Inviare un messaggio
In risposta a: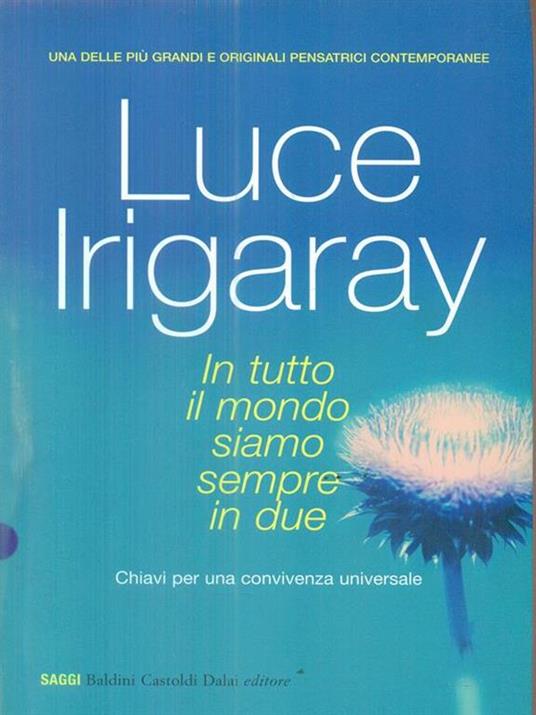
UOMO-DONNA: "I SOGGETTI SONO DUE, E TUTTO E’ DA RIPENSARE" (Laura Lilli, 1993)!!! A Mantova, Luce IRIGARAY rilancia la questione, ma - incompresa - viene "snobbata"!!!
In risposta a:
> UOMO-DONNA: "I SOGGETTI SONO DUE, E TUTTO E’ DA RIPENSARE" (Laura Lilli, 1993)!!! --- METTERE AL MONDO IL MONDO. Silvia Vegetti Finzi: «Non facciamo più figli, stiamo vivendo un’eutanasia culturale». Intervista (i R. Scorranese).
Silvia Vegetti Finzi: «Non facciamo più figli, stiamo vivendo un’eutanasia culturale»
La psicologa tra maternità (disimparata) e virilità oggi intesa come violenza
di Roberta Scorranese (Corriere della Sera, 18 settembre 2020)
Non facciamo più figli.
«Ma la colpa è anche nostra».
Si spieghi meglio.
«Io ho ottantadue anni, sono entrata nel movimento femminista tardi, nel 1980, ma sono poi stata molto attiva. E la mia generazione ha sbagliato a non proporre una nuova idea di maternità alle giovani donne di allora, oggi ultra quarantenni».
Avete insistito troppo sulla realizzazione professionale?
«Vi abbiamo insegnato ad essere figlie e non madri. A fare carriera e non a costruire un nuovo modello di maternità. Vi abbiamo spinto a cercare madri simboliche, da Virginia Woolf ai modelli più attuali, cercando di tenervi sempre in una condizione “filiale” e non “generatrice”. Non vi abbiamo passato il libretto delle istruzioni. Così oggi ci sono migliaia di quarantenni che non hanno avuto figli e quando chiedo loro il perché di questa scelta la risposta è quasi sempre “Perché c’erano altre priorità”».
Non solo. Negli anni Ottanta c’è stata una corrente di pensiero che ha provato a demolire la maternità.
«Che grave errore che abbiamo commesso, è il momento di riconoscerlo».
- Silvia Vegetti Finzi, psicologa, ha scritto numerosi libri importanti sull’adolescenza, sul femminile, sulla maternità. È anche autrice di una delle più articolate storie della psicoanalisi mai scritte in Italia. Ci incontriamo nella sua luminosa casa milanese, dove si è trasferita nel 2018 dopo la morte del marito, Mario Vegetti, al quale è stata legata per sessantadue anni. Due figli e tre nipoti.
Però si deve a voi se oggi tante ragazze non hanno paura di confrontarsi con i colleghi uomini a scuola, all’università e sul lavoro.
«Certo, ma sappiamo quello che succede: sono bravissime negli studi, si laureano meglio e prima degli uomini, magari cominciano a lavorare presto ma poi? Poi, scompaiono. Spariscono nel percorso della carriera e nella crescita professionale. Spesso per il cosiddetto «soffitto di cristallo», ma spesso anche perché non riescono a conciliare la maternità con il lavoro. Quello che avremmo dovuto fare è elaborare una maternità migliore, non cancellarla».
Così, mentre l’idea di famiglia in qualche modo si recupera - pensiamo alle famiglie allargate o a quelle costruite sul senso di comunità -, la maternità è difficilmente recuperabile nella sua natura simbolica.
«Esatto. È una perdita anche culturale. Pensiamo solo all’Italia: siamo il paese delle madri, dalla forma più discutibile come il “mammismo” a quella più nobile, cioè quella delle grandi rappresentazioni iconografiche della maternità religiosa. Eppure la sa una cosa? Ogni volta che ho proposto alle femministe una riflessione sulle annunciazioni nella pittura, mi hanno risposto molto freddamente».
Le annunciazioni sono uno scrigno di simboli materni: la paura, il coraggio, la dedizione, la crescita personale.
«Aggiungo una cosa. In molte rappresentazioni mariane non c’è solo Gesù, c’è anche il piccolo Giovanni. I due bambini vengono raffigurati come coetanei ma fisicamente diversi: il Cristo è delicato e angelico, Giovanni è materico, ricciuto, a volte vestito di pelli di animali. Io ci vedo un messaggio di profondità straordinaria: il bambino del giorno e il bambino della notte. Quello reale e vissuto e quello non vissuto e non elaborato. Pensi quanto sarebbe importante per il femminile studiare ed assimilare tutto questo. Invece nulla. E allora che cosa vediamo? Maternità conflittuali, difficoltà ad integrare i ruoli e, per riflesso, una paternità debolissima».
Il «mammo»?
«Che errore. Noi abbiamo bisogno di padri, non di mammi. La dissimmetria è un valore, io amo l’altro non il mio simile. Ma d’altra parte questo è il risultato di una maternità confusa. Il padre, simbolicamente, non esiste finché la madre non lo indica come tale. È sempre la madre che definisce la figura paterna e, al tempo stesso, ne trae forza. Bisogna capire che distilliamo potenza dalla differenza».
Lei lo ha sempre detto: sposiamo il padre ideale per i nostri figli, quello che cambia i pannolini e che cucina, ma poi non lo desideriamo più.
«Mettiamola così: molte donne sposano l’uomo che non è proprio l’oggetto del desiderio ma è grazie a lui che tante mogli potranno, come Rossella O’Hara, continuare a desiderare “l’altro”. Io e mio marito siamo stati assieme per sessantadue anni perché abbiamo riconosciuto le differenze ma ci siamo sforzati entrambi di integrarle. Ci siamo adattati alle stagioni della vita senza pretendere di rimanere nello stadio iniziale dell’incanto. Lui ha accettato di fare, qualche volta, il principe consorte accompagnandomi per convegni e io ho fatto altrettanto».
Perché ha anteposto il cognome di suo marito (Vegetti) al suo?
«Perché all’epoca era obbligatorio firmare così nei documenti pubblici, ci siamo sposati nel 1960. Poi ho mantenuto il doppio cognome. Un po’ come era obbligatorio, per una coppia sposata, esibire il certificato di matrimonio al momento di prenotare una stanza d’albergo. Di passeggiare mano nella mano non si parlava, ma pensi che una volta, era il 1963, fui costretta a scendere da un tram a Milano: indossavo un abito senza maniche. Oggi tutto questo sembra assurdo, ma quando mi sono iscritta all’Università Cattolica, nel 1963, il bidello dovette prestarmi la sua giacca perché una donna non poteva entrare in segreteria con le braccia scoperte».
È vero che c’erano due corridoi distinti, uno per gli uomini e uno per le donne?
«Certo, e così facendo si erotizzava tutto, anche la cosa meno pruriginosa come camminare per un corridoio universitario. Ma quello che non dimenticherò mai è uno specchio: recava la scritta “La donna che si depila le sopracciglia è una donna che mente”. Lo aveva voluto lo stesso padre Gemelli».
Il Sessantotto cambiò tutto?
«Sì, ma non è che nel Sessantotto le donne ebbero questo grande ruolo di protagoniste in Italia. Facevano le fotocopie dei volantini e nacquero così gli “angeli del ciclostile”. Poi vede, non era facile. Se una donna prendeva la parola in un’assemblea con centinaia di persone lo sguardo maschile era molto più presente e condizionante di quanto lo sia oggi. E lo sguardo maschile - ricordiamocelo - è sempre giudicante. Con una sua logica binaria: vecchia/giovane, brutta/bella, ribelle/docile. È stato difficilissimo affermarsi».
Soprattutto per una donna che si occupava di psicoanalisi, disciplina che in Italia venne ostacolata sia dal marxismo che dalla Chiesa cattolica.
«Mi dispiace dirlo ma il momento in cui la psicoanalisi divenne un vero fenomeno culturale coincise, in Italia, con le lezioni di Armando Verdiglione. Un personaggio molto discusso ma finalmente nei suoi incontri la psicoanalisi diventava il canale attraverso il quale leggere la cultura e il nostro tempo. Oggi io penso che solo con Massimo Recalcati questa disciplina assume un peso culturale che va oltre il mero significato terapeutico. Sono grata a Recalcati per questo, me lo faccia dire».
È d’accordo con la lettura che Recalcati ha fatto dell’assassinio di Willy Monteiro Duarte a Colleferrro (violenza contro la «parola di pace» che Willy tentava di portare in una rissa, ndr.)?
«Sì, anche se io l’avrei incentrata di più sul femminile».
Cioè?
«Penso che questi parossismi di mascolinità siano una reazione alla paura della femminilità. Donald Winnicott nei primi anni Trenta sosteneva che in ogni società persiste una grande paura delle donne. Si spiega con la dipendenza che si prova nei primi due anni di vita: senza una madre un neonato non sopravvive. E in questo mancato “grazie” alla madre risiede una violenza che tenta di abbattere quella dipendenza. E così, senza un’adeguata educazione, la virilità in molti casi cambia pelle, si confonde con la durezza e alla fine con la violenza. Specie contro le donne».
Alla base, dunque, c’è sempre una paura di essere sopraffatti.
«Winnicott poi lega questo ragionamento alla politica e dice che le tirannie sono il risultato di questa paura: diventiamo devoti ad un essere che non dipende da nessuno, un tiranno, appunto, un potere assoluto».
Torniamo ad una mancata - o monca - elaborazione della maternità.
«Lo dico da sempre: se dessimo alla maternità il giusto peso, saremmo molto più liberi».
Professoressa, lei è nata il 5 ottobre del 1938: esattamente un mese dopo la promulgazione delle leggi razziali in Italia.
«Sì, con un padre ebreo e una madre cattolica. Pensi che beffa: per i nazisti io avrei potuto rientrare nei “gentili”, ma per i fascisti no. Però la nostra origine ebraica non venne elaborata in famiglia, nessuno mi aveva mai detto che io ero ebrea così da bambina sentivo montare una paura folle quando ascoltavo certe dichiarazioni senza che l’oggetto della mia paura fosse ben chiaro. Una cosa terribile».
Nel suo libro Una bambina senza stella lei dipinge una non-madre.
«Mia madre è stata durissima con me. Ho vissuto a modo mio l’isolamento, il sentirmi invisibile e un’identità incerta. Però qualche anno fa sono stata invitata ad una serata dalle sue ex alunne, oggi anziane, che mi hanno dipinto una donna completamente diversa: una maestra dolcissima, amorevole, che si prendeva cura “delle sue bambine”. Le do atto di questo, devo farlo. Però con lucidità devo anche riconoscere che non sono stata amata. Fa bene fare i conti con il proprio passato».
Oggi qual è il suo rapporto con la fede?
«È strettamente legato al riconoscimento dei miei limiti. Vorrei fare tante cose ma non riesco, vorrei capire ma non ce la faccio. È allora che entro in un territorio diverso, quello del sacro. La fede per me è capire che siamo destinati alla finitezza».
E se si guarda indietro che cosa vede?
«Tanti errori, primo tra tutti quello di aver troppo spesso fornito “soluzioni precotte” ai miei figli, quando avrei dovuto lasciarli andare. Ma trovo anche tanta ricchezza: di amici, colleghi, dell’amore di mio marito. E mi lasci dire una cosa per chiudere: credo che oggi la vera grande povertà non sia quella dello spirito, la vera miseria è il tempo che ci manca e che non riusciamo a trovare mai».
SUL TEMA, IN RETE, SI CFR.:
Silvia Vegetti Finzi, Mettere al mondo il mondo ( Festival di Filosofia, Modena 16 settembre 2017)
Questo forum è moderato a priori: il tuo contributo apparirà solo dopo essere stato approvato da un amministratore del sito.