Inviare un messaggio
In risposta a: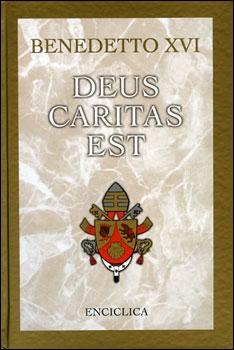
A TORINO SPIRITUALITÀ, LA GRATUITÀ . "Gratis. Il fascino delle nostre mani vuote". Sul tema, un’intervista a Carlo Ossola di Paolo Lambruschi - a cura di Federico La Sala
In risposta a:
>LA GRATUITA’. "Gratis. Il fascino delle nostre mani vuote". ---- e il "bel latino" dell’eucarestia ratzingeriana (di Carlo Ossola - Concilio, scacco al ’68).
- Nota sul tema:
L’INCIDENZA SULLA CULTURA
Concilio, scacco al ’68
di Carlo Ossola (Avvenire, 11.06.2012)
«La Cina è vicina», proclamò il Sessantotto e molti (anche giovani credenti impegnati) s’invaghirono di maoismo: il mondo era già globale, nell’attenzione che dal 1960 venne prestata alla guerra americana in Vietnam, mentre i paradigmi culturali delle Università in cui ci formavamo erano - lasciando da parte residui puramente nazionali di molta letteratura - al più europei: si salutarono dunque come un’innovazione libri quali Tristes tropiques (1955, tradotto nel 1960) di Claude Lévi-Strauss; ma quella prima "globalizzazione" degli anni Sessanta fu dolorosa e dilacerante; dappertutto si veniva a conoscenza di disuguaglianze che la decolonizzazione rendeva più vistose (vi perse la vita il Segretario generale dell’Onu Dag Hammarskjöld), il mondo veniva «a portata di mano», ma le mani erano spesso insanguinate.
Il valore prezioso che il Concilio Vaticano II portò in quello scenario fu, innanzi tutto, quello di un’universale fraternità senza frontiere e - un domani - senza più divisioni. Basti ricordare alcuni paragrafi dell’Unitatis Redintegratio ove si auspicava che «tutti i cristiani, in un’unica celebrazione dell’Eucarestia, si riuniscano in quella unità dell’una e unica chiesa, che Cristo fin dall’inizio donò alla sua chiesa».
Al monolitismo cruento, in maniera definitiva svelato dai fatti di Ungheria, del marxismo storico si opponeva, retaggio di secoli e primizia, un nuovo anelito di concordia, quella di un cristianesimo non più assetato di primati, ma pronto al servizio, al dialogo, al riconoscimento del patrimonio prezioso dell’alterità: «È necessario che i cattolici con gioia riconoscano e stimino i valori veramente cristiani, promananti dal comune patrimonio, che si trovano presso i fratelli da noi separati [...] perché Dio è sempre stupendo e sorprendente nelle sue opere» (Unitatis Redintegratio).
Nel bel latino dei Padri conciliari quel «Deus semper mirabilis et mirandus» apriva alla letizia della Gaudium et spes, ai «bona humanae dignitatis, communionis fraternae et libertatis»; dava la consolazione di aderire a ciò che di più genuino il pensiero umano (da Agostino a Pascal) aveva espresso del cuore umano: «La chiesa sa perfettamente che il suo messaggio è in armonia [concordat] con le aspirazioni più segrete del cuore umano, quando difende la causa della dignità della vocazione umana». Dignitas vocationis humanae: chiamati, infine, a essere uomini, degni di accogliere l’Incarnazione. Nessun’altra vocazione che un agire vissuto nella fratellanza, poiché l’uomo di Nazareth «pienamente manifesta l’uomo all’uomo», non solo e non tanto nella non imitabile predicazione degli ultimi tre anni di vita, ma soprattutto nella «vita ordinaria» e nascosta dei primi trent’anni, nel lavoro silente che tanto era stato messo in luce da Charles de Foucauld. Un cristianesimo infine «au cur des masses», lievito operoso, anonimo, fecondo di unità.
Non solo: studiavo allora la storia e la filosofia medievale, il poema di Dante, gli universalia tantum; e il Concilio - di fronte alle riduzioni pietiste cui si era ristretto in molti decenni di mera devozione il cristianesimo delle parrocchie - proclamava nuovamente, con titoli antichi e vigorosi, il De dignitate intellectus, de veritate et de sapientia (Gaudium et spes, §15). Fede e studio si riconciliavano, nel rispetto profondo della coscienza: «Conscientia est nucleus secretissimus atque sacrarium hominis» (Gaudium et spes, § 16).
Si è detto, allora e più tardi, che il Concilio avesse troppo incautamente innovato (ricorderò, per tutti, il manifesto anticonciliare, colto e serrato, di Romano Amerio, Iota unum, 1985); a me pare invece che nei suoi documenti fondanti il Vaticano II non abbia fatto altro che riportare alla luce il grande afflato universale della tradizione patristica e medievale di sant’Agostino, san Francesco, san Bonaventura, san Tommaso, san Bernardo, prima delle divisioni più gravi della cristianità europea e dei nazionalismi che si sono impadroniti di un messaggio che non ha alcun confine, se non quello della creazione stessa (Teilhard de Chardin). Vorrei aggiungere: una sintesi tra l’universalismo medievale e la dignitas hominis umanistica: la «altissima vocatio» dell’uomo che ancora attende di «attingere fastigium», di toccare il proprio vertice.
Proprio per questo il Concilio non è chiuso: chi l’abbia vissuto allora (attraversò tutto il mio liceo e l’inizio dell’Università) e ne abbia oggi coscienza storica, sa bene che momenti così alti di convocazione e dono distendono poi le loro acque e frutti per decenni e generazioni, mentre forme più improvvise - rivoli di qualche debordare - rinsecchiscono e altre maschere già morte, fellinianamente rimuoiono. Non tanto conta che la chiesa sia impari al proprio compito (lo è sempre stata dal tradimento di San Pietro in poi), ma che non abbia più - o molto meno - lo slancio di offrire alle «generazioni di domani ragioni di vita e di speranza» (Gaudium et spes, 31).
Oggi la secolarizzazione compiuta, il disfacimento etico dell’Occidente, il trionfo di un nuovo universalismo più subdolo - e già nei documenti conciliari denunciato - e cioè quello della pura rendita finanziaria di capitali mobili e irresponsabili, rendono l’eredità del Concilio più impegnativa e urgente.
Concludendo il mio seminario al Collège de France, questo marzo 2012, Jean Delumeau, una delle figure-faro del cristianesimo post-conciliare, ha osservato che, sebbene le varie forme di paradiso che l’umanità ha agognato si siano l’una dopo l’altra dissolte, pure rimane un compito sempre nuovo e sempre immane: realizzare le Beatitudini. E, in questo, il cristianesimo non è che a un balbuziente inizio, poiché -insegna ancora la Gaudium et Spes - «tutte queste [ingiustizie] sono certamente vergognose e, mentre guastano la civiltà umana, ancor corrompono più coloro che così si comportano che non quelli che le subiscono; e ledono grandemente l’onore del Creatore». Ecco, non siamo che un semen Gloriae e molto ci dovrà passare sopra...
Carlo Ossola
Questo forum è moderato a priori: il tuo contributo apparirà solo dopo essere stato approvato da un amministratore del sito.