Inviare un messaggio
In risposta a: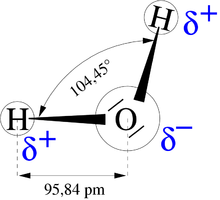
lL "LOGO" DELLA SAPIENZA, L’UMANITA’, E L’ACQUA. PAESE IMPAZZITO: FORZA "CHE RùBINO" TUTTO E TUTTI !!! PER IL "logo" della "SAPIENZA" DI ROMA, UN APPELLO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA!!! Una nota, con articoli - a cura di Federico La Sala
ITALIA: LA NOSTRA PATRIA E’ LA LINGUA, NON LA TERRA NON IL SANGUE. Dante e Saussure insegnano.
EMERGENZA EDUCATIVA: TRADIMENTO DEGLI INTELLETTUALI.
(...)
In risposta a:
> lL "LOGO" DELLA SAPIENZA, L’UMANITA’, E L’ACQUA. --- Università “La Sapienza”: Giornata del laureato ed educazione finanziaria (di Ignazio Visco)
- Continuazione e FINE
Giornata del laureato
di Ignazio Visco (Insula europea, 2 aprile 2023)
- [...]
 Il basso grado di alfabetizzazione finanziaria è però solo un aspetto del divario di conoscenze accumulato dal nostro paese. L’Italia è in ritardo sia nei tassi di scolarità e di istruzione universitaria, sia nel livello delle competenze dei giovani come della popolazione adulta. La bassa dotazione di capitale umano nel confronto internazionale è questione antica. Il progresso nei livelli di istruzione è stato considerevole, ma non tale da colmare i divari accumulati.
Il basso grado di alfabetizzazione finanziaria è però solo un aspetto del divario di conoscenze accumulato dal nostro paese. L’Italia è in ritardo sia nei tassi di scolarità e di istruzione universitaria, sia nel livello delle competenze dei giovani come della popolazione adulta. La bassa dotazione di capitale umano nel confronto internazionale è questione antica. Il progresso nei livelli di istruzione è stato considerevole, ma non tale da colmare i divari accumulati.
 Voi, i migliori laureati dell’ultimo anno, siete un’eccellenza all’interno di una minoranza. In Italia, infatti, la quota di popolazione tra i 25 e i 64 anni in possesso di un titolo di studio terziario era pari nel 2021 solo al 20 per cento, a fronte di una media del 40 tra i paesi OCSE. Se l’Italia sconta in parte il ritardo delle generazioni adulte, il differenziale resta marcato anche tra i più giovani: nella fascia di età tra i 25 e i 34 anni la quota di coloro che sono in possesso di un titolo di studio terziario è salita dal 21 per cento del 2010 al 28 per cento del 2021, ma rimane ancora al penultimo posto fra i paesi dell’OCSE; nello stesso periodo, la media dell’Unione europea (UE) è passata dal 32 al 41 per cento. Nella stessa fascia di età, resta elevata la quota di coloro che non hanno conseguito il diploma di scuola secondaria superiore (il 23 per cento nel 2021, contro il 14 della media dei paesi dell’OCSE).
Voi, i migliori laureati dell’ultimo anno, siete un’eccellenza all’interno di una minoranza. In Italia, infatti, la quota di popolazione tra i 25 e i 64 anni in possesso di un titolo di studio terziario era pari nel 2021 solo al 20 per cento, a fronte di una media del 40 tra i paesi OCSE. Se l’Italia sconta in parte il ritardo delle generazioni adulte, il differenziale resta marcato anche tra i più giovani: nella fascia di età tra i 25 e i 34 anni la quota di coloro che sono in possesso di un titolo di studio terziario è salita dal 21 per cento del 2010 al 28 per cento del 2021, ma rimane ancora al penultimo posto fra i paesi dell’OCSE; nello stesso periodo, la media dell’Unione europea (UE) è passata dal 32 al 41 per cento. Nella stessa fascia di età, resta elevata la quota di coloro che non hanno conseguito il diploma di scuola secondaria superiore (il 23 per cento nel 2021, contro il 14 della media dei paesi dell’OCSE).
 Il basso grado di istruzione si traduce in gravi carenze nelle competenze. Le più recenti rilevazioni INVALSI segnalano che circa il 10 per cento dei giovani in possesso del diploma di scuola secondaria superiore è privo di sufficienti competenze di lettura e di matematica. Il programma di valutazione internazionale PIAAC, realizzato dall’OCSE tra il 2013 e il 2016, indica che in tutti i gruppi di età gli adulti italiani presentano risultati peggiori della media. Nel nostro paese si registra, in particolare, una diffusa carenza di quelle competenze - di lettura e di comprensione, di utilizzo della logica e di analisi - che rispondono alle esigenze della vita moderna e del mondo del lavoro. Nonostante questi ritardi, la partecipazione degli adulti tra i 25 e i 64 anni a corsi di formazione e aggiornamento rimane inferiore alla media della Unione europea (9,9 contro 10,8 per cento nel 2021).
Il basso grado di istruzione si traduce in gravi carenze nelle competenze. Le più recenti rilevazioni INVALSI segnalano che circa il 10 per cento dei giovani in possesso del diploma di scuola secondaria superiore è privo di sufficienti competenze di lettura e di matematica. Il programma di valutazione internazionale PIAAC, realizzato dall’OCSE tra il 2013 e il 2016, indica che in tutti i gruppi di età gli adulti italiani presentano risultati peggiori della media. Nel nostro paese si registra, in particolare, una diffusa carenza di quelle competenze - di lettura e di comprensione, di utilizzo della logica e di analisi - che rispondono alle esigenze della vita moderna e del mondo del lavoro. Nonostante questi ritardi, la partecipazione degli adulti tra i 25 e i 64 anni a corsi di formazione e aggiornamento rimane inferiore alla media della Unione europea (9,9 contro 10,8 per cento nel 2021).
 È difficile spiegare perché in Italia si studi così poco. I rendimenti dell’istruzione sono positivi ma meno marcati che altrove. Il rapporto tra le retribuzioni dei lavoratori che hanno completato un ciclo di istruzione terziaria e quelli che hanno completato solo un percorso secondario superiore è più basso della media OCSE (o di quella della UE). Se ciò contribuisce a spiegare la minore propensione delle famiglie a investire in capitale umano, il basso rendimento di un fattore di produzione relativamente scarso rappresenta per la teoria economica un paradosso, che ho messo in evidenza già molti anni fa.
È difficile spiegare perché in Italia si studi così poco. I rendimenti dell’istruzione sono positivi ma meno marcati che altrove. Il rapporto tra le retribuzioni dei lavoratori che hanno completato un ciclo di istruzione terziaria e quelli che hanno completato solo un percorso secondario superiore è più basso della media OCSE (o di quella della UE). Se ciò contribuisce a spiegare la minore propensione delle famiglie a investire in capitale umano, il basso rendimento di un fattore di produzione relativamente scarso rappresenta per la teoria economica un paradosso, che ho messo in evidenza già molti anni fa.
 Diversi elementi contribuiscono a contenere il vantaggio salariale dei laureati in Italia nonostante la loro scarsità. Vi influiscono, in parte, l’insufficiente presenza di figure professionali specializzate e, soprattutto, il ritardo del sistema produttivo, che ha a lungo continuato a privilegiare i comparti tradizionali, più esposti alla concorrenza dei paesi in via di sviluppo, ed è rimasto sbilanciato verso imprese piccole e molto piccole, la cui risposta all’apertura dei mercati e al progresso tecnologico è necessariamente lenta e modesta.
Diversi elementi contribuiscono a contenere il vantaggio salariale dei laureati in Italia nonostante la loro scarsità. Vi influiscono, in parte, l’insufficiente presenza di figure professionali specializzate e, soprattutto, il ritardo del sistema produttivo, che ha a lungo continuato a privilegiare i comparti tradizionali, più esposti alla concorrenza dei paesi in via di sviluppo, ed è rimasto sbilanciato verso imprese piccole e molto piccole, la cui risposta all’apertura dei mercati e al progresso tecnologico è necessariamente lenta e modesta.
 Al basso rendimento dell’istruzione concorrono anche le asimmetrie informative sulla qualità di chi partecipa al mercato del lavoro, più rilevanti in Italia dato il basso livello medio di istruzione e il contesto di scarsa differenziazione dei percorsi di studio. Ciò tende a innescare un circolo vizioso: in assenza delle competenze necessarie, le imprese comprimono la propria attività innovativa e i salari dei, pochi, lavoratori qualificati; le famiglie rispondono a questa carenza di incentivi e non investono sufficientemente in conoscenza, alimentando la scarsa propensione all’innovazione del sistema produttivo.
Al basso rendimento dell’istruzione concorrono anche le asimmetrie informative sulla qualità di chi partecipa al mercato del lavoro, più rilevanti in Italia dato il basso livello medio di istruzione e il contesto di scarsa differenziazione dei percorsi di studio. Ciò tende a innescare un circolo vizioso: in assenza delle competenze necessarie, le imprese comprimono la propria attività innovativa e i salari dei, pochi, lavoratori qualificati; le famiglie rispondono a questa carenza di incentivi e non investono sufficientemente in conoscenza, alimentando la scarsa propensione all’innovazione del sistema produttivo.
 Tale spirale è accentuata dai flussi migratori: la compressione delle retribuzioni dei lavoratori più qualificati rispetto agli altri paesi avanzati spinge molti italiani, in particolare giovani con un più elevato livello di istruzione, a ricercare migliori opportunità di lavoro in altri paesi. Tra il 2009 e il 2021 gli italiani che hanno trasferito la propria residenza all’estero sono stati oltre un milione (a fronte di circa mezzo milione rientrato in Italia). Si conferma la maggior propensione allo spostamento per chi ha livelli di istruzione più elevati: sui 94.000 emigrati nel 2021, oltre un quarto aveva un titolo di studio terziario, una quota superiore al 20 per cento del totale della popolazione.
Tale spirale è accentuata dai flussi migratori: la compressione delle retribuzioni dei lavoratori più qualificati rispetto agli altri paesi avanzati spinge molti italiani, in particolare giovani con un più elevato livello di istruzione, a ricercare migliori opportunità di lavoro in altri paesi. Tra il 2009 e il 2021 gli italiani che hanno trasferito la propria residenza all’estero sono stati oltre un milione (a fronte di circa mezzo milione rientrato in Italia). Si conferma la maggior propensione allo spostamento per chi ha livelli di istruzione più elevati: sui 94.000 emigrati nel 2021, oltre un quarto aveva un titolo di studio terziario, una quota superiore al 20 per cento del totale della popolazione.
 Per invertire queste tendenze bisogna dunque riflettere sia sugli strumenti con cui la società accresce la propria dotazione di capitale umano (in primis scuola e università), sia sui fattori che determinano le scelte individuali di istruzione. L’importanza dell’istruzione e dell’investimento in conoscenza deriva anche dalla rapidità dell’innovazione tecnologica. Pensiamo ad esempio allo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale, che oggi rende difficile immaginare quali saranno i beni e i servizi offerti nei prossimi anni e, di conseguenza, quali professionalità verranno richieste sul mercato del lavoro.
Per invertire queste tendenze bisogna dunque riflettere sia sugli strumenti con cui la società accresce la propria dotazione di capitale umano (in primis scuola e università), sia sui fattori che determinano le scelte individuali di istruzione. L’importanza dell’istruzione e dell’investimento in conoscenza deriva anche dalla rapidità dell’innovazione tecnologica. Pensiamo ad esempio allo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale, che oggi rende difficile immaginare quali saranno i beni e i servizi offerti nei prossimi anni e, di conseguenza, quali professionalità verranno richieste sul mercato del lavoro.
 La consapevolezza del ruolo centrale della tecnologia e l’attenzione al capitale umano furono elementi caratterizzanti del pensiero di Carlo Azeglio Ciampi, anche nei suoi lunghi anni di servizio in Banca d’Italia. Come ebbe a dire in un’intervista rilasciata durante il suo mandato presidenziale “la cultura e l’uso critico della ragione [...] sono i cardini del progresso dell’umanità”. Ciampi avvertiva forte l’importanza della formazione, soprattutto, ma non solo, per le generazioni più giovani. Riteneva che, per essere preparati a competere, fosse necessario sviluppare attitudine al cambiamento e curiosità intellettuale, che qualificava come il “gusto dei perché”.
Concludo citando un breve passo di un saggio pubblicato da Ciampi nel 2015 nella rivista “Nuova Antologia”. Si tratta del suo ultimo saggio, raccolto insieme con tutti gli altri scritti da lui pubblicati su questa rivista nell’arco di oltre un ventennio in un volume curato dal Professor Cosimo Ceccuti e stampato dalla Banca d’Italia nel 2017. In esso, davanti alle complesse e ardue sfide del presente, Ciampi affermava: “I giovani dispongono della ricchezza del tempo che hanno davanti a sé. È loro il compito di contrastare le forze negative di un ripiegamento rassegnato o di un velleitario e sterile ribellismo. Occorre, dunque, che si preparino ad affrontarlo; che si attrezzino moralmente e culturalmente per assolverlo al meglio. La via maestra che intravedo è ancora e sempre la Cultura. Cultura, in tutte le sue declinazioni, come valore fondante di ogni progresso civile, sociale ed economico. Cultura come spinta propulsiva”.
Un messaggio, questo, che non possiamo non fare nostro, ricordando, indietro nel tempo con Socrate, che “esiste un solo bene, la conoscenza, e un solo male, l’ignoranza”.
La consapevolezza del ruolo centrale della tecnologia e l’attenzione al capitale umano furono elementi caratterizzanti del pensiero di Carlo Azeglio Ciampi, anche nei suoi lunghi anni di servizio in Banca d’Italia. Come ebbe a dire in un’intervista rilasciata durante il suo mandato presidenziale “la cultura e l’uso critico della ragione [...] sono i cardini del progresso dell’umanità”. Ciampi avvertiva forte l’importanza della formazione, soprattutto, ma non solo, per le generazioni più giovani. Riteneva che, per essere preparati a competere, fosse necessario sviluppare attitudine al cambiamento e curiosità intellettuale, che qualificava come il “gusto dei perché”.
Concludo citando un breve passo di un saggio pubblicato da Ciampi nel 2015 nella rivista “Nuova Antologia”. Si tratta del suo ultimo saggio, raccolto insieme con tutti gli altri scritti da lui pubblicati su questa rivista nell’arco di oltre un ventennio in un volume curato dal Professor Cosimo Ceccuti e stampato dalla Banca d’Italia nel 2017. In esso, davanti alle complesse e ardue sfide del presente, Ciampi affermava: “I giovani dispongono della ricchezza del tempo che hanno davanti a sé. È loro il compito di contrastare le forze negative di un ripiegamento rassegnato o di un velleitario e sterile ribellismo. Occorre, dunque, che si preparino ad affrontarlo; che si attrezzino moralmente e culturalmente per assolverlo al meglio. La via maestra che intravedo è ancora e sempre la Cultura. Cultura, in tutte le sue declinazioni, come valore fondante di ogni progresso civile, sociale ed economico. Cultura come spinta propulsiva”.
Un messaggio, questo, che non possiamo non fare nostro, ricordando, indietro nel tempo con Socrate, che “esiste un solo bene, la conoscenza, e un solo male, l’ignoranza”.
*Relazione letta il 27 marzo 2023 presso la Sapienza Università di Roma. [ripresa parziale, senza le note allegate].
Questo forum è moderato a priori: il tuo contributo apparirà solo dopo essere stato approvato da un amministratore del sito.