Inviare un messaggio
In risposta a: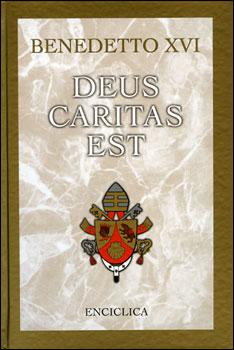
Camillo Ruini e Aldo Schiavone dialogano sull’"Avvenire" del-"la Repubblica" e si trovano d’accordo sul "caro-prezzo" ("deus caritas est") da far pagare all’Italia, con l’aiuto dell’Unto del Signore - a cura di pfls
In risposta a:
> Camillo Ruini e Aldo Schiavone dialogano sull’"Avvenire" del-"la Repubblica" --- Ponzio Pilato, ipotesi e illazioni nella nebbia. un’analisi oscillante, troppo possibilista, di Aldo Schiavone (di Carlo Franco).
Ponzio Pilato, ipotesi e illazioni nella nebbia
Aldo Schiavone, «Ponzio Pilato. Un enigma tra storia e memoria», Einaudi. Storicamente inafferrabile, il ruolo svolto dal funzionario romano nella passione di Gesù è oggetto di un’analisi oscillante, troppo possibilista
di Carlo Franco (il manifesto, 07.02.2016)
Tra storia e memoria muove l’ultimo libro di Aldo Schiavone: Ponzio Pilato Un enigma tra storia e memoria (Einaudi «Storia», pp. 174, euro 22,00). Centoquaranta pagine per ragionare sul funzionario romano che condannò a morte Gesù verso l’anno 30 della nostra era, sotto il regno di Tiberio. Lo studio storico dei resoconti della passione nei vangeli fronteggia difficoltà gravissime, forse insormontabili. Lo dimostrano le divergenze della ricerca moderna: ogni fase, ogni parola della vicenda è stata discussa, accettata, respinta, riscritta.
Una recente sintesi ha avuto bisogno, per fare il punto, di oltre ottocento pagine (The Trial and Crucifixion of Jesus. Texts and Commentary, a cura di D.W. Chapman e E.J. Schnabel, Tübingen, Mohr Siebeck, 2015).
Il libro di Schiavone è invece agile: la documentazione è confinata in appendice, insieme alla corposa bibliografia, e i tecnicismi sono poco invadenti. La scrittura, condotta con mano sicura, si apre a sviluppi narrativi. L’indagine non si limita ai problematici dati fattuali, ma si insinua nel non detto dei testi, e soprattutto nelle intenzioni dei protagonisti. Ne consegue, pur con cautele, che il piano di «ciò che avvenne veramente» è spesso superato, a favore di inferenze suggestive e però irrimediabilmente speculative. Osservazioni utili offre l’analisi della prassi amministrativa romana, determinata ove possibile a governare con il consenso delle élites (La Giudea romana e il lavoro del secondo prefetto). Ma il riflesso di questi criteri non si lascia cogliere facilmente nella vicenda di Gesù. La tradizione su Pilato induce a credere che «il prefetto non doveva capire la religiosità giudaica»: lo mostrano gli incidenti seguiti all’introduzione a Gerusalemme di stendardi con l’effigie dell’Augusto (Flavio Giuseppe, Guerra giudaica, 2.9.2-4) o alla collocazione nel Tempio di scudi dorati in onore di Tiberio (Filone di Alessandria, Ambasceria a Gaio, 38, 299-305).
Giustamente Schiavone indaga che cosa Pilato poteva sapere sulla storia e la cultura della Giudea: è possibile, ma non sicuro, che gli giungesse l’eco della storiografia greca, che andò poi a innervare l’acida digressione di Tacito (Storie, 5. 2-10). Ignote le sue idee: che condividesse il pragmatico scetticismo dell’aristocrazia romana è però ragionevole. Soccorre l’immaginazione, che è virtù dello storico, da usare con prudenza.
Posto che «non sappiamo in quale lingua Pilato e Gesù si parlassero», l’ipotesi che il prefetto sapesse l’aramaico (come nel film The Passion) è destinata a restare tale. Le incertezze sullo svolgimento degli eventi nel pretorio di Gerusalemme sono, come è noto, fortissime: per ricostruire e interpretare gli atteggiamenti del prefetto, Schiavone attinge a un piano «psicologico», velando il dettato con frequenti formule attenuative.
Nella sezione centrale del libro, dedicata all’interrogatorio (non un «processo») di Gesù, si incontra una sequenza di «è ragionevole supporre», «è probabile», «non vi è ragione per non», «non vi è motivo di dubitare». Essa conduce oltre la soglia del conoscibile, e dello storicamente accertabile. Le riflessioni su Gesù e la sua «certezza solitaria, esposta al dubbio e all’angoscia», su Pilato, che «è possibile fosse già rimasto colpito dalla predicazione di Gesù», la cui personalità «doveva essergli apparsa, nel confronto diretto, perturbante e inattesa», accompagnano una ricostruzione indiziaria, che approda a toni talora pensosi: il dialogo tra i due «è di una potenza simbolica senza eguali», e getta da secoli una luce «abbagliante in modo quasi insopportabile». Ma dopo aver definito quella scena «storicamente persuasiva», Schiavone aggiunge enigmaticamente: «Che sia anche acceduta - nei fatti e non solo nella memoria, e per giunta nei termini in cui la raccontiamo - potrebbe anche essere, fra tutte, la cosa meno importante».
Il lettore resta perplesso: si intende che il contenuto di «verità» del soggetto è inafferrabile. Sequenze di possibilistici verbi al futuro scandiscono passaggi importanti: il grido dei sacerdoti davanti alla proclamazione di Gesù come figlio di Dio «avrà sicuramente colpito il governatore», il quale «lo avrà comparato d’istinto al comportamento del prigioniero» e «si sarà chiesto» se Gesù fosse uno dei «cosiddetti uomini divini» così frequenti in Oriente.
Che le questioni del giudaismo fossero estranee alla mentalità romana, che Pilato non fosse «in sintonia con la religione ebraica» è credibile, come si è detto; più difficile pensare che egli «subito si era reso conto della diversità di Gesù»: tale è il senso del racconto evangelico, che però ha a che fare con la memoria o con la teologia più che con i fatti. Le sottili esegesi proposte da Schiavone oscillano tra la ricerca storica e la filosofia, se non la teologia.
Certo, il racconto dei vangeli non è un «documento», ma un intreccio di memorie orali, profezie «compiute», rielaborazioni successive. Coerentemente, Schiavone non attribuisce valore storico assoluto agli eventi che analizza. E il carattere non confessionale del suo discorso permette qualche provocazione. Così circa la scena dell’Ecce homo: «Non si può credere a una sola parola di questo racconto».
Sullo sfondo sta la critica neotestamentaria: il racconto della passione fu curvato dalla tradizione in una forma che aggravava la responsabilità giudaica e alleggeriva quella romana. Schiavone attribuisce assoluta importanza a eventi di cui pure invita a dubitare radicalmente. Si veda la famosa domanda di Pilato sull’essenza della «verità» (Giovanni, 18.38). «Verità» è parola tipicamente giovannea, però si esita a considerare la frase solo una «falsificazione della memoria».
A tratti il discorso si fa ispirato: «nella sua disadorna essenzialità, la prosa di Giovanni raggiunge risultati di grande efficacia espressiva. Nulla, se non un corpo ferito e oltraggiato: e in quel corpo, la maestà e l’onnipotenza di Dio, scempiate dai carnefici».
Si percepisce un moto alterno, che segue e poi rigetta la logica del testo analizzato: in una domanda di Pilato a Gesù si coglie «un’esplicita risonanza metafisica», propria di un uomo che «non senza apprensione, sta intuendo la presenza dell’ignoto innanzi a lui». Ma Pilato la ha «pronunciata davvero»? Molto spinge a «ritenerlo possibile». Però circa la successiva risposta di Gesù si annota: «è possibile che Gesù non abbia mai pronunciato quelle parole».
Il calibratissimo ma sfiancante oscillare dell’argomentazione coinvolge anche la filologia. La domanda di Pilato ai giudei («Crocifiggerò il vostro re?»: Giovanni, 19.15) è forse un’affermazione: «Quel punto interrogativo è probabilmente l’aggiunta di un copista troppo zelante, se non è stata voluta dallo stesso autore del Quarto vangelo». La filologia è destrutturata: giacché se è vera la prima ipotesi, il testo potrebbe essere corretto, ma è strana l’idea di «correggere» Giovanni nel caso della seconda alternativa.
His fretus, l’autore giunge al centro del libro: posto che la condanna di Gesù era «necessaria» al compimento del piano messianico, tra l’accusato che non si difese e il magistrato che non lo voleva mettere a morte si strinse una sorta di «patto» sul quale il vangelo di Giovanni però tace. Anche in questo caso, un’interpretazione più filosofica che storica. Del resto Schiavone ammette «l’impressione di una insuperabile ambiguità» che emana dalla figura di Pilato, «quasi la sua cifra non potesse essere altro dall’indefinito, dalla nebbia».
Questo forum è moderato a priori: il tuo contributo apparirà solo dopo essere stato approvato da un amministratore del sito.