Inviare un messaggio
In risposta a: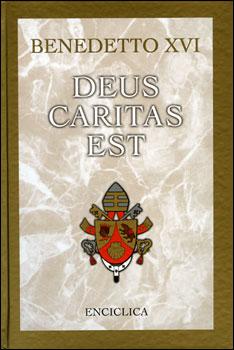
WOITYLA PREGAVA PER L’ITALIA, BENEDETTO XVI PREGA PER "FORZA ITALIA"!!! Una svolta filologica e teologico-politica totale. Una nota di Marco Politi - a c. di Federico La Sala
In risposta a:
> WOITYLA PREGAVA PER L’ITALIA .... - Quel “mea culpa” di Wojtila che serve ancora al dialogo (di Alberto Melloni).
Quel “mea culpa” di Wojtila che serve ancora al dialogo
di Alberto Melloni (Corriere della Sera, 27 febbraio 2011)
Due anniversari prossimi della vita di Karol Wojtyla - quello del mea culpa pronunciato il 12 marzo 2000 in San Pietro e poco dopo la consegna al Muro del pianto del foglietto con quel testo - potrebbero fornire i contenuti ideali per le chiese che stanno ordinando monumenti da inaugurare a maggio. Chi volesse davvero «prendere» Giovanni Paolo II per ciò che è stato non dovrebbe mettere sugli altari bronzi ineleganti, brutti dipinti, supponenze inespressive del «noto artista», ma delle video-icone: e come Bill Viola dilatare in ore i pochi secondi di un gesto che, dal 1978 in poi, è ormai il solo magistero del Papa capace di parlare.
Nella quaresima giubilare del 2000, infatti Wojtyla segnò un punto alto del dialogo ebraico cristiano: dialogo totalmente asimmetrico, giacché Israele non ha bisogno di dire cos’è la chiesa, mentre la chiesa ha bisogno di dire cos’è Israele. Un punto preparato fra errori, fra intuizioni: come quella di aggiungere un inciso («ripeto: da chiunque») al discorso alla sinagoga di Roma nel 1986, per sottolineare come la presa di distanza conciliare dall’antisemitismo praticato «ovunque e da chiunque» non ammettesse riserve. E culminato nella quarta preghiera pronunciata in San Pietro quel 12 marzo, domenica del perdono, e consegnata al Muro occidentale.
«Nel ricordo delle sofferenze patite dal popolo di Israele nella storia» riconosceva i peccati commessi «da non pochi» contro «il popolo dell’alleanza e delle benedizioni»: e confessava a Dio il profondo dolore «per il comportamento di quanti nel corso della storia hanno fatto soffrire questi tuoi figli» impegnandosi «in un’autentica fraternità con il popolo dell’alleanza». Portare queste parole a Gerusalemme voleva dire davvero salire alla dimora di Dio per un atto di umile sfida a se stessi, sottoporsi ad una prova che non ammetteva equivoci. E che meriterebbe di essere ricordato da un video-altare in una chiesa cattolica. Non per celebrare «risultati», che non ci sono: comprendersi non è una cosa e non si tramanda. Ma per ricordare che il dialogo asimmetrico con Israele si fa così (lo dimostra il summit ebraico-cristiano di oggi a Parigi): con il tremore di chi sa di dover camminare verso un muro, per togliere spazio al muro che s’alza dentro ciascuno nel muto fragore dell’indifferenza.
Questo forum è moderato a priori: il tuo contributo apparirà solo dopo essere stato approvato da un amministratore del sito.