Inviare un messaggio
In risposta a: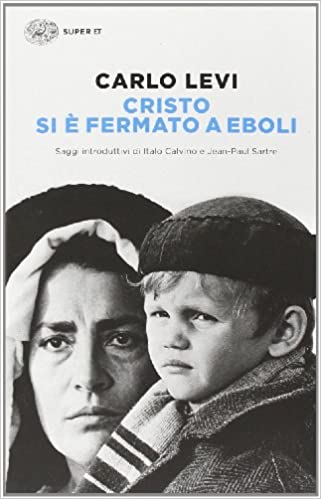
L’EUROPA, LA LUCANIA, E LA GUERRA DI TROIA: L’ANALISI DI CARLO LEVI. Una nota - di Federico La Sala
In risposta a:
> L’EUROPA, LA LUCANIA, E LA GUERRA DI TROIA --- La Patria è mobile. In pricincipio c’è Enea: "L’invenzione della patria" (di Mirella Serri)
La Patria è mobile Un concetto mutevole nel tempo e nello spazio
Come spiega Fabio Finotti in un saggio che attraversa la storia della cultura italiana, da quella alta alla pop
di Mirella Serri (La Stampa, 14/03/2016)
Carissimo, mi trovo «prigioniero in quela Signora bruta Italia» in «barache, già lo sai anche tu, che sono barache di Italiani internati». Chi scrive, con lessico a dir poco zoppicante, è il signor G., un italiano fedele suddito degli Asburgo durante la Prima guerra mondiale: è finito prigioniero di altri italiani da sempre disprezzati e considerati così fastidiosi che «non lasciano in pace nemmeno le mosche». L’ostilità del detenuto si rafforza dal momento che in quella coabitazione coatta con i connazionali finisce con l’avvertire di essere anche lui un «italiano» ovvero di far parte di quella mala genìa con cui non ha mai voluto aver niente da spartire.
Una percezione analoga (ma di segno opposto, dove il sentirsi italiano assume una valenza positiva) la proverà più di 25 anni dopo un altro internato, nel Lager di Auschwitz: «Lo jiddish era di fatto la seconda lingua del campo (sostituita più tardi dall’ungherese). Non solo non la capivo», spiega Primo Levi, «ma sapevo solo vagamente della sua esistenza... Gli ebrei polacchi, russi, ungheresi erano stupiti che noi italiani non lo parlassimo: eravamo degli ebrei sospetti, da non fidarsene». Non c’è dubbio: gli ebrei provenienti dalla Penisola riescono a comunicare molto di più con gli aguzzini nazisti (è il caso di Levi) che con i correligionari non italiani, proprio perché sono profondamente assimilati e radicati in Italia.
In principio c’è Enea
Nonostante dunque i due reclusi, il signor G. e Primo Levi, provengano da culture e abitudini assai diverse da quelle del resto dello Stivale, entrambi hanno dentro di sé la consapevolezza di un’appartenenza comune. Da dove viene questa certezza quasi subliminale, la scoperta di questo spazio interiore circoscritto dalla parola «patria», uno spazio che quasi non si sa di possedere, che stupisce e coglie di sorpresa tanto l’incolto filo-asburgico quanto il dotto futuro scrittore?
Se lo vogliamo capire, buttiamo a mare le nostre più tradizionali convinzioni: il termine patria non coincide interamente con l’etimo «terra dei padri»: è qualcosa di molto diverso e muta nel tempo e nello spazio. A spiegarci tutte le accezioni di questo singolare e a volte inafferrabile concetto è il bellissimo excursus di Fabio Finotti, che in Italia. L’invenzione della patria (Bompiani, pp. 569, € 28) attraversa tutta la cultura italiana, da quella alta a quella pop, da Dante a Petrarca, da Machiavelli a Manzoni, da Pasolini a Rossellini, dall’iconografia del Vittoriano a quella di miss Italia, da Altiero Spinelli all’avvento dell’era tv.
Docente presso la Pennsylvania University di Philadelphia, dove dirige il Center for Italian Studies, Finotti ci spiega che alle radici dell’immaginario che nutre e definisce la parola «patria» c’è l’avventura di Enea, l’eroe classico che, diversamente da Ulisse, non rientra a casa, non torna a Troia ma porta la casa originaria con sé cercando di ritrovarla e rifondarla altrove. Lo fa proprio approdando sulle coste italiane: la dimora per eccellenza, l’abitazione del cuore e dell’anima per Enea non è dunque un luogo certo, ma è qualcosa che si muove con lui. Scrittori e artisti italiani hanno poi dato forma e concretezza alla nostra mutevole identità, plasmandola e riplasmandola più volte, passando, per esempio, attraverso la nozione di Impero come insieme di diversità propria di Carlo Magno, oppure l’idea romantica di nazione di Foscolo e di Manzoni per arrivare alla «patria viaggiante» delle novecentesche migrazioni cantate da Pascoli.
Le radici in viaggio
I contadini e gli operai che agli inizi del secolo superavano confini e oceani in cerca di fortuna erano pronti a radicarsi nelle nuove terre alla maniera di Enea, portando la patria con sé. Monumenti, architettura, riti e ricette: i nostri emigranti hanno dato vita a tante Little Italy sparse per il mondo. E proprio per la varietà e la molteplicità delle loro esperienze, paradossalmente, hanno sempre coltivato un forte senso delle radici.
La storia della Penisola come patria ha così molto da insegnare all’Europa: in Italia, per esempio, gli ebrei, per secoli, non furono costretti a rinunciare alla loro peculiarità etnico-religiosa ma si sentirono - lo ricordava il poeta Umberto Saba - «figli». Oggi questo senso di appartenenza contraddistingue spesso anche coloro che approdano nel nostro paese: come documentano anche libri e testimonianze, l’Italia è percepita come una «casa» accogliente e composita, un’etnia fatta da stirpi diverse, «un tappeto dai mille colori», tutti racchiusi entro un’unica cornice. In un momento come questo, in cui tutta l’Europa è assediata da imponenti flussi migratori, il libro di Finotti si pone come un fondamentale vademecum: ci incoraggia a rimodellare senza drammi il nostro ruolo e lo stesso concetto di accoglienza e di convivenza proprio ricordandoci la nostra identità multicolore, non stabile ma «mobile» e mutevole nei secoli.
Questo forum è moderato a priori: il tuo contributo apparirà solo dopo essere stato approvato da un amministratore del sito.