Inviare un messaggio
In risposta a: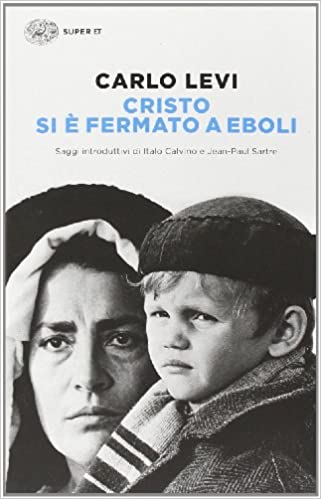
L’EUROPA, LA LUCANIA, E LA GUERRA DI TROIA: L’ANALISI DI CARLO LEVI. Una nota - di Federico La Sala
In risposta a:
> L’EUROPA, LA LUCANIA, E LA GUERRA DI TROIA --- "Paura della libertà": Carlo Levi, lo Stato mannaro (di Franco Baldasso)
Carlo Levi, lo Stato mannaro
di Franco Baldasso (Alfabeta-2, 30 giugno 2019)
- Carlo Levi, Paura della libertà, introduzione di Giorgio Agamben, Neri Pozza «La quarta prosa», 2018, 154 pp., € 15
In Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita, libro che è prima di tutto un ripensamento delle categorie del politico, Giorgio Agamben si sofferma sul significato giuridico di quella figura dell’immaginario folkloristico occidentale che è il werewolf, chiamato anche loup garou: il lupo mannaro. “Quello che doveva restare nell’inconscio collettivo”, scrive Agamben, “come un ibrido mostro tra umano e ferino, diviso tra la selva e la città - il lupo mannaro - è dunque in origine la figura di colui che è stato bandito dalla comunità”. Secondo Agamben il lupo mannaro incarna la zona di indifferenza tra ferino e umano, zona instabile che emerge dall’antichità per illuminare con una luce abbagliante le nostre idee di cittadinanza e di esclusione: come la prima sia sempre stata costruita poggiandosi sulla seconda. Un ulteriore argomento alle sue tesi viene dal racconto, citato da Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi, della trasformazione temporanea da bestia a uomo del lupo mannaro nel folklore del sud Italia: solo dopo che l’uomo trasformato in lupo ha bussato per tre volte alla porta la moglie può aprire. Solo allora infatti la metamorfosi di ritorno da belva a umano è compiuta, e con essa il ristabilimento dell’ordine civile.
“Quel che è comune all’uomo e al lupo è, per la sua indeterminatezza smisurata, uno spavento - finché una immagine totemica lo trasformerà in una sopportabile adorazione”, scrive Levi nel poco conosciuto Paura della libertà, scritto in esilio in Francia nel 1939, all’immediata vigilia della guerra. E forse proprio qui sta la chiave per comprendere la recente riproposizione che Agamben ha fatto del saggio di Levi, pubblicato per la prima volta nel 1946 a ridosso del più celebre lavoro sull’esperienza del confino in Lucania.
 Edito da Neri Pozza e con un’introduzione dello stesso Agamben, Paura della libertà è un libro difficile, inattuale, vero e proprio “poema filosofico” come lo stesso autore lo descrive in un’intervista. Il saggio propone le basi ermeneutiche di un’opera come quella di Levi che non ha mai smesso di interrogarsi sul problema della partecipazione nel vivere associato, mettendo in discussione tutta la tradizione teorica che poggia sull’idea di stato come inderogabile dato di partenza. In Paura della libertà Levi accusa la rigidità assoluta di tale concetto, di cui segnala il ricorrente scivolamento verso quella che chiama l’“idolatria statale”, violentemente esposta nei regimi fascisti. Ma aggiunge che tale concezione ipostatizzata attraversa tutta la modernità e appesantisce come una tara ereditaria anche le ideologie che dell’uomo annunciano l’emancipazione. Levi vede nello stato odierno i segni di una nefasta divinizzazione del politico nonostante l’incipiente secolarizzazione, legge il ritorno del religioso come funzionale ad una repressione che lavora a scapito della sempre possibile autonomia dell’individuo. L’individuo pensato da Levi non è quello borghese o liberale, non è neppure il consumista del capitalismo avanzato. È come egli stesso scrive il “luogo di tutti i rapporti”: di infiniti rapporti.
Edito da Neri Pozza e con un’introduzione dello stesso Agamben, Paura della libertà è un libro difficile, inattuale, vero e proprio “poema filosofico” come lo stesso autore lo descrive in un’intervista. Il saggio propone le basi ermeneutiche di un’opera come quella di Levi che non ha mai smesso di interrogarsi sul problema della partecipazione nel vivere associato, mettendo in discussione tutta la tradizione teorica che poggia sull’idea di stato come inderogabile dato di partenza. In Paura della libertà Levi accusa la rigidità assoluta di tale concetto, di cui segnala il ricorrente scivolamento verso quella che chiama l’“idolatria statale”, violentemente esposta nei regimi fascisti. Ma aggiunge che tale concezione ipostatizzata attraversa tutta la modernità e appesantisce come una tara ereditaria anche le ideologie che dell’uomo annunciano l’emancipazione. Levi vede nello stato odierno i segni di una nefasta divinizzazione del politico nonostante l’incipiente secolarizzazione, legge il ritorno del religioso come funzionale ad una repressione che lavora a scapito della sempre possibile autonomia dell’individuo. L’individuo pensato da Levi non è quello borghese o liberale, non è neppure il consumista del capitalismo avanzato. È come egli stesso scrive il “luogo di tutti i rapporti”: di infiniti rapporti.
L’idolatria dello stato, la riduzione del politico a fideismo religioso non è solo presente nelle ataviche rappresentazioni sociali delle epoche che crediamo storiche. Queste concezioni sopravvivono in forme sempre diverse nella “contemporaneità dei tempi” che secondo Levi è il dato di partenza per comprendere la vita associata. Specialmente in Italia dove le proclamate rivoluzioni nazionali, a partire proprio dal fascismo, non hanno fatto che rafforzare l’idolatria dello stato. Uno stato in cui l’individuo non può far altro che trovare rifugio nel “credo” della massa indifferenziata, proprio dallo spavento dello straniero che deve perciò essere sempre espulso. Levi propone così un’interpretazione indelebile del fascismo in cui, come ha scritto in quegli stessi anni Georges Bataille, “l’autorità è stata ridotta a fondarsi su una pretesa rivoluzione, omaggio ipocrita e forzato alla sola autorità che si impone, quella del cambiamento catastrofico”.
Denunciando la riduzione a totem dello spavento che è comune all’uomo e al lupo, Levi non intende escludere quest’ultimo dalla comunità. Nessun “lupo mannaro” verrà da Levi considerato straniero, e dunque sacrificabile e “uccidibile”, come nel gergo filosofico di Agamben. Levi intende invece sottolineare il meccanismo religioso che è inerente alle nostre accettate concezioni della comunità politica. “Qual è il carattere di ogni religione?” si chiede nelle prime pagine del saggio: “mutare il sacro in sacrificale: togliergli il carattere di inesprimibilità, trasformandolo in fatti e in parole: far dei miti, riti”. Nelle concezioni totemiche Levi non avverte nemmeno una ramificata sublimazione del complesso di Edipo, come nel Freud di Totem e tabù, ma la spinta religiosa ad istituzionalizzare, e dunque deprimere, quello che chiama “il contatto dell’individuo con l’universale indifferenziato”, che è secondo lui sorgente inesausta del sacro: “al sacro indistinto la religione sostituisce un nome e una forma divina che ci impediscono di perderci in esso, ci vietano il suicidio e l’anarchia, ci consentono di vivere”.
Diviso in otto parti, dal tema del sacrificio e del padre al significato del sangue per la politica, Paura della libertà era stato concepito come introduzione a un’opera più vasta, a suo modo enciclopedica e mai portata a termine: una teoria della crisi contemporanea che oltre le consuete categorie economiche, politiche e estetiche, facesse dialogare la sociologia di Mauss e Durkheim con la filosofia della storia di Vico e l’interpretazione dei testi biblici fino a San Paolo. È il documento di una cruciale fase intellettuale, aggiungiamo noi, da accostare agli sviluppi del coevo Collège de sociologie specialmente nel versante di Roger Caillois e del suo L’uomo e il sacro, la cui prima edizione è uscita proprio nel 1939.
Tra etnologia, psicanalisi e lirico sguardo sull’abisso della storia Paura della libertà attenta alla supremazia dello stato nelle moderne considerazioni del vivere civile, senza sfociare tuttavia in un anarchismo di maniera. Lo attestano l’attivismo politico del suo autore a sostegno del Partito d’Azione, ma anche la continuità teorica del concetto di autonomia, elaborato insieme all’amico Leone Ginzburg già nel 1932 nei Quaderni di Giustizia e Libertà, e principio attivo in tutto il saggio del 1946 come alternativa allo sciogliersi dell’individuo nella massa indifferenziata dello stato totalitario.
Su questo aspetto è necessario chiedersi se sia possibile rileggere Paura della libertà, non ristampato in volume singolo dal 1964, al di là della testimonianza di un’epoca. Certamente, risponde senza indugi Agamben nella sua prefazione, e proprio per la sua attualità politica. Nelle sue considerazioni iniziali il filosofo riprende un discorso che ritiene colpevolmente interrotto dal pensiero progressista italiano: introduce il volume non solo esplicitando quello che chiama l’ignoranza o la malafede dei recensori negli anni del dopoguerra e oltre, ma premettendo come l’amico Calvino avesse già nel 1967 indicato la via per attraversare l’originalità di Levi.
 È da questo “libro raro nella nostra letteratura”, ha sostenuto Calvino, che sarebbe dovuto “cominciare ogni discorso su Levi”. Si tratta di un vero e proprio capovolgimento critico: l’autore che è stato ridotto, prima di tutto nelle scuole, alla testimonianza sofferta della questione meridionale, se non letto come decadente orientalista, si scopre anticipatore dei più recenti dibattiti sulla biopolitica. E proprio con questo libro si rivela uno scrittore di idee, capace di far convergere travaglio storico e speculativo davanti al collasso della civiltà europea, causato dalla violenza e dal parossismo statalista dei totalitarismi. Paura della libertà è dunque anche un manifesto politico, ed è proprio la sua rimozione nella cultura italiana a renderlo oggi più attuale.
È da questo “libro raro nella nostra letteratura”, ha sostenuto Calvino, che sarebbe dovuto “cominciare ogni discorso su Levi”. Si tratta di un vero e proprio capovolgimento critico: l’autore che è stato ridotto, prima di tutto nelle scuole, alla testimonianza sofferta della questione meridionale, se non letto come decadente orientalista, si scopre anticipatore dei più recenti dibattiti sulla biopolitica. E proprio con questo libro si rivela uno scrittore di idee, capace di far convergere travaglio storico e speculativo davanti al collasso della civiltà europea, causato dalla violenza e dal parossismo statalista dei totalitarismi. Paura della libertà è dunque anche un manifesto politico, ed è proprio la sua rimozione nella cultura italiana a renderlo oggi più attuale.
Questo forum è moderato a priori: il tuo contributo apparirà solo dopo essere stato approvato da un amministratore del sito.