Inviare un messaggio
In risposta a: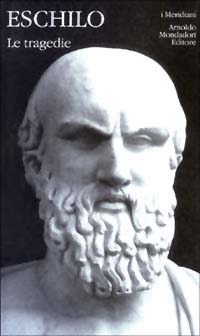
PER LA VERITÀ E LA RICONCILIAZIONE. RIMEDITARE LA LEZIONE DI ESCHILO. Dalla storia di Clitennestra, si arriva anche a immaginare una nuova giustizia, all’interno di nuovi rapporti sociali e politici. Una riflessione di Eva Cantarella - e una nota di Federico La Sala
"Duemila (...)
In risposta a:
>RIMEDITARE LA LEZIONE DI ESCHILO. Dalla storia di Clitennestra, si arriva anche a immaginare una nuova giustizia, all’interno di nuovi rapporti sociali e politici. - Il dono di Prometeo non basta all’uomo. La potenza è veleno se manca la giustizia (di Mario Vegetti)
L’inedito. Una riflessione di Mario Vegetti scomparso l’11 marzo sul mito greco che richiama il rapporto tra la scienza e la politica
Il dono di Prometeo non basta all’uomo. La potenza è veleno se manca la giustizia
di Mario Vegetti (Corriere della Sera, La Lettura, 18.03.2018)
Prometeo, figlio di Giapeto, eroe e semidio, discendeva dall’antica stirpe dei Titani. Verso di essa consumò il primo dei suoi molti tradimenti, dettati dal suo pensiero preveggente o tortuoso, come indica il nome (Prometeo, letteralmente, è colui che «comprende prima», pro-manthanei). Nella memorabile battaglia fra i Titani e i «nuovi dèi» guidati da Zeus, che grazie alla vittoria conquistarono il regno dell’Olimpo, Prometeo abbandonò i suoi fratelli e si schierò al fianco di Zeus. Ma l’alleanza con Zeus - verso la cui usurpazione nutre comunque rancore («nuovi signori governano l’Olimpo/ e con nuove leggi, al di fuori del Giusto, Zeus governa/ e annienta ora le potenze di un tempo», Eschilo, Prometeo incatenato, 149-51) - non è davvero il punto d’arrivo del disegno di Prometeo. Egli puntava piuttosto sulla nuova alleanza con l’ultimo arrivato sulla scena del mondo, il genere umano. Ma per questo occorreva compiere due passi. Il primo, spezzare l’amicizia fra uomini e dèi, e metterli in conflitto fra loro; il secondo, fornire agli uomini la potenza necessaria per sostenere il conflitto.
Il primo passo venne compiuto a Mekone. C’era allora commensalità fra uomini e dèi, che sedevano alla stessa tavola. Prometeo, maestro del banchetto, divise in due otri le parti di un grande bue. Nel primo, formato da una pelle nascosta nel ventre del bue, pose le parti migliori; nel secondo più attraente, di «bianco grasso», soltanto le ossa. Sfrontatamente, propose a Zeus la scelta fra i due otri dall’aspetto così ineguale. Che avesse fiutato o no l’inganno, Zeus finì per scegliere le ossa; abbandonò indignato il banchetto, e da allora finirono commensalità e amicizia fra uomini e dèi (Esiodo, Teogonia, 535-560).
Si trattava ora di fornire la potenza necessaria a far fronte alla loro solitudine. Prometeo non poteva che cominciare rubando a Zeus il fuoco, che egli nascondeva presso di sé, e donarlo agli uomini ai quali Zeus lo negava: il fuoco, padre della metallurgia e condizione per qualsiasi tecnica. Vedendo «fra gli uomini il bagliore lungisplendente del fuoco» ( Esiodo, Teogonia , 569), Zeus fu di nuovo preda dell’ira, e questa volta le sue punizioni non si fecero attendere.
Prometeo fu scortato fino al Caucaso dai due fedeli aiutanti di Zeus, Kratos e Bia, Forza e Violenza, e lì Efesto lo incatenò saldamente a una rupe: il suo supplizio consisteva in questo, che ogni giorno un’aquila gli rodeva il fegato, destinato ogni notte a ricrescere per fornire nuovo alimento al rapace. Quanto agli uomini, un beffardo Zeus ordinò a Efesto di forgiare una «bella e amabile figura di vergine», ad Atena di insegnarle l’arte della tessitura, ad Afrodite di effonderle «grazia intorno alla fronte e desiderio tremendo»; finalmente, una volta riccamente adornata da Atena, venne inviata presso gli uomini Pandora, madre di ogni male (Esiodo,Opere e giorni, 60-95): «Di lei infatti è la stirpe nefasta e la razza delle donne,/ che, sciagura grande per i mortali, fra gli uomini hanno dimora» (Esiodo, Teogonia, 591-2).
Ma lasciamo gli uomini intenti per ora a rallegrarsi per il bel dono di Zeus, e torniamo sulle vette del Caucaso. Qui il vecchio Titano incatenato non cessa di rievocare i suoi doni al genere umano, seguiti a quello basilare del fuoco. «Prima, avevano occhi e non vedevano, orecchie e non sentivano, ma come le immagini dei sogni vivevano confusamente una vita lunga, inconsapevole. Non sapevano costruire edifici, case all’aperto, non sapevano lavorare il legno: abitavano sottoterra, come brulicanti formiche, in caverne profonde, senza la luce del sole... Facevano tutto senza coscienza finché insegnai loro a distinguere il sorgere e il tramontare degli astri, e poi il numero, principio di ogni sapere, per loro inventai, e le lettere e la scrittura, memoria di tutto, madre feconda della poesia... Io e nessun altro inventai la nave, il cocchio marino dalle ali di lino... Se uno si ammalava non aveva alcun rimedio, né cibo, né unguento o pozione. Si consumavano così, senza farmaci, finché io non insegnai loro a miscelare medicamenti curativi per scacciare tutte le malattie». Prometeo insegna poi agli uomini l’arte della divinazione, e la scoperta dei metalli nascosti nelle viscere della terra (Eschilo, Prometeo incatenato, 447-506).
Nelle sue parole, nel suo modo di concepire il ruolo delle tecniche, il programma di Prometeo sembra così giunto a compimento: egli ha concesso agli uomini tutta la potenza necessaria a misurarsi con gli dèi. Padrone delle tecniche e dei grandi saperi del numero, della scrittura, degli astri: questa è dunque l’immagine dell’«uomo prometeico» visto con gli occhi del suo creatore.
Più inquietante è lo sguardo «umano», in qualche misura esterno, sullo stesso «uomo prometeico», quale ci viene proposto dal Coro della tragedia Antigone di Sofocle. Una sorta di sforzo di autoconsapevolezza, dunque: che cosa siamo diventati? (qui l’uomo appare ormai autodidatta, benché non sia lontana la lezione di Prometeo).
L’uomo si avverte come «terribile», anzi come la cosa più terribile (deinos: l’aggettivo vale però anche «abile», potente). Infatti è capace di attraversare il mare, di lavorare la terra, di catturare gli animali selvatici e di addomesticare quelli da lavoro. «Capisce, inventa, ha sulle arti dominio oltre l’attesa»: lo sguardo di Prometeo non si sarebbe spinto oltre questa temibile immagine dell’uomo tecnologico. Quello «umano» del coro sofocleo invece ne coglie una linea di frattura, segno di un’incertezza o un cedimento possibili. Aggiunge infatti: «Ora al bene, ora al male serpeggiando volge. Se del Paese le leggi applica e la giustizia degli dèi... in alto sarà nella patria» (Sofocle, Antigone, 331-371). Bene, male, leggi, giustizia: si profila qui una dimensione del tutto estranea all’uomo prometeico, che il vecchio Titano non aveva certamente attrezzato a fronteggiarla.
Una chiara traduzione in termini concettuali di tutto questo è nel cosiddetto «mito di Protagora», che il sofista racconta nel dialogo di Platone a lui intitolato, e che molto probabilmente si ispira a tesi dello stesso sofista. Lo scenario è un poco cambiato rispetto a quello che ci è familiare: Prometeo non è ancora sul Caucaso e resta amico degli uomini, verso i quali del resto lo stesso Zeus ora si dimostra benevolo. Non sono però cambiati i ruoli principali.
Si tratta di distribuire le dotazioni necessarie alla sopravvivenza fra i diversi animali. Lo sbadato Epimeteo, fratello di Prometeo, assegna a ogni animale mezzi di offesa e di difesa, dimenticando però l’uomo, che rimane così nuda vittima delle fiere. Prometeo decide allora di intervenire a difesa del genere umano, e lo fa come gli è consueto: «Ruba a Efesto e Atena la loro sapienza tecnica insieme col fuoco... e la dona all’uomo. In tal modo, l’uomo ebbe la sapienza tecnica necessaria per la vita, ma non ebbe la sapienza politica, perché questa si trovava presso Zeus». -Ma è qui che i doni di Prometeo rivelano tutta la loro insufficienza, che già era emersa in Sofocle - e la manifestano anche in termini di pura potenza. Per far fronte alle fiere, gli uomini cercano di riunirsi fondando città; «ma, allorché si raccoglievano insieme, si recavano ingiustizia a vicenda, perché non possedevano l’arte politica, sicché, disperdendosi, nuovamente perivano» (Platone, Protagora, 321d-322b).
Per evitare la strage, Zeus interviene ordinando a Ermes di distribuire a tutti gli uomini le doti del rispetto reciproco e della giustizia (aidos e dike), «principi ordinatori di città e vincoli produttori di amicizia» (Platone, Protagora, 322c).
L’uomo prometeico, forte solo del controllo delle tecniche, non può vivere in una comunità politica: per questo, occorrono inoltre la condivisione di un orizzonte di valori etico-politici, la giustizia, la legge, l’educazione collettiva. Propriamente parlando, non può neppure combattere, perché «l’arte della guerra è parte di quella politica» (Platone, Protagora, 522b), che egli non possiede, perché essa è inaccessibile a Prometeo. Si è spesso interpretato il mito di Protagora come risposta alle antropologie tecniciste dell’ homo oeconomicus alla maniera di Democrito, dalle quali sembrava risultare che la collaborazione fra le diverse competenze tecniche fosse in grado di formare e guidare la città. Senza dubbio, il mito si oppone inoltre alla pressione crescente di un ceto di technitai che si candidano a governare la città, tendendo a marginalizzare la dimensione politica e i suoi specialisti come i sofisti. Non c’è polis , invece, senza un sistema di norme di giustizia condivise, senza le istanze decisionali proprie della politica, infine senza un’educazione pubblica intesa a consolidare i vincoli comunitari.
Ma torniamo nel Caucaso, dal vecchio Titano, certo inconsapevole dei limiti etico-politici dei doni tecnologici che aveva elargito al genere umano: l’impotenza della forza senza politica, l’incapacità di integrare efficacia e moralità. La sua pena non sarebbe durata indefinitamente (a differenza di quella femminile comminata agli uomini). Prometeo era infatti depositario di un formidabile segreto, da cui dipendeva la sopravvivenza stessa del regno di Zeus - che si vide costretto a liberarlo, nel timore che il Titano lo rivelasse a orecchie ostili, e al contrario nella speranza di venirne a conoscenza.
Noi non possiamo conoscere il segreto di Prometeo, sul quale sono fiorite molte ipotesi. A me piacerebbe pensare che il vero, devastante, segreto di Prometeo fosse quello rivelato da Socrate - il Socrate di Aristofane, beninteso, non quello benpensante di Senofonte e di Platone - nella commedia Le nuvole:
- «Strepsiade: ma per voi, in nome della Terra, Zeus olimpio non è dio?
- Socrate: quale Zeus? Non dire sciocchezze. Zeus non esiste».
Certo, il «segreto» più efficace per por fine al potere di Zeus.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
Questo forum è moderato a priori: il tuo contributo apparirà solo dopo essere stato approvato da un amministratore del sito.