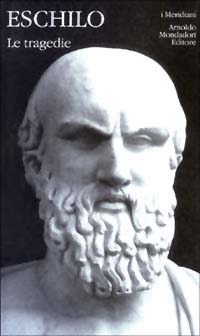
PER LA VERITÀ E LA RICONCILIAZIONE. RIMEDITARE LA LEZIONE DI ESCHILO. Dalla storia di Clitennestra, si arriva anche a immaginare una nuova giustizia, all’interno di nuovi rapporti sociali e politici. Una riflessione di Eva Cantarella - e una nota di Federico La Sala
lunedì 28 aprile 2008.
- [...] In Aristotele, insomma, troviamo una teoria delle differenza tra generi destinata a durare per secoli, che traduce la «differenza» in inferiorità: ecco perché la storia di Clitennestra è l’archetipo che consente meglio di ogni altro di interrogarsi sul rapporto uomo/donna. Nel mito in cui la sua storia è inserita la teorizzazione della inferiorità e subalternità femminile è parte integrante ed essenziale del processo che porta alla nascita del diritto e dello Stato [...]
- "Duemila anni fa, un ovulo fu miracolosamente fecondato dall’azione soprannaturale di Dio, da questa meravigliosa unione risultò uno zigote con un patrimonio cromosomico proprio. Però in quello zigote stava il Verbo di Dio"(dichiarazione del Cardinale Dario Castrillon Hoyos alla XV conferenza internazionale del Pontificio consiglio, La Repubblica del 17 novembre 2000, p. 35)
 Una nuova sintesi tra emozione e ragione. La lettura
Una nuova sintesi tra emozione e ragione. La lettura
 tradizionale dell’assoluzione del matricida Oreste e
tradizionale dell’assoluzione del matricida Oreste e
 l’esempio del Sudafrica
l’esempio del Sudafrica
 Il mito che cancella la giustizia maschile
Il mito che cancella la giustizia maschile
 Dalla tragedia classica di Clitennestra l’idea di
Dalla tragedia classica di Clitennestra l’idea di
 un diritto in grado di riconciliare uomini e donne
un diritto in grado di riconciliare uomini e donne
 di Eva Cantarella(Corriere della Sera, 28.04.08)
di Eva Cantarella(Corriere della Sera, 28.04.08)
Crudele, infida, violenta, adultera e assassina: il prototipo dell’infamia femminile. Questa era la fama di Clitennestra presso i greci, consolidata nei secoli dalla messa in scena, ad Atene, nel 458 a.C., dell’Orestea di Eschilo.
La storia è nota: nell’Agamennone,la prima tragedia della trilogia, Clitennestra, durante l’assenza del marito, diventa l’amante di Egisto, e quando Agamennone torna da Troia lo uccide, con la complicità dell’amante. Nella seconda, le Coefore, suo figlio Oreste ordisce, con la sorella Elettra, il piano per uccidere la madre ed Egisto. Nella terza, le Eumenidi, dopo aver realizzato il piano, Oreste è inseguito dalle mostruose Erinni, incitate dallo spettro di Clitennestra, assetato di vendetta. Per risolvere il caso, la dea Atena istituisce il primo tribunale della storia ateniese, l’Areopago, incaricato di giudicarlo: l’era della vendetta è finita per sempre, è nato il mondo del diritto.
Torniamo a Clitennestra: nelle riletture moderne, è molto diversa dall’immagine che i greci ci hanno tramandato. Per le femministe è una donna indomita, dignitosa, capace di opporsi all’infelicità cui le donne sono condannate in quella polis che un grande antichista ha definito «un club di uomini». E a partire dalla sua storia si pongono due domande: continua a esistere, oggi, la violenza di genere che arma la mano di Clitennestra? Quali sono i possibili obiettivi di una politica di riconversione del rapporto uomo/donna? Ma per capire perché Clitennestra diventa il personaggio attorno al quale si organizzano queste riflessioni è necessario andare oltre la sua morte, e seguire gli esiti del processo di Oreste.
La prima sentenza dell’Areopago, infatti, afferma un principio destinato a segnare per secoli il rapporto fra generi: Oreste viene assolto perché «non è la madre la generatrice di quello che è chiamato suo figlio; ella è la nutrice del germe in lei inseminato. Il generatore è colui che la feconda...». [EUMENIDI,657 SGG. ].
Inserita nel lungo dibattito greco sulla riproduzione, l’ipotesi del ruolo secondario della madre viene ribadita da Aristotele, al quale dobbiamo una teoria sulla riproduzione che codifica, su basi scientifiche, l’identificazione della donna con la materia e dell’uomo con lo spirito. Anche le donne, spiega Aristotele, hanno un ruolo nella riproduzione: accanto allo sperma, alla formazione dell’embrione concorre il sangue mestruale, ma con un ruolo diverso. Lo sperma è sangue, come quello mestruale, ma più elaborato. Il sangue altro non è che il cibo non espulso dall’organismo, trasformato dal calore: ma la donna, meno calda dell’uomo, non può compiere l’ultima trasformazione, che dà luogo allo sperma. Nella riproduzione, dunque, è il seme maschile che «cuoce» il residuo femminile, trasformandolo in un nuovo essere. Anche se indispensabile, pertanto, il contributo femminile è quello della materia, per sua natura passiva; l’apporto maschile invece è quello dello spirito, attivo e creativo.
In Aristotele, insomma, troviamo una teoria delle differenza tra generi destinata a durare per secoli, che traduce la «differenza» in inferiorità: ecco perché la storia di Clitennestra è l’archetipo che consente meglio di ogni altro di interrogarsi sul rapporto uomo/donna. Nel mito in cui la sua storia è inserita la teorizzazione della inferiorità e subalternità femminile è parte integrante ed essenziale del processo che porta alla nascita del diritto e dello Stato.
E veniamo così alle Clitennestre moderne. Le loro storie non sono meno drammatiche di quelle dell’archetipo. Penso a due esempi molto diversi fra loro, e lontani nel tempo: la Clitennestra di Dacia Maraini (I sogni di Clitennestra, Bompiani 1981) ha perso la forza di ribellarsi, e finisce in un manicomio: la follia, spiega l’autrice in un’intervista del 1984, è la conseguenza della impossibilità delle donne di adattarsi a un mondo che non è fatto per loro. La Clitennestra di Valeria Parrella (Il verdetto, Bompiani 2007) è vittima-complice di Agamennone, senza speranza alcuna di salvezza: versando il sangue del marito, dichiara, ha versato il suo stesso sangue. Danno molto a pensare, queste Clitennestre, e varrebbe la pena discuterne. Ma ragioni di spazio costringono a rinunziarvi per seguire il discorso sulle strategie di riconversione del rapporto.
Oltre alle riflessioni femministe (prevalentemente orientate verso ipotesi di tipo conciliatorio), è importante ricordare alcune recenti riflessioni sul diritto. Lo abbiamo già detto, nell’Orestea la nascita del diritto è legata alla sconfitta della parte femminile e dunque emotiva del mondo.
Ma recentemente l’idea che il diritto sia e debba essere solo ragione è stato messo in discussione anche da alcuni giuristi. Osserva ad esempio un esponente di spicco del movimento Law and literature, Paul Gewirtz, che indiscutibilmente, nell’Orestea, le forze della vendetta sono donne (Clitennestra, e le Erinni) mentre il diritto nascente è rappresentato da uomini (Apollo e i giudici, cui si aggiunge Atena, donna-uomo senza madre e senza marito).
Ma nella parte finale delle Eumenidi le Erinni, sconfitte, rinunziano al loro lato sanguinario e accettano di entrare nel sistema giudiziario, svolgendovi un ruolo: è la conciliazione dei generi sul piano del diritto. L’interpretazione secondo la quale l’assoluzione di Oreste segna la sconfitta della parte femminile del mondo è da rivedere. Il diritto non può essere solo ragione: per essere giusto, deve dare spazio alle emozioni.
Con le dovute differenze, questa visione del diritto fa pensare al ruolo assegnato alle emozioni dalla «restorative justice», la teoria di una giustizia «riparativa» emersa negli anni Novanta e teorizzata da politici, accademici, lavoratori sociali, gruppi religiosi e nuove figure professionali dette «mediatori di giustizia». Schematizzando all’estremo, per la giustizia riparativa la funzione del diritto è promuovere la riconciliazione tra chi ha commesso e chi ha subito un torto.
Per chiarire il concetto può essere utile ricordare che il caso più noto di giustizia riparativa è l’azione della Truth and Reconciliation Commission guidata da Desmond Tutu, incaricata di riportare l’ordine e la riconciliazione nello Stato Sudafricano. E uno degli aspetti fondamentali di questa giustizia è la considerazione data a temi quali le emozioni, negli ultimi anni sempre più al centro delle riflessioni da parte di tutti gli scienziati sociali.
Nel 2002, ad esempio, è stato dedicato a questi temi un numero speciale di Theoretical Criminology, ove si legge, tra l’altro, che «per avere un dibattito più razionale sulla giustizia, dobbiamo paradossalmente prestare più attenzione alla loro dimensione emozionale ». Infine, parlando di emozioni, è impossibile non ricordare le indagini a cavallo tra diritto e filosofia di Martha Nussbaum, cui si debbono libri celebri come L’intelligenza delle emozioni (Il Mulino): per comprendere la realtà e per comprendere se stessi, dice Nussbaum, non basta la ragione. Emozioni come l’amore, l’ansia, la vergogna, hanno un ruolo etico nella costruzione della vita sociale, e contribuiscono alla elaborazione di una concezione normativa nella quale le persone sono intese non come mezzi, ma come fini e come agenti.
Rileggendo la storia di Clitennestra, si arriva non solo a mettere in discussione l’opposizione donna-emozione /uomo-ragione. Si arriva anche a immaginare una nuova giustizia, all’interno di nuovi rapporti sociali e politici. Si può arrivare persino a sognare una cultura i cui valori possono cancellare per sempre la necessità della scure.
IN NOME DELL’EMBRIONE, UNA VECCHIA E DIABOLICA ALLEANZA.
Una nota di Federico La Sala *
- "Duemila anni fa, un ovulo fu miracolosamente fecondato dall’azione soprannaturale di Dio, da questa meravigliosa unione risultò uno zigote con un patrimonio cromosomico proprio. Però in quello zigote stava il Verbo di Dio"(dichiarazione del Cardinale Dario Castrillon Hoyos alla XV conferenza internazionale del Pontificio consiglio, La Repubblica del 17 novembre 2000, p. 35)
Avrei voluto con mio honore poter lasciar questo capitolo, accioche non diventassero le Donne più superbe di quel, che sono, sapendo, che elleno hanno anchora i testicoli, come gli uomini; e che non solo sopportano il travaglio di nutrire la creatura dentro suoi corpi, come si mantiene qual si voglia altro seme nella terra, ma che anche vi pongono la sua parte, e non manco fertile, che quella degli uomini, poi che non mancano loro le membra, nelle quali si fa; pure sforzato dall’historia medesima non ho potuto far altro. Dico adunque che le Donne non meno hanno testicoli, che gli huomini, benche non si veggiano per esser posti dentro del corpo [...]: così inizia il cap.15 del Libro III dell’Anatomia di Giovanni Valverde, stampata a Roma nel 1560, intitolato “De Testicoli della donna” (p. 91).
Dopo queste timide e tuttavia coraggiose ammissioni, ci vorranno altri secoli di ricerche e di lotte: “[...] fino al 1906, data in cui l’insegnamento adotta la tesi della fecondazione dell’ovulo con un solo spermatozoo e della collaborazione di entrambi i sessi alla riproduzione e la Facoltà di Parigi proclama questa verità ex cathedra, i medici si dividevano ancora in due partiti, quelli che credevano, come Claude Bernard, che solo la donna detenesse il principio della vita, proprio come i nostri avi delle società prepatriarcali (teoria ovista), e quelli che ritenevano [...] che l’uomo emettesse con l’eiaculazione un minuscolo omuncolo perfettamente formato che il ventre della donna accoglieva, nutriva e sviluppava come l’humus fa crescere il seme”(Françoise D’Eaubonne).
Dopo e nonostante questo - l’acquisizione che i soggetti sono due e che tutto avrebbe dovuto essere ripensato, si continua come prima e peggio di prima...
* Per proseguire nella lettura dell’intera nota, CLICCARE QUI
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- "VIOLENZA SULLE DONNE: PARLIAMO DI FEMMINICIDIO" - RAPPORTO OMBRA
 Per un ri-orientamento teologico-politico .... 25 Giugno: salviamo la Costituzione e la Repubblica che è in noi
Per un ri-orientamento teologico-politico .... 25 Giugno: salviamo la Costituzione e la Repubblica che è in noi
Federico La Sala
Forum
-
> PER LA VERITÀ E LA RICONCILIAZIONE. RIMEDITARE LA LEZIONE DI ESCHILO. --- L’IMMAGINARIO APOLLINEO E LA SOPRAVVIVENZA DELL’ ALGORITMO DELLA TRAGEDIA.28 giugno 2024, di Federico La Sala
A CHE #GIOCO GIOCHIAMO, IN #REALTÀ?! LA #QUESTIONEANTROPOLOGICA DEL #DIVANO DI #FREUD E IL PERMANERE DEL #COMPROMESSO "OLIMPICO" (PLATONICO E ARISTOTELICO) SUL PROBLEMA DEL "COME NASCONO I BAMBINI".
ANTROPOLOGIA E STORIA: #UNO (#ONU). Alla luce dell’eredità tragica di #Edipo (#Sofocle) e #Amleto (#Shakespeare), sulla questione antropologica (e cristologica) la cultura europea (e planetaria) ancora non è riuscita a fare chiarezza sulla dimensione "nexologica" (da "#nexus") e confonde ancora "nexuno", con "#nessuno", e non comprende nemmeno un semplice "nesso"!
PSICOANALISI ("L’INTERPRETAZIONE DEI SOGNI", 1899): "IL DIALOGO PSICOANALITICO" (Jean-Jacques #Abrahams, "Les Temps Modernes", 1969). A partire dal caso dell’«uomo dei topi» (Freud, 1909) e dell’«uomo con il magnetofono, dramma in un atto con grida d’aiuto di uno psicoanalista» (Jean-Jacques Abrahams, 1977), il problema è ancora sul divano di #SigmundFreud (non di #Lacan), e l’#enigma del "come nascono i bambini" non è stato ancora risolto... A gloria eterna della sollecitazione di "Sigismondo di Vindobona" e di Franca Ongaro Basaglia (cfr. "Così parlò Edipo a #Cuernavaca", "pM - Panorama mese", novembre 1982), che fare? Continuare i giochi "olimpici" di enigmistica nello spirito di Edipo e di cruciverba nello spirito di Amleto?
STORIA, STORIOGRAFIA E "DIVINA COMMEDIA" (#DANTE2021): L’IMMAGINARIO APOLLINEO E LA SOPRAVVIVENZA DELL’ #ALGORITMO DELLA TRAGEDIA. Se è vero, come è vero, che per la religione greca «non è la madre la generatrice di quello che è chiamato suo figlio; ella è la nutrice del germe in lei inseminato. Il generatore è colui che la feconda» (#Eschilo, "Eumenidi"), è anche vero che dopo la nascita di Cristo e dopo la diffusione del Cristianesimo, come ha scritto Franca Ongaro Basaglia (1978), continua ad essere "possibile un’operazione #matematica ritenuta abitualmente sbagliata: un uomo più una donna ha prodotto, per secoli, un uomo".
NOTE:
- "LA PAROLA CONTAMINATA" E LA "CRITICA DELLA RAGION PURA": CON KANT, FREUD, E FACHINELLI, UN OMAGGIO ALL’ UOMO COL MAGNETOFONO (J.-J. ABRAHAMS), UNA GENIALE E HAMLETICA "TRAPPOLA PER TOPI".
- MEMORIA, STORIA, E FILOLOGIA: DIVANO.
- "DIVANO DI LACAN ALL’ ASTA A PARIGI" ("La Repubblica", 06 Ottobre 1991):
- "[...] Clou della vendita il divano per analisi più illustre di Parigi: un semplice lettino, stile salotto borghese anni cinquanta. Partita dal prezzo base di poco più di 4 mila lire, l’ asta è salita subito vertiginosamente, fino a raggiungere i 20 milioni di lire. E’ a questo prezzo che un anziano signore, subito eclissatosi discretamente, senza farsi riconoscere, si è portato a casa quella specie di feticcio [...]"(cit.).
- IL CADUCEO* DI ERMES (MERCURIO) E LE "COSTRUZIONI NELL’ANALISI": COME #FREUD, CHE VOLEVA SAPERE DELLE ANGUILLE, DIVENNE TIRESIA. "Si racconta che il pastore Tiresia, figlio di Evere, sul monte Cilene percosse col bastone oppure calpestò due serpenti che si congiungevano e per questo fu trasformato in donna. Poi, consigliato da un oracolo, calpestò altri due serpenti nello stesso luogo e riprese l’aspetto antico. In quel tempo, Giove e Giunone stavano discutendo scherzosamente se durante l’amplesso il piacere più grande toccasse all’uomo o alla donna. Essi presero Tiresia come arbitro della disputa, dato che conosceva entrambe le situazioni; poiché egli aveva dato ragione a Giove, Giunone, adirata, lo toccò col dorso della mano e lo rese cieco. Ma Giove in cambio lo fece vivere per sette generazioni e ne fece l’indovino migliore fra tutti gli uomini." (Cfr. Igino, "Miti", a c. di G. Guidorizzi, Adelphi, 2022, p. 57).
- * CADUCEO.
-
> PER LA VERITA’ E LA RICONCILIAZIONE. RIMEDITARE LA LEZIONE DI ESCHILO. Dalla storia di Clitennestra, si arriva anche a immaginare una nuova giustizia, all’interno di nuovi rapporti sociali e politici. --- "Tragedia", "Divina Commedia", e "Dotta ignoranza".24 maggio 2021, di Federico La Sala
#DIVINACOMMEDIA E
#NiccoloCusano,
per indicare la #via alla "#Visione di Dio" (1454), si serve di
un quadro dell’artista Rogier Van der Wayden,
allievo di Robert #Campin,
autore del #TritticodiMerode
***
Con #Virgilio e #Beatrice (#dueSoli),
#NiccoloCusano,
(«Non è la madre che genera chi è chiamato figlio, ma solo nutrice è del seme gettato in lei»)
non esce dall’orbita
della #tragedia (#Eschilo).
-
> PER LA VERITA’ E LA RICONCILIAZIONE. RIMEDITARE LA LEZIONE DI ESCHILO --- LA FINE DELLA "GRANDE INSTAURAZIONE" PLATONICO-ARISTOTELICA E LA POCA SAGGEZZA DELLA FILOSOFIA E1 aprile 2021, di Federico La Sala
LA POCA SAGGEZZA DELLA FILOSOFIA, I “VENTICINQUE SECOLI” DI LETARGO DI DANTE E LA PRESENTE STORICA CRISI DELLA CULTURA EUROPEA...
- Nota a margine dell’art. di Sergio Benvenuto, “La poca saggezza della filosofia”, "Le parole e le cose", 15 marzo 2021.
CONSIDERATO CHE UN FILOSOFO, “Anche quando sbaglia di grosso, se è un vero filosofo sbaglia con argomenti non banali, fino al punto che, grazie a lui, l’errore brilla della luce convincente della verità” (cf. S. Benvenuto, cit. - su), E VISTO CHE EGLI HA MESSO IL DITO NELLA PIEGA (e nella piaga) della storia della filosofia, nel gioco sofistico di Socrate: «Malgrado lo slogan “so di non sapere”, tutti ci rendiamo conto che Socrate in realtà sapeva tante cose. Ma il suo sapere squisitamente filosofico era proprio quello di non sapere, ovvero, il suo appello all’epistheme come “ricominciare tutto daccapo”» (op. cit. - su), VISTO IL PERSISTERE E , AL CONTEMPO, L’ESAURIRSI DELLA “GRANDE INSTAURAZIONE” ANTROPOLOGICA ED EPISTEMOLOLOGICA apollinea-socratica (su questo, si cfr. la grande analisi di Nietzsche!), forse, è bene e salutare riprendere alla radice (Marx!) la questione e, riaccogliendo l’indicazione di Sofocle, ripensare le «perversioni» di tremila e più anni (come sapeva Dante, meglio di Goethe), rileggere il cap. 15 del manuale di “Anatomia” (Roma, 1560) di Giovani Valverde, e ripensare l’«edipo completo», come voleva Freud e Fachinelli. Altro che continuare a menare la canna per l’aria. O no?!
Sul tema,nel sito, si cfr.:
Antropologia, Storia e Diritto. Donne e Uomini.... PER LA VERITA’ E LA RICONCILIAZIONE. RIMEDITARE LA LEZIONE DI ESCHILO. Dalla storia di Clitennestra, si arriva anche a immaginare una nuova giustizia, all’interno di nuovi rapporti sociali e politici
FLS
-
> LA FINE DELLA "GRANDE INSTAURAZIONE" --- "Gli inganni di Pandora. L’origine delle discriminazioni di genere nella Grecia antica"(Eva Cantarella). Nutrici di germi inseminati (di V. Pazé).2 aprile 2021, di Federico La Sala
Nutrici di germi inseminati
di Valentina Pazé (L’Indice, 2 Aprile 2020)
- Eva Cantarella, Gli inganni di Pandora. L’origine delle discriminazioni di genere nella Grecia antica pp. 85, € 12, Feltrinelli, Milano 2019
In questo breve saggio Eva Cantarella torna su uno dei suoi cavalli di battaglia: il tema della condizione della donna nell’antica Grecia, e in particolare nella società ateniese. Lo fa a partire dalla rivisitazione del mito esiodeo della “prima donna”, Pandora, che è stato spesso accostato a quello biblico della creazione di Eva, ma che esprime - in effetti - un tasso di misoginia ben maggiore di quello rinvenibile nel testo fondativo della tradizione ebraico-cristiana. Mentre Eva, nata da una costola di Adamo, viene creata per fargli compagnia, sia pure in una posizione subordinata, Pandora, frutto di un impasto di acqua e terra che nulla ha di umano, fa la sua comparsa per punire l’umanità dopo il furto del fuoco da parte di Prometeo. Dotata di aspetto piacevole, “mente sfrontata” e “cuore pieno di menzogne”, è destinata a soggiogare gli uomini col suo fascino e a renderli irrimediabilmente infelici.
 Le variazioni sul tema della donna “genere maledetto”, o comunque genere “a parte”, radicalmente altro rispetto a quello maschile, sono molteplici nella letteratura greca: da Semonide di Amorgo, con il suo bestiario di donne-scrofa, volpe, gatta, scimmia, ape - una più funesta dell’altra -, alle successive, più meditate, riflessioni di medici e filosofi, a confronto con una differenza immancabilmente interpretata in termini di manchevolezza e inferiorità.
Le variazioni sul tema della donna “genere maledetto”, o comunque genere “a parte”, radicalmente altro rispetto a quello maschile, sono molteplici nella letteratura greca: da Semonide di Amorgo, con il suo bestiario di donne-scrofa, volpe, gatta, scimmia, ape - una più funesta dell’altra -, alle successive, più meditate, riflessioni di medici e filosofi, a confronto con una differenza immancabilmente interpretata in termini di manchevolezza e inferiorità.
 Sullo sfondo - osserva Cantarella - non è difficile intravedere una “grande paura” e una “grande invidia” maschile, derivanti entrambe dall’“indiscutibile constatazione che i figli nascevano dal corpo delle donne”. È, ancora, soprattutto il mito a rivelare questi sentimenti inconfessabili: Zeus che ingoia l’amante Metis insieme alla figlia che porta in grembo, Atena, che sarà poi “partorita” dalla sua testa; Zeus che - dopo avere folgorato Semele, incinta - raccoglie il feto tra le ceneri e lo inserisce in una delle proprie cosce, da cui nascerà Dioniso. Casi di “paternità surrogata” ante litteram - commenta Cantarella - in cui una figura maschile riesce con successo ad espropriare le donne del loro potere di procreare.
Sullo sfondo - osserva Cantarella - non è difficile intravedere una “grande paura” e una “grande invidia” maschile, derivanti entrambe dall’“indiscutibile constatazione che i figli nascevano dal corpo delle donne”. È, ancora, soprattutto il mito a rivelare questi sentimenti inconfessabili: Zeus che ingoia l’amante Metis insieme alla figlia che porta in grembo, Atena, che sarà poi “partorita” dalla sua testa; Zeus che - dopo avere folgorato Semele, incinta - raccoglie il feto tra le ceneri e lo inserisce in una delle proprie cosce, da cui nascerà Dioniso. Casi di “paternità surrogata” ante litteram - commenta Cantarella - in cui una figura maschile riesce con successo ad espropriare le donne del loro potere di procreare.Quanto viene vagheggiato nel mito continua, nell’età classica, a far discutere gli intellettuali, che si interrogano sul ruolo svolto dalle donne nel processo generativo. Giungendo, in alcuni casi, a conclusioni paradossali (che suscitano qualche brivido in chi segue il dibattito odierno sulla maternità surrogata), come quella di chi riconosce alla donna esclusivamente la funzione di “contenitore” del seme maschile.
 Questa era l’opinione degli stoici, ma era probabilmente anche espressione di un sentire comune, se nelle Eumenidi di Eschilo l’areopago assolve il matricida Oreste con questa motivazione:
“Non è la madre la generatrice di quello che è chiamato suo figlio”, “ella è nutrice del germe in lei inseminato. Il generatore è colui che feconda”.
Questa era l’opinione degli stoici, ma era probabilmente anche espressione di un sentire comune, se nelle Eumenidi di Eschilo l’areopago assolve il matricida Oreste con questa motivazione:
“Non è la madre la generatrice di quello che è chiamato suo figlio”, “ella è nutrice del germe in lei inseminato. Il generatore è colui che feconda”.
 Una tesi che Aristotele riformulerà, precisando che la donna fornisce pur sempre la materia indispensabile alla procreazione (identificata con il sangue mestruale), ma che è il maschio a trasmettere la forma, come l’artigiano che plasma la cera. Cantarella non approfondisce qui le molteplici difficoltà che una simile teoria solleva, agli occhi dello stesso Aristotele: se è il padre, e solo il padre, ad imprimere la sua impronta sul nascituro, come si spiegano i casi in cui i figli assomigliano alla madre? E come si giustifica la nascita di figlie femmine? (Su questi temi è ancora fondamentale il volume curato da Silvia Campese, Paola Manuli e Giulia Sissa, Madre materia. Sociologia e biologia della donna greca, Boringhieri, 1983). Cantarella si sofferma invece sul contributo dei medici, alle prese con le “strane malattie” delle donne, alla conoscenza del corpo femminile, molto meno accessibile di quello dei maschi, i cui corpi squartati in battaglia offrivano per lo meno qualche occasione di osservazione. Ed ecco allora “uteri vaganti” e “vergini folli”, che i medici della scuola ippocratica suggeriscono di curare principalmente attraverso il matrimonio e la gravidanza.
Una tesi che Aristotele riformulerà, precisando che la donna fornisce pur sempre la materia indispensabile alla procreazione (identificata con il sangue mestruale), ma che è il maschio a trasmettere la forma, come l’artigiano che plasma la cera. Cantarella non approfondisce qui le molteplici difficoltà che una simile teoria solleva, agli occhi dello stesso Aristotele: se è il padre, e solo il padre, ad imprimere la sua impronta sul nascituro, come si spiegano i casi in cui i figli assomigliano alla madre? E come si giustifica la nascita di figlie femmine? (Su questi temi è ancora fondamentale il volume curato da Silvia Campese, Paola Manuli e Giulia Sissa, Madre materia. Sociologia e biologia della donna greca, Boringhieri, 1983). Cantarella si sofferma invece sul contributo dei medici, alle prese con le “strane malattie” delle donne, alla conoscenza del corpo femminile, molto meno accessibile di quello dei maschi, i cui corpi squartati in battaglia offrivano per lo meno qualche occasione di osservazione. Ed ecco allora “uteri vaganti” e “vergini folli”, che i medici della scuola ippocratica suggeriscono di curare principalmente attraverso il matrimonio e la gravidanza.Le ben note discriminazioni giuridiche e politiche nei confronti delle donne, di cui l’autrice si era già occupata in L’ambiguo malanno (Feltrinelli, 2013) e in altre pubblicazioni successive, vengono di conseguenza. Nel concludere il volume, Cantarella insiste soprattutto sull’esclusione di bambine e ragazze da ogni forma di educazione: la discriminazione forse più grave, perché apre la strada a tutte le altre. E non si può qui non ricordare come questa preoccupazione fosse al centro di un classico del pensiero femminista, come A vindication of the rights of women di Mary Wollstonecraft.
 A proposito di femminismo, l’autrice non risparmia qualche frecciatina - che sarebbe stato bello fosse maggiormente sviluppata - nei confronti di letture ingenue di “Platone femminista” e Bachofen “paladino del matriarcato”. Oltre che di concezioni essenzialistiche della differenza di genere, che proprio dalla cultura greca hanno avuto origine.
A proposito di femminismo, l’autrice non risparmia qualche frecciatina - che sarebbe stato bello fosse maggiormente sviluppata - nei confronti di letture ingenue di “Platone femminista” e Bachofen “paladino del matriarcato”. Oltre che di concezioni essenzialistiche della differenza di genere, che proprio dalla cultura greca hanno avuto origine.-
> LA FINE DELLA "GRANDE INSTAURAZIONE" --- Ddl Zan calendarizzato. «Il testo punta al superamento del sesso biologico» (di Antnella Mariani).29 aprile 2021, di Federico La Sala
LA COSTITUZIONE E L’ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE (E DEL "FIGLIO").*
- COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Articolo 3:
- Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
- E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
- Ddl Zan. Intervista alla ginecologa e docente universitaria Sandra Morano: Che pericolo intravede nella legge, così com’è formulata? «Intravedo alcune derive inquietanti. La cancellazione della maternità, ad esempio, che per me è il tema centrale dell’identità femminile, quello che ancora è esclusiva delle donne. Ebbene, se il sesso diventa una percezione fluida di sé, ciascuno può giocare su più campi, un uomo può dirsi donna e reclamare il diritto a un figlio. Anche attraverso la gestazione per altri» (cfr. Antonella Mariani, Ddl Zan calendarizzato. «Il testo punta al superamento del sesso biologico», Avvenire, 28.04.2021).
Omofobia.
Ddl Zan calendarizzato. «Il testo punta al superamento del sesso biologico»
Le critiche della ginecologa e femminista genovese Sandra Morano, firmataria dell’Appello dei 400: il rischio è di far sparire l’identità femminile e con essa la sua forza distintiva, la maternità
di Antonella Mariani (Avvenire, mercoledì 28 aprile 2021)
- La ginecologa genovese e docente universitaria Sandra Morano - (Su concessione dell’interessata)
- Si sblocca il disegno di legge contro l’omotransfobia al Senato: è stato incardinato nella commissione Giustizia dopo settimane di polemiche, rimpalli pressing e resistenze. Messa ai voti la calendarizzazione, è passata con 13 sì e 11 no. A chiedere da tempo l’avvio della discussione sono Pd, M5s, Leu e Italia viva. Contrario il centrodestra. Il provvedimento è stato approvato in prima lettura alla Camera il 4 novembre 2020. Soddisfatto Alessandro Zan, autore del Ddl: "Finalmente ora può iniziare la discussione anche in questo ramo del Parlamento, per l’approvazione definitiva". Il provvedimento verrà incardinato entro il mese di maggio e il relatore sarà il presidente della commissione Andrea Ostellari, della Lega. Proprio oggi sui contenuti del ddl e sulle sue criticità è intervenuta anche la Conferenza episcopale italiana con una nota.
Il Ddl Zan punta al superamento del sesso biologico, per abbracciare altre definizioni fluide e variabili, come ’genere’, ’identità di genere’, ’percezione di sé’, che con la Costituzione e con la certezza del diritto hanno poco a che vedere e che rischiano di assottigliare fino a far scomparire il confine tra i sessi. Prima ancora che da ginecologa, parla da ’femminista della differenza’ Sandra Morano, esponente di spicco del progressismo genovese e docente universitaria. Il ddl Zan, al di là delle buone intenzioni di combattere l’omofobia e la transfobia, introduce definizioni non univoche per ’classificare’ le categorie meritevoli di tutela, entrando a gamba tesa in un dibattito scientifico, giuridico e bioetico in pieno svolgimento.
Per semplificare: se il titolo del Ddl Zan è: ’Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità’, e poi si definiscono queste categorie in modo che non è affatto condiviso, il risultato è... confusione, proprio ciò che una legge non deve fare.
Sandra Morano ha firmato l’appello per la modifica del testo della legge, insieme ad altri 400 rappresentanti della società civile. La sua esperienza professionale nel SSN è stata spesa prevalentemente nel miglioramento delle condizioni della maternità e della nascita, temi che non hanno mai avuto un posto preminente nelle agende della politica. Da questo osservatorio è difficile accettare un cambiamento delle definizioni per tutta la popolazione.
«Sarebbe come accettare di ’far sparire’ le donne e la loro incontrovertibile capacità procreativa, la maternità», dice. «Capita a noi mediche e medici di accompagnare la sofferenza di soggetti che non si riconoscono nel proprio sesso biologico. Comprendiamo il rifiuto di alcuni di essere rigidamente definiti o ri-definiti, anche se più spesso capita che molti desiderino chiarire e manifestare attraverso dolorosi percorsi la transizione verso una più soddisfacente identità sessuale. Questa libertà non può però limitare la libertà di tutti, donne e uomini, ad accettare un cambiamento lessicale che per via legale sancisce l’abbandono del concetto di sesso a favore della identità di genere con le sue varianti».
Un cambiamento che non può non innescare effetti a catena nel mondo medico, e non solo. «Pensiamo alle conseguenze che tale definizione può avere sulla Medicina di genere, cioè lo studio del diverso impatto delle malattie e dei farmaci sul femminile e sul maschile, che in questi anni sta facendo passi da giganti».
Tutto cancellato dal ddl Zan? «Questa è una delle derive di questo testo, e io invito i miei colleghi a prendere posizione. Da una legge confusiva possono derivare cambiamenti nel lessico, che non possono non coinvolgere perfino i manuali e gli insegnamenti della medicina». In che direzione vorrebbe fosse modificato il testo del ddl Zan? «Preferirei che si parlasse di prevenzione e contrasto alle discriminazione di genere e della violenza per ’motivi fondati sul sesso’. Sarebbe sufficiente e molto più utile a tutti», risponde Morano. Che pericolo intravede nella legge, così com’è formulata? «Intravedo alcune derive inquietanti. La cancellazione della maternità, ad esempio, che per me è il tema centrale dell’identità femminile, quello che ancora è esclusiva delle donne. Ebbene, se il sesso diventa una percezione fluida di sé, ciascuno può giocare su più campi, un uomo può dirsi donna e reclamare il diritto a un figlio. Anche attraverso la gestazione per altri».
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- Il Trittico di Mérode (Robert Campin, 1427).
EUROPA: EDUCAZIONE SESSUALE ED EDUCAZIONE CIVICA. ITALIA "NON CLASSIFICATA"!!! ---UNA NOTA DEL 20O5 DEL PROF. LUIGI CANCRINI SU UN TESTO DI "ANATOMIA" DEL 1560!
LA COMPETENZA ANTROPOLOGICA E TEOLOGICA DEL VATICANO E’ "PREISTORICA" E "MAMMONICA". Il "romanzo familiare" edipico della chiesa e della cultura cattolico-romana è finito
USCIAMO DAL SILENZIO: UN APPELLO DEGLI UOMINI, CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE. Basta - con la connivenza all’ordine simbolico della madre!!!
DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"!
FLS
-
> PER LA VERITA’ E LA RICONCILIAZIONE. RIMEDITARE LA LEZIONE DI ESCHILO. --- Una nuova edizione di “Lisistrata”: Aristofane, la satira declinata al femminile (di Rosita Copioli).2 febbraio 2021, di Federico La Sala
Classici.
Aristofane, la satira declinata al femminile
Una nuova edizione di “Lisistrata” curata da Perusino e tradotta da Beta è l’occasione per evidenziare come il grande autore greco metta in scena le donne con credibile efficacia
di Rosita Copioli (Avvenire, sabato 30 gennaio 2021)
- [Foto] La “Lisistrata” di Aristofane andata in scena al Festival internazionale del teatro classico di Merida a Caceres, in Spagna, nel 2016 - Lapresse / Efe /Jero Morales
Non c’è un’opera di Aristofane che non sia intrisa di una profonda passione civile e politica, nel senso più autentico dei termini. Perfino le più aeree, a fantasia sfrenata, le più surreali e metafisiche e mitiche, come le Nuvole o Gli uccelli, sono le satire più sorprendenti che siano state inventate nel gioco del paradosso: una reazione a catena che non finisce mai, di fronte all’assurdità, alla stupidità, all’egoismo, al sopruso dei singoli, delle città, di quella Atene che in perenne lotta contro Sparta sta vorticosamente precipitando verso l’auto-annientamento con la guerra del Peloponneso: dissidi interminabili, rotazioni di regimi demagogici e oligarchici, altro che democrazia, sanguinose battaglie, perdite di libertà, pur essendo scampati dall’invasore persiano grazie all’eroico sforzo comune, ma pronti a finire in bocca ai macedoni.
Quello di Aristofane è un mondo plurale, un brulichio di voci, di caratteri, a specchio della società contemporanea, che più sono parossisticamente aderenti alla realtà, più viaggiano verso l’universale. Aristofane, un genio del realismo fantastico, che usa la parodia con l’esuberanza e la disinvoltura di chi sa muoversi tra cielo e terra, tra l’infimo e l’altissimo, con la pesantezza e la leggerezza che solo il teatro di Shakespeare potrà avere. Lo guidava il senso dell’unità, del principio, dell’ordine, del piacere e della bellezza, tutti nascosti, proprio segreti, nello straripante mondo che raffigurava portando sempre all’estremo ogni tensione, ogni plurale possibilità.
Le tre commedie di Aristofane che hanno protagoniste le donne, scritte dal 411 al 391, sono al plurale. Contemporanea alle Tesmoforie (411) e pur avendo una protagonista guida, anche Lisistrata mette in scena un intero genere ( Valla Mondadori, ottima cura di Franca Perusino, efficace traduzione di Simone Beta: pagine 350, euro 50). Se dagli Acarnesi e dalla Pace Aristofane percorre tutte le strade per illustrare l’insensatezza comune che lo farà volare attraverso le Nuvole, e con gli Uccelli per descrivere i sofismi che sgretolano il buon senso e per colpire perfino Socrate; se si innalza in utopie e ribellioni e fughe del mondo fino a Nubicuculia, come il miglior antenato di Swift - mentre scenderà fin nell’Ade con Dioniso per riportare la poesia dell’odiosamato Euripide e di Eschilo sulla terra rovinata - con la trilogia al femminile Aristofane compie un viaggio altrettanto u- topistico e impercorribile: quello delle Amazzoni, o del governo femminile, in una escalation inarrivabile sotto tutti gli aspetti della immaginazione reale, fisica e prorompente, con le ali di quel dio Riso al quale credette Apuleio, e che Fellini onorò sempre, rinominandolo apposta nel Satyricon.
Nelle Tesmoforie il bersaglio femminile è un Euripide che ne mostrerebbe troppi difetti, ma poi se ne esce con la sua Elena in palinodia, e il gioco aggressivo finisce con un ritorno a casa, nell’ordine primitivo. Lisistrata bersaglia la dissennata litigiosità dei maschi guerrafondai, che più sono sobri e razionali, più trovano pretesti e cavilli di guerra, mentre la grande, saggia ebbrezza dionisiaca, di cui le donne sembrano le segrete protettrici, con il loro piacere inebriante, porta una sapienza superiore, la conciliazione e quella pace ’irragionevole’, che è l’unica via per la salvezza.
Perciò usano a ricatto l’estremo rimedio, quello dell’astensione dal sesso - e, se costrette, dal piacere - chiamando tutto il genere femminile delle città nemiche, Atene e Sparta, a giurare il patto di astinenza che dispiace a loro stesse, ma costringerà gli uomini a cessare la loro bellicosità, in nome del theleian kyprin, il piacere femminile, l’estasi dei riti della notte, sacri ad Afrodite. Come nelle Tesmoforie, la volgarità e l’oscenità si sfrena: cori di vecchi che portano il fuoco contro cori di vecchie che minacciano d’inondarli d’acqua per impedirgli di riprendere l’Acropoli di cui si sono impossessate con il tesoro che serve alla guerra, tra gli insulti e le scene più volgari, i quadri esilaranti della frustrazione del desiderio sceneggiati dalla coppia di Cinesia e Mirrina, e l’incontro degli ambasciatori resi impotenti dallo stesso urgere del loro classico strumento di potenza, il fallo. Lisistrata vincerà, anche sulle sue stesse amiche che non reggono la prova e tentano di defezionare con pretesti ridicoli; fiera di essere nominata con il proprio nome, per la virtù di un amore di patria superiore, con la splendida educazione che lei e le compagne hanno ricevuto. È riuscita a evitare la guerra. Ritorna all’ordine che accetta.
Come scrive Franca Perusino, « Lisistrata è una commedia al femminile, non una commedia femminista». Pochi anni dopo, nel 391, in quell’Atene decaduta e turpe, che le ombre di Eschilo e Sofocle, di Socrate e Platone hanno disertato, Le donne all’assemblea si spingeranno oltre. Le donne mascherate da uomini conquistano la maggioranza e impongono il comunismo, economico ed erotico. I giovani, prima di accoppiarsi con le coetanee, devono soddisfare le vecchie. È il trionfo della parodia più travolgente, che non risparmia nulla, nemmeno l’oscenità, le idee, il senso del mondo, lo stesso autore.
Certo, Aristofane non può accarezzare un pensiero femminista. Ma pur seguendo la molteplicità e la mutevolezza delle Nuvole, lo concepisce: non possiamo non vedere che queste commedie al femminile sono quanto di più ardito sia stato immaginato nei secoli. Di recente, l’ornitologo Richard O. Prum nell’Evoluzione della bellezza (Adelphi) cita l’esempio di Lisistrata per sostenere che l’evoluzione estetica, non quella adattativa, conta di più, ed è stata messa in atto dal genere femminile, anche per fare smorzare al partner maschile l’aggressività.
La scelta estetica non è tanto quella visiva, quanto quella legata alla sinestesia del piacere. Come sostiene Lisistrata, se le donne dovessero subire l’atto sessuale e non partecipassero col loro stesso piacere, gli uomini se ne stancherebbero presto. La reciprocità dell’eros, sostenuta in concordia da Lisistrata e dall’etologo Prum sembra ovvia e naturale, ma, chissà perché, nei secoli non tutti l’hanno pensata così. Anzi! L’aveva pensato il meraviglioso Aristofane, l’unico a cui Platone nel Simposio fa spiegare l’eros col mito degli esseri sferici primordiali, tragicamente segati in due da Zeus per la loro superbia, le cui metà non finiscono di attrarsi da allora, in conflitto.
-
> PER LA VERITA’ E LA RICONCILIAZIONE. RIMEDITARE LA LEZIONE DI ESCHILO - E DI SOFOCLE. -- Diritto & mito. Edipo e l’equilibrio di poteri (di Mauro Campus).21 maggio 2018, di Federico La Sala
Diritto & mito
Edipo e l’equilibrio di poteri
di Mauro Campus (Il Sole-24 Ore, Domenica, 20.05.2018)
- Marta Cartabia, Luciano Violante, Giustizia e mito. Con Edipo, Antigone e Creonte , il Mulino, Bologna, pagg. 174, € 13
Interrogare i classici per meglio interpretare la contemporaneità è uno degli esercizi cui ogni società matura dovrebbe rivolgersi costantemente. Il nostro rapporto con le radici del pensiero moderno dovrebbe essere automatico perché esse riflettono le caratteristiche delle comunità che nei secoli si sono fondate guardandole. Per i popoli che si sono culturalmente legittimati sul repertorio mitografico fluito dalle esperienze che i classici riassumono e riordinano, tale esercizio è saldato a basilari caratteri identitari. Da questa consapevolezza nasce l’esigenza di due giuristi come Marta Cartabia e Luciano Violante di misurarsi con Edipo, Antigone e Creonte. Com’è intuibile, l’analisi proposta, pur accarezzando a tratti l’approccio filologico, non ha alcuna pretesa di spiegare nuovamente l’enorme messe di riferimenti all’ordine sociale che i miti sintetizzano, si propone piuttosto di indagare le intersezioni fra quei riferimenti e la percezione contemporanea della giustizia e di un efficiente ordine sociale. Si tratta di un ragionamento la cui curvatura riflette la vita professionale dei due autori, i quali hanno sperimentato e sperimentano i dilemmi che un alto ufficio istituzionale pone.
Per quanto Cartabia e Violante riconducano l’analisi al piano giuridico presentissimo in Edipo Re e Antigone, il montaggio del loro ragionamento finisce per incrociare - seppur per allusione - l’attualità politica che, vista da quella prospettiva, richiama le evidenti incrinature dell’equilibrio dei poteri che connotano lo stato di salute della democrazia e della rappresentanza. Si tratta di temi che, sebbene i due saggi (Edipo Re di Cartabia, Antigone di Violante) si tengano correttamente lontani dall’oggi, lo descrivono però con perfezione adamantina. Ma il tentativo di non cadere nell’esplicitazione dei richiami al presente è in realtà limitato dall’universalità dei personaggi e delle vicende affrontate nelle due conversazioni.
Il perimetro in cui si articola la riflessione parallela dei due autori è definito dal conflitto tra legge umana e legge divina, tra coscienza individuale e ragion di Stato. Questa è la quinta con cui i due testi stabiliscono una dialettica che guarda i modi attraverso i quali la società occidentale si è costruita, riconosciuta e, poi, è entrata in una crisi che pare a tratti irreversibile, specie quando ancora si confronta con la contrapposizione che dovrebbe immaginarsi superata: quella tra lex e ius. E se Antigone è da sempre un interlocutore privilegiato di chi ne ha osservato la dimensione giuridica, invece i riferimenti all’equilibrio dei poteri e ai dilemmi con i quali chi governa dovrebbe dialogare sono presentissimi in Edipo. Egli è un monarca posto dinanzi alla rovina della città che regge, Tebe, dopo l’assassinio del padre e l’incesto con la madre. È quel crimine che lo colloca al centro di un complesso gioco dei punti di vista, delle ottusità, degli arcani, delle riluttanze dei protagonisti. È il conflitto tra la legge degli avi e la nuova legge della città: un conflitto irrisolto nel V secolo a.C. che ricorda le linee di faglia che la crisi delle democrazie fa sperimentare agli evolutissimi regimi capitalisti contemporanei.
Con il tempo la tendenza a identificare ciò che è buono e giusto con ciò che è consentito dalla legge e ciò che è male con quello che la legge proibisce ha costruito l’identità dell’Occidente e ha alimentato la fiducia nelle virtù del sistema democratico. Un sistema che ha fatto superare la condizione di coro al popolo e lo ha reso cittadino e attore. Ed è da cittadini che ci sentiamo sollevati dalla responsabilità personale di decidere che cosa è buono e che cosa non lo è, ma è nell’esperienza della cittadinanza - pure così confortevolmente mediata - che torna centrale il dilemma tra ciò che è religione, ciò che è morale e quello che il diritto può regolare.
 Il limes tra queste realtà appare ancora incerto e problematizzato dall’assenza di entità divine capaci di comporre conflitti apparentemente insanabili. Comporre quelle distinzioni ed equilibrarle è però necessario alla civiltà. Sono gli uomini che ora devono - attraverso la mediazione - conciliare tendenze potenzialmente conflittuali e quindi interpretare (o reinventare) lo spirito con cui Atena convinse le Eumenidi a partecipare alla vita della città. Fu quello il modo per interrompere i loro incantesimi e garantire l’edificazione di un futuro florido.
Il limes tra queste realtà appare ancora incerto e problematizzato dall’assenza di entità divine capaci di comporre conflitti apparentemente insanabili. Comporre quelle distinzioni ed equilibrarle è però necessario alla civiltà. Sono gli uomini che ora devono - attraverso la mediazione - conciliare tendenze potenzialmente conflittuali e quindi interpretare (o reinventare) lo spirito con cui Atena convinse le Eumenidi a partecipare alla vita della città. Fu quello il modo per interrompere i loro incantesimi e garantire l’edificazione di un futuro florido. -
>RIMEDITARE LA LEZIONE DI ESCHILO. Dalla storia di Clitennestra, si arriva anche a immaginare una nuova giustizia, all’interno di nuovi rapporti sociali e politici. - Il dono di Prometeo non basta all’uomo. La potenza è veleno se manca la giustizia (di Mario Vegetti)18 marzo 2018, di Federico La Sala
L’inedito. Una riflessione di Mario Vegetti scomparso l’11 marzo sul mito greco che richiama il rapporto tra la scienza e la politica
Il dono di Prometeo non basta all’uomo. La potenza è veleno se manca la giustizia
di Mario Vegetti (Corriere della Sera, La Lettura, 18.03.2018)
Prometeo, figlio di Giapeto, eroe e semidio, discendeva dall’antica stirpe dei Titani. Verso di essa consumò il primo dei suoi molti tradimenti, dettati dal suo pensiero preveggente o tortuoso, come indica il nome (Prometeo, letteralmente, è colui che «comprende prima», pro-manthanei). Nella memorabile battaglia fra i Titani e i «nuovi dèi» guidati da Zeus, che grazie alla vittoria conquistarono il regno dell’Olimpo, Prometeo abbandonò i suoi fratelli e si schierò al fianco di Zeus. Ma l’alleanza con Zeus - verso la cui usurpazione nutre comunque rancore («nuovi signori governano l’Olimpo/ e con nuove leggi, al di fuori del Giusto, Zeus governa/ e annienta ora le potenze di un tempo», Eschilo, Prometeo incatenato, 149-51) - non è davvero il punto d’arrivo del disegno di Prometeo. Egli puntava piuttosto sulla nuova alleanza con l’ultimo arrivato sulla scena del mondo, il genere umano. Ma per questo occorreva compiere due passi. Il primo, spezzare l’amicizia fra uomini e dèi, e metterli in conflitto fra loro; il secondo, fornire agli uomini la potenza necessaria per sostenere il conflitto.
Il primo passo venne compiuto a Mekone. C’era allora commensalità fra uomini e dèi, che sedevano alla stessa tavola. Prometeo, maestro del banchetto, divise in due otri le parti di un grande bue. Nel primo, formato da una pelle nascosta nel ventre del bue, pose le parti migliori; nel secondo più attraente, di «bianco grasso», soltanto le ossa. Sfrontatamente, propose a Zeus la scelta fra i due otri dall’aspetto così ineguale. Che avesse fiutato o no l’inganno, Zeus finì per scegliere le ossa; abbandonò indignato il banchetto, e da allora finirono commensalità e amicizia fra uomini e dèi (Esiodo, Teogonia, 535-560).
Si trattava ora di fornire la potenza necessaria a far fronte alla loro solitudine. Prometeo non poteva che cominciare rubando a Zeus il fuoco, che egli nascondeva presso di sé, e donarlo agli uomini ai quali Zeus lo negava: il fuoco, padre della metallurgia e condizione per qualsiasi tecnica. Vedendo «fra gli uomini il bagliore lungisplendente del fuoco» ( Esiodo, Teogonia , 569), Zeus fu di nuovo preda dell’ira, e questa volta le sue punizioni non si fecero attendere.
Prometeo fu scortato fino al Caucaso dai due fedeli aiutanti di Zeus, Kratos e Bia, Forza e Violenza, e lì Efesto lo incatenò saldamente a una rupe: il suo supplizio consisteva in questo, che ogni giorno un’aquila gli rodeva il fegato, destinato ogni notte a ricrescere per fornire nuovo alimento al rapace. Quanto agli uomini, un beffardo Zeus ordinò a Efesto di forgiare una «bella e amabile figura di vergine», ad Atena di insegnarle l’arte della tessitura, ad Afrodite di effonderle «grazia intorno alla fronte e desiderio tremendo»; finalmente, una volta riccamente adornata da Atena, venne inviata presso gli uomini Pandora, madre di ogni male (Esiodo,Opere e giorni, 60-95): «Di lei infatti è la stirpe nefasta e la razza delle donne,/ che, sciagura grande per i mortali, fra gli uomini hanno dimora» (Esiodo, Teogonia, 591-2).
Ma lasciamo gli uomini intenti per ora a rallegrarsi per il bel dono di Zeus, e torniamo sulle vette del Caucaso. Qui il vecchio Titano incatenato non cessa di rievocare i suoi doni al genere umano, seguiti a quello basilare del fuoco. «Prima, avevano occhi e non vedevano, orecchie e non sentivano, ma come le immagini dei sogni vivevano confusamente una vita lunga, inconsapevole. Non sapevano costruire edifici, case all’aperto, non sapevano lavorare il legno: abitavano sottoterra, come brulicanti formiche, in caverne profonde, senza la luce del sole... Facevano tutto senza coscienza finché insegnai loro a distinguere il sorgere e il tramontare degli astri, e poi il numero, principio di ogni sapere, per loro inventai, e le lettere e la scrittura, memoria di tutto, madre feconda della poesia... Io e nessun altro inventai la nave, il cocchio marino dalle ali di lino... Se uno si ammalava non aveva alcun rimedio, né cibo, né unguento o pozione. Si consumavano così, senza farmaci, finché io non insegnai loro a miscelare medicamenti curativi per scacciare tutte le malattie». Prometeo insegna poi agli uomini l’arte della divinazione, e la scoperta dei metalli nascosti nelle viscere della terra (Eschilo, Prometeo incatenato, 447-506).
Nelle sue parole, nel suo modo di concepire il ruolo delle tecniche, il programma di Prometeo sembra così giunto a compimento: egli ha concesso agli uomini tutta la potenza necessaria a misurarsi con gli dèi. Padrone delle tecniche e dei grandi saperi del numero, della scrittura, degli astri: questa è dunque l’immagine dell’«uomo prometeico» visto con gli occhi del suo creatore.
Più inquietante è lo sguardo «umano», in qualche misura esterno, sullo stesso «uomo prometeico», quale ci viene proposto dal Coro della tragedia Antigone di Sofocle. Una sorta di sforzo di autoconsapevolezza, dunque: che cosa siamo diventati? (qui l’uomo appare ormai autodidatta, benché non sia lontana la lezione di Prometeo).
L’uomo si avverte come «terribile», anzi come la cosa più terribile (deinos: l’aggettivo vale però anche «abile», potente). Infatti è capace di attraversare il mare, di lavorare la terra, di catturare gli animali selvatici e di addomesticare quelli da lavoro. «Capisce, inventa, ha sulle arti dominio oltre l’attesa»: lo sguardo di Prometeo non si sarebbe spinto oltre questa temibile immagine dell’uomo tecnologico. Quello «umano» del coro sofocleo invece ne coglie una linea di frattura, segno di un’incertezza o un cedimento possibili. Aggiunge infatti: «Ora al bene, ora al male serpeggiando volge. Se del Paese le leggi applica e la giustizia degli dèi... in alto sarà nella patria» (Sofocle, Antigone, 331-371). Bene, male, leggi, giustizia: si profila qui una dimensione del tutto estranea all’uomo prometeico, che il vecchio Titano non aveva certamente attrezzato a fronteggiarla.
Una chiara traduzione in termini concettuali di tutto questo è nel cosiddetto «mito di Protagora», che il sofista racconta nel dialogo di Platone a lui intitolato, e che molto probabilmente si ispira a tesi dello stesso sofista. Lo scenario è un poco cambiato rispetto a quello che ci è familiare: Prometeo non è ancora sul Caucaso e resta amico degli uomini, verso i quali del resto lo stesso Zeus ora si dimostra benevolo. Non sono però cambiati i ruoli principali.
Si tratta di distribuire le dotazioni necessarie alla sopravvivenza fra i diversi animali. Lo sbadato Epimeteo, fratello di Prometeo, assegna a ogni animale mezzi di offesa e di difesa, dimenticando però l’uomo, che rimane così nuda vittima delle fiere. Prometeo decide allora di intervenire a difesa del genere umano, e lo fa come gli è consueto: «Ruba a Efesto e Atena la loro sapienza tecnica insieme col fuoco... e la dona all’uomo. In tal modo, l’uomo ebbe la sapienza tecnica necessaria per la vita, ma non ebbe la sapienza politica, perché questa si trovava presso Zeus». -Ma è qui che i doni di Prometeo rivelano tutta la loro insufficienza, che già era emersa in Sofocle - e la manifestano anche in termini di pura potenza. Per far fronte alle fiere, gli uomini cercano di riunirsi fondando città; «ma, allorché si raccoglievano insieme, si recavano ingiustizia a vicenda, perché non possedevano l’arte politica, sicché, disperdendosi, nuovamente perivano» (Platone, Protagora, 321d-322b).
Per evitare la strage, Zeus interviene ordinando a Ermes di distribuire a tutti gli uomini le doti del rispetto reciproco e della giustizia (aidos e dike), «principi ordinatori di città e vincoli produttori di amicizia» (Platone, Protagora, 322c).
L’uomo prometeico, forte solo del controllo delle tecniche, non può vivere in una comunità politica: per questo, occorrono inoltre la condivisione di un orizzonte di valori etico-politici, la giustizia, la legge, l’educazione collettiva. Propriamente parlando, non può neppure combattere, perché «l’arte della guerra è parte di quella politica» (Platone, Protagora, 522b), che egli non possiede, perché essa è inaccessibile a Prometeo. Si è spesso interpretato il mito di Protagora come risposta alle antropologie tecniciste dell’ homo oeconomicus alla maniera di Democrito, dalle quali sembrava risultare che la collaborazione fra le diverse competenze tecniche fosse in grado di formare e guidare la città. Senza dubbio, il mito si oppone inoltre alla pressione crescente di un ceto di technitai che si candidano a governare la città, tendendo a marginalizzare la dimensione politica e i suoi specialisti come i sofisti. Non c’è polis , invece, senza un sistema di norme di giustizia condivise, senza le istanze decisionali proprie della politica, infine senza un’educazione pubblica intesa a consolidare i vincoli comunitari.
Ma torniamo nel Caucaso, dal vecchio Titano, certo inconsapevole dei limiti etico-politici dei doni tecnologici che aveva elargito al genere umano: l’impotenza della forza senza politica, l’incapacità di integrare efficacia e moralità. La sua pena non sarebbe durata indefinitamente (a differenza di quella femminile comminata agli uomini). Prometeo era infatti depositario di un formidabile segreto, da cui dipendeva la sopravvivenza stessa del regno di Zeus - che si vide costretto a liberarlo, nel timore che il Titano lo rivelasse a orecchie ostili, e al contrario nella speranza di venirne a conoscenza.
Noi non possiamo conoscere il segreto di Prometeo, sul quale sono fiorite molte ipotesi. A me piacerebbe pensare che il vero, devastante, segreto di Prometeo fosse quello rivelato da Socrate - il Socrate di Aristofane, beninteso, non quello benpensante di Senofonte e di Platone - nella commedia Le nuvole:
- «Strepsiade: ma per voi, in nome della Terra, Zeus olimpio non è dio?
- Socrate: quale Zeus? Non dire sciocchezze. Zeus non esiste».
Certo, il «segreto» più efficace per por fine al potere di Zeus.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
-
> PER LA VERITA’ E LA RICONCILIAZIONE. RIMEDITARE LA LEZIONE DI ESCHILO. --- Il conflitto tra genitori e figli nel mondo antico. Padri che dominano troppo (di Nicola Gardini)14 marzo 2016, di Federico La Sala
Eva Cantarella
Padri che dominano troppo
di Nicola Gardini (Il Sole-24 Ore, Domenica, 13.03.2016)
- Eva Cantarella, Non sei più mio padre. Il conflitto tra genitori e figli nel mondo antico , Feltrinelli, Milano, pagg. 151,€ 14
Admeto, come leggiamo in Euripide, aveva ottenuto dagli dèi di poter evitare la morte nel caso in cui qualcuno si offrisse al suo posto. Il giorno arrivò e si offrì l’irreprensibile moglie, Alcesti. I genitori, benché anziani, si guardarono bene dal sostituirsi a lei. Al funerale Admeto li rinnegò entrambi. Alcune delle parole rivolte al padre sono diventate il titolo dell’ultimo saggio di Eva Cantarella Non sei più mio padre, pubblicato da Feltrinelli. È un proclama rivoluzionario: la biologia, che non è certo riscrivibile, qui si dà per convenzione, per pratica sociale, per politica. E davvero Eva Cantarella mostra che il rapporto padre-figlio o, più latamente, tra generazioni nella Grecia antica è questione di potere; vale come istituzione giuridico-economica prima ancora che legame d’amore o esperienza affettiva.
I padri dominano, i figli subiscono. Se fanno di testa loro, sono semplicemente disobbedienti, non significa che siano artefici del proprio destino (come, invece, i figli scapestrati dei moderni romanzi di formazione). La relazione paternalistica si mantiene più o meno incontestata, almeno sulla base delle testimonianze pervenuteci, dal periodo arcaico a quello della morte di Socrate. Padri dominatori, perfino uccisori dei propri figli compaiono nella mitologia delle origini, che si fonda, guarda caso, proprio sul racconto di una competizione padre-figlio (Urano-Crono). Il figlio può, con un castrante falcetto, prevalere, ma sarà a sua volta padre dominatore. Anche Zeus ha la meglio su Crono. Sebbene con lui, finalmente, la catena di violenza familiare si interrompa, Zeus continua ad avere autorità assoluta sui figli; il suo potere paterno non si mette in dubbio. E così non si mette in dubbio quello di Odisseo.
Molti, valutando i fatti dell’Odissea, parlano di una maturazione di Telemaco. Eva Cantarella dimostra che Telemaco resta figlio e basta; quel che fa lo fa perché così vuole il padre. Lo stesso vediamo nella tragedia, in cui si esprime la voce della nuova polis. Già ho citato il caso di Admeto. Si pensi anche all’emblematico caso di Ippolito, che soccombe alla maledizione del padre, o a quello di Oreste, che si fa matricida per vendicare il padre. Insomma, il figlio sta per il padre, o sottostà al padre. E quando, come Edipo, si affranca da lui con la violenza, non trova alcuna felicità.
Le prime vere contestazioni del modello tradizionale, come risulta dalla commedia di Aristofane, cominciano solo verso la fine del quinto secolo, quando Atene, per effetto della guerra, entra in crisi e i figli cercano di ridefinire le proprio ragioni e funzioni, anche prendendo i padri a sberle. Da padre adesso fa uno come Socrate: un padre elettivo, che decostruisce qualunque rapporto di potere, autorizzando l’indipendenza e l’autosufficienza intellettuale del figlio. E immagine del nuovo figlio è, pur con tutti i suoi lati riprovevoli, un Alcibiade: ubriaco di troppa libertà, reso arrogante proprio dall’amore di Socrate, disobbediente e irriverente per principio, trionfante nella catastrofe.
Non sei più mio padre, che presto verrà completato da una seconda parte su Roma, aggiunge un sostanziale capitolo al racconto della civiltà antica che Eva Cantarella va componendo con sapienza e con eleganza da molti anni. I meriti del suo metodo sono grandi: rigore nell’utilizzo delle fonti (letterarie e no), chiarezza nella presentazione degli argomenti anche più ardui, una lucidità critica che, tendendo alla condensazione, sa però illuminare la complessità dei contesti, anche quando sfumino nel buio dell’indocumentabile. Un’altra cosa degna di lode: qui non si cade mai nella trappola dell’attualizzazione. Lo sguardo resta fermamente, scientificamente storico, come già nelle altre bellissime indagini sull’omosessualità e sulla donna per le quali Eva Cantarella è diventata celebre.
Tuttavia il lettore non può non sentire che la trattazione di temi come questi, che parlando di identità e di responsabilità, di giustizia e di benessere sociale, risponde a interrogativi e a problemi attualissimi. Finito di leggere Non sei più mio padre, dobbiamo domandarci: Chi sono i padri oggi? E i figli? I politici, lo sappiamo, stanno cercando di dare risposte e qualche felice soluzione sembra già a portata di mano (la legge Cirinnà). Pensiamoci tutti a queste domande. Ci troviamo davanti a grandi e concrete occasioni di rinnovamento, come ai tempi di Socrate. Possiamo tutti riformarci come padri e come madri, favorendo la crescita e la libertà e l’uguaglianza. Non costringiamo le nostre società all’ennesima dose di cicuta.
-
> PER LA VERITA’ E LA RICONCILIAZIONE. RIMEDITARE LA LEZIONE DI ESCHILO. --- E cosi’ Apollo rubo’ i figli alle madri (di Dacia Maraini).7 settembre 2008, di Maria Paola Falqui
E cosi’ Apollo rubo’ i figli alle madri
di DACIA MARAINI (Corriere della sera, 26 febbraio 2008)
"Non e’ la madre che crea / il figlio, come si pensa. / Ella e’ solo nutrice e niente altro, della creatura paterna / ...Soltanto chi getta il seme nella terra fertile e’ da considerarsi genitore. / La madre coltiva, ospite all’ospite, il germoglio, / quando non l’abbia disperso un demone". Questa frase messa in bocca ad Apollo da Eschilo, e pronunciata in un sacro spazio teatrale nel 458 a.C. segna un punto di svolta che ha marcato la storia della maternita’ in Occidente.
Presso i Pelasgi del II millennio, popolo antenato dei greci, chi creava il mondo era la dea Eurinome, nel cui uovo erano compresi tutti i mari, le montagne, i fiumi, le foreste del mondo. Solo lei poteva fare maturare quell’uovo, romperne il guscio e spargere i beni di cui avrebbero vissuto gli esseri umani.
Apollo, il nuovo dio della democrazia ateniese, invece sancisce un principio che avra’ conseguenze disastrose per le donne dei millenni a venire: non e’ la madre che crea il figlio. Il suo ventre e’ da considerarsi solo un vaso che custodisce il seme paterno. Ecco come nasce una societa’ dei Padri. Persino la religione cristiana, che e’ stata rivoluzionaria nel riconoscere un’anima anche alle donne, si e’ tenuta, per quanto riguarda la gerarchia, ai principi apollinei: nella Santa Trinita’ non appare la figura materna. E quando Dio decide di diventare padre, forma prima l’uomo a sua immagine e somiglianza, poi prende una costole di Adamo e da quella fa nascere la donna. Insomma capovolge la realta’ per sancire una gerarchia inamovibile.
Tutta la nostra cultura viene da questi grandi e originari avvenimenti simbolici. Poi, il laicismo, le rivoluzioni, l’illuminismo, i movimenti di emancipazione hanno cercato di rompere il dogma, riconoscendo alle donne la partecipazione al processo di riproduzione. Ma sempre sotto il controllo dei Padri e dentro le leggi stabilite da loro. Il diritto alla riproduzione non si e’ mai trasformato in liberta’ di riproduzione.
E la rete millenaria dei divieti e’ profonda e radicata anche quando non viene scritta. Da li’ derivano il culto della verginita’, la proibizione degli anticoncezionali, l’aborto clandestino, l’ignoranza indotta e tante altre disperanti piaghe della storia femminile. Se c’e’ una cosa su cui le donne hanno competenza e’ la maternita’: un processo che avviene nel loro corpo, di cui conoscono le pene e le gioie profonde, i tempi e le trasformazioni, il peso e le responsabilita’. Ma di questa competenza sono state espropriate e ogni movimento di riappropriazione viene visto come un attentato alla morale. Il processo procreativo si e’ complicato da ultimo per le scoperte della scienza: anticoncezionali meccanici e chimici, aborti chirurgici e chimici, possibilita’ di spiare e fotografare l’embrione nella sua formazione, mezzi per fare crescere un feto anche in assenza del corpo materno.
Ma tutto questo, anziche’ dare potere alle donne, le deruba ancora una volta dei loro saperi profondi, per stabilire sui loro corpi cosa fare e non fare, secondo principi assoluti stabiliti a tavolino da chi questi saperi non li conosce affatto e non vuole neanche fare lo sforzo di immaginarli.
-
> PER LA VERITA’ E LA RICONCILIAZIONE. RIMEDITARE LA LEZIONE DI ESCHILO. ---- SIRACUSA. La trilogia di Eschilo per difendere la legalità.Dopo l’anteprima con la lettura del procuratore antimafia Piero Grasso l’Inda riporta in scena l’«Orestea» con la regia di Pietro Carriglio. Intense le prove di Galatea Ranzi, Brogi e Luca Lazzareschi (di Dmenico Rigotti)11 maggio 2008, di Federico La Sala
Dopo l’anteprima con la lettura del procuratore antimafia Piero Grasso l’Inda riporta in scena l’«Orestea» con la regia di Pietro Carriglio. Intense le prove di Galatea Ranzi, Brogi e Luca Lazzareschi
La trilogia di Eschilo per difendere la legalità
Tra l’arcaica vendetta e il più elevato concetto di Giustizia rivivono a Siracusa tre capolavori della tragedia
DA SIRACUSA DOMENICO RIGOTTI (Avvenire, 10.05.2008, p. 29)
Tornano a rivestirsi di folla, soprattutto di una folla di giovani studenti, gli alti e immensi spalti del Teatro Greco di Siracusa per gli spettacoli classici dell’Inda, l’Istituto nazionale del dramma antico. E rivive quest’anno nella sua interezza l’Orestea di Eschilo. Quell’Orestea considerata una delle creazioni più altre di tutti i tempi. Dove troviamo i temi della grande Tragedia: l’ineluttabilità delle leggi divine, l’ereditarietà misteriosa del delitto, l’intimo contrasto tra la voce della natura e un ordine superiore, l’adempimento di una legge di giustizia nelle umane vicende.
Torna il capolavoro eschileo nella sua interezza a distanza di quasi mezzo secolo. da quando tra i protagonisti figurava un fiero e nobile Vittorio Gassman che firmava anche la regia (ora l’impresa, e riuscita, è toccata a Pietro Carriglio) avvalendosi di una nuova e vitale versione commissionata a Pier Paolo Pasolini. La stessa oggi riproposta. Una versione che non cerca una mediazione classicistica ma si lega al nostro tempo presente. Anche a sottolineare questo, l’anteprima di mercoledì aveva visto, alla fine, il procuratore nazionale antimafia Piero Grasso leggere un passo dello storico George Thomson sulla vittoria della Giustizia sul concetto di vendetta.
È Agamennone che apre la trilogia. Ed è Agamennone colui che rappresenta il primogenito della maledizione abbattutasi sulla stirpe degli Atridi, ma anche la vittima sacrificale. Al suo ritorno dopo la vittoria su Troia troverà ad attenderlo la morte per mano della moglie Clitennestra che ha voluto vendicare il sacrificio della figlia Ifigenia con la complicità di Egisto, futuro despota. Tragedia possente, ma è Le Coefore il momento centrale della trilogia di Oreste che racconta quel nodo di vendetta-giustizia che l’eroe scioglie uccidendo l’usurpartore e la propria madre, rei dell’assassinio.
Misteriosa e terribile è la tragedia del labile confine tra responsabilità umana e giustizia divina. E qui a giganteggiare è appunto Oreste, di cui a fare anche la grandezza del personaggio è l’angoscia di esitazione, quell’incrinatura interiore che ritroveremo in Amleto. Una tragedia, Le Coefore, rapida e intensa i cui fulminei accadimenti costituiscono i passaggi di un terribile rituale religioso: il sangue che va lavato col sangue, il delitto che va purificato con un delitto anche più fosco: il matricidio. La catena dei delitti solo alla fine è interrotta dall’intervento divino nelle Eumenidi. E sarà questa la dichiarazione religiosa di Eschilo, l’omaggio al sovrannaturale al quale l’uomo non può sottrarsi.
Impresa difficile, quella di Carriglio, ma affrontata con tenacia, senza sicurezze preconcette. Il regista fa bene ad adeguarsi alla pasoliniana strategia di ’smascheramento’ di un classico così illustre eppure così antropologicamente ambiguo e fa anche bene a far emergere il senso della legge cui gli uomini devono sottostare. Lavorando bene sui cori, mai forzando le tinte, semmai recando allo spettacolo una forte dose di spettacolarità.
Nei ben meditati costumi, sempre di Carrriglio, che da una bella grecità (tonalità soprattutto brune e nere) trapassano a un accennato modernismo, si erge a recitare una falange di attori valenti, quasi tutti persuasivi. Fisico asciutto, vocalità superba, nel ruolo di Oreste il giovane Luca Lazzareschi si rivela forse il migliore di tutti. Ma bravissima anche Galatea Ranzi, prima a dare algido furore a Clitennestra e poi giusta sofferenza ad Elettra. D’alta scuola l’Agamennone di Giulio Brogi e così l’Athena di Elisabetta Pozzi. Ma non deludono nemmeno Luciano Roman. Maurizio Donadoni, Liliana Paganini, Simonetta Cardia, Giancarlo Condè e, validissimo corifeo, Stefano Santospago. Ben inserite, d’alta civiltà, le musiche di Matteo D’Amico. Quaranta le repliche, fino a giugno inoltrato. A sere alternate, Agamennone e, unificate, Coefore ed Eumenidi.
-
> PER LA VERITA’ E LA RICONCILIAZIONE. RIMEDITARE LA LEZIONE DI ESCHILO. ---- Bachofen. Il padre del matriarcato (di Emanuele Trevi)2 febbraio 2016, di Federico La Sala
- UNA CATTOLICA, UNIVERSALE, ALLEANZA "EDIPICA"!!! IL MAGGIORASCATO: L’ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE, L’ALLEANZA DELLA MADRE CON IL FIGLIO, REGNA ANCORA COME IN TERRA COSI’ IN CIELO
Johann Jakob Bachofen
La monumentale ricerca del giurista e antropologo svizzero torna in una nuova edizione senza perdere il suo fascino originario
Il padre del matriarcato
Tradusse leggi, indagò miti, lesse documenti. Così il genio di Bachofen svelò al mondo l’antico diritto e il potere storico delle donne
di Emanuele Trevi (Corriere della Sera, La Lettura, 31.01.2016)
Quando pubblicò Il matriarcato, nel 1861, Johann Jakob Bachofen, svizzero di Basilea, aveva appena superato i quarantacinque anni: età più considerevole ai suoi tempi che oggi, ma nemmeno a quei tempi veneranda. Era il rampollo di una delle più insigni (e ricche) famiglie patrizie della sua città, e fin da giovane si era consacrato a studi severissimi, nelle migliori università tedesche ed europee, diventando precocemente uno dei massimi esperti del diritto romano. Aveva a sua volta insegnato, e ricoperto importanti cariche di magistrato, come volevano le tradizioni del suo ceto. Ma era libero di vivere seguendo esclusivamente le sue inclinazioni, e finì per dedicarsi esclusivamente alla sua fame di sapere, e alla passione per i viaggi.
Spirito laborioso e metodico, la sua erudizione in fatto di storia antica, archeologia, mitologia divenne immensa. I paesaggi della campagna romana o del Peloponneso non erano diversivi turistici, ma occasioni per affinare e precisare le sue conoscenze storiche. È difficile fare illazioni sull’uomo capaci di perforare la severa dignità delle apparenze. Che si sia sposato solo a cinquant’anni, dopo la morte della madre amatissima, è un fatto che non può essere interpretato con i maliziosi criteri odierni.
Anche a guardare i suoi ritratti, che sembrano l’esatto contrario dell’immagine dell’artista romantico, sarebbe impossibile sospettare in Bachofen uno spirito talmente geniale e visionario da rasentare la follia. Di sicuro, durante la lunga fatica che doveva portarlo alla pubblicazione del Matriarcato , il suo entusiasmo era nutrito dalla consapevolezza di una scoperta capace di rivoluzionare tutto ciò che si sapeva sulla storia del mondo greco-romano, e più in generale delle antiche civiltà mediterranee. Non era il solo uomo del suo tempo ad avere accumulato un sapere quasi inconcepibile per un singolo individuo. Ma un erudito, di per sé, è solo il proprietario di un’immensa massa di macerie, informe e tarlata di contraddizioni. Pochi sono in grado di compiere quel salto mortale che solo può condurre dal sapere al comprendere. E ancora minore è il numero di coloro a cui tocca in sorte il pensare qualcosa che nessuno ha mai pensato prima.
Nonostante la compostezza dello stile, alieno da inutili effusioni, queste emozioni trapelano nitidamente nelle prime righe del Matriarcato , ora riedito da Einaudi, che sono la promessa di un viaggio mai tentato dallo spirito umano. «La presente opera affronta un fenomeno storico di cui pochi tennero conto e di cui nessuno valutò a fondo la portata. Le scienze che studiano l’antichità hanno continuato a ignorare fino ad oggi il diritto materno: nuova è tale espressione, e sconosciuta è la condizione familiare che essa designa».
Ecco l’oggetto misterioso, o meglio la chiave d’accesso al mistero che è la nostra storia, quando cerchiamo di decifrarne le origini. Noi diamo al capolavoro di Bachofen un titolo, Il matriarcato , che rende omaggio alla sua idea più memorabile e affascinante. Ma il titolo originale è Das Mutterrecht , ovvero il diritto materno. Il matriarcato o la ginecocrazia, ovvero «il potere delle donne», non è un’oscura favola, ma una fase capitale della storia umana. Un’epoca in cui la madre prevale sul padre nel sentimento dell’esistenza, così come è testimoniato dai miti, dai racconti degli storici, dalle leggi.
Per ricostruire quest’epoca dimenticata, Bachofen passa al vaglio, con sovrumana pazienza, le migliaia di testimonianze che ha raccolto (a un certo punto, appare anche una poesia del «conte Leopardi»!). Erodoto racconta che gli abitanti della Licia ereditavano il nome della madre e si trasmettevano i beni in linea femminile. Non è la notizia bizzarra di uno storico curioso di costumi esotici, ma la tessera di un immenso puzzle le cui tessere sono sparse su tutte le rive del Mediterraneo. Il potere delle donne è un istituto giuridico e nello stesso tempo un sistema simbolico, un’interpretazione totale della vita, una religione. La mano sinistra prevale sulla destra, la notte sul giorno, la luna sul sole. Dei fratelli, è l’ultimo nato il più importante. Tra gli esseri viventi prevale un senso di pace e fratellanza, conseguenza della consapevolezza di essere generati dalla stessa terra e di dover presto ritornare, con la morte, nel suo grembo.
Bachofen immaginò quest’epoca della storia umana con tanta intensità che ne immagino addirittura il paesaggio fisico, nel quale la vegetazione palustre, simbolo della spontaneità della vita, soverchiava i campi arati. Il fatto è che Bachofen, e proprio in questo consiste il fascino indelebile delle sue pagine, non distingue un mito da una legge, la testimonianza approvata di uno storico dalla decorazione di un vaso o di una tomba. Non ci sono documenti antichi più o meno «veri» di altri. Esistono solo modi diversi di tradurre la stessa esperienza umana. Anche le parole di un eroe di Omero sono un documento storico.
In una pagina che meriterebbe di figurare in tutte le antologie della prosa, Bachofen interpreta alla luce del diritto materno un bellissimo e celebre episodio dell’ Iliade. Prima di affrontarlo in duello, il greco Diomede chiede al suo avversario, Glauco, notizie sulla sua stirpe. Diomede è un greco, figlio di una cultura patriarcale, fondata sulla discendenza dai padri e sulla sottomissione della donna. Per lui è naturale chiedere cavallerescamente al nemico chi sia suo padre. Ma Glauco è un Licio. E gli risponde da Licio. In pratica, dichiara a Diomede che la sua domanda è insensata, dal suo punto di vista. Non esistono i padri e i figli, dice Glauco a Diomede, perché gli uomini sono come le foglie. Nascono tutti dallo stesso tronco e quando viene il loro momento cadono tutti a terra nello stesso modo. Nessuno discende da nessuno.
Bachofen considera questi versi di Omero, sempre ammirati per la loro bellezza, il riflesso di una condizione di esistenza, vale a dire di qualcosa che ha avuto luogo nella realtà. Un’organizzazione sociale e religiosa fondata sul predominio della madre e destinata a essere soppiantata, non senza conflitti molto aspri, dal principio maschile e paterno.
Distacchiamoci adesso dal grandioso scenario dipinto da Bachofen per considerarne il totale insuccesso tra i contemporanei. Da un certo punto di vista, il poderoso libro di Bachofen sembrava fatto apposta per non essere letto da nessuno. Alla solita meditazione sulla genialità e la solitudine bisogna aggiungere il ricordo ben più concreto di un tipografo folle, che ebbe l’assurda idea di mescolare un testo già lungo e impegnativo con le migliaia di note che dovevano corredarlo di tutte le indicazioni bibliografiche ed erudite. Ne venne fuori quello che il nostro più importante studioso di Bachofen, Furio Jesi, ha definito «un orrido groviglio» stampato su due colonne. Poteva capitare che una frase, cominciata a una data pagina, finisse soltanto a metà di quella successiva.
Che cosa ne avrà pensato l’autore? In qualche modo, quella catastrofe aveva qualcosa di simile alla sua mente poderosa e labirintica. Fatto sta che quando, dopo la sua morte, la vedova e il figlio provvidero a una ristampa, ripeterono la stessa assurdità, accompagnata questa volta da un numero esorbitante di errori di stampa. Forse non erano del mestiere, ma si sarebbero comportati così se Bachofen si fosse molto lamentato della prima edizione?
Lui era morto a settantadue anni, nel 1887, nel più completo isolamento intellettuale. Non cambiò mai idea, a quanto pare, su quella «poesia della storia», come la definiva, che era l’epoca del potere femminile. Sarebbe stato assurdo obiettargli che il matriarcato, come l’immane guerra tra i sessi che ne aveva dichiarato la fine e instaurato il potere del maschio, erano cose accadute solo nella sfera del mito e non sul piano della realtà. Perché tutta l’impresa di Bachofen si basa su un atto di fede fondamentale: il mito è realtà, traccia di una realtà vissuta non meno di un utensile o delle rovine di un’abitazione o di una norma giuridica. «Abbiamo di fronte a noi non finzioni, ma destini vissuti», affermava con una certezza che si addice più al poeta romantico che al filologo.
Ma la sorte del Matriarcato è tutt’altro che un argomento malinconico. Semmai, è una lezione istruttiva sulla potenza delle grandi visioni, che, come certi organismi naturali, resistono e si rafforzano nelle condizioni avverse, sanno aspettare il loro momento. A volte bastano dieci lettori per traghettare un capolavoro misconosciuto sulle acque oscure della dimenticanza. Oggi Il matriarcato ci appare pienamente comprensibile a un livello della verità che non è quello dell’archeologia o della storia del diritto, ma quello delle opere d’arte.
Più che a Friedrich Nietzsche, che non ne nutriva una grandissima stima, Bachofen sembra accostabile all’altro grande profeta inascoltato del suo tempo, Herman Melville. Potremmo affermare che Il matriarcato sta alla storia antica come Moby Dick sta alla caccia alla balena. In entrambi i casi, si tratta di una lettura indimenticabile, di quelle capaci di trasformare la vita. In ogni forma di espressione umana, nel romanzo come negli studi storici, esistono regole fondate sul buon senso e su una certa dose di conformismo. Ma se in determinati momenti non spuntassero fuori spiriti eretici e infiammati come Melville e Bachofen, tutto il resto si ridurrebbe al ben misero bottino delle carriere accademiche e dei premi letterari.
-