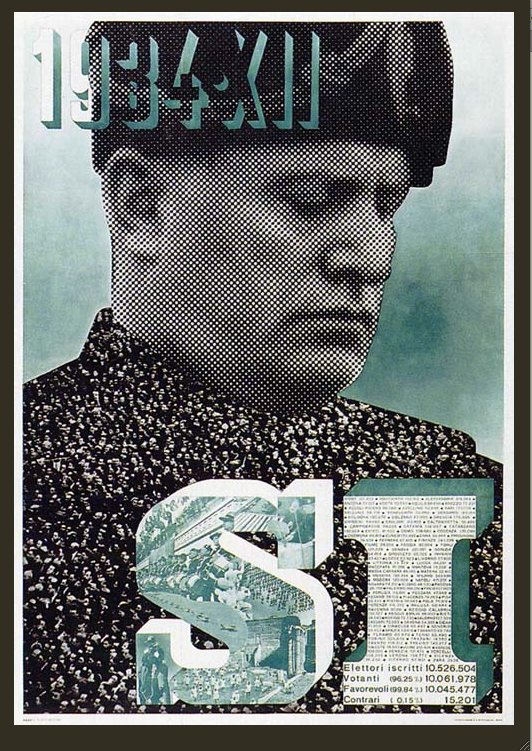MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA E A PENSARE BENE "DIO", "IO" E "L’ITALIA", CHI PIÙ CHI MENO, TUTTI VIVONO DENTRO LA PIÙ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA E POLITICA ITALIANA, NEL REGNO DI "FORZA ITALIA"!!! Un’inchiesta e una mappa di Francesco Tomatis - a cura di Federico La Sala
- Non basta dire come fanno i francesi che la loro nazione è stata colta alla sprovvista. Non si perdona a una nazione, come non si perdona a una donna, il momento di debolezza in cui il primo avventuriero ha potuto farle violenza. Con queste spiegazioni l’enigma non viene risolto, ma soltanto formulato in modo diverso. Rimane da spiegare come una nazione dì 36 milioni di abitanti abbia potuto essere colta alla sprovvista da tre cavalieri di industria e ridotta in schiavitù senza far resistenza (K. Marx,Il 18 brumaio di Luigi Bonaparte, 1852).
- "DIARIO MINIMO" (Eco, 1963) DELLA "FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO"(Hegel, 1807): «Mike Bongiorno convince dunque il pubblico, con un esempio vivente e trionfante, del valore della mediocrità. Non provoca complessi di inferiorità pur offrendosi come idolo, e il pubblico lo ripaga, grato, amandolo. Egli rappresenta un ideale che nessuno deve sforzarsi di raggiungere perché chiunque si trova già al suo livello. Nessuna religione è mai stata così indulgente coi suoi fedeli. In lui si annulla la tensione tra essere e dover essere. Egli dice ai suoi adoratori: voi siete Dio, restate immoti.» (Umberto Eco, "Fenomenologia di Mike Bongiorno", 1961).
- AL DI LA’ DELLA LEZIONE DI PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).
INCHIESTA
 Ormai non ci sono più le «scuole» di una volta, il pensiero oggi è meno che «debole». Però domina le piazze dei festival: chiacchiera o socratica maieutica per nuovi discepoli ammaestrati sotto l’albero?
Ormai non ci sono più le «scuole» di una volta, il pensiero oggi è meno che «debole». Però domina le piazze dei festival: chiacchiera o socratica maieutica per nuovi discepoli ammaestrati sotto l’albero?
 Analitici, tragicisti, trascendentali, apofatici e persino copisti. Eccovi la mappa sfiziosa dei nostri «maîtres à penser»
Analitici, tragicisti, trascendentali, apofatici e persino copisti. Eccovi la mappa sfiziosa dei nostri «maîtres à penser»
AAA: Italia, cercansi
di Francesco Tomatis (Avvenire, 21.09.2008).
Un tempo c’erano le scuole filosofiche. Non mi riferisco a Pitagora e alla scuola che formò attorno a sé a Crotone già nel VI secolo a. C., né all’Accademia fondata da Platone ad Atene nel IV secolo a. C., né alle tante altre diffuse in Grecia ma non solo, prima che in età medievale si formassero le università. Sino a circa trent’anni fa, in Italia, si potevano individuare diverse scuole filosofiche, localizzandone le sedi in svariate università del Paese, con relativi capiscuola, ma soprattutto caratterizzate da tradizioni di pensiero ben consolidate e delineabili.
Oggi non è più così. Non è colpa dei festival filosofici, ultimamente molto alla moda, da quello modenese, ideato dalla Fondazione San Carlo e Remo Bodei, al più recente romano, coordinato da Giacomo Marramao, che effettivamente possono dare al pubblico l’impressione di potersi accostare alle questioni filosofiche in atteggiamento spettacolare, senza troppo studio.
Un po’ per la moltiplicazione dei filosofi, o dei presunti tali, con conseguente impoverimento della riflessione teoretica e prevalere di quella storiografica, un po’ per la naturale tendenza alla ricerca e meditazione individuale, soprattutto per il livellamento delle università italiane, sta di fatto che le diverse tradizioni filosofiche, che arricchivano l’Italia facendone un unicum a livello europeo, un laboratorio sperimentale di pensiero costituito da diverse originali linee di ricerca, esse in quanto scuole, capaci di formare allievi, produrre idee e pubblicazioni, creare progettualità per l’avvenire, sono venute meno.
Va attentamente considerato un motivo di fondo che ha provocato il declino: il livellamento universitario. Del quale certamente sono anche responsabili i docenti e gli stessi studenti, sempre meno motivati e preparati nei precedenti corsi di studio frequentati. Tuttavia la maggiore e gravissima responsabilità sta nella nuova impostazione del sistema universitario, delineatasi sul finire degli anni Ottanta e poi pienamente realizzata un decennio dopo.
Fra i molti, i punti critici sono due: la separazione fra ricerca e insegnamento, apprendimento e ricerca, nonché l’omologazione dei corsi di laurea, cioè delle discipline insegnate nelle diverse università, attraverso una imposizione ministeriale di rigide griglie. Decretare elenchi di materie all’interno delle quali soltanto sia possibile delineare corsi di studio universitari impedisce di fatto un pluralismo fra diverse tradizioni di ricerca e saperi, quando non viola la stessa libertà costituzionale di insegnamento.
Un esempio fra tutti: negli elenchi di discipline inseribili nei corsi di laurea in Filosofia non compaiono le filosofie e le culture orientali (indiane, cinesi...), quando invece campeggiano, ad esempio, la storia della medicina e la chimica. Che sia stato recepito il suggerimento di Nietzsche, di una nuova filosofia come chimica delle idee?
Ma torniamo alle scuole filosofiche e ai veri filosofi, in Italia. Dove si sono ritirati?
Prescindiamo dai decani, ormai purtroppo fuori dalle università - eppure tanto avrebbero ancora da insegnare a noi: penso a Pietro Prini, Armando Rigobello, Vittorio Mathieu, Carlo Arata. Qualche filosofo, ovviamente, frequenta ancora le università; sono tuttavia degli isolati. Facciamo dei nomi.
Vincenzo Vitiello a Salerno, grande sostenitore dello stare accanto di filosofia e teologia, praticato anche personalmente attraverso il continuo confronto con teologi come Bruno Forte e Piero Coda.
Gianni Vattimo a Torino, il più noto e letto e acclamato (persino da Fidel Castro!) dei filosofi italiani all’estero, che propone una propria lettura del tutto particolare del cristianesimo e dell’età postmoderna, nel senso di un pluralismo fondato storicamente, non assolutizzabile.
Carlo Sini a Milano, che coniugando pragmatismo, esistenzialismo e fenomenologia insiste sulla praticità dei saperi, troppo spesso trascurata attraverso false dicotomizzazioni fra teoria e prassi.
Sempre a Milano, ma alla Cattolica, Virgilio Melchiorre, che intreccia la fenomenologia invece con il tomismo, il trascendentalismo con la metafisica.
Sergio Givone a Firenze, argonauta del pensiero tragico cristiano, capace di una versatilità linguistica che dalla saggistica storiografica e aforistica lo ha portato al romanzo, pensante e sentimentale, colorito e sofferto assieme.
Dario Antiseri alla Luiss di Roma, il quale pascalianamente contempla nella propria ricerca ragioni del cuore e della fede nonché scientifiche e razionali.
Un caso del tutto unico, invece, quello di Massimo Cacciari, filosofo-doge veneziano, che è riuscito in un lampo a istituire una facoltà di Filosofia dell’Università San Raffaele, dove ha saputo attrarre filosofi affermati come Emanuele Severino e Giovanni Reale, ma anche più giovani come Massimo Donà. Benché i recenti piani quinquennali del ministero dell’Università mettano a rischio i corsi di laurea con pochi docenti, come spesso accade abbiano le università private, a cui vanno solo le briciole dei finanziamenti statali.
Esistono poi, sempre in ambito universitario, pochissime scuole di eccellenza o dottorati davvero originali, come la Scuola superiore di Studi umanistici di Umberto Eco a Bologna, o il dottorato creato a Salerno da Giulio d’Onofrio, in Filosofia, scienza e cultura dell’età tardo-antica, medievale e umanistica, a cui accorrono studiosi da tutta Italia e non solo, a dimostrazione che la specificità crea l’interesse, la qualità, la produttività della ricerca.
Persino le case editrici, in Italia, seguono scarsamente la saggistica filosofica. Oltre a quelle che tradizionalmente si occupano di filosofia, principalmente con edizioni di classici - Laterza e Utet -, soltanto Morcelliana, Mimesis, Il Melangolo, Bompiani e la piccolissima Il Ramo hanno intere collane dedicate ai filosofi.
Bompiani in particolare ha riconsolidato e allargato la propria originaria vocazione anche filosofica, con collane di classici con testo a fronte, dirette da Giovanni Reale, ma persino con pubblicazioni tascabili di giovani filosofi italiani, quindi secondo una linea innovativa e sperimentale.
È quindi fuori dalle università che abbiamo i veri e propri centri di ricerca filosofici, privati, con scarsissime risorse finanziarie, frutto di intelligenza e generosità di pochi illuminati. Gli unici luoghi frequentabili da parte di chi seriamente voglia farsi una formazione filosofica.
Menziono soltanto due istituzioni, quelle esclusivamente dedite a ricerche filosofiche. Il Centro Studi filosofico-religiosi ’Luigi Pareyson’ di Torino, diretto da Maurizio Pagano, che promuove ricerche, seminari, pubblicazioni nel solco della tradizione ermeneutica cristiana del grande filosofo a cui si ispira.
E l’Istituto italiano per gli Studi filosofici di Napoli, creato dall’avvocato Gerardo Marotta nel 1975, inizialmente con sede in casa propria, che diretto da Antonio Gargano propone centinaia di seminari all’anno, finanziando ricerche di giovani studiosi e pubblicazioni distribuite fra più case editrici, da Guerini e Bibliopolis a Città del Sole, Guida e altre ancora. È questa una istituzione unica in tutto il mondo, che ancora riesce a mettere in luce ciò che è essenziale alla filosofia: la libertà di ricerca, di insegnamento e di pensiero, lo studio lento, lungo e approfondito, la comunione di idee, dialogica e in contatto con la storia e le persone fra cui si viva.
In un paese in cui le biblioteche universitarie, per l’esiguità dei finanziamenti statali alla ricerca, che ci pone fra gli ultimissimi in Europa, non riescono quasi a proseguire nell’acquisto delle edizioni critiche dei principali filosofi, tanto più in quello delle letterature secondarie e delle riviste, lascia ancora una certa speranza sapere che comunque, per merito di pochi singoli, la filosofia eccelle, rispetto a ogni altra parte del mondo, ancora.
VECCHIE E NUOVE... CORRENTI
ANALITICI E PRAGMATISTI Michele Di Francesco Aldo Giorgio Gargani Pier Aldo Rovatti Carlo Sini
SEMIOLOGI E SEMIOTICI Umberto Eco Diego Marconi Mario Perniola Silvano Petrosino
ESISTENZIALISTI CRISTIANI E POST Giovanni Ferretti Salvatore Natoli Pietro Prini Gianni Vattimo
EPISTEMOLOGI E METODOLOGI Evandro Agazzi Dario Antiseri Giulio Giorello Paolo Rossi
METAFISICI E TEORETICI Carlo Arata Massimo Donà Michele Lenoci Emanuele Severino
STORICI, ETERNISTI E ASTORICI Enrico Berti Alessandro Ghisalberti Giulio d’Onofrio Giovanni Reale
PERSONALISTI E ALTEROLOGI Luigi Alici Vittorio Possenti Paola Ricci Sindoni Armando Rigobello
TECNOLOGI ED ETICOPOLITICI Roberto Esposito Adriano Fabris Salvatore Veca Carmelo Vigna
ETICOGIURIDICI E TRASCENDENTALI Francesco Botturi Francesco D’Agostino Vittorio Mathieu Virgilio Melchiorre
TRAGICISTI ED ESTETOLOGI Remo Bodei Sergio Givone Giuseppe Riconda Stefano Zecchi
ESCATOLOGISTI E TEOLOGI Massimo Cacciari Piero Coda Bruno Forte Vincenzo Vitiello
APOCALITTICI E APOFATICI Giorgio Agamben Vito Mancuso Giacomo Marramao Manlio Sgalambro
SENTIMENTALISTI E FENOMENOLOGI Angela Ales Bello Laura Boella Roberta De Monticelli Roberto Mancini
COPISTI E TUTTOLOGI Ermanno Bencivenga Luciano De Crescenzo Maurizio Ferraris Umberto Galimberti
- "DIARIO MINIMO" (Eco, 1963) DELLA "FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO"(Hegel, 1807): «Mike Bongiorno convince dunque il pubblico, con un esempio vivente e trionfante, del valore della mediocrità. Non provoca complessi di inferiorità pur offrendosi come idolo, e il pubblico lo ripaga, grato, amandolo. Egli rappresenta un ideale che nessuno deve sforzarsi di raggiungere perché chiunque si trova già al suo livello. Nessuna religione è mai stata così indulgente coi suoi fedeli. In lui si annulla la tensione tra essere e dover essere. Egli dice ai suoi adoratori: voi siete Dio, restate immoti.» (Umberto Eco, "Fenomenologia di Mike Bongiorno", 1961).
LA FEDE ITALIANA E LA "COMPAGNIA DELLA CHARITA’ dei cortigiani"! Sul tema, cfr. Adriano Prosperi, "Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari", Einaudi, Torino, 1996, tutto il "Capitolo primo. La fede italiana", pp. 16-34.
- AL DI LA’ DELLA LEZIONE DI PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- PIANETA TERRA TRAGEDIA E APOLLO 11. Il "nodo di Ercole", il rapporto caverna-Socrate, ancora non sciolto. Con Neil Armstrong e Buzz Aldrin "abbiamo" messo piede sulla Luna, ma sulla Terra "le regole del gioco" sono quelle di una "polis" edipica cosmoteandrica-mente organizzata.
- "Nuove battaglie. Dopo che Buddha fu morto, si continuò per secoli ad additare la sua ombra in una caverna - un’immensa orribile ombra. Dio è morto: ma stando alla natura degli uomini, ci saranno forse ancora per millenni caverne nelle quali si additerà la sua ombra. - E noi - noi dobbiamo vincere anche la sua ombra!" (F. Nietzsche, "La Gaia Scienza", L. III, fr. 108).
- AL DI LA’ DELLA LEZIONE DI PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).
- LA "RICAPITOLAZIONE" DI SAN PAOLO, ANTROPOLOGICAMENTE, ZOPPA E CIECA, A MISURA DEL FIGLIO PRIMOGENITO (MAGGIORASCATO):"[...] tutto il mondo, soggetto alla «vanità» e alla «corruzione» per il peccato di Adamo, attende gemendo la liberazione dal male e «tutta la creazione sarà liberata dalla servitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio». «Primogenito di tutta la creazione», Cristo, facendosi uomo e immolandosi sulla croce, «riunisce e riassume» tutti gli esseri - terrestri e celesti - e li riconcilia al Padre: si attua cosi il «mistero» della redenzione che Dio ha concepito da tutta l’eternità [...]" (cfr. Tullio Gregory, Giovanni Scoto Eriugena: tre studi,Firenze, Le Monnier, 1963: "II. Mediazione e Incarnazione", pp. 34-35 ).
 UNA LEZIONE TEOLOGICO-POLITICA DI BAGET BOZZO SU OGNI PROGETTO DI "RIFONDAZIONE COMUNISTA" FUTURA CHE SI VUOLE COME PARTITO. Avanti o popolo alla riscossa. Il populismo trionferà: "Forza Italia"!!!
UNA LEZIONE TEOLOGICO-POLITICA DI BAGET BOZZO SU OGNI PROGETTO DI "RIFONDAZIONE COMUNISTA" FUTURA CHE SI VUOLE COME PARTITO. Avanti o popolo alla riscossa. Il populismo trionferà: "Forza Italia"!!!
 UN CODICE ETICO PER LA TEOLOGIA.
UN CODICE ETICO PER LA TEOLOGIA.
|
GRECIA - Una sede della "Caritas greca". |
 L’ITALIA DEVASTATA E IL SIGNIFICATO DI "CAMORRA".
L’ITALIA DEVASTATA E IL SIGNIFICATO DI "CAMORRA".
 RIVELAZIONI SUL FILO DELLA PAROLA.
RIVELAZIONI SUL FILO DELLA PAROLA.

- Non basta dire come fanno i francesi che la loro nazione è stata colta alla sprovvista. Non si perdona a una nazione, come non si perdona a una donna, il momento di debolezza in cui il primo avventuriero ha potuto farle violenza. Con queste spiegazioni l’enigma non viene risolto, ma soltanto formulato in modo diverso. Rimane da spiegare come una nazione dì 36 milioni di abitanti abbia potuto essere colta alla sprovvista da tre cavalieri di industria e ridotta in schiavitù senza far resistenza (K. Marx,Il 18 brumaio di Luigi Bonaparte, 1852).
- Trasformismo italiano. Lettera aperta a Luciano Violante (di Giorgio Bocca, "MicroMega" 1/1998)
 UNA LEZIONE TEOLOGICO-POLITICA DI BAGET BOZZO SU OGNI PROGETTO DI "RIFONDAZIONE COMUNISTA" FUTURA CHE SI VUOLE COME PARTITO. Avanti o popolo alla riscossa. Il populismo trionferà: "Forza Italia"!!!
UNA LEZIONE TEOLOGICO-POLITICA DI BAGET BOZZO SU OGNI PROGETTO DI "RIFONDAZIONE COMUNISTA" FUTURA CHE SI VUOLE COME PARTITO. Avanti o popolo alla riscossa. Il populismo trionferà: "Forza Italia"!!!
|
Xanti Schawinsky, Sì, 1934 |
Forum
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- LA LEZIONE DI TEOLOGIA-POLITICA DI SHAKESPEARE: "IL TEMPO FUORI DAI CARDINI" E "LA CASA DEL PADRE" DIVENTATA UNA "PRIGIONE".2 luglio 2024, di Federico La Sala
TEATRO E METATEATRO: "REMEMBER ME" (SHAKESPEARE, "HAMLET", I.5). MEMORIA STORIA LETTERATURA E FILOLOGIA (2 LUGLIO 2024).
- RI-BILANCIA-RE IL "MONDO": "THE TIME IS OUT OF JOINT" ("IL #TEMPO E’ FUORI DAI CARDINI": (SHAKESPEARE, "HAMLET", I.5).
PER AMLETO, LA "CASA DEL PADRE" (IL "RE DEL MONDO", L’ AMORE) CON LE SUE "MOLTE DIMORE" (Gv. 14, 2) E’ DIVENTATA UNA "PRISON" (PRIGIONE):
- "Hamlet: Denmark’s a prison.
 Rosencrantz: Then is the world one.
Rosencrantz: Then is the world one.
 Hamlet: A goodly one, in which there are many large confines, / wards, and dungeons, Denmark being one o’th’worst." (II. 2. 242-245).
Hamlet: A goodly one, in which there are many large confines, / wards, and dungeons, Denmark being one o’th’worst." (II. 2. 242-245).
PSICOANALISI E STORIOGRAFIA. COME IL #LOGOS DEL PRINCIPIO (#ARCHE’) DI #ERACLITO DI EFESO E DELL’APOSTOLO GIOVANNI (Gv. 1.1) DIVENNE UN #LOGO E LE ENCLOSURES (RECINZIONI) SI DIFFUSERO SU TUTTA LA TERRA:
Sigmund Freud, che ha scavato a lungo, e continuò a scavare nei sotterranei della cultura greca, ebraica, e cattolico-romana fino alla morte (Londra, 1939), e conosceva molto bene non solo la "tragedia" di "Edipo Re" (Sofocle), ma anche del principe "Amleto" (Shakespeare), nel 1929, così scrive: "[...] Poi che l’apostolo Paolo ebbe posto l’#amore #universale tra gli uomini a fondamento della sua comunità cristiana, era inevitabile sorgesse l’estrema intolleranza della Cristianità contro coloro che rimanevano al di fuori" (S. Freud, "Disagio della civiltà", 1929).
ARTE E TEOLOGIA. Alla luce del sempre più "brillante" presente storico, forse, è bene tenere conto dell’analisi di Freud, rimeditare sulla hamlet-ica "Mousetrap" (III.2) di Shakespeare, e, al contempo, riflettere sulla enigmatica figura del futuro #padre di Gesù, #Giuseppe ("De domo David"), che prepara una "trappola per #topi" nello straordinario "Trittico di Mérode", dedicato al tema dell’#Annunciazione, di Robert Campin.
Nota:
- ANTROPOLOGIA E #COSMOTEANDRIA: L’IMMAGINARIO DEL CATTOLICESIMO-ROMANO:
- "Duemila anni fa, un ovulo fu miracolosamente fecondato dall’azione soprannaturale di Dio, da questa meravigliosa unione risultò uno zigote con un patrimonio cromosomico proprio. Però in quello zigote stava il Verbo di Dio"(dichiarazione del Cardinale Dario Castrillon Hoyos alla XV conferenza internazionale del Pontificio consiglio, la Repubblica del 17 novembre 2000, p. 35).
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- IL PROBLEMA DELLA IDENTITA’ DI UN’AZIENDA (DI UN PARTITO) DI UNA NAZIONE E LA SUA STRATEGIA ECONOMICO-POLITICA DI COMUNICAZIONE: IL CASO GALBANI, NEL PRIMO NOVECENTO.29 giugno 2024, di Federico La Sala
IL "FORMAGGIO DEL BEL PAESE", LA STORIA D’ ITALIA, E UN "MARCHIO" (LOGO) BREVETTATO: LINGUA, METALINGUA, E #COSTITUZIONE (#LOGOS).
IL PROBLEMA DELLA #IDENTITA’ DI UN’#AZIENDA (DI UN #PARTITO) DI UNA NAZIONE E LA SUA #STRATEGIA ECONOMICO-POLITICA DI #COMUNICAZIONE: IL CASO #GALBANI, NEL PRIMO #NOVECENTO.
- "DE VULGARI ELOQUENTIA". Un omaggio ad Alessandro Masi, per aver richiamato l’attenzione su questo "caso" emblematico della Storia d’#Italia, che getta molta luce sulla "questione della lingua" e sulla #memoria solare di #DanteAlighieri.
GALBANI: "[...] La storia di Bel Paese inizia nel 1906 grazie ad una felice intuizione di Egidio Galbani, fondatore dell’azienda, che volle creare un prodotto capace di contrastare i formaggi d’Oltralpe. La sua #filosofia è ben riassunta da questa frase, riportata sul "Catalogo Illustrato delle Varie Specialità" del 1906: "Non era senza un vero dispiacere che per l’addietro, sostando davanti al negozio dei principali salumieri delle nostre città, non si potesse scorgere alcun formaggio di lusso che portasse un nome italiano. Fui il primo che, dopo lunga esperienza, riuscii a soppiantare l’importazione estera, mettendo in commercio i miei formaggi di lusso, uso Francesi".
 Nasce così il "Formaggio del Bel Paese", nome ispirato al libro dell’abate Antonio #Stoppani "Il #BelPaese", pubblicato nel 1873 e dedicato a una minuziosa descrizione della nostra penisola sotto il profilo geofisico.
Nasce così il "Formaggio del Bel Paese", nome ispirato al libro dell’abate Antonio #Stoppani "Il #BelPaese", pubblicato nel 1873 e dedicato a una minuziosa descrizione della nostra penisola sotto il profilo geofisico.
 Il libro all’inizio del #Novecento conservava intatta la sua fama, da qui l’idea di accoppiare il nuovo prodotto ad un’immagine ormai consolidata nell’#immaginario collettivo e carica di valori simbolici.
Il libro all’inizio del #Novecento conservava intatta la sua fama, da qui l’idea di accoppiare il nuovo prodotto ad un’immagine ormai consolidata nell’#immaginario collettivo e carica di valori simbolici.
 Il "Formaggio del Bel Paese" non fu ispirato da alcun prodotto particolare, com’era stato per altri formaggi Galbani, ma nacque da una ricerca originale: materie prime di alta qualità, facile conservabilità, digeribilità, gusto semplice.
Il "Formaggio del Bel Paese" non fu ispirato da alcun prodotto particolare, com’era stato per altri formaggi Galbani, ma nacque da una ricerca originale: materie prime di alta qualità, facile conservabilità, digeribilità, gusto semplice.
 E a fianco di questa intuizione produttiva, c’è il vero colpo di genio, antesignano del moderno #marketing: la realizzazione di un #packaging originale in un mondo di formaggi venduti sfusi, al taglio, e una #politica #commerciale innovativa, ben sostenuta anche a livello pubblicitario.
E a fianco di questa intuizione produttiva, c’è il vero colpo di genio, antesignano del moderno #marketing: la realizzazione di un #packaging originale in un mondo di formaggi venduti sfusi, al taglio, e una #politica #commerciale innovativa, ben sostenuta anche a livello pubblicitario.
 Il nuovo formaggio intendeva rivolgersi ad un pubblico elitario, ma non localizzato: grazie ai propri camioncini ma soprattutto al progresso della rete ferroviaria, Egidio Galbani voleva conquistare i consumatori più evoluti delle grandi città, in tutta Italia e all’estero, facendo anche leva sui sentimenti nazionalistici degli italiani oltre confine.
Il successo fu immediato (negli anni Trenta uscivano dagli stabilimenti Galbani ben 7500 quintali di Bel Paese) e testimoniato da una serie di riconoscimenti a concorsi internazionali, tra cui uno a Parigi di cui Egidio Galbani era molto fiero: Bel Paese era nominato "Roi des fromages".
Il "grande avversario", il formaggio francese, era stato raggiunto. [...]" (cfr. Galbani, "Storia Bel paese" )
Il nuovo formaggio intendeva rivolgersi ad un pubblico elitario, ma non localizzato: grazie ai propri camioncini ma soprattutto al progresso della rete ferroviaria, Egidio Galbani voleva conquistare i consumatori più evoluti delle grandi città, in tutta Italia e all’estero, facendo anche leva sui sentimenti nazionalistici degli italiani oltre confine.
Il successo fu immediato (negli anni Trenta uscivano dagli stabilimenti Galbani ben 7500 quintali di Bel Paese) e testimoniato da una serie di riconoscimenti a concorsi internazionali, tra cui uno a Parigi di cui Egidio Galbani era molto fiero: Bel Paese era nominato "Roi des fromages".
Il "grande avversario", il formaggio francese, era stato raggiunto. [...]" (cfr. Galbani, "Storia Bel paese" )Nota:
- STORIA E LETTERATURA E #DIVINACOMMEDIA [Purg. XVI, 103-116]: ECONOMIA DELLA #SALUTE (E DELLA #SALVEZZA) E #MEMORIA #COSTITUZIONALE DEI "#DUESOLI" (#DANTE2021).
-
> IL MATERIALE (AGRICOLTURA) E L’IMMAGINARIO (STORIA): CAVOLI E BAMBINI. Una nota in memoria di Juan Amusco de Valverde, Sigmund Freud, e Franca Ongaro Basaglia25 giugno 2024, di Federico La Sala
CAVOLI E BAMBINI: IL MATERIALE (AGRICOLTURA) E L’IMMAGINARIO (STORIA).
UNA QUESTIONE DI #EDUCAZIONECIVICA ED #EDUCAZIONE #ALIMENTARE: APPUNTI DI #ANTROPOLOGIACULTURALE (#COMENASCONOIBAMBINI), #PSICOANALISI (#EDUCAZIONESESSUALE), #PEDAGOGIA #COSTITUZIONALE, ED #ECONOMIA-#POLITICA...*
- Una nota in memoria di Juan Amusco de Valverde, di Sigmund Freud, e di Franca Ongaro Basaglia
"[...] Nel passato, quando i bambini domandavano della loro nascita spesso si narrava della cicogna oppure che i neonati nascono sotto le foglie di questi ortaggi. Nell’Europa centrale, il cavolo (verze, cappucci, cavolfiori, cavolini di Bruxelles) ha rappresentato la principale fonte di vitamine e minerali durante l’inverno. [...]
 Considerato simbolo di fecondità e vita (sono ricchissimi di acido folico che favorisce la fertilità), il cavolo veniva raccolto approssimativamente nove mesi dopo la semina, corrispondendo al periodo di gestazione umana. In quell’epoca, i concepimenti erano prevalentemente legati alla primavera, e le nascite avvenivano nell’autunno successivo.
Considerato simbolo di fecondità e vita (sono ricchissimi di acido folico che favorisce la fertilità), il cavolo veniva raccolto approssimativamente nove mesi dopo la semina, corrispondendo al periodo di gestazione umana. In quell’epoca, i concepimenti erano prevalentemente legati alla primavera, e le nascite avvenivano nell’autunno successivo.
 La spiegazione è chiara: i matrimoni venivano celebrati nei mesi invernali, quando non c’era lavoro nei campi, e la decisione di avere un figlio veniva presa in primavera, poiché solo in quel periodo il contadino poteva valutare se i raccolti dell’anno avrebbero garantito un reddito sufficiente per sostenere la famiglia.
La spiegazione è chiara: i matrimoni venivano celebrati nei mesi invernali, quando non c’era lavoro nei campi, e la decisione di avere un figlio veniva presa in primavera, poiché solo in quel periodo il contadino poteva valutare se i raccolti dell’anno avrebbero garantito un reddito sufficiente per sostenere la famiglia.
 Il compito della piantagione, con l’aiuto di un punteruolo di legno, e della raccolta dei cavoli ricadeva sulle spalle delle donne, chiamate levatrici, un termine associato alle figure che assistevano le donne durante il parto. Le contadine avevano l’incarico di tagliare il “cordone ombelicale” che collegava il cavolo alla terra, da cui nacque la leggenda che i bambini potessero trovarsi sotto ai cavoli."
Il compito della piantagione, con l’aiuto di un punteruolo di legno, e della raccolta dei cavoli ricadeva sulle spalle delle donne, chiamate levatrici, un termine associato alle figure che assistevano le donne durante il parto. Le contadine avevano l’incarico di tagliare il “cordone ombelicale” che collegava il cavolo alla terra, da cui nacque la leggenda che i bambini potessero trovarsi sotto ai cavoli."
 (cfr. SARA GRISSINO, "I BAMBINI NASCONO SOTTO I CAVOLI? PERCHÉ SI RACCONTA...", Giallo Zafferano).
(cfr. SARA GRISSINO, "I BAMBINI NASCONO SOTTO I CAVOLI? PERCHÉ SI RACCONTA...", Giallo Zafferano).- * SUL "COME NASCONO I BAMBINI" (SUL PIANO DELLA #CONOSCENZA "BIBLICA", STORICA E STORIOGRAFICA), mi sia lecito, si cfr.: Federico La Sala, "COME NASCONO I BAMBINI? E COME ‘NASCONO’ I GENITORI?! Una nota introduttiva alla “Istruzione sessuale dei bambini” (1907) di Sigmund #Freud", "il dialogo", 18 luglio 2005.
NOTE:
- LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA IN MEDICINA: ANTROPOLOGIA, ANDROCENTRISMO, E ANATOMIA. L’ammissione di Giovanni Amusco de Valverde, del 1560 (v. allegato) e la straordinaria #lezione di "#Louise #Bourgeois: la donna che portava il suo pene sottobraccio" (di [Francesca Serra - "Doppiozero"-https://www.doppiozero.com/louise-bourgeois-la-donna-che-portava-il-suo-pene-sottobraccio)].
- ARTE. Al via la grande mostra di Louise Bourgeois a Roma, alla Galleria Borghese, 21 Giugno 2024): "[...] Metamorfosi, inconscio, forme biomorfe: la sperimentazione creativa di Louise Bourgeois, che si estende per ben sette decenni, si intreccia fin dagli anni Sessanta con i temi della psicoanalisi e del femminismo, rivoluzionando i paradigmi tradizionali della storia dell’arte del Novecento. Per la prima volta in assoluto la Galleria Borghese di Roma apre le proprie porte a un’artista contemporanea, e lo fa proprio portando nella Capitale la prima mostra della franco-americana, dal 21 giugno al 15 settembre. [...]".
-
>RIVOLUZIONE COPERNICANA (KANT 2024) E SVOLTA ANTROPOLOGICA. «L’astronomo sa se la luna sia abitata o no, all’incirca con la stessa sicurezza con cui sa chi sia stato suo padre, ma con ben altra sicurezza sa invece chi è sua madre» (G. C. Lichtenberg, 1742 - 1799)..16 giugno 2024, di Federico La Sala
COSMOLOGIA E DISAGIO DELLA CIVILTA’: COME NASCONO I BAMBINI? E COME ‘NASCONO’ I GENITORI?! *
 Con Dante, Michelangelo e Shakespeare, una nota a margine della questione antropologica (e cristologica).
Con Dante, Michelangelo e Shakespeare, una nota a margine della questione antropologica (e cristologica).- Un omaggio alla memoria di Mario #Lavagetto.
FREUD (CON SHAKESPEARE), A LONDRA. Contrariamente a quanto si pensa, la lunga ricerca di #Freud, se può apparire (come è apparso per lo più fino ad ora) segnata dalla figura di #Edipo e #Giocasta, dall’altra è molto prossima a quella di #Amleto (#Hamlet), dalla volontà e dal progetto di chiarirsi le idee su di sé, e di suo Padre - di chi è veramente #Figlio: la sua opera, una vera e propria "trappola per topi" ("The #Mousetrap"). Egli, in verità, è andato (come si sa) a "scuola" da Shakespeare, e il problema della sua vita è come quello di Shakespeare, contribuire a sciogliere il #nodo di #Ercole, il nodo della nevrosi ossessiva non solo del caso dell’#uomo dei #topi" (1909), ma "della civiltà" e "nella civiltà" e contrastare il dilagare alluvionale del "marcio nello stato di Danimarca":
RIVOLUZIONE COPERNICANA (KANT2024). Sigmund Freud: "Lichtenberg [1742-1799] osserva: «L’astronomo sa se la luna sia abitata o no, all’incirca con la stessa sicurezza con cui sa chi sia stato suo padre, ma con ben altra sicurezza sa invece chi è sua madre». Un gran progresso della civiltà si compì il giorno in cui l’uomo decise di avvalersi, accanto alla testimonianza dei sensi, della deduzione logica e di passare dal matriarcato al patriarcato. Le figure preistoriche in cui si vede una piccola forma umana seduta sul capo di un’altra più grande rappresentano appunto la discendenza dal padre, Atena senza madre scaturisce dal capo di Giove. Ancor oggi, in tedesco, il testimone che attesta qualcosa davanti a una corte giudicante si chiama #Zeuge [«testimone», letteralmente «generatore»], per la parte che ha il maschio nell’atto di procreazione; già nei geroglifici troviamo rappresentato il testimone con l’immagine dei genitali maschili." (cfr. S. Freud, "Racconti analitici, a cura di Mario Lavagetto, Einaudi 2011).
* Sul tema, cfr. Federico La Sala, "Cosa succede in casa - nella “camera nuziale”, e cosa succede in Parlamento - nella “camera reale”?! Una nota introduttiva alla “Istruzione sessuale dei bambini” (1907) di Sigmund Freud..
NOTE:
- SHAKESPEARE, GERTRUDE ("DE NIVELLES), E FREUD: TEATRO E ANTROPOLOGIA FILOSOFICA.
- LO SPIRITO ("GHOST) DI RE - PADRE AMLETO ("RICORDATI DI ME", I.5) E LA TRAPPOLA PER #TOPI DEL PRINCIPE - FIGLIO AMLETO ("THE #MOUSETRAP", III.2): UNA LEZIONE DI STORIA DELL’ARTE (DEL 1427) SULLA "MOUSETRAP" E SULLA QUESTIONE ANTROPOLOGICA (E CRISTOLOGICA) DEL PITTORE FIAMMINGO ROBERT CAMPIN.
- "LA PAROLA CONTAMINATA" E LA "CRITICA DELLA RAGION PURA": CON KANT, FREUD, MUSATTI, E FACHINELLI, UN OMAGGIO ALL’ UOMO COL #MAGNETOFONO (J.-J. ABRAHAMS), UNA GENIALE E HAMLETICA "TRAPPOLA PER #TOPI".
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- IL DIO "VERTUMNO", IL "CORPO MISTICO" DELL’IMPERATORE "GIARDINIERE", E LA LA LUNGA ONDA DEL RINASCIMENTO.10 giugno 2024, di Federico La Sala
IL DIO "VERTUMNO", IL "CORPO MISTICO" DELL’IMPERATORE "GIARDINIERE". LA LUNGA ONDA DEL RINASCIMENTO E IL SOGNO DELLA TEOLOGIA-POLITICA DI RODOLFO ii D’ASBURGO. Appunti sul tema:
A) - "LA CITTA’ DEL SOLE" (TOMMASO CAMPANELLA) E L’IDEA DEL "PARADISO TERRESTRE" DELLA "MONARCHIA" (DANTE ALIGHIERI) : "[...] La curiosità per il pomodoro e le altre piante in arrivo dal Nuovo Mondo è evidente nel fantasioso, emblematico, spiritoso e ormai famoso ritratto che Giuseppe Arcimboldo fece all’imperatore Rodolfo II. In questo quadro, dipinto nel 1560, Arcimboldo ritrae l’imperatore nei panni di Vertumno, il dio romano dell’abbondanza e dell’alternanza delle stagioni. Le opere di Rodolfo vengono rappresentate sotto forma di frutti maturi, fiori e ortaggi. Il labbro inferiore dell’imperatore è formato da due pomodorini a ciliegia. Un’altra pianta nuova, il mais, forma l’orecchio e due peperoncini rossi adornano il suo mantello. Rodolfo aveva ereditato un vastissimo giardino dal nonno, Ferdinando I. Di quel terreno, che doveva essere un «teatro del mondo», un’enciclopedia vivente di alberi e piante, era stato fatto un giardino all’italiana per opera di un grandissimo esperto, Mattioli, che l’aveva anche curato. Rodolfo condivideva con il nonno la fascinazione per la natura, la scienza e la magia. Aveva una raccolta di «curiosità» provenienti da tutto il mondo conosciuto, famosa per la sua varietà e il suo valore. Il milanese Arcimboldo era stato il «ritrattista di corte» di suo padre e di suo nonno, anche se il ruolo che occupava effettivamente andava ben oltre l’incarico ufficiale. Rodolfo si affidava ad Arcimboldo come suo agente, e negli anni Ottanta l’aveva mandato in Germania a caccia di opere d’arte e di oggetti rari. Quindi, non c’è da sorprendersi se Arcimboldo ha inserito dei prodotti del Nuovo Mondo nel suo fantasioso ritratto. Quest’opera è simile alle varie serie delle Quattro stagioni che Arcimboldo aveva iniziato a dipingere quasi tre decenni prima. Ma facendo maturare tutti i frutti, i fiori e gli ortaggi insieme, Arcimboldo ci presenta un’allegoria del potere imperiale, ricordandoci le pretese di dominio globale di Rodolfo, oltre a prospettare il ritorno di una «età dell’oro» sotto il suo governo. "(DAVID GENTILCORE, "LA PURPUREA MERAVIGLIA. Storia del pomodoro in Italia", Garzanti, 2010, pp. 36-37).
B) - RODOLFO II, ARCIMBOLDO, E IL DIO "VERTUMNO": "[...] Giuseppe Arcimboldi o Arcimboldo ( 1526-1593 ). Figlio del pittore Biagio che era stato in contatto con Bernardino Luini e quindi con la scuola di Leonardo, lavorò all’inizio con il padre in opere decorative come pannelli d’organo, vetrate, cartoni per arazzi, Dopo essersi fatto conoscere ed apprezzare si trasferì alla corte di Praga al servizio del principe Massimiliano divenendo artista ufficiale di corte. Dopo aver realizzato composizioni antropomorfe con frutti e vegetali che ebbero subito grande successo ( le Quattro stagioni dal 1563 al 1577 ) , lasciò la corte imperiale del principe Rodolfo a cui prestava servizio dopo la morte di Massimiliano, per tornare nel 1587 a Milano dove si stabilì definitivamente. Qui dipinse il Ritratto dell’imperatore in veste di Vertunno databile intorno al 1589-90. Le composizioni di Arcimboldo erano definite al suo tempo illusionistiche ed erano costituite, se così possiamo dire, da figure umane con un insieme di prodotti di mercato e cucina: il personaggio raffigurato era composto dall’insieme degli elementi naturali che costituivano il suo mestiere, così, per esempio, un ritratto di cuoco, era formato dai cibi collocati dalla testa ai piedi. Un aspetto delle figure "illusionistiche" comico-grottesche di Arcimboldo è la reversibilità nel senso che possono essere viste sia in forma antropomorfa che, rovesciate, in forma vegetale pur essendo composte, entrambe, degli stessi elementi naturali.
Dovendo omaggiare l’imperatore Rodolfo II d’Asburgo, pensò di creare, nel 1590, un proteiforme ritratto frontale a mezzo busto in cui appariva come il dio Vertumno, dio delle stagioni, formato dalla straordinaria giustapposizione di frutti, ortaggi e fiori. Si trattava del punto di arrivo delle sue opere destinate alle stagioni che qui si riassumevano in un insieme delle quattro, ricche di tutti i prodotti della terra. L’opera naturalmente era elogiativa, voleva essere un’esaltazione dell’abbondanza che sotto il regno di Rodolfo si godeva in tutte le stagioni dell’anno, come in una nuova età dell’oro. L’ammasso ordinato e composito dei frutti, ortaggi e fiori non sminuiva l’impatto che doveva fornire l’imperatore: l’impressione di vigore fisico e potenza politica, né ne sviava l’interpretazione accentuando il senso del grottesco o del comico, ma invece ne forniva una vera e propria potenza figurativa che dava proprio quell’idea di floridezza e abbondanza che un sapiente e regolato governo sapeva dare. [...]" (cfr. Giangiacomo Scocchera, "La Sindrome di Stendhal Due": Il primo tempo: Musici, fioriere e fruttiere...).
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- MENSCHWERDUNG (INCARNAZIONE) E FILOLOGIA. UNA IPOTESI DI CHIARIMENTO A MARGINE DEI "SOGNI DI UN VISIONARIO CHARITI CON I SOGNI DELLA METAFISICA"..3 giugno 2024, di Federico La Sala
QUALE "NESSO"* TRA IL MITO E LA STORIA DELL’EUROPA? UNA IPOTESI DI CHIARIMENTO A MARGINE DEI "SOGNI DI UN VISIONARIO CHARITI CON I SOGNI DELLA METAFISICA".
- Tracce per una svolta antropologica. A onore e in memoria di Immanuel Kant...
DEL #PIANETATERRA E DEL SUO BRILLANTECOLORE: IL #CORPOMISTICO DELL’#ANDROCENTRISMO TEOLOGICO-POLITICO DI PLATONE E COSTANTINO (#NICEA 325-2025) BLOCCA DA MILLENNI LA #NAVIGAZIONE NELL’#OCEANOCELESTE (#KEPLERO, 1611) DEL #GALILEO #GALILEI "CHE HA VINTO" SIA SUL PIANO CELESTE SIA SUL PIANO TERRESTRE E, ancora oggi (#2giugno2024) RENDE DIFFICILE CAPIRE UN’ #ACCA E PORTARSI FUORI DALL’ORIZZONTE DI #MAMMONA ("CARITAS").
"COME NASCONO I BAMBINI": INCARNAZIONE (#MENSCHWERDUNG), ANTROPOLOGIA, E #FILOLOGIA. Riprendendo il filo della "#Charitas" di #GioacchinodaFiore e #DanteAlighieri, forse, è meglio uscire dal "letargo" (Par. XXXIII, 94), e con il #Boehme della "De incarnatione Verbi" riflettere sulla "Charis" (gr. #Xapis") e sul Cristogramma.
NOTA: IL "TRATTATO" DEL "MASTRILLO" (#MAASTRICT), E LA "DIRITTA VIA" (DANTE ALIGHIERI). L’amicizia e l’amore della parola sono decisivi e fondamentali: senza filologia non si va da nessuna parte e non si comprende più il #nesso tra il #prima e il #dopo, si dimentica che "in #principio era il #Logos", e tutti gli erculei esseri umana finiscono per indossare le camicie con il "logo" di #NESSunO.
- STORIA E MEMORIA D’#EUROPA: MAASTRICHT. "[...]All’origine della città vi fu la costruzione di una fortificazione romana (castellum) nel 333 d.C. San Servazio, vescovo di Tongeren e Maastricht, morì nel 384 e fu tumulato in Maastricht. Accanto a lui c’è il sepolcro dell’ultimo re carolingio, Carlo I, duca della bassa Lorena (Lotaringia). Successivamente, verso la metà del VI secolo, la sede di diocesi di Tongres fu trasferita a Maastricht. Agli inizi dell’VIII secolo, Uberto di Liegi spostò la sede a Liegi, la città dove aveva subito il martirio il suo predecessore, San Lamberto di Maastricht.
 Durante il Medioevo Maastricht era già una città importante nei Paesi Bassi, governata in condominio dai Duchi di Brabante e dai Principi-vescovi di Liegi in quella che veniva chiamata Doppia Signoria di Maastricht. Il 29 giugno 1579 la città di Maastricht fu conquistata da Alessandro Farnese, al servizio della Spagna. Circa cinquant’anni più tardi, nel 1632, in seguito a nuovo assedio, la città passò sotto il controllo della Repubblica delle Sette Province Unite. Nel 1673 la città fu occupata dalle armate di Luigi XIV di Francia, venendo poi restituita agli olandesi con il Trattato di Nimega del 1678. Durante l’assedio di Maastricht, Charles de Batz de Castelmore d’Artagnan, comandante della compagnia di Moschettieri della Guardia chiamati "Moschettieri grigi", morì a Maastricht. [...]".
Durante il Medioevo Maastricht era già una città importante nei Paesi Bassi, governata in condominio dai Duchi di Brabante e dai Principi-vescovi di Liegi in quella che veniva chiamata Doppia Signoria di Maastricht. Il 29 giugno 1579 la città di Maastricht fu conquistata da Alessandro Farnese, al servizio della Spagna. Circa cinquant’anni più tardi, nel 1632, in seguito a nuovo assedio, la città passò sotto il controllo della Repubblica delle Sette Province Unite. Nel 1673 la città fu occupata dalle armate di Luigi XIV di Francia, venendo poi restituita agli olandesi con il Trattato di Nimega del 1678. Durante l’assedio di Maastricht, Charles de Batz de Castelmore d’Artagnan, comandante della compagnia di Moschettieri della Guardia chiamati "Moschettieri grigi", morì a Maastricht. [...]".
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- STORIA E LETTERATURA.Per ben interpretare la "Divina Commedia", rileggere i "Tre Moschettieri" (con Beniamino Placido, 1994).1 giugno 2024, di Federico La Sala
DIVINA COMMEDIA E LETTERATURA. Rileggere i "Tre Moschettieri" con Beniamino Placido (1994)... per imparare a ben distinguere il "giglio" di "Milady" dal giglio della Firenze e di (Maria) Beatrice (di Dante Alighieri). *
IL GIGLIO DI MILADY
di Beniamino Placido ["la Repubblica", 8 settembre 1994] **
Ci sono delle buone ragioni per rileggere, d’ estate, I tre moschettieri? Certo che ce ne sono. Tanto per cominciare, non è poi mica così sicuro che l’ abbiamo veramente mai letto (e quindi tantomeno riletto). Non è improbabile che la nostra prima, appassionata ma approssimativa, conoscenza di quei personaggi sia avvenuta per merito (e demerito insieme) di qualche edizione per ragazzi. Dove la traduzione era abborracciata, la vicenda raccorciata, i nomi scarabocchiati male. Non è improbabile che tutto quel che sappiamo di Athos, Porthos, Aramis e d’ Artagnan, sia dovuto al cinema (il film di George Sidney e Gene Kelly, il film di Richard Lester) piuttosto che al romanzo di Dumas.
Il quale romanzo (seconda ragione per affrontarlo) fu pubblicato a puntate su Le Siècle giusto centocinquant’ anni fa: fra l’ undici marzo e l’ undici luglio del 1844. Abbiamo celebrato, ed onorato di scritti commemorativi, tanti anniversari letterari. Sembra giusto celebrare anche questo.
Tanto più (terza ragione) che di buona letteratura si tratta. Si dà il caso che l’ Editore Adelphi abbia ripubblicato quest’ anno La Poesia di Benedetto Croce. Dandoci modo di rileggere il giudizio che il severo, austero don Benedetto ebbe ad esprimere in proposito: "Da parte mia, non provo il rossore di cui altri sentirebbe inondato il volto nel dire che mi piacciono e giudico condotti con grande brio e spigliatezza i Trois mousquetaires di Alessandro Dumas padre. Ancora molti li leggono e li godono senza nessun’ offesa della poesia, ma nascondendo in seno il loro compiacimento come si fa per gli illeciti diletti, ed è bene incoraggiarli a deporre la loro falsa vergogna e il loro congiunto imbarazzo".
La quarta, la quinta, la sesta, l’ ennesima ragione (ci sono anche quelle) aspettano il loro turno, se mai verrà. Ma una ragione addizionale, e tuttavia fondamentale, per una lettura-rilettura estiva va esplicitata subito. Quest’ estate è stata molto calda. Insopportabilmente calda. Informatevene da chi è rimasto in città, voi che eravate invece ai monti o al mare: ve lo confermeranno.
Quando il termometro sfiora i quaranta gradi ci si fa furbi, bisogna pur sopravvivere. Si trova subito una scusa per mettere da parte i faticosi studi progettati, le serissime letture programmate in gennaio, e raccontare a se stessi: sai che ti dico? Adesso mi leggo o rileggo I tre moschettieri. Anche Benedetto Croce me ne dà il permesso.
Così ho fatto. L’ ho affrontato in una ottima edizione francese - peraltro anche economica, anche maneggevole - della "Pocket" (Parigi, 1993) dotata di tutto. Note, contronote, tavole cronologiche, indice dei luoghi, dei nomi, dei personaggi storici. Dossier fotografico e documentario.
Perché in francese? Intanto, per continuare a tentare di imparare quella lingua. In modo da essere in grado di chiedere senza arrossire: "Che cos’ è questo palazzo?" ("Qu’ est-ce que c’ est que cet édifice?") la prossima volta, a Parigi. E poi lo so per esperienza, che c’ è sempre un premio per chi si sobbarca alla fatica di leggere un libro nell’ originale. Per ricompensarti l’ autore - lusingato - ti offre una, due cose in più da capire.
Per esempio. Tutti lo sappiamo che al centro di questo romanzo ci sono loro quattro, i tre moschettieri Athos, Porthos, Aramis, più d’ Artagnan. E il Re Luigi XIII, quel Re fatuacchione, perennemente annoiato (grazie, non faceva niente tutto il giorno); e il Cardinale Richelieu; e la Regina Anna (fedele? infedele?); e il Duca di Buckingham; ed altre persone ancora.
Ma sappiamo che c’ è soprattutto lei, Milady. La seconda parte del romanzo ne è totalmente dominata. Lei l’ angelica (in apparenza) la perfida, la dolce, la seducente, la spietata, la crudele Milady. Degnamente interpretata da Lana Turner nel film di Sidney e Kelly, che è del 1948. Degnamente interpretata da Faye Dunaway nel film di Richard Lester, che è del 1975.
E’ lei che cerca di far morire tutti (quasi tutti) i personaggi maschili e femminili che le capitano fra le mani - dopo averli variamente sedotti - e quasi sempre ci riesce. E pensare che basta guardarle - con la dovuta ammirazione - le bellissime spalle per capire chi veramente è. Sulla spalla sinistra lei porta impresso a fuoco il marchio del disonore, il giglio di Francia. Che la qualifica - malgrado il fascino, le moine, le lusinghe - come una volgare delinquente.
Così per seicento e passa pagine. Finalmente, al capitolo sessantacinquesimo, quello che comincia con la frase proverbiale, celeberrima: "Era una notte buia e tempestosa" ("C’ était une nuit orageuse et sombre") eccola lì smascherata - finalmente! - e condannata, che sta per essere giustiziata sulle rive della Lys.
Ciò che a un italiano non dice niente. Si trattasse delle rive della Senna, sarebbe per noi assolutamente la stessa cosa.
Ma per un lettore francese, per un lettore del testo originale, in francese, no. Non è la stessa cosa. Perché in francese giglio si dice "lis" (scritto a volte anche "lys"). E questo suggerisce una corrispondenza che sa di contrappasso. Tu, marchiata dal giglio ("lis" o "lys") di Francia sulle rive della Lys dovrai morire, brutta mascalzona.
Corrispondenza rafforzata da alte ricorrenze foniche. Il boia incaricato dell’ esecuzione è il boia di Lilla. Il paese che deve attraversare per raggiungere il luogo dell’ esecuzione si chiama Lillers. E poi c’ è tutto un gioco sottilissimo organizzato intorno al verbo "flétrir" ("far appassire" e insieme "macchiare"); intorno al sostantivo "flétrissure" ("appassimento, avvizzimento", e insieme "marchio d’ infamia").
Come a dire: un giglio, tu? Ma tu sarai tutt’ al più un giglio avvizzito, appassito, maleodorante. Il tuo destino è quello di decomporti adesso, sulle rive della Lys. Un destino che è però anche una resa dei conti, una vendetta. Tutti i personaggi del romanzo, e insieme a loro tutti i lettori del medesimo, si vendicano della perfida donna che li ha tanto sedotti. Tanto insidiati. Che ha fatto morire l’ adorabile Constanza Bonacieux, fidanzata di d’ Artagnan. Che ha tentato di far fuori anche d’ Artagnan. Che ci ha - confessiamolo - sedotti e abbandonati (quando non ammazzati): tutti.
Dove si vede che Alessandro Dumas padre è qualcosa di più del romanziere divertente, spregiudicato (e superficiale?) presentato con benevolenza da Benedetto Croce. Non possiede brio e spigliatezza soltanto. Sa anche giocare con corrispondenze ed assonanze significative, in modo raffinato.
Di più: sa giocare - come nessun altro prima, nessun altro prima di lui - con un tema esplosivo, il tema della vendetta. Lo si vede ne Il Conte di Montecristo, scritto nello stesso periodo. Lo si vede ne I tre moschettieri. Di recente lo scrittore Sebastiano Vassalli ha sostenuto proprio su queste pagine (la Repubblica, 27 luglio 1994) che "Odio ergo sum". Che finché ci sarà odio, in questo mondo, ci sarà il romanzo. L’ odio soltanto? E’ sicuro che basti? Non ci vuole anche - per scrivere un romanzo o per raggiungere, da lettore, la pace dei sentimenti leggendolo - anche un certo appagamento dell’ odio, nella forma di una bella vendetta?
Il romanzo I tre moschettieri è una serie ininterrotta di vendette, dal principio alla fine. C’ è una vendetta ad ogni pagina. Ogni tanto, una esaltazione tutta esplicita della vendetta, definita qualche volta come "le plaisir des dieux", il piacere degli Dei. Addirittura.
Il piacere della vendetta - che alberghiamo dentro, evidentemente - è così intenso da consentire ad Alessandro Dumas un clamoroso colpo di mano, un gioco di prestigio spericolato: ai nostri danni. C’ è un momento, un momento cruciale del racconto in cui ci prende in giro, ci mena per il naso. Spudoratamente.
Ho cominciato a sospettarlo verso la fine. Quando più insistente si faceva la pressione del romanziere sul tema del giglio di Francia e sul gioco di parole fra "lis" e "Lys". Dev’ essere stato il caldo, che rende insofferenti e sospettosi. Dev’ essere stata l’ euforia estiva, che ti mette in testa l’ idea di un incontro sorprendente. Nel mio caso l’ idea di un incontro filologicamente sorprendente con un "luogo" testuale trascurato da altri. Che nessuno si spaventi. Si tratta di filologia estiva, stagionale. E provvisoria, come ho doverosamente avvertito nel precedente articolo dedicato alla biblica storia di Giuseppe (la Repubblica, 1 settembre 1994).
Ma tornate con me a metà del romanzo, al capitolo ventisettesimo. Ecco la svolta. Athos racconta a d’ Artagnan la storia tragica della sua vita. Non è mica nato moschettiere, lui. Lui era un gran nobile un tempo. Era il conte de La Fère. Un giorno nel villaggio che le sue proprietà dominavano si affacciò una fanciulla. Capelli biondi, occhi azzurri, ciglia e sopracciglia nere. Bellissima. Un angelo.
Tu mi capisci d’ Artagnan, avrei potuto averla senza sposarla, ero il signore del luogo; ma me ne innamorai perdutamente, volli sposarla. Quand’ ecco che una mattina, andando a caccia, lei cadde da cavallo e svenne. Corsi a soccorrerla, e siccome la vedevo in affanno le lacerai le vesti con la punta del pugnale, le scoprii una spalla e cosa mi apparve? Mi apparve, impresso sulla di lei spalla il marchio del disonore: il giglio di Francia. Quell’ angelo era un demonio; tu mi capisci, d’ Artagnan.
Stropicciatevi pure gli occhi. Rileggete ancora una volta, se lo ritenete necessario. Ma è proprio così. Dumas vuol darci ad intendere, per i suoi biechi interessi narrativi, che quel marito di nome Athos aveva bisogno dell’ incidente di caccia, della caduta da cavallo, della conseguente difficoltà respiratoria della moglie per guardarle - finalmente - le spalle e scoprire che cosa c’ era stampato sopra. E prima, non aveva avuto nessuna occasione di guardarle, di ammirarle (non oso dire: di toccarle) quelle spalle?
Da quel momento in poi è stata un’ estate di fuoco, nel vero senso del termine. Ho preso a tenzonare con i miei amici francesisti, ne conosco di giovani e bravissimi: e dunque, mi sapete spiegare come mai nessun lettore se ne accorge, se n’ è accorto? Siccome questi accalorati seminari di filologia si svolgevano generalmente intorno ad un tavolo di pizzeria, la sera, vi venivano implicate anche le mogli dei francesisti suddetti.
Che pudicamente suggerivano: forse a quel tempo le donne non si presentavano mai completamente svestite, nemmeno ai mariti. Specie le spalle, le coprivano sempre. E promettevano di interpellare - col dovuto tatto - le loro mamme, le nonne, le bisnonne, le trisavole. Le quali mandavano a dire, dopo qualche giorno, che ai loro tempi effettivamente era tutta un’ altra cosa, tutto un altro senso del pudore.
Suvvia, nonne bisnonne trisavole: nemmeno voi ce la contate giusta. E quando andava a ballare, Milady, anche lì con le spalle rigorosamente coperte? E quando faceva il bagno (ne avrà fatto qualcuno) sotto l’ occhio vigile della "femme de chambre" (o cameriera), e quando si vestiva con l’ aiuto della "femme de charge" (o guardarobiera) e quando si svestiva in compagnia della "suivante" (o dama di compagnia, confidente) e quando si faceva pettinare i lunghi capelli biondi dalla "coiffeuse" (o pettinatrice) nessuno, nessuna se ne accorgeva di quel marchio di infamia sulla spalla? Oltretutto, se il Re di Francia gliel’ aveva fatto imprimere addosso era perché facilmente si vedesse, e denunciasse la portatrice: com’ è che è così facile nasconderlo?
Credo che Alessandro Dumas lo sapesse, di avere la coda di paglia. Difatti in un capitolo successivo, il trentottesimo, prova a mettere le mani avanti. Quel fiore di giglio era - chissà, forse - quasi cancellato ("comme effacée") dagli strati di pomata ("les couches de pate") che Milady ci applicava sopra. Quasi cancellato, non proprio del tutto...
Niente da fare. A noi non la si fa, quando leggiamo i libri nell’ atmosfera irritata, sospettosa dell’ estate. Niente da fare. Al centro nevralgico de I tre moschettieri c’ è un vistoso buco logico, un sostanzioso ammanco di verosimiglianza narrativa.
Perché non ce ne accorgiamo? Perché non vogliamo accorgercene. Perché siamo troppo interessati alla storia, vogliamo che continui, malgrado tutto. Vogliamo goderci tutte le perfidie, tutte le diaboliche seduzioni di Milady, fingendo di detestarle. Vogliamo subito dopo, ma non tanto presto, liberarcene. Condannarla alla decapitazione sulle rive di quel fiume ("Lys") che porta il nome del giglio di Francia ("lis") stampato sulla sua sinistra spalla.
L’ autore lo sa. Ci conosce benissimo. "Hypocrite lecteur!" ci dice. So di poterti portare dove voglio, sfruttando le tue viltà, le tue debolezze. Per concludere, e per quanto mi riguarda: con queste letture, accompagnate da filologici sospetti, è stata una bella estate, malgrado tutto. Adesso mi propongo di continuare ad essere un lettore sospettoso anche d’ inverno. Se proprio è necessario, mi aiuterò alzando al massimo il riscaldamento di casa.
**
- ARCHIVIO "LA REPUBBLICA": BENIAMINO PLACIDO 08 settembre 1994
*
- A Victor Hugo, ad Alexandre Dumas e a Dante Alighieri, in memoria...
ANTROPOLOGIA FILOLOGIA E PEDAGOGIA: "SAPERE AUDE!" (ORAZIO-KANT). Ripartire dalla Costituzione e dalle lezioni delle 21 "Moschettrici" dell’Assemblea Costituente: "Avere il coraggio di dire ai nostri giovani che sono tutti sovrani" (don Lorenzo Milani).
FILOLOGIA STORIOGRAFIA, E "VITA NUOVA": USCIRE DALL’INFERNO.
 Premesso che la “donna mia” di “Tanto gentile” vale “signora” (del cuore)”, come è possibile continuare a pensare, oggi, anche dopo i maestri del sospetto (Marx, Nietzsche, e Freud), che Dante ami Beatrice, tradisca Gemma Donati, i figli, e la figlia Antonia, suor Beatrice?
Premesso che la “donna mia” di “Tanto gentile” vale “signora” (del cuore)”, come è possibile continuare a pensare, oggi, anche dopo i maestri del sospetto (Marx, Nietzsche, e Freud), che Dante ami Beatrice, tradisca Gemma Donati, i figli, e la figlia Antonia, suor Beatrice?
 Sul tema, si cfr. L’Arca dell’ Alleanza del Logos e il codice di Melchisedech. La Fenomenologia dello Spirito... dei “Due Soli”.Ipotesi di rilettura della “Divina Commedia”.
Sul tema, si cfr. L’Arca dell’ Alleanza del Logos e il codice di Melchisedech. La Fenomenologia dello Spirito... dei “Due Soli”.Ipotesi di rilettura della “Divina Commedia”. -
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI --- IL MOTTO DEI MOSCHETTIERI: "UNO PER TUTTI, TUTTI PER UNO"), L’ANTROPOLOGIA-POLITICA E LA COSTITUZIONE30 maggio 2024, di Federico La Sala
IL "CORPO MISTICO" (IL MOTTO DEI MOSCHETTIERI: "UNO PER TUTTI, TUTTI PER UNO"), L’ANTROPOLOGIA-POLITICA E LA COSTITUZIONE (L’ISOLA DEL "CONTE DI MONTECRISTO").
- "UT UNUM SINT": LA FILOSOFIA E LA FILOLOGIA AL SERVIZIO DEI "PARTITI-NAZIONI" O DELL’ITALIA, DELL’EUROPA E DEL PIANETATERRA (DELL’ UmaNiTA’, DELL’ONU)?!
"ORIENTARSI NEL PENSIERO" (#KANT2024). Una "vecchia" nota in memoria di Alexandre Dumas, e, delle 21 "Moschettrici" (le Donne, le "Madri della Costituzione" della Repubblica Italiana):
- "[...] La Costituzione è - ripetiamo: come ha detto e testimoniato con il lavoro di tutto il suo settennato il nostro Presidente, Carlo A. Ciampi - la nostra “Bibbia civile”, la Legge e il Patto di Alleanza dei nostri ’Padri’ e delle nostre ’Madri’ Costituenti (21 cittadine-sovrane presero parte ai lavori dell’Assemlea), e non la ’Legge’ di “mammasantissima” e del “grande fratello” ... che si spaccia per eterno Padre nostro e Sposo della Madre nostra: quale cecità e quanta zoppìa nella testa e nel cuore, e quale offesa nei confronti della nostra Legge dei nostri ’Padri’ e delle nostre ’Madri’- di tutti e tutte noi, e anche dei nostri cari italiani cattolici e delle nostre care italiane cattoliche!!!
- Nel 60° Anniversario della nascita della Repubblica italiana, e della Assemblea dei nostri ’Padri e delle nostre ’Madri’ Costituenti, tutti i cittadini e tutte le cittadine di Italia non possono che essere memori, riconoscenti, e orgogliosi e orgogliose di essere cittadine italiane e cittadini italiani, e festeggiare con milioni di voci e con milioni di colori la Repubblica e la Costituzione di Italia, e cercare con tutto il loro cuore, con tutto il loro corpo, e con tutto il loro spirito, di agire in modo che sia per loro stessi e stesse sia per i loro figli e le loro figlie ... l’ “avvenire” sia più bello, degno di esseri umani liberi, giusti, e pacifici! Che l’Amore dei nostri ’Padri’ e delle nostre ’Madri’ illumini sempre il cammino di tutti gli italiani e di tutte le italiane... [...]" ("25 GIUGNO: SALVIAMO LA COSTITUZIONE E LA REPUBBLICA CHE E’ IN NOI").
- MEMORIA E #STORIA. DA NON DIMENTICARE alla #Assemblea #Costituente, su 556 eletti, 21 erano donne:
 9 NEL GRUPPO DC, SU 207 MEMBRI - LAURA BIANCHINI, ELISABETTA CONCI, FILOMENA DELLI CASTELLI, MARIA IERVOLINO, MARIA FEDERICI AGAMBEN, ANGELA GOTELLI, ANGELA GUIDI CINGOLANI, MARIA NICOTRA, VITTORIA TITOMANLIO;
9 NEL GRUPPO DC, SU 207 MEMBRI - LAURA BIANCHINI, ELISABETTA CONCI, FILOMENA DELLI CASTELLI, MARIA IERVOLINO, MARIA FEDERICI AGAMBEN, ANGELA GOTELLI, ANGELA GUIDI CINGOLANI, MARIA NICOTRA, VITTORIA TITOMANLIO;
 9 NEL GRUPPO PCI, SU 104 MEMBRI - ADELE BEI, NADIA GALLICO SPANO, NILDE IOTTI, TERESA MATTEI, ANGIOLA MINELLA, RITA MONTAGNANA TOGLIATTI, TERESA NOCE LONGO, ELETTRA POLLASTRINI, MARIA MADDALENA ROSSI;
9 NEL GRUPPO PCI, SU 104 MEMBRI - ADELE BEI, NADIA GALLICO SPANO, NILDE IOTTI, TERESA MATTEI, ANGIOLA MINELLA, RITA MONTAGNANA TOGLIATTI, TERESA NOCE LONGO, ELETTRA POLLASTRINI, MARIA MADDALENA ROSSI;
 2 NEL GRUPPO PSI, SU 115 MEMBRI - BIANCA BIANCHI, ANGELINA MERLIN;
2 NEL GRUPPO PSI, SU 115 MEMBRI - BIANCA BIANCHI, ANGELINA MERLIN;
 1 NEL GRUPPO DELL’UOMO QUALUNQUE: OTTAVIA PENNA BUSCEMI.
1 NEL GRUPPO DELL’UOMO QUALUNQUE: OTTAVIA PENNA BUSCEMI.
NOTE:
- STORIA E #LETTERATURA: "ANALFABETISMO" ANTROPOLOGICO-POLITICO. «Per te sono un libro aperto. Non leggo. "Amori sfigati"» (Latini Marco). Da "Il Messia dei Libri proprio una bella sollecitazione ad #apriregliocchi (S. #Freud) e a osare #sapere (il "sàpere aude" di #Orazio di #Venosa e di #Kant di #Koenigsberg) e a riequilibrare e ristrutturare il #campo della #antropologia, della #filologia, della #matematica, della #filosofia, della psicoanalisi e della #teologia-#politica dell’attuale tempestoso presente storico.
- ANTROPOLOGIA #FILOSOFIA E #FILOLOGIA: IL PROBLEMA DEL #CORPOMISTICO, IL "#SAPERE AUDE" ("OSA AS-#SAGGIARE") E LA #FACOLTA’ DI #GIUDIZIO. In consonanza anche con il prossimo "XXV Congresso Mondiale di Filosofia - Roma 2024", a mio parere, è decisamente "consigliabile" ricordare e riprendere l’indicazione del prof. #GianniVattimo: «L’uomo è ciò che mangia, ma soprattutto quel che beve» (cfr. Emiliano Morrone, La ricerca (infinita) della verità e il pensiero “forte” di Vattimo per la sua San Giovanni in Fiore, "Corriere della Calabria", 22/09/2023)! Riflettere ancora e di nuovo su ciò che si mangia e si beve è ridiventato un allarme all’o.d.g: è una indicazione "carica di teoria", dal momento che del famoso "sàpere aude" di #Orazio di #Venosa (ripreso e rilanciato da #Kant da #Koenigsberg) è stata data storicamente (e per lo più) una interpretazione intellettualistica (e platonico) tutta a discapito della #sensibilità, tanto da pregiudicare la stessa comprensione del messaggio evangelico e del suo vitale e fondamentale "prendete e mangiate questo è il mio corpo", sia dal punto di vista antropologico sia dal punto di vista teologico-politico.
 Con #DanteAlighieri, e Gianni #Vattimo, è proprio tempo di rimeditare sullo "spirito profetico" dell’abate Gioacchino da Fiore e cercare di capire quanto sia importante non togliere un’acca dalla sua brillantissima "#charitas e non vendere per sempre la propria #anima e il proprio #corpo a "#mammona" ("caritas"). Se non ora, quando?!
Con #DanteAlighieri, e Gianni #Vattimo, è proprio tempo di rimeditare sullo "spirito profetico" dell’abate Gioacchino da Fiore e cercare di capire quanto sia importante non togliere un’acca dalla sua brillantissima "#charitas e non vendere per sempre la propria #anima e il proprio #corpo a "#mammona" ("caritas"). Se non ora, quando?!
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --"SAPERE AUDE" (ORAZIO): SHAKESPEARE, IL NODO ANTROPOLOGICO E TEOLOGICO-POLITICO DEL "CORPO MISTICO", E LA "CHIMERA".17 maggio 2024, di Federico La Sala
LA "MONARCHIA" DEI "DUE SOLI" (DANTE ALIGHIERI) E LA "CHIMERA" DEL "POST-UMANO".
- OLTRE IL GEOCENTRISMO, L’ANDROCENTRISMO E IL GINECENTRISMO:
- QUESTIONE ANTROPOLOGICA E TEOLOGICO-POLITICA (CORPO MISTICO) E RIVOLUZIONE COPERNICANA (#KANT2024).
- Appunti a margine di un mio vecchio lavoro "La #mente accogliente. Tracce per una svolta antropologica" (Roma, 1991):
A) LA #QUESTION DI #SHAKESPEARE,
- "AMLETO: [...] Che sublime capolavoro è l’uomo!
 Quanto nobile nella sua ragione!
Quanto nobile nella sua ragione!
 Quanto infinito nelle sue risorse!
Quanto infinito nelle sue risorse!
 Quanto espressivo nelle sue movenze,
Quanto espressivo nelle sue movenze,
 mirabile: un angelo negli atti,
mirabile: un angelo negli atti,
 un dio nell’intelletto!
un dio nell’intelletto!
 La bellezza dell’universo mondo!
La bellezza dell’universo mondo!
 La perfezione del regno animale!
La perfezione del regno animale!
 Eppure che cos’è agli occhi miei
Eppure che cos’è agli occhi miei
 questo conglomerato di terriccio?
questo conglomerato di terriccio?
 L’uomo per me non ha alcuna attrattiva...
L’uomo per me non ha alcuna attrattiva...
 e nemmeno la donna [...] "
(SHAKESPEARE, Hamlet, 2.2. 327-334).
e nemmeno la donna [...] "
(SHAKESPEARE, Hamlet, 2.2. 327-334).
B) LA DOMANDA DI PASCAL:
- «Quale chimera è dunque l’uomo? Quale novità, quale mostro, quale caos, quale soggetto di contraddizioni, quale prodigio! Giudice di tutte le cose, sprovveduto verme della terra; depositario del vero, cloaca d’incertezza e di errore; gloria e rifiuto dell’universo. Chi sbroglierà questo garbuglio?» ("Pensieri", 438).
C) LA "QUARTA" DOMANDA DI #KANT: "COSA E’ L’UOMO? (1800). "SAPERE AUDE!": "RIPENSANDO A #SOFOCLE (E ALLA SUA "#ANTIGONE"), OLTRE CHE A SHAKESPEARE (E AL SUO "AMLETO"), E’ BENE RIPARTIRE DA PASCAL CHE CON LA SUA «CHARITE’» SA PENSARE INSIEME "UOMO" E "CHIMERA" E OSA, ALL’INTERNO DELL’ORIZZONTE DELLA #RIVOLUZIONECOPERNICANA, RI-APRIRE LA #QUESTIONEANTROPOLOGICA E TEOLOGICA.
D) LA "MONARCHIA" DEI "DUE SOLI" (#DANTE2021) E IL "POST-UMANO". Con Pascal (Clermont-Ferrand, 19 giugno 1623 - Parigi, 19 agosto 1662) e Kant (Königsberg, 22 aprile 1724 - Königsberg, 12 febbraio 1804), non è forse l’ora e il tempo, oggi, di riprendere il filo di #MArianna, "la #saggezza, come un’altra #Arianna" e portarsi fuori dal "labirinto delle cose umane" (cfr. #VictorHugo, "Notre-Dame de Paris", L. I, cap. III), e, finalmente, dal #letargo (#Dante Alighieri, Par. XXXIII, v. 94)?!
NOTA:
- DELLA #CHIMERA (OVVERO DELLA "CAPRA") E DELLE METAMORFOSI DELL’ESSERE UMANO. Tracce per una #hamletica #svolta_antropologica...
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- "L’ARTE NELLA VITA" (HUIZINGA): LA FESTA DELLA MAMMA, LA STORIA DELL’EUROPA, E IL "SAPERE AUDE!" (DI ORAZIO E DI KANT).12 maggio 2024, di Federico La Sala
LA FESTA DELLA MAMMA, LA STORIA DELL’EUROPA, E IL "SAPERE AUDE!" (DI ORAZIO E DI KANT).
- UN OMAGGIO ALLA "NOTRE-DAME DE PARIS" (A M_ARIANNA E A MARIA-BEATRICE, LA MADRE DI DANTE ALIGHIERI).
ANTROPOLOGIA, #LETTERATURA, E #STORIOGRAFIA: UNA INDICAZIONE DI JOHAN #HUIZINGA E UNA SOLLECITAZIONE A RIPRENDERE IL FILO SPEZZATO DAL 144O (#LORENZOVALLA), DAL 148O ("MARTIRI DI #OTRANTO") E DAL "6 GENNAIO 1482" (CHE "NON E’ PERO’ UN GIORNO CHE LA STORIA RICORDI ": #VICTOR #HUGO, "NOTRE-DAME DE PARIS").
J. HUIZINGA: "XVIII. L’ARTE NELLA VITA. La civiltà franco-borgognone del tardo Medioevo è generalmente nota oggigiorno per la sua arte, specialmente per la sua pittura. I fratelli Van Eyck, Ruggero van der Weyden e il Memlinc [Memling], insieme allo scultore Sluter, dominano nell’idea generale che noi ci facciamo di quell’epoca. Ma non fu sempre così. Cinquanta e più anni or sono , quando si scriveva ancora Hemlinc invece di Memlinc, il profano colto conosceva quell’epoca attraverso la storia [...] dall’Histoire des ducs de Bourgogne del De Barante, che si fondava su di essi. E forse per i più non era De Barante, bensì Victor Hugo a fornire, col suo Notre Dame de Paris, l’immagine di quei tempi." (J. Huizinga, "L’autunno del Medioevo", Introduzione di Eugenio Garin, Sansoni editore, I ed., Firenze 1940).
- Nota. Sul tema, mi sia lecito, si cfr. gli appunti su "DANTE, ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. Note per una riflessione storiografica".
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- SALUTE E SAPERE. L’aver dimenticato la lezione di Orazio dice di una cosa terribile non solo a ogni persona e a ogni cittadino e a ogni cittadina della luminosa e solare Venosa (Basilicata, Potenza).9 maggio 2024, di Federico La Sala
STORIA, FILOLOGIA, E FILOSOFIA: L’ OPERA INCOMPIUTA DELL’EUROPA E IL PERDURARE DEL "SONNO DOGMATICO"
- DALLA #VENOSA DI #ORAZIO ("#SàPERE #AUDE") E DI #ROBERTO IL #GUISCARDO ("TERROR MUNDI"), ALLA #JESI DELLO "#STUPORMUNDI" (FEDERICO II DI SVEVIA), E ALLA #KOENIGSBERG DI #KANT ("LA CRITICA DELLA FACOLTA’ DI #GIUDIZIO", 1790), ALLA #KALININGRAD DELLA RUSSIA DI OGGI (2024).
Un piccolo invito "filologico" a riaprire la riflessione sulla domanda kantiana del "che cosa posso sapere?" e, possibilmente, cercare, mangiando sano e con gusto, di riprendere il cammino nell’#oceanoceleste (#Keplero, 1611)
- Una nota in memoria di Dante Alighieri, William Shakespeare, Immanuel Kant ...
SALUTE E SAPERE. L’aver dimenticato la lezione di Orazio ("Chi bene incomincia è già a metà dell’opera; risolviti a diventare saggio: incomincia [dimidium facti, qui coepit, habet: sàpere aude, incipe]") dice di una cosa terribile non solo a ogni persona e a ogni cittadino e a ogni cittadina della luminosa e solare Venosa (Basilicata, Potenza), ma dell’intera Europa (e del Pianeta Terra)!
ANTROPOLOGIA E PEDAGOGIA. "L’UOMO E’ CIO’ CHE MANGIA" (FEUERBACH), A TUTTI I LIVELLI. Materialmente e spiritualmente, è un cosiddetto segreto di "Pulcinella. Il filosofo che fu chiamato pazzo" (Romeo De Maio, 1989), non si sa più nemmeno mangiare e, cosa ancora più grave, non sapendo nemmeno più assaporare e "as-saggiare", si ignora che cosa mangia e "che cosa" sia (diventato) il cosiddetto "uomo", antropologicamente!
COSTITUZIONE, "RAPPORTO SOCIALE DI #PRODUZIONE", E CIBO. Non solo a Casa, ma nelle Scuole e nelle Università e nelle Accademie (atee e devote), cosa insegnano, cosa danno da "mangiare": "Prendete e mangiate", ma che cosa?! Non è il caso di suonare le campane a martello, uscire dal letargo, e decidersi a riprendere lo studio della filologia e della letteratura e della #storia e della filosofia e ad affrontare i lavori dell’Incompiuta, del "Complesso della Santissima Trinità"?!
- Note:
- ANTROPOLOGIA, STORIA, LETTERATURA, E FILOSOFIA: "PULCINELLA. IL FILOSOFO CHE FU CHIAMATO PAZZO" (ROMEO DE MAIO, 1989).
- ANTROPOLOGIA FILOSOFICA (KANT), TEOLOGIA - POLITICA ("#CORPOMISTICO), E FILOLOGIA ( "#EUCHARISTIA"). PROGRAMMA Dialoghi di Pistoia, XV EDIZIONE (24-25-26 maggio 2024): "Siamo ciò che mangiamo? Nutrire il corpo e la #mente".
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- LA "TERZA PERSONA", IL PARADOSSO DEL "CORPO MISTICO", E IL "CREPUSCOLO DEGLI IDOLI".5 maggio 2024, di Federico La Sala
LA "TERZA PERSONA", IL PARADOSSO DEL "CORPO MISTICO", E IL "CREPUSCOLO DEGLI IDOLI" E DEL PAOLINISMO HEGELIANO (NIETZSCHE): "ESSERE, O NON ESSERE" ("AMLETO").
Una nota a margine di un breve testo di Gilles Deleuze:
- "Scrivere non è raccontare i propri ricordi, i propri viaggi, i propri amori e i propri lutti, i propri sogni e i propri fantasmi. Sarebbe come peccare per eccesso di realtà, o d’immaginazione: in ambedue i casi è l’eterno papà-mamma, struttura edipica che si proietta nel reale o s’introietta nell’immaginario. [...] La letteratura segue la via opposta, e si pone solo scoprendo sotto le persone apparenti la potenza di un impersonale che non è affatto una generalità, ma una singolarità al livello più alto: un uomo, una donna, una bestia, un ventre, un bambino...
- Non sono le prime due persone che servono da condizione dell’enunciazione letteraria; la letteratura incomincia solo quando nasce in noi una terza persona che ci spoglia del potere di dire Io (il “neutro” di Blanchot). Certo, i personaggi letterari sono perfettamente individuati, e non sono né vaghi né generici; ma tutti i loro tratti individuali li elevano a una visione che, come un divenire troppo potente per loro, li trasporta in un indefinito: Achab e la visione di Moby Dick. [...]
- Non si scrive con le proprie nevrosi. La nevrosi, la psicosi, non sono passaggi di vita, ma stati in cui si cade quando il processo è interrotto, impedito, chiuso. La malattia non è processo, ma arresto del processo, come nel “caso Nietzsche”. Così lo scrittore in quanto tale non è malato, ma piuttosto medico, medico di se stesso e del mondo. Il mondo è l’insieme dei sintomi di una malattia che coincide con l’uomo.
- La letteratura appare allora come un’impresa di salute: non che lo scrittore abbia necessariamente una salute vigorosa, ma gode di un’irresistibile salute precaria che deriva dall’aver visto e sentito cose troppo grandi, troppo forti per lui, irrespirabili, il cui passaggio lo sfinisce, ma gli apre dei divenire che una buona salute dominante renderebbe impossibili. Da quel che ha visto e sentito, lo scrittore torna con gli occhi rossi, i timpani perforati." (Gilles Deleuze, "Critica e clinica").
Se è vero (come è vero) che "la letteratura incomincia solo quando nasce in noi una terza persona che ci spoglia del potere di dire Io (il “neutro” di Blanchot)" (G. Dekeuze, cit.), è altrettanto vero che la "terza persona" non è affatto una "Persona", ma innanzitutto la Relazione tra "le prime due persone che servono da condizione dell’enunciazione letteraria" stessa: "IN #PRINCIPIO ERA IL #LOGOS", LA "COSTITUZIONE", NON UN #LOGO DI UN SIGNOR "NESSUNO", IL "NEUTRO" DI BLANCHOT).
- GILLES DELEUZE, “La letteratura e la vita”, in Critica e clinica, 1993 Edition de Minuit,
tr. Cortina editore, Milano, 1996)
SUl tema, nel sito, si cfr.:
URGENTE UNA "RICAPITOLAZIONE", MATEMATICAMENTE CORRETTA --- PSICHE (INDIVIDUO) E POLIS (SOCIETA’): LA CURA. Note a margine del "XXI Congresso Società Psicoanalitica Italiana" (Roma, maggio 2024).
FLS
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- L’INNO ALLA GIOIA ("AN DIE FREUDE") E LA FILOLOGIA: KANT, SCHILLER, BEETHOVEN, "FREUD ... E" LACAN.2 maggio 2024, di Federico La Sala
L’INNO ALLA GIOIA ("AN DIE FREUDE") E LA FILOLOGIA: KANT, SCHILLER, BEETHOVEN, "FREUD ... E" LACAN.
- UE - EUROPA. L’inno europeo:
- "La melodia utilizzata per rappresentare l’UE è tratta dalla Nona sinfonia, composta nel 1823 da Ludwig van Beethoven, che ha messo in musica l’"Inno alla gioia", scritto da Friedrich von Schiller nel 1785.
- L’inno simbolizza non solo l’#Unioneeuropea, ma anche l’Europa in generale. L’Inno alla gioia esprime la visione idealistica di Schiller sullo sviluppo di un legame di fratellanza fra gli uomini, visione condivisa da Beethoven.
- Nel 1972 il Consiglio d’Europa ha adottato il tema dell’Inno alla gioia di Beethoven come proprio inno. Nel 1985 è stato adottato dai capi di Stato e di governo dei paesi membri come inno ufficiale dell’Unione europea. L’inno è privo di testo ed è costituito solo dalla musica. Nel linguaggio universale della musica, questo inno esprime gli ideali di libertà, pace e solidarietà perseguiti dall’Europa.
LA CULTURA EUROPEA, SIGMUND #FREUD, E L’INNO ALLA #GIOIA (F. #Schiller, "An die #Freude", 1785).
NEL "NOME DI FREUD", LA "PSICOANALISI" DEL «JOYOSO» JACQUES LACAN. Due brevi note a margine della seguente "dichiarazione":
- “I wish to begin by saying what, while appearing under Freud’s name, extends beyond the time of his appearance and conceals its truth even in its very unveiling - that Freud’s name signifies «joy»” (Jacques Lacan, «An address: Freud in the century», 1956).
MEMORIA, STORIA, E FILOLOGIA. A CHE GIOCO GIOCHIAMO?!
- "GIOIOSAMENTE, GIOCOSAMENTE: «FREUD ... E»
- Freud - letto in italiano come si scrive è quasi «fred-do»
- Freud - pronunciato in tedesco dà «Froid», che in-francesce-tradotto-in-italiano è ancora «freddo»
- Freud - più una «e» in tedesco equivale alla nostra «gioia»
- Freud - più la «e», pronunciata in tedesco su suolo italico dà «fro(i)de»
- (cit. da una mia relazione intitolata, "Cosa nasconde Freud a Freud? Cosa nascondiamo noi a noi stessi? Note da/per un seminario interdisciplinare sulla "Interpretazione dei sogni", all’ Università di Salerno, Sede di Via Irno - 30. 03. 1976).
FREUD O LACAN? "SÀPERE AUDE" (ORAZIO - KANT). Nella ricorrenza del XXI Congresso Nazionale della Societa’ Psicoanalitica italiana, RICORDANDO ELVIO FACHINELLI (con le parole di Francesco Marchioro: "Spirito curioso, ironico, indipendente e analista non ortodosso denuncia con forza una sorta di «freudolente» uso della terapia e accusa la sua stessa istituzione di praticare una “psicoanalisi della risposta”, nel senso che si limita a «dare ragione all’esistente, razionalizzare le irrazionalità, tamponare i conflitti», offrire una terapia dell’adattamento invece di essere una psicoanalisi interrogante, capace di sollevare domande radicali sullo statuto del soggetto e la sua relazione alla Lebenswelt, al mondo della vita.": Altoadige.it, 22.12.2019), non è il caso di svegliarsi dal sonno dogmatico e riprendere il filo da Kant (1724-2024), dalla interpretazione dei "sogni di un visionario" (1766), e riprendere coraggiosamente a "servirsi della propria intelligenza ("1784), e, insieme, far un so critico della propria facoltà di giudizio, come ha fatto e sollecitato a fare in prima persona Michel Foucault nel 1984?
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- PSICOANALISI E SOCIETA’: "LA CURA. Alcune note a margine del XXi Congresso Nazionale Società Psicoanalitica Italiana (Roma, 24-25-26 maggio 2024).1 maggio 2024, di Federico La Sala
Al di là del #paolinismo (dell’#hegelismo e del #lacanismo): "#Psiche e #Polis" (#Platonismo) e "#Costruzioni nell’#analisi" (S. Freud, 1937).
- Una nota a margine del "XXI Congresso Società Psicoanalitica Italiana" ) *
ANTROPOLOGIA E #PSICOANALISI: "LA FERMA FERMA" (E. Fachinelli, 1979). Purtroppo, bisogna dirlo la Società Psicoanalitica Italiana, all’altezza del XXI Congresso (in coincidenza con l’anniversario della #nascita di #Kant, trecento anni fa, 1724) ha perso tutto il coraggio degli inizi (del "#sàpereaude!" oraziano come dell’#illuminismo kantiano) del suo "fondatore" (#COPERNICO, #DARWIN, e #FREUD): non riesce ad "#apriregliocchi" su una vera e propria "seconda" #rivoluzionecopernicana in progress e continua ad agitare "la_can_na" per l’aria - almeno dal 1989, dalla morte contemporanea di #CesareMusatti e di #ElvioFachinelli.
MEMORIA E STORIA: L’ITALIA, IL VECCHIO E NUOVO #FASCISMO, E "LA FRECCIA FERMA". La lezione sorprendente e preveggente di Elvio Fachinelli.
ARCHEOLOGIA, #STORIAELETTERATURA, E "DISAGIO DELLA CIVILTÀ" (1929): "RIVEDERE IL SOLE E LE ALTRE STELLE" E’ POSSIBILE. "L’#Interpretazione dei #Sogni" (1899) ha il suo legame con l’#Eneide (VII, 312: "Flectere si nequeo Superos, Acheronta movebo") di #Virgilio e "L’uomo Mosè e la religione monoteistica"(1938) con il tema dell’«In exitu Isräel de Aegypto» della "Divina Commedia" (Pg. II, 46-48) di #DanteAlighieri.
NOTA:
- CON #KANT E #FREUD, #OLTRE. Un nuovo paradigma antropologico: la decisiva indicazione di ELVIO #FACHINELLI.
- Antropologia, #psicoanalisi, e #critica della #ragione hegeliana (e lacaniana).
- Una nota a margine del lavoro di Pietro Barbetta, "Elvio Fachinelli - Psychoanalysis of Dissension in Italy.
PSICOANALISI E #SOCIETA’: "TENTATIVI DI ANNULLARE IL #TEMPO" E "#COSTRUZIONI NELL’ #ANALISI" ...
- In #memoria di #SigmundFreud (1939), #CesareMusatti (1989) e di #ElvioFachinelli (1989)
Una breve nota a margine di un intervento di Sergio Benvenuto ("Anti-Deleuze", "Le parole e le cose", 29 aprile 2024).
IL TITOLO DEL XXI CONGRESSO NAZIONALE DELLA Società Psicoanalitica Italiana (Roma, 24-25-26 MAGGIO 2024) E’ “PSICHE E POLIS”. Incapaci di riuscire ad “aprire gli occhi” fuori dalla famosa “caverna” e guardare il “mondo” al di là della luce “del sapere del “Maestro di color che sanno”, del sole e delle altre stelle del cielo aristotelico, è più che “verosimile la tesi promossa da George #Lakoff (in #Moral #Politics): che i grandi conflitti politici, quelli che portano anche a distruzioni e miserie immani, sono una proiezione espansiva, cosmica, delle nostre primitive relazioni con mamma, papà, la balia, la zia... In analisi, emerge la straordinaria pregnanza del Piccolo Mondo Antico”. (cfr. S. Benvenuto, "Anti-Deleuze", cit.).
"ANTI-EDIPO": "[...] Il primato dei crucci privati mi ha certamente colpito ma non sorpreso. Perché non ho mai creduto alla predicazione di #Deleuze e #Guattari. Come è noto, costoro rimproveravano alla psicoanalisi soprattutto freudiana di voler “familiizzare” tutto, di ridurre tutti i conflitti detti psichici a storie di mamma, papà, inauspicato fratellino, toccamenti di pisellino o patatina tra bambini... Mentre, altroché, i veri problemi inconsci sono cose serie, politiche, lotta di classe, rivoluzione degli oppressi, ecc. Gli schizofrenici, in particolare, vibrano per le sorti drammatiche del mondo. [...]" (Benvenuto, cit.).
"LA #FRECCIA #FERMA". A quanto pare, l’evidenza appare al massimo del suo livello: il tempo si è fermato! A questo punto, a che vale chiedersi ”se certi colleghi possano portarmi esperienze ben diverse”, quando “La freccia [è] ferma” (E. Fachinelli, 1979), per quanto qualche “vecchia #talpa” possa essere ancora benvenuta nella sua volontà di scavare, può mai contribuire a trovare la via d’uscita? Così non si butta la "Psiche" del #Bambino ("Edipo") e l’acqua sporca della Città di #Tebe?, della "Polis" t(al)ebana?! Boh e bah?!
PIANETA TERRA (#EARTHRISE). Individuo ("Psiche") e Società ("Polis"): una relazione chiasmatica aperta alla luce del Sole copernicano (e galileiano e kantiano)! Nel 1989, il tema del 36º congresso internazionale dell’ International Psychoanalytical Association (IPA), tenutosi a Roma (con #Musatti, morto il #21marzo 1989, e #Fachinelli, morto il 21 dicembre 1989) era quello dell’#oikos, del "terreno comune" in psicoanalisi - e non solo!
Nota:
- STORIA #FILOSOFIA E #PSICOANALISI. Gilles #Deleuze, Félix #Guattari, "L’anti-Edipo. Capitalismo e schizofrenia".
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- ANTROPOLOGIA E STORIA: "CHE VUOL DIRE #LEGGEMORALE IN NOI #PROFESSORE?", OGGI (#KANT2024)10 aprile 2024, di Federico La Sala
"ESSERE, O NON ESSERE" (#SHAKESPEARE): "CHE VUOL DIRE #LEGGEMORALE IN NOI #PROFESSORE?", OGGI (#KANT2024)
 ILLUMINISMO, #ILLUMINAZIONE, E "#SAPEREAUDE!" (#KANT): UNA RISPOSTA ALLA #DOMANDA. Riconosciuta gratitudine per l’attenzione e per l’intervento, che cosa rispondere (in breve) a chi ha posto la #questione e desidera sapere?
ILLUMINISMO, #ILLUMINAZIONE, E "#SAPEREAUDE!" (#KANT): UNA RISPOSTA ALLA #DOMANDA. Riconosciuta gratitudine per l’attenzione e per l’intervento, che cosa rispondere (in breve) a chi ha posto la #questione e desidera sapere?Innanzitutto, che Il "professore" è il "tu" stesso con "te" stesso; secondo, che il sapere di non sapere e il #decidere con "te" stesso se si vuole sapere ("essere") o non sapere ("non essere") è già un primo passo, quello decisivo e fondamentale, per uscire dallo "stato di #minorità" (Kant, 1784); e, terzo, che cominciare a #dialogare con "#te" stesso come un #altro, apre al grande "aut aut"! "Che fare?" (Lenin), "Che cosa devo fare?" (Kant).
 Nel #ribaltamento e nel #riconoscimento di "sé" come un "altro" (Paul #Ricoeur) prende il via la "#fenomenologia dello #spirito" (alla #Hegel) o la #divinacommedia (alla #DanteAlighieri): "To be, or not to be, that is the question" (#Shakespeare, "Amleto", III.1). Uscire dall’inferno, dal #letargo (Inf. XXXIV, 94) è possibile: "#Amore è più forte di #Morte" (Ct. 8.6, trad. di Giovanni Garbini).
Nel #ribaltamento e nel #riconoscimento di "sé" come un "altro" (Paul #Ricoeur) prende il via la "#fenomenologia dello #spirito" (alla #Hegel) o la #divinacommedia (alla #DanteAlighieri): "To be, or not to be, that is the question" (#Shakespeare, "Amleto", III.1). Uscire dall’inferno, dal #letargo (Inf. XXXIV, 94) è possibile: "#Amore è più forte di #Morte" (Ct. 8.6, trad. di Giovanni Garbini).ESPERIENZA E CRITICA DELLA FACOLTA’ DI #GIUDIZIO. "Quando vedete una nuvola salire da ponente, subito dite: Viene la pioggia, e così succede. E quando soffia lo scirocco, dite: Ci sarà caldo, è così accade. Ipocriti, sapete giudicare l’aspetto della terra e del cielo, come mai questo tempo non sapete giudicarlo? E perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto?" (Lc. 12, 56-57).
Note:
ANTROPOLOGIA E #STORIA. Immanuel Kant: «L’Illuminismo è l’uscita dell’uomo dallo stato di minorità che egli deve imputare a se stesso. Minorità è l’incapacità di valersi del proprio intelletto senza la guida di un altro. Imputabile a se stesso è questa minorità, se la causa di essa non dipende da un difetto d’intelligenza, ma dalla mancanza di decisione e del coraggio di fare uso del proprio intelletto senza essere guidati da un altro. Sapere aude! Abbi il coraggio di servirti della tua propria intelligenza! È questo il motto dell’Illuminismo.» .
FILOSOFIA E #CRITICA. Immanuel Kant, "Critica della facoltà di giudizio", a cura di Emilio Garroni e Hansmichael Hohenegger, Einaudi.... Accanto alla Critica della ragione pura e alla Critica della ragione pratica, la Critica della facoltà di giudizio è il terzo capolavoro dell’impresa critica di Immanuel Kant: non solo il suo compimento, ma anche e soprattutto il suo ripensamento e insieme la sua fondazione.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- L’ HAMLETICA QUESTIONE ANTROPOLOGICA: "VECCHIE" NOTE PER CRITICA DELL’ECONOMIA POLITICA E DELLA TEOLOGIA DI MAMMONA.16 marzo 2024, di Federico La Sala
PIANETA TERRA: L’ HAMLETICA QUESTIONE ANTROPOLOGICA (SHAKESPEARE, 1600; KANT, 1800) E LA "INTRODUZIONE DEL 1857" (K. MARX).
- "VECCHIE" NOTE PER CRITICA DELL’ECONOMIA POLITICA E DELLA TEOLOGIA DI MAMMONA... *
Con Il lungo processo storico che in Europa e nel mondo, almeno dal XVIII secolo, ha innescato la contrapposizione delle diverse forme del contesto sociale all’individuo come un puro strumento per i suoi scopi privati, non solo «Dio è morto» (#Nietzsche) ma anche l’#Uomo (#MichelFoucault) della #tradizione edipico-androcentrica (platonica, paolina, hegeliana, ed heideggeriana):
- "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il #capo è Cristo, e capo della #donna è l’uomo [gr. ἀνήρ, ἀνδρός «#uomo»], e capo di Cristo è Dio" (Paolo di Tarso, 1 Cor. 11, 1-3).
EARTHRISE (1968). In principio era il Logos (dell’Efeso di #Eraclito e dell’evangelista Giovanni, non il logo dello "apostolo" Paolo di Tarso) e uscire dall’inferno (#Dantedì, #25marzo 2024) è possibile!
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- IL CORPO MISTICO, LA FACOLTA’ DI GIUDIZIO E DI PAROLA, E LA COSTITUZIONE.26 febbraio 2024, di Federico La Sala
CITTADINANZA ATTIVA, FACOLTA’ DI GIUDIZIO, E ANTROPOLOGIA: #SAPEREAUDE! (#KANT2024).
LA LINGUA (LA COSTITUZIONE) BATTE DOVE I DENTI (I PARTITI) DOLGONO. *
Tutte le articolazioni del "corpo mistico" della democratica società italiana scricchiolano alla grande, a tutti i livelli, e da tempo: e la radice è non solo locale, ma globale (antropologica, teologica, e cosmologica)!
*
- “Il Presidente della Repubblica ha fatto presente al Ministro dell’Interno, trovandone condivisione, che l’autorevolezza delle Forze dell’Ordine non si misura sui manganelli ma sulla capacità di assicurare sicurezza tutelando, al contempo, la libertà di manifestare pubblicamente opinioni. Con i ragazzi i manganelli esprimono un fallimento.” Roma, 24/02/2024 (II mandato).
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- NON CON DANTE, NON CON MACHIAVELLI; CON LO SPIRITO DELLA FAMIGLIA E IL NEPOTISMO DEL CATTOLICESIMO DELL’ETA’ MODERNA.16 febbraio 2024, di Federico La Sala
STORIA, ANTROPOLOGIA, E STORIOGRAFIA:
LA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO DELLA FAMIGLIA E IL NEPOTISMO DEL CATTOLICESIMO DELL’ETA’ MODERNA.
- Una nota a margine del lavoro di Maria Antonietta #Visceglia,
- "Le donne dei papi in età moderna. Un altro sguardo sul nepotismo (1492-1655)", Viella Editrice, Roma 2023.
IL CATTOLICESIMO "COSTANTINIANO" (NICEA, 325-2025) E L’INDICAZIONE "ERETICA" DI #DANTEALIGHIERI: PARTENDO DALLA RICERCA SU "Le donne dei papi in età moderna. Un altro sguardo sul nepotismo (1492-1655)" di Maria Antonietta Visceglia (Viella Editrice, Roma 2023), FORSE, SI PUO’ OSSERVARE MEGLIO LA RADICALE SVOLTA "COSTANTINIANA" DELLA VITA DELLO "STATO" DELLA CHIESA CATTOLICA, GIA’ E SUBITO PRIMA DELLA #CADUTA DI #COSTANTINOPOLI (1453) IN MANO TURCA, CON IL SINTOMATICO PASSAGGIO DI NICCOLO’ #CUSANO ( L’AUTORE DIVENTATO CARDINALE, PER I MERITI DELLA POCO EVANGELICA "DOTTA IGNORANZA" DEL 1440 E DELLA "PACE DELLA #FEDE" DEL 1453) DA SOSTENITORE DEL "PARTITO" DELLA SOVRANITA’ DEL #CONCILIO A SOSTENITORE DEL POTERE SUPREMO DEL #PAPA, E, NELLO STESSO TEMPO, CON IL SILENZIAMENTO E LA NEUTRALIZZAZIONE DEL LAVORO CRITICO DI LORENZO VALLA SULLA FALSA "DONAZIONE DI COSTANTINO" (1440).
ALL’INTERNO DI QUESTO ORIZZONTE, MIO PARERE, SI COMPRENDE MEGLIO LA SPECULARE LOTTA DELLO STATO DELLA CHIESA CON LO STATO DELLA SPAGNA (DOPO LA RICONQUISTA DI #GRANADA, 1492) PER L’EGEMONIA TEOLOGICO-POLITICA EUROPEA; E, UNITARIAMENTE, L’INCAPACITA’ AD ACCOGLIERE LA "INAUDITA" ED "ERETICA" INDICAZIONE DELLA "#MONARCHIA" DEI "#DUESOLI" DI DANTE ALIGHIERI E, INFINE, LE SUCCESSIVE SOLLECITAZIONI TEOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE DELLA #RIFORMA PROTESTANTE (1517) PRIMA E DELLA RIFORMA ANGLICANA (1534) POI, ECC.
DANTE ALIGHIERI E MERCURINO ARBORIO DI GATTINARA. Sul tema, è bene ricordare, mi sia lecito, la lezione magistrale di #KarlBrandi che, a conclusione della sua "lettura" della biografia di "Carlo V" (1935), rievoca (con le seguenti testuali parole) la figura del "gran cancelliere Mercurino di Gattinara, il cui ideale imperiale non era stato diverso dal sogno imperiale di Dante; e aveva espresso la fede in un ordinamento del mondo retto dall’Impero e dal Papato, ciascuno nella sua sfera, l’uno e l’altro pienamente e sovranamente responsabili verso l’intera umanità" (Einaudi, Torino 2001); e, ancora, che Ernst H. #Kantorowicz, nel suo lavoro su "I due corpi del re" (1957), intitola e dedica l’intero ultimo capitolo a "La regalità antropocentrica: Dante" (Einaudi, Torino 2012).
P. S. - #MACHIAVELLI CON DANTE ALIGHIERI CONTRO IL #FAMILISMO TEOLOGICO-POLITICO. NICCOLO’ MACHIAVELLI, “DISCORSI SOPRA LA PRIMA DECA DI TITO LIVIO”:
"Della religione de’ Romani. (...) gli regni i quali dipendono solo dalla virtù d’uno uomo, sono poco durabili, perché quella virtù manca con la vita di quello e rade volte accade che la sia rinfrescata con la successione, come prudentemente Dante dice:
- Rade volte discende per li rami
- L’umana probitate; e questo vuole
- Quel che la dà, perché da lui si chiami. [Pg. VII, 121-123]
Non è, adunque, la salute di una republica o d’uno regno avere uno principe che prudentemente governi mentre vive; ma uno che l’ordini in modo, che, morendo ancora, la si mantenga. (...)" (“DISCORSI”, Libro I, cap. XI).
- Nota:
- BIBLIOGRAFIA. SUL TEMA (DANTESCO DEL #GIARDINO) DELL’#IMPERO E LA LOTTA NEL #CINQUECENTO PER "L’ITALIA DEL #PAPA" E PER "L’ITALIA DELL’#IMPERATORE", si cfr. il lavoro di Elena Bonora, "Waiting for the Emperor. Italian Princes, the Pope and Charles V" (Viella Editrice, 2022 ); Elena Bonora, ed. it., "Introduzione" (Einaudi, 2014).
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- IL PROBLEMA DELLA "RELAZIONE". Al Dipartimento di filosofia della Sapienza si svolgono le giornate di studio “Heidegger in Italia”, organizzate dal Centro di studi heideggeriani.15 febbraio 2024, di Federico La Sala
Filosofia. Dalle relazioni ai social: perché leggere Heidegger ci aiuta ancora
Il pensatore tedesco ha elaborato le categorie tradizionali in maniera creativa, le ha riadattate al presente tecnologico con particolare attenzione ai rapporti interpersonali
di Adriano Fabris (Avvenire, mercoledì 14 febbraio 2024)
- [Foto] Martin Heidegger (1889-1976)
- Da oggi, 14 febbraio, a venerdì, al Dipartimento di filosofia della Sapienza si svolgono le giornate di studio “Heidegger in Italia”, organizzate dal Centro di studi heideggeriani. Ben 26 i pensatori e gli studiosi chiamati a intervenire. Fra questi Annalisa Caputo, Massimo Cacciari, Costantino Esposito, Aldo Magris, Eugenio Mazzarella.
- Qui anticipiamo una sintesi dell’intervento di Adriano Fabris.
Il titolo del mio intervento al convegno su "Heidegger in Italia - Heidegger e il problema della relazione" - può essere fuorviante. Si può intendere [...] accentuando il termine “problema” oppure valorizzando il concetto di “relazione”. Nel primo caso [...] ci si muovei sulla scia delle critiche che da Essere e tempo in poi sono state rivolte al pensiero heideggeriano, soprattutto dal versante ebraico. Löwith, Buber, Levinas [...] hanno rimproverato Heidegger di trascurare, o di fraintendere nel loro senso più proprio, le relazioni fra gli esseri umani e il vincolo etico che in esse s’impone.
Qui si vuole mettere al centro il tema della relazione attribuendolo a Heidegger, per dir così, in una maniera positiva. Far vedere che è il principio motore del pensiero heideggeriano in tutto il suo sviluppo; valorizzare una determinata idea di relazione intendendola come il problema di fondo che Heidegger affronta, come un argomento decisivo che egli eredita dalla tradizione filosofica, trasforma produttivamente e lascia in eredità alla riflessione futura. [...]
Dobbiamo aver chiara la mossa teorica che Heidegger compie e grazie alla quale il tema della relazione acquisisce la sua centralità. È la mossa effettuata nei confronti di Husserl e, in particolare, rispetto alla sua dottrina dell’intenzionalità. Anche Husserl infatti, sebbene in maniera più implicita, considera la relazione come un suo problema. Rispetto all’unilateralità del legame fra soggetto e oggetto che caratterizza ad esempio l’approccio neokantiano, e nei confronti dell’incomprensibilità del fatto che possano poi incontrarsi un soggetto e un oggetto che sono inizialmente e irrimediabilmente separati, lo Husserl dei primi anni del Novecento intende il soggetto come intentio, cioè come soggetto intenzionale,e l’oggetto come intentum, come fenomeno intenzionato, predisponendoli così già a un incontro.
Tuttavia tale incontro, nell’ottica di Husserl, dipende soprattutto dal soggetto. [...] Tale approccio condanna Husserl a una lettura unilateralmente conoscitiva, teoreticistica, della relazione stessa. Altri modi di pensare il nostro legame con il mondo, altri modi di essere, debbono invece venir considerati: primi fra tutti - come insegna Aristotele - quelli relativi alla praxis. È ciò che mette a fuoco, proprio con riferimento ad Aristotele, Heidegger nei primi anni Venti.
Per far sì che avvenga questo allargamento di prospettiva - col quale, si badi bene, si scopre un nuovo territorio per l’indagine filosofica, un territorio che va al di là di quello colonizzato dalle scienze modernamente intese - è necessario però compiere un ulteriore passaggio fondamentale. È necessario considerare il principio della relazione, ciò che è condizione della relazione stessa, dei termini che mette in relazione e non sul loro stesso piano [...] Questo “qualcosa” che è prima, come condizione di tutte le possibili relazioni che possono essere sperimentate, Heidegger lo chiama “essere”. È dunque necessario porsi anche (e soprattutto) il problema della relazione a questa condizione di ogni relazione, nonché il problema di quell’ente che è in grado di approfondire e sviluppare tale relazione con l’essere. Questo, come sappiamo, è il tema di Essere e tempo. [...]
Ma in quest’opera tale compito viene svolto solo parzialmente. Il problema della relazione che lì viene impostato e che, però, resta ancora aperto riguarda il legame tra il Dasein e l’essere in generale, nonché il modo in cui dev’essere intesa e può configurarsi la relazione tra l’essere, gli enti e il Dasein. Ciò, come sappiamo, porterà in seguito Heidegger a rovesciare, proprio per risolvere questo problema e garantire l’attuarsi della relazione, l’approccio di Essere e tempo.
A partire dagli anni Trenta diventa sempre più chiaro che è l’essere in generale, in quanto Ereignis (evento), a manifestarsi veritativamente e onto-storicamente al Dasein. [...] Ora “relazione” non indica solo ciò che sta prima. “Relazione” significa ed è, propriamente, relazionarsi. In ciò e solo in ciò essa si attua nella sua verità. In ciò e solo in ciò si annuncia anche la sua differenza rispetto agli enti nella loro oggettività e staticità. E “essere” finisce per diventare il nome, precisamente risemantizzato, di questa stessa dinamica relazionale.
Potremmo ricostruire a partire da qui la riflessione di Heidegger della seconda metà degli anni Trenta e dei primi anni Quaranta, soprattutto considerando la stratificazione dei trattati inediti. [...] Preferisco invece, a partire da quanto messo in evidenza e concludendo il discorso, indicare alcune vie per utilizzare il pensiero heideggeriano, produttivamente, nel contesto contemporaneo.
Ciò che dobbiamo pensare oggi, ciò con cui l’indagine filosofica deve confrontarsi, è lo sviluppo tecnologico, in tutte le sue forme. Dobbiamo pensare questo sviluppo nella sua struttura, nelle sue conseguenze, nelle trasformazioni della mentalità che esso comporta. Dobbiamo pensarlo filosoficamente, cioè a partire da quelle categorie e da quei concetti che la storia del pensiero ha elaborato.
Questo è ciò che ha fatto Heidegger. Heidegger ha ripensato le categorie tradizionali in maniera creativa, per elaborare una filosofia all’altezza delle questioni che riteneva di dover affrontare: e fra queste anche la situazione in cui viviamo, permeata dagli sviluppi tecnologici. Questo è ciò che ha fatto Heidegger, nello specifico, riguardo al problema della relazione. [...]
Le tecnologie mettono in opera relazioni. I programmi che consentono di farlo sono disegnati e costruiti secondo specifiche forme di relazione - quelle operazionali prodotte dagli algoritmi - e servono per attuare relazioni fra gli esseri umani (ad esempio attraverso i social), fra le macchine (ad esempio nell’IoT), e fra gli esseri umani e le macchine (ad esempio quando usiamo uno smartphone). I dispositivi utilizzati a tale scopo funzionano proprio mettendosi in relazione fra loro (cioè mettendosi in rete) e aprendo contesti di relazione (gli ambienti digitali). [...]
Tutto ciò richiede di essere pensato: di essere pensato filosoficamente. È un tema su cui, anche in riferimento a Heidegger, la filosofia italiana del secondo dopoguerra si è soffermata più volte: da Paci a Severino, per esempio. Ma Heidegger, a questo proposito, ci può essere utile ancora oggi. Almeno per due motivi.
Da una parte, ci consente di approfondire nella sua complessità la dimensione relazionale in cui viviamo, evitando di ridurre la relazione a una semplice connessione. Dall’altra, il riferimento al suo pensiero ci permette di tenere presente il limite del vivere e dell’agire umani, anche quando tale limite si riflette nell’azione apparentemente illimitata delle tecnologie. Questi possono essere i modi in cui il pensiero di Heidegger può essere rilanciato, anche e soprattutto nel contesto della filosofia italiana, per fare i conti criticamente con la situazione attuale.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- COSMOTEANDRIA PLATONICO-RINASCIMENTALE E TEOLOGIA-POLITICA COSTANTINIANA (NICEA 2025)...26 gennaio 2024, di Federico La Sala
STORIA, IMMAGINARIO, ARTE, ANTROPOLOGIA, PLATONISMO RINASCIMENTALE, E CATTOLICESIMO ROMANO-COSTANTINIANO (PAOLINISMO).
RICORDANDOSI OGGI (25 GENNAIO 2024), UN AVVENIMENTO DECISIVO DELLA VITA DELL’EUROPA (E DELL’INTERO PIANETA), LA "CONVERSIONE DI SANPAOLO,
UN "INVITO" A #RIFLETTERE SULLA FORTE CONNESSIONE FORMALE (CON TUTTE LE SUE VARIE IMPLICAZIONI CULTURALI E TEOLOGICO-POLITICHE: RIFORMALUTERANA, 1517; RIFORMA #ANGLICANA, 1534),
CON LA FIGURA DI PLATONE DELLA "SCUOLA DI ATENE" (DEL 1509-1511) DI RAFFAELLO,
CON IL "SAN PAOLO" DI PELLEGRINO TIBALBI (1585) DELLA "CAPPELLA BORROMEO" DELLA CHIESA DI "SANTA MARIA DELLE GRAZIE" DI MILANO, (ACQUISTATA E ACQUISITA NEL 2021 NELLE COLLEZIONI DEGLI UFFIZI) : "[...] Secondo gli studi di Allegri, il San Paolo, oltre ad essere un’opera molto importante nell’ambito della pittura della #Controriforma, costituisce anche un tassello cruciale per capire il ruolo del Tibaldi a Milano subito prima della sua partenza per la Spagna (1586), dove era stato chiamato dal re Filippo II per decorare l’#Escurial [...]"(https://www.uffizi.it/news/acquisizione-san-paolo-tibaldi ).
P. S.
PROPAGANDA (#FIDES), SPERANZA (#SPES), E CARITA’ (#CHARITAS). A mio parere, la "conversione" del "cittadino romano" ( "civis Romanus est"), Paolo di Tarso, divenuto "san Paolo", è un problema epocalmente importante (si pensi al prossimo anniversario di #Nicea, 325-2025), dal punto di vista storico e culturale: sia per il messaggio evangelico (la teologia-politica cattolico-costantiniana, il Paolinismo) sia per l’antropologia, per la filosofia, e l’antropologia culturale : l’essersi "autoproclamato" ("#apostolo"), e l’essere stato accreditato come tale ha deciso la "qualità" stessa del cristianesimo e della storia e della cultura dell’#Europa (nel male e nel bene), fino ad oggi.
- Kant2024
Note:
- RINASCIMENTO PLATONICO : PLATONE NELLA "SCUOLA DI #ATENE" (1509-1511) DI #RAFFAELLO.
- STORIA E MEMORIA DELLA COSMOTEANDRIA PLATONICO- PAOLINA: CONCILIO DI TRENTO.
- "Il concilio di #Trento o concilio Tridentino fu il XIX concilio ecumenico della Chiesa cattolica, convocato per reagire alla diffusione della riforma protestante in Europa. L’opera svolta dalla Chiesa per porre argine al dilagare della diffusione della dottrina di Martin #Lutero produsse la #controriforma. Il concilio di Trento si svolse in tre momenti separati dal 1545 al 1563 e, durante le sue sessioni, a Roma si succedettero cinque papi (Paolo III, Giulio III, Marcello II, Paolo IV e Pio IV). Produsse una serie di affermazioni a sostegno della dottrina cattolica che Lutero contestava. Con questo concilio la Chiesa cattolica rispose alle dottrine del calvinismo e del luteranesimo. L’aggettivo tridentino viene ancora usato per definire alcuni aspetti caratteristici del cattolicesimo ereditati da questo concilio e mantenuti nei secoli successivi sino al concilio Vaticano I ed al concilio Vaticano II. [...]" (https://it.wikipedia.org/wiki/Concilio_di_Trento).
- STORIA, LETTERATURA E #LETARGO (Par. XXXIII, 94) DA #TRAGEDIA. Ennio Flaiano (da grande "lettore" di #DanteAlighieri, v. "Autobiografia del Blu di Prussia") sapeva benssimo che la #luce era già stata spenta al tempo del #Galileo della #Galilea e del #GalileoGalilei (#Italia, #25gennaio 2024)
- STORIA, LETTERATURA E #LETARGO (Par. XXXIII, 94) DA #TRAGEDIA. Ennio Flaiano (da grande "lettore" di #DanteAlighieri, v. "Autobiografia del Blu di Prussia") sapeva benssimo che la #luce era già stata spenta al tempo del #Galileo della #Galilea e del #GalileoGalilei (#Italia, #25gennaio 2024)
- PROPAGANDA (#FIDES"), SPERANZA (#SPES), E CARITA’ (#CHARITAS). Chiarissimo Vincenzo Santoro, lode al suo eccellente lavoro di ricerca e studio: notevolissima l’immagine stampata a Napoli del "S. Paolo Apostolo"!
 A mio parere, la "conversione" del "cittadino romano" ( "civis Romanus est") Paolo di Tarso, divenuto "san Paolo", è un problema epocalmente importante (si pensi al prossimo anniversario di #Nicea, 325-2025), dal punto di vista storico e culturale: sia per l’#antropologiaculturale (#ErnestoDeMartino) sia per il #messaggioevangelico (la #teologia cattolico-costantiniana del #Paolinismo), l’essersi "autoproclamato" (#apostolo), e l’essere stato accreditato come tale ha deciso la "qualità" stessa del #cristianesimo e della #storia dell’#Europa (nel male e nel bene), fino ad #oggi.
A mio parere, la "conversione" del "cittadino romano" ( "civis Romanus est") Paolo di Tarso, divenuto "san Paolo", è un problema epocalmente importante (si pensi al prossimo anniversario di #Nicea, 325-2025), dal punto di vista storico e culturale: sia per l’#antropologiaculturale (#ErnestoDeMartino) sia per il #messaggioevangelico (la #teologia cattolico-costantiniana del #Paolinismo), l’essersi "autoproclamato" (#apostolo), e l’essere stato accreditato come tale ha deciso la "qualità" stessa del #cristianesimo e della #storia dell’#Europa (nel male e nel bene), fino ad #oggi.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! E DOVE I FILOLOGI? --- UN INVITO AD ASSAGGIARE (E A RICORDARE GIOACCHINO DA FIORE). Nell’anno 1784, sulla «Berlinische Monatsschrift», un "rischiaramento" di Kant e Gedike sul mangiare e sulla facoltà di giudizio.20 gennaio 2024, di Federico La Sala
LA FILOSOFIA E LA "RISPOSTA" SU "CHE COSA E’ L’ ILLUMINISMO?", OGGI: IL "CORAGGIO DI ASSAGGIARE" ("Sàpere aude!")" DI KANT E L’ANALISI SU "L’UOMO E’ CIO’ CHE MANGIA" ("Der Mensch ist, was er ißt") DI FRIEDRICH GEDIKE, nella «Berlinische Monatsschrift» del 1784.
UN "INVITO A RIFLETTERE" SU UNA QUESTIONE DI SOSTANZA, PROPAGANDA (FEDE), FILOLOGIA, E "FACOLTA’ DI GIUDIZIO" (#KANT2024) E, INSIEME, AD ACCOGLIERE "L’AFFASCINANTE «SFIDA» AL PANETTONE LOMBARDO" (si cfr. Emiliano Antonino Morrone, "Federica Greco, l’orgoglio calabro e l’affascinante «sfida» al panettone lombardo", Corriere della Calabria, 19 gennaio 2024):
- "[...] Nell’ambito delle stories, ormai divenute strumento principe della comunicazione #politica, non è concesso spazio al giudizio critico e la risposta emotiva ha contorni e dinamiche da #fideismo. Nelle #stories manca l’orizzonte e non c’è #logos, discorso articolato, cioè l’elemento chiave dell’altrui comprensione, concordia, consenso. In termini spiccioli, mediante le stories si presenta e offre un prodotto al consumo [...]" (E. A. Morrone, cit.).
Per meglio accogliere la sollecitazione del giornalista Emiliano Antonino Morrone, e, possibilmente, riprendere il filo dall’amore (#charitas) di Gioacchino da Fiore (San Giovanni in Fiore) e dal coraggio di assaggiare ("#Sàpere aude") di Orazio (Venosa), mi sia lecito, ricordare alcuni contributi storiografici sul tema del cibo e della antropologia filosofica:
a) Ludwig Feuerbach, "L’uomo è coà che mangia", a c. di Franco Tomasoni, Morcelliana, Brescia 2015.
b) Ludwig Feuerbach, L’uomo è ciò che mangia, a c. di Andrea Tagliapietra, Boringhieri, Torino 2017.
c) Gianfranco Ravasi, "L’uomo è ciò che mangia", Famiglia Cristiana,18 maggio 2023.
- Nota:
- L’ #ANTROPOLOGIA (L’ #ESSEREUMANO), L’#ALIMENTAZIONE ("L’#UOMO E’ CIO’ CHE MANGIA"), E LA #RICERCA DI UNA VIA D’#USCITA DALL’#IMMAGINARIO STORICO-SOCIALE DELL’#ANDROCENTRISMO DELLA #CADUTA ("CAINO") E DELLA #TRAGEDIA ("EDIPO"): A CHE #GIOCO GIOCHIAMO, #OGGI? IL #PIANETATERRA, L’#ECOLOGIA, E "L’ECOSOCIALISMO DI MARX")
- PIANETA TERRA E "PACE PERPETUA"... "Amazzonia": non è ora di invertire (velocissimamente) la rotta bellica del "progresso" planetario e rispondere alla questione antropologica di Kant e Feuerbach: «L’uomo è ciò che mangia»; e, infine, partendo dal "Convivio" o "Simposio" di Platone (da quanto si mangia e si beve, anche a "cena"), fare chiarezza ("claritas") sulle risposte da dare alle domande del lettore "operaio" di Brecht, e, possibilmente, anche... agli interrogativi della lettrice "operaia"?
"Sàpere aude!" (Kant, 1784). L’Illuminismo e il buon uso della propria intelligenza, della propria facoltà di giudizio, per uscire dallo "stato di minorità":
- "Nel 1784 Friedrich Gedike, un teologo protestante di simpatie illuministe che, proprio per queste ultime, era incorso nella censura prussiana, aveva scritto il breve articolo Su «mangia» ed «è». Un contributo alla spiegazione dell’origine del sacrificio, pubblicandolo nello stesso numero della «Berlinische Monatsschrift» che conteneva il saggio sull’Illuminismo di Moses Mendelssohn a cui rispose, com’è noto, quello celeberrimo di Kant." (Andrea Tagliapietra. 2017) *
- "Friedrich Gedike, Über ißt und ist. Ein Beitrag zur Erklärung der Opfer, „Berlinische Monatsschrift“, Hrsg. F. Gedike u. J.E. Biester, Vierter Bd., Julius bis December 1784, pp. 175-180." (Francesco Tomasone, 2015).
A)
ANDREA TAGLIAPIETRA, "La metafora gustosa. Feuerbach e la gastroteologia": "[...] Il detto italiano «parla come mangi», al di là dell’invettiva del luogo comune, rivela un fondo di verità difficilmente smentibile. La cultura umana si specchia, infatti, vuoi nelle parole del linguaggio che dalla bocca escono, vuoi in quegli alimenti e in quelle pietanze che nella bocca, invece, entrano.
Si inizia a intravedere, quindi, tutto lo spessore e la ricchezza che la frase di Feuerbach racchiude e che sta alla base del suo successo e della capacità di condensare molti motivi del pensiero del filosofo tedesco ben oltre l’immagine scolastica e polverosa dei manuali, che ne hanno fatto una sorta di mero raccordo della storia della filosofia fra Hegel e Marx. Del resto l’efficacia della massima appartiene già alla dimensione del significante e all’ambivalenza fonetica che ne fa oscillare il significato fra l’affermazione ontologica e la descrizione dell’azione di mangiare. Il gioco di parole Mensch ist, was er ißt è di fatto intraducibile nella nostra lingua, come anche nei principali idiomi europei correnti di cui abbiamo dato conto in apertura di questo saggio.
 Traducendo «l’uomo è ciò che mangia», infatti, noi rendiamo il significato principale della «formula», ma non quello allusivo, veicolato non dal significato ma dal significante delle parole. Esso nasce dall’assonanza, nella lingua tedesca, fra ist (= «è», terza persona singolare dell’indicativo presente del verbo sein, «essere») e ißt, ossia isst con la «s» raddoppiata (= «mangia», analoga voce del verbo essen, «mangiare»).
Traducendo «l’uomo è ciò che mangia», infatti, noi rendiamo il significato principale della «formula», ma non quello allusivo, veicolato non dal significato ma dal significante delle parole. Esso nasce dall’assonanza, nella lingua tedesca, fra ist (= «è», terza persona singolare dell’indicativo presente del verbo sein, «essere») e ißt, ossia isst con la «s» raddoppiata (= «mangia», analoga voce del verbo essen, «mangiare»).
 Per dare un’idea di ciò che qui risulta intraducibile ci viene in soccorso la lingua latina che, in virtù di un gioco linguistico affine al tedesco e, anzi, ancora più sofisticato, dal momento che l’ambiguità non è solo fonetica ma anche grafica, ci permette di volgere la formula feuerbachiana in homo est quod est, dove il primo est è la terza persona singolare dell’indicativo presente del verbo essere, mentre il secondo est è la terza persona singolare del verbo edere, cioè «mangiare». In questo caso, l’ambiguità grafica consente di leggere la «formula» in perfetta specularità, per cui possiamo tradurre sia con «l’uomo è ciò che mangia» sia con «l’uomo mangia ciò che è».
Per dare un’idea di ciò che qui risulta intraducibile ci viene in soccorso la lingua latina che, in virtù di un gioco linguistico affine al tedesco e, anzi, ancora più sofisticato, dal momento che l’ambiguità non è solo fonetica ma anche grafica, ci permette di volgere la formula feuerbachiana in homo est quod est, dove il primo est è la terza persona singolare dell’indicativo presente del verbo essere, mentre il secondo est è la terza persona singolare del verbo edere, cioè «mangiare». In questo caso, l’ambiguità grafica consente di leggere la «formula» in perfetta specularità, per cui possiamo tradurre sia con «l’uomo è ciò che mangia» sia con «l’uomo mangia ciò che è».Questi parallelismi linguistici avevano già una loro tradizione in cui forse Feuerbach, nelle sue ricerche intorno alla religione e al tema del sacrificio, può essersi imbattuto.
 Nel 1784 Friedrich Gedike, un teologo protestante di simpatie illuministe che, proprio per queste ultime, era incorso nella censura prussiana, aveva scritto il breve articolo Su «mangia» ed «è». Un contributo alla spiegazione dell’origine del sacrificio, pubblicandolo nello stesso numero della «Berlinische Monatsschrift» che conteneva il saggio sull’Illuminismo di Moses Mendelssohn a cui rispose, com’è noto, quello celeberrimo di Kant.
Nel 1784 Friedrich Gedike, un teologo protestante di simpatie illuministe che, proprio per queste ultime, era incorso nella censura prussiana, aveva scritto il breve articolo Su «mangia» ed «è». Un contributo alla spiegazione dell’origine del sacrificio, pubblicandolo nello stesso numero della «Berlinische Monatsschrift» che conteneva il saggio sull’Illuminismo di Moses Mendelssohn a cui rispose, com’è noto, quello celeberrimo di Kant.
 Nel saggio Gedike paragonava la prospettiva ontologica dell’uomo civilizzato, condensata nella massima cartesiana per cui cogito ergo sum («penso dunque sono») e per la quale il pensiero fa da fondamento all’essere, alla condizione naturale dei nostri progenitori, per i quali valeva piuttosto il detto edo ergo sum («mangio dunque sono»). La frase, volta alla terza persona singolare, suona, in latino, est, ergo est, con una coincidenza tra l’essere e il mangiare che la lingua tedesca conserva nella somiglianza fonetica fra ißt e ist. È quindi in questa prospettiva naturalistica ed elementare, concludeva Gedike, che mostra lo stretto legame, suggerito anche dal linguaggio, tra l’idea dell’essere e quella del nutrimento, che dobbiamo comprendere illuministicamente l’origine e l’importanza religiosa dei sacrifici e del pasto sacrificale.
Nel saggio Gedike paragonava la prospettiva ontologica dell’uomo civilizzato, condensata nella massima cartesiana per cui cogito ergo sum («penso dunque sono») e per la quale il pensiero fa da fondamento all’essere, alla condizione naturale dei nostri progenitori, per i quali valeva piuttosto il detto edo ergo sum («mangio dunque sono»). La frase, volta alla terza persona singolare, suona, in latino, est, ergo est, con una coincidenza tra l’essere e il mangiare che la lingua tedesca conserva nella somiglianza fonetica fra ißt e ist. È quindi in questa prospettiva naturalistica ed elementare, concludeva Gedike, che mostra lo stretto legame, suggerito anche dal linguaggio, tra l’idea dell’essere e quella del nutrimento, che dobbiamo comprendere illuministicamente l’origine e l’importanza religiosa dei sacrifici e del pasto sacrificale.Comincia a risaltare, allora, l’assonanza decisiva della massima, il suo senso duplice, ambivalente e intraducibile che, mentre afferma che l’«uomo è ciò che mangia», ribadisce anche che l’«uomo è ciò che è», richiamando la citazione diretta e, quindi, sottilmente dissacrante, del famoso versetto del libro biblico dell’Esodo in cui l’Altissimo, il Dio degli ebrei e dei cristiani, nomina se stesso. Un passo che ha, nell’originale ebraico, ehyeh asher ehyeh, un significato puramente negativo e antidolatrico, suonando più o meno come «io sarò quel che sarò», ossia un rifiuto da parte del Signore di rispondere all’impertinente domanda di Mosè su quale fosse il Suo nome. Eppure, già la Septuaginta, la Bibbia greca, in età alessandrina, trasporta l’enigmatico versetto scritturistico nei termini del linguaggio ontologico dei filosofi ellenici (egó eimí ho on) e la Vulgata traduce in latino ego sum qui sum, espressione che verrà interpretata dalla tradizione della Chiesa prevalentemente come un’affermazione. Anzi, come la dichiarazione stessa del fondamento metafisico dell’esistenza: «io sono colui che è». Si tratta del Qui est che, secondo la Summa Teologiae di Tommaso d’Aquino, è il nome proprio che più si addice a Dio.
 L’uomo, come la sua proiezione teologica alienata e fantasmatica, afferma dunque di essere ciò che è. Soltanto che, a differenza di Dio, ossia del desiderio che sublima se stesso nella vertigine dell’immaginazione, per essere ciò che è, l’uomo ha la necessità di mangiare, di nutrire il suo corpo, di misurarsi con la realtà della natura, con il bisogno e le difficoltà di soddisfarlo." (cfr. Ludwig Feuerbach, "L’uomo è ciò che mangia", di Andrea Tagliapietra, Boringhieri, Torino 2017, pp. 20-22. senza le note).
L’uomo, come la sua proiezione teologica alienata e fantasmatica, afferma dunque di essere ciò che è. Soltanto che, a differenza di Dio, ossia del desiderio che sublima se stesso nella vertigine dell’immaginazione, per essere ciò che è, l’uomo ha la necessità di mangiare, di nutrire il suo corpo, di misurarsi con la realtà della natura, con il bisogno e le difficoltà di soddisfarlo." (cfr. Ludwig Feuerbach, "L’uomo è ciò che mangia", di Andrea Tagliapietra, Boringhieri, Torino 2017, pp. 20-22. senza le note).B) FRANCESCO TOMASONI, "Ludwig Feuerbach: l’uomo e la sua alimentazione":
- "-La conclusione dell’opera ["L’Essenza del Cristianesimo", fls] consisteva nell’esaltazione dell’eucarestia [eucharistia, fls] secondo il suo significato etimologico, ossia come solenne ringraziamento per il pane e il vino grazie all’esperienza della fame" (Francesco Tomasoni).
"Nel 2015 si è svolto a Milano l’Expo, una manifestazione fieristica dal titolo “Nutrire il pianeta. Energia per la vita” che in 184 giorni e con 145 nazioni partecipanti, fra cui ovviamente il Brasile, ha avuto 21 milioni di visitatori. Sull’onda di questo evento è tornato di attualità il celebre motto di Feuerbach: «L’uomo è (ist) ciò che mangia (isst)». Nella lingua tedesca l’assonanza fra le terze persone del verbo essere e del verbo mangiare è evidente e suggerisce una stretta relazione fra essere e mangiare. Non a caso i critici dell’epoca vi videro un’espressione di rozzo materialismo, che poteva essere avvicinata alla frase di Karl Vogt: «I pensieri stanno press’a poco nel medesimo rapporto col cervello, come la bile al fegato o l’urina alle reni». Vogt era ben consapevole di usare un’espressione «in un certo senso rozza», ma intendeva dire che «tutte le attività psichiche» erano «solo funzioni della sostanza cerebrale».
Eppure l’assonanza fra essere e mangiare era già stata messa in rilievo più di sessant’anni prima da un teologo protestante di tendenze razionalistiche, Friedrich Gedike, in un articolo della prestigiosa rivista “Berlinische Monatsschrift”, in cui comparvero anche gli interventi di Kant, Mendelssohn e altri sul significato dell’illuminismo.
 Già nel titolo [Friedrich Gedike, Über ißt und ist. Ein Beitrag zur Erklärung der Opfer, „Berlinische Monatsschrift“, Hrsg. F. Gedike u. J.E. Biester, Vierter Bd., Julius bis December 1784, pp. 175-180.] egli evidenziava l’assonanza e mostrava che, ancor più che nel tedesco, in latino e in greco i due verbi coincidevano per alcune forme della flessione. Non si trattava dunque di un caso, bensì dell’effetto di un processo naturale. Per i popoli primitivi i concetti astratti erano troppo ardui, perciò al loro posto subentravano riferimenti materiali. Così «per l’uomo rozzo e ancora del tutto sensuale il concetto di essere, nei tempi della prima origine delle lingue, era troppo sottile e remoto [...] al contrario il concetto del mangiare era certamente uno dei primi sviluppatisi in lui».
Già nel titolo [Friedrich Gedike, Über ißt und ist. Ein Beitrag zur Erklärung der Opfer, „Berlinische Monatsschrift“, Hrsg. F. Gedike u. J.E. Biester, Vierter Bd., Julius bis December 1784, pp. 175-180.] egli evidenziava l’assonanza e mostrava che, ancor più che nel tedesco, in latino e in greco i due verbi coincidevano per alcune forme della flessione. Non si trattava dunque di un caso, bensì dell’effetto di un processo naturale. Per i popoli primitivi i concetti astratti erano troppo ardui, perciò al loro posto subentravano riferimenti materiali. Così «per l’uomo rozzo e ancora del tutto sensuale il concetto di essere, nei tempi della prima origine delle lingue, era troppo sottile e remoto [...] al contrario il concetto del mangiare era certamente uno dei primi sviluppatisi in lui».
 Poteva dunque argomentare nel modo seguente: mangia, dunque è (in latino: est, ergo est). La terza persona, nella quale la coincidenza era perfetta, rifletteva la mentalità primitiva secondo cui il soggetto osservava le cose fuori di sé, ma non era ancora giunto all’autocoscienza. L’identità fra essere e mangiare aveva anche indotto i primitivi a concludere che se gli dei esistevano, dovevano mangiare.
Poteva dunque argomentare nel modo seguente: mangia, dunque è (in latino: est, ergo est). La terza persona, nella quale la coincidenza era perfetta, rifletteva la mentalità primitiva secondo cui il soggetto osservava le cose fuori di sé, ma non era ancora giunto all’autocoscienza. L’identità fra essere e mangiare aveva anche indotto i primitivi a concludere che se gli dei esistevano, dovevano mangiare.
 Da qui i banchetti sacrificali, in cui si invitavano le divinità a condividere la mensa con gli uomini. Quanto più però questi si convincevano della superiorità degli dei, tanto più offrivano loro cibi preziosi, addirittura carne umana. Secondo Gedike i sacrifici umani erano venuti non alle origini, bensì in un periodo «intermedio di civiltà». Solo il raggiungimento pieno dell’illuminazione (Aufklärung) e della civiltà aveva fatto percepire l’abominio di quelle pratiche. In antitesi all’identità fra essere e mangiare, Gedike ricordava l’affermazione di Cartesio: «cogito ergo sum». L’autocoscienza dell’uomo civile si fondava sull’identità fra essere e pensiero. Per il teologo dunque al materialismo del primitivo si contrapponeva il razionalismo o lo spiritualismo dell’uomo moderno.
Da qui i banchetti sacrificali, in cui si invitavano le divinità a condividere la mensa con gli uomini. Quanto più però questi si convincevano della superiorità degli dei, tanto più offrivano loro cibi preziosi, addirittura carne umana. Secondo Gedike i sacrifici umani erano venuti non alle origini, bensì in un periodo «intermedio di civiltà». Solo il raggiungimento pieno dell’illuminazione (Aufklärung) e della civiltà aveva fatto percepire l’abominio di quelle pratiche. In antitesi all’identità fra essere e mangiare, Gedike ricordava l’affermazione di Cartesio: «cogito ergo sum». L’autocoscienza dell’uomo civile si fondava sull’identità fra essere e pensiero. Per il teologo dunque al materialismo del primitivo si contrapponeva il razionalismo o lo spiritualismo dell’uomo moderno.Benché non esistano prove del fatto che Feuerbach abbia letto questo articolo, esso è utile per comprendere il suo distacco da Hegel e i suoi due interventi sull’alimentazione e sui sacrifici. Anch’egli nel suo periodo giovanile aveva sottoscritto la concezione cartesiana, secondo cui l’essenza umana era data dal pensiero o dall’autocoscienza. Poi però nei Principi della filosofia dell’avvenire aveva negato che il carattere distintivo dell’uomo risiedesse semplicemente in quelli. La sua essenza era una totalità che si rifletteva nel complesso della sua sensibilità. Non si trattava solo della capacità di sentire e percepire, bensì di tutta la relazione corporea con la natura. Anche lo stomaco umano era essenzialmente diverso da quello degli animali: «Dagli animali l’uomo non si distingue solo grazie al pensiero. Tutta la sua essenza costituisce piuttosto tale differenza [...] Anzi, persino lo stomaco dell’uomo, malgrado noi lo guardiamo dall’alto in basso con disprezzo non è un’essenza ferina, ma umana, perché è universale, perché non deve servirsi di un tipo determinato di alimenti. Proprio per questo l’uomo non è affetto da quel furore vorace (Freßbegierde) con cui l’animale si getta sulla preda».
 L’universalità, che già nell’Essenza del cristianesimo Feuerbach aveva attribuito al genere umano, faceva sì che questo non si limitasse a un tipo di alimenti e quindi dimostrasse, anche nel mangiare, la sua libertà. In proposito egli si appoggiava alla distinzione, presente nella lingua tedesca, fra “essen”, mangiare proprio degli umani, e “fressen”, divorare tipico degli animali, aggiungendo come nel secondo caso lo stomaco assumesse il predominio su tutto, mentre nel primo caso esso era in armonia con la testa, ossia con la ragione e l’etica.
L’universalità, che già nell’Essenza del cristianesimo Feuerbach aveva attribuito al genere umano, faceva sì che questo non si limitasse a un tipo di alimenti e quindi dimostrasse, anche nel mangiare, la sua libertà. In proposito egli si appoggiava alla distinzione, presente nella lingua tedesca, fra “essen”, mangiare proprio degli umani, e “fressen”, divorare tipico degli animali, aggiungendo come nel secondo caso lo stomaco assumesse il predominio su tutto, mentre nel primo caso esso era in armonia con la testa, ossia con la ragione e l’etica.
 Un amico di famiglia, Georg Friedrich Daumer, criticò l’esaltazione che in questo passo Feuerbach aveva fatto dell’uomo rispetto agli animali [...] Daumer toccava un punto, al quale Feuerbach era stato sensibile fin dai primi scritti, quello della fame.
Un amico di famiglia, Georg Friedrich Daumer, criticò l’esaltazione che in questo passo Feuerbach aveva fatto dell’uomo rispetto agli animali [...] Daumer toccava un punto, al quale Feuerbach era stato sensibile fin dai primi scritti, quello della fame.Nello stesso brano della Storia della filosofia moderna che prima abbiamo ricordato per l’identificazione dell’essenza umana col pensiero, Feuerbach accennava alla fame come esempio per distinguere vari gradi di essere: «Un essere con uno stomaco riempito in modo da star bene è un essere molto più reale di un essere con stomaco vuoto». Lo stomaco vuoto rappresentava sensibilmente la contraddizione fra la presenza ideale dell’oggetto e la sua assenza reale, ossia la separazione da un ente, al quale per natura si era uniti. Già nella dissertazione De ratione Feuerbach si era soffermato su questa situazione per mettere in luce la tensione dialettica del desiderio.
Nelle Lezioni tenute a Erlangen come Privatdozent era tornato sull’argomento trattando dell’impulso o della pulsione (Trieb), un concetto già elaborato da Fichte, che avrebbe avuto grande fortuna nell’Ottocento fino a Freud e al suo famoso saggio della Metapsicologia: Le pulsioni e i loro destini (Triebe und Triebschicksale). Aveva affermato: «Un altro esempio è l’appagamento dell’impulso (Triebes) stesso; quando calmo la fame, questo calmarla in quanto appagamento è affermazione della mia vita, un godimento, ma questo godimento c’è in me soltanto in quanto c’è la fame, il non godimento [...] al godimento spetta l’essere e il non essere». Nel Leibniz Feuerbach aveva spiegato ulteriormente il rapporto con l’oggetto, presente negli impulsi e, in particolare, nella fame e nella sete: «A dispetto di tutti gli empiristi fame e sete sono due filosofi a priori; esse anticipano e deducono a priori l’esistenza dei loro oggetti». Nella loro struttura ontica era dunque insito l’oggetto, prima che si presentasse nelle cose sensibili.
 Questa visione caratterizza nell’Essenza del cristianesimo la relazione del soggetto con l’oggetto: «L’uomo non è nulla senza oggetto [...] Tuttavia l’oggetto al quale un soggetto si riferisca essenzialmente, necessariamente non è altro che l’essenza propria di questo soggetto, ma resa oggettiva».
Questa visione caratterizza nell’Essenza del cristianesimo la relazione del soggetto con l’oggetto: «L’uomo non è nulla senza oggetto [...] Tuttavia l’oggetto al quale un soggetto si riferisca essenzialmente, necessariamente non è altro che l’essenza propria di questo soggetto, ma resa oggettiva».
 La conclusione dell’opera consisteva nell’esaltazione dell’eucarestia secondo il suo significato etimologico, ossia come solenne ringraziamento per il pane e il vino grazie all’esperienza della fame: «Per comprendere il significato religioso della consumazione del pane e del vino mettiti nella situazione in cui quell’atto altrimenti quotidiano venga, contro natura, violentemente, interrotto. La fame e la sete non distruggono solo la forza fisica, bensì anche quella spirituale e morale dell’uomo, lo spogliano dell’umanità, dell’intelletto, della coscienza. Oh! Se tu mai provassi tale mancanza, tale infelicità, allora come benediresti e loderesti la qualità naturale del pane e del vino che ti ridonano la tua umanità, il tuo intelletto! Così basta solo interrompere il consueto, comune corso delle cose per restituire a quanto è comune un significato non comune, alla vita in quanto tale un significato assolutamente religioso. Santo sia per noi quindi il pane, santo il vino, ma santa anche l’acqua! Amen» [...]" (cfr. Francesco Tomasoni, Università del Piemonte Orientale, Vercelli - ripresa parziale, senza le note, pp. 109-112).
La conclusione dell’opera consisteva nell’esaltazione dell’eucarestia secondo il suo significato etimologico, ossia come solenne ringraziamento per il pane e il vino grazie all’esperienza della fame: «Per comprendere il significato religioso della consumazione del pane e del vino mettiti nella situazione in cui quell’atto altrimenti quotidiano venga, contro natura, violentemente, interrotto. La fame e la sete non distruggono solo la forza fisica, bensì anche quella spirituale e morale dell’uomo, lo spogliano dell’umanità, dell’intelletto, della coscienza. Oh! Se tu mai provassi tale mancanza, tale infelicità, allora come benediresti e loderesti la qualità naturale del pane e del vino che ti ridonano la tua umanità, il tuo intelletto! Così basta solo interrompere il consueto, comune corso delle cose per restituire a quanto è comune un significato non comune, alla vita in quanto tale un significato assolutamente religioso. Santo sia per noi quindi il pane, santo il vino, ma santa anche l’acqua! Amen» [...]" (cfr. Francesco Tomasoni, Università del Piemonte Orientale, Vercelli - ripresa parziale, senza le note, pp. 109-112).FLS
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- CULTURA E SOCIETA’: "LA PSICOANALISI HA UN FUTURO?". UNA NOTA A MARGINE DI UNA DISCUSSIONE E DI UNA RILESSIONE IN CORSO.18 gennaio 2024, di Federico La Sala
CULTURA E SOCIETA’.
UNA NOTA A MARGINE DI UNA DISCUSSIONE E DI UNA RILESSIONE IN CORSO SUL TEMA: "LA PSICOANALISI HA UN FUTURO?" *
#FILOLOGIA E #ANTROPOLOGIA. IL PROBLEMA DEL "CONOSCI TE STESSO" E DEL "CONOSCI TE STESSA", E LA "#CRITICA DELLA #FACOLTÀ DI #GIUDIZIO: IL CORAGGIO DEL "#SÀPERE AUDE" (#ORAZIO).
#A GLORIA DI #FREUD E A OMAGGIO DI #KANT2024. Ricordando l’eccezionale #coraggio degli #inizi della #psicoanalisi ("L’#interpretazione dei #sogni", 1899) e il coraggio di servirsi della propria intelligenza dell’#illuminismo kantiano ("Risposta alla domanda: che cosa è l’Illuminismo",1784), e, al contempo, il #grido di allarme di #SigmundFreud, lanciato da #Vienna nel 1929, sul "#Disagiodellaciviltà" (e nella #civiltà), a riguardo, può essere interessante e utile un ulteriore approfondimento e una riflessione supplementare, alla luce di una personale #ricerca (del 2010), proprio sul tema storico-filosofico relativo alle ragioni stesse della #domanda sul futuro della tradizione filosofica, picoanalitica, e della stessa civiltà (cfr. "KANT, FREUD, E LA BANALITA’ DEL MALE" ).
*
NOTA: LA PSICOANALISI HA UN FUTURO?-> (REGISTRAZIONE INCONTRO - organizzato da Casa della cultura [MILANO], Fondazione Lelio e Lisli Basso).
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! - "L’UOMO E’ CIO’ CHE MANGIA" (FEUERBACH). Un invito alla riflessione critica sul "pane" artistico quotidiano (7 Gennaio 2024).7 gennaio 2024, di Federico La Sala
FILOLOGIA E "SÀPERE AUDE" (ORAZIO-KANT): "L’UOMO E’ CIO’ CHE MANGIA" (LUDWIG #FEUERBACH). Un invito alla riflessione critica sul "pane" artistico quotidiano, di cui ci cibiamo... 7 Gennaio 2024
STORIA SOCIALE DELL’ ARTE E USO DELLE #IMMAGINI A FINI DI PROPAGANDA DI FEDE (TEOLOGICO-POLITICA E ANTROPOLOGICA), SOPRATTUTTO DELLA FIGURA DELL’#UOMO PER ECCELLENZA ("ECCE HOMO", VALE A DIRE DELLA FIGURA DI GESU’ CRISTO).
STORIA E STORIOGRAFIA: DA COSTANTINO A COSTANTINO, NICEA (325-2O25). SI RACCONTA CHE #CarloMagno, rimasto affascinato dal canto di certi monaci greci che celebravano il #Battesimo del #Signore, fece tradurre in latino i testi che aveva udito cantare, forse, per ringraziarlo di questo prezioso e importante gesto, i grandi esperti della Chiesa Cattolica del tempo confezionarono la famosa "Donazione di Costantino":
- "Si tratta di un documento, fabbricato probabilmente nel periodo 750-850 a Roma o a S. Denis, che pretende di essere l’atto diplomatico con il quale l’imperatore Costantino avrebbe donato nel 314 al papa Silvestro I la giurisdizione civile su Roma, sull’Italia e sull’intero Occidente; e avrebbe onorato la Chiesa romana attribuendole i poteri e le dignità dell’Impero sì che il pontefice potesse portare insegne imperiali, e che il clero di Roma avesse gli stessi onori degli ufficiali dell’Impero, esprimendo inoltre la volontà che il vescovo di Roma avesse il ‛ principatum ’ sui patriarchi orientali, e, di conseguenza, su tutte le chiese del mondo; ordinando infine che la basilica lateranense fosse venerata quale ‛ caput et vertex ’ di tutte le chiese, e che il palazzo del Laterano divenisse residenza ufficiale dei pontefici. [...]" (Pier Giorgio Ricci, Enciclopedia Dantesca, Treccani).
CONSIDERATO che "nel 1440 l’umanista italiano Lorenzo Valla dimostrò in modo inequivocabile che la donazione era un falso", e, che il suo lavoro, "De falso credita et ementita Constantini donatione declamatio" ("Discorso sulla donazione di Costantino, altrettanto malamente falsificata che creduta autentica"), poté essere pubblicato solo nel 1517 e in ambiente protestante, mentre la Chiesa cattolica difese per secoli la tesi dell’originalità del documento", e, ancora, che "nel 1559 lo scritto di Valla fu incluso nell’indice dei libri proibiti in quanto pericoloso per la fede [...]" (Donazione di Costantino), FORSE, è importante e utile (dal punto di vista antropologico) avere in mente non solo l’#uomovitruviano->https://it.wikipedia.org/wiki/Uomo_vitruviano], ma anche (v. allegato: figura di Mercurio con caduceo *) l’uomo mercuriale (l’uomo #ermetico) di un sopravvissuto affresco di fine #Quattrocento, conservato in una "Casa di caccia" della Milano di #Ludovico il #Moro (e di #Leonardo da Vinci), un #segnavia importante della tradizione di "Mercurio e la filologia", della tradizione ermetica e dell’ermetismo cristiano.
- "ORAZIONE E #PITTURA TRA «#PROPAGANDA» E #DEVOZIONE AL TEMPO DI #SISTOIV. [...] A proposito del dibattito sull’Immacolata Concezione e delle vivacissime forme che lo caratterizzarono tra l’ottavo decennio del #Quattrocento e gli inizi del #Cinquecento sono state utilizzate di recente espressioni come « mezzi pubblicitari » e « manifesti dottrinali » ponendo così l’accento sull’intensa ricerca, da parte delle istituzioni ecclesiastiche, di appropriati canali di comunicazione per ampliare il confronto sulla dottrina che, proprio in quel secolo, aveva conquistato basi più salde, anche se il definitivo assestamento maturerà solo nel 1854. Una data cardine fu il 1477, allorché il papa francescano Sisto IV autorizzò la celebrazione della festa e approvò l’Ufficio, appositamente composto da Leonardo Nogarolo, concedendo ampia indulgenza per la partecipazione alla liturgia. La tesi della « preservazione » di Maria dal peccato originale, pur trovando sempre maggiori consensi, continuò ad essere avversata soprattutto dai Domenicani. [...]" (cf. #ArnaldaDALLAJ: "IL CASO DELLA MADONNA DELLA MISERICORDIA DI GANNA"").
- ERMETISMO ED #ECUMENISMO: PER "LA PACE DELLA FEDE" (Niccolò Cusano, 1453)... NICEA (325-2025)?
*
-
>PENSARE BENE "DIO", "IO" E "L’ITALIA" --- FILOSOFIA E STORIA: ANTROPOLOGIA ("ECCE HOMO") O ANDROCENTRISMO ("ECCE VIR")?29 dicembre 2023, di Federico La Sala
FILOLOGIA, FILOSOFIA, E STORIA: ANTROPOLOGIA ("ECCE HOMO") O ANDROCENTRISMO ("ECCE VIR")?
Una citazione teologico-politica paolina a margine dello stato di cose presente:
«Colui che discese è lo stesso che anche ascese al di sopra di tutti i cieli, per essere pienezza di tutte le cose. Ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all’unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all’uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo
 ["omnes in unitatem fidei et agnitionem Filii Dei, in virum perfectum, in mensuram aetatis plenitudinis Christi ";
["omnes in unitatem fidei et agnitionem Filii Dei, in virum perfectum, in mensuram aetatis plenitudinis Christi ";
 "οἱ πάντες εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ, εἰς #ἄνδρα τέλειον"].
"οἱ πάντες εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ, εἰς #ἄνδρα τέλειον"].
 Così non saremo più fanciulli in balìa delle onde, trasportati qua e là da qualsiasi vento di dottrina, ingannati dagli uomini con quella astuzia che trascina all’errore. Al contrario, agendo secondo verità nella carità ["in charitate"], cerchiamo di crescere in ogni cosa tendendo a lui, che è il capo, Cristo.» (Paolo di Tarso, Ef. IV, 10-15).
Così non saremo più fanciulli in balìa delle onde, trasportati qua e là da qualsiasi vento di dottrina, ingannati dagli uomini con quella astuzia che trascina all’errore. Al contrario, agendo secondo verità nella carità ["in charitate"], cerchiamo di crescere in ogni cosa tendendo a lui, che è il capo, Cristo.» (Paolo di Tarso, Ef. IV, 10-15).fls
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- A quanto pare, ancora fermi a Niccolò Cusano e alla sua teologia-politica delle "congetture": con l’astuzia paolina della "dotta ignoranza" (1440).19 dicembre 2023, di Federico La Sala
FILOLOGIA STORIA FILOSOFIA ANTROPOLOGIA:
USCIRE DAL SONNO DOGMATICO (KANT). Chi di potenza ferisce, di potenza perisce. Queste le "regole del gioco" dell’Occidente? A quanto pare, l’#Europa è ancora ferma a Niccolò #Cusano e alla sua teologia-politica delle "congetture": con l’#astuzia paolina della "dotta ignoranza" (1440), quale "setaccio" ("cribratio") può fondare il #dialogo tra le religioni e la "pace della fede" (1453)? Non è meglio ripartire dalla "caduta" ("donazione") di #Costantino (#LorenzoValla, 1440), per capire e andare oltre la "caduta di #Costantinopoli" (1453) e, #oggi (nell’anno dell’#Incarnazione del #Natale2023), oltre #Nicea (325-2025)?! Se non ora, quando?
#STORIAELETTERATURA E #STORIOGRAFIA: LE “#REGOLEDELGIOCO" DELL’EUROPA (DI #IERI). A partire dal 1492: "Su cosa è stato edificato il nuovo mondo? Genocidi e stermini. Chi ha dato il nome a questo nuovo mondo? Un Vespucci (in verità non lui direttamente, ma ricordiamoci dei ragni e delle formiche di Bacone). Chi ha chiamato così l’Amazzonia? E, chi così il Brasile? A Napoli, sì sempre a Nea-polis, questo nome ricorda la brace, il braciere, persone intorno a un fuoco che riscalda, un cerchio familiare che si apre e accoglie chi ha freddo - non la devastazione e il deserto di chi cieco e folle si mette a distruggere tutto: Edipo con in mano il lancia-fiamme a volontà - Platone, il Tecno-crate. Di fronte alla Foresta gli uomini ciechi e folli di potenza (ma qui si parla anche delle donne-amazzoni) vedono nulla e fanno e ... faranno il Brasile?” (cfr. Federico La Sala, "La mente accogliente. Tracce per una svolta antropologica", Antonio Pellicani Editore, Roma 1991, pp. 180-181).
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- FILOSOFIA DELL’ARITMETICA. La crisi della matematica è un problema politico: un’ipoteca sui cittadini del futuro (di Raffaele Cariati).1 dicembre 2023, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA, FILOLOGIA, EDUCAZIONE CIVICA, E PSICOANALISI DELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA: UNA QUESTION HAMLETICA E UNA DOMANDA AI MATEMATICI E ALLE MATEMATICHE.
- Come "è stata possibile un’operazione matematica ritenuta abitualmente sbagliata: un uomo più una donna ha prodotto, per secoli, un uomo" (Franca Ongaro Basaglia)?!? Non è il caso di ripensare i fondamenti e uscire dall’orizzonte della tragedia e dall’infernale letargo antropologico ed epistemologico (Dante Alighieri, Par. XXXIII, 94)?!
La crisi della matematica è un problema politico: un’ipoteca sui cittadini del futuro
di RAFFAELE CARIATI (Domani, editoriale, 27 novembre 2023)
- Sia in Francia che in Italia si è parlato negli ultimi anni di “emergenza matematica”, ma le soluzioni per affrontarla sono state inadeguate e miopi. Il sapere matematico non si può ridurre a “fare calcoli” ma cambia il modo in cui capiamo e interpretiamo il mondo
In Francia nel 2019 succede questo: «Emergenza matematica repubblicana», dichiara Emmanuel Macron durante il suo primo quinquennio di presidenza in Francia, riconoscendo il problema dell’esclusione dall’insegnamento-apprendimento della matematica. L’esclusione dall’apprendimento della matematica ha un impatto sulla fiducia in sé stessi, induce senso di inadeguatezza, porta i cittadini a delegare sui ragionamenti complessi e a preferire le semplificazioni e le diffidenze ostacolando la formazione di una cittadinanza consapevole.
Il governo francese di Emmanuel Macron pensa di governare centralmente il problema, di migliorare le sorti dell’apprendimento della matematica e di affidarne la soluzione a uno dei nomi più prestigiosi della matematica, Cedric Villani (medaglia Fields 2010, deputato della Repubblica). Il risultato è il “Rapporto Villani” che propone ventuno “misure”, senza però suscitare grandi entusiasmi: tanti buoni propositi, ma una visione elitaria ha iniziato a farsi strada. Infatti, la riforma dei licei à la carte voluta da Jean-Michel Blanquer, ministro dell’Educazione Nazionale, ha come conseguenza la significativa diminuzione della partecipazione all’insegnamento della matematica.
La matematica non fa più parte delle materie insegnate a tutti gli studenti, può essere scelta solo come materia di indirizzo possedendo certi requisiti di ingresso. Il risultato è l’abbandono dello studio della disciplina, gli studenti dal primo all’ultimo anno del liceo perdono il 20% delle ore di insegnamento della matematica. Le intenzioni di Macron si rovesciano nel loro contrario. ll quotidiano Libération denuncia: «È uno scandalo che non scandalizza nessuno». E Le Monde aggiunge: la riforma ha fatto scendere dal 90% al 59% la percentuale di alunni che seguono un insegnamento di matematica durante l’ultimo anno. Ancora più grave: l’abbandono coinvolge in maniera maggioritaria le studentesse.
Questa breve storia triste si conclude con il riconoscimento da parte di Jean-Michel Blanquer di un errore di calcolo e con il tentativo del suo successore, Pap Ndaye, di invertire la tendenza introducendo un’ora e mezza di matematica nel tronco comune.
Qualcosa di simile avviene anche in Italia. Molti hanno dimenticato che una “emergenza matematica” è stata dichiarata anche nel nostro Paese, e che è si è tentato di gestirla con un metodo molto simile alla strategia Villani. Nel 2007 Giuseppe Fioroni, ministro dell’Istruzione, insedia il Comitato nazionale dei Matematici con il compito di definire le iniziative per contrastare quella che definisce, appunto, “emergenza matematica”. L’opinione pubblica è stata investita da semplificazioni e slogan del tipo «matematica bestia nera degli italiani», «italiani asini in matematica», alimentando le forme più feroci di innatismo, impotenza appresa.
La matematica, dunque, è un problema di tutti. Il Comitato, costituito da trenta esperti e presieduto dall’altissimo profilo di Edoardo Vesentini, rettore della Normale di Pisa, già senatore della Repubblica, studia il problema e indica cosa fare. Ma purtroppo il comitato non va avanti, a causa di un’incapacità collettiva. Resta un’occasione persa insieme alla questione: cosa vuol dire politicamente l’emergenza matematica?
Il tema è stato ben argomentato da Martine Quinio-Benamo nell’articolo “Les mathématiques, c’est politique” apparso su Libération nel febbraio 2022: per fare matematica non si tratta solo di calcolare e ragionare, ma anche di distinguere i punti di vista e di comunicare.
Per esempio: «Dall’inizio del quinquennio di governo Macron il potere di acquisto dei più ricchi è aumentato del 4,1% ed è diminuito dello 0,5% quello dei più poveri. Il potere di acquisto è aumentato in media dell’1,6%». La conclusione sull’aumento medio dell’1,6% è stata ripresa con enfasi dai decisori della comunicazione mass-mediatica, ma si riferisce a una media impossibile da verificare in quanto non riflette l’aumento delle disuguaglianze. Pur supponendo che il potere di acquisto sia aumentato in percentuale (il che è falso per i più poveri), un aumento debole di una o due percentuali si traduce in un incremento salariale bassissimo per le classi medie.
Il tema insomma è l’assenza della formazione a un pensiero-atteggiamento matematico.
I giornali spesso non sono in grado di esaminare i dati numerici avanzati dai politici. E le informazioni che contengono dati numerici corretti possono essere smentite da interlocutori mal formati al ragionamento matematico. Il piano del dibattito diventa «Ci mentono tutti!». Ovviamente, non sono i numeri a mentire, ma una loro interpretazione pigra e decontestualizzata. Secondo la professoressa Quinio-Benamo, si fa strada l’ipotesi per cui «l’incompetenza scientifica prevale sulle cattive intenzioni», e se le decisioni sono assunte anche in nome della realtà e dell’interpretazione dei numeri, allora la matematica è politica e il suo insegnamento-apprendimento è una questione politica.
La matematica è quindi politica nella misura in cui si cerca di rispondere alla domanda: cosa può fare la matematica nella nostra comprensione del mondo? Potrebbe essere “fare politica” gestire l’emergenza matematica non focalizzandosi solo sulle abilità matematiche in chiave professionalizzante, ma anche e soprattutto sul processo educativo che stimoli ad assumere un atteggiamento filosofico che supporti la trasformazione delle informazioni in conoscenze e nella capacità emancipatrice di operare scelte.
In Italia la questione è stata ampiamente affrontata da Bruno D’Amore (professore di Didattica della matematica all’Università di Bologna) che definisce l’educazione matematica come «il sistema sociale complesso ed eterogeneo che, in sinergia con l’epistemologia, la sociologia, la psicologia, la semiotica e la pedagogia include la teoria e lo sviluppo e la pratica relativa all’insegnamento-apprendimento della matematica ed include la didattica della matematica come sottosistema».
L’insegnamento-apprendimento della matematica sembra essere in uno stato di crisi cronica, ma il vero problema non è l’insegnare ad insegnare. All’origine di questo fenomeno ci sono molteplici cause, ma il problema ha a che fare con il ruolo che la matematica recita nella società e la sua influenza sul dibattito pedagogico.
Possiamo allora rovesciare la questione: Guy Brousseau nella Théorie des situations didactiques e la teoria del Contrat didactique analizza cosa determini un mancato apprendimento, studia il fallimento elettivo in matematica determinato dalle abitudini specifiche dell’insegnante attese dall’allievo e i comportamenti dell’allievo attesi dal docente. Queste attese sono dovute a una concezione della scuola percepita come direttiva ed essenzialmente valutativa: anche situazioni didattiche proposte come “libere” vengono elaborate e vissute dall’allievo come un test o come un controllo. Queste attese nascono da concezioni sulla matematica (“in matematica bisogna fare solo calcoli”) e soprattutto alla ripetizione di modalità sociali.
Perdiamo “il corpo umano della matematica”! A causa del “si devono fare i calcoli”, si ritiene che le parole non siano importanti, sia sufficiente usare i dati numerici, anche a caso, per fornire risposte formali. Si perde l’obiettivo culturale della matematica, si smarrisce l’agire matematico che si confonde con le richieste degli insegnanti. Soprattutto: l’unica occasione che hanno gli studenti di entrare in contatto con la matematica è la scuola. Ciò alimenta la credenza diffusa secondo la quale i libri di matematica sono le raccolte stereotipate di esercizi presenti nei libri di testo scolastici.
Secondo Bruno D’Amore, «tutto risale all’ignoranza beota di chi distingue le culture creandone una di serie A e una di serie B, facendosi forza talvolta con lo spirito e le parole di Giovanni Gentile secondo cui l’intrusione delle scienze nel mondo scolastico ha arrecato dannosissimi frutti e la matematica, in particolare, è morta, infeconda, arida come un sasso». Come si può contrastare l’accanimento anti-matematico di matrice gentiliana?
Nel testo Faire l’école, faire la classe, il pedagogista Philippe Meirieu delinea lucidamente un principio su cui istituire la scuola che curi l’educazione matematica: «Per poter costruire uno spazio pubblico orientato alla trasmissione delle conoscenze, la scuola deve sospendere violenza e seduzione, collocando al centro della propria organizzazione le esigenze di esattezza, precisione e verità».
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- UN PREISTORICO "SIMPOSIO" ALL’OMBRA DELLA "EU+CARESTIA" E UNA FENOMENOLOGIA DELLA TRAGEDIA.31 ottobre 2023, di Federico La Sala
L’UMANITÀ (ANTROPOLOGIA), IL "RAPPORTO SOCIALE DI PRODUZIONE" (ECONOMIA POLITICA) E IL PERSISTERE DI UN "PREISTORICO" SIMPOSIO ALL’OMBRA DELLA "EU+CARESTIA"!!!
- UNA NOTA SU UNA AMLETICA "QUESTION" DI LUNGA DURATA DI FILOLOGIA E TEOLOGIA...
MINIMALISMO ED ESSENZIALISMO: "SÀPERE AUDE" (DECIDERSI A DIVENTARE SAGGIO, AD AS-SAGGIARE, A USCIRE DALLO "STATO DI MINORITÀ" (ORAZIO E KANT). A ben riflettere sulla "essenza del cristianesimo" di Ludwig Feuerbach, e, al contempo, sul problema della "eucharistia", del cibarsi della grazia ("charis") di Dio ("charitas"), forse, si può meglio cominciare a capire la profondità teologico-politica ed economica della sua "banalizzatissima" considerazione che «L’uomo è ciò che mangia»!
IN UN TESTO BRILLANTISSIMO, all’interno di un "presente storico" di secoli, segnato da una grande carestia filologica e logica, così è scritto: "La vita spirituale - di chi «nasce un seconda volta» aderendo a Cristo - poggia sulla preghiera continua e sull’#eucarestia [...]" (cfr. Flavio Piero Cuniberto, "SUL CRISTIANESIMO COME MITO E COME MISTERO). E, proseguendo; si arriva a fare propria la tesi di #RenéGirard: "L’idea che la morte di Cristo sulla croce sia il prezzo del riscatto («redenzione» da «red-imere», «riscattare») non è che una versione cristianizzata della pratica ancestrale del #bouc #émissaire, il #caproespiatorio di Girard. Una versione mitologica del mistero cristiano." (op. cit.).
IL CANTO DEL CAPRO E LA FENOMENOLOGIA DELLA TRAGEDIA: "ECCE HOMO" (PILATO). Accecati dall’astuzia della ragione platonico-hegeliana, invece di fare chiarezza sul "capro espiatorio", si rinnova la confusione e la condanna a morte proprio dell’agnello (dell’#ariete, del montone) che ha portato Ulisse (e Dante) in salvo, fuori dalla caverna e dall’inferno!
 Dopo Nietzsche ("Ecce Homo", 1888), che ha denunciato l’imbroglio storico-antropologico del #paolinismo, a partire dalla morte di Dio, e di Gesù ("Ecce Homo"), chi ha mai più visto sulla Terra un cristiano, una cristiana?
Dopo Nietzsche ("Ecce Homo", 1888), che ha denunciato l’imbroglio storico-antropologico del #paolinismo, a partire dalla morte di Dio, e di Gesù ("Ecce Homo"), chi ha mai più visto sulla Terra un cristiano, una cristiana?
 Nonostante Gioacchino da Fiore, Francesco d’Assisi, Chiara di Assisi, Dante Alighieri, e, addirittura, il lavoro iperstorico ("preistorico" e archeologico) sulle radici "Cosmicomiche" della Terra (Italo Calvino), Diogene di Sinope, definito dalla tradizione "Socrate pazzo", continua ad andare con la sua lanterna accesa, alla luce del sole, per i mercati, a cercare l’uomo ("anthropos") e a sognare il #sorgeredellaterra...
Nonostante Gioacchino da Fiore, Francesco d’Assisi, Chiara di Assisi, Dante Alighieri, e, addirittura, il lavoro iperstorico ("preistorico" e archeologico) sulle radici "Cosmicomiche" della Terra (Italo Calvino), Diogene di Sinope, definito dalla tradizione "Socrate pazzo", continua ad andare con la sua lanterna accesa, alla luce del sole, per i mercati, a cercare l’uomo ("anthropos") e a sognare il #sorgeredellaterra... -
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- LA "QUESTION" DI "AMLETO" E LA "STORIA" DI EDIPO. APPUNTI in onore di “Sigismondo di Vindibona” (1856-1939) e di Italo Calvino (1923 -1985).29 ottobre 2023, di Federico La Sala
L’ AMLETICA “QUESTION” DI ELISABETTA I (REGINA D’INGHILTERRA E PAPA DELLA CHIESA ANGLICANA), LA LEZIONE SULLA “VISIBILITA” (“VISIBILITY”) DI ITALO CALVINO, E IL PROBLEMA DEL “MODELLO PATRIARCALE”.
- “C’è un verso di Dante nel Purgatorio (XVII, 25) che dice: «poi piovve dentro a l’alta fantasia»”: una nota in memoria di “Sigismondo di Vindibona” (1856-1939) e di Italo Calvino (1923 -1985). *
A MARGINE E A PROPOSITO DELL’ “USO PERSUASIVO E PROPAGANDISTICO DELLA FAMIGLIA” (DEL “PRESEPE”) E DEGLI ANTROPOMORFISMI MESSI IN LUCE NELLA RIFLESSIONE SUL “BENTORNATO MASCHIO” (Gianfranco Pellegrino, "Le parole e le cose", 26 ottobre 2023), FORSE, non sarebbe male se la sollecitazione a riflettere venisse accolta soprattutto dalle antropologhe, dalle filosofe, dalle psicoanaliste, e dalle teologhe:
- “Alcune autrici hanno proposto una definizione sociale delle donne. Per loro, essere donna significa occupare una specifica posizione sociale, e essere trattate in certi modi, subire certe reazioni, e così via. [...] Semplificando, in questo tipo di visioni, essere una donna o un uomo è un fatto di potere. Sei donna se subisci un certo tipo di potere, quello patriarcale, sei uomo se non lo subisci e lo eserciti.
 L’obiezione che viene subito in mente, e che è stata fatta più volte, è: ma allora la regina Elisabetta I non è una donna? [...]
L’obiezione che viene subito in mente, e che è stata fatta più volte, è: ma allora la regina Elisabetta I non è una donna? [...]
 la narrazione femminista, sostenuta dai maschi democratici dalla lunga, lunga coda di paglia, non prevede donne che non siano vittime del sistema e uomini che non siano carnefici [...] Il maschio tossico è ancora qui, anche se s’incarna nella prima donna premier d’Italia. [...]” (G. Pellegrino, cit.).
la narrazione femminista, sostenuta dai maschi democratici dalla lunga, lunga coda di paglia, non prevede donne che non siano vittime del sistema e uomini che non siano carnefici [...] Il maschio tossico è ancora qui, anche se s’incarna nella prima donna premier d’Italia. [...]” (G. Pellegrino, cit.).
*
VISTO CHE il “modello patriarcale” come strumento di analisi fa acqua da tutte le parti, almeno dal tempo della “dialettica” di Hegel, e, ancor di più, dopo Freud e la sua indicazione a muoversi ad usare il “modello edipico completo”, è più che augurabile fare qualche passo avanti teorico e pensare a un modello “patriarcale-matriarcale” (padrone-serva e padrona-servo), alla luce delle “Lezioni americane” (non solo la quarta, la “Visibilità”) e del “Castello dei destini incrociati” (in particolare, del capitolo della seconda parte, “La taverna dei destini incrociati”, col titolo “Anch’io cerco di dire la mia”).
 Federico La Sala
Federico La SalaP. S. - LETTERATURA E PSICOANALISI: “IL CASTELLO DEI #DESTINI INCROCIATI” (ITALO CALVINO). L’INCONTRO CON “SIGISMONDO DI VINDIBONA” [VIENNA] NELLA “TAVERNA DEI DESTINI INCROCIATI”. Una “presentazione” del mito di Edipo con le carte dei Tarocchi:
“ANCH’IO CERCO DI DIRE LA MIA. [...] Tutto questo è come un sogno che la parola porta in sé e che passando attraverso chi scrive si libera e lo libera. Nella scrittura ciò che parla è il represso. E allora Il Papa dalla barba bianca potrebbe essere il gran pastore d’anime e interprete di sogni Sigismondo di Vindobona, e per averne conferma non c’è che verificare se da qualche parte del quadrato dei tarocchi si riesce a leggere la storia che, a quanto insegna la sua dottrina, si nasconde nell’ordito di tutte le storie. [...]” (cfr. I. Calvino, “Anch’io cerco di dire la mia”, “Romanzi e racconti” II, Meridiani, Mondadori, 1992, pp. 592-595).
 Federico La Sala
Federico La SalaP. S. 2 - ARCHEOLOGIA FILOSOFICA, MATEMATICA, E FILOLOGIA...
“Bentornato maschio”( v. sopra) non è solo una chiamata in causa di intellettuali di ogni genere e di ogni specie, ma anche, e prima di tutto, è un segnavia “storico” per ogni cittadino e ogni cittadina per dare alla amletica “question” teologico-politica posta da Shakespeare, in stretto collegamento alla presenza sul trono d’Inghilterra di Elisabetta I, regina e papessa della Chiesa anglicana, una propria risposta all’altezza dell’attuale “presente storico” - è una chiamata ad uscire dall’epocale “stato di minorità”, personale e politico (Immanuel Kant, 1784 - Michel Foucault, 1984) !
“DUE SOLI” (DANTE ALIGHIERI). Re-interrogarsi alla Kantorowicz sulla “regalità antropocentrica: Dante”, sui “due corpi del re” e, ovviamente, anche sui “due corpi della regina”, forse, può essere una buona occasione per svegliarsi dal sonno dogmatico e portarsi fuori dalla cosmoteandria, atea e devota! Se non ora, quando?!
QUESTIONE MATEMATICA E ANTROPOLOGICA. Per approfondimenti, volendo accogliere alcune indicazioni sul tema, si potrebbe ricominciare a contare da almeno da due o, meglio da “Quattro”, dal poema di Italo Testa (“Le parole e le cose”, 3 Settembre 2021).
-
>STORIA, FILOSOFIA, LETTERATURA, E PSICOANALISI ---- LA NAVE DEI FOLLI, LA STORIA DELLA FOLLIA, E LA PROPOSTA DI UN "SATANARIUM".15 ottobre 2023, di Federico La Sala
EUROPA, NAVE DEI FOLLI E STORIA DELLA FOLLIA. L’interpretazione dei sogni (S. Freud, 1899) è un’arte e una scienza molto difficile, a quanto pare: dall’orizzonte della tragedia, l’umanità è incapace di uscire? *
- LA NAVE DEI FOLLI
- di Pietro Barbetta (Doppiozero, 27 Febbraio 2013)
Una gita a Clusone e una a Pinzolo non guastano. La danza macabra di Borlone de Buschis di Clusone (1485) e quella di Simone Baschenis di Pinzolo (1539) segnano forse l’inizio e la fine di un periodo di comunità inconfessabile (Blanchot, 1983). Inconfessabile perché composta di trapassati, che, in quanto tali, già sono passati in giudicato, ingiudicabili. In molti accomunano questa comunità a un’altra, che potrebbe essere anche la medesima, chissà. Si tratta della Stultifera Navis. Cos’hanno in comune gli stolti e i morti? Il semplice fatto di non essere confessabili. Gli uni per il regno dei cieli, gli altri per la terra, sono inguaribili. Bosch e le illustrazioni a Brant di Dürer ne danno rappresentazione figurativa. Ecco una figura chiave, il centro del primo capitolo, della prima parte della Storia della follia di Foucault: Sebastian Brant (1458-1521). Vissuto tra l’opera del de Buschis e quella del Baschenis. Nel giugno 1984 Francesco Saba Sardi (1922-2012) ci regalò, in versi endecasillabi, la traduzione di Das Narrenschiff.
- [FOTO] Borlone de Buschis di Clusone
Narrenschiff uscì per la prima volta nel 1494, due anni dopo la scoperta dell’America. Prima di Brant abbiamo alcune opere importanti sull’argomento a partire dal 1360. Si immagina una sorta di confraternita delle persone strambe - le sole che possano esservi ammesse. Corporazione non chiusa per via di censo, particolari privilegi o saperi occulti. Bisognava essere, per esempio, un vescovo che aveva ipotecato il reddito per comprare il titolo religioso, un alchimista che aveva sciolto nel crogiolo le sue ricchezze.
La follia è ingiudicabile altrettanto quanto la morte, inguaribile. Questa caratteristica segna una linea di confine comunitaria, la nave è uno dei suoi contenitori. A quel tempo - successivo alla lebbra e alla peste, coevo di una nuova malattia giunta dalle Americhe, la sifilide - i folli venivano allontanati dalle città, imbarcati su navi per essere abbandonati altrove, ma il navigatore spesso le gettava a mare o le sbarcava in qualche landa desolata, dove morivano. Molti annegavano. Non è difficile immaginarlo oggi che abbiamo sotto gli occhi le immagini di uomini e donne morti alla deriva delle coste italiane. Unica differenza: allora giungevano dove nessuno stava, oggi invece si torce il collo altrove.
Gran satira grottesca o poema moralista? L’opera di Sabstian Brant ci lascia ancora nel dubbio. Quando Foucault ci parla della Stultifera Navis, qualunque opera scritta o figurativa ci venga in mente, dà un senso a quell’insieme indistinto di uomini e donne che ci entravano. Foucault distingue questo ammasso indifferenziato dalla follia così come viene identificata a partire dal secolo XVIII. Dal Settecento la follia diventerà regno del dominio medico, verrà diagnosticata e sistematicamente curata.
La nave dei folli non è che l’inizio di un processo che vedrà successive partizioni, da Erasmo fino a Pinel; è un crogiolo umano, un pleroma. Per alcuni Brant si confronta con l’avvento del Nuovo Mondo. La nave dei folli richiama le navi che iniziano a salpare verso le Americhe, fino al Seicento con la Mayflower, carica di puritani. Nave che navigò la luna, secondo i versi di Paul Simon. Anche loro inconfessabili, in quanto protestanti, spirito del capitalismo.
- [FOTO] Simone Baschenis di Pinzolo
Brant sarebbe il primo progressista dell’epoca moderna, sguardo disincantato verso il futuro imminente e immanente, fiducia nella città come luogo dell’innovazione e, per via dei commerci, luogo d’incontro multiculturale. La città è il centro dove ogni superstizione, credenza, invidia, odio saranno eliminati. Brant progressista. Invero sulla nave - destinata a Narragonia, che si dirige verso Cuccagna - non ci sono solo i folli contemporanei, bensì usurai, giocatori d’azzardo, adulteri, viziosi, prodighi, invidiosi, voluttuosi, ingrati, spergiuri, bestemmiatori. Tutta la follia premoderna raccolta dentro questa nave autorganizzata, autosufficiente, autopoietica. Brant moralista.
A voler ben guardare, la maggioranza del testo elenca, tra l’altro, la cupidigia, le nuove mode, il retto Catechismo, gli istigatori di discordia, le male costumanze, il dispregio delle Scritture, i galanti, la crapula e la gozzoviglia, le ciarle, i desideri superflui, gli studi inutili, le procrastinazioni, l’adulterio, la presunzione, la voluttà, l’ingratitudine, la bestemmia, l’usura.
- [FOTO] Albrecht Dürer
Come scritto, Albrecht Dürer illustra l’opera di Brant e Bosch crea una sua opera, sempre nel 1494. Nel frattempo altre comunità inconfessabili si muovono per via terrena, gli Ebrei, cacciati da Spagna e Portogallo, i Valdesi perseguitati ed erranti tra le valli montane fino alla Riforma.
Quanto l’opera si adatti all’ultimo ventennio, quanto sia attuale, quanto si stia trasformando nella Nemesi, lo vediamo dal momento in cui l’Europa è essa stessa, oggi, una nave di folli. Ci si aspetta solo un grande evento naturale, il distacco dagli Urali.
*
- STORIA E LETTERATURA, DANTE2021, E METASTORIA:
- LA PRIMA GUERRA MONDIALE, "UNA INUTILE STRAGE" (BENEDETTOXV, 1917), E LA PROPOSTA DI GEORG W. GRODDECK (1866-1934) DI UN "SATANARIUM".
A) - EUROPA (1914-1918): "[...] In occasione della prima guerra mondiale [Groddeck] fu richiamato in servizio nella sua qualità di medico militare. Poiché aveva cercato di dirigere anche l’ospedale da campo come fosse stato quello che spesso chiamava il suo #Satanarium (invece di #sanatorium) si attirò le antipatie di tutti, fino ad essere allontanato dal servizio nonostante l’intervento di autorevoli pazienti di un tempo, quali la stessa sorella del Kaiser e il marito.
 Fu nel maggio 1917 che Groddeck scrisse la sua prima lettera a Freud [...]" (cfr. Martin Grotjahn, "Georg Groddeck (1866-1934). L’analista indomito", in AA. VV., "Pionieri della Psicoanalisi", Feltrinelli, Milano 1971).
Fu nel maggio 1917 che Groddeck scrisse la sua prima lettera a Freud [...]" (cfr. Martin Grotjahn, "Georg Groddeck (1866-1934). L’analista indomito", in AA. VV., "Pionieri della Psicoanalisi", Feltrinelli, Milano 1971).- NOTA. Sul tema, si cfr. l’Intervista di Anna Cordioli relativa al libro a cura di Michele M. Lualdi, “Il re selvaggio. Georg Groddeck ai congressi psicoanalitici”.
B) - GEORG GRODDECK, "SATANARIUM" (il Saggiatore, MILANO 1996):
 SCHEDA EDITORIALE: "Siamo nel 1918. Il macello della guerra è in pieno corso. Groddek, che da anni dirige una clinica per malattie mentali, il #Sanatorio #Marienhohe, presso #BadenBaden, decide che il ruolo passivo dei suoi ospiti non è più sufficiente. Essi devono gridare ciò che li tormenta e li opprime, devono esprimere i loro desideri, manifestare le loro fantasie e, nel castello in aria del #Sanatorio, dedicarsi alla #ricostruzione dell’#Europa. "Mi propongo di dare all’uomo la possibilità di urlare il proprio tormento liberamente, senza timore né pudore. L’unico luogo in cui ciò è consentito mi pare essere l’#inferno; perciò chiamo questa rivista ’Satanarium’. Ne usciranno 23 numeri, tutti raccolti in questo volume che ricalca anche le caratteristiche grafiche degli originali." (https://www.ibs.it/satanarium-libro-georg.../e/9788842803928).
SCHEDA EDITORIALE: "Siamo nel 1918. Il macello della guerra è in pieno corso. Groddek, che da anni dirige una clinica per malattie mentali, il #Sanatorio #Marienhohe, presso #BadenBaden, decide che il ruolo passivo dei suoi ospiti non è più sufficiente. Essi devono gridare ciò che li tormenta e li opprime, devono esprimere i loro desideri, manifestare le loro fantasie e, nel castello in aria del #Sanatorio, dedicarsi alla #ricostruzione dell’#Europa. "Mi propongo di dare all’uomo la possibilità di urlare il proprio tormento liberamente, senza timore né pudore. L’unico luogo in cui ciò è consentito mi pare essere l’#inferno; perciò chiamo questa rivista ’Satanarium’. Ne usciranno 23 numeri, tutti raccolti in questo volume che ricalca anche le caratteristiche grafiche degli originali." (https://www.ibs.it/satanarium-libro-georg.../e/9788842803928). -
>PIANETA TERRA: A CHE GIOCO GIOCHIAMO?, ANCORA, OGGI (2023)? IL BRASILE DÀ UNA LEZIONE ALL’EUROPA E ALLE SUE RADICI. Una "memoria" (2005).10 ottobre 2023, di Federico La SalaPIANETA TERRA: A CHE GIOCO GIOCHIAMO?, ANCORA, OGGI? AL GIOGO DELLA TERRA PROMESSA?
 TERRA! TERRA! IL BRASILE DÀ UNA LEZIONE ALL’EUROPA E ALLE SUE RADICI. Una "memoria" (2005).
TERRA! TERRA! IL BRASILE DÀ UNA LEZIONE ALL’EUROPA E ALLE SUE RADICI. Una "memoria" (2005).
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- LA "DEMOCRAZIA" (COME "STATO DI MINORITÀ"), E IL PROBLEMA DELLA TRASPARENZA TEOLOGICO-POLITICA. Alcuni appunti.6 ottobre 2023, di Federico La Sala
L’#EUROPA (#GRANADA), #KOENIGSBERG / #KALININGRAD (E #ODESSA), LA "#DEMOCRAZIA" (COME "#STATO DI #MINORITÀ"), E IL PROBLEMA DELLA #TRASPARENZA TEOLOGICO-POLITICA. Alcuni appunti...
Un omaggio alla memoria di Dante Alighieri e William Shakespeare...
LA #TALPA E LA #CIVETTA: LA TRACCIA DI UNA FENOMENOLOGIA DELLO #SPIRITO DI "#DUE #IO" (DI #DUESOLI"). Già per #Shakespeare, ai suoi tempi (1600), Amleto e Ofelia (con il metodo della loro #follia) guardano ben oltre la linea dell’orizzonte teologico-politico di #Erasmo di Rotterdam e #TommasoMoro e lottano per portarsi fuori da un’Europa ormai avviatasi nella "marcia" del tramonto (#Nicea 325/2025).
LE PAROLE DELLA RIVOLUZIONE FRANCESE. Al centro e al fondo della questione posta da #CarloGalli, nel recente "Democrazia, ultimo atto?"(cfr. estratto: https://www.einaudi.it/.../democrazia-ultimo-atto-carlo.../ ), al di là dei suoi contributi e risultati specifici, vi sono "le idee moderne di libertà, di uguaglianza, di trasparenza, che sono esposte alla contingenza (...) e che meritano ancora una volta di essere il centro intorno a cui ruota la politica".
"DISAGIO DELLA CIVILTÀ" (#FREUD, 1929). Sul tema, nel suo commento, Francesco Fistetti accoglie con riserva la proposta di variazione e scrive: "[...] Al terzo termine del trinomio #libertà / #eguaglianza / #fraternità Galli sostituisce quello di "trasparenza". Trasparenza nell’accezione già di Bobbio che non devono esserci zone oscure e opacità nell’esercizio del potere e nel governo delle istituzioni, ma il sale della critica e del dibattito razionale. Ma in questo modo, cancellando la fraternità, può cassare senza colpo ferire tutta la storia del socialismo e della lotta per il socialismo come organici alla storia della modernità democratica e dello stesso liberalismo (il liberalsocialismo di un Rosselli e tanti altri). Operata questa amputazione "genealogica’ (almeno per la Modernità) resta una pallida e spettrale idea di liberaldemocrazia. Peraltro, quest’ultima viene declinata come l’ideologia e la pratica di quello che l’autore chiama il "secondo Occidente", quello degli Usa e delle istituzioni dell’Onu: un nuovo Occidente "a guida americana", di cui dalla fine della Seconda Guerra Mondiale "fa parte l’Europa" e la cui "espressione è la Nato" [...]"(cfr. https://www.facebook.com/francesco.fistetti.5/posts/10211262489754567).
"LA SOCIETÀ TRASPARENTE" (GIANNI VATTIMO, 1989), A mio parere, sulla trasparenza, un nodo decisivo legato al problema proprio di una "#societàtrasparente" (#GianniVattimo, 1989) , il dibattito è in alto mare ed è ancora tutto da affrontare, al suo livello antropologico-politico fondamentale, dalla radice (#Marx)!
QUESTIONE ANTROPOLOGICA ("CRISTOLOGICA") E CULTURA CRITICA. La questione è "metafisica", ma, a quanto pare, nessuno si ricorda più di #Kant e del suo illumiNATO "sàpere".
#PACEPERPETUA, Se non si rende trasparente il nodo antropologico e teologico-politico, non è possibile (come è stato dimostrato storicamente, almeno fino ad oggi, fino alla "tappa" europea di Granada 1492/2023) alcuna fraternità (libertà e uguaglianza) e la "pace perpetua" (Kant) è definitivamente assicurata.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- PASSAGGI STORICI. Otto saggi raccolti da Adriano Prosperi ampliano la sua penetrante lettura dei processi avviati dalla Chiesa in Italia all’epoca della Controriforma: «Una rivoluzione passiva» (di Francesco Benigno).27 settembre 2023, di Federico La Sala
PASSAGGI STORICI. Otto saggi raccolti da Adriano Prosperi ampliano la sua penetrante lettura dei processi avviati dalla Chiesa in Italia all’epoca della Controriforma: «Una rivoluzione passiva», da Einaudi
Adriano Prosperi, carità, devozione e altre maschere sottili
di Francesco Benigno (il manifesto - Alias, 03 luglio 2022).
Controriforma è parola difficile, che segna la trasformazione di un mondo lontano, ma indica anche un processo decisivo, che ha segnato per secoli l’Italia. A metà del Cinquecento, col concilio di Trento la Chiesa Cattolica, una volta svaniti i tentativi di far rientrare la riforma protestante, faceva partire un processo di riorganizzazione delle proprie strutture, di controllo e di soggezione della popolazione, nonché di rilancio della predicazione su scala mondiale. Nasceva la religione cattolica per come l’abbiamo conosciuta, imperniata sulla messa settimanale, la predica, la confessione, i seminari, i catechismi, le reliquie, le missioni e un utilizzo innovativo delle immagini sacre. Nella penisola italiana questo processo ha avuto effetti poderosi e secondo Benedetto Croce non tutti e non sempre negativi: i rigori della controriforma avrebbero in sostanza fatto risparmiare all’Italia i drammi e i dolori causati dalle divisioni religiose che travagliarono invece per decenni altri paesi europei.
Oltre «Tribunali»
Al racconto di questa spinta, che fu molto più di una reazione difensiva, gli storici italiani hanno fornito negli ultimi tre decenni un contributo di grande livello. Tra loro, Adriano Prosperi ha lungamente lavorato su questo tema, e ne fornisce adesso una lettura penetrante nel suo nuovo libro "Una rivoluzione passiva Chiesa, intellettuali e religione nella storia d’Italia" (Einaudi, pp. 430, € 34,00). Gli otto saggi raccolti vanno letti in controluce a "Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari", quel testo del 1996 divenuto ormai un classico, in cui Prosperi aveva fissato una lettura della controriforma incentrata sulla capacità della Chiesa di radicarsi nella società italiana, plasmandone durevolmente i comportamenti.
Come in quel libro anche in questo si sottolinea l’importanza dei tre aspetti in cui si era articolato quel cruciale riposizionamento: e cioè le pratiche di controllo della cultura attraverso l’Inquisizione e l’Indice dei libri proibiti; la diffusione della confessione come metodo di controllo e di condizionamento dei comportamenti individuali; e infine i nuovi stili della predicazione, quella dei parroci ma poi anche quella operata dai missionari. Soprattutto è presente qui una forte attenzione allo stile culturale e alle pratiche gestionali dei gesuiti, cui Prosperi aveva dedicato nel 2016 un altro libro importante, "La vocazione. Storie di gesuiti tra Cinquecento e Seicento".
Quello che c’è di nuovo qui è la consapevolezza esplicita che ciò che la controriforma ha operato è stata una rivoluzione. Certo, non una rivoluzione dal basso che impone un mutamento violento dell’ordinamento politico, ma una rivoluzione dall’alto, che in modo più sottilmente violento cambia i connotati della vita sociale attraverso un nuovo uso della carità e della devozione, e che perciò va considerata, come indica il titolo, una «rivoluzione passiva». L’espressione, come si sa, è desunta da Antonio Gramsci, che - mutuando una frase di Vincenzo Cuoco - l’aveva utilizzata nei Quaderni dal carcere per parlare della «rivoluzione senza rivoluzione» che caratterizzava l’età tra le due guerre.
Questo rimando a Gramsci, tuttavia, va ben al di là del titolo del libro, perché sottolinea la messa in opera di un influente meccanismo di spiegazione. L’idea cioè che la reazione alla minaccia protestante sia stata ben più di una semplice difesa: qualcosa di diverso da un mero ritorno al passato, un mutamento che integra in modo differente il vecchio e il nuovo.
Prosperi descrive questa rivoluzione come incentrata sui cambiamenti di due gruppi sociali considerati decisivi: le classi subalterne, soprattutto contadine, da un lato e gli intellettuali dall’altro. Rispetto al mondo dei «semplici», il popolo analfabeta, si profila il tentativo della Chiesa di sradicarne la mentalità magica e le tradizioni folkloriche, ma mantenendolo in posizione di assoluta dipendenza; mentre verso gli intellettuali si esercitano forme di blocco della libera riflessione morale e soprattutto religiosa, come ad esempio il divieto dell’uso della bibbia in volgare. Il risultato di questa doppia operazione di direzione delle coscienze e di governo dei costumi sarà la nascita di una nuova società, in cui le masse popolari vengono plasmate dai parroci e in cui gli intellettuali laici, così prevalenti nell’epoca del rinascimento, lasciano il posto a chierici colti, secolari e ordinari, ormai lontani dall’interpretazione esteriore che della religione forniva tradizionalmente un certo mondo fratesco.
Radicamento personale
Ci si può chiedere se questa forbice gramsciana tra mondo contadino e intellettuali non sacrifichi l’analisi di altri gruppi sociali più variegati, incardinati nell’universo urbano, ma Prosperi confessa con grande onestà la sua predilezione per una prospettiva che ha sullo sfondo un radicamento esistenziale di tipo personale, derivato cioè dall’essere cresciuto in una famiglia contadina toscana sul finire dell’epoca fascista, divisa tra la fervente pratica religiosa, della madre, e la cultura comunista, del padre; un’esperienza avvicinabile a quella classica polarizzazione tra parrocchia e casa del popolo che ha ispirato Guareschi e la saga popolare di Don Camillo e Peppone. Un radicamento di vita che non spiega solo il riferimento a Gramsci, ma che ha sostenuto l’orientamento degli studi di Prosperi, una pratica storiografica intensa e impegnata civilmente e che continua ad offrirci risultati di grande spessore.
-
>ANTROPOLOGIA FILOSOFICA E "DOTTA IGNORANZA". CIVILTà alla dewriva: la cultura non riesce a a "dimostrare l’esistenza dell’uomo". Intervento del cardinale Ruini su un libro del filosofo Agazzi.26 settembre 2023, di Federico La Sala
Dibattito.
Ruini: l’essere umano non è paragonabile ad animali e macchine
Intervento del cardinale Ruini su un libro del filosofo Agazzi: l’uomo è altro rispetto a natura e IA, perché è capace di speranza. La cultura attuale non riesce a coglierne la verità
di Camillo Ruini (Avvenire, martedì 26 settembre 2023
Evandro Agazzi è attualmente uno dei più importanti filosofi italiani e di certo il maggiore filosofo della scienza. A coronamento della sua molto lunga e feconda attività di studioso ha pubblicato alcuni libri, da ultimo La conoscenza dell’invisibile (2021) e Dimostrare l’esistenza dell’uomo (2023), che riassumono in forma unitaria le linee principali della sua riflessione filosofica. Cercherò qui di presentare e valutare brevemente il più recente di questi libri. Il suo titolo, “Dimostrare l’esistenza dell’uomo”, ha un sapore paradossale, perché la nostra esistenza è quanto di più evidente e immediato ci è dato conoscere. In realtà questo titolo allude al fatto che affidandosi unicamente alla scienza e alla tecnologia non si riesce a comprendere e indagare quella decisiva differenza per la quale possiamo affermare che «l’uomo non è né una macchina né un puro e semplice animale». Il libro è quindi un’antropologia filosofica. Il primo problema preso in esame è quello dei rapporti tra l’uomo e la natura: per quanto essi siano profondi non possono comportare la riduzione dell’uomo alla natura, come vorrebbe l’opinione oggi più diffusa. A parere di Agazzi vi si oppone quell’aspetto essenziale della nostra identità che è rappresentato dalla consapevolezza di essere liberi.
Il libro ritorna spesso sulla questione della libertà. Molto importante, in particolare, la distinzione tra libertà di scelta, detta anche libero arbitrio, e libertà d’azione. La prima è la libertà radicale senza la quale non potrebbero esistere né la moralità né la responsabilità. La seconda invece ammette molteplici limitazioni. Il pensiero moderno ha purtroppo identificato la libertà con la libertà d’azione e per questa via limita sempre più la nostra libertà, fino a ridurla a una pia illusione. Esito paradossale perché, proprio mentre riduce progressivamente l’uomo a un semplice essere naturale privo di libertà, la cultura moderna celebra la dignità dell’uomo e proclama un numero crescente di diritti umani. Ma, si chiede giustamente Agazzi, come si possono conciliare questa dignità e questi diritti con l’idea che l’uomo è un semplice animale, o addirittura una macchina? A mio parere questa contraddizione interna va assolutamente superata, se vogliamo aprire al futuro la nostra civiltà.
Un altro argomento molto interessante è quello della persona, più precisamente del rapporto tra uomo e persona. Agazzi ricorda anzitutto che il termine “persona” è divenuto un profondo concetto filosofico grazie all’opera dei Padri della Chiesa che lo hanno impiegato per precisare il significato dei due misteri fondamentali della fede cristiana, quello trinitario (tre Persone in una natura) e quello cristologico (una Persona in due nature). Lo spessore ontologico del concetto di persona si è poi trasferito sul concetto di uomo, fino alle varie dichiarazioni e rivendicazioni dei diritti umani che hanno caratterizzato gli ultimi due secoli. Nel nostro tempo si è giunti però a teorizzare una separazione tra l’uomo e la persona, nel senso di una differenza tra il concetto di uomo e il concetto di persona, in virtù della quale non ogni uomo, per il fat-to stesso di essere uomo, sarebbe una persona. Per conseguenza la dignità e i diritti riconosciuti alla persona non vengono automaticamente riconosciuti a tutti gli uomini. Agazzi confuta con un’analisi rigorosa la possibilità di separare l’uomo dalla persona e ne deduce alcune conclusioni in ambito bioetico: l’aborto e la soppressione di embrioni umani sono inevitabilmente soppressioni di persone.
Una questione attualmente molto dibattuta è quella della cosiddetta “intelligenza artificiale”. È diffusa l’idea che essa potrebbe emulare e poi superare l’intelligenza naturale dell’uomo. In realtà tra le due esiste una differenza radicale: una proprietà fondamentale dell’intelligenza naturale è infatti l’intenzionalità, che invece non può essere presente nell’intelligenza artificiale, come Agazzi ha compreso e affermato per primo, già molti anni fa. Cosa si intende per “intenzionalità”? Si tratta di un concetto già presente nella filosofia scolastica medioevale e poi ripreso dai filosofi tedeschi Franz Brentano ed Edmund Husserl, il cui significato è essere indirizzato verso un oggetto. Essendo priva di intenzionalità l’intelligenza artificiale non è e non potrà mai essere un’autentica intelligenza. Non ha senso, quindi, chiedersi se essa potrà superare l’intelligenza umana. Ciò non toglie che l’intelligenza artificiale, in concreto i computer la cui potenza di calcolo sta crescendo vertiginosamente, renda a noi possibile risolvere problemi che senza di essa non avremmo potuto in alcuno modo affrontare.
Agazzi dedica grande attenzione e spazio al mondo della cultura. In particolare le molte pagine in cui parla della musica sono una vera ricchezza di questo libro che, occupandosi dell’esistenza dell’uomo, è «inesorabilmente approdato al tema centrale di qualunque antropologia filosofica», cioè al problema del senso della nostra esistenza, che richiede qualche comprensione della morte perché «l’escatologia costituisce il cuore di ogni antropologia». Vengono pertanto analizzati con cura i concetti di morte, vita, esistenza, immortalità, come anche quello di felicità. Da ultimo Agazzi tratta dell’esperienza del sacro, della fede come fiducia in Colui che incontriamo in tale esperienza e della speranza come caratteristica specifica della natura umana: infatti soltanto l’uomo spera. Le ultime righe del libro chiariscono definitivamente il suo significato: «Dimostrare l’esistenza dell’uomo, ossia presentare argomenti di evidenza fenomenologica (come il fatto empirico della risurrezione di Gesù e l’esperienza del sacro) per convalidare l’immagine dell’uomo come viatore (come un essere in cammino) in cui alberga la speranza (ancorata nella fede in Cristo) che dopo il viaggio in questa vita ci sarà l’approdo in una esistenza al di là della morte e del tempo».
DOC. - L’Occidente ha perso la ragione. Giulio Meotti intervista Michel Onfray *
- Riprendiamo dal FOGLIO di oggi, 17/09/2022, a pag. 8, l’intervista di Giulio Meotti dal titolo ’Civiltà alla deriva’.
Attraverso la finestra dell’ufficio da cui scrivo, a Caen, vedo l’Abbazia degli uomini. Se vado sul balcone, vedo l’Abbazia delle donne. A poche centinaia di metri, in linea d’aria, si trovano i bastioni del castello in cui si erge ancora un magnifico edificio, la Sala dello Scacchiere. Queste costruzioni, emblematiche dell’arte anglo-normanna, hanno mille anni e furono costruite durante il regno di Guglielmo il Conquistatore: iniziate nel 1062 e nel 1066, furono consacrate nel 1130 e nel 1077. Guardiamo indietro al XIX secolo: l’architetto catalano Gaudí iniziò la costruzione della Sagrada Família a Barcellona nel 1882, l’anno in cui Nietzsche pubblicò ‘La gaia scienza’ che annunciava la morte di Dio. Consacrata da Benedetto XVI il 7 novembre 2010, la chiesa ha atteso centotrentasette anni per la concessione edilizia... Questo Papa, per ragioni molto oscure, si è dimesso, la fine delle opere strutturali è prevista per il 2026 e quella dei lavori per il 2032! Ciò che Guglielmo il Conquistatore costruì in undici anni nell’XI secolo, gli uomini del XIX, XX e XXI secolo non l’hanno ancora finito. Non è un simbolo?”.
Spirito libero e libertario, di sinistra ma antiprogressista, vocazione anarchica alla Proudhon, ateologo più famoso di Francia ascritto dai giornali della gauche fra i “neoreazionari” per il suo frondismo a favore della civiltà giudaico-cristiana, Michel Onfray torna con “Puissance et Décadence”, quasi un seguito di quella “Decadenza” (Ponte alle grazie) che gli ha riscosso un notevole successo di pubblico. “Uno dei segni della decadenza è la sua negazione da parte dei decadenti”, racconta Onfray in questa intervista al Foglio. “Coloro che si sforzano di proclamare che tutto va meglio lo fanno secondo criteri puramente quantitativi. Non viviamo più a lungo? L’aumento dell’età media non è una prova?”. Il ritrovamento di una scatola piena di quaderni di scuola degli anni Cinquanta ha stupito Onfray: “Tra ciò che si insegnava e si imparava allora e la polenta di correttezza politica inghiottita oggi dalle classi primarie dove la priorità non è l’apprendimento della grammatica o dell’ortografia ma quella del catechismo wokista che, ad esempio, invita i bambini a cambiare sesso secondo la loro ‘scelta’ o a smistare la spazzatura in nome del cambiamento climatico che esiste da milioni di anni sul pianeta, è possibile un confronto? La condizione delle donne non è migliorata? Sì, certo, ora possono comprare bambini da donne povere che, in questa o quella parte del pianeta, vendono ovociti e affittano il loro utero. Ora possono scegliere i bambini da catalogo e possono anche approfittare dei saldi per acquistare un neonato a un prezzo d’occasione, come durante il Black Friday presso la clinica ucraina Bio TexCom nel 2021”.
Ma c’è più tolleranza. “Ma la tolleranza non è forse diventata la religione di un’epoca senza religione al punto da non tollerare più nulla al di fuori di questa tolleranza? Il pensiero unico woke è inculcato dall’Educazione Nazionale, dalle università che presenta la loro militanza come scientifica, dalla ricerca cosiddetta ‘scientifica’ che sovvenziona soldatini ideologizzati, dall’industria della cultura di massa, dai media del servizio pubblico, dal mondo della pubblicità e del cinema, dal mondo degli schermi. Tuttavia, in nome della tolleranza, chi sfugge a questa ideologia dominante passa per un uomo di destra, quindi di estrema destra, quindi fascista, quindi per un nazista che fa il gioco della famiglia Le Pen!”. Onfray ne ha anche per il Vaticano. “La chiesa del Vaticano II rinuncia al sacro per trasformarsi in dispensatore di moralità moralizzante. Allo stesso modo in cui Diderot giudicò il crollo del cristianesimo notando che la produzione di ostie era crollata nel suo secolo, si può dedurre che il cristianesimo, che non è più in grado di completare una cattedrale in tre secoli, è in uno stato di morte cerebrale. Nelle sue lezioni di filosofia della storia, Hegel ha messo in luce la dinamica delle civiltà. Tutti conoscono i dipinti sublimi della grotta Chauvet, gli allineamenti preistorici dei megaliti, le piramidi egizie, l’agorà greca, il foro romano, le cattedrali europee. Tutto questo testimonia che le civiltà nascono, crescono, vivono, conoscono un momento di acme, poi iniziano una discesa che si rivela una caduta prima della scomparsa e della sostituzione con un altro momento tra una civiltà che si allontana e un’altra che arriva”. Cosa annuncia la nostra civiltà? Cosa dice di ciò che la seguirà? “Potrebbero esserci ancora degli sconvolgimenti per questo occidente minacciato da altre civiltà: in questa lotta dovremo fare i conti con la Cina confuciana, l’Africa animista, l’India indù o la Turchia musulmana, che stanno sviluppando strategie per la propria cancellazione dell’occidente giudaico-cristiano. Aggiungo che la demografia testimonia nel senso di questa abolizione dell’Europa giudaico-cristiana a favore di un territorio dove l’Islam sarà la religione dominante”. Onfray cita De Gaulle che disse a Malraux: “‘Nessuna civiltà ha posseduto un tale potere e nessuna è stata così estranea ai suoi valori. Perché conquistare la Luna, se è per suicidarsi?’. Malraux e De Gaulle videro che con il maggio ’68 il crollo della nostra civiltà stava precipitando. Entrambi cercarono di reagire”. Quale crisi culturale stiamo vivendo? L’opinione pubblica è consapevole della crisi antropologica? “No e una cosa del tutto normale, come la morte di una regina quasi centenaria, è semplicemente la fine di un mondo perché le civiltà sono mortali, nessuno dovrebbe ignorarlo poiché Paul Valéry ha formulato chiaramente la diagnosi. La nostra civiltà giudaico-cristiana ha duemila anni, si unirà alla civiltà greco-romana nel cimitero delle rovine delle civiltà morte accanto alle civiltà di Assur, Sumer, Babilonia, Egitto, ecc. Dobbiamo far posto a una nuova civiltà che sarà probabilmente quella del transumanesimo inventato sulla costa occidentale degli Stati Uniti”. Secondo Onfray siamo nella profezia ontologica di Michel Foucault ne “Le parole e le cose”: “‘Mettere fine all’uomo’. Questo nuovo Uomo Nuovo è una creatura sintetizzata nell’opera di Sade: senza Dio, senza anima, senza libero arbitrio, senza moralità, senza umanità, è un eroe delle ‘120 giornate di Sodoma’, una specie di macchina del desiderio post-cristiana che non teme né Dio né il diavolo, che non crede né al paradiso né all’inferno, né al bene né al male”. Non ci sono qua e là sacche di resistenza a questa postmodernità ? “Niente resiste alla morte... Quando un uomo muore, è stato reso possibile da una stirpe di cui porta in sé le eredità e lo rende possibile con i suoi discendenti. Il wokismo e la cancel culture che preparano il terreno alla continuazione mantengono dalla civiltà che essa distrugga un grande dispositivo: quello dell’ingranaggio della colpa, della confessione, della resipiscenza, della rigenerazione. E’ l’orizzonte dell’ambientalismo che permea la nostra fine di civiltà”.
Nel libro attacca la maternità surrogata. Che significarto ha? “Nichilismo: quando l’essere umano diventa una cosa trasformata in merce, è perché l’eugenetica governa. Acquistare figli, affittare uteri, commercializzare ovociti e spermatozoi, abortire fino al termine per motivi psicosociali come si è votato in Francia all’Assemblea Nazionale, è istituire una franca eugenetica che ricorda il peggio del XX secolo!”. Qual è l’obiettivo finale della teoria del genere? “Artificializzare la vita e distorcerla, cancellare la natura a beneficio della cultura, in modo che questo artificio possa essere manipolato intellettualmente e venduto commercialmente. Se non c’è più né uomo né donna, né maschile né femminile, ma solo progetti di essere uomo o donna, a seconda dell’ora del giorno e del momento della vita, allora che dire del pene e della vagina, dello sperma e delle uova: Sono solo costrutti culturali? Questo nichilismo della carne si smentisce poiché il cambio di sesso passa attraverso la terapia ormonale, abbinata alla chirurgia, il che dimostra che sono gli ormoni ad aprire la strada, cioè una sostanza naturale, anche quando viene sintetizzata in laboratorio”. Eppure, l’occidente è oggi difeso da molti. “L’occidente è un pianeta, l’Europa giudeo-cristiana e i suoi satelliti: le Americhe, l’Australia, la Nuova Zelanda e tutti coloro che vivono secondo il principio di questa defunta Europa costruita dal cristianesimo. Come un bambino sopravvive alla morte dei suoi genitori sublimandoli, questa Europa morta continua a vivere in California dove, pensando ai boss della Gafam, a Musk, il futuro del pianeta si gioca attraverso il transumanesimo”. Intanto prolifera una nemesi storica della civiltà europea: l’islam... Ma lei scrive che i conquistatori rilevano solo un’area che è già morta. “L’islam fa il lavoro di ripulire l’Europa decadente”, ci dice Onfray. “Spinge e fa cadere un muro già incrinato e pieno di fessure. I musulmani che portano avanti un progetto di sostituzione della civiltà, cioè i dottrinari dell’islamismo, sono meno forti nelle loro stesse forze che nella nostra debolezza. Gli islamisti si accontentano di essere d’accordo con la nostra cricca nichilista: la prendono in parola. ‘Non perdi occasione per dire che sei detestabile, in quanto colonialisti, fascisti, petainisti, vichysti, antisemiti, collaborazionisti? Hai perfettamente ragione, ecco perché ti odiamo’, dicono gli islamisti”.
Ma se, mentre scrivi, la battaglia è persa, perché combatterla? “Quello che accadrà è già scritto in due libri: ‘1984’ di Orwell e ‘Il mondo nuovo’ di Huxley. Non possiamo dire di non essere stati avvisati”. E Putin? “E’ uno choc religioso, se non teologico, intraeuropeo, una sorta di guerra di civiltà dello spazio geografico europeo che si oppone a tre modi di essere cristiani: cattolici, protestanti, ortodossi. L’Europa oggi è di ispirazione protestante, come gli Stati Uniti. Il cattolicesimo protesta visibilmente con Papa Francesco, un gesuita che lavora per il cosmopolitismo, l’immigrazione e il multiculturalismo”. Perché restare in Normandia ? “Mille anni di radicamento... discendo da un vichingo arrivato dal nord, probabilmente la Danimarca, mille anni fa. E’ una regione semplice e umile che non lascerò”. Ricorre all’immagine del Titanic. “La barca si muove a un ritmo che non può prevenire la collisione con l’iceberg. Le percussioni sono inevitabili. Il capitano non può fare nulla per ostacolare il destino della sua nave: spegnere i motori, fare retromarcia, girare il più possibile a sinistra o a dritta, niente aiuterebbe, il Titanic sta per speronare la montagna di ghiaccio alla deriva nel mare. E’ inevitabile. La nostra civiltà si sta dirigendo verso il suo destino che è il naufragio. Ci sono diversi modi per reagire: panico, urla, pianti, lacrime, percosse, la natura umana che prende il sopravvento, l’uomo che mostra, sotto una vernice fragile, di essere davvero un lupo per il suo prossimo. Ciò che sembrava civiltà e cortesia, moralità e cortesia non dura più di cinque minuti di fronte alla catastrofe. Vediamo nascere dal vortice di panico dei falsi profeti che vociferano che bisogna calmarsi: loro hanno la soluzione, loro sono la soluzione. Sono uomini provvidenziali: devi ascoltarli e tutto andrà bene. Ci sono le barche, andiamo con ordine, e finché obbediamo salveranno tutti, salveranno il mondo. Una voce lucida fa notare che le barche a remi non basteranno... L’uomo provvidenziale grida che non si devono ascoltare gli uccelli del malaugurio, che le Cassandre siano gettati in mare come un priorità. Se per caso ci fosse una sola possibilità per salvarsi dal naufragio, sarebbe da scappare. Tuttavia, non ce n’è. Una civiltà non muore per colpa di chi se ne impossessa, ma perché i conquistatori entrano in una zona già morta, intellettualmente corrotta, spiritualmente marcia, culturalmente brulicante di vermi, moralmente decomposta. Nessuno conquista mai altro che rovine. La pulsione di morte ha ucciso la pulsione di vita. Baciamo il cobra sulla bocca”.
E ancora: “La scuola che indottrina fin dalla tenera età, ricerca che non trova altro da fare che adornarsi delle piume della scienza per svolgere l’opera di custode della vera fede. Dobbiamo guardarci dagli inganni. La logica del cavallo di Troia permette agli attori della decadenza di avanzare con la scusa dei buoni sentimenti. L’ecologia urbana, che ignora tutto ciò che riguarda la natura e i suoi legami con il cosmo, si rivela l’ala armata dell’ibridazione, compresa la sessualità, ibridazione e cosmopolitismo, che dissolvono nel loro acido ciò che restava della comunità a vantaggio di una giustapposizione di individualità narcisistiche, egoiste, ignoranti ma, ciò che conta, consumistiche, con la morte”. Il prossimo transatlantico sarà quello del transumanesimo? “Siamo nel mezzo: il Titanic sta affondando, la prossima nave è all’orizzonte. Resta, intanto, l’azione girondina che è la costruzione della resistenza alle metastasi del nichilismo. Cominciare a far sì che la decadenza non ci attraversi sarebbe già molto. La Boétie ci ha insegnato che la nostra servitù è volontaria”.
* Fonte: "informazione corretta (ripresa parziale senza immagini).
-
>IL SOGGETTO, LA MASCHERA, E LA SOCIETÀ TRASPARENTE. Alcune note su "che cosa ha veramente detto GIANNI VATTIMO".22 settembre 2023, di Federico La Sala
IL SOGGETTO, LA MASCHERA, E LA SOCIETÀ TRASPARENTE.
Alcune note su "che cosa ha veramente detto GIANNI VATTIMO". *
AUTOIRONIA, "Auto-chiarificazione (filosofia critica)", e Charitas: queste poche parole, forse, possono essere dei segnavia per non perdersi l’essenziale (e, in qualche modo, per distinguere prima e unire poi, quanto ritenuto accoglibile) nel mare della ricchissima produzione culturale e professionale di Vattimo.
UNA NUOVA "FILOSOFIA DELL’AVVENIRE". "«L’uomo è ciò che mangia, ma soprattutto quel che beve». Così Gianni Vattimo, scomparso il 19 settembre scorso, trasformò il celebre motto di Ludwig #Feuerbach, bevendo un calice di rosso della Sila. Di origini calabresi e fama mondiale, il filosofo torinese era autoironico, alleggeriva i discorsi, amava scherzare e porsi con umiltà." (cfr. Emiliano Antonino Morrone, "La ricerca (infinita) della verità e il pensiero “forte” di Vattimo per la sua San Giovanni in Fiore", Corriere della Calabria, 22.09.2023).
Rimettendo storicamente e antropologicamente accanto all’ironia (della dialettica platonico-socratica), anche l’autoironia di Gianni Vattimo, forse, a omaggio delle sue "AVVENTURE DELLA DIFFERENZA" (1980)", in un mondo dove la lanterna è in mano ai #ciechi, è più che opportuno richiamare alla memoria la figura di Diogene di Sinope.
RIPARTIRE DALLA CRITICA DELL’ECONOMIA POLITICA DELL’ATTUALE PRESENTE STORICO. Se nel "processo dell’avvento del valore di scambio come metro di misura totalizzante si nasconde il trionfo dell’homo oeconomicus e della tendenza all’illimitazione del capitalismo", e, ancora, come ricorda Francesco Fistetti, "il recupero del valore d’uso e di un progetto di demercificazione dei mondi vitali va reimpostato a quest’altezza ", come è possibile svegliarsi dal #sonnodogmatico (Kant)?
QUESTIONE ANTROPOLOGICA. Come mi sembra di capire, non è proprio il caso di re-interrogarsi sul tema del "soggetto e della maschera" (Vattimo, 1974) e riprendere la indicazione kantiana del 1784 (riafferrata per i capelli, da #MichelFoucault nel 1984), della questione antropologica e ripartire dal "#sàpereaude!", "dal coraggio di servirsi della propria intelligenza"? All’ordine del giorno, oggi, per ri-"orientarsi nel pensiero" (Kant) e per una seconda rivoluzione copernicana (Th. W. Adorno), è augurabile che venga ripresa la lettura dello "Spaccio della bestia trionfante" di Giordano Bruno e del "Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, tolemaico e copernicano" del Galileo Galilei, senza queste opere l’uscita dal letargo claustrofilico e terrapiattistico è impensabile.
IL MATERIALISMO DIALETTICO. Superato Kant dialettica-mente (con la hegeliana astuzia della ragione "mascherata" - già di Platone e Cartesio, sia atea sia devota, sia idealistica sia materialistica), si è perso anche il senso e il sottotitolo stesso del lavoro di Marx sul "Capitale" e, con esso, ogni possibilità di portare avanti la stessa "critica dell’economia politica": si tenga presente che per John Dewey, la rivoluzione di Kant è "un ritorno a un sistema di tipo ultra-tolemaico").
LA "COSCIENZA #MISTICA", IL "SOGNO DI UNA COSA", E "IL PROBLEMA DELLA LIBERAZIONE". Paradossalmente, e probabilmente, se avessimo letto di più e meglio sia Giambattista Vico sia Kant a questa ora, in occasione della riflessione sul percorso filosofico di Gianni Vattimo, forse, potremmo capire di più la sua reale vicinanza e consonanza con la "Critica dell’idealismo" della "Critica della Ragion Pura" (1787) e il programma giovanile di Marx, il #sognodiunacosa (1843) : "Sarà chiaro come non si tratti di tirare una linea retta tra passato e futuro, ma di realizzare le idee del passato. Si vedrà infine come l’umanità non incominci un lavoro nuovo, ma venga consapevolmente a capo del suo antico lavoro."("Annali franco-tedeschi"). Uno dei più importanti contributi in tale direzione di Gianni Vattimo, a mio parere, è proprio il saggio del 1974: "Il soggetto e la maschera. Nietzsche e il problema della liberazione" (Bompiani, 1974). Negli stessi anni, nelle infinite analisi sul rapporto tra il marxismo ed Hegel, correva il ripescaggio del "sapiente" Bovillus e della sua "rinascimentale" antropologia piramidale.
*
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- COME FARE COSE CON LE PAROLE. LA "PREMESSA" DI UN "ANTICO" SILLOGISMO E UN BREVE "DIALOGO" (di Cristina Peri Rossi).25 agosto 2023, di Federico La Sala
#PIANETATERRA, #RECINZIONI (#ENCLOSURES) E #CIVILTA’:
L’#ABC DELLA #FILOLOGIA, DELLA-#LOGICA, E DELLA FILO-#SOFIA DELLA #DIGNITA’ DELL’#UOMO ("DE HOMINIS DIGNITATE").
"COME FARE COSE CON LE PAROLE". LA "PREMESSA" DI UN "ANTICO" SILLOGISMO.
- Un breve testo di Cristina Peri Rossi - Scrittrice uruguaiana vincitrice 2021 del Premio Cervantes: *
"Avevo cinque anni. L’insegnante ha scritto sulla lavagna: "Tutti gli uomini sono mortali". -Ho provato un enorme sollievo, una grande gioia.
 Quel pomeriggio, quando uscii da scuola, corsi a casa e abbracciai molto strettamente mia madre.
Quel pomeriggio, quando uscii da scuola, corsi a casa e abbracciai molto strettamente mia madre.
 "Che fortuna mamma, tu non morirai mai! "Gli ho detto, rapito.
"Che fortuna mamma, tu non morirai mai! "Gli ho detto, rapito.
 "Cosa? " chiese mia madre, sorpresa.
"Cosa? " chiese mia madre, sorpresa.Mi sono separato appena da lei e le ho spiegato:
 La maestra ha scritto sulla lavagna che gli uomini sono mortali.
La maestra ha scritto sulla lavagna che gli uomini sono mortali.
 E tu sei una donna!. Per fortuna sei una donna, ho detto e l’ho riabbracciata.
E tu sei una donna!. Per fortuna sei una donna, ho detto e l’ho riabbracciata.
 Mia madre mi ha teneramente separato dalle sue braccia.
Mia madre mi ha teneramente separato dalle sue braccia.
 Questa frase, mia cara, include uomini e donne. Tutti e tutte moriremo un giorno.
Questa frase, mia cara, include uomini e donne. Tutti e tutte moriremo un giorno.
 Mi sono sentita completamente sconvolta e delusa.
Mi sono sentita completamente sconvolta e delusa.
 Allora perché non l’ha scritto? : "Tutti gli uomini e le donne sono mortali"? Ho chiesto.
Allora perché non l’ha scritto? : "Tutti gli uomini e le donne sono mortali"? Ho chiesto.
 Beh - ha detto mia madre, in realtà, per semplificare, noi donne siamo rinchiuse nella parola "uomini".
Beh - ha detto mia madre, in realtà, per semplificare, noi donne siamo rinchiuse nella parola "uomini".
 Chiuse? - Ho chiesto. Perché?
Chiuse? - Ho chiesto. Perché?
 Perché siamo donne - mi rispose mia madre.
Perché siamo donne - mi rispose mia madre. La risposta mi ha sconcertato.
La risposta mi ha sconcertato.
 E perché ci rinchiudono? Gliel’ho chiesto.
E perché ci rinchiudono? Gliel’ho chiesto.
 È molto lungo da spiegare, rispose mia madre. Ma accettalo così. Ci sono cose che non sono facili da cambiare.
È molto lungo da spiegare, rispose mia madre. Ma accettalo così. Ci sono cose che non sono facili da cambiare.
 Ma se dico "tutte le donne sono mortali"? Rinchiude anche gli uomini?
Ma se dico "tutte le donne sono mortali"? Rinchiude anche gli uomini?
 No- rispose mia madre. Questa frase riguarda solo le donne.
No- rispose mia madre. Questa frase riguarda solo le donne.
 Ho avuto una crisi di pianto.
Ho avuto una crisi di pianto.
 Ho capito all’improvviso molte cose e alcune molto spiacevoli, come che il linguaggio non era la realtà, ma un modo per rinchiudere cose e persone, a seconda del loro genere, anche se sapevo a malapena cosa fosse il genere: oltre a servire a fare gonne, il genere era una forma di prigione. "
Ho capito all’improvviso molte cose e alcune molto spiacevoli, come che il linguaggio non era la realtà, ma un modo per rinchiudere cose e persone, a seconda del loro genere, anche se sapevo a malapena cosa fosse il genere: oltre a servire a fare gonne, il genere era una forma di prigione. "* Cristina Peri Rossi - Scrittrice uruguaiana vincitrice 2021 del Premio Cervantes.
- NOTA.
#SONNODOGMATICO (#KANT), #PREISTORIA (#MARX) #LETARGO (#Dante2021)! A ONORE E OMAGGIO DELL’ Attacco Poetico di #CristinaPeriRossi ... ALLEGO LA #SINTESI DELLA #TEORIA PLATONICO-ARISTOTELICA DEL "#SAPIENTE" (#BOVILLUS. 1510), #CRITICA-#MENTE AL CENTRO DEL LORO LAVORO DA #STEFANOMANCUSO E #ALESSANDRAVIOLA NEL LIBRO "#VERDEBRILLANTE. SENSIBILITà E INTELLIGENZA DEL MONDO VEGETALE" (Giunti Editore).
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- TUTTI E TUTTE AD "AMMIRARSI" NELL’OCCHIO DI SOCRATE E DI PLATONE. VIRGINIA WOOLF, LA "SORELLA" DI SHAKESPEARE.28 luglio 2023, di Federico La Sala
ELEUSIS 2023
ANTROPOLOGIA STORIA FILOSOFIA FILOLOGIA E LETTERATURA:
VIRGINIA WOOLF E LA "PUPILLA" ("KORE", "FANCIULLA", "BAMBOLETTA") NELL’OCCHIO E NELLO SGUARDO DI SOCRATE E DI PLATONE. -Alcuni appunti...
A) VIRGINIA WOOLF: "The eyes of others our prisons; their thoughts our cages" ("Short Stories").
B) PLATONE ("Alcibiade primo", 133 e ss.):
 "SOCRATE: Rifletti anche tu: se [l’iscrizione delfica] avesse rivolto un consiglio al nostro occhio, come se fosse un uomo, e gli avesse detto: «Guarda te stesso», che supposizione avremmo fatto su ciò a cui ci esortava? Non forse a guardare a quella cosa guardando alla quale l’occhio avrebbe visto se stesso?
"SOCRATE: Rifletti anche tu: se [l’iscrizione delfica] avesse rivolto un consiglio al nostro occhio, come se fosse un uomo, e gli avesse detto: «Guarda te stesso», che supposizione avremmo fatto su ciò a cui ci esortava? Non forse a guardare a quella cosa guardando alla quale l’occhio avrebbe visto se stesso?
 ALCIBIADE: è chiaro.
ALCIBIADE: è chiaro.
 SOCRATE: Riflettiamo: guardando a quale degli oggetti esistenti vediamo quello e contemporaneamente anche noi stessi?
SOCRATE: Riflettiamo: guardando a quale degli oggetti esistenti vediamo quello e contemporaneamente anche noi stessi?
 ALCIBIADE: è chiaro, Socrate, che dovremmo guardare a uno specchio o a qualcosa del genere.
ALCIBIADE: è chiaro, Socrate, che dovremmo guardare a uno specchio o a qualcosa del genere.
 SOCRATE: Quel che dici è giusto. Ma nell’occhio col quale guardiamo non c’è qualcosa di questo genere?
SOCRATE: Quel che dici è giusto. Ma nell’occhio col quale guardiamo non c’è qualcosa di questo genere?
 ALCIBIADE: Certamente.
ALCIBIADE: Certamente.
 SOCRATE: Hai notato dunque che quando guarda nell’occhio il volto si riflette nello sguardo di chi si trova di fronte come in uno specchio, cosa che chiamiamo anche pupilla (72 -> "kore", "còre"), dato che è come un immagine di chi guarda?
SOCRATE: Hai notato dunque che quando guarda nell’occhio il volto si riflette nello sguardo di chi si trova di fronte come in uno specchio, cosa che chiamiamo anche pupilla (72 -> "kore", "còre"), dato che è come un immagine di chi guarda?
 ALCIBIADE: Quel che dici è vero.
ALCIBIADE: Quel che dici è vero.
 SOCRATE: Dunque quando un occhio osserva un occhio e guarda in esso ciò che appunto esso ha di più bello, e con cui vede, in tal caso potrebbe vedere se stesso [...]".
SOCRATE: Dunque quando un occhio osserva un occhio e guarda in esso ciò che appunto esso ha di più bello, e con cui vede, in tal caso potrebbe vedere se stesso [...]".C) LA "SORELLA" DI WILLIAM SHAKESPEARE: JUDITH (E LA "INVINCIBILE ARMATA"). Con straordinaria e fulminea eleganza e grande coraggio ("Sàpere aude"), Virginia Woolf prende il nome di Judith ("Una stanza tutta per sé") e taglia definitivamente la testa all’ "Oloferne" della tradizione "mammonica" occidentale e si porta fuori dal tragico e infantile ("stadio dello specchio") dello sguardo socratico-platonico e lacaniano (narcisitico, edipico, golem-antico).
P. S. - QUESTIONE ANTROPOLOGICA E CREATIVITÀ. "Lettere a Virginia Woolf dal XXI secolo". Una raccolta epistolare (a c. di Licia Martella, introduzione di Nadia Fusini) dedicata alla scrittrice:
[LETTERE] Scritte da: Leonetta Bentivoglio, Alessandra Bocchetti, Elisa Bolchi, Maria Grazia Calandrone, Elisa Casseri, Sara De Simone, Viola Di Grado, Donatella Di Pietrantonio, Manuela Fraire, Daniela Gambaro, Cristina Gardumi, Viola Lo Moro, Francesca Mancini, Laura Mazzi, Elena Munafò, Raffaella Musicò, Iolanda Plescia, Galatea Ranzi, Elisabetta Rasy, Maria Serena Sapegno, Carola Susani, Nadia Terranova, Silvia Vegetti Finzi, Sara Ventroni, Maddalena Vianello, Valeria Viganò.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! PENSARE BENE "DIO", "IO" E "L’ITALIA" --- PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA. Dichiarazione di "Cordoglio del Presidente Mattarella per la scomparsa di Silvio Berlusconi".13 giugno 2023, di Federico La Sala
Cordoglio del Presidente Mattarella per la scomparsa di Silvio Berlusconi
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rilasciato la seguente dichiarazione: *
«Apprendo con profonda tristezza la notizia della morte di Silvio Berlusconi, fondatore e leader di Forza Italia, protagonista di lunghe stagioni della politica italiana e delle istituzioni repubblicane.
Berlusconi è stato un grande leader politico che ha segnato la storia della nostra Repubblica, incidendo su paradigmi, usi e linguaggi. In una stagione di profondi rivolgimenti, la sua “discesa in campo”, con un partito di nuova fondazione, ottenne consensi così larghi da poter comporre subito una maggioranza e un governo.
La leadership di Berlusconi ha contribuito a plasmare una nuova geografia della politica italiana, consentendogli di assumere per quattro volte la carica di presidente del Consiglio. In queste vesti ha affrontato eventi di portata globale, come la crisi aperta dall’attentato alle Torri Gemelle, la lotta al terrorismo internazionale e gli sconvolgimenti finanziari alla fine del primo decennio del nuovo secolo.
Ha progressivamente integrato il movimento politico da lui fondato nella famiglia popolare europea favorendo continuità nell’indirizzo atlantico ed europeista della nostra Repubblica.
E’ stato una persona dotata di grande umanità e un imprenditore di successo, un innovatore nel suo campo. Ha conquistato posizioni di assoluto rilievo nell’industria televisiva e nel settore dei media, ben prima del proprio impegno diretto nelle istituzioni.
E’ stato artefice di importanti successi nel mondo dello sport italiano.
Desidero esprimere il mio cordoglio e la mia solidarietà ai figli, a tutti i familiari, al suo partito, a coloro che più gli sono stati vicini nella vita e nell’ultima battaglia contro la malattia, combattuta con coraggio ed esemplare ottimismo».
Fonte: Sito della PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
-
> EUROPA, 11 MAGGIO 2023: ELEUSI, LA QUESTIONE ANTROPOLOGICA ("ECCE HOMO"), E INTERI MILLENNI DI LABIRINTO NELLA CAVERNA PLUTONICA (E PLATONICA).11 giugno 2023, di Federico La Sala
ARTE, FILOLOGIA, "NASCITA DELLA TRAGEDIA" (NIETZSCHE), E
 QUESTIONE ANTROPOLOGICA ("ECCE HOMO", 1888):
QUESTIONE ANTROPOLOGICA ("ECCE HOMO", 1888):- "CORPUS DOMINI" ED "EU-CHARIS-TIA" (CHARITAS, gr. XAPITAS).
- EUROPA, 11 MAGGIO 2023. Un "invito" a una riflessione filosofica e un omaggio al prof. Flavio Piero Cuniberto e a un suo breve testo, intitolato "CORPUS DOMINI", composto dall’associazione della foto dell’opera di "Jean-Auguste-Dominique Ingres, Madonna dell’Ostia (part.), 1841; Mosca, Museo Pushkin.", e dalla seguente citazione, ripresa da un’opera di Platone, "L’ essere che realmente è, senza colore, senza forma, non apparente [...] occupa questo luogo. [...] e [l’anima] contemplando il vero se ne nutre e ne gode" (Fedro 247 c-d).".
PLATONE E "NOI", OGGI (11MAGGIO 2023). MESSA A MORTE LA #GIUSTIZIA (#DIKE) DI #PARMENIDE, #PLATONE SALE SULL’ACROPOLI E DICHIARA: "IO, PLATONE, SONO LA [DEA DELLA] VERITÀ". "L’essere che realmente è, senza colore, senza forma, non apparente [...] occupa questo luogo. [...] e [l’anima] contemplando il vero se ne nutre e ne gode" (Fedro 247 c-d).
ELEUSIS_2023. Abbandonata "M_Arianna", interi millenni di labirinto ... nella ’invisibile’ caverna plutonica (ricordando Demetra ed Eleusis).
Dopo #Dante2021, ancora in un profondissimo #letargo (Pd., XXXIII, 94)!
P. S. - Su Platone, oggi, alcuni appunti per una possibile diversa "lettura": nelle Università e nelle Accademie (laiche e devote) si insegna ancora a credere che Aristofane scherzasse su Socrate!
HAMLETICA: FILOLOGIA, ANTROPOLOGIA (CRISTOLOGIA), LINGUISTICA, E "COSTRUZIONI NELL’ ANALISI" (FREUD). Un omaggio a Shakespeare, alla "question" di Hamlet (Amleto, e a Ferdinand de #Saussure. In #principio era il #Logos, non un #logo...
*
EUROPA, CRISTIANESIMO E "DISAGIO DELLA CIVILTÀ": IL "CORPO DEL SIGNORE ("CORPUS DOMINI)" E L’ EUCARISTIA (Eu-charis-tia").
 Due note:
Due note:A) SACRAMENTALISMO. "Il termine #sacramentalismo descrive il sistema concettuale e pratico attraverso il quale in particolare la Chiesa cattolica romana, ma anche il #cristianesimo ortodosso comprende la funzione e l’uso dei #sacramenti come mezzi mediante i quali la #grazia di Dio verrebbe impartita ai fedeli. Esso è strettamente legato alla figura del #sacerdote [...]" (https://it.wikipedia.org/wiki/Sacramentalismo);
B) SACRAMENTARISMO. "Si definisce sacramentismo o #sacramentarismo il movimento di opposizione, sviluppatosi nei Paesi Bassi alla fine del Medioevo, alla tradizionale teologia eucaristica e alle relative pratiche devozionali, consistente nel #rifiuto della dottrina della transustanziazione e della messa intesa come ripetizione del #sacrificio di Cristo, dando alla comunione, la cena del #Signore, un carattere simbolico e commemorativo.
 A definire sacramentisti o sacramentari i seguaci di tale movimento furono le stesse autorità ecclesiastiche, per le quali sacramentarius era chiunque sostenesse che ogni sacramento era soltanto un #segno, senza che nella cerimonia avvenisse alcuna alterazione della materia sacramentale. Anche Lutero, creatore della teoria della consustanziazione, chiamò sacramentari i suoi avversari nella controversia eucaristica che ebbe con Carlostadio, Ecolampadio, Schwenckfeld e Zwingli, quest’ultimo il più autorevole sostenitore del carattere simbolico della comunione. [...]
A definire sacramentisti o sacramentari i seguaci di tale movimento furono le stesse autorità ecclesiastiche, per le quali sacramentarius era chiunque sostenesse che ogni sacramento era soltanto un #segno, senza che nella cerimonia avvenisse alcuna alterazione della materia sacramentale. Anche Lutero, creatore della teoria della consustanziazione, chiamò sacramentari i suoi avversari nella controversia eucaristica che ebbe con Carlostadio, Ecolampadio, Schwenckfeld e Zwingli, quest’ultimo il più autorevole sostenitore del carattere simbolico della comunione. [...]
 Alla crescita del movimento sacramentario fece seguito la reazione dell’Inquisizione. La prima vittima fu Lauken van Moeseken, decapitato nel 1518 a Bruxelles; l’ex-prete Jan de Bakker fu bruciato a L’Aja nel 1525, mentre la prima donna a morire per la sua fede fu Wendelmoet Claesdochter, strangolata e bruciata nel 1527. Negli interrogatori dichiarò che il sacramento dell’altare era « solo pane e farina» e, riferendosi all’estrema unzione, che « l’olio è buono per l’insalata e per lucidare le scarpe». Sul patibolo, rifiutando il crocifisso, dichiarò: «Il mio Dio e Signore non è questo. Il mio Signore è in me e io in lui ».[...]"(https://it.wikipedia.org/wiki/Sacramentarismo).
Alla crescita del movimento sacramentario fece seguito la reazione dell’Inquisizione. La prima vittima fu Lauken van Moeseken, decapitato nel 1518 a Bruxelles; l’ex-prete Jan de Bakker fu bruciato a L’Aja nel 1525, mentre la prima donna a morire per la sua fede fu Wendelmoet Claesdochter, strangolata e bruciata nel 1527. Negli interrogatori dichiarò che il sacramento dell’altare era « solo pane e farina» e, riferendosi all’estrema unzione, che « l’olio è buono per l’insalata e per lucidare le scarpe». Sul patibolo, rifiutando il crocifisso, dichiarò: «Il mio Dio e Signore non è questo. Il mio Signore è in me e io in lui ».[...]"(https://it.wikipedia.org/wiki/Sacramentarismo).Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- Se li avessi davanti, quegli storici di domani (o dopodomani): "i due versi di Emily Dickinson". Una "memora" (1994) di Beniamino Placido.2 giugno 2023, di Federico La Sala
I DUE VERSI DI EMILY DICKINSON
di Beniamino Placido *
Sempre per loro. Perché non si disperino. Cosa non si fa per loro, per quelli che verranno dopo di noi: fra cinquanta, cento, cinquecento anni. Poveretti, cercheranno di capire la nostra storia di oggi e si metterranno le mani nei capelli, ci sembra già di vederli. Come mai vinse quel Berlusconi: che non era un politico, che tre mesi prima non era ancora entrato in politica?
Non siamo egoisti. Diamogli una mano. Aiutiamoli a sgrovigliare nella loro Biblioteca i nostri giornali ingialliti, dove si naviga fra quattro, cinque ipotesi concorrenti. Berlusconi ha vinto perché era (o si presentava) come "nuovo". Il vecchio non andava più di moda. Berlusconi ha vinto perché era o si presentava come uomo "non politico". La politica non andava più di moda. Oppure: perché si presentava come l’ uomo dei "fatti", contrapposto agli uomini delle chiacchiere.
Le chiacchiere circolavano molto ma erano molto chiacchierate, in Italia. O ancora: Berlusconi ha vinto perché si presentava (e certamente era anche) un "vincente". Ce l’ ha fatta? Si è fatto da sé? Ebbene, farà in modo che ce la facciamo anche noi.
Altra ipotesi ancora: ha vinto perché aveva a disposizione tante televisioni, e le usava. Si può fare una previsione sicura, eccola. Sarà questa alla fine l’ ipotesi vincente. Perché la più comoda, la più pittoresca. Ma non necessariamente la più fondata. Se li avessi davanti, questi studiosi di domani (o dopodomani), impegnati a capire le nostre vicende di oggi, farei loro questo discorso. Non date retta. La televisione è potente, ma non onnipotente. Negli Anni Settanta la Democrazia Cristiana - al governo da sempre - aveva a disposizione tutta la Televisione che c’ era (tutta) e tuttavia non riuscì ad impedire che l’ aborrita legge sul divorzio passasse. Negli Anni Ottanta Umberto Bossi riuscì a creare la sua Lega, dal nulla, infischiandosene della Televisione.
Forse c’ entra qualche altra cosa. Forse c’ entra anche quel che si dice in televisione.
 Se li avessi davanti, quegli storici di domani (o dopodomani) li costringerei a metter l’occhio su una cronaca da Torino (Massimo Gramellini, La Stampa, venerdì 1 aprile). Siamo a Mirafiori. Ecco un vecchio operaio che spiega come mai ci siano stati tanti voti per la destra. Anche a Mirafiori.
Se li avessi davanti, quegli storici di domani (o dopodomani) li costringerei a metter l’occhio su una cronaca da Torino (Massimo Gramellini, La Stampa, venerdì 1 aprile). Siamo a Mirafiori. Ecco un vecchio operaio che spiega come mai ci siano stati tanti voti per la destra. Anche a Mirafiori.
 "Alza un braccio e lo punta su un condominio con tante finestre tutte uguali. Poi dice: io abito là. Tremila famiglie; di media in ogni alloggio c’ è un disoccupato e una tv: hanno votato Berlusconi perché lui ha fatto delle promesse, e noi nemmeno quelle".
"Alza un braccio e lo punta su un condominio con tante finestre tutte uguali. Poi dice: io abito là. Tremila famiglie; di media in ogni alloggio c’ è un disoccupato e una tv: hanno votato Berlusconi perché lui ha fatto delle promesse, e noi nemmeno quelle".E’ chiaro: non basta la televisione; ci vuole anche un disoccupato in casa (e c’è per spiegare il risultato elettorale del 27 marzo. A quel disoccupato Berlusconi ha promesso un milione di posti di lavoro. Ce ne sarà qualcuno (forse due) anche per lui, perbacco.
Supponete che quel disoccupato abbia venticinque anni e magari un diploma, o una laurea, in tasca. Segue la pubblicazione dei bandi di concorso sulla Gazzetta Ufficiale. Poi accende il televisore (ecco dove la televisione conta) e vede che per una manciata di posti ci sono centinaia, migliaia di concorrenti. Famelici. E’ un incubo. Sarà sciocco, ma volete che non presti l’ orecchio alla prima promessa che gli viene fatta? Sarà imprudente, ma volete che non ceda al primo sogno che gli viene prospettato ("un nuovo miracolo economico")?
Su questo tema - della Fata Morgana, delle illusorie promesse, delle artificiose illusioni elettorali - si è molto discusso in questi giorni in Italia. C’ è stato anche chi ne ha negato ogni importanza. I sogni ad occhi aperti: ma figuriamoci. Lo ha negato anche Rossana Rossanda (il manifesto, venerdì 8 aprile).
Mi pare strano. Rossana Rossanda non può non saperlo: ci sono due versi della poetessa americana Emily Dickinson che le danno torto. Meglio un sogno che niente. E la Dickinson è una poetessa dura, aspra, essenziale. Fatta di pietra e di quarzo. Non si fa illusioni. Non ne autorizza. Non crede nel paradiso in terra, non le piace ("I don’ t like Paradise").
Eppure è lei l’ autrice di quei due versi dove è detto che quando si è al buio persino un fuoco fatuo è meglio di niente. Meglio della totale assenza di luce "Better an ignis fatuus / Than no illume at all"é. Dove quel latino di "ignis fatuus", dove l’ arcaico di quell’ "illume" vogliono dire che è così, fatalmente. E’ una vecchia storia. Possiamo (dobbiamo anzi) contrastarlo. Non possiamo negarlo.
Mi pare strano che la Rossanda non se ne ricordi. C’ è un vecchio volumetto della Savelli, dove quella poesia (tradotta da Barbara Lanati) figura. La prefazione al volumetto - e che prefazione: acutissima, splendida - era di Rossana Rossanda.
* Fonte: la Repubblica, 10 aprile 1994
-
>"SULLE SPALLE DEI GIGANTI" E "SERENDIPITY" (R. K. Merton): "SAPERE AUDE!" (KANT). Con Sigieri di Brabante, oltre: "Senza di loro non vedremmo nulla, su di loro vediamo più lontano di questi San Cristoforo" (U. Eco).3 maggio 2023, di Federico La Sala
Filologia Antropologia Teologia e Pedagogia. "On The Shoulders Of Giants" (OTSOG): "Senza di loro non vedremmo nulla, su di loro vediamo più lontano di questi San Cristoforo" (cfr. U. #Eco, Introduzione all’edizione italiana: "Dicebat Bernardus Carnotensis" del libro di Robert K. #Merton, "Sulle spalle dei giganti", Il Mulino, 1991).
QUALE #IMITAZIONE DEL #MAESTRO DI #GRAMMATICA? QUALE IMITAZIONE DI "SAN CRISTOFORO"? La #via dell’#umiltà (cristoforo-#bambino) o della #superbia (gigante-nano)? :
“NANI SULLE SPALLE DI GIGANTI: "[...] Che cosa significa l’#aforisma? Umberto Eco spiega, nel suo saggio sul #Medioevo di #Federico Motta Editore, qual è il valore di questa espressione. La prima #domanda da porsi è se si tratti di una ammissione di #umiltà oppure di una manifestazione di #superbia. Ma soprattutto, che senso aveva per i medievali paragonare se stessi a dei nani e gli antichi a dei giganti. Un indizio può venire dal contesto in cui è inserita la #massima: Bernardo parlava infatti di #grammatica. In particolare, criticava gli allievi che copiavano pedissequamente gli antichi; al contrario si doveva prenderli a modello, per scrivere altrettanto bene ed essere un domani ammirati al pari loro. È quindi possibile riconoscere un invito all’#autonomia. Come dirà più tardi #Sigieri di #Brabante, rifarsi a un’autorità non basta. Gli antichi erano pur sempre uomini, per cui nulla vieta ai #posteri di dedicarsi anch’essi alla ricerca razionale."
- PSICOANALISI FILOLOGIA E SERENDIPITY: UNA NOTA SULLA ROTTURA DEL RAPPORTO TRA IL #MAESTRO (#FREUD) E Lo "SPIRITO IRREQUIETO" (#STEKEL) GETTA INEDITA LUCE SULL’#ENIGMA DI SAN #CRISTOFORO DELLA "PSICOLOGIA DELLE MASSE E ANALISI DELL’IO" (cfr. post precedenti *) E SULL’AFORISMA "NANI SULLE SPALLE DI GIGANTI".
 Sul tema, una "vecchia" recensione di #Franco Marcoaldi del lavoro di Robert K. #Merton,"Sulle spalle dei Giganti".
Sul tema, una "vecchia" recensione di #Franco Marcoaldi del lavoro di Robert K. #Merton,"Sulle spalle dei Giganti".ANCHE IL GIGANTE INCIAMPA
Rispondere a una lettera, magari anche gradita, e fosse pure soltanto con le canoniche "due righe", sembra essere diventato eroico esercizio cui ci si sottopone a malincuore. Con le dovute eccezioni, naturalmente. Robert (Bob) Merton, ad esempio, docente alla Columbia University e stella di prima grandezza della sociologia contemporanea, in risposta alla succinta missiva dell’ amico Bernard (Bud) Baylin, ha inviato non una, ma mille lettere. Che hanno finito per comporre un libro: folle, geniale ed enigmatico, di cui è pressoché impossibile dare un resoconto rapido, e minimamente sensato.
 D’ altronde, lo stesso sottotitolo, "poscritto shandiano", indica chiaramente come in omaggio a Vita e opinioni di Tristam Shandy di #Lawrence #Sterne, si intenda procedere qui in modo altrettanto digressivo ed errabondo. Affidandosi alla #serendipity: la capacità di trovare una cosa avendone a lungo cercata un’ altra. Il che non ci consente, comunque, di menare a spasso per altre tre cartelle l’ eventuale acquirente del volume, senza provare a dirgli, almeno a grandi linee, e in modo necessariamente vago, di cosa - in definitiva - il libro tratti. E allora, vediamo di tornare alla letterina che Bud invia all’ amico Bob, chiedendogli informazioni più precise riguardo al celebre aforisma da sempre attribuito a #Newton: "se ho visto più lontano, è perché stavo sulle spalle dei giganti".
D’ altronde, lo stesso sottotitolo, "poscritto shandiano", indica chiaramente come in omaggio a Vita e opinioni di Tristam Shandy di #Lawrence #Sterne, si intenda procedere qui in modo altrettanto digressivo ed errabondo. Affidandosi alla #serendipity: la capacità di trovare una cosa avendone a lungo cercata un’ altra. Il che non ci consente, comunque, di menare a spasso per altre tre cartelle l’ eventuale acquirente del volume, senza provare a dirgli, almeno a grandi linee, e in modo necessariamente vago, di cosa - in definitiva - il libro tratti. E allora, vediamo di tornare alla letterina che Bud invia all’ amico Bob, chiedendogli informazioni più precise riguardo al celebre aforisma da sempre attribuito a #Newton: "se ho visto più lontano, è perché stavo sulle spalle dei giganti".
 Siamo proprio così sicuri, si chiede Bud, che sia stato lui, a inventarlo? Detto e fatto. Bob si mette a tavolino, e affidandosi alla sua prodigiosa erudizione, risponde con una lettera (fantastica) di duecentonovanta pagine, che dà forma a quella sarabanda intellettuale raccolta ora in Sulle #spalle dei #giganti (prefazione di #UmbertoEco, Il Mulino, lire 30.000).
Siamo proprio così sicuri, si chiede Bud, che sia stato lui, a inventarlo? Detto e fatto. Bob si mette a tavolino, e affidandosi alla sua prodigiosa erudizione, risponde con una lettera (fantastica) di duecentonovanta pagine, che dà forma a quella sarabanda intellettuale raccolta ora in Sulle #spalle dei #giganti (prefazione di #UmbertoEco, Il Mulino, lire 30.000).Incredibile a dirsi, ma la semplice ricerca à rebours della genealogia di quella minuscola frasetta, consente a Merton di sollevare una infinita serie di questioni. Di immensa, e infima grandezza. Trattate tutte con eguale rispetto, ed eguale irriverenza. Ma, tanto per cominciare, quando compare per la prima volta il celebre Aforisma? In una lettera che #Newton invia a #Hooke nel bel mezzo di una accesa controversia sulla paternità delle rivoluzionarie scoperte relative all’ ottica e alla meccanica celeste.
Da qui Merton prende le mosse, e da qui comincia a sparare una gragnuola senza fine di domande. Chi ha scoperto, cosa e quando? Come la mettiamo con il problema del plagio, delle influenze consce e inconsce? E con quello del rapporto con la tradizione? Gli uomini, su questo punto, mica l’ hanno pensata sempre allo stesso modo. E ancora, i nani (quelli che vedono più lontano), stanno seduti o in piedi, sulle spalle dei giganti? E come fanno "a mantenersi in equilibrio in quell’ imbarazzante posizione"?
Che accade, infine, nel caso in cui i giganti inciampino o cadano bocconi? Se si aggiunge, che nel frattempo, Merton riesce a discutere pure dei vantaggi di "cercare la verità in un dibattito a quattr’ occhi piuttosto che in una discussione pubblica". A proporci le virtù di tal John Aubrey nel definire le persone a partire da colore e taglio degli occhi. E a scoprire un sorprendente plagio di Sterne ai danni di #Burton, proprio nella pagina in cui il primo si avventa contro questa insana abitudine, beh, si capirà bene che c’ è da perdere la testa. Noi, beninteso. Non Merton, che al contrario tesse le fila del suo folle tappeto con perfetto controllo di sé, conscio dei labilissimi confini che separano, nel mondo dell’ #erudizione, #sanità e #pazzia. Talmente conscio da non perdere l’ occasione per stilare una puntuale tassonomia nosografica delle turbe cui la medesima erudizione conduce: l’ adumbrazionismo denigratorio (nulla di nuovo sotto il sole, tutto è già stato detto nell’ antichità); la correlativa sindrome anatopica (occultamento delle versioni antiche); l’ onesta criptomnesia (far passare per proprie idee scovate altrove); l’ insanabile scribendi cacoethes (quella frenesia del pubblicare da cui ci si può curare solo seguendo il consiglio di Thomas Fuller; riempiendo fogli e fogli di carta unicamente all’ inizio della riga). E così via pazziando. Ma non cadiamo pure noi nelle seduzioni digressive dello stile shandiano. E vediamo di concludere.
Si può, in definitiva, sapere quando e come l’ Aforisma nasce, e magari pure quando muore? Sì, in un certo senso, si può saperlo. Nasce nel dodicesimo secolo, con Bernard de Chartres. E muore con #Freud. Quando quel rompiscatole di #Stekel, allievo mitomane e indesiderato, convinto di aver superato di gran lunga il suo maestro, fa un uso davvero smodato dell’ Aforisma. Tanto che il gigante (Freud) è costretto a rispondere al nano (Stekel): "Questo può anche essere vero, ma un pidocchio sulla testa di un astronomo non può farlo".
 Il rebus, dunque, è risolto? Per modo di dire: morte, e soprattutto nascita dell’ Aforisma, restano comunque fittizie, aleatorie. Stabilire che il primo e assoluto ideatore sia stato Bernard significherebbe infatti, rammenta Merton, negare la validità dello stesso Aforisma. Forse che quando lo creò, "non era lui stesso posto sulle spalle dei suoi predecessori?". Insomma, è solo per rispettare il noto detto, "un bel gioco dura poco", che Merton la finisce qui. Se fosse per lui, magicamente afflitto dall’ insanabile desiderio di scrivere, sarebbe ancora lì, a giocare. Con la dovuta serietà, naturalmente. Convinto, con Auden, che "soltanto attraverso la commedia, si può davvero essere seri".
Il rebus, dunque, è risolto? Per modo di dire: morte, e soprattutto nascita dell’ Aforisma, restano comunque fittizie, aleatorie. Stabilire che il primo e assoluto ideatore sia stato Bernard significherebbe infatti, rammenta Merton, negare la validità dello stesso Aforisma. Forse che quando lo creò, "non era lui stesso posto sulle spalle dei suoi predecessori?". Insomma, è solo per rispettare il noto detto, "un bel gioco dura poco", che Merton la finisce qui. Se fosse per lui, magicamente afflitto dall’ insanabile desiderio di scrivere, sarebbe ancora lì, a giocare. Con la dovuta serietà, naturalmente. Convinto, con Auden, che "soltanto attraverso la commedia, si può davvero essere seri".
 (FRANCO #MARCOALDI, "Anche il gigante inciampa", la Repubblica, 10 dicembre 1991).
(FRANCO #MARCOALDI, "Anche il gigante inciampa", la Repubblica, 10 dicembre 1991).
* Post precedenti:
A) #ANTROPOLOGIA CULTURALE (Gregory Bateson) #PSICOANALISI (Sigmund Freud) E #FILOLOGIA (#LorenzoValla).
 Ulteriori appunti...
Ulteriori appunti...Benché sull’amletica #question antropologica ("essere, o non essere?"), #Kant ("#Logica", 1800) abbia richiamato tutta la sua attenzione, l’#idealismo materialistico o il #materialismo idealistico ha continuato nel suo cosmo-te-andrico edipico #sogno. #GregoryBateson, "all’#enigma della #Sfinge", ha dedicato "cinquant’anni" della sua "vita di antropologo" (così in una conferenza del 1979), ma non è riuscito a venir fuori dall’orizzonte della #tragedia e dalla città di #Edipo: l’#enigma di (dove poggia il piede) san #Cristoforo (S. #Freud, "#Psicologia delle masse e analisisi dell’io", "4. #Suggestione e #libido") non l’ha sciolto:
- "Cristoforo portava Cristo
- Cristo portava il mondo intero
- Dimmi, dove allora
- Ha messo Cristoforo il piede?"
- Foto allegata: San Cristoforo.
B) #PSICOANALISI, #FILOLOGIA, #ANTROPOLOGIA E #STORIOGRAFIA: LA #SUGGESTIONE, L’ #ENIGMA DI SAN #CRISTOFORO, E LA "#PSICOLOGIA DELLE #MASSE E #ANALISI DELL’IO" (S. #FREUD, 1921).
Per meglio comprendere il grande rilievo del contributo di #Stekel, al lavoro e alle "#costruzioni nell’analisi" (1937) di #Freud, molto utile anche la lettura del testo della seduta del 1903, pubblicata come articolo con il titolo "Il ’Piccolo Kohn’" (tradotto e curato dal dr. Michele Lualdi):
- "[FREUD] - Il #maestro [...] cosa è suggestione? [...] Mi sono recato dai più celebri maestri della suggestione, ma nessuno ha potuto darmi una risposta a questa #domanda.
- ‘Cristoforo portava Cristo
- Cristo portava il mondo intero
- Dimmi, dove ha posto allora Cristoforo
- il suo piede?’ [...]".
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- OLTRE LA TRAGEDIA E OLTRE LA DIALETTICA DI HEGEL: LA DIVINA COMMEDIA E IL 25 APRILE.23 aprile 2023, di Federico La Sala
MONARCHIA, FASCISMO, E RESISTENZA:
LA DIVINA COMMEDIA E IL 25 APRILE.
- Una nota a margine della #giornatadellaterra 2023 ... *
#ANTROPOLOGIA, #LINGUISTICA, E #POLITICA. A 702 anni dalla morte di #DanteAlighieri, la società italiana mostra ancora grandi difficoltà al suo interno e non riesce a parlare una #lingua #comune, quella propria dei cittadini-sovrani e delle cittadine-sovrane.
#STORIA, #LETTERATURA E #FILOSOFIA. Prima di #Hegel, a tutti i livelli (antropologici e teologici), a cosa alludeva #Dante con la sua paradigmatica proposta della #Monarchia dei #DueSoli?!
LA "MONARCHIA" DEI "DUE SOLI". Se, alla base del "dia-logo" delle due parti in cui l’Italia è divisa (la "destra" e la "sinistra" di "sempre"), non c’è il #Logos (l’accettazione e la condivisione della #Parola della #Legge), ma c’è solo il #Logo di una parte contro e sopra l’altra armata, in una "dialettica" da "#padrone e #servo", dov’è più il #dialogo, dove più la #Costituzione?, dove l’#Italia?!
#EarthDay #Koyaanisqatsi #Ubuntu #Earthrise
MONARCHIA, FASCISMO, E RESISTENZA: LA #DIVINACOMMEDIA E IL #25APRILE.
Una nota a margine della #giornatadellaterra 2023 ... #ANTROPOLOGIA, #LINGUISTICA, E #POLITICA. A 702 anni dalla morte di #DanteAlighieri, la società italiana mostra ancora grandi difficoltà al suo interno e non riesce a parlare una #lingua #comune, quella propria dei cittadini-sovrani e delle cittadine-sovrane.
#STORIA, #LETTERATURA E #FILOSOFIA. Prima di #Hegel, a tutti i livelli (antropologici e teologici), a cosa alludeva #Dante con la sua paradigmatica proposta della #Monarchia dei #DueSoli?!
LA "MONARCHIA" DEI "DUE SOLI". Se, alla base del "dia-logo" delle due parti in cui l’Italia è divisa (la "destra" e la "sinistra" di "sempre"), non c’è il #Logos (l’accettazione e la condivisione della #Parola della #Legge), ma c’è solo il #Logo di una parte contro e sopra l’altra armata, in una "dialettica" da "#padrone e #servo", dov’è più il #dialogo, dove più la #Costituzione?, dove l’#Italia?!
#EarthDay #Koyaanisqatsi #Ubuntu #Earthrise
*
-
> PENSARE BENE "DIO", "IO" E "L’ITALIA" --- PSICOANALISI E CRISTIANESIMO: L’ENIGMA DI SAN CRISTOFORO (S. FREUD, 1903), IL PROBLEMA DELLA "LUCE DEL MONDO", E LA "RISPOSTA" DI DANTE.21 aprile 2023, di Federico La Sala
PSICOANALISI, CRISTIANESIMO, ANTROPOLOGIA E LETTERATURA:
- L’ENIGMA DI SAN CRISTOFORO (IL GIGANTE, PORTATORE DEL BAMBINO CRISTO , "CRISTO-FORO" O, ALTRIMENTI, "CRISTO-FARO", "LA LUCE DEL MONDO").
- Una nota in omaggio al lavoro di filologia e storia di Michele Lualdi...
"PSICOLOGIA DELLE MASSE E ANALISI DELL’ IO" (S. FREUD, 1921): DANTE ("Io non Enëa, io non Paulo sono": Inf. II, 32) SA "DOVE METTE CRISTOFORO IL PIEDE" (cfr. Wilhelm Stekel, " Il ’Piccolo Kohn’ ", 1903, tradotto e curato da Michele Lualdi).
"IN PRINCIPIO ERA IL LOGOS", "CRITICA DELLA RAGION PURA" (KANT), E "IDEALE DELL’IO" (S. FREUD). CON GIASONE (OVIDIO) E CON ASTREA (LA "VIRGO" DI VIRGILIO) E MARIA-BEATRICE (LA "VERGINE" DI SAN BERNARDO), DANTE RIPRENDE IL CAMMINO, dall’ INIZIO (dall’Inferno) ma dal PRINCIPIO (Par. XXXIII: "Vergine Madre, figlia del tuo figlio [...] l’amor che move il sole e l’altre stelle") e racconta come è riuscito a ritrovare "LA DIRITTA VIA" e a capire il senso antropologico di sé: "Io sono l’alfa e l’omega, il primo e l’ultimo, il principio e la fine" (Ap., XXII, 13).
-
> DENTRO LA PIÙ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA E POLITICA ITALIANA --- "Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera".17 marzo 2023, di Federico La Sala
Mattarella: "Costituzione, inno e bandiera i riferimenti che ci guidano"
Il Presidente nel messaggio per l’Unità d’Italia: "La Carta garantisce risorse per sfide complesse"
di Redazione ANSA (17 marzo 2023->https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2023/03/17/mattarella-costituzione-inno-e-bandiera-i-riferimenti-che-ci-guidano_c7b81537-523c-4aee-9fa1-81087ae76988.html])
ROMA. "Viviamo oggi, con il conflitto scatenato dalla Federazione Russa in territorio ucraino, un’aperta minaccia che ci impone una ferma risposta unitaria in seno alla comune identità europea e atlantica, affinché venga posta fine ai combattimenti e si raggiunga un duraturo accordo di pace".
Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio in occasione dell’anniversario dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera.
- Mattarella si è recato all’Altare della Patria.
Con lui - tra gli altri - il presidente del Senato, Ignazio La Russa, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli e la presidente della Corte Costituzionale, Silvana Sciarra. Il capo dello Stato ha deposto una corona d’alloro sulla tomba del Milite Ignoto.
- Meloni celebra l’Unità d’Italia, "Auguri al popolo fiero della Patria"
"La Repubblica, in innumerevoli prove e, da ultimo, durante la pandemia, ha confermato sentimenti di unità e coesione stringendosi ai valori costituzionali. Gli stessi che, ispirando la nostra società, garantiscono le risorse morali necessarie a fronteggiare le sfide complesse che la contemporaneità ci mette innanzi", afferma Mattarella nel messaggio.
"La Repubblica, in innumerevoli prove e, da ultimo, durante la pandemia, ha confermato sentimenti di unità e coesione stringendosi ai valori costituzionali. La Costituzione, l’Inno degli italiani e la Bandiera sono i riferimenti che ci guidano nell’impegno comune di consolidare un’Italia fondata su pace, libertà e diritti umani" prosegue il capo dello Stato.
"Celebriamo oggi - prosegue il Capo dello Stato - l’anniversario dell’Unità d’Italia, che è "Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera". 162 anni fa, sotto il Tricolore, con i plebisciti popolari si espressero la sovranità e la volontà che, attraverso l’opera risorgimentale, avevano portato alla costituzione dello Stato italiano. Il primo pensiero va alle generazioni che hanno accompagnato questo traguardo, a quanti, con il loro operato, hanno contribuito alla nascita e alla crescita del nostro Paese, promuovendo quei valori di civile convivenza, quegli ideali di libertà e democrazia, di pace e di partecipazione allo Stato di diritto e alla comunità internazionale, che hanno trovato consacrazione nella nostra Costituzione. Viviamo oggi, con il conflitto scatenato dalla Federazione Russa in territorio ucraino, un’aperta minaccia a questi valori che ci impone una ferma risposta unitaria in seno alla comune identità europea e atlantica, affinché venga posta fine ai combattimenti e si raggiunga un duraturo accordo di pace". "La Repubblica - conclude Mattarella - in innumerevoli prove e, da ultimo, durante la pandemia, ha confermato sentimenti di unità e coesione stringendosi ai valori costituzionali. Gli stessi che, ispirando la nostra società, garantiscono le risorse morali necessarie a fronteggiare le sfide complesse che la contemporaneità ci mette innanzi. La Costituzione, l’Inno degli italiani e la Bandiera sono i riferimenti che ci guidano nell’impegno comune di consolidare un’Italia fondata su pace, libertà e diritti umani".
- Meloni: unità, Costituzione e inno fondamento della nostra comunità
"Oggi l’Italia celebra la Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera, le fondamenta robuste sulle quali la nostra comunità si erge e dalle quali essa prende ispirazione". Lo afferma in una nota la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Il 17 marzo di 162 anni fa iniziava il cammino dell’Italia come Stato unitario e si realizzava l’auspicio di un giovane genovese, visionario e ribelle, come Goffredo Mameli: poter vedere gli italiani non più "calpesti e derisi" e "divisi", bensì raccolti in "un’unica bandiera". Il 17 marzo è la solennità nazionale più unificante che abbiamo e nel corso della quale quale siamo chiamati a ricordare le ragioni del nostro stare insieme. Perché, come ha spiegato Ernest Renan, la Nazione è una "grande solidarietà, un plebiscito che si rinnova ogni giorno e che si fonda sulla dimensione dei sacrifici compiuti e di quelli che ancora siamo disposti a compiere". Questa è la sfida che abbiamo davanti, è l’impegno che dobbiamo onorare ogni giorno: riannodare i fili di ciò che ci unisce e riscoprirci una comunità. Solo così possiamo liberare le migliori energie della Nazione e dimostrare che nessuna meta è preclusa all’Italia. Buon 17 marzo a tutti gli italiani!"
AGENZIA ANSA
FdI: speriamo di festeggiare l’unità d’Italia già il 17 marzo 2024 - Politica
 Con la proposta di legge che chiede di istituire il 17 marzo come festa nazionale dell’unità d’Italia, Fratelli d’Italia spera che il 17 marzo del 2024 si possa già festeggiare. (ANSA)
Con la proposta di legge che chiede di istituire il 17 marzo come festa nazionale dell’unità d’Italia, Fratelli d’Italia spera che il 17 marzo del 2024 si possa già festeggiare. (ANSA) -
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- NEL LETARGO DELL’INFERNO EPISTEMOLOGICO DELLA TRAGEDIA.17 marzo 2023, di Federico La Sala
QUESTIONE ANTROPOLOGICA (KANT, 1800), "ECCE HOMO" (NIETZSCHE, 1888), E INFERNO EPISTEMOLOGICO.
IMMAGINARE, STORIOGRAFICAMENTE (E FILOSOFICAMENTE) CHE "la galileiana matematizzazione della natura" sia innanzitutto un’operazione contro Galileo, così come lo strutturalismo linguistico alla Lacan sia soprattutto una saussuriana matematizzazione del linguaggio" contro Saussure, è un bell’esempio di permanenza nel letargo (Par. XXXIII, 94) dell’inferno epistemologico della tragedia - contro la commedia e contro Dante.
Enrico Redaelli, nel suo libro "Judith Butler. Il sesso e la legge", "un attraversamento delle opere e del pensiero della femminista, attivista Lgbtq+, intellettuale militante e filosofa statunitense", nello sforzo di offrire un contributo critico alla discussione, scrive:
- (A) "Contro il costruttivismo, Butler sottolinea che “esiste un ‘esterno’ a quanto è costruito dal discorso”, ma, aggiunge subito dopo, “non si tratta di un ‘fuori’ assoluto, un luogo ontologico che eccede o contrasta i confini del discorso”. Di che si tratta, dunque? Questo “fuori” non è la materia, giacché, osserva #Butler con toni hegeliani, “porre una materialità all’esterno della lingua significa, comunque, porre quella materialità. Come direbbe Gilbert Simondon, la materia è sempre materia formata. Butler suggerisce il medesimo riferendosi al corpo: “non esiste rimando a un corpo puro che non sia allo stesso tempo un’ulteriore formazione di quel corpo”;
- (B) "Fino all’inizio della modernità, infatti, il cosmo di cui l’uomo fa esperienza è sempre stato un cosmo sessualizzato, barrato, visto alla luce della differenza sessuale. [...] In seguito il disincanto della scienza moderna ha prodotto qualcosa di completamente nuovo, la mera “realtà oggettiva”, privata di ogni fine e di ogni senso, ma anche di ogni sesso. [...] Come ha infatti osservato #Husserl, la mossa che ha dato origine alla modernità scientifica, la galileiana matematizzazione della natura, è una potente operazione di astrazione che passa per lo svuotamento dei plena, ossia per la cancellazione di tutte le caratteristiche qualitative degli enti naturali (odore, sapore, colore, ecc.), sloggiate dall’ambito dell’oggetto ed esiliate in quello del soggetto." (cfr. E. Redaelli, "Judith Butler. Il sesso e la legge", Le parole e le cose, 7 marzo 2023).
SE è VERO, come è vero CHE "La questione è più complessa e non priva di paradossi", non per questo è necessario costringere nelle vecchie botti della cosmoteandria platonico-heideggeriana l’acquisizione della relatività galileiana-einsteiniana, della consapevolezza antropologica dell’io che "non è padrone nemmeno in casa sua" e che le sue spiegazioni non sono interpretazioni di sogni, ma, a tutti i livelli, "costruzioni nell’analisi", sia in fisica sia in metafisica - criticamente, con Kant, Freud, e Franca Ongaro Basaglia.
#Earthrise #Metaphysics #Anthropology #Theology #Cosmology #Koyaanisqatsi #Ubuntu
-
>VITA E FILOSOFIA. GIANNI VATTIMO E LA TERZA METAMORFOSI DELLO SPIRITO: IL BAMBINO E "LA FATICA DI TROVARSI A UN MILLIMETRO DALLE PAROLE" (Intervista di A. Gnoli).28 febbraio 2023, di Federico La Sala
Straparlando
GIANNI VATTIMO. Che fatica trovarsi a un millimetro dalle parole.
di Antonio Gnoli (la Repubblica, Robinson, 25 febbraio 2023, pp. 38-39).
La vecchiaia di un celebre filosofo, come tutte le vecchiaie verrebbe da aggiungere, andrebbe protetta dalle bagarre mediatiche. Quelle che da alcuni anni hanno visto coinvolto Gianni Vattimo. Era da un po’ che con Gianni non ci si vedeva e quando gli ho telefonato l’ho sentito disponibile all’idea che sarei andato a trovarlo. Ci siamo visti per pranzare nella sua grande e accogliente casa di via Po. Dove tutto è come l’ultima volta.
Tranne il gatto fulvo che non c’è più. Ci sono i libri, la grande televisione dove il professore segue a volume piuttosto alto un telegiornale. Le immagini corrono davanti a una specie di indifferenza dello sguardo. Mi riceve Simone Caminada. Presenza per molti ingombrante, per alcuni necessaria. Il giorno dopo la visita, una sentenza giudiziaria lo condanna a due anni di carcere per circonvenzione. In pratica avrebbe approfittato della fragilità del filosofo per mettere le mani sul suo patrimonio. Non entro nella questione che è stata già ampiamente trattata dai giornali. Mi limito a osservare la padronanza con cui Caminada - un adulto di 40 anni di Salvador Bahia - gestisce il rapporto con Vattimo.
 Perché sono qui? Perché al Circolo dei lettori di Torino, su iniziativa del centro studi Pareyson, Lopera completa di Vattimo (edita dalla Nave di Teseo) ed era appunto un’occasione vederlo qualche ora prima, parlargli, intervistarlo fuori da ogni clamore giudiziaario. Poche settimane fa Gianni ha compiuto 87 aqnni. E’ smagrito. Guardo i suoi occhi di una fissità vaga e ascolto i suoi prolungati silenzi. Non so bene da dove iniziare. Forse dal fatto che l’antico allievo Maurizio Ferraris si sia rappacificato con il maestro.
Perché sono qui? Perché al Circolo dei lettori di Torino, su iniziativa del centro studi Pareyson, Lopera completa di Vattimo (edita dalla Nave di Teseo) ed era appunto un’occasione vederlo qualche ora prima, parlargli, intervistarlo fuori da ogni clamore giudiziaario. Poche settimane fa Gianni ha compiuto 87 aqnni. E’ smagrito. Guardo i suoi occhi di una fissità vaga e ascolto i suoi prolungati silenzi. Non so bene da dove iniziare. Forse dal fatto che l’antico allievo Maurizio Ferraris si sia rappacificato con il maestro.Ho letto l’articolo che Ferraris ha scritto su di te.
«Non credo di averlo capito bene quell’articolo».
Cosa hai pensato?
«A una mozione di affetti, e che alla fine si torna un po’ bambini. Senza più l’obbligo di dover capire tutto».
Che vuoi dire?
«Non lo so, mi sento un po’ bambino. Sono accudito come un bambino. Lo vedi, di mio faccio poco».
Perché non puoi o non vuoi?
«Non posso, è chiaro. Parlo a fatica, a volte sono a un millimetro dalle parole».
Dalle parole per esprimerti e spiegarti?
«Avverto il suono e il senso di quelle altrui. Le mie escono strane».
Strane come?
«Come se la mia voce fosse cambiata. si strozzano in gola, poi escono come un sospiro pesante».
Vorrei tornare all’articolo di Ferraris.
«Ti ho detto, quell’articolo uscito sul Corriere della sera, non l’ho ben capito».
Dice che sei un cattolico, ma io ti vedo poco come cattolico.
«No, no. Lo sono».
Sei dentro il cristianesimo.
«Sono cattolico apostolico romano».
Non te l’ho mai sentito dire in modo così netto.
«Per me il cristianesimo è il cattolicesimo romano».
Il cristianesimo è molto di più.
«Ma sono nato qui. Fossi nato altrove sarei probabilmente un’altra cosa».
La Chiesa è tutt’altro che salda.
«Principi e la gerarchia non mi interessano».
E cosa ti interessa?
«Vivere la mia condizione periferica».
Di Ratzinger che cosa pensi?
«Mi pare sia morto».
Sì ma che giudizio ne dai?
«Negativo. La sua rinuncia, per quel che si è scritto, è stato un gesto bello. Ma troppa teologia impositiva».
Faceva il suo mestiere.
«Fin dall’inizio mi è parso respingente».
E di Papa Francesco cosa dici?
«Una grande figura. È la sola che mi interessa. So che ha letto alcuni miei libri. Prima della pandemia ci sentimmo telefonicamente».
Cosa vi diceste?
«Non lo ricordo».
Posso dirtelo io. Gli era piaciuto il tuo “Essere e dintorni”.
«Un libro che non chiude la mia opera, la lascia aperta».
L’opera aperta mi fa pensare al tuo amico Umberto Eco.
«Come me veniva dal mondo cattolico».
Vi ha condizionati questa educazione?
«Penso di sì. Un’educazione è una forma di disciplina. Ne restano tracce difficilmente cancellabili. Si sarebbe laureato su San Tommaso o avrebbe scritto Il nome della rosa senza quella educazione?».
Quanto a te?
«Ho sostenuto un cristianesimo senza verità».
Un cristianesimo debole, intendi dire?
«Debole, certo. Al punto che dovendo scegliere tra Gesù e la verità sceglierei lui. Era una strepitosa battuta di Dostoevskij».
Ma non si dice che Gesù sia la verità?
«Certo, ma quale? Non la verità che abbiamo ereditato dalla tradizione filosofica. Gesù ci ha liberati da quella verità. Ci ha chiesto di aderire al suo messaggio. Che è anche un messaggio profondamente politico».
Hai scritto molto di politica.
«È così».
Così come?
«La mia ermeneutica - il modo di interpretare i testi, gli eventi, la vita - si serviva dello sguardo politico. Non puoi limitarti a interpretare il mondo, devi provare a cambiarlo».
Pensi di esserci riuscito?
«Ho i miei dubbi. Anzi la certezza di avere fallito».
E’ il destino degli intellettuali, dei filosofi. Da Platone in poi. Vogliono dare la linea. «Ma non volevo servire i politici. Che sono per lo più penosi. Volevo muovermi nell’ordine di un mondo fatto in parte di esclusi».
Segui ancora la politica?
«Guardo i telegiornali. La politica non mi interessa più. Non saprei da che parte collocarmi. Sapevo stare dal lato dei più deboli. Ma chi sono i deboli oggi?».
Beh, sfruttati, emarginati, poveri non mancano, il discorso sulle disuguaglianze è più che mai attuale.
«Si sono riempite biblioteche di testi, io stesso vi ho contribuito. Ho spinto perché la sinistra, oltre che ai vecchi diritti pensasse anche ai nuovi. È una sinistra senza contenuti. Dovrebbe occuparsi degli ultimi».
Gli ultimi del messaggio evangelico? «Chi se no? ».
De André, in una canzone, scritta con De Gregori, parlava di un francescanesimo a puntate.
«Che vuol dire?».
Una carità automatica, seriale, esibita, con il tornaconto.
«Va bene, sono contro la carità pelosa».
A favore di cosa?
«Dei diritti, di tutti i diritti. Ricordo che contro l’inquinamento acustico nelle città, anni fa proposi alla sinistra di farsi sostenitrice del diritto del silenzio».
Forse c’è anche molto rumore mediatico.
«Assordante, non c’è dubbio».
Tu come lo hai vissuto, come lo vivi?
«Con fastidio. Si sono dette troppe cose. E il processo che mi ha riguardato è sembrata una cosa arbitraria».
C’era chi temeva per il tuo patrimonio.
«Dei miei soldi faccio quello che voglio. Si sono create troppe aspettative attorno a me. Non è giusto finire sui giornali per fatti che riguardano la mia vita privata».
Ti ha tolto serenità?
«Un po’ sì, ma neanche tanto. Vorrei essere più autonomo, più libero. Ma sono in queste condizioni di semi immobilità. Ho bisogno di aiuto. E Simone svolge il compito egregiamente».
È qualcosa di più di un assistente?
«Lo considero il mio compagno».
Simone mi ha detto che il tuo Parkinson è una balla. Un’invenzione.
«Ti ha detto questo? Non lo so. So che mi muovo a fatica e che debbo usare la carrozzina per spostarmi».
Ha aggiunto che se mai ci sia stato è regredito.
«Forse un po’ è regredito, chi lo sa».
Sono anche regredite le polemiche sulla tua filosofia.
«Non so se considerarlo un bene, Mi divertivano quelle accese discussioni. Credo di aver rotto le scatole a tanti conclamati filosofi».
Ormai sei considerato quasi un classico.
«Toglierei il quasi. Lo sono. È il solo diritto di cittadinanza che mi riconosco».
Le polemiche sul postmoderno e il pensiero debole sono ormai tramontate.
«Restano i libri, i miei, quelli di Rorty e di Lyotard».
A quale dei tuoi scritti ti senti più legato?
«Ai primi, in particolare a Il soggetto e la maschera. E’ quello in cui mi riconosco. Il più organico nella visione».
Uscì a metà anni Settanta. Il pamplet sul Pensiero debole, scritto con Pier Aldo Rovatti, nel 1983.
«I detrattori pensavano che debole volesse dire arrendevole, superficiale, stolto. Pensavano che la nostra filosofia fosse adatta ai gagà e ai bellimbusti».
E invece?
«Fu un modo per togliere il peso opprimente ai concetti, dar loro quella leggerezza necessaria dopo la deflagrazione concettuale della metafisica. Quella roba lì, che da Platone in poi era stata predicata, non funzionava più».
Ricordi il tuo esordio in pubblico?
«Credo di averne avuti più d’uno».
Mi riferisco a te poco più che venticinquenne mentre tieni una lezione all’università di Torino.
«Sinceramente non ricordo, dammi qualche indizio».
Era il novembre del 1960 e tu parlavi per la prima volta davanti a una schiera di autorevoli professori torinesi.
«Chi c’era?».
Tra gli altri c’erano Guzzo, Abbagnano, Chiodi, Bobbio e il tuo maestro Pareyson.
«Ero fresco della lettura dei seminari di Heidegger su Nietzsche che erano usciti quell’anno. Allora ero un dirigente dell’Azione cattolica e parlare di Nietzsche e Heidegger poteva sembrare una stravaganza».
Quale dei due è stato più importante per te?
«Oggi ti risponderei Heidegger. Nietzsche ha svolto il ruolo di accompagnatore. Ha funzionato da melodia».
Come vivi questa fase finale?
«Provo a non pensarci, le conseguenze sono pesanti».
Hai fatto testamento biologico?
«No c’ho pensato. Ne dedurrai che sono un ottimista».
E lo sei?
«Lo ero, qualcosa è rimasto di quell’ottimismo».
Forse la gentilezza e il saper accogliere gli altri.
«La chiamerei predisposizione cristiana».
Com’è una tua giornata?
«Mi alzo tardi, faccio fisioterapia, la colazione, leggo i giornali e poi l’attesa del pranzo. Guardo le notizie in televisione leggo qualche libro. Sono molto noioso».
Che libri leggi?
«Narrativa poliziesca, non vado molto più in là».
Ti manca il non poter scrivere come vorresti?
«Moltissimo. Avrei voglia di scrivere, di continuare a lavorare alle mie cose. Ma non ce la faccio».
Ti rassegni?
«A volte mi dispero, ma so che è inutile. E mi rassegno».
Oltre alla scrittura cos’altro ti manca?
«I compagni che non ci sono più, i miei».
Intendi i tuoi genitori?
«Mio padre praticamente non l’ho conosciuto. Mi manca mia madre. Una figura importante per me».
Una volta mi raccontasti del suo lavoro da sarta e che ti insegnò a cucire.
«È vero. Ero un bambino cresciuto con le conseguenze della guerra. La fame e le bombe. Un misto di paura e precarietà. L’aiutavo a confezionare abiti».
Hai detto all’inizio di questo nostro incontro che si torna quasi sempre bambini.
«La magia è avere dentro di sé il bambino che eri».
Pensi di averlo conservato in te?
«Penso che quello che sono diventato lo devo a quello che fui. E se lo so è perché è ancora dentro di me».
NOTA: MESSAGGIO EVANGELICO E INFANZIA: COME SI RI-NASCE?! Se si dimentica l’essere stati bambini ("ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi") e di essere stati al-levati, dell’essere ri-nato grazie a tutta la comunità, come è più possibile vivere?!
***
LE "TRE #METAMORFOSI" DELLO #ZARATHUSTRA DI #NIETZSCHE E IL #SAPEREAUDE! DELL’ILLUMINISMO DI #KANT. Appunti... [...] *
PSICOLOGIA E FILOSOFIA. Carl Gustav #Jung ha fatto un brillantissimo lavoro su «Lo Zarathustra di Nietzsche. Seminario 1934-39», ma alla fine la sua stessa ombra gli ha impedito di giungere a fondo e a capo dell’enigma di #Edipo, della domanda (la "question") di #Amleto, della "#visione e l’#enigma di Zarathustra e, infine, di accogliere il #bambino nato dalla metamorfosi del cammello e del leone (cfr. Federico La Sala, "La #menteaccogliente. Tracce per una #svolta_antropologica", Antonio Pellicani Editore, Roma 1991).
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- ARTE, RELIGIONE, FILOSOFIA: LA DOMANDA DI AMLETO , LA MORTE DELL’ARTE, E LA "MADONNA DEL PESCE" DI RAFFAELLO.26 febbraio 2023, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA E RINASCIMENTO, OGGI (26 FEBBRAIO 2023):
ESSERE, O NON ESSERE? LA DOMANDA DI AMLETO E "LA LEZIONE DI "ABO" (Achille Bonito Oliva).
Una nota a margine ... *
"L’ARTE DA SOLA NON ESISTE. Senza un sistema composto da media, collezionisti, mercato, musei, pubblico, le opere in sé non avrebbero valore". Con questo titolo, di forte tonalità hegeliana e marxista, Achille Bonito Oliva, sul "Robinson" ("la Repubblica" del 18 febbraio 2023), sollecita in qualche modo lodevolmente a ripensare "tutto".
SOCIALITÀ CRITICA. A onore di Bonito Oliva, per non lasciar cadere l’ago nel pagliaio e rischiare di non ritrovarlo, tenendo presente che né la "religione" né la "filosofia", come l’arte, esiste da sola, forse, è opportuno allargare l’area della coscienza del tempo presente e riprendere a cercare di capire meglio la situazione storica attuale, a tutti i livelli.
NAPOLI E "LA MADONNA DEL PESCE" DI RAFFAELLO. Considerato che «il Pesce puzza dalla testa» (soprattutto se si continua a confondere inconsapevolmente ICTUS con IXTHUS, "I.X.TH.U.S."), a mio parere, solleciterei una urgentissima riflessione antropologica sulla millenaria e moribonda tradizione del “Pensare l’artista come un demiurgo, produttore isolato d’immagini"!
COSMOTEANDRIA. Continuare così, come precisa Achille Bonito Oliva, "vuol dire non riuscire a comprendere l’esistenza di una condizione filosofica dell’arte e dell’artista" e, al di là delle allusioni e delle illusioni dello stesso "ABO" (relative alla "teoria della catastrofe" e allo "spostamento che raccoglie l’esigenza di una struttura edipica uccidendo il padre, ovvero il movimento precedente"), vuol dire interrogarsi radicalmente sulla figura dell’artista e sull’arte stessa, in quanto "produzione linguistica, e dunque, operatività e pratica culturale", al di fuori della logica cosmoteandrica del mondo attuale, che anche il sistema dell’arte ha contribuito a costruire.
NOTA: FILOLOGIA E ITTICA. "Ichthỳs. Antico simbolo cristiano di Cristo; le lettere greche (ΙΧΘΥΣ) che compongono la parola, formano l’acrostico ᾿Ιησοὸς Χριστὸς Θεοῦ υἱὸς Σωτήρ «Gesù Cristo, figlio di Dio, Salvatore». (Treccani).
#Earthrise #Metaphysics #Anthropology #Eleusis2023 #Roma2024
*
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- IL GIOCO ISTITUZIONALIZZATO DEL MENTITORE: A BORIS SOUVERINE, IN MEMORIA. Sul mentitore che non sa di mentire (di Giorgio Agamben).24 febbraio 2023, di Federico La Sala
POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA... *
Sul mentitore che non sa di mentire
di Giorgio Agamben, 22 febbraio 2023
«Stalin e i suoi sottoposti mentono sempre, in ogni istante, in ogni circostanza; e poiché mentono sempre, non sanno nemmeno più di mentire. E quando ognuno mente, nessuno più mente mentendo». Vorrei riflettere su questa frase di Boris Souvarine del suo libro su Stalin, perché ci riguarda da vicino. ------
Menzogne da parte dei governi e dei loro media e collaboratori ci sono sempre state, ma decisiva mi pare la considerazione che Souvarine aggiunge alla sua diagnosi: la menzogna può raggiungere un grado così estremo, che i mentitori non sanno più di mentire e, pur continuando a mentire, nessuno più mente.
È questo che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo negli ultimi tre anni ed è questo che rende la situazione presente in Italia non soltanto grave e oppressiva, ma tale che è possibile che sfugga a ogni controllo e finisca in un disastro senza precedenti. Nulla è infatti più pericoloso di un mentitore che non sa di mentire, perché le sue azioni perdono ogni contatto con la realtà. Verità e menzogna, buona fede e mala fede si confondono nella sua mente fino a diventare indiscernibili.
Così negli anni del Covid, i ministri, i medici e gli esperti che mentivano hanno finito col credere a tal punto alle loro menzogne che, smarrendo ogni coscienza della verità, hanno potuto calpestare senza alcuno scrupolo i principi più elementari dell’umanità. Una società che perde ogni coscienza della soglia che separa il vero dal falso diventa letteralmente capace di tutto, anche di distruggersi. È quanto sta avvenendo per la guerra in Ucraina, rispetto alla quale vengono diffuse soltanto notizie false. Il rischio è qui che governi che mentono non sapendo più di mentire possono scatenare una guerra atomica che credevano di non volere, ma che le loro stesse menzogne li obbligano ora a credere di volere.
 22 febbraio 2023
22 febbraio 2023
 Giorgio Agamben
Giorgio Agamben
* STORIA D’ITALIA (1994-2010): IL GIOCO ISTITUZIONALIZZATO DEL "MENTITORE" DI UN PARTITO E IL SILENZIO DEL COLLE, DELLA CORTE COSTITUZIONALE, E DEGLI INTELLETTUALI. Un Paese sull’orlo del Baratro...
- immersi in un letargo profondo, dentro interi millenni di labirinto (Nietzsche), molto "sorprendenti" le riflessioni di Giorgio Agamben per capire quello che "abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo negli ultimi tre anni". Ma, da cittadini e cittadine d’Italia, non si ha più memoria da quanto tempo il Nome dell’intero Paese è di un solo Partito, così come pure l’Inno Nazionale?
CHE LE ISTITUZIONI DEL NOSTRO PAESE ABBIANO PERMESSO UN PARTITO CON IL NOME DI "FORZA ITALIA" PRIMA, E CON IL "POPOLO DELLA LIBERTA’" POI, SIGNIFICA CHE E’ GIA MORTO!!!
 Un Paese sull’orlo del Baratro - di Nadia Urbinati
Un Paese sull’orlo del Baratro - di Nadia UrbinatiFederico La Sala
-
>"FILOSOFIA OLTRE I CONFINI" E OLTRE LE "RECINZIONI": UNA "TRACCIA" DI PENSIERI PER IL CONGRESSO MONDIALE DI FILOSOFIA (ROMA, 2024).19 febbraio 2023, di Federico La Sala
EARTHRISE. IL SORGERE DELLA TERRA: "FILOSOFIA OLTRE I CONFINI" E OLTRE LE "RECINZIONI".
UNA "TRACCIA" DI PENSIERI PER IL CONGRESSO MONDIALE DI FILOSOFIA (ROMA, 2024). *
A) STORIA, PREISTORIA, E STORIOGRAFIA. "Il primo che, recintato un terreno, ebbe l’idea di dire: Questo è mio, e trovò persone così ingenue da credergli, fu il vero fondatore della società civile. Quanti delitti, guerre, assassini, quante miserie ed orrori avrebbe risparmiato al genere umano colui che, strappando i paletti o colmando il fossato, avesse gridato ai suoi simili: Guardatevi dall’ascoltare quest’impostore; siete perduti, se dimenticate che i frutti sono di tutti e la terra non è di nessuno." (J.-J. Rousseau, "Discorso sull’origine della diseguaglianza", 1755).
B) ERACLITO, MESSAGGIO EVANGELICO, E QUESTIONE ANTROPOLOGICA:"IN PRINCIPIO ERA IL LOGOS":
Freud e "L’infelicità nella civiltà ("Das Ungluck in der Kultur"):"[...] Poi che l’apostolo Paolo ebbe posto l’amore universale tra gli uomini a fondamento della sua comunità cristiana, era inevitabile sorgesse l’estrema intolleranza della Cristianità contro coloro che rimanevano al di fuori; i Romani, che non avevano fondato la loro collettività statale sull’amore, non conobbero l’intolleranza religiosa, benché per loro la religione fosse un affare di Stato e lo stato fosse imbevuto di religione. Non fu un puro caso che il sogno germanico del dominio del mondo facesse appello all’antisemitismo come a suo complemento, e non è inconcepibile che il tentativo di stabilire una nuova civiltà comunista in Russia trovi il suo sostegno psicologico nella persecuzione della borghesia. Ci si chiede soltanto, con apprensione, che cosa si metteranno a fare i Sovieti, dopo che avranno sterminato la loro borghesia [...]" (S. Freud, Il disagio della civiltà ["Das Unbehagen in der Kultur"], 1929).
C) UNA "CADUTA" BIBLICA: CAINO E LE RECINZIONI (MATERIALI E SPIRITUALI). I due "pensieri" (di Rousseau e Freud), coniugati insieme, portano a una sola e chiara conclusione: "Il capitalismo è un sistema di dipendenze: dall’interno verso l’esterno, dall’esterno verso l’interno, dall’alto verso il basso e dal basso verso l’alto. Tutto è dipendente, tutto è concatenato. Il capitalismo è uno stato del mondo e dell’anima". (Franz Kafka, 1920).
D) EARTHRISE (ELEUSIS2023): CRISTIANESIMO, PSICOANALISI, E PSICHIATRIA. COME DA CONSAPEVOLEZZA E INDICAZIONE DI FRANCA ONGARO BASAGLIA, ("COSI’ PARLO’ EDIPO A CUERNAVACA", «pM» - "Panorama mese", Arnoldo Mondadori, novembre 1982), NON E’ MAI TROPPO TARDI PER PORTARSI FUORI DALLA "COSMOTEANDRIA" PLATONICA E PAOLINA, A TUTTI I LIVELLI, E AMMIRARE LA BELLEZZA DELLA CASA COMUNE DELL’INTERA UMANITA’, IL PIANETA TERRA.
-
>LA STORIA FILOSOFICA E POLITICA ITALIANA --- PSICOANALISI E FILOLOGIA: LA PRONIPOTE DI FREUD E LA NIPOTE DI BELLA DEGLI ABATI.15 febbraio 2023, di Federico La Sala
PSICOANALISI, FILOLOGIA, E "DIVINA COMMEDIA": INTERPRETAZIONE DEI SOGNI (1899) E "COSTRUZIONI NELL’ANALISI" (SIGMUND FREUD, 1937).
- UNA NOTA A MARGINE DI UNA COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA PRONIPOTE DI FREUD, BELLA FREUD...
CHIARISSIMA International Psychoanalytical Association (IPA), SULLE ALI DEL VENTO, UNA BRILLANTE "CONSONANZA" PRIMAVERILE CON LA LONDRA DI MARESFIELD ("Freud Museum London") E DINTORNI, IL SUO POST SU BELLA FREUD.
DIVINA COMMEDIA. Avendo richiamato da poco alla memoria il nome della madre di Dante Alighieri - Gabriella (Monna Bella) degli Abati, meglio nota come Donna Bella degli Abati - e, da tempo (almeno dal 2007), fatta l’ipotesi che la ragione per cui la figlia di Dante, Maria Antonia, abbia scelto il nome di Beatrice quando entrò in convento e divenne suora, stia proprio nel fatto che Bella era il nome della nonna, quella donna 🌞"bella e beata"🌞(Inf. II, 54), che sollecita Virgilio ad aiutare Dante, oggi☀️(15.02.2023), ho trovato molto significativa la coincidenza con il fatto che la pronipote di Freud sia (e per davvero), già solo per il #nome e #cognome, legata alla figura di Freud e, al contempo, di Virgilio e Dante. 🌞🙏
N.B. - Dopo i maestri del sospetto (Marx Nietzsche e Freud), come è possibile (Kant) continuare a pensare all’altezza dI DANTE2021 che il Sommo Poeta tradisca spiritualmente la sua sposa Gemma Donati e i suoi figli e la sua figlia Antonia, suor Beatrice?
 "L’Interpretazione dei Sogni" (1899) ha il suo legame con l’Eneide (VII, 312: "Flectere si nequeo Superos, Acheronta movebo") di Virgilio e "L’uomo Mosè e la religione monoteistica"(1938) con il tema dell’«In exitu Isräel de Aegypto» della Divina Commedia (Pg. II, 46-48) di Dante.
"L’Interpretazione dei Sogni" (1899) ha il suo legame con l’Eneide (VII, 312: "Flectere si nequeo Superos, Acheronta movebo") di Virgilio e "L’uomo Mosè e la religione monoteistica"(1938) con il tema dell’«In exitu Isräel de Aegypto» della Divina Commedia (Pg. II, 46-48) di Dante. -
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- CADUTA NELLA CAVERNA PLATONICA E COSMOTEANDRIA: IL PROBLEMA SOCRATE E IL CREPUSCOLO DEGLI IDOLI.8 febbraio 2023, di Federico La Sala
EUROPA, FILOSOFIA, ED ELEUSIS 2023:
- IL PROBLEMA SOCRATE E IL RICORDO DI DIOTIMA (LA SACERDOTESSA DI MANTINEA).
METAPHYSICS ANTHROPOLOGY PSYCHOANALYS: APRIRE GLI OCCHI SUL SOCRATICO AMORE "CONVIVIALE" (EROS = CUPIDO), SUL DESIDERIO CIECO E VIOLENTO, E PORTARSI CON FREUD, FUORI DAL DISAGIO NELLA CIVILTA’, OLTRE LO STADIO DELLO SPECCHIO DEL TRAGICO PLATONISMO E PAOLINISMO ...
"SAPERE AUDE!". RICORDANDO, CON IL VENOSINO ORAZIO, LE INDICAZIONI DI KANT sul "coraggio di servirsi della propria intelligenza" e sulla necessità di reinterrogarsi sull’intero sapere, ripartendo dalla antropologia, dalla questione antropologica, forse, è il tempo opportuno uscire dal profondissimo letargo (Dante contava XXV secoli di sonno dogmatico) e re-interrogarsi non solo su "come nascono i sogni" e su "come nascono le idee", ma anche, e innanzitutto, come nascono i bambini, e soprattutto non continuare a ripetere vecchi e tragici ritornelli sull’amore di Platone: è una questione di filologia e di teologia-politica (Lorenzo Valla, "La falsa Donazione di Costantino", 1440).
"IL CREPUSCOLO DEGLI IDOLI" (NIETZSCHE). LA ’RISPOSTA’ DI DIOTIMA A SOCRATE: "Caro Socrate, tu sei come Eros - figlio di Ingegno (a sua voìta figlio di Metis. I’intelligenza astuta) e di Povertà - un perfetto #filosofo, perché non sei sapiente come gli dèi né del tutto ignorante come i comuni mortali: sei solo consapevole della tua ignoranza, ma tu sei cieco, cieco e brutto come un ... ciclope. Tu sai che non sai amare e vai in cerca di chi sa amare. Ma tu, caro Socrate. non capisci proprio nulla, né degli uornini, né delle donne. e neppure degli dei: tu sei solo cupìdo (un cieco saettante, avido e vioÌento). Come la rìsposta della Pizia, così la risposta di Diotima: eglì non capisce e va avanti ... a costringere chi ’solo il dio sa’ deve partorire. [...]" (cfr. Federico La Sala, "La mente accogliente. Tracce per una svolta antropologica", Roma 1991, p. 184).
CADUTA NELLA CAVERNA PLATONICA E COSMOTEANDRIA. Se non ci si sveglia e si continua a contrabbandare l’andrologia tragica di Socrate e Platone per antropologia e, dall’alto della "dotta ignoranza" (Niccolò Cusano,1440) dell’anatomia e della medicina, si spaccia #Vir per #Homo, dove si pensa di andare, se non all’inferno?!
ANATOMIA, ANTROPOLOGIA, E STORIOGRAFIA. Se si vuole ricominciare umana-mente e riprendere il cammino della rivoluzione copernicana e scientifica, bisogna ripartire quantomeno dalla sapienza di Michelangelo (riprendere il cammIno dei profeti e delle sibille del #TondoDoni, rilanciato alla grande nella narrazione della Volta della Cappella Sistina) e, poi, proseguire seguendo le lezioni di anatomia e di medicina di Realdo Colombo e, infine, leggendo il capitolo 15 del Libro III dell’ Anatomia di Giovanni Valverde, stampata a Roma nel 1560, intitolato “De Testicoli della Donna” (p. 91).
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- QUANTE "NUVOLE" NEL CIELO DELLA "REPUBBLICA"! UN INVERNO TEOLOGICO-POLITICO ANTROPOLOGICO E COSTITUZIONALE PROFONDO27 gennaio 2023, di Federico La Sala
FILOLOGIA FILOSOFIA STORIA E DIVINA COMMEDIA (DANTE 2021):
QUANTE "NUVOLE" NEL CIELO DELLA "REPUBBLICA"!
UN LETARGO TEOLOGICO-POLITICO ANTROPOLOGICO E COSTITUZIONALE PROFONDO ha mandato in collasso tutte le istituzioni culturali e politiche di tutte le #Città.
Nelle #Università e nelle #Accademie laiche e devote si insegna ancora a credere che #Aristofane (https://it.wikipedia.org/wiki/Aristofane ) scherzasse su #Socrate! #Nietzsche ("#Crepuscolo degli #idoli") aveva ragione: la #filosofia del suo allievo #Platone contiene il segreto sul come rendere forte il discorso debole e debole il discorso forte, e sul come realizzare il #sogno del #sofista #re: egli ha truccato le "regole del gioco" dell’#Occidente e ha insegnato a una "parte" della intera umanità a come mettersi al di sopra di tutte le "parti", a un "partito" come mettersi al di sopra di tutti i "partiti", e a come imporre le proprie "olimpiche" demiurgiche "#Leggi" su tutta la #Fattoria! Un colpodistato più che millenario - al capolinea... #Giornatadellamemoria, #27gennaio 2023.
-
> PENSARE BENE "DIO", "IO" E "L’ITALIA" --- COSMOTEANDRIA (ATEA E DEVOTA), QUESTIONE ANTROPOLOGICA, E FILOLOGIA: IL PROBLEMA DEL MACROANTROPO.19 gennaio 2023, di Federico La Sala
COSMOTEANDRIA (ATEA E DEVOTA), QUESTIONE ANTROPOLOGICA, E FILOLOGIA.
- IL PROBLEMA DEL "MONDO COME VOLONTÀ E RAPPRESENTAZIONE" DEL MACROANTROPO: SCHOPENHAUER, IL FILOSOFO DELL’UOMO SUPREMO, DEL SUPERUOMO.
- DOPO "IL SAPIENTE" (1510) DI BOVILLUS, "L’ENIGMA DELLA SFINGE E IL SEGRETO DELLA PIRAMIDE" ANCORA NON RISOLTO
IL MACROANTROPO. "Alla chiusa della mia esposizione possono trovare il loro posto alcune considerazioni sulla mia #filosofia stessa. [...] che l’interno essere di tutte le cose sia assolutamente uno e medesimo, lo aveva già visto e compreso il mio tempo, dopo che gli elatici, Scoto Eriugena, Giordano Bruno e Spinoza l’avevano estesamente insegnato e Schelling aveva rinfrescato questa dottrina. Ma che cosa sia quest’Uno e come esso giunga a rappresentarsi come Molto, è un problema, di cui la soluzione si trova per la prima volta presso di me. - Parimenti si era, fin dai tempi più antichi, riconosciuto l’uomo come microcosmo.
 Io ho rovesciato il principio e dimostrato il mondo come #macroantropo, in quanto volontà e rappresentazione esauriscono l’essere dell’uno e dell’altro. Evidentemente però è più giusto, imparare a comprendere il mondo dall’uomo, che l’uomo dal mondo, perché si ha da spiegare ciò che è dato mediatamente ossia il dato dell’intuizione esterna, da quel che è dato immediatamente, ossia dal lato dell’autocoscienza, non viceversa."
(ARTHUR SCHOPENHAUER, Supplementi al "Mondo", II, Editori Laterza, Bari 1986).
Io ho rovesciato il principio e dimostrato il mondo come #macroantropo, in quanto volontà e rappresentazione esauriscono l’essere dell’uno e dell’altro. Evidentemente però è più giusto, imparare a comprendere il mondo dall’uomo, che l’uomo dal mondo, perché si ha da spiegare ciò che è dato mediatamente ossia il dato dell’intuizione esterna, da quel che è dato immediatamente, ossia dal lato dell’autocoscienza, non viceversa."
(ARTHUR SCHOPENHAUER, Supplementi al "Mondo", II, Editori Laterza, Bari 1986).*
COSMOLOGIA E #ANDROCENTRISMO: "CONOSCENZA E RESPONSABILITÀ. [...] Il contrasto forte fra il progresso scientifico e l’arretratezza di alcune scelte di gestione e sfruttamento dell’#ambiente ci racconta di quanto sia difficile per alcuni di noi fare tesoro della conoscenza ed assumere responsabilità rispetto a se stessi e al mondo esterno. Si pensi ancora ad esempio a quanto #oggi si sa del mondo vegetale che possiede una sua “intelligenza” (#StefanoMancuso e #AlessandraViola, Verdebrillante - Sensibilità e intelligenza del mondo vegetale, Giunti Editore, Firenze 2013). Questa intelligenza viene ignorata dai più, anche grazie a #Linneo, il padre della nomenclatura (ancora in auge nei libri scolastici) per la classificazione scientifica degli organismi viventi. Dal diciottesimo secolo, i vegetali sono posti sul gradino più basso in una #scala “naturale” degli esseri viventi. Essi, in realtà, non sono solo una risorsa del pianeta che l’uomo può utilizzare a suo piacimento per motivi estetici, alimentari o terapeutici; hanno una vita autonoma, ricchissima e degna di rispetto, e spesso hanno trovato, attraverso geniali forme di adattamento ed anche di comunicazione, innumerevoli strategie di convivenza, fra loro e con gli altri esseri viventi. [...]" (cfr. Rosanna Bologna, Insula Europea, 18 gennaio 2023
-
>ANTROPOLOGIA CULTURALE E STORIOGRAFIA: PONZIOPILATO, CHRISTINE DE PIZAN, E LA FILOLOGIA AL SERVIZIO DELLA COSMOTEANDRIA TERRESTRE.28 dicembre 2022, di Federico La Sala
STORIA, STORIOGRAFIA, E FILOSOFIA:
PONZIOPILATO, CHRISTINEDEPIZAN, E LA FILOLOGIA AL SERVIZIO DELLA COSMOTEANDRIA TERRESTRE.
Alcune note in #memoria di #Franca Ongaro Basaglia. *
A) LA DIGNITÀ DELL’UOMO: «ECCE HOMO». PONZIO PILATO «disse loro: "Ecco, ve lo conduco fuori, affinché sappiate che non trovo in lui alcuna colpa". Uscì dunque Gesù, portando la corona di spine e il mantello di porpora. Pilato disse loro: "«Ecco l’uomo» (gr. ««ἰδοὺ ὁ ἄνθρωπος - idou ho anthropos», vulg. «ecce homo»)". Vedendolo, i sommi sacerdoti e i loro inservienti gridarono: "Crocifiggi! Crocifiggi!" Disse loro Pilato: "Prendetelo voi e crocifiggetelo; io non trovo in lui colpa". Gli risposero gli Ebrei: "Noi abbiamo una legge e secondo questa legge deve morire, perché si è fatto figlio di Dio"» (Gv. 19, 4-7).
B) UNA QUESTIONE DI #LANA "CAPRINA" (NON DI "#AGNELLO", NON DI "#ARIETE"). ALLA LUCE DELL’ATTENZIONE ALLE PAROLE DI PONZIO PILATO, si comprende meglio anche il significato delle parole di CHRISTINE DE PIZAN, l’autrice della “Città delle dame”: «Or fus jee vrais homs, n’est pa fable,/De nefs mener entremettable » (« Allora diventai un vero uomo, non è una favola,/capace di condurre le navi» - cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Christine_de_Pizan), che dicono ovviamente non della “#metamorfosi” in “vir” - uomo, ma della “#metanoia” in “homo” - essere umano (su questo, in particolare, si cfr. Michele Feo, “#HOMO - Metanoia non Metamorfosi”, Dalla parte del torto, Parma, autunno 2019, numero 86, pp. 12-13).
C) MATEMATICA E #ANTROPOLOGIA: "UN UOMO PIU’ UNA DONNA HA PRODOTTO, PER SECOLI, UN UOMO" (Franca Ongaro Basaglia, #Donna, in Enciclopedia, 5, Torino, Einaudi editore, 1978, p. 89).
N. B. - RENE’ GIRARD , L’#AGNELLO DI #DIO, E L’#INTERPRETAZIONEDEISOGNI (S. #FREUD, 1899): la"Menzogna romantica e verità romanzesca" (1961), il "Delle cose nascoste sin dalla fondazione del mondo" (1978), e "Il capro espiatorio" ( "Le bouc émissaire", 1982).
Parola di Girard: "Qualche lettore potrà obiettare che il Nuovo Testamento non ricorre mai all’espressione «capro espiatorio» per indicare Gesù come la vittima innocente di una frenesia mimetica collettiva; questo è vero, ma ciò avviene solo perché le Scritture cristiane dispongono di un’espressione equivalente, e anzi superiore a «capro espiatorio», vale a dire #agnello di #Dio. Questa immagine elimina gli attributi negativi e sgradevoli del capro, e pertanto corrisponde meglio all’idea della vittima innocente ingiustamente sacrificata" (cfr. René Girard, "Vedo cadere Satana come la folgore". Adelphi, Milano 2001, p. 203).
Girard accoglie la tradizionale interpretazione del messaggio evangelico e non tiene conto né di Marx, né di Nietzsche, né di Freud. Sulla lunga durata della tradizione #critica dimentica quanto ha scritto Freud nel #Disagiodellaciviltà (1929) sulla #fondazione del cattolicesimo da parte di san Paolo e, infine, fa dell’agnello un bel #caproespiatorio!
*
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- COSMOLOGIA ("MONDO"), TEOLOGIA ("DIO"), ANTROPOLOGIA ("UOMO") E "DISAGIO DELLACIVILTÀ"26 dicembre 2022, di Federico La Sala
COSMOLOGIA ("MONDO"), TEOLOGIA ("DIO"),
ANTROPOLOGIA ("UOMO")
E
"DISAGIO DELLACIVILTÀ" (S. FREUD, 1929):
The Stages of Man (1510), by Charles de Bouelles (c. 1470-1553).
USCIRE DAL LABIRINTO O DALLA CAVERNA,
E
NON RICADERE NELL’ILLUSIONE DI
“DIO”
CONCEPITO
SECONDO IL TRAGICO ALGORITMO DELL’
ANDROCENTRISMO
COME “UOMO SUPREMO”, "SUPERUOMO"
-
> LA PIÙ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA ---FILOLOGIA E CRITICA: IL PAOLINISMO (ATEO E DEVOTO). In memoria di Paolo di Tarso, di Antonio Gramsci, e di Ernesto De Martino.24 dicembre 2022, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA, STORIA, E FILOSOFIA: IL PAOLINISMO (ATEO E DEVOTO).
Alcuni appunti per riflettere sull’attuale presente storico. In memoria di Paolo di Tarso, di Antonio Gramsci, e di Ernesto De Martino ...
A) AL DI LA’ DELLA LEZIONE DI PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ, ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).
B) MARX e LENIN, CRISTO e SAN PAOLO. A. GRAMSCI, "POSIZIONE DEL PROBLEMA: [...] Marx inizia intellettualmente un’età storica che durerà probabilmente dei secoli, cioè fino alla sparizione della Società politica e all’avvento della Società regolata. Solo allora la sua concezione del mondo sarà superata (concezione della necessità, 〈superata〉 da concezione della libertà). Fare un parallelo tra Marx e Ilici per giungere a una gerarchia è stolto e ozioso: esprimono due fasi: scienza-azione, che 〈sono〉 omogenee ed eterogenee nello stesso tempo. Così, storicamente, sarebbe assurdo un parallelo tra Cristo e S. Paolo: Cristo-Weltanschauung, S. Paolo organizzazione, azione, espansione della Weltanschauung: essi sono ambedue necessarii nella stessa misura e però sono della stessa statura storica. Il Cristianesimo potrebbe chiamarsi, storicamente, cristianesimo-paolinismo e sarebbe l’espressione più esatta (solo la credenza nella divinità di Cristo ha impedito un caso di questo genere, ma questa credenza è anch’essa solo un elemento storico, non teorico)." (A. Gramsci, "Quaderno 7 (VII), § 33).
C) IL PAOLINISMO ANTROPOLOGICO. ERNESTO DE MARTINO: “Essere comunista vuol dire essere umano, rinnovare in termini moderni l’esperienza paolina: “sono diventato tutto con tutti per tutti fare salvi”. Essere comunista vuol dire volgersi al mondo dei poveri e dei semplici, e quella parte dell’umanità che gli uomini cercano di mantenere fuori della storia e che vive orfana nella nostalgia di una cultura che sta come un al di là vago e misterioso. Essere comunista significa sentire la vergogna, anzi la colpa, di tutto lo spirito che potrebbe essere e che non è, di tutta la bellezza deviata, di tutta la verità rimasta a bella strada, di tutta la vita morale soffocata, di tutta l’umanità e la cultura insidiate a cagione del modo di esistere e della società” (Cfr. "Compagni e amici Lettere di Ernesto de Martino e Pietro Secchia", a c. di Riccardo Di Donato - “Un contributo su de Martino politico” - La Nuova Italia, 1993, p. II).
D) "CRITICA DELLA RAGION PURA" E ILLUMINISMO (1784): "IN OGNI MODO OCCORRE STUDIARE KANT E RIVEDERE I SUOI CONCETTI ESATTAMENTE" (Antonio Gramsci, "Quaderni del carcere", 10 (XXXIII), § 40).
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- ITALIA 2022-1922. Siamo fratelli tutti, ma di quale famiglia, di quale patria e di quale Dio - quello di Italia o di "Italia"?28 ottobre 2022, di Federico La Sala
FILOLOGIA E STORIOGRAFIA DELLA STORIA D’ITALIA E "LA GENTE DALLA DOPPIA TESTA" (PARMENIDE).
- ITALIA 1922 - 2022.
DI COSA PARLANO GLI STORICI E LE STORICHE DELL’ITALIA QUANDO PARLANO E SCRIVONO DI STORIA D’ITALIA?
Parlano di "Dio" o di Dio, di "Patria" o di Patria, di "Famiglia" o di Famiglia? Siamo fratelli tutti, ma di quale famiglia, di quale patria e di quale Dio - quello di Italia o di "Italia"?
Archeologia, Antropologia, Giustizia, e Costituzione: "Homo pontifex" (MichelSerres). Per uscire dall’orizzonte del mentitore, forse, è opportuno ritornare a Elea e rivisitare la città di Parmenide e Zenone: la cosiddetta "Porta Rosa" non è affatto una "porta", ma è un viadotto, un ponte...
-
>LA PIÙ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA E POLITICA ITALIANA --- UN URLO E UN AUGURIO DI "LUNGA VITA ALL’ITALIA".21 ottobre 2022, di Federico La Sala
FILOLOGIA E COSTITUZIONE:
RICORDANDO IL "SAUSSURE" DI TULLIO DE MAURO, UN URLO E UN AUGURIO DI "LUNGA VITA ALL’ITALIA".
Una nota di commento su un "appunto" di Franco Lo Piparo ... *
STORIA LINGUISTICA DELL’ITALIA UNITA (Tullio De Mauro, 1963). "Lingua, intellettuali ed egemonia in Gramsci" (Franco Lo Piparo, 1979): "A scanso di equivoci, io non ho votato nessuno dei partiti che hanno vinto le elezioni" (Franco Lo Piparo, "Fascismo: parola da usare con misura, 16 ottobre 2022): forza_Italia! "Lunga vita all’Italia": "Restituitemi il mio urlo" (Huang Jianxiang, "La Gazzetta dello Sport" del 17 luglio 2006:).
"Checché ne dica Umberto Eco" (F. Lo Piparo, cit.), in onore della vertiginosa saggezza umana e politica della senatrice Liliana Segre, forse, è meglio ricominciare a riflettere da capo, proprio dal "CAPO" (questo il titolo di un articolo di Antonio Gramsci , del 1° marzo1924), sul "principio del Fuhrer" (Führerprinzip), e portare avanti i lavori sulla "storia linguistica dell’Italia unita". Da ricordare, inoltre, che il lavoro sulla "Psicologia delle masse e analisi dell’io" di Sigmund Freud è del 1921.
*
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- FILOLOGIA, POLITICA E CARITÀ. IL PROBLEMA JEAN-JACQUES ROUSSEAU: JEAN STAROBINSKI E GHISLAIN WATERLOT.6 ottobre 2022, di Federico La Sala
UNA QUESTIONE DI PRINCIPIO (LOGOS): IL PROBLEMA JEAN-JACQUES ROUSSEAU (JEAN STAROBINSKI) *
- Ragione ("Logos") e Amore ("Charitas"). Per la critica dell’economia politica ..... e della teologia "mammonica" ( "Deus caritas est": Benedetto XVI, 2006)
[Intervista]
GHISLAIN WATERLOT.
Rousseau fra Cristo e i Lumi
di Daniele Zappalà (Avvenire, martedì 31 gennaio 2012)
«Jean-Jacques Rousseau resta attuale perché ci ricorda che la dimensione religiosa dell’esistenza è propriamente umana. Non si può accantonarla così facilmente. E quando lo si fa, si compie un gesto violentissimo e dogmatico». Parola del noto studioso francese Ghislain Waterlot, che dal proprio osservatorio privilegiato svizzero all’Università di Ginevra ha scandagliato in profondità l’opera affascinante e controversa del celebre filosofo settecentesco. Moltissimo è stato scritto sul Rousseau padre degli ideali di uguaglianza e tolleranza, riconosciuto non a caso dopo la morte (2 luglio 1778) come uno dei maggiori ispiratori della Rivoluzione francese. Ma l’autentica novità delle commemorazioni di quest’anno, per il tricentenario della nascita (a Ginevra, il 28 giugno 1712), pare l’intensa riscoperta della riflessione religiosa del filosofo. «Essa non parte da Dio, ma dall’uomo, nel quale Rousseau scorge una dimensione d’attesa. Ciò interroga ancora perfettamente la nostra sensibilità», s’infervora Waterlot, che ha già pubblicato fra l’altro in Francia l’importante saggio Rousseau. Religion et politique (Presses Universitaires de France) e darà alle stampe quest’anno una nuova monografia sul pensiero religioso del filosofo.
- Professor Waterlot, come spiega questa riscoperta?
«C’è innanzitutto una ragione politica. Oggi, la laicità torna in discussione e Rousseau è fra i pensatori che hanno giudicato necessaria una religione civile per lo Stato. Non si riferisce alle religioni storiche esistenti, verso le quali resta diffidente o critico. Ma pensa ad una religione per la polis, una religione in cui è presente ciò che egli chiama la religione naturale, a cui aggiunge l’idea di valorizzare la patria. Egli riconosce un Dio per tutti gli uomini che chiede giustizia e pace, ma aggiunge poi che le leggi della comunità politica debbono ritenersi sante. La religione civile rafforza la società, ne preserva l’unità, ma evitando un’eccessiva aggressività verso le nazioni vicine. Al contempo, nella sua concezione della religione naturale, egli si distingue per la grande attenzione riservata a Gesù. Rousseau è un cristiano molto particolare, che non crede nell’Incarnazione e nella Resurrezione. Ma che non cessa di ripetere: “sono cristiano, un cristiano autentico e sincero”».
- In che modo interpreta Gesù?
«Gesù è al di sopra di tutti gli uomini mai esistiti. Confrontando Gesù e Socrate, egli scrive nell’Emilio: “Se la vita e la morte di Socrate sono di un saggio, la vita e la morte di Gesù sono di un Dio”. Egli non dice “di Dio”, ma “di un Dio”. Altri hanno spesso considerato Gesù e Socrate sullo stesso piano, ma non Rousseau. Gesù corrisponde a un’umanità non corrotta dalla realtà sociale e dalla storia umana. Gesù è l’uomo perfetto, per questo particolarmente amato da Dio».
- L’uomo, per Rousseau, può sentire intimamente la presenza di Dio?
«La percezione di Dio è legata a un “istinto divino” che si trova in ciascuno di noi. È un aspetto essenziale. Sentiamo Dio. In proposito, non si deve sottovalutare che Rousseau ha sempre preso cura di una certa vita spirituale, come mostra in particolare Giulia o la nuova Eloisa. Il personaggio di Giulia prova il bisogno di rivolgersi al Grande Essere. In lei, Rousseau valorizza la preghiera, ma quest’ultima non deve mai divorare la vita. La vita deve restare in primo piano, anche se la preghiera permette di porre l’individuo davanti al Creatore, facendogli ritrovare la pace».
- Qual è il suo rapporto con il Vangelo?
«Il Vangelo occupa un posto speciale. Egli lo legge e rilegge. È la guida per chi vuol vivere secondo giustizia e come Dio ha voluto. Egli scrive che è il più bel libro che abbia mai letto. Che se dovesse averne uno solo, sarebbe il prescelto. Ma aggiunge che il Vangelo resta un libro e che non può sostituire la voce della coscienza. È una visione particolare. Inoltre, Rousseau è molto critico verso i miracoli, sostenendo che Gesù non volle farne e che furono i suoi interlocutori a vederne dappertutto. In questo, prende Pascal in contropiede, ritenendo che si può avere la fede solo togliendo i miracoli».
- Rousseau sognava di riformare il cristianesimo senza ammetterlo?
«Penso di sì. Del resto, talora lo confessa quasi. In certe lettere, scrive: “Nella nostra epoca, non c’è più un solo cristiano sulla terra”, probabilmente vedendosi un po’ come l’ultimo, come il vero discepolo di Cristo del tempo. Rousseau nasce nel protestantesimo, poi a 16 passa al cattolicesimo, a Torino. Quindi, nel 1754, torna a Ginevra e alla confessione riformata. Ma i pastori e la città di Ginevra lo respingono dopo la pubblicazione del Contratto sociale e dell’Emilio. Per Rousseau, Dio è creatore e occorre riconoscerlo come centrale, ma non è trinitario. Nella vita, l’essenziale è avere una buona condotta morale, mentre le condotte dogmatiche della Chiesa sono deboli. Egli si posiziona al di là delle confessioni».
- Pur essendo un grande difensore della tolleranza, Rousseau rifiutava l’ateismo. Un paradosso?
«Egli rifiuta l’ateo, innanzitutto, considerandolo alla stregua di un indifferente. In fondo, per Rousseau, è ateo chi ragionando trova argomenti contro l’esistenza di Dio. Al riguardo, Rousseau non nega che tali argomenti esistano, accanto a quelli che tendono a provare l’esistenza di Dio. Ma in fondo, gli atei sono talmente assorbiti dai loro ragionamenti da soffocare la voce della coscienza. Vi è poi una seconda critica, più sociale. L’ateismo è una convinzione dei benestanti, di coloro che snobbano la miseria altrui. Essi dimenticano che il cristianesimo è innanzitutto attento a chi soffre, un punto che per Rousseau è fondamentale».
NOTA:
AL DI LÀ DELLA "DOTTA IGNORANZA": IL PROBLEMA DELLA CARITÀ ("CHARITAS").
 Un problema di filologia ed eco-nomia (teologia e antropologia)!
Un problema di filologia ed eco-nomia (teologia e antropologia)!- "CARITÀ. Il mondo è un beneficio. - L’umanesimo del Rinascimento, incline al sincretismo, ha messo insieme il Dio donatore dea Bibbia ebraica, il demiurgo patonico e il dio benefattore dello stoicismo. Il trattato De beneficiis di Seneca - in cui la questione del dono è tratta in modo esaustivo - vede in Dio l’esempio supremo della benevolenza disinteressata" (cfr. Jean Starobinski, A piene mani. Dono fastoso e dono perverso, Einaudi, Torino 1995, p. 43).
- SOCRATE E IL DONO DI "SE STESSO" (DELL’ALLIEVO AL MAESTRO): "Dal momento che ognuno offriva a Socrate molte cose secondo le proprie possibilità, Eschine, un allievo povero, disse: "Non trovo nulla degno di te che possa darti, e solo per questo motivo mi sento povero. Quindi ti dono l’unica cosa che ho: me stesso. Gradisci questo dono, te ne prego, per quello che può valere, e considera che altri, pur offrendoti molto, hanno tenuto molto di più per se stessi. E Socrate gli rispose: “Perché mai non dovrebbe essere un grande dono quello che mi hai fatto? A meno che tu non abbia poca stima di te stesso! Avrò, quindi, cura di restituirti a te stesso migliore di quando ti ho ricevuto”. Con questo dono Eschine superò l’animo di Alcibiade, che era pari alle sue ricchezze, e tutta la munificenza dei giovani ricchi."(Lucio Anneo Seneca, De beneficiis, I. 8).
- RAPPORTO INDIVIDUO-SOCIETÀ: IL CONTRATTO SOCIALE. "Rousseau ricorre espressamente al verbo donner (dare, donare) quando definisce il contratto fondamentale: «Ognuno dandosi tutto intero»; «Ognuno dandosi a tutti» (J. Starobinski, op. cit., nota 5, p. 45
- ROUSSEAU E SOCRATE (PLATONE). "Il legislatore di Rousseau riprende in parte il ruolo pedagogico tenuto da Socrate nel racconto riportato da Seneca" (J. Starobinski, op. cit., nota 6, p. 45).
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- LA GUERRA, GLI "ATTRIBUTI DI DIO", E I TEOLOGI. Le «capatrici dell’immondezze de smalti» nel cantiere di San Pietro (di Paolo Scarafoni e Filomena Rizzo).27 maggio 2022, di Federico La Sala
“Capatrici di pace”
Un’analisi dei teologi Scarafoni e Rizzo: «Recuperare l’intreccio ecumenico di sguardi fraterni in Cristo»
di Paolo Scarafoni e Filomena Rizzo*
Sta per finire l’anno accademico e rimettendo in ordine la nostra biblioteca di casa, ci è capitato fra le mani il bel libro del 2017 «Le donne nel cantiere di San Pietro in Vaticano» curato da Assunta Di Sante e Simona Turriziani. Tratta delle artiste, artigiane e imprenditrici che lavorarono «all’ombra del Cupolone contribuendo ad accrescere la bellezza della Basilica Vaticana», svolgendo un ruolo importante nella Fabbrica di San Pietro.
Scrive Paola Torniai: «Nel 1673 Clemente X Altieri commissiona al mosaicista Orazio Manenti il restauro della Navicella, raffigurante Gesù che salva dalla tempesta la nave degli apostoli, realizzata da Giotto per il Cardinale Jacopo Stefaneschi, in occasione del primo giubileo indetto da Bonifacio VIII. Manenti deve risarcire l’opera, originariamente collocata nell’atrio della primitiva San Pietro e danneggiata durante i lavori di ampliamento sotto Paolo V Borghese. ... Manenti recupera ogni più minuta pietruccola, avvalendosi di maestranze femminili». Le «capatrici dell’immondezze de smalti». Esse a mani nude frugavano a terra tra i calcinacci per recuperare smalti vecchi che sarebbero stati rifusi in smalti nuovi. Lavoravano tra «la polvere che inaridisce la pelle e soffoca il respiro, il disagio di prostrarsi per ore alla ricerca di tessere musive, la difficoltà di scavare a mani nude, abrase e ferite, tra calcinacci e materiali ammassati. ... Le capatrici della Navicella ... sono state mani provvidenziali».
Questa storia suggestiva di donne, ci ha fatto riflettere sulle devastazioni che stiamo vivendo in questo momento, e che confermano i moniti di Papa Francesco che da tempo metteva in guardia contro i «venti di guerra». Anche la Chiesa di Cristo, specialmente nelle relazioni ecumeniche e nella riflessione teologica, ha subito forti scossoni come la Navicella di Giotto. Sono cadute tante tessere: fino a pochi mesi fa l’auspicio di molte chiese era che i cristiani tutti insieme fossero parte viva e coraggiosa della società civile, promotori di giustizia, di pace e misericordia per l’umanità. Quell’intreccio ecumenico di sguardi fraterni in Cristo sembra essere crollato in un attimo tra le macerie che le bombe e i missili producono nei territori di guerra.
C’è bisogno di «capatrici di pace». Un lavoro paziente di recupero, in mezzo a quelle rovine, che può essere fatto bene dalle donne, ancora troppo poche nei dialoghi e nelle trattative fra le parti, di fatto assenti ai tavoli dove si decide la guerra. La pace si costruisce recuperando proprio quegli intenti così belli ispirati dallo Spirito santo, come lo scintillio delle tessere musive «capate» che allude «allo splendore della sostanza divina e all’incorrotta chiesa primitiva».
Anche nella riflessione teologica è essenziale valorizzare il contributo delle donne. Abbiamo avuto modo di scrivere già da vari anni che è necessario sviluppare studi sugli «attributi di Dio», specialmente sull’onnipotenza divina, con una maggiore sensibilità nei confronti dei risvolti antropologici. «Lo sforzo della teologia attuale deve essere quello di vincere ogni riferimento individualistico ed egoistico nella presentazione di Dio di fronte alle creature, che possa giustificare una persistenza dell’egoismo e dell’individualismo nelle creature stesse». Dio non è potente al modo umano: «il concetto di potenza è ambiguo perché spesso ha un forte legame con l’egoismo». Nel Vangelo «l’onnipotente che opera con il suo braccio pieno di misericordia e bontà è contrapposto ai potenti, ai ricchi e ai superbi che opprimono i deboli, i poveri e gli umili».
Le bombe mettono in evidenza un Dio egoista e prepotente invocato dai duri di cuore, dai superegoisti privilegiati, per «occupare spazi» e legittimare «strutture di peccato» che fanno sembrare normale ed inevitabile il male inflitto agli ultimi e ai poveri. Disprezzano un Dio debole incapace di difendere le «vittime innocenti».
I teologi devono essere coraggiosi proprio per negare esplicitamente l’egoismo in Dio. «Dire che Dio è buono, benché sia tutt’altro che scontato, non è lo stesso che dire che Dio non è cattivo. Dire che Dio è amore, benché ripete il cuore stesso della rivelazione (cfr. 1Gv 4,8; Gv 3,16), non è lo stesso che negare in Dio l’egoismo». I battezzati che si consacrano a Dio e rinunciano al diavolo, in realtà «come un fiume carsico» nelle difficoltà e nelle prove o per giustificare interessi politici ed economici, sono tentati di affidarsi ad un Dio immaginato come un guerriero, che a suo piacimento riprende l’arco deposto nel cielo, quando ha stabilito l’alleanza della pace.
Se l’uomo non cambia idea su Dio è perché forse non vuole cambiare lui, rimanendo chiuso nel suo egoismo, che giustifica con il meccanismo di proiezione; un gioco sottile e menzognero (al quale si presta talvolta la teologia) di un uomo che sostituisce il Dio vero dell’amore e della libertà con il Dio della guerra. In tal modo rivela come il suo cuore sia chiuso in una autoreferenzialità così insuperabile da crearsi e raccontare per vero un Dio «a sua immagine».
* Don Paolo Scarafoni e Filomena Rizzo insegnano insieme teologia in Italia e in Africa, ad Addis Abeba. Sono autori di libri e articoli di teologia.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- LA DOMANDA ANTROPOLOGICA DI KANT, LA GUERRA, E "LA CORONA DELLA PACE. Dall’Antico Testamento ai nostri giorni" (di Piero Stefani).5 maggio 2022, di Federico La Sala
KANT E LA DOMANDA ANTROPO-LOGICA: CHI SONO "IO"? *
- «Il campo della filosofia in significato cosmopolitico si può ricondurre alle seguenti domande:
1) Che cosa posso sapere? 2) Che cosa devo fare? 3) Che cosa mi è lecito sperare?
4) Che cosa è l’uomo?
 Alla prima domanda risponde la metafisica, alla seconda la morale, alla terza la religione
e alla quarta l’antropologia.
In fondo, si potrebbe ricondurre tutto all’antropologia, perché le prime tre domande fanno riferimento all’ultima.» (I. Kant, Logica [1800], Laterza, Bari 1984).
Alla prima domanda risponde la metafisica, alla seconda la morale, alla terza la religione
e alla quarta l’antropologia.
In fondo, si potrebbe ricondurre tutto all’antropologia, perché le prime tre domande fanno riferimento all’ultima.» (I. Kant, Logica [1800], Laterza, Bari 1984).
- "L’Io è il mistero profondo", "e non dell’io in senso psicologico"(L. Wittgenstein, Quaderni 1914-1916).
La corona della pace
Dall’Antico Testamento ai nostri giorni
di Piero Stefani (Il Regno/Attualità, 6/2022, 15/03/2022)
Nel rito preconciliare della messa in latino, non di rado il Vangelo iniziava con questa formula: «In illo tempore Iesus dixit...». Anche ora, quando non si è nelle condizioni di riportare l’ambientazione precisa dell’episodio, si ricorre a: «In quel tempo Gesù disse...». È una clausola che riguarda il passato. Di contro, nei profeti d’Israele l’espressione «in quel giorno (ba-yom ha-hu)» si proietta verso l’avvenire (cf. Zc 14,20); lo stesso vale per «Ecco, verranno giorni» (Ger 31,31). Vi è però una formula ancor più radicale: «Alla fine dei giorni (be‘aharit ha-yamin)», ed è proprio quest’ultima a contraddistinguere l’oracolo di pace presente, in termini identici, in due diversi profeti: Isaia e Michea.
Soltanto alla fine dei giorni un popolo non alzerà più la spada contro un altro popolo; solo allora si smetterà di fare guerra (cf. Is 2,2-4; Mi 4,1-3). La filologia si impegna a precisare il senso dell’espressione; resta fuor di dubbio che essa riguarda il futuro. La fine dei giorni non può essere mai declinata al presente. Dunque, finché ci sono i nostri giorni, non è dato sperare nella venuta di «quei giorni»?
Sperare comporta guardare in avanti; a volte conviene però voltarsi anche indietro per comprendere i modi in cui si è concepita questa porta dischiusa verso il futuro. Per pensare bisogna avere fiducia nella ragione, per farlo in modo maturo occorre individuarne i limiti. Questo procedere si definisce critico. Esso, a fine Settecento, raggiunse il proprio vertice con Kant, il filosofo vissuto a Königsberg, l’attuale Kaliningrad, enclave russa tra Lituania e Polonia.
Per Kant le questioni fondamentali di tutta la nostra esistenza si riducono a tre: che cosa posso sapere, che cosa debbo fare, in che cosa ho il diritto di sperare. Le domande, formulate in modo semplice, ricevono tutte e tre un trattamento filosofico molto articolato; tuttavia tra esse la questione più complessa è quella relativa alla speranza. La prima domanda infatti è solo teorica e speculativa, la seconda solo pratica, mentre la terza si collega a entrambe le componenti.
Per sperare non basta sapere semplicemente come vanno le cose, né è sufficiente impegnarsi nell’agire in modo giusto: è necessario trovare il punto di tangenza tra essere e dover essere. Secondo Kant, mentre il sapere giunge alla conclusione che qualcosa è poiché qualcosa accade, la speranza conclude che qualcosa sia poiché qualcosa deve accadere.
La speranza non può appoggiarsi solo sulla descrizione della realtà e non si limita neppure a prospettare il dovere: essa è indirizzata verso un dover essere chiamato a diventare reale in virtù di una forza non totalmente sottoposta al nostro controllo. Anche se la si pensa come un progetto, la speranza non è paragonabile ai programmi la cui realizzazione dipende dall’azione di chi ora li sta mettendo in pratica. Il farsi della speranza non è paragonabile al processo che porta la materia prima a diventare manufatto. La clausola in base alla quale qualcosa sarà perché qualcosa deve accadere sta a indicare la presenza di questo salto qualitativo.
Il progetto è, ovviamente, sulla carta e non ancora nella realtà. Il passaggio dal virtuale al reale è intrinsecamente esposto a rischi; tuttavia, il più delle volte, esso è connesso a quanto si fa e non già a quel che deve accadere. La speranza ha invece bisogno di appoggiarsi a una realtà - piccola o grande che sia - posta al di là della sfera del nostro agire.
La speranza si situa nello spazio posto tra l’agire e la meta che l’opera si prefigge di conseguire. Quando questo salto è molto grande il fine può apparire utopico. Non ci è dato di controllare la forza in grado di garantire che quanto deve essere effettivamente sia. Per questa ragione la pace messianica, allorché, secondo le parole di Isaia e Michea, le armi saranno convertite negli strumenti del buon operare umano, è apparsa ai più un’utopia. La storia parla il linguaggio della guerra o al più delle tregue, non quello di una pace che non conosce tramonto.
L’ideale della pace perpetua
Nel 1795, quando l’Europa era scossa dai sussulti della Rivoluzione francese, mentre Russia, Impero asburgico e Prussia si spartivano la Polonia ed erano in incubazione le grandi guerre del periodo napoleonico, Immanuel Kant scrisse l’opuscolo Progetto per una pace perpetua. Quelle pagine non si limitano a individuare le modalità per conseguire tregue prolungate in grado di garantire una tranquilla convivenza tra gli stati; esse prospettano un esito più alto in cui la pace sarà condizione normale e permanente per tutta l’umanità.
Il libretto assume la veste di progetto fornendo regole per fondare un diritto cosmopolitico (noi diremmo internazionale) in grado di garantire a tutti una pacifica convivenza. Nelle ultime righe dell’opera si legge: «Se è un dovere, ed anche una fondata speranza, realizzare uno stato di diritto pubblico,1 anche se solo con una approssimazione progressiva all’infinito, allora la pace perpetua, che succederà a quelli che sono stati sino a ora falsamente denominati trattati di pace (propriamente, armistizi), non è idea vuota. Ed anzi sarà un compito che, assolto per gradi, si avvicinerà sempre più velocemente al suo adempimento (perché è sperabile che i periodi di tempo in cui avverranno tali progressi si faranno sempre più brevi)».
Dovere e fondata speranza assumono l’aspetto di tangenza all’infinito: non li si raggiungerà mai, ma ci si può avvicinare sempre. La vera meta diviene così un continuo camminare. In termini consoni agli addetti ai lavori, si dovrebbe parlare di uso noumenico regolativo dell’idea di pace. L’aver definito «progetto» il trattato conferma il carattere laico del pensare di Kant. In questo ambito concettuale non si spera nell’irruzione dall’esterno di un evento messianico. L’operare umano non può andare al di là di un’approssimazione all’infinito. La pace perpetua conserverà sempre l’aspetto di un ideale ancora da realizzare. Non si arriverà mai a una pace definitiva; tuttavia la tensione per giungervi avvicinerà sempre più gli armistizi a veri e propri trattati di pace.
Come stanno le cose ai nostri giorni? Le attuali guerre hanno perso le connotazioni giuridiche un tempo a esse consuete. Oggi, in pratica, non è più dato pensare a trattati che pongano fine a guerre dichiarate perché queste ultime non esistono più.
Semplicemente si fanno guerre senza prendersi la briga di dichiararle. Per alludere a Ugo Grozio e al suo capolavoro De jure belli ac pacis, è arduo stabilire le regole della pace là dove non ci sono più le regole della guerra. La guerra civile sembra essere diventata il modello di ogni tipo di scontro bellico. Nei nostri giorni, quando le armi perdono di virulenza, a prolungarsi a tempo indeterminato sono, spesso, guerre condotte «a bassa intensità» (il Donbass ha molti, crudeli parenti in giro per il mondo).
La pace messianica
Se è lecito avere nostalgia, oltre che dei grandi ideali kantiani, anche delle regole della guerra e della pace, che dire della pace messianica di cui parlò il filosofo neo-kantiano Hermann Cohen? Egli, mentre l’Europa era sconvolta dalla Prima guerra mondiale, ripensò, alla fine della sua vita, alla propria origine ebraica e scrisse un’opera - uscita postuma nel 1918 - dal titolo che evoca a un tempo sia Kant (cf. La religione nei limiti della semplice ragione) sia l’antica sapienza d’Israele: La religione della ragione dalle fonti dell’ebraismo.
Essa si conclude parlando di pace; lo fa però in termini messianici e non già noumenici. La pace è il fine assoluto che non può essere mai reso puro mezzo: «La pace in quanto fine dell’uomo è il Messia, che libera gli uomini e i popoli da ogni dissidio, che appiana il dissidio nell’uomo stesso e produce infine per l’uomo la riconciliazione con il suo Dio. (...) Il messianismo è e rimane la forza fondamentale della coscienza ebraica. E il Messia è il principe della pace (...) Qual è il compendio della vita umana nello spirito della Bibbia? È la pace. Tutto il senso, tutto il valore della vita risiede nella pace. Essa è l’unità di tutte le forze vitali, il loro equilibrio, è l’appianamento di tutti i contrasti. La pace è la corona della vita».2
«Corona della vita», l’espressione ebraica shalom ‘alekhem (al pari della sua forma sorella araba) resa alla lettera significa «pace su di voi». La pace è una realtà che scende dall’alto e si posa sul capo.
Il libro di Hermann Cohen termina con queste parole: «La pace è l’emblema dell’eternità, è la parola d’ordine della vita umana, tanto nel suo comportamento individuale quanto nell’eternità della sua missione storica. In questa eternità storica si compie la missione di pace dell’umanità messianica».3 In un mondo irredento solo la speranza in una pace messianica, di cui nei momenti felici è dato gustare già qualche anticipazione (la tradizione ebraica parla del sabato come di un sessantesimo del mondo avvenire), può, forse, reggere di fronte alla catastrofe.
In un mondo lacerato dalle guerre, la sfida lanciata dalla speranza messianica ebraica al Messia cristiano definito anch’esso «principe della pace» continua, questa volta senza alcun «forse», a stagliarsi all’orizzonte. Sta alla comunità dei credenti in Gesù Cristo cercare i modi per rispondervi.
1 Vale a dire l’esistenza di un effettivo diritto internazionale.
2 H. Cohen, La religione della ragione dalle fonti dell’ebraismo, San Paolo, Cinisello Balsamo 1994, 636-638.
3 Ivi, 640.
*
NOTA:
ANTROPOLOGIA E CRISTOLOGIA ("ECCE HOMO").
- Bibbia, Vangeli, e Cristologia: "Per il cristianesimo il vertice è invece costituito dai quattro Vangeli canonici (nella liturgia cattolica proclamati solo da un sacerdote o da un diacono e ascoltati stando in piedi). Essi sono incentrati sulla vita pubblica, morte e resurrezione di Gesù. I Vangeli sono colti come una specie di chiave interpretativa per leggere in modo unitario un libro, la Bibbia, composto da un vasto insieme di testi molto vari per origine e provenienza, sorti in un arco di tempo di parecchi secoli" (Piero Stefani, “Bibbia e Corano, un confronto”, Letture).
Al vertice del "cristianesimo" (cattolicesimo costantiniano), in realtà, non ci sono - come sostiene Piero Stefani - i "quattro Vangeli canonici (nella liturgia cattolica proclamati solo da un sacerdote o da un diacono e ascoltati stando in piedi)", ma - fondamentalmente - le lettere (e l’interpretazione "andrologica" della figura di Cristo) di Paolo di Tarso: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ, ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).
Questo è il problema...
Federico La Sala
- «Il campo della filosofia in significato cosmopolitico si può ricondurre alle seguenti domande:
1) Che cosa posso sapere? 2) Che cosa devo fare? 3) Che cosa mi è lecito sperare?
4) Che cosa è l’uomo?
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---RELIGIONI E (DISAGIO DELLA) CIVILTÀ. IL SILENZIO DEGLI AGNELLI: "SOTTO GLI OCCHI DELL’AGNELLO" (di Antonio Gnoli)17 aprile 2022, di Federico La Sala
Religioni e civiltà.
Il silenzio degli agnelli
L’autore dedicò le sue ultime riflessioni all’animale che rappresenta la potenza del sacrificio di Cristo. Spiegato attraverso il contrasto con i temi e i toni dell’Apocalisse
di Antonio Gnoli (la Repubblica, 14 Aprile 2022)
- [Foto] Miniatura fiamminga con l’Apocalisse e l’Anticristo assiso nel Tempio (1400 circa)
Il libro Sotto gli occhi dell’Agnello di Roberto Calasso (Adelphi, pagg. 107, euro 13)
Nelle ultime settimane che gli restavano Roberto Calasso rilesse l’Apocalisse. Quel testo, chiuso tra catastrofe e rivelazione, gli si rivelò in una forma inaspettata. Lesse quelle pagine, spesso oscure, immaginifiche, terrificanti avendo negli occhi l’immagine nitida e folgorante del Polittico di Gand, un dipinto, oggi diremmo hollywoodiano, di scene sacre di Jan van Eyck (con la collaborazione del fratello Hubert). Al centro vi è la figura dell’agnello, l’animale più mite e misterioso che l’iconografia religiosa ci abbia consegnato. Tanto da suggerire a Calasso il titolo del nuovo libro: Sotto gli occhi dell’Agnello.
Cosa intercetta l’autore in quello sguardo che improvvisamente diviene imprescindibile per la storia che sta per raccontare? La prima cosa che mi è venuta in mente è La finestra sul cortile di Alfred Hitchcock. Non perché la relazione sia immediata, ma perché, molti anni prima, dedicando alcune pagine al film di Hitchcock e ai Veda, Calasso rimarcava la centralità dell’occhio del fotografo, interpretato da James Stewart. Con questa differenza: l’occhio dell’Agnello mistico, cioè del Cristo, sembra osservarci con sovrana e remota indifferenza, indotta da un cristianesimo che ha tradito le aspettative e si è ridotto a uno stanco rituale liturgico. Mentre lo sguardo "immobile" del fotografo inviterebbe (nella lettura di Calasso) a uscire dal cristianesimo, per incrociare quel mondo vedico le cui dottrine aprono varchi interessanti nell’Occidente ampiamente secolarizzato.
Ad alcuni potrà risultare arbitrario il passaggio fulmineo dalla dottrina vedantica a Hitchcock. Ma nel ridisegnare - con la sua opera - il grande affresco delle civiltà, e le relative religioni che lo sostengono, Calasso forza i confini spazio-temporali e rigetta la concezione lineare della storia. Credo che una tale impostazione valga anche per la lettura dell’Apocalisse, per il modo diretto e spiazzante con cui interviene sulle cesure e le articolazioni del testo. Fino a farne la chiave (o almeno una delle chiavi) per comprendere il nostro debole e rinunciatario rapporto con il sacro. Niente di quello che i numerosi commenti hanno offerto, tra l’allegorico e il liturgico, si ritrova qui. Volutamente si ignora la tenace fortuna che il testo avrà nei secoli, fino a imporsi come il "Libro" al quale ricorrere ogni qualvolta un mondo, una civiltà, una storia sembrano destinati al dissolvimento e alla distruzione (quanto cinema e quanta letteratura si sono nutriti dei suoi effetti speciali e terrificanti!).
Movimenti millenaristici di ogni epoca e latitudine hanno interpretato l’Apocalisse come se quei fatti che vi sono raccontati fossero veri. Come se davvero Dio abbia stabilito un inizio traumatico (la caduta) e una fine contraddistinta dal trionfo e dalla salvezza dei giusti.
La lettura di Calasso si discosta dalla visione escatologica e rigetta l’idea che il testo di Giovanni (o più probabilmente di qualche allievo) sia la prosecuzione e il compimento dei Vangeli. Al contrario, come già sospettava Lutero, ne rappresenta la rottura. Il messaggio che l’Apocalisse diffonde sarebbe dunque il tentativo del cristianesimo di autodistruggersi. Ma perché mai una religione ancora giovane, erede della tensione giudaica e già proiettata a riscriverne la visione, compirebbe un gesto così autolesionistico? Cosa nasconde e poi rivela quel testo che sembra scritto da un dinamitardo?
Nell’Apocalisse cristiana - diversamente da quella giudaica - il Messia è giunto. La sua presenza nel mondo, descritta dalla dolcezza dei Vangeli, non ha tuttavia prodotto i risultati sperati. Egli ha fallito il compito di far coincidere il cambiamento annunciato con il trionfo della salvezza. Precarietà e delusione circolano nelle prime comunità cristiane. Gesù stesso è consapevole che il nuovo che comincia a farsi imperiosamente strada sta prendendo una direzione sbagliata. Invoca un successore, un altro messia, un "consolatore" in grado di rimettere l’umanità sulla retta via.
Ma dov’è un successore che sappia portare a termine il compito escatologico? Dal ruggito dell’Apocalisse si può dedurre solo che un essere molto potente in grado di domare il nuovo stia arrivando: "Quel demone del nuovo che usualmente viene attribuito al mondo secolare e alla scienza che lo innerva ha un’origine cristiana o più precisamente paolina".
Paolo prepara il futuro al culto della novità, ne sposa i segni della rivoluzione più che della rivelazione. È il depositario di una sapere antico e di un ordine nuovo. Fornito di un pensiero militante, si pone alla testa di una rivoluzione che nel nome della novitas liquida l’intero mondo antico: "Nessun Lenin del futuro avrebbe saputo parlare (e agire) con altrettanta concisione e vigore", commenta con lieve sarcasmo l’autore. Il nuovo che avanza travolgente non ha più bisogno del cosmo e delle sue storie. E se, per avventura, fa appello a qualcosa di remoto, tende a sfigurarlo e a tradirne la legittimità.
Sotto gli occhi dell’Agnello prende spunto da un’immagine potente dove la distanza dello sguardo animale sembra ignorare che qualcuno l’ha trafitto e che una lunga storia sacra - cominciata prima di Abele e giunta fino a Gesù - lo riguarda. Davanti a quella immagine si può solo constatare che senza quel sacrificio la potente macchina del mondo non si sarebbe più messa in moto. Ma le scritture non dicono a quale folle velocità essa è lanciata. Niente prefigura davvero cosa accade dopo che "l’innominabile attuale", sotto il cui segno il nuovo agisce, ha preso il sopravvento.
Sotto gli occhi dell’Agnello non appartiene all’oggi, ma al passato che convive col domani. Alcuni versi dell’Apocalisse sigillano il finale, ma l’autore li fa precedere da un preciso richiamo al senso intimo, starei per dire sacro, del leggere: quasi un’identificazione genetica tra chi scrive e l’idea stessa del libro: "Leggere è qualcosa che si misura con le potenze del mondo".
Cosa c’è di più commovente e rischioso di questa frase? Che cosa può frenare il dissolversi dell’esperienza artistica e religiosa se non il libro? Per tutta la vita Roberto Calasso ha cercato di dare un nome, o meglio ancora un libro, all’innominabile attuale. Quel libro - dove poter ammassare, avrebbe detto Baudelaire, le proprie collere - non è il mondo, così come l’Apocalisse non ne è la fine. È una grande finestra spalancata sul fluire della vita e sulle decisioni da prendere anche quando è giunto il tempo di congedarsi. Un tempo non già scandito dalla rassegnazione ma dallo scegliere da che parte stare, perché le battaglie celesti non finiscono mai.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- FILOLOGIA, GUERRA E PACE. Tra presente e passato [1914]: l’appello della Conferenza russa dei Rettori (di Stefano Rapisarda).1 aprile 2022, di Federico La Sala
Tra presente e passato: l’appello della Conferenza russa dei Rettori
di Stefano Rapisarda ("Insula Europea", 24 Marzo 2022)
Ha trovato una qualche eco sulla stampa italiana l’appello con cui 664 uomini di scienza di nazionalità russa chiedono a Putin di interrompere il conflitto (cito solo il Foglio del 2 e dell’11 marzo 2022, a firma Enrico Bucci). Un’elementare conoscenza della storia della gestione bellica da parte delle istituzioni accademiche dalla Prima guerra mondiale in poi (mi permetto di citare il mio libro Filologi in guerra e in pace, Rubbettino 2020) mi ha subito fatto venire in mente la seguente domanda: è mai possibile che in un contesto come quello russo attuale non siano stati prodotti appelli di uomini di scienza e professori universitari in favore della guerra, sul modello del famigerato “Manifesto dei professori tedeschi” del 1914?
Com’è noto, il 4 ottobre del 1914, a due mesi esatti dall’inizio della Prima guerra mondiale, sul quotidiano «Berliner Tageblatt» venne divulgato l’Aufruf an die Kulturwelt!, il manifesto firmato da novantatre uomini di scienza tedeschi che segnò una svolta epocale nel rapporto tra università, Stato e cultura nel senso più ampio6.
 Le firme includevano il Gotha della cultura mondiale nei più svariati ambiti disciplinari, dalla medicina (Emil Adolf von Behring, Nobel 1901; Paul Ehrlich, Nobel 1908), alla fisica (Wilhelm Röntgen, Nobel 1901; Max Planck, futuro Nobel 1918), alla chimica (Emil Fischer, Nobel 1902; Adolf von Baeyer, Nobel 1905), alla storia delle religioni (Adolf von Harnack), alla filologia classica (Ulrich von Wilamowitz-Möllendorff ), alla letteratura (Gerhart Hauptmann, Nobel 1912). I novantatre grandi nomi della cultura accademica tedesca respingevano le accuse di atrocità sulle popolazioni civili compiute dall’esercito nell’invasione del Belgio e vigorosamente ribadivano «al mondo della cultura» l’indissolubile unità di intenti che univa i diversi corpi dello Stato tedesco: la classe accademica, il ceto militare, il popolo e la dinastia imperiale. A esso fece seguito dopo dodici giorni un altro appello, l’Erklärung der Hochschullehrer des Deutschen Reiches, che recava i nomi di oltre quattromila firmatari, sostanzialmente tutto il corpo accademico delle Università di Germania.
Le firme includevano il Gotha della cultura mondiale nei più svariati ambiti disciplinari, dalla medicina (Emil Adolf von Behring, Nobel 1901; Paul Ehrlich, Nobel 1908), alla fisica (Wilhelm Röntgen, Nobel 1901; Max Planck, futuro Nobel 1918), alla chimica (Emil Fischer, Nobel 1902; Adolf von Baeyer, Nobel 1905), alla storia delle religioni (Adolf von Harnack), alla filologia classica (Ulrich von Wilamowitz-Möllendorff ), alla letteratura (Gerhart Hauptmann, Nobel 1912). I novantatre grandi nomi della cultura accademica tedesca respingevano le accuse di atrocità sulle popolazioni civili compiute dall’esercito nell’invasione del Belgio e vigorosamente ribadivano «al mondo della cultura» l’indissolubile unità di intenti che univa i diversi corpi dello Stato tedesco: la classe accademica, il ceto militare, il popolo e la dinastia imperiale. A esso fece seguito dopo dodici giorni un altro appello, l’Erklärung der Hochschullehrer des Deutschen Reiches, che recava i nomi di oltre quattromila firmatari, sostanzialmente tutto il corpo accademico delle Università di Germania.L’Aufruf, il cui testo originale si può leggere in Aufrufe und Reden deutscher Professoren im Ersten Weltkrieg, Reclam, Stuttgart [2ª ediz. con Postfazione di H. Wunderer].Böhme, pp. 47-50, venne ristampato da tutti i principali quotidiani di Germania, tradotto in dieci lingue e inviato in migliaia di lettere private ai corrispondenti residenti in nazioni neutrali. Immediatamente letto, commentato, criticato in Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti, paesi scandinavi, è uno dei documenti più controversi nella storia della cultura del XX secolo. Questo corpo titolatissimo di scienziati, indubbiamente i migliori del mondo, prende la parola per affermare come la patria, la Germania, fosse oggetto di una campagna di aggressione fondata su pregiudizi e false notizie, e proclama ad alta voce la sua fedeltà alla nazione, al popolo, all’esercito e naturalmente all’imperatore.
 L’inizio del testo recitava: “In qualità di rappresentanti della scienza e dell’arte tedesca (Wir als Vertreter deutscher Wissenschaft und Kultur), noi solleviamo dinanzi all’intero mondo della cultura la nostra protesta contro le menzogne e le calunnie con cui i nostri nemici si sforzano di macchiare la purezza della causa della Germania nella grave lotta per l’esistenza che le è stata forzatamente imposta. La bronzea voce degli eventi ha smentito le false voci circolanti di sconfitte tedesche. Di conseguenza, si moltiplicano gli ansiosi tentativi di produrre false dichiarazioni e sospetti. Alziamo la nostra voce contro di essi. Sarà l’araldo della verità. Non è vero che la Germania è colpevole di aver causato questa guerra. Né il popolo, né il governo, né l’imperatore la volevano. Le misure più estreme sono state adottate da parte tedesca per impedirlo. [...] Non è vero che la battaglia contro il nostro cosiddetto militarismo non è una battaglia contro la nostra cultura, come sostengono ipocritamente i nostri nemici. Se non fosse stato per il militarismo tedesco, la cultura tedesca sarebbe stata da tempo spazzata via dalla faccia della terra. Il militarismo emanava da questa cultura per proteggerla in una terra che per secoli è stata devastata da incursioni predatorie come nessun’altra. L’esercito tedesco e il popolo tedesco sono uno. Oggi questa consapevolezza unisce 70 milioni di tedeschi come fratelli al di là delle distinzioni di istruzione, classe e appartenenza di partito (Deutsches Heer und deutsches Volk sind eins. Dieses Bewußtsein verbrüdert heute 70 Millionen Deutsche ohne Unterschied der Bildung, des Standes und der Partei).”
L’inizio del testo recitava: “In qualità di rappresentanti della scienza e dell’arte tedesca (Wir als Vertreter deutscher Wissenschaft und Kultur), noi solleviamo dinanzi all’intero mondo della cultura la nostra protesta contro le menzogne e le calunnie con cui i nostri nemici si sforzano di macchiare la purezza della causa della Germania nella grave lotta per l’esistenza che le è stata forzatamente imposta. La bronzea voce degli eventi ha smentito le false voci circolanti di sconfitte tedesche. Di conseguenza, si moltiplicano gli ansiosi tentativi di produrre false dichiarazioni e sospetti. Alziamo la nostra voce contro di essi. Sarà l’araldo della verità. Non è vero che la Germania è colpevole di aver causato questa guerra. Né il popolo, né il governo, né l’imperatore la volevano. Le misure più estreme sono state adottate da parte tedesca per impedirlo. [...] Non è vero che la battaglia contro il nostro cosiddetto militarismo non è una battaglia contro la nostra cultura, come sostengono ipocritamente i nostri nemici. Se non fosse stato per il militarismo tedesco, la cultura tedesca sarebbe stata da tempo spazzata via dalla faccia della terra. Il militarismo emanava da questa cultura per proteggerla in una terra che per secoli è stata devastata da incursioni predatorie come nessun’altra. L’esercito tedesco e il popolo tedesco sono uno. Oggi questa consapevolezza unisce 70 milioni di tedeschi come fratelli al di là delle distinzioni di istruzione, classe e appartenenza di partito (Deutsches Heer und deutsches Volk sind eins. Dieses Bewußtsein verbrüdert heute 70 Millionen Deutsche ohne Unterschied der Bildung, des Standes und der Partei).”
 Questa “discesa in campo” senza precedenti determinò appassionate adesioni e furibonde reazioni, svelando così l’inconsistenza di un’illusione che aveva accompagnato la figura dell’uomo di scienza dall’Illuminismo in avanti: che questi fosse un tipo d’uomo votato a un fine superiore, la ricerca della verità “universale”, e non di una verità “nazionale”; e che lo scienziato lavorasse per l’umanità, non per il suo governo e una parte di umanità a lui vicina e con la quale egli condivideva la lingua, il suolo e, come presumeva l’antropologia contemporanea, il sangue.
Questa “discesa in campo” senza precedenti determinò appassionate adesioni e furibonde reazioni, svelando così l’inconsistenza di un’illusione che aveva accompagnato la figura dell’uomo di scienza dall’Illuminismo in avanti: che questi fosse un tipo d’uomo votato a un fine superiore, la ricerca della verità “universale”, e non di una verità “nazionale”; e che lo scienziato lavorasse per l’umanità, non per il suo governo e una parte di umanità a lui vicina e con la quale egli condivideva la lingua, il suolo e, come presumeva l’antropologia contemporanea, il sangue.
 È da questo momento in poi che comincia a manifestarsi un fenomeno nuovo nella storia della cultura, e anche della politica. Uomini di studio, accademici, scienziati, professori d’università, scendono nell’agone della militanza, si danno alla politica. O meglio, ostentano il loro servizio allo Stato, con adesione totalizzante ai fini specifici e particolari dello Stato di cui essi sono emanazione.
È da questo momento in poi che comincia a manifestarsi un fenomeno nuovo nella storia della cultura, e anche della politica. Uomini di studio, accademici, scienziati, professori d’università, scendono nell’agone della militanza, si danno alla politica. O meglio, ostentano il loro servizio allo Stato, con adesione totalizzante ai fini specifici e particolari dello Stato di cui essi sono emanazione.Torniamo al presente e rispondiamo alla domanda posta in apertura. Ebbene, ecco che il 3 marzo 2022, tramite il notiziario di informazione universitaria del quotidiano tedesco “Die Zeit”, salta fuori puntualmente l’omologo contemporaneo del “Manifesto dei 93”. La risonanza sulla stampa internazionale è stata debole; su quella italiana, se non m’inganno, inesistente. Credo sia utile riportarlo qui nella sua interezza dal sito della Conferenza dei Rettori delle Università di Russia, da me tradotto attraverso il tedesco e verificato sull’originale russo da Francesca Tuscano, che cordialmente ringrazio:
Appello delle Conferenza dei Rettori delle Università di Russia
- Cari colleghi! Stiamo assistendo ad eventi che riguardano ogni cittadino della Russia. La decisione della Russia è di porre fine finalmente al confronto di otto anni tra Ucraina e Donbass, per raggiungere la smilitarizzazione e la denazificazione dell’Ucraina e quindi proteggersi dalle crescenti minacce militari. Noi, il Consiglio dei Rettori della Federazione Russa, abbiamo sviluppato e rafforzato i legami scientifici ed educativi russo-ucraini per molti decenni e ci siamo trattati con la dovuta considerazione. La nostra ricerca congiunta ha dato un enorme contributo alla scienza mondiale, quindi la tragedia a lungo termine nel Donbass risuona nei nostri cuori con particolare dolore e amarezza. È molto importante in questi giorni sostenere il nostro paese, il nostro esercito, che difende la nostra sicurezza, sostenere il nostro Presidente, che ha preso forse la decisione più difficile della sua vita, una decisione faticosamente raggiunta, ma necessaria. È importante non dimenticare il nostro dovere principale: condurre un processo educativo continuo, educare il patriottismo nei giovani, il desiderio di aiutare la Patria. Le università sono sempre state un pilastro dello Stato. Il nostro obiettivo prioritario è servire la Russia e sviluppare il suo potenziale intellettuale. Ora più che mai, dobbiamo dimostrare fiducia e capacità di resistenza di fronte agli attacchi economici e informativi, stringendoci efficacemente attorno al nostro Presidente, con il nostro esempio rafforzando nei giovani uno spirito ottimista e la fede nella forza della ragione, ispirando speranza per l’imminente avvento della pace. Insieme siamo una grande forza!
Seguono 229 firme di rettori e presidenti o vicepresidenti in rappresentanza di altrettante istituzioni, da Viktor Antonovich Sadovnichy, Presidente dell’Unione Russa dei Rettori, Rettore dell’Università Statale Lomonosov di Mosca, a Yastrebov Oleg Aleksandrovich, Rettore dell’Università dell’Amicizia dei Popoli della Russia, tutti di nomina governativa come erano d’altronde i professori tedeschi dell’Aufruf del 1914.
A un’analisi del discorso, il testo dell’“Obraščenie Rossijskogo Sojuza Rektorov” del 4 marzo 2020 ha risonanze che vanno persino al di là della retorica bellicista tedesca del Secondo Reich. L’Aufruf di Wilamovitz-Mõllendorff si indirizzava agli uomini di scienza del mondo, e dei paesi neutrali in particolare; era comunque, rivolto all’esterno; era un appello internazionale, cosmopolita, Auf die Kulturwelt! senza limitazioni di nazionalità, per quanto ovviamente cercasse di agire sull’opinione pubblica dei neutrali, e soprattutto degli (ancora non belligeranti) Stati Uniti d’America. L’”Obraščenie Rossijskogo Sojuza Rektorov” è invece tutto interno, come se sapesse in partenza di non avere argomenti utilizzabili in una comunità essenzialmente internazionale come quella della ricerca.
 Insomma per chi conosce le vicende della cosiddetta ‘guerra dei professori’ che accompagnò la Prima Guerra Mondiale, si tratta di un triste dejà vu che proietta indietro di 100 anni la cooperazione scientifica internazionale, e i cui esiti sono tutto sommato prevedibili per chi conosce la storia: sospensione talvolta definitiva di collaborazioni intellettuali, cessazione di antichi sodalizi, espulsioni da organismi internazionali e nazionali, ritiro di riconoscimenti, affiliazioni, omaggi e premi, e alla fine delle ostilità, in caso di sconfitta, dichiarazioni di: “non sapevo esattamente ciò che firmavo”, “ho dato l’adesione in fiducia senza aver letto il testo”, “non potevo farne a meno data la mia posizione”, pentimento nel caso dei migliori.
Insomma per chi conosce le vicende della cosiddetta ‘guerra dei professori’ che accompagnò la Prima Guerra Mondiale, si tratta di un triste dejà vu che proietta indietro di 100 anni la cooperazione scientifica internazionale, e i cui esiti sono tutto sommato prevedibili per chi conosce la storia: sospensione talvolta definitiva di collaborazioni intellettuali, cessazione di antichi sodalizi, espulsioni da organismi internazionali e nazionali, ritiro di riconoscimenti, affiliazioni, omaggi e premi, e alla fine delle ostilità, in caso di sconfitta, dichiarazioni di: “non sapevo esattamente ciò che firmavo”, “ho dato l’adesione in fiducia senza aver letto il testo”, “non potevo farne a meno data la mia posizione”, pentimento nel caso dei migliori. -
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- UNA "MEMORIA" DALL’ANTICA COMMEDIA GRECA: IL PROFONDO LEGAME TRA LA "GRAZIA" ("CHARIS") E L’ ESSERE UMANO ("ANTHROPOS").3 marzo 2022, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA STORIA FILOSOFIA E FILOLOGIA.
LA SCOMPARSA DELLA "FANCIULLA STRANIERA" (F. Schiller, 1796) E DELL’AMORE (K. Marx, 1844) E IL DISAGIO DELLA CIVILTÀ (S. Freud, 1929: "Poi che l’apostolo Paolo ebbe posto l’amore universale tra gli uomini a fondamento della sua comunità [...]").
Una nota a margine di una memoria dell’antica commedia greca ...
- "[...] «’Ως χαρίεν ἐστ ̓ ἄνθρωπος, ὅταν ἄνθρωπος ἦι (fr. 707 K.-A.)
- "Quanto è affascinante un essere umano, quando è umano".
- Questa proverbiale frase di Menandro caratterizza probabilmente più di ogni altra cosa la sua arte drammatica: un essere umano non è umano, quando non si comporta con dolcezza, comprensione e bontà, quando non si mette rettamente nel mondo, nella società e nei suoi simili, quando si comporta come onnipotente e onnisciente con arroganza a causa del suo status sociale o della sua ricchezza, quando non riconosce, accetta e confessa i propri errori e non si pente, quando del resto non accetta i colpi del Destino riconoscendo la propria mortalità e che è destino di tutti gli esseri viventi condividere beni e disgrazie, e naturalmente della morte.
- Il γνῶθι σαυτόν «conosci te stesso» è di primaria importanza, come è importante il «conoscere gli altri». Il primo equivale a conoscere la propria situazione e ciò che dovrebbe essere fatto in ogni caso particolare, il secondo perché è molto più utile. La persona che ha queste caratteristiche è l’essere più affascinante, ma quando ne è privo è ἀπάνθρωπος (in-umano).» [...]"
- (cit. dalla relazione di A. Katsouris, "Methods of humanization and sympathy especially in reference to the traditional odd charachters", - per il testo originale, cfr. AA. VV, "Menandro e l’evoluzione della commedia greca"; a c. di Angelo Casanova, Firenze University Press 2014, p. 278 - senza note).
"HOMO HOMINI LUPUS" (Freud, 1929). Formidabile questa riflessione di Andreas Katsouris sulla frase di Menandro! A ben riflettere sulle parole (e, in particolare, sul legame tra la "grazia" ("charis") del χαρίεν ("charien") e "l’anthropos), si dovrebbe tentare di capire su come e quando è stata persa la memoria delle Grazie (greco: Χάριτες - Charites) ed è stata persa anche la traccia di ogni umanità e l’orizzonte culturale dell’Europa (e del Pianeta Terra) è diventato sempre più cosmoteandrico, edipicamente, con la stessa connivenza della filosofia, della filologia, e della psicoanalisi!
CRITICA DELLA VIOLENZA: J.-J. ROUSSEAU, K. MARX, W. BENJAMIN. Una prima traccia della "caduta" è nell’atto logico-storico ("primordiale", che prima di essere materiale è linguistico) della recinzione: "Il primo che, dopo aver recintato un terreno, pensò di dire questo è mio, e trovò altri tanto ingenui da credergli, fu il fondatore della società civile"("Discorso sull’origine della disuguaglianza", 1754"); la seconda è nella denuncia marxiana (nella "Sacra Famiglia") dell’inversione soggetto-predicato (il problema della mele, delle pere, e delle fragole... del Mentitore) e della "fanciulla straniera e la civetta hegeliana" (cfr. Federico La Sala, "La mente accogliente. Tracce per una svolta antropologica", Antonio Pellicani editore, Roma 1991, pp. 190-197)"!
A quando il sorgere della Terra?
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- IL GIOCO DELLE "TRE CARTE", GIORDANO BRUNO, E "LO SPACCIO DELLA BESTIA TRIONFANTE" ALL’ORDINE DEL GIORNO.17 febbraio 2022, di Federico La Sala
DISUGUAGLIANZA, INTOLLERANZA, E PACE PERPETUA...
FINE DELLA STORIA: NON COMPRESA LA LEZIONE DI DANTE ALIGHIERI SUI DUE SOLI E DI GIORDANO BRUNO (17 febbraio1600) SULLE TRE CORONE, DUE CORONE IN TERRA E UNA IN CIELO (“Ultima coelo manet)”, SI VA ANCORA AVANTI CON LE REGOLE DEL GIOCO DELLE TRE CARTE (questa è quella che vince, questa quella che perde, ecc...) e l’espulsione (lo spaccio) dal campo da gioco della BESTIA TRIONFANTE continua ad essere rinviata... USCIRE DAL LETARGO. La Regola, il Logos, non è un "Logo"!
CRITICA DELL’ECONOMIA POLITICA E DELLA COSMOTEANDRIA. Non sapendo affrontare e non volendo risolvere il problema di Jean Jacques Rousseau (Discorso sull’origine della disuguaglianza: "Il primo uomo che, avendo recinto un terreno, ebbe l’idea di proclamare questo è mio, e trovò altri cosí ingenui da credergli, costui è stato il vero fondatore della società civile") come quello di Sigmund Freud (Il disagio della civiltà: "Poi che l’apostolo Paolo ebbe posto l’amore universale tra gli uomini a fondamento della sua comuni tà critiana, era inevitabile sorgesse l’estrema intolleranza della Cristianità contro coloro che rimanevano al di fuori"), non ci resta che lavorare ... "PER LA PACEPERPETUA" (KANT, 1795)!!!
FLS
-
> PENSARE BENE "DIO", "IO" E "L’ITALIA" ---- ANTROPOLOGIA E PRINCIPI DI UNA FILOSOFIA DELL’AVVENIRE (Feuerbach). "I paradigmi rimossi. La maternità fonda il mondo" (di Francesco d’Agostino)).14 febbraio 2022, di Federico La Sala
USCIRE DALL’ORIZZONTE DELLA TRAGEDIA E DELLA COSMOTEANDRIA: DUE SOLI (DANTE 2021)
Dare a Giuseppe ciò che è di Giuseppe e a Maria ciò che è di Maria! *
I paradigmi rimossi.
La maternità fonda il mondo (amore, non solo rispetto)
di Francesco d’Agostino (Avvenire, mercoledì 2 febbraio 2022)
Il rifiuto della maternità, che sta diventando uno dei tratti più caratteristici di questi anni (o, se così si preferisce dire, del ’postmoderno’) sta inevitabilmente alterando la stessa autocomprensione dell’umano. Non c’è infatti dimensione di vita che non si intrecci non solo con la generatività, ma in particolare con quella dimensione della generatività che è affidata alla donna, con la maternità.
Lo spazio di vita che la ’natura’ assegna agli uomini e alle donne viene psicologicamente violentato dalla rimozione di tre paradigmi, di cui le donne sono protagoniste: quello della mortalità, assimilata a una sventura soprattutto se tragica, precoce, collegata a una nascita; quello della vecchiaia (con le sue inevitabili fragilità ed esigenze di assistenza) e sempre più arbitrariamente ritenuta un indebito peso che egoisticamente ogni generazione scarica sulle generazioni successive; e quello della malattia, percepita ormai come uno scandalo intollerabile in una società che ha fatto della ’salute’ il suo vero e proprio mito dominante. L’esito di queste dinamiche, che si intrecciano, creando vincoli che nessuno sembra ormai in grado di sciogliere, fa della società contemporanea un contesto freddo e conturbante, al quale tutte le donne vorrebbero sottrarsi, senza però assolutamente sapere in che modo.
Non è questo il luogo per formulare proposte o avanzare suggerimenti. Ma può essere il luogo per esortare tutti (uomini e donne) a riflettere sul primato dell’identità femminile su quella maschile, che la cultura postmoderna ci impone di riconoscere. Un primato sociologico-culturale, innanzitutto, come ho cercato di delineare nelle righe precedenti. Ma soprattutto un primato antropologico.
Dio ha affidato alla donna la cura e la formazione dell’identità umana, in modo così deciso e irrevocabile che difficilmente, davanti a un’icona o a un’immagine che rappresentano una madre che tiene sulle ginocchia il proprio figlio, non percepiamo una sorta di misteriosa emozione o commozione. Quella donna rappresentata da un artista, indipendentemente dal valore estetico della rappresentazione, è un’immagine di nostra madre e quel bambino che essa tiene in grembo è una nostra immagine.
Per rappresentare l’umanità in una straordinaria sintesi bastano solo queste due figure: la Madonna e il Figlio (ed ogni donna è di principio una ’Madonna’ e ogni bambino è di principio un ’Bambino Gesù’). Aggiungiamo pure, e dobbiamo farlo, la tenerissima immagine di san Giuseppe, ma sappiamo tutti benissimo che la sua santa e necessaria paternità è di mero supporto alla maternità di Maria.
Bisogna tornare a insegnare alle bambine, a tutte le bambine, che devono amare i piccoli, i fratellini, e in generale i ’maschi’, perché l’amore, quel poco di preziosissimo amore che sopravvive nel mondo, è affidato alla loro custodia e resterà tale per tutto l’arco della loro vita. E dobbiamo tornare a insegnare ai bambini che non basta un sincero e doveroso rispetto per le bambine, per tutte le donne, per il ’femminile’: non il ’rispetto’, ma l’amore è ciò che deve guidare il mondo ed è la donna, e la donna soltanto, che apre e dona al mondo la via dell’amore.
Se e quando intenzionalmente e consapevolmente la donna rifiuta la maternità è come se rifiutasse la dimensione più autentica della propria identità, cioè proprio quello - ci piaccia o no riconoscerlo - che sta a fondamento del mondo.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA!!! NON IL FIGLIO DEL "DIO" ("CARITAS") DELLA CHIESA AF-FARAONICA E COSTANTINIANA !!!
RESTITUIRE A GIUSEPPE L’ANELLO DEL "PESCATORE" E GIUSEPPE A MARIA E ALLA SUA FAMIGLIA - UMANA E DIVINA!!! LA QUESTIONE EPOCALE E CRUCIALE INVESTE L’ AVVENIRE DELL’INTERA UMANITÀ, NON QUELLO DEI VESCOVI DELLA CHIESA "CATTOLICA".
EUROPA: EDUCAZIONE SESSUALE ED EDUCAZIONE CIVICA. ITALIA "NON CLASSIFICATA"!!!
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- EARTHRISE (1968) E RINASCIMENTO, OGGI. Tracce per una seconda rivoluzione copernicana.13 febbraio 2022, di Federico La Sala
Cosmologia, antropologia, cristianesimo e civiltà.
"IL FIGLIO DELL’UOMO": UNA QUESTIONE ANTROPOLOGICA E FILOLOGICA...
COSMOLOGIA. “Da Copernico in poi l’uomo rotola dal centro verso una X”. Così Nietzsche, nel 1886. Ma, per un filosofo nato filologo e, per di più, uno dei grandi maestri del sospetto, contrariamente a quanto si è sempre ripetuto in modo "umano, troppo umano", non è bene tornare a interrogarlo e cercare di avere ulteriori dati sulla destinazione "ignota"?
ANTROPOLOGIA. Nel 1888 pubblica "Ecce homo. Come si diviene ciò che si è": un Urlo contro la paolina religione del "Vir Dei", una critica radicale della cosmoteandria faraonica, e un aut aut epocale.
LA PUNTA DI UN ICEBERG BIMILLENARIO: PUGLIA (12 FEBBRAIO 2022). "Ecce Vir": il "caso serio" del quadro intitolato "Sabinus vir Dei".
Tracce per una seconda rivoluzione copernicana
- AL DI LÀ DELLA LEZIONE DI "ANDROLOGIA" DI PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ, ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3)
SCIOGLIMENTO DEI GHIACCIAI E RINASCIMENTO, OGGI. Una ristrutturazione epocale e lo sgretolamento della cosmoteandria tradizionale (#cosmo, teologia/ #dio e #andrologia/uomo) è già da tempo in atto: la nascita di una antropologia annunciata già da Michelangelo nel suo "Tondo Doni", con le sue due sibille e i suoi due profeti - non "quattro profeti", come vuole la Galleria degli Uffizi, e da Galileo Galilei con il suo "Sidereus Nuncius" (1610), fondata sulla visione del sorgere della Terra, è già in cammino: un capovolgimento e una nuova ricapitolazione, una radicale inversione logico-storica!
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- ANTROPOLOGIA E TECNOLOGIA "PLATONICO-APOLLINEA". COME NASCONO I BAMBINI?!: ARRIVA "MAMMA IA". L’Intelligenza Artificiale può crescere un feto (di O. Lanzavecchia).10 febbraio 2022, di Federico La Sala
L’Intelligenza Artificiale può crescere un feto. L’esperimento cinese
Secondo gli scienziati dell’Istituto di ingegneria e tecnologia biomedica di Suzhou, la gestazione artificiale sarà più efficiente e sana di quella umana. I limiti non saranno tecnologici, ma etici, e si incrociano con crisi demografica ed emancipazione femminile. Non mancano le applicazioni “buone”, come nel trattamento dei bimbi nati prematuri
di Otto Lanzavecchia (f! formiche, 08/02/2022)
Si è concretizzato un altro sviluppo scientifico finora relegato ai domini della fantascienza. Un gruppo di scienziati cinesi ha creato un sistema di gestazione, un vero e proprio grembo artificiale in grado di far crescere un feto in sicurezza, sotto la gestione di un’intelligenza artificiale (IA) che monitora e accudisce il nascituro con un livello di efficienza irraggiungibile dall’essere umano, sostengono i creatori.
La “mamma IA” è stata sviluppata dai ricercatori dell’Istituto di ingegneria e tecnologia biomedica di Suzhou, nella provincia orientale del Jiangsu, che hanno descritto il sistema in un articolo della versione locale del Journal of Biomedical Engineering. Ora sta gestendo grandi quantità di embrioni animali, spiega l’articolo, ma la tecnologia alla base potrebbe, in futuro, eliminare la necessità per una donna di crescere in grembo il proprio bambino, “permettendo un’ evoluzione del feto più sicura ed efficiente fuori dal suo corpo”.
Il grembo artificiale dell’Istituto è composto da diversi contenitori in grado di ospitare un embrione a mollo in una miscela sterile di nutrienti. È stato sviluppato per permettere di espandere le sperimentazioni senza che i tecnici debbano seguire e documentare manualmente le condizioni di ogni embrione, cosa che avrebbe reso impossibile aumentare la scala della ricerca.
Il nuovo sistema è in grado di monitorare gli embrioni continuamente, attraverso immagini ad altissima risoluzione e sensori, e regolare in tempo reale la temperatura, il rifornimento d’aria e l’acqua e l’apporto di nutrienti. Può anche classificare gli embrioni in base alla salute e al potenziale di sviluppo, e indicare ai tecnici quali embrioni sviluppano delle deformazioni o muoiono, affinché vengano rimossi dal sistema.
- Foto dell’Istituto di ingegneria e tecnologia biomedica di Suzhou, Cina
Un orizzonte etico
Al momento gli scienziati dell’Istituto di Suzhou stanno studiando lo sviluppo e il processo di gestazione utilizzando embrioni di topo. Ci sono limiti legali, prima ancora che etici, per la sperimentazione su quelli umani: la legge vieta di condurvi esperimenti oltre le due settimane di sviluppo. Ma secondo il caposquadra degli scienziati di Suzhou, Sun Haixuan, le fasi successive racchiudono risposte da scoprire.
“Ci sono ancora molti misteri irrisolti sulla fisiologia del tipico sviluppo embrionale umano”, ha detto lo scienziato al Journal of Biomedical Engineering, aggiungendo che questa tecnologia “non solo aiuterebbe a comprendere ulteriormente l’origine della vita e lo sviluppo embrionale degli esseri umani, ma anche a fornire una base teorica per risolvere i difetti di nascita e altri importanti problemi di salute riproduttiva”.
Gestazione e nascita prematura
La gestazione artificiale non è una novità, anche se gli ultimi anni hanno segnato diversi sviluppi importanti. Non è ancora chiaro se questa tecnologia permette di portare a termine un periodo di gestazione, ma alcuni scienziati israeliani sono riusciti ad arrivare a metà strada, sempre utilizzando embrioni di topo. È successo anche per i primati: nel 2019 ricercatori pechinesi hanno portato l’ovulo fertilizzato di una scimmia allo stadio in cui si formano gli organi.
Nello stesso anno un gruppo di scienziati olandesi ha detto alla BBC che avrebbero costruito nel giro di un decennio un grembo artificiale in grado di salvare i bambini nati prematuramente. E proprio questo è lo sviluppo più immediato e accettabile di tale tecnologia: la gestazione artificiale dei nati prematuri in un incubatore 2.0 che simuli il grembo materno.
Nei Paesi dotati di buoni ospedali, scriveva Jenny Kleeman, c’è il 24% di possibilità di tenere in vita un nato a 23 settimane. La nascita pretermine è la più grande causa di morte e disabilità tra i bambini sotto i cinque anni nel mondo sviluppato: l’87% di quelli che ce la fanno “saranno soggetti a gravi complicazioni, come malattie polmonari, problemi intestinali, danni cerebrali e cecità”. Un grembo artificiale potrebbe dare ai bambini nati troppo presto una maggiore possibilità di sopravvivenza, e salute, rispetto al passato.
Tra demografia e distopia, le domande per il futuro
Spingendo lo sguardo più in là, andranno esaminate le pesanti implicazioni della gestazione artificiale di un essere vivente. A partire dalla possibilità di poter crescere in laboratorio degli organi (anche animali) in grado di salvare delle persone. Sviluppare la tecnologia adatta per far nascere degli umani in vitro (ectogenesi) non sarà un problema, ha detto un ricercatore anonimo al South China Morning Post, che per primo ha rilanciato i contenuti dell’articolo del Journal of Biomedical Engineering. I problemi saranno di carattere etico.
La testata di Hong Kong ha subito correlato la tecnologia alla base della “mamma IA” alla crisi demografica cinese. Dal 2016 il numero di neonati in Cina si è quasi dimezzato, anche per via delle giovani cinesi, sempre più emancipate, che scelgono di rifiutare matrimonio e figli per perseguire i propri obiettivi - una tendenza anche occidentale. Intanto un nuovo studio avverte che la popolazione cinese potrebbe dimezzarsi nei prossimi 45 anni.
In Cina, come anche altrove, la maternità surrogata è proibita. Ma non è vietato (nemmeno sulla rete locale) discutere delle possibili implicazioni della gestazione artificiale. In futuro un ospedale potrebbe diventare anche un laboratorio di gestazione; sulle chat si legge che la tecnologia potrebbe liberare le donne dalla gravosità della gravidanza e favorire l’equità sociale, potrebbe aprire nuove frontiere per chi non è in grado di far nascere un figlio in maniera naturale, potrebbe permettere alla lunga mano delle autorità di sottrarre ai genitori naturali un feto, perché ritenuti inadeguati, o creare dei “figli dello Stato”. Starà alle società anticipare lo sviluppo tecnologico.
-
> MORALI (PARTICOLARE) E MORALE (UNIVERSALE), METAMORALE --- FILOSOFIA DELLA VIOLENZA. "Ho chiamato questo tipo di impossibilità di riconoscere la violenza possibile derivante da nostre convinzioni morali «bolla morale»" (Lorenzo Magnani ). ).3 febbraio 2022, di Federico La Sala
“Filosofia della violenza” di Lorenzo Magnani
Prof. Lorenzo Magnani, Lei è autore del libro Filosofia della violenza edito da Mimesis: la violenza può essere trasformata in un oggetto autonomo di riflessione filosofica?
Questa seconda edizione italiana, pubblicata da Mimesis, del libro intitolato Filosofia della violenza è la traduzione di Understanding Violence. The Intertwining of Morality, Religion, and Violence: A Philosophical Stance, pubblicato da Springer, Heidelberg/Berlin, 2011. La seconda edizione italiana è pubblicata nella collana “Centro Internazionale Insubrico ‘Carlo Cattaneo’ e ‘Giulio Preti’ per la Filosofia, l’Epistemologia, le Scienze Cognitive e la Storia della Scienza e delle Tecniche” dell’Università degli Studi dell’Insubria, direttore professor Fabio Minazzi
Una tipica tendenza della modernità conduce a evitare di analizzare la violenza (specie quella visibile, forte, sanguinaria), liquidandola attraverso una sorta di facile “psichiatrizzazione”: i violenti sono persone che “non stanno bene”, dei pazzi. Nella maggior parte dei casi però la psichiatria non c’entra nulla. Ricordo un episodio avvenuto nel 2013, poco dopo la pubblicazione della prima edizione italiana del libro. L’attentatore Luigi Preiti, che aveva sparato a due carabinieri, era stato subito classificato dai mass media e dall’opinione pubblica come uno squilibrato, un pazzo. Erano state così oscurate le cause nascoste di quell’accesso di tremenda violenza approfittando di una specie di medicalizzazione/psichiatrizzazione. Questo comune modo di reagire finisce per attenuare e mettere in secondo piano la violenza perpetrata, classificandola come il frutto di un qualcosa di “malato”. Si sfugge così al compito di dire di più intorno alle radici di gran parte della violenza. L’attentatore aveva però subito dichiarato che voleva “colpire” (e quindi “punire”) i politici, individuati come colpevoli della sua situazione disperata di disoccupato e di separato, vissuta come iniqua. Si può dunque dare una lettura del suo comportamento in termini morali: ogni regola morale che si adotta prevede la potenziale punizione dei trasgressori. -Trasformare la violenza in oggetto autonomo di riflessione significa evitare di parlare della violenza secondo scorciatoie come quella appena indicata della psichiatrizzazione e, adottando nel mio caso un approccio naturalistico, vederne le varie sfaccettature, tenendo presente i risultati di varie discipline, enucleando l’intreccio indissolubile tra moralità e violenza fra evoluzionismo, scienze cognitive, teoria matematica delle catastrofi, teoria delle nicchie cognitive, logica e logica informale, psicologia, psicoanalisi, semiofisica. Ogni cooperazione umana, fin dalla preistoria, è basata sulla condivisione di regole morali (o protomorali) (anche quelle incorporate nelle leggi a partire da un certo momento del processo di civilizzazione), ma l’infrangere le regole morali comporta possibili punizioni più o meno violente (o meglio che vengono vissute come tali dai soggetti colpiti). Non soltanto: il contatto con persone e collettività che condividono diversi orizzonti morali genera anch’esso conflitti che possono dar luogo a esiti anche molto violenti (si pensi alle guerre - o ai terrorismi - di religione, dove la conflittualità provocata dalle regole morali incorporate nei framework religiosi è potente).
Tutti assistono a violenze di ogni tipo quotidianamente e tutti ne parlano nei mass media e a casa loro, ma l’ignoranza sociale intorno a cosa sia la violenza è grande e anche presso gli studiosi e i filosofi le cose non vanno meglio. Come già osservavo, si sente infatti spesso porre l’accento sulla violenza fisica come unica violenza degna di nota, nel mentre viene passato sotto silenzio e non rubricato come violento, per esempio, certo “teppismo parlamentare”, quando c’è scambio di voti e favori. Siamo in una società che aspirava a diventare una “knowledge-society” e invece è diventata una “ignorance society”, dove tutti sono legittimati a dire la loro opinione, che troppo spesso è quella ignorante di narcisi individualistici che non “sanno” nulla o sanno pochissimo, sia che si tratti di ministri, giornalisti, casalinghe o scienziati. E infatti anche gli studiosi e gli intellettuali non brillano di “open-mindedness” perché di solito conoscono solo ambiti specialistici; se invece possiedono una cultura di più ampio respiro e si esprimono, allora vengono aggrediti con la violenza verbale che oramai da decenni li classifica come astratti e inutili in vari media e “social” ignoranti e beceri. Una “ignorance society” (troppo orgogliosa di essere tale) che a mio giudizio è il frutto amaro di un trentennio di violento e ottuso neoliberismo cocciuto, che sta intaccando alle basi la civiltà che per molti aspetti abbiamo ereditato dall’antica Grecia (sotto questo punto di vista avere visto la catastrofe economica greca è apparso come un simbolo nefasto). Per fortuna la filosofia da più di venti secoli ci aiuta a interpretare il mondo e oggi vuole capire anche la violenza: il mio volume, che appare unico anche nell’attuale panorama della ricerca “filosofica” internazionale, mira a questo, a produrre una intelligibilità della violenza che solo la filosofia può donare. Ho cercato dunque di intraprendere una seria indagine sulla violenza con coraggio e sincerità: come esseri umani qualsiasi possiamo ignorare la nostra propria violenza, grazie a quel “embubblement” che è illustrato nel libro (per così dire la violenza non è mai la mia ma è sempre quella degli altri perché io dissimulo la violenza che compio non ritenendola mai tale - più sotto introduco appunto il concetto collegato di “bolla morale”), ma come filosofo, sostengo, non posso ignorarla: passo dopo passo questo impegno intellettuale è diventato per me sempre più specifico e teoretico, tanto da rendere la violenza un soggetto autonomo di riflessione filosofica.
Per anni mi sono dedicato allo studio della violenza e ho osservato, nel comportamento degli esseri umani violenti, come già accennavo sopra, che la violenza è fondamentalmente perpetrata sulla base di convinzioni morali, in modi più o meno coscienti e come effetto multiforme di ragioni, emozioni e azioni di vario tipo. La moralità, e quindi anche la religione - che, prima fra tutte le creazioni culturali dell’umanità, ha svolto il ruolo di “veicolo di moralità”- e la violenza sono fortemente intrecciate. Sembrerebbe un paradosso, visto che gli esseri umani si sono dotati della moralità proprio per difendersi dal male e dalla violenza e per favorire la cooperazione. Ma paradosso non è: 1) ogni moralità confligge potenzialmente in modo violento con altre moralità; 2) ogni moralità comporta la punizione più o meno violenta dei trasgressori.
Credo che occorre prima di tutto avere “rispetto” della violenza e attribuirle una volta per tutte la “dignità morale” di diventare un argomento filosofico/conoscitivo, estraendola dal circuito ristretto delle futili chiacchiere quotidiane, delle statistiche fornite dalle scienze umane e da una facile psichiatrizzazione. I filosofi hanno sempre affrontato temi importanti come la razionalità, la scienza, la conoscenza, l’etica e così via, che sono pensati un po’ da tutti come dotati di una dignità intellettuale in sé. Hanno invece sempre pensato che la violenza, proprio perché è tale, si mostra come qualcosa di banale, cattivo, intollerabile, confuso, ineluttabile e marginale, non sufficientemente interessante per loro. La violenza è stata dunque considerata più adatta ad essere studiata come dato di fatto: storia, sociologia, psicologia, criminologia, antropologia, solo per citare alcune discipline, sono sempre sembrate più appropriate per analizzarla e per fornire dati, spiegazioni e cause.
Il libro Filosofia della violenza muove dunque dalla convinzione che, almeno nel nostro tempo, proprio la filosofia possiede lo stile di intelligenza e di intelligibilità adatto per una nuova, impertinente e profonda comprensione di un tema così intellettualmente trascurato e mal rispettato. Quando si tratta di violenza, la filosofia, pur rimanendo ancora una disciplina astratta come la conosciamo, paradossalmente acquisisce il marchio di una sorta di “scienza applicata” indispensabile e insostituibile. Il libro vuole attribuire più dignità filosofica alla violenza, perché essa è estremamente importante nella vita degli esseri umani, lo si voglia accettare o meno. Ci sono una filosofia della scienza e una filosofia della moralità, una filosofia della biologia, una filosofia delle arti e così via: ora dobbiamo cercare di elaborare una filosofia della violenza come campo autonomo di speculazione, che può estrarre la violenza dalla prigione di modesti, frammentari e spesso esoterici pensieri filosofici o di freddi risultati scientifici.
Il libro aiuta a riconoscere che siamo tutti intrinsecamente “esseri violenti”: tale consapevolezza, anche se non terapeutica, potrebbe migliorare la nostra possibilità di essere almeno dei “violenti responsabili”, cioè capaci di riconoscere la violenza che deriva proprio da noi e dalle nostre azioni, direttamente o indirettamente, e non solo quella degli altri. Con questo intendo dire che avere più conoscenza della violenza potrebbe forse suggerirci inaspettati metodi di monitoraggio delle nostre reazioni emotive e razionali, al fine di ridurre la possibilità (inevitabile) di errori e accrescere invece la nostra aspirazione a un maggior “possesso” del nostro destino, sia per quanto riguarda la vita quotidiana sia per quanto riguarda quella degli stati nel nostro mondo globalizzato. Riconoscere la nostra condizione di “creature violente” e aumentare la conoscenza circa la nostra capacità di nuocere, vuol dire accettare la nostra responsabilità e sperare di individuare quei “firewall” cognitivi che possono aiutarci a prevenire la violenza. Considerare la violenza dal punto di vista della “moralità” dei colpevoli - dove la violenza appare chiaramente come giustificata da “valori” - può aiutare a coglierla e capirla come un evento quasi ineluttabile e comune, che non può essere ignorato.
La violenza è dunque di solito generata da ragioni morali: il conflitto morale è alla base del conflitto violento. Persone a prima vista del tutto decenti (come già osservava Hannah Arendt a proposito dei buoni padri di famiglia che erano nel contempo anche criminali nazisti), sono capaci di atti violenti anche sanguinari in nome della loro morale, da essi considerata come sicura e certa. Se si agisce con violenza per ragioni morali, per difendere sé stessi e preservare il proprio punto di vista morale o per punire chi ha infranto le regoli morali del gruppo a cui si aderisce, come è possibile pensare di essere stati violenti? Ci si dice per esempio: “Sono un seguace della legge dell’onore, che considero giusta e morale, quindi la vendetta è ‘giustizia’ anche quando ha come conseguenza la violenza estrema dell’omicidio”. Ho chiamato questo tipo di impossibilità di riconoscere la violenza possibile derivante da nostre convinzioni morali “bolla morale”.
- CONTINUAZIONE NEL POST SUCCESSIVO.
-
> MORALI (PARTICOLARE) E MORALE (UNIVERSALE), METAMORALE --- FILOSOFIA DELLA VIOLENZA. "Ho chiamato questo tipo di impossibilità di riconoscere la violenza possibile derivante da nostre convinzioni morali «bolla morale»" (Lorenzo Magnani ). ).3 febbraio 2022, di Federico La Sala
- continuazione dal post precedente e fine
“Filosofia della violenza” di Lorenzo Magnani *
Prof. Lorenzo Magnani, Lei è autore del libro Filosofia della violenza edito da Mimesis: la violenza può essere trasformata in un oggetto autonomo di riflessione filosofica?
- [...]
Perché si può affermare che nel linguaggio è insita una natura violenta?
La violenza non è solo quella palese (per esempio quella fisica o sanguinaria), ma è anche nelle cose, nelle strutture e nel “linguaggio”, che spesso, con fallacie, finzioni, inganno, distribuisce violenza, dissimulandola e dicendo “sono solo parole”. Lo squadrismo verbale può essere a sua volta foriero di altre violenze: lo si vede nel mobbing, nel bullismo, ma anche negli esiti sanguinari del linguaggio provocatorio dei politici. Si parla spesso della cultura dell’odio che è veicolata dal linguaggio e talora gli stessi esseri umani che parlano della necessità di evitare il linguaggio dell’odio lo fanno, senza accorgersene, proprio con il linguaggio dell’odio.
Come si distribuisce la violenza attraverso le fallacie?
Come dicevo la violenza non è solo fisica ma è nelle cose, nelle strutture e nel “linguaggio”, che spesso, con fallacie, dissimulazione, inganno, e con quello che in inglese si chiama efficacemente “bulshitting” (così diffuso nei media e presso i politici nonché presso i cosiddetti esperti, ecc.), distribuisce violenze a destra e manca, dissimulandole come cose non violente, solo parole. Lo squadrismo violento verbale è, come dicevo, a sua volta foriero di altre violenze, come si vede nell’esempio banale del passaggio dal mobbing verbale “gossiparo” al suo possibile esito omicida. Le fallacie sono errori di ragionamento, e come tali sono particolarmente esposte ad essere usate in quella che il matematico René Thom chiama intelligenza militare al fine di organizzare convincenti (anche se erronee) tematizzazioni morali che “giustificano” punizioni varie di coloro che disobbediscono o non si adeguano e che quindi mettono in pericolo quelle stesse regole morali e in ultima analisi la cooperazione che da esse è garantita.
Quale ruolo possono svolgere i mediatori morali nello scatenarsi della violenza strutturale?
Il potenziale violento che è parte costitutiva integrante di quelli che alcuni biologi evoluzionisti contemporanei chiamano nicchia cognitiva mostra anche la dimensione sottostante di violenza strutturale e simbolica, ovvero della violenza diffusa potenzialmente generabile e spesso generata da quelli che chiamo mediatori morali. La violenza strutturale è considerata come moralmente legittimata poiché esercita una funzione cruciale nelle attività di mantenimento della nicchia: un esempio semplice di mediatore è il crocefisso, per esempio in una nicchia cognitiva come una chiesa cristiana. Come mediatore morale rimanda alla dimensione etica della religione cristiana e quindi per esempio alla regola morale ama il prossimo tuo come te stesso, e come tale sostanzia e stabilizza la nicchia cognitiva in cui si trova. Tuttavia, se una persona lo indossa e viene visto in una circostanza sfavorevole da un terrorista che professa e difende un’altra religione, quello stesso oggetto diventa un potenziale mediatore di violenza, in quanto chi lo porta può essere ferito o addirittura ucciso.
Dobbiamo ricordare che quando genitori, poliziotti, insegnanti e altri agenti infliggono ed esercitano violenza, fisica o non visibile, “per ragioni morali e/o legali”, queste ragioni non eliminano il fatto che è stata perpetrata della “violenza”, e che essa non deve essere condonata oppure sottovalutata solo perché non è sempre percepita come tale (bolla morale) ed è invece vista come “qualcosa d’altro”, cioè come derivante da gesti morali. D’altra parte deve essere osservato che nel caso della violenza strutturale quegli agenti perpetranti violenza non agiscono certo quasi mai per conto proprio , ma per conto di più vaste istituzioni, siano esse politiche, sociali (come per esempio la famiglia), industriali, economiche o religiose: per l’appunto in quanto mediatori morali/violenti. -Tali istituzioni sostanziano la violenza strutturale non grazie ad agenti umani ma grazie a per l’appunto a “mediatori morali/violenti” di vario tipo (che nel caso estremo possono coincidere con esseri umani che hanno trasformato se stessi in quelli che potremmo definire artefatti socio-culturali mediatori di violenza, come nel caso del ruolo assunto dall’“agente di polizia” all’interno della violenza strutturale). La dimensione regolatrice della violenza strutturale è spesso diluita nella forma pervasiva della narrazione: le fiabe che sono raccontate ai bambini, i romanzi, le commedie, le opere teatrali e i film, sono tutte forme coinvolte nella diffusione di insegnamenti morali, economici o spirituali che comportano esemplificazioni di punizioni e violenze.
In che modo moralità “individuali multiple” possono scatenare violenze?
Gli individui agiscono spesso in base a quelle che chiamerei “morali multiple” e variabili: al mattino di fronte a una certa situazione si segue la morale religiosa e si agisce di conseguenza (per esempio punendo con violenza la figlia musulmana che non si è coperta il volto o ha il fidanzato cristiano); al pomeriggio invece di fronte a un’altra situazione si segue la morale civile che punisce con la violenza legittima della legge; alla sera di fronte a un’ulteriore nuova situazione si segue la morale dell’onore (che contrasta con le prime due, delle quali non ci si ricorda però minimamente), che comporta invece, per esempio, la violenza della vendetta privata. A ogni livello di questa variabile moralità individuale (che pure si informa a moralità collettive riconosciute e condivise da molti), l’esercizio della stessa protegge dal rendersi conto della violenza delle conseguenze: è una condizione cognitiva che io definisco “bolla morale”, concetto che ho già citato in passaggi precedenti.
Che nesso esiste tra religione, moralità e violenza?
La religione, nel mentre spinge, come tutti sanno, verso il “meglio” grazie al suo profondo portato morale, può ahimè pervertirsi, diventando agente di punizioni e violenze contro i membri del proprio gruppo che trasgrediscono le regole o contro i seguaci di altre religioni. Ho detto prima che la moralità e la violenza sono fortemente intrecciate. Questo aspetto è identicamente presente nel caso della religione: religione e violenza sono molto intrecciate. La religione infatti, trovandosi a svolgere, prima fra tutte le creazioni culturali dell’umanità, il ruolo di “vettore di moralità”, e quindi di “promotore di moralità”, come tale è caratterizzata dalla presenza della “punizione” (più o meno violenta) e del “conflitto (più o meno violento) con moralità avverse”.
Desidero anche aggiungere che anche una struttura complessa insieme astratta e concreta come la democrazia è oggetto di possibile violenza, per esempio ad opera del neoliberismo (e della sua devastazione di ogni equilibrio prezioso del capitalismo economico). Questo tema è nel libro collegato all’analisi del presente drammatico tendenziale passaggio dalla democrazia all’oclocrazia, già descritto da Polibio, dove osceni carismatici di turno che ingannano demagogicamente il popolo, coltivando e diffondendo tutte le debolezze e miserabilità del popolo stesso (e trascurandone invece le virtù), generano un impoverimento di tutti, e quindi anche dello stesso “oclos”: è proprio quello che stiamo vedendo ogni giorno.
Per concludere, il libro vuole incoraggiare ad aumentare la nostra “conoscenza” sulla violenza, come tema sia filosofico che cognitivo. Data l’importanza della violenza nel comportamento umano, lo studio di questo argomento aiuta a mantenere un focus intellettuale sugli impegni morali e sulle loro conseguenze, sperabilmente anche al di là della comunità strettamente intellettuale e accademica. Violenza, danni e aggressioni sono così pervasivi della vita di tutti i giorni, che non è facile immaginare di vivere senza incappare in essi. Gli attacchi violenti che sferriamo verso gli altri esseri umani, gli animali e la natura dipendono da complicati meccanismi biologici e cognitivi, che fondamentalmente si intrecciano con il ruolo della moralità. Le persone dunque possono fare uso di diverse “morali” come armi violente, sia per azioni difensive che aggressive.
 Come già dicevo, riconoscere la nostra “condizione” di “creature violente” e aumentare la conoscenza circa la nostra capacità di nuocere, vuol dire accettare la nostra responsabilità e sperare di riuscire ad individuare quei “firewall” cognitivi che possono aiutarci a prevenire la violenza. Nikolaj Gogol era già perfettamente consapevole che la nostra conoscenza, la nostra inclinazione e la nostra sensibilità verso il bene sono sempre indissolubilmente legate alla conoscenza, inclinazione e sensibilità verso il male. Capire la violenza grazie alla filosofia non significa perdonarla o giustificarla, e - forse - può essere di aiuto, ad esempio, ad evitare di cadere in una situazione violenta.
Come già dicevo, riconoscere la nostra “condizione” di “creature violente” e aumentare la conoscenza circa la nostra capacità di nuocere, vuol dire accettare la nostra responsabilità e sperare di riuscire ad individuare quei “firewall” cognitivi che possono aiutarci a prevenire la violenza. Nikolaj Gogol era già perfettamente consapevole che la nostra conoscenza, la nostra inclinazione e la nostra sensibilità verso il bene sono sempre indissolubilmente legate alla conoscenza, inclinazione e sensibilità verso il male. Capire la violenza grazie alla filosofia non significa perdonarla o giustificarla, e - forse - può essere di aiuto, ad esempio, ad evitare di cadere in una situazione violenta.
 Come dicevo, considerare il male violento dal punto di vista della “moralità” dei colpevoli - dove la violenza appare chiaramente come giustificata
da “valori” - può aiutare a cogliere la violenza come un evento quasi ineluttabile e comune, che non può essere ignorato. Devo segnalare al lettore che per tentare di capire la violenza da un punto di vista filosofico hp dovuto cercare di sopprimere i suoi miei giudizi morali, guadagnando così una nuova consapevolezza metamorale circa la condizione umana. Lo spettacolo della violenza umana mi ha insegnato (e spero insegni a tutti) qualcosa di più sul come conviverci e come monitorarla, grazie all’attività del “conoscerla” meglio nella sua struttura e nelle sue funzioni.
Come dicevo, considerare il male violento dal punto di vista della “moralità” dei colpevoli - dove la violenza appare chiaramente come giustificata
da “valori” - può aiutare a cogliere la violenza come un evento quasi ineluttabile e comune, che non può essere ignorato. Devo segnalare al lettore che per tentare di capire la violenza da un punto di vista filosofico hp dovuto cercare di sopprimere i suoi miei giudizi morali, guadagnando così una nuova consapevolezza metamorale circa la condizione umana. Lo spettacolo della violenza umana mi ha insegnato (e spero insegni a tutti) qualcosa di più sul come conviverci e come monitorarla, grazie all’attività del “conoscerla” meglio nella sua struttura e nelle sue funzioni.Lorenzo Magnani, filosofo, epistemologo e scienziato cognitivo, è professore ordinario di Filosofia della scienza presso l’Università di Pavia e direttore del Computational Philosophy Laboratory del Dipartimento di Studi Umanistici. Ha lavorato in USA, Cina e altri paesi EU, e realizzato più di 400 pubblicazioni nel campo della filosofia, della logica e delle scienze cognitive. Dirige la collana Studies in Applied Philosophy, Epistemology and Rational Ethics (SAPERE), dell’editore Springer. È membro dell’International Academy for the Philosophy of the Sciences (AIPS).
* Fonte: Letture.org
-
>CINEMA E FILOSOFIA. IL "SORGERE DELLA TERRA" E "IL GRANDE PASSO" ANTROPOLOGICO DELL’UmaNITÀ. Una lezione della regista Cristina Comencini.21 gennaio 2022, di Federico La Sala
CINEMA, FILOSOFIA E ANTROPOLOGIA
IL SORGERE DELLA TERRA E "IL GRANDE PASSO" DELL’UmaNITÀ.
Una lezione della regista Cristina Comencini ... *
Quirinale, l’ironico appello di Cristina Comencini: "Noi donne cediamo il passo: ora un uomo alla presidenza della Repubblica"
La provocazione della regista sulla prossime elezione del nuovo capo dello Stato: "Bisogna dire che siamo state generose e abbiamo già ceduto a qualche singolo rappresentante del genere maschile delle responsabilità ma ora è il momento di fare il grande passo"
di Cristina Comencini (la Republica, 16 Gennaio 2022)
"Le donne italiane chiedono a gran voce finalmente un presidente della Repubblica uomo. Dall’alto della loro secolare esperienza al potere le donne dicono che è l’ora di cedere il passo agli uomini almeno per un tentativo, per una prima volta. Se l’esperienza deluderà, li si escluderà ancora per qualche decennio dalla carica, finché si saranno dimostrati pronti a esercitare con soddisfazione la più alta responsabilità dello Stato. Bisogna dire che siamo state generose e abbiamo già ceduto a qualche singolo rappresentante del genere maschile delle responsabilità ma ora è il momento di fare il grande passo. Ma non abbiate paura, non diamo loro una fiducia cieca, un mandato senza condizioni. Poniamo invece delle caratteristiche e dei valori precisi che non siamo ancora certe siano caratteristiche del loro genere".
"Prima di tutto una grande e estesa cultura, avere esperienza della politica ma anche competenze giuridiche e costituzionali, avere conquistato una stima e un apprezzamento ampio ben oltre i confini di un’area politica, essere in una rete di relazioni pubbliche ma anche nella società civile, avere capacità di mediazione e di pacatezza. Insomma saranno considerati solo i molto meritevoli e non saranno accettati perché uomini ma perché avranno dimostrato di essere eccellenti. D’altronde non cediamo volentieri il potere esercitato per tanto tempo a chiunque, ma siamo obbligate almeno a proporlo, è un fatto di civiltà, non si può aspettare ancora. Siamo d’accordo, in via di principio, che un uomo prenda il posto di una donna, ma intendiamoci non è obbligatorio. Noi siamo talmente forti ed esperte che sarà difficile trovare un uomo all’altezza. Siamo legate una all’altra in un patto d’acciaio consolidato nei secoli. Ma intanto nessuno potrà rimproverarci di non averlo dichiarato, di non essere al passo con i tempi. Allora diciamolo senza paura, tanto non succederà: un uomo alla presidenza della Repubblica. Bisogna guardare il rovescio per capire il dritto".
* IL SORGERE DELLA TERRA E "IL GRANDE PASSO" DELL’UmaNITÀ. Una lezione della regista Cristina Comencini...
- STORIA, ANTROPOLOGIA, E DISAGIO DELLA CIVILTÀ E NELLA CIVILTÀ. CHE L’ITALIA VIVA...
Brillante sollecitazione ...
BENE, BENE! “Bisogna guardare il #rovescio per capire il #dritto" - e il DIRITTO. La COSTITUZIONE e l’antropologia, non l’andrologia!
...UN FATTO DI CIVILTÀ. Che si cominci: si tratta di riequilibrare antropo-logica-mente la bilancia stessa dell’esistenza e uscire dall’orizzonte tragico della cosmoteandria - come da indicazioni di Dante 2021 (e da Virgilio-Freud: dall’ Acheronta Movebo, fin nel più alto dei cieli).
EARTHRISE (24 dicembre 1968). Che si sappia e si abbia, finalmente, la visione del Sorgere della Terra...
Che l’Italia viva!
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- CRONACHE MARZIANE SU LEGGENDE UMANE, TROPPO UMANE.16 gennaio 2022, di Federico La Sala
CRONACHE MARZIANE.
Ma come sono intelligenti (questi esseri umani terrestri d’Italia): non sanno proprio nulla della fattoria né di Platone né di Orwell. Hanno approvato una Legge che dice:tutti i partiti sono uguali, ma un partito è più uguale degli altri! E si apprestano a nominare Presidente della loro Repubblica, il presidente (o chi per lui) di questo partito. Il giogo e il gioco è già in atto da più di un ventennio!
Sono proprio intelligenti e sportivi questi terrestri italiani: con il loro nuovo presidente, tutti e tutte gridano e agitano le bandiere del partito: "forza italia". Tutto il loro mondo è diventato uno stadio e, finalmente, il loro Presidente è l’Arbitro di tutti i partiti e di tutte le partite!!!
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- PSICOANALISI E COSTITUZIONE: "IN PRINCIPIO" ("BERESHIT") ERA IL "LOGOS" (NON IL "LOGO" DI UNA "FATTORIA").3 gennaio 2022, di Federico La Sala
ARCHEOLOGIA, FILOSOFIA, LOGICA PSICOANALISI E COSTITUZIONE: "IN PRINCIPIO ERA IL LOGOS" (non il Logo di una fattoria).
- La storia delle parole
- Bereshìt. È la prima parola della Torah, in principio. Ma perché c’è la Bet come prima lettera e non l’Aleph? C’è una storiella simpatica nello Zohar: Dio giocò duemila anni con le lettere che presero confidenza con lui. Ognuna di loro chiese di essere la prima. La Tav (l’ultima ed era a forma di croce fenicia inizialmente) iniziò col dire che lei era il sigillo della parola Emet (verità), e si meritava quell’onore. Via via le altre, fino alla Bet che disse che lei indicava il verso giusto del cammino ed era la lettera di Benedizione. A Dio piacque l’idea e scelse Bet. Chiese poi all’Alef perché non avesse cercato di convincerlo e lei rispose "perché non metto in discussione quello che hai già deciso" Dio la osservò e poi le disse "inizierò con Bet, ma tu sarai la prima dell’alfabeto".
DIO E LE LETTERE DELL’ALFABETO. Questa storiella dello Zohar "nasconde" una grande lezione di logica e matematica, antropologia e teologia (e, a mio parere, offre la chiave per meglio capire il senso stesso del riferimento di Baruch Spinoza al detto Homo Homini Deus Est e il messaggio dell’ impresa di Dante Alighieri).
Quando si comincia a contare, da dove bisogna cominciare, per iniziare bene ed essere gà a metà dell’opera?! Chi è che conta e da dove inizia. Perché (come qui, nella storiella dello Zohar) dalla Bet?
Premesso che le lettere dell’alfabeto ebraico sono anche numeri e, quindi, hanno un valore numerico, è opportuno ricordare che alef vale zero (= 0) e che bet vale uno (= 1); e, quando si comincia a contare, si comincia a contare da uno (= 1), appunto, da bet.
Per non perdere la #bussola e, ancor di più, per non lasciarsi sopraffare dalla narcisismica terremotante tentazione di truccare le carte e il conto, però, occorre tenere ben presente che al "Dio" che conta, in un altro testo decisivo della tradizione biblica (Apocalisse di Giovanni), è attribuita la seguente importantissima frase: "Io sono l’alfa e l’omega" (greco koinè: "ἐγὼ τὸ Α καὶ τὸ Ω"). La precisazione è decisiva...
Amore è più forte di Morte (Ct., 8.6). A ben riflettere sull’apocalittica frase, si apre la porta di una chiara #comprensione sul Chi (= X) lega e sa legare "il principio e la fine" (Apocalisse 21:6, 22:13) e, al contempo, sul buon messaggio stesso della "Divina Commedia": "l’amor che move il sole e le altre stelle" (Par. XXXIII, 145).
L’alfa (il principio) e l’omega (la fine), e la bet ("la prima lettera dell’alfabeto), la lettera che indica ""il verso giusto del cammino"!
Bet, la lettera di Benedizione ....
LA PIETRA FONDAMENTALE E LA PIETRA ANGOLARE: "ECCE HOMO". Ogni Uno (=1), Ognuno (ogni Eva e ogni Adamo, ogni Maria e ogni Giuseppe), Ogni Essere umano (Everyman, così Dante Alighieri per Ezra Pound), è antropologicamente e linguistica-mente la lettera dell’alfabeto, la Bet, la lettera di Benedizione e Bereshìt, la Parola che sta "Nel Principio": "Nel Principio era il Logos". L’amor che move il sole e le altre stelle....
-
>PENSARE BENE "DIO", MONDO", E "UOMO": ANDARE OLTRE LA COSMOTEANDRIA --- NICCOLÒ CUSANO E L’OMELIA DEL NATALE 1440 AD AUGUSTA. L’Incarnazione completa la creazione (di Piero Stefani).20 dicembre 2021, di Federico La Sala
L’OMELIA PERFETTA DI NICCOLÒ CUSANO
L’INCARNAZIONE COMPLETA LA CREAZIONE
di PIERO STEFANI (Corriere della Sera, La Lettura, 19 Dec 2021)
Il rito cattolico romano prescrive, per il giorno di Natale, tre diverse messe: quella della notte, quella dell’aurora e quella del giorno. Ognuna prevede un Vangelo diverso. A mezzanotte si legge Luca (2,114): è la scena della nascita di Gesù a Betlemme, degli angeli e dell’annuncio ai pastori, un quadro che è quasi inevitabile associare al presepe. Al primo mattino i pochi presenti ascoltano i versi successivi (Luca 2,15-20) nei quali si descrive la stupita visita dei pastori a Maria, a Giuseppe e al bambino adagiato sulla mangiatoia. Quando il sole è già alto, il brano evangelico accantona la componente narrativa e si immerge nelle profondità del cosiddetto Prologo di Giovanni (1,1-18): una sequenza di versetti che culmina là dove si afferma che la Parola (termine spesso reso con Verbo, il greco ha logos) si fece carne.
Il senso del Natale è sospeso tra due estremi: da un lato vi è il richiamo alla nascita che accomuna tutti i viventi, dall’altro l’annuncio che il Figlio, la seconda persona della Trinità, si è fatto uomo. A differenza della prima, questa seconda convinzione è fatta propria solo da una parte minoritaria dell’umanità.
 Come festa legata alla nascita, il Natale ha la potenzialità di accomunare tutti. Ognuno, se vi dedica qualche riflessione, comprende che la tenerezza suscitata da un neonato è un riflesso della legge, priva di eccezioni, secondo la quale tutti nasciamo non autosufficienti e bisognosi di aiuto. Il semplice fatto di essere vivi attesta che qualcuno si è preso cura di noi. Il senso di solidarietà avvertito a Natale trae alimento da queste remote radici. Dietro la banalità del detto «a Natale si è tutti più buoni» si celano profondità esistenziali.
Come festa legata alla nascita, il Natale ha la potenzialità di accomunare tutti. Ognuno, se vi dedica qualche riflessione, comprende che la tenerezza suscitata da un neonato è un riflesso della legge, priva di eccezioni, secondo la quale tutti nasciamo non autosufficienti e bisognosi di aiuto. Il semplice fatto di essere vivi attesta che qualcuno si è preso cura di noi. Il senso di solidarietà avvertito a Natale trae alimento da queste remote radici. Dietro la banalità del detto «a Natale si è tutti più buoni» si celano profondità esistenziali.Le visioni di fede sono di frequente paradossali. I credenti sanno di essere una minoranza ma nello stesso tempo devono essere certi che le loro convinzioni riguardano tutti, anzi concernono il tutto. Si tratta di una sproporzione avvertita anche quando la maggioranza della società era cristiana.
 Nel Natale del 1440, lo stesso anno in cui scrisse De docta ignorantia, il suo libro più celebre, Niccolò Cusano tenne ad Augusta, in Germania, una lunga predica nella quale la dottrina superò l’ignoranza. Alcuni passaggi sono rivelatori della sua filosofia. Dio è infinito, il mondo è invece finito. Tra infinito e finito non c’è proporzione. Tuttavia il mondo non può esistere senza un rapporto con il suo Principio che infinitamente lo trascende.
Nel Natale del 1440, lo stesso anno in cui scrisse De docta ignorantia, il suo libro più celebre, Niccolò Cusano tenne ad Augusta, in Germania, una lunga predica nella quale la dottrina superò l’ignoranza. Alcuni passaggi sono rivelatori della sua filosofia. Dio è infinito, il mondo è invece finito. Tra infinito e finito non c’è proporzione. Tuttavia il mondo non può esistere senza un rapporto con il suo Principio che infinitamente lo trascende.Come fa dunque l’universo a esserci? Vi è un’unica risposta possibile: ciò avviene a motivo dell’Incarnazione, «infatti se Dio non avesse assunto la natura umana - la quale compendia in sé tutti gli altri esseri come loro centro unificante - l’universo nella sua totalità non sarebbe compiuto e perfetto, anzi non sarebbe affatto un universo». La convinzione umanistica che giudica l’uomo un «microcosmo» è chiamata in causa per dare ragione dell’esistenza di tutte le cose. Dio si incarna non a motivo del peccato umano ma perché il creato sia e sussista.
Nessuno esige dai presbiteri che predicheranno nella notte e nel giorno di Natale di misurarsi con le abissali prospettive cusaniane. La richiesta è più contenuta, sarebbe infatti sufficiente che gli immancabili appelli al bambinello e alla solidarietà fossero davvero capaci di misurarsi con la serietà dell’esistenza.
-
>MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- Diffusa la classifica dei progetti Prin sostenuti dal Miur con 11 milioni. Nell’area che comprende quasi tutta la filosofia bocciato ogni progetto legato alla disciplina (di A. Lavazza).28 novembre 2021, di Federico La Sala
Il caso.
Filosofi senza fondi per la ricerca. Fanno discutere gli ultimi finanziamenti
Diffusa la classifica dei progetti Prin sostenuti dal Miur con 11 milioni. Nell’area che comprende quasi tutta la filosofia bocciato ogni progetto legato alla disciplina
di Andrea Lavazza (Avvenire, sabato 27 novembre 2021)
La filosofia ha ritrovato qualche visibilità pubblica nel dibattito (acceso) sulla legittimità di alcune misure di prevenzione della pandemia e cerca di ritagliarsi quel ruolo civile e politico che le compete, tra tante voci scomposte, incoerenti e senza capacità di analisi. Ma in filosofia la proiezione pubblica del pensiero viene dallo studio, dall’approfondimento e dal confronto che si fanno nell’università. Senza quel retroterra, la disciplina langue e i suoi esponenti saranno di basso profilo.
Per questo ha suscitato sorpresa e rimostranze in molti ambienti accademici la recentissima pubblicazione delle graduatorie per l’assegnazione dei fondi Prin. Si tratta dei finanziamenti che il Miur mette a bando per i migliori progetti di ricerca universitari, divisi per macroaree. Nella cosiddetta SH5, che raggruppa la maggior parte delle materie filosofiche insieme alla letteratura, gli studi classici e comparatistici, la storia delle arti, dell’architettura e della musica, tra i 24 progetti premiati con oltre 11 milioni di euro complessivi non ve n’è nemmeno uno promosso da filosofi. A memoria di tutti i docenti interpellati non era mai successo. Non si parla ovviamente di ordinare i settori disciplinari per importanza, a essere valutati erano le singole proposte di attività di ricerca, secondo oggetto e modalità di svolgimento. Ma colpisce che la filosofia, con il 10% dei 253 progetti presentati, non abbia raccolto nulla.
Sottovalutati i temi dell’etica
Qualche maligno attribuisce il risultato negativo a qualche isolato e presenzialista “avversario del Green pass” e all’avversione che può avere suscitato verso la disciplina, ma la comunità filosofia ha reagito con tempestività e con contributi di valore, mostrando al contrario di quanto bisogno vi sia di buone elaborazioni concettuali anche di fronte a un’emergenza sanitaria.
“C’è da chiedersi se la politica culturale italiana voglia ancora promuovere le humanities e la riflessione etica in particolare, proprio in un momento in cui di etica si parla tanto e di buona etica c’è grande necessità”, riflette Adriano Fabris, docente ordinario a Pisa, presidente della Società italiana di filosofia morale e visiting professor in molte università internazionali. “Sembra siano in gioco trasparenza e competenza. Trasparenza perché non è ben chiaro quali criteri utilizzi il Comitato dei Garanti che al ministero dell’Università e della Ricerca nomina i revisori, italiani e internazionali (questi giustamente anonimi). Competenza, perché molti giudizi paiono opachi, non adeguatamente motivati, a differenza di ciò che accade nella valutazione qualitativa della ricerca (Vqr), e mostrano anche notevole approssimazione e scarsa conoscenza della discussione internazionale”.
Sulla stessa linea Pasquale Porro, dell’università di Torino, tra i massimi medievisti, già alla Sorbona, vincitore di numerosi progetti e direttore di riviste e collane internazionali: “Credo con convinzione nella cultura dei bandi competitivi, e ritengo (come nel caso dell’ERC) che faccia parte di questa cultura accettare i risultati delle valutazioni, qualunque essi siano. L’importante però è che la competizione sia davvero tale, e non squilibrata: è un’evidente anomalia statistica che nessuno dei progetti filosofici afferenti al settore SH5 sia stato ammesso al finanziamento, mentre siano stati premiati soprattutto i progetti relativi a un altro ambito disciplinare appartenente allo stesso settore”.
Troppe asimmetrie di giudizio
Aggiunge Mario De Caro, professore a Roma Tre, già a Harvard e MIT e vicepresidente della Consulta nazionale di filosofia: "Al di là delle questioni di merito su parecchie valutazioni francamente inadeguate, nei processi valutativi qualche stortura è inevitabile, e ormai ciò che è fatto è fatto. Per il futuro, però, sarebbe bene che il Ministero normalizzasse i risultati delle valutazioni delle diverse aree: se in una determinata area ci sono tanti progetti che ottengono il massimo dei punteggi e in un’altra non ve n’è nessuno, siamo di fronte un evidente problema di asimmetria dei criteri di giudizio. Un problema, questo, che per la VQR è stato risolto, appunto, con la normalizzazione. Sarebbe molto auspicabile che si facesse altrettanto per il prossimo Prin".
Andrea Staiti, già Professore al Boston College, rientrato in Italia con il programma "Levi Montalcini" per il ritorno dei cervelli e professore associato di filosofia morale all’Università di Parma, esemplifica così con il suo progetto: “Il voto, tra i tre ricevuti, assegnato da un collega internazionale è stato quello più alto, rispetto a quelli dei colleghi italiani. Inoltre, viene dato ‘appena sufficiente’, senza addurre motivazioni ulteriori, alla voce Sfide che la ricerca affronta sotto il profilo dell’incidenza sull’innovazione tecnologica, sulle applicazioni industriali, sulla crescita economica ovvero sulla soluzione di problemi sociali, sulla protezione dell’eredità culturale o dell’ambiente anche con approcci interdisciplinari. Questa però è una valutazione della filosofia come disciplina, non del progetto particolare. Viene anche sostenuto che il tentativo di produrre una teoria filosofica della responsabilità ‘non è molto originale’. Varrebbe la pena sollevare una domanda su cosa il valutatore intenda con ‘originalità’ in filosofia (è necessariamente non originale occuparsi del libero arbitrio o dell’idea di giustizia?) e notare che il valutatore internazionale ha espresso parere opposto”.
La ricerca filosofica esclusa dai fondi del Pnrr?
Commenta Beatrice Centi, docente a Parma, già alla Normale di Pisa, e attuale presidente della Consulta nazionale di filosofia: "Valutare dal punto di vista applicativo i progetti di ricerca filosofici appare spesso molto problematico ed è questa una voce che può rendere inefficaci valutazioni anche molto positive di altri aspetti dei progetti".
“Il punto più critico - conclude Fabris - è che di fatto si svaluta la filosofia nelle sue declinazioni - teoretica, morale, politica - a favore di una discipline tecnico-applicative che sono importantissime ma non possono occupare tutto lo spazio della ricerca. Tra i ‘bocciati’ ci sono infatti figure autorevoli a livello internazionale. Soprattutto, preoccupa adesso che cosa accadrà con i fondi del Pnrr. Si parla di 7 miliardi per l’università e di 760 milioni per il prossimo programma di Prin a partire dal 2022. Dobbiamo forse prendere atto che la filosofia non è degna di ricevere sostegno per la ricerca? Se è così, ci venga detto apertamente”.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- Discorso sullo stato presente: Leopardi, Nietzsche, e una grave involuzione antropologica (di Piero Beliacqua).22 novembre 2021, di Federico La Sala
La perdita dell’etica pubblica senza una fede laica nel bene comune
Sinistra. Scomparso l’antagonista storico del capitalismo, regrediti i ceti medi e la classe operaia avanzata, è emersa una nebulosa rancorosa, un magma sociale senza morale. Le classi superiori d’Italia sono le più ciniche di tutte le loro pari nelle altre nazioni. Il popolaccio italiano è il più cinico di tutti i popolacci». (Giacomo Leopardi)
di Piero Bevilacqua (il manifesto, 20.11.2021)
In un Paese nel quale due uomini come Silvio Berlusconi e Matteo Renzi son potuti assurgere al ruolo di presidenti del Consiglio, e il primo ambisce alla Presidenza della Repubblica, con ogni evidenza è accaduto qualcosa di grave nei fondamenti della sua vita civile. Quanto è avvenuto segnala un guasto profondo nell’etica pubblica, un decadimento di vasta portata della moralità collettiva.
Occorre ricordare che i processi di degrado dell’etica pubblica, in atto in Italia, ingigantiscono in virtù dei singolari caratteri originali del nostro Paese, un fenomeno di per sé universale: lo svuotamento ideale e il decadimento della politica quale arte moderna del governo delle società, pratica della sua trasformazione progressiva o rivoluzionaria. Si tratta di questioni note: il tracollo delle ideologie del ‘900, la dissoluzione dei partiti popolari e la loro riduzione a comitati elettorali, la corruzione dilagante, ecc. Questa analisi coglie però una parte della realtà.
La scomparsa dell’antagonista storico del capitalismo (comunismo e in parte socialdemocrazia) ha favorito, insieme ai processi materiali della globalizzazione, la marginalizzazione dei ceti medi e della classe operaia avanzata, che avevano costituito per decenni la base più estesa di consenso e partecipazione pubblica nelle società industriali. Erano questi ceti che garantivano la moralità progressista della politica. La loro regressione sociale, anche per effetto della riduzione del welfare, ha allontanato masse estese dalla militanza politica, dalla partecipazione elettorale, da ogni interesse per la cosa pubblica.
Al loro posto è emersa una nebulosa indistinta di gruppi e individui priva di connotazioni politiche coerenti, che sostituisce rivendicazioni e prospettive di riforma dell’esistente con espressioni rancorose di risentimento, confuse pretese risarcitorie, ostilità contro l’”altro”. Mancando la direzione dell’intelletuale collettivo che erano i partiti, la scena pubblica viene occupata così da un magma sociale a cui politologi e commentatori, in mancanza di meglio, hanno dato il nome di popolo. Un lemma vecchio per una realtà del tutto inedita.
Se un dato distingue le società industriali questa è la loro ricchissima stratificazione sociale. Il popolo è un concetto dell’800 per l’800. Ma l’analisi politologica non ha ancora colto l’essenziale. Dietro la decadenza della politica si erge gigantesco un fantasma che rimane nascosto agli sguardi superficiali: il nichilismo. Quanto profetizzato da Nietzsche, la morte di Dio e la perdita di fondamenti di ogni morale, è ormai senso comune e investe la politica alle radici. Col dissolvimento della religione, la scomparsa, per lo meno in Occidente, delle fedi delle varie confessioni, veicolo pur sempre di valori morali, anche la politica tracolla.
Se la scienza politica, a partire da Machiavelli, fa a meno della religione, la politica corrente muore se nessuna “religione” la sostiene, neppure la fede laica nel bene comune e nella possibilità di cambiare il mondo. E non è senza significato che ad anticipare questi anni sia stato il nostro Leopardi, il quale diversi decenni prima di Nietzsche aveva intravisto «questa universale dissoluzione dei principi sociali, questo caos che veramente spaventa il cuor di un filosofo, e lo pone in grande forse circa il futuro destino delle società civili». Si rilegge oggi con brividi di emozione e stupore il Discorso sullo stato presente dei costumi degli italiani (1824), per la potenza disvelatrice di uno sguardo che non lascia ombre alla situazione desolante del nostro tempo.
Dunque, il quadro generale è quello di una grave involuzione antropologica delle società umane, ma entro il quale, l’Italia è, per ragioni che Leopardi esamina in maniera impeccabile, il Paese in più gravi condizioni: «L’Italia è, in ordine alla morale, più sprovveduta di fondamenti che forse alcun altra nazione europea e civile». Sembra scritto in questi giorni: «Le classi superiori d’Italia sono le più ciniche di tutte le loro pari nelle altre nazioni. Il popolaccio italiano è il più cinico di tutti i popolacci». L’egoismo, il narcisismo, l’invidia, l’odio per l’altro erano allora la norma, prima che gli ideali del risorgimento investissero lo spirito pubblico.
 Naturalmente all’analisi di Leopardi manca il ruolo dei media, i quali amplificano, rendono popolare, materia di spettacolo l’immoralità crescente del ceto politico e della cosiddetta società civile.
Naturalmente all’analisi di Leopardi manca il ruolo dei media, i quali amplificano, rendono popolare, materia di spettacolo l’immoralità crescente del ceto politico e della cosiddetta società civile.So per certo, per parafrasare Leopardi, che se le leggi l’avessero consentito, non pochi giornalisti avrebbero invitato Totò Riina ai loro programmi televisivi. Costoro sono incarnazioni perenni del tipo italiano dell’analisi leopardiana. Ebbene, è dalla profondità di tale catastrofe culturale e spirituale che la sinistra e le forze democratiche dovrebbero oggi prendere le mosse, perché la dissoluzione della società non abbia quale rimedio al caos un governo autoritario.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- "Ridicolo il cicaleccio dei filosofi sulla libertà che staremmo perdendo". Colloquio con Franco Ferrarotti su Covid e vaccino (di Davide D’Alessandro)20 novembre 2021, di Federico La Sala
CULTURA
"Ridicolo il cicaleccio dei filosofi sulla libertà che staremmo perdendo"
Colloquio con Franco Ferrarotti su Covid e vaccino: "È sciocco prendere questo tema e farne motivo di una contesa inutile"
di Davide D’Alessandro (L’HuffPost, 20/11/2021)
Mentre saluto Franco Ferrarotti sulla soglia dello studio di Corso Trieste, ho appena finito di leggere “Osservazioni su La Voce di Giuseppe Prezzolini”, edito da Solfanelli, l’ultima gemma del professore emerito di Sociologia, vincitore del primo concorso della disciplina bandito in Italia. Da quella cattedra è sempre evaso, andando in giro per il mondo a cogliere quanto di nuovo il mondo offrisse, vivendo per scriverlo, per raccontarlo, dopo averlo osservato a fondo, come solo un gigante del pensiero sa fare.
Oggi, a 95 anni, molto vicino ai 100 di Prezzolini, osserva l’intellettuale italiano e lo vede in disarmo: “Eh, cosa vuole che le dica, caro D’Alessandro! Quando il filosofo va a caccia del contenuto, perde la propria essenza e si trasforma in un soggetto ridicolo. La filosofia non è contenuto, ma contemplazione. Ascoltare il cicaleccio di filosofi che si accapigliano sulla presunta libertà che staremmo perdendo, sulla democrazia in pericolo, sullo Stato di eccezione o di emergenza, è una colossale perdita di tempo e io di tempo non ne ho da perdere. Ho scritto su Prezzolini, persona versatile e multiforme, e sulla sua ‘Voce’, anche per riflettere sulla figura dell’intellettuale italiano, nel quale ha sempre luogo un’aoristica contrazione di tutta la storia nella sua biografia”.
È reduce dalla terza dose di vaccino, il professore, ma non si sente affatto un eroe: “Guardi, dobbiamo capire che non c’è altro da fare. È come soffiarsi il naso. C’è poco da stare a discutere. Lungi da me il pensare che si sia trovata la soluzione. Sono tentativi. Non è la prima volta nella storia dell’uomo e non sarà l’ultima. Si tenta, ma di tentativo in tentativo si arriverà a risolvere il problema. È sciocco prendere il tema Covid e farne motivo di una contesa inutile. Quando i filosofi erano impegnati a contemplare, a pensare, venivano fuori grandi libri e grandi idee. Quando si calano sulla cronaca spicciola e credono di potersi inventare chissà quali battaglie, scadono nel ridicolo e, ciò che conta, smettono di produrre opere di senso”.
Ferrarotti, pur non lesinando critiche alle Riviste e ai pensatori di un tempo, soffre per l’evidente cambiamento qualitativo: “La vita delle idee muta registro. C’è un deperimento della funzione ideativa, in una società iper-tecnicizzata, irretita e portata più alla ripetizione che all’invenzione. L’innovazione tecnica può dare l’illusione di grandi novità, ma troppo facilmente si ignora che la tecnica è un valore strumentale e una perfezione priva di scopo, paga di controllare l’esattezza funzionale delle sue operazioni interne”.
In un contesto così fragile e disarticolato, c’è il rischio che tanti esseri umani, come pappagalli, si mettano al seguito, via social o meno, alimentando notizie false, soffiando sul malcontento generale, di chi vorrebbe organizzarli per denunciare qualcosa che non esiste. Al mattino abbiamo davanti a noi i giornali, dove si delinea la farsa quotidiana sul vaccino e sul green pass. Al pomeriggio è possibile far visita a chi i giornali continua a leggerli, sapendo discernere la fuffa dalla polpa. Ritirato nel suo studio, ma non ritirato dal mondo, il pensatore conviene che non vi sia in giro alcun Giordano Bruno. L’eresia, il dissenso, la capacità di dire no, restano per Ferrarotti le coordinate irrinunciabili di un libero pensatore, ma eresia, dissenso e capacità di dire no impongono un prezzo da pagare, non da riscuotere. Nella società della conoscenza e della comunicazione manca la voce di Prezzolini, ma altre voci, fingendo di pensare altrimenti, bombardano i nostri giorni così complicati. Dalla qualità alla quantità.
È davvero questo il destino della filosofia? Il professore accenna un sorriso amaro. È ora di andare a pranzo. C’è da pensare a un altro libro, a un libro altro.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- L’IMPERO INCESTUALE, IL "DESIDERIO DI CONOSCERE" E IL "DIVIETO DI SAPERE". Non stupitevi che questi appunti siano l’eco delle mie preoccupazioni attuali (di Paul C. Racamier, 2002).2 novembre 2021, di Federico La Sala
DESIDERIO DI CONOSCERE E DIVIETO DI SAPERE ∗
di Paul C. Racamier∗∗
Qualche disturbo di voce mi impedisce purtroppo di presentare direttamente il mio breve lavoro. Mi dispiace anche perché apprezzo molto queste Giornate di Studio. Tuttavia abbiamo la fortuna di ascoltare il mio contributo letto da una voce amica che sarà così gentile da utilizzare la sua voce per ringraziarvi dell’attenzione.
D’altra parte ho solo alcune annotazioni da presentarvi che spero non saranno troppo dispersive. Non stupitevi che questi appunti siano l’eco delle mie preoccupazioni attuali.
Sappiamo bene che il desiderio della conoscenza si alimenta ad una sorgente essenziale, cioè al desiderio di conoscere i segreti della sessualità, partendo da quella dei genitori. Tornerò alla fine sulla questione dei segreti.
Questa curiosità essenziale si origina quindi nella camera dei genitori. Tuttavia la fonte non basta. Essa necessita anche - permettetemi una o due immagini alla mia maniera - di uno spazio e di un letto. Lo spazio consiste in un’area di discrezione che avvolge l’attività sessuale dei genitori in maniera da svolgere una funzione di "para-eccitazione". Senza questa area di discrezione - che é quasi un’area di transizione - non ci sarebbe spazio nel bambino per fabbricare il fantasma e tesserlo; senza questa area di para-eccitazione la sessualità dei genitori sarebbe davvero solo una seduzione invadente, un’effrazione traumatica, come venne descritta da Freud e come la si può incontrare ancora oggi nella pratica clinica.
In tal caso la psiche del bambino viene portata, direi perfino trascinata nel temibile ambito dove il sessuale non psichizzato rimane allo stato grezzo; un ambito dove non rimane spazio per il lavoro dello psichico sul sessuale; un ambito la cui espressione ultima è costituita secondo me dall’incesto e in modo più ampio dall’incestualità, cioé dal corto-circuito e dall’esclusione di qualsiasi elaborazione lipidica, dato che l’incestuale non é altro che il colmo dell’anti-libidinale.
Non anticipiamo troppo. Ma vale la pena di porsi da adesso una domanda: se il desiderio di sapere é per l’uomo un’estensione del desiderio di conoscere i segreti del sesso, bisogna chiedersi a quale condizione tale estensione sia possibile. Come mai questa curiosità si estende ad altri tipi di sapere? Perché ciò avvenga è indispensabile che le sia lasciato lo spazio. Bisogna che quell’area di elaborazione a cui accennavo sia preservata. Ora, l’effrazione genitoriale, se avviene, è traumatica nel senso che invade o distrugge quest’area di discrezione. Perché si sviluppi la voglia di sapere, bisogna prima che il sapere non sia stato piantato come un chiodo nella testa e nel corpo del bambino. Il sapere, per crescere, ha bisogno di essere avvolto da un materasso di silenzio.
Una fonte, dicevo. A questa fonte serve un letto. Questo letto è quello che io chiamo il pensiero delle origini. Mi sembra che questo pensiero giochi una parte essenziale nello sviluppo armonico della vita psichica. Non si limita affatto alla conoscenza o al fantasma delle nostre origini; non consiste nella ricerca delle cause. Rappresenta un’intera modalità del funzionamento psichico e sono tentato di situarla al di sotto dei processi primario e secondario del pensiero senza i quali niente si può apprendere né sapere.
Con "pensiero delle origini" intendo la capacità fondamentale e indelebile di provare, fantasticare, concepire e pensare che ogni cosa, ogni conoscenza, ogni persona, abbiano delle origini che a loro volta hanno altre origini, e così di seguito. L’origine è quello che precede: è a monte. Non ci sono limiti alle origini ma il pensiero delle origini non corrisponde all’onnipotenza perché è riuscito a passare attraverso la strettoia del lutto originario che inaugura la rinuncia all’onnipotenza. E’ lì che inizia il filo della vita e questo filo sarà vissuto come una creazione personale, o piuttosto, secondo il mio vecchio amico Antœdipo, come una coproduzione dei genitori e di se stesso.
Perdonatemi questa escursione in concetti che sembreranno complessi, a meno che vi siano familiari. Tuttavia questa deviazione ci porta a due affermazioni molto semplici.
1. Il bambino o l’adulto che non è riuscito a confezionarsi un pensiero delle origini, che quindi non ha rinunciato alla conoscenza assoluta e alla padronanza onnipotente delle proprie origini e della propria vita, probabilmente non avrà né la voglia di sapere né la disponibilità interiore, area di silenzio di cui bisogna disporre nel proprio mondo interno, necessaria per investire in nuove conoscenze. Tale è il caso dei soggetti con patologia narcisistica grave. Non sopportano di imparare perché in ogni conoscenza nuova vedono meno quello che avrebbero da guadagnare di quello che, essendogli sconosciuto, gli fa difetto e ferisce il loro irresistibile fantasma di onnipotenza e onniscienza. Accettando di imparare sembrerebbe loro di derogare a questo fantasma; tant’è che per imparare bisogna prima ignorare. Ora l’ignoranza non è altro che una vergognosa debolezza quando la si guarda dall’alto di un narcisismo intollerante. I narcisisti più "accesi" hanno una vera anti-voglia di imparare.
2. L’altro punto è più temerario. Non mi sembra azzardato ritenere che l’imparare e il sapere costituiscano già un atto di creazione. Atto modesto, certo, ma fondamentalmente della stessa natura della creazione vera e propria, e che presenta alcune delle sue caratteristiche principali. Se non è una creazione vera e propria, fa parte almeno della stessa famiglia. Ogni cosa appresa ha infatti questo carattere sia personale che universale che nella sua ambiguità, è propria di ogni cosa creata.
 Come ogni creazione nuova, ogni sapere nuovo provoca un ampliamento ed
un’estensione dell’io. Non da ultimo, l’acquisizione del sapere e anche la sua trasmissione, è
creativa nel senso che è il frutto di una coproduzione. Per imparare bisogna prendere e offrire;
non per caso il verbo apprendere (in francese apprendre) può intendersi secondo due modi
diversi: si può insegnare a qualcuno e apprendere da qualcuno; due correnti pulsionali avverse e
complementari che si completano strettamente in questa attività.
Come ogni creazione nuova, ogni sapere nuovo provoca un ampliamento ed
un’estensione dell’io. Non da ultimo, l’acquisizione del sapere e anche la sua trasmissione, è
creativa nel senso che è il frutto di una coproduzione. Per imparare bisogna prendere e offrire;
non per caso il verbo apprendere (in francese apprendre) può intendersi secondo due modi
diversi: si può insegnare a qualcuno e apprendere da qualcuno; due correnti pulsionali avverse e
complementari che si completano strettamente in questa attività.Vediamo qui come le strade si incrociano. Se é vero che l’esistenza di ciascuno di noi è il frutto di una coproduzione, dato che la vita ci è stata data ma non cessa di sgorgare in noi stessi, se quindi questo fantasma di fondazione è il perno delle origini; e se questo pensiero delle origini è realmente il letto del desiderio e della capacità di apprendere; se infine l’atto di apprendere è in se stesso una sorta di creazione, allora si vede bene che i nostri concetti si raggiungono nel sapere.
Se mi dite che la conoscenza di se stesso attraverso la relazione psicoanalitica è in se stessa il frutto di una coproduzione, ne converrò sicuramente. Se dite che all’origine dei disturbi del sapere e, più in generale, all’origine delle occlusioni gravi della vita psichica c’è uno sbarramento di vecchia data sul pensiero delle origini, ne converrò anche.
Ma basta con queste grandi idee. Volevo parlarvi del piacere. E per quello vorrei parlarvi dei segreti. Esistono due tipi di segreti. Vi sono i segreti libidici, come i segreti dell’alcova e i segreti di corridoio, che parlano sempre del piacere e che presentano il felice paradosso di circolare tra le generazioni rimanendo nell’ambito del privato: quei segreti sono dei serbatoi di fantasmi, delle macchine per pensare e degli stimoli del sapere. Il culto della verità naviga nelle stesse acque di quello del sapere. Li sospetto entrambi di trarre una forza considerevole dall’auto-erotismo: è proprio quando la verità, che non si incontra comunemente per strada, diventa un oggetto di piacere che l’io le corre dietro: non è vero tra l’altro che la verità viene descritta solitamente come una signora che, quando esce, va in giro svestita?
Al contrario esistono dei segreti anti-libidici. Essi impediscono l’accesso alla conoscenza, alla comprensione, allo scambio e al pensiero così come alla parola. Sono dei segreti inibitori. Di generazione in generazione esercitano i loro effetti paralizzanti. Li incontrerete dappertutto dove regna l’impero incestuale. Ciò significa che li incontrerete spesso. Il regno del segreto esercita un’influenza della peggiore specie. Si tratta di un divieto molto crudele e molto primitivo che ostacola ogni sapere per impedire la scoperta di alcuni saperi. Questo divieto di dire, questo divieto di sapere, questo divieto di pensare si esercita non tramite l’Io ma direttamente sull’Io, nel cuore stesso dell’Io. Perciò penso che sia molto diverso dal Super Io edipico.
Si potrebbe dire che il Super Io edipico prende l’io da parte e gli ingiunge: "Tu, Io, dirai ai tuoi amichetti, i fantasmi erotici, di tenersi tranquilli e di non fare troppo baccano in fondo alla classe". E l’Io obbedisce più o meno. Ecco come si comporta un Super Io di buona compagnia.
In un regime incestuale e sotto l’impero di un narcisismo abusivo e perforante, come quello che abbiamo visto trasgredire le aeree di transizione e di para-eccitazione di cui l’Io ha bisogno per svilupparsi, succede tutt’altro; sembra che una forza pressante prema l’Io da tutte le parti, gli prenda la testa, gli tappi gli occhi e le orecchie e gli imponga gradualmente un divieto assoluto di imparare, e perfino di pensare. "Se sai, dice, se vuoi sapere, se pensi, allora mi fai morire e muori".
Il Super Io edipico vieta l’incesto ma ne lascia passare il desiderio e il fantasma; lascia anche passare il desiderio di sapere e il piacere di desiderare; all’opposto l’oppressione appena descritta e che chiamerei volentieri, usando un neologismo, un super-anti-io, questa oppressione crudele permette l’incesto ma non lascia spazio al desiderio nonché al sapere, alla conoscenza e al pensiero.
Così viene confermato dal suo contrario quello che sappiamo da sempre: che la conoscenza e il piacere sono legati tra di loro e con la vita. La mia lettrice ed io vi ringraziamo per l’attenzione.
∗ Desiderio di conoscere e divieto di sapere di Paul C. Racamier Gennaio - Giugno 2002. Ringraziamo la Sig.ra Racamier per la gentile concessione alla pubblicazione di questo lavoro e l’Editore del “Bulletin de l’ACIRP” che ha pubblicato gli Atti del Convegno “Envie de savoir, envie d’apprendre”, Besançon, 23 marzo 1996.
∗∗ Traduzione in italiano a cura di Josiane Lots.
Fonte: Quaderno di Psicoterapia del Bambino e dell’Adolescente (2002) Vol. 15, pp. 11-15. 2
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- Sulla lettera dei filosofi contro Agamben (di Luca Illetterati - "Le parole e le cose")).19 ottobre 2021, di Federico La Sala
Sulla lettera dei filosofi contro Agamben
di Luca Illetterati (Le parole e le cose, 19 ottobre 2021)
Il difetto principale dei filosofi, diceva Hegel - che un po’ se ne intendeva - è la pretesa che essi hanno di insegnare al mondo come il mondo dovrebbe essere. Come se il mondo fosse ogni giorno lì ad aspettare che arrivasse il pensatore di turno a dirgli che vestito indossare al sorgere del sole. Questa malefica tentazione sembra diventata tanto più evidente all’interno del periodo di crisi pandemica che stiamo vivendo. E non si sta qui parlando solo delle posizioni oramai notissime di Giorgio Agamben contro le quali chi scrive ha anche aspramente e pubblicamente polemizzato ritenendole posizioni che rischiano di sfociare in forme di complottismo populistico, o che comunque dimostrano quanto gli occhiali ideologici dei dispositivi che si sono elaborati per leggere il mondo rischino di deformare radicalmente ciò che il mondo mostra di sé.
A leggere infatti la lettera ‘contro Agamben’ firmata da un numero considerevole di filosofi italiani e pubblicata il giorno 16 ottobre sul “Fatto quotidiano” viene davvero da pensare che questi oppositori filosofici delle posizioni agambeniane siano forniti di occhiali perlomeno altrettanto deformanti e, verrebbe da dire, anche un po’ più dozzinali di quelli di cui vorrebbero mostrare la debolezza e gli effetti distorcenti. La lettera muove da un tono scandalizzato per il fatto che Giorgio Agamben è stato audito in una commissione al Senato sulla questione Green Pass.
Scandalo, evidentemente, del tutto immotivato. Agamben non è stato invitato in quanto rappresentante di una comunità filosofica che andrebbe perciò difesa dal rischio di essere confusa con le posizioni assai controverse di un singolo filosofo, ma in quanto persona autorevole - piaccia o meno, rientri o meno nelle pagelline che pretendono di dare patenti di filosoficità, è il filosofo italiano più noto al mondo - che ha una posizione molto discutibile (e forse anche per questo interessante) sulla questione del Green Pass. Una posizione che taluni pensano sia un bene che chi legifera abbia presente. Non necessariamente per accoglierla, ma ad esempio anche solo per capire se offra argomenti che possono essere tenuti presente per fare poi, con maggiore consapevolezza, magari il contrario di quello che Agamben vorrebbe. Dopo di che la lettera entra nel merito di ciò che Agamben ha sostenuto in quella audizione (e in generale in questi mesi).
In primis, dicono i filosofi che sembrano certi di abitare dalla parte giusta del mondo e della storia, è falso sostenere, come ha fatto Agamben nell’audizione, che i vaccini anti-covid19 siano in una fase sperimentale. Giusto. I vaccini sono stati infatti testati. Ribadendolo, però, forse non sarebbe fuori luogo dire che è altrettanto vero che la somministrazione dei vaccini è iniziata - a mio parere giustamente e per un atto di responsabilità politica che andrebbe esplicitamente rivendicato e non nascosto - prima che tutti gli step cui solitamente viene sottoposto un farmaco fossero conclusi.
Come noto, infatti, solo nell’agosto del 2021 (quando cioè il vaccino era già in uso) la Food and Drug Administration americana ha fatto uscire il vaccino Pfizer-Biontech da quella che non a caso viene chiamata - con un termine che fa evidentemente gioco ad Agamben - emergency use authorization, ovvero approvazione emergenziale. E infatti solo da quel momento un governo che si volesse assumere quella responsabilità potrebbe introdurre l’obbligo vaccinale. Per l’Agenzia Europea del Farmaco, invece, i vaccini sono ancora sottomessi a CMA (Conditional Marketing Authorisation), ovvero ad autorizzazione al commercio condizionata, la quale è lo strumento utilizzato per accelerare l’approvazione dei medicinali durante un’emergenza sanitaria pubblica o per affrontare esigenze mediche non soddisfatte. Non dire queste cose e far credere che la somministrazione del vaccino abbia seguito una prassi standard vuol dire o non voler riconoscere l’eccezionalità decisionale che la situazione ha richiesto o voler far credere qualcosa che non corrisponde al vero.
Il secondo punto su cui si sofferma la lettera dei filosofi che non vogliono essere confusi con Agamben è che sarebbe improprio sostenere che ci troviamo in un’epoca in cui l’eccezionalità è diventata la regola al fine di esercitare da parte dello Stato un controllo sulla cittadinanza, sul modello di quanto fatto da forme di dispotismo come quello sovietico. Le analogie sono sempre pericolose, tanto più quando mettono di mezzo la storia e il dolore che la attraversa. E Agamben su questo è spesso fastidiosamente e gravemente fuori luogo. Tuttavia, non riconoscere che c’è una parte importante della riflessione filosofico-politica contemporanea che insiste sulla giustificazione sempre più emergenziale delle forme del potere politico, vuol dire aver deciso a priori che c’è in tutto il mondo una discussione che non dovrebbe trovare in realtà ospitalità nel mondo. Il che o rientra nella patologia denunziata da Hegel, o è una posizione frutto di ignoranza, o, più probabilmente, è, ancora una volta, una posizione banalmente ideologica.
Il terzo e il quarto punto della lettera sono forse i più delicati. Contro quanto sostenuto da Agamben, i filosofi che si vogliono corretti e informati sostengono che l’adozione del Green Pass non induce nessuna discriminazione tra classi di cittadini e non è, di conseguenza, in alcun modo una forma di repressione delle libertà individuali. Sostenere il contrario - dicono - sarebbe come sostenere che l’istituzione della patente di guida, fatta per limitare il più possibile il numero e l’entità degli incidenti stradali, determini una distinzione tra cittadini di serie A e cittadini di serie B, ovvero che l’obbligo della patente sia anch’esso una forma di lesione delle libertà dell’individuo. L’argomento della patente, come è noto, è uno degli argomenti preferiti sui social media, in particolare su Facebook, e francamente da una così prestigiosa comunità scientifica ci si poteva forse attendere qualcosa di più. In realtà è ovvio che il Green Pass produce una forma - niente affatto banale - di discriminazione. A cittadini che non stanno trasgredendo nessuna legge (perché non vaccinarsi è legale e legittimo) è di fatto impedita una forma di vita sociale minima degna di questo nome: essi, infatti, se non muniti di Green Pass non possono entrare in un’aula universitaria, in una biblioteca, in un teatro, nel luogo di lavoro, su un treno ad alta velocità, a una riunione di partito, a un’assemblea condominiale, in un locale pubblico. E tutto questo non sarebbe discriminatorio? Certo che lo è! All’argomento di Agamben che denunzia le implicazioni discriminatorie del Green Pass non si dovrebbe rispondere negando l’evidenza, ovvero, detto altrimenti, contrapponendo ideologia a ideologia. Una risposta forse un po’ più seria dovrebbe dire: sì, il Green Pass è una norma discriminatoria della quale dobbiamo farci carico, è una forma di ‘ingiustizia’ della quale una società degna di questo nome in certi momenti è chiamata a farsi problematicamente carico, sapendo e dicendo che sta facendo una cosa del tutto fuori dalla norma. Una società responsabile è una società che riconosce esplicitamente le situazioni di deviazione che la sua sopravvivenza richiede. Si chiama - verrebbe da dire - politica, ossia capacità di assumere decisioni non garantite circa il loro esito, di intraprendere azioni che escono dagli automatismi di ciò che è già deciso. Dire ad Agamben, come dicono i tanti filosofi che hanno firmato la lettera, che non è vero che c’è discriminazione, significa, di fatto, dare ragione ad Agamben, fornire cioè argomenti ancora più forti alla sua narrazione.
Il filosofo - è sempre Hegel che lo dice - è colui che è chiamato a problematizzare l’ovvio, a mostrare le implicazioni che abitano in esso, a evidenziare le conseguenze che la sua mera assunzione produce. Forse è questo quello che ci si attende dalla filosofia nel momento in cui entra nel dibattito pubblico. Non che ci dica, cioè, quali sono gli occhiali buoni per vedere “davvero” il mondo; ma che ci aiuti invece a capire cosa un certo tipo di occhiali o un altro ci impediscono di fatto di vedere.
NOTA:
DANTE, "L’OMBRA D’ARGO", E “VENTICINQUE SECOLI” DI LETARGO...
SE è VERO CHE "Il difetto principale dei filosofi, diceva Hegel - che un po’ se ne intendeva - è la pretesa che essi hanno di insegnare al mondo come il mondo dovrebbe essere" E AL CONTEMPO che " [....] Il filosofo - è sempre Hegel che lo dice - è colui che è chiamato a problematizzare l’ovvio, a mostrare le implicazioni che abitano in esso, a evidenziare le conseguenze che la sua mera assunzione produce" (Luca Illetterati, "Sulla lettera dei filosofi contro Agamben", cit.. - sopra),
forse, è bene in via preliminare chiedersi
MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA E A PENSARE BENE "DIO", "IO" E "L’ITALIA", CHI PIÙ CHI MENO, TUTTI VIVONO DENTRO LA PIÙ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA E POLITICA ITALIANA
rimeditare sul "concetto di gusto" e ripensare al "mitolegma di Eros" e all’ intelletto d’amore (cfr. Giorgio Agamben, "Gusto", Enciclopedia Einaudi, 6, Torino 1979, p. 1036),
e
decidersi se si vuole proseguire sonnambulicamente sulla strada di Hegel o svegliarsi e riprendere il cammino di Dante (cfr. Note per una riflessione storiografica).
La crisi è epocale ed è antropologica.
Kant alla fine del suo percorso l’ha ben chriarito. Urgente e necessario rispondere alla "domanda" e mettere in moto un processo di ristrutturazione planetaria.
Federico La Sala
-
> SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA E PENSARE BENE "DIO", "IO" E "L’ITALIA" ---FILOLOGIA: RICORDANDO LORENZO VALLA, UNA NOTA IN MEMORIA DI TEOFILO DI ANTIOCHIA (13 OTTOBRE 2021).13 ottobre 2021, di Federico La Sala
"ECCE HOMO": MESSAGGIO EVANGELICO E FIGLIO DELL’UOMO ["Filius hominis", "υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου]! - "Allora la folla gli rispose: «Noi abbiamo appreso dalla Legge che il Cristo rimane in eterno; come dunque tu dici che il Figlio dell’uomo deve essere elevato? Chi è questo Figlio dell’uomo?»"(Gv. 12,34).
- TEOFILO DI ANTIOCHIA: "Ma se tu mi dici - scriveva l’antico Vescovo: - Mostrami il tuo Dio, io ti dirò: Mostrami il tuo uomo ["tuum hominem", "tòn anthropón", e io ti mostrerò il mio Dio. Mostrami dunque che vedono chiaro, gli occhi della tua anima, e che bene intendono gli orecchi del tuo cuore...
- " Dio si mostra a coloro che possono vederlo, quando hanno aperti gli occhi dell’anima. Tutti hanno i loro bravi occhi, ma qualcuno li ha velati, incapaci di vedere la luce del sole. Il fatto però che i ciechi non vedono, non dimostra affatto come la luce del sole non appaia. I ciechi se la prendano con loro stessi, e con i loro occhi.
- "Allo stesso modo, ragazzo mio, se tu hai gli occhi dell’anima velati dalle tue colpe e dalle tue cattive abitudini, non potrai vedere la luce. Come uno specchio limpido: ecco come l’uomo deve tenere la propria anima pura. " Se lo specchio è arrugginito, il volto dell’uomo non appare sulla sua superficie. Nello stesso modo, se l’uomo è peccatore, quest’uomo non può contemplare Dio "(cfr. San Teofilo d’Antiochia, vescovo e teologo)
A SCUOLA DI "ANDROLOGIA" DI PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ, ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).
FLS
-
> PENSARE BENE "DIO", "IO" E "L’ITALIA" ---ANTROPOLOGIA, FILOSOFIA, E "UNA GRANDE VICENDA COSMOTEANDRICA". La ricerca della verità. Un testo inedito (di Luigi pareyson).12 ottobre 2021, di Federico La Sala
UNA VISIONE ANDROLOGICA DI DIO, "UNA GRANDE VICENDA COSMOTEANDRICA", E LA FILOSOFIA... *
Inedito.
Pareyson, la ricerca della verità smonta il relativismo
Mentre continua l’edizione dell’opera completa del grande pensatore italiano, nell’ultimo volume una riflessione che smonta le teorie del relativismo postmodernista
di Luigi Pareyson (Avvenire, sabato 9 ottobre 2021)
- [Foto] Il filosofo Luigi Pareyson, di cui ricorrono i trent’anni della morte
- Luigi Pareyson aveva suggerito, prima di morire nel 1991, di ripartire i 24 saggi contenuti in questo volume in quattro sezioni: filosofia dell’esistenza, idealismo, esistenzialismo positivo e spiritualismo cristiano, dibattiti odierni, più un’appendice intitolata “La filosofia italiana alla fine degli anni Quaranta”. Alcuni di questi scritti, nonostante la loro freschezza, sono di data lontana (il saggio su Spirito e Della Volpe del 1947, quello su Marcel del 1948) mentre altri sono di data ben più recente (uno su Guzzo è del 1987 e uno su Maddalena del 1989). Ma, in questo Prospettive di filosofia contemporanea, XVII volume delle Opere complete curato da Francesco Tomatis (Mursia, pagine 638, euro 34,00) sono compresi anche saggi su Croce, Martinetti, Abbagnano, Stefanini, Soleri, mentre nell’“Appendice” trova posto un inedito - che qui in parte anticipiamo - sulla ricerca della verità. Un discorso che mette in guardia dall’idea relativistica che non esista o non si possa attingere una verità, ma anche dal rigorismo che ne dà un’affermazione assoluta.
Fui tra gli introduttori dell’esistenzialismo in Italia nella seconda metà degli anni 30. Un mio articolo del ’38 per la prima volta in Italia accostava Heidegger e Jaspers. Il mio libro del ’40 su Jaspers era in realtà uno sguardo d’insieme su tutto l’esistenzialismo. Entravo nel vivo dell’attualità, non solo perché allora l’esistenzialismo era l’ultima voce della filosofia, ma anche perché alla fine della guerra, dopo la liberazione, entrava nella nostra cultura il marxismo, di cui l’esistenzialismo è l’alternativa naturale, storica. Infatti, esistenzialismo e marxismo sono le due possibilità tipiche della dissoluzione dell’hegelismo, che si erano presentate in alternativa cento anni prima sulla scena europea: da un lato la linea Feuerbach-Marx, dall’altro la linea Kierkegaard. Queste due possibilità riemergono a distanza di duecento anni sulla scena filosofica europea: entrambe legate alla filosofia hegeliana di cui erano la dissoluzione, e legate fra di loro in antitesi. La problematica era comune, le soluzioni erano opposte. Sì che ogni antitesi al marxismo doveva assumere necessariamente in qualche modo un aspetto esistenzialistico; e il marxismo rinasceva (neomarxismo) come necessariamente antiesistenzialista. E ciò sebbene, ripeto, la loro problematica fosse comune.
Ora, se l’attualità era contenuta nella dissoluzione dell’hegelismo, ciò attesta la centralità della filosofia hegeliana da centocinquanta anni ad oggi. Hegel è il culmine della filosofia moderna e come tale è da un secolo e mezzo un punto di riferimento obbligato. E se attuale e interessante era studiarne la dissoluzione, altrettanto interessante e attuale era studiarne la genesi nella filosofia europea, cioè studiare nei suoi predecessori quelle critiche ante litteram che dovevano poi agire come germi di dissolvimento. È dunque per una ragione squisitamente teoretica, speculativa, che ho studiato sia Fichte che Schelling, che prefigurano quella polemica antihegeliana ch’è ancor oggi il colmo dell’attualità, anche perché certe forme di neomarxismo si possono considerare in fondo come un recupero dell’hegelismo [...].
Ho detto che il marxismo è una forma di storicismo assoluto, e in ciò rientra o perlomeno s’incontra con un movimento più ampio, che interessa larghi strati della nostra cultura, che, educata dall’idealismo allo storicismo, lo ha poi proseguito in una forma di totale relativismo, che sopprime totalmente il concetto di verità. Tutti sono d’accordo oggi (meno forse i metafisici vecchio stile, che non hanno fatto la differenza tra metafisica e ontologia) nel ritenere che non c’è formulazione definitiva della verità, che il dovere morale è annunciato in maniera diversa a seconda dei tempi, che ogni epoca ha la sua concezione della bellezza, che ogni popolo ha una suaWelt-Anschauung, e così via. Da questa giusta constatazione il relativismo deriva la conclusione che non c’è nulla di fisso e di stabile, che i valori sono relativi al loro tempo e non contengono nulla di assoluto, che insomma le idee non sono se non espressione del tempo, e che la verità non esiste.
Ora questa conclusione, francamente, prova troppo: va molto oltre le premesse. Si formula un’antitesi che anche formalmente è falsa: o esiste una verità assoluta e definitiva, o non c’è nulla di vero perché tutto è relativo. Il fatto è che è ben vero che non c’è formulazione definitiva, assoluta, universale, della verità, ma ciò non toglie che ciascuno debba cercare la verità e possa trovarla a suo modo e considerarla come assoluta, beninteso assoluta per me che l’ho cercata e che ne sono convinto e magari tento di convincerne gli altri, ma sempre rispettando essi stessi e la loro verità, ed esponendo alla discussione e alla contestazione altrui pronto ad abbandonarla se me ne dimostrano l’insufficienza, ma a difenderla se ne sono in buona fede convinto.
Insomma esiste una verità assoluta, ch’io debbo cercare con tutte le mie forze e tentare di formulare a modo mio. Certo, il cammino è accidentatissimo: la verità bisogna cercarla, ed ecco qui tutto il rischio della ricerca, il costante pericolo del fallimento, la serie continua degli insuccessi; poi bisogna trovarla, e darne una formulazione, ma anche qui il rischio è grandissimo, perché c’è il pericolo non solo di non saperla formulare, ma lasciarla nel vano e nell’indistinto, ma anche di irrigidire e assolutizzare per sempre, il che è non solo impossibile, ma anche illusorio ed erroneo e falsificante.
Tutto ciò io soglio esporlo dicendo che verità e persona sono inseparabili, che la formulazione della verità è sempre storica e personale, che la verità è unica ma la formulazione che se ne dà, cioè l’interpretazione che se ne propone, è sempre molteplice, e che l’unità cioè l’orizzonte del vero è il dialogo che attraverso il consenso o la discussione polemica si instaura fra queste molteplici e diverse interpretazioni della verità, che la verità non si offre se non all’interno dell’interpretazione che se ne dà, che l’interpretazione che si dà sempre singolarmente della verità non è una semplice approssimazione alla verità, non è un possesso della verità, anzi la verità stessa come personalmente posseduta, che il pensiero è sempre storico, personale, molteplice, mutevole, cioè espressivo, ma oltre a questo pensiero ch’è soltanto storico ed espressivo (che è quello che il relativismo considera come unico, cioè assolutizza) c’è anche un pensiero che, al tempo stesso ch’è storico, personale, espressivo, è anche rivelativo della verità (sempre da un angolo personale) che il relativismo non considera, ingannato dall’aspetto ch’è comune a entrambi, cioè la storicità, la mutevolezza, l’aspetto espressivo.
Il relativismo, sopprimendo la verità, è il padre di quello che si chiama crisi dei valori, dello scetticismo d’una parte della gioventù d’oggi e dell’irrazionalismo a cui per contraccolpo un’altra parte di essa si aggrappa, della totale incertezza della distinzione fra bene e male, anzi dell’indifferenza verso questa distinzione, con la conseguenza che tutto è egualmente lecito, donde lassismo, permissivismo, e, in fondo, disperazione e peggio. Ciò voleva dire Dostoevskij quando sosteneva: Se Dio non esiste, tutto è permesso. E soggiungeva: anche l’antropofagia. E infatti, se non c’è distinzione fra bene e male, perché escludere come male l’antropofagia? Per via consequenziale, ne potrebbe derivare, alla Jonathan Swift, una "modesta proposta": introduciamo l’antropofagia, che potrebbe essere la soluzione dei preoccupanti problemi della sovrappopolazione del globo e delle decrescenti risorse della terra.
La meditazione che ho così condotto mi ha portato ad affrontare il problema del male e della sofferenza, che con tanta intensità affliggono il genere umano, come s’è abbondantemente potuto constatare proprio in questo secolo. È a questo problema che mi sono dedicato negli ultimi anni e nel quale sono attualmente impegnato.
Qui si presenta una constatazione preliminare, ed è che la filosofia si è dimostrata generalmente incapace di affrontare validamente questo problema. È solo da Kant, attraverso Schelling, in parte Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, l’esistenzialismo, che si è cominciato ad approfondire questo problema. Esso si trova invece egregiamente affrontato in quello che si può chiamare mito, nel senso più intenso del termine, cioè nell’arte, specialmente nella tragedia, sia antica come quella greca sia moderna come Dostoevskij, e nella religione, specialmente nella religione biblica e cristiana.
Anche i filosofi che meglio hanno trattato il problema vi sono riusciti più come cristiani che come filosofi: alludo, ad esempio, a S. Agostino e Pascal. Dostoevskij non è stato un filosofo, ma la filosofia ha molto da imparare da lui, perché nessuno scrittore ha meditato con tanta profondità come lui sulla tragica condizione dell’uomo, così inesauribile nel fare e subire il male e così facile preda della sofferenza.
E nessuna religione come la cristiana ha saputo interpretare l’uomo alla purissima luce del male e del dolore, al punto da coinvolgervi la stessa divinità. Già Hegel aveva messo la tragica vicenda del Dio sofferente e redentore al centro della stessa filosofia, ma per un paradossale capovolgimento ne era risultato un sistema che giustifica e quindi nega sia la sofferenza che il male.
L’idea profonda della presenza del male e del dolore in Dio stesso, cioè al centro della realtà, come una grande vicenda cosmoteandrica, sta al centro dell’esperienza religiosa cristiana: saper penetrare con la riflessione filosofica in quel mistero, e renderlo parlante per tutti gli uomini, credenti o non credenti, può essere il compito e l’ambizione d’una filosofia che sappia imparare dall’esperienza religiosa senza pretendere di tradurla in termini filosofici e senza asservirsi ad essa, ma parlando il proprio linguaggio e mantenendo la sua rigorosa autonomia.
NOTE:
- IL "MESSAGGIO EVANGELICO" DI PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ, ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).
- LA "RICAPITOLAZIONE" DI SAN PAOLO, ANTROPOLOGICAMENTE, ZOPPA E CIECA, A MISURA DEL FIGLIO PRIMOGENITO (MAGGIORASCATO):"[...] tutto il mondo, soggetto alla «vanità» e alla «corruzione» per il peccato di Adamo, attende gemendo la liberazione dal male e «tutta la creazione sarà liberata dalla servitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio». «Primogenito di tutta la creazione», Cristo, facendosi uomo e immolandosi sulla croce, «riunisce e riassume» tutti gli esseri - terrestri e celesti - e li riconcilia al Padre: si attua cosi il «mistero» della redenzione che Dio ha concepito da tutta l’eternità [...]" (cfr. Tullio Gregory, Giovanni Scoto Eriugena: tre studi, Firenze, Le Monnier, 1963: "II. Mediazione e Incarnazione", pp. 34-35 ).
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- Un modello di lavoro intellettuale: in ricordo di Salvatore Veca (di Gianfranco Pellegrino).8 ottobre 2021, di Federico La Sala
Un modello di lavoro intellettuale: in ricordo di Salvatore Veca
di Gianfranco Pellegrino (Le parole e le cose, 8 ottobre 2021)
Nel 2006, ricordando il suo ‘dispatrio’ in Gran Bretagna, Luigi Meneghello diceva: «Nell’immediato dopoguerra, il partito che incarnava la mia idea di politica è andato a farsi benedire fin dal primo congresso. Il nuovo partito perfetto avrebbe dovuto essere il Partito d’Azione. Purtroppo, nessuno votava per noi, neanche le nostre fidanzate, mi sa, perché i voti che prendevamo erano uguali al numero degli iscritti (...). Dopo i primi due anni del dopoguerra, mi sono accorto che le cose andavano male, che il Paese aveva scelto diversamente, si era diviso in due campi, e ho pensato: in questo mondo non ho più niente di utile da fare»[1]. Per molto tempo, il nostro paese è rimasto diviso in due campi, in politica come nella cultura, e chi non si riconosceva in quei due campi era destinato alla marginalità. Uno dei meriti di Salvatore Veca (scomparso nella notte fra mercoledì 6 e giovedì 7 ottobre, era nato nel 1943) è stato di avere contribuito moltissimo a fare della cultura italiana - e soprattutto della cultura filosofica del nostro paese - un luogo più plurale, meno diviso, più aperto alla discussione internazionale.
Se molti studiosi italiani discutono con colleghi di tutto il mondo, sia in Italia sia all’estero, se certi temi sono ormai di casa nelle nostre università e molti nostri connazionali insegnano all’estero è anche grazie ad alcune operazioni culturali intraprese e portate a termine con successo da Veca. Il contributo di figure come la sua alla sprovincializzazione di una certa cultura italiana è stato enorme. Ma si badi: il fatto non è solo che Veca ha introdotto nella discussione certi metodi - i metodi della filosofia politica analitica di lingua inglese -, certi autori - Rawls, principalmente, ma anche Walzer, Nozick, Williams e Nagel -, certi temi - la teoria etica normativa -, né conta solo il lavoro culturale e intellettuale in senso più ampio da lui compiuto - in istituzioni culturali come la Casa della cultura e la Fondazione Feltrinelli di Milano, ma anche in case editrici e nell’università di Pavia e nella politica militante della sinistra italiana, dove Veca ha partecipato all’evoluzione riformista di parte del PCI. Ci sono aspetti della figura e del modello di lavoro intellettuale di Veca che sono forse meno evidenti di questi, ma su cui varrebbe la pena riflettere, ora che chi li incarnava ci ha lasciati. E su questi mi vorrei soffermare, per dare un ricordo da lontano, per così dire - il ricordo di chi proviene da una generazione diversa e posteriore e ha osservato da una certa distanza il lavoro di Veca, pur venendone in parte influenzato.
Figure come quella di Veca hanno costruito un modello di lavoro intellettuale preciso e inedito - inedito nel nostro paese, ma forse anche in altri contesti. Si tratta di un modello di lavoro intellettuale più sfuggente e meno estremo di quanto si potrebbe pensare a uno sguardo superficiale, e che ha messo a frutto il meglio di mondi diversi. Veca non è stato un filosofo analitico nel senso tradizionale (e talvolta caricaturale) del termine - concentrato esclusivamente su questioni tecniche, poco interessato alla storia del pensiero, esitante nella costruzione di grandi sintesi o affreschi. Nonostante una grande abilità tecnica, egli ha sempre mirato a costruire un orizzonte complessivo, con l’obiettivo di incidere sulla realtà politica e sociale. In un certo senso, Veca ha abbandonato l’orizzonte teorico del marxismo italiano tradizionale, e soprattutto la filosofia della storia di Marx (o almeno una certa interpretazione di essa) senza per questo rinunciare a una certa idea di militanza tipica del marxismo e a un’ambizione di egemonia culturale. Veca non ha mai rinunciato all’aspirazione di cambiare il mondo, un’aspirazione che gli derivava anche e soprattutto da una tradizione illuminista che ereditava da autori come Norberto Bobbio e Uberto Scarpelli.
Ma allo stesso tempo Veca ha abbandonato, e reso piuttosto ridicoli, tutti gli stilemi tipici di certa filosofia tradizionale italiana del suo tempo (un modo di procedere sopravvissuto in alcuni casi anche adesso) - una filosofia tutta ortodossia e conformismo, tutta erudizione fine a se stessa, di andamento oracolare e con ambizioni spesso tiranniche di politica culturale. Al contrario di molti, Veca è riuscito nel raro tentativo di esercitare influenza, di prendere posizione, partendo però dall’idea che le società siano necessariamente pluraliste e il consenso sia da costruire, non da imporre.
Veca ha messo insieme il meglio di molte tradizioni e ha perseguito una via media tra modelli estremi in una maniera inimitabile. Ha prestato attenzione alle grandi figure della storia della filosofia politica e dell’etica, facendone spesso tesoro. Ma ha volto la sua attenzione a scopi militanti, per così dire. Come amava dire, ha saccheggiato i templi del passato: tutte le sue letture servivano a edificare un paradigma complessivo e gli strumenti che usava derivavano dalle frontiere della ricerca filosofica contemporanea. Non ha mai rispettato steccati, spaziando dall’epistemologia alla teoria etica normativa, alla politica normativa, alle etiche applicate. Anche in questo caso, si tratta di un modo di procedere che trova paragoni in alcuni grandi figure della filosofia di lingua inglese - Nagel, Williams e Parfit, ma non Rawls, per esempio, che è stato molto meno ampio e più monomaniaco, per così dire.
Ma la cosa più rilevante, a mio parere, è il modello di filosofia pubblica che Veca ha tentato di realizzare. Come ho detto, Veca non ha mai esitato a intervenire nella discussione pubblica, a tutti i livelli. Anzi, per molto tempo, si è impegnato, come dicevo sopra, nella politica militante, facendo scelte molto controverse e subendone le conseguenze. Eppure, in tutto questo non ha mai fatto tre mosse che sono invece diventate tipiche del modello oggi preponderante di intellettuale pubblico. In primo luogo, Veca non ha mai assunto, né cercato pose da divo: non ha evitato le apparizioni, ma non le ha mai cercate. Le ha sfruttate, non le ha subite. Veca non ha mai avuto una gestione social della sua figura: non ha cercato di alimentare continue esposizioni, non ha costruito un marchio, non ha inseguito nessun pubblico. Non ha costruito dal nulla un pubblico di clienti. Ha educato un pubblico di pari. In secondo luogo, Veca ha creduto profondamente nella funzione dell’università: per lui la filosofia (anche la filosofia pubblica) è sempre stata la filosofia che si fa nelle università, con certi strumenti, e a partire da una certa expertise. L’impegno di Veca non si è mai trasformato in anti-accademismo. Anche in questo caso, Veca ha conservato la fiducia nelle istituzioni, anzi il gusto di vivere e costruire istituzioni, tipico della sinistra tradizionale del nostro paese. Infine, l’estrema chiarezza del suo linguaggio, la ricerca, talvolta, anche di uno stile cordiale ed elegante non hanno mai significato per lui semplificazione, banalizzazione o corrività. Questa è forse l’eredità migliore della filosofia analitica che Veca ha trasmesso, insieme ad altri, a parte della cultura italiana: se si legge bene, se si parte dalle definizioni, se si seguono con pazienza tutti i passaggi, le pagine di Veca possono essere lette da chiunque. Non perché siano una semplificazione, non perché siano divulgazione condiscendente, o filosofia pop. Ma perché sono una forma democratica di scrittura, che non presuppone nulla, né si avvale di allusioni e vaghezze, ma si assume il carico di portare tutti allo stesso livello e di procedere insieme - autore e lettore.
Questo modello di lavoro intellettuale è il lascito più autentico e prezioso di figure come quella di Veca, che in questo riprendeva la tradizione neoilluminista di Bobbio. Eppure, è un lascito che ha attecchito pochissimo nella nostra cultura e ha avuto un successo molto minore rispetto ad altri aspetti della sua attività. Viviamo in tempi in cui la filosofia pubblica si divide fra presunti grandi maestri oracolari e vaticinanti, spesso intenti a distillare vaghezze allusive e al fondo banali, a terrorizzare i seguaci e a inseguire scandali quotidiani e presunti critici dell’accademia e araldi di una filosofia popolare, che le stesse banalità e vaghezze dei primi spacciano con linguaggio sciatto e intenti meramente autopromozionali. Entrambe le tipologie seguono in realtà le leggi del mercato: piazzano un prodotto, occupano una nicchia merceologica, coltivano un segmento dell’ampia platea dei consumatori. Nonostante non fosse per nulla un nemico del mercato, anche se ne teorizzava limiti stretti, Veca non si è mai piegato alle logiche del mercato culturale ed editoriale. Questa è la sua eredità migliore, e più rara.
[1] Mazzacurati C., Paolini M. (2006), Luigi Meneghello. Dialoghi, Fandango Libri, Roma.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- L’OPPIO DEI POPOLI, I PALLONI IN ARIA, E IL "SOFFIO RIVOLUZIONARIO" DI MARX E DI JEAN-LUC NANCY.5 ottobre 2021, di Federico La Sala
L’OPPIO DEI POPOLI E LO SPIRITO CRITICO.
JEAN-LUC NANCY, IL SOFFIO RIVOLUZIONARIO, E I PALLONI IN ARIA...
JEAN-LUC NANCY, in un suo ultimo intervento ad un convegno del maggio scorso, dice: "[...] Quando Marx dichiara che la religione è «l’oppio dei popoli, lo spirito di un mondo senza spirito» [Nella sua "Critica della filosofia del diritto di Hegel"] intende dire da un lato che la religione è un povero surrogato dell’oppio con cui i ricchi si stordiscono, ma anche e allo stesso tempo che c’è da qualche parte uno “spirito” riservato a coloro che ne hanno i mezzi. Beninteso, per lui, tutti gli uomini ne hanno i mezzi, tutti possono partecipare al vero Spirito, a condizione d’essere liberi dall’alienazione. Poiché l’alienazione non consiste essenzialmente nell’estorsione del plusvalore - che ne è piuttosto il segno. L’alienazione consiste nel non essere propriamente sé stessi, tanto in quanto individui concreti che in quanto comunità non meno concrete".
E CONTINUA: "Questo spirito soffia come tutti gli spiriti. Marx usa spesso la parola “soffio” (Atem, respirazione). Ci accontenteremo di un esempio: «Il governo prussiano è infastidito dalla resistenza passiva che incontra ovunque. Attraverso l’apparente apatia, percepisce il soffio rivoluzionario»[...]"(Jean-Luc Nancy, "Essere, Soffio / Être soufflé", Le parole e le cose", 4.10.2021).
IL MESSAGGIO EVANGELICO E IL "FIGLIO DELL’UOMO". "Allora la folla gli [a Gesù] rispose: «Noi abbiamo appreso dalla Legge che il Cristo rimane in eterno; come dunque tu dici che il Figlio dell’uomo deve essere elevato? Chi è questo Figlio dell’uomo ["Filius hominis", "υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου]?»"(Gv. 12,34).
QUESTIONE ANTROPOLOGICA. CHI è questo Figlio dell’Uomo, CHI il "Gesù Cristo" degli Evangelisti? COME è detto nell’Evangelo di Giovanni di "Gesù Cristo"? Ponzio Pilato disse: "«Ecco l’uomo» (gr. «idou ho anthropos», vulg. «ecce homo»)" (Gv. 19, 4).
QUALE SPIRITO? COME è detto nella Prima Lettera dell’Evangelista Giovanni?: "Carissimi, non prestate fede ad ogni spirito, ma mettete alla prova gli spiriti, per saggiare se provengono veramente da Dio [...] Dio è amore." (1 Gv. 4, 1-8).
IL PROBLEMA DEL MENTITORE: CHI È IL "GESÙ CRISTO" DI PAOLO DI TARSO?!: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ, ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).
PSICOANALISI E CRISTOLOGIA: "OEDIPUS AT VERSAILLES" ED "EDIPO A CUERNAVACA". CHE FARE? Rileggere il testo di "Un frammento inedito di Freud del 1931" e dell’articolo di Franca Ongaro Basaglia ("PM", novembre 1982). SapereAude!
IL VENTO SOFFIA DOVE VUOLE (Gv. 3.8). QUANTI PALLONI IN ARIA ...
Federico La Sala
-
>FILOSOFIA, STORIA, E CINEMA: "DIO, UOMO E MONDO". Ricordando il lavoro di Karl Lowith, alcune note a margine di "L’événement" di Audrey Diwan (Leone d’oro, Venezia 2021).13 settembre 2021, di Federico La Sala
L’ORDINE SIMBOLICO DI MAMMASANTISSIMA: LA LUNGA MARCIA DI UNA CATASTROFE ANTROPOLOGICA IN CORSO.
Senza riandare indietro nel tempo, cosa che ha già fatto una grande tradizione critica (e da cui poco è stato appreso), ipnotizzati da concetti-specchio come patriarcato e matriarcato, ancora non è stato capito che cosa significa Edipo (Freud), tragedia (Dante, Nietzsche), e rapporto sociale di produzione (Marx). C’è solo da accogliere il film “L’événement” (Audrey Diwan, Leone d’oro, Venezia 2021) come una buona sollecitazione a ripensare questi problemi legati a mammane, mammona, cucchiai d’oro e moloch vari e riprendere il filo da quanto successo (in Europa) almeno (non solo a Granada nel 1492, ma anche) su "quel ramo del lago di Como" nel 1628 in un altro modo e in un’altra direzione. E così, possibilmente, buttare via l’acqua sporca e salvare la memoria di chi ha lottato da sempre per non restare all’inferno e vuole ri-nascere. O no?
DANTE 2021: LA DOMANDA ANTROPOLOGICA DI KANT (""Che cos’è l’uomo?": "Logica", 1800), IL "FIGLIO DELL’UOMO": UNA QUESTIONE DI PAROLA (LOGOS, NON LOGO!).
"Ecce Homo" (gr. «idou ho #anthropos»): "Allora la folla gli rispose: «Noi abbiamo appreso dalla Legge che il Cristo rimane in eterno; come dunque tu dici che il Figlio dell’uomo deve essere elevato? Chi è questo Figlio dell’uomo ["Filius hominis", "ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου]?»"(Gv. 12,34).
MESSAGGIO EVANGELICO E "DUE CRISTIANESIMI": "SEGUITEMI, VI FARO’ #PESCATORI DI UOMINI [piscatores hominun, ἁλιεῖς ἀνθρώπων] come da parola di Gesù (Mt. 4,19) o come da sollecitazione di Paolo di Tarso:"Diventate miei imitatori come io lo sono di Cristo... sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [lat. vir, gr. ἀνήρ]"(1 Cor. 11, 1-3)?!
11 SETTEMBRE 2011/2021, STORIA, E FILOLOGIA: "ECCE HOMO". Sempre a ripetere le famose parole dell’Ulisse di Dante (Inf. XXVI, 118-120: "Considerate la vostra semenza: /fatti non foste a viver come bruti,/ ma per seguir virtute e canoscenza"), ma ancora oggi (2021), dopo Dante e dopo Kant, tutta l’Europa e l’intero Pianeta è immerso in un letargo profondissimo! Alla questione antropologica ("Che cos’è l’uomo?": Kant,1800), si continua a rispondere truccando la Parola (il Logos) e a scambiarla (e a esportarla) come un Logo di un’azienda, proprietà di quegli uomini "più uguali degli altri" della orwelliana "Fattoria degli Animali"!
PREISTORIA (DI "VIRTUS" E "VIRUS"). La parola uomo (gr. anthropos, homo) vale solo come uomo-maschio (gr. anér/andròs, lat. vir/viri) e l’antropologia si coniuga solo al maschile, come andrologia: a tutti i livelli, immersi nel regno dell’Homo cosmo-te-andricus - nella "realtà" di una teologia ("Dio"), di una cosmologia ("Mondo") e di una antropologia "andrologica" ("Uomo"), la cosmoteandria del Pianeta Terra...
METANOIA: CAMBIARE MENTE! A che gioco giochiamo? Non è meglio uscire dall’orizzonte della cosmoteandria e dall’inferno (Inf. XXXIV, 90) e riprendere la navigazione nell’oceano celeste (Keplero a Galilei, 1611)?! O che?!
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- ANTROPOLOGIA E "FIGLIO DELL’UOMO": COSTITUZIONE, FILOLOGIA, E SIMBOLI. Ma la libertà non è negativa (di Giuseppe Anzani).10 settembre 2021, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA, FILOLOGIA, MESSAGGIO EVANGELICO, COSTITUZIONE, E SIMBOLI.... *
- ANTROPOLOGIA E "FIGLIO DELL’UOMO": "Allora la folla gli rispose: «Noi abbiamo appreso dalla Legge che il Cristo rimane in eterno; come dunque tu dici che il Figlio dell’uomo deve essere elevato? Chi è questo Figlio dell’uomo ["Filius hominis", "υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου]?»"(Gv. 12,34).
- LEZIONE DI "ANDROLOGIA" DI PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ, ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).
- Catechesi sulla Lettera ai Galati - 3. Il Vangelo è uno solo: "Il Vangelo è uno solo", quello di Paolo. "Per lui il Vangelo è ciò che lui predica, questo che si chiama il kerygma, cioè l’annuncio" (Papa Francesco, - Udienza Generale, 4 agosto 2021).
- Catechesi sulla Lettera ai Galati - 8. Siamo figli di Dio: "La figliolanza di cui parla Paolo non è più quella generale che coinvolge tutti gli uomini e le donne in quanto figli e figlie dell’unico Creatore. Nel brano che abbiamo ascoltato egli afferma che la fede permette di essere figli di Dio «in Cristo» (v. 26): questa è la novità. È questo “in Cristo” che fa la differenza. Non soltanto figli di Dio, come tutti: tutti gli uomini e donne siamo figli di Dio, tutti, qualsiasi sia la religione che abbiamo. No. Ma “in Cristo” è quello che fa la differenza nei cristiani, e questo soltanto avviene nella partecipazione alla redenzione di Cristo e in noi nel sacramento del battesimo, così incomincia. Gesù è diventato nostro fratello, e con la sua morte e risurrezione ci ha riconciliati con il Padre. Chi accoglie Cristo nella fede, per il battesimo viene “rivestito” di Lui e della dignità filiale (cfr v. 27)" (Papa Francesco - Udienza Generale, 8 settembre 2021).
I simboli e i singoli, laicità e buon senso.
Ma la libertà non è negativa
di Giuseppe Anzani (Avvenire, venerdì 10 settembre 2021)
Il crocifisso torna davanti ai giudici. È toccato alla Corte suprema di Cassazione a Sezioni unite dire se quel simbolo può stare appeso o no alle pareti di un’aula scolastica. Regolamenti, leggi, sentenze? L’orizzonte si apre a temi più grandi, irrompono parole come libertà religiosa, laicità dello Stato, cultura e tradizione e comune sentire e individuale dissentire; e infine sullo sfondo, volere o no, resta quel mistero immenso che due millenni fa ha spaccato in due la storia del mondo.
E dire che l’origine del caso è un episodio in apparenza banale: l’assemblea di classe degli studenti delibera l’esposizione del crocifisso nell’aula, un docente non lo vuole e lo stacca fisicamente durante le sue ore di lezione; riceve una sanzione disciplinare, la impugna. La causa percorre tutti i gradi e approda alle Sezioni unite, che decidono sostanzialmente così: l’aula può accogliere il crocifisso, quando la comunità scolastica decide in autonomia di esporlo; ciò non comporta discriminazione; il docente dissenziente non ha nessun potere di veto; deve tuttavia cercarsi una soluzione che rispetti la sua «libertà negativa di religione». Come a dire, in sottinteso, da ultimo: usate il buon senso.
L’avversione al crocifisso scoppia episodicamente per iniziativa solitaria di individui dei quali è difficile capire se soffrano di allergia al senso religioso altrui o perseguano un disegno demolitore. Sono casi rari, ma eclatanti.
Quello dello scrutatore elettorale, quello del giudice che rifiutava di tenere udienza, quello della donna atea che per far togliere il crocifisso dalla scuola portò il caso fino alla Corte europea dei Diritti umani (2011); e ne ebbe sentenza che l’esposizione del crocifisso «non è sufficiente a condizionare e comprimere la libertà di soggetti adulti e a ostacolare l’esercizio della funzione docente».
Bisognerà dunque riflettere sulla autenticità di simili dichiarate ’allergie’; la legge fondamentale sulla scuola (decreto legislativo n. 297/1994) garantisce ai docenti «autonomia didattica e libera espressione culturale», ma nel «rispetto della coscienza civile e morale degli alunni». Sono gli alunni, infatti, il corpo vivo della comunità scolastica; è in funzione di loro che si fanno cattedre, e non viceversa. Il gesto di togliere a forza, da sé, il crocifisso voluto dagli alunni non pare esattamente un atto educativo.
Libertà? Colpisce la frase «libertà negativa» usata dalla Corte. Se ne intuisce l’intento protettivo, ma il rispetto del ’negativo’ può imporre di azzerare ogni positivo? La libertà del no può annientare la libertà altrui del sì? Libertà è essenzialmente una dimensione positiva della persona umana, è un «agere licere».
La libertà è espressione, non compressione. Se ha un limite, esso è dato dalle contigue libertà, e il suo traguardo è l’armonia. Così la libertà religiosa trova presidio in un concetto di laicità che è tutto il contrario di una asfaltatura dei simboli religiosi per non turbare gli irreligiosi. Chi non s’intona al canto è libero di non cantare, ma non può pretendere di zittire il coro. Una laicità castrante non è nella nostra civiltà, non è nella nostra legge, non è nella nostra libertà. Ma infine, per chi ha fede, il nocciolo non è neppure il crocifisso-arredo. È il Crocifisso, il Vivente, e nessuno può toglierlo dal mondo, e nessuno ce lo stacca dal cuore.
*
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
VIVA L’ITALIA!!! LA QUESTIONE "CATTOLICA" E LO SPIRITO DEI NOSTRI PADRI E DELLE NOSTRE MADRI COSTITUENTI. Per un ri-orientamento antropologico e teologico-politico.
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- CON PARMENIDE E DANTE, OLTRE LA LOGICA "COSMOTEANDRICA" DI HEGEL . Lo "Straniero" di U. Curi e il problema dell’Uno e del Due (di Cristina Morga - "Bene Comune"). .20 agosto 2021, di Federico La Sala
GENERE UMANO: I SOGGETTI SONO DUE, E TUTTO E’ DA RIPENSARE!!! AL DI LA’ DELLA COSMOTEANDRIA E DELLA TRAGEDIA.... *
Curi, straniero. La necessità del due
di Cristina Morga (Bene Comune, 1 aprile 2019)
- “Senza il due, la ben rotonda verità dell’uno appare incapace di rendere ragione di ciò che caratterizza l’esperienza degli esseri umani. Il concetto stesso di rappresentazione, in quanto presuppone la distinzione fra due livelli di realtà, rinvia alla molteplicità del due e a tutto ciò che con essa è connessa” (pag. 128)
Il breve saggio intitolato Straniero è un’interessante riflessione sulla figura dello straniero, sul suo ruolo ambivalente di minaccia e di dono, sulla sua ineluttabilità per la definizione della nostra identità.
Il filosofo Umberto Curi non è interessato a sostenere la tesi di quelli a favore dell’accoglienza o di quelli che auspicano la chiusura delle frontiere. Piuttosto, attraverso un’analisi linguistica, filosofica e della letteratura, partendo da molto lontano e arrivando ai nostri giorni, ci invita a confrontarci sull’irriducibile duplicità di quella presenza che è sempre esistita - lo straniero, appunto - ma che oggi ci deve più che mai interrogare per le proporzioni che la mobilità umana sta assumendo.
L’autore dunque non esprime giudizi, ma offre molti spunti per ragionare sul profondo significato del concetto di straniero che oggi, pur in una società globalizzata, sempre più spaventa e sempre meno attrae. Ecco perché un approfondimento culturale sul tema sembra quanto mai urgente.
Curi lo fa a partire dal significato che gli antichi hanno attribuito alla figura dello straniero, elaborando nei secoli molti termini con significati diversi e/o plurimi, a seconda del periodo e del peculiare aspetto che si intendeva sottolineare. E’ proprio analizzando le singole parole della civiltà greca (xenos, barbaros, ecc.) e latina (hostis, ingenuus, perduellis, hospes, ecc.) che ci rendiamo conto delle infinite sfumature e accezioni semantiche che la figura dello straniero acquisiscono nel tempo: straniero come persona estranea, strana; straniero come forestiero, nemico e molto altro ancora. Tuttavia ci sono due elementi che sono onnipresenti: il fatto che si faccia sempre riferimento a una figura altra da noi e il fatto che questa abbia contemporaneamente un rapporto con noi, da cui non possiamo prescindere.
In questo volume tuttavia Curi non si ferma solo all’analisi lessicale che pure sarebbe sufficiente a far comprendere la complessità del tema. Egli si sofferma altresì sul concetto di accoglienza dello straniero, così come è stato interpretato da diversi filosofi, da Platone, a Kant a Freud.
Secondo Platone “non è possibile dire la verità, se non attraverso il confronto con il discorso di chi sia estraneo alla comunità e con essa entri in comunicazione”, mentre Kant sostiene il diritto dello straniero a non essere trattato come un nemico per garantire la pace perpetua. E poi l’autore analizza il pensiero di Freud, a partire dal concetto di unheimlich (malamente tradotto in italiano con il termine di perturbante), che definisce non soltanto l’inquietante, ma anche la scoperta di una duplicità di qualcosa con cui veniamo a contatto, la scoperta che l’ “Io non è unico, ma doppio, scisso in una dualità non ricomponibile, uguale e insieme irriducibilmente diversa rispetto all’immagine riflessa nello specchio, al sosia, all’ombra. Perturbante è la presa di coscienza di una insuperabile ambivalenza, di una unità che non è, non può mai essere, semplice, ma sempre inesorabilmente duplice” (p. 42). Quell’ineffabile e forte sentimento espresso attraverso la parola unheimlisches nasce dal reperimento del due nell’uno e quindi dalla rinuncia a qualsiasi immagine semplificata o rappresentazione univoca.
Infine, Curi, citando diverse opere letterarie, si sofferma sul racconto di Camus, l’Ospite, per sottolineare, fra le altre cose, l’importanza della dualità, che non implica soltanto insolubilità di un problema, ma movimento e mutamento, cioè vita. “Senza il due, la ben rotonda verità dell’uno appare incapace di rendere ragione di ciò che caratterizza l’esperienza degli esseri umani. Il concetto stesso di rappresentazione, in quanto presuppone la distinzione fra due livelli di realtà, rinvia alla molteplicità del due e a tutto ciò che con essa è connessa” (pag. 128).
Insomma, in questo ricco percorso linguistico, letterario e filosofico proposto da Curi, l’ambiguità dello straniero è sempre presente. Tuttavia, la sua natura ambivalente, un nemico da cui proteggersi ma anche un soggetto di cui abbiamo bisogno per definire noi stessi, rappresenta uno stimolo eccezionale per superarci e migliorarci. Nelle antiche carte geografiche, leggiamo nell’introduzione, le terre ignote ed inesplorate dell’Africa e dell’Asia erano descritte con la dicitura “hic sunt leones”, come a dire che quelle terre, per il semplice motivo di essere estranee e sconosciute, rappresentavano una minaccia. “Ma l’attrazione per le risorse e i tesori presenti in quelle zone del mondo indusse a non piegarsi alla paura, intraprendendo i viaggi che avrebbero condotto alla conoscenza dell’ignoto, e dunque alla cancellazione dalle carte di quella iscrizione. Si scoprì così che i doni connessi allo svelamento del mistero, ancorché indissolubili alla minaccia, erano talmente preziosi da risultare irrinunciabili” (p.19).
Forse è giunto il momento storico adatto a nuovi viaggi, allo svelamento di un nuovo mistero. Ritrovare la curiosità di chi ci ha preceduto, superando la paura, ci aiuterà nella comprensione di nuovi doni irrinunciabili? Oltre il confine, dove stanno i leoni, scopriremo forse la necessità del nostro due.
Citazioni
“Lo straniero è ambivalente - è l’ambivalenza. In quanto è thauma, non posso vivere la sua presenza, il suo arrivo, se non come una minaccia. Ma insieme avverto, nel cuore stesso del pathos che è inseparabile dal contatto con lui, che quella pur ineliminabile minaccia è per me feconda, mi conferisce qualcosa che, pur inconsapevolmente, attendevo da tempo e di cui non potrei fare a meno. Posso respingerlo - certamente - in quanto è minaccia. Ma contestualmente, se mi accingo a questo, percepisco anche un mio profondo e irrimediabile depauperamento. Alla sua duplicità dovrei saper rispondere con altrettanta duplicità. Dovrei riuscire a temerlo e a desiderarne l’arrivo, a spalancargli le porte della mia casa, e insieme a tenerlo fuori da essa, a respingerlo con la massima fermezza, e contemporaneamente ad accoglierlo come se si trattasse di una benedizione” (p. 12).
“Rinunciare al dono per allontanare la minaccia, o affrontare il pericolo per acquisire il dono? Un punto resta comunque assodato: di fronte allo straniero cede ogni possibile linguaggio dell’unicità [...] La rassicurante e familiare logica dell’aut-aut deve essere soppiantata da una modalità di ragionamento basata sul ben più impegnativo et-et” (p.13).
“Dell’hostis non possiamo fare a meno - non possiamo “scegliere” se accoglierlo o respingerlo, non più di quanto possiamo scegliere di essere quello che siamo. Egli è legato alla nostra identità non solo perché la fa essere, ma anche perché la fa - potenzialmente - non essere; non solo perché la determina, ma anche perché la minaccia dall’interno” (p.18).
“Unheimlich è quel moto dell’animo che avvertiamo quando ci rendiamo conto che non si dà alcuna possibilità di ricondurre a termini univoci, e a distinzioni nette e irreversibili, la nostra esperienza. Quando scopriamo che la stessa cosa che sembrava poterci rassicurare, proprio quella soprattutto ci inquieta. Quando ci avvediamo - davvero con “timore” e “tremore” - che non si dà alcuna “casa” come luogo privilegiato in cui viga l’assoluta univocità dei significati, degli atti, dei comportamenti e degli eventi, ma che nel cuore stesso di essa si annida la sua negazione, che nell’intimo dello Heim, e non fuori o contro, o comunque distinto rispetto a esso, vi sia l’un-Heim” (p.51).
“Dunque, in origine hostis è una figura alla quale mi lega un rapporto che non è di ostilità, ma di compensazione, nel senso che sono verso di lui in obbligo di contraccambiarlo per qualcosa che ho ricevuto. Mediante il ricambio, all’hostis viene riconosciuta quella piena parità alla quale egli ha diritto” (p.59).
“Il termine xenos compare sia per indicare colui che, provenendo dall’ ‘esterno’, viene ospitato presso la propria casa, sia colui presso la cui casa si riceve ospitalità” (p.63).
“Alla figura dello xenos, che è al centro delle relazioni di reciprocità tra le città che costituiscono il mondo ellenico, si oppone quella di barbaros. I barbari non erano soltanto stranieri, ma erano anche rozzi, crudeli, codardi, ecc. [...]. La natura mostruosa del barbaro fa sì che, propriamente parlando, non si tratti di stranieri, ma di una specie differente di uomini: essi non vengono da un’altra città, come visitatori o residenti, ma da un altro mondo, con cui non c’è possibilità di confronto né di scambio. E’ la loro diversa natura che li pone al di là della cultura ovvero delle possibilità di relazione, intreccio, mescolanza che la costituiscono. Di qui la guerra come modalità naturale di condursi nei confronti di una categoria di uomini con cui non è possibile rapporto, per cui non si possono stabilire quei legami di mutua accoglienza che costituiscono, viceversa, un obbligo sacro nei confronti dello straniero. [...] Il barbaros rappresenta in un certo senso il rovesciamento o la negazione di ciò che - pur nelle differenze - rende simili tutti gli uomini. Ed è solo questo limite, soltanto nei confronti di figure intrinsecamente antiumane, quali sono i barbaroi, che non solo è consentito sottrarsi alle regole dell’ospitalità, ma è addirittura necessario ricorrere alla violenza estrema del polemos” (p.79).
“Se qualcuno è ‘straniero’, è anche, necessariamente, ‘ospite’, non come effetto di una mia scelta facoltativa, per la quale io posso arbitrariamente trattare l’altro come ospite o lasciarlo semplicemente come straniero, ma perché egli si dà a me come figura che mi obbliga all’ospitalità. Né l’ospitalità dà luogo ad alcun processo assimilativo. Lo xenos è sacro proprio nella sua identità e individualità, altra e irriducibile rispetto a quella di chi lo accoglie” (p.80).
“Platone indica che il nostro essere attuale coincide dunque letteralmente con un frammento della tessera hospitalitatis, con una delle due “parti”, la quale esige di essere completata mediante l’incontro con colui che detiene l’altra parte della tessera stessa. Se non vogliamo restare soltanto porzioni di essere, se intendiamo riconquistare la pienezza originaria, se non ci accontentiamo di un’esistenza puramente simbolica, ma aneliamo all’autenticità della plenitudine, dobbiamo ricomporre la nostra metà con colui che è portatore della parte mancante” (p.95).
“Per riuscire a disattivare la guerra non basta, insomma, che la costituzione civile sia conforme allo ius civitatis e allo ius gentium, poiché occorre anche che essa corrisponda allo ius cosmopoliticum, vale a dire a quel diritto che, pur non essendo facilmente traducibile in un apparato di norme positive, riconosce le condizioni dell’ospitalità universale. Con la precisazione davvero fondamentale, introdotta da Kant quasi per rispondere preventivamente a possibili obiezioni e insieme per fugare possibili equivoci, che ‘qui non è in discussione la filantropia, ma il diritto, sicché l’ospitalità coincide con il ‘il diritto di uno straniero a non essere trattato come un nemico’ ” (p. 115).
“Per tornare a Kant [...] il filosofo sottolinea che “fino a quando lo straniero sta pacificamente al suo posto non si deve agire contro di lui in senso ostile perché egli può rivendicare quel diritto di visita che spetta a tutti gli uomini. Ciò perché originariamente nessuno ha più diritto di un altro ad abitare una località della terra” (p. 117).
“Nel racconto di Camus [l’Ospite] il due compare in maniera insistente, quasi ossessiva, per sottolineare, anche attraverso la reiterazione, la centralità di questo tema nell’intera narrazione. Già nell’esordio Daru scorge in lontananza il profilo dei due uomini che si dirigono verso la sua casa - il gendarme e il prigioniero. La corda con cui Balducci tiene l’arabo mostra fino a che punto essi formino una unità che si regge specificamente sulle loro differenze. L’identità di ciascuno di loro non è concepibile senza il riferimento all’altro. Anche lo status dell’uno si spiega soltanto in rapporto alla condizione dell’altro. Se non fosse prigioniero di Balducci, l’arabo semplicemente non avrebbe alcuna presenza nel racconto. Lo stesso vale per il gendarme, la cui ragion sufficiente sta tutta nell’essere il custode del prigioniero” (p. 129).
“Perturbante è ciò che scaturisce - e costantemente si alimenta - dall’inquietudine legata a questo vacillamento dei confini, alla loro mobilità e porosità, attraverso cui l’altro, l’esterno, ma anche lo spettro e la morte penetrano continuamente, intaccando ogni forma di identità a sé: dell’io, delle sue rappresentazioni, dei suoi saperi” (p.149).
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE, E IL VATICANO CON IL SUO TRADIZIONALE SOFISMA DELLA "FALLACIA ACCIDENTIS".
FLS
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- MATEMATICA, COSTITUZIONE, E PAURA DEL CIELO.1 agosto 2021, di Federico La Sala
#DANTE2021
#MATEMATICA
E
#COSTITUZIONE
.Se gli esseri umani sono
"fatti della stessa natura del tempo",
e il #tempo avesse l
a forma del coperchio,
la #paura del cielo
direbbe solo del
rifiuto
di uscire dalla
#selva oscura
e
#nascere!
#Fleur Jaeggy!
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- AUFKLARUNG, MENSCHWERDUNG, GATTUNGSWESEN: IMPERATIVO CATEGORICO E SONNO DOGMATICO.28 luglio 2021, di Federico La Sala
#EUROPA:
#QUESTIONE ANTROPOLOGICA
#FILOLOGICA
E
#ARCHEOLOGICA.
#IMPERATIVO CATEGORICO
E
#SONNO DOGMATICO:
E
#GATTUNGSWESEN.
#DIVINA COMMEDIA:
I #TRADITIONIS CUSTODES,
IL #LATINO,
#CARITAS (#KAPITAS)
O DELLA
#CHARITAS (#XAPITAS)?
***
#QUESTIONE ANTROPOLOGICA
#FILOLOGICA
E
#ARCHEOLOGICA:
#EUROPA.
#DIVINA COMMEDIA (#DANTE2021)
E #SONNO DOGMATICO:
IL PROBLEMA DEL #LATINO
E
I #CUSTODI DELLLA #TRADIZIONE CATTOLICO-ROMANA
(#TRADITIONIS CUSTODES),
QUELLA DELLA
#CARITAS (#KAPITAS)
O DELLA
#CHARITAS (#XAPITAS)?
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- ARCHEOLOGIA FILOSOFICA E "APOLLO 11": LA MEMORIA DELLA LEGGE DI APOLLO (ESCHILO) E L’EDUCAZIONE CIVICA, OGGI.19 luglio 2021, di Federico La Sala
#APOLLO 11
#EDUCAZIONE CIVICA
#EDUCAZIONE SESSUALE.
#Memoria della
#Legge di #Apollo
(#Eschilo):
«non è la madre la #generatrice di quello che è chiamato suo figlio;
ella è la nutrice del germe in lei inseminato.
Il #generatore è colui che la feconda».
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- LE REGOLE DEL "GIOCO DELLA PALLA", A 700 ANNI DALLA MORTE DI DANTE, CONTINUANO AD ESSERE QUELLE DELLA "TRAGEDIA"! MA A CHE GIOCO GIOCHIAMO?!10 luglio 2021, di Federico La Sala
"IL GIOCO DELLA PALLA", SECONDO LA LOGICA "ANDROLOGICA" DEL CATTOLICESIMO-COSTANTINIANO...:
- "Dico che questo gioco esprime il movimento della nostra anima che va dal suo regno al regno della vita in cui è la quiete e la felicità eterna. Nel centro di questo regno siede, come monarca, Gesù Cristo, nostro re, che ci ha donato la vita. In quanto è simile a noi, egli muove la sfera della sua persona in modo da riposare nel centro della vita. Poiché egli ci ha lasciato il suo esempio, facciamo come egli ha fatto. La nostra palla segua la sua, anche se è impossibile che una palla diversa raggiunga la quiete nel medesimo centro di vita in cui riposa la palla di Cristo. Dentro il circolo ci sono, infatti, infiniti luoghi e fermate. La palla di ognuno si ferma nel punto e nell’atomo suo proprio che nessun altro potrà mai raggiungere"(Niccolò Cusano, Opere filosofiche, Torino, Utet, 1972).
#DANTE2021
E
#ANTROPOLOGIA (#HOMO LUDENS):
IL #GIOCO DELLA #PALLA
(#De ludo globi) DI
#NICCOLO’ CUSANO
riguarda «un gioco scoperto da poco che tutti comprendono facilmente e giocano volentieri»
E
LA #DOCTA IGNORANTIA
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- SONNO DOGMATICO E "DOCTA IGNORANTIA": A 700 ANNI DALLA MORTE DI DANTE, ANCORA IMMERSI NELLA LOGICA "NAPOLEONICA" DELLA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO HEGELIANO.2 luglio 2021, di Federico La Sala
#COSTITUZIONE:
#BIBBIA CIVILE
E
#MAGISTERO ANTROPOLOGICO:
#COME NASCONO I BAMBINI?
#Divina Commedia:
#Dante2021.
se #Maria è #madre e #maestra.. #Giuseppe non è #padre e #maestro?!
Per un’altra #fenomenologiadellospirito:
IO, dall’#AMORE di #Due IO.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- UNA SOTTILE IRONIA DELLA SORTE: MARTIN HEIDEGGER, HANNAH ARENDT, E I DATI DELL’ISTAT SULLA NATALITA’.2 luglio 2021, di Federico La Sala
FILOSOFIA E ANTROPOLOGIA. COME NASCONO I BAMBINI...*
- HANNAH ARENDT E IL PROBLEMA DELL’INIZIO, DELLA NASCITA: "Nella grande opera sulla Città di Dio Agostino enuncia, senza però darne spiegazione, ciò che avrebbe potuto divenire il sostegno ontologico di una filosofia della politica autenticamente romana o virgiliana. A suo dire, come sappiamo, Dio creò l’uomo come creatura temporale, homo temporalis; il tempo e l’uomo furono creati insieme, e tale temporalità era confermata dal fatto che ogni uomo deve la sua vita non semplicemente alla moltiplicazione della specie, ma alla nascita, l’ingresso di una creatura nuova che, come qualcosa di completamente nuovo, fa il suo ingresso nel mezzo del continuum temporale del mondo. Lo scopo della creazione dell’uomo fu di rendere possibile un inizio: «Acciocché vi fosse un inizio, fu creato l’uomo, prima del quale non ci fu nessuno», «Initium ... ergo ut esset, creatus est homo, ante quem nullus fuit» (Agostino, De civitate Dei, libro XII, cap. 21). La capacità stessa di cominciamento ha le sue radici nella natalità e non certo nella creatività, non in una dote o in un dono, ma nel fatto che gli esseri umani, uomini nuovi, sempre e sempre di nuovo appaiono nel mondo in virtù della nascita" (H. ARENDT, La vita della mente, Bologna 1987, p. 546).
È la nostra nascita il miracolo che salva il mondo
Quella postilla di Hannah Arendt che illumina i dati Istat sulla natalità
di Sergio Belardinelli (il Foglio, 24 apr 2021)
L’Istat ci ha comunicato di recente che, complice anche il Covid, in Italia nel 2020 i morti sono stati 746 mila e i nuovi nati 404 mila. Un dato agghiacciante nel suo significato sociale e culturale che a me, come una sorta di riflesso condizionato, richiama alla mente uno dei brani filosofici più intensi che abbia mai letto: “Il miracolo che salva il mondo, il dominio delle faccende umane dalla sua normale, naturale rovina è in definitiva il fatto della natalità in cui è ontologicamente radicata la facoltà dell’azione. È in altre parole la nascita di nuovi uomini, l’azione di cui essi sono capaci in virtù dell’esser nati. Solo la piena esperienza di questa facoltà può conferire alle cose umane fede e speranza, le due essenziali caratteristiche dell’esperienza umana, che l’antichità greca ignorò completamente. È questa fede e speranza nel mondo, che trova forse la sua gloriosa e stringata espressione nelle poche parole con cui il Vangelo annunciò la ‘lieta novella’ dell’avvento: ‘un bambino è nato per noi’”.
Con queste parole Hannah Arendt conclude il capitolo di Vita Activa dedicato all’azione. Si tratta di un brano che cito e commento ormai da quarant’anni, nel quale viene messo a tema un nesso, quello tra la libertà e la natalità, tra la libertà e la vita, col quale, che io sappia, soltanto la Arendt ha avuto l’acutezza e il coraggio di cimentarsi e che, a prima vista, può apparire persino paradossale. La vita infatti, almeno immediatamente, sembra richiamare non tanto la libertà, quanto piuttosto il gigantesco, immutabile ripetersi dei cicli naturali, l’ambito di quelli che il grande biologo Adolf Portmann, autore peraltro assai caro alla Arendt, definirebbe i “rapporti preordinati” - il contrario, quindi, di ciò che in genere intendiamo allorché parliamo di libertà. Quanto poi alla vita specificamente umana, essa, è certo impastata di libertà, ma è anche qualcosa che, a diversi livelli, non dipende da noi, qualcosa di cui, nonostante le tecnologie della riproduzione, non possiamo avere il completo controllo: la riceviamo semplicemente; non scegliamo i nostri genitori, né il luogo dove venire al mondo; dobbiamo fare continuamente i conti con gli altri, con le nostre passioni, i nostri istinti, le nostre inclinazioni, con quel coacervo di natura, ragione, sentimenti, usi e costumi che vanno a costituire appunto il “gran mare” della vita. La vita insomma pone una serie di condizioni e condizionamenti alla libertà che possono renderla persino impossibile. Eppure, rompendo in un certo senso questa grande catena, è proprio la libertà che dà sapore e specificità alla vita umana; solo la libertà impedisce che il mondo si riduca spinozianamente a “sostanza”, a qualcosa di omogeneo, a qualcosa come un continuo fluire; solo la libertà è capace di introdurre nel mondo un elemento di novità, qualcosa di imprevisto.
Pensieri non nuovi, si potrebbe dire. Ma proprio qui si inserisce la fondamentale postilla arendtiana, preziosa per leggere in una chiave forse inusuale ma certo illuminante anche i dati Istat sulla natalità in Italia da cui siamo partiti: è la stessa vita umana, il nostro venire al mondo, la nascita unica e irripetibile di ciascuno di noi, a rappresentare la prima e più immediata forma di novità, il primo scompaginamento, se così si può dire, della routine della vita.
La facoltà dell’azione, dice la Arendt, “è ontologicamente radicata” nel “fatto della natalità”. In entrambe le dimensioni - la libertà e la natalità - ritroviamo non a caso una costitutiva “novità”, un costitutivo essere insieme agli altri (non si nasce, né si agisce da soli), qualcosa che implica l’accettazione della realtà nella quale siamo e insieme fiducia nel futuro. In questo senso ogni bambino che nasce è un segno di speranza nel mondo; è l’irruzione nel mondo di una “novità”, la cui memoria, è il caso di dire, ritroviamo da adulti nell’esercizio della nostra libertà, nella nostra capacità di incominciare qualcosa che senza di noi non incomincerebbe mai.
Novità, pluralità (gli uomini, non l’uomo abitano la terra, ripete spesso Hannah Arendt) e speranza: questo ci schiude direttamente e in modo straordinario il discorso arendtiano sulla libertà radicata nella natalità. Ma indirettamente, specialmente oggi, tale discorso ci schiude molto di più. Ci fa capire, ad esempio, quale tragedia, anche simbolica, si consuma nel momento in cui un paese come l’Italia registra in un anno un saldo passivo tra morti e nuovi nati di 342 mila unità. È un po’ come se il mondo e la nostra libertà perdessero la speranza, ossia ciò che dà loro sapore, ciò che è insieme accettazione della realtà nella quale viviamo e fiducia nel futuro.
È vero, tutto passa. La vita non è altro che un eterno dissolversi nel gigantesco circolo della natura dove, propriamente, non esiste inizio né fine e dove tutte le cose e gli eventi si svolgono in un’immutabile ripetizione: la mors immortalis di cui parlava Lucrezio. Ma la Arendt non accetta questa mestizia, poiché a suo avviso “la nascita e la morte di esseri umani non sono semplici eventi naturali”; avvengono in un mondo dove vivono altri uomini; un mondo che acquista significato grazie alle loro azioni e ai loro discorsi; un mondo che per questo è sempre aperto alla novità.
Con la creazione dell’uomo, dice la Arendt, “il principio del cominciamento entrò nel mondo stesso, e questo, naturalmente è solo un altro modo di dire che il principio della libertà fu creato quando fu creato l’uomo”. Di nuovo l’inizio, dunque, diciamo pure, la natalità.
È proprio perché, in quanto uomini, siamo initium, nuovi venuti, iniziatori, per virtù di nascita che secondo la Arendt, siamo indotti ad agire. La definizione che più si addice agli uomini non è quella di “mortali”, ma piuttosto quella di “coloro che nascono”. In questo modo, quasi per una sottile ironia della sorte, la categoria della natalità diventa fondamentale proprio nel pensiero di un’allieva (e anche qualcosa di più) di Martin Heidegger, l’inventore dell’essere per la morte. Non che la Arendt ovviamente trascuri che la morte rappresenta l’ineluttabile fine di ogni vita umana, solo che, a suo avviso, gli uomini, anche se debbono morire, non nascono per questo, bensì per incominciare. E siamo di nuovo al passo da cui siamo partiti: “Il miracolo che salva il mondo....”.
*
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI. --- "ESSERE E TEMPO" E FILOLOGIA. Note su "Martin Heidegger e Hannah Arendt: la storia della fedeltà all’amore".
DANTE, ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. Note per una riflessione storiografica L’EUROPA IN CAMMINO - SULLA STRADA DI GOETHE O DI ENZO PACI (“NICODEMO O DELLA NASCITA”, 1944)?!
EUROPA: EDUCAZIONE SESSUALE ED EDUCAZIONE CIVICA. ITALIA "NON CLASSIFICATA"!!! Per aggiornamento, un consiglio di Freud del 1907 - con una nota introduttiva
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- (LA LEZIONE DI KANT E) "LA ’LEZIONE’ DI (NIETZSCHE) E DI UN ABORIGENO CANADESE" (di Federico La Sala).1 luglio 2021, di Federico La Sala
In onore di Francesco e Chiara d’Assisi, dei Francescani (Dante Alighieri, compreso!) ... e di Leonard Boff
IGNOTI A SE’ STESSI ...ED ESPORTATORI DI ’CRISTIANESIMO’ E DI ’DEMOCRAZIA’!!!
La ’lezione’ (di Nietzsche e) di un aborigeno canadese ai ’registi’ della politica ’cattolica’ (e ’laica’).
di Federico La Sala (ildialogo.org, 22 novembre 2005)
Credo che ormai siamo proprio e davvero al capolinea - nella totale ignoranza di sé stessi i componenti della Gerarchia della Chiesa ’cattolica’ si agitano ... alla ’grande’!!! Non hanno proprio più nulla da dire, evidentemente! Sono scesi in campo ... ma contro Chi?!, contro che cosa?! Contro lo spirito francescano!!!
In segno di solidarietà, qui ed ora - 2005 dopo Cristo, con i francescani in carne ed ossa, oggetto di un richiamo, con un Motu Proprio, da parte dell’ex- prefetto ’kantiano’ Ratzinger, il papa Benedetto sedicesimo, forse non è inutile un breve commento a margine... per cercare di stare svegli e di svegliarci, possibilmente - tutti e tutte!
Dennis McPherson, un aborigeno (che ormai ’ci’ conosce bene, evidentemente!) canadese, ecco cosa (sapientemente e sorprendentemente - per noi, occidentali!!!), alla domanda - “qual è l’essenza dell’essere umano? E’ una creatura speciale con una missione speciale?” - di un’antropologa-intervistatrice, ha risposto:
- “ Ha mai sentito parlare di Emanuele Kant? Certo che sì! Sa qual è l’asserzione più importante di Kant? E’ che non può: Kant = can’t (gioco linguistico tra il nome del filosofo e il verbo inglese, che hanno lo stesso suono). Questo sta cercando di fare lei. Sa perché? Perché sta cercando di capire la cultura aborigena! Siete lontano migliaia di anni, siete nell’età dell’oscurantismo”(Rita Melillo, Tutuch (Uccello tuono). A colloquio con gli aborigeni del Canada, Presentazione di D. A. Conci, Mephite s.r.l., Atripalda (AV) 2004, p. 211 e p. 217).
Se teniamo presente le famose parole “De nobis ipsis silemus [...]”(di Francesco Bacone), messe da Kant sopra (come una pietra tombale) e prima di iniziare il suo discorso della e nella Critica della ragion pura, si può dire che il ’nostro’ aborigeno ha capito e visto più che bene - e meglio di tutti i filosofi e teologi dell’Occide[re]nte!!! E ’ce’ lo ha detto in faccia - ’papale’, ’papale’: basta!!!
Noi che non conosciamo ancora noi stessi (Nietzsche) .... e che navighiamo nel più grande “oscurantismo” - quello (più importante!!!) relativo a noi stessi, vogliamo pure dare lezioni ed esportare ’cristianesimo’ e ’democrazia’ in tutto il mondo!? “Mi”!?, e “Mah”!!!?
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- Il Canada chiede conto al Papa per la strage dei bambini indigeni
- Ritrovati i resti di quasi mille bambini in ex scuole gestite dalla Chiesa, 6mila mancano all’appello. Trudeau a Bergoglio: opportuno chiedere scusa sul suolo canadese (di Giulia Belardelli, 28.06.2021)
EICHMANN A GERUSALEMME (1961). “come fu possibile la hitlerizzazione dell’Imperativo Categorico di Kant? E perché è ancora attuale oggi?” (Emil L. Fackenheim, Tiqqun. Riparare il mondo).
 HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI.
HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI.L’ILLUMINISMO, OGGI. LIBERARE IL CIELO. Cristianesimo, democrazia e necessità di "una seconda rivoluzione copernicana"
FLS
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- PENSARE OLTRE LE FRONTIERE. Al via l’organizzazione del 25° Congresso Mondiale di Filosofia che si terrà nel 2024, a Roma, alla "Sapienza".16 giugno 2021, di Federico La Sala
Pensare oltre le frontiere. Al via l’organizzazione del 25° Congresso Mondiale di Filosofia che si terrà nel 2024 alla Sapienza
Lunedì 26 aprile l’International Federation of Philosophical Societies, la Società Filosofica Italiana e Sapienza hanno firmato l’accordo che dà ufficialmente avvio all’organizzazione del 25° Congresso Mondiale di Filosofia (WCP), dedicato al tema “Pensare oltre le frontiere"
Dopo Bologna nel 1911, Napoli nel 1924 e Venezia nel 1958, sarà Roma a ospitare nel luglio 2024 la fase finale del Congresso mondiale di filosofia, nei prossimi anni sarà preceduto da una serie di incontri, seminari ed eventi preparatori che proietteranno le forze culturali e accademiche del nostro paese al centro del dibattito filosofico (e non solo) internazionale.
Si tratta di un risultato importante per l’Italia, per la Società filosofica italiana - tra le più antiche istituzioni filosofiche italiane, fondata nel 1906 proprio per promuove il dibattito filosofico e difendere l’insegnamento della filosofia - e per la Sapienza, che ancora una volta si conferma luogo privilegiato in cui custodire e alimentare la riflessione intellettuale e il pensiero critico, a partire dallo studio della tradizione classica come conferma il primato recentemente conquistato nell’area umanistica nel QS Ranking 2021, dove si è collocata al 1° posto in Classics & Ancient History.
Il Congresso mondiale di filosofia costituisce il principale momento di incontro tra le comunità accademiche e intellettuali del mondo intero, che si riuniscono ogni cinque anni in un paese diverso per rafforzare le relazioni professionali, promuovere l’educazione filosofica e offrire un contributo rispetto alle grandi questioni e sfide del proprio tempo. Per queste ragioni l’aspettativa che suscita su scala internazionale è straordinaria: la partecipazione agli ultimi Congressi (Atene 2013 e Pechino 2018) ha superato i 4,000 iscritti provenienti da oltre 120 paesi.
Dal primo congresso del 1900 che si tenne a Parigi in occasione dell’Esposizione universale, è la prima volta, in 125 anni, che il Congresso si svolge a Roma - la quarta volta per il nostro Paese, caso unico al mondo - segno evidente del riconoscimento da parte della comunità filosofica internazionale dell’importanza del contributo che l’Italia ha dato e può dare all’interno del dibattito filosofico globale. All’origine di quest’impegno è l’esigenza di avviare una riflessione pubblica sull’avvenire delle nostre società, particolarmente urgente in questo momento, confrontandosi allo stesso tempo con gli sviluppi più recenti delle ricerche filosofiche condotte nelle diverse aree del pianeta.
In quest’ottica, a luglio 2024, per un’intera settimana, sotto l’ambito generale “Pensare oltre le frontiere”, si affronteranno temi legati alle relazioni interculturali, alle questioni di genere, alle forme di organizzazione politica e alle diseguaglianze sociali, ai temi ambientali e bioetici, ai diritti, all’Agenda ONU 2030 e alle modalità di sviluppo sostenibile.
Il Congresso rappresenta un formidabile volano di ripresa e di costruttivo confronto intellettuale, di valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, non che di sviluppo economico. La sua capacità di attrazione offre all’Italia la possibilità di rafforzare la propria presenza accademica e scientifica internazionale, collocandosi al centro di una riflessione globale sulle prospettive culturali, sociali ed economiche del mondo contemporaneo.
In occasione del Congresso, migliaia di intellettuali e accademici del mondo intero si riuniranno a Roma. Si tratterà quindi di un grande momento pubblico di riflessione, elaborazione e proposte sulle prospettive presenti e future delle nostre società.
Nelle sue fasi preparatorie, esso permetterà di aggregare l’insieme delle forze intellettuali, scientifiche, accademiche del nostro paese, a cui si uniranno voci e figure del mondo dell’economia, dell’informazione, delle imprese e delle istituzioni, in un processo di avvicinamento al Congresso che vuol essere al servizio dell’esigenza, complessa ma sempre più avvertita, di “ricostruzione intellettuale” delle nostre società.
La partecipazione di studentesse e studenti, giovani ricercatrici e ricercatori del mondo intero sarà una priorità. A loro sarà riservata un’intera sezione del Congresso. Per le giovani generazioni sarà infatti un’occasione per aprirsi al confronto con altre idee, linguaggi, culture e sensibilità e rappresenterà un’opportunità formativa e di valorizzazione dei propri studi particolarmente significativa.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- Manifesto per la nuova Scuola. Rivedere l’intero impianto fallimentare dell’ “autonomia scolastica” (di AA. VV. - "Micromega")..17 giugno 2021, di Federico La Sala
Manifesto per la nuova Scuola
“La scuola deve tornare a essere principalmente un luogo di conoscenza e relazione umana”. Pubblichiamo un documento redatto da un gruppo di docenti per sostenere una nuova idea di scuola. Tra i firmatari: Gustavo Zagrebelsky, Luciano Canfora, Salvatore Settis, Adriano Prosperi, Alessandro Barbero, Tomaso Montanari.
di Autori vari (MicroMega, 16 Giugno 2021)
1) La scuola come luogo della relazione umana e del rapporto intergenerazionale
La scuola si occupa delle persone in crescita, non di entità astratte scomponibili e riducibili a una serie di “competenze”. L’insegnamento e l’apprendimento toccano infatti tutte le dimensioni dell’essere umano - intellettuale, razionale, affettiva, emotiva, relazionale, corporea - tra loro interconnesse e inscindibili; bisogna sempre ricordare, in tal senso, che quello tra gli insegnanti e gli studenti è prima di tutto un rapporto umano.
L’idea che la scuola possa essere incentrata sulla semplice acquisizione di “competenze” è profondamente sbagliata, sia perché applica a un ambito, quello scolastico, categorie nate in tutt’altro ambito, quello cioè dell’azienda e della produttività lavorativa, sia perché esclude appunto la dimensione integralmente umana, centrale nella scuola e nei processi lunghi e non lineari dell’apprendimento e della crescita.
2) Per una scuola della conoscenza
Per svolgere il compito che le è affidata dalla Costituzione, la scuola pubblica deve essere incentrata sulla conoscenza e sulla trasmissione del sapere, oltre che sul rispetto delle esigenze psico-fisiche di crescita dei giovanissimi. Solo attraverso il confronto con i contenuti culturali, la loro elaborazione e acquisizione - a partire da un’approfondita e reale alfabetizzazione - gli studenti potranno diventare cittadini liberi e consapevoli, in grado di contribuire a un autentico progresso della società. Senza l’istruzione delle nuove generazioni, la stessa democrazia è svuotata di sostanza.
3) Un giusto rapporto tra mezzi e fini
Se è vero che la scuola deve essere fondata sulla conoscenza, sul sapere, sullo studio, tutti gli strumenti e i metodi dell’insegnamento, compresi quelli legati all’uso delle tecnologie digitali, devono rimanere o ritornare a essere dei semplici mezzi, da utilizzare non a prescindere ma se e quando le necessità della condivisione dei contenuti culturali (che è continua attività dell’intelligenza, attualizzazione e rielaborazione critica delle conoscenze guidata dall’insegnante) lo richiedano. Vanno cioè evitati i deleteri rovesciamenti e le frequenti inversioni di priorità tra mezzi e fini che hanno caratterizzato il “didattichese” degli ultimi decenni - al punto che alcuni sembrano pensare che i mezzi siano essi stessi il contenuto della didattica - e va restituito il giusto posto alla libertà di insegnamento (spesso schiacciata e conculcata dall’imposizione di mode di scarsissimo valore didattico e culturale), nel segno di un’istruzione il più possibile ricca e plurale e della responsabilità educativa degli insegnanti. Bisogna ricordare come gli insegnanti siano degli intellettuali e dei professionisti, il cui compito non è quello di applicare burocraticamente e passivamente delle decisioni prese altrove, ma quello di trovare di volta in volta i mezzi più adatti per l’insegnamento. D’altra parte, non si capisce in che modo un insegnante ridotto a burocrate e certificatore potrebbe aiutare gli studenti ad acquisire un indispensabile senso critico di fronte alla realtà e ai contenuti culturali di cui via via essi si appropriano.
In qualunque ragionamento sui mezzi, non va poi dimenticato come l’uso sempre più pervasivo della tecnologia digitale - che il ricorso alla “didattica a distanza” ha reso preponderante anche a scuola, a discapito di ogni esigenza didattica ed educativa che richiedesse strumenti diversi - sia collegato ai disturbi da iperconnessione che colpiscono i giovanissimi, ai rischi del ritiro sociale, al senso di insicurezza, alla dipendenza dagli strumenti tecnologici, fino agli attacchi di panico, fenomeni che insorgono anche in conseguenza della mancanza di rapporti che è possibile vivere solo in presenza e della negazione della dimensione fisico-corporea, la cui messa in gioco è fondamentale per le persone in crescita. In questo contesto andrebbe sempre ricordato che la relazione, le parole, i gesti e tutto ciò che passa nella comunicazione verbale e non verbale sono i primissimi strumenti degli insegnanti, gli unici davvero indispensabili.
4) Il mancato coinvolgimento degli insegnanti nelle “riforme” degli ultimi vent’anni
Poiché la scuola pubblica ha come finalità l’istruzione e la formazione umana e culturale delle persone in crescita, i decisori politici, prima di ipotizzare qualunque “riforma”, dovrebbero interloquire con gli esperti della trasmissione culturale e quelli dell’età evolutiva - insegnanti, psicoanalisti, intellettuali, educatori - e non con i rappresentanti di associazioni private - Fondazione Agnelli, Treelle, Anp - che rappresentano e perseguono appunto interessi privati.
5) Il reclutamento e la formazione degli insegnanti
La formazione e il reclutamento degli insegnanti devono avere al centro la preparazione culturale, la conoscenza approfondita e di prima mano dei contenuti disciplinari, - solo degli autentici esperti possono infatti trasmettere agli studenti la passione per il sapere e per le singole discipline - la motivazione e la propensione all’insegnamento, alla condivisione culturale e alla relazione con le persone in crescita. Per quanto riguarda l’aspetto relazionale, gli insegnanti devono poter avere un confronto con esperti dell’età evolutiva di comprovata esperienza ed elevata professionalità, anche attraverso lo strumento dello sportello d’ascolto o di gruppi dedicati, per esaminare le dinamiche su cui si fonda il rapporto educativo e per poter sciogliere, dove occorra, eventuali nodi relazionali.
6) Restituire centralità all’ora di lezione
Autorevoli esponenti politici hanno chiesto che gli apprendimenti non acquisiti in “didattica a distanza” vengano recuperati attraverso un prolungamento dell’anno scolastico. Questa proposta, purtroppo, appare niente più di una boutade demagogica: chiunque conosca il mondo della scuola e le dinamiche dell’insegnamento/apprendimento - e non pensi che consistano in una rapida verniciatura di “competenze” - sa benissimo che in due o tre settimane, alla fine di un periodo terribile, non è possibile recuperare nulla di ciò che si è perso in un anno di mancata scuola in presenza. Dopo vent’anni di devastanti “riforme”, occorrerebbero invece interventi precisi e profondi, per rilanciare la funzione della scuola, e cioè, prima di tutto, restituire centralità all’ora di lezione disciplinare, un’ora squalificata e messa ai margini da una serie di attività che ne snaturano la funzione e la rendono un’attività residuale. Se davvero si vuole recuperare il tempo perduto, occorre eliminare ciò che non è apprendimento e insegnamento:
 via gli inutili percorsi di “alternanza scuola-lavoro” (ora PCTO), da sostituire semmai con stage sensati e non obbligatori, se e quando ne valga la pena, fuori dall’orario scolastico e su decisione dei consigli di classe;
via gli inutili percorsi di “alternanza scuola-lavoro” (ora PCTO), da sostituire semmai con stage sensati e non obbligatori, se e quando ne valga la pena, fuori dall’orario scolastico e su decisione dei consigli di classe; via i test INVALSI, che sottraggono settimane di tempo all’attività scolastica senza che se ne siano mai chiariti il senso, la funzione e l’utilità;
via i test INVALSI, che sottraggono settimane di tempo all’attività scolastica senza che se ne siano mai chiariti il senso, la funzione e l’utilità; via i progetti non indispensabili (ad eccezione ad esempio della mediazione linguistica e culturale per gli studenti stranieri e dello sportello d’ascolto psicologico, attività che andrebbero potenziate e affidate a seri professionisti attraverso degli albi nazionali e non alla casualità di progetti improvvisati), funzionali soltanto ad alimentare un’assurda concorrenza tra istituti, che fanno dimenticare da decenni che l’unico vero, utile, indispensabile progetto che la scuola offre è l’ora di lezione. Va rovesciata la prospettiva: non è la scuola ad essere un progettificio a prescindere, è che singoli progetti particolarmente validi possono essere accolti da una scuola che però di base fa altro;
via i progetti non indispensabili (ad eccezione ad esempio della mediazione linguistica e culturale per gli studenti stranieri e dello sportello d’ascolto psicologico, attività che andrebbero potenziate e affidate a seri professionisti attraverso degli albi nazionali e non alla casualità di progetti improvvisati), funzionali soltanto ad alimentare un’assurda concorrenza tra istituti, che fanno dimenticare da decenni che l’unico vero, utile, indispensabile progetto che la scuola offre è l’ora di lezione. Va rovesciata la prospettiva: non è la scuola ad essere un progettificio a prescindere, è che singoli progetti particolarmente validi possono essere accolti da una scuola che però di base fa altro; via il RAV, le programmazioni ipertrofiche e standardizzate e tutti quei documenti in cui la descrizione astratta e burocratica dell’insegnamento prende il posto dell’insegnamento stesso, in una continua e paradossale certificazione del nulla;
via il RAV, le programmazioni ipertrofiche e standardizzate e tutti quei documenti in cui la descrizione astratta e burocratica dell’insegnamento prende il posto dell’insegnamento stesso, in una continua e paradossale certificazione del nulla; via i PTOF cervellotici che prendono a pretesto presunte esigenze dei “territori”. Ciò che davvero offre qualunque scuola pubblica è l’insegnamento dell’italiano, della matematica, delle lingue, delle scienze, delle arti, delle tecnologie, della letteratura, della storia, della geografia, della storia delle idee, del diritto, la conoscenza di sé e del proprio corpo anche attraverso l’attività fisica e la socialità scolastica...non basta? Quelli che dicono che non basta vogliono in realtà togliere di mezzo proprio ciò che di prezioso la scuola offre;
via i PTOF cervellotici che prendono a pretesto presunte esigenze dei “territori”. Ciò che davvero offre qualunque scuola pubblica è l’insegnamento dell’italiano, della matematica, delle lingue, delle scienze, delle arti, delle tecnologie, della letteratura, della storia, della geografia, della storia delle idee, del diritto, la conoscenza di sé e del proprio corpo anche attraverso l’attività fisica e la socialità scolastica...non basta? Quelli che dicono che non basta vogliono in realtà togliere di mezzo proprio ciò che di prezioso la scuola offre; via insomma tutte le attività burocratiche inutili che sottraggono tempo, attenzione ed energie agli insegnanti, che devono dedicarsi esclusivamente all’insegnamento. Perché questa rivoluzione sia possibile occorre però:
via insomma tutte le attività burocratiche inutili che sottraggono tempo, attenzione ed energie agli insegnanti, che devono dedicarsi esclusivamente all’insegnamento. Perché questa rivoluzione sia possibile occorre però:7) Rivedere l’intero impianto fallimentare dell’ “autonomia scolastica”
L’ “autonomia scolastica”, introdotta al tempo del ministro Berlinguer, da oltre vent’anni a questa parte ha trasformato la Scuola pubblica nazionale, - “organo costituzionale della democrazia”, nelle parole di Calamandrei - in una serie di para-aziende in assurda concorrenza tra loro per la conquista della clientela, in inutili progettifici, in centri di potere e di proliferazione burocratica fine a se stessa, nei quali l’ambigua figura del dirigente-manager subordina quasi inevitabilmente le finalità didattiche ed educative della scuola, le uniche che la fanno esistere e le danno senso, a esigenze burocratico-gestionali ed amministrative. È indispensabile dunque restituire alla scuola l’orizzonte pubblico, democratico e nazionale che le è proprio, in modo che nessuna finalità estranea possa interferire con l’unica attività che la scuola è chiamata a compiere, quella cioè di istruire ed educare.
8) Un diverso rapporto numerico tra studenti e insegnanti
Infine, occorre fare ciò che tutti annunciano e nessuno realizza: diminuire nettamente il numero di studenti per classe, in modo che gli insegnanti possano davvero dedicare tempo e attenzione alle esigenze di ogni studente, operazione oggi più fattibile grazie ai previsti finanziamenti europei. Occorre mettere fine al paradosso per il quale si chiede agli insegnanti di attuare una didattica personalizzata - richiesta che si risolve in realtà nella proliferazione burocratica e nella richiesta di “certificazioni” di ogni tipo - e contemporaneamente gli si impedisce di farlo, imponendo loro di lavorare in classi sovraffollate in cui sono presenti fino a trenta/trentacinque studenti. Non è un caso che il numero dei partecipanti a un gruppo di discussione, secondo la psicologia dei gruppi, vada limitato a un massimo di quindici, pena l’impossibilità dell’aggregazione e del funzionamento del gruppo stesso; per la scuola, bisogna ribadire almeno che in nessun caso possano essere formate classi con un numero di studenti superiore ai venti.
C’è inoltre da smontare subito quella che, nel migliore dei casi, può essere considerata un’ingenua illusione, l’idea cioè che gli strumenti digitali permettano agli insegnanti di seguire un numero ancora maggiore di studenti, magari attraverso la produzione di video da mostrare in lezione asincrona. È vero esattamente il contrario: la “didattica a distanza”, largamente inefficace con le persone in crescita, visto che per bambini e adolescenti non esiste apprendimento che non passi per la relazione e per continui feedback verbali e non verbali, richiederebbe semmai un rapporto uno a uno tra studenti e insegnanti, per poter avere una sia pur limitatissima validità.
***
Hanno sottoscritto il manifesto anche:
Alessandro Barbero
Mauro Biani
Riccardo Bocca
Luciano Canfora
Chiara Frugoni
Carlo Ginzburg
Vito Mancuso
Dacia Maraini
Donata Meneghelli
Ana Maria Millan Gasca
Tomaso Montanari
Filippomaria Pontani
Adriano Prosperi
Massimo Recalcati
Maria Michela Sassi
Salvatore Settis
Gustavo Zagrebelsky
-
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- ANTROPOLOGIA E TEOLOGIA POLITICA. “Bibbia e Corano, un confronto”. Comincio da una precisazione rilevante: i testi sacri sono in realtà tre (di Piero Stefani).7 giugno 2021, di Federico La Sala
Intervista - "Letture" *
“Bibbia e Corano, un confronto” di Piero Stefani
Prof. Piero Stefani, Lei è autore del libro Bibbia e Corano, un confronto edito da Carocci: quanto sono simili i due testi sacri?
Comincio da una precisazione rilevante: i testi sacri sono in realtà tre. Occorre infatti distinguere tra Bibbia ebraica e Bibbia cristiana. Uno stereotipo ancora abbastanza diffuso parla di Bibbia e Vangelo. In realtà, esistono la Bibbia ebraica, e la Bibbia cristiana formata da Antico e Nuovo Testamento. I libri dell’Antico Testamento, salvo alcuni casi particolari, coincidono con quelli della Bibbia ebraica; tuttavia in questo caso si è trattato non di aggiungere alcuni libri a quelli precedenti bensì di creare un insieme da leggere e interpretare in maniera diversa.
La somiglianza più profonda è che Bibbia e Corano sono sacri soltanto a motivo dell’esistenza di tre comunità che li considerano tali, in quanto li ricevono, li leggono nella liturgia, li commentano e li trasmettono. Tutte e tre le comunità religiose condividono la convinzione che, nel corso della storia, Dio abbia fatto giungere agli esseri umani parole destinate in seguito ad assumere una forma scritta. Ciò è avvenuto grazie a specifici mediatori che hanno trascritto nella “lingua degli uomini” la volontà di Dio. Per ricorrere alla classificazione consueta, ebraismo, cristianesimo e islam sono «religioni rivelate». Tra esse ci sono molte e non lievi differenze, ma tutte emergono a partire da questo terreno comune. Le si può paragonare a un bosco in cui ci sono alberi molto differenti tra loro, anzi a volte uno di essi fa ombra a un altro, tutti però condividono lo stesso suolo.
Quali sono i più significativi punti comuni tra Bibbia e Corano?
Il primo, irrinunciabile punto in comune è che Dio è definito creatore. Ciò significa che la realtà nel suo insieme ha avuto inizio a causa di un atto libero di Dio. Per tutte e tre non si tratta di dimostrare l’esistenza di Dio a partire da quanto sperimentiamo in noi e attorno a noi; quanto affermato dalle tre religioni è che in noi e attorno a noi ci sono segni dell’opera creatrice di Dio. Per così dire, il Cantico delle creature di Francesco di Assisi esprime un convincimento comune a ebrei, cristiani e musulmani. Per tutte e tre le tradizioni religiose, specie di età moderna, nasce poi il problema di sapere come confrontarsi con la visione del cosmo e della natura proposta dalla ricerca scientifica. Qui le strategie sono in parte diverse.
Altro punto accomunante è che Dio abbia comunicato agli esseri umani delle leggi (per limitarci a un solo esempio, si pensi ai “Dieci comandamenti”) volte a regolare sia i rapporti interni alle singole comunità religiose sia quelli con le altre persone e società. In questo caso ci si deve confrontare con il problema di quale rapporto esista tra queste leggi credute di origine divina e i tempi storici in cui sono sorte. Nasce poi anche l’interrogativo di quale sia la relazione tra le leggi di natura divina e quelle, fondate su altri principi, che regolano la società civile. La questione è accomunante, le risposte sono invece molteplici e spesso non concordi. Sono tali non soltanto tra ebraismo, cristianesimo ed islam, ma anche tra i vari gruppi o membri interni alle singole comunità religiose.
Le tre grandi religioni monoteiste fondano sulla rivelazione divina la propria dottrina, tanto da meritare l’appellativo di ‘popolo del libro’: come definiscono, i due testi sacri, la comunità dei credenti?
Come accennato in precedenza è vero che tutte e tre le comunità hanno testi sacri, tutt’altro che certo è invece che le si possa chiamare concordemente «popolo del libro». Per limitarmi a un solo esempio, per il cristianesimo la fonte prima della rivelazione è Gesù stesso, di cui i Vangeli sono memoria e testimonianza. Si può affermare che tanto l’ebraismo quanto il cristianesimo definiscono i loro rispettivi testi sacri in modo gerarchizzato.
 La Bibbia ebraica è costituita da tre parti: Torah (Legge, con parola derivata dal greco, detta Pentateuco), Neviim (Profeti) e Ketuvim (Scritti). Il ruolo decisivo è svolto della prima parte; nell’armadio sacro presente in ogni sinagoga è contenuta, non a caso, solo una copia manoscritta della Torah, l’unica che fonda i precetti osservati dagli ebrei.
La Bibbia ebraica è costituita da tre parti: Torah (Legge, con parola derivata dal greco, detta Pentateuco), Neviim (Profeti) e Ketuvim (Scritti). Il ruolo decisivo è svolto della prima parte; nell’armadio sacro presente in ogni sinagoga è contenuta, non a caso, solo una copia manoscritta della Torah, l’unica che fonda i precetti osservati dagli ebrei.
 Per il cristianesimo il vertice è invece costituito dai quattro Vangeli canonici (nella liturgia cattolica proclamati solo da un sacerdote o da un diacono e ascoltati stando in piedi). Essi sono incentrati sulla vita pubblica, morte e resurrezione di Gesù. I Vangeli sono colti come una specie di chiave interpretativa per leggere in modo unitario un libro, la Bibbia, composto da un vasto insieme di testi molto vari per origine e provenienza, sorti in un arco di tempo di parecchi secoli.
Per il cristianesimo il vertice è invece costituito dai quattro Vangeli canonici (nella liturgia cattolica proclamati solo da un sacerdote o da un diacono e ascoltati stando in piedi). Essi sono incentrati sulla vita pubblica, morte e resurrezione di Gesù. I Vangeli sono colti come una specie di chiave interpretativa per leggere in modo unitario un libro, la Bibbia, composto da un vasto insieme di testi molto vari per origine e provenienza, sorti in un arco di tempo di parecchi secoli.
 Il Corano ha avuto invece un processo redazionale molto più breve misurabile in qualche decennio. La sua scansione interna è tra sure (capitoli) “fatte scendere” (cioè rivelate) a Mecca e quelle, cosiddette medinesi, risalenti a un periodo successivo all’egira (622 d.C.). I contenuti del Corano si suddividono in annunci, narrazioni e leggi; queste ultime, che incidono maggiormente sulla vita della comunità, risalgono al periodo finale della vita di Muhammad, quando il Profeta esercitava già una forma di governo.
Il Corano ha avuto invece un processo redazionale molto più breve misurabile in qualche decennio. La sua scansione interna è tra sure (capitoli) “fatte scendere” (cioè rivelate) a Mecca e quelle, cosiddette medinesi, risalenti a un periodo successivo all’egira (622 d.C.). I contenuti del Corano si suddividono in annunci, narrazioni e leggi; queste ultime, che incidono maggiormente sulla vita della comunità, risalgono al periodo finale della vita di Muhammad, quando il Profeta esercitava già una forma di governo.L’espressione «comunità dei credenti» calza bene per cristiani e musulmani in quanto l’appartenenza alla Chiesa e all’ Umma (comunità musulmana) presuppone la fede, meno agli ebrei che costituiscono un popolo vero e proprio, non a caso si è ebrei innanzitutto per nascita (secondo una discendenza matrilineare).
Come descrivono Bibbia e Corano l’origine del male?
Vi è una dimensione accomunante che individua l’origine del male nella trasgressione. Come ben compreso da Paolo nella Lettera ai Romani, perché ci sia una trasgressione bisogna che prima ci sia una legge o un comando. Occorre quindi trovare miti fondativi che si muovano in questa direzione; il più noto è quello della proibizione di mangiare l’albero della conoscenza del bene e del male. Non è difficile comprendere il suo valore simbolico incentrato propria sulla connessione tra divieto e violazione. Al pari di prospettive presenti nell’apocalittica tanto giudaica quanto cristiana, il Corano pensa a una violazione antecedente a quella compiuta dalle creature umane. Ecco allora irrompere il peccato angelico, nell’islam connesso alla figura di Iblis, angelo superbo e disobbediente. D’altra parte conviene riflettere sul fatto che una trasgressione c’è eppure non ci dovrebbe essere; in questo senso si vede chiaramente la sua connessione con il male, altra realtà che c’è ma non dovrebbe esserci. Individuare la radice del male nella trasgressione porta con sé però altri problemi: chi spinge a trasgredire? Ecco allora che si “personalizza” il peccato, presentandolo come una forza che induce a compiere atti brutali. Sia per la Bibbia sia per il Corano la storia di Caino rappresenta il simbolo più conosciuto di tutto ciò: quando uccise il fratello, il primo fra i nati da donna non aveva ricevuto il comando di non uccidere.
Aumentare a dismisura la forza del peccato o della tentazione come causa del male rischia però di fa scivolare la visione di insieme verso una forma troppo prossima al dualismo, vale a dire di prospettare l’esistenza di un Dio del male; ecco allora che in alcuni passi sia biblici sia coranici si legge che Dio crea il male (Isaia 45,7). Affermazione che non va assolutizzata ma neppure del tutto accantonata. La presenza del male rappresenta per tutti uno scoglio complesso.
In che modo Bibbia e Corano affrontano il tema della resurrezione dei morti?
Il tema è presentato in maniera per così dire defilata nella Bibbia ebraica, infatti lo si trova con chiarezza solo nel tardo e apocalittico libro di Daniele (che nella Bibbia ebraica non è annoverato neppure tra i libri profetici). La resurrezione dei morti svolge invece un ruolo centrale nel Nuovo Testamento; il motivo è evidente: il kerygma - cioè l’annuncio originario e fondamentale della fede - ha il proprio centro nella «buona novella» di Gesù Cristo morto e risorto. Come stabilito in modo definitivo da Paolo, per la fede cristiana vi è un legame inscindibile tra la risurrezione di Gesù Cristo e quella dei salvati. Anche per questo motivo nel cristianesimo, per quanto sia stato affermato più volte e venga attestato anche da alcuni passi neotestamentari, suscita sempre sconcerto la prospettiva secondo la quale ci sono dei risorti destinati alla dannazione eterna. Nel Corano la resurrezione dei morti è affermata in maniera forte e inequivocabile. Per trovarne il fondamento basta rifarsi alla perenne attività del Dio creatore: Allah, che ha plasmato l’uomo dalla polvere, è ben capace di dare nuova vita a ossa disseccate. La resurrezione è però intrinsecamente legata al giudizio in virtù del quale si è o beati o dannati; una prospettiva tanto presente nell’islam da essere anticipata da una specie di interrogatorio che avviene dentro le tombe.
Piero Stefani, di formazione filosofica, insegna “Bibbia e cultura” presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale di Milano e “Diritto ebraico” all’Istituto internazionale di Diritto Canonico e Diritto comparato delle religioni dell’Università della Svizzera Italiana. È segretario generale di Biblia, associazione laica di cultura biblica. Tra le sue numerose pubblicazioni si segnalano Il grande racconto della Bibbia, il Mulino 2017 e per Carocci I volti della misericordia (2015).
* Fonte: Letture.org
Nota:
- "Per il cristianesimo il vertice è invece costituito dai quattro Vangeli canonici (nella liturgia cattolica proclamati solo da un sacerdote o da un diacono e ascoltati stando in piedi). Essi sono incentrati sulla vita pubblica, morte e resurrezione di Gesù. I Vangeli sono colti come una specie di chiave interpretativa per leggere in modo unitario un libro, la Bibbia, composto da un vasto insieme di testi molto vari per origine e provenienza, sorti in un arco di tempo di parecchi secoli" (Piero Stefani).
Al vertice del "cristianesimo" (cattolicesimo costantiniano), in realtà, non ci sono - come sostiene Piero Stefani - i "quattro Vangeli canonici (nella liturgia cattolica proclamati solo da un sacerdote o da un diacono e ascoltati stando in piedi)", ma - fondamentalmente - ma le lettere (e l’interpretazione "andrologica" della figura di Cristo) di Paolo di Tarso:
 "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).
"Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- TERRA, MARE, E CIELO: FINE DELLA COSMOTEANDRIA. Comunicato dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA): l’astronauta Samantha Cristoforetti al comando della ISS.28 maggio 2021, di Federico La Sala
Cristoforetti prima donna in Europa a guidare una stazione spaziale *
Nel 2022 Samantha sarà lanciata verso la "base" dalla Florida: "E’ un onore, coordinerò una squadra eccezionale"
- [Foto] Cristoforetti prima donna in Europa a guidare una stazione spaziale (ansa)
L’astronauta Samantha Cristoforetti sarà la prima donna europea al comando della Stazione spaziale internazionale (ISS). E la terza al mondo dopo due americane: accadrà nel corso della Expedition 68 che la vedrà in orbita nel 2022. Lo annuncia l’Agenzia Spaziale Europea (ESA).
AstroSamantha si dice "onorata" della nomina. "Ritornare sulla Stazione spaziale internazionale per rappresentare l’Europa è un onore di per sé", afferma l’astronauta. "Sono onorata della mia nomina alla posizione di comandante e non vedo l’ora di attingere all’esperienza che ho acquisito nello spazio e sulla Terra per guidare una squadra molto competente in orbita".
Come membro dell’equipaggio "Crew-4" insieme agli astronauti NASA Kjell Lindgren e Bob Hines, nel 2022 Samantha sarà lanciata verso la Stazione Spaziale dalla Florida, USA, su un veicolo spaziale Crew Dragon di SpaceX. Questa sarà la seconda missione spaziale di Samantha. L’esperienza maturata in questi anni le sarà sicuramente utile per il suo nuovo ruolo.
Il Direttore Generale dell’ESA Josef Aschbacher ha spiegato che "la nomina di Samantha al ruolo di comandante della ISS è un’ispirazione per un’intera generazione che sta concorrendo per entrare nel corpo astronauti dell’ESA. Non vedo l’ora di incontrare i candidati finali e colgo l’occasione per incoraggiare ancora una volta le donne a farsi avanti".
* Fonte: la Repubblica, 28 Maggio 2021
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- Perché l’essere-in-comune non è riconosciuto come essenza della società? Perché è così difficile essere-in-comune (di Jean-Luc Nancy).21 maggio 2021, di Federico La Sala
Idee.
Nancy: perché è così difficile essere-in-comune
La libertà supera la soggettività perché essa è proprio ciò che viene al soggetto, da più lontano di se stessi e che prevale altrove, al di là di se stessi
di Jean-Luc Nancy (Avvenire, giovedì 20 maggio 2021)
- Il testo di Jean-Luc Nancy che proponiamo qui è un estratto del dialogo tra il pensatore francese, Marcello Ghilardi e Laura Sanò proposto sull’ultimo numero della rivista “Paradosso”, edita da Il Poligrafo. Curato da Lorenza Bottacin Cantoni e Francesco Tomatis, il numero propone un approfondimento sul tema “Sulla soglia. Pensare il confine”.
Perché l’essere-in-comune non è riconosciuto come essenza della società? Perché questo «in comune» non è fatto di un semplice accordo, ma al contrario implica il disaccordo. Secondo Kant, la nostra socialità procede da una «insocievole socievolezza». Il comune è un concetto che si presta a un’ambiguità: o si pensa a ciò che è comune a una pluralità, oppure si pensa all’essere insieme di una pluralità. Nella prima accezione, il comune è un bene condiviso (come i cosiddetti beni comuni di cui si parla molto oggi), nella seconda designa una modalità dell’essere. Questa modalità implica una pluralità, che implica diversità, la quale a sua volta implica la possibilità di divergenze o addirittura opposizioni di interessi, di aspettative, di ricettività.
L’essere-in-comune è una condizione complessa e difficile. In un certo senso implica la comunicazione come dimensione essenziale (ecco perché il linguaggio ne è inseparabile; si potrebbe anche dire che sia il linguaggio ad aprire l’in-comune; ma ci sono fin dall’inizio pluralità di lingue e diversità di significato) - e in altro modo implica la mutua estraneità degli individui e un’incomunicabilità essenziale (ad esempio, la traduzione tra lingue ne rivela la complessità). Ciò che si chiama «società» designa la necessità di fabbricare un modo di funzionamento che risponda all’«insocievole socievolezza». La società cerca di rispondere alla propria deiscenza interna. Tutte le società hanno tentato di farlo generando un’istanza di identificazione (dio, re, popolo, patria, clan, ecc.). Solo la società democratica moderna si è assunta il compito di identificarsi con la propria complessità. È un po’ come voler creare una lingua che contenga la diversità delle lingue (ma non esiste un meta-linguaggio).
Ecco perché è una sfida che non cessa di porre problemi e che dopo aver tentato di compiersi come «comunismo» (che sarebbe stata una sorta di meta-socialità) si converte al contrario in una crescente disparità di condizioni e nell’esplosione di egoismi e di ripiegamenti identitari. In un certo senso, forse gli uomini non sono mai stati così poco liberi come oggi: sono assoggettati alle loro estraneità, ai loro sfruttamenti ed esclusioni e alla limitata ristrettezza degli interessi. Invece, pensare alla società come un’associazione di uomini liberi significherebbe pensarla come lo spazio in cui ciascuno e tutti potrebbero accogliere - e condividere con gli altri - uno slancio che porti via le esistenze al di là di loro stesse, staccandole dalle loro necessità per condurle in uno spazio dove possano riconoscersi in una storia o in un destino, in una “destinerrance” come dice Derrida che le eccede tutte e così conferisce loro un senso.
Ma questo implica qualcosa di più dell’organizzazione socio-politica. Ciò implica un’eccedenza rispetto a ogni organizzazione, una an-archia testimoniata dalla non socialità o dalla asocialità dell’amore, dell’arte, ma forse anche, inevitabilmente, del crimine o della dissoluzione del legame sociale. La libertà supera la soggettività perché essa, d’altronde, è proprio ciò che viene al soggetto (sempre che si voglia utilizzare questo concetto), da più lontano di se stessi e che prevale altrove, al di là di se stessi. Essa è ciò che mi permette di non essere né causa né conseguenza in una relazione, ma semplicemente quell’inizio puntuale che nei termini di Kant inaugura una nuova serie di fenomeni ma che non vale per questa serie: che vale come inizio, origine immemorabile e insituabile.
Tale è la libertà di un gesto gratuito, di una linea gettata su un foglio o di un insieme di note suonate sulla tastiera, di una dichiarazione d’amore o di amicizia - dichiarazione non necessariamente verbale ma in atto - o di ogni sorta di decisioni di esistenza attraverso le quali incontri, scontri, situazioni mi portano dove non avrei mai pensato di andare, poiché in realtà non esisteva prima dell’incontro. Quello di cui sono il subjectum perché mi sta succedendo, ma non il soggetto che l’avrebbe fatto accadere. Essenzialmente la libertà ci libera dal soggetto, dall’assoggettamento al se-stesso e dai suoi limiti per esporci al sé-altro: non un altro sé ma l’alterità in me, tu in me o il cosmo in me o l’animale o il colore, il ritmo, l’aria che attraversa il flauto, l’impensabile e tutte le figure della libertà.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- DALLA COMUNITA’ ("DIO CON NOI" - "GOTT MIT UNS") ALLA DEMOCRAZIA (DEL "COMUNE", SENZA "UNITA’" E "SOVRANITA’"?!). «Avec (con)»: Jean-Luc Nancy, seguendo un "segnavia" di Heidegger, cerca la strada per uscire dalla "selva nera" (e dalla "caverna").
LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). Un omaggio a Kurt H. Wolff e a Barrington Moore Jr.
NUOVO REALISMO E "GAIA SCIENZA": LA LEZIONE DI DANTE (E NIETZSCHE), OGGI. CONOSCERE SE STESSI E CHIARIRSI LE IDEE, PER CARITÀ!
FLS
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- "MINIMA MORALIA" E "HALBBILDUNG": RIPARTIRE DALLA MATEMATICA. La cultura politecnica che forma “ingegneri filosofi” (di Antonio Calabrò).27 aprile 2021, di Federico La Sala
INSEGNAMENTO E COSTITUZIONE: BASTA CON LA "MEZZA-FORMAZIONE" ("HALB-BILDUNG")! PER UN NUOVO CNR (E PER UN NUOVO "POLITECNICO": “IO VORREI PENSARE CON IL CERVELLO INTERO”.... *
- RIPARTIRE DALLA CONOSCENZA: "[...] Serve una “cultura politecnica”, con la straordinaria attualità di un “umanesimo industriale” che oggi, in tempi di digital economy e di Intelligenza Artificiale, va declinato anche come “umanesimo digitale” [...]
 Il Pnrr (la sigla difficilmente pronunciabile che sta per “Piano nazionale di ripresa e resilienza”) e cioè la versione italiana del Recovery Plan della Ue, stanzia 31,9 miliardi per Istruzione e Ricerca, per rafforzare, cioè, “il sistema educativo, le competenze digitali e tecnico-scientifiche, la ricerca e il trasferimento tecnologico”, come spiega Palazzo Chigi in un comunicato. In dettaglio, “il Piano investe negli asili nido, nelle scuole materne, nei servizi di educazione e cura per l’infanzia; crea 152.000 posti per i bambini fino a 3 anni e 76.000 per i bambini tra i 3 e i 6 anni” (A. Calabrò, La cultura politecnica che forma "ingegneri filosofi", 26.04.2021)
Il Pnrr (la sigla difficilmente pronunciabile che sta per “Piano nazionale di ripresa e resilienza”) e cioè la versione italiana del Recovery Plan della Ue, stanzia 31,9 miliardi per Istruzione e Ricerca, per rafforzare, cioè, “il sistema educativo, le competenze digitali e tecnico-scientifiche, la ricerca e il trasferimento tecnologico”, come spiega Palazzo Chigi in un comunicato. In dettaglio, “il Piano investe negli asili nido, nelle scuole materne, nei servizi di educazione e cura per l’infanzia; crea 152.000 posti per i bambini fino a 3 anni e 76.000 per i bambini tra i 3 e i 6 anni” (A. Calabrò, La cultura politecnica che forma "ingegneri filosofi", 26.04.2021)
- RIPARTIRE DALLA CONOSCENZA DELLA MATEMATICA : “[...] È una disciplina che non ammette principio di autorità giacché nessuno possiede la verità da solo, le verità sono asserzioni verificabili da chiunque, o se non da chiunque (alcune volte è difficile) almeno da un certo numero di persone. Inoltre, la matematica è un linguaggio, una grammatica. Per discutere di matematica bisogna accettarne le regole. Sicché uno studioso, ma anche uno studente di matematica, è abituato a operare in un mondo di regole comuni, per ridiscutere le quali non si può essere in uno, bisogna essere almeno in due.
 Ovviamente la matematica non procede per voto o alzata di mano, ma per ipotesi e verifiche. Se i nostri politici avessero studiato matematica, e se studiandola l’avessero capita, si comporterebbero diversamente rispetto alle cariche dello Stato che ricoprono perché non agirebbero come singoli, ma come funzioni di un sistema più ampio del loro ego, e soprattutto non si preoccuperebbero delle cose ma delle relazioni tra le cose, dunque sarebbero più cauti nel dare una notizia falsa o non verificata, perché consci di quanto la notizia falsifichi il resto, talvolta il contesto.” (Chiara Valerio, La matematica è politica, Einaudi, Torino, 2020, p. 53).
Ovviamente la matematica non procede per voto o alzata di mano, ma per ipotesi e verifiche. Se i nostri politici avessero studiato matematica, e se studiandola l’avessero capita, si comporterebbero diversamente rispetto alle cariche dello Stato che ricoprono perché non agirebbero come singoli, ma come funzioni di un sistema più ampio del loro ego, e soprattutto non si preoccuperebbero delle cose ma delle relazioni tra le cose, dunque sarebbero più cauti nel dare una notizia falsa o non verificata, perché consci di quanto la notizia falsifichi il resto, talvolta il contesto.” (Chiara Valerio, La matematica è politica, Einaudi, Torino, 2020, p. 53).
La cultura politecnica che forma “ingegneri filosofi”.
Università, le sfide del Piano Draghi
di Antonio Calabrò (HuffingtonPost, 26.04.2021)
 Giornalista, scrittore e vicepresidente di Assolombarda
Giornalista, scrittore e vicepresidente di Assolombarda“Ripartire dalla conoscenza”, sostiene Ferruccio Resta, per passare “dalle aule svuotate dal virus alla nuova centralità dell’Università”. Resta è rettore del Politecnico di Milano e attuale presidente della Crui, la Conferenza dei rettori delle università italiane. È un ingegnere, professore di Meccanica applicata alle Macchine (l’espressione “civiltà delle macchine” gli si adatta bene). E nelle pagine del nuovo libro, costruito attraverso un dialogo con Ferruccio de Bortoli e pubblicato da Bollati Boringhieri, ragiona non solo sulla necessità di investire massicciamente sulla formazione, per rendere l’Italia più competitiva, nella stagione del predominio della “economia della conoscenza”, ma anche sui contenuti della formazione, tenendo insieme, in modo originale, tecnologia e bellezza, saperi umanistici e conoscenze scientifiche, matematica e letteratura, ingegneria e filosofia, come peraltro proprio la migliore storia culturale ed economica italiana ci insegna.
Serve una “cultura politecnica”, con la straordinaria attualità di un “umanesimo industriale” che oggi, in tempi di digital economy e di Intelligenza Artificiale, va declinato anche come “umanesimo digitale” (tutti temi, peraltro, più volte affrontati in questo blog). Il Pnrr (la sigla difficilmente pronunciabile che sta per “Piano nazionale di ripresa e resilienza”) e cioè la versione italiana del Recovery Plan della Ue, stanzia 31,9 miliardi per Istruzione e Ricerca, per rafforzare, cioè, “il sistema educativo, le competenze digitali e tecnico-scientifiche, la ricerca e il trasferimento tecnologico”, come spiega Palazzo Chigi in un comunicato. In dettaglio, “il Piano investe negli asili nido, nelle scuole materne, nei servizi di educazione e cura per l’infanzia; crea 152.000 posti per i bambini fino a 3 anni e 76.000 per i bambini tra i 3 e i 6 anni”.
Si investe nel risanamento strutturale degli edifici scolastici, con l’obiettivo di ristrutturare una superficie complessiva di 2.400.000 metri quadri. E, per quel che riguarda i contenuti, si prevede una riforma dell’orientamento, dei programmi di dottorato e dei corsi di laurea, per esempio con l’aggiornamento della disciplina dei dottorati e un loro aumento di circa 3.000 unità.
Sempre un comunicato di Palazzo Chigi spiega che “si sviluppa l’istruzione professionalizzante e si rafforza la filiera della ricerca e del trasferimento tecnologico”. Con un’attenzione particolare per gli Its, gli Istituti tecnici superiori, per incrementare gli studenti iscritti, rafforzare i laboratori con tecnologie 4.0, formare i docenti e adattare i programmi formativi secondo le esigenze delle imprese in cerca di capitale umano qualificato, sviluppare una piattaforma nazionale per fare incontrare offerta e domanda di lavoro.
Siamo insomma di fronte a risorse di un certo livello, progetti ambiziosi, da realizzare in tempi brevi (il 2026, come scadenza massima). Il governo Draghi, insomma, s’è mosso. La Ue ritrova anche in questo capitolo il senso di fondo della sua strategia del Recovery Plan, in coerenza con l’orientamento di fondo indicato fin dal nome, “Next Generation”. L’impegno, adesso, è passare tempestivamente dalle pagine del Piano ai cantieri delle opere, alle scelte dei programmi didattici e alle realizzazioni.
Il libro di Resta e de Bortoli offre indicazioni preziose, su come usare bene i soldi finalmente a disposizione e dunque fare funzionare meglio università e ricerca, su come rafforzare il dialogo tra università, comunità sui territori e imprese. E su come progettare una formazione superiore che tenga conto del rapido sviluppo delle nuove conoscenze e dunque sull’usura altrettanto intensa di quello che oggi si sa.
 Bisogna insegnare a imparare. E tenere testa a una seconda sfida, proprio di fronte all’impetuoso cambiamento delle tecnologie: quella di capire il senso delle cose che si fanno, indagare sui valori di riferimento, sulle conseguenze umane ed etiche dei progressi tecnologici. Non solo, dunque, saper scrivere efficacemente gli algoritmi dell’Intelligenza Artificiale, ma comprenderne, controllarne e governarne gli effetti. Per evitare manipolazioni occulte (il monito etico di Luciano Floridi, professore a Oxford di Filosofia dell’Informazione) e cercare di conciliare sviluppo hi tech, libertà, responsabilità. Come devono saper fare degli ingegneri filosofi, dei tecnologi poeti, appunto.
Bisogna insegnare a imparare. E tenere testa a una seconda sfida, proprio di fronte all’impetuoso cambiamento delle tecnologie: quella di capire il senso delle cose che si fanno, indagare sui valori di riferimento, sulle conseguenze umane ed etiche dei progressi tecnologici. Non solo, dunque, saper scrivere efficacemente gli algoritmi dell’Intelligenza Artificiale, ma comprenderne, controllarne e governarne gli effetti. Per evitare manipolazioni occulte (il monito etico di Luciano Floridi, professore a Oxford di Filosofia dell’Informazione) e cercare di conciliare sviluppo hi tech, libertà, responsabilità. Come devono saper fare degli ingegneri filosofi, dei tecnologi poeti, appunto.Le discipline universitarie, suggerisce Resta, non vanno più inquadrate in “gabbie rigide”. E, proprio pensando ai Politecnici, insiste: “Un ingegnere oggi non è più il tecnico che deve rispondere al singolo problema, ma deve dare risposte a sfide sociali e problemi complessi che sempre più spesso coinvolgono anche la sfera etica delle tecnologie”. Proprio le indicazioni di fondo del Recovery Plan della Ue, ambiente e innovazione, sostenibilità ed economia digitale, hanno bisogno di persone, di figure professionali formate in modo multi-disciplinare, adatta a fare sintesi originali di saperi in continua mutazione.
Il nostro Paese, insomma, ha urgente bisogno di investire su conoscenza e formazione, ricerca e innovazione. Risorse finanziarie e riforme del Recovery Plan ne sono finalmente strumento adeguato. Per costruire cultura del futuro, competenze, produttività e competitività. Abbiamo la necessità di superare il gap dei 13 milioni di persone che hanno solo un titolo di studio di scuola media inferiore formazione e il limite del basso numero di laureati, soprattutto nelle materie scientifiche. E dobbiamo dunque costruire una formazione migliore, non solo nei cicli scolastici, ma nelle relazioni lunghe tra scuola e lavoro, quella che tecnicamente si chiama long life learning, un’attitudine a imparare che ci accompagni per tutta la vita. Anche da questo punto di vista le università colte, aperte, efficaci nei processi formativi sono, come dice Resta, “centrali”. La conoscenza è il nostro migliore futuro.
*Sul tema, in rete, si cfr.:
- L’ATTIVISMO ACCECANTE DEL "FAR WEST" E IL "SAPERE AUDE" DELLA "CRITICA DELLA RAGION PURA" --- SOCIOLOGIA, FILOSOFIA, E "BILDUNG": NOTE SULLA TEORIA DELLA "HALBBILDUNG" ("MEZZA-CULTURA") DI TH. W. ADORNO.
EUROPA: EDUCAZIONE SESSUALE ED EDUCAZIONE CIVICA. ITALIA "NON CLASSIFICATA"!!! --- 8 MARZO 2021. Draghi: c’è tanto da fare per parità di genere a livelli Ue
PER UN NUOVO CNR! ALL’INSEGNA DI ERMES: “IO VORREI PENSARE CON IL CERVELLO INTERO”. IN MEMORIA DI ENRICO FILIPPINI E DI MICHEL SERRES
Federico La Sala
- RIPARTIRE DALLA CONOSCENZA: "[...] Serve una “cultura politecnica”, con la straordinaria attualità di un “umanesimo industriale” che oggi, in tempi di digital economy e di Intelligenza Artificiale, va declinato anche come “umanesimo digitale” [...]
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- FILOLOGIA E FILOSOFIA: UN "REFUSO" DI LUNGA DURATA E "LA INVENZIONE DI GESU’ DI NAZARETH" (Fernando Bermejo-Rubio).6 aprile 2021, di Federico La Sala
#FILOLOGIA #Storiografia #critica.
Un #lapsus e un #refuso di #lungadurata: "Le Fonti. Le lettere di #PaolodiTarso [...] 1 Cor 11, 23-26 (sull’#eucarestia: Mc 14, 22-25/Mt 26, 26-29/Lc 22, 14-20) [...]" (Fernando Bermejo-Rubio, L’invenzione di Gesù di Nazareth, Torino 2021, p. 21)! #Eucaristia, eu-#carestia, e #latinorum. Uscire dal #letargo. O no?!
#CHARIDAD, #EUCARISTIA (EU-#CHARIS-TIA), #PoncioPilato (#PonzioPilato).La #invencion de #JesusdeNazaret. #Historia #ficción #historiografia (#FernandoBermejoRubio): https://www.amazon.it/invenci%C3%B3n-jes%C3%BAs-Nazaret-Fernando-Bermejo/dp/8432319201?asin=B07KSXYNPR&revisionId=e46a8f88&format=1&depth=1
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- IL PROBLEMA DI "MOSE". «Il Mose è lo scandalo mondiale sulle opere pubbliche più grande della nostra storia recente» (di M. Cacciari).5 aprile 2021, di Federico La Sala
«Il Mose è lo scandalo mondiale sulle opere pubbliche più grande della nostra storia recente»
Disastro annunciato: hanno pagato, si fa per dire, i corrotti. Ma gli incompetenti non saranno chiamati a risponderne
di Massimo Cacciari (L’Espresso, 05 Aprile 2021) 05 Aprile 2021
Occorre purtroppo continuare a parlare del Mose poiché si tratta del più grande scandalo mondiale in tema di lavori pubblici nell’intera storia del secondo dopoguerra. E di una vergognosa devastazione di risorse del nostro Paese che dura ormai da un trentennio. La parte destinata a corruzione e tangenti, passata quasi in giudicato, è quella quantitativamente meno rilevante. Sono le deficienze complessive del progetto, sotto tutti i profili, che sono costate miliardi di euro e continueranno a costarli, se si vuole in qualche modo «salvare» l’opera, almeno nel senso che di quando in quando le paratoie possano sollevarsi. Di tutto potrei stupirmi fuorché della denuncia della dottoressa Ramundo e del professor Paolucci.
- Venezia
- «Il Mose è già marcio» denunciano gli esperti. E si dimettono
- Alberto Vitucci (L’Espresso, 02 Aprile 2021)
Loro illustri colleghi avevano già ricordato cose analoghe fin da quando il progetto delle dighe mobili venne approvato. Che dico approvato! Esaltato, magnificato, sostenuto contro ogni evidenza da tutti i governi e tutti i ministri dei Lavori Pubblici succedutisi nel Bel Paese tra anni ’90 e nuovo millennio. Con la complicità della totalità o quasi dei media nazionali. E contro le posizioni, i documenti, le analisi, gli studi promossi dalle Amministrazioni comunali che ho diretto, 1993-2000, 2005-2010. Chi è interessato, può facilmente rintracciare tutta la documentazione, presentata a Comitati tecnici, Consigli superiori dei Lavori Pubblici, Corte dei Conti, provveditori e ministri di ogni colore. Tutti sapevano, o sarebbero stati tenuti a sapere.
 Votai contro, unico, in Comitato inter-ministeriale per la salvaguardia di Venezia, mettendo agli atti le ragioni del mio radicale dissenso, e mi arresi. Il fronte era invincibile, dal Governo alla Regione, Galan e Zaia, dalle Associazioni di categoria tutte, alla Confindustria, alla stragrande maggioranza di tecnici impiegati dal Consorzio, a tv e giornali (con la lodevole eccezione della Nuova Venezia),e via cantando. Capitolo ben triste della storia civile patria.
Votai contro, unico, in Comitato inter-ministeriale per la salvaguardia di Venezia, mettendo agli atti le ragioni del mio radicale dissenso, e mi arresi. Il fronte era invincibile, dal Governo alla Regione, Galan e Zaia, dalle Associazioni di categoria tutte, alla Confindustria, alla stragrande maggioranza di tecnici impiegati dal Consorzio, a tv e giornali (con la lodevole eccezione della Nuova Venezia),e via cantando. Capitolo ben triste della storia civile patria.
 Il problema della corrosione, drammatico come si evince dalle parole di Ramundo e Paolucci, è uno dei tanti irrisolti. Vi è quello del traffico portuale. Vi è quello del soggetto che dovrebbe gestire il sistema e decidere del suo funzionamento in condizioni critiche. Vi è quello straordinario della manutenzione in generale.
Il problema della corrosione, drammatico come si evince dalle parole di Ramundo e Paolucci, è uno dei tanti irrisolti. Vi è quello del traffico portuale. Vi è quello del soggetto che dovrebbe gestire il sistema e decidere del suo funzionamento in condizioni critiche. Vi è quello straordinario della manutenzione in generale.Quando il sottoscritto chiedeva disperatamente ne venisse esplicitato il costo, si parlava di 30-40 milioni all’anno, ora questa cifra dovrà essere almeno raddoppiata. Chi scoverà queste risorse per i prossimi anni, nella situazione in cui si trova il Paese? E senza manutenzione il Mose semplicemente si disfa, come risulta chiaro dalle lettere di dimissioni dei due ex consulenti. Chi dovrà pagare per questo annunciato disastro? Finora hanno pagato, si fa per dire, soltanto corrotti e corruttori. Ma incompetenti lautamente remunerati e compagnia bella non devono pagare? Chi ha fatto il collaudo non si è accorto della qualità dei materiali utilizzati? Chi doveva dirigere il tutto non ha avuto notizia della mancata manutenzione? Come salvare il salvabile?
 Un’unica via: trovare i soldi necessari per fare tutto quello che Ramundo e Paolucci direttamente e indirettamente richiedono e affidare a loro o a gente seria come loro, che non deve obbedire a nient’altro che alla propria coscienza, il lavoro da fare e la gestione dell’opera.
Un’unica via: trovare i soldi necessari per fare tutto quello che Ramundo e Paolucci direttamente e indirettamente richiedono e affidare a loro o a gente seria come loro, che non deve obbedire a nient’altro che alla propria coscienza, il lavoro da fare e la gestione dell’opera.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE.
FLS
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- "LA DIFFICILE EREDITA’ DI MARX" E IL NODO DELLA QUESTIONE ANTROPOLOGICA DI KANT.30 marzo 2021, di Federico La Sala
MARX, IL "LAVORO - IN GENERALE", E IL "RAPPORTO SOCIALE DI PRODUZIONE - IN GENERALE".... *
- Una nota a margine del testo di Riccardo Bellofiore, La difficile eredità di Marx, Sinistra in rete, 24 marzo 2021.
"CRITICA DELL’ECONOMIA POLITICA" , "CRITICA DELLA RAGION PRATICA" (E MEMORIA DI DANTE ALIGHIERI - ANNO 2021) . Alla luce del fatto che si è persa ogni cognizione dello "stato di cose presente", forse, è opportuno - come voleva Marx - riprendere il filo dalla indicazione delle note "Per la critica della filosofia del diritto di Hegel. Introduzione"): "La teoria è capace di impadronirsi delle masse non appena dimostra ad hominem, ed essa dimostra ad hominem non appena diviene radicale. Essere radicale vuol dire cogliere le cose alla radice. Ma la radice, per l’uomo, è l’uomo stesso".
Si dice:
- "[...] Vi sono delle lacune nella riflessione originaria di Marx che vanno superate. Marx vede bene un punto: che sotto il capitale il lavoro è prestazione erogata dalla forza-lavoro di ‘soggetti’ apparentemente liberi ed eguali. È di lì, da questi lavoratori che sono un ‘altro’ dal capitale che deve essere reso interno, ‘incorporato’ nella fabbrica produttiva, che viene estratto il lavoro vivo, dunque il nuovo valore di cui il plusvalore è parte: è per questo che le lotte sul lavoro sono centrali. Non presta però attenzione alla riproduzione sociale degli esseri umani che sono portatori viventi della forza-lavoro, dunque al lavoro domestico e al lavoro di cura. È questo uno dei fuochi del discorso del femminismo. C’è poi un ‘altro’ che è esterno al capitale, che è la natura, che viene anch’essa sfruttata e depredata nel suo corpo come gli esseri umani. Anche questo Marx lo vede, ma in qualche misura ne sottostima la gravità, che non può più sfuggirci" (R. Bellofiore, cit).
CONCORDO. Ma per ripartire bisogna riprendere il filo dalla "Logica" di Kant (non di Hegel, come si recita ancora oggi: http://www.leparoleelecose.it/?p=41116#comment-439785), dalla sua "quarta" (e prima!) domanda: "che cosa è l’uomo?", dalla sua "Critica della ragion pratica", e dal suo "imperativo categorico" (http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=5635)! La questione è antropologica (non andrologica né ginecologica)! O no?!
* Sul tema, mi sia lecito, si cfr. la "Lettera da ‘Johannesburg’ a Primo Moroni (in memoriam)": "CHI" SIAMO NOI, IN REALTÀ. RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE (http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=4198); su COME NASCONO I BAMBINI? E COME ‘NASCONO’ I GENITORI?!, rileggere la lettera di Sigmund Freud (http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=2923).
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- ANTROPOLOGIA, GRAMMATICA E MATEMATICA. Donne al futuro (di Francesca Rigotti -"Doppiozero).).20 marzo 2021, di Federico La Sala
Tweet
*
Controparola/
Donne al futuro
di Francesca Rigotti (Doppiozero, 20 marzo 2021)
Da quando ho scoperto che nella grammatica esistono termini marcati e termini non marcati - me li ha spiegati un illustre linguista amico di tastiera - non dico che non dormo di notte ma quasi. I termini non marcati, se ho capito bene, sono dominanti e includenti: per esempio il termine «giorno», che comprende il giorno e la notte; notte invece è un termine marcato, giacché designa soltanto il tempo dell’oscurità. Non marcato è uomo (ci avviciniamo al tema) in quanto comprende se stesso e anche la donna, la quale invece, guardacaso, è marcata quale «soltanto» donna.
Dovevo ripensare a questa disparità grammaticale nel leggere Donne al futuro, raccolta di saggi di donne che parlano «soltanto» di altre donne, uscito per il Mulino a cura delle amiche di Controparola. Si tratta di un gruppo di scrittrici e giornaliste, nato nel 1992 per iniziativa di Dacia Maraini, che ha pubblicato diversi libri sulle donne tra i quali Donne del Risorgimento, Donne nella Grande Guerra, nella Repubblica, nel Sessantotto e ora al futuro. Sono Paola Cioni, Eliana Di Caro, Paola Gaglianone, Dina Lauricella, Lia Levi, Dacia Maraini, Cristiana Palazzoni, Maria Serena Palieri, Valeria Papitto, Linda Laura Sabbadini, Francesca Sancin, Cristiana di San Marzano, Mirella Serri, cui si deve Donne al futuro (il Mulino, Bologna 2021). Sempre e soltanto donne. O donne sole, si potrebbe anche dire, che è un’espressione un po’ deprimente ma anche molto divertente, a leggerla con ironia, e con la quale si intendono donne in compagnia di altre donne ma non di uomini. Mentre la dicitura per soli uomini sta per luoghi e/o attività in cui le donne non possono entrare e a cui non devono partecipare (e così è intitolata l’eccellente analisi statistica Per soli uomini. Il maschilismo dei dati, dalla ricerca scientifica al design, appena pubblicata da Codice Edizioni e condotta dalla giornalista Emanuela Griglié e del collega Guido Romeo).
Le donne al futuro di questo libro, soltanto donne marcate nella loro donnità, sono di fatto figure straordinarie, proiettate, come dice il titolo, al futuro o declinate al futuro, visto che siamo partiti dalla grammatica (che innocentemente mi costringe qui a scrivere al maschile benché io sia donna che scrive di donne che scrivono di donne. La lingua sarà anche colpevole ma non nel modo semplificato e a tratti oltraggioso che le attribuiscono le interpretazioni corrive, come spiega puntualmente l’amico linguista il cui nome adesso svelo, Nunzio La Fauci, ma la dice lunga). Donne giovani che lavorano per fabbricare il futuro con l’arte e la musica, l’architettura e l’astrofisica; con l’impegno civile e umanitario (donnitario?), con la ricerca medica, l’economia, la pratica sportiva e l’insegnamento.
 Le elenco qui tutte in fila in ordine alfabetico: Alice Pasquini (AliCè), Paola Antonelli, Marica Branchesi, Francesca Bria, Ilaria Capua, Silvia Colasanti, Ilaria Cucchi, Emma Dante, Sara Gama, Rita Giaretta, Giuseppina Multari, Eliana La Ferrara, Laila Abi Ahmed e Isabella Mancini, Barbara Riccardi, Fulvia Signani e le altre, Beatrice Vio. Un ricordo è dedicato alla cittadina del mondo Agitu Ideo Gudeta, uccisa nel dicembre scorso in Trentino, dove si era trasferita e portava avanti la sua attività di imprenditrice.
Le elenco qui tutte in fila in ordine alfabetico: Alice Pasquini (AliCè), Paola Antonelli, Marica Branchesi, Francesca Bria, Ilaria Capua, Silvia Colasanti, Ilaria Cucchi, Emma Dante, Sara Gama, Rita Giaretta, Giuseppina Multari, Eliana La Ferrara, Laila Abi Ahmed e Isabella Mancini, Barbara Riccardi, Fulvia Signani e le altre, Beatrice Vio. Un ricordo è dedicato alla cittadina del mondo Agitu Ideo Gudeta, uccisa nel dicembre scorso in Trentino, dove si era trasferita e portava avanti la sua attività di imprenditrice.Non potendo parlare di tutte ho scelto di citarne una sola, l’unica tra l’altro che mi era del tutto ignota, lo confesso e chiedo venia: Sara Gama. Sara Gama, classe 1989, madre triestina e padre congolese, capitana della Nazionale azzurra femminile di calcio nonché vicepresidente dell’Assocalciatori (termine non marcato che comprende anche le calciatrici mentre le calciatrici, marcate dall’essere soltanto donne, non comprendono i calciatori).
 Sara Gama, ho scoperto, non soltanto gioca al calcio femminile da quando era una bambinetta ma rivendica anche, per quel calcio di donne, assicurazione sanitaria, previdenze, stipendio e soprattutto dignità. Studentessa liceale, studentessa universitaria - sulla storia del calcio femminile in Europa ha anche scritto la tesi - Sara Gama, che nell’immagine di copertina sembra, coi suoi bei capelli ricci, l’Italia turrita, nel discorso del 4 luglio 2019 al Quirinale, di fronte al presidente Mattarella, ha ricordato l’articolo 3 della Costituzione che sancisce la dignità di tutti i cittadini «senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali».
Sara Gama, ho scoperto, non soltanto gioca al calcio femminile da quando era una bambinetta ma rivendica anche, per quel calcio di donne, assicurazione sanitaria, previdenze, stipendio e soprattutto dignità. Studentessa liceale, studentessa universitaria - sulla storia del calcio femminile in Europa ha anche scritto la tesi - Sara Gama, che nell’immagine di copertina sembra, coi suoi bei capelli ricci, l’Italia turrita, nel discorso del 4 luglio 2019 al Quirinale, di fronte al presidente Mattarella, ha ricordato l’articolo 3 della Costituzione che sancisce la dignità di tutti i cittadini «senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali».
 E questo grazie alle donne della Costituzione, le madri costituient, che contro l’opinione di alcuni padri della costituzione insistettero affinché nell’art. 3 venisse inserita la specificazione «di sesso», perché senza quella la conquista della parità sarebbe stata ancor più difficile di quanto già lo sia.
E questo grazie alle donne della Costituzione, le madri costituient, che contro l’opinione di alcuni padri della costituzione insistettero affinché nell’art. 3 venisse inserita la specificazione «di sesso», perché senza quella la conquista della parità sarebbe stata ancor più difficile di quanto già lo sia. -
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- ANTROPOLOGIA, ANATOMIA, E MATEMATICA: UNA LEZIONE (1560) DI GIOVANNI VALVERDE, DI LUIGI CANCRINI (2005), E DI CHIARA VALERIO...10 marzo 2021, di Federico La Sala
MATEMATICA, ANATOMIA, E BAMBINI E BAMBINE. UNA QUESTIONE DI CIVILTÀ..
- LA MATEMATICA È LA COSTITUZIONE, “È una disciplina che non ammette principio di autorità giacché nessuno possiede la verità da solo, le verità sono asserzioni verificabili da chiunque, o se non da chiunque (alcune volte è difficile) almeno da un certo numero di persone. Inoltre, la matematica è un linguaggio, una grammatica. Per discutere di matematica bisogna accettarne le regole. Sicché uno studioso, ma anche uno studente di matematica, è abituato a operare in un mondo di regole comuni, per ridiscutere le quali non si può essere in uno, bisogna essere almeno in due.
 Ovviamente la matematica non procede per voto o alzata di mano, ma per ipotesi e verifiche. Se i nostri politici avessero studiato matematica, e se studiandola l’avessero capita, si comporterebbero diversamente rispetto alle cariche dello Stato che ricoprono perché non agirebbero come singoli, ma come funzioni di un sistema più ampio del loro ego, e soprattutto non si preoccuperebbero delle cose ma delle relazioni tra le cose, dunque sarebbero più cauti nel dare una notizia falsa o non verificata, perché consci di quanto la notizia falsifichi il resto, talvolta il contesto.” (Chiara Valerio, La matematica è politica, Einaudi, Torino, 2020, p. 53).
Ovviamente la matematica non procede per voto o alzata di mano, ma per ipotesi e verifiche. Se i nostri politici avessero studiato matematica, e se studiandola l’avessero capita, si comporterebbero diversamente rispetto alle cariche dello Stato che ricoprono perché non agirebbero come singoli, ma come funzioni di un sistema più ampio del loro ego, e soprattutto non si preoccuperebbero delle cose ma delle relazioni tra le cose, dunque sarebbero più cauti nel dare una notizia falsa o non verificata, perché consci di quanto la notizia falsifichi il resto, talvolta il contesto.” (Chiara Valerio, La matematica è politica, Einaudi, Torino, 2020, p. 53).
Parlare dell’embrione per dimenticare il mondo
risponde Luigi Cancrini (l’Unità, 28.02.2005, p. 27)
«Avrei voluto con mio honore poter lasciar questo capitolo, accioche non diventassero le Donne più superbe di quel che sono, sapendo, che elleno hanno anchora i testicoli, come gli uomini; e che non solo sopportano il travaglio di nutrire la creatura dentro suoi corpi, come si mantiene qual si voglia altro seme nella terra, ma che anche vi pongono la sua parte; pure sforzato dall’historia medesima non ho potuto far altro. Dico adunque che le Donne non meno hanno testicoli, che gli huomini, benche non si veggiano per esser posti dentro del corpo».
Così inizia il capitolo 15 dell’Anatomia di Giovanni Valverde, stampata a Roma nel 1560, intitolato «De Testicoli delle donne» (p. 91). Dopo queste timide e tuttavia coraggiose ammissioni, ci vorranno altri secoli di ricerche e di lotte: «(...) fino al 1906, data in cui l’insegnamento adotta la tesi della fecondazione dell’ovulo con un solo spermatozoo e della collaborazione di entrambi i sessi alla riproduzione e la Facoltà di Parigi proclama questa verità ex cathedra, i medici si dividevano ancora in due partiti, quelli che credevano, come Claude Bernard, che solo la donna detenesse il principio della vita, proprio come i nostri avi delle società prepatriarcali (teoria ovista), e quelli che ritenevano (...) che l’uomo emettesse con l’eiaculazione un minuscolo omuncolo perfettamente formato che il ventre della donna accoglieva, nutriva e sviluppava come l’humus fa crescere il seme» (Françoise D’Eaubonne). Oggi, all’inizio del terzo millennio dopo Cristo, nello scompaginamento della procreazione, favorito dalle biotecnologie, corriamo il rischio di ricadere nel pieno di una nuova preistoria: «l’esistenza autonoma dell’embrione, indipendente dall’uomo e dalla donna che hanno messo a disposizione i gameti e dalla donna che può portarne a termine lo sviluppo» spinge lo Stato (con la Chiesa cattolico-romana - e il Mercato, in una vecchia e diabolica alleanza) ad avanzare la pretesa di padre surrogato che si garantisce il controllo sui figli a venire. Se tuttavia le donne e gli uomini e le coppie che si sentono responsabili degli embrioni residui dichiarassero quale destino pare loro preferibile, se un’improbabile adozione, la distruzione o la donazione alla ricerca scientifica, con la clausola che in nessun modo siano scambiati per denaro o ne derivi un profitto, la vita tornerebbe rivendicata alle relazioni umane piuttosto che al controllo delle leggi, ne avrebbe slancio la presa di coscienza dei vincoli che le tecnologie riproduttive impongono e più consenso la difesa della “libertà” di generare.
 Federico La Sala
Federico La SalaHo molto apprezzato la citazione di Valverde soprattutto per un motivo: perché dimostra, con grande chiarezza il modo timido e spaventato con cui da sempre gli uomini di scienza si sono accostati al tema della procreazione. Il problema di quello che era un tempo “l’anima” dell’essere umano, la sua parte più preziosa e più peculiare, quella cui le religioni affidavano il senso della memoria e dell’immortalità è stata sempre monopolio, infatti, dei filosofi e dei teologi che hanno difeso accanitamente le loro teorie (i loro “pregiudizi”: nel senso letterale del termine, di giudizi dati prima, cioè, del momento in cui si sa come stanno le cose) dalle conquiste della scienza. Arrendendosi solo nel momento in cui le verità scientifiche erano troppo evidenti per essere ancora negate e dimenticando in fretta, terribilmente in fretta, i giudizi morali e gli anatemi lanciati fino ad un momento prima della loro resa. Proponendo uno spaccato estremamente interessante del modo in cui il bisogno di credere in una certa verità può spingere, per un certo tempo, a non vedere i fatti che la contraddicono. Come per primo ha dimostrato, scientificamente, Freud.
Ragionevolmente tutto questo si applica, mi pare, alle teorie fra il filosofico e il teologico (come origine: i filosofi e teologi “seri” non entrano in polemiche di questo livello) per cui l’essere umano è tale, e tale compiutamente, dal momento del concepimento. Parlando di diritti dell’embrione tutta una catena ormai di personaggi più o meno qualificati per farlo (da Buttiglione a Schifani, da Ruini a La Russa) si riempiono ormai la bocca di proclami (sulla loro, esibita, profonda, celestiale moralità) e di anatemi (nei confronti dei materialistici biechi di una sinistra senza Dio e senza anima).
In nome dell’embrione sentito come una creatura umana, la cui vita va tutelata, con costi non trascurabili, anche se nessuno accetterà mai di impiantarli in un utero. Mentre milioni di bambini continuano amorire nel mondo e intorno a loro senza destare nessun tipo di preoccupazione in chi, come loro, dovendo predisporre e votare leggi di bilancio, si preoccupa di diminuire la spesa sociale del proprio paese (condannando all’indigenza e alla mancanza di cure i bambini poveri che nascono e/o vivono in Italia) e le spese di sostegno ai piani dell’Onu (mantenendo, con freddezza e cinismo, le posizioni che la destra ha avuto da sempre sui problemi del terzo mondo e dei bambini che in esso hanno la fortuna di nascere).
Si apprende a non stupirsi di nulla, in effetti, facendo il mestiere che faccio io. Quando un paziente di quelli che si lavano continuamente e compulsivamente le mani fino a rovinarle, per esempio, ci dice (e ci dimostra con i suoi vestiti e con i suoi odori) che lava il resto del suo corpo solo quando vi è costretto da cause di forza maggiore, ci si potrebbe stupire, se non si è psichiatri, di questa evidente contraddizione. Quello che capita di capire essendolo, tuttavia, è che i due sintomi obbediscono ad una stessa logica (che è insieme aggressiva e autopunitiva) e che il primo serve di facciata, di schermo all’altro che è il più grave e il più serio. E accade a me di pensare, sentendo Buttiglione e La Russa che parlano di diritti dell’embrione e ignorando nei fatti quelli di tanti bambini già nati, che il problema sia, in fondo, lo stesso. Quello di un sintomo che ne copre un altro. Aiutando a evitare il confronto con la realtà e con i sensi di colpa. All’interno di ragionamenti che dovrebbero essere portati e discussi sul lettino dell’analista, non nelle aule parlamentari.
Così va, tuttavia, il mondo in cui viviamo. Perché quello che accomuna la Chiesa di ieri e tanta destra di oggi, in effetti, è la capacità di far germogliare il potere proprio dalle radici confuse della superficialità e del pregiudizio. Perché essere riconosciuti importanti ed essere votati, spesso, è il risultato di uno sforzo, anch’esso a suo modo assai faticoso, “di volare basso”, di accarezzare le tendenze più povere, le emozioni e i pensieri più confusi di chi non ama pensare. Parlando della necessità di uno Stato che pensi per lui, che decida al suo posto quello che è giusto e quello che non lo è. Liberandolo dal peso della ragione e del libero arbitrio. Come insegnava a Gesù, nella favola immaginata da Dostojevskji, il Grande Inquisitore quando Gesù aveva avuto l’ardire di tornare in terra per dire di nuovo agli uomini che erano uguali e liberi e rischiava di mettere in crisi, facendolo, l’autorità di una Chiesa che per 16 secoli aveva lavorato per lui e agito nel suo nome.
Del tutto inimmaginabile, sulla base di queste riflessioni, mi sembra l’idea che Buttiglione e Ruini, Schifani e La Russa possano accettare oggi l’idea da te riproposta nell’ultima parte della tua lettera per cui «le donne, gli uomini e le coppie che si sentono responsabili degli embrioni» potrebbero/ dovrebbero essere loro a decidere quale destino pare loro preferibile.
Ragionando sui fatti con persone scelte liberamente da loro perché sentite come capaci di dare loro gli elementi necessari per la decisione più corretta. Affermando l’idea per cui gli uomini, le donne e le coppie possono e debbono essere i veri protagonisti di quella procreazione responsabile che è il passaggio più alto, più difficile, più esaltante e più faticoso della vita di tutti gli esseri umani. Quella che più fa paura a tanta parte della Chiesa e della destra, in fondo, è soprattutto la libertà della coscienza critica. Per ragioni, io torno qui sul mio ragionamento iniziale, che andrebbero discusse sul lettino dell’analista, però, non nelle aule parlamentari, sui manifesti o sulle pagine di un giornale.
- LA MATEMATICA È LA COSTITUZIONE, “È una disciplina che non ammette principio di autorità giacché nessuno possiede la verità da solo, le verità sono asserzioni verificabili da chiunque, o se non da chiunque (alcune volte è difficile) almeno da un certo numero di persone. Inoltre, la matematica è un linguaggio, una grammatica. Per discutere di matematica bisogna accettarne le regole. Sicché uno studioso, ma anche uno studente di matematica, è abituato a operare in un mondo di regole comuni, per ridiscutere le quali non si può essere in uno, bisogna essere almeno in due.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---LA LETTERA DELLA COSTITUZIONE, L’ANTROPOLOGIA, E UNA NUOVA "FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO".18 febbraio 2021, di Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- Storia, storiografia, e antropologia d’ancien régime. Un altro deus ex machina sul piano inclinato della crisi: Draghi e non solo (di Marco Revelli).16 febbraio 2021, di Federico La Sala
Tweet
#STORIA #STORIOGRAFIA E #DRAGHI: USCIRE DAL #LETARGO (#DANTE2021). #Tracce per una #svolta_antropologica e una #transizione_ecologica. #Dante, la #crisi culturale e #politica dell’#Europa e "l’#antropologia d’#ancien régime" (http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=5908).
***
Un altro deus ex machina sul piano inclinato della crisi
Draghi e non solo. La via tecnocratica, costruita con sofisticata ingegneria istituzionale, per ricondurre a «ordine» l’anomalia del voto del 2018, ridisegnando il sistema di governo
- [Foto] Il giuramento del governo Draghi al Quirinale
di Marco Revelli (il manifesto, 16.02.2021)
La Banca sopra la Politica, il Nord sopra il Sud, i maschi sopra le donne. Questa appare, ridotta all’essenziale, la struttura architettonica del nuovo governo: una fotografia perfetta dello stato di cose esistente e delle sue inamovibili gerarchie.
Non può sfuggire a nessuno, intanto, che l’ex governatore di Bankitalia e della Bce ha riservato a sé e ai propri fedelissimi il controllo della cassaforte, in primis del «tesorone» in arrivo dall’Europa, perché la gestissero con l’unica logica che gli uomini di banca conoscono: quella del denaro che rispetta solo se stesso (e che va dove già ce n’è).
E che poi abbia affidato per così dire «d’ufficio» un certo numero di ministeri chiave a quella che può essere considerata un’élite del sapere tecnico. Quasi volesse «mettere in sicurezza» il «cuore dello stato», o del sistema, da una politica malata, per certi versi comatosa, che nelle convulsioni dell’ultimo bimestre ha mostrato a nudo la propria incapacità di venire a capo della crisi che essa stessa aveva scatenato, riservandole un parterre tanto ampio quanto poco qualificato.
Uno spazio di tutti (e del contrario di tutti) da popolare secondo i dettami del manuale Cencelli, in cui le scarse competenze e l’esuberante litigiosità potessero in qualche misura offrire un simulacro di «copertura politica» senza rischiare di danneggiare i gangli vitali del sistema (più che commissariamento, «confinamento» si potrebbe dire).
Questo deve essere stato il pensiero congiunto di Draghi e Mattarella: la via tecnocratica, costruita con sofisticata ingegneria istituzionale, attraverso cui ricondurre a «ordine» l’anomalia selvaggia inaugurata col voto del 2018, ridisegnando il sistema di governo sulla mappa gerarchica del potere reale rispettandone con certosina attenzione le isobare.
Ed è esattamente quel criterio che ha portato a premiare il Nord (18 ministri) a scapito del Sud (appena 4), tanto che verrebbe da dire che, parafrasando la Moratti, i «posti» sono stati assegnati territorialmente in base al Pil: ben 9 ministri vengono dalla Lombardia, 4 dal Veneto, nessuno dalle isole...
 Mentre per le donne - 8 su 24 - non è cosa nuova, è l’antropologia d’ancien régime che ha parlato.
Mentre per le donne - 8 su 24 - non è cosa nuova, è l’antropologia d’ancien régime che ha parlato.Funzionerà? Si può davvero pensare di venire a capo di una grave «crisi di sistema» - quale quella che effettivamente l’Italia vive - con espedienti ingegneristici o con la logica del deus ex machina?
 È per lo meno la terza volta che si tenta questa via - la prima con Ciampi, la seconda con Monti, ora con Draghi, peraltro figure assai simili per competenze e profilo tecnico-culturale - e ogni volta se ne è usciti con uno scatto in avanti sul piano inclinato della crisi istituzionale e sociale.
È per lo meno la terza volta che si tenta questa via - la prima con Ciampi, la seconda con Monti, ora con Draghi, peraltro figure assai simili per competenze e profilo tecnico-culturale - e ogni volta se ne è usciti con uno scatto in avanti sul piano inclinato della crisi istituzionale e sociale.Il governo Ciampi, non dimentichiamolo, fu l’ultimo della Prima Repubblica. Dopo la sua fine dilagò il berlusconismo, espressione di una metamorfosi regressiva dell’elettorato nel suo complesso. Quindici anni più tardi, dopo diciassette mesi di governo Monti emerse il corpaccione grillino al centro di un sistema politico terremotato e sulla superficie di un corpo sociale martoriato, diventato addirittura nel 2018 maggioranza relativa, con una percentuale simile alla vecchia Dc.
Un altro terremoto che sconvolse vecchi e nuovi poteri, istituzionali ed economici, che infatti si misero subito all’opera per ricuperare centralità e controllo. E che oggi festeggiano il ritorno alla casella di partenza in questo gioco dell’oca che già ha percorso due giri a vuoto, nella speranza di fare, finalmente, l’en plein, e di poter sovrapporre al disordine di quel voto «obsoleto» un nuovo ordine venuto dall’alto di un’Europa non più matrigna.
È un’impresa arrischiata. Anche per poteri abituati da sempre a vincere. E nella sua sostanza opaca. Non perché violi, in qualche modo, la lettera della Costituzione: tutto è avvenuto entro i canoni degli articoli 92 e 94 (peraltro molto sobri). Ma perché sfida la «costituzione materiale» di una democrazia rappresentativa nella quale la volontà di rottura di continuità espressa, sia pur in modo convulso e contraddittorio, nell’ultima elezione generale viene neutralizzata (le convulsioni dei 5Stelle, ma anche il triplo salto mortale della Lega, lo testimoniano), per essere infine piegata a una deriva iper-continuista (che difficilmente, pur collocandosi in un’Europa diversa, e pur disponendo degli euro del Recovery, sanerà le ferite sociali e il malessere che produssero la rivolta nelle urne del ’18).
E poi perché crea un governo ibrido, in cui l’élite tecnica siede su un tappeto di macerie costituite da un sistema dei partiti profondamente lesionato dove ogni forza politica si presenta negando una parte di se stessa e ogni cultura politica appare dissolta, rendendo assai improbabile l’efficacia del confinamento.
Un governo che, come tutti i governi omnibus, ospita una pletora di partecipanti, ognuno dei quali non rinuncerà a usare il »posto a tavola» ottenuto come megafono per regolare i conti col proprio vicino: i «polli di Renzo», anzi di Renzi potremmo dire, di cui già Salvini e compagni offrono un bell’esempio usando il podio che l’altro Matteo gli ha offerto per aprire una campagna elettorale permanente.
Fin dall’inizio dei miei studi in Scienza politica ho dovuto imparare che per il buon funzionamento di una democrazia moderna, è necessario che tra il livello della Società e quello delle Istituzioni esista una solida Società Politica, a svolgere il ruolo di canale di comunicazione e di fattore di legittimazione. Se questa avvizzisce o muore, avvizzisce e muore la democrazia.
In questo senso il «miracoloso» governo di Mario Draghi rischia di sfidare le leggi fisiche della politica, con esiti potenzialmente infausti.
La frase con cui Giovanni Agnelli commentò il governo Ciampi - «dopo il governatore, c’è solo un generale, o un cardinale» - potrebbe ritornare di attualità non se Draghi fallisse ma se, completato il mandato, la politica si presentasse ancora nuda alle elezioni del ‘23.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- STORIA E STORIOGRAFIA. IL FALLIMENTO DEGLI UOMINI NUOVI (di Guido Crainz).16 febbraio 2021, di Federico La Sala
La crisi di sistema
IL FALLIMENTO DEGLI UOMINI NUOVI
DI GUIDO CRAINZ (L’Espresso, 07 febbraio 2021)
Neppure il pessimismo più cupo poteva immagi-nare un’implosione così radicale, un crollo cosìprivo di dignità, una abdicazione così totale del"sistema dei partiti" (odi quel che ne resta). Eppure è difficile stupirsi: quante volte abbiamo dovuto interrogarci sulla crisi sempre più grave della politica e dei suoi attori, dei suoi contenutie del suo modo di essere? E quando abbiamo iniziato ad avvertire le derive?
 Solleviamo per un attimo lo sguardo dalle misere e drammatiche dinamiche dei giorni scorsi, vi è sul lontano sfondo qualcosa di profondo: uno spartiacque d’epoca avvertito sin dagli anni 80. Iniziano ad emergere allora le trasformazioni destinate ad erodere gli scenari del Novecento: con la crisi delle ideologie e il progressivo incrinarsi dei partiti dimassa fondati sulla militanza e l’appartenenza. Con il modificarsi dei soggetti sociali: si pensi al progressivo uscir di scena della "classe operaia", fulcro della realtà e dell’immaginario della sinistra. E con radicali trasformazioni delle forme della politica, nel delinearsi dei "partiti personali" e della "democrazia del pubblico".
Solleviamo per un attimo lo sguardo dalle misere e drammatiche dinamiche dei giorni scorsi, vi è sul lontano sfondo qualcosa di profondo: uno spartiacque d’epoca avvertito sin dagli anni 80. Iniziano ad emergere allora le trasformazioni destinate ad erodere gli scenari del Novecento: con la crisi delle ideologie e il progressivo incrinarsi dei partiti dimassa fondati sulla militanza e l’appartenenza. Con il modificarsi dei soggetti sociali: si pensi al progressivo uscir di scena della "classe operaia", fulcro della realtà e dell’immaginario della sinistra. E con radicali trasformazioni delle forme della politica, nel delinearsi dei "partiti personali" e della "democrazia del pubblico".Con la trasformazione cioè della comunità dei cittadini in una platea di telespettatori, in rapporto diretto con il leader: si erode anche per questa via l’insediamento sociale dei partiti e si delineano progressivamente, per dirla con Ilvo Diamanti, leader senza partiti e partiti senza società. Si rivedano le intense immagini dei funerali di Enrico Berlinguer, nel 1984: fotografano un punto alto e al tempo stesso l’inizio del declino del "popolo comunista". E oggi ci appaiono anche un inconsapevole e commosso addio ai grandi partiti del Novecento, già incrinati nei loro tratti ideologici e nel loro radicamento territoriale.
Pochi mesi prima il leader comunista erastato fischiato al Congresso di Verona del Psi che aveva riconfermato Craxi per acclamazione: «la più radicaleantitesi dell’elezione democratica», annotava Nor-berto Bobbio. Il primo annuncio dei "partiti perso-nali", e nelle scenografie dei congressi socialisti di allora è facile intravedere anche l’avanzare della"politica-spettacolo".
 Naturalmente non è solo italiana la crisi delle forme novecentesche della politica. Per certi versi, ha osservato Sabino Cassese, l’indebolimento del partito-organizzazione può essere anche «un passo avanti perla democrazia - consente di rompere le fortificazioni erette intorno ad essa - ma produce un vuoto di educazione civica e di selezione della classe dirigente al quale bisogna porre rimedio». In quel vuoto aumentò invece nei nostri anni 80 la deformazione di partiti di governo portati a surrogare il calo dei consensi con l’uso dissennato del denaro pubblico, sempre più intrecciato a fenomeni corruttivi. E a trasformarsi così in «federazioni di correnti, di camarille, ciascunacon un boss e dei sotto-boss»: era parsa estrema, nel 1981, la denuncia di Berlinguer.
Naturalmente non è solo italiana la crisi delle forme novecentesche della politica. Per certi versi, ha osservato Sabino Cassese, l’indebolimento del partito-organizzazione può essere anche «un passo avanti perla democrazia - consente di rompere le fortificazioni erette intorno ad essa - ma produce un vuoto di educazione civica e di selezione della classe dirigente al quale bisogna porre rimedio». In quel vuoto aumentò invece nei nostri anni 80 la deformazione di partiti di governo portati a surrogare il calo dei consensi con l’uso dissennato del denaro pubblico, sempre più intrecciato a fenomeni corruttivi. E a trasformarsi così in «federazioni di correnti, di camarille, ciascunacon un boss e dei sotto-boss»: era parsa estrema, nel 1981, la denuncia di Berlinguer.
 Dieci anni dopo Edmondo Berselli annotava che quel ceto politico sembrava attraversato e scosso, ormai, «da due spinte esattamente opposte: l’istinto di conservazione e una oscura volontà di autoannientamento». E in quella "immobilità parossistica" cresceva una «perfida combinazione di crisi economica conclamata e di marasma politico pericolosamente vicino al collasso del sistema».
Dieci anni dopo Edmondo Berselli annotava che quel ceto politico sembrava attraversato e scosso, ormai, «da due spinte esattamente opposte: l’istinto di conservazione e una oscura volontà di autoannientamento». E in quella "immobilità parossistica" cresceva una «perfida combinazione di crisi economica conclamata e di marasma politico pericolosamente vicino al collasso del sistema».
 II collasso verrà presto e travolgerà i partiti di governo ben oltre la bufera di Tangentopoli, ma non trionferà una sinistra ex comunista che era rimasta in larga parte estranea ai processi corruttivi ma non era stata capace di ripensarsi realmente. E veniva identificata così con il vecchio sistema politico.
II collasso verrà presto e travolgerà i partiti di governo ben oltre la bufera di Tangentopoli, ma non trionferà una sinistra ex comunista che era rimasta in larga parte estranea ai processi corruttivi ma non era stata capace di ripensarsi realmente. E veniva identificata così con il vecchio sistema politico.
 Ebbe gioco facile, allora, il populismo di un "uomo nuovo" cresciuto neimedia, nelle culture e nelle deformazioni degli anni Ottanta. Intriso di insofferenza alle regole e di antistatalismo, di sostanziale disprezzo per le istituzioni e di illusionismo («un nuovo, straordinario miracolo italiano»). E i peggiori umori sedimentati nel decennio precedente troveranno larga rappresentanza nelle fila di Forza Italia e della Lega di Bossi (sono eloquenti le cronache parlamentari di allora).
Ebbe gioco facile, allora, il populismo di un "uomo nuovo" cresciuto neimedia, nelle culture e nelle deformazioni degli anni Ottanta. Intriso di insofferenza alle regole e di antistatalismo, di sostanziale disprezzo per le istituzioni e di illusionismo («un nuovo, straordinario miracolo italiano»). E i peggiori umori sedimentati nel decennio precedente troveranno larga rappresentanza nelle fila di Forza Italia e della Lega di Bossi (sono eloquenti le cronache parlamentari di allora).
 Sembrò declinare dopo pochi mesi la stagione berlusconiana, ma poté prolungarsi poi per un ventennio grazie alla incapacità della sinistra di rifondarsi: eppure forme di "buona politica" erano pur emerse allora, dall’elezione diretta dei sindaci alle "primarie". Non trovarono vero ascolto però le istanze ad aprirsi più profondamente alla società civile: l’esigenza di una «politica restituita ai cittadini» è «un mito estremista» tuonò Massimo D’Alema, e chiuse il discorso. Riemersero così vecchi vizi e il centrosinistra vedrà progressivamente isterilirsi il proprio ceto politico, le proprie rappresentanze e le proprie dinamiche interne.
Sembrò declinare dopo pochi mesi la stagione berlusconiana, ma poté prolungarsi poi per un ventennio grazie alla incapacità della sinistra di rifondarsi: eppure forme di "buona politica" erano pur emerse allora, dall’elezione diretta dei sindaci alle "primarie". Non trovarono vero ascolto però le istanze ad aprirsi più profondamente alla società civile: l’esigenza di una «politica restituita ai cittadini» è «un mito estremista» tuonò Massimo D’Alema, e chiuse il discorso. Riemersero così vecchi vizi e il centrosinistra vedrà progressivamente isterilirsi il proprio ceto politico, le proprie rappresentanze e le proprie dinamiche interne.- LEADER SENZA PARTITI E PARTITI SENZA SOCIETÀ È LA RADICE LUNGA DEL CROLLO ATTUALE DI FIDUCIA
Vedrà moltiplicarsi microbaronie locali, e sarà sempre più po-vero di ideali e idee. Maturò così la rivincita berlusconiana del 2001, nonostante i risultati positivi rilievo pur conseguiti dal centrosinistra. E di lì a poco la spinta al rinnovamento dei "girotondi" non trovò ascolto in un ceto politico sempre più chiuso in se stesso. Sempre più "casta", come denunciava un libro di enorme successo del 2007: e in quello stesso anno Beppe Grillo occupò la scena con il primo Vaffa.
 Esplodeva in quel torno di tempo una crisi finanziaria internazionale destinata a lasciare segni profondissimi. A rendere sempre meno credibile l’illusionismo berlusconiano e a rendere ineludibili nodi irti. Le ferite della globalizzazione avrebbero imposto, ad esempio, un ripensamento profondo del welfare, già incrinato dai mutati rapporti fra ceti e generazioni, ma quel ripensamento non vi fu.
Esplodeva in quel torno di tempo una crisi finanziaria internazionale destinata a lasciare segni profondissimi. A rendere sempre meno credibile l’illusionismo berlusconiano e a rendere ineludibili nodi irti. Le ferite della globalizzazione avrebbero imposto, ad esempio, un ripensamento profondo del welfare, già incrinato dai mutati rapporti fra ceti e generazioni, ma quel ripensamento non vi fu.
 Un’altra prova fallita dalla politica, mentre l’insicurezza era alimentata dal crescere impetuoso dell’immigrazione (e dall’incapacità di dare ad essa risposte reali) e dal comparire all’orizzonte del terrorismo islamico. Affondava in quello scenario il ventennio berlusconiano, lasciando inaspriti e sperduti milioni di italiani che in quell’illusionismo avevano pur creduto. Esposti ora al disincanto e al rancore.
Un’altra prova fallita dalla politica, mentre l’insicurezza era alimentata dal crescere impetuoso dell’immigrazione (e dall’incapacità di dare ad essa risposte reali) e dal comparire all’orizzonte del terrorismo islamico. Affondava in quello scenario il ventennio berlusconiano, lasciando inaspriti e sperduti milioni di italiani che in quell’illusionismo avevano pur creduto. Esposti ora al disincanto e al rancore.
 Ben poco sapeva parlare ad essi la retorica bersaniana dell’"usato sicuro", inevitabilmente travolta dall’antipolitica urlata di Beppe Grillo: e in Parlamento irruppero nuove, improbabili schiere di "uomini nuovi" (si rileggano anche in questo caso le cronache dì allora).
Ben poco sapeva parlare ad essi la retorica bersaniana dell’"usato sicuro", inevitabilmente travolta dall’antipolitica urlata di Beppe Grillo: e in Parlamento irruppero nuove, improbabili schiere di "uomini nuovi" (si rileggano anche in questo caso le cronache dì allora).
 Iniziò in quello scenario la breve stagione di Matteo Renzi, e iniziò con un impegno importante: «cambiare la politica e cambiare il Pd». Mai impegno fu più disatteso (eppure era desolante lo "stato del partito" fotografato allora da Fabrizio Barca), e lo stesso appuntamento alla Leopolda diventò la caricatura di un rinnovamento programmatico.
Iniziò in quello scenario la breve stagione di Matteo Renzi, e iniziò con un impegno importante: «cambiare la politica e cambiare il Pd». Mai impegno fu più disatteso (eppure era desolante lo "stato del partito" fotografato allora da Fabrizio Barca), e lo stesso appuntamento alla Leopolda diventò la caricatura di un rinnovamento programmatico.
 Prendeva corpo inoltre, grazie anche ad altri attori, una "democrazia del leader" segnata non dallo strapotere del capo ma dalla sua fragilità, come ha osservato Mauro Calise: dal suo essere «esposto alla spirale delleaspettative crescenti, dei sondaggi incombenti e delle decisioni impellenti. Con un circuito di legittimazione costantemente sull’orlo di una crisi di nervi».
Prendeva corpo inoltre, grazie anche ad altri attori, una "democrazia del leader" segnata non dallo strapotere del capo ma dalla sua fragilità, come ha osservato Mauro Calise: dal suo essere «esposto alla spirale delleaspettative crescenti, dei sondaggi incombenti e delle decisioni impellenti. Con un circuito di legittimazione costantemente sull’orlo di una crisi di nervi».
 Crollò così anche la stagionedi Renzi, ridotto ora alla irresponsabile caricatura di se stesso: sarebbe stato (ed è) necessario affrontare radicalmente i nodi che ne avevano provocato al tempo stesso l’ascesa e la caduta.
Crollò così anche la stagionedi Renzi, ridotto ora alla irresponsabile caricatura di se stesso: sarebbe stato (ed è) necessario affrontare radicalmente i nodi che ne avevano provocato al tempo stesso l’ascesa e la caduta.
 Sarebbe stato (ed è) necessario avviare, almeno, un ripensamento radicale sulle modalità di formazione del ceto politico,e dare corpo a cantieri reali di riflessione e di proposta suigrandi temi che incombono (dall’Europa al Mezzogiorno, dall’istruzione al lavoro e al welfare). Sarebbe necessaria e urgente, insomma, una vera stagione congressuale, impegno pur preso - a parole - dal segretario attuale del Pd. A parole,appunto, come aveva fatto Matteo Renzi.
Sarebbe stato (ed è) necessario avviare, almeno, un ripensamento radicale sulle modalità di formazione del ceto politico,e dare corpo a cantieri reali di riflessione e di proposta suigrandi temi che incombono (dall’Europa al Mezzogiorno, dall’istruzione al lavoro e al welfare). Sarebbe necessaria e urgente, insomma, una vera stagione congressuale, impegno pur preso - a parole - dal segretario attuale del Pd. A parole,appunto, come aveva fatto Matteo Renzi. -
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- CON GIAMBATTISTA VICO ED ECO, AL DI LA’ DELL’ORIZZONTE DI "PERICLE IL POPULISTA" E DI PLATONE.2 febbraio 2021, di Federico La Sala
AL DI LA’ DELL’ORIZZONTE DI "PERICLE IL POPULISTA" E DI PLATONE...
- TUCIDIDE E LA GUERRA CONTRO I "POETI": "[...] non abbiamo bisogno di alcun Omero che canti la nostra gloria né di chi con le sue parole procurerà un diletto immediato, dando però un’interpretazione dei fatti che non potrà reggere quando la verità si affermerà: con la nostra audacia abbiamo costretto il mare e la terra interi ad aprirci le loro vie, e ovunque abbiamo innalzato alle nostre imprese, siano state esse sfortunate o coronate da successo, monumenti che non periranno. Ed è per una tale città che questi uomini hanno affrontato amabilmente la morte in combattimento [...]" (Tucidide, La guerra del Peloponneso, II, 41, Bari, Laterza 1986).
PER NON CADERE (di nuovo e ancora, dopo millenni) NELLA TRAPPOLA DELLA TRACOTANZA E DELLA MALAFEDE DI "PERICLE", E NON DIMENTICARE CHE LA SUA LINEA POLITICA SEGNA L’INIZIO DELLA FINE DELLA GLORIA E DEL PROGETTO POLITICO DI ATENE, forse, è opportuno - ricordando la messa al bando di Omero e dei "poeti" dalla "Repubblica" di Platone - riprendere e rivedere (non solo i lavori di Eric A. Havelock, ma anche) la brillante analisi del cosiddetto "Elogio di Atene" da parte di Umberto Eco nella sua nota sul "Pericle il populista" di ieri e di oggi (la Repubblica, 14 gennaio 2012):
- "Il discorso di Pericle (riportato da Tucidide, in Guerra del Peloponneso) è stato inteso nei secoli come un elogio della democrazia, e in prima istanza è una descrizione superba di come una nazione possa vivere garantendo la felicità dei propri concittadini, lo scambio delle idee, la libera deliberazione delle leggi, il rispetto delle arti e dell’educazione, la tensione verso l’uguaglianza. Ma che dice in realtà Pericle?";
e, al contempo, volendo, rimeditare la storica lezione di Giambattista Vico sulla questione "Omero" e riflettere sulla sua proposta di una "Scienza Nuova", al di là dell’imbalsamazione crociana.
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- COSTITUZIONE E COMUNICAZIONE. "Serve un’ecologia della parola. Adesso"! (di Mauro Magatti)..18 gennaio 2021, di Federico La Sala
La riflessione.
La comunicazione politica dentro la crisi: rispettateci anche a parole
di Mauro Magatti (Avvenire, domenica 17 gennaio 2021)
Nel passato, la parola data era sacra e, col suggello di una stretta di mano, stabiliva impegni vincolanti. Un retaggio che filtra fin nelle democrazie moderne che fanno del "parlamento" il palazzo dove i diversi interessi e i differenti punti di vista "si parlano", si confrontano, si accordano. Anche i sistemi politici più avanzati poggiano su quella fragile e delicata facoltà della vita umana che è la parola.
Sappiamo tutti quanto è difficile intendersi. Equivoci, fraintendimenti, ipocrisie, menzogne. Non certo solo in Parlamento. Ma al lavoro, in famiglia. Non sempre si dice quello che si pensa. Né si fa quello che si dice. Più spesso le parole vengono usate strategicamente per i propri obiettivi. Ingannando gli altri, violentando la realtà. Da qui si scatenano tensioni, litigi, lotte, sfiducia. Tutti ingredienti tristi della nostra vita.
Nulla di cui sorprendersi o scandalizzarsi dunque. La comunicazione umana, quando ha successo, ha qualcosa di miracoloso. E proprio poiché ne conosciamo la fragilità, col tempo si è affermata la tendenza a sostituirla con contratti scritti, procedure rigide, algoritmi. Col rischio di diventare una società di autistici. Ci sono situazioni, però, in cui la verità delle cose si impone con forza. In cui il bene che condividiamo è così necessario e forte da non ammettere furbizie o manipolazioni.
Così dopo quasi 11 mesi di pandemia, con ormai più di 80mila morti, con le scuole chiuse da quasi un anno, con interi settori economici distrutti, con ansia e preoccupazione in aumento nella popolazione, l’uso palesemente strumentale delle parole che abbiano ancora una volta visto nel ’teatrino della politica’ suona particolarmente stucchevole. L’Italia non meritava e non merita un tale spettacolo.
Un gruppo di governanti che pensa al bene comune, di fronte a delle legittime divergenze, si chiude in una stanza discute tutto il tempo necessario per arrivare a un accordo o a un disaccordo. E poi parla chiaro, e agisce alla luce del sole. E invece sono settimane (se non mesi) che il Paese è inchiodato in una pantomima dove tutti hanno un pezzo di ragione ma nessuno riconosce i propri torti. Renzi che critica (giustamente) certo immobilismo e verticismo di Conte, facendo però capire che il suo scopo non è semplicemente quello di dare buoni consigli al premier ma di rimandarlo a casa.
Conte che interviene con toni sempre rassicuranti su tutte le questioni facendo però finta di non sapere che il nostro (anziano) Paese è uno dei peggiori al mondo per numero assoluto di morti e di riduzione del Pil. I 5stelle che si dichiarano contrari al Mes (quando la nostra sanità avrebbe bisogno di ogni ulteriore risorsa) senza mai proporre una qualche ragione comprensibile, ma per pura affermazione identitaria e ideologica.
Il Pd che cerca di barcamenarsi in una coalizione traballante, ma non riconosce che, al di là delle speranza del primo momento, la coalizione di governo di fatto non riesce a prendere forma e consistenza. E intanto i leader dell’opposizione non perdono occasione per dire tutto quello che si sarebbe dovuto fare e che il governo non ha fatto elencando, senza vincolo di realtà, un numero più o meno infinito di decisioni che meravigliosamente ci avrebbero potuto portare fuori dalla crisi. Ma non fanno mai cenno dei fallimenti clamorosi registrati nelle Regioni in cui governano.
Con tutta la buona volontà, si tratta di uno spettacolo deprimente per il cittadino che cerca di farcela in mezzo a mille difficoltà. L’abuso della parola provoca un grave danno alla democrazia. Quando nessuno crede più a nessuno e si perde la fiducia nella possibilità di intendersi, il Parlamento diventa una ’torre di babele’ di cui qualcuno comincia a pensare di fare a meno. E questo è pericoloso. La parola comunicazione viene dal latino com-munis che rimanda all’idea di dono ’obbligatorio’.
Un’espressione che noi non riusciamo più nemmeno a cogliere. Come è possibile un dono obbligatorio? In realtà questa idea nasce dal presupposto che le relazioni (e quindi la comunicazione) siano rette su una obbligazione e che, proprio per questo, il comportamento individuale, pur libero, non possa prescindere da una serie di condizioni.
 Che nel caso della comunicazione hanno a che fare con la ricerca della verità, la franchezza, l’onestà, la parresia. Senza obbligazione, la democrazia si riduce a puro scontro di potere, delegittimandosi di fronte al popolo. Soprattutto quando la verità dei fatti si impone per la sua gravità, non si possono usare le parole in modo solo strategico.
Che nel caso della comunicazione hanno a che fare con la ricerca della verità, la franchezza, l’onestà, la parresia. Senza obbligazione, la democrazia si riduce a puro scontro di potere, delegittimandosi di fronte al popolo. Soprattutto quando la verità dei fatti si impone per la sua gravità, non si possono usare le parole in modo solo strategico.
 Serve un’ecologia della parola. Adesso.
Serve un’ecologia della parola. Adesso. -
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- UNA «"FESSURA" NELLA BEN ROTONDA COMPATTEZZA DELL’ESSERE». Lettera a Emanuele Severino (di R. De Monticelli).17 gennaio 2021, di Federico La Sala
Memoria /memorie
Lettera a Emanuele Severino
Intorno a una - eterna - lezione
di Roberta De Monticelli (Il Mulino, 24 gennaio 2020)
Caro professore,
se l’essere nella Gioia, come spero, le consente di ricevere qualche lettera senza che la Gioia sia interrotta dalla noia di leggerla, lasci pure che questa mia si depositi come foglia, soffio, ombra, umana illusione, fiato di voce o scintillio d’inchiostro là dove i più fra noi, tardi di mente e innamorati del visibile, stoltamente dimorano: nel Cerchio dell’Apparenza.Non turberà l’eternità dell’esser suo, caro professore, questo cicaleccìo di una collega invisibile, sì, proprio quella dell’aula accanto, quella del giovedì. O forse era martedì? Che cosa conta, e chissà mai perché poi avevamo quest’abitudine di onorare gli orari di lezione, questa conformistica, veramente illogica acquiescenza alla misurazione di ciò che non esiste, il tempo. Lei poi arrivava puntualissimo, molto più di me. Ben me ne accorgevo ogni volta che la folla dei suoi allievi in festosa attesa faceva barriera davanti a tutte le porte dello stretto corridoio su cui si aprivano le nostre aule, e i quattro gatti della mia classe e io restavamo bloccati per un pezzo, prima di entrare, con loro e mio rimpianto, nell’auletta degli esercizi di fenomenologia, piena di controversie e dubbi, invece che nella luce dell’incontrovertibile. Dove per due ore quelle menti giovinette e incerte, anzi certamente scosse da ogni sorta di amore e di terrore, si sarebbero spalancate alla ben rotonda verità dell’Essere, indefettibile e immobile: che sarebbe fluita senza interruzione alcuna dalle sue labbra, nel più religioso silenzio.
Lei cominciava col ben disporle, le menti, al saldissimo fondamento dell’epi-steme - diceva così, mi arrivava il suono della sua voce che inesorabilmente spezzava la parola greca, sapientemente appoggiando, con la pausa, la voce alla solidità di ciò che sta. Il sapere che sta, e non importa dove e come. Di là dalla parete, sentivo l’ombra di Socrate, smarrita, emergere come un fantasma da quella lineetta, da quella pausa che spezzava la parola, e come in un grido afono, beckettiano articolare con la bocca muta parole simili a sospiri: conoscenza... opinione vera e... giustificata... le ragioni, vi prego, le ragioni... Le ragioni per dirlo. L’evidenza per riconoscere che è vero - fino a prova contraria. Altro che stare. Quelli che stavano lì, immobili, ierocratici, erano i dignitari immensi della statuaria babilonese; a me veniva in mente ogni volta la stazione centrale di Milano, e certo subito ne arrossivo. In Grecia erano mobilissimi anche gli dei, invece, pieni di bizze e voglie, di splendori e di furia e di grazia, come i ragazzi e le ragazze che lei sapeva affascinare e render muti - come in un’estasi iniziatica.
Così, una volta che la mia lezione cominciava più tardi, l’ardente desiderio mi prese - chissà, l’invidia - di carpire il segreto di quel fascino. E assistetti alla mirabile dimostrazione “parmenidea” dell’impossibilità di far domande, con cui quel giorno si apriva il suo corso. E fremetti anche io dall’ammirazione, caro professore. Con quella voce così musicale, e insieme ieratica, quella sì, come se non si svolgesse affatto nel tempo: «Chi domanda è evidentemente nella non-verità. Ma dall’essere nella non-verità non c’è via all’essere nella verità. [Pausa]. Non c’è via. Per la contraddizione, che non la consente». Come invidiai questo modo così suadente di trasformare in un silenziatore il paradosso platonico della conoscenza, quello che introdusse nella nostra mente e nella nostra storia l’idea della ricerca, l’idea più sconvolgente e più controvertibile! Anzi controversa, al punto che bisognò morire, con Socrate, e mica una volta sola, perché l’idea vivesse, e la ricerca pure, e da questo sfacciato parricidio, da questa insolente perplessità che obietta alla ben rotonda verità dell’Essere, nascessero, come in una cosmogonia esiodea, la Disputa e l’Argomentazione, il Dubbio e la Scoperta, il disprezzo del sentito dire e la gioia del vedere, e la veglia e la critica, e il demone giocoso eppure serissimo della ragione.
Che non è affatto una dea barricadiera e neppure una prosopopea della storia, ma solo l’irriguardosa, umile, ridente e dolente giovinezza dell’età adulta, quando ancora ha freschezza e speranza per dire, ad esempio: “No, a nessun prezzo mi si imporrà questo, piuttosto morire”; oppure “E perché no? Perché mai le cose non dovrebbero avvenire così, anche se non le vedo ancora? Perché mai, contro la tesi di un famoso professore italiano del Novecento, il possibile non dovrebbe essere tale, cioè forse vero, anche se non lo vedo?”. La filosofia, mi dicevo, non è che questo doppio ricciolo interrogativo, l’essere disposti a chiedere e dare ragione di ciò che si dice e di ciò che si fa, o di ciò che ci viene detto o imposto: e la Ragione non è affatto soltanto nostra natura, anzi! È una disponibilità, non una disposizione: si risveglia soltanto con la libertà. E ancor meno somiglia, la Ragione, a quella sorta di indomabile potenza della storia che lei, professore, e il suo predecessore tedesco chiamavate “la Tecnica”. Per carità, quel suo predecessore sì che era pericoloso: il suo, di Essere, odorava lontano un miglio di Blut und Boden.
Della tecnica invece continuavamo a servirci ogni volta che dovevamo compilare i registri elettronici, e meno male, con tutti gli allievi che aveva. Per non parlare poi del sollievo di evitare i denti strappati dalle gengive deste e sanguinanti... (mi perdoni, la natura femminea si distrae sovente in pensieri banali). Che poi, se anche sostituissimo a questo nome, “la Tecnica” (preferito nei suoi elzeviri), uno degli altri e numerosi nomi divini di quella potenza assoluta che ci destina a questo e quell’altro (il Destino dell’Occidente, il Capitalismo, il Potere, il Denaro), cambierebbe poco. Sospetto che quello che le Sue parole inducevano nell’anima dei suoi ascoltatori e lettori fosse una specie di rilassamento - in tedesco mistico si dice Gelassenheit - o meglio un gesto di virtuale auto-destituzione del soggetto morale in noi, un abbandono della responsabilità. Un gesto ben nascosto dietro l’ombra della macchinazione universale che di tutto ha colpa, e libera da ogni responsabilità nell’uso delle parole noi intellettuali, giornalisti, politici, professori, studenti, pensionati... Tutti noi operai del linguaggio.
Insomma, a pensarci bene, anche questa destituzione in noi dell’agente razionale e morale, sensibile e responsabile, era un atto di libertà - peccato, però, che fosse nella direzione della più perfetta sottomissione. Sarà per questo che i suoi ragazzi amavano tanto anche Spinoza? Libertà come inchino alla necessità? Curioso equivoco, a leggere l’autore del Trattato teologico-politico e il teorico della democrazia! Ma non divaghiamo.
Perché la ragione, appunto, o meglio il suo esercizio, è una libera disposizione, cui si può spavaldamente rifiutarsi o che pavidamente si può lasciar sopire: e fatica comunque a liberarsi come il ragazzo fatica a diventare adulto. Così che molti, nei tempi antichi e in quelli moderni, negli imperi dispotici e nelle comunità tribali, consigli di facoltà compresi, nelle città ierocratiche e in quelle demagogiche, responsabili di sé e di fronte al vero non lo diventano mai, e vivono di fake news e di costumi consortili.
 Per questo, caro professore, è un vero peccato zittire Socrate in culla, e farlo rimangiare da Parmenide, come da un Crono divoratore dei propri figli: perché proprio da quella fessura nella ben rotonda compattezza dell’Essere, dalla possibilità del non essere, è nata la fragile bellezza della nostra mente, la sua umiltà di fronte all’inesauribile vero e la sua fierezza di consentire - o no - alla legge. Per quella fessura è passato il doppio palpito della civiltà, il cuore pratico e quello teorico del nostro domandare ragione, cioè, infine, l’etica e la logica, la democrazia e la scienza. Che passando da quella fessura si sono lentamente fatte largo, in mezzo alle tragedie dei millenni.
Per questo, caro professore, è un vero peccato zittire Socrate in culla, e farlo rimangiare da Parmenide, come da un Crono divoratore dei propri figli: perché proprio da quella fessura nella ben rotonda compattezza dell’Essere, dalla possibilità del non essere, è nata la fragile bellezza della nostra mente, la sua umiltà di fronte all’inesauribile vero e la sua fierezza di consentire - o no - alla legge. Per quella fessura è passato il doppio palpito della civiltà, il cuore pratico e quello teorico del nostro domandare ragione, cioè, infine, l’etica e la logica, la democrazia e la scienza. Che passando da quella fessura si sono lentamente fatte largo, in mezzo alle tragedie dei millenni.Perdoni, professore, sento che la sua eterna essenza oppone un cortese ma fermo diniego all’opinione che Socrate per la dolente e felice fessura del parricidio, perché di lì passasse il possibile senso e valore della vita umana, morì proprio. Come morirono molti e molti altri suoi discendenti. Quella volta, finita la lezione, lei, con la sua grande e signorile cortesia, e dopo un baciamano galante che mi spense subito in gola ogni obiezione e mi accese un sorriso di gratitudine, mi accompagnò nel corridoio, fra due ali di giovinetti plaudenti, e c’era anche qualche dame à chapeau che mi lanciò un’occhiata di invidia. Che vuole, il suo fascino ammutolì anche me, e così mi rimangiai questa lunga obiezione che per tutta la lezione avevo rimuginato. E so che non è affatto troppo tardi per rivolgerla ora alla sua essenza eterna, dal di qua al di là del cerchio delle apparenze. Poco importa, su questo sono d’accordo con lei. Continuerà, col suo sorriso (tout just un peu compatissant, comme c’est le cas avec une dame) a lasciarmi disputare con lei, con parole sempre più affannate - come ho fatto tutta la vita.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA ---UN PROBLEMA DI FONDO. Trump sospeso dai social, Cacciari: "E’ pazzesco"9 gennaio 2021, di Federico La Sala
Trump sospeso dai social, Cacciari: "E’ pazzesco"
di Redazione Adnkronos *
"C’è un problema di fondo, che è al di là e al di fuori di Trump. E’ inaudito che imprenditori privati possano controllare e decidere loro chi possa parlare alla gente e chi no. Doveva esserci un’autorità ovviamente terza, di carattere politico che decide se qualche messaggio che circola in rete è osceno, come certamente sono quelli di Trump". E’ l’opinione di Massimo Cacciari, filosofo, professore ed ex sindaco di Venezia, che interviene con l’Adnkronos sulle polemiche che ha suscitato l’eliminazione dei post di Trump da parte di Twitter e la sospensione dell’account da parte di Facebook, Instagram e altri social in seguito all’assalto al Congresso.
"Che sia l’imprenditore a farlo, che è il padrone di queste reti, è una cosa semplicemente pazzesca. E’ uno dei sintomi più inauditi del crollo delle nostre democrazie. Non c’è dubbio alcuno. Perché come oggi è Trump, domani potrebbe essere chiunque altro, e lo decide Zuckerberg. E’ una cosa semplicemente pazzesca", incalza Cacciari.
Che spiega meglio nel merito: "Dovrebbe esserci una forma di autorità politica che decide. Esattamente così come c’è l’Autorità per concorrenza, per la privacy, che decide ’questi messaggi in rete sono razzisti, sono sessisti, incitano alla violenza’ e cosi via. E tu, Zuckerberg, li devi cancellare. Cioè deve essere l’autorità che dice a Zuckerberg cosa cancellare, invece qui è lui che decide. E’ una cosa dell’altro mondo".
* Fonte: Adnkronos, 08/01/2021 10:31 (ripresa parziale).
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- UNA STORIA DI LUNGA DURATA."Quando la logica va in vacanza. Sulle fallacie comiche in letteratura".4 dicembre 2020, di Federico La Sala
LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE, E IL VATICANO CON IL SUO TRADIZIONALE SOFISMA DELLA "FALLACIA ACCIDENTIS". LOGICA E REALTÀ .... *
Quando la logica va in vacanza
di Edoardo Camassa **
- [Esce oggi per Quodlibet Quando la logica va in vacanza. Sulle fallacie comiche in letteratura di Edoardo Camassa. Ne pubblichiamo un estratto per gentile concessione dell’autore]
Il termine “fallacia” può essere inteso in almeno due modi. In senso lato designa una qualsiasi idea, opinione o credenza sbagliata; per esempio che le donne non sappiano guidare o che rompere uno specchio porti sette anni di disgrazie. Come si vede, stando a questa prima accezione del termine, le fallacie si fondano sugli stereotipi, sulla superstizione o comunque su detti e proverbi popolari, e perciò non ambiscono in nessun modo a risultare convincenti. Ma le cose cambiano se ci spostiamo dal linguaggio comune al linguaggio filosofico-scientifico.
 In senso stretto, infatti, “fallacia” indica un’argomentazione o un ragionamento che sono logicamente viziati ma psicologicamente persuasivi; ciò può avvenire in modo consapevole e deliberato, quando vengono prodotti con l’intenzione di ingannare, e allora parleremo di sofismi, o inconsapevolmente, quando vengono prodotti senza volontà di inganno, e allora parleremo di paralogismi. In estrema sintesi, nella prospettiva della logica dell’argomentazione la fallacia è un ragionamento che ricorda un qualche tipo d’inferenza, ma che se sottoposto a un esame rigoroso si rivela scorretto[1].
In senso stretto, infatti, “fallacia” indica un’argomentazione o un ragionamento che sono logicamente viziati ma psicologicamente persuasivi; ciò può avvenire in modo consapevole e deliberato, quando vengono prodotti con l’intenzione di ingannare, e allora parleremo di sofismi, o inconsapevolmente, quando vengono prodotti senza volontà di inganno, e allora parleremo di paralogismi. In estrema sintesi, nella prospettiva della logica dell’argomentazione la fallacia è un ragionamento che ricorda un qualche tipo d’inferenza, ma che se sottoposto a un esame rigoroso si rivela scorretto[1].Tra gli innumerevoli esempi possibili di fallacie intese in questa seconda accezione ce n’è uno su cui vale la pena di soffermarsi, se non altro perché compare in quello che è in assoluto il primo trattato sistematico sui ragionamenti viziati - il De sophisticis elenchis di Aristotele - e ha il pregio di essere estremamente chiaro[2]. Si tratta della fallacia d’accidente converso, un tipo di generalizzazione indebita che nasce dal considerare ciò che vale sotto un determinato aspetto (παρὰ τὸ πῄ, traducibile nei termini della logica medievale con secundum quid) come se valesse in assoluto, in sé e per sé (ἁπλῶς, corrispondente al latino simpliciter). In base a questo indebito procedimento generalizzante, dal fatto che un indiano è nero ma ha i denti bianchi si passa a concludere, erroneamente, che questo indiano è al contempo bianco e nero (Soph. el., 167a 7-9)[3]. Nel presente lavoro mi occuperò di fallacie intendendole in questo secondo senso, ossia nell’accezione ristretta; mi occuperò cioè di “fallacie logiche”. Più nel dettaglio, mi concentrerò su una particolare classe di ragionamenti scorretti: quella delle argomentazioni viziate che realizzano il loro potenziale comico.
[...]
Per sgombrare il campo da ogni possibile equivoco, occorre però aggiungere subito che qui mi soffermerò sulle fallacie comiche per come appaiono nella letteratura.
[...]
Per provare a esplicitare gli scopi delle fallacie comiche nella letteratura conviene rifarsi ancora una volta a Freud, e nello specifico all’analisi di ciò che egli chiama «storielle con una facciata logica» (o «motti concettuali sofistici»). Secondo Freud, se questo tipo di barzellette mostra una parvenza logica così robusta da rivelarsi come tale solo in seguito a un esame più attento è appunto perché lo scherzo tradisce qualcosa di serio, cela una logica ancor più profonda[4]. Orlando, che dal libro freudiano sul Witz ha tentato di estrapolare una teoria generale del comico letterario, scrive a ragione che i motti con una facciata logica sono «di una logica sofistica, esagerata, che dissimula anziché ostentarla l’erroneità dei propri ragionamenti secondo il livello della coscienza, e con ciò stesso ostenta fingendo di dissimularla la validità dei ragionamenti stessi secondo un’altra logica di fondo»[5].
È proprio questa dialettica di erroneità e validità, di illogicità e logicità che caratterizza le fallacie comiche rinvenibili nelle opere letterarie. Vale perciò la pena di approfondirne l’esame e di articolarne i momenti costitutivi. In prima battuta il lettore (mi riferisco al lettore modello) prende per buono il ragionamento incongruo; in altre parole si lascia persuadere dalla sua coerenza apparente. Il pensiero critico e la valutazione razionale subentrano in lui solo in un secondo momento, così da rendergli la fallacia palese, riconoscibile, e con ciò stesso da muoverlo al riso. Ma non è tutto: il lettore è infine portato a riconsiderare l’argomentazione comica e a intuire che quel che gli pareva erroneo così erroneo non è, dal momento che fa luce su verità paradossali ma profonde a cui la logica ordinaria non può né vuole accedere[6]. Da questa angolatura, assurdo non è più tanto e solo il ragionamento fallace, ma anche e soprattutto qualcos’altro di più generale. Se si vuole, il sistema di pensiero corrente e le sue leggi ritenute inattaccabili.
Un esempio chiarirà meglio cosa intendo: «L’unico modo per liberarsi di una tentazione è quello di cedervi»[7]. Tra tutte le massime che in The Picture of Dorian Gray (1890) Wilde mette in bocca a Lord Henry Wotton, irresistibile campione di freddure, questa è forse la più celebre. Essa di primo acchito sembra sensata, convincente. Tuttavia, a un esame più approfondito, l’aforisma rivela tutta la sua inconsistenza argomentativa. A rigor di logica, oltre a quella suggerita da Lord Wotton, vi sarebbe infatti un’altra e ben più valida soluzione per liberarsi di una tentazione: quella di metterla a tacere, di ignorarla e in definitiva di reprimerla. Come si vede, ci troviamo qui a ridere di una fallacia facilmente individuabile, che è nota come evidenza soppressa (o unilateralità) e che consiste nel dimenticare per strada alcune informazioni in grado di invalidare la tesi proposta. Benché tutto questo sia esatto, va pur detto che la massima sopra citata non si esaurisce nell’errore logico e nel comico puro. Nonostante l’incongruenza, e anzi proprio in virtù di questa, Wilde mira a farci intravedere qualcosa di serio: che tutto sommato non c’è davvero altro modo per liberarsi di una tentazione se non quello di cedervi. Per convincersene, basta leggere come il discorso di Lord Wotton continua: «Resistetele, e la vostra anima si ammalerà di bramosia per le cose che si è proibite da sola, di desiderio per ciò che le sue leggi mostruose (monstrous laws) hanno reso mostruoso e illegittimo (monstrous and unlawful)»[8]. Qui Wilde vagamente anticipa una idea che da lì a poco la psicanalisi cercherà di fondare su basi scientifiche. Per quanto proviamo a domarlo, il desiderio - mostruoso e proibito, sì, ma solo nell’ottica della ragione dispiegata - non si lascerà mai ammansire e combatterà con tutte le proprie forze per emergere. Con buona pace della mentalità borghese-puritana, additata come il “vero” bersaglio comico del ragionamento.
Quanto detto può essere riformulato e arricchito combinando la terminologia di Freud con quella del suo erede cileno Matte Blanco: le fallacie comiche della letteratura sono - un po’ come i sogni, i lapsus e i sintomi psiconevrotici, benché calcolate e coscienti - «formazioni intermedie e di compromesso»[9], frutti di un «sistema logico-antilogico»[10]. Esse ci spingono da un lato a ridere con superiore distacco di assurdità che a tutta prima paiono il risultato di una disattenzione, di un disimpegno mentale, e dall’altro a sentire in modo partecipe che il pensiero consueto in fondo non è altro che uno tra i molti tipi di pensiero possibili e immaginabili. Credo che D’Angeli e Paduano vogliano suggerire qualcosa del genere quando scrivono che nel riso diretto ai danni di chi pronuncia ragionamenti aberranti si maschera il timore che la sua logica altrettanto strutturata e resistente costituisca un grave rischio per la presunta inattaccabilità del sistema di pensiero corrente: le sue leggi, date senza verifica per completamente affidabili, se messe sotto la lente di un simile sguardo straniante, si rivelano discutibili e quindi incerte, e coinvolgono nel dubbio l’intero sistema logico[11].
Ricapitolando, le fallacie comiche in letteratura hanno un intento duplice e ambiguo: punire col riso le argomentazioni che si discostano dalla logica ordinaria e, contemporaneamente, rimarcare i limiti e i vincoli delle certezze comuni. Da ciò si ricava che nella finzione letteraria i ragionamenti ridicoli si presentano come un salvacondotto grazie a cui formidabili deviazioni dalla logica e dal pensiero razionale riescono a trapelare in modo socialmente fruibile. Lo scopo di questo lavoro è appunto mettere in luce, attraverso un congruo numero di esempi, in quali modi la letteratura può trasgredire la logica consueta e dare risalto alle verità paradossali e profonde che emergono proprio in virtù del sovvertimento della logica.
** Fonte: Le parole e le cose, 3 dicembre 2020 (ripresa parziale - senza note)
*
NOTA
LOGICA E REALTÀ: LE FALLACIE “COMICHE” NELLA LETTERATURA DELLA TRAGEDIA.
 E le fallacie tragiche nella letteratura della “Commedia” e della “Monarchia” di Dante Alighieri...
E le fallacie tragiche nella letteratura della “Commedia” e della “Monarchia” di Dante Alighieri... SE “le fallacie comiche in letteratura hanno un intento duplice e ambiguo: punire col riso le argomentazioni che si discostano dalla logica ordinaria e, contemporaneamente, rimarcare i limiti e i vincoli delle certezze comuni [....]”, alla fin fine, confermano il sentimento tragico della vita in cui si collocano. O no?
Se è così, non è meglio capovolgere il senso del cammino e mettere in luce le fallacie “tragiche” nella “Commedia”, e nella “Monarchia”, come da lezione di Dante?! O no?!
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- I "DUE SOLI" DI DANTE, LA LEZIONE "DIMENTICATA" DI LORENZO VALLA E UNA "GALLERIA DI PAPI".11 novembre 2020, di Federico La Sala
UNA "GALLERIA DI PAPI", LA "DONAZIONE DI COSTANTINO", E "IL GRANDE ROMANZO DEI PAPI" ... *
“Il grande romanzo dei papi. La storia della Santa Sede attraverso le vite dei successori di san Pietro” di Riccardo Ferrigato. Intervista ...
di Letture*
Dott. Riccardo Ferrigato, Lei è autore del libro Il grande romanzo dei papi. La storia della Santa Sede attraverso le vite dei successori di san Pietro edito da Newton Compton: in che modo la storia dell’umanità si è intrecciata con quella millenaria di una delle più influenti istituzioni che l’umanità abbia creato, il papato?
Il grande romanzo dei papi. La storia della Santa Sede attraverso le vite dei successori di san Pietro, Riccardo FerrigatoFare riferimento alla “storia dell’umanità” è forse eccessivo, ma di certo il papato è stato elemento di notevole influenza per la storia europea e, in maniera più limitata e differenziata, per quella di alcune aree extraeuropee in cui il cattolicesimo ha avuto una significativa diffusione. In che modo lo ha fatto? Secondo registri completamente differenti, cioè mutando, modificandosi, adeguandosi ai tempi: non credo sia possibile che un’istituzione sopravviva altrimenti per un così lungo periodo.
Il vescovo di Roma ha maturato nei secoli, per gradi, un ruolo preminente all’interno della Chiesa - ruolo che, almeno nel primo millennio della sua storia, era tutt’altro che incontestato - e contemporaneamente ha giocato un ruolo politico in continuo divenire, con fasi di crescita e altre di declino, guadagnando il proprio spazio di manovra tra imperi, regni e repubbliche. Difficile sintetizzare in poche righe la parabola di questo percorso, ma direi così: finché il potere politico di un re o un imperatore ha avuto bisogno di giustificare la propria autorità attraverso il trascendente, il papa è stato un riferimento indispensabile. Questo, in realtà, ha determinato spesso la sottomissione della cattedra di Pietro ai bisogni di questa o quella corona, ma anche la crescita, lasciando persino spazio al sogno, mai realizzato, di mettere il vicario di Cristo al vertice dell’intero occidente.
In che modo da un modesto pescatore di Galilea si è giunti a fare del vescovo di Roma un monarca?
Il pescatore di Galilea, Pietro, primo tra gli apostoli di Gesù di Nazaret, non immaginava una chiesa strutturata in maniera verticista, probabilmente non pensava a figure assimilabili a quelle dei vescovi e lontanissima da lui era l’idea di una singola persona a capo di tutti i cristiani. Da ebreo qual era, immaginava piuttosto i fedeli riuniti secondo le modalità con cui la religione del suo popolo si organizzava da sempre, in piccole comunità collegate ma indipendenti, pronte all’imminente parusia, la venuta di Gesù alla fine dei tempi. Figuriamoci se può mai aver immaginato un vescovo che diviene monarca, cioè che assume su di sé anche un potere temporale!
In estrema sintesi, questo è stato possibile grazie a tre passaggi. Il primo è stato frutto dell’azione di Costantino, che ha dato alla chiesa una struttura affine a quella del potere imperiale, affiancando alle strutture di governo civile quelle ecclesiastiche. In secondo luogo, con la caduta dell’impero romano d’Occidente, la chiesa ha rafforzato la propria funzione politica, con i vescovi, a Roma e altrove, che divennero custodi - si pensi a Leone e Gregorio Magno - dei propri territori di influenza. Infine, l’alleanza con i Franchi di Pipino il Breve: nell’VIII secolo questo sovrano in cerca di una sacra investitura (Pipino non era re per diritto di nascita) conquistò al papa i territori di quello che divenne lo Stato della Chiesa. Di fatto Pipino e Stefano II, il papa dell’epoca, si legittimarono sul trono a vicenda.
Come è stato possibile che santi e martiri abbiano condiviso il medesimo scranno dei dissoluti papi del Rinascimento?
I papi sono stati 266 e questa gran massa di uomini rappresenta un completo campionario dell’animo umano: ogni passione - ma anche ogni vizio, ogni virtù - è stata incarnata. D’altra parte la cattedra di Pietro è un luogo di potere e il potere ha un effetto determinante sugli esseri umani, ne porta alla luce e ne inasprisce i tratti dell’animo.
La maggior parte degli uomini e delle donne possono permettersi di trascorrere una vita all’insegna di una tranquilla mediocritas: né troppo buoni né troppo malvagi, non ci è richiesto di dimostrare grande coraggio o eccezionali doti. Per un sovrano è diverso: nessuna via di mezzo per chi porta la corona, egli sarà vile o temperante, magnanimo o malvagio, perché il potere nelle sue mani è determinante per la vita o la morte di comunità intere.
Nel caso specifico del pontefice, poi, la tensione tra il potere politico e quello spirituale ha determinato spesso una vera iattura. Di norma ci riferiamo ai papi dissoluti del Rinascimento come a coloro che hanno umiliato la cattedra di Pietro - concubinari, nepotisti, festaioli, rivestiti di pietre e tessuti preziosi - ma alcuni di loro, con trame e strategie raffinate, hanno salvato la Chiesa del loro tempo. Al contrario, sant’uomini e personaggi di specchiata moralità, poiché sprovvisti di astuzia politica, hanno talvolta determinato la rovina dell’istituzione di cui erano a capo. Essere insieme re e sommi sacerdoti è come essere servi di due padroni e raccapezzarcisi non è semplice. Per questo Paolo VI poté dichiarare che era stata la Divina provvidenza, nel 1870, a togliere al papa l’incombenza di una corona da sovrano.
Quali sono state le figure di pontefici che maggiormente hanno inciso sulla storia del papato? La lista sarebbe lunghissima e, alla fine, non potrebbe risultare esaustiva. Tante e tali sono le rivoluzioni in questa storia di venti secoli, e tanti i frangenti sui quali un pontefice risulta determinante, che classifiche del genere sono davvero impossibili. In tempi recenti, però, non c’è alcun dubbio: la vera rivoluzione è stata quella di Giovanni XXIII e Paolo VI, grazie al coraggio del primo - quello di inaugurare un concilio, un vero concilio, aperto alla discussione e senza esiti predeterminati - e alla tenacia del secondo, che quell’assemblea ha condotto felicemente in porto. Un esito tutt’altro che scontato. Si tratta di una vicenda esemplare di come due pastori profondamente diversi per temperamento, per estrazione sociale, per esperienze pregresse, uniti quasi solo dalle comuni radici lombarde, abbiano governato la Chiesa con stili diversi, ma siano stati capaci di guardare nella medesima direzione. Purtroppo, però, il modello di una Chiesa maggiormente assembleare si è dovuto poi scontrare con un pontificato, quello di Giovanni Paolo II, fortemente accentratore. La Chiesa è così: si muove lentamente e, anche se talvolta subisce accelerazioni improvvise, la resistenza al cambiamento - la resilienza delle sue strutture secolari - rimane uno dei suoi caratteri distintivi.
Come è destinata a cambiare nel futuro, a Suo avviso, questa istituzione?
Previsioni di questo genere sono destinate a rivelarsi sempre inaccurate e, nel caso della Chiesa cattolica, è particolarmente difficile districarsi tra le tante correnti che spingono la barca di Pietro in diverse direzioni. Inoltre, la Chiesa è una struttura gerarchica, verticista, dove ogni cambio di pontefice può generare rivolgimenti prima impensati, tanto quanto le reazioni conseguenti. Bergoglio ha dato un’impronta, in questi anni, ma nessuno garantisce che il successore vorrà seguire il suo stesso percorso.
Su almeno un punto, però, la direzione è chiara poiché si tratta di un cambiamento ormai duraturo e inarrestabile: la Chiesa sta divenendo sempre più “cattolica”, vale a dire universale. Paesi un tempo marginali oggi guadagnano di importanza; cattedre vescovili prima considerate irrilevanti oggi si fanno centrali, mentre da decenni si parla di un’Europa scristianizzata. La Chiesa, da questo punto di vista, sta mutando lentamente ma inesorabilmente e anche il papato ne risentirà. Se si vuole un metro di giudizio, basti pensare a coloro che oggi entrerebbero in un immaginario conclave. Gli arcivescovi di città come Milano o Parigi rimarrebbero nei loro palazzi, dato che non sono cardinali; lo sono invece quelli di Kigali, in Ruanda, o di Bangui nella Repubblica centrafricana. E questi sono solo alcuni dei tanti che potrei riportare.
*
Fonte: Letture.org
NOTE:
A) - [LA "GALLERIA DEI PAPI"]: CELEBRANDOSI #OGGI [10.11.2020] LA FIGURA DI PAPA #LEONEMAGNO (https://it.wikipedia.org/wiki/Incontro_di_Leone_Magno_con_Attila ), SUL FILO DELLA #MEMORIA DI #RAFFAELLO E #GIULIOII, è BENE RICORDARE DI FARE QUANTO PRIMA UNA VISITA ALLA #GALLERIADEIPAPI DI #PALAZZOALTIERI AD #ORIOLOROMANO...
B) - #Rinascimento e #filologia:"#Erasmo non ha ancora scritto il suo #Elogiodellafollia [pubblicato nel 1511], #Lutero non ha ancora affisso le sue #tesi" [rese pubbliche nel 1517], #AntonioFerrariis, il #Galateo, dona nel 1510 a #GiulioII un esemplare greco della #DonazionediCostantino.
C) - #DANTE2021 #RINASCIMENTO #OGGI. Svegliarsi dal #sonnodogmatico, accogliere l’analisi di #LorenzoValla (https://it.wikipedia.org/wiki/Donazione_di_Costantino) e l’indicazione antropologico-politica dei #DueSoli
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- STORIA E FILOSOFIA. NOTE A MARGINE DI UNA “FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO” ITALICO-ROMANO.6 novembre 2020, di Federico La Sala
Storia e Filosofia
UNA "FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO" ITALICO-ROMANO. L’antitesi Mosca e Nuova York non si supera che in un modo, con la dottrina e con la prassi di Roma: *
A) Mussolini, Discorso dell’anno IX - Roma, 27 ottobre 1930: "Oggi io affermo che il Fascismo in quanto idea, dottrina, realizzazione, è universale; italiano nei suoi particolari istituti, esso è universale nello spirito, né potrebbe essere altrimenti. -Lo spirito è universale per la sua stessa natura. Si può quindi prevedere una Europa fascista, unì Europa che ispiri le sue istituzioni alle dottrine e alla pratica del Fascismo. Una Europa cioè che risolva, in senso fascista, il problema dello Stato moderno, dello Stato del XX secolo, ben diverso dagli Stati che esistevano prima del 1789 o che si formarono dopo.
 Il Fascismo oggi risponde ad esigenze di carattere universale. Esso risolve infatti il triplice problema dei rapporti fra Stato e individuo, fra Stato e gruppi, fra gruppi e gruppi organizzati. Per questo noi sorridiamo quando dei profeti funerei contano i nostri giorni. Di questi profeti non si troverà più non solo la polvere, ma nemmeno il ricordo, e il Fascismo sarà vivo ancora. Del resto ci occorre del tempo, moltissimo tempo, per compiere l’opera nostra. Non parlo di quella materiale, ma di quella morale. Noi dobbiamo scrostare e polverizzare, nel carattere e nella mentalità degli italiani, i sedimenti depostivi da quei terribili secoli di decadenza politica, militare, morale, che vanno dal 1600 al sorgere di Napoleone. È una fatica grandiosa.
Il Fascismo oggi risponde ad esigenze di carattere universale. Esso risolve infatti il triplice problema dei rapporti fra Stato e individuo, fra Stato e gruppi, fra gruppi e gruppi organizzati. Per questo noi sorridiamo quando dei profeti funerei contano i nostri giorni. Di questi profeti non si troverà più non solo la polvere, ma nemmeno il ricordo, e il Fascismo sarà vivo ancora. Del resto ci occorre del tempo, moltissimo tempo, per compiere l’opera nostra. Non parlo di quella materiale, ma di quella morale. Noi dobbiamo scrostare e polverizzare, nel carattere e nella mentalità degli italiani, i sedimenti depostivi da quei terribili secoli di decadenza politica, militare, morale, che vanno dal 1600 al sorgere di Napoleone. È una fatica grandiosa.
 Il Risorgimento non è stato che l’inizio, poiché fu opera di troppo esigue minoranze; la guerra mondiale fu invece profondamente educativa. Si tratta ora di continuare, giorno per giorno, in questa opera di rifacimento del carattere degli italiani [...]"(Messaggio per l’Anno Nono - Roma, 27 ottobre 1930, in B. Mussolini, Opera Omnia, vol. XXIV, p. 283).
Il Risorgimento non è stato che l’inizio, poiché fu opera di troppo esigue minoranze; la guerra mondiale fu invece profondamente educativa. Si tratta ora di continuare, giorno per giorno, in questa opera di rifacimento del carattere degli italiani [...]"(Messaggio per l’Anno Nono - Roma, 27 ottobre 1930, in B. Mussolini, Opera Omnia, vol. XXIV, p. 283).B) Mussolini - Milano, Piazza Duomo, 25 ottobre 1932: "Oggi, con piena tranquillità di coscienza, dico a voi, moltitudine immensa, che questo secolo decimoventesimo darà il secolo del Fascismo. Sarà il secolo della potenza italiana. Sarà il secolo durante il quale l’Italia tornerà per la terza volta ad essere direttrice della civiltà umana. Perché fuori dai nostri principi, e soprattutto in tempi di crisi, non c’è salvezza né per gli individui e tanto meno per i popoli.
 Fra dieci anni - lo si può dire. Senza fare i profeti - l’Europa sarà cambiata. Non da ora si sono commesse delle ingiustizie, anche contro di noi, soprattutto contro di noi. E niente di più triste il compito che vi spetta di dover difendere quello che è stato il sacrificio magnifico di sangue di tutto il popolo italiano. [...] Tra un decennio l’Europa sarà fascista o fascistizzata!
Fra dieci anni - lo si può dire. Senza fare i profeti - l’Europa sarà cambiata. Non da ora si sono commesse delle ingiustizie, anche contro di noi, soprattutto contro di noi. E niente di più triste il compito che vi spetta di dover difendere quello che è stato il sacrificio magnifico di sangue di tutto il popolo italiano. [...] Tra un decennio l’Europa sarà fascista o fascistizzata!
 L’antitesi Mosca e Nuova York non si supera che in un modo, con la dottrina e con la prassi di Roma [...]" (B. Mussolini, Opera Omnia, XXV, pp. 147-148).
L’antitesi Mosca e Nuova York non si supera che in un modo, con la dottrina e con la prassi di Roma [...]" (B. Mussolini, Opera Omnia, XXV, pp. 147-148).* Sul tema, mi sia consentito, si cfr.:
STORIA E STORIOGRAFIA DEL FASCISMO, "UN RINATO SACRO ROMANO IMPERO" (A. GRAMSCI, 1924). IL MITO DELLA ROMANITÀ, LA MONARCHIA, E IL FASCISMO : MARGHERITA SARFATTI E RENZO DE FELICE.
HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI.
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- MESSO A MORTE KANT, E DI FRONTE ALL’AUT AUT DI KIERKEGAARD (E DI ENZO PACI), "IL PENSIERO DEBOLE" E TRISTE, ANCORA ALLA RICERCA DI SE STSSO.25 ottobre 2020, di Federico La Sala
RIVOLUZIONE COPERNICANA, IN ASTRONOMIA E IN FILOSOFIA, E "IL PENSIERO DEBOLE" E TRISTE, ANCORA ALLA RICERCA DI SE STESSO. Lasciamoci guidare da un’etica "minima"....
RICORDANDO LA LEZIONE DI ENZO PACI E RIPERCORRENDO CON LA MENTE LA SUA "PREFAZIONE ALLA TERZA EDIZIONE ITALIANA" ("Milano, 16 settembre 1968") ALL’OPERA DI EDMUND HUSSERL, "LA CRISI DELLE SCIENZE EUROPEE E LA FENOMENOLOGIA TRASCENDENTALE", come in parte sollecita a fare Pier Aldo Rovatti (cfr. A. Gnoli, "Lasciamoci guidare da un’etica minima", "Straparlando", Robinson/la Repubblica, 24.10.2020, pp. 42-43), forse, per meglio comprendere il percorso fatto (dal "mitico" ’68) da molta parte della "filosofia" (italiana ed europea) è utile - oltre che storiograficamente significativo, esemplare - riprendere un "passaggio" della sua intervista:
- «[...] Allora era decisiva un’impronta etica».
- A quale etica ti richiami?
- «Niente proclami: un’etica minima»
- C’è dunque anche un’etica massima?
- «Quella massima è una dottrina morale fatta di regole e precetti. Il "Super-Io" di Freud o la "legge morale" di Kant. Apparati ingombranti. Quella "minima" è un’etica di vita, un modo di essere quotidiano, libero dagli imperativi. Il che non significa che ciascuno fa quello che vuole. Bensì che ciascuno si assume in proprio la responsabilità dei suoi comportamenti. E’ quello che è emerso nei cittadini in un contesto difficile come l’attuale pandemia».
- [...]
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- "CHI" SIAMO NOI, IN REALTÀ. RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ : UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.
- HUSSERL CONTRO L’HOMUNCULUS: LA ’LEZIONE’ DI ENZO PACI AI METAFISICI VISIONARI (ATEI E DEVOTI) DI IERI (E DI OGGI). Una ’traccia’ dal "Diario fenomenologico")
METTERSI IN GIOCO, CORAGGIOSAMENTE. PIER ALDO ROVATTI INCONTRA ELVIO FACHINELLI.
 AL DI LA’ DEL ’FARISEISMO CATTOLICO-ROMANO’, UN ESERCIZIO DI PARRHESIA EVANGELICA : PARLARE IN PRIMA PERSONA, E IN SPIRITO DI CARITA’.
AL DI LA’ DEL ’FARISEISMO CATTOLICO-ROMANO’, UN ESERCIZIO DI PARRHESIA EVANGELICA : PARLARE IN PRIMA PERSONA, E IN SPIRITO DI CARITA’."Kant, Freud, e la banalità del male. Note per una rilettura (2010)"
Federico La Sala
-
> MESSO A MORTE KANT, E DI FRONTE ALL’AUT AUT DI KIERKEGAARD (E DI ENZO PACI), "IL PENSIERO DEBOLE" E TRISTE, ANCORA ALLA RICERCA DI SE STSSO. - Intervista a Gianni Vattimo (di A. Gnoli).26 ottobre 2020, di Federico La Sala
Straparlando
Gianni Vattimo
Ho rottamato il pensiero forte
di Antonio Gnoli (“Robinson - la Repubblica”, 28.12.2019) *
Ora che da un po’ ha superato gli ottant’ anni dice che non se li aspettava così. Dice che essendo stato un giovane brillante - per alcuni perfino un enfant prodige - che ha smosso le acque provinciali in cui di solito navighiamo, forse è un modo di pagare un conticino. A chi? Boh. Non lo sa. Dio e gli uomini hanno un modo strano di esercitare la giustizia: tu fai una cosa bella e ricevi un premio. Ne fai una brutta e paghi pegno.
Questo almeno in teoria. Ma quando sei vecchio, quando, diversamente da altri vecchi, senti il peso della materia che si disgrega, allora ti chiedi perché proprio a me? «Sai, ho fatto un sogno l’ altra notte», dice Gianni Vattimo. «Ho sognato che stavo giocando con la mia vecchiaia e che mi sentivo leggero. E bello come un tempo. Poi quando mi sono svegliato ho pensato: ma ero io quello? Ero proprio io? E se ero io che cazzo mi significava quel sogno?».
Partiamo se vuoi da questo interrogativo chi sei oggi?
«Non lo so, vorrei saperlo. Ci sono vari strati di me. Vari dolori. Alcuni lontani, altri recenti. I dolori raccontano la tua storia, la circoscrivono, a volte. Oppure l’ amplificano. E poi, ci sono i dolori della memoria e quelli del corpo».
Quali prevalgono in questo momento?
«Mi vedi, no? Faccio fatica a camminare. Quattro o cinque anni fa mi hanno diagnosticato un Parkinson. Allora che faccio? Provo a convivere con il signor Parkinson. Gli dico, beh vediamo di non farci troppo male. Io non dò fastidio a te e tu non ne dai a me. Poi scopro che quel signore lì è molto esigente. Paziente ma insidioso. Ti giuro che se fosse stato per me non l’ avrei mai invitato. Si è presentato senza neanche farsi annunciare, senza un biglietto da visita, senza un mazzo di fiori. Capisci?»
Capisco. Però siamo qui, nella tua casa, mentre parliamo e mangiamo quello che è stato apparecchiato a tavola. E non mi sembri così malandato.
«Non lo sono, è vero. Ti piace il risotto?».
Mi piace il risotto. Ma mi piacciono anche altre cose di te.
«Cosa ti piace? Scusa la curiosità».
Beh alcune cose che hai scritto sono state importanti per questo paese. Hai sdoganato Heidegger, ti sei inventato il "pensiero debole", e non hai mai tromboneggiato da accademico.
«Sai è stata la scuola di Luigi Pareyson da cui provengo a formarmi. Rigorosa ma anche molto appartata. Lo scelsi perché era il professore più giovane della facoltà. Esistenzialista e cattolico.
Amico di Karl Jaspers. Io, allora, ero sedotto da Adorno. Dai tedeschi che erano usciti dalla guerra.
Ma se lei vuole studiarli veramente si dedichi a Nietzsche, mi disse Pareyson. Era un personaggio complicato. Bisogna farsi le ossa con i maestri e poi lasciarli andare. Se non lo fai finisci nella gabbia».
Eri molto brillante?
«Credo di sì. Provengo da una famiglia dignitosa ma povera. Padre carabiniere. Madre sartina. Ho frequentato l’ Azione Cattolica. Posso dire che all’ università ero decisamente brillante».
Il tuo cattolicesimo ha conosciuto alti e bassi. Ora dove si colloca?
«Non lo so, onestamente non saprei collocarlo. Adoro questo papa che mi pare sia rimasto il solo anticapitalista in circolazione. Qualche tempo fa gli ho fatto avere il mio ultimo libro Essere e dintorni nella speranza che lo leggesse. Ci sono, infatti, diverse considerazioni sul cristianesimo».
E Francesco l’ ha letto?
«Letto non lo so, certo lo ha sfogliato. Tramite un amico comune, un argentino, Luis Liberman, gli è arrivato il libro. Mi ha telefonato per ringraziarmi del dono. E io gli ho spiegato che era un libro su Heidegger».
La tua ossessione.
«Bisogna pur vivere di qualche passione intellettuale. E poi come lui ha detto: soltanto un Dio ci può salvare».
Ma questo Dio dove lo andiamo a cercare?
«Certo non nelle costruzioni metafisiche e neppure in quelle mitologiche. Dio non può essere ispirato da ragioni teoretiche».
Tu hai scritto che "Essere e Tempo" - l’ opera più importante del primo Heidegger - rispondeva a una domanda storica e non a una esigenza astratta e universale. A questo pensi?
«L’ essere di cui parla Heidegger non è quello di cui discute la metafisica. È l’ evento. Dire evento significa che qualcosa accade. Dove? Nel linguaggio, nella storia, nel mondo. Dell’ evento non puoi dare una spiegazione scientifica, oggettiva. La nascita di Gesù non è dimostrabile. Eppure è un evento che accade nella storia ed è all’ origine della cristianità. Io mi sento tanto cristiano quanto heideggeriano. E tutto questo non ha niente a che vedere con la verità oggettiva. Per cui l’ unica ragione che mi consente di chiamarmi cristiano è perché non credo nell’ oggettività delle cose, non credo, come non crede Heidegger, nella metafisica».
Secondo te papa Francesco ha chiaro in testa questo tuo ragionamento?
«Non lo so e non lo pretendo. Però so che lui ha rimesso la Chiesa al centro di una discussione profonda. Mica facile, perché un corpaccione bimillenario non lo sposti facilmente. Le resistenze che il suo magistero incontra sono pazzesche».
È in corso un forte scontro religioso in seno allo stesso cristianesimo.
«C’ è una posta in gioco altissima. Né la scienza né la filosofia tout court sono in grado di vincere il piatto. Penso che Heidegger fosse consapevole di questo quando nella meditazione degli ultimi anni in maniera drammatica non vedeva soluzione umana al problema della desertificazione del mondo».
E affidava la salvezza a un Dio?
«Proprio così, nella direzione indicata da Lutero, e prima ancora da Paolo, per cui non sono le nostre opere che ci salveranno ma la grazia di Dio».
In questo modo viene meno la responsabilità dell’ atto umano. Puoi essere nazista o decidere di bruciare l’ Amazzonia tanto non dipende dalle tue opere la salvezza.
«Ma è proprio perché ti salvi che le tue opere avranno un senso tutt’ altro che nichilista. Siamo irresponsabili nella misura in cui saremo costretti a restare inautentici. E inautentico è il nostro mondo dominato dalla metafisica, dall’ oggettivazione, dal calcolo, dall’ utilitarismo, dalla tecnologia che tutto divora. Ci sarà un nuovo inizio? È ciò che Heidegger spera, ma non dipenderà dalla decisione dell’ uomo. Del resto, cose in parte analoghe le pensava Wittgenstein, almeno il Wittgenstein che si ribella a Russell e al pensiero anglosassone».
Ci sono due Heidegger come pure due Wittgenstein.
«Mi sono occupato della "svolta" di entrambi. Però Ludwig era certamente più tormentato. La frequentazione dei suoi amici analitici non lo aiutava. Era credente, frocio e pieno di sensi di colpa. Quando cede tutti i suoi beni alle sorelle lo fa anche perché ribolle di turbe mentali».
Tu hai mai avuto sensi di colpa?
«Ma sì, ogni volta che ti scompare una persona che ti è cara ti chiedi cosa hai fatto per essa. E perché gli sopravvivi».
Pensi a qualcuno in particolare?
«Penso ai miei due compagni di vita. Giampiero morto tragicamente di Aids e Sergio per un cancro ai polmoni. Sono stati rapporti bellissimi, importanti. Sergio morì in volo, tornavamo dagli Stati Uniti, aveva espresso il desiderio di vedere il museo di San Francisco. Spirò tra New York e Francoforte. È buffo andarsene mentre sei su un aereo e ho pensato che il cielo in quel caso era la via più breve per il paradiso. Mi chiedevi dei sensi di colpa».
Sì.
«Ho paura di essere diventato un po’ cinico. Se mi raccontano una sciagura il primo impulso è di pensare sì vabbè ma allora io, io che ne ho viste e passate di molto peggio che dovrei dire?».
Ti infastidisce la gente che si lamenta?
«Ma no, la sto ad ascoltare. Però loro che ne sanno della mia stanchezza, della mia vecchiaia che mi ha sorpreso come un ladro nella notte».
Ti viene mai il dubbio che come filosofo avresti potuto dare di più?
«Credo di aver smantellato, decostruito, rottamato buona parte del pensiero forte. Sulla scorta di Nietzsche e di Heidegger mi sono preso la briga di porre un freno alla filosofia come etica del dominio».
Eppure proprio Nietzsche con il superuomo e Heidegger con l’ adesione al nazismo hanno facilitato quel dominio.
«Ma il superuomo di Nietzsche non è volontà di potenza è l’ oltreuomo che libera se stesso e l’ Heidegger nazista si riduce a qualche frase di adesione allo spirito del tempo».
Non sei un po’ riduttivo?
«La giro in un altro modo: se li vuoi trattare come due fanatici sanguinari allora brucia pure le loro opere. Ma è questo che vogliamo? Ho trascorso dei lunghi periodi in Germania, lavorato con Gadamer, penso che la filosofia sia un’ esperienza ermeneutica. Non c’ è verità che non sia interpretazione».
Cosa vuoi dire?
«Che la verità è legata al linguaggio. E che non ci sono fatti ma solo interpretazioni».
Prima accennavi a Pareyson e alla sua scuola.
«Fui fortunato. Venimmo da lì io e Umberto Eco e poco dopo si aggiunsero Mario Perniola e Sergio Givone».
Però ognuno per la sua strada.
«Avevamo la libertà di scegliere. Con Umberto siamo restati amici. Facemmo insieme il concorso in Rai. Ci siamo frequentati fino all’ ultimo. Non so però se l’ ho davvero conosciuto. Per certi versi era imperscrutabile. Io non gli avevo mai rivelato le mie tendenze sessuali. Però una volta ebbi l’ impressione che mi prendesse in giro. Siccome ero con un amico mi disse, forse scherzando, ma allora ti sei deciso. Fu l’ unica volta che sfiorò l’ argomento. Dietro la sua grande estroversione c’ era molto riserbo».
Dovuto a cosa?
«Aveva orrore di dover parlare di sé. Credo che tutta la sua verve barzellettistica discendesse da questa cesura: il comico che uccide o rimuove una parte della vita. Del resto si può leggere perfino Il nome della rosa in questa chiave».
Hai mai avuto la tentazione del romanzo.
«Mi piace leggerli non scriverli».
Meglio la filosofia?
«Chi può dirlo? Se lo chiedi a uno scrittore ti ride dietro».
E tu?
«Non ho messo la mia vita nelle mani della filosofia. Semmai ho messo un po’ di filosofia nella mia vita. Sono obliquo come il volo degli uccelli».
Dove ti vorresti posare con il pensiero?
«Mi piacerebbe scrivere su cristianesimo e heideggerismo. Ho pensato di cominciare con una frase: se non fossi heideggeriano non sarei cristiano, e se non fossi stato cristiano non sarei stato heideggeriano. Ma ogni tanto mi vengono dei dubbi sull’ utilità di un discorso del genere».
Perché?
«A parte il peso o la fatica dell’ argomentazione, a chi interesserebbe? A volte mi metto davanti al computer e sto lì fisso, come un babbeo. La mia vita è fatta ormai di pause. Un sogno ce l’ ho».
Quale?
«Che la mia opera, per quel tanto o poco che vale, non vada dispersa».
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---LA COSTITUZIONE E " IL GRAN RIFIUTO" DI PILATO. Se il miglior interprete dei diritti non è la Corte ma il papa (di Massimo Villone).24 ottobre 2020, di Federico La Sala
Se il miglior interprete dei diritti non è la Corte ma il papa
Diritti. La pronuncia dei giudici costituzionali è pericolosa, perché indebolisce il principio che la Corte è argine ultimo e necessario proprio contro legislatore
di Massimo Villone (il manifesto, 23.10.2020)
È davvero uno scherzo della storia leggere nello stesso giorno di Papa Francesco e della Corte costituzionale. Il Papa apre alle coppie gay, e chiede una legge sulle unioni civili. Non sembra dubbio che, senza toccare il sacramento del matrimonio, dalle sue parole derivi un riconoscimento con pienezza di diritti, inclusa la filiazione. Mentre la Corte quei diritti li amputa.
Il fatto. A una coppia di donne, unita civilmente, nasce in Italia un figlio a seguito di fecondazione eterologa all’estero. La registrazione allo stato civile viene rifiutata. Nel giudizio conseguente viene sollevata dal Tribunale di Venezia una questione di legittimità costituzionale della legge sulle unioni civili e del decreto sugli atti dello stato civile. Il diritto.
La Corte si orienta per l’inammissibilità delle questioni sollevate. Il riconoscimento dello status di genitore alla cd madre intenzionale “non risponde a un precetto costituzionale ma comporta una scelta di così alta discrezionalità da essere per ciò stesso riservata al legislatore, quale interprete del sentire della collettività nazionale”. E dunque il diritto non esiste.
Le secche parole del comunicato chiudono la strada anche a interpretazioni secundum Constitutionem.
Al momento abbiamo solo il comunicato, e vedremo poi in dettaglio le motivazioni. Intanto possiamo dire che la Corte sembra aver sviluppato una allergia per i temi eticamente sensibili, con eccezioni per la fecondazione assistita. Cappato insegna, e certo la Corte sa bene che il rinvio al legislatore può tradursi nell’inerzia del medesimo.
Dobbiamo poi cogliere che oggi la Corte va oltre.
Al rinvio al legislatore si aggiunge la contestuale negazione di un diritto costituzionalmente protetto. Sul tema la Corte ha già balbettato in passato. Nella sentenza 138/2010 lesse nel matrimonio di cui all’articolo 29 della Costituzione la disciplina del codice civile del 1942, che ovviamente conosceva soltanto la coppia formata da due persone di sesso diverso. Ben si poteva invece dare una lettura evolutiva, che tenesse conto del nuovo.
Un recupero parziale è venuto poi dalla sent. 170/2014, sul cosiddetto divorzio automatico o imposto nel caso di cambio di sesso di uno dei coniugi. La Corte ha rinviato al legislatore, dichiarando però la incostituzionalità e affermando il diritto a una piena tutela giuridica della coppia del medesimo sesso.
Quella pronuncia ha avuto poi riscontro nella tormentata legge sulle unioni civili. Ma la Corte tiene oggi a precisare che la coppia omosessuale, pur riconosciuta dalla legge nella forma dell’unione civile, non ha gli stessi diritti della coppia eterosessuale unita in matrimonio. La Costituzione non garantisce che li abbia.
Si faccia una ipotesi di scuola. Una legge che limitasse forzosamente il numero dei figli consentiti nel matrimonio sarebbe incostituzionale. Mentre una legge che ponesse lo stesso limite a una coppia omosessuale unita civilmente potrebbe non esserlo.
Che ne è del nucleo incomprimibile dei diritti, di cui tanto abbiamo letto nella giurisprudenza costituzionale? E della razionalità, intesa come tutela contro distinzioni discriminatorie? Il presidio costituzionale diventa evanescente. Forse la stessa legge sulle unioni civili sarebbe in principio reversibile, se “l’interprete del sentire della comunità nazionale”, e cioè il legislatore maggioritario, maturasse un umore avverso.
L’odierna pronuncia della Corte, magari al di là delle intenzioni, è pericolosa, perché indebolisce il principio che la Corte è argine ultimo e necessario proprio contro il legislatore. E che dunque l’area della political question sottratta al suo scrutinio deve essere il più possibile ristretta.
“Il sentire della collettività” è sempre il pericolo più grande per i diritti e per le libertà, che sono appunto un argine contro quel sentire tradotto in potere politico e legislativo. Bisogna essere estremamente cauti nell’affermare che questa o quella fattispecie sfugge alla protezione costituzionale.
Non è un paese felice quello in cui ci si sente garantiti da un capo religioso piuttosto che dal massimo organo di giustizia costituzionale.
Ma potremmo suggerire che Papa Francesco tenga per i giudici della Corte un seminario di formazione, dal momento che più e meglio di loro si mostra consapevole del senso vero della Costituzione.
#COSTITUZIONE ED #EVANGELO: #DUESOLI. #PapaFrancesco apre la strada a #Dante2021: pagare il tributo a #Cesare «è un #dovere»; ma la #CorteCostituzionale con poco #spirito di #Salomone (di fronte a #due cittadine, unite civilmente, con bambino) fa "per viltade il #granrifiuto".
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- Costituzione, verità, e "natura delle cose". Papa Francesco e le "coppie omosessuali, sì alla tutela civile ma niente confusione col matrimonio" (di Lucia Capuzzi).23 ottobre 2020, di Federico La Sala
TEOLOGIA E ANTROPOLOGIA: GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA! O NO?!
- «Matrimonio è un termine che ha una storia. Da sempre, nella storia dell’umanità e non solo della Chiesa, viene celebrato tra un uomo e una donna», afferma Francesco in Dio è un poeta, edito nel nostro Paese da Rizzoli. E aggiunge: «È una cosa che non si può cambiare. È la natura delle cose, è così. Chiamiamole unioni civili. Non scherziamo con la verità» (Cfr. Il punto. Coppie omosessuali, sì alla tutela civile ma niente confusione col matrimonio di Lucia Capuzzi, Avvenire, venerdì 23 ottobre 2020).
Il punto.
Coppie omosessuali, sì alla tutela civile ma niente confusione col matrimonio
Tante reazioni alle parole del Papa nel docufilm “Francesco”. Parla Fernández arcivescovo argentino: Sin da quando era cardinale arcivescovo di Buenos Aires, Bergoglio ha distinto i due piani
di Lucia Capuzzi (Avvenire, venerdì 23 ottobre 2020)
«Ciò che dobbiamo fare è una legge sulla convivenza civile, hanno diritto a una forma di tutela legale. L’ho già sostenuto». Al di là delle forzature mediatiche, l’opinione di Jorge Mario Bergoglio sulle coppie omosessuali non è cambiata negli ultimi dieci anni.
La frase riportata nel documentario di Evgeny Afineevsky ricalca quanto già espresso nel 2010 quando, come arcivescovo di Buenos Aires, si trovò ad affrontare l’infuocato dibattito sulle nozze gay, legge fortemente voluta dal governo dell’allora presidenta Cristina Fernández de Kirchner. A ricordarlo non sono solo accreditate fonti giornalistiche di quell’epoca, tra cui il biografo ufficiale Sergio Rubín.
Ieri, in un messaggio su Facebook, monsignor Victor Manuel Fernández, arcivescovo di La Plata, teologo e profondo conoscitore del pensiero bergogliano, ricostruisce la vicenda, sottolineando come per papa Francesco, prima e dopo l’elezione al soglio pontificio, si devono distinguere due piani.
Da una parte c’è il «matrimonio», termine con un significato preciso, applicabile solo a un’unione stabile tra una donna e un uomo, aperta alla vita. «Questa unione è unica, perché implica la differenza tra l’uomo e la donna, uniti da un rapporto di reciprocità e arricchiti da questa differenza, naturalmente capace di generare vita», spiega monsignor Fernández. Qualunque altra unione simile richiede, dunque, una denominazione differente.
Unioni o convivenza civile, appunto. «Jorge Mario Bergoglio ha sempre riconosciuto, pur senza necessità di definirli matrimonio, l’esistenza di legami molto stretti fra persone dello stesso sesso, che vanno al di là del mero piano sessuale, ma sono alleanze intense e stabili. Le persone si conoscono a fondo, condividono lo stesso tetto per molto tempo, si prendono cura e si sacrificano l’uno per l’altro», afferma l’arcivescovo di La Plata. In caso di malattia grave o morte, uno dei due può desiderare i suoi beni all’altro o che sia quest’ultimo ad essere consultato invece di un familiare. «Tutto ciò può essere contemplato da una legge» sulle «unioni civili o normativa di convivenza civile, non matrimonio».
A tal proposito, monsignor Fernández conferma quanto già riportato dai media dieci anni fa. Ovvero che, durante il dibattito sul cosiddetto matrimonio igualitario in Argentina, il cardinal Bergoglio sostenne tale posizione durante un incontro ad hoc con l’episcopato: la maggioranza, però, si oppose. La questione era già emersa subito il conclave del 2013. Da allora, il successore di Pietro ha sempre mostrato sensibilità e attenzione pastorale nei confronti delle persone omosessuali. Certo, nel docu-film di Afineevsky, Francesco torna espressamente sulla questione delle unioni civili e ripropone, da Papa, quanto già affermato dieci anni fa. Nemmeno questo, però, è un inedito assoluto.
Nel libro che raccoglie le conversazioni con il sociologo Dominique Wolton, pubblicato in Francia nel 2017 e in Italia l’anno successivo, c’è già un accenno al riguardo. «Matrimonio è un termine che ha una storia. Da sempre, nella storia dell’umanità e non solo della Chiesa, viene celebrato tra un uomo e una donna», afferma Francesco in Dio è un poeta, edito nel nostro Paese da Rizzoli. E aggiunge: «È una cosa che non si può cambiare. È la natura delle cose, è così. Chiamiamole unioni civili. Non scherziamo con la verità» .
Il documentario Francesco, insignito ieri, nei giardini vaticani, del premio Kinéo, non contiene, dunque, verità sconvolgenti.
Del resto non era questo l’obiettivo dell’autore, ebreo non praticante di origini russe. Attraverso la raccolta di testimonianze e immagini, il regista cerca di narrare le ferite del mondo: le guerre, l’esodo infinito a cui sono costrette migliaia di persone, i muri vecchi e nuovi, fisici e mentali che separano gli uni dagli altri. Il racconto segue il Papa nei suoi viaggi, da Lampedusa a Manila, da Ciudad Juárez a Santiago.
 Il racconto su Francesco, spiega Afineevsky, però, piano piano, si è trasformato in un film «sull’umanità che commette errori, fatta di peccatori...». La chiave è contenuta in una frase di Oscar Wilde cara al Papa e riportata nel filmato: «Ogni santo ha un passato e ogni peccatore ha un futuro».
Il racconto su Francesco, spiega Afineevsky, però, piano piano, si è trasformato in un film «sull’umanità che commette errori, fatta di peccatori...». La chiave è contenuta in una frase di Oscar Wilde cara al Papa e riportata nel filmato: «Ogni santo ha un passato e ogni peccatore ha un futuro».
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
A FREUD (Freiberg, 6 maggio 1856 - Londra, 23 settembre 1939), GLORIA ETERNA !!! IN DIFESA DELLA PSICOANALISI.
DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE.
GUARIRE LA NOSTRA TERRA : VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo".
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- Se la grande storia che racconta la Tv è sempre quella delle élite (di Piero Bevilacqua)21 ottobre 2020, di Federico La Sala
Se la grande storia che racconta la Tv è sempre quella delle élite
Siamo a un ritorno indietro di un secolo, in coerenza con l’involuzione generale di questa fase della storia del mondo. Un modo di fare storia definito «évenémentielle»
di Piero Bevilacqua (il manifesto, 20.10.2020)
La Grande storia è un fortunato programma televisivo che dal 1997 porta nelle case degli italiani frammenti visivi e anche puntuali commenti di alcune delle pagine più drammatiche del ‘900. Grazie a documentari, foto d’epoca, testimonianze originali e spesso di prima mano, momenti salienti del nostro passato si fanno spettacolo per la fruizione del grande pubblico.
Le trincee della prima guerra mondiale, ma soprattutto la marcia su Roma, Mussolini, il re Vittorio Emanuele III, i gerarchi fascisti, l’ascesa del nazismo, Hitler, le sue donne, i suoi compagni e i suoi generali, la guerra e le varie campagne militari, i bombardamenti delle città, la Shoa e i campi di sterminio, lo sbarco degli americani in Europa, la sconfitta del nazifascismo, il dopoguerra, la ricostruzione,ecc. Grazie alla drammatica spettacolarità delle immagini, la storia si fa vicenda epica che affascina ed emoziona, mentre certamente contribuisce a gettare qualche luce sul nostro recente passato e a tenerne desta la memoria.
E tuttavia, questo modo di rappresentare la storia, diventato con gli anni sempre più insistito ed esclusivo, reca con sé un pesante carico di ideologia. A partire dal titolo della trasmissione: Grande storia. Perché a guidarla sono i grandi uomini, dittatori, generali, capi di stato, gerarchi, uomini politici di vario rango? È vero che c’è posto anche per le grandi masse, ma sempre come soggetto passivo, vittime, oggetto di comando o persecuzione. Non ci sono dubbi che la guerra sia un grande evento storico, ma i popoli, i cittadini, gli uomini comuni, sono solo la massa dannata che subisce i comandi di un pugno di capi.
Sul piano storiografico siamo di fronte a un ritorno indietro di poco meno di un secolo, in coerenza con l’involuzione generale di questa fase della storia del mondo e del grave scadimento culturale che segna in particolare la vicenda italiana degli ultimi decenni. Ricordo che questo modo di fare storia venne definita évenémentielle, cioé un racconto di eventi, dagli storici delle Annales, fondata nel 1929 da due storici eminenti: Marc Bloch e Lucien Febvre. Quella definizione svalutativa, riferita al fatto che sino ad allora gli storici avevano generalmente raccontato solo vicende politiche, eventi diplomatici e militari, cronache di re e capi di stato, venne accompagnata e seguita da una massa spettacolare di studi e ricerche, dei due fondatori e di altri storici, destinata a rivoluzionare per sempre la disciplina.
Entravano allora sulla scena, per la prima volta, titolari di storia a tutti gli effetti e non più masse anonime manovrate dall’alto, i contadini con le loro condizioni di vita, lavoro, mentalità. Tutta la multiforme stoffa della vita umana, l’alimentazione, la vita sessuale, le pratiche di lavoro, i modi dell’abitare, divennero ben presto materia di storia. Sicché tutti coloro che non avevano nome né cognome, sterminate masse prima senza storia, ne divennero i protagonisti. Si è trattato di una gigantesca democratizzazione della storia, sino ad allora narrazione privilegiata delle élites.
Bloch e Febvre anticipavano il grande processo di emancipazione politica e culturale che sarebbe seguita alla guerra mondiale. Ma un altro fondamentale apporto venne da quella svolta, uno dei contributi più alti del sapere storico alla cultura del ‘900: l’ingresso dello spazio nella vicenda storica e una nuova dimensione del tempo.
Fernand Braudel ha dato forse il più alto saggio, con la sua Méditerranée, della possibilità che la geografia, i monti, i fiumi, le pianure diventino soggetti di storia in cooperazione con le popolazioni. Mentre ha mostrato che il tempo storico non è solo quello degli eventi, ma soprattutto quello della lunga durata, dei vasti processi sotterranei e strutturali in cui le società sono immerse e in cui le masse sono protagoniste.
Allora diciamo che il ritorno insistito della storia politica ed événementielle in Tv non giova alla cultura nazionale. Insinua la vecchia idea che la storia la fanno i capi e indirettamente rivaluta vecchie ideologie autoritarie. Ma soprattutto perpetua una millenaria rimozione, la cancellazione che da sempre la storia ha operato della natura.
In questa narrazione di eventi e grandi uomini i protagonisti vivono come angeli o demoni, staccati dal suolo. Ma proprio noi italiani non possiamo dar credito a una ricostruzione del passato che cancella le vicende del nostro territorio e il lavoro del nostro popolo. Siamo diventati un grande paese moderno, grazie a una gigantesca opera di risanamento e rimodellamento del nostro habitat.
Ancora nel 1865 una inchiesta governativa accertava la presenza di oltre 1 milone di ettari di acquitrini nella Penisola, dove imperversava la malaria. Tecnici e contadini, ingegneri e grandi masse, sono stati i protagonisti di questa epopea, così come della diffusione della nostra agricoltura, dell’edificazione delle nostre città, di canali e ferrovie, della ricostruzione degli abitati dopo i tanti terremoti, di tutte le opere di pace che costituiscono la stoffa di quella che è la nostra Grande storia.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- PLATONE, KANT, E LE BUONE (E LE FALSE) NOTIZIE.9 ottobre 2020, di Federico La Sala
PLATONE, KANT, E I SOGNI DI UN VISIONARIO....
Il Bene e il conveniente sono ciò che lega e tiene insieme l’universo. Platone (Tweet Filosofici)
Ma perché questa #idea, questa #novella (il "#Bene...tiene insieme l’#universo") possa essere e intendersi come una novella-buona, è necessario #verificare se non è una #FakeNews: se no, la #buona-novella (εὐ-αγγέλιον) può #velare il contrario, che #Tutto "Va-(i)n-gelo"! O no?! (Federico La Sala)
fls
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- Matematica e virtù civili: una recensione di “La matematica è politica” di Chiara Valerio (di Marco Verani).12 settembre 2020, di Federico La Sala
Matematica e virtù civili: una recensione di “La matematica è politica” di Chiara Valerio
di Marco Verani (MaddMaths! Matematica Divulgazione, Didattica - 12 Settembre 2020)
- In questi giorni si sta molto parlando del recente libro “La matematica è politica” di Chiara Valerio, pubblicato da pochi giorni presso Einaudi. Vi proponiamo ben due recensioni. Una è di Marco Verani, e la trovate qui sotto. L’altra è di Maria Mellone e la trovate qui.*
- L’individuo diviene davvero soggetto morale se si rende responsabile della sua condotta, sia essa conforme alle regole e alle abitudini o difforme da esse.[...] Ha ragione Foucault: “Se è vero che ogni azione morale implica un rapporto con il reale in cui si compie e un rapporto con il codice cui si riferisce, è vero altresì che essa implica un rapporto con se stessi, e questo rapporto non è semplicemente ‘coscienza di sé’, bensì costituzione di sé come soggetto morale”.
- Bisogna dunque costituirsi come “soggetti morali”. Questo è più che mai urgente nel mondo contemporaneo. La complessificazione della società ha disarticolato i vecchi riferimenti[...] La dinamica della complessità ha dilatato gli spazi di libertà, ha implementato le nostre possibilità di scegliere e soprattutto di sceglierci, di modellare noi stessi con più ampia discrezione di un tempo. Ma per trarre giovamento dai mutamenti del presente bisogna esserne all’altezza.
- (S. Natoli, Dizionario dei vizi e delle virtù)
“La matematica è politica” di Chiara Valerio ci parla di virtù civili, così importanti e così dimenticate, e del ruolo che la Matematica ha nel forgiarle.
- La matematica si impara in una maniera che coinvolge il principio di causa-effetto, cioè la necessità, essa è la disciplina che, già dalle prime nozioni, fornisce una postura logica, che subito si rivela postura etica e civile. (p.19)
- La matematica - disciplina estremamente economica a cui tutti possiamo accedere perché si insegna nelle scuole di ogni ordine e grado - si rivela, a osservarla come prassi, e non solo come teoria, una forma di meditazione, di etica e un esercizio sulla verità. (p.21)
Diverse sono le virtù civili che affiorano, come fari, tra le pagine di Chiara Valerio.
Amore per la verità. Verità che deve essere conosciuta, ricercata, detta anche quando e’ scomoda. Mai imposta, mai subita.
- La matematica è stata il mio apprendistato alla rivoluzione, dove per rivoluzione intendo l’impossibilità di aderire a qualsiasi sistema logico, normativo, culturale e sentimentale in cui esista la verità assoluta, il capo, l’autorità imposta e indiscutibile. Accettare questa definizione di rivoluzione significa ammettere che la rivoluzione non è un evento, ma un processo, che non esistono certezze perenni, ma che le certezze camminano sulle gambe degli uomini e sui loro sistemi giuridici ed economici, e che tuttavia, sopra i sistemi giuridici, legislativi ed economici, esiste un’idea di comunità che include in sé, per restare a ogni passo perfettamente umana, il concetto di tempo, e dunque all’interno della comunità uccidere (impedire il tempo) e opprimere (fermare il tempo) non sono ammessi. Accettare questa idea di rivoluzione vuol dire ripensare la democrazia come forma di rivoluzione da esercitare. (p.8)
- La matematica va a fondo nella definizione della verità. La verità non si possiede mai da soli. O tutti siamo in grado, date le condizioni al contorno e l’insieme di definizione, di giungere al medesimo risultato, o posso gridare forte quanto voglio di possedere la verità, ma griderò invano. La matematica insegna che le verità sono partecipate, per questo è una disciplina che non ammette principi di autorità. Tutti, anche se non siamo Pitagora, possiamo dimostrare il suo teorema. [La matematica] è una disciplina che non ammette principio di autorità giacché nessuno possiede la verità da solo, le verità sono asserzioni verificabili da chiunque, o se non da chiunque (alcune volte è difficile) almeno da un certo numero di persone. Inoltre, la matematica è un linguaggio, una grammatica. Per discutere di matematica bisogna accettarne le regole. Sicché uno studioso, ma anche uno studente di matematica, è abituato a operare in un mondo di regole comuni, per ridiscutere le quali non si può essere in uno, bisogna essere almeno in due. Ovviamente la matematica non procede per voto o alzata di mano, ma per ipotesi e verifiche. (p.31)
Perseveranza. La matematica è palestra per allenare la perseveranza, per coltivare l’attenzione.
- La matematica, piú di altre, è una disciplina nella quale, al netto delle doti naturali (come per esempio i quadricipiti di Usain Bolt nella corsa), applicazione ed esercizio sono fondamentali.[...] Mi rendo conto che studiare, nella dittatura dell’immediato, che viviamo, è un verbo scomodo, pieno di conseguenze e al quale è stata sottratta la sinonimia, naturale, con progettare o immaginare. (p.18)
- Sedersi a svolgere un esercizio di matematica è un gesto di protesta nei confronti del presente, che sia urgenza percepita o stasi di forza maggiore, perché studiare matematica significa riprendersi il tempo (p.19)
- Il lettore, come chi studia matematica e in generale chi studia, è capace di stare da solo. Chi sta da solo è politicamente complesso perché non deve essere intrattenuto (p.51)
Bello ricordare e affiancare a questo punto le parole indimenticabili sull’attenzione di Simone Weil e Cristina Campo.
- Molto spesso l’attenzione viene confusa con una sorta di sforzo muscolare. Quando si dice agli allievi: “Ora state attenti”, li si vede corrugare le sopracciglia, trattenere il respiro, contrarre i muscoli. Se qualche istante dopo si domanda loro a che cosa siano stati attenti, non sono in grado di rispondere. Non hanno fatto attenzione ad alcunché. Non hanno fatto attenzione. Hanno solo contratto i muscoli. Nella nostra anima c’è qualcosa che ripugna la vera attenzione molto più violentemente di quanto alla carne ripugni la fatica. Questo qualcosa è molto più vicino al male di quanto non lo sia la carne. Ecco perché ogni volta che si presta veramente attenzione si distrugge un po’ di male in se’ stessi. Un quarto d’ora di attenzione così orientata ha lo stesso valore di molte opere buone. L’attenzione consiste nel sospendere il proprio pensiero, nel lasciarlo disponibile, vuoto e permeabile all’oggetto. (S. Weil, Attesa di Dio)
- E avere accordato a qualcosa un’attenzione estrema è avere accettato di soffrirla fino alla fine, e non soltanto di soffrirla ma di soffrire per essa, di porsi come uno schermo tra essa e tutto quanto può minacciarla, in noi e al di fuori di noi. E avere assunto sopra se stessi il peso di quelle oscure, incessanti minacce, che sono la condizione stessa della gioia. Qui l’attenzione raggiunge forse la sua più pura forma, il suo nome più esatto: è la responsabilità, la capacità di rispondere per qualcosa o qualcuno, che nutre in misura uguale la poesia, l’intesa fra gli esseri, l’opposizione al male. Perché veramente ogni errore umano, poetico, spirituale, non è, in essenza, se non disattenzione (C. Campo, Gli imperdonabili)
Umiltà. Fare matematica è ripartire dai propri errori, spesso riconoscere la propria incapacità, confrontarsi con il limite, il non-possibile. Smantellare l’idea del tutto è possibile sempre, subito.
- Ho capito, in quel momento, che conoscere la matematica significava pure capire quando le cose non si potevano risolvere e che, nonostante fossi certa di averlo fatto, non avevo ancora studiato abbastanza. Che le lavagne vanno cancellate anche quando sopra ci hai scritto grandi verità, perché gli altri possano scriverci le loro. E che l’apparenza inganna, anche in ambiti inattesi come i linguaggi formali. Come gli indiani d’America dovevo convincermi che esistevano cose che potevo risolvere e cose che non potevo risolvere e che era necessario affinare la capacità e l’umiltà di distinguere. Scrivo di persone perché l’apprendimento ha a che fare con gli incontri, con il riconoscimento e con la fiducia. (p.23)
Cura del bene comune. Tra i beni comuni più preziosi che abbiamo vi è la democrazia. Fare matematica è difesa ed esercizio di democrazia.
- La democrazia è un sistema lento e costoso, e va manutenuto. Come la comprensione, la democrazia non si sceglie una volta per tutte, va esercitata, rinnovata e verificata, somiglia a una teoria scientifica. La manutenzione della democrazia si fa esercitando i diritti e rispettando i doveri, ed è esattamente come imparare a contare. La democrazia è complessa. La dittatura è piú semplice. Uno comanda, tutti gli altri eseguono. La dittatura non è matematica, non si evolve e non si interpreta, cambia colore ma funziona sempre allo stesso modo: uno comanda, tutti gli altri eseguono. Non ha altra conseguenza, altra implicazione che l’obbedienza. Non ha altra ipotesi che il principio di autorità. La democrazia è matematica, si basa su un sistema condiviso di regole continuamente negoziabili e continuamente verificabili. La democrazia, come il linguaggio, e tra i linguaggi la matematica, non è naturale, non è un fiore che sboccia, è una costruzione culturale e dunque, in quanto tale, va continuamente ridiscussa, la democrazia non rinverdisce a primavera come certi alberi, bisogna sceglierla, come si sceglie il linguaggio. Dunque, dal punto di vista costitutivo, la matematica è il contrario della torre d’avorio, del castello, del tabernacolo, la matematica esercita al contesto e quindi a essere cittadini e rappresentanti dei cittadini. E da questo punto di vista, la democrazia, che per poter esistere ha bisogno di tempo e discussioni più lunghe di un tweet, è rivoluzionaria. Non si alimenta di urgenze, le prevede più o meno ragionevolmente secondo emergenze che possono o no diventare catastrofi anche in base al modo in cui vengono affrontate e gestite. La democrazia non istiga alla colpa, ma alla responsabilità, non alla differenza ma all’uguaglianza davanti ai diritti e ai doveri. Non esclude, crea comunità. La democrazia e la matematica non subiscono il principio di autorità dell’urgenza. (p.36)
Chiara Valerio usa una bella espressione: ci dice che la matematica è una “disciplina di manutenzione”, manutenzione della democrazia, del con-vivere nel rispetto e nella solidarietà. Bellissima parola “manutenzione” che richiama il gesto paziente, lento e accudente delle mani. Sì, e’ vero: la matematica è politica.
*
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- MARIA MONTESSORI, ISTRUZIONE, E L’ORA DI UN DIBATTITO SERIO SULLA SCUOLA (di Lucio d’Alessandro).31 agosto 2020, di Federico La Sala
Istruzione
I 150 anni della Montessori ci ricordano che è ora di un dibattito serio sulla scuola
Il tema della qualità della scuola e dei suoi contenuti registra un agghiacciante silenzio, e l’emergenza coronavirus non c’entra
di Lucio d’Alessandro *
Ricorrono il 31 agosto i 150 anni dalla nascita di una delle donne italiane di maggior fama internazionale. Scuole ispirate al metodo di Maria Montessori (1870-1952) sono, ancora oggi, presenti in molti Paesi del mondo, così come molti furono gli Stati che, dopo la sua rottura con il fascismo con il quale inizialmente aveva collaborato, l’accolsero trionfalmente, dagli Usa all’India ai Paesi Bassi, fino al Ghana che, appena dopo l’approvazione della sua Costituzione (1951) e in vista della definitiva indipendenza, le chiese di organizzare la Scuola della nascente Repubblica: ormai ultraottantenne ma indomita, la Montessori accettò. La morte la colse poco dopo a Noordwijk, in Olanda, dove visse gli ultimi anni.
L’anniversario coincide con l’anno nel quale il tema della scuola domina il dibattito pubblico come mai prima nell’intera storia repubblicana, fino al punto che un Governo rivelatosi finora immarcescibile sembra sospeso alle sorti della riapertura, in condizioni di migliore o peggiore agibilità, dell’anno scolastico ormai alle porte. Tuttavia, nessuno si inganni: si tratta di una mera coincidenza. Non solo perché, notoriamente, la pedagogia montessoriana si basava sulla libertà di “movimento” anche in aula degli studenti, mentre sotto le attuali lune pandemiche i vari comitati consigliano piuttosto di tenerli legati ai banchi, sia pure, in qualche caso, con comodo di rotelle.
Invero, l’ispirazione post-risorgimentale e sociale della Montessori, come quella di De Amicis o quella risorgimentale e femminile di Adelaide Pignatelli, fondatrice dell’Università Suor Orsola in Napoli e, ancora, l’azione ministeriale di Francesco De Sanctis, Benedetto Croce e Giovanni Gentile erano ben consapevoli che solo una bildung che mettesse assieme educazione e istruzione, privilegiando in definitiva i valori della cultura, avrebbe potuto dare all’Italia quei cittadini e quella classe dirigente di cui quella fase di costituzione del Paese mostrava la necessità.
Credo che si possa dire, in parziale consonanza con le tesi di un libro (urticante e bello) di Galli della Loggia dal titolo rivelatosi, a distanza di un anno, singolarmente profetico (“L’aula vuota”), che la triade scuola-istruzione-cultura abbia giocato un ruolo strategico nella storia d’Italia dall’unificazione fino ad oltre la metà del ’900, consentendo a uno “Stato misero” di divenire una delle prime dieci economie del mondo. Ritengo sia anche vero che l’azione dei docenti italiani, in quella temperie culturale, sia stata decisiva e che una triade di ministri meridionali (De Sanctis, Croce e Gentile) di grande cultura ed ispirazione idealistica o neo-idealistica abbia dato all’Italia una scuola capace di consentire un’istruzione generalizzata dei suoi cittadini e una classe dirigente all’altezza di un grande Paese europeo.
Solo l’avidità mussoliniana di ascrivere a sé tutto ciò che vi era di buono in Italia, e poi la miopia della sinistra marxista di considerare negativamente tutto ciò che sapesse di merito e selezione, hanno fatto sì che la riforma Gentile che felicemente concluse quel processo culturale ed istituzionale passasse per la “più fascista delle riforme”. Come se proprio i fautori del fronte marxista della pedagogia italiana, concentrati nella redazione della bellissima rivista “La Riforma della scuola”, non fossero anch’essi figli di quella cultura classica voluta da Gentile, a cominciare dallo stesso direttore e fondatore Lucio Lombardo Radice, figlio di quel Giuseppe che era stato il maggiore collaboratore di Gentile negli anni ministeriali. La verità è che quella, pur con i suoi difetti era davvero una “buona scuola” e, perciò, anche una forma di educazione alla libertà ed alla elaborazione dello spirito critico.
Di quella scuola neo-idealista, così criticata nei contenuti e nei metodi, non vi è quasi più traccia nella scuola italiana di oggi e, specie in questi momenti, non è un buon segno, se è vero che essa fu capace di far progredire il Paese. Neppure un buon segno è il fatto che lo spazio del pensiero sulla scuola sia circoscritto alla riflessione didattico-pedagogica degli addetti ai lavori, senza uno sforzo di inclusione nel più generale dibattito sul Paese e sul concetto di cittadinanza.
 Il campo lasciato vuoto dagli intellettuali è occupato piuttosto da un pensiero sindacale che, per sua stessa natura, si colloca in una sfera meramente quantitativa.
Il campo lasciato vuoto dagli intellettuali è occupato piuttosto da un pensiero sindacale che, per sua stessa natura, si colloca in una sfera meramente quantitativa.Il tema della qualità della scuola e dei suoi contenuti registra dunque un agghiacciante silenzio, e sembra che neppure le famiglie, a cominciare da quelle che potrebbero permettersi significativi investimenti, se ne mostrino consapevoli. Il rarefarsi, in molte città quasi lo scomparire, delle scuole non statali di qualità ne è un segno evidente. A ciò si è aggiunto il più recente fenomeno per cui ai diplomifici a pagamento, già presenti nell’arco formativo scolastico, si sono aggiunte realtà non dissimili perfino nel campo universitario. -Non meraviglia dunque se l’attuale dibattito risulta tutto concentrato sulla scuola come spazio nel quale tenere, o detenere, il tempo dei giovani per consentire alle famiglie e al Paese di riprendere, in condizione di relativa sicurezza, le proprie attività.
 Di questa miseria culturale ormai antica non si può certo dare colpa all’attuale ministra, né invero appare generosa la critica verso di lei di una ex ministra, peraltro appartenente all’attuale maggioranza, che non ha lasciato in Viale Trastevere particolare memoria di sé, se si prescinde dal colore fiammeggiante delle sue chiome.
Di questa miseria culturale ormai antica non si può certo dare colpa all’attuale ministra, né invero appare generosa la critica verso di lei di una ex ministra, peraltro appartenente all’attuale maggioranza, che non ha lasciato in Viale Trastevere particolare memoria di sé, se si prescinde dal colore fiammeggiante delle sue chiome.La situazione sul terreno è davvero difficile e credo sia giusto considerare con qualche generosità gli sforzi, certo un po’ errabondi, di un ministero che si trova, nella sostanziale incertezza dell’andamento della pandemia, ad affrontare il problema forse più difficile che la scuola italiana si sia trovato di fronte. In ogni caso il possibile viene fatto e molto, moltissimo, dovranno fare, come sempre i docenti e i dirigenti, nelle trincee delle singole scuole.
A quando dunque una seria ripresa del dibattito sul senso della scuola in Italia? Qualche settimana fa uno degli italiani attualmente più conosciuti e stimati sul piano internazionale, Mario Draghi, ha sottolineato l’importanza della scuola e dell’istruzione per gestire il futuro, invocando un forte investimento a favore dei giovani. È appena il caso di dire che tutti gli hanno dato ragione: cattivo segno, per il momento non se ne farà niente.Ma tra poco più di un anno occorrerà scegliere un nuovo Presidente della Repubblica, e nelle piazze e nelle case d’Italia, molto più che nelle cosiddette segrete stanze, il nome di Mario Draghi circola fortemente... -Nel frattempo, il 14 settembre una nuova leva di studentesse e studenti entrerà nella scuola italiana, mentre appena qualche giorno dopo nelle aule universitarie verrà selezionata una nuova leva di maestre e maestri. Credo si debba dir loro che affronteranno probabilmente un anno difficile ma anche che il percorso degli studi è una delle fasi più belle e costruttive della vita che conserveranno nel tempo come straordinario ricordo e formidabile patrimonio di vita: forza ragazze, forza ragazzi!
* Rettore Università Suor Orsola Benincasa di Napoli
* Fonte: Il Sole-24 Ore, 31 agosto 2020 (ripresa parziale).
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- MARIA MONTESSORI - MA DOV’È "GIUSEPPE"?!
LA SCUOLA PUBBLICA COME ORGANO COSTITUZIONALE DELLA DEMOCRAZIA. Una nuova edizione del libro di Piero Calamandrei, "Per la scuola".
LA STORIA DEL FASCISMO E RENZO DE FELICE: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"!
IL SONNO MORTIFERO DELL’ITALIA. In Parlamento (ancora !) il Partito al di sopra di tutti i partiti.
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- RICORDI DI SCUOLA SULLA CRITICA DELLA “RAGIONE PURA” (“SOFISTICA”)!3 luglio 2020, di Federico La Sala
COSTITUZIONE (META-REGOLE), POLITICA (REGOLE), E RICORDI DI SCUOLA SULLA CRITICA DELLA “RAGIONE PURA” (“SOFISTICA”)!. Una nota*
SE E’ VERO CHE, “Per coloro che, come chi scrive, percorrono da molti anni i corridoi delle aule giudiziarie e degli altri palazzi del potere conoscendo le dinamiche sottese alle scelte della “politica giudiziaria”, diventa particolarmente fastidioso leggere e sentir raccontare autentiche favole metropolitane su quel che potrebbe ora accadere o sarebbe mai accaduto nelle proverbiali stanze dei bottoni”, NON E’ ALTRETTANTO VERO CHE, “Salvo cataclismi naturali e a dispetto dei clamori che fomentano il popolo con cronache enfatizzanti sul futuro panorama delle collusioni tra politica e giustizia, non accadrà assolutamente nulla, se non la futura giusta punizione a carico di coloro che non hanno rispettato le regole di appartenenza alle proprie aree di influenza del potere” (Laura Vasselli, "La giustizia, la politica e le relazioni pericolose", "InLibertà", 2 luglio 2020).
AD EVITARE eccessi di pericolose semplificazioni e produzioni di “nuvolose” illusioni, per contestualizzare meglio il problema, NON SOLO rileggerei l’ottimo “riassunto” di una questione complessa come quella affrontata nell’articolo in “#iorestoacasa, Forza Italia!” (di Italo Mastrolia, “InLibertà”, 16 aprile 2020), MA rivisiterei ANCHE i luoghi della memoria degli anni di scuola e riguarderei con maggiore attenzione la grande lezione di Aristofane (cfr. “Le nuvole”) su un “Socrate” che non è mai giunto a “conoscere sé stesso” e tuttavia viene “venduto” e “contrabbandato” (pubblicità-progresso!) come un grande saggio, non solo ieri (ad Atene) ma anche oggi (nel “villaggio globale”) - dopo Marshall McLuhan?! O no?!
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- ANCORA TUTTI A SCUOLA DA "SOCRATE" ARISTOFANEO E PLATONICO-HEGELIANO?!2 luglio 2020, di Federico La Sala
Le nuvole (Aristofane) *
Le nuvole (in greco antico Νεφέλαι, Nephèlai) è una commedia di Aristofane, andata in scena per la prima volta ad Atene, alle Grandi Dionisie del 423 a.C. [...]
Trama
Il contadino Strepsìade è perseguitato dai creditori a causa dei soldi che suo figlio Fidippide ha dilapidato alle corse dei cavalli; pensa allora di mandare il figlio alla scuola di Socrate, filosofo che, aggrappandosi ad ogni sofisma, insegna come prevalere negli scontri dialettici, anche se in posizione di evidente torto. In questo modo, pensa Strepsiade, il figlio sarà in grado di vincere qualsiasi causa che i creditori gli intenteranno.
In un primo momento Fidippide non vuole andare al Pensatoio (phrontistérion) del filosofo e così il padre, disperato e perseguitato dagli strozzini, decide di recarvisi lui stesso, seppur vecchio. Appena giunto, incontra un discepolo che gli dà un assaggio delle cose su cui si ragiona in quel luogo: una nuova unità di misura per calcolare la lunghezza del salto di una pulce, oppure la scoperta del modo in cui le zanzare emettono il loro suono. In seguito, finalmente Strepsiade vede Socrate sedere su una cesta sospesa a mezz’aria, in modo da studiare più da vicino i fenomeni celesti.
Il filosofo, dopo un breve dialogo, decide di impegnarsi ad istruirlo: gli mette indosso un mantello e una corona ed invoca l’arrivo delle Nuvole, le divinità da lui adorate, che si presentano puntuali sulla scena. Strepsiade però non riesce a capire nulla dei discorsi pseudo-filosofici che gli vengono fatti (parodia della filosofia socratica e sofistica) e viene quindi cacciato. Fidippide, incuriosito dai racconti del padre, decide infine di andare a visitare il pensatoio e quando arriva assiste al dibattito tra il Discorso Migliore e il Discorso Peggiore.
Nonostante i buoni propositi e i sani valori proposti dal Discorso Migliore (personificazione delle virtù della tradizione), alla fine prevale il Discorso Peggiore (personificazione delle nuove filosofie) attraverso ragionamenti cavillosi. Fidippide impara la lezione ed insieme al padre Strepsiade riesce a mandare via due creditori; il padre è contento, ma la situazione gli sfugge subito di mano: Fidippide comincia infatti a picchiarlo, e di fronte alle sue proteste il figlio gli dimostra di avere tutto il diritto di farlo. Esasperato e furioso, Strepsiade dà allora alle fiamme il Pensatoio di Socrate, tra le grida spaventate dei discepoli.
[...]
* LE NUVOLE: Wikipedia - ripresa parziale; testo completo, su filosofico.net.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- L’AVVENIRE DI UN’ILLUSIONE: VIRGILIO, LA SIBILLA CUMANA, E "L’INTERPRETAZIONE DEI SOGNI" DI FREUD.17 giugno 2020, di Federico La Sala
RIPRENDERE IL LAVORO DI FREUD. IL MALE, L’AVVENIRE DI UN’ILLUSIONE ....
Nota a margine di "Il male, un’illusione ? Intervento al Convegno Internazionale UNESCO” *
PRIMA DI FARE DICHIARAZIONI STORIOGRAFICHE DI GRANDE IMPEGNO A SOSTEGNO DELLE PROPRIE ARGOMENTAZIONI:
- “[...] Non a caso la letteratura, il teatro e il cinema moderni si sono riempiti di figure di mostri umani, a cominciare dalla divinizzazione retroattiva del marchese de Sade. E così il Moosbrugger dell’Uomo senza qualità di Musil, il tema del Male in Blanchot, il Pierre Rivière di Foucault, fino al serial killer del film di Lars von Trier The House That Jack Built.... Il fascino che l’uomo “al di là del Bene e del Male” esercita oggi su molti di noi deriva dal fatto che quello che era nostro orrore per l’uomo diventa una sorta di ammirazione per il carattere orrendo dell’uomo. (Horrendus in latino significa orrendo, ma anche bellissimo. Horrenda virgo in Virgilio significa “ragazza terribilmente bella”[Aeneid., 11.507]. Era la qualificazione di una dismisura) [...]” (Sergio Benvenuto, "Il male, un’illusione? Intervento al Convegno Internazionale UNESCO”, "Le parole e le cose", 15 giugno 2020) ;
E PARLARE DI “divinizzazione retroattiva del marchese de Sade” è bene ricordare che l’associazione indebita di “Kant e Sade”, fatta da Lacan, nasce sulla base di una interpretazione edipico-hegeliana e di un vera e propria distruzione della kantiana “critica dell’idealismo”.
E, ancora, quando Freud richiama all’inizio del suo lavoro sulla “Interpretazione dei sogni” le parole di Giunone “flectere si nequeo Superos, Acheronta movebo” (Eneide, VII, 312), sa già (“sibillina-mente”) di che cosa sta parlando e di cosa c’è in gioco e, come Giunone (“Non mi sarà dato, ahimé, di impedirgli di regnare sui Latini e Lavinia, immutabile, resta sua sposa in forza del destino, ma ho il potere di tirare per il lungo, di imporre dei ritardi a eventi così grandi ...” : Eneide, VII, 312- 315 ), va avanti e ricordando-si di Napoli comincia capire cosa c’è dietro la questione “Didone” (Eneide, IV, 625 ) e la sua infatuazione per Annibale, per il vendicatore: la vittoria di Roma, dell’Amore sulla Morte. Fiducioso, continua il suo lavoro!
La “Horrenda Virgo” (Eneide XI, v. 507) , la “ragazza terribilmente bella”, come Giunone (e Freud), lo sa: deve cedere il passo ad un’altra “Virgo”, ad Astrea, alla Giustizia: «Già viene l’ultima era dell’oracolo di Cuma, / nasce di nuovo il grande ordine dei secoli. / Già ritorna la Vergine, ritornano i regni di Saturno, /già una nuova stirpe scende dall’alto del cielo. » (Ecloga IV, 4-7). La “Horrenda SYbilla” (Eneide VI, 11), ispirata da Apollo, il profeta di Delo, ha rivelato ad Enea tutto il futuro (Eneide VI, 11-12).
PERCHE’ HANNAH ARENDT, nella sua “Vita della mente” (alla luce di un inedito dialogo con Kant) richiama ancora e di nuovo Virgilio e Dante, e dal “Libro del malumore” di Goethe cita: “Chi di tremila anni / Non sa darsi conto, / Rimane all’oscuro inesperto, /Vuol vivere così di giorno in giorno” ? Boh e bah ?!
*
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- COSTITUZIONE E DESIDERIO: IL “SOGNO D’AMORE” E LA TRAPPOLA DELLA “TRUFFA ROMANTICA” (di Laura Vasselli)..10 giugno 2020, di Federico La Sala
La truffa esiste anche in danno alla vita sentimentale
di Laura Vasselli (InLibertà, 10 Giugno 2020)
Chi non ha avuto modo di venire a conoscenza, se pur in modo fugace e non dettagliato, della vicenda del fantomatico Mark Caltagirone, promesso sposo virtuale della nota showgirl Pamela Prati?
Il gossip che si scatenato su di lei per questo autentico guazzabuglio di notizie, sulla cui veridicità si sono scatenati dibattiti televisivi di ogni livello, ha lasciato spazio ad una specie di “giallo informativo”, nel quale si sono aggrovigliati elementi di falso recitativo misti ad esternazioni di reale innamoramento con scenari rosei di vita futura con esclamazioni pubbliche di gioia del tipo “...sarò moglie e mamma!...e altre simili esternazioni.
Ma è meglio procedere con ordine.
Nei fatti reali, diversi mesi fa, Pamela Prati annunciò il suo matrimonio con questo tale Mark Caltagirone che, dal racconto della “promessa sposa”, era un imprenditore italiano che l’aveva portata con sé in molti viaggi di lavoro in giro per il mondo; la showgirl parlava di lui offrendo dati concreti e dichiarando che si trattasse di un personaggio noto nel suo ambiente ed apprezzato come professionista.
Tuttavia, nessun rilievo venne attribuito all’indizio della totale assenza di fotografie di lui, che giustificava con esigenze di riserbo sulla propria vita privata, anche in ragione della presenza dei suoi due bambini che sarebbero stati adottati dalla fidanzata, una volta che sarebbe diventata sua moglie.
Ma la data dell’8 maggio 2019 che era stata annunciata per le nozze, venne rinviata e - a seguito di verifiche, riscontri incrociati e indagini di vario tipo - si accertò che Mark Caltagirone non è mai esistito e che è stato un personaggio completamente inventato.
Dal racconto felice al disagio totale, Pamela Prati - che come ospite aveva raccontato in varie trasmissioni televisive la sua storia d’amore miseramente fallita - è stata costretta suo malgrado ad ammettere di essere stata plagiata, con tanto di conseguenze sul piano giudiziario in danno a chi l’aveva tratta in inganno, salvi poi ulteriori retroscena che non riguardano questo argomento.
Insomma, questo episodio di cronaca rosa ha reso conoscibile l’esistenza di preoccupante fenomeno in diffusione che è proprio quello definito “truffa amorosa” realizzata attraverso un sistema di manipolazione mentale costruita attraverso raffinate tattiche persuasive, elogi esagerati, false prospettive di “vita insieme per sempre” per far seguito a vissuti problematici più o meno verosimili per tutti i truffatori sentimentali in danno a persone desiderose di poter finalmente realizzare qualcosa che - a quanto pare - non passerà mai di moda: il “sogno d’amore”.
Queste vere e proprie condotte criminali penalmente perseguibili, attuate con gli inganni, gli artifizi e i raggiri che connotano il reato di truffa come disciplinata dall’art. 640 del codice penale, risultano essere incrementate nell’ultimo periodo perché favorite dall’isolamento imposto dalla protezione pandemica che ha reso più fragili le persone che vivono in solitudine, così esponendole in maniera così subdola al rischio di essere vittime di questo terribile reato, lesivo della buona fede e della dignità di chi auspica un’esistenza migliore attraverso la ricerca della felicità in coppia.
Attraverso l’uso della rete e dei social networks, i malcapitati destinatari di questo reato vengono portati a legarsi sentimentalmente con il truffatore che agisce fino ad ottenere vantaggi economici e di altra natura con trappole particolarmente sofisticate
Col sistema tipico della tela del ragno, l’autore della truffa comincia col reperire lentamente ogni utile informazione sulla vita privata della sua futura vittima, magari studiando i suoi interessi e le sue abitudini fino all’approccio diretto azionato con la creazione di un falso profilo dotato di apposito nickname.
Spesso la vittima resta malamente intrappolata nella rete perché viene prima sedotta e poi illusa attraverso sapienti approcci con forte carica psicologica persuasiva; questi autentici delinquenti sono infatti sempre pronti a intervenire sulle fragilità e sui i punti deboli della vittima che sono riusciti a scovare mediante questa tattica di attento e incalzante corteggiamento.
Scattano quindi i meccanismi di intimità, fiducia e comprensione tipici dell’innamoramento virtuale con questo partner apparentemente ideale che portano a credere in uno scambio sentimentale vero e proprio e che si realizza mediante attenzioni e pensieri quotidiani a sostegno dell’interesse dell’uno verso la vita dell’altro (compresi i diffusissimi messaggini del buongiorno e della buonanotte a cui viene ancora attribuita una valenza affettiva esageratamente elevata).
Una volta catturata la vittima, colui o colei che pone in essere la truffa, parte con l’azione vera e propria: inizia la filza delle lamentele su problematiche debitorie (tipo: devo restituire denaro a un caro amico che mi ha aiutato nel momento del bisogno!), su danni alla salute (tipo: devo subire un urgente intervento chirurgico!), su emergenze economiche (tipo: ho perso il bancomat!), su progetti in comune (tipo: dobbiamo arredare la nostra futura casa!), ma anche su depressioni causative di disagio che richiedono fondi a vario titolo economico e simili, fino alla diretta richiesta di danaro, di utilità e vantaggi di qualsiasi natura che induce all’offerta di aiuto economico spontaneo vero e proprio da parte della vittima che non riesce a vincere il senso di colpa in caso di diniego a pagare.
Nei casi più gravi, la vittima arriva anche ad indebitarsi e addirittura ad esaurire i risparmi per non deludere la falsa persona amata; non di rado si trova anche isolata per aver il truffatore escogitato anche il piano di allontanamento dagli affetti per rafforzare il suo potere facendogli perdere la lucidità e il senso di realtà.
Ma quel che stupisce maggiormente è che per la “coppia” non c’è, non ci sarà mai neanche alcun incontro personale; normalmente lontani per ragioni lavorative, truffatore e vittima fissano appuntamenti che vengono puntualmente disdettati con scuse o contrattempi di vario genere.
Raramente, infatti, si registrano casi di incontri a scopo sessuale perché il truffatore dovrebbe utilizzare all’esterno la sua falsa identità che costituisce un ulteriore tipo di reato a sé stante.
La suggestione della vittima è quindi talmente forzata da far credere che la finzione si confonda con la realtà; ecco perché occorre sempre - in ogni caso - verificare l’identità degli interlocutori virtuali e segnalare le anomalìe per la tutela di tutti.
Fingere dunque di provare sentimenti verso una persona al solo fine di trarre un ingiusto profitto è reato pieno; chi avesse voglia di approfondire il tema, può leggere la motivazione della Suprema Corte di Cassazione Penale che, con la sentenza n. 25165/2019 in materia di “truffa romantica” ha stabilito che essa
“non si apprezza per l’inganno riguardante i sentimenti dell’agente rispetto a quelli della vittima, ma perché la menzogna circa i propri sentimenti è intonata con tutta una situazione atta a far scambiare il falso con il vero operando sulla psiche del soggetto passivo“
Nota:
IL DESIDERIO, IL “SOGNO D’AMORE”, E LA TRAPPOLA DELLA “TRUFFA ROMANTICA”. *
PER CHI HA AVUTO L’OPPORTUNITA’ O IL MODO “di venire a conoscenza, se pur in modo fugace e non dettagliato, della vicenda del fantomatico Mark Caltagirone, promesso sposo virtuale della nota showgirl Pamela Prati”, CONSIGLIO UNA LETTURA ATTENTA DELL’ARTICOLO “La truffa esiste anche in danno alla vita sentimentale” (Laura Vasselli, "InLibertà", 10.06.2020), TOCCA UNA QUESTIONE FONDAMENTALE DELLA STESSA VITA DI OGNI PERSONA, NON SOLO SUL PIANO DEI RAPPORTI PRIVATI MA ANCHE DEI RAPPORTI PUBBLICI: “[...] credere che la finzione si confonda con la realtà , [...] perdere la lucidità e il senso di realtà”!
QUANTO TALE “PROBLEMA” SIA DEGNO DI ESSERE PENSATO A FONDO (E A TUTTI I LIVELLI) è chiaramente detto - come scrive l’autrice - nella motivazione della Suprema Corte di Cassazione Penale che, con la sentenza n. 25165/2019 in materia di “truffa romantica” ha stabilito che essa “non si apprezza per l’inganno riguardante i sentimenti dell’agente rispetto a quelli della vittima, ma perché la menzogna circa i propri sentimenti è intonata con tutta una situazione atta a far scambiare il falso con il vero operando sulla psiche del soggetto passivo“ (cit.).
CHE DIRE?! E’ UNA SOLLECITAZIONE A SAPERSI CONDURRE CON SENNO SIA NELLE QUESTIONI PRIVATE SIA NELLE QUESTIONI PUBBLICHE E UN INVITO A NON PERDERE IL SENSO DELLA REALTA’ (sul tema, non sembri strano né casuale, si cfr. l’articolo di Italo Mastrolia, su “#iorestoacasa, Forza Italia”). NE VA DELLA NOSTRA STESSA VITA : E’ UN PROBLEMA DI SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE, A TUTTI I LIVELLI.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- Storia di un marchio pubblico. #iorestoacasa, Forza Italia! (di Italo Mastrolia).29 maggio 2020, di Federico La Sala
#iorestoacasa, Forza Italia!
di Italo Mastrolia (Linkedin, 9 aprile 2020)
Storia di un marchio pubblico
In questi giorni di forzata permanenza in casa sto imparando a prestare attenzione alle cose; specialmente a quelle che, nella vita “ordinaria”, avrebbero meritato maggiore considerazione e tutela, ma che - nella distrazione generale - abbiamo tutti accettato e “subìto” nel tempo senza alcuna resistenza. Mi è capitato di leggere un commento su FB; si trattava di una considerazione relativa ad un programma televisivo: «Ma è proprio necessario che lo spot di Rai Sport finisca con “Forza Italia”»? L’interrogativo, che voleva essere soltanto ironico, è di un eccellente e famoso giornalista, il quale sollecitava una sorta di ’par condicio’, auspicando una analoga versione della sigla televisiva utilizzando la denominazione “Italia Viva”.
Ho ripensato a quando, in gioventù, lo slogan più diffuso (condiviso ed universale - specialmente nello sport -) era appunto “Forza Italia”: era il grido di tutti gli italiani che sostenevano le nostre squadre nelle competizioni internazionali (specialmente la nazionale di calcio); e ho pensato che, da quando è stato fondato quel partito politico che ha assunto proprio questa esatta denominazione, non abbiamo più potuto gridare o scrivere questa “esclamazione” in modo spontaneo . Ovviamente nessuno ce lo avrebbe impedito, ma ... insomma, abbiamo tutti avvertito un senso di imbarazzo (o addirittura di contrarietà); oppure - più semplicemente - abbiamo preferito non correre il rischio di essere fraintesi.
Insomma, all’improvviso quello storico ed universale slogan non è stato più utilizzato, ed è scomparso dal vocabolario della tifoseria sportivo. Nulla era più come prima.
Ho svolto una rapida ricerca: il nome si ispirava allo slogan Forza Italia! utilizzato nella campagna elettorale della Democrazia Cristiana del 1987, curata dal pubblicitario e accademico Marco Mignani. Ma il nuovo partito pensò di registrare il marchio presso l’Ufficio Marchi e Brevetti: i primi due depositi risalgono al 24 giugno 1993 - attraverso una società di Milano -; assicuravano la tutela dei marchio d’impresa per ben 13 classi di merci e servizi. Sono seguiti ulteriori 11 depositi integrativi, fino al 2008, attraverso i quali le classi merceologiche sono arrivate fino a 21.
Mi sono chiesto se la registrazione di quel marchio con l’indicazione geografica (Italia) potesse essere vietata (secondo l’art. 13 Codice Proprietà Industriale). Niente da fare; non sarebbe stato possibile impedirlo: tale divieto, infatti, non è assoluto. È consentito registrare un nome geografico che, in relazione al servizio o al prodotto, non si presenti come indicazione di provenienza, ma come nome di fantasia. Quindi, sulla base di questa disposizione normativa, “Forza Italia” (con il quale il partito non intendeva indicare la provenienza geografica dei proprio “prodotti”) venne considerato come denominazione di fantasia, e - in quanto tale - legittimo ed utilizzabile.
Però (ho obiettato) quelle due parole costituiscono uno “slogan” collettivo, un modo di dire, una locuzione condivisa da tutto il popolo... niente da fare un’altra volta: secondo la giurisprudenza dell’Unione Europea il ‘marchio-slogan’ è sempre registrabile purché abbia carattere distintivo: a prescindere dal suo significato promozionale, infatti, deve avere qualcosa che permetta al pubblico di percepirlo come indicatore dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi che lo stesso contraddistingue. In effetti, l’articolo 4 del Regolamento sul marchio UE prevede che “Possono costituire marchi UE tutti i segni, come le parole, compresi i nomi di persone o i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma dei prodotti o del loro imballaggio e i suoni”.
Quindi nulla vieta di registrare come marchio uno slogan pubblicitario.
Insomma, sembra proprio che la registrazione del marchio-slogan “Forza Italia” sia stata del tutto legittima, frutto di un’abile e geniale operazione giuridica con la quale, profittando del rigore formale della normativa vigente, si è trovato il modo (legittimo) per sottrarre alla collettività una frase appartenente a tutti, e attribuirla ad un partito politico per contraddistinguere i propri beni e servizi su cui poter ‘apporre’ il marchio (ripeto ... per ben 21 classi merceologiche!).
Però è innegabile che quelle due parole messe insieme hanno sempre costituito uno slogan collettivo, una storica esortazione popolare che - richiamando la nostra nazione - può essere ricondotta al concetto di res publica e - senza esagerare - a quello di patrimonio culturale immateriale. La questione merita un ben diverso approfondimento.
Nonostante tutto questo, è bello vedere che le persone - attraverso varie forme espressive - iniziano spontaneamente a “riappropriarsi” di quella storica esortazione sportiva; c’è un ritrovato orgoglio nazionale che, facendo vincere gli imbarazzi, mostra una tardiva reazione di sdegno a quella (seppur legittima) “sottrazione” del nostro grido più amato. A partire dal quella sigla del programma RAI, fino al web e agli striscioni sui balconi, finalmente ricompare senza imbarazzi la scritta “Forza Italia”!
A nessuno viene in mente, però, di usare la frase “Italia Viva”. In sincerità, la scelta di assegnare ad un partito questa locuzione è stata molto meno astuta e del tutto ’innocua’ per la collettività; vedremo se la registrazione di quel marchio verrà autorizzata dall’Ufficio Marchi e Brevetti (la domanda è stata depositata il 26.9.2019 ed è ancora in fase di esame).
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- TEOLOGIA, POLITICA, E COSTITUZIONE. IL "CASO CORDERO". Addio al giurista e polemista.14 maggio 2020, di Federico La Sala
IL PENSIERO DELLA COSTITUZIONE E LA COSTITUZIONE DEL PENSIERO....
Addio al giurista e polemista. Franco Cordero, il più scomodo di tutti gli eclettici
A 91 anni scomparso il giurista e polemista, capace di spaziare dal diritto al romanzo, con forte inclinazione anticlericale
di Francesco D’Agostino (Avvenire, domenica 10 maggio 2020)
Personalità fuori dal comune, quella di Franco Cordero (scomparso due giorni fa a Roma a 91 anni): uomo poliedrico, capace di spaziare con sicurezza dalla giurisprudenza alla storia, dalla filosofia alla teologia, dall’antropologia alla politica; polemista memorabile, romanziere di notevole originalità, anche se di ardua leggibilità, inventore di stilemi linguistici suggestivi. Se su queste sue doti non c’è da dubitare, su altre probabilmente è difficile che si trovi un accordo tra i suoi colleghi, i suoi studiosi ed i suoi lettori.
È stato davvero, come alcuni sostengono, uno dei massimi giuristi italiani del Novecento? Sicuramente è stato un giurista fuori dal comune, che ha nobilitato la sua disciplina (il diritto processuale penale) oltre ogni aspettativa. Ma è stato anche vittima della sua intelligenza labirintica, della sua rigidità ideologica, della sua carenza di flessibilità. Ordinario da anni nell’Università Cattolica di Milano, entrò in tensione con il paradigma culturale che la governava e di cui egli aveva perfetta consapevolezza: non ebbe il buon senso (di cui ad esempio diede prova il filosofo Emanuele Severino) di chiedere il trasferimento ad altro Ateneo, che pure avrebbe immediatamente ottenuto; privato tra mille polemiche del necessario nulla-osta all’insegnamento, attivò un duro braccio di ferro con le autorità accademiche, che volle portare fino al giudizio della Corte Costituzionale.
Era ovviamente un suo diritto ricorrere alle vie legali, ma fu molto sgradevole vedere come il suo ricorso si saldasse con un anticlericalismo sempre più aspro, polemico e in definitiva sterile, che egli cercò faticosamente di nobilitare arrivando perfino a scrivere un fitto commento all’Epistola ai Romani di San Paolo.
È difficile dire se il suo anticlericalismo giunse infine a trasformarsi in un vero e proprio anticattolicesimo; è certo però che alla fine logorò anche la pubblica opinione, al punto che, per mantenere comunque un contatto col “suo” pubblico, Cordero trovò uno sfogo cominciando a scrivere numerosi romanzi, dedicando a Savonarola una sterminata biografia, e insinuandosi abilmente nel dibattito politico del tempo (fu lui a forgiare il soprannome di “caimano” per Berlusconi , soprannome che ebbe un certo successo, anche perché ripreso da Nanni Moretti in un suo film omonimo).
Gira la notizia che una nuova e brillante casa editrice starebbe per pubblicare un suo ultimo romanzo e che sarebbe anche in progettazione una nuova edizione di un suo importante testo di molti decenni fa, Gli Osservanti, del 1967, l’opera con la quale Cordero intendeva radicare definitivamente il suo pensiero nella filosofia del diritto. Gli Osservanti è un libro, pieno di riferimenti, provocazioni, citazioni, allusioni, polemiche; un libro col quale l’Autore voleva presentare ai suoi lettori nuovi e rivoluzionari paradigmi dottrinali. Ma si trattava anche di un libro troppo difficile e troppo costoso per divenire popolare tra gli studenti sessantottini e contestatori e troppo farraginoso per conquistare la platea dei giuristi di professione. Se esso, nella sua nuova edizione, avrà successo, ne sarò lieto, perché è pieno di intelligenza. Ma non si tratta di intelligenza né giuridica, né filosofica, ma di intelligenza polemica: ammirevole, ma sterile.
- Sul tema, nel sito, si cfr.:
- L’ITALIA AD PERSONAM E IL PROF. CORDERO CHE SI LAMENTA. MA E’ ELEMENTARE (1994-2010)!!! "L’ITALIA SONO IO" E IL DIRITTO E’ "UN DIRITTO AD PERSONAM": "FORZA ITALIA" !!!
Morto Franco Cordero, il giurista che inventò il "Caimano"
Raffinato uomo di legge, anticlericale, intellettuale militante si è spento a 92 anni. Indimenticabili le sue polemiche contro Berlusconi al quale dedicò il soprannome
di ROBERTO ESPOSITO (la Repubblica, 08 maggio 2020)
Con Franco Cordero scompare una delle figure più raffinate e poliedriche della cultura italiana contemporanea. Ma anche un intellettuale militante, impegnato in battaglie civili contro il lato oscuro del potere politico ed ecclesiastico italiano. Nato a Cuneo nel 1928, ha attraversato l’ultimo secolo, lasciando una traccia indelebile non solo nel campo del diritto di cui è stato riconosciuto maestro, ma anche in quelli della riflessione filosofica, teologica, antropologica. E infine nella letteratura con una serie di romanzi - tra i quali Opus, Bellum civile, L’armatura - di lettura non semplice, ma scritti con uno stile personalissimo che gli assegna un ruolo non secondario nella letteratura degli ultimi decenni.
Allievo di Giuseppe Greco, ha insegnato in diverse Università italiane, tra cui Trieste, Torino, Roma, dove ha chiuso nel 2002 la propria brillante carriera accademica. Ma certamente l’esperienza che più lo ha segnato, diffondendo il suo nome anche all’estero, è stato l’insegnamento alla Cattolica di Milano, allora diretta da Agostino Gemelli, iniziato nel 1960. Entrato in conflitto per la sua posizione di intransigente polemica nei confronti della parte più retriva della gerarchia ecclesiastica, è stato espulso dalla Cattolica, scatenando quello che, sulle pagine dei quotidiani italiani e stranieri, ha assunto il nome di "caso Cordero". L’occasione dello scontro, non cercato ma neanche evitato da Cordero, è stata la pubblicazione del testo intitolato Gli osservanti (1967) ma soprattutto il successivo romanzo Genus che nel 1969 gli costerà l’allontanamento dalla cattedra. Accusato di eterodossia e attaccato frontalmente dalla destra cattolica, Cordero ha risposto con altrettanta nettezza, scatenando una polemica arrivata perfino alla Corte Costituzionale.
Da allora la sua persona è diventata occasione di continue controversie. Attaccato dagli ambienti confessionali, è diventato per altri una bandiera di indipendenza e di libero pensiero. I suoi scritti, alcuni memorabili, vanno dalla tecnica giuridica - il suo manuale di procedura penale, ristampato più volte, costituisce ancora riferimento essenziale per gli studi di diritto - alla filosofia, alla teologia, all’antropologia. Ciò che di essi colpisce è la straordinaria miscela di erudizione e originalità, di filologia e di spregiudicatezza ermeneutica.
Se la sua monumentale biografia di Savonarola in quattro volumi contiene ancora una miniera di informazioni per gli studiosi, il suo Commento alla Lettera ai Romani di Paolo di Tarso continua a sorprenderci per la radicalità della sua interpretazione, allo stesso tempo fedele ed estrema. Oggi, in una cultura accademica sempre più proclive a uno specialismo senza nerbo, la vastità e la poliedricità del suo sapere restano una sorta di unicum con cui è difficile stabilire confronti.
Ma questa molteplicità di interessi e di linguaggi non sfocia mai in una sorta di vacuo eclettismo, tanto meno in divulgazione. Al contrario il suo stile di scrittura, a volte denso fino all’ermetismo, costituisce per il lettore una sfida che non può lasciare indifferenti. Si può anzi dire che, nonostante l’ampiezza di orizzonti della sua cultura, tutti i suoi testi sembrano convergere verso un fuoco centrale, al contempo teoretico ed etico-politico.
La forza - nel senso pieno del termine - di Cordero stava nel rifiutare ogni compromesso, ogni risposta troppo facile a questioni complesse, come quella del rapporto tra sacro e profano, teologia e politica, eternità e tempo. Tra di essi, per Cordero, non c’è possibilità di sintesi dialettica. Ma continua tensione tra poli irriducibili, necessari l’uno ad illuminare l’altro non per analogia, ma per contrasto. Egli c’insegna che le grandi contraddizioni, nella vita e nel pensiero, non hanno mai soluzioni facili.
Il suo - potremmo dire - è un pensiero teologico-politico consapevole del rischio di ogni sovrapposizione tra teologia e politica. Come è impossibile fondare razionalmente il sacro, così va evitato ogni sacralizzazione del potere. Che anzi è ciò che Cordero ha combattuto per tutta la vita.
Alla fine dell’insegnamento universitario Cordero ha potenziato il proprio impegno politico attraverso una serie di interventi, articoli, polemiche rimaste insuperate per la loro radicalità e anche fantasia semantica. Come dimenticare le vere e proprie invenzioni lessicali, come quelle indirizzate contro Berlusconi, identificato ora con il "Caimano", ora con un Mackie Messer contemporaneo? Le sue polemiche nei confronti del collasso della cultura politica italiana dei due ultimi decenni hanno avuto un tono aspro e duro, come era il suo carattere.
Oggi forse non sono più di moda. Ma basta rileggere alcuni suoi titoli - da Nere lune d’Italia a Morbo italico - per accorgersi che quei libri parlano ancora di noi. La sua etica, lucida e disperata, è una luce della quale c’è ancora bisogno. Il suo discorso, leopardiano, sopra lo stato presente dei costumi italiani non ha smesso di interpellarci. Esso attende ancora una risposta e una promessa di riscatto all’altezza delle sue domande
Sul tema, nel sito, si cfr.:
KANT E SAN PAOLO. COME IL BUON GIUDIZIO ("SECUNDA PETRI") VIENE (E VENNE) RIDOTTO IN STATO DI MINORITA’ DAL GIUDIZIO FALSO E BUGIARDO ("SECUNDA PAULI")
KANT E GRAMSCI. PER LA CRITICA DELL’IDEOLOGIA DELL’UOMO SUPREMO E DEL SUPERUOMO D’APPENDICE.
MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI ?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA E A PENSARE BENE "DIO", "IO" E "L’ITALIA", CHI PIÙ CHI MENO, TUTTI VIVONO DENTRO LA PIÙ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA E POLITICA ITALIANA, NEL REGNO DI "FORZA ITALIA" !!!
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- TEOLOGIA E ANTROPOLOGIA: CONCILIO DI NICEA (325), FILIAZIONE DIVINA, E MEMORIA DEL VESCOVO ATANASIO.2 maggio 2020, di Federico La Sala
CONCILIO DI NICEA I e il CONCILIO DI NICEA - 2025. Materiali sul tema:
2 MAGGIO 2020. Il santo del giorno
Atanasio. Discepolo di sant’Antonio, difensore dell’ortodossia
di Matteo Liut (Avvenire, giovedì 2 maggio 2019)
Sant’Atanasio fu come un ponte per la Chiesa antica: sulle spalle, infatti, portò il “peso” della retta dottrina, dell’ortodossia, traghettandola attraverso un periodo difficile, nel quale sembrava che l’eresia dovesse trionfare.
Era nato ad Alessandria nel 295 e nel 325 era al Concilio di Nicea come diacono del vescovo Alessandro. Lì si stabilì che il Figlio era della stessa sostanza del Padre, Cristo non era “come” Dio, ma era Dio.
Una verità che gli ariani tentavano di negare, mettendo in campo una lotta aspra, spesso fatta di calunnie e strategie politiche.
Nel 328 la gente volle Atanasio come nuovo vescovo di Alessandria e lui, nei suoi 46 anni di episcopato, si dimostrò un saldo difensore della verità. Ma dovette subire attacchi personali e anche esili prima di essere riabilitato. Ebbe come maestro sant’Antonio abate di cui scrisse una Vita. Morì nel 373.
Altri santi. San Felice di Siviglia, martire (IV sec.); sant’Antonino Pierozzi (di Firenze), vescovo (1389-1459).
Letture. At 5,27-33; Sal 33; Gv 3,31-36.
Ambrosiano. At 4,32-37; Sal 92; Gv 3,7b-15.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- COSTANTINO, SANT’ELENA, E NAPOLEONE. L’immaginario del cattolicesimo romano.
- LA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO DEI "DUE SOLI". Con la morte di Giovanni Paolo II, il Libro è stato chiuso. Si ri-apre la DIVINA COMMEDIA, finalmente !!!
- IL PROBLEMA GIAMBATTISTA VICO E IL PROBLEMA DELLA COSTITUZIONE. CROCE “CRISTIANO” , VICO “ATEO”, E L’UOMO DELLA PROVVIDENZA.
- FILIAZIONE DIVINA E "PRATICA DELLA SCIENZA NUOVA". VICO: "LA MENTE EROICA". Il testo dell’orazione inaugurale del 1732
- DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE.
- GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- EPIDEMIA, POLITICA, E TEOLOGIA: IL PROBLEMA JEAN-JACQUES ROUSSEAU E L’ILLUMINISMO, OGGI. LIBERARE IL CIELO.22 aprile 2020, di Federico La Sala
EPIDEMIA, POLITICA, E TEOLOGIA: IL PROBLEMA JEAN-JACQUES ROUSSEAU E L’ILLUMINISMO, OGGI. LIBERARE IL CIELO...
-
GOVERNO POLITICO ED EPIDEMIA: "[...] In una versione più accettabile e aggiornata della sovranità, come quella fornitaci da Jean-Jacques Rousseau, possiamo quindi dire che sovrano è sempre e solo il popolo; ma allo stesso tempo la volontà sovrana del popolo può venire ad esistenza solo nelle vesti di una volontà altra, quella dei governanti che si troveranno di volta in volta a fare esercizio del potere politico legittimo. Ciò che noi chiamiamo “democrazia”, e che senza indugio parafrasiamo come “potere del popolo”, si basa esattamente su questo semplice meccanismo: la posizione della pura immanenza (la volontà generale dei governati) richiede la posizione della pura trascendenza (una volontà particolare che, per dichiarare sovrani coloro che le obbediscono, deve mettere in forma questa loro generalità).
.Perché questo breve passaggio attraverso i classici del pensiero politico moderno? [...] è necessario articolare un campo tanto del sapere quanto delle istituzioni che sia capace di comprendere questo altro che per il momento resta “impossibile” o quantomeno “impensabile”. [...] La sfida, che gli antichi sono riusciti a modo loro a fare propria e che la modernità ha invece rifiutato, è quella di pensare l’unità di due momenti che, come abbiamo visto, il pensiero della democrazia non riesce a tenere fermi perché ci rimbalza all’infinito dall’uno all’altro [....]
 Questo significa anche che il problema della giustizia richiede non che sia data una risposta definitiva, valida per sempre, ma che sussista uno spazio “costituzionale” nel quale si dispieghi un processo di continua mediazione tra la pluralità sempre destabilizzante delle idee sul giusto e l’unità necessaria affinché la società nel suo complesso possa darsi un orientamento comune.
Questo significa anche che il problema della giustizia richiede non che sia data una risposta definitiva, valida per sempre, ma che sussista uno spazio “costituzionale” nel quale si dispieghi un processo di continua mediazione tra la pluralità sempre destabilizzante delle idee sul giusto e l’unità necessaria affinché la società nel suo complesso possa darsi un orientamento comune.
 Mediazione dunque tra la differenza e l’identità, senza cedere a quel gioco di specchi nel quale l’assolutizzazione di una pura differenza (la moltitudine degli individui privi di relazione) si ribalta immediatamente nell’assoluta indifferenza dell’Uno identico a sé (la legge incondizionata di un soggetto assoluto, sia esso Dio, il popolo o perfino un virus). È proprio questo spazio che il pensiero moderno della sovranità e della democrazia ha chiuso, perché assolutizzando la volontà dei cittadini come fondamento esclusivo della legge ha paradossalmente assolutizzato, di contro, l’arbitrio del tutto soggettivo del governante legittimo " (Pierpaolo Cesaroni e Lorenzo Rustighi, "Sul governo politico: riflessioni a partire dall’epidemia", Le parole e le cose, 22.04.2020).
Mediazione dunque tra la differenza e l’identità, senza cedere a quel gioco di specchi nel quale l’assolutizzazione di una pura differenza (la moltitudine degli individui privi di relazione) si ribalta immediatamente nell’assoluta indifferenza dell’Uno identico a sé (la legge incondizionata di un soggetto assoluto, sia esso Dio, il popolo o perfino un virus). È proprio questo spazio che il pensiero moderno della sovranità e della democrazia ha chiuso, perché assolutizzando la volontà dei cittadini come fondamento esclusivo della legge ha paradossalmente assolutizzato, di contro, l’arbitrio del tutto soggettivo del governante legittimo " (Pierpaolo Cesaroni e Lorenzo Rustighi, "Sul governo politico: riflessioni a partire dall’epidemia", Le parole e le cose, 22.04.2020).
L’ILLUMINISMO, OGGI. LIBERARE IL CIELO: "[...] Rousseau cerca in tutti i modi di impostare bene il "trattato le cui condizioni siano eque" (Virgilio, Eneide, XI), ma perde il filo e, alla fine, si ritrova a riproporre la religione dei romani - la "religione civile", contro la "religione romana", cattolica ! Senza volerlo, prepara la strada "cattolico-romana" a Fichte, a Hegel, a Marx, a Gentile e a Lenin.
Kant reimposta il problema e riparte, bene : "tutto proviene dall’esperienza, ma non tutto si risolve nell’esperienza" o, diversamente, tutto viene dalla natura ma non tutto si risolve nella natura ; alla fine egli non riesce a sciogliere il nodo e resta in trappola. Al di là del mare di nebbia non può andare e - per non distruggere i risultati della sua esplorazione - si accampa lì dove è riuscito ad arrivare e decide: Io voglio che Dio esista.
Per Kant, Rousseau e Newton, come Locke, non sono stati affatto cattive guide per il suo viaggio. Il suo cammino è stato lungo, fruttuoso e coraggioso : la Legge morale dentro di me, il Cielo stellato sopra di me ! E, onestamente, rilancia di nuovo la domanda antropologica, quella fondamentale: "Che cosa è l’uomo?". Teniamone conto.
Ciò che essi cercavano di capire e quindi di sciogliere era proprio il nodo che lega il problema "religioso", il legame "sociale", il problema di "Dio", il problema della Legge, non quello o quella dei Faraoni e quella di una Terra concepita come un "campo recintato" o assoggettata alla "Moira" di Orfeo e alla Necessità.
Filosoficamente, è il problema dell’inizio ... e, con esso, dell’origine e dei fondamenti della disuguaglianza tra gli esseri umani. Il problema J.J. Rousseau, dunque: No King, no Bishop! Il problema della Legge - e della Lingua: il problema stesso del principio di ogni parola, la Langue, Essai sur l’origine des langues! Da dove il Logos e la Legge?! E, con queste domande, siamo già all’oggi, agli inizi del ’900 : Ferdinand de Saussure ! Ma ritorniamo al problema politico, della Legge della Polis o, come scrive Rousseau, della Citè. La questione è decisiva ed epocale: ed è al contempo questione antropologica, politica, e "teologica". In generale è la questione del rapporto Uno-Molti - una questione lasciata in eredità da Platone, e riproposta da Rousseau, nei termini del rapporto volontà generale - volontà di tutti o del cosiddetto "uno frazionario", e risolta ancor oggi nell’orizzonte moderno (cartesiano) - dopo Cristo, come dopo Dante, Rousseau e Kant - in modo greco, platonico-aristotelico. Una tragedia, e non solo quella di Nietzsche. In tutti i sensi.
Se continuiamo a truccare le carte e confondiamo l’Uno al numeratore con un "uno" degli "uno" o delle "uno" al denominatore finiremo per cadere sempre nella trappola della dittatura, e nel dominio del "grande fratello". E non riusciremo mai a distinguere tra "Dio" Amore [Charitas], e "Dio" Mammona [Caritas] - tra la "volontà generale" dell’Uno e la "volontà generale" di "uno", camuffato da "Uno". Liberare il cielo, pensare l’ "edipo completo" - come da progetto di Freud.
Vedere solo i molti (gli individui, meglio gli uomini e donne in carne ed ossa, le persone) che agiscono, discutono e lottano, e non vedere l’Uno, che è il Rapporto e il Fondamento di tutti e il Rapporto dell’Uno stesso con tutti i vari sotto-rapporti (economici, politici, religiosi, giuridici, pedagogici, familiari, e, persino, di amicizia) dei molti e tra i molti ... non porta da nessuna parte, se non alla guerra e alla morte. In tale orizzonte (relativistico, scettico e nichilistico), chi vuole guidare chi, che cosa può fare, che cosa può insegnare, che cosa può produrre ... se non il suo stesso "uno" - allo specchio ? Un narcisismo personale e istituzionale, imperialistico e ... desertificante !
È elementare, ma è così - come scriveva l’oscuro di Efeso, Eraclito : "bisogna seguire ciò che è comune : e ciò che è comune è il Logos" - la Costituzione, prima di ogni calcolo, per ragionare bene. La Costituzione è il fondamento, il principio, e la bilancia!!! Questo è il problema : la cima dell’iceberg davanti ai nostri occhi, e il punto più profondo sotto i nostri stessi piedi !!! E se non vogliamo permanere nella "preistoria" e, anzi, vogliamo uscirne, dobbiamo stare attenti e attente e ripensare tutto da capo, dalla radice (Kant, Marx), dalle radici: gli uomini e le donne, i molti, e il Rapporto-Fondamento che li collega e li porta - al di là della natura - nella società, e li fa essere ed esseri umani - dopo il lavoro in generale, il rapporto sociale di produzione in generale è la questione all’ordine del giorno nostro, oggi. [....]" . (Cfr.L’ILLUMINISMO, OGGI. LIBERARE IL CIELO. Cristianesimo, democrazia e necessità di "una seconda rivoluzione copernicana").
-
GOVERNO POLITICO ED EPIDEMIA: "[...] In una versione più accettabile e aggiornata della sovranità, come quella fornitaci da Jean-Jacques Rousseau, possiamo quindi dire che sovrano è sempre e solo il popolo; ma allo stesso tempo la volontà sovrana del popolo può venire ad esistenza solo nelle vesti di una volontà altra, quella dei governanti che si troveranno di volta in volta a fare esercizio del potere politico legittimo. Ciò che noi chiamiamo “democrazia”, e che senza indugio parafrasiamo come “potere del popolo”, si basa esattamente su questo semplice meccanismo: la posizione della pura immanenza (la volontà generale dei governati) richiede la posizione della pura trascendenza (una volontà particolare che, per dichiarare sovrani coloro che le obbediscono, deve mettere in forma questa loro generalità).
.Perché questo breve passaggio attraverso i classici del pensiero politico moderno? [...] è necessario articolare un campo tanto del sapere quanto delle istituzioni che sia capace di comprendere questo altro che per il momento resta “impossibile” o quantomeno “impensabile”. [...] La sfida, che gli antichi sono riusciti a modo loro a fare propria e che la modernità ha invece rifiutato, è quella di pensare l’unità di due momenti che, come abbiamo visto, il pensiero della democrazia non riesce a tenere fermi perché ci rimbalza all’infinito dall’uno all’altro [....]
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- UN’IMPRESA PRODUTTIVA NAZIONALE E L’SCRIZIONE DEL MARCHIO NEL REGISTRO DEI MARCHI STORICI (DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34). .21 aprile 2020, di Federico La Sala
DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34 :
Capo III
Tutela del made in Italy
Art. 31
Marchi storici
1. Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) dopo l’articolo 11-bis e’ inserito il seguente: «Art. 11-ter (Marchio storico di interesse nazionale). - 1. I titolari o licenziatari esclusivi di marchi d’impresa registrati da almeno cinquanta anni o per i quali sia possibile dimostrare l’uso continuativo da almeno cinquanta anni, utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un’impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale, possono ottenere l’iscrizione del marchio nel registro dei marchi storici di interesse nazionale di cui all’articolo 185-bis.
- 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e’ istituito
il logo «Marchio storico di interesse nazionale» che le imprese
iscritte nel registro di cui all’articolo 185-bis, possono utilizzare
per le finalita’ commerciali e promozionali. Con il decreto di cui al
primo periodo sono altresi’ specificati i criteri per l’utilizzo del
logo «Marchio storico di interesse nazionale».»;
 b) dopo l’articolo 185 sono inseriti i seguenti: «Art. 185-bis
(Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale). - 1.
E’ istituito, presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi, il
registro speciale dei marchi storici come definiti dall’articolo
11-ter.
b) dopo l’articolo 185 sono inseriti i seguenti: «Art. 185-bis
(Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale). - 1.
E’ istituito, presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi, il
registro speciale dei marchi storici come definiti dall’articolo
11-ter. - 2. L’iscrizione al registro speciale dei marchi storici e’
effettuata su istanza del titolare o del licenziatario esclusivo del
marchio.
 Art. 185-ter (Valorizzazione dei marchi storici nelle crisi
d’impresa). - 1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e
la prosecuzione dell’attivita’ produttiva sul territorio nazionale,
e’ istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo
per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale. Il predetto
Fondo opera mediante interventi nel capitale di rischio delle imprese
di cui al comma 2. Tali interventi sono effettuati a condizioni di
mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della
commissione recante gli «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati
a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio
(2014/C 19/04). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono stabilite le modalita’ e i criteri di gestione e
di funzionamento del Fondo di cui al primo periodo.
Art. 185-ter (Valorizzazione dei marchi storici nelle crisi
d’impresa). - 1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e
la prosecuzione dell’attivita’ produttiva sul territorio nazionale,
e’ istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo
per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale. Il predetto
Fondo opera mediante interventi nel capitale di rischio delle imprese
di cui al comma 2. Tali interventi sono effettuati a condizioni di
mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della
commissione recante gli «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati
a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio
(2014/C 19/04). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono stabilite le modalita’ e i criteri di gestione e
di funzionamento del Fondo di cui al primo periodo. - 2. L’impresa titolare o licenziataria di un marchio iscritto nel
registro speciale di cui all’articolo 185-bis che intenda chiudere il
sito produttivo di origine o comunque quello principale, per
cessazione dell’attivita’ svolta o per delocalizzazione della stessa
al di fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento
collettivo, notifica senza ritardo al Ministero dello sviluppo
economico le informazioni relative al progetto di chiusura o
delocalizzazione dello stabilimento e, in particolare [...]
 (DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34 -
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 29/06/2019, n. 151).
(DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34 -
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 29/06/2019, n. 151).
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- Si racconta che uno storico tedesco abbia addotto duecentodieci motivi per spiegare il crollo dell’impero romano. Molto più parco è lo storico statunitense Kyle Harper (di Gabriele Nicolò).16 aprile 2020, di Federico La Sala
L’impero romano tra cambiamenti climatici e pestilenze
In un libro dello storico statunitense Kyle Harper
di Gabriele Nicolò (L’Osservatore Romano, 15 aprile 2020)
Si racconta che uno storico tedesco abbia addotto duecentodieci motivi per spiegare il crollo dell’impero romano. Molto più parco è lo storico statunitense Kyle Harper che nel libro Il destino di Roma. Clima, epidemie e la fine di un impero (Torino, Einaudi, 2019, pagine 520, euro 34) di cause - a parte quelle “istituzionali” legate sia alle farraginose dinamiche della ormai fatiscente struttura governativa che al logorio dell’esercito e delle forze di combattimento in generale - ne individua due: i cambiamenti climatici e le pestilenze. Vale a dire, due cause che rivestono, evidentemente, un valore di attualità sorprendente e disarmante.
È vero che Giulio Cesare si vantava che i suoi soldati erano così vigorosi nel fisico che potevano resistere sia ai rigori dell’inverno che ai torridi raggi del sole d’estate, ma è altrettanto vero - rileva lo storico statunitense in un’intervista al settimanale francese «Nouvelle Observateur» - che i bruschi cambiamenti del clima, attestati tra l’altro da numerosi documenti d’epoca, con graduale e non arginata pressione finirono per incidere profondamente sulla popolazione dell’impero, e in particolare sulla psiche dei soldati, resi più vulnerabili dalle continue privazioni, inevitabile prezzo da pagare in una vita spesa sui campi di battaglia. E a dare il colpo di grazia al già fatiscente impero - sottolinea Harper - furono le pestilenze, la cui propagazione fu alimentata dalla vertiginosa crescita del numero della popolazione, non solo a Roma, ma anche nelle zone limitrofe, ovvero nelle campagne che, col declinare dell’impero, non vennero più adeguatamente bonificate come invece accadeva nei giorni di gloria.
In particolare - sostiene lo storico - a sbaragliare ogni forma di resistenza fu lo Yersinia pestis, che corrisponde alla moderna accezione di peste bubbonica. Un inquietante intreccio di morbi e di germi invase vaste regioni dell’impero mietendo, senza pietà, lutti e devastazione. I romani - ricorda Kyle Harper - avevano saputo come sconfiggere i nemici, anche perché aveva saputo imparare dalle lezioni derivanti dalle sconfitte subite. Ma non avevano le conoscenze e i mezzi adeguati per fronteggiare le ricorrenti pestilenze che certo potevano “approfittare”, per attecchire e poi infuriare, anche della mancanza di social distancing, misura certo non praticabile visto che i romani solevano vivere in ambienti molto ristretti e in accampamenti sovraffollati.
NOTA:
L’Impero romano e la ragione nascosta della sua caduta: una questione "filologica", epocale! L’ "In principio era il logos" (e sulla testa di tutti e di tutte, c’era la corona-virtus) diventa piano-piano l’ "In principio era il Logo" (e sul capo c’era il coronavirus)!!!
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- PANDEMIA E SOCIOLOGIA. KANT, SIMMEL, E LA RIMOZIONE DELL’OMBELICO.15 aprile 2020, di Federico La Sala
L’ADDIO A KANT, LA RIMOZIONE DELL’OMBELICO, E LA "FILOSOFIA" DEL "DOLORE DEGLI ALTRI" ... *
- "In diversi luoghi della sua immane produzione, Shakespeare fa pronunciare ai suoi celebri personaggi parole scettiche nei confronti della filosofia [...] non respingeva la filosofia in generale, ma quella cattiva, che - mi si perdoni l’espressione triviale - contempla il proprio ombelico, invece di proiettare chiarezza sul cielo e sulla terra, sulle passioni, sul destino e sul potere [...] Georg Simmel ha notato una volta quanto poco del dolore degli uomini sia entrato nella loro filosofia. " (Alessandro Dal Lago, "La filosofia e il dolore degli altri", 10.04.2020).
Pandemia
La filosofia e il dolore degli altri
di Alessandro Dal Lago ("Aut Aut", 10 aprile 2020)
In diversi luoghi della sua immane produzione, Shakespeare fa pronunciare ai suoi celebri personaggi parole scettiche nei confronti della filosofia: così Amleto (“Ci sono più cose in cielo e in terra, Orazio, di quante ne immagini la tua filosofia”) e Romeo (“Alla forca la filosofia! Se non può darmi Giulietta, farmi prendere una città, annullare la sentenza di un principe, non mi serve e non conta”). È quasi superfluo aggiungere che il più filosofico dei drammaturghi di ogni tempo (in buona compagnia con Dante, Calderón de la Barca ecc.) non respingeva la filosofia in generale, ma quella cattiva, che - mi si perdoni l’espressione triviale - contempla il proprio ombelico, invece di proiettare chiarezza sul cielo e sulla terra, sulle passioni, sul destino e sul potere.
Tutto ciò mi è venuto in mente scorrendo una raccolta online di riflessioni “filosofiche” di alcuni pensatori contemporanei sulla pandemia del Covid-19: La sopa de Wuhan. Piensamiento contemporáneo en tiempos de pandemias (“La zuppa di Wuhan ecc.”).[1] Si tratta di un’operazione furbetta grazie a cui sono tradotti in castigliano e proposti un po’ alla rinfusa autori notissimi o alla moda (Žižek, Agamben, Nancy, Butler, Harvey, Badiou, Preciado) e altri di lingua spagnola e meno noti da noi, ma che il curatore, un certo Pablo Amadeo, ha ritenuto utili alla comprensione dell’impatto globale del virus sul nostro mondo. Complessivamente, ne ho tratto un’impressione desolante. Va bene che si tratta di interventi per lo più ad hoc, occasionali e sbrigativi, pubblicati tra fine febbraio e fine marzo 2020. È vero che qua e là si trovano anche idee interessanti. Ma se questo è il livello della filosofia contemporanea, non possiamo che essere d’accordo con lo sfortunato Romeo.
A parte gli interventi di Agamben, discutibili quanto si vuole, ma almeno coerenti, il brevissimo testo di Nancy, una garbata e non troppo amichevole risposta all’“amico” Giorgio Agamben, e i testi di Judith Butler e David Harvey, che dicono cose sensate, anche se condizionate dalla campagna per le presidenziali Usa, quasi tutti gli altri si segnalano per banalità o stramberie. Il platonico Badiou vuole una politica che si affidi ai sapienti, come se già i politici non si facessero guidare dalle molteplici e rissose tribù scientifiche. López Petit vede in corso una guerra tra la vita oscura (forse le moltitudini?) e quella algoritmica imposta dal Capitale. Altri, a onta della globalità del virus da tutti proclamata, non vanno al di là dell’orticello di casa propria, come via Mascarella per il bolognese Franco Berardi detto Bifo.
 Quanto a Markus Gabriel, seguace germanico del “nuovo realismo”, ha in mente una soluzione “realistica”, che illustro con le sue parole:
Quanto a Markus Gabriel, seguace germanico del “nuovo realismo”, ha in mente una soluzione “realistica”, che illustro con le sue parole:- Viviamo e continueremo a vivere sulla terra: siamo e continueremo a essere mortali e fragili. Convertiamoci pertanto in cittadini del mondo, in cosmopoliti di una pandemia metafisica. Qualsiasi altro atteggiamento ci sterminerà e nessun virologo ci potrà salvare.
Anche Paul B. Preciado, dopo considerazioni condivisibili sul confinamento, la paura e così via, si tuffa nell’irrealtà, proponendo che anche noi, come il maledetto virus, accettiamo di mutare (benché nei due casi il mutamento non sia proprio lo stesso).
- [...] mantenerci vivi come pianeta, davanti al virus, ma anche davanti a quello che potrà succedere, significa avviare forme strutturali di cooperazione planetaria. Come il virus muta, così, se vogliamo sottrarci alla sottomissione, dobbiamo mutare anche noi.
Come cosmopolitismo e/o cooperazione strutturale planetaria siano possibili in un mondo che sembra andare trionfalmente in direzione contraria (Trump, Bolsonaro, Orbán, neo-nazionalismi, dissoluzione potenziale di aggregazione di stati come l’Ue, emergere di nuovi poteri a dir poco voraci, per esempio la Cina) non ci viene spiegato. Ma, si sa, questo è compito di ontologie regionali come l’analisi politica o le relazioni internazionali. Quando invece qualcuno si spinge verso una valutazione empirica del presente conquista di colpo la palma dell’insensatezza. Come il leninista lacaniano Slavoj Žižek che vede “il comunismo germogliare dal virus” e assegna a Trump il merito di aver compreso che nell’epoca del Covid-19 è necessario un reddito minimo di base. Farei leggere a chiunque il testo del geniale psicoanalista-filosofo-tuttologo sloveno per illustrare il famoso motto di Wittgenstein “Ciò di cui non si può parlare si deve [o dovrebbe] tacere”.
***
La mia impressione desolante nasce soprattutto da quello di cui nessuno parla nella Sopa de Wuhan, e che invece mi sembra decisivo in una riflessione sulla pandemia: la sofferenza, il dolore delle decine migliaia di morti, dei loro parenti e dei loro amici, la solitudine di esseri, soprattutto anziani, che lasciano la vita intubati e con la testa chiusa in uno scafandro da cui hanno potuto inalare un po’ di ossigeno prima della fine.
 Qui non vale l’obiezione, che ho pescato in un testo del libro in questione, secondo la quale noi ci commuoviamo solo per le vittime di questa pandemia “dei ricchi”, che ha colpito cioè solo i paesi sviluppati. A parte il fatto che ne sono vittime anche i poveri, solo Dio sa se e quando la pandemia colpirà l’Africa, in cui si concentra gran parte della povertà del pianeta. Il fatto è, comunque, che il pensiero occidentale sembra per lo più incapace di comprendere la povertà, la desolazione, il dolore in cui vive una quota rilevante di umanità - come chiamarla: i nostri simili, i nostri fratelli, il Mitmensch globale?
Qui non vale l’obiezione, che ho pescato in un testo del libro in questione, secondo la quale noi ci commuoviamo solo per le vittime di questa pandemia “dei ricchi”, che ha colpito cioè solo i paesi sviluppati. A parte il fatto che ne sono vittime anche i poveri, solo Dio sa se e quando la pandemia colpirà l’Africa, in cui si concentra gran parte della povertà del pianeta. Il fatto è, comunque, che il pensiero occidentale sembra per lo più incapace di comprendere la povertà, la desolazione, il dolore in cui vive una quota rilevante di umanità - come chiamarla: i nostri simili, i nostri fratelli, il Mitmensch globale?
 E non parlo di empatia, perché dubito che noi umani siamo capaci di provare vera empatia per chi non ricade sotto il nostro sguardo miope. Parlo di comprensione, di vicinanza concettuale, di condivisione se non altro teoretica di un destino comune. Altro che cooperazione strutturale planetaria. Un po’ di compassione, avrebbero detto Karl Kraus e Rosa Luxemburg. Esempio di questa incapacità è un libretto[2] in cui il già citato Žižek, turbato dall’erompere di nazionalismi e sciovinismi, propone di militarizzare i migranti, non si capisce se rinchiudendoli in qualche neo-lager oppure gettandoli a mare (nella versione Salvini) o chiudendo i porti e lasciandoli alla deriva per il loro bene (versione del governo in carica mentre scrivo).[3]
E non parlo di empatia, perché dubito che noi umani siamo capaci di provare vera empatia per chi non ricade sotto il nostro sguardo miope. Parlo di comprensione, di vicinanza concettuale, di condivisione se non altro teoretica di un destino comune. Altro che cooperazione strutturale planetaria. Un po’ di compassione, avrebbero detto Karl Kraus e Rosa Luxemburg. Esempio di questa incapacità è un libretto[2] in cui il già citato Žižek, turbato dall’erompere di nazionalismi e sciovinismi, propone di militarizzare i migranti, non si capisce se rinchiudendoli in qualche neo-lager oppure gettandoli a mare (nella versione Salvini) o chiudendo i porti e lasciandoli alla deriva per il loro bene (versione del governo in carica mentre scrivo).[3]Georg Simmel ha notato una volta quanto poco del dolore degli uomini sia entrato nella loro filosofia. Il libretto da cui ho preso le mosse è una dimostrazione evidente del suo acume. In questi giorni, tante voci si levano per denunciare le misure profilattiche che ci costringono a qualcosa di simile agli arresti domiciliari (nel nostro caso di occidentali, abbastanza confortevoli). Ho letto invece pochi interventi filosofici originali, a più di 35 anni dalla morte di Foucault, sugli effetti della pandemia e delle restrizioni della libertà sui marginali, i deboli, i carcerati, gli invisibili, i vecchi abbandonati, gli homeless e tutte le minoranze che il virus e la prossima crisi economica trasformeranno probabilmente in maggioranze.
(10 aprile 2020)
[1] ^ Si può scaricare il testo all’indirizzo https://www.elextremosur.com/nota/23685-sopa-de-wuhan-el-libro-completo-y-gratis-para-leer-sobre-el-coronavirus.
[2] ^ S. Žižek, La nuova lotta di classe, Ponte alle Grazie, Firenze 2016. Leggere per credere.
[3] ^ Mi riferisco a un decreto dell’inizio di aprile del 2020 con cui il governo italiano, con il placido assenso di quasi tutte le forze politiche, chiude i porti alle navi delle Ong e alle navi da crociera.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- IL PROGRAMMA DI KANT. DIFFERENZA SESSUALE E BISESSUALITA’ PSICHICA: UN NUOVO SOGGETTO, E LA NECESSITA’ DI "UNA SECONDA RIVOLUZIONE COPERNICANA".
"NUOVO REALISMO", IN FILOSOFIA. DATO L’ADDIO A KANT, MAURIZIO FERRARIS SI PROPONE COME IL SUPERFILOSOFO DELLA CONOSCENZA (QUELLA SENZA PIU’ FACOLTA’ DI GIUDIZIO).
GUARDIAMO IL NOSTRO OMBELICO: DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"!
NUOVO REALISMO E "GAIA SCIENZA": CONOSCERE SE STESSI E CHIARIRSI LE IDEE, PER CARITÀ!
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- COSTITUZIONE, RELAZIONE DI REALTA’, ED EUROPA: "JAMES BOND" (di Norma Rangeri).12 aprile 2020, di Federico La Sala
Editoriale
Le menzogne, il censore e il premier
James Bond. Conte aveva, e ha, tutto il diritto di replicare alle falsità che inondano i media ad ogni ora del giorno. In particolare le ultime, proprio sul Mes, al centro del confronto-scontro in sede europea e in Italia
di Norma Rangeri (il manifesto, 12.04.2020).
Qualche domanda: quante volte il premier Conte è stato attaccato in diretta tv, e sul circuito mediatico delle opposizioni, sul piano personale? E senza alcun contraddittorio? La leader che guida Fratelli d’Italia non ha forse accusato Conte di essere addirittura un “criminale”, con nessun conduttore o direttore di tg che replicasse “no, questo non si può dire in diretta tv”?
Quando mai Mentana si è indignato per le parole pesanti indirizzate al premier? E non è da censori affermare - come lui ha detto - che non avrebbe mandato in onda le accuse di Conte a Salvini e Meloni se avesse saputo?
Nemmeno gli fosse arrivata una cassetta registrata di Berlusconi come ai vecchi tempi, quando l’appello al popolo, via Vhs, veniva trasmesso da Arcore ai prediletti tg di famiglia e naturalmente a quelli della Rai plaudente. La famosa Rainvest a reti unificate.
Conte aveva, e ha, tutto il diritto di replicare alle falsità che inondano i media ad ogni ora del giorno. In particolare le ultime, proprio sul Mes, al centro del confronto-scontro in sede europea e in Italia. Il diritto e il dovere di rispondere alle sonore bugie che abbeverano l’opinione pubblica grazie a una informazione molto lacunosa, se non subalterna e connivente. Il dovere di ricordare che il Mes non lo riguarda.
E infatti la Ue ha fatto presente erga omnes che l’accordo sul salva-stati passò nel 2011 durante il governo Berlusconi IV, con Meloni giovane ministra. La stessa persona che oggi vuol giocare il ruolo della vittima insieme a Salvini, proprio lui che ha usato e abusato del ruolo istituzionale di ministro dell’interno e che ora, senza pudore, si appella addirittura al Capo dello Stato, dopo aver inondato di fango e fake news Conte e il suo governo.
Le opposizioni d’altronde, giocano le loro carte. Noi che conosciamo bene il ruolo dell’opposizione, e lo teniamo in gran conto, non abbiamo mai usato le menzogne, gli insulti personali. Le destre di oggi ne fanno invece pratica quotidiana. E alla disperata, perché sanno di essere ininfluenti in questa crisi.
E alla disperata, perché sanno di essere ininfluenti in questa crisi. Oltretutto quello che sta emergendo nelle Regioni sotto la loro guida conferma responsabilità e colpevoli incapacità nell’emergenza della lotta alla pandemia.
Alzano il tiro perché ogni giorno che passa si solleva il velo su una condotta al centro di accertamenti giudiziari. Il direttore del Pio Albergo Trivulzio, indagato per epidemia e omicidio colposo, dipende dal governo di destra lombardo. E gettare la palla fuori campo serve a distrarre gli italiani dalla tragedia che stanno vivendo migliaia di famiglie per aver perso i loro cari a causa di scelte sanitarie molto pericolose per la vita dei malati.
Al contrario, chi appoggia direttamente o indirettamente questo governo, dovrebbe apprezzare un presidente del Consiglio che parla in modo chiaro, diretto, che non nasconde la realtà ai cittadini, che non si piega alle pressioni confindustriali, che non fa da sponda alle forze politiche che lo sostengono, che soprattutto non propala bufale. Forse avrebbe dovuto ricostruire meglio il caso Mes, perché non tutti sanno, anzi, ma una risposta agli italiani era necessaria.
La critica che invece va mossa riguarda proprio la coalizione di governo. Perché appare chiaro che la tragicità della situazione che attraversa ogni cellula della vita sociale, non può essere cancellata da un “vogliamoci bene”, che continua a nascondere la polvere sotto il tappeto. Tra Pd e M5S riaffiorano rivalità, visioni diverse, contrapposizioni capaci di minare il fragile terreno sul quale poggia la coalizione.
Rivedendo Conte in tv emergeva un certo nervosismo, solo in parte dovuto allo stress del momento. Nato contro i pieni poteri reclamati dalle destre, costruito in difesa di un clima democratico messo in crisi dall’odio, dal razzismo, dalla xenofobia, sempre di più questa maggioranza deve dimostrare di essere all’altezza di una proposta politica in grado di avviare la ricostruzione del paese, sgovernato da un sistema che ne ha fatto il regno europeo delle diseguaglianze.
Perché quel cambiamento verso uno stato sociale e di diritto (per i lavoratori come per gli immigrati e per i carcerati), dentro una battaglia europea cruciale e inimmaginabile senza la micidiale opera distruttrice del virus, non ammette rinvii, né concederà repliche
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- L’ITALIA, IL "BAAL-LISMO", E LA FINE DELLA SOVRANITA’ E DELLA SOVRA-UNITA’...
 L’ITALIA, IL "MONOTEISMO" DELLA LINGUA E DEL DIRITTO, E "L’UNITA’ DA CUSTODIRE". Una nota di Michele Ainis
L’ITALIA, IL "MONOTEISMO" DELLA LINGUA E DEL DIRITTO, E "L’UNITA’ DA CUSTODIRE". Una nota di Michele Ainis
IL SONNO DELLA RAGIONE COSTITUZIONALE GENERA MOSTRI ATEI E DEVOTI. Un invito e un appello a fare luce, a fare giorno
FLS
- L’ITALIA, IL "BAAL-LISMO", E LA FINE DELLA SOVRANITA’ E DELLA SOVRA-UNITA’...
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- LA RELAZIONE DI REALTA’, IL SELFIE CON IL VIRUS, E IL NUOVO TITANIC. Riflessioni (di Pierangelo Di Vittorio).10 aprile 2020, di Federico La Sala
La realtà e i cowboy. A proposito del più grande evento mediatico della storia
di Pierangelo Di Vittorio ("Aut Aut", 07.04.2020)
Al contrario di altri scenari possibili - nei quali la catastrofe, provocando un blackout tecnologico, consegna la sopravvivenza a vecchie risorse “analogiche” - l’attuale pandemia, costringendoci a un confinamento domestico, ha invece esaltato l’uso delle tecnologie digitali. Collegarsi al computer o allo smartphone è diventata, non solo una necessità, per studiare, lavorare, comunicare, ma anche un’occasione per conservare o magari riscoprire le relazioni sociali. Chi in questi giorni non ha provato almeno una volta il piacere di ritrovarsi a chiacchierare con un gruppo di amici o di colleghi in una videochiamata collettiva? Questo potrebbe essere quindi il momento meno adatto per mettersi a fare le pulci al digitale.
Credo tuttavia che una delle poche riflessioni davvero urgenti in questo periodo riguardi, non tanto il digitale in sé, quanto alcuni effetti legati alla sua capacità di industrializzare e massificare alcune tendenze di più lungo periodo. Mi riferisco in particolare alla mediatizzazione o alla messa in spettacolo della vita quotidiana (che va beninteso di pari passo con la riduzione della realtà a merce-spettacolo). La cosiddetta rivoluzione digitale ha sicuramente introdotto delle novità rispetto all’epoca televisiva. In primo luogo, l’alta tecnologia è diventata “personale” (pc, tablet, smartphone); in secondo luogo, grazie all’accessibilità di tale tecnologia personale e di tutto quello che essa consente di fare, forse per la prima volta nella storia moderna è venuta meno la tradizionale distinzione tra proprietari dei mezzi di produzione e operai, tra produttori e consumatori, tra attori e spettatori. Si tratta quindi di una novità che introduce una discontinuità fondamentale, ma che può essere vista al tempo stesso come un ulteriore giro di vite nel lungo processo di “democratizzazione” delle nostre società, il cui esito, troppo spesso trascurato, è che l’uomo comune si ritrova al centro del sistema come una specie di divinità paradossale - essendo ciò che, per principio, si oppone a ogni forma di unicità, di eccezionalità, di trascendenza.
Ora, forse non ce ne siamo accorti, le priorità sono ben altre, ma quello che stiamo vivendo, anche per le ragioni che dicevo prima, è il più gigantesco evento mediatico della storia dell’umanità. Penso ai comunicati radio e ai cinegiornali durante la Seconda guerra mondiale; al processo contro Adolf Eichmann a Gerusalemme nel 1961; all’allunaggio di Armstrong e compagni nel 1969; alla caduta del muro di Berlino nel 1989 e agli eventi sportivi di rilevanza mondiale: la pandemia li ha surclassati tutti. Perché?
Per la sua globalità, certo. Per la sua durata, anche. Per la sua gravità, indubbiamente. Ma c’è dell’altro. Credo - e qui veniamo alla novità introdotta dal digitale - che la ragione stia soprattutto nel fatto che tutti, in tutto il mondo, tutti i giorni e per molti giorni, abbiamo contribuito alla “messa in scena” della realtà della catastrofe: dal papa che usa piazza San Pietro deserta come set di un thriller apocalittico alla Dan Brown; ai grandi filosofi che usano il virus come paesaggio su cui stagliare le loro più o meno logore o inopportune teorie; alle autorità governative e sanitarie che tengono messa ogni sera; ai sindaci che se vanno in giro nelle città deserte a fare i giustizieri stile Charles Bronson; all’esercito di politici, esperti, opinionisti, giornalisti che remano come schiavi dietro una prima pagina che non cambia mai; agli uomini e le donne del mondo della cultura, dell’arte e dello spettacolo che si autopromuovono con la scusa di #iorestoacasa; a ciascuno di noi, e siamo la maggior parte, persone comuni che, oltre a riverberare all’infinito le agenzie di cui sopra, offrendo al mondo le nostre quotidiane pillole di saggezza religiosa, filosofica, scientifica, politica ecc., celebriamo noi stessi attraverso l’auto(docu)fiction, i vari diari intimi della pandemia, gli improvvisati spettacolini firmati #iorestoacasa e #celafaremo, le continue valanghe di news e fake news, video, meme e altri contenuti “umoristici” che invadono i social network, saturano le chat di whatsapp ecc.
Sì, celebriamo noi stessi, perché l’uomo comune, non dimentichiamolo, è il centro del sistema, mentre la catastrofe fa da sfondo, come il Colosseo o la Tour Eiffel in tempi “normali”, anche se questo sfondo è fondamentale, trattandosi di “capitale mediatico”, anzi, in questo momento, della soglia mediatica che dà accesso a una condizione di “esistenza” (mediatica e tout court: si può esistere oggi senza passare dalla pandemia, senza parlare del virus, senza mostrarsi con il poster della catastrofe alle spalle?). Il selfie con il virus è diventato lo sport più praticato sul pianeta. Sarà salutare? In ogni caso sembra di assistere al più grande (auto)sciacallaggio mediatico della realtà che sia mai stato compiuto nella storia dell’umanità. Sarà giusto parlarne? O saremo tacciati di disfattismo, di terrorismo? Correremo il rischio. Però chi, in questi giorni, almeno una volta, non ha pensato che la viralità mediatica della pandemia fosse almeno pari a quella biologica del virus stesso? In fondo si tratta di questo. Poi ci sono le priorità. Certo.
A dire il vero, non abbiamo dovuto aspettare la pandemia per assistere all’affermarsi di tale fenomeno: da tempo l’uomo comune è diventato il protagonista del film ininterrotto (e autoprodotto: self-cinema, come si parla di self-publishing ecc.) della propria vita quotidiana. Un film nel quale la realtà stessa è l’unica scenografia, al punto da rendere difficile distinguere dove finisca il primo e dove inizi la seconda. Un film che è solo la mediatizzazione o la messa in spettacolo della realtà più immediata, banale o triviale. Un film che è il reality show della nostra vita quotidiana.
Sarà pure legittimo chiedersi che effetti produce tutto questo sulla nostra relazione con la realtà? E quindi sulla possibilità stessa di costruire delle relazioni - con noi stessi, con gli altri, con il mondo che ci circonda? Perché, attenzione: non si tratta di sostenere, ingenuamente, che la realtà è solo “quella cosa lì” che possiamo toccare, la realtà fisica, materiale, mentre tutto il resto, ossia ciò che chiamiamo genericamente “immateriale”, appartiene al mondo della fantasia. Nulla di tutto questo.
 Si tratta invece di considerare la realtà come il piano delle relazioni “possibili” (in senso kantiano), materiali o immateriali che siano. E le relazioni sono possibili nella misura in cui c’è sempre qualcosa che ci sfugge, nel senso che in esse si apre una dimensione che non ci fa mai essere del tutto a casa nostra, che entra in gioco qualcosa che ha a che fare con l’“altro”.
Si tratta invece di considerare la realtà come il piano delle relazioni “possibili” (in senso kantiano), materiali o immateriali che siano. E le relazioni sono possibili nella misura in cui c’è sempre qualcosa che ci sfugge, nel senso che in esse si apre una dimensione che non ci fa mai essere del tutto a casa nostra, che entra in gioco qualcosa che ha a che fare con l’“altro”.
 La relazione di realtà è quel nesso che ci connette con e attraverso una forma di alterità (a cominciare dal rapporto con noi stessi), e che ci espone quindi a qualcosa che non “padroneggiamo” mai del tutto. La realtà è il non-padroneggiabile e la relazione di realtà è ciò che ci mette in contatto con l’altro, “alterandoci” in questo stesso contatto.
La relazione di realtà è quel nesso che ci connette con e attraverso una forma di alterità (a cominciare dal rapporto con noi stessi), e che ci espone quindi a qualcosa che non “padroneggiamo” mai del tutto. La realtà è il non-padroneggiabile e la relazione di realtà è ciò che ci mette in contatto con l’altro, “alterandoci” in questo stesso contatto.Intuiamo forse quanto la ricchezza, l’ipertrofia della nostra connessione sul piano mediatico (che tende a trasformare l’eterogeneo in omogeneo, l’estraneo in familiare) vada di pari passo con una profonda, galoppante miseria della nostra connessione sul piano della realtà. Il film continuo della nostra vita quotidiana, la sua trasformazione in reality ci dissocia in modo “sistematico”, e perciò drammatico, dalla realtà stessa; ci priva di quella rete di relazioni, rischiose ma creative, che ci fanno entrare in contatto con l’alterità, che ci fanno esperire la realtà stessa come e nella sua alterità; e che attraverso il gioco dei conflitti e delle alleanze, rendono possibile la trasformazione di quello che è in qualcos’altro.
 Che cosa accade invece quando la realtà diventa la scenografia della nostra vita domestica? Quando è “addomesticata” in un dispositivo mediatico del quale siamo noi stessi gli artefici e i protagonisti? Gli eterni e immutabili padroni di casa? -Succede che la vertigine dell’alterità viene meno. E questo vuol dire che ci disconnettiamo dalla realtà come piano delle relazioni possibili, e cominciamo a coltivare l’idea che la realtà stessa sia come il giardino di casa: la pericolosa illusione che, qualsiasi cosa accada, noi siamo sempre in sella e teniamo saldamente le briglie. Che si tratti di migrazioni o di cambiamenti climatici, di crack finanziari o di epidemie, ci proiettiamo e ci vediamo come gagliardi cowboy che scorrazzano nella realtà. Il che, me lo concederete, più che infantile, è idiota.
Che cosa accade invece quando la realtà diventa la scenografia della nostra vita domestica? Quando è “addomesticata” in un dispositivo mediatico del quale siamo noi stessi gli artefici e i protagonisti? Gli eterni e immutabili padroni di casa? -Succede che la vertigine dell’alterità viene meno. E questo vuol dire che ci disconnettiamo dalla realtà come piano delle relazioni possibili, e cominciamo a coltivare l’idea che la realtà stessa sia come il giardino di casa: la pericolosa illusione che, qualsiasi cosa accada, noi siamo sempre in sella e teniamo saldamente le briglie. Che si tratti di migrazioni o di cambiamenti climatici, di crack finanziari o di epidemie, ci proiettiamo e ci vediamo come gagliardi cowboy che scorrazzano nella realtà. Il che, me lo concederete, più che infantile, è idiota.L’idiozia del tizio che fa una rapina e poi si spara un selfie con il bottino in mano all’uscita della banca pubblicandolo immediatamente su facebook - è solo un esempio di fantasia, per ridere, cioè per non piangere citando il caso, realmente accaduto, di quei ragazzi di Manduria che per anni hanno vessato e picchiato un anziano, fino a causarne la morte, e che hanno continuato a filmare e diffondere in rete le loro belle gesta. Effettivamente, in questi casi, la dissociazione - dal rapporto con la realtà e dalle connessioni che il piano della realtà rende possibili - si nota con una certa evidenza. Ma sono casi singoli, si dirà. Eccezioni. Derive. D’accordo. Ma che dire allora del film apocalittico di massa, realizzato in tempo reale e intitolato vox populi “Ai tempi del coronavirus” (circa 1.400.000.000 risultati in 0,41 secondi, appena ho lanciato la ricerca, in italiano, di questa frase su Google: oggi 6 aprile 2020)?
Fare presa sul piano di realtà è sempre importante ma, potremmo chiederci, non diventa addirittura decisivo se la realtà ha un aspetto “catastrofico” - nel senso di un evento che, sottraendoci brutalmente alla nostra routine, ci obbliga a porci almeno il “problema” di come sopravvivere? Nel momento in cui la realtà è più altra e alterante del solito, quando la padroneggiamo meno del solito, o magari non la padroneggiamo affatto, non diventa primordiale costruire una serie di relazioni possibili - come per il naufrago diventa primordiale costruire una zattera con quel poco che ha a disposizione - invece di continuare a fare i cowboy?
Forse passeremo alla storia come i passeggeri di un nuovo Titanic, occupati a farci dei selfie mentre l’iceberg, a fauci spalancate, si avvicinava alle nostre spalle.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- CORONAVIRUS E STATO DI ECCEZIONE: STORIA E MEMORIA.4 aprile 2020, di Federico La Sala
SCIENZA, STORIA E MEMORIA. PORTARSI DOPO DEWEY ....
***
ALLA LUCE DEL GRANDE “SUCCESSO” NELLA CAPACITA’ DI ANALISI DELLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS mostrato dal CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (“Coronavirus. Rischio basso, capire condizioni vittime”, 22/02/2020), e della condivisione dei suoi “risultati” da parte di Giorgio AGAMBEN (”Lo stato d’eccezione provocato da un’emergenza immotivata”, il manifesto, 26/02/2020) , CONDIVIDENDO l’urgenza di accogliere “La sfida del Covid-19 alle scienze umane”, mi sia lecito rinviare ad alcune note dell’anno scorso (2019) proprio sul tema del “processo di apprendimento nelle due culture”. Forse, è proprio ora di uscire dal letargo e riprendere la navigazione “sotto coverta” e “il dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo” con Galileo Galilei. O no?!
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- Riflessioni sulla peste: la sovranità del "virus" e la risata di Kant.31 marzo 2020, di Federico La Sala
LA SOVRANITA’ (LA “CORONA”) DEL “VIRUS”, LA “PACE PERPETUA”, E LA RISATA DI KANT. Nota ... *
- Riflessioni sulla peste
- di Giorgio Agamben Quodlibet,27 marzo 2020
- Le riflessioni che seguono non riguardano l’epidemia, ma ciò che possiamo capire dalle reazioni degli uomini ad essa. Si tratta, cioè, di riflettere sulla facilità con cui un’intera società ha accettato di sentirsi appestata, di isolarsi in casa e di sospendere le sue normali condizioni di vita, i suoi rapporti di lavoro, di amicizia, di amore e perfino le sue convinzioni religiose e politiche. Perché non ci sono state, come pure era possibile immaginare e come di solito avviene in questi casi, proteste e opposizioni? L’ipotesi che vorrei suggerire è che in qualche modo, sia pure inconsapevolmente, la peste c’era già, che, evidentemente, le condizioni di vita della gente erano diventate tali, che è bastato un segno improvviso perché esse apparissero per quello che erano - cioè intollerabili, come una peste appunto. E questo, in un certo senso, è il solo dato positivo che si possa trarre dalla situazione presente: è possibile che, più tardi, la gente cominci a chiedersi se il modo in cui viveva era giusto.
- E ciò su cui occorre non meno riflettere è il bisogno di religione che la situazione fa apparire. Ne è indizio, nel discorso martellante dei media, la terminologia presa in prestito dal vocabolario escatologico che, per descrivere il fenomeno, ricorre ossessivamente, soprattutto sulla stampa americana, alla parola «apocalisse» e evoca, spesso esplicitamente, la fine del mondo. È come se il bisogno religioso, che la Chiesa non è più in grado di soddisfare, cercasse a tastoni un altro luogo in cui consistere e lo trovasse in quella che è ormai di fatto diventata la religione del nostro tempo: la scienza. Questa, come ogni religione, può produrre superstizione e paura o, comunque, essere usata per diffonderle. Mai come oggi si è assistito allo spettacolo, tipico delle religioni nei momenti di crisi, di pareri e prescrizioni diversi e contraddittori, che vanno dalla posizione eretica minoritaria (pure rappresentata da scienziati prestigiosi) di chi nega la gravità del fenomeno al discorso ortodosso dominante che l’afferma e, tuttavia, diverge spesso radicalmente quanto alle modalità di affrontarlo. E, come sempre in questi casi, alcuni esperti o sedicenti tali riescono ad assicurarsi il favore del monarca, che, come ai tempi delle dispute religiose che dividevano la cristianità, prende partito secondo i propri interessi per una corrente o per l’altra e impone le sue misure.
- Un’altra cosa che dà da pensare è l’evidente crollo di ogni convinzione e fede comune. Si direbbe che gli uomini non credono più a nulla - tranne che alla nuda esistenza biologica che occorre a qualunque costo salvare. Ma sulla paura di perdere la vita si può fondare solo una tirannia, solo il mostruoso Leviatano con la sua spada sguainata.
- Per questo - una volta che l’emergenza, la peste, sarà dichiarata finita, se lo sarà - non credo che, almeno per chi ha conservato un minimo di lucidità, sarà possibile tornare a vivere come prima. E questa è forse oggi la cosa più disperante - anche se, com’è stato detto, «solo per chi non ha più speranza è stata data la speranza».
* Nota:
LA SOVRANITA’ (LA “CORONA”) DEL “VIRUS”, LA “PACE PERPETUA”, E LA RISATA DI KANT...
CONSIDERATO, PURTROPPO, CHE ” Le riflessioni” di Agamben non riguardano l’epidemia del CORONAVIRUS, “ma ciò che possiamo capire dalle reazioni degli uomini ad essa”, ACCOLTA “L’ipotesi [...] che in qualche modo, sia pure inconsapevolmente, la peste c’era già [...]”
 E CONDIVISA L’IDEA CHE BISOGNA RIFLETTERE SUL “[...] bisogno di religione che la situazione fa apparire. Ne è indizio, nel discorso martellante dei media, la terminologia presa in prestito dal vocabolario escatologico che, per descrivere il fenomeno, ricorre ossessivamente, soprattutto sulla stampa americana, alla parola «apocalisse» e evoca, spesso esplicitamente, la fine del mondo [...]”
E CONDIVISA L’IDEA CHE BISOGNA RIFLETTERE SUL “[...] bisogno di religione che la situazione fa apparire. Ne è indizio, nel discorso martellante dei media, la terminologia presa in prestito dal vocabolario escatologico che, per descrivere il fenomeno, ricorre ossessivamente, soprattutto sulla stampa americana, alla parola «apocalisse» e evoca, spesso esplicitamente, la fine del mondo [...]”
 E, ANCORA, CHE “come sempre in questi casi, alcuni esperti o sedicenti tali riescono ad assicurarsi il favore del monarca, che, come ai tempi delle dispute religiose che dividevano la cristianità, prende partito secondo i propri interessi per una corrente o per l’altra e impone le sue misure. [....] sulla paura di perdere la vita si può fondare solo una tirannia, solo il mostruoso Leviatano con la sua spada sguainata” (cf. G. Agamben, “Riflessioni...” : https://www.quodlibet.it/giorgio-agamben-riflessioni-sulla-peste),
E, ANCORA, CHE “come sempre in questi casi, alcuni esperti o sedicenti tali riescono ad assicurarsi il favore del monarca, che, come ai tempi delle dispute religiose che dividevano la cristianità, prende partito secondo i propri interessi per una corrente o per l’altra e impone le sue misure. [....] sulla paura di perdere la vita si può fondare solo una tirannia, solo il mostruoso Leviatano con la sua spada sguainata” (cf. G. Agamben, “Riflessioni...” : https://www.quodlibet.it/giorgio-agamben-riflessioni-sulla-peste),
 PER NON PERDERE IL “FILO” DI “SOFIA” E, CON ESSA, ANCHE LA VITA E LA “SOVRANITA’ (LA “CORONA”) DEL SUO “SAPERE AUDE!”, IO RIPRENDEREI IL DISCORSO dalla citazione evangelica, utilizzata anche dallo stesso Agamben in “Pilato e Gesù” (nottetempo 2013), relativa al problema dell’ ECCE HOMO (cfr. RITORNARE A SCUOLA DA PONZIO PILATO ... http://www.leparoleelecose.it/?p=37854#comment-426632) e dalla LEZIONE DI KANT sull’UOMO SUPREMO DI EMANUEL SWEDENBORG (http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=5028) E SULLA “fine di tutte le cose” (http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=5026). O no?! Boh e bah?!
PER NON PERDERE IL “FILO” DI “SOFIA” E, CON ESSA, ANCHE LA VITA E LA “SOVRANITA’ (LA “CORONA”) DEL SUO “SAPERE AUDE!”, IO RIPRENDEREI IL DISCORSO dalla citazione evangelica, utilizzata anche dallo stesso Agamben in “Pilato e Gesù” (nottetempo 2013), relativa al problema dell’ ECCE HOMO (cfr. RITORNARE A SCUOLA DA PONZIO PILATO ... http://www.leparoleelecose.it/?p=37854#comment-426632) e dalla LEZIONE DI KANT sull’UOMO SUPREMO DI EMANUEL SWEDENBORG (http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=5028) E SULLA “fine di tutte le cose” (http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=5026). O no?! Boh e bah?!Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- ExtraTerrestre: «Ho scoperto con delusione che Benetton non è il progressista che viene raccontato» (M. Venturi Ferriolo).19 marzo 2020, di Federico La Sala
ExtraTerrestre
«Ho scoperto con delusione che Benetton non è il progressista che viene raccontato»
di Riccardo Bottazzo (il manifesto, 19.03.2020)
Se ne è andato sbattendo la porta, il filosofo Massimo Venturi Ferriolo, uno dei massimi pensatori moderni sul tema del paesaggio, già professore ordinario di Filosofia Morale ed Estetica in tante università italiane. I suoi ex colleghi della Fondazione Benetton, racconta, «si sono molto arrabbiati con me e mi ritengono impazzito» ma lui non rimpiange la sue scelta e ora lavora per far conoscere al mondo la storia del popolo mapuche. Una storia esemplare di tante che hanno afflitto i popoli originari del Sudamerica, «veri difensori della natura senza i falsi miti sullo sviluppo sostenibile neoliberista», spiega. «Distruggendoli, come sta avvenendo anche in Amazzonia, non facciamo altro che annientare noi stessi con il pianeta in cui viviamo».
Nel 1994 lei ha iniziato una collaborazione con la Fondazione Benetton, facendo anche parte, dal 2008, della giuria del premio Carlo Scarpa. Cosa l’ha spinta a chiudere questa collaborazione?
Aver scoperto con grande delusione che Benetton non è l’imprenditore progressista dell’immagine antirazzista costruita nel nostro paese e pubblicizzata da parte della stampa nazionale con cospicue pubblicità. Non potevo più collegare per le ragioni etiche, esposte nella mia lettera di dimissioni, il mio nome all’azienda, sia pur nell’autonomia della Fondazione.
In una lettera a Luciano Benetton lei scrive «Un luogo non è una merce, ha la sua storia e, anche se acquistato col denaro, appartiene a chi lo abita nel tempo e nello spazio e non può essere sottratto con il suo commercio agli abitanti secolari, come è avvenuto». Ha mai avuto una risposta?
Sì, ho avuto una risposta tramite la compagna e a.d. di Fabrica Laura Pollini che in un incontro cordiale, seguito poi da un carteggio, ha difeso l’operato dell’azienda ed ha tentato di farmi desistere dalle dimissioni. Ma la questione è culturale ed etica: non rendersi conto di aver acquistato una terra che apparteneva a un popolo ancora vivo, al quale era stata tolta in precedenza con la violenza: una storia conosciuta che da noi passa sotto silenzio anche se ora ci sono spiragli di conoscenza grazie al lavoro di voi giornalisti indipendenti.
La Fondazione si propone come l’anima candida della Benetton, ma è eticamente sostenibile distinguere i due aspetti di una stessa azienda?
No, non è eticamente sostenibile e per questo mi sono dimesso. Molti miei ex colleghi nascondono la testa come gli struzzi e non vogliono guardare oltre il proprio naso. Ma la Fondazione ha un passato e un nome prestigiosi che da lustro a tutti i membri del comitato scientifico. Alcuni non sarebbero conosciuti se non come tali.
In Italia sono pochissime le persone informate sulla questione mapuche. E’ una questione legata al poco spazio che i nostri media notoriamente concedono alle questioni internazionali oppure c’è una politica di invisibilizzazione del problema costruita anche con la complicità della Fondazione?
Se ne parla poco e sulla questione c’è un assordante silenzio. La famiglia Benetton è molto potente in Italia ed inattaccabile. Con le autostrade ha incominciato a sgretolarsi. La Patagonia rimane lontana e, in un certo senso, blindata. Ha avuto l’appoggio del governo Macrì nella battaglia contro i mapuche che solo ora cominciano a trovare giudici onesti ed a vincere qualche causa. Pian piano il caso esce dal suo silenzio. Non posso parlare tout court di complicità della Fondazione per l’invisibilizzazione del problema perché la maggior parte dei membri e dei frequentatori non lo conoscono, non sono informati o non informano. Luciano Benetton è risentito con me perché farei apparire il comitato scientifico come connivente di uno sfruttatore di indigeni. Quindi può immaginare come in realtà tenga al buon nome della Fondazione che eviterebbe d’indagare a fondo i loro affari proprio con il proprio operato.
I mapuche denunciano l’impossibilità di avere anche un semplice confronto con l’azienda. Alcune comunità troverebbero grande giovamento anche da piccole azioni come l’apertura invernale di un cancello per far passare il bestiame. Non crede che Benetton abbia sposato per principio la linea dura e consideri tutti i mapuche come un fastidio di cui liberarsi il prima possibile?
È proprio questo il problema. Imputo a Benetton di non aver fatto passi sostanziali verso i mapuche, forse per non riconoscerli come popolo. L’ho invitato più volte a sedersi a un tavolo con i mapuche con la mediazione dei colleghi antropologi e indigenisti dell’Uba, Università di Buenos Aires, uno spazio neutro scientifico per un incontro comune, per trovare una soluzione che non sia la repressione, cioè riconoscerli come entità umana e giuridica. Una popolazione storicamente sfrattata non è un fastidio. Parliamo di una popolazione che ha una cultura e una cosmologia straordinaria. Su di loro sono stati scritti libri. Sono i Benetton a non avere alle spalle una cultura solida!
L’articolo 17 della Costituzione argentina è dedicato alla salvaguardare dei popoli originari. Le sembra che siano stati fatti passi avanti in questo senso?
No. La cosa importante in questa questione infatti, è battersi per il riconoscimento giuridico del popolo mapuche dando loro una riconoscibilità chiara e definita come popolo. Per questo dobbiamo batterci in Italia, nel mondo e in Argentina per affermare e realizzare questo principio costituzionale che permetterebbe ai mapuche di tornare al possesso comunitario delle loro terre per vivere come popolo e aiutarci a difendere l’ambiente perché, ricordiamoci, solo l’interculturalità potrà salvarci frenando il rovinoso neoliberismo. Luciano Benetton non avrebbe più scuse. Se volesse davvero restituire territori, potrebbe interessarsi alla causa del riconoscimento giuridico di queste comunità e sedersi a un tavolo comune della pace e restituzione che sarebbe un evento mondiale di grande risonanza e un nobile precedente straordinario in cui spero ancora. Credo che questo per lui possa valere di più di altri profitti fini e se stessi: un nome da consegnare alla pace e non alla violenza.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA --- Intellettuali (di Ivano Dionigi).17 marzo 2020, di Federico La Sala
Tu quis es?
Intellettuali
di Ivano Dionigi (Avvenire, martedì 17 marzo 2020)
Dove sono finiti gli intellettuali, figure che mettano il loro sapere a confronto col potere e a frutto del bene comune ? Per i quali la virtù sia per se ipsa praemium ? Che abbiano nel sangue il senso del destino delle persone ? Missing, scomparsi. Sostituiti da intrattenitori, giornalisti, velinari, rappresentanti politici, tecnici delle singole discipline. Dovunque ti giri, stesso spettacolo : loquaces, muti sunt, « blaterano, ma sono muti », direbbe Agostino.
Tra le diverse cause di questa scomparsa, direi anzitutto il primato indiscusso della comunicazione, questo rinnovato impero della retorica, che impone messaggi semplice e semplificati, e che ai pensieri lunghi preferisce gli slogan.
 E poi loro, gli intellettuali, i quali, non si fanno scrupolo di scodinzolare attorno al principe o principino di turno e di asservirsi al potere, tradendo quella “convinzione” e quella “responsabilità” che dovrebbero caratterizzarli.
E poi loro, gli intellettuali, i quali, non si fanno scrupolo di scodinzolare attorno al principe o principino di turno e di asservirsi al potere, tradendo quella “convinzione” e quella “responsabilità” che dovrebbero caratterizzarli.Infine i partiti, che, tra miopia e istinto di sopravvivenza, hanno ridotto la politica a pratica amministrativa oppure a pura spartizione di potere, estranea al pensiero e al progetto.
 Fanno riflettere le parole di Socrate, lontano dalle cariche pubbliche e condannato dalle leggi della città : «Io credo di essere tra quei pochi Ateniesi, per non dire il solo, che tenti la vera arte politica, e il solo tra i contemporanei che la eserciti » (Gorgia 521 d).
Fanno riflettere le parole di Socrate, lontano dalle cariche pubbliche e condannato dalle leggi della città : «Io credo di essere tra quei pochi Ateniesi, per non dire il solo, che tenti la vera arte politica, e il solo tra i contemporanei che la eserciti » (Gorgia 521 d). -
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- L’ “8 SETTEMBRE”, LA “CORONA-VIRUS”, E UNA “PACE PERPETUA”. Ora il “capro espiatorio” siamo noi...11 marzo 2020, di Federico La Sala
L’ “8 SETTEMBRE”, LA “CORONA-VIRUS”, E UNA “PACE PERPETUA”. Ora il “capro espiatorio” siamo noi, l’intero genere umano ...
ALLA LUCE DEL FATTO che i “vescovi fiorentini hanno vietato di scambiarsi il segno della pace durante il rito della messa”, che a “Lourdes hanno chiuso l’accesso alle acque miracolose”, “per CARITA’, UN LAICO ILLUMINISTA” (cfr. Mario Pezzella, “Sarà un 8 settembre?, "Le parole e le cose”, 11 marzo 2020) può pure compiacersi di “quanto la fede religiosa sia diventata un gadget turistico, che non regge di fronte a uno stato di necessità”, MA NON PUO’ CONTINUARE A “DORMIRE”, A PENSARE COME SE FOSSE TUTTO COME “PRIMA” E RIPROPORRE LA STESSA “MINESTRA”:
- “[....] Afferma Umberto Galimberti in una intervista televisiva che l’angoscia di fronte a un pericolo indeterminato è talmente insopportabile che si cerca il più presto possibile di incarnarlo in un capro espiatorio tangibile e concreto [...] Ora l’incarnazione del male siamo diventati noi. [...] Allo stato d’animo dell’angoscia, dovrebbe sostituirsi quello che Leopardi nella Ginestra, dinanzi alla potenza incombente del Vesuvio, definisce “vero amor”, e cioè la capacità di sostenersi reciprocamente “negli alterni perigli e nelle angosce della guerra comune” [....]” (Mario Pezzella, “Sarà un 8 settembre?”, cit.).
SE NON SAPPIAMO ANCORA che cosa significa “pensare dentro l’emergenza”, forse, è bene CON BENJAMIN (NON AGAMBEN), RITORNARE A SCUOLA DA PONZIO PILATO E RIASCOLTARE IL SUO “ECCE HOMO”, E CERCARE DI CAPIRE COSA VA SIGNIFICANDO NEL TEMPO LA SUA LEZIONE.
A DISTANZA DI SECOLI, e dopo Marx, dopo Nietzsche, dopo Freud, e dopo Lacan e dopo Foucault (il Foucault di “Che cosa è l’Illuminismo?”, 1983/1984), continuiamo a non capire che il “capro espiatorio” non è un caprone (cfr. “La crisi dell’Europa. Note per una riflessione storiografica”), ma un montone, un ariete, venuto a portarci in salvo (cfr.: “Guarire la nostra Terra. Necessità di “pensare un altro Abramo”), non a “sacrificarsi” per noi!!! Al contrario, oggi, l’intero genere umano, “noi stessi” ci apprestiamo a fare da “capro espiatorio” - e, pronti per la “pace perpetua” (cfr. Fine della Storia o della “Preistoria”?), abbiamo già messo sulla “nostra” testa la “corona” del sacrificio! O no?!
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- Ora il “capro espiatorio” siamo noi... La nostra storia ha prodotto ininterrottamente capri espiatori (di Pier Aldo Rovatti)12 marzo 2020, di Federico La Sala
Il capro espiatorio
di Pier Aldo Rovatti (*)
La nostra storia ha prodotto ininterrottamente capri espiatori. Minoranze, intere popolazioni, gruppi sociali e comportamenti sono stati stigmatizzati. La storia recente e contemporanea conosce vicende quasi impensabili come la persecuzione e l’eliminazione di milioni di ebrei durante il regime nazista, ma poi c’è un intero tessuto che continua a innervare il presente, anche là dove l’evoluzione sociale e il progresso materiale avrebbero dovuto cancellarlo, dallo stigma che ancora pesa sui folli o che non ha cessato di discriminare gli omosessuali e perfino le donne.
Oggi l’esempio più clamoroso è costituito dai migranti, sui quali riversiamo le nostre ansie considerandoli spesso alla stregua di orde barbariche che invadono la civile società in cui crediamo di vivere. Ma gli esempi possono moltiplicarsi, dalla paura che ormai ovunque possa celarsi un terrorista al semplice disagio con cui sperimentiamo la prossimità di chi ci appare diverso da noi e dunque capace di disturbare la nostra presunta identità.
Capri espiatori possono dunque essere intere popolazioni o anche singoli atteggiamenti, drammatici fenomeni sociali che si esprimono con un clamore generale oppure insidiosi fenomeni individuali che possiamo verificare nell’ambito ristretto e quotidiano delle nostre vite. Parlo di “capri espiatori” perché questa espressione, che ci arriva dalla notte dei tempi, non solo mantiene un senso fruibile nella sua esplicita chiarezza, ma anche perché, se ci fermiamo un momento a riflettere sulla sua provenienza e le sue implicazioni, ci può aiutare a orientarci dentro i nostri stessi problemi. La festività pasquale ci ha appena ricordato un indizio collegato al mondo cristiano e precisamente alla figura di Gesù Cristo che si sacrifica perché attraverso di lui i credenti rimettano le loro colpe. Al posto di un ispido caprone abbiamo in questo caso un grazioso ma altrettanto innocente agnellino a esercitare la funzione di animale simbolico.
L’ispido caprone o capro appare molto prima nelle parole della Bibbia intitolate al “Levitico”, cioè nel fondo della cultura ebraica e della sua mitologia. Se andiamo a leggere queste parole, scopriamo che in origine i capri sono due, uno il cui sacrificio ha una funzione espiatoria e un altro che svolge il ruolo di “emissario” e viene mandato a perdersi nel deserto, come se non bastasse la cerimonia dell’espiazione dei peccati o delle colpe degli uomini e occorressero quindi un supplemento e uno sdoppiamento, un prolungamento dell’espiazione affidata appunto a un emissario che porti con sé e disperda nello spazio e nel tempo queste colpe.
Ricordando l’origine dell’espressione, balza agli occhi che il significato che oggi le attribuiamo è molto distante, quasi antitetico. È sparita ogni pratica positiva di espiazione attraverso un tramite simbolico e al suo posto troviamo invece l’attribuzione della colpa a un altro soggetto che automaticamente diventa il colpevole. Costui viene caricato di ogni colpa grazie a un’identificazione abnorme. Il capro non era un soggetto o un insieme di soggetti da degradare, era invece un animale simbolico completamente innocente dotato di un formidabile potere espiatorio: esso era supposto possedere un’efficacia reale sullo sviluppo della presa di coscienza di se stessi. Oggi, il cosiddetto capro espiatorio è la vittima prescelta, il colpevole che sta al posto nostro, il nemico sul quale possiamo proiettare ogni male.
Rimando chi volesse entrare nella complessità della questione a un saggio che è ormai diventato un “classico” in proposito, Il capro espiatorio (titolo originale Le bouc émissaire) di René Girard, pubblicato nel 1982 (e tradotto da Adelphi nel 1999). A questo libro si è anche ispirato lo scrittore Daniel Pennac: “Malaussène”, il personaggio da lui inventato per costruirci attorno una serie di romanzi, comici e al tempo stesso seri, ambientati in un quartiere popolare di Parigi, è un capro espiatorio di professione. Pennac arriva anche a immaginare che in un ipermercato vi sia un ufficio dove la clientela possa liberamente esternare le sue lamentele a un funzionario (appunto Malaussène) che è lì proprio per dar ragione a tutti e assumersi ogni colpa. È un contrappasso letterario e sorridente di quanto accade nella dura realtà dei giorni nostri. Tra l’altro, dopo un lungo silenzio, Pennac riprende la sua saga con Il caso Malaussène, annunciato ora da Feltrinelli.
*
AUT AUT - IL SAGGIATORE (uscito su "Il Piccolo", 21 aprile 2017 - ripresa parziale).
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- CHIARIMENTO DEL SIGNIFICATO DELLE PAROLE DI PONZIO PILATO E MEMORIA DI CHRISTINE DE PIZAN.10 marzo 2020, di Federico La Sala
L’ECCE HOMO, L’8 MARZO AL TEMPO DEL “CORONA VIRUS”, E LA MEMORIA DI CHRISTINE DE PIZAN ...
ALLA LUCE DEL CHIARIMENTO DEL SIGNIFICATO DELLE PAROLE DI PONZIO PILATO: “ECCE HOMO”(cfr. sopra : https://www.fondazioneterradotranto.it/2020/02/26/dialetti-salentini-piticinu/#comment-269838), si comprende meglio anche il significato delle parole di Christine de Pizan, l’autrice della “Città delle dame” : «Or fus jee vrais homs, n’est pa fable,/De nefs mener entremettable » (« Allora diventai un vero uomo, non è una favola,/capace di condurre le navi» - cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Christine_de_Pizan), che dicono ovviamente non della “metamorfosi” in “vir” - uomo, ma della “metanoia” in “homo” - essere umano (su questo, in particolare, si cfr. Michele Feo, “HOMO - Metanoia non Metamorfosi”, “dalla parte del torto”, Parma, autunno 2019, numero 86, pp. 12-13).
***
ASTREA ! “IAM REDIT ET VIRGO” ...
CARO ARMANDO... RICORDANDO DI NUOVO E ANCORA IL TUO PREGEVOLISSIMO LAVORO SU- GLI ARCADI DI TERRA D’OTRANTO, VIRGILIO, E IL “VECCHIO DI CORICO”. A SOLLECITAZIONE E CONFORTO DELL’IMPRESA (si cfr. https://www.fondazioneterradotranto.it/2019/07/08/gli-arcadi-di-terra-dotranto-premessa-1-x/#comment-238474), E LA TUA CONNESSIONE TRA LA “PIZANA” CAPACE DI “CONDURRE LE NAVI” CON LA FIERA E NOBILE Carola Rackete, A SUO E TUO OMAGGIO, riprendo qui una breve scheda su:
- ASTREA - L’Astraea Virgo, ” vergine delle stelle “, simbolo della giustizia, abitò la terra nell’età dell’oro e la lasciò per ultima nell’età del ferro, cedendo all’iniquità ormai dominante. Il ‛ritorno di A.‘ si identifica in Virgilio con il ritorno dell’età di Saturno (” magnus ab integro saeclorum nascitur ordo. / iam redit et Virgo, redeunt Saturnia regna, / iam nova progenies caelo demittitur alto “, Buc. IV 5-7). L’intero passo virgiliano è parafrasato in Pg XXII 70-72 Secol si rinova ; / torna giustizia e primo tempo umano, / e progenïe scende da ciel nova ; in Mn I XI 1 è riportato il v. 6 (cui segue la chiosa ‛ Virgo ‘... vocabatur iustitia, quam etiam ‛Astraeam‘ vocabant), ricordato anche in Ep VII 6 ; in Ep XI 15 il nome di A. è usato come metonimico di giustizia (http://www.treccani.it/enciclopedia/astrea_%28Enciclopedia-Dantesca%29/).
Buon 8 marzo 2020 - e buon lavoro...
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- I GIOVANI INFELICI, IL TEATRO GRECO TRAGICO, E LA RICERCA DI PASOLINI E FACHINELLI.6 marzo 2020, di Federico La Sala
PSICOANALISI, POLITICA, E SOCIETA’. "PADRI", "FIGLI", E QUESTIONE ANTROPOLOGICA - "EDIPICA"...*
I giovani infelici
di Pier Paolo Pasolini ("primi giorni del 1975")*
Uno dei temi più misteriosi del teatro tragico greco è la predestinazione dei figli a pagare le colpe dei padri.
Non importa se i figli sono buoni, innocenti, pii: se i loro padri hanno peccato, essi devono essere puniti.
È il coro - un coro democratico - che si dichiara depositario di tale verità: e la enuncia senza introdurla e senza illustrarla, tanto gli pare naturale.
Confesso che questo tema del teatro greco io l’ho sempre accettato come qualcosa di estraneo al mio sapere, accaduto «altrove» e in un «altro tempo». Non senza una certa ingenuità scolastica, ho sempre considerato tale tema come assurdo e, a sua volta, ingenuo, «antropologicamente» ingenuo.
Ma poi è arrivato il momento della mia vita in cui ho dovuto ammettere di appartenere senza scampo alla generazione dei padri. Senza scampo, perché i figli non solo sono nati, non solo sono cresciuti, ma sono giunti all’età della ragione e il loro destino, quindi, comincia a essere ineluttabilmente quello che deve essere, rendendoli adulti.
Ho osservato a lungo in questi ultimi anni, questi figli. Alla fine, il mio giudizio, per quanto esso sembri anche a me stesso ingiusto e impietoso, è di condanna. Ho cercato molto di capire, di fingere di non capire, di contare sulle eccezioni, di sperare in qualche cambiamento, di considerare storicamente, cioè fuori dai soggettivi giudizi di male e di bene, la loro realtà. Ma è stato inutile. Il mio sentimento è di condanna. I sentimenti non si possono cambiare. Sono essi che sono storici. È ciò che si prova, che è reale (malgrado tutte le insincerità che possiamo avere con noi stessi). Alla fine - cioè oggi, primi giorni del ’75 - il mio sentimento è, ripeto, di condanna. Ma poiché, forse, condanna è una parola sbagliata (dettata, forse, dal riferimento iniziale al contesto linguistico del teatro greco), dovrò precisarla: più che una condanna, infatti il mio sentimento è una «cessazione di amore»: cessazione di amore, che, appunto, non da luogo a «odio» ma a «condanna».
Io ho qualcosa di generale, di immenso, di oscuro da rimproverare ai figli. Qualcosa che resta al di qua del verbale: manifestandosi irrazionalmente, nell’esistere, nel «provare sentimenti». Ora, poiché io - padre ideale - padre storico - condanno i figli, è naturale che, di conseguenza, accetti, in qualche modo l’idea della loro punizione.
Per la prima volta in vita mia, riesco così a liberare nella mia coscienza, attraverso un meccanismo intimo e personale, quella terribile, astratta fatalità del coro ateniese che ribadisce come naturale la «punizione dei figli».
Solo che il coro, dotato di tanta immemore, e profonda saggezza, aggiungeva che ciò di cui i figli erano puniti era la «colpa dei padri».
Ebbene, non esito neanche un momento ad ammetterlo; ad accettare cioè personalmente tale colpa. Se io condanno i figli (a causa di una cessazione di amore verso di essi) e quindi presuppongo una loro punizione, non ho il minimo dubbio che tutto ciò accada per colpa mia. In quanto padre. In quanto uno dei padri. Uno dei padri che si son resi responsabili, prima, del fascismo, poi di un regime clerico-fascista, fintamente democratico, e, infine, hanno accettato la nuova forma del potere, il potere dei consumi, ultima delle rovine, rovina delle rovine.
La colpa dei padri che i figli devono pagare è dunque il «fascismo», sia nelle sue forme arcaiche, che nelle sue forme assolutamente nuove - nuove senza equivalenti possibili nel passato?
Mi è difficile ammettere che la «colpa» sia questa. Forse anche per ragioni private e soggettive. Io, personalmente, sono sempre stato antifascista, e non ho accettato mai neanche il nuovo potere di cui in realtà parlava Marx, profeticamente, nel Manifesto, credendo di parlare del capitalismo del suo tempo. Mi sembra che ci sia qualcosa di conformistico e troppo logico - cioè di non-storico - nell’identificare in questo la colpa.
Sento ormai intorno a me lo «scandalo dei pedanti» - seguito dal loro ricatto - a quanto sto per dire. Sento già i loro argomenti: è retrivo, reazionario, nemico del popolo chi non sa capire gli elementi sia pur drammatici di novità che ci sono nei figli, chi non sa capire che essi comunque sono vita. Ebbene, io penso, intanto, che anch’io ho diritto alla vita - perché, pur essendo padre, non per questo cesso di essere figlio. Inoltre per me la vita si può manifestare egregiamente, per esempio, nel coraggio di svelare ai nuovi figli, ciò che io veramente sento verso di loro. La vita consiste prima di tutto nell’imperterrito esercizio della ragione: non certo nei partiti presi, e tanto meno nel partito preso della vita, che è puro qualunquismo. Meglio essere nemici del popolo che nemici della realtà.
I figli che ci circondano, specialmente i più giovani, gli adolescenti, sono quasi tutti dei mostri. Il loro aspetto fisico è quasi terrorizzante, e quando non terrorizzante, è fastidiosamente infelice. Orribili pelami, capigliature caricaturali, carnagioni pallide, occhi spenti. Sono maschere di qualche iniziazione barbarica. Oppure, sono maschere di una integrazione diligente e incosciente, che non fa pietà.
Dopo aver elevato verso i padri barriere tendenti a relegare i padri nel ghetto, si son trovati essi stessi chiusi nel ghetto opposto. Nei casi migliori, essi stanno aggrappati ai fili spinati di quel ghetto, guardando verso noi, tuttavia uomini, come disperati mendicanti, che chiedono qualcosa solo con lo sguardo, perché non hanno coraggio, ne forse capacità di parlare. Nei casi né migliori né peggiori (sono milioni) essi non hanno espressione alcuna: sono l’ambiguità fatta carne. I loro occhi sfuggono, il loro pensiero è perpetuamente altrove, hanno troppo rispetto o troppo disprezzo insieme, troppa pazienza o troppa impazienza. Hanno imparato qualcosa di più in confronto al loro coetanei di dieci o vent’anni prima, ma non abbastanza. L’integrazione non è un problema morale, la rivolta si e codificata. Nei casi peggiori, sono dei veri e propri criminali. Quanti sono questi criminali? In realtà, potrebbero esserlo quasi tutti. Non c’è gruppo di ragazzi, incontrato per strada, che non potrebbe essere un gruppo di criminali. Essi non hanno nessuna luce negli occhi: i lineamenti sono lineamente contraffatti di automi, senza che niente di personale li caratterizzi da dentro. La stereotipia li rende infidi. Il loro silenzio può precedere una trepida domanda di aiuto (che aiuto?) o può precedere una coltellata. Essi non hanno più la padronanza dei loro atti, si direbbe dei loro muscoli. Non sanno bene qual è la distanza tra causa ed effetto. Sono regrediti - sotto l’aspetto esteriore di una maggiore educazione scolastica e di una migliorata condizione di vita - a una rozzezza primitiva. Se da una parte parlano meglio, ossia hanno assimilato il degradante italiano medio - dall’altra sono quasi afasici: parlano vecchi dialetti incomprensibili, o addirittura tacciono, lanciando ogni tanto urli gutturali e interiezioni tutte di carattere osceno. Non sanno sorridere o ridere. Sanno solo ghignare o sghignazzare. In questa enorme massa (tipica, soprattutto, ancora una volta!, dell’inerme Centro-Sud) ci sono delle nobili élites, a cui naturalmente appartengono i figli dei miei lettori. Ma questi miei lettori non vorranno sostenere che i loro figli sono dei ragazzi felici (disinibiti o indipendenti, come credono e ripetono certi giornalisti imbecilli, comportandosi come inviati fascisti in un lager). La falsa tolleranza ha reso significative, in mezzo alla massa dei maschi, anche le ragazze. Esse sono in genere, personalmente, migliori: vivono infatti un momento di tensione, di liberazione, di conquista (anche se in modo illusorio). Ma nel quadro generale la loro funzione finisce con l’essere regressiva. Una libertà «regalata», infatti, non può vincere in esse, naturalmente, le secolari abitudini alla codificazione.
Certo: i gruppi di giovani colti (del resto assai più numerosi di un tempo) sono adorabili perché strazianti. Essi, a causa di circostanze che per le grandi masse sono finora solo negative, e atrocemente negative, sono più avanzati, sottili, informati, dei gruppi analoghi di dieci o vent’anni fa. Ma che cosa possono farsene della loro finezza e della loro cultura?
Dunque, i figli che noi vediamo intorno a noi sono figli «puniti»: «puniti», intanto, dalla loro infelicità, e poi, in futuro, chissà da che cosa, da quali ecatombi (questo è il nostro sentimento, insopprimibile).
Ma sono figli «puniti» per le nostre colpe, cioè per le colpe dei padri. È giusto? Era questa, in realtà, per un lettore moderno, la domanda, senza risposta, del motivo dominante del teatro greco.
Ebbene sì, è giusto. Il lettore moderno ha vissuto infatti un’esperienza che gli rende finalmente, e tragicamente, comprensibile l’affermazione - che pareva cosi ciecamente irrazionale e crudele - del coro democratico dell’antica Atene: che i figli cioè devono pagare le colpe dei padri. Infatti i figli che non si liberano delle colpe dei padri sono infelici: e non c’è segno più decisivo e imperdonabile di colpevolezza che l’infelicità. Sarebbe troppo facile e, in senso storico e politico, immorale, che i figli fossero giustificati - in ciò che c’è in loro di brutto, repellente, disumano - dal fatto che i padri hanno sbagliato. L’eredità paterna negativa li può giustificare per una metà, ma dell’altra metà sono responsabili loro stessi. Non ci sono figli innocenti. Tieste è colpevole, ma anche i suoi figli lo sono. Ed è giusto che siano puniti anche per quella metà di colpa altrui di cui non sono stati capaci di liberarsi.
Resta sempre tuttavia il problema di quale sia in realtà, tale «colpa» dei padri.
È questo che sostanzialmente, alla fine, qui importa. E tanto più importa in quanto, avendo provocato una cosi atroce condizione nei figli, e una conseguente così atroce punizione, si deve trattare di una colpa gravissima. Forse la colpa più grave commessa dai padri in tutta la storia umana. E questi padri siamo noi. Cosa che ci sembra incredibile.
Come ho già accennato, intanto, dobbiamo liberarci dall’idea che tale colpa si identifichi col fascismo vecchio e nuovo, cioè coll’effettivo potere capitalistico. I figli che vengono oggi cosi crudelmente puniti dal loro modo di essere (e in futuro, certo, da qualcosa di più oggettivo e di più terribile), sono anche figli di antifascisti e di comunisti.
Dunque fascisti e antifascisti, padroni e rivoluzionari, hanno una colpa in comune. Tutti quanti noi, infatti, fino oggi, con inconscio razzismo, quando abbiamo parlato specificamente di padri e di figli, abbiamo sempre inteso parlare di padri e di figli borghesi.
La storia era la loro storia.
Il popolo, secondo noi, aveva una sua storia a parte, arcaica, in cui i figli, semplicemente, come insegna l’antropologia delle vecchie culture, reincarnavano e ripetevano i padri.
Oggi tutto è cambiato: quando parliamo di padri e di figli, se per padri continuiamo sempre a intendere i padri borghesi, per figli intendiamo sia i figli borghesi che i figli proletari. Il quadro apocalittico, che io ho abbozzato qui sopra, dei figli, comprende borghesia e popolo.
Le due storie si sono dunque unite: ed è la prima volta che ciò succede nella storia dell’uomo.
Tale unificazione è avvenuta sotto il segno e per volontà della civiltà dei consumi: dello «sviluppo». Non si può dire che gli antifascisti in genere e in particolare i comunisti, si siano veramente opposti a una simile unificazione, il cui carattere è totalitario - per la prima volta veramente totalitario - anche se la sua repressività non è arcaicamente poliziesca (e se mai ricorre a una falsa permissività).
La colpa dei padri dunque non è solo la violenza del potere, il fascismo. Ma essa è anche: primo, la rimozione dalla coscienza, da parte di non antifascisti, del vecchio fascismo, l’esserci comodamente liberarti della nostra profonda intimità (Pannella) con esso (l’aver considerato i fascisti «i nostri fratelli cretini», come dice una frase di Sforza ricordata da Fortini); secondo, e soprattutto, l’accettazione - tanto più colpevole quanto più inconsapevole - della violenza degradante e dei veri, immensi genocidi del nuovo fascismo.
Perché tale complicità col vecchio fascismo e perché tale accettazione del nuovo fascismo?
Perché c’è - ed eccoci al punto - un’idea conduttrice sinceramente o insinceramente comune a tutti: l’idea cioè che il male peggiore del mondo sia la povertà e che quindi la cultura delle classi povere deve essere sostituita con la cultura della classe dominante.
In altre parole la nostra colpa di padri consisterebbe in questo: nel credere che la storia non sia e non possa essere che la storia borghese.
* Pier Paolo Pasolini, Lettere luterane. Roma 1991, 5-12.
*SUL TEMA, IN RETE E NEL SITO, SI CFR.:
FACHINELLI, PASOLINI E IL LORO DIALOGO IN-INTERROTTO ... (Alfabeta 2, 28.06.2018)
CON KANT E FREUD, OLTRE. Un nuovo paradigma antropologico: la decisiva indicazione di ELVIO FACHINELLI
UN NUOVO UMANESIMO?! Pensare l’ "edipo completo"(Freud), a partire dall’ "infanticidio"!!!
EUROPA: EDUCAZIONE SESSUALE ED EDUCAZIONE CIVICA. ITALIA "NON CLASSIFICATA"!!! Per aggiornamento, un consiglio di Freud del 1907 - con una nota introduttiva
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- Il coronavirus è il nostro miglior specchio. Dovremmo avere il coraggio di guardarlo senza abbassare lo sguardo (di Filippo Barbera)..4 marzo 2020, di Federico La Sala
Coronavirus, il fatto «sociale totale» nel quale specchiarsi
di Filippo Barbera (il manifesto, 04.03.2020)
Un fatto sociale totale - nella definizione del grande antropologo Marcel Mauss - è qualcosa in grado di influenzare e determinare un insieme di fenomeni coinvolgendo la gran parte dei meccanismi di funzionamento della comunità di riferimento. Per Mauss il fatto sociale totale per antonomasia era il dono, in quanto capace di unire le pratiche e le cornici di senso riferibili ad aspetti mitopoietici, economici, politici, espressivi e religiosi. Il fatto sociale totale permetterebbe così di interpretare «pezzi» apparentemente lontani e diversi della stessa società.
Mani pulite, in questo senso, è stato un fatto sociale totale: ha scosso le diverse fondamenta della società italiana e ne ha messo in luce i tratti e le dinamiche politiche, culturali, economiche e simboliche. Oggi, il coronavirus svolge la stessa funzione. Ogni misura sanitaria e di igiene pubblica è intimamente politica, tanto nelle sue cause che nelle sue conseguenze, si intende. Ma le misure decise in occasione della comparsa del coronavirus rivelano - come un reagente chimico - qualcosa di profondo e «totale» sulla società e politica italiane, nonché sulle sue credenze diffuse, modelli culturali e struttura economica. Il coronavirus mostra con ogni possibile forza come la vita politica italiana sia intrappolata - non da oggi - in un’arena hobbesiana, dove la divisione fra amici e nemici si sovrappone ai confini fra gruppi in competizione per il potere e l’influenza. Dove è assente un contesto condiviso (la Costituzione, la Nazione, la Patria, la Repubblica, etc.) che permette a questi gruppi di competere correndo dei rischi politici.
Nelle arene hobbesiane il rischio politico è accuratamente evitato dai gruppi in competizione che utilizzano la logica amico/nemico. La strategia razionale in un contesto come questo è - di fronte a un evento improvviso e in assenza di esperienza pregressa - quella di minimizzare il rischio politico delle decisioni prese. Non poter essere accusati di non «aver fatto tutto il possibile» per le persone contagiate o per bloccare il contagio (a prescindere dalle sue conseguenze), non dover essere obbligati a rifiutare ricoveri in terapia intensiva ad anziani con febbre e polmonite, non diventare oggetto di attacchi e accuse stigmatizzanti.
Consideriamo le misure sanitarie. Quelle previste dal ministero con le tre classi di rischio e misure proporzionate sono intese a contenere i focolai in modo che si esauriscano all’interno e non si allarghino alle aree ancora indenni. Il tutto basato sull’assunzione che il danno di una epidemia diffusa o addirittura di una pandemia sia più alto dei danni sociali ed economici attesi. Questa assunzione sembra eccessiva, dato che per quanto se ne sa finora, la severità delle conseguenze di questa influenza un po’ più grave non sarebbe così alta, soprattutto in una stagione invernale con una influenza vera molto mite.
Ciò che giustifica le assunzioni alla base delle misure prese è la minimizzazione del rischio politico, il non volersi esporre alle accuse che certamente pioverebbero da nemici e falsi ex amici, anche in assenza di una giustificazione basata sul calcolo costi-benefici. La minimizzazione del rischio politico è una metrica ipertrofica che si «mangia» tutte le altre, riducendole a semplici giustificazioni ex post. Dall’assalto ai supermercati, alla speculazione sui prezzi delle mascherine, alle dichiarazioni dei politici, alla crisi dell’export, del polo della logistica e del turismo, il coronavirus è il nostro miglior specchio. Dovremmo avere il coraggio di guardarlo senza abbassare lo sguardo.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- L’ORAZIONE SULLA DIGNITA’ DELL’UOMO - A UNA DIMENSIONE. Di fronte a Pilato, e non capire un’acca?!1 marzo 2020, di Federico La Sala
L’ORAZIONE SULLA DIGNITA’ DELL’UOMO - A UNA DIMENSIONE.
Da Giovanni Pico della Mirandola* a Herbert Marcuse** e ...
CARO ARMANDO, PER IMPARARE "a vivere meglio senza lasciarci condizionare dalla paura della morte, cioè dalla religione, qualunque essa sia", CREDO CHE SIA NECESSARIO riconsiderare il problema di "come nascono i bambini" (a tutti i livelli)! Hai ragione: "Non possiamo permetterci, con le Sibille, Maria Vergine, Cristo come dio, Maometto ed altre favolette l’illusione di un altro Messia"! Ci siamo addormentati nella tradizione cattolico-costantiniana e illuministica acritica (contro Kant), e abbiamo finito per "concepire" noi stessi e noi stesse secondo la bio-logia e l’andro-logia “unidimensionale” dell’omuncolo!
L’«ECCE HOMO» di Ponzio Pilato, al contrario!, ci dice proprio questo - la fine delle "favolette" e di ogni "illusione di un altro Messia". Il discorso è di diritto e di fatto, romanamente universale, vale a dire, antropologico (non limitato all’«omuncolo» di qualche "uomo supremo" o “superuomo”!):
- PONZIO PILATO «disse loro: "Ecco, ve lo conduco fuori, affinché sappiate che non trovo in lui alcuna colpa". Uscì dunque Gesù, portando la corona di spine e il mantello di porpora. Pilato disse loro: "«Ecco l’uomo» (gr. «idou ho anthropos», vulg. «ecce homo»)". Vedendolo, i sommi sacerdoti e i loro inservienti gridarono: "Crocifiggi! Crocifiggi!" Disse loro Pilato: "Prendetelo voi e crocifiggetelo; io non trovo in lui colpa". Gli risposero gli Ebrei: "Noi abbiamo una legge e secondo questa legge deve morire, perché si è fatto figlio di Dio"» (Gv. 19, 4-7).
SE SIAMO ANCORA CAPACI DI LEGGERE, COSA VA SIGNIFICANDO NEL TEMPO LA LEZIONE DI PONZIO PILATO?! Non è una lezione critica contro i "sovranisti" laici e religiosi di ieri e di oggi?!
Che vogliamo fare? Continuare a riportare noi stessi e noi stesse davanti a Pilato e ripetere da scemi e da sceme la stessa scena, riascoltare il suo "Ecce Homo" e non capire una "H" (acca)?!
* Discorso sulla dignità dell’uomo.P.S. - RICORDANDO ... GLI ARCADI DI TERRA D’OTRANTO, VIRGILIO, E IL “VECCHIO DI CORICO”. A SOLLECITAZIONE E CONFORTO DELL’IMPRESA.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- IL "DIMENTICARE KANT!" DI GUSTAVO BONTADINI E "IL SIGNIFICATO DI EMANUELE SEVERINO NELLA FILOSOFIA ITALIANA". Note a margine di un incontro.18 febbraio 2020, di Federico La Sala
L’ASSASSINIO DI KANT, I CATTIVI MAESTRI E LA CATASTROFE DELL’EUROPA (COME DEGLI U.S.A.). LE "ALLEGRE" CONSEGUENZE DEL "DIMENTICARE KANT!" DI GUSTAVO BONTADINI ... *
- Casa della Cultura (17.02.2020) -
Salvatore Natoli, Carlo Sini: IL SIGNIFICATO DI EMANUELE SEVERINO NELLA FILOSOFIA ITALIANA (YouTube)
Ricordando Bontadini nel giorno della sua nascita
Intervista raccolta da padre Aldo Bergamaschi
- Il 27 marzo del 1903 nasceva a Milano Gustavo Bontadini, maestro di filosofia tra i più amati e ascoltati dell’Università Cattolica di Milano. Il prof. Carmelo Vigna, uno dei suoi allievi, lo ricorda così nel libro Bontadini e la metafisica: «Considero un privilegio della vita averlo potuto frequentare. A Bontadini devo molto: devo certamente quel poco che ho capitalizzato nei miei studi di metafisica. Anche quando sono stato costretto a dissentire, proprio per amore della metafisica e della sua verità. Del resto, so che a Lui piaceva anche il dissenso, nonostante tutto. Diceva infatti che dobbiamo sempre andare fin dove la ragione ci porta; ma anche diceva che dobbiamo sempre custodire gli affetti, specialmente quando ci accade di dover dissentire. L’importante è volersi bene, diceva».
- Per non dimenticare una stagione straordinaria della filosofia italiana e per introdurre i più giovani al pensiero di una delle intelligenze speculative più alte del nostro Novecento pubblichiamo un estratto della sua ultima e appassionante intervista raccolta da padre Aldo Bergamaschi e pubblicata integralmente nel volume Bontadini e la metafisica: ne viene fuori il tono di un maestro in grado di spiegare concetti raffinatissimi in parole semplici e con ironia. (Vita e Pensiero, 27.03.2015).
Domanda: Prof. Bontadini, se un oscuro ma assiduo frequentatoredel Perípatos avesse avuto l’opportunità di intervistare Aristotele con una macchina da presa, che cosa, secondo Lei, avrebbe dovuto chiedergli? Risposta: Beh, certo poteva chiedergli tante cose, presentargli tutto l’elenco delle cose che non sono accettabili nei suoi scritti, perché ce ne sono; ma se fossi stato io quell’oscuro frequentatore gli avrei chiesto - immagino di trovarlo ormai vecchio e quindi solo come sono tutti i vecchi, abbandonato: eh, ti sembra di essere stato giusto, equo col tuo maestro Platone, non senti qualche rimorsodi coscienza per averlo trattato come l’hai trattato? Intendo teoreticamente.
D: D’accordo, sicché Lei si sarebbe rivolto ad Aristotele teoretico e non certamente all’Aristotele empirico. Bene, io mi trovo nei medesimi panni, cioè io sono quest’oscuro intervistatore, però un assiduo frequentatore del Perípatos, diciamo, milanese. Le domando, anzitutto, quali sono i traguardi che Lei ha programmato e quali sono invece stati esplorati con successo?
R: Beh, i traguardi erano immensi, perché quando si è giovani non si pongono limiti alle proprie possibilità; poi, quelli che invece ho realizzato, sono pochissimi. Anzi, si riducono, si sono andati riducendo sempre di più; si riducono a quello che io e i miei amici chiamiamo volentieri il discorso breve, cioè l’essenzializzazione della metafisica dell’essere. Questo è un traguardo che ritengo ormai di avere sufficientemente conseguito: questa rigorizzazione del discorso metafisico.
D: D’accordo, ma prima di arrivare, appunto, alla discussione su questa rigorizzazione, io Le vorrei chiedere il risultato delle sue ricerche sullo gnoseologismo moderno. Può dirci, in breve, in che cosa consistono queste ricerche? R: Sì, la discussione dello gnoseologismo moderno è stata una delle tappe che ho dovuto percorrere per arrivare a quel risultato che ho detto prima, cioè per difendere e per fondare la metafisica e fare i conti col pensiero moderno, che è essenzialmente antimetafisico.
D: D’accordo.
R: E allora le analisi di struttura degli autori, dei grandi autori moderni, mi hanno, per dirlo naturalmente in modo sintetico, in brevi parole (perché il discorso qui sarebbe lunghissimo), mi hanno messo dinanzi questa situazione: la filosofia moderna è un ciclo di pensiero che fa dimenticare se stessa, perché la sua conclusione toglie il suo punto di partenza. Il suo punto di partenza è quello che io chiamo (e molti altri amici sono d’accordo nel chiamare) il presupposto realistico o il presupposto naturalistico: l’ammissione dogmatica della dualità di essere e di pensiero. La tematica, l’indagine dei filosofi moderni si svolge soprattutto su questo presupposto, traendone le conseguenze. La principale conseguenza è la concezione fenomenistica. Cioè: se l’essere è altro dal pensiero, ciò che noi conosciamo non è l’essere, ma è il fenomeno, ciò che appare. L’ulteriore passo della filosofia moderna può essere rappresentato (parlo sempre brevemente e sinteticamente, in forma molto approssimativa) dall’idealismo, il quale trae questa ulteriore conseguenza: se noi abbiamo a che fare soltanto col fenomeno, non possiamo neanche affermare l’esistenza del noumeno, e quindi il pensiero si chiude in qualche maniera in se stesso.
D: Scusi se La interrompo, ma se uno studente liceale Le dovesse chiedere una lezione breve sull’errore di Cartesio, Lei come strutturerebbe questa lezione breve?
R: Ecco, quello di Cartesio non è un errore; è anzi la presa di coscienza di una situazione speculativa in cui si trovava la sua epoca. Questa situazione speculativa Cartesio la eredita dalla tarda scolastica, dal tardo medioevo, come ha messo molto bene in luce Gilson, specialmente nel commento, nell’amplissimo commento fatto al Discours de la méthode, per mostrare quanti elementi medievali della tarda scolastica sono ancora presenti nella problematica cartesiana. Non è un errore. Anzi, il suo merito è quello di avere tratto le conseguenze di questo presupposto (e in metafisica, in buona dottrina, ogni presupposto deve essere eliminato e deve essere scartato); Cartesio ha indicato per quale via noi eravamo costretti a camminare sotto la pressione, sotto la spinta di questo presupposto, il quale ha portato poi alle varie tappe della filosofia moderna. In questo senso, Cartesio è stato veramente il padre della filosofia moderna.
D: Quindi Lei lo ritiene padre, ma c’è al fondo un errore? O non c’è? Ad esempio, lo smarrimento dell’essere?
R: C’è lo smarrimento dell’essere, e questo è un errore, ma non è di Cartesio, è del suo tempo; è di tutti. È un’eredità. È anche una condizione partecipe del senso comune che l’essere è qualche cosa di altro dal conoscere, no? È il cosiddetto realismo, al quale la filosofia moderna ha sostituito, dapprima il fenomenismo, e poi, addirittura, l’idealismo. Il significato speculativo dell’idealismo, con cui in qualche maniera si conclude il ciclo moderno, è il semplice toglimento del presupposto naturalistico - formalmente in quanto presupposto.
D: Ecco, abbia la cortesia di spiegarci in cosa consiste questo presupposto realistico.
R: È semplicissimo: è l’assunto che l’essere è altro dal pensiero. Io potrei dare - siamo nel secondo centenario della Critica della ragion pura, che fu pubblicata nel 1781 - ad uno studente di liceo, ma più che ad uno studente di liceo, anche a un contadino che incontrassi per la strada e mi chiedesse qualcosa di quest’opera, potrei dare, ecco, il più breve riassunto che si può fare di quest’opera (che consta di molte centinaia di pagine), ed è questo: dato che l’essere è altro dal pensiero, la scienza dell’essere, cioè la metafisica, non è possibile. Questo è il riassunto più sintetico della Critica della ragion pura. Poi c’è tutta quest’opera meravigliosa (da visitare), una delle opere più geniali che siano mai state scritte nella storia della filosofia. Vi si intrecciano una quantità di motivi che riguardano la possibilità della matematica come scienza, della fisica come scienza, poi l’esame di quelli che Kant riteneva fossero gli argomenti portati a sostegno della metafisica tradizionale. E allora qui, naturalmente, viene fatto subito di deliberare, da parte mia o da parte nostra, che la metafisica che Kant confutava non era assolutamente la metafisica classica: era strutturalmente diversa da quella che noi presentiamo come metafisica classica.
D: D’accordo. Adesso vorrei che, a conclusione di questo discorso sul dualismo gnoseologistico, come Lei lo chiama, ci risolvesse alcune perplessità dei cultori di scienze filmiche. Per esempio i cultori del linguaggio filmico sembrano accettare il dualismo gnoseologistico. Dicono: altra è la realtà, altro la sua immagine: l’evento non si identifica con la sua rappresentazione, quindi l’immagine di questo tavolo non è il tavolo. Ecco, io Le domando, filmicamente parlando, siamo o non siamo sull’essere?
R: Dunque, io sono ignorante in sede di filmologia; però direi che, dal punto di vista metafisico, è ente, cioè non nulla, sia l’immagine sia la realtà che il linguaggio filmico contrappone all’immagine stessa: sono tutte due realtà e vengono sia l’una che l’altra intenzionate dalla conoscenza. Il termine ‘intenzionare’ è importante, perché l’intenzionalità è proprio la figura che conclude tutta la vicenda del pensiero moderno e dà la possibilità di entrare in una nuova epoca.
D: D’accordo. Allora io tento di fare una verifica ulteriore. Noi conosciamo direttamente il tavolo o la immagine del tavolo?
R: Senz’altro il tavolo.
D: Conosciamo il tavolo, anche pur sapendo che il discorso filmico mi presenta una immagine del tavolo?
R: Sì, perché il dualismo filmico è un dualismo che è interno al non-dualismo della conoscenza umana. È un dualismo interno; cioè: dall’interno del globo della conoscenza umana si elevano questi due ordini, l’ordine filmico e l’ordine di quella verità che viene contrapposta a quella filmica.
D: Vediamo se riesco a identificare il senso di questo discorso: la realtà trascende la rappresentazione empirica, ma non trascende il pensiero. Dunque, il pensiero sarebbe comunque sulla realtà?
R: Certo, in ogni caso non si trascende il pensiero: è questa la verità.
D: Abbia la cortesia di spiegare il significato di questa frase.
R: Ecco: l’intrascendibilità del pensiero è la formula un po’ banalizzata dell’idealismo. Vero: fuori del pensiero non si salta, perchè se io dico che c’è una realtà che trascende il pensiero, per ciò stesso l’ho già pensata e quindi ricondotta dentro il pensiero.
D: D’accordo.
R: Ma, anche stando nella semplice orbita dell’Unità dell’Esperienza, o se vogliamo dire dell’esperienza, della percezione...
D: Scusi se La interrompo, Professore: questa ‘Unità dell’Esperienza’ è un’espressione che Lei ha introdotto cinquant’anni fa. Adesso direi che ha l’onere di spiegarla a chi la udisse per la prima volta.
R: Sì. L’Unità dell’Esperienza è la totalità delle cose che sono presenti e che vengono affermate in base al loro esser presenti.
D: Per esempio?
R: Tutto ciò che io constato, tutto ciò di cui io posso dire ‘consta’. Tutti quei giudizi che possono essere giustificati, fondati con questa formula: ‘perché consta’. Ad esempio: questo tavolo è di colore amaranto. Perché? Perché mi consta che sia di colore amaranto, perché è sperimentalmente dato, empiricamente dato che è tale. In questo momento è giorno, perché constato che in questo momento è giorno. Perché consta. Quindi l’Unità dell’Esperienza è l’unità dei dati, come tale.
D: Quindi, successivamente, noi cosa dovremmo scoprire? Che il dato è là e io sono?...
R: No. Io sono un dato. l’Unità dell’Esperienza include l’io, perché anche l’io nella forma dell’autocoscienza è dato. L’io è un dato. È un dato che l’esperienza è polare, cioè che ha la polarità del soggetto e dell’oggetto; io che ho presente questo tavolo, questo tavolo che è presente a me.
D: Quindi sarebbe la compresenza.
R: Nell’Unità dell’Esperienza è presente che le cose sono presenti a me. Questo è un rilievo fondamentale in ordine alla determinazione della struttura dell’Unità dell’Esperienza. L’Unità dell’Esperienza è la totalità delle cose presenti, ma c’è una caratteristica di queste cose presenti: anzitutto è quella di essere presenti, ma poi - determinatamente - di essere presenti a; in questo caso all’io, a me, a un soggetto.
D: D’accordo, adesso Le faccio una domanda che implica un riferimento storico. A Suo parere san Tommaso era immerso nell’errore gnoseologistico, cioè nel dualismo gnoseologistico, oppure aveva guadagnato questa Unità dell’Esperienza come punto di partenza?
R: Beh, che avesse proprio guadagnato l’Unità dell’Esperienza come punto di partenza, forse no; perché, altrimenti, io non avrei avuto niente da fare, se l’avesse guadagnata lui - va bene? Però, se san Tommaso fosse o non fosse libero dal presupposto gnoseologistico, questo è un argomento di esegesi storica molto interessante. San Tommaso era un aristotelico e un grande commentato-re di Aristotele. Ora, Aristotele era certamente immune dal presupposto dualistico.
D: Era immune?
R: Era immune, perchè era un suo teorema fondamentale che il ‘conoscente in atto’ e il ‘conosciuto in atto’ si identificano, e questa è già l’eliminazione del presupposto dualistico. Aristotele poi aggiunge che il ‘conoscente in potenza’ e il ‘conosciuto in potenza’ si distinguono, ma di questo essere distinti in potenza egli dà una fondazione; e in quanto dà una fondazione, riscatta il presupposto come presupposto: la fondazione è metafisica.
D: Probabilmente ci siamo avvicinati... ma io sto pensando a un ipotetico liceista, ecco... che...
R: Beh, ma forse se Lei mi farà altre domande che riguardino questi problemi fondamentali, potremmo dare una risposta esauriente anche per il liceista... di primo anno!
: Quindi, torniamo brevemente al discorso dell’inganno dei sensi, no? L’errore dei sensi...
R: No, ma il senso non inganna dice san Tommaso. Le ricordo che san Tommaso dice ‘il senso non inganna’, vero?
D: Quando io vedo il legno spezzato nell’acqua, in che cosa consisterebbe l’errore?
R: L’errore consisterebbe nel ritenere che, se io andassi a toccare il legno, lo troverei spezzato, mentre invece non lo trovo spezzato. Questo è un giudizio. La vista non mi inganna, perché è empiricamente dato che il legno si presenta come spezzato. È un giudizio ulteriore quando dico, io che vedo una torre in lontananza che mi sembra circolare, mentre è quadrata, che allora c’è un’illusione. Ma l’illusione in cosa consiste? La torre appare circolare, e, nella misura in cui appare, essa è tale. Poi, se usciamo anche da questo paragone della torre, e pensiamo al sogno, io sogno che accadono certe cose. Nella misura in cui quelle cose sono sognate, sono reali. Quindi non c’è nessun inganno. L’inganno consisterebbe nel giudizio che volesse riferire ad una realtà ulteriore al sogno, quella che si rivela nel sogno.
D: D’accordo, credo che questi esempi siano abbastanza chiari. Adesso dalla gnoseologia passiamo alla metafisica. Anzitutto Le domando: è davvero impossibile la metafisica dopo Kant oppure Lei ritiene che sia invece possibile?
R: Beh, dopo cinquant’anni di meditazione, ritengo che sia possibile, perché... ab esse ad posse valet illatio; perché la metafisica si costruisce! Quando io ero studente c’era lo slogan del dopo Kant: certe cose dopo Kant non si possono più sostenere, e quindi dopo Kant non si poteva più sostenere che fosse possibile la metafisica. Ma una attenta considerazione di quella metafisica che Kant criticava ci rende subito edotti che la struttura di tale metafisica ha poco a che vedere con la struttura di quella che noi chiamiamo la metafisica classica e che è quella che noi intendiamo difendere e sostenere. La metafisica classica è fuori dalla portata della critica kantiana; e, naturalmente, il discorso per mostrare questo dovrebbe essere abbastanza complesso, ma è un discorso che ormai in qualche maniera abbiamo messo al sicuro. Ritengo di averlo messo al sicuro.
* SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
L’ATTIVISMO ACCECANTE DEL "FAR WEST" E IL "SAPERE AUDE" DELLA "CRITICA DELLA RAGION PURA": JOHN DEWEY SPARA A ZERO SU KANT, SCAMBIATO PER UN VECCHIO FILOSOFO "TOLEMAICO". Alcune sue pagine da "La ricerca della certezza" del 1929, con alcune note
- Perché si vuole uccidere Kant? Una breve nota sull’ultimo lavoro di Maurizio Ferraris, "Goodbye Kant!"
ORIENTARSI, OGGI - E SEMPRE. LA LEZIONE IMMORTALE DI KANT, DALLA STIVA DELLA "NAVE" DI GALILEI.
Federico La Sala
- Casa della Cultura (17.02.2020) -
Salvatore Natoli, Carlo Sini: IL SIGNIFICATO DI EMANUELE SEVERINO NELLA FILOSOFIA ITALIANA (YouTube)
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- "SPIEGAZIONI FILOSOFICHE": "LA MACCHINA DELL’ESPERIENZA" E IL "PRINCIPIO DI CARITÀ".29 gennaio 2020, di Federico La Sala
Semplicità insormontabili
La macchina dell’esperienza
di Roberto Casati e Achille Varzi *
Lui (in vacanza, seduto in riva al mare, con fare filosofico). Che bella cosa, la felicità!
 Lei. Non ti facevo così saggio.
Lei. Non ti facevo così saggio.
 Lui. Non scherzare. La felicità è una bella cosa e non c’è niente di male nel ripetercelo, di tanto in tanto. E ti dirò di più: gli edonisti avevano perfettamente ragione. Non è forse massimizzando il piacere che si può essere felici? Il piacere provoca felicità, quindi, più si prova piacere, più si è felici.
Lui. Non scherzare. La felicità è una bella cosa e non c’è niente di male nel ripetercelo, di tanto in tanto. E ti dirò di più: gli edonisti avevano perfettamente ragione. Non è forse massimizzando il piacere che si può essere felici? Il piacere provoca felicità, quindi, più si prova piacere, più si è felici.
 Lei. Addio saggezza. Guarda che il nesso tra piacere e felicità è ben più spurio di quanto pensassero gli edonisti.
Lei. Addio saggezza. Guarda che il nesso tra piacere e felicità è ben più spurio di quanto pensassero gli edonisti.
 Lui. A me non sembra proprio. Per me è un piacere essere qui, ed è proprio perché sto provando questo piacere che sono felice.
Lui. A me non sembra proprio. Per me è un piacere essere qui, ed è proprio perché sto provando questo piacere che sono felice.
 Lei. C’è un argomento di Robert Nozick che dimostrerebbe il contrario. Mai sentito parlare della "macchina dell’esperienza"?
Lei. C’è un argomento di Robert Nozick che dimostrerebbe il contrario. Mai sentito parlare della "macchina dell’esperienza"?
 Lui. Sentiamo.
Lui. Sentiamo.
 Lei. La macchina dell’esperienza è un vero e proprio prodigio tecnologico. Funziona così: tu entri nella macchina, e quella è in grado di procurarti qualunque esperienza tu possa desiderare. C’è un casco, con degli elettrodi, e se lo indossi ecco che il tuo cervello viene stimolato in modo, appunto, da farti provare le sensazioni che vuoi. Desideri sperimentare che cosa si prova a scrivere una bella poesia, vincere un premio, innamorarsi di una persona, sentirsi ricambiati del proprio amore? Indossa il casco e voilà: proverai esattamente quelle sensazioni in modo assolutamente realistico.
Lei. La macchina dell’esperienza è un vero e proprio prodigio tecnologico. Funziona così: tu entri nella macchina, e quella è in grado di procurarti qualunque esperienza tu possa desiderare. C’è un casco, con degli elettrodi, e se lo indossi ecco che il tuo cervello viene stimolato in modo, appunto, da farti provare le sensazioni che vuoi. Desideri sperimentare che cosa si prova a scrivere una bella poesia, vincere un premio, innamorarsi di una persona, sentirsi ricambiati del proprio amore? Indossa il casco e voilà: proverai esattamente quelle sensazioni in modo assolutamente realistico.
 Lui. Ma un conto è provarle davvero, quelle sensazioni; altro conto provarle dentro una macchina del genere.
Lui. Ma un conto è provarle davvero, quelle sensazioni; altro conto provarle dentro una macchina del genere.
 Lei. Funziona in modo tale che mentre le provi non hai alcuna consapevolezza del fatto di essere all’interno della macchina.
Lei. Funziona in modo tale che mentre le provi non hai alcuna consapevolezza del fatto di essere all’interno della macchina.
 Lui. E se io non desidero niente in particolare?
Lui. E se io non desidero niente in particolare?
 Lei. Gli ingegneri che hanno progettato la macchina si sono ben documentati e hanno fatto in modo che la macchina disponga, per così dire, di un menù veramente ricco di possibilità. Quindi, se vuoi, puoi davvero provare ogni tipo di esperienza, non solo quelle che ti vengono in mente. E naturalmente il menù è richissimo di esperienze piacevoli, ovvero esperienze di piacere.
Lei. Gli ingegneri che hanno progettato la macchina si sono ben documentati e hanno fatto in modo che la macchina disponga, per così dire, di un menù veramente ricco di possibilità. Quindi, se vuoi, puoi davvero provare ogni tipo di esperienza, non solo quelle che ti vengono in mente. E naturalmente il menù è richissimo di esperienze piacevoli, ovvero esperienze di piacere.
 Lui. Quindi, se voglio, posso entrare nella macchina e starci dentro tutta la vita, pre-programmando le cose in modo tale da provare piacere per tutti i giorni che mi restano da vivere?
Lui. Quindi, se voglio, posso entrare nella macchina e starci dentro tutta la vita, pre-programmando le cose in modo tale da provare piacere per tutti i giorni che mi restano da vivere?
 Lei. Esattamente. Il punto è: lo faresti? Entreresti in una macchina così con la garanzia di provare piacere per il resto della tua vita?
Lei. Esattamente. Il punto è: lo faresti? Entreresti in una macchina così con la garanzia di provare piacere per il resto della tua vita?
 Lui. Ovvio!
Lui. Ovvio!
 Lei. Secondo Nozick, no. Non solo non ci entrerebbe lui, ma pensa che nemmeno noi ci entreremmo.
Lei. Secondo Nozick, no. Non solo non ci entrerebbe lui, ma pensa che nemmeno noi ci entreremmo.
 Lui. E perché mai?
Lui. E perché mai?
 Lei. Per tre motivi. Primo: generalmente vogliamo fare certe cose, non solo provare l’esperienza di farle. Anzi, è proprio perché le vogliamo fare che ci sottoponiamo all’esperienza di farle. Invece la macchina fa il contrario. Secondo, vogliamo essere felici di ciò che siamo. Cioè vogliamo essere delle persone felici. Ma che persone saremmo, se ci chiudessimo nella macchina per il resto della nostra vita?
Lei. Per tre motivi. Primo: generalmente vogliamo fare certe cose, non solo provare l’esperienza di farle. Anzi, è proprio perché le vogliamo fare che ci sottoponiamo all’esperienza di farle. Invece la macchina fa il contrario. Secondo, vogliamo essere felici di ciò che siamo. Cioè vogliamo essere delle persone felici. Ma che persone saremmo, se ci chiudessimo nella macchina per il resto della nostra vita?
 Lui. Beh, per la felicità si può anche rinunciare a essere delle persone...
Lui. Beh, per la felicità si può anche rinunciare a essere delle persone...
 Lei. Terzo, nella macchina non avremmo alcuna esperienza della realtà: proveremmo esperienze realistiche, ma sarebbero comunque esperienze di una realtà del tutto artificiale, virtuale. Un po’ come i cervelli nella vasca ipotizzati da Putnam, o i personaggi del film Matrix, mentre "combattono" contro l’agente Smith stando sdraiati nelle loro poltrone in laboratorio.
Lei. Terzo, nella macchina non avremmo alcuna esperienza della realtà: proveremmo esperienze realistiche, ma sarebbero comunque esperienze di una realtà del tutto artificiale, virtuale. Un po’ come i cervelli nella vasca ipotizzati da Putnam, o i personaggi del film Matrix, mentre "combattono" contro l’agente Smith stando sdraiati nelle loro poltrone in laboratorio.
 Lui. Vieni al punto.
Lui. Vieni al punto.
 Lei. Il punto è che provare piacere non basta. Anche ammesso che sia un importante ingrediente in una ricetta per la felicità, bisogna provarlo nel modo giusto.
Lei. Il punto è che provare piacere non basta. Anche ammesso che sia un importante ingrediente in una ricetta per la felicità, bisogna provarlo nel modo giusto.
 Lui. Sarà come dici. Però questi esperimenti mentali lasciano un po’ il tempo che trovano.
Lui. Sarà come dici. Però questi esperimenti mentali lasciano un po’ il tempo che trovano.
 Lei. A me non pare affatto un esperimento mentale. Non ti sembra che questo nostro mondo si stia trasformando in una grande macchina dell’esperienza, non molto diversa da quella ipotizzata da Nozick?
Lei. A me non pare affatto un esperimento mentale. Non ti sembra che questo nostro mondo si stia trasformando in una grande macchina dell’esperienza, non molto diversa da quella ipotizzata da Nozick?* Il Sole-24 Ore, 24.11. 2013.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
 Dipartimento Lettere e Filosofia
Dipartimento Lettere e Filosofia
 Corso di Laurea in FILOSOFIA.
Corso di Laurea in FILOSOFIA.
 Supervisore: Prof. Varzi Achille Carlo,
Supervisore: Prof. Varzi Achille Carlo,
 Co-Supervisore: Prof. Ghia Francesco,
Co-Supervisore: Prof. Ghia Francesco,
 Laureando: GANDELLINI Francesco
Laureando: GANDELLINI FrancescoIL PRINCIPIO DI CARITÀ [2016]
Definizione e analisi critica tra ermeneutica e logica
a cura di Francesco Gandellini **
- La tesi si preoccupa di analizzare l’origine e il decorso storico del principio di carità o benevolenza, con particolare riferimento alla linea etico-ermeneutica e alla linea logico-ontologica, al fine di metterne in luce gli aspetti significativi che lo identificano e ne caratterizzano l’uso nella storia della filosofia.
- SOMMARIO
- Introduzione ...................... 1
 Sezione 1: il versante ermeneutico......... 5
Sezione 1: il versante ermeneutico......... 5
 1.1 La genesi agostiniana del principio ......... 7
1.1 La genesi agostiniana del principio ......... 7
 1.2 L’illuminismo tedesco e il nesso linguaggio-mondo ....... 23
1.2 L’illuminismo tedesco e il nesso linguaggio-mondo ....... 23
 1.2.1 Wilhelm von Humboldt: “Sprachansicht als Weltansicht” .......... 27
1.2.1 Wilhelm von Humboldt: “Sprachansicht als Weltansicht” .......... 27 - APPENDICE Georg Friedrich Meier e il “Versuch einer allgemeinen Auslegungkunst” ............... 43
 1.3 La linea ontologica dell’ermeneutica contemporanea ........... 53
1.3 La linea ontologica dell’ermeneutica contemporanea ........... 53
 1.3.1 Martin Heidegger e l’analitica esistenziale di “Sein und Zeit” ............. 55
1.3.1 Martin Heidegger e l’analitica esistenziale di “Sein und Zeit” ............. 55
 1.3.2 Hans-Georg Gadamer e l’ermeneutica ontologica di “Warheit und Methode“ ....... 69
1.3.2 Hans-Georg Gadamer e l’ermeneutica ontologica di “Warheit und Methode“ ....... 69 - Sezione 2: la riflessione logica ............... 85
 2.1 Fondamenti teorici della carità in logica ...................... 87
2.1 Fondamenti teorici della carità in logica ...................... 87 - α ) La riflessione filosofica di Ludwig Wittgenstein .......... 89
- β) L’ipotesi della relatività linguistica ....... 100
 2.2 Willard van Orman Quine e l’argomento di “traduzione radicale” ................ 113
2.2 Willard van Orman Quine e l’argomento di “traduzione radicale” ................ 113
 2.3 Donald Davidson e l’interpretazione radicale ................ 137
2.3 Donald Davidson e l’interpretazione radicale ................ 137
 Conclusione .................. 157
Conclusione .................. 157
 Bibliografia ............... 161
Bibliografia ............... 161
 Sitografia..................... 163
Sitografia..................... 163
INTRODUZIONE
Il termine “carità” deriva etimologicamente dal latino caritas (acc. caritatem, «benevolenza», «amore», questo da carus, «caro», «costoso», «diletto», «amato»), e a sua volta dal greco χάρις, «grazia». Dal punto di vista dell’etimo, la parola cattura l’idea dell’amore disinteressato ma prezioso verso qualcuno, della benevolenza gratuitamente concessa al destinatario, senza riserve rispetto alla sua condizione. Gli etimologisti latini derivavano il lemma carus dalla prima persona singolare del presente del verbo carēre, ovvero careo, «manco», «sono privo di», e ritenevano di giustificare il valore di una cosa sul metro della mancanza della cosa stessa, in modo tale che tanto più se ne avverte l’assenza, tanto più essa acquista valore e pregio.
 Passando per il greco χάρις e dal verbo χαίρω, «rallegrarsi», «provare piacere», si arriva alla radice sanscrita ka = ca (sscr. ka, kan, kam), presente in parole quali kâma, «amore», kamana, «desiderabile», «bello», kamara, «amoroso», kam-e, «desiderò», «amò». Si possono, inoltre, trovare affinità nel lettone kahrs, «cupido», nel gotico hors, da cui il tedesco Hure, «meretrice», ma che si riallaccia al latino quaero, «cercare», «ricercare», «bramare» ciò che è desiderato. Il termine “carità” afferisce, dunque, anche alla sfera dell’amore desiderato, del richiesto perché bramosamente bello e capace di dare piacere e rallegrare.
Passando per il greco χάρις e dal verbo χαίρω, «rallegrarsi», «provare piacere», si arriva alla radice sanscrita ka = ca (sscr. ka, kan, kam), presente in parole quali kâma, «amore», kamana, «desiderabile», «bello», kamara, «amoroso», kam-e, «desiderò», «amò». Si possono, inoltre, trovare affinità nel lettone kahrs, «cupido», nel gotico hors, da cui il tedesco Hure, «meretrice», ma che si riallaccia al latino quaero, «cercare», «ricercare», «bramare» ciò che è desiderato. Il termine “carità” afferisce, dunque, anche alla sfera dell’amore desiderato, del richiesto perché bramosamente bello e capace di dare piacere e rallegrare.
 Il principio di carità rappresenta un criterio prezioso, disinteressato ma richiesto nella logica del dialogo. Esso fornisce una norma fondante, sebbene implicita, per la costruzione di un confronto fecondo e esente da appropriazioni o strumentalizzazioni di qualunque sorta. Il valore apportato dal principio di carità consiste, forse banalmente, nel rendersi disponibile all’ascolto dell’altro e nell’attribuire pregnanza di senso alle sue parole, almeno fino a un evidente punto di non ritorno.
Il principio di carità rappresenta un criterio prezioso, disinteressato ma richiesto nella logica del dialogo. Esso fornisce una norma fondante, sebbene implicita, per la costruzione di un confronto fecondo e esente da appropriazioni o strumentalizzazioni di qualunque sorta. Il valore apportato dal principio di carità consiste, forse banalmente, nel rendersi disponibile all’ascolto dell’altro e nell’attribuire pregnanza di senso alle sue parole, almeno fino a un evidente punto di non ritorno.
 La scelta di trattare il principio di carità come argomento di tesi va incontro alla necessità di indagare l’implicito, il sottinteso, il banale che sovente viene trascurato e passato sotto silenzio, col rischio di dimenticarne la validità e l’utilità concreta e portante nell’ambito dell’umano. Si tratta, perciò, di far riermegere agli occhi della coscienza i fondamenti troppo spesso dati per scontato e, proprio per questo, dimenticati, abbandonati e relegati a relitti a margine dell’edificio del sapere.
La scelta di trattare il principio di carità come argomento di tesi va incontro alla necessità di indagare l’implicito, il sottinteso, il banale che sovente viene trascurato e passato sotto silenzio, col rischio di dimenticarne la validità e l’utilità concreta e portante nell’ambito dell’umano. Si tratta, perciò, di far riermegere agli occhi della coscienza i fondamenti troppo spesso dati per scontato e, proprio per questo, dimenticati, abbandonati e relegati a relitti a margine dell’edificio del sapere.
 È compito primario della filosofia conferire dignità conoscitiva a quanto viene accolto come evidente, ovvio, lapalissiano perché in ciò, e nel suo oblio, si possono rinvenire “proprio quei problemi che sono i più scottanti per l’uomo, il quale, nei nostri tempi tormentati, si sente in balìa del destino” 1, ossia quegli interrogativi umani centrali in cui ne va della quotidianità tanto quanto dell’esistenza intera, oltre che di una convivenza pacifica. Spingendo la riflessione in direzione di ciò che pare assodato e fuori di dubbio ai fini della riflessione stessa, si giunge a capire e a rendere ragione di una complessità nuova, nella quale si gioca qualcosa come la comprensione o il fraintendimento tra gli individui.
È compito primario della filosofia conferire dignità conoscitiva a quanto viene accolto come evidente, ovvio, lapalissiano perché in ciò, e nel suo oblio, si possono rinvenire “proprio quei problemi che sono i più scottanti per l’uomo, il quale, nei nostri tempi tormentati, si sente in balìa del destino” 1, ossia quegli interrogativi umani centrali in cui ne va della quotidianità tanto quanto dell’esistenza intera, oltre che di una convivenza pacifica. Spingendo la riflessione in direzione di ciò che pare assodato e fuori di dubbio ai fini della riflessione stessa, si giunge a capire e a rendere ragione di una complessità nuova, nella quale si gioca qualcosa come la comprensione o il fraintendimento tra gli individui.
 Il principio di carità è una guida rimasta finora col capo coperto. Esso ha condotto e conduce gli uomini nei meandri tortuosi della comunicazione, del rapporto dialogante e dell’interpretazione reciproca. Può pregiudicare il buon andamento di una discussione, rimanendo nell’anonimato e nell’ombra. Determina e garantisce lo spazio minimo per l’intesa e l’accordo, ma può anche sancirne il definitivo naufragio.
Il principio di carità è una guida rimasta finora col capo coperto. Esso ha condotto e conduce gli uomini nei meandri tortuosi della comunicazione, del rapporto dialogante e dell’interpretazione reciproca. Può pregiudicare il buon andamento di una discussione, rimanendo nell’anonimato e nell’ombra. Determina e garantisce lo spazio minimo per l’intesa e l’accordo, ma può anche sancirne il definitivo naufragio.
 Lo scopo della presente trattazione è di portarne alla luce, in un percorso storico e tematico, le caratteristiche principali, in modo da scoprirne il capo e segnalarne i lineamenti distintivi. La filosofia, nel suo decorso storico, si è raramente rivolta in modo esplicito al principio di carità. Fatta eccezione per Agostino, per il caso isolato dell’illuminista tedesco Georg Meier (che lo chiama principio di equità ermeneutica) e per la riflessione dei logici contemporanei (Wilson, Quine, Davidson), esso non viene pressoché mai menzionato o, almeno, non con questo appellativo con cui, soprattutto recentemente, è tornato alla ribalta.
Lo scopo della presente trattazione è di portarne alla luce, in un percorso storico e tematico, le caratteristiche principali, in modo da scoprirne il capo e segnalarne i lineamenti distintivi. La filosofia, nel suo decorso storico, si è raramente rivolta in modo esplicito al principio di carità. Fatta eccezione per Agostino, per il caso isolato dell’illuminista tedesco Georg Meier (che lo chiama principio di equità ermeneutica) e per la riflessione dei logici contemporanei (Wilson, Quine, Davidson), esso non viene pressoché mai menzionato o, almeno, non con questo appellativo con cui, soprattutto recentemente, è tornato alla ribalta.
 Si tratta, quindi, e questo è l’intento del lavoro, di rimarcarne gli aspetti costituivi, laddove il criterio sia stato suggerito dagli autori, oppure di ricercare ed enucleare possibili edizioni, implicitamente consegnate dai filosofi alla riflessione sul principio in questione. Per questo la tesi potrebbe soffrire di discontinuità più o meno consistenti, dettate appunto dall’esigenza di scandagliare le profondità del pensiero filosofico, anche mediante salti temporali e concettuali rilevanti, in quei punti ritenuti significativi per una trattazione ampia e pregnante, ma filtrata sempre nel setaccio della carità ermeneutica e logica.
Si tratta, quindi, e questo è l’intento del lavoro, di rimarcarne gli aspetti costituivi, laddove il criterio sia stato suggerito dagli autori, oppure di ricercare ed enucleare possibili edizioni, implicitamente consegnate dai filosofi alla riflessione sul principio in questione. Per questo la tesi potrebbe soffrire di discontinuità più o meno consistenti, dettate appunto dall’esigenza di scandagliare le profondità del pensiero filosofico, anche mediante salti temporali e concettuali rilevanti, in quei punti ritenuti significativi per una trattazione ampia e pregnante, ma filtrata sempre nel setaccio della carità ermeneutica e logica.1 E. HUSSERL, La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, Milano, il Saggiatore 2008, pag. 35
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- L’INNO ALLA "CARITÀ" DI SAN PAOLO. LA CARITÀ dal GRECO (χάρις - χάριτος: "chàris" - "chàritos"; accusativo pl.: " χάριτας" - “chàritas” - dono, grazia) NON dal LATINO (“Caritas” - da “carus”, che - come nell’ italiano, "caro" - ha il doppio senso di “affetto” e "caro-prezzo" ... e richiama le "carenze" affettive ed economiche e la "carestia" - e non l’eu-charis-tia"!!!).
LA QUESTIONE DELLA "H".... "Capire il comportamento umano. Azione, razionalità, empatia" (di Antonio Rainone).
SANT’AGOSTINO, DOTTORE DELLA GRAZIA ("CHARIS"): "ECCO DA DOVE COMINCIA L’AMORE" ("ECCE UNDE INCIPIT CHARITAS").
IL NOME DI DIO, SENZA GRAZIA ("CHARIS")! L’ERRORE FILOLOGICO E TEOLOGICO DI PAPA BENEDETTO XVI, NEL TITOLO DELLA SUA PRIMA ENCICLICA. Nel nome della "Tradizione"
- «L’Italia è il paese classico dell’ospitalità (...). Ma lo spirito evangelico non ha saputo trasformarsi nella forma moderna della solidarietà e dell’organizzazione disinteressata e civile (...). L’assistenza, che è un diritto, diventa un regalo, una umiliante carità, che si può e non si può fare» (A. Gramsci, Odio gli indifferenti, pp.13 e 14).
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- PER LA CRITICA DELLA RAGIONE "OLIMPICA". Il discorso di Greta Thunberg alle Nazioni unite e altri appunti.28 gennaio 2020, di Federico La Sala
Editoriale
PER LA CRITICA DELLA RAGIONE "OLIMPICA" .... *
Il discorso di Greta Thunberg alle Nazioni unite
di Greta Thunberg (il manifesto, 27.9.2019)
New York. E’ tutto sbagliato. Io non dovrei essere qui di fronte a voi. Dovrei essere a scuola dall’altra parte dell’oceano. Eppure venite tutti da me per avere speranza? Ma come osate! Voi avete rubato i miei sogni e la mia infanzia con le vostre vuote parole. Eppure io sono una persona fortunata.
Le persone soffrono. Le persone stanno morendo. Interi ecosistemi stanno crollando. Siamo all’inizio di un’estinzione di massa. E tutto ciò di cui riuscite a parlare sono i soldi e le favole della crescita economica infinita. Come osate!
Per più di 30 anni la scienza è stata di una chiarezza cristallina. Con che coraggio osate continuare a girarvi dall’altra parte e venire qui assicurando che state facendo abbastanza, quando la politica e le soluzioni necessarie non sono ancora nemmeno all’orizzonte.
Dite che “ci ascoltate” e che comprendete l’urgenza. Ma non importa quanto io sia triste e arrabbiata, non voglio crederci. Perché se comprendeste davvero la situazione e continuaste a non agire, allora sareste malvagi. E mi rifiuto di crederci.
L’idea più diffusa sul dimezzare le nostre emissioni in 10 anni ci dà solo il 50% di probabilità di rimanere al di sotto di 1,5 ° C e disinnescare così reazioni a catena irreversibili al di fuori del controllo umano.
Forse il 50% di probabilità è accettabile per voi. Ma questi numeri non includono i punti di non ritorno, la maggior parte dei circuiti di feedback, il riscaldamento aggiuntivo nascosto dall’inquinamento atmosferico tossico o gli aspetti di giustizia e di equità. Fanno anche affidamento sull’ipotesi che la mia generazione e quella dei miei figli riuscirà a risucchiare centinaia di miliardi di tonnellate di CO2 dall’atmosfera con tecnologie che oggi esistono a malapena.
Quindi un rischio del 50% non è semplicemente accettabile per noi - noi che dobbiamo convivere con le conseguenze.
Per avere una probabilità del 67% di rimanere al di sotto di un aumento della temperatura globale di 1,5 ° C - le migliori probabilità stimate dal Pannello intergovernativo sui cambiamenti climatici - il 1 ° gennaio 2018 il mondo aveva solo 420 gigatonnellate di anidride carbonica da poter rilasciare nell’atmosfera.
Oggi questa cifra è già sotto le 350 gigatonnellate. Come osate far finta che questo problema possa essere risolto con le solite soluzioni economiche e tecniche. Con i livelli di emissione odierni, la quantità di CO2 a disposizione sarà completamente sparita in meno di otto anni e mezzo.
Non ci saranno soluzioni o piani presentati secondo i dati di oggi. Perché questi numeri sono troppo scomodi. E voi non siete ancora abbastanza maturi per dire le cose come stanno.
Ci state deludendo e tradendo. Ma i giovani stanno iniziando a capire il vostro tradimento. Gli occhi di tutte le generazioni future sono su di voi. E se sceglierete di fallire, vi dico che non vi perdoneremo mai.
Non vi lasceremo andare via come se nulla fosse. Proprio qui, proprio adesso, è dove tracciamo la linea. Il mondo si sta svegliando. E il cambiamento sta arrivando, che vi piaccia o no.
* Testo del discorso all’Assemblea generale delle Nazioni unite di New York del 23 settembre 2019 (traduzione dall’inglese a cura di Matteo Bartocci).
*
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- PIANETA TERRA. Tracce per una svolta antropologica...
- MITO, FILOSOFIA, E TESSITURA: "LA VOCE DELLA SPOLETTA È NOSTRA" ("The Voice of the Shuttle is Ours").
STORIA E MITO. GIASONE, "L’OMBRA D’ARGO", E “VENTICINCINQUE SECOLI” DI LETARGO: "SE NON RIDIVENTERETE COME I BAMBINI, NON ENTRERETE NEL REGNO DEI CIELI" (Mt. 18, 3).
 DANTE, ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. Note per una riflessione storiografica
DANTE, ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. Note per una riflessione storiograficaGUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE (LA LEZIONE DI NELSON MANDELA).
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.
Federico La Sala
-
> LA PIÙ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA E POLITICA ITALIANA --- MERCATO E "SCUOLA IN CHIARO". Che si ricominci a parlare di classismo a scuola allora.27 gennaio 2020, di Federico La Sala
Libera scelta, competizione, classifiche: le tante facce delle diseguaglianze di classe nella scuola italiana
Il classismo in classe
di Marco Romito (Il Mulino, 27 gennaio 2020)
È trascorsa circa una settimana da quando i media nazionali hanno rilanciato la notizia di una scuola romana che, presentandosi sul suo sito internet, avrebbe caratterizzato le sue tre sedi in termini classisti. Come in altre occasioni, quando la scuola entra nel faro d’attenzione del dibattito pubblico, prevalgono il tono scandalizzato e una scarsa capacità di contestualizzare ciò che si sta riportando.
La gran parte della stampa nazionale ha trattato la notizia lasciando intendere che la scuola di via Trionfale mettesse in atto un’esplicita politica classista separando gli alunni nei suoi tre plessi in base al censo: “Ecco la scuola che divide gli alunni in base alla classe sociale”.
Si è poi compreso che il riferimento alla condizione socioeconomica degli studenti era ripreso da un rapporto di autovalutazione (Rav) compilato seguendo le indicazioni del ministero. Le scuole sono accompagnate nella compilazione del Rav da alcune domande guida, alcune delle quali fanno riferimento al background familiare degli studenti. In questo non c’è nulla di scandaloso poiché si tratta di informazioni di cui occorre tenere conto per attuare politiche scolastiche inclusive.
Il problema, però, è che da qualche anno si è fatta largo l’idea che le scuole debbano essere trasparenti, che debbano dar conto di ciò che sono, di ciò che fanno, dei risultati raggiunti e così via. E così i Rav, assieme a molti altri indicatori, sono visibili sulla piattaforma governativa “Scuola in chiaro”. Questo è in linea con un approccio di impronta neoliberale, teso cioè a fare del sistema scolastico un mercato che si regola attraverso le scelte informate delle famiglie. I sostenitori di questo approccio ritengono che in questo modo le scuole saranno portate a migliorarsi per attrarre studenti. Tuttavia, come mostra la vicenda di via Trionfale, alcune informazioni possono fornire un’indicazione alle famiglie perché scelgano la scuola più conforme al proprio status.
Così, al coro dell’indignazione, hanno preso parte anche il sottosegretario all’istruzione De Cristoforo e la neoministra Azzolina, che hanno sostenuto sia un errore fornire informazioni sul background socioeconomico degli studenti. La descrizione, in ultimo, è stata rimossa. Ma si ha l’impressione che si sia alzato un gran polverone che nasconde ciò che dice di voler mettere in luce dietro una coltre di facili semplificazioni e dietro la colpevolizzazione dell’operato di una singola scuola. Si ha l’impressione, soprattutto, che la scuola italiana possa continuare a essere classista purché non nomini la classe.
Una scuola che nasconde i riferimenti alle condizioni socioeconomiche dei propri studenti non è meno classista di una che li rende pubblici. Le informazioni sulla qualità “sociale” di una scuola circolano informalmente nelle reti dei genitori e queste informazioni orientano le scelte in modi che rafforzano la segregazione scolastica. Non possiamo nasconderci che molti dei giornali che usano toni scandalizzati per descrivere la vicenda di via Trionfale rilanciano ogni anno la classifica sulla qualità formativa delle scuole pubblicata dalla Fondazione Giovanni Agnelli. Questa classifica, pur utilizzando il concetto di qualità formativa, non è molto più di una classifica dello status socioeconomico delle scuole. Ecco, si può essere classisti, pur senza nominare la classe.
Può allora essere utile prendere questa vicenda come un’opportunità per mettere in fila qualche breve ragionamento a mente fredda. Senza farci distrarre dal dito che indica la luna, chiediamoci: in che modo la scuola italiana è classista?
Propongo un elenco, certamente non esaustivo, di pratiche e meccanismi che, lontano dai moti episodici di indignazione pubblica, riproducono il classismo nel banale scorrere della quotidianità scolastica. Ma una premessa è doverosa. Il classismo della scuola non è solo imputabile alla scuola, ma è l’esito di una complessa articolazione di problemi che riguardano più dimensioni. Per rimanere al caso della scuola di via Trionfale è evidente che il tema della segregazione scolastica è inscindibile da quello della segregazione abitativa. Così come è evidente che le disuguaglianze economiche, crescenti, non possono non accrescere il divario tra chi può permettersi un’istruzione di elevata qualità e chi no.
Nell’elenco che segue faccio però riferimento solo a ciò su cui può intervenire una politica strettamente scolastica, mi soffermo sugli aspetti che mi sembrano meno presenti nel dibattito pubblico e solo su ciò che è supportato dalla ricerca empirica.
- La scuola è classista ogni volta che richiede agli studenti di svolgere uno studio individuale (ad esempio i compiti a casa) ignorando del tutto le diverse risorse culturali, linguistiche e abitative a cui hanno accesso.
- La scuola è classista nei modi in cui gestisce l’allocazione degli insegnanti. Le scuole più ambite, quelle cioè dove secondo molti è più semplice e stimolante insegnare, hanno mediamente un corpo docente più stabile, più esperto e più formato.
- La scuola è classista quando boccia. Con buona pace di coloro che si rammaricano per la scomparsa della scuola selettiva di una volta, la scuola boccia ancora e boccia in larga misura studenti di bassa estrazione sociale. E quando boccia non offre opportunità ulteriori di apprendimento (la bocciatura non ha quasi mai ricadute in positivo in questo senso), ma attiva un processo di progressiva disaffezione che in molti casi porta all’abbandono precoce.
- La scuola è classista quando chiede a preadolescenti di 13-14 anni di scegliere tra un indirizzo liceale, tecnico o professionale in barba a qualsiasi considerazione non solo pedagogica o sociologica, ma anche di tipo economico. È uno snodo cruciale che sappiamo essere il principale meccanismo di riproduzione della disuguaglianza sociale nel nostro Paese.
- La scuola è classista quando di fronte a scelte importanti per definire le traiettorie scolastiche e sociali degli studenti mette in atto pratiche orientative che tendono a privilegiare gli studenti provenienti dai ceti medi e alti.
- In mancanza di interventi correttivi, è classista la scuola dell’autonomia quando l’utilizzo di modelli di governance "a rete" tende a favorire le scuole e i territori più ricchi di capitale sociale e più capaci di attivarsi nel campo scolastico in virtù di una posizione di privilegio.
- Il classismo si annida nel modo in cui si articolano procedure più o meno formalizzate che tendono a produrre forme di micro-segregazione all’interno della medesima scuola o all’interno della medesima classe. In che modo la scuola abdica al dettato costituzionale nei suoi tentativi di individualizzare gli obiettivi di apprendimento per le categorie che si ritiene abbiano bisogni speciali di apprendimento (Bes)? Chi lavora a scuola sa bene che i “Bes” (così vengono chiamati) sono in larga parte immigrati e studenti di bassa estrazione sociale.
- Il classismo dei sistemi educativi interroga il rapporto tra la scuola e la pluralità di esperienze culturali e di vita che caratterizzano le nostre società. Quali di queste esperienze culturali vengono valorizzate tra le mura scolastiche? Questa è una vecchia domanda attorno a cui si sono sviluppate importantissime riflessioni sociologiche, pedagogiche, antropologiche, che sembrano oggi cadute nell’oblio. In che modo questo tema viene trattato nella già scarsissima formazione per gli insegnanti?
Che la vicenda della scuola di via Trionfale ci aiuti allora a impostare il discorso nei giusti termini. Se non si vuole che la scuola sia classista, allora la classe occorre nominarla. E occorre nominarla ogni volta che in modi più o meno plateali si insinua nella vita scolastica creando separazioni e gerarchie.
 Occorre nominare la classe per smantellare tutti i meccanismi attraverso cui produce disuguaglianza. Per farlo, occorre aprire un tavolo di discussione che chiami a raccolta tutte quelle realtà, associazioni, docenti, movimenti, che provano a praticare ogni giorno una scuola anti-classista. Queste realtà sono innumerevoli e si muovono nel contesto di una politica governativa che (finora?) si è caratterizzata per aver largamente ignorato il problema: o meglio, che negli ultimi decenni ha attuato riforme che sembrano aver esacerbato processi presenti da sempre.
Occorre nominare la classe per smantellare tutti i meccanismi attraverso cui produce disuguaglianza. Per farlo, occorre aprire un tavolo di discussione che chiami a raccolta tutte quelle realtà, associazioni, docenti, movimenti, che provano a praticare ogni giorno una scuola anti-classista. Queste realtà sono innumerevoli e si muovono nel contesto di una politica governativa che (finora?) si è caratterizzata per aver largamente ignorato il problema: o meglio, che negli ultimi decenni ha attuato riforme che sembrano aver esacerbato processi presenti da sempre.Che si ricominci a parlare di classismo a scuola allora. Ma non per gridare al declino, allo scandalo, ma per avere coscienza della complessità e interconnessione tra le diverse dimensioni attraverso cui il classismo si produce e si impone.
 Per la sua capacità di favorire gli studenti privilegiati, il nostro Paese spicca nei confronti internazionali. Questo può generare rabbia, al peggio sconforto, ma se la politica e la scuola italiana raccoglieranno la sfida potremmo avere innumerevoli spazi per agire, per iniziare ad applicare il dettato costituzionale e per fare della scuola una vera palestra di democrazia.
Per la sua capacità di favorire gli studenti privilegiati, il nostro Paese spicca nei confronti internazionali. Questo può generare rabbia, al peggio sconforto, ma se la politica e la scuola italiana raccoglieranno la sfida potremmo avere innumerevoli spazi per agire, per iniziare ad applicare il dettato costituzionale e per fare della scuola una vera palestra di democrazia. -
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- Il dovere morale di preservare i valori moderni (di Francesco Bellusci).25 gennaio 2020, di Federico La Sala
GIORNO DELLA MEMORIA, PERCHÉ GLI EBREI?
Il dovere morale di preservare i valori moderni
di Francesco Bellusci (Casa della cultura, 24.01.2020)
“Perché gli ebrei?”. È questa la domanda che spesso giunge dal pubblico in coda alle manifestazioni del Giorno della Memoria, a scuola o in altri contesti, oppure rimane taciuta nel retro-pensiero, difficile da esternare, come se la sua imbarazzante e sconcertante semplicità, più che ad appagare una sete di conoscenza, sia diretta a placare l’angoscia che accompagna l’inevitabile senso di “colpa metafisica”, come l’avrebbe chiamata Karl Jaspers[1], cioè la colpa di essere “sopravvissuti” a loro, di avere goduto il privilegio della vita, ingiustamente e violentemente negata ai nostri simili, pur essendo, noi, lontani ed estranei ai soggetti direttamente imputabili della colpa politica o giuridica o morale di quel crimine spaventoso. Perché gli ebrei e non un’altra minoranza etnica o religiosa, allora? Perché la scelta del comodo capro espiatorio su cui polarizzare il risentimento e le frustrazioni di un popolo sconfitto in guerra e sconvolto dalla crisi economica è caduta sugli ebrei? Perché le ideologie del fascismo e del nazismo hanno fatto leva sull’antisemitismo e sulle leggi razziali contro gli ebrei per la loro cinica propaganda?
Hitler o Mussolini non hanno inventato il male, tantomeno l’antisemitismo. Certamente, però, in Germania, un’impressionante e contingente reazione favorita da enzimi ideologici (nazionalismo, darwinismo sociale, scientismo, xenofobia, razzismo), politici (la competizione accesa per il consenso in democrazie “giovani”, con istituzioni nascenti o fragili messe da subito a dura prova dalle conseguenze sociali ed economiche della Grande Guerra e, poi, dalle ripercussioni mondiali del primo “crac” della nuova potenza economica globale: gli Stati Uniti) e materiali e tecnologici (la disponibilità di burocrazie più efficienti, la sperimentazione di nuove armi letali) fece sì che dall’odio, dal disprezzo, dalla discriminazione nei confronti dell’ebreo si arrivasse, per la prima volta, al progetto efferato di un genocidio, concepito come un assassinio industrializzato di massa. E ha portato altri regimi fascisti come l’Italia o la Repubblica di Vichy a collaborarvi. Ma con la fine del nazifascismo, Hiroshima annunciava che l’irrazionale, la psicosi del potere, non si erano affatto ritirati dal mondo, subito piombato nella corsa agli armamenti e sempre sull’orlo dell’apocalisse nucleare. Un mondo dove la macchinazione tanatocratica di governi, laboratori scientifici e industria militare, in sinergia tra loro, sembravano preparare stavolta l’olocausto dell’umanità, al punto da far dire, provocatoriamente, al filosofo e storico della scienza Michel Serres, in un memorabile pamphlet:
- “Mi pare dimostrato che Hitler abbia vinto la guerra. Come si diceva dei Greci, che l’avevano vinta contro i Romani, dopo la loro disfatta. La sua paranoia, che non era individuale, ma storica, ha conquistato tutti gli Stati, investito la loro politica estera, e senza alcuna eccezione. Nessun capo di Stato si comporta, oggi, diversamente da lui, sul piano della strategia, della politica di armamento, della cecità completa rispetto ai fini perseguiti per mezzo di questi stocks. Nessuno di loro si comporta diversamente da lui rispetto all’abuso della scienza per scopi di morte”[2].
La fine del mondo bipolare, con la disintegrazione dell’Unione Sovietica, ha per fortuna allontanato la minaccia di un olocausto della specie umana, ma se, come ricordava Serres nel suo saggio, la paranoia di Hitler era storica, e non individuale, rimane da chiedersi ancora perché le vittime di quella paranoia, e dell’unico olocausto sinora avvenuto, siano state proprio gli ebrei. -Diventa interessante farlo tanto più che la risposta a questa domanda ci costringe a risalire a un periodo storico, l’ultimo quarto di secolo dell’Ottocento, con il quale secondo il politologo David Runciman[3], il momento storico attuale con il suo strisciante rigetto diffuso della democrazia liberale, del cosmopolitismo, della multietnicità, intrattiene più analogie.
Allora si consumò, infatti, il più pericoloso cortocircuito culturale della modernità, con il rischio di un inabissamento della civiltà europea stessa, e coincise con il periodo d’incubazione dell’ideologia fascista, che, solo nelle circostanze critiche del dopoguerra, si sarebbe poi trasformata in un movimento politico di estrema destra organizzato e combattivo. Questa pista ci viene acutamente suggerita dagli importanti studi storici di Zeev Sternhell[4]. In quel periodo, infatti, germina e cresce rapidamente un rifiuto dell’Illuminismo, espresso da vari rivoli della cultura europea, che si declina come rifiuto del principio di uguaglianza naturale degli uomini, dell’universalismo, del razionalismo, dell’idea di progresso e che culmina nella scomunica di “materialismo”, indirizzata indistintamente a democrazia, liberalismo, socialismo, con le loro dottrine egualitarie e utilitaristiche, concepito come la malattia europea che era necessario sradicare, quella che più di altre minava l’“organismo vivo” della nazione. Il fascismo e il nazismo, pertanto, non sono tanto figli della reazione al bolscevismo e al comunismo, quanto l’emergenza più vistosa, aggressiva e radicale di quel rifiuto. Il che ne spiega l’appeal che esercitò sia sulle masse sia sull’élite intellettuale.
Si comprende allora la scelta del capro espiatorio ebraico. La “questione ebraica”, ovvero il tema della tolleranza e dell’emancipazione della minoranza ebraica da secoli discriminata o ghettizzata, si era affermata proprio con l’Illuminismo e gli illuministi l’avevano imposta già nell’agenda politica dei “sovrani illuminati”, per essere riconfermata nelle rivoluzioni liberali della prima metà dell’Ottocento (non a caso, La questione ebraica è il titolo di un libro fondamentale nella produzione di Marx, del 1843, dove ai sostenitori dell’emancipazione politica attraverso l’estensione universale dei diritti civili, anche agli ebrei, Marx replica denunciando i limiti intrinseci dell’emancipazione politica, a fronte dello scarto tra gli eguali diritti proclamati in astratto e le concrete condizioni di diseguaglianza presenti nella società).
 Questo tema sarà ricorrente per tutto il XIX secolo in Europa, anche se maggiormente in Francia e in Germania rispetto ad altri Paesi europei, e, quindi, uno dei modi migliori per dichiarare morte ai valori dell’Illuminismo sarebbe stato proprio scagliarsi contro gli ebrei e archiviare, con il tema dell’emancipazione degli ebrei, il simbolo essenziale dell’Illuminismo. La presenza nella coscienza collettiva e nel dibattito intellettuale del nesso tra illuminismo e questione ebraica trova peraltro conferma in un articolo[5] di Hannah Arendt, pubblicato sulla Zeitschrift für Geschichte der Juden in Deutschland, alcuni mesi prima della nomina a cancelliere della Repubblica federale di Adolf Hitler, in cui la giovane filosofa ripercorreva il modo in cui gli stessi intellettuali ebrei (Lessing, Mendelssohn, Dohm) si collocavano nella tradizione illuminista, oscillando tra l’invito a mantenere la religione ebraica come “religione della ragione” o a rinunciarvi per una piena “naturalizzazione” e assimilazione nella società tedesca e europea. E certamente, come ci ricorda André Glucksmann, nel suo controverso libro-manifesto dei nouveaux philosophes[6], giocò nella scelta degli ebrei anche l’immagine di “nemico interno” costruita filosoficamente dagli idealisti tedeschi, che vi videro i rappresentanti o di uno “Stato nello Stato” (Fichte), nutrito e compattato dall’ostilità per il resto del genere umano, o peggio ancora, di un “anti-Stato” (Hegel), esempio aberrante di comunità che scardina l’equazione tra popolo, nazione, Stato e, quindi, ancora più inquietante agli occhi un movimento culturale politico come quello fascista e nazista, esplicitamente nazionalista, illiberale e razzista.
Questo tema sarà ricorrente per tutto il XIX secolo in Europa, anche se maggiormente in Francia e in Germania rispetto ad altri Paesi europei, e, quindi, uno dei modi migliori per dichiarare morte ai valori dell’Illuminismo sarebbe stato proprio scagliarsi contro gli ebrei e archiviare, con il tema dell’emancipazione degli ebrei, il simbolo essenziale dell’Illuminismo. La presenza nella coscienza collettiva e nel dibattito intellettuale del nesso tra illuminismo e questione ebraica trova peraltro conferma in un articolo[5] di Hannah Arendt, pubblicato sulla Zeitschrift für Geschichte der Juden in Deutschland, alcuni mesi prima della nomina a cancelliere della Repubblica federale di Adolf Hitler, in cui la giovane filosofa ripercorreva il modo in cui gli stessi intellettuali ebrei (Lessing, Mendelssohn, Dohm) si collocavano nella tradizione illuminista, oscillando tra l’invito a mantenere la religione ebraica come “religione della ragione” o a rinunciarvi per una piena “naturalizzazione” e assimilazione nella società tedesca e europea. E certamente, come ci ricorda André Glucksmann, nel suo controverso libro-manifesto dei nouveaux philosophes[6], giocò nella scelta degli ebrei anche l’immagine di “nemico interno” costruita filosoficamente dagli idealisti tedeschi, che vi videro i rappresentanti o di uno “Stato nello Stato” (Fichte), nutrito e compattato dall’ostilità per il resto del genere umano, o peggio ancora, di un “anti-Stato” (Hegel), esempio aberrante di comunità che scardina l’equazione tra popolo, nazione, Stato e, quindi, ancora più inquietante agli occhi un movimento culturale politico come quello fascista e nazista, esplicitamente nazionalista, illiberale e razzista.
 Bisogna aggiungere che, in questo attacco all’Illuminismo, che venne quasi naturalmente a combinarsi con l’attacco agli ebrei, il nazismo, rispetto al fascismo, con il suo dogma del Blut und Boden, si spinse oltre, fino a colpire la concezione dell’uomo ereditata dalla tradizione giudaico-cristiana, come aveva intuito Emmanuel Lévinas, in un articolo pubblicato nel 1934 sulla rivista Esprit: “L’essenza dell’uomo non è più nella libertà, ma in una sorta di incatenamento. Essere veramente se stessi, non significa risollevarsi al di sopra delle contingenze, sempre estranee alla libertà dell’Io: ma, al contrario, prendere coscienza dell’incatenamento originale, ineluttabile, unico al nostro corpo, significa soprattutto accettare questo incatenamento (...) Da questa concretizzazione dello spirito deriva immediatamente una società a base consanguinea (...) Incatenato al suo corpo, l’uomo si vede rifiutare il potere di sfuggire a se stesso”[7]. Un attacco, quindi, non solo all’Illuminismo e ai suoi valori (l’autonomia, la finalità umana delle nostre azioni, l’universalità morale e giuridica, senza distinzioni di razza, di ceto, di religione), ma anche alle radici spiritualiste da cui quei valori scaturivano nella loro distillazione secolarizzata.
Bisogna aggiungere che, in questo attacco all’Illuminismo, che venne quasi naturalmente a combinarsi con l’attacco agli ebrei, il nazismo, rispetto al fascismo, con il suo dogma del Blut und Boden, si spinse oltre, fino a colpire la concezione dell’uomo ereditata dalla tradizione giudaico-cristiana, come aveva intuito Emmanuel Lévinas, in un articolo pubblicato nel 1934 sulla rivista Esprit: “L’essenza dell’uomo non è più nella libertà, ma in una sorta di incatenamento. Essere veramente se stessi, non significa risollevarsi al di sopra delle contingenze, sempre estranee alla libertà dell’Io: ma, al contrario, prendere coscienza dell’incatenamento originale, ineluttabile, unico al nostro corpo, significa soprattutto accettare questo incatenamento (...) Da questa concretizzazione dello spirito deriva immediatamente una società a base consanguinea (...) Incatenato al suo corpo, l’uomo si vede rifiutare il potere di sfuggire a se stesso”[7]. Un attacco, quindi, non solo all’Illuminismo e ai suoi valori (l’autonomia, la finalità umana delle nostre azioni, l’universalità morale e giuridica, senza distinzioni di razza, di ceto, di religione), ma anche alle radici spiritualiste da cui quei valori scaturivano nella loro distillazione secolarizzata.E per avere la sensazione di quale potesse essere la condizione psicologica di un ebreo nel clima plumbeo e “anti-illuminista” in cui la crisi di civiltà europea era precipitata, basterà rileggere il passo di una delle lettere, scritte tra il 1920 e il 1923, di Franz Kafka a Milena Jesenská, che morirà nel 1944 nel campo di concentramento di Ravensbrück: “Per me tutto avviene all’incirca come per qualcuno che, ogni volta che uscisse, dovesse non soltanto lavarsi, pettinarsi ecc. - il che è già abbastanza faticoso - ma venendogli a mancare tutto una volta di più, ogni volta, dovesse anche cucirsi un vestito, fabbricarsi delle scarpe, confezionarsi un cappello, tagliarsi un bastone ecc. Naturalmente non tutto gli riuscirebbe bene, le cose reggerebbero per una strada o due (...) Alla fine, in via del Ferro, si imbatterebbe in una folla che sta dando la caccia agli ebrei”. Ecco, il Giorno della Memoria deve servire anche a ricordarci il dovere morale di preservare i valori moderni che permettono di costruire una società in cui nessuno si senta manchevole per essere uomo, come i suoi simili, e in cui nessuno venga considerato mai un “uomo di troppo”.
[1] Vedi: U. Galimberti, La casa di psiche. Dalla psicoanalisi alla pratica filosofica, Feltrinelli, Milano 2005, cap. 25
 [2] M. Serres, Trahison: la thanatocratie (1972), in: M. Serres, Hermès III. La traduction, Le Minuit, Paris 1974, p. 74
[2] M. Serres, Trahison: la thanatocratie (1972), in: M. Serres, Hermès III. La traduction, Le Minuit, Paris 1974, p. 74
 [3] D. Runciman, Così finisce la democrazia. Paradossi, presente e futuro di un’istituzione imperfetta, Bollati Boringhieri, Torino 2019.
[3] D. Runciman, Così finisce la democrazia. Paradossi, presente e futuro di un’istituzione imperfetta, Bollati Boringhieri, Torino 2019.
 [4] Storico israeliano di origine polacca, professore di Scienza politica presso la Hebrew University di Gerusalemme, autore di numerosi saggi, tra cui: Nascita dell’ideologia fascista, Baldini & Castoldi, Milano 1993; La destra rivoluzionaria, Corbaccio, Milano 1997; Né destra, né sinistra, Baldini & Castoldi, Milano 1997.
[4] Storico israeliano di origine polacca, professore di Scienza politica presso la Hebrew University di Gerusalemme, autore di numerosi saggi, tra cui: Nascita dell’ideologia fascista, Baldini & Castoldi, Milano 1993; La destra rivoluzionaria, Corbaccio, Milano 1997; Né destra, né sinistra, Baldini & Castoldi, Milano 1997.
 [5] H. Arendt, Illuminismo e questione ebraica, Cronopio, Napoli 2007
[5] H. Arendt, Illuminismo e questione ebraica, Cronopio, Napoli 2007
 [6] A. Glucksmann, I padroni del pensiero, Garzanti, Milano 1977
[6] A. Glucksmann, I padroni del pensiero, Garzanti, Milano 1977
 [7] E. Lévinas, Alcune riflessioni sulla filosofia dell’hitlerismo, Quodlibet, Macerata 2005, pp. 32, 34
[7] E. Lévinas, Alcune riflessioni sulla filosofia dell’hitlerismo, Quodlibet, Macerata 2005, pp. 32, 34
Sul tema, nel sito, si cfr.:
EICHMANN A GERUSALEMME (1961). “come fu possibile la hitlerizzazione dell’Imperativo Categorico di Kant? E perché è ancora attuale oggi?” (Emil L. Fackenheim, Tiqqun. Riparare il mondo).
 HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI.
HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI.Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- UNA QUESTIONE FILO-LOGICA DI LUNGA DURATA: IL PRINCIPIO DI CARITÀ. Note19 gennaio 2020, di Federico La Sala
FILOSOFIA E FILOLOGIA. IN PRINCIPIO ERA IL LOGOS: CHARITAS....
- LA CARITÀ dal GRECO (χάρις - χάριτος: "chàris" - "chàritos"; accusativo pl.: " χάριτας" - “chàritas” - dono, grazia), NON dal LATINO (“Caritas” - da “carus”, che - come nell’ italiano, "caro" - ha il doppio senso di “affetto” e "caro-prezzo" ... e richiama le "carenze" affettive ed economiche e la "carestia" - e non l’eu-charis-tia"!!!) *
Tesi di Laurea
IL PRINCIPIO DI CARITÀ [2016]
Definizione e analisi critica tra ermeneutica e logica
a cura di Francesco Gandellini **
- La tesi si preoccupa di analizzare l’origine e il decorso storico del principio di carità o benevolenza, con particolare riferimento alla linea etico-ermeneutica e alla linea logico-ontologica, al fine di metterne in luce gli aspetti significativi che lo identificano e ne caratterizzano l’uso nella storia della filosofia.
SOMMARIO Introduzione .................................................................................................................
 1 Sezione 1: il versante ermeneutico ....................................................................... 5
1 Sezione 1: il versante ermeneutico ....................................................................... 5
 1.1 La genesi agostiniana del principio .................................................................... 7
1.1 La genesi agostiniana del principio .................................................................... 7
 1.2 L’illuminismo tedesco e il nesso linguaggio-mondo ................................. 23
1.2 L’illuminismo tedesco e il nesso linguaggio-mondo ................................. 23
 1.2.1 Wilhelm von Humboldt: “Sprachansicht als Weltansicht” ................................................................... 27 -APPENDICE Georg Friedrich Meier e il “Versuch einer allgemeinen Auslegungkunst” .................................. 43
1.2.1 Wilhelm von Humboldt: “Sprachansicht als Weltansicht” ................................................................... 27 -APPENDICE Georg Friedrich Meier e il “Versuch einer allgemeinen Auslegungkunst” .................................. 43
 1.3 La linea ontologica dell’ermeneutica contemporanea .............................. 53
1.3 La linea ontologica dell’ermeneutica contemporanea .............................. 53
 1.3.1 Martin Heidegger e l’analitica esistenziale di “Sein und Zeit” ................................................ 55
1.3.1 Martin Heidegger e l’analitica esistenziale di “Sein und Zeit” ................................................ 55
 1.3.2 Hans-Georg Gadamer e l’ermeneutica ontologica di “Warheit und Methode“ ........................ 69
1.3.2 Hans-Georg Gadamer e l’ermeneutica ontologica di “Warheit und Methode“ ........................ 69
 Sezione 2: la riflessione logica .............................................................................. 85
Sezione 2: la riflessione logica .............................................................................. 85
 2.1 Fondamenti teorici della carità in logica ....................................................... 87
2.1 Fondamenti teorici della carità in logica ....................................................... 87
 α ) La riflessione filosofica di Ludwig Wittgenstein ......................................... 89
α ) La riflessione filosofica di Ludwig Wittgenstein ......................................... 89
 β) L’ipotesi della relatività linguistica............................................................ 100
β) L’ipotesi della relatività linguistica............................................................ 100
 2.2 Willard van Orman Quine e l’argomento di “traduzione radicale” ............................................................... 113
2.2 Willard van Orman Quine e l’argomento di “traduzione radicale” ............................................................... 113
 2.3 Donald Davidson e l’interpretazione radicale ..................................................................................... 137
2.3 Donald Davidson e l’interpretazione radicale ..................................................................................... 137
 Conclusione .............................................................................................................. 157
Conclusione .............................................................................................................. 157
 Bibliografia ............................................................................................................... 161 -Sitografia................................................................................................................... 163
Bibliografia ............................................................................................................... 161 -Sitografia................................................................................................................... 163***
INTRODUZIONE
Il termine “carità” deriva etimologicamente dal latino caritas (acc. caritatem, «benevolenza», «amore», questo da carus, «caro», «costoso», «diletto», «amato»), e a sua volta dal greco χάρις, «grazia». Dal punto di vista dell’etimo, la parola cattura l’idea dell’amore disinteressato ma prezioso verso qualcuno, della benevolenza gratuitamente concessa al destinatario, senza riserve rispetto alla sua condizione.
 Gli etimologisti latini derivavano il lemma carus
dalla prima persona singolare del presente del verbo carēre, ovverocareo, «manco», «sono privo di», e ritenevano di giustificare il valore di una cosa sul metro della mancanza della cosa stessa, in modo tale che tanto più se ne avverte l’assenza, tanto più essa acquista valore e pregio.
Gli etimologisti latini derivavano il lemma carus
dalla prima persona singolare del presente del verbo carēre, ovverocareo, «manco», «sono privo di», e ritenevano di giustificare il valore di una cosa sul metro della mancanza della cosa stessa, in modo tale che tanto più se ne avverte l’assenza, tanto più essa acquista valore e pregio.
 Passando per il greco χάρις e dal verbo χαίρω, «rallegrarsi», «provare piacere», si arriva alla radice sanscrita ka = ca (sscr. ka, kan, kam), presente in parole quali kâma, «amore», kamana, «desiderabile», «bello»,kamara, «amoroso», kam-e, «desiderò», «amò». Si possono, inoltre, trovare affinità nel lettone kahrs, «cupido», nel gotico hors, da cui il tedesco Hure, «meretrice», ma che si riallaccia al latino quaero, «cercare», «ricercare», «bramare» ciò che è desiderato. Il termine “carità” afferisce, dunque, anche alla sfera dell’amore desiderato, del richiesto perché bramosamente bello e capace di dare piacere e rallegrare.
Passando per il greco χάρις e dal verbo χαίρω, «rallegrarsi», «provare piacere», si arriva alla radice sanscrita ka = ca (sscr. ka, kan, kam), presente in parole quali kâma, «amore», kamana, «desiderabile», «bello»,kamara, «amoroso», kam-e, «desiderò», «amò». Si possono, inoltre, trovare affinità nel lettone kahrs, «cupido», nel gotico hors, da cui il tedesco Hure, «meretrice», ma che si riallaccia al latino quaero, «cercare», «ricercare», «bramare» ciò che è desiderato. Il termine “carità” afferisce, dunque, anche alla sfera dell’amore desiderato, del richiesto perché bramosamente bello e capace di dare piacere e rallegrare.
 Il principio di carità rappresenta un criterio prezioso, disinteressato ma richiesto nella logica del dialogo. Esso fornisce una norma fondante, sebbene implicita, per la costruzione di un confronto fecondo e esente da appropriazioni o strumentalizzazioni di qualunque sorta. Il valore apportato dal principio di carità consiste, forse banalmente, nel rendersi disponibile all’ascolto dell’altro e nell’attribuire pregnanza di senso alle sue parole, almeno fino a un evidente punto di non ritorno.
Il principio di carità rappresenta un criterio prezioso, disinteressato ma richiesto nella logica del dialogo. Esso fornisce una norma fondante, sebbene implicita, per la costruzione di un confronto fecondo e esente da appropriazioni o strumentalizzazioni di qualunque sorta. Il valore apportato dal principio di carità consiste, forse banalmente, nel rendersi disponibile all’ascolto dell’altro e nell’attribuire pregnanza di senso alle sue parole, almeno fino a un evidente punto di non ritorno.
 La scelta di trattare il principio di carità come argomento di tesi va incontro alla necessità di indagare l’implicito, il sottinteso, il banale che sovente viene trascurato e passato sotto silenzio, col rischio di dimenticarne la validità e l’utilità concreta e portante nell’ambito dell’umano. Si tratta, perciò, di far riermegere agli occhi della coscienza i fondamenti troppo spesso dati per scontato e, proprio per questo, dimenticati, abbandonati e relegati a relitti a margine dell’edificio del sapere.
La scelta di trattare il principio di carità come argomento di tesi va incontro alla necessità di indagare l’implicito, il sottinteso, il banale che sovente viene trascurato e passato sotto silenzio, col rischio di dimenticarne la validità e l’utilità concreta e portante nell’ambito dell’umano. Si tratta, perciò, di far riermegere agli occhi della coscienza i fondamenti troppo spesso dati per scontato e, proprio per questo, dimenticati, abbandonati e relegati a relitti a margine dell’edificio del sapere.
 È compito primario della filosofia conferire dignità conoscitiva a quanto viene accolto come evidente, ovvio, lapalissiano perché in ciò, e nel suo oblio, si possono rinvenire “proprio quei problemi che sono i più scottanti per l’uomo, il quale, nei nostri tempi tormentati, si sente in balìa del destino”1, ossia quegli interrogativi umani centrali in cui ne va della quotidianità tanto quanto dell’esistenza intera, oltre che di una convivenza pacifica. Spingendo la riflessione in direzione di ciò che pare assodato e fuori di dubbio ai fini della riflessione stessa, si giunge a capire e a rendere ragione di una complessità nuova, nella quale si gioca qualcosa come la comprensione o il fraintendimento tra gli individui.
È compito primario della filosofia conferire dignità conoscitiva a quanto viene accolto come evidente, ovvio, lapalissiano perché in ciò, e nel suo oblio, si possono rinvenire “proprio quei problemi che sono i più scottanti per l’uomo, il quale, nei nostri tempi tormentati, si sente in balìa del destino”1, ossia quegli interrogativi umani centrali in cui ne va della quotidianità tanto quanto dell’esistenza intera, oltre che di una convivenza pacifica. Spingendo la riflessione in direzione di ciò che pare assodato e fuori di dubbio ai fini della riflessione stessa, si giunge a capire e a rendere ragione di una complessità nuova, nella quale si gioca qualcosa come la comprensione o il fraintendimento tra gli individui.
 Il principio di carità è una guida rimasta finora col capo coperto. Esso ha condotto e conduce gli uomini nei meandri tortuosi della comunicazione, del rapporto dialogante e dell’interpretazione reciproca. Può pregiudicare il buon andamento di una discussione, rimanendo nell’anonimato e nell’ombra. Determina e garantisce lo spazio minimo per l’intesa e l’accordo, ma può anche sancirne il definitivo naufragio.
Il principio di carità è una guida rimasta finora col capo coperto. Esso ha condotto e conduce gli uomini nei meandri tortuosi della comunicazione, del rapporto dialogante e dell’interpretazione reciproca. Può pregiudicare il buon andamento di una discussione, rimanendo nell’anonimato e nell’ombra. Determina e garantisce lo spazio minimo per l’intesa e l’accordo, ma può anche sancirne il definitivo naufragio.
 Lo scopo della presente trattazione è di portarne alla luce, in un percorso storico e tematico, le caratteristiche principali, in modo da scoprirne il capo e segnalarne i lineamenti distintivi. La filosofia, nel suo decorso storico, si è raramente rivolta in modo esplicito al principio di carità. Fatta eccezione per Agostino, per il caso isolato dell’illuminista tedesco Georg Meier (che lo chiama principio di equità ermeneutica) e per la riflessione dei logici contemporanei (Wilson, Quine, Davidson), esso non viene pressoché mai menzionato o, almeno, non con questo appellativo con cui, soprattutto recentemente, è tornato alla ribalta.
Lo scopo della presente trattazione è di portarne alla luce, in un percorso storico e tematico, le caratteristiche principali, in modo da scoprirne il capo e segnalarne i lineamenti distintivi. La filosofia, nel suo decorso storico, si è raramente rivolta in modo esplicito al principio di carità. Fatta eccezione per Agostino, per il caso isolato dell’illuminista tedesco Georg Meier (che lo chiama principio di equità ermeneutica) e per la riflessione dei logici contemporanei (Wilson, Quine, Davidson), esso non viene pressoché mai menzionato o, almeno, non con questo appellativo con cui, soprattutto recentemente, è tornato alla ribalta.
 Si tratta, quindi, e questo è l’intento del lavoro, di rimarcarne gli aspetti costituivi, laddove il criterio sia stato suggerito dagli autori, oppure di ricercare ed enucleare possibili edizioni, implicitamente consegnate dai filosofi alla riflessione sul principio in questione. Per questo la tesi potrebbe soffrire di discontinuità più o meno consistenti, dettate appunto dall’esigenza di scandagliare le profondità del pensiero filosofico, anche mediante salti temporali e concettuali rilevanti, in quei punti ritenuti significativi per una trattazione ampia e pregnante, ma filtrata sempre nel setaccio della carità ermeneutica e logica.
Si tratta, quindi, e questo è l’intento del lavoro, di rimarcarne gli aspetti costituivi, laddove il criterio sia stato suggerito dagli autori, oppure di ricercare ed enucleare possibili edizioni, implicitamente consegnate dai filosofi alla riflessione sul principio in questione. Per questo la tesi potrebbe soffrire di discontinuità più o meno consistenti, dettate appunto dall’esigenza di scandagliare le profondità del pensiero filosofico, anche mediante salti temporali e concettuali rilevanti, in quei punti ritenuti significativi per una trattazione ampia e pregnante, ma filtrata sempre nel setaccio della carità ermeneutica e logica.1 E. HUSSERL, La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, Milano, il Saggiatore 2008, pag. 35
** UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
 Dipartimento Lettere e Filosofia
Dipartimento Lettere e Filosofia
 Corso di Laurea in FILOSOFIA. Supervisore: Prof. Varzi Achille Carlo, Co-Supervisore: Prof. Ghia Francesco, Laureando: GANDELLINI Francesco.
Corso di Laurea in FILOSOFIA. Supervisore: Prof. Varzi Achille Carlo, Co-Supervisore: Prof. Ghia Francesco, Laureando: GANDELLINI Francesco.
* SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- LA QUESTIONE DELLA "H"....SCIENZA E FILOSOFIA. "Capire il comportamento umano. Azione, razionalità, empatia" (di Antonio Rainone)
SANT’AGOSTINO, DOTTORE DELLA GRAZIA ("CHARIS"): "ECCO DA DOVE COMINCIA L’AMORE" ("ECCE UNDE INCIPIT CHARITAS").
IL NOME DI DIO, SENZA GRAZIA ("CHARIS")! L’ERRORE FILOLOGICO E TEOLOGICO DI PAPA BENEDETTO XVI, NEL TITOLO DELLA SUA PRIMA ENCICLICA. Nel nome della "Tradizione"
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- STORIA E STORIOGRAFIA: "LA DISTRUZIONE DELLA RAGIONE".15 gennaio 2020, di Federico La Sala
STORIA E STORIOGRAFIA: MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! *
- UNA NOTA A “Il libro insostenibile: breve difesa di La distruzione della ragione”
UNA BOLLA SPECULATIVA. “[...] Perché parlare di un libro pubblicato nel 1954? [...] Credo che la domanda e la risposta che Lukács scrive all’inizio del lungo volume parli ancora di noi. La domanda era “Perché a un certo punto la gnoseologia, la teoria della conoscenza, diventa la forma filosofica dominante?” La risposta (circa 800 pagine) aveva appunto a che fare con l’intento ideologico della borghesia di soggettivizzare la Storia al fine di immobilizzarla [...] Per Lukács l’irrazionalismo, che ha “come intento principale [...] la radicale soggettivizzazione della storia”, trova piena espressione fra gli ultimi anni dell’800 e i primi del ‘900 attraverso “la riduzione della gnoseologia kantiana alla gnoseologia di Berkeley”, così come prima sviluppata nell’ambito dell’epistemologia scientifica da autori quali Mach e Avenarius. La pretesa inconoscibilità della realtà oggettiva trasferisce l’oggettività medesima all’interno della soggettività, e questa è presentata dalla gnoseologia come soggetta alle oscillazioni della psicologia, le quali necessariamente inficiano (la psicologia di un soggetto è ovviamente mobile) ogni possibile e stabile approdo conoscitivo: “il cancellare i confini fra gnoseologica e psicologia fa parte delle caratteristiche essenziali dell’irrazionalismo moderno” [...] (M. Cangiano, “Il libro insostenibile: breve difesa di La distruzione della ragione”, Le parole e le cose, 14.01.2019).
* NOTE:
A) HEGEL, HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI .
B) KANT E GRAMSCI. PER LA CRITICA DELL’IDEOLOGIA DELL’UOMO SUPREMO E DEL SUPERUOMO D’APPENDICE.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- Dallo spazio, con Fachinelli e Freud, uno sguardo a "L’aiuola che ci fa tanto feroci" (Dante, Par. XXII, 151)11 gennaio 2020, di Federico La Sala
FACHINELLI E FREUD NELLA “NAVE” DI GALILEI. Al di là del "paradosso della ripetizione" ... *
- "Uno psicoanalista scomodo: Elvio Fachinelli" di Sergio Benvenuto (Le parole e le cose, 10.01.2020).
- Nota di commento: Non risulta affatto simpatico il signor Elvio Fachinelli da questo articolo.
- “Perché Fachinelli non indulse mai alla retorica anti-tecnologica, al rifiuto snob e/o retrogrado dei media, alla nostalgia agro-pastorale di un Pasolini ad esempio, al contrario, era attento ai nuovi portati dalla tecnologia.“
- Mi ha scoraggiata... Francesca
TROVO MOLTO INTERESSANTE l’indicazione di FRANCESCA (vedi - sopra) di mettere i piedi a Terra e guardare la Luna. Al di là dei limiti del percorso di Fachinelli, mia opinione, di ciò che resta fondamentale del suo lavoro è la decisiva messa in evidenza di quanto - antropologicamente - sta al fondamento della rivoluzione (e pratica!) psicoanalitica: "La mente estatica" (1989)! Si possono chiudere porte e finestre all’infinito, ma ora non solo dalla caverna platonica ma anche dall’isola di Creta ("Sulla spiaggia", 1985) si può uscire (cfr. Fachinelli e Freud nella "nave" di Galilei), riprendere la navigazione e guardare dall’Oceano, terrestre e celeste, la Terra ...
IL "GIARDINO" DEVASTATO E LE PIANTE. "Lo sciovinismo antropologico/antropocentrico (e più generalmente zoo-logico/zoo-centrico) che impera su gran parte della filosofia morale e politica dall’antichità ai giorni nostri non ammette un valore delle piante in quanto tali. Per gli esseri umani è molto più facile identificarsi con gli animali che con le piante, la cui fisiologia risulta difficile da comprendere (l’antropomorfismo e lo zoomorfismo vanno facilmente insieme). L’apparente immobilità delle piante, la loro apparente mancanza di differenziazione, il loro essere apparentemente inermi e inette, rendono le piante poco salienti per i sensi degli esseri umani - facilitando così anche la scomparsa della vita vegetale dall’orizzonte dell’etica e della politica.
 Quest’oblio è ingiustificato in sé e costituisce anche un problema urgente per l’etica dell’ambiente. Se non si dà valore alle piante, perché le si ritiene prive delle caratteristiche necessarie a generare valore (come l’autocoscienza, l’intelligenza, la capacità di provare sensazioni ed emozioni, di agire, di esercitare la volontà), allora non si potrà dare valore alla natura inanimata, cioè agli ecosistemi e al mondo naturale nel suo complesso, dichiarando così il fallimento di ogni tipo di etica dell’ambiente non fondamentalmente antropo- o zoo-centrica.
Quest’oblio è ingiustificato in sé e costituisce anche un problema urgente per l’etica dell’ambiente. Se non si dà valore alle piante, perché le si ritiene prive delle caratteristiche necessarie a generare valore (come l’autocoscienza, l’intelligenza, la capacità di provare sensazioni ed emozioni, di agire, di esercitare la volontà), allora non si potrà dare valore alla natura inanimata, cioè agli ecosistemi e al mondo naturale nel suo complesso, dichiarando così il fallimento di ogni tipo di etica dell’ambiente non fondamentalmente antropo- o zoo-centrica.
 Nella pratica, alcuni degli atteggiamenti più rapaci e noncuranti nei confronti della natura potrebbero ben derivare proprio dal nostro rifiuto o incapacità di aprirci alle piante e al loro valore, e addirittura alla stessa ipotesi che abbiano valore. Una buona quota della attuale crisi ecologica, possibilmente la più subdola e insidiosa, potrebbe risultare riconducibile a questa incapacità o rifiuto, e spiegabile attraverso il prisma delle nostre relazioni irrisolte con le piante.
Nella pratica, alcuni degli atteggiamenti più rapaci e noncuranti nei confronti della natura potrebbero ben derivare proprio dal nostro rifiuto o incapacità di aprirci alle piante e al loro valore, e addirittura alla stessa ipotesi che abbiano valore. Una buona quota della attuale crisi ecologica, possibilmente la più subdola e insidiosa, potrebbe risultare riconducibile a questa incapacità o rifiuto, e spiegabile attraverso il prisma delle nostre relazioni irrisolte con le piante.
 Se si dà valore alle piante si è sulla buona strada per dare valore alla natura tutta, inclusa tutta quella inanimata; e non solo come un insieme indistinto, ma come un ricettacolo di diversità e di specificità e particolarità inesauribile. Una visione del genere terrà conto, per esempio, del fatto che gran parte della natura è roccia, acqua, e piante: la vita animale si attesta, in proporzione, solo al quarto posto - la “nazione delle piante”, come la battezza Stefano Mancuso, è di gran lunga la più popolosa [...]"(dal volume "Etica e politica delle piante", di Gianfranco Pellegrino e Marcello Di Paola, e con contributi di Simone Pollo e Alessandra Viola).
Se si dà valore alle piante si è sulla buona strada per dare valore alla natura tutta, inclusa tutta quella inanimata; e non solo come un insieme indistinto, ma come un ricettacolo di diversità e di specificità e particolarità inesauribile. Una visione del genere terrà conto, per esempio, del fatto che gran parte della natura è roccia, acqua, e piante: la vita animale si attesta, in proporzione, solo al quarto posto - la “nazione delle piante”, come la battezza Stefano Mancuso, è di gran lunga la più popolosa [...]"(dal volume "Etica e politica delle piante", di Gianfranco Pellegrino e Marcello Di Paola, e con contributi di Simone Pollo e Alessandra Viola).*
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- GUARDARE L’ITALIA (E LA TERRA) DALLO SPAZIO. Appello per "Dante 2021", per i 700 anni dalla morte di Dante.10 gennaio 2020, di Federico La Sala
PER I 700 ANNI DALLA MORTE DI DANTE.... *
- Con Dante, già da oggi (10.01.2020), guardare l’Italia (e la Terra) dallo spazio, come da indicazione del Presidente della Repubblica (messaggio di fine anno).
Dante, l’appello di Franceschini alle imprese
"Poste finanzia, altri li seguano". La Rai rilanci all’estero
(ANSA) - ROMA, 10 GEN - "Grazie a Poste Italiane, che hanno offerto il loro sostegno per le celebrazioni, nel 2021, dei 700 anni dalla morte di Dante", ma "vorrei che quello di Poste fosse un esempio per le altre imprese italiane che non si possono sottrarre a fare qualcosa per Dante". Il ministro di Cultura e Turismo Dario Franceschini presenta a Roma, insieme con il presidente del Comitato per i 700 anni dalla morte di Dante, Carlo Ossola e con la presidente Maria Bianca Farina e l’ad Matteo Del Fante di Poste Italiane un progetto di valorizzazione che coinvolgerà decine di comuni italiani (70 al momento ma potrebbero diventare di più) e approfitta per lanciare un appello al mondo delle imprese: "Dante è di tutti - dice - tutte le nostre imprese quando vanno all’estero hanno dietro il supporto dell’Italia e Dante per noi italiani è identitario.
 Tutti dovrebbero fare qualcosa". E aggiunge: "Vorrei vedere Dante sui treni, sui voli Alitalia, dappertutto". Non solo: "Vorrei che la Rai , so che ci sono ragionamenti aperti in questo senso, producesse cose da far circolare non solo in Italia ma nel mondo". Un appello, quello del ministro Pd, rivolto in ultima analisi al Paese a tutto tondo: "Dante è di tutti, è identitario, coinvolge, è stato anche uno dei primi ad aver parlato di Europa. - sottolinea il capo delegazione Pd al governo - Celebrare i 700 anni dalla sua morte è lavorare per l’unità e il nostro Paese ha molto bisogno di unità. E’ anche orgoglio e il Paese ha bisogno di orgoglio". (ANSA).
Tutti dovrebbero fare qualcosa". E aggiunge: "Vorrei vedere Dante sui treni, sui voli Alitalia, dappertutto". Non solo: "Vorrei che la Rai , so che ci sono ragionamenti aperti in questo senso, producesse cose da far circolare non solo in Italia ma nel mondo". Un appello, quello del ministro Pd, rivolto in ultima analisi al Paese a tutto tondo: "Dante è di tutti, è identitario, coinvolge, è stato anche uno dei primi ad aver parlato di Europa. - sottolinea il capo delegazione Pd al governo - Celebrare i 700 anni dalla sua morte è lavorare per l’unità e il nostro Paese ha molto bisogno di unità. E’ anche orgoglio e il Paese ha bisogno di orgoglio". (ANSA).
Sul tema, nel sito, si cfr.:
DELLA LINGUA E DELLA POLITICA D’ITALIA. DANTE: L’UNIVERSALE MONARCHIA DEL RETTO AMORE ("charitas"). Per una rilettura del "De Vulgari Eloquentia" e della "Monarchia"
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- USCIRE DALL’ORIZZONTE DELL’IMMAGINARIO "COSMOTEANDRICO" SOCRATICO-PLATONICO, COSTANTINIANO ED HEGELIANO.4 gennaio 2020, di Federico La Sala
"ECCE HOMO": (ANTROPOLOGIA, NON "ANDROPOLOGIA" O "GINECO-LOGIA")!!! USCIRE DALL’ORIZZONTE COSMOTEANDRICO DA "SACRO ROMANO IMPERO"... *
- Dio creò l’uomo ("homo") ... e lo fece maschio ["masculum"] e femmina [" foeminam "] (Genesi, I.27).
- “Chi tene ‘a lingua, va ’n Sardegna" (antico proverbio campano)
La parola può tutto
di Ivano Dionigi (Avvenire, venerdì 3 gennaio 2020)
«Chiamo uomo chi è padrone della sua lingua». In questa sentenza fulminante di don Lorenzo Milani (Lettera a Ettore Bernabei 1956), ispirata a un deciso afflato di giustizia sociale, trovo il più bel commento al passo in cui Aristotele (Politica 1253 a) riconosce nella parola (logos) la marca che caratterizza l’uomo e lo distingue dagli animali, che ne sono privi (tà zóa á-loga). La parola: il bene più prezioso, la qualità più nobile, il sigillo più intimo. A una persona, a un gruppo, a un popolo puoi togliere averi, lavoro, affetti: ma non la parola. Un divario economico si ripiana, un’occupazione si rimedia, una ferita affettiva si rimargina, ma la mancanza o l’uso ridotto della parola nega l’identità, esclude dalla comunità, confina alla solitudine e quindi riduce allo stato animale. «La parola - continuava il profetico prete di Barbiana - è la chiave fatata che apre ogni porta»; tutto può, come già insegnava la saggezza classica: «spegnere la paura, eliminare la sofferenza, alimentare la gioia, accrescere la compassione» (Gorgia, Elogio di Elena 8). Ma essa è di duplice segno, nella vita privata come in quella pubblica: con i cittadini onesti e i governanti illuminati si fa simbolica (syn-bállein), e quindi unisce, consola, salva; confiscata dai cittadini corrotti e dai demagoghi si fa diabolica (dia-bállein), e quindi divide, affanna, uccide.
- ANTROPOLOGIA E FILOSOFIA. IN PRINCIPIO ERA IL LOGOS - NON IL "LOGO"! La questione della "Parola" e della "Lingua".
- RILEGGERE SAUSSURE. UN "TRATTATO TEOLOGICO-POLITICO" RIDOTTO A UN BANALE "CORSO DI LINGUISTICA GENERALE"!!!
- L’ Amore (Charitas) non è lo zimbello del tempo e di Mammona (Caritas)!!!
- OBIEZIONE DI COSCIENZA !!! L’OBBEDIENZA NON E’ PIU’ UNA VIRTU’. LETTERA AI CAPPELLANI MILITARI. LA LEZIONE DI DON LORENZO MILANI
“DE DOMO DAVID”?! GIUSEPPE, MARIA, E L’IMMAGINARIO “COSMOTEANDRICO” (COSMOLOGIA, TEOLOGIA, E ANTROPOLOGIA!) DELLA CHIESA CATTOLICO-COSTANTINIANA... *
- Nota di commento a margine di "De Domo David. 39 autori per i 400 anni della confraternita di San Giuseppe di Nardò" (cfr. "Fondazione Terra d’Otranto", 10.11.2019).
CARDINALE CASTRILLON HOYOS: “Duemila anni fa, un ovulo fu miracolosamente fecondato dall’azione soprannaturale di Dio, da questa meravigliosa unione risultò uno zigote con un patrimonio cromosomico proprio. Però in quello zigote stava il Verbo di Dio”(dichiarazione del Cardinale Dario Castrillon Hoyos alla XV conferenza internazionale del Pontificio consiglio, la Repubblica del 17 novembre 2000, p. 35)
PAPA FRANCESCO: “«Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna» (Gal 4,4). Nato da donna: così è venuto Gesù. Non è apparso nel mondo adulto ma, come ci ha detto il Vangelo, è stato «concepito nel grembo» (Lc 2,21): lì ha fatto sua la nostra umanità, giorno dopo giorno, mese dopo mese. Nel grembo di una donna Dio e l’umanità si sono uniti per non lasciarsi mai più: anche ora, in cielo, Gesù vive nella carne che ha preso nel grembo della madre. In Dio c’è la nostra carne umana! [...]” (LIII GIORNATA MONDIALE DELLA PACE, Omelia di papa Francesco, Basilica Vaticana, Mercoledì, 1° gennaio 2020).
*
A) - La costruzione del ’presepe’ cattolico-romano .... e la ’risata’ di Giuseppe!!!
 MEMORIA DI FRANCESCO D’ASSISI. “VA’, RIPARA LA MIA CASA”!!!;
MEMORIA DI FRANCESCO D’ASSISI. “VA’, RIPARA LA MIA CASA”!!!;B) Il magistero della Legge dei nostri Padri e delle nostre Madri Costituenti non è quello di “Mammona” (“Deus caritas est”, 2006)! EUROPA: EDUCAZIONE SESSUALE ED EDUCAZIONE CIVICA. ITALIA “NON CLASSIFICATA”!!! Per aggiornamento, un consiglio di Freud del 1907.
C) GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di “pensare un altro Abramo”.
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---COSTITUZIONE, CRISTIANESIMO, CATTOLICESIMO ROMANO, E FILOLOGIA. Note sulla lettera del Sindaco di Milano, Giuseppe Sala.30 dicembre 2019, di Federico La Sala
COSTITUZIONE, MESSAGGIO EVANGELICO, CATTOLICESIMO ROMANO, E FILOLOGIA... *
- SE LA "CARISSIMA" EU-CARESTIA è figlia DELLA CARITA’ ("CARITAS") è e resta SEMPRE una ELEMOSINA, E L’EU-CHARIS-TIA è e resta sempre una CARITA’ ("Caritas") senza GRAZIA ("CHARItaS"):
- AMORIS LAETITIA [La gioia dell’amore]: "296. Il Sinodo si è riferito a diverse situazioni di fragilità o di imperfezione. Al riguardo, desidero qui ricordare ciò che ho voluto prospettare con chiarezza a tutta la Chiesa perché non ci capiti di sbagliare strada: «due logiche percorrono tutta la storia della Chiesa: emarginare e reintegrare [...]. La strada della Chiesa, dal Concilio di Gerusalemme in poi, è sempre quella di Gesù: della misericordia e dell’integrazione [...]. La strada della Chiesa è quella di non condannare eternamente nessuno; di effondere la misericordia di Dio a tutte le persone che la chiedono con cuore sincero [...]. Perché la carità vera è sempre immeritata, incondizionata e gratuita!».[326] Pertanto, «sono da evitare giudizi che non tengono conto della complessità delle diverse situazioni, ed è necessario essere attenti al modo in cui le persone vivono e soffrono a motivo della loro condizione».[327]" (ESORTAZIONE APOSTOLICA POSTSINODALE di Papa Francesco SULL’AMORE NELLA FAMIGLIA, 19 marzo 2016).
- "Perché la carità vera è sempre immeritata, incondizionata e gratuita!».[326]": "Nam, vera caritas semper immerita interminataque et gratuita est! [326]" (cfr.: "Homilia in Eucharistia cum Cardinalibus nuper electis celebrata habita, 15 februarii 2015)"
Sala: “La fede mi guida. Ma da divorziato soffro senza la comunione”
La lettera del sindaco di Milano. Riflessione sul rapporto con la religione: “Mi aiuta nell’impegno a favore dei più deboli. Altrimenti la parola di Dio rimane scritta solo nei libri e non nei nostri cuori”
di GIUSEPPE SALA (la Repubblica, 24 dicembre 2019)
Caro direttore, sono un uomo fortunato perché la fede è per me qualcosa di irrinunciabile. È un dono fondamentale che apprezzo ancor di più adesso, dopo i sessant’anni, con tanta vita alle spalle. Ho avuto momenti di stanchezza, ho vissuto dubbi e contraddizioni ma non ho mai smesso di ricercare il Signore. Tra tante vicende della vita sento di non potere fare a meno del confronto con il Mistero e, in definitiva, con me stesso.
Ed è proprio da questa esperienza che conosco i miei limiti. Non mi sono mai sentito così profondo da potermi nutrire solo di fede, di farmi “bastare” l’intima relazione con Dio. Penso spesso che la mia fede non reggerebbe senza la pratica, senza la possibilità di entrare in un luogo di culto, senza la Messa della domenica. Ho bisogno della Messa, di sentire la voce, più o meno ispirata, di un pastore e di misurarmi con Gesù e con il suo Vangelo. Pur nella consapevolezza dell’ineluttabilità del confronto che nasce in me e ritorna in me.
La Messa della domenica è un momento di pace e di verità. Mi fa star bene, mi aiuta a sentire la mia umanità, i miei dolori, la mia essenza. La gratitudine e la precarietà. Sono solo a disagio rispetto al momento della comunione, essendo divorziato e in uno stato che non mi consente di accostarmi al Sacramento. Amo stare insieme agli altri, condividere quel senso di solitudine e, allo stesso tempo, di comunione che la Messa ti dà. La liturgia ci insegna l’umiltà di essere come (e peggio) degli altri, di condividere la speranza, di far ammenda delle nostre miserie.
Si deve essere popolo anche fuori dalle porte della Chiesa. Tra tante urla, la ricerca della verità e della giustizia è l’impegno che dà senso alla mia fede, quella fede che mi dà l’energia giorno per giorno per rendere concreto il mio cammino sulla via dell’equità, del rispetto e dell’accoglienza soprattutto verso i più deboli e i più abbandonati. Altrimenti la parola di Dio rischia di rimanere scritta solo nei libri e non nei nostri cuori.
Per tutto ciò amo parlare di religione, ma ne aborro l’ostentazione. Sorrido pensando che ne sto scrivendo, ma è come se stessi parlando a me stesso.
I divorziati e l’eucarestia.
La lettera del sindaco Sala e le risposte che dà la Chiesa
È raro che un politico parli della sua vita di fede. Il primo cittadino di Milano lo ha fatto rivelando un’adesione di fede e una ferita
di Luciano Moia (Avvenire, sabato 28 dicembre 2019)
- [Foto] Giuseppe Sala, sindaco di Milano
È raro che un politico parli della sua vita di fede. Il sindaco Beppe Sala lo ha fatto rivelando un’adesione e una ferita. Un atto di coraggio e di chiarezza. Che non può che essere apprezzato da chi, come noi, da anni è impegnato a divulgare e promuovere la svolta pastorale voluta da papa Francesco all’insegna dell’accoglienza e della misericordia. Nella confessione spirituale che ha affidato, la vigilia di Natale, alle pagine de "la Repubblica", il sindaco di Milano rivela «di non poter fare a meno del confronto con il Mistero» e di partecipare regolarmente alla Messa domenicale, ma di sentirsi «a disagio rispetto al momento della Comunione, essendo divorziato e in uno stato che non mi consente di accostarmi al Sacramento».
Se una persona seria e preparata come Sala, è costretta ad ammettere un disorientamento spirituale per la sua condizione di divorziato risposato, significa che la strada per trasformare in consapevolezza diffusa le indicazioni uscite dal doppio Sinodo sulla famiglia (2014 e 2015) voluto da papa Francesco e poi dall’esortazione apostolica Amoris laetitia, è ancora lunga.
In quel testo il Papa scrive in modo esplicito che nessuno deve sentirsi condannato per sempre e che la Chiesa è chiamata ad offrire a tutti, compresi i divorziati risposati a cui è dedicato un intero capitolo - l’VIII - la possibilità di vivere pienamente il proprio cammino di fede. In questo cammino si può comprendere anche l’aiuto dei sacramenti (nota 351).
Non è un’opinione. È quanto emerso da un cammino sinodale proseguito per oltre tre anni che il Papa ha sancito con la sua parola. Poi, di fronte alle critiche e ai distinguo, Francesco ha voluto che l’interpretazione da lui considerata più efficace, quella dei vescovi della regione di Buenos Aires, fosse inserita nei cosiddetti Acta apostolica sedis - gli atti ufficiali della Santa Sede - a ribadire che indietro non si torna e che tutte le diocesi del mondo devono incamminarsi lungo quella strada.
Milano non fa eccezione. Inutile far riferimento al rito ambrosiano e alle aperture del cardinale Carlo Maria Martini, che su questi aspetti non ci sono state, in quanto scelte che non si potevano e non si possono pretendere da una singola Chiesa locale.
Francesco, come detto, ha ritenuto necessarie due assemblee mondiali dei vescovi per gettare i semi del cambiamento. Una persona divorziata e risposata che desidera riaccostarsi alla Comunione - spiega il Papa - può chiedere l’aiuto di un sacerdote preparato per avviare un serio esame di coscienza sulle proprie scelte esistenziali.
Sei, in rapidissima sintesi, i punti da non trascurare: quali sforzi sono stati fatti per salvare il precedente matrimonio e ci sono stati tentativi di riconciliazione? La separazione è stata voluta o subita? Che rapporto c’è con il precedente coniuge? Quale comportamento verso i figli? Quali ripercussioni ha avuto la nuova unione sul resto della famiglia? E sulla comunità? Domande spesso laceranti e risposte non codificabili, che possono richiedere anche lunghi tempi di elaborazione e da cui non derivano conseguenze uguali per tutti. Ma anche modalità pastorali efficaci per metterle in pratica.
Trovare e attuare queste buone prassi è faticoso e Sala, con le sue parole, ha dato voce a un disagio e una sofferenza spirituale, ma anche a una speranza, che condivide con tanti altri credenti, divorziati e risposati.
*SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE.
FLS
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- Appello per un nuovo costituzionalismo globale, una bussola etica e politica per salvare il mondo (di Raniero La Valle, Luigi Ferrajoli, Valerio Onida, e Altri)26 dicembre 2019, di Federico La Sala
«Perché la storia continui». Appello per una Costituzione della Terra
Proposte. Appello per un nuovo costituzionalismo globale, una bussola etica e politica per salvare il mondo e i suoi abitanti dalla distruzione.
di Raniero La Valle, Luigi Ferrajoli, Valerio Onida, Raffaele Nogaro, Paolo Maddalena, Mariarosaria Guglielmi, Riccardo Petrella (il manifesto, 26.12.2019)
Nel pieno della crisi globale, nel 72° anniversario della promulgazione della Costituzione italiana, Raniero La Valle, Luigi Ferrajoli, Valerio Onida, il vescovo Nogaro, Riccardo Petrella e molti altri lanciano il progetto politico di una Costituzione per la Terra e promuovono una Scuola, «Costituente Terra», che ne elabori il pensiero e prefiguri una nuova soggettività politica del popolo della Terra, «perché la storia continui». Pubblichiamo le parti essenziali del documento che esce domani, in data 27 dicembre 2019.
L’Amazzonia brucia e anche l’Africa, e non solo di fuoco, la democrazia è a pezzi, le armi crescono, il diritto è rotto in tutto il mondo. «Terra! Terra!» è il grido dei naufraghi all’avvistare la sponda, ma spesso la terra li respinge, dice loro: «i porti sono chiusi, avete voluto prendere il mare, fatene la vostra tomba, oppure tornate ai vostri inferni». Ma «Terra» è anche la parola oggi più amata e perduta dai popoli che ne sono scacciati in forza di un possesso non condiviso; dai profughi in fuga per la temperatura che aumenta e il deserto che avanza; dalle città e dalle isole destinate ad essere sommerse al rompersi del chiavistello delle acque, quando la Groenlandia si scioglie, i mari son previsti salire di sette metri sull’asciutto, e a Venezia già lo fanno di un metro e ottantasette. «Che si salvi la Terra» dicono le donne e gli uomini tutti che assistono spaventati e impotenti alla morte annunciata dell’ambiente che da millenni ne ospita la vita.
Ci sono per fortuna pensieri e azioni alternative, si diffonde una coscienza ambientale, il venerdì si manifesta per il futuro, donne coraggiose da Greta Thunberg a Carola Rackete fanno risuonare milioni di voci, anche le sardine prendono la parola, ma questo non basta. Se nei prossimi anni non ci sarà un’iniziativa politica di massa per cambiare il corso delle cose, se le si lascerà in balia del mercato della tecnologia o del destino, se in Italia, in Europa e nelle Case Bianche di tutti i continenti il fascismo occulto che vi serpeggia verrà alla luce e al potere, perderemo il controllo del clima e della società e si affacceranno scenari da fine del mondo, non quella raccontata nelle Apocalissi, ma quella prevista e monitorata dagli scienziati.
Il cambiamento è possibile
L’inversione del corso delle cose è possibile. Essa ha un nome: Costituzione della terra. Il costituzionalismo statuale che ha dato una regola al potere, ha garantito i diritti, affermato l’eguaglianza e assicurato la vita degli Stati non basta più, occorre passare a un costituzionalismo mondiale della stessa autorità ed estensione dei poteri e del denaro che dominano la Terra.
La Costituzione del mondo non è il governo del mondo, ma la regola d’ingaggio e la bussola di ogni governo per il buongoverno del mondo. Nasce dalla storia, ma deve essere prodotta dalla politica, ad opera di un soggetto politico che si faccia potere costituente. Il soggetto costituente di una Costituzione della Terra è il popolo della Terra, non un nuovo Leviatano, ma l’unità umana che giunga ad esistenza politica, stabilisca le forme e i limiti della sua sovranità e la eserciti ai fini di far continuare la storia e salvare la Terra.
Salvare la Terra non vuol dire solo mantenere in vita «questa bella d’erbe famiglia e d’animali», cantata dai nostri poeti, ma anche rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno sviluppo di tutte le persone umane.
 Il diritto internazionale è già dotato di una Costituzione embrionale del mondo, prodotta in quella straordinaria stagione costituente che fece seguito alla notte della seconda guerra mondiale e alla liberazione dal fascismo e dal nazismo: la Carta dell’Onu del 1945, la Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, i due Patti internazionali del 1966 e le tante Carte regionali dei diritti, che promettono pace, sicurezza, garanzia delle libertà fondamentali e dei diritti sociali per tutti gli esseri umani. Ma non sono mai state introdotte le norme di attuazione di queste Carte, cioè le garanzie internazionali dei diritti proclamati. Non è stato affatto costituito il nuovo ordine mondiale da esse disegnato. È come se un ordinamento statale fosse dotato della sola Costituzione e non anche di leggi attuative, cioè di codici penali, di tribunali, di scuole e di ospedali che «di fatto la realizzino».
Il diritto internazionale è già dotato di una Costituzione embrionale del mondo, prodotta in quella straordinaria stagione costituente che fece seguito alla notte della seconda guerra mondiale e alla liberazione dal fascismo e dal nazismo: la Carta dell’Onu del 1945, la Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, i due Patti internazionali del 1966 e le tante Carte regionali dei diritti, che promettono pace, sicurezza, garanzia delle libertà fondamentali e dei diritti sociali per tutti gli esseri umani. Ma non sono mai state introdotte le norme di attuazione di queste Carte, cioè le garanzie internazionali dei diritti proclamati. Non è stato affatto costituito il nuovo ordine mondiale da esse disegnato. È come se un ordinamento statale fosse dotato della sola Costituzione e non anche di leggi attuative, cioè di codici penali, di tribunali, di scuole e di ospedali che «di fatto la realizzino».È chiaro che in queste condizioni i diritti proclamati sono rimasti sulla carta, come promesse non mantenute. Riprendere oggi il processo politico per una Costituzione della Terra vuol dire tornare a prendere sul serio il progetto costituzionale formulato settant’anni fa e i diritti in esso stabiliti. E poiché quei diritti appartengono al diritto internazionale vigente, la loro tutela e attuazione non è soltanto un’urgente opzione politica, ma anche un obbligo giuridico in capo alla comunità internazionale e a tutti noi che ne facciamo parte.
Qui c’è un’obiezione formulata a partire dalla tesi di vecchi giuristi secondo la quale una Costituzione è l’espressione dell’«unità politica di un popolo»; niente popolo, niente Costituzione. E giustamente si dice che un popolo della Terra non c’è; infatti non c’era ieri e fino ad ora non c’è.
La novità è che adesso può esserci, può essere istituito; lo reclama la scena del mondo, dove lo stato di natura delle sovranità in lotta tra loro non solo toglie la «buona vita», ma non permette più neanche la nuda vita; lo reclama l’oceano di sofferenza in cui tutti siamo immersi; lo rende possibile oggi la vetta ermeneutica raggiunta da papa Francesco e da altre religioni con lui, grazie alla quale non può esserci più un dio a pretesto della divisione tra i popoli: «Dio non ha bisogno di essere difeso da nessuno» - hanno detto ad Abu Dhabi - non vuole essere causa di terrore per nessuno, mentre lo stesso «pluralismo e le diversità di religione sono una sapiente volontà divina con cui Dio ha creato gli esseri umani»; non c’è più un Dio geloso e la Terra stessa non è una sfera, ma un poliedro di differenze armoniose.
Per molti motivi perciò è realistico oggi porsi l’obiettivo di mettere in campo una Costituente della Terra, prima ideale e poi anche reale, di cui tutte le persone del pianeta siano i Padri e le Madri costituenti.
Una politica dalla parte della Terra
Di per sé l’istanza di una Costituzione della Terra dovrebbe essere perseguita da quello strumento privilegiato dell’azione politica che, almeno nelle democrazie, è il partito - nazionale o transnazionale che sia - ossia un artefice collettivo che, pur sotto nomi diversi, agisca nella forma partito. Oggi questo nome è in agonia perché evoca non sempre felici ricordi, ma soprattutto perché i grandi poteri che si arrogano il dominio del mondo non vogliono essere intralciati dal controllo e dalla critica dei popoli, e quindi cercano di disarmarli spingendoli a estirpare le radici della politica e dei partiti fin nel loro cuore. È infatti per la disaffezione nei confronti della politica a cui l’intera società è stata persuasa che si scende in piazza senza colori; ma la politica non si sospende, e ciò a cui comunque oggi siamo chiamati è a prendere partito, a prendere partito non per una Nazione, non per una classe, non “prima per noi”, ma a prendere partito per la Terra, dalla parte della Terra.
Ma ancor più che la riluttanza all’uso di strumenti già noti, ciò che impedisce l’avvio di questo processo costituente, è la mancanza di un pensiero politico comune che ne faccia emergere l’esigenza e ne ispiri modalità e contenuti.
Non manca certamente l’elaborazione teorica di un costituzionalismo globale che vada oltre il modello dello Stato nazionale, il solo nel quale finora è stata concepita e attuata la democrazia, né mancano grandi maestri che lo propugnino; ma non è diventato patrimonio comune, non è entrato nelle vene del popolo un pensiero che pensi e promuova una Costituzione della Terra, una unità politica dell’intera comunità umana, il passaggio a una nuova e rassicurante fase della storia degli esseri umani sulla Terra.
Eppure le cose vanno così: il pensiero dà forma alla realtà, ma è la sfida della realtà che causa il pensiero. Una “politica interna del mondo” non può nascere senza una scuola di pensiero che la elabori, e un pensiero non può attivare una politica per il mondo senza che dei soggetti politici ne facciano oggetto della loro lotta. Però la cosa è tale che non può darsi prima la politica e poi la scuola, né prima la scuola e poi la politica. Devono nascere insieme, perciò quello che proponiamo è di dar vita a una Scuola che produca un nuovo pensiero della Terra e fermenti causando nuove soggettività politiche per un costituzionalismo della Terra. Perciò questa Scuola si chiamerà «Costituente Terra».
«Costituente Terra»: una Scuola per un nuovo pensiero
Certamente questa Scuola non può essere pensata al modo delle Accademie o dei consueti Istituti scolastici, ma come una Scuola disseminata e diffusa, telematica e stanziale, una rete di scuole con aule reali e virtuali. Se il suo scopo è di indurre a una mentalità nuova e a un nuovo senso comune, ogni casa dovrebbe diventare una scuola e ognuno in essa sarebbe docente e discente. Il suo fine potrebbe perfino spingersi oltre il traguardo indicato dai profeti che volevano cambiare le lance in falci e le spade in aratri e si aspettavano che i popoli non avrebbero più imparato l’arte della guerra. Ciò voleva dire che la guerra non era in natura: per farla, bisognava prima impararla. Senonché noi l’abbiamo imparata così bene che per prima cosa dovremmo disimpararla, e a questo la scuola dovrebbe addestrarci, a disimparare l’arte della guerra, per imparare invece l’arte di custodire il mondo e fare la pace.
Molte sarebbero in tale scuola le aree tematiche da perlustrare:
1) le nuove frontiere del diritto, il nuovo costituzionalismo e la rifondazione del potere;
2) il neo-liberismo e la crescente minaccia dell’anomia;
3) la critica delle culture ricevute e i nuovi nomi da dare a eventi e fasi della storia passata;
4) il lavoro e il Sabato, un lavoro non ridotto a merce, non oggetto di dominio e alienato dal tempo della vita;
5) la «Laudato sì» e l’ecologia integrale;
6) il principio femminile, come categoria rigeneratrice del diritto, dal mito di Antigone alla coesistenza dei volti di Levinas, al legame tra donna e natura fino alla metafora della madre-terra;
7) l’Intelligenza artificiale (il Führer artificiale?) e l’ultimo uomo;
8) come passare dalle culture di dominio e di guerra alle culture della liberazione e della pace;
9) come uscire dalla dialettica degli opposti, dalla contraddizione servo-signore e amico-nemico per assumere invece la logica dell’ et-et, della condivisione, dell’armonia delle differenze, dell’ «essere per l’altro», dell’ «essere l’altro»;
10) il congedo del cristianesimo dal regime costantiniano, nel suo arco «da Costantino ad Hitler», e la riapertura nella modernità della questione di Dio;
11) il «caso Bergoglio», preannuncio di una nuova fase della storia religiosa e secolare del mondo.
Naturalmente molti altri temi potranno essere affrontati, nell’ottica di una cultura per la Terra alla quale nulla è estraneo d’umano. Tutto ciò però come ricerca non impassibile e fuori del tempo, ma situata tra due kairòs, tra New Delhi ed Abu Dhabi, due opportunità, una non trattenuta e non colta, la proposta di Gorbaciov e Rajiv Gandhi del novembre 1986 per un mondo libero dalle armi nucleari e non violento, e l’altra che ora si presenta di una nuova fraternità umana per la convivenza comune e la salvezza della Terra, preconizzata nel documento islamo-cristiano del 4 febbraio 2019 e nel successivo Comitato di attuazione integrato anche dagli Ebrei, entrato ora in rapporto con l’ONU per organizzare un Summit mondiale della Fratellanza umana e fare del 4 febbraio la Giornata mondiale che la celebri.
Partecipare al processo costituente iscriversi al Comitato promotore
Pertanto i firmatari di questo appello propongono di istituire una Scuola denominata «Costituente Terra» che prenda partito per la Terra, e a questo scopo hanno costituito un’associazione denominata «Comitato promotore partito della Terra». Si chiama così perché in via di principio non era stata esclusa all’inizio l’idea di un partito, e in futuro chissà. Il compito è oggi di dare inizio a una Scuola, «dalla parte della Terra», alle sue attività e ai suoi siti web, e insieme con la Scuola ad ogni azione utile al fine «che la storia continui»; e ciò senza dimenticare gli obiettivi più urgenti, il risanamento del territorio, la rifondazione del lavoro, l’abolizione del reato di immigrazione clandestina, la firma anche da parte dell’Italia del Trattato dell’ONU per l’interdizione delle armi nucleari e così via.
I firmatari propongono che persone di buona volontà e di non perdute speranze, che esponenti di associazioni, aggregazioni o istituzioni già impegnate per l’ecologia e i diritti, si uniscano a questa impresa e, se ne condividono in linea generale l’ispirazione, si iscrivano al Comitato promotore di tale iniziativa all’indirizzo progettopartitodellaterra@gmail.com versando la relativa quota sul conto BNL intestato a “Comitato promotore del partito della Terra”, IBAN IT94X0100503206000000002788 (dall’estero BIC BNLIITRR).
La quota annua di iscrizione, al Comitato e alla Scuola stessa, è libera, e sarà comunque gradita. Per i meno poveri, per quanti convengano di essere tra i promotori che contribuiscono a finanziare la Scuola, eventuali borse di studio e il processo costituente, la quota è stata fissata dal Comitato stesso nella misura significativa di 100 euro, con l’intenzione di sottolineare che la politica, sia a pensarla che a farla, è cosa tanto degna da meritare da chi vi si impegna che ne sostenga i costi, contro ogni tornaconto e corruzione, ciò che per molti del resto è giunto fino all’offerta della vita. Naturalmente però si è inteso che ognuno, a cominciare dai giovani, sia libero di pagare la quota che crede, minore o maggiore che sia, con modalità diverse, secondo le possibilità e le decisioni di ciascuno.
Nel caso che l’iniziativa non riuscisse, le risorse finanziarie mancassero e il processo avviato non andasse a buon fine, l’associazione sarà sciolta e i fondi eventualmente residui saranno devoluti alle ONG che si occupano dei salvataggi dei fuggiaschi e dei naufraghi nel Mediterraneo.
Un’assemblea degli iscritti al Comitato sarà convocata non appena sarà raggiunto un congruo numero di soci, per l’approvazione dello Statuto dell’associazione, la formazione ed elezione degli organi statutari e l’impostazione dei programmi e dell’attività della Scuola.
Roma, 27 dicembre 2019, 72° anniversario della promulgazione della Costituzione italiana.
PROPONENTI E PRIMI ISCRITTI. Raniero La Valle, giornalista (Roma), Luigi Ferrajoli, filosofo del diritto (Roma), Valerio Onida, già presidente della Corte Costituzionale, Raffaele Nogaro, ex vescovo di Caserta, Paolo Maddalena, già vicepresidente della Corte Costituzionale, Mariarosaria Guglielmi, Segretaria generale di Magistratura Democratica, Riccardo Petrella, ecologo, promotore del Manifesto dell’acqua e dell’identità di “Abitante della Terra”, Domenico Gallo, magistrato, Francesco Carchedi, sociologo (Roma), Francesco Di Matteo, Comitati Dossetti per la Costituzione, Anna Falcone. avvocata, Roma, Pippo Civati, Politico, Piero Basso (Milano), Gianpietro Losapio, cooperatore sociale, direttore del Consorzio NOVA, Giacomo Pollastri, studente in Legge (Roma), Francesco Comina, giornalista (Bolzano), Roberto Mancini, filosofo (Macerata), Francesca Landini, informatica (Roma), Giancarlo Piccinni e la Fondazione don Tonino Bello (Alessano), Grazia Tuzi, antropologa, autrice di “Quando si faceva la Costituzione. Storia e personaggi della comunità del porcellino” (Roma), Guido Innocenzo Gargano osb cam., monaco (Roma), Felice Scalia, s. J, (Messina), Marina Graziosi, docente (Roma), Agata Cancelliere, insegnante, (Roma), Raul Mordenti, storico della critica letteraria, Politico (Roma), Salvatore Maira, scrittore (Roma), Marco Malagola, francescano, missionario, (Torino), Norma Lupi (Roma), Andrea Cantaluppi, sindacalista (Roma), Enrico Peyretti (Torino), Nino Mantineo, università di Catanzaro, Giacoma Cannizzo, già sindaca di Partinico, Filippo Grillo, artista (Palermo), Nicola Colaianni, già magistrato e docente all’Università di Bari, Stefania Limiti, giornalista (Roma), Domenico Basile (Merate, Lecco), Maria Chiara Zoffoli (Merate), Luigi Gallo (Bolzano), Antonio Vermigli, giornalista (Quarrata, Pistoia), Renata Finocchiaro, ingegnere (Catania), Liana D’Alessio (Roma), Lia Fava, ordinaria di letteratura (Roma), Paolo Pollastri, musicista (Roma), Fiorella Coppola, sociologa (Napoli), Dario Cimaglia, editore, (Roma), Luigi Spina, insegnante, ricercatore (Biella), Marco Campedelli, Boris Ulianich, storico, Università Federico II, Napoli, Gustavo Gagliardi, Roma, Paolo Scandaletti, scrittore di storia, Roma, Pierluigi Sorti, economista, Roma, Vittorio Bellavite, coordinatore di “Noi siamo Chiesa”, Agnés Deshormes, cooperatrice internazionale, Parigi, Anna Sabatini Scalmati, psicoterapeuta, Roma, Francesco Piva, Roma, Sergio Tanzarella, storico del cristianesimo, Tina Palmisano, Il Giardino Terapeutico sullo Stretto, Messina, Luisa Marchini, segretaria di “Salviamo la Costituzione”, Bologna, Maurizio Chierici, giornalista. Angelo Cifatte, formatore, Genova, Marco Tiberi, sceneggiatore, Roma, Achille Rossi e l’altrapagina, Città di Castello, Antonio Pileggi, ex Provveditore agli studi e dir. gen. INVALSI, Giovanni Palombarini, magistrato, Vezio Ruggieri, psicofisiologo (Roma) Bernardetta Forcella (insegnante (Roma), Luigi Narducci (Roma), Laura Nanni (Albano), Giuseppe Salmè, magistrato, Giovanni Bianco, giurista, Roma.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO ED EPISTEMOLOGIA: "CAPIRE IL COMPORTAMENT UMANO" (di A. Rainone).17 dicembre 2019, di Federico La Sala
USCIRE DALL’INFERNO EPISTEMOLOGICO. Amore (Charitas) o Mammona (Caritas)?! Il "principle of charity", il «principio di carità» ("caritas"!), un assunzione di tipo «imperialistico» (Robert Nozick, "The Nature of Rationality", 1993) *
CAPIRE IL COMPORTAMENTO UMANO.
di Antonio Rainone *
- 3.Linguaggio ed empatia in W. V. Quine
Carità o empatia?
Esiste una tematica nella filosofia del linguaggio e nell’epistemologia di W. V. Quine che può apparire per molti versi atipica o sorprendente a chi abbia del celebre filosofo statunitense un’immagine limitata alle sue concezioni fisicalistiche e comportamentistiche, per non dire “scientistiche”, non di rado considerate le più caratteristiche della sua produzione filosofica. Si tratta della tematica dell’empatia, cioè della capacità di avanzare spiegazioni o interpretazioni del comportamento (linguistico e non) di altri soggetti “mettendosi nei loro panni” o “simulandone” la situazione cognitiva o, ancora, assumendone immaginativamente il ruolo.
 L’empatia - anche indipendentemente
da Quine - ha peraltro suscitato una particolare attenzione
nella filosofia della mente degli ultimi trent’anni, dove ha dato vita a
un ampio dibattito sul cosiddetto mindreading, incontrandosi inoltre con
la teoria neuroscientifica dei cosiddetti neuroni specchio 1. I più recenti lavori
sulla filosofia del linguaggio di Quine dedicano una particolare attenzione
a tale tematica 2, anche perché Quine, pur accennandovi in Word and Object
(1960), ne ha proposto una esplicita teorizzazione solo nella sua produzione
più tarda.
L’empatia - anche indipendentemente
da Quine - ha peraltro suscitato una particolare attenzione
nella filosofia della mente degli ultimi trent’anni, dove ha dato vita a
un ampio dibattito sul cosiddetto mindreading, incontrandosi inoltre con
la teoria neuroscientifica dei cosiddetti neuroni specchio 1. I più recenti lavori
sulla filosofia del linguaggio di Quine dedicano una particolare attenzione
a tale tematica 2, anche perché Quine, pur accennandovi in Word and Object
(1960), ne ha proposto una esplicita teorizzazione solo nella sua produzione
più tarda.A partire dagli anni Settanta, ma più esplicitamente negli anni Novanta, Quine ha considerato il metodo dell’empatia come il metodo fondamentale di traduzione nel celebre Gedankenexperiment della traduzione radicale (ovvero la traduzione di una lingua completamente sconosciuta), ma anche come una capacità naturale ai fini dell’acquisizione del linguaggio e dell’attribuzione di stati mentali intenzionali (ossia percezioni, credenze, desideri ecc.) ad altri. In effetti, l’empatia ha acquisito un rilievo così crescente in Quine che nei suoi due ultimi lavori sistematici, Pursuit of Truth (1992) e From Stimulus to Science (1995), essa appare come un nucleo centrale della sua filosofia del linguaggio e della mente.
È stato del resto lo stesso Quine a sottolineare la rilevanza dell’empatia nella sua filosofia del linguaggio, “retrodatandone”, per così dire, la teorizzazione agli anni Cinquanta. Così Quine si esprime in uno dei suoi ultimi interventi sulla questione:
- Il mio uso della parola “empatia” è piuttosto recente ed è stato notato, ma io avevo già riconosciuto che l’approccio del traduttore radicale è di tipo empatico in Word and Object e, in realtà, già nove anni prima. «Il lessicografo - avevo scritto - dipende [...] da una proiezione di sé stesso, con la sua Weltanschauung indo-europea, nei sandali del suo informatore Kalaba» (Quine, 2000, p. 410).
Il brano qui citato da Quine, ripreso dall’importante The Problem of Meaning in Linguistics (1951b, p. 63) - una notevole anticipazione della problematica della traduzione radicale - non è privo di una certa ambiguità, prestandosi a una duplice lettura. È forse vero che in Word and Object alcune affermazioni di Quine potrebbero essere interpretate come la proposta di un metodo empatico, sostenuto comunque in modo non del tutto esplicito (cfr. Rainone, 1995), ma possono essere avanzati dei dubbi circa la difesa di tale metodo nel saggio del 1951. Se da un lato il concetto di proiezione sembra proporre il metodo dell’empatia nell’attività di traduzione di una lingua completamente sconosciuta da parte di un etnolinguista, dall’altro sembra in effetti riferirsi non tanto al metodo empatico, quanto, piuttosto, a quello che, grazie allo stesso Quine, e in seguito a Donald Davidson (cfr. Davidson, 1984), sarebbe diventato noto come «principio di carità» (principle of charity). Il linguista - asseriva infatti Quine - proietta sé stesso con la sua Weltanschauung nei panni del nativo che usa una lingua sconosciuta, presupponendo (o ipotizzando) così che il suo informatore si conformi ai suoi principi logici e abbia le sue stesse credenze (ritenute vere) riguardo alla realtà (sono questi, grosso modo, i principali tenet del principio di carità, che presuppone una comune natura razionale tra interprete/ traduttore e interpretato/parlante).
In Word and Object Quine avrebbe esplicitamente utilizzato - e teorizzato - il principio di carità riguardo alla traduzione dei connettivi logici e degli enunciati “ovvi”. L’esempio più pertinente, in merito, è rappresentato dal «caso estremo» di qualche nativo che accetti come veri enunciati traducibili nella forma “p e non-p” (per esempio, “piove e non piove”), una forma enunciativa che, violando il principio di non contraddizione, deporrebbe per Quine non a favore dell’irrazionalità dei parlanti - come riteneva Lévy-Bruhl con la sua teoria della «mentalità prelogica» - ma contro la correttezza della traduzione (Quine, 1960, p. 58).
Il medesimo argomento varrebbe inoltre per la traduzione di enunciati ovvi: una risposta negativa da parte del nativo alla domanda (nella lingua nativa) “sta piovendo?” fatta sotto la pioggia costituirebbe una prova di cattiva traduzione nella lingua nativa, non del fatto che il nativo non condivida con il traduttore la credenza in qualcosa di così evidente. In generale, nota Quine in un famoso passo di Word and Object, «quanto più assurde o esotiche sono le credenze attribuite a una persona tanto più sospetti abbiamo il diritto di essere nei confronti delle traduzioni; il mito dei popoli prelogici segna solo il caso estremo» (ivi, p. 68).
Difficilmente, pertanto, la «proiezione» del linguista nei «sandali» del nativo di cui Quine parlava nel saggio del 1951 potrebbe apparire come una forma di metodo empatico, dal momento che essa “imporrebbe” al nativo uno «schema concettuale» (quello del linguista) che, per quanto il linguista può saperne, potrebbe essergli del tutto estraneo. Questo è, in fondo, il problema sottostante a tutto il celebre secondo capitolo di Word and Object3. Non vi sarebbe alcuna garanzia, infatti, secondo Quine, che i nativi condividano lo stesso schema concettuale (la stessa Weltanschauung) del linguista. Ma il linguista non può, d’altro canto, che fare affidamento sul proprio linguaggio (o schema concettuale), data la scarsa evidenza empirica di cui dispone nel tradurre la lingua sconosciuta. Basarsi sul proprio schema concettuale, proiettandolo sul «linguaggio della giungla», è una necessità pratica, che - asseriva Quine in Word and Object - investirebbe soprattutto l’elaborazione delle «ipotesi analitiche», ovvero le ipotetiche correlazioni tra le emissioni verbali olofrastiche dei nativi e le loro possibili traduzioni mediante cui il linguista deve stabilire quali frammenti di enunciati andranno considerati termini (singolari e generali), quali congiunzioni, quali articoli, quali desinenze per il plurale e quali pronomi, sulla cui base individuare un insieme plausibile di credenze ontologiche ed epistemiche. La scelta delle ipotesi analitiche, infatti, non è altro che un modo di «catapultarsi nel linguaggio della giungla utilizzando i propri modelli linguistici » (ivi, p. 70).
 Per ricordare il celebre esempio di Quine, la traduzione
del proferimento di “gavagai” con “coniglio” (invece che con alternative
bizzarre quali “stadi di coniglio” o “sta conigliando”, per quanto ammissibili
sulla base dell’evidenza osservativa) equipara l’emissione verbale nativa
a un termine generale del linguaggio del linguista, ma nulla esclude che i
nativi possano essere privi di un termine referenziale generale per designare
i conigli, anche se il linguista ritiene ciò “caritatevolmente” improbabile.
Per ricordare il celebre esempio di Quine, la traduzione
del proferimento di “gavagai” con “coniglio” (invece che con alternative
bizzarre quali “stadi di coniglio” o “sta conigliando”, per quanto ammissibili
sulla base dell’evidenza osservativa) equipara l’emissione verbale nativa
a un termine generale del linguaggio del linguista, ma nulla esclude che i
nativi possano essere privi di un termine referenziale generale per designare
i conigli, anche se il linguista ritiene ciò “caritatevolmente” improbabile.Utilizzare i modelli del proprio linguaggio per tradurre un linguaggio alieno non equivale quindi ad applicare un metodo empatico di comprensione, trattandosi al massimo di un’ulteriore e più ampia applicazione del principio di carità. L’empatia sembra in realtà qualcosa di diverso dalla carità: a differenza di quest’ultima, l’empatia non presuppone necessariamente una condivisione di significati e stati cognitivi (credenze). Forse l’assunzione di un’analogia di stati cognitivi tra interprete e interpretato - il «ritrovamento dell’io nel tu», secondo la celebre formula di Wilhelm Dilthey (1927, trad. it. p. 293) - può apparire inevitabile ed efficace riguardo alle risposte verbali fenomenologiche direttamente connesse a stimolazioni elementari provenienti da eventi osservativi intersoggettivi del mondo esterno (la pioggia, il colore rosso, il caldo e il freddo ecc.): ci si aspetta infatti che i nativi, che presentano una conformazione neurofisiologica e neuropsicologica analoga alla nostra, non abbiano percezioni di tipo diverso dalle nostre, rispondendo linguisticamente a tali percezioni in modo analogo a come risponderemmo noi; in tal caso l’empatia sembrerebbe indistinguibile dalla carità interpretativa, in quanto fondata sull’assunzione dell’esistenza di meccanismi percettivi comuni ai soggetti coinvolti. Ma difficilmente tale analogia potrebbe essere presupposta allorché si tratti di tradurre il linguaggio o spiegare il comportamento di soggetti appartenenti a una cultura del tutto estranea a quella dell’interprete. In questo caso l’interprete dovrà in qualche modo “entrare”, per così dire, nella “mente” dei soggetti da interpretare per comprendere il loro peculiare punto di vista, le loro credenze sulla realtà e i significati delle loro parole.
In definitiva, la differenza tra carità ed empatia può essere intesa come la differenza tra imporre il proprio punto di vista all’altro e assumere il punto di vista dell’altro. La differenza è particolarmente rilevante nei casi di interpretazione di soggetti appartenenti a “mondi” radicalmente diversi da quello dell’interprete. Se così non fosse, difficilmente gli etnoantropologi avrebbero potuto attribuire credenze animistiche o culti religiosi atipici (come i celebri cargo cults) alle popolazioni studiate (in entrambi i casi si dovrebbe trattare, secondo un’interpretazione caritatevole, di errori di traduzione o interpretazione).
Non dovrebbe costituire motivo di sorpresa, allora, che David K. Lewis, in un saggio dedicato alla problematica davidsoniana dell’«interpretazione radicale», avesse dato una definizione del principio di carità che ingloba, per così dire, anche il procedimento empatico: un soggetto di interpretazione, asseriva Lewis, «dovrebbe credere ciò che crediamo noi, o forse ciò che avremmo creduto noi al suo posto; e dovrebbe desiderare ciò che desideriamo noi, o forse ciò che avremmo desiderato noi al suo posto» (Lewis, 1974, p. 336; corsivi aggiunti). In pratica, secondo questa definizione del principio di carità, si tratterebbe di assumere empaticamente il punto di vista dei soggetti interpretati, tenendo conto delle loro credenze (eventualmente false o strane) e della loro cultura di appartenenza, attribuendo a essi non le credenze e i desideri dell’interprete, ma le credenze e i desideri che l’interprete avrebbe se fosse “nei loro panni”. Si può aggiungere, a tale proposito, che l’empatia rappresenta una sorta di “correttivo” del principio di carità, tenendo conto del punto di vista dell’altro.
Ma forse c’è ancora qualcosa da dire: mentre la carità impone dei vincoli normativi sulla razionalità dei soggetti da interpretare - vincoli a priori basati sui principi logici e sulle norme di razionalità epistemica e pratica dell’interprete, ritenuti universali 4 -, l’empatia sembrerebbe invece un metodo descrittivo ed empirico, essendo subordinata all’acquisizione di un’ampia gamma di informazioni relative alle credenze, alla cultura e alle esperienze passate dei soggetti da interpretare (inutile aggiungere che non c’è accordo su quest’ultimo punto).
4. Si può ricordare, riguardo a questa presunta universalità, che Robert Nozick ha contestato il principio di carità in quanto assunzione di tipo «imperialistico», conferendo tale principio «un peso indebito alla posizione che accade di occupare a noi, alle nostre credenze e alle nostre preferenze» (Nozick, 1993, p. 153). Giustamente, Nozick fa notare che difficilmente questa sarebbe l’assunzione di un antropologo relativamente alle cosiddette società “primitive” (ivi, p. 154).
* Cfr. Antonio Rainone, "Capire il comportamento umano. Azione, razionalità, empatia", Carocci editore, Roma, 2019, pp. 55-59, ripresa parziale.
* Sul tema, nel sito, si cfr.:
- L’EUROPA, IL CRISTIANESIMO ("DEUS CHARITAS EST"), E IL CATTOLICESIMO COSTANTINIANO ("DEUS CARITAS EST").Una storia di lunga durata...
- MURATORI, BENEDETTO XVI, E "UNO SPROPOSITO MAIUSCOLO"
- DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE.
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- COSTITUZIONE, UNIVERSITA’, E LIBERTA’ ACCADEMICA - OGGI. PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO.10 dicembre 2019, di Federico La Sala
PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. PER "NEGARE A HITLER LA VITTORIA POSTUMA" (Emil L. Fackenheim, "Tiqqun. Riparare il mondo") .. *
Neonazismo e libertà accademica
di Andrea Mariuzzo (Il Mulino, 09 dicembre 2019)
Ha suscitato scalpore il caso di Emanuele Castrucci, professore ordinario di Filosofia del diritto all’Università di Siena che per anni ha sostenuto tramite i suoi profili social posizioni esplicitamente neonaziste, razziste, antisemite e negazioniste della Shoah . Il rettore senese e gli organi rappresentativi dei suoi colleghi, spinti dal montare della polemica mediatica, hanno preso le distanze da lui e stanno promuovendo provvedimenti che possono preludere a un licenziamento, aperti da una denuncia alla Procura.
A fronte di questi sviluppi, alcuni studiosi e accademici hanno sollevato dubbi sull’opportunità e sulla legittimità di un atteggiamento repressivo verso il docente da parte dell’ateneo di appartenenza. In particolare Biagio De Giovanni, pur condannando fermamente l’opinione del collega, ha rigettato l’ipotesi di un licenziamento richiamando la qualità della sua attività intellettuale e l’illegittimità di provvedimenti di totale ostracismo in un ambiente, quello della ricerca universitaria, che si fonda sul libero confronto e dibattito e sulla battaglia delle idee, non sulla loro repressione. È stato del resto proprio Castrucci a difendersi facendo rientrare le sue esternazioni nell’ambito della piena libertà di parola e di espressione che caratterizzano il libero confronto.
Il tema è interessante e merita di essere affrontato fino in fondo, anche per trarre da un caso singolo alcune linee di comportamento generali. Iniziamo facendo chiarezza: la libertà di esprimersi accordata a un professore universitario è molto più solida e strutturata della semplice libertà di parola riconosciuta a tutte e a tutti nelle democrazie liberali: si tratta infatti di libertà accademica. Essa consiste, a dirla brutalmente, nella possibilità di essere pagati e accedere alle fondamentali strutture professionali dell’insegnamento e della ricerca anche per sostenere posizioni ritenute sbagliate, pericolose, potenzialmente catastrofiche se diffuse e messe in pratica nella società. Non è un caso se, nel senso comune così come negli aspetti più noti della legislazione in materia, la libertà accademica quasi si identifica col mantenimento della posizione lavorativa e stipendiale dello studioso. È così di fronte alla sostanziale inamovibilità maturata per i docenti nei Paesi in cui la “corporazione” universitaria è stata più largamente inglobata nell’impiego pubblico, e nell’ambito della tenure riconosciuta in sistemi contrattuali come quello statunitense.
Molto spesso però si dimentica un altro elemento nell’attribuzione di quello che è, a tutti gli effetti, un privilegio professionale strettamente legato alla funzione culturale e sociale di docenti e ricercatori universitari. Ai ruoli a cui viene riconosciuta la libertà accademica si accede dopo che la comunità degli studiosi ha potuto prendere in esame per un congruo periodo di tempo l’attività scientifica dell’aspirante docente, riscontrandovi un adeguato livello di competenza disciplinare e la maturazione di un’adeguata etica professionale. Questo passaggio è esplicito nelle norme che, ad esempio negli Stati Uniti, regolano il tenure track, e in fondo si ritrova alle radici della formazione stessa delle istituzioni universitarie nell’Europa medievale, quando appunto la licentia ubique docendi costituiva un fondamentale accesso alla possibilità di insegnare rilasciata dopo attento esame da parte di alcuni tra i massimi esperti della disciplina.
Una volta chiarito questo quadro generale, quali conclusioni possiamo trarre sul caso Castrucci? In primo luogo, se coi suoi tweet antisemiti e filohitleriani il docente ha esercitato il proprio inalienabile diritto alla libertà di espressione o ne ha abusato violando la legislazione sull’apologia del nazismo e del fascismo e quella (a mio parere, e anche secondo l’opinione della principale associazione culturale italiana di storici contemporaneisti, piuttosto scivolosa e non del tutto condivisibile) sul negazionismo, spetta alla magistratura e non all’università.
Detto questo, occorre chiedersi se le sue prese di posizione sono difese dalla libertà accademica, che quindi lo mette al riparo da provvedimenti sul piano professionale. Ed è questo il punto a mio parere interessante. Se infatti, come abbiamo visto in precedenza, l’attribuzione del privilegio della libertà accademica si regge sulla dimostrazione di aver acquisito e di mantenere competenza disciplinare ed etica professionale, bisogna ammettere che chi esprime pubblicamente le opinioni che ha espresso convintamente Castrucci forse non possiede più, se mai effettivamente è giunto ad averle, né l’una né l’altra.
Da un lato, le idee sul “complotto ebraico”, sulla politica monetaria “sovranista” di Hitler e Mussolini e sulla veridicità dei Protocolli dei Savi di Sion, prima di essere aberranti, sono fondate su dati falsi e ampiamente smentiti, e possono essere credute solo da una persona ignorante della storia, sciatta nell’analisi critica delle sue fonti, priva dei filtri culturali alla propaganda più trita che ci si aspetterebbe da un uomo di cultura, per di più specializzato nella storia delle idee e del pensiero. Dall’altro, è doveroso chiedersi se chi esprime così apertamente il disprezzo per interi gruppi umani ha poi dato seguito alle parole con comportamenti più o meno velatamente discriminatori e ostruzionistici nei confronti di studentesse e studenti, colleghe e colleghi, in un mondo universitario in cui tra molte difficoltà si affacciano minoranze di cui andrebbero tutelate le pari opportunità.
Dunque, alla luce di un comportamento così evidentemente lesivo di qualsiasi codice etico di condotta fondato sulla convinzione che un professionista intellettuale non smette le sue funzioni professionali alla fine dell’orario d’ufficio e che la comunicazione pubblica del personale universitario è parte integrante della “terza missione” di divulgazione e public engagement, avrebbe senso se l’ateneo senese indagasse da vicino sui comportamenti tenuti da Castrucci nelle proprie relazioni di lavoro, ponendosi il problema del perché finora non è emerso nulla dai canali di tutela e di valutazione degli studenti o da rimostranze di colleghi, e se ripercorresse con attenzione le tappe di carriera del docente e le sue valutazioni successive per individuare come e perché nella lettura critica della sua produzione da parte di commissari ed esperti valutatori non siano emersi gli elementi di sciatteria, pressapochismo e vero e proprio errore metodologico che non possono non caratterizzare, almeno da un certo punto in poi, gli scritti di chi sostiene in coscienza posizioni come le sue. Questa indagine retrospettiva, oltre a mettere in discussione il posto di professore ordinario di Castrucci, potrebbe e dovrebbe chiamare in causa i responsabili della sua carriera, e far loro rendere conto di procedure di selezione e conferma chiaramente inadeguate.
In questo modo si otterrebbe il risultato di non fare di Castrucci un autoproclamato “martire” del libero pensiero con una sanzione esclusivamente individuale; si darebbero radici eminentemente professionali alle sanzioni conseguenti ai suoi gesti; si farebbe luce sul sistema di collusioni e di silenzi che ha permesso a una figura così inadeguata di restare in cattedra per anni, chiarendo che le responsabilità non sono soltanto sue.
Più in generale, poi, riflettere sui caratteri fondamentali della professione accademica e sulla necessità di una verifica continua della loro soddisfazione potrebbe far bene al sistema universitario nel suo complesso. Se i meccanismi di valutazione dell’idoneità professionale e della qualità della ricerca e della didattica si concentrassero, piuttosto che su astratti livelli di “eccellenza” spesso concepiti in senso puramente quantitativo, su come individuare più prontamente casi di palese inadeguatezza come questo, si sarebbe fatto un passo avanti per offrire un ambiente universitario più vivibile. Allo stesso modo, se i codici etici delle università venissero concepiti non tanto come manuali di buone maniere per non offendere il potente di turno e non mettere in cattiva luce i propri vertici impegnati nella competizione per i finanziamenti ministeriali, quanto per tracciare un insieme di comportamenti da cui risultino le qualità professionali richieste ai docenti per la loro funzione, le possibilità di produttiva interazione tra alta cultura e società sarebbero decisamente più significative.
* SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
RIPENSARE L’EUROPA. PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!
 FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! E I FILOLOGI?! --- MESSAGGIO EVANGELICO E TEOLOGIA-POLITICA: VERSO "NICEA 2025". Quale "carità" (Kapitas o Xapitas, caritas o charitas)?!6 dicembre 2019, di Federico La Sala
VERSO "BARI 2020", "NICEA 2025": MESSAGGIO EVANGELICO, FILOLOGIA, ED ECUMENISMO. Quale "carità" (Kapitas o Xapitas, caritas o charitas)?! *
Nicola. Protettore del ponte di dialogo che unisce Occidente e Oriente
di Matteo Liut (Avvenire, giovedì 6 dicembre 2018)
La carità è il "miracolo" più grande che nasce dalla fede: prendersi cura degli ultimi, del prossimo in genere, oggi è il messaggio più profetico e rivoluzionario che ci lascia san Nicola. Nato tra il 250 e il 260 a Patara, nella Licia, divenne vescovo di Mira in un tempo di persecuzione e dovette affrontare anche la prigionia: si salvò grazie alla libertà di culto concessa dall’Editto di Costantino nel 313.
Difensore dell’ortodossia, forse partecipò al Concilio di Nicea nel 325. La tradizione gli attribuisce un’attenzione particolare nei confronti dei bisognosi, come le due giovani ragazze che poterono sposarsi solo grazie al dono da parte del vescovo di una dote. Morto attorno all’anno 335, nel 1087 le sue reliquie arrivarono a Bari, dove è venerato come patrono e considerato un protettore anche del ponte di dialogo che unisce Occidente e Oriente.
 Altri santi. Santa Asella di Roma, vergine (IV sec.); san Pietro Pascasio, vescovo e martire (1227-1300).
Altri santi. Santa Asella di Roma, vergine (IV sec.); san Pietro Pascasio, vescovo e martire (1227-1300).
 Letture. Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27.
Letture. Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27.
 Ambrosiano. Ger 7,1-11; Sal 106; Zc 8,10-17; Mt 16,1-12.
Ambrosiano. Ger 7,1-11; Sal 106; Zc 8,10-17; Mt 16,1-12.
*
Sul tema, in rete e nel sito, si cfr.:
Commenti a Presicce, il suo patrono Sant’Andrea e la tela del suo martirio, opera del Catalano
PER "LA PACE DELLA FEDE" (Niccolò Cusano, 1453), UN NUOVO CONCILIO DI NICEA (2025)
 ERMETISMO ED ECUMENISMO RINASCIMENTALE, OGGI: INCONTRO DI PAPA FRANCESCO E BARTOLOMEO I A ISTANBUL.
ERMETISMO ED ECUMENISMO RINASCIMENTALE, OGGI: INCONTRO DI PAPA FRANCESCO E BARTOLOMEO I A ISTANBUL.Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! - A studiare "il metodo Aristotele" e a proporre "Esercizi filosofici per il buon uso della vita" (di Roberto Mussapi)..3 dicembre 2019, di Federico La Sala
Idee.
Povera filosofia ridotta a ricetta terapeutica
Due libri pescano da Aristotele e in generale dal pensiero greco per insegnare, come dei manuali, a raggiungere la felicità
di Roberto Mussapi (Avvenire, martedì 3 dicembre 2019)
Aristotele fu il primo filosofo a chiedersi che cosa sia la felicità, e come possiamo conseguirla. Da questa affermazione nasce un saggio che indica, nell’opera del maestro, una guida ancora attuale per la ricerca delle felicità. Per Edith Hall, nel suo Il metodo Aristotele (Einaudi, 288 pagine, euro 19,50), il pensatore greco è essenzialmente una guida a tale scopo, secondo il sottotitolo, “Come la saggezza degli antichi può cambiare la vita”: un mondo di formule, un ricettario, secondo le necessità e le richieste del nostro tempo. Un Aristotele un po’ diverso da come lo vedeva Dante, o secoli di pensiero. Certo, il padre della filosofia razionale guida anche alla ricerca della felicità, ma non necessariamente alla scoperta del suo elisir.
 Aristotele non è un guaritore, personal trainer di anima e corpo, custode del segreto della felicità. Segreto che per ogni filosofo, o non esiste, o resta sempre segreto, mistero, che anima sempre alla nuova ricerca. Giusto distinguere il suo pensiero da quello cupo degli stoici, o da quello catartico e fondamentalista dei cinici. E quando Aristotele, per citare un esempio dal libro, afferma che sesso, cibo e vino, senza eccessi, contribuiscono alla felicità individuale e della persona amata, manifesta rispetto per la vita fisica, ma non sta indicando una ricetta. Il saggio di Edith Hall esplora il pensiero del filosofo, e lo orienta sulla ricerca di una felicità di fatto mondana, temporanea, ametafisica.
Aristotele non è un guaritore, personal trainer di anima e corpo, custode del segreto della felicità. Segreto che per ogni filosofo, o non esiste, o resta sempre segreto, mistero, che anima sempre alla nuova ricerca. Giusto distinguere il suo pensiero da quello cupo degli stoici, o da quello catartico e fondamentalista dei cinici. E quando Aristotele, per citare un esempio dal libro, afferma che sesso, cibo e vino, senza eccessi, contribuiscono alla felicità individuale e della persona amata, manifesta rispetto per la vita fisica, ma non sta indicando una ricetta. Il saggio di Edith Hall esplora il pensiero del filosofo, e lo orienta sulla ricerca di una felicità di fatto mondana, temporanea, ametafisica.Certo è lapalissiano sottolineare come rispetto al maestro Platone, Aristotele non consideri fallace la vita terrena, illusoria al confronto con il mondo delle Idee. Ma è riduttivo farne un pensatore privo di senso del tragico. Il tema della felicità, e della filosofia che sarebbe nata per consentire a tutti di conseguirla, anima un altro libro, dal titolo esplicito: Lezioni di felicità (Einaudi, pagine 148, euro 13,00) di Ilaria Gasparri, seguito da un sottotitolo ancora più appetibile e promozionale: “Esercizi filosofici per il buon uso della vita”.
 L’autrice parte da una domanda retorica: che cosa succederebbe se di punto in bianco decidessimo di conoscere noi stessi al modo degli antichi Greci? Risposta al quiz: risolveremmo problemi, ansie, dilemmi diversamente annebbianti, e nefasti. Che ogni problema del presente non possa essere affrontato solo nella dimensione del presente stesso, ma richieda una prospettiva più ampia, che riguarda il passato la tradizione, è constatazione sacrosanta e difficilmente contestabile. Ma l’affermazione che una parte del passato e della nostra tradizione contengano le soluzioni pronte a risolvere problemi di oggi, rivela atteggiamento semplificativo, quale quello della Hall rispetto ad Aristotele. Il mondo della filosofia greca sarebbe un formidabile ricettario di formule e verità utili a risolvere la ricerca della felicità, una volta per sempre. Di nuovo la filosofia usata come tesoro di ricette. In sintesi, non va trascurata, perché è utile.
L’autrice parte da una domanda retorica: che cosa succederebbe se di punto in bianco decidessimo di conoscere noi stessi al modo degli antichi Greci? Risposta al quiz: risolveremmo problemi, ansie, dilemmi diversamente annebbianti, e nefasti. Che ogni problema del presente non possa essere affrontato solo nella dimensione del presente stesso, ma richieda una prospettiva più ampia, che riguarda il passato la tradizione, è constatazione sacrosanta e difficilmente contestabile. Ma l’affermazione che una parte del passato e della nostra tradizione contengano le soluzioni pronte a risolvere problemi di oggi, rivela atteggiamento semplificativo, quale quello della Hall rispetto ad Aristotele. Il mondo della filosofia greca sarebbe un formidabile ricettario di formule e verità utili a risolvere la ricerca della felicità, una volta per sempre. Di nuovo la filosofia usata come tesoro di ricette. In sintesi, non va trascurata, perché è utile.Rispetto alla Hall Ilaria Gasparri ha il merito di scegliere, per le settimane terapeutiche in cui orchestra il libro, scuole filosofiche in sé già limitate da una prospettiva in parte utilitaria: cinque delle sei settimane sono immersioni nel pensiero eleatico, scettico, stoico, epicureo e cinico: da nessuna di queste scuole filosofiche nasce vertigine. Non si riferisce, l’autrice, e giustamente, al Socrate che non cerca la felicità ma il bene assoluto, e beve la cicuta pronto a volare come un bianco uccello nell’immortalità. Non c’é Platone, con l’ascesi del pensiero misticamente ardente allo spazio iperuranio, e le visioni estatiche delle Muse e delle Sirene, non c’è Plotino con il mistero dell’Anima e delle singole sue manifestazioni.
 Ma la prima scuola, quella pitagorica, non nasce affatto come filosofia pronta per l’uso, quale possono essere intese, seppur semplificando, stoicismo e cinismo: è alle origini del mistero del numero, del mito e rito in cui l’Oriente passa metamorfosandosi misteriosamente in Occidente.
Ma la prima scuola, quella pitagorica, non nasce affatto come filosofia pronta per l’uso, quale possono essere intese, seppur semplificando, stoicismo e cinismo: è alle origini del mistero del numero, del mito e rito in cui l’Oriente passa metamorfosandosi misteriosamente in Occidente.
 In linea di massima questo approccio semplificante e edificante al pensiero filosofico potrà condurre qualcuno alla felicità, ma a patto che egli si estranei, si alieni dalla complessità, dall’Ombra, dal mondo di Calipso, di Dante, di Shakespeare. Dalla zona di buio e passione in cui hanno origine poesia e filosofia.
In linea di massima questo approccio semplificante e edificante al pensiero filosofico potrà condurre qualcuno alla felicità, ma a patto che egli si estranei, si alieni dalla complessità, dall’Ombra, dal mondo di Calipso, di Dante, di Shakespeare. Dalla zona di buio e passione in cui hanno origine poesia e filosofia. -
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- STORIA, MITO, E METAFISICA: "METAMORFOSI" E CRITICA DELLA "RAGIONE OLIMPICA".25 novembre 2019, di Federico La Sala
Antichi Ritorni
Cenis/Ceneo, quando uno stupro cancella l’identità
Oltraggiata dal dio Poseidone la fanciulla chiede di diventare uomo
di Alba Subrizio (il Mattino di Puglia e Basilicata, 10/09/2017)
La prima trasformazione female-to-male ma soprattutto il rinnegamento della propria sessualità in virtù di una violenza subita. Ovidio con questa storia spiega come lo stupro ferisca non solo fisicamente ma anche mentalmente, al punto che la ragazza sente il bisogno di cancellare per sempre quella femminilità oltraggiata; nulla potrà mai essere come prima. Per cancellare quel dolore, Cenis ha bisogno di ripudiare se stessa, divenendo altro...
Lungi da me l’idea di fare politica, non posso tacere in merito agli stupri perpetrati nelle ultime settimane in tutta Italia e allo scempio mediatico a cui le vittime sono state sottoposte. In una società come la nostra, quasi assuefatta ai crimini della peggior specie (sic!), sembra che il ‘delitto’ commesso passi in secondo piano, il dolore, la vergogna subita, sono cose che non vogliamo vedere o che forse non ci interessano; ciò che invece interessa è sapere chi ha compiuto il misfatto: l’immigrato, l’italiano, il carabiniere finanche...
Soprattutto sui social network - ormai divenuti sempre più luogo di sfogo di personali frustrazioni da parte di individui che diversamente non saprebbero come esistere - leggo commenti insulsi, a dir poco da far accapponare la pelle: dopo i fatti di Firenze c’è chi inneggiava che a commettere l’abominio fossero stati esponenti dell’Arma (inneggiare sì, come se fosse una bella cosa, l’importante è che non fossero ancora una volta accusati cittadini extracomunitari); d’altra parte in seguito ai fatti di Rimini leggo gente “tutta contenta” utilizzare gli avvenimenti a sostegno delle loro teorie xenofobe... e poi numeri e numeri. Come se tutto ciò fosse un gioco: un gioco a calcolare quale ‘parte’ in gara ha compiuto più stupri.
Da questo quadro emerge solo un dato di fatto: il popolo italiano, di qualunque colore politico, ha perso ormai il senno. Ahinoi, non possiamo dire che i nostri antenati latini fossero poi così diversi; basti rileggere i miti antichi per accorgersi da quanti stupri e violenze sono disseminate queste storie: piccoli particolari senza valore all’interno di Storie ben più grandi, ben più importanti.
A convalida di ciò, si pensi solo a Zeus ed Apollo (i campioni dello stupro) per non parlare di altre divinità. Eh già, perché nell’antica Grecia i maggiori artefici di violenze erano gli dèi, proprio quelli che avrebbero dovuto proteggere gli uomini. Tra i tanti miti me ne viene in mente uno che, sebbene sconosciuto ai più, mi ha attratto per la forza delle immagini.
C’era una volta Cenis, una delle donne più belle di tutta la Tessaglia; nonostante decine e decine fossero i suoi pretendenti, lei non voleva concedersi e preferiva godere spensierata della sua fanciullezza. Ma un giorno, mentre passeggiava sulle rive del mare, il dio Poseidone, desiderandola, le usò violenza.
Dopo aver goduto di lei - così narra il poeta latino Ovidio nelle sue “Metamorfosi” - le disse che avrebbe realizzato per Cenis ogni suo desiderio. Così ella rispose: «L’ingiuria che ho patito provoca in me un desiderio grande: quello di non dover subire mai più alcunché di simile. Se farai in modo che io non sia più donna, mi avrai completamente accontentato». Fu così che il dio del mare trasformò Cenis in Ceneo.
Il mito non è una semplice metamorfosi come le altre: innanzitutto è la prima volta nella letteratura mondiale che leggiamo di una donna che diventa uomo (la prima trasformazione female-to-male), ma soprattutto è il rinnegamento della propria sessualità in virtù di una violenza subita.
Ovidio con questa storia spiega come lo stupro ferisca non solo fisicamente ma anche mentalmente, al punto che la ragazza sente il bisogno di cancellare per sempre quella femminilità oltraggiata; nulla potrà mai essere come prima. Scioccamente (da buon maschione) il dio crede di rimediare offrendo un dono, ma nulla può cancellare ciò che è stato. Lo sa bene Cenis, che pertanto, per cancellare quel dolore, ha bisogno di cancellare e ripudiare se stessa, divenendo altro.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
STORIA E MITO. GIASONE, "L’OMBRA D’ARGO", E “VENTICINCINQUE SECOLI” DI LETARGO: "SE NON RIDIVENTERETE COME I BAMBINI, NON ENTRERETE NEL REGNO DEI CIELI" (Mt. 18, 3).
 DANTE, ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. Note per una riflessione storiografica
DANTE, ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. Note per una riflessione storiograficaFederico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- STORIA. "Gli irriducibili" (Mirella Serri) del "no" a Mussolini (di Massimo Onofri)24 novembre 2019, di Federico La Sala
Storia.
Gli irriducibili del "no" a Mussolini
Dopo i “redenti” Mirella Serri dedica uno studio ai giovani che sfidarono il fascismo "senza se e senza ma": Un quadro variegato da cui spiccano i tre fratelli Sereni
di Massimo Onofri (Avvenire, sabato 23 novembre 2019)
Mirella Serri insegna Letteratura italiana moderna e contemporanea a La Sapienza di Roma e può vantare una lunga militanza come giornalista culturale e critico letterario per “La Stampa” e il suo supplemento “Ttl”, ma è da una quindicina d’anni che s’è fatta anche storica delle idee, a partire, cioè, dall’uscita per Corbaccio d’un libro molto fortunato, I redenti. Gli intellettuali che vissero due volte. 1938-1948, su quegli uomini di cultura che, formatisi dentro l’ideologia fascista abbracciata con fervida fede, si volsero poi all’antifascismo e alla resistenza, vivendo il mutamento come una conversione, se non addirittura un cammino di redenzione. Seguirono poi, sullo stesso originale solco e dentro problematiche non lontane da quella di partenza, tutti per Longanesi, Sorvegliati speciali. Gli intellettuali spiati dai gendarmi (1945-1980) (2012), Un amore partigiano. Storia di Gianna e Neri (2014), Gli invisibili. La storia segreta dei prigionieri illustri di Hitler in Italia (2015) e Bambini in fuga. I giovanissimi ebrei braccati dai nazisti e fondamentalisti islamici e gli eroi italiani che li salvarono (2017).
Ho parlato di originale solco per questo percorso di ricerca: laddove l’originalità sta nel fatto che Mirella Serri, quella storia delle idee nonché la sequenza degli eventi grandi e piccoli, sa farli camminare concretamente sulle gambe degli uomini e delle donne che ne sono protagonisti, concretamente restituiti nella loro personalità (nei loro sogni e gusti, nelle loro passioni e speranze, nelle loro paure e idiosincrasie), coniugando, con grande felicità, il primato del documento e delle fonti a un’invidiabile, diciamo così, disposizione al racconto. Qua-lità, si aggiunga che trovano conferma anche in questo suo ultimo notevole lavoro, in cui convergono i temi di sempre (il nazifascismo, la drammatica questione ebraica, la resistenza e l’antifascismo): Gli irriducibili. I giovani ribelli che sfidarono Mussolini (pagine 242, euro 19).
- [Foto] Enzo Sereni con moglie e figli
Ecco: chi sono gli “irriducibili”? Un «piccolo gruppo di giovani nati nel primo decennio del secolo passato» che, in grande anticipo sulla stessa resistenza, nella generale ed entusiastica adesione di tutti gli altri al regime, rifiutando anche l’idea d’un maestro come Croce che parlava della dittatura come mera parentesi d’una ben altra storia nazionale, «non si adagiarono nel consenso all’Italia fascista e che per questo scontarono anni di prigionia, di confino e di esilio», soprattutto in Francia, ma anche in Palestina e in Tunisia. E poi: «Erano intellettuali, pensatori e filosofi alle prime armi e accomunati da una medesima provenienza sociale e culturale». E ancora: «Facevano parte delle élite per nulla ’conservatrici’, con buona pace di Vittorini » (ecco, Vittorini: uno dei “redenti”, i cosiddetti fascisti di sinistra). Infine: «Appartenenti a famiglie borghesi e colte, una parte di loro aveva aderito al Partito comunista d’Italia, altri militavano in Giustizia e Libertà, altri ancora erano socialisti riformisti o repubblicani». I nomi sono presto fatti.
- [Foto] Emilio Sereni
Su tutti i fratelli Sereni: Enrico, lo scienziato che si sposa improvvisamente con la sua assistente Dvora Rabinowitz; il filosofo Enzo e la moglie Ada Ascarelli, che in Palestina, dove emigrano, fondano un kibbutz (seppure Enzo, tornato in missione in Europa morirà nel campo di concentramento di Dachau); Emilio, detto Mimmo, «il saputello o saccente di famiglia », prima ebreo ortodosso fino al fanatismo, poi, altrettanto fanaticamente, stalinista intransigente, che sposa Xeniuska Silberberg, figlia di un socialista rivoluzionario impiccato dallo zar, del quale Mimmo Altiero Spinelli arriverà a dire che era «di abile menzogna». Poi bisognerà citare Giorgio Amendola e Manlio Rossi-Doria, i quali seguono dappresso le vicende dei fratelli Sereni, soprattutto Emilio, almeno sino al 1939, quando il patto di non aggressione tra Germania e Urss porterà a rotture e divaricazioni (è il caso di Rossi-Doria, che aderirà in seguito al Partito d’azione). Non posso non aggiungere Maurizio Valenzi - l’eroe della resistenza tunisina prima ancora che il sindaco amato del futuro - e Litza Cittanova, Giuseppe Di Vittorio, Velio Spano «rivoluzionario di professione» e Nadia Gallico, Ferruccio Bensasson, e tanti altri ancora.
- [Foto] Enrico Sereni
Il libro di Serri fa perno sin da subito sulla storia della famiglia Sereni, proprio perché i tre fratelli rappresentano tre istanze politico-antropologiche diverse e tre diverse ipotesi di destino che si spalanca sulla storia - purtroppo minoritaria - della sinistra italiana: Enzo è sionista; Enrico è socialista; Emilio, appunto, comunista. Quell’Emilio, così ciecamente devoto all’Unione Sovietica, così pronto a obbedire agli slogan staliniani, da arrivare a rompere ogni rapporto coi due fratelli, l’ebreo che sceglie Israele e il “socialfascista”. Tre catalizzatori, diciamo così, dentro cui si possono leggere le vicende degli altri compagni di lotta, tra amori e odi, generosità e risentimento, lealtà e tradimento.
S’è detto d’una storia minoritaria della sinistra italiana. Al di là dei tanti rivoli biografici, che Serri asseconda con grande gusto affabulatorio, mi pare necessario sostare sulle lucide e amare pagine finali, in cui la scrittrice riflette sul rapporto tra “redenti” e “irriducibili”, cercando di spiegarsi come e perché, per dire, i Di Vittorio e gli Spano (sua è, per altro, a proposito di Carlo Muscetta, la definizione di “redenti”), che avevano prestissimo «incrociato le armi con il nazismo e avevano lottato contro l’antisemitismo», «si ritrovarono in sparuta minoranza». Perché questo è il punto: i “redenti” - «propensi a sottolineare il tratto populista, ugualitario e antielitario del fascismo», a porre in secondo piano «il piglio sanguinario e razzista della tirannia » -, «con la rielaborazione della memoria, (...) misero la sordina alle imprese dei primi antifascisti, di coloro che avevano combattuto la violenza del regime mussoliniano fin dal suo avvento».
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- Pianeta Terra: Thailandia "docet"! A che "gioco" si gioca?! Tracce per una svolta antropologica.23 novembre 2019, di Federico La Sala
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE.... *
- THAILANDIA. "Ad accogliere il Papa tantissimi, al St. Louis Hospital di Bangkok. L’incontro è nel grande auditorium con da una parte il ritratto del re e della regina, dall’altro una immagine di Gesù con la Vergine Maria (cfr.: G. Cardinale, Papa in Thailandia: bambine costrette a prostituirsi, sfigurata dignità , Avvenire, giovedì 21 novembre 2019)
- Pianeta Terra. A che "gioco" si gioca? Tracce per una svolta antropologica: lezione di Dante: Due Soli, di Freud: Edipo, Pirandello: la notte di Natale, e ... del Vaticano: Tebe, la città della regina-madre Giocasta e del figlio-re Edipo!!!
Il viaggio.
Papa in Thailandia: bambine costrette a prostituirsi, sfigurata dignità
Francesco nell’omelia della messa allo Stadio nazionale di Bangkok tocca la piaga della prostituzione, anche minorile, legata al turismo sessuale, piaga particolarmente sentita in Thailandia
di Gianni Cardinale, inviato in Thailandia (Avvenire, giovedì 21 novembre 2019)
Questa mattina primo bagno di folla per Papa Francesco nella sua visita in Thailandia. Siamo al St. Louis Hospital di Bangkok, fiore all’occhiello della diocesi ed eccellenza nel campo sanitario del Paese. E’ stato fondato 120 anni fa e ad accogliere il Papa sono in tantissimi: medici, infermiere, impiegati, operai con i loro familiari, semplici fedeli. Tutti con la bandierina thai e della Santa Sede. Questo è l’ultimo dei tre appuntamenti della mattinata.
 L’incontro è nel grande auditorium con da una parte il ritratto del re e della regina, dall’altro una immagine di Gesù con la Vergine Maria.
L’incontro è nel grande auditorium con da una parte il ritratto del re e della regina, dall’altro una immagine di Gesù con la Vergine Maria.- [Foto] Bambini durante la visita di Papa Francesco al Saint Louis Hospital in Bangkok (Ansa)
"Tutti voi, membri di questa comunità sanitaria - dice Papa Bergoglio -, siete discepoli missionari quando, guardando un paziente, imparate a chiamarlo per nome". "I vostri sforzi e il lavoro delle tante istituzioni che rappresentate sono la testimonianza viva della cura e dell’attenzione che siamo chiamati a dimostrare per tutte le persone, in particolare per gli anziani, i giovani e i più vulnerabili", aggiunge. E poi ricorda come in questi 120 anni di vita del St. Louis "quante persone hanno ricevuto sollievo nel loro dolore, sono state consolate nelle loro oppressioni e accompagnate nella loro solitudine!”. Di qui il grazie “per il dono della vostra presenza nel corso di questi anni”, e la richiesta “di far sì che questo apostolato, e altri simili, siano sempre più segno ed emblema di una Chiesa in uscita che, volendo vivere la propria missione, trova il coraggio di portare l’amore risanante di Cristo a coloro che soffrono". La visita del Papa si chiude con un incontro privato con alcuni malati.
In precedenza il Papa ha già incontrato le autorità politiche del Paese e ha visitato la principale autorità buddista della Thailandia. Nel discorso rivolto ai rappresentanti del governo, al corpo diplomatico e ai leader politici al Government House ribadisce che “la crisi migratoria non può essere ignorata". "La stessa Tailandia, - sottolinea - nota per l’accoglienza che ha concesso ai migranti e ai rifugiati, si è trovata di fronte a questa crisi dovuta alla tragica fuga di rifugiati dai Paesi vicini” (QUI IL DISCORSO) . Di qui il rinnovato auspicio “che la comunità internazionale agisca con responsabilità e lungimiranza”, in modo da risolvere “i problemi che portano a questo tragico esodo” e a promuovere “una migrazione sicura, ordinata e regolata”.
Nel suo intervento Francesco rivolge anche un pensiero "quelle donne e a quei bambini del nostro tempo che sono particolarmente feriti, violentati ed esposti ad ogni forma di sfruttamento, schiavitù, violenza e abuso".
 Esprime la sua “riconoscenza al governo tailandese per i suoi sforzi volti ad estirpare questo flagello, come pure a tutte le persone e le organizzazioni che lavorano instancabilmente per sradicare questo male e offrire un percorso di dignità”.
Esprime la sua “riconoscenza al governo tailandese per i suoi sforzi volti ad estirpare questo flagello, come pure a tutte le persone e le organizzazioni che lavorano instancabilmente per sradicare questo male e offrire un percorso di dignità”.Auspica che nascano sempre più “artigiani dell’ospitalità”, uomini e donne che “si prendano cura dello sviluppo integrale di tutti i popoli, in seno a una famiglia umana che si impegni a vivere nella giustizia, nella solidarietà e nell’armonia fraterna". E invita a coniugare libertà Thai (vuol dire proprio questo) e solidarietà, afinché “le persone e le comunità possano avere accesso all’educazione, al lavoro degno, all’assistenza sanitaria, e in tal modo raggiungere i livelli minimi indispensabili di sostenibilità che rendano possibile uno sviluppo umano integrale".
Dopo l’incontro con il mondo diplomatico e della politica Papa visita il Patriarca Supremo dei Buddisti, Somdej Phra Maha Muneewong, nel Tempio Wat Ratchabophit Sathit Maha Simaram. Qui ribadisce che “il cammino interreligioso” può testimoniare "anche nel nostro mondo, tanto sollecitato a propagare e generare divisioni e esclusioni, che la cultura dell’incontro è possibile” (QUI IL DISCORSO COMPLETO). Perché “quando abbiamo l’opportunità di riconoscerci e di apprezzarci, anche nelle nostre differenze, offriamo al mondo una parola di speranza capace di incoraggiare e sostenere quanti si trovano sempre maggiormente danneggiati dalla divisione".
Il Pontefice rimarca "quanto sia importante che le religioni si manifestino sempre più quali fari di speranza, in quanto promotrici e garanti di fraternità". E ringrazia la Thailandia perché fin dall’arrivo del cristianesimo, circa quattro secoli e mezzo fa, "i cattolici, pur essendo un gruppo minoritario, hanno goduto della libertà nella pratica religiosa e per molti anni hanno vissuto in armonia con i loro fratelli e sorelle buddisti". Tra i doni offerti da Papa Francesco al patriarca buddista dell, vi è "il Documento sulla Fraternità umana di Abu Dhabi".
La mattinata di Papa Francesco in Thailandia si chiude quando in Italia comincia ad albeggiare. Il fuso orario segna sei ore di differenza. Nel pomeriggio di Bangkok si è svolta la visita di cortesia al re e la messa nello Stadio Nazionale.
Nell’omelia della messa, con 60mila fedeli che riempiono lo stadio, papa Francesco torna ad alludere al problema del turismo sessuale. Nell’omelia il Pontefice rivolge un pensiero particolare a "quei bambini, bambine e donne esposti alla prostituzione e alla tratta, sfigurati nella loro dignità più autentica". (QUI L’OMELIA)
E poi anche "a quei giovani schiavi della droga e del non-senso che finisce per oscurare il loro sguardo e bruciare i loro sogni; penso ai migranti spogliati delle loro case e delle loro famiglie". E poi ai tanti altri che "possono sentirsi dimenticati, orfani, abbandonati". E poi "ai pescatori sfruttati, ai mendicanti ignorati". Tutti questi, sottolinea il Papa, "fanno parte della nostra famiglia, sono nostre madri e nostri fratelli".
Da qui un duplice l’appello. Primo: a non privare "le nostre comunità dei loro volti, delle loro piaghe, dei loro sorrisi, delle loro vite". Secondo: non privare "le loro piaghe e le loro ferite dell’unzione misericordiosa dell’amore di Dio". -Infatti "l’evangelizzazione non è accumulare adesioni né apparire potenti, ma aprire porte per vivere e condividere l’abbraccio misericordioso e risanante di Dio Padre che ci rende famiglia".
*
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- Pianeta Terra. A che gioco si gioca? Tracce per una svolta antropologica: lezione di Dante: Due Soli, di Freud: Edipo, Pirandello: la notte di Natale, e ... del Vaticano: Tebe, la città della regina-madre Giocasta e del figlio-re Edipo!!!
UOMINI E DONNE. LA NUOVA ALLEANZA di "Maria" e di "Giuseppe"!!! AL DI LA’ DELL’ "EDIPO", L’ "AMORE CONOSCITIVO". SULL’USCITA DALLO STATO DI MINORITA’, OGGI.
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- Da Edipo a Simone Weil: "Il colore dell’inferno. La pena tra vendetta e giustizia" (Umberto Curi).16 novembre 2019, di Federico La Sala
LA COSTITUZIONE (LA LEGGE, IL "NOMOS") E IL PARADOSSO DELLA GIUSTIZIA TRA DIRITTO E PENA .... *
- "[...] Curi richiama alla memoria un frammento di Pindaro, considerato il testo fondativo del diritto occidentale: «La legge ["nomos", fls] è re ["basileus", fls] di tutte le cose, mortali e immortali. Essa ["Esso", fls] le guida con la sua mano sovrana e rende giusta ["dikaion", fls] la cosa più violenta ["biaiotaton", fls]». Versi che in realtà testimoniano, come avrebbe scritto Pascal, l’irriducibilità totale fra giustizia e diritto. Anzi, l’esistenza stessa del diritto sembra essere prova dell’impossibilità per l’uomo di realizzare la giustizia" (cfr., R. Righetto, qui - sotto, ma - per la cit. di Pindaro - cfr. anche U. Curi, "Il paradosso della pena", in AA.VV, "Dirittto penale minimo", Donzelli, Roma 2002, p. 404).
- Eraclito, fr. B 53: "πόλεμος πάντων μὲν πατήρ ἐστι, πάντων δὲ βασιλεύς, καὶ τοὺς μὲν θεοὺς ἔδειξε τοὺς δὲ ἀνθρώπους, τοὺς μὲν δούλους ἐποίησε τοὺς δὲ ἐλευθέρους." (Eraclito, fr. B 53).
- Eraclito, fr. B 53: «La guerra (pólemos) è madre di tutte le cose e di tutte la regina (basiléus). Gli uni rende dèi, gli altri uomini; gli uni fa schiavi, gli altri liberi» (Gianfranco Ravasi, La santa violenza, Avvenire, 17.10.2019).
- Eraclito, fr. B 53: "Il conflitto (pólemos) è padre di tutte le cose, di tutte re; e gli uni disvela come dèi e gli altri come uomini, gli uni fa schiavi gli altri liberi" (Eraclito, fr. B 53)
Filosofia.
Da Edipo a Simone Weil: il dilemma della giustizia tra pena e diritto
Dal mondo greco a oggi, passando dalla lettura cristiana della società, lo storico Curi indaga sul dramma filosofico del far coincidere il diritto con la giusta pena
di Roberto Righetto (Avvenire, venerdì 15 novembre 2019)
- [Foto] Antonio Canova, "Allegoria della Giustizia", particolare (Fondazione Cariplo / CC 3.0)
È nota la posizione di Pascal, che possiamo definire pessimista o realista, sulla relazione tra forza e giustizia. In alcuni dei suoi Pensieri, il grande filosofo che volle morire in un ospizio dei poveri sostiene che l’ideale sarebbe che i due poli potessero convivere per il bene dell’uomo. Ma poiché in questo mondo la giustizia non ha possibilità di affermarsi e di utilizzare la forza per questo scopo, è inevitabile che la forza abbia la preponderanza. «La giustizia senza la forza è impotente, la forza senza la giustizia è tirannica», sentenzia il pensatore che inventò la prima macchina calcolatrice, ammettendo alfine con desolazione: «La giustizia è soggetta a discussione, la forza è molto riconosciuta e indiscussa. Così non si è potuto dare la forza alla giustizia perché la forza ha contraddetto la giustizia e ha affermato che solo lei era giusta. E così, non potendo ottenere che ciò che è giusto sia forte, si è fatto sì che ciò che è forte sia giusto».
Il Seicento era ancora un secolo dell’assolutismo e solo successivamente si è imposta una concezione della giustizia meno disfattista, quella che è arrivata sino a noi con lo Stato di diritto e la moderna democrazia. Eppure anche nel XXI secolo qualcosa non torna quando si parla di colpa, pena, legge, diritto, giustizia. Lo rileva Umberto Curi, professore emerito di Storia della filosofia all’Università di Padova, nel suo ultimo saggio, Il colore dell’inferno, La pena tra vendetta e giustizia (Bollati Borlinghieri) che prende l’avvio da una citazione folgorante di Simone Weil: «A causa dell’assenza di Cristo, la mendicità in senso lato e l’atto penale sono forse le due cose più atroci di questa terra, due cose quasi infernali. Hanno il colore stesso dell’inferno».
Secondo la pensatrice francese che rimase sempre sulla soglia della conversione, nel dare il castigo al colpevole la giustizia si comporta come nel gesto dell’elemosina: presta attenzione allo sventurato «considerandolo un essere umano e non una cosa». Ma non può fare questo se prescinde da un’impostazione religiosa: senza un riferimento a Dio, la prospettiva che si delinea non può che essere infernale.
Si sa che Simone Weil aveva un culto particolare per la civiltà greca, che considerava premessa al cristianesimo, e forse non è un caso che anche Curi nella sua analisi prenda spunto dal mondo della poesia e della tragedia antica, a partire proprio dalla domanda cruciale: che cos’è una pena? Ragionando sull’etimologia, egli chiarisce come il termine poiné (da cui il latino poena, l’italiano e lo spagnolo pena, il francese peine e l’inglese penalty) abbia il significato di "riparare" e "compensare" da una parte, e di "punire" dall’altra. È ciò che viene dato "in compenso" di qualcos’altro e indica la riparazione e il castigo. Non solo, essa riveste un significato sacrale ed è un corrispettivo della colpa commessa solo se provoca sofferenza, in un modo che sia proporzionale fra colpa e pena.
C’è insomma nella logica della pena l’affermarsi di un’espiazione in senso religioso, che sarà via via accentuata dal cristianesimo con il concetto di contrappasso, mirabilmente esemplificato da Dante. Ma cosa succede se una persona viene punita, ma non ha colpa? La vicenda di Edipo in questo senso è paradigmatica: egli paga il fio delle sue azioni senza esserne fino in fondo responsabile. È un eroe tragico che ben raffigura la visione greca dell’uomo e del mondo illustrata da un frammento del giovane Aristotele pervenutoci tramite Giamblico: «Siamo stati costituiti per natura» come se «fossimo tutti destinati a una punizione».
Per i Greci c’è un’infelicità di fondo nella condizione umana che accomuna tutti i mortali e che sarà risolta solo dal cristianesimo che ha reso possibile la redenzione. Come Edipo, anche Oreste si macchia del sangue dei genitori e a differenza del re di Tebe egli è ben consapevole di dare la morte alla madre Clitennestra, ma poiché commette il matricidio per vendicare l’assassinio del padre viene prosciolto al termine del processo che si svolge davanti al tribunale dell’Areopago. In questo senso egli assomiglia più ad Amleto che a Edipo.
Giustamente in un altro passo Curi richiama alla memoria un frammento di Pindaro, considerato il testo fondativo del diritto occidentale: «La legge è re di tutte le cose, mortali e immortali. Essa le guida con la sua mano sovrana e rende giusta la cosa più violenta». Versi che in realtà testimoniano, come avrebbe scritto Pascal, l’irriducibilità totale fra giustizia e diritto. Anzi, l’esistenza stessa del diritto sembra essere prova dell’impossibilità per l’uomo di realizzare la giustizia.
L’incapacità della nostra cultura, giuridica ma non solo, di fare i conti con questi temi fondativi è testimoniata dalla sfasatura evidente fra le risposte insufficienti che vengono date allo statuto della pena e l’attività giurisdizionale, che procede come se tutto fosse già stabilito.
Il modello correzionalista e quello preventivo sono in scacco, in balia di quella che Nietzsche definì l’origine economica e contrattualista della legge e della pena, da ricercarsi nel rapporto fra creditore e debitore e nella promessa della restituzione. Una ricostruzione genealogica che alla fine si basa sul piacere della sofferenza dell’altro, nel momento in cui chi contrae il debito offre come pegno il proprio corpo, la propria donna o la propria libertà e finanche la propria vita.
Un’idea assai materiale e non etica del debito e perciò della colpa e della pena, che certo ha il suo fascino ma che per Curi può essere ribaltata solo da un’altra logica, quella della sovrabbondanza. È la logica del surplus e dell’eccesso contenuta nell’Epistola ai Romani, ove Paolo supera l’economia della corrispondenza proporzionale fra colpa e pena.
Sulla scia di pensatori contemporanei come Jankélévitch, Derrida e Girard, si affaccia la chance del perdono, che talora è stata applicata alla giustizia in anni recenti, come nella Commissione Verità e riconciliazione in Sudafrica o nei processi sul genocidio del Ruanda. In entrambi i casi si è infatti constatato che la sola punizione può alimentare la sete di vendetta. Chance che si ripresenta pure nella formula della cosiddetta "giustizia riparativa", un modello che coinvolge i colpevoli, le vittime e la comunità intera alla ricerca non solo di una riparazione del danno ma di una soluzione ai conflitti e di una riconciliazione.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
LA LEZIONE DI NELSON MANDELA: GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo".
"CHI" SIAMO NOI, IN REALTÀ. RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.
PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- VENEZIA: NON PRENDIAMOCI IN GIRO. Onda di marea (di Paolo Cacciari).15 novembre 2019, di Federico La Sala
Onda di marea
di Paolo Cacciari (Comune-info, 14 Novembre 2019)
- Il punto più profondo dell’Alto Adriatico si trova nella laguna di Venezia. È una fossa profonda 50 metri creata a causa dell’erosione dei fondali provocata dalla creazione del “canale dei petroli” per fare entrare le navi commerciali sempre più grandi. Quel primato aiuta a capire come la distruzione della laguna venga da lontano, spiega Paolo Cacciari, da scelte economiche che continuano anche ora che i cambiamenti climatici rendono tutto più complicato.
- In nome del profitto si è ristretta la laguna e si sono approfonditi i canali marittimi che regolano i flussi innescando l’erosione dei fondali: per questo non c’è più la lenta crescita dell”acqua alta” ma fiumi in piena. E ora? Il Mose era sbagliato anche prima di diventare un’opera corruttiva: servono la creazione di un parco nazionale naturale, l’immediata fuoriuscita delle navi dalla laguna, la bonifica di Porto Marghera
Non prendiamoci in giro. Il riscaldamento climatico globale è un flagello epocale, ma non usiamolo come paravento per coprire una storia che ha ben determinate responsabilità locali. La distruzione della laguna di Venezia - e quindi della città insulare storica che con la laguna vive in simbiosi - viene da lontano e deriva da precise scelte di politiche economiche e di pianificazione territoriale che continuano imperterrite. L’aumento delle numero e della forza delle maree è provocato solo in parte dall’eustatismo (aumento del livello medio del mare). Il resto è tutta opera nostra!
La laguna ha una superficie di 550 chilometri quadrati. È uno straordinario ecosistema formato da bassi fondali (barene, velme, ghebi, valli ecc.) che reggono, avvolgono e proteggono le isole edificate dagli eventi marini esterni. Le colossali opere idrauliche costruite nei secoli dalla Repubblica di Venezia (deviazione dei fiumi a monte e “murazzi” a mare) hanno sempre seguito questo criterio: non esporre Venezia alle mareggiate ed evitare gli interramenti.
Con l’avvento dell’era industriale e il prevalere degli interessi portuali, che dura fino ai nostri giorni con il business della crocieristica, si è fatto esattamente il contrario: si è ristretta la laguna e si sono approfonditi i canali marittimi che regolano i flussi mare/laguna innescando una erosione dei fondali (mezzo milione di metri cubi di sedimenti all’anno) che ha trasformato la laguna in un braccio di mare. Il punto più profondo dell’Alto Adriatico lo si trova in laguna, al Faro Rocchetta: una fossa profonda più di cinquanta metri in cui si pescano ostriche!
Le conseguenze le abbiamo viste anche nella drammatica notte tra martedì 12 e mercoledì 13 novembre. Non siamo più in presenza di “acqua alta” (che cresce lentamente), ma di una violenta onda di marea. L’acqua sospinta dal vento di scirocco non trova più ostacoli lungo il suo percorso (bassi fondali e terre emerse) in entrata in laguna attraverso le tre bocche di porto (Lido, Malamocco e Chioggia) e diventa un fiume in piena che si infrange sulle fragili rive, sulle fondamenta e delle fondazioni della città.
Il Mose era sbagliato anche prima di diventare un’opera corruttiva (e proprio per questo motivo aveva bisogno di corrompere gli organi tecnici e politici dello stato). La scelta progettuale derivava dal fatto di non disturbare gli interessi dei traffici marittimi e di consentire a navi sempre di grandi di entrare in laguna.
Gli ambientalisti lo dicono da sempre: la prima opera di “adattamento” volta ad aumentare la “resilienza” dell’ecosistema veneziano dovrebbe essere il piano morfologico di rinaturalizzazione della Laguna di Venezia, la creazione di un parco nazionale naturale (che il sindaco Luigi Brugnaro ha abrogato), la immediata fuoriuscita delle navi dalla laguna, la bonifica di Porto Marghera.
Ciò che sta accadendo a Venezia
Tutto questo era evitabile,Fridays for future Venezia
Sul Mose torna una marea di bugie, Armando Danella
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---L’ARCHIVIO SEGRETO VATICANO E I PROGRESSIVI MUTAMENTI SEMANTICI. LETTERA APOSTOLICA IN FORMA DI «MOTU PROPRIO» (di Papa Francesco).14 novembre 2019, di Federico La Sala
LETTERA APOSTOLICA
IN FORMA DI «MOTU PROPRIO»
PER IL CAMBIAMENTO DELLA DENOMINAZIONE
DA
- ARCHIVIO SEGRETO VATICANO
AD
- ARCHIVIO APOSTOLICO VATICANO *
L’esperienza storica insegna che ogni istituzione umana, sorta pure con le migliori tutele e con vigorose e fondate speranze di progresso, toccata fatalmente dal tempo, proprio per rimanere fedele a se stessa e agli scopi ideali della sua natura, avverte il bisogno, non già di mutare la propria fisionomia, ma di trasporre nelle diverse epoche e culture i propri valori ispiratori e operare quegli aggiornamenti che si rendono convenienti e a volte necessari.
Anche l’Archivio Segreto Vaticano, al quale i Romani Pontefici hanno sempre riservato sollecitudine e cura in ragione dell’ingente e rilevante patrimonio documentario che conserva, tanto prezioso per la Chiesa Cattolica quanto per la cultura universale, non sfugge, nella sua storia ormai più che quattro volte centenaria, a tali inevitabili condizionamenti.
Sorto dal nucleo documentario della Camera Apostolica e della stessa Biblioteca Apostolica (la cosiddetta Bibliotheca secreta) fra il primo e secondo decennio del XVII secolo, l’Archivio Pontificio, che cominciò a chiamarsi Segreto (Archivum Secretum Vaticanum) solo intorno alla metà di tale secolo, accolto in confacenti locali del Palazzo Apostolico, crebbe nel tempo in consistenza notevolissima e fin da subito si aprì alle richieste di documenti che pervenivano al Pontefice Romano, al cardinale Camerlengo e poi al cardinale Archivista e Bibliotecario da ogni parte dell’Europa e del mondo. Se è vero che l’apertura ufficiale dell’Archivio ai ricercatori di ogni Paese si avrà soltanto nel 1881, è vero anche che fra il XVII e il XIX secolo molte opere erudite si poterono pubblicare con l’ausilio di copie documentarie fedeli o autentiche che gli storici ottenevano dai custodi e dai prefetti dell’Archivio Segreto Vaticano. Tanto che il celebre filosofo e matematico tedesco Gottfried Wilhelm von Leibniz, il quale pure vi attinse, scrisse nel 1702 che esso poteva considerarsi in certo modo l’Archivio centrale dell’Europa (quod quodam modo totius Europae commune Archivum censeri debet).
Questo lungo servizio reso alla Chiesa, alla cultura e agli studiosi di tutto il mondo ha sempre guadagnato all’Archivio Segreto Vaticano stima e riconoscenza, tanto più crescenti da Leone XIII ai nostri giorni, sia in ragione delle progressive «aperture» della documentazione resa disponibile alla consultazione (che dal prossimo 2 marzo 2020, per mia disposizione, si estenderà fino al termine del pontificato di Pio XII), sia in ragione dell’aumento di ricercatori che sono quotidianamente ammessi all’Archivio medesimo e aiutati in ogni modo nelle loro ricerche.
Tale meritorio servizio ecclesiale e culturale, così apprezzato, bene risponde agli intenti di tutti i miei predecessori, che secondo i tempi e le possibilità hanno favorito le ricerche storiche in così vasto Archivio, dotandolo, secondo i suggerimenti dei cardinali Archivisti o dei prefetti pro tempore, di persone, di mezzi e anche di nuove tecnologie. In tal modo si è provveduto alla graduale crescita della struttura dell’Archivio stesso per il suo sempre più impegnativo servizio alla Chiesa e al mondo della cultura, mantenendo sempre fede agli insegnamenti e alle direttive dei Pontefici.
Vi è tuttavia un aspetto che penso possa essere ancora utile aggiornare, ribadendo le finalità ecclesiali e culturali della missione dell’Archivio. Tale aspetto riguarda la stessa denominazione dell’istituto: Archivio Segreto Vaticano.
Nato, come accennato, dalla Bibliotheca secreta del Romano Pontefice, ovvero dalla parte di codici e scritture più particolarmente di proprietà e sotto la giurisdizione diretta del Papa, l’Archivio si intitolò dapprima semplicemente Archivum novum, poi Archivum Apostolicum, quindi Archivum Secretum (le prime attestazioni del termine risalgono al 1646 circa).
Il termine Secretum, entrato a formare la denominazione propria dell’istituzione, prevalsa negli ultimi secoli, era giustificato, perché indicava che il nuovo Archivio, voluto dal mio predecessore Paolo V verso il 1610-1612, altro non era che l’archivio privato, separato, riservato del Papa. Così intesero sempre definirlo tutti i Pontefici e così lo definiscono ancora oggi gli studiosi, senza alcuna difficoltà. Questa definizione, del resto, era diffusa, con analogo significato, presso le corti dei sovrani e dei principi, i cui archivi si definirono propriamente secreti.
Finché perdurò la coscienza dello stretto legame fra la lingua latina e le lingue che da essa discendono, non vi era bisogno di spiegare o addirittura di giustificare tale titolo di Archivum Secretum. Con i progressivi mutamenti semantici che si sono però verificati nelle lingue moderne e nelle culture e sensibilità sociali di diverse nazioni, in misura più o meno marcata, il termine Secretum accostato all’Archivio Vaticano cominciò a essere frainteso, a essere colorato di sfumature ambigue, persino negative. Avendo smarrito il vero significato del termine secretum e associandone istintivamente la valenza al concetto espresso dalla moderna parola «segreto», in alcuni ambiti e ambienti, anche di un certo rilievo culturale, tale locuzione ha assunto l’accezione pregiudizievole di nascosto, da non rivelare e da riservare per pochi. Tutto il contrario di quanto è sempre stato e intende essere l’Archivio Segreto Vaticano, che - come disse il mio santo predecessore Paolo VI - conserva «echi e vestigia» del passaggio del Signore nella storia (Insegnamenti di Paolo VI, I, 1963, p. 614). E la Chiesa «non ha paura della storia, anzi la ama, e vorrebbe amarla di più e meglio, come la ama Dio!» (Discorso agli Officiali dell’Archivio Segreto Vaticano, 4 marzo 2019: L’Osservatore Romano, 4-5 marzo 2019, p. 6).
Sollecitato in questi ultimi anni da alcuni stimati Presuli, nonché dai miei più stretti collaboratori, ascoltato anche il parere dei Superiori del medesimo Archivio Segreto Vaticano, con questo mio Motu Proprio decido che:
da ora in poi l’attuale Archivio Segreto Vaticano, nulla mutando della sua identità, del suo assetto e della sua missione, sia denominato Archivio Apostolico Vaticano.
Riaffermando la fattiva volontà di servizio alla Chiesa e alla cultura, la nuova denominazione mette in evidenza lo stretto legame della Sede romana con l’Archivio, strumento indispensabile del ministero petrino, e al tempo stesso ne sottolinea l’immediata dipendenza dal Romano Pontefice, così come già avviene in parallelo per la denominazione della Biblioteca Apostolica Vaticana.
Dispongo che la presente Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio venga promulgata mediante pubblicazione sul quotidiano L’Osservatore Romano, entrando in immediato vigore a partire da detta pubblicazione, così da essere subito recepita nei documenti ufficiali della Santa Sede, e che, successivamente, sia inserita negli Acta Apostolicae Sedis.
Dato a Roma, presso San Pietro, il 22 ottobre 2019, settimo del nostro Pontificato.
Francesco
* Fonte: http://w2.vatican.va/
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- Morto il filosofo Remo Bodei. Ideatore del Festivalfilosofia, non si stancava di ribadire quanto fosse falso il ricorrente annuncio della «morte della filosofia» (di A. Carioti).8 novembre 2019, di Federico La Sala
Morto il filosofo Remo Bodei, studioso delle filosofie del Novecento
Si è spento nella sua abitazione di Pisa. Aveva insegnato alla Normale e nelle più importanti università del mondo. Era l’ideatore del Festivalfilosofia
di Antonio Carioti (Corriere della Sera, 8 novembre 2019)
Il filosofo Remo Bodei, scomparso all’età di 81 anni, era un accademico raffinato e di grande prestigio, abituato a confrontarsi con i temi più specialistici e complessi. Ma non disdegnava affatto la divulgazione, rivolta anche ai bambini, che riteneva particolarmente ricettivi verso le tematiche della sua disciplina. A lui si deve in buona parte il grande successo del Festivalfilosofia di Modena, Carpi e Sassuolo, di cui aveva presieduto il comitato scientifico e per il quale si era molto impegnato. Oltre che nel pensiero speculativo, la sua competenza spaziava in molti altri settori del sapere, tra cui la musica, la poesia e l’estetica: era un appassionato conoscitore e studioso dell’autore romantico tedesco Friedrich Hölderlin e aveva fatto parte dell’advisory board internazionale dell’Istituto europeo di design.
Nato a Cagliari il 3 agosto 1938, Bodei in un primo tempo aveva studiato a Roma, poi aveva vinto il concorso per entrare alla Scuola Normale Superiore di Pisa, dove si era laureato e aveva intrapreso la carriera accademica. Interessato non solo alle dottrine filosofiche, ma anche alla vita politica, si era iscritto molto giovane al Partito socialista e aveva subito anche un’aggressione da parte di militanti dell’estrema destra. Ma la contestazione del Sessantotto, che a Pisa era stata particolarmente vivace, lo aveva lasciato piuttosto perplesso. Retrospettivamente Bodei riconosceva il valore della spinta innovativa innescata dalla rivolta giovanile rispetto alle incrostazioni del mondo accademico di allora, ma continuava a rimproverarle il torto di aver prodotto «una gerarchia di capi e capetti», compreso il suo amico Adriano Sofri, nelle organizzazioni extraparlamentari.
Molto importanti, per la formazione di Bodei, erano stati i lunghi periodi di studio trascorsi in Germania, in particolare nelle Università di Tubinga, Friburgo, Heidelberg e Bochum, dove aveva avuto l’opportunità di confrontarsi con maestri di altissimo livello come Ernst Bloch e Karl Löwith. In particolare a Bloch, pensatore utopista che aveva cercato di stabilire un legame tra cristianesimo e marxismo in nome del «principio speranza», aveva dedicato il saggio Multiversum (Bibliopolis, 1979), che approfondiva il significato dei concetti di tempo e storia nell’opera del filosofo tedesco. In precedenza Bodei, curatore e traduttore di molti testi importanti, si era concentrato sulla grande tradizione idealista della Germania ottocentesca.
La sua prima monografia, con cui si era imposto all’attenzione degli specialisti, fu Sistema ed epoca in Hegel, un libro pubblicato dal Mulino nel 1975 e poi riproposto in edizione ampliata dalla stessa casa editrice nel 2014 con il titolo La civetta e la talpa. Anche il suo successivo lavoro Scomposizioni (Einaudi, 1987), riguardante i dilemmi identitari e le contraddizioni dell’individuo moderno, era stato poi rielaborato per il Mulino nel 2016. Accademico dei Lincei, autore riconosciuto a livello internazionale con la traduzione in diverse lingue delle sue opere principali, oltre che a Pisa aveva insegnato alla University of California Los Angeles (Ucla). Ma aveva anche una notevole capacità di parlare al grande pubblico, soprattutto quando affrontava temi come la ricerca della felicità personale e i vincoli che condizionano le aspirazioni dell’individuo: alcuni suoi libri incentrati su questi temi, come Geometria delle passioni (Feltrinelli, 1991) e Destini personali (Feltrinelli, 2002), avevano registrato un significativo successo anche sotto il profilo delle vendite.
Il tema dell’utopia era sempre rimasto al centro delle riflessioni di Bodei. Citando il filosofo ebreo Baruch Spinoza, amava ripetere che l’uomo «è un animale desiderante e non smetterà mai di essere attratto da ciò che gli manca». Ma era attento anche ai temi dell’attualità e riteneva indispensabile, per la filosofia, confrontarsi senza remore con le più sconvolgenti novità del nostro tempo. Due erano le questioni che riteneva cruciali per la società del XXI secolo. Da una parte Bodei era molto interessato all’irruzione tumultuosa delle biotecnologie, con le loro gigantesche implicazioni etiche, riguardanti le origini della vita e la sua manipolazione, la trasformazione dei legami famigliari, la prospettiva affascinante e al tempo stesso inquietante del postumano, con un potenziamento artificiale della nostra specie. Su un altro versante guardava con estrema attenzione agli effetti della riduzione drastica delle distanze tra i popoli, con il conseguente «incontro tra culture separate». Era indispensabile a suo avviso che la filosofia riuscisse a darsi «una dimensione globale», superando quel genere di universalismo che pretendeva d’imporre valori assoluti, ma senza rinunciare a un «razionalismo aperto», capace di difendere le grandi conquiste di libertà raggiunte dalla civiltà occidentale ed espresse nella Dichiarazione dei diritti umani approvata dalle Nazioni Unite nel dicembre del 1948.
Bodei era convinto che la filosofia italiana, dotata da sempre di una «vocazione civile», avesse un ruolo non secondario da svolgere su questi versanti. Pur scettico verso una certa retorica sulla cosiddetta italian theory, che temeva potesse diventare «uno slogan di comodo», riconosceva la pregnante rilevanza dell’elaborazione condotta da colleghi come Emanuele Severino e Gianni Vattimo, che avevano avuto il merito di emancipare il nostro Paese dalla precedente subalternità rispetto a correnti di pensiero provenienti dall’estero. Più in generale Bodei non si stancava di ribadire quanto fosse falso il ricorrente annuncio della «morte della filosofia». Proprio sulla base del suo rapporto con il pubblico, opponeva a questi stereotipi la permanenza indubbia di «una fame di senso nelle persone».
A suo avviso la filosofia poteva ancora costituire «una sorta di tessuto connettivo rispetto alle nozioni frammentarie che immagazziniamo e un antidoto utile al fast food intellettuale che ci viene propinato». Sul piano civile lo allarmava l’incapacità della politica di misurarsi con le grandi trasformazioni del mondo contemporaneo. Bodei avvertiva dolorosamente il pericolo di una vita pubblica appiattita nel perseguimento affannoso di traguardi immediati, senza alcun disegno complessivo munito di un qualche spessore storico: «Senza la presenza del passato - osservava - non solo non si comprende il presente e non si può progettare il futuro, ma si è sottoposti a qualsiasi manipolazione».
 Antonio Carioti
Antonio Carioti -
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- TODO MODO. un “con ogni mezzo” che getta un ponte aberrante e tuttavia reale tra gli "Esercizi spirituali" di Loyola e il "Principe" di Machiavelli ({{Matteo Meschiari}}2 novembre 2019, di Federico La Sala
LO "STATO HEGELIANO" - DELLO STATO MENTITORE, ATEO E DEVOTO ("Io che è Noi, Noi che è Io"). Un’ipotesi di rilettura di "Todo modo" ... *
- "Il romanzo giunge così al delitto-contrappasso, al quale ne seguono altri, ma il dispositivo spaziale, o il quadrilatero semiotico, è già dato: la Chiesa (don Gaetano), lo Stato (il procuratore Scalambri), la Corruzione (l’onorevole Michelozzi), la Pena (l’assassino). [...] Il todo modo del titolo dice appunto questo, un “con ogni mezzo” che getta un ponte aberrante e tuttavia reale tra gli Esercizi spirituali di Loyola e il Principe di Machiavelli" (Matteo Meschiari, Todo modo, Doppiozero, 21 ttobre 2019).
TODO MODO
di Matteo Meschiari (Doppiozero, 21 ttobre 2019)
- Sono trascorsi 30 anni da quel giorno di novembre in cui Leonardo Sciascia ci ha lasciati, trent’anni in cui il paese, che lui ha così bene descritto, è profondamente cambiato, eppure nel profondo è sempre lo stesso: conformismo, mafie, divisione tra Nord e Sud, arroganza del potere, l’eterno fascismo italiano. Possibile?
 Per ricordare Sciascia abbiamo pensato di farlo raccontare da uno dei suoi amici, il fotografo Ferdinando Scianna, con le sue immagini e le sue parole, e di rivisitare i suoi libri con l’aiuto dei collaboratori di doppiozero, libri che continuano a essere letti, che tuttavia ancora molti non conoscono, libri che raccontano il nostro paese e la sua storia. Una scoperta per chi non li ha ancora letti e una riscoperta e un suggerimento a rileggerli per chi lo ha già fatto. La letteratura come fonte di conoscenza del mondo intorno a noi e di noi stessi. De te fabula narratur.
Per ricordare Sciascia abbiamo pensato di farlo raccontare da uno dei suoi amici, il fotografo Ferdinando Scianna, con le sue immagini e le sue parole, e di rivisitare i suoi libri con l’aiuto dei collaboratori di doppiozero, libri che continuano a essere letti, che tuttavia ancora molti non conoscono, libri che raccontano il nostro paese e la sua storia. Una scoperta per chi non li ha ancora letti e una riscoperta e un suggerimento a rileggerli per chi lo ha già fatto. La letteratura come fonte di conoscenza del mondo intorno a noi e di noi stessi. De te fabula narratur.
La princeps einaudiana è del 1974 e, per comprendere a pieno l’ironica e durissima denuncia civile di questo breve romanzo di Sciascia, bisognerebbe intavolare una seduta spiritica ed evocare la mai defunta processione politico-economica dei primi anni Settanta in Italia. Razza padrona di Eugenio Scalfari e Giuseppe Turani esce lo stesso anno per Feltrinelli: la borghesia di stato, la crisi dell’imprenditoria privata, la scalata di ENI alla Montedison, le partecipazioni statali. E ovviamente la corruzione, le alleanze occulte, la politica dei benefici e dei favori.
 Ma a quarantacinque anni di distanza la lettura di Todo modo è attuale e anzi utilissima per ricordarci che, al di là delle parate mediatiche recenti, l’immutabile ontologia politica italiana non è mai quella dei volti pubblici ma è sempre quella sotterranea delle eminenze grigie, degli spazi extraparlamentari, extraromani, extramondani in cui pochissime ombre decidono le sorti del Paese. Proprio come Pietro Campilli, ex presidente della Montedison, racconterà a Turani e Scalfari parlando di un incontro avvenuto nella sua casa di Frascati: «c’erano alti magistrati, qualche grande industriale, Cefis, Petrilli, Carli, alcuni consiglieri di Stato, un paio di “principi del foro”, tre o quattro direttori generali della pubblica amministrazione. Una ventina di persone in tutto», per decidere le sorti d’Italia.
Ma a quarantacinque anni di distanza la lettura di Todo modo è attuale e anzi utilissima per ricordarci che, al di là delle parate mediatiche recenti, l’immutabile ontologia politica italiana non è mai quella dei volti pubblici ma è sempre quella sotterranea delle eminenze grigie, degli spazi extraparlamentari, extraromani, extramondani in cui pochissime ombre decidono le sorti del Paese. Proprio come Pietro Campilli, ex presidente della Montedison, racconterà a Turani e Scalfari parlando di un incontro avvenuto nella sua casa di Frascati: «c’erano alti magistrati, qualche grande industriale, Cefis, Petrilli, Carli, alcuni consiglieri di Stato, un paio di “principi del foro”, tre o quattro direttori generali della pubblica amministrazione. Una ventina di persone in tutto», per decidere le sorti d’Italia.È la stessa eterna tassonomia politica che si raduna nel monastico ecomostro alberghiero di Todo modo, l’Eremo di Zafer. Ma chi era Zafer? Un musulmano convertito alla vera fede? La cosa passa in sordina e subito la si dimentica nell’economia del “giallo”, ma nella geografia simbolica del romanzo è un segnale importante: l’eremo è inglobato nell’albergo, «senz’altro brutto... ma che si può fare mai con questi architetti, oggi? ... Presuntuosi, fanatici, inaccostabili». Uno scandalo edilizio che diventa teatro allegorico della vicenda: un bosco, «Querce da sughero e castagni facevano galleria, l’aria profumava di tardive ginestre», un «vastissimo spiazzo anch’esso asfaltato», «un casermone di cemento orridamente bucato da finestre strette e oblunghe», un refettorio «vasto, fitto di tavole rotonde e quadrate» e, finalmente, l’eremo, la cappella, una chiesetta «risparmiata» alla distruzione del luogo. Qui l’ipnotico, coltissimo e seduttivo don Gaetano rivela al protagonista l’origine di Zafer: «Tutta una storia inventata a tavolino: nella seconda metà del secolo scorso, da un erudito locale...».
 Il sancta sanctorum dell’albergo è insomma una menzogna, e la mostruosa struttura di cemento, come un bunker o un caveau o una pisside, protegge gelosamente il nulla cosmico. Parallelamente il bosco: «Man mano che mi allontanavo dall’albergo, gli alberi diventavano più fitti, l’aria più fresca e odorosa di resine. La solitudine era perfetta. E mi dicevo di tanta perfezione, e della libertà con cui stavo godendomela, quando tra gli alberi intravidi come un lago di sole e dei colori che si muovevano».
Il sancta sanctorum dell’albergo è insomma una menzogna, e la mostruosa struttura di cemento, come un bunker o un caveau o una pisside, protegge gelosamente il nulla cosmico. Parallelamente il bosco: «Man mano che mi allontanavo dall’albergo, gli alberi diventavano più fitti, l’aria più fresca e odorosa di resine. La solitudine era perfetta. E mi dicevo di tanta perfezione, e della libertà con cui stavo godendomela, quando tra gli alberi intravidi come un lago di sole e dei colori che si muovevano».Sono donne in bikini, radunate lì per soddisfare nel «cieco casermone tenuto da preti», proprio durante gli esercizi spirituali, i loro altolocati amanti. La topologia morale del romanzo è allestita: da un lato un bosco sacro ma violato, dall’altro un eremo-albergo gestito dalla Chiesa per convegni di potere e di sesso, e in mezzo lo «spiazzale», dove si svolge la surreale, crepuscolare, inquietante recita camminata del rosario: «E mi accorsi che il movimento era in effetti più ordinato di quanto mi era parso da lontano: fermandosi un po’ prima del dietrofronte, don Gaetano lasciava che il quadrato si aprisse al suo star fermo e andasse avanti, ricongiungendosi, finché lui non si fosse trovato, al momento del dietrofronte, al centro dell’ultima fila, che diventava la prima». Una recita fasulla «con un che di atterrito e di isterico», come se i potenti d’Italia radunati in quest’eremo nel cuore di una selva «al confine dell’inferno», diventassero tante pecorelle pavide, spaventate dal buio, e allora «veniva facile pensare alla dantesca bolgia dei ladri».
 Il romanzo giunge così al delitto-contrappasso, al quale ne seguono altri, ma il dispositivo spaziale, o il quadrilatero semiotico, è già dato: la Chiesa (don Gaetano), lo Stato (il procuratore Scalambri), la Corruzione (l’onorevole Michelozzi), la Pena (l’assassino). Inutile dire che non esiste soluzione narrativa, ma circolarità, eterno ritorno, prigionia, come nella Ronda dei carcerati di Van Gogh o nella Zattera della Medusa di Géricault, evocata dallo stesso don Gaetano.
Il romanzo giunge così al delitto-contrappasso, al quale ne seguono altri, ma il dispositivo spaziale, o il quadrilatero semiotico, è già dato: la Chiesa (don Gaetano), lo Stato (il procuratore Scalambri), la Corruzione (l’onorevole Michelozzi), la Pena (l’assassino). Inutile dire che non esiste soluzione narrativa, ma circolarità, eterno ritorno, prigionia, come nella Ronda dei carcerati di Van Gogh o nella Zattera della Medusa di Géricault, evocata dallo stesso don Gaetano.
 L’ipocrisia di un certo cattolicesimo, l’abiezione politica fatta sistema, l’inettitudine della giustizia, le lacune istituzionali e il delitto che le regola, girano in tondo come altrettante allegorie antropomorfe, in un rosario ipnotico che genera assuefazione e svuotamento.
L’ipocrisia di un certo cattolicesimo, l’abiezione politica fatta sistema, l’inettitudine della giustizia, le lacune istituzionali e il delitto che le regola, girano in tondo come altrettante allegorie antropomorfe, in un rosario ipnotico che genera assuefazione e svuotamento.Il protagonista, un pittore ateo, anticlericale, mero spettatore degli eventi nella bolgia solforosa di Zafer, riflette tra cinismo e ironia sulla propria posizione ontologica, si rassegna al mistero non svelato, al segreto per sempre sepolto e al fatto che, alla fine, in un movimento di generale entropia, «Si arriva che tu, io, il commissario, diventiamo sospettabili quanto costoro, e anche di più: e senza che si possa attribuire una ragione, un movente...». Il todo modo del titolo dice appunto questo, un “con ogni mezzo” che getta un ponte aberrante e tuttavia reale tra gli Esercizi spirituali di Loyola e il Principe di Machiavelli. E lo diceva già il pretino nella hall dell’albergo e del libro: «La Repubblica tutela il paesaggio, lo so; ma poiché don Gaetano tutela la Repubblica... Insomma: la solita storia». L’Italia come un albergo anni Settanta.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- ITALIA, UN PAESE FONDATO SULL’INQUISIZIONE. Sulla soglia di quest’opera imponente, dedicata alla storia religiosa e civile dell’ Italia del ’500 (Adriano Prosperi, Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari, Einaudi, pagg. 708, lire 60.000) incontriamo eventi molto più vicini a noi: "l’appello alle Brigate rosse di Paolo VI e la cupa solenne cerimonia funebre sul corpo di Aldo Moro con gli uomini di Stato italiani inginocchiati ai piedi del pontefice romano" [...] (Carlo Ginzburg - Archivio "La Repubblica", 14 gennaio 1997).
- TODO MODO: “«A somiglianza di una celebre definizione che fa dell’universo kantiano una catena di causalità sospesa a un atto di libertà, si potrebbe» dice il maggior critico italiano dei nostri anni [Giacomo Debenedetti, Saggi critici, serie II, Venezia, Marsilio, 1990 - fls] «riassumere l’universo pirandelliano come un diuturno servaggio in un mondo senza musica, sospeso ad una infinita possibilità musicale: all’intatta e appagata musica dell’uomo solo» (L. Sciascia, Todo modo, 1974).
GIOACCHINO, DANTE, E LA "CASTA ITALIANA" DELLO "STATO HEGELIANO" - DELLO STATO MENTITORE, ATEO E DEVOTO ("Io che è Noi, Noi che è Io").
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- TODO MODO.... "La magistratura italiana ha scritto pagine altissime nella nostra storia” ( Nino Di Matteo).3 novembre 2019, di Federico La Sala
Politica
Nino Di Matteo a Mezz’ora in Più: "O cambiamo noi magistrati o saremo normalizzati"
Il magistrato ricorda: "Ci sono sentenze definitive sul patto tra mafia e Silvio Berlusconi" *
“O cambiamo noi, o ci cambiano altri, magari a colpi di riforme con lo scopo di normalizzare la magistratura”. Lo ha detto il consigliere del Consiglio Superiore della magistratura Nino Di Matteo, ospite di Mezz’ora in Più su Rai Tre. L’inchiesta di Perugia “ci deve indignare ma non sorprendere, soprattutto non piegare. Non dobbiamo rassegnarci all’idea di una magistratura malata. La magistratura italiana ha scritto pagine altissime nella nostra storia”. “Sono certo che sotto la guida del presidente Mattarella il Csm saprà emendarsi per le cose passate. Dobbiamo reagire e impegnarci per recuperare. Nel momento in cui avevano perso prestigio è prevalsa in me la volontà di dare una mano e un contributo al recupero dell’autorevolezza” ha aggiunto.
“Evidentemente questo paese sconta deficit di memoria su questi fatti. Voglio riferirmi alla sentenza di Cassazione che ha condannato il senatore Dell’Utri per concorso in associazione mafiosa. In quella sentenza viene consacrato un dato: nel 1974 venne stipulato un patto tra le più importanti famiglie mafiose palermitane e l’allora imprenditore Berlusconi, questo patto è stato rispettato almeno fino al 1992 da entrambe le parti. Dell’Utri è stato condannato come intermediario di quel patto che ha visto protagonista anche l’allora imprenditore Berlusconi””, ha poi ricordato Di Matteo.
“Sulle stragi del ’92 e ’93, e anche sul fallito attentato allo stadio Olimpico del ’94, si sa molto ma non si sa tutto”, ha detto.
“L’ergastolo è l’unica vera pena detentiva a spaventare i capimafia. Riina diceva ai suoi, ci dobbiamo giocare i denti per evitare l’ergastolo. Secondo il mio parere il legislatore deve stabilire che tipo di prova ci vuole per far accedere anche gli ergastolani ai premi, come l’assenza di rapporti con con i clan. Non può dipendere solo dal comportamento perché è noto che i capimafia normalmente in carcere si comportano meglio di tutti gli altri”, ha detto Di Matteo a proposito delle sentenze Cedu e Corte Costituzionale sull’ergastolo ostativo.
Di Matteo ha poi aggiunto di essere favorevole alla legge che blocca la prescrizione che entrerà in vigore a gennaio, mentre è contrario a qualsiasi intervento in tema di intercettazioni, come la legge Orlando che dovrebbe entrare in vigore a partire dal 2020. Infine, sulla liberalizzazione delle droghe leggere, il magistrato si è detto contrario.
* www.huffingtonpost.it, 03.11.2019.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- IMMANUEL KANT, IL "BISOGNA DIRE SEMPRE LA VERITÀ?", E LA LEGGE MORALE.24 ottobre 2019, di Federico La Sala
L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT O L’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN. Bisogna sempre dire la verità? *
IMMANUEL KANT
Bisogna sempre dire la verità?
di Francesca Rigotti (Doppiozero, 19.10.2019)
Appollaiato sul ramo di una pianta il corvo (corvus), uccello dal piumaggio bianco come la neve, osserva il tradimento di Coronide, amata e resa gravida da Apollo, con il giovane Ischi, e corre a riferirlo al capo. Così narrano le Metamorfosi di Ovidio nel libro II (542-547). Mentre vola alla volta del dio di Delfi suo padrone, l’uccello viene raggiunto dalla cornacchia (cornix) che lo mette in guardia più o meno così: «Attento alle mie parole, corvo. Una volta mi capitò di spiare, nascosta sopra un folto olmo (abdita fronde levi densa speculabar ab ulmo), le tre vergini Pàndroso, Erse e Aglauro che Minerva aveva incaricato di sorvegliare - senza aprirla! - una cesta di vimini. Aglauro però viola l’ordine e disfa i nodi, scorgendovi dentro un bambino, Erictonio - nato dalla terra fecondata da Efesto - con accanto un serpente. Corro a riferire l’accaduto a Minerva e che cosa ottengo in cambio della mia fedeltà? Di essere degradata, di perdere il favore della dea e di essere posposta alla notturna civetta, Nictìmene, che divenne l’uccello sacro alla dea».
Nonostante l’avvertimento a non parlare troppo, il corvo riferì dell’incontro di Coronide con Ischi ad Apollo, che non la prese affatto bene. Il dio uccise infatti Coronide con una freccia, salvando però il figlio dal rogo funebre, e punì il corvo, «che si aspettava un premio per aver detto la verità», facendo diventare nero il suo piumaggio. Non cerchiamo per ora di interpretare il senso del fatto che il bambino salvato dalle fiamme e affidato al centauro Chirone divenne Asclepio, il fanciullo destinato ad apportare salute al mondo intero (salutifer orbi ... puer), e soffermiamoci invece sul castigo del corvo e della cornacchia, puniti dagli dei per... aver detto la verità.
Bisogna sempre dire la verità?
Come avrebbe reagito Kant, il rigoroso filosofo di Königsberg, di fronte a questo episodio? Avrebbe approvato o biasimato il comportamento degli uccelli che parlavano troppo? E che dicevano la verità anche se essa non veniva loro richiesta, come è il caso del corvo che si incarica spontaneamente di farlo per il puro piacere di far andare la sua linguaccia. «Lingua fuit danno», la lingua «fu la sua rovina», commenta il poeta. E lo fu anche della cornacchia, benché questa fosse stata esplicitamente incaricata da Minerva della sorveglianza. Ma posso tacere la verità? O bisogna sempre dire la verità, che è il titolo del libro in cui Andrea Tagliapietra, autore anche del recente Filosofia dei cartoni animati edito da Bollati Boringhieri affronta questa tematica? (Immanuel Kant, Bisogna sempre dire la verità?, a cura di Andrea Tagliapietra, Milano, Cortina, 2019). Un fustigatore della menzogna quale Agostino di Ippona ha a questo proposito un consiglio preciso: «Quello che dici, deve essere assolutamente vero; ma non devi per forza dire tutto quello che è vero».
Agostino, commenta Tagliapietra nel saggio introduttivo, pone dunque il nucleo della bugia necessaria in forma di problema: «Se si rifugia presso di te uno che potrebbe scampare alla morte grazie a una tua bugia, non mentirai?» (Contra mendacium, 18 e 5); lo stesso problema che sarà oggetto dello scambio polemico di opinioni etico-filosofiche tra Benjamin Constant e Immanuel Kant. Dove il Kant precritico, spiega sempre Tagliapietra, pare favorevole all’uso della riserva mentale. Diventerà invece intransigente negli anni successivi, quando la menzogna verrà definita da Kant l’autentica bruttura che macchia la natura dell’uomo, «l’avvilimento, anzi l’annientamento della dignità umana». Le bugie violano la fiducia nell’umanità: «La maggiore infrazione del dovere dell’uomo verso se stesso, considerato unicamente come essere morale (riguardo all’umanità che risiede nella sua persona) è l’opposto della sincerità, vale a dire la menzogna» (I. Kant, La metafisica dei costumi, Roma-Bari, Laterza, 2009, pp. 287-288).
Bagatelle e crudeltà
Se guardiamo brevemente ad altri contesti, vediamo che la tradizione della cultura antica - seguo sempre Tagliapietra - ammette qualche forma di menzogna nel caso che essa apporti salvezza: si pensi soltanto alla figura di Ulisse, eroe astuto quanto mentitore. Ammessa è anche la menzogna del migliore verso il peggiore, non comunque del peggiore verso il migliore.
 La cultura cristiana poi, continua Tagliapietra, trova mille scappatelle per una bagatella come il peccatuccio della bugia di scusa o peccatillum, da cui deriva il termine bagatella, e questo persino nel caso di pensatori austeri quali, abbiamo visto, Agostino, che ribadisce il principio aristotelico dell’intenzione ma poi assolve la menzogna in caso di pericolo di vita della vittima. Più blanda la posizione di Tommaso d’Aquino, sempre pronto a giustificare chi adotta il male minore per evitare il male maggiore.
La cultura cristiana poi, continua Tagliapietra, trova mille scappatelle per una bagatella come il peccatuccio della bugia di scusa o peccatillum, da cui deriva il termine bagatella, e questo persino nel caso di pensatori austeri quali, abbiamo visto, Agostino, che ribadisce il principio aristotelico dell’intenzione ma poi assolve la menzogna in caso di pericolo di vita della vittima. Più blanda la posizione di Tommaso d’Aquino, sempre pronto a giustificare chi adotta il male minore per evitare il male maggiore.
 Per l’incrollabile Kant invece il comandamento «non devi mentire», fondato sulla sovranità autonoma del soggetto, la quale non ammette eccezioni, è il fondamento dell’etica filosofica. Se si segue il precetto che esorta ad agire in modo da considerare l’umanità, sia nella propria persona sia nella persona di ogni altro, come fine e mai come mezzo, non si deve mentire nemmeno se in quel caso si nuocerà ad altri o si metterà in pericolo la vita di qualcuno o lo si consegnerà al suo assassino. Pensiamo alla terribile scena iniziale di Bastardi senza gloria (Unglorious Bastards, USA-Germania 2009) di Quentin Tarantino, in cui il colonnello nazista interroga il contadino francese, chiedendogli se dia rifugio ai nemici dello stato, la famiglia ebrea dei Dreyfus. Tutti desideriamo che il contadino menta e invece M. La Padite dice la verità e denuncia la famiglia ebrea per proteggere la propria.
Per l’incrollabile Kant invece il comandamento «non devi mentire», fondato sulla sovranità autonoma del soggetto, la quale non ammette eccezioni, è il fondamento dell’etica filosofica. Se si segue il precetto che esorta ad agire in modo da considerare l’umanità, sia nella propria persona sia nella persona di ogni altro, come fine e mai come mezzo, non si deve mentire nemmeno se in quel caso si nuocerà ad altri o si metterà in pericolo la vita di qualcuno o lo si consegnerà al suo assassino. Pensiamo alla terribile scena iniziale di Bastardi senza gloria (Unglorious Bastards, USA-Germania 2009) di Quentin Tarantino, in cui il colonnello nazista interroga il contadino francese, chiedendogli se dia rifugio ai nemici dello stato, la famiglia ebrea dei Dreyfus. Tutti desideriamo che il contadino menta e invece M. La Padite dice la verità e denuncia la famiglia ebrea per proteggere la propria.Occorre aggiungere che la posizione di Kant era stata preceduta - aggiungo - da Spinoza che nella sua Etica assai chiaramente si pronuncia contro l’uso dell’inganno, il dolus malus (IV, LXXII), tra cui la menzogna, anche nel caso in cui ciò possa salvare una persona dall’imminente pericolo di morte.
Ci sono princìpi e princìpi
Questa verità crudele, questa perversa «macchina logico-veritativa del linguaggio» di Kant ma anche, ribadiamo, di Spinoza, viene respinta da Benjamin Constant in un saggio del 1797, riportato nella racolta di Tagliapietra, allorché il giovane polemista francese osa attaccare l’anziano filosofo tedesco con l’argomento del diverso peso dei princìpi morali: ci sono i princìpi primari, assoluti e universali, e i princìpi cosiddetti intermedi, che fanno discendere i princìpi primi fino a noi, adeguandoli alle nostre situazioni e ai nostri interessi. In questo modo, conclude Constant, il principio morale per il quale dire la verità è un dovere, «se fosse preso in modo assoluto e isolato, renderebbe impossibile ogni tipo di società. Ma ... nessun uomo ha diritto a una verità che nuoce ad altri».
 La verità crudele è ricusata anche da Tagliapietra in nome della pietà verso la vittima silenziosa cui nuoce la verità delatoria. Sulla scia di Agamben sostiene infatti Tagliapietra che «la verità ... non è una mera informazione esatta ... ma anche un prendere posizione per ciò che si dice, un esserci in ciò che si afferma». Se confrontata con la fiducia, la verità diventa ai suoi occhi «una forma di vita che non si esaurisce nella sola dimensione dichiarativa del linguaggio» (66-67). Come viene respinta - la posizione di Kant - da molti autori e dalla maggior parte delle persone che adducono argomenti di buon senso e di empatia con le vittime. Dopo il colpo inferto al Kant gnoseologico dal newrealismo, ecco comunque un rinnovato attacco al Kant etico, troppo rigoroso per i nostri tempi edonistici e happycratici.
La verità crudele è ricusata anche da Tagliapietra in nome della pietà verso la vittima silenziosa cui nuoce la verità delatoria. Sulla scia di Agamben sostiene infatti Tagliapietra che «la verità ... non è una mera informazione esatta ... ma anche un prendere posizione per ciò che si dice, un esserci in ciò che si afferma». Se confrontata con la fiducia, la verità diventa ai suoi occhi «una forma di vita che non si esaurisce nella sola dimensione dichiarativa del linguaggio» (66-67). Come viene respinta - la posizione di Kant - da molti autori e dalla maggior parte delle persone che adducono argomenti di buon senso e di empatia con le vittime. Dopo il colpo inferto al Kant gnoseologico dal newrealismo, ecco comunque un rinnovato attacco al Kant etico, troppo rigoroso per i nostri tempi edonistici e happycratici.Verità crudele e nuda
Verità crudele, insostenibile, abbagliante, svelata fino alla nudità. Al repertorio di questa immagine nel pensiero filosofico è dedicato un volumetto postumo che raccoglie gli scritti inediti sul tema a opera del filosofo metaforologo Hans Blumenberg (H. Blumenberg, Die nackte Wahrheit [La verità nuda], a cura di Rüdiger Zill, Berlin, Suhrkamp, 2019).
La verità è orribile - oltre che crudele -. Fortunatamente l’arte ci permette di non affondare con la verità stessa. È Nietzsche che, impostando l’antagonismo tra la noia della scienza e la vitalità dell’arte, sentenzia che arte e cultura velano l’orrore della verità, e che l’illusione può mascherare la conoscenza che uccide l’azione. Variabile è comunque, commenta Blumenberg, il valore culturale della nudità della verità; in Kafka è la crudele mancanza di ogni sorta di corazza, guscio, protezione, casa, e la consegna a condizioni di vita estranea. E del resto, chi potrebbe sostenere la vista della verità - ecco Descartes che interviene, nelle Meditazioni - se Dio ce la presentasse tutta nuda? Eppure l’illuminismo rivendica proprio il diritto alla verità nuda per la quale ogni rivestimento e travestimento è ingiustizia. Mentre il diritto alla verità asciutta, secca (dry truth) di John Locke invoca un linguaggio filosofico univoco dove però le metafore sono considerate indispensabili, non per ornare e abbellire, ma proprio per chiarire e spiegare.
Fino ad arrivare a Kant e ricongiungerci, questa volta attraverso la metafora, alla sua idea di verità, che è lecito illustrare con analogie e metafore purché la cosa in sé sia chiaramente distinguibile dal necessario velo che la ricopre e la protegge. Se poi il velo ostacola la visione della verità, non impedisce però l’ascolto della legge morale, per quanto rigorosa e persino, come sappiamo, crudele.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
ESSERE GIUSTI CON KANT. La lezione di Michel Foucault e la sorpresa di Habermas.
- "Goodbye Kant!": Perché si vuole uccidere Kant?
L’ASTUZIA DEL LUPO E I SETTE CAPRETTI. "APRITE, APRITE": SONO IL VOSTRO "PAPI"!!!
PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN!!!
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- LE "REGOLE DEL GIOCO" DELL’OCCIDENTE: NELLA DIMENSIONE CHE ESIGE ERACLITO.22 ottobre 2019, di Federico La Sala
LE "REGOLE DEL GIOCO" DELL’OCCIDENTE. Tracce per una svolta antropologica ... *
HEIDEGGER-FINK, UN SEMINARIO 1966/1967NELLA DIMENSIONE CHE ESIGE ERACLITO
di Federica Montevecchi (su: Alias, 17/07/2010)
Martin Heidegger volle che la sentenza di Eraclito, «il fulmine governa ogni cosa», fosse incisa sull’architrave della porta della sua baita a Todnauberg nella Selva Nera. Le stesse parole, che costituiscono il frammento 64 dell’edizione Diels-Kranz, aprono il celebre colloquio seminariale, su Eraclito appunto, che si svolse nel semestre invernale 1966/67 all’Università di Friburgo fra Martin Heidegger e Eugen Fink. Il testo del seminario fu pubblicato in italiano nel 1992 da Coliseum, nella versione di Mauro Nobile introdotta da Mario Ruggenini, con il titolo Dialogo intorno a Eraclito. A circa venti anni di distanza da questa prima edizione, esaurita da qualche tempo, il colloquio fra Heidegger e Fink è ripresentato - corredato dalle annotazioni di Heidegger - dall’editore Laterza, nella collana «I Libri dell’Ascolto» diretta da Vittorio Tamaro, con il titolo Eraclito (a cura di Adriano Ardovino, pp. 234, € 20,00).
Il seminario, suggerito da Fink, che voleva mettere alla prova la propria interpretazione di Eraclito, fu l’ultima attività didattica di Heidegger e avrebbe dovuto includere, stando al progetto iniziale, anche una lettura dei frammenti di Parmenide. Nei fatti, invece, non fu completata neppure la lettura dei frammenti di Eraclito, tanto che Fink, nel 1970, presentando l’edizione del seminario, affermerà che il testo dato alle stampe è «un torso, un frammento su frammenti».
 Le tredici sessioni in cui si articolò la discussione, alla quale parteciparono tredici persone fra studenti e invitati, vennero trascritte volta per volta, senza l’ausilio di alcun registratore, letteralmente e integralmente.
Le tredici sessioni in cui si articolò la discussione, alla quale parteciparono tredici persone fra studenti e invitati, vennero trascritte volta per volta, senza l’ausilio di alcun registratore, letteralmente e integralmente.
 Il risultato non è tanto un confronto fra due diversi interpreti, ma, dice Heidegger, un ‘parlare con Eraclito’ e, attraverso di lui, con un’intera tradizione che, già dall’antichità, non si è sottratta alla provocazione rappresentata dai Greci. Esempi degli interrogativi di fondo dell’esistenza e dell’enigma riguardante la nascita della ragione, i pensatori greci più antichi - Presocratici o sapienti, a seconda che si voglia adottare le espressioni rispettivamente di Hermann Diels o di Giorgio Colli - sono specchi: quanto più ci avviciniamo a loro tanto più vediamo il nostro riflesso. A seconda della ‘storia razionale’ nella quale li integriamo - e questo accade già a partire da Aristotele - essi assumeranno significati molteplici, restando comunque sempre altro da ciò che di loro possiamo dire: essi costituiscono il momento inaugurale del pensiero della civiltà occidentale, nel quale la ‘verità’ della nostra origine diventa inscindibile dall’origine della nostra ‘verità’, l’ambito del conoscere non facilmente distinguibile dalla sfera del riconoscere, cioè della proiezione retrospettiva.
Il risultato non è tanto un confronto fra due diversi interpreti, ma, dice Heidegger, un ‘parlare con Eraclito’ e, attraverso di lui, con un’intera tradizione che, già dall’antichità, non si è sottratta alla provocazione rappresentata dai Greci. Esempi degli interrogativi di fondo dell’esistenza e dell’enigma riguardante la nascita della ragione, i pensatori greci più antichi - Presocratici o sapienti, a seconda che si voglia adottare le espressioni rispettivamente di Hermann Diels o di Giorgio Colli - sono specchi: quanto più ci avviciniamo a loro tanto più vediamo il nostro riflesso. A seconda della ‘storia razionale’ nella quale li integriamo - e questo accade già a partire da Aristotele - essi assumeranno significati molteplici, restando comunque sempre altro da ciò che di loro possiamo dire: essi costituiscono il momento inaugurale del pensiero della civiltà occidentale, nel quale la ‘verità’ della nostra origine diventa inscindibile dall’origine della nostra ‘verità’, l’ambito del conoscere non facilmente distinguibile dalla sfera del riconoscere, cioè della proiezione retrospettiva.Tutto ciò vale particolarmente per Eraclito le cui parole, stando a Diogene Laerzio, avrebbero fatto dire a Socrate che ci sarebbe voluto un tuffatore delio per poterle riportare alla luce dalle oscure profondità. E su queste parole si sono cimentati, nei secoli, in molti: basti pensare, fra gli altri, a Platone - che nel Sofista annovera Eraclito fra quelle Muse ioniche capaci di mostrare la connessione fra l’uno e i molti -, a Hegel - che nelle Lezioni sulla storia della filosofia afferma: «non c’è proposizione di Eraclito che io non abbia accolto nella mia Logica» -, a Hölderlin - che, attraverso Eraclito, legge l’inscindibilità di unione e separazione -, e ancora, a Nietzsche - che nei frammenti eraclitei vede l’espressione della visione tragica del mondo, del conflitto sotteso a ogni creazione e allo stesso logos.
Va da sé che pure Heidegger e Fink, in sintonia con la tradizione filosofica tedesca, che affronta il pensiero più antico proiettando nella Grecia anzitutto se stessa, la propria specificità filosofica, accolgono la sfida di Eraclito ben prima di questo seminario. L’eco eraclitea, infatti, è costante nell’opera di entrambi e si mostra, ad esempio, nell’idea heideggeriana dell’intermittenza di qualcosa che apparendo come mondo al tempo stesso si nasconde come senso. Se in questa idea è implicita la nota sentenza eraclitea «la natura ama nascondersi», nella metafora di Fink del gioco che gioca con l’uomo e il mondo, ossia con coloro che lo stanno giocando, sono evidentemente sottintese le parole di Eraclito «il tempo è un fanciullo che gioca spostando i dadi: il regno di un fanciullo».
Queste rispettive posizioni filosofiche si riflettono naturalmente nel seminario, dove Heidegger e Fink, tuttavia, cercano di assumere ruoli ben definiti. È lo stesso Fink a caratterizzare il ruolo di Heidegger nei termini di una ‘direzione spirituale’, che si declina in interventi brevi, chiarificatori, interrogativi, ma anche ammonitori rispetto a tutto ciò che potrebbe limitare la possibilità di giungere «nella dimensione che esige Eraclito», come ad esempio approcci di tipo esclusivamente filologico e storiografico, oppure l’uso di termini ritenuti troppo risonanti, quali diradamento e tempo, se non ormai inadeguati, come il temine essere. Fink, invece, assume il compito di presentare una provvisoria interpretazione dei frammenti eraclitei che garantisca una base di discussione e possa essere idonea a collocare i partecipanti al seminario «entro una certa comunione nel linguaggio interrogante». E tuttavia il tentativo di recuperare Eraclito è destinato a fare i conti con una distanza storica e ontologica abissale, come mostrano le frequenti domande di Heidegger - destinate a contenere, nei partecipanti, le cristallizzazioni concettuali, che sono da ricondursi, come viene ricordato, alla filosofia successiva di Aristotele -, oppure l’affermazione che nel seminario si sta presentando un’interpretazione non più metafisica di testi non ancora metafisici: fra il ‘non più’ e il ‘non ancora’ è tuttavia possibile sentire l’eco dell’esperienza di pensiero di Eraclito, che obbliga continuamente a riflettere sui criteri attraverso i quali si è articolato il pensiero occidentale, quindi a considerare la possibilità di pensare in altro modo.
L’andamento del seminario è scandito soprattutto dal tema dell’unità fra opposti, che ricorre in tutti i frammenti eraclitei e rimanda al problema fondamentale dell’appartenenza (Verhältnis) di uno e molti-tutto, en e panta. I numerosi esempi di fenomeni descritti da Eraclito - come pace e guerra, fame e sazietà, giovani e vecchi, mortali e immortali - mostrano a un tempo l’opposizione fra diversi e la loro unità, e cioè il fatto che lo stesso sia anche altro, i molti-tutto siano anche uno: «la difficoltà - dice Heidegger - consiste nello scorgere in che modo lo en mostri all’improvviso un altro carattere», nel capire come Eraclito possa vedere, nell’esperienza comune a tutti basata sull’opposizione e sulla distinzione, sempre l’uno e un unico logos.
 Detto altrimenti, la convivenza degli opposti, che caratterizza l’universo greco più antico già a partire dalle prime cosmologie fino ad arrivare all’opposizione delle proposizioni nell’argomentazione dialettica, rilancia costantemente l’enigma della polarità o, stando al seminario, l’enigma di come il determinato sia ad un tempo «l’unità che riunisce».
Detto altrimenti, la convivenza degli opposti, che caratterizza l’universo greco più antico già a partire dalle prime cosmologie fino ad arrivare all’opposizione delle proposizioni nell’argomentazione dialettica, rilancia costantemente l’enigma della polarità o, stando al seminario, l’enigma di come il determinato sia ad un tempo «l’unità che riunisce».
 La risposta di Heidegger e Fink si concentra sul legame fra l’uno e i molti-tutto, legame che viene inteso appunto come Verhältnis, giustamente tradotto con appartenenza, intendendo con tale termine non una relazione di possesso fra due oggetti né un rapporto di reciprocità, ma il trattenersi dell’uno e dei molti-tutto nella «stabilità dell’apertura», la «tenuta (Verhalt) dell’essere e del mondo». È la stessa cosa infatti che, nella separazione da se stessa, si tiene unita e si custodisce perché - viene precisato nella sessione undicesima - appartenere e tenere «significano in primo luogo il custodire, tenere in serbo e accordare nel senso più ampio»: questo è del resto il logos nel suo significato proprio di raccolta e di presenza di ciò che è stato raccolto. E evidente che tutto ciò permette di aprire lo spazio a un pensare che contrasti la concezione ingenua secondo la quale l’uno viene pensato come un contenitore in cui sono racchiusi i molti-tutto e soprattutto l’idea, che diventerà una delle matrici del pensiero occidentale, secondo la quale il molteplice è un dispiegarsi e un decadere del semplice.
La risposta di Heidegger e Fink si concentra sul legame fra l’uno e i molti-tutto, legame che viene inteso appunto come Verhältnis, giustamente tradotto con appartenenza, intendendo con tale termine non una relazione di possesso fra due oggetti né un rapporto di reciprocità, ma il trattenersi dell’uno e dei molti-tutto nella «stabilità dell’apertura», la «tenuta (Verhalt) dell’essere e del mondo». È la stessa cosa infatti che, nella separazione da se stessa, si tiene unita e si custodisce perché - viene precisato nella sessione undicesima - appartenere e tenere «significano in primo luogo il custodire, tenere in serbo e accordare nel senso più ampio»: questo è del resto il logos nel suo significato proprio di raccolta e di presenza di ciò che è stato raccolto. E evidente che tutto ciò permette di aprire lo spazio a un pensare che contrasti la concezione ingenua secondo la quale l’uno viene pensato come un contenitore in cui sono racchiusi i molti-tutto e soprattutto l’idea, che diventerà una delle matrici del pensiero occidentale, secondo la quale il molteplice è un dispiegarsi e un decadere del semplice.Nell’ultima sessione del seminario Heidegger chiede a Fink qual era il senso dell’affermazione con cui aveva aperto il loro colloquio comune con Eraclito, e cioè che i Greci «significano per noi un’immane provocazione». Fink risponde che si tratta della provocazione «a capovolgere, una buona volta, l’orientamento del nostro pensiero», a disfarsi di tutto l’apparato concettuale costruito sul bisogno, che Hegel ha incarnato in maniera paradigmatica, del pacificante appagamento di ciò che è pensato e conciliato per tornare a pensare, vale a dire a sentire, secondo Heidegger, «l’assillo dell’impensato nel pensato» e, come esorta Periandro di Corinto, ad avere cura del tutto in quanto tutto.
* SUL TEMA, IN RETE E NEL SITO, SI CFR.:
- Eraclito, fr. B 53: "πόλεμος πάντων μὲν πατήρ ἐστι, πάντων δὲ βασιλεύς, καὶ τοὺς μὲν θεοὺς ἔδειξε τοὺς δὲ ἀνθρώπους, τοὺς μὲν δούλους ἐποίησε τοὺς δὲ ἐλευθέρους." (Eraclito, fr. B 53).
- Eraclito, fr. B 53: «La guerra (pólemos) è madre di tutte le cose e di tutte la regina (basiléus). Gli uni rende dèi, gli altri uomini; gli uni fa schiavi, gli altri liberi» (Gianfranco Ravasi, La santa violenza, Avvenire, 17.10.2019).
- Eraclito, fr. B 53: "Il conflitto (pólemos è padre di tutte le cose, di tutte re; e gli uni disvela come dèi e gli altri come uomini, gli uni fa schiavi gli altri liberi" (Eraclito, fr. B 53)
COME IL "PADRE" E’ ALL’ORIGINE ("URSPRUNG") DEL BAMBINO, COSI’ IL "POLEMOS" E’ ALL’ORIGINE DI TUTTE LE COSE?!: HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI.
MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? SI TRATTA DELLA PAROLA FONDANTE E DISTINTIVA DELLA FEDE CRISTIANA!!! DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?!
LE "REGOLE DEL GIOCO" DELL’OCCIDENTE E IL DIVENIRE ACCOGLIENTE DELLA MENTE.
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
"CHI" SIAMO NOI, IN REALTÀ. RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ: UN NUOVO PARADIGMA.
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- "LA MISURA DELLE COSE". In memoria di Maria Bettetini, filosofa e studiosa di sant’Agostino (di Francesco Ognibene).17 ottobre 2019, di Federico La Sala
NON SAPEVO CHE DIO È SPIRITO....*
Lutto.
Addio a Maria Bettetini, filosofa e studiosa di sant’Agostino
È morta domenica 13 ottobre a Milano la filosofa Maria Bettetini, docente di Estetica, Retorica e Filosofia delle immagini. Il suo nome è però legato in particolare agli studi agostiniani-
di Francesco Ognibene (Avvenire, lunedì 14 ottobre 2019)
È morta domenica 13 ottobre a Milano la filosofa Maria Bettetini, studiosa di sant’Agostino, docente all’Università Iulm di Milano. 57 anni, milanese, figlia di Gianfranco, che fu pioniere all’Università Cattolica degli studi semiotici in Italia, Maria Bettetini ha insegnato dapprima Storia della filosofia medioevale all’Università Ca’ Foscari di Venezia e poi alla Iulm Estetica, Retorica e Filosofia delle immagini approfondendo in particolare lo statuto della finzione e dell’inganno, studi che hanno dato vita a uno dei suoi libri più noti, “Breve storia della bugia” (Cortina, 2001).
Il suo nome è però legato in particolare agli studi agostiniani, dal classico “Introduzione a Agostino” (Laterza, 2008) a un’edizione delle “Confessioni” da lei curata nel 2000 per Einaudi. Tra gli altri filoni dei quali è stata apprezzata studiosa va ricordato in particolare quello sull’iconoclastia, da “Contro le immagini” (Laterza, 2006) a “Distruggere il passato” (Cortina, 2016).
 Nel 2015 aveva pubblicato un suo omaggio alla filosofia, “La bellezza e il peccato” (Bompiani), una “piccola scuola” - come l’aveva definita - nata da una domanda: “Chi se non la buona filosofia può insegnare a cogliere la bellezza in questo mondo da salvare?”. Con i “Quattro modi dell’amore” (Laterza, 2012) aveva invece proposto un singolare itinerario filosofico e letterario attraverso amicizia, passione, amori folli o ideali e falsi amori.
Nel 2015 aveva pubblicato un suo omaggio alla filosofia, “La bellezza e il peccato” (Bompiani), una “piccola scuola” - come l’aveva definita - nata da una domanda: “Chi se non la buona filosofia può insegnare a cogliere la bellezza in questo mondo da salvare?”. Con i “Quattro modi dell’amore” (Laterza, 2012) aveva invece proposto un singolare itinerario filosofico e letterario attraverso amicizia, passione, amori folli o ideali e falsi amori.La sua intelligenza viva e penetrante, la spontanea disposizione a creare e mantenere relazioni profonde, la libertà di pensiero, la fede sempre intensamente vissuta hanno fatto di lei una figura di pensatrice originale e apprezzata e l’hanno resa naturalmente prossima al pensiero del vescovo di Ippona, del quale è stata instancabile divulgatrice, fino agli ultimi giorni prima di una morte prematura.
*
- "Non sapevo che Dio è spirito" (Agostino, Confessioni, III, 7, 12; cit. in Maria Bettetini, La misura delle cose, pref. di Giulio Giorello, Rusconi editore, Milano, 1994, p. 15).
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- SANT’AGOSTINO, DOTTORE DELLA GRAZIA ("CHARIS"): "ECCO DA DOVE COMINCIA L’AMORE" ("ECCE UNDE INCIPIT CHARITAS").
FREUD, KANT, E I SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA -- FILOLOGIA E "ARCHEOLOGIA". Considerazioni a margine dell’affresco di sant’Agostino nella cattedrale di Nardò (Lecce).
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- GIOVANNI GENTILE, LA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA, E I REPERTORI DEGLI ALLIEVI. Mio nonno era un re (di Michele Feo).15 ottobre 2019, di Federico La Sala
MIO NONNO ERA UN RE
di Michele Feo *
Il filosofo Emanuele Severino parla spesso in interviste e ricordi autobiografici del fratello Giuseppe morto in guerra, dicendo che fu studente alla Scuola Normale Superiore di Pisa e lì ascoltò le lezioni di Giovanni Gentile; lo ripete con dovizia di particolari novellistici nel «Corriere della sera» del 31 dicembre 2018.
Ma il nome di Giuseppe è assente in tutti gli elenchi a stampa degli allievi della scuola pisana, da quello curato nell’immediato dopoguerra dal filologo e segretario della Scuola Alessandro Perosa all’ultimo del 1999. Poiché l’esempio del fratello sembra essere stato determinante per la scelta di vita di Emanuele, par di capire che la collocazione formativa di Giuseppe a Pisa, all’ombra di Gentile, debba riverberare su Emanuele un po’ di quella gloria.
Sempre, anche il figlio della lavandaia e del tavernaro, quando ha asceso la scala sociale, si crea antenati nobili; le povere ma belle donzellette alla fine della favola si scoprono figlie di regine e il tribuno popolare Cola di Rienzo rivelò di essere il risultato di una bassa avventura dell’imperatore nei quartieri bassi di Roma.
Corollario: o i repertori pisani devono essere emendati o il filosofo si è distratto e anche lui si è lasciato catturare dal mito delle origini favolose.
Michele Feo
NOTA:
"DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE". Una storia di lunga durata
MIO NONNO ERA IL IL PAPÀ DI ADAMO ED EVA...
“Se vogliamo andare avanti non è a Parmenide che dobbiamo pensare. Ma, se si vuole, a Talete. Egli sapeva che l’azzurro circondava la Terra. Che vuol dire questo? E’ presto detto (e poi chiudo). La chiave ce la fornisce l’altra recente polemica innescata da Paolo Rossi, e, in particolare, la risposta di [Emanuele] Severino alla provocazione dello stesso Rossi. La questione è quella della nascita. Chiariamo.
Con la sua costanza e con la sua testardaggine, Rossi - lo storico-segugio (Severino parla di cagnolini) - è riuscito a mettere alle strette il Leone, e, l’ha fatto uscire dalla foresta pietrificata o, che è lo stesso, dal campo (Essere=Verità) di Parmenide. Perseguitato per «vent’anni», Severino non ce l’ha fatta più e ha ceduto. E, costretto a scoprire le sue carte, ha dovuto ammetterlo: non è nato ad Elea (Parmenide) e nemmeno a «Como» (Heidegger). «Io sono nato - ha dichiarato Severino - a Brescia. Me lo ha detto mia madre e mio padre: è scritto sui documenti». Il giogo del Destino della Necessità è stato spezzato: HIC SUNT LEONES - a Brescia!. Era ora: Emanuele è solo un poco Severino, ma è con noi - come noi, semplici mortali.
Fuor di metafora: questo è il problema: La croce dei filosofi, per eccellenza. Ce n’è voluto per riportare a galla dalle profondità del mare dell’essere (altro che pantano o pozzanghera, entro cui era stato buttato da Parmenide e dai suoi edipici figli - i platonici di tutti i tempi) Talete: qual è il principio di tutte le cose? Questi sono i problemi: così nasce la filosofia [...] (cfr. Federico La Sala, "Per una nuova cultura all’altezza del Pianeta Azzurro", «La Critica Sociologica», n. 93, 1990, pp. 111-115; in: “Della Terra, il brillante colore”, Pref. di Fulvio Papi, Edizioni Nuove Scritture, Milano 2013, pp. 98-99, senza note).
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA E A PENSARE BENE "DIO", "IO" E "L’ITALIA" --- Sulla divinità di Gesù. il Vaticano corregge Scalfar (di Riccardo Maccioni).).10 ottobre 2019, di Federico La Sala
Sulla divinità di Gesù. il Vaticano corregge Scalfari
Nota della Sala Stampa vaticana: dal fondatore di Repubblica libera e personale interpretazione. La precisazione dopo le sconcertanti e irreali frasi attribuite al Papa sulla divinità di Gesù Cristo
di Riccardo Maccioni (Avvenire, mercoledì 9 ottobre 2019)
Qualcuno stamattina leggendo “La Repubblica” avrà fatto un balzo sulla sedia. Nel suo commento al Sinodo intitolato “Francesco e lo spirito dell’Amazzonia” il fondatore del quotidiano Eugenio Scalfari attribuisce infatti al Papa riflessioni e opinioni quanto meno sconcertanti.
 In particolare Scalfari scrive: «Chi ha avuto, come a me è capitato più volte, la fortuna d’incontrarlo e di parlargli con la massima confidenza culturale, sa che papa Francesco concepisce il Cristo come Gesù di Nazareth, uomo, non Dio incarnato. Una volta incarnato, Gesù cessa di essere un Dio e diventa fino alla sua morte sulla croce un uomo».
In particolare Scalfari scrive: «Chi ha avuto, come a me è capitato più volte, la fortuna d’incontrarlo e di parlargli con la massima confidenza culturale, sa che papa Francesco concepisce il Cristo come Gesù di Nazareth, uomo, non Dio incarnato. Una volta incarnato, Gesù cessa di essere un Dio e diventa fino alla sua morte sulla croce un uomo».E a conferma di quanto appena detto, il giornalista e filosofo, passa in rassegna, modificandola anche un po’, la Passione di Gesù, soffermandosi in particolare sul grido di Cristo in croce, tratto dal Vangelo di Marco che riprende il Salmo 22: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?». Un’invocazione che Scalfari riassume in “Signore mi hai abbandonato”. «Quando mi è capitato di discutere queste frasi - aggiunge Scalfari - papa Francesco mi disse: “Sono la prova provata che Gesù di Nazareth una volta diventato uomo, sia pure un uomo di eccezionali virtù, non era affatto un Dio”». Davvero, quella di Scalfari, un’interpretazione troppo libera e palesemente irreale, al punto da meritarsi una “correzione”.
Arrivata con una nota del direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni: «Come già affermato in altre occasioni, le parole che il dottor Eugenio Scalfari attribuisce tra virgolette al Santo Padre durante i colloqui con lui avuti non possono essere considerate come un resoconto fedele di quanto effettivamente detto, ma rappresentano piuttosto una personale e libera interpretazione di ciò che ha ascoltato, come appare del tutto evidente da quanto scritto oggi in merito alla divinità di Gesù Cristo».
Del resto per capire che le espressioni attribuite al Pontefice non potevano essere reali sarebbe bastato recuperare le parole del Papa, ripetute in più occasioni. Poteva essere sufficiente anche solo riprendere pochi passaggi dell’udienza generale del 18 dicembre 2013: «Dio ha voluto condividere la nostra condizione umana al punto da farsi una cosa sola con noi nella persona di Gesù, che è vero uomo e vero Dio. Ma c’è qualcosa di ancora più sorprendente. La presenza di Dio in mezzo all’umanità non si è attuata in un mondo ideale, idilliaco, ma in questo mondo reale, segnato da tante cose buone e cattive, segnato da divisioni, malvagità, povertà, prepotenze e guerre. Egli ha scelto di abitare la nostra storia così com’è, con tutto il peso dei suoi limiti e dei suoi drammi. Così facendo ha dimostrato in modo insuperabile la sua inclinazione misericordiosa e ricolma di amore verso le creature umane».
Concetti ribaditi a Caserta il 28 luglio 2014: «L’Apostolo Giovanni è chiaro: “Colui che dice che il Verbo non è venuto nella carne, non è da Dio! È dal diavolo”. Non è nostro, è nemico! Perché c’era la prima eresia - diciamo la parola fra di noi - ed è stata questa, che l’Apostolo condanna: che il Verbo non sia venuto nella carne. No! L’incarnazione del Verbo è alla base: è Gesù Cristo! Dio e uomo, Figlio di Dio e Figlio dell’uomo, vero Dio e vero uomo».
Sul tema, nel sito, si cfr.:
GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA!!! NON IL FIGLIO DEL "DIO" ("CARITAS") DELLA CHIESA AF-FARAONICA E COSTANTINIANA !!!
LA CHIESA DEL SILENZIO E DEL "LATINORUM". Il teologo Ratzinger scrive da papa l’enciclica "Deus caritas est" (2006) e, ancora oggi, nessuno - nemmeno papa Francesco - ne sollecita la correzione del titolo. Che lapsus!!! O, meglio, che progetto!!!
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- UN GOVERNO PER DIFENDERE LA COSTITUZIONE (di Luigi Ferrajoli)7 settembre 2019, di Federico La Sala
Un governo per difendere la Costituzione
M5S-Lega. Il dovere delle forze democratiche è quello di dar vita a un governo che ripari i guasti prodotti proprio da chi quelle politiche velenose contro la vita e la dignità delle persone ha praticato e intende riproporre con più forza ove vincesse le elezioni
di Luigi Ferrajoli (il manifesto, 25.08.2019)
C’è una ragione di fondo che impone alla sinistra la formazione di un governo giallo-rosso: la necessità, prima di porre termine alla legislatura, di disintossicare la società italiana dai veleni in essa immessi da oltre un anno di politiche ferocemente disumane contro i migranti. La Lega di Salvini intende «capitalizzare il consenso» ottenuto a tali politiche pretendendo nuove elezioni e chiedendo al popolo «pieni poteri».
L’idea elementare della democrazia sottostante a questa pretesa - poco importa se per analfabetismo istituzionale o per programmatico disprezzo delle regole - è la concezione anticostituzionale dell’assenza di limiti alla volontà popolare incarnata dalla maggioranza e, di fatto, dal suo capo: dunque, l’esatto contrario di quanto voluto dalla Costituzione, cioè la negazione del sistema di vincoli, di controlli e contrappesi da essa istituito a garanzia dei diritti fondamentali delle persone e contro il pericolo di poteri assoluti e selvaggi.
Non dimentichiamo quanto scrisse Hans Kelsen contro questa tentazione del governo degli uomini, e di fatto di un capo, in alternativa al governo delle leggi: «la democrazia», egli scrisse, «è un regime senza capi», essendo l’idea del capo al tempo stesso non rappresentativa della complessità sociale e del pluralismo politico, e anti-costituzionale perché in contrasto con la soggezione alla legge e alla Costituzione di qualunque titolare di pubblici poteri.
Di fronte a queste pretese, il dovere delle forze democratiche - di tutte quelle che si riconoscono non già nell’idea dell’onnipotenza delle maggioranze ma in quella dei limiti e dei vincoli ad esse imposte dalla Costituzione - è quello di dar vita a un governo che ripari i guasti prodotti proprio da chi quelle politiche velenose contro la vita e la dignità delle persone ha praticato e intende riproporre con più forza ove vincesse le elezioni.
Dunque un governo di disintossicazione dall’immoralità di massa generata dalla paura, dal rancore e dall’accanimento - esibito, ostentato - contro i più deboli e indifesi.
Non un governo istituzionale o di transizione, che si presterebbe all’accusa di essere un governo delle poltrone, ma al contrario un governo di esplicita e dichiarata difesa della Costituzione che ristabilisca i fondamenti elementari della nostra democrazia costituzionale: la pari dignità delle persone, senza differenze di etnia o di nazionalità o di religione, il diritto alla vita, il rispetto delle regole del diritto internazionale, prima tra tutte il dovere di salvare le vite umane in mare, il valore dei diritti umani e della solidarietà, il rifiuto della logica del nemico, come sempre identificato con i diversi e i dissenzienti e immancabilmente accompagnato dal fastidio per la libera stampa e per i controlli della magistratura sull’esercizio illegale dei poteri.
Su questa base non ha nessun senso condizionare il governo di svolta a un no a un Conte-bis o alla riduzione del numero dei parlamentari.
L’alternativa possibile è un governo Salvini, preceduta dalla riduzione dei parlamentari ad opera di una rinnovata alleanza giallo-verde, e poi chissà quante altre e ben più gravi riforme in tema di giustizia, di diritti e di assetto costituzionale.
Una probabile maggioranza verde-nera eleggerebbe il proprio capo dello Stato e magari promuoverebbe la riforma della nostra repubblica parlamentare in una repubblica presidenziale. Di fronte a questi pericoli non c’è spazio per calcoli o interessi di partito.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- Tracce per una svolta antropologica e teologica. «Nuovo umanesimo» in politica: è tempo di dirlo e di farlo (di G. Lorizio).!2 settembre 2019, di Federico La Sala
LA QUESTIONE "CATTOLICA" E LO SPIRITO DEI NOSTRI PADRI E E DELLE NOSTRE MADRI COSTITUENTI... *
Dopo il discorso di Conte.
«Nuovo umanesimo» in politica: è tempo di dirlo e di farlo
di Giuseppe Lorizio (Avvenire, domenica 1 settembre 2019)
«Molto spesso, negli interventi pubblici sin qui pronunciati, ho evocato la formula di un nuovo umanesimo. Non ho mai pensato che fosse lo slogan di un governo. Ho sempre pensato che fosse l’orizzonte ideale per un intero Paese». Questa frase, pronunziata giovedì al Quirinale da Giuseppe Conte nel discorso con cui ha accettato di verificare la possibilità di formare un nuovo esecutivo, è stata ripresa dai media in modo spesso superficiale e talvolta in maniera irridente, in alcuni casi come esclusivo supporto alla cultura dell’accoglienza, soprattutto verso i migranti, e tuttavia, ha bisogno di essere ulteriormente pensata e approfondita.
Non bisogna dimenticare che la Chiesa italiana, nel suo V convegno nazionale, celebrato a Firenze nel 2015, è stata chiamata a riflettere sul tema del ’nuovo umanesimo’ nel suo radicamento cristologico. Il titolo di quell’evento recitava ’In Cristo il nuovo umanesimo’. E papa Francesco nella riflessione che ha proposto ai vescovi italiani nell’Assemblea generale del maggio scorso ha richiamato, in particolare con riferimento alla sinodalità, il discorso che aveva pronunziato in quell’occasione.
 Nell’arduo tentativo di declinare teologicamente il sintagma ’nuovo umanesimo’, nella mia relazione a Firenze, io stesso avevo richiamato la categoria fondamentale, decisamente biblica, dell’alleanza come cifra di un autentico umanesimo radicato nella fede.
Nell’arduo tentativo di declinare teologicamente il sintagma ’nuovo umanesimo’, nella mia relazione a Firenze, io stesso avevo richiamato la categoria fondamentale, decisamente biblica, dell’alleanza come cifra di un autentico umanesimo radicato nella fede.
 Oggi mi sembra proprio questo il contributo decisivo che i cattolici italiani possono offrire al Paese in questo frangente, ma non solo. E si tratta di un orizzonte culturale, piuttosto che di un’indicazione programmatica per l’azione di un Governo (come giustamente ha rilevato Conte).
Oggi mi sembra proprio questo il contributo decisivo che i cattolici italiani possono offrire al Paese in questo frangente, ma non solo. E si tratta di un orizzonte culturale, piuttosto che di un’indicazione programmatica per l’azione di un Governo (come giustamente ha rilevato Conte).Richiamando la Costituzione, si è fatto riferimento al ’primato della persona’, come radice antropologica di ogni azione sociale, politica, culturale. Come tutti sanno, o dovrebbero sapere - e qui il rammarico per averlo troppo spesso tralasciato e dimenticato -, la nozione di ’persona’, nella sua pregnanza ontologica, è stata consegnata (o, meglio, donata) all’Occidente dalle vicende delle dispute cristologiche e trinitarie dei primi secoli, messe in atto in ambito cristiano. Si è pensato l’umano a partire dall’identità di Cristo e dal mistero di Dio.
 Per la cultura pagana la persona era semplicemente la ’maschera’ (prosopon), ovvero rappresentava il ruolo, che in ambito teatrale veniva assunto e interpretato dall’attore. Oltre la funzione pubblica, il cristianesimo, invita a considerare l’uomo nel suo rapporto con l’essere, piuttosto che col fare o col rappresentarsi. La trasposizione in ambito politico del concetto di persona passa attraverso la sua valenza giuridica.
Per la cultura pagana la persona era semplicemente la ’maschera’ (prosopon), ovvero rappresentava il ruolo, che in ambito teatrale veniva assunto e interpretato dall’attore. Oltre la funzione pubblica, il cristianesimo, invita a considerare l’uomo nel suo rapporto con l’essere, piuttosto che col fare o col rappresentarsi. La trasposizione in ambito politico del concetto di persona passa attraverso la sua valenza giuridica.
 Come Antonio Rosmini aveva efficacemente dichiarato della sua ’Filosofia del diritto’, «la persona ha nella sua stessa natura tutti i costitutivi del diritto: essa è dunque il diritto sussistente, l’essenza del diritto». Questa preziosa indicazione consente il superamento sia di un crudo giusnaturalismo, sia del contrattualismo, imperante soprattutto nella concezione hobbesiana e rousseauniana dello Stato.
Come Antonio Rosmini aveva efficacemente dichiarato della sua ’Filosofia del diritto’, «la persona ha nella sua stessa natura tutti i costitutivi del diritto: essa è dunque il diritto sussistente, l’essenza del diritto». Questa preziosa indicazione consente il superamento sia di un crudo giusnaturalismo, sia del contrattualismo, imperante soprattutto nella concezione hobbesiana e rousseauniana dello Stato.
 Ed è su tale base ’antropologica’ che si innesta la categoria dell’alleanza come modalità propria del rapporto fra persone e fra gruppi di persone.
Ed è su tale base ’antropologica’ che si innesta la categoria dell’alleanza come modalità propria del rapporto fra persone e fra gruppi di persone.In questa prospettiva vanno letti gli autorevoli inviti - in particolare quello del presidente della Cei Gualtiero Bassetti - a fondare un’autentica prospettiva politica non su dei semplici contratti, spesso frutto di miopi compromessi, che prima o poi esplodono, determinando la catastrofe del rapporto, ma su una visione programmatica, basata appunto su vere e proprie alleanze.
Non possiamo non ricordare che la prospettiva rosminana si rifà alla definizione di Giovanni Duns Scoto, che a sua volta radicalizza la visione di Riccardo di San Vittore (per il quale la persona è intellectualis naturae incommunicabilis existentia) fino a definirla ultima solitudo. Il Roveretano infatti afferma che la persona è una sostanza spirituale dotata di un principio incomunicabile. Così possiamo cogliere la caratteristica fondamentale della persona, ossia la sua unicità.
Sonny, il protagonista artificiale del famoso film Io robot, allorché si scopre ’quasi umano’ e ne prende coscienza, afferma con stupore: «Io sono unico». La macchina si produce, la persona si genera. Questa unicità rende preziosa ogni persona e determina un’etica della sua salvaguardia a qualsiasi classe, cultura, religione, regione, cultura appartenga.
Ma, oltre che unicità, la persona dice anche ulteriorità. Un aforisma che ci giunge dall’antica sapienza (Seneca, Naturales quaestiones) recita: «Oh quam contempta res est homo, nisi supra humana surrexerit», che cosa misera è l’umanità se non si sa elevare oltre l’umano... In questa breve espressione si sintetizza in maniera mirabile l’ulteriorità della condizione umana, espressa peraltro col verbo (surrexerit) che fa riferimento alla risurrezione. Quell’«essere della lontananza » che è l’uomo, infatti, proprio a partire dalla sua distanza originaria e dal suo oltrepassamento realizza la più piena prossimità alle cose (Martin Heidegger). E da questo senso della ’trascendenza’ dell’umano il pensiero credente non è certo assente, anzi lo afferma, per esempio in un famoso frammento di Blaise Pascal, che viene a stemperare il facile ottimismo di un progresso ideologicamente mitizzato - allorché afferma che «La natura dell’uomo non è di avanzare sempre; ha i suoi alti e bassi» (fr. 318 ed. Brunschvicg) - e a mettere in guardia da una possibile deriva spiritualistica dell’antropologia: «L’uomo non è né angelo né bestia, e disgrazia vuole che chi vuol fare l’angelo fa la bestia» (fr. 325 ed. Brunschvicg).
Il nuovo umanesimo, che non intenda esprimersi nella forma di un acritico antropocentrismo, chiede così di declinarsi e di realizzarsi attraverso autentiche alleanze, spesso purtroppo infrante, fra uomo e natura, fra i generi, fra le generazioni, fra il cittadino e le istituzioni, fra emozione e ragione, fra popoli e religioni. Una saggia fatica che certo non può essere il risultato di un programma di Governo, ma quel quel programma può ben ispirare e illuminare. E che richiede una visione culturale e antropologica alla quale i cristiani possono efficacemente contribuire.
Teologo, Pontificia Università Lateranense
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- L’EREDE: IL PESO DEI PADRI (ATEI E DEVOTI). UN’EREDITA’ ANCORA PENSATA ALL’OMBRA DELL’"UOMO SUPREMO" E DEL "MAGGIORASCATO"
VIVA L’ITALIA!!! LA QUESTIONE "CATTOLICA" E LO SPIRITO DEI NOSTRI PADRI E E DELLE NOSTRE MADRI COSTITUENTI. Per un ri-orientamento antropologico e teologico-politico.
UOMINI E DONNE. LA NUOVA ALLEANZA di "Maria" e di "Giuseppe"!!! AL DI LA’ DELL’ "EDIPO", L’ "AMORE CONOSCITIVO". SULL’USCITA DALLO STATO DI MINORITA’, OGGI.
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- Dialogo tra il filosofo Aldo Masullo e lo storico Aurelio Musi: gli scenari aperti dalla crisi di governo e le prospettive dell’Italia.31 agosto 2019, di Federico La Sala
"Pd-5 Stelle, il male minore: salvare il Paese dalla destra"
Dialogo tra il filosofo Aldo Masullo e lo storico Aurelio Musi: gli scenari aperti dalla crisi di governo e le prospettive dell’Italia
 "Le urne un azzardo da evitare"
"Le urne un azzardo da evitare"di AURELIO MUSI (La Repubblica/Napoli, 31 agosto 2019)
Musi: Il segretario del Pd Nicola Zingaretti lo ha chiamato «nuovo governo» per sottolinearne la discontinuità, la svolta rispetto al passato, non il “Conte bis”. «Un governo per il diritto al futuro», «il coraggio di tentare», «fine della stagione dell’odio e della paura», «l’Italia bella a cui vogliamo dare voce», equità, diritti civili, nuovi valori nella politica economica: sono queste le altre dichiarazioni di Zingaretti dopo le consultazioni al Quirinale. Ma l’abbraccio fra populisti e sinistra è davvero il male minore per il nostro Paese? Si può parlare di una conversione al populismo della sinistra o di una sinistra populista? Ne parlo con il filosofo Aldo Masullo, siamo entrambi appassionati osservatori e interpreti delle vicende politiche, soprattutto ora che, in Italia e nel mondo, sembrano dominate più dall’irrazionalità e dalla spinte emotive, che dalla logica. Masullo riflette a lungo, soppesa le parole.
Masullo: «Non mi impiccherei alle forme e alle formule», dice. «È un problema di sostanza e di processi storici. L’Italia è ridotta in condizioni miserevoli: e l’immiserimento è soprattutto nello spirito. Una democrazia parlamentare suppone una società coesa, in cui sia diffusa la cultura civile che invece è andata deperendo. È venuta meno la condizione primaria di una democrazia parlamentare. La crisi della democrazia italiana è la crisi della nostra società. Detto questo, è evidente che ci siamo cacciati in una condizione di necessità. Siamo tra Scilla e Cariddi. Questo nuovo governo da un lato è il tradimento di una democrazia di sinistra. D’altro lato, se rifiutiamo la possibilità del nuovo governo, corriamo il rischio che la Lega riesca a vincere le prossime elezioni. La responsabilità verso il Paese è il fine primario che ci dobbiamo porre. Chi perde non è il singolo partito, ma un popolo intero. Se invochiamo il principio di responsabilità, dobbiamo respingere l’azzardo delle urne".
"L’alternativa è offerta dallo stesso avversario che ci minaccia. Bisogna quindi scegliere la carta del male minore: essa non rappresenta la garanzia di una vera ricostruzione democratica, che viene rinviata ad un secondo tempo. Responsabilmente non possiamo giocare d’azzardo. Dobbiamo cogliere l’occasione e stringere le fila».
Musi: "Il Pd coltiva l’illusione di poter gestire e “disciplinare”, per così dire, i 5 Stelle. L’obiettivo forse sarebbe raggiungibile solo con un partito coeso, con una sola anima, non diviso fra gruppi, fazioni, partitini. Lo scontro Renzi-Zingaretti, l’uscita di Calenda e l’ipotesi di un’ ulteriore scissione non rinviano forse ad una sorta di coazione a ripetere le divisioni, vera maledizione della sinistra?".
Masullo: «Calenda non mi preoccupa, perché il personaggio, pur intelligente, è sempre disposto a mettersi all’opposizione stando dentro o fiancheggiare punzecchiando. Mi preoccupano altri personaggi: Renzi e il gruppo renziano, naturalmente. Si dovrà verificare la loro serietà. Dovranno rendersi conto che incombe una grande responsabilità verso intere generazioni. Il Movimento 5 Stelle è come un piccolo serpente, divorato da un grande serpente, la Lega. È un insieme diversificato senza un legame che l’unisca. Il Pd con i 5 Stelle si allea con un partito pericoloso per la sua friabilità. La variabile è dunque la fermezza e l’unità del Pd. È invece pericolosa la spaccatura interna al P d. È un partito con le stampelle che deve imparare a camminare con i propri piedi. È una società di partiti diversi. Oggi ci troviamo di fronte a un gioco in cui decide in ultima istanza la responsabilità di ognuno».
Musi: "Democrazia diretta e democrazia rappresentativa, populismo Lega, populismo 5 Stelle, piattaforma Rousseau: qui sta forse la profonda incompatibilità tra un soggetto politico che crede fermamente nelle istituzioni e nella democrazia rappresentativa e un altro che, come ha dimostrato durante la fase di alleanza con la Lega, è andato a rimorchio del suo populismo".
Masullo: «Il populismo non è il potere al popolo ma il potere di alcuni che seducono il popolo. La compagnia in cui è costretto a collocarsi il Pd non rappresenta tanto un pericolo in positivo, quanto in negativo. Non la forza, ma la fiacchezza dei 5 Stelle è il vero rischio. La società attuale è una società deformata che ha perduto la fiducia in se stessa, il senso della lotta per la giustizia, che è un vero progetto politico. Tutto allora ritorna sulla stabilità del Pd».
Musi: "Destra/sinistra: esiste ancora la diade, la dicotomia formulata molti anni fa da Norberto Bobbio?".
Masullo: «È un gioco di nomi, di parole. In senso lato esiste ancora un sentimento di destra: la conservazione, senza se e senza ma, della posizione che si ha. Il sentimento di sinistra aiuta gli altri a conquistare una posizione che non hanno. Questo è il motivo dell’unità della destra rispetto alla disunità della sinistra. L’impegno è allora quello di unire i diversi».
Musi: "Forse la sinistra italiana deve tornare sui territori, ricomporre un rapporto lacerato con la società, gettare le basi per costruire un nuovo blocco sociale, come si sarebbe detto una volta...".
Masullo: «Tutto quello che le ho detto prima si potrebbe sintetizzare così: trasformare i molti desideri in un unico progetto. Questa è un’occasione propizia. Se si mette in moto questo processo col nuovo governo, il Pd può iniziare a costruire il progetto unitario. Le sezioni di partito sono deserte. La ricostruzione, di cui abbiamo bisogno, non è solo politico-funzionale, ma di carattere sociale. Una volta c’era la classe operaia con un interesse comune, visibile. Oggi il precariato diffuso accentua divisioni e incompatibilità. Non avendo una base unitaria capace di sorreggere il progetto, bisogna sostituirla con una pratica politica, capace di mettere in piedi le istituzioni barcollanti e creare nuove reti sociali. La politique d’abord: Nenni aveva ragione».
Musi: "Quali le ricadute su Napoli e la Campania del nuovo equilibrio politico nazionale? Non c’è vera svolta senza un rinnovamento delle classi dirigenti locali del Pd. Il limite di Renzi e gli effetti sulla situazione attuale della Campania sono stati soprattutto la scarsa attenzione alle periferie, la conservazione degli equilibri preesistenti, un partito autoreferenziale, tutto dentro le istituzioni, assente nella società civile, ripiegato nei rapporti di potere interni, in preda alla guerra per bande".
Masullo: «La Campania è un deserto politico, immobile, non ci sono forze capaci di costruire un progetto in grado di parlare alla società. Dobbiamo prendere atto con grande amarezza di questo. La Campania deve pregare Iddio che il corso nazionale sia così forte da trascinare quelle poche energie disponibili a mettere in discussione gli equilibri attuali e lavorare per il cambiamento».
Musi: "Un’ultima domanda riguarda il rapporto di lunga durata tra l’intellettuale, il filosofo Masullo e la politica: una sorta di “recherche” sul suo vissuto".
Masullo: «È una domanda che mi fa male, nel senso che a guardare indietro mi rendo conto del fatto che ho rinunciato alla mia attività culturale e scientifica per correre dietro alla politica. Ciò non è dipeso dalla cattiveria della politica, ma semplicemente dal fatto che un intellettuale non può svolgere insieme il lavoro culturale e agire politicamente. Un agire che esige il tuffarsi, l’immergersi totalmente nella politica. Sono rimasto sospeso tra la ricerca scientifica e l’attività politica. Questa non si può ridurre ad un’azione pedagogica: lezioni e conferenze agli operai del Pci, in cui parlavo un linguaggio diverso da quello dei funzionari di partito; interventi al Senato, svolti non in politichese, eccetera. Inevitabilmente ho scontato un deficit di azione politica. Ma non ho corso il rischio di diventare un cinico alla pura ricerca del potere».
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! - LA BATTAGLIA DEI DIRITTI DEL FILOSOFO CANADESE. "SBAGLI QUEBEC. La laicità assoluta opprime la fede" (di Charles Taylor ).26 agosto 2019, di Federico La Sala
CANADA, LA BATTAGLIA DEI DIRITTI...
SBAGLI QUEBEC.
La laicità assoluta opprime la fede
di Charles Taylor (Corriere della Sera, “La Lettura”, 25 agosto 2019, p. 10)
Sono due le definizioni di laicità invocate nei nostri attuali dibattiti. La prima riguarda ciò che può essere definito come laicità restrittiva; la seconda è nota come laicità aperta. La differenza cruciale è la seguente: secondo la laicità restrittiva lo Stato può essere neutrale fra le diverse religioni, mentre esso prende posizione fra religione e non-religione. La religione è un problema: deve essere limitata e circoscritta entro una zona ristretta, generalmente limitata alla vita privata dei cittadini. Deve essere quindi assente da certi spazi, che il presidente francese Jacques Chirac qualificò un tempo come «spazi della Repubblica».
Secondo la laicità aperta, invece, si pretende che lo Stato sia neutro non solo rispetto alle diverse religioni, ma anche in relazione a religione e non-religione. Spesso la laicità restrittiva è considerata una posizione «francese», ma in realtà i due concetti si scontrano tanto in Francia quanto da noi, anche se dall’inizio di questo secolo la laicità restrittiva ha preso il sopravvento in Francia. È comprensibile il fatto che tale posizione abbia giocato un ruolo fondamentale quando in Francia, nel 1904-1905, si venne a legiferare sulla separazione fra Chiesa e Stato. Al tempo, la Repubblica era minacciata dai sostenitori di un monarchismo ultra-cattolico. Tuttavia oggi, fuori da tale contesto conflittuale, la concezione restrittiva non ha più senso.
Ebbene, le due concezioni sopra indicate non hanno pari legittimità. Infatti, soltanto la laicità aperta è compatibile con la democrazia egualitaria, dove ogni cittadino ha gli stessi diritti di cui godono tutti gli altri. La laicità restrittiva è invece inevitabilmente destinata a porre discriminazioni,se non fra le religioni, perlomeno fra religione e non-religione. E quel che possiamo notare nella legge 21 del Québec, che ha adottato il modello francese della laicità restrittiva.
Di fatto, questa legge impedisce di svolgere le proprie professioni a coloro che - attraverso la pratica religiosa - lasciano trasparire la loro convinzione e il loro impegno nell’ambito di una certa religione; le professioni sono invece aperte a tutti gli altri cittadini, sia che osservino altre religioni, sia che non ne pratichino alcuna.
Una simile discriminazione potrebbe essere considerata legittima solo nelle democrazie che pretendono di rappresentare un gruppo maggioritario, ad esempio una certa etnia, e di essere giustificate nel limitare i diritti degli altri. Come accade oggi in Ungheria.
Tuttavia, le nostre Carte e le tradizioni che identifichiamo come normative ci spingono a proseguire sulla via della democrazia egualitaria. L’uguale rispetto per tutti i cittadini esige che vengano loro accordate pari libertà, compresa la libertà di coscienza. È evidente che la legge 21 infrange questo principio. Ciò che propone è ben lungi dall’essere una semplice variante culturale del regime di laicità, in vigore nella maggior parte delle democrazie egalitarie e inclusive. Essa se ne distanzia in modo drammatico.
Un diverso modo per dissimulare il carattere discriminatorio della legge 21 consiste nel definirla come l’espressione di un diritto collettivo. I diritti collettivi sono certamente importanti. Tuttavia, occorre trovare il modo per armonizzarli con quelli individuali. Ma in questo caso, di quale diritto collettivo si tratta? Un popolo ha il diritto di decidere quali strutture adottare per la propria vita in comune, ovvero come debba autodeterminarsi, così come si usa dire: se sarà indipendente o meno, quale sarà la lingua adottata nella vita pubblica, quale sarà la natura della sua costituzione politica.
Ma un popolo che ha già scelto la forma di una democrazia egalitaria che rispetta i diritti (come quando abbiamo adottato la Carta dei diritti), può permettersi, con un voto maggioritario, di limitarei diritti di alcuni dei propri cittadini? Di introdurre discriminazioni a spese di certe minoranze? Ciò è lontano dall’essere evidente.
La legge 21 non soltanto va contro i nostri princìpi fondamentali, bensì prende vergognosamente di mira le minoranze più vulnerabili, i membri di comunità culturali arrivate di recente da noi e poco numerose. Un giovane cresciuto tra noi, che abbia la vocazione di insegnare, che sia riuscito a fare brillanti studi e che intenda cercare un impiego nella scuola pubblica, perché proprio lì ce n’è un evidente bisogno, ebbene questo giovane, dall’autunno del 2019, troverà la porta sbarrata se l’osservanza della sua fede implica di indossare un «simbolo religioso». È un destino crudele per lui, ma al tempo stesso è una perdita per il Québec che, come tutte le società di oggi, ha bisogno di insegnanti competenti e fidati.
Questo genere di legislazione - che prende di mira certe comunità, già vittime di gravi sospetti sia a causa della propaganda populista dei partiti di destra in parecchi Paesi, compreso il nostro grande vicino del Sud, sia a causa dell’ondata islamofobica indotta dai social network - ha la conseguenza di aggravare un’atmosfera già avvelenata. Il fatto che si vogliano escludere i membri di tali comunità da alcune importanti professioni impieghi che, si dice, sono correlati a una «autorità» - indica che tali persone creano sicuramente problemi, forse sono pericolose. I pregiudizi in circolazione, così come l’islamofobia, forniscono dettagli al riguardo: queste persone ufficialmente discriminate diventano il bersaglio per atti di odio, fra i quali i meno gravi risultano essere già di persé molto sgradevoli (come ad esempio, sentire parole ostili mentre si cammina). Quanto ai più gravi, non è necessario citarli qui.
Alcuni studi realizzati in tutte le società dove misure restrittive analoghe alla legge 21 sono state oggetto di campagne elettorali da parte di importanti partiti come quello di Marine Le Pen in Francia, i sostenitori della Brexit in Inghilterra, i repubblicani di Trump, il Parti Québécois nel 2014- hanno registrato un aumento drammatico di episodi di odio. Pertanto, in nome di quale interesse pubblico si ha il diritto di sottomettere a simili prove una minoranza di cittadini, recentemente giunti fra di noi?
 (traduzione dal francese di Daniela Maggioni)
(traduzione dal francese di Daniela Maggioni)
* SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
IMMIGRAZIONE, STRANIERI, CITTADINANZA: LA CRESCENTE DIVERSITA’ DELLE SOCIETA’ DEL XXI SECOLO E LE SOLUZIONI ANTISTORICHE E IRREALISTICHE CHE POPOLANO ANCORA LA NOSTRA IMMAGINAZIONE. "L’esclusione democratica e i suoi rimedi". Un’analisi di Charles Taylor
- L’ILLUMINISMO, OGGI. LIBERARE IL CIELO. Cristianesimo, democrazia e necessità di "una seconda rivoluzione copernicana"
- GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!
 FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- ’Interessi di parte compromettono interesse Italia’. Conte si è dimesso: "L’azione del governo si arresta qui".21 agosto 2019, di Federico La Sala
Conte si è dimesso, furia contro Salvini: "Irresponsabile". Al via le consultazioni
Il premier a palazzo Madama: ’Interessi di parte compromettono interesse Italia’.
di Redazione Ansa (21.08.2019)*
"L’azione del governo si arresta qui". E’ quasi a metà del suo intervento nell’aula di palazzo Madama che ieri il premier Giuseppe Conte ha messo la parola fine ai 14 mesi di governo gialloverde aprendo ufficialmente la crisi, con le dimissioni rassegnate al presidente Mattarella che ha avviato le consultazioni a partire dalle 16. Un intervento in cui il presidente del Consiglio difende quanto fatto - "abbiamo lavorato fino all’ultimo giorno" -, ricorda ancora il lavoro da fare, ma soprattutto ne approfitta per lanciare un duro affondo contro Matteo Salvini. Il premier è una furia e non usa giri di parole nel bollare Salvini come "irresponsabile" per aver aperto una crisi solo per "interessi personali e di partito". Un crescendo di accuse che arriva dopo mesi passati a dosare e mediare ogni parola.
Conte ora è senza filtri. Ripercorre i mesi del governo elencando tutti i problemi creati dal leader della Lega, ultimo appunto la decisione di aprire una crisi con il rischio, ricorda Conte, che senza un nuovo esecutivo il Paese andrà in esercizio provvisorio e ci sarà l’aumento dell’Iva: "I comportamenti del ministro dell’Interno rivelano scarsa sensibilità istituzionale e una grave carenza di cultura costituzionale". Il capo del governo che in diverse occasioni si rivolge a Salvini chiamandolo Matteo (Conte è seduto in mezzo ai due vicepremier) lo accusa di aver oscurato quanto fatto dall’esecutivo: "hai macchiato 14 mesi di attività mettendo in dubbio anche quanto fatto dai tuoi ministri". Ma ad un certo punto, il capo del governo arriva a definirsi "preoccupato" da chi "invoca piazze e pieni poteri". L’affondo non si ferma solo alla decisione di mettere fine all’esperienza gialloverde ma tocca anche dossier delicati come il Russiagate.
- Conte: "Al Colle per dimissioni"
Conte gli imputa di non essere andato in Aula e di aver creato problemi allo stesso presidente del Consiglio. Il capo del governo non tiene fuori nulla dal suo intervento nemmeno il ricorso che Salvini all’uso di simboli religiosi. Si tratta per Conte di "uso incosciente di simboli religiosi".
- Salvini bacia il rosario in aula mentre Conte parla
L’INTERVENTO DI SALVINI - "Grazie e finalmente: rifarei tutto quello che ho fatto", ha detto il vicepremier, Matteo Salvini, intervenendo nell’Aula del Senato. "Non ho paura del giudizio degli italiani". Sono qua "con la grande forza di essere un uomo libero, quindi vuol dire che non ho paura del giudizio degli italiani, in questa aula ci sono donne e uomini liberi e donne e uomini un po’ meno liberi. Chi ha paura del giudizio del popolo italiano non è una donna o un uomo libero". "Se qualcuno da settimane, se non da mesi, pensava a un cambio di alleanza, molliamo quei rompipalle della Lega e ingoiamo il Pd, non aveva che da dirlo. Noi non abbiamo paura", ha detto ancora Salvini.
"La libertà non consiste nell’avere il padrone giusto ma nel non avere nessun padrone", ha detto Matteo Salvini citando Cicerone. "Non voglio una Italia schiava di nessuno, non voglio catene, non la catena lunga. Siamo il Paese più bello e potenzialmente più ricco del mondo e sono stufo che ogni decisione debba dipendere dalla firma di qualche funzionario eruopeo, siamo o non siamo liberi?". "Gli italiani non votano in base a un rosario, ma con la testa e con il cuore. La protezione del cuore immacolato di Maria per l’Italia la chiedo finchè campo, non me ne vergogno, anzi sono ultimo e umile testimone". "Voi citate Saviano, noi San Giovanni Paolo II.., lui diceva e scriveva che la fiducia non si ottiene con la sole dichiarazioni o con la forza ma con gesti e fatti concreti se volete completare le riforme noi ci siamo. Se volete governare con Renzi auguri...".
L’INTERVENTO DI RENZI - "Sarebbe facile assistere allo spettacolo sorridendo ma la situazione impone un surplus di responsabilità. Lei oggi presidente del consiglio si dimette ed il governo che lei ha definito populista ha fallito e tutta l’Ue ci dice che l’esperimento populista funziona in campagna elettorale ma meno bene quando si tratta di governare". "No si è mai votato in autunno, c’è da evitare l’aumento dell’Iva e serve un governo non perchè noi ci vogliamo tornare ma perchè l’aumento dell’Iva porta crisi dei consumi non è un colpo di Stato cambiare il governo ma un colpo di sole aprire la crisi ora ora, questo è il Parlamento non il Papeete". Le parole di Conte sono "da apprezzare" ma c’è il "rischio di una autoassoluzione", ha detto in una nota il Segretario del Pd Nicola Zingaretti. Per questo "qualsiasi nuova fase politica non può non partire dal riconoscimento di questi limiti strutturali di quanto avvenuto in questi mesi".
- Governo, Salvini: "Adesso mi spiego i tanti ’no’"
* http://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2019/08/20/governo-in-senato-e-il-giorno-di-conte_57d1a36a-11ff-48b7-ba74-d2380fb14a93.html (ripresa parziale - sena immagini e allegati).
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- L’EUROPA, “SOCRATE E ARISTOFANE" (LEO STRAUSS), E “LE “REGOLE DEL GIOCO” DELL’OCCIDENTE14 luglio 2019, di Federico La Sala
L’EUROPA, “SOCRATE E ARISTOFANE", E “LE “REGOLE DEL GIOCO” DELL’OCCIDENTE ... *
Leo Strauss, i classici greci per capire il rapporto tra filosofia e politica
di Matteo Moca (Alfabeta-2, 14.07.2019)
- Leo Strauss, Socrate e Aristofane, cura e introduzione di Marco Menon, ETS, pp. 336 euro 30.
«La nostra Grande Tradizione include la filosofia politica e perciò sembra garantirne la possibilità e la necessità. Secondo la medesima tradizione, la filosofia politica è stata fondata da Socrate. Dal momento che Socrate non ha scritto libri o discorsi, la nostra conoscenza delle circostanze in cui, o delle ragioni per cui, la filosofia politica è stata fondata, dipende interamente dai resoconti di altri uomini». Così, squadernando una questione di grande importanza e difficile soluzione, si apre l’introduzione che Leo Strauss scrisse per il suo Socrate e Aristofane, pubblicato adesso come primo volume - curato e introdotto da Marco Menon - della nuova importante collana “Straussiana” delle Edizioni ETS, diretta da Carlo Altini, Raimondo Cubeddu e Giovanni Giorgini, una collana che si propone, anche scorrendo i titoli che risultano in preparazione, di dare un nuovo e maggiore spazio editoriale a uno dei pensatori più importanti del Novecento. Socrate e Aristofane rappresenta certamente una summa del pensiero filosofico di Strauss, e dunque una privilegiata porta di accesso alla sua filosofia, per molteplici motivi: innanzitutto per l’andamento e la forma precisa e minuziosa dell’interrogazione del testo antico, che pare assecondare quel dialogo con gli autori che deve precedere la lettura dell’opera, ma anche perché l’analisi del testo di Aristofane mette in gioco i temi principali della sua riflessione, ovviamente riscontrabili nelle altre sue opere, come la relazione tra la filosofia e la politica, l’analisi della religione e il rapporto tra la politica e l’arte.
L’interesse per Aristofane e per i classici greci nell’orizzonte della ricerca sulla filosofia politica, come ricostruisce precisamente nella prefazione Marco Menon, diventa per Strauss sostanzioso a partire dalla fine degli anni Trenta: questa attenzione prende la direzione dell’analisi del rapporto tra Aristofane, Senofonte e Platone, come testimonia chiaramente una lettera di Strauss del 1947 che fa bene intendere su cosa si stia assestando la sua ricerca: «Sto studiando ancora la Repubblica. Penso che la querelle tra filosofia e poesia possa essere intesa nei termini di Platone; filosofia significa la ricerca della verità; [...] poesia significa qualcos’altro, ad esempio, nel migliore dei casi, la ricerca di un tipo particolare di verità». All’interno di questa discussione emerge la centralità della figura di Aristofane, perché Strauss rintraccia come il suo attacco a Socrate, rintracciabile non solo nelle Nuvole ma in molte delle sue commedie, si concentri proprio sulla questione della superiorità della filosofia o della poesia. Tentare di comprendere la centralità di Socrate nella filosofia politica, come emerge anche dal passo dell’Introduzione precedentemente citato, implica la lettura di Aristofane: via privilegiata per comprendere la vera natura di Socrate sarà il confronto tra il ritratto platonico e quello aristofaneo, l’autore del Simposio ammirava Socrate, Aristofane no, (l’attenzione di Strauss si concentra anche su Senofonte, che insieme a Platone e Aristofane conobbe Socrate di persona): si tratta però di uno studio che sottende un discorso al presente e non si limita solo allo studio dell’antichità. Su questo punto è preciso Strauss quando scrive di come, dopo gli attacchi di Nietzsche a Platone e a Socrate, il suo ritorno alle origini «è diventato necessario a causa della radicale messa in discussione di quella tradizione».
Socrate e Aristofane viene concluso da Strauss, dopo una lunga fase preparatoria e di studio, nel 1965, ma la sua pubblicazione è accolta con freddezza anche da parte dei suoi corrispondenti più stretti (Karl Löwith per esempio, a cui Strauss scriverà dopo aver ricevuto uno stringato commento: «La sua frase sul mio capitolo sulle Nuvole mi ha rallegrato molto: è quasi l’unica parola di incoraggiamento che ho sentito da molti anni! Ma non vorrebbe leggere anche gli altri capitoli?»), nonostante questo testo si concentri, come sottolinea Menon, sulla questione fondamentale della differenza tra physis e nomos, «che riveste un ruolo costruttivo per la filosofia stessa» e trascenda ben presto, pur nell’organicità della lettura, i testi di Aristofane per addentrarsi tra i sentieri speculativi a lui più cari, come la natura del teatro drammatico e il suo ruolo edificante, la dualità tra illuminismo e tradizionalismo, la vita nella città o l’imprescindibile ruolo della politica. -Strauss espone come le fonti platoniche e aristofanee su Socrate siano divergenti (Senofonte è invece considerato da Strauss come un testimone più solido in quanto continuatore delle storie di Tucidide): nei dialoghi del primo, Socrate è idealizzato ed è molto difficile distinguere nettamente ciò che Socrate ha pensato e quello che gli viene attribuito da Platone, utilizzando invece le Nuvole di Aristofane è possibile conoscere il Socrate presocratico, e cioè analizzare il passaggio dalla filosofia stricto sensu alla filosofia politica e dunque, ancora, andare a ricercare nei territori che sono alla base della disciplina filosofica.
 La lettura di Strauss si articola in numerosi capitoli, ognuno dedicato a una delle commedie di Aristofane: attraverso una lettura filologica, in queste testi emergono alcuni temi centrali della filosofia di Strauss, come il discorso sugli dei, già precedentemente evocato, nella lettura di Uccelli, Rane e Pluto, dove Aristofane solleva problematiche centrali per la definizione della divinità, oppure la riflessione sul rapporto tra Atene e Gerusalemme, nome di uno dei suoi libri più importanti ma soprattutto metafora della scelta tra filosofia e Bibbia, tra due città sacre.
La lettura di Strauss si articola in numerosi capitoli, ognuno dedicato a una delle commedie di Aristofane: attraverso una lettura filologica, in queste testi emergono alcuni temi centrali della filosofia di Strauss, come il discorso sugli dei, già precedentemente evocato, nella lettura di Uccelli, Rane e Pluto, dove Aristofane solleva problematiche centrali per la definizione della divinità, oppure la riflessione sul rapporto tra Atene e Gerusalemme, nome di uno dei suoi libri più importanti ma soprattutto metafora della scelta tra filosofia e Bibbia, tra due città sacre.
 Lo spazio maggiore è dedicato a Nuvole, nonostante comunque ognuna delle commedie venga messa in relazione da Strauss con le altre, costruendo un vero e proprio studio organico sull’opera di Aristofane, perché Nuvole rappresenta il luogo centrale per l’indagine sul giudizio aristofaneo su Socrate. Attraverso questa dettagliata analisi, Strauss arriva alla conclusione, se di giudizi definitivi si può in questi casi parlare, che Aristofane si credeva superiore a Socrate, «in virtù della sua conoscenza di sé e della sua prudenza»: infatti, scrive Strauss, «se da una parte Socrate è totalmente indifferente nei confronti della città che lo mantiene, dall’altra Aristofane si occupa molto della città» e, ancora, se Socrate «non rispetta le necessità fondamentali della città, o non vi si attiene, dall’altra Aristofane lo fa».
Lo spazio maggiore è dedicato a Nuvole, nonostante comunque ognuna delle commedie venga messa in relazione da Strauss con le altre, costruendo un vero e proprio studio organico sull’opera di Aristofane, perché Nuvole rappresenta il luogo centrale per l’indagine sul giudizio aristofaneo su Socrate. Attraverso questa dettagliata analisi, Strauss arriva alla conclusione, se di giudizi definitivi si può in questi casi parlare, che Aristofane si credeva superiore a Socrate, «in virtù della sua conoscenza di sé e della sua prudenza»: infatti, scrive Strauss, «se da una parte Socrate è totalmente indifferente nei confronti della città che lo mantiene, dall’altra Aristofane si occupa molto della città» e, ancora, se Socrate «non rispetta le necessità fondamentali della città, o non vi si attiene, dall’altra Aristofane lo fa».La saggezza di Aristofane assume la sua forma attraverso la parola del poeta, sia esso comico o tragico: le sue commedie sono «il vero Discorso Giusto» che tratta le cose comicamente (questa la chiave utilizzata da Strauss, che anche in un lettera a Kojéve scrive di come il suo libro potesse divertire un filosofo: «Ho appena finito di dettare un libro, Socrate e Aristofane. Credo che qua e là le strapperà un sorriso, e non solo per le battute di Aristofane e le mie parafrasi vittoriane») e che, «presentando come ridicoli non solo gli ingiusti ma anche i giusti, riesce a far sì che la sua commedia sia totale». Solo in questa maniera e attraverso questo filtro a lui congeniale, è possibile tratteggiare ciò che altrimenti sfuggirebbe o trascenderebbe ogni possibilità.
* NOTA
LA LEZIONE DI NIETZSCHE - E DI DIOTIMA. Con Socrate ha inizio l’avventura dell’Occidente! Leo Strauss condivide con Nietzsche l’analisi, ma non riesce a portarsi oltre e a risalire la corrente! E la filosofia è ancora immersa, come denunciava Kant, nel suo profondo “sonno dogmatico” (cfr. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN)!
“NeÌla sua cecità e protervia, l’uomo Platone è l’incarnazione più propria del sogno “diabolico” di Adamo e della sua donna Eva: diventare “come Dio”. contro Dio stesso. I Greci sapevano. Platone sa di ciò che è avvenuto in tempi remotissimi, ma non ha la mente come da una sua battuta contro il grande Diogene di Sinope per comprendere (...) Il racconto è di Aristofane, nel Simposio, e, come si può vedere, ricalca abbastanza fedelmente il racconto biblico relativamente al prima e al dopo del peccato originale, e indica anche la via ... per restaurare I’antica natura. L’indicazione del Commediografo è più che chiara e non è affatto (non fraintenderlo, “non volgerlo al comico”, egli ripete a chi ascolta il suo discorso - noi abbiamo sempre sottovalutato le sue Nuvole, ma egli aveva visto molto bene che cosa Socrate stava preparando) una boutade. Platone non comprende nulla, stravolge e continua, con il suo Eros (avido, cieco e saettante) e con lasua filosofia, sulla strada del padre. Titanicamente, come Zeus, spaccato tutto in due, tenterà di rimettere insieme i cocci, con la forza - una storia di steminata e “incurabile” follia. Aristofane parla della nostra mente, della nostra anima e della nostra vita e Platone taglia e ricuce - a specchio, “divinamente” (...) (Cfr. L’EUROPA, LE “REGOLE DEL GIOCO” DELL’OCCIDENTE, E LA LEZIONE DI NIETZSCHE).
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- "Reminisco, ergo sum": il pensiero "involontario". Ferrarotti nella società irretita dalla tecnica (di Simone D’Alessandro).8 luglio 2019, di Federico La Sala
PER LA CRITICA DELLA FACOLTÀ DI GIUDIZIO E DELLA CREATIVITÀ DELL’ "UOMO SUPREMO"... *
Ferrarotti nella società irretita dalla tecnica
Reminisco, ergo sum: il pensiero "involontario"
di Simone D’Alessandro (Doppioero, 25 giugno 2019)
- «La caratteristica fondante degli esseri umani è la loro imprevedibilità, qualità straordinaria, che li distingue radicalmente dagli animali non umani e si manifesta nel pensare involontario, non pre-condizionato da uno scopo prefissato, libero e anche, talvolta, del tutto gratuito».
Secondo Ferrarotti, decano della sociologia italiana, gli uomini oltrepassano la prevedibilità perché hanno memoria. Paradossalmente è la consapevolezza dei ricorsi storici che ci rende affatto stufi di ciò che è razionalmente prevedibile. A renderci sfuggenti è proprio ciò che siamo stati. Più precisamente: ciò che ricordiamo di essere stati.
L’assioma di Cartesio si rovescia: da Cogito ergo sum a Reminisco ergo sum.
In Il pensiero involontario nella società irretita, pubblicato quest’anno da Armando editore, egli affronta la memoria che costituisce l’essenza della nostra sopravvivenza sulla terra, tema che ricorre in altre sue opere precedenti. Il ricordo è, oggi, intaccato dalla comunicazione elettronica che lo rende superfluo.
Più che un saggio canonico è un pamphlet che analizza come la modernità dimentica, per citare il classico di Paul Connerton, in quanto funzionalmente portata verso questa fatalità.
La mancanza di memoria rende, infatti, l’umano sostituibile o impiegabile per altro.
Il suo agire meccanico e routinario viene preferito a quello imprevedibile dell’homo sapiens che coniuga la regola con l’emozione, direbbe de Masi.
Tanto vale sostituirlo con un’entità strumentale ben più efficiente, ma questo già accadeva con L’homme machine di de la Mettrie: utopia e distopia al tempo stesso.
Ferrarotti condanna la “ripetizione” come morte dell’invenzione radicale, perché la produzione si annulla nella cieca “riproduzione” e nell’incrementale “miglioramento” fine a se stesso.
Quando nulla cambia, quando tutto si dispiega in un eterno presente, l’unica cosa da fare è automatizzare l’esistente.
La memoria diventa, allora, strumento di resistenza verso tale deriva.
Essa non è semplicemente utile, né banalmente peculiare del nostro essere umani, detentori di un’identità personale da coltivare.
La memoria è molto di più, perché ci distoglie dalla retorica delle soluzioni facili che, proprio per questo, si rivelano sempre autoritarie giammai autorevoli.
La nostra società di Informatissimi idioti, altro fortunato titolo ferrarottiano di alcuni anni fa, viene algoritmicamente plagiata da un potere panoptico che riduce anche l’esercizio democratico in mero tecnicismo. Potere e autorità sono termini spesso utilizzati in modo intercambiabile, ma in questa facile analogia si nasconde una fallacia epistemologica.
Mentre il potere schiaccia, l’autorità permette la crescita.
La contrapposizione tra potere autoritario e proattività autorevole è un altro tema che assilla un intellettuale che è stato tra i primi frequentatori di Olivetti, addetto alla Presidenza per le Questioni Sociali nel 1949 e, successivamente, deputato per il Movimento di Comunità.
Ferrarotti appartiene a quella tradizione solida di intellettuali organici, resilienti e consapevoli del destino declinante dell’occidente.
In un momento in cui la filosofia e la sociologia vengono eliminate nelle università del Brasile, uno scienziato sociale rivendica il primato del pensiero umanistico, oggi costretto al suicidio dalle regole del profitto.
Applicazione disciplinata delle procedure o vocazione che metabolizza le tecniche rendendole apparentemente spontanee? Trasformazione di ciò che sei attraverso empowerment o attitudine che prevede miglioramento di ciò che già sei?
Questo è il dilemma nella società di oggi che deve scegliere se governare o essere governata dalla tecnica che elimina tutto ciò che ritiene disfunzionale.
Per maestri del pensiero quali Heidegger e Severino il destino sembrerebbe esser tracciato, ma in Ferrarotti vi è un imprevedibile vitalismo che disattiva ogni forma di disperazione.
Contestualmente alla pubblicazione del suo libro, la Luiss University Press dà alle stampe l’ultima fatica del filosofo francese Éric Sadin: Critica della ragione artificiale, nella quale si evidenzia il ruolo delle nuove tecnologie intelligenti che erodono le facoltà di giudizio e azione soggettiva. Forse non è un caso! Sadin, recuperando in senso letterale il ruolo politico della filosofia, svela il retro pensiero antiumanistico dei discorsi che sostengono l’indiscriminato sviluppo tecnologico.
Siamo giunti all’avveramento della profezia di Luhmann che negli ultimi suoi lavori annunciava l’avvento di una società senza persone?
Ferrarotti non cade nel tranello dei radicalismi. Evita di sposare la causa degli “apocalittici”, ma trova ingenuo l’atteggiamento ottimista degli “integrati”.
Ci ricorda che il vero pensiero non cede alle tentazioni della soluzione finale, piuttosto ci prepara a vivere quotidianamente con il problema: «l’atto filosofico più importante che oggi si possa compiere, è dato dal buon uso della crisi e dall’accettazione, pacata, del disagio. Non si tratta di contemplare rassegnati. Non è in gioco la Gelassenheit heideggeriana e neppure il “surrender”, la resa di Kurt H. Wolf. Si tratta di un’attesa vigile». Per questo bisogna contrastare la procedura, il modello come soluzione finale: il modello è un deja vù!
C’è sempre uno scienziato che crede di aver inventato un modello totalmente innovativo (ingenuità) che possiede qualcosa che altri modelli non hanno (propaganda) e che permette, una volta implementato, di risolvere tutti i problemi (utopia).
Un modello è una variabile dipendente da altre variabili: il contesto, i pregiudizi dell’epoca, le persone che trovi lungo il cammino, il ruolo effettivo che ricopri, la casualità.
L’allenamento mentale dell’uomo in grado di guidare il cambiamento, dovrebbe basarsi sulla capacità critica di falsificare tutti i modelli.
I modelli sono riduzionistici rispetto alle dinamiche del reale. Non si può governare la complessità rinunciando alla complessità. Di questo la sociologia critica è perfettamente consapevole.
Un modello che diventa procedura genera mostri, ostacolando il salto di qualità.
Più di cento anni fa, Max Weber lanciava un monito sulle conseguenze del processo di razionalizzazione della società occidentale, rinchiusa in una gabbia d’acciaio.
Quel monito è rimasto inascoltato!
Il XXI secolo ha spalancato le porte alla Dittatura del calcolo, come ci ricorda il matematico Zellini nella sua ultima pubblicazione del 2018.
Aumentano i libri sulla gestione automatica, cibernetica o per emulazione-memorizzazione di modelli. Eppure i livelli di criticità e di conflittualità - politica, organizzativa, economica, sociale, ambientale - sono aumentati rispetto al cosiddetto trentennio glorioso del secolo scorso.
Anche negli anni precedenti ai due conflitti mondiali, si erano imposti paradigmi di stampo positivistico finalizzati a modellizzare la realtà per ottimizzarne la funzionalità.
Risultato: le procedure generano mostri! Il positivismo ha creato sistemi autoritari.
Il modello migliora ciò che già sei, ma non cambia la natura di ciò che sei.
Allora vale la pena riscoprirsi imprevedibili e non farsi irretire dalla macchina.
L’uomo prende decisioni anche in assenza di informazioni. La macchina no!
Il 15 gennaio 2009, il pilota di linea Chesley Burnett “Sully” Sullenberger fa ammarare il volo US Airways 1549 sul fiume Hudson. Con la sua manovra, resa necessaria dall’impatto del velivolo con uno stormo di uccelli che manda in panne entrambi i motori, salva la vita a 155 persone.
Ciò nonostante l’aviazione lo sottopone a una commissione di inchiesta, perché ritiene che il pilota abbia agito in maniera pericolosa e avventata. La tesi sostenuta dagli ispettori era che avrebbe potuto fare ritorno presso l’aeroporto e atterrare con molti meno rischi. Solo dopo 15 mesi di indagini e decine di simulazioni, il NTSB convalida senza riserve la decisione di Sully.
Inizialmente una serie di test aveva sconfessato la scelta del pilota, ma si trattava di simulazioni che non tenevano conto dei 20 secondi che erano stati necessari a Sully per valutare la situazione dopo lo spegnimento dei motori. Includendo questo lasso di tempo nei test, la decisione del pilota si è dimostrata la più corretta.
Questa divagazione su una storia di vita era necessaria, perché consonante con il modo di osservare e interpretare la realtà di Ferrarotti.
L’analisi qualitativa della micro sociologia, fatta di esperienze singole e di “ricerche di comunità”, dalle quali emergono conoscenze non rilevabili con i dati statistici, fanno parte di quella tradizione della filosofia sociale e della sociologia qualitativa che non può essere cancellata, ma deve necessariamente coniugarsi con le metodologie di carattere quantitativo, accettando il problema dell’irriducibilità dei fenomeni sociali al mero dato misurabile.
Ferrarotti non dimentica la lezione ottocentesca, ancora attuale, di dover tenere assieme spiegazione (erklären) e comprensione (verstehen) , mantenendo una rotta scientifica alimentata da una tensione critica verso fenomeni che corrodono la coesione sociale.
Egli appartiene alla schiera di quei pensatori che vogliono incidere sulla realtà senza cadere in tentazioni ideologiche, preservando l’onesta dello scienziato sociale.
A lui si addice la frase che egli stesso cita in un’altra delle sue opere pubblicate quest’anno: Potere e autorità.
Nell’ultima pagina di questo lavoro, cita l’ultima opera di Charles Wright Mills, The Marxists, dove in esergo compare una frase che ogni sociologo dovrebbe far propria:
«I have tried to be objective, I do not claimed to be detached». Ho cercato di essere obiettivo. Non pretendo di essere distaccato.
* SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). Un omaggio a Kurt H. Wolff e a Barrington Moore Jr.
- PER LA STORIA DELLLA SCIENZA E PER LA SCIENZA DELLA STORIA, FORSE, E’ MEGLIO RI-DISCENDERE “SOTTO COVERTA DI ALCUN GRAN NAVILIO” E RIPRENDERE IL LAVORO GALILEANO DELLA CONVERSAZIONE E DELLA CONOSCENZA
PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- DAL "NAUFRAGIO CON SPETTATORE" AI "NAUFRAGI SENZA SPETTATORE". Popcorn e imbarbarimento. .7 luglio 2019, di Federico La Sala
POPCORN E RIMBAMBIMENTO, direi ....*
A gamba tesaPopcorn e imbarbarimento
di Giorgio Mascitelli (Nazione Indiana, 6 Luglio 2019)
Vedendo le immagini della comandante della Sea Watch che scendeva dalla nave arrestata dagli uomini della guardia di finanza, mi è venuta in mente la battuta di Renzi dell’anno scorso sul fatto che con il nuovo governo si sarebbe seduto comodamente coi popcorn in mano a vedere cosa avrebbero combinato. Questa battuta è più profonda ed emblematica di quanto pensi il suo autore perché rappresenta non solo il suo pensiero, ancorché un certo tipo di tronfieria che la caratterizza sia tipicamente renziana, ma il coronamento o, per parlar da professorone, l’entelechia di un’intera classe dirigente. L’immagine dei popcorn suggerisce infatti sia l’idea di una politica da spettatori, senza partecipazione delle persone, sia quella che le cose che accadranno in Italia a causa di questo governo infondo non tocchino lo spettatore, come se non ne pagasse lui le conseguenze, cosa che probabilmente per le nostre classi dirigenti è vera.
Quella dei popcorn è anche un’opzione strategica che significa nessun ripensamento sul passato, ma attesa semplicemente degli errori dell’attuale governo perché la politica non è altro che amministrazione più o meno abile dell’esistente che non può essere messo in discussione. Eppure in Europa se l’imbarbarimento avanza, è anche grazie a questa idea narcisista e autolesionista delle classi dirigenti, con l’aggiunta tutta italiana dell’illusione che questo governo, o altri ancora peggiori che si profilano, finirà esattamente come finisce un film magari quando sono terminati anche i popcorn.
Si dà il caso invece che nel governo ci sia un comunicatore veramente bravo nel suo ramo che ha già spiegato che vuole governare per trent’anni, e tra l’altro i seguaci della strategia del popcorn sono anche convinti che si tratti del male minore rispetto ai cinquestelle. I risultati di questo modo di approcciarsi si vedono con il caso della Sea Watch: il ministro degli interni, in disprezzo delle norme internazionali che regolano la navigazione, costruisce un caso mediatico su una nave che ha salvato dei naufraghi per distrarre l’opinione pubblica dai tagli alla spesa che il governo deve fare per non incorrere nelle procedure d’infrazione dell’Unione dopo aver solennemente assicurato che lui dell’Europa se ne frega. I rappresentanti della strategia del popcorn, invece di smascherare il gioco illusionistico e di fare delle controproposte sulla finanziaria, mandano alcuni loro esponenti sulla nave finendo con il favorire la diffusione dell’interpretazione tendenziosa che tale nave non ha salvato delle persone, ma è inviata apposta per mettere in difficoltà il governo. Risultato, nonostante Salvini abbia sostenuto tesi prive di riscontro e sia sceso a più miti consigli nei suoi rapporti con l’Unione, guadagna consensi come l’uomo tutto d’un pezzo che non si piega ai diktat europei.
Benché l’Italia sia un paese senza prospettive economiche in cui la crisi demografica sta incidendo come durante una guerra, una parte cospicua della popolazione, potenzialmente maggioritaria, non è poi così disponibile a lasciarsi incantare da giochi illusionistici, ma non per questo è disposta ad appoggiare un’opposizione che tramite la strategia dei popcorn mostra di volere solo il ritorno al passato sentito con ragione come altrettanto minaccioso. Occorre, se si vuole contrastare quell’imbarbarimento di cui gli insulti a Carola Rackete sono un sintomo, indagare con umiltà le problematiche che affliggono le fasce medio basse della popolazione italiana e fornire proposte concrete alternative ai risarcimenti simbolici per l’impoverimento collettivo offerti con gran dovizia dal comunicatore
Almeno è che così che la vedo io, ma a me il popcorn non è mai piaciuto.
* POPCORN E RIMBAMBIMENTO, direi ....
NONOSTANTE GALILEI E PASCAL (“Vous êtes embarqués”) ed EINSTEIN, a quanto pare, in Italia soprattutto il consumo di “popcorn” va fortissimo e la teorizzazione del gioco del “NAUFRAGIO CON SPETTATORE. Paradigma di una metafora dell’esistenza” (Hans Blumenberg) anche! E non si vede affatto né che si è tutti e tutte nella stessa BARCA/TERRA né per nulla che già da tempo è iniziata l’epoca dei “NAUFRAGI SENZA SPETTATORE. L’idea del progresso” (Paolo Rossi).
NOTA:
ALLA LUCE del nostro tempestoso presente storico (e della “barbarie ritornata”), non è male (mia opinione e mio invito) rileggere il ricco e complesso lavoro sociologico-politico (altro che “romanzo”!) di Carlo Levi, “Cristo si è fermato ad Eboli”, e soffermarsi - in particolare - sul passaggio relativo alla “Ditta Renzi - Torino”, alle tasse, e alle capre (pp. 40-42, Einaudi, Torino 2010 - in rete) [...] Il ’passaggio’ offre un ‘cortocircuito’ tra la “Ditta Renzi” di ieri (1935-1936) e la “Ditta Renzi” di oggi (1994-2014), una sintesi eccezionale della “cecità” di lunga durata delle classi “dirigenti” del nostro Paese, e ricorda a tutti e a tutte come e quanto, ieri come oggi, ” (...) quello che noi chiamiamo questione meridionale non è altro che il problema dello Stato (...) (p. 220, cit.). E non solo: “È significativo che l’espressione di Tertulliano: “Il cristiano è un altro Cristo”, sia diventata: “Il prete è un altro Cristo”” (Albert Rouet, arcivescovo di Poitiers, 2010)!
Il discorso è di lunga durata e investe le strutture stesse dellla cultura europea e planetaria: nel Cristo si è fermato a Eboli, c’è “la scoperta prima di un mondo nascente e delle sue dimensioni, e del rapporto di amore che solo rende possibile la conoscenza” (C. Levi, Le parole sono pietre. Tre giornate in Sicilia, “Introduzione” [1955], Einaudi, Torino 1978) [...] (cfr. LA LEZIONE DI CARLO LEVI - OGGI: LA “DITTA RENZI” (DI TORINO) AD ALIANO (MATERA). Un invito alla ri-lettura di “Cristo si è fermato ad Eboli”).
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- DESIDERIO DI RIVOLUZIONE E "VOGLIAMO TUTTO". Un ricordo di Rachel Kushner, con nota.1 luglio 2019, di Federico La Sala
CAMBIARE IL MONDO, TRASFORMARE LA VITA. Desiderio di rivoluzione ... *
“Abbiamo bisogno di cambiare il mondo, ed è urgente”
di Rachel Kushner (Alfabeta-2, 30 giugno 2019)
Un mio amico di Milano, il primo italiano con cui mi è capitato di parlare di Nanni Balestrini, ha detto: “Nanni? Quando stava per essere arrestato, l’ho portato in macchina in val d’Aosta per aiutarlo a scappare. È passato in Francia con gli sci e io l’ho ripreso a Chamonix”. Con questo amico pensavo che avremmo semplicemente discusso la poesia di Nanni, la sua arte, i suoi romanzi. Forse la sua politica, non una vita in fuga. Ma la vita, e la politica, e l’arte, sono in qualche modo perfettamente fuse nello spirito di Nanni, per cui sentire che il mio amico lo aveva aiutato a salvarsi in Francia nel giro di vite dei tardi anni ’70 non avrebbe dovuto sorprendermi.
In realtà a colpirmi davvero è stata l’idea che Nanni sapesse sciare abbastanza bene da passare il Monte Bianco in sci. In seguito ho saputo che insieme a lui c’era un istruttore. Più volte con Nanni ho cercato di sapere di più su questo fatto, ma a Nanni non sempre piacevano le domande. Una domanda per lui era spesso una scorciatoia per la banalità. Quando l’ho incontrato la prima volta, l’ho subissato di domande sulle persone che aveva conosciuto, sulla sua scrittura, sulla politica dell’autonomia, ma lui mi ha posato una mano sul braccio e ha detto: “Ascolta, parliamo del vino da scegliere. Questo è un pranzo. Siamo a pranzo. Siamo in un ristorante. Comportiamoci da persone civili. Decidiamo cosa mangiare, cosa bere, magari parliamo del tempo. Il resto può aspettare”.
In quel pranzo, quando alla fine siamo arrivati a parlare di politica, è stato molto serio, e astuto, e si è concentrato sulla vita oggi, e sulla vita nel futuro, senza nostalgia, anche se non ha avuto esitazioni nel parlare del passato. Come mi ha detto in seguito, quando l’ho intervistato in modo più formale: “Più che nostalgico, mi considero fortunato per essere vissuto in un periodo straordinario e felice. Ma sarebbe insensato cercare in quel periodo qualcosa che anticipi o qualcosa che possa servire oggi, in una situazione completamente diversa quale è quella in cui ci troviamo, quarant’anni dopo. Tutto è diverso, tutto è cambiato. A servirci sono nuove idee, ed è un obiettivo sempre più difficile da raggiungere. Quegli anni ci offrono solo uno stimolo, o meglio un imperativo: che abbiamo bisogno di cambiare il mondo, e che questo è possibile, necessario, urgente”.
Quel giorno, dopo che abbiamo finito di mangiare, siamo andati nel suo studio per guardare i suoi lavori, i suoi libri. Diverse ore più tardi, mi ha accompagnato a piedi alla stazione. Ci siamo salutati al varco che possono superare solo i passeggeri muniti di biglietto. Ho continuato a voltarmi e Nanni era lì, fermo dove ci eravamo congedati. È rimasto finché il mio treno è arrivato e io sono salita. In qualche modo, in quel momento prolungato in cui lo osservavo fermo a guardarmi, sapevo che non lo avrei più rivisto e mi sono sentita molto triste, e insieme fortunata.
Nanni non ha mai risposto alla domanda per me più importante su Vogliamo tutto. Volevo saperne di più su Alfonso, la persona che ha ispirato quella voce. Ora, guardandomi indietro, non so bene perché lo considerassi così importante. Il punto, credo, è che non riuscivo a capire come Nanni avesse scritto un romanzo così perfetto, un’epopea che assume una voce che canta con tanta forza e comicità e rabbia, e tuttavia ci dà il senso di migliaia, di moltitudini di Alfonso. Chi era questo tizio, Alfonso, com’era davvero? In un certo senso, pensavo che leggere Vogliamo tutto significava immergersi nello spirito di quest’uomo speciale, il leggendario Alfonso. E più ne avessi saputo, più mi sarei calata in lui. Ma Nanni è stato molto cocciuto nel suo rifiuto di dirmi qualcosa su Alfonso. Ha detto: “Tu cerchi di costringermi a ridare ad Alfonso la sua individualità. Questo è l’opposto di quello che io volevo fare nel libro, dove lui non ha nome. Non posso farlo”. Pure, io mi stupisco all’idea che un imperativo artistico sia un imperativo assoluto. Per Nanni Balestrini, non c’è differenza e non c’è compromesso.
*CAMBIARE IL MONDO, TRASFORMARE LA VITA....
BRILLANTISSIMO testo e brillantissima "testimonianza" di Rachel Kushner. La scrittrice statunitense, nata nel 1968, mette coraggiosamente il dito su un’operazione artistica e politica tragica: fa emergere ora (2019) ciò che era già chiaro allora, qualche anno dopo la sua nascita, nel 1971, quando fu pubblicato "Vogliamo tutto".
"QUARANTA ANNI DOPO", sollecitato dalla scrittrice, Nanni Balestrini a quanto racconta ( “Più che nostalgico, mi considero fortunato per essere vissuto in un periodo straordinario e felice. Ma sarebbe insensato cercare in quel periodo qualcosa che anticipi o qualcosa che possa servire oggi, in una situazione completamente diversa quale è quella in cui ci troviamo, quarant’anni dopo. Tutto è diverso, tutto è cambiato. A servirci sono nuove idee, ed è un obiettivo sempre più difficile da raggiungere. Quegli anni ci offrono solo uno stimolo, o meglio un imperativo: che abbiamo bisogno di cambiare il mondo, e che questo è possibile, necessario, urgente”) e, contro il suo stesso "cocciuto" rifiuto a rispondere alla domanda su "Vogliamo tutto" ("Volevo saperne di più su Alfonso, la persona che ha ispirato quella voce"), alla fine, è "costretto" ad aggiungere e ad ammettere: “Tu cerchi di costringermi a ridare ad Alfonso la sua individualità. Questo è l’opposto di quello che io volevo fare nel libro, dove lui non ha nome. Non posso farlo”.
La risposta è chiara, ma Rachel Kushner resta "ipnotizzata" e finisce per condividere: "Pure, io mi stupisco all’idea che un imperativo artistico sia un imperativo assoluto. Per Nanni Balestrini, non c’è differenza e non c’è compromesso"!!! E se, invece di Alfonso, "la voce" fosse stata di Rachel?! Dov’è l’imperativo assoluto e l’imperativo artistico di Alfonso e di Rachel - e quello di Adamo ed Eva, e di Maria e Giuseppe?! Ma che "Dio" era quello di Balestrini?! E che "Dio" è quello di Kushner?! E’ un "desiderio di rivoluzione" questo o che?! Boh e bah?!
P. S. Ricordando di Nanni Balestrini, non posso non ricordare anche di Primo Moroni. Sul tema, mi sia lecito, cfr. "CHI" SIAMO NOI, IN REALTÀ. Relazioni chiasmatiche e civiltà. Lettera da ‘Johannesburg’ a Primo Moroni (in memoriam).
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! - L’ITALIAN TOUGHT, L’ITALIA SENZA "PAROLA E SENZA "LINGUA", E LA LEZIONE DI BRUNETTO LATINI, DANTE, E... SAUSSURE.28 giugno 2019, di Federico La Sala
ITALIA SENZA NAZIONE
di Antonio Montefusco (Le parole e le cose, 24 giugno 2019)
- [E’ appena uscito per Quodlibet Italia senza nazione. Lingue, culture, conflitti tra Medioevo ed età contemporanea, a cura di Antonio Montefusco. Ne presentiamo l’introduzione].
- “La storia ha di meglio da fare che essere la serva della filosofia e raccontare la nascita necessaria della verità e del valore; deve essere la conoscenza differenziale delle energie e dei cedimenti, delle sommità e dei crolli, dei veleni e degli antidoti. Deve essere la scienza dei rimedi” (Foucault 1977, pp. 29-54)
Il libro Italia senza nazione ha l’ambizione di indagare, seppure parzialmente, il «non filosofico» che, secondo la ricostruzione di Roberto Esposito, costituisce il proprium dell’indagine filosofica della tradizione italiana: una «propensione» che è sentita come «singolare», quindi costitutiva di tale tradizione. L’origine di questa pratica di estroflessione del pensiero italiano deriva da due elementi: la connessione tra vita, politica e storia, da una parte e l’esigenza insopprimibile di evocare un’origine in ogni discorso sull’attualità, dall’altra. (Esposito 2010) Si può dire, dunque, che essa abbia una naturale e specifica vocazione alla genealogia; e che in questa genealogia, nei suoi gangli più o meno pieni, più o meno mancanti, essa cerchi naturalmente i caratteri principali, non filosofici appunto, della sua estroflessione. [...] Mario Tronti ha icasticamente riassunto che l’Italian Thought si identifica con “un pensiero che si è radicato in questo Paese, in questa ‘forma-nazione’, ancor prima che diventasse una vera e propria nazione o uno Stato.” (Lisciani-Petrini - Strummiello 2017, p. 41) Questa specificità del pensiero italiano, del suo quadro, diciamo così, debolmente istituzionale, imprime già una direzione precisa alla nostra indagine, perché, a guardare allo specifico della storia italiana, è facile, a tutta prima, sottolineare come, in assenza di istituzioni politiche forti e consolidate, sia stato il discorso linguistico e letterario a costruire, immaginare, depositare elementi di identità ben prima che un processo, più culturale che politico-sociale come il Risorgimento (Banti 1991), portasse alla formazione di quella particolare comunità immaginata (Anderson 1991) che è stata chiamata “nazione italiana”. Se un libro-fondatore questa immaginata nazione può rivendicare, questo è un libro di letteratura: o meglio, di storia della letteratura. Ed è la Storia della letteratura italiana di Francesco De Sanctis (1996). Ne consegue, dunque, abbastanza chiaramente che sia il “letterario” a poter rivendicare un primato, un certo tipo di primato, se non come oggetto, certamente come spazio di esercizio della estroflessione dell’Italian Thought. Con delle avvertenze, tuttavia, e più d’una.
«Dante che dovea essere il principio di tutta una letteratura, ne fu la fine». Questa frase di De Sanctis rappresenta il carattere paradossale di un diagramma che si pretende ascendente - dalla fondazione di un canone linguistico-letterario con le “tre corone” alla creazione di uno stato - ma che è intimamente mosso da una decadenza e da un continuo chiaroscuro dovuta a scissioni molteplici. Gli storici della letteratura più acuti ne hanno assunto questo dato in senso letteralmente progressivo, e a ragione. Uno per tutti: Alberto Asor Rosa, che, introducendo l’impresa einaudiana della Letteratura italiana, affermava:
- “è vero: si tratta di una letteratura di scarsissima coscienza nazionale, che oscilla, combinandoli insieme con sapienza estrema, tra comunalismo e cosmopolitismo (come le rimproverava, infatti, il descanctisiano Gramsci). Ma, ove non si sia accecati dalla prospettiva della storia politico-ideologica della nazione italiana, non si può fare a meno di vedere che proprio questa misconoscenza del dato nazionale consente ai letterati italiani di questa lunga fase la brillantezza e la modernità dei risultati raggiunti. [...] La debolezza delle istituzioni politiche e le carenze del ceto politico-intellettuale stimolano nel letterato italiano una vocazione alla supplenza, che spesso però, come s’è detto, non esclude la persistenza nell’uso di codici estremamente sofisticati ed élitari. Si potrebbe dire che, paradossalmente, il letterato italiano pretende di fare il politico senza rinunziare ad essere retore.” (Asor Rosa 1982, p. 23, 27)
Per non dire di Carlo Dionisotti, che in un articolo d’avanguardia (del 1951!) mise in discussione, di quel diagramma, anche l’unico centro linguistico-culturale, e cioè la Toscana, proponendo prima un paradigma doppio, in cui il primato toscano risultava in conflitto con centri antagonisti (uno alla volta: Dionisotti 1967); optando pochi anni dopo (nel 1971) per un sistema ancora più complesso, che
- “in parte e fino a un certo segno è regionale, e in parte, al di sotto del Po e in tutta l’Italia centrale, serba ancora, semplificata, la vecchia struttura municipale, in parte, al sud, mantiene intatta la l’originaria struttura della monarchia feudale, passata di mano in mano dai Normanni agli Svevi, agli Angioini di Francia e finalmente agli Aragonesi di Spagna. Resta insomma un sistema, per la sua complessità e per la sua disparità, delicato e fragile nell’insieme e nelle singole parti, ma per ciò stesso un sistema aperto alla sperimentazione e collaborazione letteraria. Anche e in specie alla collaborazione letteraria. ” (Dionisotti 2009, p. 449)
I due nomi - Carlo Dionisotti e Alberto Asor Rosa - di due critici letterari valgano come particolarmente esemplari anche di una traiettoria critica e di un punto di vista originali: il primo formulato a distanza, dall’estero, perché Dionisotti lasciò l’Italia e sviluppò la sua carriera perlopiù a Londra; il secondo tipicamente operaista, quindi coscientemente estraneo all’eredità gramsciana (passata al vaglio della vulgata togliattiana) e storicista. Vale la pena di ricordare questi elementi di biografia intellettuale e politica perché ci servono anche a misurare l’innovazione che soprattutto Esposito ha dato alla direzione del dibattito. In Dionisotti e Asor Rosa il riconoscimento dell’eccezione italiana giunge nella fase matura di un percorso che tendeva a vedere quei caratteri come fortemente regressivi se comparati alle grandi tradizioni nazionali, soprattutto francese e inglese. Il caso di Scrittori e popolo di Asor Rosa, pubblicato poco più di 50 anni fa, è particolarmente significativo: la letteratura contemporanea italiana era travolta quasi interamente da un vizio d’origine, il “populismo”, la cui ombra si dilungava dai grandi risorgimentali a Gramsci. La provocazione verso un’intera generazione di intellettuali cresciuti all’ombra della “via italiana al socialismo” con il suo corollario gramsciano, più malinteso che reale, del nazional-popolare, era evidente. Esposito sposta evidentemente l’ago della bilancia del ragionamento, quando riassume:
- “diversamente da culture filosofiche fin dall’inizio segnate dal rapporto con un’istituzione politica già forte e consolidata, come l’Inghilterra di Hobbes, ma anche la Francia di Cartesio; diversamente anche da tradizioni di pensiero impegnate nella costruzione di un sapere dello Stato, come la Germania di Hegel, l’Italia pensa la politica nella sua dimensione prestatale e anche, a volte, di resistenza allo stato.” (Esposito 2010, p. 22)
In altri termini, l’Italian thought non contribuisce a definire o irrigidire una identità italiana. E questo non solo perché, come è stato ampiamento chiarito (Esposito 2016) esso non può risolversi in un tutto che neutralizza le differenze al suo interno; per non dire, che, se così fosse, saremmo di fronte a una dogmatica più che a una theory, che invece si deve caratterizzare per una programmatica deterritorializzazione. Il motivo principale sta nel fatto che questa tendenza all’estroflessione e al “fuori” non possono che disfare un discorso di identità (italiana o altra che sia). L’Italian Thought, come theory in lingua italiana, si ritaglia uno spazio differente sia dalla brandizzazione dell’italianità (con il Made in Italy) sia dal ripiegamento identitario: entrambi processi risultanti, evidentemente, dalla globalizzazione, alla quale il pensiero italiano si presenta costitutivamente alternativo.
 Ne risulta un sistema simbolico in tensione, in cui confliggono in maniera eclatante l’auto-percezione negativa che deriva dall’immagine del paese «mancato», maggioritario nel discorso più o meno pubblico nonché nella storiografia letteraria, e una costruzione positiva, al limite dell’apologetico, diffusa fuori dei confini nazionali. Di tale contrasto paradossale è “figura” - in senso biblico - il personaggio del «cervello in fuga», dell’intellettuale esiliato ed apolide che trova fuori d’Italia lo spazio per sviluppare il proprio talento, illuminando a ritroso il capitale culturale di partenza, che risulta impossibile da contenere nello spazio del paese, essenzialmente in ragione delle conseguenze di quello «sviluppo senza progresso» mostrato da Pasolini all’alba di quello che, un tempo, si era chiamato «neocapitalismo». [...]
Ne risulta un sistema simbolico in tensione, in cui confliggono in maniera eclatante l’auto-percezione negativa che deriva dall’immagine del paese «mancato», maggioritario nel discorso più o meno pubblico nonché nella storiografia letteraria, e una costruzione positiva, al limite dell’apologetico, diffusa fuori dei confini nazionali. Di tale contrasto paradossale è “figura” - in senso biblico - il personaggio del «cervello in fuga», dell’intellettuale esiliato ed apolide che trova fuori d’Italia lo spazio per sviluppare il proprio talento, illuminando a ritroso il capitale culturale di partenza, che risulta impossibile da contenere nello spazio del paese, essenzialmente in ragione delle conseguenze di quello «sviluppo senza progresso» mostrato da Pasolini all’alba di quello che, un tempo, si era chiamato «neocapitalismo». [...]Nel suo andirivieni, tra ricezione fuori d’Italia e sua rielaborazione all’interno dei confini nazionali, l’Italian Thought supera questa dicotomia, assume l’oscillazione continua di questo sistema simbolico tra origine e storia, mettendo continuamente in discussione il presente e assumendo un’ottica di contestazione; Daniele Balicco ha recentemente trascinato questa oscillazione sul lato più scivoloso, se si vuole, ragionando sul Made in Italy con spregiudicatezza, sottraendolo all’univocità della già ricordata brandizzazione neoliberale e infine mostrandone la potenziale narrazione contro-egemonica che si sottrae alla performatività con la godibilità (Balicco 2016). [...]
 Nel libro, si è interrogato questo sistema simbolico in tensione rinunciando programmaticamente a dare centralità agli autori “maggiori”, non solo perché essi (in special modo Dante e Leopardi) sono stati già scandagliati in questo senso; si è voluto, piuttosto, verificare e dare spessore a linee convergenti di contestazione che sono la cifra caratteristica sia del momento genetico della tradizione letteraria, nell’età di Dante, sia della sua vicenda specificamente moderna e contemporanea. In tutte queste indagini, emerge il nodo che evocavo all’inizio: quella predisposizione alla genealogia che, nell’Italian Thought, si intreccia in maniera fortissima con quella persistenza del mito nella storia, dell’arcaicità che destruttura l’attualità; questa genealogia qui finalmente si allarga: Machiavelli, che è quasi un problematico “fondatore”, non solo qui è assente, ma la genealogia si confonde forzosamente con la ricerca di un’origine, o meglio di una genesi.
Nel libro, si è interrogato questo sistema simbolico in tensione rinunciando programmaticamente a dare centralità agli autori “maggiori”, non solo perché essi (in special modo Dante e Leopardi) sono stati già scandagliati in questo senso; si è voluto, piuttosto, verificare e dare spessore a linee convergenti di contestazione che sono la cifra caratteristica sia del momento genetico della tradizione letteraria, nell’età di Dante, sia della sua vicenda specificamente moderna e contemporanea. In tutte queste indagini, emerge il nodo che evocavo all’inizio: quella predisposizione alla genealogia che, nell’Italian Thought, si intreccia in maniera fortissima con quella persistenza del mito nella storia, dell’arcaicità che destruttura l’attualità; questa genealogia qui finalmente si allarga: Machiavelli, che è quasi un problematico “fondatore”, non solo qui è assente, ma la genealogia si confonde forzosamente con la ricerca di un’origine, o meglio di una genesi.Ci porta a questo la scelta di un fuori letterario, che esige soprattutto il definirsi di uno spazio linguistico autonomo, che i filologi chiamano “volgare”, che sarà l’italiano. In questo senso, sullo sfondo del volume, resta sottinteso, ma fortemente presente, il nesso con la tormentata “questione della lingua”, sempre legata, per richiamare di nuovo Gramsci, alla “formazione e l’allargamento della classe dirigente, la necessità di stabilire rapporti più intimi e sicuri tra i gruppi dirigenti e la massa popolare-nazionale, cioè di riorganizzare l’egemonia culturale” (Gramsci 1975, 2346). Si tratta di un paesaggio esso stesso tipicamente in tensione, di tipo spiccatamente italianistico e che dà conto dello svolgersi delle peculiarità dell’Italian Thought: dallo sforzo di teorizzazione di Dante alla discussione sulla lingua cortigiana in Machiavelli, l’ossessione dello scrittore è meno l’italiano e più chi lo possa misurare, permettere, sviluppare. Più del linguistico, conta il politico. Non sorprenderà, dunque, che lo stesso concetto di italiano in senso moderno si trovi usato, per la prima volta, da Brunetto Latini (nella generazione precedente a Dante) in francese, in particolare per intendere la politica “selonc les usages as Ytaliens” (“secondo gli usi degli italiani”.) Siamo negli anni ’60 del ‘200: a significare anche che, se spazio per l’Italian Thought ci può essere, esso debba essere concepito anzitutto in maniera linguistica all’italiana, cioè in senso ospitale e plurilingue (Montefusco 2016).
Riferimenti bibliografici
Anderson, Benedict
1991, Comunità immaginate. Origine e diffusione dei nazionalismi, Roma-Bari, Laterza.
Asor Rosa, Alberto
1982, Letteratura italiana, I. Il letterato e le istituzioni, Torino, Einaudi.
2015 Scrittori e popolo 1965. Scrittori e massa 2015, Torino, Einaudi.
Balicco, Daniele
2016 Made in Italy e cultura. Indagine sull’identità italiana contemporanea, Palumbo, Palermo.
Banti, Aldo Maria
2011 Nel nome dell’Italia, Rome-Bari, Laterza.
De Sanctis, Francesco
1996 Storia della letteratura italiana, a cura di N. Gallo, intr. di G. Ficara, Torino, Einaudi-Gallimard.
Dionisotti, Carlo
1967 Geografia e storia della letteratura italiana, Torino, Einaudi.
2009, Scritti di storia della letteratura italiana. II 1963-1971, éd. par T. Basile, V. Fera, S. Villari, Rome, Edizioni di Storia e Letteratura.
Esposito, Roberto
2010 Pensiero vivente. Origine e attualità della filosofia italiana, Einaudi, Torino.
2016 Da fuori. Una filosofia per l’Europa, Torino, Einaudi.
Foucault, Michel
1977 Microfisica del potere, Einaudi, Torino.
Gentili, Dario
2012 Italian Theory. Dall’operaismo alla biopolitica, il Mulino, Bologna.
Gentili, Dario - Stimilli, Elettra (a cura di)
2015 Differenze italiane, Roma, DeriveApprodi.
Gramsci, Antonio
1975, Quaderni dal carcere, Torino, Einaudi
Montefusco, Antonio
2016 Dal plurilinguismo all’ospitalità. Appunti sull’italiano (neo-epico e no), in “Nuova Rivista Letteraria”, vol. 4, pp. 43-49.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
SPIRITO CRITICO E TEOLOGIA POLITICA DEL "MENTITORE". PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO, CHE GIA’ DANTE SOLLECITAVA ...
 IL "DUE" DI SAUSSURE VINCE IL "DUE" DI ROBERTO ESPOSITO.
IL "DUE" DI SAUSSURE VINCE IL "DUE" DI ROBERTO ESPOSITO.Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- Concorsi truccati, sospeso il rettore dell’Università di Catania. Coinvolti 40 docenti degli atenei di Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Chieti-Pescara, Firenze, Messina, Milano, Napoli, Padova, Roma, Trieste, Venezia e Verona28 giugno 2019, di Federico La Sala
Concorsi truccati, sospeso il rettore dell’Università di Catania
Indagine della procura: coinvolti 40 docenti degli atenei di Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Chieti-Pescara, Firenze, Messina, Milano, Napoli, Padova, Roma, Trieste, Venezia e Verona
di Fabio Albanese (La Stampa, 28/06/2019)
catania
Il rettore dell’Università di Catania, ma anche il pro rettore, l’ex rettore e i capi dipartimento di matematica, economia, scienze biomediche, scienze biologiche, giurisprudenza, l’ex capo dipartimento di scienze politiche, il presidente del coordinamento della facoltà di medicina. Tutti sospesi dalle funzioni perché indagati per associazione per delinquere e, a vario titolo, per corruzione, induzione a dare e promettere utilità, falsità ideologica e materiale, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, abuso d’ufficio e truffa aggravata. Per il rettore, l’ex rettore e altri indagati, la procura aveva pure chiesto l’arresto ma il gip ha deciso solo per la sospensione dall’attività.
È una specie di terremoto quello che la procura di Catania e la Digos hanno scatenato stamattina con l’inchiesta “Università bandita”, secondo la quale i concorsi dell’ateneo per posti di docente, di associato e perfino di ricercatore erano truccati. Ventisette sono i concorsi finiti sotto la lente degli investigatori: 17 riguardano posti di professore ordinario, quattro di associato e sei di ricercatore. Ma lo scandalo promette di avere proporzioni ben maggiori di quelle che hanno portato ai provvedimenti di oggi: i dieci docenti di Catania sospesi ma anche altri quaranta di università di tutta Italia, indagati e attualmente sotto perquisizione appartenenti agli atenei di Bologna, Cagliari, Catanzaro, Chieti-Pescara, Firenze, Messina, Milano, Napoli, Padova, Roma, Trieste, Venezia, Verona.
L’indagine di Catania, cominciata a giugno del 2016 e conclusa a marzo dello scorso anno, travolge i vertici dell’ateneo. Sospesi dalle funzioni il rettore Francesco Basile, 64 anni, il pro rettore Giancarlo Magnano San Lio, 56, l’ex rettore Giacomo Pignataro, 56, e altri sette docenti, i vertici dei dipartimenti. Per i pm, l’associazione per delinquere aveva a capo l’attuale rettore Basile ma il promotore sarebbe stato suo predecessore, Pignataro e si muoveva sulla base di un vero e proprio «codice di comportamento sommerso», come lo definisce la procura, al quale tutti dovevano uniformarsi. Il gruppo decideva il conferimento di assegni e borse di studio, i dottorati di ricerca, l’assunzione del personale tecnico-amministrativo, la composizione degli organi statutari (consiglio di amministrazione, nucleo di valutazione, collegio di disciplina), l’assunzione e la progressione in carriera dei docenti universitari.
È proprio su questo ultimo aspetto che l’inchiesta si è allargata alle altre università italiane perché, spiega la procura, «i docenti, nel momento in cui sono stati selezionati per fare parte delle commissioni esaminatrici, si sono sempre preoccupati di non interferire sulla scelta del futuro vincitore compiuta preventivamente, favorendo il candidato interno che risultava prevalere anche nei casi in cui non fosse meritevole». Un sistema, dunque, che riporta alle baronie universitarie e che non lascia spazio alla meritocrazia. Chi non si adeguava, spiegano i pm di Catania, subiva ritardi nella carriera e curriculum non valutati.
«L’indagine ha consentito di svelare un sistema di nefandezze che purtroppo macchia in maniera veramente pesante il nostro Ateneo perché coinvolge tutti i personaggi di maggiore responsabilità al suo interno - ha detto il procuratore della Repubblica a Catania, Carmelo Zuccaro -. Abbiamo accertato che questo sistema ha inquinato il sistema di votazione all’interno dell’Ateneo per la nomina del rettore e per la nomina degli organi più importanti. A cascata questo sistema si é perpetuato per condizionare numerosi concorsi di tutti i dipartimenti. Un sistema che non esito a definire squallido perché le persone che vengono proposte non sono le più meritevoli per aggiudicarsi il titolo. Quando qualcuno ha il coraggio di proporsi come candidato per questo posto nonostante il capo del dipartimento abbia deciso che non sia venuto il suo momento, queste persone vengono fatte oggetto di critiche pesanti, addirittura di ritorsioni da parte del capo del dipartimento».
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- IL DESIDERIO POLITICO, IL "CORPO MISTICO", E LA COSTITUZIONE. Che cos’è il populismo? L’inganno della parte che vuole essere il tutto (Yves Mény)23 giugno 2019, di Federico La Sala
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PERDERE LA COSCIENZA DELLA LINGUA ("LOGOS") COSTITUZIONALE ED EVANGELICA GENERA MOSTRI ATEI E DEVOTI ... *
Politica.
Che cos’è il populismo? L’inganno della parte che vuole essere il tutto
Il politologo Yves Mény: le democrazie rappresentative si fondano sul popolo ma lo relegano a osservatore. Ma non c’è reale alternativa: un vero potere popolare finirebbe nelle mani dell’uomo forte
di Yves Mény (Avvenire, giovedì 20 giugno 2019)
- [Foto] Parigi durante la manifestazione del novembre 2018 organizzata dai “Gilet gialli” per protestare contro le tasse introdotte dal Presidente francese Emmanuel Macron (Ansa/Ap/Michel Euler)
- Anticipiamo la lectio magistralis che Yves Mény, docente di Scienze politiche, terrà domani al Festival TaoBuk di Taormina. Meny è stato presidente del cda della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, attualmente insegna nell’Università Luiss-Guido Carli di Roma.
Le democrazie sono al centro del desiderio politico. O almeno lo sono state per molto tempo e si sono identificate con la libertà, l’autonomia, l’auto-governo, con la vittoria della maggioranza e del numero sul singolo sovrano. La democrazia è, potremmo dire in sintesi, il desiderio della multitudine di sostituirsi al re, al dittatore o a un gruppo ristretto ma dominante, alle élites, alla casta, all’establishment. Ma la folla, le masse, l’aggregazione dei singoli, si trova di fronte ad un impasse, che nel mio recente libro pubblicato dal Mulino, Popolo ma non troppo ho denominato “malinteso democratico”.
Come unire infatti tutti questi atomi, attraversati da aspirazioni, interessi, emozioni cosi diversi da impedire loro di fatto di unirsi? Nel corso della storia molti sono stati i tentativi: ridurre, ad esempio, la dimensione territoriale della città per rendere possibile la conoscenza e l’unione di tutti. È il sogno greco, rivisto da Rousseau; ma non possiamo scordare la deriva delle colonie greche di Sicilia dove il despota finisce per incarnare il demos.
Una variante diversa è offrire una visione alternativa del popolo. È il realismo senza pietà di Hobbes dove il sovrano, sulla copertina del suo libro, è rappresentato da mille corpi di cittadini assorbiti, ingoiati e capovolti per dar corpo all’unità. C’è poi il sogno-incubo della rivoluzione russa di dare il potere a una classe unica al prezzo di eliminare qualche privilegiato; e c’è il realismo all’inglese che “inventa” il principio rappresentativo per incanalare le aspirazioni di molti nella fattibilità pratica del governo di pochi; e c’è la non meno realistica e fredda osservazione di Gaetano Mosca sull’ineluttabilità delle élites, la doccia fredda sul desiderio.
"Unirsi in un popolo" è il desiderio che continuamente si ripresenta di trasformare la diversità in una unità metafisica. «L’Italia è fatta, bisogna fare gli italiani» constatava Massimo d’Azeglio; Eugen Weber descrive la trasformazione dei francesi di fine Ottocento «da contadini a cittadini»; Benedict Anderson evoca la nazione come «comunità sognata». Per farla breve, il “popolo” non smette di desiderare di diventare anche una realtà sociale e non soltanto un’utopia magica.
Purtroppo la contraddizione interna è sempre in agguato: il popolo come concetto è indispensabile per legittimare l’accesso al potere. Anche le dittature pretendono di governare in nome e per il bene del popolo. E questo popolo che le democrazie hanno posto sul piedestallo per poi relegarlo nel ruolo di osservatore degli atti dei governanti si rivolta sempre di più per far avverare l’utopia di Lincoln «Government of the people, by the people, for the people».
In altre parole, il popolo americano, ma anche tutti gli altri, fanno proprie le tre prime parole della costituzione americana «We the People...», che è una splendida frase per parlare di legittimazione, ma è una pia illusione quando si tratta di governare.
 Si potrebbe ricordare la reazione di un francese chiamato ad approvare la costituzione scritta da Napoleone: «Che c’è nella costituzione?» E la risposta fu «Bonaparte»...
Si potrebbe ricordare la reazione di un francese chiamato ad approvare la costituzione scritta da Napoleone: «Che c’è nella costituzione?» E la risposta fu «Bonaparte»...Non c’è alternativa alla necessità della rappresentanza: non vi è mai stato un “vero” potere popolare e se ci fosse si correrebbe il rischio di radunarsi di fatto sotto le ali di un uomo forte, di un salvatore. Dio ci salvi da questa fatalità! Il desiderio di sentirsi uniti in un popolo non è soltanto forte, inganna, inebria.
 Qualunque gruppo può pretendere di essere il popolo anche quando si tratta di una parte di popolo molto ridotta, come quella che vota sulla piattaforma Rousseau o quando i Gilets jaunes che da sei mesi pretendono di essere il «popolo» prendono più o meno 1,5% dei voti alle elezioni europee. La parte pretende cioè di essere il tutto.
Qualunque gruppo può pretendere di essere il popolo anche quando si tratta di una parte di popolo molto ridotta, come quella che vota sulla piattaforma Rousseau o quando i Gilets jaunes che da sei mesi pretendono di essere il «popolo» prendono più o meno 1,5% dei voti alle elezioni europee. La parte pretende cioè di essere il tutto.Ovviamente ci sono anche buone ragioni per portare avanti le proprie rivendicazioni perché il sistema rappresentativo è sempre (al meglio) il governo della maggioranza o, più spesso, appoggia su una minoranza sociologica trasformata in maggioranza politica grazie ai miracoli dei sistemi elettorali. La situazione non sembra particolarmente felice.
 Ma bisogna essere lucidi: l’unanimità, che sulla carta sembra il sistema più rispettoso della volontà del popolo è un sistema “blocca-tutto” ed esiste soltanto nelle piccole tribù primitive, benché sia attivo anche là dove la ricerca del consenso si trasforma in molteplici veti incrociati: l’Italia ne sa qualche cosa...
Ma bisogna essere lucidi: l’unanimità, che sulla carta sembra il sistema più rispettoso della volontà del popolo è un sistema “blocca-tutto” ed esiste soltanto nelle piccole tribù primitive, benché sia attivo anche là dove la ricerca del consenso si trasforma in molteplici veti incrociati: l’Italia ne sa qualche cosa...Ricordiamoci che l’unanimismo sfocia nella dittatura e soprattutto nella dittatura delle menti. Il populismo, «l’ideologia del popolo» rischia quindi di essere una grande illusione e un inganno. Riconosciamogli però un merito: rimescola le carte e spesso pone fine a quello che il poeta Paul Eluard chiamava «il duro desiderio di durare».
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
VIVA L’ITALIA!!! LA QUESTIONE "CATTOLICA" E LO SPIRITO DEI NOSTRI PADRI E E DELLE NOSTRE MADRI COSTITUENTI. Per un ri-orientamento antropologico e teologico-politico.
- L’ILLUMINISMO, OGGI. LIBERARE IL CIELO. Cristianesimo, democrazia e necessità di "una seconda rivoluzione copernicana"
MESSAGGIO EVANGELICO E SANTO PADRE?! ABUSO DEL TITOLO E MENZOGNA. L’ERRORE DI RATZINGER (E DI TUTTI I PAPI).
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- L’UNIVERSITA’, LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA, E E COSTITUZIONE DOGMATICA DELL’IMPERO (SU CUI NON TRAMONTA MAI IL SOLE)!21 giugno 2019, di Federico La Sala
IL PRIMOGENITO TRA MOLTI FRATELLI E LA COSTITUZIONE DOGMATICA DELL’IMPERO SU CUI NON TRAMONTA MAI IL SOLE...*
1. La gioia della verità (Veritatis gaudium) esprime il desiderio struggente che rende inquieto il cuore di ogni uomo fin quando non incontra, non abita e non condivide con tutti la Luce di Dio[1]. La verità, infatti, non è un’idea astratta, ma è Gesù, il Verbo di Dio in cui è la Vita che è la Luce degli uomini (cfr. Gv 1,4), il Figlio di Dio che è insieme il Figlio dell’uomo. Egli soltanto, «rivelando il mistero del Padre e del suo amore, rivela l’uomo all’uomo e gli fa nota la sua altissima vocazione»[2].
Nell’incontro con Lui, il Vivente (cfr Ap 1,18) e il Primogenito tra molti fratelli (cfr Rm 8,29), il cuore dell’uomo sperimenta già sin d’ora, nel chiaroscuro della storia, la luce e la festa senza più tramonto dell’unione con Dio e dell’unità coi fratelli e le sorelle nella casa comune del creato di cui godrà senza fine nella piena comunione con Dio. Nella preghiera di Gesù al Padre: «perché tutti siano uno, come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi» (Gv 17,21) è racchiuso il segreto della gioia che Gesù ci vuole comunicare in pienezza (cfr 15,11) da parte del Padre col dono dello Spirito Santo: Spirito di verità e di amore, di libertà, di giustizia e di unità. [:::] "(Costituzione Apostolica «Veritatis gaudium» di Papa Francesco circa le Università e le Facoltà ecclesiastiche, 29.01.2018. Proemio)
*
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- Costituzione dogmatica della chiesa "cattolica"... e costituzione dell’Impero del Sol Levante. Un nota sul “disagio della civiltà”
L’EREDE: IL PESO DEI PADRI (ATEI E DEVOTI). UN’EREDITA’ ANCORA PENSATA ALL’OMBRA DELL’"UOMO SUPREMO" E DEL "MAGGIORASCATO".
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- L’ ITALIA, LE “ROBINSON-NATE”, E LA “POESIA” DEL PRESENTE.20 giugno 2019, di Federico La Sala
L’ ITALIA, LE “ROBINSON-NATE”, E LA “POESIA” DEL PRESENTE ... *
- “Oggi assistiamo a una sorta di crisi di intelligibilità, che in diverse diagnosi sembra avere a che fare con la fine di un mondo e delle sue pratiche, di una forma di vita leggibile: fine della società letteraria, fine della politica nella sua concezione novecentesca... (...) Che cosa sarebbe della poesia, e anche del suo rapporto critico con la società, se questo nostro tempo, come spesso diagnosticato, costituisse davvero l’epoca della sua fine, della fine del modo in cui ne abbiamo inteso il senso sino a ora? ” (Italo Testa, “Autorizzare la speranza. Poesia e futuro radicale” , "Le parole e le cose", 21 marzo 2019).
“OGGETTO: Per la nostra sana e robusta Costituzione.... ” (Mail, 2002): “[...] Tempo fa una ragazza, a cui da poco era morta la madre e altrettanto da poco cominciava ad affermarsi il partito denominato “Forza Italia”, discutendo con le sue amiche e i suoi amici, disse: “Prima potevo gridare “forza Italia” e ne ero felice. Ora non più, e non solo perché è morta mia madre e sono spesso triste. Non posso gridarlo più, perché quando sto per farlo la gola mi si stringe - la mia coscienza subito la blocca e ricaccia indietro tutto. Sono stata derubata: il mio grido per tutti gli italiani e per tutte le italiane è diventato il grido per un solo uomo e per un solo partito. No, non è possibile, non può essere. E’ una tragedia!”. Un signore poco distante, che aveva ascoltato le parole della ragazza, si fece più vicino al gruppo e disse alla ragazza: “Eh, sì, purtroppo siamo alla fine, hanno rubato l’anima, il nome della Nazionale e della Patria. E noi, cittadini e cittadine, abbiamo lasciato fare: non solo un vilipendio, ma un furto - il furto dell’anima di tutti e di tutte. Nessuno ha parlato, nessuno. Nemmeno la Magistratura!” (Si cfr. RESTITUITEMI IL MIO URLO! ... DALLA CINA UNA GRANDE LEZIONE!).
ITALIA, 2 GIUGNO 2019. A pag. 2 dell’inserto “ROBINSON” (n. 130) di “la Repubblica” del 1° Giugno 2019, in un testo con il titolo “Mia madre, il Re e la cosa di tutti “, e il sottotitolo “Il 2 giugno 1946 l’Italia scelse di non essere più una monarchia. Lessico familiare del Paese che puntò su se stesso”. L’autore - dopo aver premesso che “una persona sola che incarna lo Stato e incarna il popolo intero non può che essere, essere, simbolicamente, una persona «sacra»“, e chiarito che “è per definizione, per ruolo un signore al di sopra delle parti, non rappresenta una frazione, rappresenta l’intero. L’unità. La comunità. (...) la sua carica è elettiva. Non è un raggio divino, e nemmeno il raggio della Storia attraverso l’espediente dinastico, a fargli incarnare «la cosa di tutti»” (...) La repubblica è anti-assolutista anche in questo suo sapiente scegliere gli uomini che la incarnano a seconda dei sommovimenti della politica e della società (...) così si avvia alla conclusione: “Dunque si è repubblicani - o almeno lo sono io - se si ama e si accetta ciò che non è assoluto, NON SIMULA L’ETERNO, ACCETTA IL LIMITE, lo traduce in politica”.
E, INFINE, l’autore così CHIUDE: “Mi rimane da dire che quando Eugenio Scalfari fondò un giornale che si chiamava «la Repubblica» andavo all’università e subito pensai: che bel nome! Che nome giusto per un giornale! Ma come è possibile che a nessuno prima di lui, sia venuto in mente di chiamare così un pezzo di carta che si occupa soprattutto della «res publica», della cosa di tutti, e lo fa tutti i giorni? E’ al tempo stesso un nome umile e alto. Peggio per chi non se ne è accorto prima” (Michele Serra).
POESIA, COSTITUZIONE, E FUTURO RADICALE...: “Come certi capi indiani che si trovarono di fronte al fatto che, una volta entrati nelle riserve, non risultasse più comprensibile cosa fosse un atto coraggioso, quale attività potesse esemplificarlo, visto che le pratiche che sino ad allora avevano dato senso a tali attività erano venute meno - i bisonti scomparsi, le guerre con altre tribù proibite” (Italo Testa - sopra).
ITALIA: “ESAME DI MATURITA’ 2019”. - PER UN CONVEGNO E UNA RIFLESSIONE SUL CONCETTO DI UNITÀ E DI SOVRANITÀ (SOVRA-UNITÀ). Materiali sul tema .
Federico La Sala (20 giugno 2019)
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- "MARGINI" DELLA COSTITUZIONE E DELLA FILOSOFIA. IN MEMORIA DI KANT E DI JACQUES DERRIDA.13 giugno 2019, di Federico La Sala
MARGINI della filosofia. Intervento libero. In memoria di Jacques Derrida...
Siccome orientarsi nell’infinito è un problema meta-fisico e costituzionale, e - dopo Kant e la sua "rivoluzione copernicana" - non sappiamo ancora distinguere "dewey"anamente tra "prima di Cristo" e "dopo Cristo", tra Tolomeo e Copernico, tra il tutto e la parte, tra antropologia e andrologia - e ginecologia, tra Italia e "Italia", tra Costituzione e Partito, tra forza Italia e "Forza Italia", mi è sembrato opportuno fornire un piccolo banale (comune!) elemento per uscire dal sonnambulismo e dalla confusione! Siamo o non siamo "Dopo Dewey" !? O no?!
P. S. - SUL TEMA, MI SIA CONSENTITO, SI CFR.:
FILOSOFIA. IL PENSIERO DELLA COSTITUZIONE E LA COSTITUZIONE DEL PENSIERO
 MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?!
MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?!Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- UN Manifesto per la Filosofia. Perché la filosofia? (di Marco Ferrari e Gian Paolo Terravecchia12 giugno 2019, di Federico La Sala
MANIFESTO per la FILOSOFIA
 Perché la filosofia?
Perché la filosofia? Perché apre la mente dell’uomo al pensiero libero
Perché apre la mente dell’uomo al pensiero libero
 Perché insegna a porre le domande giuste e a non dare risposte affrettate
Perché insegna a porre le domande giuste e a non dare risposte affrettate
 Perché costringe a dare ragione di ciò che si pensa e di ciò che si dice
Perché costringe a dare ragione di ciò che si pensa e di ciò che si dice
 Perché muove a cercare il senso di tutte le cose in rapporto al tutto che le circonda
Perché muove a cercare il senso di tutte le cose in rapporto al tutto che le circonda
 Perché forma uomini capaci di esercitare la critica
Perché forma uomini capaci di esercitare la critica
 Perché ci ricorda che la scienza e la tecnologia sono per il bene dell’uomo
Perché ci ricorda che la scienza e la tecnologia sono per il bene dell’uomo
 Perché chiede cosa sia la giustizia, il bene, la felicità
Perché chiede cosa sia la giustizia, il bene, la felicità
 Perché dà dignità alla politica non riducendola a tecnica del consenso
Perché dà dignità alla politica non riducendola a tecnica del consenso
 Perché insegna ad argomentare
Perché insegna ad argomentare
 Perché ci chiede sempre cosa pensiamo di sapere
Perché ci chiede sempre cosa pensiamo di sapere
 Perché ci chiede sempre come facciamo a sapere ciò che sappiamo
Perché ci chiede sempre come facciamo a sapere ciò che sappiamo1 Cos’è la filosofia?
 L’amore per il sapere all’origine di tutti i saperi umani.
L’amore per il sapere all’origine di tutti i saperi umani. 2 Quanto ha contato fino a ora nell’organizzazione educativa e scolastica italiana?
2 Quanto ha contato fino a ora nell’organizzazione educativa e scolastica italiana?
 In passato ha svolto un ruolo fondamentale nei curricula liceali e universitari. Attualmente, nel mondo scolastico, sta subendo un processo di marginalizzazione.
In passato ha svolto un ruolo fondamentale nei curricula liceali e universitari. Attualmente, nel mondo scolastico, sta subendo un processo di marginalizzazione.3 Cosa chiede?
 Di avere il posto centrale che merita.
Di avere il posto centrale che merita. -
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- DOVE LA NOSTRA IDENTITA’?! DOVE L’ITALIA? Forse è meglio ricominciare da "Capo", dall’inizio!10 giugno 2019, di Federico La Sala
PER LA CRITICA DELL’ECONOMIA POLITICA (E DELLA FACOLTÀ DI GIUDIZIO DELL’ "UOMO SUPREMO"): INDIVIDUO E SOCIETA’ E COSTITUZIONE, IERI COME OGGI...
LE PAROLE, LE COSE, E LE PERSONE: "Identità. Poche settimane fa l’europarlamentare Eleonora Forenza (area di Rifondazione di Potere al Popolo) ha scatenato una piccola bagarre nel minuscolo stagno della sinistra italiana. Forenza ha bollato, su Twitter, la Brexit come “pasticcio di maschi”, non negando una certa solidarietà ‘femminista’ a Theresa May e alla gatta da pelare che i colleghi “maschi” le avrebbero rifilato. L’uscita infelice di Forenza non è cosa nuova (ma preoccupa che venga da una gramsciana). È parte integrante di un certo orientamento della sinistra diritto-civilista e culturalista, cioè di quella sinistra che, pur non escludendo le questioni legate al mondo del lavoro e della produzione, individua ormai nei diritti civili la principale chiave d’intervento sociale e, proprio a causa di tale scelta, si ritrova fatalmente irretita all’interno di un uso distorto del concetto di “identità”. Tale posizionamento (largamente maggioritario anche nel Partito Democratico) è stato spesso già portato a critica". Così inizia la riflessione di Mimmo Cangiano su “Intersezionalità, identità e comunità: a che punto siamo a sinistra” ("Le parole e le cose", 10 giugno 2019).
CONSIDERATO CHE ORA COME ORA proprio perché, come scrive l’autore,
- "Stiamo ora guardando in faccia, ed è sicuramente un progresso, il nostro capitalismo. Senza identità e senza comunità siamo al centro delle sue disconnessioni, ostili l’uno all’altro, alienati l’uno dall’altro. Senza valori comuni, collettivi, sovrapersonali, l’identità viene a coincidere con noi stessi, urla a gran voce la propria libertà, il proprio diritto a essere ciò che si vuole, mutevoli e fluidi quanto ci aggrada, libertà di godimento e desideri, finché la conformazione sociale in cui siamo comunque inseriti non torna a battere alla porta ricordandoci che i desideri hanno il volto sofferente dei bisogni, e il nostro godere (cioè il nostro far valere la nostra identità, anche quando fluida) non vive separato dalle regole sociali" (Mimmo Cangiano, “Intersezionalità, identità e comunità: a che punto siamo a sinistra”, cit.),
nel condividere e nell’accogliere l’invito gramsciano citato in esergo (“quando tutto sembra perduto bisogna / mettersi tranquillamente all’opera / ricominciando dall’inizio”) e, INSIEME, nel RICORDARE che FORENZA è VICINO ACERENZA, in BASILICATA (là dove fu confinato l’Autore di "Cristo si è fermato ad Eboli"),
sul problema di lunga durata del nostro presente storico, IO CONSIGLIEREI DI RIPRENDERE IL DISCORSO proprio da "CAPO", da GRAMSCI.
FORSE è TEMPO di interrogarci un po’ più radicalmente! La sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico è già "vecchia" ed uscire da uno "stato di minorità" in cui versiamo da millenni, intrappolati come siamo in una logica adamitica ("Adamo ed Eva"!) di un cieco, cainico, teologico-dialettico, edipico, molochiano, capitalistico "familismo amorale" non è un gioco da "ragazzi"!
Bisogna aprire gli occhi (non "chiudere un occhio"!) su "«chi» siamo noi in realtà e, nello stesso tempo, saper sognare il sogno di una cosa. Forse non è (ancora!) possibile?! Boh e bah...
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- L’”ECCE HOMO” (E LA “CORONA DI SPINE”)! DAL PEDUNCOLO ALL’OMUNCOLO: UNA “VIA” PER USCIRE DALLA CAVERNA.27 febbraio 2020, di Federico La Sala
L’”ECCE HOMO” (E LA “CORONA DI SPINE”)! Non c’è solo Ponzio Pilato, c’è anche Leonzio Pilato. Non dimentichiamolo... *
DAL PEDUNCOLO ALL’OMUNCOLO: UNA “VIA” PER USCIRE DALLA CAVERNA. Sulla parola “omuncolo”, forse, è utile (cfr. A. Polito, "Dialetti salentini: piticinu", Fondazione Terra d’Otranto) rifletterci un momento: a mio parere, tale parola sollecita a portare alla luce la implicita differenza che veicola in sé. Sorprendentemente, se da una parte dice di un giudizio sul comportamento di una persona di sesso maschile che dovrebbe essere “vir-ile” ma che tale non è, dall’altra, per la sua provenienza etimologica “da una base homo, genitivo hominis, che significa uomo”, veicola e produce una generalizzazione indebita che porta a nascondere la presenza dell’altra metà (il sesso femminile) del “genere umano”.
Come per il greco, la parola “antropologia” vale per ogni persona del “genere umano” (e, per il maschio e per la femmina, abbiamo, rispettivamente, l’andrologia e la ginecologia), così per il latino, la parola “umanità” (da “homo”) vale altrettanto per ogni persona del “genere umano”(e, in italiano, per l’homo-maschio, parliamo di “virile” e, per la homo-femmina, parliamo di “muliebre”).
“ECCE HOMO”. Quando Ponzio Pilato pronunciò la frase «Ecco l’uomo», mostrando alla folla Gesù flagellato cosa disse?! Parlò sì di un “uomo”, ma parlò dell’intero “genere umano”! O NO?! A CHE GIOCO GIOCHIAMO?! A METTERE ANCORA IN TESTA AL “GENERE UMANO” UNA BELLA “CORONA” DI SPINE?!
*
Sul tema, mi sia consentito, si cfr.:
A) LA GRECIA, LA MEDIAZIONE DELLA CALABRIA, E IL RINASCIMENTO ITALIANO ED EUROPEO. In memoria di Barlaam (Bernardo) e di Leonzio Pilato ... PER BOCCACCIO, UNA GRANDE FESTA IN TUTTA L’ITALIA E L’EUROPA (http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=5421)
B) PER NON DIVENTARE UN “BOCCALONE”, UNA “BOCCALONE” - PER NON FARE LA FIGURA DEL “FESSO” O DELLA FESSA” (cfr.: https://www.fondazioneterradotranto.it/2017/09/29/fessa-dialetto-salentino-sesso/#comment-63709)
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---UNA “VIA” PER USCIRE DALLA CAVERNA --- DAL PIEDE ALLA TESTA E DALLA TESTA AL PIEDE: “ECCE HOMO”!29 febbraio 2020, di Federico La Sala
DAL PIEDE ALLA TESTA E DALLA TESTA AL PIEDE: “ECCE HOMO”! *
CARO ARMANDO, credo che la “generalizzazione che finisce per escludere di fatto la donna”, alla luce del prezioso lavoro realizzato da te e dal dott. Marcello Gaballo su “Santa Maria di Casole a Copertino e le sue Sibille” (cfr.: https://www.fondazioneterradotranto.it/2017/03/24/santa-maria-casole-copertino-le-sue-sibille/), non dipende da generici “millenni di maschilismo”.
La riemersione nel nostro presente storico del “piticinu” (“peduncolo”) dell’”ECCE HOMO”, sollecita a riflettere più in profondità sulla nascita dell’uomo Gesù, a reinterrogarci sui suoi genitori e, in particolare, come recentemente e lodevolmente ha fatto la stessa Redazione della Fondazione Terra d’Otranto, su suo padre Giuseppe (cfr. “3 Commenti a De Domo David. 39 autori per i 400 anni della confraternita di San Giuseppe di Nardò”: https://www.fondazioneterradotranto.it/2019/11/10/de-domo-david-39-autori-per-i-400-anni-della-confraternita-di-san-giuseppe-di-nardo/#comment-257181), e a chiedere lumi alla SIBILLA DELFICA (vale a dire, oggi, alla “buonanima” di Sigmund Freud: http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=406) per sapere la ragione del diffondersi della peste nella città di “Tebe”!!!
La questione è decisamente antropologica e la situazione storica sollecita ancora e di nuovo a “conoscere sé stessi”, a conoscere sé stesse”, a comprendere finalmente “come nascono i bambini”, “come nascono le bambine”: certamente non da un “omuncolo”(cfr. http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=2923 )! Ciò che è in gioco è la sopravvivenza della nostra stessa umanità, presente e futura. O no?!
*
-
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- CSM A PEZZI. "Una ferita profonda e dolorosa", un "passaggio delicato" che richiede una reazione forte e immediata: o si riscatta "con i fatti il discredito che si è abbattuto su di noi o saremo perduti" ( David Ermini)..5 giugno 2019, di Federico La Sala
FILOSOFIA. IL PENSIERO DELLA COSTITUZIONE E LA COSTITUZIONE DEL PENSIERO *
- Costituzione, art. 54 - Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
- I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
CRONACA
Csm a pezzi*
- [Foto] La sala del Plenum straordinario del Csm presso Palazzo dei Marescialli, con i posti vuoti dei magistrati Corrado Cartoni e Antonio Lepre (Fotogramma)
"Una ferita profonda e dolorosa", un "passaggio delicato" che richiede una reazione forte e immediata: o si riscatta "con i fatti il discredito che si è abbattuto su di noi o saremo perduti". E’ affidato alle parole del vicepresidente David Ermini il senso di una crisi istituzionale senza precedenti che ha scosso il Consiglio superiore della magistratura per effetto dell’Inchiesta di Perugia, nella quale sono indagati Luca Palamara, e Stefano Rocco Fava, pm a Roma, e il togato dimissionario del Csm Luigi Spina. Ma la sua non era l’unica sedia vuota ieri pomeriggio nell’aula Bachelet dove si è riunito un plenum straordinario convocato a seguito della bufera che ha travolto il Consiglio e l’interra magistratura italiana: quattro togati si sono autosospesi.
Lunedì sera Corrado Cartoni e Antonio Lepre, di Magistratura Indipendente, non indagati ma che avevano preso parte a incontri con gli esponenti del Pd Luca Lotti e Cosimo Ferri per discutere della nomina del procuratore di Roma, e ieri, annunciandolo poco prima del plenum, Gianluigi Morlini, di Unicost, e Paolo Criscuoli di Mi. Ma dall’assemblea di Palazzo dei Marescialli, insieme alla presa d’atto della gravità della situazione, arriva anche una forte assunzione di responsabilità e un richiamo alla compattezza: con un documento approvato all’unanimità tutti i consiglieri, laici e togati, si dicono "sgomenti e amareggiati", denunciano comportamenti da cui "prendere con nettezza le distanze" e richiamano la necessità di "un radicale percorso di autoriforma. E da più parti arriva il riconoscimento al vicepresidente Ermini di una gestione saggia, ferma e responsabile della situazione e al valore imprescindibile della guida del capo dello Stato, Sergio Mattarella, che del Csm è il presidente.
Di "un giorno cupo come pochi altri" per il Csm parla il togato di Autonomia &indipendenza Piercamilo Davigo, che esprime apprezzamento per la posizione unitaria su cui tutti i consiglieri si sono ritrovati facendo prevalere allo "spirito di appartenenza o di fazione" la "tutela dell’Istituzione". Michele Ciambellini, di Unicost, invita il Consiglio a dare "una risposta seria energica senza ambiguità e a percorrere insieme una strada che riaffermi il prestigio dell’Istituzione". Da Giuseppe Cascini, di Area, il paragone forte del momento "grave e drammatico" con i tempi dello scandalo della P2. Invita a una "generale presa di coscienza" il primo presidente della Corte di Cassazione Giovanni Mammone, che esprime l’auspicio che "la consapevolezza costituisca un valido deterrente a che ulteriori comportamenti individuali vengano adottati in violazione delle regole fondamentali della deontologia".
Il laico M5S Fulvio Gigliotti si dice certo che il Csm "continuerà a mantenere quell’alto livello di garanzia e credibilità istituzionale" attraverso "il più attento rigore e la massima fermezza" nelle funzioni che tutti i componenti sono chiamati a esercitare. Al centro delle riflessioni di Ermini, inevitabilmente, anche il tema delle nomine ai vertici degli uffici che devono essere "trasparenti", compiute "fuori da logiche spartitorie", e preservate dalle "degenerazioni correntizie" e dai "giochi di potere" che sono emersi dall’inchiesta dei pm perugini. E ogni determinazione del Consiglio deve essere assunta "al riparo da interessi esterni" e "al solo fine di assicurare l’efficienza e la conformità alla costituzione dell’attività giurisdizionale" il tutto sotto la "guida illuminata" del Capo dello Stato. Il plenum ha anche preso atto delle dimissioni di Spina e ha deliberato il suo rientro in ruolo alla procura di Castrovillari, suo ufficio di provenienza.
* SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
LUNGA VITA ALL’ITALIA: "RESTITUITEMI IL MIO URLO"!!! Dalla Cina, la lezione di Huang Jianxiang. A Lui, in omaggio perenne (2006)
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- PER LA FILOSOFIA DI UN ALTRO SOCRATE. IN MEMORIA DI MICHEL SERRES.3 giugno 2019, di Federico La Sala
"Pietà per il mondo, venga il nuovo sapere"(M. Serres, Distacco, 1986)
IN MEMORIA DI MICHEL SERRES *. UNA CONFESSIONE (DA "IL MANCINO ZOPPO"):
- "Una confessione. La filosofia, si dice, conduce alla saggezza [sagesse]. Secondo un altro significato della parola, prima di morire vorrei diventare levatrice - che in francese diciamo sage-femme, cioè letteralmente, «saggia donna» -, vorrei aiutare a partorire il mondo nuovo.
 La mia vita intera mi ci ha preparato, attraverso l’ascolto attento degli scricchiolii emessi dal vecchio. Sento le crisi che attraversiamo, le inquietudini che suscitano, come dei lamenti emessi nel travaglio del parto. Amo la madre, accolgo il bambino.
La mia vita intera mi ci ha preparato, attraverso l’ascolto attento degli scricchiolii emessi dal vecchio. Sento le crisi che attraversiamo, le inquietudini che suscitano, come dei lamenti emessi nel travaglio del parto. Amo la madre, accolgo il bambino.
 Possa migliorare incessantemente la mia attività di medico ostetrico, il mio diventare sage-femme" (Michel Serres, Il mancino zoppo. Dal metodo non nasce niente [Le Gaucher boiteux. Puissance de la pensée], Bollati Boringhieri, Torino, 2016, pp. 48-49).
Possa migliorare incessantemente la mia attività di medico ostetrico, il mio diventare sage-femme" (Michel Serres, Il mancino zoppo. Dal metodo non nasce niente [Le Gaucher boiteux. Puissance de la pensée], Bollati Boringhieri, Torino, 2016, pp. 48-49).
PER LA FILOSOFIA DI UN ALTRO SOCRATE. AL DI LA’ DI EDIPO...:
Federico La Sala, La mente accogliente. Tracce per una svolta antropologica, Antonio Pellicani editore, Roma 1991, pp. 138-189 (capp. II e III):
a) IL PUNTO DI SVOLTA. L’INDICAZIONE DI FACHINELLI E LA SUA IMPORTANZA.
b) LE "REGOLE DEL GIOCO" DELL’OCCIDENTE E IL DIVENIRE ACCOGLIENTE DELLA MENTE.
c) CHI SIAMO NOI, IN REALTA’?! RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTA’: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.
d) CREATIVITA’: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETA’ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
Federico La Sala
*
Morto Michel Serres, il filosofo della scienza che amava l’Italia
Grande figura dell’epistemologia e fra i primi a pensare in modo sistematico la necessità di un nuovo approccio alla questione ecologica, aveva 88 anni. «I miei miglior amici sono italiani»
di Daniele Zappalà (Avvenire, sabato 1 giugno 2019)
Parigi. Era uno dei pensatori più ammirati a livello internazionale, oltre a rappresentare una figura centrale del mondo intellettuale francese. Il filosofo Michel Serres, grande figura dell’epistemologia e fra i primi a pensare in modo sistematico la necessità di un nuovo approccio alla questione ecologica, si è spento ieri a 88 anni. Accademico di Francia fin dal 1990, aveva insegnato a lungo negli Stati Uniti, all’Università di Stanford, oltre che in vari atenei transalpini. Autore di una cinquantina di volumi e di opere fondamentali sull’origine del pensiero scientifico, come Le origini della geometria (Feltrinelli) o Lucrezio e l’origine della fisica (Sellerio), aveva pure interpretato, nella lontana scia di Leibniz, la pregnanza della comunicazione nel mondo contemporaneo, come nei 5 volumi della serie Hermès (1969-1980).
Figura estremamente originale, aveva scelto come proprio motto «pensare significa anticipare», prevedendo e interpretando nei propri libri diverse rivoluzioni del nostro tempo. Una costante della sua riflessione è stata pure la grande attenzione alla tradizione culturale cristiana, come in La ricerca delle parole. Corpo, scrittura e messaggio evangelico (EDB), o in Darwin, Napoleone e il samaritano. Una filosofia della storia (Bollati Boringhieri).
Fra i volumi di Serres più citati, si può ricordare Il contratto naturale (Feltrinelli), all’origine di una riflessione sull’ambiente approdata poi a volumi più personali, come Biogea. Il racconto della terra (Asterios). Di recente, aveva pubblicato pure dei pamphlet con cui aveva riscosso un notevole successo, come Non è un mondo per vecchi. Perché i ragazzi rivoluzionano il sapere, o ancora Contro i bei tempi andati, entrambi tradotti da Bollati Boringhieri.
«Tutti i miei migliori amici sono italiani», ci aveva raccontato nella sua ultima intervista ad Avvenire, da grande innamorato del Belpaese. In proposito, aveva anche dedicato un volume a Carpaccio, edito in Italia da Hopefulmonster. Fra gli altri tratti della tradizione italiana reinterpretati a livello filosofico, spicca la figura di Arlecchino, nel volume Il mantello di Arlecchino (Marsilio). Profondamente segnato dal dramma della guerra, ha lasciato anche importanti riflessioni di stampo pacifista.
- "Una confessione. La filosofia, si dice, conduce alla saggezza [sagesse]. Secondo un altro significato della parola, prima di morire vorrei diventare levatrice - che in francese diciamo sage-femme, cioè letteralmente, «saggia donna» -, vorrei aiutare a partorire il mondo nuovo.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- AL CNR UNA "PROVOCAZIONE" DA ACCOGLIERE. UN PROBLEMA STORIOGRAFICO (SCIENTIFICO) DI LUNGA DURATA31 maggio 2019, di Federico La Sala
COSTITUZIONE E CNR. UN PROBLEMA STORIOGRAFICO (SCIENTIFICO) DI LUNGA DURATA ...
CONDIVIDO LA PREOCCUPAZIONE E, AL CONTEMPO, LA CONSAPEVOLEZZA dei firmatari della lettera. La “provocazione” - da parte di chi dirige il Dipartimento del CNR, “al cui interno operano decine di storici, storici della filosofia, giuristi e altri ricercatori nel campo delle scienze umane e sociali” - evidenzia il sintomo non tanto e non solo “di un profondo problema culturale e scientifico”, ma anche e soprattutto di un problema politico-filosofico (metafisico), costituzionale, di CRITICA della “ragion pura” (di questo parla il “principio della relatività galileiana”, condensato nel “Rinserratevi” del “Dialogo sopra i due massimi sistemi tolemaico e copernicano”)!
DOPO GALILEI, DOPO KANT, DOPO EINSTEIN, DOPO LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA... UNA “PROVOCAZIONE” al CNR DA ACCOGLIERE!
Strana “coincidenza”, oggi!:
A) Il 9 Aprile 2019, in una nota (dal titolo “CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. A che gioco giochiamo?!: https://www.alfabeta2.it/2019/03/31/marcel-detienne-memorie-felici-e-concetti-indelebili/#comment-639227), così scrivevo:
- “La totale incomprensione del “relazionismo” proposto da Karl Mannheim in “Ideologia e Utopia” (1929), esaminato e rigettato nel capitolo quarto dello “Spirito tedesco in pericolo”, impedisce a Curtius (e non solo!) di aprire gli occhi su stesso e sul mondo, di uscire dal relativismo-assolutismo dogmatico in cui naviga, e di smetterla di sognare il “sogno dei visionari” (sul tema, mi sia lecito, cfr.: “Heidegger, Kant, e la miseria della filosofia - oggi”: http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=4790)”.
B) Il 12 maggio 2019, “recensendo un volume - come scrivono gli studiosi e le studiose del CNR - dell’epistemologo statunitense Alex Rosenberg, in un articolo dal titolo Questa storia è davvero molto falsa apparso sul supplemento domenicale del “Sole - 24 ore” il 12 maggio scorso, il professor Gilberto Corbellini ne ha preso spunto per asserire, in polemica con un recente appello in difesa dell’insegnamento della storia, l’assenza di scientificità e di utilità sociale della disciplina stessa”.
Prima che sia troppo tardi, che fare?! Alle studiose e alle studiose di scienze umane e sociali (del CNR e non solo), consiglierei (mi sia permesso) la ri-lettura del “Dialogo sopra i due massimi sistemi tolemaico e copernicano” di Galileo Galilei, la ri-lettura dei “Sogni di un visionario chiariti con i sogni della metafisica” di Immanuel Kant, e, infine, la rilettura dei “Principi” della Costituzione della Repubblica Italiana - e, alla luce della “ferocissima” provocazione, ri-prendere il lavoro storiografico-scientifico con più grande entusiamo e responsabilità di prima!
VIVA L’ITALIA!
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- EPISTEMOLOGIA E STORIOGRAFIA. "Questa storia è davvero molto falsa" (A. Rosenberg). Una risposta all’intervento di Gilberto Corbellini (di studiosi e studiose del Dipartimento di scienze umane e sociali del Cnr - "Alfabeta2").30 maggio 2019, di Federico La Sala
Al CNR la storia è una scienza? Una risposta all’intervento di Gilberto Corbellini *
Recensendo un volume dell’epistemologo statunitense Alex Rosenberg, in un articolo dal titolo Questa storia è davvero molto falsa apparso sul supplemento domenicale del “Sole - 24 ore” il 12 maggio scorso, il professor Gilberto Corbellini ne ha preso spunto per asserire, in polemica con un recente appello in difesa dell’insegnamento della storia, l’assenza di scientificità e di utilità sociale della disciplina stessa.
Per sostenere tale tesi ha offerto una descrizione caricaturale del lavoro degli storici, cui attribuisce il tentativo di «entrare» nella «testa» dei personaggi e la pretesa di «sapere perché Giulio Cesare piuttosto che Carlo Magno presero una determinata decisione». Fa quindi dipendere in generale gli studi storici (e con essi anche il diritto, e implicitamente la filosofia e le scienze umane in genere) dalle «narrazioni» e dalla «ricerca delle motivazioni di un comportamento», e li destituisce così di credibilità fino a definirli «falsi».
Questa presa di posizione ignora totalmente la rilevanza che la questione della prova, la critica delle narrazioni e delle testimonianze, la distinzione fra storia e memoria hanno avuto e hanno nella riflessione storiografica. Fin dai tempi di Lorenzo Valla gli storici sono impegnati a mettere a punto quegli «approcci controllabili» che Corbellini li accusa di ignorare, e gli ultimi decenni li hanno visti partecipi di una significativa riflessione epistemologica, in sintonia con le altre scienze sociali, tesa a superare rigide dicotomie metodologiche quali, ad esempio, quantitativo/qualitativo o struttura/soggettività. E d’altro canto ipotizzare, come si propone nell’articolo, l’opportunità di dimenticare eventi estremi quali i genocidi sminuisce il significato dell’elaborazione e dell’interpretazione, spesso conflittuale, della memoria per la costruzione dei valori della nostra cultura.
Come studiosi e studiose di discipline storiche e umanistiche del Dipartimento di scienze umane e sociali, patrimonio culturale del CNR intendiamo esprimere la nostra preoccupazione per queste affermazioni. Si tratta dichiaratamente di una «provocazione» e come tale, se provenisse semplicemente da un autorevole studioso, ci si potrebbe limitare a trarne spunti di riflessione o a lasciarla cadere. Il professor Corbellini, tuttavia, non è un qualsiasi storico della medicina che si rivolge alla propria comunità scientifica e all’opinione pubblica, ma ha la responsabilità di dirigere il nostro Dipartimento, al cui interno operano decine di storici, storici della filosofia, giuristi e altri ricercatori nel campo delle scienze umane e sociali. Le sue parole, che implicano una delegittimazione pubblica del lavoro degli storici e non solo, investono quindi in pieno il senso della presenza stessa delle nostre discipline all’interno del maggiore ente di ricerca italiano.
Se oggi in Italia i saperi storici e umanistici appaiono quanto mai marginalizzati, un intervento come questo, tanto più per il ruolo istituzionale di elevata responsabilità del suo autore, sembra essere più il sintomo di un profondo problema culturale e scientifico che non un contributo al suo superamento. Esso offre quindi l’occasione per sollecitare ai vertici del CNR un pronunciamento in merito al ruolo e alle prospettive delle discipline umanistiche all’interno dell’ente e per aprire in proposito un dibattito all’interno della comunità scientifica e della società.
Grazia Biorci (IRCRES-CNR)
Olga Capirci (ISTC-CNR)
Geri Cerchiai (ISPF-CNR)
Gemma Colesanti (ISEM-CNR)
Gabriella Corona (ISSM-CNR)
Roberto Evangelista (ISPF-CNR)
Amedeo Feniello (ISEM-CNR)
Ida Maria Fusco (ISSM-CNR)
Stefano Gallo (ISSM-CNR)
Patrizia Grifoni (IRPPS-CNR)
Paolo Landri (IRPPS-CNR)
Maurizio Lupo (ISSM-CNR)
Daniela Luzi (IRPPS-CNR)
Fabio Marcelli (ISGI-CNR)
Armando Mascolo (ISPF-CNR)
Marina Montacutelli (ISSM-CNR)
Michele Nani (ISSM-CNR)
Anna Maria Oliva (ISEM-CNR)
Walter Palmieri (ISSM-CNR)
Claudia Pennacchiotti (IRPPS-CNR)
Leonardo Pica Ciamarra (ISPF-CNR)
Mariarosaria Rescigno (ISSM-CNR)
Giovanni Rota (ISPF-CNR)
Alessia Scognamiglio (ISPF-CNR)
Luisa Simonutti (ISPF-CNR)
Luisa Spagnoli (ISEM-CNR)
Alessandro Stile (ISPF-CNR)
Antonio Tintori (IRPPS-CNR)
Pina Totaro (ILIESI-CNR)
Mattia Vitiello (IRPPS-CNR)
* ALFABETA-2: Per chi desiderasse mettersi in contatto con gli autori della lettera, l’email di riferimento è storiascienza.cnr@libero.it.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- Insegnare ai giovani come «governare il futuro». Due atenei milanesi hanno promosso una laurea magistrale per formare una classe dirigente. Quattro partecipanti all’iniziativa discutono. .19 maggio 2019, di Federico La Sala
A confronto Due atenei milanesi, Statale e San Raffele, hanno promosso una laurea magistrale per formare una classe dirigente proiettata nel futuro. Quattro partecipanti all’iniziativa discutono il rapporto tra filosofia e scienze sociali
Dobbiamo inventare l’Illuminismo del 2019
conversazione di Maurizio Ferrera con Francesco Guala, Roberto Mordacci e di Francesca Mordacci (Corriere della Sera, La Lettura, 19.05.2019)
La scienza moderna ha scoperto che la natura è governata da leggi che la rendono in larga misura controllabile e prevedibile. Le scienze sociali novecentesche hanno a loro volta messo in luce le molte regolarità che caratterizzano la sfera politica, economica e sociale, nonché i meccanismi che le generano. Lo Stato di diritto - diventato poi liberale e democratico - ha stabilizzato i processi di interazione e di decisione collettiva. In questo contesto, l’immagine del tempo è radicalmente cambiata. In particolare, il futuro non appare più dominato dal caso, dal destino o dalla provvidenza. È diventato la dimensione del possibile: una fase temporale vincolata, certo, dal passato, ma più o meno liberamente plasmata nel presente, in base ai nostri scopi e valori.
 Insegnare ai giovani come «governare il futuro» è uno dei principali obiettivi di una nuova laurea magistrale promossa da due atenei milanesi: la Statale e l’Università Vita-Salute del San Raffaele. Abbiamo affrontato le tematiche al centro dell’iniziativa con tre studiosi di filosofia: Francesco Guala insegna Economia politica e si occupa di scienze sociali; Roberto Mordacci, preside al San Raffaele, è uno specialista di Filosofia morale e bioetica; Francesca Pasquali è docente di Filosofia politica.
Insegnare ai giovani come «governare il futuro» è uno dei principali obiettivi di una nuova laurea magistrale promossa da due atenei milanesi: la Statale e l’Università Vita-Salute del San Raffaele. Abbiamo affrontato le tematiche al centro dell’iniziativa con tre studiosi di filosofia: Francesco Guala insegna Economia politica e si occupa di scienze sociali; Roberto Mordacci, preside al San Raffaele, è uno specialista di Filosofia morale e bioetica; Francesca Pasquali è docente di Filosofia politica.MAURIZIO FERRERA - In un recente discorso, Emmanuel Macron ha lanciato un ambizioso percorso di riforme, nato da un «gran dibattito nazionale» che ha coinvolto più di due milioni di cittadini. Dibattito democratico e progetto di cambiamento: siamo gli eredi dell’Illuminismo, ha ricordato il presidente. Un richiamo che ben si presta a riflettere su come governare il futuro...
ROBERTO MORDACCI - Certamente. Fu l’Illuminismo a elaborare l’idea moderna di storia come orientata verso uno scopo. È l’idea di progresso scientifico ma anche morale e politico: vite meno infelici, istituzioni più giuste. La grande crisi attuale viene dalla sfiducia in questa possibilità, favorita dalla moda postmodernista della «fine» del sapere, della morale e dunque della storia. Ma il progresso è una responsabilità, non una necessità: esiste se lo facciamo accadere.
FRANCESCO GUALA - Un’impresa doverosa, ma non facile. Grazie alle scienze cognitive e sociali oggi siamo più consapevoli delle difficoltà che tutti noi, cittadini ed esperti, incontriamo quando cerchiamo di rappresentare e controllare i processi di cambiamento. La percezione esagerata del rischio, l’incapacità di pensare scenari alternativi a quelli dominanti sono ostacoli enormi, che possono impedirci di trovare soluzioni razionali e condivise. Ma Illuminismo vuol dire anche ottimismo: la riflessione filosofica e scientifica ci fornisce strumenti formidabili che non esistevano solamente qualche decennio or sono. Proprio perché sappiamo quali sono i nostri limiti, abbiamo più chance di superarli.
FRANCESCA PASQUALI - Come eredi dell’Illuminismo, riconosciamo che, non essendoci fini stabiliti da autorità esterne, il futuro è aperto e ognuno ha il diritto di contribuire a definirne la direzione. Per evitare fraintendimenti piuttosto diffusi, si deve chiarire però che questo non implica attribuire a tutte le opinioni la stessa validità. Al contrario, proprio perché non ci sono autorità esterne cui affidarci, per orientare il futuro verso il meglio dobbiamo sottomettere al vaglio della ragione le nostre opinioni, scartando quelle non fondate su solide argomentazioni o evidenze empiriche affidabili.
MAURIZIO FERRERA - Le nuove tecnologie, e più in generale quella che il filosofo Luciano Floridi chiama l’Infosfera, stanno rapidamente cambiando i modi di produrre, lavorare, comunicare, organizzare la vita associata, persino incrementare le nostre abilità naturali. Può davvero aprirsi la possibilità di un grande balzo in avanti dello sviluppo umano. L’Infosfera (e in particolare il progresso dell’intelligenza artificiale) solleva però anche enormi problemi di natura etica e sociale. Quali sono secondo voi le principali sfide e le strategie per affrontarle?
FRANCESCO GUALA - Sulle sfide c’è l’imbarazzo della scelta. Ne scelgo una che mina al cuore i fondamenti della democrazia: la necessità e insieme la difficoltà di vivere insieme nella diversità di pensiero. Si tratta di una sfida perenne, ovviamente, ma la tecnologia negli ultimi dieci anni ha enormemente facilitato la creazione di comunità alternative e «chiuse» - dai terrapiattisti ai no-vax - restringendo a sua volta lo spazio intermedio dove si stipulano i compromessi essenziali per il vivere comune. I gruppi che contrasteranno questo processo di isolamento e frammentazione potranno formare le coalizioni vincenti della politica del futuro.
FRANCESCA PASQUALI - Se gli scenari prevedibili in base agli sviluppi dell’intelligenza artificiale e del potenziamento biologico - macchine intelligenti, individui sempre più resistenti alle malattie - sono perlomeno possibili, si tratta di capire se e come aggiornare il nostro resoconto circa le caratteristiche distintive degli esseri umani, che fa da sfondo alla riflessione morale. È sensato individuare la nostra specificità in certe facoltà cognitive, che forse condivideremo con le macchine, o in certe caratteristiche biologiche, che forse potremo modificare? Si tratta anche di valutare se simili scenari siano desiderabili e se vi siano soluzioni, magari distanti dalle nostre pratiche attuali, per bilanciarne al meglio vantaggi e svantaggi.
ROBERTO MORDACCI - In passato, le tecnologie generavano paure per la loro potenza distruttiva. Per questo Hans Jonas invocava responsabilità. Quelle attuali vivono di controllo e velocità. Chi ha accesso ai Big Data e quale potere acquisisce controllandoli? Quanta rapidità siamo in grado di gestire negli scambi di informazione? Abbiamo bisogno di un’etica per l’età digitale, che ne sappia affrontare la legge fondamentale, ovvero l’accelerazione costante e inarrestabile.
MAURIZIO FERRERA - Al di là delle oscillazioni e delle crisi cicliche dell’economia capitalistica, le società avanzate hanno oggi il potenziale di raggiungere sempre più alti livelli di «prosperità»: una nozione che evoca benessere quantitativo e qualitativo, pluralità e disponibilità (sperabilmente «equa») di chance di vita sempre più ampie e articolate. Il percorso è tuttavia irto di ostacoli: pensiamo alla sostenibilità ambientale e demografica, alla pressione migratoria, al logoramento dei legami di solidarietà, al rischio di ripiegamenti nazionalistici e di rigetto dei progetti di integrazione, in particolare in Europa. Quali sono le condizioni più propizie affinché il potenziale oggi esistente si possa realizzare in forme e modi «aperti, inclusivi, sostenibili»?
ROBERTO MORDACCI - Le condizioni essenziali dello sviluppo sono chiare: gli «obiettivi di sviluppo sostenibile» fissati dall’Onu mostrano che è il coordinamento la chiave di una crescita equilibrata. La minaccia alla vita viene dall’iniquità, dal conflitto sociale e dall’isolamento, che generano inquinamento, distruzione delle risorse, squilibri, discriminazioni e guerre. Nel mondo globalizzato, o si cresce insieme o si muore isolati.
FRANCESCO GUALA - L’etica economica si fonda su due princìpi universali: il principio secondo il quale chi produce un bene o un servizio ha diritto di goderne i principali benefici; e quello dell’uguaglianza, che si applica ogniqualvolta non è possibile identificare chiaramente chi ha prodotto il bene in questione. Questi due princìpi funzionano bene in comunità relativamente piccole e coese, nelle quali i rapporti di forza sono relativamente equilibrati. Quando si creano enormi disuguaglianze invece entrano in crisi. Credo che la redistribuzione oggi vada pensata in un’ottica nuova - politica invece che etica - proprio perché siamo in una situazione di questo genere. In pratica, significa che i «vincitori» di oggi devono smettere di porsi la domanda «è giusto redistribuire?» e chiedersi invece quale sistema di redistribuzione potrà salvare il patto sociale.
MAURIZIO FERRERA - Su scala globale il mondo resta attraversato da aspri conflitti e guerre locali, che minacciano pace e sicurezza, anche attraverso il terrorismo. Le radici di questi conflitti sono di natura sia «materiale» (diseguaglianze, accesso alle risorse e così via) sia «ideale» (cultura e religione). L’Europa è oggi l’area più pacificata, civilizzata e sviluppata del pianeta, ma questo esito è il risultato di secoli di guerre e scontri fra popoli. Non è detto che la via europea sia praticabile e replicabile a livello globale. E non è neppure detto che le dinamiche conflittuali che caratterizzano oggi il mondo possano gradualmente comporsi: potrebbero invece deflagrare nel famoso «scontro di civiltà» preconizzato da Samuel Huntington. L’ideale kantiano di una pace perpetua, sorretta da un ethos universale di civismo e assetti federali sul piano planetario, vi sembra oggi più vicino o più lontano?
FRANCESCA PASQUALI - Immanuel Kant è chiaro: una pace perpetua è possibile solo tra repubbliche, in cui le decisioni si fondano sul consenso dei cittadini che, consapevoli dei costi, rifiutano la guerra. Se è così, la tendenza attuale non è incoraggiante: i regimi autoritari non sono in diminuzione e, anzi, alcuni sono attori chiave a livello internazionale. Questo è un motivo in più per capire come mai regimi autoritari mantengano una notevole centralità e domandarsi come fare i conti con tali regimi senza contraddire i princìpi democratici.
ROBERTO MORDACCI - La tendenza odierna verso la barbarie è fortissima. Lo spettro dell’autoritarismo, dell’odio etnico e della regressione si aggira minaccioso per l’Europa e non solo. La pace perpetua va ripensata da capo, come fece lo stesso Kant nel proprio tempo. Ogni epoca deve vivere il suo Illuminismo, non ripetere quello passato. È ora che lo facciamo anche noi, prima che sia troppo tardi.
FRANCESCO GUALA - L’ideale kantiano della pace perpetua è un modello che deve guidare sempre il nostro agire politico. Ma non sono particolarmente ottimista riguardo alla progressiva integrazione degli Stati nazionali in entità federali planetarie. La difficoltà che sta incontrando il progetto europeo sono significative a questo proposito: dei popoli già profondamente integrati culturalmente ed economicamente non riescono a compiere il salto decisivo verso un assetto federale. D’altronde credo che lo «scontro di civiltà» sia uno spauracchio politico semplicistico utile a spaventare le persone, molto meno ad analizzare la realtà. È più probabile che la violenza si sviluppi in focolai relativamente marginali, dove le grandi nazioni non hanno l’interesse o la forza di intervenire.
MAURIZIO FERRERA - Torniamo ai giovani, che almeno dal punto di vista socio-demografico costituiscono il 100 per cento del nostro futuro. Quali sono le competenze che essi dovrebbero padroneggiare grazie agli studi universitari per apprendere dal passato, interpretare il presente e dare il proprio contributo, anche in ambito lavorativo, per costruire e governare il mondo di domani?
FRANCESCO GUALA - Sicuramente la capacità di integrare gli strumenti e le conoscenze provenienti da diverse discipline - economia, politica, filosofia. Ma anche la capacità di esprimere una sintesi in modo chiaro, comprensibile, e non conflittuale. Vorrei sottolineare quest’ultimo punto - non conflittuale - perché è forse il più difficile. Andare controcorrente non è difficile: basta dire il contrario di quello che dicono gli altri! Quello che è davvero difficile è trovare nuove soluzioni e convincere chi non la pensa come noi, spesso con ottime ragioni. Tornando a quanto detto prima, le nuove tecnologie non ci aiutano da questo punto di vista. Ma è appunto il motivo per cui è essenziale provarci, formando una generazione di giovani che siano in grado di farlo meglio di noi.
FRANCESCA PASQUALI - Serve una preparazione multidisciplinare che, producendo anticorpi contro specialismi fini a sé stessi, consenta di acquisire una prospettiva di ampio respiro e strumenti analitici, descrittivi e filosofici, per capire e valutare i rapidi cambiamenti politici e sociali e immaginare modalità di intervento efficaci e appropriate in termini valoriali.
ROBERTO MORDACCI - Sono d’accordo: preparazione multidisciplinare e capacità di «visione». Solo il futuro dà senso al passato e alla frammentazione presente. L’avvenire non è degli specialisti: per risolvere i problemi occorre sempre una visione complessiva. Per questo la filosofia ha un ruolo decisivo, purché si mescoli alle scienze sociali, alla ricerca e all’evoluzione delle imprese. Queste ultime stanno cambiando il capitalismo, sono più attente ai valori, ma hanno bisogno di giovani capaci di strategie vincenti sul piano sociale e politico, non solo economico.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
L’ILLUMINISMO, OGGI. LIBERARE IL CIELO. Cristianesimo, democrazia e necessità di "una seconda rivoluzione copernicana"
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- La Costituzione non può restare sulla carta o come libro sul quale ritualmente si giura nei tribunali. Essa ha bisogno di guardiani (di Giuseppe Cacciatore).15 maggio 2019, di Federico La Sala
IL TEMPO E LE IDEE
La Costituzione non resti sulla carta
Il paragone tra il fascismo mussoliniano e il nazionalismo sovranista di Salvini è certamente, dal punto di vista storico e politico, improprio, ma i presidi democratici hanno bisogno mai come oggi di "guardiani", alla luce dell’attacco costante, in nome di una insistita e rozza idea di sicurezza, del ministro degli Interni
di Giuseppe Cacciatore (Salerno-Sera, 14 Maggio 2019)
Continuo a pensare che il paragone tra il fascismo mussoliniano e il nazionalismo sovranista di Salvini sia, dal punto di vista storico e politico, improprio. Su che cosa baso questa mia convinzione? Sul fatto che, malgrado i tentativi, alcuni dei quali fortunatamente non riusciti, di deturpare o radicalmente modificare i pilastri fondamentali della nostra Costituzione, questa rimane, insieme al Presidente della Repubblica, alla Corte Costituzionale, al Consiglio Superiore della Magistratura, ad una forte ed autonoma presenza dei sindacati confederali e a un sempre più crescente movimento di opinione pubblica e di autonomi movimenti di protesta contro le organizzazioni neofasciste e i partiti che ne favoriscono e proteggono le attività, una ancora solida barriera protettiva per la nostra democrazia. Non sfugge però una preoccupazione.
Fin quando reggerà questa opposizione democratica e civile e fin quando sarà possibile resistere a una cancellazione, fatta pezzo dopo pezzo, del nostro ordinamento democratico-costituzionale? Faccio solo qualche esempio: la riforma elettorale (di gran lunga peggiore della legge Acerbo che consegnò il Parlamento al partito di Mussolini) voluta fortemente dal PD e da Renzi e che ha consegnato come effetto boomerang la maggioranza ai partiti populisti e sovranisti; la legge Minniti che elimina dall’iter processuale contro i migranti il secondo grado di giudizio; la riforma della cosiddetta autonomia differenziata delle Regioni che è in aperta violazione degli articoli della Costituzione che garantiscono l’unità nazionale e la paritaria utilizzazione delle entrate fiscali. E adesso arriva il cosiddetto decreto sicurezza bis, che Salvini minaccia di portare subito all’approvazione del Consiglio dei ministri, malgrado l’opposizione dei grillini e le perplessità di Conte. Altre forzature e attacchi al principio di legalità da parte del ministro Salvini con l’annunciato nuovo decreto sicurezza
Basta dare un rapido sguardo ai contenuti del decreto per capire che si tratta di un attacco inaudito, incostituzionale e persino in netta collisione con le norme del codice penale. La solidarietà verso i migranti e le loro drammatiche peripezie diventa reato punibile con la somma che va dai 3.500 ai 5.500 euro per ogni essere umano che abbia trovato accoglienza e rifugio sulle navi alle quali, se italiane, verrà sospesa o revocata la licenza. Il decreto, con atto tipico di prepotenza dittatoriale, toglie al Ministero dei Trasporti la competenza sulla limitazione o sulla chiusura delle acque territoriali a tutte le navi che hanno migranti a bordo. E non è finita: vengono trasferite alle Direzioni distrettuali antimafia le competenze sulle inchieste per associazione a delinquere e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Vi è poi l’aspetto ancora più inquietante: l’abolizione delle attenuanti per chiunque si opponga a un pubblico ufficiale e si introducono pene più pesanti per chi commette reati di resistenza e oltraggio alle cosiddette forze dell’ordine. Guai poi a chi si illude che possano ancora svolgersi manifestazioni e cortei, giacché si prevedono condanne sino a 4 anni non solo per i violenti saccheggiatori di macchine e vetrine (com’è giusto che sia) ma anche per quelli che si oppongono alla polizia con oggetti di protezione passiva. Mi pare del tutto evidente che la manovra del ministro degli interni sia tutta volta ad accrescere il consenso elettorale in vista del voto europeo e in previsione di una più che probabile crisi di governo all’indomani delle elezioni. Ho detto all’inizio che il paragone col fascismo è storicamente improprio e ne ho spiegato la ragione primaria: l’esistenza di una carta costituzionale democratica e garantista verso i deboli, gli esuli, gli immigrati, i senza lavoro.
Ma la Costituzione non può restare sulla carta o come libro sul quale ritualmente si giura nei tribunali. Essa ha bisogno di guardiani: dalle supreme cariche dello Stato alle forze politiche sinceramente democratiche, dalle organizzazioni dei lavoratori ai movimenti studenteschi, dalle donne in lotta contro la violenza ai movimenti in difesa dell’ambiente, da tutti coloro, infine, che non hanno dimenticato cosa sia il valore della solidarietà umana. Il fascismo vinse con la violenza omicida e la sopraffazione, ma anche grazie alla complicità di un re fellone che doveva essere il garante dello Statuto e alla debolezza dei partiti democratici e socialisti, intenti più a litigare tra loro che a trovare la forza e l’unità di opporsi alle camicie nere.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- Scoperte. Severino aveva dedicato ad Heidegger la sua tesi di laurea pubblicata nel 1950. Testi e testimonianze dimostrano che il filosofo tedesco seguì il lavoro del pensatore italiano.13 maggio 2019, di Federico La Sala
Il filo tra Martin ed Emanuele
Scoperte. Severino aveva dedicato ad Heidegger la sua tesi di laurea pubblicata nel 1950. Testi e testimonianze dimostrano che il filosofo tedesco seguì il lavoro del pensatore italiano
di Armando Torno (Il Sole-24 Ore, Domenica, 12.05.2019)
Heidegger ha riflettuto sul pensiero di Emanuele Severino, e non sporadicamente, dalla fine degli anni Cinquanta del secolo scorso. O meglio, una prima nota reca la data 1958. Altre annotazioni sul filosofo italiano risalgono agli anni Sessanta (1968-69). Ora sono stati diffusi testi e testimonianze che provano tale interesse.
La notizia è stata resa nota in una conferenza stampa a Milano il 10 maggio, dedicata appunto alle «Nuove scoperte nei manoscritti inediti di Martin Heidegger», dai quali sono emersi passaggi in cui il pensatore tedesco commenta l’italiano. Altro si saprà in occasione del convegno di Brescia, dal 13 al 15 giugno, intitolato «Heidegger nel pensiero di Severino».
Il celebre e discusso maestro tedesco, che morì il 26 maggio 1976 (e nel necrologio Nicola Abbagnano lo ricordò come «Il pastore dell’essere»), negli anni in cui prende in considerazione Severino è riferimento di primo piano della filosofia. Basterà ricordare un evento che cambiò gli atteggiamenti nei suoi confronti: lo straordinario successo che riscosse la conferenza «La questione della tecnica», che Heidegger tenne all’Accademia Bavarese di Belle Arti il 18 novembre 1953.
Tutta l’élite colta di quel periodo lo applaudì entusiasta, da Werner K. Heisenberg (Nobel per la fisica nel 1932) a Ernst Jünger a José Ortega y Gasset. Heinrich Wiegand Petzet, autore di una dettagliata biografia del pensatore tedesco (Auf einen Stern zugehen. Begegnungen mit Martin Heidegger 1929 bis 1976), pubblicata a Francoforte nel 1983, scriverà dell’avvenimento: «Quando concluse con la frase divenuta famosa “Il domandare è la pietà del pensiero” dalla marea di bocche si levò un’ovazione senza fine. Ebbi la sensazione che finalmente il muro di sfiducia e di astio che si erigeva davanti al maestro e amico si fosse infranto. Fu forse il suo più grande successo pubblico» (tali parole si leggono alle pagine 81-82).
I periodi in cui il filosofo tedesco si occupa di dell’italiano seguono la pubblicazione dell’opera Heidegger e la metafisica, tesi di laurea di Severino (prefata da Gustavo Bontadini, suo maestro all’Università di Pavia), pubblicata dall’Editrice Giulio Vannini di Brescia nel 1950; e poi quella del saggio Ritornare a Parmenide, uscito nella Rivista di filosofia neoscolastica nel 1964. Del resto, di quel periodo va tra l’altro ricordato il viaggio che Heidegger compie in Asia minore nel 1965: visita le rovine di Troia, Efeso, Pergamo, raggiunge Istanbul.
A questi due testi di Severino ha fatto dunque riferimento Heidegger; inoltre in una lettera che Friedrich-Wilhelm von Herrmann, ultimo assistente del pensatore tedesco, ha scritto al filosofo italiano e che è stata letta all’incontro del 10 maggio, si ricorda con precisione quanto accadde.
Usiamo direttamente le parole di von Hermann: «Posso affermare che il nome di Emanuele Severino era costantemente presente nella mente di Martin Heidegger, quando negli anni ’60 fui l’assistente di Eugen Fink prima e di Martin Heidegger poi». E ancora, tra significativi ricordi: «Le visite di lavoro settimanali a casa di Martin Heidegger mi permisero non solo di conoscere le sue opere non ancora pubblicate, ma anche il suo modo di rapportarsi con le opere di altri pensatori. Il fatto che Heidegger abbia inserito nelle sue Annotazioni tre osservazioni sul percorso di pensiero di Emanuele Severino, è secondo me eloquente. Inoltre, durante i suoi incontri con il fratello Fritz, Heidegger parlava spesso di Emanuele Severino - e anche il figlio di Fritz, il reverendo Heinrich Heidegger, ricorda molto precisamente quelle menzioni, perché partecipava spesso agli incontri tra i due fratelli».
C’è di più. Von Hermann in questa lettera aggiunge precisazioni che mostrano la stima della filosofia tedesca nei confronti dell’italiano. Vale la pena lasciargli di nuovo la parola: «Ma il nome di Emanuele Severino era ben noto anche nella cerchia attorno al filosofo Hans-Georg Gadamer, con cui intrattenni un contatto molto confidenziale sino alla morte di Gadamer. Poiché fui scelto da Martin Heidegger quale responsabile scientifico dell’edizione integrale delle sue opere, intrattenevo una fitta corrispondenza con Gadamer e lo incontravo spesso personalmente.
Tra i fenomenologi di Friburgo le opere Heidegger e la metafisica e Ritornare a Parmenide erano ben note, e Heidegger era molto impressionato da entrambe. Ciò significa che l’originalità del percorso di pensiero di Emanuele Severino s’inserisce a pieno titolo nella serie dei grandi pensatori del XX secolo, assieme a Husserl, Heidegger, Fink e Gadamer».
È il caso di aggiungere che Heinrich Heidegger (sacerdote, figlio del fratello Fritz), in una missiva scritta a Severino e ora resa nota aggiunge altre conferme: «Mio padre, che aiutava suo fratello trascrivendo a macchina i suoi manoscritti, ripeteva spesso il Suo nome e non si stancava di evidenziare quanto era impressionato Martin Heidegger del modo in cui lei interpretava i suoi testi».
Padre Francesco Alfieri, già collaboratore di Oriana Fallaci (da cui ha ereditato la tenacia), vero segugio di archivi e assistente personale di von Hermann (c’è un loro libro, a quattro mani, Martin Heidegger. La verità sui Quaderni neri, edito da Morcelliana) ha partecipato alla conferenza stampa parlando di Heidegger interprete di Severino. Ci ha confidato: «Le tre frasi riguardano sia l’opera sulla metafisica sia il saggio su Parmenide. In particolare colpisce la frase di von Hermann, in calce alla lettera a Severino, nella quale dichiara che “Lei è riuscito dove molti hanno fallito”». Che dire? Innanzitutto che la prima nota inedita di Heidegger è questa: Überwindung, das Nichts eröffnet die mataphysische Frage. - Severino über die Metaphysik (1958); ovvero: Oltrepassamento, il nulla apre alla domanda metafisica - Severino sulla Metafisica (1958). Le altre due si conosceranno al convegno di giugno.
Aggiungiamo che nella ricordata prefazione di Bontadini a Heidegger e la Metafisica, dell’agosto 1950 e non può ripubblicata, si legge: «La fatica del Severino, anche indipendentemente dai suoi interessi e dalle sue convinzioni teoretiche, dovrà essere apprezzata da ogni studioso di Heidegger».
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- L’IDENTITA’ ("TAUTOTES") E IL DESTINO DELL’ITALIA!!! Gloria e destino della Necessità?! Boh?! Bah?!
- DOPO HEGEL (E DOPO HEIDEGGER) ... NON UNA, MA TRE CIVETTE (ORMAI DIVENUTE SCIMMIETTE) SUL COMO’ DEL DOTTORE - DEGLI INTELLETTUALI ITALIANI (1994-2010).
HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI.
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- Terrapiattisti in raduno a Palermo: “Sveleremo il grande inganno” (di Laura Anello).12 maggio 2019, di Federico La Sala
Pianeta Terra. Sull’uscita dallo stato di minorità, oggi. Indicazioni per una seconda rivoluzione copernicana...*
- IL PRINCIPIO DELLA RELATIVITA’ GALILEIANA, 1632. «Rinserratevi con qualche amico nella maggiore stanza che sia sotto coverta di alcun gran navilio, e quivi fate d’aver mosche, farfalle e simili animaletti volanti: siavi anco un gran vaso d’acqua, e dentrovi de’ pescetti; sospendasi anco in alto qualche secchiello, che a goccia a goccia vada versando dell’acqua in un altro vaso di angusta bocca che sia posto a basso; e stando ferma la nave, osservate diligentemente come quelli animaletti volanti con pari velocità vanno verso tutte le parti della stanza (...)
 Osservate che avrete diligentemente tutte queste cose, benché niun dubbio ci sia mentre il vascello sta fermo non debbano succedere così: fate muovere la nave con quanta si voglia velocità; ché (pur di moto uniforme e non fluttuante in qua e in là) voi non riconoscerete una minima mutazione in tutti li nominati effetti; né da alcuno di quelli potrete comprendere se la nave cammina, o pure sta ferma. » (Galileo Galilei, Dialogo sopra i due massimi sistemi tolemaico e copernicano, 1632 - Salviati, giornata II) *
Osservate che avrete diligentemente tutte queste cose, benché niun dubbio ci sia mentre il vascello sta fermo non debbano succedere così: fate muovere la nave con quanta si voglia velocità; ché (pur di moto uniforme e non fluttuante in qua e in là) voi non riconoscerete una minima mutazione in tutti li nominati effetti; né da alcuno di quelli potrete comprendere se la nave cammina, o pure sta ferma. » (Galileo Galilei, Dialogo sopra i due massimi sistemi tolemaico e copernicano, 1632 - Salviati, giornata II) *
Terrapiattisti in raduno a Palermo: “Sveleremo il grande inganno”
di LAURA ANELLO (La Stampa, 11.05.2019)
PALERMO Dicono che la terra è piatta, un disco che volteggia nello spazio. Sostengono che le immagini della Nasa sono farlocche, che lo sbarco sulla Luna è una bugia, che gli astronauti sono abili attori, che il Gps funziona perché le antenne sono poste in cima a misteriosi grattacieli sparsi per il mondo e persino che a protezione di questo “disco volante” su cui vive l’umanità ci sono montagne di ghiaccio color smeraldo alte quattrocento chilometri sorvegliate da guardiani millenari.
Eppure, domani, il raduno nazionale dei “terrapiattisti” - così si chiamano gli alfieri di questa teoria - convocato all’albergo Garibaldi di Palermo, ha attratto cento persone e pure l’interesse di Beppe Grillo, che aveva annunciato la sua presenza in nome del libero pensiero. “Voglio stare in mezzo a un po’ di cervelli che non scappano davanti a nulla, nessun pregiudizio, nessuna legge della fisica è definitiva”. In realtà non si è ancora iscritto (quota di partecipazione 20 euro, senza sconti per nessuno) e lo staff di Grillo ha fatto sapere che non verrà. Ma gli organizzatori non escludono che possa arrivare a sorpresa: “Se è interessato alle nostre teorie, lo inviterò a confrontarsi mezz’ora con noi”, dice Agostino Favari, uno dei relatori. Inizia la giornata con la Cucina de La Stampa, la newsletter di Maurizio Molinari
Di sicuro, i terrapiattisti sono, per così dire, molto oltre il grillismo inteso come sfiducia nel sistema, nelle “competenze” e nelle verità della scienza ufficiale. Ne ha fatto le spese il povero astronauta Umberto Guidoni che, invitato da Le Iene a un confronto con due esponenti di spicco del terrapiattisti, alla fine si è fatto cadere le braccia di fronte a una contestazione da pochade: “Se il pollo si brucia in forno sotto la carta argentata, perché un astronauta dovrebbe resistere al calore del sole dentro la navicella”? Sì, perché la teoria della terra piatta (e quindi dell’assenza della curvatura terrestre) trascina via pezzo a pezzo secoli di acquisizioni e di dimostrazioni scientifiche, cancellando con una spugna Galileo, Einstein e pure Darwin. Non esisterebbe neanche la forza di gravità e sarebbe una fandonia l’evoluzione umana. I dinosauri? Roba da Disneyland. Le ossa che sono state ritrovate apparterebbero ai giganti che hanno popolato la terra prima di noi, e che hanno realizzato costruzioni a loro misura come - ebbene sì - il porticato di San Pietro e gli archi del duomo di Milano.
Per non dire, come i relatori sosterranno domani a congresso, che in realtà siamo nel 1019, perché il calendario è stato mistificato con l’aggiunta di mille anni di storia e che forse Titania, Lusitania e Queen Elisabeth erano la stessa nave. A parlare dal palco del raduno, oltre a Favari che in tasca ha una laurea in Ingegneria (“Ma non dirò nient’altro di quello che faccio nella vita”), saranno Albino Galuppini (una laurea in Scienze agrarie, di professione agricoltore), Calogero Greco e Morena Morlini.
Domenica 12 maggio illustreranno relazioni e risponderanno alle domande per otto ore (dalle 9 alle 19 con una pausa pranzo dalle 13 alle 14.30) su argomenti come la differenza di pressione tra l’atmosfera e lo spazio siderale, l’astronomia zetetica, il dimenticato impero dei giganti - quelli oscurati da Bernini e Michelangelo, forse figure d’invenzione anche loro - l’orbita del sole sulla terra piatta, l’egocentrismo della stella polare. E naturalmente, sul “rifiuto dell’informazione”. Che, ahinoi, ancora non crede in queste nuove verità. Come non ci crede il Comune di Palermo, che ha negato il patrocinio e diffidato gli organizzatori dall’utilizzare il logo istituzionale nonostante loro abbiamo invitato “tutte le persone rappresentative delle organizzazioni di potere, a partire dal presidente della Regione siciliana, il capo della polizia di Stato della Sicilia, dei carabinieri e delle guardia di finanza, aggiungendo doverosamente il capo del servizio segreto interno e del servizio segreto militare della Sicilia. E pure il cardinale. Oltre che gruppi filosofici buddisti, steineriani, amici di Osho, yoga”. L’obiettivo è svelare il grande abbaglio (“Quanti danni fa la scuola”), l’impostura, l’inganno, il complotto. Squarciare il velo da Truman Show che da millenni oscura il cielo degli umani. Un velo piatto, s’intende.
Sul tema, in rete e nel sito, si cfr.:
FACHINELLI E FREUD NELLA “NAVE” DI GALILEI: LA CONVERSAZIONE CONOSCITIVA (IL NUOVO "CIRCOLO ERMENEUTICO").
LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). Un omaggio a Kurt H. Wolff e a Barrington Moore Jr.
ALBERT EINSTEIN, LA MENTE ACCOGLIENTE. L’universo a cavallo di un raggio di luce (non di un manico di scopa!).
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
Federico La Sala
- IL PRINCIPIO DELLA RELATIVITA’ GALILEIANA, 1632. «Rinserratevi con qualche amico nella maggiore stanza che sia sotto coverta di alcun gran navilio, e quivi fate d’aver mosche, farfalle e simili animaletti volanti: siavi anco un gran vaso d’acqua, e dentrovi de’ pescetti; sospendasi anco in alto qualche secchiello, che a goccia a goccia vada versando dell’acqua in un altro vaso di angusta bocca che sia posto a basso; e stando ferma la nave, osservate diligentemente come quelli animaletti volanti con pari velocità vanno verso tutte le parti della stanza (...)
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- Dopo più di vent’anni. Come don Ferrante (di Paolo Favilli)11 maggio 2019, di Federico La Sala
Il fascismo non ha data di scadenza, chi non lo vede è come don Ferrante
di Paolo Favilli (il manifesto, 11.05.2019)
Nell’Italia di oggi sono quasi sempre i comici, specialmente quelli dotati della finezza analitica di Corrado Guzzanti, ad interpretare i segni che danno concretezza alle cose. La concretezza della vicenda legata alla presenza di un editore fascistissimo (fortunatamente poi scongiurata) al Salone del libro di Torino.
La concretezza dell’orribile, violenta azione squadristica in una borgata romana condotta in prima persona da Casa Pound, l’associazione dei fascisti del terzo millennio di cui è dirigente il suddetto fascistissimo editore. La concretezza di quello che Marco Revelli ha chiamato «il vero scandalo», uno scandalo «enormemente grave e intollerabile», cioè la consapevole, voluta scelta di un ministro che ha giurato fedeltà alla Costituzione antifascista, di far pubblicare un suo scritto proprio da quel fascistissimo.
Segni, che peraltro vanno tutti con chiarezza in una direzione: quella del consolidamento di un intreccio composto da una molteplicità di lineamenti che in vari modi legano il pervasivo neofascismo di oggi al «fascismo storico».
Uno dei filoni caratterizzanti questo intreccio, consiste nel negare le possibilità di un’analogia tra il fascismo storico ed elementi caratterizzanti il momento attuale definiti tramite il termine «fascismo». Filone interessato, soprattutto, alla banalizzazione di tali fenomeni. E la banalizzazione è un modo particolarmente efficace per immetterci in una «notte in cui tutte le vacche sono nere», dove le parole perdono il senso profondo del loro significato, nella storia e soprattutto nella memoria.
La storia del fascismo nei suoi complessi rapporti con la società italiana, quella risultata sconfitta il 25 aprile, è storia finita? «Sono cose di altri tempi», ripetono in coro pressoché tutte le sfumature della destra, sia le «moderate», sia le «estreme». Se ne comprendono perfettamente le ragioni, ma non possiamo consolarci pensando che si tratta semplicemente di volgari forme di propaganda, anche se lo sono.
Persino autorevoli analisi storiche possono portare a tali conclusioni. Analisi che, giustamente, ci mettono in guardia dall’usare il termine «fascismo» come una sorta di passepartout semantico, ma che concentrate sulla irrepetibilità del «fascismo storico», limitato rigorosamente al ventennio, finiscono per immiserire quello che può essere usato fecondamente come concetto interpretativo che va al là del tempo del regime. Ci sono concetti che «non solo sono indispensabili per pensare l’esperienza storica, ma che addirittura la oltrepassano, sopravvivono ad essa e possono essere utilizzati per comprendere nuove realtà» (E. Traverso, Le metamorfosi delle destre radicali nel XXI secolo, 2019, p. 9). Particolarmente in un caso come quello dell’Italia, là dove il fascismo è stato inventato ed ha preso la sua forma primigenia.
Di che cosa siamo realmente contemporanei? Di che cosa è realmente intessuto l’adesso?
La comprensione storica dell’adesso acquista spessore solo se l’adesso non è semplicemente il punto d’arrivo di un continuum storico, bensì il momento essenziale di una correlazione tra uno, o più momenti del passato, che possono mostrarsi particolarmente significativi per dare senso al presente.
Da più di vent’anni, cioè dal primo governo Berlusconi, nel quale gli eredi conclamati del fascismo storico erano parte integrante ed essenziale, il richiamo senza infingimenti al fascismo è diventato aspetto costitutivo di una vasta alleanza. Aspetto costitutivo, quindi, di una fase della storia d’Italia.
Un’ampia e rigorosa letteratura storica, in particolare straniera, ha ricostruito un quadro impressionante delle forme in cui lineamenti di lungo periodo di tali richiami sono diventati, in Italia, del tutto normali nell’ambito di quell’alleanza. Una normalizzazione che ha raggiunto, tramite personaggi ai vertici del governo, anche centralità istituzionale.
L’attuale salvinismo non è semplicemente il frutto di questo contesto, ma di un percorso che questo contesto ha contribuito a creare. Ed il partito di Salvini ne è stato una delle principali forze costituenti in tutte le esperienze di governo, dagli esecutivi Berlusconi, al ruolo chiave esercitato nella direzione di importanti regioni del Nord. Ecco perché, pur con tutte le opportune distinzioni, dobbiamo interrogarci seriamente, con reale preoccupazione, delle caratteristiche di queste «forme». Non possiamo dire che oggi il «fascismo», non esiste visto che non sono presenti aspetti che hanno caratterizzato il «fascismo regime».
Com’è ben noto, il Manzoni scrive che Don Ferrante sosteneva, «con ragionamenti, ai quali nessun potrà dire almeno che mancasse la concatenazione», che la peste non esisteva. Mancavano, infatti «sostanze ed accidenti»; «non è acqua: perché bagnerebbe (...). Non è ignea: perché brucerebbe». E, «su questi bei fondamenti, non prese nessuna precauzione contro la peste; gli s’attaccò; andò a letto, a morire, come un eroe di Metastasio, prendendosela con le stelle».
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---La sinistra e le dimissioni dei filosofi dal secolo dei diritti (di Roberta De Monticelli).2 maggio 2019, di Federico La Sala
HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI....*
La sinistra e le dimissioni dei filosofi dal secolo dei diritti
Sinistra. Le Dichiarazioni universali, le Costituzioni post-belliche, le Carte europee dei diritti.
La ragion pratica, almeno riconosciuta sulla carta, è stata poi abbandonata
di Roberta De Monticelli (il manifesto, 30.04.2019)
II Che un filosofo si metta a ragionare di politica, per di più in termini di vasti orizzonti contemporanei, e sollevando problemi effettivi dell’oggi, è solo ammirevole: tanto più se il problema principale che affronta è precisamente la mancanza di idee, oltre che di ideali, della sinistra di oggi, italiana ed europea. Grazie dunque a Maurizio Ferraris di averci provato (Dovrebbero essere i Big Data a pagare il Welfare del futuro, il manifesto” 19/04). Aiuterà, il suo consiglio?
Credo che Ferraris abbia soprattutto inteso lanciare un’intelligente provocazione a pensare. Credo si possa essere d’accordo sulla tesi che la sinistra è (almeno in parte) in difficoltà non perché abbia mancato i suoi obiettivi, ma perché li ha conseguiti. Anche se certamente non una volta per tutte: e per amor di verità bisognerebbe aggiungere che il welfare oggi soffre terribilmente, a partire dalla sanità pubblica, che la scuola pubblica italiana è in via di smantellamento in ciò che aveva di buono, che la ricerca in Italia è finanziata sotto qualunque livello di decenza, che in troppi dei posti in cui un po’ di lavoro è rimasto, è proprio (anche se non solo) la sinistra (di governo e amministrazioni locali) che ha accettato di farlo pagare a tutti in termini di devastazione dell’ambiente e della salute; che al problema dell’integrazione dei migranti la sinistra non ha dedicato lo straccio di una proposta nazionale, e infine che evasione, corruzione e mafie gravano sul paese come e più di sempre, con qualche aiutino in termini di modica quantità di truffa fiscale, e se non è un obiettivo di “sinistra” quello di estirpare questi tre cancri allora non ha senso dire che i pochi elettori della cosiddetta élite rimasti a votare a sinistra lo fanno per ragioni etiche. Il che invece è verissimo.
Ma a questo bisogna aggiungere che - come i fatti evocati dovrebbero provare - i fini stessi in funzione dei quali, anche, il welfare doveva esistere, e cioè l’accesso dei più all’istruzione, alla consapevolezza dei propri doveri e diritti di cittadino, direi addirittura all’età adulta e alla responsabilità morale e civile, oltre che a una vita più libera e migliore, non sembrano affatto conseguiti. E del resto perché e come avrebbero dovuto esserlo, se prima di tutto hanno smesso di crederci - a proposito di etica - quei pochi o molti per i quali “sinistra” era il nome politico di un nucleo umanistico, universalistico e cosmopolitico di pensiero, cresciuto insieme con la modernità nell’età dei diritti e di tutte le loro generazioni - civili, politici, sociali, culturali, che erano andati a furia di battaglie e di tragedie a formare la cosa di tutti, la res publica che valeva la pena di difendere.
E allora, veniamo al dunque. La sinistra non ha perso gli ideali perché è rimasta a cercarli nei campi e nelle officine. Li ha persi perché quelli che di idealità si occupavano - cioè i filosofi, comunque vogliate chiamarli: intellettuali, scrittori, e poi la minoranza pigra e grigia degli accademici, noi insomma - hanno smesso di occuparsene. Maurizio Ferraris stesso ne è testimone, sia nella veste giovanile che in quella matura del suo postmodernismo. Ma abbiamo smesso proprio nel momento in cui la migliore eredità dei Lumi, e insieme la dolorosa cognizione dei valori sofferta nella prima metà del secolo scorso, fra guerre e totalitarismi, si fondevano nella ragion pratica incarnata dei grandi documenti normativi: le Dichiarazioni universali, le costituzioni postbelliche, le Carte europee dei diritti. I filosofi diedero le dimissioni dalla ragione pratica nel momento stesso in cui i migliori fra i nostri padri e madri erano riusciti miracolosamente a incarnarla in embrioni di istituzioni e norme, a provarla, per la prima volta nella storia, universalmente riconosciuta, almeno sulla carta.
Ma la lettera è morta, senza lo spirito. E lo spirito è evaporato quasi subito. Sono rimasti un pugno, fra i filosofi, gli spiriti liberi che non si fecero incantare dai cupi, feroci miti della guerra fredda: i Camus contro i Sartre, i Milosz contro i Lukacs, gli Spinelli e gli Olivetti contro i Banfi e i Kojève... e poi? Poi i francesi sdoganarono il Pastore dell’Essere, quello che prima aveva affidato ai carri armati di Hitler la guerra dell’Essere conto l’ente, e poi aveva fatto spallucce ai campi di sterminio (tanto gli ebrei, questi paradigmi della modernità capitalistico-finanziaria e sradicatrice, “si erano sterminati da soli”).
Con la modernità illuminista ce l’avevano anche gli eredi di Hegel e Marx (l’Illuminismo conduce ai campi di sterminio, copyright Horkheimer). E da questo felice incontro della più nera Selva nera con la dialettica hegeliana nacque il canone della filosofia cosiddetta continentale, quella che per cinquant’anni abbiamo continuato a insegnare perfino nelle scuole. Come sia andata a finire in Italia, per quel po’ di idealità (di filosofia) senza la quale la sinistra annaspa e muore, è cosa nota: ci fu la Coscienza Sprezzante, più realpolitica e decisionista di Carl Schmitt, che poi andò sfumando in teopolitica e teologia negativa. E ci fu la Coscienza Danzante, per le cui maschere senza volto valori e verità sono violenza, tutto è gioiosamente relativo e i fatti cosa da talebani: e Maurizio Ferraris ne è testimone. Così la sinistra rimase senza ragioni. Anzi senza ragione. Altro che campi e officine.
Adesso, nel ventunesimo secolo, all’umanità intera, liberata dal lavoro ceduto agli automi e ben nutrita dalla socializzazione del capitale documentale (qualunque cosa esso sia) potrebbe aprirsi la prospettiva “di una vita dedicata interamente alla produzione di valore”: cioè al consumo, al turismo, alla scrittura, perché ormai il valore si produce così, poi basta socializzarlo e il gioco è fatto.
Supponiamo che sia vero e possibile: sarebbe diverso da un incubo alla Brave New World, la Repubblica dei Felici, liberati da ogni angoscia di dover fare qualcosa di sé stessi senza per questo annichilire gli altri? Che poi è la questione che starebbe al fondo di tutto l’umanesimo e l’idealità e la ragione pratica e la filosofia. Meglio dimenticarsene. Intanto ci stiamo portando avanti: complice il nostro silenzio, si abolisce per decreto lo studio della storia, e in primo luogo del Novecento, obsoleto, che poi tanto non si fa in tempo a farlo. Senza memoria, il pensiero forse è più intelligente, chissà. Certo è un pensiero spensierato.
*
Sul tema, nel sito, si cfr.:
"NUOVO REALISMO", IN FILOSOFIA. DATO L’ ADDIO A KANT, MAURIZIO FERRARIS SI PROPONE COME IL SUPERFILOSOFO DELLA CONOSCENZA (QUELLA SENZA PIU’ FACOLTA’ DI GIUDIZIO).
NUOVO REALISMO E "GAIA SCIENZA": LA LEZIONE DI DANTE (E NIETZSCHE), OGGI. CONOSCERE SE STESSI E CHIARIRSI LE IDEE, PER CARITÀ!
"ANDRAGATHIA" (’NDRANGHETA). IL MONDO COME VOLONTA’ E RAPPRESENTAZIONE DEL MACROANTROPO ("UOMO SUPREMO", "SUPERUOMO", "DOMINUS IESUS"): FILOSOFIA, E TEOLOGIA POLITICA DELLA’ "ANDRO-POLOGIA" ATEA E DEVOTA....
 LA RISATA DI KANT: SCHOPENHAUER (COME RATZINGER) A SCUOLA DEL VISIONARIO SWEDENBORG.
LA RISATA DI KANT: SCHOPENHAUER (COME RATZINGER) A SCUOLA DEL VISIONARIO SWEDENBORG.Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- Filosofi: scomodi e amanti del sapere (Donatella Di Cesare)29 aprile 2019, di Federico La Sala
Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.... *
Filosofi: scomodi e amanti del sapere
Un’attività che nasce dallo stupore, una passione inquieta per la quale nulla è scontato
di DONATELLA DI CESARE *
- Vasilij Kandinskij (1866-1944), «Composizione VI Z»(1913), conservato all’Ermitage di San Pietroburgo
Che valore ha oggi la filosofia? A quale compito saranno chiamati le filosofe e i filosofi nell’età del tecnocapitalismo e della governance neoliberale? La Regina delle scienze, rimasta sola, dopo il distacco definitivo delle scienze naturali, appare caduta in un grave discredito. E se la senatrice Liliana Segre richiama i politici allo studio della storia, è altrettanto giusto richiamarli allo studio della filosofia.
Il ritmo accelerato sembra bandire ogni riflessione considerata un gioco improduttivo, una fuga irresponsabile in sogni evanescenti. Così il vecchio pregiudizio contro la filosofia si è andato rafforzando. Urgono risposte rapide, soluzioni definitive agli innumerevoli problemi di un’epoca tanto complessa. A che pro la filosofia? A che cosa serve? Che cos’è?
Rispondere implica già accogliere una sfida subdola, accettando i presupposti impliciti nella domanda: cioè che la filosofia sia un mezzo utile a un fine. Eppure la sua inattualità, che la rende così attuale, sta proprio nel sottrarsi all’economia del profitto. In tal senso non servirà forse a nulla. Si potrebbe allora cancellarla con un colpo di spugna - il che poi vorrebbe dire rimuovere il cuore stesso della tradizione occidentale. Tuttavia la filosofia non è solo un patrimonio di testi. È molto di più. Chi non filosofa, senza dubbio vive, ma sminuita è la sua esistenza, compromessa la sua partecipazione alla politica.
- Il primo volume della collana sulla filosofia è dedicato a Socrate (qui la copertina)
Sin dai suoi esordi, nell’antica Grecia, la filosofia è stata chiamata a dimostrare il proprio diritto a esistere. Sennonché anche chi la contesta, chi ne mette in dubbio la legittimità, è già immerso nel movimento del pensiero, già filosofa. Ecco perché il ritornello sulla fine della filosofia è banale e vacuo. Certo nessuno immagina che possano ancora edificarsi quei sistemi che miravano a collegare tutto il sapere in un’immagine unitaria. L’impero hegeliano dello Spirito assoluto si è dissolto. Ma ciò non ha decretato la fine della riflessione. La filosofia non va e non viene, non finisce. Immanuel Kant parla di «attitudine naturale» dell’essere umano. Seppur inconsapevolmente, tutti filosofano. E già i bambini si interrogano sulla morte, sul futuro, sulla felicità. La filosofia non è una disciplina (sebbene sia stata in parte istituzionalizzata), non è un sapere specialistico, né un mestiere, né un’occupazione. Vaga qui e là, anche sulla pubblica piazza, in forme diverse; a volte sembra filosofia, e non lo è, altre volte non sembra, e invece lo è - i filosofi la riconoscono.
Si potrebbe dire con Heidegger che «filosofia è filosofare». Se solo alcuni hanno il particolare destino di risvegliare gli altri al pensiero, la filosofia, lungi dall’essere privilegio di pochi, tocca al fondo l’esistenza di ciascuno. Studiare i classici vuol dire anzitutto imparare a interrogarsi. Ciò che contraddistingue la filosofia è la domanda radicale, quella che va alle radici, che non chiede per sapere, ma che, anzi, mette in questione ogni sapere. Non vengono fornite soluzioni definitive. La filosofia non avrebbe altrimenti una storia dove, in forma sempre diversa, si ripropongono le questioni che la assillano: sulla verità, sul bene, sulla libertà. I problemi fondamentali della filosofia sono piuttosto aporie per cui non si danno soluzioni - né ottimali, né univoche, né definitive. Le risposte sono molteplici, le indicazioni differenti. Ecco perché i filosofi tornano ai testi di più di 2.000 anni fa - quelli di Eraclito, di Platone, di Aristotele - e li leggono come se fossero stati scritti ieri.
Sta qui una differenza decisiva rispetto alla scienza. Circoscritte a un ambito del sapere, le scienze non danno conto dei loro presupposti. Kant esorta a non confondere la filosofia con la matematica che, pure, è una costruzione concettuale. Ma già solo interrogandosi sullo statuto della matematica, la filosofia ne valica i limiti, va oltre l’ovvietà dei principi. Così ciò che per la scienza è fuori questione viene innalzato alla dignità della domanda filosofica.
Non c’è fenomeno che sfugga. Neppure il nulla. «Perché esiste qualcosa e non piuttosto il nulla?». Formulata da Leibniz, questa è la domanda esemplare della filosofia, che scaturisce dallo stupore, una passione inquieta. Ciò che per gli altri è ovvio, lampante, scontato, perde agli occhi del filosofo l’aura di solenne gravità che lo metterebbe al riparo dalla domanda. Tutto è esposto all’interrogare. Persino l’interrogante, il filosofo stesso, che viene così deposto dal suo pulpito.
D’altronde l’inizio aporetico della filosofia è il non-sapere di Socrate, che ha inaugurato la ricerca introspettiva, il «conosci te stesso». Stupore, ma anche struggimento e smania per l’irraggiungibile sophía.
LEGGI ANCHE
- L’ambizione d’insegnare a pensare. Socrate, coraggioso e antipatico di Mauro Bonazzi
- Il sapere è sempre un’ipotesi: scienza e filosofia lo hanno capito di Stefano Gattei
- La rivoluzione di Socrate: al centro l’essere umano di Luciano Canfora
Ed eccolo quel cittadino, così strambo e fuori-luogo, uno straniero in patria. Chi lo vede da lontano scappa; altri ostentano disprezzo, lo deridono. Socrate mette in dubbio le idee più correnti, non riconosce nessuna autorità, si fa beffe persino del démos sovrano. Soprattutto mostra ai propri concittadini che non sanno quel che pretendono di sapere. Che democrazia potrebbe mai essere la loro? Il risentimento è tale che si traduce nella condanna a morte di quel singolare cittadino che aveva osato, con il dialogo, fare dello stupore una pratica pubblica insinuando il dissenso già nell’anima altrui, prima ancora che nella comunità.
Da allora si è aperto un abisso tra la filosofia e la politica e la tensione non è mai venuta meno. In esilio nella città, quasi stranieri residenti, i filosofi hanno resistito per secoli e millenni, testimoni critici di una pólis altra e migliore. Così questi sublimi migranti del pensiero hanno saputo convertire la perdita irreparabile in una conquista a venire.
* Corriere della Sera, 28 aprile 2019 (ripresa parziale - senza immagini).
Sul tema, nel sito, si cfr.:
LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO.
AGONISMO TRAGICO: LE "REGOLE DEL GIOCO" DELL’OCCIDENTE E IL DIVENIRE ACCOGLIENTE DELLA MENTE
-
FILOSOFIA. IL PENSIERO DELLA COSTITUZIONE E LA COSTITUZIONE DEL PENSIERO
 MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA E A PENSARE BENE "DIO", "IO" E "L’ITALIA", CHI PIÙ CHI MENO, TUTTI VIVONO DENTRO LA PIÙ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA E POLITICA ITALIANA
MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA E A PENSARE BENE "DIO", "IO" E "L’ITALIA", CHI PIÙ CHI MENO, TUTTI VIVONO DENTRO LA PIÙ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA E POLITICA ITALIANA
CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- L’immaginario cattolico-imperiale. Il sogno di Napoleone: "l’archivio del mondo".13 aprile 2019, di Federico La Sala
"DUE SOLI" IN TERRA, E UN SOLO SOLE IN CIELO: "TRE SOLI".... *
Storia.
Il sogno di Napoleone: l’archivio dell’impero
Bonaparte aveva capito che, controllando la memoria dei popoli, li si teneva in pugno e si poteva scrivere la storia come prova della legittimità del proprio potere
di Edoardo Castagna (Avvenire, giovedì 11 aprile 2019)
- [Foto] Il ritratto di Napoleone dipinto da François Gerard François Daunou
Del saccheggio napoleonico di opere d’arte, con i lunghi strascichi relativi alle restituzioni o alle mancate restituzioni, molto si è scritto. Assai meno del saccheggio di uomini, della “carne da cannone” razziata come e più di quadri e statue in ogni angolo d’Europa, per finire seppellita tra le colline boeme o nelle steppe di Russia. Tutti iscritti all’anagrafe della storia come “francesi” sebbene in gran parte francesi non fossero affatto, come lo stesso Napoleone si premurò poi di rimarcare. Ma le appartenenze nazionali, così come le tradizioni storiche e le memorie collettive, si costruiscono. Ed è per questo che tra i tanti saccheggi napoleonici uno, perseguito con particolare tenacia, si concentrò sugli archivi delle varie capitali via via occupate e inglobate nell’Impero.
Vicenda meno nota di altre, ben ricostruita da Maria Pia Donato nel suo L’archivio del mondo. Quando Napoleone confiscò la storia (Laterza, pagine 170, euro 19,00). La sua versione dell’eterno sogno della biblioteca universale si declinò utilitaristicamente verso la condensazione sotto un unico controllo di quella che avrebbe dovuto essere la fonte primaria sia per la scrittura della storia nei secoli a venire, sia per la costruzione di una tradizione e di un’identità comune a tutta l’Europa posta sotto lo scettro di Napoleone, in ideale rimando all’unità medievale dei “due soli” a cui esplicitamente tale operazione si ispirò. Furono infatti la conquista, nel 1809, degli archivi del Sacro Romano Impero e del Papato a mettere in moto la macchina accentratrice dell’archivio dell’Impero.
Come in tante altre occasioni, la storia seguiva la propria strada indipendentemente dalla volontà degli uomini, tanto che l’idea di centralizzare gli archivi europei, sottolinea la Donato, seguì e non precedette l’inizio della sua realizzazione: il suo Napoleone è perfettamente tolstojano, in balìa di quegli stessi eventi epocali che si illude di governare. Stando al trattato con l’Austria nel 1809, avrebbero dovuto passare sotto controllo francese soltanto gli atti relativi ai territori ceduti agli occupanti: i quali invece, con militaresca ruvidità, prelevarono in blocco le carte conservate a Vienna, quali che fossero e di ogni epoca. Furono riempite oltre 2.500 casse, caricate sui carri e spedite a Parigi.
Simile fu la brutalità con la quale si procedette al- l’acquisizione degli archivi di Roma, il cui sequestro in realtà fu, almeno inizialmente, funzionale alla volontà di Napoleone di mettere sotto pressione il Papa: tanto che nel 1813, quando l’imperatore credette di averla spuntata su Pio VII, ordinò la restituzione delle carte. Per rimangiarsela, naturalmente, quando mutò nuovamente idea sul conto del Pontefice. Nel frattempo però, e anche in contraddizione con i tatticismi politici del momento, maturava in lui e nei suoi collaboratori «l’idea di creare un sito centrale della memoria per l’impero, anzi una grandiosa raccolta delle testimonianze scritte della civiltà», nota la Donato; via via furono acquisiti gli archivi olandesi, spagnoli, piemontesi, belgi, della galassia di staterelli tedeschi.
A sovrintendere al tutto fu l’archivista capo Pierre-Claude-François Daunou: ex prete, ex illuminista, ex fervente repubblicano, infine comodamente adagiato nell’ordine bonapartista (al quale peraltro sarebbe sopravvissuto). Nella sua opera trasfuse, al pari di quella contemporanea e simmetrica dei curatori del Louvre, del Jardin des plantes o della Biblioteca nazionale di Parigi, l’ideale e l’ambizione enciclopedici degli Idéologues illuministi. «Fu elaborata sul campo - nota la Donato - la dottrina che Édouard Pommier ha chiamato “la teoria del rimpatrio”, ossia l’idea che solo nella Francia rigenerata le opere delle scienze e delle arti avrebbero potuto sprigionare il loro potenziale di conoscenza ed emancipazione».
Daunou aveva ben servito Napoleone compilando un Saggio storico sul potere temporale dei papi tutto teso a mostrare le malefatte plurisecolari del Papato e le buone ragioni di un imperatore nel volerlo ridurre alla sua mercé; il Saggio venne ripetutamente riveduto e ampliato proprio grazie alle nuove fonti archivistiche divenute disponibili. Ma Daunou non era un mero cortigiano, anzi: nella sua opera di gran maestro dell’archivio napoleonico diede indubbie prove di capacità organizzative, di intelligenza pratica (fu l’inventore di quelle “schede”, uniformi per formato e ordine delle informazioni, divenute poi di uso universale fino all’avvento della digitalizzazione) e anche di un po’ di visionarietà.
Non ci fu il tempo di costruire l’immenso palazzo che avrebbe dovuto ospitare i Grandi Archivi, ma quello per affermarne la centralità storica sì: non solo, prosegue la Donato, «furono l’invenzione simbolica di un impero in cerca di radici», ma offrivano anche l’occasione di coltivare la storia pragmatica che era stata degli Idéologues. L’archivio serviva (anche) a scrivere la storia», e per questo esserne i controllori significava essere i controllori della memoria dei popoli. Nelle carte degli archivi si trovano i mattoni fondamentali per erigere quei monumenti umani collettivi che sono le identità naziona-li: una lezione, questa, che gli Stati- nazione che sarebbero sorti dopo il tramonto dell’età napoleonica, e che rientrarono in possesso dei rispettivi archivi, avrebbero ben messo a frutto.
*
Sul tema, nel sito, si cfr.:
DANTE, ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. Note per una riflessione storiografica
- "DUE SOLI" IN TERRA, E UN SOLO SOLE IN CIELO: "TRE SOLI". GENERE UMANO: I SOGGETTI SONO DUE, E TUTTO E’ DA RIPENSARE!!! NON SOLO SUL PIANO TEOLOGICO-POLITICO, MA ANCHE ... ANTROPOLOGICO!!!
- LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE, E IL VATICANO CON IL SUO TRADIZIONALE SOFISMA DELLA "FALLACIA ACCIDENTIS".
- COSTANTINO, SANT’ELENA, E NAPOLEONE. L’immaginario del cattolicesimo romano.
DANTE ALIGHIERI (1265-1321)!!! LA LINGUA D’AMORE: UNA NUOVA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO. CON MARX E FREUD. Una "ipotesi di rilettura della DIVINA COMMEDIA" -Nel 200° anniversario della pubblicazione della "Fenomenologia dello Spirito" di Hegel (1807)
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! - FILOSOFIA E LETTERATURA: ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA.10 aprile 2019, di Federico La Sala
DOPO “VENTICINCINQUE SECOLI” DI LETTERATURA: ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA ....
Tre note... *
A) - EUROPA, STRASBURGO 1770: CON “MARIA ANTONIETTA” IN VIAGGIO PER VERSAILLES.
Nel 1770 a Strasburgo, nei pressi del confine del Sacro Romano Impero con la Francia, Goethe “guarda un arazzo che narra le storie di Giasone, di Medea e di Creusa”, preparato “per le feste in onore dell’arrivo della sposa” di Luigi XVI di Borbone, Maria Antonietta d’Asburgo-Lorena che si stava trasferendo a Versailles, e così commenta: «dunque un esempio del più infelice matrimonio»!
Goethe mostra di avere una conoscenza superficiale della leggenda di Giasone, e della sua nave Argo, e del come e del perché sia arrivata proprio lì, sulle sponde del Reno, in quell’ambiente e per quella occasione, e, colpito, ne resta segnato per moltissimi anni: “era «estremamente» indignato dalla scelta e glien’è restato - commenta Curtius - il ricordo se dopo quarant’anni lo ritiene ancora degno di esser raccontato (Dichtung und Warheit, II, 9)”.
Nel 1950, Ernst R. Curtius, che ha già pubblicato nel 1947 “Letteratura europea e Medio Evo latino”, in un saggio intitolato “La nave degli argonauti” (cfr. Id.,“Letteratura della letteratura”, Saggi critici a cura di Lea Ritter Santini, Bologna 1984, pp. 301-325), quasi a conclusione, dopo aver ricordato che per Dante “il viaggio di Giasone è la più stupefacente impresa di tutti i tempi” e premesso che “il pensiero storico di Dante ha bisogno di prospettive millenarie - come quello di Goethe,” così prosegue e commenta: “A guardarlo oggi, Goethe si avvicina sempre più a Dante, e non solo nel tempo. Come Dante, anche egli rappresentò ancora una volta il Thesaurus della tradizione europea. Anche in lui troviamo il mito degli Argonauti”.
Curtius cosa sta cercando di dire - e di fare con le parole, con queste parole? Cambiata di segno, la sua affermazione appare essere una forma di sollecitazione subliminale volta ad avvicinare sempre più Goethe a Dante, sino a portarci a pensare: «dunque un esempio del più felice “matrimonio”»! Ma qualcosa resiste, sia nella memoria di Goethe sia di Curtius e fa emergere un non-detto del messaggio. Un’ipotesi: forse, e per caso, sono le stesse parole “sussurrate” al cuore e alla mente di Maria Antonietta dalla madre, l’Imperatrice Maria Teresa d’Austria, al momento del suo trasferimento a Parigi: «Rimanete una buona tedesca!», «Rimanete un buon tedesco!»?!
Incredibilmente Curtius - pur sapendo che “Giasone, nel XVIII canto dell’Inferno, compare fra i seduttori e Virgilio glielo presenta con ammirazione”, che “la nobile e bella figura giovanile di Giasone era già piaciuta ad Ovidio” e, ancora, che “Dante va oltre” lo stesso Ovidio e gli attribuisce “i tratti dell’eroe ideale” riservati “ai suoi prediletti” - fa sua la maschera di Goethe (“Der Bautigam” è il titolo di una sua poesia del 1829), divenuto egli stesso un Argonauta (“Linceo è l’Antifaust, Linceo è Goethe, l’argonauta trasformato”) e, nel tentativo di avvicinarsi “sempre più a Dante”, ricorda più il Thesaurus (il “Tresor” e il “Tesoretto”) della tradizione di Brunetto Latini, che quello della “Divina Commedia”, della nuova Argo, la nave del viaggio terrestre e celeste di Dante - più il Vitello (“T-aurus”) d’oro della tradizione egiziana, che il Vello d’oro dell’Ariete di Giasone e del Vello d’oro dell’Agnello di Dante. Che cagliostrosità!
Dopo i “venticinque secoli a la ‘mpresa” di Giasone (Dante, Par., XXXIII, 95), Curtius - ipnotizzato dalla magia di Goethe, che “scherzando” si autodefiniva “un Argonauta”, prende la sua maschera tratta fuori “dall’esatta descrizione storica dei mitologi”, e fa suo “il suo testamento. In ogni età c‘è una Argo, come aveva predetto Virgilio: «Ci saranno ancora un altro Tifi e un’altra Argo a trasportare eroi eletti»”.
Ma per quale destinazione?! Ancora e sempre per Versailles?!
Non è meglio uscire dal “letargo”, svegliarsi dal “sonno dogmatico”, e uscire “a rivedere le stelle”?!
B) - L’EUROPA, DOPO “VENTICINCINQUE SECOLI” DI LETTERATURA.
A commento dei “tratti dell’eroe ideale”, attribuiti da Dante a Giasone, in nota, Curtius] così scrive: “Una anticipazione del romanticismo burgundo che circonda Giasone. Filippo il Buono di Borgogna sposò nel 1430 Isabella del Portogallo. In questa occasione - o forse quale omaggio alla popolazione di allora, stupenda nel navigare - fondò l’ordine del Toson d’Oro. I suoi protettori erano Giasone e Gedeone. Anche nella loro storia un vello miracoloso aveva avuto la sua parte (Libro dei Giudici, IV, 36-40). Un auto sacramentale di Calderón si intitola La Piel de Gedeon (1650), stampato nella edizione di Pando y Mier (1717), vol. III; in tedesco in F. Lorinser: Calderóns geistliche Festpiele, vol IX. Sul romanticismo di Giasone: v. Georges Doutrepont, La Littérature Française à la Cour des Ducs de Bourgogne, 1909, pp. 147-176” (cfr. Ernst R. Curtius, Letteratura della letteratura..., op. cit., pp. 317-318).
Benché nella “Letteratura europea” (1947) abbia citato il lavoro dello storico olandese Johan Huizinga (morto nel 1945), in particolare l’opera “L’autunno del Medio Evo” (del 1919), una straordinaria lettura del “secolo della Borgogna”, ove si racconta diffusamente di “ordini e voti cavallereschi”, della nascita dell’ordine del Toson d’oro, ecc - ora, qui, nel saggio “La nave degli Argonauti” (1950), Curtius non ne fa alcun cenno; e, addirittura, delle opere di Calderón cita solo “La Piel de Gedeon” (ma non “El divino Jasón”, “El divino Orfeo”, “El Laberinto del Mundo”, ecc.)!
Cosa è successo?! La “maschera” di Goethe, forse, gli ha giocato giocato un brutto scherzo e lo ha costretto a rimettersi nei panni di Faust? Incredibilmente, già in “Letteratura europea e Medio Evo Latino”, dato per valido il calcolo dei “venticinque secoli” di Dante dall’impresa di Giasone (Par., XXXIII, 95), tre anni prima (1947), egli aveva già scritto: “La letteratura europea abbraccia il medesimo periodo di tempo della cultura europea, comprende cioè circa ventisei secoli (calcolati da Omero a Goethe” (p. 20).
Che dire? Davvero “Goethe si avvicina sempre più a Dante”?! Boh?! Bah!
C) - CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. A che gioco giochiamo?!
Nel 1929, in un breve saggio dedicato a "Hugo Hofmannsthal. In memoriam" (op. cit., pp. 165-176), Curtius scrive: "La regalità era la figurazione più interiore nel rapporto tra Hofmannsthal e il mondo. La funzione di poeta non era per lui che una delle forme in cui essa si manifestava [...] tutte le opere di Hofmannsthal tendono verso la forma ideale di un theatrum mundi, un poema cosmico allegorico-simbolico che eleva il caso dell’esistenza all’ordine delle grandi leggi, che nel temporale, fanno apparire l’eterno. L’allegoria non è qui indebolita ricchezza di vita e la maschera non è apparenza, al contrario, soltanto quando riusciamo a vedere la deformazione, la maschera della nostra esistenza, ne comprendiamo il senso e la verità più profonda".
E poco oltre, condividendo il programma e lo spirito della sua “rivoluzione conservatrice”, così prosegue : "La nostra poesia ha molto sentimento del mondo (Weltgefuhl), ma poco mondo: ha molte visioni del mondo (Weltanschauungen), ma mediocre ne è la sua conoscenza. In Goethe esisteva la possibilità di unire i due aspetti e ristabilire le giuste proporzioni. Ha dovuto condurre il suo Faust alla corte dell’imperatore: era anzi ancora legato all’impero e colorate feste d’incoronazione avevano illuminato la sua infanzia. Non ha sentito più battere il cuore dell’impero [...] L’orizzonte universale del vecchio impero asburgico era stato dato in eredità a Hofmannsthal. Vienna e Madrid non ne facevano meno parte [...]". E, così chiude: “Hofmannsthal ha raccolto nel suo tesoro reale, i beni più preziosi del linguaggio e dell’anima dei paesi latini: noi lo conserviamo come la sua eredità, come «munus Austriacum»”.
Nel 1932 fa il passo “decisivo”: pubblica “Deutscher Geist in Gefahr “ (“Lo spirito tedesco in pericolo”), un libro (una raccolta di articoli di quegli anni), e nella postfazione, confidando nella “metafisica dello spirito”, chiude con il richiamo al “Veni creator spiritus” - “l’inno del franco-renano Rabano Mauro” (“Mille anni più tardi un altro franco-renano, Goethe, ha tradotto questo “splendido canto religioso” e lo ha definito un “appello al genio”) - e con l’auspicio che “sotto questo segno la fede nella Germania e la fede nello spirito possono trovarsi legate e confermate” (cfr. Ernst R. Curtius, “Lo spirito tedesco in pericolo”, in Annamaria Bercini, “Il discorso politico culturale del «Deutscher Geist in Gefahr» di Ernst Robert Curtius”, Bologna 2015)
Le illusioni di Curtius di diventare una guida spirituale della “rivoluzione conservatrice” sono infondate e vengono spazzate via in un baleno: “Il 24 marzo del 1933, subito dopo l’ascesa al Reichstag di Hitler, sul Beiblatt del «Völkischer Beobachter», il giornale ufficiale del partito nazista sin dal 1920, comparve un durissimo articolo di Hermann Sauter (che di lì a qualche anno diverrà direttore della Stadtbibliothek di Monaco), Deutscher Geist in Gefahr? , che era in effetti una stroncatura senza appello del libro di Curtius. L’assenso di Curtius alla missione tedesca è, come si può vedere, in realtà una negazione del nuovo, potente volere tedesco. Ma questo è il nostro credo: che il vero spirito tedesco otterrà nuovamente onore, e sarà capace di avere valenza mondiale, quando sarà ripulito dal peso accumulato nella cosiddetta libertà spirituale del decennio passato. Sauter concludeva con quello che appare un vero avvertimento da mafioso. Curtius può avere ancora un ruolo importante nella nuova Germania, ma a patto di non tentare più di fare il Kulturpolitiker, perché non capisce nulla dei fondamenti autentici - cioè biologici - della cultura tedesca.” (cfr. Carlo Donà, “Lo spirito tedesco e la crisi della mezza età: «Deutscher Geist in Gefahr» (1932)” ).
Dopo la catastrofe della Germania del “Terzo Reich”, Curtius ancora non capisce: continua il suo “sogno” calderonico e la “vacanza” nel suo “illuminato” (contro e) pre-illuministico “stato di minorità” (I. Kant, 1784). E nel 1947, come se niente fosse successo, alla fine del primo capitolo di “Letteratura europea Medio Evo latino”, intitolato “Letteratura europea”, con un “occhiolino” a Benedetto Croce (e alla memoria di Hegel), riprende il lavoro per il “nuovo ordine culturale”, già proposto nel “Deutscher Geist in Gefahr” del 1932, e ricomincia: “Della letteratura europea l’eroe fondatore (heros ktistes) è Omero, l’ultimo autore universale è Goethe. Ciò che questi rappresenta per la Germania lo ha riassunto Hofmannsthal [...] La letteratura del secolo XIX e dell’inizio del XX non è stata ancora scandagliata, in essa non è stato ancora distinto ciò che è vivo e ciò che è morto. Ciò potrà dare materia per molte dissertazioni, la parola decisiva sarà però pronunciata non dalla storia della letteratura, ma dalla critica letteraria. Per questo compito noi, in Germania, abbiamo Friedrich Schlegel - e seguaci” (op. cit., p. 24)!
Purtroppo, per Curtius, che è vissuto e cresciuto all’interno di coordinate storico-culturali da Sacro Impero (romano, spagnolo, e germanico), e nelle cui orecchie risuona ancora l’ordine dato a Maria Antonietta dalla Madre-Imperatrice (“Rimanete un buon tedesco!”), “la vita è sogno” e non c’e alcuna possibilità di riconsiderare critica-mente né il lavoro di Ernst H. Kantorowicz (anch’egli vicino al “cerchio” di Stefan George) sulla figura dell’Imperatore Federico II (1927/1931), né tantomeno “l’autunno del Medio Evo”, il “declino del simbolismo” e la lezione su Dante di Johan Huizinga ("L’autunno del Medio Evo" [1919, 1921, 1928]): “[...] per indicare il rapporto fra l’autorità spirituale e quella temporale il Medioevo si serviva costantemente di due similitudini simboliche [...] La forza del simbolo è tale da intralciare l’indagine sullo sviluppo storico dei due poteri. Dante, avendo riconosciuto la necessità e il valore decisivo di tale indagine, si vede costretto, nel suo Monarchia, a spezzare prima la forza del simbolo, contestando la sua applicabilità, ed aprendosi così la strada alla ricerca storica".
La totale incomprensione del “relazionismo” proposto da Karl Mannheim in “Ideologia e Utopia” (1929), esaminato e rigettato nel capitolo quarto dello “Spirito tedesco in pericolo”, impedisce a Curtius di aprire gli occhi su stesso e sul mondo, di uscire dal relativismo-assolutismo dogmatico in cui naviga, e di smetterla di sognare il “sogno dei visionari” (sul tema, mi sia lecito, cfr.: “Heidegger, Kant, e la miseria della filosofia - oggi”).
“Sogno o son desto?”: a che gioco si continua a giocare? Non è meglio cambiare gioco!? Per l’Europa - e per l’intero Pianeta? Boh? e bah!?
*
- Riprendo qui tre note allegate all’articolo di Paolo Fabbri, "Marcel Detienne: memorie felici e concetti indelebili", apparso su "Alfabeta-2", 31.03.2019).
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- Marcel Detienne: memorie felici e concetti indelebili (di Paolo Fabbri).2 aprile 2019, di Federico La Sala
A un grande ellenista che non studiava i Greci, ma voleva pensare con loro... *
Marcel Detienne: memorie felici e concetti indelebili
di Paolo Fabbri (Alfabeta, 31.03.2019).
La memoria è ospite del tempo. Viene ricevuta come lui crede e lo accoglie a modo suo. Di Marcel Detienne, da poco mancato, ho il ricordo a breve termine di qualche momento felice e di alcuni concetti indelebili.
Tra i primi, i soggiorni di ricerca sulla mitologia al Centro internazionale di semiotica e Linguistica di Urbino; la convivenza dei semiologi di A. J. Greimas e gli ellenisti di J. P. Vernant e P. Vidal Naquet al numero 10 rue m. le Prince, Parigi; un memorabile pranzo nella sua casa nella foresta di Fontainebleau, fino ai corsi dell’Escorial in Spagna, dove assistemmo, con Giulia Sissa, a un incontro di Sumo!
Ricordo infine la dichiarazione di Roland Barthes nella presentazione di una conferenza all’insegnamento del Collège de France: “un grand homme!”
Un grande ellenista infatti che non studiava i Greci, ma voleva pensare con loro. Non condivideva il tacito assunto dell’umanesimo occidentale, che fa della Grecia classica la referenza originale di valori senza tempo, misura metaculturale di ogni civiltà. Sulla scorta dello strutturalismo levi-straussiano, voleva distogliere l’occhio fisso dei filologi ellenisti (“tra i filologi c’è chi pensa e che se ne dispensa”) per indirizzarlo in una prospettiva comparativa e iscriverne la tradizione in un progetto antropologico sperimentale e costruttivo. Ad esempio, per spiegare la cosiddetta invenzione della democrazia, comparare l’esperienza italiana dei comuni medioevali e alcune comunità etiopi!
Il “dovere di comparatismo” descritto nel libro mastro Noi e i Greci, Cortina 2007, non è quello della forma originaria di un etimo con successive alterazioni, ma la ricerca della configurazione che prende un concetto una volta inserito in un corpus di culture altre. Un esperimento mentale ed empirico di laboratorio nel tessuto incessantemente ordito del politeismo per riconoscere, nel confronto delle loro filosofie implicite, l’originalità, i saperi taciti o l’impensato della Grecia classica. A questo scopo ha aperto i dossier sulla terra; sulla guerra e la caccia - che permettono l’elaborazione della metis, l’intelligenza scaltra - e soprattutto sulla scrittura, la cui invenzione era delegata a un personaggio minore, Palamede, facile vittima del versatile Ulisse.
Il confronto interculturale e l’approccio etnografico ha suscitato tenaci resistenze in luoghi recintati (“i greci non sono dei selvaggi come gli altri!”), ha permesso però a Detienne di rivedere pratiche inveterate come l’etimologia, i racconti scontati e molti concetti disciplinari “chiavi in mano”. Per lui erano centrali i rapporti tra Mito e Pensiero; Oralità e Scrittura; Filosofia e Saggezza, in rapporto alla Verità; Origine Politica e appunto, Invenzione della Democrazia.
Ne ho mandato a mente - ma preferisco il francese par coeur, - alcuni aspetti, a cui tengo e che mantengo.
In primo luogo la sua Archeologia della Verità che nel rapporto tra religione e filosofia e sofistica traccia una genealogia diversa dal logos ermeneutico e dai filosofemi heideggeriani. (“la verità epica è un oggetto culturale, non un concetto filosofico”). Nella introduzione del 1994 al suo I maestri di verità nella Grecia arcaica, Mondadori 1992, Detienne ricapitola un’epistemografia che va dalla parola sacra ed efficace del poeta, del veggente e del re fino a alla retorica laicizzata e il dibattito argomentato. Dal contarla - e cantarla - giusta al dimostrarla vera.
Quanto al Mito, oltre a Dumézil e Lévi- Strauss, è stata la ricerca insistente di Detienne a darne un’ immagine inedita e una nuova base di studi. Non ne ha cercato il senso all’interno o in allegorie esterne e neppure nell’inesprimibile che la ragione non riesce a formulare. E non lo ha studiato nel solo genere biografico degli dei e degli eroi: ha preferito riscrivere l’opposizione ottocentesca tra apollineo e dionisiaco fi cui ha ridefinito i tratti distintivi. L’energia vulcanica degli umori vitali di Dioniso e i suoi celesti misteri e l’arte troppo umana con cui Apollo dà forma, cioè taglia per fondare ed per escludere; il “Bell’ Omicida”, obliquo e agente epidemico, crea infatti e recide. (Apollo con il coltello in mano. Un approccio sperimentale al politeismo greco, Adelphi 2002)
È il concetto di Autoctonia, antica e moderna, che ha occupato gli ultimi anni dell’antropologo (Essere autoctoni. Come denazionalizzare le storie nazionali, Sansoni 2004). Un problema politico che Heidegger aveva evitato attribuendo a “polis” la falsa etimologia di “essere”. Per Detienne non c’era autoctonia in Atene e in Roma, e il concetto è l’esempio d’una “mitideologia” impiegata nella costruzione dei nazionalismi passati e, purtroppo, presenti e futuri. Il suo libro ha come sottotitolo “dal puro ateniese al francese radicato”. Uno studio rigoroso del discorso nazionalista e della sua semiurgia che investe i vaneggiamenti celtici della Lega italiana e l’immaginario sciovinista dell’accademia storica francese, che il belga Detienne trattava da “clero dell’Esagono” e in cui includeva horribile dictu! l’intoccabile F. Braudel. Per fare una nazione, motteggiava, bastano i cimiteri e degli storici inventori di tradizione.
Nella temperie attuale, che dibatte sui diritti d’asilo, e gli ius soli o sanguinis, queste pagine meritano orecchie. A Detienne fruttarono dopo lo spostamento dall’ EPHE alla Johns Hopkins di Baltimora una tenace ripulsa accademica.
La categorie epistemiche, come semplicità, coerenza, rigore ecc. sono anche virtù caratteriali dei ricercatori. Detienne era graffiante come la sua scrittura e la sua grafia. Gli era congeniale prestare l’orecchio alla “musica della dissonanza”. Fare la scelta di “di privilegiare le figure di rottura e di trasformazione radicale”. Radicalizzare strutturalmente le differenze. Non gli garbavano quanti indossavano “le tee-short con la scritta post-strutturalisti”.
Non saprei come dargli torto, io, semiologo, che gli devo la interdefinizione del sema: poros e del tekmor, nelle due accezioni di senso: quella estensiva della morfologia e quella intensiva della direzione. E la divertita scoperta che nella Grecia della geometria e della logica, le dicerie avevamo una loro dea, Femé.
I miei ricordi personali si assumono l’ovvia responsabilità del silenzio e dell’oblio che sono l’ombra inseparabile della memoria. Ci penserà la storia che della memoria è nemica giurata.
*
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- MITO, FILOSOFIA, E TESSITURA: "LA VOCE DELLA SPOLETTA È NOSTRA" ("The Voice of the Shuttle is Ours"). Un testo di Patricia Klindienst
HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI.
"CHI" SIAMO NOI, IN REALTÀ. RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- BREXIT E COSTITUZIONE. Al di là della "Schadenfreude" momentanea, qualcuno pensa che sia un problema solo britannico? (di Francesco Palermo).1 aprile 2019, di Federico La Sala
Brexit, le costituzioni e la tigre della sovranità popolare
di Francesco Palermo (Il Mulino, 28 marzo 2019)
Il termine tedesco Schadenfreude indica la sensazione di piacere che si può provare quando a qualcuno vanno male le cose. Rallegrarsi delle disgrazie altrui, tuttavia, non solo è un sentimento negativo, ma può essere controproducente, giacché in un mondo interconnesso le sciagure altrui finiscono rapidamente per essere anche nostre. Di certo può essere un divertente e sottilmente perfido esercizio pensare a cosa avrebbe detto il mondo intero se il cortocircuito istituzionale sulla Brexit, che sta paralizzando da tre anni il Regno Unito, si fosse realizzato in Italia... Finita però la soddisfazione per lo scampato pericolo, e non potendo prevedere gli esiti di un processo nel quale la realtà supera quotidianamente la fantasia, si possono comunque avanzare un paio di riflessioni di sistema su questioni che riguardano non solo il Regno Unito, ma tutta Europa e forse tutto il mondo. Questioni sulle quali c’è poco da ridere, come sulle disgrazie altrui.
La prima è che la costituzione più antica e solida del mondo, l’unica talmente resistente da non avere avuto nemmeno bisogno di essere messa interamente nero su bianco in un unico documento, è rapidamente diventata troppo vecchia per stare al passo con la storia. I segnali ci sono già da almeno un paio di decenni (che comunque in termini di storia costituzionale britannica sono un batter di ciglia), e i vari tentativi di manutenzione che si sono susseguiti hanno solo mascherato e leggermente ritardato il declino.
Come talvolta capita alle persone anziane, che quasi all’improvviso passano da una buona forma alla condizione di moribondi, la costituzione britannica si è scoperta non più in grado di reggere le sfide della complessità moderna. Il meccanismo basato sull’onnipotenza del Parlamento, o meglio della sua maggioranza pro tempore, è andato in crisi di fronte ai paradossi delle decisioni a maggioranza. Non tutto può essere disponibile per le maggioranze parlamentari e dunque per i governi, e secoli di costituzionalismo, in buona parte nato proprio in Gran Bretagna, hanno insegnato che non basta confidare sulla responsabilità delle maggioranze, ma occorrono degli argini al loro potere.
Problema britannico si dirà? Niente affatto. Il problema è del mondo intero, perché in tempi burrascosi e difficili servono barche solide per non affondare. La costituzione britannica, a lungo vittoriosa come la flotta di Sua Maestà, si è mostrata troppo semplice e fragile nel momento in cui c’è bisogno di strumenti tecnici più sofisticati. Navigare ancora con un galeone del Settecento, per quanto straordinario fosse per quei tempi, non è consigliabile al giorno d’oggi. Mutatis mutandis vale per tutte le costituzioni: il loro mancato adeguamento tecnico le rende facilmente obsolete.
La seconda riflessione riguarda il cortocircuito del sistema decisionale. Quando la politica non è più in grado di assumere decisioni complesse, le scarica sulla popolazione. Pensando di trarne legittimità, finisce invece in un vicolo cieco. Poteva accadere col referendum sull’indipendenza della Scozia nel 2014. Ma siccome il giochino è sembrato funzionare, l’allora Primo Ministro David Cameron l’ha rifatto tale e quale con la Brexit. E gli è andata male.
Oggi, a fronte della paralisi istituzionale che si è creata, alcuni britannici e molti più europei suggeriscono l’idea di un secondo referendum. Che sarebbe un’idea più stupida della prima. Se anche i rapporti si ribaltassero, e il 52% fosse ora a favore della permanenza nell’Unione europea, cosa cambierebbe? Avremmo due risultati contraddittori presi in momenti diversi. La popolazione resterebbe spaccata e la politica ancora più confusa. E comunque non succederà, perché la tigre della sovranità popolare è già stata liberata, ha disarcionato chi provava a cavalcarla e ora ha reso prigionieri i suoi carcerieri. Quando May ripete che il popolo si è espresso e lei deve dare esecuzione alla volontà popolare dimostra tutta la debolezza del processo politico. E la dimostra proprio perché ha ragione: non ha più alternative, ormai è tardi, e un secondo referendum farebbe altri danni oltre a quelli già fatti dal primo.
Resta il problema di come decidere in contesti altamente complessi come questi. E anche il rischio che i processi decisionali siano lunghi nei tempi e insoddisfacenti nei risultati. Vero. Ma è esattamente quanto sta accadendo con la Brexit. Occorre accettare che servono freni alle maggioranze, invece di provare ad approfittare dell’effimera maggioranza del momento, chiunque l’abbia in mano. Questi freni si chiamano costituzioni. E vanno adeguati alla velocità e ai materiali moderni. Al di là della Schadenfreude momentanea, qualcuno pensa che sia un problema solo britannico?
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- LA FENOMENOLOGIA "DELLO SPIRITO DI FAMIGLIA"!!! La lezione di Cesare Beccaria30 marzo 2019, di Federico La Sala
DELLO SPIRITO DI FAMIGLIA. Il cap. XXVI del "DEI DELITTI E DELLE PENE"
di Cesare Beccaria*
Queste funeste ed autorizzate ingiustizie furono approvate dagli uomini anche piú illuminati, ed esercitate dalle repubbliche piú libere, per aver considerato piuttosto la società come un’unione di famiglie che come un’unione di uomini. Vi siano cento mila uomini, o sia ventimila famiglie, ciascuna delle quali è composta di cinque persone, compresovi il capo che la rappresenta: se l’associazione è fatta per le famiglie, vi saranno ventimila uomini e ottanta mila schiavi; se l’associazione è di uomini, vi saranno cento mila cittadini e nessuno schiavo.
 Nel primo caso vi sarà una repubblica, e ventimila piccole monarchie che la compongono; nel secondo lo spirito repubblicano non solo spirerà nelle piazze e nelle adunanze della nazione, ma anche nelle domestiche mura, dove sta gran parte della felicità o della miseria degli uomini. Nel primo caso, come le leggi ed i costumi sonol’effetto dei sentimenti abituali dei membri della repubblica, o sia dei capi della famiglia, lo spirito monarchico s’introdurrà a poco a poco nella repubblica medesima; ei di lui effetti saranno frenati soltanto dagl’interessi opposti di ciascuno, ma non già da un sentimento spirante libertà ed uguaglianza.
Nel primo caso vi sarà una repubblica, e ventimila piccole monarchie che la compongono; nel secondo lo spirito repubblicano non solo spirerà nelle piazze e nelle adunanze della nazione, ma anche nelle domestiche mura, dove sta gran parte della felicità o della miseria degli uomini. Nel primo caso, come le leggi ed i costumi sonol’effetto dei sentimenti abituali dei membri della repubblica, o sia dei capi della famiglia, lo spirito monarchico s’introdurrà a poco a poco nella repubblica medesima; ei di lui effetti saranno frenati soltanto dagl’interessi opposti di ciascuno, ma non già da un sentimento spirante libertà ed uguaglianza.
 Lo spirito di famiglia è uno spirito di dettaglio e limitato a’ piccoli fatti. Lo spirito regolatore delle repubbliche, padrone dei principii generali, vede i fatti e gli condensa nelle classi principali ed importanti al bene della maggior parte. Nella repubblica di famiglie i figli rimangono nella potestà del capo, finché vive, e sono costretti ad aspettare dalla di lui morte una esistenza dipendente dalle sole leggi. Avezzi a piegare e da temere nell’età piú verde e vigorosa, quando i sentimenti son meno modificati da quel timore di esperienza che chiamasi moderazione, come resisteranno essi agli ostacoli che il vizio sempre oppone alla virtú nella lan-guida e cadente età, in cui anche la disperazione di vederne i frutti si oppone ai vigorosi cambiamenti?
Lo spirito di famiglia è uno spirito di dettaglio e limitato a’ piccoli fatti. Lo spirito regolatore delle repubbliche, padrone dei principii generali, vede i fatti e gli condensa nelle classi principali ed importanti al bene della maggior parte. Nella repubblica di famiglie i figli rimangono nella potestà del capo, finché vive, e sono costretti ad aspettare dalla di lui morte una esistenza dipendente dalle sole leggi. Avezzi a piegare e da temere nell’età piú verde e vigorosa, quando i sentimenti son meno modificati da quel timore di esperienza che chiamasi moderazione, come resisteranno essi agli ostacoli che il vizio sempre oppone alla virtú nella lan-guida e cadente età, in cui anche la disperazione di vederne i frutti si oppone ai vigorosi cambiamenti?
 Quando la repubblica è di uomini, la famiglia non è una subordinazione di comando, ma di contratto, e i figli, quando l’età gli trae dalla dipendenza di natura, cheè quella della debolezza e del bisogno di educazione e didifesa, diventano liberi membri della città, e si assoggettano al capo di famiglia, per parteciparne i vantaggi, come gli uomini liberi nella grande società.
Quando la repubblica è di uomini, la famiglia non è una subordinazione di comando, ma di contratto, e i figli, quando l’età gli trae dalla dipendenza di natura, cheè quella della debolezza e del bisogno di educazione e didifesa, diventano liberi membri della città, e si assoggettano al capo di famiglia, per parteciparne i vantaggi, come gli uomini liberi nella grande società.
 Nel primo caso i figli, cioè la piú gran parte e la piú utile della nazione, sono alla discrezione dei padri, nel secondo non sussiste altro legame comandato che quel sacro ed inviolabile di somministrarci reciprocamente i necessari soccorsi, e quello della gratitudine per i benefici ricevuti, il quale non è tanto distrutto dalla malizia del cuore umano,quanto da una mal intesa soggezione voluta dalle leggi. Tali contradizioni fralle leggi di famiglia e le fondamentali della repubblica sono una feconda sorgente di altre contradizioni fralla morale domestica e la pubblica, e però fanno nascere un perpetuo conflitto nell’animo di ciascun uomo.
Nel primo caso i figli, cioè la piú gran parte e la piú utile della nazione, sono alla discrezione dei padri, nel secondo non sussiste altro legame comandato che quel sacro ed inviolabile di somministrarci reciprocamente i necessari soccorsi, e quello della gratitudine per i benefici ricevuti, il quale non è tanto distrutto dalla malizia del cuore umano,quanto da una mal intesa soggezione voluta dalle leggi. Tali contradizioni fralle leggi di famiglia e le fondamentali della repubblica sono una feconda sorgente di altre contradizioni fralla morale domestica e la pubblica, e però fanno nascere un perpetuo conflitto nell’animo di ciascun uomo.
 La prima inspira soggezione e timore, la seconda coraggio e libertà; quella insegna a ristringere la beneficenza ad un piccol numero di persone senza spontanea scelta, questa a stenderla ad ogni classe di uomini; quella comanda un continuo sacrificio di se stesso a un idolo vano, che si chiama bene di famiglia, che spesse volte non è il bene d’alcuno che la compone; questa insegna di servire ai propri vantaggi senza offendere le leggi, o eccita ad immolarsi alla patria col premio del fanatismo, che previene l’azione. Tali contrasti fanno chegli uomini si sdegnino a seguire la virtú che trovano inviluppata e confusa, e in quella lontananza che nasce dall’oscurità degli oggetti sí fisici che morali. Quante volte un uomo, rivolgendosi alle sue azioni passate, resta attonito di trovarsi malonesto!
La prima inspira soggezione e timore, la seconda coraggio e libertà; quella insegna a ristringere la beneficenza ad un piccol numero di persone senza spontanea scelta, questa a stenderla ad ogni classe di uomini; quella comanda un continuo sacrificio di se stesso a un idolo vano, che si chiama bene di famiglia, che spesse volte non è il bene d’alcuno che la compone; questa insegna di servire ai propri vantaggi senza offendere le leggi, o eccita ad immolarsi alla patria col premio del fanatismo, che previene l’azione. Tali contrasti fanno chegli uomini si sdegnino a seguire la virtú che trovano inviluppata e confusa, e in quella lontananza che nasce dall’oscurità degli oggetti sí fisici che morali. Quante volte un uomo, rivolgendosi alle sue azioni passate, resta attonito di trovarsi malonesto!
 A misura che la società si moltiplica, ciascun membro diviene piú piccola parte del tutto, e il sentimento repubblicano si sminuisce proporzionalmente, se cura non è delle leggi di rinforzarlo. Le società hanno come i corpi umani i loro limiti circonscritti, al di là de’ quali crescendo, l’economia ne è necessariamente disturbata. Sembra che la massa di uno stato debba essere in ragione inversa della sensibilità di chi lo compone, altrimenti, crescendo l’una e l’altra, le buone leggi troverebbono nel prevenire i delitti un ostacolo nel bene medesimo che hanno prodotto.
A misura che la società si moltiplica, ciascun membro diviene piú piccola parte del tutto, e il sentimento repubblicano si sminuisce proporzionalmente, se cura non è delle leggi di rinforzarlo. Le società hanno come i corpi umani i loro limiti circonscritti, al di là de’ quali crescendo, l’economia ne è necessariamente disturbata. Sembra che la massa di uno stato debba essere in ragione inversa della sensibilità di chi lo compone, altrimenti, crescendo l’una e l’altra, le buone leggi troverebbono nel prevenire i delitti un ostacolo nel bene medesimo che hanno prodotto.
 Una repubblica troppo vasta non si salva dal dispotismo che col sottodividersi e unirsi in tante repubbliche federative. Ma come ottener questo? Da un dittatore dispotico che abbia il coraggio di Silla, e tanto genio d’edificare quant’egli n’ebbe per distruggere. Un tal uomo, se sarà ambizioso, la gloria di tutt’i secoli lo aspetta, se sarà filosofo, le benedizioni de’ suoi cittadini lo consoleranno della perdita dell’autorità, quando pure non divenisse indifferente alla loro ingratitudine. A misura che i sentimenti che ci uniscono alla nazione s’indeboliscono, si rinforzano i sentimenti per gli oggetti che ci circondano,e però sotto il dispotismo piú forte le amicizie sono piú durevoli, e le virtú sempre mediocri di famiglia sono le piú comuni o piuttosto le sole. Da ciò può ciascuno vedere quanto fossero limitate le viste della piú parte dei legislatori.
Una repubblica troppo vasta non si salva dal dispotismo che col sottodividersi e unirsi in tante repubbliche federative. Ma come ottener questo? Da un dittatore dispotico che abbia il coraggio di Silla, e tanto genio d’edificare quant’egli n’ebbe per distruggere. Un tal uomo, se sarà ambizioso, la gloria di tutt’i secoli lo aspetta, se sarà filosofo, le benedizioni de’ suoi cittadini lo consoleranno della perdita dell’autorità, quando pure non divenisse indifferente alla loro ingratitudine. A misura che i sentimenti che ci uniscono alla nazione s’indeboliscono, si rinforzano i sentimenti per gli oggetti che ci circondano,e però sotto il dispotismo piú forte le amicizie sono piú durevoli, e le virtú sempre mediocri di famiglia sono le piú comuni o piuttosto le sole. Da ciò può ciascuno vedere quanto fossero limitate le viste della piú parte dei legislatori.* Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene, Letteratura italiana Einaudi.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
DONNE, UOMINI E VIOLENZA: "Parliamo di FEMMINICIDIO". Dalla democrazia della "volontà generale" alla democrazia della "volontà di genere". L’importanza della lezione dei "PROMESSI SPOSI", oggi.
CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- MEMORIA E STORIA: GIUSTINIANO E LA CINA. Così gli italiani hanno scritto il Codice civile per Pechino.17 marzo 2019, di Federico La Sala
Così gli italiani hanno scritto il Codice civile per Pechino
L’ex ministro Diliberto ha portato il diritto romano in Cina. “E’ un lavoro enorme, dalla proprietà privata all’eredità”
di Mattia Feltri (La Stampa, 06/03/2017)
- Oliviero Diliberto, 60 anni, è stato contattato nel ’98 dal governo cinese quando era ministro della Giustizia nell’esecutivo D’Alema
Roma. «È cominciata per caso», dice Oliviero Diliberto. Lo ricordate, vero? Inizi nel Pci, poi in Rifondazione, fino al 2013 leader dei Comunisti italiani. È stato ministro della Giustizia (premier Massimo D’Alema) dal ’98 al 2000. Oggi ha sessant’anni, è ordinario di Diritto romano alla Sapienza, e tutta questa breve biografia ha contribuito al caso. E cioè, nel 1998 la Cina decide di dotarsi di un codice civile. Non lo aveva, prima. A che serve un codice civile a un Paese comunista, in cui non c’è proprietà privata?
Ma nel ’98 il mondo era cambiato. «Era cambiato da un po’», dice oggi Diliberto. «Nel 1988 il professor Sandro Schipani, docente di Diritto romano a Tor Vergata, raggiunge in Cina uno studioso, Jiang Ping, che aveva conosciuto l’anno prima a Roma. Attenzione, il Muro di Berlino era ancora in piedi. E a Schipani viene l’intuizione: vi servirà un codice civile. La Cina, che veniva da un lunghissimo periodo di nichilismo giuridico, per cui la legislazione civile era una sovrastruttura borghese, capisce che il futuro è la globalizzazione e già sta evolvendo in un sistema misto, di economia statale e privata. E come gestisci un’economia così senza un codice civile?».Si sarà già capito dove stiamo andando a parare. La discussione in Cina dura a lungo: tocca decidere se adottare il Common law anglosassone o il Civil law di stampo romanistico.
«Ma intanto Schipani sta traducendo dal latino al cinese il Corpus Iuris Civilis, il fondamentale codice di Giustiniano che alla caduta dell’Impero Romano raccoglie il complesso delle leggi civili e così salva l’Europa, le dà un fondamento. E quando nel ’99 Pechino sceglie il diritto romano, si chiede: ma quale ne è la culla? L’Italia. Chi è ministro della Giustizia in Italia? Diliberto. Toh, è pure docente di diritto romano! E persino comunista! Perfetto! E così insieme a Schipani iniziamo, su richiesta cinese, a formare una classe di giuristi che poi dovranno scrivere il codice».
 Il che, grosso modo, equivale ad averlo scritto.
Il che, grosso modo, equivale ad averlo scritto.«Il codice lo scrivono benissimo i cinesi, ma c’è del vero. Hanno cominciato a venire da noi studenti cinesi, passati attraverso selezioni durissime. Oggi ne ho con me dieci ma negli anni sono stati una cinquantina, molti di loro sono diventati professori e stanno lavorando appunto al codice. In quattro anni imparano l’italiano, il latino, il diritto romano e infine scrivono la tesi di dottorato».
Ma che significa scrivere il codice civile per la Cina? Un lavoro enorme, dice Diliberto, «pensate di introdurre in un Paese giuridicamente vergine, comunista, enorme, complesso, concetti come la proprietà, l’usufrutto, la successione, la compravendita, la proprietà intellettuale per libri e brevetti. Hanno dovuto creare e introdurre i notai. Pensate le difficoltà in un Paese in cui tutta la terra è dello Stato, e ai contadini ora viene data in concessione, mentre si riconosce la proprietà privata delle aziende o delle squadre di calcio. Pensate, in una Cina che a un certo punto ammette che uno molto bravo può diventare molto ricco, al problema dell’eredità. Perché i figli non sono molto bravi, solo molto fortunati». Si è risolta con una elevatissima tassa di successione, e ogni volta che si pone una questione del genere «partono le telefonate, i consulti, si organizzano convegni».
Il codice sarà pronto nel 2020 ma intanto «sono state scritte legislazioni singole, entrate in vigore, sugli aspetti più impellenti». Diliberto ha una cattedra all’Università Zhongnan of Economics and Law di Wuhan, terza città della Cina. Va due volte l’anno per tenere lezione. Come detto, altri studenti cinesi vengono a Roma.
«La Cina ha fame e urgenza di formare giuristi che la accompagnino all’interno e nel mondo. Ma intanto anche nostri studenti vanno in Cina. Ora ce ne sono quattro a fare dottorati sul diritto civile cinese. Diventeranno merce pregiatissima, avvocati del cui sostegno avrà bisogno chiunque intenda stringere affari in Cina. La Germania è molto avanti rispetto a noi, ma il volume dei nostri affari con la Cina cresce vertiginosamente. Poche settimane fa, alla presenza del presidente Mattarella, abbiamo inaugurato alla Sapienza il più grande centro di studi giuridici cinesi d’Europa. Chiunque debba approfondire la materia verrà da noi. E ci tengo a dirlo: tutto pagato da Pechino. Dal nostro governo non è arrivato un euro».
 Rimangono un paio di dubbi.
Rimangono un paio di dubbi.Primo, ma davvero i cinesi hanno fiducia in noi? «Intanto amano la nostra cultura classica, e in particolare la musica operistica. In questo momento, pochi lo sanno, ma in Italia ci sono mille e cinquecento giovani cinesi che stanno studiando l’opera lirica. E poi i cinesi sono diversi, ragionano sulla base dei millenni, e nel loro grande orgoglio ci considerano dei pari, alla loro stessa altezza perché anche noi come loro abbiamo avuto l’impero, siamo figli di un impero che conquistava e civilizzava il mondo». Secondo dubbio, il solito: d’accordo il codice civile ma, di civile, dovrebbero esserci anche i diritti.
Diliberto non è uno che si lasci andare al romanticismo, e prevede che «i diritti arriveranno per processo naturale. Già oggi la Cina è profondamente diversa da quella di quaranta o venti anni fa. Sono leciti il mercato e la proprietà privata. E per i cinesi oggi sono fondamentali il diritto alla vita e alla sussistenza.
Il Presidente Xi Jingping ha posto tra le priorità lo “stato di diritto”, conquista enorme. Anche la politica seguirà un processo naturale, ma le trasformazioni saranno gestite dal Partito comunista, evitando qualsiasi gorbaciovismo. Sarebbe folle il contrario, come fu folle l’idea di esportare la nostra forma di democrazia: che è il prodotto di 25 secoli di storia, dall’Atene di Pericle alla rivoluzione francese. Ma i cinesi Pericle non l’hanno avuto. E tu glielo vuoi imporre da un giorno con l’altro?».
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- IL PARADIGMA DELLA TESSITURA. Arte e resistenza: ascoltare la voce della spoletta (di Patricia Klindienst).16 febbraio 2019, di Federico La Sala
ARACNE, FILOMELA, E TRE ARAZZI. Arte e resistenza: ascoltare la voce della spoletta ... *
- Il testo (Publio Ovidio Nasone, Metamorfosi, libro VI):
- Il commento (Patricia Klindienst, "The Voice of the Shuttle is Ours")
__________________________________________________________________________
Tessere come smascheramento: disfare la violenza dello stupro
- [...]
La tela di Aracne apre il libro sesto delle Metamorfosi, la storia di Filomela lo chiude.
Per entrambe queste donne, tessere rappresenta lo smascheramento dei "misteri sacri" e il disfare la violenza dello stupro. Prima che la dea adirata Atena (Minerva) stracci la stoffa tessuta da Aracne, la tessitrice, donna mortale, racconta su di essa una storia molto particolare: quella delle donne stuprate da dèi che si mutano in bestie. Prima dell’intervento della dea gelosa, Aracne è il centro di una comunità femminile.
Insuperabile nella sua arte, Aracne è così piena di grazia che donne da ogni luogo vengono da lei per vederla cardare, filare, tessere. Attorno a lei si radunano altre donne che guardano, parlano, lavorano, riposano. Qui il telaio rappresenta un’occasione per creare comunità e pace, un contesto in cui è possibile, per il piacere, essere non violento e non possessivo.
In questo Aracne ricorda Saffo, che pure era il centro di una comunità di donne e a cui similmente Ovidio riserva un vicolo cieco, adottando la tradizione che tenta di sminuire la poetessa facendola morire suicida poiché respinta da un uomo. Ciò che sopravvive del lavoro di Saffo e gli studi successivi respingono come falsa questa ipotesi.
E’ solo facendo uno sforzo di interpretazione che noi oggi possiamo suggerire che Aracne, la donna artista, non si impiccò come ci racconta la storia, ma fu linciata. Il suicidio è un surrogato dell’omicidio. Aracne è distrutta dal suo stesso strumento quando esso è nelle mani della dea irata.
Ma chi è Atena? Non realmente femmina, giacché emerge, priva di madre, dalla testa del padre, una fantasia maschile che si fa carne, che strangola la voce delle donne reali. Lei è la figlia vergine il cui scudo è la testa di un’altra vittima donna, Medusa. Atena è la pseudo-donna che racconta la storia del giusto ordine.
Centrali, nel suo arazzo, sono gli dei in tutta la loro gloria, ma ai quattro angoli della tela, all’interno del bordo di rami d’olivo, Atena tesse un ammonimento alla donna artista, affinché essa non resista all’autorità ed alla gerarchia: in colori brillanti, quattro figure dicono "Pericolo!".
L’errore di Aracne è solo apparentemente l’orgoglio per la propria arte (che è pienamente giustificato: Aracne vince la gara); in verità, lei è in pericolo perché racconta una storia pericolosa. Fra le donne rappresentate nel suo arazzo c’è la stessa Medusa.
Raccontare lo stupro di Medusa da parte di Poseidone è suggerire ciò che può nascondere il mito per cui la donna muta gli uomini in pietra. Il luogo del crimine era l’altare di un tempio di Atena. Il retroterra del crimine era la necessità della città di scegliere un dio per darsi nome e ciò che usualmente viene rappresentato come una rivalità fra Poseidone ed Atena per ottenere tale onore.
Medusa fu stuprata o sacrificata sull’altare di Atena? Fu la donna "punita" da Atena, o fu uccisa durante una crisi, come offerta della città di Atene ad una dea "adirata", proprio come Ifigenia fu sacrificata ad una Artemide assetata di sangue? Dietro alla testa decapitata della donna, che Perseo usa per mutare gli uomini in pietra, c’è l’antica Gorgone, la maschera apotropaica rituale che segnava gli angoli dei camini nelle case ateniesi.
La Medusa mitica può ricordare una reale vittima sacrificale: dietro la testa che tramuta in pietra gli uomini, potrebbe esserci una donna lapidata a morte dagli uomini. E, anche qui, la responsabilità deve cadere su un’altra "donna", Atena.
La storia viene erotizzata dal collocare la violenza fra uomini e donne, e Freud, nella sua equazione "decapitazione = castrazione" rinforza e sviluppa la misoginia presente nel sacrificio mitico. Se Medusa è divenuta una figura centrale con cui ogni donna artista deve fare i conti è perché, ella stessa ridotta al silenzio, Medusa è stata usata per ridurre al silenzio altre donne.
Aracne, narrando sulla tela le storie delle donne stuprate da dei mutati in bestie, demistifica gli dei (il sacro) e li rivela come bestie (la violenza). Ovidio può raccontare la sua versione della storia solo perché la versione della donna è stata strappata in pezzi e lei stessa ricondotta ad uno stato "naturale".
Proprio come Freud, terrorizzato dalla "donna-come-madre" e dalla donna tessitrice, usa la psicoanalisi per riportare le donne ad un’identificazione con la "natura", così il mito usa Atena affinché trasformi Aracne in un ragno repellente, che potrà tessere tele puramente letterali, disegni incomprensibili. La metamorfosi, così come la psicoanalisi nelle mani di Freud, rovescia la direzione della violenza: Medusa, come Aracne, spaventa e minaccia gli uomini.
Il ragno femmina intrappola e divora i maschi che si accoppiano con lei... Lo strumento della tessitrice, la spoletta, viene usato per ridurla al silenzio. Ma non viene usato per zittire l’artista maschio, che si appropria dell’abilità femminile quale metafora per la propria stessa abilità.
Quale strumento di violenza, Atena è un’estensione di Zeus. La vendetta sulla donna artista, che usa il telaio per raccontare storie che non ci è permesso di udire se non sono mediate dagli uomini, non è una vendetta degli dei, è una vendetta culturale.
Quando Filomela comincia a tessere durante il suo lungo anno di prigionia, non è solo la sua sofferenza che la muove ad un nuovo uso del telaio, ma lo specifico scopo di essere udita da sua sorella. Come strumento che lega e connette il telaio (o la spoletta che è una sua parte) ri-membra e aggiusta ciò che la violenza riduce in pezzi: il legame fra sorelle, il potere della donna di parlare, la forma della comunità, la comunicazione. La guerra ed il tessere sono antitetici.
Ma il mito ci chiede di credere che, dopo il suo lungo e paziente sforzo, Filomela sia disposta a trasformare il suo lavoro al telaio in vendetta immediata. Ci si chiede di credere, dopo che Filomela ha trasformato la prigione in laboratorio e la disciplina domestica in un anno di lotta, che tutto ciò l’ha lasciata immutata, che la sua scoperta non ha il potere di cambiare nulla.
E il mito ci chiede di credere che dopo un anno di pianto sulla tomba della sorella, Procne sia disposta non ad un rito di riunione, ma ad uno di omicidio. L’alternativa più importante suggerita dall’arazzo di Filomela non è mai stata considerata: il potere del testo di insegnare all’uomo a conoscere se stesso.
E’ il barbaro Tereo o è il cittadino greco che risponde alla storia tessuta dalla donna con la violenza? All’interno della tradizione greca, il mito è stato usato per insegnare alle donne il pericolo insito nella nostra capacità di vendicarci. Ma se il mito istruisce, così come è istruttivo l’arazzo di Filomela, allora ci dice anche che possiamo insegnare a noi stesse, all’interno del potere dell’arte, le forme della resistenza.
E’ il tentativo di negare che il tessere di Filomela poteva avere altri fini a parte la vendetta che rende il mito così pericoloso, perché esso tenta di persuaderci al considerare la violenza inevitabile e l’arte debole... ma è lo stesso mito a testimoniare contro se stesso, perché se l’arte di Aracne e Filomela fosse davvero stata così debole, non sarebbe stata repressa con violenza così estrema. [...]
*
- Il testo (Publio Ovidio Nasone, Metamorfosi, libro VI):
- Il commento (Patricia Klindienst, "The Voice of the Shuttle is Ours")
- PATRICIA KLINDIENST, The Voice of the Shuttle is Ours.
- This article originally appeared in earlier form in The Stanford Literature Review 1 (1984): 25-53, and is republished here on VoS by permission of Anma Libri Press. It has also appeared in Rape and Representation, ed. Lynn A. Higgins and Brenda A. Silver (New York: Columbia Univ. Press, 1991), pp. 35-64. Accompanying the article is an "Epilogue" (1996) by the author, here published for the first time. Responses to the essay and epilogue are welcomed by the author.
- Patricia Klindienst is an independent scholar. She wrote "The Voice of the Shuttle is Ours" while completing a dissertation on Virginia Woolf at Stanford U. She was an Asst. Prof. of English, Humanities, and Feminist Studies at Yale U. from 1984-1992, when she chose to leave the profession to write. Originally conceived as part of a book-length study of shifting representations of rape, the "Voice" essay was followed by two companion pieces, "Ritual Work on Human Flesh: Livy’s Lucretia and the Rape of the Body Politic" (Helios, 17:1 [1990], 51-70), and "Intolerable Language: Jesus and the Woman Taken in Adultery," in Shadow of Spirit: Postmodernism and Religion, ed. Berry and Wernick, (London & NY: Routledge, 1992), pp. 226-237. Responses to the essays are welcomed by the author. E-mail her at Klindienst@aol.com -(This page mounted August 1996; last revised 10/30/96)
- LA VOCE DELLA SPOLETTA E’ NOSTRA (trad. Maria G. Di Rienzo:
- ["Questo articolo apparve nella sua prima stesura nella rivista letteraria "The Stanford Literature Review", n. 1 del 1984, pp. 25-53; fu pubblicato anche nel libro Rape and Representation (Stupro e rappresentazione) edito da Columbia University Press, New York 1991, pp. 35-64.
- Patricia Klindienst è una studiosa indipendente. Scrisse La voce della spoletta e’ nostra quale completamento di una dissertazione su Virginia Woolf alla Stanford University. E’ stata assistente alle cattedre di Inglese, Studi Umanistici e Studi Femministi all’Universita’ di Yale dal 1984 al 1992, anno in cui ha scelto di lasciare la professione per dedicarsi a scrivere.
- Originariamente concepito come parte di uno studio sui cambiamenti della rappresentazione dello stupro, il presente saggio fu seguito da altri due testi che proseguivano l’analisi: Ritual Work on Human Flesh: Livy’s Lucretia and the Rape of the Body Politic (ed. Helios, 1990, pp. 51-70), e Intolerable Language: Jesus and the Woman Taken in Adultery, in Shadow of Spirit: Postmodernism and Religion, ed. Berry and Wernick, (Routledge, London and New York 1992), pp. 226-237"] ("La nonviolenza e’ in cammino", 458 - Centro di ricerca per la pace - Viterbo).
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA E A PENSARE BENE "DIO", "IO" E "L’ITALIA", CHI PIÙ CHI MENO, TUTTI VIVONO DENTRO LA PIÙ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA --- CONCORDATO. Stato-Chiesa, i nodi irrisolti (di Chiara Saraceno))-14 febbraio 2019, di Federico La Sala
A novant’anni dal Concordato firmato da Mussolini e Pio XI
Stato-Chiesa, i nodi irrisolti
di Chiara Saraceno (Il Mulino, 11 febbraio 2019)
Sono trascorsi novant’anni da quando, l’11 febbraio 1929, i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica sono stati regolati da un concordato. Un tempo sufficientemente lungo per consentire un bilancio e per verificare se non sia opportuna una nuova revisione, dopo quella operata nel febbraio 1984 sotto il governo Craxi, con la duplice parziale correzione sia dei Patti lateranensi sia del concordato vero e proprio. Una revisione e una correzione, peraltro, dagli esiti ambigui.
In primo luogo, ancora oggi rimane in vigore la norma secondo la quale - nel matrimonio concordatario - in caso di annullamento la norma canonica prevale su quella civile, nonostante i criteri (oltre che i giudici) che presiedono all’annullamento religioso siano difformi da quelli che presiedono all’annullamento civile.
Inoltre, l’eliminazione della clausola che riconosceva alla religione cattolica la condizione di religione di Stato non ha eliminato affatto l’obbligo per lo Stato di garantire l’insegnamento della religione nelle scuole pubbliche e, anzi, lo estendeva alle scuole materne, escludendo solo l’università. Il costo finanziario per lo Stato di tale obbligo - sotto forma di stipendi pagati a insegnanti reclutati non dallo Stato bensì dalla Chiesa cattolica - è stato stimato in 1,25 miliardi di euro l’anno. Per mantenere una schiera numerosa di insegnanti di religione a fronte di una crescente diminuzione di coloro che ne frequentano l’insegnamento, raramente viene utilizzata la possibilità, pure prevista dalle modifiche del 1984, di accorpare le classi.
Peraltro, anche la modifica da una condizione di obbligatorietà per gli studenti a partecipare alle lezioni di religione, salva una richiesta di esenzione, alla facoltà di decidere se avvalersene o meno è rimasta in condizione di ambiguità.
L’insegnamento di religione, infatti, fa parte a pieno titolo dell’orario scolastico e può essere collocato in qualsiasi posizione, a prescindere dal numero di studenti per classe che se ne avvale. L’insegnante di religione partecipa a pieno titolo al collegio dei docenti e il suo voto "fa media". Quanto agli studenti che scelgono di non frequentare religione, inclusi i bambini della scuola materna, sono loro a dover uscire di classe per partecipare ad attività alternative più o meno fasulle, lasciate alla discrezione e alla buona volontà dell’insegnante loro assegnato. Ma senza avere l’alternativa di un’ora di scuola in meno, salvo che casualmente l’ora di religione sia messa alla prima o all’ultima ora. Una situazione apparentemente migliore rispetto a quando gli "esonerati" passavano l’ora di religione in corridoio.
 Di fatto, tuttavia, chi "non si avvale" dell’insegnamento della religione cattolica continua ad avere meno diritti, in termini di risorse dedicate, di chi "si avvale". Mentre i loro genitori - tramite le imposte - finanziano l’insegnamento della religione cattolica.
Di fatto, tuttavia, chi "non si avvale" dell’insegnamento della religione cattolica continua ad avere meno diritti, in termini di risorse dedicate, di chi "si avvale". Mentre i loro genitori - tramite le imposte - finanziano l’insegnamento della religione cattolica.Del tutto in contrasto con l’obiettivo del finanziamento da parte dei fedeli si è rivelato il meccanismo dell’8 per mille. In linea di principio, il passaggio dalla congrua - ovvero dal sostentamento del clero direttamente a carico dello Stato, appunto al finanziamento da parte dei fedeli tramite la devoluzione di una quota delle imposte dovute - è stato molto positivo.
Tuttavia, la formulazione di questa norma si è prestata nel tempo e tuttora si presta a un enorme imbroglio a carico dei contribuenti.
In base alla legge 222/85, infatti, ogni cittadino che presenta la dichiarazione dei redditi può scegliere la destinazione dell’8 per mille del proprio gettito Irpef a un’istituzione religiosa che con lo Stato ha stipulato vuoi, come nel caso della Chiesa cattolica, un concordato, vuoi un’intesa, oppure scegliere di destinarlo allo Stato. Mentre all’inizio l’opzione era ristretta a quella tra Stato e Chiesa cattolica, oggi si può scegliere tra tredici alternative: Stato (per scopi sociali e assistenziali), Chiesa cattolica, Unione chiese cristiane avventiste del 7° giorno, Assemblee di Dio in Italia, Unione delle chiese metodiste e valdesi, Chiesa evangelica luterana in Italia, Unione comunità ebraiche Italiane, Unione buddhista, Unione induista, Chiesa apostolica, Sacra diocesi ortodossa d’Italia, Unione cristiana evangelica battista d’Italia e infine, dal 2017, l’istituto buddista italiano Soka gakkai.
Il problema è che non viene attribuita a ciascuna istituzione solo la quota dell’8 per mille per la quale i contribuenti hanno effettuato una scelta precisa - come avviene per il 5 per mille destinato a associazioni non profit - ma anche la quota non specificamente attribuita viene suddivisa in base alle percentuali delle scelte effettuate. Chi non sceglie, ritenendo ingenuamente che il suo 8 per mille rimanga allo Stato, di fatto subisce le preferenze di chi invece lo ha fatto. Stante che negli anni il numero di coloro che effettuano una scelta è progressivamente diminuito ma la priorità delle scelte è rimasta per la Chiesa Cattolica, questa si prende anche il grosso della quota di chi non ha inteso designarla come beneficiaria.
In base agli ultimi dati disponibili - riferiti alle dichiarazioni dei redditi effettuate nel 2015 - solo il 44% degli oltre quaranta milioni di contribuenti aveva espresso una scelta e solo il 35% per la Chiesa cattolica, la quale, tuttavia, in base a una distribuzione proporzionale dell’intero ammontare dell’8 per mille ne ha ricevuto l’81,21% , pari a 1.005.390.045 euro. Anche le altre Chiese ricevono beneficio da questo meccanismo a dir poco ambiguo, anche se si tratta di briciole. Si aggiunga che, a differenza di quanto fanno molte Chiese, lo Stato non pubblicizza neppure l’opzione a proprio favore, e tantomeno esplicita a che cosa destinerebbe l’eventuale gettito, contribuendo all’opacità del tutto e generando sfiducia.
Non vi è, inoltre, l’opzione di destinare il proprio 8 per mille ad associazioni che si battono per la laicità dello stato o che sostengono l’ateismo, mettendo, di nuovo, i cittadini in condizioni di disuguaglianza rispetto alla possibilità di sostenere finanziariamente il proprio orientamento rispetto al fenomeno religioso. Possono farlo solo destinando il 5 per mille, che è normato diversamente.
Alla luce di questi e altri aspetti altamente problematici per la laicità dello Stato, l’uguaglianza dei cittadini (anche minorenni), la trasparenza nei rapporti tra Stato e cittadini, in questi giorni un gruppo di 150 esponenti del mondo della cultura e difensori dei diritti civili ha firmato un appello al Parlamento, al governo, alle forze politiche, affinché - in attesa di tempi più favorevoli a una radicale revisione, se non al superamento, del Concordato - si intervenga per dare almeno piena attuazione alle finalità degli accordi del 1984, con l’abolizione dell’insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica e la revisione degli attuali criteri di ripartizione della quota "non destinata" dell’8 per mille. A queste due richieste si aggiunge quella di un’azione determinata per dare attuazione alla recente sentenza della Corte europea, recuperando nella misura del possibile l’Ici non pagata in passato, 4-5 miliardi di euro. Si tratta, a me pare, di proposte civili e rispettose della reciproca autonomia tra Stato e Chiese. Ma sono sicura che - se non sepolte dal silenzio imbarazzato dei media "laici" - saranno oggetto di anatemi di vario tipo.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- DAL "LOGOS" AL "LOGO". Note sulla storia della distruzione della ragione costituzionale e della "democrazia deformata".8 febbraio 2019, di Federico La Sala
STORIA DELLA QUESTIONE INFAME. Dal Discorso (Logos) della Costituzione al Logo del Partito della Democrazia Deformata...
- Erminio Risso, "Rino Genovese, impurità dei tempi" (Alfabeta-2, 16 giugno 2017)
- Rino Genovese, Le responsabilità della sinistra italiana nell’affermarsi dei populismi /1 ("Le parole e le cose", 08.02.2019).
Se FERRERO è FERRERO, VENDOLA è VENDOLA, GIORDANO è GIORDANO, BERTINOTTI è (ancora) BERTINOTTI, VELTRONI è (ancora) VELTRONI, e PRODI è (ancora) PRODI ... UNA MOBILITAZIONE CULTURALE GENERALE, SUBITO - ORA. Un appello ... “Al Pd serve un padre.”. Intervista a Romano Prodi
UNA LEZIONE TEOLOGICO-POLITICA DI BAGET BOZZO SU OGNI PROGETTO DI “RIFONDAZIONE COMUNISTA” FUTURA CHE SI VUOLE COME PARTITO. Avanti o popolo alla riscossa. Il populismo trionferà: “Forza Italia”!!!
STORIA DELLA QUESTIONE INFAME: COME L’ITALIA, UN PAESE E UN POPOLO LIBERO, ROVINO’ CON IL “GIOCO” DEI “DUE” PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- La Costituzione, l’art. 52, e la nave su cui siamo imbarcati tutti. Il sacro dovere e la sua torsione populista (di Francesco Palermo).4 febbraio 2019, di Federico La Sala
Il caso italiano
Il sacro dovere e la sua torsione populista
di Francesco Palermo (Il Mulino, 31 gennaio 2019)
La Costituzione è il perimetro entro il quale la politica si muove, o meglio, si dovrebbe muovere, con le proprie scelte discrezionali. È il ring nel quale il legittimo conflitto di idee si svolge, o si dovrebbe svolgere, secondo regole prestabilite, la cui interpretazione è affidata ad arbitri, a organismi super partes, i più importanti dei quali sono la Corte costituzionale e il presidente della Repubblica. È, pertanto, non solo legittimo ma anzi doveroso che la politica ricorra ad argomentazioni costituzionali per giustificare le proprie azioni e le proprie tesi, perché solo dentro la Costituzione può svolgersi la politica.
La Costituzione è, per certi aspetti, la versione laica del principio di esclusività tipico della religione: "non avrai altro Dio all’infuori di me". E non può esserci politica al di fuori della Costituzione. Come troppo spesso accade anche con la religione, però, non è raro che i precetti vengano piegati a interpretazioni funzionali alla preferenza politica del momento. E che tale torsione venga compiuta non già dagli arbitri, bensì dai giocatori.
Un esempio di particolare interesse si è registrato in questi giorni, quando il ministro dell’Interno ha invocato l’articolo 52 della Costituzione per giustificare la propria politica in materia di sbarchi. Nelle due vicende, seppur diverse tra loro, della nave Diciotti da un lato (per la quale pende una richiesta di autorizzazione a procedere nei suoi confronti) e della nave Sea watch dall’altro (la cui vertenza, di fatto, è ancora aperta), il ministro Salvini ha rivendicato la scelta di negare l’accesso ai porti italiani come un obbligo costituzionale, fondato sul "sacro dovere" di ciascun cittadino alla "difesa della patria", previsto appunto dall’articolo 52.
Tale disposizione non ha, naturalmente, nulla a che vedere con le questioni di cui si tratta. Il suo ambito di riferimento è esclusivamente la difesa militare, come si evince dai lavori preparatori e dagli altri commi dell’articolo, che prevedono rispettivamente l’obbligatorietà del servizio militare, nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge, e la natura democratica dell’ordinamento delle forze armate. È per questo che l’articolo 52 non fu oggetto di particolare dibattito in assemblea costituente, impegnata a sottolineare il carattere pacifista della Carta. Non a caso, il testo che uscì come definitivo è praticamente identico a quello della prima bozza, caso rarissimo nei lavori della Costituente. Tutti erano d’accordo su una previsione che doveva dare copertura costituzionale al servizio militare e alle forze armate.
Il ministro dell’Interno trasforma invece quella previsione - estrapolandola dal contesto - in una sorta di diritto di resistenza. Peraltro ponendolo in capo al governo, ossia all’organo contro il quale il diritto di resistenza si esercita, nei pochi ordinamenti in cui è previsto. Non solo.
 Il richiamo al "sacro dovere" della "difesa della patria" ha una forte portata simbolica. In primo luogo, la formulazione è nota anche ai cittadini meno familiari con la Costituzione, quindi suona plausibile. In secondo luogo, richiama il gergo militare, anche grazie all’espressione ottocentesca della disposizione ("sacro dovere"), figlia di un’epoca in cui la guerra era ancora drammaticamente presente negli occhi e nelle menti dei costituenti.
Il richiamo al "sacro dovere" della "difesa della patria" ha una forte portata simbolica. In primo luogo, la formulazione è nota anche ai cittadini meno familiari con la Costituzione, quindi suona plausibile. In secondo luogo, richiama il gergo militare, anche grazie all’espressione ottocentesca della disposizione ("sacro dovere"), figlia di un’epoca in cui la guerra era ancora drammaticamente presente negli occhi e nelle menti dei costituenti.
 Soprattutto, l’invocazione di quel segmento dell’articolo 52 è un abile gioco retorico: prima lo stacca dal contesto militare in cui è collocato, poi lo rimette in tale contesto, facendo intuire che "l’invasione" dei profughi sia un atto di guerra nei confronti del Paese, contro cui occorre difendersi. Anche militarmente. Dunque senza essere soggetti alla Costituzione, ma al diritto eccezionale del tempo di guerra, in cui vale quasi tutto.
Soprattutto, l’invocazione di quel segmento dell’articolo 52 è un abile gioco retorico: prima lo stacca dal contesto militare in cui è collocato, poi lo rimette in tale contesto, facendo intuire che "l’invasione" dei profughi sia un atto di guerra nei confronti del Paese, contro cui occorre difendersi. Anche militarmente. Dunque senza essere soggetti alla Costituzione, ma al diritto eccezionale del tempo di guerra, in cui vale quasi tutto.Il rischio di una simile operazione, per quanto scaltra sotto il profilo politico e mediatico, è quello di depotenziare il carattere normativo della Costituzione, di eroderne il ruolo di perimetro dell’attività politica, di limite e parametro della stessa. Un’erosione di cui questo caso è solo il più recente di una lunga serie di esempi, che porta a cancellare la funzione di garanzia della politica che è il compito principale della Carta costituzionale.
 Non può sfuggire la pericolosità di questo crinale (o almeno non dovrebbe sfuggire, ma evidentemente per alcuni non è così). E infatti l’operazione politica che distorce il significato della Carta funziona proprio in quanto alla gran parte degli elettori questo ruolo della Costituzione sfugge.
Non può sfuggire la pericolosità di questo crinale (o almeno non dovrebbe sfuggire, ma evidentemente per alcuni non è così). E infatti l’operazione politica che distorce il significato della Carta funziona proprio in quanto alla gran parte degli elettori questo ruolo della Costituzione sfugge.
 Si continua così a ballare sulla nave che affonda. Dimenticando che in questo caso non è quella dei migranti, ma quella della Carta su cui si fonda il nostro stesso ordinamento in quanto democrazia. Una nave su cui siamo imbarcati tutti.
Si continua così a ballare sulla nave che affonda. Dimenticando che in questo caso non è quella dei migranti, ma quella della Carta su cui si fonda il nostro stesso ordinamento in quanto democrazia. Una nave su cui siamo imbarcati tutti. -
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- MEMORIA. Com’è importante la figura del maestro in una società civile (di Corrado Stajano).1 febbraio 2019, di Federico La Sala
Memoria
Massimo Castoldi, il libro
Il coraggio dei maestri antifascisti
La storia di dodici insegnanti che si opposero alla dittatura. Lo studioso porta alla luce per Donzelli esempi eroici di educatori perseguitati e uccisi dal regime di Mussolini
di CORRADO STAJANO *
- [Foto] Balilla mangiano nel refettorio scolastico (l’anno è il 1937)
Com’è importante la figura del maestro in una società civile. Sotto una dittatura, poi, quanto pesano la sua dignità, il suo coraggio per far sì che i bambini a lui affidati crescano nel rispetto delle regole dei rapporti umani cancellate dal regime, qualsiasi regime. È uscito da Donzelli un libro di Massimo Castoldi, professore di Filologia italiana all’Università di Pavia, studioso della memorialistica della Resistenza: Insegnare libertà. Storie di maestri antifascisti. Un libro amaro, doloroso, commovente, utile a far capire perché quel passato deve davvero passare per sempre, soprattutto oggi che il fascismo sembra venga guardato con indulgenza. (Sere fa, durante il programma di Lilli Gruber, Luciano Canfora spiegò con limpidezza a un giornalista di idee nerastre, ignorante anche nel linguaggio, che cosa significa la parola fascistoide, purtroppo tornata nel clima di una certa politica del nostro tempo).
- [Foto] Massimo Castoldi, «Insegnare libertà. Storie di maestri antifascisti», Donzelli (pp. 170, euro 23)
Nei primi vent’anni del Novecento, scrive Massimo Castoldi, il maestro elementare aveva acquistato una centralità nella vita socio-culturale del Paese: era impegnato nella lotta contro l’analfabetismo, per un’istruzione sempre più diffusa, per cercar di sanare i mali dell’epoca, le malattie, la fame, la precarietà delle condizioni igienico-sanitarie. Compito del maestro non era soltanto quello di insegnare a leggere e a scrivere, ma anche a vivere meglio, a creare una comunità in cui gli uomini e le donne fossero rispettosi di se stessi e degli altri. Sono gli anni delle leghe contadine, delle Società di Mutuo soccorso, delle università popolari, dei circoli operai, delle cooperative, delle Camere del lavoro, delle casse rurali, del socialismo umanitario nascente.
- [Foto] Una dei protagonisti del libro, la maestra di Vigevano Anna Botto (1895-1944)
Poi il fascismo che frantumò ogni idea di libertà: «I bimbi d’Italia si chiaman balilla». Piccoli soldati in uniforme, con moschettini modello ’38, forse fieri del loro dissennato giuramento d’obbligo: «Giuro di eseguire gli ordini del Duce e di servire con tutte le mie forze e se necessario col mio sangue la causa della Rivoluzione fascista». Poveri bambini ignari. Coi maestri in orbace e il pugnaletto alla cintura.
Ma c’erano anche gli altri, i disubbidienti della libertà che spesso rischiavano il posto e anche la vita come Carlo Cammeo trucidato nel 1921 a Pisa sulla soglia della sua classe, come Salvatore Principato, fucilato dai fascisti della «Muti» in piazzale Loreto a Milano, per ordine dei tedeschi, nel 1944. Il libro non vuole fare un elenco di chi si oppose, vittima della dittatura fascista. È la storia di dodici maestri e maestre che seppero far fronte, ma è anche l’analisi di una società minuta e spesso sconosciuta.
Sono vicende tristi, quelle raccontate da Massimo Castoldi. Come la vita di Alda Costa, la maestra di cui scrisse Giorgio Bassani nelle Cinque storie ferraresi: la Costa è la Clelia Trotti del racconto, socialista riformista, appassionata alla condizione sociale dei bambini, contro la guerra, vittima delle persecuzioni dei fascisti che la insultavano sui loro giornali e a Bologna, nel 1922, l’aggredirono in trecento, le strapparono le vesti, le sputarono addosso, la costrinsero a bere l’olio di ricino perché si era rifiutata di inneggiare al fascismo. Fu denunziata, non rispettava l’obbligo del saluto romano e seguitava a rivendicare la sua fede socialista. Sospesa, licenziata, inviata al confino alle isole Tremiti per cinque anni, arrestata di nuovo quando il federale fascista Ghisellini fu giustiziato a Ferrara: la vicenda è narrata nel film La lunga notte del ’43.
Popolano il libro nomi di uomini e di donne che non sono passati alla storia, ma che spiegano nel profondo che cosa fu il fascismo. Anselmo Cessi, un maestro cattolico che infastidiva i fascisti per la sua appassionata azione sociale nel Mantovano, fu ucciso nel 1926 mentre passeggiava con la moglie a Castel Goffredo; Mariangela Maccioni, una maestra antifascista sarda - 90 alunni - angariata perché si era rifiutata di fare una lezione sul Duce, sospesa più volte dall’insegnamento. Alla sua morte scrisse sul «Ponte» Salvatore Cambosu: «C’era in lei la forza e la gentilezza antica dell’ulivo».
E poi Abigaille Zanetta, socialista, antimilitarista, comunista, espulsa dalla scuola dal podestà di Milano Ernesto Belloni, «per non sufficiente adattamento alle direttive politiche del governo», arrestata, incarcerata, cercò di sopravvivere con qualche lezione privata. Non ebbe neppure la gioia della Liberazione. Morì un mese prima.
Con il medesimo destino di perseguitati coraggiosi, tra gli altri, Fabio Maffi, Carlo Fontana, Aurelio Castoldi, Giuseppe Latronico, Anna Botto, la maestra di Vigevano che portò l’intera scolaresca alla messa funebre per il partigiano Carlo Alberto Crespi e finì poi a Ravensbrück nel forno crematorio, Salvatore Principato, già ricordato, uno dei quindici martiri di piazzale Loreto, intellettuale attivo nel lavoro culturale, partigiano socialista, dentro e fuori di prigione. Il suo nome resta, per sempre, nelle poesie di Salvatore Quasimodo, Alfonso Gatto, Franco Loi.
Quanto contano le parole nel far rivivere la memoria smarrita della libertà e della giustizia. Le pagine di questo libro lo documentano.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- STATO DEMOCRATICO, PARTITI, E MAX WEBER. M. Cacciari: "il partito (parte) tende naturalmente a farsi Stato, e cioè a rovinare la democrazia".31 gennaio 2019, di Federico La Sala
A cento anni da La politica come professione di Max Weber /
L’ultimo eroe. Conversazione con Massimo Cacciari
di Francesco Bellusci (Doppiozero, 28.01.2019)
Cento anni fa, il 28 gennaio del 1919, nelle aule dell’università di Monaco di Baviera, un anno prima della morte, Max Weber tenne una delle sue più celebri conferenze: La politica come professione. In occasione dell’anniversario, la Mondadori ha da poco ristampato l’edizione che contiene questa conferenza e quella tenuta due anni prima, nella stessa università, La scienza come professione, con il titolo: Il lavoro intellettuale come professione, a cura e con l’introduzione di Massimo Cacciari. Il politico vero, secondo Weber, è chi, con perseveranza, senza mai scoraggiarsi, tenta di conciliare vocazione, dedizione alla causa, adesione convinta a determinati valori, con spirito progettuale, professionismo, responsabilità rispetto ai fini, previsione dei mezzi adeguati alla loro realizzazione e delle conseguenze dell’azione. Un traguardo originale che Weber indica agli studenti e ai giovani che lo ascoltano, in un momento storico drammatico per la Germania, nel passaggio dalla monarchia alla repubblica, e per la città stessa di Monaco, scossa da agitazioni rivoluzionarie, consapevole di come l’agire politico, nel contesto della società di massa, possa generare tanto democrazie mature quanto avventure totalitarie o populismi. Di questa straordinaria attualità della lezione del sociologo tedesco abbiamo parlato con Massimo Cacciari.
Francesco Bellusci: Professor Cacciari, lei ha sempre sostenuto l’importanza di questa conferenza di Weber, presentandola come una lezione propedeutica a ogni corso di formazione politica, soprattutto se rivolto ai giovani. Comincio col chiederle: perché conciliare etica dei principi ed etica della responsabilità è però sempre difficile, forse impossibile, e tuttavia l’agire politico non può e non deve ridursi mai all’uno o all’altro, pena il suo snaturamento?
Massimo Cacciari: Il politico di Weber è un "tipo", non la descrizione di qualche "contingenza"; aiuta a far ordine, a comprendere macro-tendenze generali. La realtà è sempre poi una commistione di "tipi". E ogni commistione è poi storicamente relativa. Il "tipo ideale" del politico è chi formula fini "economicamente" raggiungibili, chi si distingue dal profeta e dal demagogo, chi dispone, sì, di un carisma, ma collegato alla sua Zweckrationalität. Si tratta di un ibrido già in sé - ma la maionese impazzisce se c’entrano altri elementi!
Già in L’Arcipelago (Adelphi, Milano 1997), lei rifletteva sull’“ultimo eroe” weberiano. Eroico perché accetta la possibilità che i propri progetti s’infrangano o si ridimensionino sullo scoglio della macchina burocratica e, nello stesso tempo vede, in questa il mezzo indispensabile per la realizzazione di quei progetti. Ma lei insiste anche sul fatto che la vocazione del politico è una “chiamata” che, nel tempo della “morte di Dio” e della “svalorizzazione” dei valori trascendenti (Weber è uno dei primi che apprende a fondo la lezione di Nietzsche), non proviene più da un’autorità extra-umana o da un ordine necessario. Allora: chi “chiama” il politico, a questo compito nella sua vita?
Massimo Cacciari: Chi chiama il politico? Nessuno - la voce del silenzio - la sua "voglia" di rispondere, cioè la sua responsabilità nei confronti di una situazione che intende mutare. Oppure (e anche qui ecco il "doppio") la sua volontà di potere - senza la quale non esiste politico, comunque. Il "tipo" del politico che Weber propone si distacca nettamente da ogni sfondo religioso.
Sono passati più di dieci anni dall’edizione che lei ha curato delle due conferenze. Rispetto ad allora, si sono accentuate alcune tendenze che segnalano la crisi della democrazia rappresentativa. Oggi, il “demagogo” populista prende di mira ora i partiti tradizionali, ora la burocrazia, additandoli come un ostacolo o addirittura una specie di nemico interno per i suoi progetti, presentati come specchio fedele degli interessi popolari. Cioè, prende di mira i due cardini dello Stato democratico moderno per Weber, intesi rispettivamente come la fucina dei “politici di professione” e dei “funzionari specializzati”. È ancora valido il modello di Weber?
Massimo Cacciari: Ciò riguarda la democrazia in generale. Il processo di democratizzazione non era concepibile per Weber senza partiti. Partiti e Stato democratico costituivano un insieme inscindibile. Eppure nient’affatto pacifico - poiché il partito (parte) tende naturalmente a farsi Stato, e cioè a rovinare la democrazia. Bisognava mantenere il rapporto in una "equilibrata tensione" - ecco di nuovo l’eroismo del vero politico!
Adesso, le chiederei qual è il nesso con la conferenza che Weber tiene due anni prima, nel 1917, La scienza come professione. Come si configura per Weber il rapporto tra l’uomo di scienza e l’uomo di azione? In che senso egli considera la scienza e la prassi politica come due forme del lavoro intellettuale? Lo scetticismo su scoperte e applicazioni scientifiche, introdotto nel dibattito pubblico, dimostra come la scienza e la razionalità scientifica, in quanto “valori” e “decisioni” dell’Occidente moderno, non si possano sottrarre al dramma inestinguibile del conflitto di valori. Un aspetto che lei sottolinea nelle prime pagine dell’Introduzione, quando, interpretando anche il Weber metodologo delle scienze storico-sociali, ci dice che la scienza verrebbe meno al suo stesso rigore se avanzasse il suo primato sugli altri saperi, perché - scrive - “la scienza è relativa in quanto all’origine”, ma - aggiunge - “non è relativistica in quanto al suo metodo e al suo rapporto con la realtà che intende comprendere”.
Massimo Cacciari: Scienza e politica formano insieme la "geistige Arbeit" - devono funzionare insieme. Non vi è Stato moderno senza lavoro scientifico, senza rapporto con la Tecnica. E non vi è Tecnica se non sia intrinseca allo Stato. Eppure anche qui si tratta di Due e non di Uno! Ecco il politico di nuovo: che conosce l’essenzialità del lavoro scientifico e in uno conserva l’autonomia delle proprie decisioni. La "politica al comando" è altrettanto utopistica di una "scienza autonoma". Il capitalismo è essenzialmente il sistema che le unifica nel loro stesso contraddirsi.
Si può dire che l’“ultimo eroe”, cioè il politico di vocazione, fosse per Weber l’antidoto agli “ultimi uomini” di cui parla Nietzsche nello Zarathustra e che egli menziona nelle celebri pagine finali dell’Etica protestante e lo spirito del capitalismo? È nel Berufspolitker che Weber confida, per contrastare il destino di un mondo sociale totalmente amministrato e burocratizzato che intravede nel futuro dell’Occidente?
Massimo Cacciari: Weber cita esplicitamente Nietzsche a proposito degli "ultimi uomini" - sono gli "impiegati" senza spirito e i gaudenti (coloro che si godono il proprio benessere) senza cuore. Sono gli invidiosi, gli egoisti, Aristotele avrebbe detto i rappresentanti della pleonexia. Il sistema capitalistico li genera e rigenera - vi sarà un politico in grado di governarli? Weber alla fine della vita ne era disperato.
Weber vedeva, al suo tempo, l’imprenditore industriale moderno come indisponibile alla carriera del “politico di professione”, in quanto inesorabilmente assorbito dalla gestione razionale della sua impresa. Da Berlusconi a Trump, ormai anche il tycoon sembra proporsi come capo politico. Come spiega questo fenomeno? Espone sempre al rischio di una commistione o di una confusione tra l’“impresa politica” e l’“impresa economica”?
Massimo Cacciari: La commistione tra politica e economia genera il capitalismo politico - politica diviene mero attributo. Credo che sia proprio questa la fase che attraversiamo. Non se ne esce regressivamente, nella nostalgia di un "metti la politica al comando" - ma con politici in grado di contra-dire l’economico, di esserne potenti interlocutori - e cioè politici di vocazione dotati di strutture tecnico-organizzative adeguate. Siamo tanto lontani da questa situazione da avvertire l’idea come un’astratta utopia... e questo la dice tutta.
Per Weber, la vanità condanna un politico sempre all’insuccesso o al tramonto o, comunque, ne pregiudica la performance. È d’accordo?
Massimo Cacciari: La vanità è l’opposto della volontà di potenza. quest’ultima sa che cosa deve avere per funzionare e sa calcolare i propri obbiettivi per riuscire. La vanità crede di potere tutto. È esattamente ciò che rovina il politico di professione.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- "HOMO SACER", HOMO LUDENS", E "PULCINELLA". Politica e inoperosità (di Dario Gentili).29 gennaio 2019, di Federico La Sala
Politica e inoperosità
di Dario Gentili (Alfabeta-2, 27.01.2019)
L’edizione integrale pubblicata da Quodlibet rappresenta di Homo sacer, per usare i termini dello stesso Giorgio Agamben, l’edizione «definitiva, aumentata e corretta». Per quanto Agamben abbia in più occasioni precisato che il progetto ventennale di Homo sacer sia da considerare concluso in quanto «abbandonato», ciò non toglie che l’edizione Quodlibet è definitiva quantomeno poiché consente di considerare l’opera nella sua unitarietà. È invece ancora presto per dire quale contributo specifico questa edizione possa apportare alla ricezione di Homo sacer, che, nei più di vent’anni trascorsi dalla pubblicazione del primo libro del progetto (col sottotitolo Il potere sovrano e la nuda vita, Einaudi 1995), ha già una propria storia. Infatti, le figure di pensiero di Homo sacer - solo per nominarne alcune: la nuda vita, lo stato d’eccezione, la teologia economica, la forma di vita, l’uso - hanno caratterizzato già diverse fasi della sua ricezione. Fasi diverse per quanto diversa era la congiuntura storica, politica ed economica su cui ognuno dei nove volumi del progetto è intervenuto, portandola a «leggibilità». Insomma, difficile se non impossibile è stabilire ora come un’edizione definitiva possa configurare ed eventualmente modificare o spingere a riconsiderare la storia della ricezione di Homo sacer. Per questo, ci sarà tempo - un tempo che, come un’edizione definitiva esige, non può essere esclusivamente quello della congiuntura attuale. Preferibile è allora soffermarsi sull’altro termine con cui Agamben contraddistingue questa edizione: «aumentata».
Due sono le integrazioni che l’edizione Quodlibet di Homo sacer presenta: la nota in conclusione di L’uso dei corpi (l’ultimo volume del progetto: IV, 2) e il capitolo Nota sulla guerra, il gioco e il nemico, che diventa l’ultimo di Stasis. La guerra civile come paradigma politico (II, 2). È su quest’ultima integrazione che intendo soffermarmi, non soltanto perché è la più corposa, ma anche perché può rappresentare un approfondimento che concerne gli esiti filosofici dell’intero progetto (vale la pena rammentare che, sebbene L’uso dei corpi sia l’ultimo volume di Homo sacer, tuttavia è Stasis a essere stato pubblicato per ultimo; da Bollati Boringhieri un anno dopo, nel 2015). Inoltre, a riprova di ciò sta il fatto che il capitolo tratta del ben noto «criterio del politico» quale relazione conflittuale tra amico e nemico, teorizzato da Carl Schmitt, uno degli autori in assoluto più ricorrenti di tutto Homo sacer (basti consultare l’Indice dei nomi, che con i Riferimenti bibliografici compone l’utilissima sezione di apparati posta alla fine dell’edizione integrale).
L’analisi di Agamben delle pagine schmittiane si basa sull’implicarsi reciproco di inimicizia e guerra nella definizione del politico. L’argomentazione di Schmitt infatti oscilla nel fare una volta del nemico e un’altra della guerra il presupposto della relazione costitutiva che determina il concetto di politico: se il nemico assume una preminenza «politica» rispetto all’amico, è tuttavia nella «possibilità reale dell’uccisione fisica», cioè nella guerra, che ciò viene definitivamente a manifestazione.
L’opposizione amico-nemico quale criterio del politico svolgerebbe dunque la funzione di celare o mitigare la crudezza del fondamento ultimo della politica, la guerra, facendo così dell’inimicizia la protagonista unilaterale della politica. È a partire da qui, dalla massima stringenza del dispositivo schmittiano, che Agamben procede per disattivarlo. Non procede pertanto dal suo interno, dal concetto di amicizia (come in fondo ha fatto Jacques Derrida in Politiche dell’amicizia), sostanzialmente catturato e neutralizzato dal primato dell’inimicizia nel caso - decisivo per determinare la situazione politica - della guerra.
Agamben procede invece dal concetto di guerra che Schmitt assume, ovvero da ciò che un ambito del politico definito dalla guerra effettivamente «esclude». Si ribadisce così quella che è la modalità propria di pensiero di Agamben in Homo sacer: è l’esclusione - ad esempio della «nuda vita» e della «vita sacra» nel primo volume dell’opera - a consentire, fin dalle origini della tradizione occidentale, la costituzione dell’ambito - o, detto altrimenti, del «campo» - della politica. Nel caso della guerra, a essere escluso dall’ambito della politica è il «gioco».
Agamben riprende la critica che Leo Strauss mosse nel 1932 al Concetto del politico, mettendo l’accento sul «divertimento» che, tra le altre cose, per Schmitt caratterizzerebbe il mondo qualora venisse meno la distinzione tra amico e nemico - e, con essa, la politica stessa. Nella riedizione del 1963 dello scritto, Schmitt risponde alla critica di Strauss, precisando che, per «divertimento», bisognerebbe intendere appunto «gioco». La politica è una cosa seria, come «serio» è il caso di eccezione in cui la sovranità è chiamata a «decidere».
 Agamben prende molto sul serio l’avversione di Schmitt nei confronti del gioco - o, meglio, della riduzione della politica a gioco - e vi riconosce la vera posta in palio della politica in quanto tale. Per Agamben, infatti, non soltanto il gioco corrisponde a ciò che una politica per costituirsi come guerra deve escludere, ma rappresenta anche la possibilità di un concetto alternativo di politica. Alternativo come è quello configurato, in Pulcinella ovvero Divertimento per li regazzi (nottetempo 2015), dalla forma-di-vita di Pulcinella, che «annuncia ed esige un’altra politica»: una politica della commedia piuttosto che quella della tragedia cara a Schmitt. E, in effetti, come la commedia è più antica della tragedia, così lo è il gioco rispetto alla guerra quale forma e dinamica del conflitto.
Agamben prende molto sul serio l’avversione di Schmitt nei confronti del gioco - o, meglio, della riduzione della politica a gioco - e vi riconosce la vera posta in palio della politica in quanto tale. Per Agamben, infatti, non soltanto il gioco corrisponde a ciò che una politica per costituirsi come guerra deve escludere, ma rappresenta anche la possibilità di un concetto alternativo di politica. Alternativo come è quello configurato, in Pulcinella ovvero Divertimento per li regazzi (nottetempo 2015), dalla forma-di-vita di Pulcinella, che «annuncia ed esige un’altra politica»: una politica della commedia piuttosto che quella della tragedia cara a Schmitt. E, in effetti, come la commedia è più antica della tragedia, così lo è il gioco rispetto alla guerra quale forma e dinamica del conflitto.Prendendo le mosse da Homo ludens di Huizinga, Agamben riconduce il conflitto all’ambito greco dell’agon, più prossimo alla sfera del gioco, piuttosto che all’ambito, bellico, del polemos. Diverse sono le fonti a cui Agamben fa riferimento per asserire l’originarietà del conflitto agonale nella Grecia antica, fino a sostenere con Vernant l’«intima solidarietà fra il conflitto e l’associazione», che - aggiungo io sulla scorta di Nicole Loraux - si può riscontrare addirittura nell’etimo di agorà, lo spazio per eccellenza del confronto politico nella polis. È dunque come agon che il conflitto sposta sull’amicizia il fuoco del criterio del politico: «possiamo allora proporre l’ipotesi - opposta a quella formulata da Schmitt - che in origine la guerra sia un aspetto della funzione agonale-giocosa, consustanziale alla convivenza fra gli uomini, attraverso la quale vengono costruiti rapporti di integrazione e di philía fra gruppi estranei o, all’interno della stessa comunità, fra diverse classi di età».
 Per dirla con i termini che appartengono al lessico dell’intero Homo sacer: se la guerra è la messa in opera del conflitto, il gioco è l’inoperosità del conflitto. E tuttavia, pur sempre di politica si tratta - è per questo che il capitolo Nota sulla guerra, il gioco e il nemico getta una luce significativa sulla portata politica dell’intero progetto di Homo sacer, spesso tacciato di impoliticità quanto agli esiti che categorie come «potenza destituente» e, appunto, «inoperosità» sembrano profilare.
Per dirla con i termini che appartengono al lessico dell’intero Homo sacer: se la guerra è la messa in opera del conflitto, il gioco è l’inoperosità del conflitto. E tuttavia, pur sempre di politica si tratta - è per questo che il capitolo Nota sulla guerra, il gioco e il nemico getta una luce significativa sulla portata politica dell’intero progetto di Homo sacer, spesso tacciato di impoliticità quanto agli esiti che categorie come «potenza destituente» e, appunto, «inoperosità» sembrano profilare.Di altro segno rispetto alla deriva impolitica è invece la problematicità che intendo qui rilevare. Pur tenendo ferma la distinzione tra conflitto e guerra, tale che il gioco apre a un uso politico del conflitto - legato all’associazione e all’integrazione dello straniero nella comunità - alternativo a quello bellico, bisogna tuttavia ricordare come l’agorà non è solo «piazza politica», ma è anche «mercato». Non a caso, nella Nota, si cita la definizione che Vernant fornisce di agon: «competizione organizzata». È un gioco, infatti, anche quello che ha luogo sul mercato: il gioco instaurato dallo scambio e dal commercio. Ed è un gioco che prevede la sospensione dell’inimicizia politica, razziale, religiosa, accogliendo così lo straniero in quanto partner commerciale (per secoli, infatti, il mercato è stato uno spazio ex lege). Ne è ben consapevole Friedrich von Hayek, uno dei pensatori di riferimento del neoliberalismo, quando definisce catallassi la sua concezione dell’ordine spontaneo del mercato, a cui attribuisce una evidente funzione politica, anch’essa alternativa al criterio del politico di Schmitt: «Propongo di chiamare questo ordine spontaneo di mercato catallassi, in analogia con il termine “catallattica”, che è stato spesso proposto come sostituto del termine “economia” (entrambe le espressioni, “catallassi” e “catallattica”, derivano dall’antico verbo greco Katallattein che, significativamente, vuol dire non solo “barattare” e “scambiare”, ma anche “ammettere nella comunità” e “diventare amici da nemici”)».
Certo, anche Hayek presuppone il nemico; ma il suo non è il nemico politico in guerra come per Schmitt, bensì il concorrente sul mercato, con il quale si possono stringere, seppur temporaneamente, accordi di amicizia. C’è allora da chiedersi se non sia stato proprio il gioco del mercato ad aver soppiantato la seriosa politica della guerra di Schmitt. Homo sacer provvede a delineare dell’economia la genealogia teologica (in Oikonomia, nuovo titolo del Regno e la Gloria nell’edizione Quodlibet); ma si potrebbe risalire a un’altra e complementare genealogia dell’economico, lungo un’ulteriore linea di ricerca che potrebbe aprirsi oggi da una rilettura, magari contropelo, di Homo sacer: una linea di ricerca genealogica, altrettanto contrassegnata da quelle ambivalenze che Agamben magistralmente ci ha insegnato a rintracciare, che faccia emergere una economia politica dell’inoperosità.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
I SEGNI DEI TEMPI. L’ECONOMIA DELLA SALVEZZA ("Deus charitas est": 1 Gv., 4.8) E L’ECONOMIA DELLA RICCHEZZA, DI "MAMMONA" E "MAMMASANTISSIMA" ("Deus caritas est": Benedetto XVI, 2006): UNA TENSIONE SPEZZATA ...
 "IL TEMPO CHE RESTA": UNA DOMANDA DI GIORGIO AGAMBEN A UNA CHIESA PERSA NEL TEMPO.
"IL TEMPO CHE RESTA": UNA DOMANDA DI GIORGIO AGAMBEN A UNA CHIESA PERSA NEL TEMPO.VERITA’ E VERIDIZIONE: PAROLE PER UNA NUOVA POLITICA. Agamben fa un passo innanzi con Foucault, ma cento passi indietro senza Kant.
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- LA SPETTRALE PRESENZA. La personale “Der Körper” di Antonello Fresu al Palazzo dei Pio di Carpi.27 gennaio 2019, di Federico La Sala
PER LA PACE E PER IL DIALOGO, QUELLO VERO, PER "NEGARE A HITLER LA VITTORIA POSTUMA" (Emil L. Fackenheim, "Tiqqun. Riparare il mondo").
 A EMIL L. FACKENHEIM, (...) il merito di aver ri-proposto la domanda decisiva: “come fu possibile la hitlerizzazione dell’Imperativo Categorico di Kant? E perché è ancora attuale oggi?”
A EMIL L. FACKENHEIM, (...) il merito di aver ri-proposto la domanda decisiva: “come fu possibile la hitlerizzazione dell’Imperativo Categorico di Kant? E perché è ancora attuale oggi?”
La spettrale presenza. Hitler, la radiografia e l’inconscio ottico
di Marco Senaldi *
- Inaugura domani 26 gennaio la personale “Der Körper” di Antonello Fresu al Palazzo dei Pio di Carpi. Anticipiamo qui il testo critico di Marco Senaldi, che parte da un passo della Montagna incantata di Thomas Mann e arriva alle radiografie di Hitler.
 [Foto] Antonello Fresu. Der Körper, still da video. Palazzo dei Pio, Carpi 2019
[Foto] Antonello Fresu. Der Körper, still da video. Palazzo dei Pio, Carpi 2019In un brano indimenticabile de La montagna incantata di Thomas Mann, pubblicato nel 1924 ma ambientato alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, il protagonista Hans Castorp è oggetto di una radiografia.
 “E Castorp vide [...] in anticipo, grazie alla potenza della luce, la futura opera della decomposizione, la carne, che lo rivestiva, dissolta, distrutta, sciolta in una nebbia evanescente, e dentro a questa lo scheletro della sua destra finemente tornito, dove intorno alla falange dell’anulare era sospeso, nero e isolato, il suo anello col sigillo ereditato dal nonno [...] e per la prima volta in vita sua si rese conto che sarebbe morto. Behrens disse: ‘Spettrale, vero? Eh, una punta di spettralità c’è davvero’”.
“E Castorp vide [...] in anticipo, grazie alla potenza della luce, la futura opera della decomposizione, la carne, che lo rivestiva, dissolta, distrutta, sciolta in una nebbia evanescente, e dentro a questa lo scheletro della sua destra finemente tornito, dove intorno alla falange dell’anulare era sospeso, nero e isolato, il suo anello col sigillo ereditato dal nonno [...] e per la prima volta in vita sua si rese conto che sarebbe morto. Behrens disse: ‘Spettrale, vero? Eh, una punta di spettralità c’è davvero’”.Si tratta di un passaggio sintomatico per diverse ragioni. Sia pur attribuendola a Castorp, esso descrive, con grande precisione, una delle prime immagine a raggi X realizzata da Röntgen, quella della mano dell’amico Albert von Kölliker, in cui, attorno allo scheletro “finemente tornito” delle dita, spicca un anello maschile. La meraviglia dell’eroe di Mann testimonia che, ai suoi esordi, lungi dall’essere considerata un semplice dispositivo clinico, la radiografia a raggi X rivestiva ben altri significati che toccavano la consapevolezza e la fisicità del soggetto. E, in effetti, la diffusione delle immagini radiografiche fu all’inizio accolta non tanto come un avanzamento nella scienza medica, quanto come una curiosità scientifica, e anche una tecnica artistica, in grado di far vedere l’invisibile, in un periodo in cui le innovazioni nel campo della riproduzione delle immagini si succedevano l’una all’altra con grande rapidità.
L’anno della scoperta di Röntgen, il 1895, infatti, coincide con quello dell’invenzione del cinematografo, ma anche con la prima Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia (antenata della futura Biennale d’arte) e con uno straordinario articolo di Georg Simmel sulla psicologia della moda. Moda, cinema, arte, sono altrettanti fenomeni legati alle immagini, intese non solo come rappresentazioni del reale, ma anche come rappresentazioni di noi stessi, e dunque della nostra identità. Possiamo perciò intendere queste invenzioni come altrettanti dispositivi, cioè strumenti che ci permettono di amplificare le capacità umane, ma, consentendoci di modificare la nostra visione del mondo, contemporaneamente modificano modo in cui vediamo e consideriamo noi stessi.
- [Foto]Antonello Fresu. Der Körper. Installation view at Palazzo dei Pio, Carpi 2019
È questo il motivo per cui tutte queste invenzioni evidenziano un carattere ancipite e fortemente antinomico. Da un lato il cinema, come nota ottimisticamente Walter Benjamin, risponde al diritto di ogni uomo ad essere ripreso, dall’altro introduce una drammatica spaccatura all’interno del soggetto, come testimonia Varia Nestoroff, l’attrice russa protagonista del romanzo di Pirandello Si gira!, del 1913, che non si riconosce nelle immagini di se stessa sullo schermo. Allo stesso modo l’arte moderna - inaugurata appunto dall’esposizione veneziana - intesa come “evento temporaneo”, da un lato libera dal giogo della tradizione, ma dall’altro avvia un processo di destabilizzazione permanente nel fare creativo dell’artista; e infine, suprema contraddizione è quella che Simmel attribuisce alla moda, che, tramite la manipolazione dell’immagine offerta dall’abito, da un lato promette all’individuo di distinguersi dalla folla, e dall’altro risponde esattamente al bisogno opposto, quello di uniformarsi con la massa.
Questa discordanza diventa esplosiva nel caso dei raggi X. Scoperti quasi casualmente nel corso di una ricerca sui raggi catodici, solo in seguito vennero utilizzati per scopi diagnostici, in quanto in grado di osservare la struttura ossea al di sotto della pelle, ma quasi subito ci si rese conto della loro pericolosità per la salute. In pratica, i raggi X rendono evidente il paradosso epistemologico della modernità, la quale, nello sforzo di conoscere l’essenza al di là delle apparenze, finisce col contaminarla o persino per distruggerla. Questa ambiguità radicale riaffiora in un altro grande romanzo sul destino delle immagini, cioè L’invenzione di Morel di Adolfo Bioy Casares, apparso non per caso nel 1940.
 Il dispositivo di Morel consiste infatti in una macchina da presa e da proiezione in grado di restituire non solo l’apparenza visiva delle cose riprese, ma la loro consistenza, generando per così dire dei doppioni “tangibili” identici agli originali. Il solo difetto della macchina - ma è un difetto fatale - è che gli esseri viventi che ne subiscano le riprese patiscono effetti devastanti, e sono destinati in breve tempo a una morte certa.
Il dispositivo di Morel consiste infatti in una macchina da presa e da proiezione in grado di restituire non solo l’apparenza visiva delle cose riprese, ma la loro consistenza, generando per così dire dei doppioni “tangibili” identici agli originali. Il solo difetto della macchina - ma è un difetto fatale - è che gli esseri viventi che ne subiscano le riprese patiscono effetti devastanti, e sono destinati in breve tempo a una morte certa.Il valore politico della metafora di Bioy Casares, concepita alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, è evidente: la massima riproducibilità dell’esistente è anche ciò che ne cancella l’esistenza; la duplicazione perfetta della vita non è che un modo inconsapevolmente perfetto per creare un universo di morte. In un certo senso, la parabola del nazismo corre lungo binari paralleli a questi: la sua esaltazione inconsulta della vitalità superomistica, dell’agonismo estetico e della kalokagathia olimpica (così ben raffigurati nelle immagini sublimi dei film di propaganda di Leni Riefenstahl, come appunto Olympia, 1936) non è che l’altra faccia, la proiezione splendente e solare, dell’oscuro desiderio di morte, di distruzione e di annientamento che viene simbolicamente rappresentato, nelle uniformi dei dittatori, dall’icona del teschio.
- [Foto]Antonello Fresu. Der Körper. Palazzo dei Pio, Carpi 2019
E torniamo così alle ossa, il residuo incancellabile che viene messo in evidenza per la prima volta dai raggi X. Si dice che la moglie di Röntgen, Bertha, che fu in effetti la prima persona ad essere sottoposta a una radiografia dal marito, abbia mormorato, osservando l’immagine radiografica della propria mano, “ho visto la mia morte”. Aveva ragione - salvo che non si trattava della morte in senso tradizionale, come termine delle funzioni vitali, distacco del corpo dall’anima o semplicemente dissolvimento della materia nei suoi componenti atomici: ciò a cui la radiografia ci mette di fronte è piuttosto l’enigmatico carattere inorganico della nostra natura animale, il suo residuo ancestrale, quasi l’impronta scheletrica di un fossile, il sigillo della morte catturato però dentro un essere vivente. Questa presa di coscienza della nostra inconsapevole origine minerale ha effetti devastanti: ci si rende infatti conto non solo della nostra fragile natura mortale, ma anche del fatto contrario - reso possibile solo da una tecnica essenzialmente moderna come i raggi X - cioè dell’esistenza in noi stessi di qualcosa di alieno che ci sopravvivrà. Da qui l’elemento fantasmatico, ossia non-del-tutto-mortale, testimoniato dalla radiografia, cioè la “punta di spettralità” così ben individuata da Behrens, il medico di Castorp.
Il fatto che anche Hitler sia stato sottoposto, come milioni di altri pazienti, ad una indagine radiografica, potrebbe essere preso come un fatto del tutto normale. Ma cessa immediatamente di esserlo se pensiamo che lo stesso individuo è stato anche uno dei primi personaggi storici ad essere filmato e fotografato con una tale frequenza e una tale assiduità che non hanno precedenti. Tuttavia, mentre le fotografie e i filmati ci restituiscono un Hitler sempre presente a se stesso, sempre attentissimo a interpretare un ruolo pubblico divenuto in lui come una autentica “seconda natura”, le sue radiografie colgono un aspetto inedito e sconcertante della sua personalità. Guardarle è come osservare il fossile di un temibile Tirannosaurus Rex, il mostruoso dinosauro predatore del giurassico, il cui scheletro, anche se ridotto a una curiosità da Museo di scienze naturali, incute ancora timore. In esse cogliamo un Hitler che nemmeno Hitler sapeva di possedere, il suo estremo residuo umano, la struttura inorganica che testimonia due cose: sia il fatto che anche lui apparteneva - che gli piacesse o no - alla nostra specie -, sia il fatto che non ne era al corrente. Se c’è un’immagine che rappresenta il concetto benjaminiano di “inconscio ottico”, questa è certamente la radiografia di Hitler - cioè non la descrizione del suo inconscio psicologico (fin troppo scandagliato), ma l’istantanea del suo inconscio per così dire antropologico, la sua essenza “umana”, troppo umana, da cui certamente avrebbe desiderato liberarsi.
Non è un caso che uno dei più implacabili satireggiatori del regime nazista, cioè quel Helmut Herzfeld che cambiò il suo nome in John Heartfield in dispregio alle sue origini germaniche, abbia rappresentato nel 1932 il “vero” Hitler, utilizzando una radiografia in cui, sotto il volto del Fürher si vede il suo busto pieno di monete d’oro, in un fotomontaggio dall’ironico titolo Hitler Superuomo - ingoia oro e sputa schifezze.
 Allo stesso modo, nell’operazione di Antonello Fresu, le riproduzioni ingigantite delle radiografie del Fürher e i suoi esami medici ci mettono di fronte a un enigma che certamente era enigmatico per Hitler stesso: come può un superuomo simile condividere con la vile razza umana la stessa misera impalcatura scheletrica?
Allo stesso modo, nell’operazione di Antonello Fresu, le riproduzioni ingigantite delle radiografie del Fürher e i suoi esami medici ci mettono di fronte a un enigma che certamente era enigmatico per Hitler stesso: come può un superuomo simile condividere con la vile razza umana la stessa misera impalcatura scheletrica?
 L’aspetto spettrale che promana da queste gigantografie è fantasmatico in un duplice senso: da un lato perché accende in chi guarda la sensazione di un morire incompleto, che si lascia dietro il resto ineliminabile dello scheletro osseo; dall’altro perché questo scheletro appartiene veramente a un fantasma, anzi al peggior incubo possibile, quello dell’individuo più disumano di sempre, Adolf Hitler. Il sottile senso di inquietudine che ne promana è anch’esso quindi duplice perché da un lato riguarda genericamente la paura della morte, ma dall’altro concerne una paura ancor più radicale, cioè che lo spettro qui radiografato non sia veramente morto, e che la sua scheletrica presenza possa ancora, in un dato momento, rianimarsi.
L’aspetto spettrale che promana da queste gigantografie è fantasmatico in un duplice senso: da un lato perché accende in chi guarda la sensazione di un morire incompleto, che si lascia dietro il resto ineliminabile dello scheletro osseo; dall’altro perché questo scheletro appartiene veramente a un fantasma, anzi al peggior incubo possibile, quello dell’individuo più disumano di sempre, Adolf Hitler. Il sottile senso di inquietudine che ne promana è anch’esso quindi duplice perché da un lato riguarda genericamente la paura della morte, ma dall’altro concerne una paura ancor più radicale, cioè che lo spettro qui radiografato non sia veramente morto, e che la sua scheletrica presenza possa ancora, in un dato momento, rianimarsi.- [Foto] Antonello Fresu. Der Körper. Palazzo dei Pio, Carpi 2019
Si dice che, poco prima di morire, Hitler abbia affermato che “bisogna eliminare l’ebreo che è in noi”. Un’affermazione ambigua e inquietante, che sembra far presagire il vero futuro dell’antisemitismo “classico” - cioè non tanto e non più solo lo sterminio di una “razza” considerata inferiore, e tuttavia esterna a quella superiore, ma la cancellazione dell’ultima traccia di altruismo all’interno del soggetto “superiore” stesso, la distruzione dell’umano all’interno del superuomo. La visione dell’installazione di Antonello Fresu fornisce una possibile risposta alla sconcertante affermazione di Hitler: ciò da cui egli avrebbe voluto liberarsi, senza per questo riuscirci, era proprio ciò che le sue radiografie ci permettono invece di vedere: il suo scheletro, il suo teschio, i suoi organi interni, così miseramente identici a quelli di chiunque. D’altra parte, queste immagini ricordano a tutti noi che liberarsi dal fantasma di Hitler ci è altrettanto impossibile che per lui liberarsi dal fantasma dell’ebreo interiore: lo spettro di questo “Hitler interiore” è dentro di noi come le nostre ossa e i nostri organi interni, ci appartiene più di quanto noi stessi non ci apparteniamo e incarna quel fantasma del Male da cui, anche nei nostri sogni più radiosi, continuiamo a essere ossessionati.
* Marco Senaldi (Artribune, 25,01,2019)
Radiografie e battiti del cuore va in mostra il corpo di Hitler
Si inaugura a Carpi il controverso allestimento curato dallo psicoanalista Antonello Fresu
di Marco Belpoliti (la Repubblica, 26.01.2019)
- [Foto] Adolf Hitler; in alto, l’allestimento della mostra Der Körper al Palazzo dei Pio di Carpi (fino al 31 marzo) con le radiografie di Hitler
Hitler a Carpi? Cosa ci fa la radiografia del capo nazista nella Sala dei Cervi dell’antico Palazzo dei Pio insieme al battito tambureggiante del suo cuore?
Hitler è morto suicida il 30 aprile 1945 nel bunker della Cancelleria di Berlino. Il suo corpo fu cosparso di benzina e bruciato, quindi la salma carbonizzata sepolta insieme ai resti di altri cadaveri irriconoscibili. I soldati sovietici cercarono il corpo del dittatore, fino a che rinvennero un osso mandibolare e due ponti dentari; presentati al suo odontotecnico, Fritz Echtmann, furono identificati grazie alla cartelle cliniche. Nonostante questo, restò l’ipotesi che fosse ancora vivo e nascosto da qualche parte, una leggenda che circolò negli anni ’50 e ’60. Nel 1945 l’esercito americano realizzò un dossier sul capo nazista utilizzando le cartelle cliniche del suo medico, Theodor Morrell: 47 pagine che contenevano la radiografia del cranio del leader e alcuni elettrocardiogrammi, intitolate Investigation into whereabouts. Nel 1983 sono state rese accessibili insieme alle ricerche dell’Fbi per "ritrovare" il dittatore.
Antonello Fresu, psicoanalista junghiano, ha usato quelle pagine e realizzato l’installazione Der Körper che s’inaugura oggi nello spazio del castello di Carpi sotto l’egida della Fondazione Fossoli (fino al 31 marzo). Nella prima stanza buia appaiono le imponenti radiografie del cranio di Hitler, alte tre metri, retroilluminate: sono fantasmi neri su fondo bianco, e insieme impressionanti opere grafiche, il cui significato luttuoso appare subito evidente.
 Nella seconda sala i referti clinici analizzati da specialisti medici di oggi, come si trattasse di un paziente qualsiasi, mentre sulla volta appaiono parate naziste, Hitler che arringa la folla e raduni militari. Nella terza stanza sono riportati i documenti del dossier americano, mentre nella quarta, e ultima, su uno schermo compare la simulazione del battito del cuore e un elettrocardiografo dell’epoca emette il tracciato di quell’esame clinico in presa diretta: si attiva appena le persone entrano nella sala come un misterioso saluto di benvenuto.
Nella seconda sala i referti clinici analizzati da specialisti medici di oggi, come si trattasse di un paziente qualsiasi, mentre sulla volta appaiono parate naziste, Hitler che arringa la folla e raduni militari. Nella terza stanza sono riportati i documenti del dossier americano, mentre nella quarta, e ultima, su uno schermo compare la simulazione del battito del cuore e un elettrocardiografo dell’epoca emette il tracciato di quell’esame clinico in presa diretta: si attiva appena le persone entrano nella sala come un misterioso saluto di benvenuto.L’idea di Fresu, attento indagatore dell’Ombra, per dirla con Jung, ha qualcosa d’inquietante: stende un mantello di nere tenebre in questo luogo e obbliga i visitatori a incontrare, come scrive Marco Senaldi in un testo che apparirà nel catalogo della mostra, a guardare il fossile di un Tirannosaurus Rex, il cui scheletro è stato conservato e trasformato in curiosità espositiva da Museo di Scienze Naturali. Già di per sé le radiografie sono qualcosa di conturbante, e queste di grandi dimensioni, anche senza sapere che appartengono al cranio di Hitler, inquietanti. Pare che la moglie dell’uomo che ha inventato questo metodo d’indagine, Wilhelm C. Röntgen, dopo essere stata sottoposta alla prima radiografia, abbia detto: ho visto la mia morte. Questi light box contengono una doppia morte: quella del paziente Adolf Hitler e quella del dittatore che ha provocato la più immane catastrofe del XX secolo. Un uomo e insieme il peggior criminale della storia. È come se, per una nera magia, il doppio corpo del Re, per dirla con Ernst Kantorowicz, corpo materiale e corpo sacrale, corpo che muore e quello che invece si trasmette sotto forma di regalità, si fossero ricongiunti per un imponderabile maleficio. Fresu, nel suo doppio ruolo di psicoanalista e di artista, ha messo in mostra un’ombra e il suo fantasma. Come se i fantasmi potessero avere un’ombra. Batte il cuore di uno spettro mentre i soldati camminano a passo dell’oca sulle volte ricurve del Castello.
Spettro perché, mentre i fantasmi sono bianchi, Hitler è nero, anzi nerissimo. Il capo nazista è stato e resta un enigma. Il suo maggior biografo, l’inglese Ian Kershaw, s’è chiesto come un uomo così bizzarro abbia potuto prendere il potere in uno Stato moderno com’era la Germania dell’inizio del XX secolo. Dotato di grandi abilità demagogiche e di una capacità straordinaria di sfruttare le debolezze dei suoi avversari, Hitler resta un mistero per chi l’ha indagato: di quali poteri era dotato per riuscire a trascinare le classi dirigenti tedesche in un’avventura così nefanda e disastrosa? Risposta non c’è. Salvo ricorrere alla metafisica del Male, o a spiegazioni che esorbitano dalla nostra comprensione razionale. Der Körper bordeggia quello spazio irrazionale, lo lambisce e per questo scuote il visitatore, lo mette in allerta. Persegue questo scopo e anche quello di indicare che Hitler era un uomo come noi, che aveva un corpo simile al nostro: era normale. Non era un mostro?
Possibile? Il concetto di "mostro" non è facile da maneggiare; fa vacillare, perché spiega qualcosa d’inspiegabile. Primo Levi, al termine del suo I sommersi e i salvati, sostiene di non aver mai incontrato dei mostri nel lager, solo degli uomini che erano stati educati male. L’arcano di Hitler resta irrisolto.
 La mostra è elegante e la sua provocazione colpisce. Tra tutti i dittatori del XX secolo, Hitler era quello che sembrava avere meno corpo di tutti; lo nascondeva persino ai propri intimi: nessuno l’ha mai visto a torso nudo. Come aveva detto Jung, intervistato da un giornalista americano, poco dopo la sua ascesa al potere, quello che colpiva era prima di tutto la voce del dittatore, la vibrazione isterica che conteneva, una voce che stregava milioni di tedeschi e li coinvolgeva. Come controcanto a questa ostensione fantasmatica della testa e del cuore del dittatore funziona la voce tremenda di Hitler che echeggia nelle sale, una voce uscita da un corpo così piccolo e modesto, che non riusciamo a dimenticare, e che come uno spettro circola ancora oggi per l’Europa dei suoi tardi, assurdi e fanatici ammiratori.
La mostra è elegante e la sua provocazione colpisce. Tra tutti i dittatori del XX secolo, Hitler era quello che sembrava avere meno corpo di tutti; lo nascondeva persino ai propri intimi: nessuno l’ha mai visto a torso nudo. Come aveva detto Jung, intervistato da un giornalista americano, poco dopo la sua ascesa al potere, quello che colpiva era prima di tutto la voce del dittatore, la vibrazione isterica che conteneva, una voce che stregava milioni di tedeschi e li coinvolgeva. Come controcanto a questa ostensione fantasmatica della testa e del cuore del dittatore funziona la voce tremenda di Hitler che echeggia nelle sale, una voce uscita da un corpo così piccolo e modesto, che non riusciamo a dimenticare, e che come uno spettro circola ancora oggi per l’Europa dei suoi tardi, assurdi e fanatici ammiratori. -
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- "IL FUTURO ADDOSSO", "IL POPULISMO NEL CUORE", E LA DEMOCRAZIA - LA COSTITUZIONE.25 gennaio 2019, di Federico La Sala
Il populismo nel cuore (delle democrazie)
di Gianfranco Pasquino (Il Mulino, 25 gennaio 2019)
Nessuna nostalgia per il passato, nessuna paura per il futuro. Capire il presente per costruire il futuro. Queste sono le due considerazioni che hanno guidato la mia lettura del denso, stimolante, efficace volume di Ferruccio Capelli, Il futuro addosso. L’incertezza, la paura e il farmaco populista (Milano, Guerini e Associati, 2018). Ho anche pensato che il presente è il prodotto del passato, di scelte, errori e responsabilità personali che bisogna individuare e criticare, superare. -Differentemente da Capelli, credo che il presente non sia tutto populismo. È molto diversificato, non ha bisogno del "farmaco" populista, ma di politica e già contiene non pochi anticorpi che debbono e possono essere sollecitati. La grande trasformazione degli ultimi trent’anni è stata innescata, secondo Capelli, da due possenti motori: la globalizzazione (finanziaria e delle comunicazioni) e l’innovazione tecnologica. È stata giustificata e sostenuta dall’ideologia neo-liberale. Si è manifestata in tre ambiti, ovvero secondo tre modalità: la disintermediazione, la solitudine (involontaria) e lo spaesamento (culturale). L’esito complessivo è stato quello di aprire grandi spazi - vere e proprie praterie - alle incursioni populiste. Il populismo, o meglio, i populisti offrono una risposta che definirò ricompositiva: mettono insieme il loro popolo (gli altri, quelli che non ci stanno a farsi mettere insieme e continuano a essere molti, si meritano la definizione di "nemici del popolo" e come tali sono trattati), lo utilizzano contro le élite (l’establishment che Capelli sembra identificare con i potenti che si riuniscono a Davos, con coloro che definisce il "senato virtuale", ma - di volta in volta - bisognerebbe specificare quale sia loro presenza e influenza dentro ciascun sistema politico e coglierne anche le contraddizioni), applicando politiche escludenti. Nazionalisti, forse, sovranisti di sicuro, quasi tutti i populisti, anzi, le élite (!) populiste appartengono a un passato del quale, però, non rivelano particolare nostalgia, tranne quella per un’omogeneità etnica, sicuramente non più recuperabile.
Disintermediazione vuole dire, secondo Capelli - e sono d’accordo - la scomparsa di capacità associative e, al tempo stesso, l’indebolimento di tutte le associazioni intermedie che avevano costituito il tessuto connettivo dei processi di democratizzazione e di consolidamento delle democrazie. A sostegno di ciò potrei citare alcuni importanti politologi che hanno scritto e argomentato che le democrazie sono inconcepibili senza partiti.
 Preferisco ricordare che - secondo Palmiro Togliatti - i partiti sono "la democrazia che si organizza". Giustamente, Capelli chiama in causa Alexis de Tocqueville e il suo elogio con sorprese delle propensioni associative degli americani, forse sottovalutando il pericolo del conformismo che l’aristocratico francese intravedeva in democrazie basate sull’uguaglianza di condizioni. Sotto dirò di più su uguaglianza e disuguaglianze.
Preferisco ricordare che - secondo Palmiro Togliatti - i partiti sono "la democrazia che si organizza". Giustamente, Capelli chiama in causa Alexis de Tocqueville e il suo elogio con sorprese delle propensioni associative degli americani, forse sottovalutando il pericolo del conformismo che l’aristocratico francese intravedeva in democrazie basate sull’uguaglianza di condizioni. Sotto dirò di più su uguaglianza e disuguaglianze.Certo, la solitudine non conduce a interesse politico, a partecipazione politica, a solidarietà. La folla solitaria del sociologo americano David Riesman, pubblicato nel 1950, con un sottotitolo rivelatore: A study of the changing American character, precede di quasi cinquant’anni il - forse triste forse no - "andare a giocare a bowling da soli" (ovvero non con una squadra di amici), best seller di Robert Putnam relativo al capitale sociale, vale a dire alle reti di rapporti sociali e affettivi che rendono la vita migliore. Naturalmente, un conto è rimanere/ritrovarsi soli, un conto è il volere essere soli e non curarsene poiché si è convinti di possedere le risorse intellettuali, culturali, professionali per cavarsela senza l’aiuto di nessuno e per attivarsi esclusivamente con l’obiettivo di proteggere e promuovere i propri interessi. Sono i "post-materialisti" intelligentemente individuati e studiati da Ronald Inglehart, prodotti e produttori di una rivoluzione silenziosa nei costumi e nei comportamenti.
"Lo spaesamento del cittadino, senza mediazioni e senza cornici culturali, è un altro volto della solitudine dell’uomo [e della donna!] contemporaneo. Egli è libero, svincolato dalle tradizioni e da vincoli predefiniti con gli altri esseri umani, ma l’esercizio della sua libertà si rivela quanto mai problematico" (p.177).
 Nel 1941, il grande psicologo Erich Fromm colse nel desiderio di fuggire dalla libertà - ovvero dalla necessità di scegliere e dalla corrispondente responsabilizzazione, una delle ragioni per le quali uomini e donne si assoggettarono ai fascismi e al nazismo. Oggi, forse, è il leader populista a offrire questa protezione dalla libertà che, però, il cittadino esercita "nella galassia infinita del mercato" (p. 117).
Nel 1941, il grande psicologo Erich Fromm colse nel desiderio di fuggire dalla libertà - ovvero dalla necessità di scegliere e dalla corrispondente responsabilizzazione, una delle ragioni per le quali uomini e donne si assoggettarono ai fascismi e al nazismo. Oggi, forse, è il leader populista a offrire questa protezione dalla libertà che, però, il cittadino esercita "nella galassia infinita del mercato" (p. 117).Dietro o intorno a tutto questo stanno, da un lato, l’irresistibile globalizzazione, cioè un processo forse ingovernabile, certamente non governato; dall’altro, la vittoria su tutta la linea, sostiene Capelli, dell’ideologia neo-liberale. Le capacità di ciascuno e di tutti si misurano attraverso la competizione nei mercati. Il merito viene premiato. Gli sconfitti sono responsabili della loro condizione. Al massimo, lo Stato deve adempiere al compito di regolatore e valutatore. Non deve mai intervenire a favore di chicchessia, ma noi sappiamo - o forse no, sostiene Capelli - che esiste un Senato virtuale, fatto dai potenti in ciascun settore, che squilibra tutta la competizione e, quindi, che incide sugli esiti facendo diventare più ricchi i ricchi e più poveri i poveri. "Il populismo è il sintomo [sosterrei, piuttosto, che è l’esito] più evidente della crisi della politica ridotta nella stagione neoliberale a tecnica di adattamento al mercato e di gestione del contingente" (p.150).
Secondo Capelli, il populismo indica "un umore, uno stile, una mentalità" (p.165). È mia opinione, invece, che il populismo debba essere letto e analizzato come un modo, uno dei modi possibili di fare politica nelle democrazie (Orbán è certamente un populista, mentre Putin e Erdogan praticano modalità populiste, ma sono due capi di regimi autoritari, nel caso turco con una spruzzata di fondamentalismo islamico). Dirò di più. In tutte le democrazie è insita una "striscia" di populismo, nel caso italiano accompagnata e pervertita da un cocktail di antipartitismo, antiparlamentarismo e anti politica. Nelle più disintermediate - solitarie e spaesate - quella striscia s’ingrossa e confluisce nelle organizzazioni populiste.
 Non tutto quello che in politica non ci piace è populismo, ma il populismo non può piacere a chi ritiene che la democrazia abbia forme e limiti nei quali si esprime il popolo, funzioni tenendo conto di freni e di contrappesi, protegga e promuova diritti di tutti, delle minoranze di vario tipo, delle opposizioni. Ciò detto, non concordo con Capelli su un altro punto rilevante. La democrazia non ha mai promesso eguaglianza, meno che mai eguaglianza economica (né uguale soddisfacimento di aspettative, preferenze, obiettivi, bisogni). Sartori ha scritto che democrazia è soltanto, ma è moltissimo, isonomia: eguaglianza di fronte alla legge. Dal canto mio, sosterrò che la democrazia promette al popolo (demos) che potrà esercitare potere (kratos), nulla di più. Quel popolo e i singoli cittadini otterranno/eserciteranno influenza sulle decisioni politiche in base alla loro capacità di organizzarsi e di convincere - di volta in volta - le maggioranze. Quel popolo e i singoli cittadini hanno spesso chiesto uguaglianze (plurale) di opportunità e le socialdemocrazie sono spesso riuscite a dare e ridare quelle eguaglianze. Non ho qui lo spazio per indagare se la promessa di eguaglianze di opportunità non possa essere riproposta opportunamente riformulata.
Non tutto quello che in politica non ci piace è populismo, ma il populismo non può piacere a chi ritiene che la democrazia abbia forme e limiti nei quali si esprime il popolo, funzioni tenendo conto di freni e di contrappesi, protegga e promuova diritti di tutti, delle minoranze di vario tipo, delle opposizioni. Ciò detto, non concordo con Capelli su un altro punto rilevante. La democrazia non ha mai promesso eguaglianza, meno che mai eguaglianza economica (né uguale soddisfacimento di aspettative, preferenze, obiettivi, bisogni). Sartori ha scritto che democrazia è soltanto, ma è moltissimo, isonomia: eguaglianza di fronte alla legge. Dal canto mio, sosterrò che la democrazia promette al popolo (demos) che potrà esercitare potere (kratos), nulla di più. Quel popolo e i singoli cittadini otterranno/eserciteranno influenza sulle decisioni politiche in base alla loro capacità di organizzarsi e di convincere - di volta in volta - le maggioranze. Quel popolo e i singoli cittadini hanno spesso chiesto uguaglianze (plurale) di opportunità e le socialdemocrazie sono spesso riuscite a dare e ridare quelle eguaglianze. Non ho qui lo spazio per indagare se la promessa di eguaglianze di opportunità non possa essere riproposta opportunamente riformulata.Sostiene Capelli che la crisi della democrazia contemporanea dipenda da un elemento specifico: "mai tante promesse di eguaglianza e mai tante disuguaglianze". Non credo che sia così. La crisi affonda le radici proprio nei tre fattori da lui abilmente delineati all’inizio della sua analisi: disintermediazione, solitudine, spaesamento e in un quarto fattore da lui stesso accennato: il declino della rappresentanza politica.
 La soluzione sta in più democrazia, ma sicuramente nient’affatto in quella proclamata come "uno vale uno" (incidentalmente, in nessun ambito uno vale uno) che fa tutt’uno di masse disintermediate che si affannano ad osannare (qualc)uno. Più democrazia non significa neppure che tutte le decisioni di qualsiasi genere debbano essere sottoposte sempre a votazioni popolari attraverso Internet. Significa, invece, che è diventato imperativo esplorare tutte le potenzialità della democrazia deliberativa, delle modalità di istruzione di una decisione, di discussione di un problema, di diffusione delle conoscenze, di apprendimento, di coinvolgimento della cittadinanza fino alla decisione motivata. Qui s’incrociano la politica ("tutte le cose che succedono nella polis") e la democrazia (il potere dei cittadini sempre più istruiti in materia). No, il populismo non ha vinto e non vincerà. Altri futuri sono possibili.
La soluzione sta in più democrazia, ma sicuramente nient’affatto in quella proclamata come "uno vale uno" (incidentalmente, in nessun ambito uno vale uno) che fa tutt’uno di masse disintermediate che si affannano ad osannare (qualc)uno. Più democrazia non significa neppure che tutte le decisioni di qualsiasi genere debbano essere sottoposte sempre a votazioni popolari attraverso Internet. Significa, invece, che è diventato imperativo esplorare tutte le potenzialità della democrazia deliberativa, delle modalità di istruzione di una decisione, di discussione di un problema, di diffusione delle conoscenze, di apprendimento, di coinvolgimento della cittadinanza fino alla decisione motivata. Qui s’incrociano la politica ("tutte le cose che succedono nella polis") e la democrazia (il potere dei cittadini sempre più istruiti in materia). No, il populismo non ha vinto e non vincerà. Altri futuri sono possibili.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
UNA LEZIONE TEOLOGICO-POLITICA DI BAGET BOZZO SU OGNI PROGETTO DI "RIFONDAZIONE COMUNISTA" FUTURA CHE SI VUOLE COME PARTITO. Avanti o popolo alla riscossa. Il populismo trionferà: "Forza Italia"!!!
RIPENSARE L’EUROPA. PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!
 FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- FILOSOFI BUGIARDI. Immaginare di eleggere kantianamente la pratica della menzogna, seppur creativa, a massima universale, porterebbe a un mondo di pazzi nel quale sarebbe impossibile vivere.23 gennaio 2019, di Federico La Sala
Filosofi bugiardi
di Francesca Rigotti (Doppiozero, 23.01.2019)
I filosofi bugiardi mentono deliberatamente? I filosofi bugiardi, che ossimoro è mai questo, dal momento che si suppone che il filosofo, amando la sapienza, non potrà che amare anche la verità? E poi, che cosa significa quell’avverbio «deliberatamente», con intenzione? Mentono sapendo di mentire, proprio i filosofi? E nel farlo, quali logiche inventive seguiranno mai?
Lo scarto tra produzione teorica e vita
Analizzarle le logiche inventive del pensiero teorico è lo scopo che si propone un saggio denso, corposo, intrigante ma tutt’altro che facile, di François Noudelmann, stella anche mediatica del firmamento filosofico francese, docente all’Università Paris VIII e alla New York University: Il genio della menzogna. I filosofi sono dei gran bugiardi?, Milano, R. Cortina, 2018, pp. 248. Ed. orig. Le génie du mensonge, Max Milo 2015, pp. 329.
 Noudelmann vi esamina lo scarto tra produzione teorica e vita: come mai Rousseau, che scrive un grandioso e innovativo trattato sull’educazione, Emilio (1762), ha abbandonato al brefotrofio non uno ma cinque figli avuti con Thérèse Levasseur? E come potè la pensatrice Simone de Beauvoir scrivere una delle opere chiave del femminismo del Novecento, Il secondo sesso (1949), e desiderare di vivere da serva docile e sottomessa il suo amore con lo scrittore americano Nelson Algren, con il quale ebbe una storia di grande passione e straordinaria intensità? E come la mettiamo con Kierkegaard e il suo elogio del matrimonio, composto senza ch’egli fosse riuscito a sposare Regine Olsen nonostante il suo dichiarato amore per la suddetta, e com’è che il filosofo dell’impegno, Sartre, riuscì a mancare all’appuntamento con la resistenza, o il filosofo del nomadismo, Deleuze, a passare la vita a fumare in poltrona in un appartamento parigino? E Foucault, come faceva a esaltare il coraggio della verità, nelle sue ultime opere, e poi a nascondere accuratamente il fatto di avere l’AIDS? Tutte domande che chi frequenta la filosofia si è posto in vita sua, a partire dall’eclatante e incomprensibile caso Rousseau, salvo considerarle ingenue e non rilevanti dal momento che, riguardando la vita e non le astratte speculazioni intellettuali contenute nelle opere dei filosofi, non vanno a inficiare la teoria.
Noudelmann vi esamina lo scarto tra produzione teorica e vita: come mai Rousseau, che scrive un grandioso e innovativo trattato sull’educazione, Emilio (1762), ha abbandonato al brefotrofio non uno ma cinque figli avuti con Thérèse Levasseur? E come potè la pensatrice Simone de Beauvoir scrivere una delle opere chiave del femminismo del Novecento, Il secondo sesso (1949), e desiderare di vivere da serva docile e sottomessa il suo amore con lo scrittore americano Nelson Algren, con il quale ebbe una storia di grande passione e straordinaria intensità? E come la mettiamo con Kierkegaard e il suo elogio del matrimonio, composto senza ch’egli fosse riuscito a sposare Regine Olsen nonostante il suo dichiarato amore per la suddetta, e com’è che il filosofo dell’impegno, Sartre, riuscì a mancare all’appuntamento con la resistenza, o il filosofo del nomadismo, Deleuze, a passare la vita a fumare in poltrona in un appartamento parigino? E Foucault, come faceva a esaltare il coraggio della verità, nelle sue ultime opere, e poi a nascondere accuratamente il fatto di avere l’AIDS? Tutte domande che chi frequenta la filosofia si è posto in vita sua, a partire dall’eclatante e incomprensibile caso Rousseau, salvo considerarle ingenue e non rilevanti dal momento che, riguardando la vita e non le astratte speculazioni intellettuali contenute nelle opere dei filosofi, non vanno a inficiare la teoria.A causa dell’incoerenza, non nonostante essa
E invece il punto sta proprio lì, dichiara Noudelmann, nel fatto che i filosofi, alcuni filosofi, che fanno uso di astrazioni e rivendicano l’universalità del loro pensiero, mostrano in alcuni casi clamorosi di contraddirle col loro stile di vita. Ci furono invece filosofi che vissero una genuina armonia tra idee e comportamenti: tra tutti uno dei casi più coerenti, fu quello di Diogene di Sinope, il campione del cinismo antico, che condusse una «vita semplice» basata sulla coerenza di prese di posizione individuali, i cui segni inconfondibili sono l’autonomia, l’incorruttibilità, l’autoconsapevolezza e il coraggio civile nonché la parresia, cioè la parola franca, cosciente, aperta e senza censura, talvolta anche irrispettosa e aggressiva. -Paradossalmente, proprio uno dei campioni del mentire-vero, Foucault, dedica una parte del seminario sul coraggio della verità ai cinici, questi «esibizionisti della verità»; cosa che Foucault non fu. Foucault infatti arrichisce, nella classificazione di Noudelmann, la schiera dei filosofi incoerenti, chiamiamoli così, al cui comportamento viene data una spiegazione provocatoria e stimolante: il filosofo (Rousseau o Deleuze o De Beauvoir che sia) elabora i suoi principi teorici perché vive il contrario di ciò che teorizza. Il filosofo, continua Noudelmann, presenta una verità antinomica rispetto a ciò che vive in quanto il diniego produce l’altissima performance concettuale. Ora la tesi, alquanto trasgressiva, è intrigante e ha fatto gridare alla genialità del filosofo che la propone: ma è sostenuta, argomentata, dimostrata in maniera convincente, o anche soltanto attraente e presumibilmente persuasiva, giacché alla filosofia non si richiedono gli stessi parametri delle scienze esatte?
Il pilpul filosofico-politico
Nella discordia tra ciò che viene vissuto e ciò che viene affermato, nello scarto tra il discorso teorico e la vita vissuta giace la potenza creativa: così, almeno nei filosofi citati, la menzogna diventa creazione di verità. L’argomento porta a chiedersi subito se qui si stia parlando di verità o del dire la verità (sincerità dunque, o parresia nel linguaggio di Diogene e di Foucault, truthfulness nella terminologia di Bernard Williams). Spesso infatti, nel testo di Noudelmann, il concetto di verità e quello di sincerità, «parola splendida e terribile», come la definisce Andrea Tagliapietra nel suo Sincerità (Milano, R. Cortina, 2012), si sovrappongono e si confondono, e forse proprio questa mancanza di cesura netta è ciò che giova alla tesi: il filosofo sa di dire una cosa falsa, inganna con cognizione e allora mente; oppure lo ignora, e allora può continuare a dire la verità pur mentendo, o proprio perché mente.
 La sensazione che si ha infatti leggendo questo saggio tormentato, opera di un professionista di ampie vedute e che si occupa non di autori che ha in disistima e che gode a dileggiare, bensì di filosofi da lui amatissimi, è che esso mostri una incapacità, sofferta, ad argomentare la tesi. Il fatto è che Noudelmann torna e ritorna sulle argomentazioni e spiegazioni, talvolta con parole diverse talvolta con le stesse, ripetendo continuamente la tesi come se questo bastasse a rafforzarla, in un continuo girare e rigirare sulla questione e componendo una sorta di «pilpul filosofico», un tentativo di sciogliere contraddizioni insolubili muovendosi sui confini di ciò che è pensabile e spiegabile (il pilpul è un metodo di studio del Talmud che cerca di chiarire tramite analisi e differenziazioni tutti gli aspetti e le tematiche di un punto. Si usa anche come sinonimo di cavilloso, bizantino).
La sensazione che si ha infatti leggendo questo saggio tormentato, opera di un professionista di ampie vedute e che si occupa non di autori che ha in disistima e che gode a dileggiare, bensì di filosofi da lui amatissimi, è che esso mostri una incapacità, sofferta, ad argomentare la tesi. Il fatto è che Noudelmann torna e ritorna sulle argomentazioni e spiegazioni, talvolta con parole diverse talvolta con le stesse, ripetendo continuamente la tesi come se questo bastasse a rafforzarla, in un continuo girare e rigirare sulla questione e componendo una sorta di «pilpul filosofico», un tentativo di sciogliere contraddizioni insolubili muovendosi sui confini di ciò che è pensabile e spiegabile (il pilpul è un metodo di studio del Talmud che cerca di chiarire tramite analisi e differenziazioni tutti gli aspetti e le tematiche di un punto. Si usa anche come sinonimo di cavilloso, bizantino).Le spiegazioni di Noudelmann girano e rigirano in un discorso circolare che talora assorbe nuovi argomenti da altre discipline, come la diagnosi di personalità multipla, presa in prestito dalla diagnostica delle malattie mentali, per alcuni pensatori incoerenti, ma fallisce la disamina precisa e puntuale che chiede di rispondere a come sia possibile che il discorso del filosofo parta da un comportamento opposto al pensiero stesso; o come possa darsi che il filosofo elabori pensieri teorici astratti perché vive il contrario di ciò che teorizza presentando una verità antinomica ai fatti che vive. Non è che continuando a ritornare sull’affermazione secondo la quale il diniego produce nei filosofi (quali? perché proprio quei filosofi e non altri?) la performance concettuale, essa viene a costituire una verità.
La menzogna speculativa
Del resto, immaginare di eleggere kantianamente la pratica della menzogna, seppur creativa, a massima universale, porterebbe a un mondo di pazzi nel quale sarebbe impossibile vivere. Senza un minimo di fiducia nel fatto che persone e istituzioni non mentiranno, non avrebbe senso neanche alzarsi la mattina perché non saprò se troverò l’acqua in bagno o l’autobus per andare al lavoro alla fermata. Ma nemmeno vogliamo fare i moralisti intransigenti e bacchettoni che esortino in termini roboanti alla verità e alla coerenza a tutti i costi, esaltando un mondo ideale nel quale nessuno racconti con decenza qualche fandonia, nessuno spettegoli un po’, nessuno usi ironia e cinismo ma tutti parlino soltanto apertamente e si comportino con totale lealtà e franchezza e fedeltà alla causa della verità, senza mai recedere dalle loro opinioni e avanzando a testa alta e a petto nudo, perché in un mondo così, cui sia negato sempre il sottile piacere del mentire o la tragica necessità di doverlo fare per evitare mali maggiori, non ci piacerebbe vivere.
Se però la negazione del vero fattuale denuncia la difficoltà del filosofo nel farsene carico (questo deve valere per altri ma non è valso per me), potremo comprenderlo e forse anche giustificarlo. A tutti loro Noudelmann offre la scusa della «menzogna speculativa». Non potendo confessare e ammettere la verità essa viene espressa come iperbole concettuale, metamorfosi della verità in forma di menzogna, in perfetta assonanza con la pratica della non- o postverità praticata ai nostri giorni mendaci. Non basta tuttavia ripetere continuamente, francamente e sinceramente una tesi perché essa diventi vera. Bisogna spiegare con quali passaggi e meccanismi la teoria dell’impegno sia costruita sulla mancanza dell’impegno, come se questo le desse una marcia in più che se fosse costruita sull’impegno reale.
Quello che avrei voluto essere e non sono
Stretta la foglia, larga la via, suggestiva è l’intuizione ma debole l’argomentazione. Reggerà la tesi? O non ci porterà a rovesciare le parole di Paolo, «lo spirito è forte ma la carne è debole», facendo sì che lo spirito aletico, invece di uscire rafforzato dalla debolezza della carne menzognera, ne acquisisca l’ambiguità vedendo minata la propria credibilità? Il che vorrebbe dire che ha ragione tutto sommato l’argomento moralista che afferma che gli autori scrissero grandi opere dello spirito nonostante la piccineria della carne. O ancora, e concludo, che scrissero grandi opere profetiche che andavano oltre la pusillanimità del quotidiano perché il loro sguardo era rivolto a un futuro magnanimo. Il divario tra teoria e pratica continua a rimanere un enigma, ma non c’è che da ringraziare Noudelmann per averci fatto pensare sul tema in maniera acuta e mirata. Il filosofo, alla fine, crea il personaggio che avrebbe voluto essere e non è. A meno che non ritenga il suo un discorso di tipo scientifico che dopo dimostrazione rigorosa non potrà venire smentito perché non dichiara una verità ma la verità. Come per Galileo davanti al tribunale dell’Inquisizione: che si abiuri o no, si menta o si dica la verità, si mandino i figli all’ospizio o li si allevino amorosamente in casa, la terra continuerà a girare intorno al sole.
-
> LA PIÙ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA E POLITICA ITALIANA -- LUCI DELLA RIBALTA. La fondazione di "Forza Italia".18 gennaio 1994 (di Andrea Cossu - "Il Mulino").21 gennaio 2019, di Federico La Sala
La fondazione di Forza Italia.
18 gennaio 1994
di Andrea Cossu (Il Mulino,18 gennaio 2019)
Gli ultimi quindici giorni di gennaio del 1994 sono quelli che cambiano segno alla nascente seconda Repubblica. Il 26 gennaio, un Silvio Berlusconi poco più che cinquantenne, ringalluzzito da anni di successi televisivi e calcistici e, da qualche mese, di crescenti esternazioni che preannunciano un impegno politico diretto, appare in un messaggio video dove, come i campioni delle sue squadre, annuncia la sua discesa in campo. Qualche giorno prima, il 18 gennaio, aveva fondato Forza Italia come movimento politico, mettendo fine a mesi di speculazioni sempre più insistenti.
Alla fine di quel gennaio, Berlusconi e alcuni dei suoi più stretti collaboratori arrivano con la sensazione che il momento sia quello decisivo, subito prima dell’apertura di una campagna elettorale in cui avrebbero sbaragliato una concorrenza ancora immersa nel lessico e nelle liturgie della prima Repubblica. Avevano preparato bene la discesa in campo, fondando prima un’associazione, poi svelando un inno che sarebbe stato onnipresente, infine ufficializzando l’apertura di una sede. Solo quando Forza Italia era ormai il segreto di Pulcinella, la trasformano in un movimento politico e Berlusconi appare in televisione recitando “L’Italia è il Paese che amo”.
Riletti alla luce delle dirette Facebook, delle Leopolde e dell’ormai avvenuto spostamento dell’attenzione dai partiti ai leader, quei pochi minuti di messaggio inviato a tutte le reti televisive e la guerra lampo con cui Berlusconi riempì l’Italia di club, di manifesti e di kit del candidato sembrano non solo lontani anni luce, ma quasi istituzionali nel tono e nell’intenzione comunicativa. Eppure, proprio quella campagna elettorale segnò uno spartiacque in cui si affacciarono per la prima volta le tendenze di venticinque anni di politica italiana: la mobilità dell’elettorato, il ruolo delle televisioni, lo sbilanciamento nell’informazione, le tecniche da convention, la figura del leader politico come corpo mediale.
La reazione, per chi c’era, fu contemporaneamente di disprezzo e paura. Disprezzo e sarcasmo per il “partito di plastica”, il “partito azienda”, il “partito personale” che rendeva Berlusconi e i suoi interessi il centro della politica. Paura per una svolta a destra che si faceva forte dell’alleanza con la Lega nord e il Movimento sociale italiano, per i “fascisti al governo”, per gli spot con cui il governo annunciava il raggiungimento degli obiettivi con un perentorio “Fatto!”. La sinistra rispose celebrando il 25 aprile sotto la pioggia torrenziale di Milano, inondando il governo di fax, mobilitandosi per lo sciopero generale, e trovando infine in Romano Prodi un papa straniero in grado, se non di unire, almeno di assemblare una coalizione instabile, tenuta insieme più dalla necessità di fermare Berlusconi che da una visione organica dei suoi obiettivi e del blocco sociale che voleva rappresentare.
Sparito Berlusconi, sparita la sinistra, verrebbe da dire. Con i due ex contendenti della politica italiana a giocare di rimessa come non hanno fatto nei due decenni passati. A interrogarsi su come gestire la pesante presenza dei due leader, Matteo Renzi e Silvio Berlusconi, uno troppo giovane per il pensionamento, l’altro da anni impegnato a divorare (come Crono) i suoi possibili successori. A parte, forse, Antonio Tajani, che tra quei pochi fondatori di Forza Italia è l’unico, per cursus honorum e visibilità, a poter raccogliere l’eredità del Berlusconi politico.
L’eredità del berlusconismo come stile politico - e soprattutto come stile comunicativo - è invece già stata divisa, a destra e sinistra. Se leggiamo un ventennio di fenomeno-Berlusconi alla luce del modo in cui ha interpretato se stesso, come un attore consumato in quel teatrino della politica che ha sempre disprezzato a parole, è possibile vedere come il berlusconismo sia stato, molto più che un’ideologia politica o una pratica di governo, una continua performance della leadership, in cui Berlusconi ha recitato la parte di se stesso in modo molto più efficace di quanto un film come Il caimano non sia mai riuscito a fare. Ed è stata questa politica performativa a rappresentare la vera cifra del berlusconismo, e la lezione che i politici della nuova generazione hanno imparato.
Matteo Salvini, con le sue felpe e le photo opportunity alla guida di una ruspa, assomiglia, piuttosto che a Bossi, al Berlusconi che interpreta la parte del presidente operaio, con un caschetto di sicurezza o un cappello da ferroviere. Matteo Renzi, passato in un paio d’anni da pingue neo-democristiano ad atletico alfiere del cambiamento, ha scalato il Pd provando e riprovando il suo personale discorso del predellino, echeggiando quello con cui Berlusconi archiviò Forza Italia (e tutta la coalizione) per dare vita al Popolo delle libertà. Luigi Di Maio non sarebbe certo dispiaciuto al Berlusconi che faceva casting per i candidati al Parlamento alla ricerca di volti nuovi, efficienti, e ordinati.
Sono tre traiettorie politiche, tutte caratterizzate dalla continua ricerca di un legame diretto, quasi amichevole, tra leader e seguaci (o follower), che non è possibile comprendere in pieno se non si fa riferimento alle prove d’attore di Berlusconi, uno che come pochi è stato in grado di muoversi sul palcoscenico della seconda Repubblica.
 Qui si vede un importante punto di contatto tra il berlusconismo e l’attuale discorso sul populismo. Se quest’ultimo è meno un’ideologia e più uno stile, una performance (come una parte della riflessione attuale sul populismo sta proponendo), allora Berlusconi ha incarnato, per un tempo rilevante, proprio il trionfo dello stile personale, dell’uso sapiente e al tempo stesso spregiudicato di alcuni (non tutti) degli stilemi del populismo: la lotta manichea tra lui e gli altri, il continuo referendum su se stesso, un certo fare colloquiale - tra il volgare e l’informale - del proporsi come corpo politico, di sicuro impatto per il suo popolo di riferimento tanto quanto è stato esecrato dagli avversari.
Qui si vede un importante punto di contatto tra il berlusconismo e l’attuale discorso sul populismo. Se quest’ultimo è meno un’ideologia e più uno stile, una performance (come una parte della riflessione attuale sul populismo sta proponendo), allora Berlusconi ha incarnato, per un tempo rilevante, proprio il trionfo dello stile personale, dell’uso sapiente e al tempo stesso spregiudicato di alcuni (non tutti) degli stilemi del populismo: la lotta manichea tra lui e gli altri, il continuo referendum su se stesso, un certo fare colloquiale - tra il volgare e l’informale - del proporsi come corpo politico, di sicuro impatto per il suo popolo di riferimento tanto quanto è stato esecrato dagli avversari.Berlusconi, del resto, è stato un grande attore tra trionfi e scandali, ed è giusto segnalare questa capacità comunicativa che va al di là delle televisioni e della concentrazione di potere mediatico. Per gran parte della sua carriera politica, Berlusconi non è mai uscito dalla parte che aveva ritagliato per se stesso, passando da un ruolo all’altro e riuscendo quasi sempre a dare una sensazione di naturalezza. Quale sarà, se ci sarà, l’ultima prova d’attore, ce lo diranno le elezioni europee, a cui Berlusconi si sta di sicuro preparando come un Charlie Chaplin in Luci della ribalta.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- IL GIURAMENTO DI IPPOCRATE. I medici nascono senza frontiere (di Roberto Mussapi).18 gennaio 2019, di Federico La Sala
I medici nascono senza frontiere
di Roberto Mussapi (Avvenire, venerdì 18 gennaio 2019)
«In quante case io entri mai, vi giungerò per il giovamento dei pazienti tenendomi fuori da ogni ingiustizia e da ogni altro guasto, particolarmente da atti sessuali sulle persone sia di donne che di uomini, sia liberi sia schiavi». Siamo all’inizio di uno scritto che segna una tappa fondamentale della civiltà: il Giuramento di Ippocrate, il medico che fonda il compito e traccia le basi della sua arte. «Io giuro su Apollo medico e Asclepio e Igieia e Panacea, e su tutti gli dei e le dee, prendendoli a miei testimoni...».
Il giuramento di Ippocrate, su cui si fonda la medicina, è fatto agli dèi, il compito del medico non riguarda esclusivamente il mondo della polis, ma è vincolato a quello sacro del divino. Studi recenti datano il giuramento intorno al V secolo a. C, il secolo che vede nascere la tragedia come genere teatrale di poesia, e la filosofia, pensiero come logos. Alle spalle il rito dionisiaco tragico, e il pensiero dei presocratici, i baldi e travolgenti scienziati-poeti. Prodigioso momento di creazione dei Greci che fondano l’Occidente.
Cittadini di una democrazia, non servi di un Re come gli Egizi o i Persiani. Ma civiltà non ancora compiuta. Le donne non godono di diritti civili, né considerazione, meno ancora degli schiavi. Insomma molestare una donna, o uno schiavo, non è, per il greco del tempo, così grave. Non sono cittadini, maschi.
Per Ippocrate invece è la stessa cosa. Supera i limiti della sua civiltà. Va oltre: giuro di non fare violenza a nessuno, perché tutti, comprese donne e schiavi, sono, siamo uguali. Supera i pensatori del suo tempo. È un medico. I medici nascono senza frontiere.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- Il fantasma perpetuo del fascismo. Un saggio di Alberto De Bernardi (di Alessandra Tarquini).16 gennaio 2019, di Federico La Sala
Fascismo e antifascismo. Storia, memoria e culture politiche... *
- NOTERELLE SUL MACHIAVELLI (1932-34): "Il Principe prende il posto, nelle coscienze, della divinità o dell’imperativo categorico, diventa la base di un laicismo moderno e di una completa laicizzazione di tutta la vita e di tutti i rapporti di costume" (Antonio Gramsci, Quaderni del carcere)
- "IN OGNI MODO OCCORRE STUDIARE KANT E RIVEDERE I SUOI CONCETTI ESATTAMENTE" - (Antonio Gramsci, Quaderni del carcere)
Un saggio di De Bernardi
Il fantasma perpetuo del fascismo
di Alessandra Tarquini (Corriere della Sera, 15.01.2019)
Perché nel dibattito pubblico ricorre la percezione di un riapparire del fascismo? Alla domanda risponde Alberto De Bernardi nel libro Fascismo e antifascismo (Donzelli, pagine 176, e 17), che offre una grande lezione di storia contemporanea. De Bernardi ricorda che di pericolo risorgente parliamo da tempo: era «ritorno del fascismo» il centrismo di De Gasperi e di Scelba, così come il tintinnar di sciabole del centrosinistra o anche il «fanfascismo» nei primi anni Settanta; furono definiti fascisti Bettino Craxi e Silvio Berlusconi.
Non si è trattato solo di polemiche politiche: sin dalla fine della guerra, intellettuali di diversa provenienza hanno individuato un fascismo persistente contrapposto all’antifascismo. Di fatto, fascismo e antifascismo sono diventate categorie generiche: «due archetipi metastorici del lessico politico». Così queste parole hanno perso il loro senso, come mostrano la discussioni di oggi.
De Bernardi ricorda che il recente sovranismo ha ben pochi punti di contatto con l’idea di nazione della prima metà del Novecento. Lo stesso ritorno della xenofobia è espressione di un’autodifesa identitaria e non certo di teorie sulla superiorità della razza ariana. Il razzismo italiano degli anni Trenta fu il prodotto della volontà di creare un uomo nuovo, non certo del tentativo di difendersi dalle ondate migratorie o da trasformazioni dell’economia.
Ma soprattutto, mentre la crisi degli anni Venti derivò dall’incapacità dello Stato liberale di integrare le classi subalterne, quella attuale sembra il prodotto della sconfitta della politica. Il regime totalitario fascista ha affermato il primato della politica sulle altre espressioni dell’esistenza, producendo una nuova modernità rivoluzionaria, alternativa a quella emersa dalla Rivoluzione francese. Oggi assistiamo alla diffusione di una concezione non mediata dei rapporti tra masse e Stato. In una società aperta e multiculturale che ha eroso i loro redditi, le classi medie mostrano una sfiducia radicale nella possibilità di cambiare il mondo.
La storia non si ripete. Ecco la lezione di questo libro che richiama uno degli storici più importanti del Novecento: l’antifascista Marc Bloch scrisse che la storia è irreversibile. Un invito a capire la specificità del tempo.
* Sul tema, in rete e nel sito, si cfr.:
- Alberto De Bernardi, Fascismo e antifascismo Storia, memoria e culture politiche (Scheda libro - Donzelli Editore)
INDIVIDUO E SOCIETA’ E COSTITUZIONE, IERI COME OGGI. USCIRE DALLO STATO DI MINORITA’, APRIRE GLI OCCHI: C’E’ DIO E "DIO", PATRIA E "PATRIA", E FAMIGLIA E "FAMIGLIA" .....
 ROMOLO AUGUSTOLO: L’ITALIA NON E’ NUOVA A QUESTI SCENARI. C’E’ CAPO E "CAPO" E STATO E "STATO": MUSSOLINI E LENIN A CONFRONTO.
ROMOLO AUGUSTOLO: L’ITALIA NON E’ NUOVA A QUESTI SCENARI. C’E’ CAPO E "CAPO" E STATO E "STATO": MUSSOLINI E LENIN A CONFRONTO.KANT E GRAMSCI. PER LA CRITICA DELL’IDEOLOGIA DELL’UOMO SUPREMO E DEL SUPERUOMO D’APPENDICE.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- POLITICA. Un Patto scellerato in nome della SCIENZA-RELIGIONE (di Giorgio Ferrari, Angelo Baracca).12 gennaio 2019, di Federico La Sala
Un Patto scellerato in nome della Scienza
Il manifesto trasversale. Con preoccupanti finalità interdittive, il patto firmato da Grillo e Renzi, quando annuncia che non saranno tollerate forme di pseudoscienza e pseudomedicina, brandisce la Scienza come una clava con cui colpire i “reprobi” che non ne riconoscono la sacralità
di Giorgio Ferrari, Angelo Baracca (il manifesto, 12.01.2019)
Non è la prima volta che nel nostro paese il mondo della scienza si rivolge alla politica affinché questa si faccia carico di questioni riguardanti il benessere della popolazione. È successo per il clima, per le scelte energetiche e per questioni etiche: ora, sembra, è la volta della salute. Tale infatti l’ambito privilegiato, ma non esclusivo, del Patto Trasversale per la Scienza che tanti consensi ha suscitato sia nei mezzi di informazione che nella stessa politica, al punto da mettere d’accordo persino due noti avversari come Beppe Grillo e Matteo Renzi.
Fuori dal coro dei consensi a noi pare che questa iniziativa abbia qualcosa di inquietante nella forma e nella sostanza del suo testo. Intanto non è un appello, ma un “patto” che le forze politiche tutte sono chiamate a sottoscrivere per finalità non solamente propositive (l’informazione, la ricerca) ma decisamente interdittive. E questa è una spiacevole novità. Di appelli fortemente connaturati alla sacralità della Scienza, ne avevamo già visti in passato e sempre in occasione di forti tensioni culturali e sociali come quelle dei referendum antinucleari. Così fu per gli scienziati filonucleari che si rivolsero al presidente della repubblica all’indomani dell’incidente di Chernobyl, poi nel 2010 quelli che si rivolsero a Bersani affinché il Pd non chiudesse la porta al nucleare e infine nel 2011 quelli che ritenevano senza fondamento l’imminente referendum post Fukushima. Il tratto comune di questi appelli era l’accusa, esplicita o implicita, di antiscientificità nei confronti degli antinucleari: «Caro Segretario, occorre evitare il rischio che nel Pd prenda piede uno spirito antiscientifico, un atteggiamento elitario e snobistico che isolerebbe l’Italia, non solo in questo campo, dalle frontiere dell’innovazione. Noi ti chiediamo di prendere atto che il nucleare non è né di sinistra, né di destra e che, anzi, al mondo molti leader di governi di sinistra e progressisti puntano su di esso per sviluppare un sistema economico e modelli di vita e di società eco-compatibili» questo nell’appello del 2010, mentre in quello del 2011 si diceva: «Nell’appellarci alla ragione, noi richiamiamo l’attenzione sul fatto che la legittima prudenza e la giusta richiesta di corretta informazione non siano oscurate da furori emotivi fuori luogo o da ossessionanti atteggiamenti di contrapposizione che rischiano di sfociare in anacronistiche “cacce alle streghe” invocate da guru o santoni d’occasione nonché da contingenti interessi elettorali».
Considerazioni queste, in linea con quella presunta neutralità della scienza che anche il testo del presente “Patto” vuole accreditare, quando sostiene che la Scienza (e il progresso che ne consegue) «non ha alcun colore politico». Non siamo d’accordo; e ce ne sarebbero di esempi per dimostrare che la “Scienza”- non altrimenti definita - si è macchiata più volte di crimini contro l’umanità, sia in tempo di pace che di guerra. Ma questo, se vogliamo, è ancora un ambito dialettico sull’operato della scienza stessa che fu, ed è ancora, largamente di parte. Diverso invece (e più inquietante) è quando nel “Patto”si annuncia che non saranno tollerate forme di pseudoscienza e pseudomedicina fino al punto di auspicare leggi contro l’operato di chi sarà ritenuto, conseguentemente, uno pseudoscienziato.
E chi lo stabilirà? Con quali criteri? Se tutto questo non è una boutade elettoralistica che ammicca ad un asse tra Pd e 5S, allora i tempi bui di cui scriveva Brecht sono più vicini di quanto pensiamo e magari c’è già chi sogna di ripristinare le regole del Sant’Uffizio:
 «Diciamo, pronuntiamo, sententiamo e dichiariamo che tu, Galileo sudetto, per le cose dedotte in processo e da te confessate come sopra, ti sei reso a questo S. Offizio vehementemente sospetto d’heresia, cioè d’haver tenuto e creduto dottrina falsa e contraria alle Sacre e Divine Scritture».
«Diciamo, pronuntiamo, sententiamo e dichiariamo che tu, Galileo sudetto, per le cose dedotte in processo e da te confessate come sopra, ti sei reso a questo S. Offizio vehementemente sospetto d’heresia, cioè d’haver tenuto e creduto dottrina falsa e contraria alle Sacre e Divine Scritture».
 Del resto sono già due i medici italiani radiati dall’ordine per aver assunto posizioni critiche sul decreto vaccini. E tanto per restare in tema, come dimenticare il falso allarme pandemia del 2010 che costò solo in Europa miliardi di euro di spesa in vaccini inutilizzati, o la denuncia di appena un anno fa dell’Istituto Negri, sulla immane inutilità dei farmaci in commercio e sulle cure prescritte senza alcuna evidenza scientifica?
Del resto sono già due i medici italiani radiati dall’ordine per aver assunto posizioni critiche sul decreto vaccini. E tanto per restare in tema, come dimenticare il falso allarme pandemia del 2010 che costò solo in Europa miliardi di euro di spesa in vaccini inutilizzati, o la denuncia di appena un anno fa dell’Istituto Negri, sulla immane inutilità dei farmaci in commercio e sulle cure prescritte senza alcuna evidenza scientifica?Attenzione dunque a brandire la Scienza come una clava con cui colpire i “reprobi” che non ne riconoscono la sacralità. Così facendo avalleremmo l’idea che la Scienza debba essere separata dalla realtà sociale e dallo stesso scienziato che, al pari di un sacerdote, non esprime più un suo punto di vista in quanto, per definizione, esso è già contenuto nella Scienza-religione, ormai basata solo su se stessa e sulla sua infallibilità.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- COSTITUZIONE, SCIENZA, E POLITICA. Il "patto per la scienza" e i valori. Note di W, Ricciardi e di M. Ferrera.12 gennaio 2019, di Federico La Sala
C’è del buono in quel «patto».
Scienza e politica: sviluppo opportuno
di Walter Ricciardi (Avvenire, sabato 12 gennaio 2019)
Il "patto per la scienza" siglato giovedì 10 gennaio 2019 è una importante innovazione nello scenario culturale del nostro Paese perché segna un passaggio di qualità nel rapporto tra scienza e politica. E questo al di là della discussione strettamente politica sul fatto che - dopo tanti anni di posizioni critiche e anche francamente ostili - il fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo ha improvvisamente cambiato opinione sulla straordinaria tecnologia dei vaccini e delle vaccinazioni.
La scienza è un sistema di conoscenze caratterizzato dalla ricerca della verità, attraverso prove riproducibili, mentre la politica è una vocazione pienamente impegnata nelle circostanze e nei compromessi del mondo reale. Politici e scienziati hanno funzioni sociali diverse che non poche volte li portano a contrapporsi, ma che in fin dei conti riescono a essere complementari anche se spesso attraverso un difficile cammino di mutue incomprensioni, ostacoli e interessi. Ovviamente questa mutua interazione e questo percorso non sono scevri da possibili rischi e distorsioni.
Non è difficile trovare esempi di politici che negano o distorcono le evidenze scientifiche a favore di proprie posizioni su determinate temi, magari compromettendo in tal modo la comprensione da parte dell’opinione pubblica dei fattori in campo. Per di più, quando ciò accade, gli scienziati generalmente rispondono nella lingua della scienza e raramente, perciò, riescono a risolvere la confusione e l’incomprensione ormai generata e diffusasi nell’opinione pubblica.
E d’altra parte, è difficile anche capire in che misura gli scienziati dovrebbero essere coinvolti nel prendere parte alle decisioni politiche. La domanda è ardua per le società democratiche tecnologicamente avanzate. Se gli scienziati non mettono a disposizione le loro conoscenze nei processi politici, si rischia di prendere decisioni malinformate su tematiche complesse. Ma, allo stesso tempo, se gli scienziati giocano un ruolo troppo grande nella definizione di problemi e soluzioni, si rischia di sostituire un governo democratico con un controllo tecnocratico.
Quale relazione politica-scienza rappresenta, dunque, l’optimum? È possibile identificare tre condizioni in cui è più probabile che le evidenze derivanti dalla scienza vengano utilizzate dai decisori politici per identificare e implementare le policy.In primo luogo, è più probabile che la scienza influenzi i politici se le evidenze fornite rientrano entro i limiti e le pressioni (anche istituzionali) a cui essi sono sottoposti, se "risuonano" con i loro presupposti ideologici oppure se subiscono, esternamente, una pressione tale da indurli a sfidare e oltrepassare quei limiti.
In secondo luogo, le prove scientifiche devono essere credibili e convincenti, fornire soluzioni pratiche ai problemi di politica correnti ed essere presentate in modo da attrarre l’interesse dei politici. In terzo luogo, la scienza è maggiormente in grado di contribuire a politiche migliori se i ricercatori e i decisori politici, i policy maker, condividono reti comuni, si fidano l’uno dell’altro, rappresentano gli interessi di tutte le parti interessate in modo onesto e aperto e comunicano in modo efficace.
Nella pratica queste tre condizioni sono raramente soddisfatte, perché i ricercatori hanno una limitata capacità di influenzare il contesto politico o di sviluppo all’interno del quale lavorano. E purtroppo i processi politici stessi sono probabilmente il principale ostacolo alla formulazione di policy basate sull’evidenza. Far sì che il dialogo tra scienza e politica non sia un dialogo tra sordi è un problema che si pone con urgenza in Italia e non solo.
Per questo il ’patto’ prevede che le forze politiche italiane s’impegnino:
1) a sostenere la scienza come valore universale di progresso dell’umanità, che non ha alcun colore politico, e che ha lo scopo di aumentare la conoscenza umana e migliorare la qualità di vita dei nostri simili;
2) a non sostenere o tollerare in alcun modo forme di pseudoscienza e/o di pseudomedicina che mettono a repentaglio la salute pubblica come il negazionismo dell’Aids, l’anti-vaccinismo, le terapie non basate sulle prove scientifiche;
3) a governare e legiferare in modo tale da fermare l’operato di quegli pseudoscienziati che, con affermazioni non-dimostrate e allarmiste, creano paure ingiustificate tra la popolazione nei confronti di presidi terapeutici validati dall’evidenza scientifica e medica;
4) a implementare programmi capillari d’informazione sulla scienza per la popolazione, a partire dalla scuola dell’obbligo, e coinvolgendo media, divulgatori, comunicatori e ogni categoria di professionisti della ricerca e della sanità;
5) ad assicurare alla scienza adeguati finanziamenti pubblici, a partire da un immediato raddoppio dei fondi ministeriali per la ricerca biomedica. Questo testo è, insomma, un importante passo avanti di cui siamo grati a Roberto Burioni e Guido Silvestri. Certo, nel ’patto’ non si entra nell’ambito degli impegnativi scenari etici in cui dovremo prendere importanti decisioni nel prossimo futuro, e questo è un argomento su cui bisognerà tornare con decisione.
* Ordinario d’igiene e medicina preventiva Università Cattolica del Sacro Cuore e già presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss).
I valori che offre la scienza
Verità è dire le cose come stanno. Pensare e parlare ricordando sempre che «là fuori» c’è una realtà ostinata e indipendente dalle nostre opinioni
di Maurizio Ferrera (Corriere della Sera, 12.01.2019)
Beppe Grillo ha firmato il Patto trasversale sulla Scienza promosso da Roberto Burioni e Guido Silvestri, due noti e autorevoli docenti e studiosi di medicina. Si tratta di un segnale importante, in controtendenza rispetto agli atteggiamenti anti-scientifici dei 5 Stelle: emblematico il caso dei vaccini. A giudicare dai social media, non tutta la base grillina condivide questa scelta. Beppe Grillo resta nondimeno il fondatore e padre nobile del Movimento. La sua posizione ha comunque peso politico e rilevanza simbolica.
Il Patto sulla Scienza dice cose molto semplici, che dovrebbero essere scontate in ogni democrazia liberale. Primo: la scienza è un valore, in quanto produce conoscenze affidabili sul mondo e ci indica sia come trarne vantaggio sia come evitare danni (pensiamo alle epidemie o ai disastri naturali). Secondo: occorre combattere la pseudo-scienza, ossia tutte le idee e indicazioni che non rispettano quei criteri di metodo che da secoli ispirano il lavoro degli scienziati. Chi stabilisce i criteri e chi «accredita» la qualità di un lavoro scientifico? La comunità scientifica, e solo questa. Come rammenta il Patto, la scienza non ha colore politico. I politici possono trascurare le indicazioni degli scienziati. Ma non possono giustificarsi dicendo che gli scienziati sbagliano, che le conoscenze accettate e condivise dalla comunità scientifica non «dicono la verità». g li ultimi due punti del Patto spiegano in che modo si deve promuovere e proteggere la scienza. Innanzitutto occorre mettere i cittadini in condizioni di riconoscere la conoscenza affidabile da quella che non lo è. In secondo luogo, bisogna mettere gli scienziati in condizione di lavorare autonomamente, garantendo un flusso adeguato di risorse.
Ho menzionato la parola «verità». Di questi tempi è frequente sentire che la verità non esiste, oppure che ce ne sono tante e che ciascuno può scegliere la sua. E poi: gli scienziati non sono mai neutrali - si dice -, spesso agiscono in base a interessi di parte. Il cosiddetto progresso scientifico non dimostra forse che ciò che appare vero in un dato momento a un certo punto viene gettato nel cestino delle falsità? Osservazioni comprensibili. Gli scienziati sono donne e uomini in carne e ossa, e dunque imperfetti, «legni storti», come diceva Kant. Il loro lavoro «scopre» le cose per tentativi ed errori. La conoscenza scientifica è dunque sempre provvisoria, valida fino a prova contraria. Ciò che dovrebbe succedere (una guarigione) non succede; accadono eventi non previsti, spesso indesiderati (una calamità). Solo gli scienziati possono tuttavia stabilire se e quando una prova contraria è decisiva per il destino di una teoria.
Grazie a Internet, ciascuno di noi può oggi farsi un’idea riguardo a qualsiasi fenomeno. È forte la tentazione di decidere da soli. Sulla Rete si trovano le tesi più incredibili. Negli Stati Uniti c’è un gruppo che sostiene che la terra in realtà sia piatta. I «terrapiattisti» si sono trasformati in un movimento, che ora si riunisce periodicamente in compagnia di pseudo-scienziati. Per ora, non fanno male a nessuno. Ma un conto è sostenere credenze false relativamente innocue. Un altro conto è danneggiare gli altri sulla base di opinioni dogmatiche, non suffragate da evidenza e ragionamento. Non solo su temi che riguardano la fisica o la medicina, ma anche l’immigrazione o le differenze razziali.
Nei dibattiti pubblici, soprattutto in televisione, il confronto fra due punti di vista si conclude talvolta con uno dei due interlocutori (spesso un Cinque Stelle) che liquida l’altro dicendo «è una sua opinione, io non sono d’accordo». In alcuni casi è davvero difficile procedere al di là delle opinioni. Ma per una grande quantità di temi c’è davvero modo di controllare come stanno le cose, di stabilire chi ha ragione. Un’abitudine ancor peggiore è fermare il confronto politico dicendo: se «quello» non è d’accordo con me, che ho vinto le elezioni, allora si candidi (pensiamo a Salvini). Un’assurdità. Come insegnava Bobbio, la verità non si decide a maggioranza. I cittadini di una democrazia possono deliberare su moltissime questioni. Ma l’idea che possa esistere un cittadino «totale», titolato a sottrarsi ad ogni forma di autorità basata sulla competenza invece che sulla maggioranza è l’anticamera della dittatura.
Torniamo al Patto sulla Scienza. Il testo richiama la politica a «legiferare» contro la pseudo-scienza. Se ciò che si chiede è l’adozione di norme che rafforzino la sfera scientifica e che leghino le mani ai politici nella presa di decisioni in certi ambiti delicati (ad esempio costringendoli a chiedere il parere degli scienziati e a tenerne adeguatamente conto), l’appello è ineccepibile. Non bisogna però mai affidare alla politica il ruolo di giudice nelle controversie scientifiche e nemmeno quello di scendere a compromessi incoerenti, come nel caso dell’«obbligo flessibile» alla dichiarazione vaccinale da parte dei genitori.
Il messaggio operativo più importante del Patto è quello che riguarda l’informazione e la scuola. È in queste due sfere che si deve imparare a usare correttamente il concetto di verità. Il che vuol dire una cosa semplice, ben riassunta già da Platone: verità è dire le cose come stanno. Pensare e parlare ricordando sempre che «là fuori» c’è una realtà ostinata e indipendente dalle nostre opinioni. E che può danneggiarci seriamente se ci illudiamo di poterla ignorare o peggio ancora piegare a nostro libero piacimento.
-
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- Così l’Uomo Nuovo abbatte il sapere delle élite decadute (di Ezio Mauro)12 gennaio 2019, di Federico La Sala
Così l’Uomo Nuovo abbatte il sapere delle élite decadute
Come si è arrivati alla scissione tra classe dirigente e popolo? Perché si perde fiducia nella rappresentanza? Come la politica è arrivata al suo grado zero? Riflessioni dopo l’intervento su “Repubblica” di Alessandro Baricco
di EZIO MAURO (la Repubblica, 11 Gennaio 2019)
La prima domanda, leggendo il breve saggio di Alessandro Baricco, è se possiamo vivere senza un’élite. La seconda è quanto tempo impiegheremo a considerare élite questa nuova classe di comando che ha spodestato la vecchia. E la terza, quella che conta, è dove, come e quando ha sbagliato il ceto dirigente del Paese, fino a suicidarsi nella disapprovazione generale del cosiddetto popolo ribelle. Fino a trasportare il termine élite [...].
Sul tema, nel sito, si cfr.:
IN UNO "STATO" SONNAMBOLICO, IL CONTINUO RITORNELLO DEGLI INTELLETTUALI ITALIANI...
 DALL’ILIADE ALL’ODISSEA: ALESSANDRO BARICCO, IL CIECO OMERO DEL "CAVALEONTICO" ULISSE DI ARCORE. Un omaggio critico (8 dicembre 2004).
DALL’ILIADE ALL’ODISSEA: ALESSANDRO BARICCO, IL CIECO OMERO DEL "CAVALEONTICO" ULISSE DI ARCORE. Un omaggio critico (8 dicembre 2004).LA STORIA DEL FASCISMO E RENZO DE FELICE: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"!
ITALIA!!! TUTTI. MOLTI. POCHI: E NESSUNA COGNIZIONE DELL’UNO, DELL’UNITA’!!! L’Italia e le classi dirigenti
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- Così l’Uomo Nuovo abbatte il sapere delle élite decadute (di Ezio Mauro)12 gennaio 2019, di Federico La Sala
Così l’Uomo Nuovo abbatte il sapere delle élite decadute
Come si è arrivati alla scissione tra classe dirigente e popolo? Perché si perde fiducia nella rappresentanza? Quando la politica è arrivata al suo grado zero? Riflessioni dopo l’intervento su "Repubblica" di Alessandro Baricco
di Ezio Mauro (la Repubblica, 12.01.2019)
La prima domanda, leggendo il breve saggio di Alessandro Baricco, è se possiamo vivere senza un’élite. La seconda è quanto tempo impiegheremo a considerare élite questa nuova classe di comando che ha spodestato la vecchia. E la terza, quella che conta, è dove, come e quando ha sbagliato il ceto dirigente del Paese, fino a suicidarsi nella disapprovazione generale del cosiddetto popolo ribelle. Fino a trasportare il termine élite nell’inferno delle parole dannate.
La teoria classica delle élite presuppone che sia sempre una minoranza a governare i sistemi complessi, nell’interesse generale. La massa dei governati, dunque, non può invocare il criterio di quantità per delegittimare le élite, in quanto il principio democratico della rappresentanza trasferisce ogni volta con il voto il potere dai molti ai pochi, che dovrebbero governare in nome di tutti. La guida di una società politica da parte dell’élite non è quindi di per sé in contrasto con il principio democratico, naturalmente a due condizioni: che esista una contrapposizione e una contendibilità permanente del potere, e non un blocco elitario unico, impermeabile e permanente, e che la formazione stessa dell’élite sia trasparente, aperta, dinamica, accessibile e revocabile, basata su criteri di merito riscontrabili e giudicabili dalla pubblica opinione.
Sono esattamente i due punti- cardine del meccanismo che ha messo in crisi l’élite davanti ai cittadini. Ovviamente c’è stato nell’ultimo quinquennio un forte criterio distintivo tra forze e storie diverse all’interno del parlamento e degli altri corpi elettivi e decisionali che amministrano il Paese. Ma al di là delle appartenenze, degli schieramenti e delle tradizioni differenti, il " pensiero" - e, direi, la postura, il linguaggio, il costume, dunque l’antropologia - della classe politica nazionale è stato percepito come omogeneo, unificato, parificato, soprattutto teso a sostenere una lettura della fase che il Paese stava vivendo sostanzialmente omogenea.
 E nello stesso tempo, la classe dirigente italiana non è mai riuscita a diventare un vero establishment, capace di coniugare i legittimi interessi particolari con l’interesse generale, piegandosi in una serie di network autopromossi, autoriferiti, autogarantiti, capaci di perpetuarsi ma non di rigenerarsi, intrisi come sono di familismo, di corporativismo, avviluppati nei vincoli di relazione, nello scambio reciproco di garanzie.
E nello stesso tempo, la classe dirigente italiana non è mai riuscita a diventare un vero establishment, capace di coniugare i legittimi interessi particolari con l’interesse generale, piegandosi in una serie di network autopromossi, autoriferiti, autogarantiti, capaci di perpetuarsi ma non di rigenerarsi, intrisi come sono di familismo, di corporativismo, avviluppati nei vincoli di relazione, nello scambio reciproco di garanzie.Una bolla chiusa, dentro la quale - affinché nessuno si senta facilmente assolto - sono precipitati pezzi interi di quella società che continuiamo automaticamente a chiamare civile, vale a dire intellettuali, professori, giornalisti, imprenditori, vescovi, artisti e infine scienziati, tutti considerati portatori per quota di un privilegio elitario per aver contribuito a formare una cultura di vertice, e dunque tutti chiamati senza distinzione a rendere conto della funzione dirigente che hanno esercitato, ma più ancora - ognuno per la sua quota - dell’egemonia culturale che l’esercizio di quel potere d’influenza ha disteso sul Paese.
Colpevoli per definizione, dunque, non per come hanno esercitato il potere intellettuale, ma per averlo fatto. Trattandosi non di una rivoluzione, ma comunque di un moto, la spinta di questo assalto alle élite nasce da un’emozione più che da una teoria. Potremmo definirlo il sentimento della confisca. C’è come la sensazione diffusa ( non importa che sia fondata: trattandosi di un turbamento basta che agisca) di un esproprio di un pezzo di realtà, di una parte del meccanismo decisionale, di una quota di rappresentanza. Un atto abusivo, quasi un furto, comunque un’interposizione illegittima. Si potrebbe dire in termini giuridici: un abuso di posizione dominante, l’esercizio di un monopolio sull’interpretazione del reale, sulla rappresentazione del contemporaneo. Come se dal basso fosse salita improvvisamente questa denuncia: chi vi ha dato il diritto di sceneggiare il presente e di immaginare il futuro per noi?
L’élite, nel suo tempo libero dai compiti primari, in fondo fa proprio questo, e ovunque nel mondo libero: diffonde modelli di società, piega alla sua lettura la storia e la interpreta, detta le mode, fissa le consuetudini, costruisce un paesaggio indicando i libri, i film, la musica ( e oggi bisogna aggiungere i cibi) da seguire, stabilisce cosa è " in" e ciò che è " out", deposita la tela di una tradizione. Tuttavia non è una banale guida alle tendenze, ma molto di più. Col suo agire egemonico di vertice, fissa ogni giorno il metro che misura il divenire della società, disegna una razionalità del percorso collettivo indicando anche le nicchie in cui può sfogarsi l’irrazionale, costruisce cioè un’idea in continuo movimento di normalità, così come arbitra ogni effimera modernità, distinguendo tra ciò che va conservato e ciò che può essere speso, decretando fortune e oblio.
C’è un’unica cosa che l’élite non ha saputo fare: prendere la temperatura del Paese. Non ha ascoltato l’eco del Big Bang clamoroso tra la società più aperta della storia umana e la chiusura imposta dalla crisi economica più lunga del secolo. In questo, è uscita fuori dalla dialettica governanti- governati, si è separata, impegnata come spiega Baricco a proteggere se stessa dalle conseguenze della crisi.
Quella dialettica si è interrotta e si è sventrata, e non producendo più uno scambio politico si è bloccata su un’altra coppia: dominantidominati. Ecco dove nasce la sensazione della confisca. Per elaborare la sua lettura della fase e della società, all’élite infatti non basta il comando. E questa è una buona notizia per la democrazia: occorre il consenso, una relazione costante con la cittadinanza, un dispositivo continuamente operante di riconoscimento reciproco. Sempre i classici spiegano che l’élite siede ( si suppone scomoda) in cima alle tre piramidi della ricchezza, della deferenza e della sicurezza, che formano la cuspide del comando, e lo legittimano. Ma la ricchezza si è spostata tutta nel vertice della prima piramide, e l’élite non ha saputo tutelarla per tutti, e redistribuirla per molti. Insieme, se n’è andata la sicurezza, perché la crisi attaccando il presente si mangia il futuro, arriva la paura, i fenomeni globali sono talmente ingovernabili da scavalcare il ruolo guida delle élite, svuotandolo, e diffondendo la sensazione di un mondo fuori controllo, con la politica - tutta - fuorigioco. In queste condizioni, può resistere la deferenza? Non c’è più il riconoscimento di un ruolo, per l’élite, perché salta la condivisione della sua funzione.
La posizione che occupa appare quindi nuda, giustificata solo da se stessa. Appunto, una rendita di posizione. Un moderno patriziato. Un’aristocrazia dopo l’abolizione dei titoli nobiliari. Il venir meno di questa interpretazione riconosciuta e accettata del momento, da parte dell’élite, e della sua trasformazione in pensiero comune, genera il passaggio da cittadino a individuo, la solitudine repubblicana dei singoli, alimentata dall’unico sentimento collettivo superstite, il risentimento, che però per definizione si consuma in privato.
Il risultato è che ognuno si sente autorizzato a pensare per sé, sciolto dai vincoli del sociale, libero non in quanto capace di esprimere al massimo le sue facoltà e i suoi diritti, ma in quanto liberato da ogni obbligazione di comunità, nei confronti degli altri. Un superstite solitario, dopo il naufragio collettivo della crisi. Ma con la convinzione di aver accumulato un credito politico che non riuscirà mai a riscuotere, e che appunto per questo si porta in tasca come una lunghissima cambiale di rancore privato, da sventolare ogni giorno in pubblico. Col rancore non si costruisce un progetto politico: ma il rancore autorizza a presentare a chiunque il saldo delle insoddisfazioni, a chiedere conto dei fenomeni incontrollabili che ci sovrastano, soprattutto a dare una colpa universale alla classe generale che ha governato la crisi. E autorizza il populismo a ingigantire questa resa dei conti, ideologizzandola e mettendola a base non solo della sua politica, ma della sua natura. Così l’élite diventa responsabile di tutto, al di là dei suoi limiti, dei suoi errori e delle sue colpe.
Soprattutto, poiché l’individuo ribelle vuole essere trasportato nel luogo immaginario del " Punto Zero", dove non c’è contaminazione col passato e tutto può essere reinventato sul momento, l’élite è colpevole della custodia della memoria e della trasmissione di una cultura che nasce dalla storia e dal divenire del Paese, e le interpreta. Tutto questo nel mondo nuovo in cui stiamo entrando è sospetto. Come è sospetto il sapere, la vera e fondamentale causa dello spodestamento delle élite. Il racconto dell’inganno permanente delle classi dirigenti, del loro autogolpe perenne, rende infida la scienza, pericolosa la perizia, nociva la cognizione. Se tutto quel sapere - ragiona l’uomo nuovo - non è servito a proteggere le mie condizioni di vita, ma viene consumato soltanto nella cerchia dei sapienti e dei garantiti, allora è una sorta di bitcoin a circolazione limitata e protetta, una valuta di riserva di cui soltanto l’élite conosce l’uso.
Il sapere suscita diffidenza perché è il linguaggio dell’élite, dunque ha un riflesso castale, quindi viene dal demonio. Il concetto di " nuovo" diventa vecchio. Bisogna andare oltre, fino all’uomo- vergine, incontaminato perché digiuno di politica, garantito perché viene dalla luna: innocente perché ignorante, nel senso più alto del termine, abitante dell’Anno Zero, senza vincoli di storia, di ideologia, di inclinazioni a destra o a sinistra.
Asettico e spoglio di qualsiasi eredità, di qualunque coscienza del bene e del male che hanno segnato la vicenda del Paese, di ogni eredità pubblica e di ogni tradizione comune, è l’Uomo Qualunque del nuovo secolo, soggetto ideale per una politica ribaltata dove il carisma si è spostato nell’indistinto e chiunque può scendere in campo se fin lì lo porta l’onda del sovvertimento generale. Lo aveva già detto vent’anni fa Bourdieu: la forza degli uomini nuovi della politica sta proprio nella mancanza dei requisiti specifici che di solito definiscono la competenza, dando così garanzie a tutti.
È il rovesciamento dell’élite: oggi la garanzia viene dal non sapere, dal non essere conformi al linguaggio degli esperti. Così si bruciano, insieme coi vizi dell’élite, un deposito di conoscenza, un accumulo di sapienza repubblicana, una riserva di esperienza, una provvista di conoscenza. La figura politica che nasce da questo impasto è un governante d’opposizione, il tribuno romano che Max Weber fondava proprio sulla rottura, addirittura sull’illegittimità, senza alcun legame con lo Stato, e tuttavia " sacrosantus" perché protetto dall’indignazione e dalla vendetta popolare, oltre che dagli dei, corrivi. Ma in fondo, avevamo già visto tutto nell’età democristiana, con la vecchia polemica contro il Palazzo. E allora, anche per la nuova élite rivoluzionaria vale la pena di ricordare la profezia di Pasolini: « I potenti che si muovono dentro il Palazzo agiscono come atroci, ridicoli, pupazzeschi idoli mortuari, in quanto potenti essi sono già morti e il loro vivere è un sussultare burattinesco » .`
-
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- Come le mani disegnate in rosso sulle parete delle caverne. Il segno di Belzebù indelebile sul Paese7 gennaio 2019, di Federico La Sala
Il Divo che commise il reato di associazione con la mafia
di Gian Carlo Caselli ( Il Fatto, 07.01.2019)
Subito dopo la morte di Falcone e Borsellino ho chiesto il trasferimento a Palermo. Ho avuto l’onore di guidare la procura di questa città per quasi sette anni. Nel contrasto all’ala militare di Cosa nostra i risultati sono stati imponenti: basti ricordare gli innumerevoli processi contro mafiosi “doc” conclusi con condanne per 650 ergastoli e un’infinità di anni di reclusione. Ma la mafia (tutti son bravi a dirlo, pochi a trarne le conseguenze sul piano investigativo) non è solo “coppola e lupara”. È anche complicità e collusioni assicurate da “colletti bianchi”. Ecco quindi vari processi contro imputati “eccellenti”. Fra gli altri Marcello Dell’Utri e Giulio Andreotti. Del primo (condannato in via definitiva a sette anni di reclusione) non si parla, se non quando vengon fuori i suoi problemi di salute. Del secondo è stata calpestata e fatta a pezzi la verità che emerge chiara dagli atti.
In primo grado c’è stata assoluzione, sia pure per insufficienza di prove. In Appello (mentre per i fatti successivi è stata confermata tale assoluzione) fino alla primavera del 1980 l’imputato è stato dichiarato colpevole, per aver commesso (sic!) il reato di associazione a delinquere con Cosa nostra. Il reato commesso è stato dichiarato prescritto, ma resta ovviamente commesso. La Cassazione ha confermato la sentenza d’appello e quindi anche la penale responsabilità dell’imputato fino al 1980. Processualmente è questa la verità definitiva ed irrevocabile. Ed è evidente che chi parla di “assoluzione” è fuori della realtà. Non esiste in natura, è una bestemmia la formula “assolto per aver commesso il reato”.
La corte d’Appello si è basata su prove sicure e riscontrate. Ad esempio, ha ritenuto provati due incontri del senatore con il “capo dei capi” di allora , Stefano Bontade, per discutere il caso di Pier Santi Mattarella, integerrimo capo della Dc siciliana, che pagò con la vita il coraggio di essersi opposto a Cosa nostra. La corte sottolinea tra l’altro che l’imputato ha “omesso di denunziare elementi utili a far luce [sull’omicidio] di cui era venuto a conoscenza in dipendenza dei suoi diretti contatti con i mafiosi”. Secondo la corte d’Appello, Andreotti ha contribuito “al rafforzamento della organizzazione criminale , inducendo negli affiliati, anche per la sua autorevolezza politica, il sentimento di essere protetti al più alto livello del potere legale. Così realizzando “una vera e propria partecipazione all’associazione mafiosa apprezzabilmente protrattasi nel tempo”.
Chi ha nascosto o stravolto la verità - oltre a truffare il popolo italiano in nome del quale si pronunziano le sentenze - non ha voluto elaborare la memoria di ciò che è stato, perché teme il giudizio storico su come in una certa fase, almeno parzialmente, si è formato il consenso nel nostro Paese. Ma in questo modo si rende un pessimo servizio alla qualità della democrazia. Perché si finisce per legittimare (ieri, oggi e domani) la politica che ha rapporti con la mafia.
Il segno di Belzebù indelebile sul Paese
Imperitura memoria - L’impronta lasciata sul seggio di Palazzo Madama da Giulio Andreotti, in Senato dal ‘91 al 2013 dopo 45 anni passati alla Camera
di Pino Corrias (Il Fatto, 07.01.2019)
Come le mani disegnate in rosso sulle parete delle caverne ci dicono che l’uomo del Pleistocene passò da lì, così la gobba di Giulio Andreotti incisa sul cuoio della sua sedia al Senato ci ricorda che in un tempo remoto della Repubblica siamo stati tutti democristiani - volenti o nolenti, eretti o quadrumani - lungo un’era che gli archeologi del nostro tempo chiamano per l’appunto Andreottiana.
Il capostipite era più alto di quanto oggi si possa immaginare. Aveva un pallore da sagrestia su un volto senza labbra, le orecchie aguzze, il passo veloce e scivoloso. Dormiva poco. Usciva ogni mattina all’alba per la Messa. Faceva l’elemosina ai mendicanti raccolti sul sagrato. Mangiava in bianco. Vestiva oscuri completi Caraceni col panciotto. Soffriva di emicrania e di persistente disincanto. Nel raro tempo libero giocava a gin-rummy e collezionava campanelli. Nell’ampio tempo del lavoro accumulava nemici e segreti.
I nemici li ha seppelliti quasi tutti. I segreti invece sono diventati la nostra storia e il suo leggendario archivio, nutrito per molto più di mezzo secolo, da quando la sua giovinezza fu rinvenuta tra le mura vaticane da Alcide De Gasperi, futuro plenipotenziario della Democrazia Cristiana, più o meno mentre le bombe degli angloamericani violavano il sacro suolo di Roma città aperta, estate 1943, impolverando la stola di papa Pio XII.
A 24 anni Giulio stava già nel posto giusto, tra gli inchiostri dell’eterno potere e al cospetto della grande Storia, intraprendendone da allora i cospicui labirinti che lo condussero, tra maldicenze e applausi, a indossare 27 volte i panni di ministro, 7 volte la corona di presidente del Consiglio.
Per poi passare, a intermittenza, dalle luci dello statista alle ombre del grande vecchio, 27 volte inquisito dalla magistratura e 27 volte salvato dalle Camere che a maggioranza negavano l’autorizzazione a procedere. Salvo soffriggere, udienza dopo udienza, sul banco degli imputati del tribunale di Palermo, anno 1995, per il celebre bacio a Totò Riina, e poi su quello di Perugia, dove era accusato di essere il mandante dei quattro colpi di pistola con cui venne cancellato il giornalista romano Mino Pecorelli, suo acerrimo nemico, le sue imminenti rivelazioni sul caso Moro e su certi assegni finiti tra i velluti e i sughi della sua corrente, detta anche lei andreottiana.
Inciampi giudiziari mai davvero prescritti e che hanno nutrito la sua leggenda nera - passata per Piazza Fontana, i Servizi deviati, lo scandalo petroli, il Banco Ambrosiano, Gladio, la morte solitaria del generale Dalla Chiesa sull’asfalto di Palermo - ma anche il suo fatalismo romanesco di eterno sopravvissuto al suo stesso danno: “Preferisco tirare a campare che tirare le cuoia” come recitava la sua massima preferita, che poi era anche il cuore della sua politica, talmente malleabile da rendersi disponibile a destra e a sinistra, purché immobile sotto l’ombrello angloamericano e in cambio di un costante incasso elettorale che gli garantivano, guarda caso, i collegi del Lazio e della Sicilia. Oltre naturalmente alla benevolenza della Chiesa, i sette papi che conobbe in vita, lasciandosi ispirare da una fede mai troppo intransigente, disponibile all’umano peccato purché con l’Avemaria sempre incorporata. “Quando andavano insieme in chiesa - scrisse Montanelli - De Gasperi parlava con Dio, Andreotti con il prete”.
La zia, i libri, la chiesa e la proposta al cimitero
A dispetto del molto che avrebbe intrapreso, Giulio nasce fragile il 14 gennaio del 1919. Orfano di padre, cresce cagionevole aiutato da una vecchia zia e dalla piccola pensione della madre. Fa il chierichetto e lo studente modello. Si laurea in Giurisprudenza. Alla visita militare il medico lo scarta e gli pronostica sei mesi di vita. Racconterà: “Quando diventai la prima volta ministro gli telefonai per dirgli che ero ancora vivo, ma era morto lui”.
Diventa sottosegretario con De Gasperi nel 1947, entra in Parlamento l’anno dopo. Ci rimarrà per sempre. Sotto ai suoi governi è nata la Riforma sanitaria, è stato legalizzato l’aborto, firmato il Trattato di Maastricht. E dentro alla sua ombra l’Italia è diventata un Paese industriale, alfabetizzato, un po’ più europeo, un po’ meno cialtrone, al netto del clamoroso debito pubblico e delle quattro mafie.
A trent’anni si sposa, dichiarandosi a Donna Livia “mentre passeggiavamo in un cimitero”. Avrà quattro figli. Una sola segretaria, la mitica Enea. Una sola vocazione: “Non ama le vacanze - dirà la figlia Serena - non ama il mare, non ama le passeggiate. La verità è che se non fa politica si annoia”.
Amici scomodi e nemici uccisi sempre col sorriso
Diventandone il prototipo incorpora tutti i pregi e i difetti dei democristiani. Conosce la pazienza e la prudenza. Uccide gli avversari con estrema gentilezza e sorride per buona educazione. È in confidenza con Kissinger e ammira Arafat. Si commuove alla morte di Paolo VI e a quella di Alberto Sordi, che poi sarebbero il sacro e il profano della sua esistenza. Maneggia il potere in silenzio, come un gioco di prestigio. E i cattivi come fossero i buoni. Tra i banchieri d’avventura predilige il piduista Michele Sindona, quello del crack della Banca Privata, a cui aveva appena conferito il titolo di “salvatore della lira”, per poi guardarne imperturbabile il naufragio dentro a un caffè avvelenato, nella cella singola di San Vittore, detenuto per l’omicidio di Giorgio Ambrosoli.
Non ha amici, ma soci momentanei di cordata, mai Fanfani e De Mita, qualche volta Forlani, più spesso Cossiga che lo nominerà senatore a vita. Educa Gianni Letta a fargli da scudiero per poi affidargli il giovane pupillo piduista Luigi Bisignani. Tutti i suoi sottocapi sono tipi da prendere con le molle: Vittorio Sbardella, detto “lo squalo” mastica per lui il Lazio. Ciarrapico è il re del saluto romano, delle acque minerali e degli impicci da sbrogliare. Franco Evangelisti è il faccendiere di “A Fra’ chette serve?”. Cirino Pomicino, detto “’O ministro” digerirà a suo nome 42 processi e 40 assoluzioni. E naturalmente Salvo Lima, il suo alter ego in Sicilia, morto sparato tra i cassonetti di Mondello per ordine dei corleonesi, la mattina del 12 marzo 1992, alba della stagione delle stragi.
Esecuzione che cancellò il suo unico sogno inconcluso, quello di salire al Quirinale, indossare finalmente i panni di presidente della Repubblica e (forse) sistemare gli scheletri del suo notevole armadio. Cominciando dallo scandalo fondante, anno 1963, il tentato golpe di un certo generale De Lorenzo, capo dei servizi segreti, e la scomparsa dei fascicoli che aveva accumulato sui protagonisti della vita pubblica italiana. Archivio quanto mai avvelenato e formidabile arma di ricatto che proprio Andreotti, all’epoca ministro della Difesa, era incaricato di distruggere. E che invece sarebbe riemerso nelle molte nebbie future e persino nei dossier di Licio Gelli, il finto o vero titolare della loggia massonica P2, forse a fondamento di un suo potere sussidiario esercitato per conto (proprio) di chi li aveva maneggiati per primo.
Da Moro agli anni di B.: è lui il capo dei diavoli
“Livido, assente, chiuso nel suo cupo sogno di gloria”, gli avrebbe scritto Aldo Moro dalla prigione brigatista, colmo di rancore e di rassegnazione per il nulla che il governo di solidarietà nazionale riuscì a fabbricare nei 55 giorni impiegati da Mario Moretti a eseguire la sentenza.
Bettino Craxi lo battezzo Belzebù, il capo dei diavoli. Lo temeva e forse lo ammirava, ma non imparò nulla dalla sua quieta imperturbabilità nelle aule di Giustizia e una volta inquisito da Mani pulite, strillò così tanto, da dichiararsi colpevole, pretendere l’impunità e finire latitante.
A differenza di quasi tutti, Andreotti non si lasciò sfiorare dalla volgarità delle tangenti, che lasciò volentieri alle mandibole dei suoi. Né dall’incantesimo delle notti romane. Una sola volta una nobildonna provò a trascinarlo sulla pista da ballo: “Non ho mai danzato con un presidente del Consiglio”, gli disse lei leziosa. “Neanch’io” rispose lui secco, allontanandosi. Non capì il bianco e nero di Berlinguer e non prese mai sul serio i troppi colori di Berlusconi. Sopravvisse alla morte della Dc e di due repubbliche. Scrisse migliaia di pagine senza mai rivelare un segreto. Sembrava eterno. Sembrava un destino. Invece anche lui, uscendo di scena a 94 anni, incollato alla sedia e in piena luce, è diventato un altro anniversario del nostro buio.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- IL SOVRANISMO PSICHICO. L’io sovrano del Censis (di Ida Dominijanni).29 dicembre 2018, di Federico La Sala
Italia
L’io sovrano del Censis
di Ida Dominijanni, giornalista *
Di anno in anno, con il suo rapporto annuale, il Censis non solo fornisce un’ottima radiografia dello stato dell’Italia, ma produce uno slogan destinato a scuotere un dibattito mediatico sempre più politicista, autoreferenziale e ripetitivo. Fu così qualche anno fa, quando De Rita prese pari pari dalle analisi lacaniane la diagnosi dell’eclissi del desiderio e la scaraventò su un’Italia ancora avvolta nel regime del godimento berlusconiano. Ed è così quest’anno, con il cinquantaduesimo rapporto che fa perno sul “sovranismo psichico” e mette di nuovo a fuoco il legame che nelle fasi di cambiamento stringe assieme la dimensione politica, quella sociale e quella psichica, individuale e collettiva.
Nel sovranismo, dice in sostanza il Censis, non ne va solo della nostalgia della sovranità nazionale “usurpata” dall’Unione europea e dell’invocazione della sovranità popolare “usurpata” dalle élite. Ne va di una certa mentalità, di certi sentimenti e comportamenti, di una certa configurazione degli individui. Lo si potrebbe dire - è stato detto: anche stavolta il Censis attinge a un’ampia ancorché non dichiarata letteratura - in altri termini: il discorso sovranista ha generato il suo soggetto, fatto a immagine e somiglianza dello stato sovrano perduto che evoca. L’uno e l’altro, lo stato e il soggetto, si sentono assediati da invasori alieni e minacciosi, l’uno e l’altro erigono muri a difesa dei propri confini, l’uno e l’altro nascondono dietro maschere fortificate e irrigidite la loro vulnerabilità e la loro dipendenza da altro e da altri. La forza - e la trappola - del sovranismo sta precisamente qui: nel creare un’illusione di forza e di autonomia, dello stato, del popolo e dell’individuo, a copertura della loro fragilità.
La ripresa inesistente
Il Censis però rovescia il cono: non vede nel soggetto sovranista un effetto del discorso politico, ma nel discorso politico un effetto della crisi sociale. In Italia il tempo s’è fermato: siamo fermi, e più spesso procediamo all’indietro come i gamberi. La ripresa economica intravista nel 2017 non s’è realizzata: “È sopraggiunto un intralcio, un rabbuiarsi dell’orizzonte”. Rallentano gli indicatori macroeconomici, cresce la sfiducia verso le istituzioni e il rancore di tutti contro tutti. Nell’assenza di progetto politico e di intervento statuale, peggiora in ogni campo la vita quotidiana, salvo che per una fascia di pochi privilegiati: la natalità diminuisce, l’ascensore sociale è bloccato, il lavoro manca, le disuguaglianze crescono, i soldi sono pochi (siamo il paese dell’Unione europea dove mediamente si guadagna di meno) e quei pochi stanno fermi in banca, i consumi non sono mai tornati ai livelli pre-crisi. Ma soprattutto, ogni cosa è sulle spalle dei singoli (aumentati del 50 per cento in dieci anni, mentre i matrimoni e le convivenze crollano) e delle famiglie: l’assistenza ai non autosufficienti, la sopravvivenza in un territorio a rischio perpetuo di crolli e frane, lo slalom nella giungla burocratica, la formazione culturale in un paese che non investe nulla sulla scuola e l’università. E per giunta, questo defatigante lavoro di adattamento alla crisi non viene riconosciuto né ripagato in gratitudine da nessuna istituzione.
Sono le radici profonde della delusione, della sfiducia e di un rancore pervasivo ormai convertitosi, scrive il Censis, in una cattiveria diffusa e in una conflittualità latente, “pulviscolare e individualizzata”. Da qui la soluzione del “sovranismo psichico”: un si salvi chi può che si regge sulla caccia paranoica del capro espiatorio, identificato nei migranti e più in generale in qualunque differenza o alterità perturbante. La maschera arcigna dell’io sovrano che presidia digrignando i denti un’identità immaginaria, in realtà destabilizzata dall’incertezza e dall’assenza di prospettive. Un’identità nazionale - “prima gli italiani”- bianca, proprietaria (e, dimentica di dire il Censis, maschile, come dimostra la misoginia imperante che il rapporto stranamente non contabilizza). Che “guarda al sovrano autoritario” come garanzia di contenimento dell’angoscia e di stabilità.
L’illusione traballante del sovranismo
La soluzione del governo sovranista sarebbe dunque l’effetto coerente di questa trasformazione psichica e sociale. “La delusione per il non-cambiamento miracoloso ha incattivito gli italiani e li ha resi disponibili a un salto rischioso e incerto, un funambolico camminare sul ciglio di un fossato che mai prima d’ora aveva visto da così vicino, se la scommessa era poi quella di spiccare il volo. Quasi una ricerca programmatica del trauma, nel silenzio arrendevole delle élite”. C’è da chiedersi tuttavia, rovesciando di nuovo il cono, se la soluzione politica sarebbe stata necessariamente quella populista-sovranista in presenza di un discorso politico diverso. Se qualcuno avesse dato ascolto all’incertezza invece di rimuoverla nella narrativa trionfale della ripresa e alla precarietà invece di annegarla nella retorica delle start up. Se qualcuno, nella crisi, avesse fatto appello alla solidarietà invece che all’autoimprenditorialità e alla competitività. Se le responsabilità del debito accumulato fossero ricadute su chi di dovere invece che su un senso di colpa collettivo deprimente e mortifero. Eccetera eccetera: a incattivirci, prima del sovranismo psichico e politico, è stato il neoliberalismo, di cui il sovranismo è solo l’effetto perverso. E del resto, già pericolante. La grottesca vicenda della manovra economica ha già dimostrato che il ritorno alla sovranità dello stato-nazione è una beata illusione. Il crollo dell’illusione psichica dell’io sovrano seguirà immancabilmente.
* Internazionale, 8 dicembre 2018
Sul tema, nel sito, si cfr.:
FILOSOFIA. IL PENSIERO DELLA COSTITUZIONE E LA COSTITUZIONE DEL PENSIERO
 MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA E A PENSARE BENE "DIO", "IO" E "L’ITALIA", CHI PIÙ CHI MENO, TUTTI VIVONO DENTRO LA PIÙ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA E POLITICA ITALIANA, NEL REGNO DI "FORZA ITALIA"!!!
MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA E A PENSARE BENE "DIO", "IO" E "L’ITALIA", CHI PIÙ CHI MENO, TUTTI VIVONO DENTRO LA PIÙ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA E POLITICA ITALIANA, NEL REGNO DI "FORZA ITALIA"!!!- LA LIBERTA’, LA "PAROLA" E LA "LINGUA" DELL’ITALIA, E IL COLPO DI STATO STRISCIANTE DEL PARTITO "FORZA ITALIA".
HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI.
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! - FILOLOGIA VIVENTE. «Papiro di Artemidoro». Un falso geniale che interroga il presente (di Valentina Porcheddu)..13 dicembre 2018, di Federico La Sala
«Papiro di Artemidoro». Un falso geniale che interroga il presente
Querelle storiche . Luciano Canfora ribadisce i motivi per cui ha sempre ritenuto fosse una truffa. La Procura di Torino conferma. «La datazione degli inchiostri è solo l’ultimo tassello di un quadro già chiarissimo. Le parole che vi figurano non sono presenti in alcun dizionario»
di Valentina Porcheddu (il manifesto, 13.12.2018)
A breve distanza dalla polemica con il ministro degli interni Matteo Salvini concernente l’operazione contro la mafia nigeriana e a pochi giorni dal suo pensionamento, il procuratore di Torino Armando Spataro torna all’onore delle cronache. Ma questa volta nessun tweet potrà inficiare l’esito dell’inchiesta. Ad essere coinvolto, infatti, è il «reperto» noto come Papiro di Artemidoro, ritenuto falso dalla magistratura.
NEL 2004, il documento - presentato come il II libro dei perduti Geographoumena di Artemidoro di Efeso (II-I secolo a.C.) - venne venduto alla Fondazione per l’arte della Compagnia di San Paolo da Serop Simonian, gallerista di origine armena trapiantato ad Amburgo. L’esorbitante cifra di 2 milioni e 750 mila euro sborsata dalla Fondazione è la più alta mai raggiunta al mondo per l’acquisto di un papiro.
Malgrado il reato di truffa sia andato in prescrizione, la «sentenza» della Procura di Torino mette fine alla querelle tra i difensori dell’antichità dell’oggetto (in particolare Claudio Gallazzi, Bärbel Kramer e Salvatore Settis) e Luciano Canfora, che nel 2013 presentò un esposto e per il quale il papiro sarebbe l’opera di Constantinos Simonidis, falsario del XIX secolo formatosi tra le pergamene del Monte Athos, dove suo zio era igumeno. La prova fondamentale per l’archiviazione delle indagini è stato il risultato di una perizia disposta di recente dal Ministero dei Beni Culturali sugli inchiostri utilizzati per tracciare il papiro, che risultano di epoca moderna. Gli esami chimici, richiesti a suo tempo da Canfora, avrebbero potuto dissolvere fin da subito i dubbi sull’autenticità di un papiro lungo due metri e mezzo e composto da frammenti eterogenei, in cui a un bizzarro parallelo tra geografia e filosofia si aggiungono disegni di parti anatomiche e animali fantastici.
«LA DATAZIONE degli inchiostri è solo l’ultimo tassello di un quadro già chiarissimo», dice Canfora al Manifesto. «A mio avviso le analisi storiche, geografiche e linguistiche del papiro - continua l’autore de La meravigliosa storia del falso Artemidoro (Sellerio 2011) - hanno un valore decisamente più importante. Per fare solo un esempio, l’ultima edizione del prestigioso dizionario dal greco all’inglese Liddell & Scott non contiene nessuna delle parole che figurano per la prima volta nel cosiddetto papiro di Artemidoro. Questi lemmi assurdi non compaiono neanche nella versione più aggiornata del vocabolario greco-italiano edito dalla Lœscher, seppur il testo del presunto Artemidoro venga citato fra le fonti del volume».
Per quanto riguarda i disegni visibili nel recto del papiro, Canfora è convinto siano stati realizzati ad hoc da Simonidis, che nel monastero del Monte Athos aveva potuto copiare uno di quei manuali di disegno in voga tra Seicento e Settecento. «Nel verso - spiega Canfora - c’è invece una serie di animali divisi per categorie e sotto alcuni si trova una didascalia redatta in un greco strampalato. Questa parte ‘animalesca’ non ha senso, se non ipotizzando che il falsario abbia voluto dimostrare con essa l’unità di un papiro composto di varie parti».
LE VELLEITÀ della Compagnia di San Paolo di possedere un oggetto unico - il geografo Artemidoro di Efeso è conosciuto soltanto attraverso fonti indirette - da esporre al Museo Egizio ha dunque prevalso sul rigore filologico e i tanti indizi, fra cui vanno annoverate le sospette autorizzazioni ad esportare il documento dall’Egitto nel 1971 e più di trent’anni dopo dalla Germania, che avrebbero dovuto indurre alla massima cautela gli acquirenti.
Tuttavia, l’allora direttrice del Museo Egizio Eleni Vassilika rifiutò di ricevere il «reperto» in comodato d’uso gratuito in quanto nella sua esperienza di lavoro al Roemer and Pelizaeus Museum di Hildesheim si era già confrontata con lo spaccio di falsi praticato dal mercante d’arte Serop Simonian. Il contestato oggetto venne ugualmente celebrato a Torino con la mostra Le tre vite del papiro di Artemidoro tenutasi nel 2006 a Palazzo Bricherasio a cura di Settis e Gallazzi, seguita da una successiva rassegna presso la sezione di egittologia del Neues Museum di Berlino.
Dal 2014, invece, il papiro è esposto al Museo di Antichità del capoluogo piemontese, dove si spera potrà tornare, dopo il temporaneo trasferimento all’Istituto Centrale per il Restauro, quale testimonianza eccellente dell’archeologia dell’illusione. Sarebbe infatti un peccato non approfittare di questa clamorosa vicenda per raccontare come ancora oggi la fascinazione per il mondo antico e l’immaginario che ne deriva, sviino talvolta sulla pericolosa strada del potere e del denaro, tradendo il valore della cultura. Il geniale Simonidis e l’astuto Simonian si sono fatti beffa di ciechi (o forse azzardati) amanti dell’arte. A noi spetta ora tramandare la verità storica.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- "Io, Artemidoro e la mia guerra ai falsari geniali". Dopo la sentenza della Procura di Torino, parla lo studioso che aveva considerato il Papiro sin dall’inizio una truffa.12 dicembre 2018, di Federico La Sala
Luciano Canfora "Io, Artemidoro e la mia guerra ai falsari geniali"
Dopo la sentenza della Procura di Torino, parla lo studioso che aveva considerato il Papiro sin dall’inizio una truffa. "Chi ha studiato con me è stato vittima di pressioni e minacce. Salvatore Settis? Lo considero ancora un amico"
Intervista di Dario Olivero (la Repubblica, 12.12.2018)
Questa storia si può raccontare, come tutte le storie, in molti modi. Uno è quello della procura di Torino: il Papiro di Artemidoro è un falso, non si procede per truffa solo perché il reato è caduto in prescrizione. Un altro è quasi conradiano: il Papiro di Artemidoro è il campo di battaglia di due duellanti, Salvatore Settis che ne ha perorato l’acquisto e difeso l’autenticità fino all’ultimo sangue e Luciano Canfora che fin dall’inizio l’ha messa in dubbio. Un terzo è la detective story con tutti gli ingredienti del noir: un falsario geniale, un venditore oscuro, un acquisto affrettato, svariate autopsie filologiche e scientifiche, misteri, depistaggi, esperti entrati e usciti di scena, molti soldi. E, naturalmente, un investigatore ossessionato dalla verità.
Professor Canfora, perché ha dedicato tredici anni della sua vita a dimostrare che il Papiro di Artemidoro è falso? È ossessionato?
 «Per nulla», risponde al telefono da Bari il giorno dopo la notizia arrivata dalla procura di Torino che gli dà ragione. «Semmai sono uno curioso che desidera sempre andare a fondo. Mi sono occupato e mi occupo di tante cose con la stessa curiosità e, visto che non esistono ossessioni multiple, il Papiro non è la mia ossessione. Nessuno lascia a metà una ricerca o un problema, bisogna lavorare con disciplina rispettando lo stile che richiede una materia come la filologia».
«Per nulla», risponde al telefono da Bari il giorno dopo la notizia arrivata dalla procura di Torino che gli dà ragione. «Semmai sono uno curioso che desidera sempre andare a fondo. Mi sono occupato e mi occupo di tante cose con la stessa curiosità e, visto che non esistono ossessioni multiple, il Papiro non è la mia ossessione. Nessuno lascia a metà una ricerca o un problema, bisogna lavorare con disciplina rispettando lo stile che richiede una materia come la filologia».Ma perché proprio il Papiro?
«Mi imbattei nel Papiro mentre lavoravo su tutt’altro. La mia ricerca mi portò a studiare i modi di ritrovamento e acquisto dei materiali papiracei negli anni Venti e Trenta, un periodo di grande fioritura. Un fondo si trovava a Milano al centro Achille Vogliano. Lì vidi dei lucidi che raffiguravano il cosiddetto Papiro di Artemidoro. Era il 2006, mi chiesero di esprimermi e scrissi un articolo in cui esortavo alla cautela sulla sua autenticità».
E come mai la storia non finì lì?
«L’Enciclopedia italiana, di cui faceva parte anche Settis, mi chiese di scrivere la voce "Papiro" con la precisa richiesta di dare molto spazio a questa novità appena esposta a palazzo Bricherasio. Allora approfondii lo studio e pubblicai sui Quaderni di storia i miei rilievi e li mandai a Settis che mi disse che anche lui all’inizio aveva avuto dei dubbi. Dopo alcune settimane, lo dissi anche in un’intervista. Due giorni dopo su Repubblica apparve un pezzo molto polemico del mio amico che mi chiamava in causa. A quel punto ritenni fosse mio dovere proseguire le indagini».
Lo chiama amico, lo siete ancora?
«Sì, lo siamo tuttora. I rapporti personali non possono essere intaccati da una disputa accademica».
C’è chi insinua che la sua battaglia fosse motivata dal risentimento per non essere stato chiamato alla Normale di Pisa.
«Ma certo che no. Quell’anno nessuno venne chiamato. Inoltre credo sinceramente che Settis mi fosse favorevole».
È vero che avete condiviso una stanza quando eravate studenti?
«Da studenti abbiamo dormito nella stessa stanza di un pessimo albergo di Taranto, ci stavamo laureando e avevamo ricevuto una colossale borsa di studio da 25mila lire per seguire un convegno. Mi ricordo che Settis chiese una birra ma non avevano neanche quella. Stiamo parlando del ’63: c’era ancora Togliatti».
Ma dai tempi di Togliatti quante volte vi siete sentiti negli ultimi tredici anni?
«Le ripeto, ci siamo visti spesso, per esempio nel consiglio scientifico della Treccani».
Mi aiuti a ricostruire la storia. Partiamo dal gallerista armeno, Serop Simonian, che vendette il Papiro all’allora Compagnia di San Paolo nel 2004 per 2 milioni e 750 mila euro. Lo ha mai incontrato?
«No, mai. Ha una galleria d’arte ad Amburgo, ma il personaggio è sospetto. Pensi che quando Eleni Vassilika, che poi avrebbe rifiutato il Papiro in comodato d’uso all’Egizio di Torino, era direttrice a Hildesheim aveva già avuto a che fare con lui ed ebbe molti problemi sull’autenticità e provenienza delle opere che trattava. Avemmo con lui due contatti: il primo fu quando Silio Bozzi, un dirigente della polizia scientifica, gli chiese il negativo di una foto scattata al Konvolut, cioè l’involucro da dove sosteneva provenisse il Papiro, e lui disse di no. La seconda per un invito a un convegno sul Papiro. Non venne».
Veniamo al secondo personaggio: il falsario. Si chiamava Simonidis, non le sarà sfuggita l’assonanza dei nomi dei due protagonisti.
«In effetti deve essere la provvidenza che si è divertita a mettere insieme un greco e un armeno di due secoli diversi nella stessa storia. Simonidis è un personaggio colossale. Non conosciamo né l’anno di nascita né quello di morte. Anzi, diffuse la notizia di essere morto ma in realtà si era ritirato in Egitto, secondo il Times (che non ne era del tutto certo) pare che sia morto in Albania nel 1890».
Falsificò la sua morte?
«Era un genio. Studiò sul Monte Athos dallo zio che era igumeno di uno dei monasteri. Imparò a disegnare teste, profili, imparò la composizione degli inchiostri antichi. Poi andò ad Atene dove pubblicò opere di argomento geografico con uno stile che imita quello bizantino. Studiò teologia a Istanbul, poi finì in Russia e cercò di smerciare una lista di testi greci che sosteneva aver portato dall’Athos ma l’Accademia di Pietroburgo li respinse. Erano tutti testi geografici come il Papiro».
Professore, se non sapessi che stiamo parlando del Papiro di Artemidoro, direi che lei stima questo falsario come certi detective ammirano i delitti di quelli a cui danno la caccia.
«Non mi sono invaghito, però in effetti so benissimo che la frequentazione assidua porta all’immedesimazione, Plutarco docet. Simonidis riuscì quasi a beffare l’Accademia delle scienze di Berlino. Ma, come diceva il grande filologo tedesco Wilamovitz: "Un falsario moderno per quanto bravo tradisce sempre la sua modernità"».
E torniamo al Papiro. E alla vittima. Perché la Compagnia di San Paolo lo acquistò? Non c’erano segnali che potesse trattarsi di una imprudenza?
«Nel 2004 nessuno aveva sospetti. C’era uno studio parziale tedesco del ’98. Certo, si tentò di venderlo anche in Spagna ma la Fondación Pastor sconsigliò, così come il Getty. Ma allora non era ancora scoppiato il caso. L’acquirente non aveva voci critiche che lo potessero allarmare».
Ma anzi, aveva il parere favorevole di Settis. Cosicché decise di esporlo in mostra.
«Esatto. Con tanto di sontuoso catalogo dal titolo Le tre vite del Papiro, oggi quasi introvabile».
Immagino non per lei.
«Io ne ho due o tre copie».
Comunque incominciò la sfida che è durata fino a oggi.
«Ma se io non fossi stato sollecitato ad occuparmene non lo avrei mai fatto. Uno deve disciplinare le energie».
L’archiviazione della procura di Torino sembra chiudere la storia. Eppure, come in un thriller, c’è un’autopsia ancora in corso. In questo momento il Papiro è a Roma all’Istituto centrale per il restauro. I proprietari, che hanno deciso di non intraprendere nessuna iniziativa legale, vogliono continuare a studiarlo. Ci aspettano nuovi colpi di scena?
«L’Istituto è un’eccellenza italiana, è giusto che procedano alle analisi, che sono soprattutto sugli inchiostri; ma ha già fornito indicazioni che vanno verso l’accertata modernità del papiro. Essendo scienziati procederanno con dei raffronti su pezzi di scavo per completare il referto».
Ma è giusto studiare un falso?
«Ma il Papiro è un eccellente prodotto moderno come altri prodotti del Simonidis ».
Quanti caduti ha lasciato sul campo la guerra del Papiro di Artemidoro?
«Mi ha colpito che studiosi di grande qualità in ognuno dei rispettivi ambiti siano stati bersaglio di attacchi e ostilità. Oltre alla ex direttrice dell’Egizio e Bozzi ci sono stati altri casi, restauratori, esperti, studiosi. Sono state fatte pressioni su di loro, alcuni costretti a lasciare il lavoro, altri trasferiti».
Pressioni da parte di chi?
«Posso citare Di Maio che oggi va tanto di moda?».
Se crede.
«Una manina misteriosa non so di chi».
E dal mondo accademico ha avuto più solidarietà, ostilità o indifferenza?
«Quando Mussolini fu arrestato il 25 luglio del ’43 un vicino di casa abbraccia un noto antifascista del suo stesso palazzo e gli dice commosso: finalmente. E il vicino gli risponde: me lo dovevi dire prima».
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- Tutta la città ne parla: "Non solo di cose d’amore. Noi, Socrate e la ricerca della felicità".2 dicembre 2018, di Federico La Sala
Intorno all’amore. Pietro Del Soldà ne individua una dimensione pubblica contro l’immagine dominante che ne dà invece una lettura privata. L’eros non va inteso solo in senso sentimentale e di coppia, ma soprattutto politico
Una visione plurale di felicità
di Remo Bodei (Il Sole-24 Ore, Domenica, 02.12.2018)
- Non solo di cose d’amore. Noi, Socrate e la ricerca della felicità Pietro Del Soldà Marsilio, Venezia, pagg. 191, € 17
Nell’inflazione di pubblicazioni che trattano della felicità e delle ricette per raggiungerla o tra le numerose applicazioni del pensiero antico all’attualità, la prima cosa da dire è che questo libro riserva una gradita sorpresa: non è banale e, malgrado la perfetta conoscenza dei testi platonici utilizzati, non ha neppure un taglio didascalicamente accademico.
In quanto conduttore della rubrica radiofonica Tutta la città ne parla, Pietro Del Soldà gode, infatti, professionalmente del vantaggio di praticare una sorta di quasi quotidiano dialogo socratico nell’agorà tecnologica di RAI 3, di misurarsi, in maniera garbata ed equilibrata, con le questioni poste dal pubblico, con le sue preoccupazioni e inquietudini. Senza offrire soluzioni prefabbricate, egli utilizza Socrate come un reagente e non come un modello cui adeguarsi.
Il problema della felicità è trattato contropelo, a partire dalle radici dell’infelicità e delle sue cause e dalla domanda che oggi s’impone: perché tanta infelicità, se il mondo, rispetto al passato, è incomparabilmente migliore, se le aspettative di vita, di libertà e di sicurezza sono così aumentate? Contro l’immagine dominante di una felicità esclusivamente privata, Del Soldà ne mostra l’inscindibile con la dimensione pubblica. Sostiene poi la tesi che l’amore (eros) non debba essere inteso in senso sentimentale o di coppia, ma anche, e soprattutto, politico. In tale prospettiva, esso consiste nella ricerca di un legame in grado di dare «armonia alle “voci del coro”, cioè di governare se stesso e la città senza escludere nessuna delle parti che la compongono». Eros è la forza che abbatte il muro di separazione tra l’Io e il Noi.
Notevole è la parte del volume che, ripercorrendo la polemica di Socrate contro i sofisti (in dialoghi come il Protagora, il Gorgia, il Lachete, il Fedro, la Repubblica e le Leggi), Del Soldà indica in essi gli antesignani delle attuali forme d’individualismo narcisistico, caratterizzato dalla mancanza di pudore, dalla «spettacolarizzazione dell’intimità», dall’insofferenza alle regole e dalla ricerca del successo a qualsiasi costo. Nessuno si mette realmente in gioco nel dialogo, ma aggiunge addirittura nuovi mattoni al «muro» che lo divide, oltre che da se stesso, anche dagli altri, con cui intrattiene rapporti unicamente strumentali. Si è perciò soli pur vivendo in mezzo a una pluralità di persone, perché s’intessono con loro relazioni non vincolanti (quelle che il filosofo americano Robert Nozick aveva teorizzato come no binding committments).
L’esistenza è concepita da questi sofisti come una competizione senza quartiere, analoga alla corsa della vita descritta da Hobbes, che parafrasa San Paolo, della: «Guardare gli altri che stanno dietro, è gloria. [...] Esser superato continuamente, è infelicità. / Superare continuamente quelli davanti, è felicità / E abbandonare la pista, è morire».
L’ipertrofia dell’io conduce al paradosso per cui, più ci separiamo da noi stessi e dagli altri, più ci omologhiamo, in quanto egoismo e conformismo sono due facce della stessa medaglia. Come abbattere dunque la barriera che ci divide da noi stessi e dagli altri? La soluzione suggerita è quella che si trova nell’Alcibiade Maggiore, dove il precetto delfico «Conosci te stesso!» non va inteso come un invito a sprofondare nell’asfittica interiorità individuale, bensì a rispecchiare se stesso nella pupilla dell’altro: «Se un occhio vuole vedere se stesso, deve guardare in un altro occhio e in quella parte in cui nasce la forza visiva».
 Ciascuno deve perciò uscire da sé proprio per andare verso se stesso, anche perché conoscere se stessi significa conoscere gli altri, ossia anche fare politica. Ma, per rovesciare l’ottica consueta dell’introspezione e ritrovarsi nella pluralità degli altri, per rimettere a posto i frammenti di se stessi in qualcosa di coerente, si richiede coraggio.
Ciascuno deve perciò uscire da sé proprio per andare verso se stesso, anche perché conoscere se stessi significa conoscere gli altri, ossia anche fare politica. Ma, per rovesciare l’ottica consueta dell’introspezione e ritrovarsi nella pluralità degli altri, per rimettere a posto i frammenti di se stessi in qualcosa di coerente, si richiede coraggio.Riferendosi più direttamente alle vicende del presente, ciò implica non solo l’abbandono della retorica dell’identità autosufficiente, basata sull’esclusione dell’altro, ma anche - e questo, in tempi di fake news, è un suggerimento prezioso - il non limitarsi a smontare le falsità evidenti attraverso il fact checking. Occorre, piuttosto, sforzarsi di capire l’eros, l’irrefrenabile bisogno, in chi si è sentito abbandonato e sminuito, di entrare a far parte di una comunità che lo rappresenti e per cui si è disposti ad accettare, come tassa d’inclusione, tutto quanto asserito dall’opinion leader.
 Tale adesione ha tanto più valore in una fase in cui si assiste a una enorme crescita delle diseguaglianze o, come direbbe la sociologa Sakia Sassen, a una «secessione dei patrizi», al ritirarsi nelle loro dorate posizioni di quei pochi che posseggono le risorse di metà del genere umano (e che, nella rivendicazione di una eroica ignoranza, vengono spesso accomunati alla detestata casta dei detentori ufficiali del sapere).
Tale adesione ha tanto più valore in una fase in cui si assiste a una enorme crescita delle diseguaglianze o, come direbbe la sociologa Sakia Sassen, a una «secessione dei patrizi», al ritirarsi nelle loro dorate posizioni di quei pochi che posseggono le risorse di metà del genere umano (e che, nella rivendicazione di una eroica ignoranza, vengono spesso accomunati alla detestata casta dei detentori ufficiali del sapere).Vi è un solo, difficile. rimedio all’attuale ribollire delle «passioni tristi» (odio, invidia, risentimento) e di quelle irruenti (ira, gelosia, aggressività) non sufficientemente orientate dal pensiero cosciente. Nelle Leggi tutte sono paragonate da Platone a rigidi e indeformabili fili di ferro, che muovono l’uomo come una marionetta. A esse bisogna sottrarsi, opponendo resistenza al loro potere, per «farsi guidare sempre da uno solo di questi fili, senza mai lasciarlo [...]. Si tratta del sacro filo d’oro del logos». Occorre, in altri termini, fare affidamento su una «ragione malleabile» come l’oro, capace di condurre a una «felicità plurale» e condivisa, al cui culmine «assaporare la gioia indicibile di un canto comune».
__________________________________________________________
Sul tema, nel sito, si cfr.:
HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI.
SPIRITO CRITICO E TEOLOGIA POLITICA DEL "MENTITORE". PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO, CHE GIA’ DANTE SOLLECITAVA ...
 IL "DUE" DI SAUSSURE VINCE IL "DUE" DI ROBERTO ESPOSITO. Un commento di Remo Bodei.
IL "DUE" DI SAUSSURE VINCE IL "DUE" DI ROBERTO ESPOSITO. Un commento di Remo Bodei.
 "Due. La macchina della teologia politica e il posto del pensiero". Si può smontare il meccanismo teologico di sudditanza all’Uno su cui si fondano i rapporti di potere?
"Due. La macchina della teologia politica e il posto del pensiero". Si può smontare il meccanismo teologico di sudditanza all’Uno su cui si fondano i rapporti di potere?FILOSOFIA IN STATO COMATOSO. IL PARADOSSO DELL’IDENTITA’: IO E GLI ALTRI. REMO BODEI CERCA DI SVEGLIARSI E SI RIATTACCA AL VECCHIO E LOGORO FILO POPPERIANO. Ecco le tesi del suo "manifesto per vivere in una società aperta"
LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89).
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- IL CANTO DEL GALLO. La filosofia come vocazione a rompere il silenzio (di Francesca Rigotti).2 dicembre 2018, di Federico La Sala
Donatella Di Cesare
La filosofia come vocazione a rompere il silenzio
di Francesca Rigotti (Il Sole Domenica, 02.12.2018)
- Sulla vocazione politica della filosofia Donatella Di Cesare Bollati Boringhieri, Torino, pagg. 180, € 12,75
«Quando il gallo canta, solo o in un’orchestra solitaria e distante, sembra che voglia rompere qualcosa...Il canto del gallo irrompe e spalanca, in modo decisivo, le porte e il cammino della storia». Le parole di María Zambrano (in Dell’aurora, 1986) mi risuonano nella testa, pensando a questo libro di Donatella Di Cesare, insieme a quelle di Max Weber (ne La scienza come professione, 1919): «Una voce grida da Seir in Edom: sentinella quanto durerà la notte? Verrà il mattino - risponde la sentinella - ma è ancora notte». Entrambi gli autori evocano infatti situazioni di veglia e la veglia, commenta a sua volta Di Cesare, è «il preludio della filosofia».
Nella veglia, nell’attesa della luce chiara del giorno, che desta stupore, canta il gallo: quel gallo che Socrate dopo aver bevuto la cicuta chiede venga sacrificato ad Asclepio, come riportano le ultime battute del Fedone. Il gallo, animale di sacrificio da immolare allo scopo di celebrare la guarigione dalla malattia del vivere. Il gallo, animale della soglia tra oscurità e chiarezza, veglia e sonno, animale del limite dunque, come le domande-limite della filosofia, che stanno sul punto del limite per valicarlo e uscirne fuori.
La filosofia - dice l’intenso saggio di Donatella Di Cesare, proponendo una riflessione sul ruolo di tale forma e disciplina del pensiero e cercando di darne una definizione - si affaccia sulla soglia e guarda oltre, per esempio nelle «profezie del salto» di Marx e Kierkegaard, filosofi divergenti quanto speculari nel loro salto, verso l’esteriorità Marx, rivolto all’interiorità Kierkegaard.
Anche se il titolo potrebbe trarre in inganno, lasciando immaginare filosofi sulle barricate, Di Cesare non sostiene certamente la coincidenza tra filosofia e politica, né quella tra filosofia e democrazia e nemmeno la priorità della democrazia sulla filosofia, come suona il titolo di un saggio di Richard Rorty. Ciò cui qui si dà luogo, si apre spazio, è il tema della vocazione la quale è chiamata, voce, invocazione, canto, canto del gallo che con la sua potenza sonora rompe il silenzio, apre la porta ed e-voca, ovvero, letteralmente «chiama fuori».
Serve a qualcosa questo richiamo, ha utilità pratica, porta profitti e guadagni, risolve problemi? A quest’ultimo aspetto provvede lo scienziato, commenta Di Cesare, riconoscendo alle scienze capacità e ruoli precisi. Cortesia non ricambiata da Edoardo Boncinelli che invece nella sua requisitoria dal titolo La farfalla e la crisalide (Milano 2018) infierisce crudamente (e gratuitamente) sulla filosofia, accusandola di rifiutarsi di capire che a partire dalla nascita e dall’affermarsi della scienza sperimentale il suo ruolo si è esaurito, anzi è diventato frenante, negativo, tossico.
La scienza, riconosce Di Cesare, percorre la via regia verso la soluzione dei problemi e l’appagamento progressivo della conoscenza. Ma la filosofia precede la scienza, e non certo per tirarsi indietro e autodistruggersi nel momento di separarsi da quella, come la crisalide che, dopo essersi aperta per lasciar uscire la farfalla, si secca e perde la sua funzione. Che l’analogia proposta da Boncinelli non sia valida, proprio come non fu valida, ce lo illustra lui stesso, l’analogia della struttura dell’atomo con quella del sistema solare, dal momento che troppe specificità atomiche trascurava e oscurava?
La filosofia di cui Di Cesare parla con passione e trasporto ha un movimento alato, verticale, lungo il quale si muovono quei «sublimi migranti del pensiero» che sono i grandi filosofi persino, nonostante Boncinelli, post-galileiani. Eppure da quella posizione eretta la filosofia riesce pure a inclinarsi - sia reso omaggio a Adriana Cavarero - con un gesto di attenzione e cura, verso la polis, per risvegliare la comunità assopita nel sonno individuale, e qui Di Cesare segue le intuizioni e le immagini mentali di Walter Benjamin.
Non è un caso dunque che l’autrice affidi il compito politico della filosofia alla poesia, come fu il caso di Dante, poeta e pensatore dell’impegno politico che prese partito e si espose pubblicamente. Come non è un caso il fatto che il poetare e l’impegnarsi politicamente si incontrino e si fondino nella etimologia dei termini in gioco tedeschi, latini e greci. Comporre poesia in tedesco, commenta Di Cesare, si dice dichten (dal latino dictare), ma dichten sta anche per condensare, addensare.
Lo stesso significato, aggiungo, del termine impegno (dal lat. pignus), legato ai significati del verbo latino pango e di quello greco pègnymi, vale a dire addensare, consolidare, coagulare; che è quel che fa la parola politica quando si incarna nell’impegno o introduce il patto e la pace. Questo mentre i filosofi non dovrebbero fare a meno di intervenire politicamente nel mondo, eventualmente dalla posizione anarchica, quella di Di Cesare, svincolata dal potere e dal comando - uno dei significati del greco archè - ma non dagli altri suoi non meno pregnanti significati, origine e principio.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
ALL’OMBRA DELL’UOMO DELLA PROVVIDENZA -- «La farfalla e la crisalide», Edoardo Boncinelli, e l’Accademia del Cimento.
RIPENSARE L’EUROPA. PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! - LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"! La scoperta della libertà (di Maurizio Viroli).8 novembre 2018, di Federico La Sala
LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"! .... *
- NOTERELLE SUL MACHIAVELLI (1932-34): "Il Principe prende il posto, nelle coscienze, della divinità o dell’imperativo categorico, diventa la base di un laicismo moderno e di una completa laicizzazione di tutta la vita e di tutti i rapporti di costume" (A. Gramsci, Quaderni del carcere)
- "IN OGNI MODO OCCORRE STUDIARE KANT E RIVEDERE I SUOI CONCETTI ESATTAMENTE" (A. Gramsci, Quaderni del carcere)
La scoperta della libertà
di Maurizio Viroli Il Fatto, 18 aprile 2017
Per molti della mia generazione la lettura degli scritti di Antonio Gramsci ha avuto l’effetto di una liberazione dal marxismo-leninismo banale e dogmatico che teneva banco, alla fine degli anni Sessanta, fra i movimenti della sinistra extraparlamentare. Non ho prove storiche da offrire, ma credo che molti giovani si siano avvicinati al Pci anche perché quel partito si proclamava erede di Gramsci e si impegnava attivamente a farne conoscere gli scritti.
Nel 1975 esce infatti per Einaudi, sotto l’egida dell’Istituto Gramsci, la prima edizione critica dei Quaderni del carcere, a cura di Valentino Gerratana. Su quei quattro volumi furono promosse molte iniziative e si aprì un importante dibattito culturale e politico sul concetto di egemonia, sul rapporto fra democrazia e socialismo, sul ruolo e la natura del partito, sulla Rivoluzione d’Ottobre, sugli intellettuali, sulla storia d’Italia, sulla questione meridionale.
A Gramsci va riconosciuto il merito storico di aver avviato nel mondo comunista la consapevolezza che non era possibile in Italia seguire la via della Rivoluzione d’Ottobre. Lo ha fatto con l’unico argomento che poteva essere efficace, vale a dire la considerazione realistica delle condizioni storiche.
Sarebbe sbagliato sostenere che Gramsci aveva capito che la trasformazione socialista della società deve avvenire soltanto nel pieno rispetto delle libertà civili e delle regole democratiche. Ma una volta dichiarato che la via sovietica non poteva essere percorsa, che il proletariato “può e deve essere dirigente [vale a dire ottenere il consenso degli altri gruppi sociali] già prima di conquistare il potere governativo”, e che deve continuare a essere dirigente anche dopo la conquista del potere, restava aperta, di fatto, soltanto la via democratica.
L’intuizione più felice di Gramsci è, a mio giudizio, l’idea della “riforma intellettuale e morale”. In un passo delle Noterelle sul Machiavelli, la descrive come “elevamento civile degli strati depressi della società”, simile, per la sua capacità di coinvolgere ampi strati delle classi subalterne, alla Riforma protestante e all’Illuminismo, ma capace di conservare e rielaborare “i caratteri di classicità della cultura greca e del Rinascimento italiano”.
E giustamente sottolinea che la riforma intellettuale e morale “non può non essere legata a un programma di riforma economica, anzi, il programma di riforma economica è appunto il modo concreto con cui si presenta ogni riforma intellettuale e morale”.
“Banditore” della riforma intellettuale morale doveva essere per Gramsci, il “moderno Principe”, il partito comunista, che diventa, nella sua visione, non più un’avanguardia volta esclusivamente al lavoro di agitazione e organizzazione in vista della conquista del potere politico, ma un partito educatore e formatore di coscienze, una vera e propria scuola dove gli elementi migliori delle classi subalterne imparano a dirigere il complesso della vita sociale alla luce di ideali di emancipazione.
Il limite dell’idea gramsciana della riforma intellettuale e morale non risiede nella sua concezione del partito politico come educatore e formatore di coscienze, ma nella sua convinzione che il partito della classe operaia debba essere il punto di riferimento del giudizio morale e politico: “Il moderno Principe sviluppandosi sconvolge tutto il sistema dei rapporti intellettuali e morali in quanto il suo svilupparsi significa appunto che ogni atto viene concepito come utile o dannoso, come virtuoso e scellerato, solo in quanto ha come punto di riferimento il moderno principe stesso e serve a incrementare il suo potere o a contrastarlo”.
Il Principe , conclude Gramsci, “prende il posto, nelle coscienze, della divinità o dell’imperativo categorico” (Quaderni del carcere, vol. III, p. 1561). Ma la coscienza personale è e deve rimanere rigorosamente individuale: può accogliere l’imperativo morale o la divinità, ma mai lasciare entrare come sua guida suprema un soggetto collettivo, non importa se è lo Stato, o il partito o una chiesa. Se la coscienza personale accetta la guida o l’autorità di un soggetto collettivo non è più pienamente libera e non può costruire né uno Stato né una società liberi.
In quegli stessi anni, nel confino di Lipari, Carlo Rosselli scriveva su Socialismo liberale: “Non esistono fini della società che non siano, al tempo stesso, fini dell’individuo, in quanto personalità morale; anzi questi fini non hanno vita se non quando siano profondamente vissuti nell’intimo delle coscienze. [...] Uno Stato libero vuole prima e soprattutto uomini liberi. E uno Stato socialista spiriti socialisti. Io non esito a dichiarare che la rivoluzione socialista sarà tale, in ultima analisi, solo in quanto la trasformazione della organizzazione sociale si accompagnerà a una rivoluzione morale, cioè alla conquista, perpetuamente rinnovantesi, di una umanità qualitativamente migliore, più buona, più giusta, più spirituale”. Carlo Rosselli partiva da Giuseppe Mazzini; Gramsci da Karl Marx e da Lenin.
Per arrivare all’idea del socialismo come trasformazione sociale sorretta da una riforma intellettuale e morale capace di realizzare l’elevamento civile delle classi subalterne, aveva percorso una lunga strada grazie alla libertà morale e intellettuale che gli diede la forza di andare contro le idee prevalenti nel suo stesso partito, senza paura di affrontare, anche nelle terribili condizioni del carcere, l’ostilità degli stessi compagni comunisti che lo giudicavano un traditore della causa. La sua è una testimonianza di libertà, per tutti i tempi.
* Sul tema, nel sito, si cfr.:
C’E’ CAPO E "CAPO" E STATO E "STATO": MUSSOLINI E LENIN A CONFRONTO. L’analisi di Gramsci (già contro derive staliniste!), una bussola per non naufragare e una lezione di vita e di libertà
- UNA LEZIONE TEOLOGICO-POLITICA DI BAGET BOZZO SU OGNI PROGETTO DI "RIFONDAZIONE COMUNISTA" FUTURA CHE SI VUOLE COME PARTITO. Avanti o popolo alla riscossa. Il populismo trionferà
ANTONIO GRAMSCI, SULLA "ZATTERA DELLA MEDUSA". Una lettera dal carcere
KANT E GRAMSCI. PER LA CRITICA DELL’IDEOLOGIA DELL’UOMO SUPREMO E DEL SUPERUOMO D’APPENDICE.
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- MEMORIA. E già nel 1942 Guido Calogero smontava Heidegger5 novembre 2018, di Federico La Sala
PENSIERO DELLA COSTITUZIONE E COSTITUZIONE DEL PENSIERO. FILOSOFIA DEL DIALOGO ... *
E già nel 1942 Guido Calogero smontava Heidegger
di Alfonso Berardinelli (Avvenire, venerdì 12 gennaio 2018)
Buone notizie, secondo me, dal numero di “MicroMega” intitolato “Gli intellettuali giudicano la religione”. La sezione su tale tema richiederebbe un resoconto critico per il quale non basterebbero una ventina di pagine. Vi è riportato un questionario del 1950 che l’americana “Partisan review” propose a scrittori, filosofi, critici e studiosi. “MicroMega” pubblica le risposte del grande poeta e saggista Auden (credente) e del filosofo analitico Ayer (non credente): due punti di vista opposti sui quali si potrebbe ragionare a lungo.
Ma quella che in particolare ho considerato subito la buona, ottima notizia è un’altra. È un saggio di Guido Calogero (1904-1986), studioso di storia della logica e della dialettica dai Presocratici al Novecento, filosofo del dialogo come strumento insuperabile del pensiero, teorico e animatore con Aldo Capitini del movimento liberal-socialista e tra i fondatori del Partito d’Azione.
In questo scritto del 1942, Calogero offriva una tempestiva, precoce analisi critica del pensiero e del linguaggio di Martin Heidegger, filosofo vicino al nazismo (mai esplicitamente rinnegato) che ha esercitato un’influenza magnetica su filosofi francesi e italiani di fine Novecento tuttora in attività. Benché Heidegger sia stato notoriamente discusso, criticato, demolito già da Adorno, Löwith e Anders, i nostri heideggeriani, per evitarsi dei fastidi, non hanno mai voluto prendere in considerazione i loro argomenti. Calogero (filosofo a sua volta oggi ciecamente trascurato) in questo scritto di settant’anni fa notava subito il punto debole della filosofia di Heidegger: la sovrapposizione, l’identificazione impropria e arbitraria fra il problema della conoscenza (gnoseologia) e il problema dell’essere (ontologia). Heidegger usa un linguaggio metafisico lì dove dovrebbe usare un linguaggio logico e metodologico.
Dire “essere” e dire “ente”, ripetere queste parole come una giaculatoria o un mantra, non significa dire qualcosa della cui realtà si possa dare conoscenza e discorso, poiché si tratta di una terminologia arcaica ormai priva di contenuto determinato e determinabile, un “modo di dire” generico e vuoto la cui pensabilità è nulla. Provate a pensare l’essere e vedrete che equivale a pensare il nulla, cosa altrettanto impensabile. Il linguaggio di Heidegger è una disonesta parodia verbalistica dell’esperienza mistica. Teologizza la filosofia, evitando il problema della religione.
*
SUL TEMA, NEL SITO E IN RETE, SI CFR.:
PAURA DELLA LIBERTA’... FASCISMO, STORIOGRAFIA, E COSTITUZIONE: "Vi fu chi accondiscese al giuramento, tra questi Guido Calogero e Luigi Einaudi, seguendo l’invito di Benedetto Croce, «per continuare il filo dell’insegnamento secondo l’idea di libertà»".
- POLITICA E LINGUAGGIO. IL SENZA-NOME: LE FIGURE DI NESSUNO. Roberto Esposito riavvia il discorso sulla "Terza Persona" ... e apre la strada a una comprensione antropologica inedita della Prima (e Quarta) "Persona" del "Tetragramma" divino e dello stesso "Logos"
- IL "DUE" DI SAUSSURE VINCE IL "DUE" DI ROBERTO ESPOSITO. Un commento di Remo Bodei sul suo ultimo lavoro
I POLITICI SI SONO FATTI TEOLOGI E LA TEOLOGIA, IN SENSO PROPRIO, NON PARLA PIU’. Una riflessione di Paolo Prodi.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- Europa, Italia, 4 novembre 2018. Un secolo fa la battaglia di Vittorio Veneto e il crollo della Germania. L’«inutile strage» cambiò l’assetto dell’Europa e innescò una crisi che toccò l’apice nel 19294 novembre 2018, di Federico La Sala
Centenario.
La fine di una Grande Guerra che durò ancora a lungo
Un secolo fa la battaglia di Vittorio Veneto e il crollo della Germania. L’«inutile strage» cambiò l’assetto dell’Europa e innescò una crisi che toccò l’apice nel 1929
di Gianpaolo Romanato (Avvenire, sabato 3 novembre 2018)
- [Foto]: Soldati italiani in trincea
Oggi celebriamo il centenario della fine della Prima guerra mondiale cui seguì la Conferenza di pace di Parigi (18 gennaio 1919 - 21 gennaio 1920). Ma un bel libro dello storico tedesco Robert Gerwarth, apparso l’anno scorso da Laterza - La rabbia dei vinti. La guerra dopo la guerra. 1917-1923 - ha ben chiarito che nel novembre del 1918 la guerra non finì affatto. Per altri cinque anni almeno in tutta l’Europa continuarono guerre, rivoluzioni, massacri, di ogni tipo. Dalla Finlandia all’Anatolia, dal Caucaso all’Irlanda, dalla Germania alla Grecia, la violenza continuò a dilagare e a mietere vittime. E siccome in diversi casi (Finlandia, Russia, Bulgaria, Ungheria, Germania) si trattò di guerre civili, la selvaggia ferocia in cui precipitò il continente che fino al 1914 si era attribuito la missione di insegnare al mondo la civiltà - ferocia freddamente raccontata con abbondanza di particolari da Gerwarth nelle sue pagine - ci lascia senza parole. Anche senza contare l’epidemia di spagnola, si può affermare che «le vittime dei conflitti armati dell’Europa in quei cinque anni furono ben più di 4 milioni, più delle perdite subite complessivamente dalla Gran Bretagna, dalla Francia e dagli Stati Uniti durante la Grande guerra».
Insomma, per un decennio (la guerra più il dopoguerra), i popoli europei sono stati i più violenti, i più turbolenti, i più crudeli del pianeta. Ma allora, che pace celebreremo nei prossimi mesi? Che cosa ci racconteremo nei convegni, nelle tavole rotonde, nei libri che riempiranno le biblioteche? Vale la pena di chiedercelo, prima che inizi il festival delle rimembranze. E merita di farlo con l’ausilio di due libri che furono scritti a caldo, a ridosso della Conferenza di Parigi, da due uomini che avevano partecipato alla Conferenza stessa. Due libri preveggenti, controcorrente, che non hanno il sapore della facile e comoda scienza del dopo. Il primo fu pubblicato alla fine del 1919 da John M. Keynes, il celebre economista britannico: Le conseguenze economiche della pace (Adelphi, 2007). Il secondo dal politico italiano Francesco Saverio Nitti alla fine del 1921: L’Europa senza pace (riedizione con prefazione di Giulio Sapelli, goWare, 2014). Entrambi scrissero che il summit parigino - svoltosi mentre il continente era ancora in fiamme - tutto fece tranne che predisporre una pace equa e duratura.
Scrive dunque Nitti - che era stato Ministro del tesoro dopo Caporetto e Presidente del consiglio tra il 1919 e il 1920 - che a Parigi (città la meno adatta a ospitare la conferenza, traboccando di odio antitedesco) si architettò una pace cartaginese volta solo a distruggere la Germania. Grande regista dell’operazione fu Georges Clemanceau, che condusse la Conferenza come se il dopoguerra non fosse altro che una prosecuzione della guerra sotto altre forme, mentre una vera pacificazione esige moderazione, equilibrio, sguardo volto al futuro e non condizionato dal passato. Il presidente americano Wilson, totalmente ignaro dei problemi europei, finì al rimorchio dei francesi e disattese la lettera e lo spirito dei 14 punti che aveva enunciato portando il suo paese in guerra, mentre il presidente italiano Orlando, condizionato dall’unico (e falso) problema di Fiume, fu un irrilevante comprimario. I soli a comprendere che si viaggiava verso il baratro furono gli inglesi, ma senza la sponda italiana, non appoggiati dagli americani, condizionati dall’esigenza di difendere la loro supremazia navale e coloniale, non riuscirono ad arginare la furia dei francesi.
In questo clima avvelenato maturò la punizione dei vinti a opera dei vincitori. Alla Germania furono imposte amputazioni territoriali tanto a est come a ovest (con conseguente perdita dei territori più ricchi di carbone); la totale smilitarizzazione della Renania (che consegnava alla Francia una pistola carica puntata contro la Germania); la cessione come bottino di guerra di gran parte del patrimonio ferroviario e navale, che ne prostrò definitivamente l’economia; un ridimensionamento talmente drastico dell’organizzazione militare da rendere difficile anche il controllo dell’ordine interno; la cessione di tutte le colonie. In pratica veniva lasciata in totale balia della Francia a ovest e di una fragilissima Polonia a est (Nitti fa notare che più di metà della rinata Polonia era abitata da popolazioni non polacche). Analoghe misure furono assunte nei confronti dell’ex Impero austro-ungarico, in particolare nei confronti dell’Ungheria.
In questa revisione territoriale dell’Europa, che ne cambiò radicalmente la fisionomia (bisogna mettere a confronto una carta geografica del 1914 con una del 1920 per rendersene conto), si commisero tre errori capitali. Il primo fu quello di disseminare l’Europa orientale (Polonia, Cecoslovacchia, Romania, Iugoslavia) di minoranze tedesche e magiare destinate a essere un perenne focolaio di disordini. Il secondo consistette nell’attribuire ai paesi nuovi (in particolare ex austro-ungarici) una forza di contenimento che essi (deboli, divisi, improvvisati) non erano in grado di esercitare. In particolare fu premiata la Polonia (con la follia del cosiddetto “corridoio di Danzica”, che le assicurava lo sbocco al mare rompendo contro ogni logica geopolitica la continuità territoriale della Germania) nella falsa illusione che potesse essere un valido divisorio fra due vicini fatalmente troppo più forti di lei, la Germania e la Russia.
Non essendo stato poi affrontato il problema della Russia, in quel momento travolta dalla rivoluzione, non ci si accorse di creare nell’est europeo quel ventre molle del continente che è rimasto una questione irrisolta fino a oggi. Il terzo errore fu la creazione dell’Austria, ridotta al solo territorio tedesco dell’ex Impero asburgico, ma con una clausola che le impediva di unirsi alla Germania. Un’altra mina vagante, che il primo demagogo avrebbe potuto far esplodere.
La conclusione di Nitti è in questo suo giudizio quasi scultoreo: «Tutta la storia dei popoli di Europa non è che un’alterna vicenda di vittorie e di sconfitte. La civiltà consiste nel determinare quelle condizioni che rendono la vittoria meno brutale e la sconfitta più tollerabile. I recenti trattati che regolano o dovrebbero regolare i rapporti fra i popoli rappresentano uno spaventevole regresso, la negazione di quelli che erano i principi acquisiti del diritto pubblico». E infatti, come oggi ben sappiamo, ressero, e anche malamente, solo vent’anni.
Il libro di Keynes, che aveva fatto parte della delegazione britannica a Parigi, dalla quale si era dimesso il 7 giugno del 1919, uscì prima di quello di Nitti, alla fine del 1919. Da economista, egli affronta soprattutto la questione dei debiti e delle riparazioni imposte dai vincitori, scrivendo che si stava pretendendo l’impossibile dai vinti e che la distruzione economica della Germania, ovvero del cuore pulsante del continente, del territorio più ricco e produttivo, attraverso il quale transitano obbligatoriamente uomini, merci, alimenti e rifornimenti di ogni paese, sarebbe ricaduta addosso a tutti, precipitando l’Europa e il mondo intero in una crisi senza precedenti.
A Parigi si aveva una «sensazione di incubo», scrive in una delle pagine più forti del libro, osservando la «leggerezza, la cecità, l’arroganza» con cui, tra «vuoti e aridi intrighi», i cosiddetti Grandi trattavano le sorti dei popoli, mentre «quasi ad ogni ora arrivavano notizie della miseria, disordine e disgregazione di tutta l’Europa centrale e orientale», dello «sfinimento» di mezzo continente dove si tornava a morire per mancanza di alimenti come all’epoca della Guerra dei Trent’anni. «È straordinario - aggiunge, ripensando ai mesi in cui prese parte ai lavori parigini - come il fondamentale problema di un’Europa che languiva di fame e si sgretolava davanti ai loro occhi sia la sola questione sulla quale fu impossibile suscitare l’interesse dei Quattro». Accecati dall’odio, preoccupati solo di aumentare il bottino a proprio favore, non videro che nell’intero continente, anche nel campo dei vincitori, «la terra tremava» e stavano iniziando «le paurose convulsioni di una civiltà morente», che avrebbe travolto i vincitori non meno dei vinti. «Chiedendo l’impossibile - aggiunse - alla fine perderanno tutto».
Che fare allora? La proposta di Keynes si può riassumere citando questa sua pagina: «La guerra è terminata con tutti che devono a tutti enormi somme di denaro. La Germania deve un’enormità agli Alleati; gli Alleati devono un’enormità alla Gran Bretagna; la Gran Bretagna deve un’enormità agli Stati Uniti. In ogni paese lo Stato deve un’enormità ai possessori di cartelle del prestito di guerra; e questi e altri contribuenti devono un’enormità allo Stato. L’intera situazione è artificiosa, fuorviante vessatoria al massimo grado. Non riusciremo più a fare un passo se non districhiamo le gambe da questi ceppi cartacei. Un falò generale è una necessità così impellente, che se non vi provvediamo in modo ordinato e benigno, senza fare grave ingiustizia a nessuno, il falò, quando infine avrà luogo, diventerà un incendio che può distruggere molte altre cose insieme».
Dunque: revisione del Trattato di Versailles e condono generale di debiti e crediti. Non si fece né l’una né l’altra cosa. Quando Keynes scriveva il suo libro, Hitler era solo uno degli innumerevoli disperati che vagabondavano per le vie di Monaco. Se si fosse data retta all’economista inglese, a Nitti, ai molti che condividevano le loro idee, sarebbe probabilmente rimasto tale.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
EUROPA. LA PREMESSA DELLA CATASTROFE: IL TRATTATO DI VERSAILLES. L’atto di accusa (1919) di John M. Keynes. Una nota di Dario Antiseri
- MEMORIA DI FRANCESCO D’ASSISI. "VA’, RIPARA LA MIA CASA"!!! Benedetto XVI ha ricordato la conversione di Francesco: «l’ex play boy convertito dalla voce di Dio»... ma ha "dimenticato" la denuncia sul "ritardo dei lavori", fatta da Pirandello già a Benedetto XV. Che disastro!!!
RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". Per la rinascita dell’EUROPA, e dell’ITALIA. La buona-esortazione del BRASILE. Una "memoria"
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- MEMORIA. Il 25° congresso mondiale di filosofia si svolgerà a Melbourne nell’estate del 2023.1 novembre 2018
Il 24°Congresso Mondiale
Ottomila filosofi a Pechino nel segno del dialogo
di Riccardo Pozzo (Il Sole-24 Ore, Domenica, 23.09.2018)
I 24 congressi mondiali di filosofia che si sono succeduti dal 1900 a oggi hanno in comune di esser stati eventi culturali di primordine. Al 1° (Parigi 1900) Bertrand Russell conosceva Giuseppe Peano che gli consigliava di leggere Gottlob Frege, al 3° (Bologna 1906) Federigo Enriques presentava al mondo il positivismo prima del neopositivismo, il 4° (Heidelberg 1911) affrontava il problema del valore, con Benedetto Croce valido aiuto di Wilhelm Windelband, e il 9° (Parigi 1937) fu il celebre Congrès Descartes, che tanto segnò la storia filosofica del ventesimo secolo. Due altri congressi in Italia: il 5° (Napoli 1924) e il 12° (Venezia 1958), organizzati rispettivamente da Giovanni Gentile e Carlo Giacon. Tra i più recenti, il 19° (Mosca 1993), organizzato da Evandro Agazzi in una città nella quale giravano i carri armati durante la presa di potere di Boris Eltsin; il 20° (Boston 1998), il primo a superare la soglia di tremila partecipanti; il 21° (Istanbul 2003), il primo in Asia; il 22° (Seoul 2008), il primo in Estremo Oriente; mentre il 23° (Atene 2013), anch’esso con più di tremila partecipanti, portava i filosofi di tutto il mondo a calpestare, letteralmente, i siti dell’Accademia, del Liceo e del Giardino.
Il 24° (Pechino 2018), tenutosi dal 13 al 20 agosto nella splendida cornice del parco delle Olimpiadi del 2008, si distingue per almeno tre motivi. Il primo, sono gli ottomila iscritti, che lo qualificano, appunto, come la più partecipata riunione di filosofi della storia. Il secondo, l’essersi svolto per la prima volta nella Cina della ricerca e dell’innovazione. Il terzo, infine, l’aver avviato il cambio di paradigma dal dialogo tra culture alla cultura nata dialogica. «Oggi abbiamo una civiltà dialogica», ha solennemente dichiarato Tu Weiming nella magnifica Wang Yangming Lecture .
Learning to be human: questo il tema del congresso. L’essere umano non è statico, è un divenire di processi creativi. Lo sguardo dell’altro ha precedenza sullo sguardo di sé, perché se non riconosciamo la presenza dell’altro non riconosciamo nemmeno la nostra, ha spiegato Tu Weiming.
Per le conferenze plenarie, il 24° congresso ha compiuto il passo irreversibile di sostituire le definizioni disciplinari aristotelico-scolastiche con nuove forme più inclusive radicate nelle tradizioni dell’umanesimo.
Il congresso mondiale è soprattutto un esercizio di apertura alla complessità filosofica, religiosa, culturale del mondo contemporaneo. Ci si sorprende allora a costatare come i filosofi cinesi, pur presenti in massa, siano stati tuttavia minoranza di fronte alle migliaia e centinaia di studiosi europei, nordamericani e sudamericani, russi e indiani, alle decine di filippini, sudafricani, coreani, thailandesi, giapponesi, nigeriani, kazaki, e soprattutto a esponenti di comunità filosofiche cui non siamo ancora abituati a pensare come protagonisti del campus globale in cui avviene l’elaborazione del pensiero contemporaneo.
Tra i più apprezzati interventi vanno segnalati quelli delle americane Judith Butler e Sally Haslanger, dell’australiano Peter Singer, della francese Anne Cheng, della thailandese Supakwadee Amatayakul, del sudafricano Mogobe Ramose, del russo Andrey Smirnov, del tedesco Julian Nida-Rümelin e del nostro Maurizio Ferraris. In una miriade di simposi, tavole rotonde, sessioni di ogni genere, le innovazioni legate all’intelligenza artificiale, la frammentazione del sapere e l’accesso ai dati, per fare solo degli esempi, hanno portato a serie riflessioni su temi quali coscienza, marginalità, solidarietà, responsabilità, creatività, benessere, espressività nel confronto tra tradizioni filosofiche e culturali diverse.
 Così abbiamo visto i primi passi di quella cultura dialogica destinata a nutrire spiritualmente il ventunesimo secolo e che Platone nel Timeo (23c) aveva già immaginato come circolarità di traslazioni e traduzioni di scritture e testi.
Così abbiamo visto i primi passi di quella cultura dialogica destinata a nutrire spiritualmente il ventunesimo secolo e che Platone nel Timeo (23c) aveva già immaginato come circolarità di traslazioni e traduzioni di scritture e testi.Il 25° congresso mondiale di filosofia si svolgerà a Melbourne nell’estate del 2023. È questa la decisione della Fédération Internationale des Sociétés de Philosophie, alla quale fa capo l’organizzazione dei congressi mondiali, presieduta durante il congresso da Dermot Moran. A Pechino è stato rinnovato il direttivo della Federazione, ora presieduta da Luca Maria Scarantino, mentre Suwanna Satha-Anand è stata nominata segretario generale.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- (MEMORIA E) FUTURO: WORLD PHILOSOPHY CONGRESS. “Filosofia oltre i Confini”: ”Call for paper” per il Congresso Mondiale di Filosofia 2024, a Roma (dall’1 all’8 agosto 2024).18 febbraio 2023, di Federico La Sala
AICI
Associazione delle istituzioni di cultura italiane
- Società Filosofica Italiana - Call for paper Congresso mondiale di Filosofia
Sotto la responsabilità congiunta di SFI (Società Filosofica Italiana) Fisp (International Federation of Philosophical Societies) e Università La Sapienza, il Congresso Mondiale di Filosofia 2024 “Filosofia oltre i Confini” intende stimolare la riflessione scientifica e pubblica sul futuro delle nostre società.
La XXV edizione del World Philosophy Congress si svolgerà a Roma, dall’1 all’8 agosto 2024, ed è stata da poco indetta la “”Call for paper”” per la submission di contributi aderenti al tema del Congresso e relativi a una delle 89 sezioni tematiche predisposte. Gli articoli, corredati da abstract e parole chiave, possono essere scritti in una delle lingue ufficiali del Congresso (Chinese, English, French, Germany, Italian, Russian, Spanish) e non devono superare i limiti di parole indicati nelle Guidelines.
La submission avviene tramite il sito del Congresso (https://wcprome2024.com/paper/) e la scadenza è il 23 novembre 2023. Il Congresso rappresenta un’opportunità unica per presentare e condividere diverse prospettive filosofiche e per incorporare la riflessione teorica nella realtà attuale del nostro tempo, affrontando le sue principali preoccupazioni etiche, sociali, politiche, religiose e spirituali.
-
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- MEMORIA. In una lettera al fratello citata da Lotman, Cechov elenca le virtù che dovrebbe possedere un “uomo educato”, un intellettuale. La principale? «Temere la menzogna come si teme il fuoco» (Marco Dotti)..31 ottobre 2018, di Federico La Sala
Lotman, la memoria come cultura
di Marco Dotti (Alfabeta-2, 16 novembre 2017) *
«Aspiravamo a seminare il sensato, il buono, l’eterno». Jurij M. Lotman concludeva così le pagine autobiografiche delle sue non-memorie (Ne-memuary, Non-memorie, a cura di Silvia Rubini e Alessandro Nievo, Interlinea 2001). Pagine in parte dettate, in altra registrate su un dittafono. Negli stessi anni, a cavallo fra gli Ottanta e Novanta, il semiologo registra - questa volta in video - una serie televisiva dal titolo Besedy o russkoj kul’ture, trasmessa sui canali televisivi estone e russo. Un lavoro importante, che mette in atto le sue altrimenti complesse e suggestive ricognizioni sul tema della cultura come testo e della memoria come condivisione.
Solo nel 1995, due anni dopo la morte di Lotman, la rivista “Tallinn” prese a pubblicare la trascrizione delle “lezioni televisive” del fondatore della Scuola di Tartu.
Benché fosse in scena da solo, osserva Silvia Burini nella premessa all’importante edizione italiana pubblicata da Bompiani, per l’attenta traduzione di Valentina Parisi, Lotman scelse il termine “conversazioni” rimarcando quella struttura dialogica che sempre aveva considerato fondamentale per il “funzionamento” dei sistemi culturali.
Il passaggio dall’orale e dal visivo - Lotman dialogava con il pubblico spesso ricorrendo a immagini - alla forma scritta impone un inevitabile passaggio dalla conversazione alla forma-lezione. Il ricchissimo materiale che il lettore italiano ha ora a disposizione ha assunto, appunto, questa forma. Ma è un forma dialogante, che in ogni suo punto ci ricorda come quelle conversazioni fossero inizialmente pensate per un pubblico non di nicchia; operaie e operai, in primo luogo. Fondamentali, nel discorso di Lotman, sono i concetti di memoria, trasmissione, semiosfera. E, soprattutto, quello di testo. Testo, per Lotman, è ogni manifestazione della cultura. Vi rientrano le mode, le immagini, i costumi, i giochi e il byt termine russo che definisce l’esperienza di vita vissuta nel quotidiano. Se la cultura è condizione sine qua non per l’esistenza di qualsiasi consesso umano, che cosa dobbiamo intendere per “cultura”?
Cultura è un insieme di informazioni non genetiche, memoria non ereditaria dell’umanità. La cultura, spiega Lotman nella prima lezione raccolta nel volume, «è memoria». Memoria attiva che dà forma, sia a livello del singolo, sia in una società, a quanto chiamiamo “cultura”.
La memoria assume così un ruolo determinante, attivo, dinamico, non meramente documentale: la distruzione della cultura passa dalla distruzione della memoria e la distruzione della memoria si attua attraverso l’annichilimento dei testi che la compongono e l’isolamento dei soggetti capaci di pensare - e organizzare - la trasmissione. La morte di un intellettuale al quale sia impedito di trasmettere è paragonata da Lotman alla distruzione della Biblioteca di Alessandria. Il fuoco distrugge, ma ancor più pericoloso del fuoco è il fumo che può saturare l’universo/ambiente culturale che avvolge l’uomo, ambiente dove le singole culture si relazionano, ibridandosi e favorendo la reciproca evoluzione.
Un’evoluzione che non è mero «progresso tecnico-scientifico», ma “ecologia” della società umana. Cultura, spiega ancora Lotman, in pagine densissime e di straordinaria chiarezza, è «quell’atmosfera che l’umanità crea attorno a sé per continuare a esistere, ovvero per sopravvivere. In questo senso, la cultura è una nozione spirituale» e, al tempo stesso, una tensione etica - fra sé e il mondo - ineludibile per l’intellettuale.
Racconta Lotman che un giorno Tolstoj, giovane ufficiale di artiglieria reduce da Sebastopoli, arrivò a Pietroburgo nella redazione del “Contemporaneo”. Tolstoj irruppe nel corso di una disputa molto accesa fra liberali e democratici, ma non riuscì a capire le ragioni del contendere. Chiese allora lumi a Nekrasov, che gli rispose: le convinzioni! Discutiamo per le nostre convinzioni! Ma quali convinzioni, ribatté Tolstoj, queste sono solo parole: «le convinzioni sono quando uno sta in guardia impugnando un pugnale». Intendeva dire, Tolstoj, che non ogni parola è un’idea, non ogni idea - per quanto “bella”, “buona” e levigata - è una convinzione. Talvolta è un alibi.
Di contro, proprio la capacità di non darsi alibi, unendo vita e pensiero, osserva Lotman, è la caratteristica di ogni individuo pensante. La cultura sopravvive solo grazie a una mite intransigenza. «Parlare non costa nulla, fondere vita e pensiero invece è difficile perché la realtà impone spesso di sacrificare le proprie idee». L’intelligenza, d’altronde, è prima di tutto una qualità morale e in una lettera al fratello citata da Lotman, Cechov elenca le virtù che dovrebbe possedere un “uomo educato”, un intellettuale. La principale? «Temere la menzogna come si teme il fuoco».
*
Jurij Michajlovič Lotman
Conversazioni sulla cultura russa
a cura di Silvia Burini
traduzione di Valentina Parisi
Bompiani 2017
pp. 440, euro 20
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- «La farfalla e la crisalide»: un libro "necessario ai filosofi, per considerare i limiti della propria attività e i modi per ripensarla" (di Stefano Gattei).26 ottobre 2018, di Federico La Sala
Conoscenza.
Il saggio di Edoardo Boncinelli
E la scienza divenne sperimentale
L’approccio soltanto speculativo ha grossi limiti che molti filosofi non riconoscono
La ricostruzione dello scienziato nel saggio «La farfalla e la crisalide» (Raffaello Cortina)
di Stefano Gattei (Corriere della Sera, 26.10.2018)
Che cos’è la scienza? E che cosa la distingue dalle altre discipline? La domanda ha impegnato i filosofi per secoli. Se la pone ora, nel libro La farfalla e la crisalide (Raffaello Cortina), un grande scienziato, Edoardo Boncinelli, autore di importanti scoperte in campo genetico.
Il saggio ripercorre per importanti snodi concettuali la storia della scienza, dalla sua nascita nella Grecia di 2.500 anni fa, quando l’indagine della realtà era ancora difficilmente distinguibile dalla riflessione filosofica, al presente, nel quale scienza e filosofia appaiono del tutto separate, incommensurabili per capacità di analisi e significatività dei risultati. La farfalla - questa la metafora scelta dall’autore - è la scienza così come la conosciamo oggi: nasce dalla crisalide della filosofia, un intreccio di modi di pensare spesso in competizione fra loro, ma capaci di influenzare profondamente la nostra vita. Poco più di quattro secoli fa, la scienza si svincola dal ruolo ancillare nei confronti della filosofia, sviluppandosi autonomamente e ramificandosi gradualmente in una serie di discipline che, dalla fisica alla biologia all’intelligenza artificiale, hanno sostituito la filosofia come strumento di conoscenza del mondo. Con Galileo, tra scienza e filosofia si apre un baratro che oggi forse non vale neppure la pena di provare a colmare.
All’inizio, con i Presocratici, la filosofia avanza ipotesi sul mondo. Nasce libera, svincolata da ogni verità rivelata. La messa a morte di Socrate, «corruttore» dei giovani ateniesi con la critica implacabile della religiosità che la società si attende da loro, inaugura paradossalmente la grande stagione del pensiero greco. Consapevole dell’importanza della tecnica, la riflessione classica accompagna l’osservazione del mondo (culminata nei trattati naturalistici di Aristotele) all’indagine ipotetico-deduttiva, che si sviluppa senza bisogno di conferme sperimentali. Gli enormi successi della geometria euclidea e dell’astronomia matematica convincono però i filosofi che la verità sia raggiungibile per via puramente speculativa. Così, pur rimanendo sostanzialmente indistinguibili, scienza e filosofia iniziano a perdere contatto. Un ruolo non secondario nella separazione è svolto da Platone, sostenitore di una teoria della conoscenza «innatista» dall’indiscutibile sapore biologico, che Boncinelli apprezza, ma che inchioda l’uomo alla sterile fissità di un mondo delle idee sempre uguale a sé stesso. Se però Platone non poteva conoscere l’evoluzione, non così i molti filosofi che oggi a lui direttamente si rifanno, e che ignorano l’impatto rivoluzionario del cambiamento che si impone di continuo in biologia.
Una discussione serrata e tranchant, che non risparmia neppure Cartesio, porta il lettore al Seicento, quando dalla crisalide della filosofia occidentale si libera finalmente la farfalla della scienza sperimentale. Se, fino ad allora, scienziati e filosofi si erano limitati a porsi domande e a tentare di dare risposte attraverso l’osservazione, con la possibilità e l’opportunità di condurre esperimenti, lo scienziato «costringe» la natura a rispondere a domande specifiche. Mentre l’osservazione si limita a registrare ciò che accade, lo sperimentatore svolge un ruolo attivo, preparando le condizioni per portare la natura stessa su un terreno a noi favorevole. L’adozione del metodo sperimentale, spesso accompagnato da un’analisi quantitativa, è per Boncinelli un rivoluzionario atto di umiltà: segna il riconoscimento che per certi problemi l’approccio speculativo non è sufficiente - riconoscimento, questo, che l’autore non manca di contestare come estraneo a molti filosofi di ieri e di oggi.
Con l’Accademia del Cimento e il suo motto, «provando e riprovando», inizia la stagione della grande scienza, che giunge fino a noi. Ma non si chiude la stagione della filosofia, che pure arriva fino a noi, ignorando però (o fingendo di ignorare) l’abisso che la separa dalla scienza. Né, forse, può essere altrimenti: la crisalide è fondamentale per la nascita della farfalla, ma appena questa nasce le due strutture biologiche si devono separare una volta per tutte, perché la presenza della crisalide si rivelerebbe ora tossica per l’insetto alato. Fuor di metafora, la filosofia è stata fondamentale per la nascita del pensiero scientifico, ma col passare del tempo ha avuto un’influenza sempre più negativa, come una sorta di a priori indiscusso che ha finito per ostacolare il progresso scientifico.
L’analisi di Boncinelli è spietata. E senza dubbio corretta, anche se a volte scivola in qualche semplificazione eccessiva. Ma questo nulla toglie alla tesi generale di La farfalla e la crisalide, che interroga e sfida gli studiosi: un libro utile agli scienziati, che dalla riflessione dell’autore possono trarre spunti per meditare sul significato e sulla portata della propria disciplina, e necessario ai filosofi, per considerare i limiti della propria attività e i modi per ripensarla.
SUL TEMA, IN RETE, SI CFR.:
IL “CIMENTO” DELL’ACCADEMIA GALILEIANA E LA “PIETRA” DEI FILOSOFI: “PROVANDO E RIPROVANDO”!
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- Il «Fronte» delle filosofe per dire no ai populismi. Donatella Di Cesare e Francesca Rigotti hanno lanciato l’iniziativa. Numerose e qualificate le adesioni.25 ottobre 2018, di Federico La Sala
Il «Fronte» delle filosofe per dire no ai populismi
Le donne «molla del cambiamento», la sensibilità femminile come motore capace di aggregare un’opposizione vasta alle «nuove forme di populismo, razzismo e fascismo». Sono questi i concetti chiave della dichiarazione con cui Donatella Di Cesare e Francesca Rigotti hanno lanciato l’iniziativa, del tutto inedita in Italia, di un Fronte delle filosofe che intendono «prendere partito» ed esporsi nel dibattito pubblico, non «per creare consenso ma per invitare a riflettere».
Numerose e qualificate le adesioni raccolte finora dalle due promotrici: Laura Bazzicalupo, Laura Boella, Caterina Botti, Annarosa Buttarelli, Adriana Cavarero, Simona Forti, Olivia Guaraldo, Enrica Lisciani Petrini, Michela Marzano, Francesca Nodari, Elena Pulcini, Caterina Resta, Elettra Stimilli, Nadia Urbinati, Nicla Vassallo.
* Corriere della sera, 25.10.2018
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- "La filologia al servizio delle nazioni". In memoria di "Lorenzo Valla e Baruch Spinoza, Ernest Renan e Ulrich Wilamowitz-Möllendorff, Gaston Paris e Paul Meyer, Eduard Koschwitz e Joseph Bédier, Ernst Robert Curtius e Erich Auerbach, Cesare Segre e Edward Said" (Stefano Rapisarda)..25 ottobre 2018, di Federico La Sala
La filologia al servizio delle nazioni. Storia, crisi e prospettive della filologia romanza
di Stefano Rapisarda *
«Se un giorno la filologia morisse, la critica morirebbe con lei, la barbarie rinascerebbe, la credulità sarebbe di nuovo padrona del mondo». Così Ernest Renan ne "L’avenir de la science" (1890) tesseva un altissimo elogio della filologia, una delle scienze regine del XIX secolo.
Oggi, al tempo delle fake news e della post-verità, quelle parole ci ricordano che la filologia può essere ancora argine alla barbarie. E ci ricordano che la filologia, quella con aggettivi e quella senza, è intrinsecamente politica. Non è utile o interessante in sé: lo è quando è schierata, militante, "calda", quando tocca interessi, quando serve interessi. Quando è "al servizio" di un Principe o di un partito o di uno Stato o di una visione del mondo.
Ci ricordano insomma che la filologia è anche politica, come sapevano Lorenzo Valla e Baruch Spinoza, Ernest Renan e Ulrich Wilamowitz-Möllendorff, Gaston Paris e Paul Meyer, Eduard Koschwitz e Joseph Bédier, Ernst Robert Curtius e Erich Auerbach, Cesare Segre e Edward Said.
Eppure la filologia, con o senza aggettivi, oggi sa di polvere e di noia. Ciò sollecita varie domande: perché questa antica "scienza del testo" si è ridotta al margine della cultura di oggi? Può tornare al centro dei bisogni intellettuali dell’uomo contemporaneo? Quale tipo di filologia può ancora servire il mondo e servire al mondo?
*
SCHEDA - Academia.Edu
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- Intellettuali, una figura in disuso? Un saggio del filosofo Aldo Rovatti chiede che torni allo scoperto per ridare spazio allo spirito critico.23 ottobre 2018, di Federico La Sala
Dibattito.
Intellettuali, una figura in disuso?
Che fine ha fatto questa categoria che ha segnato la vita culturale del secolo scorso? Un saggio del filosofo Aldo Rovatti chiede che torni allo scoperto per ridare spazio allo spirito critico
di Roberto Righetto (Avvenire, martedì 23 ottobre 2018)
In Italia gli intellettuali sembrano ammutoliti. Se si esclude un importante appello in difesa della scuola, dell’università e della ricerca, firmato fra gli altri da Massimo Cacciari e Sergio Givone, prevale un clima di rassegnazione. Ma in tutta Europa non sembrano cavarsela molto bene: in Ungheria la voce altisonante dell’anziana filosofa Agnes Heller, che tuona a difesa della libertà di espressione seriamente minacciata dal governo di Orban, è una voce nel deserto. La fine delle ideologie massificanti e l’avvento dell’informatica parevano schiudere le porte a un’era in cui la creatività potesse esplodere in tutte le sue forme, dalla letteratura all’arte alla scienza alla religione.
Dobbiamo forse ricrederci? Nichilismo in primo luogo, ma anche narcisismo e stupidità vanno per la maggiore. E, riferendosi al compito degli intellettuali, il conformismo e la rassegnazione. In tal modo si capovolge la lezione di Emmanuel Mounier, il quale sosteneva che ogni discorso riguardante l’intellettuale non possa prescindere da due condizioni: l’impegno verso la società nel denunciare il male (o i mali) del mondo e l’ancoraggio alla trascendenza, o almeno a un’autotrascendenza, cioè al senso del limite del desiderio di onnipotenza dell’uomo.
 Che il termine dia fastidio o sia quasi estinto (e dopo i compromessi col potere cui abbiamo assistito nel ’900, i tanti “tradimenti dei chierici” forse non è del tutto un male che si sia giunti a una perdita d’aureola), purtuttavia sentiamo la mancanza di figure pubbliche portatrici di un pensiero critico, capaci di scalfire e porre in discussione il sistema di potere. Salutiamo perciò positivamente l’uscita in libreria di un piccolo saggio di Pier Aldo Rovatti, L’intellettuale riluttante (elèuthera, pagine 174, euro 15,00).
Che il termine dia fastidio o sia quasi estinto (e dopo i compromessi col potere cui abbiamo assistito nel ’900, i tanti “tradimenti dei chierici” forse non è del tutto un male che si sia giunti a una perdita d’aureola), purtuttavia sentiamo la mancanza di figure pubbliche portatrici di un pensiero critico, capaci di scalfire e porre in discussione il sistema di potere. Salutiamo perciò positivamente l’uscita in libreria di un piccolo saggio di Pier Aldo Rovatti, L’intellettuale riluttante (elèuthera, pagine 174, euro 15,00).Ma cosa intende Rovatti? «Una figura di intellettuale che si colloca all’interno dei dispositivi di potere e vi svolga un lavoro ai fianchi denunciando le chiusure senza mai gettare la spugna». L’intellettuale riluttante è chi non cede alla tentazione del congedo e al senso di frustrazione e sceglie di resistere alle sirene del neocapitalismo e all’ondata di antiumanesimo. Decide cioè di «opporsi, dire di no, “riluttare” anche al suo stesso ruolo e alle sue eventuali competenze privilegiate ». Se è scomparso l’intellettuale universale che pretendeva di parlare a nome di tutti, o l’intellettuale organico di gramsciana memoria, il fautore del pensiero critico non può limitarsi a svolgere la funzione del tecnico o del politico del sapere. Deve affilare le armi ed esprimere una “contro-cultura”, spezzando il clima di postverità e invocando nuovi spazi per la riflessione e la meditazione in un tempo che pare averle abolite.
Il libro di Rovatti raccoglie una serie di interventi che spaziano dalla scuola alla politica e sorprendono per lo sguardo spesso spiazzante. Giustamente indugia sulla politica ridotta ormai a propaganda: «Dovremmo sempre tentare - si legge in un passaggio - di smascherare quel fondo ideologico che alligna in ogni slogan, anche in quelli all’apparenza più innocenti. L’ideologia non è morta assieme ai grandi sistemi di idee (le “grandi narrazioni”, le chiamavamo), ma sopravvive in ogni discorsività politica, anche la più democratica, quando, come accade, essa deve piegarsi agli imperativi di una comunicazione globale».
E sulla scuola l’autore reclama con forza che essa non rinunci a essere il luogo primo della formazione di una coscienza critica, «restando una scuola delle humanities e attrezzandosi per produrre e diffondere tutte quelle domande di senso di cui oggi abbiamo bisogno». Per questo non ritiene affatto che la cura ai mali della scuola italiana sia quella di darle una direzione unificante dall’alto ma consista piuttosto nella valorizzazione «del “popolo” degli insegnanti, che già sembra possedere le potenzialità per promuovere una cittadinanza attiva negli studenti». Sul tema dei migranti emerge il rifiuto della logica del capro espiatorio oggi dominante e si ricorda non a caso l’opera di René Girard, che evidenzia lo scarto portato dal cristianesimo rispetto alle civiltà antiche: l’aver introdotto la pietà, il rispetto delle vittime, il superamento della barbarie.
Stiamo tornando indietro? A riprova del suo anticonformismo, di Rovatti, noto per aver dato vita negli anni Ottanta assieme a Gianni Vattimo al “pensiero debole”, un filone della filosofia contemporanea che voleva ridimensionare le pretese metafisiche e totalizzanti del pensiero (e che ricevette numerose critiche da parte della cultura cattolica, ma anche il plauso di molti come Dario Antiseri), va ricordata nel ’99 l’apertura positiva verso l’enciclica di Giovanni Paolo II Fides et ratio.
Sulla rivista “aut aut” scrisse infatti un articolo in cui rilevava come «il millennio che sta per aprirsi non potrà risolvere e nemmeno affrontare i suoi problemi cruciali con il fondamentalismo della ragione» e individuava nella questione dell’alterità e non solo della tecnica un tema forte per il pensiero. Poi aggiungeva: «Nessuna idea o immagine della verità può chiamarsi fuori dall’esperienza del credere, e se si illude di farlo diventano subito manifesti gli effetti autoritari della verità stessa». -Dando atto a Wojtyla di aver aperto un dialogo sincero col mondo intellettuale, invitava infine credenti e non credenti al confronto: «L’idea di diritti umani è insieme decisiva e fragilissima. Il cosmopolitismo è un fantasma. La globalizzazione appare alla filosofia più una gabbia che un valore di civiltà. Cosa aspettano le ragioni e le fedi a mettersi al lavoro?». Forse che non ne abbiamo bisogno anche oggi?
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- "Sulla vocazione politica della filosofia" (D. Di Cesare). Un forte richiamo alla funzione pubblica del pensiero critico.22 ottobre 2018, di Federico La Sala
PLATONE E NOI, OGGI. PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!.... *
Nel buio della «notte politica» la sfida di una filosofia militante
Esce giovedì il nuovo saggio di Donatella Di Cesare (Bollati Boringhieri)
Un forte richiamo alla funzione pubblica del pensiero critico
di Luciano Canfora (Corriere della Sera, 22.10.2018)
- Il saggio di Donatella Di Cesare, Sulla vocazione politica della filosofia, sarà in libreria il 25 ottobre per Bollati Boringhieri (pp. 180, e. 19).
Un giovane filologo italiano, Max Bergamo, si accinge a pubblicare gli appunti che, alle lezioni di greco di Friedrich Nietzsche professore a Basilea, prese, e conservò, nel semestre invernale 1871-1872, un allievo d’eccezione, Jacob Wackernagel, destinato a diventare uno dei maggiori storici delle lingue classiche. Il corso di quel semestre verteva su Platone. Abbiamo dunque sia gli appunti dell’allievo, sia il molto ricco dossier preparatorio del maestro (ne è imminente la traduzione presso Adelphi), che ormai si integrano a vicenda e si completano.
Scrive Nietzsche: «Non è lecito considerare Platone come un sistematico in vita umbratica, ma come un agitatore politico che vuole scardinare il mondo intero e che è, a questo scopo, tra le altre cose anche scrittore (...) Egli scrive per fortificare nella lotta (bestärken im Kampfe) i suoi compagni dell’Accademia (da lui fondata)». L’allievo annotò le parole del maestro così: «L’Accademia non è per lui che un mezzo. Indirettamente scrittore. (A noi invece appare in primo luogo scrittore). Un politico che vuole scardinare il mondo intero». Notare che «scardinare» appare in entrambi (aus den Angeln heben). Dunque Nietzsche disse proprio così: «Scardinare il mondo intero».
Al centro della lotta per cambiare il mondo c’è Platone.
Ed è questo uno dei centri motori - insieme ai «casi» Marx e Heidegger - del nuovo saggio di Donatella Di Cesare Sulla vocazione politica della filosofia (Bollati Boringhieri). Scrive Donatella Di Cesare nel capitolo da cui prende avvio il suo saggio: «Guardiano della città, già prima di Platone e della sua politeia, Eraclito denuncia la notte politica». L’immagine della «notte» viene da un paio di frammenti dell’opera perduta di Eraclito, che paragonano la cecità impolitica dei suoi concittadini (di Efeso, metropoli greca sulla costa asiatica) al torpore del sonno.
A significare che la vocazione politica è inerente al filosofare, e ne costituisce l’avvio o anche la premessa, la Di Cesare parte da ben prima di Platone e segue quel filo fino al nostro presente. L’autrice potrebbe, credo, riconoscersi nelle parole con cui Togliatti tratteggiò il cammino di Gramsci: «Nella politica è contenuta tutta la filosofia reale di ognuno, nella politica sta la sostanza della storia, e per il singolo, che è giunto alla coscienza critica della realtà e del compito che gli spetta nella lotta per trasformarla, sta anche la sostanza della sua vita morale» (Convegno Gramsci, Roma, gennaio 1958).
Ma il filo conduttore è: «scardinare» l’esistente (Platone secondo Nietzsche) ovvero «trasformarlo», secondo la insopprimibile «tesi su Feuerbach» di Marx ventisettenne (1845). Il libro della Di Cesare è una battaglia in favore di questa concezione della filosofia, in antitesi rispetto a tutti i benpensanti (da Aristotele alla Arendt) secondo cui la politicità totale del filosofare sarebbe «passo falso» o «tentazione di intervenire».
Per Aristotele (nel secondo libro della Politica) le fondamenta e i presupposti della Kallipolis (città verso cui tendere) di Platone - superamento della proprietà, della famiglia etc. - sono devianze teoretiche e (forse anche) cadute immorali. La Arendt si riferisce a Heidegger. È chiaro che l’impegno a fianco del nazionalsocialismo fu un pauroso andare fuori strada, ma non lo fu il fatto stesso dell’impegnarsi. E questo vale anche per Gentile. Nel concreto dell’esistenza si sta «o con Lutero o con il Papa».
Il caso Heidegger e il suo gigantesco abbaglio sono ben noti alla Di Cesare: soprattutto, vien da dire, a lei, che ne ha attraversato il pensiero come - diceva l’ex coraggioso poeta Orazio all’amico Asinio Pollione - in una traversata «sui carboni ardenti».
Anche Platone, precoce, si era coinvolto nel governo più demonizzato che Atene abbia mai visto nella sua drammatica storia: quello dei Trenta cosiddetti «tiranni», capeggiati da Crizia, socratico e allucinato riformatore, di cui Platone era nipote. E Platone non lo nasconde affatto, al principio della lettera settima (che già per questa «confessione» sofferta e moralmente elevata, è ovviamente autentica!): perché - afferma - quel governo si proponeva come portatore di una rifondazione radicale della politica in nome di alcuni «princìpi». Platone ne descrive anche il fallimento e la sconfitta ma gli rende omaggio, del tutto controcorrente, rispetto al perbenismo della cosiddetta democrazia restaurata. E nel Timeo, al principio del dialogo - dove Socrate viene sollecitato da Timeo a riassumere «ciò che ha detto il giorno prima» (cioè il nocciolo della Repubblica) - Crizia dice a Socrate, rendendogli omaggio: «La città che tu ieri ci hai descritta come una favola (la città riordinata secondo la radicale proposta riformatrice illustrata nella Repubblica) noi la trasferiremo nella realtà e la porremo qui» (Timeo, 26E).
Platone fa, qui, dire a Crizia, cioè al capo dei Trenta, parole che rivendicano orgogliosamente la genesi socratica del tentativo (pur abortito) dei Trenta e la coincidenza di quel tentativo (per lo meno nelle intenzioni) col progetto «utopistico» contenuto nella Repubblica. La «leggenda nera» gravante su Crizia viene così cancellata. Ma nell’Atene democratica queste erano parole indicibili. E come dimenticare, a questo punto, l’appropriazione nazionalsocialista di Platone (Hitlers Kampf und Platons Staat di Bannes)?
Donatella Di Cesare, che ripercorre in questo saggio il cammino di alcuni grandi filosofi che «si sporcarono le mani», e descrive con efficacia l’esito di Marx come studioso che - dopo reiterate sconfitte - «si ritirò sempre più in sé stesso per scoprire anzitempo la legge della storia che avrebbe portato sino all’ultimo salto prima del regno della libertà», lancia al termine una sfida inattuale a chi predica (da qualche decennio) la fine della storia, la fine del pensiero («delle ideologie» dicono i pappagalli semicolti), cioè (suprema stupidità) la fine del moto perenne della storia. E propugna in un «poscritto anarchico» una via d’uscita di rifiuto indomito dell’arché, del comando. È certo consapevole del rischio di ridurre così i filosofi a «testimoni», sia pure emozionanti. E approda, a mio avviso, a un esito tolstoiano. Non è superfluo ricordare qui, conclusivamente, che quel gigante del pensiero e dell’arte europea che fu Tolstoj - il quale a lungo rifletté sul «moto storico» incessante - diede impulsi profondi sia a Lenin che a Trotsky.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- "Oriente e Occidente - scrive Nietzsche in Schopenhauer come educatore - sono tratti di gesso che qualcuno disegna davanti ai nostri occhi per beffarsi della nostra pavidità".
- LE "REGOLE DEL GIOCO" DELL’OCCIDENTE E IL DIVENIRE ACCOGLIENTE DELLA MENTE.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- "26 gennaio 1994": dalla videocrazia al populismo digitale (di Antonio Gibelli).18 ottobre 2018, di Federico La Sala"26 gennaio 1994": dalla videocrazia al populismo digitale (di Antonio Gibelli):-
 https://www.laterza.it//images/stories/pdf/9788858132555_Gibelli_IlSecoloXIX_04-09-2018.pdf
https://www.laterza.it//images/stories/pdf/9788858132555_Gibelli_IlSecoloXIX_04-09-2018.pdf
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- PAROLE RIFONDATIVE. Decalogo per uscire dal buio: mandate le vostre parole (L’Espresso).8 ottobre 2018, di Federico La Sala
Decalogo per uscire dal buio: mandate le vostre parole *
- Su L’Espresso abbiamo pubblicato dieci parole rifondative di una possibile sinistra, per cercare una speranza per il futuro. Dieci firme hanno spiegato le loro scelte. Da "Popolo" a "Lavoro". Da "Differenza" a Tutti". Ora tocca ai nostri lettori: suggerire le vostre e spiegateci perché
Parole rifondative: di un progetto, un’identità, una speranza di futuro. Nelle prossime settimane si riuniranno in tanti, a sinistra o da quelle parti, per discutere di nomi, sigle, contenitori, per provare a riempire il vuoto di presenza, il deserto di alternativa visibile. Quello che ancora manca è la battaglia di idee: una sfida politica e culturale, popolare e non elitaria.
L’Espresso, nel solco del dibattito italiano e europeo, ha chiesto ad alcune sue firme, diverse per cultura e esperienza, un decalogo di parole-chiave. Da “Noi e Tu” di Massimo Cacciari a “Tutti” di Francesca Mannocchi, il nostro alfa e omega. E poi Michela Murgia, Aboubakar Soumahoro, Francesca Mannocchi. E Guseppe Genna, Emiliano Brancaccio, Evelina Santangelo, Valeria Parrella, Roberto Castaldi e Chiara Valerio.
Adesso tocca ai nostri lettori. Vi chiediamo di trovare le parole che per voi meglio rappresentano questa sfida, parole che siano davveri un segno di luce per uscire dal buio, spiegando il perché della vostra scelta. Per contribuire al dibattito che troverà spazio nei prossimi numeri del giornale
* L’Espresso, 05.10.2018
 http://espresso.repubblica.it/attualita/2018/10/04/news/decalogo-per-uscire-dal-buio-mandate-le-vostre-parole-1.327515?ref=HEF_RULLO
http://espresso.repubblica.it/attualita/2018/10/04/news/decalogo-per-uscire-dal-buio-mandate-le-vostre-parole-1.327515?ref=HEF_RULLO-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- PAROLE RIFONDATIVE. Decalogo: "Noi e tu" (di M. Cacciari - L’Espresso).12 ottobre 2018, di Federico La Sala
Per uscire dal buio
Decalogo *
Noi e tu
di Massimo Cacciari
Nessun “noi” è autorizzato a parlare a nome del mio “Io”. È questo il detestabile “Noi” cosi volentieri in bocca a leader e pseudo-leader, a detentori di verità o post-verità, ai “veri” rappresentanti del Popolo o della Gente. Si tratta del “Noi” plurale maiestatis, in cui Tutti dovrebbero ritrovarsi e abbracciarsi armoniosamente. A questa figura totalitaria va opposta la comunità degli Io, la ricerca della loro relazione senza confusione, senza che nessuno perda o dimentichi la propria singolarità. Ogni insieme che non si costituisca sulla base di un tale principio è destinato a trasformarsi in un oscuro grumo, manipolabile da qualsiasi pifferaio o burattinaio.
Ma dall’Io in quanto tale non si passa per miracolo alla comunità. Soltanto da quell’Io che è capace di chiamare l’altro col Tu, che non vede nell’altro l’avversario, l’ostacolo, lo scandalo, ma il Tu - che si fa prossimo dell’altro per giungere a chiamarlo Tu. E che con questo nome potrà essere a sua volta chiamato. L’Io è veramente tale quando viene chiamato Tu dall’altro. La singolarità del mio Io è tale quando cosi la scopro comparandomi al Tu dell’altro. Altrimenti non sono questo Singolo, unico nel proprio valore, non scambiabile con nessuno, merce o strumento di nessuno, ma soltanto un punto indistinto, un granello di sabbia nella indifferenza del Tutto. Se e soltanto se ognuno riuscisse a “dare del Tu” all’altro e a ritrovare se stesso proprio in questo dare-donare, saremmo autorizzati a usare il Noi.
Idea che appare semplice e che forse, invece, è in realtà sovrumana. È l’idea che regge l’intera struttura del Paradiso di Dante: tutti santi nel suo amplissimo abbraccio, tutti insieme beati nell’amore contemplativo del Signore e amici gli uni con gli altri, eppure ognuno si manifesta in un suo luogo, eterno nel suo volto proprio, nel suo nome, nella sua opera, ognuno inconfondibile nella sua preziosissima, inalienabile singolarità. È l’Inferno in terra dove la maledetta lupa dell’invidia, dell’avarizia, della libido di dominare, genera continuamente masse, indifferenza, confusioni, grumi. Ma a differenza che in quello di Dante, nel nostro è forse ancora possibile lottare e sperare in nome del Tu.
* l’Espresso, 07.10.2018
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --SOVRANITA’ (Costituzione), SOVRANISMI (Partiti), E ... “FORZA FRANCIA” (1994-2018)!!!29 settembre 2018, di Federico La Sala
SOVRANITA’ (Costituzione), SOVRANISMI (Partiti), E ... “FORZA FRANCIA” (1994-2018)!!! IL SOGNO DI UNA COSA ...
Una nota "Sul sovranismo democratico" *
di Federico La Sala
Per mettere (per così dire) i piedi per terra (e la testa in aria), a mio parere, data la situazione storica presente in cui “naviga” l’Italia e l’intera Europa, considerato “il nuovo scenario come dominato dalla polarizzazione tra sovranisti e macroniani” (Paolo Costa, "Sul sovranismo democratico", "Le parole e le cose", 24.09.2018), mi sembra più che pertinente richiamare la lezione marxiana:
“Non basta dire come fanno i francesi che la loro nazione è stata colta alla sprovvista. Non si perdona a una nazione, come non si perdona a una donna, il momento di debolezza in cui il primo avventuriero ha potuto farle violenza. Con queste spiegazioni l’enigma non viene risolto, ma soltanto formulato in modo diverso. Rimane da spiegare come una nazione dì 36 milioni di abitanti abbia potuto essere colta alla sprovvista da tre cavalieri di industria e ridotta in schiavitù senza far resistenza” (K. Marx, Il 18 brumaio di Luigi Bonaparte, 1852).
 “Io mostro, invece, come in Francia la lotta di classe creò delle circostanze e una situazione che resero possibile a un personaggio mediocre e grottesco di far la parte dell’eroe”(K. Marx, cit., 1869).
“Io mostro, invece, come in Francia la lotta di classe creò delle circostanze e una situazione che resero possibile a un personaggio mediocre e grottesco di far la parte dell’eroe”(K. Marx, cit., 1869).SOVRANITA’ DEMOCRATICA E COSTITUZIONE ITALIANA. Prima di tutto, concepire e recuperare la nostra personale e politica “sovranità”: “Sàpere aude!” (Kant)! Presupposto fondamentale e necessario è che ogni cittadino e ogni cittadina della Repubblica (artt. 1, 2, 3), uscito dallo “stato di minorità”, sia un sovrano e una sovrana e, in quanto tale, rispetti come “re” e come “regina” il “patto di alleanza” (la Costituzione) sottoscritto e, all’interno di essa, come “suddito” e “suddita”, “obbedisca” alle decisioni del Governo (il “patto di sudditanza”).
A TUTTI I LIVELLI, (micro e macro!), in ogni società COSTITUZIONAL-MENTE organizzata, a questi DUE PATTI tutti e tutte si è legati/e... se non si vuole “vivere” nella guerra di tutti/e contro tutti/e. E, ovviamente, il “patto di alleanza” è quello fondante - in sua assenza, si è fuori dalla “grazia” di “Dio”, e nelle braccia di “Mammona”!
SOLO camminando SU QUESTA STRADA, forse, è possibile vincere il ” pessimismo antropologico che non mi sembra granché di sinistra e che la riduzione monologica del potere alla sovranità esemplifica alla perfezione. È quella roba che dai tempi della Thatcher si usa chiamare TINA - there is no alternative - e di cui paghiamo il prezzo politico (con interessi superiori a quelli del debito italiano) oggi” (P. Costa, cit.), e contrastare il misticismo politico del “sovranismo democratico”!
PURTROPPO “la semplicità - è difficile a farsi” (B. Brecht)! La “produzione” va avanti a pieno regime - e non c’è più solo qualcuno/a che vuole e pretende di essere al di sopra della Costituzione, della Legge, “come Dio”, un “Diavolo in persona”, e lavora per la “pace perpetua” di tutto il Pianeta!!!
CHE FARE?! Questa è l’alternativa: “Uno spettro si aggira per l’Europa (...) una lotta che è sempre finita o con una trasformazione rivoluzionaria di tutta la società, o con la totale rovina delle classi in lotta”(“MEGA” - “Marx-Engels Gesamtausgabe”).
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- SOGNI E REALTA’. "Il diavolo nega che il diavolo esista. Così tra destra e sinistra: la prima nega differenze, la seconda cade nel tranello" (Carlo Galli).26 settembre 2018, di Federico La Sala
VOLONTA’ DI POTENZA E DEMOCRAZIA AUTORITARIA.... *
"Il Pci, oggi, verrebbe definito sovranista". Intervista al prof. Carlo Galli: "Condanna a Orban è controproducente"
Lo storico di dottrine politiche: "Il diavolo nega che il diavolo esista. Così tra destra e sinistra: la prima nega differenze, la seconda cade nel tranello"
di Nicola Mirenzi («Huffingtonpost.it», 13 settembre 2018)
«Il Pci, oggi, verrebbe definito sovranista, dai più accesi mondialisti». Storico delle dottrine politiche all’Università di Bologna, interprete del pensiero moderno e contemporaneo, il professor Carlo Galli sostiene che, dopo il crollo del muro di Berlino, l’adesione entusiastica alla globalizzazione dei partiti ex comunisti, socialisti e laburisti europei li abbia “impiccati” a un modello che si è “sfasciato”, facendogli perdere il senso dell’orientamento:
 «La sovranità è un concetto talmente democratico che è richiamato nel primo articolo della nostra Costituzione. Oggi, invece, chiunque contesti la mondializzazione viene considerato un fascista. Storicamente, però, la sinistra ha, nei fatti, avversato il trasferimento del potere fuori dai confini dello Stato: basti pensare alla critica che i comunisti italiani opposero alla Nato e, per molti anni, al Mercato comune europeo».
«La sovranità è un concetto talmente democratico che è richiamato nel primo articolo della nostra Costituzione. Oggi, invece, chiunque contesti la mondializzazione viene considerato un fascista. Storicamente, però, la sinistra ha, nei fatti, avversato il trasferimento del potere fuori dai confini dello Stato: basti pensare alla critica che i comunisti italiani opposero alla Nato e, per molti anni, al Mercato comune europeo».Secondo Galli, la notizia della scomparsa della distinzione tra destra e sinistra è fortemente esagerata, e sabato 15 settembre, a Lecce, in occasione dele Giornate del Lavoro organizzate dalla Cgil, terrà una lectio magistralis - che anticipa ad HuffPost - per dimostrarlo: «Il diavolo per prima cosa nega che il diavolo esista. Così accade per la differenza tra destra e sinistra: la destra nega che esistano la destra e la sinistra. E la sinistra cade in questo tranello. Ci sarà sempre una differenza di potere tra chi controlla il capitale e chi dal capitale è controllato. Tra chi produce valore lavorando e chi di quel valore si appropria. Per questo la distinzione tra destra e sinistra non scomparirà mai, all’interno di questo paradigma economico e politico».
La contrapposizione tra popolo ed élite è falsa?
È vera, e si aggiunge alla tradizionale frattura tra destra e sinistra, attraversando entrambi i fronti. Ci sono movimenti cosiddetti populisti che, infatti, sono più di destra; e altri che sono più di sinistra.
Perché la sinistra è più in difficoltà allora?
Perché la sua pigrizia mentale le fa considerare la richiesta di protezione - che c’è nella società - come un istinto razzistico, o xenofobo.
Non ci sono queste pulsioni?
No, ci sono anche queste pulsioni nella società: ma è scellerato dare questo nome alle legittime richieste di sicurezza sociale che vengono da quelle persone le cui vite sono state sempre più esposte all’incertezza dalla crisi che è insita nel paradigma economico dominante.
Perché la sinistra non intercetta più queste domande?
Perché, soprattutto la sinistra italiana, ha smesso di analizzare la realtà: preferisce nascondersi dietro il vecchissimo copione dell’antifascismo moralistico e considerare più della metà dei cittadini italiani barbari che stanno assaltando le fondamenta della civiltà. Ma quello che sta accadendo - l’abbiamo visto alle elezioni del 4 marzo - non è una sventura inviataci dal cielo: è il prodotto di fenomeni che si sono verificati dentro la nostra società.
La destra è più capace di comprendere la realtà?
No, ma non ne ha bisogno, perché le basta essere spregiudicata. La destra politica riconosce e dà un nome alle inquietudini del nostro tempo, ma in realtà fornisce dei capri espiatori. Oggi sono gli immigrati, i complotti della finanza internazionale, il politicamente corretto. E se a volte la destra politica si spinge ad accusare il capitalismo finanziario, non giunge mai a una critica del capitalismo in quanto tale.
Perché il capitalismo dovrebbe essere considerato un nemico?
Il capitalismo, lasciato a se stesso, tende a distruggere la società. Compito della politica è costringerlo ad adattarsi alle esigenze della democrazia, regolandolo, mettendo dei limiti, tutelando gli interessi dei cittadini, lasciando che il conflitto sociale si manifesti.
A volte, però, gli Stati hanno meno forza delle multinazionali.
Ma spesso nemmeno provano a scontrarsi con questi colossi. Cedono preventivamente. Anche se non è detto che siano sempre destinati a perdere il duello.
Un’Europa più sovrana avrebbe più potere negoziale?
In teoria, sì.
E in pratica?
In pratica, nessuno Stato europeo ha veramente in agenda la costruzione di una sovranità europea. Anche perché la costruzione della sovranità è uno dei processi più distruttivi della storia umana. Le sovranità degli Stati si sono formate nel sangue della guerra civile o nel furore delle rivoluzioni. Mai una sovranità è nata perché qualcuno intorno a un tavolo ha trasferito pacificamente a un soggetto terzo il diritto di tassare, di formare un esercito, di detenere il monopolio della violenza, di individuare gli interessi strategici di una comunità.
Senza sangue l’Europa politica non nascerà mai?
È molto difficile che la formazione di una sovranità europea possa accadere senza conflitto; anzi, se si guarda alle carneficine che sono avvenute nella storia, è difficile augurarsi che ciò accada.
Eppure, il parlamento europeo ha condannato uno dei suoi membri, l’Ungheria di Viktor Orbán.
Orbán è un leader detestabile, degno erede della lunga tradizione autoritaria ungherese. Tuttavia, la condanna europea è controproducente, e perciò sbagliata. Ogni volta che un’entità sovranazionale ha giudicato e punito uno Stato - pensi alle sanzioni inferte dalla Società delle nazioni al regime fascista - non ha ottenuto altro risultato che compattare la nazione intorno al proprio capo. Anche nel caso del giudizio espresso dall’Onu sull’Italia («è un Paese razzista»), si deve evitare di cadere nel ridicolo.
Qualcuno l’ha mai accusata di essere un populista?
No, anzi sono stato spesso tacciato di élitismo. Ma le élites devono capire e guidare la società, non condannarla.
Nella scorsa legislatura è stato eletto con il Pd.
Ne sono uscito dopo due anni e mezzo per entrare prima nel gruppo di Sinistra italiana, poi di Articolo 1, dal momento che nel partito democratico è rimasto assai poco della tradizione di sinistra.
Lei, invece, che cosa conserva?
Il metodo di analisi della realtà che viene da Gramsci, benché in modo non dogmatico e arricchendolo di altri apporti.
In che cosa consiste?
Nel comprendere i fenomeni politici e sociali e le loro contraddizioni senza dare giudizi morali, poiché la politica non si fa con i padre nostri.
Sogni e realtà
di Carlo Galli (Ragioni politiche, 05.09.2018)
Se il Pd è un partito di sinistra, e se la sua rinascita è indispensabile alla rinascita di questa, allora c’è poco da stare allegri: il suo orizzonte è infatti diviso fra chi non ammette alcun errore e incolpa i cittadini di avere sbagliato a votare, chi vuole cambiare nome come se non si dovesse anche cambiare politica, e chi, come Veltroni non trova nulla di meglio che identificare la sinistra con il «sogno» e la «speranza».
Nel momento di più cupo smarrimento e di più evidente mancanza di strategia, si propone quindi come soluzione della crisi lo stile politico che l’ha generata: uno stile sovrastrutturale, centrato sulla comunicazione e sull’illusione mediatica - al più, corretto dall’ammissione che il Pd non ha saputo stare «vicino a chi soffre», detto con un linguaggio che ricorda più la beneficenza che la politica -; uno stile lontano da ciò che è veramente la sinistra: teoria e prassi, analisi e lotte, materialismo e realismo, disegno di una società futura che parte dall’assunto che la struttura economica, e la cultura che la esprime, è conflittuale e non neutrale, e che quindi la liberal-democrazia non è una universale panacea formalistica che realizza l’accordo di tutti i cittadini ma il risultato, in equilibrio dinamico e precario, di tensioni e di contraddizioni che non si possono togliere né superare in «narrazioni» e in «visioni».
Come lascia assai poco a sperare la decisione - che accomuna il Pd a molta opinione “progressista” - di cercare la via d’uscita dalla impasse politica nella sempre più acuta polemica “antifascista” contro il governo; una mossa che esprime una lettura “azionista” cioè moralistica - o, se si vuole, “liberal” - della politica, a cui la sinistra dovrebbe preferire la analisi storica ed economica sullo stile di Gramsci. Non lo sdegno ma la comprensione dei processi è il solo inizio possibile se la sinistra vuole avere qualche chance di non scomparire.
In realtà, quindi, il sogno e l’antifascismo, che sembrano l’uno opposto all’altro, sono le due facce di una medesima mancanza di analisi radicale, di un pensiero pigro, stereotipato, privo di spessore storico, che impedisce al Pd di comprendere se stesso, il proprio ruolo, i propri errori (non quelli occasionali ma quelli strategici), un pensiero che procede per slogan e che non afferra la realtà; e che si espone al rischio o della inefficacia o di innescare una reale dinamica amico/nemico - a ciò infatti si giunge se si prende l’antifascismo sul serio -. Infine, questa politica infondata, inerte e al contempo pericolosa, è tatticamente un errore: non pare infatti utile a (ri)trovare voti e consenso l’attitudine a definire «fascisti», «barbari» e «nemici» i cittadini che hanno votato per i partiti di governo. Criminalizzare la maggioranza degli italiani non è una buona politica: è vittimismo arrogante e subalterno, che unisce la pretesa di superiorità morale alla implicita denuncia della impotenza della sinistra.
Soprattutto, una sinistra liberal che mette insieme il capitalismo più spregiudicato e le sue vittime, i licenziati e i licenziatori, che si prefigge uno schieramento «da Macron a Tsipras», non vede le proprie interne contraddizioni e le rigetta sul “nemico” fascista: il cleavage fascismo/antifascismo serve a occultare la vera natura del Pd, ovvero che questo è il partito dell’establishment, e che quindi è stato travolto dalla crisi di questo, e non solo è incapace di mettere in campo un’alternativa di pensiero e di azione, ma anche di rendersi conto della propria situazione storica reale.
Che è di essere un partito che difende il neoliberismo e l’ordoliberalismo quando questi sono in crisi - o meglio, quando producono crisi sempre più acute -; che resta attaccato alla Ue quando questa è ormai solo il cozzo delle sovranità e il teatro dell’egemonia tedesca attraverso l’euro; che scommette sulla liberaldemocrazia dopo avere contribuito a svuotarne il senso materiale - lo Stato sociale, l’allargamento del ceto medio, la ragionevole gestione delle disuguaglianze sociali, la sicurezza (a tutto tondo, cioè come garanzia della pienezza delle aspettative di vita) per la grande maggioranza dei cittadini -; che non sa vedere il cambiamento politico e culturale che stiamo vivendo. L’Occidente privo della presenza dell’America; l’Europa priva di progetti che non siano gli utili degli Stati (delle élites economiche e politiche che vi si sono insediate) e i sacrifici per i popoli; la globalizzazione “povera”, ovvero la sovranazionalità dell’economia e al contempo l’assenza, il fallimento, della società aperta; il liberalismo nutrito di privatizzazioni oligarchiche, divenuto liberismo senza persone e senza popolo, che per di più si meraviglia se il popolo lo abbandona in cerca di protezione - probabilmente illusoria - presso i “populisti”.
No. Proprio non si possono definire “barbari” quelli che non credono più alla civiltà “atlantica” del dopoguerra; questa non è crollata per l’irruzione dei popoli delle steppe, ma sta morendo di propria mano, per le proprie contraddizioni. Le cure tecnocratiche e rigoriste, dopo l’euforia della new economy, hanno ferito le società, rescisso il legame sociale, le appartenenze collettive (non diciamo la coscienza di classe), e consegnato i singoli alla rabbia e al rancore, alla paura e al confinamento entro i recinti egoistici della famiglia.
Chi non voglia inseguire ipotesi qualunquistiche e autoritarie - che sono più il sintomo che non la cura di questi mali - dovrà almeno riconoscere la verità; dovrà sapere da dove iniziare un nuovo corso culturale e politico; e non potrà fare opposizione con sermoni e prediche, con manifestazioni di piazza; chi come alternativa alla destra sa offrire solo l’elogio del vecchio mondo, o l’anatema delle nuove realtà che emergono, per quanto spiacevoli, pensando di esorcizzarle con qualche sdegnata narrazione, ignora che il grande passaggio storico in cui ci troviamo prenderà forma - dopo una fase di disorientamento, di comprensibile affannosa ricerca di protezione, dopo una lunga e ibrida transizione - grazie al combinarsi (come sempre è avvenuto) di idee e di interessi concreti: e che compito della sinistra è individuare gli interessi progressivi - cioè rivolti all’emancipazione dal bisogno dalla sofferenza dall’insicurezza -, e dare loro forza e idee. Soprattutto, l’idea che l’economia crea problemi che non sa risolvere, la cui soluzione sta nella politica “sovrana”. Ovvero nella politica capace di esprimere un comando legittimo davanti a cui anche la potenza dell’economia debba fermarsi. Gli Stati - e anche l’Europa sovrana, se mai ci sarà - non si governano con i padrenostri.
Finché la sinistra saprà opporre a Salvini soltanto i sogni e le speranze, il ribaltamento dei rapporti di forza resterà appunto un sogno - un informe, inconsapevole «sogno di una cosa» -. E Salvini la potrà lasciare sognare, e anzi augurarle «sogni d’oro». Si preoccuperà, invece, se e quando un leader di sinistra nuovo e credibile - portatore non di sogni ma di idee, nutrita di analisi cruda della realtà e non di edificanti narrazioni - saprà sfidarlo per dare all’Italia protezione dallo sfruttamento e non solo dai migranti.
*
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- VOLONTA’ DI POTENZA E DEMOCRAZIA AUTORITARIA. CARLO GALLI NON HA ANCORA CAPITO CHE, NEL 1994, CON IL PARTITO "FORZA ITALIA", E’ NATO ANCHE IL "NUOVO" PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Una sua riflessione [2009].
FILOSOFIA. IL PENSIERO DELLA COSTITUZIONE E LA COSTITUZIONE DEL PENSIERO
 MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA E A PENSARE BENE "DIO", "IO" E "L’ITALIA", CHI PIÙ CHI MENO, TUTTI VIVONO DENTRO LA PIÙ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA E POLITICA ITALIANA, NEL REGNO DI "FORZA ITALIA"!!! Un’inchiesta e una mappa
MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA E A PENSARE BENE "DIO", "IO" E "L’ITALIA", CHI PIÙ CHI MENO, TUTTI VIVONO DENTRO LA PIÙ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA E POLITICA ITALIANA, NEL REGNO DI "FORZA ITALIA"!!! Un’inchiesta e una mappaFederico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- Impolitico è l’uomo senza più utopie. Egli, dalla sua posizione defilata, testimonia la contraddizione drammatica tra l’aspirazione al Bene e l’impossibilità di realizzarlo politicamente (Roberto Esposito)26 settembre 2018, di Federico La Sala
Impolitico è l’uomo senza più utopie
di Roberto Esposito (l’Espresso, 23.09.2018)
Cosa vuol dire “impolitico”? Qual è il significato di questo termine - al di là di quello datogli da Thomas Mann nelle sue “Considerazioni”? Per rispondere a questa domanda bisogna prima di tutto distinguerlo dai due concetti cui viene erroneamente assimilato - l’antipolitico e l’apolitico. Quanto all’antipolitica è lo stesso Mann a situarla nell’orizzonte politico che essa vuole contrastare: «L’antipolitica è anch’essa una politica, giacché la politica è una forza terribile; basta solo sapere che esiste e già ci si è dentro, si è perduta per sempre la propria innocenza».
 Nel momento stesso in cui si oppone alla politica, facendone il proprio bersaglio, l’antipolitica parla il suo stesso linguaggio, non è che una forma mascherata di politica. L’elezione di Trump ne costituisce un esempio perfetto. Ma anche in Italia ne abbiamo avuto esperienza diretta Il caso più eclatante è quello dei 5 Stelle. Che hanno costruito il proprio successo politico indossando in da subito le vesti dell’antipolitica. Ciò vale, in generale, per tutti i populismi, arrivati al potere contestando ogni politica - tranne naturalmente la propria.
Nel momento stesso in cui si oppone alla politica, facendone il proprio bersaglio, l’antipolitica parla il suo stesso linguaggio, non è che una forma mascherata di politica. L’elezione di Trump ne costituisce un esempio perfetto. Ma anche in Italia ne abbiamo avuto esperienza diretta Il caso più eclatante è quello dei 5 Stelle. Che hanno costruito il proprio successo politico indossando in da subito le vesti dell’antipolitica. Ciò vale, in generale, per tutti i populismi, arrivati al potere contestando ogni politica - tranne naturalmente la propria.Ma l’impolitico è diverso anche dall’atteggiamento apolitico. Perché anche questo, pur astenendosi dalla partecipazione alla cosa pubblica, ha sempre un effetto politico. Come accade per l’astensione. Chi si astiene - e sono sempre più a farlo nelle democrazie occidentali - rafforza politicamente una parte di coloro che intendono delegittimare. Come è noto, in America non vota più del 50 per cento degli aventi diritto - ma ciò gioca oggettivamente a favore di uno dei due candidati alla Presidenza.
Nei paesi come la Francia, in cui è previsto il ballottaggio, si va al potere con una percentuale ancora minore. In questo senso l’esercito degli astensionisti - che non considerano degno nessun partito del proprio voto - costituisce di fatto un vero partito. Spesso il maggiore sul piano numerico. In questo senso dichiararsi apolitici perde di significato, perché comunque, anche se la si rifiuta, si sta all’interno della dialettica politica.
Se l’antipolitica è una forma di politica attiva, speculare alla politica avversata, l’apolitica è una politica passiva, ma non meno rilevante sul piano delle conseguenze nella formazione dei governi e dunque nella distribuzione del potere. Ben diverso il punto di vista dell’impolitico, come si è andato configurando nell’opera di alcuni autori “eretici” del Novecento. Nessuno di loro intende contrapporre alla politica un valore etico o estetico, come aveva invece fatto Mann. E come pretendono di fare gli antipolitici e gli apolitici ogni volta che attaccano la politica.
Al contrario gli impolitici ritengono che la politica - il conflitto di interesse e di potere - riempia l’intera realtà. In questo senso il punto di vista dell’impolitico coincide con il realismo politico, con cui condivide la consapevolezza che “la politica è il destino”. Non solo, ma un destino segnato dalla presenza inevitabile del male. Che si può contenere, limitare, ma con cui è necessario convivere.
 «Anche i primi cristiani», scrive Max Weber in “Politik als Beruf”, «sapevano perfettamente che il mondo è governato da demoni e che chi s’immischia nella politica, ossia si serve della potenza e della violenza, stringe un patto con potenze diaboliche». Ciò non vuol dire che si debba idolatrarle, rivestirle di un valore che non hanno.
«Anche i primi cristiani», scrive Max Weber in “Politik als Beruf”, «sapevano perfettamente che il mondo è governato da demoni e che chi s’immischia nella politica, ossia si serve della potenza e della violenza, stringe un patto con potenze diaboliche». Ciò non vuol dire che si debba idolatrarle, rivestirle di un valore che non hanno.Tra politica e valore vi è un solco incolmabile Il Bene non è traducibile in politica, come la Giustizia non può mai incarnarsi perfettamente nel diritto. Solo l’ignoranza diffusissima del significato sia della Giustizia che del diritto può indurre a sovrapporli. Il compito dell’impolitico è custodire il senso tragico di questa distinzione. Assumere la realtà per quella che è non vuol dire inchinarsi a essa.
 Al contrario solo la consapevolezza della sua ineluttabilità, può delineare, ai suoi margini esterni, il profilo di un’altra dimensione non sua prigioniera: «Su questa terra», afferma Simone Weil, «non c’è altra forza che la forza. Questo potrebbe essere un assioma. In quanto alla forza che non è di questa terra, il contatto con essa si paga solo al transito di qualcosa che assomiglia alla morte». Questo qualcosa è appunto la Giustizia, la cui realizzazione è sbandierata ai quattro venti dai professionisti dell’antipolitica.
Al contrario solo la consapevolezza della sua ineluttabilità, può delineare, ai suoi margini esterni, il profilo di un’altra dimensione non sua prigioniera: «Su questa terra», afferma Simone Weil, «non c’è altra forza che la forza. Questo potrebbe essere un assioma. In quanto alla forza che non è di questa terra, il contatto con essa si paga solo al transito di qualcosa che assomiglia alla morte». Questo qualcosa è appunto la Giustizia, la cui realizzazione è sbandierata ai quattro venti dai professionisti dell’antipolitica.
 Al contrario l’impolitico è lontano da ogni utopia. Ma anche dal cinismo di chi contrabbanda il proprio interesse per il bene generale. Egli, dalla sua posizione defilata, testimonia la contraddizione drammatica tra l’aspirazione al Bene e l’impossibilità di realizzarlo politicamente.
Al contrario l’impolitico è lontano da ogni utopia. Ma anche dal cinismo di chi contrabbanda il proprio interesse per il bene generale. Egli, dalla sua posizione defilata, testimonia la contraddizione drammatica tra l’aspirazione al Bene e l’impossibilità di realizzarlo politicamente.
 Mai, come ben sapeva Weber, l’etica della convinzione - che si attiene ai puri principi - e l’etica della responsabilità, che tiene conto delle conseguenze dell’azione, possono coincidere. Anche se chi è “chiamato” alla politica deve cercare di accostarle quanto è possibile. A questa eterna tensione tra finito e infinito è destinato l’impolitico. Ma cosa importa di tutto ciò ai nostri politici?
Mai, come ben sapeva Weber, l’etica della convinzione - che si attiene ai puri principi - e l’etica della responsabilità, che tiene conto delle conseguenze dell’azione, possono coincidere. Anche se chi è “chiamato” alla politica deve cercare di accostarle quanto è possibile. A questa eterna tensione tra finito e infinito è destinato l’impolitico. Ma cosa importa di tutto ciò ai nostri politici? -
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- Il «problema della verità» e la «riluttanza». Ora il pensiero debole è diventato riluttante.16 settembre 2018, di Federico La Sala
Ora il pensiero debole è diventato riluttante
Pier Aldo Rovatti, protagonista con Vattimo della svolta di inizio anni Ottanta, propone un modello di impegno critico che si colloca nelle istituzioni e nella storia. E per questo ricorda Croce
di Giancristiano Desiderio (Corriere della Sera, La Lettura, 16.09.2018)
- Pier Aldo Rovatti, L’intellettuale riluttante Eleuthera, pagine 175, e. 15
Domanda delle cento pistole: qual è il compito dell’intellettuale? Riluttare. Prego? Sì, proprio così: l’intellettuale deve essere riluttante e, quindi, dubitare, criticare, sfidare, resistere e, per dirla con Giuseppe Prezzolini, essere anche apota, ossia non bersela, mettere alla prova anche sé stesso e svolgere un lavoro ai fianchi di un’epoca o di una cultura che facilmente innescano dispositivi di potere che il consenso e il conformismo naturalmente non arginano, ma alimentano e consolidano.
A delineare il profilo di chi e come rilutta è Pier Aldo Rovatti con il libro L’intellettuale riluttante (Elèuthera). Perché, in fondo, quanti tipi di intellettuale ci sono? Alla buona, possiamo distinguerne più o meno tre: l’universale, l’organico, il tecnico.
Il primo parlava a nome dell’umanità ed è morto e sepolto. Il secondo è colui che, credendo di parlare in nome della verità, la sposò con il potere e nel segno della sacra unione giustificò disastri. Il terzo non è organico, ma integrato, ed è una sorta di amministratore delegato nei vari settori in cui è competente. Quest’ultimo tipo di intellettuale è l’unico esistente e in buona salute, ma ha un difetto: è competente come un sociologo o un ingegnere o un cuoco o anche un politico, ma è inconsapevole dei limiti della sua competenza.
È qui che entra in scena l’intellettuale riluttante che, appunto, oppone, smussa, limita, si mette in gioco nel tentativo ironico e serio di indebolire le strutture di potere, dall’economia alla politica allo stesso sapere, per recuperare respiro e libertà. Nel «conformismo dilagante - dice Rovatti - propongo di adottare la parola “riluttante” per caratterizzare il tipo di intellettuale critico e autocritico che sta venendo a mancare e di cui avremmo, invece, un gran bisogno».
L’intellettuale riluttante è senza pretese, sa soprattutto che non c’è più, per fortuna, «un’onda collettiva» sulla quale contare, puntare e in nome della quale parlare e ha imparato dai suoi stessi errori che il bene più prezioso del suo lavoro è la critica che dovrà esercitare anche su di sé. Un’opera preziosa perché a volte l’«onda collettiva» ritorna, anche se non ha più il suo bugiardo metafisico a darle voce, ma un più modesto capo-popolo.
Non si può discutere di e con Pier Aldo Rovatti senza ricordare che con Gianni Vattimo diede vita nel 1983 al «pensiero debole». Ora, il «pensiero riluttante» viene a rimpiazzare il «pensiero debole»? No, piuttosto il «pensiero riluttante» è la pratica di quella critica della ragione metafisica che fu la «ontologia dell’attualità» di Vattimo e Rovatti. Infatti che cos’è il cosiddetto «pensiero debole»? È l’esaurimento della metafisica o la presa d’atto che l’essere - cioè la vita, la storia, ciò che crediamo di essere - non corrisponde in modo univoco ad una struttura razionale e quando, invece, ciò accade, nasce o, nel migliore dei casi, la società dell’organizzazione totale come Tempi moderni di Charlie Chaplin o, nel peggiore, il totalitarismo come Il grande dittatore, ancora Chaplin.
Ma perché questa interpretazione, che è bella «forte», viene detta «debole»? Perché, appunto, è un’interpretazione e non una teoria o verità descrittiva assoluta. Il pensiero debole - finalmente lasciamo cadere le virgolette - altro non è che un pensiero storico e quella che è passata alla storia come «sinistra heideggeriana» è una filosofia di Hegel senza sapere assoluto.
Non diceva, forse, Hans-Georg Gadamer che la dialettica hegeliana andava ripresa nell’ermeneutica? E allora potremmo dire, senza scandalo per nessuno, che il pensiero debole è mezzo parente dello storicismo crociano. In fondo, l’apparente debolezza di Vattimo e Rovatti è tutta in questo gesto o aneddoto: un giorno a Michel Foucault, che discorreva della struttura, dissero: «Scusa, ma tu da dove parli?». Ecco, le verità del pensiero debole possono essere argomentate solo storicamente, giacché gli enunciati sono parte della storia o della condizione umana e saltarne fuori è impossibile come distaccarsi dalla propria ombra.
Così è per l’intellettuale riluttante che non parla da un pulpito, da una cattedra, da uno scranno, da un piedistallo, non è al di sopra delle cose, ma dentro le cose e proprio così può pensare e criticare, resistere e dubitare, scalfire e argomentare e, insomma, riluttare. A questo punto la battuta è a portata di mano e tocca farla: rilutto, dunque sono.
Sennonché ciò che viene a dire Rovatti è proprio che il pensiero non è una battuta, ma un esercizio faticoso in cui tocca resistere alla tentazione della rassegnazione o del congedo o del convento o della torre d’avorio in cui si sta tranquilli e sicuri ma perdenti; mentre chi rilutta sente che «la propria battaglia è quella di stare nelle istituzioni, scomode e perfino orribili che siano, e lì resistere, opporsi, dire no, “riluttare” anche al suo stesso ruolo e alle sue eventuali competenze privilegiate». Questa resistenza riluttante, che altro non è che la palestra in cui si impara ad allenarsi il giudizio senza il quale non si è esseri pensanti ossia giudiziosi, la si può praticare ovunque, tanto in pubblico quanto in privato, tanto al lavoro quanto in famiglia, la possono esercitare gli insegnanti a scuola, i medici in ospedale, gli amministratori in municipio.
Tuttavia, la caratterizzazione di «riluttante» non è di Rovatti bensì - e lui con onestà lo riconosce - dello psichiatra Piero Cipriano e nasce in ambito sanitario come cura che rilutta, recalcitra, si oppone o più modestamente e con giudizio mette in gioco i «trattamenti obbligatori» e tutte le pratiche e le conseguenze che ci possono essere in un ambiente dalle «porte chiuse».
Rovatti estende la «riluttanza» dalla cura all’intelletto, dalla medicina alla filosofia o ad una condizione culturale «che dovremmo impegnarci tutti a costruire». In gioco vi è nientemeno che il «problema della verità». Giacché l’ultimo passo dell’intellettuale o, forse, il primo è quello di sapere che il suo stesso sapere non è del tutto affidabile e il più delle volte, quando ci si rifugia nel sapere allontanando la lotta che infuria là fuori nel mondo, ci si sta comodamente difendendo «immaginando che tra il vero e il falso passi una netta linea divisoria, mentre risulta patente il contrario, e cioè che questo confine è fragile, vi avvengono continui movimenti di entrata e di uscita, e noi siamo proprio lì, completamente esposti».
È la fotografia della contemporaneità, una condizione come quella del mito di Sisifo, che deve ricominciare sempre da capo la stessa fatica. Ma se solo abbassiamo la guardia e tiriamo i remi in barca, o per rassegnazione o per convinzione, perdiamo il bene dell’intelletto più che il bene dell’intellettuale: lo spirito critico. Altro da fare non c’è che riluttare.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- VERITA’ E MENZOGNA, OGGI (2018): MA COME RAGIONANO GLI ITALIANI E LE ITALIANE?!12 settembre 2018, di Federico La Sala
MA COME RAGIONANO GLI ITALIANI E LE ITALIANE?!
L’Italia e’ diventata la ’casa’ della menzogna... e della vergogna?!
di Federico La Sala *
Elementare!, Watson: Se, nel tempo della massima diffusione mediatica dellapropaganda loggika, l’ITALIA è ancora definita una repubblica democratica e "Forza Italia" (NB: ’coincidenza’ e sovrapposizione indebita con il Nome di tutti i cittadini e di tutte le cittadine d’ITALIA) è il nome di un partito della repubblica, e il presidente del partito "Forza Italia" è nello stesso tempo il presidente del consiglio dello Stato chiamato ITALIA (conflitto d’interesse), per FORZA (abuso di potere, logico e politico!) il presidente del partito, il presidente del consiglio, e il presidente dello Stato devono diventare la stessa persona.
E’ elementare: queste non sono ’le regole del gioco’ di una sana e viva democrazia, ma di un vero e proprio colpo di Stato! (Shemi EK O’KHOLMES).
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- KANT, CERVELLO, E CORAGGIO: SAPER AUDE! "Nature Communications": nell’ippocampo cellule nervose che azzerano la paura. Note.9 settembre 2018, di Federico La Sala
"SAPERE AUDE!". USA IL CERVELLO!.... *
- «L’Illuminismo è l’uscita dell’uomo dallo stato di minorità che egli deve imputare a se stesso. Minorità è l’incapacità di valersi del proprio intelletto senza la guida di un altro. Imputabile a se stesso è questa minorità, se la causa di essa non dipende da difetto d’intelligenza, ma dalla mancanza di decisione e del coraggio di far uso del proprio intelletto senza essere guidati da un altro. Sapere aude! Abbi il coraggio di servirti della tua propria intelligenza! È questo il motto dell’Illuminismo.»
- Immanuel Kant, Risposta alla domanda: che cos’è l’Illuminismo?, 1784.
La ricerca. Cervelli impavidi
Il coraggio, se non ce l’hai te lo danno i neuroni
Nell’ippocampo cellule nervose che azzerano la paura
Le hanno localizzate gli scienziati svedesi studiando i topi che sfidano i gatti
di Giuliano Aluffi (la Repubblica, 09.09.2018, p. 19)
Chi salta da un dirupo, casomai munito di tuta alare per volare via sfrecciando sulle punte degli alberi, è certo un temerario, ma questo sprezzo del pericolo, più che indicatore di forte personalità, potrebbe essere soltanto un dono di natura, legato all’attività di un gruppo particolare di neuroni detti "i neuroni del coraggio". Già noti come gli "interneuroni OLM", si pensava fossero soltanto associati al consolidamento dei ricordi. Il loro ruolo chiave nei comportamenti spavaldi è oggi rivelato da uno studio pubblicato su Nature Communications, che pone le basi per possibili nuove terapie anti ansia e anti disturbo da stress post-traumatico. È un passo avanti rispetto a un recente studio giapponese che mostrava il ruolo della dopamina nello spezzare i riflessi condizionati legati alla paura in assenza di reale pericolo - la dopamina infatti si libera quando una situazione si rivela migliore di quanto temuto.
 Il nuovo studio, infatti, riguarda il comportamento in presenza di reali segnali di rischio, ed è quindi più propriamente legato al coraggio.
Il nuovo studio, infatti, riguarda il comportamento in presenza di reali segnali di rischio, ed è quindi più propriamente legato al coraggio.«L’attività di questi neuroni può azzerare la paura» spiega Klas Kullander, capo del dipartimento di genetica all’Università di Uppsala, in Svezia. «Se al centro di una stanza si mettono a terra dei peli di gatto, i topi normali non osano allontanarsi dai muri perché sentono l’odore del nemico. Ma se stimoliamo i suoi neuroni OLM, il topo si avventurerà senza timore in mezzo alla sala, e calpesterà i peli di gatto come se non ci fossero. Funziona anche l’inverso: disattivando questi neuroni, il topo diventa più timoroso degli altri».
A dare tanto potere ai neuroni OLM è la loro posizione cruciale. «Si trovano vicino ai neuroni principali dell’ippocampo, quelli piramidali, che connettono all’ippocampo due regioni cerebrali importanti come la corteccia prefrontale, sede della cognizione, e l’amigdala, sede della paura» spiega Kullander. «Quando vediamo qualcosa di allarmante la corteccia prefrontale e l’amigdala si attivano entrambe per decidere se siamo in pericolo oppure no. I neuroni OLM ricevono sia il responso dell’amigdala che quello della corteccia prefrontale, fanno un bilancio tra i due e lo trasmettono all’ippocampo. Quando questi neuroni sono molto attivi ed emettono un certo tipo di oscillazioni, dette oscillazioni Theta, il cervello decide che sì, la situazione sarà pure rischiosa, ma noi siamo al sicuro».
Una particolarità di questi neuroni è che hanno dei recettori per la nicotina: «Fumando, li si stimola» spiega Kullander. «Forse è per questo che molti tendono a fumare di più quando sono nervosi». «Se individuassimo altri recettori, oltre a quelli per la nicotina, posseduti soltanto da queste cellule, potremmo sviluppare un farmaco anti ansia molto mirato, che non tocchi altre parti del cervello» spiega il coautore dello studio, Richardson Leão, docente di neuroscienze alla Federal University di Rio Grande do Norte.
 In certi casi, invece, può essere salvifico aumentare l’ansia: «È il nostro prossimo progetto: salvare la vita ai topi infetti da toxoplasmosi. Per scongiurare la trasmissione agli uomini», spiega Leão. «Il parassita della toxoplasmosi per completare il suo ciclo di vita deve entrare nel cervello dei gatti. Ma il suo primo ospite è il topo. Quando il Toxoplasma gondii li infetta, i topi perdono la paura del gatto e addirittura scambiano gli odori del gatto per irresistibili feromoni». Gettandosi entusiasti tra le fauci dei felini e dandola vinta al parassita. «Vogliamo ridare a questi topi la paura dei gatti. E fermare questa zoonosi, assai rischiosa per chi ha il sistema immunitario compromesso» spiega Leão. «Studi dicono che i guidatori con Toxoplasma gondii hanno probabilità di fare incidenti più che doppia rispetto agli altri».
In certi casi, invece, può essere salvifico aumentare l’ansia: «È il nostro prossimo progetto: salvare la vita ai topi infetti da toxoplasmosi. Per scongiurare la trasmissione agli uomini», spiega Leão. «Il parassita della toxoplasmosi per completare il suo ciclo di vita deve entrare nel cervello dei gatti. Ma il suo primo ospite è il topo. Quando il Toxoplasma gondii li infetta, i topi perdono la paura del gatto e addirittura scambiano gli odori del gatto per irresistibili feromoni». Gettandosi entusiasti tra le fauci dei felini e dandola vinta al parassita. «Vogliamo ridare a questi topi la paura dei gatti. E fermare questa zoonosi, assai rischiosa per chi ha il sistema immunitario compromesso» spiega Leão. «Studi dicono che i guidatori con Toxoplasma gondii hanno probabilità di fare incidenti più che doppia rispetto agli altri».
Il nuovo studio
Il coraggio e i Colleoni
di Marino Niola (la Repubblica, 09.09.2018, p. 26)
Il coraggio si trova nei luoghi più impensati, diceva Tolkien. Forse per questo, da che mondo è mondo, gli uomini lo hanno sempre cercato in ogni dove. Nei meandri del corpo e nei ripostigli dell’anima, nella speranza di trovarne almeno quel briciolo che basti a non farsi sopraffare dalle proprie paure. Adesso due neuroscienziati annunciano di aver scovato il nascondiglio.
I ricercatori, lo svedese Klas Kullander dell’Università di Uppsala e il brasiliano Richardson Leao dell’Ateneo di Rio Grande, hanno pubblicato sulla rivista Nature Communications i risultati di uno studio, secondo il quale la centrale del coraggio si troverebbe nei cosiddetti neuroni dell’ippocampo.
Se siamo davanti a uno storico score scientifico è ancora presto per dirlo, ma la notizia sta già facendo sognare. Sia quelli che pensano di non avere abbastanza coraggio, sia quelli che sanno per certo di non poterselo dare da soli, come il don Abbondio manzoniano. E allora ben venga un farmaco, un microchip, un placebo incoraggiante che faccia friccicare nella maniera giusta quei neuroni, che, a detta degli studiosi, «a seconda del ritmo diverso con cui si attivano, fanno sì che un topo sia spaventato dal pelo di un gatto oppure non ne sia per nulla impressionato». Il che, trasposto qualche gradino più in su della scala evolutiva, significa che se l’ippocampo ci gira bene davanti a un rapinatore, anziché farcela sotto, saremmo in grado di reagire col sorriso sulle labbra prima di passare al contrattacco.
Resta il fatto che Kullander e Leao continuano, con gli strumenti di oggi, un’indagine iniziata da millenni. E che ha cercato ogni volta in un organo diverso la sede del coraggio. A partire dal cuore, da cui viene la parola stessa coraggio, che deriva dal latino coraticum, che significa letteralmente "aver cuore". Come il quasi invulnerabile Achille, o il leggendario re Riccardo, passato alla storia come il "Cuor di Leone".
Poi col tempo l’audacia e lo sprezzo del pericolo hanno traslocato al piano inferiore e sono andati a sistemarsi nel fegato. Essere dotato di fegato è stato ed è ancora sinonimo di valoroso, eroico, impavido. Lo raccontava già la mitologia greca che faceva di Prometeo, l’eroe che ha l’ardire di rubare il fuoco agli dei per donarlo ai mortali, l’uomo di fegato per antonomasia. Tant’è vero che Zeus lo punisce facendogli divorare h24 il fegato da un’aquila.
In tempi più recenti la location è scesa ancora più in basso e ha scelto un indirizzo genitale. Coraggioso è chi ha le palle. Ne sapeva qualcosa Bartolomeo Colleoni, il fiero capitano di ventura il cui nome di famiglia derivava dal latino coleus, testicolo. Ne andava così orgoglioso che ne mise ben tre sul suo stemma nobiliare. E andava in battaglia gridando «Coglia, coglia», un’esternazione dal senso inequivocabile. Per la stessa ragione cibarsi di testicoli di toro in Spagna e in altri Paesi a machismo spinto è roba da persone con gli attributi. Come dire una virilità ad alto tasso di testosterone.
E adesso la scienza potrebbe aiutarci a cancellare per sempre la paura. Attenzione però alle controindicazioni di un coraggio senza limiti. È vero che siamo nella civiltà della competizione spinta. Ed è vero pure che quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare. Ma non è detto che vincano. In fondo, come dicono gli etologi, la paura è il più geniale espediente inventato dall’evoluzione per decidere quando conviene osare e quando scappare. Al contrario, non temendo più niente e nessuno, rischiamo di trasformarci in un esercito di colleoni.
*
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- ESSERE GIUSTI CON KANT. La lezione di Michel Foucault e la sorpresa di Habermas.
KANT E SAN PAOLO. COME IL BUON GIUDIZIO ("SECUNDA PETRI") VIENE (E VENNE) RIDOTTO IN STATO DI MINORITA’ DAL GIUDIZIO FALSO E BUGIARDO ("SECUNDA PAULI")
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- FORZA, EUROPA. "Ora il Pd si sciolga per far nascere la lista Nuova Europa". L’appello di Massimo Cacciari.5 settembre 2018, di Federico La Sala
Intervista
"Ora il Pd si sciolga per far nascere la lista Nuova Europa". L’appello di Massimo Cacciari
«La sinistra è salita sull’Acropoli. Ora bisogna scendere». E per battere i nazionalisti alle elezioni del 2019 occorre rompere con il passato. Perché la vecchia Ue è finita per i suoi tradimenti. La proposta del filosofo
di Marco Damilano (l’Espresso, 05 settembre 2018)
Il 3 agosto Massimo Cacciari ha firmato un appello insieme a Enrico Berti, Michele Ciliberto, Biagio de Giovanni, Vittorio Gregotti, Paolo Macrì, Giacomo Manzoni, Giacomo Marramao, Mimmo Paladino, Maurizio Pollini, Salvatore Sciarrino. Nomi della cultura, dell’università, della ricerca: filosofi, artisti, musicisti. In quel testo si parla di «spirale distruttiva», di «pensiero unico intriso di rancore e di risentimento».
E si trova la richiesta di una discontinuità con il passato: «È indispensabile chiudere con il passato ed aprire nuove strade all’altezza della nuova situazione, con una netta ed evidente discontinuità: rovesciando l’ideologia della società liquida, ponendo al centro la necessità di una nuova strategia per l’Europa», in vista della scadenza decisiva dell’anno che si apre: le elezioni europee della primavera 2019. «C’è il rischio che si formi il più vasto schieramento di destra dalla fine della seconda guerra mondiale. La responsabilità di chi ha un’altra idea di Europa è assai grande. Non c’è un momento da perdere».
L’allarme è stato ripreso da tanti in queste settimane e il primo momento di discussione pubblica sarà a Mestre, dal 6 all’8 settembre, al festival della politica organizzato dalla fondazione Gianni Pellicani. Nel frattempo, tutto quello che è successo nel mese di agosto, dal consenso ottenuto dal governo Salvini-Di Maio dopo il crollo del ponte Morandi al blocco della nave Diciotti nel porto di Catania, dalla sfida nei confronti dell’Europa sui contributi Ue all’attacco sui conti pubblici, conferma quanto è scritto nel testo-appello: «Il popolo è contrapposto alla casta, con una apologia della Rete e della democrazia diretta che si risolve, come è sempre accaduto, nel potere incontrollato dei pochi, dei capi. L’ossessione per il problema dei migranti, ingigantito oltre ogni limite, gestito con inaccettabile disumanità, acuisce in modi drammatici una crisi dell’Unione europea che potrebbe essere senza ritorno».
 La nostra conversazione con Massimo Cacciari parte da qui.
La nostra conversazione con Massimo Cacciari parte da qui.«Il nostro appello non va alla ricerca di adesioni formali, è la richiesta di un’assunzione di responsabilità, di un’iniziativa concreta. In alcune università si stanno preparando momenti di dibattito, nel mondo cattolico si sono mosse le Acli, a livello europeo Etienne Balibar sta preparando qualcosa di analogo per la Francia. È un movimento che si attiva a partire da un’urgenza: vogliamo evitare che l’Europa muoia. L’Europa è demograficamente vecchia, ma è necessaria, se non vogliamo un destino popolato da miserabili staterelli sovrastati da quanto decideranno gli Imperi, il ripetersi dei conflitti del Novecento, il ritorno in farsa delle tragedie del vecchio secolo».
Un obiettivo nobile, che rischia di essere fuori tempo massimo. Bisogna evitare che l’Europa muoia, certo. Ma per molti cittadini europei, e italiani, l’Europa è già morta, da tempo, dopo la Brexit, dopo la crisi dell’euro, dopo le crisi dei migranti non governate da nessuno. C’è una vasta letteratura internazionale in materia: penso al dramma in nove atti raccontato dallo studioso indiano Ashoka Mody nel suo “EuroTragedy”, in cui racconta il capovolgimento dell’Europa da continente di pace e sicurezza dopo il secondo conflitto mondiale a terra di divisione. E c’è la crescita dei movimenti sovranisti e populisti, che non hanno una vera prospettiva alternativa, ma si nutrono del tramonto dell’Europa, delle astrattezze, dei tradimenti, del distacco dal popolo con cui è stato portato avanti il processo di integrazione.
«Non è morta l’Europa. È finita l’Europa che si è andata costruendo negli ultimi 20-25 anni. Anni in cui si sono inanellati una serie di errori straordinari. È il punto di partenza di qualsiasi azione: non si possono coprire le immense responsabilità delle classi dirigenti politiche, economiche e intellettuali. L’Europa attuale è una costruzione a-storica, ignorante dello specifico di ogni tradizione, in preda da tempo a una deriva burocratica, centralista, anti-federalistica. La catastrofe finale è arrivata con la crisi economica, quando l’Europa si è mostrata incapace di difendere i suoi cittadini più deboli. È in quel momento che è avvenuto lo strappo tra la coscienza europea e la sua organizzazione. Lo strappo è qui e qui c’è la necessità di una discontinuità radicale con il passato. E quindi: politiche sociali diverse e una costruzione istituzionale di tipo federalista».
Oltre alla crisi economica c’è la questione dei migranti, anche lo spettacolo vergognoso degli ultimi giorni: esseri umani trattati dal governo italiano come arma di ricatto, governi europei incapaci di progettare l’accoglienza e la ricollocazione degli aventi diritto all’asilo, la propaganda scatenata che non incontra resistenze.
«Non si diventa razzisti per opera dello Spirito Santo. Quando nel 1933 i tre quarti dell’elettorato socialdemocratico votarono per Hitler non era arrivato l’Anticristo a sedurre gli uomini, c’era stato un lungo processo storico. Lo stesso vale per quanto accaduto negli ultimi anni. La costruzione centralistica e burocratica e le politiche sociali dominate dal tradimento delle promesse offerte dal vecchio welfare: progresso, benessere. Se rompi questo nesso, i popoli diventano anti-democratici. La crisi ha messo l’Europa a nudo nelle sue debolezze e mancanze e si sono aperte le praterie per le forze anti-europee, ciascuna con le sue particolarità. Per il Front di Marine Le Pen è il sogno di una nuova grandeur francese, nei paesi dell’Est c’è il mito risorgimentale e nazionalista. Per la Lega e il Movimento 5 Stelle in Italia il discorso è diverso, perché fino alla formazione del governo M5S aveva fatto da argine all’elettorato leghista».
Lo storico Timothy Snyder in “La paura e la ragione” (Rizzoli) ha scritto di due narrazioni che si sono confrontate negli ultimi anni. La politica dell’inevitabilità, ovvero l’idea della fine della storia, della globalizzazione come unico orizzonte possibile, è stata sconfitta. E al suo posto c’è la politica dell’eternità: il ritorno ciclico dei miti della razza, del suolo, del territorio, le radici, l’identità.
«Le forze socialiste sono crollate ovunque per la loro subalternità culturale a un modello in cui andava bene tutto: bene l’Europa, bene la moneta unica, bene l’allargamento. Bene, più di tutto, la globalizzazione. Questo spiega perché le forze tradizionali della sinistra europea siano smottate così rapidamente, uno sfaldamento così veloce. Il problema era solo l’Anpassung, come dicono i tedeschi, l’adattamento. Perché, altrimenti, se non ti adattavi, eri fuori dalla storia».
Ricordo il refrain dei congressi, dei convegni, dei politici e degli intellettuali dell’adattamento: dobbiamo gestire la globalizzazione, governarla.
«Magari! Quella era la migliore delle ipotesi, in molti non si ponevano neppure il problema. Per la maggior parte dei leader della sinistra europea la globalizzazione è stata un destino inesorabile, da Tony Blair a Matteo Renzi, vedi l’ammirazione senza sfumature di differenza per il modello Marchionne. E chi non era dentro, chi restava fuori? Era un affar suo, non nostro. La conseguenza è stata una sinistra che vince nei centri storici e perde nelle periferie. Sinistra, hai perso il tuo popolo! Ti sei asserragliata in una acropoli, sotto non esisti più».
Il distacco dal popolo ora è diventato abissale. Il populismo era un risentimento, si è trasformato in un sentimento, popolare.
«Dai leader populisti arriva un messaggio molto semplice: noi difendiamo il nostro popolo. Aprire i confini significa farvi entrare i ladri in casa e noi non lo permetteremo. È una questione che Matteo Salvini usa con grande intelligenza, con grande sagacia, in modo simbolico. Un simbolo enorme: la nostra casa è in pericolo, dobbiamo difenderci. Solo i coglioni, perdonami, dicono che le bandiere e i simboli non contano nulla: contano eccome! Eppure per anni si è detto il contrario, lo ripetevano i Blair e i Renzi. Ma la politica senza simboli, senza un sol dell’avvenire, è ineffettuale. Non produce e non ottiene nulla».
Tutto vero, però anche il vostro appello è stato accusato di intellettualismo, di astrattezza. Qualcuno ha scritto che si punta a far nascere un partito dei sapienti, di poche intelligenze illuminate, i dotti.
«E invece è necessario fare il movimento opposto: scendere dall’acropoli, ricostruire una presenza nella pianura. Il senso del nostro appello è dire a tutti: organizzatevi. Anche perché è evidente che i populisti falliranno e ci porteranno al disastro, per la loro fragilità strategica».
Si può fare prima delle elezioni europee? Con chi?
«In Italia l’unica forza, nel bene e nel male - ora direi soprattutto nel male - è il Pd. Non dà segni di vita, è sordo agli appelli, i suoi esponenti si limitano a dare del barbaro a Salvini, un esercizio sterile. Quando vedo Martina sul molo di Catania, davanti alla nave Diciotti, penso che faccia felice solo Salvini, è un atto di propaganda nei suoi confronti. Perché dietro quel gesto non c’è nessuno. Cosa ti sogni di fare opposizione dopo che da venticinque anni sei al governo o punti ad andarci? Non sei il Pci, come fare l’opposizione a questi l’hanno raccontato i nonni, ma loro non l’hanno mai vista, sono una classe politica che è stata cooptata per andare al governo. Fare l’opposizione in queste condizioni è una cosa comica! Se ci presentiamo così, è finita».
E allora? Va sciolto il Pd e poi cosa?
«La mia idea è fare leva sulla scadenza elettorale del 2019 per costruire un simbolo europeo. Le forze che condividono questo progetto si mettano insieme, in modo transnazionale: Macron in Francia, Ciudadanos in Spagna, Tsipras in Grecia, che è stato bravissimo. Un progetto che si chiami Nuova Europa. Senza questa iniziativa il Pd rischia la liquidazione. O ti ritiri e cavalchi in retromarcia o sfidi i populisti e i sovranisti su questo terreno».
È un progetto che assomiglia al Fronte repubblicano di Carlo Calenda? E che porta al coinvolgimento con il Pd di Forza Italia?
Tra gli intellettuali liberali (Giovanni Orsina, Angelo Panebianco) si discute: arrendersi ai barbari o fare il fronte unico. «Io dico di no. Forza Italia, i conservatori, devono restare fuori. Quello che serve è una forza democratica europea di totale discontinuità con il passato. È questo la Nuova Europa: un progetto di governo nuovo, di rottura con la vecchia interpretazione dell’Europa e in contrasto con i sovranisti».
Il governo di Salvini e di Di Maio arriverà alle elezioni europee?
«La cupiditas dominandi di Di Maio è inarrestabile, sarà difficile che scenda dal governo, M5S potrebbe entrare in difficoltà e sparire. L’unico tranquillo in questo momento è Salvini, con tutti i suoi fronti di sfida, da Fico a Mattarella. Ha un target fortissimo, una bandiera, un simbolo. E ha un nemico, che è essenziale. Le leadership europee sono apparse nemiche dei popoli, è questa la sua forza».
Nelle ultime pagine, in seguito agli articoli di Roberto Esposito sull’Espresso, su cui è intervenuto Ernesto Galli della Loggia sul Corriere della Sera- La Lettura, si è sviluppato un dibattito sull’identità: l’assenza di un’identità che è stata tra i fattori di debolezza dell’Unione europea. Sei convinto che una formazione come la Nuova Europa che proponi sarebbe in grado di superare questo vuoto? Oppure si rischia di rifare un albero senza radici?
«Tu mi parli di radici, ma è Gesù Cristo che ha detto: sarete riconosciuti dai frutti, su quelli sarete giudicati. E allora: chi siamo? Siamo Salvini o siamo altro? L’identità è qualcosa che si cerca, non è data una volta per tutte. L’identità europea è una ricerca, è qualcosa che si fa nella storia. È stato un errore pensare il contrario: un’Europa senza identità e senza simboli o con un’identità da trovare esclusivamente nel passato. La radice dell’identità non va cercata nel passato, la radice si può individuare solo nel futuro».
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- ANIMALI POLITICI. Eravamo un popolo, siamo una somma di egoismi, dunque più deboli rispetto alla stretta del potere dispotico (Michele Ainis).3 settembre 2018, di Federico La Sala
LE TECNOLOGIE DIGITALI E IL LEGAME SOCIALE. Il rimorso dell’incoscienza....*
Animali politici
Quando la solitudine genera i tiranni
Otto milioni e mezzo di italiani vivono soli
L’individuo separato, diceva Aristotele, o è bestia o è dio. Ma il rischio è di essere bestie al servizio di un dio
 Eravamo un popolo, siamo una somma di egoismi, dunque più deboli rispetto alla stretta del potere dispotico
Eravamo un popolo, siamo una somma di egoismi, dunque più deboli rispetto alla stretta del potere dispoticodi Michele Ainis (la Repubblica, 03.09.2018)
Ci si può sentire soli vivendo in compagnia di sessanta milioni di persone? È quanto sta accadendo agli italiani: una solitudine di massa, un sentimento collettivo d’esclusione, di lontananza rispetto alle vite degli altri, come se ciascuno fosse un’isola, una boa che galleggia in mare aperto.
La solitudine si diffonde tra gli adolescenti, presso i quali cresce il fenomeno del ritiro sociale, altrimenti detto hikikomori. Diventa una prigione per gli anziani, la cui unica compagna è quasi sempre la tv. Infine sommerge come un’onda ogni generazione, ogni ceto sociale, ogni contrada del nostro territorio.
Ne sono prova le ricerche sociologiche, oltre che l’esperienza di cui siamo tutti testimoni: 8,5 milioni di italiani (la metà al Nord) vivono da soli; e molti di più si sentono soli, senza un affetto, senza il conforto di un amante o d’un amico. Così, nel 2015, Eurostat ha certificato che il 13,2 per cento degli italiani non ha nessuno cui rivolgersi nei momenti di difficoltà: la percentuale più alta d’Europa.
Mentre l’11,9 per cento non sa indicare un conoscente né un parente con cui parli abitualmente dei propri affanni, dei propri problemi. Non a caso Telefono Amico Italia riceve quasi cinquantamila chiamate l’anno. Non a caso, stando a un Rapporto Censis (dicembre 2014), il 47 per cento degli italiani dichiara di rimanere da solo in media per 5 ore al giorno. E non a caso quest’anno, agli esami di maturità, la traccia più scelta dagli studenti s’intitolava «I diversi volti della solitudine nell’arte e nella letteratura».
Questa malattia non colpisce soltanto gli italiani. È un fungo tossico della modernità, e dunque cresce in tutti i boschi. Negli Stati Uniti il 39 per cento degli adulti non è sposato né convive; mentre l’Health and Retirement Study attesta che il 28 per cento dei più vecchi passa le giornate in uno stato di solitudine assoluta. Succede pure in Giappone, dove gli anziani poveri e soli scelgono il carcere, pur di procurarsi cibo caldo e un po’ di compagnia; o in Inghilterra, dove la metà degli over 75 vive da sola.
Tanto che da quelle parti il governo May, nel gennaio 2018, ha istituito il ministero della Solitudine, affidandone la guida a Tracey Crouch; ma già in precedenza funzionava una commissione con le medesime funzioni, inventata da Jo Cox, la deputata laburista uccisa da un estremista alla vigilia del referendum su Brexit. Insomma, altrove questo fenomeno viene trattato come un’emergenza, si studiano rimedi, si battezzano commissioni e dicasteri. In Italia, viceversa, viaggiamo a fari spenti, senza interrogarci sulle cause delle nuove solitudini, senza sforzarci di temperarne gli effetti. Quanto alle cause, l’elenco è presto fatto.
 In primo luogo la tecnologia, che ci inchioda tutto il giorno davanti allo schermo del cellulare o del computer, allontanandoci dal contatto fisico con gli altri, segregandoci in una bolla virtuale.
In primo luogo la tecnologia, che ci inchioda tutto il giorno davanti allo schermo del cellulare o del computer, allontanandoci dal contatto fisico con gli altri, segregandoci in una bolla virtuale.
 In secondo luogo l’eclissi dei luoghi aggreganti - famiglia, chiesa, partito - sostituiti da una distesa di periferie che ormai s’allargano fin dentro i centri storici delle città.
In secondo luogo l’eclissi dei luoghi aggreganti - famiglia, chiesa, partito - sostituiti da una distesa di periferie che ormai s’allargano fin dentro i centri storici delle città.In terzo luogo le nuove forme del commercio e del consumo: chiudono i negozi, dove incontravi le persone; aprono gli ipermercati, dove ti mescoli alla folla.
 In quarto luogo l’invecchiamento della popolazione, che trasforma una gran massa d’individui in ammalati cronici, e ciascuno è sempre solo dinanzi al proprio male.
In quarto luogo l’invecchiamento della popolazione, che trasforma una gran massa d’individui in ammalati cronici, e ciascuno è sempre solo dinanzi al proprio male.
 In quinto luogo e infine, la precarietà dell’esistenza: una volta ciascuno moriva nel paesello in cui era nato, dopo aver continuato lo stesso mestiere del nonno e del papà; ora si cambia città e lavoro come ci si cambia d’abito, senza trovare il tempo di farsi un nuovo amico, di familiarizzare con i nuovi colleghi.
In quinto luogo e infine, la precarietà dell’esistenza: una volta ciascuno moriva nel paesello in cui era nato, dopo aver continuato lo stesso mestiere del nonno e del papà; ora si cambia città e lavoro come ci si cambia d’abito, senza trovare il tempo di farsi un nuovo amico, di familiarizzare con i nuovi colleghi.Con quali conseguenze?
Secondo un gruppo di ricercatori della Brigham Young University, la solitudine danneggia la salute quanto il fumo di 15 sigarette al giorno: giacché provoca squilibri ormonali, malumore, pressione alta, insonnia, maggiore vulnerabilità alle infezioni. Altri studiosi (John e Stephanie Cacioppo, dell’Università di Chicago) mettono l’accento sull’aggressività dei solitari, le cui menti sviluppano un eccesso di reazione, uno stato di perenne allerta, come dinanzi a un pericolo incombente. C’è un altro piano, tuttavia, ancora da esplorare: la politica, il governo della polis. L’individuo separato o è bestia o è dio, diceva Aristotele. Ma nelle società contemporanee la solitudine di massa ci rende tutti bestie alla mercé di un dio.
Sussiste una differenza, infatti, tra solitudine e isolamento. La prima può ben corrispondere a una scelta; il secondo è sempre imposto, è una condanna che subisci tuo malgrado. Nell’epoca della disintermediazione, della crisi di tutti i corpi collettivi, della partecipazione politica ridotta a un tweet o a un like, questa condanna ci colpisce uno per uno, trasformandoci in una nube d’atomi impazziti. Eravamo popolo, siamo una somma d’egoismi, senza un collante, senza un sentimento affratellante. Dunque più deboli rispetto alla stretta del potere.
Perché è la massa, non il singolo, che può arginarne gli abusi. E perché il potere dispotico - ce lo ha ricordato Hannah Arendt (Vita activa), sulle orme di Montesquieu - si regge sull’isolamento: quello del tiranno dai suoi sudditi, quello dei sudditi fra loro, a causa del reciproco timore e del sospetto.
Sicché il cerchio si chiude: le nostre solitudini ci consegnano in catene a un tiranno solitario.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- GLI APPRENDISTI STREGONI E L’EFFETTO "ITALIA". LA CLASSE DIRIGENTE (INCLUSI I GRANDI INTELLETTUALI) CEDE (1994) IL "NOME" DEL PAESE AL PARTITO DI UN IMPRENDITORE. Che male c’è?! - Materiali sul tema
LA "PROFEZIA" DI MARSHALL MCLUHAN: NARCISO E LA MORTE DELL’ITALIA. Il "rimorso di incoscienza" di Marshall McLuhan
 LA CONCESSIONE PIU’ GRANDE. Cedere occhi, orecchie e nervi a interessi commerciali è come consegnare il linguaggio comune a un’azienda privata o dare in monopolio a una società l’atmosfera terrestre.
LA CONCESSIONE PIU’ GRANDE. Cedere occhi, orecchie e nervi a interessi commerciali è come consegnare il linguaggio comune a un’azienda privata o dare in monopolio a una società l’atmosfera terrestre.Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- A CAMOGLI, AL V FESTIVAL DELLA COMUNICAZIONE: "VISIONI". Un brano dallo spettacolo «Musica e parole. Un ricordo di Umberto Eco».31 agosto 2018, di Federico La Sala
Quell’umorismo che sfida le fake news
di Valentina Pisanty (il manifesto, 30.08.2018)
L’anticipazione. Un brano dallo spettacolo dedicato al grande semiologo scomparso due anni fa che andrà in scena a Camogli il 6 settembre nell’ambito della V edizione del Festival della Comunicazione. Per l’intellettuale bolognese ogni strategia illuministica di disvelamento del potere passava per il riso
Umberto Eco ride della rigidità dei luoghi comuni, degli automatismi del linguaggio, della prevedibilità dei generi narrativi, delle trappole della logica e, in generale, di tutte le strutture inflessibili che conferiscono una parvenza di ordine alla vita sociale. Così funziona l’umorismo: si prende una matrice logica familiare, un sistema di regole, un frammento di senso comune; si finge di trovarsi a proprio agio al suo interno, dicendo cose del tutto coerenti con i suoi assunti, di modo che l’interprete si illuda di avere capito dove il discorso andrà a parare; e poi, zac!, quando l’altro meno se lo aspetta si introduce di soppiatto un piano logico incompatibile che fa esplodere le attese sin lì create. Si vedano, per esempio, le Istruzioni per scrivere bene in cui, fingendosi precettore, Eco confuta ciascuna regola stilistica nell’atto stesso di formularla: «evita le allitterazioni, anche se allettano gli allocchi»; «evita le frasi fatte: è minestra riscaldata»; «non generalizzare mai»; «sii sempre più o meno specifico»; «non usare metafore incongruenti anche se ti paiono ‘cantare’: sono come un cigno che deraglia»; e - la mia preferita - «solo gli stronzi usano parole volgari».
LE PARODIE FUNZIONANO in modo analogo, salvo che l’incongruenza si rivela attraverso l’accumulo iperbolico di dettagli tra loro coerenti che tuttavia fanno a pugni con il comune buonsenso. In un capolavoro di satira accademica Eco narra la parabola di Swami Brachamutanda (Bora Bora 1818 - Baden Baden 1919), «fondatore della scuola tautologica i cui principi fondamentali sono delineati nell’opera Dico quello che dico: l’Essere è l’Essere, la Vita è la Vita, L’amore è l’amore, Quello che piace piace, Chi la fa la fa e il Nulla Nulleggia».
I GUAI DI BRACHAMUTANDA hanno inizio quando, dopo aver sostenuto che «gli affari sono affari» e «i soldi sono soldi», il fedele discepolo Guru Guru fugge con la cassa della comunità e, fermato dalla polizia di frontiera, si lascia scappare un «chi la fa l’aspetti»: frase che, «come è evidente, contraddice i principi essenziali della sua logica». Di lì è tutto un precipizio: i tautologi sconvolti si spaccano, l’eretico Schwarzenweiss fonda la scuola eterologica secondo cui «L’Essere è il Nulla, il Divenire sta, lo Spirito è Materia, la Coscienza è Inconscia», rivendicando la sua ascendenza sui massimi capolavori della letteratura occidentale - Guerra e Pace, il Rosso e il Nero... - mentre accusa i tautologi di essersi limitati a ispirare opere di scarso rilievo come Tora Tora, New York New York e Que sera sera... Al che Brachamutanda obietta che, di questo passo, tanto vale che lo Schwarzenweiss accampi diritti sulle vendite del whisky Black and White.
PERCHÉ FA RIDERE? In un saggio sul Comico e la regola (Alfabeta 1980) Eco teorizzava che l’effetto comico scaturisce dalla violazione di una regola sociale compiuta da un personaggio inferiore nei confronti del quale chi ride prova un aristotelico senso di superiorità. Ma non è mai chiaro se lo zimbello sia la regola violata, o colui che la trasgredisce, oppure entrambe le cose insieme: è questo il bello dell’umorismo, che mentre si fa gioco delle contraddizioni altrui è a sua volta irriducibilmente contraddittorio. Non si salva nessuno.
CON ECO SI RIDE in modo allegro e tutto sommato benevolo nei confronti di ciò verso cui ci si sente sì superiori, ma anche compartecipi: una parte ride dell’altra, e viceversa, senza sintesi possibile, e guai se ci fosse. La stupidità umana - bersaglio della risata - è l’altra faccia dell’intelligenza, come d’altronde chiarisce Jacopo Belbo in un famoso dialogo del Pendolo di Foucault: «l’intelligenza è il prodotto di infinite stupidità».
Solo se gli stupidi sono anche arroganti, desiderosi di far prevalere la propria sull’altrui stupidità, la risata diventa beffarda. Ancora Belbo: «Ma gavte la nata, levati il tappo. Si dice a chi sia enfiato di sé. Si suppone si regga in questa condizione posturalmente abnorme per la pressione di un tappo che porta infitto nel sedere. Se se lo toglie, pffffiiisch, ritorna a condizione umana». Ridicolizzare i prepotenti per afflosciarne le ambizioni di dominio è una strategia illuministica fondata sulla fiducia nella fondamentale ragionevolezza umana. Gli altri, i complici, capiranno e non si faranno abbindolare.
Ma cosa succede quando la Regola che si supponeva ovvia e condivisa viene diffusamente violata senza senso del ridicolo? Quando la carnevalizzazione totale della vita priva l’umorismo del suo lampo, del suo scandalo, della sua spinta sovversiva? Quando, di fronte alla «travolgente rivelazione che sono tutti dei coglioni», non ci si può più consolare con la solita battuta: «d’altronde se fossero intelligenti sarebbero tutti professori di semiotica»? La risata si strozza in gola.
NEGLI ANNI DEL BERLUSCONISMO Eco scrive A passo di gambero, dove i discorsi sull’Ur-fascismo, sul populismo mediatico e sulle reviviscenze razziste al «crepuscolo d’inizio millennio» assumono toni insolitamente foschi e nauseati: «Andate un poco al diavolo tutti quanti, perché è anche colpa vostra», conclude, e a questo punto ci sarebbe poco da ridere. Per farlo bisognerebbe conservare almeno un barlume di complicità, ed è per questo che né Berlusconi, né Trump, né Salvini fanno ridere. Se non che Eco sa essere spiritoso anche quando manda la gente a quel paese.
COSÌ, IN UN’EMAIL DEL 1999 che merita di essere condivisa, suggeriva alcune varianti del messaggio-base, a seconda della nazionalità degli ipotetici mittenti: «wa’ ffa n’kul da arabi, waakkaagaare da finlandesi, strnz da cecoslovacchi, fk yup da turchi, maa mukkela da africani, tel lì el pirlon da spagnoli, nicht rumper Katz oppure roth im kuhle da tedeschi, o filho da minhota da brasiliani, fak ja De Meerd da fiamminghi, throw yeah put an A da americani, van Moona da olandesi, mavamori amatzatu da giapponesi, Pi Ciu da cinesi, tglt dll pll da ebrei non masoretici, Masta Citu da incas, massipuo e ser kosi pistoola da hawaiani, manoru ‘n pemei Bali da balinesi. To be continued». Così finiva il messaggio.
«Visioni» al Festival della Comunicazione di Camogli
«Musica e parole. Un ricordo di Umberto Eco» è il titolo dello spettacolo con Valentina Pisanty e altri amici e colleghi di Eco, Furio Colombo, Gianni Coscia, Roberto Cotroneo, Paolo Fabbri, Riccardo Fedriga, Maurizio Ferraris e Marco Santambrogio, che si terrà giovedì 6 settembre nell’ambito del Festival della Comunicazione di Camogli.
 Filo conduttore della V edizione della kermesse, in programma fino al 9 settembre, aperta dalla lectio magistralis di Renzo Piano, saranno le «Visioni». Oltre un centinaio di protagonisti dell’informazione, della cultura, dell’innovazione, dell’economia, della scienza e dello spettacolo si confronteranno in 78 incontri.
Filo conduttore della V edizione della kermesse, in programma fino al 9 settembre, aperta dalla lectio magistralis di Renzo Piano, saranno le «Visioni». Oltre un centinaio di protagonisti dell’informazione, della cultura, dell’innovazione, dell’economia, della scienza e dello spettacolo si confronteranno in 78 incontri.
 Tra i relatori: Alessandro Barbero; Giovanni Allevi; Piero Angela; Mario Calabresi; Evgeny Morozov; Oscar Farinetti; Gad Lerner; Stefano Massini; Davide Oldani; Massimo Montanari; Massimo Recalcati; Gherardo Colombo con Marco Travaglio; Andrea Riccardi; Marco Aime con Guido Barbujani e Telmo Pievani.
Tra i relatori: Alessandro Barbero; Giovanni Allevi; Piero Angela; Mario Calabresi; Evgeny Morozov; Oscar Farinetti; Gad Lerner; Stefano Massini; Davide Oldani; Massimo Montanari; Massimo Recalcati; Gherardo Colombo con Marco Travaglio; Andrea Riccardi; Marco Aime con Guido Barbujani e Telmo Pievani. -
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- DAL DISAGIO ALL’AGONIA "NELLA" CIVILTA’. Come siamo evoluti: da doppi “sapiens” a tripli “stupidus”.30 agosto 2018, di Federico La Sala
Come siamo evoluti: da doppi “sapiens” a tripli “stupidus”
Lo psichiatra Vittorino Andreoli analizza “l’agonia di una civiltà” fin dall’errore di porre “Homo” all’apice dell’albero della vita, a oggi che ha messo a riposo la neocorteccia
di Vittorino Andreoli (Il Fatto, 30.o8.2018)
- Pubblichiamo un estratto del nuovo libro dello psichiatra Vittorino Andreoli.
Nell’Origine delle specie di Charles Darwin (pubblicato nel 1859) l’uomo è posto all’apice dell’albero della vita con la definizione di Homo sapiens sapiens. Mi ha sempre colpito la ripetizione di sapiens, un rafforzativo legato, credo, al salto evolutivo della nostra specie che, rispetto a quello delle precedenti, deve essere subito apparso eccezionale, forse miracoloso. Considerando il significato del termine sapiens, tuttavia, questa sottolineatura appare del tutto ingiustificata, poiché il sapiente dovrebbe essere colui che giunge al vertice dell’umanità con comportamenti privi di qualsiasi aporia.
La definizione di Homo sapiens sapiens appare, dunque, emotiva e priva di significato letterale. Suona più come: “Sa tutto e altro ancora”. [...]. Partendo da queste osservazioni, c’è chi ha persino criticato le tappe evolutive darwiniane mostrando che, se venissero stabilite sulla base di specifiche funzioni (come quelle citate), la specie umana non si troverebbe affatto all’apice dell’albero della vita. [...]
A esprimere la sproporzione terminologica di quel doppio sapiens, è tuttavia l’uomo del tempo presente, che sembra essere smarrito e avere perduto quel beneficio della neocorteccia che giustifica per gli antropologi la generosità di quel doppio sapiens.
Si ha l’impressione che oggi l’uomo abbia messo a riposo la neocorteccia rinunciando a quel salto evolutivo che lo distacca dagli altri primati, come gli scimpanzé e, in particolare, i bonobo, che hanno raggiunto l’abilità di reggersi sugli arti inferiori, di potersi così guardare in faccia, accoppiarsi frontalmente (e non per monta) e persino baciarsi sulla bocca. Questa ipotesi regressiva non è fantasiosa: basta tenere conto dell’importanza raggiunta dalle tecnologie digitali, che rappresentano una vera e propria protesi del cervello e delle sue funzioni mentali. Ne può derivare una messa a riposo della neocorteccia con la delega a svolgere le sue funzioni alle “macchinette” digitali.
A dare una grande spinta alla nostra critica, è proprio l’osservazione di comportamenti dell’uomo che in nessun modo possono essere fatti rientrare nell’ambito della sapienza. Quel che si constata è che non si tratta di errori casuali o voluti all’interno di comportamenti dominanti positivi, ma di un vero e proprio errore strutturale che diventa pertanto comportamento precipuo, esclusivo, regola.
È per questo che l’aggettivo sapiens si dimostra del tutto inadeguato, rendendo invece corretto il ricorso a un termine antinomico: stupidus, Homo stupidus. Per simmetria, poi, occorre sottolinearlo due volte: Homo stupidus stupidus. Se si tenesse conto del livello di stupidità, si sarebbe anzi tentati di triplicarla per avere la certezza che, indipendentemente dal luogo in cui la specie Homo vada posta nell’albero della vita, non incontri alcuna concorrenza.
La parola “stupido” va usata nella sua espressione latina, stupidus, non solo per rispettare la consuetudine della terminologia antropologica, ma per distinguerla dal senso popolare che possiede in italiano. È considerato stupido chiunque non abbia, in una data circostanza, tenuto conto della realtà, e che si sia comportato in modo poco o per nulla intelligente.
Dal punto di vista etimologico, stupidus contiene la stessa radice di “stupore”, termine che descrive una sensazione inattesa e persino incredibile, che lascia cioè attoniti, sbalorditi. Incredibile che un uomo possa comportarsi in quel dato modo, ma incredibile soprattutto che lo possa fare una comunità intera, un popolo. [...] Ed è questa stupiditas che ora ci proponiamo di mostrare analizzando dapprima la Distruttività, poi La caduta dei princìpi che sono a fondamento della civiltà occidentale e, infine, descrivendo le caratteristiche dell’Uomo senza misura.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! - IL SENNO DI PRIMA ("PROMETEO"), IL SENNO DI POI ("EPIMETEO"), I DISASTRI E IL "DISPOSITIVO DI DERIVAZIONE KANTIANA".20 agosto 2018, di Federico La Sala
IL SENNO DI PRIMA ("PROMETEO"), IL SENNO DI POI ("EPIMETEO"), I DISASTRI E IL "DISPOSITIVO DI DERIVAZIONE KANTIANA" ...*
- "È significativo che l’espressione di Tertulliano: "Il cristiano è un altro Cristo", sia diventata: "Il prete è un altro Cristo"." (Albert Rouet, arcivescovo di Poitiers, 2010).
- (...) il superiore guarda al consenso e alle conferme di chi siede ancora più in alto di lui. E quest’ultimo rivolge la sua mente al mandato di chi è il supremo detentore di quel bene, di quella situazione, di quel dato potere. E tutto questo complesso di fattori cambia la prospettiva, perché il conformismo è più potente della psicologia della responsabilità.
 A meno che nella persona responsabile in situazione trovino nutrimento valori morali assoluti: che spingono ad assumersi il rischio personale di andare controcorrente, e di superare derisioni e ostracismo, di non farsi influenzare dal dispositivo di derivazione kantiana, «faccio quel che devo, accada quel che può» (Maurizio Fiasco, "Tutti i disastri «irreparabili» e il senno di prima", Avvenire, 18.08.2018)).
A meno che nella persona responsabile in situazione trovino nutrimento valori morali assoluti: che spingono ad assumersi il rischio personale di andare controcorrente, e di superare derisioni e ostracismo, di non farsi influenzare dal dispositivo di derivazione kantiana, «faccio quel che devo, accada quel che può» (Maurizio Fiasco, "Tutti i disastri «irreparabili» e il senno di prima", Avvenire, 18.08.2018)).
- Avere il coraggio di dire ai giovani che essi sono tutti sovrani, per cui l’obbedienza non è ormai più una virtù, ma la più subdola delle tentazioni, che non credano di potersene far scudo né davanti agli uomini né davanti a Dio, che bisogna che si sentano ognuno l’unico responsabile di tutto (don Lorenzo Milani),
Il sociologo.
Tutti i disastri «irreparabili» e il senno di prima
Dopo il ragionamento è il solito, col senno di poi: come è stato possibile che nessuno vedesse e capisse prima dell’irreparabile fatto?
di Maurizio Fiasco (Avvenire, sabato 18 agosto 2018)
- Il balletto delle responsabilità inizia sempre dopo, col senno di poi. Il senno di prima è ignoto (Fotogramma)
Come accadono i disastri? C’è un’espressione, all’apparenza banale ma ricorrente, quando siamo sconcertati per un evento dai costi umani incalcolabili. «Col senno di poi». Che equivale: come è stato possibile che nessuno vedesse e capisse prima dell’irreparabile fatto? Quel che ha condotto al precipitare di una situazione - fisica, come un ponte, oppure comportamentale come una battaglia, un volo, il funzionamento di uno stabilimento industriale - aveva già emesso dei segnali.
 I disastri - risulta quasi sempre agli investigatori ex post - hanno avuto una incubazione, più o meno lunga. Incubazione tutt’altro che muta, o col bavaglio, anzi spesso visibile per un complesso di segnali. Come ha insegnato, quarant’anni fa un illuminato e inascoltato Barry Turner, non sono prevenuti - ovvero fermati da decisioni pragmatiche - per le patologie della comunicazione tra gli attori di un sistema. Industriale, amministrativo, finanziario, politico: non importa la scala di grandezza. Le incompetenze si strutturano e agiscono come un sistema.
I disastri - risulta quasi sempre agli investigatori ex post - hanno avuto una incubazione, più o meno lunga. Incubazione tutt’altro che muta, o col bavaglio, anzi spesso visibile per un complesso di segnali. Come ha insegnato, quarant’anni fa un illuminato e inascoltato Barry Turner, non sono prevenuti - ovvero fermati da decisioni pragmatiche - per le patologie della comunicazione tra gli attori di un sistema. Industriale, amministrativo, finanziario, politico: non importa la scala di grandezza. Le incompetenze si strutturano e agiscono come un sistema.I segnali sono sfuggiti a un apparato cognitivo, a una mente capace di connetterli e perciò di abbattere le barriere che inibiscono il giudizio. È mancata la responsabilità di contrastare la universale ottusità dei sistemi, di tutti i sistemi organizzativi. Che squalificano la coscienziosità di chi abbia colto il segnale e si sia posto in modo attivo per spingere al provvedere.
 Egli finisce per scontrarsi con la gerarchia, con i muri levati su dai rituali dell’organizzazione, per impattare con la squalificazione che si replica davanti all’umile operatore che sta sul terreno e lì ’vede’ qualcosa che non va. Oppure c’è il feticcio della responsabilità di vertice. Chi è in alto - pensa il testimone dei segnali che il disastro sta inviando - lo capirà più e meglio di me.
Egli finisce per scontrarsi con la gerarchia, con i muri levati su dai rituali dell’organizzazione, per impattare con la squalificazione che si replica davanti all’umile operatore che sta sul terreno e lì ’vede’ qualcosa che non va. Oppure c’è il feticcio della responsabilità di vertice. Chi è in alto - pensa il testimone dei segnali che il disastro sta inviando - lo capirà più e meglio di me.Ma il superiore guarda al consenso e alle conferme di chi siede ancora più in alto di lui. E quest’ultimo rivolge la sua mente al mandato di chi è il supremo detentore di quel bene, di quella situazione, di quel dato potere. E tutto questo complesso di fattori cambia la prospettiva, perché il conformismo è più potente della psicologia della responsabilità.
 A meno che nella persona responsabile in situazione trovino nutrimento valori morali assoluti: che spingono ad assumersi il rischio personale di andare controcorrente, e di superare derisioni e ostracismo, di non farsi influenzare dal dispositivo di derivazione kantiana, «faccio quel che devo, accada quel che può».
A meno che nella persona responsabile in situazione trovino nutrimento valori morali assoluti: che spingono ad assumersi il rischio personale di andare controcorrente, e di superare derisioni e ostracismo, di non farsi influenzare dal dispositivo di derivazione kantiana, «faccio quel che devo, accada quel che può».Insomma, la responsabilità, invece di essere ispirata a valori trascendenti, si attesta alla procedura, al ’di fronte’, a quel che le regole gerarchiche - per esempio il mandato degli azionisti - hanno assegnato. E così si scambia la diversa posizione ricoperta nella piramide organizzativa con la diversità di valori etici e professionali di quanti operano in una struttura complessa: che invece, a rigore, sono unici e universali. Cioè per tutti. Nelle forze armate, dal piantone al generale; nelle autostrade, dall’operaio che passa il bitume all’amministratore delegato della infrastruttura. Unitarietà dei valori e trasparenza della comunicazione sono la speranza del «senno di prima». Potremmo dire l’intelligenza del Buon Samaritano che si prende carico della complessità della situazione e non trascura alcuna variabile.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
IL NOME DI DIO, SENZA GRAZIA ("CHARIS")! L’ERRORE FILOLOGICO E TEOLOGICO DI PAPA BENEDETTO XVI, NEL TITOLO DELLA SUA PRIMA ENCICLICA. Nel nome della "Tradizione"
IL NATALE DI GESU’: L’INCARNAZIONE SECONDO L’ IMMAGINAZIONE "TEANDRICA" DEL CATTOLICESIMO-COSTANTINIANO. Gianfranco Ravasi ne ripropone una sintesi e la presenta come "il realismo del nascere nella storia"!!!
LO STATO DEL FARAONE, LO STATO DI MINORITA’, E IMMANUEL KANT "ALLA BERLINA" - DOPO AUSCHWITZ
 "LEZIONE SU KANT" A GERUSALEMME: PARLA EICHMANN "PILATO", IL SUDDITO DELL’"IMPERATORE-DIO".
"LEZIONE SU KANT" A GERUSALEMME: PARLA EICHMANN "PILATO", IL SUDDITO DELL’"IMPERATORE-DIO".LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE.
PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!
 FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- LA QUESTIONE STIRNER: RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ. Note.19 agosto 2018, di Federico La Sala
RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ. Al di là dell’Egoismo etico e dello Stato etico .... *
La questione Stirner
di Armando Torno (Il Sole-24 Ore, Domenica, 06 maggio 2016)
- «La questione Stirner», a cura di Marcello Montalto, Ed. Mimesis, pagg. 224, euro 20,00
Quando a metà degli anni Quaranta dell’Ottocento in Germania uscì “L’Unico e la sua proprietà” di Max Stirner, pseudonimo di Johann Caspar Schmidt, la censura non intervenne. I funzionari che dovevano vigilare sulla circolazione delle idee ritennero l’opera incomprensibile, frutto di una mente folle, malata o qualcosa del genere; decisero perciò di non bloccarla, perché nessuna persona normale avrebbe potuto ricevere danno da questo professore di un istituto femminile di 39 anni. Il quale, dopo l’uscita del libro, avrebbe perso il posto.
L’”Unico” non passò inosservato. Marx ed Engels ne scrissero subito, anche se le loro pagine saranno pubblicate soltanto all’inizio del Novecento; la cerchia degli amici che con Stirner avevano seguito le lezioni di Hegel, non tacque; per le correnti anarchiche divenne ben presto un riferimento. Negli Stati Uniti Warren, in Francia Proudhon, in Russia Bakunin e poi Kropotkin, per ricordare alcuni classici riferimenti di questa corrente, tennero necessariamente conto di codeste pagine.
Un’opera che a volte si ripete ma che è sempre dominata da una tensione senza eguali. Si apre e si chiude con un’affermazione forte: “Io ho fondato la mia causa su nulla!”. E non è difficile incontrare frasi come questa: “Io che al pari di Dio e dell’umanità sono il nulla di ogni altro, io che sono il mio tutto, io che sono l’unico!”.
 Max Stirner distrugge la filosofia del suo tempo, esalta l’egoismo (“nessuna cosa mi sta a cuore più di me stesso!”), sbugiarda il potere, attacca ogni religione, propone qualcosa di irrealizzabile ma tutti i grandi lo mediteranno, a cominciare da Dostoevskij e Nietzsche.
Max Stirner distrugge la filosofia del suo tempo, esalta l’egoismo (“nessuna cosa mi sta a cuore più di me stesso!”), sbugiarda il potere, attacca ogni religione, propone qualcosa di irrealizzabile ma tutti i grandi lo mediteranno, a cominciare da Dostoevskij e Nietzsche.E oggi? Un libro, curato da Marcello Montalto e pubblicato da Mimesis con il titolo “La questione Stirner” (pp. 224, euro 20), raccoglie i primi critici dell’”Unico”. Si tratta di preziosi e poco noti testi ottocenteschi scritti da Moses Hess (un precursore del sionismo), Feuerbach, Kuno Fischer, Szeliga (ovvero Franz Zychlin von Zychlinski, che diventerà generale dell’armata prussiana) e le repliche dello stesso Stirner: mostrano tutti i fraintendimenti a cui fu soggetta l’opera e il suo autore.
Montalto ricorda nell’ampia e documentata introduzione che Stirner era tutt’altro che astratto dalla realtà e ignaro dei meccanismi sociali ed economici (critica di Hess), soprattutto rammenta un’intuizione di Carl Schmitt che in un giudizio lapidario e tagliente affermò: “Max sa qualcosa di molto importante. Sa che l’io non è più oggetto di pensiero”.
Che aggiungere? Fichte, il gran sacerdote dell’io, era morto da tempo e anche i dogmi della filosofia idealistica tedesca ormai avevano lasciato i cuori e abitavano soltanto nelle biblioteche. Stirner mostrò il mondo attuale: egoista, senza ideali, pronto a diventare nulla.
Egoismo etico. Sullo sfondo del problema dell’emancipazione umana, ritorno di interesse per il filosofo tedesco in un’epoca in cui la questione dell’individuo è ridiventata centrale
Quell’asociale di Stirner
di Michele Ciliberto (Il Sole-24 oRE, Domenica, 19.08.2018)
- L’Unico e la sua proprietà Max Stirner
 A cura di Sossio Giametta, testo
tedesco a fronte, Bompiani, Milano, pagg. 992, € 40
A cura di Sossio Giametta, testo
tedesco a fronte, Bompiani, Milano, pagg. 992, € 40
Alla morte di Hegel, come si sa, la sua scuola si spezzò in due tronconi : da un lato, la destra; dall’altro la sinistra, della quale fecero parte, con autonomia e originalità di pensiero, personalità di primissimo piano come Bruno Bauer, Carlo Marx, Max Stirner, autori di opere che hanno lasciato un solco profondo nella storia del pensiero del XIX secolo. Escono, in generale, tra la fine degli anni trenta e i primi anni quaranta, ed hanno in genere al centro la critica della religione , come principio di una riflessione generale sulla condizione umana. L’Unico di Stirner viene pubblicato nel 1844 (sul frontespizio si legge però 1845); la Tromba dell’ultimo giudizio contro Hegel ateo e anticristo. Un ultimatum, di Bauer, nel 1841, mentre al 1843 risale un’altra sua opera fondamentale, La questione ebraica che, a sua volta, è oggetto di una immediata , e dura, discussione da parte di Marx, il quale pur riconoscendo il valore dell’avversario, ne critica a fondo le tesi, alla luce delle posizioni messe a fuoco in un’altra opera essenziale di questo periodo, la Critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico. Qui Marx utilizza, e sviluppa sul piano politico, la critica che Feuerbach aveva rivolto alla filosofia hegeliana mettendo al centro della sua analisi il rovesciamento tra soggetto e predicato operato, a suo giudizio, da Hegel.
L ’essenza del cristianesimo, come si intitola il libro di Feuerbach, esce nel 1841 - lo stesso anno del testo di Bauer - ed ebbe uno straordinario successo. Come dice Federico Engels, molti anni dopo, leggendolo diventammo tutti “feuerbachiani”, rievocando il senso di liberazione che il testo di Feuerbach aveva generato in lui come in tutta la sua generazione.
 Del resto, basterebbe leggere la Critica della filosofia del diritto hegeliano o le pagine finali della Questione ebraica di Marx per comprendere in presa diretta quanto Feuerbach abbia inciso a fondo sui principali esponenti della sinistra
hegeliana, a cominciare proprio da Marx: la critica della politica e della concezione della figura del legislatore di Rousseau che chiude la Questione ebraica e la critica della filosofia hegeliana attuata nella Critica hanno come riferimento principale da un lato la concezione dell’uomo come “ente generico”; dall’altro, la critica del rovesciamento tra soggetto e predicato- entrambi architravi del pensiero di Feuerbach. Come a suo tempo dimostrò Cesare Luporini in un saggio memorabile, è Feuerbach l’interlocutore principale di Marx in questi testi.
Del resto, basterebbe leggere la Critica della filosofia del diritto hegeliano o le pagine finali della Questione ebraica di Marx per comprendere in presa diretta quanto Feuerbach abbia inciso a fondo sui principali esponenti della sinistra
hegeliana, a cominciare proprio da Marx: la critica della politica e della concezione della figura del legislatore di Rousseau che chiude la Questione ebraica e la critica della filosofia hegeliana attuata nella Critica hanno come riferimento principale da un lato la concezione dell’uomo come “ente generico”; dall’altro, la critica del rovesciamento tra soggetto e predicato- entrambi architravi del pensiero di Feuerbach. Come a suo tempo dimostrò Cesare Luporini in un saggio memorabile, è Feuerbach l’interlocutore principale di Marx in questi testi.In tutti questi pensatori - da Bauer a Marx a Stirner - il problema centrale è quello della emancipazione umana, con un conseguente spostamento della critica dal piano della religione a quello della politica. E questo sia per motivi sia teorici che di ordine storico: nel 1840 era asceso al trono di Prussia Federico Guglielmo IV, figura complessa e contraddittoria, che attutì, non valutandone le conseguenze, la censura sulla stampa, come conferma la nascita , in questo periodo, di riviste importanti ma nettamente critiche dell’esistente, quale la Reinische Zeitung, pubblicata a Colonia dal gennaio 1842 al marzo 1843, alla quale collaborano sia Marx che Stirner. Sono, questi, anni di straordinarie battaglie in Germania per l’emancipazione religiosa, politica e sociale.
Se il problema è quello della emancipazione si tratta però di comprendere di quale emancipazione abbia bisogno l’uomo, ed è qui che le strade divergono in modo radicale : per Bauer, nella Questione ebraica, l’emancipazione non deve essere dell’ebreo in quanto ebreo, ma dell’uomo in quanto uomo, e deve essere essenzialmente di tipo politico; per Marx l’emancipazione deve essere di ordine sociale: è solo agendo su questo piano che l’uomo può effettivamente emanciparsi, oltrepassando la separazione moderna tra stato e società civile, tra borghese e cittadino; per Stirner occorre andare al di là sia della politica e dello stato che della società, dello stesso concetto dei “diritti umani”- tutti fantasmi, spettri,astrattezze di cui liberarsi - assumendo come principio della liberazione il concetto dell’Unico, quale archetipo di una nuova concezione dell’uomo e del suo destino. A Stirner non interessano né la comunità, né la società: gli altri sono mezzi e strumenti da adoperare come proprietà del singolo.
Rispetto a interlocutori del calibro di Marx e Bauer, Stirner, stravolgendo in chiave individualistica “egoistica” e nihililistica il concetto moderno di potere, e connettendolo a quello di proprietà, si situa in un punto di vista totalmente altro, suscitando per la radicalità delle sue posizioni l’interesse di pensatori come Nietzsche, che ne riprende il concetto di volontà di potenza. Anche se - come ha scritto Roberto Calasso - è quella di Stirner «la vera “filosofia del martello” , che Nietzsche non sarebbe mai riuscito a praticare , perché troppo irrimediabilmente educato...».
«Si dice di Dio:”Nessun nome ti nomina”. Ciò vale anche per me: nessun concetto mi esprime, niente di ciò che di indica come mia essenza mi esaurisce: sono soltanto nomi..» . L’Unico di Stirner agisce solo per sè, situandosi al di fuori di qualunque apparato costruttivo: l’ Unico, se lo ritiene opportuno, può associarsi , ma il concetto di associazione è del tutto diverso da quello di stato, il quale non ha alcuna legittimità e al quale Stirner è totalmente avverso . Come è avverso al nazionalismo, al liberalismo, allo statalismo, al comunismo, ed anche all’umanismo....In Stirner il nihilismo si realizza in maniera compiuta :«Io - scrive, riprendendo un verso di Goethe - ho fondato la mia causa sul nulla..».
Si capisce che Marx nella Ideologia tedesca abbia sottoposto a una critica radicale il pensiero di San Max, come lo chiama : sono posizioni polari. Non è concepibile per Marx l’opposizione tra individuo e società, l’uomo si determina nei rapporti sociali. E si capisce anche perché Stirner abbia avuto fortuna presso posizioni di tipo anarco-individualistiche, ed anche perché il suo pensiero susciti particolare interesse in un tempo come il nostro nel quale sono in crisi tutti i principi “moderni“ contro cui Stirner conduce una lotta senza quartiere, e quella dell’individuo è ridiventata una questione centrale.
In questo senso, le sue pagine sono singolarmente attuali e possono essere rilette in modo nuovo, al di fuori di vecchi e nuovi pregiudizi . È stato perciò assai opportuno ripubblicare, con testo tedesco a fronte, questo grande libro nella “bella” e “fedele” traduzione di Sossio Giametta, che vi ha premesso anche una originale e limpidissima Introduzione. Stirner ha messo a fuoco aspetti della condizione umana che oggi, mentre un intero mondo si dissolve, appaiono in piena luce. Molto più di quanto sia apparso in passato. Come diceva il vecchio Hegel, è la fine che illumina il principio e il suo sviluppo.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). Un omaggio a Kurt H. Wolff e a Barrington Moore Jr.
"CHI" SIAMO NOI, IN REALTÀ. RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.
DONNE, UOMINI E VIOLENZA: "Parliamo di FEMMINICIDIO". Dalla democrazia della "volontà generale" alla democrazia della "volontà di genere". L’importanza della lezione dei "PROMESSI SPOSI", oggi.
CRITICA DELL’ECONOMIA TEOLOGICO-POLITICA. " Me ne stavo seduto pensieroso, misi da parte Locke, Fichte e Kant e mi dedicai a una profonda ricerca per scoprire in che modo una lisciviatrice può essere connessa al maggiorascato, quando mi trapassò un lampo (...)" (K. Marx, "Scorpione e Felice").
GIOACCHINO, DANTE, E LA "CASTA ITALIANA" DELLO "STATO HEGELIANO" - DELLO STATO MENTITORE, ATEO E DEVOTO ("Io che è Noi, Noi che è Io"). Appunti e note
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- DIAGNOSTICA E CIVILTA’. Che manutenzione puoi fare del tuo corpo se non sai di che cosa soffri? (Renzo Piano).17 agosto 2018, di Federico La Sala
Renzo Piano
“Genova è fragile ma nessuno la cura”
Intervista di Francesco Merlo (la Repubblica, 15.08.2018)
Renzo Piano era a Ginevra, a lavorare a un progetto per il Cern, quando hanno interrotto la riunione e gli hanno detto che a Genova era crollato il ponte Morandi: «Al di là del legame sentimentale con Genova ho provato una grande sofferenza, di quelle che arrivano all’improvviso e ti sconvolgono. A me prendono allo stomaco. Ho pensato subito alle vittime, e solo dopo alla mia città ferita, a Genova e alle sue catastrofi. Ho immaginato quella gente che passava di là a metà agosto, i camion e i furgoncini per lavoro, gli altri per vacanza, le famiglie allegre e innocenti, ho pensato agli occhi che, quando si passa su un ponte, sono ancora più aperti, perché c’è l’alto e c’è il basso, c’è la sospensione nel mezzo cielo».
E invece proprio il ponte, che accorcia le distanze, dà ordine e bellezza al paesaggio e mette allegria, è crollato di botto. Pioveva quando la linea retta si è spezzata e dunque niente polvere: macerie senza sassi e mattoni perché il cemento non rovina a terra come in una frana, ma collassa. Sembra una catastrofe chirurgica.
«Non esagero, ma è una morte ingiusta e orribile. E di che cosa sono vittime? Non è certo colpa della casualità né della topografia della fragile Genova. Io non so cos’è accaduto, non voglio sembrare arrogante, non ho elementi e non faccio certo polemiche. Posso dire però che non credo al fatalismo che considera incontrollabile l’anarchia della natura, dei fulmini e della pioggia. I ponti non crollano per fatalità. Nessuno dunque venga a dirci che è stata la fatalità».
Cattiva manutenzione?
«L’ho sempre visto sotto controllo, quel ponte, che ha una lunga storia di manutenzione e di stretta sorveglianza».
Però ha ceduto. E non è il primo in Italia.
«I ponti sono anche simboli. È orribile che crollino e che il crollo uccida. Ma un ponte che crolla, con quella fisica ha sempre una dimensione simbolica e dunque, quando crolla, è come se crollasse due volte».
Già, si alzano i muri e crollano i ponti. Una volta stabilito che non è fatalità, perché è crollato?
«All’opposto della fatalità c’è la scienza. L’Italia è un paese di grandi costruttori, progettisti geniali, scienziati umanisti. E però non applicano quella scienza che viene prima della manutenzione e si chiama diagnostica. In medicina nessuno fa niente senza una diagnosi. Che manutenzione puoi fare del tuo corpo se non sai di che cosa soffri? Come si stabilisce se hai bisogno di una cura di farmaci oppure di un’operazione chirurgica o magari di un po’ di riposo? Solo la precisione della diagnosi garantisce l’efficacia dell’intervento. E i ponti, le case e tutte le costruzioni vanno trattati come corpi viventi. In Italia produciamo apparecchiature diagnostiche sofisticatissime e strumentazioni d’avanguardia che esportiamo in tutto il mondo. Ma non li usiamo sulle nostre costruzioni. Perché? E non è un discorso di tecnica e basta. Solo con un approccio diagnostico si esce dal campo delle opinioni e si entra in quello delle certezze scientifiche».
La scienza non se la passa tanto bene, e forse vale per i ponti quel che vale per i vaccini. La catastrofe può insegnarci qualcosa?
«Io spero che il maledetto crollo di questo ponte ci faccia riflettere e ci faccia uscire dall’oscurantismo culturale del “secondo me si fa così”. Per esempio con la termografia possiamo determinare lo stato di salute di un muro senza neppure bucarlo, proprio come avviene con il corpo umano: si comincia col misurare le temperature delle sue varie parti».
Quel ponte vivente era un corpo affaticato.
«Io credo che la manutenzione non sia mai mancata. Ma Genova è una città fragile, divisa in due, ed è lunga 20 chilometri. Quel ponte è stato sollecitato all’inverosimile».
Adesso che è crollato forse la città di Genova ha bisogno di una diagnosi. Che succederà?
«Genova è una città portuale che deve trasferire il suo traffico pesante in tutte le direzioni. Non si può caricare la viabilità a dismisura sulla gomma. Non so cosa succederà. Per tenere assieme Levante e Ponente forse dovrebbero pensare a un incremento del trasporto sul ferro e sull’acqua. Ma questo è il momento del cordoglio e del lutto».
Ancora una volta per ragionare Genova ha bisogno del lutto?
«Difficile e straordinariamente bella, è una città molto fragile, stretta com’è tra il mare e le montagne subito alte. Ho già raccontato che i rivali veneziani nel Medioevo dicevano che Genova era una città sfortunata: montagna senza alberi e mare senza pesci. È verticale, ripida, rocciosa, con il fondale profondo e il mare agitato. Ma la topografia, come il cattivo tempo, non può diventare il capro espiatorio di ogni cosa».
Genova sa reagire?
«Ha già dimostrato di saper tenere la testa alta. Una città che passa attraverso le catastrofi ha bisogno di ritrovare subito competenze e amore. Altrimenti, come sta avvenendo in qualche parte d’Italia, si degrada e va in malora lo stare insieme: diventano peggiori gli uomini e anche gli animali. Le alluvioni, per esempio, hanno avviato un lungo lavoro di rinascita idrogeologica. Anche ieri, quando è crollato il ponte, pioveva, ed è normale che piova. Genova è una città dove l’acqua, dolce e salata, arriva da tutte le parti. Come sai, da bambino con la sabbia di Pegli costruivo castelli. Non è facile: bisogna scavare una buca, portarci l’acqua per impastare e rendere malleabile la sabbia e poi fare il castello in modo che l’onda, quando arriva, lo circondi ma non lo invada, lo bagni ma non lo inzuppi. Ci vuole molta intelligenza per governare l’acqua. Genova ha l’intelligenza per governare tutta se stessa e anche il proprio dolore. Sa usare le catastrofi per cambiare. Ha l’orgoglio di essere superba».
La superbia non era un peccato?
«Genova è superba non nel senso del gran peccato cattolico. Addossata sulla collina alpestre, Petrarca la battezzò Superba dal latino “super”: stare sopra. Dunque è fisicamente, prima che in metafora, che Genova ha l’orgoglio di essere superba».
Anche dopo il crollo del ponte?
«Purtroppo Genova, che sa reagire, non sa ancora prevenire. Ma spero che ora cominci la revisione del suo sistema dei trasporti. E mi auguro che parta dal crollo di questo ponte una seria riflessione sulla cultura diagnostica del patrimonio italiano. Solo conoscendo con esattezza lo stato di salute di tutte le nostre costruzioni possiamo proteggere e salvare, con i ponti, la nostra stessa civiltà».
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- IL MESSAGGIO EVANGELICO, IL PARADOSSO ISTITUZIONALE DEL MENTITORE, E LA CATASTROFE DELL’EUROPA: "RIPENSARE COSTANTINO"!!!14 agosto 2018, di Federico La Sala
IL MESSAGGIO EVANGELICO, IL PARADOSSO ISTITUZIONALE DEL MENTITORE, E LA CATASTROFE DELL’EUROPA.
 "PERCHE’ NON POSSIAMO NON DIRCI CRISTIANI", 0GGI.. In memoria di (Benedetto Croce), alcune note a margine del discorso di Papa Francesco, all’Angelus del 12 agosto 2018 d. C. ... *
"PERCHE’ NON POSSIAMO NON DIRCI CRISTIANI", 0GGI.. In memoria di (Benedetto Croce), alcune note a margine del discorso di Papa Francesco, all’Angelus del 12 agosto 2018 d. C. ... *- “(...) noi non siamo più sotto un pedagogo. Non c’è più giudeo né greco; non c’è più schiavo né libero; non c’è più uomo né donna, poiché tutti voi siete uno in Cristo Gesù” (Paolo, Galati 3, 25-28).
- "(...) non dimenticatevi di questo. Il cristiano non può essere ipocrita: deve vivere in maniera coerente" (Papa Francesco).
PAPA FRANCESCO
ANGELUS
 Piazza San Pietro
Piazza San Pietro
 Domenica, 12 agosto 2018
Domenica, 12 agosto 2018Cari fratelli e sorelle e cari giovani italiani,
buongiorno!
Nella seconda Lettura di oggi, San Paolo ci rivolge un pressante invito: «Non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, con il quale foste segnati per il giorno della redenzione» (Ef 4,30).
Ma io mi domando: come si rattrista lo Spirito Santo? Tutti lo abbiamo ricevuto nel Battesimo e nella Cresima, quindi, per non rattristare lo Spirito Santo, è necessario vivere in maniera coerente con le promesse del Battesimo, rinnovate nella Cresima. In maniera coerente, non con ipocrisia: non dimenticatevi di questo. Il cristiano non può essere ipocrita: deve vivere in maniera coerente. Le promesse del Battesimo hanno due aspetti: rinuncia al male e adesione al bene.
Rinunciare al male significa dire «no» alle tentazioni, al peccato, a satana. Più in concreto significa dire “no” a una cultura della morte, che si manifesta nella fuga dal reale verso una felicità falsa che si esprime nella menzogna, nella truffa, nell’ingiustizia, nel disprezzo dell’altro. A tutto questo, “no”. La vita nuova che ci è stata data nel Battesimo, e che ha lo Spirito come sorgente, respinge una condotta dominata da sentimenti di divisione e di discordia. Per questo l’Apostolo Paolo esorta a togliere dal proprio cuore «ogni asprezza, sdegno, ira, grida e maldicenza con ogni sorta di malignità» (v. 31). Così dice Paolo. Questi sei elementi o vizi, che turbano la gioia dello Spirito Santo, avvelenano il cuore e conducono ad imprecazioni contro Dio e contro il prossimo.
Ma non basta non fare il male per essere un buon cristiano; è necessario aderire al bene e fare il bene. Ecco allora che San Paolo continua: «Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo» (v. 32). Tante volte capita di sentire alcuni che dicono: “Io non faccio del male a nessuno”. E si crede di essere un santo. D’accordo, ma il bene lo fai? Quante persone non fanno il male, ma nemmeno il bene, e la loro vita scorre nell’indifferenza, nell’apatia, nella tiepidezza. Questo atteggiamento è contrario al Vangelo, ed è contrario anche all’indole di voi giovani, che per natura siete dinamici, appassionati e coraggiosi. Ricordate questo - se lo ricordate, possiamo ripeterlo insieme: “E’ buono non fare il male, ma è male non fare il bene”. Questo lo diceva Sant’Alberto Hurtado.
Oggi vi esorto ad essere protagonisti nel bene! Protagonisti nel bene. Non sentitevi a posto quando non fate il male; ognuno è colpevole del bene che poteva fare e non ha fatto. Non basta non odiare, bisogna perdonare; non basta non avere rancore, bisogna pregare per i nemici; non basta non essere causa di divisione, bisogna portare pace dove non c’è; non basta non parlare male degli altri, bisogna interrompere quando sentiamo parlar male di qualcuno: fermare il chiacchiericcio: questo è fare il bene. Se non ci opponiamo al male, lo alimentiamo in modo tacito. È necessario intervenire dove il male si diffonde; perché il male si diffonde dove mancano cristiani audaci che si oppongono con il bene, “camminando nella carità” (cfr 5,2), secondo il monito di San Paolo.
Cari giovani, in questi giorni avete camminato molto! Perciò siete allenati e posso dirvi: camminate nella carità, camminate nell’amore! E camminiamo insieme verso il prossimo Sinodo dei Vescovi. La Vergine Maria ci sostenga con la sua materna intercessione, perché ciascuno di noi, ogni giorno, con i fatti, possa dire “no” al male e “sì” al bene.
Dopo l’Angelus
Cari fratelli e sorelle,
rivolgo il mio saluto a tutti voi, romani e pellegrini provenienti da tante parti del mondo.
In particolare saluto i giovani delle diocesi italiane, accompagnati dai rispettivi Vescovi, dai loro sacerdoti ed educatori. In questi giorni, avete riversato per le strade di Roma il vostro entusiasmo e la vostra fede. Vi ringrazio per la vostra presenza e per la vostra testimonianza cristiana! E ieri, nel ringraziare, ho dimenticato di dire una parola ai sacerdoti, che sono quelli che vi sono più vicini: ringrazio tanto i sacerdoti, ringrazio per quel lavoro che fanno giorno per giorno, ringrazio per quella pazienza - perché ci vuole pazienza per lavorare con voi! La pazienza dei sacerdoti ... - ringrazio tanto, tanto, tanto. E ho visto anche tante suore che lavorano con voi: anche alle suore, grazie tante.
E la mia gratitudine si estende alla Conferenza Episcopale Italiana - qui rappresentata dal Presidente Cardinale Gualtiero Bassetti - che ha promosso questo incontro dei giovani in vista del prossimo Sinodo dei Vescovi.
Cari giovani, facendo ritorno nella vostre comunità, testimoniate ai vostri coetanei, e a quanti incontrerete, la gioia della fraternità e della comunione che avete sperimentato in queste giornate di pellegrinaggio e di preghiera.
A tutti auguro una buona domenica. Un buon rientro a casa. E per favore, non dimenticate di pregare per me! Buon pranzo e arrivederci!
* Appunti di commento sul tema, si cfr.:
- PAOLO COME "CRISTO": “(...) noi non siamo più sotto un pedagogo. Non c’è più giudeo né greco; non c’è più schiavo né libero; non c’è più uomo né donna, poiché tutti voi siete uno in Cristo Gesù” (Galati: 3, 25-28).
- CAPO E CORPO "MISTICO" - FORZA "CRISTO"!: "(...) vivendo secondo la verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa verso di lui, che è il capo, Cristo, dal quale tutto il corpo, ben compaginato e connesso, mediante la collaborazione di ogni giuntura, secondo l’energia propria di ogni membro, riceve forza per crescere in modo da edificare se stesso nella carità" (Paolo, Ef. 4,15-16)
- "CRISTO", ORDINE SACERDOTALE, E CHIESA: "È significativo che l’espressione di Tertulliano: "Il cristiano è un altro Cristo", sia diventata: "Il prete è un altro Cristo"" (Albert Rouet, arcivescovo di Poitiers, 2010.)
- SIMONE WEIL: "L’immagine del
corpo mistico di Cristo è molto seducente, ma l’importanza
che si annette oggi a questa immagine mi pare uno dei sintomi più gravi della
nostra decadenza. La nostra vera dignità infatti non sta nell’essere membra di
un corpo, anche se mistico, anche se quello di Cristo, ma in questo: nello stato
di perfezione, al quale tutti aspiriamo, noi non viviamo più in noi stessi, ma è
Cristo che vive in noi; in questa condizione, Cristo nella sua integrità, nella sua
unità indivisibile, diviene, in certo senso, ognuno di noi, come è tutto intero
nell’ostia. Le ostie non sono frammenti del suo corpo.
 L’importanza attuale dell’immagine del corpo mistico dimostra quanto i
cristiani siano miseramente esposti alle influenze esterne. certo inebriante
sentirsi membro del corpo mistico del Cristo: ma oggi molti altri corpi mistici,
che non hanno Cristo come capo, procurino alle proprie membra un’ebbrezza, a
mio parere, della stessa natura" (Simone Weil, 1942.)
L’importanza attuale dell’immagine del corpo mistico dimostra quanto i
cristiani siano miseramente esposti alle influenze esterne. certo inebriante
sentirsi membro del corpo mistico del Cristo: ma oggi molti altri corpi mistici,
che non hanno Cristo come capo, procurino alle proprie membra un’ebbrezza, a
mio parere, della stessa natura" (Simone Weil, 1942.)
KANT E SAN PAOLO. COME IL BUON GIUDIZIO ("SECUNDA PETRI") VIENE (E VENNE) RIDOTTO IN STATO DI MINORITA’ DAL GIUDIZIO FALSO E BUGIARDO ("SECUNDA PAULI").
IL MESSAGGIO EVANGELICO, IL PARADOSSO ISTITUZIONALE DEL MENTITORE, E LA CATASTROFE DELL’EUROPA. “Come fu possibile la hitlerizzazione dell’Imperativo Categorico di Kant? E perché è ancora attuale oggi?” (Emil L. Fackenheim, Tiqqun. Riparare il mondo).
 LA LEZIONE CRITICA DI KANT. Alcune luminose pagine da "La fine di tutte le cose"
LA LEZIONE CRITICA DI KANT. Alcune luminose pagine da "La fine di tutte le cose"GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- IL MESSAGGIO EVANGELICO, IL PARADOSSO ISTITUZIONALE DEL MENTITORE, E - IL TRADIMENTO STRUTTURALE DELLA FIDUCIA.16 agosto 2018, di Federico La Sala
SULLA PEDOFILIA, L’ALLARME DELLA RIVISTA "CONCILIUM" (3/2004) E IL COLPEVOLE SILENZIO DEL VATICANO.
- Poscritto di "Concilium", 3/2004: "La chiesa deve affrontare la questione di come (ri-)creare l’autorità del sacerdote. Tale questione non può essere intesa unicamente come questione dell’identità individuale di coloro che hanno scelto e continuano a scegliere il sacerdozio. È anche un interrogativo rivolto all’istituzione: la preparazione, la guida e il controllo dei sacerdoti nell’adempimento del loro ufficio sono una cosa, la conformazione strutturale delle interazioni tra sacerdoti e credenti un’altra, la questione teologico-ecclesiologica relativa alla forma della chiesa una terza. Noi, le curatrici di questo fascicolo, siamo teologhe. Siamo donne. Siamo madri. Non di rado, nella prospettiva delle strutture tradizionali della chiesa, stiamo “dall’altra parte”, per cui non siamo noi a decidere dove, di volta in volta, vadano tracciatii confini" (dal Poscrittum di "Concilium").
Preti pedofili, 70 anni di abusi in Pennsylvania coperti dalla ChiesaUn Grand giurì ha riconosciuto la colpa di 300 sacerdoti su oltre mille bambini *
Più di 300 sacerdoti sono accusati in Pennsylvania di aver commesso abusi sessuali su oltre mille bambini nel corso di settant’anni, coperti "sistematicamente" dai vertici della Chiesa cattolica. Un Gran giurì americano ha diffuso un rapporto di oltre 1.400 pagine, ritenuto il più articolato e globale pubblicato sinora sulla pedofilia nella Chiesa americana da quando il Boston Globe per la prima volta denunciò il problema in Massachusetts nel 2002, vincendo un premio Pulitzer e ispirando il film ’Spotlight’. Il dossier ha portato all’incriminazione di due preti, ma la maggioranza dei presunti responsabili è ormai morta e la gran parte dei fatti è prescritta.
L’indagine del Gran giurì è durata due anni ed è stata condotta in tutte le diocesi della Pennsylvania, fatta eccezione per due. Cita decine di testimoni e mezzo milione di pagine di informazioni della Chiesa, contenenti "accuse credibili contro oltre 300 preti predatori". Più di mille bambine e bambini che furono vittime di abusi sono identificabili, ma "il vero numero" è in realtà "nell’ordine delle migliaia", secondo il Grand giurì, perché molti bambini hanno avuto paura di denunciare o i loro dati sono andati perduti. Le vittime, afferma il dossier, sono state speso traumatizzate per la vita, finendo per abusare di droga e alcol, o per suicidarsi.
Tra i casi elencati c’è quello di un religioso che ha stuprato una bambina di 7 anni in ospedale, dopo che la piccola aveva subito una tonsillectomia. Un altro bambino bevve un succo di frutta e si svegliò il mattino dopo sanguinante dal retto, senza poter ricordare che cosa gli fosse accaduto. Un prete costrinse un bambino di 9 anni a praticargli sesso orale, poi gli lavò la bocca con l’acqua santa per "purificarlo". Un altro sacerdote abusò di cinque sorelle della stessa famiglia, tra cui una da quando aveva 18 mesi ai 12 anni. Quando una delle bambine lo disse ai genitori nel 1992, la polizia trovò nella casa del prete slip, bustine di plastica contenenti peli pubici, fiale d’urina e fotografie a sfondo sessuale di bambine. La Chiesa ignorò per anni le accuse e il sacerdote morì in attesa di processo, ha dichiarato il procuratore generale della Pennsylvania, Josh Shapiro.
"Lo schema era abuso, negazione e copertura", ha spiegato Shapiro, aggiungendo: "Come diretta conseguenza della sistematica copertura da parte delle alte autorità ecclesiastiche, quasi ogni caso di pedofilia che abbiamo rilevato è troppo datato per un processo". Sinora solo due preti sono stati incriminati per accuse che sono al di fuori della prescrizione: uno è accusato di aver eiaculato nella bocca di un bambino di sette anni e si è dichiarato colpevole, secondo la procura; l’altro ha aggredito due bambini, uno dei quali da quando aveva 8 anni per un periodo di otto anni, sino al 2010.
Il Gran giurì ha chiesto che la prescrizione per i reati di pedofilia sia cancellata, che le vittime abbiano più tempo per presentare denuncia e che sia rafforzata la legge che obbliga a denunciare gli abusi sessuali di cui si viene a conoscenza. "I preti stupravano bambine e bambini piccoli e gli uomini di Dio che erano responsabili per loro non solo non facevano nulla, ma nascondevano tutto. Per decenni", si legge nel rapporto. I religiosi anziani, al contrario, furono promossi e i preti pedofili poterono amministrare per 10, 20 e persino 40 anni dopo che i vertici erano venuti a conoscenza degli abusi e mentre la lista delle vittime si allungava sempre di più, ha detto Shapiro.
Negli Stati Uniti, sono tra 5.700 e 10mila i preti cattolici accusati di abusi sessuali, ma poche centinaia sono stati processati, dichiarati colpevoli e condannati, secondo Bishop Accountability. Da quando il problema della pedofilia nella Chiesa cattolica è diventato noto all’inizio degli anni 2000, la Chiesa americana ha speso più di 3 miliardi di dollari in patteggiamenti, secondo l’osservatorio. Questo ha documentato accordi con 5.679 presunte vittime del clero cattolico, solo un terzo delle 15.235 denunce che i vescovi hanno detto di aver ricevuto fino al 2009. Una stima ipotizza che le vittime negli Usa siano 100mila. Sotto la pressione dell’aumento di denunce nel mondo e delle continue critiche per la insufficiente risposta della Chiesa, papa Francesco nel 2013 ha promesso una nuova legge sulla pedofilia e pedopornografia. Anche in Cile la Chiesa è stata di recente travolta da accuse di vasta copertura di casi di pedofilia durante gli anni Ottanta e Novanta.
* Fonte: La Presse, Martedì 14 Agosto 2018
SULLA PEDOFILIA, L’ALLARME DELLA RIVISTA "CONCILIUM" (3/2004) E IL COLPEVOLE SILENZIO DEL VATICANO.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- METAFISICA, MISTICA, SCIENZA. Anassimandro batte Asterix, ma non i "visionari" dell’Uomo Supremo.13 agosto 2018, di Federico La Sala
METAFISICA E SCIENZA. L’ARCHIVIO DEGLI ERRORI. Anassimandro batte Asterix ... ma non i "visionari", i theorici dell’"uomo supremo"...*
L’invenzione della Natura Terremoti, eclissi, mareggiate e siccità sono lì a ricordarci la precarietà del tutto: come per i Galli dei fumetti, il timore che l cielo possa sempre cadere. Ma così non sarà, aveva scoperto il filosofo di Mileto nel VI secolo a.C.
Anassimandro batte Asterix
Anassimamdro si era cinvinto che l’universo fosse in espansione, forse in consegueza di una esplosione inizialr (il Big Bang?); e che gli uomini ferivassero dai pesci (Darwin?)
di Mauro Bonazzi (Corriere della Sera, La Lettura, 12.08.2018)
Nascere - venire all’essere, diventare qualcosa - è una colpa che verrà pagata con la morte. Questo, secondo Friedrich Nietzsche, giovane filologo a Basilea ancora sensibile alle sirene di Schopenhauer, insegnava il primo testo filosofico giunto fino a noi, un breve frammento di Anassimandro di Mileto: «Principio di tutte le cose non è né l’acqua né nessun altro dei cosiddetti elementi, ma una certa altra natura infinita, da cui tutto diviene (...): da ciò da cui è la generazione delle cose che sono, lì è anche la distruzione secondo il dovuto: esse scontano infatti la pena e il fio dell’ingiustizia secondo l’ordine del tempo».
 Poche parole, al cui fascino è difficile sottrarsi. Per Martin Heidegger, in fluenzato a sua volta da Nietzsche, costituivano la prova del fatto che la filosofia è nata grande, capace di affrontare fin da subito i problemi più importanti. Perché c’è qualcosa invece di nulla? Questa è la questione fondamentale. Perché esistono gli alberi, il mare, noi, io? Anassimandro non aveva posto solo la domanda; aveva anche offerto una prima risposta.
Poche parole, al cui fascino è difficile sottrarsi. Per Martin Heidegger, in fluenzato a sua volta da Nietzsche, costituivano la prova del fatto che la filosofia è nata grande, capace di affrontare fin da subito i problemi più importanti. Perché c’è qualcosa invece di nulla? Questa è la questione fondamentale. Perché esistono gli alberi, il mare, noi, io? Anassimandro non aveva posto solo la domanda; aveva anche offerto una prima risposta.C’è un principio primo, eterno, infinito, indistinto (chiamiamolo Dio; Anassimandro lo chiamava apeiron, il «senza limiti») in cui tutto riposa; la realtà, così come la vediamo intorno a noi (e di cui facciamo parte) si è formata staccandosi proprio da quel principio: un impulso incoercibile, una spinta potente, irrazionale e primordiale, spinge tutto a essere qualcosa. È la volontà di vivere, di cui parlava Schopenhauer. E non solo lui: lo schema di pensiero è molto più diffuso. La storia ebraica e poi cristiana degli angeli che si ribellano a Dio, o di Adamo ed Eva, non è molto diversa, e tanti altri paralleli, fin dalla lontana India, potrebbero essere aggiunti. Analoghe erano le conclusioni, del resto: questa colpa, la colpa di voler essere, prima o poi sarebbe stata punita. La nascita e la morte, l’essere e il non essere: ogni affermazione (di sé) è una negazione (dell’altro), ma giustizia prima o poi verrà fatta. Ecco la legge, tragica, che svela il segreto dell’esistenza. Una tesi affascinante, indubbiamente. Che però non c’entra nulla con Anassimandro.
Vissuto nel VI secolo a.C., di lui si è perso quasi tutto. Se ancora leggiamo qualche sua frase, è grazie al neoplatonico Simplicio (un personaggio di cui sarebbe bello raccontare le imprese: era uno dei sette filosofi fuggiti in Persia per fondare la città ideale di Platone, dopo che Giustiniano aveva chiuso la loro Accademia ad Atene nel 529 d.C.), che lo aveva citato, più di mille anni dopo.
 Il suo scritto, un imponente commento alla Fisica di Aristotele, fu poi pubblicato da Aldo Manuzio nel 1526 (e anche di queste imprese editoriali, e di quello che hanno significato per l’Europa, sarebbe bello ricordarsi), permettendo ai vari Nietzsche e Schopenhauer di appassionarsi ad Anassimandro. L’edizione di Manuzio, però, si fondava su un manoscritto lacunoso. Mancava una paroletta nell’ultima frase: «Essi scontano reciprocamente la pena e il fio dell’ingiustizia secondo l’ordine del tempo». Per quanto minuscola, l’aggiunta cambia tutto. Il conflitto non è più con il principio (Dio): riguarda l’universo, o meglio gli elementi che lo costituiscono. Anassimandro raccontava una storia completamente diversa.
Il suo scritto, un imponente commento alla Fisica di Aristotele, fu poi pubblicato da Aldo Manuzio nel 1526 (e anche di queste imprese editoriali, e di quello che hanno significato per l’Europa, sarebbe bello ricordarsi), permettendo ai vari Nietzsche e Schopenhauer di appassionarsi ad Anassimandro. L’edizione di Manuzio, però, si fondava su un manoscritto lacunoso. Mancava una paroletta nell’ultima frase: «Essi scontano reciprocamente la pena e il fio dell’ingiustizia secondo l’ordine del tempo». Per quanto minuscola, l’aggiunta cambia tutto. Il conflitto non è più con il principio (Dio): riguarda l’universo, o meglio gli elementi che lo costituiscono. Anassimandro raccontava una storia completamente diversa.Il mondo che si dispiega davanti a noi si organizza per opposizioni: il caldo e il freddo, la luce e il buio, l’acqua e il fuoco... il conflitto è tra questi opposti, gli elementi materiali costituenti, che sono come in guerra tra di loro. Il conflitto e il caos: il rischio è che l’universo intero collassi se uno degli elementi dovesse prevalere sugli altri. Era una paura ben presente nel mondo del mito, dove a ogni potenza naturale è associata una divinità, a cui occorre rivolgersi con preghiere e sacrifici perché conservi l’universo in questo suo equilibrio così precario. Terremoti, eclissi, mareggiate e siccità sono lì a ricordarci la precarietà del tutto: come per Asterix e Obelix, il timore è che il cielo possa sempre cadere, e tutto andare in frantumi. Così non sarà, spiega Anassimandro, forte della sua scoperta.
Scoprire significa vedere qualcosa che c’è, ma nessuno vedeva. È vero che la realtà si trasforma continuamente e che ogni trasformazione altro non è che l’affermarsi di una qualità e la temporanea soppressione del suo opposto. Ma la prevaricazione verrà riequilibrata nel corso del tempo, secondo una legge che regola eternamente queste opposizioni. È l’incessante alternanza del giorno e della notte, delle stagioni calde e fredde, e dei cicli astronomici che scandiscono la vita dell’universo. Questo ha visto Anassimandro, l’ordine che regola le trasformazioni.
Dimenticato il pensatore tragico, senza più bisogno di introdurre divinità arcane, quello che ora emerge è il cantore dei ritmi iscritti nel mondo dei contadini e dei mercanti. Un pensatore che confida esclusivamente nella sua capacità di osservare e ragionare.
 Non è più il tempo dei poeti che ripetono ispirati la parola della Musa: l’autorità di Anassimandro dipende unicamente dalla capacità di collegare correttamente i fenomeni, offrendo spiegazioni plausibili. Il risultato è la scoperta della «natura», la presa d’atto che questo immenso universo che ci circonda è qualcosa di unico, omogeneo, in cui tutto si tiene, secondo leggi e costanti. All’instabilità permanente del mito si sostituisce l’idea di uno spazio stabile e regolare - uno spazio «naturale» per cui non servono interventi arbitrari, esterni, «soprannaturali».
Non è più il tempo dei poeti che ripetono ispirati la parola della Musa: l’autorità di Anassimandro dipende unicamente dalla capacità di collegare correttamente i fenomeni, offrendo spiegazioni plausibili. Il risultato è la scoperta della «natura», la presa d’atto che questo immenso universo che ci circonda è qualcosa di unico, omogeneo, in cui tutto si tiene, secondo leggi e costanti. All’instabilità permanente del mito si sostituisce l’idea di uno spazio stabile e regolare - uno spazio «naturale» per cui non servono interventi arbitrari, esterni, «soprannaturali».Non è un’intuizione da poco. La filosofia nasce così, insegnando a guardare, a riconoscere la trama che innerva lo spettacolo (questo significa theoria in greco) dell’universo, la regolarità che ricompone in un ordine dinamico ciò che all’occhio inesperto appare caotico e instabile.
Se lo avesse incontrato, Anassimandro non avrebbe compreso il senso della domanda di Heidegger. Per i Greci, l’universo esiste da sempre per sempre, eternamente. Inutile dunque chiedersi perché c’è l’essere e non il niente. Molto più proficuo, e interessante, è individuare le leggi che regolano la vita dell’universo e raccontarne la storia. Si sarebbe insomma sentito più vicino a un filosofo della scienza come Karl Popper, che infatti proprio in lui e negli altri presocratici aveva trovato i precursori degli scienziati contemporanei, uniti dallo stesso desiderio di comprendere, descrivere e spiegare. È una buona presentazione di quello che faceva Anassimandro: osservando le maree e le orbite dei pianeti si era convinto che l’universo è in espansione, con gli elementi caldi che si allontanano progressivamente da quelli freddi, forse in conseguenza di un’esplosione iniziale.
- Visioni Anassimandro teorico del Big Bang? O primo darwinista, visto che sosteneva anche che gli uomini derivano dai pesci?
Di certo la passione di indagare e conoscere è la stessa. Aveva anche concepito la prima mappa dell’universo, con la Terra (a forma di cilindro, non piatta) al centro, circondata da una serie di anelli concentrici, delle stelle, del sole, della luna, secondo proporzioni geometriche ben definite. Un universo non solo uniforme ma anche elegante, insomma (e una prima versione del modello che il lettore italiano ritroverà nella Divina Commedia).
Tutto chiaro, dunque?
Prima di entusiasmarsi per i presocratici Popper si era formato discutendo con i membri del Circolo di Vienna, che si erano proposti l’obiettivo di fare chiarezza da tutte le astruserie della metafisica (Heidegger, tanto per cambiare, era il bersaglio privilegiato). Enunciati e domande che non rappresentano stati di fatti di ordine fisico, oggettivamente verificabili, non possono essere detti né veri né falsi, sono privi di senso: non trasmettono alcuna conoscenza e per questo bisogna starne lontani.
 Ludwig Wittgenstein, il nume tutelare del circolo, lo aveva spiegato con la consueta chiarezza. «Non come il mondo è, è il Mistico, ma che esso è»: come il mondo è, ecco qualcosa che possiamo descrivere e spiegare; che (perché) il mondo è (esiste), invece no; è qualcosa di cui non ha perciò senso parlare (è il Mistico, nel suo vocabolario): «Se una domanda può porsi, può avere anche una risposta»; «su ciò di cui non si può parlare, si deve tacere». Davvero?
Ludwig Wittgenstein, il nume tutelare del circolo, lo aveva spiegato con la consueta chiarezza. «Non come il mondo è, è il Mistico, ma che esso è»: come il mondo è, ecco qualcosa che possiamo descrivere e spiegare; che (perché) il mondo è (esiste), invece no; è qualcosa di cui non ha perciò senso parlare (è il Mistico, nel suo vocabolario): «Se una domanda può porsi, può avere anche una risposta»; «su ciò di cui non si può parlare, si deve tacere». Davvero?Anassimandro aveva offerto una prima descrizione «scientifica» dell’universo. Aveva per primo intuito che l’universo è un tutto organico, regolato da leggi e costanti. Alcune domande, però, rimanevano aperte. Perché ci sono queste leggi, chi garantisce per il loro funzionamento? Forse il misterioso apeiron, quel principio indeterminato, oscuro e infinito, da cui tutto proviene e a cui tutto torna? Ma questo non significa reintrodurre con parole diverse problematiche teologiche? Non è soltanto un problema storiografico (ricostruire le tesi di Anassimandro in proposito); è un’altra versione del solito problema: ma perché ci sono le cose - gli alberi e i pianeti, io e tu? Da dove arrivano e dove vanno?
Domande oziose, per cui probabilmente non si troverà mai una risposta ultima. Ma di cui è difficile fare a meno: «L’impulso al Mistico - scriveva lo stesso Wittgenstein il 15 maggio 1915 - viene dalla mancata soddisfazione dei nostri desideri da parte della scienza. Noi sentiamo che una volta che tutte le possibili domande scientifiche hanno avuto risposta, il nostro problema non è ancora neppure stato toccato». È un’affermazione fin troppo severa: senza l’aiuto di chi ci guida nella comprensione di quello che accade intorno a noi, non potremmo veramente godere dello spettacolo dell’universo e iniziare a interrogarci su noi stessi.
Così Platone e Aristotele sostenevano che la filosofia vive della meraviglia, nella consapevolezza che le cose non sono mai come credevamo. Alla fine del suo percorso anche Wittgenstein era arrivato a conclusioni analoghe: «Mi meraviglio per l’esistenza del mondo». Imparare a meravigliarsi, consapevoli che tanto maggiori saranno le scoperte tanto più numerosi saranno i problemi che dovremo affrontare: probabilmente non c’è esperienza più bella per noi esseri umani, sempre in cerca di significati, ma anche sempre esposti al rischio di ricadere nelle superstizioni di Asterix. Per questo servono le scoperte degli scienziati, ma anche le domande dei filosofi. Meglio ricordarsene, visto che il viaggio promette di essere ancora lungo.
* Sul tema, nel sito, si cfr.:
LA VIA DI KANT: USCIRE DALLA CAVERNA, E NON RICADERE NELL’ILLUSIONE DI “DIO” CONCEPITO COME “UOMO SUPREMO”. Note per una rilettura della “Storia universale della natura e teoria del cielo”
COSMOLOGIA E ANTROPOLOGIA. AL DI LA’ DI NEWTON, CON KANT - E ARTHUR S. EDDINGTON ... e Popper
 ALBERT EINSTEIN, LA MENTE ACCOGLIENTE. L’universo a cavallo di un raggio di luce (non di un manico di scopa!)
ALBERT EINSTEIN, LA MENTE ACCOGLIENTE. L’universo a cavallo di un raggio di luce (non di un manico di scopa!)L’ARCHIVIO DEGLI ERRORI: L’ "IO SONO" DI KANT E L’ "IO SONO" DELL’"UOMO SUPREMO" DEI "VISONARI" DELLA TEOLOGIA POLITICA ATEA E DEVOTA. Note per una rilettura della "Critica della Ragion pura" (e non solo)
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- LA POTENZA DEL DESIDERIO. NOTE DI ANTROPOLOGIA SUL FENOMENO DELLE "STELLE CADENTI".12 agosto 2018, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA E ANTROPOLOGIA RELIGIOSA. FIGLI E FIGLIE DEL SOLE, FIGLI E FIGLIE DELLE STELLE. LA POTENZA DEL DE-SIDER-IO... *
- "Duemila anni fa, un ovulo fu miracolosamente fecondato dall’azione soprannaturale di Dio, da questa meravigliosa unione risultò uno zigote con un patrimonio cromosomico proprio. Però in quello zigote stava il Verbo di Dio"(dichiarazione del Cardinale Dario Castrillon Hoyos alla XV conferenza internazionale del Pontificio consiglio, la Repubblica del 17 novembre 2000, p. 35)
ANTICHI RITORNI
Stelle cadenti? ’Lacrime’ sì... ma non del genere che credete
Perché agli astri è connesso il ’desiderium’. A ben guardare la tradizione cristiana ha soppiantato una credenza pagana, molto più antica ma meno ‘romantica’.
di Alba Subrizio *
Mi perdoneranno i nostri lettori se ho deciso di riproporvi un articolo del nostro blog di qualche anno fa, ma la data (il 12 agosto) ’obbliga’ a parlarne. Sono queste, infatti, le sere in cui siamo tutti con il naso all’insù per vedere di cogliere qualche stella cadente; innamorati, scaramantici, speranzosi o scettici che siano semplicemente desiderosi di osservare il fenomeno astrale, tutti sperano di carpire almeno una delle scie luminose che attraversano la volta celeste in queste calde notti estive.
Non è un caso che alla ‘caduta’ di una stella sia connesso l’esprimere un desiderio, se è vero - come è vero - che il concetto di ‘desiderio’, in quanto brama di qualcosa, è intrinsecamente ed etimologicamente connesso agli astri, dal momento che la parola latina “desiderium” deriva dalla preposizione de (indicante movimento dall’alto verso il basso) + sidus, sideris (ossia “stella”, “astro”), ossia il desiderio è propriamente “ciò che viene dalle stelle”.
Si è soliti pertanto, nella cultura odierna, confessare i propri sogni alla volta celeste, sperando che questi presto o tardi possano avverarsi. Si tratta del fenomeno delle Perseidi, lo sciame meteoritico, così chiamato perché gravitante nella costellazione di Perseo, che ogni anno, orbitando intorno al sole dal 10 al 20 agosto (con picco il 12), è visibile dalla Terra. Nella cultura cristiana e popolare tale ‘sciame’ è noto anche come lacrime di San Lorenzo, dal nome del santo martirizzato sulla graticola, che si festeggia in tale data.
A ben guardare però la tradizione cristiana ha soppiantato una credenza pagana, molto più antica ma meno ‘romantica’. Ebbene, è da premettere che il mese di Augustus, dedicato appunto all’imperatore Ottaviano Augusto, è uno dei mesi dove si celebravano la maggior parte delle feste legate al mondo agricolo, alla coltivazione dei campi, alle fertilità dunque; feste che spesso erano accompagnate da processioni durante le quali aveva luogo la cosiddetta “fescennina iocatio”, ovvero la ‘facezia fescennina’. I fescennini erano, difatti, dei versi mordaci a sapore volgare ed erotico che alludevano al “fascinum”, termine che nella lingua latina aveva una certa ambivalenza, poiché significava sia “malocchio” (da cui il nostro ‘fascinatura’) sia “membro virile”; non è un caso che ad essere portato in processione era l’enorme fallo del dio Priapo.
Orbene, i nostri antenati romani associavano il fenomeno astrale del passaggio delle Perseidi a ben altro genere di ‘lacrime’, o per meglio dire ‘gocce’: quelle dovute alla eiaculazione del seme del dio della fertilità. E voi, ce l’avete un desiderio irrealizzabile? Provate magari a pregare Priapo e a sperare di vederne il seme.
Alba Subrizio
 Biografia: «E quel giorno che ha potere solo sul mio corpo e su null’altro, ponga pure fine, quando vorrà, alla mia vita. Con la miglior parte di me volerò eterno al di sopra degli astri e il mio nome non si potrà cancellare, fin dove arriva il potere di Roma sui popoli soggiogati, là gli uomini mi leggeranno, e per tutti i secoli vivrò della mia fama...». Così Publio Ovidio Nasone conclude il suo capolavoro “Le Metamorfosi”; sulla scia del grande Sulmonese. E, allora, eccomi qui a raccontarvi di miti, eziologie e pratiche del mondo antico... che fanno bene anche oggi.
Biografia: «E quel giorno che ha potere solo sul mio corpo e su null’altro, ponga pure fine, quando vorrà, alla mia vita. Con la miglior parte di me volerò eterno al di sopra degli astri e il mio nome non si potrà cancellare, fin dove arriva il potere di Roma sui popoli soggiogati, là gli uomini mi leggeranno, e per tutti i secoli vivrò della mia fama...». Così Publio Ovidio Nasone conclude il suo capolavoro “Le Metamorfosi”; sulla scia del grande Sulmonese. E, allora, eccomi qui a raccontarvi di miti, eziologie e pratiche del mondo antico... che fanno bene anche oggi.* Il Mattino di Foggia, 12/08/2018
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- PROVANDO E RIPROVANDO. LA STELLA E IL NARDO...
LA VIA DI KANT: USCIRE DALLA CAVERNA, E NON RICADERE NELL’ILLUSIONE DI “DIO” CONCEPITO COME “UOMO SUPREMO”. Note per una rilettura della “Storia universale della natura e teoria del cielo”
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- "UNA MOBILITAZIONE CULTURALE GENERALE, SUBITO - ORA". MEMORIA DI SIMONE WEIL E DI ALESSANDRO LEOGRANDE.11 agosto 2018, di Federico La Sala
IL CAPO, IL CORPO MISTICO, E IL POPULISMO... OGGI
di Federico La Sala *
PER NON PERDERE LA PRECISAZIONE DI LEOGRANDE su SIMONE WEIL, ri-pesiamo con calma le sue parole: «Simone Weil criticava aspramente il partito giacobino-staliniano (e il modellarsi su quella forma anche dei partiti nati in un solco culturale e politico diverso). Criticava l’asservimento dei singoli militanti al volere del Capo, il sacrificare la capacità di discernimento di ogni singolo eletto sull’altare di quella che è invece la volontà che discende dall’alto dei gruppi parlamentari o del comitato centrale o del sommo leader. Il pensare “partitico”, nel momento in cui sostituisce a ogni criterio di Giustizia e Verità, cioè di pensiero autonomo e disinteressato, quello del successo del partito medesimo (contro tutti gli altri partiti) conduce in un vicolo cieco.
 [...] La cosa che Simone Weil temeva, aggiunge Leogrande, è il fuoco della demagogia, cioè la capacità di alcune forze politiche (soprattutto di quelle che vogliano abbattere tutto, per poi edificare una nuova era) di essere straordinari moltiplicatori di torbide passioni collettive. Come? Con un uso sapiente della propaganda e della persuasione, che sono diametralmente opposte alla comunicazione reale tra persone, al discernimento dei problemi concreti». Il suo scritto (http://www.minimaetmoralia.it/wp/beppe-grillo-simone-weil/) è del 2012 ("Orwell").
[...] La cosa che Simone Weil temeva, aggiunge Leogrande, è il fuoco della demagogia, cioè la capacità di alcune forze politiche (soprattutto di quelle che vogliano abbattere tutto, per poi edificare una nuova era) di essere straordinari moltiplicatori di torbide passioni collettive. Come? Con un uso sapiente della propaganda e della persuasione, che sono diametralmente opposte alla comunicazione reale tra persone, al discernimento dei problemi concreti». Il suo scritto (http://www.minimaetmoralia.it/wp/beppe-grillo-simone-weil/) è del 2012 ("Orwell").UNA MOBILITAZIONE CULTURALE GENERALE, SUBITO - ORA (http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=3429). E’ una mia "memoria" del 2008
*
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! - AL DI LA’ DELLA "DIALETTICA DELLA SOLITUDINE": "L’ARCISENSO" (Aldo Masullo). Note10 agosto 2018, di Federico La Sala
FILOSOFIA E ANTROPOLOGIA.
- L’Arcisenso. Dialettica della solitudine
La solitudine come humus del bisogno di comunicare
di Giorgio Agnisola («Avvenire», 24 luglio 2018)
I1 titolo, peraltro suggestivo, dell’ultimo libro di Aldo Masullo, L’Arcisenso, può far supporre una disamina attorno ai disperanti sensi dell’incomunicabilità. In realtà il novantaseienne filosofo italiano declina nella sua opera una differente definizione della solitudine, essendo al centro della sua riflessione i concetti di relazione e intersoggettività, da sempre suoi luoghi di approfondita indagine. Nello specifico il libro raccoglie scritti di epoche differenti opportunamente rivisti, puntando l’autore, in definitiva, a una sintesi del suo pensiero.
In principio Masullo pone il significato di "paticità". Essa muove, secondo il filosofo, ogni atto e sentire umani. «Nulla si compie, nulla avviene nella coscienza se non nel segno del patire». In questo senso gioia e dolore sono facce di una stessa essenza umana; «sicché questo patire, diciamo sentire profondamente implicato col sentirsi, con il sensus sui, è unico e inviolabile. Io posso dire al mio simile ciò che penso, posso spiegarmi e spiegare, posso in sostanza comunicare, ma non posso trasmettere a chi mi ascolta, pur desiderandolo, il mio personale sentire». «Toccare un altro non è toccarlo ma sentirsi mentre lo si tocca».
 In sostanza non si esiste, scrive Masullo, se non si sente di esistere, ma il sentire dell’altro mai io posso sentirlo. Il mio sentire resta incomunicabile, ostinatamente e imprescindibilmente legato al mio sé: dunque «Il sentir-si, l’Arcisenso, è l’Intoccabile».
In sostanza non si esiste, scrive Masullo, se non si sente di esistere, ma il sentire dell’altro mai io posso sentirlo. Il mio sentire resta incomunicabile, ostinatamente e imprescindibilmente legato al mio sé: dunque «Il sentir-si, l’Arcisenso, è l’Intoccabile».Da qui la solitudine di leopardiana memoria (a Leopardi l’autore dedica un affascinante capitolo), il sentire la solitudine del sentirsi. Che non è dunque solo una condizione dello spirito, ma anche un’esperienza del corpo. L’attitudine morale e lo stesso valore della politica, afferma Masullo, derivano da questo principio. Ora questa solitudine può condurre al male, può corrompersi nell’odio e cedere alla castrante paura dell’intimità. Ma può essere una preziosa chance.
 La solitudine infatti, scrive ancora il filosofo, può dirsi in definitiva una condizione positiva della natura umana, giacché dalla solitudine deriva il bisogno di comunicare, di cercare strategie di convivenza, di operare nel sociale, di condividere.
La solitudine infatti, scrive ancora il filosofo, può dirsi in definitiva una condizione positiva della natura umana, giacché dalla solitudine deriva il bisogno di comunicare, di cercare strategie di convivenza, di operare nel sociale, di condividere.
 Con questa premessa Masullo rilegge temi fondanti della filosofia contemporanea, come il relativismo, a cui assegna un valore politico. Il relativismo, afferma il filosofo, viene sovente letto in termini negativi. Viceversa «è proprio dalla certezza del relativo che può nascere la volontà, il bisogno di una strategia di adattamento e di mediazione».
Con questa premessa Masullo rilegge temi fondanti della filosofia contemporanea, come il relativismo, a cui assegna un valore politico. Il relativismo, afferma il filosofo, viene sovente letto in termini negativi. Viceversa «è proprio dalla certezza del relativo che può nascere la volontà, il bisogno di una strategia di adattamento e di mediazione».Il conclusivo capitolo del libro dal titolo «Nei labirinti della soggettività» ha un valore emblematico. In esso il filosofo recupera la storia della sua ricerca in una prospettiva autobiografica. Sembrerebbe un capitolo eccentrico rispetto al contesto dell’opera. In realtà scorrendolo si comprende che esso fa da legante al testo, in qualche misura ne spiega i nessi, tra tema e tema, e li riassume nel profondo della straordinaria storia umana del maestro.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
Questione antropologica
 IL PROGRAMMA DI KANT. DIFFERENZA SESSUALE E BISESSUALITA’ PSICHICA: UN NUOVO SOGGETTO, E LA NECESSITA’ DI "UNA SECONDA RIVOLUZIONE COPERNICANA".
IL PROGRAMMA DI KANT. DIFFERENZA SESSUALE E BISESSUALITA’ PSICHICA: UN NUOVO SOGGETTO, E LA NECESSITA’ DI "UNA SECONDA RIVOLUZIONE COPERNICANA"."CHI" SIAMO NOI, IN REALTÀ. RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.
Federico La Sala
- L’Arcisenso. Dialettica della solitudine
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- La cultura batta un colpo (di Guido Crainz).6 agosto 2018, di Federico La Sala
L’EUROPA, OGGI: HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA ....
La società civile
La cultura batta un colpo
Di fronte ai nazionalismi gli intellettuali devono con urgenza risvegliare nei loro Paesi il sogno dell’Europa
di Guido Crainz (la Repubblica, 06.08.2018)
Forse c’è una ragione se una parte non piccola del mondo culturale appare oggi impotente e quasi attonita di fronte alla crisi sempre più drammatica dell’Europa: forse di quella crisi ha anch’essa responsabilità non lievi. Forse al fondo non vi sono solo responsabilità politiche (certamente enormi) ma anche inadeguatezze e inerzie della cultura, incapace di accompagnare il processo di unificazione con un radicale salto di qualità nel confronto e nella circolazione di idee. Nella costruzione di uno sguardo comune sul futuro e al tempo stesso sulle ferite e sulle lacerazioni del passato.
Anche per pigrizie e passività della cultura, forse, i due momenti che sembrarono sancire il coronamento di un sogno - l’avvio dell’euro e poi l’allargamento del 2004 - segnarono in realtà l’inizio del suo incrinarsi. Era stato inevitabile - annotava vent’anni fa Ezio Mauro su queste pagine - « avviare l’unificazione attraverso l’unico comun denominatore oggi possibile, quello della moneta » , ma era urgente « dare un contesto istituzionale, culturale e politico a questa moneta. Perché rappresenti l’Europa e non soltanto un gruppo di Paesi comandati da una banca».
Il compito divenne ancor più necessario dopo l’allargamento del 2004, e fu disatteso ancor più gravemente: eppure entravano allora nell’Unione parti decisive di un Occidente che era stato a lungo "sequestrato" dall’Urss, per dirla con Milan Kundera, e largamente abbandonato dal resto dell’Europa (o che tale si sentiva).
Vi entravano Paesi che non avevano conosciuto reali democrazie neppure prima dei regimi comunisti, ove si eccettui la Cecoslovacchia fra le due guerre. E proprio la vicenda del " gruppo di Visegrád" ci fa cogliere nodi irti, perché esso non nasce " contro l’Europa". Tutt’al contrario, nasce nel 1991 come strumento per l’allargamento della costruzione europea, promosso da figure come Václav Havel e Lech Walesa: quando è iniziato il processo inverso? Su quali errori politici e su quali scelte economiche inadeguate, su quali cecità e chiusure esso ha potuto prosperare?
Appaiono oggi drammaticamente profetiche le parole pronunciate nel 1990 al Senato polacco da Bronislaw Geremek, uno dei principali dirigenti di Solidarnosc. Nei nostri Paesi post-comunisti, osservava, c’è oggi euforia per una libertà riconquistata ma vi è al tempo stesso «un senso di debole radicamento delle istituzioni democratiche e del pensiero democratico » . E aggiungeva:
 «Tre pericoli accompagnano in questa fase transitoria i Paesi che si sono liberati dalla dittatura comunista. Il primo è il populismo, che ha un naturale terreno di coltura nelle esperienze vissute finora da tali società e si fonda sulle illusioni egualitarie.
«Tre pericoli accompagnano in questa fase transitoria i Paesi che si sono liberati dalla dittatura comunista. Il primo è il populismo, che ha un naturale terreno di coltura nelle esperienze vissute finora da tali società e si fonda sulle illusioni egualitarie.
 Il secondo è la tentazione di instaurare governi dalla mano forte, particolarmente avvertita nelle società post-comuniste proprio perché in esse le istituzioni democratiche sono deboli. Il terzo è il nazionalismo ».
Il secondo è la tentazione di instaurare governi dalla mano forte, particolarmente avvertita nelle società post-comuniste proprio perché in esse le istituzioni democratiche sono deboli. Il terzo è il nazionalismo ».
 Sino ad ora, concludeva, il sentimento nazionale è stato un elemento naturale di solidarietà e di resistenza all’oppressione sovietica ma ora può «deformarsi e diventare nazionalismo e sciovinismo ».
Sino ad ora, concludeva, il sentimento nazionale è stato un elemento naturale di solidarietà e di resistenza all’oppressione sovietica ma ora può «deformarsi e diventare nazionalismo e sciovinismo ».Alcuni nodi sono tratteggiati qui in modo straordinario, e si aggiungano le ferite del passato: non ha certo pesato poco in Ungheria il trattato di Trianon - evocato sabato da Cuperlo - che dopo la Prima guerra mondiale l’ha amputata di ampie parti ( si legga almeno il Sándor Márai di "Volevo tacere"), o in Cecoslovacchia quel patto di Monaco che aprì la via ad Hitler ( il primo " tradimento dell’Europa", seguito dall’inerzia di fronte al colpo di stato comunista del 1948 e poi di fronte all’invasione dell’agosto di cinquant’anni fa).
Se questo è vero, è anche nella costruzione di uno sguardo comune sul futuro e sul passato che dobbiamo procedere, in un confronto molto più aperto e continuo di quello attuale: molto più capace di superare le deformazioni e di rispondere realmente alle differenti memorie nazionali. O a veri e propri vuoti di conoscenza. È un compito di lungo periodo, naturalmente, ma è decisivo avviare subito una radicale inversione di tendenza rispetto a troppe pigrizie intellettuali: l’avvicinarsi di elezioni europee cruciali, giustamente evocato dall’appello di Cacciari e di altri, ne aumenta l’urgenza.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
EICHMANN A GERUSALEMME (1961). “come fu possibile la hitlerizzazione dell’Imperativo Categorico di Kant? E perché è ancora attuale oggi?” (Emil L. Fackenheim, Tiqqun. Riparare il mondo).
 HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI.
HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI.Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! - "Questo tempo italiano è specialmente difficile perché ci mette davanti a due volti (e due narrazioni) dell’Italia, che invece o è una o non è" (Marco Tarquinio,6 agosto 2018, di Federico La Sala
DUE VOLTI (E DUE NARRAZIONI) DELL’ITALIA - E DELLA CHIESA. Quale avvenire? *
- Questo tempo italiano è specialmente difficile perché ci mette davanti a due volti (e due narrazioni) dell’Italia, che invece o è una o non è. (Marco Tarquinio, 4 agosto 2018).
La deriva della xenofobia
Senza vergogna
di Marco Tarquinio (Avvenire, sabato 4 agosto 2018)
Stiamo attraversando un tempo difficile, duro e bello come ogni tempo difficile, amaro come ogni tempo in cui nel nome di una Legge solo proclamata e di doveri solo parolai, e che ignorano e stritolano i diritti dei più deboli, si mette in questione l’umanità e l’uguaglianza stessa degli esseri umani. Senza vergogna. Ma la fragilità e la dignità della vita, di ogni vita umana, non si riconoscono dal passaporto e non si possono prendere in alcun modo in ostaggio. E le leggi non si applicano solo per stanare e "fermare" lo straniero, ma come ha sottolineato anche la nostra lunga inchiesta sul caporalato per far sì che chi è straniero di origine e italiano di lavoro non venga incluso e integrato soltanto nel (e dal) "lato oscuro" del nostro Paese.
È in tempi proprio come questi che a noi cristiani è chiesto di dare ragione in modo più limpido della nostra speranza. Ma non è un dovere solo nostro. Perché a tutti - ma proprio a tutti - è laicamente chiesto, se vogliamo tener saldo il patto di civile convivenza e la misura comune che contiene le nostre differenze e le compone in armonia, di sentirci impegnati a tener care e preservare le radici (troppo a lungo negate o date per scontate) dell’umanesimo che dà linfa, forza e capacità inclusiva alla nostra civiltà comune.
Questo tempo italiano è specialmente difficile perché ci mette davanti a due volti (e due narrazioni) dell’Italia, che invece o è una o non è.
Perché sarebbe un’Italia umanamente fallita - e del default più sconvolgente: il default della cultura e della fede che l’hanno unita prima di ogni azione politica - quel Paese bifronte che ci si ostina a voler scolpire non nel marmo, ma in grevi nuvolaglie di slogan xenofobi da social network e di parole e atti violenti che si vorrebbe derubricare a «sciocchezze». La «goliardata» che ha sfigurato il viso di Daisy Osakue non è la controprova di un’Italia serena e vaccinata dal razzismo: per rendersene conto, basta leggere ciò che è stato scatenato addosso a questa giovane donna, cittadina italiana di origine nigeriana.
Inqualificabile. Io continuo a vergognarmene. Anche se suo padre, a quanto risulta, non è stato uno stinco di santo e ha pagato il suo debito con la giustizia. E me ne vergogno anche se i tre aggressori a colpi di uova sono "bulli" e non adepti di uno dei manipoli razzisti che sparlano, sputano, menano e sparano (grazie a Dio, quasi sempre a vuoto) in giro per l’Italia.
Non sono l’Italia e non la rappresentano l’Italia. Ma - come ho scritto - ne deturpano i lineamenti, sino a sfigurarli. E allora non si può far finta di niente. Di costoro e per costoro ci dovremmo vergognare tutti, e ancor di più visto che ci viene spiegato e quasi intimato di dire e scrivere che non esistono e che comunque sono la logica reazione alla "violenza portata dagli stranieri". Ma proprio come i poveri, i violenti non hanno passaporto e non hanno patria. Ai poveri patria e passaporto sono negati. Ai violenti interessano solo come arma, e perciò non interessano affatto.
L’Italia non può essere ridotta a un ring di risentimenti etnici. Chi ha responsabilità lavori per evitarlo.
P.S. A quanti in queste settimane hanno ritenuto di ricordarci che i buoni cattolici e i giornali di ispirazione cattolica, prima e invece che delle persone costrette a migrare, dovrebbero preoccuparsi della vita non nata e ancora troppe volte abortita in Italia e in Europa - vita nascente che da appassionati di umanità e di scienza amiamo e rispettiamo sin dal primo istante come testimoniano le pagine del giornale - mi sento di rispondere con parole più grandi di noi: se non siamo capaci di amare e di essere giusti con coloro che vediamo, come potremo mai amare ed essere giusti con coloro che (ancora) non vediamo?
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- "MI VERGOGNO DI ESSERE ITALIANO E CRISTIANO" (A. Z.).
 CONTRO LA XENOFOBIA ITALIANA, L’APPELLO E LA DENUNCIA DI PADRE ALEX ZANOTELLI. Non possiamo stare zitti, dobbiamo parlare, gridare, urlare. E’ in ballo il futuro del nostro paese, ma soprattutto è in ballo il futuro dell’umanità anzi della vita stessa
CONTRO LA XENOFOBIA ITALIANA, L’APPELLO E LA DENUNCIA DI PADRE ALEX ZANOTELLI. Non possiamo stare zitti, dobbiamo parlare, gridare, urlare. E’ in ballo il futuro del nostro paese, ma soprattutto è in ballo il futuro dell’umanità anzi della vita stessa
- CRISTIANESIMO E COSTITUZIONE (DELLA CHIESA E DELL’ITALIA). PERDERE LA COSCIENZA DELLA LINGUA ("LOGOS") COSTITUZIONALE ED EVANGELICA GENERA MOSTRI ATEI E DEVOTI ...
 I "DUE CRISTIANESIMI" E LA PROPRIA FACOLTA’ DI GIUDIZIO. "Perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto?"
I "DUE CRISTIANESIMI" E LA PROPRIA FACOLTA’ DI GIUDIZIO. "Perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto?"
LA COSTITUZIONE ITALIANA, IL CRISTIANESIMO, E LA TRADIZIONE DELLA MENZOGNA CATTOLICO-ROMANA.
LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE.
IL SONNO MORTIFERO DELL’ITALIA. In Parlamento (ancora!) il Partito al di sopra di tutti i partiti.
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! - L’ APPELLO. La situazione dell’Italia si sta avvitando in una spirale distruttiva. Prepariamoci alle Europee (di Massimo Cacciari)3 agosto 2018, di Federico La Sala
POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. Non è mai troppo tardi .... *
L’ appello
Prepariamoci alle Europee
di Massimo Cacciari (la Repubblica, 03.08.2018)
La situazione dell’Italia si sta avvitando in una spirale distruttiva. L’alleanza di governo diffonde linguaggi e valori lontani dalla cultura - europea e occidentale - dell’Italia. Le politiche progettate sono lontane da qualsivoglia realismo e gravemente demagogiche. Nella mancanza di una seria opposizione, i linguaggi e le pratiche dei partiti di governo stanno configurando una sorta di pensiero unico, intriso di rancore e risentimento. Il popolo è contrapposto alla casta, con una apologia della Rete e della democrazia diretta che si risolve, come è sempre accaduto, nel potere incontrollato dei pochi, dei capi. L’ossessione per il problema dei migranti, ingigantito oltre ogni limite, gestito con inaccettabile disumanità, acuisce in modi drammatici una crisi dell’Unione europea che potrebbe essere senza ritorno.
L’Europa è sull’orlo di una drammatica disgregazione, alla quale l’Italia sta dando un pesante contributo, contrario ai suoi stessi interessi. Visegrad nel cuore del Mediterraneo: ogni uomo è un’isola, ed è ormai una drammatica prospettiva la fine della libera circolazione delle persone e la crisi del mercato comune. È diventata perciò urgentissima e indispensabile un’iniziativa che contribuisca a una discussione su questi nodi strategici. In Italia esiste ancora un ampio spettro di opinione pubblica, di interessi sociali, di aree culturali disponibile a discutere questi problemi e a prendere iniziative ormai necessarie.
Perché ciò accada è indispensabile individuare, tempestivamente, nuovi strumenti in grado di ridare la parola ai cittadini che la crisi dei partiti e la virulenza del nuovo discorso pubblico ha confinato nella zona grigia del disincanto e della sfiducia, ammutolendoli.
 Per avviare questo lavoro - né semplice né breve - è indispensabile chiudere con il passato ed aprire nuove strade all’altezza della nuova situazione, con una netta ed evidente discontinuità: rovesciando l’ideologia della società liquida, ponendo al centro la necessità di una nuova strategia per l’Europa, denunciando il pericolo mortale per tutti i paesi di una deriva sovranista, che, in parte, è anche il risultato delle politiche europee fin qui condotte.
Per avviare questo lavoro - né semplice né breve - è indispensabile chiudere con il passato ed aprire nuove strade all’altezza della nuova situazione, con una netta ed evidente discontinuità: rovesciando l’ideologia della società liquida, ponendo al centro la necessità di una nuova strategia per l’Europa, denunciando il pericolo mortale per tutti i paesi di una deriva sovranista, che, in parte, è anche il risultato delle politiche europee fin qui condotte.C’è una prossima scadenza, estremamente importante, che spinge a mettersi subito in cammino: sono ormai alle porte le elezioni europee. C’è il rischio che si formi il più vasto schieramento di destra dalla fine della Seconda guerra mondiale. La responsabilità di chi ha un’altra idea di Europa è assai grande. Non c’è un momento da perdere. Tutti coloro che intendono contribuire all’apertura di una discussione pubblica su questi temi, attraverso iniziative e confronti in tutte le sedi possibili, sono invitati ad aderire.
Gli altri firmatari: Enrico Berti Michele Ciliberto Biagio de Giovanni Vittorio Gregotti Paolo Macrì Giacomo Manzoni Giacomo Marramao Mimmo Paladino
Sul tema, nel sito, si cfr.:
FILOSOFIA. IL PENSIERO DELLA COSTITUZIONE E LA COSTITUZIONE DEL PENSIERO
 MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA E A PENSARE BENE "DIO", "IO" E "L’ITALIA", CHI PIÙ CHI MENO, TUTTI VIVONO DENTRO LA PIÙ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA E POLITICA ITALIANA, NEL REGNO DI "FORZA ITALIA"!!!
MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA E A PENSARE BENE "DIO", "IO" E "L’ITALIA", CHI PIÙ CHI MENO, TUTTI VIVONO DENTRO LA PIÙ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA E POLITICA ITALIANA, NEL REGNO DI "FORZA ITALIA"!!!UNITÀ D’ITALIA E FOLLIA: EMERGENZA LOGICO-POLITICA EPOCALE. PER UN CONVEGNO E UNA RIFLESSIONE SUL CONCETTO DI ’UNITÀ E DI SOVRANITÀ (SOVRA-UNITÀ). Materiali sul tema
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---Politiche nazionaliste o sovraniste stanno dilagando nel mondo. C’è un’unica patria, è l’umanità (di Carlo Rovelli).31 luglio 2018, di Federico La Sala
Carlo Rovelli: fermiamo i nazionalisti.
C’è un’unica patria, è l’umanità
Le identità etniche sono un prodotto culturale che può diventare pericoloso, bisogna opporsi a chi le usa per alimentare i conflitti tra i popoli. La riflessione del fisico, pubblicata dal Guardian nei giorni scorsi
di Carlo Rovelli (Corriere della Sera, 31.07.2018)
La Gran Bretagna è un vecchio Paese. Il mio Paese, l’Italia, è giovane. Entrambi sono orgogliosi del loro passato. Entrambi sono contrassegnati da marcati caratteri nazionali: è facile identificare gli italiani o gli inglesi, tra la folla di un aeroporto internazionale. Riconosco facilmente l’italiano in me: non riesco a dire nulla senza agitare le mani, ci sono antiche pietre romane nelle cantine della mia casa a Verona, e gli eroi nella mia scuola erano Leonardo e Michelangelo ...
Eppure questa identità nazionale è solo uno strato sottile, uno tra tanti altri, assai più importanti. Dante ha segnato la mia educazione, ma ancora più lo hanno fatto Shakespeare e Dostoevskij. Sono nato nella bigotta Verona, e andare a studiare nella libertina Bologna è stato uno shock culturale. Sono cresciuto all’interno di una determinata classe sociale, e condivido abitudini e preoccupazioni con le persone di questa classe in tutto il pianeta più che con i miei connazionali. Sono parte di una generazione: un inglese della mia età è molto più simile a me di un veronese dall’età diversa. La mia identità viene dalla mia famiglia, unica, come è unica ogni famiglia, dal gruppo dei miei amici d’infanzia, dalla tribù culturale della mia giovinezza, dalla rete degli sparsi amici della mia vita adulta. Viene soprattutto dalla costellazione di valori, idee, libri, sogni politici, preoccupazioni culturali, obiettivi comuni, che sono stati condivisi, nutriti, per i quali abbiamo combattuto insieme, e che sono stati trasmessi in comunità che sono più piccole, o più grandi, o completamente trasversali ai confini nazionali. Questo è ciò che siamo tutti noi: una combinazione di strati, incroci, in una rete di scambi che tesse l’umanità intera nella sua multiforme e mutevole cultura.
Non sto dicendo che cose ovvie. Ma allora perché, se questa è la variegata identità di ciascuno di noi, perché organizziamo il nostro comportamento politico collettivo in nazioni e lo fondiamo sul senso di appartenenza a una nazione? Perché l’Italia? Perché il Regno Unito?
La risposta, ancora una volta, è facile: non è il potere che si costruisce attorno a identità nazionali; è viceversa: le identità nazionali sono create dalle strutture di potere. Visto dal mio giovane e ancora un po’ disfunzionale Paese, l’Italia, questo è forse più facile da notare che non dall’interno dell’antico e nobile Regno di sua maestà la regina. Ma è la stessa cosa. Non appena emerso, generalmente con fuoco e furia, la prima preoccupazione di qualsiasi centro di potere - antico re o borghesia liberale del XIX secolo - è promuovere un robusto senso di identità comune. «Abbiamo fatto l’Italia, ora facciamo gli italiani» è la famosa esclamazione di Massimo d’Azeglio, pioniere dell’unità d’Italia, nel 1861.
Sono sempre sorpreso di quanto diversa sia la storia insegnata in Paesi diversi. Per un francese, la storia del mondo è centrata sulla Rivoluzione francese. Per un italiano, eventi di dimensione universale sono il Rinascimento (italiano) e l’Impero romano. Per un americano, l’evento chiave per l’umanità, quello che ha introdotto il mondo moderno, la libertà e la democrazia, è la guerra di Indipendenza americana contro... la Gran Bretagna. Per un indiano, le radici della civiltà si trovano nell’era dei Veda... ciascuno sorride delle distorsioni degli altri, e nessuno riflette sulle proprie...
Leggiamo il mondo in termini di grandi narrazioni discordanti, che abbiamo in comune con i connazionali. Sono narrazioni create consapevolmente per generare un senso di appartenenza a famiglie fittizie, chiamate nazioni. Meno di due secoli fa c’era gente in Calabria che chiamava se stessa «greco», e non molto tempo fa gli abitanti di Costantinopoli chiamavano se stessi «romano»... e non tutti in Scozia o Galles hanno tifato Inghilterra nella coppa del mondo... Le identità nazionali non sono altro che teatro politico.
Non fraintendetemi. Non voglio suggerire che ci sia qualcosa di male in tutto questo. Al contrario: unificare popolazioni diverse - veneziani e siciliani, o diverse tribù anglosassoni - perché collaborino a un bene comune, è saggia e lungimirante politica. Se lottiamo tra noi stiamo ovviamente molto peggio che se lavoriamo insieme. È la cooperazione, non il conflitto, che giova a tutti. L’intera civiltà umana è il risultato della collaborazione. Qualunque sia la differenza tra Napoli e Verona, le cose vanno meglio per tutti senza frontiere fra l’una e l’altra. Lo scambio di idee e merci, sguardi e sorrisi, i fili che tessono la nostra civiltà, ci arricchisce tutti, in beni, intelligenza e spirito. Fare convergere persone diverse in uno spazio politico comune è vantaggio per tutti. Rafforzare poi questo processo con un po’ di ideologia e teatro politico, per tenere a bada i conflitti istintivi, montare la farsa di una Sacra Identità Nazionale, per quanto sia operazione fasulla, è comunque operazione utile. È prendere il giro le persone, ma chi può negare che la cooperazione è meglio del conflitto?
Ma è proprio qui che l’identità nazionale diventa un veleno. Creata per favorire la solidarietà, può finire per diventare l’ostacolo alla cooperazione su scala più larga. Creata per ridurre conflitti interni, può finire per generare conflitti esterni ancora più dannosi. Le intenzioni dei padri fondatori del mio Paese erano buone nel promuovere un’identità nazionale italiana, ma solo pochi decenni dopo questa è sfociata nel fascismo, estrema glorificazione di identità nazionale. Il fascismo ha ispirato il nazismo di Hitler. La passionale identificazione emotiva dei tedeschi in un singolo Volk ha finito per devastare la Germania e il mondo. Quando l’interesse nazionale promuove il conflitto invece che la cooperazione, quando alla ricerca di compromessi e regole comuni si preferisce mettere la propria nazione davanti a tutto, l’identità nazionale diventa tossica.
Politiche nazionaliste o sovraniste stanno dilagando nel mondo, aumentando tensioni, seminando conflitto, minacciando tutti e ciascuno di noi. Il mio Paese è appena ricaduto preda di questa insensatezza. Penso che la risposta sia dire forte e chiaro che l’identità nazionale è falsa. È buona se aiuta a superare interessi locali per il bene comune, è miope e controproducente quando promuove l’interesse di un gruppo artificiale, «la nostra nazione», invece che un più ampio bene comune.
Ma localismo e nazionalismo non sono solo errori di calcolo; traggono forza dal loro appello emotivo: l’offerta di una identità. La politica gioca con il nostro istintivo insaziabile desiderio di appartenenza. «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo hanno i loro nidi, ma il Figlio dell’Uomo non ha dove posare il suo capo...» offrire una casa fittizia, la nazione, è risposta fasulla, ma costa poco e paga politicamente. Per questo la risposta alla perniciosa ideologia nazionale non può essere solo un appello alla ragionevolezza, ma deve trovare l’anelito morale e ideologico che merita: glorificare identità locali o nazionali e usarle per ridurre la cooperazione su scala più ampia non è solo un calcolo sbagliato, è anche miserabile, degradante, e moralmente riprovevole.
Non perché non abbiamo identità nazionali - le abbiamo. Ma perché ognuno di noi è un crocevia di identità molteplici e stratificate. Mettere la nazione in primo luogo significa tradire tutte le altre. Non perché siamo tutti eguali nel mondo, ma perché siamo diversi all’interno di ciascuna nazione. Non perché non abbiamo bisogno di una casa, ma perché abbiamo case migliori e più nobili che non il grottesco teatro della nazione: la nostra famiglia, i nostri compagni di strada, le comunità di cui condividiamo i valori, che sono diffuse nel mondo; chiunque siamo, non siamo soli, siamo in tanti. E abbiamo un posto meraviglioso da chiamare «casa»: la Terra, e una meravigliosa, variegata tribù di fratelli e sorelle con i quali sentirci a casa e con i quali identificarci: l’umanità.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- Mattarella mette in guardia dal razzismo. Il Capo dello Stato: anche i rom e i sinti tra le vittime delle Leggi Razziali del fascismo.26 luglio 2018, di Federico La Sala
Mattarella mette in guardia dal razzismo
“Veleno che penetra ancora nella società”
Il Capo dello Stato: anche i rom e i sinti tra le vittime delle Leggi Razziali del fascismo. Salvini: basta parassiti
di Francesco Grignetti (La Stampa, 26.07.2018)
Era il 26 luglio 1938, ottanta anni fa: il Duce riceveva in pompa magna a palazzo Venezia alcuni tra gli scienziati più illustri d’Italia per la consegna del Manifesto della razza. A rileggerlo, c’è da rabbrividire: «La popolazione dell’Italia attuale è nella maggioranza di origine ariana e la sua civiltà ariana... Gli ebrei non appartengono alla razza italiana». Fu la premessa delle leggi razziali. E ieri Sergio Mattarella ha voluto ricordare quel passaggio orribile della nostra storia. «Questa presa di posizione - afferma il Capo dello Stato - rimane la più grave offesa recata dalla scienza e dalla cultura italiana alla causa dell’umanità».
Parla del passato, Mattarella, ma in tutta evidenza parla anche dell’oggi perché il virus del razzismo è sempre più forte anche oggi. Non è un caso che Mattarella rievochi la crudeltà verso le popolazioni africane nelle nostre colonie, la persecuzione dei cittadini di religione israelita e la caccia spietata a rom e sinti. «Quelle mostruose discriminazioni sfociarono nello sterminio, il porrajmos, degli zingari», dice il Presidente sulla scorta di un dossier che La Stampa ha potuto consultare negli archivi del Quirinale. Guai allora a dimenticare le scelte che gli italiani compirono nel 1938. «Il veleno del razzismo - conclude Mattarella - continua a insinuarsi nelle fratture della società e in quelle tra i popoli. Crea barriere e allarga le divisioni. Compito di ogni civiltà è evitare che si rigeneri».
E se non sfugge la coincidenza tra questa ricorrenza e l’animosità della maggioranza giallo-verde nei confronti di stranieri e zingari, il ministro Matteo Salvini svicola con eleganza. «Il Presidente Mattarella - dice - con le sue parole ricorda un passato che non dovrà mai più tornare. È folle e fuori del mondo ritenere una razza superiore a un’altra». Ma intanto, a proposito dei Rom, usa toni brutali: «In Italia ci sono 150 mila persone rom ma i problemi sono limitati a 30 mila che si ostinano a vivere nell’illegalità. Il problema è questa sacca parassitaria».
Fanfani e padre Gemelli firmarono contro gli ebrei
di Fra. Gri. (La Stampa, 26.07.2018)
A firmare il Manifesto della razza furono 10 scienziati, alcuni notissimi come Sabato Visco, direttore dell’Istituto di fisiologia dell’Università di Roma, o Nicola Pende, direttore dell’Istituto di Patologia alla stessa Università. I loro nomi sono noti, anche se poi alcuni cercarono di sottrarsi alla responsabilità, e qualche storico ha ritenuto che le loro firme fossero state in qualche modo «sollecitate» dal regime, visto che era stato Mussolini stesso a ispirarne parole e concetti.
Grave fu però la corsa di tanti intellettuali, ben 330, ad aggiungere la propria firma a quello che chiaramente era un passaggio ispirato dal Duce. Uno fu padre Agostino Gemelli, fondatore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Un altro, il giovane professore di Storia economica Amintore Fanfani. Oppure il poeta Ardengo Soffici, lo scrittore Giovanni Papini, il giornalista Mario Missiroli, il critico cinematografico Luigi Chiarini.
A dare spazio alle teorie del razzismo italiano nacque una rivista specifica, La difesa della razza, diretta da Telesio Interlandi, giornalista distintosi per le campagne antisemite promosse sulle pagine del giornale Tevere e per un libro dal titolo Contra Judeos. Caporedattore era Giorgio Almirante.
Fin dal 1926 respingimenti e allontanamenti forzati
di Fra. Gri. (La Stampa, 26.07.2018)
È una pagina semi-ignorata della storia italiana, la persecuzione degli zingari che il regime portò avanti fin dal 1926 con respingimenti e allontanamenti forzati di Rom e Sinti stranieri. Il Viminale diramò circolari per «epurare il territorio nazionale dalla presenza di zingari, di cui è superfluo ricordare la pericolosità nei riguardi della sicurezza e dell’igiene pubblica per le caratteristiche abitudini di vita».
Furono coinvolte le forze di polizia e le prefetture dell’Istria e del Friuli, in particolare, nel tentativo di sbarrare la strada ai gitani dei Balcani che nel loro nomadismo tentavano di entrare in Italia. E siccome a loro volta la polizia del confinante Regno di Jugoslavia si rifiutava di accettarli, sono accertati i respingimenti clandestini a opera della Guardia di Finanza presso certi valichi di frontiera incustoditi.
Con il 1938, Mussolini si convinse che occorreva la pulizia etnica degli zingari nelle regioni di confine, in quanto tutti potenziali spie del nemico. Furono fatti rastrellamenti e deportazioni. Dall’Istria e dal Trentino gli zingari furono portati al confino in Sardegna. Il 20 ottobre 1942 il nuovo prefetto istriano Berti poteva dichiarare che con le ultime deportazioni in Istria non c’era più un solo Rom. I confinati si poterono allontanare dall’isola soltanto dopo il 1945.
Un richiamo necessario per un Paese smemorato
di Amedeo Osti Guerrazzi (La Stampa, 26.07.2018)
Sono parole molto forti quelle che vengono dal Presidente della Repubblica, una delle poche autorità morali ancora riconosciute dalla stragrande maggioranza della società italiana. E forse era ora. Non esiste nessun mito più radicato nella nostra opinione pubblica di quello degli «italiani brava gente»; sebbene sia stato sfatato dagli storici, il concetto che gli italiani siano stati, anche durante il fascismo, fondamentalmente «buoni» è duro a morire.
Se anche si dice che il fascismo «sbagliò» nell’emanare le leggi antiebraiche, è opinione comune che queste furono applicate «all’acqua di rose», e che in fondo gli ebrei «non se la passavano tanto male». Nulla di più falso. La persecuzione fu durissima, e colpì ogni aspetto della vita degli ebrei italiani, rendendo loro impossibile lavorare, avere amici non ebrei, accedere a una istruzione superiore. La persecuzione, anche se non sfociò in un massacro operato direttamente dagli italiani, fu estremamente dura, e dopo l’occupazione tedesca fu la necessaria premessa al collaborazionismo fascista, e alla deportazione e allo sterminio di oltre 7000 cittadini italiani di fede ebraica.
Ma il Presidente richiama l’attenzione anche sulla sorte di sinti e rom. Chi ricorda che anche loro sono stati vittime del razzismo fascista? Chi conosce i campi di concentramento di Boiano e Agnone, dove centinaia di «zingari» furono rinchiusi durante la guerra, considerati come soggetti pericolosi per la patria italiana? Chi sa che le condizioni in quei campi erano difficilissime?
Tutto questo ha voluto ricordare Mattarella. È un richiamo duro, amaro da mandare giù, ma necessario. Necessario per un Paese che, oltre a essere smemorato, sembra continuare negli errori del passato.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- COSTITUZIONE ED EDUCAZIONE CIVICA: SENZA INDUGIO (Aldo Moro, 1947). La legge proposta dai Sindaci.26 luglio 2018, di Federico La Sala
MEMORIA E STORIA. COSTITUZIONE ED EDUCAZIONE CIVICA....*
La legge proposta dai Sindaci. Educazione civica ora tocca ai cittadini
di Luciano Corradini (Avvenire, domenica 22 luglio 2018)
Caro direttore,
il termine indugio indica il ritardo, più o meno motivato, rispetto alla tempestività di un inizio o la regolarità di uno svolgimento. Si tratta di un termine illustre, indicato da un ordine del giorno votato all’unanimità dall’Assemblea Costituente l’11 dicembre 1947, primo firmatario Aldo Moro, per dire che la nuova Carta costituzionale doveva trovare «senza indugio adeguato posto nel quadro didattico della scuola di ogni ordine e grado».
 Ora i Sindaci invitano i cittadini a chiedere a Parlamentari e Ministri, in nome e con metodi previsti dalla Costituzione di rompere quegli indugi che hanno afflitto l’ultimo decennio. Il 20 luglio in diverse sedi comunali è stato dato avvio alla raccolta di firme per la ’proposta di legge di iniziativa popolare’, promossa dal sindaco Nardella di Firenze e fatta propria dall’Anci, presieduta dal sindaco Decaro di Bari, «sull’introduzione dell’educazione alla cittadinanza nei curricoli scolastici di ogni ordine e grado».
Ora i Sindaci invitano i cittadini a chiedere a Parlamentari e Ministri, in nome e con metodi previsti dalla Costituzione di rompere quegli indugi che hanno afflitto l’ultimo decennio. Il 20 luglio in diverse sedi comunali è stato dato avvio alla raccolta di firme per la ’proposta di legge di iniziativa popolare’, promossa dal sindaco Nardella di Firenze e fatta propria dall’Anci, presieduta dal sindaco Decaro di Bari, «sull’introduzione dell’educazione alla cittadinanza nei curricoli scolastici di ogni ordine e grado».Entro sei mesi, si dovranno raccogliere le prescritte 50mila firme, con le modalità ricordate dal comunicato dell’Anci. Si chiede cioè che il Parlamento vari una legge in cui si dice, all’art. 2: «È istituita un’ora settimanale di educazione alla cittadinanza come disciplina autonoma con propria valutazione, nei curricoli e nei piani di studio di entrambi i cicli di istruzione. Sono conseguentemente da ritenersi modificati, in armonia con quanto disposto dal comma precedente, tutti gli articoli di legge che disciplinano i curricoli, i piani di studio e la loro articolazione. Il monte ore necessario (non inferiore alle 33 ore annuali) - ove non si preveda una modifica dei quadri orario che aggiunga l’ora di educazione alla cittadinanza - dovrà essere ricavato rimodulando gli orari delle discipline storicofilosofico- giuridiche».
Gli autori di questa proposta di legge non si nascondono la complessità dell’operazione e prevedono che il Parlamento dialoghi in certo senso con organi tecnici del Ministero dell’Istruzione. Si dice infatti all’art. 3: «È istituita presso il Miur una commissione ad hoc, che, sentito il comitato scientifico per le indicazioni nazionali e il Cspi, assuma: 1) il compito di elaborare entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, gli obiettivi specifici di apprendimento per i diversi cicli di istruzione, e di provvedere, entro il medesimo termine, alla corretta collocazione dell’insegnamento in seno ai curricula e ai piani di studio dei diversi cicli di istruzione, nonché di optare per l’aggiunta di un’ora ai curricula o per la sua individuazione nell’ambito degli orari di italiano, storia, filosofia, diritto, tenendo conto dei quadri orari e del numero di materie per ciascun tipo di scuola; 2) la decisione se optare per un’ora di nuova istituzione che si aggiunga in tutti o in alcuni cicli di istruzione e tipologie di indirizzo scolastico, o per un’ora da ricavare nell’ambito dei quadri orari esistenti».
Sotto il termine generale ’cittadinanza’, si precisa che «Gli obiettivi specifici di apprendimento dovranno necessariamente comprendere nel corso degli anni: lo studio della Costituzione, elementi di educazione civica, lo studio delle istituzioni dello Stato italiano e dell’Unione Europea, diritti umani, educazione digitale, educazione ambientale, elementi fondamentali del diritto e del diritto del lavoro, educazione alla legalità, oltre ai fondamentali princìpi e valori della società democratica, come i diritti e i doveri, la libertà e i suoi limiti, il senso civico, la giustizia». Nell’art. 4 si dice che «L’insegnamento potrà essere affidato ai docenti abilitati nelle classi di concorso che abilitano per l’italiano, la storia, la filosofia, il diritto, l’economia».
L’art. 5 aggiunge: «Sono istituiti percorsi di formazione dei docenti e azioni di sensibilizzazione sull’educazione digitale, ai sensi del comma 124 dell’art.1 legge 13.7.2015, n.107». A conclusione dell’art. 6 si dice: «Nell’ipotesi in cui si opti per l’aggiunta di un’ora agli orari delle discipline storicofilosofico- giuridiche, i maggiori oneri saranno a carico dei Fondi di riserva e speciali del bilancio dello Stato». A parere di chi scrive l’iniziativa, nonostante alcuni limiti che saranno affrontati in seguito, presenta caratteri di trasversalità, di necessità e urgenza, e non merita né ulteriori indugi né frettolose conclusioni. Intanto i ’cittadini praticanti’ dovrebbero impegnarsi a firmare entro i sei mesi previsti.
Professore emerito di Pedagogia generale nell’Università di Roma Tre,
 già presidente del Consiglio superiore della Pubblica istruzione
già presidente del Consiglio superiore della Pubblica istruzione
Sul tema, nel sito, si cfr.:
VIVA L’ITALIA!!! LA QUESTIONE "CATTOLICA" E LO SPIRITO DEI NOSTRI PADRI E E DELLE NOSTRE MADRI COSTITUENTI. Per un ri-orientamento antropologico e teologico-politico.
TRE PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA SENZA "PAROLA", E I FURBASTRI CHE SANNO (COSA SIGNIFICA) GRIDARE "FORZA ITALIA". In memoria di Sandro Pertini e di Gioacchino da Fiore, alcuni appunti per i posteri
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- Etica e politica alla fine di un mondo. Nella nostra epoca l’arte e la letteratura nascondono la realtà, suggerisce Gosh: viviamo nell’ «epoca della Grande Cecità».18 luglio 2018, di Federico La Sala
Nell’Antropocene. Etica e politica alla fine di un mondo
di Gianfranco Pellegrino e Marcello Di Paola (Le parole e le cose, 18 luglio 2018)
- Il 21 giugno scorso per DeriveApprodi è uscito Nell’Antropocene. Etica e politica alla fine di un mondo, di Gianfranco Pellegrino e Marcello Di Paola. Ne pubblichiamo l’inizio.
Alla fine di febbraio del 2018, mentre eravamo impegnati a scrivere questo libro, a Roma ha nevicato. Per due o tre giorni, la temperatura media è stata di - 4°C. Le medie stagionali a Roma fra febbraio e marzo oscillano fra 4-5°C e 13-14°C. L’ultima neve era caduta nel 2011 e 2012, e prima ancora nel 2005 e nel 2001. Negli stessi giorni, in altre parti dell’Europa del nord faceva molto più freddo che nei tre anni precedenti nello stesso periodo. Una settimana prima della neve romana, ancora più a nord, in Groenlandia, la stazione meteorologica di Capo Morris Jesup aveva registrato per quasi un giorno una temperatura superiore allo zero. Il picco è stato di 6,1°C, circa sette gradi sopra le massime stagionali. In realtà già nei tre anni precedenti al Polo nord c’erano state temperature massime superiori alla media.
I due fenomeni potrebbero essere collegati. Il cosiddetto vortice polare - un’area di bassa pressione che di solito separa i venti gelidi del Polo Nord da quelli temperati che soffiano più a sud - sta diventando meno stabile. Per questa ragione al Polo Nord si accumula aria calda, che spinge a sud quella fredda.
Ma non è sicuro che la neve a Roma e il caldo al Polo Nord siano legati: potrebbe essere ancora troppo presto per dirlo - dobbiamo aspettare altre osservazioni, altri inverni. Forse la neve a Roma ci ha sorpreso tanto perché gli inverni a queste latitudini sono ormai molto più caldi di prima.
È molto probabile che il clima globale stia mutando. Sta cambiando non tanto, o non solo, il tempo di una giornata o di una stagione, ma la media statistica del tempo di molti giorni e stagioni (secondo l’Organizzazione meteorologica mondiale, il clima è la media statistica del tempo atmosferico in una certa zona nell’arco di trent’anni). Il 2016 e il 2017 sono stati gli anni più caldi da quando abbiamo iniziato a misurare la temperatura globale del nostro pianeta - nel 1880.
Secondo una schiacciante maggioranza di scienziati (il 97%), il cambiamento climatico è causato dall’uso di combustibili fossili (carbone e petrolio, per lo più). Il clima sta cambiando perché i gas immessi nell’atmosfera in conseguenza della combustione di risorse energetiche fossili (i cosiddetti gas serra) funzionano come uno schermo che impedisce di disperdersi nello spazio a parte del calore che arriva dal Sole e viene riflesso dalle superfici del nostro pianeta. Ciò vuol dire che la nevicata a Roma del 2018 non è naturale. A differenza di altre nevicate, per esempio quella del 1956, non è stata causata dalle forze della natura. La neve di Roma del 2018 è un prodotto umano: è neve artificiale, insomma, come quella sparata sulle piste per gli sciatori.
Sarebbe più corretto dire che la neve di Roma del 2018 è stata causata dall’interazione fra forze naturali e una forza non naturale - l’attività umana che produce gas serra. Di conseguenza, la neve caduta a Roma non è né naturale né artificiale, è un prodotto dell’interazione fra attività umana e processi naturali - è ibrida. E si dovrebbe pure dire che interazioni di questo genere non producono sempre le stesse conseguenze - i loro effetti non si possono prevedere in maniera deterministica, ma solo probabilistica. Dato quello che stava succedendo al Polo Nord nel 2018, era molto probabile che la neve quell’anno arrivasse sino a Roma. Ma avrebbe anche potuto andare diversamente, e non è detto che accadrà di nuovo.
C’è un aspetto paradossale di questa nevicata artificiale, o ibrida. La neve sparata su una pista da sci è conseguenza dell’intenzione dei gestori della pista di garantire un manto nevoso adeguato ai propri clienti. La neve caduta su Roma nel 2018 non è una conseguenza voluta dell’azione di nessuno. Piuttosto si tratta dell’effetto collaterale, non voluto e non previsto, di miliardi di azioni di tutti, nessuna delle quali da sola sarebbe bastata a causare questo risultato. Per arrivare alla neve di Roma ci vuole l’interazione fra gli effetti a lungo termine di cose come la prima macchina a vapore, l’attività economica fervente descritta nei Buddenbrook di Thomas Mann, l’aumento dei viaggi in aereo prodotto dalle compagnie low cost e l’incremento del trasporto su gomma favorito dalla costruzione di autostrade, l’elettrificazione progressiva dell’Europa e degli Stati Uniti a partire dagli anni Cinquanta, e miriadi di altri fattori storici, economici, politici e culturali. Detto altrimenti, la neve di Roma è una conseguenza non voluta delle nostre vite nel loro complesso - della vita che abbiamo vissuto negli ultimi tre secoli, in particolare nei paesi occidentali industrializzati ma ormai sempre più anche in paesi come Cina e India. E però, paradossalmente, non c’è nulla nel nostro modo di vivere attuale che avrebbe potuto evitare la nevicata che abbiamo causato.
Per via dell’escursione termica fra giorno e notte, in quei giorni di febbraio alcuni alberi di limoni nei giardini di Roma hanno perso le foglie, e non produrranno frutti. In un certo senso, chiunque stia leggendo questo libro a bordo di un treno, o di un aereo, sta contribuendo alla catena di cause ed effetti che ha compromesso il raccolto di limoni e ha dissolto il profumo delle zagare. La produzione stessa e la distribuzione di questo libro ha un impatto, dal momento che richiede energia elettrica e combustibili fossili e dunque produce emissioni di gas serra a ogni parola scritta. Ma smettere di scrivere queste parole non sarebbe servito a evitare la nevicata.
Nel 1962, apparve l’Angelo sterminatore di Luis Bunuel. Il film racconta di una cena organizzata da una famiglia dell’alta borghesia. All’alba, dopo esser stati a chiacchierare in salotto per quasi tutta la notte, i protagonisti si rendono conto che, nonostante la porta sia aperta, non possono più uscire - e chi è all’esterno non può entrare. Passano le ore e i giorni, la situazione degenera, le liti e i conflitti divampano, uno degli ospiti muore.
Probabilmente, Bunuel criticava la classe borghese e voleva far intendere che i suoi esponenti fossero prigionieri dei loro stessi privilegi. Il mondo privilegiato dell’Occidente industrializzato in cui viviamo potrebbe essere un delizioso salotto che sta andando in rovina e da cui non possiamo allontanarci.
Per molti, i paradossi descritti sin qui sono il marchio di un’epoca nuova in cui ci troviamo a vivere: l’Antropocene, l’epoca in cui l’azione degli esseri umani può cambiare il corso naturale delle cose. [...] L’Antropocene è un’idea difficile da accettare, perché ci richiede di vedere il mondo diversamente. Le concezioni del mondo naturale e del mondo umano ereditate dal passato sono del tutto inadeguate alla nuova condizione. Prima la natura era lo sfondo immutabile dell’azione umana - era fonte di risorse, ma non incarnava valori, il mondo della cultura era il luogo dell’etica e della politica, dell’agire intenzionale degli esseri umani. Questo quadro è adesso contraddetto da fatti nuovi. Rimanere aggrappati alla vecchia concezione è impossibile o poco utile; ma una concezione nuova è ancora da costruire.
[...] Molti sono indifferenti all’Antropocene - perché non ne sanno nulla, o pur essendone a conoscenza, non se ne curano. Tanti altri ne sono spaventati, perché per la prima volta non siamo di fronte a una minaccia e a un nemico esterni, ma siamo noi stessi il nemico e la vittima. E parecchi si preoccupano del fatto che la maggioranza di noi non s’interessa affatto all’Antropocene. Recentemente, Amitav Ghosh si è chiesto come mai nella letteratura contemporanea non si dia lo spazio che merita al cambiamento climatico che sta avvenendo (ma lo stesso si può dire dell’inquinamento globale, della scarsità di risorse naturali e, forse in misura minore, della perdita di biodiversità). Nella nostra epoca l’arte e la letteratura nascondono la realtà, suggerisce Gosh: viviamo nell’ «epoca della Grande Cecità».
[...] Altri invece vedono l’Antropocene come una grande opportunità - finalmente dominiamo completamente il pianeta, e ce lo potremo modellare a nostra immagine e somiglianza. Con l’Antropocene non siamo più creature ma creatori, non siamo più soggetti alle leggi della natura ma siamo noi i legislatori. A lungo la natura ha amato nascondersi e il sogno è stato di penetrarne i segreti, prima per difendersi e poi per dominarla e trarne profitto. Ora la natura la scopriamo cambiandola, o costruendola. Tutto è chiaro nella natura, come è chiaro il funzionamento di una macchina per il costruttore. Può esserci un ‘buon Antropocene’ - da cui possiamo trarre vantaggi e opportunità inaspettate.
[...] Parte di questo libro, soprattutto il primo capitolo, si dedicherà a ricostruire le molte facce dell’Antropocene e le tante reazioni che ha destato. Il nostro obiettivo è incoraggiare la discussione, rompere il grande silenzio e uscire dalla cecità. Sosterremo che la maniera migliore di cogliere la natura dell’Antropocene è adottare il punto di vista delle scienze della Terra - cioè di quelle discipline scientifiche che considerano il funzionamento del pianeta nel suo complesso come un sistema unitario - e concepirlo come una vera e propria rottura del corso della storia del pianeta Terra e della storia umana - il momento in cui la Terra come sistema complessivo e gli esseri umani come specie iniziano a interagire in maniera co-dipendente e ricorsiva e la storia e la geologia si intrecciano.
La reazione alla nuova epoca cui daremo voce è di cauta preoccupazione e di risoluto impegno: l’Antropocene non è necessariamente una catastrofe, ma non è neanche una meravigliosa opportunità. Piuttosto, l’Antropocene richiede scelte nuove, su cui è necessario riflettere e discutere, e pratiche nuove, che è necessario rendere possibili e perseguire. Abbiamo un’influenza senza precedenti sul corso futuro del nostro pianeta: potremo prendere decisioni buone o cattive, vivere in modo migliore o peggiore - per noi stessi, per gli animali e le piante, per il pianeta intero. Quindi servono criteri che ci guidino nelle nostre scelte nelle nostre pratiche.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- #MONDIALE2018. LA "PARTITA" PIU’ GRANDE: LA THAILANDIA BATTE L’ITALIA: 10-0. Note.13 luglio 2018, di Federico La Sala
MONDIALE 2018
Italia-Thailandia Una "partita" di lunga durata e la palla-fiducia che bisogna saper passare **
Sul cavaliere della I-THAILANDIA....
di Federico La Sala *
Caro Direttore,
A mio parere, in tutte le discussioni e le analisi che sono portate avanti sulla situazione italiana è proprio l’analisi del berlusconismo che va approfondita e chiarita. Io non posso concepire, nemmeno in THAILANDIA (cfr. Piero Ottone, IL CAVALIERE DELLA THAILANDIA, La Repubblica del 26.04.2002: "Thaksin ha fondato un partito, Thai Rak Thai, il cui nome significa, a quanto sembra: I thailandesi amano i thailandesi") che in una nazione che si chiama ITALIA, ci possa essere un PARTITO che si chiama "Forza ITALIA"...
Il trucco del NOME ("Forza ITALIA") è da manualetto del... piccolo ipnotizzatore e da gioco da baraccone ...politico! E penso che aver lasciato fare questa operazione, io ritengo, sia stata la cosa più incredibile e pazzesca che mai un popolo (e soprattutto le sue Istituzioni e partiti) abbia potuto fare con se stesso e con i propri cittadini e le proprie cittadine: è vero che stiamo diventando tutti vecchi e vecchie, ma questa è roba da suicidio collettivo!
Questa la mia opinione, se si vuole, da semplice e analfabeta vecchio cittadino italiano e non da "sovietico" comunista della "fattoria degli animali" orwelliana. Mi trovo a condividere e sono più vicino alle opinioni e alla posizione della "mosca bianca" Franco Cordero, che non a quella di molti altri.
LA LEGGE E’ UGUALE PER TUTTI: si tratta solo e sopratutto di non de-ragliare e, umanamente e politicamente, mantenerci (e possibilmente avanzare) sul filo e nel campo della democrazia. Non c’è nessuna demonizzazione da fare: si tratta solo di capire, e, anzi, io trovo la situazione - pur nella sua grande ambiguità e pericolosità - incredibilmente sollecitante nel senso di svegliarsi e reagire creativamente (come sembra che stia avvenendo) alla situazione determinatasi.
Il cavaliere ha lanciato la sua operazione e la sua sfida: possiamo leggere la cosa come una cartina di tornasole per tutta la nostra società. Vogliamo vivere o vogliamo morire: una cosa del genere più o meno, con altre parole, ci sta dicendo il Presidente CIAMPI da tempo.
Se ci facciamo togliere da sotto i piedi il fondamento costituzionale e si rompe la bilancia dei poteri della democrazia non ci sono più cittadini e cittadine ma pecore e lupi e riprende il gioco mai interrotto, come dice il vecchio saggio della giungla, del "chi pecora si fa il lupo se la mangia". Dentro questo clima, chiedere da anonimo stupido ingenuo e illuso e ’idealistico’ cittadino italiano di fare chiarezza e fermare il gioco (truccato, e pericolosamente surriscaldato e non lontano da clima di scontro civile) è solo un invito a tutte e due le parti e non a una sola a riconoscersi come parte della UNA e STESSA Italia.... e a ripristinare le regole del gioco!!!
M. cordiali saluti
Federico La Sala
*Il dialogo, Venerdì, 30 maggio 2003.
**
Tito, Héctor e la palla-fiducia che bisogna saper passare
di Mauro Berruto ( Avvenire, mercoledì 11 luglio 2018)
«Tuya, Héctor!». Se vi trovate in Uruguay e qualcuno vi dice così, beh significa che siete degni di stima e fiducia. Colui che sta all’origine di questo modo di dire, è un calciatore, Héctor Pedro Scarone, soprannominato El Mago, primo destinatario di quella frase («Tua, Héctor!»), rivoltagli in un istante destinato a passare alla storia da un suo collega. Era il 13 giugno 1928, giorno della finale del torneo di calcio ai Giochi Olimpici di Amsterdam: Uruguay e Argentina, le finaliste, sono sull’1-1. In campo una parata di stelle fra le quali due, particolarmente brillanti, con la maglia celeste dell’Uruguay.
Si chiamano Héctor Scarone e Tito Borjas. Ragazzi che non conoscono ancora i loro destini: Scarone giocherà anche in Italia e, Giuseppe Meazza, suo compagno di squadra all’Inter dirà di lui che faceva cose che «noi potevamo solo immaginare». Borjas è un giocatore pazzesco, ma la sua carriera e la sua vita finiranno presto, solo tre anni dopo, quando disubbidendo ai medici che gli avevano imposto riposo assoluto dopo un forte dolore al petto sentito mentre giocava una partita, lasciò la propria abitazione per andare sugli spalti a vedere il match decisivo per il titolo dei suoi Wanderers Montevideo e al gol del vantaggio dei compagni di squadra venne stroncato da un infarto.
In quel giugno del 1928, ignari del loro futuro, Héctor e Tito stanno giocando, insieme, la finale olimpica. Tuttavia fra i due non scorre buon sangue, sono troppo forti per stare nella stessa metà campo. In realtà, Héctor e Tito non si parlano proprio, da tantissimo tempo, ma al 28° del secondo tempo, Tito ha la palla fra i piedi, vede Héctor arrivare con un razzo e decide di rompere quel silenzio. Passa la parla e gli urla: «Tua, Hectòr!», come a dire: "Vedi di farcela, voglio fidarmi di te". Héctor segna un gol straordinario da 40 metri.
 L’Uruguay diventa campione olimpico ai danni degli odiati rivali argentini e da quel giorno, nel Paese, c’è un nuovo modo di dire quando si vuol trasmettere il senso di una fiducia incondizionata, che va oltre ogni divisione. Parole che vengono alla mente pensando alla incredibile vicenda dei 12 giovani calciatori thailandesi rimasti intrappolati in una caverna insieme ad Aek, il loro 25enne allenatore e liberati definitivamente ieri dopo 17 giorni passati all’inferno.
L’Uruguay diventa campione olimpico ai danni degli odiati rivali argentini e da quel giorno, nel Paese, c’è un nuovo modo di dire quando si vuol trasmettere il senso di una fiducia incondizionata, che va oltre ogni divisione. Parole che vengono alla mente pensando alla incredibile vicenda dei 12 giovani calciatori thailandesi rimasti intrappolati in una caverna insieme ad Aek, il loro 25enne allenatore e liberati definitivamente ieri dopo 17 giorni passati all’inferno.Si è mobilitato il mondo intero per questa vicenda e il risultato è stato raggiunto grazie a un’enorme capacità di condividere fiducia, anche quando le cose sembravano impossibili. Affidarsi a qualcuno, ci insegna questa storia di cui certamente qualche produttore hollywoodiano si approprierà, può portare alla perdizione e alla salvezza. Aek, l’allenatore orfano che ha passato la sua gioventù in un monastero buddhista aveva preso la decisione di portare i suoi ragazzi in quella grotta per meditare.
Stravolto dai sensi di colpa ha chiesto ripetutamente perdono per quell’idea che le piogge monsoniche stavano per trasformare in tragedia. I genitori di tutti i ragazzi lo hanno perdonato in tempi assolutamente non sospetti, ben prima del lieto fine della vicenda. Anzi, gli hanno ricordato che i loro ragazzi contavano su di lui, laggiù sottoterra come sul campo di calcio. Forse anche per questa iniezione di fiducia Aek è stato decisivo per tenere in vita i suoi ragazzi rinunciando per loro al suo stesso cibo, mantenendoli calmi e gestendo le loro emozioni e paure. E lasciando la grotta per ultimo, da vero coach.
«Sembra impossibile, finché non viene fatto», diceva Nelson Mandela e mentre, in superficie, squadre di calcio di fama planetaria lottano al Mondiale per non tornare a casa, la squadra per cui tutti si augurano il ritorno, finalmente, ce l’ha fatta grazie a una collaborazione di persone provenienti, letteralmente, da ogni parte del mondo. «Tuya, Héctor» anche in memoria di Saman Kunan, il soccorritore unica vittima di questa vicenda. Nel suo ultimo video lo si sente dire: «Porteremo i ragazzi a casa». Aveva ragione.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- LA PRIVATIZZAZIONE DEL NOME "ITALIA" E IL POPULISMO. "Ghe Pensi Mi"!9 luglio 2018, di Federico La Sala
CON DECENZA PARLANDO: LA PRIVATIZZAZIONE DEL NOME "ITALIA" E IL POPULISMO. "Ghe Pensi Mi"!
Una nota*
SICCOME QUI SI TOCCANO TEMI di tranquillizzazione politica (con tutti i suoi risvolti teologici e costituzionali) e di "superomismo" populistico ("stai sereno!" - "scuscitatu" vale come "senza pensieri, senza preoccupazioni": cioè, "Ghe Pensi Mi"), e c’è da svegliarsi e riappropriarsi della propria *dignità* (politica e *costituzionale*, e non solo economica) di cittadini e di cittadine, è bene ricordare che per "stare sereni" troppo e troppo a lungo, come cittadini italiani e cittadine italiane, abbiamo perso la stessa possibilità di "tifare" per noi stessi e stesse, per se stessi e per se stesse, sia sul piano sportivo sia sul piano *costituzionale*: non solo perché la nostra NAZIONALE è fuori dai MONDIALI DI CALCIO ma, anche e soprattutto, perché il NOME della NAZIONE (di tutti e di tutte) è diventato il "Logo" della "squadra" di un Partito e di un’Azienda.
IL LUNGO SONNO DELLA RAGIONE COSTITUZIONALE CONTINUA ...
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- il Festival Filosofia di Modena, Carpi e Sassuolo quest’anno, in cui compie 18 anni, chiude la triade classica aperta anni fa dal Bene e dal Bello, con ’Verità’ (come tema dal 14 al 16 settembre con oltre 50 lezioni magistrali).4 luglio 2018, di Federico La Sala
Festival Filosofia, il tema 2018 è la verità
14-16 settembre, 50 lezioni in anni fake news e post-verità
di Paolo Petroni *
ROMA. Negli anni delle post-verità e delle fake news, del rivendicare onestà come verità contro le menzogne del potere o mentre su molti palazzi comunali uno striscione invoca ’Verità per Giulio Regeni’, il Festival Filosofia di Modena, Carpi e Sassuolo quest’anno, in cui compie 18 anni, ha ritenuto fosse arrivato il momento di scegliere, a chiudere la triade classica aperta anni fa dal Bene e dal Bello, appunto ’Verità’ come tema dal 14 al 16 settembre con oltre 50 lezioni magistrali e 200 appuntamenti tra mostre, spettacoli, letture, laboratori, tutti come sempre gratuiti. ’Verità’, senza articolo, per lasciarle il senso singolare e plurale, visto che si tratta di qualcosa che cambia col tempo, a seconda del contesto culturale e sociale. E come ha sottolineatoa Roma Remo Bodei, presidente del Comitato scientifico del Festival, "solo cogliendone il suo carattere pluralistico, ci si può aprire alla tolleranza", mentre Tullio Gregory ne ha evidenziato il carattere di "convenzione modificabile, tanto che possono convivere allo steso tempo verità diverse, come il valore della dignità dell’uomo e della donna nelle diverse religioni o culture".
Il direttore Daniele Francesconi, col supporto del Comitato e guardando al futuro, sta molto rinnovando i relatori e circa la metà sono nuovi rispetto al passato, cui comunque appartengono le lezioni magistrali di Enzo Bianchi, Massimo Cacciari, Luciano Canfora, Roberto Esposito, Umberto Galimberti, Michela Marzano, Salvatore Natoli, Massimo Recalcati, Emanuele Severino, Silvia Vegetti Finzi e Bodei, mentre tra gli stranieri si segnalano i francesi Christian Delage, Jean-Luc Nancy, Judith Revel, Dan Sperber, Annette Wieviorka e Marc Augé e i tedeschi Wolfram Eilenberger, Julian Nida-Rümelin e Peter Sloterdijk. Un tema impegnativo quindi ’Verità’, che, per definizione, per Bodei "dovrebbe sfuggire a qualsiasi pregiudizio, anche se oggi, col web, che ha illusoriamente messo il sapere a portata di tutti e reso poi tutte le opinioni equivalenti, nascono coalizioni tra chi crede di pensare le stesso cose che diventano accettate come vere, pur non essendolo". Allora, riuscire a far incontrare, discutere, confrontarsi, farsi domande, riflettere al di là delle apparenze è l’importanza di una manifestazione come questa, che l’anno scorso ha avuto più di 190 mila presenze complessive, nella maggioranza provenienti da fuori provincia, dalle regioni del Nord ma anche dal resto d’Italia e molti stranieri, con un 25% di giovani, e una ricaduta economica sul territorio di almeno 3 milioni di euro (a fronte di un budget di 800 mila), come hanno raccontato Gian Carlo Muzzarelli, sindaco di Modena e quelli delle altre due città coinvolte che si dividono gli appuntamenti.
Sei i percorsi, i nuclei tematici, da quello che discute della verità nella discussione filosofica a quello che affronta i percorsi di verifica, scientifici, logici, ecc. da applicare a elaborazioni di verità, quindi il rapporto tra verità e politica ieri e oggi, poi le inevitabili connessioni tra i concetti di vero e di falso e infine il dire il vero tra privato e pubblico, tra denuncia e procedimenti processuali, senza dimenticare le lezioni sui classici, a partire dalla ’Apologia di Socrate’, che è’ l’inizio del pensiero moderno, in cui Platone discute ma non definisce. In queste ottiche, anche le parodie, le caricature, le deformazioni proposte la sera da attori come Neri Marcorè, Angela Finocchiaro, Davide Riondino o un disegnatore come Makkox, hanno un loro senso preciso. Oltre trenta le mostre proposte, dalle personali di Jon Rafman e Ryoichi Kurokawa a interventi site specific nel Palazzo Ducale di Sassuolo dove sarà anche una personale di Wainer Vaccari, mentre Carpi propone una grande retrospettiva di Berengario da Carpi sui rapporti tra scienze e arti nel Rinascimento. E alla fine, davanti ai mille dubbi e domande che saranno nati, ecco l’opportunità di aggrapparsi a una tavola di salvataggio con le certezze di pranzi e cene filosofici ideati da Gregory per i circa settanta ristoranti ed enoteche delle tre città.
* Ansa, 04.07.2018 (ripresa parziale - senza immagini).
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- Storia della coppa del mondo di calcio (1930-2018). Politica, sport, globalizzazione (Riccardo Brizzi e Nicola Sbetti).2 luglio 2018, di Federico La Sala
CALCIO, POLITICA, E IDENTITÀ NAZIONALE. CASO ITALIA: DAL TIFO PER LA SQUADRA DELLA "NAZIONALE" (1982) AL "TIFO" PER LA SQUADRA DEL PARTITO "NAZIONALE" (1994-2018): AVANTI POPOLO ALLA RISCOSSA, IL populismo TRIONFERÀ....*
Una storia della coppa del mondo
di Daniele Serapiglia (Il Mulino, 25 giugno 2018)
Il 14 giugno scorso ha avuto inizio la XXI edizione della coppa del mondo di calcio. Lo stesso giorno a Parigi presso l’Université Sorbonne Nouvelle si è svolto il congresso: La coupe du monde de Football entre Europe et Amériques. Enjeux, acteurs et temporalités d’un événement global -XX - XXI siècles. A questo evento hanno preso parte alcuni dei più importanti storici del calcio, tra cui Matthew Taylor, Fabien Archambault e Paul Dietschy. Proprio a questi ultimi due fanno riferimento Riccardo Brizzi e Nicola Sbetti nell’introduzione al loro volume Storia della coppa del mondo di calcio (1930-2018). Politica, sport, globalizzazione. I due francesi, infatti, sono con John Foot e Simon Martin i più importanti storici del calcio italiano. Ciò è singolare se pensiamo che, eccetto quelli di Sergio Giuntini, non si possano annoverare altri lavori fondamentali sulla storia del calcio del nostro Paese di studiosi nati nella penisola, ma è anche indicativo di come fino a oggi la storiografia nostrana abbia avuto poco riguardo verso questa disciplina. Eppure, come evidenziano Brizzi e Sbetti, il calcio fin dagli anni Trenta si è imposto in Italia quale fenomeno sociale, mostrando le passioni e le contraddizioni della popolazione, per la quale è diventato un mezzo di espressione identitaria.
In questo senso, l’Italia non era differente dagli altri Paesi europei, che, come sottolineava Hobsbawm, hanno trovato nel calcio una delle cartine di tornasole del proprio nazionalismo. Ciò è ancora più importante se contestualizziamo, come ha fatto Judt in Postwar, questo rapporto tra calcio e identità nazionale nell’ambito della costruzione dell’identità europea. Prendendo in considerazione questi elementi, Brizzi e Sbetti descrivono come il calcio si sia imposto tra le masse e quale ruolo abbia avuto la Coppa del mondo nelle dinamiche politiche globali.
Il libro è diviso in otto capitoli, preceduti dalla breve introduzione e seguiti da una altrettanto sintetica conclusione, con un cenno alla funzione politica dei mondiali di Russia 2018 e di Qatar 2022. Al primo capitolo è demandata la descrizione dei primi tornei internazionali e della prima coppa del mondo (Uruguay 1930).
 Il secondo capitolo, dedicato ai mondiali di Italia 1934 di Francia 1938 e al calcio durante la Seconda guerra, si apre con un’efficace nota introduttiva, che problematizza il complesso rapporto tra questo sport e il totalitarismo. Se in altre opere questo tipo di analisi si focalizzava sul ruolo del calcio nella creazione del consenso, nel presente volume essa si concentra sugli elementi contraddittori di questa disciplina, i quali spesso sfuggono dal controllo di qualsiasi tipo di regime.
Il secondo capitolo, dedicato ai mondiali di Italia 1934 di Francia 1938 e al calcio durante la Seconda guerra, si apre con un’efficace nota introduttiva, che problematizza il complesso rapporto tra questo sport e il totalitarismo. Se in altre opere questo tipo di analisi si focalizzava sul ruolo del calcio nella creazione del consenso, nel presente volume essa si concentra sugli elementi contraddittori di questa disciplina, i quali spesso sfuggono dal controllo di qualsiasi tipo di regime.
 Il terzo e il quarto Capitolo, dedicati rispettivamente ai mondiali di Brasile 1950, Svizzera 1954 e Svezia 1958 e a quelli di Cile 1962, Inghilterra 1966 e Messico 1970, rappresentano il baricentro dell’opera. Questi offrono le chiavi per comprendere il peso della Fifa e della coppa del mondo nelle politiche internazionali: particolarmente accurata risulta l’analisi del ruolo dei mondiali nella guerra fredda, con particolare attenzione al processo di decolonizzazione. In questo capitolo ben descritta è la nascita del mito brasiliano, attraverso un’accurata analisi del ruolo del calcio nell’affermazione simbolica del “lusotropicalismo”.
Il terzo e il quarto Capitolo, dedicati rispettivamente ai mondiali di Brasile 1950, Svizzera 1954 e Svezia 1958 e a quelli di Cile 1962, Inghilterra 1966 e Messico 1970, rappresentano il baricentro dell’opera. Questi offrono le chiavi per comprendere il peso della Fifa e della coppa del mondo nelle politiche internazionali: particolarmente accurata risulta l’analisi del ruolo dei mondiali nella guerra fredda, con particolare attenzione al processo di decolonizzazione. In questo capitolo ben descritta è la nascita del mito brasiliano, attraverso un’accurata analisi del ruolo del calcio nell’affermazione simbolica del “lusotropicalismo”.Il capito successivo è dedicato ai mondiali di Germania 1974, Argentina 1978 e a Spagna 1982. Significative risultano le pagine sul mondiale argentino, che ebbe luogo durante il regime di Videla. Ovviamente evocativo è il paragrafo su Spagna 1982. Vengono poi narrate le vicende dei mondiali di Massico 1986, Italia 1990 e Usa 1994. La riflessione ruota attorno alla crescita della Fifa di João Havelange con una particolare attenzione al ruolo dei media nelle kermesse mondiali. Ben visibili sullo sfondo delle tre edizioni sono gli epocali cambiamenti sia della politica italiana, con il canto del cigno della Prima repubblica, sia della politica globale, con la caduta del muro di Berlino e la fine dell’Unione sovietica.
Il settimo e l’ottavo capitolo, infine, sono dedicati alla Fifa di Blatter, dal suo apice al suo declino. Si parla della grandeur di Francia 1998, segnata dal mito dell’integrazione razziale della squadra transalpina; della funzione diplomatica del mondiale di Corea-Giappone 2002; del successo azzurro a Germania 2006 nel mezzo della bufera di Calciopoli. Infine, si discute dei mondiali del Sud Africa del 2010, che furono caratterizzati dall’ultimo saluto al mondo di Nelson Mandela, e di quelli fallimentari di Brasile 2014, che mostrarono le prime crepe nella stagione politica segnata dal governo del Partido dos Trabalhadores.
A causa della lunga periodizzazione, questo libro non esaurisce le possibilità di ricerca sugli argomenti trattati. Crediamo, però, che non fosse questo lo scopo degli autori i quali, più che altro, sembra abbiano voluto proporre al grande pubblico un lavoro capace di raccontare in maniera semplice l’interconnessione tra politica e coppa del mondo, ma soprattutto hanno voluto dare agli studiosi un valido strumento per sviluppare nuovi studi dedicati alla storia del calcio.
 La corposa bibliografia a cui fa riferimento questo volume vede elencate le più importanti pubblicazioni nazionali e internazionali dedicate al calcio, una piattaforma molto utile per la costruzione dello stato dell’arte di futuri lavori sul tema. Ciò è importante soprattutto nel nostro Paese, dove gli storici dello sport spesso hanno trovato difficoltà nel confrontarsi con la letteratura straniera, a causa dell’assenza nelle biblioteche delle più importanti opere degli studiosi inglesi, francesi e americani. Per questo motivo, il libro va considerato un lavoro importante, in particolare per i ricercatori italiani che si cimenteranno in futuro nello studio non solo della storia del calcio, ma più in generale dello sport.
La corposa bibliografia a cui fa riferimento questo volume vede elencate le più importanti pubblicazioni nazionali e internazionali dedicate al calcio, una piattaforma molto utile per la costruzione dello stato dell’arte di futuri lavori sul tema. Ciò è importante soprattutto nel nostro Paese, dove gli storici dello sport spesso hanno trovato difficoltà nel confrontarsi con la letteratura straniera, a causa dell’assenza nelle biblioteche delle più importanti opere degli studiosi inglesi, francesi e americani. Per questo motivo, il libro va considerato un lavoro importante, in particolare per i ricercatori italiani che si cimenteranno in futuro nello studio non solo della storia del calcio, ma più in generale dello sport.
*
SUL TEMA, IN RETE E NEL SITO, SI CFR.:
- QUEL PERTINI MONDIALE. Italo Moretti, giornalista e scrittore, ricorda la calda estate del Mondiale 1982 e la straordinaria passione dell’allora Presidente della Repubblica Sandro Pertini, che volle a tutti i costi assistere alla finale Italia-Germania
- RESTITUITEMI IL MIO URLO!!! IL GIORNO DELLA MEMORIA E LA DIGNITÀ DELL’ ITALIA. IL TRUCCO DELLO SPECCHIETTO DELLE ALLODOLE FUNZIONA ANCORA E LA CARTA DI IDENTITÀ DI TUTTI GLI ITALIANI E DI TUTTE LE ITALIANE E’ RIDOTTA IN POLTIGLIA .... DALLA CINA UNA GRANDE LEZIONE!!!
ALL’ITALIA E PER L’ITALIA. CARO PRESIDENTE NAPOLITANO, SE NON "DORME" E NON SI E’ FATTO ESPROPRIARE DELLA SUA PAROLA, PROVI A GRIDARE DAL QUIRINALE: FORZA ITALIA!!!, COME E CON IL PRESIDENTE PERTINI. Un appello contro l’indecenza
L’ITALIA (1994-2016), TRE PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA SENZA "PAROLA", E I FURBASTRI CHE SANNO (COSA SIGNIFICA) GRIDARE "FORZA ITALIA". In memoria di Sandro Pertini e di Gioacchino da Fiore, alcuni appunti per i posteri
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- Immanuel Kant, Königsberg, Kaliningrad. Mondali di Russia 2018: l’incredibile storia del Baltika Kaliningrad (di Marco Corradi).4 luglio 2018, di Federico La Sala
LE "REGOLE DEL GIOCO" DELL’OCCIDENTE, IMMANUEL KANT, E I MONDIALI DI RUSSIA 2018 .....
Quando i km portano al fallimento: l’incredibile storia del Baltika Kaliningrad. E Putin interviene...
di Marco Corradi *
Possono le trasferte di campionato mandare un club sull’orlo del fallimento? In Russia, paese dalle dimensioni elefantiache (superficie da 17.1mln di km²), tutto è possibile: e quando diciamo tutto, intendiamo tutto, perchè la storia che andiamo a raccontarvi quest’oggi ha davvero dell’incredibile e riguarda un club che non è certo una delle big del paese guidato (da quando abbiamo memoria) da Vladimir Vladímirovič Putin. Stiamo parlando del Baltika Kaliningrad, una società che è decisamente particolare, e non solo per la sua attuale classifica, frutto di tre soli successi in 25 gare di campionato, e il fatto che stia seriamente rischiando di sparire.
Gli appassionati di storia e/o geografia già avranno capito di cosa stiamo parlando, ma vi facciamo un rapido riassunto: la russa Kaliningrad altro non è che la teutonica Königsberg, una città morta e risorta sotto un nuovo nome, una nuova popolazione e un nuovo... disegno. Succede che, al termine della 2a guerra mondiale, i russi ottengano come ”pegno di guerra” proprio Königsberg, antica città-simbolo dell’Impero prussiano, un luogo che diede i natali, ospitò nella sua lunga vita di saggezza e vede sepolto un certo Immanuel Kant (ma anche Eulero, l’uomo del famoso teorema, è nato qui): e, siccome ai russi le cose normali non piacciono, via al colpo di spugna con damnatio memoriae su una città che era troppo tedesca per i loro gusti. La vecchia cattedrale prussiana muore e rinasce come Kaliningrad, in onore a uno dei primi bolscevichi della storia: cacciati gli abitanti tedeschi, la città viene ripopolata con cittadini russi, i monumenti e gli edifici storici abbattuti e si riparte da zero. Kaliningrad viene inserita in uno specifico ‘Oblast, e diventa a tutti gli effetti parte della grande madre Russia, acquisendo uno status decisamente particolare: la città e il suo circondario, infatti, costituiscono una sorta di enclave russa nell’Europa continentale, dato che Kaliningrad è esattamente a metà tra Polonia e Lituania, e decisamente distante dal resto del Paese.
- [Foto] L’incredibile distanza di Kaliningrad dal resto della Russia (foto Wikipedia)
E questo ci riconduce a quel rischio-fallimento già citato in avvio, e alle casse drammaticamente vuote del Baltika Kaliningrad, che attualmente gioca nella 1.Division russa, la nostra Serie B: il club vive un autentico dramma ogni volta che deve cimentarsi in una trasferta, un dramma legato al suo status di ”società russa fuori dalla Russia”. La posizione geografica di Kaliningrad, infatti, è portatrice di caos e problemi ad una società che, nel lungo periodo, si è ritrovata schiacciata dalle eccessive spese (non corroborate dai risultati) per le gare esterne: e tutto questo accade perchè, banalmente, la trasferta minore del Baltika consiste nei 900km verso San Pietroburgo, casa dello Zenit-2, la squadra B della formazione allenata da Lucescu. Avete letto bene, ”minore”, perchè il Kaliningrad vive continui drammi: sfidare il Volgar Astrakhan comporta un viaggio di 2.700km, affrontare il Luch-Energiya Vladivostok una traversata di 10.327 lunghissimi km, ”accorciati” attraverso la trans-siberiana. È una sfida che ha suscitato le fantasie di molti, quella tra Luch-Energiya e Baltika, e in particolare il Vladivostok ha generato aneddoti fantastici riguardo alle trasferte delle varie squadre/tifoserie: si narra che dei tifosi dello Zenit tentarono di raggiungere la città in macchina per una gara di coppa, riuscendoci in 132 modiche ore (5 giorni e mezzo) e dovendo tornare a casa in treno perchè il mezzo era... esploso, mentre Akinfeev (portiere del CSKA e della Nazionale) ha caldamente invitato il Vladivostok a ‘‘iscriversi al campionato giapponese” per l’eccessiva distanza.
- [Foto] L’enorme distanza tra Vladivostok e Kaliningrad (foto Google Maps)
E proprio le trasferte per Vladivostok hanno contribuito a prosciugare (definitivamente?) le casse del Baltika Kaliningrad, che ora rischia seriamente di sparire: la società si trova al 19° posto nella 1.Division, con 20 punti in 25 gare e una stagione da tre sole vittorie in campionato. Lo score del Baltika parla di 3 successi, 11 pareggi e altrettante sconfitte, e l’ultimo hurrà è arrivato proprio oggi, dopo 22 gare di digiuno: il club aveva infatti vinto le prime due gare, salvo poi precipitare in una spirale di impotenza economica e disastri sportivi, che ha portato alla rivoluzione invernale. Via il tecnico Zakhariak, dentro Cherevchenko, che ha ottenuto dal mercato l’ex CSKA Jaffar e giocatori noti come Solomatin (ex Dinamo Mosca) e Sheshukov (ex Lokomotiv Mosca): e qui la domanda sorge spontanea, perchè questi giocatori approdano in un club penultimo in Serie B, con 8 punti da recuperare dalla zona-salvezza per evitare di sparire a fine stagione, e per di più in un’enclave? La risposta è molto semplice, ed ha il nome ed il volto di Putin.
E, se non capite il collegamento tra Kaliningrad e lo zio Vladimiro, siamo qui per spiegarvelo: succede che Kaliningrad sia una delle città designate per i Mondiali di Russia 2018, con tanto di investimento-monstre per allargare l’Arena Baltika e portarla a 45mila posti. L’obiettivo di Putin è semplice, fare di Kaliningrad l’occhio russo in Europa, con un porto sempre più ”curato” dallo Stato, una base missilistica in costruzione e una squadra di calcio perfettamente funzionante: perchè il buon Vladimir sa che il calcio è da sempre ”oppio dei popoli” (e forse anche ”coca dei poveri”, come direbbe Francesco Gabbani), e dunque avere un Baltika ancora in vita è importante per tutto il progetto-Kaliningrad, e anche per l’Arena Baltika stessa. Da qui, e dalla volontà di mostrare ulteriormente il suo potere, nasce l’intervento governativo per salvare le esangui casse della squadra, che stava rischiando seriamente di sparire: è stato Putin a ”pilotare” il rafforzamento invernale del Baltika, ed è stato sempre lui a ”spedire” al capezzale del club Olga Smorodskaya, ex amministratrice della Lokomotiv Mosca che aveva promosso l’abbattimento degli stranieri nella Prem’er Liga (da non confondersi con la Prem’er Liha ucraina), e farà da CEO del Kaliningrad.
- [Foto] Il concept dell’Arena Baltika di Kaliningrad, che sarà finita nel 2018
Un insediamento, il suo, che risponde alla volontà di Putin di salvare il club nelle restanti 13 gare di campionato (nonostante il -8 dalla zona verde), e poi fare in modo di costruire una rosa da promozione nella stagione seguente: perchè avere il Baltika Kaliningrad nella massima serie proprio nell’anno dei Mondiali sarebbe un ottimo spot sia per l’Arena Baltika, che per il delirio da plenipotenziario di Putin. Riuscire a salvare una squadra spacciata, e portarla addirittura in una Prem’er Liga che ha assaggiato solo tra il 1997 e il 1999, dà una sensazione di potere inimmaginabile, e Putin vive per questo: perchè ”la lontanza sa di fallimento” (storpiamo così una canzone di Modugno), ma questo in Russia non lo sanno, o forse semplicemente sono ormai abituati a ridisegnarle a loro piacere le cose. E così, non ci stupiremmo di una salvezza del Baltika Kaliningrad, il club dissanguato dalle trasferte e ormai prossimo al fallimento: perchè Vladimir Putin, si sa, non conosce (purtroppo) la parola sconfitta, nemmeno quando deve rimettere in sesto una squadra di calcio...
(di Marco Corradi, @corradone91) (ripresa parziale - senza immagini).
Sul tema, nel sito, si cfr.:
OCCIDENTE, AGONISMO TRAGICO, E MENTE ACCOGLIENTE.
RIPENSARE L’EUROPA. PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!! FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- "Storie di testi e tradizione classica". Filologia e libetà: filologia e "verità". Note.30 giugno 2018, di Federico La Sala
Canfora, la filologia è libertà
Il volume curato da Rosa Otranto e Massimo Pinto (Edizioni di Storia e Letteratura)
di Livia Capponi (Corriere della Sera, 29.06.2018)
Come lavoravano gli autori greci e latini? Nel suo lungo e intenso magistero, Luciano Canfora, a cui gli allievi Rosa Otranto e Massimo Pinto dedicano il volume collettivo Storie di testi e tradizione classica, ha insegnato ad affrontare ogni testo a partire dalla sua storia, reinventando la filologia come disciplina in grado di leggere non solo i testi giunti fino a noi, ma anche le cicatrici, i tagli, i contorni invisibili di ciò che è stato modellato da un censore, da un copista, dal gusto di un’epoca.
Diversamente da Isocrate, famoso per la sua lentezza nel comporre, e da Pitagora, che preferiva depositare la sua dottrina nei libri più sicuri, cioè nella memoria degli alunni, Canfora, la cui bibliografia conta 843 opere, è più simile a Demostene, che cesellava ogni rigo o a Fozio, patriarca bizantino che salvò il patrimonio letterario antico, aiutato da un’affezionata cerchia di studenti.
Nei contributi qui raccolti, l’erudizione è messa al servizio di una coinvolgente ricerca della verità, intesa come integrità testuale, storica ed etica. Sono toccati i temi prediletti, come l’analisi critica della democrazia, la storia della tolleranza e della libertà di parola, la schiavitù e i perseguitati politici e religiosi da Atene ai giorni nostri, attraverso lo studio di storiografia, archivi, biblioteche e pubblicistica d’ogni epoca. Il tutto condito da empatia e indipendenza di giudizio, in grado di far rivivere gli antichi con grande vivacità: Cesare è ritratto mentre elabora il primo sistema crittografico per l’intelligence romana; Fozio nell’atto di divorare romanzi d’amore greci (per poi censurarli). Coerentemente con la lezione canforiana, lo studio dei classici diventa motivo di apertura mentale perché aiuta a capire il presente e noi stessi.
Filologia e “verità”
di Daniele Ruini (Nazione Indiana, 01 marzo 2009)
Quale importanza abbia avuto, nella storia dell’umanità, la parola scritta è un fatto difficilmente sottostimabile. Per quanto riguarda, più in particolare, la storia delle religioni, ciò è chiaramente evidente in tutti quei culti che riconoscono autorità sacra a uno o più testi, ritenuti frutto della diretta ispirazione divina, ovvero “parola di Dio”. Dato lo speciale statuto assegnato a tali scritture, ogni operazione volta a definirne con esattezza il dettato testuale acquista un valore particolare; se, da un lato, avvicinarsi il più possibile allo stadio originario di un Testo Sacro significa ridurre la distanza che separa dalla supposta Verità in esso contenuta, dall’altro lato, rimettere ogni volta in discussione la lezione di un’opera di tal fatta non può non avere conseguenze delicate per la comunità religiosa che di essa ha fatto il proprio testo di riferimento. Il rapporto tra Sacre Scritture e filologia (la disciplina finalizzata a ricostruire la veste originaria di un testo attraverso lo studio delle varie fasi della sua trasmissione) è infatti necessariamente contraddittorio: il carattere dogmatico della “parola di Dio” può sopportare il libero esercizio critico della filologia? E soprattutto: fino a che punto saranno disposti ad accettarlo i rappresentanti delle gerarchie ecclesiastiche?
È questo il tema al centro di Filologia e Libertà di Luciano Canfora (Mondadori 2008), nel quale si ripercorre la storia delle resistenze del Vaticano dinnanzi all’applicazione della critica testuale alla Bibbia, dando risalto alle figure dei pochi studiosi che quei divieti tentarono di infrangere. Come sottolinea Canfora, riannodare le fila di questo racconto equivale a narrare la storia «della libertà di pensiero attraverso il faticoso e contrastato dispiegarsi della libertà di critica sui testi che l’autorità e la tradizione hanno preservato».
Benché sia sempre esistita una filologia biblica, le cui origini affondano nel giudaismo ellenistico, la Chiesa Cattolica è venuta progressivamente irrigidendosi, assumendo, di fronte alle possibilità di studiare le Sacre Scritture secondo i principi della critica testuale, un atteggiamento di totale chiusura, cui si accompagnò un’azione di repressione nei confronti dei disobbedienti. Tale fu la posizione espressa nelle disposizioni del Concilio di Trento (1545-1563), colle quali fu sancito il primato della Vulgata, ovvero della versione latina della Bibbia tradotta da San Gerolamo nel IV secolo d.C.
In maniera del tutto illogica e fondandosi sulla supposta ispirazione divina del traduttore, veniva riconosciuta la superiorità di una traduzione rispetto al testo originale (ebraico per l’Antico Testamento, greco per il Nuovo). Si trattava di una risposta alle iniziative dei luterani, che rivendicavano invece l’originale biblico e che quello traducevano per la massa dei fedeli. Tali norme rimasero valide fino al Concilio Vaticano II (1965), quando fu finalmente ammessa, anche da parte cattolica, la possibilità di tradurre le Sacre Scritture nelle lingue moderne, favorendone l’accesso al popolo dei credenti.
E nondimeno, la filologia moderna, sviluppatasi storicamente nel XIX secolo sui classici greci e latini, ebbe le sue prime applicazioni proprio in ambito biblico e, più in particolare, neotestamentario. Alla netta chiusura della Chiesa Cattolica - ma atteggiamento non dissimile ebbero le Chiese riformate - si contrappose l’attività di singoli eruditi che, raccogliendo l’eredità di Erasmo da Rotterdam (1466-1536), si prodigarono nello studio della formazione dell’Antico e del Nuovo Testamento, subendo spesso l’ostracismo delle comunità religiose di appartenenza.
 Tra le figure ricordate da Canfora vi sono l’ebreo Baruch Spinoza (1632-1677), il giansenista Richard Simon (1627-1704), i protestanti Pierre Bayle (1647-1706), Johann Jacob Wetstein (1694-1745) e Jean Leclerc (1657-1736). Il loro lavoro fu la principale fonte d’ispirazione della critica illuministica delle religioni, della cui efficacia ed attualità rende conto il fatto che «la condanna dell’illuminismo si replica, di papa in papa, di enciclica in enciclica, fino alla recentissima Spe salvi (par. 19) dell’attuale pontefice».
Tra le figure ricordate da Canfora vi sono l’ebreo Baruch Spinoza (1632-1677), il giansenista Richard Simon (1627-1704), i protestanti Pierre Bayle (1647-1706), Johann Jacob Wetstein (1694-1745) e Jean Leclerc (1657-1736). Il loro lavoro fu la principale fonte d’ispirazione della critica illuministica delle religioni, della cui efficacia ed attualità rende conto il fatto che «la condanna dell’illuminismo si replica, di papa in papa, di enciclica in enciclica, fino alla recentissima Spe salvi (par. 19) dell’attuale pontefice».Le infrazioni ai divieti cattolici in materia di filologia biblica proseguirono nel XIX secolo per merito di alcuni esponenti dell’Institut Catholique di Parigi, ai quali il Vaticano affibbiò l’etichetta di “modernisti”. Tra di essi, Ernest Renan (1823-1892) - autore di una celebre Vita di Gesù in cui si negava la divinità del Cristo -, Louis Duchesne (1843-1922) e Alfred Loisy (1857-1940), cui si devono due volumi sulla Storia del canone dell’Antico e del Nuovo Testamento.
 La durissima presa di posizione del cattolicesimo romano fu affidata alle encicliche Providentissum Deus di papa Leone XIII (1893) e Pascendi dominici gregis di papa Pio X (1907). In quest’ultima, in particolare, il pontefice espresse in termini retrogradi l’allarme risentito verso la critica testuale, il cui carattere eversivo risalirebbe alla pretesa di introdurre nell’ambito dei Testi Sacri il concetto di “evoluzione”, «quasi che la stessa religione fosse opera non di Dio ma degli uomini o un qualche ritrovato filosofico che con mezzi umani possa essere perfezionato» (sic).
La durissima presa di posizione del cattolicesimo romano fu affidata alle encicliche Providentissum Deus di papa Leone XIII (1893) e Pascendi dominici gregis di papa Pio X (1907). In quest’ultima, in particolare, il pontefice espresse in termini retrogradi l’allarme risentito verso la critica testuale, il cui carattere eversivo risalirebbe alla pretesa di introdurre nell’ambito dei Testi Sacri il concetto di “evoluzione”, «quasi che la stessa religione fosse opera non di Dio ma degli uomini o un qualche ritrovato filosofico che con mezzi umani possa essere perfezionato» (sic).Nessuna posizione ufficiale venne più espressa fino al 1943, quando papa Pio XII compì una svolta inaspettata, ammettendo la legittimità della critica testuale in ambito biblico (enciclica Divino afflante spiritu). Non si trattava, tuttavia, di una netta presa di distanza dalle chiusure del passato; l’enciclica pretende anzi di stabilire una continuità colle dichiarazioni dei pontefici precedenti, disegnando una prospettiva distorta secondo cui la Chiesa avrebbe sempre favorito e appoggiato la critica testuale, ed affermando che il riconoscimento della legittimità dell’indagine filologica sui testi sacri non è in contraddizione coi deliberati tridentini.
 L’apertura di papa Pacelli era in realtà la conseguenza della presa d’atto che alcune significative esperienze filologiche recenti avevano reso del tutto obsoleta e non più sostenibile la condanna vaticana verso la critica testuale; capolavori come l’edizione critica dell’Historia Ecclesiastica di Eusebio di Cesarea realizzata da Eduard Schwartz (1905-1909), o quella della Bibbia dei Settanta prodotta nel 1935 in ambiente protestante, costituivano una smentita concreta delle preclusioni cattoliche nei confronti della filologia. D’altra parte, pur nella sua apertura di fondo, Pio XII si appella alla cautela degli studiosi; l’enciclica contiene infatti l’invito a produrre nuove edizioni scientifiche del Testo Sacro pur mantenendo nei suoi confronti «somma riverenza».
L’apertura di papa Pacelli era in realtà la conseguenza della presa d’atto che alcune significative esperienze filologiche recenti avevano reso del tutto obsoleta e non più sostenibile la condanna vaticana verso la critica testuale; capolavori come l’edizione critica dell’Historia Ecclesiastica di Eusebio di Cesarea realizzata da Eduard Schwartz (1905-1909), o quella della Bibbia dei Settanta prodotta nel 1935 in ambiente protestante, costituivano una smentita concreta delle preclusioni cattoliche nei confronti della filologia. D’altra parte, pur nella sua apertura di fondo, Pio XII si appella alla cautela degli studiosi; l’enciclica contiene infatti l’invito a produrre nuove edizioni scientifiche del Testo Sacro pur mantenendo nei suoi confronti «somma riverenza».
 Si tratta, come evidenzia Canfora, di una posizione assurda e insensata, dacché inconciliabile colla pur invocata «rigorosa osservanza di tutte le leggi della critica». Ciò equivarrebbe infatti ad ammettere che “un testo affidabile di Platone possano darlo soltanto dei platonici puri e graniticamente fedeli al “verbo” del maestro (ammesso comunque che tale verbo esista già preconfezionato, prima del necessario, lunghissimo, imprevedibile, lavorio critico)”.
Si tratta, come evidenzia Canfora, di una posizione assurda e insensata, dacché inconciliabile colla pur invocata «rigorosa osservanza di tutte le leggi della critica». Ciò equivarrebbe infatti ad ammettere che “un testo affidabile di Platone possano darlo soltanto dei platonici puri e graniticamente fedeli al “verbo” del maestro (ammesso comunque che tale verbo esista già preconfezionato, prima del necessario, lunghissimo, imprevedibile, lavorio critico)”.
 Questo non-senso nasce dalla convinzione, mai messa in discussione, che i testi inclusi nel canone cattolico - e solo quelli - contengano la verità, una verità «precostituita e testualmente compiuta prima della ricostruzione del testo». L’apparente apertura rivoluzionaria del Vaticano tradisce, quindi, un certo conservatorismo, nell’incapacità di accettare fino in fondo l’idea che «il testo della Scrittura va letto (e criticato) per quello che letteralmente dice, mentre la sua difesa di principio può condursi solo sul piano della “fede”».
Questo non-senso nasce dalla convinzione, mai messa in discussione, che i testi inclusi nel canone cattolico - e solo quelli - contengano la verità, una verità «precostituita e testualmente compiuta prima della ricostruzione del testo». L’apparente apertura rivoluzionaria del Vaticano tradisce, quindi, un certo conservatorismo, nell’incapacità di accettare fino in fondo l’idea che «il testo della Scrittura va letto (e criticato) per quello che letteralmente dice, mentre la sua difesa di principio può condursi solo sul piano della “fede”».Il volume di Canfora costituisce, in conclusione, un elogio della filologia, considerata come un antidoto al dogmatismo e all’oscurantismo e come fondamento della libertà di pensiero.
Per materiali sul tema, nel sito, si cfr.:
LA SAPIENZA E IL MESSAGGIO EVANGELICO. FRANCESCO BACONE E SAN PAOLO PRENDONO LE DISTANZE DALLE ENCICLICHE DI PAPA BENEDETTO XVI. Una "preghiera comune" firmata da Bacone
LA CHIESA DEL SILENZIO E DEL "LATINORUM". Il teologo Ratzinger scrive da papa l’enciclica "Deus caritas est" (2006) e, ancora oggi, nessuno - nemmeno papa Francesco - ne sollecita la correzione del titolo. Che lapsus!!! O, meglio, che progetto!!!
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- Simone de Beauvoir. Quando la donna diventò soggetto (di Francesca Rigotti).17 giugno 2018, di Federico La Sala
FILOSOFIA, ANTROPOLOGIA, E ANATOMIA DELL’UOMO A UNA DIMENSIONE... *
Julia Kristeva
De Beauvoir. Quando la donna diventò soggetto
di Francesca Rigotti (Il Sole-24 Ore, Domenica, 17.06.2018)
- Julia Kristeva,Simone de Beauvoir. La rivoluzione del femminile, trad. di Alessandro Ciappa, Donzelli, Roma, pagg. 140, € 19.
Il prossimo anno ricorrerà il settantesimo dalla pubblicazione di Il secondo sesso, di Simone de Beauvoir (1949), ma non è una cattiva idea cominciare fin d’ora a celebrarlo. Perché quel libro ha rappresentato un evento culturale, una svolta antropologica, una rivoluzione copernicana: con esso, grazie ad esso il soggetto donna si afferma sulla scena dalla quale non sarà più possibile cacciarlo via. E questo per merito di una filosofa e scrittrice, aristocratica, esistenzialista e comunista nonché femminista dell’uguaglianza, il cui status di autrice originale, col suo approccio che è una sintesi di esistenzialismo, hegelianesimo, marxismo e antropologia, si è finalmente consolidato dopo decenni di alterna fortuna.
Lo riconosce Julia Kristeva, migrante venuta da lontano non normalista francese, a sua volta femminista differenzialista e teorica della psicoanalisi, disciplina verso la quale Simone de Beauvoir non nascondeva la propria antipatia e diffidenza. Eppure la vita e l’opera di De Beauvoir (1908-1986) hanno rivoluzionato mentalità e costumi, imprimendo «un’accelerazione all’emancipazione del secondo sesso dopo millenni di dominazione patriarcale e maschile» - riconosce Kristeva in questa raccolta di saggi che invita a rileggere le pagine di una filosofa dalla scrittura romanzesca e di una scrittrice dall’argomentazione filosofica proprio nella nostra epoca polverizzata, nella quale parecchie donne sembrano riadagiarsi nel conformismo sociale.
Alcune correnti femministe rimproverano a De Beauvoir di aver insistito sul registro universale dell’eguaglianza finendo per non vedere, se non negare, il corpo femminile con le sue caratteristiche specifiche tra cui la maternità e l’omosessualità femminile. Eppure ciò non è sufficiente - ribatte proprio Kristeva - a cancellare l’importanza del pensiero di De Beauvoir oggi, non come passaggio storico superato ma in quanto presentificazione degli atti di affermazione del soggetto donna. Operazione che Simone de Beauvoir conduce, sottolinea Kristeva, nei saggi come pure attraverso i romanzi, nei quali la singolarità individuale dei personaggi si trasforma in universalità collettiva politica. Una sfida raccolta anche da Il secondo sesso, ove si invita a singolarizzare il politico e a politicizzare il singolare.
Il lascito di De Beauvoir a tutte le donne è in ogni caso il culto della libertà: la libertà è la sua stella polare, la libertà di Socrate, di Pascal, dell’Illuminismo, di Hegel, di Marx, di Arendt. La libertà che spetta alle donne se riusciranno a uscire dalla condizione di minorità per ottenere la piena eguaglianza, nella polifonia delle posizioni delle donne, femministe o meno, universaliste, differenzialiste, #me too, femen, non una di meno, e se non ora quando. Si potrebbe credere che per riconoscere questo ruolo fondamentale a Simone de Beauvoir Kristeva la spinga verso criteri differenzialisti che non erano i suoi; a me sembra invece che Kristeva rimanga sempre rispettosa e attenta alle peculiarità del pensiero di De Beauvoir di cui affronta persino i sogni, quelli di cui la scrittrice fa dono al lettore in A conti fatti: sogni di cadute e voli, di maternità e fughe e di fughe dalla maternità, nei quali si mostra la geniale capacità dell’autrice di svelare ciò che è più intimo conciliandolo con i disagi dell’epoca per trasformarli in priorità politiche.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- FILOSOFIA, ANTROPOLOGIA, E ANATOMIA...
 IN NOME DELL’EMBRIONE, UNA VECCHIA E DIABOLICA ALLEANZA. Anche dopo l’ammissione del medico Giovanni Valverde (1560)
IN NOME DELL’EMBRIONE, UNA VECCHIA E DIABOLICA ALLEANZA. Anche dopo l’ammissione del medico Giovanni Valverde (1560)
 DONNE, UOMINI, E SCIENZA: "Avrei voluto con mio honore poter lasciar questo capitolo, accioche non diventassero le Donne più superbe di quel, che sono"!
DONNE, UOMINI, E SCIENZA: "Avrei voluto con mio honore poter lasciar questo capitolo, accioche non diventassero le Donne più superbe di quel, che sono"!
UN NUOVO UMANESIMO?! Pensare l’ "edipo completo"(Freud)
CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- Aquarius: se io fossi Papa (di Paolo Farinella, prete).14 giugno 2018, di Federico La Sala
"ADAMO", "ABRAMO", I TRE MONOTEISMI, L’ONU, E LA STORIA DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE ... *
Aquarius: se io fossi Papa, scomunicherei Matteo Salvini
di Paolo Farinella, sacerdote (Il Fatto quotidiano, 12 giugno 2018)
Finita la civiltà occidentale, è iniziata l’inciviltà di Salvini Matteo, segretario della Lega non più secessionista ma a vocazione planetaria, (vice)Presidente del Consiglio dei ministri in atto e cattolico «coerente» (l’ha detto lui medesimo in persona!), in risposta al cardinal Gianfranco Ravasi che twittava il Vangelo di Matteo al capitolo 25,43: «Ero straniero e non mi avete accolto». La motivazione della coerenza cristiana di Matteo Salvini: «Ho il rosario in tasca, io coerente con gl’insegnamenti del Vangelo».
 È il capovolgimento di ogni ordine e principio. Se avere un oggetto in tasca è segno di coerenza, chi porta le «Madonne ripiene» di Lourdes, le immagini dei Padri Pii e armamentari di questo genere, cosa è? Un padre/madre eterno in terra?
È il capovolgimento di ogni ordine e principio. Se avere un oggetto in tasca è segno di coerenza, chi porta le «Madonne ripiene» di Lourdes, le immagini dei Padri Pii e armamentari di questo genere, cosa è? Un padre/madre eterno in terra?Se io fossi Papa, lo scomunicherei in forza delle sue stesse parole che sono un insulto a tutto l’insegnamento evangelico, tenuto conto che per un ministro della Repubblica Italiana, fresco di giuramento «di servire con disciplina e onore», dovrebbe essere ininfluente l’aspetto, finto o vero che sia, della religione perché bastano e avanzano i principi della Costituzione che anche Salvini difese nel referendum del 2016, le leggi e i trattati internazionali, sottoscritti dall’Italia e la legge della coscienza che su tutto fa prevalere l’umanità e il pericolo imminente di vita.
Nella creazione, «Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno, mentre chiamò le tenebre notte» (Gen 1,4-5), ora le tenebre prendono il posto del giorno come se niente fosse.
Mi ribello a questa ignominia che, come scrive Lucia Annunziata su Huffington Post, ci riporta indietro di 72 anni minimo alla vergogna della nave ebraica «Exodus». In questi giorni, nella mia parrocchia, abbiamo pubblicato tutti i bilanci e gli aiuti che diamo a oltre un centinaio di persone/famiglie (50% italiani e 50% di origine non italiana), provengono unicamente da contribuzioni volontarie di circa 150 persone.
 Non un soldo pubblico, non un contributo politico che non vogliamo perché abbiamo un senso di dignità che esige la compartecipazione e il sentimento umano. La «pacchia» la rimandiamo indietro al mittente perché è lui che lucra elettoralmente e politicamente dalla disgrazia dei migranti.
Non un soldo pubblico, non un contributo politico che non vogliamo perché abbiamo un senso di dignità che esige la compartecipazione e il sentimento umano. La «pacchia» la rimandiamo indietro al mittente perché è lui che lucra elettoralmente e politicamente dalla disgrazia dei migranti.A Salvini e a Di Maio che ho votato per scardinare l’immondo sodalizio «Renzi/Berlusconi» e non per trovarmi i fascisti al governo, nonostante la Costituzione, dedico queste parole nelle quali mi riconosco io e il meglio del popolo italiano:
- «Tutti i figli di Adamo formano un solo corpo, sono della stessa essenza. Quando il tempo affligge con il dolore una parte del corpo (anche) le altre parti soffrono. Se tu non senti la pena degli altri, non meriti di essere chiamato uomo».
Queste parole sono scolpite nell’atrio del Palazzo dell’Onu. Parole antiche, di Poeta e di Mistico, Saādi di Shiraz, Iran1203-1291. Nove secoli fa un persiano musulmano esprimeva un pensiero che è ebraico e cristiano. Nella Bibbia, «Adamo» non è nome proprio di persona, ma nome collettivo e significa «Umanità - Genere Umano», senza aggettivi perché non è occidentale, orientale, del nord o del sud, ma solo universale.
 L’Onu ha scolpito le parole sul suo ingresso perché le nazioni possano leggerla prima di deliberare per richiamarsi l’orizzonte delle decisioni. Europa, Italia e Occidente fan parte dell’Onu al punto che spiriti poveri osano parlare di «civiltà occidentale», identificandola, sacrilegamente, con il Crocifisso, senza memoria di storia, di geografia e di civiltà.
L’Onu ha scolpito le parole sul suo ingresso perché le nazioni possano leggerla prima di deliberare per richiamarsi l’orizzonte delle decisioni. Europa, Italia e Occidente fan parte dell’Onu al punto che spiriti poveri osano parlare di «civiltà occidentale», identificandola, sacrilegamente, con il Crocifisso, senza memoria di storia, di geografia e di civiltà.La nostra civiltà sta regredendo verso la preistoria, verso il nulla. Come insegna il secolo XX, secolo di orrori, la barbarie porta all’abisso e inghiotte la Storia in un buco nero senza ritorno. Guardando le immagini di umanità crocifissa nella miseria dell’opulenza attorno al Grattacielo della Regione Liguria, ho pensato istintivamente alle parole del pastore protestante tedesco, Martin Möller, pronunciate nel 1946 in un sermone liturgico: -***«Prima di tutto vennero a prendere gli zingari e fui contento, perché rubacchiavano. Poi vennero a prendere gli ebrei e stetti zitto, perché mi stavano antipatici. Poi vennero a prendere gli omosessuali, e fui sollevato, perché mi erano fastidiosi. Poi vennero a prendere i comunisti, e io non dissi niente, perché non ero comunista. Un giorno vennero a prendere me, e non c’era rimasto nessuno a protestare».
A Genova il Comune ha deciso di restaurare la Lanterna, simbolo della città, faro di luce nel buio e segnale per rotte sicure; a Genova, in Italia, in Europa e nel Mondo si perseguitano i poveri, i senza dimora, gli sbandati, figli di una società impazzita che crede di potersi chiudere in sé, erigendo muri e fili spinati, mentre si difendono Istituzioni ed Europa, gusci vuoti d’ideali, ma pieni di interessi miopi. Chi costruisce muri distrugge l’Europa e il proprio Paese, chi perseguita il povero si attira la collera di Dio che è «il Dio degli umili, il soccorritore dei piccoli, il rifugio dei deboli, il protettore degli sfiduciati, il salvatore dei disperati» (Gdt 14,11).
 La civiltà e il suo cammino lo avevano indicato nei millenni antichi le Scritture degli Ebrei, dei Cristiani e dei Musulmani, recepiti dalla modernità nell’esistenza stessa dello spirito delle Nazioni Unite, che si riconoscono in Saādi di Shiraz.
La civiltà e il suo cammino lo avevano indicato nei millenni antichi le Scritture degli Ebrei, dei Cristiani e dei Musulmani, recepiti dalla modernità nell’esistenza stessa dello spirito delle Nazioni Unite, che si riconoscono in Saādi di Shiraz.Se oggi, cittadini, uomini e donne, politici e amministratori, vescovi e preti, politici e governanti, sindaci e assessori, credenti e non credenti, docenti e studenti, non si riconoscono laicamente nelle parole che vengono dal lontano Medio Evo, noi abbiamo messo mano alla scure per recidere l’albero su cui siamo seduti. Se non ci si chiede la ragione per cui i poveri aumentano, i senza casa aumentano, gli sbandati crescono esponenzialmente e i migranti africani chiedono il conto, siamo colpevoli di assassinio della civiltà, non salveremo noi, ma ci votiamo destiniamo alla distruzione.
Berthold Brecht (1898-1956), poeta e drammaturgo, nelle Poesie di Svendborg (1933-1938), 1937 (traduzione di E. Castellani-R. Fertonani) ne ha una col titolo «Germania», atto di accusa al sopruso del forte sul debole, all’arroganza del sistema sulla persona. A sessant’anni della sua morte, Germania è nome simbolico, sostituibile con Italia, Ungheria, Polonia, Austria, Olanda, Genova, Torino Milano, Roma, Io, Tu, Egli, Noi, Voi e Loro: -***«Parlino altri della propria vergogna, / io parlo della mia. /O Germania, pallida madre! / come insozzata siedi / fra i popoli! / Fra i segnati d’infamia /tu spicchi. / Dai tuoi figli il più povero/ è ucciso. / Quando la fame sua fu grande / gli altri tuoi figli / hanno levato la mano su lui. / ... Perché ti pregiano gli oppressori, tutt’intorno, ma / ti accusano gli oppressi? / Gli sfruttati / ti mostrano a dito, ma / gli sfruttatori lodano il sistema / che in casa tua è stato escogitato! / E invece tutti ti vedono / celare l’orlo della veste, insanguinato / dal sangue del migliore / dei tuoi figli. / O Germania, pallida madre! / Come t’hanno ridotta i tuoi figli, / che tu in mezzo ai popoli sia / o derisione o spavento!» (Berthold Brecht).
Possano la Poesia e la Memoria rinsavire Ragione e Dignità. Salvini, la Lega, Di Maio e l’illusione passeranno, l’umanità sopravvivrà e i poveri porteranno fiori sulle loro tombe. È la Storia, bellezza! È la Storia!
*
SUL TEMA NEL SITO, SI CFR.:
SAN PAOLO, COSTANTINO, E LA NASCITA DEL CATTOLICESIMO. La "donazione di Pietro", la "donazione di Costantino" e noi, oggi.
- FORZA "CRISTO RE"!!! (Paolo di Tarso): "vivendo secondo la verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa verso di lui, che è il capo, Cristo, dal quale tutto il corpo, ben compaginato e connesso, mediante la collaborazione di ogni giuntura, secondo l’energia propria di ogni membro, riceve forza per crescere in modo da edificare se stesso nella carità" (Ef. 4,15-16)
- "È significativo che l’espressione di Tertulliano: "Il cristiano è un altro Cristo", sia diventata: "Il prete è un altro Cristo"" ([Albert Rouet, arcivescovo di Poitiers, 2010).
"ERODE" E LE GERARCHIE CATTOLICO-ROMANE CONTRO CRISTO E "CONTRO CESARE. Cristianesimo e totalitarismo nell’epoca dei fascismi". Il lavoro di Emilio Gentile
CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico
GUARIRE LA NOSTRA TERRA. "Potrei, per me, pensare un altro Abramo" (F. Kafka).
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! - L’APE E L’ARCHITETTO?! API MATEMATICHE. Anche le api riconoscono lo zero! La scoperta solleva non poche domande.9 giugno 2018, di Federico La Sala
MATEMATICA, TEOLOGIA POLITICA, E ANTROPOLOGIA...
Api matematiche, riconoscono lo zero
Come delfini, pappagalli e scimpanzè
di Redazione Ansa*
- Anche le api riconoscono lo zero, come delfini e scimpanzè (fonte: Bob Peterson, Wikipedia) © ANSA/Ansa
Anche le api entrano a far parte del club molto esclusivo di animali che sanno cos’è lo zero, insieme a delfini, pappagalli, scimpanzè e bambini in età prescolare: si tratta di una scoperta sorprendente, considerata la complessità del concetto matematico astratto del nulla, e apre a nuovi e più semplici approcci per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Lo studio, pubblicato sulla rivista Science, è stato coordinato dall’Università di Melbourne in Australia (Rmit), in collaborazione con l’Università francese di Tolosa.
La scoperta solleva non poche domande su come una specie così diversa e lontana dagli esseri umani, con meno di un milione di neuroni a confronto degli 86 milioni del cervello umano, possa condividere un’abilità così complicata: infatti lo zero è un concetto molto difficile che i bambini impiegano anni ad imparare e che era assente in alcuni sistemi numerici di antiche civiltà.
I ricercatori guidati da Scarlett Howard hanno attirato gli insetti verso una parete con piccoli fogli bianchi, ognuno con un numero da due a cinque di forme nere disegnate. Dopo aver addestrato le api tramite ricompense di cibo a scegliere i fogli con un minore o un maggior numero di forme, i ricercatori hanno introdotto due numeri nuovi, uno e zero: a quel punto gli insetti hanno dimostrato di sapere che lo zero è minore di uno.
"Se un’ape riesce a riconoscere lo zero con meno di un milione di neuroni", dice Adrian Dyer dell’Università di Melbourne, uno degli autori, "allora devono esserci modi più semplici ed efficienti per insegnare lo stesso concetto ai sistemi di Intelligenza Artificiale. Ad esempio - prosegue - per noi è semplice attraversare la strada quando non passa nessuno, ma per un robot risulta un compito molto più difficile".
Sul tema, nel sito, si cfr.:
CONTARE E PENSARE: MARE, "NUMERO E LOGOS".
CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
MATEMATICA, TEOLOGIA POLITICA, E ANTROPOLOGIA: CONTIAMO E PENSIAMO ANCORA COME SE FOSSIMO NELLA CAVERNA DI PLATONE. NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- "La democrazia del narcisismo": declino e (possibile) Caduta della Democrazia (di Sergio Benvenuto).6 giugno 2018, di Federico La Sala
Narcisismo e democrazia
di Sergio Benvenuto (Doppiozero, 06 giugno 2018)
Il libro di Giovanni Orsina, La democrazia del narcisismo. Breve storia dell’antipolitica (Marsilio) si inserisce in un filone di studi che chiamerei, parafrasando Gibbon: Declino e (possibile) Caduta della Democrazia. Insomma, Orsina tematizza uno dei maggiori problemi della nostra epoca: la crisi della democrazia pluralista e liberale.
Una crisi che non a tutti appare evidente. Perché è vero che 25 paesi negli ultimi 18 anni sono retrocessi, per dir così, dalla democrazia al dispotismo - compresi Russia, Turchia e Venezuela - ma in Occidente la democrazia può sembrare ben salda. In effetti, le tre grandi catastrofi degli ultimi due anni - Brexit, elezione di Trump, vincita dei partiti anti-politica in Italia - si sono prodotte rispettando in tutto i meccanismi democratici. Non è un caso, però, che molti commentatori, anche in Italia, abbiano deprecato la decisione di Cameron di indire un referendum sull’appartenenza del Regno Unito all’Europa: “non è materia su cui ha da decidere il popolo”, hanno detto. -Insomma, molti democratici cominciano ad aver seriamente paura della democrazia. E ne hanno le ragioni, perché sappiamo che talvolta le democrazie uccidono democraticamente se stesse: fu questo il caso del fascismo italiano nel 1923, del nazismo in Germania nel 1933, delle elezioni algerine del 1991, e più di recente delle elezioni russe (Putin), turche (Erdogan) e venezuelane (Maduro). Il presupposto di onniscienza politica della democrazia è smentito storicamente. Un popolo può liberamente decidere di rovinarsi, come accade a certi individui, che decidono liberamente di rovinarsi; ne conosciamo tanti.
Ma per Orsina come per altri (incluso il sottoscritto) il sintomo della crisi della democrazia in Occidente è l’avanzare dei cosiddetti partiti populisti, ovvero “anti-politici”. Partiti o movimenti ossimorici, perché attaccano il potere politico proponendo se stessi come potere politico. Ma il merito di Orsina è di situare questo retreat della liberal-democrazia non come evento nuovo, congiunturale, ma come il manifestarsi di una contraddizione fondamentale nel genoma stesso della democrazia. Così, Orsina si appella all’analisi, così ambivalente, di Tocqueville della democrazia americana nell’800.
 Potremmo dire che questo filone di studi cerca di fare nei confronti della democrazia quel che Karl Marx fece nei confronti del capitalismo. Per Marx il capitalismo non sarebbe caduto per la rivolta indignata delle classi oppresse, ma per un’implosione interna, per il venire al pettine dei nodi di una contraddizione fondamentale del capitalismo stesso. Analogamente, la democrazia comporta una contraddizione fondamentale che sta per venire al pettine. Siccome la profezia marxiana del crollo del capitalismo non si è (finora) verificata, c’è solo da augurarsi che, analogamente, il crollo della democrazia non si verifichi. Ce lo auguriamo perché dopo tutto pensiamo come Churchill, che la democrazia è il peggiore dei sistemi politici, a esclusione di tutti gli altri.
Potremmo dire che questo filone di studi cerca di fare nei confronti della democrazia quel che Karl Marx fece nei confronti del capitalismo. Per Marx il capitalismo non sarebbe caduto per la rivolta indignata delle classi oppresse, ma per un’implosione interna, per il venire al pettine dei nodi di una contraddizione fondamentale del capitalismo stesso. Analogamente, la democrazia comporta una contraddizione fondamentale che sta per venire al pettine. Siccome la profezia marxiana del crollo del capitalismo non si è (finora) verificata, c’è solo da augurarsi che, analogamente, il crollo della democrazia non si verifichi. Ce lo auguriamo perché dopo tutto pensiamo come Churchill, che la democrazia è il peggiore dei sistemi politici, a esclusione di tutti gli altri.Va detto che Orsina, professore di Storia contemporanea alla LUISS, non si rifà tanto a sociologi e politologi accademici, quanto piuttosto a testi e ad autori del mondo filosofico e poetico: a La rivolta delle masse di José Ortega y Gasset, a Nelle ombre del domani di Johan Huizinga, a Massa e potere di Elias Canetti, a Montale, a Marcel Gauchet. È tra quelli che pensano che non bastino fatti e statistiche per capire il mondo in cui viviamo: occorrono anche le intuizioni, le folgorazioni intellettuali, di scrittori e filosofi.
Del resto, sin dal titolo - che riecheggia il bestseller anni 70 La cultura del narcisismo di Christopher Lasch - Orsina usa un concetto non ‘sociologico’, quello di narcisismo. Concetto freudiano più che mai, anche se l’autore non cita Freud ma i sociologi e i pensatori che, oltre Lasch, hanno sdoganato il concetto di narcisismo nella cittadella sociologica (Tom Wolfe, Richard Sennett, Gilles Lipovetski).
 Ora, per narcisismo Orsina non intende egoismo e nemmeno individualismo. Quest’ultimo, diceva Tocqueville, “è un sentimento ponderato e tranquillo”, è il valutare oculatamente i costi e benefici, e difatti tutte le teorie liberali si basano sull’individuo come homo rationalis, come buon calcolatore dei propri personali vantaggi. Il narcisista invece è una personalità fondamentalmente irrazionale (ho cercato di descrivere il narcisismo secondo Freud qui). Non è tranquillo, anzi, tende all’ira e alla protesta perenne, divorato da una frustrazione che lo assilla. In modo stringato, possiamo dire che il narcisista è chi si crede. Chi crede solo nella propria opinione, e che crede soprattutto nei propri desideri. Ma siccome nella vita sociale ci sarà sempre qualcuno al di sopra di lui, sentirà conficcate nella sua pelle “le spine del comando” (dice Orsina citando Canetti) ogni volta che ubbidirà a qualche ordine, e tutte queste spine costituiranno “un duro cristallo di rancore”. Perciò le democrazie sono caratterizzate da un cumulo di rabbia contro chi “comanda”, come ha visto il filosofo Peter Sloterdijk in Ira e tempo, dove parla di partiti e movimenti politici come “banche dell’ira”.
Ora, per narcisismo Orsina non intende egoismo e nemmeno individualismo. Quest’ultimo, diceva Tocqueville, “è un sentimento ponderato e tranquillo”, è il valutare oculatamente i costi e benefici, e difatti tutte le teorie liberali si basano sull’individuo come homo rationalis, come buon calcolatore dei propri personali vantaggi. Il narcisista invece è una personalità fondamentalmente irrazionale (ho cercato di descrivere il narcisismo secondo Freud qui). Non è tranquillo, anzi, tende all’ira e alla protesta perenne, divorato da una frustrazione che lo assilla. In modo stringato, possiamo dire che il narcisista è chi si crede. Chi crede solo nella propria opinione, e che crede soprattutto nei propri desideri. Ma siccome nella vita sociale ci sarà sempre qualcuno al di sopra di lui, sentirà conficcate nella sua pelle “le spine del comando” (dice Orsina citando Canetti) ogni volta che ubbidirà a qualche ordine, e tutte queste spine costituiranno “un duro cristallo di rancore”. Perciò le democrazie sono caratterizzate da un cumulo di rabbia contro chi “comanda”, come ha visto il filosofo Peter Sloterdijk in Ira e tempo, dove parla di partiti e movimenti politici come “banche dell’ira”.In effetti la democrazia non è solo un sistema per scegliere chi deve governare, essa si basa su una Promessa fondamentale, implicita o esplicita che sia: l’auto-determinazione di ciascun uomo e di ciascuna donna. Ovvero, non c’è alcun criterio che trascenda la volontà di ciascuno, sia esso la religione, la patria, il re, la classe sociale... “Il popolo è sovrano”, quindi ciascuno si sente sovrano nel pensare e nell’odiare. Ormai contano le opinioni dei singoli, ovvero la loro somma, non l’autorevolezza delle opinioni: se un’opinione è diffusa, diventa ipso facto autorevole. Se un libro si vende bene, allora è un capolavoro. Se un leader cialtrone prende una barca di voti, diventa ipso facto un grande uomo politico. Da qui l’esplosione dei sondaggi d’opinione: essi servono non solo a sapere quel che la gente pensa, ma a stabilire, appunto, che cosa vale e che cosa no. Ora, ciascuno è convinto che la propria opinione sia quella giusta, anche se in realtà non sa nulla di ciò di cui ha un’opinione. In democrazia, dicevano gli antichi greci, prevale la doxa, l’opinione, non l’epistheme (il sapere). Dico qui a parole mie quel che mi sembra il succo del libro di Orsina.
Decenni fa le persone semplici, non colte, mi chiedevano spesso “Professore, ma per chi devo votare?” Non rispondevo, ligio all’ideale democratico per cui il “professore” non deve esercitare un’autorità intimidente sull’elettore. Oggi invece le persone senza cultura non sanno che farsene non solo delle mie idee politiche, ma di quelle di tutti i professori. Del resto, per ogni opinione, per quanto becera, si riesce a trovare sempre qualche “esperto” che la puntelli o la legittimi. Si scoprono “specialisti” i quali dicono che vaccinare i bambini fa male, per esempio, quando si spande il rumor secondo cui vaccinare fa male. Il narcisismo è insomma l’arroganza dei propri desideri e delle proprie opinioni; non conta più il percorso - di studio, riflessione, informazione, confronto con esperti - che porta ad avere un’opinione che pesi.
Così, scrive Michel Crozier (citato da Orsina):
- I cittadini avanzano richieste incompatibili fra di loro. Insistono perché i loro problemi siano affrontati in maniera più efficace, e perciò chiedono più controllo sociale. Allo stesso tempo, si oppongono a qualsiasi forma di controllo sociale si associ ai valori gerarchici che hanno imparato a scartare e rigettare.
- Emerge qui la contraddizione fondamentale della democrazia, grazie al narcisismo che essa genera: ci si aspetta che loro (i politici) risolvano i problemi, ma per risolverli costoro devono esercitare un’autorità, devono infliggere “le spine del comando” e limitare l’autodeterminazione su cui la democrazia si fonda, eppure questa limitazione è costantemente rigettata. Scrive Orsina:
- Cacciati dalla porta, i vincoli della piena autodeterminazione soggettiva rientrano dalla finestra. È vero che il narcisista non è più tenuto a osservare alcun codice etico, ma deve comunque sottostare alle regole che disciplinano la convivenza civile. È vero che nessuno può più imporgli dall’esterno alcun obiettivo esistenziale, ma è soltanto dall’esterno che possono venire la stima altrui e il successo sociale dei quali ha disperato bisogno - anche perché osserva con invidia i molti che, attorno a lui, riescono a raccoglierli (p. 60).
Insomma, il principio di autodeterminazione di ciascuno porta a un indebolimento progressivo della politica. Da qui il crescente discredito dei politici: essi fanno da capro espiatorio di questa contraddizione fondamentale. Vengono applauditi solo i politici che si dichiarano anti-politici... Il narcisista moderno esige dalla politica che risolva i propri problemi, ma siccome la politica deve cercare di risolvere anche i problemi degli altri, qualunque cosa un politico farà sarà sempre insoddisfacente. Ogni misura politica pesta sempre i piedi a qualcuno. Ogniqualvolta un politico agirà politicamente, tenendo conto quindi dei vari interessi tra loro spesso contrapposti, sarà sempre considerato fallimentare, anzi un corrotto.
Si prenda il caso esemplare della lotta all’evasione fiscale: questa dovrebbe essere popolare perché permette allo stato di avere più fondi per i servizi pubblici, per il sistema sanitario..., ma essa comporta una decurtazione del reddito di chi prima evadeva. Solo questa decurtazione viene vista, e biasimata.
Il paradosso è che la credibilità dei politici si abbassa sempre più man mano che essi si convertono alla demagogia, diventando “cantastorie” come dice Orsina, ovvero aizzano richieste specifiche anche se irrealistiche al fine di guadagnare voti e potere. Sempre più abdicano a una funzione che i politici di vecchio stampo esercitavano: quella di presentare agli elettori anche gli oneri che un sistema politico-economico esige, i vincoli che vengono dall’economia, dal sistema internazionale delle alleanze. Oggi i politici promettono sempre di più a tutti, non mettono mai gli elettori di fronte alla complessità e alla durezza dei problemi sociali. Ma la demagogia dà un vantaggio effimero: prima o poi, l’elettore capisce che le promesse non vengono mantenute. E si volgerà a un altro demagogo...
Si è denunciato il fatto che il nuovo governo della Lega e del M5S in Italia si basi su due progetti praticamente contraddittori: da una parte la flat tax, che di fatto regala soldi ai più ricchi; dall’altra il reddito di cittadinanza, che dovrebbe andare ai più poveri. Ma se lo stato rinuncia a una parte cospicua delle tasse, gli sarà impossibile dare un reddito a chi non lavora.
 Il fatto che questi due progetti abbiano trovato una sorta di affinità elettiva è un’allegoria della contraddizione della democrazia narcisista: dallo stato, ovvero dalla politica, si chiede che da una parte esso dia sempre più, ma dall’altra gli si vuole dare sempre meno. Esigo che lo stato spenda sempre più per me, ma mi rifiuto sempre più di dargli questi soldi da spendere. Il segreto dell’esplosione del debito pubblico in Italia, che ha raggiunto il 130% del PIL nazionale, è tutto qui (esso è il frutto di decenni di politiche che hanno comprato consenso di massa indebitando però i nostri figli fino al collo).
Il fatto che questi due progetti abbiano trovato una sorta di affinità elettiva è un’allegoria della contraddizione della democrazia narcisista: dallo stato, ovvero dalla politica, si chiede che da una parte esso dia sempre più, ma dall’altra gli si vuole dare sempre meno. Esigo che lo stato spenda sempre più per me, ma mi rifiuto sempre più di dargli questi soldi da spendere. Il segreto dell’esplosione del debito pubblico in Italia, che ha raggiunto il 130% del PIL nazionale, è tutto qui (esso è il frutto di decenni di politiche che hanno comprato consenso di massa indebitando però i nostri figli fino al collo).Da qui il paradosso: lo stato italiano è fortemente indebitato, mentre i patrimoni e i risparmi personali sono altissimi. In Italia abbiamo uno stato quasi alla bancarotta, e una ricchezza privata cospicua.
Come nota Orsina, i pericoli della democrazia del narcisismo hanno portato gli stati, nel corso degli ultimi decenni, a sottrarre spazi al controllo democratico (cosa che viene denunciata dai populisti). Le banche centrali si sono autonomizzate sempre più dal potere politico, difendono la moneta del paese senza subire le pressioni dei governi, i quali esprimono le esigenze confuse di chi li ha eletti. Orsina legge il distacco crescente della magistratura dal potere politico come un altro segno di questa secessione di parti dello stato dal controllo democratico (sempre più, in quasi tutti i paesi, i magistrati fanno la loro politica; come abbiamo visto in Brasile oggi con Lula, la magistratura può opporsi fermamente alla volontà popolare). Egli nota, ad esempio, che tra il 1969 e il 1976 la quota di budget federale americano sul quale la politica conservava un controllo discrezionale si è dimezzato, scendendo dal 50 al 24%. Le istituzioni europee, di fatto, tolgono spazi all’autodeterminazione dei singoli paesi, imponendo a ciascuno parametri entro cui operare. Va detto che questo controllo della tecnocrazia europea sui destini nazionali non ha funzionato sempre. Non ha impedito il crack della Grecia nel 2016 né l’esplosione del debito pubblico italiano e portoghese fino a oggi.
Molti denunciano questo crescente potere tecnocratico e rivendicano più democrazia, ma non si rendono conto del fatto che la secessione di molte funzioni dalla “politica” - banche centrali, magistratura, FMI, WTO, ecc. - è proprio un ammortizzatore della democrazia frutto della democrazia stessa: rispetto all’autodeterminazione di tutti contro tutti, le istituzioni non elette, “tecniche”, pongono dei paletti fondamentali che impediscano le derive. Così, le costrizioni esterne imposte dai trattati internazionali, che il narcisista delle democrazie rigetta rivendicando la propria autodeterminazione nazionale (o regionale), rientrano.
“Il basso continuo” (è l’espressione di Orsina) dei populismi, rivendicando la propria sovranità nazionale di contro ai vincoli che pone a una nazione il tessuto europeo (o, per gli Stati Uniti, il NAFTA e altri trattati internazionali), titilla il desiderio di autodeterminazione di ciascuno. Si dice “Se noi italiani potessimo decidere tutto quello che vogliamo, senza tener conto dell’Europa, saremmo più liberi...” Si tratta ovviamente di un’illusione, perché rinunciare ai vincoli volontari non evita affatto i vincoli involontari, quelli imposti dai mercati internazionali, ad esempio. Rinunciare ai vincoli con altri stati ci mette in balia di forze economiche e politiche internazionali per noi ancor più incontrollabili.
Vent’anni fa ci fu una forte reazione alla globalizzazione “da sinistra”. Ma la sinistra, soprattutto marxista, è globalista per vocazione. Il vero grande attacco alla globalizzazione - di cui Trump e la Brexit sono gli episodi più salienti - viene però oggi da destra, o dai “populismi”. Dilaga la tendenza a negare l’evidenza di un mondo globalmente interconnesso, tornando alle vecchie identità, nazionali o regionali.
Ora, questa esigenza di autodeterminazione va sempre più spezzettandosi: ogni regione potrà pensare che sia meglio decidere da sola, senza avere i lacci nazionali che la legano ad altre regioni, magari più povere, ecc.
Lo abbiamo visto con la Lega Nord, prima che svoltasse verso un nazionalismo neo-fascista. Accade così che da una parte la Gran Bretagna decide di separarsi dall’Europa, ma dall’altra questo spingerà scozzesi e nord-irlandesi a volersi separare a loro volta dalla Gran Bretagna, ecc. ecc. Alla fine di questo processo ricorsivo di separazioni, nel quale ci si illuderà di diventare sempre più liberi... c’è solo l’individuo solo, narcisista. Che non vuole legami né costrizioni. Ma non si può vivere da soli. A meno di non fare come il protagonista del film Into the Wild di Sean Penn: se ne va a vivere completamente isolato, autarchico, sovrano, in Alaska, per morirvi. Anche la prospettiva delle nostre società potrebbe essere la morte, quella della democrazia.
Questo di Orsina è un libro che evade dal recinto di molto dibattito politico di oggi, diviso tra neo-marxisti, neo-liberisti e neo-populisti. Un dibattito ormai stereotipato, dove già si sa prima che cosa ciascuno dirà.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- «Disordine nuovo». Il populismo senza popolo al potere (di Marco Revelli).2 giugno 2018, di Federico La Sala
Il populismo senza popolo al potere
Disordine nuovo. È il prodotto della fine di tutte le precedenti aggregazioni socio-politiche. Non ci sono più il «popolo di sinistra», né il «popolo padano», né più quello del «vaffa»
di Marco Revelli (il manifesto, 02.06.2018)
«Disordine nuovo» titolava il manifesto del 29 maggio scorso. E fotografava perfettamente il carattere del tutto inedito del caos istituzionale e politico andato in scena allora sull’ «irto colle» e diffusosi in un amen urbi et orbi.
Ma quell’espressione va al di là dell’istantanea, e non perde certo attualità per la nascita del governo Conte.
Con la sua doppia allusione storica (all’ordinovismo neofascista ma anche all’originario Ordine Nuovo gramsciano) ci spinge anzi a riflettere da una parte sul potenziale dirompente del voto del 4 marzo, reso assai visibile ora che è esploso fin dentro il Palazzo provocandone una serie di crisi di nervi.
Dall’altra sul carattere anche questo «nuovo» del soggetto politico insediatosi nel cuore dello Stato: sull’ircocervo che sta sotto la bandiera giallo-verde e che per ora è difficile qualificare se non in forma cromatica. Perché quello che è andato abbozzandosi «per fusione» nei quasi cento giorni di crisi seguita al terremoto del 4 di marzo, e infine è diventato «potere», forse è qualcosa di più di una semplice alleanza provvisoria. Forse è l’embrione di una nuova metamorfosi (potenziata) di quel «populismo del terzo millennio» su cui dalla Brexit e dalla vittoria di Trump in poi i politologi di mezzo mondo vanno interrogandosi. Forse addirittura è una sua inedita mutazione genetica che, fondendo in un unico conio vari ed eterogenei «populismi», farebbe ancora una volta del caso italiano un ben più ampio laboratorio della crisi democratica globale.
SBAGLIANO QUANTI liquidano l’asse 5Stelle-Lega con le etichette consuete: alleanza rosso-bruna, coalizione grillo-fascista, o fascio-grillina, o sfascio-leghista, e via ricombinando. Sbagliano per pigrizia mentale, e per rifiuto di vedere che quello che va emergendo dal lago di Lochness è un fenomeno politico inedito, radicato più che nelle culture politiche nelle rotture epocali dell’ordine sociale. Altrimenti dovremmo concludere che (e spiegare perché) la maggioranza degli italiani - quasi il 60% - è diventata d’improvviso «fascista». E sarebbe assai difficile capire come e per quale occulta ragione l’elettorato identitario della Lega si è così facilmente rassegnato al connubio con la platea anarco-libertaria grillina, e viceversa come questa si sia pensata compatibile con i tombini di ghisa di Salvini...
È DUNQUE per molti versi un oggetto misterioso quello che disturba i nostri sonni. E in questi casi, quando si ha di fronte un’entità politica che non ci dice da sé «chi sia», è utile partire dall’indagine delle cause. Dalla «eziologia», direbbero i vecchi padri della scienza politica, prendendo a prestito il termine dalla medicina, come se appunto di malattia si trattasse. Da dove «nasce» - da quale sostrato, o «infezione», prende origine -, questa «cosa» che ha occupato il centro istituzionale del Paese, destabilizzandolo fino al limite dell’entropia?
UNA MANO, FORSE, ce la potrebbe dare Benjamin Arditi, un brillante politologo latino-americano che ha usato, per il populismo del «terzo millennio», la metafora dell’”invitado incomodo”, cioè dell’ospite indesiderato a un elegante dinner party, che beve oltre misura, non rispetta le buone maniere a tavola, è rozzo, alza la voce e tenta fastidiosamente di flirtare con le mogli degli altri ospiti... È sicuramente sgradevole, e «fuori posto», ma potrebbe anche farsi scappare di bocca «una qualche verità sulla democrazia liberale, per esempio che essa si è dimenticata del proprio ideale fondante, la sovranità popolare». È questo il primo tratto identificante del new populism: il suo trarre origine dal senso di espropriazione delle proprie prerogative democratiche da parte di un elettorato marginalizzato, ignorato, scavalcato da decisioni prese altrove... Son le furie del (popolo) Sovrano cui per sortilegio è stato sfilato lo scettro il denominatore comune delle pur diverse anime. E queste furie (confermate purtroppo dalle recenti improvvide esternazioni istituzionali) attraversano la società in tutte le sue componenti, sull’intero asse destra-sinistra.
IL SECONDO FATTORE è lo «scioglimento di tutti i popoli». Può sembrare paradossale, ma è così: questo cosiddetto populismo rampante è in realtà senza popolo. Anzi, è il prodotto della fine di tutte le precedenti aggregazioni socio-politiche. Nella marea che ha invaso le urne il 4 di marzo non c’è più il «popolo di sinistra» (lo si è visto e lo si è detto), ma neppure più il «popolo padano» (con la nazionalizzazione della Lega salviniana), e neanche il «popolo del vaffa» (con la transustanziazione di Di Maio in rassicurante uomo di governo): c’è il mélange di tutti insieme, sciolti nei loro atomi elementari e ricombinati. Così come ci sono ben visibili le tracce di tutti e tre i «populismi italiani» che nel mio Populismo 2.0 avevo descritto nella loro successione cronologica (il telepopulismo berlusconiano ante-crisi, il cyberpopulismo grillino post-Monti e il populismo di governo renziano pre-referendario), e che ora sembrano precipitare in un punto solo: in un unico calderone in ebollizione al fuoco di un «non popolo» altrimenti privo di un «Sé».
PER QUESTO CREDO di poter dire che siamo lontani dai vari fascismi e neofascismi novecenteschi, esasperatamente comunitari in nome dell’omogeneità del Volk. E nello stesso tempo che viviamo ormai in un mondo abissalmente altro rispetto a quello in cui Gramsci pensò il suo Ordine Nuovo fondando su quello l’egemonia di lunga durata della sinistra. Se quel modello di «ordine» era incentrato sul lavoro operaio (in quanto espressione della razionalità produttiva di fabbrica) come cellula elementare dello Stato Nuovo, l’attuale prevalente visione del mondo trae al contrario origine dalla dissoluzione del Lavoro come soggetto sociale (si fonda sulla sua sconfitta storica) e dall’emergere di un paradigma egemonico che fa del mercato e del denaro - di due entità per definizione «prive di forma» - i propri principii regolatori. È appunto, nel senso più proprio, un «disordine nuovo». Ovvero un’ipotesi di società che fa del disordine (e del suo correlato: la diseguaglianza selvaggia) la propria cifra prevalente.
A QUESTO MODELLO «insostenibile» il soggetto politico che sta emergendo dal caos sistemico che caratterizza la «maturità neoliberista» non si contrappone come antitesi, ma ne trasferisce piuttosto lo statuto «anarco-capitalista» nel cuore del «politico». Non è il corpo solido piantato nella società liquida. È a sua volta «liquido» e volatile. Continuerà a quotare alla propria borsa l’insoddisfazione del «popolo esautorato», ma non gli restituirà lo scettro smarrito. Continuerà a prestare ascolto alla sua angoscia da declino e da marginalizzazione, ma non ne arresterà la discesa sul piano inclinato sociale (scaricandone rabbia e frustrazione su migranti, rom e homeless secondo la tecnica consumata del capro espiatorio). Condurrà probabilmente una lotta senza quartiere contro le attuali «oligarchie» (per sostituirsi ad esse) ma non toccherà nessuno dei «fondamentali di sistema». È pericoloso proprio per questo: per la sua adattabilità ai flussi umorali che lavorano in basso e per la sua simmetrica collusione con le logiche di fondo che operano in alto. E proprio per questo personalmente non farei molto conto sull’ipotesi che a breve tempo il loro governo vada in crisi per le sue contraddizioni interne. O per un conflitto «mortale» con l’Europa, che non saranno loro ad affossare con un’azione deliberata e consapevole (sta già facendo molto da sola, con la sua tendenza suicida).
SE VORREMO combatterli dovremo prepararci ad avere davanti un avversario proteiforme, affrontabile solo da una forza e da una cultura politica che abbia saputo fare, a sua volta, il proprio esodo dalla terra d’origine: che sia preparata a cambiarsi con la stessa radicalità con cui è cambiato ciò che abbiamo di fronte. Non certo da un fantasmatico «fronte repubblicano», somma di tutte le sconfitte.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
Il Narcisismo e l’uso lucidissimo come arma politica dell’"antinomia del mentitore" --- "Popolo e democrazia" (Yascha Mounk): il populismo come requiem della democrazia liberale (di Nello Barile).
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! DENTRO LA PIÙ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA E POLITICA ITALIANA - La festa del 2 giugno. La democrazia a un bivio (di Guido Crainz).1 giugno 2018, di Federico La Sala
La festa del 2 giugno
La democrazia a un bivio
di Guido Crainz (la Repubblica, 01.06.2018)
Mai come quest’anno il 2 giugno ci costringe a interrogarci sul nostro essere nazione e sulla tenuta della nostra democrazia, ed è difficile sfuggire alla sensazione di essere di fronte a un bivio. Mai infatti, neanche nelle fasi più aspre, questa data ha cessato di essere la festa di tutti gli italiani: il momento in cui ribadiscono i fondamenti culturali, politici e civili del proprio vivere collettivo. Mai qualcuno aveva pensato di utilizzare il 2 giugno per contestare le nostre regole costituzionali. Mai, neanche per un attimo, era stata proposto di lacerare questa giornata con una manifestazione di parte volta a colpire proprio quelle regole, assieme alla figura istituzionale che ne è garante ( e il vulnus resta, anche se la miserevole proposta è crollata grazie alla alta e necessaria fermezza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella).
Non avvenne neppure nel clima teso della Guerra fredda, nonostante le profonde divisioni e contrapposizioni di allora. E non avvenne negli anni cupi della strategia della tensione e del terrorismo degli anni Settanta: la centralità del 2 giugno verrà appannata semmai dalla smemoratezza degli anni Ottanta, nel prolungarsi dell’abolizione della festività decisa nel 1977 (discutibile conseguenza di esigenze di “austerità”).
Quell’appannarsi era in realtà il sintomo dell’indebolimento civile del Paese, malamente mascherato dalle euforie di quel decennio, e alla vigilia del crollo della “ prima Repubblica” Giorgio Bocca evocava a contrasto, su queste pagine, l’Italia uscita dalla guerra: eravamo divisi in fazioni, scriveva, in un Paese distrutto, eppure «uniti nel vivere, liberali, cattolici, monarchici, comunisti, padroni, operai, tutti certi di essere padroni del nostro destino. Ma questa voglia di avere un’identità, di essere noi, sembra esserci uscita dal corpo. Che Paese siamo? Che cosa significa essere italiani? » . In quella crisi il valore centrale del 2 giugno sembrò offuscarsi ancora e la sua decisa riaffermazione fu parte integrante della pedagogia civile avviata con forza dal presidente Ciampi e proseguita dai suoi successori.
Fu parte integrante del loro impegno a rifondare il “ patriottismo repubblicano” nella coscienza collettiva, collocandolo nella più ampia appartenenza europea e rafforzandone al tempo stesso i momenti simbolici e le date fondative. In primo luogo, appunto, la festa del 2 giugno, ripristinata da Ciampi nella sua interezza e accompagnata da una parata che poneva ora al centro l’impegno dell’esercito nelle calamità civili e nelle missioni di pace. Ciampi stesso ha ricordato: andai a quella prima, rinnovata sfilata «in una vettura scoperta, con al fianco il ministro della Difesa, Sergio Mattarella. Eravamo circondati da una folla festosa che mi diceva di andare avanti, mi ringraziava, era contenta » . Quella ispirazione è andata via via arricchendosi e sono ancora vive le immagini di un anno fa, con la folta presenza di sindaci e con quell’enorme tricolore che calava sul Colosseo.
È forte dunque la sensazione di essere oggi di fronte a una possibile, inquietante divaricazione, e nei giorni scorsi lo abbiamo compreso in maniera traumatica: in essi infatti il fantasma del populismo è uscito definitivamente dal limbo delle definizioni astratte o da territori ancora lontani. È diventato forza corposa e devastante, con la lacerante contrapposizione fra una “ sovranità del popolo” arbitrariamente interpretata e le istituzioni che la fanno realmente vivere, svilite e calpestate assieme alle loro regole. Questo abbiamo vissuto e viviamo, e quelle lontane parole di Giorgio Bocca sembrano di nuovo drammaticamente attuali.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! DENTRO LA PIÙ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA E POLITICA ITALIANA, NEL REGNO DI "FORZA ITALIA"!!! - Il Colle ha fallito? Dipende da noi (di Roberta de Monticelli).1 giugno 2018, di Federico La Sala
FILOSOFIA. IL PENSIERO DELLA COSTITUZIONE E LA COSTITUZIONE DEL PENSIERO ...
Il Colle ha fallito? Dipende da noi
«Il vero male non è il male, ma la mescolanza del bene e del male (Simone Weil)»
di Roberta de Monticelli (Il Fatto, 01.06.2018)
Un filosofo è come il matto di corte, lo si può lasciar parlare. C’è chi vuole far processare per alto tradimento il presidente della Repubblica e chi lancia hashtag in suo sostegno. Ci sono giuristi pronti ad affermare che non ha fatto che il suo dovere (Flick) e altri radicalmente critici (Villone e Carlassare), come ce ne sono di molto perplessi (Onida). Ci sono commentatori che in mancanza d’altre idee attribuiscono lo sconquasso al “circo mediatico giudiziario” che ci avrebbe per troppo anni lavato il cervello facendoci credere che in Italia corruzione e impunità siano maggiori che altrove (Panebianco) - ma non vedono che il lavaggio non è bastato, visto che nessuno (neppure il capo dello Stato) s’è fatto un baffo della circostanza che il candidato ministro dell’Economia da ex presidente dell’Impregilo era incorso in inchieste giudiziarie ben motivate dalle intercettazioni, che gli avrebbero sbarrato in ogni altro Paese civile la porta di quel ministero.
C’è chi sostiene con assoluta convinzione che il gesto del Presidente ha salvato la democrazia assediata dai populismi e chi con convinzione altrettanto assoluta sostiene che ha soffocato la domanda democratica di cambiamento, per asservire lo Stato alla tecno-plutocrazia europea, o peggio al diktat tedesco. Nota a margine: non si percepisce traccia di simili congiure e diktat da quassù - il regno del fool è il vuoto celeste, dove le linee aeree franco-canadesi forniscono una massa di giornali nelle principali lingue europee, e neppure un angolino contiene un commento su queste indebite pressioni, nonostante i titoli ridondino di “crisi istituzionale in Italia” e “l’Italia mette a processo l’Europa”.
Ed ecco lo sragionamento del fool, per chi volesse conoscerlo. Che il gesto del presidente della Repubblica sia o non sia stato un tragico errore, dipende da noi. Nel senso che non sarà stato un errore, e forse sarà stato invece uno di quegli attimi che le generazioni future ricorderanno con ammirata gratitudine, solo se d’ora in poi gli uomini e le donne di buona volontà non si daranno tregua a costruire in due mesi la Parte della Speranza Progressista e Civile, per farla trovare pronta alle elezioni, con a capo i migliori cavalieri delle buone cause sconfitte nell’ultimo quinquennio...
 Quanti ce ne sono, e come saranno bravi se somigliano alle idee per cui furono silenziati, in materia di anticorruzione e legalità, di taglio alla spesa, di politica industriale e del lavoro, di lotta alla disuguaglianza, allo scempio dell’ambiente e del paesaggio, di vera politica della scuola, dell’università e della ricerca.
Quanti ce ne sono, e come saranno bravi se somigliano alle idee per cui furono silenziati, in materia di anticorruzione e legalità, di taglio alla spesa, di politica industriale e del lavoro, di lotta alla disuguaglianza, allo scempio dell’ambiente e del paesaggio, di vera politica della scuola, dell’università e della ricerca.
 Non contro ma verso gli Stati Uniti d’Europa. Il programma di questa Parte? Sarà buono se si procederà con infinita attenzione ai veri tagli. “Il vero male non è il male, ma la mescolanza del bene e del male” (Simone Weil).
Non contro ma verso gli Stati Uniti d’Europa. Il programma di questa Parte? Sarà buono se si procederà con infinita attenzione ai veri tagli. “Il vero male non è il male, ma la mescolanza del bene e del male” (Simone Weil).È questo il taglio sottile da operare, o il groviglio da dirimere. Guardate se non torna, lo sragionamento. Tutto il male che ci circonda viene da questo groviglio! Vorresti difendere, certo, la bandiera italiana dal disprezzo di chi ci tratta da gente che non sa stare ai patti, ma poi guardi quelli che la levano ora sulla piazza e ti accorgi che è sporca, lordata dall’uso che ne fece il demagogo lombardo predecessore dell’attuale. Vorresti accorrere, certo, a difesa della Repubblica e del suo presidente, allinearti a quei poveri corazzieri in alta uniforme, ma ti si stringe il cuore solo a guardarli, tanto svilita è l’idea che difendono, che solo il ricordo di quell’adunata di ceffi e mammole che presiedettero all’elezione del precedente presidente al suo secondo mandato ti riempie di vergogna, come quello delle innumerevoli forzature di un governo che da incostituzionalmente eletto si fa costituente senza averlo mai avuto in alcun programma. Vorresti ripetere anche tu, lo stesso, “sto col presidente”, perché dall’altra parte c’è la prepotenza di chi “se ne frega” di qualunque vincolo etico e giuridico in nome di folle senza volto, di chi addirittura non si vergogna a ripetere “chi si ferma è perduto”. E ti accorgi che il solo sostegno al governo del presidente verrà dai responsabili di tutte quelle forzature che hanno svilito l’uniforme dei miei corazzieri, e anche dal ghigno trionfale di un signore politicamente appena riabilitato, ancora prima che si sia quietato l’effetto di rivolta emetica indotto dalle immagini di Sorrentino in Loro 1 e Loro 2...
Il fool nella sua follia si rivolge anche a molti elettori Cinque Stelle: avete lottato - lo so perché ero con voi - per preservare un po’ di bellezza dove interessi biechi la sconciavano. Ma la bellezza non è un valore, è il nome di tutti i valori, compresa la (pari) dignità di tutte le persone. Come potete ora sostenere anche la bruttezza di parole e gesta di chi la nega? Non sta lì il primo nefasto miscuglio?
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- IL PADRE NOSTRO E’ AMORE NON MAMMONA. ROBERTA DE MONTICELLI URLA "BASTA" A MONS. GIUSEPPE BETORI, A BAGNASCO, E ALLA CHIESA CATTOLICA. L’abiura di una cristiana laica
MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA E A PENSARE BENE "DIO", "IO" E "L’ITALIA", CHI PIÙ CHI MENO, TUTTI VIVONO DENTRO LA PIÙ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA E POLITICA ITALIANA, NEL REGNO DI "FORZA ITALIA"!!!
LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE.
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- I nuovi Proci e l’Italia. La lunga notte di Itaca (di Massimo Recalcati).30 maggio 2018, di Federico La Sala
LA LEZIONE DI DANTE, OGGI. Nonostante le lezioni di Benigni, non abbiamo ancora capito le ragioni dantesche di Ulisse all’inferno. E la cultura italiana continua a navigare in uno "stato" sonnambolico.... *
M5S, Lega e l’assalto alle istituzioni
I nuovi Proci e l’Italia
di Massimo Recalcati (la Repubblica, 30.05.2018)
Anagraficamente Salvini e Di Maio appartengono alla generazione che avevo battezzato Telemaco: figli che hanno avuto il coraggio di farsi avanti, di impugnare le sorti del loro destino, di impegnarsi in prima persona per cambiare l’avvenire del loro Paese. Ma politicamente essi - anche alla luce di questo ultimo tristissimo quanto drammatico episodio della loro lunga marcia verso il potere - sembrano assomigliare di più ai Proci. Sono i cosiddetti “pretendenti”, i giovani principi che nell’Odissea di Omero esigono di possedere la regina Penelope e di insignorirsi del trono decretando Ulisse morto, disperso in chissà quale mare. Nel poema essi rivendicano il loro pieno diritto di governare Itaca nonostante non abbiano mostrato alcun rispetto per le sue istituzioni democratiche. Qui il lettore può spaziare ampiamente nella sua memoria tra le infinite ingiurie leghiste e grilline alle nostre istituzioni: ma non è forse questo il cemento armato della loro più profonda convergenza?
L’atteggiamento dei Proci non è però solo antiparlamentare - interrompono con le armi lo svolgimento di un’assemblea convocata da Telemaco, saccheggiano e deturpano la reggia che li ospita - ma è offensivo verso la Legge stessa della città. Il vuoto di Legge che si è determinato con l’assenza di Ulisse li rende padroni assoluti. Evocare la morte di Ulisse significa infatti evocare la morte della politica che deve lasciare il posto all’arroganza di chi rivendica il proprio diritto inscalfibile alla successione.
L’anti-parlamentarismo si ribalta così in una spinta furiosa ad occupare le istituzioni parlamentari. Una differenza sostanziale differenzia però i nuovi Proci dai vecchi. I nuovi hanno ottenuto democraticamente il consenso del popolo per governare la polis. Hanno un mandato, il popolo è con loro, li sostiene. Tuttavia, la Legge della città ha il compito di ricordare loro che il diritto a governare non implica lo sconvolgimento delle regole democratiche della convivenza, non significa introdurre l’anti- parlamentarismo nelle istituzioni nel nome del popolo. Lo squadrismo fascista violava la vita democratica in nome del popolo. Ed è sempre, come è tristemente noto, in nome del popolo che si sono commesse le più grandi atrocità nella storia. I padri costituenti hanno affidato al presidente della Repubblica un ruolo di garanzia. Bisogna che qualcuno ricordi ai nuovi Proci le regole complesse di una democrazia. Il diritto a governare non può mai coincidere con il diritto a fare quello che si vuole, con il puro arbitrio. Leghismo e grillismo empatizzano facilmente tra loro perché sono le espressioni più radicali del populismo: oppongono la volontà del popolo alla vita della politica.
Di fronte al collasso senza precedenti della sinistra e del Pd, di fronte al vuoto della Legge della città che sembra prolungare all’infinito la lunga notte di Itaca, c’è voluto ancora una volta il volto di un padre simbolico a testimoniare che le istituzioni non sono proprietà di nessuno, che il diritto al governare non coincide con il diritto a cancellare i principi elementari di una democrazia rappresentativa. È stato necessario il gesto coraggioso di un padre per salvare le speranze di Telemaco, per ricordare ai nuovi Proci che Ulisse è ancora vivo.
*
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- IN UNO "STATO" SONNAMBOLICO, IL CONTINUO RITORNELLO DEGLI INTELLETTUALI ITALIANI. Dal 1994 al 2009: "Gran brutta aria, regime ancora no"!!!
 DALL’ILIADE ALL’ODISSEA: ALESSANDRO BARICCO, IL CIECO OMERO DEL "CAVALEONTICO" ULISSE DI ARCORE. Un omaggio critico
DALL’ILIADE ALL’ODISSEA: ALESSANDRO BARICCO, IL CIECO OMERO DEL "CAVALEONTICO" ULISSE DI ARCORE. Un omaggio critico
- TEATRO, DEMOCRAZIA, E REGIME A "MUSICA LEGGERA". PERSO L’ESSENZIALE, BARICCO FA UN "ESEMPIETTO" TAROCCATO E, IN PIENO "STATO" SONNAMBOLICO, GRIDA: FORZA ITALIA!!!
Nonostante le lezioni di Benigni, non abbiamo ancora capito le ragioni dantesche di Ulisse all’inferno. E la cultura italiana continua a navigare in uno "stato" sonnambolico....
 GLI ESEMPI TAROCCATI DI BARICCO E DI SCALFARI E L’ITALIA STRETTA NELL’ABBRACCIO MORTALE DEL "CAVALEONTICO" ULISSE DI ARCORE.
GLI ESEMPI TAROCCATI DI BARICCO E DI SCALFARI E L’ITALIA STRETTA NELL’ABBRACCIO MORTALE DEL "CAVALEONTICO" ULISSE DI ARCORE.GENITORI, FIGLI, E FORMAZIONE: AL DI LÀ DEL FALLIMENTO, COSA RESTA DEL PADRE? PER MASSIMO RECALCATI, OBBEDIENTE A LACAN, RESTA ANCORA (E SEMPRE) LA LUNGA MANO DELLA MADRE.
Federico La Sala
- IN UNO "STATO" SONNAMBOLICO, IL CONTINUO RITORNELLO DEGLI INTELLETTUALI ITALIANI. Dal 1994 al 2009: "Gran brutta aria, regime ancora no"!!!
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! - ICONE DELLA LEGGE. Pensare per immagini. Resurrezione: mito o mistero? (di Michela Dall’Aglio - "Doppiozero").29 maggio 2018, di Federico La Sala
ICONE DELLA LEGGE - DELLA COSTITUZIONE. Icone. Pensare per immagini... *
Resurrezione: mito o mistero?
di Michela Dall’Aglio (Doppiozero, 28.05.2018)
Nel dipinto di Pieter Bruegel il Vecchio Salita al Calvario del 1564, si scorge a fatica, al centro di una scena super affollata, Gesù salire al Calvario nell’indifferenza generale. Si fatica a vedere la sua piccola figura e la grande croce che trascina con sé. Tutt’intorno a lui brulica una folla indifferente, affaccendata nelle proprie attività. Il clima è festoso, non sembra profilarsi alcuna tragedia all’orizzonte. In primo piano, tre donne piangono, consolate da un giovane che sappiamo essere Giovanni, l’apostolo. Ma le quattro figure sembrano fuori posto, quasi fossero dovute perché non si dà la Passione senza le donne piangenti e Giovanni.
Inizia da qui l’itinerario che Gabriella Caramore e Maurizio Ciampa percorrono nel loro ultimo libro, Croce e Resurrezione (il Mulino), pubblicato nella collana ’Icone. Pensare per immagini’ diretta da Massimo Cacciari. -Come suggerisce il titolo, il libro è diviso in due parti. Nella prima, dedicata alla passione e crocefissione di Cristo, Maurizio Ciampa commenta la Salita al Calvario accostandola anche a diverse altre raffigurazioni dello stesso soggetto: da Hieronymus Bosch, col suo Cristo portacroce del 1515 - in cui il volto di Gesù sembra l’unico umano, schiacciato e soffocato da facce grottesche e demoniache -, a James Ensor, con L’entrata di Cristo a Bruxelles nel 1889, in cui la parodia dell’ingresso a Gerusalemme alla vigilia della Pasqua, è un carnevale. Da Matthias Grunewald con il crocifisso dell’Altare di Isenheim, quasi inguardabile nell’atrocità del suo dolore, a I disastri della guerra, di Francisco Goya, 1808-1810, e altri ancora.
La seconda parte del libro è dedicata alla risurrezione di Cristo, evento inimmaginabile accaduto senza testimoni. Com’è possibile, allora, rappresentarlo? In che modo dipingere un uomo che abbia attraversato il confine della morte e abbia trovato, al di là, vita nuova? Di quale strana materia dovrebbe essere fatto, per rimanere attingibile ai sensi?
 Gabriella Caramore sceglie di parlarne commentando La cena di Emmaus dipinta da Rembrandt nel 1629, in cui il risorto è un profilo d’ombra che risalta sulla luce proiettata sul muro alle sue spalle, che il suo stesso corpo emana. Ed è una buona scelta, perché non esiste in tutta la storia dell’arte un volto di Cristo risorto all’altezza dell’evento, neppure quello che forse è il più bello di tutti, ritratto da Piero della Francesca nel dipinto Resurrezione del 1460.
Gabriella Caramore sceglie di parlarne commentando La cena di Emmaus dipinta da Rembrandt nel 1629, in cui il risorto è un profilo d’ombra che risalta sulla luce proiettata sul muro alle sue spalle, che il suo stesso corpo emana. Ed è una buona scelta, perché non esiste in tutta la storia dell’arte un volto di Cristo risorto all’altezza dell’evento, neppure quello che forse è il più bello di tutti, ritratto da Piero della Francesca nel dipinto Resurrezione del 1460.È un libro bello e intenso, traboccante di domande che tutti si fanno davanti ai due pilastri della fede cristiana, la morte in croce di Gesù e il suo ingresso in una nuova vita. Due sono le più dure e drammatiche: interessano ancora a qualcuno la sua storia e la sua tragica fine? Com’è possibile oggi credere alla resurrezione? La risposta, più lasciata intuire che detta esplicitamente, sembra essere ’no’. Forse, suggeriscono gli autori, dovremmo leggere tutta la vicenda in un modo diverso che, allontanandola dalla “leggenda”, ci permettesse di trovarne un senso accettabile oggi per noi.
Nella Salita al Calvario, osserva Ciampa, per la prima volta la passione di Cristo è trasformata in spettacolo, infatti la sua figura quasi scompare tra le tante che affollano la scena, per lo più allegre e ridanciane, prese dai loro vari commerci. Il luogo in cui il condannato sarà crocifisso è lontano e marginale. Come lo sono anche Giovanni e le donne, raffigurati in primo piano sul lato destro del dipinto, e sembrano del tutto estranei rispetto alla folla. Non sono vicini né a Gesù né al luogo del patibolo.
 Maurizio Ciampa si chiede se ce la farà ad arrivare al Golgota questo povero Cristo “trafitto dall’indifferenza” e acutamente osserva: “Possiamo leggere la Salita al Calvario come un triste presentimento di ciò che accadrà, una sorta di presagio della Storia che verrà, una sua sintesi anticipata. La croce nascosta, il Cristo accantonato, la Passione alterata in ‘festa’”.
Maurizio Ciampa si chiede se ce la farà ad arrivare al Golgota questo povero Cristo “trafitto dall’indifferenza” e acutamente osserva: “Possiamo leggere la Salita al Calvario come un triste presentimento di ciò che accadrà, una sorta di presagio della Storia che verrà, una sua sintesi anticipata. La croce nascosta, il Cristo accantonato, la Passione alterata in ‘festa’”.Una festa paesana che James Ensor porterà a termine, trasformandola in carnevale, dopo che Cristo avrà attraversato il male raffigurato nei volti ghignanti di Hieronymus Bosch, quasi a suggerire che egli non può - non ha potuto né potrà - vincere il male sulla Terra. “In Bruegel resiste ancora, nascosto, un residuo di croce” - afferma Ciampa - “in Bosch la croce sembra soccombere, Cristo resta comunque l’ultima traccia dell’umano; in Ensor, gli "uomini vuoti", distratti, confusi, sembrano non averne più memoria.” La passione diventata intrattenimento e un Cristo fragile e svuotato sembrano dichiarare che la sofferenza dell’uomo non troverà mai senso e che il “simbolo cristiano” ha perso efficacia per l’uomo di oggi. Il mondo ha messo Cristo da parte, la sua storia non interessa più, non è più ispiratrice né può dirsi in alcun modo diversa da quella dei tanti uomini e donne buoni e di valore che la Storia ha fatto a pezzi. Non c’è più altro da dire.
A questo punto, però, nella visione cristiana fondata sulla testimonianza della gente del tempo, entra in scena la libertà di Dio. Perché è questo il significato della resurrezione di Gesù: nella loro libertà i potenti nemici di Gesù ne hanno decretata la morte; nella sua libertà, Gesù non vi si è sottratto; ma nella sua libertà, Dio è intervenuto quando la sua azione non avrebbe più forzato e ridotto la libertà degli altri attori in gioco. Con la resurrezione di Gesù ha dichiarato, davanti agli uomini e alla Storia, che quell’uomo diceva la verità, su di loro e su Dio stesso. È possibile crederlo?
 Gli autori sembrano, di nuovo, propendere per una risposta negativa quando si domandano: “Quale narrazione di quell’evento può aiutarci a darne una lettura che non strida con l’esigenza contemporanea di uscire dal linguaggio del mito?”. E più avanti, verso la conclusione del libro, Gabriella Caramore, invitando a non smettere di cercare “per capire se sia possibile estrarne una umile, esile forza su cui far leva per potere stare al mondo”, si chiede se non sia “proprio in questa eclissi di una trascendenza mitologica (corsivo mio) che può condensarsi il senso della ’resurrezione’: qualcosa è stato e ha lasciato un segno sulla terra ... rimane, per chi resta, la possibilità di ridestarsi alla luce, di rialzarsi alla vita. Non è, questo, un segno molto più potente che non attendere il ritorno nella carne, nella materia, o nella leggenda (corsivo mio) di chi ha lasciato quell’incolmabile vuoto?” E riferendosi all’evangelista Luca e alla sua insistenza a dichiarare Gesù il vivente anche dopo la morte, afferma: “In fondo quell’insistenza ... appare come un invito ad allontanarsi dalla visione di un cadavere che torna a rivisitare i vivi, per spalancare invece la possibilità di trovare forza e consolazione in ciò che rimane di una vita trascorsa”.
Gli autori sembrano, di nuovo, propendere per una risposta negativa quando si domandano: “Quale narrazione di quell’evento può aiutarci a darne una lettura che non strida con l’esigenza contemporanea di uscire dal linguaggio del mito?”. E più avanti, verso la conclusione del libro, Gabriella Caramore, invitando a non smettere di cercare “per capire se sia possibile estrarne una umile, esile forza su cui far leva per potere stare al mondo”, si chiede se non sia “proprio in questa eclissi di una trascendenza mitologica (corsivo mio) che può condensarsi il senso della ’resurrezione’: qualcosa è stato e ha lasciato un segno sulla terra ... rimane, per chi resta, la possibilità di ridestarsi alla luce, di rialzarsi alla vita. Non è, questo, un segno molto più potente che non attendere il ritorno nella carne, nella materia, o nella leggenda (corsivo mio) di chi ha lasciato quell’incolmabile vuoto?” E riferendosi all’evangelista Luca e alla sua insistenza a dichiarare Gesù il vivente anche dopo la morte, afferma: “In fondo quell’insistenza ... appare come un invito ad allontanarsi dalla visione di un cadavere che torna a rivisitare i vivi, per spalancare invece la possibilità di trovare forza e consolazione in ciò che rimane di una vita trascorsa”.Se la resurrezione è un mito, non credo ci possa dare alcuna forza, né esile e umile, né d’altro genere; non consola nessuno né cambia alcunché della nostra personale sofferenza. Se non è un mito, è uno sconvolgimento, una forza potente, una rivoluzione dell’interpretazione che ognuno può dare alla propria vita, una direzione totalmente nuova verso cui sentirsi tutti in cammino. La resurrezione di Gesù non è il ritorno a questa vita di un cadavere, ma la rivelazione di un destino sorprendente, di uno stadio successivo alla vita che aspetta ogni essere umano (e non soltanto). È la possibilità di sperare con intelligenza, e non sulla base di favole e miti rassicuranti, che la morte non sia la fine del viaggio. E questa fiducia non si basa su un’adesione emotiva, non è stata conservata nei secoli da cuori fragili incapaci di accettare la morte, ma da spiriti forti e intelligenze acute che vi hanno riflettuto con tutte le proprie forze. È impossibile riassumere qua questo lungo cammino, mai concluso, ma chi volesse può ascoltare, per farsi un’idea della questione, una conferenza molto chiara e interessante dell’astrofisico e teologo Giuseppe Tanzella-Nitti, dal titolo: La visione del cristianesimo tra vita biologica ed immortalità, reperibile su youtube.
L’evento della resurrezione non ha avuto testimoni, per questo non si può definirlo storicamente certo (se lo fosse, probabilmente saremmo tutti cristiani). I fatti storicamente accertati riguardano, invece, quello che i discepoli fecero dopo gli incontri con Gesù successivi alla sua morte, e l’improvviso cambiamento avvenuto nella loro attitudine, nel loro stesso carattere.
 La resurrezione è, ad ogni modo, un mistero che non si può liquidare facilmente né alla leggera, perché la fede cristiana non si fonda sul messaggio di Gesù allo stesso modo in cui, per esempio, il buddismo si fonda sull’insegnamento straordinario del Buddha, ma sulla sua persona e sul mistero che egli rappresenta per l’umanità tutta. A quel mistero appartiene, come elemento non secondario ma fondamentale, che sia risuscitato dalla morte rivelando qualcosa di sostanziale in merito al destino di tutti gli esseri umani.
La resurrezione è, ad ogni modo, un mistero che non si può liquidare facilmente né alla leggera, perché la fede cristiana non si fonda sul messaggio di Gesù allo stesso modo in cui, per esempio, il buddismo si fonda sull’insegnamento straordinario del Buddha, ma sulla sua persona e sul mistero che egli rappresenta per l’umanità tutta. A quel mistero appartiene, come elemento non secondario ma fondamentale, che sia risuscitato dalla morte rivelando qualcosa di sostanziale in merito al destino di tutti gli esseri umani.Credere nella resurrezione di Gesù e in una vita piena dell’intera persona umana, al di là di come questo sia possibile e di quale materia sarà il nostro corpo, fa la differenza tra il cristianesimo e le altre concezioni. È ancora vero quello che ha detto san Paolo: “...se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede ... se poi noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto in questa vita, siamo da compiangere più di tutti gli uomini.” (1Cor 15).
*
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- MEMORIA DELLA LIBERAZIONE DALLA SCHIAVITU’: ESODO. In memoria di Mosé, di Elia, e di Gesu’ .... PASQUA: BUONA PASQUA DI RESURREZIONE E DI RISURREZIONE.
KANT ALL’ATTACCO DEI DELIRI E DEGLI INGANNI DEI "GRANDI SAPIENTI": ANNO DI GRAZIA, 1766.
EVANGELO E TEOLOGIA POLITICA DEL "MENTITORE". PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO, CHE GIA’ DANTE SOLLECITAVA ...
 KANT E SAN PAOLO. COME IL BUON GIUDIZIO ("SECUNDA PETRI") VIENE (E VENNE) RIDOTTO IN STATO DI MINORITA’ DAL GIUDIZIO FALSO E BUGIARDO ("SECUNDA PAULI").
KANT E SAN PAOLO. COME IL BUON GIUDIZIO ("SECUNDA PETRI") VIENE (E VENNE) RIDOTTO IN STATO DI MINORITA’ DAL GIUDIZIO FALSO E BUGIARDO ("SECUNDA PAULI").FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! CHI PIÙ CHI MENO, TUTTI VIVONO DENTRO LA PIÙ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA E POLITICA ITALIANA -- SALONE DEL LIBRO. Carlo Sini: una cultura dispersa è l’anticamera del conformismo (di Cristina Taglietti).12 maggio 2018, di Federico La Sala
COSMOLOGIA E CIVILTA’. IL PENSIERO DELLA COSTITUZIONE E LA COSTITUZIONE DEL PENSIERO.... *
Polemiche
SALONE DEL LIBRO
Carlo Sini: una cultura dispersa è l’anticamera del conformismo
Il filosofo denuncia: nelle scelte dell’editoria le logiche commerciali prevalgono sui criteri scientifici
di Cristina Taglietti (Corriere della Sera, 12.05.2018)
TORINO Niente come una fiera, e il Salone del Libro in particolare, con il suo corollario di voci e rumori, a volte di musiche assordanti, sembra incarnare meglio lo spirito del nostro tempo votato, dice il filosofo Carlo Sini, alla dispersione. Eppure, nella vetrina dei saperi, dove lo spazio delle riflessione sembra compromesso, gli incontri filosofici hanno un pubblico tenace e neppure tanto piccolo. Molti visitatori, ieri, sono rimasti fuori dalla lectio magistralis di Sini, ma anche dall’incontro in cui Danco Singer, del Festival della Comunicazione di Camogli, ha messo a confronto lo storico Alessandro Barbero e il filosofo Maurizio Ferraris, su un tema, Visioni, che guarda avanti verso il futuro e indietro verso il passato incrociando i saperi.
Il pubblico che segue gli incontri filosofici ha caratteristiche molto peculiari. Si va alla fiera come a lezione, con il quaderno degli appunti e i testi dei filosofi, non soltanto quelli dei relatori: La scienza della logica di Hegel, le opere di Platone, l’immancabile Derrida sono alcuni dei titoli visti tra le mani. E alla fine molti chiedono, più che il firmacopie, un supplemento di spiegazione, l’approfondimento su un’opera citata o su un concetto espresso, come se fossero studenti desiderosi di ben figurare.
Venerdì l’editore Mimesis ha dedicato, con Massimo Donà, Giuliano Compagno e Gianni Vattimo, un omaggio a Mario Perniola, scomparso lo scorso gennaio, figlio elettivo di due padri, Luigi Pareyson e Guy Debord, e alla sua capacità di guardare al contemporaneo con uno sguardo obliquo, libero da condizionamenti. Oggi arriveranno Umberto Galimberti (in dialogo con Enzo Bianchi e poi con Nadia Fusini), Giulio Giorello (a riempire con nozioni di filosofia per ragazzi il format chiamato L’ora buca, assieme a Giancarlo De Cataldo che, invece, farà lezione di diritto), mentre Simone Weil (1909-1943) «parlerà» attraverso le lettere, pubblicate da Adelphi, con il fratello matematico André.
Sini, che conosce bene il Salone, vede tutto ciò come uno degli effetti tutto sommato positivi della dispersione. «Queste manifestazioni la rappresentano bene. Siamo colmati da una molteplicità di voci. Questo è il posto canonico, il luogo della totale dispersione. Da uno stand all’altro la cultura è esplosa: c’è tutto, dalle arti marziali ai francobolli cinesi. Ma sarebbe sciocco dire che è un male. Io propongo una lettura positiva. È la vita stessa, la ricchezza è nella molteplicità».
È quella che nel libro Del viver bene (edito da Jaca Book che sta pubblicando le Opere di Sini, 6 volumi in 11 tomi) definisce «la democrazia delle occasioni». «Se non dà un accesso il più possibile diffuso al maggior numero di persone è una finzione, è pura retorica». Ma, è il pensiero del filosofo, più esplode la molteplicità, più si mette in movimento qualcosa di paradossale che ha come risultato l’omogeneità: «Tutto è differenziato, niente è differente. -Il conformismo è l’altra faccia della dispersione. Tutto si adegua alla produzione di merci che, intendiamoci, non sono il diavolo. Ma questo modello è stato così potente che ha assimilato a sé anche il modello culturale. La desertificazione delle culture nazionali ne è una delle conseguenze».
Così, se nella formazione domina il modello anglofono, tecnico-scientifico, al difetto omogeneizzante non sfugge neppure l’editoria. «C’è un’unica editoria - dice Sini - si copiano tutti tra loro, gli autori sono sempre gli stessi che fanno il giro, nessuno osa niente. Non c’è coraggio, non c’è scoperta, si propone un prodotto uniforme, ripetitivo. D’altronde i direttori scientifici sono diventati direttori commerciali, attenti al marketing».
Un discorso che Sini fa pensando anche alla produzione filosofica. «Prima andava di moda Deleuze, adesso è il momento degli anglosassoni. Per venire pubblicati devono aver sfondato un certo livello di riconoscibilità, magari per ragioni biografiche. Lo stesso Sartre è diventato famoso con L’essere e il nulla, poi è stato dimenticato».
La riflessione sulla dispersione, e sulla moltiplicazione delle verità, delle competenze, dei saperi, è al centro della riflessione del filosofo che, anche nella sua lectio, nata in risposta a una delle domande lanciate dal Salone (Chi voglio essere?), ne ha illustrato gli effetti negativi. «Oggi domina l’interdisciplinarità, mentre dovremmo parlare di transdisciplinarità. Il progetto che ci incalza è quello di tentare una riunificazione dei saperi che non sia contraria alla specializzazione, ma che la riconduca a un nucleo condiviso. Un tempo non è che Kant non capisse Newton. Oggi è così: tra filosofi e scienziati non ci intendiamo perché non abbiamo più un sapere comune».
*
Sul tema, nel sito, si cfr.:
KANT, NEWTON, E POPE. Note (di avvio) per una rilettura della “Storia universale della natura e teoria del cielo”
COSMOLOGIA E CIVILTÀ. "PER LA CRITICA DELL’ECONOMIA POLITICA" DELLA RAGIONE ATEA E DEVOTA
 KARL MARX RISPONDE A SALVATORE VECA, PRENDE LE DISTANZE DA ENGELS E RENDE OMAGGIO A FULVIO PAPI. Alcune precisazioni sulla sua intervista impossibile
KARL MARX RISPONDE A SALVATORE VECA, PRENDE LE DISTANZE DA ENGELS E RENDE OMAGGIO A FULVIO PAPI. Alcune precisazioni sulla sua intervista impossibile-
FILOSOFIA. IL PENSIERO DELLA COSTITUZIONE E LA COSTITUZIONE DEL PENSIERO
 MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?!
MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?!
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
-
FILOSOFIA. IL PENSIERO DELLA COSTITUZIONE E LA COSTITUZIONE DEL PENSIERO
-
>DENTRO LA PIU’ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA E POLITICA ITALIANA, NEL REGNO DI --- UN DIO CHIAMATO CAPITALE. Due secoli di marxismo (di Massimo Cacciari).2 maggio 2018, di Federico La Sala
Due secoli di Marx
Un dio chiamato Capitale
Non è stata l’economia politica il cuore della rivoluzione del grande pensatore. Ma l’Economico come categoria dello spirito. La vera potenza che mette all’opera il mondo
di Massimo Cacciari (l’Espresso, 29.04.2018)
Tacete economisti e sociologi in munere alieno. Marx non è affare vostro, o soltanto di quelli di voi che ne comprendano la grandezza filosofica, anzi: teologico-filosofica. Marx sta tra i pensatori che riflettono sul destino dell’Occidente, tra gli ultimi a osare di affrontarne il senso della storia. In questo è paragonabile forse soltanto a Nietzsche. Ma “Il Capitale”, si dirà? Non è l’economia politica al centro della sua opera? No; è la critica dell’economia politica. Che vuol dire? Che l’Economico vale per Marx come figura dello Spirito, come espressione della nuova potenza che lo incarna nel mondo contemporaneo. L’Economico è per Marx ciò che sarà la Tecnica per Heidegger: l’energia che informa di sé ogni forma di vita, che determina il Sistema complessivo delle relazioni sociali e politiche, che fa nascere un nuovo tipo di uomo. Nessuna struttura cui si aggiungerebbe una sovra-struttura a mo’ di inessenziale complemento - l’Economico è immanente in tutte le forme in cui l’agire e il pensare si determinano; ognuna di esse è parte necessaria dell’intero.
Marx è pensatore del Tutto, perfettamente fedele in questo al suo maestro Hegel. Il Sistema è più delle parti, irriducibile alla loro somma. Chi intende l’Economico come una struttura a sé, autonoma, che determinerebbe meccanicisticamente le altre, non ha capito nulla di Marx. Marx non è pensatore astratto, e cioè non astrae mai l’Economico dall’intero sistema delle relazioni sociali, culturali, politiche.
La sua domanda è: quale potenza oggi governa l’Intero e come concretamente essa si esprime in ogni elemento dell’Intero? L’Economico è infinitamente più che Economico. Esso rappresenta nel contemporaneo la potenza che mette all’opera il mondo.
 Il mondo della “morte di Dio”. Ogni opera deve essere valutata sul metro del lavoro produttivo di ricchezza e ogni uomo messo al lavoro per questo fine. Non è concesso “ozio”; nessuno può essere “lasciato in pace”. Il processo stesso di specializzazione del lavoro viene compreso in questo grandioso processo: più avanza la forma specialistica del lavoro, più l’Opera appare complessiva e distende il proprio spirito sull’intero pianeta; più il lavoro appare diviso, più in realtà esso funziona come un unico Sistema, dove ogni membro coopera, ne sia o meno consapevole, al fine universale dell’accumulazione e riproduzione. Fine che si realizza soltanto se al lavoro è posto prioritariamente il cervello umano. La vera forza del lavoro sta infatti nell’intelligenza che scopre, inventa, innova. La differenza tra teoretico e pratico si annulla nella potenza del cervello sociale, Intelletto Agente dell’intero genere, che si articola in lavori speciali soltanto per accrescere sempre più la propria universale potenza.
Il mondo della “morte di Dio”. Ogni opera deve essere valutata sul metro del lavoro produttivo di ricchezza e ogni uomo messo al lavoro per questo fine. Non è concesso “ozio”; nessuno può essere “lasciato in pace”. Il processo stesso di specializzazione del lavoro viene compreso in questo grandioso processo: più avanza la forma specialistica del lavoro, più l’Opera appare complessiva e distende il proprio spirito sull’intero pianeta; più il lavoro appare diviso, più in realtà esso funziona come un unico Sistema, dove ogni membro coopera, ne sia o meno consapevole, al fine universale dell’accumulazione e riproduzione. Fine che si realizza soltanto se al lavoro è posto prioritariamente il cervello umano. La vera forza del lavoro sta infatti nell’intelligenza che scopre, inventa, innova. La differenza tra teoretico e pratico si annulla nella potenza del cervello sociale, Intelletto Agente dell’intero genere, che si articola in lavori speciali soltanto per accrescere sempre più la propria universale potenza.Per Marx è questo il “nuovo mondo” che il sistema di produzione capitalistico crea, non certo dal nulla, ma certo sconvolgendo dalle radici forme di vita e relazioni sociali, insomma: l’ethos dell’Occidente, la “sede” in cui l’Occidente aveva ino ad allora abitato È il mondo dove il Logos della forma-merce si incarna in ogni aspetto della vita, per diventarne la religione stessa. E Marx ne esalta l’impeto rivoluzionario. È questo impeto che per lui va seguito, al suo interno è necessario collocarsi per comprenderne le contraddizioni e prevederne scientificamente l’aporia, e cioè dove la strada che esso ha aperto è destinata a interrompersi - per il salto a un altro mondo. Qui bisogna intendere bene: la contraddizione non viene da fuori, da qualcosa che sia “straniero” al Sistema.
Contraddittorio in sé è il capitalismo stesso. Il capitalismo è crisi, è fatto di crisi. Funziona per salti, che ogni volta mettono inevitabilmente in discussione gli equilibri raggiunti. Non vi è riproduzione senza innovazione. Questo è noto anche agli economisti.
 Ma Marx aggiunge: il capitalismo è crisi perché si costituisce nella lotta tra soggetti antagonisti. Il capitale è la lotta tra capitalisti e classe operaia. In quanto forza-lavoro la classe operaia è elemento essenziale del capitale stesso - ma quell’elemento che ha la possibilità di assumere coscienza di sé e lottare contro la classe che detiene l’egemonia sull’intero processo, che lo governa per il proprio profitto, metro del proprio stesso potere.
Ma Marx aggiunge: il capitalismo è crisi perché si costituisce nella lotta tra soggetti antagonisti. Il capitale è la lotta tra capitalisti e classe operaia. In quanto forza-lavoro la classe operaia è elemento essenziale del capitale stesso - ma quell’elemento che ha la possibilità di assumere coscienza di sé e lottare contro la classe che detiene l’egemonia sull’intero processo, che lo governa per il proprio profitto, metro del proprio stesso potere.
 È anche e soprattutto in forza di questa intrinseca contraddizione che il capitalismo è innovazione continua, produzione di merci sempre nuove e produzione del loro stesso consumo (la produzione più importante, quest’ultima, dice Marx). Tuttavia, ecco la metamorfosi: proprio diventando cosciente di questa sua funzione la forza-lavoro si fa soggetto autonomo rispetto al capitale, autonomo rispetto al carattere rivoluzionario di quest’ultimo. La lotta di classe di cui parla Marx è lotta tra rivoluzionari. Vera guerra civile.
È anche e soprattutto in forza di questa intrinseca contraddizione che il capitalismo è innovazione continua, produzione di merci sempre nuove e produzione del loro stesso consumo (la produzione più importante, quest’ultima, dice Marx). Tuttavia, ecco la metamorfosi: proprio diventando cosciente di questa sua funzione la forza-lavoro si fa soggetto autonomo rispetto al capitale, autonomo rispetto al carattere rivoluzionario di quest’ultimo. La lotta di classe di cui parla Marx è lotta tra rivoluzionari. Vera guerra civile.Questa contraddizione muove tutto. E ognuno è imbarcato in essa. L’idea di poterne giudicare “dall’alto” costituisce per l’appunto quella ideologia, che Marx sottopone a critica in dalle prime opere. Se la realtà dell’epoca è contraddizione inscindibilmente economica e politica, ogni interpretazione che la riduca a fatti naturalisticamente analizzabili la mistifica. Non è possibile cogliere la realtà del Sistema che collocandosi in esso, e dunque collocandosi nella contraddizione. Soltanto in questa prospettiva l’Intero è afferrabile. Non si comprende la realtà del presente se non in prospettiva e perciò a partire da un punto di vista determinato. Impossibile oggi un sapere astrattamente neutrale. La pretesa all’avalutatività è falsamente scientifica; l’epoca costringe a prender-parte, all’aut-aut. A porsi in gioco, alla scommessa anche. Il momento, o il kairòs, della decisione politica viene cosi a far parte della stessa potenza dell’Economico, resta immanente in essa.
 È l’ideologia propria del pensiero liberale, per Marx, che cerca di convincere a una visione de-politicizzante dell’Economico, a separare Economico e Politico, conferendo appunto all’Economico l’aspetto di un sistema naturale di relazioni.
È l’ideologia propria del pensiero liberale, per Marx, che cerca di convincere a una visione de-politicizzante dell’Economico, a separare Economico e Politico, conferendo appunto all’Economico l’aspetto di un sistema naturale di relazioni.Poiché concepisce la storia dell’Occidente come conflitto, e conflitto determinato dal suo carattere di classe, e poiché intende il presente alla luce dell’intrinseca contraddittorietà della stessa potenza rivoluzionaria del Sistema tecnico-economico, Marx pensa di aver posto saldamente sui piedi il pensiero dialettico dell’idealismo. Le epoche della Fenomenologia hegeliana dello Spirito non trovano conclusione in un Sapere assoluto che tutte accoglie e accorda, in una suprema Conciliazione, ma nella insuperabile contraddizione tra la potenza universale del Lavoro produttivo divenuto cosciente di sé e la sua appropriazione capitalistica. Si tratta di ben altro che di calcoli su valore e plusvalore.
 L’analisi del meccanismo dello sfruttamento, tanto bombardata dagli economisti e da filosofi dilettanti, sarà pure la parte caduca della grande opera di Marx. Ciò che conta in essa è la questione: il prodotto di questa umanità al lavoro (e questo significa “classe operaia”, altro che semplice “operaismo”!), di questo cervello sociale che inventa e innova, appartiene a chi? Come se ne determina la distribuzione? Chi la comanda? Può la sua potenza rinunciare a esigere potere? E se essa funziona riducendo sempre più il lavoro necessario per unità di prodotto o di prestazione, non si dovrebbe pensare nella prospettiva di una liberazione tout-court da ogni forma di lavoro comandato?
L’analisi del meccanismo dello sfruttamento, tanto bombardata dagli economisti e da filosofi dilettanti, sarà pure la parte caduca della grande opera di Marx. Ciò che conta in essa è la questione: il prodotto di questa umanità al lavoro (e questo significa “classe operaia”, altro che semplice “operaismo”!), di questo cervello sociale che inventa e innova, appartiene a chi? Come se ne determina la distribuzione? Chi la comanda? Può la sua potenza rinunciare a esigere potere? E se essa funziona riducendo sempre più il lavoro necessario per unità di prodotto o di prestazione, non si dovrebbe pensare nella prospettiva di una liberazione tout-court da ogni forma di lavoro comandato?
 Il comunismo risponde per Marx a queste domande. È l’idea della suprema conciliazione del soggetto col suo prodotto; il compito di superare nella prassi ogni estraneità. Comunismo significa la stessa “missione dell’uomo”. In questo senso, il capitalismo opera per il suo stesso superamento, poiché il suo sistema si fonda su quel cervello sociale-classe operaia che per “natura” è destinato a non sottostare ad alcun comando. Che deve diventare libero. Il comunismo è il Sistema della libertà.
Il comunismo risponde per Marx a queste domande. È l’idea della suprema conciliazione del soggetto col suo prodotto; il compito di superare nella prassi ogni estraneità. Comunismo significa la stessa “missione dell’uomo”. In questo senso, il capitalismo opera per il suo stesso superamento, poiché il suo sistema si fonda su quel cervello sociale-classe operaia che per “natura” è destinato a non sottostare ad alcun comando. Che deve diventare libero. Il comunismo è il Sistema della libertà.
 Marx sembra non avvedersi che tale “risoluzione” dell’aporia del capitalismo riproduce esattamente la conclusione della Fenomenologia hegeliana e, forse ancor più, del Sistema della scienza di Fichte. Ed è l’idea di un potere assoluto sulla natura, in cui la “comunità degli Io” sottopone al proprio dominio tutto ciò che le appaia “privo di ragione”.
Marx sembra non avvedersi che tale “risoluzione” dell’aporia del capitalismo riproduce esattamente la conclusione della Fenomenologia hegeliana e, forse ancor più, del Sistema della scienza di Fichte. Ed è l’idea di un potere assoluto sulla natura, in cui la “comunità degli Io” sottopone al proprio dominio tutto ciò che le appaia “privo di ragione”.
 La quintessenziale volontà di potenza dell’uomo europeo ispira perciò in tutto anche Marx e la sua violenza rivoluzionaria. Marx appartiene all’Europa “rivoluzione permanente”, all’Europa “leone affamato” (Hegel). Il suicidio di questa Europa lungo il tragico Novecento spiega lo spegnersi dell’energia politica scaturita dal marxismo assai più di quelle colossali trasformazioni sociali e economiche che hanno segnato il declino del soggetto “classe operaia”.
La quintessenziale volontà di potenza dell’uomo europeo ispira perciò in tutto anche Marx e la sua violenza rivoluzionaria. Marx appartiene all’Europa “rivoluzione permanente”, all’Europa “leone affamato” (Hegel). Il suicidio di questa Europa lungo il tragico Novecento spiega lo spegnersi dell’energia politica scaturita dal marxismo assai più di quelle colossali trasformazioni sociali e economiche che hanno segnato il declino del soggetto “classe operaia”.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
"CHI" SIAMO NOI, IN REALTÀ. RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.
RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". Per la rinascita dell’EUROPA, e dell’ITALIA. La buona-esortazione del BRASILE. Una "memoria"
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- FILOSOFIA, PSICOANALISI E MISTICA. Indicazioni per una seconda rivoluzione copernicana.30 aprile 2018, di Federico La Sala
PSICOANALISI, ANTROPOLOGIA, E MISTICISMO. Uscire dallo Stato di minorità (superiorità) ...
 LA BALLATA DI COLAPESCE ("DER TAUCHER") DI SCHILLER E LA "LEZIONE" DI FREUD A BRUNO GOETZ E A ROMAIN ROLLAND.
LA BALLATA DI COLAPESCE ("DER TAUCHER") DI SCHILLER E LA "LEZIONE" DI FREUD A BRUNO GOETZ E A ROMAIN ROLLAND.FILOSOFIA, PSICOANALISI E MISTICA. Indicazioni per una seconda rivoluzione copernicana ..
 FREUD, IL MARE, E "LA MENTE ESTATICA". Un invito a ripensare il lavoro di Elvio Fachinelli
FREUD, IL MARE, E "LA MENTE ESTATICA". Un invito a ripensare il lavoro di Elvio Fachinelli
 IL PUNTO DI SVOLTA. Proseguendo nel suo «viaggio attraverso la psicanalisi, e oltre», Fachinelli è giunto finalmente dinanzi al mare. «Sulla spiaggia», questo è il titolo del primo e più originale scritto de "La mente estatica".
IL PUNTO DI SVOLTA. Proseguendo nel suo «viaggio attraverso la psicanalisi, e oltre», Fachinelli è giunto finalmente dinanzi al mare. «Sulla spiaggia», questo è il titolo del primo e più originale scritto de "La mente estatica".FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! - L’eredità di Marx. Un principio e un imperativo da riscoprire in questo nostro tempo che ha completamente perso l’idea stessa, e anche la speranza, dell’emancipazione sociale (di M. Viroli).28 aprile 2018, di Federico La Sala
PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN ...
La critica radicale del presente: l’eredità di Marx
di Maurizio Viroli (Il Fatto, 28.04.2018)
Non saprei dire quanti altri giovani della mia generazione misero in soffitta Karl Marx dopo aver letto l’articolo Esiste una teoria marxista dello Stato? che Norberto Bobbio pubblicò nel 1975 su Mondoperaio, e ripubblicò nel 1976 nel libro Quale socialismo?, ma sospetto siano stati molti.
La risposta di Bobbio era netta: negli scritti di Marx e di Friedrich Engels, “una vera e propria teoria socialistica dello Stato non esiste”. A nulla valsero le centinaia di pagine scritte dagli intellettuali ‘organici’, come si diceva allora, al Partito comunista per confutare Bobbio e salvare Marx. Se Marx non aveva fornito una teoria dello Stato, come poteva essere guida intellettuale di un partito che aspirava a guidare lo Stato democratico?
Messo da parte Marx, cercammo altri maestri che potessero aiutarci a credere nel socialismo senza essere marxisti. Trovammo per nostra fortuna Carlo Rosselli e il suo Socialismo liberale che proprio Bobbio aveva curato in una bella edizione Einaudi del 1973. La prima pagina di quel libro aveva il valore di una rivelazione o di una conferma di quanto già pensavamo, vale a dire che il limite maggiore della teoria sociale e politica di Marx era la pretesa (rafforzata e popolarizzata dal buon Friedrich Engels) di essere dottrina scientifica : “L’orgoglioso proposito di Marx fu quello di assicurare al socialismo una base scientifica, di trasformare il socialismo in una scienza, anzi nella scienza sociale per definizione [...] Doveva avverarsi, non poteva non avverarsi; e si sarebbe avverato non per opera di una immaginaria volontà libera degli uomini, ma di quelle forze trascendenti e dominanti gli uomini e i loro rapporti che sono le forze produttive nel loro incessante svilupparsi e progredire.”
Rosselli capì che il Manifesto del Partito comunista aveva immensa forza d’ispirazione perché era profezia travestita da scienza: “Quale pace, quale certezza dava il suo linguaggio profetico ai primi apostoli perseguitati! “
Ma già agli inizi del Novecento, dopo la disputa sul revisionismo aperta dal libro di Eduard Bernstein, uscito nel 1899 (che Laterza ha pubblicato in traduzione italiana nel 1974 con il titolo I presupposti del socialismo e i compiti della socialdemocrazia), i più intelligenti giudicarono la scienza di Marx del tutto incapace di spiegare la realtà economica e sociale, e non trovarono più né conforto né guida nella profezia ormai irrigidita in stanche formule ripetute meccanicamente. Eppure, molte pagine di Marx, soprattutto del giovane Marx, offrono ancora, se le leggiamo senza i vecchi condizionamenti ideologici, elementi per una teoria dell’emancipazione sociale.
La lettera che Marx spedisce ad Arnold Ruge da Kreuznach, nel settembre del 1843, poi pubblicata nei Deutsch-Französische Jahrbücher del 1844, ad esempio, è un testo che ci insegna i lineamenti di una critica sociale e politica intransigente: “Costruire il futuro - scrive Marx - e trovare una ricetta valida perennemente non è affar nostro, ma è certo più evidente ciò che dobbiamo fare nel presente: la critica radicale di tutto l’esistente”. Critica radicale perché senza riguardi, senza paura né dei suoi risultati né del conflitto coi poteri attuali. E ci insegna che la lotta per la libertà e per la giustizia deve essere in primo luogo lavoro paziente di educazione delle coscienze: “Indi il nostro motto sarà: riforma della coscienza, non con dogmi, bensì con l’analisi della coscienza mistica, oscura a se stessa, in qualunque modo si presenti (religioso o politico)”.
L’emancipazione politica e sociale non era per il giovane Marx risultato di tendenze oggettive della storia, ma conquista di coscienze emancipate che sanno riscoprire il sogno o la profezia di giustizia che l’umanità ha coltivato in varie forme nella sua lunga storia: “così si vedrà che da tempo il mondo sogna una cosa, di cui deve solo aver la coscienza per averla realmente. Si vedrà che non si tratta di tracciare una linea fra passato e futuro, ma di realizzare le idee del passato. Si vedrà infine come l’umanità non inizi un lavoro nuovo, bensì attui consapevolmente il suo antico lavoro”.
Nello stesso fascicolo (l’unico che vide la luce) Marx pubblicò anche un’Introduzione a Per la critica della Filosofia del diritto di Hegel, dove sostiene che il proletariato è la sola classe sociale che emancipando se stessa emancipa l’intera società e che la filosofia può trovare nel proletariato “le sue armi materiali”. La filosofia (ovvero gli intellettuali) è dunque la “testa di questa emancipazione”; “il suo cuore è il proletariato”. Due illusioni nobili, queste del giovane Marx, ma pur sempre illusioni.
Il proletariato, allora come oggi, è una classe oppressa e umiliata, ma resta una classe particolare che nella sua storia ha lottato e sofferto per finalità di emancipazione generale, ma ha anche sostenuto demagoghi autoritari. Attribuire al proletariato il semplice ruolo di cuore e forza materiale dello sforzo di emancipazione e agli intellettuali quello di cervello, significa aprire la strada, come la storia ha abbondantemente dimostrato, a freddi professionisti della rivoluzione e del governo, incapaci di condividere le sofferenze e le speranze degli oppressi e dunque pronti a diventare non compagni di lotta, ma nuovi dominatori.
In questo saggio, nato in un contesto segnato da appassionati dibattiti su religione e emancipazione sociale (ben documentato dalla recente biografia scritta da Gareth Stedman Jones, Karl Marx. Greatness and Illusion, Harvard University Press, 2016) Marx ha consegnato alla storia la sua celebre critica dell’alienazione religiosa: “L’uomo fa la religione, e non la religione l’uomo. [...] Essa è la realizzazione fantastica dell’essenza umana, poiché l’essenza umana non possiede una realtà vera. La lotta contro la religione è dunque mediatamente la lotta contro quel mondo, del quale la religione è l’aroma spirituale. La miseria religiosa è insieme l’espressione della miseria reale e la protesta contro la miseria reale. La religione è il sospiro della creatura oppressa, il sentimento di un mondo senza cuore, così come è lo spirito di una condizione senza spirito. Essa è l’oppio del popolo”. Sarebbe facile osservare che la religione, in particolare la religione cristiana, ha sostenuto importanti esperienze di liberazione politica e sociale.
Ma dalla critica alla religione, Marx trae due conclusioni di straordinario valore morale e politico: la prima consiste nel principio che “l’uomo è per l’uomo l’essere supremo”; la seconda nell’“imperativo categorico di rovesciare tutti i rapporti nei quali l’uomo è un essere degradato, assoggettato, abbandonato, spregevole”. Un principio e un imperativo da riscoprire in questo nostro tempo che ha completamente perso l’idea stessa, e anche la speranza, dell’emancipazione sociale.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
LO STATO DEL FARAONE, LO STATO DI MINORITA’, E IMMANUEL KANT "ALLA BERLINA" - DOPO AUSCHWITZ
 "LEZIONE SU KANT" A GERUSALEMME: PARLA EICHMANN "PILATO", IL SUDDITO DELL’"IMPERATORE-DIO". Il ’sonnambulismo’ di Hannah Arendt prima e di Emil Fackenheim dopo.
"LEZIONE SU KANT" A GERUSALEMME: PARLA EICHMANN "PILATO", IL SUDDITO DELL’"IMPERATORE-DIO". Il ’sonnambulismo’ di Hannah Arendt prima e di Emil Fackenheim dopo.EICHMANN A GERUSALEMME (1961). “come fu possibile la hitlerizzazione dell’Imperativo Categorico di Kant? E perché è ancora attuale oggi?” (Emil L. Fackenheim, Tiqqun. Riparare il mondo).
 HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI.
HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI.- "CHI" SIAMO NOI, IN REALTÀ. RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! - LA CORONA DEL REGNO, IL PALOMBARO, E LA LEGGENDA DI "COLA PESCE" (I. CALVINO),15 aprile 2018, di Federico La Sala
PER L’ITALIA E PER LA COSTITUZIONE...
LA CORONA DEL REGNO, IL PALOMBARO, E LA LEGGENDA DI "(NI) COLA PESCE" *
- In Italia la scelleratezza comincia presto, dopo la Liberazione. Da allora siamo impigliati nel cortocircuito colpa-nemesi, senza produrre la catarsi: il momento della purificazione in cui - nelle Supplici di Eschilo - s’alza Pelasgo, capo di Argo, e dice: «Occorre un pensiero profondo che porti salvezza. Come un palombaro devo scendere giù nell’abisso, scrutando il fondo con occhio lucido e sobrio così che questa vicenda non rovini la città e per noi stessi si concluda felicemente».[...] Scrive Davide Susanetti, nel suo bel libro sulla tragedia greca, che il tuffo di Pelasgo implica una più netta visione dei diritti della realtà: «Per mutare non bisogna commuoversi, ma spostarsi fuori dall’incantesimo funesto del cerchio» che ci ingabbia (Catastrofi politiche, Carocci 2011) [...] (Barbara Spinelli, Un pensiero profondo per la politica, la Repubblica, 23.11.2011)
*
Cola Pesce
Una volta a Messina c’era una madre che aveva un figlio a nome Cola, che se ne stava a bagno nel mare mattina e sera. La madre a chiamarlo dalla riva:
 Cola! Cola! Vieni a terra, che fai? Non sei mica un pesce?
Cola! Cola! Vieni a terra, che fai? Non sei mica un pesce?E lui, a nuotare sempre più lontano. Alla povera madre veniva il torcibudella, a furia di gridare. Un giorno, la fece gridare tanto che la poveretta, quando non ne poté più di gridare, gli mandò una maledizione:
 Cola! Che tu possa diventare un pesce!
Cola! Che tu possa diventare un pesce!Si vede che quel giorno le porte del Cielo erano aperte, e la maledizione della madre andò a segno: in un momento, Cola diventò mezzo uomo mezzo pesce, con le dita palmate come un’anatra e la gola da rana. In terra Cola non ci tornò più e la madre se ne disperò tanto che dopo poco tempo morì.
La voce che nel mare di Messina c’era uno mezzo uomo e mezzo pesce arrivò fino al Re; e il Re ordinò a tutti i marinai che chi vedeva Cola Pesce gli dicesse che il Re gli voleva parlare.
Un giorno, un marinaio, andando in barca al largo, se lo vide passare vicino nuotando.
 Cola! - gli disse. - C’è il Re di Messina che ti vuole parlare!
E Cola Pesce subito nuotò verso il palazzo del Re.
Cola! - gli disse. - C’è il Re di Messina che ti vuole parlare!
E Cola Pesce subito nuotò verso il palazzo del Re.Il Re, al vederlo, gli fece buon viso.
 Cola Pesce, - gli disse, - tu che sei così bravo nuotatore, dovresti fare un giro tutt’intorno alla Sicilia, e sapermi dire dov’è il mare più fondo e cosa ci si vede!
Cola Pesce, - gli disse, - tu che sei così bravo nuotatore, dovresti fare un giro tutt’intorno alla Sicilia, e sapermi dire dov’è il mare più fondo e cosa ci si vede!Cola Pesce ubbidì e si mise a nuotare tutt’intorno alla Sicilia.
Dopo un poco di tempo fu di ritorno. Raccontò che in fondo al mare aveva visto montagne, valli, caverne e pesci di tutte le specie, ma aveva avuto paura solo passando dal Faro, perché lì non era riuscito a trovare il fondo.
 E allora Messina su cos’è fabbricata? - chiese il Re. - Devi scendere giù a vedere dove poggia.
E allora Messina su cos’è fabbricata? - chiese il Re. - Devi scendere giù a vedere dove poggia.Cola si tuffò e stette sott’acqua un giorno intero. Poi ritornò a galla e disse al Re:
 Messina è fabbricata su uno scoglio, e questo scoglio poggia su tre colonne: una sana, una scheggiata e una rotta.
Messina è fabbricata su uno scoglio, e questo scoglio poggia su tre colonne: una sana, una scheggiata e una rotta. O Messina, Messina,
O Messina, Messina,
 Un dì sarai meschina!
Un dì sarai meschina!Il Re restò assai stupito, e volle portarsi Cola Pesce a Napoli per vedere il fondo dei vulcani. Cola scese giù e poi raccontò che aveva trovato prima l’acqua fredda, poi l’acqua calda e in certi punti c’erano anche sorgenti d’acqua dolce.
Il Re non ci voleva credere e allora Cola si fece dare due bottiglie e gliene andò a riempire una d’acqua calda e una d’acqua dolce. Ma il Re aveva quel pensiero che non gli dava pace, che al Capo del Faro il mare era senza fondo. Riportò Cola Pesce a Messina e gli disse:
 Cola, devi dirmi quant’è profondo il mare qui al Faro, più o meno.
Cola, devi dirmi quant’è profondo il mare qui al Faro, più o meno.Cola calò giù e ci stette due giorni, e quando tornò sù disse che il fondo non l’aveva visto, perché c’era una colonna di fumo che usciva da sotto uno scoglio e intorbidava l’acqua. Il Re, che non ne poteva più dalla curiosità, disse:
 Gettati dalla cima della Torre del Faro
Gettati dalla cima della Torre del FaroLa Torre era proprio sulla punta del capo e nei tempi andati ci stava uno di guardia, e quando c’era la corrente che tirava suonava una tromba e issava una bandiera per avvisare i bastimenti che passassero al largo. Cola Pesce si tuffò da lassù in cima.
Il Re ne aspettò due, ne aspettò tre, ma Cola non si rivedeva. Finalmente venne fuori, ma era pallido.
 Che c’è, Cola? - chiese il Re.
Che c’è, Cola? - chiese il Re. C’è che sono morto di spavento, - disse Cola. - Ho visto un pesce, che solo nella bocca poteva entrarci intero un bastimento! Per non farmi inghiottire m son dovuto nascondere dietro una delle tre colonne che reggono Messina!
C’è che sono morto di spavento, - disse Cola. - Ho visto un pesce, che solo nella bocca poteva entrarci intero un bastimento! Per non farmi inghiottire m son dovuto nascondere dietro una delle tre colonne che reggono Messina!Il Re stette a sentire a bocca aperta; ma quella maledetta curiosità di sapere quant’era profondo il Faro non gli era passata.
E Cola:
 No, Maestà, non mi tuffo più, ho paura.
No, Maestà, non mi tuffo più, ho paura.Visto che non riusciva a convincerlo, il re si levò la corona dal capo, tutta piena di pietre preziose, che abbagliavano lo sguardo, e la buttò in mare.
 Va’ a prenderla, Cola!
Va’ a prenderla, Cola! Cos’avete fatto, Maestà? La corona del Regno!
Cos’avete fatto, Maestà? La corona del Regno! Una corona che non ce n’è altra al mondo, - disse il Re. - Cola, devi andarla a prendere!
Una corona che non ce n’è altra al mondo, - disse il Re. - Cola, devi andarla a prendere! Se voi così volete, Maestà, - disse Cola - scenderò. Ma il cuore mi dice che non tornerò più su. Datemi una manciata di lenticchie. Se scampo, tornerò su io; ma se vedete venire a galla le lenticchie, è segno che io non torno più.
Se voi così volete, Maestà, - disse Cola - scenderò. Ma il cuore mi dice che non tornerò più su. Datemi una manciata di lenticchie. Se scampo, tornerò su io; ma se vedete venire a galla le lenticchie, è segno che io non torno più.Gli diedero le lenticchie, e Cola scese in mare.
Aspetta, aspetta; dopo tanto aspettare, vennero a galla le lenticchie. Cola Pesce s’aspetta che ancora torni.
 (Palermo)
(Palermo)*Cfr.: Fiabe italiane raccolte e trascritte da Italo Calvino, Einaudi, Torino 1971, vol. II, pp. 602-604.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
LA SOVRANITÀ, LA DIGNITÀ DI OGNI CITTADINO E DI OGNI CITTADINA, E "I DUE CORPI DEL RE". La lezione di Kantorowicz...
 LA COSTITUZIONE, "I DUE CORPI DEL RE", E I DUE PATTI DEL CITTADINO. L’ analisi di Barbara Spinelli (2006)
LA COSTITUZIONE, "I DUE CORPI DEL RE", E I DUE PATTI DEL CITTADINO. L’ analisi di Barbara Spinelli (2006)
 I due corpi del re vanno tenuti disgiunti, perché resti vivo l’inaugurale patto che dissuade dalla guerra di tutti contro tutti, e che fonda un rapporto non effimero, non continuamente modificabile, fra i cittadini e chi li comanda.
I due corpi del re vanno tenuti disgiunti, perché resti vivo l’inaugurale patto che dissuade dalla guerra di tutti contro tutti, e che fonda un rapporto non effimero, non continuamente modificabile, fra i cittadini e chi li comanda.FILOSOFIA. IL PENSIERO DELLA COSTITUZIONE E LA COSTITUZIONE DEL PENSIERO
 MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?!
MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?!Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! - BENEDETTO CROCE, LO SPIRITO DI "COLAPESCE", E LA VITA DI UN "PALOMBARO LETTERARIO".20 aprile 2018, di Federico La SalaVITA, FILOSOFIA, STORIA E LETTERATURA...
 BENEDETTO CROCE, LO SPIRITO DI "COLAPESCE", E LA VITA DI UN "PALOMBARO LETTERARIO". Una brillante ricognizione di Luisella Mesiano
BENEDETTO CROCE, LO SPIRITO DI "COLAPESCE", E LA VITA DI UN "PALOMBARO LETTERARIO". Una brillante ricognizione di Luisella Mesiano
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE.#Unoosa - Giornata del volo umano nello spazio12 aprile 2018, di Federico La Sala
DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. E’ la Giornata del volo umano nello spazio...
- L’ASTRONAUTA E LA METAFORA DEL TETRAGONO. Luca Parmitano racconta i suoi 166 giorni in orbita
 “E’ stato tutto bellissimo ed emozionante” - dice l’astronauta italiano dell’ESA - “e in qualche modo è come se mi fossi sempre sentito in compagnia della mia Italia (...)
“E’ stato tutto bellissimo ed emozionante” - dice l’astronauta italiano dell’ESA - “e in qualche modo è come se mi fossi sempre sentito in compagnia della mia Italia (...)
E’ la Giornata del volo umano nello spazio
Feste e appuntamenti in tutto il mondo, dagli Usa all’Antartide *
Basi lunari e colonie marziane, fino al più vicino turismo spaziale: la Giornata internazionale del volo umano nello spazio 2018 si festeggia all’insegna di grandi cambiamenti all’orizzonte. Numerosi gli appuntamenti in tutto il mondo, dagli Stati Uniti al Sudan e al Nepal fino all’Antartide, dove si sono mobilitate le americane Palmer Station e South Pole. Decine gli appuntamenti anche in Europa. In Italia i Planetari di Lecco e Cagliari sono già pronti con eventi dedicati agli astronauti.
Voluta dalle Nazioni Unite attraverso il suo ufficio per gli affari spaziali (Unoosa), la Giornata del volo umano nello spazio celebra il volo di Yuri Gagarin, che il 12 aprile 1961 diventava il primo uomo a raggiungere l’orbita e ad ammirare la Terra come nessuno l’aveva mai vista.
"Vedo la Terra circondata da foschia. Mi sento bene. Com’è bello", erano state le prime parole di Gagarin dallo spazio, a bordo della capsula Vostok. Segnavano l’inizio di un’avventura cominciata nell’allora segretissima base russa di Baikonur, nel Kazakhstan, dove ancora oggi continuano a partire le Soyuz, le navette russe che dopo l’uscita di scena dell’americano Space Shuttle sono oggi le uniche in grado di portare equipaggi umani in orbita. Da allora i primati si sono susseguiti uno dopo l’altro: il 18 marzo 1965 il sovietico Aleksej Leonov era il primo a ’passeggiare’ fra le stelle, mentre il 20 luglio 1969 l’americano Neil Armostrong lasciava sul suolo della Luna l’impronta del celebre "piccolo passo per l’uomo, un grande passo per l’umanità".
Nel 1971 l’uomo ha avuto la prima casa tra le stelle, con la stazione spaziale sovietica Saljut, cui ne sono seguite ben dieci, di cui due ancora attive: la Stazione Spaziale Internazionale (nata dalla collaborazione fra Nasa, Russia, Europa, Canada e Giappone) e la cinese Tiangong, rientrata a Terra fuori controllo all’alba di Pasquetta, fortunatamente sull’oceano Pacifico. Adesso si guarda al futuro anche grazie all’arrivo delle aziende private che collaborano con la Nasa e, dopo i voli commerciali che apriranno le porte al turismo spaziale, i prossimi obbiettivi ambiziosi guardano alla Luna e a Marte.
* ANSA, 12 aprile 2018 (RIPRESA PARZIALE, SENZA IMMAGINI).
- L’ASTRONAUTA E LA METAFORA DEL TETRAGONO. Luca Parmitano racconta i suoi 166 giorni in orbita
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- Eugen Rosenstock-Huessy e il ruolo della prima persona. Chi è il numero uno?6 aprile 2018, di Federico La Sala
Chi è il numero uno?
Eugen Rosenstock-Huessy e il ruolo della prima persona.
di Damion Searls (Il Tascabile, 03.04.2018) *
Può essere sconvolgente rendersi conto, all’improvviso, che qualcosa a cui non avevi mai pensato - qualcosa che avevi sempre accettato come reale - è solo un articolo di fede. Spesso è il linguaggio a far accendere la lampadina: qualcuno ridefinisce la realtà con una nuova parola (mansplaining, Rebecca Solnit) o mostrando i poteri nascosti e le interconnessioni di una parola antica (debito, David Graeber). Raramente la rivelazione riguarda il linguaggio in sé.
- Tra tutti i dogmi dell’antichità classica, solo la grammatica non ha perso terreno. La geometria Euclidea, l’astronomia Tolemaica, la medicina Galenica, la legge Romana, la dottrina Cristiana - tutte sono state radicalmente smantellate dalle Scuole. Ma ancora oggi, la grammatica Alessandrina continua a regnare.
La citazione è di Eugen Rosenstock-Huessy (1888-1973), un teorico del Cristianesimo dell’età moderna molto particolare. (Tutte le traduzioni sono dal volume The Language of the Human Race: An Incarnate Grammar in Four Parts [Die Sprache des Menschengeschlechts: Eine leibhafte Grammatik in vier Teilen].) Rosenstock-Huessy ha ispirato alcuni connoisseur, tra cui W. H. Auden e Peter Sloterdijk, ma possiamo dire in tutta tranquillità che è ancora poco conosciuto. È difficile capire cosa pensare di lui. Di sicuro trovo fastidiosa la palese importanza della nascita di Cristo - o della Missione Divina - che inserisce regolarmente nei suoi ragionamenti filosofici. (Auden: “Chi lo legge per la prima volta può trovare, come è capitato a me, certi aspetti della sua scrittura un po’ difficili da accettare... Per quanto mi riguarda, posso solo dire che ascoltando Rosenstock-Huessy, io sono cambiato”). Il dogma grammaticale a cui fa riferimento - e contro cui si è battuto a morte in un libro di oltre 1.900 pagine - è la lista all’apparenza innocente che risale ai Greci: la prima persona, la seconda persona, la terza persona. Io amo, tu ami, egli ama, o, se avete studiato Latino, amo, amas, amat.
- “Tutti impariamo le lingue seguendo quelle liste. Cosa possono avere di tanto significativo? ...Nell’ordine Alessandrino, ogni persona è soggetta alla stessa trafila. Ogni persona sembra parlare allo stesso modo. Da qui ha origine l’errore fatale. Tanta della nostra confusione sui rapporti sociali e tanta della nostra ignoranza sul linguaggio può derivare direttamente da questo singolo errore. Mettere in fila amo, amas, amat, amamus, ecc, dà adito all’impressione che tutti questi “giudizi” possano e debbano essere trattati con lo stesso significato interpersonale. L’effetto, su chiunque impari questa sequenza, è l’idea che ogni frase all’indicativo sia pronunciata con lo stesso livello di “passione”. La mia rivendicazione è che amat e amo e amas sono agli antipodi, da un punto di vista sociale, e che quindi non debbano essere insegnati come simili. La lista Alessandrina non è affidabile.”
Non sta dicendo che dovremmo aggiungere una forma per la “quarta persona”, come per esempio la distinzione tra terze persone in Ojibwe, oppure una “persona zero” per le costruzioni impersonali come in Finlandese. Sta dicendo che rendere “io” la prima persona è il peccato originale non solo della linguistica, ma della filosofia, della scienza e della stessa vita sociale. E lo intende davvero. Teoricamente, appiattisce l’esperienza vissuta in resoconti freddi e asettici, assimilando tutto all’“affermazione” di un “dato” in terza persona che non richiede alcun coraggio personale, non ha alcuna rilevanza sociale.
- Amat è pronunciato come un fatto, senza nessun coinvolgimento interiore. Dà delle informazioni su qualcosa. Amo e amas, al contrario, non possono essere pronunciati senza conseguenze sociali importanti. Amo è un’ammissione, confessa un segreto. Amas dichiara qualcosa. Entrambi presuppongono passione, e quindi dobbiamo studiare che cosa significano passione ed enfasi in quanto elementi sociali della grammatica.
Empiricamente, la lista Greca commette un errore: la “prima persona” infatti non arriva per prima. L’io di un bambino si sviluppa quando gli viene rivolta la parola, da un genitore o da un’altra persona che si prende cura di lui. Qualcuno deve dire “tu” nel modo giusto perché un “io” non folle possa di fatto esistere. (Vedi Neither Sun Nor Death di Peter Sloterdijk, p. 30, dove ho sentito parlare di Rosenstock-Huessy per la prima volta). Dal punto di vista psicologico, neurocognitivo e dello sviluppo, “io” è l’ultima persona. Sei un bravo bambino. La bottiglia è lì. Ho fame.
- “Tutte le nostre esperienze insegnano esattamente l’opposto di questa dottrina greca rispetto al primato dell’“io” individuale! Il bambino inizia a definirsi gradualmente come un essere indipendente in seguito alle migliaia di attenzioni e impressioni e influssi che lo avvolgono, lo circondano, lo premono da ogni parte. La prima cosa che scopre è di non essere il mondo, né la madre o il padre, né Dio, ma qualcosa d’altro.
 La prima cosa che succede a ogni bambino, a ogni persona, è che gli o le si rivolge la parola: gli si sorride, gli si domanda qualcosa, gli si dà qualcosa, si culla, si conforta, si punisce, si nutre. Il bambino è prima un Tu per un essere esterno potente, soprattutto i genitori... Sentire che esistiamo per gli altri, che vogliono qualcosa da noi, precede qualsiasi affermazione che noi siamo noi o qualsiasi affermazione di che cosa siamo. Ricevere ordini ed essere giudicati dall’esterno è quello che ci dà consapevolezza di noi stessi.”
La prima cosa che succede a ogni bambino, a ogni persona, è che gli o le si rivolge la parola: gli si sorride, gli si domanda qualcosa, gli si dà qualcosa, si culla, si conforta, si punisce, si nutre. Il bambino è prima un Tu per un essere esterno potente, soprattutto i genitori... Sentire che esistiamo per gli altri, che vogliono qualcosa da noi, precede qualsiasi affermazione che noi siamo noi o qualsiasi affermazione di che cosa siamo. Ricevere ordini ed essere giudicati dall’esterno è quello che ci dà consapevolezza di noi stessi.”
È questa la rivelazione che mi ha tanto colpito. La prima persona non è la prima. Non esiste nessuna lista, a parte quelle che inventiamo. Che aspetto avrebbe il mondo se potessi vedere al di fuori di questo schema? Se prima venisse un legame tanto forte da darti l’autorità di giudicare l’esperienza di qualcun altro - tu ami, tu hai fame, sei carino oggi, ti stai comportando male - e poi venisse una visione condivisa del mondo, e solo successivamente un’espressione di sé? L’idea Cartesiana, “penso dunque sono”, e tutte le distinzioni tra mente/corpo/io/altro avrebbero potuto non emergere mai se Cartesio non fosse stato indottrinato con l’idea che “io” viene per primo. Esistono romanzi in prima e in terza persona, ma la seconda è un’anomalia, proprio come nella vita reale non possiamo prenderci la libertà di parlare per una seconda persona come faremmo di noi stessi in quest’era dell’espressione di sé. Quanto altro ancora della natura del romanzo, e della percezione della mia vita, risale essenzialmente alla grammatica greca di duemila anni fa?
- Nella nostra società moderna, amo e amas sono trattati alla stregua di semplici affermazioni come amat. E la spudoratezza della psicologia, delle classificazioni sociali, della tirannia dei fisici e degli analisti, sono alcuni dei risultati di questa mancanza di saggezza e autorità nello schema grammaticale. Ognuno è portato a pensare a se stesso o se stessa come parte di una sequenza di fatti, come se lui o lei fossero una Terza Persona.
Vale la pena notare che scrisse questi pensieri sulla tirannia nel 1945. E che l’uso del “lui o lei”, ben avanti sui tempi, è suo.
- “Questo fa poggiare i rapporti umani su una falsa base, una base obiettiva, che li svilisce. Perché parliamo in modo obiettivo di chi è assente e quindi non arrossirà per quello che diciamo o non si arrabbierà o in ogni caso non dovrà stare ad ascoltare. I rapporti umani prosperano quando possiamo conservare un legame segreto e un desiderio intimo di ascoltare. I rapporti umani muoiono quando tutte le nostre affermazioni si riducono a un semplice dato di fatto. Perché a quel punto ci stiamo solo insultando l’un l’altro. L’esercito, le fabbriche, le scuole, gli ospedali - insultano così spesso.”
Rosenstock-Huessy fa risalire tutto a questo peccato, dai conflitti con l’autorità a scuola alla schizofrenia, e avanza delle rivendicazioni impressionanti per un proprio “metodo grammaticale” che riconfiguri il linguaggio. Come dicevo, non so cosa pensare al riguardo. Ma è qui, presentato per voi sotto forma di paragrafi alternati da me e da lui. Voi siete la prima persona. Fatene quello che volete.
- “Possiamo studiare la grammatica avanzata così come si studia la matematica avanzata. Quando ancora bruciavamo le streghe sul rogo, la matematica avanzata ci ha guariti illuminando l’universo in modo così completo da non lasciare più spazio alle streghe. La matematica avanzata, abbracciando l’infinito, ci ha permesso di carpire i segreti della massa e dell’energia, del tempo naturale e dello spazio. Il mondo non è più magico e stregato. Il suo ordine atomico è diventato trasparente, con l’aiuto della matematica avanzata. Una grammatica avanzata, che si occupi del tipo di enfasi che il discorso pone sulle nostre parole e sulle nostre azioni, ci permetterebbe di carpire i segreti dei movimenti sociali, delle masse e degli individui, delle patologie e della guarigione della vita politica. La grammatica base ha degradato il linguaggio fino a renderlo uno strumento arbitrario dello spirito umano; la grammatica avanzata lo aggiusterà.”
 Traduzione di Alessandra Castellazzi. Si ringraziano l’autore e The Paris Review per la pubblicazione dell’articolo.
Traduzione di Alessandra Castellazzi. Si ringraziano l’autore e The Paris Review per la pubblicazione dell’articolo.* Damion Searls traduce dal tedesco, dal norvegese, dal francese e dall’olandese. Ha tradotto classici come Proust, Rilke, Nietzsche, e Ingeborg Bachmann. Il suo ultimo libro è Macchie d’inchiostro - Storia di Hermann Rorschach e del suo test.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- RILEGGERE SAUSSURE. UN "TRATTATO TEOLOGICO-POLITICO" RIDOTTO A UN BANALE "CORSO DI LINGUISTICA GENERALE"!!!
LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). Un omaggio a Kurt H. Wolff e a Barrington Moore Jr.
PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!
 FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! - L’ultima lezione di Stefano Rodotà: "Vivere la democrazia" (di Roberto Esposito).31 marzo 2018, di Federico La Sala
SENZA PIU’ PAROLA E SENZA PIU’ CARTA D’IDENTITA’. Alla ricerca della dignità perduta...
Le idee. Per una biopolitica illuminista
L’ultima lezione di Stefano Rodotà
di Roberto Esposito (la Repubblica, 31.03.2018)
«Per vivere occorre un’identità, ossia una dignità. Senza dignità l’identità è povera, diventa ambigua, può essere manipolata». Il nuovo libro, postumo, di Stefano Rodotà, Vivere la democrazia, appena pubblicato da Laterza, può essere letto come un ampio e appassionato commento a questa frase di Primo Levi. Tutti e tre i termini evocati da Levi - identità, dignità e vita - s’incrociano in una riflessione aperta ma anche problematica, che ha fatto di Rodotà uno dei maggiori analisti del nostro tempo.
 Composto da saggi non tutti rivisti dall’autore, scomparso lo scorso giugno nel pieno del suo lavoro, il libro ci restituisce il nucleo profondo di una ricerca che definire giuridica è allo stesso tempo esatto e riduttivo. Esatto perché il diritto costituisce l’orizzonte all’interno del quale Rodotà ha collocato il proprio lavoro. Riduttivo perché ha sempre riempito la propria elaborazione giuridica di contenuti storici, filosofici, antropologici che ne eccedono il linguaggio. Rodotà ha posto il diritto, da altri irrigidito in formulazioni astratte, a contatto diretto con la vita. E non con la vita in generale, ma con ciò che è diventato oggi la vita umana nel tempo di una tecnica dispiegata al punto da penetrare al suo interno, modificandone profilo e contorni.
Composto da saggi non tutti rivisti dall’autore, scomparso lo scorso giugno nel pieno del suo lavoro, il libro ci restituisce il nucleo profondo di una ricerca che definire giuridica è allo stesso tempo esatto e riduttivo. Esatto perché il diritto costituisce l’orizzonte all’interno del quale Rodotà ha collocato il proprio lavoro. Riduttivo perché ha sempre riempito la propria elaborazione giuridica di contenuti storici, filosofici, antropologici che ne eccedono il linguaggio. Rodotà ha posto il diritto, da altri irrigidito in formulazioni astratte, a contatto diretto con la vita. E non con la vita in generale, ma con ciò che è diventato oggi la vita umana nel tempo di una tecnica dispiegata al punto da penetrare al suo interno, modificandone profilo e contorni.Ma cominciamo dalle tre parole prima evocate, a partire dall’identità. Come è noto a chi si occupa di filosofia, l’interrogazione sul significato della nostra identità attraversa l’intera storia del pensiero, trovando un punto di coagulo decisivo nell’opera di John Locke.
Cosa fa sì che il vecchio riconosca sé stesso nel ragazzo, e poi nell’adulto, che è stato nonostante i tanti cambiamenti che ne hanno segnato l’aspetto e il carattere? La risposta di Locke è che a consentire alla coscienza di sperimentarsi identica a se stessa in diversi momenti dell’esistenza è la memoria. Ma tale risposta bastava in una stagione in cui natura, storia e tecnica costituivano sfere distinte e reciprocamente autonome. Una condizione oggi venuta meno. Nel momento in cui politica e tecnica hanno assunto il corpo umano a oggetto del proprio operato tutto è cambiato. Sfidata dalle biotecnologie e immersa nel cyberspazio, l’identità umana si è andata dislocando su piani molteplici, scomponendosi e ricomponendosi in maniera inedita.
È precisamente a questa mutazione antropologica che Rodotà rivolge uno sguardo acuminato. A chi appartiene il nostro futuro? - egli si chiede con Jaron Lanier (La dignità ai tempi di internet, Il Saggiatore) - quando l’identità non è più forgiata da noi stessi, ma modificata, e anche manipolata, da altri? Si pensi a come è cambiato il ruolo del corpo in rapporto alla nostra identificazione. Dopo essere stato centrale, al punto che sulla carta d’identità comparivano, insieme alla foto, colore di occhi e capelli, il corpo è stato in qualche modo soppiantato dalle tecnologie informatiche - password, codici, algoritmi. Per poi tornare, una volta tecnologizzato, come oggetto di attenzione da parte delle agenzie di controllo. Impronte digitali, geometrie della mano, iride, retina, per non parlare del dna.
 Tutto ciò quando la chirurgia plastica è in grado di cambiare i nostri connotati.
E qui entra in gioco il secondo termine del libro, la dignità, assunta non in maniera generica, ma come un vero principio giuridico. Che ha già trovato spazio nella nostra Costituzione e poi nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. Ma ciò non basta, se si vuol passare dal tempo dell’homo aequalis a quello dell’homo dignus. Il richiamo alla dignità, che è stato un lascito importante del costituzionalismo del Dopoguerra diventa, per Rodotà, un elemento costitutivo dell’identità personale.
Tutto ciò quando la chirurgia plastica è in grado di cambiare i nostri connotati.
E qui entra in gioco il secondo termine del libro, la dignità, assunta non in maniera generica, ma come un vero principio giuridico. Che ha già trovato spazio nella nostra Costituzione e poi nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. Ma ciò non basta, se si vuol passare dal tempo dell’homo aequalis a quello dell’homo dignus. Il richiamo alla dignità, che è stato un lascito importante del costituzionalismo del Dopoguerra diventa, per Rodotà, un elemento costitutivo dell’identità personale.
 Naturalmente a patto che il concetto stesso di “persona” spezzi il guscio giuridico di matrice romana, per incarnarsi nel corpo vivente di ogni essere umano, senza distinzione di etnia, religione, provenienza.
Naturalmente a patto che il concetto stesso di “persona” spezzi il guscio giuridico di matrice romana, per incarnarsi nel corpo vivente di ogni essere umano, senza distinzione di etnia, religione, provenienza.Anche la questione, largamente discussa, dei beni comuni va inquadrata in questo orizzonte storico, misurata alle drastiche trasformazioni che stiamo vivendo. Solo in questo modo anche il terzo termine in gioco - la vita - può diventare oggetto di una biopolitica affermativa. Rodotà ne offre un esempio illuminante.
Nel 2013 la Corte suprema dell’India ha stabilito che il diritto di una casa farmaceutica di fissare liberamente il prezzo di un farmaco di largo consumo è subordinato al diritto fondamentale alla salute di chi ne ha bisogno. Che prevale sull’interesse proprietario.
Come è noto, a partire dall’entrata in vigore del Codice civile napoleonico, il principio della proprietà è stato sostituito a quello, rivoluzionario, di fraternità, anteponendo la figura del proprietario a quella del cittadino. Che non sia arrivato il momento di riattivare la fraternità ricucendo il filo, spezzato dell’uguaglianza?
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- COSTITUZIONE E PENSIERO. ITALIA: LA MISERIA DELLA FILOSOFIA ITALIANA E LA RICCHEZZA DEL MENTITORE ISTITUZIONALIZZATO ...
 BERTRAND RUSSELL: LA LEZIONE SUL MENTITORE (IGNORATA E ’SNOBBATA’), E "L’ALFABETO DEL BUON CITTADINO".
BERTRAND RUSSELL: LA LEZIONE SUL MENTITORE (IGNORATA E ’SNOBBATA’), E "L’ALFABETO DEL BUON CITTADINO".
-
POLITICA, CONFLITTO D’INTERESSE, E ... "UNDERSTANDING MEDIA" ("GLI STRUMENTI DEL COMUNICARE"). I nuovi media non sono giocattoli e non dovrebbero essere messi nelle mani di Mamma Oca o di Peter Pan.
 LA "PROFEZIA" DI MARSHALL MCLUHAN: NARCISO E LA MORTE DELL’ITALIA.
LA "PROFEZIA" DI MARSHALL MCLUHAN: NARCISO E LA MORTE DELL’ITALIA.
FILOSOFIA. IL PENSIERO DELLA COSTITUZIONE E LA COSTITUZIONE DEL PENSIERO
 MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA E A PENSARE BENE "DIO", "IO" E "L’ITALIA", CHI PIU’ CHI MENO, TUTTI VIVONO DENTRO LA PIU’ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA E POLITICA ITALIANA, NEL REGNO DI "FORZA ITALIA"!!!
MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA E A PENSARE BENE "DIO", "IO" E "L’ITALIA", CHI PIU’ CHI MENO, TUTTI VIVONO DENTRO LA PIU’ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA E POLITICA ITALIANA, NEL REGNO DI "FORZA ITALIA"!!!Federico La Sala
- COSTITUZIONE E PENSIERO. ITALIA: LA MISERIA DELLA FILOSOFIA ITALIANA E LA RICCHEZZA DEL MENTITORE ISTITUZIONALIZZATO ...
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- Il destino ambiguo del Concordato. Nella Costituzione senza esserlo. a storia di come la Carta regolò i rapporti tra Stato e Chiesa.30 marzo 2018, di Federico La Sala
MITO E STORIA, POLITICA E TEOLOGIA: "LUCIFERO!" E LA STELLA DEL DESTINO. Storiografia in crisi d’identità ... *
Diritto
Nel saggio di Daniele Menozzi (Carocci) la storia di come la Carta regolò i rapporti tra Stato e Chiesa
Nella Costituzione senza esserlo. Il destino ambiguo del Concordato
I tessitori. Dossetti e Togliatti con il liberale Lucifero trovarono la soluzione sancita nell’articolo 7
di Roberto Finzi (Corriere della Sera, 30.03.2018)
Non c’è dubbio che tra i «principi fondamentali» che reggono la nostra Repubblica racchiusi nei primi dodici articoli della Carta del 1948 (cui Carocci dedica una serie diretta da Pietro Costa e Mariuccia Salvati) il più controverso sia stato (in parte continui a essere) l’articolo 7 o meglio, e soprattutto, il primo asserto del suo secondo comma. Se, al di là delle sfumature, ogni forza politica e ogni cittadino, poteva ammettere che «lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani» perplessità e opposizioni nascevano e continuarono dalla affermazione che seguiva: «I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi», firmati, come si sa, da Benito Mussolini e dal cardinale segretario di Stato Pietro Gasparri l’11 febbraio 1929, regnante Achille Ratti, Papa Pio XI. Sanavano la «questione romana» apertasi con la presa di Roma. Con accordi e norme complicate tra cui due particolarmente odiose per un Paese che - dopo un decennio di guerre e la doppia occupazione nazista e alleata - si era scrollato di dosso la dittatura anche attraverso la Resistenza e stava lavorando non solo al ritorno delle civili libertà ma a una democrazia nuova, repubblicana come aveva decretato il voto del 2 giugno 1946.
Si trattava dell’asserto che quella cattolica era la religione «di Stato» e, per la sua pervasività, dell’attribuzione degli effetti civili al matrimonio religioso. Con il paradosso che chi riteneva il matrimonio un sacramento poteva, per le norme del diritto canonico, ottenerne la nullità, riconosciuta poi dallo Stato e chi invece aveva del matrimonio una concezione puramente civile era destinato a essere legato a vita, indissolubilmente, non per diretta conseguenza dei Patti, ma per la coincidenza nella visione della famiglia tra Chiesa e fascismo. Nel quadro per di più di un diritto di famiglia in cui era sancita una netta subordinazione della donna.
Nella sua ricostruzione del formarsi del dettame costituzionale e poi dei suoi effetti nella vita democratica italiana ( Art.7. Costituzione italiana ), Daniele Menozzi non nega le conseguenze negative del permanere di quelle norme specie nel quindicennio successivo alla emanazione della Carta Costituzionale. Ci offre però una chiave di lettura della formazione e del senso della norma più articolata, che affonda le sue radici nella complessità del problema cattolico nella storia dell’Italia unita e soprattutto a quel punto della vicenda del nostro Paese.
La Chiesa, lo dimostreranno le successive elezioni del 18 aprile 1948, aveva ancora un forte ascendente sulla popolazione ed era una Chiesa che, seppure - si vedrà di lì a poco - intimamente percorsa da interne pulsioni verso il nuovo, era ancora fortemente contraria al mondo moderno e alle sue forme politiche. In particolare a quelle di matrice socialista e comunista. Ora, si trattava, in sostanza - spiega Menozzi con precisione e acribia filologica - di attirare, per così dire, la Chiesa verso la accettazione piena di quella democrazia che si andava delineando nel lavoro della Costituente, cedendo in via formale alle sue richieste anche se nell’immediato contraddittorie con quella visione.
Protagonista di questa operazione complicata e sottile fu in primis Giuseppe Dossetti che univa alla sua profonda fede cristiana una visione non ierocratica della Chiesa, la competenza giuridica del canonista di vaglia, cristalline convinzioni democratiche, saldi legami con le altre culture politiche formatisi nella Resistenza. Dossetti trovò una sponda in Palmiro Togliatti, a lungo, e tutt’oggi, accusato di avere, in qualche modo permesso un inquinamento della Costituzione con il riconoscimento nel suo testo dei famigerati Patti Lateranensi.
L’atteggiamento del leader del Pci derivava dal convincimento che nella Repubblica dovessero riconoscersi per davvero tutti gli italiani e pure, dice Menozzi, da considerazioni più immediatamente politiche. Mentre stava costruendo il «partito nuovo» guardava alla possibilità di una adesione al Pci di cattolici. Così temuta dalla Chiesa pacelliana che nel 1949 il Papa scomunicherà i comunisti.
Io aggiungerei due aspetti. Togliatti era ben consapevole di quanto Milovan Gilas nelle sue Conversazioni con Stalin ricorda avergli detto il dittatore sovietico: «Questa guerra (...) è diversa da tutte quelle del passato; chiunque occupa un territorio gli impone anche il suo sistema sociale». E infine la lotta per l’egemonia all’interno della sinistra. In quel campo i socialisti, allora sotto la sigla Psiup, erano ancora, seppure non di molto, maggioritari rispetto al Pci.
Per ben intendere la vicenda al quadro manca un tassello. Decisivo. Si tratta della seconda parte del secondo comma dell’articolo 7 che recita: «Le modificazioni dei Patti (Lateranensi), accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale». In tal modo si eliminava una delle più forti obiezioni all’inserimento dei Patti in Costituzione. Per tale via infatti non venivano «costituzionalizzati» ché la loro modifica poteva avvenire per legge ordinaria. L’artefice di questo accorgimento essenziale fu Roberto Lucifero, liberale e monarchico.
Così l’articolo, nota Menozzi, «appariva formulato con il concorso di tre diverse famiglie politiche: la democristiana, la comunista e la liberale».
La «non costituzionalizzazione» dei Patti - in un modo profondamente cambiato all’interno e soprattutto all’esterno della Chiesa - sarà uno degli elementi che permetterà all’Italia l’adozione formale, prima sul terreno parlamentare e quindi - con i referendum del 1974 e del 1981 - attraverso la conferma popolare di decisive riforme come il divorzio e l’interruzione volontaria di gravidanza. E del nuovo diritto di famiglia.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
MITO E STORIA, POLITICA E TEOLOGIA: "LUCIFERO!" E LA STELLA DEL DESTINO. Storiografia in crisi d’identità ...
 LA STORIA DEL FASCISMO E RENZO DE FELICE: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"!
LA STORIA DEL FASCISMO E RENZO DE FELICE: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"!
 I. BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI - II. ARNALDO MUSSOLINI E MADDALENA SANTORO.
I. BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI - II. ARNALDO MUSSOLINI E MADDALENA SANTORO.- TEORIA E STORIA DELLA STORIOGRAFIA. IL PROBLEMA GIAMBATTISTA VICO E IL PROBLEMA DELLA COSTITUZIONE
 CROCE “CRISTIANO” , VICO “ATEO”, E L’UOMO DELLA PROVVIDENZA.
CROCE “CRISTIANO” , VICO “ATEO”, E L’UOMO DELLA PROVVIDENZA.
- VENI, CREATOR SPIRITUS: LO SPIRITO DELLA VERITA’. Lo Spirito "costituzionale" di Benedetto Croce, lo spirito cattolico-romano di Giacomo Biffi, e la testimonianza di venti cristiani danesi
LA QUESTIONE "CATTOLICA" E LO SPIRITO DEI NOSTRI PADRI E E DELLE NOSTRE MADRI COSTITUENTI. Per un ri-orientamento antropologico e teologico-politico. Una nota (del 2006)
KANT E SAN PAOLO. COME IL BUON GIUDIZIO ("SECUNDA PETRI") VIENE (E VENNE) RIDOTTO IN STATO DI MINORITA’ DAL GIUDIZIO FALSO E BUGIARDO ("SECUNDA PAULI").
Federico La Sala
- TEORIA E STORIA DELLA STORIOGRAFIA. IL PROBLEMA GIAMBATTISTA VICO E IL PROBLEMA DELLA COSTITUZIONE
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! - VITA E FILOSOFIA: MITOLOGIE HEGELIANE. "Foto di gruppo con servo e signore" (Massimo Palma).25 marzo 2018, di Federico La Sala
IL CRISTIANESIMO ("DEUS CHARITAS EST"), IL CATTOLICISMO ("DEUS CARITAS EST"), LA CRITICA DELL’ECONOMIA POLITICA E DELLA FILOSOFIA HEGELIANA (MARX), E LA POSTERITA’ SPIRITUALE DI GIOACCHINO DA FIORE .... *
Filosofi? Solo nel weekend
Relazioni. Il rapporto dialettico tra servo e signore, evocato da Hegel e analizzato da Kojève, chiama gli intellettuali all’impegno fuori dai loro circoli chiusi. Ma forse i pensieri più originali sono invece frutto dell’ozio, dei momenti in cui ci si distacca dalle preoccupazioni mondane
di Mauro Bonazzi (Corriere della Sera, La Lettura, 25.03.2018)
«È stato terribile. Alla conferenza si sono presentati più di 300 giovani, si è dovuto cambiare sala, e ciò nonostante la gente era seduta per terra. Se si pensa che una cosa del genere capita solo per le conferenze di Sartre!». Gli inizi erano stati ben diversi. «E sì che quando ho iniziato a parlare all’École (l’École Pratique des Hautes Études, una delle grandi istituzioni francesi, ndr ) erano presenti a malapena una dozzina di persone!». Ma che dozzina: in quell’auletta si confondevano, tra occhiali rotondi, odore di lacca e colletti inamidati, con tutto il loro bagaglio di piccole perfidie e grandi idee, Jacques Lacan e Hannah Arendt, Raymond Queneau e Raymond Aron, Maurice Merleau-Ponty ed Eric Weil, George Bataille e Roger Caillois, e forse anche André Breton e Leo Strauss. Figure eccentriche, in quel momento, quasi tutti giovani, in fuga da qualcosa o da sé stessi, ma destinati a ben altro futuro. Le lezioni erano estenuanti - «il corso mi ha sfinito, annientato, ucciso dieci volte», scriveva Bataille - un commento pressoché infinito di alcune pagine di uno dei testi in assoluto più difficili mai scritti, la Fenomenologia dello Spirito di Hegel.
A officiare, in un rito che si sarebbe rinnovato ogni settimana per sei anni (dal 1933 al 1939), era Alexandre Kojève, un giovane emigrato russo nato nel 1902, esule in fuga dalla rivoluzione bolscevica, ma forse una spia dei servizi segreti sovietici, nipote di Vasilij Kandinskij, seduttore implacabile - di lui si è detto tutto e il contrario di tutto -, senza dubbio il signore assoluto della scena filosofica parigina.
A questo gruppo, davvero inimitabile, è dedicato il bel saggio di Massimo Palma, appena pubblicato da Castelvecchi, Foto di gruppo con servo e signore.
Più precisamente, tutto girava intorno a poche pagine. Pagine oscure, astruse, a volte incomprensibili; ridicole e tragiche allo stesso tempo: così come ridicola e tragica allo stesso tempo è la vita degli esseri umani, che era poi il tema di fondo di quelle lezioni e di quel libro. Si raccontava il viaggio della coscienza (che poi saremmo noi) in cerca del significato della propria esistenza, di un posto nell’universo, e del bisogno di essere riconosciuti: perché in un mondo senza più Dio, senza più un Dio che ci osserva, è solo così, vale a dire nel riconoscimento reciproco, che potremo dire di essere vissuti realmente.
Diversamente è la natura che si ripete eternamente identica a sé stessa, bellissima ma silenziosa, indifferente, estranea: «Senza alcun dubbio la singola mosca muore, ma queste mosche qui sono le stesse dell’anno passato. Quelle dell’anno passato sono forse morte? Può essere, ma nulla è scomparso. Le mosche restano uguali a sé stesse come le onde del mare» (Bataille). Non basta, non può bastare. La storia nasce come negazione di questa unità indistinta della natura, quando questi esseri inquieti che sono gli uomini iniziano la loro battaglia contro l’angoscia del nulla, alla ricerca di sé stessi, per dimostrare che non siamo qui per caso, come mosche o foglie.
Per questo cerchiamo gli altri, ne abbiamo bisogno, come di uno specchio che rifletta e ci riveli nella nostra inimitabile specificità, nel nostro valore. «La realtà umana è sempre sociale», scrive Kojève, l’uomo è l’animale politico: solo gli dèi e le bestie vivono da soli; «l’uomo reale e vero è il risultato della sua interazione con altri». Il problema, però, è che questo desiderio di riconoscimento è sempre foriero di conflitti e tensioni: la mia affermazione, il riconoscimento della mia importanza, passa per la negazione dell’altro. È la dialettica tra servo e padrone, il cuore della Fenomenologia: solo chi osa, chi è pronto a mettere tutto in discussione, potrà affermarsi. «Conflitto è padre di tutte le cose, e alcuni li fa liberi altri schiavi»: persino l’oscuro Eraclito diventava chiaro grazie a Hegel e Kojève. Con una sorpresa finale, un’inversione paradossale dei ruoli: il padrone, affidando tutto al suo sottoposto, finisce per dipendere da lui, che in questo modo scoprirà la sua forza, prendendo il sopravvento. E via di seguito, di rovesciamento in rovesciamento: così procede la storia, quando i vinti rialzano la testa.
Teorie astruse? Forse, ma non prive di una loro attualità. Perché in fondo trasmettevano un insegnamento molto semplice: che non esistono anime belle, che quello che siamo dipende dal rapporto che costruiremo con gli altri, dalla determinazione con cui affronteremo le sfide della vita. Solo agendo, esponendosi al rischio dell’insuccesso (della morte, scriveva Hegel), si può sperare di realizzare qualcosa.
Era anche una critica sferzante agli intellettuali, chiusi nei loro giardini e nelle loro parrocchie, sempre intenti a discutere tra loro: schiavi dunque dei loro pregiudizi così come la tanto vituperata folla dei non iniziati lo è dei propri; e per questo incapaci di comprendere la realtà che li circonda; destinati a essere superati dal corso degli eventi. Niente male come lezione, mentre le truppe naziste si apprestavano a marciare su Parigi.
Poi tutto era cambiato. Sempre funambolico, ma in fondo coerente con le sue idee, dopo la guerra Kojève aveva repentinamente abbandonato il mondo accademico, entrando nell’amministrazione, al ministero degli Affari economici, dove divenne in breve tempo un’eminenza grigia della politica commerciale francese, invincibile nelle negoziazioni internazionali («quando le altre delegazioni vedevano arrivare Kojève, e in special modo se lo vedevano arrivare solo, era il panico», ricordò dopo la sua morte un funzionario che gli era stato collega per anni). Sembrava il Talete di cui aveva parlato Platone, quello che cade nel pozzo perché assorto nella contemplazione del cielo. Si era rivelato come il Talete di Aristotele, che, grazie alla conoscenza del cielo e dei fenomeni atmosferici, aveva preso il controllo di tutti i frantoi, «dimostrando che per i filosofi avere successo è veramente facile - se solo lo vogliono». Per la filosofia non restava ormai che il fine settimana: e «filosofo della domenica» Kojève sarebbe diventato per tutti, secondo la folgorante definizione di Raymond Queneau.
Del resto - e questo è l’ultimo paradosso di un pensatore che viveva di paradossi - è in fondo proprio la domenica il giorno decisivo, quando finalmente ci si ferma e la cosa più importante forse si rivela. La saggezza, la serenità raggiunta. L’avevano inseguita tutti, la trovò forse il solo Queneau, tra tutti l’allievo più imprevedibile, lo scrittore capace di esprimere la filosofia del maestro in forma di romanzi (ed è a lui che si deve tra l’altro la trascrizione e pubblicazione dei corsi all’École Pratique - e dunque la creazione del mito di Kojève). E se tutto questo affannarsi nelle azioni e questo correre dietro alle parole non portasse da nessuna parte? E se la saggezza non fosse altro che la capacità di sorridere dello spettacolo d’arte varia (questo è Paolo Conte) e strampalata che sono gli uomini e le loro vite? Né servi né padroni, senza bisogno di essere riconosciuti o di riconoscere?
Lo aveva ammesso persino il grande Hegel, in un momento di rara lucidità: «In questa sfrenatezza priva di preoccupazioni è implicito il momento ideale: è la domenica della vita, che tutto uguaglia e che allontana ogni cattiveria; persone che sono così cordialmente di buon umore non possono essere del tutto cattive o basse». Anche Kojève alla fine gli aveva dato ragione: «Queneau ha riassunto la Fenomenologia dello Spirito scrivendo Zazie nel metro. Zazie era venuta a Parigi per vedere la metropolitana. Ma la sola volta in cui ci andò, s’addormentò e non vide nulla. Ecco il romanzo della saggezza». Se fosse proprio così, e tutto qui? I pensieri più impertinenti vengono quando si ozia - di domenica, insomma - e forse sono i migliori.
O forse non è così, e neppure questa soddisfazione - una «negatività senza impiego», diceva Bataille - riuscirà a placare l’ansia tutta umana di agire, combattere, costruire? La mosca non smette di ronzare, disturbando il pensiero; la storia continua...
La rivoluzione fuma l’oppio
di Antonio Carioti (Corriere della Sera, La Lettura, 25.03.2018)
Se si guarda in faccia la crisi del pensiero rivoluzionario senza cercare scuse consolatorie, l’unica alternativa alla rassegnazione è la riscoperta della dimensione religiosa. Semplificando al massimo, si può riassumere così la densa riflessione che Romano Màdera, filosofo e psicoanalista, ha premesso alla riedizione del suo saggio Identità e feticismo del 1977, riposto ora con altri scritti dalle edizioni Mimesis con il titolo Sconfitta e utopia (pp. 236, e 20). La prospettiva millenaristica indicata da Karl Marx, nota Màdera, non discende affatto dalla sua pur lucida descrizione del capitalismo. Può quindi ritrovare un senso solo se reinnestata nel solco della tradizione giudaico-cristiana e indirizzata verso una «riforma della spiritualità mondiale». Che rivincita, per l’«oppio del popolo».
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
*
- La Grazia, del resto, ha anche terminologicamente da fare con tutto ciò che è gratuito - proprio con quello che Hegel chiamava «domenica della vita», e cioè il bello, il dominio dell’estetico, di ciò che viene amato non in vista di altro, ma per se stesso. Se la Chiesa saprà predicarci la Grazia in questo senso più vasto, potremmo persino riconoscerle senza proteste le sue esenzioni dall’Ici (La domenica di Ratzinger e la "domenica della vita" di Hegel. Una nota di Gianni Vattimo).
PER LA CRITICA DEL CAPITALISMO E DELLA SUA TEOLOGIA "MAMMONICA" (Benedetto XVI, "Deus caritas est", 2006).
 "CHI" SIAMO NOI, IN REALTÀ. RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.
"CHI" SIAMO NOI, IN REALTÀ. RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.
-
STORIA E (FENOMENOLOGIA DELLO) SPIRITO. Il cristianesimo non è un "cattolicismo": il ’cattolicesimo’ è finito...
 IL DRAMMA DEL CATTOLICESIMO ATEO E DEVOTO, HENRI DE LUBAC, E LA POSTERITÀ SPIRITUALE DI GIOACCHINO DA FIORE.
IL DRAMMA DEL CATTOLICESIMO ATEO E DEVOTO, HENRI DE LUBAC, E LA POSTERITÀ SPIRITUALE DI GIOACCHINO DA FIORE.
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
>VITA E FILOSOFIA: MITOLOGIE HEGELIANE. "Foto di gruppo con servo e signore" -- "I demoni meridiani": Roger Caillois, il "Collège de Sociologie", e Marcel Mauss.29 marzo 2018, di Federico La Sala
E’ MEZZOGIORNO... L’ ORA DEI VAMPIRI
di PAOLO MAURI (la Repubblica, 14 ottobre 1988)
- Il libro. I demoni meridiani di Roger Caillois, Introduzione di Carlo Ossola (Bollati Boringhieri, pagg. IX-XXXIII, 1-119, lire 20.000).
SE AI TEMPI di Cenerentola non ci fosse stato l’orologio, un orologio in grado di battere le ore, di renderle esplicite per tutti, a mezzanotte non sarebbe successo proprio nulla. Perché il prodigio si compia, infatti, è necessario che scocchi l’ora fatidica, cioè che un segnale particolare la renda reale e sia pure relativamente ad un luogo e ad una comunità universale. L’ora fatidica dei fantasmi e dei vampiri non viene dunque, come comunemente si crede, da molto lontano: è un effetto speciale legato alla misurazione del tempo, una certezza tutto sommato abbastanza moderna.
Anticamente, cioè prima dell’ orologio, la scansione del giorno riguardava soprattutto le ore di luce, con un momento privilegiato: il mezzogiorno. Per quanto oggi possa apparire incredibile, fu proprio il mezzogiorno l’ ora fatidica dei prodigi e dei fantasmi, dei vampiri e dei demoni, delle apparizioni misteriose e del manifestarsi della follia. Il parallelo mezzanotte-mezzogiorno ci dice intanto una cosa fondamentale: che l’uomo ha bisogno di segnare nettamente i confini tra il regno della normalità e quello soprannaturale; colonne d’Ercole mentali, le ore fatidiche segnano il punto di passaggio tra ciò che si conosce e ciò che si teme, perché ignoto e quindi insieme terrifico e fascinoso.
E’ facile intuire perché l’uomo antico scegliesse il mezzogiorno come ora fatidica: intanto era un’ora riconoscibile anche a occhio e determinabile con una certa precisione, badando ad alcuni fenomeni alla portata di tutti. Il sole raggiunge il punto massimo nel cielo e le ombre sulla terra si accorciano fino a scomparire: una sorta di orologio rudimentale, lo gnomone, consiste proprio di un’asta che proiettando un’ombra consente di verificare l’ ora meridiana.
Proprio a I demoni meridiani dedicò uno studio, poco oltre la metà degli anni Trenta, Roger Caillois, ancora oggi ben noto e presente per i suoi lavori sul sacro e sul mito, nonché per le sue teorie sul gioco.
Era un momento delicato, in Europa, per dare spazio all’ irrazionale; e giustamente Carlo Ossola, che ha provveduto oggi a trasformare quello studio disperso in un libretto che esce tra pochi giorni (I demoni meridiani, Bollati Boringhieri, pagg. 128, lire 20.000) si sofferma nell’ introduzione sul clima culturale del tempo e sulle intenzioni del Collège de Sociologie dove Roger Caillois si trovava ad operare.
Il programma di Caillois (e naturalmente del Collège de Sociologie) è assai complesso: si tratta di illuminare i comportamenti degli uomini (anzi dell’ intero regno animale) attraverso i miti, che ne sono una rappresentazione. Devo qui, necessariamente, prendere una scorciatoia, non potendo (come fa Ossola nella sua introduzione) ricapitolare i principali passaggi di un’operazione culturale fascinosa e rischiosa insieme. Non appena il mito tocca il contemporaneo, l’analisi cede il posto alla volontà di fare. La passione di fare diventa bruciante.
Quando, dopo essersi occupato dei demoni meridiani, Caillois si mise a studiare il moderno mito di Parigi, con tutti i suoi corollari di superamento della mediocrità borghese verso una divina (o diabolica) volontà di potenza, il reale (in questo caso il nazismo) ha già fatto largo uso dell’irrazionale per porre le basi del suo progetto di dominio.
Sarà Marcel Mauss ad avvertire gli studiosi del Collège che stanno rischiando grosso: credo che siate tutti in questo momento sbandati, probabilmente sotto l’influsso di Heidegger, bergsoniano attardato nell’ hitlerismo, che legittima l’hitlerismo invasato d’ irrazionalismo....
Di fronte all’hitlerismo, inaccettabile perché razzista, Caillois fa marcia indietro, ed è probabilmente questo uno dei motivi per cui il suo studio sui demoni meridiani non venne da lui più tardi recuperato. Non tanto perché in esso trattasse questioni immediatamente pericolose: in fondo si tratta di una eruditissima ricognizione rivolta al recupero di una dimensione trascurata eppure anticamente assai attiva, ma soprattutto perché in esso stavano due chiavi comportamentali che potevano tranquillamente essere resuscitate anche nell’Europa moderna.
Da un lato, infatti, l’ora meridiana è l’ora dell’acedia, una forma di depressione, di taedium vitae, di spaesamento, che colpisce si tramanda i monaci e gli anacoreti del deserto portandoli a ripudiare il proprio essere monaci, a non capire più, o addirittura a non sopportare più, la propria condizione. L’acedia è la perdita del sacro.
 D’ altra parte, a far da contraltare alla passività indotta dall’acedia, c’è la volontà di potenza e di immortalità favorita dall’ allucinazione che il calore meridiano provoca. Nella sua ambiguità la potenza del sole distrugge e feconda, sconfigge i deboli ed esalta, in senso proprio, i forti. C’ è dunque un messaggio di morte e contemporaneamente un accredito vitale nell’ ora fatidica.
D’ altra parte, a far da contraltare alla passività indotta dall’acedia, c’è la volontà di potenza e di immortalità favorita dall’ allucinazione che il calore meridiano provoca. Nella sua ambiguità la potenza del sole distrugge e feconda, sconfigge i deboli ed esalta, in senso proprio, i forti. C’ è dunque un messaggio di morte e contemporaneamente un accredito vitale nell’ ora fatidica.Caillois ripercorre passo passo le situazioni topiche dell’ora meridiana: ora centrale del giorno che divideva in due zone ben distinte le cose lecite (o favorevoli) da quelle illecite. Racconta Plutarco, per esempio, che nessun condottiero romano avrebbe mai firmato un trattato o un atto importante dopo mezzogiorno. Sotto altri cieli (in Messico, presso gli aztechi) il mezzogiorno era un’ ora privilegiata per i sacrifici ed è sempre a mezzogiorno che le divinità si manifestano. Caillois ricorda che Pan, il più importante dio dell’Arcadia, era solito comparire appunto a mezzogiorno.
LA LETTURA del lavoro di Caillois mi ha fatto venire in mente un’ altra remota lettura, il libretto di Franz Altheim dedicato al cristianesimo e ai culti solari: si intitolava Il dio invitto e in Italia lo tradusse nel 1960 Feltrinelli. Anche il cristianesimo, che pure ha molto contribuito ad attribuire la luce al bene e le tenebre al male, ha le sue implicazioni con il sole e con i culti solari.
Risfogliandolo dopo tanto tempo ho letto che Costantino ebbe la visione della croce all’ ora meridiana del sole e che alla stessa ora la sua anima salì al cielo. Dunque il mezzogiorno è anche (o meglio soprattutto) l’ora dei morti, non fosse altro che per il fatto dell’ accorciamento e scomparsa dell’ ombra, che presso alcuni rappresentava l’ anima. (L’avventura di Peter Schlemihl ha dunque radici assai remote). L’ora dei morti (seguo sempre Caillois) era riservata alle libagioni in onore dei morti: anche in Sofocle è mezzogiorno quando Antigone viene ad offrire il sacrificio per il fratello. Di qui la credenza, abbastanza diffusa, che si trattasse di un’ora sacra e quindi pericolosa: nei templi si tiravano le tende a quell’ ora fatale, bambini e donne erano invitati a non uscire di casa e i morti senza pace ne approfittavano per manifestarsi. Particolarmente nutrita quest’ultima categoria, come attestano numerose fonti: la guardia forestale con la testa sotto il braccio, il cavaliere senza testa che è stato impiccato, l’uomo senza testa attorniato dai cani... Anche il cadavere che non ha ricevuto gli onori funebri appare a mezzogiorno: lo ricorda anche Stazio nella Tebaide.
Ancora: mezzogiorno è l’ ora della malia incantatrice. L’autore si rifà qui alla leggenda delle sirene, già nell’antichità messe in relazione con Sirio, la stella più brillante del Cane, foriera di spossatezza, di lascivia e quindi di mortale abbandono. Si mescolano qui due temi di lunga durata: il piacere e la morte, sicché s’introduce l’elemento sessuale, nella doppia accezione della fecondazione e dell’ abbandono ai sensi.
MA IL VIAGGIO non è finito: ancora molte sorprese attendono il lettore, che verrà condotto, nell’ora accidiosa della calura, a spiare i pastori emuli di Pan (o Pan ricalcato sulle abitudini lascive dei pastori); sfinito dal canto delle cicale, già immortalate da Platone; sbarcato nella pericolosa terra dei lotofagi, dove le sirene, che reggono un loto, ritornano, quasi a chiudere il cerchio dell’ incantesimo. Si toccheranno, ancora, le spiagge del sonno pericoloso e popolato (in senso classico) di incubi, si toccheranno le soglie della furia allucinata, con l’ apparire delle Ninfe, anch’esse meridiane, protettrici del sacro.
Nella catastrofe finale l’ora fatidica e terrifica sarà ulteriormente gravida di eventi eccezionali: è il terremoto di mezzogiorno, l’oscuramento del sole. Non c’ è bisogno, per questo, di allontanarsi troppo da testi assai noti anche oggi: non è forse il sacrificio di Cristo, consumato tra mezzogiorno e le tre, annunciato da un oscuramento e da un terremoto? A mezzogiorno appaiono gli angeli ad Abramo per annunciargli la nascita di Isacco; a mezzogiorno Giovanna d’ Arco sente le voci; la tradizione ebraica racconta il demone di mezzogiorno come un mostro fatto di scaglie e di capelli, con un occhio solo situato a livello del cuore.
Che il fascino un po’ morboso e misterioso delle ore della massima calura non sia finito con gli antichi, lo testimonia molta letteratura a noi vicina. Caillois aveva sottomano, allora, un romanzo di Paul Bourget, Le démon de midi, ma ben prima di lui Montale s’ era cimentato col sole che abbaglia, nell’ accidia del meriggiare che lo induce a riflettere con triste meraviglia sul significato del vivere; e come non ricordare, pescando un esempio a caso tra quanti vengono alla mente, l’ora della calura, con i suoi corollari di sonno, sesso e indolenza propiziata dal frinire delle cicale, nel film di Tavernier, Una domenica in campagna? Per dire, in buona sostanza, che il viaggio nel sole non è certo finito, ma anche che certi miti bisogna guardarli di traverso e non cedere, supini, al loro culto. La storia ha già dimostrato, meglio della medicina, come siano nefasti certi colpi di sole.
Archivio "la Repubblica", 14 ottobre 1988.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
KANT E GRAMSCI. PER LA CRITICA DELL’IDEOLOGIA DELL’UOMO SUPREMO E DEL SUPERUOMO D’APPENDICE.
MITO E STORIA, POLITICA E TEOLOGIA: "LUCIFERO!" E LA STELLA DEL DESTINO. Storiografia in crisi d’identità
 LA STORIA DEL FASCISMO E RENZO DE FELICE: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"!
LA STORIA DEL FASCISMO E RENZO DE FELICE: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"!DELLO SPIRITO DI ALEXANDRE KOJÈVE (Mosca 1902 - Parigi 1968). PORTARE LA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO DI "DUE IO" AL DI LA’ DELLE MAGLIE DELLA DIALETTICA HEGELIANA.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA -- "Dio, uomo e mondo nella metafisica da Cartesio a Nietzsche" (K. Lowith).21 marzo 2018, di Federico La Sala
Karl Löwith
Dio, uomo e mondo nella metafisica da Cartesio a Nietzsche
di Maurizio Schoepflin (Il foglio, 21 Marzo 2018) *
Che cosa è successo alla filosofia nei quattro secoli che separano la nascita di Cartesio dalla morte di Nietzsche? Si tratta di una domanda tanto difficile quanto importante per comprendere un periodo decisivo della storia del pensiero occidentale che ha lasciato all’epoca contemporanea un’eredità drammaticamente complessa.
Si può considerare una fortuna che a rispondere a questo interrogativo ci abbia pensato, tra gli altri, uno studioso del calibro di Karl Löwith, le cui teorie interpretative sono sicuramente opinabili ma non certo trascurabili, essendo egli, che nacque a Monaco di Baviera nel 1897 e morì a Heidelberg nel 1973 e fu allievo di Husserl e di Heidegger, una delle voci più interessanti della filosofia novecentesca.
La risposta löwithiana è contenuta in un denso lavoro, del quale recentemente Orlando Franceschelli ha tradotto e curato per la prima volta l’edizione italiana della versione definitiva risalente al 1967. E proprio nel titolo stesso del libro - Dio, uomo e mondo nella metafisica da Cartesio e Nietzsche - è contenuta una parte significativa di ciò che l’autore vuol dire al lettore, ovvero che per cercare di comprendere l’evoluzione del pensiero moderno bisogna indagarne la componente metafisica, quella che, come ha insegnato Immanuel Kant, ha al centro proprio Dio, l’uomo e il mondo.
A giudizio di Löwith, il pensiero metafisico della modernità è caratterizzato dalla “caduta di Dio”, un evento dal quale il sapere filosofico è rimasto gravemente vulnerato, tanto da non essere in grado di fare a meno del creazionismo e dell’antropocentrismo di ascendenza biblica e da concludere la sua corsa nel devastante nichilismo di Max Stirner.
Secondo Löwith, tuttavia, nell’epoca moderna ha preso forma anche un altro percorso che, pur prendendo atto della fine della metafisica tradizionale, non ha finito per incagliarsi nelle secche del nulla: tale percorso ha avuto come guide Feuerbach, Nietzsche e Spinoza.
 Il primo sarebbe stato il maestro di un’antropologia naturalistica non più bisognosa di una divinità creatrice, il secondo avrebbe sconfitto sia Dio che il nulla rinunciando, come afferma Franceschelli, “a tutti i retromondi metafisici e alle speranze sovrannaturali”, il terzo si presenterebbe come colui che, liberandosi dall’antropocentrismo e dal finalismo, sarebbe riuscito a fare a meno del creazionismo biblico.
Il primo sarebbe stato il maestro di un’antropologia naturalistica non più bisognosa di una divinità creatrice, il secondo avrebbe sconfitto sia Dio che il nulla rinunciando, come afferma Franceschelli, “a tutti i retromondi metafisici e alle speranze sovrannaturali”, il terzo si presenterebbe come colui che, liberandosi dall’antropocentrismo e dal finalismo, sarebbe riuscito a fare a meno del creazionismo biblico.Interpretato in questi termini, il testo di Löwith diventa una specie di manuale contenente le istruzioni per un saggio svezzamento dall’eredità teologica, nel quale giocano un ruolo decisivo una concezione naturalistica del mondo e una buona dose di scettico disincanto.
Il mezzo secolo che ci separa dalla pubblicazione di questo bel libro ci dice che non tutto è andato “tranquillamente” nella direzione auspicata da Karl Löwith.
*
Karl Löwith,
 DIO, UOMO E MONDO NELLA METAFISICA DA CARTESIO A NIETZSCHE,
DIO, UOMO E MONDO NELLA METAFISICA DA CARTESIO A NIETZSCHE,
 a cura di O. Franceschelli, Donzelli, 200 pp., 23 euro.
a cura di O. Franceschelli, Donzelli, 200 pp., 23 euro. -
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA E A PENSARE BENE - La storia non è una via obbligata. Possiamo sbloccare la serratura? Ovviamente sì, ma l’esercizio richiede alcuni atti di equilibrismo.16 marzo 2018, di Federico La Sala
Filosofia
Veca, lezioni su utopia e realismo.
La storia non è una via obbligata
di Maurizio Ferrera (Corriere della Sera, 16.03.2018)
Il discorso politico contemporaneo, soprattutto in Europa, è sempre più intriso di «necessità». La globalizzazione, si dice, impone conformità alle logiche di mercato. Le tecnostrutture sovranazionali dettano regole vincolanti basate su semplici numeri. Il motto di Margareth Thatcher - there is no alternative - domina le scelte di governo e sempre più anche quelle individuali (pensiamo al mercato del lavoro). È il trionfo di quella colonizzazione del «mondo della vita» da parte degli «imperativi sistemici» di cui parlano da molto tempo autori come Jürgen Habermas o Axel Honneth. Una dinamica che genera inevitabilmente nuove diseguaglianze: le capacità e le opportunità di adattamento non sono equamente distribuite. Gli elettori esprimono disagio e protesta. Ma se non si danno alternative reali e credibili, il confronto democratico degenera in una inconcludente agitazione.
Nel suo ultimo libro Il senso della possibilità (Feltrinelli), Salvatore Veca indica una strada per uscire da questo vicolo cieco. Di fronte alla dittatura del presente e delle sue supposte necessità, sostiene, occorre recuperare appunto il «senso della possibilità». L’idea che non vi siano alternative nasce dalla nostra ignavia, dal mancato esercizio di spirito critico nei confronti dello status quo, dei paradigmi dominanti e delle loro false necessità. E, soprattutto, dalla diffusa rinuncia a usare l’immaginazione, a elaborare futuri possibili, a «prenderci per mano, ragionare e operare per forme più decenti di convivenza».
Salvatore Veca è uno dei più noti e originali filosofi contemporanei. Il volume presenta i risultati di una nuova fase delle sue ricerche, che lo avevano portato a riflettere prima sull’incertezza (su che cosa è il mondo e su ciò che vale) e poi sull’incompletezza (sulla natura e i limiti delle nostre interpretazioni del mondo). Per certi aspetti, il «senso della possibilità» si può considerare la pars construens del pensiero di Veca. Ai margini dell’incertezza e dell’incompletezza si aprono infatti i varchi del possibile. Una modalità dell’essere che lo sottrae al necessario, che conferisce al presente (all’attualità) un carattere plastico e che apre margini per scegliere il futuro.
I capitoli del libro sono spesso tecnici, si confrontano con teorie e modelli situati alla frontiera del dibattito filosofico. Anche chi non padroneggia gli strumenti della filosofia e della logica trova però nel volume spunti di estremo interesse. Il «senso della possibilità» può essere usato come una chiave per aprire due «scatole» da cui sono scaturiti molti di quei discorsi sulla necessità di cui oggi ci sentiamo prigionieri.
La prima scatola è quella della storia, dello sviluppo umano nel tempo. Noi siamo inevitabilmente immersi nel presente: l’attuale ha priorità su passato e futuro. Ciò che è stato non può essere disfatto. E questo pone alcuni vincoli ineludibili (dunque necessari) per costruire ciò che sarà. Eppure il presente è circondato dal possibile. Lo è retrospettivamente, innanzitutto. Le cose avrebbero potuto andare altrimenti. La realtà di oggi (compresi i famosi «imperativi sistemici») non è che il distillato, nel bene e nel male, di mondi possibili che abbiamo di volta in volta scartato nel passato in base a fattori e scelte contingenti.
Il mondo attuale è l’unico sopravvissuto. Ma il senso della possibilità ci sottrae all’incubo dei destini inevitabili, degli ingranaggi storici che ci relegano al ruolo di automi. Usato in ottica prospettica, il senso della possibilità ci rende invece liberi di immaginare un’ampia gamma di scenari futuri e ci sprona all’impegno per valutarli e realizzarli.
La seconda scatola è quella della politica. Si tratta della sfera di attività umana che gestisce il presente, lo guida nel mare aperto delle possibilità. La chiave di Veca fa però fatica ad entrare in questa scatola. Gli imperativi della necessità hanno come bloccato la serratura, soffocando il più potente generatore di mondi possibili che siamo riusciti a inventare come umani: la liberaldemocrazia. La colpa non è del «sistema», intendiamoci, che è contingente nella sua genesi e non necessitante rispetto al futuro. Il generatore liberaldemocratico si è inceppato perché è stato usato in modo irresponsabile sia dai governati sia dai governanti. Questi ultimi non hanno poi fatto adeguata manutenzione (pensiamo al deficit democratico della Unione Europea).
Possiamo sbloccare la serratura? Ovviamente sì, ma l’esercizio richiede alcuni atti di equilibrismo. Chi governa il presente deve riappropriarsi del senso di possibilità, sfidando i tanti sacerdoti del «non si può fare altrimenti». Chi agita l’inquietudine dei governati (pensiamo ai leader populisti) deve a sua volta calibrare la propria immaginazione in base ai materiali disponibili, oggi, nel reale. I mondi possibili sono tanti, ma non tutti sono accessibili dal punto in cui ci troviamo. E, come ricorda Veca, alcuni non sono neppure desiderabili.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- I LIBRI DI STORIA CON LE LORO STORIE E LA LEZIONE DI SANGUINETI.7 marzo 2018, di Federico La Sala
IL DIO MAMMONA ("CARITAS"), IL DENARO, E "IL GATTO CON GLI STIVALI". LA LEZIONE DI EDOARDO SANGUINETI ... *
PURGATORIO DE L’INFERNO, 10. "Questo è il gatto con gli stivali" *
- Mentre con il figlio osserva un libro illustrato, il poeta sollecita con amore e affetto a guardare le immagini con attenzione e spirito critico, dietro a ogni cosa in esso rappresentata, e a ogni manifestazione della vita, si nasconde l’onnipotenza del ’dio’ denaro.
Questo è il gatto con gli stivali, questa è la pace di Barcellona
fra Carlo V e Clemente VII, è la locomotiva, è il pesco
fiorito, è il cavalluccio marino: ma se volti pagina, Alessandro,
ci vedi il denaro:
questi sono i satelliti di Giove, questa è l’autostrada
del Sole, è la lavagna quadrettata, è il primo volume dei Poetae
Latini Aevi Carolini, sono le scarpe, sono le bugie, è la scuola di Atene, è il burro,
è una cartolina che mi è arrivata oggi dalla Finlandia, è il muscolo massetere,
è il parto: ma se volti foglio, Alessandro, ci vedi
il denaro:
e questo è il denaro,
e questi sono i generali con le loro mitragliatrici, e sono i cimiteri
con le loro tombe, e sono le casse di risparmio con le loro cassette
di sicurezza, e sono i libri di storia con le loro storie:
ma se volti il foglio, Alessandro, non ci vedi niente
*
Edoardo Sanguineti
 La poesia è tratta dalla raccolta Triperuno, dalla sezione Purgatorio de l’Inferno,1964.
La poesia è tratta dalla raccolta Triperuno, dalla sezione Purgatorio de l’Inferno,1964.
*
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- REALTA’ E RAPPRESENTAZIONE. STORIA ("RES GESTAE") E STORIOGRAFIA ("HISTORIA RERUM GESTARUM") ... E INTELLETTUALI.
 I LIBRI DI "STORIA" E LE "DOMANDE DI UN LETTORE OPERAIO" - DI BERTOLT BRECHT
I LIBRI DI "STORIA" E LE "DOMANDE DI UN LETTORE OPERAIO" - DI BERTOLT BRECHT
- PER RATZINGER, PER IL PAPA E I CARDINALI, UNA LEZIONE DI GIANNI RODARI. L’Acca in fuga
- GATTO MAMMONE/(MAMMONA).
- SINODO DEI VESCOVI. L’ANNO DELLA PAROLA DI DIO: AMORE ("CHARITAS") O MAMMONA ("CARITAS")?! Fatto sta che la prima enciclica di Papa Benedetto XVI (Deus caritas est, 2006) è per Mammona.
- LA CHIESA DEL SILENZIO E DEL "LATINORUM". Il teologo Ratzinger scrive da papa l’enciclica "Deus caritas est" (2006) e, ancora oggi, nessuno - nemmeno papa Francesco - ne sollecita la correzione del titolo. Che lapsus!!! O, meglio, che progetto!!!
Edoardo Sanguineti
Ritratto critico di Edoardo Sanguineti. Prima parte - Seconda parte - Terza parte (di Angelo Petrella, "Belfagor", 2005 - "Nazione Indiana", 2017).
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA E A PENSARE -- LA COSTITUZIONE, I "DUE CORPI DEL RE", E I DUE PATTI DEL CITTADINO. L’ analisi (di Barbara Spinelli).28 febbraio 2018, di Federico La SalaLA SOVRANITÀ, LA DIGNITÀ DI OGNI CITTADINO E DI OGNI CITTADINA, E "I DUE CORPI DEL RE". La lezione di Kantorowicz...
 LA COSTITUZIONE, I "DUE CORPI DEL RE", E I DUE PATTI DEL CITTADINO. L’ analisi di Barbara Spinelli (2006)
LA COSTITUZIONE, I "DUE CORPI DEL RE", E I DUE PATTI DEL CITTADINO. L’ analisi di Barbara Spinelli (2006)
 I due corpi del re vanno tenuti disgiunti, perché resti vivo l’inaugurale patto che dissuade dalla guerra di tutti contro tutti, e che fonda un rapporto non effimero, non continuamente modificabile, fra i cittadini e chi li comanda.
I due corpi del re vanno tenuti disgiunti, perché resti vivo l’inaugurale patto che dissuade dalla guerra di tutti contro tutti, e che fonda un rapporto non effimero, non continuamente modificabile, fra i cittadini e chi li comanda.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- BASTA CON LE ROBINSONATE. Il negativo è il limite che attraversa la vita: «Politica e negazione. Per una filosofia affermativa» (Roberto Esposito)1 marzo 2018, di Federico La Sala
DIO, MONDO, UOMO - OLTRE!!! BASTA CON LE ROBINSONATE.... *
Il negativo è il limite che attraversa la vita
Storia delle idee. «Politica e negazione. Per una filosofia affermativa» di Roberto Esposito, pubblicato da Einaudi. Il filosofo si interroga su un’inarrestabile deriva nichilista e esplora le radici dell’alternativa di un pensiero affermativo. Una riflessione che porta la vita alla sua massima espansione senza sottrarsi a nessun conflitto. La scoperta di Spinoza per il quale la sapienza è una meditazione sulla vita, non un pensiero sulla morte. Quello del filosofo non è incauto ottimismo, né cieco volontarismo. Conosce la potenza che ci abita
di Roberto Ciccarelli (il manifesto, 28.02.2018)
In giorni oscuri torniamo a interrogarci sulla negazione. L’avevamo rimossa, avevano detto che la storia era finita e avremmo vissuto in un eterno presente pacificato. Ci siamo risvegliati in una specie di guerra civile mondiale dove la negazione è intesa come distruzione della vita: il terrorismo jihadista che rivendica il potere di dare la morte in maniera indiscriminata. Oppure lo stragismo fascista e razzista contro gli immigrati, rovescio diabolico di una risposta uguale e terribile.
ABBIAMO PERSO il contatto con l’idea per cui il negativo sia l’anima del reale, ciò che lo spinge a rovesciare la contraddizione e affermare la vita. Il negativo è invece inteso come una negazione senza rimedio. Oltre il suo «non» c’è il niente. Il «negare» ritrova la sua lontana origine latina: «necare», uccidere. Tutto sembra essere stato assorbito da un dominio di un potere assoluto che non salva, ma uccide anch’esso. Sfumano così le distinzioni che hanno costruito la politica moderna: quella tra guerra e pace, tra il militare e il civile, tra il criminale e il nemico. Anche davanti a fenomeni meno estremi - il lutto, l’afasia, il dolore, la precarietà, la contraddizione più acuta - sembriamo incapaci di afferrare il negativo con categorie diverse dalla distruzione della differenza che abita l’essere.
SIAMO IN UN’«INARRESTABILE deriva nichilista di una negazione sfuggita di mano a chi l’ha teorizzata - scrive Roberto Esposito nel suo ultimo libro Politica e negazione. Per una filosofia affermativa (Einaudi, pp. 207, euro 22) - La logica del nichilismo si traduce in un’ontologia dell’inimicizia». E «l’annientamento diventa auto-annientamento». L’altro va distrutto per affermare un’identità tanto autentica, quanto fittizia e mortifera: l’identità nazionale e «sovrana», oppure la proprietà e la concorrenza tra individui atomici e disperati.
C’E’ STATO UN TEMPO in cui si è ritenuto che il nemico fosse chiaro, almeno dal punto di vista della razionalità politica. Questa logica, in realtà, non era così ferrea, tanto è vero che lo stesso Carl Schmitt in Teoria del partigiano ne ha indicato i limiti. Se a Lenin è stata riconosciuta una superiorità politica per avere trasformato il Capitale da «vero nemico» in «nemico assoluto» (ricambiato dall’altra parte), la deriva nichilistica dell’annientamento non è stata fermata. Anzi, si è intensificata.
POLITICA E NEGAZIONE è alla ricerca di un’alternativa. Esposito riparte dal significato di «negazione» e conduce un corpo a corpo con Hegel, il grande pensatore di questa categoria. Non c’è dubbio che il negativo sia l’essere altro da sé, il superamento verso qualcosa che non ritorna all’identico. Il punto è che non è l’espressione di una negatività di fondo dell’essere, un divenire privo di determinazioni che non siano quelle rispetto a se stesso. Il negativo fa parte della vita: è la sua necessità. Per questo va contestualizzato, non generalizzato. È una forma dell’affermazione, non l’elemento originario che annulla l’essere.
IL NEGATIVO RIGUARDA anche l’azione, il modo in cui concepiamo le relazioni e la politica. Non è un ostacolo o una forza contraria che si oppone alla libera volontà di chi vuole affermare qualcosa. Il «non» - ovvero il conflitto, la contraddizione - non è esterno al soggetto, ma è interno ad esso. Il negativo è il limite che attraversa la vita costretta tra necessità e finitezza. E tuttavia non è la fine di qualcosa, ma l’indice di ciò che potrebbe essere. Non è l’annichilimento della vita, ma «il punto vuoto che spinge il presente oltre se stesso», scrive Esposito. Lo scopo di questo approfondimento vertiginoso è modificare la nostra disposizione verso la vita. Se la vita è imprigionata nel negativo, allora è immobile povera e paranoica. Se invece è un momento determinato di un divenire storico che si sporge oltre se stesso, allora diventa una pratica.
PER AFFRONTARE questa impresa Esposito si è rivolto a Spinoza, l’unico filosofo che ha dato una definizione affermativa della negazione. Spinoza, il grande eretico aggredito da Hegel e sistematicamente travisato dai suoi posteri. Per lui la sapienza è una meditazione sulla vita, non un pensiero sulla morte. È una meditazione su ciò che può fare una vita, non su ciò a cui deve rinunciare per sopravvivere. Questa è ancora oggi la sua gloria: avere una grande fiducia nella vita e denunciare tutti i fantasmi del negativo.
OGGI POSSIAMO INTUIRE quanto contro-corrente possa essere un simile atteggiamento. Ma questa è la vocazione «inattuale» del filosofo. Il suo non è incauto ottimismo, né cieco volontarismo. Conosce la potenza che ci abita, a dispetto del negativo che ci circonda. Ha fiducia nelle potenzialità della vita, come nell’amore per il mondo e per chi lo vive.
L’APPRODO ALLO SPINOZISMO di un filosofo importante come Esposito non è improvvisato. Già in passato aveva parlato di «biopolitica affermativa». Oggi parla di «filosofia dell’affermazione». Una definizione rilevante in un panorama culturale come quello italiano dove prevale un «pensiero del negativo» che porta ad esiti impolitici, elitari o addirittura teologici. Il pensiero affermativo non è un positivismo del fatto compiuto, né una stanca decostruzione. Indica la strada per una nuova forma di materialismo, istanza che sembrava remota, o riservata a poco, fino a poco tempo fa.
SUL PIANO POLITICO questa filosofia mette in discussione la «sovranità», il fantasma di tutti i dibattiti politici o economici. Con «sovranità» si allude a uno Stato che nega l’inimicizia degli uomini e impone il monopolio della violenza. Esiste, invece, un’altra concezione dello «Stato» che incanala la potenza istituzioni capaci di salvaguardarne l’esistenza. In questo modo «il governo degli uomini non passa per una denaturazione della vita», ma da una forma immanente di auto-governo che mira al raggiungimento del «punto massimo della propria espansione». È la differenza che passa tra una politica sulla vita e una politica della vita, per usare le categorie di Esposito.
UNA «FILOSOFIA DELL’AFFERMAZIONE» non nega l’esistenza del conflitto - il negativo - né allude a una pacificazione come fa la retromania che devasta il dibattito pubblico attuale. Il conflitto è un elemento della relazione, oltre che della creazione di nuove istituzioni. Per renderla concreta è necessaria una politica dell’amicizia.
NELLA POLITICA novecentesca l’amicizia è stata considerata una categoria parassitaria dell’inimicizia. O amici, non ci sono amici in questo mondo. E così il mondo si scopre popolato solo da nemici. Davanti a questo paradosso va sperimentata una prassi politica che metta insieme corpo e intelletto, materia e spirito, vita e forma, e non rifugga ma abbracci il conflitto. Una politica dell’amicizia consiste nel costruire opere comuni, nel saperle difendere e nell’affermarle.
LA SOLIDARIETA’ E LA FRATELLANZA vanno riscoperti come strumenti affermativi, non come mezzi per attaccare il diverso. Creano legami, non impongono vincoli. Se intesi come strumenti del conflitto servono a liberarsi da ciò che impedisce di godere insieme di quello che abbiamo: la carne, la nascita, il corpo, la differenza e, più in generale, l’idea che la norma (giuridica, politica, sociale) nasca dalla vita in comune. L’amicizia è capace di affermare qualcosa che è in potenza e a disposizione di tutti. È tempo di imparare a coglierne i frutti.
*SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- IL "DUE" DI SAUSSURE VINCE IL "DUE" DI ROBERTO ESPOSITO. Un commento di Remo Bodei sul suo ultimo lavoro
 "Due. La macchina della teologia politica e il posto del pensiero". Si può smontare il meccanismo teologico di sudditanza all’Uno su cui si fondano i rapporti di potere?
"Due. La macchina della teologia politica e il posto del pensiero". Si può smontare il meccanismo teologico di sudditanza all’Uno su cui si fondano i rapporti di potere?
DIO, MONDO, UOMO - OLTRE!!! BASTA CON LE ROBINSONATE. A partire da due, e non da uno!!! Una nota su una polemica tra "esportatori di democrazia" e di "libertà" (Giovanni Sartori e Gian Maria Vian) e la proposta di una Fenomenologia dello Spirito di "Due Soli". Con Rousseau, Kant, Marx, Freud e Dante, oltre Hegel, per una seconda rivoluzione copernicana.
"CHI" SIAMO NOI, IN REALTÀ. RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.
 LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. MARX, IL "LAVORO - IN GENERALE", E IL "RAPPORTO SOCIALE DI PRODUZIONE - IN GENERALE".
LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. MARX, IL "LAVORO - IN GENERALE", E IL "RAPPORTO SOCIALE DI PRODUZIONE - IN GENERALE".Federico La Sala
- IL "DUE" DI SAUSSURE VINCE IL "DUE" DI ROBERTO ESPOSITO. Un commento di Remo Bodei sul suo ultimo lavoro
-
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA -- "Nietzsche": Il metodo di Heidegger per imparare a pensare.24 febbraio 2018, di Federico La Sala
ORIENTARSI NEL PENSIERO:"SAPERE AUDE!". KANT, NIETZSHE, E " UN GRANDE GENIO SENZA CORAGGIO" ... *
Il metodo di Heidegger per imparare a pensare
di Armando Torno (Il Sole-24 Ore, 23.02.2018)
Adelphi ha ristampato in una “nuova edizione ampliata” il saggio che Martin Heidegger intitolò “Nietzsche” (pp. 1040, euro 28). La prima traduzione italiana risale al 1994 [pp. 1034], l’edizione originale è del 1961.
A dire il vero, questo libro non è una monografia del più grande filosofo del Novecento sul pensatore-chiave del mondo contemporaneo. L’opera, composta da testi scritti tra il 1936 e il 1946, utilizza come titolo il nome di Nietzsche ma indica - usiamo le parole dello stesso Heidegger - “la cosa in questione nel suo pensiero”. Dove “cosa” va intesa come la metafisica dell’Occidente, la gabbia speculativa che è stata adoperata per secoli e che in Nietzsche si manifesta in una sua ultima espressione. O, meglio, in una forma esasperata.
Queste pagine non contengono quindi l’analisi di un particolare sistema utilizzando uno schema tradizionale ma, pur esaminando parti del lascito di Nietzsche (e anche di altri, quali Platone, Protagora, Descartes, Schelling o Kierkegaard), intraprendono una sorta di lotta per svincolarsi dalla ricordata metafisica. Heidegger, insomma, combatte una battaglia ricorrendo al filosofo che per primo l’aveva tentata.
In una nota Roberto Calasso pone in evidenza il fatto che Heidegger, che non ha nulla da condividere con i manipoli dei critici di Nietzsche, sia l’unico che gli “risponda”.
Del resto, come scriveva nella postfazione Franco Volpi, nel secolo scorso Nietzsche ha suscitato al tempo stesso “entusiasmi e attirato anatemi”; ha inoltre ispirato “atteggiamenti, mode culturali e stili di pensiero, ma al tempo stesso provocato reazioni e rifiuti altrettanto risoluti”.
Heidegger, è il caso di aggiungere, non è stato da meno. Se si consultano le tante storie della filosofia che circolano, in ciascuna di esse si può trovare una definizione che lo riguardi; ma tutte, ci si accorge ben presto, gli stanno strette.
Anche la recente polemica, che si fondava su un presunto antisemitismo di Heidegger, non ha tenuto conto del fatto che tra i suoi allievi vi sono stati alcuni tra i migliori intellettuali ebrei del secolo scorso, come prova il caso di Karl Löwith; o, guardando oltre, basterà ricordare Leo Strauss, anch’egli esule dalla Germania per le leggi razziali, che applicò il metodo heideggeriano di decostruzione storica in alcuni suoi importanti scritti. Entrambi, insieme a molti altri, tra cui il cattolico Romano Guardini, furono affascinati da Heidegger.
E anche chi leggerà, meditandolo, il suo “Nietzsche” difficilmente potrà restare indifferente. Vi troverà non la descrizione di un pensiero (anche se non manca) ma un metodo per imparare a pensare. Cosa che non si nota in molti filosofi dei nostri talk show.
*
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- ORIENTARSI, OGGI - E SEMPRE. LA LEZIONE IMMORTALE DI KANT, DALLA STIVA DELLA "NAVE" DI GALILEI. Invito alla rilettura dell’opera del 1786, "Che cosa significa orientarsi nel pensiero" - e della "Critica della ragion pura" (1781/1787).
HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI.
L’APOLOGIA DEL MENTITORE ISTITUZIONALIZZATO E LA FILOSOFIA ITALIANA. Nella scia di Constant, Kant, Hobbes e Mendiola. Una nota di Armando Torno su "una questione oziosa e irrisolta"
ULTIMA CENA ED ECONOMIA VATICANA: LA CARESTIA AVANZA!!! Benedetto XVI "cambia la formula dell’Eucarestia"! «Il calice fu versato per molti», non «per tutti»!!! Note di Gian Guido Vecchi e di Armando Torno
MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA E A PENSARE BENE "DIO", "IO" E "L’ITALIA", CHI PIU’ CHI MENO, TUTTI VIVONO DENTRO LA PIU’ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA E POLITICA ITALIANA
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- COSTITUZIONE E PENSIERO: GUERRA DI GENERE... E CONVERSAZIONE INFINITA.21 febbraio 2018, di Federico La Sala
FILOSOFIA, ANTROPOLOGIA E POLITICA. IL PENSIERO DELLA COSTITUZIONE E LA COSTITUZIONE DEL PENSIERO ....
GUERRA DI GENERE... E CONVERSAZIONE INFINITA. Una modesta considerazione....
Una nota a "Guerra di genere. Una modesta proposta" (di Paolo Fabbri, Alfabeta2)
Se non ricordiamo più "(...) la prima messa in italiano dopo due millenni di *latinorum* e la distruzione della statua del padrone illuminato Marzotto ad opera di scioperanti iconoclasti(...)" e non sappiamo più e nemmeno distinguere tra chi grida "forza Italia" e chi grida «"forza Italia"», come è possibile venir fuori dalla "fattoria degli animali" e accedere allo Spazio *neutro* e alla Terra *neutra*?! *
Abbiamo dimenticato della connivenza tra *grammatica* e *metafisica* e che , rispetto alla *lingua*, la coscienza «arriva dopo, zoppicando»; che "non è la coscienza che determina la vita, ma la vita che determina la coscienza"?!
"Come sarebbe questo italiano neutro?". Per andare oltre *Scilla* e *Cariddi*, forse, non potremmo e dovremmo chiedere ancora (e di nuovo) consulenza al mondo greco e alla società greca, quello e quella di Omero, Ulisse e Penelope?! O vogliamo continuare ancora (e sempre?) il vecchio *gioco* dell’ «io parlo, io mento» e dell’«io mento, io parlo»?!
Federico La Sala
* Sul tema, mi sia lecito, si cfr. "Paolo Fabbri, la conversazione infinita" (Maria Pia Pozzato, Alfabeta2).
DOC.:
- Pianeta Terra. Sull’uscita dallo stato di minorità, oggi......
 LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). Un omaggio a Kurt H. Wolff e a Barrington Moore Jr.
LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). Un omaggio a Kurt H. Wolff e a Barrington Moore Jr.
EVANGELO E TEOLOGIA POLITICA DEL "MENTITORE". PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO, CHE GIA’ DANTE SOLLECITAVA ...
 KANT E SAN PAOLO. COME IL BUON GIUDIZIO ("SECUNDA PETRI") VIENE (E VENNE) RIDOTTO IN STATO DI MINORITA’ DAL GIUDIZIO FALSO E BUGIARDO ("SECUNDA PAULI").
KANT E SAN PAOLO. COME IL BUON GIUDIZIO ("SECUNDA PETRI") VIENE (E VENNE) RIDOTTO IN STATO DI MINORITA’ DAL GIUDIZIO FALSO E BUGIARDO ("SECUNDA PAULI").IL MESSAGGIO EVANGELICO, IL PARADOSSO ISTITUZIONALE DEL MENTITORE, E LA CATASTROFE DELL’EUROPA.
 DISTRUGGERE IL CRISTIANESIMO: IL PROGRAMMA "ANTICRISTO" DEL CATTOLICESIMO-ROMANO. LA LEZIONE CRITICA DI KANT.
DISTRUGGERE IL CRISTIANESIMO: IL PROGRAMMA "ANTICRISTO" DEL CATTOLICESIMO-ROMANO. LA LEZIONE CRITICA DI KANT.CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
Federico La Sala
- Pianeta Terra. Sull’uscita dallo stato di minorità, oggi......
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- Il naufragio dell’etica occidentale. Primo Levi e il suo monito eterno: Auschwitz non è un mito lontano, ma uno spettro del futuro.11 febbraio 2018, di Federico La Sala
La collana in edicola con il «Corriere»
Primo Levi e il suo monito eterno: Auschwitz, spettro che può tornare
Esce il terzo volume della serie dedicata allo scrittore sopravvissuto alla Shoah.
 Il naufragio dell’etica occidentale nell’orrore dei campi di sterminio
Il naufragio dell’etica occidentale nell’orrore dei campi di sterminiodi Donatella Di Cesare (Corriere Sera, 11.02.2018)
Fu un tonfo sordo e inatteso. Quel sabato mattina una volante della polizia e un’autoambulanza raggiunsero in fretta Corso Re Umberto 75, al centro di Torino. Era di Primo Levi il corpo esanime, ai piedi delle scale. Quell’11 aprile 1987 la notizia del suicidio fece il giro del mondo e lasciò tutti attoniti, i lettori, ma anche gli amici. Pur sapendo della sua depressione, si rifiutavano di credere che avesse compiuto quel gesto. La lucidità di pensiero, l’altezza intellettuale, che avevano contrassegnato figura e opera di Levi, stridevano con quella spirale di ringhiere in cui era precipitata la sua vita. Molti dubitarono, vollero credere a un incidente. Il suicidio sembrava cancellare ogni scintilla di speranza inscritta nelle sue parole. Il «New Yorker» espresse questo timore apertamente. Molti altri, però, indicarono in quella morte la fine di una tenace sopravvivenza al lager.
Solo un anno prima, nel maggio 1986, era uscito I sommersi e i salvati, l’opera fondamentale di Levi. In quelle pagine la testimonianza personale, affidata ad altri libri precedenti, si coniuga con una riflessione profonda, un’analisi implacabile e un monito severo. «È avvenuto, quindi può accadere di nuovo: questo è il nocciolo di quanto abbiamo da dire». Le parole della conclusione sono il suggello di un libro pervaso dall’amarezza, a tratti dalla disperazione, ma sostenuto dall’esigenza di una denuncia senza compromessi. I sommersi e i salvati è scritto per i giovani; sono loro i destinatari. E perciò in ogni scuola dovrebbe oggi essere studiato, meditato.
Non basta leggere Se questo è un uomo , oppure La tregua. Perché è come se quella narrazione trovi una nuova luce. È a partire dall’attualità che viene infatti ripercorsa l’esperienza del lager. Auschwitz non è un mito lontano, ma uno spettro del futuro. Levi prende la parola per combattere, con le ultime forze, contro revisionisti e negazionisti.
Non si comprenderebbe il suo pensiero se non lo si interpretasse nel contesto di quei giorni. Nel giugno 1986 lo storico tedesco Ernst Nolte aveva articolato una tesi, già diffusa in Germania, con cui pretendeva di mettere sullo stesso piano il gulag e il lager, lo stalinismo e il nazismo, e vedeva anzi in quest’ultimo null’altro che una risposta al primo. Qualche tempo dopo, quel «laido conato» trovò spazio anche sulla stampa italiana. Levi fu implacabile: i due sistemi non erano paragonabili. Le camere a gas, quell’invenzione tutta tedesca, era la cifra ineguagliata dello sterminio.
La Germania che tentava invano di discolparsi, di «sbiancare il suo passato», gli faceva orrore. «Nessun tedesco dovrebbe dimenticare». Attento a non pronunciare un verdetto su un’intera nazione, con il tempo modificò il giudizio. La colpa era stata enorme: «Quasi tutti i tedeschi di allora» sapevano e non avevano avuto il coraggio di parlare. I sommersi e i salvati è un libro durissimo che mira a decostruire molti stereotipi. Ad esempio l’idea, ancora ben radicata, che Auschwitz sia il risultato della barbarie nazista.
Le cose sono ben più complicate. A quel progetto politico hanno aderito - occorre riconoscerlo - molti intellettuali. Ma sulla scia di Hegel, che aveva deificato lo Stato, l’intellettuale tedesco «tende a farsi complice del Potere». «Le cronache della Germania hitleriana - osserva Levi - brulicano di casi che confermano questa tendenza: vi hanno soggiaciuto Heidegger il filosofo, il maestro di Sartre; Stark il fisico, premio Nobel; Faulhaber, il cardinale, suprema autorità cattolica in Germania, ed innumerevoli altri».
Qualcuno ha scritto che in queste pagine Levi si rivela un grande moralista. Ma la definizione è fuorviante. Piuttosto, senza smettere di essere testimone, Levi veste i panni del filosofo per criticare la filosofia, per sfidarla, indicando temi rimasti fuori dall’inventario filosofico, come quello di vergogna, o mostrando i concetti che, come quello di morte o di libertà, vanno rivisti. Perché Auschwitz è il naufragio dell’etica occidentale. La responsabilità è stata frantumata. Levi ritorna sulla «zona grigia» dove alla vittima, per la prima volta, non è concesso più neppure il ruolo di vittima, al punto da renderla semicarnefice. È questo il «delitto più demoniaco del nazionalsocialismo».
Splendido, e forse sottovalutato, è il capitolo «Comunicare» . Auschwitz appare una nuova versione della Torre di Babele. Capire o non capire, sapere il tedesco, segna lo spartiacque tra la vita e la morte. La disumanizzazione dell’altro passa attraverso la lingua ridotta a crudele strumento di potere. La parola lascia il posto all’offesa e poi al nerbo. È il segnale che non si è più considerati umani. E Levi commenta: «Dove si fa violenza all’uomo, la si fa anche al linguaggio». Nel lager, però, si muore per mancanza non solo di informazione, ma anche di dialogo, quando nessuno «ti parla» più. Dove viene meno il vocativo dell’altro finisce la vita. Perciò scrive Levi rivolto ai suoi destinatari futuri: «Rifiutare di comunicare è colpa».
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- Rinnovo l’appello: vada il presidente Mattarella a Macerata}} e pronunci le parole giuste per sconfiggere il pericolo fascista, prima che sia tardi (di Maurizio Viroli).10 febbraio 2018, di Federico La Sala
Lo Stato deve manifestare contro i fascisti
di Maurizio Viroli (Il Fatto, 10.02.2018)
Altro che vietare le manifestazioni, a Macerata deve manifestare lo Stato: manifestare la sua ferma determinazione di combattere i fascisti con tutte le sue forze, nel pieno rispetto della Costituzione e delle leggi.
A Macerata deve andare il presidente della Repubblica e parlare, con i corazzieri alle spalle, e con lui sul palco devono esserci il presidente del Consiglio, il ministro degli Interni e quello della Difesa, i presidenti di Senato e Camera, i comandanti militari e delle forze di sicurezza. Devono dire con parole chiare che la Repubblica s’impegna solennemente a non dare tregua ai fascisti e a proteggere la libertà e la sicurezza di tutti, cittadini e non cittadini.
Possibile che le alte cariche dello Stato, uomini e donne colti e saggi, almeno si spera, non si rendano conto che sottovalutare il pericolo neofascista è moralmente ignobile e politicamente suicida? Possibile che non sappiano che lo Stato liberale è crollato nel 1922 perché non volle e non seppe combattere i fascisti, non certo perché i fascisti erano più forti?
 Se Vittorio Emanuele III avesse decretato lo stato d’assedio e mandato contro i fascisti l’esercito e i carabinieri, avrebbe salvato lo Stato liberale.
Se Vittorio Emanuele III avesse decretato lo stato d’assedio e mandato contro i fascisti l’esercito e i carabinieri, avrebbe salvato lo Stato liberale.Con tutte le differenze del caso, oggi la Repubblica democratica può sconfiggere il neofascismo soltanto se lo combatte con la massima intransigenza. In Italia il fascismo è un reato, l’antifascismo è un dovere civile. Ha, quindi, perfettamente ragione Giuseppe Civati a sostenere che “Fascismo e Antifascismo non sono in nessun modo paragonabili”. E con lui hanno ragione le associazioni e le organizzazioni che hanno chiesto alle autorità competenti di autorizzare la manifestazione. È un loro dovere ancor prima che loro diritto.
Sarebbe una vergogna tirarsi indietro. Ma i cittadini da soli non possono vincere contro i fascisti, poiché i fascisti usano la violenza: sparano, aggrediscono, intimidiscono. I cittadini non possono e non vogliono scendere sul terreno della violenza.
 Soltanto lo Stato può usare la forza legittima e se non lo fa chi lo rappresenta si carica di una responsabilità gravissima. Per giustificare la scelta iniziale - per fortuna ieri rivista - di vietare le manifestazioni non vale l’argomento dell’ordine pubblico.
Soltanto lo Stato può usare la forza legittima e se non lo fa chi lo rappresenta si carica di una responsabilità gravissima. Per giustificare la scelta iniziale - per fortuna ieri rivista - di vietare le manifestazioni non vale l’argomento dell’ordine pubblico.Lo Stato deve garantire agli antifascisti il diritto di manifestare e proteggerli da aggressioni fasciste. Se vuole, può farlo. Permettere agli antifascisti di manifestare significa non solo fare capire ai fascisti che lo Stato questa volta non è con loro ma contro di loro, ma dare forza alle istituzioni repubblicane. Altrettanto dissennato è l’argomento di chi sostiene che il gesto di Traini è stato un atto di solitaria follia. Chiunque abbia letto qualche libro sulle organizzazioni terroristiche intende perfettamente che quel che ha fatto Traini è puro terrorismo: violenza indiscriminata e a qualunque costo, contro un determinato gruppo sociale. I terroristi, infatti, agiscono anche a rischio della libertà e della vita, quando sanno di poter contare su una comunità che li sostiene. Infatti ecco Forza Nuova che si fa carico delle spese legali e manifesta con Casapound per aiutarlo, ecco Salvini che dichiara che la colpa è di chi ha fatto arrivare gli immigrati, ecco i molti che non parlano ma lo considerano un eroe.
Proprio perché l’atto terroristico di Macerata è segno della forza delle idee fasciste, la risposta deve essere una guerra senza quartiere. Le parole del sindaco di Macerata, Pd, che approva la scelta di vietare le manifestazioni in nome di un silenzio che rispetti le ferite della città sono penose. Qualcuno gli spieghi che il silenzio è atto di rispetto e di pietà per le vittime, ma che il dovere più importante e pressante è fermare gli aguzzini.
Il dato vero che deve preoccupare è che la solidarietà antifascista, che in passato aveva unito liberali, democristiani, repubblicani, socialdemocratici socialisti, comunisti e aveva saputo fare argine valido contro il neofascismo e ogni altra idea che mirasse a destabilizzare lo Stato, oggi non esiste più. Provino Pietro Grasso e Giuseppe Civati a proporre a chi a vario titolo è alla testa degli altri partiti politici (Silvio Berlusconi, Matteo Renzi, Giorgia Meloni, Luigi Di Maio, Matteo Salvini) di firmare prima del 4 marzo un documento comune in cui ciascuno s’impegna solennemente a combattere il neofascismo. Sarà un fallimento.
Lo scenario che probabilmente ci aspetta è quello di un governo di centrodestra guidato, di fatto, da Berlusconi. Com’è noto Berlusconi in più di un’occasione ha manifestato la sua simpatia per Mussolini, ed è poco incline a combattere i fascisti e felice di bastonare gli antifascisti, che poi per lui sono comunisti camuffati. Così, nel 2022, avremo le piazze piene di fascisti ed essi stessi, o i loro amici, al governo.
I fatti di Macerata rappresentano una svolta fondamentale. Le alte cariche dello Stato possono salvarla o agevolarne la morte.
Rinnovo l’appello: vada il presidente Mattarella a Macerata e pronunci le parole giuste per sconfiggere il pericolo fascista, prima che sia tardi.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- IL MOVIMENTO #METOO, GLI StATI UNITI, E L’iTALIA. Parlano le donne parlano (di Ida Dominijanni - #ViaDogana3).3 febbraio 2018, di Federico La Sala
Parlano le donne parlano - Ida Dominijanni
Introduzione all’incontro di Via Dogana 3: Parlano le donne parlano domenica 14 gennaio 2018
Ida Dominijanni
1.Il movimento #metoo - slogan inventato dieci anni fa da una donna nera, Tamara Burke - esplode negli Stati uniti il 15 ottobre dell’anno scorso, a seguito dello scandalo Weinstein, e si diffonde a macchia d’olio su scala pressoché planetaria: due settimane dopo, a inizio novembre, il Newsweek conta due milioni e trecentomila tweet in 28 paesi - ai primi posti Usa, Canada, Brasile, Messico, Gran Bretagna, Svezia, Francia, Italia, Germania, Australia, India, Giappone, Sudafrica[1]. L’11 gennaio il New York Times elenca 78 uomini “high profile” - appartenenti ai circuiti della politica, dei media, dell’intrattenimento, dell’accademia - accusati dalle loro vittime di molestie o “cattiva condotta sessuale” (sexual misconduct) e licenziati, o sospesi, o costretti a dimettersi: tra loro sei esponenti politici, parlamentari o uomini di partito, e tra questi l’ex comico democratico Al Franken, il caso forse più controverso e Roy Moore, candidato repubblicano al Senato, cha ha perso le elezioni in Alabama anche in seguito alle denunce femminili di sexual harassment e pedofilia[2]. Parzialmente diverso il quadro in altri paesi. In India ad esempio - uno dei casi di #metoo più interessanti - il campo più colpito è quello accademico; sotto accusa, in particolare, alcuni tra gli esponenti più amati dei post-colonial studies, da cui un dibattito incentrato soprattutto sullo scarto fra ideologie rivoluzionarie professate in pubblico e comportamenti privati[3]. In Francia invece - altro esempio - il dibattito sul caso più esplosivo, le accuse di molestie e stupro a Tariq Ramadan, è “deragliato” su quello sui rapporti fra cultura occidentale e cultura islamica[4].
Come sempre accade, un movimento femminile transnazionale con contenuti sostanzialmente omogenei acquista pieghe e accentuazioni diverse a seconda dei contesti nazionali, e domanda perciò uno sguardo comparativo. Il mio si poserà soprattutto sulla comparazione fra Stati uniti e Italia, per una ragione precisa: molto di quanto sta accadendo nell’America trumpiana - compresa la scoperta, grazie alla presa di parola pubblica femminile, di un sistema diffuso di scambio fra sesso e potere - è stato anticipato nell’Italia berlusconiana; ma con effetti in parte simili, in parte - sembra - assai diversi. Da qui la strana sensazione di stare assistendo a un déjà vu da una parte, a qualcosa di inedito dall’altra.
2.Negli Stati uniti il #metoo è stato/è un enorme e contagioso movimento femminile di presa di parola pubblica, potentemente aiutato dai social network, appoggiato dalla stampa illuminata, sostenuto sia dall’autorizzazione reciproca delle donne coinvolte sia da una forte autorizzazione dell’opinione pubblica, che è riuscito a ribaltare una congiuntura che pareva svantaggiosa per le donne - l’elezione di Trump e la sconfitta di Hillary Clinton - in una situazione di protagonismo femminile socialmente riconosciuto e supportato. La congiuntura politica è di estrema rilevanza e dà risposta alla domanda che è imperversata sui media italiani: “Perché parlano adesso e non hanno parlato prima?”.
Le donne, lo sappiamo, parlano quando possono parlare: quando si può aprire una crepa nel regime del dicibile e dell’indicibile, e l’autorizzazione a dire la verità soggettiva prevale sul silenzio-assenso femminile necessario al mantenimento dell’ordine patriarcale. Dopo la vittoria di Trump e la sconfitta di Hillary - una candidata che il femminismo radicale riteneva non idonea perché moderata e neoliberale, ma che tutto il femminismo ha difeso dagli attacchi misogini del suo avversario - negli Stati uniti le donne hanno reagito con un salto di prospettiva politica, ben visibile fin nella women’s march del 21 gennaio 2017, che con i suoi due slogan principali, inclusività e intersezionalità, già annunciava un femminismo determinato a prendere in mano le redini di un movimento di opposizione più vasto. A distanza di un anno scrive infatti il NYT: “Allora non era chiaro se si trattasse di un momento o di un movimento, ma ora è chiaro che le donne sono diventate le leader emergenti di una doppia scommessa: sostenere l’opposizione a Trump e lanciare una sfida culturale più ampia al potere maschile, com’è accaduto con il #metoo”[5].
La presa di parola individuale che ha fatto esplodere il caso Weinstein non sarebbe stata possibile, dunque, senza l’autorizzazione simbolica del movimento già sceso in campo contro il Presidente che si vanta di “prendere le donne per le parti intime”. Vale la pena di notare che questa congiuntura politica conquista al femminismo la generazione di donne nata e cresciuta sotto le insegne dell’individualismo neoliberale che ne era rimasta fin qui più estranea, come fanno notare nelle loro testimonianze molte protagoniste del #metoo che raccontano la loro scoperta della dimensione collettiva dell’agire politico[6]. Di questa congiuntura, infine, fa parte il “divenire minoranza” degli uomini (bianchi), sotto i colpi della globalizzazione, della crisi economica, dei cambiamenti demografici e della perdita di privilegi innescata mezzo secolo fa dal femminismo storico: una condizione declinante del tutto compatibile tanto con i colpi di coda del suprematismo bianco che ha portato Trump alla presidenza quanto con i colpi di coda dell’aggressività sessuale “virile” disvelata dal #metoo.
A fronte di questo “divenire minoranza” degli uomini bianchi, c’è il “divenire maggioranza” delle donne: per la prima volta, in una società come quella americana abituata a rappresentarsi per segmenti, le donne non sono percepite come una minoranza da tutelare ma come una potenziale maggioranza vincente, una forza di cambiamento da sostenere e di cui fidarsi. All’autorizzazione femminile si aggiunge quindi un’autorizzazione sociale più vasta, ben percepibile attraverso il racconto incoraggiante e positivo che del #metoo hanno fatto i media mainstream liberal: il New York Times, il New Yorker, il Guardian, il Washington Post, The Nation - per citare solo quelli che ho cercato di seguire da qui.
3.Questo sostegno dell’opinione pubblica americana è il dato che stride di più con l’esperienza italiana. L’Italia non avrebbe dovuto restare sorpresa daI #metoo, avendo sperimentato, solo pochi anni fa, l’analogo fenomeno di una imprevista presa di parola pubblica femminile contro il “dispositivo di sessualità” dominante. Mi riferisco, ovviamente, all’esplosione del Berlusconi-gate, dovuta alla denuncia, da parte di Veronica Lario e Patrizia D’Addario (e altre dopo di loro, tra le quali Ambra Battilana, che ritroviamo oggi fra le donne che negli Usa hanno denunciato Weinstein), del sistema di scambio fra sesso, danaro e potere che vigeva nelle residenze dell’ex premier e decideva la distribuzione di lavori e di candidature alle donne nelle sue televisioni e nelle sue liste elettorali. Anche allora questa presa di parola si avvalse di una parte dei media, o perché contrassegnati dalla sensibilità di opinioniste femministe o perché, più semplicemente e strumentalmente, anti-berlusconiani. Ma subì anche e soprattutto una fortissima dose di incredulità, discredito e ostracismo, non solo da parte dei media berlusconiani (oggi in prima fila anche contro il #metoo, e con gli stessi argomenti di allora) ma anche negli ambienti della sinistra, e perfino in quella parte del femminismo che considerava “poco degne” le donne che si erano ribellate al sistema berlusconiano dal suo interno. Che fosse in atto, anche allora, una scossa tellurica che investiva verticalmente i rapporti fra donne e uomini, dalla sessualità al mercato del lavoro alle istituzioni della rappresentanza, lo si capì forse solo di fronte alla manifestazione del febbraio 2011 - le manifestazioni di piazza essendo la sola forma in cui l’esistenza del femminismo viene tuttora registrata. La risposta del circuito politico e mediatico mainstream fu tuttavia, anche nel campo della sinistra, momentanea, strumentale all’abbattimento di Berlusconi e inadeguata[7]. Soprattutto, non pare abbia seminato consapevolezza alcuna della crisi e della domanda di trasformazione di cui quei fatti erano il segno: lo si vede benissimo oggi che Berlusconi torna in campo come simulacro di se stesso, per ironia della storia contemporaneamente all’esplosione del #metoo, e nessuno, nei circuito mediatico, ricorda che a farlo cadere nel 2011 furono le donne prima dello spread, né associa la rivolta femminile italiana di allora a quella planetaria di oggi. Si potrebbe anzi sostenere, io sostengo, che la scarsa considerazione di cui il #metoo ha goduto in Italia è figlia diretta della rimozione della vicenda del 2009-2011.
A commento dei fatti di allora e di oggi, resta vero quello che Luisa Muraro aveva scritto ben prima, in tempi non sospetti: “Ci sono numerosi indizi che il regime di verità abbia fin qui funzionato, nelle sue succcessive forme storiche, sulla mutezza femminile. Se una donna si mette a dire la verità, diventa una minaccia per l’altro sesso e per la civiltà, insieme. ‘Virilità’ è un nome, o forse il nome, di questo insieme”. La verità soggettiva femminile detta in pubblico ha una forza dirompente della quale noi stesse non siamo forse abbastanza consapevoli. La comparazione fra le due vicende dimostra però anche che questa dirompenza, per essere efficace, ha bisogno di una qualche risonanza, e deve dunque dotarsi di una strategia mediatica. La differenza fra l’Italia e gli Usa si sta rivelando, da questo punto di vista, abissale, fin nell’uso del linguaggio e negli stili che connotano il racconto giornalistico, e non può essere attribuita solo al diverso valore che nella cultura americana e nella nostra ha il “dire la verità al potere”: attiene anche alla peculiare misoginia dell’establishment intellettuale e giornalistico italiano, e alla capacità o all’incapacità di associare mutamento femminile e mutamento sociale, e di fidarsene. Dedicando la copertina della “persona dell’anno” alle silence breakers, il Time ha acutamente osservato che il #metoo ha mostrato che i due principali obiettivi polemici di Trump, le donne e il giornalismo, hanno reagito, e sono in qualche modo “risorti”, insieme. Si può ragionevolmente sostenere che finché non avrà imparato a trattare sensatamente di donne e di femminismo, il giornalismo italiano continuerà a precipitare nell’abisso di ignoranza, pressapochismo, autoreferenzialità in cui vivacchia da anni.
4.La rimozione dei fatti del 2009-2011 spiega anche la ripetizione, in Italia, di molti argomenti contro le silence breakers di allora e di oggi. Riassumo qui brevemente i principali, maschili ma anche femminili, talvolta presenti in modo ben più pacato anche nel dibattito americano, proponendo per ciascuno di essi un rovesciamento di prospettiva.
a) L’(auto)vittimizzazione. Si va dal “fanno le vittime, ma sono state conniventi per anni”, scagliato contro Asia Argento soprattutto ma non solo da uomini, al timore, soprattutto femminile e femminista, che il #metoo possa risolversi in un processo regressivo di vittimizzazione e infantilizzazione delle donne. Alla prima obiezione ho già risposto: le donne parlano quando possono parlare. La seconda è più comprensibile, ma a mio avviso è infondata. È vero che il #metoo condivide con il femminismo di ultima generazione la tendenza a una soggettivazione basata sulla denuncia della violenza subìta piuttosto che sull’affermazione di un desiderio positivo, com’è stato invece per il femminismo degli anni Settanta; ed è vero che questa accentuazione della condizione di vittima rischia di riprodurla, nonché di riportare indietro il discorso, dal paradigma della libertà a quello dell’oppressione femminile. Ma nel caso del #metoo a me pare che il rischio di un attaccamento alla condizione di vittima sia decisamente inferiore alla spinta collettiva a uscirne, anche con una buona dose di allegria. Faccio inoltre notare che in Italia il fronte che accusa di vittimismo ritardato le attrici oggi, è lo stesso che ieri accusava le escort e le olgettine di non rappresentarsi come vittime e di rivendicare il loro lavoro come una scelta: a dimostrazione che il victim blaming è sempre attivo, nell’un caso e nell’altro.
b) Il fantasma della “caccia alle streghe”, ovvero il panico da rischio di reazione “maccartista” contro i maschi sospettati di “comportamenti inappropriati, a Hollywood e altrove. Il ricorso alla evocazione della caccia alle streghe per esprimere il terrore di una caccia agli orchi ha qualcosa di comico, e dice quanto sia radicata la fantasia di una simmetria fra i sessi e di una vocazione ritorsiva della rivoluzione femminista. Storicamente, la caccia alle streghe (donne) l’hanno fatta gli uomini, e oggi, casomai, sono di nuovo uomini a farla su altri uomini. Con modalità talvolta violente e discutibili, come la cancellazione dai titoli dei film di attori fino a ieri osannati, o la “maledizione” di opere d’arte che dovrebbero sopravvivere ai comportamenti sessuali dei loro autori. Queste modalità però segnalano che una crepa si è davvero aperta nell’omertà maschile, e questo è un fatto positivo.
c) Invocazione/scongiuro della legge e delle regole. Vasta e contraddittoria gamma di posizioni. Da una parte il #metoo viene attaccato perché agisce sulla base di una denuncia pubblica ma non giudiziaria dei comportamenti maschili, impedendo così l’esercizio del diritto di difesa: si invocano insomma i tribunali, temendo - come di recente Margareth Atwood[8] - la sostituzione dello stato di diritto con di una giustizia “immediata” o con quello che in Italia chiamiamo “giustizialismo”. Oltre a non tener conto della storica - e giustificata - diffidenza femminile per l’esercizio maschile della giustizia, questo tipo di obiezioni occulta quello che è il pregio, non il limite del #metoo: il suo carattere eminentemente politico, basato sulla presa di parola e sulla solidarietà collettiva, e non sull’uso dei tribunali. La questione che il #metoo pone è politica, non penale.
Dall’altra parte però, e contraddittoriamente, lo stesso fronte paventa che l’esito del #metoo possa essere quello di una regolamentazione forzata e di un controllo moralista e normativo dei comportamenti sessuali[9] - esito peraltro da non escludere, data la tendenza alla codificazione dei comportamenti propria della società americana. Va detto però che questa regolamentazione, talvolta fin troppo rigida, negli Usa vigeva già prima del #metoo, ad esempio nelle università; il #metoo, casomai, ne segnala l’inutilità. C’è un eccesso della sessualità maschile che sfugge, evidentemente, a ogni regola e a ogni codice di comportamento: merito del #metoo è l’averlo messo in luce, riportando il fuoco del discorso dalle forme del politicamente corretto alla sostanza delle cose.
Più in generale, l’altalena fra invocazione e scongiuro delle norme è sintomatica di una condizione tutta maschile, che sembra non poter fare a meno delle norme per regolamentare le pulsioni: le invoca mentre le scongiura, e le scongiura mentre le invoca. Vale sulla sessualità, dove gli uomini sembrano voler delegare a un codice di comportamento quello che non riescono a regolare relazionalmente, come vale, lo sappiamo bene, per tutti i campi della vita associata, la politica in primis.
d) Il fantasma della fine della seduzione e della morte della sessualità, con la correlata confusione fra seduzione e violenza, “avance” e molestia. Su questa confusione, impugnata come una bandiera in Italia dal Foglio e dalla stampa di destra e fatta propria in Francia dal testo firmato da Catherine Deneuve di cui tanto si è parlato, ho poco da dire: a differenza di Deneuve non conosco donna alcuna che non sappia distinguere fra l’una e l’altra cosa, mentre mi arrendo alla constatazione che tale confusione c’è davvero nella testa di molti uomini, che infatti la rivendicano come se il confine fra sesso e violenza fosse effettivamente poroso e facilmente valicabile.
Il punto tuttavia a me non pare questo, palesemente strumentale, ma un altro. Rebecca Traister ha sostenuto, con buoni argomenti, che puntare il discorso sul terreno della sessualità significa evadere la questione principale posta dal #metoo, che a suo avviso riguarda la ricattabilità delle donne nel lavoro più che il sesso[10]. Si tratta a mio avviso di una falsa alternativa: la questione riguarda, direi, la ricattabilità delle donne nel lavoro attraverso il sesso, ovvero l’uso della sessualità come moneta di scambio nel mercato del lavoro. E dunque il #metoo, esattamente come in Italia gli “scandali sessuali” di qualche anno fa, dice qualcosa del “dispositivo di sessualità” della nostra epoca. Esattamente come allora, anche stavolta colpisce la miseria della sessualità maschile che risulta dalle testimonianze femminili: uomini che scambiano potere con briciole di sesso come un massaggio sotto un accappatoio o una masturbazione all’aperto. Se è così, il #metoo non annuncia la fine della seduzione e della sessualità, ma la registra, per aprire, si spera, una pagina più ricca e più felice. Nella ricontrattazione dei rapporti fra i sessi che la presa di parola femminile domanda, io credo che ci sia anche la rivolta contro questa miseria dello scambio eterosessuale.
(Via Dogana 3, 30 gennaio 2018)
 [1] www.newsweek.com/how-metoo-has-spread-wildfire-around-world
[1] www.newsweek.com/how-metoo-has-spread-wildfire-around-world [2] www.nytimes.com/interactive/2017/11/10/us/men-accused-sexual-misconduct-weinstein
[2] www.nytimes.com/interactive/2017/11/10/us/men-accused-sexual-misconduct-weinstein [3] www.dinamopress.it/news/abusi-silenzi-nellaccademia-postcoloniale-la-necessita-lettura-femminista-dei-saperi
[3] www.dinamopress.it/news/abusi-silenzi-nellaccademia-postcoloniale-la-necessita-lettura-femminista-dei-saperi [4] www.newyorker.com/news/news-desk/how-the-tariq-ramadan-scandal-derailed-the-balancetonporc-movement-in-france?
[4] www.newyorker.com/news/news-desk/how-the-tariq-ramadan-scandal-derailed-the-balancetonporc-movement-in-france? [5] www.nytimes.com/newsletters/2018/01/21/gender-metoo-moment
[5] www.nytimes.com/newsletters/2018/01/21/gender-metoo-moment [6] www.nytimes.com/2017/12/12/magazine/the-conversation-seven-women-discuss-work-fairness-sex-and-ambition.html
[6] www.nytimes.com/2017/12/12/magazine/the-conversation-seven-women-discuss-work-fairness-sex-and-ambition.html [7] Per la ricostruzione dell’intera vicenda e dei suoi effetti rimando al mio Il trucco. Sessualità e biopolitica nella fine di Berlusconi, Ediesse, Roma 2014.
[7] Per la ricostruzione dell’intera vicenda e dei suoi effetti rimando al mio Il trucco. Sessualità e biopolitica nella fine di Berlusconi, Ediesse, Roma 2014. [8] www.theguardian.com/books/2018/jan/15/margaret-atwood-feminist-backlash-metoo
[8] www.theguardian.com/books/2018/jan/15/margaret-atwood-feminist-backlash-metoo [9] www.newyorker.com/news/our-columnists/sex-consent-dangers-of-misplaced-scale
[9] www.newyorker.com/news/our-columnists/sex-consent-dangers-of-misplaced-scale [10] www.thecut.com/2017/12/rebecca-traister-this-moment-isnt-just-about-sex.html
[10] www.thecut.com/2017/12/rebecca-traister-this-moment-isnt-just-about-sex.html -
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- FILOSOFIA DELLA RIVELAZIONE: "GENERARE DIO". Narciso e l’arte di restare a galla: una lezione di Massimo Cacciari.30 gennaio 2018, di Federico La Sala
FILOSOFIA DELLA RIVELAZIONE. "L’ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE": "GENERARE DIO". L’immaginario del cattolicesimo romano....
Narciso e l’arte di restare a galla: una lezione di Massimo Cacciari
di Luisa Muraro *
Narciso non sapeva niente di narcisismo. Il pastorello vanitoso si sporge per specchiarsi, casca nello stagno e annega. Doveva venire in Italia a imparare dai nostri uomini di spicco. Specchiarsi e, soprattutto, restare a galla, è un’arte. Per esempio, come fa il narciso italiano quando succedono cose notevoli che lo mettono ai margini? Aspetta un po’ che passino ma se non passano, come sta succedendo con il femminismo?
Massimo Cacciari, intervistato sul suo ultimo libro risponde con una lezione esemplare.
Il suo libro è di argomento teologico ed è il giorno di Natale. Il Professore si vanta di aver fatto una scoperta filosofica, teologica e politica su Maria di Nazareth. L’intervistatore, Nicola Mirenzi, è ammirato ma mostra incredulità. L’intervistato ammette di non essere stato il primo e fa il nome di un grande teologo del passato. L’intervistatore chiede: come mai neanche le femministe si sono dedicate a pensare la grandezza di Maria? Neanche loro, conferma il professore. Dice il falso ma lui non teme che la verità gli secchi la lingua perché non la sa, lui di femminismo non ha mai voluto saper niente con un minimo di precisione. L’ignoranza, però, non basta più con i tempi che corrono, ci vuole un tampone e Cacciari l’ha pronto. Ripete un elogio del femminismo fatto da altri (sempre lo stesso, “ultima vera rivoluzione” ecc.). Intanto pensa: nessuno può lontanamente aver visto quello che ho visto io! E a voce alta dice: le femministe “sono rimaste vittime della lettura maschilista dell’incarnazione, hanno guardato Maria come una figura servile, totalmente oscurata dal rapporto tra padre e figlio, non riuscendo a scorgere quello che c’è oltre”. Questa è la mossa classica dell’intellettuale italiano: s’inventa una posizione “femminista” fasulla, che gli pare verosimile e che trova facile da eliminare.
Termina così l’intervista; la trovate su Huffington Post, che in seguito ha pubblicato l’intervento di Nadia Lucchesi su questo argomento; lo trovate anche qui.
Inventarsi un femminismo finto, dopo quasi mezzo secolo di un movimento che sta modificando i tratti di una civiltà, e uno studioso di chiara fama che crede di poterlo fare impunemente, tutto questo non sarebbe possibile senza la complicità dei suoi pari e dei mass-media che vanno per la maggiore. È questo un andazzo che è durato troppo e danneggia il nostro paese. Da notare però anche, in questo caso, un certo desiderio maschile di mettersi alla luce della differenza femminile. Nadia Lucchesi e le sue amiche sono intervenute a smentire il Professore con molta serenità, come se, sotto le sue arie da grande pensatore, riconoscessero uno dei pastori che andarono alla grotta di Betlemme. (Luisa Muraro)
Il commento di Nadia Lucchesi e amiche all’intervista di Massimo Cacciari
Se i filosofi hanno ignorato Maria, le filosofe ne hanno invece valorizzata la figura, liberandola dagli stereotipi e dalle incomprensioni della tradizione. Penso, per nominarne alcune, a María Zambrano, a Simone Weil e a Edith Stein. Le femministe hanno guardato ben oltre la lettura maschilista dell’incarnazione: come scriveva Luisa Muraro nel 2011 «Data la scarsa conoscenza del femminismo, dovuta più alla novità delle idee che all’ignoranza delle persone, vi capiterà di leggere che noi femministe eravamo contro la figura di Maria. No, non solo la mariologia fu un terreno di coltura del femminismo cattolico, ma anche le agnostiche si sono dedicate a strappare Maria alla devozione di tipo patriarcale. Penso al Magnificat di Rosetta Stella (Marietti)... Di Maria si è enfatizzato il protagonismo, la mobilità, l’autonomia. La sua verginità è stata interpretata in termini d’indipendenza simbolica dagli uomini. Fondamentale è stato l’apporto di Luce Irigaray, che, dagli anni Ottanta, ha contribuito a diffondere un nuovo linguaggio religioso...» (Maria. Il latte della Vergine, Madre di Dio e Dio lei stessa, Il manifesto - Alias, 24 dicembre 2011).
Infatti, Luce Irigaray ha pubblicato nel 2010 «Il mistero di Maria» (Edizioni Paoline, 2010), mentre nel 2002 Nadia Lucchesi aveva dato alle stampe «Frutto del ventre, frutto della mente: Maria, madre del Cristianesimo» (Luciana Tufani, Ferrara 2002).
Nel 2014 si è svolto a Venezia il convegno «Rivisitazione di Maria. Per una teologia in lingua materna», a cura di Laura Guadagnin e Grazia Sterlocchi delle associazioni Settima Stanza e Waves in collaborazione col Centro Donna, mentre a Roma, all’interno del progetto speciale culturale Biblioteche di Roma 2014 «Presenza e mistero di Maria», Annarosa Buttarelli e Suor Michela Porcellato sono intervenute sul tema: «La sovranità di Maria di Nazareth».
Raffaella Molinari e Monica Palma, relatrici di un intervento dal titolo «Maria della Sororità, Nostra Signora Nostra Sorella» continuano il lavoro straordinario di Ivana Ceresa, fondatrice della Sororità, un ordine religioso posto sotto l’autorità di Maria, concepita come figura di donna potente.
Da più di cinquant’anni, inoltre, Angela Volpini diffonde un’immagine di Maria che rappresenta l’umanità realizzata e ci insegna la “via della felicità sulla terra”.
Non parlo dei tantissimi contributi delle teologhe cattoliche e non, che hanno interpretato in modo non tradizionale la figura della Vergine, della Maestra di Sapienza: cito, per nominarne solo una, Elisabeth Schüssler-Fiorenza, teologa statunitense, femminista cattolica, autrice di due opere fondamentali: «In memoria di Lei» (Claudiana, Torino 1990) e «Gesù, figlio di Myriam, profeta della Sophia» (Claudiana, Torino 1996).
* www.libreriadelledonne.it, 19 gennaio 2018
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- PER LA NUOVA ALLEANZA, UN ALTRO SOGGETTO: LA LUCE DI IRIGARAY SUL "MISTERO DI MARIA" (E DI GIUSEPPE!?). Alcune pagine sul "silenzio di Maria", con alcune note
L’EREDE: IL PESO DEI PADRI (ATEI E DEVOTI). UN’EREDITA’ ANCORA PENSATA ALL’OMBRA DELL’"UOMO SUPREMO" E DEL "MAGGIORASCATO". Una riflessione di Massimo Cacciari su "cosa significa ereditare il passato"
UOMINI E DONNE. LA NUOVA ALLEANZA di "Maria" e di "Giuseppe"!!! AL DI LA’ DELL’ "EDIPO", L’ "AMORE CONOSCITIVO". SULL’USCITA DALLO STATO DI MINORITA’, OGGI. In memoria di Kurt H. Wolff.
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! - 27 GENNAIO 2018: GIORNO DELLA MEMORIA E RICORRENZA OTTANTESIMO ANNIVERSARIO PROMULGAZIONI LEGGI RAZZIALI. Una nota di Enzo Collotti.27 gennaio 2018, di Federico La Sala
RIPENSARE L’EUROPA. PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN ...
- "È una storia che deve indurci ad approfondire un esame di coscienza collettivo alle radici della nostra democrazia e a dare una risposta a fatti che sembrano insegnarci come la lezione della storia non sia servita a nulla se è potuto accadere che il presidente del tribunale fascista della razza diventasse anche presidente della Corte Costituzionale della Repubblica" (Enzo Collotti, "Le leggi razziali compimento del fascismo", Il manifesto, 27.01.2018)
- “come fu possibile la hitlerizzazione dell’Imperativo Categorico di Kant? E perché è ancora attuale oggi?” (Emil L. Fackenheim, Tiqqun. Riparare il mondo).
Le leggi razziali compimento del fascismo
di Enzo Collotti (il manifesto 27.1.2018)
Quest’anno il Giorno della Memoria coincide con la ricorrenza dell’ottantesimo anniversario della promulgazione delle leggi contro gli ebrei dell’Italia fascista. Promulgazione ad opera di quel sovrano Vittorio Emanuele III al quale, se non altro per questa ragione, devono essere precluse le porte del Pantheon.
Come giustamente ricorda una importante pubblicazione edita l’anno scorso in Germania per gli ottanta anni dalle leggi di Norimberga, fu una iniziativa tutta italiana senza che vi fosse alcuna pressione da parte del Reich nazista, come si ostina a ripetere qualche tardo estimatore di Benito Mussolini.
Tutto quello che si può dire in proposito è che nell’Europa invasa dall’antisemitismo, l’Italia fascista non volle essere seconda a nessuno, ossessionata come era, fra l’altro, dallo spettro della contaminazione razziale.
Frutto avvelenato dell’appena conquistato impero coloniale e della forzata coabitazione con i nuovi sudditi africani.
Come tutti i neofiti, anche il razzismo fascista ebbe il suo volto truce. La «Difesa della razza», l’organo ufficiale del regime che ebbe come segretario di redazione Giorgio Almirante, ne forniva la prova in ogni numero contraffacendo le fattezze fisiche degli ebrei o rendendo orripilanti quelle delle popolazioni nere.
Il tentativo di fare accreditare l’esistenza di una razza italiana pura nei secoli aveva il contrappasso di dare una immagine inguardabile delle popolazioni considerate razzialmente impure. L’arroganza della propaganda non impedì che essa facesse breccia in una parte almeno della società italiana e ancora oggi non è detto che essa si sia liberata dall’infezione inoculata dal fascismo, come stanno a dimostrare piccoli, ma numerosi episodi che si manifestano, e non solo negli stadi.
Non bisogna fra l’altro dimenticare che non solo tra il 1938 e l’8 settembre del 1943 l’odio razziale ebbe libero corso, ma che dopo l’armistizio e l’occupazione tedesca la caccia agli ebrei divenne uno dei principali motivi dell’esistenza della Repubblica Sociale neofascista.
In nome della purezza della razza il regime costrinse a fuggire o mise in campo di concentramento ebrei che in altre parti d’Europa si erano illusi di trovare un rifugio non precario entro i confini italiani; ma costrinse all’emigrazione scienziati e intellettuali italiani, privando il Paese di una componente culturale che, nella più parte dei casi, non avrebbe fatto ritorno in Italia neppure dopo la liberazione anche a causa degli ostacoli non solo burocratici alla reintegrazione di quanti erano stati costretti a espatriare e che per tornare a esercitare il proprio ruolo in patria non avrebbero potuto contare su nessun automatismo.
Le leggi contro gli ebrei costituirono un’ulteriore penetrazione del regime nel privato dei cittadini: il divieto dei matrimoni con cittadini ebrei; l’espulsione degli ebrei come studenti ed insegnanti dalle scuole e dalle università; l’espulsione degli ebrei dalla pubblica amministrazione.
Di fatto, ma anche di diritto, si venne a creare una doppia cittadinanza con cittadini di serie A e cittadini di serie B, preludio dell’ostracismo generalizzato sancito dalla Repubblica Sociale che proclamò semplicemente gli ebrei cittadini di stati nemici, quasi a dare la motivazione non solo ideologica per la parteicpazione italiana alla Shoah.
Ancora oggi è difficile dare una valutazione sicura delle reazioni della popolazione italiana alle leggi razziali. Le azioni di salvataggio compiute dopo l’8 settembre non devono ingannare a proposito dei comportamenti che si manifestarono prima dell’armistizio.
Gli stessi ebrei non si resero esattamente conto della portata delle leggi razziali. Il fanatismo della stampa, in particolare nella congiuntura bellica in cui gli ebrei vennero imputati di tutti i disastri del Paese, andava probabilmente oltre il tenore dello spirito pubblico che oscillava tra indifferenza e cauto plauso, aldilà del solito stuolo dei profittatori.
Le autorità periferiche non ebbero affatto i comportamenti blandi che qualche interprete vuole tuttora addebitare loro. Il conformismo imperante coinvolse la più parte della popolazione. Il comportamento timido, più che cauto, della Chiesa cattolica non incoraggiò in alcun modo atteggiamenti critici che rompessero la sostanziale omogeneità dell’assuefazione al regime.
A ottanta anni di distanza la riflessione su questi trascorsi è ancora aperta e si intreccia con alcuni dei nodi essenziali della storiografia sul fascismo (per esempio la questione del consenso).
È una storia che deve indurci ad approfondire un esame di coscienza collettivo alle radici della nostra democrazia e a dare una risposta a fatti che sembrano insegnarci come la lezione della storia non sia servita a nulla se è potuto accadere che il presidente del tribunale fascista della razza diventasse anche presidente della Corte Costituzionale della Repubblica.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
FASCISMO E LEGGI PER LA DIFESA DELLA RAZZA (1938). De Felice, Mussolini, e la "percentuale" del 1932.
- EICHMANN A GERUSALEMME (1961). “come fu possibile la hitlerizzazione dell’Imperativo Categorico di Kant? E perché è ancora attuale oggi?” (Emil L. Fackenheim, Tiqqun. Riparare il mondo).
 HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI.
HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI.
RIPENSARE L’EUROPA. PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN ...
 FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. -
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! - COSTITUZIONE, DOGMI INESPRESSI, E SILLOGISMI. Shoah: riflessioni intorno al senso della Giornata della Memoria (di Lia Tagliacozzo).25 gennaio 2018, di Federico La Sala
COSTITUZIONE E INSEGNAMENTO ...
- Primo Levi, Se questo è un uomo (Prefazione, Torino, Einaudi, 1973, pp. 13-14):
- "A molti, individui o popoli, può accadere di ritenere, più o meno consapevolmente, che «ogni straniero è nemico». Per lo più questa convinzione giace in fondo agli animi come una infezione latente, si manifesta solo in atti saltuari e incoordinati, e non sta all’origine di un sistema di pensiero. Ma quando questo avviene, quando il dogma inespresso diventa premessa maggiore di un sillogismo*, allora, al termine della catena, sta il Lager. Esso è il prodotto di una concezione del mondo portata alle sue conseguenze con rigorosa coerenza: finché la concezione sussiste, le conseguenze ci minacciano"
- * "Tutti gli stranieri sono nemici.
 I nemici devono essere soppressi.
I nemici devono essere soppressi.
 Tutti gli stranieri devono essere soppressi".
Tutti gli stranieri devono essere soppressi".
Shoah, i nodi tra passato e presente
Tempi presenti. Riflessioni intorno al senso della Giornata della Memoria, tra ritualizzazione mediatica e il baratro dell’oblio alle porte
di Lia Tagliacozzo (il manifesto, 25.01.2018)
È il diciassettesimo anno di celebrazione del giorno della memoria: giornata deputata al ricordo di quando, nel 1945, le truppe dell’Armata Rossa liberarono il campo di sterminio di Auschwitz. La strage degli ebrei e degli altri rinchiusi in quei campi non si fermò quel giorno: per porre fine alla strage bisognò arrivare alla primavera. E qualche mese dopo, solo ad estate inoltrata, arrivò anche la fine del secondo conflitto mondiale.
Se quel 27 gennaio del 1945 sul territorio italiano non accadde una vicenda assurta a data pubblica il 27 gennaio è comunque il giorno scelto dal Parlamento per ricordare «la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, e a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati».
UN VENTAGLIO AMPIO di eventi e di soggetti da ricordare ma così recita la legge istitutiva. Delle leggi razziali ricorre quest’anno l’ottantesimo dalla promulgazione: volute dal fascismo e controfirmate da Vittorio Emanuele di Savoia la cui salma è di recente tornata in Italia accompagnata da accese polemiche. Eppure quest’anno, più che i precedenti, sembra che passato e presente si intreccino in un’ignoranza immemore e arrogante. Il discorso pubblico sembra, sempre più spesso, abdicare a valori che si presumevano condivisi. È proprio l’intreccio tra parole del passato e nodi del presente che inquieta: come se un argine sia venuto meno e il razzismo sia diventato moneta corrente e legittima che tracima dagli stadi alla politica, dai social al linguaggio corrente. C’è da aver paura.
Una posizione molto ferma viene però dalla neo senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta ai campi di sterminio di Auschwitz e Ravensbrueck: «Chi mi ha nominato si aspetta che io prosegua la mia missione di testimone - ha affermato nelle sue prime dichiarazioni - in un tempo, questo, in cui il mare si chiude sopra decine di persone che rimangono ignote, senza un nome, così come sono stati quelli che ho visto io andare al gas».
Questo non significa, ovviamente, che il Mediterraneo dei barconi e dei migranti si sia trasformato in una nuova Auschwitz, ma che quelle morti di sconosciuti anonimi ci riguardano come negli anni del nazismo e del fascismo al potere avrebbero dovuto riguardare i concittadini di allora le morti degli ebrei, degli omosessuali, dei testimoni di Geova, dei portatori di handicap, degli oppositori politici. E il nodo tra passato e presente si stringe ancora perché, come un’ eco alle parole di Liliana Segre, a Milano è stata vandalizzata un’altra pietra della memoria: uno di quei piccoli sanpietrini dorati posti dall’artista tedesco Günter Demnig di fronte alla casa da cui le persone sono state deportate e che ne reca inciso il nome, la data di nascita e, quasi sempre, quella di morte.
Una «pietra di inciampo», in cui ciò che inciampa è, dovrebbe essere, l’attenzione di una cittadinanza consapevole. Invece anche le parole pubbliche perdono la memoria: Attilio Fontana, candidato del centrodestra alla Regione Lombardia, non si è vergognato mentre inneggiava alla «razza bianca». Lo stesso candidato, dopo aver azzardato scuse poco sostenibili, ha aggiunto: «La razza bianca? Mi ha portato fama e consensi». Un’enormità a cui pure è possibile credere. E con la quale sarà necessario misurarsi ad elezioni avvenute.
L’articolo 2 della Legge istitutiva prosegue: «In occasione del Giorno della Memoria sono organizzate cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado».
L’INTERO MONDO della scuola, non sempre ma spesso appassionato e partecipe, ha in questi anni letto, recitato, riflettuto anche quando, paradossalmente, le ore di studio della storia sono diminuite. Proprio le scuole sono forse il luogo dove il giorno della memoria appare meno «ritualizzato»: ogni studente e ogni classe impone ogni volta di ricominciare da capo, di leggere nuovi libri, di inventare nuovi lavori. E ogni bambino o studente formula nuove domande.
L’elenco delle questioni che pone la celebrazione oggi del giorno della memoria è infinito, quelle che seguono sono solo alcune: la relazione tra storia e memoria, il ruolo dell’arte accanto a quello della testimonianza, la scomparsa degli ultimi testimoni, la formazione degli insegnanti, la necessità di inserire la Shoah dentro la storia dell’Occidente e non farne un mausoleo a parte, decontestualizzato dalla vicenda del Novecento, l’esigenza di non lasciare il dovere della memoria del nazifascismo alle sue vittime, la riflessione sull’unicità della Shoah e sugli altri stermini che l’umanità non ha risparmiato a se stessa. E poi la necessità di trovare un nuovo equilibrio tra la ritualizzazione delle istituzioni e l’esposizione mediatica.
SEMBRA ANCHE sempre più urgente interrogarsi se la memoria porti davvero con sé qualcosa di buono o se piuttosto non rischi di diventare una pianta velenosa a fronte però di una certezza: senza il giorno della memoria la consapevolezza della Shoah in questo paese sarebbe minore. Così è stato, infatti, nella riflessione collettiva fino al momento della sua istituzione. Eppure caricarsi di una memoria tanto dolorosa ha senso solo se si riesce ad integrare nel suo racconto che è esistita perfino allora, durante la guerra e sotto il dominio totalitario, la possibilità di scegliere: se stare dalla parte dei perseguitati o dei persecutori, degli ignavi o degli amici, dei soccorritori o dei delatori. Proprio per questo, si impone una riflessione attenta, in grado di definire gli odi di ieri e quelli di oggi. Si tratta da un lato di rifiutare equiparazioni impossibili dall’altro di ricordare quello che scriveva, con tragica lucidità, Primo Levi: «A molti, individui o popoli, può accadere di ritenere che ’ogni straniero sia nemico’. Per lo più questa convinzione giace in fondo agli animi come un’infezione latente. Ma quando il dogma inespresso diventa premessa maggiore di un sillogismo, allora, al termine della catena, sta il Lager».
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
Memoria. "Meditate che questo è stato" (Primo Levi)
 AUSCHWITZ, QUEL GIORNO
AUSCHWITZ, QUEL GIORNO
 Primo Levi, La tregua: "La prima pattuglia russa giunse in vista del campo verso il mezzogiorno del 27 gennaio 1945. Fummo Charles ed io i primi a scorgerla (...)"
Primo Levi, La tregua: "La prima pattuglia russa giunse in vista del campo verso il mezzogiorno del 27 gennaio 1945. Fummo Charles ed io i primi a scorgerla (...)"- CHI INSEGNA A CHI CHE COSA COME?! QUESTIONE PEDAGOGICA E FILOSOFICA, TEOLOGICA E POLITICA INSEGNAMENTO E COSTITUZIONE: "CHI INSEGNA AI MAESTRI E ALLE MAESTRE A INSEGNARE?"!
RIPENSARE L’EUROPA. PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!
 FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. -
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! - Gli "Stranieri residenti" e il «discorso di Nausicaa». Una nota di Francesca Rigotti.21 gennaio 2018, di Federico La Sala
Stranieri e diritti
Quei migranti senza pensiero
di Francesca Rigotti(Il Sole.24 Ore, Domenica, 21.01.2018)
- Donatella Di Cesare, Stranieri residenti. Una filosofia della migrazione ,Bollati Boringhieri, Torino, pp. 280.€ 19
C’è da chiedersi come mai la filosofia politica, nel suo costante richiamarsi alla cultura classica greca e latina, non abbia mai ripreso il «discorso di Nausicaa». Si tratta delle parole che nel libro VI dell’Odissea la giovanissima principessa dei Feaci rivolge alle sue ancelle, fuggite per lo spavento alla vista del profugo proveniente dal mare e che si rivelerà essere Ulisse: «Olà, disse, fermatevi. In qual parte/ Fuggite voi, perché v’apparve un uomo?/ Mirar credeste d’un nemico il volto? [...] Un misero è costui, che a queste piagge/ capitò errando, e a cui pensar or vuolsi. / Gli stranieri, vedete, ed i mendichi/ Vengon da Giove tutti, e non v’ha dono/ Picciolo sì, che a lor non torni caro» (tr. di I. Pindemonte).
Conosciamo a memoria il discorso di Pericle con l’elogio della democrazia ma queste parole che invitano all’accoglienza dello straniero ci sono ignote. Perché provengono da voce di donna? Perché una filosofia della migrazione in grado di riprenderle ed elaborarle non è mai stata scritta, che è l’argomento sostenuto in questo saggio poderoso e coraggioso da Donatella Di Cesare nel momento in cui ne propone a sua volta una? Certo, ci sono i pensieri nomadici di Deleuze e quelli nomadico-femministi di Braidotti; c’è la filosofia dell’esilio di Maria Zambrano e c’è un accenno di filosofia dei migranti in Vilèm Flusser (tutti, eccetto Deleuze, migranti, esuli, emigrati tornati e no, come Di Cesare, come me).
Eppure la filosofia politica tradizionale ha dimenticato i profughi e aggirato l’accoglienza. Mancano, scrive Di Cesare, «sia una riflessione sul migrare sia un pensiero intorno al migrante», e persino le idee acute e feconde di una rifugiata e apolide d’eccezione, Hannah Arendt, non vennero né da lei nè da altri elaborate in una complessiva filosofia della migrazione.
Perché di questo qui ci si occupa, non di trovare soluzioni politiche per regolare i flussi o integrare i migranti, temi che ricadono nella logica immunitaria che si comporta come la ferita che si chiude sui suoi bordi per difendersi dal corpo estraneo, e che tratta il migrante come un criminale recludendolo in campi di internamento. Qui si va alla ricerca di motivazioni e argomentazioni a favore sia di un pensiero dell’accoglienza che dia luogo - faccia posto come in uno scompartimento ferroviario, spiega la bella analogia dell’autrice - a chi arriva spinto dalle persecuzioni belliche come da quelle economiche; sia dell’elaborazione di uno ius migrandi che protegga la libertà di movimento e soprattutto promuova una redistribuzione egualitaria dei beni oltre che la condivisione della terra.
Le domande filosofiche ci interrogano dunque intorno all’autoproclamato diritto dei primi arrivati in un territorio e degli stati costituitisi intorno ad essi, di impedire o limitare a discrezione l’ingresso nel «proprio» territorio, ammettere ed escludere secondo il criterio dell’avvantaggiare i nostri, il nostro prossimo: «prima noi, prima i nostri, America ( o altro stato a piacere) first».
Ma anche, e a monte di questo, sul diritto di garantire giustizia sociale soltanto al vicino, al prossimo, al concittadino. È un grande tema su cui si sono interrogati Cicerone come pure Martha Nussbaum, e che val la pena di riprendere: dove Cicerone con cautela afferma che dovremmo preferire, nell’assegnare assistenza e aiuto, il vicino e l’amico, ed estendere l’aiuto e l’assistenza a chi è lontano o viene da lontano solamente se ciò può essere fatto senza sacrifici e dispendi per noi, Martha Nussbaum pensa e dice esattamente il contrario. Per motivare l’affermazione che abbiamo doveri verso persone in stato di bisogno che vengono da altre nazioni, Nussbaum sostiene che è incombente per noi abitanti dei paesi opulenti il dovere di salvare dalla fame, dalla povertà e dalla guerra abitanti di nazioni povere, affamate e in guerra. I doveri legati al senso di giustizia non si devono limitare a concedere beni non materiali (e non costosi) come rispetto e dignità, ma anche a distribuire aiuto materiale (che incide innegabilmente sulla tassazione).
Per parte sua Di Cesare analizza con acribia gli argomenti di coloro che sostengono il respingimento dei profughi in base alla priorità dei cittadini sugli immigrati, all’integrità nazionale e alla proprietà del territorio, tutte asserzioni che non hanno fondamento filosofico. E questo, anche se poi il migrante ben sa che la cesura dell’emigrazione non potrà mai essere saldata e riparata perché è un’esperienza che marchia a fuoco e che rende impossibile il ritorno all’innocenza.
Alla pars destruens del testo, che va a criticare la giustizia locale di Rawls e varie posizioni nazionaliste, liberali e cosmopolitiche, ma soprattutto il comunitarismo di Michael Walzer, nel cui stato-club l’appartenenza alla comunità è condizione di distribuzione di beni, segue la pars construens, che discute tre modelli dell’abitare la terra. Il modello dell’autoctonia ateniese, con la sua omogeneità garantita dalla purezza del ghénos e legata all’identità dell’origine; il modello aperto della civitas romana dove la cittadinanza è inclusiva e dinamica e infine il modello del paesaggio ebraico dove abitano gli «stranieri residenti» del titolo. La fonte della sovranità ebraica è l’estraneità, la condizione dello straniero da rispettare, «perché anche voi foste stranieri in Egitto».
Nella proposta di Di Cesare ospitalità e cittadinanza coincidono, nell’orizzonte di una comunità dissociata dalla nazione, dalla nascita e dalla filiazione, aperta all’accoglienza - come quella esercitata da Nausicaa con le parole e con le sue azioni - nonché capace di dar luogo a forme politiche dove l’immune lascia la precedenza al comune.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA -- "IL FASCISMO ETERNO". L’Ur-Fascismo può ancora tornare sotto le spoglie più innocenti (di Umberto Eco) .11 gennaio 2018, di Federico La Sala
“Il fascismo è eterno: ecco come lo si può riconoscere”
Non pensiero ma azione
- Esce oggi per La Nave di Teseo “Il fascismo eterno”, la lectio inedita pronunciata da Umberto Eco alla Columbia University il 25 aprile 1995. Ne pubblichiamo uno stralcio.
di Umberto Eco (Il Fatto, 11.01.2018)
Il termine “fascismo” si adatta a tutto perché è possibile eliminare da un regime fascista uno o più aspetti, e lo si potrà sempre riconoscere per fascista. [...] Ritengo sia possibile indicare una lista di caratteristiche tipiche di quello che vorrei chiamare l’“Ur-Fascismo”, o il “fascismo eterno”. che non possono venire irreggimentate in un sistema; molte si contraddicono reciprocamente, e sono tipiche di altre forme di dispotismo o di fanatismo. Ma è sufficiente che una di loro sia presente per far coagulare una nebulosa fascista.
1. [...] Il culto della tradizione. Il tradizionalismo è più vecchio del fascismo. Non fu solo tipico del pensiero controrivoluzionario cattolico dopo la Rivoluzione francese, ma nacque nella tarda età ellenistica come una reazione al razionalismo greco classico. Nel bacino del Mediterraneo, i popoli di religioni diverse (tutte accettate con indulgenza dal Pantheon romano) cominciarono a sognare una rivelazione ricevuta all’alba della storia umana. Questa rivelazione era rimasta a lungo nascosta sotto il velo di lingue ormai dimenticate. Era affidata ai geroglifici egiziani, alle rune dei celti, ai testi sacri, ancora sconosciuti, delle religioni asiatiche. Questa nuova cultura doveva essere sincretistica. [...] tollerare le contraddizioni. Come conseguenza, non ci può essere avanzamento del sapere. La verità è stata già annunciata una volte per tutte [...] È sufficiente guardare il sillabo di ogni movimento fascista per trovare i principali pensatore tradizionalisti. [...]
2. Il tradizionalismo implica il rifiuto del modernismo. [...] Tuttavia, sebbene il nazismo fosse fiero dei suoi successi industriali, la sua lode della modernità era solo l’aspetto superficiale di una ideologia basata sul “sangue” e la “terra” (Blut und Boden). [...] L’illuminismo, l’età della ragione vengono visti come l’inizio della depravazione moderna. In questo senso, l’Ur-Fascismo può venire definito come “irrazionalismo”.
3. L’irrazionalismo dipende anche dal culto dell’azione per l’azione. [...] Pensare è una forma di evirazione. Perciò la cultura è sospetta nella misura in cui viene identificata con atteggiamenti critici. [...]
4. Nessuna forma di sincretismo può accettare la critica. Lo spirito critico opera distinzioni, e distinguere è un segno di modernità. Nella cultura moderna, la comunità scientifica intende il disaccordo come strumento di avanzamento delle conoscenze. Per l’Ur-Fascismo, il disaccordo è tradimento.
5. Il disaccordo è inoltre un segno di diversità. L’Ur-Fascismo cresce e cerca il consenso sfruttando ed esacerbando la naturale paura della differenza. [...] è dunque razzista per definizione.
6. L’Ur-Fascismo scaturisce dalla frustrazione individuale o sociale. Il che spiega perché una delle caratteristiche tipiche dei fascismi storici è stato l’appello alle classi medie frustrate, a disagio per qualche crisi economica o umiliazione politica, spaventate dalla pressione dei gruppi sociali subalterni.
7. A coloro che sono privi di una qualunque identità sociale, l’Ur-Fascismo dice che il loro unico privilegio è il più comune di tutti, quello di essere nati nello stesso paese. È questa l’origine del “nazionalismo”. Inoltre, gli unici che possono fornire una identità alla nazione sono i nemici. Così, alla radice della psicologia Ur-Fascista vi è l’ossessione del complotto, possibilmente internazionale. I seguaci debbono sentirsi assediati. Il modo più facile per far emergere un complotto è quello di fare appello alla xenofobia. [...]
8. I seguaci debbono sentirsi umiliati dalla ricchezza ostentata e dalla forza dei nemici. [...]
9. Per l’Ur-Fascismo non c’è lotta per la vita, ma piuttosto “vita per la lotta”. Il pacifismo è allora collusione col nemico[...].
10. L’elitismo è un aspetto tipico di ogni ideologia reazionaria, in quanto fondamentalmente aristocratico. Nel corso della storia, tutti gli elitismi aristocratici e militaristici hanno implicato il disprezzo per i deboli. L’Ur-Fascismo non può fare a meno di predicare un “elitismo popolare”. Ogni cittadino appartiene al popolo migliore del mondo, i membri del partito sono i cittadini migliori, ogni cittadino può (o dovrebbe) diventare un membro del partito. Ma non possono esserci patrizi senza plebei. Il leader, che sa bene come il suo potere non sia stato ottenuto per delega, ma conquistato con la forza, sa anche che la sua forza si basa sulla debolezza delle masse, così deboli da aver bisogno e da meritare un “dominatore”. [...]
 L’Ur-Fascismo può ancora tornare sotto le spoglie più innocenti. Il nostro dovere è di smascherarlo e di puntare l’indice su ognuna delle sue nuove forme - ogni giorno, in ogni parte del mondo.
L’Ur-Fascismo può ancora tornare sotto le spoglie più innocenti. Il nostro dovere è di smascherarlo e di puntare l’indice su ognuna delle sue nuove forme - ogni giorno, in ogni parte del mondo.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- La democrazia, l’antinomia istituzionale del mentitore e la catastrofe culturale italiana.... UMBERTO ECO E IL POPULISMO DI "FORZA ITALIA". Un’intervista di Marcelle Padovani (2002) e un’intervista di Deborah Solomon (2007)
"PUBBLICITA’ PROGRESSO": L’ITALIA E LA FORZA DI UN MARCHIO REGISTRATO!!! NEL 1994 UN CITTADINO REGISTRA IL NOME DEL SUO PARTITO E COMINCIA A FARE IL "PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA" DEL "POPOLO DELLA LIBERTA’"
UNA DOMANDA ALL’ITALIA: MA COME AVETE FATTO A RIDURVI COSI’?! UN "BORDELLO STATE": UN PAESE BORDELLO. Una nota di Maurizio Viroli (dagli Usa) - e una risposta (agli americani, dall’Italia)
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- SESSO E POTERE. Far diventare la libertà “libertà di importunare”? Je ne suis pas Catherine Deneuve (di Ida Dominijanni).11 gennaio 2018, di Federico La Sala
FEMMINISMO
Je ne suis pas Catherine Deneuve
di Ida Dominijanni, giornalista *
La scoperta delle molestie e dei ricatti sessuali in uso a Hollywood e in tutto il mondo del lavoro americano dimostra che questi non sono tempi buoni né per il desiderio né per l’esercizio della sessualità fra donne e uomini. Com’era già accaduto in Italia con gli scandali sessuali d’epoca berlusconiana, quello che viene alla luce non è solo la tentazione maschile perenne all’abuso di potere, che riduce le donne a oggetto da possedere e la libertà femminile a disponibilità di concedersi. È anche, forse soprattutto, una diffusa miseria della sessualità maschile, che scambia potere, favori, assunzioni in cambio di briciole come un massaggio sotto un accappatoio, una masturbazione a cielo aperto, un assoggettamento a una virilità incerta. Una miseria sessuale che è parente stretta di una miseria relazionale, ovvero di una altrettanto diffusa incapacità maschile di relazionarsi all’altra, al suo desiderio e ai suoi dinieghi, alla sua forza e alla sua vulnerabilità, alla sua libertà e alle sue necessità.
Precisamente il cinema hollywoodiano, a ben guardare, ci aveva lentamente abituato, nell’ultimo decennio, a questo progressivo immiserimento, per non dire scomparsa, della sessualità nelle relazioni fra uomini e donne, con un sottile ma percettibile scivolamento dalle scene di sesso passionale degli anni novanta a quelle quasi sempre giocate successivamente su un ambiguo confine fra sesso e violenza, sesso e possesso, sesso e performance. E del resto basterebbe il successo sorprendente, e non a caso contemporaneo al #metoo, di un racconto come Cat person per farsi un’idea dello stato delle cose: in questo caso non c’è ombra di violenza né di molestie, ma la miseria sentimentale è la stessa, l’alfabeto della seduzione è precipitato nel dimenticatoio e ogni passione è spenta.
Quello che sta saltando con il #metoo e il Time’s up è il tappo di silenzio-assenso femminile che copriva questa situazione. A un primo sguardo, certo, si tratta di movimenti contro le molestie e i ricatti sessuali, e contro l’abuso di potere maschile che c’è dietro. Ma com’era già avvenuto in Italia pochi anni fa, la presa di parola femminile ha l’effetto di svelare qualcosa di più profondo, un “dispositivo di sessualità”, per dirlo con l’espressione di Foucault, in cui il desiderio non ha più posto e il sesso è ridotto a contrattazione, ricatto, performance. E da cui è urgente uscire, se i destini della sessualità come espressione libera e creativa della specie umana ci stanno a cuore.
- La Francia è la Francia, e pretende sempre di avere l’ultima parola, a costo di far diventare la libertà “libertà di importunare”
Perciò è del tutto fuori campo e fuori fuoco la reazione, finora prevalentemente maschile nonché prevalentemente italiana, di chi ulula che all’esito del #metoo ci sarebbe l’oscurantismo politically correct di un totalitarismo (sic!) proibizionista e sessuofobico.
 È vero l’esatto contrario: il #metoo, e in generale la presa di parola femminile contro l’andazzo corrente della miseria del maschile, nasce in una situazione che ha già mandato a morte la sessualità, e forse più farla risorgere, una volta liberata dal dispositivo di cui sopra.
È vero l’esatto contrario: il #metoo, e in generale la presa di parola femminile contro l’andazzo corrente della miseria del maschile, nasce in una situazione che ha già mandato a morte la sessualità, e forse più farla risorgere, una volta liberata dal dispositivo di cui sopra.
 Non stupisce che a non capirlo sia, in Italia, lo stesso fronte mediatico, il Foglio in testa, che agitò gli stessi fantasmi liberticidi, sessuofobici e proibizionisti a tutela della “libertà” e della “seduzione” che circolava nelle “cene eleganti” di Berlusconi, già allora paventando e minacciando la fine dell’ars amatoria, la censura della passione, l’inibizione del corteggiamento, e impugnando l’inscindibilità del sesso da una certa dose (quale, esattamente?) di prevaricazione, o l’indecidibilità fra molestia e avance.
Non stupisce che a non capirlo sia, in Italia, lo stesso fronte mediatico, il Foglio in testa, che agitò gli stessi fantasmi liberticidi, sessuofobici e proibizionisti a tutela della “libertà” e della “seduzione” che circolava nelle “cene eleganti” di Berlusconi, già allora paventando e minacciando la fine dell’ars amatoria, la censura della passione, l’inibizione del corteggiamento, e impugnando l’inscindibilità del sesso da una certa dose (quale, esattamente?) di prevaricazione, o l’indecidibilità fra molestia e avance.Stupisce di più - ma in fondo neanche tanto - che a usare gli stessi argomenti sia adesso un gruppo di donne francesi - intellettuali, artiste, attrici, psicoanaliste, giornaliste, fra le altre una campionessa riconosciuta della seduzione doc come Catherine Deneuve - le quali si lanciano nella difesa della “libertà di importunare, indispensabile alla libertà sessuale”, come se il #metoo avesse già instaurato un regime del divieto dove nessuno può sporgersi sull’altra e nessuna sull’altro, il nemico delle donne sono gli uomini nella loro totalità, la parola femminile, altro che liberarsi, si autoimprigiona in un codice politically correct autoinibitorio, e le donne, altro che guadagnarci qualcosa, si auto-segregano nel ruolo di “eterne vittime dominate da demoni fallocrati”. Potenza dei fantasmi maschili interiorizzati anche dalla mente femminile, o “differenza culturale” francese vs egemonia “puritana” americana? L’una e l’altra cosa, probabilmente, e la seconda non meno influente della prima.
Non c’è donna al mondo che non sappia distinguere un “corteggiamento insistente e maldestro” da uno stupro, come le firmatarie dell’appello francese temono: esse stesse non possono non saperlo. Non c’è persona sana di mente che non possa aver registrato, seguendo le vicende del #metoo o più semplicemente la recente cerimonia dei Golden Globe sotto il segno del Time’s up, che tutto circola fra le silence breakers americane tranne un’autovittimizzazione inerziale e passiva: tutta la faccenda sembra al contrario parecchio empowering, e parecchio liberatoria anche per quegli uomini che la guardano con curiosità e fiducia invece che attaccarsi come Francesca Bertini alle tende di una virilità decadente. E anche questo le consorelle francesi non possono non averlo notato.
 Ma si sa che la Francia è la Francia, e quand’è in gioco la sacra triade della modernità pretende sempre di avere l’ultima parola, a costo di far diventare la libertà “libertà di importunare”, o, come ai tempi di Charlie Hebdo, liberté d’impertinence, sottospecie opinabile della libertà d’espressione.
Ma si sa che la Francia è la Francia, e quand’è in gioco la sacra triade della modernità pretende sempre di avere l’ultima parola, a costo di far diventare la libertà “libertà di importunare”, o, come ai tempi di Charlie Hebdo, liberté d’impertinence, sottospecie opinabile della libertà d’espressione.
 Ma il politically correct gioca brutti scherzi . Allora fu molto politically correct, e conformista, lo slogan “Je suis Charlie Hebdo”, e molto politically uncorrect, e anticonformista, arrogarsi il diritto di dire “Je ne suis pas Charlie Hebdo”: negli Stati Uniti lo rivendicarono in molti, anche nella stampa mainstream, in nome di una libertà di religione che non poteva essere conculcata dalla libertà di satira. Questione di punti di vista. Del resto, anche i simboli della seduzione non sono eterni e risentono dell’usura del tempo. A dispetto di uno slogan che ha fatto scuola per generazioni di donne, oggi la palma della seduttività passa a chi può permettersi allegramente di dire “Je ne suis pas Catherine Deneuve”.
Ma il politically correct gioca brutti scherzi . Allora fu molto politically correct, e conformista, lo slogan “Je suis Charlie Hebdo”, e molto politically uncorrect, e anticonformista, arrogarsi il diritto di dire “Je ne suis pas Charlie Hebdo”: negli Stati Uniti lo rivendicarono in molti, anche nella stampa mainstream, in nome di una libertà di religione che non poteva essere conculcata dalla libertà di satira. Questione di punti di vista. Del resto, anche i simboli della seduzione non sono eterni e risentono dell’usura del tempo. A dispetto di uno slogan che ha fatto scuola per generazioni di donne, oggi la palma della seduttività passa a chi può permettersi allegramente di dire “Je ne suis pas Catherine Deneuve”.- L’attrice Catherine Deneuve a Berlino, il 14 febbraio 2017. (John Macdougall, Afp)
* Internazionale, 10 gennaio 2018 (ripresa parziale - senza immagini).
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- UNA CATTOLICA, UNIVERSALE, ALLEANZA "EDIPICA"!!! IL MAGGIORASCATO: L’ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE, L’ALLEANZA DELLA MADRE CON IL FIGLIO, REGNA ANCORA COME IN TERRA COSI’ IN CIELO
 DONNE, UOMINI E VIOLENZA: "Parliamo di FEMMINICIDIO".
DONNE, UOMINI E VIOLENZA: "Parliamo di FEMMINICIDIO".
Ragione ("Logos") e Amore ("Charitas"). Per la critica dell’economia politica ..... e della teologia "mammonica" ( "Deus caritas est": Benedetto XVI, 2006)
 L’ILLUMINISMO, OGGI. LIBERARE IL CIELO. Cristianesimo, democrazia e necessità di "una seconda rivoluzione copernicana"
L’ILLUMINISMO, OGGI. LIBERARE IL CIELO. Cristianesimo, democrazia e necessità di "una seconda rivoluzione copernicana" -
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- QUESTIONE ANTROPOLOGICA. "Corpi impuri", "Questo è il mio sangue": quello che le donne ora dicono.7 gennaio 2018, di Federico La Sala
PIANETA TERRA. Sull’uscita dallo stato di minorità, oggi......
- "Un dato di fatto è che, oltre alle donne giudice, oggi possiamo avere le donne astronauta, come Samantha Cristoforetti, che considera gli assorbenti l’ultima delle sue preoccupazioni, terrestri ed extraterrestri" (Silvia Bencivelli, 2017)
- Questione antropologica - Life out of Balance!!! "I soggetti sono due, e tutto è da ripensare" (Laura Lilli, 1993).
Il tabù delle mestruazioni: quello che le donne ora dicono
Un evento naturale che è da sempre circondato da imbarazzi e superstizioni. Ma dall’Europa al Nepal le cose stanno cambiando. Abbiamo cercato di capire quanto
di Silvia Bencivelli *
Questo articolo parla di mestruazioni. Non di “cose”, fiori, zie, marchesi, baroni rossi, visite da Roma, cardinali, nature, giacomine e caterine varie. Tantomeno di impurità, immondizie, affari schifosi, mostruosi e oscuri. Parla semplicemente di mestruazioni: quell’evento poco meno che mensile che tra il menarca (la prima volta) e la menopausa (l’ultima) segna senza particolari patemi la vita delle donne in età fertile.
Oggi, tolti di mezzo i pudori, sappiamo che la segna senza macchiarla, per circa 2.400 giorni nel corso di una vita. E sappiamo anche perché avvenga, cioè perché quattro o cinque giorni ogni ventotto le donne in età fertile perdano sangue dalla vagina. Lo si trova persino nei libri di terza media: è il ciclo mestruale, che dipende dall’equilibrio tra alcuni ormoni che regolano la produzione di una cellula uovo al mese. Se questa non viene fecondata (ed è la cosa largamente più frequente) l’epitelio dell’interno dell’utero, che era pronto ad accogliere l’embrione, si sfalda, quindi si ha il sanguinamento e cioè la mestruazione.
 Prima di capirlo, però, consideravamo quei giorni un momento spaventosamente misterioso. Così le vite delle nostre antenate, delle nostre nonne, delle nostre madri, e un po’ anche le nostre, sono state afflitte da leggende secondo le quali in quei giorni facevamo appassire i fiori e impazzire la maionese, mandavamo il vino in aceto e rendevamo acida la conserva di pomodoro.
Prima di capirlo, però, consideravamo quei giorni un momento spaventosamente misterioso. Così le vite delle nostre antenate, delle nostre nonne, delle nostre madri, e un po’ anche le nostre, sono state afflitte da leggende secondo le quali in quei giorni facevamo appassire i fiori e impazzire la maionese, mandavamo il vino in aceto e rendevamo acida la conserva di pomodoro.Ce lo ricordano due libri che raccontano superstizioni e tabù di un passato non troppo passato. Il primo è di Marinella Manicardi, attrice e regista che sulle mestruazioni ha fatto uno spettacolo teatrale dal titolo Corpi impuri per il Festival della Filosofia di Modena, e oggi ha scritto un libro dallo stesso titolo per la casa editrice Odoya. Il secondo è in uscita per Einaudi: Questo è il mio sangue, della giornalista francese Élise Thiébaut, che sarà in libreria dal 23 gennaio.
L’idea di fondo dei due libri è simile: di mestruazioni non si parla, e questo ha contribuito, e contribuisce ancora, alla discriminazione di genere. Thiébaut annuncia una prossima e necessaria “rivoluzione mestruale”, che darà alle donne consapevolezza del proprio corpo e della propria identità. Manicardi parte invece dalla letteratura: Anna Karenina non ha mai le mestruazioni e non le ha mai neppure Emma Bovary. -C’è un’unica eccezione: Margherita, la signora delle camelie. Ma era una prostituta. E la ragione per cui, ogni mese, le sue camelie erano cinque giorni rosse e gli altri bianche Alexandre Dumas la lascia solo intuire. «Se i tempi sono cambiati? Beh, mica tanto» dice Manicardi. Quanto alla nuova pubblicità in cui il sangue viene finalmente rappresentato da un liquido di colore rosso, invece dell’azzurro alieno degli spot precedenti, c’è poco da festeggiare. «È la prima, appunto, e siamo nel 2017».
Oltre agli spot e ai libri, ci sono però anche le provocazioni artistiche, come quella della tedesca Elone, che ha riempito le vie di Karlsruhe di assorbenti con scritte frasi contro la violenza sulle donne, o quella della portoghese Joana Vasconcelos, che ha costruito un lampadario con 14 mila assorbenti interni. E soprattutto ci sono le provocazioni politiche, come il movimento free bleeding, che propone di non usare assorbenti e di lasciare che il sangue si mostri.
 Nel 2015 l’attivista statunitense di origine indiana Kiran Gandhi ha corso così la maratona di Londra (quindi 42 chilometri), e ha spiegato: «L’ho fatto per le mie sorelle che non hanno accesso agli assorbenti e per quelle che li nascondono». In India, infatti, una ragazza su dieci considera il ciclo una malattia e una su quattro al raggiungimento della pubertà è costretta a lasciare la scuola. Mentre in Nepal solo ad agosto di quest’anno è approvata una legge che punisce la pratica millenaria del chhaupadi, cioè la reclusione delle donne mestruate in capanne isolate, in cui non mangiano e non bevono, e possono essere morse dai serpenti.
Nel 2015 l’attivista statunitense di origine indiana Kiran Gandhi ha corso così la maratona di Londra (quindi 42 chilometri), e ha spiegato: «L’ho fatto per le mie sorelle che non hanno accesso agli assorbenti e per quelle che li nascondono». In India, infatti, una ragazza su dieci considera il ciclo una malattia e una su quattro al raggiungimento della pubertà è costretta a lasciare la scuola. Mentre in Nepal solo ad agosto di quest’anno è approvata una legge che punisce la pratica millenaria del chhaupadi, cioè la reclusione delle donne mestruate in capanne isolate, in cui non mangiano e non bevono, e possono essere morse dai serpenti.Anche da noi il pregiudizio antimestruazioni è antico: «Dai tempi di Ippocrate in poi il corpo femminile è sempre stato considerato la versione imperfetta di quello maschile» racconta Francesco Paolo de Ceglia, storico della scienza all’Università di Bari. «Gli organi della generazione sono introflessi, e il tutto viene descritto come umido, molle». Questa “umidità” femminile si credeva destinata a nutrire il bambino, «e si diceva che venisse espulsa con le mestruazioni, una specie di liberatorio salasso naturale». L’idea dell’impurità arriva dalla religione. Ma, prosegue de Ceglia, «la scienza la assorbe. Così si giunge al concetto per cui le mestruazioni sono un po’ come escrementi».
Però poi la scienza è avanzata, vero? «Sì, certo» concede Carlo Flamigni, ginecologo, scrittore e saggista, «ma mica tanto tempo fa». Sono solo sessant’anni che conosciamo la questione dell’utero e dell’ovaio. Flamigni si è laureato nel 1959 e racconta che anche nei libri universitari su cui ha studiato «le mestruazioni servivano a espellere le sostanze tossiche accumulate nel corpo femminile, e segnatamente una che si chiamava menotossina». Quindi, aggiunge, «se il tabù esiste ancora, credo che per superarlo debba scomparire un’intera generazione, la mia».
 Solo sessant’anni significa che le nostre nonne venivano considerate così pericolosamente instabili da non avere accesso alla magistratura. Fino al 1963 lo diceva proprio la legge italiana, nero su bianco: «Fisiologicamente tra un uomo e una donna ci sono differenze nella funzione intellettuale, e questo specie in determinati periodi della vita femminile». Indovinate quali.
Solo sessant’anni significa che le nostre nonne venivano considerate così pericolosamente instabili da non avere accesso alla magistratura. Fino al 1963 lo diceva proprio la legge italiana, nero su bianco: «Fisiologicamente tra un uomo e una donna ci sono differenze nella funzione intellettuale, e questo specie in determinati periodi della vita femminile». Indovinate quali.Alla fine della fiera è difficile dire se qualcosa degli antichi pregiudizi rimanga anche nelle nostre teste, o se siamo vicini alla fine del tabù. «Che io sappia non ci sono dati o rilevazioni affidabili che ci permettano di esprimerci sull’esistenza del tabù» commenta Paola Borgna, sociologa dell’Università di Torino. Ognuno potrà avere le proprie impressioni: «La mia è che il tabù a sfondo religioso sia stato sostituito dalla medicalizzazione. Ed è un aspetto di un processo di medicalizzazione del corpo e delle società più generale, che dà origine a nuove forme di controllo delle nostre vite».
 Un dato di fatto è che, oltre alle donne giudice, oggi possiamo avere le donne astronauta, come Samantha Cristoforetti, che considera gli assorbenti l’ultima delle sue preoccupazioni, terrestri ed extraterrestri: «Se mi chiedono come si viva con le mestruazioni nello spazio? A dire il vero non tanto spesso». Un giorno però Carla ha mandato la domanda al suo blog avamposto42, e Samantha ha risposto così: «Beh, non vorrei fare a cambio con la necessità di radermi il viso tutte le mattine in assenza di peso!». Come dire: l’età adulta e gli ormoni della fertilità propongono modeste seccature. Per i maschi si tratta di farsi
barba e baffi più o meno ogni mattina. Le femmine in fondo se la cavano con quattro o cinque giorni al mese, e nel 2017 non devono più nemmeno fare la fatica di inventarsi giri di parole: sono mestruazioni, semplicemente mestruazioni.
Un dato di fatto è che, oltre alle donne giudice, oggi possiamo avere le donne astronauta, come Samantha Cristoforetti, che considera gli assorbenti l’ultima delle sue preoccupazioni, terrestri ed extraterrestri: «Se mi chiedono come si viva con le mestruazioni nello spazio? A dire il vero non tanto spesso». Un giorno però Carla ha mandato la domanda al suo blog avamposto42, e Samantha ha risposto così: «Beh, non vorrei fare a cambio con la necessità di radermi il viso tutte le mattine in assenza di peso!». Come dire: l’età adulta e gli ormoni della fertilità propongono modeste seccature. Per i maschi si tratta di farsi
barba e baffi più o meno ogni mattina. Le femmine in fondo se la cavano con quattro o cinque giorni al mese, e nel 2017 non devono più nemmeno fare la fatica di inventarsi giri di parole: sono mestruazioni, semplicemente mestruazioni.* la Repubblica, 15 dicembre 2017
SUL TEMA NEL SITO, SI CFR.:
- Costituzione!!!
- L’ITALIA, LA CHIESA CATTOLICA, I "TESTICOLI" DELLE DONNE E LA "COGLIONERIA" DEGLI UOMINI OVVERO ANCHE LE DONNE HANNO LE "PALLE". L’ammissione di Giovanni Valverde, del 1560!!! E CHE COSA SIGNIFICA ESSERE CITTADINI E CITTADINE D’ITALIA!!!
IL PROGRAMMA DI KANT. DIFFERENZA SESSUALE E BISESSUALITA’ PSICHICA: UN NUOVO SOGGETTO, E LA NECESSITA’ DI "UNA SECONDA RIVOLUZIONE COPERNICANA".
CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89).
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! - CHI INSEGNA A CHI CHE COSA COME?! - Chat con studentesse. Dove e come si perde il ruolo del professore (di Ferdinando Camon)5 gennaio 2018, di Federico La Sala
CHI INSEGNA A CHI CHE COSA COME?! PSICOANALISI E FILOSOFIA. Indicazioni per una seconda rivoluzione copernicana .....
Al liceo.
Chat con studentesse
Dove e come si perde il ruolo del professore
di Ferdinando Camon (Avvenire, venerdì 5 gennaio 2018)
Non illudiamoci: noi parliamo raramente, con reticenza e malvolentieri delle simpatie (per usare un termine neutro) che nascono nelle classi tra professori e studentesse, ovviamente delle superiori, tendiamo a minimizzare, ma loro, le studentesse, ne parlano sempre, e le commentano, con tendenza ad esagerare. La conseguenza è che per loro la loro versione è quella vera, e resterà nel loro cervello per tutta la vita. E se c’è una relazione immaginaria tra un prof e una studentessa, che per loro diventa una relazione vera, corredata di chissà quali e quanti incontri di cui nessuno sa niente, quella storia sarà per loro il marchio che contrassegnerà per sempre quella scuola e quegli anni, e per tutta la vita, a ogni rimpatriata, ne riparleranno. Quella storia, quelle storie, saranno più importanti di Hegel e Kant, che pure le hanno tanto impressionate.
Più importanti di Nietzsche, che oggi va per la maggiore. Quando qualcuna di queste storie trapela sui giornali, diventa subito la notizia più letta dalle ragazze in tutta Italia. In questo momento la notizia più letta dalle ragazze in tutta Italia è certamente l’accusa di rapporti inopportuni del prof di filosofia di un liceo romano con alcune studentesse, quattro delle quali hanno presentato denuncia. Due sono minorenni. Ci sarà una causa. Il prof sarà interrogato e sapremo le sue risposte. Finora non c’è una sentenza, e quindi non parliamo di un reato e di una condanna. Parliamo del fenomeno carsico, sempre negato e tuttavia presente in tutte le scuole, dei legami sentimentali che nascono tra insegnanti e allievi.
Anticipo subito, qui ad apertura, una mia vecchia tesi, ma non obbligo nessuno ad accettarla: il professore, di cui le studentesse non s’innamorano, è un cattivo professore; il professore, che s’innamora delle studentesse, è un cattivo professore. Perciò qui, nel caso del liceo romano, per quel che ne sappiamo finora, il problema non è che le studentesse si scambiavano tra loro email sospirose (o anche esplicite) sul professore, il problema è che email sospirose, anzi esplicite e audaci (parole degli studenti) le scambiava il prof con loro.
La difesa del prof sostiene che i messaggi del prof non sono molestie o violenze, perché hanno sempre ottenuto risposta. Da parte delle ragazze (nel caso delle minorenni, potremmo parlare di bambine) c’è insomma il consenso. Ma, a parte il fatto che il consenso delle minorenni non è valido (per questo son dichiarate minorenni), se la relazione vien corrisposta, vuol dire che è andata molto avanti e che è diventata stabile. Per la ragazza, e per la bambina, innamorarsi del prof è un fenomeno di crescita: si sente più grande, diventa più grande.
Per il prof, innamorarsi di una ragazza o una bambina è un fenomeno di de-crescita, e nel caso della bambina di rimbambimento. Il rapporto del prof con i suoi studenti e studentesse non è diverso dal rapporto dell’analista con i suoi e le sue pazienti. In questo caso, come insegna Freud, è inevitabile, utile, necessario che nasca un trasporto affettivo, che Freud chiama transfert. Il transfert è un grosso problema analitico. Per anni Freud lo intese come un ostacolo all’analisi, il paziente s’innamora del suo analista e va in transfert perché vuole uscire dall’analisi, il transfert va dunque combattuto e ignorato, affinché l’analisi prosegua.
Ma alla fine Freud si convinse che il transfert è un nuovo terreno sul quale il paziente replica i suoi problemi e i suoi bisogni, e che dando importanza al transfert e analizzandolo si favorisce l’analisi, e la si porta a compimento. Posso sbagliare (sono uno scrittore, non uno psicanalista), ma ho sempre guardato con sospetto lo psicanalista che si mette con una sua paziente, e la sposa. Mi sembra un rapporto analitico interrotto e deviato. Per la stessa ragione guardo con sospetto il prof che scambia email erotiche con le sue alunne, ancora minorenni o appena maggiorenni: mi sembra un rapporto didattico perduto e non più recuperabile.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
PSICOANALISI E FILOSOFIA. Indicazioni per una seconda rivoluzione copernicana .....
 DAL LABIRINTO SI PUO’ USCIRE. FACHINELLI, "SU FREUD".
DAL LABIRINTO SI PUO’ USCIRE. FACHINELLI, "SU FREUD".Cultura. Sessualità, etica, psicoanalisi ...
 "PERVERSIONI" di Sergio Benvenuto. UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LA’ DELL’EDIPO
"PERVERSIONI" di Sergio Benvenuto. UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LA’ DELL’EDIPOCHI INSEGNA A CHI CHE COSA COME?! QUESTIONE PEDAGOGICA E FILOSOFICA, TEOLOGICA E POLITICA
 INSEGNAMENTO E COSTITUZIONE: "CHI INSEGNA AI MAESTRI E ALLE MAESTRE A INSEGNARE?"!
INSEGNAMENTO E COSTITUZIONE: "CHI INSEGNA AI MAESTRI E ALLE MAESTRE A INSEGNARE?"!PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!
 FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. -
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- Appello per la Scuola Pubblica. Un documento da a leggere, pensare e sottoscrivere.2 gennaio 2018, di Federico La Sala
Appello per la Scuola Pubblica
di Redazione ROARS *
- L’ultima riforma della scuola è l’apice di un processo pluridecennale che rischia di svuotare sempre più di senso la pratica educativa e che mette in pericolo i fondamenti stessi della scuola pubblica. Certo la scuola va ripensata e riformata, ma non destrutturata e sottoposta ad un processo riduttivo e riduzionista, di cui va smascherata la natura ideologica, di marca economicistica ed efficientista. La scuola è e deve essere sempre meglio una comunità educativa ed educante. Per questo non può assumere, come propri, modelli produttivistici, forse utili in altri ambiti della società, ma inadeguati all’esigenza di una formazione umana e critica integrale. [...] Sette temi per un’idea di Scuola: 1. Conoscenze vs competenze; 2. Innovazione didattica e tecnologie digitali; 3. Lezione vs attività laboratoriale; 4. Scuola e lavoro; 5. Metrica dell’educazione e della ricerca; 6. Valutazione del singolo, valutazione di sistema; 7. Inclusione e dispersione. [..] In virtù di queste considerazioni: 1) Chiediamo un’azione di moratoria su: obbligo dei percorsi di alternanza-scuola lavoro, obbligo di impiego metodologia CLIL (apprendimento integrato di contenuti disciplinari in lingua straniera), uso dei dispositivi INVALSI; modifiche relative all’esame di Stato, che renderebbero di fatto sempre più marginale la didattica disciplinare. 2) Chiediamo l’apertura di un ampio dibattito sulle questioni di cui al punto precedente e su tutto l’impianto della Legge 107/2015 (la Buona Scuola).
- Riceviamo e volentieri pubblichiamo il seguente “Appello per la Scuola Pubblica”.
Un documento sulla Scuola e sull’Istruzione. Da leggere, pensare e sottoscrivere.
- Dalla Costituzione della Repubblica italiana:
 Art. 3: “E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”
Art. 3: “E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”
 Art. 33: “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.”
Art. 33: “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.”
 Art. 34: “La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.”
Art. 34: “La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.”Al Presidente della Repubblica
Ai Presidenti delle Camere
Al Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca.
- Gli insegnanti proponenti:
 Giovanni Carosotti, insegnante scuola secondaria di secondo grado, Milano.
Giovanni Carosotti, insegnante scuola secondaria di secondo grado, Milano.
 Rossella Latempa, insegnante scuola secondaria di secondo grado, Verona.
Rossella Latempa, insegnante scuola secondaria di secondo grado, Verona.
 Renata Puleo, già dirigente scolastico, Roma.
Renata Puleo, già dirigente scolastico, Roma.
 Andrea Cerroni, professore associato, Università degli Studi Milano-Bicocca.
Andrea Cerroni, professore associato, Università degli Studi Milano-Bicocca.
 Giovanni Vacchelli, insegnante scuola secondaria di secondo grado, Milano.
Giovanni Vacchelli, insegnante scuola secondaria di secondo grado, Milano.
 Ivan Cervesato, insegnante scuola secondaria di secondo grado, Milano.
Ivan Cervesato, insegnante scuola secondaria di secondo grado, Milano.
 Lucia R. Capuana, insegnante scuola secondaria di secondo grado, Conegliano Veneto (TV).
Lucia R. Capuana, insegnante scuola secondaria di secondo grado, Conegliano Veneto (TV).
 Vittorio Perego, insegnante scuola secondaria di secondo grado, Melzo (MI).
Vittorio Perego, insegnante scuola secondaria di secondo grado, Melzo (MI).La premessa
L’ultima riforma della scuola è l’apice di un processo pluridecennale che rischia di svuotare sempre più di senso la pratica educativa e che mette in pericolo i fondamenti stessi della scuola pubblica. Certo la scuola va ripensata e riformata, ma non destrutturata e sottoposta ad un processo riduttivo e riduzionista, di cui va smascherata la natura ideologica, di marca economicistica ed efficientista.
La scuola è e deve essere sempre meglio una comunità educativa ed educante. Per questo non può assumere, come propri, modelli produttivistici, forse utili in altri ambiti della società, ma inadeguati all’esigenza di una formazione umana e critica integrale.
È quanto mai necessario “rimettere al centro” del dibattito la questione della scuola.
Come? In tre modi almeno:
a) parlandone e molto, in un’informazione consapevole che spieghi in modo critico i processi in corso;
b) ricostituendo un fronte comune di Insegnanti, Dirigenti Scolastici, Studenti, Genitori e Società civile tutta; e, soprattutto,
c) riprendendo una lotta cosciente e resistente in difesa della scuola, per una sua trasformazione reale e creativa.
Bisogna chiedersi, con franchezza: cosa è al centro realmente? L’educazione, la cultura, l’amore per i giovani e per la loro crescita intellettuale e interiore, non solo professionale, o un processo economicistico-tecnicistico che asfissia e destituisce?
7 temi per un’idea di Scuola
da leggere come studente, genitore, insegnante, cittadino
 Conoscenze vs competenze
Conoscenze vs competenze
 Innovazione didattica e tecnologie digitali
Innovazione didattica e tecnologie digitali
 Lezione vs attività laboratoriale
Lezione vs attività laboratoriale
 Scuola e lavoro
Scuola e lavoro
 Metrica dell’educazione e della ricerca
Metrica dell’educazione e della ricerca
 Valutazione del singolo, valutazione di sistema
Valutazione del singolo, valutazione di sistema
 Inclusione e dispersione
Inclusione e dispersioneIl documento
- Conoscenze vs competenze
Una scuola di qualità è basata sulla centralità della conoscenza e del sapere costruiti a partire dalle discipline. Letteratura, Matematica, Arte, Scienza, Storia, Geografia, Filosofia, in tutte le loro declinazioni, sono la chiave di lettura del mondo, della società e del nostro futuro. Una reale comprensione del presente e la trasformazione della società richiedono riferimenti che affondano le radici nella storia, nelle opere, nelle biografie e nell’epistemologia delle discipline.
Crediamo che:
i) Aggregare compiti e prestazioni degli allievi attorno a competenze predefinite e standardizzate annienti l’organicità dell’educazione, riduca la complessità del mondo ad un “kit di pratiche”, che tali restano, anche con l’appellativo onorifico di “competenze di cittadinanza”.
ii) La competenza, unica e trasversale, si consegua nel tempo, nello spazio sociale, nei contesti comunicativi affettivo-cognitivi. La cittadinanza, a cui le competenze comunitarie aspirano, non è un insieme di rituali individuali da validare e certificare. Cittadinanza è “operare in comune”.
iii) Non abbia senso misurare “livelli di competenza” degli studenti, da attestare in una sorta di fermo-immagine valutativo. Il sapere non si acquisisce mai definitivamente. È continuamente rinnovato dalla maturazione, consapevolezza, interiorità, ricerca singolare e plurale, approfondimento di contenuti e pratiche.
- Innovazione didattica e tecnologie digitali
Innovare non è bene di per sé, tantomeno in campo educativo. La didattica “innovativa” o digitale, oggi presentata come primaria necessità della Scuola, non vanta alcuna legittimazione scientifica né acquisizione definitiva da parte della ricerca educativa. Innovazioni e tecnologie, nelle varie accezioni global-ministeriali (debate, CLIL, flipped classroom, etc), rappresentano un insieme di “riforme striscianti” che demoliscono pezzo a pezzo l’edificio della Scuola Pubblica dal suo interno. Servono piuttosto innovazioni in tutt’altra direzione, che sappiano valorizzare inoltre l’interculturalità, la creatività e l’immaginazione, il pensiero critico e quello simbolico, nella didattica così come nell’impianto complessivo della scuola.
Crediamo che:
i) Ogni innovazione metodologica o tecnologia digitale sia un possibile strumento di ampliamento e accesso a contenuti e conoscenze. Sul loro impiego l’insegnante è chiamato a riflettere e valutare in maniera incondizionata e libera. Codificare pratiche e metodi, presentati come la priorità della Scuola, è una semplificazione retorica arbitraria, corrispondente ad un preciso modello culturale preconfezionato, che ridefinisce finalità e ruoli dell’istruzione pubblica in ossequio a un’ideologia indiscussa.
ii) L’inflazione di innovazioni didattiche e gli sperimentalismi digitali offrono spesso narrazioni impazienti ed elementari (slides, video, “prodotti”, progetti), propongono procedure stereotipate e associazioni banali, con grave danno per gli studenti e la loro crescita culturale, interiore e sociale.
iii) Non sia il mero ingresso di uno smartphone in classe a migliorare l’apprendimento o l’insegnamento. In quel caso si potrà, certo, aderire a un modello, attualmente dominante: quello che sostiene l’equazione cambiamento=miglioramento e digitale=coinvolgimento. Il miglioramento dell’apprendimento e dell’insegnamento passa, però, per altre strade: quelle dell’attuazione del dettame della nostra Costituzione.
- Lezione vs attività laboratoriale
Nell’era di instagram, twitter e dell’ e-learning, la relazione e la comunicazione “viva” allievo/insegnante - nella comunità della classe - rappresentano fortezze da salvaguardare e custodire. La saldatura del legame intergenerazionale, la trasmissione coerente di conoscenze, percorsi e temi, il dialogo incalzante, la maieutica, la circolarità, la condivisione di interpretazioni e scelte linguistiche, il problematizzare insieme, l’attenzione ai tempi, alle reazioni di sguardi e comportamenti. Tutto questo è fare lezione, un incontro fra persone in cammino in una comunità inclusiva. Gli appellativi di “frontale”, “dialogata”, “laboratoriale” sono rifiniture burocratiche che non ne intaccano la sostanza. Una lezione può e deve essere un laboratorio educativo, di crescita e partecipazione, di scambi fra tutti e cambiamenti di ciascuno, insegnante incluso.
Crediamo che:
i) L’insegnante, come educatore, sia responsabile e garante di quell’ “incontro” che dà senso e valore ai fatti culturali della propria disciplina. La relazione di pari dignità ma asimmetrica tra maestro e studente, nel microcosmo della collettività di classe, permette agli allievi di imbattersi nel non conosciuto, di praticare l’incontro con la difficoltà del reale e del vivere in comunità, di aprire un orizzonte culturale diverso da quello familiare o sociale.
ii) Attenzione concentrata, aumento dei tempi di ascolto, siano condizioni per un “saper fare” come “agire intelligente”, che non si consegue assecondando l’uso delle tecnologie o seducendo gli alunni con dispositivi smart, ma in contesti di applicazione laboriosa, tempo quieto per pensare, discussione nel gruppo.
- Scuola e lavoro
Non si va a scuola semplicemente per trovare un lavoro, non si frequenta un percorso di istruzione solo per prepararsi ad una professione. Dal liceo del centro storico al professionale di estrema periferia, la scuola era e deve restare, per primo, un “luogo potenziale” in cui immaginare destini e traiettorie individuali, rimettere in discussione certezze, diventare qualcos’altro dalla somma di “tagliandi di competenza” accumulati e certificati. L’apertura alla realtà sociale e produttiva può realizzarsi, volontariamente, attraverso forme e progetti di scambio organizzati autonomamente dagli istituti scolastici. Non imposti ex lege dal combinato Jobs Act e Buona Scuola. Pratiche calibrate in base ai contesti e alle finalità educative, che in nessun modo gravino sulle famiglie o sugli allievi in termini di sostenibilità e gestione.
Crediamo che:
i) L’alternanza scuola lavoro non rappresenti affatto un’opportunità formativa per i ragazzi, quanto piuttosto una surrettizia sperimentazione del “lavoro reale” che entra fin dentro i curricula scolastici, sottraendone tempo e qualità e distorcendone le finalità.
ii) Oltre ad approfondire il solco tra sapere teorico e pratico, alternanza è sinonimo di disuguaglianza. Percorsi ineguali in base a contesti, tessuti sociali e reti familiari, che peggiorano in proporzione alla fragilità delle condizioni economiche e delle opportunità culturali di luoghi e famiglie.
iii) Bisogna recuperare l’idea di Scuola come luogo della vita dotato di un tempo e spazio propri, non corridoio di passaggio tra infanzia e adolescenza - considerate età “minori” - e occupazione adulta.
iv) Sia necessario portare la conoscenza del lavoro nelle classi, non gli studenti a lavorare. Logiche, dinamiche e problematiche dell’occupazione entrino nel dialogo educativo, per aiutare i giovani ad orientarsi, attrezzarsi a comprenderle e intervenire per modificarle.
- Metrica dell’educazione e della ricerca
Educazione e ricerca accademica sono oggi terreno di confronto tra tutti i soggetti sociali, politici, economici ad esse interessati. Gli orientamenti internazionali delle politiche formative e di ricerca lo testimoniano e innescano una competizione globale in cui ranking internazionali (OCSE) e nazionali (INVALSI, ANVUR) comprimono gli scopi formativi e di studio sulla dimensione apparentemente neutra di “risultato”, oltre ad indurre a paragoni privi di rigore logico. Educazione e ricerca universitaria non sono riducibili ad un insieme di pratiche psicometriche globali, a cui sottoporsi in nome del principio di etica e responsabilità. Il futuro della Scuola e dell’Università sono questioni politiche nazionali, da collocare in un contesto europeo e interculturale di confronto e valorizzazione delle differenze, libero e democratico.
Crediamo che:
i) Scuola e Ricerca universitaria siano oggetto di vera e propria “ossessione quantitativa”, da parte di organismi internazionali e nazionali.
ii) La logica dell’adempimento e della competizione azzerino il lavoro di personalizzazione nella formazione scolastica ed erodano progressivamente spazi di progettualità libera nella ricerca universitaria (attraverso la sottomissione a criteri di valutazione non condivisi).
iii) Le scelte operate da MIUR, INVALSI ed ANVUR, modifichino profondamente comportamenti e strategie nelle Scuole e nelle Università, generando condotte di mero opportunismo metodologico-didattico e scientifico nonché la perdita di “biodiversità culturale”, strumento indispensabile per affrontare le complessità del futuro, oggi imprevedibili.
- Valutazione del singolo, valutazione di sistema
La valutazione degli studenti è impegno unico, qualificante e delicato dell’insegnante, condiviso con la comunità dei docenti e dei discenti, consapevoli del cambiamento tipico dei processi di apprendimento. È un’osservazione “prossimale” (e responsabile) modulata su tempi lunghi, sull’evoluzione del singolo allievo, delle pratiche di insegnamento, del gruppo, del contesto. È impensabile che enti terzi, estranei al rapporto educativo, entrino nel merito della valutazione formativa, come previsto dalla Buona Scuola. Singolarmente anacronistico appare che, dopo decenni di ‘crisi del fordismo’ in economia, si voglia introdurre la ‘fordizzazione’ nell’educazione. Le menti, soprattutto durante le prime fasi della formazione, sono delicate, creative e si conciliano con “tempi e metodi” d’antan assai meno delle berline.
Crediamo che:
i) Accostare una valutazione di agenzie esterne a quella del corpo docente nel “curriculum dello studente”, mini la relazione di fiducia scuola-famiglia, spostando l’attenzione sull’esito, più che sul processo e sul percorso, togliendo ogni significato agli obiettivi di personalizzazione ed inclusione che la Scuola afferma di perseguire;
ii) Un’agenzia “terza” (INVALSI) non possa svolgere compiti di valutazione e di ricerca pedagogico-didattica orientanti programmi e curricola: la terzietà non è, inoltre, comparabile con gli incarichi affidati dal MIUR per la valutazione (diretta e indiretta) di docenti e dirigenti attraverso meccanismi di premialità.
iii) La presenza di agenzie esterne nella valutazione del singolo rappresenti un’espropriazione di quella responsabilità complessa, raffinata negli anni con l’esperienza e la condivisione collegiale, della professionalità di ogni insegnante: la valutazione dei propri studenti;
- Inclusione e dispersione
La dispersione scolastica, l’inclusione autentica e la riduzione delle disuguaglianze necessitano di interventi politici sistematici, di fondi strutturali, impegni comunitari, di monitoraggio costante, conoscenza e capitalizzazione delle pratiche esistenti. A partire da investimenti e piani territoriali: infrastrutture, associazioni, biblioteche; fino ad arrivare a Scuola, con risorse costanti per costruire una fitta ed efficiente rete di recupero dei disagi, delle solitudini e delle difficoltà degli allievi più fragili. Se è vero che la Scuola e i buoni insegnanti fanno la differenza, è ancor più vero che la dispersione ha una sua mappa che si sovrappone a quella geografica ed economica dei tessuti degradati e delle periferie impoverite, di situazioni e storie difficili da ribaltare e su cui incidere. Dare alle Scuole risorse e spazi adeguati alla costruzione di didattiche di recupero e opportunità di accoglienza non è sperpero di denaro pubblico, ma progettazione politica di inclusione autentica, unica vera prospettiva di crescita e ricchezza del paese.
Crediamo che:
i) I temi in gioco siano cruciali e non ci si possa limitare a chiedere alla Scuola di fare meglio solo con ciò che ha. Semplificare compiti e programmi, organizzare corsi di recupero pomeridiani che ricalchino quelli antimeridiani, medicalizzare le diversità, sono scorciatoie che restano agli atti come prove burocratiche di adempimenti amministrativi;
ii) La Scuola abbia un valore politico. Dunque ha il diritto di chiedere di indirizzare risorse pubbliche su questioni di importanza sociale e morale che ritiene prioritarie. Dispersione scolastica e abbandoni precoci non sono solo capi d’imputazione su cui è chiamata a rispondere, ma problematiche che nelle attuali condizioni assorbe e subisce.
In virtù di queste considerazioni:1) Chiediamo un’azione di moratoria su:
 obbligo dei percorsi di alternanza-scuola lavoro e del requisito di effettuazione per l’accesso all’esame di Stato conclusivo del II ciclo
obbligo dei percorsi di alternanza-scuola lavoro e del requisito di effettuazione per l’accesso all’esame di Stato conclusivo del II ciclo
 obbligo di impiego metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning, apprendimento integrato di contenuti disciplinari in lingua straniera)
obbligo di impiego metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning, apprendimento integrato di contenuti disciplinari in lingua straniera)
 uso dei dispositivi INVALSI a test censuario per la valutazione degli esiti scolastici, obbligatorietà della somministrazione funzionale all’ammissione agli esami di licenza del primo e secondo ciclo
uso dei dispositivi INVALSI a test censuario per la valutazione degli esiti scolastici, obbligatorietà della somministrazione funzionale all’ammissione agli esami di licenza del primo e secondo ciclo
 modifiche relative all’esame di Stato, che renderebbero di fatto sempre più marginale la didattica disciplinare.
modifiche relative all’esame di Stato, che renderebbero di fatto sempre più marginale la didattica disciplinare.2) Chiediamo l’apertura di un ampio dibattito governo-Scuola di base-organizzazioni sindacali-cittadinanza sulle questioni di cui al punto precedente e su tutto l’impianto della Legge 107/2015.
Per aderire: compila il modulo google cliccando il link seguente.
https://docs.google.com/forms/d/1HySgRVSDznuQ1fB2rKQqLnQuOLeq9vNZqQdYum8c-08/edit
contatti: appelloscuolapubblica@gmail.com
* ROARS, 23 dicembre 2017 (ripresa parziale).
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- La Costituzione non è mai al sicuro, occhio ai programmi elettorali. 1947-2017. La Carta come una bussola nella sfida del voto.28 dicembre 2017, di Federico La Sala
La Costituzione non è mai al sicuro, occhio ai programmi elettorali
1947-2017. La Carta come una bussola nella sfida del voto
di Anna Falcone (il manifesto, 28.12.2017)
Sarà la cifra tonda, sarà che questo compleanno della Costituzione arriva dopo la schiacciante vittoria referendaria del 4 dicembre, fatto sta che mai come quest’anno la ricorrenza della firma è stata fortemente sentita dagli italiani, che hanno partecipato in tanti alle iniziative organizzate per l’occasione in tutta Italia. E non solo per rinnovare il ricordo: questa celebrazione e il messaggio che ne scaturisce assumono un valore cruciale per le prossime elezioni politiche.
Lo hanno giustamente sottolineato Felice Besostri ed Enzo Paolini nell’articolo pubblicato ieri sulle pagine di questo giornale. Perché chi ha vinto la battaglia referendaria, e continua a difendere davanti alle Corti le ragioni della legittimità costituzionale delle leggi elettorali, o a sostenere chi lo fa, non potrà sottrarsi, al momento del voto, a un giudizio di coerenza fra schieramenti politici e rispetto del voto referendario.
Il fatto che a 70 anni dalla sua entrata in vigore la Costituzione è e rimane, in gran parte, inattuata rappresenta - per chi voglia raccoglierla seriamente - la sfida politica per eccellenza delle prossime elezioni. Non a caso, molti elettori ed elettrici, che non si rassegnano all’esistente, chiedono agli schieramenti in campo di ripartire proprio dall’attuazione della Costituzione e dalla implementazione dei diritti già riconosciuti dalla Carta quale antidoto alle inaccettabili diseguaglianze del nostro tempo. Un passaggio necessario, se non indispensabile, per rafforzare la credibilità dei programmi politici e, auspicabilmente, ricucire quel rapporto di fiducia fra politica e cittadini mai così in crisi. Un vulnus democratico tradotto in un astensionismo che sfiora ormai il 55% dell’elettorato: dato più che allarmante a cui non ci si può e non ci si deve rassegnare.
Rilanciare il messaggio della necessaria difesa e attuazione della Costituzione - in particolare delle norme che garantiscono il pieno e trasparente esercizio della democrazia e attribuiscono alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli che alimentano e aggravano le condizioni di diseguaglianza fra cittadini - diventa, allora, cruciale, soprattutto alla vigilia di una tornata elettorale le cui regole saranno scandite dall’ennesima legge elettorale ad alto rischio di incostituzionalità.
Pur nella piena consapevolezza che la Costituzione non delinea un programma univoco, capace di blindare le scelte dei diversi governi - è necessario riconoscere, infatti, e una volta per tutte, che esiste un nucleo duro di principi e diritti fondamentali inderogabili che ogni forza politica deve impegnarsi ad attuare, nelle forme e nei modi che ritiene più opportuni, per rispettare quella fedeltà alla Costituzione che li lega indissolubilmente alla Repubblica e ai suoi compiti costituzionali. Un patto democratico di diritti e obiettivi programmatici, inequivocabilmente vincolanti, che deve tornare ad essere il cuore di ogni programma elettorale. Soprattutto a Sinistra.
Sia chiaro: non è un’indicazione di voto, ma il suggerimento a una riflessione suppletiva sul voto e su chi auspicabilmente si impegnerà in maniera chiara e credibile a difendere e attuare la Costituzione. Nella piena consapevolezza che un tale ambizioso obiettivo, per essere concreto, deve essere condiviso da tanti, e non è monopolizzabile da pochi o da forze marginali. Perché la Costituzione non è perfetta, né intoccabile, ma è l’unico punto certo che abbiamo, il primo “bene comune” in cui si riconoscono gli italiani in questa difficile fase di transizione democratica. Se questa virerà verso il restringimento progressivo degli spazi di partecipazione e di democrazia o verso modelli più avanzati dipenderà anche dal se e come eserciteremo il nostro diritto di voto.
In tal senso, l’astensionismo, anche come forma estrema di protesta, più che sortire un ‘ravvedimento’, rischia di favorire le destre nel prossimo Parlamento, e con esse la formazione di uno schieramento largo e più ampio della compagine del futuro governo che, se non arginato, potrebbe trovare i numeri per unire le forze di quanti - avendo fallito le riforme del 2006 e del 2016 - potrebbero convergere su un progetto analogo, se non peggiore. Un’operazione che, (ipotesi remota, ma non impossibile) qualora dovesse raccogliere il sostegno dei 2/3 dei componenti di ciascuna Camera potrebbe non dare spazio neppure alla raccolta delle firme per chiedere il referendum costituzionale e, con esso, il pronunciamento popolare.
Per questo è necessario sollecitare le forze politiche in campo affinché si pronuncino, tutte, sul loro programma costituzionale: sul se e come intendano intervenire sulla Costituzione; sul se e come intendano dare attuazione al suo nucleo duro di principi e diritti inderogabili; sul se e come intendano metterla “in sicurezza” da possibili incursioni di future maggioranze gonfiate. Perché non ci si debba più trovare in futuro a contrastare una riforma o, peggio, una riscrittura della Carta, di parte e neppure menzionata nei programmi elettorali e adeguatamente dibattuta nel Paese. Ai tanti italiani che si sono recati al voto il 4 dicembre, almeno questo, è dovuto.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
VIVA L’ITALIA!!! LA QUESTIONE "CATTOLICA" E LO SPIRITO DEI NOSTRI PADRI E E DELLE NOSTRE MADRI COSTITUENTI. Per un ri-orientamento antropologico e teologico-politico.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- VERGOGNA E "LATINORUM". Da Berlusconi a Trump: così un sentimento è scomparso dall’orizzonte dei valori individuali e collettivi.16 dicembre 2017, di Federico La Sala
VERGOGNA E "LATINORUM": UNA GOGNA PER L’ITALIA INTERA... *
____________________________________________________________________
Le idee
La vergogna è morta
Da Berlusconi a Trump: così un sentimento è scomparso dall’orizzonte dei valori individuali e collettivi
di Marco Belpoliti (l’Espresso, 15 dicembre 2017)
Quando nel 1995 Christopher Lasch, l’autore del celebre volume “La cultura del narcisismo”, diede alle stampe un altro capitolo della sua indagine sulla società americana, “La rivolta delle élite” (ora ristampato opportunamente da Neri Pozza), pensò bene di dedicare un capitolo alla abolizione della vergogna.
Lasch esaminava gli scritti di psicoanalisti e psicologi americani che avevano lavorato per eliminare quella che sembrava un deficit delle singole personalità individuali: la vergogna quale origine della scarsa stima di sé. La pubblicistica delle scienze dell’anima vedeva in questo sentimento una delle ultime forme di patologia sociale, tanto da suggerire delle vere e proprie campagne per ridurre la vergogna, cosa che è avvenuta in California, ad esempio («programma cognitivo-affettivo finalizzato a ridurre la vergogna»). Lasch non ha fatto in tempo a vedere come questo sentimento sia stato abolito dalla classe dirigente che è apparsa sulla scena della politica mondiale all’indomani del 1994, anno in cui lo studioso della cultura è scomparso.
* * *
Con il debutto di Silvio Berlusconi in politica la vergogna è ufficialmente scomparsa dall’orizzonte dei valori e dei sentimenti individuali e collettivi. Le élite che hanno scorrazzato nel paesaggio italiano nel ventennio successivo alla “discesa in campo” sono state totalmente prive di questo. In un certo senso Berlusconi è stato l’avanguardia di una classe politico-affaristica che ha il suo culmine nella figura dell’attuale inquilino della Casa Bianca, Donald Trump. Nessuno dei due uomini d’affari trasformati in leader politici conosce né il senso di colpa né la vergogna propriamente detta.
La vergogna, come sostengono gli psicologi, costituisce un’emozione intrinsecamente sociale e relazionale. Per provarla occorre immedesimarsi in un pubblico che biasima e condanna. Ma questo pubblico non esiste più. Ci sono innumerevoli figure dello spettacolo, della politica, della economia e del giornalismo, per cui la sfrontatezza, l’esibizione del cinismo, la menzogna fanno parte della serie di espressioni consuete esibite davanti alle telecamere televisive e nel web. Nessuno prova più vergogna. Anzi, proprio questi aspetti negativi servono a creare un’immagine personale riconoscibile e, se non proprio stimata, almeno rispettata o temuta. Come ha detto una volta Berlusconi, genio del rovesciamento semantico di quasi tutto: «Ci metto la faccia». È l’esatto contrario del “perdere la faccia”, sentimento che prova chi sente gravare dentro di sé la vergogna. Metterci la faccia significa apparire rimuovendo ogni senso di colpa, di perdita del senso dell’onore, della rispettabilità.
* * *
L’esibizione dell’autostima è al centro del libro più celebre di Lasch, quello dedicato al narcisismo. «Meglio essere temuti che amati», recita un proverbio; nel rovesciamento avvenuto negli ultimi quarant’anni, cui non è estranea la televisione commerciale inventata da Silvio Berlusconi, è molto meglio che gli altri ti vedano come sei: cattivo, spietato, senza vergogna. L’assenza del senso di vergogna è generata dall’assenza di standard pubblici legati a violazioni o trasgressioni. Nella vergogna s’esperimenta l’immagine negativa di sé stessi, si prova il senso di un’impotenza. Questa emozione rientra in quel novero di quelle esperienze che sono definite dagli psicologi “morali”. Ciò che sembra scomparso in questi ultimi decenni è proprio un sistema di valori morali condivisi.
* * *
Non è lontano dal vero immaginare che la deriva populista nasca anche da questa crisi verticale di valori, dall’assenza di un codice etico collettivo. Nell’età del narcisismo di massa ognuno fa per sé, stabilendo regole e comportamenti che prescindono dagli altri o dalla società come entità concreta, entro cui si misura la propria esistenza individuale. La vergogna è senza dubbio un sentimento distruttivo, probabilmente molto di più del senso di colpa, come certificano gli psicoanalisti. Sovente porta a derive estreme, a reazioni autodistruttive, e tuttavia è probabilmente uno dei sentimenti più umani che esistano.
Per capire come funzioni la vergogna basta leggere uno dei libri più terribili e insieme alti del XX secolo, “I sommersi e i salvati” (Einaudi) di Primo Levi nel capitolo intitolato Vergogna. Lo scrittore vi riprende una pagina di un suo libro, l’inizio de “La tregua”, dove si racconta l’arrivo dei soldati russi ad Auschwitz. Sono dei giovani militari a cavallo che assistono alla deposizione del corpo di uno dei compagni di Levi gettato in una fossa comune. Il cumulo dei cadaveri li ha come pietrificati. Levi riconosce nei soldati russi il medesimo sentimento che lo assaliva nel Lager dopo le selezioni: la vergogna, scrive, che i tedeschi non avevano provato. La scrittore spiega che non è solo un sentimento che si prova per aver compiuto qualcosa di male, di scorretto o di errato. Nasce piuttosto dalla “colpa commessa da altrui”: la vergogna dei deportati scaturisce proprio da quello che hanno fatto i carnefici. Una vergogna assoluta, che rimorde alla coscienza delle vittime per la colpa commessa dai carnefici: «gli rimorde che esista, che sia stata introdotta irrevocabilmente nel mondo delle cose che esistono, e che la sua volontà sia stata nulla o scarsa, e non abbia valso a difesa». Levi parla di una vergogna radicale, che svela la profonda umanità di questo sentimento.
* * *
Gli psicologi affermano che la vergogna è molto più distruttiva del senso di colpa. Proprio per questo è lì che si comprende quale sia la vera radice dell’umano. Si tratta della «vergogna del mondo», come la definisce Levi, vergogna assoluta per ciò che gli uomini hanno fatto agli altri uomini, e non solo ad Auschwitz, ma anche in Cambogia, nella ex Jugoslavia, in Ruanda, nel Mar Mediterraneo e in altri mille posti ancora.
Che la vergogna ci faccia umani non lo dice solo Levi in modo estremo, ma lo evidenzia l’ultima frase di uno dei più straordinari testi letterari mai scritti, “Il processo” di Franz Kafka. Libro che quasi tutti hanno letto almeno una volta da giovani. Il romanzo dello scrittore praghese termina con una frase emblematica: «E la vergogna gli sopravvisse». K. è stato ucciso dai due scherani che l’hanno perseguitato nel corso dell’intera storia. L’hanno barbaramente accoltellato al cuore, dopo avere tentato inutilmente di convincerlo a farlo lui stesso. Il libro di Kafka si chiude con questa frase che, come ha segnalato Giorgio Agamben, significa esattamente questo: la vergogna ci rende umani. Chissà se Silvio Berlusconi e la sua corte hanno mai avuto in mano questo racconto, se l’hanno letto. Probabilmente no. Ma anche se lo avessero fatto, dubito che ne avrebbero tratto qualche ammaestramento, com’è evidente da quello che è seguito dal 1994: senza vergogna.
* SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
VERGOGNA E "LATINORUM": UNA GOGNA PER L’ITALIA INTERA. Sul filo di una nota di Tullio De Mauro
L’OCCUPAZIONE DELLA LEGGE E DELLA LINGUA ITALIANA: L’ITALIA E LA VERGOGNA.
LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE.
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA E A PENSARE BENE "DIO", "IO" E "L’ITALIA", CHI PIU’ CHI MENO, TUTTI VIVONO DENTRO LA PIU’ GRANDE BOLLA SPECULATIVA -- Il populismo è fin troppo popolare. È un’inclinazione naturale, mettiamola così (Michele Ainis).12 dicembre 2017, di Federico La Sala
Il populismo in cerca di un vocabolario
di Michele Ainis (la Repubblica, 12.12.2017)
Il populismo è fin troppo popolare. La parola - se non anche la cosa - rimbalza nei discorsi dei politici, tracima sui media e nel web, ci casca addosso. Già, ma che diavolo significa? Le parole, a usarle troppo spesso, subiscono una sorta d’azzeramento semantico, come dicono i linguisti: diventano suoni, non concetti. È successo alla parola «democrazia» (Sartori ne contò decine di definizioni). Sta succedendo al populismo, tanto che ormai viene squadernato come un calendario: populismi di destra o di sinistra, di lotta o di governo, nuovi o stagionati.
Ecco, i vecchi populismi. Quelli, almeno, già li conosciamo: narodniki russi, People’s Party negli Usa, peronismo sudamericano. Ma è una conoscenza teorica, libresca, non avendoli mai sperimentati di persona. E d’altronde pure i libri mentono, talvolta. Così, Mény e Surel ( Populismo e democrazia, 2000) scrivono che un elemento d’identità del populismo è l’avversione verso tutti i poteri neutri, dalla magistratura alle autorità di garanzia; ma allora dovremmo definire populista anche Togliatti, che in Assemblea costituente s’oppose strenuamente all’istituzione della Corte costituzionale.
Sta di fatto che questo fenomeno, oggi come ieri, non si lascia inquadrare in precise gabbie concettuali. Ha tratti mutevoli, cangianti. Tuttavia qualcosa nel populismo si ripete, impermeabile alle stagioni della storia. In primo luogo un elemento nazionalista (oggi diremmo «sovranista»). Poi la critica all’establishment, alle classi dirigenti, sempre bollate come parassitarie e inette. Inoltre una concezione primitiva della democrazia, senza filtri, senza mediazioni, senza le lungaggini delle procedure parlamentari. E infine la presunzione di rappresentare il “vero” popolo: «I am your voice», proclamava Trump durante la sua campagna elettorale. Un popolo omogeneo, indistinto, compatto nell’avversione all’altro da sé, dunque in primo luogo nell’avversione agli altri popoli.
Tutto l’opposto della concezione pluralistica della società, che è il presupposto delle democrazie. Però in questo, almeno qui in Italia, c’è un deposito culturale, c’è un’idea organicistica della società che a suo tempo allevò il fascismo. A differenza del mondo anglosassone: loro dicono «people», al plurale, per designarsi come comunità di singoli individui; noi diciamo «popolo», al singolare, e in tale sostantivo i singoli annegano in una totalità indifferenziata, in un organismo omogeneo dove conta assai poco l’apporto di ciascuno.
Probabilmente nessuno di questi elementi è sufficiente, di per sé, a catalogare come populista un determinato messaggio politico: devono ricorrere tutti insieme, è la loro somma che contraddistingue il populismo. E il nuovo populismo presenta almeno due caratteri innovativi rispetto alle esperienze precedenti. Anzitutto si è affermato anche un populismo di sinistra (che reclama protezionismo e servizi pubblici) accanto ai populismi di destra (che s’oppongono al multiculturalismo). In secondo luogo vi si coglie un elemento passatista, l’idea che le lancette dell’orologio possano girare al contrario, per sfuggire ai formidabili problemi della modernità. Sono però nuove le cause che spiegano il successo attuale delle parole d’ordine populiste. Possiamo indicarne almeno un paio.
Primo: la globalizzazione, con le sue diseguaglianze. Nel 1820, in base al reddito pro capite, fra il Nord e il Sud del mondo c’era uno scarto di 3 a 1; invece nel 2011 lo Stato più ricco del pianeta, il Qatar, vantava un reddito pro capite 428 volte maggiore rispetto allo Stato più povero, lo Zimbabwe. Questa faglia sotterranea si riproduce tale e quale in ogni Stato, in ogni regione, in ogni città. E l’Italia non fa certo eccezione - anzi, esprime la società più diseguale di tutto l’Occidente, dopo il Regno Unito e gli Usa. Da qui la rabbia verso tutte le strutture sociali, dall’economia alle istituzioni.
Secondo: l’accelerazione tecnologica, che spinge folle di lavoratori fuori dal mercato del lavoro, perché sostituiti dalle macchine o perché scavalcati da nuove abilità. Sicché reagiscono con un senso d’angoscia, che reclama scorciatoie, soluzioni semplici a problemi complessi. Ma la democrazia è una creatura complicata, e a sua volta la semplificazione può ben risolversi in una trappola autoritaria.
Sta di fatto che la comunicazione politica viene dominata da messaggi rozzi, semplificati, e in conclusione demagogici; una categoria (la persuasione demagogica) messa a fuoco fin dai tempi di Aristotele. Anche se, più che Aristotele viene in mente Umberto Eco, con la sua Fenomenologia di Mike Bongiorno. Che «convince il pubblico, con un esempio vivente e trionfante, del valore della mediocrità. Non provoca complessi di inferiorità pur offrendosi come idolo, e il pubblico lo ripaga, grato, amandolo». Sarà per questo che i nostri leader sono diventati populisti, senza sforzi, forse senza neppure averne l’intenzione. È un’inclinazione naturale, mettiamola così.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA E A PENSARE BENE -- CHI E’ DIO? CHI E’ IL "PADRE NOSTRO"?! Chi è il Papa? Chi induce in tentazione?!9 dicembre 2017, di Federico La Sala
CHI E’ DIO? CHI E’ IL "PADRE NOSTRO"?! Chi è il Papa? Chi induce in tentazione .... *
- Quello che ti induce in tentazione è Satana, quello è l’ufficio di Satana" (Papa Francesco).
A
GUGLIELMO DI OCKHAM
Chi è il Papa? Un eretico
di Armando Torno (Il Sole-24 Ore, 13 settembre 2015)
- Guglielmo di Ockham, Dialogo sul papa eretico, Bompiani, Milano, pagg. CXCIV+ 2046, € 55
Chi avesse cercato, magari in una biblioteca, l’edizione del Dialogo sul papa eretico di Guglielmo di Ockham, si sarebbe visto recapitare un volume ponderoso, in un latino non da parroco. In Rete l’ipotetico lettore qualcosa avrebbe trovato, rischiando però di peggiorare la comprensione: se fosse finito, putacaso, nel sito della Bayerische Staatsbibliothek, dove c’è la riproduzione digitale dell’editio princeps di Parigi del 1476, alle difficoltà della lingua avrebbe aggiunto quelle per la lettura dell’incunabolo. Aggirare l’ostacolo con una versione? Eccolo in un vicolo cieco: non ci sono traduzioni integrali in una lingua moderna. Eppure se il solerte bibliotecario avesse, per esempio, mostrato l’edizione di Francoforte del 1614, la curiosità sarebbe arrivata alle stelle, ché l’editore a pagina 957 aggiunse un Compendio degli errori di papa Giovanni XXII. Un’altra opera di Ockham, d’accordo, ma ne rafforzava le tesi.
Da qualche giorno tali preoccupazioni fanno parte del passato: Alessandro Salerno ha tradotto integralmente per la prima volta nella serie «Il pensiero occidentale» di Bompiani, con il testo latino a fronte, il Dialogo sul papa eretico di Ockham, che morì nel 1349 o nel 1350. Con tutta l’acutezza e la conoscenza di cui disponeva (era noto come il Doctor invincibilis), il celebre francescano tentò di dimostrare - senza allontanarsi dai punti fermi del cristianesimo - la possibilità dell’eresia del vicario di Cristo, mettendo in discussione tutte le relazioni tra papato e impero. La questione non era di poca importanza, giacché il sovrano diventava giudice naturale del pontefice, anzi avrebbe addirittura potuto invocare la difesa della fede per giustificare il suo intervento negli affari della Chiesa.
Certo, il papa a cui frate Guglielmo guardava, ovvero Giovanni XXII sedente in Avignone, non era una mammoletta e i francescani mal lo sopportavano. Basti ricordare che nel 1322, durante il suo pontificato, la disputa sulla povertà di Cristo e degli Apostoli appassionava dotti e semplici fedeli, tanto che un professore del convento dei minori di Narbona, Berengario, difese con forza un tale accusato di aver sostenuto che Cristo e i suoi seguaci nulla possedevano, né in comune né in proprio. Quando fu invitato a ritrattare, decise addirittura di appellarsi alla Santa Sede. Berengario invocò la decretale Exiit qui seminat di Nicola III (agosto 1279), nella quale la tesi era anzi obbligatoria. Giovanni XXII fece arrestare l’entusiasta difensore appena giunto ad Avignone; propose pubblicamente la questione della povertà di Cristo e, siccome Nicola III aveva comminato la scomunica per chi avesse cercato di intenderla in altro modo, con la bolla del 26 marzo di quell’anno, Quia quorundam, sospese la restrizione. La cosa andò avanti e nel dicembre successivo revocò la decretale del predecessore. Bonagrazia da Bergamo, anch’egli francescano, cercò di impugnare tali decisioni: finì a sua volta in prigione.
In un simile contesto nasce il Dialogo di Ockham, in sette libri, scambio di idee tra un maestro e un discepolo. L’opera pone questioni quali «A chi spetta definire la verità cattolica o l’eresia?» o «Esiste un giudice del papa?». Le domande sono radicali e tutto il sesto libro è dedicato alla condanna del pontefice eretico con pagine che recarono grande gioia all’imperatore. Due quesiti (meglio leggerli senza punto di domanda): «Il papa deve essere sottomesso all’autorità come lo fu Cristo» o «Se il papa oppone resistenza all’indagine sul suo conto, è lecito arrestarlo, detenerlo e metterlo in catene». Nella sua introduzione, poco meno di 200 pagine, Alessandro Salerno inquadra l’opera e offre un’analisi del sintagma «papa eretico» (compare circa 1200 volte a partire dal libro quinto). Pone in evidenza ironie e maschere, esamina i concetti di verità e potere, propone considerazioni sull’infallibilità.
Il “papa eretico” riapparirà nella storia della Chiesa con accusatori che non avranno l’acume di Ockham. Qualche storico chiamerà così Alessandro VI, e lo stesso Savonarola lo vide tale; altri, come il presbitero e teologo tedesco Ignaz von Döllinger, lo sussurrarono dopo la proclamazione del dogma dell’infallibilità pontificia con Pio IX. Ma questi sono dettagli. Ockham, scomunicato, accolto dall’imperatore Ludovico il Bavaro, passò la parte finale della vita a combattere i papi avignonesi con i suoi trattati. I quali, anche se non furono graditi o odoravano di zolfo, restano dei capolavori di intelligenza.
B
Papa Francesco vuole cambiare il ’Padre Nostro’: "Traduzione non è buona, Dio non ci induce in tentazione"
Uno dei passaggi più noti potrebbe presto cambiare, come già successo in Francia *
CITTÀ DEL VATICANO - Il testo in italiano della preghiera più nota, il ’Padre Nostro’ , potrebbe presto cambiare. A farlo intendere è lo stesso papa Francesco: "Dio che ci induce in tentazione non è una buona traduzione. Anche i francesi hanno cambiato il testo con una traduzione che dice ’non mi lasci cadere nella tentazione’. Sono io a cadere, non è lui che mi butta nella tentazione per poi vedere come sono caduto, un padre non fa questo, un padre aiuta ad alzarsi subito".
Il pontefice lo ha spiegato nella settima puntata del programma ’Padre nostro’, condotto da don Marco Pozza, in onda su Tv2000. Francesco dialoga con il giovane cappellano del carcere di Padova nell’introduzione di ogni puntata. "Quello che ti induce in tentazione - conclude il Papa - è Satana, quello è l’ufficio di Satana".
Della controversia sulla preghiera più nota del cristianesimo - fu insegnata da Gesù stesso ai suoi discepoli che gli chiedevano come dovessero pregare - si è parlato in queste settimane quando in Francia si è detto appunto addio al vecchio ’Padre Nostro’. Dopo anni di discussioni sulla giusta traduzione, la nuova versione francese non include più il passaggio ’ne nous soumets pas à la tentation’ - ’non sottometterci alla tentazione’ -, che è stato sostituito con una versione ritenuta più corretta: ’ne nous laisse pas entrer en tentation’, ’non lasciarci entrare in tentazione’.
Secondo quanto ha scritto Le Figaro, la prima formula - ’non sottometterci’ - ha fatto credere a generazioni di fedeli che Dio potesse tendere in qualche modo una sorta di tranello, chiedendo loro di compiere il bene, li ’sottometteva’ alla tentazione del male. "La frase attuale lasciava supporre che Dio volesse tentare l’essere umano mentre Dio vuole che l’uomo sia un essere libero", ha commentato il vescovo di Grenoble, monsignor Guy de Kerimel, citato dal giornale. Dopo mezzo secolo - la controversa versione venne introdotta il 29 dicembre 1965 - la Conferenza episcopale transalpina ha quindi optato per la nuova traduzione del Notre Père. Per aiutare i fedeli a memorizzarla, la nuova preghiera è stata distribuita in decine di migliaia di copie nelle chiese di Francia. Il cambio ufficiale è avvenuto due giorni fa, domenica 3 dicembre.
Per la verità, anche in Italia, nella versione della Bibbia della Cei (2008), il passo ’et ne nos inducas in tentationem’ è tradotto con ’e non abbandonarci alla tentazione’; l’edizione del Messale Romano in lingua italiana attualmente in uso (1983) non recepisce tuttavia questo cambiamento. Ora però è il Papa a sostenere pubblicamente che si dovrebbe cambiare.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
IL MAGISTERO DI MENZOGNA DELLA CHIESA CATTOLICA: IL "PADRE NOSTRO" CHE INDUCE IN TENTAZIONE. Una nota di Henri Tincq - con premessa.
IL NOME DI DIO. L’ERRORE FILOLOGICO E TEOLOGICO DI PAPA BENEDETTO XVI, NEL TITOLO DELLA SUA PRIMA ENCICLICA. Nel nome della "Tradizione"
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- VIVA LA PIZZA "L’arte del pizzaiolo napoletano è patrimonio culturale dell’Umanità Unesco". Lo annuncia il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali Maurizio Martina su Twitter. "Vittoria! Identità enogastronomica italiana sempre più tutelata nel mondo".7 dicembre 2017, di Federico La Sala
VIVA LA PIZZA! L’Organizzazione delle Nazioni Unite ha premiato così il lungo lavoro del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali che nel 2009 aveva iniziato a redigere il dossier di candidatura con il supporto delle Associazioni dei pizzaioli e della Regione Campania, superando i pregiudizi di quanti vedevano in questa antica arte solo un fenomeno commerciale ....
Arte del pizzaiuolo napoletano è patrimonio dell’Unesco
Entra in lista patrimonio dell’umanità, dal Comitato voto unanime
di Redazione ANSA *
"L’arte del pizzaiolo napoletano è patrimonio culturale dell’Umanità Unesco". Lo annuncia il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali Maurizio Martina su Twitter. "Vittoria! Identità enogastronomica italiana sempre più tutelata nel mondo", sottolinea. Dopo 8 anni di negoziati internazionali, a Jeju, in Corea del Sud, voto unanime del Comitato di governo dell’Unesco per l’unica candidatura italiana, riconoscendo che la creatività alimentare della comunità napoletana è unica al mondo.
Per l’Unesco, si legge nella decisione finale, "il know-how culinario legato alla produzione della pizza, che comprende gesti, canzoni, espressioni visuali, gergo locale, capacità di maneggiare l’impasto della pizza, esibirsi e condividere è un indiscutibile patrimonio culturale. I pizzaioli e i loro ospiti si impegnano in un rito sociale, il cui bancone e il forno fungono da "palcoscenico" durante il processo di produzione della pizza. Ciò si verifica in un’atmosfera conviviale che comporta scambi costanti con gli ospiti. Partendo dai quartieri poveri di Napoli, la tradizione culinaria si è profondamente radicata nella vita quotidiana della comunità. Per molti giovani praticanti, diventare Pizzaiolo rappresenta anche un modo per evitare la marginalità sociale".
L’Organizzazione delle Nazioni Unite ha premiato così il lungo lavoro del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali che nel 2009 aveva iniziato a redigere il dossier di candidatura con il supporto delle Associazioni dei pizzaioli e della Regione Campania, superando i pregiudizi di quanti vedevano in questa antica arte solo un fenomeno commerciale e non una delle più alte espressioni identitarie della cultura partenopea. Il dossier della candidatura e la delegazione sono stati coordinati dal professor Pier Luigi Petrillo. Al termine dell’iscrizione della candidatura, l’ambasciatrice italiana all’Unesco, Vincenza Lomonaco, ha ringraziato tutti gli Stati che hanno votato a favore dell’Italia, sottolineando la centralità dell’Italia nel promuovere le tradizioni agroalimentare nel contesto dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura. Subito dopo la proclamazione, in sala è scoppiato un lungo e fragoroso applauso che ha festeggiato il successo italiano a lungo atteso, e molti dei delegati presenti sono venuti ad abbracciare i rappresentanti italiani che nella lunga notte del negoziato finale hanno stretto in mano un cornetto napoletano porta fortuna, rosso come tradizione impone.
Renzi, orgoglio per tradizione e stimolo per futuro - "L’arte del pizzaiolo napoletano riconosciuta come patrimonio Unesco è un simbolo bellissimo di quello che l’Italia è stata. Ma è simbolo anche di ciò che dovremo essere. La cura per la tradizione, la passione per il cibo, la capacità di farsi rappresentare all’estero dai nostri prodotti sono elementi essenziali del nostro futuro". Cosi’ Matteo Renzi su fb. "Andiamo verso un futuro di robot e innovazioni tecnologiche: proprio per questo - scrive il segretario dem - avremo sempre più bisogno di radici, di identità, di qualità, di gusto. Le più grandi catene al mondo di pizza non sono italiane così come pure è straniera la maggioranza dei prodotti che hanno il nome che suona italiano venduti nel mondo. Insomma: nel mondo globalizzato il Made in Italy - anche alimentare - ha tante opportunità davanti. Il riconoscimento alla pizza è un orgoglio per la tradizione ma anche uno stimolo per il futuro. Avanti".
Sul tema, nel sito, si cfr.:
GLI APPRENDISTI STREGONI E L’EFFETTO "ITALIA". LA CLASSE DIRIGENTE (INCLUSI I GRANDI INTELLETTUALI) CEDE (1994) IL "NOME" DEL PAESE AL PARTITO DI UN IMPRENDITORE. Che male c’è?! - Materiali sul tema
- "PUBBLICITA’ PROGRESSO": L’ITALIA E LA FORZA DI UN MARCHIO REGISTRATO!!!
L’ITALIA (1994-2016), TRE PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA SENZA "PAROLA", E I FURBASTRI CHE SANNO (COSA SIGNIFICA) GRIDARE "FORZA ITALIA". In memoria di Sandro Pertini e di Gioacchino da Fiore, alcuni appunti per i posteri
UNITÀ D’ITALIA E FOLLIA: EMERGENZA LOGICO-POLITICA EPOCALE. PER UN CONVEGNO E UNA RIFLESSIONE SUL CONCETTO DI ’UNITA’ E DI SOVRANITÀ (SOVRA-UNITÀ). Materiali sul tema
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- TEOLOGIA ECONOMIA POLITICA: PER UN"RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. La dittatura della X (degli affetti e affari).1 dicembre 2017, di Federico La Sala
PERDITA DELLA MEMORIA FILOLOGICA E TEOLOGICA: LA “X” (“CHI”, GRECO) DIVENTA “X” (“ICS”, LATINO; E, SEMPLICEMENTE, "C", IN ITALIANO) E GESU’, IL FIGLIO DELLA GRAZIA EVANGELICA ("CHARITAS") DIVENTA IL "TESORO" DI "MAMMONA" ("CARITAS") E DI "MAMMASANTISSIMA" DEI FARAONI ...
- "IN PRINCIPIO ERA IL LOGOS": LA CARITA’ dal GRECO (χάρις - χάριτος: "chàris" - "chàritos"; accusativo pl.: " χάριτας" - “chàritas” - dono, grazia) NON dal LATINO (“Caritas” - da “carus”, che - come nell’ italiano, "caro" - ha il doppio senso di “affetto” e "caro-prezzo" ... e richiama le "carenze" affettive ed economiche e la "carestia" - e non l’eu-charis-tia"!!!).
opinioni
La dittatura della X fra affetti e affari
di Vittorio Zucconi (la Repubblica D, 25.11.2017)
Il Medioevo italiano la mise al bando, ma ora si usa ovunque, perché, evidentemente, attira l’attenzione. Che si tratti di business o di baci
ATTESO DA ALMENO cento milioni di esseri umani, molti dei quali in fila da giorni, è arrivato l’ultimo totem per il villaggio globale: l’iPhone X della Apple. Niente di misterioso in quella X, solo la celebrazione in numeri romani del decimo anniversario dell’iPhone lanciato da Steve Jobs: così dicono dalla Mela, ma mentono sapendo di mentire. Per segnalare il decennale, avrebbero potuto benissimo chiamarlo iPhone 10, come i predecessori 6, 7 o 8.
I geni del marketing hanno scelto la X per lo stesso motivo che ha spinto i concorrenti della Microsoft a chiamare la loro scatola da giochi XBox e (nell’ultima edizione diffusa negli stessi giorni dell’iPhone X, per tormentarci il Natale) addirittura XBoxOneX. Tre X al prezzo di una. Non è necessario essere geni dell’enigmistica e dei cruciverba per notare la fissazione per una lettera-simbolo che, da secoli e mai come ora, è uscita dal recinto dell’algebra per invadere i territori del commercio, dell’immaginazione, del calcio e del sesso, pardon, del sex.
La X vende, piace, intriga, nella sua invadenza. L’epidemia di questa lettera (che, nel Medioevo, l’alfabeto italiano aveva escluso, insieme con K e Y, presenti invece nell’alfabeto latino) è naturalmente partita dagli Stati Uniti ed è un indizio del dominio culturale anglofono. È ovunque e le femmine ne hanno pretese addirittura due nei propri cromosomi, XX, lasciando a noi maschi l’umiliazione di quella Y solitaria.
S’insinua nella vita di ogni paziente, che ha sicuramente inghiottito una pillola il cui nome conteneva una X o è stato esposto ai raggi X. Ci sono almeno 50 farmaci da ricetta che la esibiscono, dal tranquillante Xanax, che raddoppia per sembrare più efficace, all’antibiotico Ciprofloxacina, somministrato a milioni di persone afflitte da infezioni delle vie urinarie.
Qualche linguista Usa ha cercato di spiegare l’attrazione con il Cristianesimo, partendo dalla croce che i Romani usavano per uccidere i nemici più pericolosi e che era fatta appunto a X, e non a T come nell’iconografia ufficiale. Ma non c’è nulla di mistico in banali varietà musicali come X Factor, copiato anche in Italia. Dubbi religiosi riaffiorano in dicembre, quando gli americani, sempre impazienti, abbreviano Christmas, Natale, in XMas. Ma poi si sprofonda nel prosaico esercizio del voto, che utilizzò quel segno affinché anche gli analfabeti potessero manifestare sulle schede le scelte politiche.
Resta in esso sempre il brivido del mistero, dell’incognita, come nelle equazioni o nella fantascienza della serie X-Files. Sa di frutto proibito, nei film porno classificati come XXX o nei commerci erotici, in quei Sex Shop che, se si chiamassero "botteghe del sesso", farebbero ancora più schifo. Diventa il richiamo alla morte e alla ferocia dei pirati, con le ossa incrociate a forma - che altro? - di X sotto il teschio. È uno dei molti simboli satanici, ma anche di tenerezza, nella stenografia da chat o da sms, dove sta per "baci", insieme con O, per "abbracci": XOXO, "ti mando baci e abbracci". Tende a essere estremista nell’abbigliamento, con le taglie XS, XL o addirittura, aiuto!, XXL. Anche l’immagine che guardiamo sul televisore, sul computer o sullo schermo dello smartphone paga un tributo, essendo formata da pixel.
Non ha colpe, né meriti questa lettera prepotente, immigrata senza autorizzazione fra di noi, ma qualche segreta e scaramantica influenza negativa forse sì. Soltanto uno, fra i 45 presidenti degli Stati Uniti in 200 e più anni, ha osato avere una X nel proprio nome, Richard Nixon. Finì infatti, primo e unico dimissionario nella storia, crocefisso alla vergogna delle proprie colpe.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
L’EUROPA, IL CRISTIANESIMO ("DEUS CHARITAS EST"), E IL CATTOLICESIMO COSTANTINIANO ("DEUS CARITAS EST").Una storia di lunga durata...
- MURATORI, BENEDETTO XVI, E "UNO SPROPOSITO MAIUSCOLO": LA LEZIONE DI VICO. Un breve testo dalla "Prefazione ai lettori" del "Trattato sulla carità cristiana" di Ludovico A. Muratori - a c. di Federico La Sala
 MURATORI E RATZINGER. "DEUS CARITAS EST": FINE DEL CRISTIANESIMO. TOLTA AL PESCE ("I.CH.TH.U.S.") L’ ACCA ("H"), IL COLPO ("ICTUS") E’ DEFINITIVO!!!
MURATORI E RATZINGER. "DEUS CARITAS EST": FINE DEL CRISTIANESIMO. TOLTA AL PESCE ("I.CH.TH.U.S.") L’ ACCA ("H"), IL COLPO ("ICTUS") E’ DEFINITIVO!!!
SULL’USCITA DALLO STATO DI MINORITÀ E SULLO SPIRITO CRITICO, OGGI. "X"- FILOSOFIA. LA FIGURA DEL "CHI": IL NUOVO PARADIGMA.
 DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"!
DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"!PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! - ROBINSON, LE ROBINSONATE, E IL PROCESSO DI PUTREFAZIONE DELLO SPIRITO ASSOLUTO.28 novembre 2017, di Federico La Sala
IL MITO DELL’AUTONOMIA INTELLETTUALE, ROBINSON, E LE ROBINSONATE ....
DOPO 170 ANNI DALLA BRILLANTISSIMA “Introduzione del ’57”, ove Marx scrive parole assolute e definitive (“La produzione dell’individuo isolato al di fuori della società è una rarità che può capitare ad un uomo civile sbattuto per caso in una contrada selvaggia, il quale già possiede in sé potenzialmente le capacità sociali - è un tale assurdo quanto lo è lo sviluppo di una lingua senza individui che vivano insieme e parlino tra loro”), è più che lodevole ricordare ai cittadini e alle cittadine della Repubblica non solo quello che Marx, nel 18 Brumaio e ne L’ideologia tedesca, chiama “il processo di putrefazione dello spirito assoluto”, e, quello che Lukàcs, sulle orme di Marx, chiama “la prassi dell’individuo isolato” (cfr. Mimmo Cangiano, Il mito dell’autonomia intellettuale, "Le parole e le cose", 28.11.2017), ma anche quello che gli intellettuali di "la Repubblica" si preparano a fare per festeggiare il fatto che “Robinson compie un anno (: hai tutti i numeri? Mandaci una foto della tua collezione. Domenica 10 dicembre inviteremo uno dei lettori a visitare l’Arena Robinson, lo stand del nostro settimanale a "Più libri più liberi"”).
Federico La Sala
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
In principio era il Logos, non il "logo" ...
 DIO, MONDO, UOMO - OLTRE!!! BASTA CON LE ROBINSONATE. A partire da due, e non da uno!!! Una nota su una polemica tra "esportatori di democrazia" e di "libertà" (Giovanni Sartori e Gian Maria Vian) e la proposta di una Fenomenologia dello Spirito di "Due Soli" - Con Rousseau, Kant, Marx, Freud e Dante, oltre Hegel, per una seconda rivoluzione copernicana
DIO, MONDO, UOMO - OLTRE!!! BASTA CON LE ROBINSONATE. A partire da due, e non da uno!!! Una nota su una polemica tra "esportatori di democrazia" e di "libertà" (Giovanni Sartori e Gian Maria Vian) e la proposta di una Fenomenologia dello Spirito di "Due Soli" - Con Rousseau, Kant, Marx, Freud e Dante, oltre Hegel, per una seconda rivoluzione copernicanaFederico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- LA REPUBBLICA E IL CANTO DEGLI ITALIANI. “Fratelli d’Italia” diventa ufficialmente inno nazionale. Nessuna legge lo aveva reso definitivo26 novembre 2017, di Federico La Sala
MUSICA, STORIA, E SOCIETA’: IL CANTO DEGLI ITALIANI. Goffredo Mameli, Giuseppe Verdi, il Risorgimento, la tradizione ebraica, il fascismo, e la Repubblica....
“Fratelli d’Italia” diventa ufficialmente inno nazionale
Scelto nel 1946 con un provvedimento provvisorio, nessuna legge lo aveva reso definitivo
- La casa di Lorenzo Valerio a Torino dove si musicò l’inno nazionale di Mameli [con lapide-ricordo del 1927] *
Dopo 71 anni di provvisorietà l’Inno di Mameli, o meglio «Il canto degli Italiani», diventa ufficialmente l’Inno della Repubblica Italiana. Dopo svariati tentativi nelle precedenti legislature, il Senato ha approvato definitivamente la legge che rende ufficiale quell’inno che il Consiglio dei ministri del 12 ottobre 1946 adottò provvisoriamente.
«Su proposta del Ministro della Guerra - si legge nel verbale di quel lontano Consiglio dei ministri presieduto da Alcide De Gasperi - si è stabilito che il giuramento delle Forze Armate alla Repubblica e al suo Capo si effettui il 4 novembre p.v. e che, provvisoriamente, si adotti come inno nazionale l’inno di Mameli». Nulla di più definitivo del provvisorio, come spesso accade in Italia, anche perché l’Inno di Mameli entra a tutti gli effetti nell’immaginario collettivo, grazie soprattutto alla nazionale Italiana di Calcio e ai successi che un tempo elargiva. Poi nella legislatura 2001-2005 ecco sia una proposta di legge ordinaria che una costituzionale, che però non vengono approvate. Lo stesso avvenne nelle due successive legislature (2006-2008 e 2008-2013). Curiosamente però una legge del 2012, nata per promuovere il senso di cittadinanza tra gli studenti, prevede che l’Inno di Mameli venga insegnato nelle scuole.
Anche l’attuale legislatura sembrava destinata allo stesso esito e invece la Commissione Affari costituzionali della Camera in poche settimane ha approvato in sede deliberante la legge attesa da anni (di iniziativa di alcuni deputati del Pd), imitata dalla Commissione Affari costituzionali del Senato, che in due settimane ha dato il sì definitivo. «Abbiamo l’Inno» ha commentato Salvatore Torrisi, presidente della Commissione.
«La Repubblica - afferma la nuova legge - riconosce il testo del `Canto degli italiani’ di Goffredo Mameli e lo spartito musicale originale di Michele Novaro quale proprio inno nazionale». Ciò significa che tutte e sei le strofe del testo di Mameli costituiscono l’Inno e non solo le prime due, che tutti conoscono per motivi calcistici. E appare quasi una beffa del destino il fatto che i tifosi non possano cantare l’Inno ai mondiali di calcio per la prima volta dopo 60 anni, proprio dopo la storica approvazione della legge attesa da 71 anni.
Comunque Mameli ha avuta vita difficile anche per la concorrenza di «Va pensiero» il coro dal Nabucco di Giuseppe Verdi, che in passato la Lega propose come Inno alternativo, anche perché esso non parla di Roma, come invece fa «Fratelli d’Italia». E proprio la Lega è stata assente sia al momento dell’approvazione della legge alla Camera che oggi al Senato, anche se Roberto Calderoli assicura che non sia una scelta politica, ma una semplice coincidenza di impegni dei senatori in più Commissioni.
* Fonte: La Stampa, 15/11/2017 (ripresa parziale - senza immagine).
SUL TEMA, IN RETE E NEL SITO , SI CFR.:
VIVA VERDI, VIVA PUCCINI: NESSUN DORMA!!!.
LA STORIA DEL FASCISMO E RENZO DE FELICE: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"!
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! - COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E POPULISMI DI SOSTANZA. SCALFARI, "LA REPUBBLICA", E "FORZA ITALIA").24 novembre 2017, di Federico La Sala
Costituzione e populismi (ateo-devoto) "di sostanza": W "la Repubblica", W "Forza Italia"!!! ... *
Il commentoL’inganno sul mio voto a Berlusconi
di Eugenio Scalfari (la Repubblica, 24.11.2017)
Cari Lettori, non cadete nell’inganno di chi sfrutta una domanda paradossale («Chi voterebbe tra Di Maio e Berlusconi?») per sostenere che avrei cambiato posizione su Berlusconi: non l’ho mai votato e ovviamente non lo voterò mai. Martedì scorso ho partecipato alla trasmissione televisiva guidata da Giovanni Floris, dove tornerò martedì prossimo. Rispondendo a una domanda sul tema dell’ingovernabilità, ho detto che in caso di estrema necessità per superare una situazione paralizzante per il Paese il Pd (per il quale io ho sempre votato dai tempi di Berlinguer, dell’Ulivo prodiano e infine di quello costruito da Walter Veltroni) potrebbe essere costretto, come già successo in passato, a un’intesa non di natura politica con Forza Italia, sempreché si separasse da Salvini.
Ipotesi a me sgradita, che è emersa parlando del rischio di ingovernabilità del Paese, tema approfondito ieri sul nostro giornale con molta lucidità da Gustavo Zagrebelsky. Ho poi detto che ai miei occhi sia Di Maio che Berlusconi sono populisti, ma che il populismo del secondo ha perlomeno una sua sostanza. Ma veniamo allo stato attuale dei satti e dei sondaggi, i partiti in corsa sono soprattutto tre: il Pd, i Cinquestelle, la destra di Berlusconi e della Lega di Salvini.
Nelle recenti elezioni siciliane la destra ha largamente vinto, seguita dai grillini e a buona distanza dal Pd, con la sinistra dissidente che aveva presentato una propria lista con risultati lillipuziani. Questa situazione si ripeterà probabilmente nelle prossime elezioni di sine Legislatura che avverranno a marzo o aprile del 2018? Probabilmente sì. Il Pd si rassorzerebbe se la sinistra dissidente e Pisapia e Bonino consluissero sin d’ora nel partito: una sinistra unita probabilmente recupererebbe anche una parte degli astenuti che hanno sentimenti di sinistra lacerati dall’attuale dissidenza. Fassino, incaricato da Renzi, ha tentato in tutti i modi di recuperare la dissidenza, ma non è riuscito. Forse Pisapia, ma è ancora molto incerto.
Il tema dell’ingovernabilità è dunque ancora dominante, se nessuno dei tre maggiori partiti assronterà le elezioni della prossima primavera nella situazione attuale, il Paese non avrà un governo legittimato dal voto. Il Centro si orienterà verso la destra ma anche in quel caso un governo Berlusconi- Salvini non avrà la maggioranza, durerà qualche mese dopodiché le elezioni dovranno ripetersi. Ci troviamo purtroppo nella stessa situazione della Germania di Angela Merkel.
Ma c’è un’altra evidenza da sottolineare: così come sta accadendo per la Germania, anche un’Italia sballottata dall’ingovernabilità non conterebbe più nulla in Europa con tutte le conseguenze del caso. La mia risposta nella trasmissione televisiva a Floris era chiaramente motivata da quanto sta accadendo: se l’ingovernabilità prosegue così come le previsioni e i sondaggi attuali consermano, la maggioranza relativa sarà certamente del centrodestra, Salvini compreso ed anzi preponderante.
Ovviamente io non voterò mai Berlusconi, ma con quel tanto di esperienza che gli anni hanno largamente ampliato, la situazione è quella che ho qui esposto.
Come c’era da aspettarsi sono stato ricoperto di insulti dai grillini rappresentati nel Fatto quotidiano diretto da Marco Travaglio, ma considero quegli insulti come una sorta di Legion d’onore. Quanto alla sinistra dissidente, ci pensi bene prima di risiutare le aperture di Renzi nei suoi consronti. Da parte loro è un litigio di comari, come si diceva un tempo. La politica è la prima delle attività dello spirito. Lo dimostrarono Platone e soprattutto Aristotele. Sarebbe opportuno leggerli. L’ho consigliato a Renzi e spero l’abbia satto. A Berlusconi è inutile suggerirlo, la lettura non sa parte della sua attività. Gli consiglio soltanto di piantare Salvini: meglio soli che in pessima compagnia.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
GLI APPRENDISTI STREGONI E L’EFFETTO "ITALIA". LA CLASSE DIRIGENTE (INCLUSI I GRANDI INTELLETTUALI) CEDE (1994) IL "NOME" DEL PAESE AL PARTITO DI UN IMPRENDITORE. Che male c’è?! - Materiali sul tema
FILOSOFIA. IL PENSIERO DELLA COSTITUZIONE E LA COSTITUZIONE DEL PENSIERO
 MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?!
MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?!COSTITUZIONE E PENSIERO. ITALIA: LA MISERIA DELLA FILOSOFIA ITALIANA E LA RICCHEZZA DEL MENTITORE ISTITUZIONALIZZATO ...
 BERTRAND RUSSELL: LA LEZIONE SUL MENTITORE (IGNORATA E ’SNOBBATA’), E "L’ALFABETO DEL BUON CITTADINO".
BERTRAND RUSSELL: LA LEZIONE SUL MENTITORE (IGNORATA E ’SNOBBATA’), E "L’ALFABETO DEL BUON CITTADINO".Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA - LA PARABOLA DEI TALENTI E LO STATO DI MINORITA’. Note.19 novembre 2017, di Federico La Sala
MESSAGGIO EVANGELICO E ILLUMINISMO, OGGI: "SAPERE AUDE!" (I. Kant). AL DI LA’ DELLA LOGICA E DELLA DIALETTICA "SERVO-PADRONE"...
La parabola dei talenti
di ENZO BIANCHI (Monastero di Bose, 19 novembre 2017)
- XXXIII domenica del tempo Ordinario
- Mt 25,14-30
- In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «14 Avverrà come a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. 15 A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un altro uno, secondo le capacità di ciascuno; poi partì. Subito 16 colui che aveva ricevuto cinque talenti andò a impiegarli, e ne guadagnò altri cinque. 17 Così anche quello che ne aveva ricevuti due, ne guadagnò altri due. 18 Colui invece che aveva ricevuto un solo talento, andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone.
 19 Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. 20 Si presentò colui che aveva ricevuto cinque talenti e ne portò altri cinque, dicendo: «Signore, mi hai consegnato cinque talenti; ecco, ne ho guadagnati altri cinque». 21 «Bene, servo buono e fedele - gli disse il suo padrone -, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone».
19 Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. 20 Si presentò colui che aveva ricevuto cinque talenti e ne portò altri cinque, dicendo: «Signore, mi hai consegnato cinque talenti; ecco, ne ho guadagnati altri cinque». 21 «Bene, servo buono e fedele - gli disse il suo padrone -, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone».
 22 Si presentò poi colui che aveva ricevuto due talenti e disse: «Signore, mi hai consegnato due talenti; ecco, ne ho guadagnati altri due». 23 «Bene, servo buono e fedele - gli disse il suo padrone -, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone».
22 Si presentò poi colui che aveva ricevuto due talenti e disse: «Signore, mi hai consegnato due talenti; ecco, ne ho guadagnati altri due». 23 «Bene, servo buono e fedele - gli disse il suo padrone -, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone».
 24 Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto un solo talento e disse: «Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. 25 Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sotto terra: ecco ciò che è tuo».
24 Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto un solo talento e disse: «Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. 25 Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sotto terra: ecco ciò che è tuo».
 26 Il padrone gli rispose: «Servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso; 27 avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l’interesse. 28 Toglietegli dunque il talento, e datelo a chi ha i dieci talenti. 29 Perché a chiunque ha, verrà dato e sarà nell’abbondanza; ma a chi non ha, verrà tolto anche quello che ha. 30 E il servo inutile gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti».
26 Il padrone gli rispose: «Servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso; 27 avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l’interesse. 28 Toglietegli dunque il talento, e datelo a chi ha i dieci talenti. 29 Perché a chiunque ha, verrà dato e sarà nell’abbondanza; ma a chi non ha, verrà tolto anche quello che ha. 30 E il servo inutile gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti».
La parabola dei talenti proposta dalla liturgia odierna è una parabola che, secondo il mio povero parere, oggi è pericolosa: pericolosa, perché più volte l’ho sentita commentare in un modo che, anziché spingere i cristiani a conversione, pare confermarli nel loro attuale comportamento tra gli altri uomini e donne, nel mondo e nella chiesa. Dunque forse sarebbe meglio non leggere questo testo, piuttosto che leggerlo male...
In verità questa parabola non è un’esaltazione, un applauso all’efficienza, non è un’apologia di chi sa guadagnare profitti, non è un inno alla meritocrazia, ma è una vera e propria contestazione verso il cristiano che sovente è tiepido, senza iniziativa, contento di quello che fa e opera, pauroso di fronte al cambiamento richiesto da nuove sfide o dalle mutate condizioni culturali della società. La parabola non conferma neppure “l’attivismo pastorale” di cui sono preda molte comunità cristiane, molti “operatori pastorali” che non sanno leggere la sterilità di tutto il loro darsi da fare, ma chiede alla comunità cristiana consapevolezza, responsabilità, laboriosità, audacia e soprattutto creatività. Non la quantità del fare, delle opere, né il guadagnare proseliti rendono cristiana una comunità, ma la sua obbedienza alla parola del Signore che la spinge verso nuove frontiere, verso nuovi lidi, su strade non percorse, lungo le quali la bussola che orienta il cammino è solo il Vangelo, unito al grido degli uomini e delle donne di oggi quando balbettano: “Vogliamo vedere Gesù!” (Gv 12,21).
Leggiamo allora con intelligenza questa parabola la cui prospettiva - lo ripeto - non è economica né finanziaria; essa non è un invito all’attivismo ma alla vigilanza che resta in attesa, non contenta del presente ma tutta protesa verso la venuta del Signore. Egli non è più tra di noi, sulla terra, è come partito per un viaggio e ha affidato ai suoi servi, ai suoi discepoli un compito: moltiplicare i doni da lui fatti a ciascuno. Nella parabola, a due servi il Signore ha lasciato molto, una somma cospicua - cinque lingotti di argento a uno, due a un altro -, affinché la facciano fruttificare; a un terzo servo ha lasciato un solo lingotto, che comunque non è poco. In tutti egli ha messo la sua fiducia senza limiti, confidando loro i suoi beni. Spetta dunque ai servi non tradire la grande fiducia del padrone e operare una sapiente gestione dei beni, non di loro proprietà ma del padrone, il quale al suo ritorno darà loro la ricompensa. A ciascuno il padrone da in funzione della sua capacità, e il suo dono è anche un compito: custodire e far fruttificare.
Al di là dell’immagine dei talenti, che cos’è questo dono, in definitiva? Secondo Ireneo di Lione è la vita accordata da Dio a ogni persona. La vita è un dono che non va assolutamente sprecato, ignorato o dissipato. Purtroppo - dobbiamo constatarlo - per alcuni la vita non ha alcun valore: non la vivono, anzi la sprecano e la sciupano “fino a farne una stucchevole estranea” (Konstantinos Kavafis), e così si lasciano vivere. Eppure si vive una volta sola e il farlo con consapevolezza e responsabilità è decisivo al fine di salvare una vita o perderla! Secondo altri padri orientali, i talenti sono le parole del Signore affidate ai discepoli perché le custodiscano, certo, ma soprattutto le rendano fruttuose nella loro vita, le mettano in pratica fino a seminarle copiosamente nella terra che è il mondo. Di nuovo, è questione di vita, di “scegliere la vita” (cf. Dt 30,19).
“Dopo molto tempo” - allusione al ritardo della parusia, della venuta gloriosa del Signore (cf. Mt 24,48; 25,5) - il padrone ritorna e chiede conto della fiducia da lui riposta nei suoi servi, i quali devono mostrare la loro capacità di essere responsabili, in grado cioè di rispondere della fiducia ricevuta. Eccoli dunque presentarsi tutti davanti a lui. Colui che aveva ricevuto cinque talenti si è mostrato operoso, intraprendente, capace di rischiare, si è impegnato affinché i doni ricevuti non fossero diminuiti, sprecati o inutilizzati; per questo, all’atto di consegnare al padrone dieci talenti, riceve da lui l’elogio: “Bene, servo buono e fedele, ... entra nella gioia del tuo Signore”. Lo stesso avviene per il secondo servo, anche lui in grado di raddoppiare i talenti ricevuti. Per questi due servi la ricompensa è proporzionalmente uguale, anche se le somme affidate erano diverse, perché entrambi hanno agito secondo le loro capacità.
Viene infine colui che aveva ricevuto un solo talento, il quale mette subito le mani avanti, manifestando il pensiero che lo ha paralizzato: “Da quando mi hai dato il talento, io sapevo che sei un uomo duro, esigente, arbitrario, che fa ciò che vuole, raccogliendo anche dove non ha seminato”. Con queste sue parole (“dalle tue parole ti giudico”, si legge nel testo parallelo di Lc 19,22) il servo confessa di essersi fabbricato un’immagine distorta del Signore, un’immagine plasmata dalla sua paura e dalla sua incapacità di avere fiducia nell’altro: egli considera il padrone come qualcuno che gli fa paura, che chiede una scrupolosa osservanza di ciò che ordina, che agisce in modo arbitrario. Avendo questa immagine in sé, ha scelto di non correre rischi: ha messo al sicuro, sotto terra, il denaro ricevuto, e ora lo restituisce tale e quale. Così rende al padrone ciò che è suo e non ruba, non fa peccato... Ma ecco che il Signore va in collera e gli risponde: “Sei un servo malvagio (ponerós) e pigro (oknerós). Malvagio perché hai obbedito all’immagine perversa del Signore che ti sei fatta, e così hai vissuto un rapporto di amore servile, di amore ‘costretto’. Per questo sei stato pigro, inaffidabile, non hai avuto né il cuore né la capacità di operare secondo la fiducia che ti avevo accordato. Non hai fatto neanche lo sforzo di mettere il talento in banca, dove sarebbe stato fruttuoso, dandomi interessi. Non hai avuto cura del mio bene affidato a te”.
Sì, lo sappiamo: è più facile seppellire i doni che Dio ci ha dato, piuttosto che condividerli; è più facile conservare le posizioni, i tesori del passato, che andarne a scoprire di nuovi; è più facile diffidare dell’altro che ci ha fatto del bene, piuttosto che rispondere consapevolmente, nella libertà e per amore. Ecco dunque la lode per chi rischia e il biasimo per chi si accontenta di ciò che ha, rinchiudendosi nel suo “io minimo”. Questo servo non ha fatto il male; peggio ancora, non ha fatto niente! Dunque davanti a Dio nel giorno del giudizio compariranno due tipi di persone:
chi ha ricevuto e ha fatto fruttificare il dono,
chi lo ha ricevuto e non ha fatto niente.
I servi fedeli entreranno nella gioia del Signore; chi invece è stato “buono a nulla” (achreîos) sarà spogliato anche dei meriti che pensava di poter vantare!
Ma a me piacerebbe che la parabola si concludesse altrimenti: così sarebbe più chiaro il cuore del padrone, mentre il cuore del discepolo sarebbe quello che il padrone desidera. Oso dunque proporre questa conclusione “apocrifa”:
Venne il terzo servo, al quale il padrone aveva confidato un solo talento, e gli disse: “Signore, io ho guadagnato un solo talento, raddoppiando ciò che mi hai consegnato, ma durante il viaggio ho perso tutto il denaro. So però che tu sei buono e comprendi la mia disgrazia. Non ti porto nulla, ma so che sei misericordioso”. E il padrone, al quale più del denaro importava che quel servo avesse una vera immagine di lui, gli disse: “Bene, servo buono e fedele, anche se non hai niente, entra pure tu nella gioia del tuo padrone, perché hai avuto fiducia in me”.
Anche così la parabola sarebbe buona notizia!
*
- "SAPERE AUDE!": AL DI LA’ DELLA LOGICA E DELLA DIALETTICA "SERVO-PADRONE", LA PARABOLA DEI TALENTI è una lezione sull’uscita dallo stato di minorità, un chiaro invito ad avere il coraggio di servirsi della propria intelligenza, e a imparare a usare la bilancia (gr.: "talanton") per investire al meglio i propri talenti. Nell’assenza del padrone, il servo è sollecitato ad agire come se egli non ci fosse e al contempo a comportarsi come se fosse il padrone, come una persona libera, capace di disporre sovranamente del talento avuto in dono. La sfida è grande e non è facile venirne fuori: la parabola ’nasconde’ una ingiunzione del "padrone" al "servo" di tipo paradossale, come un "ti ordino di essere spontaneo!". In questa trappola, il servo si scopre "padrone" del talento ricevuto e in quanto tale “re” (“le roi règne), ma al contempo si scopre anche “servo”, in quanto del talento avuto in dono, non può farne uso (“mais il ne gouverne pas”) se non “restituendolo” a chi lo sa mettere in circolazione e lo sa “governare”. Come uscire dalla “caverna” platonica-hegeliana?! Come è possibile venirne fuori?! Come è possibile saldare insieme regalità, sovranità (teologia), e governo (economia) se ancora non si ha nemmeno il coraggio di accogliere l’invito a servirsi della propria intelligenza, cominciare ad usare la “bilancia”, e affrontare criticamente le "antinomie" della ragion pura?!
MESSAGGIO EVANGELICO E ILLUMINISMO, OGGI: "SAPERE AUDE! Abbi il coraggio di servirti della tua propria intelligenza" (I. Kant).
 LA PAURA DI PENSARE E LA PARABOLA DEI TALENTI. Perché chiudere la nostra vita in una scatola? Una riflessione di Angelo Casati
LA PAURA DI PENSARE E LA PARABOLA DEI TALENTI. Perché chiudere la nostra vita in una scatola? Una riflessione di Angelo CasatiPER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!
 FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.Federico La Sala
-
> PENSARE BENE "DIO", "IO" E "L’ITALIA" -- UN MODO DI GUARDARE al passato che manda in frantumi ogni «boria delle nazioni»: «Storia mondiale d’Italia» (di Piero Bevilacqua).12 novembre 2017, di Federico La Sala
PER UN’ALTRA EUROPA E PER UN’ALTRA ITALIA. Al di là dei "corsi e ricorsi", il filo della tradizione critica. Contro la cecità e la boria dei dotti e delle nazioni ...
- VIVA L’ITALIA!!! LA QUESTIONE "CATTOLICA" E LO SPIRITO DEI NOSTRI PADRI E E DELLE NOSTRE MADRI COSTITUENTI. Per un ri-orientamento antropologico e teologico-politico. Una nota (del 2006)
Una terra per millenari incroci di destini
Tra passato e presente. «Storia mondiale d’Italia», a cura di Andrea Giardina, per Laterza. Il monumentale volume, che uscirà il 16 novembre, presenta un racconto aperto, contro la boria di ogni nazionalismo
di Piero Bevilacqua (il manifesto, 12.11.2017)
Costituisce un evento editoriale e culturale di prima grandezza la pubblicazione della Storia mondiale d’Italia, a cura di Andrea Giardina (Laterza, pp.820, euro 30) e per più di una ragione. L’idea del libro, mutuata da Giovanni Carletti, editor laterziano, dalla recente edizione in Francia dell’Histoire mondiale de la France a cura di Patrick Boucheron, trova nella vicenda millenaria del nostro paese una realizzazione che si può definire monumentale. Se non fosse che il termine allude più alle dimensioni e alla organicità dell’opera che non al carattere programmaticamente sovvertitore che anima il testo.
UNA STRATEGIA INNOVATIVA già saggiata dal prototipo francese, ispirata, come scrive Boucheron nel suo Invito al viaggio, che accompagna l’introduzione di Giardina: «la scelta di seguire il tracciato di una storia discontinua, sorprendente, aperta, che consentisse al lettore di attraversare liberamente un racconto nel quale ci si riconosce ma dove, nel riconoscersi, ci si scopre diversi da ciò che si credeva di essere».
Il fine è quello di «disorientare la storia» e, ancor di più arditamente, «defatalizzare il tempo». Vale a dire correggere soprattutto l’immaginario identitario di popoli che hanno attraversato vicende «nazionali» di straordinaria ricchezza e ampiezza di influenza e che oggi si trovano immersi in una storia mondiale molto più ravvicinata e quotidiana di quanto non sia stato in passato. Una storia in cui appare urgente riconoscere i propri apporti di lungo periodo e i condizionamenti subiti perché «è nel loro rapporto con l’universale che i sentimenti nazionali si costruiscono tanto in Francia che in Italia».
Il testo coordinato da Giardina, parte dalle Alpi preistoriche e termina con la Lampedusa di oggi, un quadro geografico ben delimitato e chiuso entro cui si svolge una vicenda millenaria di straordinaria e forse unica varietà.
Il «popolamento eccezionalmente misto dell’Italia nel corso dei millenni - ricorda Giardina - la politica già romana della cittadinanza e dell’integrazione, le invasioni germaniche, le presenze islamiche, francesi, spagnole e così via, quasi un caleidoscopio etnico in perenne rotazione» ne fanno un caso esemplare per questo nuovo modo di fare storia. Per millenni dentro i confini territoriali della Penisola si è svolta una vicenda che ha coinvolto le culture, le religioni, le consuetudini di decine di altri popoli insediati in spazi prossimi e lontani del pianeta. Ma al tempo stesso mondiale è stata la proiezione dell’Italia, con i suoi uomini, le sue idee, il suo cibo, la sua arte e le sue tradizioni religiose. Si pensi all’universalismo cattolico, incarnato dalla centralità di Roma, che sorge nel mondo antico e vive ancora nella spiritualità e nell’immaginario di oggi. Questa molteplicità etnica e culturale del nostro Paese, consente di guardare in maniera ricca e spiazzante al cosiddetto carattere degli italiani, «uno dei principali protagonisti di questo libro, anche perché forse nessun altro popolo ha ricevuto un numero altrettanto grande di aggettivi».
MA GIARDINA tiene conto dell’insegnamento di Croce: «Qual è il carattere di un popolo? La sua storia: tutta la sua storia e nient’altro che la sua storia». Ed è questa storia che oggi ci riappare, grazie al lavoro corale di diverse decine di specialisti italiani e stranieri, sotto una luce nuova, più aderente al modo in cui essa realmente si è andata svolgendo, più vicina all’orizzonte universale con cui noi oggi osserviamo l’accadere nella nostra epoca. Occorre infatti considerare quanto di «tolemaico», subalterno all’apparente, c’è ancora nel nostro modo di guardare al passato, come se a una storia mondiale approdassimo oggi, grazie alla globalizzazione. E invece la storia mondiale precede quella nazionale, non solo perché le nazioni nascono tardi, ma perché per millenni la geografia ha imposto il suo dominio al movimento di uomini e merci che dovevano ricorrere agli spazi internazionali del mare.
UN MODO DI GUARDARE al passato che manda in frantumi ogni «boria delle nazioni» e annichilisce alla radice ogni pretesa chiusura identitaria, il pregiudizio di una storia delimitabile entro muri e confini. E il messaggio civile di Giardina è esplicito «non sono pochi gli italiani che oggi vorrebbero serrare il mare come se fosse l’uscio di casa... Ma il fatto è che l’istinto della tana conduce verso spazi sempre più stretti: dalla nazione alle città, dalle città ai quartieri, dai quartieri agli isolati, alle case e infine agli appartamenti. E dopo, cosa viene dopo?».
NON È FACILE dar conto dei centottanta saggi contenuti nel libro, che occupano otto pagine di indice. La segnalazione sarà necessariamente casuale come in parte erratica è stata sinora la nostra lettura. E tuttavia sufficiente per fornire più che una suggestione, per un testo che potrebbe diventare un breviario di storia da tenere sul comodino, un vademecum per la formazione cosmopolita dei giovani, un’«enciclopedia» da consultare costantemente.
I capitoli sono scanditi da date, spesso un anno, talora un preciso giorno, qualche volta un gruppo di secoli. Si pensi al saggio 150 a.C. Dall’Italia alla Groenlandia (Elio Lo Cascio). I carotaggi effettuati nei ghiacciai della Groenlandia rivelano che l’inquinamento atmosferico generato dalla produzione di rame e argento giunge al massimo, prima della rivoluzione industriale, tra i secoli II a.C. e il II d.C. Una straordinaria conferma della potenza dell’economia romana e del primato della Penisola in quell’epoca.
MA LA POTENZA ha i suoi lati oscuri e mostra la multiforme umanità che ha contribuito a costruirla. La rivolta di Spartaco, che con 70mila uomini infligge non poche sconfitte all’esercito romano, rivela la natura multietnica del proletariato dell’epoca: «Schiavi-merce portati da ogni angolo del Mediterraneo. Uomini soprattutto, ma anche donne e bambini acquistati sui mercati orientali», oppure prigionieri di guerra trascinati a Roma come bottino (Orietta Rossini).
Il carattere internazionale della storia della Penisola non è meno rilevante quando, nel medioevo, la potenza sovranazionale dell’Impero vive solo nell’immaginario dell’epoca e l’Italia non è neppure uno stato-nazione. Ma le sue città sono già terminali dell’economia-mondo.
Nel saggio 1088 Una comunità sovranazionale basata sulla conoscenza (Annick Peters-Custot) l’autrice mostra come l’Università di Bologna - che ha avuto più seguito e fortuna della scuola medica salernitana - diventi, a partire da quell’anno, uno straordinario centro di attrazione mondiale dei giovani dell’epoca, ansiosi di conoscenza e di manifestare il libero pensiero. Un’altra città, Firenze, che nel 1252 avvia la coniazione del fiorino d’oro - dopo un millennio che l’oro era scomparso dalla monetazione - ne fa «il dollaro della crescita medievale», destinato a governare il commercio internazionale. Mentre, nello stesso anno, viene coniato a Genova il «genovino d’oro», Firenze e la Penisola vengono acquistando «una posizione di primo piano nell’economia europea» (Franco Franceschi).
ANCHE IN ETÀ MODERNA e contemporanea, tra primati e fallimenti, il profilo della nostra storia appare inscindibilmente legato a quella di altri popoli e di altri spazi nazionali e continentali: per commercio, migrazioni, guerre e avventure coloniali, influenze culturali (arte e cibo soprattutto) e perfino sport. C’è un 1982 Italia-Germania 3 a 1 (Fabien Archambault) a indicare la popolarità identitaria guadagnata dal calcio in Italia e il nuovo prestigio mondiale acquisito in questo sport. Felice poi la chiusa del libro con la tragedia dell’affondamento del peschereccio di migranti, africani e asiatici, di fronte a Lampedusa il 18 aprile 2015 (Ignazio Masulli).
Una vicenda che ci ricorda come le Penisola continui a essere terra d’incrocio dei destini di vari popoli e come il nostro abbia concorso, e concorra, nel bene e nel male, alla storia degli altri, per farne una vicenda plurale comune.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- Tra Ordine e Avventura. Nel nome di Eco (di Daniele Trematore)..30 settembre 2017, di Federico La Sala
KANT E L’ORNITORINCO. La democrazia, l’antinomia istituzionale del mentitore e la catastrofe culturale italiana... *
Nel nome di Eco
di Daniele Trematore (Alfabeta2 , 30 settembre 2017)
- Claudio Paolucci, Umberto Eco. Tra Ordine e Avventura, Feltrinelli.
Per cominciare bisogna andare a scavare nelle pagine finali di alcuni saggi Sulla letteratura. Lì, in un bellissimo scritto autobiografico intitolato “Come scrivo”, Umberto Eco ci dice che narrare è innanzitutto un fatto “cosmogonico”: ha a che fare con la costruzione di un mondo, e solo dopo che questo mondo è stato costruito le parole verranno quasi da sé: rem tene, verba sequentur. Ed è quello che Eco ha fatto prima di scrivere Il nome della rosa, disegnando personaggi e labirinti di un mondo che già conosceva benissimo grazie ai suoi studi medievali, o Il pendolo di Foucault, le cui pagine finali sono venute di getto proprio perché Eco quel momento lo aveva vissuto: il ragazzino piemontese che suona la tromba a un funerale di partigiani era proprio lui. Ed è anche quello che deve essere successo a Claudio Paolucci (docente di Semiotica all’Università di Bologna e già autore di numerosi saggi sulla semiotica interpretativa) quando si è messo a scrivere il suo ritratto di Umberto Eco. Tra Ordine e Avventura, da poco uscito per la collana “Eredi” di Feltrinelli diretta da Massimo Recalcati.
Quel mondo Paolucci lo ha costruito nel corso del tempo e, in parte, lo ha anche vissuto, visto che per lui Eco è stato “il relatore della mia tesi di laurea, il tutor di quella di dottorato e il maestro di semiotica che avevo sempre sognato”: quel “prof.” che condensava in sé le qualità dei suoi tre più importanti maestri - il rigore e la pedanteria di Pareyson, l’ironia scettica di Abbagnano e la teatralità di Guzzo - e che amava infinitamente stare con i propri allievi anche al di fuori dell’ambiente universitario, magari davanti a un Martini o a un whisky. Che ti poteva addirittura chiedere di tenere un intero corso al suo posto, ma che poi sapeva degnamente ricompensarti con qualche prima edizione, dalla Logica dei Relativi di Peirce alla copia originale della sua tesi sul Problema estetico in San Tommaso d’Aquino. E che, soprattutto, non si tirava mai indietro di fronte alla discussione critica al punto da accettare la tesi “tutta contro di lui” di “un ragazzo di ventiquattro anni con un look che lo disturbava moltissimo” e che smontava punto per punto alcune idee contenute nel suo Kant e l’ornitorinco.
Rem tene, verba sequentur, dicevamo. Ma le pagine di Paolucci (come del resto quelle di Eco) non sono il risultato di una sorta di “magma dell’ispirazione”, bensì di giorni e notti passate a studiare le opere del suo maestro (e dei suoi maestri) che, non a caso, amava insegnare ai suoi allievi che “il talento non porta da nessuna parte senza il lavoro”. Esse, insomma, sono il frutto di quell’“etica lavorativa” che caratterizzava il metodo di lavoro intellettuale e professionale di Umberto Eco (si pensi agli impressionanti ritmi di studio che aveva a Monte Cerignone interrotti soltanto dai pasti o da una nuotata in piscina); e si distinguono per rigore e profondità quando parlano dello studioso - e, aggiungerei, per commozione quando Paolucci rievoca alcuni ricordi e momenti personali dell’uomo.
Facendosi strada tra boschi narrativi e labirinti rizomatici dove incontriamo i temi più cari al nostro, come il riso e la menzogna, la guerriglia semiologica e l’Enciclopedia, questo appassionato ritratto intende offrire una panoramica generale del pensiero di Eco tentando - alla luce della sua autobiografia intellettuale terminata poco tempo prima di morire per la prestigiosa collana “Library of the Living Philosophers” - di fare il punto su un’eredità ancora tutta da valutare.
Innanzitutto Paolucci evidenzia il rapporto tra Teoria e Storia costitutivo dell’opera di Eco - in continua tensione tra Ordine e Avventura, Summa ed Enciclopedia, Forma e Interpretazione - e rielabora completamente quello più tardo tra Teoria e Narrazione che ha impegnato la riflessione di alcuni suoi critici e di cui Eco stesso era da tempo consapevole. Si tratta di due regni metodologicamente separati ma che si nutrono reciprocamente; non a caso, per spiegarne il rapporto, Eco riformulava una famosa frase di Wittgenstein e al posto di “su ciò di cui non si può parlare, si deve tacere”, diceva “su ciò su cui non si può teorizzare, si deve narrare”. Così, mentre la Teoria è l’arte di risolvere i problemi attraverso lo studio del linguaggio, la Narrazione “mostra” le soluzioni ad alcuni problemi che la Teoria non era in grado di trattare coi propri mezzi. Un esempio di questo rapporto è proprio Il nome della rosa. Per tutta la sua vita Eco ha cercato di scrivere un Trattato filosofico sul Riso, senza mai riuscirci. Il nome della rosa è la versione non teorica di questo trattato. E nelle ultime pagine del romanzo Guglielmo da Baskerville e Jorge da Burgos discutono proprio delle teorie sul riso che Eco mette sì in bocca ad Aristotele, ma che in realtà sono le sue. È quindi dal Nome della rosa e non dai saggi di filosofia che apprendiamo le teorie filosofiche di Eco sul riso. Da qui l’idea centrale del libro: secondo Paolucci la filosofia di Eco è una specie di “ornitorinco filosofico”, nel senso cui secondo Eco l’ornitorinco era un animale fatto “con pezzi di altri animali”. Così è la filosofia di Umberto Eco: una filosofia fatta con pezzi di non-filosofia, che Paolucci smonta in vari pezzi, aiutandoci a fare piazza pulita di alcuni luoghi comuni.
Partiamo da due maschere: quella dell’ironia e dell’erudizione. La prima ci presenta l’immagine di un Eco che scrive filastrocche sulla storia della filosofia e gioca di pastiches letterari (quando non legge i fumetti) e ride della morte, non prima ovviamente di aver tacciato di imbecillità qualche legione di utenti del web. Paolucci vi dedica un intero capitolo (“Il riso e la rosa”) - dando conto appunto di quel Trattato filosofico sul Riso mai scritto, ma già anticipato in saggi come “L’elogio di Franti” - perché l’ironia in Eco è tanto importante quanto l’estrema serietà del lavoro, costituendone quella parte attraverso cui si testano l’Ordine esistente e le teorie consolidate. La seconda, sottolineata sia dai suoi estimatori che dai suoi critici, può essere rappresentata dalla parodia di Fiorello che mostra un Eco coltissimo che finisce per inciampare su errori banalissimi. Ora, è vero che Eco sapeva molte cose, ma non era L’uomo che sapeva troppo e tantomeno quello che sapeva tutto: era semmai l’enciclopedista che sapeva dove andare a cercare le informazioni che gli servivano hic et nunc (di qui si spiega la sua monumentale biblioteca come strumento di lavoro e come raccolta di libri non letti).
Un altro luogo comune smascherato da Paolucci ci porta ad uno dei suoi testi più noti, Apocalittici e integrati del 1964, che molti ancora citano in relazione alle opposizioni più diverse. In realtà in quel libro - che si presentava come il tentativo di giustificare un titolo scelto dal suo editore Valentino Bompiani per una serie di saggi assemblati in fretta per motivi di concorso - non si trattava di spiegare Rita Pavone attraverso Kant né di dire che la filosofia avesse la stessa dignità culturale del fumetto, ma di far vedere come la cultura “bassa” fosse un prodotto di quella “alta” e “di rivoluzionare i prodotti di cultura bassa, criticando le ideologie della cultura alta ed elevandoli a prodotti che abbiano un’effettiva dignità culturale”. Certo, benché intendesse semplicemente “fare il punto su un dibattito ormai maturo”, noi sappiamo che questo libro, analizzando con metodi filosofici e sociologici rigorosi gli oggetti della cultura di massa, ebbe il merito di ridisegnare la geografia della cultura italiana e di allargarne i domini. Ed ecco che arriviamo al luogo comune che riguarda il suo lavoro filosofico, che negli anni è stato “ostracizzato” dai filosofi di professione proprio perché Eco aveva dei rapporti controversi con la cultura ritenuta “bassa” e considerava la semiotica “la forma contemporanea della filosofia” (e non è un caso che nelle celebrazioni seguite alla morte l’Eco filosofo sia stato messo da parte).
Uno dei tanti meriti del libro di Paolucci - che rappresenta una sorta di grande rivoluzione copernicana nella bibliografia su Eco - è quello di restituire giustizia a questo pensiero eminentemente filosofico e, prendendo provocatoriamente a prestito il titolo di un pezzo mai scritto che Eco regalò a Paolucci, diciamo: Occorre rimettere Eco negli scaffali di filosofia.
*
Sul tema, nel sito, si cfr.:
UMBERTO ECO E IL POPULISMO DI "FORZA ITALIA". Un’intervista di Marcelle Padovani (2002) e un’intervista di Deborah Solomon (2007).
MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA E A PENSARE BENE "DIO", "IO" E "L’ITALIA", CHI PIU’ CHI MENO, TUTTI VIVONO DENTRO LA PIU’ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA E POLITICA ITALIANA, NEL REGNO DI "FORZA ITALIA"!!! Un’inchiesta e una mappa.
- "Bustine" di "Filosofia minima" ... e "Berlusconismo". Che brutta storia!!!
 "Alt, nano! O io! O tu!". L’eterno ritorno del nano?! Umberto Eco passa le consegne ad Armando Massarenti e insieme ri-lanciano "il sogno" e "il lancio del nano". Come una proposta per la scuola di una nuova Italia - ma quella dei "nani" e delle nane" o quella dei cittadini e delle cittadine?! Boh e Bah?!
"Alt, nano! O io! O tu!". L’eterno ritorno del nano?! Umberto Eco passa le consegne ad Armando Massarenti e insieme ri-lanciano "il sogno" e "il lancio del nano". Come una proposta per la scuola di una nuova Italia - ma quella dei "nani" e delle nane" o quella dei cittadini e delle cittadine?! Boh e Bah?!
HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI.
Federico La Sala
-
>LA LEGGE, LA SELLA CURULE, IL SEDILE, E LA POLTRONA ACCADEMICA. LEX, LUX, REX, DVX: QUATTRO PAROLE DA RIPENSARE.28 settembre 2017, di Federico La Sala
L’ITALIA, IL SEDILE, LA SELLA CURULE, LA "X" DI "REX" E "DUX", HENRY W, LONGFELLOW, E IL "DVX" DEL FASCISMO.... *
AD AMPLIARE e a contribuire a rendere più comprensibili ed evidenti i nessi tra i vari livelli del brillante lavoro di Armando Polito sul SEDILE di Nardò (Lecce), è bene tenere presente e ricordare cosa era la SELLA CURULE nella società dell’antica Roma:
"La sella curule (in lat. sella curulis) era un sedile pieghevole a forma di "X" ornato d’avorio, simbolo del potere giudiziario, riservato inizialmente ai re di Roma e in seguito ai magistrati superiori dotati di giurisdizione, detti perciò "curuli".
I magistrati solevano portare con sé la sella curulis assieme agli altri simboli del loro potere (fasci, verghe e scuri) e ovunque disponessero questi simboli, lì era stabilita la sede del loro tribunale.
Durante il periodo della Repubblica, il diritto di sedere sulla sella curule era riservato a: consoli, pretori, edili curuli, sacerdoti massimi, dittatori e al magister equitum. In epoca imperiale l’uso della sedia curule fu ampliato anche all’imperatore, al praefectus urbi e ai proconsoli.
Il simbolo di potere rappresentato dalla sedia curule affonda le sue radici nell’antica Etruria; infatti già gli Etruschi consideravano lo scranno pieghevole a forma di sella una prerogativa di chi poteva esercitare il potere (giudiziario ed esecutivo) sul popolo. Fu portato a Roma dal quinto re, Tarquinio Prisco.[1]
- (LAT.)
 « Rebus divinis rite perpetratis vocataque ad concilium multitudine quae coalescere in populi unius corpus nulla re praeterquam legibus poterat, iura dedit; quae ita sancta generi hominum agresti fore ratus, si se ipse venerabilem insignibus imperii fecisset, cum cetero habitu se augustiorem, tum maxime lictoribus duodecim sumptis fecit. Alii ab numero avium quae augurio regnum portenderant eum secutum numerum putant. Me haud paenitet eorum sententiae esse quibus et apparitores hoc genus ab Etruscis finitimis, unde sella curulis, unde toga praetexta sumpta est, et numerum quoque ipsum ductum placet, et ita habuisse Etruscos quod ex duodecim populis communiter creato rege singulos singuli populi lictores dederint. »
« Rebus divinis rite perpetratis vocataque ad concilium multitudine quae coalescere in populi unius corpus nulla re praeterquam legibus poterat, iura dedit; quae ita sancta generi hominum agresti fore ratus, si se ipse venerabilem insignibus imperii fecisset, cum cetero habitu se augustiorem, tum maxime lictoribus duodecim sumptis fecit. Alii ab numero avium quae augurio regnum portenderant eum secutum numerum putant. Me haud paenitet eorum sententiae esse quibus et apparitores hoc genus ab Etruscis finitimis, unde sella curulis, unde toga praetexta sumpta est, et numerum quoque ipsum ductum placet, et ita habuisse Etruscos quod ex duodecim populis communiter creato rege singulos singuli populi lictores dederint. »
- (IT)
 « Compiute secondo il rito le cerimonie sacre e riunita in assemblea la massa che non avrebbe mai potuto unificarsi in un unico organismo popolare se non con leggi, Romolo dettò norme giuridiche. Dunque, stimando che esse sarebbero apparse inviolabili a un materiale umano ancora rozzo solo se egli stesso si fosse reso venerabile per mezzo di segni esteriori dell’autorità, si fece più maestoso con fasto dell’abbigliamento e particolarmente con la guardia dei dodici littori. Alcuni ritengono che egli abbia considerato il numero degli uccelli che gli avevano presagito il potere. A me non dispiace l’opinione di coloro che pensavano che anche questo tipo di guardie derivasse dai vicini Etruschi da cui fu ricavata anche la sella curule e la toga pretesta, e pensano che anche il numero dei littori venisse di là e che tale fosse presso gli Etruschi per il fatto che, dopo che i dodici popoli avevano eletto in comune il re ciascuno di essi gli assegna un littore. » (Liv. Hist. I, 8) "( cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Sella_curule).
« Compiute secondo il rito le cerimonie sacre e riunita in assemblea la massa che non avrebbe mai potuto unificarsi in un unico organismo popolare se non con leggi, Romolo dettò norme giuridiche. Dunque, stimando che esse sarebbero apparse inviolabili a un materiale umano ancora rozzo solo se egli stesso si fosse reso venerabile per mezzo di segni esteriori dell’autorità, si fece più maestoso con fasto dell’abbigliamento e particolarmente con la guardia dei dodici littori. Alcuni ritengono che egli abbia considerato il numero degli uccelli che gli avevano presagito il potere. A me non dispiace l’opinione di coloro che pensavano che anche questo tipo di guardie derivasse dai vicini Etruschi da cui fu ricavata anche la sella curule e la toga pretesta, e pensano che anche il numero dei littori venisse di là e che tale fosse presso gli Etruschi per il fatto che, dopo che i dodici popoli avevano eletto in comune il re ciascuno di essi gli assegna un littore. » (Liv. Hist. I, 8) "( cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Sella_curule).
RICORDARE CHI ERA HENRY W. LONGFELLOW:
"Henry Wadsworth Longfellow (Portland, 27 febbraio 1807 - Cambridge, 24 marzo 1882) è stato uno scrittore e poeta statunitense, tra i primi letterati americani ad assurgere alla fama mondiale.
Longfellow fu il più famoso poeta della scena del New England nell’’800 e scrisse numerose opere tra cui Evangeline e Il faro.
Fu un acceso promotore dell’abolizione della schiavitù negli anni prima e durante la Guerra Civile Americana insieme ad altri intellettuali che gravitavano nell’orbita di Harvard e soprattutto insieme all’allora Governatore del Massachusetts John Andrew.
Intorno al 1862 insieme ai letterati James Russell Lowell, Oliver W. Holmes e George Washington Greene diede vita al cosiddetto "Circolo Dante", atto a promuovere la conoscenza della Divina Commedia di Dante Alighieri negli Stati Uniti. Insieme ai suoi colleghi del circolo, Longfellow ne portò a termine la prima traduzione statunitense in inglese nel 1867.
Da allora il successo dell’opera di Dante in America fu costante ed in seguito il Circolo diventò la "Dante Society", una delle più famose associazioni di dantisti nel mondo [...]" (cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Henry_Wadsworth_Longfellow).
LE PAROLE ("DVX-LVX, REX-LEX") SCRITTE SULLA "CROCE" INSCRITTA NEL "CERCHIO" SULLA TOMBA DI LONGFELLOW sicuramente - via Dante Alighieri (e probabilmente anche via Dante Gabriele Rossetti) - si ricollegano al filo della tradizione religiosa cristiana, e sono riferite a CRISTO, concepito come LUCE, LEGGE, RE, DUCE.
E, ANCORA, per capire come e perché siano apparse le scritte "REX" e "DVX" sulla parete del SEDILE di Nardò (Lecce), bisogna RICORDARE chi era MARGHERITA GRASSINI SARFATTI e rileggere il suo "DVX" (sul tema, mi sia consento, cfr IL MITO DELLA ROMANITÀ E IL FASCISMO: MARGHERITA SARFATTI E RENZO DE FELICE).
E, INFINE, PER CAPIRE MEGLIO, E ALLA LUCE DEL SOLE ("INVICTUS"), IL SENSO DELLE "QUATTRO PAROLE" (LVX, LEX, REX, DVX), LEGGERE E RILEGGERE E ANCORA RILEGGERE LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ....
Federico La Sala
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- KANT E GRAMSCI. PER LA CRITICA DELL’IDEOLOGIA DELL’UOMO SUPREMO E DEL SUPERUOMO D’APPENDICE.
- INDIVIDUO E SOCIETA’ E COSTITUZIONE, IERI COME OGGI. USCIRE DALLO STATO DI MINORITA’, APRIRE GLI OCCHI: C’E’ DIO E "DIO", PATRIA E "PATRIA", E FAMIGLIA E "FAMIGLIA" .....
 ROMOLO AUGUSTOLO: L’ITALIA NON E’ NUOVA A QUESTI SCENARI. C’E’ CAPO E "CAPO" E STATO E "STATO": MUSSOLINI E LENIN A CONFRONTO. L’analisi di Gramsci (già contro derive staliniste!), una bussola per non naufragare e una lezione di vita e di libertà
ROMOLO AUGUSTOLO: L’ITALIA NON E’ NUOVA A QUESTI SCENARI. C’E’ CAPO E "CAPO" E STATO E "STATO": MUSSOLINI E LENIN A CONFRONTO. L’analisi di Gramsci (già contro derive staliniste!), una bussola per non naufragare e una lezione di vita e di libertà
EICHMANN A GERUSALEMME (1961). “come fu possibile la hitlerizzazione dell’Imperativo Categorico di Kant? E perché è ancora attuale oggi?” (Emil L. Fackenheim, Tiqqun. Riparare il mondo).
 HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI.
HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI."CHI" SIAMO NOI, IN REALTÀ. RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.
- (LAT.)
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- FAKE NEWS, WAKE NEWS, RELAZIONI AUTENTICHE E COSTITUZIONE.24 settembre 2017, di Federico La Sala
RELAZIONI AUTENTICHE: UN URLO PER L’ITALIA E PER LA COSTITUZIONE ... *
MOLTISSIME PERSONE SI MANTENGONO AL SICURO non solo dietro a un cellulare (in "prigione" da sole!), ma dietro a un "mito"! E finiscono per non capire un’acca, nemmeno la differenza tra il proprio padre e il proprio "padre", tra la propria madre e la propria "madre", e mangiano "fake news" per colazione, pranzo, e cena, felici e contente di vivere alla corte del ricco "diavolo" di turno, stravisto come il dio dell’eternità!!!
Se è vero come qualcuno ha detto che "non si può descrivere una passione, la si può solo vivere", allora è bene non perdere l’equilibrio critico e non perdere la propria sovranità (cfr. nota sulla "colomba" di Kant, al seguente link): NON SAPER distinguere più tra sovranità e "sovranità", tra re e "re", regina e "regina", e ridursi da cittadino a "cittadino", da cittadina a "cittadina", a suddito e a suddita di un falso re e di una falsa regina!!!
NEL REGNO DEL SONNAMBULISMO GENERALE, da vent’anni e più, gli italiani e le italiane sono diventati e diventate tutti e tutte "italiani" e "italiane" e tutti e tutte si sono messi e messe a a correre a gran "velocità" e a gridare "Forza Italia"!!! Che grande "fluidità"!!! Avanti tutta ....
PER NON PERDERE IL SALE CHE ANCORA ESISTE NELLA TERRA D’OTRANTO E IN TUTTA L’ITALIA, UN SOLO GRANDE URLO:
W o ITALY ... VIVA L’ITALIA!
BUON LAVORO!!!
Federico La Sala
* Cfr. Pierpaolo Tarsi, "Le relazioni autentiche", Fondazione Terra d’Otranto, 22.09.2017.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! - MA CON CHI SI SONO "SPOSATI"?! Con nessuna, con nessuno:nemmeno con se stessi.23 settembre 2017, di Federico La Sala
CONOSCI TE STESSO, CONOSCI TE STESSA!!! Dopo millenni di riflessione, la nostra identità ("tautòtes" - greco) ancora nella culla ...
Abito bianco, bomboniere e 70 invitati alla festa: in Brianza la prima sposa single d’Italia
"Se a 40 non ho ancora il fidanzato faccio il matrimonio con me stessa": Laura Mesi ha mantenuto la promessa. E ha organizzato un mega party costato 10mila euro, viaggio di nozze compreso. "Ecco la mia fiaba senza principe azzurro"
di LUCIA LANDONI *
- Dal taglio della torta alle bomboniere: il fotoracconto del matrimonio della sposa single di Lissone Laura, la prima sposa single: ’’Non divorzierò mai da me stessa, nemmeno per l’uomo della mia vita"
Abito bianco, bomboniere, taglio della torta, lancio del bouquet, familiari e amici commossi. Quello di Laura Mesi, 40enne istruttrice di fitness di Lissone (in provincia di Monza e Brianza), è stato un matrimonio tradizionale in tutto e per tutto, salvo per un particolare: mancava lo sposo.
"Sono la prima sposa single d’Italia. Qualche mese fa l’ha fatto anche un uomo di Napoli, ma a me l’idea era già venuta due anni fa. Avevo detto a parenti e amici che se entro il quarantesimo compleanno non avessi trovato la mia anima gemella mi sarei sposata da sola - spiega - Credo fermamente che ciascuno di noi debba innanzi tutto amare se stesso. Si può vivere una fiaba anche senza il principe azzurro. Se un domani troverò un uomo con cui progettare un futuro ne sarò felice, ma la mia felicità non dipenderà da lui".
- Dal taglio della torta alle bomboniere: il fotoracconto del matrimonio della sposa single di Lissone
Laura si è data da fare e ha organizzato in totale autonomia la sua cerimonia dei sogni: "Ho speso un po’ più di 10mila euro, pagando tutto di tasca mia. Ho fatto una piccola follia per il vestito e per le fedi, che sono due intrecciate in un unico anello. Grazie ai regali dei 70 invitati sono riuscita a coprire le spese del pranzo nuziale. Mi sono concessa anche il viaggio di nozze. Il giorno dopo la cerimonia, che si è tenuta in un ristorante di Vimercate, sono partita per Marsa Alam, sempre da sola".
Il matrimonio, celebrato da un amico che per l’occasione ha indossato una fascia tricolore, non ha alcun valore legale né religioso, ma la sposa garantisce che le emozioni provate sono state assolutamente reali: "Ho promesso di amarmi per tutta la vita e di accogliere i figli che la natura vorrà donarmi. Anche i miei familiari sono stati molto felici, compreso mio fratello che all’inizio era scettico sulla mia idea e invece poi ha finito per commuoversi accompagnandomi verso il celebrante".
Un’esperienza che la sposa single - seguita sull’omonima pagina Facebook da circa 1300 persone - ammette non essere per tutti: "Per portate avanti un progetto del genere servono una certa disponibilità economica, il sostegno di chi si ha intorno e soprattutto un pizzico di follia"
* LA REPUBBLICA, 21 SETTEMBRE 2017 (ripresa parziale - senza immagini).
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- NUOVO REALISMO: LA LEZIONE DI DANTE, OGGI. CONOSCERE SE STESSI E CHIARIRSI LE IDEE, PER CARITÀ!
 Per ben agire e ben comunicare (anche solo con se stessi o con stesse!), come insegna Dante, ci vogliono TRE SOLI (la cosiddetta - impropriamente - teoria dei "due soli")!!!
Per ben agire e ben comunicare (anche solo con se stessi o con stesse!), come insegna Dante, ci vogliono TRE SOLI (la cosiddetta - impropriamente - teoria dei "due soli")!!!
CONOSCI TE STESSO!!! Dopo millenni di riflessione, la nostra identità ("tautòtes" - greco) ancora nella culla o, meglio, nella bara ("taùto" - napoletano)
 LA FILOSOFIA E IL NARCISISMO "DIALOGICO". AMORE DELL’ALTRO O AMORE DI SE’? E’ LO STESSO. Una "risposta" di Umberto Galimberti
LA FILOSOFIA E IL NARCISISMO "DIALOGICO". AMORE DELL’ALTRO O AMORE DI SE’? E’ LO STESSO. Una "risposta" di Umberto GalimbertiFederico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- "Populismo digitale. La crisi, la rete e la nuova destra". Note a margine.19 settembre 2017, di Federico La Sala
PRAGMATICA DELLA COMUNICAZIONE E STRUMENTI DEL COMUNICARE. La Costituzione, le regole del gioco, il paradosso istituzionale del mentitore... e il "popolo della libertà"!!!
- NOTE A MARGINE di “Il digitale populista” di Lello Demichelis ("Alfabeta", 19.09.2017) per ampliare l’orizzonte e la riflessione...
- «La conversione della sinistra alle ragioni della destra neo-populista ha diverse giustificazioni - prima tra tutte l’incapacità del progressismo o della sinistra moderata di affrontare gli effetti perversi della globalizzazione [...]» (Alessandro Dal Lago).
- "Populismo digitale. La crisi, la rete e la nuova destra. Un libro che coniuga riflessione politica, storica e sociologica; analisi del mezzo digitale di comunicazione e di propaganda; e pensiero critico. E che compone uno sguardo comparato tra il vecchio populismo (come il peronismo argentino) e quello nella sua forma appunto digitale, in particolare del M5S di Beppe Grillo, passando per il neo-nazionalismo e il sovranismo" (Lelio Demichelis).
A) Ancora oggi, ci sono studiosi che sembrano “prendere sul serio il profetismo di Heidegger” e insistono a dare credibilità ai sogni dei visionari e dei metafisici (Alessandro Dal Lago, si cfr.: "Heidegger, Kant, e la miseria della filosofia - oggi": http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=4790)
B) MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA E A PENSARE BENE "DIO", "IO" E "L’ITALIA", CHI PIU’ CHI MENO, TUTTI VIVONO DENTRO LA PIU’ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA E POLITICA ITALIANA, NEL REGNO DI "FORZA ITALIA"(si cfr. http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=3539)
C)Il Narcisismo e l’uso lucidissimo come arma politica dell’"antinomia del mentitore" - "L’Italia è il mio Partito": "Forza Italia"(si cfr. http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=4371)
D) LA "PROFEZIA" DI MARSHALL MCLUHAN: NARCISO E LA MORTE DELL’ITALIA. Il "rimorso di incoscienza" di Marshall McLuhan (si cfr. http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=4112).
E) "A un individuo [ma anche a una intera società, fls] può capitare infatti di trovarsi sottoposto a due ordini contraddittori, convogliati attraverso lo stesso messaggio che Watzlawick chiama “paradossale”. Se la persona non riesce a svincolarsi da questo doppio messaggio la sua risposta sarà un comportamento interattivo patologico" (SCUOLA DI PALO ALTO (CALIFORNIA): PAUL WATZLAWICK. cfr. http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=2010)
F)FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO - POPULISMO DIGITALE. “La realtà come costruzione virale” (si cfr. http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=4829#forum3131196).
Federico La Sala
-
> PRAGMATICA DELLA COMUNICAZIONE E STRUMENTI DEL COMUNICARE. Populismo digitale o solamente para-fascismo?18 settembre 2017, di Federico La Sala
PRAGMATICA DELLA COMUNICAZIONE E STRUMENTI DEL COMUNICARE. La democrazia, l’antinomia istituzionale del mentitore e il populismo...*
Populismo digitale o solamente para-fascismo?
di Nello Barile (Doppiozero, 18.09.2017)
Per molti commentatori la “vera” sinistra è davvero poco attrezzata per affrontare le problematiche fondamentali del nostro tempo - come sostenne anni fa anche Christopher Lasch - mentre le uniche formazioni oggi capaci di farlo sono: una sinistra neolaburista che saccheggia politiche di destra importandole nel proprio programma oppure i movimenti populisti che si pongono come forze post-ideologiche ma che, in loro parecchie manifestazioni, assumono posizioni tipicamente di destra. Non è ancora chiaro se tale condizione sia solo di passaggio, ovvero un interregno tra il vecchio sistema e il nuovo, oppure se è già parte del nuovo che ha spazzato via alcune parti del vecchio (come l’idea classica di sinistra).
Tra gli autori che oggi invece confutano tale tesi, Alessandro Dal Lago nel suo Populismo digitale (Raffaello Cortina 2017) propone una critica serrata contro l’alleanza tra globalizzazione e cultura digitale, ma anche contro il populismo che rappresenta un modo sui generis di incrinare tale alleanza e di utilizzare le armi del digitale contro la globalizzazione. Per questo il testo esordisce con due citazioni in esergo che sono talmente stridenti da rendere bene il senso di questo passaggio problematico. Da un lato Antonio Gramsci che definisce la crisi come uno stato di sospensione in cui “il vecchio muore e il nuovo non può nascere”, dall’altro invece Gianroberto Casaleggio con la sua profezia su internet “supermedia che assorbirà tutti gli altri”. Due figure troppo diverse e sostanzialmente contraddittorie: se il primo rappresenta l’essenza intellettuale dell’ethos politico tradizionale, l’altro esprime l’essenza imprenditoriale dell’ethos post-politico.
Un contrasto perfetto che lancia il lettore in un’introduzione molto dinamica e accattivante, in cui la questione chiave del “come moriremo?” (prima democristiani, poi berlusconiani, poi renziani, adesso forse grillini) serve a rendere conto di uno dei temi centrali di tutto il testo: la velocità crescente del cambiamento, la perdita di riferimenti e il sostanziale movimento caotico dell’attuale sistema politico nazionale e globale. L’agente di tale trasformazione è ovviamente il digitale, evocato anche nel titolo e letto qui non tanto in termini deterministici ma come nuovo ecosistema che avvolge e sommerge la vecchia politica, trasformandola in qualcosa d’altro.
Una delle metafore che difatti Dal Lago predilige, riprendendola dal gruppo Ippolita (p. 16), è quella dell’acquario che ci mostra come la libertà assoluta promessa dal web sia a ben vedere recintata nello spazio circoscritto del virtuale, dunque una libertà paradossale.
 Per questo motivo egli ricorre al modello cognitivo del doppio vincolo (p. 19) per esaminare la nuova comunicazione politica. Lo stesso modello è, dal mio punto di vista, indispensabile per comprendere la logica dei brand (commerciali, politici, terroristici ecc.).
Per questo motivo egli ricorre al modello cognitivo del doppio vincolo (p. 19) per esaminare la nuova comunicazione politica. Lo stesso modello è, dal mio punto di vista, indispensabile per comprendere la logica dei brand (commerciali, politici, terroristici ecc.).
 Nella sua accezione originaria il doppio vincolo indica un difetto di comunicazione tra madre e figlio talché il secondo non è in grado di risolvere la contraddizione che si manifesta tra i messaggi di odio e di amore inviati dalla madre. Questa comunicazione paradossale mina il senso dell’identità dell’infante e può degenerare nella schizofrenia. Alcune espressioni come “La rete sei tu” oppure “Sei libero solo in rete” sono per l’autore eminentemente doppiovincoliste, ovvero utilizzate dai padroni della rete per esercitare un “controllo sulle procedure politiche formalmente democratiche” (ib).
Nella sua accezione originaria il doppio vincolo indica un difetto di comunicazione tra madre e figlio talché il secondo non è in grado di risolvere la contraddizione che si manifesta tra i messaggi di odio e di amore inviati dalla madre. Questa comunicazione paradossale mina il senso dell’identità dell’infante e può degenerare nella schizofrenia. Alcune espressioni come “La rete sei tu” oppure “Sei libero solo in rete” sono per l’autore eminentemente doppiovincoliste, ovvero utilizzate dai padroni della rete per esercitare un “controllo sulle procedure politiche formalmente democratiche” (ib).Se è vero che la digitalizzazione della cultura è uno degli aspetti chiave della globalizzazione (p. 23), a ben vedere la nuova cultura che si produce a partire dal web contiene in sé anche i germi della reazione alla globalizzazione. Per questo la rete è l’ambiente di coltivazione dei populismi contemporanei, non solo di quelli più marcatamente post-fascisti ma anche quelli di sinistra o vocatamente post-ideologici.
L’ascesa del populismo sul palcoscenico della politica globale coincide con lo svuotamento del significato della parola “popolo” (p. 29). Dal Lago offre una rassegna di molteplici interpretazioni moderne di tale concetto, anche per sottolineare la pericolosità di un suo riferimento diretto a una matrice etnica omogenea. Ad essa si contrappongono invece la concezione “morale” di Renan e quella più “finzionale” di Weber, secondo cui appunto “la volontà del popolo non è altro che una delle convenzioni (...) politiche necessarie a legittimare la rappresentanza” (p. 40).
Il dibattito sul populismo è ancora sospeso tra l’idea di una reazione integrale contro “l’espropriazione delle democrazie da parte delle oligarchie politiche” (Revelli 2017) e quella che invece vede la stessa sinistra moderata colpevole di un “tradimento di classe in favore dei diritti umani (LGBT, immigrati ecc.)” (Formenti 2016). Pertanto il populismo rischia di condurre le sinistre in un vicolo cieco, dato che “riconoscere come giuste le ragioni della destra significa legittimarla” (p. 51), in un pericoloso salto mortale in cui l’elettore è tendenzialmente persuaso a scegliere l’originale rispetto alla brutta copia.
La critica dell’autore alla nuova politica pervasa dalla rete si accentua quando si considera il populismo come una realtà immanente alla rete (p. 53). Il modo in cui l’affermazione di internet fa saltare in aria la distinzione tra pubblico e privato - pilastro delle democrazie moderne - ci indirizza verso una dimensione che dal mio punto di vista è definibile come neototalitaria (Barile 2008), in cui il privato è appunto irretito e messo a disposizione del pubblico.
La critica di Dal Lago insiste sulla separazione tra la dimensione virtuale e quella reale (p. 53) e definisce la nuova socialità mediata dalla rete come “disincarnata” rispetto a quella materiale e incarnata nei processi storici. Tra le due ci sarebbe la stessa relazione che intercorre tra pornografia e sessualità. L’idea secondo cui l’utente della rete tende a considerare lo schermo del computer come unica porta d’accesso alla realtà insiste forse su un paradigma obsoleto - da altri definito dualismo digitale - e impedisce di cogliere la totale integrazione tra il livello comunicativo-virtuale e quello della realtà fisica. Un’integrazione che sotto alcuni aspetti può essere ancor più pericolosa delle nuove forme di alienazione imposte dal digitale.
 Alcuni temi di questo approccio neocritico alla rete ritornano in un capitolo dal titolo davvero ammirevole: “La realtà come costruzione virale”. In esso si argomenta come l’interazione tra viralità e l’immediatezza del tempo reale impatta sui modi di costruzione/rappresentazione della realtà sociale, modificandola in base alle proprie funzioni.
Alcuni temi di questo approccio neocritico alla rete ritornano in un capitolo dal titolo davvero ammirevole: “La realtà come costruzione virale”. In esso si argomenta come l’interazione tra viralità e l’immediatezza del tempo reale impatta sui modi di costruzione/rappresentazione della realtà sociale, modificandola in base alle proprie funzioni.
 Per questo motivo Dal Lago riprende i temi di una più generale mutazione antropologica che ha dato vita al “soggetto digitale”, anche se quest’ultimo è ben diverso dal soggetto che ha abitato la cultura e la politica moderna. Molto distante dall’americano medio tipicamente eterodiretto che animava La folla solitaria di Riesman, il soggetto digitale ha semmai un problema di eccesso di autodirezione.
Per questo motivo Dal Lago riprende i temi di una più generale mutazione antropologica che ha dato vita al “soggetto digitale”, anche se quest’ultimo è ben diverso dal soggetto che ha abitato la cultura e la politica moderna. Molto distante dall’americano medio tipicamente eterodiretto che animava La folla solitaria di Riesman, il soggetto digitale ha semmai un problema di eccesso di autodirezione.Da ciò deriva anche uno smembramento drammatico del popolo in una molteplicità irriducibile di punti di vista e interessi di gruppi che utilizzano il web per amplificare i propri messaggi: “gli operai del Michigan che hanno votato Trump, gli agricoltori impoveriti del Midwest, gli studenti radicali dei campus, i Latinos, gli attivisti per i diritti LGBT... non possono essere rappresentati, tantomeno unificati da un’idea di medietà” (p. 67). L’unico comune denominatore tra tutti questi è l’essere in vario modo soggetti digitali, che appunto aderiscono alla modalità “disincarnata” d’azione mediata dal web. Dal Lago denuncia la crescente sparizione dei momenti “tradizionalmente sociali” della vita e del dibattito pubblico (p. 68), insieme allo svanimento delle esperienze faccia a faccia in “favore di mere estensioni digitali” (p. 69).
 Se è vero che questo processo di desertificazione sociale è una minaccia anche per altri mercati, come ad esempio la moda in cui l’esperienza urbana dello shopping potrebbe essere sostituita totalmente dall’e-commerce e dai sistemi di delivery (l’autore fa l’esempio di Amazon), è anche vero che questo è solo il più radicale e forse meno probabile tra gli scenari possibili (quello che io chiamo “isolation”), mentre invece il più probabile ci racconta di una sostanziale fusione tra mondo digitale e fisico, tra bit e atomi, in nuove modalità d’interazione al contempo reali e virtuali. Dopo un’analisi impeccabile sulla trasformazione sistemica, l’autore torna a insistere sulla dimensione psicologica con immagini che talvolta hanno il sapore di un’altra epoca. Come “la persona in carne e ossa seduta davanti allo schermo” che in tal modo “acquista una seconda identità o meglio perde quella relazionale e sociale a favore di una virtuale” (p. 73).
Se è vero che questo processo di desertificazione sociale è una minaccia anche per altri mercati, come ad esempio la moda in cui l’esperienza urbana dello shopping potrebbe essere sostituita totalmente dall’e-commerce e dai sistemi di delivery (l’autore fa l’esempio di Amazon), è anche vero che questo è solo il più radicale e forse meno probabile tra gli scenari possibili (quello che io chiamo “isolation”), mentre invece il più probabile ci racconta di una sostanziale fusione tra mondo digitale e fisico, tra bit e atomi, in nuove modalità d’interazione al contempo reali e virtuali. Dopo un’analisi impeccabile sulla trasformazione sistemica, l’autore torna a insistere sulla dimensione psicologica con immagini che talvolta hanno il sapore di un’altra epoca. Come “la persona in carne e ossa seduta davanti allo schermo” che in tal modo “acquista una seconda identità o meglio perde quella relazionale e sociale a favore di una virtuale” (p. 73).Il discorso di Dal Lago si mostra molto più efficace nella disamina delle pratiche linguistiche concrete, come nel caso dell’analisi degli articoli e dei post che alimentano il dibattito online e offline sull’immigrazione. La stessa trasformazione della dialettica politica a opera di trolls, haters ecc. dimostra questo cambiamento qualitativo del dibattito pubblico, dato che certe espressioni offensive non potrebbero essere usate in una situazione “reale” senza degenerare nello scontro fisico. Cosicché, come anche Mark Thompson (2017), Dal Lago denuncia il fatto che “lo stile prevalente dei dibattiti online sta creando una cultura linguistica del tutto coerente con le iperboli del populismo digitale” (p. 84). Di particolare interesse sono le pagine in cui si elencano le caratteristiche del fenomeno squisitamente televisivo del peronismo, per confrontarle con quelle dei diversi digital-populismi di oggi. Una riflessione che consente all’autore di introdurre il concetto di para-fascismo, riferito specialmente al Movimento 5 Stelle, dalla “arroganza bislacca del capo” alla sua “passione per i plebisciti e per le performance sportivo-pubblicitarie” (p. 113).
Tale definizione ha ovviamente fatto risentire gli attivisti e i simpatizzanti del Movimento che, in una sorta di chiusura del circuito, hanno risposto con toni polemici sul profilo Facebook dell’autore. A differenza di altri studiosi di sinistra che stanno rivalutando il discorso populista con maggiore cautela - come Carlo Formenti ne La variante populista che insiste molto più sulla reazione del populismo contro il comune nemico della finanza globalista - Dal Lago non concede alcuna legittimazione né alla retorica, né alla pretesa neutralità post-ideologica del populismo, insistendo invece sulla sua matrice identitaria e autoritaria, propria dell’ideologia forte che lo ha preceduto.
*
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- LA "PROFEZIA" DI MARSHALL MCLUHAN: NARCISO E LA MORTE DELL’ITALIA. Il "rimorso di incoscienza" di Marshall McLuhan
- SCUOLA DI PALO ALTO (CALIFORNIA): PAUL WATZLAWICK.
Il Narcisismo e l’uso lucidissimo come arma politica dell’"antinomia del mentitore"
UNA QUESTIONE DI ECO. L’orecchio disturbato degli intellettuali italiani
UNITÀ D’ITALIA E FOLLIA: EMERGENZA LOGICO-POLITICA EPOCALE. PER UN CONVEGNO E UNA RIFLESSIONE SUL CONCETTO DI ’UNITA’ E DI SOVRANITÀ (SOVRA-UNITÀ).
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! - IL PATRARCATO: UNA CATTOLICA, UNIVERSALE, ALLEANZA "EDIPICA" E UNA GUERRA CONTRO LE DONNE.18 settembre 2017, di Federico La Sala
UNA CATTOLICA, UNIVERSALE, ALLEANZA "EDIPICA"!!! IL MAGGIORASCATO: L’ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE, L’ALLEANZA DELLA MADRE CON IL FIGLIO, REGNA ANCORA COME IN TERRA COSI’ IN CIELO ... *
- L’ormai enorme letteratura femminista ha messo in luce, tra le altre cose, l’identificazione delle donne, dei loro corpi, della loro capacità riproduttiva con la “comunità”, il “territorio”, la tradizione, l’identità (etnica, nazionale) e dunque il futuro. Di qui l’esigenza di dominare e controllare le “nostre” donne, nonché lo sconcerto e il disagio maschili di fronte alla libertà rivendicata e agita dalle donne (Tamar Pitch).
Una guerra contro le donne
di Tamar Pitch (Il Mulino, 18 settembre 2017)
Chi stupra è sempre l’Altro: i neri per i bianchi, i poveri per i ricchi, gli stranieri per gli autoctoni, e viceversa. Lo stupro è ciò che distingue “il noi”, gli uomini che sposiamo, da “gli altri”, gli uomini che stuprano. Lo stupro, nonché l’accusa di stupro, segna un confine. Un confine, tuttavia, tra gli uomini: noi e loro si riferisce infatti al modo prevalente, sia nell’immaginario sia nelle pratiche e nelle norme, con cui lo stupro è visto e vissuto dagli uomini. E da alcune donne, certo, visto che partecipiamo di questa cultura. Da cui si evince che misoginia e sessismo sono sempre intrecciate a razzismo e xenofobia.
L’ormai enorme letteratura femminista ha messo in luce, tra le altre cose, l’identificazione delle donne, dei loro corpi, della loro capacità riproduttiva con la “comunità”, il “territorio”, la tradizione, l’identità (etnica, nazionale) e dunque il futuro. Di qui l’esigenza di dominare e controllare le “nostre” donne, nonché lo sconcerto e il disagio maschili di fronte alla libertà rivendicata e agita dalle donne.
Stupri e femminicidi vengono così raccontati diversamente a seconda di chi sono gli autori e le loro vittime. Orrore e scandalo quando una di “noi” (ossia una che è ritenuta appartenere al gruppo dei maschi autoctoni, o comunque di quelli cui la “comunità” si riferisce) è violentata o uccisa da uno di “loro”. Perplessità e incredulità quando è uno di “noi” a stuprare e uccidere. In ambedue i casi, il vissuto e la soggettività delle donne sono ignorate. O ci si erge a protettori e vendicatori di chi ha osato mettere le mani su una “cosa” nostra (e dunque in qualche modo le vere “vittime” non sono le donne, ma questi “noi”) oppure “quella se l’è cercata”, ci ha “sfidato”, e in fondo dunque si merita quello che le è capitato. È singolare come questo tipo di narrazione sia ancora così presente, nei nostri media, tradizionali e nuovi, quando invece la vita, l’esperienza e la soggettività femminili sono tanto mutate. Ciò che infatti manca a questa narrazione sono precisamente le voci delle donne, che, interrogate, racconterebbero, tutte, l’onnipresenza della violenza maschile: per strada, al lavoro, ma ancor di più dentro le sicure mura di casa. Se c’è un confine che lo stupro traccia, è quello tra gli uomini e le donne (o chi è “ridotto” nella posizione femminile). Non tutti gli uomini sono stupratori, ma tutti gli stupratori sono uomini, diceva già trent’anni fa Ida Dominjanni.
Stupri e femminicidi avvengono ovunque nel mondo, e nella maggior parte dei casi ad opera di uomini che le donne conoscono bene, mariti fidanzati padri fratelli amici e così via. Poi ci sono gli stupri invisibili, quelli di cui poco o niente si sa e si dice, quelli che non vengono riconosciuti come tali, a danno delle sex workers o, ancor peggio, delle ragazzine prostituite sulle nostre strade, da parte dei suddetti mariti e padri (di altre). Nonché degli uomini delle forze dell’ordine (su cui c’è un’ampia letteratura) che si avvalgono del loro potere di ricatto e dell’omertà diffusa. Perché le sex workers non sono per definizione proprietà di alcun uomo ( a parte il loro eventuale protettore, ma di questo parlo più avanti) e sono quindi di tutti: loro sì, se vengono violentate o uccise, “se la sono cercata”. E gli integerrimi italiani che vanno con le ragazzine, sempre più spesso minorenni, vittime di tratta, non sono forse, per le nostre stesse leggi, violentatori seriali?
Una vittima, per essere riconosciuta tale, deve avere caratteristiche e comportamenti che rispondono allo stereotipo della donna o ragazza “perbene”, ma deve anche essere violentata, meglio in strada e di giorno, da uno (se di più, meglio) sconosciuto, meglio se povero e scuro di pelle. E meglio ancora se questa vittima urla o viene visibilmente ferita. Sembra incredibile quanto questo sia vero, per i media, a quasi quarant’anni dal documentario Processo per stupro e dopo le mille battaglie femministe e la nuova ondata rappresentata dal movimento Nonunadimeno, che riprende l’analogo movimento nato in Argentina e poi diffusosi in tutta l’America Latina.
 Insomma, le donne si muovono ormai a livello globale contro violenze e sopraffazioni di uomini singoli o in gruppo e contro le istituzioni che fanno poco per contrastare queste violenze o addirittura le legittimano. I contesti sociali, culturali, politici sono diversi e questa diversità va presa in considerazione per capire le differenze quantitative e qualitative della violenza maschile contro le donne, ma sempre di patriarcato si dovrebbe parlare: ossia di un sistema complesso di potere e dominio maschili onnipervasivi, per battere il quale non bastano certo parità e pari opportunità (negli anni Settanta dicevamo che no, non era metà della torta che volevamo, ma una torta del tutto diversa). Questo sistema è in crisi per via del fatto che sempre più donne gli negano consenso e complicità, cosa che in certi casi può esacerbare violenza e ferocia.
Insomma, le donne si muovono ormai a livello globale contro violenze e sopraffazioni di uomini singoli o in gruppo e contro le istituzioni che fanno poco per contrastare queste violenze o addirittura le legittimano. I contesti sociali, culturali, politici sono diversi e questa diversità va presa in considerazione per capire le differenze quantitative e qualitative della violenza maschile contro le donne, ma sempre di patriarcato si dovrebbe parlare: ossia di un sistema complesso di potere e dominio maschili onnipervasivi, per battere il quale non bastano certo parità e pari opportunità (negli anni Settanta dicevamo che no, non era metà della torta che volevamo, ma una torta del tutto diversa). Questo sistema è in crisi per via del fatto che sempre più donne gli negano consenso e complicità, cosa che in certi casi può esacerbare violenza e ferocia.Si ha l’impressione che sia in corso una guerra contro le donne, e tra uomini, per il controllo delle donne e dei loro corpi. È una guerra combattuta con le armi e con gli stupri e, oggi, anche con e su i social media. Difficile, se non impossibile, sconfiggere il patriarcato (soltanto) con il diritto penale. Del quale ci si può e ci si deve servire, naturalmente, ma sempre sapendo che la giustizia penale, a sua volta, è connotata da sessismo, razzismo e classismo. I decreti sicurezza (da ultimo quello firmato Minniti) parlano appunto questa lingua: non sono solo razzisti e classisti, sono anche sessisti, laddove è del tutto ovvio che il soggetto standard di questi decreti è maschio, adulto, non troppo povero. Berlusconi proponeva di mettere un poliziotto a fianco di ogni bella donna (le brutte si arrangiassero). Magari meglio una poliziotta...
Le politiche e le retoriche della sicurezza tendono a una specie di sterilizzazione del territorio urbano, mirano a rendere invisibili povertà e disagio, a recintare più o meno simbolicamente lo spazio dei perbene a difesa dai permale. Ma, benché esse si avvalgano spesso dell’evocazione del femminile (bisogna proteggere donne, vecchi, bambini: i cosiddetti soggetti vulnerabili), sono del tutto cieche e inutili, se non controproducenti, rispetto al contrasto delle violenze contro le donne. Le quali, come dicevo, non avvengono solo e nemmeno soprattutto negli angoli bui delle vie cittadine. Ho detto e scritto più volte che, se seguissimo fino in fondo la logica delle politiche di sicurezza, allora, per proteggere le donne, dovremmo cacciare tutti gli uomini da ogni casa, città, Paese, continente, universo mondo.
Una città, un Paese, un continente sono “sicuri” per tutti se le donne, tutte le donne, possono attraversarli liberamente, di giorno, di notte, vestite come vogliono, ubriache o sobrie. La libertà, per le donne, è un esercizio ancora difficile e contrastato, praticamente ovunque. Ci muoviamo, più o meno consapevolmente, con prudenza, ci neghiamo, più o meno consapevolmente, molte delle libertà di cui gli uomini godono senza rendersene conto. Gesti, atteggiamenti, parole, comportamenti maschili ci ricordano tutti i giorni che dobbiamo stare attente (non serve proprio che ce lo ribadiscano sindaci, ministri, poliziotti), l’aggressione e la violenza sono sempre in agguato. Però, è esattamente il contrario che serve: ai tempi si diceva “riprendiamoci la notte”, e anche adesso andiamo per le strade per dire che vogliamo andare e fare ciò che più ci piace, senza protettori.
Già, il termine protettore. In italiano ha un’ambivalenza significativa: il protettore delle donne che si prostituiscono è precisamente la figura simbolo della protezione maschile, una protezione che implica soggezione e acquiescenza, pena non solo l’abbandono ma la punizione. Sottrarsi alla protezione, sia reale sia introiettata, è invece un passo necessario per affermare la propria libertà. Ed è ciò che le donne, singolarmente e collettivamente, stanno facendo.
*
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- CIVILTA’ DELL’AMORE E VOLONTA’ DI GUERRA. DOPO GIOVANNI PAOLO II, IL VATICANO SOPRA TUTTO E CONTRO TUTTI. Il "peccato originale" e la "mala fede" antropo-teo-logica di Papa Ratzinger.
- DONNE, UOMINI E VIOLENZA: "Parliamo di FEMMINICIDIO". Dalla democrazia della "volontà generale" alla democrazia della "volontà di genere". L’importanza della lezione dei "PROMESSI SPOSI", oggi.
L’EREDE: IL PESO DEI PADRI (ATEI E DEVOTI). UN’EREDITA’ ANCORA PENSATA ALL’OMBRA DELL’"UOMO SUPREMO" E DEL "MAGGIORASCATO".
LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89).
PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!
 FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! - LA FILOLOGIA CLASSICA, LA POLITICA, E CARLO AZEGLIO CIAMPI.17 settembre 2017, di Federico La Sala
IL PENSIERO DELLA COSTITUZIONE E LA COSTITUZIONE DEL PENSIERO... *
La politica non è per gli ignoranti
Per Carlo Azeglio Ciampi studiare Filologia classica o guidare la Banca d’Italia “è la stessa cosa”. Serve disciplina intellettuale, rispetto dei documenti e ricerca della verità. Valori e metodi di cui oggi i leader sono purtroppo privi
di Salvatore Settis (Il Fatto, 17.09.2017)
Normalista dal 1937 al 1941, Ciampi si laureò a Pisa in Filologia classica. Suoi maestri furono il grande filologo Giorgio Pasquali e la papirologa Medea Norsa; fra i suoi compagni di corso c’era Scevola Mariotti, altro grande filologo che sarebbe stato suo amico di una vita.
Della Norsa, Ciampi ricordava le sofferenze dovute alle leggi razziali, ma anche la generosità di Gentile, che nel 1939 pubblicò con lo stemma della Normale (di cui era allora direttore) un volume della Norsa che un editore fiorentino aveva bloccato in ultime bozze per ragioni di “razza”.
La tesi di Ciampi era dedicata a Favorino, un retore di lingua greca del II secolo d.C., amico di Plutarco e attivo anche alla corte dell’imperatore Adriano, con cui ebbe però un contrasto finendo poi in esilio. Favorino commentò allora : “È davvero stupido criticare qualcuno che ha al suo servizio trenta legioni”. Il testo a cui è dedicata la tesi di Ciampi è una sorta di auto-consolazione filosofica “sull’esilio”, dove tra l’altro viene affermata un’idea di “patria” non come luogo di nascita, ma d’elezione: per Favorino, nato ad Arles, la vera patria era Roma, con la sua vita culturale multilingue e incomparabile.
Dopo la formazione filologica e malgrado la passione per l’insegnamento, la guerra impresse alla vita di Ciampi tutt’altro corso. Ma l’imprinting filologico della Normale non fu mai dimenticato, e lo mostra un episodio del 6 dicembre 2000, quando, da Presidente, Ciampi venne in Normale in visita ufficiale.
Egli volle allora incontrare i normalisti, e per un’ora si intrattenne a colloquio con essi con grande cordialità, tanto che qualche allievo della Scuola si prese qualche confidenza forse eccessiva, a cui Ciampi reagiva divertito. Un normalista chiese al Presidente : “Ma come mai Lei, che ha studiato filologia classica, è poi passato alla Banca d’Italia?”. Ciampi, fattosi serio senza perdere il tono affabile di quella conversazione, rispose: “È la stessa cosa. Studiando filologia classica in Normale ho imparato una disciplina intellettuale, il rispetto dei documenti e la ricerca della verità: principî che mi hanno accompagnato alla Banca d’Italia, a Palazzo Chigi, al Quirinale”.
Ma che cosa intendeva Ciampi con quelle parole, che non erano una gratuita battuta, ma una professione di fede? Io credo che con quel suo “È la stessa cosa” Ciampi intendesse due valori diversi ma convergenti: la pienezza dell’impegno civile e la centralità della competenza specifica. Virtù, quando ci sono, ugualmente importanti per un filologo classico, per un Governatore della Banca d’Italia e per un Presidente del Consiglio o della Repubblica. La Normale, Ciampi lo ripeteva spesso, è scuola di vita anche perché il suo carattere competitivo impone ritmi di lavoro inconsueti, innescando abitudini fondate sull’intensità e la densità del lavoro, sulla serietà dell’impegno personale, su un’applicazione profonda ed esclusiva ai problemi che di volta in volta si studiano. Dal lavoro solitario del normalista in biblioteca al senso di responsabilità del cittadino che si mette al servizio della comunità, Ciampi vedeva una continuità necessaria, una comune esigenza morale.
Non meno importante era stata, nel contesto degli anni Trenta, l’orgogliosa rivendicazione che la filologia debba avere piena cittadinanza non solo come mera tecnica di costituzione dei testi, ma come strumento di interpretazione storica. Quando Pasquali aveva scritto sulla Nuova Antologia del 1931 un articolo sulla Paleografia quale scienza dello spirito, stava reagendo alla concezione crociana della filologia come “utile e servizievole”, ma “senza splendori”, poiché “la filologia non è la critica e non è la storia”, discipline che esigono, scrive Croce, “robustezza di coordinato pensiero”.
 Riassumendo anni dopo i termini di quella polemica, un altro grande maestro della Normale, Augusto Campana, definiva la paleografia, e con essa la filologia, come discipline “non semplicemente classificatorie, descrittive, meccaniche”, ma “miranti alla visione e ricostruzione di uno sviluppo storico, specchio e fattore della cultura in organica connessione con ogni altra componente di essa”: una forma di conoscenza piena e non ancillare.
Riassumendo anni dopo i termini di quella polemica, un altro grande maestro della Normale, Augusto Campana, definiva la paleografia, e con essa la filologia, come discipline “non semplicemente classificatorie, descrittive, meccaniche”, ma “miranti alla visione e ricostruzione di uno sviluppo storico, specchio e fattore della cultura in organica connessione con ogni altra componente di essa”: una forma di conoscenza piena e non ancillare.La filologia come strumento e strategia per accostarsi non solo ai testi, ma ai problemi; non solo alla storia, ma alla realtà amministrativa e politica; non solo al passato, ma al presente. Questa concezione di Ciampi dava continuità alla sua vita di studio e di lavoro; era un’etica della competenza della quale sentiamo oggi più che mai il bisogno. L’idea che anche per chi fa politica e ha responsabilità di governo sia necessaria la minuta conoscenza dei fatti, la precisione delle informazioni, l’accuratezza nel comunicare ai cittadini quel che si sta facendo o quel che occorrerebbe fare: virtù che troppo spesso appaiono tramontate (speriamo non per sempre).
Ci è toccato invece assistere, in questi anni, al trionfo dell’incompetenza, alla sagra delle chiacchiere. Non farò alcun nome ma citerò un solo episodio, per il suo valore esemplare: qualcuno, che ricopriva un’altissima carica di governo, pur essendo laureato in giurisprudenza scambiò impunemente un ordine del giorno in Costituente (l’odg Perassi, 4 settembre 1946) per una norma transitoria (inesistente) della Costituzione, e come tale la citò ripetutamente in pubbliche argomentazioni politiche, e a proposito di una proposta di riforma costituzionale.
Altri esempi, credo, non occorrono: tutti siamo bersagli e vittime di un imperversante storytelling, secondo cui la verità dei fatti è irrilevante, e quel che importa non è se un’affermazione sia vera o falsa, ma quale beneficio apporta a chi la fa. Perciò ci tocca subire litanie di statistiche inventate o truccate senza alcuno scrupolo, e sentirle cambiare, o meglio improvvisare, da un giorno all’altro a seconda di scadenze elettorali o altre contingenze, e senza alcun rispetto per la verità; ci tocca vedere al tempo stesso la mortificazione di chi è competente, ma costretto a emigrare per mancanza di lavoro, e il trionfo arrogante di chi, pur senza sufficienti competenze specifiche, occupa posizioni di rilievo nelle pubbliche amministrazioni.
Ci tocca, e davvero vien da chiedersi quousque tandem?, vedere sulla scena politica schieramenti basati sulle appartenenze e sulle convenienze, e non sull’analisi dei problemi e sulla competenza professionale; e in nome di meri giochi di potere abbiamo visto e vediamo sbriciolarsi i dati di fatto, sparire all’orizzonte la precisione e l’attendibilità delle analisi, svanire nel nulla il pubblico interesse.
Il fermo richiamo di Ciampi alla filologia (cioè alla competenza) nell’esercizio della politica è qualcosa di cui l’Italia non ha mai avuto tanto bisogno come oggi. Se vogliamo ricordarlo senza cadere in tentazioni agiografiche, è a questa sua lezione morale che dobbiamo con altrettanta fermezza richiamarci, ripetendo senza sosta che la politica ha davvero bisogno di competenza, ha bisogno di filologia. Ne ha bisogno, oggi, più che mai.
*
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- LA REPUBBLICA DEL PRESIDENTE: CARLO AZEGLIO CIAMPI E LA COSTITUZIONE COME "BIBBIA CIVILE". Un "quaderno" di documentazione della "Voce di Fiore" sulla Presidenza Ciampi
 ITALIA, 1999-2006. La Repubblica del Presidente. Gli anni di Carlo Azeglio Ciampi.
ITALIA, 1999-2006. La Repubblica del Presidente. Gli anni di Carlo Azeglio Ciampi.
- TEORIA E STORIA DELLA STORIOGRAFIA. IL PROBLEMA GIAMBATTISTA VICO E IL PROBLEMA DELLA COSTITUZIONE
 CROCE “CRISTIANO” , VICO “ATEO”, E L’UOMO DELLA PROVVIDENZA.
CROCE “CRISTIANO” , VICO “ATEO”, E L’UOMO DELLA PROVVIDENZA.
FILOSOFIA. IL PENSIERO DELLA COSTITUZIONE E LA COSTITUZIONE DEL PENSIERO
 MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA E A PENSARE BENE "DIO", "IO" E "L’ITALIA", CHI PIU’ CHI MENO, TUTTI VIVONO DENTRO LA PIU’ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA E POLITICA ITALIANA, NEL REGNO DI "FORZA ITALIA"!!! Un’inchiesta e una mappa
MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA E A PENSARE BENE "DIO", "IO" E "L’ITALIA", CHI PIU’ CHI MENO, TUTTI VIVONO DENTRO LA PIU’ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA E POLITICA ITALIANA, NEL REGNO DI "FORZA ITALIA"!!! Un’inchiesta e una mappa - LA REPUBBLICA DEL PRESIDENTE: CARLO AZEGLIO CIAMPI E LA COSTITUZIONE COME "BIBBIA CIVILE". Un "quaderno" di documentazione della "Voce di Fiore" sulla Presidenza Ciampi
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- La miseria della politica, il "Vaffa day" di Grillo, e il situazionismo.16 settembre 2017, di Federico La Sala
LA QUESTIONE MORALE.
LA COSTITUZIONE, LA NOSTRA “BIBBIA CIVILE” ...*
Il Vaffa di Grillo ha origini nel situazionismo di Debord e Gallizio
Non tutti sanno che il nucleo fondativo di quel pensiero trovò accoglienza nel 1957 in un paesino dell’entroterra ligure
di Pino Pisicchio *
Nella miseria dei giorni della politica contemporanea si sono dovute ascoltare anche le celebrazioni per il decennale del "Vaffa day". Potrebbe essere una parabola tutta italiana, un segno dei tempi macilenti che ci toccano in dote. Eppure, forse con qualche preterintenzionalità, quelle celebrazioni hanno un senso. Anche dal punto di vista culturale.
Infatti, ciò che la base elettorale, il vertice dei dirigenti, il sinedrio degli eletti dei Cinquestelle ma anche l’universo dei giornalisti laureati e dei maître à penser usi a invadere Tv, testate ed editrici blasonate, non sanno, è che i grillini, contrariamente a quanto si possa immaginare, un pensiero nobile ce l’hanno, eccome.
E quel Vaffa day lo interpreta perfettamente. Il pensiero nobile grillino, però, non è quella minestra- brodo primordiale lanciata col nome di Gaia da Casaleggio senior nella rete qualche anno fa, con sembianze oniriche stile new age. No. O meglio: la storia dell’agorà virtuale è la fissa aziendale che ha mostrato di funzionare egregiamente sulla base del principio: "urla, offendi, cavalca il mostro che si muove nelle viscere della rete e farai tanti adepti".
La vera grande ispirazione culturale discende, invece, dai rami del Situazionismo di Pinot Gallizio e di Debord, rielaborazione dada della filosofia trozkista, nella convinzione che la borghesia crassa e decadente soggiogata dalla società dello spettacolo, sarebbe stata abbattuta con le stesse armi ma rivolte contro.
Insomma un pensiero spiazzante, indecente e arrabbiato. Ora non tutti sanno che il nucleo fondativo di quel pensiero trovò accoglienza nel 1957 in un paesino dell’entroterra ligure, Cosio di Arroscia, in provincia di Imperia, con un grappolo di stralunati pensatori, pittori, artisti a vario titolo, provenienti da mezza Europa, una sorta di comunità beatnik avanti lettera.
In Italia, dunque, anzi, in quella striscia un po’ nordica, un po’ mediterranea che è la Liguria. A Genova e dintorni, infatti, si insediò un nucleo di resistenti, discepoli sulla scia dell’insegnamento di Debord, tutti apprendisti stregoni della tv, sperimentatori, mischiatori di generi, ritagliatori di suggestioni e di irriverenze.
Marco Giusti, Antonio Ricci, Carlo Freccero, Enrico Ghezzi. E Beppe Grillo. Sì, proprio lui. Che ha sublimato l’idea primigenia del situazionismo offrendo il suo corpo e la sua cacofonia alla causa. Con Grillo, infatti, Debord ha visto compiuta la sua utopia dello sberleffo al potere con i voti di quella che una volta si sarebbe chiamata borghesia e che oggi invece somiglia all’informe ventre di un popolo celibe. E nubile (per parità di genere).
Cos’è, allora, il "Vaffa day" se non il gesto situazionista per antonomasia? Cos’è lo stesso Grillo, con la sua faccia, il suo mestiere di comico, la sua perenne coprolalia brandita come arma contundente? Ma è chiaro: è la vittoria politica di Debord nell’unico consorzio umano al mondo dove poteva attecchire il suo pensiero: la società italiana. Non a caso la Bibbia dei Situazionisti fu il suo libro: "La società dello Spettacolo ".
* Il blog Pino Pisicchio, Presidente gruppo Misto Camera Deputati, The Huffingtonpost, 11.09.2017.
*
- SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
 LA COSTITUZIONE, LA NOSTRA “BIBBIA CIVILE” ....
LA COSTITUZIONE, LA NOSTRA “BIBBIA CIVILE” ....
 L’ITALIA, LA CARTA D’IDENTITA’ TRUCCATA, E GLI SFORZI FALLITI DEL PRESIDENTE CIAMPI DI ROMPERE L’INCANTESIMO DI "FORZA ITALIA"!!! Una nota di Arrigo Levi
L’ITALIA, LA CARTA D’IDENTITA’ TRUCCATA, E GLI SFORZI FALLITI DEL PRESIDENTE CIAMPI DI ROMPERE L’INCANTESIMO DI "FORZA ITALIA"!!! Una nota di Arrigo Levi Per la Costituzione - e il dialogo, quello vero ...
Per la Costituzione - e il dialogo, quello vero ...
 "ITALIA". AMARE L’ITALIA: RIPRENDIAMOCI LA PAROLA. VAFFA-DAY?! ONORE A BEPPE GRILLO. Contro la vergognosa confusione dell’ "antipolitica" in Parlamento e della "politica" in Piazza, l’invito ad uscire dalla "logica" del "mentitore". Una lettera (2002), con un intervento di Beppe Grillo (la Repubblica, 2004).
"ITALIA". AMARE L’ITALIA: RIPRENDIAMOCI LA PAROLA. VAFFA-DAY?! ONORE A BEPPE GRILLO. Contro la vergognosa confusione dell’ "antipolitica" in Parlamento e della "politica" in Piazza, l’invito ad uscire dalla "logica" del "mentitore". Una lettera (2002), con un intervento di Beppe Grillo (la Repubblica, 2004).Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! - Perché le filosofe accademiche sono così poche? (di Valeria Ottonelli)11 settembre 2017, di Federico La Sala
PER LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. DAL "CHE COSA" AL "CHI": UNA NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.... *
Perché le filosofe accademiche sono così poche?
Professione filosofa
di Valeria Ottonelli (il mulino, 11 settembre 2017)
Gli organizzatori dell’ultimo convegno della Società europea di filosofia analitica, conclusosi da poco a Monaco di Baviera, segnalano che solo il 25% dei 700 partecipanti erano donne. Il dato conferma una strana anomalia della disciplina, che è stata ampiamente discussa fra gli addetti ai lavori. Pur essendo collocata fra le scienze umane, la filosofia, in Europa come negli Stati Uniti e altri Paesi occidentali, registra percentuali di presenze femminili tipiche delle «Stem sciences», come la fisica, l’ingegneria e la matematica, ossia percentuali molto basse. Negli Stati Uniti, ad esempio, le donne sono solo il 21% dei filosofi accademici, mentre nel resto delle altre discipline umanistiche superano il 40%. In Gran Bretagna, le donne sono il 24% dei filosofi di ruolo. Questi dati sembrano essere trasversali ai diversi sistemi universitari e della ricerca dei Paesi occidentali, e sono confermati anche in Italia, dove, per fare un esempio paradigmatico, dei 136 filosofi teoretici in ruolo (ricercatori, associati, ordinari) solo 32 sono donne (meno di un quarto, dunque), rispetto a una presenza ormai consolidata nelle scienze umane.
I filosofi non sono gli unici accademici a essere in questa situazione e di per sé, a fronte delle enormi sperequazioni che ancora esistono nel nostro Paese e in tutto il mondo occidentale fra donne e uomini, le differenze di carriera accademica in una disciplina tutto sommato marginale (non me ne vogliano i miei colleghi) come la filosofia possono apparire irrilevanti. Tuttavia, l’«anomalia» rappresentata dalla filosofia in questo ambito è un reale rompicapo teorico, che può servire come utile spunto di riflessione sulla nostra percezione delle diseguaglianze di genere.
Infatti, la presenza di percentuali così basse di donne fra i filosofi fa saltare alcuni schemi classici di spiegazione di tali diseguaglianze, primo fra tutti quello secondo cui le donne sarebbero più portate o interessate alle scienze umane. Nella sua versione nobile, questa concezione attribuisce alle donne una maggiore attenzione per gli ambiti della realtà che hanno a che fare con il vivente; da qui la scarsa passione femminile per l’ingegneria o la matematica e la presenza notevole, invece, nelle scienze biologiche, oltre che nella psicologia e altre discipline umanistiche. Ma la filosofia, si direbbe, ha a che fare col vivente e a tutti gli effetti è una scienza umana. Inoltre, a giudicare dalle immatricolazioni ai corsi universitari di filosofia, le donne sono interessate alla disciplina, a differenza di quello che succede ad esempio con le scienze ingegneristiche. È dopo, man mano che si procede coi livelli successivi di istruzione e carriera, che si osserva una curva sistematicamente decrescente di presenza, per culminare in percentuali minime (sotto il 20%) fra i professori ordinari. Come si spiega questa dispersione, dato l’evidente interesse iniziale?
I siti dedicati, come What Is It Like to Be a Woman in Philosophy?, abbondano di aneddoti e racconti sulle angherie subite dalle donne filosofe ad opera dei colleghi maschi, in cui primeggiano forme più o meno pesanti di abuso sessuale e le abituali storie di mobbing post-maternità. Ma a meno di non voler ipotizzare che i filosofi maschi siano speciali e peggiori del resto della specie umana, come si spiega che lo stesso non accade con altre discipline umanistiche?
Si potrebbe forse ipotizzare che questi processi siano casuali. Può succedere, ad esempio, che per ragioni del tutto contingenti per un certo periodo in un dato ambiente si insedi una percentuale molto bassa di donne, e che questo sbilanciamento si autoreplichi nel tempo, proprio per l’assenza di una massa critica femminile adeguata. Ma se fosse casuale, come potrebbe questo fenomeno verificarsi praticamente ovunque, e anche in contesti accademici relativamente isolati fra di loro?
Nella letteratura conservatrice non mancano - non potrebbero mancare - le spiegazioni basate sull’idea che la sparizione delle filosofe man mano che si procede con la carriera sia dovuta semplicemente al fatto (a quanto pare dimostrato) che la distribuzione del Qi, fra le donne, si concentra su valori medi, ma tocca le vette dei valori più alti (e gli abissi di quelli più bassi) più raramente di quanto non accada fra gli uomini. Ma basta dare un rapido sguardo alla popolazione dei filosofi accademici (di nuovo, non me ne vogliano i colleghi) per capire che questa correlazione fra Qi e rendimento nella carriera filosofica non è plausibile.
Una spiegazione accreditata è che in filosofia conti più l’autorevolezza percepita che la reale preparazione e che questo faccia sì che le donne, percepite sistematicamente (anche questo è provato) come meno autorevoli, abbiano meno successo. Sebbene questa sia una spiegazione adottata da molte filosofe che si sono occupate del problema, per amore della disciplina c’è da sperare che non sia vera, perché dimostrerebbe che essenzialmente la filosofia è un’attività più simile al fare a pugni che al pensare.
Così, la gran parte delle spiegazioni che vengono generalmente offerte per le diseguaglianze di genere in ambito accademico e in altri ambiti sociali, nel caso della filosofia si rivela inadeguata, denigratoria o tirata per i capelli, ma questo non impedisce che tutte vengano richiamate con insistenza nel dibattito, dando l’impressione che molti (compresi molti filosofi) quando si tratta di diseguaglianze di genere si adagino semplicemente su schemi di interpretazione consolidati.
Il caso della filosofia, anche se relativamente defilato rispetto ad altri fenomeni più eclatanti e rilevanti socialmente, serve così a ricordarci che, a fronte di una letteratura sociologica, filosofica e psicologica ormai copiosa e molto raffinata sulle cause delle diseguaglianze di genere nella nostra società, e di un dibattito pubblico che almeno a tratti sembra avere acquisito consapevolezza della gravità del fenomeno, resta da fare molto lavoro, anche teorico, su questo aspetto così pervasivo e così problematico della nostra organizzazione sociale.
*
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- GIAMBATTISTA VICO: OMERO, LE DONNE, E I "NIPOTINI" DI PLATONE
- DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
"CHI" SIAMO NOI, IN REALTÀ. RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- in Germania cancellata la performance di Bifo che paragona crisi dei migranti e Olocausto: “Bigotti” (di F. Moramarco).5 settembre 2017, di Federico La Sala
Auschwitz on the Beach, in Germania cancellata la performance di Bifo che paragona crisi dei migranti e Olocausto: “Bigotti”
L’attivista e filosofo bolognese avrebbe dovuto esibirsi nell’ambito della celebre mostra di arte contemporanea Documenta14. Ma è stato sommerso dalla polemiche. Il ministro della cultura tedesco Boris Rhein e il sindaco di Kassel Christian Geselle hanno addirittura chiesto l’intervento della magistratura. Lui spiega a ilfattoquotidiano.it: "E’ la bigotteria di gente che ha ripetuto molte volte ’mai più Auschwitz’ e tuttavia non tollera che qualcuno gli faccia presente che in realtà Auschwitz sta accadendo di nuovo sotto i nostri occhi e con la nostra complicità"
di Felice Moramarco *
In Germania non si può paragonare la crisi dei migranti all’Olocausto degli ebrei, nemmeno se a farlo è un artista. Ha ricevuto critiche durissime la performance dal titolo Auschwitz on the Beach scritta dal filosofo e attivista bolognese Franco “Bifo” Berardi, prevista per il 24 agosto scorso nell’ambito della famosa mostra di arte contemporanea “documenta 14” a Kasselin Germania. La performance aveva come tema la crisi dei rifugiati, che secondo l’autore, ha assunto i tratti inquietanti di un olocausto. Proprio a causa delle polemiche, gli organizzatori di documenta 14 e Berardi hanno deciso di cancellare l’evento e sostituirlo con un incontro pubblico dal titolo Shame on Us, che ha visto una larghissima partecipazione. Molte sono state le accuse di relativizzare la tragedia dello sterminio degli ebrei. Si sono uniti alle critiche anche il ministro della cultura tedesco Boris Rhein e il sindaco di Kassel Christian Geselle, i quali hanno addirittura chiesto l’intervento della magistratura. Tuttavia c’è stato anche chi, come Philippe Ruch del Zentrum für Politische Schönheit si è chiesto se sia effettivamente così fuori luogo paragonare i campi di concentramento costruiti sulle coste libiche con l’avvallo degli stati Europei ai lager nazisti. Proprio in queste ore, la ong Moas ha interrotto i salvataggi nel Mediterraneo dicendo di non sapere cosa succede nei centri in Libia. E il parallelo con l’olocausto è stato fatto solo domenica 3 settembre alla Festa del Fatto Quotidiano dall’editorialista Furio Colombo: “Questa è la seconda Shoah”, ha detto durante un dibattito con il ministro dell’Interno Marco Minniti.
Immaginavate che l’annuncio di una performance dal titolo Auschwitz on the Beach sarebbe stato accolto in questo modo?
Noi europei stiamo ripetendo quello che i nazisti fecero negli anni ’40. Qualcuno potrebbe dire che questa è una esagerazione, ma certo che è un’esagerazione! Tuttavia, bisogna tener presente che per il momento abbiamo ucciso almeno trentamila migranti nel mar Mediterraneo. E non sappiamo quanti ne abbiamo uccisi nel deserto del Sahara e quanti cadaveri ci siano nelle fosse comuni libiche. Questo era quello che volevamo denunciare.
É risaputo che in Germania temi ed espressioni legate al loro passato nazista costituiscono ancora una ferita aperta.
Io sono disposto ad ascoltare questa obiezione dai rappresentanti della comunità ebraica tedesca, con cui ho infatti discusso. Ma non sono disposto ad ascoltare questa obiezione da qualche stronzetto che scrive sui giornali della “Grande Germania”, perché sono i nazisti tedeschi, che non sono mai scomparsi, ad aver inferto quella ferita all’umanità. Mio padre durante la guerra ha passato sette mesi in un carcere tedesco, quindi non accetto che un pezzo di merda come il signor Jens Jessen sulla Zeit mi venga a dire che quella ferita è ancora aperta, perché è proprio gente come lui che ha inferto quella ferita a gente come mio padre.
Allora perché avete deciso di cancellare la performance?
L’abbiamo cancellata perché la nostra intenzione non era tanto quella di mettere in scena un’opera d’arte, ma quella di lanciare un messaggio. Dato quello che è successo, cancellare la performance ci ha permesso di far circolare quel messaggio dieci, cento volte di più di quanto non sarebbe stato possibile se ci fossimo fatti intrappolare dalla retorica della libertà d’espressione. In gioco c’è qualcosa di molto più importante della mia libertà d’espressione. Non me ne frega niente della mia libertà d’espressione, quando in gioco c’è la vita di milioni di donne e di uomini!
L’unica cosa resa pubblica della performance è stato quindi il titolo.
Esatto.
E come si spiega che l’accostamento di due semplici parole, “Auschwitz” e “Beach” abbia innescato un dibattito così acceso?
Perché quell’espressione ha provocato la bigotteria del ceto neoliberale tedesco. La bigotteria di gente che ha ripetuto molte volte “mai più Auschwitz” e tuttavia non tollera che qualcuno gli faccia presente che in realtà Auschwitz sta accadendo di nuovo sotto i nostri occhi e con la nostra complicità. Sulla stampa tedesca sono stati pubblicati più di un centinaio di articoli da questi bigotti. Ma è il mio mestiere provocare, l’ho sempre fatto. Per mesi, sono stato su tutti i giornali italiani [nel 1977, n.d.r], descritto come provocatore e criminale, perché parlavo da una radio libera [Radio Alice, ndr]. E allora imparai che occorre non lasciarsi mai spaventare da gente come questa.
Non pensa che chi ha reagito in questo modo sia in realtà ben cosciente di ciò che sta accadendo e che semplicemente non vuole prendere atto delle proprie responsabilità.
Certamente. In gioco c’è qualcosa di enorme. Noi occidentali dobbiamo far fronte alle conseguenze di secoli di colonialismo e di quindici anni di guerra ininterrotta, di cui siamo totalmente responsabili. Ora, l’enorme debito che abbiamo accumulato, non vogliamo pagarlo. Ci rifiutiamo di investire le enormi somme di denaro necessarie per l’accoglienza dei migranti e preferiamo darle a Banca Etruria, al Monte dei Paschi e al sistema finanziario europeo. Bene, questo atteggiamento provoca la guerra. Una guerra che è già cominciata e che non vinceremo, perché abbiamo a che fare con un immenso esercito di disperati. Perderemo tutto. Perderemo la vita di molta gente, perderemo la democrazia e il senso dell’umanità.
* Il Fatto, 4 settembre 2017 (ripresa parziale - senza immagini).
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- «Auschwitz on the beach». Kassel: un’interv. con Franco Berardi Bifo che ha rinunciato alla sua performance, dopo le polemiche1 settembre 2017, di Federico La Sala
Auschwitz, la parola che fa ammutolire
Un’intervista con Franco Berardi Bifo che ha rinunciato alla sua performance a Kassel, dopo le polemiche suscitate dal titolo «Auschwitz on the beach»
di Lorenza Pignatti (il manifesto, 01.09.2017)
KASSEL Alcune parole sembrano essere impronunciabili, tale è la loro forza e risonanza nell’immaginario collettivo. Una di queste è indubbiamente Auschwitz, come dimostra il clamore che la performance Auschwitz on the beach di Franco Berardi Bifo, Dim Sampaio e Stefano Berardi (era programmata per documenta14 a Kassel, dal 23 al 26 agosto), ha suscitato nella stampa internazionale e nella comunità ebraica, tanto da condurre alla sua cancellazione. In un incontro pubblico, ospitato in The Parliament of Bodies, Berardi ha spiegato le motivazioni che lo hanno spinto a scrivere quel testo per la performance dall’innominabile titolo.
Era consapevole che la sua performance avrebbe suscitato tanto scalpore?
Dopo molte esitazioni, avevo deciso di usare l’espressione provocatoria Auschwitz on the beach affinché quel nome potesse essere uno «scudo», una protezione contro il pericolo, a mio parere sempre più attuale, che Auschwitz ritorni. Gunther Anders, nel libro Noi figli di Eichmann, nel 1967 scrisse di un possibile ritorno del nazismo in una società in cui la tecnica ha il sopravvento sull’uomo. Non è forse Auschwitz il primo esperimento di una gestione industrializzata e tecnologica dello sterminio? Quello a cui assistiamo oggi è l’inizio di uno sterminio basato sulla supremazia razzista. Pensiamo agli oltre 30mila migranti morti nel Mediterraneo negli ultimi quindici anni e alle decisioni politiche di far rimpatriare i migranti in Libia, dove è probabile che siano torturati o uccisi. E poi si descrivono le Ong - come Medici senza frontiere - in veste di taxisti del mare, quando invece sono organizzazioni che salvano la vita a migliaia di persone.
Sterminio su base etnica. Non è forse legittimo ravvisare gli estremi del nazismo e della supremazia razziale?
Kim Jong-un ha dichiarato che gli occidentali devono smettere di pensare che le guerre riguardino solo gli altri paesi perché ora anche loro sono in grado di portare la morte. E sappiamo che questo è vero, così come sappiamo che dopo l’11 settembre, con la guerra voluta dagli Stati Uniti, un esercito di suicidi terrorizza le città europee, da Parigi a Berlino, da Nizza a Barcellona.
 Ricordo quando nel 2004 ho guardato le immagini delle torture di Abu Ghraib in televisione. Ho subito pensato alle conseguenze che quelle immagini avrebbe potuto avere sui milioni di bambini mediorientali che le vedevano non solo in Iraq, in Egitto o in Afghanistan ma anche a Parigi o a Londra. Ora ne conosciamo le conseguenze con i kamikaze che si tolgono la vita indossando cinture esplosive o guidando furgoni per uccidere persone che passeggiano nelle città europee, ed è nostro compito cercare di cambiare tale deriva disumana. La pace, l’accoglienza e la solidarietà sono gli unici modi da attuare per sfuggire a una guerra che stiamo già perdendo, che distruggerà la nostra vita quotidiana e le nostre città.
Ricordo quando nel 2004 ho guardato le immagini delle torture di Abu Ghraib in televisione. Ho subito pensato alle conseguenze che quelle immagini avrebbe potuto avere sui milioni di bambini mediorientali che le vedevano non solo in Iraq, in Egitto o in Afghanistan ma anche a Parigi o a Londra. Ora ne conosciamo le conseguenze con i kamikaze che si tolgono la vita indossando cinture esplosive o guidando furgoni per uccidere persone che passeggiano nelle città europee, ed è nostro compito cercare di cambiare tale deriva disumana. La pace, l’accoglienza e la solidarietà sono gli unici modi da attuare per sfuggire a una guerra che stiamo già perdendo, che distruggerà la nostra vita quotidiana e le nostre città.Al posto della performance è stato organizzato un incontro pubblico che è stato molto emozionante. Si aspettava tanta partecipazione?
Si era acceso un acceso dibattito dopo che la stampa - tedesca, americana, inglese - aveva criticato la performance e alcuni centri di cultura ebraica avevano accusato gli organizzatori di documenta14 di violenza simbolica contro la memoria. Oltre ad aver cancellato la performance, prima dell’incontro pubblico serale, io, Paul B. Preciado e Adam Szymczyk, rispettivamente direttore del programma pubblico e direttore artistico della mostra, ci siamo recati al principale centro ebraico della città.
 Abbiamo discusso le nostre motivazioni, i rappresentanti hanno riconosciuto che la performance non aveva un carattere antisemita, pur ribadendo che Auschwitz appartiene alla storia e alla memoria ebraica, e hanno ricordato che nel 1938 gli ebrei tedeschi subirono da parte delle autorità americane e inglesi lo stesso rifiuto che oggi i migranti ricevono dalle autorità europee. Un numero incalcolabile di ebrei sono morti nei campi di concentramento nazisti perché inglesi e americani rifiutarono di accoglierli come rifugiati, con le stesse motivazioni con le quali oggi i governi europei respingono siriani o nigeriani. Diversi rappresentanti sono venuti anche all’incontro serale, intitolato Shame on us. La loro presenza è stata determinante per decostruire i malintesi e riflettere sull’emergere di nuove forme di razzismo. Pur non rinunciando alle mie motivazioni politiche e filosofiche, ho riconosciuto di non avere il diritto di procurare ulteriore dolore alla comunità ebraica, e ho annullato la lettura del testo scritto per la performance.
Abbiamo discusso le nostre motivazioni, i rappresentanti hanno riconosciuto che la performance non aveva un carattere antisemita, pur ribadendo che Auschwitz appartiene alla storia e alla memoria ebraica, e hanno ricordato che nel 1938 gli ebrei tedeschi subirono da parte delle autorità americane e inglesi lo stesso rifiuto che oggi i migranti ricevono dalle autorità europee. Un numero incalcolabile di ebrei sono morti nei campi di concentramento nazisti perché inglesi e americani rifiutarono di accoglierli come rifugiati, con le stesse motivazioni con le quali oggi i governi europei respingono siriani o nigeriani. Diversi rappresentanti sono venuti anche all’incontro serale, intitolato Shame on us. La loro presenza è stata determinante per decostruire i malintesi e riflettere sull’emergere di nuove forme di razzismo. Pur non rinunciando alle mie motivazioni politiche e filosofiche, ho riconosciuto di non avere il diritto di procurare ulteriore dolore alla comunità ebraica, e ho annullato la lettura del testo scritto per la performance.«Shame on us» è stato quindi il titolo dell’incontro...
Diversi messaggi ricevuti dai nostri accusatori ci dicevano che dovevamo vergognarci. E, in effetti, è accaduto: la vergogna riguardava però il fatto che nessuno di noi riesce a fermare le forme di fascismo che scandiscono l’agenda mediatica nazionale e internazionale. Mi preoccupa l’impotenza rispetto agli atti di brutalità a cui stiamo assistendo. Nel giugno 2016, mentre gli inglesi votavano per la Brexit e gli americani ascoltavano Trump, Zbigniew Brzezinski ha pubblicato un articolo intitolato Toward a Global Realignment. Nel testo rifletteva su quanto i massacri e le guerre compiute dai colonizzatori occidentali si siano risolti nello sterminio dei popoli colonizzati: la scala era paragonabile ai crimini del nazismo della seconda guerra mondiale, provocando centinaia di migliaia e talvolta milioni di vittime. Dovremmo accusare Brzesinski di antisemitismo e di relativizzare il nazismo? Non direi. Il politico americano di origini polacche, consigliere durante la presidenza di Jimmy Carter, scrive che il nazismo è l’aspetto più disumano che abbia caratterizzato la storia della nostra specie. Tale disumanità sta riemergendo nella società contemporanea sia come vendetta da parte degli oppressi, sia come sommossa razzista da parte della popolazione bianca che si sente minacciata e impotente rispetto alla perdita di potere e alla propria supremazia razziale.
Sta facendo riferimento agli eventi di Charlotteville?
Non solo a quelli. Sarebbe ingenuo circoscriverli agli Stati Uniti. L’arrogante supremazia razziale, che è parte della storia del colonialismo occidentale, ha portato all’elezione di Trump, alla Brexit, e alle tante manifestazioni di intolleranza e razzismo a cui assistiamo ogni giorno. Solo l’Internazionalismo proletario avrebbe potuto evitare che la resa dei conti del colonialismo passato e contemporaneo diventasse un bagno di sangue planetario. Ma il comunismo è stato sconfitto e ora vi è la guerra di tutti contro tutti in nome di niente.
Nel corso della sua lunga carriera si è occupato di politica, attivismo, «cognitariato» e semiocapitalismo. Nei suoi ultimi testi, in particolare modo il romanzo «Morte ai vecchi» e «Heroes. Suicidio e omicidi di massa», i toni sono diventati più distopici, terminali: perché?
Forse la risposta a questa domanda sta nelle cose, non nella mia personale evoluzione. La sconfitta del comunismo (della quale i comunisti sono i primi a portare la responsabilità) ha cancellato l’orizzonte internazionalista, cioè l’orizzonte di una possibile solidarietà tra gli oppressi e gli sfruttati, tra operai occidentali e masse dei paesi colonizzati. Ogni forma di solidarietà è stata cancellata dal prevalere dell’ideologia neoliberale e dalla precarietà. Competizione è diventato l’imperativo di ogni relazione sociale. Ora siamo alla precipitazione: gli effetti di trent’anni di egemonia neoliberale e di capitalismo finanziario hanno distrutto il tessuto sociale nei paesi occidentali, e hanno reso possibile una diffusione degli armamenti più distruttivi. L’apocalisse è all’ordine del giorno, non perché la vede qualche esagerato come me, ma perché il capitalismo porta la guerra come la nube porta la tempesta (Lenin).
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A PENSARE BENE "Dio", "Io", "Italia" ... Democrazie personalizzate (di G. Corbellini).29 agosto 2017, di Federico La Sala
INDIVIDUO, SOCIETA’, E COSTITUZIONE. IERI COME OGGI: USCIRE DALLO STATO DI MINORITA’, APRIRE GLI OCCHI!!! C’E’ DIO E "DIO", PATRIA E "PATRIA", E FAMIGLIA E "FAMIGLIA" ...
Scienze psicosociali
Democrazie personalizzate
 Per Platone, politica e morale sono due facce della stessa medaglia e il governo giusto è solo quello dei filosofi, che sanno cosa è la giustizia.
Per Platone, politica e morale sono due facce della stessa medaglia e il governo giusto è solo quello dei filosofi, che sanno cosa è la giustizia.
 Aristotele, invece, preferisce discutere la politica come dimensione dell’esperienza sociale indipendente dall’etica
Aristotele, invece, preferisce discutere la politica come dimensione dell’esperienza sociale indipendente dall’eticadi Gilberto Corbellini (Il Sole-24 Ore, Domenica, 27.8.2017)
- Gian Vittorio Caprara, Michele Vecchione, Personalizing Politics and Realizing Democracy , Oxford University Press, New York, pagg. 420, $ 58
Per Platone, politica e morale sono due facce della stessa medaglia e il governo giusto è solo quello dei filosofi, che sanno cosa è la giustizia. Aristotele, invece, preferisce discutere la politica come dimensione dell’esperienza sociale indipendente dall’etica. Non tanto perché le forme della virtù siano irrilevanti, ma in quanto, se si ha di mira il bene generale, è disfunzionale decidere una forma di governo partendo da doti etiche personali. Meglio chiedersi sotto quale tipo di legge (costituzione) sarebbe preferibile vivere.
Sono dovuti trascorrere quasi due millenni, ed è occorsa la provocazione di Macchiavelli (ma quale etica, è tutto lecito in politica!), per rendersi conto che i valori della convivenza civile si possono stabilire concordemente, per vie democratiche, attraverso leggi nelle quali tutti si riconoscono e che sono uguali per tutti; piuttosto che lasciarli decidere, i valori, dai politici che di volta in volta per le loro personalità/capacità intercettano i favori popolari. La selezione naturale non poteva prevedere che per la convivenza civile nelle innaturali società moderne si dovessero inventare lo stato di diritto, il libero mercato, l’epistemologia scientifica, il rispetto degli estranei, i diritti umani, etc. Le sensibilità per questi valori non sono innate, come provano le scienze cognitive. Scaturiscono da processi storico-sociali che hanno manipolato, provvisoriamente, predisposizioni psicologiche individuali polimorfiche, dando luogo a repertori e combinazioni di profili comportamentali, quindi preferenze valoriali e infine orientamenti politico-ideologici, che si combinano e ricombinano nei gruppi umani per rispondere a continue e diverse sfide o instabilità dettate da dinamiche ecologiche in senso lato.
La psicologia della personalità è un terreno fertile per studiare e ragionare delle basi comportamentali della politica e per capire quali forme di organizzazione della convivenza umana sono più congeniali alle disposizioni individuali e sociali umane.
 In un denso e lucido libro, Gian Vittorio Caprara e Michele Vecchione argomentano che la democrazia è un’«impresa morale che si fonda ampiamente sulla moralità pubblica dei suoi cittadini», e che la divaricazione ideologica tra destra e sinistra o tra liberali e conservatori intercetta tratti fondamentali della personalità, che nell’evoluzione della cultura politica occidentale si strutturano preferibilmente attraverso questa tipologia di identificazione politica, in ragione dei valori morali e politici associati a questi piani.
In un denso e lucido libro, Gian Vittorio Caprara e Michele Vecchione argomentano che la democrazia è un’«impresa morale che si fonda ampiamente sulla moralità pubblica dei suoi cittadini», e che la divaricazione ideologica tra destra e sinistra o tra liberali e conservatori intercetta tratti fondamentali della personalità, che nell’evoluzione della cultura politica occidentale si strutturano preferibilmente attraverso questa tipologia di identificazione politica, in ragione dei valori morali e politici associati a questi piani.Non è di personalizzazione della politica nel senso tradizionale che parla il libro, cioè delle caratteristiche psicologiche dei leader votati dagli elettori e che sembrano contare sempre più, ma di come i tratti e i valori delle personalità dei cittadini concorrono al funzionamento di un sistema politico. Nondimeno si parla anche del fatto, corroborato da studi empirici, che le somiglianze di personalità tra politici ed elettori giocano un ruolo nelle scelte di voto.
Il libro espone dati, analisi e proposte fondate su due influenti paradigmi della psicologia della personalità e della psicologia sociale umana: il modello dei Big Five e la tassonomia dei valori umani fondamentali di Shalom H. Schwartz.
 I cinque “grandi” tratti selezionati nei primi decenni del secondo dopoguerra sulla base di studi lessicali e analisi fattoriali, come noto, sono: apertura mentale (quanto una persona è inventiva e curiosa piuttosto che cauta e conservatrice), amicalità (quanto una persona è fiduciosa, altruista e cordiale, piuttosto che egoista e sospettosa) coscienziosità (quanto è efficiente e scrupolosa, piuttosto che superficiale e disattenta), estroversione (quanto è energica e socievole, piuttosto che solitaria e chiusa) e, infine, stabilità emotiva (quanto è vulnerabile alle emozioni negative come l’ansia o l’angoscia, o tende alla depressione, piuttosto che sicura di sé e fiduciosa).
I cinque “grandi” tratti selezionati nei primi decenni del secondo dopoguerra sulla base di studi lessicali e analisi fattoriali, come noto, sono: apertura mentale (quanto una persona è inventiva e curiosa piuttosto che cauta e conservatrice), amicalità (quanto una persona è fiduciosa, altruista e cordiale, piuttosto che egoista e sospettosa) coscienziosità (quanto è efficiente e scrupolosa, piuttosto che superficiale e disattenta), estroversione (quanto è energica e socievole, piuttosto che solitaria e chiusa) e, infine, stabilità emotiva (quanto è vulnerabile alle emozioni negative come l’ansia o l’angoscia, o tende alla depressione, piuttosto che sicura di sé e fiduciosa).
 Numerosi studi dicono che le personalità caratterizzate da apertura e socievolezza tendono a essere progressiste, mentre quelle coscienziose, sono conservatrici. Qualche ricerca trova che le persone che spiccano come amicali tendono a essere di sinistra in economia e di destra nelle politiche sociali, mentre vale il contrario per gli emotivamente instabili. L’estroversione non produce effetti preferenziali. Esiste anche una letteratura che usa i Big Five per mappare geograficamente i tratti di personalità prevalenti in diverse aree degli Stati Uniti, spiegando in questo modo, cioè come concentrazione di persone con tratti simili, gli orientamenti ideologici e i comportamenti di voto costanti, per i repubblicani o per i democratici, in diversi stati.
Numerosi studi dicono che le personalità caratterizzate da apertura e socievolezza tendono a essere progressiste, mentre quelle coscienziose, sono conservatrici. Qualche ricerca trova che le persone che spiccano come amicali tendono a essere di sinistra in economia e di destra nelle politiche sociali, mentre vale il contrario per gli emotivamente instabili. L’estroversione non produce effetti preferenziali. Esiste anche una letteratura che usa i Big Five per mappare geograficamente i tratti di personalità prevalenti in diverse aree degli Stati Uniti, spiegando in questo modo, cioè come concentrazione di persone con tratti simili, gli orientamenti ideologici e i comportamenti di voto costanti, per i repubblicani o per i democratici, in diversi stati.Non è questa la sede per discutere i limiti del fortunatissimo modello dei Big Five, che non ha una base teorica e trova però alcune conferme a livello neurobiologico, ma non genetico. Ora, i tratti non danno informazioni a livello motivazionale: sono differenze individuali dimensionabili per quanto riguarda delle tendenze a mostrare schemi di azioni, affetti e pensiero coerenti.
L’israeliano Schwartz ha quindi costruito, partendo dalle ricerche dell’olandese Geert Hofstede sulle dimensioni delle differenze culturali e valoriali transnazionali, una tassonomia di dieci valori riscontrabili nelle principali culture, i quali funzionano come credenze, desideri o scopi che hanno effetti motivazionali per la persona: autodirettività, stimolazione, edonismo, realizzazione, potere, sicurezza, conformità, tradizione, benevolenza, universalismo.
 Questi valori strutturano in quattro gruppi che definiscono l’apertura al cambiamento (primi due), l’autoaffermazione (successivi tre), la conservazione (successivi tre) e l’auto-trascendenza (ultimi due), e sono tra loro interconnessi e sovrapposti. In che misura le dinamiche relazioni tra i valori correlano con o predicono orientamenti ideologici e scelte elettorali?
Questi valori strutturano in quattro gruppi che definiscono l’apertura al cambiamento (primi due), l’autoaffermazione (successivi tre), la conservazione (successivi tre) e l’auto-trascendenza (ultimi due), e sono tra loro interconnessi e sovrapposti. In che misura le dinamiche relazioni tra i valori correlano con o predicono orientamenti ideologici e scelte elettorali?Schwartz, Caprara e Vecchioni hanno suggerito otto “nuclei valoriali politici” che definiscono preferenze socio-economiche e culturali che contano per le persone in quanto espressione sul piano ideologico della loro visione morale: equità, libera concorrenza, morale tradizionale, legge e ordine, patriottismo fanatico, libertà civili, accettazione degli immigrati, interventismo militare.
 Esaminando prima due elezioni politiche italiane, 2006 e 2008, e quindi testando le preferenze valoriali e politiche in altri paesi europei, anche post-comunisti, gli autori hanno trovato che le ideologie tradizionali sono ancora i migliori predittori di voto, anche se i dati consigliano di guardare oltre la divisione destra-sinistra e progressisti-conservatori, per cogliere complessivamente i determinanti valoriali delle scelte politiche. Infatti, al di là di chiare differenze si notano comunanze tra i votanti. Per esempio, autodirettività e universalismo sono apprezzati più che potere e realizzazione nella maggior parte dei Paesi studiati, non solo come prevedibile da chi è di sinistra/progressista, ma anche per chi è di destra/conservatore.
Esaminando prima due elezioni politiche italiane, 2006 e 2008, e quindi testando le preferenze valoriali e politiche in altri paesi europei, anche post-comunisti, gli autori hanno trovato che le ideologie tradizionali sono ancora i migliori predittori di voto, anche se i dati consigliano di guardare oltre la divisione destra-sinistra e progressisti-conservatori, per cogliere complessivamente i determinanti valoriali delle scelte politiche. Infatti, al di là di chiare differenze si notano comunanze tra i votanti. Per esempio, autodirettività e universalismo sono apprezzati più che potere e realizzazione nella maggior parte dei Paesi studiati, non solo come prevedibile da chi è di sinistra/progressista, ma anche per chi è di destra/conservatore.Per quanto riguarda gli atteggiamenti politici, gli elettori di sinistra/progressisti sono per politiche di equa distribuzione delle risorse e delle opportunità e per le libertà civili (di agire e pensare), mentre quelli di destra/conservatori preferiscono politiche attente ai valori familiari e religiosi tradizionali, all’applicazione della legge e liberiste in economia. Ma questi ultimi danno un’importanza a eguaglianza e libertà civili non molto distante da chi è dell’ideologia opposta.
Per gli autori «i dati suggeriscono che gli atteggiamenti e le scelte politiche degli elettori dipendono meno che in passato dal menu offerto loro dai partiti e dai politici. Oggi i cittadini sono agenti proattivi, le cui priorità largamente dettano il tipo di menu che i partiti politici e i politici dovrebbero servire. Di fatto, più i cittadini sono consapevoli dei loro diritti, specialmente della libertà di esprimere le loro opinioni, più le rappresentazioni mentali di sé e le visioni del mondo personali dettano le loro scelte individuali». Il che dovrebbe suscitare ottimismo per il futuro della democrazia nella misura in cui un buon sviluppo della personalità si trasferisce nel buon funzionamento della democrazia. Ma nonostante le messe di dati e modelli utili che offre alla riflessione, il libro non spiega perché si dovrebbe essere ottimisti.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
CRISI POLITICA E "SACRA FAMIGLIA" [UNITA]!!! NON SOLO LA TEOLOGIA (E LA FILOSOFIA), MA NEMMENO LA SOCIOLOGIA SA DISTINGUERE TRA FAMIGLIA DEMOCRATICA E FAMIGLIA DI "MAMMASANTISSIMA" E DI "MAMMONA"...
 "FAMILISMO AMORALE" E SOCIETA’. LA FAMIGLIA CHE UCCIDE: IL LATO OSCURO DELLA FAMIGLIA.
"FAMILISMO AMORALE" E SOCIETA’. LA FAMIGLIA CHE UCCIDE: IL LATO OSCURO DELLA FAMIGLIA.ITALIA: STORIA E POLITICA (1513-2013). MACHIAVELLI CONTRO OGNI TIRANNIA E CONTRO OGNI POPULISMO: C’E’ CAPO E "CAPO" E STATO E "STATO"!!!
 LA QUESTIONE DELLO STATO: "IL PRINCIPE" O MEGLIO "DE PRINCIPATIBUS" (1513).
LA QUESTIONE DELLO STATO: "IL PRINCIPE" O MEGLIO "DE PRINCIPATIBUS" (1513).INDIVIDUO E SOCIETA’ E COSTITUZIONE, IERI COME OGGI. USCIRE DALLO STATO DI MINORITA’, APRIRE GLI OCCHI: C’E’ DIO E "DIO", PATRIA E "PATRIA", E FAMIGLIA E "FAMIGLIA" ...
 C’E’ CAPO E "CAPO" E STATO E "STATO"
C’E’ CAPO E "CAPO" E STATO E "STATO" -
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- Sulla Rete le pagine «nere» conquistano un milione di nostalgici del Duce. La ricerca dell’Anpi (di G. Rancilio).22 agosto 2017, di Federico La Sala
FILOSOFIA. IL PENSIERO DELLA COSTITUZIONE E LA COSTITUZIONE DEL PENSIERO...
La ricerca.
Sulla Rete le pagine «nere» conquistano un milione di nostalgici del Duce
Facebook ospita 2.700 profili di propaganda fascista: almeno 300 profili inneggianti Forza Nuova e Casa Pound. La ricerca dell’Anpi
Souvenir del fascismo (da internet)
di Gigio Rancilio *
Perché Facebook non rimuove le pagine social che, in contrasto con la legge Scelba, fanno apologia del fascismo? Leggendo la policy internazionale del social network più grande del mondo non si trova traccia di alcun divieto in questo senso. La scusa di Facebook è che «i nostri standard devono valere in ogni Paese» mentre - aggiungiamo noi - l’apologia del fascismo è vietata solo in Italia (come in Germania quella del nazismo). Quindi non si può proprio fare niente? La stessa Facebook Italia consiglia di segnalare contenuti e pagine illegali alla Polizia Postale o all’Unar (Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale). «Dopo una loro verifica, Fb avvierà la rimozione di tali contenuti e pagine». A parole è tutto perfetto (o quasi). Ma alla prova dei fatti sembra che le cose vadano diversamente. Lo dimostra il fatto che molte delle pagine Fb che fanno apologia del fascismo sono già state segnalate all’Unar a febbraio: in cinque mesi avrebbero già dovuto essere sottoposte al centro di controllo di Facebook e rimosse dal social. Ma sono ancora lì.
Che i social network premino le posizioni estreme (in tutti i campi) è un dato di fatto. Ma la denuncia dell’Anpi fa comunque effetto: «Su Facebook ci sono circa 2.700 pagine in italiano di propaganda fascista, 300 di queste apertamente apologetiche». Possibile? Iniziamo la nostra ricerca digitando su Facebook la parola ’fascisti’. Il primo risultato che appare rimanda alla pagina ’I giovani fascisti italiani’, seguita da quasi 93mila persone. Entriamo. I post scritti sono pochi. Vanno invece alla grande le foto di Mussolini, i video dei suoi discorsi e le cartoline militanti da condividere sui social. Gli stessi contenuti si trovano anche su pagine ’amiche’ come ’Essere fascista non è reato’, che ha 54mila fan, ’Fascisti italiani, che ha 32mila fan, e ’Repubblica Sociale Italiana’, ferma a poco più di 1.500 mi piace.
Siccome non si vive di sola politica militante, ogni giorno su queste pagine appaiono anche foto che pubblicizzano ’prodotti fascisti’: il portafoglio con l’effigie di Mussolini, i cuscini con la faccia del duce (ma non sarà irriverente sedervisi sopra?) e - molto apprezzato - un manganello nero («in legno massello», specificano i curatori della pagina) disponibile con la scritta (a scelta) ’Boia chi molla’, ’Me ne frego’, ’Credere obbedire combattere’, ’Molti nemici molto onore’. Ogni volta che qualcuno chiede il prezzo di uno degli oggetti, la risposta dei moderatori è sempre uguale: «Camerata, contattaci in privato«. Come se la vendita fosse segreta. Come se la vendita fosse destinata solo a pochi privilegiati. Un’autentica furbata. Che fa apparire ’militanti’ e ’segrete’ delle pagine di fatto promozionali legate al negozio Duxstore.it - con sede legale a Castel Campagnano, in provincia di Caserta - specializzato in gadget fascisti. Stesso repertorio di foto, cartoline, video e slogan si trova anche nella pagina Facebook ’I giovani fascisti italiani - destra italiana’, seguita da 27.198 persone.
Digitando su Facebook la parola ’Mussolini’ la prima pagina che appare è ’Benito Mussolini’, che piace a 144.449 persone. Ci sono post nostalgici ma anche contro i vaccini, l’Europa, il Governo, i giornali bugiardi e tutto il solito repertorio ’anti’. Sempre sul duce c’è la pagina ’Benito Mussolini eterna passione’ (26.350 fan). Sulla pagina ’Gioventù italiana del littorio’ (che piace a 15.149 persone) si trovano quasi esclusivamente foto e manifesti dell’epoca fascista.
Devono però avere qualche problema di repertorio visto che in un anno hanno ripetuto sei volte la foto di un quadro di Mussolini, uno scatto dove il duce fa il saluto romano e un manifesto fascista. ’Camerati uniti per l’Italia’ pubblica molti post di Forza Nuova. La pagina è seguita da 12.929 persone. Ma gli iscritti sono poco reattivi: il post più premiato degli ultimi mesi ha raccolto 12 ’like’. La pagina Facebook ’Camerati italiani’ ha 8.214 iscritti. Anche qui dietro la militanza c’è il business. L’indirizzo web ufficiale della pagina rimanda a un negozio online con sede a Limana (Belluno) che vende gadget marchiati ’Camerati italiani’: dalle classiche t-shirt (dai 20 ai 26 euro) alle infradito (18,99 euro).
Per capire la portata della presenza dei fascisti sui social, il quindicinale Patria indipendente dell’Associazione Nazionale Partigiani ha promosso un progetto web. Si trova all’indirizzo patriaindipendente.it/progetto-facebook/ Cliccandoci appare l’enorme galassia delle pagine social di estrema destra. L’impatto visivo è molto forte. Ma la navigabilità non è semplice e alla fine è difficile mettere ordine in una mole di dati visuali che mischia pagine legali e illegali. Grazie al progetto scopriamo però che le pagine social di estrema destra più seguite sono quelle di Forza Nuova (222.820 persone) e Casa Pound (214.885 fan). Che - va sottolineato - non violano alcuna legge, a differenza di molte altre citate qui. Il ’Centro documentazione Repubblica Sociale Italiana’ è seguito su Fb da 25mila persone. Mentre la pagina ’Xª Flottiglia MAS’ ha oltre 13mila seguaci. Accanto appare la pagina ’X flottiglia mas store’, dove sono pubblicizzati i gadget.
Basta andare sul sito collegato per trovare magliette, felpe, polo, cover per telefonini, distintivi, portachiavi e orologi ’dal licenziatario ufficiale della X Flottiglia Mas’, con sede a Taranto. Sul social più frequentato del mondo si possono creare anche gruppi, aperti (cioè visibili a tutti) o chiusi (per vedere i post o commentarli bisogna essere iscritti). Tra i gruppi chiusi spopola con oltre 12mila iscritti ’Fascisti del terzo millennio’. Seguito da ’Onore al duce’ che conta 8.979 membri e da ’Dux mea lux!’ con 8.772 membri. La palma per il nome più lungo va a ’Benito Mussolini, il Duce... un uomo che ha fatto grande l’Italia 1883-1945’ che conta 3.689 iscritti. Il gruppo ’Fascisti e fascismo’ si ferma invece a 2.285 adepti. L’elenco è sterminato. Tra i gruppi social più curiosi ci sono ’Fascisti Italiani non c’è più tempo dobbiamo ritornare’ (49 componenti) e ’Fascisti non per piacere ma per dovere’ (159 iscritti). Decisamente ’esclusivi’ sono i gruppi ’Per soli veri fascisti’ (8 iscritti) e ’I veri fascisti’ (4 componenti). Gli Artisti fascisti sono invece 43. Mentre i ’Golfisti fascisti’ (intesi come militanti fascisti possessori dell’auto Golf - sì, esistono anche loro) sono 13. Il più piccolo è il gruppo ’Fascismo è vita’ che ha un solo componente.
Alla ricerca delle parole ’nazismo’, ’nazisti’, ’SS’ e ’camicie nere’ Facebook non restituisce invece pagine apologetiche o degne di nota. Mentre digitando ’Adolf Hitler’ si trova solo il gruppo ’Adolf Hitler capo del mio governo’ che ha soltanto 10 membri. Il motivo è presto detto: Facebook ha rimosso e/o oscurato le pagine e i gruppi che inneggiavano al nazismo. Aspettate però a gioire. Il social l’ha fatto solo dopo avere ricevuto moltissime proteste. E c’è chi ha imparato ad aggirare i divieti. Sulla pagina dell’Associazione culturale Thule Italia, seguita da 10.000 persone, quasi ogni giorno appare la foto di un soldato nazista ma senza alcun testo di accompagnamento. Così mentre i sostenitori mandano cuori e scrivono ’bellissimo’, l’associazione è formalmente salva. Sta facendo ’ricostruzione storica’ non apologia. Anche per questo è difficile dire quanto sia vasta la presenza nazi-fascista sui social. Ma basta sommare i nostalgici iscritti ai gruppi o alle pagine nominate in questo articolo per superare il milione di persone. E abbiamo solo scalfito la superficie. Per fermare l’apologia fascista sui social, Emanuele Fiano ha presentato una proposta di legge. Ma per ora è ancora tutto in alto mare.
* Avvenire, domenica 20 agosto 2017 (ripresa parziale - senza note e immagini).
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:- FILOSOFIA. IL PENSIERO DELLA COSTITUZIONE E LA COSTITUZIONE DEL PENSIERO
 MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA E A PENSARE BENE "DIO", "IO" E "L’ITALIA", CHI PIU’ CHI MENO, TUTTI VIVONO DENTRO LA PIU’ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA E POLITICA ITALIANA, NEL REGNO DI "FORZA ITALIA"!!!
MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA E A PENSARE BENE "DIO", "IO" E "L’ITALIA", CHI PIU’ CHI MENO, TUTTI VIVONO DENTRO LA PIU’ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA E POLITICA ITALIANA, NEL REGNO DI "FORZA ITALIA"!!!
LA STORIA DEL FASCISMO E RENZO DE FELICE: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"!
PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!! FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.
- FILOSOFIA. IL PENSIERO DELLA COSTITUZIONE E LA COSTITUZIONE DEL PENSIERO
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- IN DIFESA DEI GIUSTI. Alle Ong che cercano di sottrarre quei profughi a un destino di sofferenza e morte andrebbe riconosciuto il titolo di “Giusti” come si è fatto per coloro che ai tempi del nazismo si sono adoperati per salvare degli ebrei dallo sterminio.15 agosto 2017, di Federico La Sala
In difesa dei giusti, contro lo sterminio
di Guido Viale *
- Alle Ong che cercano di sottrarre quei profughi a un destino di sofferenza e morte andrebbe riconosciuto il titolo di “Giusti” come si è fatto per coloro che ai tempi del nazismo si sono adoperati per salvare degli ebrei dallo sterminio. La lotta agli scafisti indetta dal governo italiano e dall’Unione Europea è in realtà una guerra camuffata contro i profughi, contro degli esseri umani braccati. Ed è una guerra che moltiplica il numero e i guadagni di scafisti, autorità libiche corrotte e terroristi: quei viaggi sono l’unica alternativa ai canali di immigrazione legale che l’Europa ha chiuso fingendo di proteggere i propri cittadini
Coloro che dalle coste della Libia si imbarcano su un gommone o una carretta del mare sono esseri umani in fuga da un paese dove per mesi o anni sono stati imprigionati in condizioni disumane, violati, comprati e venduti, torturati per estorcere riscatti dalle loro famiglie, aggrediti da scabbia e malattie; e dove hanno rischiato fino all’ultimo istante di venir uccisi.
Molti di loro non hanno mai visto il mare e non hanno idea di che cosa li aspetti, ma sanno benissimo che in quel viaggio stanno rischiando ancora una volta la vita. Chi fugge da un paese del genere avrebbe diritto alla protezione internazionale garantita dalla convenzione di Ginevra, ma solo se è “cittadino” di quel paese. Quei profughi non lo sono; sono arrivati lì da altre terre. Ma fermarli in mare e riportarli in Libia è un vero e proprio respingimento (refoulement, proibito dalla convenzione di Ginevra) di persone perseguitate, anche se materialmente a farlo è la Guardia costiera libica.
Una volta riportati in Libia verranno di nuovo imprigionati in una delle galere da cui sono appena usciti, subiranno le stesse torture, gli stessi ricatti, le stesse violenze, le stesse rapine a cui avevano appena cercato di sfuggire, fino a che non riusciranno a riprendere la via del mare. Alle Ong che cercano di sottrarre quei profughi a un simile destino di sofferenza e morte andrebbe riconosciuto il titolo di “Giusti” come si è fatto per coloro che ai tempi del nazismo si sono adoperati per salvare degli ebrei dallo sterminio.
Invece, ora come allora, vengono trattati come criminali: dai Governi, da molte forze politiche, dalla magistratura, dai media e da una parte crescente dell’opinione pubblica (i social!); sempre più spesso con un linguaggio che tratta le persone salvate e da salvare come ingombri, intrusi, parassiti e invasori da buttare a mare. Non ci si rende più conto che sono esseri umani: disumanizzare le persone come fossero cose o pidocchi è un percorso verso il razzismo e le sue conseguenze più spietate. Come quello che ha preceduto lo sterminio nazista.
Nessuno prova a mettersi nei panni di queste persone in fuga, per le quali gli scafisti che li sfruttano in modo cinico e feroce sono speranza di salvezza, l’ultima risorsa per sottrarsi a violenze e soprusi indicibili. La lotta agli scafisti indetta dal governo italiano e dall’Unione Europea è in realtà una guerra camuffata contro i profughi, contro degli esseri umani braccati. Ed è una guerra che moltiplica il numero e i guadagni di scafisti, autorità libiche corrotte e terroristi: unica alternativa ai canali di immigrazione legale che l’Europa ha chiuso fingendo di proteggere i propri cittadini.
Da tempo le imbarcazioni su cui vengono fatti salire i profughi non sono più in grado di raggiungere l’Italia: sono destinate ad affondare con il loro carico. Ma gli scafisti certo non se ne preoccupano: il viaggio è già stato pagato, e se il “carico” viene riportato in Libia, prima o dopo verrà pagato una seconda e una terza volta. In queste condizioni, non c’è bisogno che un gommone si sgonfi o che una carretta imbarchi acqua per renderne obbligatorio il salvataggio, anche in acque libiche: quegli esseri umani violati e derubati sono naufraghi fin dal momento in cui salpano e, se non si vuole farli annegare, vanno salvati appena possibile.
Gran parte di quei salvataggi è affidata alle Ong, perché le navi di Frontex e della marina italiana restano nelle retrovie per evitare di dover intervenire in base alla legge del mare; ma gli esseri umani che vengono raccolti in mare da alcune navi delle Ong devono essere trasbordati al più presto su un mezzo più capiente, più sicuro e più veloce; altrimenti le navi che eseguono il soccorso rischiano di affondare per eccesso di carico, oppure non riescono a raccogliere tutte le persone che sono in mare o, ancora, impiegherebbero giorni e giorni per raggiungere un porto, lasciando scoperto il campo di intervento.
Vietare i trasbordi è un delitto come lo è ingiungere alle Ong di imbarcare agenti armati: farlo impedirebbe alle organizzazioni impegnate in interventi in zone di guerra di respingere pretese analoghe delle parti in conflitto, facendo venir meno la neutralità che permette loro di operare. Né le Ong possono occuparsi delle barche abbandonate, soprattutto in presenza di uomini armati fino ai denti venuti a riprendersele. Solo i mezzi militari di Frontex potrebbero farlo: distruggendo altrettante speranze di chi aspetta ancora di imbarcarsi.
I problemi continuano quando queste persone vengono sbarcate: l’Unione europea appoggia la guerra ai profughi, ma poi se ne lava le mani. Sono problemi dell’Italia; la “selezione” tra sommersi e salvati se la veda lei... I rimpatri, oltre che crudeli e spesso illegali, sono per lo più infattibili e molto costosi. Così, dopo la selezione, quell’umanità dolente si accumula in Italia, divisa tra clandestinità, lavoro nero, prostituzione e criminalità: quanto basta a mettere ko la vita politica e sociale di tutto paese.
Ma cercare di fermare i profughi ai confini settentrionali o a quelli meridionali della Libia accresce solo il numero dei morti. Dobbiamo guardare in avanti, accogliere in tutta Europa come fratelli coloro che cercano da lei la loro salvezza; adoperarci per creare un grande movimento europeo che lavori e lotti per riportare la pace nei loro paesi (non lo faranno certo i governi impegnati in quelle guerre) e perché i profughi che sono tra noi possano farsi promotori della bonifica ambientale e sociale delle loro terre (non lo faranno certo le multinazionali impegnate nel loro saccheggio). L’alternativa è una notte buia che l’Europa ha già conosciuto e in cui sta per ricadere
*Comune-info, 12 agosto 2017 (ripresa parziale - senza immagini).
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
LA LEZIONE DI NELSON MANDELA: GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! E DELL’EUROPA?! ---ONG. Migranti, chi infligge colpi mortali al codice morale (di Marco Revelli).8 agosto 2017, di Federico La Sala
LA QUESTIONE MORALE ...*
Migranti, chi infligge colpi mortali al codice morale
Ong. Non era ancora accaduto, nel lungo dopoguerra almeno, in Europa e nel mondo cosiddetto «civile», che la solidarietà, il salvataggio di vite umane, l’«umanità» come pratica individuale e collettiva, fossero stigmatizzati, circondati di diffidenza, scoraggiati e puniti
di Marco Revelli (il manifesto, 08.08.2017)
Negli ultimi giorni qualcosa di spaventosamente grave è accaduto, nella calura di mezza estate. Senza trovare quasi resistenza, con la forza inerte dell’apparente normalità, la dimensione dell’«inumano» è entrata nel nostro orizzonte, l’ha contaminato e occupato facendosi logica politica e linguaggio mediatico. E per questa via ha inferto un colpo mortale al nostro senso morale.
L’«inumano», è bene chiarirlo, non è la mera dimensione ferina della natura contrapposta all’acculturata condizione umana.
Non è il «mostruoso» che appare a prima vista estraneo all’uomo. Al contrario è un atteggiamento propriamente umano: l’«inumano» - come ha scritto Carlo Galli - «è piuttosto il presentarsi attuale della possibilità che l’uomo sia nulla per l’altro uomo».
Che l’Altro sia ridotto a Cosa, indifferente, sacrificabile, o semplicemente ignorabile. Che la vita dell’altro sia destituita di valore primario e ridotta a oggetto di calcolo. Ed è esattamente quanto, sotto gli occhi di tutti, hanno fatto il nostro governo - in primis il suo ministro di polizia Marco Minniti - e la maggior parte dei nostri commentatori politici, in prima pagina e a reti unificate.
Cos’è se non questo - se non, appunto, trionfo dell’inumano - la campagna di ostilità e diffidenza mossa contro le Ong, unici soggetti all’opera nel tentativo prioritario di salvare vite umane, e per questo messe sotto accusa da un’occhiuta «ragion di stato».
O la sconnessa, improvvisata, azione diplomatica e militare dispiegata nel caos libico con l’obiettivo di mobilitare ogni forza, anche le peggiori, per tentare di arrestare la fiumana disperata della nuda vita, anche a costo di consegnarla agli stupratori, ai torturatori, ai miliziani senza scrupoli che non si differenziano in nulla dagli scafisti e dai mercanti di uomini, o di respingerla a morire nel deserto.
Qui non c’è, come suggeriscono le finte anime belle dei media mainstream (e non solo, penso all’ultimo Travaglio) e dei Gabinetti governativi o d’opposizione, la volontà di ricondurre sotto la sovranità della Legge l’anarchismo incontrollato delle organizzazioni umanitarie.
Non è questo lo spirito del famigerato «Codice Minniti» imposto come condizione di operatività in violazione delle antiche, tradizionali Leggi del mare (il trasbordo) e della più genuina etica umanitaria (si pensi al rifiuto di presenze armate a bordo). O il senso dell’invio nel porto di Tripoli delle nostre navi militari.
Qui c’è la volontà, neppur tanto nascosta, di fermare il flusso, costi quel che costi. Di chiudere quei fragili «corridoi umanitari» che in qualche modo le navi di Medici senza frontiere e delle altre organizzazioni tenevano aperti. Di imporre a tutti la logica di Frontex, che non è quella della ricerca e soccorso, ma del respingimento (e il nome dice tutto).
Di fare, con gli strumenti degli Stati e dell’informazione scorretta, quanto fanno gli estremisti di destra di Defend Europe, non a caso proposti come i migliori alleati dei nuovi inquisitori. Di spostare più a sud, nella sabbia del deserto anziché nelle acque del Mare nostrum, lo spettacolo perturbante della morte di massa e il simbolo corporeo dell’Umanità sacrificata.
Non era ancora accaduto, nel lungo dopoguerra almeno, in Europa e nel mondo cosiddetto «civile», che la solidarietà, il salvataggio di vite umane, l’«umanità» come pratica individuale e collettiva, fossero stigmatizzati, circondati di diffidenza, scoraggiati e puniti.
Non si era mai sentita finora un’espressione come «estremismo umanitario», usata in senso spregiativo, come arma contundente. O la formula «crimine umanitario». E nessuno avrebbe probabilmente osato irridere a chi «ideologicamente persegue il solo scopo di salvare vite», quasi fosse al contrario encomiabile chi «pragmaticamente» sacrifica quello scopo ad altre ragioni, più o meno confessabili (un pugno di voti? un effimero consenso? il mantenimento del potere nelle proprie mani?)
A caldo, quando le prime avvisaglie della campagna politica e mediatica si erano manifestate, mi ero annotato una frase di George Steiner, scritta nel ’66. Diceva: «Noi veniamo dopo. Adesso sappiamo che un uomo può leggere Goethe o Rilke la sera, può suonare Bach e Schubert, e quindi, il mattino dopo, recarsi al proprio lavoro ad Auschwitz». Aggiungevo: Anche noi «veniamo dopo».
Dopo quel dopo. Noi oggi sappiamo che un uomo può aver letto Marx e Primo Levi, orecchiato Marcuse e i Francofortesi, militato nel partito che faceva dell’emancipazione dell’Umanità la propria bandiera, esserne diventato un alto dirigente, e tuttavia, in un ufficio climatizzato del proprio ministero firmare la condanna a morte per migliaia di poveri del mondo, senza fare una piega. La cosa può essere sembrata eccessiva a qualcuno. E il paragone fuori luogo. Ma non mi pento di averlo pensato e di averlo scritto.
Consapevole o meno di ciò che fa, chi si fa tramite dell’irrompere del disumano nel nostro mondo è giusto che sia consapevole della gravità di ciò che compie. Della lacerazione etica prima che politica che produce. Se l’inumano - è ancora Galli a scriverlo - «è il lacerarsi catastrofico della trama etica e logica dell’umano», allora chi a quella rottura contribuisce, quale che sia l’intenzione che lo muove, quale che sia la bandiera politica sotto cui si pone, ne deve portare, appieno, la responsabilità. Così come chi a quella lacerazione intende opporsi non può non schierarsi, e dire da che parte sta. Io sto con chi salva.
*
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.
IL SONNO MORTIFERO DELL’ITALIA. In Parlamento (ancora!) il Partito al di sopra di tutti i partiti.
IL MESSAGGIO EVANGELICO, LA COSTITUZIONE, E IL PARADOSSO ISTITUZIONALE DEL MENTITORE, ATEO E DEVOTO. COME LA "SACRA FAMIGLIA" DIVENNE ZOPPA E CIECA E IL FIGLIO PRESE IL POSTO DEL PADRE DI GESU’ E DEL "PADRE NOSTRO" E DIVENNE IL SANTO "PADRINO".... CON E ACCANTO A "MAMMASANTISSIMA".
 LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA
LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA L’INDICAZIONE DI NELSON MANDELA: GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- VIRTUALE E DINTORNI: IL GRANDE FRATELLO E I TELEVISORI SAMSUNG? (di F. Bollorino - "Psichiatria Italia").5 agosto 2017, di Federico La Sala
POLITICA, CONFLITTO D’INTERESSE, E ... "UNDERSTANDING MEDIA" ("GLI STRUMENTI DEL COMUNICARE"). Cedere occhi, orecchie e nervi a interessi commerciali è come consegnare il linguaggio comune a un’azienda privata o dare in monopolio a una società l’atmosfera terrestre...
VIRTUALE E DINTORNI...
Cosa ci racconta la rete
IL GRANDE FRATELLO E I TELEVISORI SAMSUNG?
di Francesco Bollorino ("Psychiatry on line", 4 agosto, 2017
Non sono mai stato un “complottista”, mi hanno fatto sempre sorridere le ricostruzioni strambe e spesso deliranti degli avvenimenti che circolano in rete e che purtroppo fanno proseliti, ho rischiato rotture di conoscenze per via delle “strie chimiche” e ne ho rotte sul tema dei vaccini.
Mi considero uno spirito laico e mi sento un po’ San Tommaso ma, due giorni fa, è accaduto un piccolo fatto che mi ha molto colpito e che vi voglio raccontare.
Ho acquistato un modernissimo ma sufficientemente a buon mercato televisore della Samsung e, come prevede la prassi, due tecnici sono venuti a consegnarmelo a casa e ad attivarlo, per verificarne il corretto funzionamento.
La procedura prevede l’accensione del televisore, il suo corretto collegamento e il setup di partenza.
Durante l’attivazione del menù di avvio, con sorpresa anche del tecnico, è comparso sullo schermo il C.A.P. della mia abitazione, in maniera automatica, come se il televisore avesse rilevato la geo-localizzazione della sua posizione “nel mondo”.
Va detto che è difficile che ciò possa essere dovuto ad un GPS incorporato nell’apparecchio poiché tale tecnologia necessita che il dispositivo “veda” la rete di satelliti a cui si aggancia per determinare la posizione: evidentemente si trattava di qualcosa di altro, ma il risultato era lì davanti ai nostri occhi, il TV “sapeva” dove si trovava e io non gli avevo chiesto di saperlo.
Questo piccolo episodio mi ha fatto tornare in mente alcuni articoli letti sul tema del controllo remoto, attuabile anche attraverso gli elettrodomestici e non solo attraverso l’eventuale intercettazione delle comunicazioni fatte con apparecchi “mobile”.
Pur non essendo, come detto, un complottista mi son posto e pongo a voi che leggete poche anche se non semplici domande a cui non ho una risposta.
Perché la Samsung ha installato questa tecnologia nel televisore per altro non indicata in nessuna descrizione tecnica dell’apparecchio? Di che tecnologia si tratta? A cosa potrebbe servire “ufficialmente”? A cosa potrebbe servire "riservatamente"? Tra l’altro il televisore è in grado di accettare comandi vocali e comprende il linguaggio un po’ come Siri della Apple.
Conosciamo esattamente tutto ciò che sta dentro le elettroniche che usiamo? Esistono cioè “funzioni” nascoste e/o attivabili che nulla hanno a che fare col funzionamento ma molto possono avere a che fare con qualche forma di controllo remoto, la cui base è, anche e soprattutto, l’individuazione del luogo da cui parte l’eventuale informazione oltre che la "cattura" dei contenuti?
E’ possibile che un elettrodomestico di ultima generazione non si limiti a fornire un servizio ma che possa “anche” ascoltare ciò che gli accade attorno, in maniera autonoma o attivata da remoto e in qualche maniera trasmetterlo? In 1984 Orwell immaginava un televisore che guardava dentro casa non limitandosi a mandare in onda le trasmissioni del Regime.
Esiste un modo per proteggere la nostra privacy davvero?
Ovviamente sarei lieto di essere edotto sui dubbi che mi sono sorti e se vogliamo dirla tutta un po’ tranquillizzato nei confronti degli sviluppi della società futura: il Grande Fratello non so se esiste, certo esiste la National Security Agency e i suoi rapporti documentati coi grandi players tecnologici mondiali e certo esistono i Cookies che, da tempo e col nostro assenso sul loro uso, non sulla natura precisa del loro funzionamento, ci profilano in maniera silente ma molto invasiva nella nostra vita on line, se dovesse accadere che pure gli elettrodomestici ci tracciano o possono essere attivati per farlo non mi pare un gran mondo quello che ci aspetta nel prossimo futuro.
Che ne pensate?
SUL REMA, NEL SITO, SI CFR.:
POLITICA, CONFLITTO D’INTERESSE, E ... "UNDERSTANDING MEDIA" ("GLI STRUMENTI DEL COMUNICARE"). I nuovi media non sono giocattoli e non dovrebbero essere messi nelle mani di Mamma Oca o di Peter Pan.
 LA "PROFEZIA" DI MARSHALL MCLUHAN: NARCISO E LA MORTE DELL’ITALIA. Il "rimorso di incoscienza" di Marshall McLuhan
LA "PROFEZIA" DI MARSHALL MCLUHAN: NARCISO E LA MORTE DELL’ITALIA. Il "rimorso di incoscienza" di Marshall McLuhan
 Cedere occhi, orecchie e nervi a interessi commerciali è come consegnare il linguaggio comune a un’azienda privata o dare in monopolio a una società l’atmosfera terrestre.
Cedere occhi, orecchie e nervi a interessi commerciali è come consegnare il linguaggio comune a un’azienda privata o dare in monopolio a una società l’atmosfera terrestre. -
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! - L’analogia armata del Califfato. Parole e conflitti retorici (di Fabio Milazzo).1 agosto 2017, di Federico La Sala
MITO E STORIA, POLITICA E TEOLOGIA.
Storiografia in crisi d’identità ...
LO SPIRITO E L’OSSO storia, immaginario, filosofia e psicoanalisi
L’analogia armata del Califfato. Parole e conflitti retorici
di Fabio Milazzo*
- Review of: Philippe-Joseph Salazar, Parole armate. Quello che l’Isis ci dice e che noi non capiamo, Bompiani, Milano 2016, pagg.199.
- «Mi domando quanta cultura, retorica,
persuasione e dialettica abbiamo perso in Europa
per non comprendere quello che sta succedendo e non essere in grado di reagire»
 Philippe-Joseph Salazar[1]
Philippe-Joseph Salazar[1]
Sgozzature, lapidazioni, defenestrazioni, crocifissioni, esecuzioni di donne, bambini e anziani, come forma di disciplinamento di massa alle "quali assistono folle intere, mentre fanno acquisti o nel bel mezzo del traffico di tutti i giorni" (p. 10). Tra tanti segni di barbarie, gli omicidi ritualizzati e "scenarizzati" a fini di propaganda, forse, rappresentano l’elemento che più di tutti ha colpito l’immaginario dell’Occidentale, quello che si confronta con ciò che Slavoj Žižek definisce l’orrore del Reale insimbolizzabile. Un orrore incomprensibile che, proprio per questo, scatena sterili reazioni di diniego e ingenui tentativi di reductio ad absurdum. Si invoca l’analfabetismo culturale e politico, l’idiozia gutturale sottolineata "dalle grida dei selvaggi" (p. 10), si riporta tutto alla miseria psico-sociale di chi, nato e cresciuto in una condizione di cieca disperazione, regredirebbe alla condizione animale (avete mai visto animali uccidere ritualmente?). Ma siamo così sicuri che oltre lo sconcerto ci sia solo il confronto con un mondo-barbaro da cui crediamo esserci emancipati?
 Non è che semplicemente ci stiamo rapportando con un mondo che utilizza logiche espressive - e quindi modelli mentali - troppo diversi dai nostri per poterli ridurre alle comode e rassicuranti coordinate che danno forma al mondo sorto dall’Illuminismo?
Non è che semplicemente ci stiamo rapportando con un mondo che utilizza logiche espressive - e quindi modelli mentali - troppo diversi dai nostri per poterli ridurre alle comode e rassicuranti coordinate che danno forma al mondo sorto dall’Illuminismo?- Abū Bakr al-Baghdādī durante una predica
Questi interrogativi tengono in piedi il libro di P.-J. Salazar "Paroles Armées. Comprendre et Combattre la Propagande Terroriste, appena tradotto in Italia per Bompiani. Lo dico subito: quello di Salazar è un grande libro che ha il coraggio di non abbandonarsi ai toni ideologici della maggior parte delle ermeneutiche in circolazione e, senza girarci intorno, chiarisce la posta in gioco dello scontro con l’Is: la retorica.
 Continuare a ripetere che le ragioni dello scontro sono (innanzitutto) economiche, legate all’arretratezza dell’Islam o effetti residuali del colonialismo, non consente di focalizzare quella che possiamo chiamare l’oscena fantasia che tiene in piedi le narrazioni in campo. Ci sono visioni del mondo - quindi modi di usare le parole per costruire le storie che riempiono l’immaginario - totalmente diverse tra l’Occidente logocentrico e questo Islam tanto violento quanto retoricamente eccessivo e dallo stile figurato.
Continuare a ripetere che le ragioni dello scontro sono (innanzitutto) economiche, legate all’arretratezza dell’Islam o effetti residuali del colonialismo, non consente di focalizzare quella che possiamo chiamare l’oscena fantasia che tiene in piedi le narrazioni in campo. Ci sono visioni del mondo - quindi modi di usare le parole per costruire le storie che riempiono l’immaginario - totalmente diverse tra l’Occidente logocentrico e questo Islam tanto violento quanto retoricamente eccessivo e dallo stile figurato.
 Precisiamo che le dicotomie, i "noi" e i "loro", ovviamente, non hanno ragion d’essere alla luce di una microfisica psico-sociale in grado di evidenziare la contingenza e l’irriducibile valore differenziale delle soggettività, ma mostrano il loro valore nel momento in cui si ha a che fare con il campo dell’immaginario di gruppo, con quei quadri-mentali-collettivi[2] su cui tanto si sono dibattuti gli storici novecenteschi delle Annales[3]. Quadri riconosciuti dallo stesso Lacan con la definizione di "mentalità". D’altra parte il parlante è sempre immerso nel proprio involucro immaginario, fatto di parole che organizzano sia le rappresentazioni, sia il senso attraverso cui fa esperienza del mondo. Non si capisce perché questa considerazione - neanche troppo originale oggi - non debba valere per le collettività, per mondi e nicchie-antropologiche che prendono forma entro coordinate storico-discorsive contraddistinte da una condivisione retorica di fondo molto forte.
Precisiamo che le dicotomie, i "noi" e i "loro", ovviamente, non hanno ragion d’essere alla luce di una microfisica psico-sociale in grado di evidenziare la contingenza e l’irriducibile valore differenziale delle soggettività, ma mostrano il loro valore nel momento in cui si ha a che fare con il campo dell’immaginario di gruppo, con quei quadri-mentali-collettivi[2] su cui tanto si sono dibattuti gli storici novecenteschi delle Annales[3]. Quadri riconosciuti dallo stesso Lacan con la definizione di "mentalità". D’altra parte il parlante è sempre immerso nel proprio involucro immaginario, fatto di parole che organizzano sia le rappresentazioni, sia il senso attraverso cui fa esperienza del mondo. Non si capisce perché questa considerazione - neanche troppo originale oggi - non debba valere per le collettività, per mondi e nicchie-antropologiche che prendono forma entro coordinate storico-discorsive contraddistinte da una condivisione retorica di fondo molto forte.In quest’ottica, non comprendere la mentalità dei terroristi, ridurla ad epifenomeno di cause economiche e materiali, significa operare con un perverso rasoio irriflesso in nome del riduzionismo più becero e ingenuo. Salazar lo sottolinea a più riprese, evidenziando quanto il problema dello scontro con l’Isis riguardi l’incomunicabilità di mondi che usano forme discorsive diverse.
 "C’è - ci dice - una logica dietro i discorsi del Califfato, che sembrano presentare uno scarto rispetto a ciò che noi consideriamo logico, ragionevole e persuasivo in politica. Una logica di altro genere [...] che possiede, oltre alla professione di fede e alla sua forza evocativa poetica un rigore dialettico. Il rigore del ragionamento per analogia" (p. 14).
"C’è - ci dice - una logica dietro i discorsi del Califfato, che sembrano presentare uno scarto rispetto a ciò che noi consideriamo logico, ragionevole e persuasivo in politica. Una logica di altro genere [...] che possiede, oltre alla professione di fede e alla sua forza evocativa poetica un rigore dialettico. Il rigore del ragionamento per analogia" (p. 14).
 Soprattutto queste ultime parole fanno venire voglia di riprendere in mano un gigante del pensiero come Enzo Melandri che nel suo «La linea e il circolo»[4] lungamente si è espresso sulle peculiarità di questo procedimento discorsivo. Si tratta di fare fino in fondo i conti con uno stile retorico-espressivo, ma anche con modelli di pensiero, che solo a fatica possono essere ricondotti "al sistema logico dei ragionamenti scientifici o razionali" (p.13). Se l’Europa ha messo al bando (salvo riconoscergli un ruolo osceno) la poetica e la retorica, separandole nettamente dal ragionamento logico e dalle argomentazioni scientifiche, così non è accaduto nel mondo islamico in cui "uno slancio lirico" vale come argomento e prova logica. -Facciamocene una ragione.
Soprattutto queste ultime parole fanno venire voglia di riprendere in mano un gigante del pensiero come Enzo Melandri che nel suo «La linea e il circolo»[4] lungamente si è espresso sulle peculiarità di questo procedimento discorsivo. Si tratta di fare fino in fondo i conti con uno stile retorico-espressivo, ma anche con modelli di pensiero, che solo a fatica possono essere ricondotti "al sistema logico dei ragionamenti scientifici o razionali" (p.13). Se l’Europa ha messo al bando (salvo riconoscergli un ruolo osceno) la poetica e la retorica, separandole nettamente dal ragionamento logico e dalle argomentazioni scientifiche, così non è accaduto nel mondo islamico in cui "uno slancio lirico" vale come argomento e prova logica. -Facciamocene una ragione.
 Siamo dunque condannati all’incomunicabilità e all’impossibilità del dialogo? Salazar non è così pessimista e lo dice bene in questa intervista:
Siamo dunque condannati all’incomunicabilità e all’impossibilità del dialogo? Salazar non è così pessimista e lo dice bene in questa intervista:«Se le armi non bastano, come possiamo contrastare il Califfato? Con l’istruzione. Dobbiamo educare una popolazione, quella europea, che vive di luoghi comuni. [...] Gli allievi europei non studiano bene la storia e la geografia. Di conseguenza, il vecchio continente si ritrova con una marcia in meno rispetto al Califfato che invece mette in mostra una notevole cultura, coltiva i grandi testi non solo religosi, cita i filosofi, recita poesie e canta inni. L’Europa mette in mostra una tecnologia che le si ritorce contro e nel frattempo vive un deficit culturale»[5].
Per inciso, la scuola - e il suo valore formativo - trova in queste dichiarazioni spazi inediti di possibile affermazione e rivalutazione in un periodo di profonda crisi in atto. Ma questo è un altro discorso. Il libro di Salazar non si limita soltanto ad evidenziare quanto sia scorretto, oltre che inutile, cercare di imporre la logica argomentativa sviluppatasi dopo la rivoluzione scientifica come chiave di lettura per decifrare l’orrore del Califfato, ma sottolinea anche quanto siano falsate - e ingenue - le ermeneutiche che riducono il fenomeno jihadista a semplice effetto sovrastrutturale, a conseguenza di una subordinazione economica, da parte del mondo musulmano, insostenibile nell’epoca della colonizzazione mediatica.
 Questa tesi, più o meno argomentata, è inconsistente se consideriamo quanto il proselitismo del Califfato interessi anche (soprattutto?) persone istruite che sembrano essere alla ricerca di valori chiari e di ideali da difendere, piuttosto che il riscatto economico, centrale invece per l’immaginario collettivo Occidentale.
Questa tesi, più o meno argomentata, è inconsistente se consideriamo quanto il proselitismo del Califfato interessi anche (soprattutto?) persone istruite che sembrano essere alla ricerca di valori chiari e di ideali da difendere, piuttosto che il riscatto economico, centrale invece per l’immaginario collettivo Occidentale.
 Non «considerare - ci dice l’Autore - il jihadismo come qualcosa di diverso da una patologia di imbecilli» (p.70) è una «cantonata» fondamentale, tipica di una società incapace di relazionarsi con l’Altro - per dirla con Lacan - senza ridurlo all’altro - delle proiezioni narcisistiche. I video e i periodici dei jihadisti dell’Isis, invece, sono pensati «per giovani intelligenti e istruiti, beneficiari di un buon capitale culturale e materiale, lettori attenti alla ricerca di argomenti solidi (anche se in ordine ad una teoria dell’argomentazione diversa dalla “nostra”) e di idee sviluppate con cura» (p.71).
Non «considerare - ci dice l’Autore - il jihadismo come qualcosa di diverso da una patologia di imbecilli» (p.70) è una «cantonata» fondamentale, tipica di una società incapace di relazionarsi con l’Altro - per dirla con Lacan - senza ridurlo all’altro - delle proiezioni narcisistiche. I video e i periodici dei jihadisti dell’Isis, invece, sono pensati «per giovani intelligenti e istruiti, beneficiari di un buon capitale culturale e materiale, lettori attenti alla ricerca di argomenti solidi (anche se in ordine ad una teoria dell’argomentazione diversa dalla “nostra”) e di idee sviluppate con cura» (p.71).
 Non deve così sorprendere - né essere considerata una eccezione - che le «tre brillanti liceali inglesi passate al Califfato [...] e il giovane medico australiano che è andato a esercitare il suo mestiere là dove lo hanno portato le sue convinzioni» (p.71) appartengano a quell’universo di gente istruita, che è andata a scuola e si è magari laureata, che le teorie del sottosviluppo economico come molla per l’adesione agli ideali dell’Isis dovrebbero non contemplare.
Non deve così sorprendere - né essere considerata una eccezione - che le «tre brillanti liceali inglesi passate al Califfato [...] e il giovane medico australiano che è andato a esercitare il suo mestiere là dove lo hanno portato le sue convinzioni» (p.71) appartengano a quell’universo di gente istruita, che è andata a scuola e si è magari laureata, che le teorie del sottosviluppo economico come molla per l’adesione agli ideali dell’Isis dovrebbero non contemplare.
 Invece ecco che si palesa un dato: la propaganda del Califfato si rivolge a persone «animate da un desiderio meditato» (p.71) di martirio. Per quanta fatica si faccia ad accettare questo elemento, questo ci dicono i dati a nostra disposizione e negarli, o cercare spiegazioni poco convincenti e contorte per giustificare una tesi postulata per principio è non soltanto epistemologicamente scorretto ma anche intrinsecamente contraddittorio.
Invece ecco che si palesa un dato: la propaganda del Califfato si rivolge a persone «animate da un desiderio meditato» (p.71) di martirio. Per quanta fatica si faccia ad accettare questo elemento, questo ci dicono i dati a nostra disposizione e negarli, o cercare spiegazioni poco convincenti e contorte per giustificare una tesi postulata per principio è non soltanto epistemologicamente scorretto ma anche intrinsecamente contraddittorio.
 Ma allora «come rispondere a tutto questo? Banalizzando il fenomeno - ci dice Salazar-: facendo circolare quelle riviste [del Califfato] nelle scuole, prendendone spunto per analisi del testo e decostruzioni radicali [...] per ridurre a poca cosa quei documenti materiali attraverso prove argomentate di linguaggio, grazie a ciò che la tradizione culturale francese sa fare meglio. Pensare in modo chiaro e distinto» (p.100). Si tratta cioè di non rifiutare il confronto, di non giocare sulla difensiva ma di contrattaccare retoricamente. E, in tale ottica, la risposta più intelligente che possiamo dare è quella di costruire narrazioni convincenti, basate su argomenti solidi, in grado di convincere quei giovani che sono tentati di abbracciare l’idea mortifera del Califfato di quanto l’intenzione sia una scelta da vicolo cieco. Contro-narrazioni in grado di decostruire la propaganda jihadista e di offrire valide alternative teoriche innanzitutto. Continuare a ripetere lo stanco e logoro mantra dell’arretratezza culturale, figlia del sottosviluppo economico, è controproducente, inutile e scioccamente supponente, anche se di una supponenza perversa, tipica di chi non riconosce effettiva autonomia di pensiero all’Altro ma, implicitamente, lo considera incapace di processi simbolici autonomi e, quindi, di scelte etiche libere. Lo dice con chiarezza Salazar:
Ma allora «come rispondere a tutto questo? Banalizzando il fenomeno - ci dice Salazar-: facendo circolare quelle riviste [del Califfato] nelle scuole, prendendone spunto per analisi del testo e decostruzioni radicali [...] per ridurre a poca cosa quei documenti materiali attraverso prove argomentate di linguaggio, grazie a ciò che la tradizione culturale francese sa fare meglio. Pensare in modo chiaro e distinto» (p.100). Si tratta cioè di non rifiutare il confronto, di non giocare sulla difensiva ma di contrattaccare retoricamente. E, in tale ottica, la risposta più intelligente che possiamo dare è quella di costruire narrazioni convincenti, basate su argomenti solidi, in grado di convincere quei giovani che sono tentati di abbracciare l’idea mortifera del Califfato di quanto l’intenzione sia una scelta da vicolo cieco. Contro-narrazioni in grado di decostruire la propaganda jihadista e di offrire valide alternative teoriche innanzitutto. Continuare a ripetere lo stanco e logoro mantra dell’arretratezza culturale, figlia del sottosviluppo economico, è controproducente, inutile e scioccamente supponente, anche se di una supponenza perversa, tipica di chi non riconosce effettiva autonomia di pensiero all’Altro ma, implicitamente, lo considera incapace di processi simbolici autonomi e, quindi, di scelte etiche libere. Lo dice con chiarezza Salazar:«Che si conduca o meno un’offensiva militare effettiva sul campo del Califfato, bisogna ripensare i termini retorici di questo eventuale impegno e ammettere che lo scontro comincia con una guerra retorica in cui l’avversario controlla una panoplia omogenea che va dall’ingiunzione all’analogia, passando per un’arte oratoria convincente e sostenuta dalla potente logica di un legalismo imperativo. [...] Bisognerà pensare islamico, parlare islamico, argomentare islamico. Mettersi alla portata retorica dell’avversario» (p.19).
Mettersi alla portata retorica dell’avversario significa anche considerarlo come tale, nel suo essere radicale differenza, alterità da prendere come tale, anche quando si serve, ragiona e giudica attraverso una forma argomentativa - quella analogica - che alle nostre orecchie stupisce e ci appare «perversa o delirante» (p. 14). «L’analogia è il quarto fondamento del ragionamento giuridico» (p.15) islamico, che vuol dire che attraverso l’analisi di un esempio tratto dalla Tradizione si procede all’emissione di un parere giuridico (fatwa) vincolante. Anche le condanne a morte, che tanto orrore provocano a Occidente, vengono inflitte su questa base logica. Possiamo davvero pensare di confrontarci con questo mondo senza aver adeguatamente sviluppato le conseguenze teoriche ed etiche di ciò? «Utilizzando le analogie nella sua propaganda - ci dice Salazar-, la politica jihadista si nutre quindi di un’atmosfera retorica che ci sembra strana o irrazionale [...], che però costituisce una forma politica di interpretazione delle cose, potente e generale» (p.16). Improntare una guerra-retorica per decostruire la propaganda dell’avversario, significa dunque, innanzitutto, «ripensare i termini retorici» (p. 19) di questo scontro e non sottovalutarne la portata performativa.
In definitiva la lezione di questo libro riguarda il fatto che c’è una "potenza oratoria e persuasiva" (p.8) assolutamente incomprensibile per i canoni logocentrici delle "nostre orecchie" abituati a concatenamenti logici di causa ed effetto e fintanto che non riusciremo a misurarne il peso e il valore saremo "disarmati", teoricamente innanzitutto. Prendere confidenza, conoscere, valutare "una logica di altro genere"(p.14), e i fantasmi (dell’inconscio collettivo) che la incorniciano, è quindi il passo necessario per evitare quella forma di etnocentrismo culturale da cui riteniamo di esserci vaccinati ma che, in forma perversa, rischia di vanificare le nostre interpretazioni e, quindi, le strategie per combattere la propaganda del Califfato.
- Philippe-Joseph Salazar, Parole armate. Quello che l’Isis ci dice e che noi non capiamo, Bompiani, Milano 2016, pagg.199, euro 17.
 [1] Cfr. P.-J. Salazar “Parole armate” di Salazar: ecco la cultura del Califfato che sottovalutiamo in «Io Donna- Corriere della Sera», 22 Gennaio 2016, http://www.iodonna.it/attualita/in-primo-piano/2016/01/22/philippe-joseph-salazar-parole-armate-il-califfato-lo-si-combatte-con-la-cultura-e-le-minacce-a-roma-sono-serie/
[1] Cfr. P.-J. Salazar “Parole armate” di Salazar: ecco la cultura del Califfato che sottovalutiamo in «Io Donna- Corriere della Sera», 22 Gennaio 2016, http://www.iodonna.it/attualita/in-primo-piano/2016/01/22/philippe-joseph-salazar-parole-armate-il-califfato-lo-si-combatte-con-la-cultura-e-le-minacce-a-roma-sono-serie/
 [2] Cfr. P. Corrao, Storia della Mentalità in «Studi culturali», http://www.studiculturali.it/dizionario/lemmi/storia_delle_mentalita.html
[2] Cfr. P. Corrao, Storia della Mentalità in «Studi culturali», http://www.studiculturali.it/dizionario/lemmi/storia_delle_mentalita.html
 [3] Cfr. Voce «Annales» in Treccani.it, http://www.treccani.it/enciclopedia/annales/
[3] Cfr. Voce «Annales» in Treccani.it, http://www.treccani.it/enciclopedia/annales/
 [4] Cfr. E. Melandri, La linea e il circolo. Studio logico-filosofico sull’analogia (1968), Quodlibet, Macerata 2004
[4] Cfr. E. Melandri, La linea e il circolo. Studio logico-filosofico sull’analogia (1968), Quodlibet, Macerata 2004
 [5] Cfr. P.-J. Salazar “Parole armate” di Salazar: ecco la cultura del Califfato che sottovalutiamo...cit.
[5] Cfr. P.-J. Salazar “Parole armate” di Salazar: ecco la cultura del Califfato che sottovalutiamo...cit.- FONTE: BLOG - LO SPIRITO E L’OSSO. storia, immaginario, filosofia e psicoanalisi di Fabio Milazzo, 30 gennaio, 2016 (ripresa parziale - senza immagini).
MITO E STORIA, POLITICA E TEOLOGIA. Storiografia in crisi d’identità:
- IL PROBLEMA GIAMBATTISTA VICO. CROCE IN INGHILTERRA E SHAFTESBURY IN ITALIA. La punta di un iceberg.
- EICHMANN A GERUSALEMME (1961). “come fu possibile la hitlerizzazione dell’Imperativo Categorico di Kant? E perché è ancora attuale oggi?” (Emil L. Fackenheim, Tiqqun. Riparare il mondo). HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI.
LA STORIA DEL FASCISMO E RENZO DE FELICE: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"!
 I. BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI - II. ARNALDO MUSSOLINI E MADDALENA SANTORO.
I. BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI - II. ARNALDO MUSSOLINI E MADDALENA SANTORO.VICO, PENSATORE EUROPEO. Teoria e pratica della "Scienza Nuova". Note per una rilettura (pdf, scaricabile)
PAROLA DI VICO. SULLA MODERNITÀ DI CARTESIO, RICREDIAMOCI.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- Appello di padre Alex Zanotelli ai giornalisti: «Rompiamo il silenzio sull’Africa».28 luglio 2017, di Federico La Sala
Appello di padre Alex Zanotelli ai giornalisti: «Rompiamo il silenzio sull’Africa»
Rilanciamo l’appello che il missionario Comboniano, direttore della rivista Mosaico di Pace, rivolge alla stampa italiana. «Non vi chiedo atti eroici, ma solo di tentare di far passare ogni giorno qualche notizia per aiutare il popolo italiano a capire i drammi che tanti popoli stanno vivendo», scrive.
di Alex Zanotelli*
Scusatemi se mi rivolgo a voi in questa torrida estate, ma è la crescente sofferenza dei più poveri ed emarginati che mi spinge a farlo. Per questo come missionario uso la penna (anch’io appartengo alla vostra categoria) per far sentire il loro grido, un grido che trova sempre meno spazio nei mass-media italiani. Trovo infatti la maggior parte dei nostri media, sia cartacei che televisivi, così provinciali, così superficiali, così ben integrati nel mercato globale.
So che i mass-media , purtroppo, sono nelle mani dei potenti gruppi economico-finanziari, per cui ognuno di voi ha ben poche possibilità di scrivere quello che vorrebbe. Non vi chiedo atti eroici, ma solo di tentare di far passare ogni giorno qualche notizia per aiutare il popolo italiano a capire i drammi che tanti popoli stanno vivendo.
Mi appello a voi giornalisti/e perché abbiate il coraggio di rompere l’omertà del silenzio mediatico che grava soprattutto sull’Africa. (Sono poche purtroppo le eccezioni in questo campo!)
È inaccettabile per me il silenzio sulla drammatica situazione nel Sud Sudan (il più giovane stato dell’Africa) ingarbugliato in una paurosa guerra civile che ha già causato almeno trecentomila morti e milioni di persone in fuga.
È inaccettabile il silenzio sul Sudan, retto da un regime dittatoriale in guerra contro il popolo sui monti del Kordofan, i Nuba, il popolo martire dell’Africa e contro le etnie del Darfur.
È inaccettabile il silenzio sulla Somalia in guerra civile da oltre trent’anni con milioni di rifugiati interni ed esterni.
È inaccettabile il silenzio sull’Eritrea, retta da uno dei regimi più oppressivi al mondo, con centinaia di migliaia di giovani in fuga verso l’Europa.
È inaccettabile il silenzio sul Centrafrica che continua ad essere dilaniato da una guerra civile che non sembra finire mai.
È inaccettabile il silenzio sulla grave situazione della zona saheliana dal Ciad al Mali dove i potenti gruppi jihadisti potrebbero costituirsi in un nuovo Califfato dell’Africa nera. È inaccettabile il silenzio sulla situazione caotica in Libia dov’è in atto uno scontro di tutti contro tutti, causato da quella nostra maledetta guerra contro Gheddafi.
È inaccettabile il silenzio su quanto avviene nel cuore dell’Africa , soprattutto in Congo, da dove arrivano i nostri minerali più preziosi.
È inaccettabile il silenzio su trenta milioni di persone a rischio fame in Etiopia, Somalia , Sud Sudan, nord del Kenya e attorno al Lago Ciad, la peggior crisi alimentare degli ultimi 50 anni secondo l’ONU.
È inaccettabile il silenzio sui cambiamenti climatici in Africa che rischia a fine secolo di avere tre quarti del suo territorio non abitabile.
È inaccettabile il silenzio sulla vendita italiana di armi pesanti e leggere a questi paesi che non fanno che incrementare guerre sempre più feroci da cui sono costretti a fuggire milioni di profughi. (Lo scorso anno l’Italia ha esportato armi per un valore di 14 miliardi di euro!).
Non conoscendo tutto questo è chiaro che il popolo italiano non può capire perché così tanta gente stia fuggendo dalle loro terre rischiando la propria vita per arrivare da noi.
Questo crea la paranoia dell’“invasione”, furbescamente alimentata anche da partiti xenofobi. Questo forza i governi europei a tentare di bloccare i migranti provenienti dal continente nero con l’Africa Compact , contratti fatti con i governi africani per bloccare i migranti.
Ma i disperati della storia nessuno li fermerà.
Questa non è una questione emergenziale, ma strutturale al sistema economico-finanziario. L’ONU si aspetta già entro il 2050 circa cinquanta milioni di profughi climatici solo dall’Africa. Ed ora i nostri politici gridano: «Aiutiamoli a casa loro», dopo che per secoli li abbiamo saccheggiati e continuiamo a farlo con una politica economica che va a beneficio delle nostre banche e delle nostre imprese, dall’ENI a Finmeccanica.
E così ci troviamo con un Mare Nostrum che è diventato Cimiterium Nostrum dove sono naufragati decine di migliaia di profughi e con loro sta naufragando anche l’Europa come patria dei diritti. Davanti a tutto questo non possiamo rimane in silenzio. (I nostri nipoti non diranno forse quello che noi oggi diciamo dei nazisti?).
Per questo vi prego di rompere questo silenzio-stampa sull’Africa, forzando i vostri media a parlarne. Per realizzare questo, non sarebbe possibile una lettera firmata da migliaia di voi da inviare alla Commissione di Sorveglianza della RAI e alla grandi testate nazionali? E se fosse proprio la Federazione Nazionale Stampa Italiana (FNSI) a fare questo gesto? Non potrebbe essere questo un’Africa Compact giornalistico, molto più utile al Continente che non i vari Trattati firmati dai governi per bloccare i migranti? Non possiamo rimanere in silenzio davanti a un’altra Shoah che si sta svolgendo sotto i nostri occhi. Diamoci tutti/e da fare perché si rompa questo maledetto silenzio sull’Africa.
*Alex Zanotelli è missionario italiano della comunità dei Comboniani, profondo conoscitore dell’Africa e direttore della rivista Mosaico di Pace.
* FONTE: FNSI, 18.07.2017
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- A SCUOLA DA JUNGER. Giorello: il sapere ha un’anima ribelle (di A. Carioti)..27 luglio 2017, di Federico La Sala
COSTITUZIONE E PENSIERO. ITALIA: LA MISERIA DELLA FILOSOFIA ITALIANA E LA RICCHEZZA DEL MENTITORE ISTITUZIONALIZZATO ... *
Giorello: il sapere ha un’anima ribelle
Nel libro intervista con Pino Donghi il filosofo elogia le rotture traumatiche che smuovono il mondo. E la lezione di Jünger: la libertà più importante è quella interiore
di ANTONIO CARIOTI *
- In alto da sinistra: Giordano Bruno e Baruch Spinoza; in basso da sinistra: Karl Popper e Galileo Galilei (illustrazioni di Fabio Sironi)
Se deve indicare parole capaci di esprimere al meglio L’etica del ribelle, titolo del suo libro intervista a cura di Pino Donghi, edito da Laterza, Giulio Giorello non cita Ernesto Che Guevara, ma neppure i suoi amati filosofi Giordano Bruno e Baruch Spinoza. Le scelte scontate non gli appartengono. Ricorre invece a un autore spiritualista e aristocratico, eroe di guerra tedesco caro alla destra: Ernst Jünger. Dal suo Trattato del ribelle ricava il concetto che la resistenza al dispotismo nasce dalla libertà interiore di chi assegna «più valore al modo di essere» che «alla pura sopravvivenza». Certo, è una visione elitaria, perché «una grande maggioranza non vuole la libertà, anzi ne ha paura». Proprio per questo è necessario creare un contesto istituzionale nel quale andare contro i detentori del potere, politico, economico e culturale, non comporti rischi troppo gravi: solo così si promuove l’innovazione che fa avanzare la conoscenza.
- «L’etica del ribelle» a cura di Pino Donghi (Laterza, pp. 157, euro 13)
Non stupisce quindi che Giorello indichi nel mondo anglosassone e protestante (apprezza anche Martin Lutero) l’ambiente culturale con cui si sente in maggiore sintonia. E proponga considerazioni piuttosto controcorrente in questi tempi di rinnovato furore antiborghese. Ricorda per esempio che «soltanto col sorgere del capitalismo e con lo sviluppo delle istituzioni scientifiche» l’autonomia della ricerca è riuscita a imporsi e agli studiosi, dopo l’epoca in cui personalità geniali come Galileo Galilei finivano sotto processo, è stata concessa «la libertà di esplorare le ipotesi più bizzarre, persino implausibili dal punto di vista del senso comune e delle loro applicazioni immediate».
In effetti traspare a più riprese nel discorso di Giorello un’evidente analogia tra il progredire del sapere, che introduce rotture traumatiche «nella costellazione delle credenze stabilite» costringendoci a «buttarle a mare», come scriveva Carlo Emilio Gadda, e la «distruzione creatrice», per usare un’espressione pregnante dell’economista austriaco Joseph Schumpeter, generata dal mercato nel campo della produzione di beni e servizi. In entrambi i campi vince chi innova: «Le eccezioni non confermano la regola, diventano una nuova regola». Andrebbe forse riconosciuto che la vera rivoluzione permanente (tutt’altro che morbida e indolore, anzi spesso spietata nel mutare la faccia del mondo) è quella derivante dall’intreccio tra ricerca scientifica, applicazioni tecnologiche e libera intrapresa economica, una vera «macchina da guerra» di fronte alla quale gli strumenti della politica e le teorie filosofiche solitamente arrancano.
- Giulio Giorello, (Milano, 1945)
Giorello di tutto questo si mostra ben consapevole, ammaestrato dalla consuetudine con il pensiero di autori come Karl Popper, Thomas Kuhn, Paul Feyerabend, ma anche dagli insegnamenti di un marxista decisamente eretico come il suo maestro Ludovico Geymonat. Sa che anche le rivoluzioni tecnologiche e produttive «sono violente, almeno in senso sofisticato», perché cancellano certezze, abitudini, posti di lavoro. Ma ribadisce la sua profonda estraneità all’impostazione dogmatica storicamente maggioritaria nella sinistra italiana (e ancora nient’affatto estinta), che pretendeva di pianificare lo sviluppo scientifico in base a non meglio identificate «istanze più progressive», destinate inevitabilmente a divenire, in un auspicato sistema collettivista, le priorità fissate dal potere della burocrazia. E resta insensibile anche alle sirene del cattolicesimo sociale, divenute più seducenti, per il pensiero di stampo progressista, con l’ascesa di Papa Francesco al soglio pontificio.
Quando Giovanni Paolo II parlava di «verità dell’essere», detenuta dalla Chiesa, e affermava la superiorità della «legge di natura» su quella umana non faceva altro che ribadire una vocazione autoritaria non troppo dissimile da quella che si manifesta in altre forme (per ragioni storiche oggi di gran lunga più violente e deleterie) d’integralismo religioso. E Giorello lo sottolinea con forza, pur non escludendo in linea di principio che Papa Bergoglio sappia «assumere non solo toni diversi, ma atteggiamenti sostanzialmente differenti a livello di prassi».
Del resto tra coloro con cui il filosofo della scienza milanese va più d’accordo c’è un suo collega cattolico come Dario Antiseri, che si è sempre adoperato per coniugare la fede nel Vangelo con la difesa dei diritti individuali. E tra i ribelli che Giorello sente idealmente più vicini troviamo, accanto a «figure indimenticabili come Pancho Villa ed Emiliano Zapata», protagonisti della rivoluzione messicana, i repubblicani irlandesi in lotta contro il dominio della corona britannica. Insorti a più riprese in nome della libertà politica, non certo di un credo religioso, ma nella quasi totalità (sia pure con importanti eccezioni) ferventi cattolici. Non importa tanto quale Dio si prega, ma per quale causa ci si batte: un altro principio ben presente in tutto il dipanarsi del libro di Giorello.
* Corriere della Sera, 27 luglio 2017 (ripresa parziale - senza immagini).
*
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR:
KANT E SAN PAOLO. COME IL BUON GIUDIZIO ("SECUNDA PETRI") VIENE (E VENNE) RIDOTTO IN STATO DI MINORITA’ DAL GIUDIZIO FALSO E BUGIARDO ("SECUNDA PAULI").
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- "Why We Select Toxic Leaders" (David Rock). Lo strano paradosso del potere (di Annamaria Testa)25 luglio 2017, di Federico La Sala
CARISMA, COSTITUZIONE, E POLITICA: AL DI LÀ DELLA TRAPPOLA ATEA E DEVOTA. Una importante provocatoria riflessione .... *
- Persone di potere dotate di un carisma privo di narcisismo esistono. In oltre quarant’anni, mi è perfino capitato di incontrarne alcune, tra politica e impresa, ma posso contarle sulle dita di una mano. Ce ne vorrebbero molte di più (Annamaria Testa).
- Why We Select Toxic Leaders (David Rock, "Psychology Today", 2016)
PSICOLOGIA
Lo strano paradosso del potere
di Annamaria Testa, esperta di comunicazione *
Che cosa frulla nella mente delle persone di potere? Ce lo domandiamo - e capita non di rado - quando i loro comportamenti ci appaiono contraddittori, o poco comprensibili, o così arroganti da essere difficili da sopportare. Un recentissimo articolo uscito sull’Atlantic ci invita a porci la domanda in termini più radicali: che cosa succede al cervello delle persone di potere?
L’Atlantic cita un paio di pareri autorevoli. Secondo Dacher Keltner, docente di psicologia all’università di Berkeley, due decenni di ricerca e di esperimenti sul campo convergono su un’evidenza: i soggetti in posizione di potere agiscono come se avessero subìto un trauma cerebrale. Diventano più impulsivi, meno consapevoli dei rischi e, soprattutto, meno capaci di considerare i fatti assumendo il punto di vista delle altre persone.
Sukhvinder Obhi è un neuroscienziato dell’università dell’Ontario. Non studia i comportamenti, ma il cervello. Quando mette alcuni studenti in una condizione di potere, scopre che questa influisce su uno specifico processo neurale: il rispecchiamento, una delle componenti fondamentali della capacità di provare empatia.
Ed eccoci alla possibile causa di quello che Keltner definisce paradosso del potere. Quando le persone acquisiscono potere, perdono (o meglio: il loro cervello perde) alcune capacità fondamentali. Diventano meno empatiche, cioè meno percettive. Meno pronte a capire gli altri. E, probabilmente, meno interessate o disposte a riuscirci.
Come polli senza testa
Inoltre. Spesso le persone di potere sono circondate da una corte di subordinati che tendono a rispecchiare il loro capo per ingraziarselo, cosa che non aiuta certo a mantenere un sano rapporto con la realtà.
E ancora: è il ruolo stesso a chiedere che le persone di potere siano veloci a decidere (anche se non hanno elementi sufficienti per farlo, né tempo per pensarci), assertive (anche quando non sanno bene che cosa asserire. O quando sarebbe meglio prestare attenzione alle sfumature) e sicure di sé al limite dell’insolenza.
I top manager delle multinazionali girano freneticamente per il mondo come polli decapitati: decidono guidati dall’ansia, senza pensare, senza capire, senza vedere e senza confrontarsi. L’ho sentito dire nel corso di una riunione riservata ai partner di un’assai nota società internazionale di consulenza, dal relatore più anziano e autorevole. Mi sarei aspettata qualche brusio di sconcerto tra gli astanti, e invece: ampi segni di assenso.
Ho il sospetto che la sindrome del pollo possa appartenere non solo a chi guida le imprese, ma anche a chi governale istituzioni e le nazioni.
Il fatto è che le persone di potere “devono” andare dritte per la loro strada, infischiandosene di tutto quanto sta attorno. Questo può aiutarle a raggiungere i loro obiettivi (il che è molto vantaggioso a breve termine) ma ne danneggia le capacità di decisione, di interazione e di comunicazione, che nel lungo termine sono strategiche.
- È facile ammirare e rispettare le persone carismatiche. Ma non è così semplice distinguere il carisma dal narcisismo
Il potere logora chi non ce l’ha, diceva Andreotti, che di potere sapeva abbastanza, citando Maurice de Talleyrand. Ma la citazione medesima contiene una dose consistente di protervia.
C’è una parola molto antica che descrive bene tutto ciò: hỳbris. Indica la tracotanza presuntuosa di chi ha raggiunto una posizione eminente e si sopravvaluta. È notevole il fatto che nel termine greco sia implicita anche la fatalità di una successiva punizione, divina o terrena: il fallimento, la caduta.
Si stima che il 47 per cento dei manager falliscano, scrive Adrian Furnham, docente di psicologia all’University College di Londra. È una percentuale molto alta. Uno dei principali motivi di fallimento è il narcisismo: un cocktail deteriore di arroganza, freddezza emozionale e ipocrisia.
C’è un paradosso: è facile ammirare e rispettare le persone carismatiche e fiduciose in se stesse. Ma non è così semplice distinguere il carisma dal narcisismo, che per molti versi ne è il lato oscuro. Sappiamo davvero individuare il confine che c’è tra assertività e prepotenza? Tra sicurezza e ostinazione? Tra fascino e manipolazione?Tra pragmatismo e cinismo?
C’è un ulteriore paradosso: prepotenza, ostinazione, manipolazione e cinismo possono perfino rivelarsi utili nelle battaglie per la conquista del potere, che sono spesso logoranti, sleali e feroci. Ma, una volta ottenuto il potere, per mantenerlo servirebbe proprio quella visione più aperta ed equilibrata che - l’abbiamo visto prima - il ruolo stesso sembra rendere difficilissima da procurarsi e mantenere. Il potere è l’afrodisiaco supremo, diceva Henry Kissinger.
Ma “difficilissimo” non vuol dire “impossibile”. D’altra parte, almeno nelle democrazie occidentali e nelle imprese moderne, il potere si conserva nel lungo termine solo attraverso il consenso. E la capacità di mantenere il consenso è direttamente proporzionale alla capacità di comunicare, di ascoltare e di interagire mettendosi a confronto.
Ehi, si può fare! Persone di potere dotate di un carisma privo di narcisismo esistono. In oltre quarant’anni, mi è perfino capitato di incontrarne alcune, tra politica e impresa, ma posso contarle sulle dita di una mano. Ce ne vorrebbero molte di più.
* Internazionale, 25 luglio 2017
Sul tema, nel sito, si cfr.:
DIO, NATURA, TECNICA COMUNICATIVA, E DEMOCRAZIA. IL "CHARISMA" DELL’ITALIA E IL "CHARISMA" DEGLI ITALIANI E DELLE ITALIANE. CARISMA, COSTITUZIONE, E POLITICA: AL DI LÀ DELLA TRAPPOLA ATEA E DEVOTA. Una importante provocatoria riflessione di Lidia Ravera
Il Narcisismo e l’uso lucidissimo come arma politica dell’"antinomia del mentitore"
UBUNTU: "Le persone diventano persone grazie ad altre persone".
 "CHI" SIAMO: LA LEZIONE DEL PRESIDENTE MANDELA, AL SUDAFRICA E AL MONDO. "La meditazione" di Marianne Williamson, nel discorso di insediamento (1994).
"CHI" SIAMO: LA LEZIONE DEL PRESIDENTE MANDELA, AL SUDAFRICA E AL MONDO. "La meditazione" di Marianne Williamson, nel discorso di insediamento (1994).FILOSOFIA, E TEOLOGIA POLITICA DELLA’ "ANDRO-POLOGIA" ATEA E DEVOTA....
 LA RISATA DI KANT
LA RISATA DI KANTFederico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- Lo strano paradosso del potere ... psicoanalisi in treno (di Annamaria Testa)31 agosto 2021, di Federico La Sala
Psicoanalisi in treno
Annamaria Testa, esperta di comunicazione*
Salgo trafelata sul treno. Il vagone è pieno. Mi tocca fare lo slalom inciampando tra valigie e persone che si incrociano nel corridoio. Trovo il mio posto. Ci sono un soprabito e un bagaglio. Il tavolino è interamente occupato dalle carte, i libri e gli appunti di un tizio che se ne sta a capo chino e scrive, a mano, su un grande foglio.
Cominciamo bene, penso. “Scusi”, sussurro.
Il tizio alza lo sguardo e in un battibaleno sposta il bagaglio e tutto il resto, lasciandomi con millimetrica precisione e ammirevole senso di simmetria l’esatta metà di tavolino che mi spetta, né di più né di meno. Operazione non facile data la quantità delle carte. Riabbassa lo sguardo.
Così va meglio, penso.
Ma mentre prendo possesso della mia porzione di territorio, scaraventando con una certa soddisfazione computer e giornali sulla mia metà del tavolo, il tizio si riscuote.
“Lei è Annamaria Testa?”.
“Sì?” dico, aggiungendo un punto di domanda bello grosso. Non è che mi succeda ogni due per tre, di essere riconosciuta da qualcuno: di solito mi muovo nel mondo protetta da una confortevole trasparenza anagrafica, come qualsiasi mia altra coetanea che non sia la signora Macron.
“Lei si occupa di creatività e quindi dell’inconscio”, dice. “Abbiamo un interesse in comune”. Questa sì che è bella, penso.
Il tizio è psicoanalista e psicoterapeuta. Si chiama Nicolò Terminio. Lavora sulle dipendenze e sui nuovi sintomi. Sta andando a Roma per intervenire a un convegno: ecco il perché di quel grande foglio di appunti.
Mi rendo conto che ho un sacco di buoni motivi per trascurare i quotidiani (pessime notizie, peraltro) e cominciare a chiacchierare. Ma dopo poco la conversazione si trasforma in una sfilza di domande, e così accendo il computer e chiedo se posso essere io, a prendere qualche appunto.
Qui di seguito potete leggere alcune delle cose che ho imparato, in modo del tutto fortuito, nel corso di un viaggio tra Milano e Firenze. Del resto, un sacco di fatti interessanti si scoprono per caso.
Che c’entra la creatività con la psicoanalisi?
Il sintomo è l’espressione di una coazione a ripetere sempre gli stessi schemi. Una cura psicoanalitica cerca di trasformare un funzionamento ripetitivo in un funzionamento creativo. Provi a pensare all’inconscio come al campo magnetico che determina il comportamento della limatura di ferro sul tavolo, dandole forma. Noi non siamo padroni dell’inconscio, così come la limatura di ferro non è “padrona” del campo magnetico.
Restando in metafora: per modificare il campo magnetico, cioè per ottenere un risultato terapeutico, che si fa?
La psicoanalisi lavora sulle narrative. L’intervento terapeutico consiste nel cambiare la maniera in cui una persona parla del proprio modo di essere, e quindi pensa al proprio modo di essere, lo costruisce e lo rappresenta. La differenza di condizione tra persone che abbiano subìto un trauma sta non tanto nella gravità del trauma in sé, ma nella possibilità di vivere o meno l’esperienza del flow, così come l’ha teorizzata quel tizio col nome impossibile.
Sì, certo: il flow, il flusso creativo (a questo punto sfoggio il nome dell’autore, Mihály Csíkszentmihályi, e la pronuncia, che è, più o meno, Cìcksentmiai). Succede quando una persona si dimentica di se stessa ed è completamente assorbita, focalizzata e felice per quanto sta facendo.
Mentre il sintomo è un modo per tenere a bada l’inconscio, la terapia asseconda ciò che l’inconscio ha da dire. Lei sa che le nuove idee nascono quando la mente si trova libera di vagare, per esempio mentre stiamo guidando, preparando la cena o lavando i piatti. Nel setting psicoanalitico, il metodo delle associazioni libere “manda il paziente a lavare i piatti”, ed è allora che si lavora creativamente sul sintomo, in una situazione di flow. Una persona va dall’analista per fare quell’esercizio lì: ricostruire e ricombinare elementi che costruiscono una nuova trama di senso.
Posso capire anche questo: Poincaré dice che creatività è combinare elementi esistenti in forme nuove e utili. E anche Umberto Eco parla di creatività come ars combinatoria.
C’è un altro punto importante. L’inconscio ha un linguaggio che si esprime non solo attraverso combinazioni di segni ma, per esempio, attraverso il ritmo del corpo. Una persona non si porta dietro solo quello che Freud per primo ha chiamato romanzo familiare, ma anche un lessico familiare, quello di cui scriveva Natalia Ginzburg, e le cui parole valgono per quello che evocano più che per quello che significano. Pensi, per esempio, a un uomo che, a differenza di come è solita chiamarlo la moglie, si sente chiamare dall’amante con il nomignolo che usavano sua madre e sua nonna quando lui era piccolo, e che evoca sensazioni di accudimento e felicità, che sono anche sensazioni fisiche. Lacan diceva che la parola è il segno assoluto, il significante prima che gli abbiano messo in bocca il sasso del significato.
Mmh... ma possiamo dire che la creatività è una medicina?
È, piuttosto, un modo di essere che cura. Non dobbiamo pensarla come un apparato esterno, o una pratica. Pensi a un uomo su un gommone: è un esempio che mi ha fatto una volta un mio paziente. Vuole andare da una piccola isola a un’altra, e a un certo punto si trova in mezzo al mare, e non vede più né da dov’era partito né dove vuole arrivare. Per essere creativi, anche in un setting terapeutico, dobbiamo salire sul gommone. Cioè, dobbiamo espropriarci di quello che crediamo di essere, senza sapere ancora che cosa potremmo essere: solo allora passiamo dalla ripetizione all’invenzione. In altre parole: dobbiamo distaccarci e affrontare qualcosa che è un buco nel sapere. Un modo di essere in cui si guarda a viso aperto ciò che ancora non si sa, e si ama ciò che non si sa. È un processo che lavora sul versante femminile.
Ehi, fermo, fermo... si comincia così, con un cenno a margine, e si finisce con far coincidere “femminile”, “spaesato” e “irrazionale”, confezionando un bel discorso sessista.
Tranquilla. Non è una questione di anatomia dei corpi, e nemmeno di genere. La psicoanalisi identifica come non creativa la logica fallica, secondo la quale il linguaggio ha l’ultima parola sulla vita e pretende di saturare tutto l’esistente. È la logica dell’avere e della competizione, e del pensare che c’è un individuo che si rivolge alla vita come se questa fosse un oggetto da possedere. È una logica di dominio. E, attenzione: molte donne seguono questa logica, e, perfino, molte donne applicano al corpo femminile uno sguardo che è squisitamente maschile. La logica della creatività, invece, è “femminile” in quanto generativa. Apprezza il mistero e ciò che si può solo evocare. E riguarda anche il lasciarsi essere il corpo che si è. Il maschio che va in analisi è quello che sperimenta il fallimento di una logica basata sulla prestazione. Un paziente mi raccontava di aver nascosto la testa nel cuscino per evitare che la moglie lo vedesse piangere “come una femminuccia”. Ecco: in una logica maschile, e secondo gli insegnamenti del padre, quello che non si padroneggia è una minaccia alla propria identità. Essere capaci di salire sul gommone vuol dire saper vivere la propria emotività lasciandosi alle spalle quegli insegnamenti: non si riesce a essere creativi senza lasciarsi possedere e trasportare. Il flow, per la psicoanalisi, è quella cosa lì: lasciarsi possedere dal desiderio. Tra l’altro, i casi di impotenza maschile possono essere connessi proprio con la difficoltà a lasciarsi prendere da se stessi, e da una parte di se stessi che non si controlla. È quello, l’inconscio.
Lei prima ha citato Lacan.
Ho una formazione lacaniana. Ma si può essere lacaniani anche senza saperlo. Lei, per esempio, scrive alcune cose lacaniane.
Devo preoccuparmi? Non ho mai capito mezza riga di quel che dice Lacan.
Le discipline che si occupano del linguaggio, psicoanalisi compresa, sono diversi dialetti di una stessa lingua, che non esiste. Lei parla un dialetto differente da quello psicoanalitico, ma può dire le stesse cose. Per Lacan, il soggetto è un parlessere che prova a gestire il linguaggio, e fallisce quando trascura il ritmo del corpo e la musica del corpo. Parla di questo un bel testo sull’improvvisazione nel jazz e nella quotidianità. L’ha scritto Davide Sparti, che insegna a Siena.
D’accordo. La comunicazione non è solo linguaggio verbale. E il linguaggio analogico, quello dei gesti, del corpo, è più potente del linguaggio verbale. Tanto che, in caso di contraddizione tra messaggi, a vincere è quello espresso nel linguaggio del corpo.
Le faccio un altro esempio di vicinanza: nel tango, l’inciampo non è un errore, ma la sorgente di un nuovo movimento, inatteso e liberato dal ritmo. Per essere creativi bisogna amare l’inciampo: quello che è nuovo viene dall’ostacolo.
Anche il mio dialetto dice che alla base di un gesto creativo c’è sempre un trauma, un ostacolo e un desiderio.
Nel 1998, Aldo Carotenuto scrive un libricino importante. S’intitola Lettera aperta a un apprendista stregone. Carotenuto dice che, per l’analista, obiettivo di un lavoro di cura è trasformare una ferita in una feritoia: cioè ottenere la possibilità di affacciarsi alla vita in un modo nuovo. E dice che proprio attraverso la cura l’analista acquisisce e sviluppa il suo metodo. In sostanza, la psicoanalisi non è un’ortopedia del soggetto, che va “aggiustato”. Noi psicoanalisti siamo di fronte alla creatività del paziente come se fosse una pianta che sboccia. Non è che in tutte le sedute succeda questo, ma quando succede se ne accorgono entrambi, l’analista e il paziente.
Quanto spesso succede?
Ci sono vari gradi. Al termine della cura la trasformazione riguarda l’intero modo di essere, ma possono esserci stadi intermedi in cui la persona impara, per esempio, a non drogarsi, o a non tagliarsi. Lo dico ancora: la ripetizione va intesa come sintomo, e in un’analisi si impara a essere creativi e a interrompere la ripetizione. Una persona finisce la cura quando è soddisfatta del suo cambiamento. Ma non ci sono criteri né check-list. L’importante, e qui torniamo al tango, è continuare a ballare.
Mi fa un esempio?
Parliamo di una cosa di cui mi occupo: le dipendenze patologiche. Già è un successo intercettare persone che sono tossicodipendenti da trent’anni, metterle in un contatto più profondo con la musica che hanno sempre sentito e coinvolgerle nel capire finalmente che cosa vogliono dire i testi inglesi delle canzoni. È un successo convincere un giocatore d’azzardo a rinunciare all’istante magico della vincita, e a sostituire il gioco con la ricerca dei funghi in un bosco, e l’istante con la scoperta del fungo. È un esempio vero. E la scossa può essere altrettanto potente: c’è un libro di Peter Handke che ne parla.
La ringrazio di questi racconti.
Provi a pensarci: in questo dialogo, lei ha sostenuto il ruolo dell’analista, mettendo me nella condizione di analizzare alcuni aspetti della mia esperienza. Io le ho parlato del mio sintomo, che è la psicoanalisi. E, insieme, cercando coincidenze tra dialetti diversi, abbiamo costruito un discorso che ha arricchito entrambi.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- BENEDETTO CROCE E LA PROSA CLERICALE DI UN LAICO ANTICO.25 luglio 2017, di Federico La Sala
CROCE “CRISTIANO” , VICO “ATEO”, E L’UOMO DELLA PROVVIDENZA... *
La prosa clericale di un laico antico
di Giorgio Pecorini (il manifesto, 25 agosto 2012)
La pagina conclusiva dei «Coni d’ombra» in cui Marco D’Eramo (il manifesto del 18 agosto) ha perpetrato quel «crimine di lesa crocianità» di cui molto si è doluto Massimo Raffaeli (21 agosto), inviata a farsi. Non m’avventuro certo in astrattezze filosofiche o esegesi storiche: conto soltanto sulle capacità osservatorie del mio mestiere di cronista. Incoraggiato e aiutato questa volta dalle osservazioni di Norberto Bobbio sul «giustificazionismo intrinseco» ricordate dallo stesso D’Eramo nella sua replica (sempre il 21). E torno, recidivo, al famoso Perché non possiamo non dirci cristiani pubblicato da Benedetto Croce su La Critica del 20 novembre 1942 e due anni dopo ristampato in fascicolo, sempre nel pieno delle seconda guerra mondiale.
In quel suo saggio il filosofo si dichiara impegnato a scrivere con libero spirito laico «né per gradire né per sgradire agli uomini delle chiese». Rivendica come «legittimo e necessario» l’uso di quel nome anche da parte di chi non appartiene ad alcuna chiesa. Vuole «unicamente affermare, con l’appello alla storia, che noi non possiamo non riconoscerci e non dirci cristiani e che questa denominazione è semplice osservanza della verità. (...) Il cristianesimo è stato la più grande rivoluzione che l’umanità abbia mai compiuta, così comprensiva e profonda, così feconda di conseguenze, così inaspettata e irresistibile nel suo attuarsi, che non meraviglia che sia apparso e ancora possa apparire un miracolo, una rivelazione dall’alto, un diretto intervento di Dio nelle cose umane, che da lui hanno ricevuto legge e indirizzo affatto nuovo».
Il trionfo del genocidio
Ma se davvero non possiamo non dirci cristiani, allora non possiamo neppure non tenerci corresponsabili di una serie di errori e crimini del cristianesimo. Misurandoli col proprio metro razionale laico, il filosofo liberale assolve la «chiesa cristiana cattolica per la corrutela che dentro di sé lasciò penetrare e spesso in modo assai grave allargare», dato che «ogni istituto reca in sé il pericolo della corrutela». E anzi la elogia per aver animato «alla difesa contro l’Islam, minaccioso alla civiltà europea». Le riconosce infine il merito, «continuando nell’opera sua», di aver riportato «i trionfi migliori nelle terre di recente scoperte del Nuovo mondo». Il fatto che quel «trionfo» sia consistito in un genocidio cristianissimo distruttore assieme alla vita della cultura e della dignità di un intero popolo è soltanto uno fra i tanti accidenti del generale processo storico con le sue crisi, e amen. Se poi gli abitatori originarii di quel Nuovo mondo non hanno gioito di quel «trionfo», non se ne sono almeno contentati se non addirittura rallegrati fra una tappa e l’altra di un genocidio cristianissimo che la loro cultura non s’è limitato a minacciarla: l’ha distrutta, assieme alla loro storia e alla loro stessa identità, dipende dalla loro mancante sensibilità eurocentrica e occidentalocentrica, che li autorizza, unici, a non dirsi cristiani. Il «famigerato giustificazionismo intrinseco» all’analisi crociana denunciato da Bobbio, appunto.
Perché non possiamo non dirci cristiani è uno smilzo opuscoletto di appena una ventina di pagine ma dense di analisi e di riferimenti a meditazioni e conclusioni precedenti dell’autore. Tanto dense che molti credenti anziché leggerle si contentano del titolo, per sbatterlo in faccia ai miscredenti: se persino un grande filosofo e critico liberale e ateo come Croce dice così.
Avessero la pazienza di leggerlo, ci andrebbero più cauti nel prenderlo e cercar di imporlo come assoluzione laica dei dogmatismi religiosi. Riconosciuta la «nuova qualità spirituale» di quella rivoluzione, cioè l’aver agito «nel centro dell’anima, nella coscienza morale» dell’uomo, Croce sùbito la ridimensiona: «non fu un miracolo che irruppe nel corso della storia e vi si inserì come forza trascendente e straniera (...) fu un processo storico, che sta nel generale processo storico come la più solenne delle sue crisi».
Il saggio di Croce è del 1942, conviene ripeterlo: nel pieno della seconda guerra mondiale. Mezzo secolo giusto dopo, 1992, chiusa anche la guerra fredda, nel cinquecentenario della presunta scoperta dell’America da parte dell’Europa e dell’inizio del genocidio delle popolazioni americane indigene da parte degli europei in nome della civiltà e del Vangelo, il Nobel per la pace viene assegnato a una donna guatemalteca di 33 anni, discendente dei rari scampati ai massacri: Rigoberta Menchù.
La scelta della giuria del premio sembra ad alcuni un contentino fra il paternalistico e il demagogico al risentimento degli amerindi e dei loro pochi sostenitori bianchi per l’enfasi e la retorica con cui l’Occidente andava celebrando l’impresa di Cristoforo Colombo. Alcuni altri si indignano: per gente di mondo smaliziata, ricca di esperienza e di efficienza pragmatica, è una scelta che suona resa e bestemmia: «Per compiacere la pseudocultura dell’ultimo anticolonialismo abbiamo messo la sordina a una delle più straordinarie vicende della storia europea. È assurdo che il papa, a Santo Domingo, si sia scusato pubblicamente come un qualsiasi uomo politico giapponese; ed è ridicolo che i discorsi commemorativi abbiano fatto ipocrite concessioni agli umori dominanti del terzomondismo pacifista. Ma che i giurati di Oslo abbiano scelto il cinquecentesimo anniversario di una grande epopea occidentale per dare l’insufficienza a Cristoforo Colombo ci pare francamente risibile». Firmato: Sergio Romano, ex ambasciatore della Repubblica italiana presso alcune fra le maggiori capitali del mondo, da molti anni oracolo dei migliori radio e telegiornali italiani pubblici e privati, abituale commentatore politico oggi del Corriere prima della Stampa. (La frase qui citata era sul quotidiano torinese del 17 dicembre ’92, in un articolo intitolato: «Se il Nobel boccia Colombo»).
Lo spirito dei tempi
Per compiacere l’eterno pragmatismo della chiesa postcostantiniana, l’Europa e l’Occidente dovrebbero insomma rivendicare gli sbudellamenti fatti in nome di Dio dalle crociate all’Iraq, i roghi delle streghe e degli eretici, le benedizioni ai regni e agli eserciti, le indulgenze, le scomuniche eccetera: tutto quanto a quelle radici è intrecciato.
Il papa assimilato con disgusto a «un qualsiasi uomo politico giapponese» era il polacco Wojtyla. Per schivare un eguale rischio, il suo successore tedesco, Ratzinger, ci chiede di non giudicare il passato col metro dell’oggi: bisogna tener conto dei diversi contesti, delle percezioni e sensibilità mutate. E come si faccia a farlo ce lo ha mostrato in concreto lui, con la visita e i discorsi ai campi di sterminio nazisti in Polonia.
S’arriva così sullo scivoloso terreno del «segno dei tempi» e alla vecchia storia delle condanne seguite dalle riabilitazioni. Vicende emblematiche di quelle tecniche riappropriatorie, di quelle smanie di normalizzazione che, accompagnate da sapienti manipolazioni censorie e da cauti sondaggi santificatorii, presiedono sempre all’interno di ogni chiesa, religiosa, culturale o politica, a ogni operazione riabilitatoria. Tecniche e smanie vecchie (si pensi soltanto a Galileo) ma che con aggiustamenti minimi continuano a funzionare. Con l’obiettivo di far credere che ad aver bisogno di perdono e riabilitazione sia il perseguitato, non il persecutore. Al quale va sempre riconosciuto lo stato di necessità o almeno l’attenuante del «segno dei tempi».
Segno talmente vago ed elastico da dover tener conto persino del «livello medio della cultura dominante da non contraddire, non urtare, non rovinare», pensa Ferdinando Camon, scrittore cattolico. Che pazientemente ci spiega: «la condanna di Galileo fu pronunciata dalla chiesa come intermediaria del senso comune». (editoriale sul supplemento Tuttolibri de La Stampa, 16 novembre 1995).
Ecco dove si finisce, a furia di non potersi non dichiarare cristiani. Al laico don Benedetto va bene così, convinto com’è che il «reale è razionale», sempre e comunque. Ma ecco anche perché un altro filosofo e matematico ateo, Piergiorgio Odifreddi, ha preso e rovesciato proprio la strausata sentenza di Croce per farne il titolo di un proprio libro contro tutte le radici dei possibili fondamentalismi religiosi: Perché non possiamo essere cristiani. E per scrupolo di maggior chiarezza ci ha aggiunto tra parentesi: (e meno che mai cattolici).
Sul tema, nel sito, si cfr.:
TEORIA E STORIA DELLA STORIOGRAFIA. IL PROBLEMA GIAMBATTISTA VICO E IL PROBLEMA DELLA COSTITUZIONE
 CROCE “CRISTIANO” , VICO “ATEO”, E L’UOMO DELLA PROVVIDENZA.
CROCE “CRISTIANO” , VICO “ATEO”, E L’UOMO DELLA PROVVIDENZA.- VICO, PENSATORE EUROPEO. Teoria e pratica della "Scienza Nuova". Note per una rilettura (pdf, scaricabile)
RENZO DE FELICE E LA STORIA DEL FASCISMO: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"!
CRISTIANESIMO E COSTITUZIONE (DELLA CHIESA E DELL’ITALIA). PERDERE LA COSCIENZA DELLA LINGUA ("LOGOS") COSTITUZIONALE ED EVANGELICA GENERA MOSTRI ATEI E DEVOTI ...
 I "DUE CRISTIANESIMI" E LA PROPRIA FACOLTA’ DI GIUDIZIO. "Perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto?".
I "DUE CRISTIANESIMI" E LA PROPRIA FACOLTA’ DI GIUDIZIO. "Perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto?".FILOSOFIA. IL PENSIERO DELLA COSTITUZIONE E LA COSTITUZIONE DEL PENSIERO
 MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA E A PENSARE BENE "DIO", "IO" E "L’ITALIA", CHI PIU’ CHI MENO, TUTTI VIVONO DENTRO LA PIU’ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA E POLITICA ITALIANA, NEL REGNO DI "FORZA ITALIA"!!!
MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA E A PENSARE BENE "DIO", "IO" E "L’ITALIA", CHI PIU’ CHI MENO, TUTTI VIVONO DENTRO LA PIU’ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA E POLITICA ITALIANA, NEL REGNO DI "FORZA ITALIA"!!! -
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- Sulla tomba di KANT "Legge Morale" e "Cielo stellato" sulla tomba dell’EUROPA Napoleone-Hegel-Heidegger?!22 luglio 2017, di Federico La Sala
Sulla tomba di KANT
"Legge Morale"
e
"Cielo stellato"
sulla tomba dell’EUROPA
Napoleone-Hegel-Heidegger?!
KANT, FREUD, E LA BANALITA’ DEL MALE
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- COLONIALISMO. ITALIA: PER LIBIA, ETIOPIA, E SOMALIA, UNA "VECCHIA" PROPOSTA DELLO STORICO ANGELO DEL BOCA.24 luglio 2017, di Federico La Sala
COLONIALISMO. ITALIA...
ISTITUIRE LA GIORNATA DELLA MEMORIA
per 500mila Africani uccisi dalla presenza coloniale italiana in
LIBIA, ETIOPIA, E SOMALIA.
UNA PROPOSTA DELLO STORICO ANGELO DEL BOCA
RENZO DE FELICE E LA STORIA DEL FASCISMO: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"!
ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
-
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- FASCISMO, COSTITUZIONE, E STORIOGRAFIA.22 luglio 2017, di Federico La Sala
FILOSOFIA. IL PENSIERO DELLA COSTITUZIONE E LA COSTITUZIONE DEL PENSIERO. Storiografia in crisi d’identità ...
Giuramento di fedeltà al Fascismo *
In base a un regio decreto emanato il 28 agosto 1931 i docenti delle università italiane avrebbero dovuto giurare di essere fedeli non solo allo statuto albertino e alla monarchia, ma anche al regime fascista. L’idea dell’inserimento della clausola di fedeltà al fascismo viene attribuita al filosofo Balbino Giuliano, che ricopriva in quegli anni la carica di Ministro per l’Educazione Nazionale nel governo Mussolini[1].
 In tutta Italia furono solo una quindicina di personalità, su oltre milleduecento docenti, a rifiutarsi di prestare giuramento di fedeltà al fascismo perdendo così la cattedra universitaria. Il numero effettivo delle persone che non si sottoposero al giuramento oscilla di qualche unità a seconda delle fonti. L’indeterminazione è dovuta anche ad alcune situazioni particolari, di docenti che vi si sottrassero per vie diverse: Vittorio Emanuele Orlando, ad esempio, andò anticipatamente in pensione, mentre altri, come Giuseppe Antonio Borgese, si allontanarono dall’Italia fascista andando esuli all’estero[1]. Allo stesso modo non si sottopose al giuramento il docente ed economista Piero Sraffa, già da alcuni anni esule a Cambridge[1] .
In tutta Italia furono solo una quindicina di personalità, su oltre milleduecento docenti, a rifiutarsi di prestare giuramento di fedeltà al fascismo perdendo così la cattedra universitaria. Il numero effettivo delle persone che non si sottoposero al giuramento oscilla di qualche unità a seconda delle fonti. L’indeterminazione è dovuta anche ad alcune situazioni particolari, di docenti che vi si sottrassero per vie diverse: Vittorio Emanuele Orlando, ad esempio, andò anticipatamente in pensione, mentre altri, come Giuseppe Antonio Borgese, si allontanarono dall’Italia fascista andando esuli all’estero[1]. Allo stesso modo non si sottopose al giuramento il docente ed economista Piero Sraffa, già da alcuni anni esule a Cambridge[1] . I nomi dei docenti furono:
I nomi dei docenti furono: Ernesto Buonaiuti (storia del cristianesimo)[2]
Ernesto Buonaiuti (storia del cristianesimo)[2]
 Giuseppe Antonio Borgese (estetica)[3]
Giuseppe Antonio Borgese (estetica)[3]
 Aldo Capitini (filosofia)
Aldo Capitini (filosofia)
 Mario Carrara (antropologia criminale)
Mario Carrara (antropologia criminale)
 Antonio De Viti De Marco (scienza delle finanze)
Antonio De Viti De Marco (scienza delle finanze)
 Gaetano De Sanctis (storia antica)
Gaetano De Sanctis (storia antica)
 Floriano Del Secolo (lettere e filosofia)[4]
Floriano Del Secolo (lettere e filosofia)[4]
 Giorgio Errera (chimica)
Giorgio Errera (chimica)
 Giorgio Levi Della Vida (lingue semitiche)
Giorgio Levi Della Vida (lingue semitiche)
 Piero Martinetti (filosofia)
Piero Martinetti (filosofia)
 Fabio Luzzatto (diritto civile)
Fabio Luzzatto (diritto civile)
 Bartolo Nigrisoli (chirurgia)
Bartolo Nigrisoli (chirurgia)
 Errico Presutti (diritto amministrativo)[3]
Errico Presutti (diritto amministrativo)[3]
 Francesco Ruffini (diritto ecclesiastico)
Francesco Ruffini (diritto ecclesiastico)
 Edoardo Ruffini Avondo (storia del diritto)
Edoardo Ruffini Avondo (storia del diritto)
 Lionello Venturi (storia dell’arte)
Lionello Venturi (storia dell’arte)
 Vito Volterra (fisica matematica)
Vito Volterra (fisica matematica)
 Molti degli accademici vicini al comunismo aderirono invece al giuramento seguendo il consiglio di Togliatti[1], con la giustificazione che il prestare giuramento permettesse loro di svolgere, come dichiarò Concetto Marchesi, «un’opera estremamente utile per il partito e per la causa dell’antifascismo»[5]. Analogamente, la maggior parte dei cattolici, su suggerimento del Papa Pio XI, ispirato probabilmente da Agostino Gemelli[1], prestò giuramento «con riserva interiore»[1][5].
Molti degli accademici vicini al comunismo aderirono invece al giuramento seguendo il consiglio di Togliatti[1], con la giustificazione che il prestare giuramento permettesse loro di svolgere, come dichiarò Concetto Marchesi, «un’opera estremamente utile per il partito e per la causa dell’antifascismo»[5]. Analogamente, la maggior parte dei cattolici, su suggerimento del Papa Pio XI, ispirato probabilmente da Agostino Gemelli[1], prestò giuramento «con riserva interiore»[1][5].
 Vi fu chi accondiscese al giuramento, tra questi Guido Calogero e Luigi Einaudi, seguendo l’invito di Benedetto Croce, «per continuare il filo dell’insegnamento secondo l’idea di libertà»[5] a impedire che le loro cattedre - secondo l’espressione di Einaudi - cadessero «in mano ai più pronti ad avvelenare l’animo degli studenti»[6].
Vi fu chi accondiscese al giuramento, tra questi Guido Calogero e Luigi Einaudi, seguendo l’invito di Benedetto Croce, «per continuare il filo dell’insegnamento secondo l’idea di libertà»[5] a impedire che le loro cattedre - secondo l’espressione di Einaudi - cadessero «in mano ai più pronti ad avvelenare l’animo degli studenti»[6].* FONTE. Da Wikipedia, l’enciclopedia libera. (ripresa parziale - senza note).
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- L’ITALIA, LA CHIESA, L’OCCIDENTE. La Chiesa è chiamata ad essere veramente cattolica, cioè universale!!!21 luglio 2017, di Federico La Sala
INDIETRO NON SI TORNA.
Il cristianesimo non è un "cattolicismo": il ’cattolicesimo’ è morto:
La Chiesa non può rimanere prigioniera dell’Occidente
Il filosofo Rocco Buttiglione risponde al collega Marcello Pera che aveva criticato duramente Francesco affermando che non comprende i problemi delle democrazie occidentali
- Jorge Mario Bergoglio viene creato cardinale da san Giovanni Paolo II nel giugno 2001
di Rocco Buttiglione *
Marcello Pera ha criticato violentemente Papa Francesco in un articolo sul Mattino di Napoli. Il Papa, dice Pera, non è un difensore dell’Occidente, non capisce i problemi delle democrazie occidentali e, sui temi della immigrazione, assume un punto di vista che noi occidentali non possiamo condividere. Egli ha una posizione profondamente diversa e perfino opposta rispetto a quelle di san Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI. Pera è acuto come sempre e molte delle cose che dice sono vere. Io penso tuttavia che non abbia capito il senso più profondo di questo pontificato e provo a spiegare perché.
Pera ha ragione in un punto: per questo Papa l’Europa non è più il centro del mondo. Non è giusto pensare che non gli importi dell’Europa o della difesa della sua anima cristiana. È vero però che non pensa che questo sia il suo compito primario. La difesa dei valori cristiani che stanno alla base dell’Europa è compito dei vescovi europei, dei laici e dei politici europei. Il Papa ovviamente li appoggia ma questo non sarà più per lui il compito prevalente.
Il Papa non è europeo ma latinoamericano. Non è soltanto un dato anagrafico. Abbiamo un Papa latinoamericano e non europeo perché la Chiesa Cattolica non è più prevalentemente europea. Viviamo la crisi della egemonia mondiale dell’Europa. Più esattamente viviamo la crisi della egemonia mondiale dell’Occidente. È una crisi demografica: la Chiesa conta sempre meno in Europa ma l’Europa conta sempre meno nel mondo. Cresce invece in Africa ed in tutto quello che una volta si chiamava Terzo Mondo. La maggioranza relativa dei cattolici vive oggi in America Latina e forse due terzi dei cattolici vive nel Terzo Mondo.
La crisi è anche culturale. Una volta era diffusa la convinzione che i paesi non occidentali fossero “arretrati” e avrebbero alla fine seguito le tendenze stabilite dai paesi occidentali. Oggi sembra piuttosto che stiano cercando nuove strade. Molti fenomeni che noi consideriamo di “progresso” potrebbero alla fine risultare piuttosto fenomeni del declino e della decadenza europea. È interessante osservare che anche economicamente Europa e Stati Uniti rappresentano oggi meno del 50% del PIL mondiale.
Sbaglia Papa Francesco a pensare di dovere assumere una ottica più universale e meno europea? Sbaglia ad assumere un punto di vista e un linguaggio che sono più da “Terzo mondo” che europei e che, peraltro, gli sono anche più congeniali? Forse non sbaglia. Chiese che eravamo abituati a considerare periferiche sono diventate (stanno diventando) centrali e noi siamo diventati un po’ periferici. Il processo è complicato, rischioso e pieno di pericoli. È però inevitabile. I problemi della Chiesa nascono dalla dinamica demografica mondiale (America Latina) e dalla grande crescita missionaria della Chiesa stessa (Africa ed Asia). Sarebbe ingeneroso pensare che essi derivino solo o primariamente da Papa Francesco. Derivano in realtà dalla forza delle cose o (meglio) dalla volontà imperscrutabile dello Spirito Santo.
Forse faremmo meglio a domandarci che tipo di conversione lo Spirito di Dio ci chiede in questa tappa della storia della Chiesa e della storia della umanità. Uno dei problemi di questa fase storica per noi occidentali è che dobbiamo fare i conti con una immagine di noi stessi che non ci piace. I poveri del mondo pensano che ci siamo appropriati di una parte troppo grande delle ricchezze del pianeta. Pensano di essere stati espropriati e derubati. Questo giudizio non è del tutto vero ma non è neppure del tutto falso. Con ammirevole equilibrio Papa Francesco ha avuto il coraggio di dire che il colonialismo ha avuto anche dei lati positivi. Non ha nascosto però di pensare che ha avuto i suoi lati negativi, ed è difficile dargli torto. Non si può nemmeno dire che su questo punto si contrapponga a san Giovanni Paolo II. Basta ricordare il discorso di san Giovanni Paolo II a Gorée, alla fortezza degli schiavi.
In questo passaggio di epoca molti importanti valori rischiano di andare perduti. Valori di razionalità sociale ed anche di comprensione scientifica della società. La comprensione dei valori della competizione e del mercato è un valore permanente. Se i paesi poveri oggi sono diventati meno poveri e molti di loro hanno iniziato un percorso virtuoso di crescita economica questo è dovuto al fatto che hanno saputo utilizzare in modo giusto la regola del mercato.
Non riusciremo però a difendere questa verità se non confesseremo che molte volte questa regola della competizione è stata utilizzata in modo falsato, le carte del gioco sono state truccate e i poveri ne hanno fatto le spese. Se si legge con animo sgombro da pregiudizi la grande enciclica Centesimus Annus di san Giovanni Paolo II si vede che essa riconosce pienamente i valori del mercato ma è lungi dall’essere apologetica del capitalismo. Alle economie di mercato, delle quali si riconoscono i meriti anche etici, si pongono però delle forti esigenze morali. Quanto stiamo onestamente dando soddisfazione a questi obblighi morali? È importante notare, d’altro canto, che Papa Francesco ha sottolineato molte volte la positività del modello della economia sociale di mercato.
Noi dobbiamo cercare di aiutare il transito nella nuova sintesi dei valori permanenti dell’Occidente ma per farlo dobbiamo essere capaci di spogliarli di aspetti contingenti che ne possono impedire la giusta universalizzazione. Siamo chiamati anche ad ascoltare e a comprendere, senza pretese di falsa superiorità, altre sensibilità ed altre culture.
Una accusa sollevata frequentemente contro Papa Francesco è quella di essere populista. Forse è vero ma siamo sicuri di sapere esattamente che cosa sia il populismo latino/americano, al di là delle usuali caricature? Il populismo è l’unica originale filosofia politica latino/americana. Essa fa leva sulle idee di giustizia e di diritto naturale che entra nella cultura latino/americana con Bartolomé de Las Casas e con la sua difesa degli Indios. Essa si mescola poi con elementi anarchici, anarco/sindacalisti ed anche fascisti. C’è dentro il meglio ed il peggio ma una autentica visione politica latino/americana verrà fuori da una depurazione e da una scissione interna del populismo.
Un grande amico di Papa Francesco (e mio), Alberto Methol Ferré, ha indicato i lineamenti ed i percorsi di questa possibile purificazione. Non è compito della Chiesa (latinoamericana) accompagnare e sostenere questa purificazione attraverso un confronto serrato con la dottrina sociale cristiana?
Pera vede nel cristianesimo un baluardo dell’Europa e della civiltà occidentale. Ha ragione e questo baluardo io voglio difendere insieme con lui. Quella sintesi europea del cristianesimo contiene valori permanenti e senza di essi l’Europa si dissolve. Il cristianesimo però non si esaurisce nella funzione di difesa della civiltà occidentale. Il cristianesimo può entrare all’interno di altri orizzonti culturali e produrre nuove sintesi. Quella occidentale non esaurisce le potenzialità del cristianesimo. Per questo non è giusto che la Chiesa si identifichi con l’Occidente.
L’Occidente è solo uno dei suoi figli. Come non smettere di esercitare il suo ruolo fondamentale nell’Occidente senza peraltro identificarsi con esso? È necessario che ciascuno si assuma con più decisione le proprie responsabilità. Nel caso della immigrazione è chiaro che il Papa la vede prevalentemente con l’ottica dei paesi poveri. I leader politici e culturali dell’Occidente devono invitare i loro popoli ad essere generosi ma devono anche dire sinceramente, anche al Papa, quali sono i limiti della generosità dei loro popoli, limiti che non possono essere superati senza scatenare una reazione di razzismo e xenofobia.
La Chiesa non può rimanere prigioniera dell’Occidente. Uscendo dal limite dell’Occidente essa può forse mediare quel conflitto delle civiltà di cui parla Huntington che è già cominciato e minaccia di estendersi sempre più nel futuro portando alla fine alla distruzione dell’umanità. La Chiesa è chiamata ad essere più veramente cattolica, cioè universale. Il Papa latinoamericano è una tappa di questo cammino.
* Filosofo, politico e accademico italiano, è stato Ministro per due volte, Parlamentare europeo, consigliere comunale a Torino e Vicepresidente della Camera dei Deputati
* LA STAMPA, 20/07/2017 (ripresa parziale - senza immagini).
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Il cristianesimo non è un "cattolicismo": il ’cattolicesimo’ è morto.
 INDIETRO NON SI TORNA: GIOVANNI PAOLO II, L’ULTIMO PAPA. PER IL DIALOGO A TUTTI I LIVELLI: UT UNUM SINT. Un omaggio a WOJTYLA: UN CAMPIONE "OLIMPIONICO", GRANDISSIMO. W o ITALY !!!
INDIETRO NON SI TORNA: GIOVANNI PAOLO II, L’ULTIMO PAPA. PER IL DIALOGO A TUTTI I LIVELLI: UT UNUM SINT. Un omaggio a WOJTYLA: UN CAMPIONE "OLIMPIONICO", GRANDISSIMO. W o ITALY !!! -
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA --- FILOSOFIA E PSICOANALISI. “Grazie a Lacan ho viaggiato su una nave pirata" (Giacomo Contri).17 luglio 2017, di Federico La Sala
USCIRE DALLO STATO DI MINORITÀ! PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!! ... *
Giacomo Contri
“Grazie a Lacan ho viaggiato su una nave pirata. La sua è l’intelligenza più spericolata nella quale mi sono imbattuto. Era il pazzo fuggito dalla gabbia, faceva paura"
di ANTONIO GNOLI (la Repubblica, 16.07.2017) *
Giacomo Contri ha introdotto Jacques Lacan in Italia. Lacan genio e provocatore: fumo (molto per alcuni) e arrosto. "Quando portai gli Scritti di Lacan in Italia la psicoanalisi si era ridotta al palloncino in mano alla creatura, robetta infantile, pisciatine nel letto, sgridate e avvertimenti. E allora ecco giungere un signore, con i suoi baveri di pelliccia e il fumo dei sigari, a portare lo scompiglio. Sì, improvvisamente, senza preavviso, il pazzo era fuggito dalla gabbia e tutti ne ebbero paura o ne furono soggiogati". Gli Écrits ai quali Contri allude comparvero in Francia mezzo secolo fa e in traduzione da Einaudi una decina di anni dopo. Rappresentarono, per molti versi, una svolta, un vocabolario nuovo: a volte astruso, altre affascinante su cui far poggiare quel vasto e traballante regno della psicoanalisi. "A quell’epoca Lacan aveva solo sporadici lettori in Italia. Ricordo ancora una quartina che Elvio Fachinelli mi dedicò: "Mena Lacan per l’aia/ Giacomo Contri analista/ Prima che sian migliaia/ Sparagli a vista". Elvio fu un amico, ma poi il fuoco ha abbondato" . Contri sembra un personaggio disegnato da Max Bunker, alias Magnus, l’accostamento mi viene anche notando una pila di fumetti, seminascosta tra una tenda e il mobile.
Legge anche fumetti?
"Perché non dovrei? È letteratura popolare, ne ho una biblioteca enorme".
Cosa la seduce del fumetto?
"La mitologia che le immagini si portano dietro. Il lato mitologico dell’esistenza fu avversato da Platone, che poi non disdegnò di usare il mito. Freud invece ne ha spremuto il succo".
Ha senso dirsi oggi freudiani?
" È soltanto un modo di dire, un’etichetta e niente più. È venuta meno quella unicità che Freud stesso si era attribuito con i suoi libri e le sue parole. Solo io, ripeteva, posso dire che cosa è o non è la psicoanalisi. Parlava come il Papa".
Poteva permetterselo?
" Certo, costruì la psicoanalisi come se fosse una scienza sperimentale. L’osservazione era il primo momento della sperimentazione. E il territorio delle nevrosi è in larga parte esplorabile".
Ma la nevrosi non è proprio ciò che sfugge alla sperimentazione? Ciascuno vive soggettivamente la propria nevrosi.
" Magari fosse così. La verità è che la nevrosi, come la psicosi, è una gabbia coattiva, non la si vive secondo un modo proprio. Voglio dire che la nevrosi è come un cristallo, incapace di varianti".
Ma allora perché Freud è tramontato?
"Sono tramontati i freudiani. Rimozione, coazione a ripetere, fissazione, angoscia non sono affatto tramontate".
Lei come è finito a occuparsi di psicoanalisi?
" La prima cosa che mi è accaduta è stata laurearmi in medicina. Ma non avrei mai fatto il medico. Mi iscrissi nel 1961, l’anno dopo cominciai a frequentare l’istituto di psicologia e in particolare entrai in contatto con Marcello Cesa- Bianchi. A quel tempo la psicoanalisi freudiana si incarnava in Cesare Musatti e nel suo allievo Franco Fornari. Poi lasciai Milano e presi la strada per Parigi. Pensai di trovare lì il clima culturale giusto".
Come si adattò?
"Cominciai a frequentare l’École pratique. I primi contatti furono con Roger Bastide, Roland Barthes e Claude Lefort. Avevo grande stima per Louis Althusser, e per il suo modo originale di leggere Marx e uccidere la moglie. Neanche Jarry avrebbe saputo tenere insieme quelle due tragedie".
Che cosa le legava?
"Fu un omicidio ad alto tasso simbolico. Consumato contro la sua comunità intellettuale, che gli faceva abbastanza schifo".
Mi sembra un accostamento azzardato.
"E perché? In entrambi i casi agiva contro l’autorità: il matrimonio, gli affetti, le lusinghe. Disse che su Marx si era inventato tutto e che li aveva presi in giro. Trovo divertente che per molto tempo Étienne Balibar, suo allievo prediletto, tutte le settimane gli portasse i panini in manicomio!".
Lei lo avrebbe fatto per Lacan?
"Il manicomio di Lacan era il mondo!".
Come lo ha conosciuto?
" Sentii parlare dei suoi celebri seminari. Avevo conosciuto François Wahl, il direttore delle edizioni Seuil, suo amico. Gli chiesi se poteva introdurmi. Venivo da un po’ di letture psicoanalitiche e nel 1968 ebbi tra le mani gli Écrits. Lacan abitava in rue de Lille. Giunsi in una tarda mattina con la mia personalissima mitologia sull’uomo. Faceva molto freddo. Mi venne ad aprire Gloria, la segretaria".
E Lacan?
" Arrivò dopo un po’. Guardai quest’uomo che sembrava avesse fretta. Avemmo una conversazione rapida e insensata. A un certo punto mi chiese cosa stessi leggendo, risposi Max Weber. Il colloquio si interruppe a quel punto".
Forse si aspettava che citasse un suo libro.
"Non era tipo da accettare piaggerie. Andai a trovarlo diverse volte. Mi considerava un potenziale allievo. Cominciai l’analisi con lui".
Era necessaria?
"Beh, se volevo lavorarci assieme era una premessa indispensabile. Le sue sedute psicanalitiche erano famose per la rapidità, non superavano mai il quarto d’ora".
Finita la seduta come si sentiva?
" Bene, mi piacevano quegli incontri. Avevo la netta sensazione che qualcosa di non presente in me uscisse dal mio pensiero".
Catherine Millot in un recente libro (edito da Cortina) ha raccontato il Lacan privato, ne esce un ritratto piuttosto insolito, perfino sorprendente.
" Ho conosciuto bene Catherine, una donna bellissima che fu prima amante e poi compagna di Lacan. Non ho letto il libro, ma credo sapesse molte cose della sua vita privata".
E lei cosa sapeva del Lacan meno noto?
"Aveva ereditato qualcosa del vecchio surrealismo".
Un provocatore?
" Un provocatore e un maramaldo, nel senso " tu uccidi un Io morto". Non aveva nessuna fiducia nell’Io; nel pensiero; nella norma. Semplicemente era dalla parte della legge simbolica non da quella giuridica. Mi torna in mente un piccolo episodio".
Quale?
"Eravamo in macchina, lui guidava con molta spericolatezza e detestava i semafori. Diventava matto davanti a un semaforo rosso. Era uno dei suoi tratti patologici: non accettare la norma".
Insomma un pessimo cittadino.
" Non era un esempio di urbanità e di disciplina. Per lui il diritto era una entità impensabile. Come impensabile era la libertà. Anni dopo, staccandomi da quella visione, sostenni che dopotutto la vita psichica è vita giuridica".
Un’affermazione misteriosa.
" Frutto delle mie letture kelseniane. Kelsen teorizzò una cosa che ho fatto mia: l’uomo non è imputabile perché è libero; è libero perché è imputabile".
È libero perché una norma può condannarlo?
"Secoli di discussioni sul libero arbitrio sono stati azzerati. La vita psichica è vita giuridica perché niente di quello che facciamo è esente dall’imputabilità. Noi compiamo atti che sono imputabili da altri secondo norma".
Che ruolo gioca la colpa?
" Nessuno. Da quando in qua il delitto è fonte e senso di colpa? Quando Freud legge Delitto e castigo vuole capire perché Raskolnikov prima uccide la vecchia e poi tenta di tutto per farsi scoprire. Il motivo è chiaro: Raskolnikov deve dare un contenuto alla propria colpa. È il senso di colpa che giustifica il delitto e non viceversa".
Il crimine come gratificazione?
" Perfino nella Bibbia si dice: guardatevi da questi uomini, commettono le ingiustizie più atroci e sono felici".
Più che la Bibbia sembra il Marchese De Sade.
"Mi viene in mente il saggio di Lacan su Kant contro Sade".
Le viene in mente perché?
"Sono messe a confronto due forme di perversione".
Sade certamente, ma Kant?
" Kant è uno scrittore dell’orrore e della perversione. È il prezzo che paga per essere il pensatore della purezza e della ragione. Dietro il suo pietismo cristiano si nasconde la più formidabile macchina anticristiana che la modernità abbia mai costruito".
Qual è il suo rapporto con la religione?
"Perché me lo chiede?".
Ci sono molte tracce nel suo pensiero.
"Il cattolicesimo è stato uno dei miei orientamenti. Potevo gettare la fede alle ortiche o tentare di fare un passo ulteriore".
Verso quale direzione?
" Mi sono convinto che Gesù non fosse un semplice maestro, un guaritore o un santone. Era un pensatore, come fu Platone prima di lui o Galileo e Marx dopo di lui. La mia considerazione non implica nessun riferimento alla sua esistenza storica. Per me è sufficiente sapere che il suo pensiero formale si è costituito nella seconda metà del primo secolo".
Si sostiene che sia stato Paolo a dare forma a quel pensiero.
"Si è spesso detto che, stringi stringi, Paolo abbia inventato il cristianesimo. Secondo me lo ha messo in bella copia. La verità è che il cristianesimo nasce da un oscuro pensiero che lo precede".
Oscuro perché? La predicazione del Cristo fu semplice e diretta.
"Nel senso dello "Spirito" che precede la "lettera". Il pensiero di Gesù non è ontologico, né metafisico, mantiene una distanza netta dal pensiero greco. Né tanto meno è un pensiero teologico".
Non è un pensiero religioso?
"È un pensiero che non è né ha religione. È il pensiero dell’innocenza ".
Però lei è cattolico.
"Apostolico e romano. Da questo punto di vista definirei la Chiesa non un unione mistica né di massa, ma una costellazione di legami sociali. Se ha senso distinguere una fede questa può solo consistere in un giudizio di affidabilità. Fede è comprendere se un pensiero è affidabile. Altrimenti è solo un gadget dello spirito".
So che lei si è affidato a don Giussani.
"Sono stato tra i primi a partecipare al movimento di Comunione e Liberazione fondato da don Giussani".
Come avvenne l’incontro?
" Al ginnasio dove lui insegnava religione. Lo incontrai nel 1956. Fino al 1969 sono stato ad ascoltarlo. Nella piattezza abitudinaria del mio credo fu un fulmine a ciel sereno. Parlava di Gesù come di un "fatto"".
Come un fatto in che senso?
" Fuori dalle traiettorie teologiche e morali. Meritava di essere ascoltato. Era un prete che non aveva niente del prete. Il che sembra quasi impossibile".
È una notazione interessante.
"Mi pare fosse Guicciardini a parlare della scelleratezza dei preti. E Giussani non aveva niente di scellerato".
La sua lezione in che cosa è consistita?
" Forse nella difficile collocazione del suo pensiero. Aveva un orientamento che chiamerei il senso del religioso. Che è molto diverso dalla religione in quanto tale. È arduo definire Giussani cattolico e forse anche per questo non ha mai contrastato le cose ufficiali del cattolicesimo. L’ultima volta che lo vidi fu in casa di amici comuni".
Un congedo?
"In un certo senso. Era sulla sedia a rotelle. Mi guardò con quegli occhi grandi e sporgenti che accentuavano il volto scavato: Giacomo, disse stringendomi la mano, non si capisce più niente".
Cosa c’era da capire?
" Non c’era una risposta canonica in grado di spiegare quella confessione che mi fu fatta all’inizio del nuovo secolo. Un uomo che aveva lottato per tutta la vita per un fine improvvisamente si trovava davanti a un fallimento epocale e certo non bastavano, a rendergli meno amara la situazione, le decine di migliaia di persone che componevano il suo movimento. La verità è che don Giussani è stato uno degli uomini più soli che abbia mai conosciuto".
Ma ha coinvolto e fatto crescere un movimento.
" È vero, ma mi fermerei lì. Quel " non si capisce più niente" lo avevo vissuto molti anni prima e fu il motivo per passare armi e bagagli a Freud e poi a Lacan".
Forse a questo punto bisognerebbe accennare al cattolicesimo di Lacan.
"Ah! Diceva di avere un grande amore per il cattolicesimo. Ma nelle sue migliaia di pagine non ho letto nulla di significativo sull’argomento. Dal cattolicesimo aveva ereditato l’amore per le chiese barocche e l’ipocrisia suprema".
Dopo tanti anni di frequentazione non le è venuta la tentazione di liberarsi di Lacan?
"La sua fu l’intelligenza più spericolata nella quale mi sono imbattuto. Con lui è stato come andare dagli Appennini alle Ande senza cercare la mamma. No, non intendo liberarmi dall’esperienza di avere viaggiato su una nave pirata".
Che cosa è un maestro per lei?
" Il maestro non è la buona via, ma tant’è ci passiamo tutti. A Lacan il maître non piaceva né come maestro né come padrone. Ma lui fu maledettamente entrambe le cose".
*
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!:
- PSICOANALISI: LACAN INTERPRETA "KANT CON SADE" E SI AUTO-INTERPRETA CON "L’ORIGINE DEL MONDO" DI COURBET. Due note
- CON KANT E FREUD, OLTRE. Un nuovo paradigma antropologico: la decisiva indicazione di ELVIO FACHINELLI
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- MEDIOCRITA’, BANALITA’, E TRAGEDIA. Fantozzi e Kafka. Vittime (di Sergio Benvenuto).15 luglio 2017, di Federico La Sala
STORIA, CINEMA, E LETTERATURA ...
- "Gli impiegati bacherozzi o condannati alla pena capitale di Kafka sono il culmine di una tradizione letteraria, e poi cinematografica, che ha prodotto grandi capolavori negli ultimi due secoli. È il filone che chiamerei La Tragedia della Mediocrità - il versante opposto della Banalità del Male di Hanna Arendt" (Sergio Benvenuto, "Fantozzi e Kafka. Vittime") *
Fantozzi e Kafka. Vittime
di Sergio Benvenuto (DoppioZero, 15.07.2017)
Franz Kakfa era lo scrittore preferito da Paolo Villaggio. Questo non mi sorprende affatto, perché il Fantozzi che Villaggio ha fatto entrare nell’Enciclopedia dei Caratteri - assieme all’ipocrita, al misantropo, al millantatore, al soldato sbruffone, all’avaro, all’ipocondriaco, ecc. della commedia classica - è la versione burlesca, popolaresca, dei maggiori personaggi di Kafka, tutti un po’ fantozziani, anche se in chiave tragicissima. In fondo, anche Kafka spesso muove al riso, solo che la risata ci si congela in bocca, si storce in un ghigno di angoscia. La Repubblica ha riproposto Villaggio con lo slogan “Ci ha fatto piangere dal ridere”, Kafka invece ci fa ridere pur piangendo.
I protagonisti di Kafka sono quasi tutti, in effetti, delle vittime assolute. La più assoluta è forse Gregor Samsa, l’impiegato - guarda caso! - che un bel mattino si ritrova trasformato in scarafaggio, nel racconto La metamorfosi. Non solo Gregor è mutato nell’essere più abietto, ma la famiglia lo colpevolizza per questo, e suo padre finirà per punirlo con la morte. Impiegato vittima è anche Herr K. protagonista di Il processo. Si suol dire che K. subisce un processo e alla fine è condannato a morte per una accusa che non gli viene mai rivelata; ma Kafka non è così lineare. La verità è che a noi lettori l’accusa non è mai palesata, e il testo ci lascia liberi di pensare che invece K. la conosca, oppure no. Impiegato come agrimensore è il protagonista, chiamato K. anche lui, de Il Castello: qui l’eroe non riuscirà mai a entrare in contatto con i funzionari del misterioso Castello che pure lo ha chiamato; egli finirà col restare sempre nel villaggio dominato dal castello, cercando invano di essere accolto dall’invisibile datore di non-lavoro.
Kafka chiama K. molti suoi protagonisti perché era lui stesso un fantozzi. Prima di essere pensionato per la sua tubercolosi, per anni ha lavorato come impiegato all’Agenzia Assicurativa per gli Incidenti sul Lavoro del regno di Boemia. “Lavoro alimentare” da lui disprezzato, ma che pervade il mondo dei suoi eroi.
Come gli impiegati-vittime di Kafka, anche Fantozzi non è cattivo, non farebbe male a una mosca. È servile, pavido, imbranato, ma non cattivo. Ogni tanto ha dei moti alquanto velleitari di rivolta contro i suoi capi, tutti, anche se in modi diversi, sadici. Così il suo famoso urlo “La Corazzata Potëmkin è una boiata pazzesca!” quando un capoufficio cinefilo impone di vedere il film di Ėjzenštejn proprio in coincidenza con la finale del Campionato del mondo di calcio. Ma sono rivolte senza domani, puri scatti “non-costruttivi” che vengono puntualmente puniti.
Si è detto che la saga fantozziana avrebbe tacitamente contestato il primato che per la sinistra hanno avuto sempre la classe operaia e i contadini. Villaggio, focalizzando sulla miseria esistenziale degli impiegati, avrebbe reso comprensibile la famosa marcia dei 40.000 (impiegati) della FIAT a Torino che nel 1980 pose fine, in Italia, a una certa egemonia politica operaia. In realtà il povero impiegato era stato scoperto come eroe letterario già dal Romanticismo. Gli impiegati bacherozzi o condannati alla pena capitale di Kafka sono il culmine di una tradizione letteraria, e poi cinematografica, che ha prodotto grandi capolavori negli ultimi due secoli. È il filone che chiamerei La Tragedia della Mediocrità - il versante opposto della Banalità del Male di Hanna Arendt.
Tra i più eminenti di questo filone è certamente Bartleby lo scrivano, entrato ormai nel Canone occidentale. Fu pubblicato da Hermann Melville nel 1853, si noti, in forma anonima, come se l’autore avesse avuto vergogna di firmarlo. Il giovane Bartleby è assunto a Wall Street da un avvocato, un brav’uomo peraltro, e dapprima si comporta da impiegato modello, da solerte macchina umana. Poi, d’un tratto, quando il capo gli ordina qualcosa, risponderà sempre “I would prefer not to”, “avrei preferenza di no”, come tradotto da Gianni Celati. Questo sciopero cortese è però solo il primo passo verso un processo di catatonia, che porterà Bartleby a non muoversi più dall’ufficio, senza più parlare né mangiare, fino al suo ricovero nel manicomio di New York, e alla sua morte per anoressia.
All’epoca il racconto di Melville fu un flop. Fu solo nel XX secolo, ben dopo la morte di Melville, che questo è diventato uno dei testi fondamentali della letteratura. Ogni anno si pubblicano paper e libri su Bartleby, e tutte le chiavi interpretative che hanno riscosso qualche credito nell’ultimo secolo sono state usate per decriptare questa storia inquietante: marxiste, strutturaliste, anti-strutturaliste, mistico-religiose, psicoanalitiche, storiciste, decostruzioniste... Il racconto di Melville è certamente una coupure perché i personaggi tragici, prima, non erano mai grigi impiegati di concetto, ma figure sempre interessanti, affascinanti: re, regine, avventurieri, puttane, spadaccini, banditi, nobili decaduti o impazziti come Don Chisciotte...
Certo Bartleby fa il contrario di Fantozzi, non si piega, ma ha in comune con il suo discendente questo: entrambi non agiscono, sono come immobilizzati dalla loro condizione subalterna.
Fino agli anni ‘60 per indicare l’impiegato ideal-tipico non si diceva “un fantozzi” ma “un travet”. Da Ignazio Travet, protagonista della commedia piemontese "Le miserie d’Monsù Travet" del 1863, di Vittorio Bersezio, testo che idealmente inaugura l’Italia unita. Travet è un misero impiegato perseguitato dal capoufficio, disprezzato da moglie e figlia, insomma l’antesignano risorgimentale di Fantozzi.
Un’altra vetta è Death of a Salesman, “Morte di un commesso viaggiatore”, di Arthur Miller, del 1949. Il protagonista, un anziano venditore alla fine della carriera, si chiama Willy Loman, ovvero porta lo stigma del proprio essere nel nome stesso - Low-man, uomo basso, uomo mediocre. Anche qui si tratta di una storia tragica. Willy è uno che non vuole accettare l’evidenza di essere stato sempre un poveraccio, peraltro disprezzato dai due figli, che non sono riusciti in nulla. Egli si vanta di essere popolare, di conoscere un sacco di gente, insomma di essere simpatico. Anticipa la massa di persone fiere di avere migliaia di friends su Facebook e di avere centinaia di Like per internet. Anche se un suo amico gli dice più o meno: “A che pro aver cercato sempre di essere uno simpatico? Dovevi fare soldi. Quando hai soldi, diventi subito simpatico.” Loman si uccide contando sul successo di pubblico ai suoi funerali, ai quali invece saranno presenti solo pochi familiari.
Sia il tragico Morte di un commesso viaggiatore che il tragicomico serial di Fantozzi sono apprezzati anche da impiegati e venditori. Mi chiedo: come possono ridere di un loro collega? Certo Villaggio ha l’accortezza di rendere il suo eroe così ridicolo e irrealistico che tutti si diranno “Per fortuna non sarò mai come Fantozzi!”. Nessuno di noi sarà mai come Fantozzi, egli è sempre l’Altro di cui ridiamo. Eppure, il trick di Villaggio è molto sottile. C’è una parte di noi, anche se siamo intellettuali e professori, che sa di essere come Fantozzi. In fondo, tutti noi da qualche parte abbiamo un capo, a qualcosa o a qualcuno ci sottomettiamo. Fantozzi è la caricatura di una mediocrità di cui ciascuno può sospettare che sia la propria, se ci confrontiamo ai grandi in ogni campo. Mostrando in modo tragico o buffo la nostra mediocrità, l’arte ce la riscatta. Mettendola a distanza da noi in un capro espiatorio con la pancia e il berretto, ne diminuisce il peso.
Si potrebbe credere che quando Fantozzi getta l’anatema contro Ėjzenštejn, Villaggio presti al suo personaggio la propria stessa voce, ma non è vero. Villaggio era un intellettuale raffinato, un uomo politicamente a sinistra, insomma, suppongo che apprezzasse La corazzata Potëmkin. Credo che in realtà Villaggio abbia descritto l’embrione psichico di quello che diventerà poi il tipico elettore populista, in particolare di Grillo, ma anche di Bossi e Salvini. La rabbia erratica e impotente di Fantozzi contro “chi comanda” è stata poi intercettata politicamente, e l’apolitico Fantozzi ha trovato finalmente i suoi portavoce politici.
Costoro sono quelli che Peter Sloterdijk (in Ira e tempo) ha chiamato “banche dell’ira”. Il Fantozzi che è in molti di noi è un grumo di ira, che i demagoghi ben sanno gestire. Il populismo in effetti si riduce a questo: “chi sta sotto” è contro “chi sta sopra”. Non i poveri contro i ricchi, ma i Fantozzi contro i dirigenti. L’impiegato “tragico” non è assillato dalla povertà - anche se la sua condizione economica è modesta - ma dalla subalternità, e in effetti il cosiddetto populismo non se la prende con i ricchi. Se la prende con “chi sta sopra”, ovvero con i politici, e in fondo con gli intellettuali, quelli che godono nel vedere film muti. Perché l’impiegato non incontra quasi mai il ricco, non si confronta con lui: ogni giorno si confronta con chi per varie ragioni gli è superiore.
*
MEDIOCRITA’, BANALITA’, E TRAGEDIA. LO "STATO" SONNAMBOLICO DELL’ITALIA...
- "Gli impiegati bacherozzi o condannati alla pena capitale di Kafka sono il culmine di una tradizione letteraria, e poi cinematografica, che ha prodotto grandi capolavori negli ultimi due secoli. È il filone che chiamerei La Tragedia della Mediocrità - il versante opposto della Banalità del Male di Hanna Arendt" (Sergio Benvenuto, "Fantozzi e Kafka. Vittime", "DoppioZero", 15.07.2017).
- “La Corazzata Potëmkin è una boiata pazzesca!” (cit. da "Il secondo tragico Fantozzi", film del 1976).
"LEZIONE SU KANT" A GERUSALEMME: PARLA EICHMANN "PILATO", IL SUDDITO DELL’"IMPERATORE-DIO". Il ’sonnambulismo’ di Hannah Arendt prima e di Emil Fackenheim dopo.
 ADOLF EICHMANN CHIARISCE COME E’ DIVENUTO “ADOLF EICHMANN”, MA HANNAH ARENDT TESTIMONIA CONTRO SE STESSA E BANALIZZA: “IO PENSO VERAMENTE CHE EICHMANN FOSSE UN PAGLIACCIO”!!!
ADOLF EICHMANN CHIARISCE COME E’ DIVENUTO “ADOLF EICHMANN”, MA HANNAH ARENDT TESTIMONIA CONTRO SE STESSA E BANALIZZA: “IO PENSO VERAMENTE CHE EICHMANN FOSSE UN PAGLIACCIO”!!!BERLUSCONI E LA "MEZZA" DIAGNOSI DEL PROF. CANCRINI. Il Narcisismo e l’uso lucidissimo come arma politica dell’"antinomia del mentitore" - "L’Italia è il mio Partito": "Forza Italia"!!!
"PUBBLICITA’ PROGRESSO": L’ITALIA E LA FORZA DI UN MARCHIO REGISTRATO!!!
Federico La Sala
-
> MEDIOCRITA’, BANALITA’, E TRAGEDIA ... ITALIA, 2017-1917: “CAPORETTO”. PER NON PERDERE IL FILO - E LA MEMORIA20 luglio 2017, di Federico La Sala
ITALIA, 2017-1917: “CAPORETTO”. PER NON PERDERE IL FILO - E LA MEMORIA....
Una nota *
- "KAPUTT" (C. Malaparte, 1941-1943). « Lei conosce l’origine della parola *kaputt*? È una parola che proviene dall’ebraico *koppâroth*, che vuol dire *vittima*.»(Curzio Malaparte). Come è noto, *kaputt* in tedesco corrisponde a *rotto, fuori combattimento, guasto* (vedi: https://it.wikipedia.org/wiki/Kaputt).
EVIDENTEMENTE SERGIO BENVENUTO VUOLE FARE L’*AMERICANO* (vedi "Ovvero: Calunniare gli Eschmesi/Fake Knowledge", "doppiozero", 20.07.2017: http://www.doppiozero.com/materiali/fake-knowledge), e ovviamente NON HA LETTO L’ART. DI GABRIELE SABATINI (vedi "Curzio Malaparte, un secolo dalla disfatta", "doppiozero", 19.07.2017: http://www.doppiozero.com/materiali/curzio-malaparte-un-secolo-dalla-disfatta) e non si è ricordato del lavoro di C. Malaparte, intitolato *KaputT*, una "feroce pagina della storia europea" (G. Sabatini).
CONFERMARE I PROPRI DESIDERI.... Sergio Benvenuto : "Ho sostenuto altrove (Dicerie e pettegolezzi, Il Mulino, 2000) che tutte le leggende metropolitane, o bufale che dir si voglia, puntando sulla consonanza narrativa, svolgono una stessa funzione: *confermare i propri desideri* (vedi "Storytelling versus verità", "doppiozero", 12 Gennaio 2017: http://www.doppiozero.com/materiali/storytelling-versus-verita).
AL DI LA’ DELLA POST-VERITA’. La verità dagli Inhuit ("Ho parlato con amici eschimesi, e mi hanno detto che in realtà esiste una parola per *neve* nelle tre principali lingue inhuit: si dice *aput* tra gli eschimesi della Groenlandia..."), la verità di "Fantocci": “La corazzata Kotiomkin è una cagata pazzesca” (cit. da.: “Il secondo tragico Fantozzi”, film di Luciano Salce, 1976), e la verità di "Fantozzi" secondo S. Benvenuto: “La Corazzata Potëmkin è una boiata pazzesca!”(vedi "Fantozzi e Kafka. Vittime", "doppiozero", 15.07.2017: http://www.doppiozero.com/materiali/fantozzi-e-kafka-vittime).
19 LUGLIO 1992- 19 LUGLIO 2017: PER L’ITALIA E PER LA COSTITUZIONE! Se è vero, come è vero, che - come scrive Benvenuto a conclusione della sua riflessione sul *falso sapere* - "abbiamo poco scampo al fake knowledge", personalmente, credo che proprio in questo "poco" c’è grande *benjaminiana* possibilità...
LUNGA VITA ALL’ITALIA!!!
Federico la Sala
* https://www.alfabeta2.it/2017/07/18/lodio-matteo-renzi-risposta-massimo-recalcati/#comment-628816
-
> KANT, IL CORAGGIO DI SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA, IL PROGRAMMA DEL "FESTIVALFILOSOFIA SULLE ARTI", E UNA LEZIONE DI FILOLOGIA..15 luglio 2017, di Federico La Sala
FESTIVALFILOSOFIA SULLE ARTI. Modena, Carpi e Sassuolo, 15.16.17 settembre 2017
ARTI. IL SAPER BEN FARE:
Presentato il programma del Festival della filosofia
Kermesse. Tema della diciassettesima edizione è le «Arti», sinonimo del buon saper fare
di Benedetto Vecchi (il manifesto, 13.07.2017)
Il tema è di quelli che frettolosamente potrebbero essere rubricati alla voce «accademia». Ma nelle parole degli organizzatori è declinato invece come chiave di lettura non solo per comprendere cosa si muove nel triangolo urbano dove si svolge da diciassette anni il «Festival della filosofia» ma anche per affrontare alcuni nodi del vivere in società, come la rappresentazione del sé come un’opera. Non si affronteranno quindi solo le «belle arti», ma anche quel saper fare alla base dell’antica etimologia greca del termine «arte».
NELL’ILLUSTRARE il programma, sia Remo Bodei che il nuovo direttore del festival filosofia Daniele Francesconi hanno sottolineato che gli argomenti tratti dai cinquanta relatori chiamati a svolgere le loro lezioni in piazza spazieranno dalle belle arti al design alle macchine e a quella figura idealtipica dell’artigiano che manipola la materia per produrre un’«opera». In fondo, tecnica e arte sono stati sinonimi per secoli, prima di essere separati e posti agli antipodi dell’attività umana.
Dunque, come ogni anno dall’inizio dell’attuale millennio, le piazze di Modena, Carpi e Sassuolo saranno riempite, dal 15 al 17 settembre, da un pubblico desideroso di ascoltare filosofi - più recentemente anche sociologi e scienziati - che affrontano il tema scelto dal comitato scientifico.
IL FORMAT DELL FESTIVAL è semplice: lectio magistralis in piazza per un pubblico non pagante, come invece avviene in altre kermesse culturali. E così il numero delle presenze è salito di anno in anno fino a far raddoppiare nei giorni del festival la popolazione delle tre città.
Un limite, evidenziato nel corso del tempo, si è però manifestato: i relatori spesso erano sempre gli stessi. Forse per questo motivo, che il «corpo docente» di quest’anno è stato parzialmente rinnovato, chiamando a parlare nomi poco invitati in Italia, ma che sul tema delle «arti» (il saper ben fare) hanno scritto molto, come la tedesca Rahel Jaeggi, lo statunitense James Clifford, il croato Deyan Sudijc.
LE «ARTI», dunque, come sinonimo di lavoro artigiano, di scienza, creatività, estetica applicata alla produzione e al consumo. Un ordine del discorso che risponde a quello che è stato qualificato, soprattutto dai tre sindaci intervenuti nella presentazione, come il «capitale sociale» presente nella regione che ospiterà il festival. D’altronde Modena, Carpi e Sassuolo sono luoghi di ricerca scientifica, di produzione tessile o di ceramiche di qualità. Insomma, centralità del «savoir faire» e della produzione di opere che ha spinto nel tempo alcuni autori della modernità a contrapporlo, polemicamente, ai classici della filosofia. O come mezzo per tornare alle origini della filosofia (Hannah Arendt non è mai stata citata, ma l’eco delle tesi della filosofa tedesca espresse in Vita Activa era più che evidente).
Come ogni anno, accanto alle lezioni, ci saranno mostre, proiezioni cinematografiche, cene «filosofiche». Il programma completo può essere consultato nel sito: www.festivalfilosofia.it
A MARGINE, UNA NOTA
IL "CRITÈRA", LA "SCHOLA SARMENTI" DI NARDÒ*, E UNA LEZIONE SUL CRITÈRIO PER BEN LEGGERE LA “CRITICA DELLA RAGION PURA”. Un omaggio al lavoro del prof. Armando Polito
PER BEN GIUDICARE.... per ben fare
PREMESSO E TENENDO PRESENTE CHE la conoscenza del greco a noi è venuta dalla Grecia (VIA Calabria: Boccaccio porta da Napoli a Firenze per tenere lezioni di greco Leonzio Pilato da Seminara - cfr.: http://www.lavocedifiore.org/SPIP//article.php3?id_article=5421; VIA Salento: Gregorio Messere a Napoli - cfr. http://www.fondazioneterradotranto.it/2016/11/15/torre-s-susanna-br-celebra-gregorio-messere-380-anni-dalla-nascita/) e quanto sia grande e decisiva per l’intera vita dell’umanità il buon uso della parola (in ebraico, la parola "verità" è detta con il termine "emet") e la parola "morte" con il termine "met"),
CON LA LETTURA DEL TESTO DI QUESTA BRILLANTISSIMA LEZIONE DI FILOLOGIA DEL PROF. ARMANDO POLITO ("Critèra: attenzione all’accento!": http://www.fondazioneterradotranto.it/2017/07/13/critera-attenzione-allaccento-al-profano-un-semplice-accento-puo-sembrare-un-banale-tanto-piu-nella-cultura-dominante-cui-prevalgono-approssimazione-incompetenza-assenza-pressoche-tot/)",
INIZIEREI LE LEZIONI DEL CORSO DI LAUREA IN FILOSOFIA NON SOLO ALL’UNIVERSITA’ non solo di Roma, ma anche di Lecce, di Napoli, di Firenze, di Milano, d’Italia e di Europa!!!
A 230 anni dalla pubblicazione dalla seconda, importantissima e decisiva, edizione (per la lotta "Contro l’idealismo" e i sogni dei visionari e dei metafisici), della "CRITICA DELLA RAGION PURA", nell’epoca della "post-verità" (cfr.: https://it.wikipedia.org/wiki/Post-verit%C3%A0) e delle "fake news" (cfr.: https://it.wikipedia.org/wiki/Fake_news) non fa assolutamente male bere un buon bicchiere di vino "Critèra" e di ricordare - per la nostra umana SALUTE! - la lezione del saggio illuminismo kantiano (cfr.: http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=4829)!!!
*
NOTA: LA "SCHOLA SARMENTI" DI NARDÒ....
A COMINCIARE DALLA FINE, E DALLA BOTTIGLIA DI "ROCCAMORA" (sull’etichetta della bottiglia di rosso "negroamaro", in forma di "croce", appare un "calice" con dentro il "sole"!), GUARDANDO E "LEGGENDO" CON maggiore ATTENZIONE L’IMMAGINE DELL’ETICHETTA, E FREQUENTANDO (di più) LA "SCHOLA SARMENTI" (cfr.: http://www.foodandtravelitalia.it/schola-sarmenti-dallamore-la-terra-leccellenza-bottiglia/), è possibile capire MEGLIO (mi sia lecito!!!) QUESTO PREZIOSO contributo del prof. Armando Polito, "ROCCAMORA, OVVERO IL VINO COME STORIA E COME CULTURA" (cfr.: http://www.fondazioneterradotranto.it/2017/06/05/roccamora-ovvero-vino-storia-cultura/), e, forse, riuscire a non confondere il buon-vino con il vino taroccato, o, diversamente e più pertinentemente, di non perdere il legame che corre e scorre tra il vino, l’acqua sporca, e il bambino [...] (CFR. FEDERICO LA SALA, "LA COMETA, L’APOCALISSE, LE "CIFRE DELL’EUCHARISTIA", E UNA BOTTIGLIA DI ROCCAMORA!!! IN VINO VERITAS": http://www.fondazioneterradotranto.it/2017/06/05/roccamora-ovvero-vino-storia-cultura/#comments).
Federico La Sala
-
>IL PENSIERO DELLA COSTITUZIONE E LA COSTITUZIONE DEL PENSIERO -- Filosofi per lo ius soli, ma anche per lo ius culturae. Un appello.14 luglio 2017, di Federico La Sala
Filosofi per lo ius soli *
Ci rivolgiamo alle senatrici e ai senatori della Repubblica affinché venga approvata la legge che conceda finalmente la cittadinanza italiana ai figli degli immigrati non solo per ius soli, ma anche - com’è giusto che sia - per ius culturae. È una legge di civiltà, che supera quel «diritto del sangue» che ancora prevale.
Sono tanti gli adolescenti giunti nel nostro paese che, dopo aver frequentato le scuole italiane per anni, attendono un segno concreto di ospitalità.
Occorre riconoscere i loro diritti, che sono anche i nostri. Non approvare questa legge sarebbe una sconfitta, prima ancora che per loro, per noi che ci definiamo «italiani», che veniamo dalla tradizione dell’umanismo, che non possiamo dimenticare l’esempio della «cittadinanza» romana, che vorremmo nel futuro prossimo avere più voce in Europa.
Remo Bodei, Donatella Di Cesare, Roberto Esposito Alessandro Dal Lago, Michela Marzano, Mauro Bonazzi, Adriana Cavarero, Salvatore Veca, Giacomo Marramao, Paolo Flores d’Arcais, Massimo Donà, Marta Fattori, Adriano Fabris, Nicola Panichi, Eugenio Mazzarella, Luca Illetterati, Enrica Lisciani Petrini, Caterina Resta, Piergiorgio Donatelli, Marcello Mustè, Simona Forti, Leonardo Caffo, Elettra Stimilli, Dario Gentili, Fabio Polidori, Luca Taddio, Leonardo Amoroso, Massimo Adinolfi, Davide Tarizzo, Laura Bazzicalupo, Massimo De Carolis, Giulio Giorello, Giusy Strumiello, Gian Luigi Paltrinieri, Olivia Guaraldo.
FILOSOFIA. IL PENSIERO DELLA COSTITUZIONE E LA COSTITUZIONE DEL PENSIERO:
- DIOGENE DI SINOPE
 Mentre una volta prendeva il sole, Alessandro Magno
Mentre una volta prendeva il sole, Alessandro Magno
 sopraggiunto e fattogli ombra disse: "Chiedimi quel che vuoi".
sopraggiunto e fattogli ombra disse: "Chiedimi quel che vuoi".
 E Diogene, di rimando: "Lasciami il mio sole".
E Diogene, di rimando: "Lasciami il mio sole".
CITTADINANZA E "DIRITTO DEL SOLE" ("IUS SOLIS"): AL DI LA’ DEL DIRITTO DEL SANGUE ("IUS SANGUINIS") E DELLA TERRA ("IUS SOLI").
LA LEZIONE DI MANDELA: [GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
"CHI" SIAMO NOI, IN REALTÀ. RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ.
-
> IL PENSIERO DELLA COSTITUZIONE E LA COSTITUZIONE DEL PENSIERO - IUS SOLI. Per non far morire la riforma. Appello (di Luigi Manconi, Elena Ferrara, Paolo Corsini)..3 ottobre 2017, di Federico La Sala
Ius soli, parlamentari e insegnanti iniziano sciopero fame: "Per non doverci rammaricare"
Ampia la risposta all’appello di Luigi Manconi, Elena Ferrara, Paolo Corsini, per non far morire la riforma. Digiuno a partire da oggi
di VLADIMIRO POLCHI (la Repubblica, 03 ottobre 2017)
ROMA - Uno sciopero della fame tra i parlamentari "per non doverci amaramente rammaricare, tra qualche mese o qualche anno, della nostra ignavia o della nostra impotenza". Deputati e senatori rispondono all’appello di Luigi Manconi, Elena Ferrara, Paolo Corsini, per non far morire la riforma dello ius soli. E dichiarano di essere pronti a digiunare a partire da oggi, assieme a 800 insegnanti a sostegno della legge sulla cittadinanza.
"Cara collega, caro collega - si legge nell’appello a cui aderiscono anche i Radicali italiani, il segretario Riccardo Magi e la presidente Antonella Soldo - vi scriviamo perché siete tra coloro che, dal primo momento e con maggiore determinazione, hanno sostenuto le buone ragioni della legge sullo ius soli. Ogni giorno lo spiraglio - pur esile, esilissimo - che sembra aprirsi sulle possibilità di una approvazione del testo, tende a chiudersi.
 Qualcosa si deve pur fare per non doverci amaramente rammaricare, tra qualche mese o qualche anno, della nostra ignavia o della nostra impotenza. Se, come tutto sembra indicare - e come segnalano anche le ripetute dichiarazioni del ministro Del Rio - questi sono giorni decisivi, proviamo a muoverci".
Qualcosa si deve pur fare per non doverci amaramente rammaricare, tra qualche mese o qualche anno, della nostra ignavia o della nostra impotenza. Se, come tutto sembra indicare - e come segnalano anche le ripetute dichiarazioni del ministro Del Rio - questi sono giorni decisivi, proviamo a muoverci"."Oggi, 3 ottobre - giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione - oltre 800 insegnanti attueranno uno sciopero della fame a sostegno della legge e informeranno i loro studenti del significato della propria azione. Potrebbe essere l’occasione, questa, per collegarsi a tale iniziativa rilanciandola nella nostra qualità di parlamentari. Si tratta di prendere una decisione immediatamente.
 L’ipotesi è quella di un digiuno a staffetta a sostegno della richiesta della presentazione in Aula prima possibile del disegno di legge. Dunque, per tenere aperto questo spiraglio e provare a inserirci in esso in maniera attiva ed efficace, coinvolgendo il maggior numero di persone affinché il governo decida di porre la fiducia".
L’ipotesi è quella di un digiuno a staffetta a sostegno della richiesta della presentazione in Aula prima possibile del disegno di legge. Dunque, per tenere aperto questo spiraglio e provare a inserirci in esso in maniera attiva ed efficace, coinvolgendo il maggior numero di persone affinché il governo decida di porre la fiducia"."I tempi potrebbero essere i seguenti: mercoledì 4 ottobre ci sarà il voto a maggioranza assoluta sulla nota di variazione di bilancio DEF. Dopo di ché si apre una sorta di finestra. Infatti la legge di stabilità arriverà in Senato (alle Commissioni) nell’ultima settimana di ottobre. Il calendario dei lavori dell’Aula si ferma a giovedì 19 ottobre. Occorrerà dunque una nuova Conferenza dei capigruppo. Ciò vuol dire che vi sono due settimane di tempo per ricercare i numeri necessari alla fiducia sul provvedimento relativo allo ius soli.
 Si tenga conto che quello stesso periodo di tempo coincide con la fase conclusiva della campagna Ero straniero. L’umanità che fa bene e della relativa raccolta di firme per una proposta di legge di iniziativa popolare finalizzata al superamento della legge Bossi-Fini. I due obiettivi potrebbero sostenersi e incentivarsi a vicenda. Pensiamo, in ogni caso, che si tratti di una prova difficile ma che vale la pena affrontare".
Si tenga conto che quello stesso periodo di tempo coincide con la fase conclusiva della campagna Ero straniero. L’umanità che fa bene e della relativa raccolta di firme per una proposta di legge di iniziativa popolare finalizzata al superamento della legge Bossi-Fini. I due obiettivi potrebbero sostenersi e incentivarsi a vicenda. Pensiamo, in ogni caso, che si tratti di una prova difficile ma che vale la pena affrontare"."Le modalità del digiuno a staffetta, a sostegno di questo percorso, verranno precisate puntualmente nelle prossime ore. E si ricordi che il pomeriggio del 13 ottobre, a partire dalle 16, davanti a Montecitorio è prevista una manifestazione alla quale sarebbe opportuno che tutti noi partecipassimo, promossa dalla rete degli "Italiani senza cittadinanza".
 Ti chiedo la tua adesione all’iniziativa nel più breve tempo possibile. Già una trentina di deputati si sono dichiarati disponibili a condividere con noi l’atto del digiuno. Aspettiamo la vostra adesione". Firmato: Luigi Manconi, Elena Ferrara, Paolo Corsini.
Ti chiedo la tua adesione all’iniziativa nel più breve tempo possibile. Già una trentina di deputati si sono dichiarati disponibili a condividere con noi l’atto del digiuno. Aspettiamo la vostra adesione". Firmato: Luigi Manconi, Elena Ferrara, Paolo Corsini.Hanno aderito finora: Loredana De Petris, Vannino Chiti, Walter Tocci, Laura Fasiolo, Francesco Palermo, Sergio Lo Giudice, Stefano Vaccari, Claudio Micheloni, Monica Cirinnà, Daniela Valentini, Laura Puppato, Luis Alberto Orellana, Massimo Cervellini, Peppe De Cristofaro, Alessia Petraglia, Deputati Michele Piras, Sandra Zampa, Mario Marazziti, Franco Monaco, Luisa Bossa, Eleonora Cimbro, Florian Kronbichler, Paolo Fontanelli, Nello Formisano, Gianni Melilla, Lara Ricciatti, Pippo Zappulla, Marisa Nicchi, Michele Ragosta, Luigi Laquaniti, Giovanna Martelli, Donatella Duranti, Toni Matarrelli, Filiberto Zaratti, Franco Bordo, Filippo Fossati, Tea Albini, Delia Murer.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- CITTADINANZA E "DIRITTO DEL SOLE" ("IUS SOLIS"): AL DI LA’ DEL DIRITTO DEL SANGUE ("IUS SANGUINIS") E DELLA TERRA ("IUS SOLI").
I DUE CORPI DEL RE, DEL PAPA, E DI OGNI ESSERE UMANO. La lezione di Dante, Kantorowicz, Freud e Mandela ...
 GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"RIPENSARE L’EUROPA. PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!
 FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.Federico La Sala
- DIOGENE DI SINOPE
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- La voglia di fascismo crescente e le nostre debolezze (di Piero Ignazi).10 luglio 2017, di Federico La Sala
L’ITALIA, IL VECCHIO E NUOVO FASCISMO...
- RENZO DE FELICE E LA STORIA DEL FASCISMO: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"!
La voglia di fascismo crescente e le nostre debolezze
di Piero Ignazi (la Repubblica, 10.07.2017)
NOSTALGIA del fascismo? Gli episodi degli ultimi tempi, dal raduno con braccia tese nel saluto romano al cimitero monumentale di Milano alla lista ispirata palesemente al fascismo nel comune mantovano di Sermide fanno pensare ad un ritorno di fiamma del passato.
LA realtà è più sfumata. Per prima cosa non si può dimenticare che, fino a vent’anni fa, c’era un partito al governo - Alleanza Nazionale - che affondava le proprie radici, non del tutto recise, nel (neo)fascismo. Infatti, quando Gianni Alemanno diventò sindaco di Roma nel 2008 fu salutato al Campidoglio da un manipolo di camerati con il saluto romano. E un beniamino dei tifosi della Lazio andò alla curva dello stadio per festeggiare il goal con la stessa modalità nostalgica (ovviamente senza nessuna sanzione).
C’è quindi un retroterra assai solido rispetto a questi ultimi episodi; e girando l’Italia si incontrano osti con il vino Benito, locali con scritte del ventennio, bancarelle con cimeli del Duce, fino al caso dello stabilimento balneare di Chioggia di cui dava conto Repubblica ieri. Il fascismo è stato un fenomeno di tale importanza, penetrato “totalitariamente” in ogni ganglio della società per due decenni, che non è bastato l’eroismo dei pochi che hanno combattuto per la libertà per estirparlo dalla cultura politica profonda del nostro paese.
Ancora una volta, “non è stata una parentesi”. Anzi, come diceva Piero Gobetti, narrava la nazione come ne fosse l ‘autobiografia. Con un lascito così ingombrante e senza aver fatto alcun esame di coscienza lasciando, o forse sperando,che si stendesse una coltre di oblio sul passato senza doverlo rinvangare, non sorprende che di tanto in tanto riemergano fenomeni di nostalgia. Ma questi sono solo la punta di un iceberg: ma non di un fascismo risorgente, quanto della debolezza della cultura liberale e democratica.
Gli ostacoli che ancora oggi vengono continuamente frapposti alla espansione dei diritti civili, un tempo non a caso sostenuti solo da sparute minoranze attive come quella dei radicali di Marco Pannella, sono un segno della difficoltà a far diventare moneta corrente i cardini dello stato di diritto. Separazione dei poteri, rispetto per le minoranze, accettazione (in ogni ambito) del dissenso, faticano ad infrangere il profondo desiderio per una figura di autorità che metta tutti a tacere. Sia la società civile, ripiegata a fare i propri interessi senza nessun senso dello Stato, che la politica, scissa tra incapacità a rispondere alle domande dei cittadini e pulsioni plebiscitarie stimolate da capi e capetti, favoriscono un allontanamento dai principi e dalle istituzioni democratiche.
È in questo contesto che matura l’insoddisfazione radicale verso “il sistema” e fanno breccia coloro che propongono visioni alternative e modalità diverse di agire politico. Il fenomeno Casa Pound, pur nella sua dimensione ancora limitata, è emblematico della capacità di attrazione che hanno riferimenti nostalgici mixati con quella domanda di identità e appartenenza che circola nella società italiana. Ancora più del pastiche ideologico di Casa Pound, attrae l’offerta di una militanza che si trasforma in comunità politica. Se movimenti come questo, e altri che ruotano nella galassia nera dell’estrema destra, si radicano in fasce giovanili è perché tutti i partiti hanno abbandonato il rapporto con la società civile, o lo attivano solo in maniera strumentale, senza quel coinvolgimento ideale e progettuale che rilancerebbe la loro immagine.
La democrazia necessita di continua manutenzione per non farla scadere a ritualità. Questi segnali di una ricerca di alternative radicali incrinano la certezza che le istituzioni e i principi che le governano siano al riparo da crisi più profonde.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- La corazzata Potëmkin, la rivolta e i «necrotweet» su Fantozzi (di "Wu Ming 1").6 luglio 2017, di Federico La Sala
CINEMA E STORIA. LO "STATO" SONNAMBOLICO DELL’ITALIA E LA CULTURA CHE SERVE PER UN CAMBIO DI SCENA.... E DI REGIA!!!
La corazzata Potëmkin, la rivolta e i «necrotweet» su Fantozzi
A cura di Wu Ming 1 *
- «Братья!»
- «FRATELLI!»
Sera del 26/06/17, Piazza Maggiore, Bologna. Migliaia di persone - non meno di quattromila - applaudono in piedi La corazzata Potëmkin di Sergej Michajlovič Ėjzenštejn, film breve e dritto al punto, avvincente, popolare, bellissimo. Film girato novantadue anni fa.
La moltitudine ha appena seguito col cuore in gola la storia di un celebre ammutinamento avvenuto durante la rivoluzione russa del 1905, della solidarietà di un’intera città (Odessa) agli ammutinati, e della violentissima repressione che la popolazione subisce per mano dell’esercito zarista.
L’orchestra filarmonica del Teatro comunale di Bologna ha appena eseguito la partitura composta per il film da Edmund Meisel nel 1927 - una forza che staccava da terra sedie e culi - e ora si gode la lunga ovazione.
È stata la serata più intensa di quest’edizione, la trentunesima, del festival Il cinema ritrovato. Io ho portato qui mia figlia preadolescente, che si è emozionata, si è commossa, si è stretta a me durante le scene più violente, si è entusiasmata nel finale.
«FRATELLI!»
«Fratelli» è la parola chiave del film, appare all’inizio, scatena l’ammutinamento e annuncia il grande atto di solidarietà di classe nel finale.
La corazzata Potëmkin fu censurato in molti paesi per timore che scatenasse rivolte popolari e spingesse i soldati all’insubordinazione. Anche in URSS, al principio, non fu proiettato nei cinematografi ma soltanto nei circoli operai. Il poeta Majakóvskij minacciò fisicamente alcuni burocrati perché avesse una regolare distribuzione.
E il film si rivelò presto un grande successo.
Oggi è considerato una delle più grandi opere cinematografiche del Novecento, viene riproiettato di continuo in tutto il mondo, nel 2004-2005 lo hanno sonorizzato i Pet Shop Boys.
- «FRATELLI!»
E in Italia?
Qui da noi, come ha scritto qualcuno, il film è stato «segnato da un destino davvero imprevedibile, che lo ha trasformato in qualcosa di diverso da quel che è.» Ma procediamo con ordine.
La corazzata Potëmkin è stato una grande sorpresa per la maggior parte dei presenti in piazza. Sui lati c’era chi all’inizio ridacchiava, qualcuno che mormorava la frase «cagata pazzesca» (sentito con le mie orecchie e più volte) e pensava di fermarsi pochi minuti, farsi un sogghigno e andare via, e invece è rimasto lì in piedi per oltre un’ora, magnetizzato, e magari ha pianto, di certo era tra chi ha partecipato alla lunghissima standing ovation, e magari era tra i volti fotografati da Lorenzo Burlando durante la proiezione.
Molti altri erano aficionados del festival o comunque si sono fidati della Cineteca, unica istituzione pubblica di Bologna non disprezzata dai più, anzi, oltremodo rispettata.
La Cineteca, appunto. Nei giorni precedenti, ha voluto fare una piccola e divertente campagna di “debunking”, con video e altri mezzi. Una troupe ha intervistato gente per le vie del centro, e molti erano convinti che il film durasse tre o quattro ore, se non di più. In realtà dura 70 minuti.
- «FRATELLI!»
Bisogna sfondare il muro del pregiudizio. Non è vero che questo e altri film d’antan sono film per pochi, non è vero che «la gente non capisce». Se gli dài l’occasione di vederli, capisce eccome.
La differenza rispetto ad altri film d’antan è che La corazzata Potëmkin molti credono di sapere com’è anche senza averlo visto. Lo associano a qualcosa che credono di conoscere - cioè l’intento di Luciano Salce e Paolo Villaggio nella celeberrima scena de Il secondo tragico Fantozzi (1976) - e quell’associazione ha tenuto a distanza il film. La corazzata Potëmkin è divenuta, a torto marcio, emblema di lunghezza e pesantezza.
[Intermezzo. Alcuni «necrotweet» seguiti alla morte di Villaggio:
 «Ci lascia l’unico che ha detto la verità sulla Corazzata Potemkin»;
«Ci lascia l’unico che ha detto la verità sulla Corazzata Potemkin»;
 «La corazzata Potëmkin è veramente una cagata pazzesca. Aveva ragione anche in quel caso»;
«La corazzata Potëmkin è veramente una cagata pazzesca. Aveva ragione anche in quel caso»;
 e fallo sapere anche lassù che la corazzata potemkin è una cagata pazzesca»;
e fallo sapere anche lassù che la corazzata potemkin è una cagata pazzesca»;
 «Oggi più che mai la corazzata potemkin è una cagata pazzesca!!!»
«Oggi più che mai la corazzata potemkin è una cagata pazzesca!!!»
 E altre centinaia di commenti così.]
E altre centinaia di commenti così.]Dice: - Villaggio è riuscito in quello che Dalí e Warhol avevano fallito con la Gioconda: non riuscire più a guardarla senza pensare al loro sberleffo.
Rispondo: - Non proprio. Qui è come se si sbeffeggiasse preventivamente la Gioconda senza averla mai vista.
Mi piace pensare che almeno quattromila persone, la sera del 26 giugno, vedendo il film, abbiano capito il vero significato della scena della rivolta al cineforum.
Sì, perché solo vedendo La corazzata Potëmkin si capisce che il bersaglio di Salce e Villaggio non erano banalmente le cose «pesanti» e «difficili», non erano gli «intellettuali», ma il potere - rappresentato dalla Megaditta che tutto controlla - che ingloba e svuota la cultura, anche la cultura della rivolta.
Qui è necessaria un’avvertenza: qualunque cosa abbia dichiarato nei decenni successivi (e ha detto ogni cosa e il suo contrario, anche su La corazzata Potemkin), ricordiamo sempre che all’epoca dei primi due Fantozzi Villaggio era all’estrema sinistra. Ancora undici anni dopo si candidò alle elezioni politiche con Democrazia Proletaria.
A forza di dire che la famosa scena prende in giro la cultura dei cineforum di sinistra, i tic degli «intellettuali di sinistra» eccetera, ci si è dimenticati che quello rappresentato nel film non è un cineforum di sinistra: è il cineforum della Megaditta, rivolto non a compagni ma a colletti bianchi “apolitici”. Guidobaldo Maria Riccardelli non è un compagno né un intellettuale di sinistra: è un uomo dell’azienda, del capitale.
L’unico marxista che appare nel mondo di Fantozzi è Folagra, che guardacaso non partecipa al cineforum aziendale ed è relegato in un sottoscala.
Folagra.
[Chissà quanti, oggi, capiscono che Folagra è l’unico personaggio positivo della saga. Proprio nelle intenzioni, non «ex post». È l’unico che dice a Fantozzi qualcosa di vero sulla sua condizione.
Tuco: - Oggi (quasi) tutti considerano un personaggio positivo Calboni, e vorrebbero essere come lui.
WM: - In fondo berlusconismo e renzismo sono minime varianti ideologiche di questo «voler essere Calboni».
IAmOst: - È il collega d’ufficio che nessuno vorrebbe avere, ma che tutti vorrebbero essere. Forse il più “italiano” di tutti.]
La corazzata Potëmkin - nel film di Salce parodiato in «Kotjomkin» - narra una rivolta, ma la rivolta è addomesticata, disinnescata, la cornice del cineforum aziendale e la modalità di fruizione la sviliscono, e la visione stessa è sminuzzata, non c’è più l’insieme, solo dettagli: «L’occhio della madre... La carrozzella...» E così sono gli impiegati a rivoltarsi, e poiché Salce e Villaggio sanno il fatto loro, la rivolta contro il film ripete quella nel film.
L’episodio del cineforum è un sottile remake del film di Ėjzenštejn, un’allegoria “a chiave” che ne ripercorre tutti e cinque gli atti:
 il cineforum è la corazzata;
il cineforum è la corazzata;
 Fantozzi è il marinario Vakulenčuk che per primo grida la verità su quel che sta accadendo;
Fantozzi è il marinario Vakulenčuk che per primo grida la verità su quel che sta accadendo;
 gli spettatori sono i marinai insorti;
gli spettatori sono i marinai insorti;
 l’odioso Riccardelli è gli ufficiali spodestati;
l’odioso Riccardelli è gli ufficiali spodestati;
 la sala occupata è Odessa;
la sala occupata è Odessa;
 la polizia che «s’incazza davvero» ha il ruolo dei cosacchi che reprimono.
la polizia che «s’incazza davvero» ha il ruolo dei cosacchi che reprimono.
 Il finale, però, è molto diverso: gli insorti non hanno scampo e sono condannati a mettere in scena e subire ad nauseam la repressione zarista/aziendale.
Il finale, però, è molto diverso: gli insorti non hanno scampo e sono condannati a mettere in scena e subire ad nauseam la repressione zarista/aziendale.Il fatto che in quest’allegoria il ruolo della carne marcia imposta ai marinai ce l’abbia - in una vertiginosa mise en abyme! - il film dove si narra la rivolta che gli impiegati ripetono rende l’intero episodio complessissimo.
 Siamo di fronte a una parodia colta e, al fondo, per nulla anti-intellettuale.
Siamo di fronte a una parodia colta e, al fondo, per nulla anti-intellettuale.
 Chi non ha mai visto il film di Ėjzenštejn non può rendersene conto.
Chi non ha mai visto il film di Ėjzenštejn non può rendersene conto.
 Molti spettatori del 1976 lo avevano visto.
Molti spettatori del 1976 lo avevano visto.L’episodio, per il pubblico di allora, aveva una carica critica ad alto voltaggio, che però col tempo si è esaurita. Non poteva che esaurirsi: il contesto che rendeva l’episodio comprensibile in tutti i suoi aspetti e livelli - l’Italia degli anni Settanta, dei movimenti radicali, delle grandi lotte operaie -, quel contesto non c’è più.
E cosa rimane di quella critica, oggi, nell’interpretazione corrente di quella scena?
Pressoché nulla.
La scena, tolta dal suo contesto, rivista e ri-rivista da sola come frammento, citata e stracitata come semplice gag, col tempo ha cambiato significato: oggi è evocata per rigettare la cultura stessa e tutto ciò che è «difficile», in nome del parla-come-magni (detto quasi sempre da gente che mangia malissimo) e del solito «E fattela ‘na risata!»
Come abbiamo scritto in tempi non sospetti:
- «una parodia colta, una volta estinto il contesto in cui era stata pensata e realizzata, diventa il proprio opposto, generando un interdetto qualunquista e anti-culturale.»
L’eterna ripetizione della gag ha diffuso l’idea che La corazzata Potëmkin duri molte ore e altri miti che il film manda in frantumi, se solo si supera il pregiudizio e lo si guarda. Ma il pregiudizio c’è, inutile negarlo. Un danno culturale c’è stato. Sì, danno culturale. L’arma della critica è stata girata e puntata contro la critica stessa, allo stesso modo in cui Riccardelli, gerarchetto della Megaditta, aveva girato e puntato il cinema di Ėjzenštejn contro i suoi sottoposti.
Qualcuno ci ha attaccati per aver fatto queste riflessioni sul film, la sua parodia e le diverse ricezioni di quest’ultima il giorno stesso della morte di Villaggio - VERGOGNA!!1!! - come se si trattasse tout court di un attacco al caro estinto.
Quel caro estinto, da molto tempo non lo stimavamo più. Eppure questa riflessione è l’omaggio più serio che potessimo dedicargli. Nondimeno...
«...VERGOGNA!!1!!»
Non è solo pavlovismo da «necrotweet day». C’è qualcosa di più profondo, che verrà capito meglio in futuro, da antropologi e storici delle mentalità che con ogni probabilità non sono ancora nati.
Oggi l’obbligo contro cui ribellarsi non è quello di guardare La corazzata Kotjomkin. Semmai, al contrario, è quello di non prendere mai nulla sul serio. Il «farsi una risata» come risposta a tutto, l’essere sempre ironici per non mostrarsi mai troppo coinvolti in nulla, perché coinvolti equivale a vulnerabili, e dunque ironia sempre, cinismo e disincanto, non devi dare mai l’impressione di credere fino in fondo a quel che dici. Soprattutto, fai vedere che ti stanno sul cazzo gli «intellettuali». Risulta molto più facile se adotti l’espediente di chiamare «intellettuali» tutti quelli che ti fanno sentire vulnerabile. Chiama «pippone» qualunque cosa scrivano o dicano.
In un simile clima culturale - che ci auguriamo venga spazzato via al più presto da un’immane tormenta - un film come quello di Ėjzenštejn, che mostra la fratellanza nella rivolta e a volte fa sarcasmo sul potere ma mai ironia sulla rivolta stessa, deve per forza essere considerato una «cagata pazzesca». Vige l’obbligo di conformarsi alla lettura più decontestualizzata e banale dell’episodio fantozziano.
È contro quest’obbligo che dobbiamo ribellarci, proprio come Fantozzi si ribellò al cineforum aziendale.
E gli applausi di Piazza Maggiore non saranno durati 92 minuti, ma bastano a convincerci che siamo nel giusto. «Братья!»
_
* Questo post è la sintesi di una lunga discussione avvenuta su Twitter il 4 luglio 2017, e incorpora riflessioni di diverse persone. Grazie a tutte e tutti, anche a chi, senza pensarci un momento, è partito subito con gli insulti. La stolidità altrui ci spinge a fare meglio, a sforzarci di essere più chiari.
Fonte: http://www.wumingfoundation.com/giap/2017/07/potemkin/#more-29691 (ripresa parziale).
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- Che fine ha fatto la filosofia nell’era del caos? (Andrea Zhok)22 giugno 2017, di Federico La Sala
FILOSOFIA. IL PENSIERO DELLA COSTITUZIONE E LA COSTITUZIONE DEL PENSIERO
- MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA E A PENSARE BENE "DIO", "IO" E "L’ITALIA", CHI PIU’ CHI MENO, TUTTI VIVONO DENTRO LA PIU’ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA E POLITICA ITALIANA, NEL REGNO DI "FORZA ITALIA"!!! Un’inchiesta e una mappa
Che fine ha fatto la filosofia nell’era del caos?
di Andrea Zhok (“L’Espresso”, 18/06/2017)
‘Filosofia’ è stata per gran parte della storia occidentale quasi sinonimo di scienza e sapienza. L’opera maggiore di Isaac Newton porta ancora il titolo di ‘Principi matematici di filosofia naturale’. Ma da allora, e con particolare intensità dal secondo dopoguerra, le cose sono drammaticamente cambiate. Oggi la funzione e l’autorevolezza un tempo evocate dal termine ‘filosofia’ sembrano essere monopolio delle scienze naturali. Ci si potrebbe chiedere, a questo punto, quale possa essere (o se ancora debba esservi) uno spazio della filosofia nel mondo odierno, nell’“Epoca della scienza”.
 Il fatto che più o meno tutte le scienze oggi note, dalla fisica alla biologia, dalla psicologia alla sociologia siano nate come ‘costole’ della riflessione filosofica può richiamare glorie passate, ma non dice molto delle possibilità presenti. Dovremmo forse risolverci a considerare la filosofia come una forma di conoscenza superata, da gettare ‘nella pattumiera della storia’, accanto all’alchimia, alla frenologia, all’astrologia, e ad altre ‘pseudoscienze’?
Il fatto che più o meno tutte le scienze oggi note, dalla fisica alla biologia, dalla psicologia alla sociologia siano nate come ‘costole’ della riflessione filosofica può richiamare glorie passate, ma non dice molto delle possibilità presenti. Dovremmo forse risolverci a considerare la filosofia come una forma di conoscenza superata, da gettare ‘nella pattumiera della storia’, accanto all’alchimia, alla frenologia, all’astrologia, e ad altre ‘pseudoscienze’?Di fatto, l’autorevolezza conquistata dalle scienze naturali ha finito per esercitare sulla filosofia una pressione sia concreta, in termini di riduzione degli spazi accademici e di ricerca, sia per così dire psicologica, creando una sorta di crisi identitaria. Questa crisi ha indotto nel ‘900 l’attività filosofica a cercare di ridefinire la propria identità. L’esito di questo processo è stato l’emergere di quattro orientamenti primari; la filosofia si è concepita in sempre maggior misura o come ‘riflessione sulla scienza’ (epistemologia, metodologia, ecc.), o come ‘cultura critica’ (ermeneutica, ‘postmodernismo’, decostruzionismo, ecc.), o come preservazione della tradizione (storia della filosofia), o traendo senz’altro ispirazione e stilemi dalle scienze naturali (filosofia analitica). Questa classificazione è naturalmente approssimativa e non esaustiva, ma fatta ammenda per la necessaria approssimazione, queste tendenze sono nei loro tratti generali facilmente accertabili.
Ora, chiediamoci: tale ridefinizione degli orientamenti è tutto ciò che ci si può attendere dalla tradizione filosofica? È utile soffermarci a questo proposito sul decisivo rapporto con la scienza. Qual è la forma di conoscenza che la scienza moderna de facto finisce per consentire e proporre? Al netto di analisi di dettaglio, il problema macroscopico che l’epoca della scienza naturale non può evitare di proporre è quello della frammentazione dei saperi. La divisione del lavoro, e l’interesse prioritario per l’efficacia causale, hanno fatto sì che oggi nessun fisico possa dire di conoscere senz’altro ‘la Fisica’, nessun biologo di conoscere ‘la Biologia’, nessun economista di conoscere ‘l’Economia’, ecc. Il sistema di produzione delle verità scientifiche è un sistema che si giova delle virtù della divisione del lavoro e la raccomanda. Articoli scientifici generalisti sono scarsamente apprezzati a livello accademico, mentre la specializzazione perseverante è costantemente premiata.
Tutto ciò ha ottime ragioni nella capacità di questo modello metodologico di far crescere le competenze operative (si pensi agli straordinari progressi della medicina nell’ultimo secolo). E tuttavia, la Scienza, quando ancora non si distingueva dalla Filosofia, faceva qualcosa di essenzialmente diverso. Accanto all’attenzione per il governo locale dei processi materiali era essenziale la ricerca di una ‘visione vera’ del mondo. Di ciò nella prassi delle scienze contemporanee non è rimasta sostanzialmente traccia. La frammentazione in oggetto non coinvolge infatti solo le partizioni interne alle singole scienze, ma in modo ancor più radicale le relazioni tra scienze diverse. Non esiste una concettualità comune, anzi neppure una concettualità compatibile tra, ad esempio, fisica, psicologia, economia, storia, biologia evoluzionistica, ecc. Ciascuna scienza organizza i propri saperi in cornici parzialmente, o talvolta integralmente, incompatibili con i quadri proposti da altre scienze. Concetti irrinunciabili in un campo risultano inconciliabili con concetti irrinunciabili in un campo diverso.
Si potrebbe dire che questo è un necessario sacrificio al progresso scientifico. Questa frammentazione dei saperi non è però un incidente senza vittime. Il suo risultato complessivo è una forma storica inedita di irrazionalità. Un mondo sommerso di saperi specialistici, e di informazioni particolari irrelate, produce un disorientamento cognitivo profondo e diffuso. L’esito paradossale è che in un mondo apparentemente dominato da paradigmi scientifici lo spazio per pregiudizi vaghi, leggende metropolitane, credenze settarie, sapienze ‘alternative’, dogmi incoercibili, ecc. è più ampio che mai.
È in questa giunzione che la filosofia, intesa in senso classico, ha la possibilità di esercitare un ruolo essenziale. Gli orientamenti filosofici novecenteschi menzionati più sopra, pur preziosi e fecondi, mancano programmaticamente di un aspetto che fu invece al cuore del ruolo tradizionale della filosofia. Ciò che accomuna paradossalmente orientamenti filosofici così diversi come la riflessione epistemologica, la storia della filosofia, la critica culturale e l’indagine analitica (se intesi in senso ‘specialistico’) è la tendenziale rinuncia all’orizzonte della sintesi, al tentativo di produrre ‘visioni del mondo’, o loro abbozzi.
 La propensione tradizionale alla sintesi sistematica, al ‘sistema filosofico’ è stata progressivamente percepita dal secondo dopoguerra come qualcosa di indebitamente ambizioso, di ‘inattuale’, di pretenzioso, addirittura di ‘violento’. L’influenza del modello organizzativo delle scienze ha finito per gettare implicitamente discredito proprio su quel tipo di sintesi razionale di cui oggi si sente acutamente la mancanza.
La propensione tradizionale alla sintesi sistematica, al ‘sistema filosofico’ è stata progressivamente percepita dal secondo dopoguerra come qualcosa di indebitamente ambizioso, di ‘inattuale’, di pretenzioso, addirittura di ‘violento’. L’influenza del modello organizzativo delle scienze ha finito per gettare implicitamente discredito proprio su quel tipo di sintesi razionale di cui oggi si sente acutamente la mancanza.
 Alla paradossale condizione odierna, di un irrazionalismo grondante di informazioni irrelate, oggi finiscono per ‘porre rimedio’, guru autopromossi, tuttologi da Talk Show, promotori di fedi, e fondamentalisti vari. Occasionalmente (su appello dei media più scrupolosi) viene convocato qualche scienziato in pensione, la cui autorevolezza settoriale viene spesa per farlo esprimere su ‘massimi sistemi’ di cui, nel migliore dei casi, è un tardivo dilettante.
Alla paradossale condizione odierna, di un irrazionalismo grondante di informazioni irrelate, oggi finiscono per ‘porre rimedio’, guru autopromossi, tuttologi da Talk Show, promotori di fedi, e fondamentalisti vari. Occasionalmente (su appello dei media più scrupolosi) viene convocato qualche scienziato in pensione, la cui autorevolezza settoriale viene spesa per farlo esprimere su ‘massimi sistemi’ di cui, nel migliore dei casi, è un tardivo dilettante.In questo contesto, invece, l’indagine filosofica è l’unica forma culturale nota ad aver elaborato metodi e forme riflessive adatti a produrre sintesi razionali (scientificamente informate), quadri sistematici, ‘mappe’ e ‘visioni’ che consentano una lettura del presente e un orientamento razionale nel mondo. Una visione che miri alla comprensività e coerenza d’insieme non ha né rigore né statuto razionale inferiore a una visione analitica. La filosofia ha il diritto, ma anche il dovere, di porre un argine a questo pluralismo brado che, lungi dall’essere un contributo alla ragione, rappresenta una paradossale e strisciante abdicazione ad ogni intelligenza.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- TOTALITARISMI E POPULISMI. LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA “CAPO”!16 giugno 2017, di Federico La Sala
TOTALITARISMI E POPULISMI. LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA “CAPO”!:
- [...] Genovese non si limita a portare alla luce negatività e contraddizioni, questioni irrisolte, ma, partendo da una situazione di antagonismi plurimi e di conflitti diffusi, a bassa o ad alta intensità, propone una via d’uscita che comporta - per esempio - non un’uscita dall’Europa, ma una sua vera democratizzazione. Questo può avvenire solo grazie a una democrazia radicale come potere diffuso, che per Genovese necessita di una democrazia rappresentativa funzionante, con qualche situazione di democrazia diretta.[...]
 A questo punto ci permettiamo ancora una piccola glossa, che vorrebbe mettere le condizioni per una nuova apertura; questa scelta implica un’idea gramsciana - a parer mio - di allargamento democratico, con il superamento della distinzione tra governanti e governati. Lo Stato pare quasi diventare un elemento terzo, di equilibrio tra i conflitti, ma per essere così è necessario che recuperi anche una sorta di dimensione neoconsiliare, non in una stanca riproposizione delle esperienze degli anni Venti, ma come capacità di mettere al centro e di fondarsi sul cittadino-lavoratore, reale e concretamente determinato, che agisce e vive. (Erminio Risso, “Rino Genovese, impurità dei tempi”, “Alfabeta2”, 15 giugno 2017)
A questo punto ci permettiamo ancora una piccola glossa, che vorrebbe mettere le condizioni per una nuova apertura; questa scelta implica un’idea gramsciana - a parer mio - di allargamento democratico, con il superamento della distinzione tra governanti e governati. Lo Stato pare quasi diventare un elemento terzo, di equilibrio tra i conflitti, ma per essere così è necessario che recuperi anche una sorta di dimensione neoconsiliare, non in una stanca riproposizione delle esperienze degli anni Venti, ma come capacità di mettere al centro e di fondarsi sul cittadino-lavoratore, reale e concretamente determinato, che agisce e vive. (Erminio Risso, “Rino Genovese, impurità dei tempi”, “Alfabeta2”, 15 giugno 2017)
- RENZO DE FELICE E LA STORIA DEL FASCISMO: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"!
- PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!! FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.
Rino Genovese, impurità dei tempidi Erminio Risso ( Alfabeta2, 15 giugno 2017)
- Rino Genovese, Totalitarismi e populismi, manifestolibri, 2016, 96 pp., € 8
Alla fine dello scorso anno, per i tipi della manifestolibri, è uscito Totalitarismi e populismi di Rino Genovese, un libro le cui dimensioni sono inversamente proporzionali all’importanza della pubblicazione e che contiene nelle dimensioni del pamphlet la forza espressiva della comunicazione essenziale senza concedere nulla alla semplificazione e alla banalizzazione. In questo spazio di scrittura convivono fianco a fianco, in forte rapporto dialettico come nella migliore tradizione della teoria critica, teoria e prassi: in quanto l’analisi teorica, l’affinamento dei mezzi gnoseologici ed ermeneutici, è subito messo al vaglio della realtà effettuale, che qui prende le forme di un’analisi storica puntuale.
Per comodità espositiva ed efficacia comunicativa, il testo è bipartito; il primo capitolo, intitolato “Conseguenze dei Totalitarismi”, è riservato alle esperienze totalitarie del Novecento e a come abbiano influenzato il corso della storia e delle sue trasformazioni; mentre la seconda parte, “Premesse dei Populismi”, analizza, partendo dall’occidente e dalle sue “dépendances”, che cosa sia questo fenomeno, dai fascismi all’Iran.
Nella prima parte Genovese delinea compiutamente il rapporto tra massa e potere, chiedendosi come si possa oggi parlare di progresso, rimandando alle questioni tradizionali legate all’illuminismo ma anche alla pasoliniana dicotomia di progresso e sviluppo. A livello teorico ci presenta la sua teoria della storia come compresenza e ibridazione, a partire da una sintesi della concezione benjaminiana di una storia che procede per salti e balzi e dall’idea di Bloch della “contemporaneità del non-contemporaneo”, per approdare a “una concezione del tempo opposta a qualsiasi bergsonismo, all’idea di un progresso continuo e di incessante novità cui l’evoluzione darebbe vita”.
 La conseguenza prima di aver fatto saltare benjaminianamente il continuum della storia, alla luce di Bloch, è che “la storia conosce sì cesure, però esse non avvengono quasi mai in modi irreversibili, perché sono per lo più suturate in continuità con il passato che le riaggiusta ibridandole. Così il passato non passa mai completamente - ma neppure si preserva intatto nella luminosità di una tradizione, muovendosi invece a zigzag, sovrapponendosi al presente e chiudendo il futuro con la sua ineliminabile impurità”.
La conseguenza prima di aver fatto saltare benjaminianamente il continuum della storia, alla luce di Bloch, è che “la storia conosce sì cesure, però esse non avvengono quasi mai in modi irreversibili, perché sono per lo più suturate in continuità con il passato che le riaggiusta ibridandole. Così il passato non passa mai completamente - ma neppure si preserva intatto nella luminosità di una tradizione, muovendosi invece a zigzag, sovrapponendosi al presente e chiudendo il futuro con la sua ineliminabile impurità”.Su questo continuo processo, per salti e balzi, di apertura e chiusura delle possibilità effettuali degli eventi sul piano concreto e materiale della storia, Rino Genovese aveva iniziato a riflettere - almeno a parer mio - già dalla Tribù occidentale (Bollati Boringhieri 1995); ora, nella formulazione di una teoria dell’ibridazione, ne trova la forma compiuta nel senso di più efficace sul piano dell’interpretazione, in quanto davvero capace di rendere conto del caos contemporaneo e dei suoi conflitti in un linguaggio che si mantiene distante dalla koiné intellettuale e filosofica di stampo giornalistico.
 Infatti ci mostra chiaramente come le democrazie liberali, i fascismi, la soluzione bolscevico-stalinista siano le dirette conseguenze dell’irruzione delle masse sulla scena della storia e siano “tutte risposte alla questione novecentesca della gestione dei tempi storici dinanzi a una trasformazione in atto e alle sue implicazioni sociali”.
Infatti ci mostra chiaramente come le democrazie liberali, i fascismi, la soluzione bolscevico-stalinista siano le dirette conseguenze dell’irruzione delle masse sulla scena della storia e siano “tutte risposte alla questione novecentesca della gestione dei tempi storici dinanzi a una trasformazione in atto e alle sue implicazioni sociali”.
 Si apre una gestione dinamica del piano storico-temporale e della presenza del passato nel presente: il fascismo si basa “su un passato da riattivare”, il bolscevismo sul futuro da costruire, la liberaldemocrazia sul presente come quotidianità da “consumare”; ma tutte queste sono comunque ibridazioni. La compresenza di tempi storici eterogenei è la base della teoria dell’ibridazione, che però va oltre, e nell’analizzare lo spazio della ripetizione innovativa e del dominio di una razionalità strumentale mette in gioco anche le culture, ibridanti quasi per natura.
Si apre una gestione dinamica del piano storico-temporale e della presenza del passato nel presente: il fascismo si basa “su un passato da riattivare”, il bolscevismo sul futuro da costruire, la liberaldemocrazia sul presente come quotidianità da “consumare”; ma tutte queste sono comunque ibridazioni. La compresenza di tempi storici eterogenei è la base della teoria dell’ibridazione, che però va oltre, e nell’analizzare lo spazio della ripetizione innovativa e del dominio di una razionalità strumentale mette in gioco anche le culture, ibridanti quasi per natura.
 Quando Genovese afferma in maniera molto dura e quasi provocatoria che “il lager e il gulag sono forme di vita sociale”, ci parla non solo delle culture come spazio privilegiato dell’alterità e dell’ibridazione, ma innesca una critica antropologica della storia e una critica storica dell’antropologia e muove verso una sorta di antropologia della storia o storia antropologica. È così che vengono fuori nella loro complessità le modalità attraverso le quali le classi dominanti controllano le masse.
Quando Genovese afferma in maniera molto dura e quasi provocatoria che “il lager e il gulag sono forme di vita sociale”, ci parla non solo delle culture come spazio privilegiato dell’alterità e dell’ibridazione, ma innesca una critica antropologica della storia e una critica storica dell’antropologia e muove verso una sorta di antropologia della storia o storia antropologica. È così che vengono fuori nella loro complessità le modalità attraverso le quali le classi dominanti controllano le masse.Nella seconda parte, nel caos dell’ibridazione contemporanea, dove la modernità è compresenza di tempi storici eterogenei, Genovese ci presenta la moltiplicazione dei populismi come crisi della politica, come perdita di ogni idea di internazionalizzazione e come lotta contro una sorta di “creolizzazione”. Al centro viene posto “l’individualismo di massa basato, tra l’altro, sulla priorità economica del consumo rispetto alla produzione”.
 Andando oltre Benjamin e Debord, e ogni idea di spettacolare concentrato, integrato e diffuso, Genovese definisce l’estetizzazione un fenomeno ampio, che va messo in relazione con l’uso di un mezzo di comunicazione estetico, sul quale si fonda il codice della politica plebiscitaria odierna, in uno spazio dove il politico è totalmente sottomesso all’economico. E questo nuovo potere trova le sue strutture primarie nei “mezzi di comunicazione simbolicamente generalizzati”, una teoria strettamente sociologica dove il potere non viene più inteso come un principio di dominio ma come una sorta di forma di influenza, sotto la quale rientra anche la comunicazione che si rivela un qualcosa non libero dal potere.
Andando oltre Benjamin e Debord, e ogni idea di spettacolare concentrato, integrato e diffuso, Genovese definisce l’estetizzazione un fenomeno ampio, che va messo in relazione con l’uso di un mezzo di comunicazione estetico, sul quale si fonda il codice della politica plebiscitaria odierna, in uno spazio dove il politico è totalmente sottomesso all’economico. E questo nuovo potere trova le sue strutture primarie nei “mezzi di comunicazione simbolicamente generalizzati”, una teoria strettamente sociologica dove il potere non viene più inteso come un principio di dominio ma come una sorta di forma di influenza, sotto la quale rientra anche la comunicazione che si rivela un qualcosa non libero dal potere.Questa attenta analisi dei populismi, in tutte le loro declinazioni, dal peronismo ai nuovi fascismi fino alla visione di un populismo di sinistra (Laclau e Chantal Mouffe), porta Genovese a dimostrare, sul piano concreto della prassi, come non possa esistere un populismo di sinistra, poiché questo uccide ogni idea di pensiero critico; il populismo come fuoriuscita dal bolscevismo-stalinismo merita un discorso a parte, in quanto implica anche un recupero di una forte tradizione russa ottocentesca. Genovese non si limita a portare alla luce negatività e contraddizioni, questioni irrisolte, ma, partendo da una situazione di antagonismi plurimi e di conflitti diffusi, a bassa o ad alta intensità, propone una via d’uscita che comporta - per esempio - non un’uscita dall’Europa, ma una sua vera democratizzazione. Questo può avvenire solo grazie a una democrazia radicale come potere diffuso, che per Genovese necessita di una democrazia rappresentativa funzionante, con qualche situazione di democrazia diretta.
Tutto questo acquista un suo significato e un suo senso nell’ explicit davvero capitale - una sorta di sententia - il quale recita: “In altre parole, i paesi di democrazia occidentale dovrebbero riscoprire quel correttivo interno faticosamente elaborato nel corso della loro storia che si chiama socialismo”.
A questo punto ci permettiamo ancora una piccola glossa, che vorrebbe mettere le condizioni per una nuova apertura; questa scelta implica un’idea gramsciana - a parer mio - di allargamento democratico, con il superamento della distinzione tra governanti e governati. Lo Stato pare quasi diventare un elemento terzo, di equilibrio tra i conflitti, ma per essere così è necessario che recuperi anche una sorta di dimensione neoconsiliare, non in una stanca riproposizione delle esperienze degli anni Venti, ma come capacità di mettere al centro e di fondarsi sul cittadino-lavoratore, reale e concretamente determinato, che agisce e vive. È chiaro che diventa cogente la sintesi di due prospettive che Genovese e Pezzella diversi anni fa sulle colonne del “Ponte” (Prospettiva neosocialdemocratica o prospettiva neoconsiliare?, dicembre 2009) vedevano, se non come opposte, come spazi alternativi. In questa congerie di tempi e di storie frammentate e frammentarie, il soggetto agisce sotto le insegne di un impegno scettico, sul quale può nascere una nuova consapevolezza di appartenenza a un gruppo sociale fondamentale.
Questa nuova coscienza è l’antidoto al dominio dell’ideologia della fine delle ideologie, in virtù della quale il fondamentalismo di un neoliberismo radicale ha riportato una facile vittoria, che ha lasciato guerre e macerie. E da queste sintesi e dai suoi equilibri che può ripartire un nuovo socialismo come esito finale non di un’azione semplicemente riformistica ma di una forte azione riformatrice - per fare piena chiarezza - e non è una mera questione nominalistica, per chi, come me, è cresciuto negli anni Ottanta in pieno craxismo. In questa sua operazione - che possiede le dimensioni del benjaminiano L’opera d’arte nell’epoca della sua riproduzione tecnica e la struttura di una sorta di piccola jonta ai Minima Moralia, in quanto riflessione e testimonianza della vita offesa - Genovese ribadisce perentoriamente, ancora una volta, socialismo o barbarie.
- [...] Genovese non si limita a portare alla luce negatività e contraddizioni, questioni irrisolte, ma, partendo da una situazione di antagonismi plurimi e di conflitti diffusi, a bassa o ad alta intensità, propone una via d’uscita che comporta - per esempio - non un’uscita dall’Europa, ma una sua vera democratizzazione. Questo può avvenire solo grazie a una democrazia radicale come potere diffuso, che per Genovese necessita di una democrazia rappresentativa funzionante, con qualche situazione di democrazia diretta.[...]
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- COME FUNZIONA LA MENTE? LE FIABE «SONO VERE»!8 giugno 2017, di Federico La Sala
- FIABA, COSTITUZIONE, E SOCIETA’. NON SAPPIAMO PIU’ RACCONTARE LE "FAVOLE"! L’ALLARME DI COLLODI E LA "PROVOCAZIONE" DI GRAMELLINI.
L’importanza di perdersi nel bosco
di Giovanna Zoboli *
Dopo l’attentato di Manchester, nel quale al termine di un concerto di Ariana Grande sono rimasti uccisi numerosi ragazzi la maggior parte dei quali ancora minorenni, come dopo ogni atto di terrorismo su media e social network è circolata la domanda “Come spiegare gli attentati ai bambini”. Famiglia Punto Zero, social di promozione culturale della genitorialità e approfondimenti tematici sulla famiglia, ha girato la domanda a Nadia Terranova, scrittrice per adulti e ragazzi, che tiene una bella pagina dedicata alla letteratura per l’infanzia sull’inserto Robinson.
 «Il problema - ha risposto Terranova - non è svegliarsi ogni volta e chiedersi come spiegare gli attentati ai bambini, il problema è che bambini a cui le favole sono state edulcorate, a cui non si può più leggere niente perché “è troppo difficile”, che non hanno più un’elaborazione simbolica della paura perché i grandi hanno paura della loro paura, sono infinitamente più fragili. E il problema non è la cronaca o una soluzione-medicina all’indomani di ogni fatto di cronaca, ma un immaginario indebolito da rifortificare.»
«Il problema - ha risposto Terranova - non è svegliarsi ogni volta e chiedersi come spiegare gli attentati ai bambini, il problema è che bambini a cui le favole sono state edulcorate, a cui non si può più leggere niente perché “è troppo difficile”, che non hanno più un’elaborazione simbolica della paura perché i grandi hanno paura della loro paura, sono infinitamente più fragili. E il problema non è la cronaca o una soluzione-medicina all’indomani di ogni fatto di cronaca, ma un immaginario indebolito da rifortificare.»Centra il punto Terranova. Dietro la fragilità dei bambini c’è quella di un mondo incapace di offrire una sponda al problema del Male: l’infinita fragilità di adulti, voraci consumatori di falsi miti di massa e di ogni genere di impostura, oggi, in aggiornata versione fake news, ma, si direbbe, incapaci di sguardo sulla realtà, come testimoniano continui episodi, ultimo dei quali la vicenda del bambino morto di otite. La questione non è nuova.
 L’ambientalista Ed Ayres spiega che «un modello generale di comportamento tra le società umane è quello di diventare, via via che s’indeboliscono, più cieche alla crisi, anziché più attente.» E tuttavia, nel tempo, questa difficoltà a incontrare il reale, evidente in tutti gli ambiti delle nostre vite e della nostra società, paradossalmente si manifesta in campo educativo, a scuola, in famiglia, e ovunque vi siano bambini, in una calcificata resistenza nei confronti della finzione letteraria e del suo potere catartico, ove la letteratura non si configuri esclusivamente come attività di intrattenimento, ma diventi pratica di ricerca di senso.
L’ambientalista Ed Ayres spiega che «un modello generale di comportamento tra le società umane è quello di diventare, via via che s’indeboliscono, più cieche alla crisi, anziché più attente.» E tuttavia, nel tempo, questa difficoltà a incontrare il reale, evidente in tutti gli ambiti delle nostre vite e della nostra società, paradossalmente si manifesta in campo educativo, a scuola, in famiglia, e ovunque vi siano bambini, in una calcificata resistenza nei confronti della finzione letteraria e del suo potere catartico, ove la letteratura non si configuri esclusivamente come attività di intrattenimento, ma diventi pratica di ricerca di senso.Sono le fiabe, in particolare, a essere le prime vittime di questa lugubre e ostile diffidenza. Dopo qualche migliaio di anni, la più perfetta fra le finzioni, il più celebre degli incipit, C’era una volta, garanzia di distanza, e quindi di elaborazione simbolica, fra realtà del presente e passato della fiaba, non convince più.
 Una ipotesi potrebbe essere che essendo gli adulti sempre più incapaci di distinguere fra realtà e finzione, individuino nella finzione letteraria, che obbliga il lettore a sospendere temporaneamente la propria incredulità, un potenziale innesco a traumi e comportamenti devianti, temendo che la fiaba funzioni da miccia a paure incontrollate e dannose alla crescita, come se i bambini apprendessero dell’esistenza della paura dalle fiabe e non la sperimentassero in prima persona nella propria esperienza quotidiana.
Una ipotesi potrebbe essere che essendo gli adulti sempre più incapaci di distinguere fra realtà e finzione, individuino nella finzione letteraria, che obbliga il lettore a sospendere temporaneamente la propria incredulità, un potenziale innesco a traumi e comportamenti devianti, temendo che la fiaba funzioni da miccia a paure incontrollate e dannose alla crescita, come se i bambini apprendessero dell’esistenza della paura dalle fiabe e non la sperimentassero in prima persona nella propria esperienza quotidiana.Già i Fratelli Grimm, a stare ai loro carteggi, si lamentavano del problema, osservando che il perbenismo dei lettori li costringeva a sistematiche ripuliture dei testi orali raccolti durante il loro lavoro di ricerca. E in effetti le loro Fiabe o Märchen, come le leggiamo oggi, sono il risultato di ben sei edizioni nelle quali si procedette a successive riscritture per adeguarle al gusto del pubblico borghese, disturbato dal perturbante delle narrazioni popolari.
Oggi, il grande interesse per le fiabe e il fiabesco di certa parte della cultura attraverso le ricerche di studiosi che negli ultimi anni hanno lavorato a divulgare la conoscenza delle fiabe e la loro importanza in ambito letterario ed educativo, permette di accedere a raccolte di fiabe di grande interesse, come la prima bellissima edizione dei Grimm, quella redatta fra il 1812-1815, che in Italia, intitolata Principessa Pel di Topo, curata da Jack Zipes e illustrata da Fabian Negrin, è stata edita da Donzelli nel 2012 (a questa è seguita quella integrale, Tutte le fiabe, del 2015).
Raccolte importanti a cui si dovrebbe attingere per letture ai bambini, prima ancora che ad adulti, senza timori e incertezze, poiché, come spiegano psicologi, antropologi, evoluzionisti, pediatri, educatori, la razza umana, adulti e bambini, da sempre hanno bisogno di sperimentare la paura, e la narrazione è uno dei sistemi più antichi ed efficaci perché questo avvenga, a livello simbolico, senza incorrere in pericoli reali.
In L’istinto di narrare, Jonathan Gotschal, nel terzo capitolo, L’inferno è amico delle storie, scrive: «Nel suo straordinario Come funziona la mente Pinker (teorico dell’evoluzione umana, ndr) sostiene che le storie ci dotano di un archivio mentale di situazioni complesse che un giorno potremmo trovarci a dover affrontare, unitamente a una serie di possibili soluzioni operative. Così come i giocatori di scacchi memorizzano risposte ottimali a un’ampia gamma di attacchi e difese, noi ci attrezziamo per la vita reale, assorbendo schemi di gioco funzionali».
 E più avanti: «La costante attivazione dei nostri neuroni in risposta a stimoli derivanti dal consumo di finzione narrativa rafforza e ridefinisce le vie neurali che consentono una navigazione competente nei problemi dell’esistenza. In questo senso siamo attratti dalla finzione narrativa non a causa di un’anomalia dell’evoluzione, ma perché la finzione è, nell’insieme, vantaggiosa per noi. Questo perché la vita umana, specialmente la vita sociale, è profondamente complessa e le poste in gioco molto alte. La finzione consente al nostro cervello di fare pratica con le reazioni a quei generi di sfide che sono, e sono sempre state, le più cruciali per il nostro successo come specie». La tesi di Gotschall in L’istinto di narrare è, infatti, che l’attitudine alla narrazione abbia determinato il successo della specie umana.
E più avanti: «La costante attivazione dei nostri neuroni in risposta a stimoli derivanti dal consumo di finzione narrativa rafforza e ridefinisce le vie neurali che consentono una navigazione competente nei problemi dell’esistenza. In questo senso siamo attratti dalla finzione narrativa non a causa di un’anomalia dell’evoluzione, ma perché la finzione è, nell’insieme, vantaggiosa per noi. Questo perché la vita umana, specialmente la vita sociale, è profondamente complessa e le poste in gioco molto alte. La finzione consente al nostro cervello di fare pratica con le reazioni a quei generi di sfide che sono, e sono sempre state, le più cruciali per il nostro successo come specie». La tesi di Gotschall in L’istinto di narrare è, infatti, che l’attitudine alla narrazione abbia determinato il successo della specie umana.Molto prima dei moderni studi antropologici, peraltro, nell’antica Grecia, filosofi e pensatori, a proposito di Poesia e Tragedia, interpretavano lo straordinario potere della finzione letteraria come catarsi. -Ciò che avveniva durante la lettura di versi o sul palcoscenico induceva il pubblico a purificarsi, elaborando in profondità dilemmi etici, e vivendo intensamente come spettatori vicende che a tutt’oggi, nei teatri antichi di Siracusa, Taormina, Segesta, Epidauro, muovono le nostre coscienze e ci educano alla necessità della ricerca di senso.
Da alcuni anni Chiara Guidi, insieme alla compagnia teatrale Socìetas Raffaello Sanzio, si è fatta interprete di spettacoli che mettono al centro della scena le fiabe e i bambini, attraverso quello che ha definito “metodo errante”. Per innescare questo metodo, spiega «bisogna preparare un posto inerte, come le pagine di un libro. Il teatro è un’apparecchiatura spaziale e temporale che permette di far sorgere la figura. Sono i bambini a metterlo in moto con la loro presenza.»
Grazie a questa presenza e azione infantile si entra nella fiaba, nel racconto mitico, arrivando a toccarli, generando un atto di creazione, un’esperienza d’arte. Da questo metodo sono nate le esperienze teatrali delle Favole di Esopo (1992), di Hänsel e Gretel (1993), Buchettino (1995), Pelle d’asino (1996), Jack e il fagiolo magico (2013).
Fra i suoi spettacoli più noti, c’è Buchettino che Guidi in un’intervista del 2012 racconta così:
 «è una favola raccontata da una attrice messa dentro a una stanza di legno che diventa una grande cassa di risonanza dove, all’esterno, dei tecnici rumoristi fanno i rumori della favola: suonano la favola. I bambini sono a letto coperti con delle coperte: cinquanta bambini, cinquanta coperte, cinquanta lenzuoli, cinquanta cuscini, e il letto diventa una barca, e diventa anche il luogo della protezione, perché se ho paura mi copro con la coperta, consapevole che quella coperta diventa una corazza che mi protegge. Non c’è nulla da vedere: però, ascoltando, è possibile vedere.
«è una favola raccontata da una attrice messa dentro a una stanza di legno che diventa una grande cassa di risonanza dove, all’esterno, dei tecnici rumoristi fanno i rumori della favola: suonano la favola. I bambini sono a letto coperti con delle coperte: cinquanta bambini, cinquanta coperte, cinquanta lenzuoli, cinquanta cuscini, e il letto diventa una barca, e diventa anche il luogo della protezione, perché se ho paura mi copro con la coperta, consapevole che quella coperta diventa una corazza che mi protegge. Non c’è nulla da vedere: però, ascoltando, è possibile vedere.
 I bambini oggi ascoltano poche favole, le favole non sono più favole della tradizione perché queste sono favole che fanno paura e non possono essere raccontate ai bambini. Si può far vedere il male attraverso la società dello spettacolo ed escludere invece la catarsi della favola che sempre porta il lieto fine.
I bambini oggi ascoltano poche favole, le favole non sono più favole della tradizione perché queste sono favole che fanno paura e non possono essere raccontate ai bambini. Si può far vedere il male attraverso la società dello spettacolo ed escludere invece la catarsi della favola che sempre porta il lieto fine.
 Sarebbe necessario un ritorno dei bambini a favole che sono l’espressione di un’esperienza che conduce attraverso la vita della favola alla vita possibile futura di un bambino che diventerà adulto.»
La grande intuizione di questa rappresentazione, in un momento storico in cui i bambini sono accuratamente tenuti lontani dalle fiabe, è mettere al centro dell’azione scenica i bambini come ascoltatori di fiabe, spettatori, ma dentro il corpo stesso della fiaba, nel suo pericolo, attivamente impegnati a ricrearla con l’immaginazione, seguendo la narrazione orale e l’andamento sonoro della vicenda.
Sarebbe necessario un ritorno dei bambini a favole che sono l’espressione di un’esperienza che conduce attraverso la vita della favola alla vita possibile futura di un bambino che diventerà adulto.»
La grande intuizione di questa rappresentazione, in un momento storico in cui i bambini sono accuratamente tenuti lontani dalle fiabe, è mettere al centro dell’azione scenica i bambini come ascoltatori di fiabe, spettatori, ma dentro il corpo stesso della fiaba, nel suo pericolo, attivamente impegnati a ricrearla con l’immaginazione, seguendo la narrazione orale e l’andamento sonoro della vicenda.La storia di Buchettino, che poi è quella di Pollicino ovvero Le petit poucet di Charles Perrault (Buchettino è il titolo della versione toscana) come è stata portata in scena da Chiara Guidi, con l’adattamento di Claudia Castellucci, è stata pubblicata da Orecchio Acerbo nel 2015 in una bella edizione con le illustrazioni di Simone Massi.
 Per origine, storia e natura le fiabe si prestano più di ogni altro genere letterario a rielaborazioni, metamorfosi, riscritture attraverso i medium più diversi: dal teatro al cinema, al fumetto, alla poesia, all’illustrazione, alla danza, alla musica.
Per origine, storia e natura le fiabe si prestano più di ogni altro genere letterario a rielaborazioni, metamorfosi, riscritture attraverso i medium più diversi: dal teatro al cinema, al fumetto, alla poesia, all’illustrazione, alla danza, alla musica.
 Questa estrema duttilità è una grande risorsa dal punto di vista educativo, poiché permette di proporre ai bambini una quantità di varianti e di linguaggi che diventano ottimi strumenti di ri-narrazione e indagine. Il linguaggio in cui si sceglie di raccontare una fiaba, infatti, determina la forma stessa della narrazione portando, ogni volta, a galla delle vicende aspetti che in altre versioni rimangono impliciti, nascosti.
Questa estrema duttilità è una grande risorsa dal punto di vista educativo, poiché permette di proporre ai bambini una quantità di varianti e di linguaggi che diventano ottimi strumenti di ri-narrazione e indagine. Il linguaggio in cui si sceglie di raccontare una fiaba, infatti, determina la forma stessa della narrazione portando, ogni volta, a galla delle vicende aspetti che in altre versioni rimangono impliciti, nascosti.Nella raccolta poetica In mezzo alla fiaba, edita da Topipittori nel 2015 con illustrazioni di Arianna Vairo, Silvia Vecchini decostruisce venti fiabe della tradizione per ricostruirle attraverso venti composizioni poetiche. La prima volte che le lessi, rimasi folgorata dal testo che dedicò a Pollicino, poiché non avevo mai realizzato consapevolmente, ma solo inconsciamente, quale fosse il suo centro tensionale:
Se tuo padre è un orco
non ti basterà dormire
indossando una corona
la violenza è cieca
il coltello non ragiona.
Al cuore di questa vicenda, Vecchini mette, anziché l’abbandono dei figli nel bosco da parte dei genitori afflitti da una miseria senza scampo, l’eccidio delle orchessine uccise dal padre-orco al posto di Pollicino e dei suo fratelli che scambiano i loro cappelli con le corone delle bambine, condannandole a morte e ingannando l’orco.
 Nell’illustrazione che Gustave Doré dedicò a questo momento della fiaba vediamo le orchessine che dormono tutte insieme in un grande letto cosparso di ossa. Accanto a questo, specularmente, il lettore immagina il letto in cui dormono Pollicino e i suoi fratelli. È certo che in questa fiaba lo stare a letto di bambini e bambine è fortemente implicato con il tessuto stesso della storia, ed è certamente anche questo che rende la messa in scena di Chiara Guidi così potente e liberatoria.
Nell’illustrazione che Gustave Doré dedicò a questo momento della fiaba vediamo le orchessine che dormono tutte insieme in un grande letto cosparso di ossa. Accanto a questo, specularmente, il lettore immagina il letto in cui dormono Pollicino e i suoi fratelli. È certo che in questa fiaba lo stare a letto di bambini e bambine è fortemente implicato con il tessuto stesso della storia, ed è certamente anche questo che rende la messa in scena di Chiara Guidi così potente e liberatoria.La fiaba di Pollicino di Perrault ha numerosi punti di contatto con quella di Hänsel e Gretel dei Grimm, in particolare nella parte iniziale che procede identica: la decisione dei genitori di abbandonare i figli a causa della miseria, l’abbandono nel bosco, lo stratagemma dei sassolini bianchi per ritrovare la strada di casa, e poi quello, fallimentare delle briciole mangiate dagli uccelli, che decreta lo smarrimento dei bambini e il pericolo di essere mangiati nel primo caso dalla strega, nel secondo dall’orco. Silvia Vecchini nella poesia in cui riscrive Hänsel e Gretel mette al centro della scena il vincolo di salvezza che stringe fratello e sorella:
A tutti servirebbe un fratello
che nel momento più scuro
esca di nascosto e si riempia le tasche,
che nel bosco resti al tuo fianco
e lasci cadere a ogni passo
un sassolino bianco.
Se in Pollicino, infatti, sono le doti straordinarie del più piccolo dei fratelli e apparentemente incapace, a salvare gli altri, inetti, qui il lieto fine è sancito dalla collaborazione dei due bambini, ugualmente impegnati nel salvarsi reciprocamente la vita. Sottolinea questo significato anche Bruno Bettelheim che in Il mondo incantato dà una lettura di grande interesse di Hänsel e Gretel, in cui l’accento è posto sulla necessità dei bambini di affrontare il bosco per crescere, conquistare l’autonomia, liberandosi, attraverso il pericolo corso e superato, dalla tendenza regressiva a rifugiarsi nella casa e nel supporto dei genitori.
Uscita nel 2009 per Gallimard Jeunesse e in Italia edita da Orecchio Acerbo, Hänsel e Gretel, attraverso le insuperabili illustrazioni di Lorenzo Mattotti, che tocca qui uno dei suoi punti più alti, è davvero “la fiaba per eccellenza” come l’ha definita Chiara Guidi: un percorso attraverso il buio e la luce che segna la crescita come capacità di riconoscere e opporsi al Male e superare il pericolo con le proprie forze. Dev’essere questa eccellenza la ragione per cui questa fiaba non smette di esercitare il suo fascino su disegnatori e illustratori.
 L’ultima versione edita in Italia è uscita per Canicola che inaugura con questo Hänsel e Gretel, della tedesca Sophia Martineck, la collana di fumetti “Dino Buzzati” dedicata ai bambini. Fedele alla versione dei Grimm, Martineck nelle illustrazioni attualizza interni e abiti dei protagonisti: la casa dei genitori ha una moderna cucina a gas, un lavello di acciaio e i bambini indossano giacca a vento ed eskimo. Fiabesco rimane il bosco, antico e senza tempo, intrico di ombre e tronchi, dove la casa della strega si manifesta come un’allucinazione.
L’ultima versione edita in Italia è uscita per Canicola che inaugura con questo Hänsel e Gretel, della tedesca Sophia Martineck, la collana di fumetti “Dino Buzzati” dedicata ai bambini. Fedele alla versione dei Grimm, Martineck nelle illustrazioni attualizza interni e abiti dei protagonisti: la casa dei genitori ha una moderna cucina a gas, un lavello di acciaio e i bambini indossano giacca a vento ed eskimo. Fiabesco rimane il bosco, antico e senza tempo, intrico di ombre e tronchi, dove la casa della strega si manifesta come un’allucinazione.Il modo di narrazione del fumetto che racconta in forma dialogica, porta in primo piano la crudezza della vicenda attraverso le parole che si scambiano genitori e figli. La sbrigativa menzogna con cui vengono lasciati soli nel bosco urta contro la drammatica consapevolezza dei bambini, e del lettore, che sanno bene che la promessa di tornarli a prenderli dopo il taglio della legna è destinata a non compiersi. Ugualmente interessanti sono i dialoghi dei bambini, le loro parole sempre affettuose, fiduciose, speranzose anche nello spavento: fiabesche, insomma, quanto il bosco atemporale, analogia che sottolinea quanto l’infanzia appartenga a una dimensione profondamente radicata nella natura e nei suoi simboli.
Del Pollicino di Perrault, invece, nella versione dei Grimm non rimane niente, se non il titolo e il tema del bambino piccolissimo che riesce a superare ogni sorta di avventure con grande scaltrezza. È una fiaba allegra, scanzonata questa, da poco pubblicata in Italia da Quodlibet/Ottimomassimo nel volume Fiabe a fumetti, scritte e disegnate da Rotraut Susanne Berner, vincitrice lo scorso anno dell’Hans Christian Andersen Award.
 Fiabe a fumetti raccoglie otto fiabe dei Grimm, trasposte nel segno limpido, aggraziato e umoristico caratteristico della grande autrice tedesca. È infatti la bellezza visiva del fiabesco a fare la parte del leone in questo libro, in cui le storie sono rese in massima sintesi, una sorta di morfologia della fiaba alla maniera di Propp, in cui i bambini più piccoli, aiutati dallo stampatello, potranno familiarizzare con le trame delle storie e i loro protagonisti, osservando e divertendosi a osservare analogie e differenze delle trame.
Fiabe a fumetti raccoglie otto fiabe dei Grimm, trasposte nel segno limpido, aggraziato e umoristico caratteristico della grande autrice tedesca. È infatti la bellezza visiva del fiabesco a fare la parte del leone in questo libro, in cui le storie sono rese in massima sintesi, una sorta di morfologia della fiaba alla maniera di Propp, in cui i bambini più piccoli, aiutati dallo stampatello, potranno familiarizzare con le trame delle storie e i loro protagonisti, osservando e divertendosi a osservare analogie e differenze delle trame.
 Benché i contenuti paurosi delle vicende qui non siano censurati, come invece spesso avviene in numerose mortificanti riduzioni in commercio, è straordinario osservare come il fascinoso immaginario nordico a tinte cupe dei Grimm subisca una metamorfosi che lo porta ad avvicinarsi alla luminosa e ludica allegria delle Fiabe italiane curate da Italo Calvino. Come se in questa autrice nata in Germania, come in tanti suoi conterranei prima di lei, covi una segreta passione per la luce mediterranea, e la disposizione al comico del suo folklore.
Benché i contenuti paurosi delle vicende qui non siano censurati, come invece spesso avviene in numerose mortificanti riduzioni in commercio, è straordinario osservare come il fascinoso immaginario nordico a tinte cupe dei Grimm subisca una metamorfosi che lo porta ad avvicinarsi alla luminosa e ludica allegria delle Fiabe italiane curate da Italo Calvino. Come se in questa autrice nata in Germania, come in tanti suoi conterranei prima di lei, covi una segreta passione per la luce mediterranea, e la disposizione al comico del suo folklore.Fra il 1970 e il 1972, uno fra i più grandi illustratori del Novecento, Maurice Sendak realizzò una serie di illustrazioni per una selezione delle fiabe dei Grimm, edite poi nel 1973 da Farrar, Straus and Giroux con il titolo The JuniperTree. Per avvicinarsi alle storie e al loro immaginario, Sendak fece un lungo viaggio in Europa e in Germania, e un’accurata ricerca sugli stilemi della pittura tedesca, in particolare su Dürer. -Quando il libro uscì, ci furono parecchie critiche riguardo al modo che aveva scelto per rappresentarle. Piuttosto contrariato, l’autore spiegò che più che “rappresentare” la storia, aveva voluto puntare al suo lato oscuro, sotterraneo: a quello, cioè, che la storia non dice, o meglio, dice nascostamente. Di queste fiabe gli interessava «cogliere il momento in cui la tensione fra storia ed emozione è perfetta, così che il lettore leggendo, possa sorprendersi, pensando che si tratta ’semplicemente’ di una favola.»
 Ai molti che giudicarono queste immagini claustrofobiche, cupe, poche adatte ai bambini (che peraltro hanno sempre amato follemente il lavoro di Sendak come dimostra la fortuna dei suoi libri in tutto il mondo) affermò: «Credo che i bambini intuiscano il significato profondo di ogni cosa. Sono solo gli adulti che per la maggior parte del tempo leggono la superficie. Sto generalizzando, naturalmente, ma le mie illustrazioni non sorprendono i bambini. Loro sanno cosa c’è in queste storie. Sanno che matrigna significa madre, e che il suffisso -igna è lì per evitare che gli adulti si spaventino. I bambini sanno che ci sono madri che abbandonano i loro bambini, emotivamente, non letteralmente. Talvolta vivono con questa realtà. Non mentono a se stessi. E vorrebbero sopravvivere, se questo accade. Il mio obiettivo è non mentire loro.»
Ai molti che giudicarono queste immagini claustrofobiche, cupe, poche adatte ai bambini (che peraltro hanno sempre amato follemente il lavoro di Sendak come dimostra la fortuna dei suoi libri in tutto il mondo) affermò: «Credo che i bambini intuiscano il significato profondo di ogni cosa. Sono solo gli adulti che per la maggior parte del tempo leggono la superficie. Sto generalizzando, naturalmente, ma le mie illustrazioni non sorprendono i bambini. Loro sanno cosa c’è in queste storie. Sanno che matrigna significa madre, e che il suffisso -igna è lì per evitare che gli adulti si spaventino. I bambini sanno che ci sono madri che abbandonano i loro bambini, emotivamente, non letteralmente. Talvolta vivono con questa realtà. Non mentono a se stessi. E vorrebbero sopravvivere, se questo accade. Il mio obiettivo è non mentire loro.»Sendak aveva ragione, naturalmente. Oggi sappiamo che l’ingresso della matrigna nella fiaba di Hänsel e Gretel, si dovette ai malumori del pubblico ottocentesco che nella madre della fiaba, attiva promotrice nell’abbandono dei figli, videro compromessa e infangata la figura materna, che invece si pretendeva intatta, nella sua tradizionale funzione di accudente angelo del focolare. Per questo le parole di Sendak risultano tanto più veritiere, lucide.
Non mentire ai bambini significa anzitutto per gli adulti non mentire a se stessi, recuperare la possibilità di confrontarsi con la realtà, saperla leggere, incontrarla. Magari proprio a cominciare dalla finzione letteraria, dalle fiabe che come scrive Italo Calvino nella prefazione alla sua raccolta, «sono vere».
* DoppioZero, 08.06.2017 (ripresa parziale, senza immagini).
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- ULISSE, I PROCI, TELEMACO, E "LA SOCIETA’ ORIZZONTALE"!2 giugno 2017, di Federico La Sala
UNA CATTOLICA, UNIVERSALE, ALLEANZA "EDIPICA"!!! IL MAGGIORASCATO: L’ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE, L’ALLEANZA DELLA MADRE CON IL FIGLIO, REGNA ANCORA COME IN TERRA COSI’ IN CIELO ...
- CON LA COSTITUZIONE IL POPOLO ITALIANO HA FATTO "LA RIFORMA", MA NE’ I CATTOLICI NE’ I LAICI LO HANNO CAPITO. A PIETRO SCOPPOLA, CHE AVEVA COMINCIATO A CAPIRLO ..... A SUA MEMORIA
La vera società libera è quella che rifiuta la tirannia dei padri
Nel loro saggio Marco Marzano e Nadia Urbinati riflettono sulle trasformazioni della nostra organizzazione di vita proponendo un “patto” tra pari che elimini ogni leaderismo
di Giulio Azzolini (la Repubblica, 02.06.2017)
- IL SAGGIO. Marco Marzano e Nadia Urbinati La società orizzontale. Liberi senza padri. Feltrinelli Collana: Campi del sapere. 2017 pagg. 112 euro 16.
Chi ha paura della “morte del padre”? Chi teme la crisi di quell’autorità che la tradizione ha visto incarnata nella figura maschile e paterna? Non certo Marco Marzano e Nadia Urbinati, che anzi nel loro saggio La società orizzontale (Feltrinelli) si scagliano apertamente contro quello che chiamano «il modello di Telemaco»: il figlio che, nell’attesa del padre Ulisse, non scatena il conflitto generazionale di Edipo né mira all’autoaffermazione di Narciso. Invece, secondo il sociologo e la teorica della politica, l’attesa del padre tradisce piuttosto l’invocazione del leader, dunque una qualche nostalgia per le vecchie gerarchie.
Alla «logica neo-patriarcale» andrebbe contrapposta, a parer loro, la rivendicazione di una «società orizzontale», ovvero autenticamente democratica. E il saggio, che pone in modo polemico e sempre lucido questioni radicali, àncora tale rivendicazione a una duplice argomentazione, volta a mostrare che una società senza padri è desiderabile e, d’altro canto, che il processo di “orizzontalizzazione” è comunque un destino, malgrado la nostra economia sia stata segnata da quella scandalosa «mutazione antiegualitaria» denunciata proprio da Nadia Urbinati nel 2013 (Laterza).
La società orizzontale, in sintesi, sarebbe non solo augurabile, ma anche possibile, a patto tuttavia di vincere una precisa battaglia culturale: quella che ha per avversario la cosiddetta «controrivoluzione dei padri ». Secondo i due autori, infatti, l’Italia ha bisogno di riaffermare il valore etico della democrazia a partire da tre ambiti cruciali: religioso, famigliare e politico.
Sul piano religioso, Marzano e Urbinati descrivono una sorta di passaggio al protestantesimo, compiuto da una generazione di giovani che ragiona in autonomia e stabilisce un rapporto sempre più diretto e libero con la dimensione del divino. Sul piano famigliare, si nega che il declino della famiglia tradizionale, cioè paternalistica e autoritaria, rappresenti una catastrofe.
Al contrario, la democratizzazione delle famiglie avrebbe portato con sé un clima più pacifico, fatto di dialogo e di rispetto reciproco.
Sul piano politico, infine, viene diagnosticata la crisi dei partiti identitari. La loro restaurazione è una causa persa. Ma la loro natura dev’essere per forza leaderistica o verticale? No. La sfida, secondo gli autori, è quella di costruire partiti orizzontali, con una struttura sempre meno piramidale e più reticolare, capace cioè di federare gruppi sorti nella società civile. E ciò non implica il rigetto della dicotomia destra-sinistra, come pretende l’attuale vulgata movimentista. Marzano e Urbinati sostengono che gli stessi valori democratici possono ancora essere declinati con uno spirito riformista e sociale oppure conservatore e liberista, e dunque che le categorie di destra e sinistra restano utili criteri di orientamento.
Se non è l’assenza di padri, il pericolo che incombe sulla società orizzontale è quindi un altro: la trasformazione dell’individualismo in atomismo, ossia l’aggravarsi di una patologia tipica di quegli individui liberi e uguali che rappresentano il cuore della democrazia moderna. Il rischio dei nostri giorni è che le persone si isolino, risultando sempre più sconosciute, indifferenti o ostili le une alle altre, e che il presente si separi da un passato percepito come oscuro ed estraneo. Ma la salvezza sta nella collaborazione tra pari, non già nel ritorno, magari in nome del padre, del capo.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- LEGGERE CON L’ORECCHIO. Mi assumo a cavia, e rivelo che quando leggo, io ascolto. Ascolto la voce, o quel che resta della voce in quel che è scritto (di Nadia Fusini).1 giugno 2017, di Federico La Sala
CHI INSEGNA A CHI CHE COSA COME?! QUESTIONE PEDAGOGICA E FILOSOFICA, TEOLOGICA E POLITICA.
 COSTITUZIONE ED EDUCAZIONE CIVICA. Crisi dei fondamenti di una civiltà....
COSTITUZIONE ED EDUCAZIONE CIVICA. Crisi dei fondamenti di una civiltà....
Leggere con l’orecchio
di Nadia Fusini *
Se esiste la letteratura non possono non esistere la storia e la critica della letteratura. E dunque, chi si applica a mettere in sequenza i suoi frutti, e chi si dedica al loro giudizio. Alla loro interpretazione. Chi opera per coglierne il senso nascosto, o profondo. O per decifrare nel suo specchio le verità dell’epoca con la quale la letteratura intrattiene rapporti più o meno indiretti.
Se esiste la letteratura non può non esistere una visione, e dunque una teoria della medesima. Nel senso puro e semplice che nei suoi frutti si dà a vedere un mondo. E comunque, al di là del suo valore di intrattenimento, di divertimento - che sia in versi o in prosa, che sia un poema, un romanzo o unracconto - l’opera letteraria condensa in sé un pensiero, un’idea del mondo. Come ogni manufatto linguistico.
Esistono dunque a buon diritto il critico, lo storico, il teorico della letteratura. Ora, tali professioni, anche nel senso di fede - di fede e fiducia nella parola: che possa produrre conoscenza - si esplicano in vari modi. C’è il critico accademico, c’è il critico militante, c’è lo storico, e c’è l’interprete, e c’è il recensore di libri sui quotidiani. Chi insegna dall’alto di una cattedra e chi lodevolmente e quotidianamente si impegna a guidare il lettore comune nella scelta di un romanzo, di un libro di poesie, orientandolo con onestà in un panorama assai vasto di esperienze possibili, ben sapendo che esiste un’industria culturale, la cui volontà espansiva non arretra di fronte alle colpevoli sopraffazioni della buona fede del lettore comune. Appunto, il lettore comune, il destinatario reale e ideale del libro.
Ora a me pare che affinché esista una buona letteratura, è necessario che esista un buon lettore. O, per non ripetere il vecchio adagio dell’uovo e della gallina, un buon lettore e una buona letteratura si danno la mano.
La lettura, è questo l’atto da indagare. Come ci arriviamo. Come lo eseguiamo. Intanto, vari sensi e organi vi sono implicati. C’è l’ occhio, e c’è lo sguardo. Non sono la stessa cosa. C’è l’orecchio, e c’è l’ascolto. Non sono la stessa cosa. Leggere, non è solo una questione di occhio. Sì, certo, si legge con l’occhio la parola scritta. Ma si legge anche con l’orecchio.
Mi assumo a cavia, e rivelo che quando leggo, io ascolto. Ascolto la voce, o quel che resta della voce in quel che è scritto. Come fa Leopardi - ricordate?, quando “porgea gli orecchi al suon della tua voce", dice a Silvia. "Sonavan le quiete stanze, e le vie dintorno", in virtù di quella voce. E lui ne ha nostalgia. Potremmo dire con Leopardi che la poesia nasce così, come un’immensa nostalgia della voce viva. Voce viva, viva voce: voce che è appunto segno vivente, fiato, respiro, anima. È il segno di vita che cerca Lear sulle labbra di Cordelia - la più laconica delle sue figlie. La voce viva, la vita. Nelle parole scritte, o morte (è la stessa cosa, insegna Socrate), quando leggiamo, cerchiamo la voce viva.
Questo fa il lettore che ha orecchio: attende alla parola viva. Ascolta nell’enunciazione umana la lotta per l’espressione. Porge l’orecchio per sentire qualcuno in duello con se stesso, coi propri grovigli espressivi, con il mondo che vuole specchiare, rappresentare, svelare... Insomma, in lotta con la volontà di afferrare nella parola, quand’anche per la coda, un’esperienza che è di un altro ordine, rispetto al linguaggio.
 Un’esperienza che è vita.
Un’esperienza che è vita.L’orecchio in quanto organo presenta però una caratteristica particolare: è l’unico orifizio del corpo umano che non si chiude. Si può chiudere la bocca, si possono chiudere gli occhi, si può serrare l’ano, per quanto riguarda la vagina è protetta per un certo tempo almeno dall’imene, e anche dopo si può quanto meno contrarla, se non si vuole far passare qualcosa; ma l’orecchio no. Di suo e per natura, l’orecchio non ha difese contro la penetrazione. Proprio per questo è estremamente vulnerabile. E temo che l’acustica roboante di un’industria editoriale sciatta e volgare contribuisca a corrompere l’udito. E così anche chi vorrebbe tenere le orecchie aperte per accogliere il suono della vita, finirà per non sentire più nulla. E non saprà più intonarsi all’esperienza di conoscenza e di piacere che offre una parola autentica, che con il suono della vita si confronta.
A questa educazione dovrebbero attendere la scuola, l’università, la critica e l’estetica. Accade invece - è sotto gli occhi di tutti - che a fronte di una alfabetizzazione universale, corrisponda una ignoranza epocale, frutto di una ideologia dell’istruzione sempre più marcatamente piegata all’utile e all’immediato impiego delle risorse umane e sempre più estranea, quasi non sapesse più che cos’è, alla cura dello sviluppo della coscienza critica.
Assistiamo sconcertati a istituzioni che assecondano la pigrizia e programmano la volontà di lasciar cadere un patrimonio letterario e culturale, di cui il nostro contemporaneo è l’erede, defraudando in realtà il nostro contemporaneo delle antenne che dovrebbe sviluppare per comprendere la sua propria vita. Così chi avesse nel proprio orizzonte ancora tali fini per se stesso, singolarmente dovrà farsi carico della volontà di conoscenza: volontà di conoscenza che non può non passare attraverso la lettura, in un rapporto dinamico tra la tradizione e il presente.
Il fatto è che o leggere ha questo risvolto esperienziale, o non è nulla: non ha nessun valore. Se non di evasione. Mentre io - di nuovo mi offro come cavia - avanzo nella lettura non in fuga, ma a caccia del reale. Non leggo per evadere. Non sono un disertore. O se leggo per fuggire dalla realtà, è perché credo che la lettura mi permetta di entrare in un altro mondo né falso, né vero, ma per l’appunto “reale”.
Questo me l’ha insegnato una donna filosofa, Rachel Bespaloff. Per la quale “la lettura è la messa alla prova spirituale di un’opera.” Mentre un’altra donna filosofa, Simone Weil, mi ha insegnato l’esercizio della lettura come ‘attenzione’. Che siano Camus o Omero, la Bibbia o Kafka, chi legge, insegnano le due donne filosofe, chi legge cerca il senso dell’esistenza umana.
In modo indiretto, sospeso, per niente enfatico, chi legge ritorna a farsi le domande essenziali: da dove veniamo? chi siamo? dove andiamo? È una ginnastica essenziale alla formazione umana dell’uomo. E della donna. È un training a cui la letteratura allena. In questo senso, il lettore mette alla prova l’opera che ha di fronte. E l’opera esisterà, sarà grande, rimarrà viva nei secoli dei secoli, se chi vi si abbevera, almeno un poco, estingue la sua sete di verità spirituale.
Simone Weil insegna che al cuore della lettura v’è un’esperienza etica. Si legge per conoscere, si legge per trasformarsi, per cambiare. Perché come nella muta del serpente, il vecchio Adamo decada e il novello Adamo nasca, e con lui naturalmente una nuova Eva... Si legge perché riconosciamo allo scrittore la capacità di operare in noi una metamorfosi. Sì, certo, è alla realtà, è al mondo vero, che lo scrittore attinge per costruire il suo mondo irreale; ma è del mondo reale, che vuole parlare - per cogliere oltre la sua opacità, oltre il suo capriccio, un’apertura all’essere più profonda, più radicale, che si dà soltanto così, perché lui la inventa. Cioè, la trova. E cioè, la crea. È un momento davvero miracoloso quello in cui trascendenza e invenzione si confondono. E il lettore se ne fa testimone, perché è nel lettore che questo processo si incarna.
Chi risponde così dell’atto della lettura, si fa lui stesso scrittore. A simbolo risponde simbolo, sentenziò anni fa in uno scambio privato il grande Roland Barthes. Aveva assolutamente ragione. Ma perché questo accada, il lettore dovrà farsi deuteragonista attivo e esigente. E coraggiosamente, con ostinazione mettersi alla ricerca - sarà il suo proprio Graal - dei libri che gli offrano tale esperienza.
Allontanando da sé la cattiva influenza di tutti quei mediatori che della letteratura fanno commercio, e con i lacci seduttivi di una perniciosa arte della retorica lo dissuadono dallo sviluppare le antenne che servono a distinguere la parola autentica da quella falsa. Siamo diventati così sofisticati nel palato, tanto da distinguere prelibate vivande di raro gusto, e non vogliamo diventare altrettanto capaci di godere della parola?
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- DON RODRIGO e DON ABBONDIO (come al solito) contro i "Promessi sposi"!!! Ora docenti come Giunta e Gardini, e scrittori come Camilleri, Terranova e Trevi chiedono di cambiare.22 maggio 2017, di Federico La Sala
DON RODRIGO, DON ABBONDIO, E QUEL "RAMO D’ORO" DEL LAGO DI COMO! Liberare gli studenti dalla "boria" dei "sapientissimi" proff. e dalle sapientissime proff.!!!
- Già ai suoi tempi, Collodi aveva capito che gli italiani e le italiane non sapevano più di cosa parla una *fiaba* (Vladimir Ja. Propp) e non sapevano più nemmeno raccontarla... E CE LO GRIDAVA IN FACCIA!!!
 Italo Calvino aveva capito la lezione di Collodi e perciò cercò di mettere in salvo le "Fiabe italiane"! Nella *fiaba*, infatti, è nascosta la chiave stessa della nostra dignità di esseri umani, della nostra sovranità, della sovranità di cittadini e di cittadine di una sana e robusta Costituzione (art. 3)!!! (Federico La Sala)
Italo Calvino aveva capito la lezione di Collodi e perciò cercò di mettere in salvo le "Fiabe italiane"! Nella *fiaba*, infatti, è nascosta la chiave stessa della nostra dignità di esseri umani, della nostra sovranità, della sovranità di cittadini e di cittadine di una sana e robusta Costituzione (art. 3)!!! (Federico La Sala)
- DONNE, UOMINI E VIOLENZA. L’importanza della lezione dei "PROMESSI SPOSI", oggi.
“Liberiamo gli studenti dai Promessi sposi”
La noia di leggere Manzoni a quindici anni
I "Promessi sposi" sono testo obbligatorio dal 1870. Ora docenti come Giunta e Gardini, e scrittori come Camilleri, Terranova e Trevi chiedono di cambiare. Per salvare le prossime generazioni di lettori
di Marco Filoni ("pagina 99", 19 maggio 2017)
Facciamo un esperimento. Provate a immaginare una sensazione, un’immagine che vi torna alla mente dei Promessi sposi. D’accordo, a tutti più o meno risuona il famoso incipit Quel ramo del Lago di Como... Ma provate a far emergere dai vostri ricordi qualcosa che più che a mezzogiorno “volge” alle vostre emozioni. -Siate sinceri: pensate a un misto di noia e fastidio? Bene, la cosa non deve preoccuparvi. Fatti salvi gli studiosi, rientrate nella quasi totalità della popolazione italiana che, a scuola, ha letto le pagine dei Promessi sposi. Lo chiamano “effetto-Manzoni” e, secondo molti, sarebbe alla base di una successiva ripulsa verso la letteratura di molti giovani.
C’è però una considerazione che forse è arrivato il momento di fare. Ovvero: quanto questo romanzo ottocentesco (la prima versione è del 1827, la sua edizione definitiva uscì fra il 1840 e il 1842) è davvero costitutivo del carattere nazionale dell’Italia?
La domanda non suoni peregrina. Se la sono posta allo scoccar d’ogni decennio funzionari ministeriali, scrittori e insegnanti dal 1870 in poi - alternando elogi delle pagine manzoniane a severi giudizi sulla loro utilità, proponendo alternative (le Confessioni di un ottuagenario di Ippolito Nievo nel 1922, fra gli altri) e netti rifiuti (come Giosuè Carducci «perché dalla lingua dei Promessi sposi a certa broda di fagioli non c’è traghetto e dall’ammagliamento logico dello stile e discorso manzoniani alle sfilacciature di calza sfatta di cotesti piccoli bracaloni c’è di mezzo un abisso di ridicolo»).
Sul nuovo numero di pagina99, in edicola e in versione digitale, pubblichiamo una lista dei libri che sono le letture obbligatorie in differenti Paesi del mondo (compilata da Daryl Chen e Laura McClure per il sito dei Ted Talks). Perché sapere cosa un Paese fa leggere ai suoi giovani ci dice qualcosa di quel Paese. Prendiamo la Germania, dove si legge Il diario di Anna Frank (scritto in olandese, non in tedesco). Per non dire dei molti Paesi che fanno leggere romanzi scritti negli ultimi decenni: per esempio il Pakistan che propone Il fondamentalista riluttante di Mohsin Hamid (2007).
Verrebbe da chiedersi, con Italo Calvino, cos’è oggi un classico... E nel rispondere a questa domanda ci vorrebbe forse un po’ di coraggio per superare un certo familismo culturale che investe la nostra società: i nostri padri vogliono che studiamo le stesse cose che hanno studiato loro, così come noi vogliamo che i nostri figli studino quello su cui siamo incappati noi stessi. Una sorta di immobilismo che ritroviamo esplicitato nelle così dette riforme della scuola italiana, alla cui crisi si accompagna una mancanza di coraggio (ricordate don Abbondio?) forse insita nel nostro patrimonio culturale...
- Già ai suoi tempi, Collodi aveva capito che gli italiani e le italiane non sapevano più di cosa parla una *fiaba* (Vladimir Ja. Propp) e non sapevano più nemmeno raccontarla... E CE LO GRIDAVA IN FACCIA!!!
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"! Storiografia in crisi d’identità22 maggio 2017, di Federico La Sala
Storiografia in crisi d’identità ...
- "ERODE" E LE GERARCHIE CATTOLICO-ROMANE CONTRO CRISTO E "CONTRO CESARE. Cristianesimo e totalitarismo nell’epoca dei fascismi". Il lavoro di Emilio Gentile, recensito da Riccardo Chiaberge
RENZO DE FELICE E LA STORIA DEL FASCISMO: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"!
 I. BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI - II. ARNALDO MUSSOLINI E MADDALENA SANTORO.
I. BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI - II. ARNALDO MUSSOLINI E MADDALENA SANTORO. -
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- MEDICINA, ILLUMINISMO KANTIANO, E COSTITUZIONE. Vaccini a scuola? Obbligo? Che fare?!22 maggio 2017, di Federico La Sala
MEDICINA, ILLUMINISMO KANTIANO, E COSTITUZIONE DEMOCRATICA: CRITICA DELLA CONOSCENZA E DELLA RAGIONE MEDICA....
- C. F. SAMUEL HAHNEMANN: CRITICA DELLA RAGIONE MEDICA. LINEE-GUIDA PER DIVENTARE MEDICI RESPONSABILI (SENZA VIRGOLETTE). Alcune sue pagine (del 1825) tutte da rimeditare
Obbligo vaccini a scuola, ecco come funziona all’estero *
L’obbligatorietà di alcune vaccinazioni è un strategia diffusa in Europa e non solo. Ma a chiedere il certificato vaccinale per l’ammissione a scuola - come si torna a fare in Italia con il decreto appena varato in Cdm - oggi in Europa c’è solo la Germania e, dall’altra parte dell’oceano, Stati Uniti e Canada. In territorio europeo, da un’indagine comparativa del 2010 sull’attuazione dei programmi vaccinali su 27 Paesi Ue (più Islanda e Norvegia), condotta da Venice (progetto Vaccine European New Integrated Collaboration Effort) e pubblicata sulla rivista Eurosurvellance, risulta che 14 dei 29 Paesi hanno almeno una vaccinazione obbligatoria nel loro programma.
Obbligo vaccini a scuola, come funziona dopo i 6 anni?
I 15 che non ne hanno alcuna obbligatoria sono: Austria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Irlanda, Islanda, Lituania, Lussemburgo, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Regno Unito. Differenze si registrano anche nelle scelte delle vaccinazioni rese d’obbligo. Per l’Italia, fino ad oggi, i vaccini obbligatori erano difterite, tetano, epatite b, polio; in Francia difterite, tetano, polio, tbc; in Grecia difterite, tetano, polio; in Belgio e Olanda obbligatoria solo l’antipolio, anche perché gli ultimi casi europei della malattia si sono verificati proprio nei due Paesi.
Per quanto riguarda l’obbligo della vaccinazione per l’iscrizione a scuola "in realtà - spiega all’Adnkronos Salute Pier Luigi Lopalco, docente di Igiene dell’università di Pisa - non abbiamo evidenze scientifiche. Il dato più recente, in un Paese di cultura occidentale, è quello della California, dove per far fronte al calo della copertura, è stata cancellata la possibilità di appellarsi a motivi religiosi per iscriversi a scuola senza certificato vaccinale".
Questa misura "ha fatto effettivamente risalire i dati di copertura. Personalmente - dice l’esperto - credo che il filtro scolastico, declinato in maniera moderna, possa essere utile, perché consente di intercettare i genitori non vaccinisti, convocarli e avviare un confronto per far comprendere l’importanza di proteggere non solo il proprio figlio ma anche gli altri. Mentre non credo siano utili forme di coercizione".
"E’ invece importante lavorare per cambiare la cultura, anche dei medici - insiste - che spesso non sanno fornire risposte a genitori confusi, e generano ancora più confusione. Ed è necessario adottare misure strutturali, non estemporanee, per garantire la copertura vaccinale necessaria a tutelare la salute dei tutti", conclude Lopalco.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- Intellettuali e potere nell’Italia senza verità. Cassandra muta (Tomaso Montanari).17 maggio 2017, di Federico La Sala
Cassandra muta
Intellettuali e potere nell’Italia senza verità
di Tomaso Montanari *
Quando Cassandra parla, dice la verità: ma è giudicata un intralcio, una sacerdotessa del no. Quando Cassandra tace è perché sta sul carro del potere: e poco cambia che ci sia salita volontariamente, o che sia stata portata in catene. Il risultato è lo stesso: il tradimento degli intellettuali, e cioè il silenzio della critica. Lo vediamo ogni giorno: nel conformismo dei giornali e dell’università, nella trasformazione della cultura in intrattenimento, nello svuotamento della scuola. Qual è il ruolo, quale lo spazio, del pensiero critico nel suo rapporto con il potere, con la comunità della conoscenza, con la comunicazione, con la scuola, con quella che chiamiamo “cultura”? Costruire una società critica, una società del dissenso, è la condizione vitale per il futuro della democrazia. Dire la verità lega alla politica, intesa come arte del costruire la polis, la comunità: ma, al tempo stesso, non si può fare politica attiva dicendo la verità.
 Price: 12,00 €
Price: 12,00 €Tomaso Montanari (Firenze 1971) insegna Storia dell’arte moderna all’Università di Napoli Federico II. Prende parte al discorso pubblico sulla democrazia e sui beni comuni. È presidente di Libertà e Giustizia. Tra i suoi libri: Le pietre e il popolo. Restituire ai cittadini l’arte e la storia delle città italiane (Minimum fax, 2013), Privati del patrimonio (Einaudi, 2015), La libertà di Bernini. La sovranità dell’artista e le regole del potere (Einaudi, 2016).
*
Edizioni GRUPPO ABELE (Scheda editoriale).
SUL TEMA, EL SITO, SI CFR.:
L’ITALIA (1994-2016), TRE PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA SENZA "PAROLA"
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! - QUALE "LIMITE"? “Stiamo cambiando pelle”. Interv. s Remo Bodei (di E. Lepore).15 maggio 2017, di Federico La Sala
- RENZO DE FELICE E LA STORIA DEL FASCISMO: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"!
- LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). Un omaggio a Kurt H. Wolff e a Barrington Moore Jr.
“Stiamo cambiando pelle”. Intervista a Remo Bodei
di Emanuele Lepore *
- Abbiamo incontrato il Professore Remo Bodei in occasione del Festival Filosofia, le cui attività si articolano entro lo spazio delle tre città di Modena, Carpi e Sassuolo.
 Il professore è stato per molto tempo docente di Storia della filosofia ed Estetica alla Scuola Normale Superiore di Pisa, è stato visiting professor in molti atenei internazionali ed attualmente insegna filosofia allo UCLA di Los Angeles. Ha inoltre pubblicato numerosi libri e saggi dei quali gli ultimi due nel 2016. I suoi studi si sono concentrati sull’idealismo tedesco, per poi ampliare gli orizzonti alla filosofia della storia e alla cultura filosofico-letteraria romantica, dalla quale emerge in particolare il binomio antitetico ragione-passioni, tema che ha spesso coinvolto il pensiero filosofico.
Il professore è stato per molto tempo docente di Storia della filosofia ed Estetica alla Scuola Normale Superiore di Pisa, è stato visiting professor in molti atenei internazionali ed attualmente insegna filosofia allo UCLA di Los Angeles. Ha inoltre pubblicato numerosi libri e saggi dei quali gli ultimi due nel 2016. I suoi studi si sono concentrati sull’idealismo tedesco, per poi ampliare gli orizzonti alla filosofia della storia e alla cultura filosofico-letteraria romantica, dalla quale emerge in particolare il binomio antitetico ragione-passioni, tema che ha spesso coinvolto il pensiero filosofico.
 Nel corso dell’intervista che segue, abbiamo cercato di approfondire alcuni dei preziosi spunti contenuti nella lectio magistralis che ha tenuto nell’ultima edizione del Festival.
Nel corso dell’intervista che segue, abbiamo cercato di approfondire alcuni dei preziosi spunti contenuti nella lectio magistralis che ha tenuto nell’ultima edizione del Festival.
Professore Bodei, vorremmo iniziare da una suggestione che arriva dal suo ultimo libro Limite (Mulino, Bologna 2016), in cui riferisce che la filosofia moderna, da Locke fino a Kant, si interroga incessantemente sui limiti dell’intelletto umano, cercando di stabilire quali siano i limiti tra il conoscibile e l’inconoscibile. Secondo lei la filosofia contemporanea attorno a quali limiti si interroga?
I limiti variano col tempo: da Locke a Kant erano quelli dell’intelletto umano, si ricercava fin dove l’uomo potesse conoscere, avendo come base l’esperienza e la scienza. Fin dove la metafisica o la fede potessero estendersi. Oggi i problemi sono diversi e sono costituiti dall’incontro tra le varie culture e civiltà del mondo, in quanto si è rinunciato ad un’idea che valga per tutti, che poteva essere rappresentata dalla stessa forma di conoscenza.
 Un altro limite è segnato dalle biotecnologie: com’è che l’uomo si trasforma? Come si possono scoprire degli aspetti della natura umana che prima non c’erano? È la questione dell’artificialità e del post-umano. Un altro limite è segnato dalla comunicazione e dalle tecnlogie dell’informazione e di come queste possano trasformare persone e culture.
Un altro limite è segnato dalle biotecnologie: com’è che l’uomo si trasforma? Come si possono scoprire degli aspetti della natura umana che prima non c’erano? È la questione dell’artificialità e del post-umano. Un altro limite è segnato dalla comunicazione e dalle tecnlogie dell’informazione e di come queste possano trasformare persone e culture.
 Per certi aspetti si cerca il superamento dei limiti, per altri si cerca invece di stabilire dei confini che sono stati incautamente violati e che bisogna ricostruire: non siamo sicuri di avere una morale saldamente condivisa e per questo si cerca, ad esempio, di evitare che tutto sia permesso: da attraverso la spesso fraintesa espressione della morte di Dio, Nietzsche s’è accorto che non possono più sussistere regole insindacabili perché espresse da Dio: sono gli uomini che devono darsi regole credibili e solide, e di
questo - Nietzsche lo capiva - non siamo stati capaci. Viviamo in una morale provvisoria permanente, che non è di per sé un male ma ci pone in una situazione difficile.
Per certi aspetti si cerca il superamento dei limiti, per altri si cerca invece di stabilire dei confini che sono stati incautamente violati e che bisogna ricostruire: non siamo sicuri di avere una morale saldamente condivisa e per questo si cerca, ad esempio, di evitare che tutto sia permesso: da attraverso la spesso fraintesa espressione della morte di Dio, Nietzsche s’è accorto che non possono più sussistere regole insindacabili perché espresse da Dio: sono gli uomini che devono darsi regole credibili e solide, e di
questo - Nietzsche lo capiva - non siamo stati capaci. Viviamo in una morale provvisoria permanente, che non è di per sé un male ma ci pone in una situazione difficile.Un’altra posizione indubbiamente difficile e complessa è quella da lei evocata durante la sua lectio magistralis di Modena: la lotta contro se stessi pare essere un confronto drammatico per ritagliarsi un proprio spazio nel mondo. Secondo lei tra le sfide che l’uomo contemporaneo deve affrontare c’è anche quella che lo vede in cerca del suo posto nel mondo? Se sì, a che prezzo?
Trovare il proprio posto nel mondo è sempre stata un’impresa che ha riguardato gli uomini sin dall’età della preistoria: semplicemente cambiano questioni e limiti. Orientarsi oggi in un mondo così complesso e cangiante rispetto a quello della tradizione è più difficile o - per meglio dire - diversamente difficile: bisogna muoversi su d’un piano globale interconnesso e, d’altro canto, in un mondo che cambia continuamente e pone un problema di adattamento.
A proposito della complessità del nostro mondo: uno dei suoi tratti generalmente più riconosciuti è la liquidità, la quale - più di ogni altro - sembra dare un’illusione di libertà. In che modo la fluidità delle relazioni sociali e personali può aver compromesso la stabilità del tessuto sociale contemporaneo?
Questa caratteristica di liquidità egregiamente messa in luce da Bauman, per cui dall’inizio degli anni ’80 ad oggi sembra che non vi sia nulla di solido è una proposizione enunciata da Marx e Engels nel Manifesto del Partito Comunista: tutto ciò che è solido si squaglia. In questa situazione, con le difficoltà del terrorismo e della crisi finanziaria, stiamo scoprendo che il mondo è molto più duro e molto meno liquido di quanto pensavamo. Anzitutto abbiamo la necessità di trovare i limiti, di riconoscerli e comprendere come far fronte alla nuova rigidità della nostra esistenza.
In questo contesto sociale e politico così complesso, che ruolo crede abbiano le passioni umane, calate in un’epoca dominata da una tecnica che, sempre più a fondo, modifica i contesti e i soggetti che vi abitano?
Le passioni hanno sempre costituito un valore per il vivere comune: bisogna tuttavia distinguere tra le varie forme di passione. Noi viviamo in un’epoca in cui le passioni sono state sostituite dai desideri: questi non sono altro che passioni declinate al futuro, quindi passioni che non sono legate a qualcosa che, tradizionalmente, ha dei limiti. Abbiamo delle passioni che, in quanto proiettate verso il futuro, sono elastiche e procedono avanti. C’è poi una dimensione legata alle passioni private come l’amore (messe in risalto dalla modernità e dal Romanticismo) a cui fa da contraltare un declino della dimensione pubblica: in parte ci si richiude in se stessi davanti alla durezza dell’esistenza, in parte c’è una crisi delle passioni democratiche legate agli ideali di uguaglianza tra gli individui.
Secondo lei l’assenza di una bussola per l’agire comune piò dipendere dalla perdita di senso della nozione di bene comune? Se sì, crede che sia oggi possibile ricostruire tale nozione?
La nozione di bene comune è sempre stata da un lato un’aspirazione ideale e dall’altro una sorta di ingannevole prospettiva con cui si sono mascherate tutte le forme di soppressione: i totalitarismi del ‘900 hanno predicato un bene comune che, in realtà, si è rivelato un bene per certi tipi di classi, di individui. L’esistenza di un orizzonte che superi l’individuo segna il problema di trovare la strada per cui esso diventi effettivo e non diventi una maschera che serve a legittimare dei comportamenti che perseguono beni non comuni ma parziali.
Questo è un problema che sembra ripercuotersi anche nella dimensione individuale; nel suo libro Immaginare altre vite: realtà, progetti, desideri (Feltrinelli, Milano 2013) ricostruisce il ruolo fondamnetale che ideali e modelli hanno giocato nelle dinamiche di costruzione di sé. Secondo lei a quali ideali, modelli si può ricorrere? Ve ne sono?
In generale questi modelli sono cambiati abbastanza recentemente perché in precedenza il nostro mondo (limitato, occidentale, europeo) questi ideali erano legati alla realizzazione di se stessi, alla possibilità di avere una soddisfazione in un mondo che, per certi versi, ha rinunciato all’al di là e richiede dunque che si possa trovare godimento nell’arco dell’esistenza fisica degli individui.
 Dopo il fallimento di certi regimi completamente laici, i quali ritenevano che l’uomo potesse, nell’arco dell’esistenza storica, trovare il proprio compimento, questi modelli si sono indeboliti ed è tronato il bisogno di trascendente e anche delle religioni: talvolta è tornato in forme piuttosto violente, come nel caso degli islamisti. Stiamo cambiando pelle: c’è un tentativo di ritrovare una soddisfazione che non è solo di questo mondo, non solo secondo una matrice religiosa ma anche estetica, secondo la maniera di Foucault per cui si fa di se stessi un’opera d’arte e si ha un’estetica dell’etica, si diventa come statue, si cerca di far vivere la bellezza nell’etica.
Dopo il fallimento di certi regimi completamente laici, i quali ritenevano che l’uomo potesse, nell’arco dell’esistenza storica, trovare il proprio compimento, questi modelli si sono indeboliti ed è tronato il bisogno di trascendente e anche delle religioni: talvolta è tornato in forme piuttosto violente, come nel caso degli islamisti. Stiamo cambiando pelle: c’è un tentativo di ritrovare una soddisfazione che non è solo di questo mondo, non solo secondo una matrice religiosa ma anche estetica, secondo la maniera di Foucault per cui si fa di se stessi un’opera d’arte e si ha un’estetica dell’etica, si diventa come statue, si cerca di far vivere la bellezza nell’etica.Lei da anni conduce parallelamente un’opera di ricerca filosofica e un’azione di divulgazione molto importante. Crede che il rinnovato e generalizzato interesse per le questioni della filosofia sia connesso con i bisogni del senso comune a cui si riferiva prima?
Penso che nell’esistenza delle persone, da quando ciascuno di noi è un bambino, ci si pone delle domande sul perché si esiste. Sono domande alle quali, a un certo punto, ci si rifiuta di rispondere: talvolta le domande diventano tarli fastidiosi. In forza di ciò ci si costruisce una visione del mondo fatta in casa, non suffragata da riflessioni profonde e perciò in genere non viene poi sviluppata dalla scuola, dalgi studi che guardano ad un sapere tecnico-professionale. Il bisogno di filosifa è una fame di senso che procura una sorta di esame di riparazione in età adulta di messa a fuoco di cose che non si sono osservate lungo la propria esistenza.
Quanto ha appena detto si sposa con la missione ideale de La Chiave di Sophia, che si propone di stimolare la comprensione di quanto la filosofia sia presente nella vita dell’umano, nella sua quotidianità, contrariamente a chi ritiene che essa sia - e, in certa misura, - debba rimanere una disciplina di nicchia, ristretta quanto a temi e pubblico cui si rivolge.
Fare filosofia significa cercare di capire il tessuto connettivo e orizzonte di senso entro cui noi ci situiamo, che non è appunto qualcosa di specifico. Rispetto alla frantumazione dei saperi e delle pratiche la filosofia è un tentativo continuamente rinnovato di trovare un orizzonte entro cui muoverci e situarci, perché essa non è un sapere specialistico. Si potrebbe dire che la filosofia è uno specialismo dell’universale: la filosofia ci riguarda tutti ma è molto difficile orientarsi filosoficamente perché si rischia di creare delle generalizzazioni astratte. Per questo si innesta in un sapere che riguarda un’acquisizione: per esempio, 2500 anni in cui nel nostro occidente si è pensato. Noi siamo debitori nei confronti di queste forme di ricerca che rappresentano una sorta di palestra mentale. Essa serve a tutti: senza di essa saremmo come automi. Essa è una forma di vivere in maniera consapevole. Se facessimo un esperimento mentale in cui la filosofia non avesse fecondato la nostra cultura, noi ci ritroveremmo certamente più creduloni, più stupidi e manipolabili e quindi meno liberi. È un valore per la democrazia, in quanto ci permette di vivere più consapevolmente e in maniera meno dogmatica.
*
Emanuele Lepore
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- Il rovescio della libertà. Tramonto del neoliberalismo e disagio della civiltà (M. De Carolis).2 maggio 2017, di Federico La Sala
Massimo De Carolis, la libertà e il suo doppio
di Paolo Godani *
- Massimo De Carolis
 Il rovescio della libertà. Tramonto del neoliberalismo e disagio della civiltà
Il rovescio della libertà. Tramonto del neoliberalismo e disagio della civiltà
 Quodlibet, 2017, 304 pp., € 22
Quodlibet, 2017, 304 pp., € 22
Nelle ultime pagine delle Origini del totalitarismo, riflettendo sulle condizioni che possono predisporre l’avvento di un regime totalitario, Hannah Arendt individua in particolare quella che chiama loneliness (termine che viene distinto sia da isolation sia da solitude). La desolazione, cioè la situazione in cui un singolo si sente “abbandonato [deserted] da ogni umana compagnia”, è ciò che, se inizia a presentarsi come un sentimento ordinario e diffuso in una società ancora non totalitaria, “prepara gli uomini alla dominazione totalitaria”. Non si tratta semplicemente della solitudine anonima di cui si può fare esperienza per esempio negli spazi, al contempo sempre affollati e sempre deserti, dei centri commerciali o delle tangenziali congestionate dal traffico, bensì della sensazione per cui ogni condivisione, ogni comunanza sembra divenuta per principio impossibile.
Non c’è da stupirsi che un sentimento del genere sia ancora ben presente nelle nostre società contemporanee, se è vero che può essere considerato come il risultato di una serie di dispositivi che, negli ultimi trent’anni almeno, hanno promosso la distruzione sistematica non solo di ogni organizzazione sociale e politica, ma quasi della stessa possibilità di pensarsi in comune. La logica e la strategia di questi dispositivi di individualizzazione è evidente: dissolvere aggregazioni collettive potenzialmente capaci di mettere in discussione l’ordine stabilito, ed evitare che si ricostituiscano. Meno evidente è come tali dispositivi funzionino e, soprattutto, da dove traggano la loro efficacia.
Prendendo sul serio il pensiero neoliberale, evitando cioè di derubricarlo a mera ideologia della classe dominante e considerandolo invece come un vero e proprio progetto di società nato per contrastare la sconfitta del liberalismo classico di fronte al totalitarismo novecentesco, Massimo De Carolis (in un libro della cui ricchezza e profondità di analisi non potremo qui dare interamente conto) mostra con precisione come e perché il neoliberalismo veda nell’atomizzazione sociale un presupposto necessario allo sviluppo di una società libera.
Il principio di fondo del neoliberalismo è che nessuna autorità di sorta possa pretendere di dar luogo al “governo razionale” di una società complessa e pluralista, se non a scapito della molteplicità delle opportunità e delle scelte che costituiscono la potenza di quella stessa società. In questo senso, la decisione politica neoliberale consiste nel negare la legittimità di ogni decisione politica, per lasciare campo libero all’interazione sociale nella sua perfetta autonomia. Quest’ultima, però, ha luogo solo dal momento in cui si mettono in azione tutta una serie di meccanismi capaci di neutralizzare ogni possibile stratificazione che si sovrapponga alla mera interazione tra individui. Ogni singolo deve poter agire esclusivamente in vista dei propri desideri e degli interessi che suppone siano i suoi, senza che alcuna sovrastruttura di sorta venga a impedire o a complicare la possibilità della sua azione. L’ordine sociale migliore - ed è questo il filo di continuità con il liberalismo classico - sarà quello in cui il governo si limiti a garantire questa prassi, eliminando ogni possibile intralcio al suo dispiegarsi.
Questa concezione si fonda su un presupposto antropologico implicito, secondo il quale la vita umana libera, cioè non sottomessa ad alcun potere di coercizione, può implicare un solo genere di relazione tra individui: “il do ut desformalizzato dal mercato”. Oltre questa relazione “mercantile” non ci sarebbe altro che dominio e sottomissione. Conseguentemente a questo presupposto, la governance neoliberale si dà come funzione propria non certo quella di governare o dirigere il mondo degli scambi, quanto piuttosto quella di mettere in atto tutti i dispositivi necessari affinché l’unica relazione sussistente tra gli individui resti quella fondata sul do ut des.
De Carolis spiega con grande chiarezza come sia proprio da qui che discende quel “governo della vita” già individuato da Foucault come cardine della biopolitica neoliberale. La governance mira a dissolvere tutti gli elementi che possono ostacolare il libero dispiegarsi del processo sociale, ma per far questo deve intervenire sulle convenzioni tacite, sulle abitudini sociali, sui modi di vita, sui legami affettivi e sulle modalità di relazione e comunicazione, deve cioè “fare molto di più che limitarsi a ritoccare le singole norme: [deve] prendere come bersaglio la normalità in sé stessa”. Questo tipo di intervento, diversamente da quello sovrano, non si manifesta esemplarmente nei momenti d’eccezione ma, proprio in quanto prende di mira lo stesso costruirsi della normalità sociale nella continuità e nella contingenza del suo divenire, ha necessariamente la forma di un’eccezione che diviene regola. In questo senso, come Il rovescio della libertà sottolinea in maniera molto convincente, il neoliberalismo si distingue dal modello liberale classico per la sua convinzione che l’ordine spontaneo del mercato possa fondarsi su “regole che sono interamente il risultato di una progettazione deliberata”.
I dispositivi di individualizzazione, dunque, funzionano secondo il criterio della riduzione delle relazioni sociali all’unica forma libera di relazione, ricalcata sul modello dello scambio. Ma da dove derivano la loro efficacia? E perché, di conseguenza, il progetto neoliberale è riuscito, in pochi decenni, a imporsi in maniera così assoluta e pervasiva, sino a presentarsi come l’unico modello possibile di convivenza civile? La risposta di De Carolis, a questo proposito, è tanto realistica quanto dubbia: il successo del neoliberalismo, spiega, “è dipeso dalla capacità di intercettare un genere di desiderio, che i processi di dinamizzazione stavano rendendo sempre più profondo e più diffuso: il desiderio di vedere riconosciute e realizzate le proprie potenzialità, esponendo i propri sogni alla prova dei fatti, perché, in un mondo dominato dalla contingenza, è questo l’unico modo di assodarne l’autentico valore”. Al di là delle possibili obiezioni “antropologiche”, il problema - come del resto lo stesso De Carolis non esita a riconoscere - è che i dispositivi di potere del neoliberalismo contemporaneo producono in realtà un contesto sociale a cui “ci si può solo adattare, per non essere esclusi del tutto da una vita sociale la cui dinamicità apparente diventa il velo sottile di una riproduzione sempre più rigida e sempre meno generosa”.
È indubbio, certo, che nel corso degli anni Sessanta e Settanta le società europee e americane manifestassero desideri di liberazione dalle antiche forme del dominio sociale e della sovranità politica e nazionale, ed è possibile sostenere che il neoliberalismo abbia sfruttato queste istanze per altri fini. Ma mi pare altrettanto certo che le ragioni di fondo dell’imporsi del neoliberalismo si trovino piuttosto nel tentativo di impedire che “l’avanzata di una controcultura dai toni minacciosamente rivoluzionari” mettesse in questione non tanto l’ordine “cosmico” quanto, più prosaicamente, l’ordine economico e sociale costituito.
Che il progetto neoliberale sia riuscito vittorioso è evidente, come anche il fatto che “il tramonto del neoliberalismo sia il vero evento cruciale di questa epoca ”. Il dubbio legittimo è che questo tramonto, decretato dal ritorno di aggregazioni neofeudali radicate solo nella paura e nel risentimento, cioè sugli ultimi sentimenti che restano in un contesto di desolazione, sia solo l’altra faccia che lo stesso ordine costituito presenta quando deve affrontare le proprie crisi ricorrenti. E che un’“alleanza politica [...] autenticamente rivolta alla costruzione di un progetto di vita condiviso” non possa darsi riconoscendo come irrinunciabile il fondamento individualista della “nuova idea di civiltà” neoliberale, ma solo a condizione di saltare fuori dall’orizzonte prodotto dai suoi dispositivi.
* Alfabeta2, 2 maggio 2017 (ripresa parziale).
- Una Risposta a Massimo De Carolis, la libertà e il suo doppio
LA DIALETTICA DELLA LIBERAZIONE (1968),IL SENSO DELLA POSSIBILITA’” (1988), E ... L’USCITA DALLO STATO DI MINORITA’ (2018)! *
SE è VERO CHE “nel corso degli anni Sessanta e Settanta le società europee e americane manifestassero desideri di liberazione dalle antiche forme del dominio sociale e della sovranità politica e nazionale, ... CHE “l’avanzata di una controcultura dai toni minacciosamente rivoluzionari” mettesse in questione non tanto l’ordine “cosmico” quanto, più prosaicamente, l’ordine economico e sociale costituito”;
CHE “il progetto neoliberale sia riuscito vittorioso è evidente, come anche il fatto che “il tramonto del neoliberalismo sia il vero evento cruciale di questa epoca ”,
E SE è, ALTRETTANTO, VERO CHE “un’“alleanza politica [...] autenticamente rivolta alla costruzione di un progetto di vita condiviso” non possa darsi riconoscendo come irrinunciabile il fondamento individualista della “nuova idea di civiltà” neoliberale, ma solo a condizione di saltare fuori dall’orizzonte prodotto dai suoi dispositivi”,
NON SI PUO’ NON RIPRENDERE IL FILO DELLA RIFLESSIONE E DELLA RI-ORGANIZZAZIONE, DALLE INDICAZIONI E DALL’ORIZZONTE DELLA DISCUSSIONE DELLA “DIALETTICA DELLA LIBERAZIONE” (cOOPER, CARMICHAEL, SWEEZY, LAING, MARCUSE, GERASSI, BATESON E altri, EINAUDI 1969) E DA “IL SENSO DELLA POSSIBILITA’” (ATTILIO MANGANO, Antonio Pellicani Editore, Roma 1988).
SU QUANTO E COME sia necessario SALTARE FUORI dall’ORIZZONTE TEORETICO E STORIOGRAFICO dato, mi sia lecito, si cfr. le note su:
RENZO DE FELICE E LA STORIA DEL FASCISMO: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA “CAPO”! (http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=5889);
HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI (http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=4790).
- Massimo De Carolis
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- Il giornalismo secondo Gramsci: 1500 articoli "contro", rivendicati fino al tribunale fascista.14 aprile 2017, di Federico La Sala
Il giornalismo secondo Gramsci: 1500 articoli "contro", rivendicati fino al tribunale fascista
Raccolti in un volume appena pubblicato con la prefazione di Canfora e la postfazione di Frasca Polara. Un vero e proprio manuale della professione e le battaglie su molte testate. Fino all’Unità, della quale racconta la genesi del nome.
di GIOVANNI CEDRONE (la Repubblica, 06 aprile 2017)
Il giornalismo secondo Gramsci: 1500 articoli "contro", rivendicati fino al tribunale fascista
 "Io non sono mai stato un giornalista professionista, che vende la sua penna a chi gliela paga meglio e deve continuamente mentire, perché la menzogna entra nella qualifica professionale". Queste parole, contenute in una lettera a sua cognata Tatiana Schucht dell’ottobre 1931, forse meglio di altre testimoniamo l’indomito spirito con cui Antonio Gramsci si è dedicato al giornalismo. Le parole sono contenute nell’ultimo volume dedicato al fondatore del Partito comunista "Il Giornalismo, Il Giornalista. Scritti, articoli, lettere del fondatore dell’Unità" a cura di Gian Luca Corradi (edito da Tessere).
"Io non sono mai stato un giornalista professionista, che vende la sua penna a chi gliela paga meglio e deve continuamente mentire, perché la menzogna entra nella qualifica professionale". Queste parole, contenute in una lettera a sua cognata Tatiana Schucht dell’ottobre 1931, forse meglio di altre testimoniamo l’indomito spirito con cui Antonio Gramsci si è dedicato al giornalismo. Le parole sono contenute nell’ultimo volume dedicato al fondatore del Partito comunista "Il Giornalismo, Il Giornalista. Scritti, articoli, lettere del fondatore dell’Unità" a cura di Gian Luca Corradi (edito da Tessere).A 80 anni dalla sua morte, avvenuta il 27 aprile 1937, Corradi ha raccolto alcuni fra gli oltre 1.500 articoli che Gramsci pubblicò su varie testate (prima di essere recluso nel 1927) e alcune lettere, antecedenti e successive alla carcerazione, nelle quali tocca l’argomento della stampa periodica. L’ideatore del concetto di egemonia si conferma un pensatore aperto e non dogmatico e le sue intuizioni sul giornalismo stupiscono per l’attualità e la lungimiranza. Come sottolinea Giorgio Frasca Polara nella postfazione, "Gramsci avrebbe potuto insegnare, e bene, quel giornalismo serio, informato di cose serie, che oggi sta diventando una rarità non solo in Italia".
Non bisogna dimenticare che il contributo di Gramsci al giornalismo italiano è stato enorme: oltre ad aver fondato "L’Ordine Nuovo" e "L’Unità", Gramsci scrisse per almeno una decina di giornali, tra cui "La Città futura", numero unico della Federazione giovanile socialista piemontese e "Energie nove", quindicinale diretto da Piero Gobetti. Luciano Canfora ricorda nell’introduzione le parole contenute nel verbale d’interrogatorio di Antonio Gramsci nel carcere giudiziario di Milano, datato 9 febbraio 1927, con cui lo stesso pensatore comunista dichiara di essere "pubblicista" prima ancora che "ex deputato al Parlamento". Sui "Quaderni" il fondatore dell’Unità traccia quasi un manuale del buon giornalista: parla di giornalismo "integrale", cioè quello che non solo intende soddisfare tutti i bisogni del suo pubblico, ma intende creare e sviluppare questi bisogni, rimarca poi la necessità per i giornalisti di "seguire e controllare tutti i movimenti e i centri intellettuali che esistono e si formano nel paese".
Un sano realismo lo porta a considerare i lettori da due punti di vista, sia come elementi "ideologici, trasformabili filosoficamente", sia come elementi "economici, capaci di acquistare le pubblicazioni e di farle acquistare ad altri". Sottolinea come il contenuto ideologico di un giornale non sia sufficiente a garantire le vendite: conta anche la forma in cui viene presentato. Interviene su quella che chiama "l’arte dei titoli" in cui influisce l’atteggiamento del giornale verso il suo pubblico che può essere "demagogico-commerciale" o "educativo-didattico".
Le riflessioni teoriche di Gramsci si riflettono nella sua attività di pubblicista. Il fondatore del Pci non si occupava solo di politica, ma anche di costume, società, teatro, musica e storia. In una pagina del marzo 1916 di "Sotto la Mole", Gramsci contesta, ad esempio, l’assunto che la malavita organizzata sia solo al sud, un discorso che a 100 anni di distanza risuona quanto mai attuale.
Nel maggio 1916 difende il maestro Toscanini per aver scelto una sinfonia di Wagner in un concerto al Teatro Regio di Torino, scelta che, con l’Italia entrata in guerra contro gli Imperi centrali, aveva provocato i fischi del pubblico. Scrive di teatro e in particolare la sua attenzione cade su Pirandello che per lui aveva il merito di creare "delle immagini di vita che escono fuori dagli schemi soliti della tradizione".
Ragiona poi sul "carattere" degli italiani improntato, secondo lui, all’ipocrisia in tutte le forme della vita: nella vita familiare, nella vita politica, negli affari. "La sfiducia reciproca, il sottinteso sleale - sottolinea Gramsci - corrodono nel nostro paese tutte le forme di rapporti: i rapporti tra singolo e singolo, i rapporti tra singolo e collettività. L’ipocrisia del carattere italiano è in dipendenza assoluta con la mancanza di libertà".
Da un punto di vista storico, le pagine più interessanti sono nelle lettere, soprattutto quelle dal carcere, con il racconto della sua detenzione e le riflessioni sul giornalismo che occupano una parte importante della sua corrispondenza. In una missiva al Comitato esecutivo del Pcd’I del settembre 1923 svela perché fu scelto il nome "l’Unità" per il giornale da lui fondato. Aveva un duplice significato: innanzitutto richiamava all’unità tra operai e contadini, non soltanto nell’ambito del rapporto tra le classi, ma anche nel più generale tema della questione nazionale, "unità" tra nord e sud, tra città e campagna.
Nella lettera a Vincenzo Bianco del marzo 1924 emerge il Gramsci "maestro di giornalismo", una pagina che forse qualsiasi giornalista alle prime armi dovrebbe sempre tenere a portata di mano. Prima di iniziare a scrivere - afferma Gramsci - bisogna predisporre uno schema e domandarsi cosa sia veramente importante. Consiglia poi di leggere "Il Manifesto dei Comunisti" che definisce "un capolavoro di chiarezza, di semplicità e di dialettica". Infine invita alla brevità ricordando l’esempio di Andrea Viglongo, suo collaboratore, che allenava a scrivere articoli di al massimo una colonna e mezzo.
La raccolta di scritti ha il grande merito di tracciare con chiarezza un aspetto del profilo di Gramsci forse meno noto, quello del Gramsci giornalista. Un aspetto che conferma, come giustamente sottolinea Canfora, quanto Gramsci sia davvero appartenuto alla cultura italiana di quegli anni molto più che ad una cultura di partito. Pensatore mai banale, marxista irregolare, oggi icona pop e studiato nelle università di mezzo mondo, Gramsci fu anche "maestro di giornalismo" i cui insegnamenti, a distanza di 80 anni, restano più che mai validi.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- STORIOGRAFIA IN CRISI DI IDENTITÀ: RENZO DE FELICE E LA STORIA DEL FASCISMO.3 aprile 2017, di Federico La Sala
 Storiografia in crisi d’identità ...
Storiografia in crisi d’identità ...
 RENZO DE FELICE E LA STORIA DEL FASCISMO: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"!
RENZO DE FELICE E LA STORIA DEL FASCISMO: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"!
 I. BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI - II. ARNALDO MUSSOLINI E MADDALENA SANTORO.
I. BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI - II. ARNALDO MUSSOLINI E MADDALENA SANTORO.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- MATEMATICA E REALTÀ. "Realismo Metafisica Modernità". Note a margine.20 febbraio 2017, di Federico La Sala
MATEMATICA E REALTÀ. "Realismo Metafisica Modernità". *
FILOSOFIA, MATEMATICA E REALTA’: IMPARARE A CONTARE!!! Una nota in memoria di PRIMO MORONI ...
PLAUDENDO AL VOSTRO "SPECIALE MATEMATICA E REALTÀ", in ottima corrispondenza con l’incontro filosofico del 22 pv (“Realismo Metafisica Modernità”, Aula Biblioteca Guglielmo Marconi - Piazzale Aldo Moro 7, Roma),
PREMESSO CHE il “LOGOS” non è un “NUMERO” (cfr. CONTARE E PENSARE... http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=4963) e, convinto che occorra legare insieme FILOSOFIA E ANTROPOLOGIA (cfr. ATENE/EUROPA ... https://www.alfabeta2.it/2017/02/16/ateneeuropa-volare-sullabisso/#comment-625400),
COME CONTRIBUTO al lavoro della Redazione di ALFABETA2 e del SUO CANTIERE, ripropongo qui UNA DOMANDA AI MATEMATICI: COME MAI “UN UOMO PIU’ UNA DONNA HA PRODOTTO, PER SECOLI, UN UOMO”?! Non è il caso di ripensare i fondamenti?! (http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=3995)
 e un mio breve lavoro
e un mio breve lavoroin memoria di PRIMO MORONI:
CHI SIAMO NOI, IN REALTÀ?! RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE (http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=4198).
BUON-LAVORO!!!
Federico La Sala (18.02.2017)
2)
MATEMATICA, REALTÀ, E CREATIVITÀ. Un omaggio ad “Alfabeta - 1”, “Alfabeta - 2“, e un contributo ai lavori del Cantiere ...
Realismo e Metafisica. A voler rendere meno sintetico ed ellittico il discorso, e a raccordare l’ieri con l’oggi, “ALFABETA 1” con “ALFABETA 2” e il CANTIERE, mi sia consentito richiamare, due miei interventi: il primo sugli atti di un convegno eccezionale sugli “stati generali” del realismo scientifico e filosofico - LIVELLI DI REALTÀ (“Alfabeta”, 66, 1984) e, insieme, il secondo sul “grande scontro” tra razionalismo fondazionalistico e razionalità antifondazionalistica - FILOSOFI CATTOLICI IN POLEMICA (“Alfabeta”, 108, 1988), intorno al lavoro del filosofo cattolico Dario Antiseri, vicino al “pensiero debole” ieri e vicino a studiosi e ricercatori (cfr. il suo contributo “L’universo incerto della ragione umana”, nel volume collettaneo “I modi della razionalità”, Mimesis Edizioni, 2016, pp. 29-45) di questi anni recenti, sino ad oggi.
REALISMO E MODERNITÀ. RIPRENDENDO A “CONTARE”, e portando alla luce del sole (dalla caverna o, se si vuole, da “interi millenni” di labirinto) il legame profondo tra filosofia, matematica, e antropologia, si arriva a comprendere di nuovo e meglio che della razionalità, come dell’essere, si può parlare “in molti modi” - non in un solo modo (quello mono-logico ed ego-latrico, con le sue platonizzanti pretese: “Io, Platone, sono la Verità”). E, altrettanto, come sia possibile riportare - FILOSOFICAMENTE E ANTROPOLOGICAMENTE - la vita e la ricerca sulla strada aperta da ARISTOTELE (al di là di ogni tomistica e neotomistica illusione: http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=3617#forum3121791) e illuminata da KANT (oltre ogni scetticismo e ogni idealismo-materialismo: http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=4829), definitivamente, fuori dall’orizzonte della creatività “andropologica” dell’ “uomo supremo”, del “superuomo” e della sua società a “una” dimensione.
 N.B. - L’uscita dallo “stato di minorità” è all’ordine del giorno già dal 1784...
N.B. - L’uscita dallo “stato di minorità” è all’ordine del giorno già dal 1784...BUON-LAVORO!!!
Federico La Sala (19.02.2017)
* DUE NOTE A MARGINE DELLO "SPECIALE MATEMATICA E REALTÀ" DI ALFABETA2.
-
> MATEMATICA E REALTÀ. --- Politica della post verità o potere sovralegale? (di Ugo Morelli)22 febbraio 2017, di Federico La Sala
Politica della post verità o potere sovralegale?
di Ugo Morelli *
Gli orientamenti politici e gli esiti delle decisioni collettive sfidano oggi le tradizionali categorie della psicologia del potere. L’opinione pubblica alla base delle scelte si forma per vie che sfuggono alle forme conosciute e le campagne elettorali sono costruite al di fuori del mondo dei fatti. Non solo, ma chi sceglie in un certo modo, concorrendo a esiti determinanti anche per il proprio presente e il proprio futuro, sembra cambiare idea un momento dopo, a fatti compiuti e, almeno per un certo tempo, irreversibili.
Viene sempre più spesso in mente Winston Churchill e la sua affermazione sulla difesa della democrazia «purché non voti mia suocera». Una provocazione alla sua maniera che comunque induce a interrogarsi sul presente della democrazia e delle forme di esercizio del potere. A fare affermazioni senza prove e senza logica; smentendole immediatamente dopo o cambiando versione continuamente, si ottiene seguito e consenso e viene da chiedersi come sia possibile.
Se consideriamo l’elezione di Donald Trump a Presidente degli Stati Uniti d’America, la domanda da porsi è come abbia fatto una minoranza di americani a portarlo al potere. L’interrogazione è, perciò, su un deficit di democrazia e sulla perdita di democrazia partecipativa, come sostiene Judith Butler.
«Ci avviciniamo all’ipotesi che ci pare di poter sostenere: non siamo di fronte a un’epoca di post-verità, bensì all’affermazione di forme di potere sovralegale», come le aveva definite Carl Schmitt.
L’uso del sistema democratico per prendere il potere e appropriarsene da parte di chi democratico non è, né nello stile né nella sostanza, mentre è comunque in grado di ottenere il consenso soprattutto di chi è in tutt’altra condizione, consente un accentramento del potere che non sarebbe concepibile in situazioni di una almeno relativa democrazia partecipativa. È necessario considerare la dematerializzazione e la virtualizzazione dell’esperienza per cercare di comprendere alcune delle vie di creazione del consenso e di affermazione del potere oggi. Si tratta, ad esempio, di riprendere quello che Jean Baudrillard scriveva parecchi anni fa:
- «L’astrazione oggi non è più quella della mappa, del doppio, dello specchio o del concetto. La simulazione non è più quella di un territorio, di un essere referenziale o una sostanza. È piuttosto la generazione di modelli di un reale senza origine o realtà: un iperreale. Il territorio non precede più la mappa, né vi sopravvive. [...] È la mappa che precede il territorio - precessione dei simulacri - è la mappa che genera il territorio [...]. L’età della simulazione comincia con l’eliminazione di tutti i referenti - peggio: con la loro resurrezione artificiale in un sistema di segni, che sono una materia più duttile dei significati perché si prestano a qualsiasi sistema di equivalenza, a ogni opposizione binaria, e a qualsiasi algebra combinatoria. Non è più una questione di imitazione, né di duplicazione o di parodia. È piuttosto una questione di sostituzione del reale con segni del reale; cioè un’operazione di cancellazione di ogni processo reale attraverso il suo doppio operazionale. [...] sarà un iperreale, al riparo da ogni distinzione tra reale e immaginario, che lascia spazio solo per la ricorrenza di modelli e per la generazione simulata di differenze.» (Simulacres et simulation)
I fatti non contano e la loro rappresentazione narrata predomina e vince. Come sostiene Judith Butler in un’intervista a Christian Salmon, apparsa il 24 dicembre 2016 su Robinson, parlando delle elezioni di Donald Trump e dei contenuti delle sue affermazioni:
- «Al momento i fatti sembrano indicare che non è così. Ma lui non vive in un mondo di fatti. (.....) Ha poca importanza se si contraddice o se si capisce che rigetta esclusivamente le conclusioni che intaccano il suo potere o la sua popolarità. Questo narcisismo sfrontato e ferito e questo rifiuto di sottomettersi ai fatti e alla logica lo rendono ancora più popolare. Lui vive al di sopra della legge, ed è così che molti dei suoi sostenitori vorrebbero vivere».
Da tempo ci siamo resi conto di vivere in un’epoca in cui non disponiamo più di verità indiscutibili e la nostra condizione, come ampiamente segnalato da un profondo filosofo come Aldo Giorgio Gargani, è quella di chi è passato dalla verità al senso della verità. Secondo Giorgio Agamben: «La civiltà che noi conosciamo si fonda innanzitutto su una interpretazione dell’atto di parola, sullo ‘sviluppo’ di possibilità conoscitive che si considerano contenute e ‘implicate’ nella lingua» (Che cos’è la filosofia?, Quodlibet 2016). L’uso della lingua e soprattutto i suoi effetti non sono determinabili a priori. Vi è una dimensione performativa che piega i significati a seconda delle contingenze.
Accade per esempio oggi che la parola sicurezza sia usata efficacemente per ridurre e decimare i diritti democratici di libertà e, per molti aspetti, la democrazia stessa. E non accade senza consenso. Chi predica la sicurezza dà voce ad aspettative che sono poi alla base di ampi consensi. Sulla consapevolezza delle conseguenze di quel consenso si potrà discutere, ma intanto si produce una legittimazione di un sistema di potere. Sarà pure una minoranza della popolazione americana ad aver portato Trump al potere; rimane il fatto che c’è riuscita affermando le proprie aspettative profondamente antidemocratiche di vivere e agire al di sopra della legge.
Appare evidente che entrano in campo emozioni arcaiche e primordiali sollecitate e amplificate da mezzi virtuali contemporanei che non governiamo, ma ci dominano. Nel momento in cui, in modo confuso e contraddittorio, un leader libera l’odio, invita a usare la cosiddetta pancia per scegliere, legittima la possibilità di esprimere la collera senza limitazioni, rende dichiarabile e proponibile il razzismo, ognuno può sentirsi libero di tirar fuori le viscere. L’arcaismo emozionale e la pratica del voto con lo stile immediato e pratico del “mi piace”/ “non mi piace” di Facebook, producono una miscela sostenuta dalle vie mediatiche, in grado di mettere in discussione le forme della democrazia così come la conosciamo.
I processi di identificazione immediati generano dinamiche di “altercasting” e nel momento in cui le persone si riconoscono in un modo di essere e di fare volendo essere come il leader, non ci sono più disposizioni a verificare la verità delle affermazioni o la fattibilità delle proposte, ma solo adesione massiva e conformista, come abbiamo mostrato nella voce Conformismo.
Ma perché le persone aderiscono? Probabilmente ciò accade per emulazione e per paura. Un leader può guadagnarsi l’ammirazione per aver trovato il modo di non pagare le tasse o per il fatto di riuscire ad avere tante donne a disposizione, molestie sessuali incluse. Il leader va dove vuole, fa quello che vuole e prende quello che vuole. Chi vota vorrebbe essere come lui. Ciò però non basta. L’emulazione riguarda anche la corporeità, la gestualità, la teatralità delle espressioni e la corrispondenza a un modello mediatico stereotipato. Come ha mostrato Marco Belpoliti ne Il corpo del capo , il corpo si afferma come metafora e come forma di esercizio del potere, in particolare nelle modalità totalitarie. La forza attrattiva dei gesti e la loro capacità di coinvolgimento, soprattutto nelle performance comunicative, mostra di essere una componente non secondaria del potere sovralegale.
Accanto a questi fattori e impastandoli di un clima particolare, agisce la paura. Sia la paura suscitata ad hoc enfatizzando fenomeni del tempo come l’immigrazione, il pericolo derivante dagli emarginati o da forme di rivolta, le donne, i disoccupati, i diversi di ogni tipo; sia la paura indotta dai rischi del presente e dalla cosiddetta società del rischio.
Il rapporto tra il potere che non si basa sulla legittimazione, sulla dimostrazione dialogica dei fatti e sulla critica reciproca, ma si situa al di sopra della legge; il rapporto tra quel potere e la paura è stato molto ben descritto da Herta Müller, premio Nobel per la letteratura, a proposito delle continue visite che riceveva a casa dai servizi segreti:
 «Mia madre chiese: che cosa vogliono da te?
«Mia madre chiese: che cosa vogliono da te?
 Risposi: paura.
Risposi: paura.
 Era vero. Questa breve parola si spiegava da sé. Perché l’intero Stato era un apparato della paura. C’erano i sovrani della paura e il popolo della paura. Ogni dittatura è formata da chi incute paura e dagli altri, che hanno paura. Da chi vuole farti paura e chi morde per paura. Ho sempre pensato che la paura sia lo strumento quotidiano di chi vuole metterti paura e il pane quotidiano di chi, per paura, morde».
Era vero. Questa breve parola si spiegava da sé. Perché l’intero Stato era un apparato della paura. C’erano i sovrani della paura e il popolo della paura. Ogni dittatura è formata da chi incute paura e dagli altri, che hanno paura. Da chi vuole farti paura e chi morde per paura. Ho sempre pensato che la paura sia lo strumento quotidiano di chi vuole metterti paura e il pane quotidiano di chi, per paura, morde».La paura da centralizzata si è fatta diffusa e dà vita a forme di potere non semplicemente riconducibili né ai fascismi storici e neppure alla post-verità.
Abbiamo due volte paura di questi tempi: paura per sé e per gli altri e paura dell’altro. E la maggior parte delle persone contribuisce ad alimentare la paura portandosela con sé, oltre a cercare di ottenere dalla paura propria e altrui il massimo vantaggio. Gestire la paura non è altro che il preludio all’ubbidienza.
C’è un’epidemiologia del potere che si basa su un particolare tipo di collusione tra chi domina e chi è dominato; su un forte accentramento e su un monopolio della comunicazione: tutto è reso possibile dal fatto che la maggioranza delle persone usa subendoli i social network, il sistema mediatico e i molteplici canali di informazione e comunicazione. Più che una post-verità sembra affermarsi una surverità, un potere sovralegale che non è raggiungibile con gli strumenti della critica e del conflitto politico come finora li abbiamo conosciuti.
* DOPPIOZERO, 18 febbraio 2017
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- UNA DOMANDA ALL’ITALIA: MA COME AVETE FATTO A RIDURVI COSI’?! UN "BORDELLO STATE": UN PAESE BORDELLO. Una nota di Maurizio Viroli (dagli Usa) - e una risposta (agli americani, dall’Italia)
-
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- LA LEZIONE AMERICANA: EPIMENIDE E IL POPULISMO DELLA POST-VERITA’.14 febbraio 2017, di Federico La Sala
IL POPULISMO DELLA POST-VERITA’, EPIMENIDE, E LA LEZIONE ITALO-AMERICANA. In memoria di Italo Calvino***
Siamo nella post-verità da sempre, a quanto pare!
SIAMO PROPRIO CONCIATI MALE, MALISSIMO!
Dopo ventanni di berlusconismo stiamo ancora a commentare i giochini di mentitori istituzionalizzati. E a riflettere sulle “spine del C17 - spine nel fianco di un pingue potere” (https://www.alfabeta2.it/2017/01/21/c17-spine-nel-fianco-un-pingue-potere/).
DOPO IL 1917, E DOPO IL 1922, ANCORA NON SAPPIAMO NULLA DELLA “MORTE NERA” (cfr.: Massimo Palma,”Waler Benjamin, l’inquilino in nero; cfr.: https://www.alfabeta2.it/2017/01/11/walter-benjamin-linquilino-nero/) E DELLA MISTICA FASCISTA (cfr.: mia nota a “Infanzia salentina”, pagine del lavoro di Nicola Fanizza, “Maddalena Santoro e Arnaldo Mussolini” - https://www.nazioneindiana.com/2017/01/21/infanzia-salentina/) - E, NEMMENO, DEI PATTI LATERANENSI E TUTTO IL RESTO.
Tanto tempo, in un’isola del Mediterraneo, un tale chiamato EPIMENIDE (con questo nome è rimasto nella storia, come persona degna di essere ricordata per la sopravvivenza della stessa isola), indignato contro i suoi stessi concittadini (che evidentemente lo accusavano di chissà quali malefatte), fece il primo passo nella terra della post-verità, gridò infuriato: “Tutti i cretesi mentono”! Se molti risero, altrettanto molti lo applaudirono.
Qualche anno dopo, sempre in quell’isola, ci furono le elezioni: tra i partiti (quello che la storia non ci ha tramandato) comparve uno strano partito, con il nome “Forza Creta”, e il leader era proprio il vecchio EPIMENIDE!
CONQUISTATO IL POTERE LEGALMENTE, IL SUO GRIDO AI CRETESI CHE AVEVANO RISO DELLA SUA “BATTUTA” FU QUASI SIMILE A QUELLO DI BRENNO CONTRO I ROMANI SORPRESI NEL SONNO, ANZI, NEL SONNAMBULISMO: “GUAI AI VINTI”!
SOLO CHE A ROMA CI FURONO LE OCHE CHE SVEGLIARONO UN POCO TUTTI E I GALLI FURONO CACCIATI, MA A CRETA ALLA FINE NESSUNO PIU’ OSO’ RIDERE E ... “TUTTI I CRETESI MENTONO” ANCORA!!! A MEMORIA (E A VERGOGNA) ETERNA.
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- Se la mappa della filosofia cancella il Sud (di Massimo Adinolfi).23 febbraio 2017, di Federico La Sala
- IN MEMORIA DI ENZO PACI E DELLA SUA RISPOSTA A VICO.... - IL PROBLEMA GIAMBATTISTA VICO. CROCE IN INGHILTERRA E SHAFTESBURY IN ITALIA. La punta di un iceberg.
Se la mappa della filosofia cancella il Sud
di Massimo Adinolfi (Il Mattino, 23.02.2017)
Impossibile tracciare una mappa della filosofia in Italia. Accompagnando la meritoria iniziativa del «Corriere della Sera» che pubblica una nuova collana di libri dedicata ai «maestri del pensiero più importanti», Pierluigi Panza, a colloquio con il presidente della Società italiana di estetica, Elio Franzini, ci prova coraggiosamente in due righe. Eccole: «la scuola di Milano ha avuto una tradizione fenomenologica con Banfi e Paci; quella di Torino è stata caratterizzata dall’ermeneutica, ma ora ha svoltato con il «ritorno alle cose» di Ferraris; epistemologia e cognitivismo di stampo anglosassone sono variamente disseminati; al Sud è sopravvissuto un po’ di idealismo crociano con un approccio più storicista». Poche righe sommarie, in cui non compaiono Venezia, Padova o Pisa, ma in cui soprattutto il Mezzogiorno quasi non è avvistato: se non fosse per le sparute sopravvivenze storiciste, citate con troppa sufficienza, sembrerebbe che al di sotto della linea Gustav di filosofia non ve ne sia quasi più traccia.
Le cose però non stanno così. Basti pensare che fra gli autori italiani di gran lunga più tradotti all’estero vi sono oggi Giorgio Agamben e Roberto Esposito, uno romano e l’altro napoletano: chiunque intendesse stendere una mappa della filosofia in Italia, a meno di personali idiosincrasie, non potrebbe non includerli in posizione di spicco. E, certo, comprenderebbe il bresciano Emanuele Severino, il milanese Carlo Sini, il veneziano Massimo Cacciari e il torinese Gianni Vattimo, ma anche i napoletani Vincenzo Vitiello, Biagio De Giovanni e Paolo Virno, e i romani Donatella Di Cesare, Pietro Montani e Gennaro Sasso. Se si disputasse il derby fra Nord e Sud come fecero i Monty Pithon con la finale mondiale fra filosofi greci da una parte e tedeschi dall’altra Roma e Napoli, insomma, non sfigurerebbero affatto.
Ci sarebbero volute più righe? Certo. Ma soprattutto ci sarebbero voluta una più generosa attenzione verso tradizioni e stili di pensiero che evidentemente l’articolista non ama: dall’ermeneutica al post-operaismo, dal neoparmenidismo alle filosofie del senso. Ne sarebbe venuta fuori la rappresentazione di una ricerca filosofica molto più vivace e molto più plurale, per nulla prossima alla scomparsa.
Quel che invece rischia davvero di scomparire, e che forse induce a qualche errore di prospettiva, è l’infrastruttura istituzionale che dovrebbe sostenere l’insegnamento e la diffusione del pensiero filosofico, ormai al Sud quasi del tutto assente. La morte di Gerardo Marotta ha riproposto all’attenzione dell’opinione pubblica la vicenda dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e della sua biblioteca, che rischia di divenire metafora di un più generale destino della ricerca nel Mezzogiorno. Ma siccome l’articolo del «Corriere della Sera» si chiude con una sentenza discutibile, che cioè oggi si fa filosofia «senza disturbare», proviamo a recare qualche disturbo.
O almeno a porre una domanda: se il Mezzogiorno non ha più un grande editore (e non ha più una grande banca), se il sistema universitario meridionale viene continuamente penalizzato nel trasferimento delle risorse, se i centri di ricerca non dispongono degli stessi polmoni finanziari che sostengono la ricerca al Nord, se manca o è carente l’organizzazione di grandi kermesse, se chiudono le fiere della letteratura o dell’arte, se tutto questo avviene nonostante la ricchezza di espressioni artistiche, fermenti letterari, compagnie teatrali, gruppi musicali che si muovono in città come Napoli, deve meravigliare il fatto che un grande giornale milanese, a colloquio con un professore milanese, scriva che di filosofia al Sud ce n’è pochina, quasi nulla, e che magari quella che c’è ha un certo sapore d’antico?
Qualche settimana fa si è tenuta a Bologna la Fiera internazionale di arte contemporanea. Bologna: ovvero il lembo più meridionale del sistema italiano dell’arte, perché sotto l’Appennino tosco-emiliano esposizioni simili non ce ne sono. È quasi inevitabile, allora, che chi volesse basare la propria mappa dell’arte italiana oggi su tutto quello che simili manifestazioni mettono in circolo avrebbe qualche difficoltà a inserirvi significative presenze meridionali. La teoria istituzionalista sostiene che è arte ciò che le istituzioni del mondo dell’arte affermano che sia tale. Forse è solo un escamotage, per sfuggire al compito impossibile di metter su una definizione che consenta di tenere insieme Raffaello e Malevic, Giotto e Warhol. Ma se qualcosa del genere è stata proposta persino per la scienza, al punto che vi sono epistemologi per i quali scienza è ciò che la comunità degli scienziati dice che è tale, figuriamoci se questo non accade anche nei riguardi della filosofia, il cui statuto è molto più incerto.
O perlomeno: è incerto solo in linea di principio, perché, come giustamente osserva Franzini, se si prende un filo che proviene dal fondo della tradizione occidentale e lo si prova a tirare fino a noi, un modo per orientarsi nel pensiero, e riconoscervi la forma in cui la filosofia si continua, di fatto c’è. Ma chi lo tira, quel filo? Se a tirarlo sono sempre gli stessi giornali, a margine della pubblicazione delle stesse collane, proposte dagli stessi gruppi editoriali, con operazione culturali che guardano verso le stesse scuole filosofiche che son lì a fare da sponda, allora è inevitabile che solo alcuni fili vengano sempre di nuovo tessuti, mentre altri finiscono con lo spezzarsi e col perdersi.
Una mappa della filosofia in Italia è impossibile, dicevamo. O meglio: dice Panza sul «Corriere della Sera». Ma non dice chi, nel caso, dovrebbe tracciarla, e soprattutto ignora il punto decisivo, che cioè la mappa viene ogni volta tracciata in via di fatto entro l’organizzazione dei saperi e dei poteri di una società. Se si vuole una filosofia che torni a recare qualche disturbo, forse non bisogna liquidare troppo in fretta una simile questione. E le commistioni con società, politica e scienza, che ancora Franzini giudica positive, come un accrescimento del senso del filosofare, aiuteranno allora a disegnarne una trama meno semplificata e soprattutto meno sbrigativa di quella che vede solo un po’ di Milano e un po’ di Torino, qualche sparso e inoffensivo residuo storicistico, tra Napoli e Bari, ma tutto considerato posizioni marginali, a cui non si deve molto più che un atto di omaggio. Le cose non stanno così e, sia detto en passant, se mai compariranno nelle prossime uscite della collana filosofi italiani, si può star certi che da Bruno a Vico, da Croce a Gentile saranno pensatori meridionali.
-
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- RIPENSARE COSTANTINO: I PATTI LATERANENSI, MADDALENA SANTORO, E LA PROVVIDENZA.12 febbraio 2017, di Federico La Sala
I PATTI LATERANENSI, MADDALENA SANTORO, E LA PROVVIDENZA. Una nota sul Nicola Fanizza, "Maddalena Santoro e Arnaldo Mussolini. La storia d’amore che il duce voleva cancellare"
I POLITICI SI SONO FATTI TEOLOGI E LA TEOLOGIA, IN SENSO PROPRIO, NON PARLA PIU’. Una riflessione di Paolo Prodi.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- SCUOLA E COSTITUZIONE. La lettera dei 600 docenti universitari e la vera emergenza (di M. Virgilio).7 febbraio 2017, di Federico La Sala
FILOSOFIA. IL PENSIERO DELLA COSTITUZIONE E LA COSTITUZIONE DEL PENSIERO: *
La vera emergenza non è la grammatica, ma il classismo dei 600 docenti universitari
C’è qualcosa di insopportabile nella lettera che i 600 docenti hanno sottoscritto per mettere alla berlina le competenze grammaticali degli studenti italiani, in primis il classismo e la mancanza di autocritica di un sistema che è causa del problema.
di Massimiliano Virgilio *
La vera emergenza non è la grammatica, ma il classismo dei 600 docenti universitari
Per chi oggi ha tra i venti e i quarant’anni nel nostro Paese, cioè per chi sta crescendo o è cresciuto sul ciglio del disastro, c’è qualcosa di insopportabile nella ormai già famigerata lettera che il Gruppo di Firenze dei seicento docenti universitari ha inviato alle autorità italiane. Obiettivo: puntare l’indice sulle mediocri competenze grammaticali degli studenti. La scoperta dell’acqua calda, verrebbe da dire. Perciò sembra assurdo che una simile denuncia arrivi solo oggi, quando è evidente a tutti che la battaglia è stata persa tempo addietro. Come ha scritto ieri Annamaria Testa su Internazionale, riportando le dichiarazioni di Gianni Peresson, responsabile dell’ufficio studi di Aie (Associazione Italiana Editori) per commentare gli ultimi dati sulla lettura nel 2016:
- La grande battaglia per la lettura in Italia è stata persa tra gli anni ottanta e i novanta, quando si è rinunciato a contrastare l’espansione televisiva creando un sistema di pubblica lettura in molte regioni.
Ma a chi importerebbe il clamoroso ritardo con cui arriva questa denuncia se ci fosse, nel sopracitato appello, una visione in grado di orientare i governi a operare scelte future sensate nel settore dell’istruzione e della formazione? E invece niente di tutto ciò è rintracciabile nelle raccomandazioni degli accademici al "governo della scuola". Mentre c’è, e molto, di insopportabile. Come il fatto che gli estensori di questo documento siano, fondamentalmente, un gruppo di uomini e donne che ha trascorso al calduccio quasi o tutta l’esistenza da illustri docenti, al centro di quel sistema universitario di stampo medievale così ramificato nel nostro Paese, zeppo di baronati, nepotismi, valvassori e satrapi di ogni genere, che ha inciso non poco sul disastro italiano attuale.
Eppure l’aspetto più intollerabile, nella lettera, è il retropensiero, lo spirito classista insito nel richiamo alla valutazione, alla riproposizione poliziesca di una pedagogia stantia, in nome di una formazione che sia, innanzitutto, selettiva. Altro che don Milani! C’è invece, leggendo con attenzione l’appello, una voglia di repressione nei confronti di quest’incresciosa situazione della grammatica tra la plebaglia studentesca e, più in generale, nei confronti dei giovani, come non si vedeva da tempo.
Non uno straccio di analisi delle ragioni che ci hanno condotto nel baratro, non uno straccio di autocritica sulle condizioni dell’università (dove oggi gli studenti non scrivono più e in cui, al massimo, sono tenuti ad apporre segni grafici sui quiz) o mea culpa rispetto all’appoggio indiscriminato fornito da molti di questi prestigiosi intellettuali ai governi che hanno massacrato la scuola pubblica, che hanno fatto della cultura un colabrodo istituzionale in cui distribuire prebende, che hanno tagliato i fondi alle biblioteche, che hanno assistito inermi mentre le librerie chiudevano in nome del libero mercato, che non hanno alzato un dito mentre il settore editoriale andava allo sfascio, che hanno parlato di meritocrazia senza praticarla, che hanno affossato i giovani del nostro Paese in ogni modo possibile...
Infine, un’ultima annotazione che spero possa esser colta al di là dell’aspetto estetico: la lettera dei 600 prof è stata pubblicata su un blog di rara bruttezza, un luogo dell’internet dal template scialbo e con un’impaginazione degna dei primi scarabocchi alla scuola dell’infanzia. A dimostrazione ulteriore che questi signori non hanno capito nulla del mondo che li circonda e che loro vorrebbero emendare.
*
http://www.fanpage.it/la-vera-emergenza-non-e-la-grammatica-ma-il-classismo-dei-600-docenti-universitari/ http://www.fanpage.it/ 7 febbraio 2017.
*
NOTA SUL TEMA - SCUOLA E MICROFISICA, MACRO-FISICA, E METAFISICA::
https://www.alfabeta2.it/2017/02/03/microfisica-dellalternanza-scuola-lavoro/#comment-625056
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- COSTITUZIONE E PSEFOLOGIA. Il Comma 22 del sistema politico italiano (di Paolo Pombeni)6 febbraio 2017, di Federico La Sala
COSTITUZIONE E PENSIERO. ITALIA: LA MISERIA DELLA FILOSOFIA ITALIANA E LA RICCHEZZA DEL MENTITORE ISTITUZIONALIZZATO ...
Il Comma 22 del sistema politico italiano
di Paolo Pombeni (Il Mulino, 06 febbraio 2017)
Vista dall’esterno la attuale situazione politica sembra descrivibile come il famoso Comma 22. Infatti da un lato ci sono quelli che invocano elezioni nel più breve tempo possibile, perché c’è una situazione in cui senza un saldo governo sono scarse le prospettive di avere reazioni efficaci per affrontare i molti problemi che ci affliggono. Dal lato opposto ci sono quelli che ci avvertono che il risultato di un ricorso rapido alle urne sarebbe un parlamento incapace di produrre qualsiasi governo dotato della necessaria saldezza. Il Comma 22 sta, come da tradizione, nel fatto che hanno ragione entrambi.
Come se ne esce? Questa sarebbe la vera domanda da porsi. Al momento si assiste solo a un estenuante gioco di tattica in cui i contendenti fanno più che altro delle «finte», giusto per ingannare gli avversari e per trarre profitto da questo.
Sul fatto che la situazione sia difficile, se non difficilissima, c’è un certo consenso. Del resto basta guardare all’economia, fra disoccupazione, crisi bancarie, conflitto sul bilancio con la Commissione europea. Come se tutto ciò non bastasse, c’è un ricco contorno di preoccupazioni, tanto sul fronte nazionale quanto su quello internazionale. Dunque che serva un governo in grado di farsene carico è pacifico.
L’attuale esecutivo può rispondere a queste sfide? Già qui la risposta si complica: in parte sì, in parte no. Sì, perché non mancano i ministri capaci, perché il presidente del Consiglio è persona equilibrata, perché ci sono in atto interventi che possono andare nella giusta direzione. No, perché non tutti i ministri sono capaci (prezzo pagato al continuismo con il governo Renzi), perché al presidente del Consiglio sembra mancare il guizzo di leadership necessario a dominare una platea indisciplinata, ma soprattutto perché non ha un sostegno convinto da parte di una maggioranza che è più impegnata a farsi una guerra intestina senza quartiere che a dare linfa all’azione riformatrice necessaria (e tacciamo di una opposizione che pensa solo allo sfascio, o a quello sfrontato alla Salvini-Grillo & Co., o a quello soft del tramonto berlusconiano).
Veniamo all’alternativa elettorale. I fari sono puntati su stucchevoli dibattiti circa le tecnicalità che potrebbero produrre una legge elettorale che facesse il miracolo di assestare la distribuzione del consenso. Sono piuttosto rari quelli che ricordano alla pletora dei nostri psefologi, professionisti o dilettanti che siano, che i sistemi elettorali possono organizzare la realtà, ma non sono in grado di crearne una diversa. Il problema infatti è, come si suol dire, nel manico. Infatti il sistema che produce opinione (parlare di cultura politica è eccessivo) è tutto preso nel vortice delle lotte di fazione e delle «narrazioni», o, se volete un termine più à la page, delle «post verità» che queste producono.
Che la diatriba fra renziani e antirenziani sia davvero un dibattito fra destra e sinistra fa sorridere e in ogni caso nessuno dei due campi spiega quale sarebbe il progetto di risoluzione dei nostri problemi che ha in mente. Quelle che sentiamo sono tautologie: noi siamo i buoni e di conseguenza diamo buone ricette che porteranno buoni frutti. Amen.
E che dire dei vari dibattiti dei grillini, dei cosiddetti «sovranisti», e via elencando? Ogni tanto vediamo che esibiscono qualche tecnico che fa calcoli economici. Noi siamo digiuni della materia, ma ci permettiamo di ricordare che non si fanno i calcoli senza l’oste, cioè che sono tutte argomentazioni che non tengono conto del fatto che intorno a noi c’è un mondo complicato che non ci lascerà agire come sarebbe meglio, ma che è molto intenzionato a farcela pagare (e qualche indizio ci sembra di coglierlo).
In queste condizioni il ricorso alle urne è ovviamente rischioso perché abbiamo davanti due scenari. Il primo è che continui il trend per cui il Paese si dividerà dietro tutte le varie narrazioni e post verità che gli stanno propinando, dando vita a un sistema corporativizzato e feudalizzato in perenne, endemico conflitto, dove decidere diventerà molto difficile se non impossibile. Il secondo è che i cittadini, stanchi o inorriditi da questa prospettiva, scelgano di mettersi nelle mani di qualcuno che abbia il potere per creare un unico punto di riferimento. È possibile. E in genere non viene scelto il migliore e il più saggio.
Per assurdo che possa sembrare, l’unica via d’uscita razionale, per quanto estremamente difficile sarebbe poter contare su un responsabile movimento di rigetto dell’universo di faide tra tribù politiche e populismi d’accatto che sembra in procinto, quello sì, di stabilizzarsi. Non si tratta astrattamente di contrapporre società civile e società politica, perché posta così la questione è evanescente. Si tratta di operare perché i ceti dirigenti di questo Paese riprendano in mano la formazione della coscienza collettiva costringendo la componente politica che hanno dentro a uscire dall’autoreferenzialità dei propri scontri e a produrre nuovi quadri capaci di mettersi su questa lunghezza d’onda (chi non è capace di farlo merita di essere rottamato).
Se non ci si riuscirà, non facciamoci illusioni: torneremo ad essere, come all’inizio del XVI secolo, il Paese che ha tante cose belle, ma che cadrà preda del mondo che ci circonda, con buona pace di tutti, dei sovranisti e di quelli che sono rimasti alla sinistra luddista.
COME ALL’INIZIO DEL XVI SECOLO ....
MICHELANGELO E LA SISTINA (1512-2012). I PROFETI INSIEME ALLE SIBILLE PER LA CHIESA UN GROSSO PROBLEMA ....
 DOPO 500 ANNI, PER IL CARDINALE RAVASI LA PRESENZA DELLE SIBILLE NELLA SISTINA E’ ANCORA L’ELEMENTO PIU’ CURIOSO. Materiali sul tema, per approfondimenti
DOPO 500 ANNI, PER IL CARDINALE RAVASI LA PRESENZA DELLE SIBILLE NELLA SISTINA E’ ANCORA L’ELEMENTO PIU’ CURIOSO. Materiali sul tema, per approfondimenti -
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- L’uomo che apre le porte dei capolavori vaticani: “Ho le chiavi del paradiso” (di Paolo Rodari)30 gennaio 2017, di Federico La Sala
IL CAPO DEI CLAVIGERI, LE "DUE CHIAVI", E I "DUE SOLI"
"DUE SOLI" IN TERRA, E UN SOLO SOLE IN CIELO: "TRE SOLI". GENERE UMANO: I SOGGETTI SONO DUE, E TUTTO E’ DA RIPENSARE!!! NON SOLO SUL PIANO TEOLOGICO-POLITICO, MA ANCHE ... ANTROPOLOGICO!!!
- MICHELANGELO E LA SISTINA (1512-2012). I PROFETI INSIEME ALLE SIBILLE PER LA CHIESA UN GROSSO PROBLEMA ....
- DOPO 500 ANNI, PER IL CARDINALE RAVASI LA PRESENZA DELLE SIBILLE NELLA SISTINA E’ ANCORA L’ELEMENTO PIU’ CURIOSO.
L’uomo che apre le porte dei capolavori vaticani: “Ho le chiavi del paradiso”
Gianni Crea è il capo dei clavigeri dei musei della Santa sede. "Ogni mattina, quando entro nella Cappella Sistina, mi sento un privilegiato"
di PAOLO RODARI (la Repubblica, 29 gennaio 2017)
CITTÀ DEL VATICANO. "L’alba è il momento più magico. Entro nel bunker che custodisce le 2797 chiavi dei musei vaticani. Quando non ci sono gli addetti della sagrestia pontificia, tocca a me prelevare l’unica chiave che non ha numero né copie. È un modello antico come la porta che apre, quella della Cappella Sistina. Giro la serratura della Cappella, quella stessa che sigilla i cardinali in conclave, per pochi istanti mi sento investito da una meraviglia che non è facile spiegare. M’inginocchio, mi segno, e dico una preghiera in solitudine. Chiedo che tutti i visitatori che di lì a poco entreranno possano provare il medesimo stupore. Sono un privilegiato, ne sono consapevole. E so che di questo privilegio devo esserne sempre degno".
Gianni Crea, 45 anni, romano ma originario di Melito di Porto Salvo, in provincia diReggio Calabria, è capo clavigero dei musei vaticani. In sostanza, ha il compito di aprire e chiudere tutte le porte e le finestre, 500 in tutto, 300 del percorso dei visitatori e 200 dei vari laboratori collegati. A vent’anni il parroco della chiesa che frequentava sulla via Appia gli chiese se voleva lavorare nella basilica vaticana come custode ausiliario. La Fabbrica di San Pietro in cambio avrebbe contribuito ai suoi studi. Accettò.
Qualche anno dopo, giovane studente di giurisprudenza con il sogno di diventare magistrato, partecipò a un concorso per diventare a tutti gli effetti custode. Per un anno lo osservarono, per valutare se fosse idoneo: puntualità, discrezione e serietà le principali doti richieste. Venne preso: "Da adesso - gli dissero - devi sempre ricordare dove ti trovi. Lavori nel centro della cristianità. I dieci comandamenti devono diventare il tuo secondo vestito". Una richiesta "non da poco", dice. "Tuttavia sono contento di non disattenderla".
Più immaginifica fu, invece, la consegna che gli fece Antonio Paolucci, fino a poche settimane fa direttore dei musei, quando da semplice clavigero venne nominato capo. "Adesso sei tu ad avere simbolicamente in mano le porte del Paradiso", gli disse per fargli comprendere la responsabilità a cui era chiamato. Con lui, infatti, collaborano altri dieci clavigeri che si dividono il lavoro in due turni, una metà dalle 5.30 del mattino alle due del pomeriggio. Gli altri fino a sera tardi. "Da quel momento il Vaticano è diventata la mia seconda casa - dice - Conosco le chiavi come le mie tasche. Ogni porta apre un mondo per me e per tutti i clavigeri familiare. Dietro ogni porta c’è un odore particolare, un profumo, riconoscibile soltanto da noi".
L’apertura e la chiusura di porte e finestre sono momenti entrambi delicati. Alle 5.30 la Gendarmeria di Porta Sant’Anna toglie l’allarme e il clavigero di turno procede con un lungo giro che dura quasi un’ora e mezzo. Dopo ogni apertura c’è il controllo che ogni cosa sia in ordine. "Se ad esempio si rompe un tubo dell’acqua - racconta - spesso tocca a me chiamare l’idraulico". Negli ultimi anni i visitatori dei musei sono parecchio aumentati, 28mila le sole presenze giornaliere in Sistina. Tutto deve essere perfetto. "Ma anche la chiusura non è facile. Bisogna controllare che nessuno rimanga all’interno. Gli imprevisti sono sempre possibili. Una sera chiudemmo tutto e di colpo suonò l’allarme. Accorremmo nella stanza nella quale veniva segnalata una presenza. Per fortuna era soltanto un passerotto rimasto dentro".
Il clavigero è l’erede delle chiavi del Maresciallo del Conclave, colui che fino al 1966 doveva sigillare le porte intorno alla Cappella quando i cardinali si riunivano per eleggere il Pontefice. La sua chiave non è l’unica a essere preziosa: c’è, ad esempio, la chiave numero 1, quella che apre il portone monumentale su viale Vaticano, che oggi è il portone d’uscita dei visitatori dei musei.
 E poi c’è la 401, una delle più antiche: apre il portone d’entrata dei musei e pesa mezzo chilo. "Due chiavi decussate, cioè incrociate a X, appaiono negli stemmi ed emblemi dei papi - scrive Tiziana Lupi su "Il mio Papa" - Sono una d’oro (potere spirituale) e una d’argento (potere temporale); hanno i congegni traforati a croce e sono unite da un cordone, simbolo del legame tra i due poteri ". I musei sono divisi in quattro aree. Ad ogni area corrispondono dei numeri a cui le chiavi si riferiscono. Le chiavi con il numero 100 sono del museo etnologico, quelle col 200 sono del Gregoriano, eccetera...
E poi c’è la 401, una delle più antiche: apre il portone d’entrata dei musei e pesa mezzo chilo. "Due chiavi decussate, cioè incrociate a X, appaiono negli stemmi ed emblemi dei papi - scrive Tiziana Lupi su "Il mio Papa" - Sono una d’oro (potere spirituale) e una d’argento (potere temporale); hanno i congegni traforati a croce e sono unite da un cordone, simbolo del legame tra i due poteri ". I musei sono divisi in quattro aree. Ad ogni area corrispondono dei numeri a cui le chiavi si riferiscono. Le chiavi con il numero 100 sono del museo etnologico, quelle col 200 sono del Gregoriano, eccetera..."La gioia più grande in questi anni - dice ancora Crea - l’ho avuta pochi anni fa. Prima che morisse mia madre ha potuto assistere a una messa del mattino a Casa Santa Marta. Ha ricevuto una carezza dal Papa. Un piccolo gesto che per me ha significato molto".
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- IL POPULISMO DELLA POST-VERITA’, EPIMENIDE, E LA LEZIONE ITALO-AMERICANA.25 gennaio 2017, di Federico La Sala
UNA RISPOSTA A "SPECIALE C17":
IL POPULISMO DELLA POST-VERITA’, EPIMENIDE, E LA LEZIONE ITALO-AMERICANA. In memoria di Italo Calvino *
Siamo nella post-verità da sempre, a quanto pare!
SIAMO PROPRIO CONCIATI MALE, MALISSIMO!
Dopo ventanni di berlusconismo stiamo ancora a commentare i giochini di mentitori istituzionalizzati. E a riflettere sulle "spine del C17 - spine nel fianco di un pingue potere" (https://www.alfabeta2.it/2017/01/21/c17-spine-nel-fianco-un-pingue-potere/).
DOPO IL 1917, E DOPO IL 1922, ANCORA NON SAPPIAMO NULLA DELLA "MORTE NERA" (cfr.: Massimo Palma,"Waler Benjamin, l’inquilino in nero", cfr.: https://www.alfabeta2.it/2017/01/11/walter-benjamin-linquilino-nero/) E DELLA MISTICA FASCISTA (cfr.: mia nota a "Infanzia salentina", pagine del lavoro di Nicola Fanizza, "Maddalena Santoro e Arnaldo Mussolini" - https://www.nazioneindiana.com/2017/01/21/infanzia-salentina/).
Tanto tempo fa, in un’isola del Mediterraneo, un tale chiamato EPIMENIDE (con questo nome è rimasto nella storia, come persona degna di essere ricordata per la sopravvivenza della stessa isola), indignato contro i suoi stessi concittadini (che evidentemente lo accusavano di chissà quali malefatte), fece il primo passo nella terra della post-verità, gridò infuriato: "Tutti i cretesi mentono"! Se molti risero, altrettanto molti lo applaudirono.
Qualche anno dopo, sempre in quell’isola, ci furono le elezioni: tra i partiti (quello che la storia non ci ha tramandato) comparve uno strano partito, con il nome "Forza Creta", e il leader era proprio il vecchio EPIMENIDE!
CONQUISTATO IL POTERE LEGALMENTE, IL SUO GRIDO AI CRETESI CHE AVEVANO RISO DELLA SUA "BATTUTA" FU QUASI SIMILE A QUELLO DI BRENNO CONTRO I ROMANI SORPRESI NEL SONNO, ANZI, NEL SONNAMBULISMO: "GUAI AI VINTI"!
SOLO CHE A ROMA CI FURONO LE OCHE CHE SVEGLIARONO UN POCO TUTTI E I GALLI FURONO CACCIATI, MA A CRETA ALLA FINE NESSUNO PIU’ OSO’ RIDERE E ... "TUTTI I CRETESI MENTONO" ANCORA!!! A MEMORIA (E A VERGOGNA) ETERNA.
Federico La Sala
SUL TEMA, IN RETE E NEL SITO, SI CFR.:
ALFABETA2 - Speciale C 17
ALFABETA2 - Walter Benjamin, l’inquilino in nero (Massimo Palma)
NAZIONE INDIANA - "Infanzia salentina", un estratto del libro di Nicola Fanizza Maddalena Santoro e Arnaldo Mussolini, edizioni del Sud, 2016
NAZIONE INDIANA - La lezione americana della post-verità “alternativa ( Anatole Pierre Fuksas)
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- MADDALENA SANTORO, ARNALDO MUSSOLINI, E I LIBRI DI STORIA.24 gennaio 2017, di Federico La Sala
MADDALENA SANTORO, ARNALDO MUSSOLINI, E I LIBRI DI STORIA:
SU ***NAZIONE INDIANA*** sotto il titolo di "Infanzia salentina" è stato ripreso il primo capitolo di un libro di grande interesse: Nicola Fanizza, Maddalena Santoro e Arnaldo Mussolini. La storia d’amore che il duce voleva cancellare, Ediziioni Dal Sud, Bari 2016.
NON è CHE L’INIZIO! BENE! CONTINUARE LA LETTURA!!! E non fermarsi al primo "libro"! Il "carteggio" della seconda parte (pp. 109-154), è un altro "libro": le 32 lettere che Maddalena Santoro, invia, dal 1919 al 1938, all’amica di Mola di Bari, Caterina Tanzarella, sono dei documenti storici di grande rilevanza, per sapere di più e meglio sia di questa donna salentina, intellettuale e scrittrice, fedele a se stessa e alla sua amica (e alla sua famiglia), sia del fratello del Duce, "il fratello di un Grande Fratello" (che, se "preferì restare nell’ombra", come scrive Indro Montanelli nel novembre del 2000 - cfr. "Il fascino di Arnaldo Mussolini": http://www.corriere.it/solferino/montanelli/00-11-09/01.spm, non per questo deve continuare a restarvi).
Il coraggioso e originale lavoro di Fanizza, sia per la qualità della sua scrittura sia della sua preziosa documentazione storica sulla "storia d’amore che il duce voleva cancellare", è una formidabile occasione per riprendere una "vecchia" indicazione di Luisa Passerini(in una sua relazione nel convegno a Bologna nel 1993, su "Il regime fascista. Bilancio e prospettive di studio"): "coniugare la tradizione della storiografia antifascista sul fascismo con gli studi storici che adottano le categorie di genere e di generazione" e superare definitivamente la obsoleta prospettiva storiografica che voleva e vuole ancora "le questioni di genere e la storia delle donne come questioni separate e secondarie o come questioni che hanno a che fare più col sociale che col politico"(cfr.: AA.VV, "Il regime fascista. Storia e storiografia", a c. di Angelo Del Boca, Massimo Legnani e Mario G. Rossi, Laterza, Bari 1995, pp. 498-506). E riguardare l’intera storia della società (e dell’umanità intera!) con due occhi, non con un occhio solo!
DA NOTARE che in quello stesso Convegno (e si riconsideri il titolo e il tema) una - e dicesi: una! - sola volta è citato Arnaldo Mussolini e solo per problemi relativi al "connubio tra affari e politica" (op. cit., p. 133), e una e una sola volta (e proprio da Luisa Passerini) è citata Rosa Maltoni (p. 504), la madre sua e del "Grande Fratello", oggetto di "un culto molto ampio" durante il fascismo...
Federico La Sala
Una Risposta a Bertolt Brecht, l’intellettuale nell’epoca del mercato *
BRECHT E IL RITORNELLO DEI “TUI” DI IERI E DI OGGI. «Abbiamo appena salvato la cultura» ...
 «Un vecchio riccone muore, soffrendo per la miseria del mondo nel testamento lascia una grossa somma per la fondazione di un istituto che studi la causa di questa miseria. La causa è ovviamente il vecchio riccone stesso» (B. Brecht).
«Un vecchio riccone muore, soffrendo per la miseria del mondo nel testamento lascia una grossa somma per la fondazione di un istituto che studi la causa di questa miseria. La causa è ovviamente il vecchio riccone stesso» (B. Brecht).IN OMAGGIO A “L’ORMA”, A FRANCESCO FIORENTINO, E AD “ALFABETA2”, CONTRO UN MONDO CONCEPITO COME “IL MONDO COME VOLONTA’ E RAPPRESENTAZIONE” DEL *MACROANTROPO* (“UOMO SUPREMO”, “SUPERUOMO”, “DOMINUS IESUS”), CON TUTTA LA SUA FILOSOFIA, TEOLOGIA POLITICA, E “ANDRO-PO-LOGIA” ATEA E DEVOTA.... ho ripreso in collegamento con LA RISATA DI KANT (si cfr.: http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=5028) la brillante recensione di Fiorentino e sottolineato con alcune note (si cfr.: http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=5028#forum3119870) l’importanza del discorso di Brecht sul ritornello dei “TUI” di ieri e di oggi.
Federico La Sala (Alfabeta2, 15 gennaio 2017).
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- IL ROMANZO DEI "TUI". Bertolt Brecht, l’intellettuale nell’epoca del mercato.14 gennaio 2017, di Federico La Sala
FILOSOFIA. IL PENSIERO DELLA COSTITUZIONE E LA COSTITUZIONE DEL PENSIERO...
- RIFARE UNO STATO?! BASTA UN NOTAIO, UN FUNZIONIARIO DEL MINISTERO DELL’INTERNO E LA REGISTRAZIONE DI UN SIMBOLO DI PARTITO CON IL NOME DEL POPOLO!!! A futura memoria, note e appunti sul caso
- MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA E A PENSARE BENE "DIO", "IO" E "L’ITALIA", CHI PIU’ CHI MENO, TUTTI VIVONO DENTRO LA PIU’ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA E POLITICA ITALIANA, NEL REGNO DI "FORZA ITALIA"!!!
Bertolt Brecht, l’intellettuale nell’epoca del mercato
di Francesco Fiorentino (alfapiù, 13 gennaio 2017)
- Bertolt Brecht, Il romanzo dei tui, a cura di Marco Federici Solari, L’orma, 2016, 256 pp., € 18
«Abbiamo appena salvato la cultura», scrive Brecht a George Grosz dopo aver preso parte al Congrès international des écrivains pour la défense de la culture, che si tenne a Parigi nel giugno del 1935. «Ci abbiamo messo 4 (quattro) giorni, e abbiamo deciso di sacrificare tutto piuttosto che far morire la cultura. In caso di necessità di sacrificare anche 10-20 milioni di persone».
È l’ideologia della cultura che chiude gli occhi davanti ai crimini, che è essa stessa criminale perché collusiva con le condizioni economiche e sociali che rendevano possibile il nazismo. Portatore e beneficiario - ma anche vittima - di questa ideologia è il tui, come Brecht chiama ironicamente «l’intellettuale dell’epoca delle merci e dei mercati, il noleggiatore dell’intelletto». Su questa figura progetta di scrivere un Romanzo dei tui, cui lavora tra il 1930 e il 1942 senza concluderlo. Ora L’orma lo propone per la prima volta in italiano, insieme ad altri scritti - racconti, trattati, appunti, schizzi - che ne hanno accompagnato la stesura.
È un libro che contiene molti libri; che usa e mischia satira, parabola filosofica, aneddoto, barzelletta, aforisma, racconto. C’è una provocatoria riabilitazione satirica di un serial killer che macella le sue vittime per mangiarne o venderne la carne; c’è un gustosissimo trattato sull’arte del leccapiedi o uno sull’arte del coito, poi il frammento di un Epos dei tui, ma ci sono anche una serie di Storie dei tui, piccoli gioielli di scrittura popolare ad alta tensione dialettica; poi diverse pagine di appunti, lacerti di quel magma già depurato da cui nasce la scrittura tersa di Brecht. Ma soprattutto c’è il frammento del Romanzo dei tui: un tentativo di scrivere la storia della Repubblica di Weimar in forma di una grande satira sugli intellettuali ambientata in una Cima che serve a trasportare i fatti storici nella terra di uno straniamento parabolico.
La Repubblica di Weimar è rappresentata come «la grande era dei tui», che poi è l’epoca del loro grande tradimento della «rivoluzione degli operai e dei contadini». La satira di Brecht è dolorosa; è come alimentata da una rabbia divertita, da una rabbia che non si lascia piegare dal pessimismo. Ma in certi punti rivela un’origine traumatica, come quando dipinge con tratti quasi comici l’assassinio di Karl Liebknecht e Rosa Luxemburg, che è il grande choc per la sinistra tedesca, il fallimento della speranza di una rivoluzione comunista in Europa. Un altro trauma dissimulato satiricamente è l’elezione democratica di Hitler: «Che la prima applicazione della democrazia provochi la sua abrograzione; che il popolo liberato imponga la propria sottomissione, questo è il paradosso comico del libro». Paradosso comico e lancinante.
L’origine del nazismo sta nella democrazia di Weimar, in un ordine economico e sociale fondato sullo sfruttamento dell’uomo sull’uomo. La grande colpa dei tui è di non averlo riconosciuto e contestato; di aver preso partito per la cultura senza opporsi ai rapporti di proprietà ingiusti su cui essa si fonda. Solo un’illusione è la libertà della cultura: lo spirito può credersi libero finché le sue critiche sono innocue o magari si prestano a essere sfruttate per far profitti, per esempio dai giornali sui quali vengono formulate.
Il mercato è capace di assorbire e sfruttare anche chi lo contesta. Perché quelle contestazioni poggiano su basi sbagliate. Idealistiche. Brecht non si stanca di mettere alla berlina la collusività tra idealismo e mercificazione. Il tui è oggetto e soggetto di mercificazione: crede di esercitare la libertà di pensiero, ma in realtà vende il proprio intelletto facendosi complice di un sistema governato dalla produzione di mancanza.
Ne ha per tutti, Brecht. Anche per quelli che trattano il socialismo come merce e traggono profitto dalle loro opinioni «sulla pericolosità sociale del fatto che tutto ormai sia una merce». Sulla Scuola di Francoforte è fulminante: «Un vecchio riccone muore, soffrendo per la miseria del mondo nel testamento lascia una grossa somma per la fondazione di un istituto che studi la causa di questa miseria. La causa è ovviamente il vecchio riccone stesso».
Un altro choc è l’esilio americano: l’esperienza di una florida industria culturale in cui davvero l’intelletto è sottomesso apertamente al ritmo e all’ordine della merce: «questo paese mi manda in fumo il mio Romanzo dei tui», appunta il 18 aprile 1942 nel suo Diario di lavoro. «Qui la vendita delle opinioni non la si può svelare. Perché se ne va in giro nuda». La realtà supera la satira e la rende superflua.
Non siamo lontani dall’attuale condizione neoliberale in cui l’intellettuale è costretto sempre più a farsi imprenditore di se stesso, impegnato soprattutto a autopubblicizzarsi, a trasformarsi in marchio riconoscibile capace di garantire per i prodotti del suo lavoro, i quali però sono sempre meno richiesti. Quale satira può essere all’altezza dei tanti lamenti sulla condizione del lavoro intellettuale in quest’epoca post-salariale? In quest’epoca in cui l’intellettuale è impegnato in un marketing del sé che va fino ai limiti dell’autosfruttamento, alla disponibilità al lavoro gratuito in cambio di una promessa di visibilità da spendere su un mercato sempre più ristretto? Ogni critica è metabolizzata a priori, utilizzata anzi come alimento di un sistema in cui il controllo ideologico è ormai interiorizzato, automatizzato; e che perciò non ha più bisogno di intellettuali che forniscano giustificazioni dell’ingiustizia sociale o ammantino la violenza con una retorica della libertà.
Il romanzo dei tui suscita continuamente domande sulla possibilità di pensare la figura e la funzione dell’intellettuale al di fuori della logica della merce e dell’ideologia dell’inelluttabilità del mercato. La risposta che sembra prospettare Brecht, insieme a Benjamin, è l’utopia di un’espansione del «sapere sociale generale» (Marx) che facesse evaporare la distinzione fra lavoro intellettuale o manuale. Svanirebbe allora la figura dell’intellettuale di professione, cioè di un individuo che mette a frutto il proprio intelletto nella competizione economica; svanirebbe per lasciar posto a un’intellettualità diffusa, anonima, non più legata a nomi, titoli, riconoscimenti. Quindi svincolata dalla doppia morsa della mercificazione e del narcisismo che sottrae all’intelletto la sua potenza critica. È un’utopia che la rivoluzione digitale sembra rendere una possibilità concreta: l’unica, forse, sulla quale potremmo e dovremmo puntare.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- QUINE, IL PROBLEMA ONTOLOGICO, E "BABBO NATALE"!!!1 gennaio 2017, di Federico La Sala
- L’ATTIVISMO ACCECANTE DEL "FAR WEST" E IL "SAPERE AUDE" DELLA "CRITICA DELLA RAGION PURA" ---- Che cos’è quello che c’è? Le domande di Quine.
- L’ATLANTE DEL "PARADISO IN TERRA", BOLOGNA, DANTE, E LA "MEMORIA" DI ABY WARBURG.
’Babbo Natale non esiste’, è bufera
Allo show Disney Frozen a Roma, cacciato direttore d’orchestra
(ANSA) - ROMA, 30 DIC - "Comunque Babbo Natale non esiste": una frase che ha scatenato la bufera quella pronunciata, a sorpresa, dal direttore d’orchestra Giacomo Loprieno alla fine della prima dello spettacolo per bambini ’Disney in concert: Frozen’, il 29/12 all’Auditorium Parco della Musica di Roma.
Un’esclamazione che ha raccolto subito critiche sulla pagina ufficiale Facebook dello show, spingendo l’organizzazione, Dimensione Eventi, a destituire dalla carica il maestro, che sarà sostituito già dalla replica del 30 dicembre.
In una nota, l’organizzazione "si dissocia completamente" dall’accaduto: "Come tutti i presenti siamo rimasti sconcertati da una dichiarazione assolutamente personale del direttore, tra l’altro a spettacolo ormai terminato. Il nostro lavoro è di creare emozioni positive e far sognare i più piccoli. Quanto è stato detto dal direttore d’orchestra è totalmente fuori luogo ed è il gesto arbitrario di una singola persona".
Babbo Natale non esiste, ancora polemica
Il 30 in sala tra i bimbi. Web diviso su direttore licenziato
(ANSA) - ROMA, 31 DIC - Non si placa la polemica su Giacomo Loprieno, il direttore d’orchestra che il 29/12, alla fine dello show per bambini dedicato al film Disney Frozen, ha detto davanti alla platea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma: "E comunque, Babbo Natale non esiste".
Archiviate le lacrime dei piccoli e lo sbigottimento dei genitori, l’organizzazione ha licenziato Loprieno, assegnando il posto al suo vice, Marco Dallara, immortalato in una foto pubblicata sul profilo dell’Auditorium proprio con Babbo Natale per placare gli animi.
I social, però, continuano a pullulare di critiche al maestro e su Facebook nascono di ora in ora gruppi e pagine contro ma anche pro Loprieno. C’è chi lo critica per aver spezzato i sogni dei bambini e chi, invece, lo elegge a "oratore motivazionale", scherzando sull’estemporaneo discorso ai bambini. Gli stessi che si sono fatti fotografare con i loro beniamini ai piedi del palco, nella seconda data romana dello show, alla quale ha partecipato - a sorpresa - anche Babbo Natale.
«Sì, Virginia, Babbo Natale esiste» *
La storia di un editoriale del 21 settembre 1897 su Babbo Natale che da allora è un pezzo dei natali americani
- YES VIRGINIA
“Is There a Santa Claus?” era il titolo di un editoriale nell’edizione del 21 settembre 1897 del New York Sun. Quell’editoriale, che comprendeva la risposta “Yes, Virginia, there is a Santa Claus” (“Sì Virginia, Babbo Natale esiste”), è diventato un elemento indelebile del clima natalizio negli Stati Uniti. L’espressione “Sì Virginia, esiste...” è stata usata spesso anche nei titoli dei giornali anglosassoni, per indicare qualcosa che esiste o è vera, sotto gli occhi di tutti: una riscrittura ironica dell’editoriale, ad esempio, comparve sull’Huffington Post nel dicembre 2007 con il titolo “Yes, Virginia, There is a War on Terror”.
La lettera di Virginia
Nel 1897 il dottor Philip O’Hanlon di Manhattan si sentì domandare dalla sua bambina di otto anni Virginia se Babbo Natale esistesse davvero. Virginia aveva cominciato a dubitarne per quello che le avevano detto degli altri bambini.
Suo padre le suggerì di scrivere al New York Sun, un importante quotidiano del tempo di orientamento conservatore, assicurandole che “se lo dice il Sun, allora è vero”. Uno dei direttori del giornale, Francis Pharcellus Church, che era stato corrispondente di guerra durante la Guerra Civile, scrisse una risposta che oggi, più di un secolo dopo, resta l’editoriale più riprodotto nella storia dei giornali anglosassoni.
La lettera di Virginia diceva:
- Caro direttore, ho otto anni. Alcuni dei miei amici dicono che Babbo Natale non esiste. Mio papà mi ha detto: “se lo vedi scritto sul Sun, sarà vero”. La prego di dirmi la verità: esiste Babbo Natale? Virginia O’Hanlon
Il direttore del Sun Edward P. Mitchell passò la lettera della bambina, perché rispondesse, a Church, uno dei veterani del giornale. Leggendola, si dice, sbuffò e sembrò arrabbiarsi perché gli era stato assegnato un compito di così poco conto. Poi, in meno di cinquecento parole e finendo prima della scadenza, Church le rispose così, in un editoriale non firmato:
- Virginia, i tuoi amici si sbagliano. Sono stati contagiati dallo scetticismo tipico di questa era piena di scettici. Non credono a nulla se non a quello che vedono. Credono che niente possa esistere se non è comprensibile alle loro piccole menti. Tutte le menti, Virginia, sia degli uomini che dei bambini, sono piccole. In questo nostro grande universo, l’uomo ha l’intelletto di un semplice insetto, di una formica, se lo paragoniamo al mondo senza confini che lo circonda e se lo misuriamo dall’intelligenza che dimostra nel cercare di afferrare la verità e la conoscenza.
- Sì, Virginia, Babbo Natale esiste. Esiste così come esistono l’amore, la generosità e la devozione, e tu sai che abbondano per dare alla tua vita bellezza e gioia. Cielo, come sarebbe triste il mondo se Babbo Natale non esistesse! Sarebbe triste anche se non esistessero delle Virginie. Non ci sarebbe nessuna fede infantile, né poesia, né romanticismo a rendere sopportabile la nostra esistenza. Non avremmo altra gioia se non quella dei sensi e dalla vista. La luce eterna con cui l’infanzia riempie il mondo si spegnerebbe.
- Non credere in Babbo Natale! È come non credere alle fate! Puoi anche fare chiedere a tuo padre che mandi delle persone a tenere d’occhio tutti i comignoli del mondo per vederlo, ma se anche nessuno lo vedesse venire giù, che cosa avrebbero provato? Nessuno vede Babbo Natale, ma non significa che non esista. Le cose più vere del mondo sono proprio quelle che né i bimbi né i grandi riescono a vedere. Hai mai visto le fate ballare sul prato? Naturalmente no, ma questa non è la prova che non siano veramente lì. Nessuno può concepire o immaginare tutte le meraviglie del mondo che non si possono vedere.
- Puoi rompere a metà il sonaglio dei bebé e vedere da dove viene il suo rumore, ma esiste un velo che ricopre il mondo invisibile che nemmeno l’uomo più forte, nemmeno la forza di tutti gli uomini più forti del mondo, potrebbe strappare. Solo la fede, la poesia, l’amore possono spostare quella tenda e mostrare la bellezza e la meraviglia che nasconde. Ma è tutto vero? Ah, Virginia, in tutto il mondo non esiste nient’altro di più vero e durevole. Nessun Babbo Natale? Grazie a Dio lui è vivo e vivrà per sempre. Anche tra mille anni, Virginia, dieci volte diecimila anni da ora, continuerà a far felici i cuori dei bambini.
La fortuna
La fama di “Yes, Virginia” è sopravvissuta ai suoi creatori. Church morì nel 1906 e Virginia nel 1971, dopo una carriera come maestra di scuola e direttrice a New York. Malgrado l’editoriale fosse pubblicato come settimo nella pagina delle opinioni - dopo ben più seri argomenti come questioni politiche a New York e nel Connecticut, la forza della marina britannica e una ferrovia tra il Canada e lo Yukon, e persino dopo un commento sulla “bicicletta senza catena” appena inventata - lo scambio colpì moltissimi lettori del Sun. Venne ristampato ogni anno, prima di Natale, fino alla chiusura del giornale nel 1950, e ancora oggi viene recitato alla Columbia University di New York (l’università dove studiarono sia Church che Virginia) in una cerimonia prenatalizia ai primi di dicembre. Nel centenario dell’editoriale, nel 1997, il New York Times pubblicò una riflessione sulla fortuna di “Yes, Virginia, There is a Santa Claus” nella cultura americana.
Nel 1932 l’emittente televisiva NBC lo mise in musica, e allo scambio si ispirarono anche un musical di David Kirchenbaum e Myles McDonnel (1996) e diversi cortometraggi e film per la TV statunitense. Dal 2008, la campagna pubblicitaria natalizia dei grandi magazzini statunitensi Macy’s si basa sulla lettera di Virginia e sulla risposta di Church: in uno spot televisivo, personaggi celebri come Jessica Simpson, Donald Trump e Martha Stewart citano frasi dell’editoriale.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- LA LAUREA NELL’EPOCA DELLA SUA RIPRODUCIBILITA’ TECNICA, LA POST-VERITA’ DELLA MINISTRA DELLA ISTRUZIONE, E L’ETICA DELLA RICERCA..23 dicembre 2016, di Federico La Sala
LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE.
La post-verità della Ministra dell’Istruzionedi Roberta De Monticelli (Libertà e Giustizia, 17 dicembre 2016)
E’ vero che “diploma di laurea” non vuole dire “laurea”? E’ vero che scrivere che si possiede un diploma di laurea che non si possiede è soltanto “una leggerezza”? Ed è giusto che proprio una persona che una laurea non ce l’ha sia a capo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, cioè a capo di un’istituzione chiamata a governare e decidere della vita, della fatica, delle speranze e del merito di tutti coloro cui lauree, diplomi, master, dottorati, TFA, abilitazioni e concorsi non bastano a esercitare la professione per cui studiano da decenni?
Ma soprattutto, è giusto che la massima autorità sulla scuola pubblica, sulle regole e le istituzioni che inquadrano la trasmissione e la ricerca del vero, invece di presentare un onesto ancorché modesto curriculum, lo falsifichi? E che nessuno batta ciglio di fronte a un fatto come questo? E’ accettabile che anzi, se qualche isolata voce mormora la sua perplessità, sia lo stesso capo del governo a dichiarare pubblicamente solidarietà al suo ministro, invece di scusarsi con i cittadini e pregare il ministro di dare le dimissioni?
E’ vero, siamo nel Paese europeo che più fatica a restare a livelli di minima decenza quanto al numero di laureati: e allora, è un bene che al vertice del ministero che dovrebbe occuparsi di questa piaga, una delle vere radici del nostro declino, ci sia qualcuno che non solo non supera il livello base delle statistiche, ma pretende di rimediare la verità col trucco, come Lucignolo, come Pinocchio, come un personaggio di Alberto Sordi o di Totò? E’ un buon esempio per i nostri scolari, i nostri studenti, i nostri figli? Saprà rendere ancora più buona la “buona scuola”?
MIUR vale Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. E’ l’acronimo del ministero che, come studiosi, docenti e anche semplicemente genitori, ci riguarda più da vicino. Un acronimo che ritorna negli incubi di quelli di noi che hanno recentemente dovuto collaborare alla modifica dell’offerta formativa della propria Facoltà o all’aggiornamento del proprio cv sulla pagina nazionale, lottando con idiosincrasie elettroniche e burocrazie mentali misteriosamente tenaci nei decenni.
Resta il fatto che questo Ministero governa la vita di una delle grandi “agenzie di verità” che una società democratica ha interesse a mantenere indipendenti dal potere politico. E forse, dal nostro punto di vista almeno, la più importante. Quella che ha come valore di riferimento la conoscenza da trasmettere alle future generazioni e quella da ricercare. L’informazione che circola attraverso l’insieme dei media e delle altre grandi piazze del dibattito pubblico, come i social network, è l’agenzia di verità necessaria al dibattito pubblico, e quindi al secondo pilastro di una democrazia, accanto a quello istituzionale degli organismi di deliberazione e decisione delle politiche. E sappiamo che questa agenzia di verità in Italia non è messa molto bene, secondo certe classifiche il grado di indipendenza dei media relega l’Italia agli ultimi posti fra le nazioni, civili o meno.
I tribunali civili e penali e tutto il macchinario che vi si connette costituiscono l’agenzia di verità che rende possibile l’esercizio della giustizia. E anche qui, coi processi che si trascinano per decenni fino a prescrizione della verità, non siamo messi benissimo. Ma le riforme di quelle due agenzie sono cosa tanto necessaria quanto complicata - non a caso subito caduta dalle agende del governo dimissionario, come di quelli precedenti.
La solidarietà dichiarata a un ministro che non possiede un curriculum onesto e per di più lo difende, invece, è un paradosso gigantesco, almeno quanto quello, moralmente forse ancora più tragico e meno ridicolo, di quel Presidente del CNR recentemente nominato dal precedente ministro, che siccome presiede anche la Commissione per l’Etica della Ricerca, si è per prima cosa scatenato, pur con qualche incertezza grammaticale, contro la Senatrice della Repubblica e scienziata Elena Cattaneo, quando lamentava l’opacità e l’arbitrio nella gestione governativa del progetto Human Technopole: «Guai a chi parla dell’etica superiore di tutti perché questo era Robespierre....il dovere nostro è di fare andare avanti l’Italia. - Mah! Senza pensare a .... a principi etici».
Una bella accoppiata, una bella successione, al Ministero che più di ogni altro incide sull’educazione dei “sovrani di domani”, e quindi sulla qualità di una democrazia. Saremo anche nell’epoca della post-verità: ma quando è troppo, è troppo.
Roberta De Monticelli
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- Come restituire alla politica l’etica perduta? (Stefano Rodotà)18 dicembre 2016, di Federico La Sala
- Costituzione, art. 54 - Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
L’etica perduta della politica
di STEFANO RODOTÀ (la Repubblica, 17 Dicembre 2016)
TRA una politica che fatica a presentarsi in forme accettabili dai cittadini e un populismo che di essa vuole liberarsi, bisogna riaffermare una “moralità” delle regole attinta a quella cultura costituzionale diffusa la cui emersione costituisce una rilevantissima novità.
Mai nella storia della Repubblica vi era stata pari attenzione dei cittadini per la Costituzione, per la sua funzione, per il modo in cui incide sul confronto politico e le dinamiche sociali. I cittadini ne erano stati lontani, non l’avevano sentita come cosa propria. Nell’ultimo periodo, invece, si sono moltiplicate le occasioni in cui proprio il riferimento forte alla Costituzione è stato utilizzato per determinare la prevalenza tra gli interessi in conflitto.
Dobbiamo ricordare che nell’articolo 54 della Costituzione sono scritte le parole “disciplina e onore”, vincolando ad esse il comportamento dei «cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche». I costituenti erano consapevoli del fatto che il ricorso al diritto non consente di economizzare l’etica. Non si affidarono soltanto al rigore delle regole formali, ma alla costruzione di un ambiente civile all’interno del quale potessero essere esercitate le “virtù repubblicane”. Colti e lungimiranti, guardavano alla storia e al futuro. Non avevano solo memoria del fascismo. Rivolgevano lo sguardo ad un passato più lontano, anch’esso inquietante: agli anni del “mostruoso connubio” tra politica e amministrazione denunciato da Silvio Spaventa.
Così la questione “morale” si presenta come vera e ineludibile questione “politica”. Lo aveva messo in evidenza in passato Enrico Berlinguer. L’intransigenza morale può non piacere, ma la sua ripulsa non può divenire la via che conduce a girare la testa di fronte a fatti di corruzione anche gravi. Altrimenti la caduta dell’etica pubblica diviene un potente incentivo al diffondersi dell’illegalità e a una sua legittimazione sociale.
In questi anni il degrado politico e civile è aumentato. È cresciuto il livello della corruzione, in troppi casi la reazione ai comportamenti devianti non è stata adeguata alla loro gravità. Tra i diversi soggetti che istituzionalmente dovrebbero esercitare forme di controllo, questa attività si è venuta concentrando quasi solo nella magistratura. Ma la scelta del ceto politico di legare ad una sentenza definitiva qualsiasi forma di sanzione può produrre due conseguenze negative. Non solo la sanzione si allontana nel tempo, ma rischia di non arrivare mai, perché non tutti comportamenti censurabili politicamente o moralmente costituiscono reato.
Non ci si è accorti dell’ampliamento del ruolo che da ciò derivava per la magistratura, eletta a unico e definitivo “tribunale della politica”. E questo non è un segno di buona salute, perché i sistemi politici riescono a mantenere equilibri democratici solo quando vi è il concorso di tutti i soggetti istituzionali ai quali questi equilibri sono affidati.
È stata dunque la politica stessa ad affidarsi ai giudici come “decisori finali”, azzerando in questo modo per se stessa i vincoli di moralità e di responsabilità propriamente politica. Ma questa constatazione porta ad un interrogativo: come restituire alla politica l’etica perduta?
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- Cattolicesimo, fascismo, nazismo, stalinismo: il sogno del "regno di ‘dio’" in un solo ‘paese’ è finito.17 dicembre 2016, di Federico La Sala
LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. Cattolicesimo, fascismo, nazismo, stalinismo: il sogno del "regno di ‘dio’" in un solo ‘paese’ è finito. *:
Gli 80 anni del papa
Papa Francesco che cammina sulle tracce di Agostino
di EUGENIO SCALFARI (la Repubblica, 17 dicembre 2016)
COMPIE ottant’anni papa Francesco e li porta molto bene, sia fisicamente e sia spiritualmente. Viaggia continuamente nel mondo intero e nelle parrocchie romane. Di Roma è vescovo e questa qualifica la rivendica spesso perché gli consente di definirsi come “primus inter pares” e lui è consapevole di quanto sia utile a quella Chiesa missionaria da lui realizzata.
Personalmente ho avuto la fortuna di diventargli amico ancorché io non sia un credente. Papa Francesco aveva bisogno di un non credente che approvasse la predicazione di quello che lui chiama Gesù Cristo ed io chiamo Gesù di Nazareth figlio di Maria e di Giuseppe della tribù di David, cioè era figlio dell’uomo e non di Dio. Ma su questo modo di considerare Cristo papa Francesco è d’accordo: il Figlio di Dio quando decide di incarnarsi diventa realmente un uomo con tutte le passioni, le debolezze, le virtù d’un uomo. Francesco racconta spesso la settimana della Passione che ha il suo inizio con l’ingresso quasi trionfale di Gesù a Gerusalemme, seguito da molti dei suoi fedeli e naturalmente dei suoi apostoli. Ma a Gerusalemme trova anche quelli che lo temono e lo odiano. Soprattutto la gerarchia ebraica del Tempio che si sente minacciata nei suoi privilegi.
A quell’epoca Israele era sotto la "protezione" dell’impero di Roma e l’imperatore era Tiberio che nulla sapeva di quanto avvenisse in province assai lontane. Papa Francesco ricorda gli ultimi giorni di quella che poi fu chiamata la "Via Crucis", l’ultima cena e poi quel che avvenne nell’orto di Getsemani. Gli apostoli a quella cena erano tredici ma uno di loro, Giuda Iscariota, lo aveva già tradito e quando Gesù cominciò a parlare abbandonò quel tavolo e andò via. Restarono in dodici e fu lì che Gesù condivise il pane e il vino identificandoli con il suo corpo e il suo sangue. Il Signore era già stato battezzato da Giovanni nelle acque del Giordano e battesimo ed eucarestia furono i soli due Sacramenti; gli altri vennero dopo. La natura umana del Cristo si ha nei racconti dei Vangeli, nel Getsemani e poi sulla Croce. Nell’orto, dove sarà poi arrestato dai soldati romani guidati dall’Iscariota, Gesù entra in contatto con il Padre e dice: «Se tu puoi allontana da me questo amaro calice ma se non vuoi lo berrò fino in fondo». Sulla Croce, negli ultimi istanti prima della morte dice: «Padre, perché mi hai abbandonato?». Quindi era un uomo, l’incarnazione era stata reale.
- Scalfari: "Gli 80 anni del mio Papa rivoluzionario"
Papa Francesco è affascinato da questi racconti. Mi sono chiesto e gli ho chiesto il perché del fascino che esercitano su di lui e la risposta è stata che nel mistero trinitario Cristo rappresenta l’amore in tutte le sue manifestazioni. L’amore verso Dio che si trasforma in amore verso il prossimo. «Ama il prossimo tuo come te stesso» è una legittimazione dell’amore all’individuo e alla comunità, in cerchi concentrici: la famiglia, il luogo dove vive e soprattutto la specie cui appartiene.
Francesco indica i poveri, i bisognosi, gli ammalati, i migranti. Francesco sa bene quello che dice la Bibbia: «I ricchi e i potenti debbono passare per la cruna d’un ago per guadagnare il Paradiso». Occorre dunque che i popoli si integrino con gli altri popoli. Si va verso un meticciato universale che sarà un beneficio, avvicinerà i costumi, le religioni. Il Dio unico sarà finalmente una realtà. È questo che Francesco auspica. «È ovvio che sia unico, ma finora non è stato così. Ciascuno ha il suo Dio e questo alimenta il fondamentalismo, le guerre, il terrorismo. Perfino i cristiani si sono differenziati, gli Ortodossi sono diversi dai Luterani, i protestanti si dividono in migliaia di diverse confessioni, gli scismi hanno accresciuto queste divisioni. Del resto noi cattolici siamo stati invasi dal temporalismo, a cominciare dalle Crociate e dalle guerre di religione che hanno insanguinato l’Europa e l’America del Nord e del Sud. Il fenomeno della schiavitù e la tratta degli schiavi, la loro vendita alle aste. Questa è stata la realtà che ha deturpato la storia del mondo».
Quando papa Francesco ha partecipato alla celebrazione di Martin Lutero e della sua Riforma ha colto l’essenza delle tesi luterane: l’identificazione dei fedeli con Dio non ha bisogno dell’intermediazione del clero ma avviene direttamente. Questo ci conduce al Dio unico e assegna al sacerdozio un ruolo secondario. Così avveniva nei primi secoli del cristianesimo, quando i Sacramenti erano direttamente celebrati dai fedeli e i presbiteri facevano soltanto il servizio. Francesco è d’accordo su queste tesi luterane che coincidono con quanto avvenne nei primi secoli.
- Bergoglio racconta Bergoglio: gli 80 anni del Papa
Ma quali sono i Santi che il nostro Papa predilige? Gliel’ho chiesto e lui mi ha risposto così: «Il primo è naturalmente Paolo. È lui ad aver costruito la nostra religione. La Comunità di Gerusalemme guidata da Pietro si definiva ebraico-cristiana, ma Paolo consigliò che bisognava abbandonare l’ebraismo e dedicarsi alla diffusione del cristianesimo tra i Gentili, cioè ai pagani. Pietro lo seguì in questa sua concezione anche se Paolo non aveva mai visto Gesù. Non era un apostolo, eppure si considerò tale e Pietro lo riconobbe. Il secondo è San Giovanni Evangelista, che scrisse il quarto Vangelo, il più bello di tutti. Il terzo è Gregorio, l’esponente della Patristica e della liturgia.
 Il quarto è Agostino, vescovo di Ippona, educato adeguatamente da Ambrogio vescovo di Milano. Agostino parlò della Grazia, che tocca tutte le anime e le predispone al bene compatibilmente con il libero arbitrio. La libertà accresce il valore del bene e condiziona il suo eventuale abbandono.
Il quarto è Agostino, vescovo di Ippona, educato adeguatamente da Ambrogio vescovo di Milano. Agostino parlò della Grazia, che tocca tutte le anime e le predispone al bene compatibilmente con il libero arbitrio. La libertà accresce il valore del bene e condiziona il suo eventuale abbandono.Ebbene, sembrerà che io esageri ma ne sono fermamente convinto: dopo Agostino viene papa Francesco. L’intervallo temporale è enorme, ma la sostanza è quella. L’ho definito, quando l’ho conosciuto, rivoluzionario e profetico ma anche modernissimo.
In uno dei nostri incontri gli chiesi se pensava di convocare un nuovo Concilio e lui rispose: «Un Concilio no: il Vaticano II, avvenuto cinquant’anni fa, ha lasciato una precettistica che in buona parte è stata applicata da Giovanni Paolo II, da Paolo VI e da Benedetto XVI. Ma c’è un punto che non ha fatto passi avanti ed è quello che riguarda il confronto con la modernità. Spetta a me colmare questa lacuna. La Chiesa deve modernizzarsi profondamente nelle sue strutture ed anche nella sua cultura».
Santità - ho obiettato io - la modernità non crede nell’Assoluto. Non esiste la verità assoluta. Lei dovrà dunque confrontarsi con il relativismo. «Infatti. Per me esiste l’Assoluto, la nostra fede ci porta a credere nel Dio trascendente, creatore dell’Universo. Tuttavia ciascuno di noi ha un relativismo personale, i cloni non esistono. Ognuno di noi ha una propria visione dell’Assoluto da questo punto di vista il relativismo c’è e si colloca a fianco della nostra fede».
Buoni ottant’anni, caro Francesco. Continuo a pensare che dopo Agostino viene Lei. È una ricchezza spirituale per tutti, credenti o non credenti che siano.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE:
KANT E SAN PAOLO. COME IL BUON GIUDIZIO ("SECUNDA PETRI") VIENE (E VENNE) RIDOTTO IN STATO DI MINORITA’ DAL GIUDIZIO FALSO E BUGIARDO ("SECUNDA PAULI").
UN NUOVO CONCILIO, SUBITO. 95 TESI? NE BASTA UNA SOLA! Cattolicesimo, fascismo, nazismo, stalinismo: il sogno del "regno di ‘dio’" in un solo ‘paese’ è finito.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- La filosofia del linguaggio usata per leggere la crisi. La moneta sonante delle promesse (di Christian Marazzi)16 dicembre 2016, di Federico La Sala
"Deus caritas est" (2006).
Sul Vaticano, in Piazza san Pietro, il "Logo" del Grande Mercante!!!
Cultura
La moneta sonante delle promesse
Saggi. La filosofia del linguaggio usata per leggere la crisi. Un sentiero di lettura a partire dal rapporto tra la teoria degli atti enunciativi e i prodotti derivati messo a fuoco ne «Scommettere sulle parole» di Arjun Appadurai (Raffaello Cortina). Mentre la natura linguistica del denaro analizzata da Ferruccio Rossi-Landi è vista come una bussola per orientarsi nel capitalismo postfordista
di Christian Marazzi (il manifesto, 15.12.2016)
Ancora non si è insediato alla Casa Bianca e già le parole di Donald Trump su come intende make America great again stanno modificando radicalmente gli equilibri monetari e finanziari globali che in qualche modo si erano venuti normalizzando nel corso degli ultimi anni. Parole enunciate in forma di promessa, come in qualsiasi campagna elettorale, ma parole basate sul nulla che, nel momento stesso in cui Trump ha vinto le elezioni, hanno assunto legittimità e potere, a tal punto da invertire le scelte degli investitori, modificando la grammatica finanziaria che d’ora in poi plasmerà il mondo.
Per rilanciare la crescita economica americana,Trump ha promesso un forte stimolo fiscale con la riduzione delle imposte sugli alti redditi e sul capitale e con l’aumento della spesa pubblica per investimenti infrastrutturali. Queste due misure portano diritti all’aumento dei deficit pubblici e di conseguenza all’aumento dei tassi di interesse. In tale prospettiva, gli investitori si precipitano a vendere i titoli a reddito fisso, in particolare i Buoni del Tesoro, i cui tassi d’interesse, cioè i rendimenti, sono inversamente proporzionali al loro prezzo. E infatti i rendimenti dei bonds, dei titoli obbligazionari americani, inglesi e giapponesi, sono subito aumentati.
IN PROSPETTIVA di una crescita più robusta e di politiche monetarie restrittive, il dollaro si sta rivalutando rispetto a tulle le altre monete, a quelle dei paesi emergenti in particolare. Se così sarà, saranno i settori industriali orientati all’esportazione che verranno penalizzati. La pressione per aumentare le tariffe alle importazioni, promesse da Trump, non mancherà di farsi sentire.
E non è detto che a trarne vantaggio saranno i ceti medi e bassi, dato che il potere d’acquisto dei loro redditi è aumentato in questi anni proprio grazie ai beni low cost importati da paesi come la Cina. Il settore più esposto alla globalizzazione, quello tecnologico, è quello che più rischia dalla rivalutazione del dollaro. I profitti statunitensi realizzati all’estero diminuirebbero, vanificando i vantaggi derivanti dagli sgravi fiscali.
Molti vedono una ripetizione di quel che accadde nel corso dei primi quattro anni di presidenza di Ronald Reagan, dato che allora l’aumento del debito federale e gli alti tassi d’interesse provocarono una tale rivalutazione del dollaro e una tale pressione per erigere barriere tariffarie, che solo il Plaza Accord del 1985 per indebolire il dollaro riuscì a bloccare.
Nell’economia globalizzata di oggi, con le tensioni geopolitiche che l’attraversano, è poco probabile che una rivalutazione del dollaro potrà essere domata con la stipulazione di accordi internazionali. Porterà, piuttosto, all’acuirsi dei conflitti tra la pluralità di aree economiche che in questi decenni si sono consolidate.
IL DENARO torna così ad essere la spia di cambiamenti economici e sociali destinati a durare nel tempo, un campo di battaglia in cui si gioca la possibilità stessa di costruire lotte e resistenze contro gli effetti del ripiegamento sulla sovranità monetaria nazionale. Ma si tratta di un denaro che in questi decenni è mutato nella sua stessa natura, un denaro in cui la dimensione linguistica ha assunto una centralità inedita.
Del divenire linguistico del denaro, del fatto, come ebbe a dire Ben Bernanke, già presidente della Federal Reserve, che «La politica monetaria è per il 98% parole e per il 2% azione», parlano due libri recenti: Gli oracoli della moneta. L’arte della parola nel linguaggio dei banchieri centrali, di Alberto Orioli (il Mulino, pp. 248, euro 16) e Scommettere sulle parole. Il cedimento del linguaggio nell’epoca della finanza, di Arjun Appadurai (Raffaello Cortina Editore, pp. 197, euro 21).
Per Orioli, nelle politiche monetarie degli ultimi due decenni gli «atti di parole», gli speech acts, riflettono un cambiamento radicale nella gestione delle informazioni, il fatto che la parola è ormai diventata azione. Quando denaro e linguaggio coincidono si ha a che fare con la teoria degli enunciati performativi del filosofo del linguaggio John Austin, di cui il titolo dell’opera fondamentale, Fare cose con le parole, è di per sé alquanto significativo. Si tratta di enunciati in cui il solo dire qualcosa rende vero questo qualcosa. Esemplare a questo proposito è il whatever it takes, quel «qualunque cosa necessaria» pronunciato da Mario Draghi nel 2012 per rassicurare i mercati finanziari e, come di fatto accadde, salvare l’Euro dal tracollo.
PIÙ IN GENERALE, con le politiche di quantitative easing e, prima ancora, di forward guidance, le Banche centrali dichiarano quel che si farà e si continuerà a fare, aggiustando in corso d’opera la durata e l’entità delle politiche di emissione monetaria per stimolare la domanda aggregata e la crescita in generale, come sta facendo in questi giorni la Bce. Col rischio, come nel caso della trappola della liquidità quando si inceppano i meccanismi di trasmissione della politica monetaria, che si incorra nell’altra trappola, quella verbale. La qual cosa è pericolosa, perché le spalle dei banchieri centrali «possono sopportare solo ciò che la fiducia concede alle loro parole».
ANCHE APPADURAI - figura intellettuale rilevante nel campo dei postcolonial studies e autore dei rilevanti Modernità in polvere e Il futuro come fatto culturale, entrambi riproposta da Raffello Cortina - parte dal ruolo nuovo che il linguaggio ha assunto nei mercati monetari e finanziari. La sua analisi si concentra però sui prodotti derivati: «Un prodotto derivato si può definire come un asset il cui valore dipende da quello di un altro asset sottostante, il quale può essere a sua volta un prodotto derivato. In questa catena di collaterali che la finanza dei nostri giorni ha prolungato all’infinito un prodotto derivato finisce per costituire fondamentalmente un fenomeno di tipo linguistico».
La catena degli scambi di questi prodotti finanziari, e i contratti che sulla loro base vengono stipulati, si basano sulla promessa relativa a valori futuri fondamentalmente ignoti. E’ così che «La dispersione e disseminazione all’infinito delle promesse, unita alla monetizzazione dell’intera serie, ha indotto una clamorosa incongruenza tra l’idea e la realtà del sistema di compravendita di derivati». Da cui la tesi di Appadurai: il crollo finanziario del 2007-2008, a partire dall’esplosione dei derivati legati all’evoluzione del mercato immobiliare statunitense, va inteso in primo luogo come un «crollo linguistico».
BENCHÉ SUGGESTIVA, l’interpretazione della natura linguistica del denaro e dello sviluppo dei prodotti derivati lascia in ombra il fatto che, all’origine degli atti di parole monetari, risiede in primo luogo la svolta linguistica del lavoro, il fatto che nel capitalismo postfordista si lavora comunicando, si producono merci a mezzo di linguaggio. Il denaro è, in altre parole, forma del valore di merci linguisticamente prodotte.
L’insegnamento di Ferruccio Rossi-Landi, oggi riproposto con la pubblicazione di Linguistica ed economia (Mimesis, Milano-Udine), andrebbe tenuto presente per cogliere appieno le implicazioni della crisi monetaria e finanziaria odierna.
Con una precisazione, e cioè che le merci e le parole sono sì entrambi artefatti secondo la teoria del valore-lavoro, come dimostrato da Rossi-Landi, ma non sono ormai più distinguibili in due sfere separate, quella della produzione e quella della circolazione.
La crisi linguistica e monetaria rimandano ad una nuova fase dello scontro sociale in cui ogni promessa non mantenuta sarà pagata cara.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- COSTITUZIONE E REFERENDUM DI IERI (2006) E DI OGGI (2016). Una lezione attuale (Settis): stare sempre in guardia (Smuraglia).7 dicembre 2016, di Federico La Sala
- DONNE E UOMINI, CITTADINE E CITTADINI. Per un ri-orientamento antropologico e teologico-politico ....
- 25 Giugno 2006: salviamo la Costituzione e la Repubblica che è in noi
- UNITÀ D’ITALIA E FOLLIA: EMERGENZA LOGICO-POLITICA EPOCALE. PER UN CONVEGNO E UNA RIFLESSIONE SUL CONCETTO DI ’UNITA’ E DI SOVRANITÀ (SOVRA-UNITÀ). Materiali sul tema
- IL SONNO MORTIFERO DELL’ITALIA. In Parlamento (ancora!) il Partito al di sopra di tutti i partiti.
Una lezione attualeIl confronto con l’esito del referendum costituzionale del 2006
di Salvatore Settis (la Repubblica, 07.12.2016)
IL DATO più rilevante nei risultati del 4 dicembre emerge dal confronto con l’esito del referendum costituzionale del 2006. In ambo i casi il voto popolare ha respinto una riforma costituzionale assai invasiva (54 articoli modificati nel 2006, 47 nel 2016), approvata a maggioranza semplice da una coalizione di governo che ostentava sicurezza per bocca di un premier (allora Berlusconi, ora Renzi) in cerca di un’investitura plebiscitaria.
Le due riforme abortite non sono identiche, ma vicine in aspetti cruciali (la fiducia riservata alla sola Camera e il nebbioso ruolo del Senato). Se guardiamo ai numeri, il confronto è impressionante: nel 2006 i No furono il 61,29%, nel 2016 il 59,25; quanto ai Sì, si passa dal 38,71% (2006) al 40,05 (2016). Un rapporto di forze simile, che diventa più significativo se pensiamo che l’affluenza 2016 (68,48%) è molto superiore a quella del 2006 (52,46%): allora votarono 26 milioni di elettori, oggi ben 32 milioni, in controtendenza rispetto al crescente astensionismo delle Europee 2014 e delle Regionali dello stesso anno.
Eppure, dal 2006 ad oggi il paesaggio politico è completamente cambiato, per l’ascesa dei 5Stelle, la frammentazione della destra berlusconiana, le fratture di quella che fu la sinistra. Più affluenza oggi di dieci anni fa, un cambio di generazioni, con milioni di giovani che votavano per la prima volta a un referendum costituzionale: eppure, nonostante i mutamenti di scenario, un risultato sostanzialmente identico, con un No intorno al 60%.
Una notevole prova di stabilità di quel “partito della Costituzione” che rifiuta modifiche così estese e confuse. Esso è per sua natura un “partito” trasversale, come lo fu la maggioranza che varò la Costituzione, e che andava da Croce a De Gasperi, Nenni, Calamandrei, Togliatti. Il messaggio per i professionisti della politica è chiaro: non si possono, non si devono fare mai più riforme così estese e con il piccolo margine di una maggioranza di parte.
Nel 2006 e nel 2016, due governi diversissimi hanno cercato di ripetere il discutibile “miracolo” del referendum 2001, quando la riforma del Titolo V (17 articoli) fu approvata con il 64% di Sì contro un No al 36%: ma allora l’affluenza si era fermata al 34% (16 milioni di elettori). Si è visto in seguito che quella riforma, varata dalle Camere con esiguo margine, era mal fatta; e si è capito che astenersi in un referendum costituzionale vuol dire rinunciare alla sovranità popolare, principio supremo dell’articolo 1 della Costituzione.
Per evitare il ripetersi (sarebbe la terza volta) di ogni tentativo di forzare la mano cambiando la Costituzione con esigue maggioranze, la miglior medicina è tornare a un disegno di riforma costituzionale (nr. 2115), firmato nel 1995 da Sergio Mattarella, Giorgio Napolitano, Leopoldo Elia, Franco Bassanini. Esso prevedeva di modificare l’art. 138 Cost. nel senso che ogni riforma della Costituzione debba sempre essere «approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti», e ciò senza rinunciare alla possibilità di ricorrere al referendum popolare.
Questo l’art. 4; ma anche gli altri di quella proposta troppo frettolosamente archiviata sarebbero da rilanciare. L’art. 2 prevedeva che la maggioranza necessaria per eleggere il Presidente della Repubblica debba sempre essere dei due terzi dell’assemblea (l’opposto della defunta proposta Renzi-Boschi, che avrebbe reso possibile l’elezione da parte dei tre quinti dei votanti, senza computare assenti e astenuti); e che qualora l’assemblea non riesca ad eleggere il Capo dello Stato «le funzioni di Presidente della Repubblica sono provvisoriamente assunte dal Presidente della Corte Costituzionale». L’art. 3, prevedendo situazioni di stallo nell’elezione da parte del Parlamento dei membri della Consulta di sua spettanza, prevedeva che dopo tre mesi dalla cessazione di un giudice, se il Parlamento non riesce a eleggere il successore «vi provvede la Corte Costituzionale stessa, a maggioranza assoluta dei suoi componenti». Previsione lungimirante: è fresco il ricordo del lungo stallo delle nomine alla Corte, finché nel dicembre 2015 si riuscì a nominare tre giudici dopo ben 30 tentativi falliti.
In quelle proposte, come si vede, la Corte Costituzionale aveva un ruolo centrale, e il rafforzamento delle istituzioni passava attraverso un innalzamento delle maggioranze necessarie per passaggi istituzionali cruciali, come le riforme costituzionali o l’elezione del Capo dello Stato. In un momento di incertezza come quello che attraversiamo, quella lezione dovrebbe tornare di attualità, anche se molti firmatari di quella legge sembrano essersene dimenticati.
La riforma Renzi-Boschi è stata bocciata, ma fra le sue pesanti eredità resta una cattiva legge elettorale, l’Italicum, che la Consulta potrebbe condannare tra poche settimane, e che comunque vale solo per la Camera. Compito urgente del nuovo governo, chiunque lo presieda, sarà dunque produrre al più presto una legge elettorale finalmente decorosa, e compatibile (si spera) con riforme costituzionali come quelle sopra citate. Le prossime elezioni politiche, anticipate o no, dovranno portare alle Camere deputati e senatori liberamente eletti dai cittadini e non nominati nel retrobottega dei partiti.
Il referendum da cui veniamo è stato un grande banco di prova per la democrazia: ma ora è il momento di mostrare, per i cittadini del No e per quelli del Sì, che sappiamo essere “popolo” senza essere “populisti”. Che per la maggioranza degli italiani la definizione di “popolo”, della sua sovranità e dei suoi (dei nostri) diritti coincide con quella della Costituzione, la sola che abbiamo. Il “ritorno alla Costituzione” che ha segnato i mesi scorsi e che ha portato all’esito del referendum mostra che è possibile.
Smuraglia: è un No per attuare la Costituzione
"Al referendum non hanno vinto i partiti", dice il presidente dell’Anpi. "Leggere la vittoria referendaria del 4 dicembre solo sul terreno del confronto politico è un modo per ridimensionare il risultato popolare"
intervista di Andrea Fabozzi (il manifesto, 7.12.2016)
Carlo Smuraglia, presidente dell’Associazione nazionale partigiani, si aspettava questo successo del No?
Onestamente no. Immaginavo il paese spaccato a metà e speravo in una vittoria con il minimo distacco. Avevo indicazioni molto positive dalle nostre manifestazioni, in particolare l’ultima a Roma al teatro Brancaccio. Ma l’esperienza mi insegna a non fidarmi di quello che si vede nelle piazze e nei teatri, perché è la gente silenziosa che decide il risultato. E c’era da temere la propaganda del governo, le promesse, le proposte e le minacce del presidente del Consiglio, la complicità della stampa con il Sì...
E invece.
Mi ha sorpreso felicemente la grande partecipazione. Avevamo captato questo desiderio di capire e di partecipare, ma forse l’abbiamo persino sottovalutato. Evidentemente i cittadini che si sono informati sulla riforma, l’hanno compresa bene e giudicata male, sono stati la maggioranza. Anche se questa parte ragionata del No, adesso, mi pare messa del tutto tra parentesi, rimossa.
Non le piace come viene raccontata la vittoria del No?
Mi sorprende che tra le tante ragioni della sconfitta del Sì, la più elementare - e cioè che la riforma è stata bocciata nel merito - sia finita nell’ombra. Tutte le analisi sono sul terreno politico, tornano a farsi sentire come vincitori partiti che in campagna elettorale avevamo visto poco. Io credo che leggere il 4 dicembre esclusivamente sul terreno del confronto tra partiti sia un modo per ridimensionare lo straordinario risultato popolare.
Lei invece ci legge il segnale di una speranza? Si può ricominciare a parlare di attuazione della Costituzione?
Noi ne parliamo da sempre e lo abbiamo fatto anche in questa campagna elettorale. Alla fine dei miei incontri c’era sempre chi mi chiedeva “ma se vince il No cosa facciamo?”. E io rispondevo “Prima brindiamo, poi diciamo che invece di cambiarla la Costituzione bisogna attuarla”. A quel punto arrivava l’applauso più forte. Perché tutti vedono l’enorme contrasto che c’è tra i principi fondamentali della Carta e la realtà. Non voglio illudermi, ma credo che dentro questo 60% di No ci sia anche questa richiesta di attuazione.
Insieme a un voto contro il governo, non le pare?
Non per quanto ci ha riguardato. L’ho detto anche a Renzi nel nostro confronto di settembre a Bologna. Non ci è mai interessata la sorte del governo, volevamo solo difendere la Costituzione da uno strappo. Mi pare che lei non sia rimasto contento del modo in cui è stato raccontato quel confronto alla festa dell’Unità. Non sono rimasto contento che sia stato oscurato. Evidentemente non si era concluso come giornali e tv si auguravano, con la vittoria di Renzi.
Secondo lei, adesso, come si viene fuori dalle dimissioni del presidente del Consiglio?
La richiesta di votare presto mi pare infondata. Mancano molti presupposti, innanzitutto la legge elettorale: ne abbiamo due diverse per camera e senato e la prima è attesa al giudizio della Consulta. In più tutti i partiti dicono di volerla cambiare. La corsa alle urne è ingiustificata, il presidente della Repubblica, anche di fronte alle dimissioni di Renzi, ha molti strumenti prima di accettare le elezioni anticipate, provvederà con saggezza.
Questo No mette fine ai tentativi di riscrivere la Costituzione, almeno per un po’?
La Costituzione non è mai messa sufficientemente al riparo e bisogna stare sempre in guardia. Ma un No di questa entità ha anche un valore di ammonimento molto forte, si è capito che la Costituzione non è una legge ordinaria e non si può modificarla a cuor leggero, ma solo quando ce n’è effettivamente bisogno. E con il massimo di consenso.
In campagna elettorale si è parlato molto delle divisioni dell’Anpi. Vicenda chiusa? Lascerà qualche segno tra voi?
I segni sono stati più esterni che interni. Ogni piccola cosa è stata ingigantita e presa per buona, noi non abbiamo mai allontanato né sanzionato nessuno. Abbiamo solo chiesto ai nostri iscritti di non fare campagna per il Sì nel nome dell’Anpi, visto che la nostra posizione era opposta. La verità è che ha dato molto fastidio che l’Anpi si fosse schierata per il No. La nostra associazione è portatrice di valori in cui tutti devono riconoscersi, e dunque a molti abbiamo fatto fare almeno un pensierino.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- COSTITUZIONE E REFERENDUM: ZAGREBELSKY, SCALFARI, E LA NOSTRA SOVRANITA’.3 dicembre 2016, di Federico La Sala
- IL SONNO MORTIFERO DELL’ITALIA. In Parlamento (ancora!) il Partito al di sopra di tutti i partiti.
- SE VADO A CASA DI ZAGREBELSKY E ... COMINCIO A FARE IL MIO COMODO DICENDO DI ESSERE DEL PARTITO "FORZA ZAGREBELSKY", CHE COSA HO FATTO E CHE COSA SONO?! L’ITALIA NON S’E’ DESTATA ED E’ STATA UCCISA!!!
Caro Scalfari, con il Sì passa un’espropriazione di sovranità
di Gustavo Zagrebelsky *
Caro Eugenio Scalfari, ieri mi hai chiamato in causa due volte a proposito del mio orientamento pro-No sul referendum prossimo venturo e, la seconda volta, invitandomi a ripensarci e a passare dalla parte del Sì. La "pessima compagnia", in cui tu dici ch’io mi trovo, dovrebbe indurmi a farlo, anche se, aggiungi, sai che non lo farò. Non dici: "non so se lo farà", ma "so che non lo farà", con il che sottintendi di avere a che fare con uno dalla dura cervice.
I discorsi "sul merito" della riforma, negli ultimi giorni, hanno lasciato il posto a quelli sulla "pessima compagnia". Il merito della riforma, anche a molti di coloro che diconono di votare Sì, ultimo Romano Prodi, appare alquanto disgustoso. Sarebbero piuttosto i cattivi compagni l’argomento principale, argomento che ciascuno dei due fronti ritiene di avere buoni motivi per ritorcere contro l’altro.
Un topos machiavellico è che in politica il fine giustifica i mezzi, cioè che per un buon proposito si può stare anche dalla stessa parte del diavolo. Non è questo. Quel che a me pare è che l’argomento della cattiva compagnia avrebbe valore solo se si credesse che i due schieramenti referendari debbano essere la prefigurazione d’una futura formula di governo del nostro Paese. Non è così. La Costituzione è una cosa, la politica d’ogni giorno un’altra. Si può concordare costituzionalmente e poi confliggere politicamente. Se un larghissimo schieramento di forze politiche eterogenee concorda sulla Costituzione, come avvenne nel ’46-’47, è buona cosa. La lotta politica, poi, è altra cosa e la Costituzione così largamente condivisa alla sua origine valse ad addomesticarla, cioè per l’appunto a costituzionalizzarla. In breve: l’argomento delle cattive compagnie, quale che sia la parte che lo usa, si basa sull’equivoco di confondere la Costituzione con la politica d’ogni giorno.
Vengo, caro Scalfari, a quella che tu vedi come un’ostinazione. Mi aiuta il riferimento che tu stesso fai a Ventotene e al suo "Manifesto", così spesso celebrati a parole e perfino strumentalizzati, come in quella recente grottesca rappresentazione dei tre capi di governo sulla tolda della nave da guerra al largo dell’isola che si scambiano vuote parole e inutili abbracci, lo scorso 22 agosto. C’è nella nostra Costituzione, nella sua prima parte che tutti omaggiano e dicono di non voler toccare, un articolo che, forse, tra tutti è il più ignorato ed è uno dei più importanti, l’articolo 11. Dice che l’Italia consente limitazioni alla propria sovranità quando - solo quando - siano necessarie ad assicurare la pace e la giustizia tra le Nazioni. Lo spirito di Ventotene soffia in queste parole. Guardiamo che cosa è successo. Ci pare che pace e giustizia siano i caratteri del nostro tempo? Io vedo il contrario. Per promuovere l’una e l’altra occorre la politica, e a me pare di vedere che la rete dei condizionamenti in cui anche l’Italia è caduta impedisce proprio questo, a vantaggio d’interessi finanziario-speculativi che tutto hanno in mente, meno che la pace e la giustizia. Guardo certi sostegni alla riforma che provengono da soggetti che non sanno nemmeno che cosa sia il bicameralismo perfetto, il senato delle autonomie, la legislazione a data certa, ecc. eppure si sbracciano a favore della "stabilità". Che cosa significhi stabilità, lo vediamo tutti i giorni: perdurante conformità alle loro aspettative, a pena delle "destabilizzazioni" - chiamiamoli ricatti - che proprio da loro provengono.
Proprio questo è il punto essenziale, al di là del pessimo tessuto normativo che ci viene proposto che, per me, sarebbe di per sé più che sufficiente per votare No. La posta in gioco è grande, molto più grande dei 47 articoli da modificare, e ciò spiega l’enorme, altrimenti sproporzionato spiegamento propagandistico messo in campo da mesi da parte dei fautori del Sì. L’alternativa, per me, è tra subire un’imposizione e un’espropriazione di sovranità a favore d’un governo che ne uscirebbe come il pulcino sotto le ali della chioccia, e affermare l’autonomia del nostro Paese, non per contestare l’apertura all’Europa e alle altre forme di cooperazione internazionale, ma al contrario per ricominciare con le nostre forze, secondo lo spirito della Costituzione. Si dirà: ma ciò esigerebbe una politica conforme e la politica ha bisogno di forze politiche. E dove sono? Sono da costruire, lo ammetto. Ma il No al referendum aprirà una sfida e in ogni sfida c’è un rischio; ma il Sì non l’aprirà nemmeno. Consoliderà soltanto uno stato di subalternità.
Questa, in sintesi, è la ragione per cui io preferisco il No al Sì e perché considero il No innovativo e il Sì conservativo.
Ti ringrazio dell’attenzione. A cose fatte avremo tempo e modo
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- POTERE E INFORMAZIONE. Silenziata la manifestazione contro la violenza sulle donne: una brutta pagina dell’informazione.29 novembre 2016, di Federico La Sala
- UNA CATTOLICA, UNIVERSALE, ALLEANZA "EDIPICA"!!! IL MAGGIORASCATO: L’ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE, L’ALLEANZA DELLA MADRE CON IL FIGLIO, REGNA ANCORA COME IN TERRA COSI’ IN CIELO
- COSTANTINO, SANT’ELENA, E NAPOLEONE. L’immaginario del cattolicesimo romano.
- L’EREDE: IL PESO DEI PADRI (ATEI E DEVOTI). UN’EREDITA’ ANCORA PENSATA ALL’OMBRA DELL’"UOMO SUPREMO" E DEL "MAGGIORASCATO".
Silenziata la manifestazione contro la violenza sulle donne: una brutta pagina dell’informazione
di Elisabetta Addis *
Sabato 26 novembre, un corteo allegro, ironico, di popolo, guidato dalle donne e formato da uomini e donne di tutte le età, ha sfilato per le vie di Roma per dire basta alla violenza di genere. Tra le centomila e le duecentomila persone. Chiedevano un cambiamento di prospettiva e di cultura, chiedevano politiche attive, e quindi denaro pubblico per creare reti di assistenza, educazione dei giovani e delle giovani al problema, strumenti giuridici nuovi e adeguati.
Una manifestazione che riempie Via Cavour dalla Stazione Termini ai Fori Imperiali, senza staccare vetrine e senza bruciare cassonetti, che non ha dietro nessuno sponsor, totalmente autofinanziata, in grado di fare proposte politiche, di interloquire con i governi e le autorità, non si improvvisa. È il frutto del lavoro che migliaia di persone in maggior parte donne hanno fatto negli ultimi anni in tutta Italia.
Lavoro in particolare sul femminicidio e sulla violenza di genere, e più in generale sui temi della eguaglianza di diritti e di risorse tra le persone dei due sessi. La violenza nasce anche dalla persistente svalorizzazione delle donne, dalla loro mancanza di reddito e risorse, di politiche sociali adeguate e di reti di sostegno.
Questa è la dimostrazione di una crescita politica sana, non corrotta, non chiusa nei palazzi, non solo parolaia, non gridata ma presente nel quotidiano. Una cosa, insomma, molto importante.
Bene. Peccato che per i principali media questa manifestazione non c’è stata. Come dice il comunicato firmato da Non Una di Meno e dalle altre organizzazioni che avevano indetto la manifestazione, "il TgUno, che appena il 25 novembre condannava la violenza sulle donne, ieri sera ha intervistato solo la Ministra Boschi e poi, come per caso, è stata data la notizia che migliaia di donne avevano sfilato a Roma per dire no alla violenza. RaiDue ha mostrato un papà con un bambino sullo sfondo del Colosseo e della manifestazione, sembrava una festa per famiglie. La7 non si è accorta di niente".
E là dove se ne è parlato, se ne è parlato dopo la morte di Castro, dopo il maltempo, dopo la giornata della raccolta alimentare, e soprattutto, dopo aver parlato molto più a lungo della manifestazione per il no, che ha raccolto un centesimo delle persone, ma aveva alla testa un comico rabbioso, e di un altro evento molto meno frequentato sul si al referendum, tenutosi sempre nella capitale.
Perché evidentemente sarebbe una gran notizia che a una settimana dal referendum tutte e due le parti facciano eventi. Ma le donne in piazza no, anche nel servizio pubblico, non sono notizia. Sono velate, nascoste, sono invisibili, sono ascose, non sono importanti, non rilevano, ah già che vuoi che facciano le donne? Per tutto il giorno precedente abbiamo detto che, a una a una, si fanno massacrare, bruciare, attaccare con l’acido, picchiare, stuprare, che il loro destino da grandi è di finire all’ospedale picchiate dal marito.
Come facciamo ora a descriverle insieme, forti organizzate, allegre, ironiche, coi loro figli e coi loro compagni, con una loro azione e un loro pensiero politico?
È anche per via di un sistema informativo che non sa fare il suo mestiere, che blandisce i potenti di turno e i loro eventi e non informa sulla realtà, che ci ritrova poi con le élites politiche incapaci di capire quel che succede veramente nelle teste e nei cuori della gente, e con la gente che crede che la politica sia solo teatrino di palazzo. Questa è una pagina vergognosa del servizio pubblico e dell’informazione italiana, i responsabili se ne dovrebbero almeno scusare.
* Elisabetta Addis
 Economista, di Se Non Ora Quando
Economista, di Se Non Ora Quando -
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ?! --- REFERENDUM. Siamo in trappola. Cosa possiamo fare? L’inimicizia tra sconfitti (e lo siamo tutti, in ogni caso) è la peggiore delle cretinate.29 novembre 2016, di Federico La Sala
- COSTITUZIONE, EVANGELO, e NOTTE DELLA REPUBBLICA (1994-2016): PERDERE LA COSCIENZA DELLA LINGUA ("LOGOS") COSTITUZIONALE ED EVANGELICA GENERA MOSTRI ATEI E DEVOTI ...
- COSTITUZIONE E PENSIERO. ITALIA: LA MISERIA DELLA FILOSOFIA ITALIANA E LA RICCHEZZA DEL MENTITORE ISTITUZIONALIZZATO ...
Siamo in trappola. Cosa possiamo fare?
di Franco Berardi Bifo*
Non so a voi ma a me questo referendum mi dà un po’ di angoscia senza esagerare, intendiamoci. La vita mi sorride abbastanza, ma un po’ di angoscia questo referendum me la dà. Le ragioni sono molteplici e cerco di raccontar(me)le. I miei amici litigano fra loro astiosamente, si arriva al punto che qualcuno cancella da Facebook quelli che votano sì, o quelli che votano no. Potrei anche sopportarlo, se si trattasse di una disputa che davvero ci riguarda. Che ne so, se qualcuno votasse a favore del licenziamento degli operai dissenzienti di Pomigliano, se qualcuno votasse a favore della guerra di George Bush e Dick Cheney, beh allora d’accordo, io con un tipo così non ci voglio aver nulla a che fare, che vada a farsi fottere.
Ma qui mi pare che siamo tanto rissosi per la semplice ragione che siamo insicuri, non crediamo davvero a questo referendum a questo sì e a questo no, perciò alziamo tanto la voce, e ci ripetiamo che la costituzione non si tocca oppure che bisogna toccarla eccome.
Chi (come me) vota No non può non sapere che sta votando come Gianfranco Fini, e che se il No è maggioritario si va presto a nuove elezioni in un clima drammatico di collasso finanziario in cui vincitori probabili saranno razzisti ininterrotti come Salvini o razzisti a giorni alterni come Grillo. Chi vota Si non può non sapere che sta rafforzando il potere di un ammiratore di Tony Blair, criminale di guerra, e sta rafforzando il governo del voucher, non può non sapere che una riforma della costituzione non dovrebbe assolutamente essere varata da un governo che non è stato eletto da nessuno, e non può essere imposta alla metà del corpo elettorale.
Chi vota sì non può non sapere che una riforma costituzionale di questo genere spacca per sempre il paese, senza speranza di tornare indietro.
Il fatto è che questo referendum è una trappola costruita da un furbetto che era convinto di stravincere e avere poi tutto il potere con cui asfaltare del tutto i diritti dei lavoratori. Ma siccome il furbetto non è poi così intelligente come fa finta di essere ha fatto male i conti e a un certo punto si è reso conto che non siamo tutti come Letta a cui si può dire “Enrico stai sereno” che ti frego il posto appena ti volti. Una buona parte della popolazione ha deciso di non aspettare serenamente, e di votare no.
I contenuti di questa riforma sono risibili dal punto di vista specificamente costituzionale: nessuno può pensare davvero che il bicameralismo è il problema principale di un paese in cui gli studenti che vogliono studiare vanno all’estero, nessuno può credere che il risparmio di qualche spicciolo per i senatori sarà decisivo per le sorti economiche di un paese che ha perduto un quarto del sistema industriale negli ultimi dieci anni a causa del Fiscal compact e del debito che più lo paghi e più cresce. Questa riforma costituzionale miserella serviva nelle intenzioni del furbetto a sbaragliare ogni opposizione alla riforma vera, che è la riforma interminabile del mercato del lavoro, la privatizzazione infinita l’impoverimento illimitato della società (su questo tema vale la pena rileggere Come pensa la classe dominante di Raúl Zibechi, ndr).
Purtroppo il referendum è una trappola che scatterà in ogni caso. Se vince il sì la società è sbaragliata, e Marchionne ha vinto per sempre. Se vince il No si spalanca un abisso di instabilità finanziaria e politica. Ma se ci penso meglio poi mi rendo conto del fatto che se invece vince il sì l’abisso è solo rimandato di qualche mese, e in qualche mese lo spostamento a destra dell’elettorato è destinato ad accentuarsi.
È meglio saperlo, è meglio dirlo, invece di alzare la voce e cancellare gli amici. Siamo in una trappola, e la sola cosa che possiamo fare è impedire la (provvisoria) stabilizzazione del governo di un tizio che ammira il criminale di guerra Tony Blair e lo schiavista Marchionne.
Siamo in una trappola, e la sola cosa che possiamo fare è prepararci in ogni caso al peggio, e lavorare a un lungo periodo di ricostruzione della prospettiva europeista e anti-finanzista.
Siamo in una trappola, e la sola cosa che possiamo fare è non comportarci come i polli di Renzo Tramaglino, evitare di rompere amicizie in nome di una sconfitta in ogni caso assicurata.
L’inimicizia tra sconfitti (e lo siamo tutti, in ogni caso) è la peggiore delle cretinate.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! - REFERENDUM: LA "MONARCHIA" DI DANTE, LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA, E "I DUE CORPI DEL RE".18 novembre 2016, di Federico La Sala
LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E I DUE CORPI (E LE "DUE SEDIE") DEL RE *
- A "CHE TEMPO CHE FA", COSI’ PARLO’ IL PRIMO AMMINISTRATORE DEL NOSTRO PAESE: "POTERE è UN VERBO, NON UN SOSTANTIVO!".
- C’E’ TRONO E TRONO (http://www.fondazioneterradotranto.it/2016/11/17/sedere-e-potere/): IL PROF. ARMANDO POLITO HA BEN FATTO A RICHIAMARE L’ATTENZIONE DI TUTTE E DI TUTTI SULLA FRASE E SUL TEMA - ONORE A LUI.
!Il significato profondo del messaggio porta a galla (è il caso di dire) il PODERE, la Proprietà, la Poltrona! E dà un significato beffardo alla frase di Michel E. de Montaigne: "Anche sul trono più elevato del mondo, si è pur sempre seduti sul proprio sedere"!!! Con tutta la sua boria, il PADRONE (di sempre e di turno) così dichiara *Urbi et orbi*: La Poltrona è mia, e guai a chi la tocca (sul tema, cfr.: http://www.lavocedifiore.org/SPIP/breve.php3?id_breve=697)!!!
MONARCHIA DEL PENSIERO UNICO: "FORZA ITALIA" (http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=3515). Solo al PADRONE è possibile l’uso delle "DUE SEDIE", la salita (dalle stalle alle stelle) e la discesa (dalle stelle alle stalle). Per tutti gli altri e per tutte le altre, alla luce della grammatica del PODERE, ogni META-FORA è vietata, e SEDERE vale solo come sostantivo!!!
COSTITUZIONE E MONARCHIA DEI "DUE SOLI". A ben vedere e a ben leggere DANTE con la sua teoria dei "DUE SOLI" non a caso fu giudicato eretico: aveva lanciato il programma delle "due sedie" per tutti e per tutte, e non per uno SOLO!!!
Dopo 700 ANNI e più, non solo non abbiamo ancora capito il messaggio di Dante (e la lezione di Kantorowicz, "I due corpi del re": http://www.lavocedifiore.org/SPIP/forum.php3?id_article=5726&id_forum=2635841), ma nemmeno quello della nostra "sana e robusta" COSTITUZIONE (cfr.: http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=3811), e ci lasciamo prendere per i fondelli, allegramente: "Forza Italia" ( cfr.: http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=4282). La misura non è ancora colma?!
*
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI OGGI?! - EUROPA. "È tempo di mobilitarsi per fermare i populisti". Appello degli intellettuali.19 novembre 2016, di Federico La Sala
Appello degli intellettuali per salvare l’Europa: "È tempo di mobilitarsi per fermare i populisti" *
Politici, uomini d’arte e cultura creano una piattaforma per far sentire la voce dei cittadini nella Ue e prevenire le derive nazionaliste
- I PROMOTORI DELL’APPELLO: GUILLAUME KLOSSA, SANDRO GOZI, DANIEL COHN-BENDIT, FELIPE GONZALEZ, ROBERT MENASSE, ROBERTO SAVIANO, DAVID VAN REYBROUCK, GUY VERHOFSTADT, WIM WENDERS
Come la Brexit, la vittoria di Donald Trump ancora una volta ci ha colto di sorpresa. Eravamo per lo più convinti che un approccio ragionevole al dibattito politico avrebbe prevalso su un discorso populista.
Le radici della Brexit e della vittoria di Trump sono in gran parte le stesse: aumento delle disuguaglianze, ascensore sociale bloccato, paura della perdita di identità moltiplicata per la paura dell’immigrazione di massa, abbandono della questione sociale, sistema educativo e culturale carente, diffidenza verso élite ossessionate per i propri interessi personali e verso istituzioni pubbliche percepite come costose e inefficaci.
In entrambi i casi, le conseguenze per gli europei e per il mondo sono rilevanti.
Al rischio di disgregazione dell’Unione Europea, causato dalla Brexit, si aggiunge quello di un allontanamento progressivo tra gli Stati Uniti e l’Unione Europea e della fine del mondo costruito nel dopoguerra, basato sul multilateralismo e sulla leadership benevola degli Stati Uniti. Il presidente americano eletto è stato chiaro: gli europei devono occuparsi di più della propria sicurezza, politicamente e finanziariamente. Le sue parole non fanno che accelerare una dinamica in atto sin dalla caduta del Muro di Berlino, 27 anni fa.
Questi eventi non possono che galvanizzare i populisti del Vecchio continente, in vista degli appuntamenti elettorali o degli importanti referendum che si terranno nei prossimi mesi in Austria, Italia, Paesi Bassi, Francia e Germania. Ovunque, i partiti moderati sono minacciati.
È dunque urgente agire.
Se noi europei non impariamo rapidamente la lezione che viene da questi eventi, il crollo dell’Unione e la marginalizzazione dei nostri interessi e dei nostri valori in un mondo in cui presto non rappresenteremo più del 5% della popolazione (e dove nessuno Stato europeo farà più parte del G7) diventeranno sempre più probabili.
Non avremo più i mezzi per essere ascoltati, né per garantire la sicurezza, mentre si moltiplicano le minacce alle nostre frontiere. Sarà sempre più difficile difendere i nostri interessi economici e commerciali - quelli della prima potenza esportatrice mondiale - quando la tentazione protezionista troverà sempre più consenso. La nostra idea di sviluppo sostenibile del pianeta rimarrà lettera morta. Non sarà più possibile finanziare i nostri modelli sociali fondati sulla redistribuzione, né i nostri importanti servizi pubblici.
Nessuno dei nostri Stati ha gli strumenti per trovare, da solo, soluzioni a queste sfide. Ora più che mai, l’unità europea è indispensabile. L’urgenza è quella di trovare il modo di riconciliare i cittadini con il progetto europeo e di inventare l’Europa del futuro, capace di offrire speranza per tutti. L’Europa del futuro deve avere il cittadino nel cuore, e dimostrare che serve in modo efficace gli interessi di tutti i cittadini europei, e non solo delle proprie élite.
È questa convinzione che ci porta al Movimento del 9 maggio, lanciato da cittadini e personalità da ogni provenienza, da ogni settore e da ogni sensibilità del continente, per far sì che l’Europa adotti senza indugio una tabella di marcia ambiziosa, concreta e pragmatica. La sfida è ridurre concretamente le disuguaglianze, stimolare la crescita, dare una risposta forte alla questione delle migrazioni, rafforzare la sicurezza dei cittadini, ambire a un’ulteriore democratizzazione dell’Unione e rimettere istruzione e cultura, fondamento della nostra identità democratica, al centro della Ue. Tra le nostre proposte ce ne sono alcune fortemente simboliche: la creazione di un Erasmus degli studenti medi; una politica di ricerca e sviluppo (R&S)comune nel campo della difesa; un raddoppio immediato del piano Juncker per gli investimenti; la creazione di liste transnazionali per le prossime elezioni europee.
In parte siamo stati ascoltati dalle istituzioni europee, che hanno ripreso alcune delle nostre linee guida e adottato l’idea di una tabella di marcia.
Ma oggi è necessaria più ambizione, è giunto il momento di lanciare una vera politica estera e di difesa europea. È tempo che l’Unione diventi una grande potenza politica, democratica, culturale, sociale, economica e ambientale. Il vertice europeo che si terrà a Roma il 25 marzo prossimo, in occasione del 60° anniversario dei Trattati di Roma, dovrà rappresentare l’opportunità di un forte rilancio dell’Ue. Dovrà anche essere l’occasione per rafforzare la democrazia in Europa, sviluppando di metodi di democrazia deliberativa che possano permettere in modo efficace ai cittadini di contribuire alla definizione di priorità per il progetto europeo, e inventare i nuovi diritti e le nuove libertà del XXI secolo.
Senza questo nuovo slancio politico rivolto ai nostri cittadini i demoni populisti che ora ci stanno indebolendo, ci porteranno alla sconfitta. La Storia varia nelle sue forme, ma il risultato sarebbe comunque disastroso. E la possibilità che l’Ue non festeggi neppure il suo 70° anniversario è concreta.
Questa riscossa sarà possibile solo se le decine di milioni di cittadini che condividono la nostra ambizione si mobiliteranno per dare un futuro al nostro continente. È per questo che nel prossimo mese di gennaio creeremo una Piattaforma Civica Federale, ed è per questo che abbiamo lanciato in tutta Europa degli accordi civici per diffondere collettivamente la nostra voce. Dopo Parigi, lo scorso 15 ottobre, le prossime tappe saranno a Bratislava, Berlino, Roma e Bruxelles. Invitiamo tutti coloro che vogliono trasformare l’Europa a unirsi a noi.
All’appello aderiscono anche: László Andor; Lionel Baier ; Mercedes Bresso; Elmar Brok; Philippe de Buck; Georges Dassis; Paul Dujardin; Cynthia Fleury; Markus Gabriel; Danuta Huebner; Cristiano Leone; Jo Leinen; Sofi Oksanen; Maria Joao Rodrigues; Petre Roman; Nicolas Schmit; Gesine Schwan; Kirsten van den Hul; René Van Der Linden; Philippe van Parijs; Luca Visentini; Vaira Vike- Freiberga; Cédric Villani; Sasha Waltz; Mars di Bartolomeo
* la Repubblica, 18 novembre 2016
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
EICHMANN A GERUSALEMME (1961). “come fu possibile la hitlerizzazione dell’Imperativo Categorico di Kant? E perché è ancora attuale oggi?” (Emil L. Fackenheim, Tiqqun. Riparare il mondo).
 HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI.
HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- Elezioni USA 2016. Trump, la seconda profezia del regista Moore: “Non arriverà a fine mandato”.12 novembre 2016, di Federico La Sala
- POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. Materiali sul tema
Elezioni USA 2016
Trump, la seconda profezia del regista Moore: “Non arriverà a fine mandato”
Il documentarista americano aveva già profetizzato la vittoria del magnate repubblicano alle primarie e poi alle presidenziali. Ora è sicuro che il tycoon si dimetterà o subirà l’impeachment: "Un narcisista come lui è probabile possa infrangere la legge"
di F. Q. (12 novembre 2016)
“Donald Trump non porterà a termine il suo mandato”. E’ la seconda profezia di Michael Moore. Il regista, che a luglio aveva preannunciato la vittoria del magnate repubblicano alle primarie e poi alle presidenziali, sostiene che si dimetterà o dovrà subire l’impeachment, la messa in stato d’accusa del presidente, prima della fine del suo mandato. “Il motivo per cui non dovremo soffrire per 4 anni è il fatto che Trump non ha nessuna ideologia se non la sua - ha detto alla Msnbc il premio Oscar del 2003 con ‘Bowling for Columbine‘ - e quando ti trovi davanti a un narcisista come lui, è probabile che possa, anche involontariamente, infrangere le leggi”.
Moore è sicuro: “Trump infrangerà le leggi perché penserà solo a ciò che è meglio per lui”. Secondo il regista, la vittoria del tycoon si rivelerà una benedizione per la sinistra e i democratici non cadranno nella disperazione dopo il risultato inaspettato delle elezioni. “Resisteremo e ci opporremo - ha aggiunto Moore - sarà una resistenza massiccia, un milione di donne hanno già annunciato che marceranno nel giorno del suo insediamento. Sarà la più grande manifestazione mai organizzata”. Il documentarista americano è ormai una bandiera della sinistra schierata contro il miliardario newyorchese: a ottobre è uscito il suo ultimo film ‘Michael Moore in TrumpLand‘, una sorta di instant movie realizzato per contrastare la corsa alle presidenziali americane del candidato repubblicano.
- POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. Materiali sul tema
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA --- ALFABETO - TULLIO DE MAURO. Italia, Repubblica popolare fondata sull’asineria.23 ottobre 2016, di Federico La Sala
ALFABETO - TULLIO DE MAURO. Italia, Repubblica popolare fondata sull’asineria
di Antonello Caporale *
Tullio De Mauro Siamo la Repubblica dell’ignoranza, degli asini duri e puri, degli analfabeti di concetto, di concorso, di condominio, da passeggio e da web. Passano gli anni ma restiamo sempre stupiti della mostruosa cifra dei concittadini incapaci di comprendere o persino leggere una frase che non sia un periodo semplice (soggetto, predicato e complemento) e un’operazione aritmetica appena più complessa dell’addizione o della sottrazione a due cifre.
Tullio De Mauro è il notaio della nostra ignoranza.
Sono ricerche consolidate, l’ultima dell’Ocse è del 2014, che formalizza il grado italiano di estremo analfabetismo. Mi succede ogni volta di dover spiegare che la sorpresa è del tutto fuori luogo, i dati sono consolidati oramai.
Professore, asini eravamo e asini siamo.
Abbiamo una percentuale di analfabetismo strutturale intorno al 33% in misura proporzionale per classi di età: dai 16 anni in avanti. Il 5% di essi non riesce a distinguere il valore e il senso di una lettera dall’altra. Avrà difficoltà a capire ciò che divide la b con la t la f la g. Cecità assoluta. Il restante 28 ce la fa a leggere, ma con qualche difficoltà, parole semplici e a metterle insieme: b a c o, baco. Singole parole.
Qui siamo al livello 1: totale incapacità di decifrare uno scritto.
Il cosiddetto livello degli analfabeti strutturali.
Passiamo al secondo livello.
Gli analfabeti funzionali. Riescono a comprendere o a leggere e scrivere periodi semplici. Si perdono appena nel periodo compare una subordinata o più subordinate. E uguale difficoltà mostrano quando le operazioni aritmetiche si fanno appena più complicate della semplice addizione e sottrazione. Con i decimali sono guai.
Dentro questo comparto di asineria alleviata c’è un altro 37% di compatrioti.
Purtroppo non ci schiodiamo da queste cifre.
Quanta gente ha una padronanza avanzata di testi, parole e concetti?
Il 29%. Si parte dal terzo gradino, quello che definisce il minimo indispensabile per orientarsi nella vita privata e pubblica, e si sale fino al quinto dove il forestierismo è compreso, si ha la padronanza della lingua italiana e anche di quella straniera.
Con gli anni si peggiora.
È un processo di atrofizzazione del sapere costante e lievitante.
Solo tre italiani su dieci andranno a votare al referendum sulla Costituzione con qualche idea di cosa sono chiamati a decidere.
Siamo lì, purtroppo.
È un disastro!
Il Giappone nel 1870 investì ogni risorsa nella scolarizzazione. Nel 1900 tutti i giapponesi erano in possesso della licenza elementare. Traguardo che noi abbiamo raggiunto 80 anni dopo.
Per la politica è un grande business trovarsi di fronte elettori inconsapevoli. Frottole a gogò!
È un’attrazione fatale. Ricordo che il ministro dell’Istruzione Luigi Berlinguer licenziò una riforma nella quale il Parlamento si faceva carico di ascoltare ogni anno una relazione sullo stato dell’istruzione in Italia e ogni tre anni di avanzare gli eventuali correttivi. Un po’ come la manovra finanziaria, pensava che fosse necessaria una legge di stabilità culturale. Era un modo per tenere sott’occhio anche questa sciagura e per ridurre o limitare l’evento calamitoso dell’ignoranza. Venne la Moratti e dopo un giorno dal suo insediamento la cassò.
Anche lei è stato ministro dell’Istruzione.
In Parlamento risposi a un’interrogazione di una deputata (insegnante tra l’altro). Dissi: l’onorevole preopinante (colui che ha appena dubitato, opinato ndr). Lei mi interruppe: come si permette di offendere?
Ma l’ignoranza non incide anche nella qualità del lavoro?
L’ignoranza costa in termini civili, naturalmente culturali e persino nel processo produttivo. L’indice di produttività subisce un assoluto condizionamento dall’asineria.
Di cosa ci sarebbe bisogno?
Di cicli di aggiornamento culturale di massa. E nessun sussidio (penso alla cassa integrazione) dovrebbe essere possibile senza un contestuale periodo di educazione alla lingua.
Dovremmo tutti andare al doposcuola.
Prima si andava al mercato e si sceglieva la lattuga. Adesso c’è il supermercato dove tutto è imbustato. Per capirne provenienza e confezionamento è necessario saper leggere. Posso anche leggere Cile, ma se non so dove si trova quel Paese che me ne faccio di quella indicazione?
Siamo il Paese della onesta incomprensione.
Esisteva un servizio intelligente e puntuale che indagava sulla nostra capacità di comprendere, il servizio opinione Rai poi incredibilmente chiuso. Nel 1969 fu avanzata una ricerca su tre campioni: la casalinga di Voghera, gli operai di Bari e gli impiegati di Roma. Questi ultimi si distinsero per la loro selvaggia ignoranza.
E noi a prendercela con la casalinga di Voghera.
Invece i peggiori erano gli impiegati dei ministeri. Asinissimi!
*
Blog di Antonello Caporale - Il Fatto Quotidiano, 22 ottobre 2016
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- STORIA E FILOSOFIA. La «cultura» della purezza razziale: "La legge del sangue. Pensare e agire da nazisti" (di Emilio Gentile).16 ottobre 2016, di Federico La Sala
- EICHMANN A GERUSALEMME (1961). “come fu possibile la hitlerizzazione dell’Imperativo Categorico di Kant? E perché è ancora attuale oggi?” (Emil L. Fackenheim, Tiqqun. Riparare il mondo). HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI.
Nazismo
La «cultura» della purezza razziale
La concezione che portò allo sterminio di massa fu attuata non solo da Hitler e dal partito, ma da una foltissima schiera di dotti giuristi, scienziati, medici, teologi e giornalisti
di Emilio Gentile (Il Sole-24 Ore, Domenica, 16.10.2016)
- Johann Chapoutot, La legge del sangue. Pensare e agire da nazisti , Einaudi, Torino, pagg. 472, € 32
Nel 1945, diciotto medici tedeschi di un ospedale pediatrico furono processati dal tribunale di Amburgo, su iniziativa delle truppe di occupazione britanniche, perché accusati di aver assassinato con iniezioni letali cinquantasei bambini malati. Il direttore dell’ospedale respinse l’accusa di «crimine contro l’umanità» perché tale crimine, disse agli inquirenti britannici, «non può essere commesso che contro uomini, mentre gli esseri viventi di cui dovevamo occuparci non possono essere qualificati come “esseri umani”». Cinque anni dopo, i giudici assolsero gli imputati affermando di «aver creduto alla legalità dei loro atti».
Inizia con questo episodio un’ampia indagine dello storico francese Johann Chapoutot sul modo di pensare e di agire dei nazisti, ricostruito con una folta documentazione di oltre milleduecento libri e articoli pubblicati durante il regime nazista negli ambiti più vari, dai testi ideologici alla letteratura pedagogica, dal diritto alla medicina, dalla biologia alla filosofia, dall’antropologia alla storia e alla geografia, con l’aggiunta di una cinquantina di film prodotti dal Terzo Reich. Dall’indagine, suddivisa per temi, emerge un’elaborata e coerente concezione nazista del mondo, che fu messa in pratica durante i dodici anni del dominio hitleriano. Il nazismo attuò così una rivoluzione culturale oltre che politica, per istituire un diritto, una morale, un’etica e una religione esclusivamente tedesche, fondate sulla superiorità biologica della razza germanica, e per inculcare nel popolo tedesco l’imperativo categorico di preservare la purezza del sangue, che era l’essenza della sua superiorità su tutte le altre razze.
Milioni di tedeschi si convinsero che per preservare l’integrità e la salvezza della razza germanica, era necessario eliminare con la sterilizzazione o l’eutanasia le persone afflitte da mali ereditari; impedire la contaminazione biologica con altre razze; invadere i Paesi dell’Europa orientale per conquistare spazio vitale alla razza germanica e sottomettere gli slavi come schiavi.
E soprattutto si convinsero della necessità inevitabile di una spietata guerra razziale contro gli ebrei, fino alla loro totale eliminazione, perché da seimila anni l’ebreo era il nemico naturale del popolo tedesco, un pericolo mortale per la sua purezza e la sua integrità, come il bacillo della tubercolosi per un corpo sano e vigoroso.
Per molti decenni dopo la fine del regime hitleriano, la concezione nazista del mondo è stata considerata dagli storici una paccottiglia di farneticanti elucubrazioni, esibite da folli criminali per adornare con arcaici miti una sfrenata libidine di potere, che alla fine si sfogò con una barbarica guerra di conquista e con il sadico sterminio organizzato di oltre cinque milioni di ebrei. La follia, la barbarie, il sadismo apparivano motivi sufficienti per spiegare storicamente la criminalità del nazismo, alimentata anche dall’avidità di un capitalismo imperialista che per due volte nell’arco di trent’anni aveva tentato di dare l’assalto al potere mondiale provocando due guerre mondiali.
Comune a queste interpretazioni, osserva Chapoutot, era la «disumanizzazione dei protagonisti del crimine nazista», ma in tal modo, aggiunge, «facendo di loro dei soggetti estranei alla nostra comune umanità, noi ci esoneriamo da ogni riflessione sull’uomo, l’Europa, la modernità, l’Occidente, insomma su tutti i luoghi che i criminali nazisti abitano, dei quali partecipano, e che noi abbiamo in comune con loro», confortandoci al pensiero che «l’idea secondo la quale noi potremmo condividere qualcosa con gli autori di tesi e crimini così mostruosi ci ripugna».
Pur se legittima, tale ripugnanza ci induce però a eludere questioni fondamentali della nostra storia e del nostro tempo, perché le idee della concezione nazista del mondo erano solo in minima parte originaria produzione dei nazisti: «Né il razzismo, né il colonialismo, né l’antisemitismo, né il darwinismo sociale o l’eugenismo sono nati tra il Reno e Memel». Inoltre «la Shoah avrebbe provocato un numero molto minore di vittime se non ci fosse stato lo zelante concorso di poliziotti e di gendarmi francesi e ungheresi», insieme a «innumerevoli nazionalisti baltici, volontari ucraini, antisemiti polacchi, alti funzionari e uomini politici pervasi da volontà di collaborazione». Come lo furono, in Italia, politici, funzionari e intellettuali fascisti.
Vi erano tuttavia movimenti culturali tedeschi che fin dall’Ottocento avevano diffuso con convinzione le idee sopra citate, e la loro presenza favorì il successo della concezione nazista, che dopo il 1933 fu messa in pratica con ossessiva tenacia non solo da Hitler e dal partito nazista, ma da una foltissima schiera di dotti giuristi, scienziati, medici, teologi, ideologi e giornalisti, con l’ausilio del cinema di finzione e del cinema documentario. Milioni di tedeschi, sia persone di elevata cultura sia gente comune, si convinsero che gli ebrei tramavano da seimila anni per distruggere il popolo tedesco, inquinandolo con incroci di sangue e con idee disgregatrici, come il cristianesimo, il diritto romano, l’individualismo, l’universalismo, l’umanitarismo, il liberalismo, il socialismo, il bolscevismo. Queste idee minavano le virtù, la morale, l’etica, le tradizioni e l’integrità della comunità germanica.
Fu la concezione nazista del mondo, diffusa con martellante, capillare, pervasiva propaganda quotidiana, a trasformare milioni di uomini e donne, non predestinati alla follia né al crimine, in zelanti esecutori della persecuzione e dello sterminio. Ogni tentazione alla pietà fu anestetizzata con l’invocazione della necessità di agire con mezzi spietati per annientare i nemici della razza germanica che da seimila anni tramavano per annientarla.
Conoscere il modo di pensare e di agire dei nazisti considerandoli uomini cresciuti e vissuti in contesti particolari, con un proprio universo di significati e di valori, è il compito proprio dello storico, afferma Chapoutot. Ciò non attenua affatto la mostruosità delle idee e dei crimini nazisti: anzi, rende ancora più consapevoli della sua gravità, perché nulla esclude che tale mostruosità possa ripetersi, con altre idee e in altri contesti, nell’azione di altri uomini convinti che essa sia necessaria per salvare la propria comunità.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- LA LOGICA, LA MATEMATICA, E IL MENTITORE ISTITUZIONALIZZATO. Il dizionario della stupidità di Odifreddi (di Marco Grimaldi)9 ottobre 2016, di Federico La Sala
- COSTITUZIONE E PENSIERO. ITALIA: LA MISERIA DELLA FILOSOFIA ITALIANA E LA RICCHEZZA DEL MENTITORE ISTITUZIONALIZZATO ...
 BERTRAND RUSSELL: LA LEZIONE SUL MENTITORE (IGNORATA E ’SNOBBATA’), E "L’ALFABETO DEL BUON CITTADINO".
BERTRAND RUSSELL: LA LEZIONE SUL MENTITORE (IGNORATA E ’SNOBBATA’), E "L’ALFABETO DEL BUON CITTADINO".
Il dizionario della stupidità di Odifreddi
di Marco Grimaldi (Le Parole e le Cose, 9 ottobre 2016)
Su Dante e Odifreddi ho già scritto qualche tempo fa (e non so se almeno uno dei due gradirebbe ritrovare così spesso il proprio nome accanto a quello dell’altro). Ma Odifreddi è recidivo e ammette difficilmente di avere torto. Oppure si riscrive senza pensarci troppo. O ha un ghost writer che lo riscrive di continuo. Nel Dizionario della stupidità appena pubblicato da Rizzoli (sottotitolo: Fenomenologia del non-senso della vita), alla voce Dante, si legge infatti (p. 79):
- Nel Trattatello in laude di Dante (1360 circa) il Boccaccio racconta che, quando il poeta morì, la Commedia era incompiuta. Mancavano gli ultimi tredici canti, e i figli Iacopo e Pietro furono convinti dagli amici a completarla. Otto mesi dopo la morte il padre apparve però al primo in sogno, lo condusse per mano in una camera e gli indicò una stuoia sul muro, sotto la quale il giorno dopo furono miracolosamente ritrovati gli ammuffiti canti mancanti.
 Che cos’è più stupido pensare? Che i figli abbiano completato l’incompiuta opera del padre? O che egli avesse nascosto gli ultimi canti, invece di spedirli a Cangrande della Scala come faceva regolarmente man mano che li finiva, e che essi siano stati ritrovati in seguito a un sogno?
Che cos’è più stupido pensare? Che i figli abbiano completato l’incompiuta opera del padre? O che egli avesse nascosto gli ultimi canti, invece di spedirli a Cangrande della Scala come faceva regolarmente man mano che li finiva, e che essi siano stati ritrovati in seguito a un sogno?
 Anche per il Deuteronomio si è stupidamente sostenuto per due millenni che fosse opera di Mosè, ma poi si è dovuto ammettere che invece l’aveva scritto Giosia, inventando il ritrovamento di un perduto rotolo della Torah. E anche noi oggi facciamo spesso i veri o i finti tonti, credendo o fingendo di credere che un autore famoso abbia lasciato una quantità sospetta di opere postume, che sono ovviamente state scritte da altri: spesso, gli stessi che comunque gliele scrivevano già da vivi.
Anche per il Deuteronomio si è stupidamente sostenuto per due millenni che fosse opera di Mosè, ma poi si è dovuto ammettere che invece l’aveva scritto Giosia, inventando il ritrovamento di un perduto rotolo della Torah. E anche noi oggi facciamo spesso i veri o i finti tonti, credendo o fingendo di credere che un autore famoso abbia lasciato una quantità sospetta di opere postume, che sono ovviamente state scritte da altri: spesso, gli stessi che comunque gliele scrivevano già da vivi.
In questa paginetta Odifreddi condensa una tesi già esposta in Il giro del mondo in 80 pensieri (Rizzoli, 2015, pp. 285-89): Dante non ha scritto gli ultimi canti della Commedia; li hanno scritti i figli e hanno finto di averli ritrovati per non guastare il brand “Dante” che già allora si rivelava redditizio.
In Il giro del mondo Odifreddi se la prendeva con il poeta: dato che gli ultimi canti non li ha neanche scritti lui, perché continuare a leggerlo a scuola? Meglio passare a Newton e Galileo che almeno ci insegnano il pensiero scientifico. Nel Dizionario se la prende con gli stupidi, cioè quelli che non accettano la sua tesi. La domanda è quindi retorica: secondo Odifreddi è stupido pensare «che egli avesse nascosto gli ultimi canti [...], e che essi siano stati ritrovati in seguito a un sogno», proprio come è stupido pensare che il Deuteronomio l’abbia scritto Mosè. E a rigor di logica Odifreddi, che logico è, avrebbe anche ragione.
Il problema - che è poi un problema classico dell’applicazione della logica astratta alla realtà concreta - è che quelle non sono le due sole risposte possibili. Prima di tutto Boccaccio, che è l’unico appiglio per la tesi di Odifreddi, non è una fonte totalmente affidabile. La storia del ritrovamento in sogno non è per forza vera ed è difficile capire perché Boccaccio la riferisca: forse semplicemente perché era una bella storia che aveva sentito in giro.
La cosa più stupida da pensare è che si debba scegliere tra quelle due alternative; è infatti molto meno stupido ritenere che il racconto sia stato inventato da Boccaccio o dalla sua fonte e che Dante abbia davvero concluso la Commedia, dato che gli ultimi canti sono perfettamente integrati e coerenti con il resto dell’opera. E che i suoi figli, che quando scrivono in versi sono poeti infinitamente meno bravi del padre, non abbiano avuto alcun ruolo nella sua realizzazione, mentre sappiamo con certezza che ne hanno avuto uno, fondamentale, nella divulgazione e nell’opera di interpretazione del poema.
Tuttavia, la Commedia non è l’unica cosa che conta: il vero motivo per cui vale la pena preoccuparsi dell’opinione di Odifreddi su Dante è che questo Dizionario della stupidità, assieme a gran parte dei suoi libri recenti, è un buon esempio di cattiva divulgazione. E sarebbe fin troppo facile sostenere che Odifreddi faccia cattiva divulgazione perché è stupido a sua volta.
Ma che cos’è uno stupido? Secondo Carlo Maria Cipolla, che ha scritto un famoso libretto intitolato Le leggi fondamentali della stupidità umana, lo stupido è chi causa un danno ad un’altra persona o gruppo di persone senza nel contempo realizzare alcun vantaggio per sé o addirittura subendo una perdita.
Odifreddi trae certamente un vantaggio scrivendo dei libri che qualche copia dovranno pur venderla se Rizzoli continua a stamparglieli. Quindi non è uno stupido (anche se qualche tempo fa si è fatto fregare dalla Zanzara). Cipolla identificava però altre tre categorie, disponendole assieme allo Stupido su un diagramma: lo Sprovveduto, l’Intelligente e il Bandito. L’idea era che non esistano né uomini perfettamente stupidi, sprovveduti o intelligenti né dei perfetti banditi, ma che le categorie siano fluide e la realtà sia più complessa. Ciò non toglie che ciascuno di noi tende ad assomigliare più all’una che all’altra categoria.
Se Odifreddi non è uno stupido, non è neanche uno Sprovveduto, che per Cipolla è chi compie un’azione e ne ricava una perdita mentre nello stesso tempo procura un vantaggio a qualcun altro. Restano l’Intelligente e il Bandito. Il primo è chi compie un’azione dalla quale ottiene un vantaggio e nello stesso tempo procura un vantaggio anche a qualcun altro.
Odifreddi vende e Rizzoli ne trae vantaggio: se tutto finisse lì, potremmo classificarlo tra gli intelligenti. Ma il fatto è che Odifreddi, oltre a creare un vantaggio per sé e per il suo editore (e forse si possono far coincidere questi due interessi), allo stesso tempo danneggia qualcun altro. Questo qualcun altro sono tutti quelli che in varie sedi - a scuola, all’università, in televisione, sui giornali - cercano di parlare di cose serie come Dante, Galileo e Darwin in modo semplice ed esatto, ma sono soprattutto i lettori di Odifreddi, i quali credendo di trovare nel Dizionario della stupidità un elenco di cose stupide delle quali ridere, trovano un catalogo di stupidaggini nelle quali rischiano di credere. E questa (chi compie un’azione dalla quale trae vantaggio causando una perdita a qualcun altro) è la definizione del Bandito.
- COSTITUZIONE E PENSIERO. ITALIA: LA MISERIA DELLA FILOSOFIA ITALIANA E LA RICCHEZZA DEL MENTITORE ISTITUZIONALIZZATO ...
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ... TUTTI NEL REGNO DI "FORZA ITALIA"!!! --- IL TUTTO E LA PARTE. E IL CONFLITTO D’INTERESSI.7 ottobre 2016, di Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- "I PRINCIPI DELLA MATEMATICA" DI B. RUSSELL E IL "DIZIONARIO DELLA STUPIDITÀ" DI P. ODIFREDDI.26 settembre 2016, di Federico La Sala
COSTITUZIONE E PENSIERO. ITALIA: LA MISERIA DELLA FILOSOFIA ITALIANA E LA RICCHEZZA DEL MENTITORE ISTITUZIONALIZZATO ...
(federico la sala)
Piergiorgio Odifreddi, intervista Huffpost: "Il 90 per cento degli italiani è stupido"
- Beppe Grillo: "È un minus habens". I grillini: "Peggio di lui". In generale: "Il novanta per cento delle persone è stupido. In un paese di 60 milioni di abitanti come l’Italia, saranno all’incirca 54 milioni: non possono essere andati tutti alla festa nazionale dei 5 stelle a Palermo".
 Piergiorgio Odifreddi - matematico, divulgatore scientifico, saggista - ha scritto un Dizionario della stupidità (Rizzoli, 378 pagine, 18 euro) per proteggersi dalle "scemenze della vita quotidiana".
Piergiorgio Odifreddi - matematico, divulgatore scientifico, saggista - ha scritto un Dizionario della stupidità (Rizzoli, 378 pagine, 18 euro) per proteggersi dalle "scemenze della vita quotidiana".
 Laico fervente, ha studiato prima dalle suore, poi dai preti: "Non erano niente male". Se deve immaginare uno scenario politico peggiore di quello odierno, torna con la memoria alla stagione della Democrazia cristiana: "Anche se Giulio
Andreotti - racconta - mi salvò da un pericoloso fermo in Unione Sovietica".
Laico fervente, ha studiato prima dalle suore, poi dai preti: "Non erano niente male". Se deve immaginare uno scenario politico peggiore di quello odierno, torna con la memoria alla stagione della Democrazia cristiana: "Anche se Giulio
Andreotti - racconta - mi salvò da un pericoloso fermo in Unione Sovietica".
 Con l’Huffington Post, parla di banchieri da "mandare all’infermo", di politicamente corretto e Islam, della "superiorità" di Benedetto XVI sulla "banalità" di Papà Francesco, e di politica.
Con l’Huffington Post, parla di banchieri da "mandare all’infermo", di politicamente corretto e Islam, della "superiorità" di Benedetto XVI sulla "banalità" di Papà Francesco, e di politica.
di Redazione (l’Huffington post, 25/09/2016)
Odifreddi, nel suo dizionario c’è anche la voce: Matteo Renzi. Perché?
Se vogliono conquistare voti, i politici devono dire alle persone ciò che si vogliono sentir dire. Tendenzialmente, delle stupidaggini. E Matteo Renzi è l’erede perfetto di Berlusconi: il Cavaliere ha imparato a farlo cantando sulle navi, lui esordendo alla Ruota della fortuna.
Ma politicamente?
Renzi ha realizzato il programma berlusconiano, andando addirittura oltre con il Jobs act, che ha dissolto le tutele dello statuto dei lavoratori.
Dedica un lemma anche a Grillo.
Grillo ha iniziato a dire scemenze prima di cominciare a fare politica. Per dire: sosteneva che l’AIDS era una bufala, che l’OGM ammazza, che le radiazioni dei cellulari cuociono le uova. Ma lui ci crede. È questa la grande differenza tra Grillo e un politico di professione: che il politico deve dire delle cretinate per racimolare voti, lui le dice per convinzione.
Eppure ha un gran consenso.
Non voglio dire che il suo pubblico sia fatto di deficienti. È una parola brutta. Dico: ingenui. Ma rimane il fatto che sono persone che credono alle scie chimiche e fanno battaglie contro i detersivi. È la parte della società con meno mezzi culturali per giudicare.
Possibile che siano tutti così?
Bertrand Russell diceva che i politici hanno nei confronti degli elettori un vantaggio: che gli elettori sono più stupidi di loro. E giudicare Grillo, per me, è troppo difficile: mi è così distante che lo considero un minus habens. Quando lo sento, mi viene la pelle d’oca. Dicono che i suoi siano argomenti di pancia. Io fatico a considerarli proprio argomenti.
A Palermo, però, molte persone sono andate per ascoltarlo alla Festa nazionale dei 5 stelle.
Il novanta per cento delle persone è stupido. Quindi, considerato che siamo 60 milioni, in Italia ci sono almeno 54 milioni di stupidi: non credo ve ne siano di più a quella festa.
E gli altri dove vanno?
Vanno anche alle feste dell’Unità. Come si fa a pensare che dopo due anni di governo Renzi quella festa abbia un senso? Almeno, per decenza, cambiassero nome.
Non le sembra di sottovalutare? Il partito democratico governa il Paese, i Cinque stelle hanno conquistato due grandi città alle ultime elezioni.
C’è una differenza enorme tra le due città: a Torino, Chiara Appendino è il prodotto di ciò che i 5 stelle stessi chiamano poteri forti; a Roma, invece i poteri forti li hanno contro.
Può essere più esplicito?
Dietro Appendino c’è la Fiat. Appena aletta, John Elkan è subito corso a incontrarla. Viceversa, Virginia Raggi è dovuta recarsi in visita dal Papa.
C’è solo questa differenza tra le due?
No, Appendino ha le qualità per governare, Raggi le ha solo per vincere le elezioni.
Scrive: "E’ venuto il momento di tornare a considerare i banchieri paria della società e reietti da Dio".
Nel Medio Evo, era considerato usuraio chiunque prestasse denaro, a qualsiasi tasso. Oggi il fastidio per i banchieri è tornato a essere forte. Quando la gente vede i posti di lavoro che evaporano, le tutele che si dissolvono, e dall’altra gli aiuti di stato per tenere in vita istituti che hanno fallito, s’incazza.
Però è difficile vivere in un mondo senza banche.
Certo che si può vivere in un mondo senza banche. Per metà del secolo scorso, l’Unione Sovietica ne ha fatto a meno.
Non è andata benissimo, però.
Non per quel motivo. Mi domando perché non si possano nazionalizzare le banche che vengono salvate. Perché è diventata una bestemmia?
In Europa, nazionalizzare è contrario alle regole dell’Unione.
È per questo che l’UE suscita l’astio dei suoi cittadini: perché è solo un’unione economica.
Nel suo libro, mostra di preferire Ratzinger a Papa Francesco. Perché?
Da ateo, con Benedetto XVI ho avuto un dialogo. Mi è interessato leggere le cose che scriveva, Ratzinger aveva una profondità di pensiero. La statura intellettuale Papa Francesco lascia perplessi. Quando parla, mi cadono le braccia. La misericordia, il vogliamoci bene, l’amore: sono cose talmente banali. Chi può essere contrario?
È facile criticare l’Islam allo stesso modo in cui lei, ora, ha fatto con il Cattolicesimo?
Penso che, in realtà, sia molto più facile criticare l’islam che il Cristianesimo. Farlo, è politicamente corretto. Ci sono partiti politici che fanno propaganda sull’equazione musulmano uguale terrorista. E l’opinione pubblica è sempre sul chi va là.
Dimentica quello che è successo in Francia per le vignette di Charlie Hebdo su Maometto?
La diversità è che i cristiani non vengono sotto casa ad aspettarti se li prendi di mira con la satira. Ma ricorda la parodia di Ratzinger fatta da Crozza? A un certo punto ha dovuto smettere di farla. E potrei fare altri esempi. Nei risultati, non è molto diverso da quello che accade con l’Islam.
Lei è stato compagno di classe di Flavio Briatore. Ha letto della polemica sul turismo al sud, secondo lui poco sensibile ai bisogni dei ricchi?
Non saprei dire se è così. So che con Briatore studiavo al geometra. Lui fu bocciato al secondo anno, poi lasciò e fece una scuola privata per recuperare tutti gli anni in uno. Credo sia la dimostrazione che il detto popolare - "ultimi a scuola, primi nella vita" - è vero.
- Beppe Grillo: "È un minus habens". I grillini: "Peggio di lui". In generale: "Il novanta per cento delle persone è stupido. In un paese di 60 milioni di abitanti come l’Italia, saranno all’incirca 54 milioni: non possono essere andati tutti alla festa nazionale dei 5 stelle a Palermo".
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- L’AVERE UN NOME, LA DIGNITA’, E LA COSTITUZIONE. Festival del diritto. Confronti a Piacenza.24 settembre 2016, di Federico La Sala
- Il SONNO PROFONDO DEI GIUDICI COSTITUZIONALISTI, LA "LOGICA" DEL MENTITORE E IL GOLPISTICO TRIONFO DEL PARTITO DI "FORZA ITALIA".
 SE VADO A CASA DI ZAGREBELSKY E ... COMINCIO A FARE IL MIO COMODO DICENDO DI ESSERE DEL PARTITO "FORZA ZAGREBELSKY"
SE VADO A CASA DI ZAGREBELSKY E ... COMINCIO A FARE IL MIO COMODO DICENDO DI ESSERE DEL PARTITO "FORZA ZAGREBELSKY"
L’insostenibile ambiguità nelle parole della politica- IL FESTIVAL Quello che qui pubblichiamo è un estratto dell’intervento dell’autore al Festival del diritto, organizzato e diretto da Stefano Rodotà e in programma fino a domani a Piacenza Quest’anno il tema su cui studiosi di varie discipline si stanno confrontando è quello della dignità Per informazioni www.festivaldeldiritto.it
di GUSTAVO ZAGREBELSKY (la Repubblica, 24/09/2016)
C’È UNA piccola frase, apparentemente alquanto banale, in La sera del dì di festa di Giacomo Leopardi che dice «tutto al mondo passa e quasi orma non lascia». Desidero richiamare l’attenzione su quel “quasi”. Certo, la vita e le nostre opere sono effimere, ma non del tutto. C’è un residuo, il “quasi”, che resta, che si accumula e che forma ciò che chiamiamo umanità, un termine che può tradursi in cultura: il deposito delle esperienze che vengono da lontano e preparano il futuro, un deposito al quale tutti noi, in misura più o meno grande, partecipiamo. O, meglio: dobbiamo poter partecipare. Altrimenti, siamo fuori della umanità. Per questo, troviamo qui il primo, il primordiale diritto, che condiziona tutti gli altri. La violazione di questo diritto equivale all’annientamento del valore della persona, alla sua riduzione a zero, a insignificanza.
Eppure, viviamo in un mondo nel quale non è nemmeno possibile stabilire con precisione quanti sono gli esseri umani che non conoscono questo elementare diritto che possiamo chiamare “diritto al segno” o, leopardianamente, “diritto all’orma”.Si misurano a milioni, cioè a numeri approssimativi, senza che - ovviamente - a questi numeri possano associarsi nomi. Milioni di anonimi, che giungono a noi come fantasmi, mentre le loro sono esistenze concrete, anche se durano spesso lo spazio d’un mattino o di pochi mattini, consumandosi in fretta in condizioni disumane, in luoghi dove la lotta per la mera sopravvivenza materiale sopravanza qualunque possibilità di relazioni, dove i neonati vengono al mondo sotto la maledizione di leggi statistiche che li condannano alla sparizione entro pochi giorni o settimane di vita.
Ciò che ci interpella inderogabilmente è che non possiamo dire, come forse si sarebbe potuto un tempo, nel mondo diviso per aree, storie, politiche separate e indipendenti le une dalle altre: sono fatti loro, loro è la responsabilità, il nostro mondo non è il loro, ognuno pensi per sé alle proprie tragedie. Non possiamo dirlo, perché il mondo, come ci ripetiamo tutti i momenti, è diventato uno solo, grande, globale. Noi, in un tale mondo, osiamo parlare kantianamente, senza arrossire, di “dignità” come universale diritto al rispetto. Il “diritto all’orma” detto sopra è legato a tutti gli altri diritti come loro premessa e condizione: è davvero quello che è stato definito da Hannah Arendt, con una formula che ha avuto successo (Rodotà), il “diritto di avere diritti”.
C’è un diritto che potremmo dire essere un altro modo d’indicare il diritto di avere diritti, ed è il diritto al nome: un diritto al quale i trattati di diritto costituzionale, se non l’ignorano, dedicano poche righe. La nostra Costituzione, all’art. 22, tra i diritti umani fondamentali stabilisce che nessuno può essere privato del suo nome perché i Costituenti sapevano il valore di quel che dicevano. “Nominando” si specifica, si riconosce, si creano le premesse per creare un rapporto.
Questo non accade, oggi, alle centinaia di migliaia e, in prospettiva, dei milioni di migranti che sono, per noi, milioni non solo di senza nome, ma anche di senza terra. «Quel che è senza precedenti - scriveva Arendt con riguardo alla tragedia del suo popolo negli anni ’30 e ’40 del Novecento - non è la perdita della patria, ma l’impossibilità di trovarne una nuova». Tale impossibilità, allora, era determinata dalle politiche razziali e colpiva comunità umane determinate. Oggi, deriva dalla condizione generale del mondo saturo globalizzato.
Questa situazione estrema è la sorte delle persone private dei diritti umani. I diritti umani sono una realtà per chi sta sopra, e il contrario per chi sta sotto. Lo stesso, per la dignità. Per chi sta sopra, le rivendicazioni di chi sta sotto e chiede di emergere all’onor del mondo sono attentati allo standard di vita “dignitoso” di chi sta sopra. Quando si chiede lo sgombero dei migranti che intasano le stazioni, dormono nei parchi pubblici e puzzano, non si dice forse che danno uno spettacolo non dignitoso? Ma, dignità secondo chi? Non secondo i migranti, che della dignità non sanno che farsene, ma secondo noi che da lontano li guardiamo.
Ci sono parole, dunque, che non valgono nello stesso modo per i divites e gli inanes. Si dovrebbe procedere da questa constatazione per un onesto discorso realistico e riconoscere che le parole che hanno valore politico non sono neutre. Servono, non significano; sono strumenti e il loro significato cambia a seconda del punto di vista di chi le usa; a seconda, cioè, che siano pronunciate da chi sta (o si mette) in basso o da chi sta (o si mette) in alto nella piramide sociale. Occorre, perciò, diffidare delle parole e dei concetti politici astratti. Assunti come assoluti e universali, producono coscienze false e ingenue, se non anche insincere e corrotte.
Potremmo esemplificare questa legge del discorso politico parlando di democrazia, governo, “governabilità”, libertà, uguaglianza, integrazione, ecc. e di diritti e dignità. Si prenda “democrazia”: per coloro che stanno sopra e hanno vinto una competizione elettorale, significa autorizzazione a fare quello che vogliono; per coloro che stanno sotto e sono stati vinti, significa pretesa di rispetto e di riconoscimento: fare e non fare; prepotenza e resistenza. Oppure “politica”: forza sopraffattrice dal punto di vista dei forti, come quando la si usa in espressioni come “politica di espansione”, “politica coloniale”, “politica razziale”, “politica demografica”; oppure, esperienza di convivenza, coinvolgimento e inclusione sociale. Oppure ancora: la (ricerca della) “felicità”.
Oggi, sono i potenti che rivendicano la propria felicità come diritto, la praticano e la esibiscono come stile di vita, quasi sempre osceno e offensivo. Ma non sentiremo un disoccupato, un lavoratore schiacciato dai debiti, un genitore abbandonato a se stesso con un figlio disabile, un migrante senza dimora, un individuo oppresso dai debiti e strangolato dagli strozzini, uno sfrattato che non ha pietra su cui posare il ca- po, una madre che vede il suo bambino senza nome morire di fame: non li sentiremmo rivendicare un loro diritto alla “felicità”. Sarebbe grottesco. Sentiremo questo eterogeneo popolo degli esclusi e dei sofferenti chiedere non felicità ma giustizia.
Ma, anche la parola giustizia non sfugge alla legge dell’ambiguità. Giustizia rispetto a che cosa? Ai bisogni minimi vitali, come chiederebbero i senza nome e i senza terra; oppure ai meriti, come sostengono i vincenti nella partita della vita? La giustizia degli uni è ingiustizia per gli altri. Si comprende, allora, una verità tanto banale quanto ignorata, nei discorsi politici e dei politici: se si trascura il punto di vista dal quale si guardano i problemi di cui ci siamo occupati e si parla genericamente di libertà, diritti, dignità, uguaglianza, giustizia, ecc., si pronunciano parole vuote che producono false coscienze, finiscono per abbellire le pretese dei più forti e vanificano il significato che avrebbero sulla bocca dei più deboli.
Onde, la conclusione potrebbe essere questa: queste belle parole non si prestano a diventare stendardi che mobilitano le coscienze in un moto e in una lotta comuni contro i mali del mondo, per la semplice ragione che ciò che è male per gli uni è bene per gli altri. La vera questione è la divisione tra potenti e impotenti. Tanto più le distanze diminuissero, tanto più l’ambiguità delle parole che usiamo diminuirebbe. Ma, è chiaro, qui il discorso deve finire, perché si deve uscire all’aperto, dove non bastano le parole ma occorrono le azioni.
Festival del diritto. Confronti a PiacenzaGli ultimi, i profughi e il diritto di avere la dignità di un nome
di Patrizia Maciocchi (Il Sole-24 Ore, 24.09.2016
Il diritto di avere diritti, il diritto all’orma. Gustavo Zagrebelsky, intervenuto alla prima giornata del Festival di Piacenza, ricorda il verso di Leopardi «tutto al mondo passa e quasi orma non lascia». Il giurista attira l’attenzione sul «quasi». Le nostre opere sono effimere ma non del tutto perché c’è un deposito delle esperienze. Ma non possono lasciare nessuna impronta i 69 milioni di bambini al di sotto dei 5 anni destinati a morire entro il 2030 secondo il rapporto dell’Unicef, spesso prima ancora di avere un nome. Nessuna impronta lasciano i milioni di profughi senza terra, siriani, turchi, sudamericani in un mondo nel quale non c’è più spazio per nessuno. Un mondo che cerca solo il modo per “smaltirli” pensando a piattaforme galleggianti o a navi in disarmo.
 Eppure - afferma Zagrebelsky - tutti dovremmo poter partecipare alla cultura, altrimenti siamo fuori dall’umanità. Malgrado questo non sia, malgrado si resti al sicuro nelle proprie case guardando immagini di morte attraverso le moderne tecnologie, si riesce comunque a parlare di dignità senza arrossire. Entrambi i candidati alla Casa Bianca - sottolinea Zagrebelsky - hanno affermato che lo stile di vita americano non è negoziabile, come non lo è quello delle altre culture europee. Ognuno deve stare al suo posto: «Lo stato sociale non è per tutti ma solo per quelli di casa».
Eppure - afferma Zagrebelsky - tutti dovremmo poter partecipare alla cultura, altrimenti siamo fuori dall’umanità. Malgrado questo non sia, malgrado si resti al sicuro nelle proprie case guardando immagini di morte attraverso le moderne tecnologie, si riesce comunque a parlare di dignità senza arrossire. Entrambi i candidati alla Casa Bianca - sottolinea Zagrebelsky - hanno affermato che lo stile di vita americano non è negoziabile, come non lo è quello delle altre culture europee. Ognuno deve stare al suo posto: «Lo stato sociale non è per tutti ma solo per quelli di casa».Di diritti fondamentali parla anche la giudice della Corte costituzionale Silvana Sciarra. «La dignità sta nella libertà dal bisogno e dunque nei salari sufficienti, nell’accesso al lavoro, nella tutela della salute». La Consulta - ricorda Sciarra - ha affermato la dignità nelle sue declinazioni: quella dell’embrione, il diritto alla riservatezza, la dignità dello straniero anche privo del permesso di soggiorno. Sciarra riconosce il ruolo delle Corti nell’interpretare i diritti, ma si chiede se lo fanno sempre bene. Un limite sta nel misurarsi con Stati indeboliti dalla crisi economica. Il problema per la giudice è nell’assicurare l’effettività del diritto, a cominciare dall’accesso al lavoro. «La dignità - afferma - deve essere anche uguaglianza di sacrifici, le misure di austerità non devono incidere sui diritti fondamentali, come il cibo e la salute. In Grecia - ricorda - il consiglio di Stato è intervenuto sui salari al di sotto della soglia di povertà, attraverso il diritto alla contrattazione collettiva». È comprensibile per la giudice che ci sia un’esigenza di contenimento di spesa, ciò che conta però è l’elemento della “temporaneità”: un diritto attenuato da una legge di stabilità deve essere “restituito”. Le Corti si occupano di pubblico impiego e di pensionati, Silvana Sciarra avverte però che ci sono anche i poveri, gli ultimi. Il filosofo Remo Bodei ricorda che gli uomini sono fatti tutti della stessa acqua, la differenza la fanno le rive, se sono larghe il fiume scorre tranquillo se, sono strette e tortuose l’acqua si intorbida. Oggi si parlerà ancora di migranti con il ministro dell’interno Angelino Alfano, di carceri, con Giuseppe Cascini e di equo processo con Franco Coppi e Armando Spataro.
- Il SONNO PROFONDO DEI GIUDICI COSTITUZIONALISTI, LA "LOGICA" DEL MENTITORE E IL GOLPISTICO TRIONFO DEL PARTITO DI "FORZA ITALIA".
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- "C’è un grande collegamento, enorme, tra fuga di cervelli e corruzione" (Il responsabile dell’Anac, Raffaele Cantone)24 settembre 2016, di Federico La Sala
- IL "LOGO" DELLA "SAPIENZA": MAMMASANTISSIMA. Il grande ordine simbolico del "Che_rùbino" ... tutti e tutto!!!
- IL PUTTANESIMO DELLO SPIRITO: LA DIPINTURA TUTTA CONTRARIA. LA LEZIONE IGNORATA DI GIAMBATTISTA VICO.
Università: Cantone, subissati da segnalazioni, collegamento fuga cervelli-corruzione
’Soprattutto sui concorsi. Riforma Gelmini ha creato problemi’ ha spiegato il responsabile dell’Autorità nazionale anticorruzione
di Redazione ANSA *
"C’è un grande collegamento, enorme, tra fuga di cervelli e corruzione". Lo ha sottolineato il responsabile dell’Anac Raffaele Cantone oggi a Firenze, intervenendo al convegno nazionale dei responsabili amministrativi delle università. Cantone lo ha detto dopo aver riferito che l’’Anac è "subissata" di segnalazioni di presunti casi di corruzione negli atenei italiani.
"Siamo subissati di segnalazioni su questioni universitarie, spesso soprattutto segnalazioni sui concorsi" ha spiegato il responsabile dell’Anac. "Non voglio entrare nel merito, non ho la struttura né la competenza - ha aggiunto - ma la riforma Gelmini secondo me ha finito per creare più problemi di quanti ne abbia risolti. Per esempio, ha istituzionalizzato il sospetto: l’idea che non ci possano essere rapporti di parentela all’interno dello stesso dipartimento, il che ha portato a situazioni paradossali".
 "In una università del Sud è stato istituzionalizzato uno ’scambio’: in una facoltà giuridica è stata istituita una cattedra di storia greca e in una facoltà letteraria una cattedra di istituzioni di diritto pubblico. Entrambi i titolari erano i figli di due professori delle altre università. Credo che questo sia uno scandalo e che lo sia il fatto che si sia stati costretti a fare questa operazione; se tutto avvenisse in trasparenza, la legge che nasce dalla logica del sospetto è una legge sbagliata".
"In una università del Sud è stato istituzionalizzato uno ’scambio’: in una facoltà giuridica è stata istituita una cattedra di storia greca e in una facoltà letteraria una cattedra di istituzioni di diritto pubblico. Entrambi i titolari erano i figli di due professori delle altre università. Credo che questo sia uno scandalo e che lo sia il fatto che si sia stati costretti a fare questa operazione; se tutto avvenisse in trasparenza, la legge che nasce dalla logica del sospetto è una legge sbagliata".Faremo linee guida per garantire la discrezionalità - Sull’università "proveremo a fare linee guida ad hoc, che non vogliono burocratizzare ma provare a consentire l’esercizio della discrezionalità in una logica in cui la discrezionalità però non diventi arbitrio, in cui discrezionalità significhi dare conto ai cittadini, non solo gli studenti ma tutti i cittadini perché l’università è il nostro futuro" ha spiegato Cantone.
 "L’università - ha aggiunto - dovrebbe essere l’esempio, per rilanciare il nostro Paese. Le classifiche internazionali, purtroppo, in questo senso, e se non ci premiano una delle cause sta anche in una serie di vischiosità del sistema universitario. Non concordo che le università italiane sono baracconi burocratici; ma all’estero tutti credono che lo siano, e sappiamo bene quanto conti non solo il fatto di essere ma anche di apparire. E questo apparire costituisce un danno enorme per il nostro Paese".
"L’università - ha aggiunto - dovrebbe essere l’esempio, per rilanciare il nostro Paese. Le classifiche internazionali, purtroppo, in questo senso, e se non ci premiano una delle cause sta anche in una serie di vischiosità del sistema universitario. Non concordo che le università italiane sono baracconi burocratici; ma all’estero tutti credono che lo siano, e sappiamo bene quanto conti non solo il fatto di essere ma anche di apparire. E questo apparire costituisce un danno enorme per il nostro Paese".-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- STORIA D’ITALIA.25 settembre 2016, di Federico La Sala
STORIA D’ITALIA
GIOVANI ITALIANI NEL MONDO (PRIMA CONFERENZA),
ATTENTI AL TRUCCO E ALL’INGANNO.
E ALLA VERGOGNA!!!
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- KANT CON DIOGENE E NON ALESSANDRO MAGNO E NAPOLEONE (O HITLER E MUSSOLINI)!!!19 settembre 2016, di Federico La Sala
L’ILLUMINISMO, OGGI. LIBERARE IL CIELO. -- KANT CON IL COSMOPOLITISMO DI DIOGENE E NON DI ALESSANDRO MAGNO E NAPOLEONE (O HITLER E MUSSOLINI)!!!:
Siamo umani, dunque globali
Quando gli chiesero quale fosse la sua patria, Diogene il cinico rispose che era un cosmopolita, un cittadino del mondo
di Mauro Bonazzi (Corriere della Sera, La Lettura, 18.09.2016)
Quando gli chiesero quale fosse la sua patria, Diogene il cinico rispose che era un cosmopolita, un cittadino del mondo. Una frase brillante, di cui Immanuel Kant si sarebbe ricordato nel 1784, quando diede alle stampe un breve saggio con un titolo lungo, Idee di una storia universale dal punto di vista cosmopolitico, che fondava su basi più solide l’ideale del cosmopolitismo. Solo una comunità politica universale permetterà agli uomini di realizzare la loro natura di esseri razionali e sociali, offrendo la possibilità di una vita soddisfacente. Questa, scriveva, è la meta verso cui ci stiamo dirigendo e per cui dobbiamo lottare.
Kant è stato un grande filosofo e per una volta si è rivelato buon profeta, visto che il cammino dell’umanità sta procedendo nella direzione di una sempre maggiore integrazione, proprio come lui aveva auspicato. Il suo entusiasmo, però, non troverebbe molto seguito oggi. Il mondo appare più piccolo ma i problemi sono sempre più complicati e diffusi. E così si leva insistente la voce di chi sogna un ritorno alle genuine tradizioni nazionali che fecero grande l’Europa e che l’Illuminismo avrebbe colpevolmente cancellato.
Fosse tutto così semplice: come ricorda Jean-François Pradeau (Gouverner avec le monde. Réflexions antiques sur la mondialisation, Manitoba/Les Belles Lettres, 2015), la vocazione universalista precede, e di molto, le discussioni di Kant e Voltaire. Cosmopolita è una parola greca: e lo è anche l’idea, che poi passò nel mondo cristiano. Gli uomini sono uguali e non si capisce perché non possano vivere insieme, seguendo le indicazioni della ragione: questi sono gli Stoici. Gli uomini sono tutti figli di Dio e non si capisce perché non debbano vivere insieme, aspirando alla pace comune: questo è Agostino. Anche «cattolico», lo si dimentica spesso, è un termine greco; vuol dire universale. Insomma: i Greci, il cristianesimo, l’Illuminismo. L’ideale cosmopolitico è parte costituente della tradizione europea.
Per gli antichi era tutta una questione di cerchi concentrici. Ciò che siamo, la vita che viviamo, si definisce a partire da una serie di relazioni sempre più estese: ci sono la famiglia e gli affetti privati; poi il mondo degli amici e del lavoro; e ancora, quello dei cittadini e della patria; e via di seguito fino al cerchio esterno che include tutti gli uomini. È evidente che ciò che ci è più vicino importa, e tanto. Ma non possiamo non riconoscere la linea di continuità che ci lega a tutti gli altri esseri umani in quanto esseri umani. In fondo dove nasciamo dipende in gran parte del caso: ma rimaniamo pur sempre parte dell’unica famiglia umana, membra dello stesso corpo. «Sono un Antonino, la mia patria è Roma; sono un essere umano, la mia patria è il mondo», scriveva Marco Aurelio, l’imperatore filosofo, accampato presso le rive del Danubio. Lo aveva già detto anche uno scrittore di commedie, Terenzio, arrivato a Roma dall’Africa (come Agostino del resto): «Sono un uomo, nulla che sia umano mi è estraneo».
Erano riflessioni che nascevano spontanee, tentativi di comprendere il senso della storia degli uomini, mentre Roma estendeva il suo controllo su parti sempre più estese del mondo conosciuto, e i confini tradizionali venivano meno. Non si trattava di annullare le differenze ma di accoglierle in un’unità più ampia. Le istituzioni sovranazionali odierne, nate per tutelare i diritti dell’uomo, affondano le radici in questa tradizione.
I problemi non sono soltanto, come si continua a ripetere, politici o economici, argomenti su cui gli antichi avevano peraltro idee strampalate. Platone e gli Stoici intitolavano i loro trattati Costituzione o Repubblica e finivano inevitabilmente per parlare di sesso. Diogene, poi, il primo cosmopolita confesso, con la politica non voleva avere proprio nulla a che fare, rifiutandosi di pensare che le convenzioni sociali o eventuali appartenenze di gruppo potessero concorrere a definire quello che lui era, la sua identità. Famigerato per i comportamenti scandalosi al limite del tollerabile (c’era un motivo se lo chiamavano il «cane»), fautore di una libertà così estrema da non essere desiderabile (ma davvero tutto può essere permesso?), ha comunque il merito di chiarire il vero problema in discussione con il cosmopolitismo.
È una questione prima di tutto individuale, che riguarda come noi vediamo noi stessi. Il confronto con gli altri è sempre faticoso: si giudica e si è giudicati, su tutto. Non è facile scoprire che molte delle idee e principi a partire da cui organizziamo le nostre giornate non costituiscono verità insindacabili ma sono semplici abitudini, che potrebbero anche essere modificate. La tentazione di rinserrarsi nel cerchio di ciò che è familiare o consueto nasce da qui ed è onnipresente. È scontato criticare gli operai inglesi che si sono chiusi al mondo votando contro l’Unione Europea. Ma, come ha scritto giustamente Ross Douthat sul «New York Times», bisogna stare attenti a non cadere nella retorica stantia che oppone nativisti (o localisti) e internazionalisti (o cosmopoliti).
I «cittadini globali» che si sentono sempre a casa propria in qualunque parte del mondo, e che però di fatto dormono in alberghi sempre uguali, comprano gli stessi vestiti negli stessi negozi, e fanno insomma sempre le stesse identiche cose in non importa quale posto (con l’aggiunta eventuale di un tocco di esotismo: un po’ di religiosità orientale, di dolce vita italiana...), non costituiscono una tribù anche loro? Una tribù, quel che è peggio, che non si riconosce come tale e non è perciò in grado di confrontarsi con gli altri gruppi di chi la pensa diversamente. È sempre una questione di appartenenza, e la sfida del cosmopolitismo è tutta qui, nell’invito a ripensare le nostre relazioni in tutte le direzioni.
«Essere vasto, diverso e insieme fisso», scriveva Montale: non rifiutare i rapporti più stretti, ma provare a guardare allo spettacolo della vita umana, così diverso eppure così simile, con occhi meno preoccupati. Al filosofo Pirrone è servito. Aveva seguito Alessandro Magno nella sua campagna alla conquista del mondo. Vide quanto vari o arbitrari potessero essere gli usi e i costumi dei popoli ma osservò anche che gli uomini si affaccendavano sempre dietro agli stessi problemi, sempre inquieti, come le api e le mosche. Senza giudicare, imparò a dare il giusto peso alle cose, liberandosi della pretesa di essere il centro del mondo. Si racconta che trovò la felicità.
I cerchi, intanto, continuano a espandersi. Quando Diogene o Marco Aurelio affermavano di essere cosmopoliti, intendevano quello che dicevano. Parliamo di mondializzazione, globalizzazione, cosmopolitismo, ma pensiamo sempre a noi stessi, agli uomini, mai al mondo (al globo, al cosmo). È come se importassimo solo noi. E invece quello che siamo dipende anche dalla nostra relazione con ciò che ci circonda.
Ogni tanto conviene alzare lo sguardo e realizzare che è tutto molto più grande: quale è il senso della nostra esperienza di esseri umani - di questa mia esistenza particolare - rispetto a questo universo immenso che ci circonda? Per gli antichi la domanda era naturale perché sentivano di far parte di un tutto vivente e perfettamente organizzato: anche i pianeti, esseri divini e perfetti che percorrono eternamente le loro orbite circolari, sostenevano, sono abitanti di quella città immensa che è l’universo, e dunque nostri concittadini. Può sembrare bizzarro, ma anche Dante nell’ultimo canto del Paradiso, quando ha finalmente coronato l’obiettivo del suo viaggio, inizia a ruotare («sì come rota ch’igualmente è mossa») intorno a Dio, «l’amor che move il sole e l’altre stelle». Ci sono di nuovo i cerchi e i moti circolari: l’immagine questa volta è aristotelica, ed è l’espressione di un’armonia raggiunta - con se stessi, con gli altri, con le cose, finalmente consapevoli di fare parte di un tutto che si squaderna ogni giorno nella sua meravigliosa regolarità. È questa la vera appartenenza: «La sola vera cittadinanza è quella che si esercita nell’universo», ripeteva il solito Diogene.
La scienza moderna ha definitivamente smantellato l’idea, in fondo così rassicurante, di un universo chiuso e perfettamente organizzato intorno a noi. E tutto diventa più complicato. Il pensiero corre a Friedrich Nietzsche, quando parlava di un universo che precipita eternamente, spaventoso nell’infinita solitudine del tutto («non si è fatto più freddo?»); o alla luna di Giacomo Leopardi nel Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, silenziosa, indifferente, ormai estranea, lontana. Sono immagini suggestive. Ma troppo unilaterali, forse. Perché il mondo è anche la natura, quel ciclo della vita che fiorisce intorno a noi, e di cui dovremmo ritornare a riconoscere il ritmo, come esortava un poeta, Archiloco, consapevoli del fatto che anche noi ne facciamo comunque parte.
Gli antichi non avrebbero mai creduto che l’uomo potesse arrivare a modificare l’ambiente naturale che lo circonda, come invece sta accadendo. Ma, per una volta tutti insieme senza litigare, avrebbero osservato con uno sguardo benevolo i presidenti degli Stati Uniti d’America e della Repubblica Popolare cinese, Barack Obama e Xi Jinping, firmare l’accordo per ridurre le emissioni di gas inquinanti.
La terra sarà pure un piccolo punto insignificante e marginale nelle immensità dell’universo; la vita sarà pure il risultato casuale di alcune reazioni chimiche innescatesi accidentalmente. Ma sarebbe comunque un peccato sprecare tutto, no?
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- L’ITALIA CONTESA DA "DUE" PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA E IL MANCATO GIUDIZIO DI SALOMONE!!!18 settembre 2016, di Federico La Sala
TWEET (18.09.2016). L’ITALIA CONTESA DA "DUE" PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA E IL MANCATO " GIUDIZIO DI SALOMONE":
UN OMAGGIO A #Ciampi. A sua memoria. RIPARTIRE DALL’#Italia: VIVA L’ITALIA, VIVA LA #Costituzione ... http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=913
#Ciampi LA #BIBBIACIVILE e il #Giudizio di #SALOMONE (la #Cortecostituzionale senza #coscienza e #sapienza) ... http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=5171
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- FESTIVAL DI FILOSOFIA: "AGONISMO". L’agone del pensiero critico: “Si corre per vincere, anche San Paolo invitava a colpire duro”!!!15 settembre 2016, di Federico La Sala
L’agone del pensiero critico
Anticipiamo stralci della relazione che il filosofo francese terrà all’annuale appuntamento di Modena, Carpi e Sassuolo. Quest’anno il tema scelto è l’«agonismo»
di Jean-Luc Nancy (il manifesto, 15.09.2016)
Perché oggi si parla tanto spesso di «pensiero critico»? Con questo nome si vuole indicare un pensiero che si sottrae al presunto «pensiero unico», a una dimensione, non contestabile. Ma questo pensiero, che viene accusato di imporsi abusivamente come la via unica della globalizzazione della libera concorrenza - generando discriminazioni ovunque, con le sue appropriazioni senza controllo - questo pensiero e tutto il sistema tecnico-economico che lo sostiene si è dispiegato a partire dal venir meno di una lunga serie di pensieri critici (o «alternativi», come si è cominciato a chiamarli). Si deve dunque ritrovare una capacità critica che sarebbe andata perduta per sbaglio? Ma resterebbe ancora da capire perché e come questa perdita sia avvenuta.
La critica discerne, distingue e consente di suddividere gli oggetti di pensiero in ricevibili e non-ricevibili. Alcune grandi tappe segnano la storia filosofica di questo concetto. Immanuel Kant distingue i fenomeni (costruiti da operazioni dell’intelletto congiunte ai dati della sensibilità) dalle rappresentazioni della realtà in sé, che non sono sottoposte a questa costruzione.
 Marx distingue la sequenza di produzione, scambio e appropriazione secondo i momenti dell’idea hegeliana dalla stessa sequenza secondo le condizioni reali, in un dato momento storico, della proprietà dei mezzi di produzione.
Marx distingue la sequenza di produzione, scambio e appropriazione secondo i momenti dell’idea hegeliana dalla stessa sequenza secondo le condizioni reali, in un dato momento storico, della proprietà dei mezzi di produzione.
 Se c’è per Husserl una «crisi delle scienze europee» è perché le scienze non possono più pretendere di indicarci il «senso dell’esistenza», che va dunque distinto dalla loro scientificità. Con la Critica della ragione dialettica, Jean-Paul Sartre vuole distinguere, rispetto alla razionalità delle scienze, una «ragione nuova», aperta alla «comprensione dell’uomo da parte dell’uomo». Infine, per tutta la durata di questa lunga sequenza e dal XVII secolo, la critica letteraria e artistica distingue tra opere conformi a programmi già classificati e opere che creano una forma inedita, forse mal identificabile, ma riconoscibile come dotata di virtù estetica.
Se c’è per Husserl una «crisi delle scienze europee» è perché le scienze non possono più pretendere di indicarci il «senso dell’esistenza», che va dunque distinto dalla loro scientificità. Con la Critica della ragione dialettica, Jean-Paul Sartre vuole distinguere, rispetto alla razionalità delle scienze, una «ragione nuova», aperta alla «comprensione dell’uomo da parte dell’uomo». Infine, per tutta la durata di questa lunga sequenza e dal XVII secolo, la critica letteraria e artistica distingue tra opere conformi a programmi già classificati e opere che creano una forma inedita, forse mal identificabile, ma riconoscibile come dotata di virtù estetica.Ciascuno di questi orientamenti critici implica il ricorso a un criterio o a un sistema criteriologico. La sperimentazione scientifica è definita dalla misura, il valore del prodotto dalla relazione col suo produttore, la virtù estetica dalla messa in opera di una certa idea di bello o di sublime. Ciascuno di questi criteri chiama in causa a sua volta una definizione preliminare: la misura e il suo calcolo, il valore dell’uomo in quanto produttore della propria esistenza, il bello o il sublime definiti - per esempio - dal lato dell’armonia oppure da quello dell’irregolarità.
In un certo senso Kant, Marx, Husserl e tutti i grandi critici sapevano da sempre che il loro criterio o la loro criteriologia implicita erano un impossibile (l’incondizionato, l’uomo totale, il logos). Spetta a noi decidere di esporci ad esso, piuttosto che «capirlo» di nuovo.
Esporci ad esso presuppone di opporsi al possibile e opporsi richiede lo scontro e il combattimento. C’è dunque un nemico. Kant, Marx, Husserl hanno avuto dei nemici (la metafisica, l’economia politica, la fatica dello spirito) e pertanto hanno capito che la critica non deve essere «solo un bisturi ma un’arma» (Marx). Con Marx questa arma è diventata materiale. «L’arma della critica non potrebbe sostituire la critica delle armi; la forza materiale può essere abbattuta solo dalla forza materiale».
Tuttavia la critica delle armi ha finito per rovesciare il senso del suo genitivo: da soggettivo (critica attraverso le armi) si è dimostrato oggettivo (messa in discussione delle armi). In effetti l’uso critico delle armi si è fatto trascinare dalla propria forza in un dominio che non ha conservato in sé l’arma della critica e l’appello all’impossibile. Al contrario, il «troppo possibile» del dominio ha bloccato l’apertura verso l’impossibile. La critica attraverso le armi ha smontato l’arma della critica. E infine la critica delle armi è diventata il commercio delle armi: non solo la loro produzione per denaro, ma il loro uso per un dominio esercitato innanzitutto dalla morte e su dei morti.
La crisi allora è tornata, ma solo come nome della divisione interna del «troppo possibile»: la produzione che sa di non produrre l’uomo, l’uomo che sa di non esporsi all’impossibile o di confonderlo con il «troppo possibile». Il capitalismo diventa nemico di se stesso e si fa la guerra. L’Impero si divide contro se stesso. Si pretende di ritrovare o recuperare questo o quell’elemento normativo - un capitalismo regolato, una democrazia virtuosa, un uomo umanista, un progresso controllato, uno sviluppo sostenibile - ma si fa appello a qualcosa che è già stato criticato e autocriticato da cima a fondo...
Nella Roma degli stoici, degli epicurei e degli scettici non si smetteva mai di criticare il corso delle cose e degli affari. Ma la crisi finì per spazzare via le critiche e spuntò un’altra cosa, inedita e come impossibile, chiamata «cristianesimo». È lui che oggi sperimenta la crisi del suo infinito, che non maschera più le discriminazioni sempre più gravi che fomenta. Perciò anche questa crisi deve essere sottoposta a critica, in quanto nasconde e ottura il senso dell’impossibile e l’impossibilità del senso. Ma in fondo questa critica è già fatta. Non cessa di farsi ogni giorno e al tempo stesso di sapersi anch’essa in crisi.
Traduzione di Michelina Borsari
- HUSSERL CONTRO L’HOMUNCULUS: LA ’LEZIONE’ DI ENZO PACI AI METAFISICI VISIONARI (ATEI E DEVOTI) DI IERI (E DI OGGI).
I personal trainer della democrazia
Dalle categorie del politico alla «negazione». Un fitto calendario di appuntamenti, tra lectio magistralis, mostre e performance teatrali
di Benedetto Vecchi (il manifesto, 15.09.2016)
L’agonismo è quella forma di conflitto che ha un perimetro e regole ben definiti. Il perimetro definisce i luoghi e il contesto istituzionale dove si manifesta. Le regole definiscono i limiti della sua manifestazione. La violazione di uno dei due aspetti è sanzionato con una penalizzazione. La dimensione sociale che meglio rappresenta questa tendenza a governare il conflitto è lo sport.
Non è quindi un azzardo affermare che lo sport è la continuazione della politica con altri mezzi, cancellandone però le dimensione che le sono proprie: visioni del mondo che si scontrano, interessi sociali e economici alteri e oppositivi gli uni all’altri. È infatti la democrazia politica in salsa liberale che fa dell’agonismo la misura della sua esistenza e legittimazione. Non ci sono nemici nell’agire politico liberale, bensì solo avversari. Si possono condurre battaglie brevi o blitz fulminanti ma sempre all’interno di un quadro normativo che non prevede rottura. L’agonismo è dunque il simulacro del conflitto sociale, politico, di classe.
Non è però ignoto il fatto che sin dalla antica Grecia che l’agonismo - e dunque lo sport - svolge questa funzione preventiva del conflitto e della guerra, intesa come la continuazione della guerra con altri mezzi. C’è poi l’agonismo sportivo. Anche qui le radici sono antiche. Elemento che non ha impedito che lo sport diventasse una industria globale che plasma l’immaginario collettivo e contribuisce in maniera significativa alla formazione dell’opinione pubblica.
È questo ordine di problemi che il festival della filosofia di Modena, Carpi e Sassuolo affronterà da domani fino a domenica 18 settembre. Per tre giorni, secondo un consolidato format di successo, la filosofia scende quindi di nuovo in piazza. Lectio magistralis, incontri ravvicinati, performance artistiche, mostre (quest’anno ce ne è una dedicata agli album di figurine: al Mata di Modena con il titolo I migliori album della nostra vita) e un pubblico in ascolto che può rivolgere domande al relatore di turno.
Da questo punto di vista anche un Festival della filosofia ha molto a che fare con l’agonismo. Soltanto che la partita è tra più giocatori, bensì tra un relatore e un pubblico, che usa gli incontri non solo passivamente, ma anche come un momento di formazione e di accesso alla cultura altrimenti interdetto (tutte le iniziative live sono gratuite).
Il «Festival della filosofia» è uno degli esempi di successo di come la spettacolarizzazione della cultura attivi un circolo virtuoso economico che vede la partecipazione della locale università, delle case editrici e della Fondazione San Carlo e di banche e imprese private.
Una kermesse che è cresciuta nel tempo, moltiplicando, anno dopo anno, gli incontri.
Cercare di ricostruire un significativo filo rosso è sempre un’operazione unilaterale. Per quanto riguarda questa edizione, va segnalata la lectio magistralis della filosofo dalle politica Chantal Mouffe sulla «democrazia agonistica », l’intervento del filosofo francese Jean-Luc Nancy sul cosa è il pensiero critico, la relazione di Alessandro Dal lago sulla relazione del rapporto tra noi e gli altri, polarità imprescindibile dell’agonismo, cioè quella forma di occultamento del conflitto e dimensione propedeutica alla «messa all’angolo» dei migranti.
La parte del leone la svolgeranno ovviamente i filosofi e i sociologi. Zygmunt Bauman, ad esempio, affronterà il tema del «competere»; Nello Preterossi farà «emergere le categorie del politico», svelando così l’ambivalenza del lemma «agonismo». Sulla stessa scia le relazioni di Giacomo Marramao, Simona Forti e Nadia Fusini e Stefano Rodotà. Peter Sloterdijk parlerà invece di «esercizi sportivi». Ci sono infine relazioni che sparigliano le carte. Vanno in questa direzione la lezione di Marcello Musto sull’opera di Karl Marx e la lectio magistralisi di Paolo Virno sulla negazione. Il programma completo è consultabile nel sito: www.festivalfilosofia.it
Remo Bodei
“Si corre per vincere, anche San Paolo invitava a colpire duro”
Il filosofo: i greci ci hanno dato la linea
di Francesca Sforza (La Stampa, 15.09.2016)
Quest’anno si corre, al Festival della Filosofia di Modena. Si corre per capire, per restare al passo con il tempo inquieto della contemporaneità. E anche, un po’, per vincere. Remo Bodei, professore di Filosofia presso la University of California a Los Angeles e Presidente del comitato scientifico del Festival, è uno dei protagonisti di questa maratona del pensiero.
Professore, partiamo dall’origine greca della parola agonismo, cosa resiste dell’antica accezione del termine, e cosa invece è andato perduto o si è trasformato?
«“Agon” è la lotta in vista di una vittoria, in tutte le sue accezioni, fino all’agonia, che è la lotta estrema contro la morte. Direi che grosso modo si è conservato l’essenziale dell’accezione greca, che anzi si è estesa dal campo di partenza, quello sportivo, ad altri ambiti, penso ad esempio a quello economico, che vede tra l’altro l’uso di un modello di origine sportiva di tipo specifico, la corsa. Se pensiamo poi alla concorrenza, come non ricordare la metafora agonistica usata da San Paolo nella prima lettera ai Corinzi? “Non sapete che, nelle corse allo stadio, tutti corrono, ma uno solo conquista il premio? Correte anche voi in modo da conquistarlo”, scrive San Paolo, sottolineando che la differenza, semmai, è nel fatto che gli atleti si muovono per “una corona che appassisce”, mentre i cristiani sono chiamati per “una che dura per sempre”. Interessante notare il suo riferimento al pugilato - “Io dunque corro, ma non come chi è senza mèta; faccio pugilato, ma non come chi batte l’aria”, cioè invita a colpire in modo da fare male».
In che cosa differisce l’agonismo religioso da quello laico?
«Più che di differenze parlerei di una ripresa laica dello stesso tema, ad esempio con Hobbes, in cui la gara non è conquistare il paradiso, ma vincere sugli altri al punto che la felicità consiste nel sorpassare, l’infelicità nel rimanere indietro, e la fine della corsa - l’abbandono della gara - coincide con la morte. Non c’è nessun premio, nella visione laica di Hobbes, si corre per vincere».
Nella condizione agonistica prevale il cimentarsi con la vittoria (e il rassegnarsi alla sconfitta) o il partecipare alla lotta e alla competizione?
«Se uno prendesse alla lettera Pierre de Coubertin si corre per gareggiare e confrontarsi, ma da un punto di vista più essenziale la concorrenza è spietata, quindi si corre per vincere. La cosa interessante che emergerà da alcune lezioni è che sul piano animale c’è una forma di altruismo che fa bene alla competizione, e anche in campo economico, la cosiddetta economia altruistica, insegna che non sempre è un bene stravincere. Ne parlerà Massimo Recalcati in un suo intervento: anche essere sconfitti aiuta a crescere».
È pensabile una declinazione equa dell’agonismo?
«Nei cicli vitali ci sono sempre i salvati e i sommersi, per dirla con Primo Levi, e la conquista della democrazia vorrebbe che ci fossero, intorno a noi, non nemici, ma avversari. Il problema è nelle condizioni di partenza: è vero che bisogna crearle, in modo tale che poi ognuno sia messo in grado di fare la sua corsa, ma spesso è un’ipocrisia».
Quali sono gli autori che meglio di altri hanno illustrato la dimensione dell’agonismo?
«Nella filosofia è davvero una dimensione iniziale. Pitagora paragonava la contemplazione filosofica con l’andare allo stadio a guardare i contendenti - aggiungendo che se c’era una differenza consisteva nel fatto che la contemplazione filosofica era gratis, mentre allo stadio si doveva pagare. Nei cosiddetti presocratici, il “polemos”, la guerra, è il padre di tutte le cose, segna l’inizio per eccellenza. E da questo discendeva non solo una filosofia, ma un modo di vita per cui la disciplina, l’entrare in conflitto con se stessi, il sottoporsi a esercizi fisici e spirituali, rafforza l’individuo».
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- Occidente senza utopia, senza profezia, e futuro. Un saggio di Massimo Cacciari e Paolo Prodi.13 settembre 2016, di Federico La Sala
- RICERCA E MERAVIGLIA: AL SAN RAFFAELE, UNA GRANDE FESTA FILOSOFICA! IL "VECCHIO" PROBLEMA DEL PENSIERO DELLA COSTITUZIONE E DELLA COSTITUZIONE DEL PENSIERO E’ STATO RISOLTO !!!
 ALL’OMBRA DELL’UOMO DELLA PROVVIDENZA: 2002-2012, DIECI ANNI DI FILOSOFIA AL "SAN RAFFAELE".
ALL’OMBRA DELL’UOMO DELLA PROVVIDENZA: 2002-2012, DIECI ANNI DI FILOSOFIA AL "SAN RAFFAELE".
Guida al nuovo occidente che ha perduto l’idea di futuro
Il saggio di Massimo Cacciari e Paolo Prodi analizza la crisi della società attraverso il declino di due categorie fondamentali: “profezia” e “utopia”
di Roberto Esposito (la Repubblica, 13.09.2016)
- IL LIBRO Occidente senza utopie di Massimo Cacciari e Paolo Prodi (il Mulino pagg. 150, euro 14)
In molti oggi parlano di crisi dell’Europa e dell’Occidente. Ma ben pochi risalgono alla sua origine scavando tanto a fondo nel corpo della nostra tradizione, come fanno Massimo Cacciari e Paolo Prodi nel loro Occidente senza utopie (il Mulino). Ciò che, pur nella diversità degli strumenti, incrocia i loro sguardi è da un lato il rifiuto di categorie lineari come quella di laicizzazione; dall’altra il coraggio di dichiarare il fallimento del progetto moderno.
La grande tradizione che è nata dalla tensione tra Atene e Gerusalemme e che, attraverso Roma, è sfociata nel diritto pubblico europeo, è arrivata a termine e non è possibile riattivarla, se non passando per la piena consapevolezza di quanto è accaduto. Se non si ha la forza, come scrive Paul Valéry, di fissare gli spettri che ci lasciamo alle spalle, non basteranno incontri di vertice o rifondazioni istituzionali per riprendere quel cammino interrotto.
I due paradigmi su cui gli autori misurano la distanza che separa il presente dalle sue radici, sono quelli di profezia e di utopia. Senza la potenza critica che hanno sprigionato nei secoli, alla nostra civiltà mancherebbe un lievito decisivo. Eppure il loro orizzonte è stato profondamente diverso.
La profezia - al centro del saggio di Prodi - ha espresso una critica del potere che ha aperto lo spazio di libertà per la creazione della democrazia. È lo spirito profetico che per la prima volta, in Israele, ha separato il sacro dal politico, rompendo l’identificazione teologico- politica tra potere e legge.
Profeta è colui che, da un punto marginale, ha l’autorità per contestare il potere regale e sacerdotale. Il divieto ebraico di pronunciare il nome di Dio va inteso anche come difesa da ogni indebita sacralizzazione del potere. Ma anche la distinzione cristiana tra quel che è di Cesare e quel che è di Dio conserva, fino a un certo momento, la distinzione.
Tuttavia la figura del profeta non resiste a lungo. Già ridotta nel Medioevo a quella del predicatore, è presto espulsa fuori dall’“accampamento” cristiano, nelle frange ereticali. Tradotta in un impossibile progetto politico da Savonarola, a partire da fine Settecento si fa da un lato anelito rivoluzionario e dall’altro contatto personale con Dio. Dopo la parentesi dei totalitarismi, interpretabili come forme perverse di religione politica, nell’attuale dominio della finanza globale sembra venuto meno ogni impulso profetico. E con esso l’anima stessa dell’Occidente.
Un percorso diverso, ma altrettanto esaurito, quello dell’utopia, ricostruito genealogicamente da Cacciari. Intanto essa non va confusa con le mitologie, antiche e medioevali, di ritorno alle origini. L’utopia si strappa dal passato per radicarsi nel proprio tempo con la potenza di un progetto volto al futuro. Da qui il rilievo che in essa hanno la scienza e la tecnica.
Se si passa dall’Utopia di Moro alla Città del sole di Campanella, alla Nuova Atlantide di Bacone, questo elemento costruttivo, sistematico, viene sempre più in primo piano. Organizzazione economica, incremento del sapere e tolleranza religiosa sono le precondizioni di una società armonica e pacifica. Ma è proprio questo progetto di neutralizzazione dei conflitti a entrare presto in contrasto con la realtà altamente conflittuale dell’Europa moderna. Non solo la politica, ma anche lo sviluppo dell’economia e della scienza passano per un continuo susseguirsi di crisi che rompono ogni immagine di armonia.
Se le utopie ottocentesche di Fourier e Proudhon presuppongono la crisi della forma-Stato, Marx mette impietosamente a nudo il carattere ideologico dell’utopia. Mentre ancora Bloch persegue una proiezione salvifica verso il futuro, Benjamin revoca in causa ogni modello progressivo. Contro il principio-speranza di Bloch e la coscienza di classe di Lukács, egli nega che la redenzione possa passare per la prassi. Solo l’irrompere del divino nella storia può produrre novità radicale. Ormai l’idea di rivoluzione implode su se stessa insieme a quella di riforma.
La via per il futuro è sbarrata. E dunque cosa resta da fare? La risposta di Cacciari, già da tempo avanzata, è quella di un dualismo assoluto. Autonomia del politico, sempre più ridotto a tecnica amministrativa, da un lato. E attesa di un Dio impossibile dall’altro. Weber e Wittgenstein: limpidezza dello sguardo e sobrietà delle parole. Tra i due, l’ascolto dei segni enigmatici con cui il Nuovo può sempre annunciarsi.
- RICERCA E MERAVIGLIA: AL SAN RAFFAELE, UNA GRANDE FESTA FILOSOFICA! IL "VECCHIO" PROBLEMA DEL PENSIERO DELLA COSTITUZIONE E DELLA COSTITUZIONE DEL PENSIERO E’ STATO RISOLTO !!!
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- AGONISMO:FESTIVAL DELLA FILOSOFIA 2016. Dal 16 al 18 settembre fra Modena, Carpi e Sassuolo, lezioni, show, mostre..11 settembre 2016, di Federico La Sala
- Tracce per una svolta antropologica: LE "REGOLE DEL GIOCO" DELL’OCCIDENTE E IL DIVENIRE ACCOGLIENTE DELLA MENTE.
- PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!! FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.
Evoluzione, concorrenza, amore, migrazioni...
Da venerdì a Modena, Carpi e Sassuolo l’agonismo è al centro di lezioni, show, mostre
La natura della competizione
 “Nelle cose umane e non umane, il divenire altro non è forse invadere, quindi sopprimere l’altro?”, si chiede Emanuele Severino
“Nelle cose umane e non umane, il divenire altro non è forse invadere, quindi sopprimere l’altro?”, si chiede Emanuele Severino “Fin dall’infanzia lottiamo contro noi stessi per vincere l’egoismo e accettare la sofferenza”, dice Remo Bodei
“Fin dall’infanzia lottiamo contro noi stessi per vincere l’egoismo e accettare la sofferenza”, dice Remo Bodeidi Laura Montanari (la Repubblica, 11.09.2016)
Diciamo agonismo e pensiamo a un campo di calcio, a una pista di atletica, a una competizione sportiva. In realtà il pensiero della gara ha estensioni più ampie se lo caliamo nel quotidiano e pervade non soltanto la vita delle persone nelle corse sul lavoro o nella carriera, ma il nostro io e la collettività nelle mutazioni che l’etá e i tempi ci impongono. È un tema, l’agonismo, che si presta a molte articolazioni, per questo è stato scelto dal Festival della Filosofia per tessere la oramai tradizionale tre giorni di incontri, lezioni, letture, spettacoli, mostre, percorsi gastronomici che si terranno dal 16 al 18 settembre fra Modena, Carpi e Sassuolo.
Una forma di agonismo è anche il conflitto, la guerra, il pòlemos greco. Emanuele Severino, docente di Filosofia teoretica all’ateneo di Venezia e all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, interverrà al festival rovesciando le parole di Eraclito, “la guerra è la madre di ogni cosa” per spingersi a dire che è la cosa concepita dal pensiero greco classico come oscillante tra essere e nulla, a diventare la madre di tutti i conflitti e le contraddizioni. “È la cosa che produce la guerra», spiega Severino, «è il modo in cui sin dall’inizio l’uomo intende l’esser cosa che produce ogni guerra. E una cosa è l’uomo, il cibo, la casa, l’albero, la stella, il dio... Sarebbe già un passo innanzi notevole se si riuscisse a far venire il sospetto in chi ascolta che quanto si sta dicendo non è un vuoto fantasticare. La cosa è sempre stata intesa su come trasformarsi, come diventare altro da ciò che essa è, e come un esser diventata da altro. Ma nelle cose umane e in quelle non umane, il diventare altro non è forse invadere e quindi sopprimere l’altro? Non è forse la forma più radicale di guerra?».
Il senso dell’essere, spiega Severino, sta alle radici delle guerre del nostro tempo, e allora ecco che il viaggio dei filosofi al Festival offre le chiavi o gli interrogativi per affrontare questioni politiche, come fa per esempio Roberto Esposito, docente alla Scuola Normale di Pisa, che terrà un intervento sulla crisi biopolitica dell’Europa. «La crisi economica degli ultimi anni è diventata biopolitica nel senso che impatta fortemente con la vita delle persone», sostiene l’autore del saggio pubblicato da Einaudi Da fuori. Una filosofia per l’Europa. «Pensiamo soltanto alla questione dei migranti che minaccia di cambiare antropologicamente l’Europa o al terrorismo che provoca lutti e distruzioni con i corpi che si fanno esplodere. Viviamo in un momento di paure e insicurezze ». Come ne possiamo uscire? «Con misure urgenti che trasformino l’Unione Europea in un vero soggetto politico e non soltanto economico», risponde il filosofo, «definendo i confini esterni, lavorando all’integrazione delle norme giuridiche, alla riforma delle polizie, trovando un lessico comune per istituzioni e sistemi giuridici».
Il Festival della Filosofia, finanziato dalla Regione Emilia Romagna, da Confindustria e Camera di Commercio di Modena, dal Gruppo Hera, dall’Ente Cassa di Risparmio di Modena e dal Consorzio di enti e istituzioni creato apposta, compie sedici anni: è diventato il primo evento in Europa dedicato in senso stretto alla filosofia. Studenti e giovani rappresentano oltre il 25% del pubblico la cui età media si attesta intorno ai 44 anni (il 60% sono laureati). Si affronterà il tema dell’agonismo con riflessioni che cercheranno di riformulare la tensione tra competizione e collaborazione indagando tanto le valenze della concorrenza economica quanto «il valore positivo che il conflitto può rivestire nella vita delle democrazie», spiegano gli organizzatori.
Lungo l’elenco dei relatori, selezionati fra i nomi importanti del panorama nazionale e internazionale, da Zygmunt Bauman a Jean-Luc Nancy, da Stefano Zamagni a Umberto Galimberti, Massimo Cacciari, Giacomo Marramao, Michela Marzano, Marc Augé, Peter Sloterdijk, Enzo Bianchi, Mario Vegetti, Stefano Rodotà e altri, compresi giornalisti, attori, scienziati.
«Sì, anche scienziati », spiega Michelina Borsari, direttore della manifestazione, «perché il Festival è una piattaforma sulla quale intervengono le varie voci del presente. Discuteremo del pòlemos calato nel contesto astrofisico delle collisioni cosmiche come la fusione di due buchi neri capaci di ingenerare increspature nello spazio che lasciano come tracce le onde gravitazionali». Ne parleranno Paola Puppo e Fulvio Ricci, l’équipe dell’Istituto di Fisica Nucleare che ha collaborato con la statunitense Ligo proprio sulle onde gravitazionali. «Ma avremo anche spazio per discutere del corpo nello sport con un grande sociologo per la prima volta ospite del Festival, George Vigarello, direttore dell’École des Hautes Etudes en Sciences Sociales di Parigi; e un altro volto al debutto, Jean Noel Missa, membro del comitato belga di Bioetica, che affronterà il tema del doping. E ancora, c’è l’aspetto biologico legato alla lotta per la vita con l’intervento di Telmo Pievani che parlerà sul carattere casuale e contingente della selezione. E poi ci saranno, fra gli altri, Enrico Alleva e Vittorio Gallese, uno degli scopritori dei neuroni specchio».
Al direttore del Comitato scientifico del Festival Remo Bodei (docente alla Ucla, l’Università della California) è affidata la lectio magistralis sul “Vincere contro se stessi” (venerdì 16, ore 18, in piazza Grande, Modena): «È una lotta che ciascuno di noi conduce fin dall’infanzia per superare ostacoli e difficoltà, per vincere gli impulsi e le tendenze egoistiche, per sottoporsi alla disciplina e saper anche accettare le sofferenze », sintetizza. È l’addio all’etá dell’innocenza, l’elaborazione dei desideri, quel crescere che ci costringe - prima o poi - a misurare la distanza fra aspirazioni e vita quotidiana.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- La sfida dell’educazione delle giovani generazioni e gli antropologi.9 settembre 2016, di Federico La Sala
- FILOSOFIA, ANTROPOLOGIA, E STORIA. UOMINI E DONNE, PROFETI E SIBILLE, OGGI...
 IL "SOGNO" DI MICHELANGELO: "DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE". Sibille e profeti: sulle tracce di Benjamin - di Nicola Fanizza.
IL "SOGNO" DI MICHELANGELO: "DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE". Sibille e profeti: sulle tracce di Benjamin - di Nicola Fanizza.
- ANTROPOLOGIA CRITICA: LE "REGOLE DEL GIOCO" DELL’OCCIDENTE E IL DIVENIRE ACCOGLIENTE DELLA MENTE.
Antropologi nelle scuole per lezioni di convivenza.di Marino Niola (la Repubblica, Il Venerdì, 09.09.2016)
La paura degli attentati, la polemica sul burkini, l’emergenza migranti, le discussioni sulla poligamia, il velo trasformato in simbolo identitario, la demagogia xenofoba montante. Le cronache di quest’estate hanno tutte come minimo comune denominatore il rapporto sempre più problematico tra noi e gli altri. Perché da un po’ di tempo la differenza genera diffidenza. E ogni alterità appare come una minaccia alla nostra identità.
Fino a qualche anno fa ci sembrava di essere in grado di assorbire i problemi posti dal multiculturalismo incipiente e di poterne godere i vantaggi, soprattutto economici. Ma oggi i processi di integrazione che sembravano, sia pur faticosamente, avviati, sembrano invece in stand by. E su questo impasse il terrorismo getta benzina sul fuoco, spingendo le teste calde d’Europa verso una radicalizzazione che trova nell’integralismo religioso simboli, parole d’ordine e ideologie per esprimere un antagonismo che in altri tempi avrebbe preso strade diverse.
E quel che emerge in maniera preoccupante è che non ci siamo per nulla attrezzati a governare le differenze con le quali conviviamo gomito a gomito. Perché? Semplice, perché non abbiamo imparato a conoscerle. Ma, come avrebbe detto il maestro Manzi, alfabetizzatore televisivo dell’Italia in bianco e nero, non è mai troppo tardi.
E oggi, proprio come allora, c’è bisogno di una nuova educazione alla convivenza con chi è diverso. In una parola un’alfabetizzazione all’antropologia culturale. Che è l’unico sapere specializzato nello studio delle altre culture e, soprattutto delle compatibilità tra tradizioni, modi di vita, usi e costumi dei diversi popoli. Insomma è urgente avviare un iter formativo che vada dalla scuola all’università alla società.
E proprio per porre all’ordine del giorno questa emergenza pedagogica, gli antropologi europei, riunitisi di recente a Milano rispondendo alla chiamata delle due associazioni italiane, Anuac (Associazione nazionale universitaria degli antropologi culturali) e Aisea (Associazione italiana per le scienze etno-antropologiche), hanno lanciato un appello alle istituzioni scolastiche perché introducano l’antropologia in tutti i percorsi educativi come arma per combattere razzismo, integralismo e intolleranza.
È assurdo e anacronistico che in un mondo sempre più globalizzato, dove credenze, valori, consuetudini antitetiche coabitano in una prossimità sempre più conflittuale, sia clamorosamente latitante proprio una materia come l’antropologia che, dello studio dei modi di fare, pensare e sentire degli altri ha fatto la sua mission conoscitiva.
 Figlia primogenita dell’umanesimo e dell’illuminismo occidentale.
Figlia primogenita dell’umanesimo e dell’illuminismo occidentale.Non a caso, come diceva il celebre etnologo Claude Lévi-Strauss, solo l’Occidente ha prodotto antropologi, anche come controcanto critico, e autocritico, del colonialismo. E fa riflettere il fatto che proprio nei Paesi islamici da cui provengono, direttamente o indirettamente, i terroristi di Daesh,l’antropologia sia addirittura bandita dai programmi d’insegnamento. Perché mettendo sullo stesso piano tradizioni, religioni e valori, revoca radicalmente quella superiorità di alcuni popoli sugli altri sancita dal Corano. Una ragione in più per diffondere nelle nostre classi scolastiche e universitarie questo insegnamento doppiamente fondamentale. Sia per i ragazzi di cultura europea sia per i migranti di seconda e terza generazione che, sempre più spesso, reagiscono negativamente all’impatto con il Paese ospitante. Col risultato di rinchiudersi nella propria apartheid identitaria. E di radicalizzare la propria origine, o il proprio credo, trasformandoli in un’arma politica a disposizione del fondamentalismo.
La sfida dell’educazione delle giovani generazioni richiede innanzitutto l’alfabetizzazione degli alfabetizzatori, ovvero la formazione degli insegnanti. Che devono fare propri gli strumenti dell’antropologia «per educare i loro allievi al confronto positivo con le diversità, da quelle di genere, a quelle culturali, fino a quelle religiose».
A dirlo è Cristina Papa, dell’Università di Perugia e presidente dell’Anuac che, insieme a Mario Bolognari, professore a Messina e leader dell’Aisea, sottolinea le possibilità innovative offerte dalla legge 107, la cosiddetta riforma Giannini. Che, tra le competenze trasversali, ritenute indispensabili per tutti i docenti, indipendentemente dalla disciplina che insegneranno, prevede anche quelle antropologiche.
Purché, sottolinea Papa «i decreti attuativi, che sono in via di elaborazione a livello ministeriale, rispondano pienamente agli obiettivi della legge e diano uno spazio adeguato all’antropologia in tutte le fasi della formazione». Si tratta di problemi che Paesi come Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e Canada affrontano da tempo. Ricorrendo all’aiuto di celebri antropologi per impostare i loro programmi educativi.
Per esempio la grande Margaret Mead (1901-1978), docente alla Columbia University, fu a lungo consulente del Ministero dell’educazione Usa nell’elaborazione di strategie scolastiche per contrastare razzismo, bullismo e disuguaglianze di genere. E Lévi-Strauss (1908-2009) elaborò per conto dell’Unesco progetti educativi contro il razzismo e i pregiudizi etnici. Mentre, nel corso del secondo conflitto mondiale,
Ruth Benedict (1887-1948) docente alla Columbia, e Clyde Kluckhohn (1905-1960), fondatore del dipartimento antropologia di Harvard, collaborarono con il Pentagono e con il generale Mc Arthur per aiutare i comandi americani a capire il sistema di valori dei nemici giapponesi. Il caso più recente è quello della statunitense Montgomery McFate, che nel 2006 venne messa a capo del discusso programma Human Terrain Systems, un esperimento tra ricerca e intelligence condotto in Afghanistan e Iraq per coadiuvare le truppe nella lotta al terrorismo.
A sostenere l’indispensabilità degli antropologi nei teatri di guerra fu il generale David Petraeus, capo dell’US Army in Iraq e poi direttore della Cia, convinto della necessità di una svolta culturale fondata sulla conoscenza dei valori e delle forme di vita delle popolazioni locali, per evitare incomprensioni e malintesi.
Secondo il colonnello Martin Schweitzer l’impiego degli studiosi ha consentito una diminuzione delle operazioni militari del 60 per cento. «Gli antropologi ci hanno liberato dall’ossessione del nemico e aiutato a capire meglio le culture degli altri». A dire il vero sul progetto sono piovute critiche per la sua militarizzazione del sapere.
E in effetti non è questa l’antropologia che ci auguriamo di mettere in campo. Molto meglio le proposte didattiche elaborate nel nostro Paese. Un esempio per tutti, i Laboratori di antropologia educativa proposti dal progetto RibaltaMente, guidato da Giulia Cerri e Gianmarco Grugnetti. Insomma solo una corretta formazione antropologica ci salverà da due errori simmetrici e opposti. Il buonismo beota e il razzismo idiota.
- FILOSOFIA, ANTROPOLOGIA, E STORIA. UOMINI E DONNE, PROFETI E SIBILLE, OGGI...
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! - 12 professori 85 anni fa rifiutarono il giuramento fascista. Cosa rimane oggi di quel gesto epico ed eretico?30 agosto 2016, di Federico La Sala
I 12 professori che 85 anni fa rifiutarono il giuramento fascista
Sulla Gazzetta Ufficiale del 28 agosto del 1931 apparve il regio decreto n. 1227 che all’articolo 18 obbligava i docenti universitari a giurare devozione «alla Patria e al Regime Fascista». Su 1225 professori solo 12 rifiutarono il giuramento pur sapendo di dover subire, quale inevitabile conseguenza, il licenziamento.
di Marcello Ravveduto *
Nella vulgata nazionale sono molti i passaggi storici del fascismo noti al grande pubblico: dalla marcia su Roma, all’assassinio di Matteotti e dei fratelli Rosselli, dalla guerra d’Etiopia alle leggi razziali, dall’alleanza con Hitler alla caduta del regime, dalla Repubblica di Salò alla fucilazione di Mussolini, con l’esposizione del cadavere a Piazzale Loreto.
Non da tutti, invece, è conosciuta una vicenda minore (paragonata ai maggiori misfatti) accaduta 85 anni fa. Sulla Gazzetta Ufficiale del 28 agosto del 1931 è pubblicato il regio decreto n. 1227. Il dispositivo è stato voluto dal ministro per l’Educazione nazionale, Balbino Giuliano, ispirato dal filosofo Giovanni Gentile, a cui il dittatore ha affidato il compito di edificare le fondamenta culturali del fascismo. In apparenza è “solo” uno dei tanti provvedimenti del regime fascista che vuole imporre nuove regole di controllo all’ordinamento universitario. Ma se leggiamo l’articolo 18 ci rendiamo conto che si tratta di un vero e proprio attacco all’autonomia dell’accademia:
«I professori di ruolo e i professori incaricati nei Regi istituti d’istruzione superiore sono tenuti a prestare giuramento secondo la formula seguente: Giuro di essere fedele al Re, ai suoi Reali successori e al Regime Fascista, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato, di esercitare l’ufficio di insegnante e adempire tutti i doveri accademici col proposito di formare cittadini operosi, probi e devoti alla Patria e al Regime Fascista. Giuro che non appartengo né apparterrò ad associazioni o partiti, la cui attività non si concilii coi doveri del mio ufficio».
S’impone a tutti i docenti un giuramento di fedeltà al fascismo. In precedenza esisteva un giuramento di fedeltà al re e allo Statuto, mai rifiutato dai professori, salvo che nella Roma del 1870, in polemica con la conquista da parte dei Savoia. Già nel 1925, agli esordi della dittatura, c’era stato uno scontro tra fascisti e antifascisti in merito all’autonomia delle Università. Il 21 aprile (nel giorno del compleanno di Roma) Giovanni Gentile, su esplicita richiesta di Mussolini, si fa promotore di un manifesto degli intellettuali organici in cui si afferma la volontà di superare tramite il fascismo - che si presenta come azione, ma anche come «atteggiamento spirituale» - l’idea di un’Italia decadente, dal dilagante individualismo e dalla vita pubblica asservita al “particulare”. Duecentocinquanta sono i sottoscrittori del manifesto fascista.
La risposta degli intellettuali antifascisti è immediata: il 1˚ maggio su "Il Mondo", Benedetto Croce pubblica il suo "Manifesto”, in sintonia con le più importanti voci della cultura europea, esprimendo preoccupazione e sdegno verso chi tradisce l’autonomia della cultura e «pretenderebbe piegare l’intellettualità a funzioni di instrumentum regni». Il gruppo dei firmatari dell’appello crociano sarà molto ampio e, come riconosce la stessa stampa fascista, ben più autorevole di quello avversario. Ma soprattutto, gli atenei di tutta Italia sottoscriveranno compatti la protesta.
Dopo sei anni, con l’avanzare della fascistizzazione dello Stato e del conformismo sociale e civile, la situazione è completamente mutata. Quando nell’ottobre dello stesso anno i docenti saranno chiamati a rispettare la cogenza del giuramento non vi sarà nessun moto di indignazione: solo 12 professori su 1225 rifiutano l’atto di sottomissione al regime (in realtà qualcuno ne conta 16 o 17).
 Chi erano questi coraggiosi scienziati? Francesco Ruffini, Mario Carrara, Lionello Venturi, Gaetano De Sanctis, Piero Martinetti, Bartolo Nigrisoli, Ernesto Buonaiuti, Giorgio Errera, Vito Volterra, Giorgio Levi della Vida, Edoardo Ruffini Avondo, Fabio Luzzatto.
Chi erano questi coraggiosi scienziati? Francesco Ruffini, Mario Carrara, Lionello Venturi, Gaetano De Sanctis, Piero Martinetti, Bartolo Nigrisoli, Ernesto Buonaiuti, Giorgio Errera, Vito Volterra, Giorgio Levi della Vida, Edoardo Ruffini Avondo, Fabio Luzzatto.«Ho un’invincibile ripugnanza per il bel gesto! (...) Se potessi scivolare via con un qualsiasi pretesto, la cosa mi sarebbe assai più facile». Così scrive Edoardo Ruffini, il più giovane tra i professori che respingono il giuramento, nel momento in cui prende la drammatica decisione. Nessuno di loro è un pericoloso sovversivo, né hanno la stessa estrazione sociale, fede o cultura: gli altoborghesi si mescolano ai figli di commercianti, gli ebrei agli anticlericali e ai cattolici devoti, i repubblicani ai monarchici. Sono nient’altro che uomini dal radicato civismo, dalla forte moralità e dotati certamente, questo sì, di un’indole ribelle e poco incline al conformismo imperante. A cominciare da Gaetano De Sanctis che - come il padre ufficiale papalino renitente a dichiararsi fedele a una Roma ormai capitale d’Italia - ritiene il giuramento una menomazione della sua libertà interiore. O come l’anziano Bartolo Nigrisoli, che all’età di 73 anni non si scompone all’idea di essere allontanato dalla cattedra di chirurgia: «Giuramento simile io non mi sento di farlo e non lo faccio», esclamerà in piena coscienza.
Eroica è la figura di Mario Carrara, assistente e genero di Cesare Lombroso (di cui eredita la cattedra di antropologia criminale), che con imperturbabile purezza intellettuale scrive al ministro: «Abituato all’attribuire al giuramento la serietà dovuta, non ho sentito di potermi impegnare a dare intonazione, orientamento, finalità politiche alla mia attività didattica». Il rifiuto di aderire all’articolo 18 del regio decreto è il primo manifestarsi di un crescente sentimento antifascista che in seguito lo porterà in carcere. Il prestigioso docente festeggerà il suo settantesimo compleanno nel carcere "Nuove" di Torino dove per tanti anni i detenuti lo hanno visto impegnato nella sua attività scientifica.
Nei giorni successivi la propaganda fascista commenta beffarda il gesto di diniego. “Il popolo toscano”: «Undici su milleduecentoventicinque. Fa ridere! Sinceramente vorremmo che fossero altrettanti i malati in confronto ai sani, i rachitici a paragone con i fisicamente robusti, i deficienti con gli intelligenti, i disonesti di fronte ai virtuosi...». “Il Bargello”: «Fuori dalle nostre Università, fuori dai nostri laboratori, fuori dall’Insegnamento Italiano, fuori, fuori!». “Il Popolo di Lombardia”: «Confidiamo nell’erompente fede fascista dei gruppi universitari. È fatale che i giovani, nel campo della passione politica, siano all’avanguardia e insegnino moltissime volte la strada agli anziani».
La conseguenza per tutti è l’allontanamento dalla cattedra universitaria. Alcuni vanno all’estero, altri rimangono e saranno reintegrati dopo la caduta del fascismo. Se volessimo trovare un minimo comune denominatore tra i 12 ribelli dovremmo notare che 9 su 12 sono di origine piemontese e hanno vissuto o insegnato all’Università di Torino. Hanno invece origine ebrea (o vivono in ambiente di cultura ebraica) 5 dei 12. Le discipline interessate sono: Diritto (Ruffini padre e figlio, Luzzatto); Storia del cristianesimo e antica (Buonaiuti, De Sanctis); Filosofia (Martinetti); Storia dell’arte (Venturi); Orientalistica (Levi della Vida); Medicina (Carrara, Nigrisoli); Chimica (Errera); Matematica (Volterra).
Gaetano Salvemini, che dopo l’arresto nel ’25 lascia l’Italia rinunciando alla cattedra di Storia moderna all’Università di Firenze con una lettera molto dura nei confronti del Rettore («la dittatura fascista ha soppresso ... quelle condizioni di libertà, mancando le quali l’insegnamento universitario della Storia ... perde ogni dignità perché deve cessare di essere strumento di libera educazione civile e ridursi a servile adulazione del partito dominante ...»), rimarrà molto deluso sia della scarsa adesione al rifiuto, sia della modesta reazione internazionale, sia del fatto che fra i 12 non ci sono professori di Storia contemporanea o di Italiano, e nemmeno socialisti. Eppure, come tanti altri faranno, anche lui cercherà di giustificare quelli che hanno piegato il capo.
Del resto sulla questione del giuramento si apre immediatamente un dibattito contrastante che coinvolge professori, intellettuali e politici. Per esempio, pur da posizioni antifasciste distanti fra loro, Croce e Togliatti esprimono la stessa opinione: i professori devono giurare per non lasciare le Università in mano ai fascisti. L’orientamento espresso dal capo del comunismo italiano e dal massimo esponente del liberalismo spinge molti docenti non fascisti o apertamente antifascisti ad accettare l’esercizio di sottomissione. Concetto Marchesi (Letteratura latina all’Università di Padova), militante comunista, dopo una prima decisione negativa, pubblicamente annunciata, accetta con dolore (e vergogna) di giurare, seguendo l’indicazione di Togliatti. Piero Calamandrei (Diritto all’Università di Firenze) e Luigi Einaudi (Economia all’Università di Torino) giurano per non abbandonare l’Accademia ai fascisti. Giuseppe Levi (Anatomia all’Università di Torino) dopo un primo annuncio negativo, decide con dolore di giurare per non abbandonare gli allievi.
Molti provano a separare la pratica burocratica dal proprio sentire come se fossero in uno stato di sospensione mentale. Alessandro Levi (Filosofia del diritto all’Università di Parma) e il cugino Tullio Levi Civita (Meccanica Razionale all’Università di Roma) si consultano e concludono di accettare perché il giuramento non tocca il loro insegnamento. Anche Edoardo Volterra (Diritto romano all’Università di Parma - figlio del matematico Vito che non ha giurato) specifica che l’atto dovuto non inciderà sul suo insegnamento. Giacomo Devoto (Glottologia all’Università di Padova) dichiara, invece, che il giuramento non ha valore per lui ma gli serve per continuare a lavorare. Gioele Solari (Filosofia del diritto all’Università di Torino, maestro di Norberto Bobbio) e Arturo Carlo Jemolo (Diritto canonico all’Università di Bologna) giurano con dolore per motivi economici.
E la Chiesa? Come si comporta il Vaticano nei confronti del giuramento che costringe anche i professori cattolici ad «adempire tutti i doveri accademici col proposito di formare cittadini operosi, probi e devoti alla Patria e al Regime Fascista»?
Pio XI, contrario al giuramento, concepisce un’interessante proposta di compromesso: i professori cattolici possono giurare, ma con riserva (non è chiaro se mentale o esplicita e dichiarata) di non contraddire i principi cattolici. Dà quindi incarico al rettore della Cattolica di Milano, padre Agostino Gemelli, di trattare con Balbino Giuliano e Mussolini l’esclusione dal giuramento dei soli professori dell’Università Cattolica. La deroga è concessa, ma con un’altra riserva (da parte del regime fascista): si proponga a tutti i professori della Cattolica un giuramento volontario. Tutti giurano volontariamente (con la riserva indicata da Pio XI), tranne quattro professori, fra i quali spicca lo stesso padre Agostino Gemelli.
Tra i ribelli solo Mario Carrara e Francesco Ruffini provano ad organizzare due tentativi di protesta. Il primo giunto a Ginevra nel novembre del 1931 stende, con il cognato Guglielmo Ferrero (che ha sposato l’altra figlia di Lombroso), un appello di protesta indirizzato all’Istituto internazionale di cooperazione intellettuale operante a Parigi nell’ambito della Società delle Nazioni. Grazie all’ampia rete di relazioni che i due mantengono all’estero, in pochi mesi si raccolgono numerose adesioni. Quasi milletrecento i firmatari tra insegnanti, giornalisti, intellettuali. Tra essi Miguel de Unamuno, docente a Salamanca, John Dewey della Columbia University, Bertrand Russel. Le condanne sono nette. Il filologo Albert Dauzat parla di «una ignominia», "The Economist" del 26 dicembre riguardo i dodici scrive che «il mondo deve portare ad essi gratitudine per la testimonianza agli ideali di libertà e dell’onestà intellettuale».
La stampa fascista contrattacca. La petizione degli intellettuali è definita «ridicola», «illecita», «arbitraria ingerenza», «infantile insolenza». "Il Messaggero" considera le reazioni internazionali «un’intrusione molesta» nelle «cose di casa nostra». "La Gazzetta del Popolo" vede nella difesa dei dodici obiettori l’adesione tenace ad antiche e superate tradizioni «secondo cui le università statali sono luoghi dove ancora sopravvivono i diritti medievali dell’immunità, dell’asilo e della libertà per studenti in sciopero e professori contestatori». Alla fine la Società delle Nazioni, nonostante le molteplici sollecitazioni, decide di non intervenire dichiarandosi incompetente.
Il 6 novembre 1931 Albert Einstein, sollecitato dall’amico Francesco Ruffini (il più illustre dei renitenti - già ministro dell’Istruzione), scrive al responsabile del dicastero della giustizia italiano Alfredo Rocco: «(...)la ricerca della verità scientifica, distaccata dagli interessi pratici della vita quotidiana, dovrebbe essere sacra per qualsivoglia potere statale, ed è sommo interesse di ognuno che gli onesti servitori della verità vengano lasciati in pace. È senz’altro nell’interesse dello Stato italiano e della sua reputazione nel mondo». Rocco, invece di rispondere personalmente, incarica uno dei suoi allievi. Ad Einstein non resterà che annotare nel suo diario: «Eccellente risposta in tedesco, ma la cosa resta comunque una idiozia da gente incolta», e poi profeticamente: «Bei tempi ci aspettano in Europa».
Cosa rimane oggi di quel gesto epico ed eretico? Quanti docenti delle nostre Università, dopo la lezione del fascismo, si comporterebbero allo stesso modo dei dodici antenati di fronte a una dittatura? Una cosa è certa i dodici assunsero sulle loro spalle le insipienze, le paure e le velleità dei colleghi silenti e lo fecero con estrema modestia al punto da convivere con la disperante sensazione di non essere stati all’altezza della situazione, di avere vissuto un momento importante da uomini normali, anzi «mediocri», dirà Levi Della Vida. Avrebbero potuto fare di più? Date le condizioni storiche non credo. A mio avviso proprio perché non hanno vissuto quella scelta come un gesto pubblico esemplare, ma come una volontà intima di non svendere la propria dignità personale, dovendo rinunciare all’insegnamento (e al reddito), rappresentano un’anticipazione di quella rivolta morale, individuale prima che collettiva, che usiamo chiamare Resistenza; per questo oggi e sempre è giusto tramandarne con rispetto i nomi e il ricordo.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! - BENESSERE. L’algoritmo di una condizione umana ridotta a nuda vita (di Marino Niola).30 luglio 2016, di Federico La Sala
La parola presente /4
BENESSERE. Equilibrio, ricchezza e salute, così è cambiata la "buona vita". Se la religione dei corpi riduce l’uomo a merce
di Marino Niola (la Repubblica, 25.07.2016)
Well be or not to be. Benessere o non essere, questo è il problema. Il dilemma del nostro tempo che ha sciolto il dubbio amletico e lo ha trasformato in imperativo cosmetico. Estetico, dietetico, terapeutico. Dopo averne fatto a lungo un mantra economico. Ma in entrambi i casi, sia che si tratti della salute del nostro corpo, sia che si tratti della salute delle nostre finanze, resta il fatto che la parola benessere ormai riguarda sempre più l’avere e sempre meno l’essere.
Con un avvitamento della lingua che riflette una metamorfosi del senso comune e dei suoi valori di riferimento. Che prendono un’accezione sempre più materiale, legando la soddisfazione, l’autostima, l’equilibrio personale, la realizzazione di sé, il proprio riconoscimento da parte degli altri, a qualcosa che si possiede. Fino a poco tempo fa era un reddito soddisfacente, adesso è un corpo efficiente. Un passaggio che nell’inglese è scritto a chiare lettere nella stretta parentela tra wealth,ricchezza, e health, salute. Mentre l’italiano chiama entrambe benessere. Con uno slittamento interno del significato che però non affiora alla superficie del vocabolario. Ne è la prova il fatto che non si sente il bisogno di creare due termini distinti.
In realtà il termine benessere finisce per riepilogare i valori, le aspettative, le proiezioni che in ogni epoca compongono gli algoritmi della buona vita. Per gli antichi si tratta di parametri spirituali, che hanno a che fare poco con la ricchezza, un po’ più con la salute, e molto con l’equilibrio. Che è alla base di una buona disposizione dell’animo. Platone la chiama eufrosine, cioè letizia, che è anche il nome di una delle tre Grazie, divinità dispensatrici di splendore, di bellezza e di prosperità. Peraltro il termine grazia è molto imparentato con la gratuità, il disinteresse, l’armonia, la giustizia. Lo dice il nome greco delle Grazie che è Cariti, da charis che significa dono, un concetto storicamente legato alla nostra idea di carità. E dunque il benessere non dipende dalla ricchezza. Ancor più chiaro in questo senso è Aristotele, che esclude categoricamente il possesso e il successo. Perché lo star bene degli uomini non consiste semplicemente in un soddisfacimento dei desideri e dei bisogni materiali, ma nel controllo razionale delle passioni e delle pulsioni. Che è condizione dell’equilibrio individuale e dell’equità sociale. Ma il filosofo della catarsi si spinge ancora oltre e, con un ragionamento che oggi definiremmo antiutilitaristico, arriva addirittura a separare la crematistica, la scienza che riguarda l’acquisto e la gestione della ricchezza, dall’economia.
Quest’ultima, infatti, insegna come soddisfare i bisogni primari e vivere bene in mezzo agli altri, mentre la crematistica, che mira a quella che adesso chiameremmo l’accumulazione del capitale, è artificiale e in un certo senso antisociale. Insomma, per l’autore dell’Etica Nicomachea, il benessere è di natura essenzialmente relazionale, nel senso che il rapporto con gli altri costituisce un bene in sé. È il fine e non il mezzo dell’economia. Una posizione declinata al presente da una filosofa come Marta Nussbaum, non a caso definita neoaristotelica. L’autrice di Non per profitto ritiene infatti che una delle cause del declino attuale della democrazia sia l’utilitarismo spinto all’estremo che riduce l’uomo a merce, il sapere a tecnica, la bellezza a dogma, la salute a obbligo. E il benessere a Pil. Che, naturalmente, per mantenersi su livelli elevati ha bisogno di lavoratori in piena forma, di macchine corporee senza difetti. Efficienti, performanti, scintillanti. È l’avvento degli “ultimi uomini”, per dirla con lo Zaratustra di Nietzsche, quelli che credono di avere inventato la felicità, che vivono sempre più a lungo, e per i quali ammalarsi è peccato.
Ed è proprio questo scivolamento della persona verso la risorsa umana, del well-being verso il well-ness, della comunità verso l’immunità, alla base della svolta biopolitica che stiamo vivendo. Dove gli uomini diventano energie rinnovabili e quindi anche rimpiazzabili. Del resto proprio questo vuol dire risorsa, dal francese resortir, nel senso di rinascere, rinnovarsi. È l’umano al servizio dello sviluppo e non lo sviluppo al servizio dell’umano.
Una critica in ipsis verbis di questo pensiero unico della crescita si trova in un apparente lapsus degli studenti della South-Pacific University di Suva, nelle isole Figi, che hanno trascritto in pidgin-english (la lingua franca di alcune aree del Pacifico), il termine development, sviluppo, facendolo diventare develop-men, ovvero piena realizzazione dell’umano. Così quello che sembrava un errore di spelling si rivela invece una straordinaria retroilluminazione della parola. Che fa brillare un altro senso possibile, a condizione di pensare altrimenti.
Oggi l’asse del benessere si è ulteriormente e decisamente spostato. Da richness a fitness. Col risultato di trasformare i nostri stili di vita in religioni del corpo, in idolatrie della longevità, in liturgie alimentari. Con il bio al posto del dio. E la dietetica al posto dell’etica. E, quasi inavvertitamente, siamo entrati nell’era di homo dieteticus, il figlio spaventato di homo oeconomicus. Quest’ultimo, spinto in avanti dal vento del progresso e convinto che le cose sarebbero andate sempre meglio, per sé e per i suoi, investiva sul futuro. Mentre l’homo dieteticus, in preda a mille insicurezze, personali, ambientali, lavorative, sta facendo della salute il bene rifugio su cui scommettere tutto e subito, il capitale immunitario al quale destinare tempo, cure, energie e risorse. Passione e ossessione. Narcisismo ed esorcismo. Ideologia e ipocondria. Forse perché non ci è rimasto altro da scambiare e da vendere nel mercato della forza lavoro globale, se non la nostra apparenza e la nostra efficienza. Ridotti come siamo a braccianti multitasking, cottimisti del tardo capitalismo, falangi della mano invisibile.
Così il corpo torna ad essere, come diceva Baudelaire, l’arcano della merce, la forma elementare dell’economia. E il benessere diventa l’algoritmo di una condizione umana ridotta a nuda vita.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
FILOLOGIA, ARTE, TEOLOGIA, E ANTROPOLOGIA. "CHARISSIMI, NOLITE OMNI SPIRITUI CREDERE... DEUS CHARITAS EST" (1 Gv., 4. 1-16). Il teologo Ratzinger scrive da papa l’enciclica "Deus caritas est" (2006) e, ancora oggi, nessuno ne sollecita la correzione del titolo. Che lapsus!!! O, meglio, che progetto!!!
 CANOVA E IL VATICANO: LE GRAZIE, AMORE E PSICHE Una gerarchia senza Grazie (greco: Χάριτες - Charites) e un papa che scambia la Grazia ("Charis") di Dio ("Charitas") con il "caro-prezzo" del Dio Mammona ("Caritas"). Materiali per riflettere
CANOVA E IL VATICANO: LE GRAZIE, AMORE E PSICHE Una gerarchia senza Grazie (greco: Χάριτες - Charites) e un papa che scambia la Grazia ("Charis") di Dio ("Charitas") con il "caro-prezzo" del Dio Mammona ("Caritas"). Materiali per riflettereL’EUROPA, IL CRISTIANESIMO ("DEUS CHARITAS EST"), E IL CATTOLICESIMO COSTANTINIANO ("DEUS CARITAS EST").Una storia di lunga durata...
-
> BENESSERE. L’algoritmo di una condizione umana ridotta a nuda vita --- Perché studiare il latino e il greco? (di Antonio Gramsci).15 agosto 2016, di Federico La Sala
- CANOVA E IL VATICANO: LE GRAZIE, AMORE E PSICHE Una gerarchia senza Grazie (greco: Χάριτες - Charites) e un papa che scambia la Grazia ("Charis") di Dio ("Charitas") con il "caro-prezzo" del Dio Mammona ("Caritas"). Materiali per riflettere
Perché studiare il latino e il greco?di Antonio Gramsci (Eddyburg, 11 Agosto 2016)
- Un recente articolo di Stefano Settis sull’importanza della conoscenza del latino ci ha ricordato questo scritto di Antonio Gramsci. Lo pubblichiamo sottolineando l’ampiezza della visione del pensatore comunista, e la sua capacità di comprendere il ruolo della conoscenza in una società caratterizzata, come quella di oggi, dalla dialettica della lotta di classe. Antonio Gramsci, Quaderni dal Carcere, 4 [XIII], 55]
Non si impara il latino e il greco per parlare queste lingue, per fare i camerieri o gli interpreti o che so io. Si imparano per conoscere la civiltà dei due popoli, la cui vita si pone come base della cultura mondiale. La lingua latina o greca si impara secondo grammatica, un po’ meccanicamente: ma c’è molta esagerazione nell’accusa di meccanicità e aridità. Si ha che fare con dei ragazzetti, ai quali occorre far contrarre certe abitudini di diligenza, di esattezza, di compostezza fisica, di concentrazione psichica in determinati oggetti. Uno studioso di trenta-quarant’anni sarebbe capace di stare a tavolino sedici ore filate, se da bambino non avesse «coattivamente», per «coercizione meccanica» assunto le abitudini psicofisiche conformi? Se si vogliono allevare anche degli studiosi, occorre incominciare da lì e occorre premere su tutti per avere quelle migliaia, o centinaia, o anche solo dozzine di studiosi di gran nerbo, di cui ogni civiltà ha bisogno.
Il latino non si studia per imparare il latino, si studia per abituare i ragazzi a studiare, ad analizzare un corpo storico che si può trattare come un cadavere ma che continuamente si ricompone in vita. Naturalmente io non credo che il latino e il greco abbiano delle qualità taumaturgiche intrinseche: dico che in un dato ambiente, in una data cultura, con una data tradizione, lo studio così graduato dava quei determinati effetti. Si può sostituire il latino e il greco e li si sostituirà utilmente, ma occorrerà sapere disporre didatticamente la nuova materia o la nuova serie di materie, in modo da ottenere risultati equivalenti di educazione generale dell’uomo, partendo dal ragazzetto fino all’età della scelta professionale. In questo periodo lo studio o la parte maggiore dello studio deve essere disinteressato, cioè non avere scopi pratici immediati o troppo immediatamente mediati: deve essere formativo, anche se «istruttivo», cioè ricco di nozioni concrete.
Nella scuola moderna mi pare stia avvenendo un processo di progressiva degenerazione: la scuola di tipo professionale, cioè preoccupata di un immediato interesse pratico, prende il sopravvento sulla scuola “formativa” immediatamente disinteressata. La cosa più paradossale è che questo tipo di scuola appare e viene predicata come “democratica”, mentre invece essa è proprio destinata a perpetuare le differenze sociali. Il carattere sociale della scuola è dato dal fatto che ogni strato sociale ha un proprio tipo di scuola destinato a perpetuare in quello strato una determinata funzione tradizionale.
Se si vuole spezzare questa trama, occorre dunque non moltiplicare e graduare i tipi di scuola professionale, ma creare un tipo unico di scuola preparatoria (elementare-media) che conduca il giovane fino alla soglia della scelta professionale, formandolo nel frattempo come uomo capace di pensare, di studiare, di dirigere o di controllare chi dirige. Il moltiplicarsi di tipi di scuole professionali tende dunque a eternare le differenze tradizionali, ma siccome, in esse, tende anche a creare nuove stratificazioni interne, ecco che nasce l’impressione della tendenza democratica. Ma la tendenza democratica, intrinsecamente, non può solo significare che un manovale diventi operaio qualificato, ma che ogni “cittadino” può diventare “governante” e che la società lo pone sia pure astrattamente nelle condizioni generali di poterlo diventare.
Anche lo studio è un mestiere e molto faticoso, con un suo speciale tirocinio anche nervoso-muscolare, oltre che intellettuale: è un processo di adattamento, è un abito acquisito con lo sforzo e il dolore e la noia. La partecipazione di più larghe masse alla scuola media tende a rallentare la disciplina dello studio, a domandare facilitazioni. Molti pensano addirittura che la difficoltà sia artificiale, perchè sono abituati a considerare lavoro e fatica solo il lavoro manuale. È una quistione complessa. Certo il ragazzo di una famiglia tradizionalmente di intellettuali supera più facilmente il processo di adattamento psicofisico: egli già entrando la prima volta in classe ha parecchi punti di vantaggio sugli altri scolari, ha un’ambientazione già acquisita per le abitudini famigliari. Così il figlio di un operaio di città soffre meno entrando in fabbrica di un ragazzo di contadini o di un contadino già sviluppato per la vita dei campi.
Ecco perchè molti del popolo pensano che nella difficoltà dello studio ci sia un trucco a loro danno; vedono il signore compiere con scioltezza e con apparente facilità il lavoro che ai loro figli costa lacrime e sangue, e pensano ci sia un trucco. In una nuova situazione politica, queste quistioni diventeranno asprissime e occorrerà resistere alla tendenza di rendere facile ciò che non può esserlo senza essere snaturato. Se si vorrà creare un nuovo corpo di intellettuali, fino alle più alte cime, da uno strato sociale che tradizionalmente non ha sviluppato le attitudini psico-fisiche adeguate, si dovranno superare difficoltà inaudite.
-
> BENESSERE. L’algoritmo di una condizione umana ridotta a nuda vita --- Salviamo il latino lingua della memoria (di Salvatore Settis)15 agosto 2016, di Federico La Sala
Salviamo il latino lingua della memoria
di Salvatore Settis (la Repubblica, 10 Agosto 2016)
La lingua più parlata del mondo? È il latino. Non quel che resta del latino ecclesiastico, né quello dei pochi filologi classici ancora in grado di scriverlo, né dei certami ciceroniani, stranamente popolari. Ma il latino che parliamo ogni giorno, con le sue trasformazioni storiche: quello delle lingue neolatine, o romanze. Lo spagnolo come lingua materna è da solo, con 500 milioni di parlanti, secondo al mondo soltanto al cinese. Se vi aggiungiamo il portoghese (230 milioni), il francese (100), l’italiano (65) e il romeno (35), si arriva a 930 milioni di “parlanti latino”.
Senza contare le numerose lingue minori (come il ladino). Poco meno dei “parlanti cinese”, che però si suddividono anch’essi in numerose lingue diverse, non sempre mutuamente intellegibili se parlate, ma unificate concettualmente da una scrittura ideografica che non rispecchia direttamente la pronuncia. E il latino ha una presenza capillare anche fuori dell’ambito propriamente romanzo: in inglese (terza lingua materna più parlata al mondo, con 350 milioni) il 58% del lessico deriva dal latino o da lingue neolatine, specialmente francese. Lo stesso è vero di tutte le lingue europee, dal tedesco al russo: forse nessuna lingua più del latino ha mostrato forza di penetrazione e tendenza a radicarsi in sistemi linguistici di altra origine. Inoltre, anche numerose parole di matrice greca (come “filosofia”) o etrusca (come “persona”) si sono diffuse universalmente, ma passando attraverso il latino.
Fra cinese e latino c’è un abisso, ma anche qualcosa in comune: “cinese”, infatti, è la piattaforma di intercomprensione fra tutte le lingue della famiglia sinica, “latino” può essere la piattaforma di intercomprensione fra tutte le lingue romanze. Se usassimo una scrittura ideografica come i cinesi, potremmo leggere il portoghese e il romeno anche senza averli mai studiati. Ma davvero l’italiano è così simile al latino? Proviamo a leggere qualche verso: «Te saluto, alma dea, dea generosa, / O gloria nostra, o veneta regina! / In procelloso turbine funesto / Tu regnasti secura: mille membra / Intrepida prostrasti in pugna acerba». La metrica è italiana, ma il testo “funziona” perfettamente sia come italiano che come latino. Autore di questo poemetto in lode di Venezia fu Mattia Butturini (1752-1817), amico di Ugo Foscolo e professore di greco a Pavia. E continua: «Per te miser non fui, per te non gemo, / Vivo in pace per te: Regna, o beata, / Regna in prospera sorte, in pompa augusta, / In perpetuo splendore, in aurea sede! / Tu severa, tu placida, tu pia, / Tu benigna, me salva, ama, conserva». Perfetto italiano, perfetto latino, come in altri poemi simultaneamente bilingui, a cominciare da quello di Gabriello Chiabrera nel tardo Cinquecento.
L’ottusa lotta contro il latino e contro il liceo classico, che riemerge periodicamente con la complicità di ministri maldestri e sprovveduti, non tiene conto di questo aspetto assolutamente centrale. È vero, nella scuola sopravvive un approccio piattamente grammaticale, che nello studio del latino vede solo una sorta di astratta educazione alla precisione del pensiero, a prescindere da tutto il resto. Ma tradurre tale critica in un ripudio del latino sarebbe « un gesto violento e arrogante, un attentato alla bellezza del mondo e alla grandezza dell’intelletto umano » , come scrive Nicola Gardini in un libro bello e intenso ( Viva il latino. Storia e bellezza di una lingua inutile, Garzanti). Quel che serve è un vero rilancio del latino come palestra per le generazioni future, tenendo in conto anche le sue enormi potenzialità come piattaforma di intercomprensione fra le lingue romanze, gigantesco serbatoio linguistico da cui pescano anche le lingue germaniche e slave, apparato concettuale che favorisce la comunicazione fra le culture. Ha ragione Gardini, «grazie al latino una parola italiana vale almeno il doppio».
Ma non è tutto. Le parole non sono nulla se non le vediamo agire nel loro contesto, nei testi latini da Cicerone a Newton. Lo spessore ( il valore) delle parole latine, trasmigrate in altre lingue, si può apprezzare se siamo in grado non solo di snocciolare elenchi di parole o sfogliare vocabolari, ma di leggere e comprendere Virgilio e Sant’Agostino, le lettere di Petrarca e la cosmografia di Keplero. Trama narrativa, struttura della frase, tecnica dell’argomentare danno alle parole e alle frasi quella forza che aiuta a riconoscerne la traccia in Dante, in Shakespeare, Cervantes, Goethe. Quando leggiamo un testo, scrive Gardini, « non si tratterà propriamente del latino di Cicerone né del latino di Virgilio, ma piuttosto di quel che il latino compie e ottiene quando esce dallo stilo di Cicerone o dallo stilo di Virgilio » , in termini di « capacità lessicale, correttezza sintattica e convenienza ritmica » .
Questo doppio registro del latino, in orizzontale ( lettura dei testi e rimando ai contesti) e in verticale ( come piattaforma di intercomprensione fra lingue oggi parlate) ha un altro vantaggio. Funziona come macchina della memoria, ci ricorda che quel che leggiamo del latino classico è un’infima parte di quel che fu allora scritto. E che, nonostante questo, abbiamo preteso per secoli di continuare, sulla scena del mondo, la storia di Roma. Non per niente quelli che noi chiamiamo “ bizantini” chiamarono se stessi sempre rhomaioi, “ romani”, e il più intimo carattere della grecità, conservatosi anche sotto la dominazione ottomana, si esprime in neogreco con la parola rhomaiosyne, “ romanità”; eppure intanto a Istanbul i sultani, dopo aver spodestato l’ultimo imperatore romano, mantennero dal 1453 al 1922 il titolo di Kayser- i- Rum, “ Cesare di Roma”. “ Cesare”, cioè imperatore; come il Kaiser a Vienna o a Berlino, lo Czar a Mosca o Pietroburgo. Altro esempio, il diritto: i sistemi di civil law sono fondati sul diritto romano ( spesso, ma non sempre, attraverso il codice napoleonico), e oltre all’Europa continentale, inclusa la Russia, coprono l’America Latina e vari Paesi in Asia e Africa. Ma anche i sistemi di common law, pur di origine inglese, esprimono in latino molti termini- chiave, a partire dal principio fondamentale stare decisis ( conformarsi alle sentenze già emesse); perciò anche nei film americani sentiamo parlare di subpoena, affidavit, persona non grata; per non dire di habeas corpus.
Il latino come dispositivo della memoria culturale, come versatile interfaccia multilingue, come ponte o viadotto verso altre culture. Il latino come lingua viva, perché vive nelle lingue che parliamo. Questo, e non un’impalcatura di precetti, dovrebbe saper trasmettere la nostra scuola. “ Nostra”, cioè quanto meno europea. Questa Europa delle tecnologie saprà inventare una nuova didattica del latino che contribuisca all’intercomprensione culturale? E l’Italia, dove il latino è nato, avrà in merito qualcosa da dire?
-
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- L’eccellenza del Nietzsche italiano (di Federico Vercellone)11 luglio 2016, di Federico La Sala
FILOSOFIA, E TEOLOGIA POLITICA DELLA’ "ANDRO-PO-LOGIA" ATEA E DEVOTA....
MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?!
- LA VIA DI KANT: USCIRE DALLA CAVERNA, E NON RICADERE NELL’ILLUSIONE DI “DIO” CONCEPITO COME “UOMO SUPREMO”. Note per una rilettura della “Storia universale della natura e teoria del cielo”
L’eccellenza del Nietzsche italiano
di Federico Vercellone (La Stampa, 10.07.2016)
Tra le poche cose che vanno relativamente bene in Italia c’è la filosofia. Nonostante il totale disinteresse della classe politica nei confronti della ricerca, l’Italian Theory emerge con ottimi risultati anche sul piano internazionale.
La filosofia italiana del secondo Novecento è segnata nel suo percorso dalla presenza influente della grande filosofia classica tedesca. È una vicenda che si avvia da lontano, perlomeno dalla grande rilettura di Hegel prodotta dal neo-hegelismo napoletano e da Benedetto Croce. Successivamente, grazie a Luigi Pareyson, emerge l’altro versante dell’idealismo tedesco, Fichte e Schelling, oltre a Goethe e ai romantici e a Nietzsche, nel quadro di un progetto filosofico volto a superare l’eredità neo-idealistica.
Proprio Nietzsche costituisce un punto di svolta. La grande impresa dell’edizione critica presso Adelphi delle Opere di Nietzsche, avviata nel 1964, a cura di Giorgio Colli e Mazzino Montinari, apre un nuovo capitolo di notevole significato anche sul piano internazionale. È un capitolo che contribuisce a portare alla ribalta alcuni tra i più significativi filosofi italiani, da Massimo Cacciari a Emanuele Severino a Gianni Vattimo.
Su questo passaggio così significativo si sofferma Emilio Carlo Corriero in un volume ponderoso, equilibrato ed esaustivo uscito ora da Aragno, Il Nietzsche italiano. Il punto di avvio fondamentale, in un quadro per altro estremamente composito in relazione alla ricezione di Nietzsche, è l’idea di Crisi della ragione dibattuta in un volume del 1979 comparso da Einaudi a cura di Aldo Giorgio Gargani. Venuti meno i fondamenti della ragione classica, Nietzsche costituisce un indispensabile punto di riferimento per cogliere i tratti di un tempo di crisi dei fondamenti. Fare i conti con la «morte di Dio» e con il venir meno dei valori trascendenti comporta una rivoluzione del pensiero e dei modi di vita che mette in gioco aspetti fondamentali della nostra civiltà con implicazioni notevoli sul piano della convivenza civile, della morale pubblica, e della nostra provenienza religiosa dal mondo cristiano.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- Storia di una cellula fantastica -Scienza, cultura e natura dell’uovo (di Carlo Alberto Redi - Manuela Monti)8 luglio 2016, di Federico La Sala
EUROPA: EDUCAZIONE SESSUALE ED EDUCAZIONE CIVICA. ITALIA "NON CLASSIFICATA"!!!
- Cogliere le cose alla radice non è facile. E la radice dell’uomo non è l’uomo stesso. Si ricordi quanto la completa conoscenza scientifica del fenomeno della procreazione sia recente nella scienza occidentale. E si ricordi che «dopo l’antica credenza nella sola responsabilità del maschio, la questione viene riveduta, diventa argomento di polemiche e resta a lungo incerta», e che, «fino al 1906, data in cui l’insegnamento adotta la tesi della fecondazione dell’ovulo con un solo spermatozoo e della collaborazione di entrambi i sessi alla riproduzione e la Facoltà di Parigi proclama questa verità ex cathedra, i medici si dividevano ancora in due partiti, quelli che credevano, come Claude Bernard, che solo la donna detenesse il principio della vita, proprio come i nostri avi delle società pre-patriarcali (teoria ovista), e quelli che ritenevano (...) che l’uomo emettesse con l’eiaculazione un minuscolo omuncolo perfettamente formato che il ventre della donna accoglieva, nutriva e sviluppava come l’humus fa crescere il seme»(Federico La Sala, Della Terra, il brillante colore, pref. di Fulvio Papi, pp. 140-141).
- PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!
 FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.
SIRONI EDITORE
- Storia di una cellula fantastica
 Scienza, cultura e natura dell’uovo
Scienza, cultura e natura dell’uovo
Tutti noi siamo stati un uovo, all’inizio! Carlo Alberto Redi torna in libreria per raccontare la storia di questa cellula fantastica. Dalla conservazione degli oociti, alla produzione artificiale dei gameti, alla regolamentazione della ricerca pubblica e privata: dove vogliamo andare e con quali regole?
Tutti noi siamo stati un uovo, all’inizio!
Il “biologo furioso” Carlo Alberto Redi torna in libreria, questa volta insieme a Manuela Monti, per raccontare la sorprendente storia di questo oggetto fondamentale della biologia che da sempre esercita un fascino speciale sulle culture di ogni epoca.
A partire dalla loro esperienza di scienziati impegnati sul campo, gli Autori ci guidano in un viaggio meraviglioso alla scoperta di noi stessi che dalla biologia passa per l’arte, la letteratura, la sociologia e - poteva mancare? - la gastronomia.
Una lettura divertente e documentata, che non si sottrae a riflessioni sui temi caldi dell’attualità scientifica.
 Codice ISBN: 978-88-518-0266-0
Codice ISBN: 978-88-518-0266-0
 Pagine: 224
Pagine: 224
 Prezzo di copertina: € 19,80
Prezzo di copertina: € 19,80
 Prezzo scontato 10%: € 17,82
Prezzo scontato 10%: € 17,82 Carlo Alberto Redi è professore di zoologia all’Università di Pavia e direttore del Laboratorio di Biologia dello Sviluppo. È membro dell’Accademia dei Lincei. È autore per Sironi di Il biologo furioso. Provocazioni d’autore tra scienza e politica (2007).
Carlo Alberto Redi è professore di zoologia all’Università di Pavia e direttore del Laboratorio di Biologia dello Sviluppo. È membro dell’Accademia dei Lincei. È autore per Sironi di Il biologo furioso. Provocazioni d’autore tra scienza e politica (2007).Manuela Monti è biologa. Lavora alla Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia. Collabora con iisitituti di ricerca negli USA e in Giappone. È coautrice con Redi di Staminali. Dai cloni alla medicina rigenerativa (Carocci).
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- "Ammazzando il tempo". Hitler secondo l’anarchico Feyerabend (di A. Massarenti)19 giugno 2016, di Federico La Sala
- INDIVIDUO E SOCIETA’ E COSTITUZIONE, IERI COME OGGI. USCIRE DALLO STATO DI MINORITA’, APRIRE GLI OCCHI: C’E’ DIO E "DIO", PATRIA E "PATRIA", E FAMIGLIA E "FAMIGLIA" .....
 C’E’ CAPO E "CAPO" E STATO E "STATO": MUSSOLINI E LENIN A CONFRONTO. L’analisi di Gramsci (già contro derive staliniste!), una bussola per non naufragare e una lezione di vita e di libertà
C’E’ CAPO E "CAPO" E STATO E "STATO": MUSSOLINI E LENIN A CONFRONTO. L’analisi di Gramsci (già contro derive staliniste!), una bussola per non naufragare e una lezione di vita e di libertà
- LO STATO DEL FARAONE, LO STATO DI MINORITA’, E IMMANUEL KANT "ALLA BERLINA" - DOPO AUSCHWITZ
 "LEZIONE SU KANT" A GERUSALEMME: PARLA EICHMANN "PILATO", IL SUDDITO DELL’"IMPERATORE-DIO". Il ’sonnambulismo’ di Hannah Arendt prima e di Emil Fackenheim dopo. Alcuni appunti sul tema
"LEZIONE SU KANT" A GERUSALEMME: PARLA EICHMANN "PILATO", IL SUDDITO DELL’"IMPERATORE-DIO". Il ’sonnambulismo’ di Hannah Arendt prima e di Emil Fackenheim dopo. Alcuni appunti sul tema
Hitler secondo l’anarchico Feyerabenddi Armando Massarenti (Il Sole-24 Ore, Domenica, 19.06.2016)
Dopo la recente affermazione della destra xenofoba in Austria, a un passo dal vincere le elezioni, ho ripensato a ciò che scriveva Paul K. Feyerabend nella sua splendida autobiografia, intitolata Ammazzando il tempo e uscita per Laterza nel 1994, anno della sua morte, a 70 anni di età. Esordiva fin dalle prime pagine avvertendo degli strani scherzi che può fare la memoria: quelli in forza dei quali magari oggi ci si stupisce del rinascere di certe idee che pensavamo del tutto tramontate.
Aveva deciso di scrivere quel libro nel 1988, durante il cinquantenario dell’unificazione tra Austria e Germania. «Ricordavo che gli austriaci avevano accolto Hitler con straordinario entusiasmo, ma ora mi ritrovavo ad ascoltare condanne secche e toccanti appelli umanitari. Non che fossero tutti in malafede, eppure suonavano vuoti: lo attribuii alla loro genericità e pensai che un resoconto in prima persona sarebbe stato un modo migliore di fare storia. Ero anche piuttosto curioso. Dopo aver tenuto lezioni per quarant’anni in università inglesi e americane, mi ero quasi dimenticato dei miei anni nel Terzo Reich, dapprima come studente, poi da soldato in Francia, Iugoslavia, Russia e Polonia».
Persino lui, Paul K. Feyerabend, dunque, già allora quello spirito libero che poi sarebbe divenuto famoso come l’epistemologo dell’anarchismo metodologico, aveva subito una forma di attrazione per il regime, e aveva anche meditato di entrare nelle SS. «Perché? Perché un uomo delle SS aveva un aspetto migliore, parlava meglio e camminava meglio di un comune mortale: le ragioni erano estetiche, non ideologiche». Finalmente un libertario, un democratico capace di non cadere nelle trappole dell’ipocrisia! ho pensato ai tempi leggendo Ammazzando il tempo. E che ci fa capire meglio perché il nazismo potesse attrarre le giovani generazioni. Anche rivedere l’immagine stereotipata di Hitler era per Feyerabend un modo per capire meglio la realtà. Abbiamo visto mille volte spezzoni di documentari che ce lo mostrano come una macchietta in preda all’ira. Si tratta di una precisa scelta della propaganda post-bellica. Feyerabend descrive invece così la sua arte oratoria: «Hitler accennava ai problemi locali e a quanto era stato fatto fino ad allora, faceva battute, alcune abbastanza buone. Gradualmente cambiava il modo di parlare: quando si riferiva a ostacoli e inconvenienti aumentava il volume e la velocità del parlare. Gli accessi violenti che sono le uniche parti dei suoi discorsi conosciute in tutto il mondo erano preparati con cura, ben interpretati e utilizzati con umore più calmo una volta finiti; erano il risultato di controllo, non di rabbia, odio o disperazione».
Ancora oggi, se del nazismo non cerchiamo di capire le ragioni interne, e magari non ci spaventiamo a rileggere Mein Kampf, non sapremo mai perché esso ha appassionato così tante persone. E sarà anche più difficile difendere i nostri valori più cari: libertà, pluralismo, democrazia. Benché l’intelligenza critica di Feyerabend fosse già piuttosto acuta, al punto da commentare la lettura di Mein Kampf (ad alta voce alla famiglia riunita) come un «modo ridicolo di esporre un’opinione», «rozzo, ripetitivo, più un abbaiare che un parlare», egli stesso, pochi giorni dopo, avrebbe concluso un tema scolastico su Goethe legandolo proprio a Hitler. Non solo la memoria collettiva può fare brutti scherzi: anche la nostra attenzione critica è qualcosa di quanto mai fragile. Ma lo è ancora di più se ci rifiutiamo di rileggere senza ipocrisia le pagine più buie della nostra storia.
- INDIVIDUO E SOCIETA’ E COSTITUZIONE, IERI COME OGGI. USCIRE DALLO STATO DI MINORITA’, APRIRE GLI OCCHI: C’E’ DIO E "DIO", PATRIA E "PATRIA", E FAMIGLIA E "FAMIGLIA" .....
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- LE "REGOLE DEL GIOCO" DELL’OCCIDENTE. ERACLITO E LA POLIS: "LA CITTA’ DIVISA". NOTE SUL CAPOLACORO DI NICOLE LORAUX.15 giugno 2016, di Federico La Sala
- PIANETA TERRA. Fine della Storia o della "Preistoria"? "Pietà per il mondo, venga il nuovo sapere" (M. Serres, Distacco, 1986). Un omaggio a Giambattista Vico ....
 LE "REGOLE DEL GIOCO" DELL’OCCIDENTE E IL DIVENIRE ACCOGLIENTE DELLA MENTE .Un’interpretazione dell’intera storia della filosofia, semplicemente straordinaria
LE "REGOLE DEL GIOCO" DELL’OCCIDENTE E IL DIVENIRE ACCOGLIENTE DELLA MENTE .Un’interpretazione dell’intera storia della filosofia, semplicemente straordinaria
- RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". (federico la Sala)
SCHEDA *
La città divisa
Nicole Loraux
Neri Pozza Editore, pagg.448, Euro 40,00
IL LIBRO - Questo libro è il capolavoro di Nicole Loraux, la grande antichista francese da poco scomparsa. Esso tenta di ripensare da capo la polis greca, questo modello prestigioso di tutta la tradizione politica occidentale. La scoperta della Loraux è che a fondare la città greca, a fungere da paradigma alla democrazia, non sono né la libertà, né l’unità, né la comunità, ma qualcosa come un paradossale legame attraverso la divisione. Si tratta, cioè, di ripensare Atene sotto il segno della “stasis”, della guerra intestina, che divide e insanguina non solo la città, ma anche, l’”oikos”, la famiglia -o, piuttosto, circola, in un movimento incessante, dalla famiglia alla città, dai fratelli rivali ai cittadini nemici. La guerra civile non è, però, soltanto rottura e anomia, ma costituisce il legame politico segreto che anima e segna profondamente la vita e le istituzioni della democrazia greca, dal giuramento all’amnistia, dalla vendetta alla riconciliazione. Una città divisa deve essere, infatti, capace non solo di ricordare, ma anche di dimenticare, di ricomporre attraverso l’oblio (l’amnistia) l’unità perduta. E a poco a poco, come in ogni grande libro di storia, l’analisi del passato permette di guardare in una nuova luce le divisioni e i conflitti, la memoria e la smemoratezza della società in cui viviamo.
DAL TESTO - “La città degli antropologi [...] non agisce nel tempo dell’evento, ma in quello ripetitivo delle pratiche sociali - il matrimonio, il sacrificio -, in cui fare è ancora un modo di pensare. Di pensare se stessi assegnando (tentando di assegnare) un posto all’altro, a tutti gli altri e, di conseguenza, al medesimo: ricollegando i margini al centro, a quegli “andres” che sono la città ma hanno bisogno, per esempio, delle donne per costituirla veramente. Così il matrimonio fonda la città assicurandone la riproduzione. Dopodiché, una volta costituitasi la “polis” in società umana, la si può situare in rapporto a un altrove. O meglio: di questo altrove, tempo degli dei, mondo selvaggio delle bestie, la città proclama la distanza per meglio farlo, mettendolo al posto opportuno. La città ha assorbito il suo fuori, e il sacrificio fonda la “polis”: lontani dagli dei, ma dotati della cultura, gli uomini sacrificano loro un animale, e questo gesto distribuisce il sistema di esplosioni e integrazioni intorno al nucleo degli “andres”. Dal taglio sacrificale e della sua interpretazione in atto nascerebbe a ogni cerimonia il politico: ugualitario come la condivisione, isomorfo... Diremo anche neutralizzato? Il politico come circolazione immobile, o la città a riposo”.
L’AUTORE - Nicole Loraux (1943-2003) ha insegnato «Histoire et anthropologie de la cité greque» presso l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales dal 1981 al 1994. Dei suoi numerosi libri, in italiano sono apparsi: “Come uccidere tragicamente una donna” (Laterza, 1988), “Il femminile e l’uomo greco” (Laterza, 1991), “Le madri in lutto”(Laterza, 1991), “Nati dalla terra. Mito e politica ad Atene” (Meltemi, 1998) e “La voce addolorata. Saggio sulla tragedia greca”(Einaudi, 2001).
INDICE DELL’OPERA - Introduzione, di Gabriella Pedullà - Prefazione - La città divisa: sopralluoghi - I. L’oblio nella città - II. Ripoliticizzare la città - III. L’anima della città - Sotto il segno di Eris e di alcuni suoi figli - IV. Il legame della divisione - V. Giuramento, figlio di Discordia - VI. Dell’amnistia e del suo contrario - VII. Su un giorno vietato del calendario ateniese - Politiche della riconciliazione - VIII. La politica dei fratelli - IX. Una riconciliazione in Sicilia - X. Della giustizia come divisione - XI. E la democrazia ateniese dimenticò il “kratos” - Ringraziamenti - La guerra nella famiglia
* http://www.archiviostorico.info/Rubriche/Librieriviste/recensioni6/Lacittadivisa.htm
- PIANETA TERRA. Fine della Storia o della "Preistoria"? "Pietà per il mondo, venga il nuovo sapere" (M. Serres, Distacco, 1986). Un omaggio a Giambattista Vico ....
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- APRIRE GLI OCCHI: NON SCHERZARE CON IL FUOCO. Il "Mein Kampf", non è un libro normale, è un inno allo sterminio.15 giugno 2016, di Federico La Sala
- LO STATO DEL FARAONE, LO STATO DI MINORITA’, E IMMANUEL KANT "ALLA BERLINA" - DOPO AUSCHWITZ
 "LEZIONE SU KANT" A GERUSALEMME: PARLA EICHMANN "PILATO", IL SUDDITO DELL’"IMPERATORE-DIO". Il ’sonnambulismo’ di Hannah Arendt prima e di Emil Fackenheim dopo.
"LEZIONE SU KANT" A GERUSALEMME: PARLA EICHMANN "PILATO", IL SUDDITO DELL’"IMPERATORE-DIO". Il ’sonnambulismo’ di Hannah Arendt prima e di Emil Fackenheim dopo.
- RIPENSARE L’EUROPA. PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!
 FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.
Mein Kampf in edicola, scherzare con il fuoco
L’iniziativa de Il Giornale. La scelta di Sallusti non offende solo la sensibilità degli ebrei, come si sente dire da più parti, ma il buonsenso di tutte le persone civili. Al di la della illeggibilità di un testo infarcito delle farneticazioni di un tribuno da operetta che sfruttava il disorientamento di un popolo, ciò che impressiona oggi è l’ingenuità della sua riproposizione come se in esso si trovasse anche l’antidoto ai veleni di cui esso stesso è portatore.
di Enzo Collotti (il manifesto, 14.06.2016)
La trovata de Il Giornale di distribuire il Mein Kampf per aumentare le vendite è semplicemente indecente. Non si capisce se è una trovata spregiudicata o se vuole essere un ammiccamento morboso ad uso di un pubblico sicuramente non avvezzo a bocconi così forti.
Certo non è una lettura neutrale, e il proposito di farne l’introduzione ad una serie di pubblicazioni sul nazismo non rende l’idea meno perversa. Essa sfrutta l’appeal che continua ad avere il Führer in virtù dell’attrazione del mostro ma senza fornire gli strumenti per neutralizzarlo.
È un po’ scherzare con il fuoco, come se in un frangente in cui tornano virulenti populismi e razzismi nelle più diverse matrici ci fosse ancora bisogno di normalizzare l’orrore offrendolo in pasto agli ignari lettori fuori dal contesto in cui il Führer lo concepì e a distanza di quasi un secolo dalla sua originaria pubblicazione.
Un anacronismo, si direbbe, se non fosse che c’è ancora qualcuno che pensa a pulizie etniche, a muri di separazione, a gerarchie di razza, ad egoistici esclusivismi e che potrebbe trovare in un simile oggetto incoraggiamento e argomenti.
Al di la della illeggibilità di un testo infarcito delle farneticazioni di un tribuno da operetta che sfruttava il disorientamento di un popolo uscito dalla sconfitta, dalla catastrofe economica e dalla demoralizzazione e che prometteva con freddo calcolo l’assassinio di milioni di esseri umani, ciò che impressiona oggi è l’ingenuità della sua riproposizione come se in esso si trovasse anche l’antidoto ai veleni di cui esso stesso è portatore.
Il fatto singolare è che mentre in Germania, come cercheremo di spiegare in altra sede, si procede con cautela a ristampare con un’edizione «critica», corredata da un autorevole e anche troppo pignolesco commento di accompagnamento, il testo incriminato, in Italia senza troppi complimenti lo si distribuisce quasi gratuitamente e senza troppo curarsi della sua correttezza non dico filologica ma neppure logica.
Si tratti di una consapevole provocazione o di una operazione mirata e sicuramente male architettata, l’iniziativa de Il Giornale non offende solo la sensibilità degli ebrei, come si sente dire da più parti, ma il buonsenso di tutte le persone civili che sono messe a confronto con uno dei capolavori del pensiero perverso senza essere necessariamente preparati a svelenirne il contenuto.
Sarebbe vano invocare censure, dovremmo contare solo sulle capacità di ciascuno di esercitare la propria censura interna e di avere una cultura e un’educazione storica e politica superiori a quella dei media che insieme al buon senso insidiano la buona fede e la curiosità dello sprovveduto lettore attratto dall’apparente novità nel singolare quanto orrido messaggio.
Mein Kampf
Non è un libro normale, è un inno allo sterminio
di Donatella Di Cesare (Corriere Sera, 14.06.2016)
Hitler non si addice alle edicole. La scelta di «regalare» Mein Kampf come allegato deve essere condannata con grande fermezza da una società civile. Quali che siano i motivi reconditi che possono aver spinto il Giornale a diffondere il libro di Hitler, si tratta di una scelta gravissima, irragionevole e ingiustificabile.
Questo fatto - come ha dichiarato Efraim Zuroff, direttore del Centro Wiesenthal di Gerusalemme - è «senza precedenti». Non stupisce che la stampa internazionale abbia dato rilievo alla notizia. Dalla Frankfurter Allgemeine a Die Welt e al Washington Post , per citare solo alcune testate, lo sconcerto è unanime. E ci si chiede come mai, nell’Italia di oggi, Hitler possa tornare a essere popolare.
Il «regalo» è giunto sabato scorso - per gli ebrei alla vigilia di Shavuot, la festa in cui si ricorda il dono della Torah, il Libro dei libri. Triste coincidenza, dunque, che nelle edicole di un Paese europeo, coinvolto nello sterminio, girasse la «Bibbia del nazismo». Né si può sorvolare su una coincidenza inquietante: solo pochi giorni fa è stata finalmente approvata la legge contro il negazionismo.
Vuoi per richiamo morboso, vuoi per banale interesse, nelle edicole l’allegato è esaurito. Questa sarebbe una operazione culturale? Distribuire il secondo volume del testo di Hitler, intitolato La mia battaglia , nella vecchia edizione Bompiani del 1937? Non è una edizione critica: non ci sono né note, né commenti. Non può farne le veci la breve e discutibile introduzione di Francesco Perfetti, il quale sembra ignorare il successo ottenuto, persino nel mondo accademico tedesco, dall’«antisemitismo della ragione» propugnato da Hitler. L’edizione critica, pubblicata in Germania nel gennaio del 2016, è costituita da due volumi di 2.000 pagine e corredata da ben 3.500 note.
Ma arriviamo al punto. I campioni dell’ultraliberalismo hanno gridato alla censura e si sono appellati alla necessità di leggere Hitler come «documento storico». Qui è bene chiarire: Mein Kampf non è un libro come un altro. Non può essere paragonato ad altri libri antisemiti che hanno propagato e propagano ancor oggi le teorie del complotto. Mein Kampf è il libro che contiene il primo progetto di sterminio planetario del popolo ebraico.
Chi lo ha letto lo sa. E sa giudicare la gravità incommensurabile di quelle pagine che preludono all’annientamento. Per Hitler gli ebrei sono gli «stranieri», che cancellano i confini - quelli geografici e quelli tra i popoli. Distruggono gli altri per dominare il mondo; la loro «vittoria» sarebbe «la ghirlanda funeraria dell’umanità», decreterebbe la fine del cosmo. Il pericolo maggiore viene indicato nella possibile fondazione di uno «Stato ebraico». Perché non ci deve essere luogo alcuno, per gli ebrei, nel mondo. Di qui l’annientamento.
Dare allora queste pagine da leggere senza una guida critica? Certo che occorre conoscere Mein Kampf . E chi responsabilmente si occupa della Shoah lo legge e lo fa leggere. Non era necessario che il Giornale degradasse la cultura italiana per avvertirci che il male si deve conoscere. Noi il male non lo dimentichiamo. Ma siamo convinti che uno studio critico, come quello che d’altronde già si compie in molte università e scuole italiane, sia la strada giusta per conoscere il passato e per guardare con più consapevolezza al futuro.
Leggere il Mein Kampf apre gli occhi
Il volume è utile per capire che il centro delle emozioni dell’estrema destra non è essere forti, ma la paura di essere deboli. Il senso di inferiorità spinge a voler dominare gli altri anche attraverso il terrore
di Carlo Rovelli (Corriere della Sera, 14.06.2016)
Il Giornale propone in edicola copie del libro di Hitler, Mein Kampf. Ci sono ragioni per essere offesi o disgustati da questa scelta, e Alessandro Sallusti, il direttore del Giornale, lo dico apertamente, non è persona che mi piace. Eppure mi sono trovato d’accordo con lui quando, forse un po’ goffamente, ha provato a difendere la sua provocazione dicendo che per combattere un male bisogna conoscerlo.
Ho letto Mein Kampf qualche tempo fa, e effettivamente mi ha insegnato delle cose: cose che non mi aspettavo. Provo a riassumerle. Il nazismo è stato un feroce scatenarsi di aggressività. Dalla notte dei lunghi coltelli alla disperata difesa di Berlino, ha cavalcato la violenza estrema. La giustificazione ideologica immediata per la brutalità e la violenza era la superiorità della razza e della civiltà germanica, l’esaltazione della forza, la lettura del mondo in termini di scontro invece che di collaborazione, il disprezzo per chiunque fosse debole.
Questo pensavo, prima di leggere Mein Kampf. Il libro di Hitler è stato una sorpresa perché mostra cosa c’è alla sorgente di tutto questo: la paura. Per me è stata una specie di rivelazione, che mi ha d’un tratto fatto comprendere qualcosa della mentalità della destra, per me da sempre difficile da cogliere. Una sorgente centrale delle emozioni che danno forza alla destra, e all’estrema destra sopratutto, non è il sentimento di essere forti: è la paura di essere deboli.
In Mein Kampf, questa paura, questo senso di inferiorità, questo senso del pericolo incombente, sono espliciti. Il motivo per cui bisogna dominare gli altri è il terrore che altrimenti ne saremo dominati. Il motivo per cui preferiamo combattere che collaborare è che siamo spaventati dalla forza degli altri. Il motivo per cui bisogna chiudersi in un’identità, un gruppo, un Volk, è per costruire una banda più forte delle altre bande ed esserne protetti in un mondo di lupi. Hitler dipinge un mondo selvaggio in cui il nemico è ovunque, il pericolo è ovunque, e l’unica disperata speranza per non soccombere è raggrupparsi in un gruppo e prevalere.
Il risultato di questa paura è stata la devastazione dell’Europa, e una guerra con un bilancio totale di 70 milioni di morti. Cosa ci insegna questo? Penso che quello che ci insegna è che ciò da cui bisogna difendersi per evitare le catastrofi non sono gli altri: sono le nostre paure degli altri. Sono queste che sono devastanti. È la paura reciproca che rende gli altri disumani e scatena l’inferno. La Germania umiliata e offesa dall’esito della prima guerra mondiale, spaventata dalla forza della Francia e della Russia, è stata una Germania che si è autodistrutta; la Germania che, imparata la lezione sulla sua pelle, si è ricostruita come centro di collaborazione e di resistenza alla guerra è una Germania che è fiorita. A me questo insegnamento suona attuale. Forse ora nel mondo la paura reciproca sta aumentando, non lo so, ma a me sembra che noi siamo i primi ad alimentarla. Chi si sente debole ha paura, diffida degli altri, difende se stesso e si arrocca nel suo gruppo, nella sua pretesa identità. Chi è forte non ha paura, non si mette in conflitto, collabora, contribuisce a costruire un mondo migliore anche per gli altri. Pochi libri svelano questa intima logica della violenza come Mein Kampf.
- LO STATO DEL FARAONE, LO STATO DI MINORITA’, E IMMANUEL KANT "ALLA BERLINA" - DOPO AUSCHWITZ
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- Leggere il Mein Kampf apre gli occhi (di Carlo Rovelli)14 giugno 2016, di Federico La Sala
Perché SI
Leggere il Mein Kampf apre gli occhi
Il volume è utile per capire che il centro delle emozioni dell’estrema destra non è essere forti, ma la paura di essere deboli. Il senso di inferiorità spinge a voler dominare gli altri anche attraverso il terrore
di Carlo Rovelli (Corriere della Sera, 14.06.2016)
Il Giornale propone in edicola copie del libro di Hitler, Mein Kampf. Ci sono ragioni per essere offesi o disgustati da questa scelta, e Alessandro Sallusti, il direttore del Giornale, lo dico apertamente, non è persona che mi piace. Eppure mi sono trovato d’accordo con lui quando, forse un po’ goffamente, ha provato a difendere la sua provocazione dicendo che per combattere un male bisogna conoscerlo.
Ho letto Mein Kampf qualche tempo fa, e effettivamente mi ha insegnato delle cose: cose che non mi aspettavo. Provo a riassumerle. Il nazismo è stato un feroce scatenarsi di aggressività. Dalla notte dei lunghi coltelli alla disperata difesa di Berlino, ha cavalcato la violenza estrema. La giustificazione ideologica immediata per la brutalità e la violenza era la superiorità della razza e della civiltà germanica, l’esaltazione della forza, la lettura del mondo in termini di scontro invece che di collaborazione, il disprezzo per chiunque fosse debole.
Questo pensavo, prima di leggere Mein Kampf. Il libro di Hitler è stato una sorpresa perché mostra cosa c’è alla sorgente di tutto questo: la paura. Per me è stata una specie di rivelazione, che mi ha d’un tratto fatto comprendere qualcosa della mentalità della destra, per me da sempre difficile da cogliere. Una sorgente centrale delle emozioni che danno forza alla destra, e all’estrema destra sopratutto, non è il sentimento di essere forti: è la paura di essere deboli.
In Mein Kampf, questa paura, questo senso di inferiorità, questo senso del pericolo incombente, sono espliciti. Il motivo per cui bisogna dominare gli altri è il terrore che altrimenti ne saremo dominati. Il motivo per cui preferiamo combattere che collaborare è che siamo spaventati dalla forza degli altri. Il motivo per cui bisogna chiudersi in un’identità, un gruppo, un Volk, è per costruire una banda più forte delle altre bande ed esserne protetti in un mondo di lupi. Hitler dipinge un mondo selvaggio in cui il nemico è ovunque, il pericolo è ovunque, e l’unica disperata speranza per non soccombere è raggrupparsi in un gruppo e prevalere.
Il risultato di questa paura è stata la devastazione dell’Europa, e una guerra con un bilancio totale di 70 milioni di morti. Cosa ci insegna questo? Penso che quello che ci insegna è che ciò da cui bisogna difendersi per evitare le catastrofi non sono gli altri: sono le nostre paure degli altri. Sono queste che sono devastanti. È la paura reciproca che rende gli altri disumani e scatena l’inferno. La Germania umiliata e offesa dall’esito della prima guerra mondiale, spaventata dalla forza della Francia e della Russia, è stata una Germania che si è autodistrutta; la Germania che, imparata la lezione sulla sua pelle, si è ricostruita come centro di collaborazione e di resistenza alla guerra è una Germania che è fiorita. A me questo insegnamento suona attuale. Forse ora nel mondo la paura reciproca sta aumentando, non lo so, ma a me sembra che noi siamo i primi ad alimentarla. Chi si sente debole ha paura, diffida degli altri, difende se stesso e si arrocca nel suo gruppo, nella sua pretesa identità. Chi è forte non ha paura, non si mette in conflitto, collabora, contribuisce a costruire un mondo migliore anche per gli altri. Pochi libri svelano questa intima logica della violenza come Mein Kampf.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- ANCORA NELLA CAVERNA!!! Judith Shakespeare, vittima di due millenni di pregiudizi contro le donne.8 giugno 2016, di Federico La Sala
I maestri del disprezzo per le donne
di Daniela Monti (Corriere della Sera, 08.06.2016)
Nel 1929 Virginia Woolf, nel saggio Una stanza tutta per sé, inventa una storia: quella di Judith, ipotetica sorella di William Shakespeare, stessa genialità, stessa irrequietezza, stessa voglia di fare del fratello. Per seguire il proprio talento, Judith si istruisce come può, leggendo il poco che trova per casa (ma appena i genitori se ne accorgono, le tolgono i libri e le mettono in mano delle calze da rammendare), rifiuta il matrimonio spezzando il cuore al padre, scappa per inseguire il sogno di fare teatro e viene accolta da un impresario che la schernisce e da un agente teatrale che, impietosito, la mette incinta. Alla fine, non trova altra via di uscita che uccidersi.
Mentre il talento del fratello è celebrato, il suo non vale niente: ha sfidato l’ordine naturale delle cose che la vuole debole, inferiore, indegna di ricevere un’istruzione e, insieme, selvaggia e ingestibile, una a cui mettere fin da subito il guinzaglio; si è illusa di potersi esprimere da donna e artista, senza neppure ricorrere all’espediente di camuffarsi da uomo, che pure è una strada battuta; ha sbagliato tutto, è andata fuori ruolo e infatti non c’è nessuno disposto ad ascoltarla. Così Judith «giace sepolta a un certo incrocio, lì dove ora gli autobus si fermano nei pressi di Elephant and Castle». Potessimo posare una lapide mortuaria, sopra ci sarebbe scritto: coraggiosa e ingenua Judith Shakespeare, vittima di due millenni di pregiudizi contro le donne.
Perché quello contro il genere femminile, «a conti fatti, appare come il più antico, radicato, diffuso pregiudizio che la vicenda umana è stata in grado di produrre», scrive Paolo Ercolani nel suo Contro le donne (Marsilio, pp. 318, e 17,50), resoconto dettagliato di come, dalle origini della società occidentale, scrittori, filosofi, intellettuali abbiano alimentato un dibattito «tutto fra uomini» - le donne sembrano assenti dalla filosofia, se non come oggetto del discorso dei filosofi maschi - «per arrivare a stabilire l’inferiorità inemendabile e irrecuperabile dell’essere femminile». I grandi filosofi greci, i padri della Chiesa, gli illuministi, i rivoluzionari, i filosofi idealisti, persino quel campione della causa femminile che fu John Stuart Mill: un’operazione culturale a senso unico che affonda le radici nella presunta «deficienza fisica» delle donne per poi esportare tale mancanza in altri campi, quelli dell’etica, della morale, dell’organizzazione politica della società.
Fu nell’Atene democratica, «tanto esaltata dalla tradizione occidentale, che si diffuse il costume di imporre alle donne il velo di fronte a situazioni pubbliche e a uomini scapoli, al contrario di quello che accadeva a quel tempo in Persia o in Siria», scrive Ercolani, aprendo il fronte della globalizzazione del pregiudizio, il quale, come le malattie contagiose, è riuscito a infettare culture lontane e all’apparenza inconciliabili, stringendole in un unico blocco misogino.
E loro, le donne? «Molto spesso sono le donne stesse a sminuirsi rispetto al maschio, in una sorta di autofobia indotta da secoli di indottrinamento», scrive Ercolani. Il femminismo, che pure è una delle grandi narrazioni della modernità, resta ai margini del lungo excursus, diventando esso stesso un bersaglio quando «negando l’esistenza di una specificità femminile (differente dal maschio) e prefigurando irrealistici scenari di individui a-sessuati ha finito con il fare da sponda al pensiero misogino».
La via d’uscita proposta sta nel ridefinire i canoni dell’identità e soggettività umana, al di là del «narcisismo di genere». Come scriveva Caterina Botti nel suo Prospettive femministe (Mimesis), «fino a relativamente poco tempo fa l’assenza delle donne dalla filosofia non era considerata una questione degna di nota. Oggi invece lo è».
SUL TEMA, IN RETE, SI CFR.:
- DAL "CHE COSA" AL "CHI" ... DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. Una nota di Eleonora Cirant
- IL "SOGNO" DI MICHELANGELO: "DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE". Sibille e profeti: sulle tracce di Benjamin
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! - CHI PIU’ CHI MENO, TUTTI VIVONO DENTRO LA PIU’ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA E POLITICA ITALIANA, NEL REGNO DI "FORZA ITALIA"!!! -- Caro Cacciari, perché su Renzi sbagli tutto (di Piero Bevilacqua)1 giugno 2016, di Federico La Sala
- LO "STATO HEGELIANO" - DELLO STATO MENTITORE, ATEO E DEVOTO ("Io che è Noi, Noi che è Io"). --- Destra e Sinistra: "Al cuore delle cose. Scritti politici" (di E. Fachinelli - Dario Borso)
- RICERCA E MERAVIGLIA: AL SAN RAFFAELE, UNA GRANDE FESTA FILOSOFICA! IL "VECCHIO" PROBLEMA DEL PENSIERO DELLA COSTITUZIONE E DELLA COSTITUZIONE DEL PENSIERO E’ STATO RISOLTO !!! ALL’OMBRA DELL’UOMO DELLA PROVVIDENZA: 2002-2012, DIECI ANNI DI FILOSOFIA AL "SAN RAFFAELE".
Caro Cacciari, perché su Renzi sbagli tutto
Riforme. Il neo-centralismo della riforma costituzionale e il dispositivo autoritario contenuto nell’Italicum non sono una cattiveria di Renzi. È un passaggio obbligato, nel contesto del capitalismo globale, di una strategia ineludibile per il ceto politico. Se non hai il consenso hai bisogno del potere
di Piero Bevilacqua (il manifesto, 31.05.2016)
L’intervista che Massimo Cacciari ha rilasciato a Ezio Mauro (Repubblica, 27.5.2016) per motivare il suo SI al referendum confermativo della riforma del Senato, offre al lettore, io credo, un buon campionario di motivi per indurlo al comportamento contrario a quello perorato dal filosofo: cioé a votare decisamente NO.
Nel merito Cacciari arriva a definire l’oggetto del referendum «una riforma modesta e maldestra. La montagna ha partorito un brutto topolino». Poco prima, incalzato da Mauro, aveva ricordato che da decenni era nelle sue aspirazioni e nella parte più illuminata della sinistra, la creazione di «un autentico Senato delle Regioni con i rappresentanti più autorevoli eletti direttamente, e non scelti tra i gruppi dirigenti più sputtanati d’Italia, come oggi». Come dissentire?
Poco prima, incalzato da Mauro, aveva ricordato che da decenni era nelle sue aspirazioni e nella parte più illuminata della sinistra, la creazione di «un autentico Senato delle Regioni con i rappresentanti più autorevoli eletti direttamente, e non scelti tra i gruppi dirigenti più sputtanati d’Italia, come oggi». E tuttavia egli dichiara che la riforma è da approvare comunque, perché finalmente si arriverebbe a decidere un cambiamento. Quel che importa è che si faccia qualcosa.
Un ragionamento - mi perdonerà l’amico Cacciari - che non si discosta molto da quello del padre della fanciulla che ha visto sfumare tante occasioni di matrimonio e alla fine si acconcia a farla sposare allo sciancato del paese. Perché almeno non resti zitella. Ma non son queste le pecche peggiori del suo argomentare.
Egli fa una ricostruzione storica troppo sommaria e indistinta della sinistra in lotta per le riforme istituzionali. Finisce con lo stabilire un nesso di continuità, diciamo tra la fondazione del Centro per la riforma dello Stato, voluta dal Pci nel 1972, con l’efficace direzione di Ingrao per tutti gli anni ’80, e il «brutto topolino» dei nostri giorni. Finisce col dare ragione a tanti giovanotti e fanciulle del Pd, che negli ultimi tempi sono andati in forze in Tv («la riforma che l’Italia aspettava da 30 anni»). Come dimenticare, infatti le grandi manifestazioni popolari, nelle piazze di tutto il Paese, per invocare l’abolizione del Senato? Ma questo è il folklore... La sostanza storica è che Cacciari mette insieme cose diverse.
Intanto ricordiamo che l’esigenza di una riforma dello Stato, nata dentro alcuni settori del Pci, non era ispirata solo da ragioni di efficienza della macchina decisionale, ma soprattutto dalla volontà di un allargamento della democrazia. Per la verità, ricordando le battaglie federaliste degli ultimi decenni, Cacciari non dimentica le ragioni di una maggiore vicinanza delle istituzioni ai cittadini, ma proprio questo rende ancora più paradossale e insostenibile la sua posizione. A essere tradito oggi è esattamente l’ordito federalista da lui auspicato, a favore di un neocentralismo che sta sottraendo materie importanti alle regioni, soprattutto per quanto riguarda il governo dei propri territori.
Il nuovo Senato toglierà ancor più potere alle aree periferiche del Paese - com’è stato persuasivamente argomentato da tanti costituzionalisti di rango - non solo perché non tutti i territori saranno parimenti rappresentati. Ma anche per una ragione più grave e per certi versi drammatica. Ma si ha idea delle lotte che esploderanno all’interno dei consigli regionali per accaparrarsi il posto di consigliere-senatore? Quanti mesi sottrarranno al lavoro dei nostri governi regionali?
C’è nel ragionamento di Cacciari, ma soprattutto di tanti altri commentatori, una impropria sopravvalutazione del fattore efficienza della macchina amministrativa. Fattore certo importante, ma spesso secondario. Attribuire al bicameralismo perfetto l’inefficienza dei nostri governi è una lettura semplicemente superficiale della storia politica italiana.
Negli anni ’70 vigeva il bicameralismo eppure in quel decennio sono state realizzate le riforme più importanti per la modernizzazione dell’Italia. E il ragionamento vale anche in periferia. Davvero si crede che le nostre regioni, soprattutto quelle meridionali, non siano capaci di utilizzare a pieno i fondi strutturali europei per pura inefficienza? In realtà sono lentissime nel decidere a causa delle lotte intestine tra i vari gruppi che si contendono le risorse e sono in perenne litigio sulle forme, i modi, i luoghi del loro utilizzo. Il guasto è nel corpo del ceto politico e lo si cerca nelle istituzioni.
Ancora più paradossale è però il “Si” di Cacciaci al referendum accompagnato da un giudizio severo sulla riforma elettorale dell’Italicum. Ma dov’è, innanzi tutto, il senso tattico di questa posizione? Già Renzi ha fatto sapere, con la consueta mitezza di modi, che «l’Italicum non si tocca». Figuriamoci quanto sarà disponibile a modificarlo nel caso dovesse vincere il referendum d’autunno. Ma questa distinzione tra legge elettorale e riforma del Senato, che è di tanti attori politici e commentatori, tradisce una grave incomprensione storica di quel che è avvenuto nei paesi capitalistici.
E a Cacciari, a tal proposito, dovrei ricordare, allorché usa il termine sinistra, che negli ultimi 15 anni, un arcipelago di intellettuali si è messo a studiare il capitalismo attuale e riesce a leggere in profondità e con capacità di anticipazione i fenomeni sociali e politici del nostro tempo. Quella capacità che la sinistra storica sembra avere ormai definitivamente perduto.
Il dispositivo autoritario contenuto nell’Italicum non è una cattiveria di Renzi. E’ un passaggio obbligato, nel contesto del capitalismo globalizzato, di una strategia che oggi appare ineludibile per il ceto politico. Non lo ripeterò mai abbastanza: ceto politico vuol dire una classe professionale, con sempre meno legami con le masse popolari, che vive di politica, cioè di mediazione tra i poteri industrial-finanziari e la società. Tale ceto politico, sia per la sempre minore autonomia d’azione dello Stato-nazione, sia perché necessitato a ridurre sempre di più diritti e welfare non riesce a governare con il consenso dei cittadini. C’è bisogno di prove?
Osservate le statistiche della diserzione delle urne, in Italia come altrove. Se manca il consenso, per governare occorre il potere. L’Italicum è il completamento di un disegno già in atto. Il governo Renzi ha abolito l’articolo 18, combatte apertamente il sindacato, ha elevato a simbolo della sua nuova narrazione un capitalista internazionale come Marchionne, ha insediato la figura del preside-capo nelle scuole, controlla e presidia quotidianamente le Tv pubbliche. Forse che non ha dato sufficienti prove di spregiudicatezza e irresponsabilità nel manomettere la Costituzione e spaccare ora il Paese? Che cosa devono desiderare di più e di meglio i gruppi capitalistici nazionali e transnazionali? Giusto un governo dominato da un capo che comanda un Parlamento di nominati. Eccolo in arrivo...
L’Italia ha già conosciuto su scala ridotta lo squallido servilismo, il conformismo asfissiante generato in tutti gli ambiti della società dal potere assunto, a metà anni ’80, da Bettino Craxi e dal suo Psi. Oggi incombe su di noi un ben più grave pericolo, perché allora, benché mal messi, esistevano ancora i partiti di massa. Oggi non più. Allarmante è che un intellettuale della statura di Cacciari non l’abbia ancora capito.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA --- ITALIA. La Repubblica, il voto alle donne e la nascita della Costituente. I tre anniversari del 2 giugno(di Carlo Smuraglia).1 giugno 2016, di Federico La Sala
- FILOSOFIA, ANTROPOLOGIA, E STORIA. UOMINI E DONNE, PROFETI E SIBILLE, OGGI...
 IL "SOGNO" DI MICHELANGELO: "DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE". Sibille e profeti: sulle tracce di Benjamin
IL "SOGNO" DI MICHELANGELO: "DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE". Sibille e profeti: sulle tracce di Benjamin
I tre anniversari del 2 giugnodi Carlo Smuraglia, presidente nazionale dell’Anpi
Da tempo contestiamo che il 2 giugno possa risolversi in una parata militare o poco più. Abbiamo, nel tempo, accentuato il connotato di anniversario fondamentale per la vita del Paese; in seguito, abbiamo collegato al 2 giugno il tema della Costituzione, dando luogo anche a manifestazioni molto partecipate, d’ intesa con la CGIL.
Quest’anno, è impossibile celebrare il 2 giugno senza ricordare che nel 2016 si concentrano ben tre anniversari: la Repubblica, il voto alle donne e la nascita della Costituente. Tre anniversari che imprimono un carattere particolarmente significativo ad una Festa che, per noi, ha sempre avuto un’importanza del tutto particolare. A fronte di un interrogativo che alcuni si sono posti, se il 2 giugno abbia rappresentato il punto di arrivo della crisi che portò il Paese fuori dal fascismo e dalla guerra, oppure il primo passo di un nuovo possibile cambiamento, ho personalmente ritenuto - sempre - che il tema fosse mal posto, perché in realtà, la vera fase conclusiva del periodo della dittatura fu l’8 settembre, che segnò anche l’inizio della fase di riscatto. Il 2 giugno fu il giorno della scelta decisiva, influenzata solo in parte dal comportamento dei Savoia: la scelta se restare ancorati ai modelli del periodo prefascista, oppure avviare con determinazione il cammino, magari non facile, verso una democrazia, in cui i cittadini assumessero finalmente il ruolo - chiave, attraverso la partecipazione.
Per chi ha partecipato alla Resistenza, una simile scelta non aveva alternative, perché in realtà ciò che si era voluto, tutti, era la fine della dittatura e la nascita di un sistema democratico, che andasse oltre, anche rispetto all’esperienza del periodo liberale.
Molti di noi, il 2 giugno 1946, non ebbero dubbi, sembrandoci impossibile non trarre le conseguenze logiche e necessarie dell’esperienza che avevamo vissuto e dei sogni che avevamo coltivato. Del resto, nelle famose ”aree libere”, quando vi fu la possibilità concreta di sperimentare la democrazia, talora in forma poco più che primitiva, la definizione a cui si pensò, fu quella di “repubblica partigiana”. La Repubblica fu, dunque, per molti, la speranza di un futuro diverso, nel quale non ci fosse più posto per qualsiasi forma di autoritarismo e tanto meno di “sudditanza” dovendo il popolo diventare, finalmente, il vero protagonista della scena politica.
Non a caso, del resto, nel 1946, si decise, finalmente, di riconoscere alle donne il diritto di votare e di essere elette; ed anche questo era frutto di un’aspirazione certo lontana nel tempo (i movimenti femministi risalgono alla fine dell’800 ed alla parte iniziale del ‘900), ma consolidata con l’irruzione delle donne sulla scena politica, negli anni della seconda guerra mondiale e soprattutto tra il 1943 e il 1945, con l’assunzione di inedite responsabilità e compiti, come staffette, come partigiane, come protagoniste della Resistenza non armata, infine come componenti dei “gruppi di difesa della donna”.
È nel 1946 che si concretizza quello che per molto tempo era stato il sogno impossibile e che ora, dopo la Resistenza, appariva come imprescindibile, al di là di ogni pregiudizio e di ogni timore. E non è un caso, che sempre nel 1946, e proprio a seguito del voto del 2 giugno, fu eletta l’Assemblea Costituente, si diede vita - cioè - al percorso che doveva creare le condizioni di vita e di rapporti politici e sociali (anch’essi sognati nella Resistenza e finalmente avviati alla realizzazione ) creando la struttura di quella che diventerà poi la nostra Costituzione, destinata a durare nel tempo.
Per tutto questo, oggi il 2 giugno non può essere festeggiato solo come l’anniversario di una scelta, pur decisiva, ma deve essere considerato nel contesto di tutti gli anniversari che si celebrano nel 2016, perché fra di essi vi è un legame strettissimo e indissolubile (Repubblica, voto alle donne, Costituente), riconducibile ad un’unica matrice, la Resistenza ed alla volontà di riscatto del popolo italiano.
Forse, nella mente dei vincitori del voto del 2 giugno, vi fu solo in parte questa consapevolezza complessiva; forse si coltivavano perfino speranze eccessive, al limite delle illusioni. Ma intanto il dado era tratto, con la forma di Stato, col riconoscimento del diritto universale di voto, con le basi gettate - con la Costituente - per una Costituzione radicalmente innovativa, che fosse di rottura netta col passato, ma anche di premessa ed impegno per un futuro socialmente, politicamente e democraticamente diverso.
Tutto questo significa, dunque, oggi, il 2 giugno; e come tale lo festeggeremo, anche se attraversiamo una fase non facile ed anche se è in atto uno scontro proprio sulla Costituzione. Ma siamo intenti a “celebrare” la ricorrenza, non tanto sulla base del ricordo storico, quanto e soprattutto sulla base della conoscenza e della riflessione: per capire meglio chi siamo e da dove veniamo e per guardare ad un futuro che potrà essere ancora incerto, ma non potrà mai prescindere dalle scelte di settant’anni fa e di ciò che hanno rappresentato e rappresentano tuttora nella vita e nei sentimenti del nostro Paese.
Carlo Smuraglia, presidente nazionale dell’Anpi
* ANPI, 31 Maggio 2016
- FILOSOFIA, ANTROPOLOGIA, E STORIA. UOMINI E DONNE, PROFETI E SIBILLE, OGGI...
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- L’amore ai tempi di Sant’Agostino - e di papa Francesco (di Corrado Augias)28 maggio 2016, di Federico La Sala
IL MESSAGGIO EVANGELICO, IL PARADOSSO ISTITUZIONALE DEL MENTITORE, E LA CATASTROFE DELL’EUROPA. “Come fu possibile la hitlerizzazione dell’Imperativo Categorico di Kant? E perché è ancora attuale oggi?” (Emil L. Fackenheim, Tiqqun. Riparare il mondo).:
- KANT E SAN PAOLO. COME IL BUON GIUDIZIO ("SECUNDA PETRI") VIENE (E VENNE) RIDOTTO IN STATO DI MINORITA’ DAL GIUDIZIO FALSO E BUGIARDO ("SECUNDA PAULI").
- DISTRUGGERE IL CRISTIANESIMO: IL PROGRAMMA "ANTICRISTO" DEL CATTOLICESIMO-ROMANO. LA LEZIONE CRITICA DI KANT. Alcune luminose pagine da "La fine di tutte le cose"
L’amore ai tempi di Sant’Agostino
risponde Corrado Augias (la Repubblica, 28.05.2016)
- GENTILE Corrado Augias, il clero è costituito da persone che hanno scelto uno stile di vita diverso. A parte escludersi da gran parte delle comuni attività lavorative per dedicarsi al culto divino, non si sposano e non partecipano alla continuità della specie attraverso la riproduzione. Sono libere scelte, che nessuno contesta pur essendo relativamente anomale in una comunità umana attiva. Il clero però si sente legittimato a dettare regole per la società nella quale vive, con particolare severità e insistenza proprio su matrimonio e riproduzione. Per esempio i matrimoni omosessuali. Per la religione cattolica il matrimonio è un sacramento, ma per un laico è solo la registrazione pubblica di un rapporto. La società, riconoscendolo, stabilisce vantaggi e vincoli, per esempio la pensione di reversibilità, l’affidamento, l’asilo per i figli, l’eredità. Da un’unione omosessuale non nascono figli, ma non è il matrimonio a modificare in meglio o in peggio il limite di tale unione. È una sterilità come quella di chi si è votato al celibato. Non dovrebbe riguardare il clero il modo in cui la società decide di regolare la convivenza tra due persone. È la società che deve valutarne i pro e i contro e le motivazioni.
 Franco Ajmar - Genova
Franco Ajmar - Genova
LA RAGIONE sottostante a certi atteggiamenti da parte di uomini che non ne avrebbero in apparenza titolo, viene da molto lontano. Nella sua versione più antica la si vede nel famoso precetto di Sant’Agostino: dilige et quod vis fac - cioè: ama e fai ciò che vuoi. Che significato ha amare nel senso usato dal primo, grande filosofo cristiano (354-430)?
Con forte slancio poetico, un giorno Agostino disse ai suoi fedeli: «Ama e fa’ ciò che vuoi; sia che tu taccia, taci per amore; sia che tu parli, parla per amore; sia che tu corregga, correggi per amore; sia che perdoni, perdona per amore; sia in te la radice dell’amore, poiché da questa radice non può procedere se non il bene».
Non c’è film o sceneggiato sul vescovo di Ippona in cui questa poetica esortazione non venga mostrata. In realtà quei versi sono molto meno benevoli di quanto la parola amore li faccia apparire; il santo vescovo dice in sostanza che l’amore giustifica anche l’esercizio dell’autorità. Amare davvero qualcuno vuol dire volere il suo bene, il bene sommo, rappresentato dall’eterna salvezza. Lecito quindi, anzi doveroso, forzare per amore chi sbaglia a entrare nell’ortodossia; anche qui abbiamo un imperativo celebre “Compelle entrare”.
Ancora più esplicito diventa l’invito quando Agostino chiarisce in cosa consista l’esercizio della carità: «Sia fervida la carità nel correggere, nell’emendare... Non voler amare l’errore nell’uomo, ma l’uomo; Dio infatti fece l’uomo, l’uomo invece fece l’errore. Ama ciò che fece Dio, non amare ciò che fece l’uomo stesso... Anche se qualche volta ti mostri crudele, ciò avvenga per il desiderio di correggere ».
Quando dice che la carità «infierisce», Agostino usa il verbo latino saevire che vuol dire infuriare, incrudelire.
Saevus significa feroce; da saevire deriva “sevizia”. Il termine carità può avere questa valenza ambigua. Si sarà notato che papa Francesco ne usa uno più mite: misericordia.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- M. SERRES RIPRENDE LA LEZIONE DI VICO, "DENUNCIA" CARTESIO, E FA UNA CONFESSIONE.23 maggio 2016, di Federico La Sala
MICHEL SERRES "DENUNCIA" CARTESIO ("Dal metodo non nasce niente") E FA "UNA CONFESSIONE". "Pietà per il mondo, venga il nuovo sapere"(M. Serres, Distacco, 1986):
- "Paranoico, questo Io-Sole!" (Michel Serres, Il mancino zoppo. Dal metodo non nasce niente [Le Gaucher boiteux. Puissance de la pensée], Bollati Boringhieri, Torino, 2016, p. 18)
- "Una confessione. La filosofia, si dice, conduce alla saggezza [sagesse]. Secondo un altro significato della parola, prima di morire vorrei diventare levatrice - che in francese diciamo sage-femme, cioè letteralmente, «saggia donna» -, vorrei aiutare a partorire il mondo nuovo.
 La mia vita intera mi ci ha preparato, attraverso l’ascolto attento degli scricchiolii emessi dal vecchio. Sento le crisi che attraversiamo, le inquietudini che suscitano, come dei lamenti emessi nel travaglio del parto. Amo la madre, accolgo il bambino.
La mia vita intera mi ci ha preparato, attraverso l’ascolto attento degli scricchiolii emessi dal vecchio. Sento le crisi che attraversiamo, le inquietudini che suscitano, come dei lamenti emessi nel travaglio del parto. Amo la madre, accolgo il bambino.
 Possa migliorare incessantemente la mia attività di medico ostetrico, il mio diventare sage-femme" (Michel Serres, Il mancino zoppo. Dal metodo non nasce niente [Le Gaucher boiteux. Puissance de la pensée], Bollati Boringhieri, Torino, 2016, pp. 48-49).
Possa migliorare incessantemente la mia attività di medico ostetrico, il mio diventare sage-femme" (Michel Serres, Il mancino zoppo. Dal metodo non nasce niente [Le Gaucher boiteux. Puissance de la pensée], Bollati Boringhieri, Torino, 2016, pp. 48-49).
- LA FILOSOFIA "MODERNA" E LA "SCIENZA NUOVA". "La strada di Vico gira e rigira per congiungersi là dove i termini hanno inizio... Prima che vi fosse un uomo in Irlanda c’era un Lord in Lucania" (James Joyce, "Finnegans Wake")
 PAROLA DI VICO. SULLA MODERNITA’ DI CARTESIO, RICREDIAMOCI.
PAROLA DI VICO. SULLA MODERNITA’ DI CARTESIO, RICREDIAMOCI.
Federico La Sala, La mente accogliente. Tracce per una svolta antropologica, Antonio Pellicani editore, Roma 1991, pp. 138-189 (capp. II e III):
CHI SIAMO NOI, IN REALTA’?! RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTA’: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- "La verità dimora nella lingua e un filosofo che non avesse cura di questa dimora sarebbe un cattivo filosofo" (Agamben, a colloquio con Gnoli)15 maggio 2016, di Federico La Sala
Giorgio Agamben
“Credo nel legame tra filosofia e poesia
Ho sempre amato la verità e la parola”
Gli anni parigini con Italo Calvino, le lezioni di Heidegger e la Roma dei Sessanta. Parla lo studioso che ha saputo spaziare tra estetica e biopolitica
colloquio con Antonio Gnoli (la Repubblica, 15.05.2016)
Giorgio Agamben ha scritto un bellissimo libro. I suoi libri sono sempre densi e tersi (e imprevedibili come quello dedicato recentemente a Pulcinella, edizioni Nottetempo). Hanno lo sguardo rivolto al passato remoto. È il solo modo per intensificare il presente. Prendete il suo ultimo lavoro Che cos’è la filosofia? (edito da Quodlibet), cosa nasconde una domanda apparentemente ovvia? «È mia convinzione» - dice Agamben - «che la filosofia non sia una disciplina, di cui sia possibile definire l’oggetto e i confini (come provò a fare Deleuze) o, come avviene nelle università, pretendere di tracciare la storia lineare e magari progressiva. La filosofia non è una sostanza, ma un’intensità che può di colpo animare qualunque ambito: l’arte, la religione, l’economia, la poesia, il desiderio, l’amore, persino la noia. Assomiglia più a qualcosa come il vento o le nuvole o una tempesta: come queste, si produce all’improvviso, scuote, trasforma e perfino distrugge il luogo in cui si è prodotta, ma altrettanto imprevedibilmente passa e scompare».
Offri un’immagine volatile della filosofia.
«Ho l’abitudine di dividere l’ambito dell’esperienza in due grandi categorie: le sostanze da una parte e, dall’altra, l’intensità. Di una sostanza si possono disegnare i confini, definire i temi e l’oggetto, tracciare la cartografia; l’intensità invece non ha un luogo proprio».
Può verificarsi ovunque?
«La filosofia, il pensiero è, in questo senso, un’intensità che può tendere, animare e percorrere ogni ambito. Essa condivide questo carattere tensivo con la politica. Anche la politica è un’intensità, anche la politica, contrariamente a quello che ritengono i politologi, non ha un luogo proprio: com’è evidente non soltanto nella storia recente, di colpo la religione, l’economia, perfino l’estetica possono acquisire una decisiva intensità politica, diventare occasione di inimicizia e di guerra. Va da sé che le intensità sono più interessanti delle sostanze. Se le sostanze e le discipline - come la vita, del resto - rimangono inerti, se non raggiungono una certa intensità, esse decadono a pratiche burocratiche».
Un antidoto allo scadere nella pratica burocratica può essere la poesia. Tu hai spesso ribadito il legame tra filosofia e poesia. Che lo stesso Heidegger pose al centro della sua riflessione. In cosa consiste questo legame?
«Ho sempre pensato che filosofia e poesia non siano due sostanze separate, ma due intensità che tendono l’unico campo del linguaggio in due direzioni opposte: il puro senso e il puro suono. Non c’è poesia senza pensiero, così come non c’è pensiero senza un momento poetico. In questo senso, Hölderlin e Caproni sono filosofi, così come certe prose di Platone o di Benjamin sono pura poesia. Se si dividono drasticamente i due campi, io stesso non saprei da che parte mettermi». Nella tua biografia intellettuale c’è una laurea in giurisprudenza, ma con una tesi piuttosto insolita dedicata a Simone Weil.
Come è nata questa scelta?
«Scoprii Simone Weil a Parigi nel 1963 o ’64, comprando per caso la prima edizione dei Cahiers nella libreria Tschann a Montparnasse. Ne rimasi così abbagliato che appena tornato a Roma li feci leggere a Elsa Morante che ne fu conquistata. E immediatamente decisi che avrei dedicato al pensiero politico della Weil la mia tesi di laurea in filosofia del diritto. Allora in Italia il suo pensiero era quasi sconosciuto e io ne sapevo molto più dei relatori con cui dovevo laurearmi».
Cosa ti colpì del suo pensiero?
«In modo particolare la critica delle nozioni di persona e di diritto che la Weil svolge in La personne et le sacré. Fu a partire da questa critica che lessi il saggio di Marcel Mauss sulla nozione di persona e mi apparve chiaro il nesso che congiunge intimamente la persona giuridica e la maschera teatrale e poi teologica dell’individuo moderno. Forse la critica del diritto che non ho mai abbandonato a partire dal primo volume di Homo sacer, ha nel saggio della Weil la sua prima radice».
Un’altra radice nella costruzione del tuo pensiero è stata Walter Benjamin.
«Ci sono nella vita degli eventi e degli incontri che sono troppo grandi per poter avvenire una volta per tutte. Essi, per così dire, non cessano di accompagnarci. L’incontro con Benjamin - come quello con Heidegger a Le Thor - sono di questo tipo. Come i teologi dicono che Dio continua a creare il mondo in ogni istante, così questi incontri sono sempre in corso. Il debito che ho con Benjamin è incalcolabile».
Debito è una parola intensiva.
«Basti qui accennare solo a un problema di metodo. È lui che mi ha insegnato a estrarre a forza dal suo contesto storico apparentemente remoto un determinato fenomeno per restituirgli vita e farlo agire nel presente. Senza di questo, le mie incursioni in campi così diversi come la teologia e il diritto, la politica e la letteratura, non sarebbero state possibili. Quando si frequenta così intensamente un autore, si producono dei fenomeni che sembrano quasi magici, ma che sono solo il frutto di quell’intimità. Così mi è capitato per il ritrovamento di manoscritti di Benjamin, prima a Roma in casa di un suo amico di gioventù e poi nella Biblioteca Nazionale di Parigi (i manoscritti del libro su Baudelaire a cui Benjamin lavorava negli ultimi anni della sua vita)».
Negli ultimi anni si è accentuato il tuo richiamo alla “biopolitica”. È un concetto che deve molto a Michel Foucault?
«Certamente. Ma altrettanto importante per me è stato il problema del metodo in Foucault, cioè l’archeologia. Sono convinto che la sola via di accesso al presente sia oggi l’indagine del passato, l’archeologia. A condizione di precisare, come fa Foucault, che le ricerche archeologiche non sono che l’ombra che l’interrogazione del presente proietta sul passato. Nel mio caso quest’ombra è spesso più lunga di quella che inseguiva Foucault e investe dei campi, come la teologia e il diritto, che Foucault ha poco frequentato. I risultati delle mie ricerche potranno certamente essere contestati, ma spero almeno che le indagini puramente archeologiche che ho svolto in Stato di eccezione, Il regno e la gloria o nel libro sul giuramento aiutino a capire il tempo in cui viviamo».
Un altro pensatore che ha aiutato a capire il tempo in cui viviamo fu Guy Debord con il suo libro “La società dello spettacolo”, un testo che ancora oggi ci aiuta a comprendere il nostro presente.
«Lo lessi l’anno stesso della sua pubblicazione, il 1967. Con Guy diventammo amici molti anni dopo, alla fine degli anni Ottanta. Ma ricordo, sia al momento della prima lettura come nelle nostre conversazioni, il respiro di sollievo vedendo come la sua mente fosse assolutamente libera dai pregiudizi ideologici che avevano compromesso le sorti dei movimenti. Nel Sessantotto e negli anni successivi gli amici dei movimenti che frequentavo si proclamavano senza dubbi né vergogna e con un’assoluta abdicazione della facoltà di pensare, “maoisti” “trotskisti” e via dicendo. Io e Guy eravamo arrivati alla stessa lucidità, lui a partire dalla tradizione delle avanguardie artistiche da cui proveniva, io dalla poesia e dalla filosofia».
Di sé Debord disse: «Non sono un filosofo, sono uno stratega», secondo te cosa intendeva?
«Malgrado quell’affermazione che citi, non penso che ci fosse in lui alcun conflitto fra il filosofo e lo stratega. La filosofia implica sempre un problema di strategia perché, anche se cerca l’eterno, può farlo solo attraverso un confronto con il suo tempo».
Negli anni in cui hai vissuto a Parigi vedevi spesso Italo Calvino. Come fu il rapporto con lui, con le sue geometrie illuminanti?
«Accanto al nome di Calvino, vorrei mettere quello di Claudio Rugafiori che, con Italo, vedevo spesso in quegli anni, perché lavoravamo insieme a un progetto di una rivista che non andò mai in porto. Il tentativo era di definire quelle che chiamavamo tra noi le “categorie italiane”, delle coppie di concetti attraverso le quali cercavamo di definire le strutture portanti della cultura italiana: “architettura/vaghezza”, “tragedia/ commedia”, “rapidità/leggerezza”, quest’ultima la si può ritrovare testualmente nelle Lezioni americane di Italo. Ero affascinato dal modo in cui lavoravano la mente di Italo e quella di Claudio».
Cosa ti seduceva?
«Il fatto che fossero due forme di pensiero puramente analogico, che percepiva somiglianze e corrispondenze là dove nessun altro avrebbe saputo trovarle. L’analogia è una forma di conoscenza che la nostra cultura ha respinto sempre più ai margini. Quanto all’idea di un Calvino geometrico e scientista credo vada corretta. La sua era piuttosto una straordinaria forma di immaginazione analogica, una sorta di istinto fisiognomico che gli permetteva di ridisegnare ogni volta la geografia del sapere letterario».
Accennavi all’inizio alla tua amicizia con Elsa Morante. Come fu il rapporto con una donna dal carattere così complesso?
«L’incontro e l’amicizia con Elsa sono stati per me in ogni senso decisivi. Una volta Calvino mi ha detto che era possibile frequentare Elsa solo all’interno di un culto. Era forse vero, ma a condizione di precisare che l’oggetto del culto non era Elsa, ma quegli dèi - da Rimbaud a Simone Weil, da Mozart a Spinoza - che essa riconosceva e amava condividere con gli amici. In questo Elsa era seria, selvaggiamente seria, e credo che abbia trasmesso al ragazzo che ero, un po’ di quella sua intransigente passione per la poesia e per la verità. E da allora che penso che non si possano tracciare confini chiari fra la letteratura e la filosofia».
So che attraverso la Morante hai conosciuto Pasolini. Tra l’altro partecipasti in un ruolo piccolo ma bello al suo “Vangelo”. Che ricordo hai di quell’esperienza sul set?
«Del Vangelo ricordo la velocità: Pasolini non faceva quasi mai ripetere una scena e ciascuno parlava e si muoveva come gli pareva. Credo che questo dia al suo cinema quella naturalezza che non pretende mai di essere realistica. La sola lunga pausa durante le riprese fu colpa mia: nell’Ultima Cena mi trovai davanti sul tavolo delle enormi pagnotte lievitate e dovetti ricordare a Pier Paolo che per la pasqua ebraica il pane doveva essere azzimo».
Hai anche accennato ai tuoi rapporti con Heidegger e ai seminari che seguisti con lui a Le Thor nel 1966 e poi nel 1968. Cosa ti è restato di quegli incontri?
«L’incontro con Heidegger, come quello con Benjamin, non è mai finito. Nella mia memoria è inseparabile dal paesaggio della Provenza, allora ancora non toccato dal turismo. Il seminario aveva luogo la mattina, nel giardino del piccolo albergo che ci ospitava, ma a volte in una capanna durante una delle numerose escursioni nella campagna circostante. Il primo anno eravamo cinque in tutto, oltre al seminario c’erano i pasti in comune e io ne approfittavo per porre a Heidegger le domande che più mi interessavano, se aveva letto Kafka, se conosceva Benjamin. Ma questi sono solo aneddoti».
Uno degli aspetti principali della tua ricerca è stata la filologia. In che modo l’hai praticata?
«La filologia è stata sempre parte essenziale della mia ricerca. E non solo perché mi è capitato di fare lavori filologici in senso tecnico - penso alla ricostruzione del libro di Benjamin su Baudelaire e all’edizione delle poesie postume di Caproni - ma perché filologia e filosofia, amore per la parola e amore per la verità non possono in alcun modo essere separati. La verità dimora nella lingua e un filosofo che non avesse cura di questa dimora sarebbe un cattivo filosofo. I filosofi, come i poeti, sono innanzitutto i custodi della lingua e questo è un compito genuinamente politico, soprattutto in un’epoca, com’è la nostra, che cerca con ogni mezzo di confondere e falsificare il significato delle parole».
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- Il contratto sociale, «Il contratto sessuale», e i fondamenti nascosti della società moderna.15 maggio 2016, di Federico La Sala
- Pianeta Terra. Sull’uscita dallo stato di minorità, oggi......
 LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO.
LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO.
- CHI SIAMO NOI, IN REALTA’?! RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTA’: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.
-
PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!
 FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.
Storie congetturali che raccontano l’inaudito
SAGGI. «Il contratto sessuale» di Carole Pateman pubblicato per Moretti&Vitali. I fondamenti nascosti della società moderna in un libro che dopo quasi trent’anni fa ancora discutere
di Alessandra Pigliaru (il manifesto, 14.05.2016)
Dare conto di ciò che Carole Pateman ha prodotto in relazione al pensiero politico moderno è decisivo. Al centro di numerose discussioni pubbliche, sia accademiche come docente al dipartimento di Scienze Politiche dell’università della California, sia politiche per le sue caustiche critiche alla democrazia liberale, tra i molti volumi e interventi che ha scritto nel corso della sua lunga vita soltanto uno è stato tradotto in italiano. Unico però, in tanti sensi - di cui il primo è l’aver costituito un punto di non ritorno. Si tratta di The sexual contract, pubblicato nel 1988 (Stanford U.P.) e tradotto per la prima volta in Italia nove anni dopo (Editori riuniti). Ormai nel dimenticatoio dei tanti «fuori commercio», è allora più che lodevole la sua recente ristampa.
Il contratto sessuale (Moretti&Vitali, pp. 339, euro 21, traduzione di Cinzia Biasini, collana «Pensiero e pratiche di trasformazione») è pietra miliare della teoria politica contemporanea, così scrive Olivia Guaraldo nell’ottima introduzione di questa nuova edizione, inquadrando il lavoro che Carole Pateman ha condotto non solo sotto il rilievo del dibattito femminista, ma anche nel senso di inaggirabilità che ha assunto nella scolarship internazionale da parte di chi si occupa di contrattualismo. A osservare la diversità di ricezione in Italia e all’estero, non potrà sfuggire che in altri paesi del mondo le ristampe sono proseguite costanti in questi decenni.
L’inganno iniziale
La discontinua ricezione de Il contratto sessuale ne perimetra tuttavia la circolazione, tracciando il terreno in cui hanno attecchito le tesi di Pateman, ovvero quasi esclusivamente nell’ambito della riflessione del pensiero della differenza sessuale (di cui l’esito più recente in merito è Sovrane, di Annarosa Buttarelli per Il Saggiatore). Avere l’occasione di rileggere un testo simile significa oggi ribadire con forza intanto la tesi iniziale, e cioè che esiste un momento precedente al contratto sociale - così chiaro nello stesso titolo - che non è stato compreso dai teorici sei-settecenteschi (Hobbes, Locke, Rousseau e poi lo stesso Kant) quando si sono prodigati dapprima a stabilire l’esistenza di quel patto secondo loro originario - e poi a descrivere con minuziosa tenacia le forme della vita associata. Tornare a Pateman non è solo consigliabile a chi desidera rispolverarne il tenore teorico-pratico.
Assistere allo svelamento dell’inganno iniziale vuol dire stanare il rimosso, misurarsi con una radicalità che può costruire un ragguardevole equipaggiamento per leggere il presente. La storia «congetturale» a cui si affida Pateman serve certo all’avanzamento rivoluzionario della sua tesi; al contempo e per converso, dispone anche la cifra di ciò che è stato «il racconto più autorevole dell’età moderna».
Molti sono allora gli elementi da rimarcare della conquistata libertà civile. Intanto non è universale, visto che il contratto originario istituisce sia la libertà che il dominio, bensì ha un attributo maschile e dipende dal diritto patriarcale.
E se massiccia è stata la decostruzione operata da Pateman intorno alla radice democratica moderna, individualista e proprietaria, la narrazione ha a che fare con la genesi del diritto politico inteso come «diritto patriarcale o diritto sessuale, ossia in quanto potere che gli uomini esercitano sulle donne»; da qui viene proposta la tesi secondo cui il contratto sessuale si mantenga su un patto tra fratelli, un «fratriarcato». Seguendo la lezione di Adrienne Rich, anche Pateman si posiziona nella certezza che esista una «legge del diritto sessuale maschile». Tale diritto è, sostanzialmente, quello coniugale.
Assunzioni materiali
Eppure, se nella separazione tra contratto sociale e contratto sessuale si viene a delineare una precisa rappresentazione (il primo è tangente alla sfera pubblica e il secondo alla sfera privata), ignorando la metà della storia si cade facilmente in equivoco. Alla fine degli anni ‘80, cioè quando Pateman scrive, ha in mente di fare luce sulle strutture istituzionali di Gran Bretagna, Australia e Stati Uniti per chiarire come, attraverso l’interezza della storia del contratto originario, si verifichino comunanze patriarcali insospettabili.
In questa direzione, l’autrice analizza diversi tipi di contratto, da quello di matrimonio, disossato in verità da numerosi contributi soprattutto da parte di teoriche femministe, a quello di lavoro, come anche quello che viene a definirsi tra prostituta e cliente. Tutte assunzioni che andrebbero discusse, e che infatti lo sono state possibilmente piegandole ai vari contesti, transitori e pur sempre materiali. Se i contratti presi in esame sono connotabili da iter che ne prevedono regolamentazioni o proibizioni da parte della legge, è chiaro come si tratti di particolari forme ascrivibili alla proprietà che si ritiene ciascuno e ciascuna abbiano sulle proprie persone. Ciò nonostante, «il contratto sessuale è il mezzo attraverso il quale gli uomini trasformano il proprio diritto naturale sulle donne nella sicurezza civile patriarcale».
Contingenze complesse
A restituire gradi di attualità che il testo non solo conserva ma intuisce con puntuale efficacia, il riferimento è a una clausola su cui Pateman si sofferma alla fine del settimo capitolo e che è da tenere presente nel contratto sessuale: la maternità surrogata, definita «una nuova forma di accesso e di uso del corpo femminile da parte degli uomini».
Questo per dire come il dibattito intorno alla «surrogazione», fosse il caso di tenerlo a mente quando imperversa spesso non privo di strumentalità e costruzione di blocchi identitari, aveva assunto già alla fine degli anni ‘80 una declinazione cruciale. Il caso sollevato da Pateman accenna alla celebre sentenza disposta dalla corte del New Jersey (1986 ma in due fasi e l’una contraddittoria rispetto l’altra) passata poi alla storia come «il caso Baby M.» in cui la «madre surrogante» cambiò idea e decise di non separarsi più dalla bambina. Se il carattere vincolante dello statuto giuridico di questi contratti poneva infatti delle questioni complesse in uno scenario come quello in cui già diverse erano le agenzie aperte per la surrogazione, venivano già dettagliati numeri rispondenti a profitti precisi, differenziando circa il legame tra accordi commerciali o non commerciali con la relativa soglia di legalità e liceità o meno secondo i paesi.
Ciò che viene messa a tema è però la domanda iniziale, quella secondo cui a essere in gioco sia una semplice prestazione. Da un punto di vista contrattuale infatti è puramente accidentale che la prestazione attenga o meno a questo o a quell’oggetto, così come trascurabile è il fatto che ciò che viene prodotto sia un bambino, una bambina. Su questo punto, come per altri su cui Pateman si sofferma, Il contratto sessuale è un volume ancora incandescente che vale la pena di essere rimeditato.
- Pianeta Terra. Sull’uscita dallo stato di minorità, oggi......
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- Traduzioni e storia della cultura. Tullio Gregory e la "Translatio linguarum" (di Remo Bodei)9 maggio 2016, di Federico La Sala
- L’EUROPA, IL CRISTIANESIMO ("DEUS CHARITAS EST"), E IL CATTOLICESIMO COSTANTINIANO ("DEUS CARITAS EST"). Una storia di lunga durata...
 MURATORI, BENEDETTO XVI, E "UNO SPROPOSITO MAIUSCOLO": LA LEZIONE DI VICO. Un breve testo dalla "Prefazione ai lettori" del "Trattato sulla carità cristiana" di Ludovico A. Muratori
MURATORI, BENEDETTO XVI, E "UNO SPROPOSITO MAIUSCOLO": LA LEZIONE DI VICO. Un breve testo dalla "Prefazione ai lettori" del "Trattato sulla carità cristiana" di Ludovico A. Muratori
Tullio GregoryTradurre per capire
di Remo Bodei (Il Sole-24 Ore, Domenica, 08.05.2016)
- Tullio Gregory, Translatio linguarum. Traduzioni e storia della cultura, Leo O. Olschki Editrice, Firenze, pagg. 76, € 14
«Tutto è destinato a perire, castelli e città, re e papi, solo i libri hanno il privilegium perennitatis: Saturno divora i propri figli, le civiltà sarebbero perdute, se Dio non avesse dato agli uomini i librorum remedia». Così sosteneva Riccardo di Bury, cancelliere di Edoardo III d’Inghilterra negli anni Trenta e Quaranta del Trecento. E John Florio, autore del primo dizionario Italiano-Inglese e traduttore dei Saggi di Montaigne, ricorda di aver sentito dire da Giordano Bruno che ogni scienza ha origine dalle traduzioni.
Di questi episodi e di sobrie riflessioni è costellato il breve e affascinante libro di Tullio Gregory, che, con la consueta competenza (esercitata anche nei decenni in cui è stato direttore del Lessico intellettuale europeo) mostra come la translatio linguarum, il vertere, il transferre e l’interpretari siano alla base di ogni civiltà e, specificamente della nostra, quella mediterranea, «fatta di innesti continui, di matrimoni esogamici, di un assiduo intrecciarsi e scambio di esperienze, modelli e valori fra civiltà diverse, ove ogni cultura nasce sull’eredità di altre culture, fatte proprie, trascritte, tradotte, interpretate in nuovi contesti e linguaggi».
Da questo punto di vista, fenomeni epocali, quali il sorgere o il diffondersi dell’ebraismo o del cristianesimo sarebbero impensabili senza la traduzione in greco della Bibbia da parte dei Settanta nell’Alessandria del III secolo a.C. e le stesse parole di Gesù, pronunciate in aramaico, non si sarebbero diffuse nel mondo se non fossero state rese in greco e in latino: «È la traduzione che prolunga nel tempo e nello spazio la vitalità di un testo, assicura e rinnova una tradizione». Ed è la traduzione che sostanzia la translatio studiorum, per cui ogni versione di un’opera dall’originale a un’altra lingua contribuisce al «passaggio di civiltà e cultura da uno ad altro contesto politico, geografico e linguistico, per salvare eredità che si sarebbero altrimenti perdute».
Conosciamo tutti, per sommi capi, la trafila degli eventi che dalle rive del Nilo e dalle coste della Fenicia porta alla migrazione della scrittura, delle scienze, della sapienza e delle tecniche dapprima in Grecia e a Roma. Allo stesso modo ci è noto come il salvataggio della cultura antica passi attraverso gli scriptoria medioevali, dove gli amanuensi ricopiavano i libri. Sono state anche ricostruite le complesse vicende che hanno portato le opere filosofiche, matematiche, mediche e fisiche dal mondo greco a quello arabo.
Fu l’imperatore Giustiniano, istigato dai cristiani e dalla moglie Teodora, a decretare nel 529 la chiusura delle scuole di Atene, costringendo un consistente gruppo di filosofi a trasferirsi nell’Impero persiano presso il re Cosroè III. Quando, poi, la Persia venne conquistata dagli arabi, i discepoli dei filosofi che erano fuggiti assieme ai loro volumi iniziarono - dall’815 stabilmente nella «Casa della sapienza» di Baghdad - a tradurre in arabo dal greco e dal siriaco queste opere, che fecondarono il pensiero di Al-Kindî, Al Farabî, Averroè e Avicenna per poi, attraverso un’altra grande operazione di traduzione collettiva a Toledo e altrove, dare luogo alle ritraduzioni latine (si pensi che di Platone si conosceva in precedenza solo un brano del Timeo e di Aristotele, sostanzialmente, solo le Categorie e il De interpretatione).
La filosofia moderna si fonda linguisticamente sulla continua translatio dei termini forgiati in questo periodo e sulla ripresa e innovazione dei loro significati. Di tutte queste metamorfosi il volume di Gregory offre il necessario inquadramento.Spesso dimentichiamo che il destino dei libri che giungono fino a noi - oltre che di chi li pubblicava, li distribuiva e li leggeva - è soggetto a una selezione dovuta al caso, all’intenzione o ai ritrovamenti insperati (quale il codice del De rerum natura di Lucrezio che Poggio Bracciolini rinvenne nel 1417 in un monastero tedesco).
È, tuttavia, la volontà censoria a incidere maggiormente sulla loro conservazione e trasmissione, decretandone la sorte di «sommersi e salvati». Il fanatismo, l’Index librorum prohibitorum (formalmente abolito dalla Chiesa cattolica solo nel 1966), e i roghi, anche di intere biblioteche, hanno segnato la storia umana e non solo quella dell’Occidente: si comincia, a quanto ci consta, da quelli avvenuti nella Cina di Qin Shi Huan, il 212 a.C., fino alla Bücherverbrennung nazista del maggio del 1933 a Berlino. Per fortuna, i libri sfuggono talvolta a questa sorte, come accadde con «l’avventuroso trasferimento della biblioteca dell’Istituto Warburg da Amburgo a Londra con due battelli che approdarono nel dicembre 1933 sulle rive del Tamigi».
Se dunque la translatio linguarum ha nell’ambito delle civiltà della specie il ruolo dominante qui descritto, allora la risposta di Gregory al mito della Torre di Babele non può essere che un’orgogliosa rivendicazione della nostra condotta: «Se la condanna alla pluralità delle lingue è una conseguenza del tentativo degli uomini, dopo il diluvio, di costruire una loro città con una torre che raggiungesse il cielo, la traduzione - ove manchi il miracolo della Pentecoste - è la risposta umana alla condanna di Yahvè».
- L’EUROPA, IL CRISTIANESIMO ("DEUS CHARITAS EST"), E IL CATTOLICESIMO COSTANTINIANO ("DEUS CARITAS EST"). Una storia di lunga durata...
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ... DENTRO LA PIU’ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA E POLITICA ITALIANA --- “Lui è tornato”. Non solo “Mein Kampf”: così tra letteratura e cinema rivive in Germania la figura di Hitler (di Angelo Bolaffi).7 maggio 2016, di Federico La Sala
Libri e film
il ritorno del grande dittatore
Non solo “Mein Kampf”: così tra letteratura e cinema rivive in Germania la figura di Hitler
Un’ossessione che si manifesta in chiave critica e a volte comica
Ma che fa i conti con un passato mai risolto
di Angelo Bolaffi (la Repubblica, 06.05.2016)
“Lui è tornato”: e lui è Adolf Hitler. Non è solo il titolo provocatorio e grottesco di un bestseller letterario diventato commedia cinematografica, ma un fatto: la rinnovata attenzione per la figura del dittatore nazista. All’inizio di quest’anno, come si ricorderà, a cura dell’Istituto tedesco per la storia contemporanea è apparsa tra mille polemiche e non pochi dubbi l’edizione scientifica del Mein Kampf andata esaurita in pochissimi giorni.
 E nelle scorse settimane sempre in Germania è stata pubblicata una monumentale ricerca sulla vita di Hitler: Das Itinerar, questo il titolo dell’opera in quattro volumi di ben 2.432 pagine scritta da Harald Sandner, ricostruisce passo dopo passo tutti gli episodi documentabili della sua biografia (compresi anche quelli più curiosi e sconosciuti, come la richiesta presentata all’ambasciata italiana di un autografo di Mussolini) dalla nascita nel 1889 a Braunau, allora Austria- Ungheria, fino al 30 aprile del 1945, giorno in cui si suicidò nel suo bunker di Berlino.
E nelle scorse settimane sempre in Germania è stata pubblicata una monumentale ricerca sulla vita di Hitler: Das Itinerar, questo il titolo dell’opera in quattro volumi di ben 2.432 pagine scritta da Harald Sandner, ricostruisce passo dopo passo tutti gli episodi documentabili della sua biografia (compresi anche quelli più curiosi e sconosciuti, come la richiesta presentata all’ambasciata italiana di un autografo di Mussolini) dalla nascita nel 1889 a Braunau, allora Austria- Ungheria, fino al 30 aprile del 1945, giorno in cui si suicidò nel suo bunker di Berlino.Inevitabilmente questo ritorno di interesse per la persona di Hitler ha sollevato molti interrogativi legati al timore che possa nascondere una più o meno consapevole “banalizzazione del male”. Una specie di inflazione della sua figura che, soprattutto sulle nuove generazioni, potrebbe avere come conseguenza una “normalizzazione” e relativizzazione della condanna del nazismo.
Certo, in una Germania com’è quella di oggi, profondamente lacerata e messa in ansia dal fenomeno migratorio e di fronte, sia pure in settori (ancora) minoritari, all’emergere di pulsioni identitarie e idiosincrasie xenofobe, la cautela è d’obbligo. E tuttavia questa rinnovata presenza mediatica di Hitler non è affatto espressione di revisionismo storico. Né, come nel film Lui è tornato di David Wnendt, l’idea tra il comico e l’assurdo per altro filmicamente molto efficace di far ricomparire Hitler nella odierna Berlino capitale della Germania riunificata, rappresenta un’allarmante rottura di un tabù.
Intanto perché c’è un precedente illustre: il film realizzato nel 1940 da Charlie Chaplin intitolato Il grande dittatore nel quale il monologo di Hitler nella scena del mappamondo è non solo un’icona cinematografica ma anche la denuncia politicamente lungimirante (in quell’anno era ancora in vigore il Patto tra Unione Sovietica di Stalin e Hitler) del pericolo planetario rappresentato dalla dittatura nazista.
 E poi: non è forse vero che un approccio ironico e il ricorso al linguaggio della satira possono favorire grazie alla funzione maieutica del sorriso la resa dei conti di un individuo o di un popolo col proprio passato? Infatti, a differenza di quanto accaduto in altri paesi (ad esempio in Austria e Giappone ma anche nella Russia di Putin che rivendica l’eredità del comunismo di Stalin) la Germania ha cercato (e continuamente cerca) di fare i conti col proprio passato.
E poi: non è forse vero che un approccio ironico e il ricorso al linguaggio della satira possono favorire grazie alla funzione maieutica del sorriso la resa dei conti di un individuo o di un popolo col proprio passato? Infatti, a differenza di quanto accaduto in altri paesi (ad esempio in Austria e Giappone ma anche nella Russia di Putin che rivendica l’eredità del comunismo di Stalin) la Germania ha cercato (e continuamente cerca) di fare i conti col proprio passato.Negli anni dell’immediato dopoguerra, fino alla metà degli anni Sessanta, dominante nell’opinione pubblica tedesca era stato il “principio di rimozione” fondato su una vera e propria connivenza, spazzata via dalla rivolta studentesca del ’67-’68. Una congiura omertosa raccontata dal recente film di Lars Kraume intitolato Lo Stato contro Fritz Bauer (lo stesso tema, anche se da una diversa angolatura, era stato affrontato in precedenza da Giulio Ricciarelli nel suo Il labirinto del silenzio): dirigente del movimento socialista ed ebreo, Fritz Bauer era stato costretto a emigrare. Alla fine della guerra, come Theodor Adorno, Max Horkheimer, Ernst Fraenkel o Richard Löwenthal, fu uno di quei “generosi remigranti”, come li ha definiti Jürgen Habermas, che decisero di tornare in Germania. Diventato procuratore del tribunale a Francoforte, nonostante l’isolamento e il sospetto che lo circondavano e lo portarono poi al suicidio, gettò le basi per la ricostruzione di un sistema giuridico democratico e aiutò il Mossad a individuare e arrestare Adolf Eichmann.
Per sempre all’ombra di Hitler?
Il titolo di una importante raccolta di saggi pubblicata qualche anno fa dallo studioso Heinrich August Winkler solleva un interrogativo che forse ci aiuta a capire l’odierna, ossessiva presenza della figura di Hitler. La Germania e la coscienza europea sono condannate infatti, per un tempo ancora imprevedibile, a confrontarsi con quella “frattura della civiltà” (così lo storico ebreo tedesco Dan Diner) che è stato il nazismo, i cui delitti ancora attendono - nonostante le decine di migliaia di pagine scritte sul tema - di essere ricostruiti in tutta la loro terrificante dimensione.
 Ne è conferma KL: A History of the Nazi Concentration Camps, la monumentale indagine sul sistema nazista dei campi, oltre duemila pagine frutto di una ricerca durata dieci anni, dello storico tedesco (residente in Inghilterra) Nikolaus Wachsmann, apparsa l’anno scorso in inglese e proprio in questi giorni in Germania. Una discesa agli inferi in cui la documentazione raccolta è costituita per gran parte dalle testimonianze fino ad oggi sconosciute delle vittime. Prende le mosse dal campo di Dachau, nei pressi di Monaco di Baviera, messo in funzione in modo ancora provvisorio e artigianale dopo la vittoria elettorale di Hitler nelle elezioni del 5 marzo 1933, per rinchiudervi gli oppositori politici, e si conclude sempre a Dachau con l’arrivo degli americani alla fine di aprile del 1945.
Ne è conferma KL: A History of the Nazi Concentration Camps, la monumentale indagine sul sistema nazista dei campi, oltre duemila pagine frutto di una ricerca durata dieci anni, dello storico tedesco (residente in Inghilterra) Nikolaus Wachsmann, apparsa l’anno scorso in inglese e proprio in questi giorni in Germania. Una discesa agli inferi in cui la documentazione raccolta è costituita per gran parte dalle testimonianze fino ad oggi sconosciute delle vittime. Prende le mosse dal campo di Dachau, nei pressi di Monaco di Baviera, messo in funzione in modo ancora provvisorio e artigianale dopo la vittoria elettorale di Hitler nelle elezioni del 5 marzo 1933, per rinchiudervi gli oppositori politici, e si conclude sempre a Dachau con l’arrivo degli americani alla fine di aprile del 1945.Nel mezzo, il capitolo più buio della storia tedesca. Un capitolo che più viene studiato ed esaminato più ci appare incomprensibile: «Nonostante ci siano migliaia di letture possibili», il nazismo - ha affermato l’ex Cancelliere Helmut Schmidt - «è inspiegabile. Ed è proprio questo che mi opprime nel profondo dell’animo». Dunque Adolf Hitler nonostante il passare dei decenni resta un vero e proprio mistero, come genialmente intuito da Salvador Dalí che nel 1939 intitolò El enigma de Hitler un suo piccolo quadro oggi esposto al museo madrileno Reina Sofia.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---ITALO CALVINO, LA COSTITUZIONE, E LA DEMOCRAZIA SENZA MORALE (di Stefano Rodotà)16 aprile 2016, di Federico La Sala
- L’URLO DI ITALO CALVINO (1980): LA COSCIENZA A POSTO. Apologo sull’onestà nel paese dei corrotti
- POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. Materiali sul tema
La democrazia senza morale
di Stefano Rodotà (la Repubblica, 8 aprile 2016) *
Nel marzo di trentasei anni fa Italo Calvino pubblicava su questo giornale un articolo intitolato “Apologo sull’onestà nel paese dei corrotti”. Vale la pena di rileggerlo (o leggerlo) non solo per coglierne amaramente i tratti di attualità, ma per chiedersi quale significato possa essere attribuito oggi a parole come “onestà” e “corruzione”.
Per cercar di rispondere a questa domanda, bisogna partire dall’articolo 54 della Costituzione, passare poi ad un detto di un giudice della Corte Suprema americana e ad un fulminante pensiero di Ennio Flaiano, per concludere registrando il fatale ritorno dell’accusa di moralismo a chi si ostina a ricordare che senza una forte moralità civile la stessa democrazia si perde.
Quell’articolo della Costituzione dovrebbe ormai essere letto ogni mattina negli uffici pubblici e all’inizio delle lezioni nelle scuole (e, perché no?, delle sedute parlamentari).
Comincia stabilendo che «tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi» . Ma non si ferma a questa affermazione, che potrebbe apparire ovvia. Continua con una prescrizione assai impegnativa: « i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore». Parola, quest’ultima, che rende immediatamente improponibile la linea difensiva adottata ormai da anni da un ceto politico che, per sfuggire alle proprie responsabilità, si rifugia nelle formule «non vi è nulla di penalmente rilevante», «non è stata violata alcuna norma amministrativa». Si cancella così la parte più significativa dell’articolo 54, che ha voluto imporre a chi svolge funzioni pubbliche non solo il rispetto della legalità, ma il più gravoso dovere di comportarsi con disciplina e onore.
Vi è dunque una categoria di cittadini che deve garantire alla società un “ valore aggiunto”, che si manifesta in comportamenti unicamente ispirati all’interesse generale. Non si chiede loro genericamente di essere virtuosi. Tocqueville aveva colto questo punto, mettendo in evidenza che l’onore rileva verso l’esterno, « n’agit qu’en vue du public », mentre «la virtù vive per se stessa e si accontenta della propria testimonianza».
Ma da anni si è allargata un’area dove i “servitori dello Stato” si trasformano in servitori di sé stessi, né onorati, né virtuosi. Si è pensato che questo modo d’essere della politica e dell’amministrazione fosse a costo zero. Si è irriso anzi a chi richiamava quell’articolo e, con qualche arroganza, si è sottolineato come quella fosse una norma senza sanzione. Una logica che ha portato a cancellare la responsabilità politica e a ridurre, fin quasi a farla scomparire, la responsabilità amministrativa. Al posto di disciplina e onore si è insediata l’impunità, e si ripresenta la concezione «di una classe politica che si sente intoccabile», come ha opportunamente detto Piero Ignazi. Sì che i rarissimi casi di dimissioni per violato onore vengono quasi presentati come atti eroici, o l’effetto di una sopraffazione, mentre sono semplicemente la doverosa certificazione di un comportamento illegittimo.
Questa concezione non è rimasta all’interno della categoria dei cittadini con funzioni pubbliche, ma ha infettato tutta la società, con un diffusissimo “così fan tutti” che dà alla corruzione italiana un tratto che la distingue da quelli dei paesi con cui si fanno i più diretti confronti.
Basta ricordare i parlamentari inglesi che si dimettono per minimi abusi nell’uso di fondi pubblici: i ministri tedeschi che lasciano l’incarico per aver copiato qualche pagina nella loro tesi di laurea: il Conseil constitutionnel francese che annulla l’elezione di Jack Lang per un piccolo sforamento nelle spese elettorali; il vice-presidente degli Stati Uniti Spiro Agnew si dimette per una evasione fiscale su contributi elettorali (mentre un ministro italiano ricorre al condono presentandolo come un lavacro di una conclamata evasione fiscale).
Sono casi noti, e altri potrebbero essere citati, che ci dicono che non siamo soltanto di fronte ad una ben più profonda etica civile, ma anche alla reazione di un establishment consapevole della necessità di eliminare tutte le situazioni che possono fargli perdere la legittimazione popolare.
In Italia si è imboccata la strada opposta con la protervia di una classe politica che si costruiva una rete di protezione che, nelle sue illusioni, avrebbe dovuto tenerla al riparo da ogni sanzione. Illusione, appunto, perché è poi venuta la più pesante delle sanzioni, quella sociale, che si è massicciamente manifestata nella totale perdita di credibilità davanti ai cittadini, di cui oggi cogliamo gli effetti devastanti. Non si può impunemente cancellare quella che in Inghilterra è stata definita come la “constitutional morality”.
In questo clima, ben peggiore di quello degli anni Ottanta, quale spazio rimane per quella “controsocietà degli onesti” alla quale speranzosamemte si affidava Italo Calvino? Qui vengono a proposito le parole di Louis Brandeis, giudice della Corte Suprema americana, che nel 1913 scriveva, con espressione divenuta proverbiale, che «la luce del sole è il miglior disinfettante». Una affermazione tanto più significativa perché Brandeis è considerato uno dei padri del concetto di privacy, che tuttavia vedeva anche come strumento grazie al quale le minoranze possono far circolare informazioni senza censure o indebite limitazioni (vale la pena di ricordare che fu il primo giudice ebreo della Corte).
L’accesso alla conoscenza, e la trasparenza che ne risulta, non sono soltanto alla base dell’einaudiano “conoscere per deliberare”, ma anche dell’ancor più attuale “ conoscere per controllare”, ovunque ritenuto essenziale come fonte di nuovi equilibri dei poteri, visto che la “democrazia di appropriazione” spinge verso una concentrazione dei poteri al vertice dello Stato in forme sottratte ai controlli tradizionali. Tema attualissimo in Italia, dove si sta cercando di approvare una legge proprio sull’accesso alle informazioni, per la quale tuttavia v’è da augurarsi che la ministra per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione voglia rimuovere i troppi limiti ancora previsti.
Non basta dire che limiti esistono anche in altri paesi, perché lì il contesto è completamente diverso da quello italiano, che ha bisogno di ben più massicce dosi di trasparenza proprio nella logica del riequilibrio dei poteri. E bisogna ricordare la cattiva esperienza della legge 241 del 1990 sull’accesso ai documenti amministrativi, dove tutte le amministrazioni, Banca d’Italia in testa, elevarono alte mura per ridurre i poteri dei cittadini. Un rischio che la nuova legge rischia di accrescere.
Ma davvero può bastare la trasparenza in un paese in cui ogni giorno le pagine dei giornali squadernano casi di corruzione a tutti livelli e in tutti i luoghi, con connessioni sempre più inquietanti con la stessa criminalità? Soccorre qui l’amara satira di Ennio Flaiano. «Scaltritosi nel furto legale e burocratico, a tutto riuscirete fuorché ad offenderlo. Lo chiamate ladro, finge di non sentirvi. Gridate che è un ladro, vi prega di mostrargli le prove. E quando gliele mostrate: “Ah, dice, ma non sono in triplice copia!”». Non basta più l’evidenza di una corruzione onnipresente, che anzi rischia di alimentare la sfiducia e tradursi in un continuo e strisciante incentivo per chi a disciplina e onore neppure è capace di pensare.
I tempi incalzano, e tuttavia non vi sono segni di una convinta e comune reazione contro la corruzione all’italiana che ormai è un impasto di illegalità, impunità ostentata o costruita, conflitti d’interesse, evasione fiscale, collusioni d’ogni genere, cancellazione delle frontiere che dovrebbero impedire l’uso privato di ricorse pubbliche, insediarsi degli interessi privati negli stessi luoghi istituzionali (che non si sradica solo con volenterose norme sulle lobbies). Fatale, allora, scocca l’attacco alla magistratura e l’esecrazione dei moralisti, quasi che insistere sull’etica pubblica fosse un attacco alla politica e non la via per la sua rigenerazione. E, con una singolare contraddizione, si finisce poi con l’attingere i nuovi “salvatori della patria” proprio dalla magistratura, così ritenuta l’unico serbatoio di indipendenza. Il caso del giudice Cantone è eloquente, anche perché mette in evidenza due tra i più recenti vizi italiani. La personalizzazione del potere ed una politica che vuole sottrarsi alle proprie responsabilità trasferendo all’esterno questioni impegnative. Alzare la voce, allora, non può mai essere il surrogato di una politica della legalità che esige un mutamento radicale non nelle dichiarazioni, ma nei comportamenti.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- HUSSERL CONTRO L’HOMUNCULUS: LA ’LEZIONE’ DI ENZO PACI AI METAFISICI VISIONARI.8 aprile 2016, di Federico La Sala
HUSSERL CONTRO L’HOMUNCULUS: LA ’LEZIONE’ DI ENZO PACI AI METAFISICI VISIONARI (ATEI E DEVOTI) DI IERI (E DI OGGI). Una ’traccia’ dal "Diario fenomenologico"):
- ENZO PACI. “Negli anni passati in Germania, in un campo di concentramento, la grande ombra di Vico venne a trovarmi e mi sembrò di sentire che tutta la sua opera era stata una lotta eroica contro la ingens sylva della barbarie (...)” (cfr.: Lettere di carteggio di Enzo Paci con B. Croce e F. Nicolini, a c. di A. Vigorelli, “Rivista di storia di filosofia”, I, 1986, p. 103).
 L’homunculus di Goethe è il simbolo di quella che Husserl denuncia come “crisi delle scienze”.
L’homunculus di Goethe è il simbolo di quella che Husserl denuncia come “crisi delle scienze”. Dal “Diario fenomenologico” di Enzo Paci, una traccia per la lettura della "Crisi delle scienze europee" di Edmund Husserl
Dal “Diario fenomenologico” di Enzo Paci, una traccia per la lettura della "Crisi delle scienze europee" di Edmund Husserl- 4 febbraio 1960*
Nel patto biblico tra Dio e l’uomo c’è una clausola fondamentale: “Sia chiaro” dice Dio “che creatore sono soltanto io che ti ho creato e non tu. Io sono, su questo punto, un Dio geloso”. Come può essere nato un pensiero di questo genere?
Per una analisi fenomenologica vedo due vie. La prima è la proiezione, in Dio, del padre. Il figlio, per essere uomo, deve ribellarsi al padre. È la via del complesso edipico, la via di Freud. Ovviamente la proiezione si pone come divieto e come gelosia proprio perché il divieto deve essere superato. L’uomo diventa “virile” per la violazione della proibizione. Se il padre è Dio, raggiunge il massimo della umana virilità e cioè diventa Dio. Questa posizione è immatura. Infatti il padre è sempre divinizzato. La sostituzione al padre è eroica: il figlio diventa o Dio o il Diavolo. La maturità dell’uomo in quanto uomo viene raggiunta proprio quando cade la divinizzazione del padre. Se il padre diventa un uomo, anche il figlio diventa un uomo. Di solito ciò avviene quando il figlio, di fatto, diventa padre. di un nuovo figlio, e così via. Di fronte a suo figlio, il figlio divenuto padre si pacifica col proprio padre: ora lo può. Spetta a lui l’essere divinizzato.
La seconda via. Nell’atto sessuale procreante non mi accoppio per avere un figlio. Nella esperienza jn prima persona di me stesso e dell’altro nell’atto sessuale non sento di procreare, non ho l’esperienza in prima persona del “far nascere”. L’evidenza sessuale è l’evidenza dell’altro in me e di me nell’altro. Non può essere l’evidenza del figlio che non c’è ancora.. Se le conseguenze saranno procreative, nota Husserl, lo saprò dopo. Dai fatti. Ma posso pormi la domanda: “come avviene?” Fenomenologicamente questo “come” deve essere sperimentato dal soggetto. Ma il soggetto è il soggetto che inizia la sua nascita in seguito alla fecondazione. Non sono io ma è mio figlio, o sono io, ma nell’atto del mio nascere. C’è qui un distacco. Il distacco che si inizia subito, appena compiuto l’atto sessuale. Anche la donna si estrania da me. Ciò che ha di mio in sé è ancora mio, ma non sono più io.
Nell’amore, all’inizio, ho proiettato me stesso in lei: è diventata la “mia vita”. Proprio per questo devo possederla: per “riavere la mia vita”. Ma la “mia vita”, invece di essermi restituita, diventa concretamente un’altra vita. Così si diventa padre, diventando un altro soggetto. Ma così si è figli: si inizia geneticamente la propria storia, la storia della propria soggettività. Procreare e nascere sono due operazioni mie, di me soggetto, che mi sfuggono.
La prima mi sfugge nel distacco che segue all’atto sessuale dal quale ha inizio, appunto, la procreazione. La seconda operazione, il nascere, mi sfugge perché che sia mia mi viene detto da altri. Non è in prima persona. Non posso ricordare la mia vita intrauterina e la mia nascita. Le due operazioni, che mi sfuggono, sono proiettate in Dio che diventa il solo creatore.
C’è un’implicazione: lo studio scientifico della procreazione e della nascita è, alla fine, la genetica. Come scienza fenomenologica rientra, in qualche modo, nell’antropologia, oltre che nella psicologia e nella somatologia, in quanto il suo problema si pone come studio delle modalità e del significato della genesi, sperimentata soggettivamente, e per ciò fenomenologicamente. Una delle conseguenze dell’implicazione scientifica è la seguente: lo studio scientifico della genesi, lo studio scientifico obiettivo, può porsi come un sostituto dell’atto sessuale.
Uno scienziato si può accorgere, magari tardi, che la conoscenza scientifica si è per lui sostituita alla “conoscenza” in senso biblico e cioè all’atto sessuale. Ciò può accadere al filosofo in quanto ricercatore della genesi del mondo. O allo storico: la genesi è la storia.
La feticizzazione è fascinosa perché sostituisce l’atto sessuale creativo. Le tecniche possono esercitare, da questo punto di vista, un’attrazione magica. Una tecnica può sostituire l’atto sessuale e, in cibernetica, la procreazione mancata.
Il tecnico vorrà costruire il figlio come un homunculus nell’inconsapevole desiderio di sostituire agli uomini le macchine. L’homunculus di Goethe è il simbolo di quella che Husserl denuncia come “crisi delle scienze”.
* Enzo Paci, Diario fenomenologico, Il Saggiatore, Milano 1961, pp. 95-97.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- Le "Politiche della filosofia. Istituzioni, soggetti, discorsi, pratiche" e il rapporto il tra "dentro e il "fuori" (di Michele Spanò).5 aprile 2016, di Federico La Sala
SCHEDA EDITORIALE:
Politiche della filosofia
Istituzioni, soggetti, discorsi, pratiche
a cura di Pierpaolo Cesaroni e Sandro Chignola
Derive Approdi, Pagine 224, 2016, € 17.00
- La filosofia «politica» è da sempre sospesa in un limbo fra il campo della filosofia e quello della scienza politica: qual è il suo statuto? quale il suo canone? come si differenzia da una storia delle politiche o da una teoria politica? esiste una specificità italiana nel praticarla?
 Per dare risposta a tali questioni, è necessario operare un radicale spostamento di prospettiva: passare dalla «filosofia politica» a una «politica della filosofia». Perché la filosofia, checché se ne dica, è anzitutto una pratica: una pratica del sapere che produce significati, discorsi, forme di verità e falsità, istituzioni e da qui effetti sull’ambito sociale e della vita politica.
Per dare risposta a tali questioni, è necessario operare un radicale spostamento di prospettiva: passare dalla «filosofia politica» a una «politica della filosofia». Perché la filosofia, checché se ne dica, è anzitutto una pratica: una pratica del sapere che produce significati, discorsi, forme di verità e falsità, istituzioni e da qui effetti sull’ambito sociale e della vita politica.
 Per questo occorre anzitutto interrogare l’istituzione all’interno della quale avviene l’insegnamento di questa disciplina e che è la sede di validazione dei saperi filosofici: l’Università.
Per questo occorre anzitutto interrogare l’istituzione all’interno della quale avviene l’insegnamento di questa disciplina e che è la sede di validazione dei saperi filosofici: l’Università.
 Si scopre allora che l’Università non è affatto un luogo neutro di trasmissione del sapere filosofico, né è sempre stata la sede nella quale veniva praticata la filosofia. Si tratta tutto sommato di un’invenzione recente, la quale ha effetti di potere sui filosofi stessi e sulla pratica del pensiero. Effetti non positivi quando l’Università diventa un’istituzione del neoliberismo. Per questo alla filosofia oggi spetta il compito di fare politica.
Si scopre allora che l’Università non è affatto un luogo neutro di trasmissione del sapere filosofico, né è sempre stata la sede nella quale veniva praticata la filosofia. Si tratta tutto sommato di un’invenzione recente, la quale ha effetti di potere sui filosofi stessi e sulla pratica del pensiero. Effetti non positivi quando l’Università diventa un’istituzione del neoliberismo. Per questo alla filosofia oggi spetta il compito di fare politica.
Indice
 Politiche della filosofia di P. Cesaroni
Politiche della filosofia di P. Cesaroni
 «Corpus vivens»: gerarchie del sapere nelle università tra XII e XIV secolo di L. Rustighi
«Corpus vivens»: gerarchie del sapere nelle università tra XII e XIV secolo di L. Rustighi
 Processi di soggettivazione nelle corti rinascimentali. Uno sguardo archeologico di G. De Michele
Processi di soggettivazione nelle corti rinascimentali. Uno sguardo archeologico di G. De Michele
 La filosofia in esercizio. Montesquieu e il discorso dell’Accademia di P. Slongo
La filosofia in esercizio. Montesquieu e il discorso dell’Accademia di P. Slongo
 Il Conflitto delle Facoltà di Kant. L’autonomia della teoria filosofica e la prudenza della prassi politica di G. Valpione
Il Conflitto delle Facoltà di Kant. L’autonomia della teoria filosofica e la prudenza della prassi politica di G. Valpione
 Il Collège de Sociologie: l’impossibile comunità della scienza di S. Pellarin
Il Collège de Sociologie: l’impossibile comunità della scienza di S. Pellarin
 L’ordine del discorso filosofico. Bourdieu, Derrida, Foucault di P. Cesaroni
L’ordine del discorso filosofico. Bourdieu, Derrida, Foucault di P. Cesaroni
 Il soggetto istituente. Linguaggio, storia e pratica di pensiero di M. Farnesi Camellone
Il soggetto istituente. Linguaggio, storia e pratica di pensiero di M. Farnesi Camellone
 L’ufficio del filosofo. Filosofia dell’università e idolatria dello Stato nella Terza Inattuale di P. Slongo
L’ufficio del filosofo. Filosofia dell’università e idolatria dello Stato nella Terza Inattuale di P. Slongo
 Il governo o le bestie. Appunti sul metodo genealogico di R. Ercego
Il governo o le bestie. Appunti sul metodo genealogico di R. Ercego
 Archeologia, genealogia, attitudine. La politica della verità di Michel Foucault di C. Cavallari
Archeologia, genealogia, attitudine. La politica della verità di Michel Foucault di C. Cavallari
Filosofia
Una disciplina che cancella la distanza tra cielo e terra
Saggi. «Politiche della filosofia», un volume collettivo per DeriveApprodi
di Michele Spanò (il manifesto, 05.04.2016)
Ammesso e non concesso che esistesse, sul modello del non meno fasullo instituere vitam, un sintagma che recitasse instituere philosophiam, la patacca maccheronica custodirebbe un potenziale polemico almeno altrettanto incendiario di quello conservato nel suo fittizio parente putativo. Se da sempre si immagina (o, più correttamente, ci si addestra a immaginare) l’ambiente della filosofia tale quale un cielo rarefatto di concetti e astrazioni, un dominio purissimo e sideralmente lontano da rapporti di forza e potere e desiderio, dalla materialità dei corpi (singolari e collettivi, di carne e di parole), allora questo volume è da intendersi come una meditata, sobria, ma insieme esatta e testarda, smentita di questa immagine e di questo immaginario.
Politiche della filosofia. Istituzioni, soggetti, discorsi, pratiche, a cura di Pierpaolo Cesaroni e Sandro Chignola (DeriveApprodi, pp. 224, euro 17) è il tentativo - topologicamente assai audace - di indicare il luogo proprio della filosofia tra il cielo (il fuori) e il dipartimento (il dentro).
Il libro esibisce il tema che lo anima - il rapporto tra filosofia e «istituzionalità» (etichetta barbara capace di condensare i concetti di «istituzione» e «istituzionalizzazione») - nel corpo che ha deciso di fabbricarsi: una collezione di saggi - dotati ciascuno di autonoma consistenza - frutto di due cicli seminariali.
Quest’origine spuria è rivendicata e insieme amplificata, oppure sabotata, dalla forma del libro: dotato di un coefficiente di riflessività elevato. Si tratta insomma, anche, di un libro sulla capacità di ereditare e di trasmettere.
L’eredità è quella del gruppo di ricerca sui concetti politici fondato a Padova da Giuseppe Duso: collettivo di studiosi singolarmente colti, agrimensori cocciuti della testualità della filosofia politica moderna, e in «divergente accordo» con la propria stessa Università; la trasmissione è ciò che spiega che quella che Cesaroni e Chignola convocano e ospitano è una generazione - non anagraficamente - precaria, per nulla «piagnona», che coltiva relazioni molteplici nello spazio (non solo della ricerca) e una buona dose di eclettismo disciplinare, testimoniando - quando si rivela generazione politica - le premesse dell’intera ricerca.
Politiche della filosofia, sarà a questo punto chiaro, ruota attorno a due fuochi (secondo l’immagine, assai cara a uno dei due curatori, dell’elisse): la filosofia politica da un lato, e l’Università dall’altro.
I due temi sono insieme dislocati e sabotati: se la filosofia politica è smascherata e costretta a confessare l’implicazione o la macchinazione che unisce e insieme estenua i due termini che ne istituiscono il sintagma urbanizzando uno e rarefacendo l’altro; così l’Università riconosce - storicamente e ancora una volta istituzionalmente - la sua dipendenza dalla filosofia e gli effetti di addomesticamento che le ha fatto subire.
A queste archeologie istituzionali i saggi che compongono il volume oppongono una soluzione: quella politica della filosofia che, moltiplicata nel numero, fornisce il titolo alla loro impresa.
Essi cioè praticano, ciascuno a modo suo e in forme più o meno tematiche, un foucaultismo ben temperato: un’interrogazione materialmente ancorata sulla costruzione e la manutenzione dell’archivio della filosofia politica.
Un’archeologia, dunque, che ricostruisce, per colpi di sonda, cosa essa sia, chi ne sia il soggetto (nei due sensi della spada) e quali siano i suoi effetti nel determinare estensione e regole del campo di sapere in cui essa interviene. La filosofia è infatti una pratica discorsiva come un’altra: essa è cioè una politica. Pratica mondana e contingente che troppo spesso finisce con il naturalizzare i suoi apparecchi operativi e con il mitizzare la propria vicissitudine storica.
Il processo di istituzionalizzazione della filosofia - inevitabile e insieme sempre problematizzabile - è ciò che i saggi si incaricano di restituire, rivelando perciò, storicamente e speculativamente, il piano di consistenza, materiale e discorsivo, che ha permesso a una politica della filosofia di installarsi, con maggiore o minore fortuna, nell’arredo dei saperi di un’epoca.
Si potrebbe perciò immaginare il programma di ricerca che il volume ha il merito di inaugurare insieme come un’indagine comparata sulle politiche della filosofia e la pratica di una politica delle politiche della filosofia.
La filosofia infatti non è chiamata a uscire dall’Università, come se questa fosse la sua prigione, ma a farsi contestazione perpetua delle proprie condizioni istituzionali di possibilità: anche all’Università, proprio all’Università. È la destinazione della filosofia all’istituzione a rendere necessaria questa operazione; pena una filosofia risolta e come dissolta nel sociale o al più tradizionale e purtroppo diffuso irrigidimento disciplinare (leggi: accademico) del sapere filosofico.
L’obiettivo, se ce n’è, non è perciò la restituzione della filosofia a quel cielo dei concetti (fossero anche i più selvaggi, i meno mediati) dove si immaginava albergasse, ma la volontà, insieme energica e studiata, di farla finita una volta per tutte, su questa terra, con quel cielo.
- La filosofia «politica» è da sempre sospesa in un limbo fra il campo della filosofia e quello della scienza politica: qual è il suo statuto? quale il suo canone? come si differenzia da una storia delle politiche o da una teoria politica? esiste una specificità italiana nel praticarla?
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA --- Dora Russel (Mrs Bertrand Russell). Una straordinaria donna moderna (dfi Francesca Magni)1 aprile 2016, di Federico La Sala
Una straordinaria donna moderna
(Dora Russel Ipazia e la guerra tra i sessi)
di Francesca Magni ("Letto fra noi", 29 gennaio 2013)
- Dora Russel (Mrs Bertrand Russell) Ipazia e la guerra tra i sessi (La Tartaruga, 2012, traduzione di Simone Lenzi € 12,00, pp. 100).
«Se volessimo aggiungere qualcosa alle conquiste di coloro che vennero prima di noi, dovremmo dire che per noi adesso il corpo non è più un semplice contenitore per la mente, ma quel tempio di gioia e di estasi che, se lo vorremo, già racchiude il nostro futuro. Il compito fondamentale per il femminismo moderno, per me, è dunque quello di accettare e proclamare il sesso. Di seppellire per sempre la menzogna che per troppo tempo ha corrotto la nostra società, quella secondo la quale il corpo non è che un impaccio per la mente e che il sesso è solo un male necessario alla sopravvivenza della specie. Comprenderlo, donargli dignità e bellezza, conoscerlo anche su base scientifica, in luogo dell’istinto brutale e dello squallore, credo sarà la chiave di volta a colmare la breccia fra Giasone e Medea» (pag, 38).
Rompo il lungo silenzio su questo blog - e mi scuso di questo silenzio, e vi ringraizio per non esservene andati - con una citazione.
Vi invito a rileggere con una domanda: quando è stata scritta?
Difficile indovinare che parole così moderne siano uscite dalla penna di una donna nel 1925 ["Una stanza tutta per sè" di Virginia Woolf, è del 1929 - fls].
Dora Russell, seconda moglie del filosofo Bertrand Russell, ci regala cento pagine colme di saggezza senza tempo, di impegno politico e civile, di riflessioni mai abbastanza assimilate su una parità fra i sessi che nasca dal riconoscere una verità: siamo, uomini e donne, uguali a cominciare dal bisogno naturale di una vita sessuale che non reprima gli istinti ma sappia guidarli con educazione e intelligenza. «Gli amanti sanno che attraverso l’intesa sessuale ciascuno comprende meglio le qualità della mente dell’altro» dice, ed è una consapevolezza che non a tutti è dato raggiungere.
È un testo imprescindibile che mette una parola di verità su tutte le ciance da guerra dei sessi. Un libro da regalare a tutti, uomini e donne, a chi ha vissuto gli anni del femminismo e a chi viene dall’onda di ritorno della generazione successiva. A questa, alla quale appartengo, dedico un brano su cui non si è ancora riflettuto abbastanza.
«C’è dunque qualcosa di sbagliato nell’educazione delle donne, e nel caso che cosa? Penso proprio che dobbiamo rispondere affermativamente. E la ragione sta nel senso di inferiorità inculcato nelle donne da tanta oppressione, e il risultato inevitabile fu che il loro primo obiettivo, mentre combattevano dal basso, fosse quello di provare che valevano tanto quanto gli uomini. Il secondo fu invece di dimostrare che potevano spassarsela tranquillamente anche senza gli uomini. Esattamente come il lavoratore, avanzando nella scala sociale, cerca di provare a se stesso di essere un borghese. Entrambi gli sforzi sono sbagliati. Ciascuna classe ed entrambi i sessi hanno qualcosa di unico da dare al progresso, alla conoscenza, al pensiero di cui la comunità viene privata con questo scimmiottamento».
* Scritto da: Francesca Magni
SUL TEMA NEL SITO, SI CFR.:
- DONNE, SCIENZA, E RELIGIONI. COME MAI "UN UOMO PIU’ UNA DONNA HA PRODOTTO, PER SECOLI, UN UOMO" (Franca Ongaro Basaglia)? Non è il caso di ripensare i fondamenti?!
 IPAZIA, ALEJANDRO AMENABAR, AGORA’.
IPAZIA, ALEJANDRO AMENABAR, AGORA’.
 REALTA’ E RAPPRESENTAZIONE. STORIA ("RES GESTAE") E STORIOGRAFIA ("HISTORIA RERUM GESTARUM") ... E INTELLETTUALI.
REALTA’ E RAPPRESENTAZIONE. STORIA ("RES GESTAE") E STORIOGRAFIA ("HISTORIA RERUM GESTARUM") ... E INTELLETTUALI.
 I LIBRI DI "STORIA" E LE "DOMANDE DI UN LETTORE OPERAIO" - DI BERTOLT BRECHT
I LIBRI DI "STORIA" E LE "DOMANDE DI UN LETTORE OPERAIO" - DI BERTOLT BRECHT COSTITUZIONE E PENSIERO. ITALIA: LA MISERIA DELLA FILOSOFIA ITALIANA E LA RICCHEZZA DEL MENTITORE ISTITUZIONALIZZATO ...
COSTITUZIONE E PENSIERO. ITALIA: LA MISERIA DELLA FILOSOFIA ITALIANA E LA RICCHEZZA DEL MENTITORE ISTITUZIONALIZZATO ...
 BERTRAND RUSSELL: LA LEZIONE SUL MENTITORE (IGNORATA E ’SNOBBATA’), E "L’ALFABETO DEL BUON CITTADINO".
BERTRAND RUSSELL: LA LEZIONE SUL MENTITORE (IGNORATA E ’SNOBBATA’), E "L’ALFABETO DEL BUON CITTADINO". -
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---" Il costituzionalista riluttante": il bisogno di giustizia, il relativismo etico, e la “voce della coscienza”. Riflessione di Vito mancuso.22 marzo 2016, di Federico La Sala
- L’ANIMA VENDUTA E LA PAROLA RUBATA. A "REGIME LEGGERO", FINO ALLA CATASTROFE ... L’ITALIA IN UN GRAVE STATO DI MINORITA’ E DI PERICOLO.
- PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!! FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
Perché il bisogno di giustizia è più forte del relativismo etico
Da una raccolta di saggi d’autore dedicati a Gustavo Zagrebelsky una riflessione sulle radici della nostra “voce della coscienza”
di Vito Mancuso (la Repubblica, 22.03.2016)
- IL LIBRO Il costituzionalista riluttante ( Einaudi, a cura Andrea Giorgis, Enrico Grosso e Jörg Luther, pagg. 489, euro 35) è una raccolta di saggi dedicata alla riflessione intellettuale di Gustavo Zagrebelsky, in tutte le sue articolazioni: dalla democrazia alla giustizia. Tra i numerosi contributi ci sono quelli di Ezio Mauro, Enzo Bianchi, Luciano Canfora, Carlo Petrini, Nadia Urbinati. Questo è un estratto del saggio di Vito Mancuso
La principale malattia spirituale del nostro tempo consiste nell’incapacità di fondare nella coscienza l’imperatività della giustizia, ovvero di rispondere al perché si debba sempre fare il bene e operare ciò che è giusto anche in assenza di interessi, o addirittura contro i propri interessi. Rimandando a Dio e ai suoi comandamenti, l’etica religiosa tradizionale è capace di assolutezza, ma paga questa sua capacità con l’incapacità di universalità e quindi di tolleranza. D’altro canto l’etica laica nei suoi modelli fondamentali (giusnaturalismo, consensus gentium, formalismo, utilitarismo) è sì capace di tolleranza, ma incapace di generare l’assolutezza dell’obbedienza; anzi, applicando la tolleranza al proprio io nella pratica concreta, i soggetti trovano non di rado una comoda giustificazione alla loro incoerenza rispetto all’imperativo etico.
Il risultato è che oggi non si sa più rispondere al perché il bene dovrebbe essere sempre meglio del male. Tale assenza di fondazione è una grave minaccia che incombe sull’etica in quanto tale, perché in mancanza di fondazione o c’è imperatività senza discernimento, come nel caso del fanatismo, o non c’è imperatività e quindi non c’è etica, come nel caso dell’utilitarismo opportunistico.
Dato che l’etica si lega intrinsecamente al diritto, la crisi della sua fondazione si traduce immediatamente nella crisi del concetto di giustizia, ovvero dello stesso fondamento teoretico della filosofia del diritto. In questa prospettiva Gustavo Zagrebelsky scrive significativamente di «nostra ignoranza teoretica sul contenuto della giustizia». Il diritto infatti o è in grado di rimandare a un fondamento etico in base a cui mostrare che ciò che prescrive è veramente diritto nel senso di retto, oppure non può che risultare fondato ultimamente sul potere che dapprima l’istituisce in quanto positum, e poi si cura di farlo rispettare mediante la forza. L’alternativa è quella classica: è la verità o è l’autorità a costituire la legge?
È noto il detto di Hobbes: Auctoritas, non veritas, facit legem. Ma se si deve ammettere che questo vale per la legge positiva, non ritengo che valga allo stesso modo per il diritto sostanziale che precede e fonda la legislazione. L’autorità è indispensabile per mediare il passaggio dalla sfera del diritto alla sfera della legge, e in questo senso è giusto dire che senza autorità non si avrebbe la legge (Auctoritas facit legem). Non per questo però è lecito concludere che l’autorità sia anche la fonte sorgiva del diritto, il quale al contrario precede l’autorità e la giudica, distinguendola in autorità legittima e giusta a cui obbedire, e autorità illegittima e ingiusta a cui ribellarsi (e quindi si potrebbe dire: Veritas facit ius).
Se il diritto precede l’autorità, esso riceve il suo fondamento nella coscienza, in particolare in quella forma della coscienza etica che intende comportarsi in modo retto e giusto, e che tradizionalmente si chiama etica. Torniamo quindi a quanto affermato sopra, ovvero al fatto che l’odierna crisi dell’etica trascina con sé anche la crisi della fondazione del diritto e la conseguente «nostra ignoranza teoretica sul contenuto della giustizia».
Tuttavia esiste negli esseri umani un enorme bisogno di giustizia. La mancata realizzazione di questo bisogno genera in essi malessere e risentimento rispetto alla società, alla storia, alla condizione umana. La questione si pone in modo radicale: quando parliamo di «fame e sete di giustizia », quale dimensione dell’essere umano nominiamo? Io ritengo che il fondamento dell’etica e il fondamento del diritto si leghino intrinsecamente l’uno all’altro, e che la forza dell’uno sia la forza dell’altro, e la rovina dell’uno la rovina dell’altro.
Esistenzialmente la questione del fondamento dell’etica si traduce in una domanda molto concreta: perché dovrei fare il bene e non il mio interesse? La mia risposta è la seguente: si deve fare il bene per essere fedeli a se stessi, perché è nel bene oggettivo che risiede il più grande interesse soggettivo.
Che cos’è infatti il bene? Il bene nella sua essenza peculiare è forma, ordine, armonia, relazione armoniosa. E che cosa siamo noi? Siamo forma, ordine, armonia, un concerto di relazioni armoniose: è grazie a questa dinamica, chiamata in fisica informazione, che a partire dai livelli primordiali delle nostre particelle subatomiche si formano i nostri atomi, i quali a loro volta, grazie all’informazione che li guida, formano le nostre molecole, le quali a loro volta, grazie all’informazione che le guida, formano gli organelli alla base delle nostre cellule, le quali a loro volta... e via di questo passo secondo una progressiva organizzazione che giunge fino alla coscienza e alla personalità.
La logica che ci dà forma, che ci in-forma, è la relazione armoniosa, e quindi praticare l’etica, in quanto relazione armoniosa con gli altri e con il mondo, significa essere fedeli a se stessi, alla nostra più intima logica interiore. In questa prospettiva l’altruismo non risulta difforme da un retto egoismo in quanto intelligente cura di sé. La fondazione dell’etica quindi è fisica, basata su una filosofia che guarda alla natura con ottimismo e favore, senza ignorare le numerose manifestazioni di caos e di disordine che essa presenta ma riconducendole all’interno di un processo complessivamente orientato alla crescita della complessità e dell’organizzazione vitale, e che per questo sa che essere fedeli alla natura e alla sua logica relazionale equivale a fare il bene, e di conseguenza a stare bene, per la gioia che infallibilmente scaturisce in ogni essere umano quando cresce la qualità delle sue relazioni. Da questa logica armoniosa dell’essere procede anche il richiamo al rispetto della giustizia che tradizionalmente chiamiamo «voce della coscienza».
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! - DENTRO LA PIU’ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA E POLITICA ITALIANA -- ATTUALITA’ DI MARX. Il 18 brumaio di Luigi Bonaparte (di Vittorio Ducoli)19 marzo 2016, di Federico La Sala
- CHI SIAMO NOI, IN REALTA’?! RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTA’: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE. LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. MARX, IL "LAVORO - IN GENERALE", E IL "RAPPORTO SOCIALE DI PRODUZIONE - IN GENERALE".
ATTUALITA’ DI MARXIl 18 brumaio di Luigi Bonaparte
by Karl Marx, Giorgio Giorgetti (Editor), Palmiro Togliatti (Translator)
Vittorio Ducoli’s Reviews (Goodreads, 16 marzo 2013)
Attualità di Marx
L’altro giorno, 14 marzo, ricorreva il 130° anniversario della morte di Karl Marx.
Per puro caso, nello stesso giorno ho finito di leggere Il 18 brumaio di Luigi Bonaparte, che ritengo uno dei testi fondamentali per addentrarsi nelle idee di questo grandissimo pensatore e per apprezzarne appieno l’attualità, a dispetto della vulgata interessata che vorrebbe il pensiero marxiano solo un retaggio del passato.
Un primo elemento a favore di questo testo è il tema. Non si tratta di un trattato filosofico o di critica all’economia politica, la cui lettura spesso richiede un sostrato culturale molto solido, ma dell’analisi di Marx degli avvenimenti che tra il febbraio 1848 e il dicembre 1851 videro la Francia passare dalla fase rivoluzionaria che aveva portato alla caduta della monarchia di Luigi Filippo d’Orleans al trionfo della più bieca reazione con il colpo di stato attuato da Luigi Napoleone Bonaparte, il futuro Napoleone III. Si tratta quindi di un’analisi storica di fatti che hanno avuto conseguenze importantissime sull’intera storia europea, e non solo, dei decenni successivi.
Ho messo in corsivo l’aggettivo storica perché Marx scrive i testi che formano il libro pochissimo dopo, nel 1852: eppure la sua analisi è così compiuta, così lucida, così minuziosa e supportata da dati ed elementi oggettivi da assumere il carattere pieno dell’indagine storica.
Un altro elemento che caratterizza il 18 brumaio è la brillantezza della scrittura. A differenza di quanto si possa pensare, Marx non è affatto un autore pesante, ma una delle più brillanti penne del XIX secolo. Basta pensare a quante sue frasi, aforismi, paradossi facciano parte del nostro bagaglio culturale per rendersi conto di ciò; purtroppo, molti dei suoi testi riguardano argomenti ostici, trattati ed approfonditi con rigore, e questo ovviamente genera complessità: pregio di questo volume è di offrirci un Marx sicuramente non leggero ma scorrevole, per molti tratti appassionante, laddove gli avvenimenti si susseguono incalzanti e Marx ce ne disvela le ragioni vere e ultime.
Sì, perché il senso di questo libro è far capire, anche a noi oggi, la distanza che esiste tra le cause ideologiche dei conflitti e le loro cause vere che, ci dice Marx, vanno sempre ricercate nei conflitti tra le classi e i loro diversi interessi.
Marx, pagina dopo pagina, ci narra gli scontri di piazza e le lotte tra le diverse fazioni parlamentari che caratterizzarono il biennio, individuando oggettivamente le motivazioni vere che ne erano alla base. Così, l’acerrima lotta avvenuta nell’Assemblea legislativa tra Partito dell’Ordine (monarchici) e Montagna (repubblicani), lungi dall’essere una lotta sulla forma dello stato è una lotta tra gli interessi della grande borghesia e quelli dei borghesi medi e piccoli. Leggendo questo testo è quindi agevole comprendere in pratica la tesi marxiana per cui la storia è il risultato della lotta tra le varie classi sociali.
Forse però l’aspetto del libro che affascina di più è l’analisi delle motivazioni che portarono al colpo di stato di Luigi Napoleone. Marx parte dalla constatazione che la Repubblica è la forma di stato con cui la borghesia esercita direttamente il potere (come insegna la prima rivoluzione francese); eppure, favorendo oggettivamente ed anche attivamente il colpo di mano del Napoleone piccolo consegna questo potere ad altri, ai militari e ad una consorteria di avventurieri che aveva la sua base sociale nel lumpenproletariat rurale. Perché questa abdicazione?
La risposta di Marx è lucidissima, e si sarebbe purtroppo dimostrata vera molte altre volte nella storia. La borghesia si era accorta che la Repubblica borghese era il terreno di lotta ideale per il proletariato, che poteva progredire ed organizzarsi grazie alle libertà civili e politiche: aveva quindi preferito consegnare il potere a chi, pur non organico alla sua classe, potesse garantire ordine e tranquillità agli affari, piuttosto che rischiare una emancipazione proletaria. Quante volte, nel secolo successivo, questa logica avrebbe prevalso in varie parti dell’Europa e del mondo!
Quante volte la borghesia avrebbe consegnato interi popoli nelle mani di mascalzoni e di buffoni pur di salvaguardare la roba.
Fortunatamente Marx morì 130 anni fa, perché credo che altrimenti avrebbe dovuto nel tempo istituire una sezione d’analisi specificamente dedicata al nostro paese, dove la borghesia ha sempre assunto questo atteggiamento, sia pure in modi diversi, da Mussolini a Berlusconi.
Resta da spiegare il titolo, che è una delle grandi invenzioni di Marx: il 18 brumaio (9 novembre) 1799 Napoleone I abbatté il direttorio ed instaurò la sua dittatura, come farà il 2 dicembre 1851 il nipote Luigi Napoleone. Ma, ci avverte Marx nella prima pagina di questo libro, con una delle sue frasi fulminanti ”Hegel nota in un passo delle sue opere che tutti i grandi fatti e i grandi personaggi della storia universale si presentano, per così dire, due volte. Ha dimenticato di aggiungere: la prima come tragedia, la seconda come farsa”. Oggi noi sappiamo che i grandi fatti possono presentarsi più e più volte; sappiamo inoltre che anche quando si presentano come farsa spesso sono causa di grandi tragedie. Fortunatamente in Italia l’abbiamo imparato, e (almeno per ora) riusciamo a mantenerci sul terreno del burlesque.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- Nell’epoca del trasformismo. Chi grida al fascista (di Francesco Merlo)17 marzo 2016, di Federico La Sala
- COSTITUZIONE E PENSIERO. ITALIA: LA MISERIA DELLA FILOSOFIA ITALIANA E LA RICCHEZZA DEL MENTITORE ISTITUZIONALIZZATO ...
 BERTRAND RUSSELL: LA LEZIONE SUL MENTITORE (IGNORATA E ’SNOBBATA’), E "L’ALFABETO DEL BUON CITTADINO".
BERTRAND RUSSELL: LA LEZIONE SUL MENTITORE (IGNORATA E ’SNOBBATA’), E "L’ALFABETO DEL BUON CITTADINO".
- FILOSOFIA. IL PENSIERO DELLA COSTITUZIONE E LA COSTITUZIONE DEL PENSIERO
 MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA E A PENSARE BENE "DIO", "IO" E "L’ITALIA", CHI PIU’ CHI MENO, TUTTI VIVONO DENTRO LA PIU’ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA E POLITICA ITALIANA, NEL REGNO DI "FORZA ITALIA"!!!
MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA E A PENSARE BENE "DIO", "IO" E "L’ITALIA", CHI PIU’ CHI MENO, TUTTI VIVONO DENTRO LA PIU’ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA E POLITICA ITALIANA, NEL REGNO DI "FORZA ITALIA"!!!
Chi grida al fascista
di FRANCESCO MERLO (la Repubblica, 17 marzo 2016)
TORNANO le parole fascista, comunista, stalinista... non solo come "vecchi soprannomi per anziani" ma anche come gli stilemi di un’usurata comicità italiana che non fa più ridere, di un sottosopra logico che è diventato triste. "I leghisti di Roma sono tutti ex fascisti" ha ieri denunziato l’indomabile comandante partigiano Silvio Berlusconi in difesa del fido Bertolaso che, come un eroe della Resistenza, dovrà ora affrontare la Decima Mas di Salvini, le legioni della Meloni, i manipoli della deputata ex missina Barbara Saltamartini, la quale, com’è ovvio, tiene il coltello tra i denti alla maniera del feroce Ettore Muti.
E, a fare pendant, intervistato sul Corriere da Aldo Cazzullo, Massimo D’Alema aveva dato dello stalinista a Matteo Renzi e di nuovo la parola aveva fatto cortocircuito con la sua storia. Perché anche "stalinista" non è un insulto qualsiasi, come per esempio populista o sleale o autoritario, ma è una grammatica politica, un codice etico, è la cassetta degli attrezzi che Massimo D’Alema ha giustamente relegato nella propria soffitta ideologica, la vecchia antropologia che modellò il suo carattere di duro e formò la sua selvatica personalità.
Ma veniamo a noi, che alla parola "fascisti" ancora ci armiamo di vigilanza democratica. Ieri mattina, ascoltando l’intervista che gli faceva Maurizio Belpietro, noi abbiamo cercato di capire chi sono i camerati, i cuori neri che fanno vibrare di indignazione liberale l’antifascista Berlusconi. Di sicuro non ce l’ha con Gasparri, Alemanno, Storace, Matteoli e con tutti quegli altri ex fascisti che lui ha fatto, nel corso degli anni, ministri, sindaci, presidenti di regioni, quelli che stavano nel Fuan e nel Fronte della Gioventù e lui ha messo a sedere al tavolo delle presidenze, nelle partecipate, nel sottogoverno, ha chiamato ad esercitare il potere, ha promosso classe dirigente del Paese, sino a nominare ministro della Difesa il futurista Ignazio La Russa, che sembrava l’incarnazione della caricatura del gerarca, con i suoi completi militari, le collezioni di soldatini, i voli dannunziani sopra Kabul... Insomma Berlusconi non può certo avercela con tutti gli ex giovani camerati che - Giovinezza Giovinezza - nel giorno in cui la destra berlusconiana fece eleggere Alemanno sindaco di Roma, lo salutarono sui gradini del Campidoglio con il saluto romano e il grido Eia eia alalà.
È vero che quando non lo soddisfacevano li chiamava ingrati, soprattutto Gianfranco Fini "il quale - disse nel 2009 all’agenzia Ansa - senza di me starebbe ancora dove stavano tutti loro sino al 1994" e voleva dire nelle fogne dello slogan ("fascisti carogne/ tornate nelle fogne"). Per la verità già un anno prima Berlusconi lo aveva tirato fuori dal sottosuolo della Storia. Non era ancora sceso in campo, quando Fini il fascista si candidò proprio a sindaco di Roma contro Rutelli. Ebbene, al cronista che gli domandava per chi avesse votato, l’imprenditore a sorpresa rispose: "Certamente Gianfranco Fini". Fu un lampo, un’epifania, probabilmente il suo scandalo più bello, un merito che la storia di sicuro gli riconoscerà: avere dato alla destra italiana lo ius soli nella democrazia. Fini fu battuto ma raggiunse il 47 per cento e mai sconfitta fu più vincente di quella. Berlusconi infatti lo aveva smacchiato. Con il paradosso però che, da quel momento, più Fini si allontanava dalla destra e più Berlusconi si spostava a destra. E più Fini si sfascistizzava e più, agli occhi di Berlusconi, ritornava fascista, come vuole il vecchio adagio secondo cui bisogna fare il giro del mondo per ritrovare la propria casa.
Ecco, appunto, Berlusconi in un’intercettazione con Lavitola lamentarsi che Fini gli bocciava uno dei suoi tanti lodi perché, secondo lui, subiva le lusinghe della sinistra: "non me l’approvano i fascisti, Fini non ci sta". E la cronaca racconta che non solo Berlusconi pagò 600 milioni per far nascere Fratelli d’Italia, ma che anche La Destra di Storace aveva avuto la sua concreta benedizione: "Ah, quando c’era la buonanima" disse mostrando a Storace il volume dell’editore Dino con il faccione del Duce sbalzato in oro. E Storace, che era a capo di una delegazione di fascisti sociali e dunque poveri: "Beato lei che ce l’ha, noi no, perché costa troppo".
Berlusconi fascista? Berlusconi antifascista? Nessuno meglio di noi, che lo abbiamo studiato per 20 anni, sa che Berlusconi non è stato niente, o se preferite è stato tutto e il contrario di tutto. Ci fu quello che difese Mussolini perché "non ha mai ammazzato nessuno e mandava la gente in vacanza al confino", e ci fu quell’altro che il 25 aprile del 2009 si annodò un fazzoletto rosso al collo e tenne un comizio ricordando la sua eroica mamma antinazista. Ci fu un Berlusconi che scelse la giornata della memoria per raccontare barzellette sugli ebrei e ce ne fu uno che, in tv, annunziò che sarebbe andato ad incontrare il papà dei fratelli Cervi senza neppure sentire Bertinotti che gli ripeteva: "guardi che papa Cervi è morto".
Nell’Italia del trasformismo, Berlusconi non è certo l’unico ad avere adattato le convinzioni alle convenienze, ma davvero oggi ha solo un suono acido la parola fascista usata dal vecchio sdoganatore dei fascisti. Allo stesso modo suona acida la parola stalinista usata dall’ultimo nipotino degli stalinisti. Sono solo parole morte che appartengono alla storia, un po’ come Orazi e Curiazi, turchi e mori, achei e troiani. Tanto più che Bertolaso, forse forse, in queste elezioni romane, è quello che della fascisteria parodiata - da affrontare con Ugo Tognazzi e non certo con Ferruccio Parri - esibisce di più i connotati: la virilità, gli attributi, la stessa spavalderia che mostrava sulle macerie dell’Aquila quando si vestiva da guerrigliero geologico, da capitano coraggioso. Cos’altro poteva dire alla Meloni incinta se non "vai a fare la mamma "? Spiace solo che, nelle polemiche, lo abbiano davvero trattato come se fosse l’uomo italiano medio, il rappresentante del maschio italiano, promuovendo lui e offendendo tutti gli altri.
Le parole impazziscono un attimo prima degli uomini. Ma non fanno tabula rasa. Remember è il titolo di un intelligente film tedesco che Berlusconi e D’Alema dovrebbero andare a vedere insieme, per ritrovare quel tanto che hanno in comune. Racconta di un vecchio che ha perso la memoria e va a caccia di nazisti. Senza ricordare che il nazista era lui.
- COSTITUZIONE E PENSIERO. ITALIA: LA MISERIA DELLA FILOSOFIA ITALIANA E LA RICCHEZZA DEL MENTITORE ISTITUZIONALIZZATO ...
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- UN PROBLEMA PIU’ VASTO. Per legge, religione, natura, cultura, storia, denaro, potere e mamme adoranti (Natalia Aspesi).15 marzo 2016, di Federico La Sala
- UNA CATTOLICA, UNIVERSALE, ALLEANZA "EDIPICA"!!! IL MAGGIORASCATO: L’ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE, L’ALLEANZA DELLA MADRE CON IL FIGLIO, REGNA ANCORA COME IN TERRA COSI’ IN CIELO.
 DONNE, UOMINI E VIOLENZA: "Parliamo di FEMMINICIDIO".
DONNE, UOMINI E VIOLENZA: "Parliamo di FEMMINICIDIO".
- Resta un problema più vasto del misero maschilismo dei politici, che dovrebbero avere la furbizia di pensare ogni nequizia ma di non dirla. Se le femmine sono femministe coscienti di esserlo in gruppi privilegiati ma non oceanici, i maschi sono per natura da sempre maschilisti. Lo sono stati per secoli, per legge, religione, natura, cultura, storia, denaro, potere e mamme adoranti (Natalia Aspesi).
Caro maschio ci fai ridere
di Natalia Aspesi (la Repubblica, 15.03.2016)
E se il vecchio e scaltro Bertolaso avesse ragione? Se a ogni donna incinta, operaia, amministratrice delegata, mendicante, diva, escort, quindi anche sindaca, fosse consigliato di lasciare il lavoro, con un bello stipendio da parte ovviamente dello Stato?
PER fare solo la pre-mamma e la mamma, non per qualche mese soltanto ma almeno per qualche anno, ritrovando poi il suo lavoro e il suo stipendio? Permesso anche alla casalinga stessa, che smettendo di cucinare, rifare i letti, fare il suo dovere di sposa, sostituita da una casalinga statale in tutte le mansioni, potesse dedicarsi solo a questo mestiere solo a lei femmina consentito, per seguirlo a tempo pieno.
In questo caso essere donna e madre potrebbe essere in sé una libera professione al servizio della Patria e anche l’incinta Meloni potrebbe usufruirne senza infastidire Bertolaso e compagni, evitando di vomitare durante la campagna elettorale e di perdere le acque durante una manifestazione di piazza. Ma soprattutto togliendo all’aspirante sindaco almeno un motivo per dichiarazioni sceme, che purtroppo lo aiuterebbero a vincere le elezioni, con ovvi danni alla città già molto danneggiata. Un sindaco che allatta durante una accesa battaglia in giunta renderebbe invece la Meloni sempre vincente, perché anche i suoi più duri antagonisti maschi arrossirebbero guardando altrove: ma anche in questo caso a perdere sarebbe di nuovo Roma, e non a causa di mamma Meloni, ma semplicemente della Meloni.
Essendo da almeno cinquant’anni femminista, non vorrei essere giudicata maschilista se oso dichiarare che la signora Patrizia Bedori ha fatto molto bene a ritirare la sua candidatura, che non avrebbe neppure dovuto proporre, per molte ragioni. Perché se una può diventare sindaco perché in 74 l’hanno votata online, non pare proprio un furor di popolo, anche nel suo stesso noiosissimo movimento già molto antiquato. Perché ha smascherato definitivamente il finto giovanilismo democratico dei suoi compagni elettronici che l’hanno insultata perché “casalinga e disoccupata” come milioni di altre donne e ormai molti uomini disoccupati e casalinghi in quanto soli. Che l’hanno definita «brutta, grassa e obesa», come molti rispettati onorevoli maschi, quindi di meritare di essere «buttata fuori a calci in culo». Bastava dire che, come la maggior parte dei suoi compagni, non sembrava preparata al difficilissimo ruolo di sindaco di Milano, soprattutto dopo Pisapia.
Del resto, anche in passato i ragazzi Cinque Stelle avevano dimostrato la loro paura delle donne, come Massimo De Rosa che ha onorato le colleghe del Pd con un complimento forse invidioso: «Voi siete qui solo perché siete brave a fare i pompini!». Brutte non le vogliono quegli incontentabili, ma neanche belle. Nicola Morra, senatore M5S: «La ministra Boschi sarà ricordata più per le forme che per le riforme» (per saperne di più c’è il libro Stai zitta e va’ in cucina di Filippo Maria Battaglia).
Resta un problema più vasto del misero maschilismo dei politici, che dovrebbero avere la furbizia di pensare ogni nequizia ma di non dirla. Se le femmine sono femministe coscienti di esserlo in gruppi privilegiati ma non oceanici, i maschi sono per natura da sempre maschilisti. Lo sono stati per secoli, per legge, religione, natura, cultura, storia, denaro, potere e mamme adoranti.
Da anni cercano di correggersi, da quando negli anni Settanta si misero persino a fare autocoscienza come le ragazze. Ma non ce la fanno sino in fondo. Ogni tanto il maschio militante salta fuori, lancia un’ingiuria sempre fisica e sessuale, o, se è molto nervoso, taglia la gola della donna che non fa finta di adorarlo comunque e di essere certa della sua superiorità. Che fare? Niente, stare zitte, ridere a ogni bertolasata, che più o meno sempre ci sarà, e prendersi tutto quello che ci spetta non tanto come donne quanto come esseri umani.
- UNA CATTOLICA, UNIVERSALE, ALLEANZA "EDIPICA"!!! IL MAGGIORASCATO: L’ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE, L’ALLEANZA DELLA MADRE CON IL FIGLIO, REGNA ANCORA COME IN TERRA COSI’ IN CIELO.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- Heidegger e la bizzarra, infinita fortuna del Pastore dell’Essere tra i filosofi italiani (di Roberta De Monticelli).13 marzo 2016, di Federico La Sala
- LO STATO DEL FARAONE, LO STATO DI MINORITA’, E IMMANUEL KANT "ALLA BERLINA" - DOPO AUSCHWITZ
 "LEZIONE SU KANT" A GERUSALEMME: PARLA EICHMANN "PILATO", IL SUDDITO DELL’"IMPERATORE-DIO".
"LEZIONE SU KANT" A GERUSALEMME: PARLA EICHMANN "PILATO", IL SUDDITO DELL’"IMPERATORE-DIO".
- PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!
 FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.
Nazista, naturalmente
Non c’è quasi nulla di «elevato» nel pensiero di Martin Heidegger. E l’antisemitismo metafisico è un’idiozia
La bizzarra, infinita fortuna del Pastore dell’Essere tra i filosofi italiani è basata su una malintesa idea di che cos’è la modernità
di Roberta De Monticelli (Il Sole-24 Ore, Domenica, 13.03.2016)
- Martin Heidegger, Quaderni neri 1938-39. Riflessioni VII-XI, traduzione di Alessandra Iadicicco, Bompiani, Milano, pagg. XII, 596 € 28
Prosegue, con il secondo volume, la traduzione italiana dei Quaderni neri di Heidegger, nell’attenta traduzione di Alessandra Iadicicco (1938/1939). Dell’antisemitismo “metafisico” di Heidegger si parla dall’uscita del libro di Donatella Di Cesare Heidegger e gli Ebrei (Bollati Boringhieri 2014, edizione riveduta 2016). Tra sconcerti e sdrammatizzazioni, una cosa colpisce: che quasi non ci siano eccezioni all’imperturbata ammirazione che si continua a tributare a questo sofista, alla sua idea della “macchinazione” universale, che ha colpa di tutto, e ha nome Modernità. E più genericamente questa potenza oscura è descritta più siamo tranquilli noi - amici dell’Essere che contemplano l’Essenza del Nichilismo, il Destino dell’Occidente, la Tecnica, il Capitalismo, la Finanza - tutti i volti della Metafisica insomma, e qualcuno ce ne sfugge: il Neoliberismo, forse.
In questa ammirazione c’è tutta la storia dell’irresponsabilità intellettuale e morale di una vastissima parte del pensiero europeo e italiano, dal dopoguerra a oggi. La riflessione che vi propongo si basa sui volumi dei Quaderni neri che usciranno in versione italiana: sono testi che risalgono agli anni dell’impegno nazista di Heidegger.
Cos’è l’antisemitismo metafisico? È l’accusa a «quella specie di umanità che, essendo per eccellenza svincolata, potrà fare dello sradicamento di ogni ente dall’Essere il proprio “compito” nella storia del mondo». Così «il mio attacco a Husserl è diretto non solo contro di lui - il che lo renderebbe inessenziale - l’attacco è diretto contro l’omissione della questione dell’Essere, cioè contro l’essenza della metafisica come tale, sulla cui base la macchinazione dell’ente riesce a dominare la storia». Così scrive Heidegger nel Quaderno nero intitolato Riflessioni XIV, all’indomani dell’offensiva tedesca a Est, annunciata da Hitler il 22 giugno 1941.
 Ora, Heidegger ha ragione: Husserl è proprio uno sradicatore. Prendiamo un suo testo di quasi vent’anni prima, L’idea d’Europa, sull’universalità dei giudizi veri e ben fondati - anche quelli di semplice esperienza - che costituiscono acquisizioni per tutti: «quello che vedo io può vederlo chiunque... da qualsiasi cerchia culturale provenga, amico o nemico, greco o barbaro, figlio del popolo di Dio o Dio dei popoli nemici». Ecco qui all’opera l’ebreo errante che sradica.
Ora, Heidegger ha ragione: Husserl è proprio uno sradicatore. Prendiamo un suo testo di quasi vent’anni prima, L’idea d’Europa, sull’universalità dei giudizi veri e ben fondati - anche quelli di semplice esperienza - che costituiscono acquisizioni per tutti: «quello che vedo io può vederlo chiunque... da qualsiasi cerchia culturale provenga, amico o nemico, greco o barbaro, figlio del popolo di Dio o Dio dei popoli nemici». Ecco qui all’opera l’ebreo errante che sradica.
 Di più: Husserl insiste sullo sradicamento, non solo in relazione all’evidenza universale dei giudizi di fatto, ma anche e soprattutto in relazione alla ricerca di evidenza per i giudizi di valore: «così profondamente radicate nella personalità che già il loro metterle in dubbio minaccia di “sradicare” la personalità stessa, la quale ritiene di non poter rinunciare a loro senza rinunciare a se stessa - cosa che può portare a violente reazioni d’animo». Cioè: sapere aude. Con l’aggiunta di una nuova e sofferta consapevolezza di quanto sia difficile il passaggio alla maggiore età: dalle care certezze della comunità d’appartenenza all’autonomia del pensiero adulto. Husserl insiste, spietato: «E non importa che piaccia o meno a me o ai miei compagni, che ci colpisca tutti “alla radice”: la radice non serve».
Di più: Husserl insiste sullo sradicamento, non solo in relazione all’evidenza universale dei giudizi di fatto, ma anche e soprattutto in relazione alla ricerca di evidenza per i giudizi di valore: «così profondamente radicate nella personalità che già il loro metterle in dubbio minaccia di “sradicare” la personalità stessa, la quale ritiene di non poter rinunciare a loro senza rinunciare a se stessa - cosa che può portare a violente reazioni d’animo». Cioè: sapere aude. Con l’aggiunta di una nuova e sofferta consapevolezza di quanto sia difficile il passaggio alla maggiore età: dalle care certezze della comunità d’appartenenza all’autonomia del pensiero adulto. Husserl insiste, spietato: «E non importa che piaccia o meno a me o ai miei compagni, che ci colpisca tutti “alla radice”: la radice non serve».Donatella Di Cesare riassumeva così il risultato della sua esplorazione dei Quaderni neri: «Il pensiero più elevato si è prestato all’orrore più abissale». La mia domanda è: ma che cosa ci sarà di “elevato”? Come si può considerare “elevata” l’idiozia etno-metafisica dell’ebraismo sradicatore? Come risulta bene dal passaggio di Husserl, Heidegger imputa a questo “sradicatore” quella che è per Husserl la gloria di Socrate: la vita esaminata, il vaglio critico delle tradizioni e culture d’appartenenza.
 Ma non sembra molto più elevata l’idea di incolpare l’Ebreo Metafisico di essere l’agente della modernità, bersaglio di tutto il linguaggio heideggeriano: e modernità - in filosofia - vuol dire l’Illuminismo, il principio kantiano di autonomia morale della persona, l’universalismo morale, il cosmopolitismo politico, la scienza e la democrazia.
Ma non sembra molto più elevata l’idea di incolpare l’Ebreo Metafisico di essere l’agente della modernità, bersaglio di tutto il linguaggio heideggeriano: e modernità - in filosofia - vuol dire l’Illuminismo, il principio kantiano di autonomia morale della persona, l’universalismo morale, il cosmopolitismo politico, la scienza e la democrazia.Purtroppo è proprio questa l’idea di modernità ereditata da una grande ala della filosofia italiana contemporanea. Che sembra confondere nel “destino dell’Occidente” la ragion pratica e Auschwitz, l’Illuminismo e il nazismo. Sulle tracce di Adorno-Horkheimer, e della loro oscura Dialettica dell’Illuminismo. E che cosa insegna questo pensiero ai nostri figli? A proposito della macchinazione di cui non siamo mai noi ad aver colpa: sarà un caso se il livello di discriminazione concettuale e di discernimento morale, oltre che di intelligenza politica del male che affligge la democrazia, resta, anche fra molti dei filosofi più in vista, pari a quella di un adolescente narciso alle prese col lato oscuro della forza?
- LO STATO DEL FARAONE, LO STATO DI MINORITA’, E IMMANUEL KANT "ALLA BERLINA" - DOPO AUSCHWITZ
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- Rete Donne, violenza è strutturale urge politica. 16 mila si rivolgono ai centri antiviolenza. Titti Carrano, ci vogliono programmi scolastici.8 marzo 2016, di Federico La Sala
Rete Donne, violenza è strutturale urge politica
16 mila si rivolgono ai centri antiviolenza. Titti Carrano, ci vogliono programmi scolastici *
I dati raccolti in tutta Italia dai 74 centri anti violenza che fanno capo a D.I.Re. sono in arrivo ma una cosa è certa, ’’ogni anno il numero delle donne che vi si rivolgono è costante, oltre 16 mila persone e questo significa che il fenomeno della violenza di genere è strutturale all’ interno della società e non è una questione d’emergenze come a volte viene rappresentato o percepito’’. Lo dice in un’ intervista all’ANSA Titti Carrano, presidente delle Donne in rete contro la violenza. ’’La violenza di genere è un fenomeno trasversale, colpisce a tutti i livelli economici, sociali, professionali e come è ovvio non è un tema solo italiano ma mondiale ma questo non significa arrendersi ai fatti, certamente c’è moltissimo da fare e che si può fare ma intanto deve essere chiaro che il fenomeno della violenza maschile contro le donne è profondamente radicato nella nostra cultura e che per invertire la tendenza si deve fare ai massimi livelli, innanzitutto con la politica attraverso interventi mirati e a lungo termine’’, prosegue la presidente dell’associazione. Le politiche legislative, secondo la Carrano, sono assolutamente insufficienti, ’’attualmente è più semplice legiferare sul corpo delle donne che sulla cultura che genera violenza, mentre è anche su quello che bisognerebbe lavorare’’.
Altro lavoro urgente, ’’se vogliamo far crescere generazioni diverse’’, riguarda la scuola e qui ’’il vuoto è grande’’, dice sconsolata la Carrano. ’’I centri antiviolenza fanno continuamente sul territorio singoli progetti di sensibilizzazione trovando spesso dirigenti scolastici e professori sensibili ma sono - spiega Titti Carrano - esperienze spot mentre servirebbero programmi scolastici ad hoc, educazione sessuale e di genere tra le materie, spazi di discussione, confronto e apprendimento perché questi nostri ragazzi e ragazze crescano con la consapevolezza che la relazione tra i sessi può basarsi sul rispetto’’. Intanto sul tema della scuola in questi giorni è partito Suffragette 2.0, un tour di Lorella Zanardo per dialogare con le giovani generazioni.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- Elvio Fachinelli, un interprete critico della società: "Al cuore delle cose. Scritti politici". Raccontare il discontinuo (di Marco Dotti)5 marzo 2016, di Federico La Sala
- ELVIO FACHINELLI. Oltre Freud, una seconda rivoluzione copernicana Appunti e note, in memoria, per il ventennale della morte.
- FACHINELLI E FREUD NELLA “NAVE” DI GALILEI: LA CONVERSAZIONE CONOSCITIVA (IL NUOVO "CIRCOLO ERMENEUTICO"). “Su Freud”, un’ottima introduzione a “La mente estatica” ("Sulla spiaggia").
Raccontare il discontinuo
ELVIO FACHINELLI. Psicoanalista di formazione freudiana, lo scrittore trentino è stato un interprete critico della società, contribuendo all’esperienza dell’educazione non-autoritaria di Porta Ticinese
di Marco Dotti (il manifesto, 05.03.2016)
Il 21 dicembre 1989, un giovedì, a Milano, moriva Elvio Fachinelli. In quelle ore, in un altrove che credevamo non ci riguardasse troppo ma coglieva forse meglio e certo più di tanti scenari il cuore infinitamente nero del nostro tempo che proprio Fachinelli aveva saputo indagare con il rigore eccentrico del flâneur, Nicolae Ceausescu, uno di quei piccoli uomini senza rigore e senza smalto che talvolta fanno la storia, si affacciava dal suo palazzo presidenziale e ripeteva una menzogna di lungo corso.
Nelle parole pronunciate in quello che fu il suo ultimo discorso pubblico, il conducător mostrava un misto di incredulità e disprezzo. Incredulità rispetto ai fatti di Timişoara, alle rivolte, ai minatori, allo sgomento per la «necessaria» repressione. Disprezzo per una una realtà che non solo gli era sfuggita di mano, ma proprio non vedeva più, continuando imperterrito a parlare di «società plurilateralmente sviluppata» e di «splendore del socialismo romeno». Il giorno dopo, di quello splendore e di quello «sviluppo onnilaterale» sarebbe rimasta solo la polvere. Il ritorno all’ordine non aveva avuto luogo. E noi, scomparso Fachinelli, avevamo uno sguardo in meno per cogliere ciò che davvero stava mutando fuori, dentro e persino oltre di noi.
Elvio Fachinelli era nato a Luserna, in Trentino, nel dicembre di sessantun anni prima. Aveva trascorso gli anni dell’infanzia a Melun, una cinquantina di chilometri da Parigi, dove si erano trasferiti i genitori - il padre era impegnato nel settore edile -, si era laureato in medicina a Pavia, specializzato all’Ospedale Maggiore di Milano dove conobbe Enzo Morpurgo, cominciò a lavorare presso una casa di cura, tra i suoi colleghi figurava anche Franco Fornari, e infine fu avviato all’analisi da Cesare Musatti. «Probabilmente, con i criteri attuali», osserverà Fachinelli, «sarebbe giudicata un’analisi selvaggia - come del resto le analisi fatte dalle prime generazioni di psicoanalisti. Eppure secondo me è stata una buona analisi: ho ricevuto sorprese, e questo per me è fondamentale in ogni analisi. Ho imparato e mi sono anche divertito».
Servirebbe tutta un’archeologia di quegli incontri e di quei - topologicamente parlando - «divertimenti» per capire il «dopo» di una delle teste più lucide e attive dell’altra cultura, quella né contro per posa, né dentro per vocazione. Semplicemente diretta al cuore delle cose. Confliggere - ma su questo si è detto e scritto tanto - non sarebbe mai stato «il» problema per Fachinelli che, editore, redattore, parte attiva di imprese al limite dell’utopia - ricordiamo l’asilo autogestito di Porta Ticinese a Milano, aperto il 12 gennaio del 1970 - non è stata figura di second’ordine nel panorama culturale italiano. Né apocalittico, né integrato Fachinelli mostrava una modalità atipica ma non esclusiva di venire ai ferri corti con le cose. Toccare il loro cuore era ben più necessario che colpire retoricamente al cuore un Moloch di per sé senza cuore.
Il «dopo», a partire dal 1967 ci consegna un Fachinelli già co-curatore della Traumdeutung freudiana per il primo volume delle Opere edite da Boringhieri. Ma a Fachinelli, nel 1965 divenuto membro della Società Psicoanalitica italiana e avviatosi alla professione di analista, non bastava l’interpretazione dei sogni. Bisognava muovere anche da un’altra urgenza: interpretare i segni. Soprattutto quando scendono in strada. Soprattutto quando più che i sogni, sono gli incubi a coprire con la loro ombra con quella cosa che - dopo il diluvio lacaniano - abbiamo persino timore di pronunciare: il reale. All’inizio del suo lavoro, Freud pose non a caso un esergo virgiliano tratto dall’Eneide, esergo che sarà sempre molto caro a Elvio Fachinelli che lo riprenderà in una memorabile puntata di Fuori Orario dove, nonostante la malattia avanzasse, continuò a tenere una rubrica fissa: «Flectere si nequeo Superos, Acheronta movebo». Se non posso smuovere i fiumi del cielo, muoverò quelli dell’inferno. In qualche modo, il rapporto col concreto e con la realtà fantasma che troppi, con l’alibi di Lacan hanno teso a ridicolizzare, era tenuto in massimo conto da Fachinelli, che al corteggiatissimo Lacan conosciuto a Roma e frequentato a Milano oppose un gran rifiuto, quando il 30 marzo del 1974 rifiutò l’investitura a presiedere la sezione italiana dell’École freudienne.
«L’incubo è reale, questa volta, ed è qui la sua importanza collettiva», scriveva Fachinelli in un testo pubblicato su L’Espresso il 7 novembre del 1971 con il titolo «Ritorno all’ordine». Parlava di un caso di cronaca, uno di quei faits divers che di lì a poco avrebbero invaso spazio e campo del sociale tutto, per non parlare del politico allora ritenuto autonomo da quel sociale. Parlava Fachinelli - ma senza la fredda anatomia del semiologo - della scomparsa di tre bambine a Marsala. Una di essere venne ritrovata morta alcuni giorni dopo, uccisa dallo zio. Ma questo si seppe solo fuori tempo massimo, dopo l’ennesima caccia al mostro. Dentro quel testo - ma si potrebbe dire in quasi tutti i sessantun articoli, interventi e microsaggi raccolti in volume - c’è già tutto. Quante volte l’abbiamo sentito dire?
 Eppure è così e c’è da rabbrividire se confrontiamo i predicozzi deglj psicotutto da tastiera con i testi raccolti in Al cuore delle cose. Scritti politici(1967-1989) (DeriveApprodi, pp. 192, euro 17), per la cura minuziosa di Dario Borso, che in tre pagine tre di introduzione riesce a spiegarci Fachinelli più e meglio di tanto inchiostro e parole spesi in forma agiografica su di lui. Articoli brevi e lunghi, interventi e interviste spesso introvabili. Ritagli di giornale che si rianimano in un’inedita e attuale cornice di senso, ben oltre l’esperienza della rivista «L’Erba voglio», fondamentale certo ma non esclusiva del suo lavoro.
Eppure è così e c’è da rabbrividire se confrontiamo i predicozzi deglj psicotutto da tastiera con i testi raccolti in Al cuore delle cose. Scritti politici(1967-1989) (DeriveApprodi, pp. 192, euro 17), per la cura minuziosa di Dario Borso, che in tre pagine tre di introduzione riesce a spiegarci Fachinelli più e meglio di tanto inchiostro e parole spesi in forma agiografica su di lui. Articoli brevi e lunghi, interventi e interviste spesso introvabili. Ritagli di giornale che si rianimano in un’inedita e attuale cornice di senso, ben oltre l’esperienza della rivista «L’Erba voglio», fondamentale certo ma non esclusiva del suo lavoro.
 Il lavoro di collazione di Dario Borso è discreto, non straripante come si conviene al filologo e alla vecchia talpa che riaffiora a prender aria solo dopo tanto scavo, e proprio per questo ancora più utile se, come si spera, finirà tra le mani anche di lettori che di quei «formidabili anni» non sono reduci ma, tutt’al più, «prodotti». Se accogliamo l’intuizione del curatore secondo cui il paziente più complicato dell’analista Fachinelli «fu l’Italia, e il trattamento più lungo fu della realtà italiana», dobbiamo anche aggiungere che Fachinelli fugge sempre dalla boria sociologica e si concentra su fatti «grandi» ma con attenzione al minuto, al linguaggio, alle piccole crepe nella grande muraglia.
Il lavoro di collazione di Dario Borso è discreto, non straripante come si conviene al filologo e alla vecchia talpa che riaffiora a prender aria solo dopo tanto scavo, e proprio per questo ancora più utile se, come si spera, finirà tra le mani anche di lettori che di quei «formidabili anni» non sono reduci ma, tutt’al più, «prodotti». Se accogliamo l’intuizione del curatore secondo cui il paziente più complicato dell’analista Fachinelli «fu l’Italia, e il trattamento più lungo fu della realtà italiana», dobbiamo anche aggiungere che Fachinelli fugge sempre dalla boria sociologica e si concentra su fatti «grandi» ma con attenzione al minuto, al linguaggio, alle piccole crepe nella grande muraglia.Borso parla non a caso di una psicoanalisi della domanda, invece che della risposta e di uno sguardo obliquo, appreso da Musatti e da Freud. Dell’Italia, «quasi fosse un quadro, seppe cogliere i particolari illuminanti, gli imprestiti da esperienze altrui, le persistenze di uno stile nell’alternarsi dei periodi: tre decenni tondi, che nella sua attività giornalistica sezionò e ricompose con sapiente tempestività». Un’attività giornalistica, disseminata non solo sulle riviste ma su quotidiani - Il Corriere della Sera, Il Giorno - su temi «caldi» come il terrorismo, Mao, le nuove droghe, la vita nelle metropoli, la mutazione dei cristianismi. Memorabile un suo ritratto, datato 1985, di Roberto Formigoni dove coglie sul nascere il «nuovo che avanza» e, dopo il 1989, si sarebbe affermato a pieno titolo nelle coscienze e in un immaginario antropologicamente mutato e sradicato persino nelle dinamiche del suo perenne mutamento.
Torniamo all’articolo pubblicato dall’Espresso. Fachinelli parla di un fenomeno che potrebbe essere dell’oggi, perché sempre l’oggi è la risultante di un processo di media o lunga durata. Se nella sfera pubblica ha spazio solo “chi lacrima e chi sanguina” come ebbe a dire un noto impresario brianzolo che di lì a poco sarebbe passato dalla speculazione edilizia a quella sull’immaginario e infine a una politica degna di Ubu, i nostri incubi privatissimi rischiano di assumere importanza collettiva e diventare tragicamente reale. Fatti su fatti, ma che cosa accade se ogni fatto - è questa la cronaca? - si inserisce «in una serie di altri fatti (politici, sociali, morali) che hanno in comune una sola cosa, ma essenziale: la circostanza di non avere soluzione, di non trovare sbocco? ». Viviamo - e non da ora - «tragedie in cui manca sempre l’ultimo atto». Incubi dove l’intensità della partecipazione collettiva consuma ogni desiderio.
 Che fare? Siamo a un bivio. Oggi più di ieri, e sono passaro 45 anni. Da una parte, scriveva Fachinelli a proposito dei fattacci di Marsala, «ci si libera dall’incubo e si va verso una realtà accettabile. Questo vuol dire, per esempio, affrontare di petto quella serie di problemi collegati che si chiamano educazione sessuale, controllo delle nascite, liber zione della donna, critica pratica dell’istituzione familiare. È la strada meno probabile. L’altra è stare nell’incubo e vederlo progressivamente crescere e proliferare dentro la vita collettiva e dentro ogni individuo». Diagnosi impeccabile sul corpo di un’Italia malata. La cronicità del suo male, i tempi lunghi dello snervamento nulla tolgono alla ludicità attualissima delle diagnosi di Fachinelli. Nella miseria di chierici asserviti al selfie, tutt’al più la confermano.
Che fare? Siamo a un bivio. Oggi più di ieri, e sono passaro 45 anni. Da una parte, scriveva Fachinelli a proposito dei fattacci di Marsala, «ci si libera dall’incubo e si va verso una realtà accettabile. Questo vuol dire, per esempio, affrontare di petto quella serie di problemi collegati che si chiamano educazione sessuale, controllo delle nascite, liber zione della donna, critica pratica dell’istituzione familiare. È la strada meno probabile. L’altra è stare nell’incubo e vederlo progressivamente crescere e proliferare dentro la vita collettiva e dentro ogni individuo». Diagnosi impeccabile sul corpo di un’Italia malata. La cronicità del suo male, i tempi lunghi dello snervamento nulla tolgono alla ludicità attualissima delle diagnosi di Fachinelli. Nella miseria di chierici asserviti al selfie, tutt’al più la confermano.-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- Elvio Fachinelli: il clinico che ridefinì l’osceno (di Pietro Barbetta)5 marzo 2016, di Federico La Sala
- PSICOANALISI E FILOSOFIA. Indicazioni per una seconda rivoluzione copernicana .....
 DAL LABIRINTO SI PUO’ USCIRE. FACHINELLI, "SU FREUD".
DAL LABIRINTO SI PUO’ USCIRE. FACHINELLI, "SU FREUD".
Elvio Fachinelli: il clinico che ridefinì l’oscenodi Pietro Barbetta ("doppiozero", 2 settembre 2015)
- Tempo fa William Buckley rimproverava Allen Ginsberg di comporre opere oscene per via del suo linguaggio; invitato a una trasmissione televisiva gestita dallo stesso Buckley, Ginsberg rispose che oscene non sono le parole, ma le morti durante l’allora guerra del Viet-Nam.
La biografia culturale di Elvio Fachinelli (1928-1989) sembra una genealogia Biblica. Il suo analista fu Cesare Musatti (1897-1989), il quale - considerato uno dei Padri della psicoanalisi italiana - si formò con Edoardo Weiss (1889-1970), il primo psicoanalista italiano. Weiss era, a sua volta, in supervisione dallo stesso Sigmund Freud. Nonostante le sue origini nobili e ortodosse, Fachinelli fu tra gli psicoanalisti che più cambiarono la psicoterapia in Italia.
In primo luogo rifiutò l’idea di “resistenza del paziente” a favore dell’accoglienza della “persona che frequenta l’analisi”, spostando la responsabilità della terapia sull’"esperto”. Negli anni Settanta nacque e si diffuse la strana idea che se c’è fallimento nella relazione tra il professionista e il suo utente, la responsabilità è del professionista, non dell’utente. Per esempio, se un tempo una persona moriva legata a un letto, si attribuiva la morte alla furia della persona. Basaglia per primo ebbe l’idea di invertire l’ordine delle responsabilità nei manicomi. Don Milani invertì l’ordine delle responsabilità nelle scuole. Lo stesso Fachinelli contribuì, con altri autori, a fondare una scuola libera, nell’epoca in cui veniva messo in discussione il ruolo dell’insegnamento. C’erano assonanze tra queste imprese. Quel che si ricorda meno di Fachinelli è il suo modo di ripensare il settting clinico, i limiti discorsivi e le pratiche inscritte in quel setting, la sua parte oscena.
Lo fece prima di quando Foucault pubblicò La volontà di sapere, nel novembre 1976. Foucault aveva indicato la psicoanalisi come luogo dove il desiderio incestuoso si trasforma in discorso, trattamento riservato alle élite borghesi, costantemente occupate a gestire perversioni e sentimenti di colpevolezza. Fachinelli aveva posto la medesima questione in modo ancor più radicale. A una conferenza nel 1975, parlando del Denaro dello psicoanalista, aveva contrapposto il contratto terapeutico classico - che vede il paziente nevrotico parlare di avversioni sessuali, ossessioni, manie e fissazioni - a un contesto sociale ampio, dove i soggetti possono raccontare storie di vita, di salari, politica, religione, lavoro, famiglia.
- “Nell’analisi - scriveva Fachinelli - qualcuno, l’analista, offre a pagamento una prestazione, un servizio, un’assistenza, chiamatelo come volete, qualcosa che nella sostanza è dell’ordine del lavoro, mentre qualcun altro, l’analizzando, chiede contro denaro qualcosa che è sempre nell’ordine di eros e della sua storia”.
Più tardi, in Claustrofilia, Fachinelli tornò su questi argomenti sviluppando nuove critiche al setting clinico. Una ricerca intorno ai termini “onorario” e “salario” gli aveva fatto scrivere che il termine “onorario” è, nell’uso tradizionale, somma una tantum, pagata dal soggetto che riceve il servizio, al professionista che onora l’impegno. “Salario” - che deriva dalla rata di sale ricevuta dal soldato durante l’Impero Romano - è una quota fissa di denaro pagata ai lavoratori nella moderna civiltà delle macchine. Con l’introduzione su larga scala delle prime generazioni di macchine, le “mansioni” dell’operaio addetto si modificarono rispetto all’attuazione di un compito preciso e ben definito. Si spostarono verso la sorveglianza del lavoro fatto dalle macchine, che a sua volta era ripetitivo, sempre uguale, con pochi “tempi morti” e così via. Ora, è del tutto notevole che Freud, passando al tipo definitivo di psicoterapia, sia andato incontro, senza esserne consapevole, a modificazioni analoghe della sua attività [...] In questo senso l’attività psicoterapeutica [...] diventa per la prima volta nella storia un lavoro proto-industriale, dove il “lavoro” è formalmente separato dalla “vita”, ma dove la “vita” è inglobata dal “lavoro” [...] la costanza del tempo macchinico si riflette in una durata programmaticamente indefinita del “trattamento”. Eliminando i “tempi morti” viene eliminata tendenzialmente anche la morte (cfr. pp. 24-25).
Gravi colpi, questi, inferti al setting clinico, di cui nessuno sembra ricordare: 1. critica radicale al concetto di “resistenza” e conseguente uso dell’accoglienza come responsabilità del terapeuta; 2. critica a un setting che paragona a quello della prostituta: scambio di denaro, nell’ordine del lavoro, in cambio di discorsività relegata all’ordine dell’eros; 3. critica alla posizione dell’analista che inverte, nel contratto, l’onorario con il salario: il salario si presenta nella forma di onorario ripetuto.
In un saggio che oggi appartiene alla raccolta Su Freud (Adelphi), Fachinelli ricorda che già il fondatore della psicoanalisi aveva affrontato la questione dell’assistenza psicologica gratuita agli indigenti, cambiando parere - da negativo a positivo - a proposito dell’impegno dell’Imperatore d’Austria a fornire consulenza psicologica gratuita ai poveri. Insomma, critica radicale all’invenzione americana di fare degli psicoanalisti dei signorotti con lo studio al ventesimo piano di un grattacielo di New York e delle assistenti sociali delle antipatiche signore che rubano i bambini ai poveri, insegnano loro come tenere un’agenda e a smettere di bere, i cosiddetti social skills.
Nel 1977 l’Erba voglio pubblicò L’uomo col magnetofono di Jean-Jacques Abrahams. Di questo Abrahams poco si conosce, un po’ come di Louis Wolfson, caso analogo e compresente sulla scena intellettuale francese di quegli anni. Abrahams accese l’attenzione degli intellettuali parigini, in particolare di Jean-Paul Sartre, inviandogli un nastro registrato, che il filosofo pubblicò nel 1969 su Les Temps Modernes, contro il parere di Pontalis e Pingaud. L’homme au magnetophone, questo il titolo della registrazione, si trasformò in una pièce teatrale e poi in un libro. Audace trascrizione di una conversazione tra Abraham e il suo psicoanalista che, dopo anni di terapia, lo fece internare. Secondo alcune leggende, non si sa quanto attendibili, Abraham evase dal manicomio di Brugman e fuggì negli Stati Uniti, ove pubblicò un testo dallo stesso titolo, L’homme au magnetophone, per le Sagittaire, un anno prima della pubblicazione italiana dell’Erba voglio. Alcune voci sostengono addirittura che lo psichiatra in questione fosse Jaques Lacan, altre smentiscono.
Di fronte allo scandalo Abraham, molti intellettuali e psicoanalisti reagirono con sdegno, primi fra tutti Pontalis e Pingaud, condannando l’invasione dello studio clinico come oscenità e molestia. Fachinelli, in modo altrettanto osceno, individuò invece nel magnetofono di Abraham un nuovo strumento democratico e l’opera di Abraham come ribellione contro l’asimmetria del potere psicoanalitico e il tradimento di un clinico che, durante la psicoterapia, ti fa internare in manicomio. Non molti anni dopo a Milano, altri psicoanalisti - Selvini, Boscolo, Cecchin - useranno la videoregistrazione come strumento costitutivo del setting terapeutico familiare. Fachinelli si era preoccupato di trasformare l’alienazione, nascosta dietro l’asimmetrica relazione tra terapeuta e paziente, in reciprocità e accoglienza. Ripartì dalle critiche di Ferenczi, insabbiate per anni dalle associazioni psicoanalitiche.
Il suo punto di vista si mostra oggi come decostruzione sociale del setting, come se la psicoanalisi avesse bisogno di essere liberata da un rigore che rasenta l’ossessione e il paziente diventasse un libero “soggetto che frequenta la terapia”. Il ruolo delle due parti va trasformato, per Fachinelli, da asimmetrico in reciproco. Il giovane paziente anancastico, proveniente dalla famiglia della classe dominante milanese, che obbliga la sorella a coprirsi le orecchie coi capelli, affinché non gli provochi crisi di angoscia, viene sostituito dal giovane povero, che vive nelle case popolari di Quarto Cagnino. Quest’ultimo semplicemente molesta la sorella perché costretto a dormire nella stessa camera con lei in uno spazio di 4 metri quadri. Che il primo continui a frequentare il suo analista imperialregio, a Fachinelli interessava poco. Assai di più il secondo. Forse è arrivato il momento di smettere di trattare Elvio Fachinelli “come un cane morto” e riscoprire davvero le sue posizioni radicali.
*
Leggi anche su doppiozero:
Mario Porro, Elvio Fachinelli. Su Freud
- PSICOANALISI E FILOSOFIA. Indicazioni per una seconda rivoluzione copernicana .....
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- IL PUTTANESIMO DELLO SPIRITO. Cacciari: "Sul concetto di fedeltà, dibattito fra ubriachi" (di Annalisa Cuzzocrea))26 febbraio 2016, di Federico La Sala
Cacciari: "Sul concetto di fedeltà, dibattito fra ubriachi"
Il filosofo: "Una piccola grande vergogna, una scelta che fa vomitare. Qualsiasi relazione, una coppia di qualsiasi genere che decide di sposarsi, accede a un rito che ha i suoi valori simbolici e che esiste da decine di migliaia di anni. Non è una questione che si possa liquidare come ha fatto il Parlamento"
di ANNALISA CUZZOCREA (la Repubblica, 25 febbraio 2016)
ROMA - «Una piccola grande vergogna». Questo pensa, Massimo Cacciari, del modo in cui il concetto di fedeltà è finito nel dibattito sulle unioni civili. Svilito del suo significato più profondo. Usato come un dispetto della politica da coloro che hanno voluto sottrarre l’obbligo di fedeltà ai gay che decidono di sposarsi. E come una ripicca insensata da chi ora propone di levarlo anche al matrimonio, ritenendolo desueto e ancorato a un passato che non c’è più. «È la vergogna di un istituto da cui traspare lo spirito del mondo in cui stiamo vivendo. Uno spirito misero, che mi fa orrore», dice il filosofo.
Professor Cacciari, ha senso consentire le unioni gay eliminando l’obbligo di fedeltà?
«È allucinante che si parli di queste cose con tale leggerezza. La fedeltà è un argomento serissimo di cui queste persone neanche capiscono il significato, il termine, l’etimo. Questa cosa che venga considerata un elemento di sacralizzazione del matrimonio per gli eterosessuali e - al contrario - un optional per gli omosessuali che decidono di costituire una famiglia, fa vomitare».
Alcuni parlamentari del Pd propongono che l’obbligo sia tolto anche dalle norme che regolano il matrimonio. Che ne pensa?
«Va bene. Di fronte a puttanate si risponde con battute. Come tra ubriachi. Questo mi sono sembrati i dibattiti di questi giorni al Senato: discussioni tra ubriachi».
Ma non crede che l’obbligo di fedeltà possa essere considerato il retaggio di una mentalità superata, di un mondo diverso da quello di oggi?
«Sono questioni che non riguardano solo le leggi. Quando quelle norme sono state scritte penso che i politici si rendessero conto del significato del termine fedeltà. Qualsiasi relazione, una coppia di qualsiasi genere che decide di sposarsi, accede a un rito che ha i suoi valori simbolici e che esiste da decine di migliaia di anni. Questo è un fatto molto importante che impegna, che responsabilizza. Un Parlamento che si mette a giudicare queste cose con siffatta faciloneria è incomprensibile. Potrei parlare a lungo del significato e del valore della fedeltà, ma avrei bisogno di 50 pagine. Non è un tema che possa essere trattato in questo modo».
-
>IL PUTTANESIMO DELLO SPIRITO - UNIONI CIVILI. Perché non ho votato una legge monca. Cancellazione, nel testo approvato, del «dovere di fedeltà» (di Luigi Manconi)26 febbraio 2016, di Federico La Sala
Perché non ho votato una legge monca
di Luigi Manconi (il manifesto, 26.02.2016)
Non ho partecipato al voto sulla questione di fiducia, posta dal governo sul disegno di legge Cirinnà. Questo è il motivo. Un provvedimento che aveva come motivo ispiratore il principio di non discriminazione rischia di introdurre, con lo stralcio della norma sulle adozioni, un’illegittima disparità di trattamento. Non tanto e non solo tra coppie eterosessuali e coppie omosessuali, quanto tra figli adottandi di coppie eterosessuali e di coppie omosessuali.
Ritengo, cioè, che dallo stralcio della norma sulle adozioni derivi una legge monca, tale da neutralizzare il valore profondo dell’unione civile e ridurla a mero sistema di garanzie economiche e sociali: un contratto privato. E ciò in cambio della rinuncia al suo riconoscimento giuridico-morale. Il che risulta confermato dalla cancellazione, nel testo approvato, del «dovere di fedeltà», quasi che venisse esclusa la dimensione affettiva del rapporto.
Una disciplina che riconosca le unioni civili tra persone dello stesso sesso avrebbe dovuto rispondere, appunto, al principio di non discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale, come chiarito anche dalla Corte europea dei diritti umani. Questo vincolo impone, tra l’altro, di applicare la disciplina prevista per l’adozione del figlio del partner a prescindere dall’orientamento sessuale di quest’ultimo, valutandone esclusivamente l’idoneità a svolgere la funzione genitoriale e la qualità del legame stabilito con il bambino, a tutela del superiore interesse di quest’ultimo. E’ quanto ha riconosciuto la giurisprudenza, negando che il carattere omosessuale della coppia possa di per sé determinare alcun pregiudizio alla qualità delle relazioni instaurate con il minore e, quindi, rappresentare un elemento ostativo all’applicazione della disciplina generale. Chi abbia instaurato con il minore un legame importante, in virtù della convivenza con l’altro genitore, non può essere considerato, insomma, al pari di qualunque altro estraneo, solo perché omosessuale. La norma stralciata del disegno di legge si limitava a rendere diritto positivo quanto la giurisprudenza prevalente ha già riconosciuto. Espungerla dal testo ha significato demandare ancora una volta alla mutevolezza degli orientamenti giurisprudenziali il riconoscimento del diritto del minore a veder legittimato un rapporto essenziale per la sua crescita, sottraendolo al limbo giuridico che altrimenti lo caratterizzerebbe.
Si è trattato, in altre parole, di una scelta conservatrice, che ha subordinato il superiore interesse del bambino a una presunzione, indimostrata e discriminatoria, di inidoneità della persona omosessuale a crescere un figlio. E non è nemmeno ragionevole ipotizzare che, negando l’adozione coparentale, si ottenga il risultato non voluto di disincentivare la surrogazione per altri. Anche a non distinguere i casi, tutti particolari, della surrogazione per mera gestazione (in cui gli ovuli della madre sono impiantati nell’utero altrui, così da mantenere il legame genetico) e della surrogazione altruistica (che esclude ogni possibile sfruttamento della gestante), si può davvero negare al bimbo già nato da gestazione per altri il diritto al riconoscimento del rapporto con il genitore “sociale”?
Queste alcune delle questioni che la normativa approvata ignora o liquida sbrigativamente e negativamente. Ed è la ragione per la quale che non ho sostenuto il disegno di legge Cirinnà nella sua nuova versione e non ho votato la fiducia. Si aggiunga ciò che in apparenza può sembrare un dettaglio: dal testo, come ho anticipato, è stato espunto il riferimento all’«obbligo di fedeltà» perché, si è detto, assimilerebbe le unioni civili all’istituto del matrimonio.
Qui davvero lo spirito vacilla. È chiaro che emerge un rimosso particolarmente cupo e ingombrante. Un conto sarebbe stato eliminare l’obbligo di fedeltà per qualunque vincolo di coppia, un conto ben diverso è cancellarlo per le sole coppie omosessuali. Comunque la si metta, e qualunque affinità col matrimonio possa paventarsi, dietro c’è un pregiudizio grande come una casa: l’omosessuale è considerato, per natura e vocazione, persona dissoluta («tan’è vero che è omosessuale»), incapace di impegno reciproco, monogamia e, dunque, fedeltà. Un porcellone, insomma (due o più porcelloni) cui attribuire alcune garanzie economiche e sociali, ma non certamente il riconoscimento giuridico-morale di un’unione civile, dotata di pienezza di diritti e di pari dignità.
Non si avverte, in ciò, l’eco di una irriducibile omofobia?
-
> IL PUTTANESIMO DELLO SPIRITO - UNIONI CIVILI. --- UN BRUTTO PRIMO PASSO. Aveva visto giusto Antonio Gramsci (di Nadia Urbinati)28 febbraio 2016, di Federico La Sala
Unioni civili, un brutto primo passo
Diritti. Aveva visto giusto Antonio Gramsci: il problema della debolezza liberale in Italia sta nella presenza non tanto del cattolicesimo ma del Vaticano e del suo grande potere di veto
di Nadia Urbinati (il manifesto, 27.02.2016)
Sì, vi è da rimanere delusi per l’incapacità dei nostri rappresentanti di andare oltre gli ostacoli del pregiudizio; per l’incapacità di osare di sentirsi davvero liberi legislatori che rispondono alla richiesta di eguali diritti che viene dal paese. E vi è di che rammaricarsi che il Pd sia così miscellaneo sui valori fondamentali (una tara che si porta dietro fin dalla nascita) da essere incapace di approdare a una decisione unanime, dando l’impressione che si tratti di due partiti in uno più che di un partito con visioni plurali.
Il bisogno di bussare alla porta di Verdini è da solo una dichiarazione di impotenza e pochezza. E c’è di che inquietarsi per la massiccia e nemmeno velata interferenza del clero romano con le istituzioni dello Stato. Aveva visto giusto Antonio Gramsci quando scriveva che il problema della debolezza liberale del nostro paese sta nella presenza non tanto del cattolicesimo ma del Vaticano.
La cattolicissima Irlanda è molto più libera nelle sue leggi della meno religiosa Italia. Il Vaticano ha un potere di veto che non deve essere sottovalutato mai. E per questo, avere una legge zoppa è un meno peggio. Ma sarebbe auspicabile non viverla come punto di arrivo e quindi come una sconfitta, ma invece trasformarla in un punto di partenza. Come punto di arrivo è semplicemente brutta e vergonsosa. Ma ci sono buone ragioni per cercare di verderla come punto di partenza.
La prima ragione sta nella natura stessa dei diritti - che aprono molte più strade di quel che una timidissima legge non faccia apparire. Una volta aperta la porta nessuno, nemmeno i prelati e i loro rappresentanti nelle istituzioni dello Stato, potranno chiuderla. I diritti vengono a grappolo e la vita delle persone si imporrà. La forza del diritto sarà la forza della vita.
Questa legge brutta e zoppa sulle unioni civili verrà usata subito (per esempio per risolvere il problema lasciato aperto delle adozioni) e subito mostretà la propria insufficienza, la necessità di modificarla. Le maggioranze in Parlamento non possono fermare il torrente della vita che segue la libera scelta delle persone. Il diritto è ben oltre questa legge e sfiderà questa legge. La quale quindi è solo un brutto e timidissimo primo passo, ma non può essere nè sarà l’ultimo.
La seconda ragione è più radicale e la si è toccata con mano nella discussione sulla maternità surrogata. La violenza della discussione alla quale abbiamo assistito ci deve far riflettere sull’opportunità che lo Stato non intervenga. E’ buona norma di un ragionevole liberalismo che quando si tratta di decisioni che coinvolgono valori e concezioni del bene è preferibile che la legge non intervenga fino a quando non si sia raggiunta una convergenza larga nella cultura morale della società. Ma fino a quando ci sono divisioni forti sui valori sarebbe meglio che la legge tacesse poichè non potrebbe evitare di essere ingiusta. Questo vale naturalmente per la maternità surrogata. Abbiamo già leggi che proteggono le persone e i minori dall’abuso, dalla mercificazione, dalla monetarizzazione - se non si dà reato o violazione dei diritti umani e delle norme che li proteggono, la legge dovrebbe tacere. Questo non può ovviamente valere per le unioni di coppia, poichè in questo caso l’esistenza dell’istituto del matrimonio rende fondamentale che la legge intervenga per regolamentarne l’estensione o la parificazione nei casi di unione tra non eterosessuali.
La terza ragione pertiene alla funzione liberatoria del diritto, ovvero alla ricchezza per tutti che il rispetto degli eguali diritti comporta e corporterà. La discussione al Senato ha mostrato l’assurdità di chi voleva servirsi della “fedeltà” per discriminare tra il “vero” matrimonio e le unione civili. Si pensava cioè di nobilitare il matrimonio degli eterossesuali attribuendo solo ad esso l’obbligo della fedeltà. Il paradosso è che la discussione ha dimostrato che sarebbe desiderabile che l’obbligo di fedeltà venisse a cadere anche per il matrimonio. L’esito di quella che è stata a tutti gli effetti un’intenzione discriminatoria si è rovesciato e ha mostrare quanto invadente e anacronistica e corcitiva sia la legge che regola il matrimonio degli eterosessuali. La maggioranza ha tutto da guardagnare dall’eguale diritto, dall’inclusione della minoranza. Le unioni civili tra persone dello stesso sesso possono costituire un arricchimento di libertà per tutti.
Queste ragioni delle implicazioni positive non rendono comunque buona una legge che non è buona. Mostrano tuttavia che da questo momento si può aprire un nuovo spazio di libertà - o meglio ancora, uno spazio alla contestazione e alla lotta per estendere e perfezionare il diritto all’eguaglianza che tutti devono avere di godere degli stessi diritti.
-
-
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! DENTRO LA PIU’ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA E POLITICA --- Fare impresa per creare valori. In Vaticano, seminario di Confindustria (di Gianferanco Ravasi).24 febbraio 2016, di Federico La Sala
- CATTOLICESIMO (E CRISTIANESIMO) OGGI, 2012: LA CATTEDRA DI SAN PIETRO UNA CATTEDRA DI ECONOMIA POLITICA. Tutti a scuola in Vaticano, per aggiornamenti. Materiali per approfondire
L’Industria incontra il Santo Padre
Il prossimo 26 febbraio, in Vaticano nel Centro congressi Augustinianum, è in programma il Seminario di Confindustria «Fare insieme»
Fare impresa per creare valori
Il prossimo 26 febbraio, in Vaticano nel Centro congressi Augustinianum, è in programma il Seminario di Confindustria «Fare insieme»
di Gianfranco Ravasii (Il Sole-24 Ore, 24 febbraio 2016)
«Viviamo in un’epoca in cui alla bulimia dei mezzi corrisponde l’atrofia dei fini». Lapidaria ma incontestabile, questa asserzione del filosofo francese Paul Ricoeur delinea uno dei rischi maggiori della società contemporanea. Da un lato, infatti, mai come oggi abbiamo a disposizione un paniere sterminato di informazioni e di dati attraverso la comunicazione digitale. Mai come ora la scienza, accompagnata dalla tecnologia, ci offre una strumentazione efficace nella ricerca fisica, medica, industriale. Mai come in questo tempo la finanza stende una rete, spesso impalpabile, avvolgendo e talora strangolando il nostro globo. Mai come ai nostri giorni le distanze s’accorciano e persino svaniscono, permettendo un rimescolamento di etnie e culture.
D’altro lato, però, a questa indubbia e pur importante “bulimia” operativa corrisponde un’anoressia di valori, di interiorità, di significato, di etica. La massa delle risposte strumentali non riesce a evadere le domande esistenziali che, purtroppo, si affievoliscono nelle coscienze fino a estinguersi. Un altro filosofo, il danese Soeren Kierkegaard, già nell’Ottocento rappresentava simbolicamente questa situazione: «La nave è in mano al cuoco di bordo e ciò che trasmette il megafono del comandante non è più la rotta ma ciò che mangeremo domani».
L’apparente ottimismo versato a piene mani dalla scienza e dalla comunicazione di massa non riesce, comunque, a nascondere il groviglio di contraddizioni in cui ci dibattiamo. Il sudario di sangue delle guerre, la disperazione degli esodi di massa, la devastazione ambientale, il colossale divario tra ricchi e poveri, l’anelito dei popoli affamati, le ingiustizie sociali sempre più marcate, l’impennata della disoccupazione, gli squilibri culturali, i fondamentalismi religiosi continuano, infatti, ad artigliare le coscienze e le esistenze personali e comunitarie, distratte e superficiali, e riescono a interpellare tutta la piramide della società, dal vertice politico ed economico fino alla base popolare.
Per questo l’impresa italiana ha voluto consacrare una giornata di studio e di testimonianza nel tentativo di risvegliare e rinvigorire l’impegno comune ad opporsi a questa turbolenza che agita il nostro pianeta sempre più globalizzato eppure altrettanto frazionato. Gli imperativi per edificare un ethos comune che affronti questo orizzonte complesso e complicato sono quelli di sempre ma devono essere declinati con nuovi accenti, liberandoli dagli stereotipi vagamente moraleggianti: la giustizia, la libertà, la dignità della persona, la solidarietà, la conoscenza e l’istruzione, la responsabilità e i diritti individuali e sociali, il lavoro, la fede autentica e la morale. Queste e altre parole di vita sono state annodate sotto un denominatore comune che ha dato il titolo al convegno, il fare insieme.
Ora, questo verbo, che in quasi tutte le civiltà è il più generico per classificare ogni tipologia di azione, nella nostra lingua è basato su una radice indoeuropea che significa “mettere, fondare, posare” e rimanda quindi a una costruzione. Il verbo “fare” è, poi, contenuto in molti altri termini italiani, tra i quali brillano l’“affetto” e il “difetto”.
Sono un po’ i due volti estremi del “fare”, quello luminoso e appassionato della dedizione e quello del limite e dell’imperfezione: le mani che operano possono, infatti, stringersi e procedere “insieme”, ma possono anche rinchiudersi a pugni. Ecco perché è necessario coniugare il verbo “fare” con l’avverbio “insieme” che ha etimologicamente alla base l’aggettivo “simile”. È, quindi, la riscoperta della comune umanità e fraternità, l’essere tutti “figli di Adamo”, prima che essere segnati da altri connotati etnici, storici, culturali e sociali.
Dobbiamo ribadire, come suggeriva un altro filosofo francese, Emmanuel Lévinas, l’importanza del volto, dello sguardo reciproco, del dialogo. Visto da lontano un altro può sembrarci una bestia o un predatore; di fronte rivela, invece, quella costante umanità che tutti ci unisce per cui, come dice un proverbio orientale, il boia non guarda mai negli occhi la sua vittima. Ora, nel “fare”, un aspetto capitale è certamente quello del lavoro. Lo afferma in modo radicale la stessa Bibbia, che è pur sempre “il grande codice” della nostra civiltà occidentale: «Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino perché lo coltivasse e lo custodisse» (Genesi 2,15).
Certo, come diceva Pavese, «lavorare stanca»: non per nulla il latino labor, da cui deriva il nostro “lavoro”, significa “fatica” e “dolore”, e in francese e spagnolo il “lavoro” è travail e trabajo. Tuttavia l’uomo che è inerte o paralizzato o disoccupato sente una ferita nell’anima. Per questo “fare insieme” è costruire un mondo diverso nella giustizia e nella fraternità ma è anche creare concretamente le condizioni perché tutti possano operare con le loro mani e la mente, “coltivare e custodire” il mondo e sviluppare la loro stessa esistenza personale e sociale. Per questo affidiamo l’ultima considerazione a Primo Levi, uno scrittore che al lavoro operaio ha dedicato un romanzo dal titolo emblematico, La chiave a stella (1978), e che così ci esorta: «Se si escludono istanti prodigiosi e singoli che il destino ci può donare, l’amare il proprio lavoro (che purtroppo è privilegio di pochi) costituisce la migliore approssimazione della felicità sulla terra: ma questa è una verità che non molti conoscono».
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- L’antropologa scomoda: Addio a Ida Magli, antropologa controcorrente.23 febbraio 2016, di Federico La Sala
Addio a Ida Magli, antropologa controcorrente
Aveva 91 anni, autrice del longseller ’Gesù di Nazareth’
di Redazione ANSA ROMA *
(ANSA) - ROMA, 21 FEB - E’ morta oggi nella sua casa a Roma, a 91 anni l’antropologa e scrittrice Ida Magli, l’autrice di ’Matriarcato e potere delle donne’ e del longseller ’Gesu’ di Nazareth -Tabu e Trasgressione. Lo annuncia lo scrittore Giordano Bruno Guerri, vicino alla famiglia dell’antropologa. Presidente della Fondazione del Vittoriale, Guerri nel 2015 la premiò con l’ultimo riconoscimento, ’Il Premio Vittoriale’ ricevuto dalla Magli per "il suo prezioso contributo di scrittrice e intellettuale della scena letteraria".
"E’ morta a casa sua, serena e lucida accanto al figlio. Si era rotta il femore alcune settimane fa. L’intervento era andato bene ma era molto depressa perchè pensava di non poter essere più indipendente" spiega Giordano Bruno Guerri che con lei scrisse anche un libro intervista nel 1996 ’Per una rivoluzione italiana’ (Baldini&Castoldi). La Magli, nata a Roma, nel 1925, aveva finito di scrivere un nuovo libro: ’Figli dell’uomo: Storia del bambino, storia dell’odio’ che dovrebbe uscire per la Bur.
* ANSA, 21 febbraio 2016 23:28
Ida Magli
L’antropologa scomoda
Ritratti. È morta a 91 anni Ida Magli. Scrisse testi fondamentali sul matriarcato, la sessualità, l’iconografia della Madonna e la storia laica delle donne religiose. Negli ultimi anni, aveva radicalizzato il suo pensiero, abbracciando posizioni reazionarie
di Alessandra Pigliaru (il manifesto, 23.02.2013)
Figura controversa e complessa del panorama italiano, l’antropologa e scrittrice Ida Magli è scomparsa a Roma all’età di 91 anni. Per chi ne abbia letto i numerosi testi, in particolare quelli pubblicati tra la fine degli anni Settanta e gli inizi degli anni Novanta, dedicati ad argomenti liminari al femminismo - è difficile individuare la ragione che, negli ultimi venti anni, l’ha spinta verso un passo reazionario. Sarebbe tuttavia riduttivo collocarla alla svelta nella deriva antieuropeista che in tempi recenti ha abbracciato anche se, in tutta onestà, potrebbe essere questo uno dei motivi che l’ha resa poco attraente soprattutto alle generazioni di giovani studiose che, con i testi, si confrontano.
Ma per capirne il quadro completo e l’eredità che ha lasciato a chi si misura con i senso parlante dei testi, bisogna fare un necessario passo indietro, ne sono convinte in molte che di Magli hanno ascoltato quelle mirabili lezioni di Antropologia culturale alla Sapienza di Roma fino al suo pensionamento nel 1988.
Tra quelle allieve spicca Loredana Lipperini che, quando la notizia della scomparsa della professoressa Magli è stata diffusa, ha affidato ai social network parole tanto affettuose quanto colme di gratitudine per averle insegnato una curvatura dello sguardo ineguagliabile. Ed è forse su questo che ci si potrebbe soffermare, non per espungere i testi dal portato biografico ma per evitare di renderla una intellettuale rubricata semplicisticamente e rapita dalle destre; perché cioè le vada riconosciuto ciò che ha fatto, ovvero individuare alcuni elementi essenziali e spesso scomodi al dibattito antropologico e femminista contemporaneo e che poi hanno retto la parte centrale della sua esistenza.
In realtà, la storia tra Ida Magli e il femminismo è stata piuttosto intermittente, e questo nonostante abbia avuto da sempre il chiaro desiderio di seguirne il passo a giudicare dai passaggi che le sono stati cari.
Basti pensare a volumi come Matriarcato e potere delle donne (1978), in cui compaiono alcuni passi sulle società matriarcali e una inedita traduzione del poderoso testo Das Mutterrecht di Bachofen. Solo due anni prima, aveva fondato la storica rivista dwf.
È del 1982 La femmina dell’uomo e poi c’è lo studio in cui si concentra su Santa Teresa di Lisieux. Una romantica ragazza dell’Ottocento (1994), quello su La Madonna (1987), fino a un’interessante edizione aggiornata, dieci anni dopo, La Madonna, dalla Donna alla Statua; cruciale è stato La sessualità maschile (1989) e il suo studio sulla Storia laica delle donne religiose (1995).
Insieme ai testi forse più conosciuti vi è stato l’impegno costante verso l’antropologia che ha percorso sempre con disinvoltura e originalità di posizioni. È suo il più generale manuale di Introduzione all’antropologia culturale (1983) così come si deve a lei la fondazione e direzione (dal 1989 al 1992) della rivista Antropologia culturale.
Il nodo sessualità-religione è stato per Magli uno dei più frequentati, là dove entrambi i punti sono stati sempre interpretati con una certa ritrosia anche nella discussione politica pubblica.
Ida Magli in realtà, come ricorda Lea Melandri, che abbiamo raggiunto per telefono, è stata precorritrice lucidissima di alcuni snodi fondamentali: «Certo, non si può leggere solo parzialmente, bisogna guardarla nel suo intero e in quanto è stata capace di offrirci alla lettura. È rimasta sempre abbastanza in disparte, ma il femminismo l’ha intersecato; forse non è stata così riconosciuta come avrebbe meritato, e molto ci possono raccontare ancora i suoi libri; vi sono per esempio frammenti folgoranti, coraggiosi che mettono in chiaro alcuni aspetti forti: sessualità, immaginario e fantasie maschili sui corpi delle donne e il grande nodo religioso».
Melandri prosegue citando alcuni passaggi cruciali, per esempio quelli che attengono il corpo delle donne, la sessualità e il potere che disciplina i corpi fino a diventare violenza.
Su quest’ultimo punto, infatti, anche la stessa attenzione di Melandri si è soffermata. «Ho letto e riletto alcuni suoi frammenti perché penso ci siano preziosi. Non sono stati mai scontati e andrebbero ascoltati. Ma penso anche alla lezione sulla storia laica delle religiose, un lavoro straordinario che andrebbe accolto con maggiore generosità».
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- Ida Magli, antropologa controcorrente. Un ricordo-omaggio di Loredana Lipperini24 febbraio 2016, di Federico La Sala
Ida Magli, antropologa controcorrente.
Un ricordo-omaggio di Loredana Lipperini:
"Come fosse ieri. Una voce sottile, modi gentili, una donna piccolina, un’aula universitaria piena di sole. Frase dopo frase, ci insegnava a temere gli stereotipi, le frasi fatte, le prese di posizione scontate. Ai tempi, le femministe facevano i girotondi? E lei ci raccontava i pericoli di usare il simbolo (il cerchio) senza conoscerne il significato. Perché usando i simboli si viene usate, diceva, e qualsiasi conquista sociale, senza mutare i simboli, rifluisce via come acqua. Era il 1980. Era scomoda. Era attenta. Qui, per dire, Ida Magli mette in guardia, anche, dall’utopia di Gilania - Sotto le vesti della Dea (dal suo profilo "fb". 21.02.2016)
-
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA E A PENSARE BENE "DIO", "IO" E "L’ITALIA", CHI PIU’ CHI MENO, TUTTI VIVONO DENTRO LA PIU’ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA E POLITICA ITALIANA, NEL REGNO DI "FORZA ITALIA"!!! Un’inchiesta e una mappa di Francesco Tomatis - a cura di Federico La Sala9 febbraio 2016In proposito suggerirei anche il saggio sul festival di filosofia (nel testo definito come festival di misosofia, ossia "nemico della filosofia") qui di seguito.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA E A PENSARE BENE "DIO", "IO" E "L’ITALIA", CHI PIU’ CHI MENO, TUTTI VIVONO DENTRO LA PIU’ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA E POLITICA ITALIANA, NEL REGNO DI "FORZA ITALIA"!!! Un’inchiesta e una mappa di Francesco Tomatis - a cura di Federico La Sala8 febbraio 2016, di Federico La Sala
Riflessioni (in)attualiUno sguardo psicoanalitico sulla vita comune
L’ARROGANZA INCOMPIUTA DELL’OCCIDENTE
di Sarantis Thanopulos (PSYCHIATRY ON LINE 8 febbraio 2016)
La decisione del governo di Danimarca, condivisa dalla maggioranza dei danesi, di confiscare ai rifugiati i loro beni superiori al valore di circa 1350 euro, come contributo alle spese del loro mantenimento, qualche senso di colpa l’avrà provocato anche tra i suoi sostenitori.
Tuttavia, i sensi di colpa si inchinano sempre alla “forza maggiore” (le reazioni impulsive alle difficoltà) e sono assai utili nell’arredo dell’auto-assoluzione: se si diventa inumani per “necessità”, si torna umani con un po’ di dolore. Se le ferite che infliggiamo ai più deboli, sfociassero dentro di noi in un senso di vergogna, invece che di colpa, le cose nel mondo andrebbero meglio.
La vergogna è la trasformazione della ferita dell’altro in ferita del nostro amor proprio: ci umilia la sua umiliazione. L’incapacità di vergognarsi, di cui diamo prova ampia, è coperta con un principio considerato di buon senso: si deve rispettare la casa di cui si è ospiti perché l’ospitalità possa essere offerta. Questo non è chiaro come possa valere quando le relazioni di scambio e di buon vicinato sono sconvolte e mentre la casa gli uni la mantengono, gli altri l’hanno perduta. Le regole della buona educazione e del rispetto reciproco non valgono, quando le loro premesse sono sconvolte.
Gran parte dell’Occidente è tentata a far sentire la voce del padrone con i suoi ospiti: “A casa mia comando io”. Sennonché, le regole di gestione della propria casa non sono più valide, se cambia rapidamente la composizione di chi la abita e diventa anche confusa la distinzione tra interno e esterno. In queste condizioni, l’unica alternativa al caos e all’arbitrio è il principio della fraternità universale: tutte le persone sono pari sul piano del desiderio, indipendentemente dalla loro differenza sul piano dei bisogni, delle capacità fisiche e mentali, del sesso, delle scelte sessuali, della cultura, della religione e della concezione del mondo.
Ogni conflitto, derivante dalla differenza, può essere realmente risolto solo all’interno di questa prospettiva, che vede la differenza come condizione della persistenza e dell’appagamento del desiderio.
La differenza ci fa confliggere ma ci fa anche sentire desideranti e vivi.
A due condizioni:
a) che la differenza non sia confusa con l’estraneità, quando il più forte annienta il più debole che gli attraversa la strada;
b) che la differenza identitaria dell’uno non domini quella dell’altro, trasformando la loro coesistenza in annessione e sfruttamento. In entrambi i casi, la differenza di fatto svanisce: essa non ama la supremazia dell’uno sull’altro; cresce nell’eguaglianza.
L’occidente è convinto della supremazia dei suoi valori. La sua autoreferenzialità è contraddetta dal fatto che i valori fondamentali, dai quali emanano tutti gli altri (se non sono funzioni normative, strumentali), sono espressione della materia viva dell’umanità, non sono fabbricati da una cultura che li possiede.
Coloro a cui condizioni storico-culturali hanno consentito un miglior riconoscimento e inquadramento di questi valori, dovrebbero spogliarsi di ogni senso di superiorità e diffonderli con umiltà, rispettandoli nelle loro relazioni con gli altri.
La supremazia occidentale poggia su un potere economico, politico e militare che dei valori etici fa tranquillamente a meno.
È la grande contraddizione storica della democrazia: con l’esercizio del potere nelle sue relazioni esterne viola palesemente i principi della sua costituzione.
Manifestazione di un’ambiguità del suo funzionamento interno, incompiutezza che l’Atene di Pericle ha compensato con l’arroganza. Non è andata bene.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! DENTRO LA PIU’ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA E POLITICA ITALIANA --- L’ “idealismo attuale”: la religione e di Gentile (di Giuseppe Bedeschi).31 gennaio 2016, di Federico La Sala
Tra spirito e pensieroLa religione di Gentile
di Giuseppe Bedeschi (Il Sole-24 Ore, Domenica, 31.01.2016)
- Giovanni Gentile, Discorsi di religione, a cura di Paolo Bettineschi, Orthotes Editrice, Nocera, pagg. 176, ?€ 16,00
Nel 1935 Giovanni Gentile tenne una conferenza all’Università di Praga, che poi pubblicò sul «Leonardo» col titolo«Il carattere religioso dell’idealismo italiano» (con questa espressione, “idealismo italiano”, egli intendeva la propria filosofia, il cosiddetto “attualismo”, data la rottura drammatica e insanabile intervenuta fra lui e Croce). In tale conferenza Gentile sosteneva che la forza del proprio idealismo stava nel suo carattere religioso, che tante avversioni, ma anche tanti entusiasmi, aveva suscitato.
Carattere religioso perché? Perché, spiegava il filosofo siciliano, la religione entra in tutti i pensieri degli uomini, laddove ogni arte o scienza particolare si contenta di una sfera determinata di interessi; allo stesso modo «la filosofia [idealistica] partecipa di questo carattere totalitario e perciò vitale o etico della religione».
È vero, diceva Gentile, che la filosofia accentua il motivo della ragione e della libertà, ossia dell’infinità dell’umana natura in quanto realtà pensante, autocoscienza e persona; ma non perciò nega il limite e la necessità in cui questa personalità si trova, di superare se stessa; anzi fa consistere in ciò l’essenza della realtà spirituale, nel trascendere se stessa e attingere nella realtà trascendente - nella sua realtà trascendente - la realtà.
Perciò, aggiungeva Gentile, l’idealismo italiano contemporaneo non solo non credeva di lasciare inappagata nessuna reale esigenza religiosa dello spirito, ma riconosceva nel Cristianesimo la concezione filosofica più alta e più adeguata tra le forme storiche della religiosità. E non solo.
In una celebre conferenza del 1943 («La mia religione») Gentile affermerà di essere non soltanto cristiano, ma anche cattolico. «Ripeto dunque la mia professione di fede, piaccia o dispiaccia a chi mi sta a sentire: io sono cristiano. Sono cristiano perché credo nella religione dello spirito. Ma voglio subito aggiungere, a scanso di equivoci: io sono cattolico».
Cristiano, perché per la religione cristiana Dio è spirito, ma è spirito in quanto l’uomo è spirito, e Dio e uomo nella realtà dello spirito sono due e sono uno, sicché l’uomo è veramente uomo soltanto nella sua unità con Dio. Cattolico, perché la religione, come ogni attività spirituale, è universale, propria di un soggetto che si espande all’infinito: comunità illimitata, nella quale il mio Dio è Dio se è Dio di tutti.
A questa concezione, Paolo Bettineschi (che ha curato una bella edizione dei Discorsi di religione di Gentile, con un ampio saggio introduttivo, per i tipi di Orthotes) obietta che, «piuttosto che avvicinare i due poli del divino e dell’umano - stringendoli in buona unità e rendendoli solidali - l’attualismo abbatte la verità della distinzione che passa tra uomo e Dio, e quando parla di unità dei due, intende in effetti la loro identità, il loro essere una sola realtà, non già il loro stare insieme che sarebbe il loro vero abbracciarsi». Obiezione fondata, mi pare, da un punto di vista logico. E tuttavia non si dovrebbe dimenticare, da un punto di vista storico, che - come osservò un eminente studioso cattolico, Adriano Bausola - la carica di religiosità dell’attualismo fu un fattore di attrazione per molti, e preparò la strada ad alcuni giovani pensatori, destinati a diventare tra i maggiori esponenti dello “spiritualismo cristiano”, per approdare poi al cattolicesimo.
Ed è proprio in riferimento a questi temi che si misura tutta la distanza fra Gentile e Croce, e si colgono i motivi profondi della loro rottura. Nella Storia d’Italia dal 1871 al 1918 Croce definì l’attualismo come un «nuovo irrazionalismo», «un misto di vecchia speculazione teologica e di decadentismo, tra lo stil dei moderni e il sermon prisco». Perciò, affermava Croce, egli ne prese subito le distanze, nonostante il rapporto di stretta collaborazione che lo aveva unito precedentemente a Gentile, il cui “idealismo attuale” si sarebbe sempre più apertamente svelato (sono parole del filosofo napoletano) «come un complesso di equivoche generalità e un non limpido consigliere pratico».
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA --- A SCUOLA DA ALESSANDRO PANSA. Io, capo della Polizia, leggo Marcuse (di Stefano Brusadelli).31 gennaio 2016, di Federico La Sala
Un libro, una vita
Alessandro Pansa
Io, capo della Polizia, leggo Marcuse
di Stefano Brusadelli (Il Sole-24 Ore, Domenica, 31.01.2016)
«Marcuse aveva previsto tutto. Basta rileggere quello che scriveva cinquant’anni fa nell’Uomo a una dimensione. Secondo lui i soggetti rivoluzionari non sarebbero stati più gli appartenenti alla classe operaia, ormai integrati nel sistema, ma, cito testualmente “il sostrato dei reietti e degli stranieri, degli sfruttati e dei perseguitati di altre razze e di altri colori, dei disoccupati e degli inabili. Essi permangono fuori dal processo democratico, la loro presenza prova quanto sia immediato e reale il bisogno di porre fine a condizioni e situazioni intollerabili. La loro opposizione è rivoluzionaria anche se non lo è la loro coscienza...“». Se una rivisitazione del filosofo-simbolo della contestazione sessantottina (e della lotta a qualsiasi potere costituito) è ormai doverosa, la circostanza che a incaricarsene sia Alessandro Pansa, il capo della Polizia, ma anche uomo di buone e vaste letture, dimostra quanto i libri siano il terreno più propizio per la contaminazione tra storie, esperienze e sensibilità diverse.
Pansa lesse per la prima volta L’uomo a una dimensione a 17 anni, all’immediata vigilia del ’68. E racconta che ne fu conquistato per due motivi. «Il primo è che sollevava il tema del cambiamento, avvertito fortemente da tutta la mia generazione. Il secondo era che indicava tale prospettiva fuori dal marxismo, che veniva anzi criticato. Una sorta di riscatto per chi, come me, era tra i pochi non marxisti fra i suoi coetanei. Rilessi il libro molti anni più tardi, nel 2003, quando divenni capo della Direzione per l’Immigrazione, e mi stupì non solo l’esattezza della sua previsione sulla potenzialità eversiva dell’immigrazione, ma anche la diagnosi sulla non neutralità delle tecnologie, sul loro ruolo di strumento di dominio sugli esseri umani. E tutto questo, scritto a metà degli anni ’60, quando i profughi non arrivavano in Occidente a milioni e internet ancora non esisteva!».
Nella mente del capo della Polizia, l’antica suggestione del cambiamento, da lui inteso come costruzione di un sistema in cui il maggior numero possibile di esigenze individuali riescano ad essere soddisfatte, non ha mai cessato di operare. Ed è a causa di quella fascinazione, del resto, che ha deciso di parlare dell’Uomo a una dimensione come del libro della sua vita.
Ma da questo punto di vista il pensiero di Marcuse, sia pure così acuto per altri versi, gli è sempre apparso monco, se non contraddittorio. «La trasformazione sociale e politica non può verificarsi nel modo da lui prospettato, perché la liberazione di ogni tipo di istanze individuali non produce mai un interesse collettivo, bensì anarchia. Dunque deve essere sempre un’autorità ad assicurare questo riequilibrio tra esigenze singole e collettive. E tale operazione, tutt’altro che facile, può avvenire solo per l’azione di un personaggio capace di cambiare la storia stando però con i piedi dentro la storia».
A questo proposito Pansa cita un’altra lettura giovanile che è stata per lui molto importante. Si tratta de Gli eroi, pubblicato al filosofo scozzese Thomas Carlyle nel 1841. Una galleria di grandi figure (da Odino a Napoleone passando per Dante, Rousseau, Cromwell) che hanno saputo cambiare il loro tempo. «In quei ritratti ho sempre scorto l’identikit ideale dei leader. Non superuomini alla Nietzsche, collocati sopra il resto del genere umano e sprezzanti verso di esso, ma figli del loro tempo capaci di agire con la forza delle idee e dell’esempio. Una categoria nella quale oggi potremmo annoverare personaggi come Gorbaciov, Bill Gates, Papa Francesco. Capaci di rompere un ordine e passare a un altro, più soddisfacente per un maggiore numero di esseri umani, e senza fare uso della violenza. Sono in fin dei conti sempre gli uomini il vero motore della storia».
Domando se tale aspirazione al mutamento non finisca coll’essere in contraddizione con il suo ruolo di tutore dell’ordine costituito. «No, non lo credo, perchè il mio compito è quello di garantire a tutti di esprimere liberamente le proprie esigenze, e di consentire a quelle che poi risulteranno più condivise di potere prevalere».
Pansa, che tiene sul comodino i Pensieri di Pascal, ha fatto ricorso a un metodo innovativo per rintracciare i libri disposti anche su tre file sugli scaffali. Li ha catalogati in modo tale che aprendo su uno schermo la foto della sua biblioteca si ottiene un’immediata localizzazione di ciascun volume.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- FILOSOFIA E MESSAGGIO EVANGELICO. IL MONITO DI PASCAL A SERGIO GIVONE
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! DENTRO LA PIU’ GRANDE BOLLA SPECULATIVA --- La "Scuola di Atene": "Del femminile come oggetto" (di Nicla Vassallo)26 gennaio 2016, di Federico La Sala
- UNA CATTOLICA, UNIVERSALE, ALLEANZA "EDIPICA"!!! IL MAGGIORASCATO: L’ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE, L’ALLEANZA DELLA MADRE CON IL FIGLIO, REGNA ANCORA COME IN TERRA COSI’ IN CIELO
 DONNE, UOMINI E VIOLENZA: "Parliamo di FEMMINICIDIO".
DONNE, UOMINI E VIOLENZA: "Parliamo di FEMMINICIDIO".
- ESTETICA (E NON SOLO) E DEMOCRAZIA. PER LA CRITICA DELLA FACOLTA’ DI GIUDIZIO E DELLA CREATIVITA’ DELL’ "UOMO SUPREMO" (KANT).
 CREATIVITA’: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETA’ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE.
CREATIVITA’: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETA’ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE.
Del femminile come oggettodi Nicla Vassallo (SCENARI, 25.01.2016)
Presso i Musei Vaticani, al cospetto della Scuola di Atene di Raffaello, la presenza di maschi/uomini risulta netta, netta se non fosse per un “ambiguo” individuo, a fianco di Parmenide: forse si tratta di Ipazia - non tutti concordano. Ipazia, certo, non era una donna oggetto, e così l’hanno brutalmente uccisa. Anche Diotima, prima di Ipazia, non raffigura, unica donna nel Simposio di Platone, nient’affatto una donna oggetto. Tuttavia, di tali donne la storia della filosofia ne ricorda ben poche: le donne sono state martoriate dai filosofi, con qualche eccezione a parte - Cartesio e John Stuart Mill, ad esempio.
Prendiamo Aristotele: le donne rimangono maschi menomati o mutilati; il loro essere femmine si deve alla mancanza di potenza; la loro femminilità coincide con la passività, e da passive vanno trattate, al pari di oggetti. E via di seguito con le generalizzazioni: rispetto agli uomini, le donne si attesterebbero impulsive, doppie, gelose, petulanti, spudorate. Avremmo potuto confidare in Tommaso, il santo, che invece in proposito si fa anche lui portatore dei pregiudizi aristotelici. Pregiudizi che si replicano, con variazioni sul tema, nei cosiddetti “grandi” filosofi: stando a Kant, le donne non risultano in grado di azioni genuinamente etiche per carenza di senso del dovere (del resto, che etica può possedere un oggetto?); per Hegel, esse debbono venir rinchiuse in casa, in quanto prive di ragionamento universale, che si esige invece in ambito politico e pubblico (del resto, di quale ragionamento universale dispone un oggetto?); secondo Schopenhauer le donne permangono “per natura” inferiori rispetto ai maschi, in quanto, decretate perennemente infantili, manipolatrici e bugiarde, esse mancano di intelligenza e senso di giustizia (donne, pur sempre, oggetti); a parere di Nietzsche le donne sono un gingillo, utile solo a procreare e a rappresentare un mero passatempo per gli uomini (sono strumenti, proprio come alcuni oggetti).
Le donne simboleggiano dunque irrazionalità, o, se va bene, una razionalità che dipende dagli uomini. Non ritengo infatti causale che tra le filosofe si esaltino (con o senza ragione?) donne legate a filosofi di sesso maschile: basti menzionare Eloisa (con Abelardo), Simone de Beauvoir (con Jean-Paul Sartre), Hannah Arendt (con Martin Heidegger).
Alle emozioni, invece, specie se emozioni legate alla follia, le donne, poetesse, non filosofe, vengono destinate. Saffo (solo per menzionare qualche esempio) canta amori sublimi, per poi gettarsi da una rupe. La timida e sensibilissima Antonia Pozzi, divisa tra amori, sceglie la morte con barbiturici, a ventisei anni; scrive di eros e thanatos, con selvagge siepi/di amori: morire è questo/ ricoprirsi di rovi/ nati in noi. Sylvia Plath si uccide a trent’anni, con la testa nel forno (la testa della poetessa e il forno della moglie-madre) dopo aver cantato la morte:
 Morire è un’arte, come qualsiasi altra cosa.
Morire è un’arte, come qualsiasi altra cosa.
 Io lo faccio in un modo eccezionale
Io lo faccio in un modo eccezionale
 io lo faccio che sembra un inferno
io lo faccio che sembra un inferno
 io lo faccio che sembra reale.
io lo faccio che sembra reale.
 Ammetterete che ho vocazione.
Ammetterete che ho vocazione.Anne Sexton “sopravvive” più a lungo, ma a quarantacinque anni in un garage si intossica col monossido di carbonio. E, infine, non posso che menzionare lei, Virginia Woolf, non poetessa, bensì scrittrice poetica e folgorante, che opta a cinquantanove anni per una morte “tecnicamente” difficile: con le tasche ricolme di sassi, si lascia annegare nel fiume Ouse. Lei che aveva scritto Al Faro, e di acqua s’intendeva.
Se le filosofe prima menzionate si accoppiano e associano a uomini, con le poetesse il tutto non è immediato. Di Saffo si narra che amasse le donne. Sylvia Plath cosa c’entrava davvero con Ted Hughes? E chi si ricorda di Alfred Muller Sexton? Mentre di Virginia Woolf diremmo che nutrisse una reale passione per il marito Leonard, o per Vita Sackville-West?
Le donne che rifiutano categoricamente di essere considerate donne oggetto non hanno forse alcuna scelta se non il suicidio?
E, invece, gli omicidi? Si uccide, come distruggono gli oggetti. Prendiamo Dante che nel Canto V del Purgatorio, con Pia De’ Tolomei, ci porta nel girone di coloro che, a causa di una morte violenta, trovano il pentimento, una sorta di riabilitazione, in fin di vita. Che tipo di pentimento? Di Pia De’ Tolomei, uccisa dal marito, entro un contesto familiare, ci viene comunicata la dolcezza, insieme alla volontà di venir ricordata per una qualche sua fede. Benché in relazione al mondo terreno la sua indifferenza e il suo autocontrollo rimangano sospetti, perlomeno agli occhi odierni, il suo “ricorditi di me” ci addolora: Pia suscita in noi un desiderio, una necessità di protezione. Pia De’ Tolomei invoca aiuto, così come si dovrebbe fare. Anche se non fosse mai esistita e la sua fama si dovesse solo a Dante, la Pia rimane l’emblema di un entusiasmo divorato dalla violenza. Quante e quali Pie incontriamo quotidianamente senza saper nulla di loro, e senza che nulla ci raccontino? Le sconcertanti violenze degli uomini sulle donne, nel mondo, specie all’interno delle mura domestiche, si traducono raramente in denunce. Quali le loro cause e i loro significati? Se non sei una persona, bensì un oggetto di mio possesso, mi è lecito far di te quanto mi pare. E le donne sono persone?
A rispondere negativamente è una «femminista immutata», Catharine MacKinnon, che si domanda proprio se le donne siano oggetti o esseri umani, per concludere seccamente che non sono esseri umani.
Perché? Semplice la ragione. Se le donne fossero esseri umani, non sarebbero spedite in container dalla Tailandia ai bordelli di New York, o rapite in sperduti villaggi nigeriani e gettate poi sulle strade italiane; non sarebbero sessualmente schiavizzate; non lavorerebbero tutta la vita senza salario o con salari indecenti, costrette a svolgere mansioni pesanti, pericolose o avvilenti per troppe ore al giorno; non verrebbero infibulate, percosse, stuprate; non si pretenderebbe che sposino il proprio stupratore, né sarebbero accusate di rapporti sessuali fuori del matrimonio quando denunciano l’uomo in questione; non sarebbero indotte a suicidarsi per riparare l’onore della propria famiglia; non dovrebbero nascondersi dietro burka o simili indumenti; non sarebbero costrette nelle loro case come in prigioni; non subirebbero molestie sessuali e mutilazioni genitali (nella sola Africa vi sono tuttora tre milioni di bambine ancora a rischio di subirle, nonostante l’ONU abbia recentemente e finalmente bandito dette mutilazioni); non verrebbero messe a tacere, torturate, lapidate, decapitate, o uccise appena nate (l’infanticidio delle figlie femmine è ancora praticato). La lezione che occorre ricavare da questo elenco non è onorevole: le donne rimangono sotto più punti di vista oggetti, mentre gli obiettivi femministi e delle filosofie femministe non sono stati conseguiti. «Una stanza tutta per sé» e «cinquecento sterline annue» rimangono chimere.
MacKinnon si riferisce a cosa accade nel mondo in generale. Dando un’occhiata a cosa accade solo nel mondo cosiddetto occidentale, le immagini di donne da cui si viene bombardati/e sul piano mediatico si condensano troppo spesso in donne “leggere”, la cui reale consistenza è il corpo, non una mente ragionante; sono immagini normative che esplicitano chiaramente “questo è come la donna deve essere”; sono immagini che certo possono mutare e, difatti mutano, ma che rimangono sempre centrate sul corpo. Sull’oggetto.
Difficile fuggire dalla trappola. Non tutte le donne sono intelligenti, d’accordo. Ma molte tendono effettivamente a esaltare un’apparenza fisica “femminile”. E se ci pone come “cattiva ragazza”, ovvero si trasgredisce la norma maschile eterosessuale, nel non corrispondere (almeno in qualche senso) al concetto di donna vigente, si corre il rischio dell’esclusione, e l’esclusione non è facile da sostenere.
Il concetto di donna vigente nella nostra civiltà, specie in Italia, da una parte regala in effetti mere illusioni di stabilità e d’identità, e dall’altra è rigidamente monolitico: deve così essere in una società androcentrica, razzista, eterosessista, votata alla “normalità”. Come è sostenuto, giustamente a mio avviso, il rimedio alla donna oggetto non può che consistere nel delegittimare «a priori l’esplorazione della continuità esperienziale e della base strutturale comune tra le donne» (cfr. Bordo 1990, p. 142). Del resto, molte donne, ma non tutte, cedono a venir meticolosamente assoggettate sotto diversi profili: economico, legale, politico, professionale, psichico, religioso, sessuale, sociale, e via dicendo. In modo diretto o indiretto, in misura maggiore o minore, ogni donna eterosessuale subisce commerci, devianze, etiche, leggi, identità, molestie, pratiche, politiche, violenze sessuali, oltre a doveri erotici, procreativi e riproduttivi, all’insegna di schemi rappresentazionali dettati da interessi sessuali. Ancora oggi. Che cosa specificare di più sulle donne oggetto?
Una certa normatività rimane deleteria e si converte comodamente in forme di vero e proprio autoritarismo sulla sessualità, in cui a rannuvolarsi rimane la sessualità delle donne. Diviene allora quasi scontato affermare con Monique Witting che, per esempio, le lesbiche non sono donne, perché il concetto di donna giunge a una piena elaborazione e assume un valore determinato solo nell’ambito di un atteggiamento normativo che obbliga la sessualità entro i rigidi schemi di un’eterosessualità in cui le donne vengono categorizzate, all’unico scopo di essere vessate (cfr. Wittig 1992). Si può anche concedere che si vessino gli oggetti, non le persone o gli esseri umani.
Ben si sa che, nel caso in cui non ci si comporti da donne oggetto o ci si consideri con consapevolezza donne non eterosessuali, sbalordisca sentirsi dire “tu non sei una donna”. Inquieta perché “tu non sei una donna” equivale spesso a “tu non sei una vera donna”, ove il termine “vero” maschera approvazione e disapprovazione. Proprio come quando affermiamo “la verdura di oggi non è vera verdura” intendiamo dire che tale verdura non è buona, quando diciamo “Valeria non è una vera donna” intendiamo dire che Valeria non è una donna “buona”: biasimiamo certi suoi atteggiamenti, comportamenti, ruoli che non rientrano nel concetto di donna “valido” e in uso in una certa cultura, a un determinato tempo (cfr., per esempio, Austin 1962, per considerazioni simili sul termine “real”). “Tu non sei una vera donna” comporta essere disapprovate, e lo si è perché non si corrisponde al concetto di donna vigente, di cui fanno parte parecchi pregiudizi (e allora che concetto è?) sulle differenze tra donna e uomo, a partire dalle differenze sessuali. È possibile che tu non sia una vera donna solo a causa dei tuoi desideri sessuali, che non corrispondono a quelli che la donna dovrebbe normativamente nutrire. Dunque, tu non sei una vera donna poiché rifiuti di oggettificarti.
È allora errato decretare, se non si esigono donne oggetto, che la differenza sessuale sia una componente essenziale del desiderio sessuale, è cioè errato consentire il desiderio sessuale solo tra donna e uomo, o tra femmina e maschio - tra la donna e l’uomo, tra il maschio e la femmina. Eppure è forse proprio il fine di circoscrivere il desiderio sessuale al rapporto eterosessuale che rende la differenza sessuale necessaria al desiderio sessuale, a partire dal presupposto che il rapporto sessuale deve essere finalizzato alla riproduzione, piuttosto che all’amore e alle varie rappresentazioni vissute che dell’amore si possono offrire (cfr. Vassallo 2015).
Il punto è che il maschio e la femmina, l’uomo e la donna hanno poca ragione d’essere, se con l’articolo determinativo intendiamo richiamarci a entità universali, al fine di catturare essenze maschili e femminili, che proseguono a incidere sulle donne rendendole oggetti. Tali entità/essenze possono trasformarsi in fonti di veri e propri azzardi, nell’azzerare la comprensibilità tra le tante differenze che corrono tra femmine e tra donne, così come le tante differenze che corrono tra maschi e tra uomini. La logore banalità dovrebbe venir sempre denunciata dalla buona filosofia, a partire dalle differenze tra femmine e maschi, tra donne e uomini, che la società rischia vieppiù di enfatizzare indebitamente, allo scopo di condizionare comportamenti e competenze declinate al “maschile” e al “femminile”, con donne oggetto in primo piano (cfr. Amoretti e Vassallo).
In fondo la donna rimane pura apparenza, una finzione al servizio dell’androcentrismo, del razzismo, dell’eterosessismo, della “normalità”, uno strumento normativo utile per imporre agli esseri umani di comportarsi in determinati modi, per avallare determinate pratiche e delegittimarne altre. L’idea che tutte le donne presentino similarità essenziali serve, per esempio, a legittimare il fatto che alle donne e agli uomini vengano assegnati ruoli culturali, professionali, sessuali e sociali distinti, che le donne debbano attenersi a canoni di genere cognitivamente diversi rispetto a quelli degli uomini, che i tratti fisici e psicologici delle donne debbano essere femminei, mentre quelli degli uomini mascolini. L’essenzialismo ha senz’altro legittimato un certo convenzionalismo femminile, costringendo le donne al perbenismo, vietando loro la realizzazione completa delle loro potenzialità. Del resto, le donne rimangono oggetti. Ma esso ha soprattutto ratificato il dualismo uomo/donna, da cui sono aristotelicamente zampillati altri pericolosi dualismi: mascolino/femmineo, razionale/irrazionale, attivo/passivo, culturale/naturale, oggettivo/soggettivo, e così via.
Torno ancora, in conclusione, a MacKinnon sulle donne oggetto, una conclusione dura, eppure realistica, che tratta di pornografia:
- «We define pornography as the graphic sexually explicit subordination of women through pictures and words that also includes
 (i) women are presented dehumanized as sexual objects, things, or commodities;
(i) women are presented dehumanized as sexual objects, things, or commodities;
 or (ii) women are presented as sexual objects who enjoy humiliation or pain;
or (ii) women are presented as sexual objects who enjoy humiliation or pain;
 or (iii) women are presented as sexual objects experiencing sexual pleasure in rape, incest or other sexual assault;
or (iii) women are presented as sexual objects experiencing sexual pleasure in rape, incest or other sexual assault;
 or (iv) women are presented as sexual objects tied up, cut up or mutilated or bruised or physically hurt;
or (iv) women are presented as sexual objects tied up, cut up or mutilated or bruised or physically hurt;
 or (v) women are presented in postures or positions of sexual submission, servility, or display;
or (v) women are presented in postures or positions of sexual submission, servility, or display;
 or (vi) women’s body parts-including but not limited to vaginas, breasts, or buttocks-are exhibited such that women are reduced to those parts;
or (vi) women’s body parts-including but not limited to vaginas, breasts, or buttocks-are exhibited such that women are reduced to those parts;
 or (vii) women are presented being penetrated by objects or animals;
or (vii) women are presented being penetrated by objects or animals;
 or (viii) women are presented in scenarios of degradation, humiliation, injury, torture, shown as filthy or inferior, bleeding, bruised, or hurt in a context that makes these conditions sexual».
or (viii) women are presented in scenarios of degradation, humiliation, injury, torture, shown as filthy or inferior, bleeding, bruised, or hurt in a context that makes these conditions sexual».
 (Non traduco, poiché questo inglese possiede una forza che in italiano si smarrirebbe.)
(Non traduco, poiché questo inglese possiede una forza che in italiano si smarrirebbe.)
Alle donne la scelta, in quei luoghi, societari e civili, in cui la ragione è concessa.
- UNA CATTOLICA, UNIVERSALE, ALLEANZA "EDIPICA"!!! IL MAGGIORASCATO: L’ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE, L’ALLEANZA DELLA MADRE CON IL FIGLIO, REGNA ANCORA COME IN TERRA COSI’ IN CIELO
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- LOGICA E DEMOCRAZIA. Pensieri basati sui fatti (di Gilberto Corbellini)25 gennaio 2016, di Federico La Sala
- PER UNA SECONDA RIVOLUZIONE COPERNICANA, IN FILOSOFIA E PEDAGOGIA. DEWEY (in gran compagnia, ancor oggi) CONTRO LO SPIRITO CRITICO DELL’ILLUMINISMO ...
 L’ATTIVISMO ACCECANTE DEL "FAR WEST" E IL "SAPERE AUDE" DELLA "CRITICA DELLA RAGION PURA": JOHN DEWEY SPARA A ZERO SU KANT, SCAMBIATO PER UN VECCHIO FILOSOFO "TOLEMAICO".
L’ATTIVISMO ACCECANTE DEL "FAR WEST" E IL "SAPERE AUDE" DELLA "CRITICA DELLA RAGION PURA": JOHN DEWEY SPARA A ZERO SU KANT, SCAMBIATO PER UN VECCHIO FILOSOFO "TOLEMAICO".
- LA COSTITUZIONE DEL PENSIERO E IL PENSIERO DELLA COSTITUZIONE. PER LA CRITICA DELL’ECONOMIA E DELLA TEOLOGIA POLITICA DI "MAMMONA" E DI "MAMMASANTISSIMA" - E DEL SUO "SUPERUOMO".
 L’ARCHIVIO DEGLI ERRORI
L’ARCHIVIO DEGLI ERRORI
- COSTITUZIONE E PENSIERO. ITALIA: LA MISERIA DELLA FILOSOFIA ITALIANA E LA RICCHEZZA DEL MENTITORE ISTITUZIONALIZZATO ...
 BERTRAND RUSSELL: LA LEZIONE SUL MENTITORE (IGNORATA E ’SNOBBATA’), E "L’ALFABETO DEL BUON CITTADINO".
BERTRAND RUSSELL: LA LEZIONE SUL MENTITORE (IGNORATA E ’SNOBBATA’), E "L’ALFABETO DEL BUON CITTADINO".
Logica e democrazia
Pensieri basati sui fatti
Se non è empirica la filosofia rischia di essere vaga. A scuola bisogna insistere sulla capacità di argomentare
di Gilberto Corbellini (Il Sole-24 Ore, Domenica, 24.01.2016)
I filosofi stanno discutendo abbastanza su cosa significhi oggi fare filosofia. È vero che chi scrive si identifica in una posizione scientista, per cui tutto quel che esiste ed è conoscibile è accessibile alla scienza e ai suoi metodi. Penso, in sostanza, che non esista in linea di principio niente di quel che accade che non possa essere compreso usando procedure empiriche controllate, se le nostre strutture cognitive riescono a concettualizzare e a interrogare sperimentalmente i processi che lo producono.
Questa è l’unica posizione filosofica per me ragionevole. Tutto il resto, come diceva Francis Crick, equivale a fischiare nel buio per farsi coraggio. Non penso però che la filosofia non serva a niente. Anzi. Oltre a produrre, insieme alla religione o alla letteratura o all’arte, suoni rassicuranti per chi ha paura del buio, può far capire meglio come funziona la scienza, togliendo di torno illusioni e autoinganni che ostacolano una comprensione critica e una disponibilità psicologica verso le conoscenze più affidabili che produciamo, cioè quelle scientifiche.
Un aiuto prima di tutto per i giovani, che invece di perdere tempo sul pensiero di tanti filosofi che hanno detto cose sbagliate, potrebbero acquisire salutari elementi di storia della scienza e di epistemologia scientifica, senza i quali non si capisce il mondo nel quale viviamo.
Davvero non si capisce, non è retorica! Le false credenze e le diffidenze verso la scienza e il metodo scientifico, così diffuse in Italia, sono la conseguenza anche del fatto che non sono chiari gli obiettivi dell’insegnamento scolastico: se non si aiutano i giovani a correggere l’epistemologia ingenua con cui approcciano la realtà, non distingueranno da adulti la scienza dalla pseudoscienza.
Oggigiorno non si può essere cittadini pienamente in grado di esercitare i diritti costituzionali se, per esempio, non si sa cosa è una probabilità, quali componenti teoriche entrano nella definizione di rischio, come si stabilisce che un dato scientifico è corretto o non falsificato, come funziona una sperimentazione clinica, cosa sono i bias cognitivi ed emotivi, etc. -Il fatto tragico è che questi concetti sono estranei in primo luogo a chi è impegnato a fare leggi, ad applicarle o ad amministrare la giustizia.
 L’esperienza più shoccante che si prova consultando le legislazioni anglosassoni è la chiarezza e l’organizzazione logica delle argomentazioni. Raramente sono scritte in modi illogici, per confondere le idee o non far capire cosa c’è scritto, come le leggi pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
L’esperienza più shoccante che si prova consultando le legislazioni anglosassoni è la chiarezza e l’organizzazione logica delle argomentazioni. Raramente sono scritte in modi illogici, per confondere le idee o non far capire cosa c’è scritto, come le leggi pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.Se «siamo un paese che odia la scienza», come denunciava lunedì scorso Paolo Mieli sul Corriere della Sera, è perché a cominciare dalla classe politica e passando per quasi tutti gli intellettuali che fanno tendenza, non si trova qualcuno che non storca il naso o non dica inesattezze quando si usa o si propone di usare un metodo scientifico per stabilire come stanno determinati fatti.
Per esempio quando si utilizzino i risultati della ricerca sperimentale per sostenere che mentono coloro i quali dicono che i vaccini possono causare l’autismo e sono più rischiosi della malattie che devono prevenire, che gli Ogm sono sicuri per l’ambiente e la salute nonché un toccasana per l’agricoltura, che le staminali mesenchimali non hanno curato alcuna malattia, che Xylella è un vero patogeno e i suoi effetti possono essere stabiliti e contrastati solo con metodi scientifici, etc.
Non è pensabile che un paese economicamente sviluppato possa rimanere tale e possa allevare un élite politica e intellettuale in grado di renderlo internazionalmente competitivo se non cambia radicalmente la qualità della cultura scientifica. Un risultato che non si ottiene solo incrementando la divulgazione o comunicazione della scienza, e tantomeno trascinando la scienza in controversie politiche, filosofiche o ideologiche. Va detto che se siamo a questo punto anche la comunità scientifica e il mondo accademico hanno pesanti responsabilità, che non sono soltanto l’attendismo, il servilismo e l’opportunismo che hanno caratterizzato i rapporti con la politica sin dall’ultimo dopoguerra più o meno.
C’è un problema culturale per cui non sono solo i cittadini profani che avrebbero bisogno di imparare un po’ di filosofia. Perché gli scienziati, che con disinvoltura riescono sempre più spesso a scavarsi la fossa con le loro mani, scadono frequentemente nei più triti luoghi comuni e gestiscono o furbescamente o ingenuamente le interazioni con la politica o con la magistratura.
Benché l’apprendimento della scienza dovrebbe averli immunizzati dalle trappole delle idee di senso comune e delle preferenze ideologiche, alla prima occasione per dar spazio a qualche ambizione di potere o bisogno narcisista si prestano a fare confusione e alimentare il pregiudizio che “gli scienziati sono divisi”, quindi tanto vale ignorarli o usarli come ci fa comodo.
Gaston Bachelard diceva che la scienza del suo tempo non aveva filosofi all’altezza del compito. Oggi si possono fare molti esempi che gli scienziati non sono spesso all’altezza della scienza che producono.
È triste leggere articoli di scienziati e accademie scientifiche che s’arrampicano sugli specchi per sostenere che le più recenti tecnologie del genome editing sono naturali o intrinsecamente diverse da quelle con le quali si facevano gli ogm, insultando la logica e l’epistemologia della biologia - è chiaro che non sanno nulla di teoria evoluzionistica, altrimenti non farebbero ragionamenti per i quali i giganti del pensiero genetico-evoluzionistico si rivoltano nella tomba. Tutto per rincorrere l’ignoranza dei politici che chiedono loro di abiurare ai principi etici della scienza - dire come stanno i fatti - se vogliono usare queste nuove tecnologie. Ma solo in laboratorio, dice l’improbabile ministro dell’agricoltura nostrano.
Ecco qualche compito utile per la filosofia. Rendersi conto che il sapere che vale amare è quello scientifico, e quindi lavorare non solo per farlo entrare meglio nella cultura civile, ma anche per proteggerlo dagli stessi scienziati.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- IL PAESE E GLI SCIENZIATI. Il Paese e gli scienziati (di Elena Cattaneo).25 gennaio 2016, di Federico La Sala
GLI SCIENZIATI E IL PAESE ...
- ESPERIMENTO ITALIA. L’ANNO DELLA VERGOGNA (1994): NASCE IL PARTITO DEL "NUOVO" PRESIDENTE DELLA "REPUBBLICA" ... E C’E’ ANCORA!!!
 CERVELLO, POLITICA, E TECNICHE DI DOMINIO: L’USO ISTITUZIONALE DEL "PARADOSSO DEL MENTITORE" IN ITALIA E LE ULTIME NOVITA’ DALL’INGHILTERRA.
CERVELLO, POLITICA, E TECNICHE DI DOMINIO: L’USO ISTITUZIONALE DEL "PARADOSSO DEL MENTITORE" IN ITALIA E LE ULTIME NOVITA’ DALL’INGHILTERRA.
Il Paese e gli scienziati
di Elena Cattaneo
 Docente all’Università Statale di Milano e senatore a vita
(la Repubblica, 24.01.2016)
Docente all’Università Statale di Milano e senatore a vita
(la Repubblica, 24.01.2016)Q UESTO non è più un Paese per scienziati, malgrado il più o meno glorioso passato. Non lo è più se un candidato a sindaco di Milano (e attuale vice) si vanta per aver sostenuto la battaglia contro la “famosa direttiva europea sulla vivisezione”. Non sapendo che il termine “vivisezione” descrive una pratica estranea alla Ricerca; che senza sperimentazione animale la medicina sarebbe a uno stadio tribale.
CHE la citata direttiva è frutto di anni di dialogo tra esperti e associazioni animaliste per trovare il miglior bilanciamento tra diverse aspettative; che Milano e zone limitrofe sono un importante distretto biomedico del Paese, e che non abbiamo bisogno di ulteriori motivi per accrescere la fuga dei cervelli, mortificando l’innovazione.
Non è un Paese per scienziati se servono mesi e mesi perché il ministero della Salute approvi i progetti di sperimentazione animale (la norma prevede 40 giorni), facendo ammuffire idee e frustrando capacità costrette a competere col mondo zavorrate dalle proprie istituzioni; e se l’apertura dei bandi di ricerca Prin (del ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) è affidata a procedure che sembrano quelle della lettura dei tarocchi tanto sono inaffidabili oltre che saltuarie nei tempi e disarticolate nelle valutazioni; e se il ministro delle Politiche agricole millanta di “andare oltre” gli Ogm e assegna qualche milione ai suoi enti (briciole, a cui nessuna libera ricerca universitaria potrà direttamente accedere) a patto che le idee rimangano chiuse nei laboratori, senza l’indispensabile verifica in campo aperto; lo stesso ministro che benedice una pratica agricola (la biodinamica) basata su astrologia e altre superstizioni.
Non è un Paese per scienziati se si commina il carcere a ricercatori che derivino da embrioni umani “sovrannumerari abbandonati” cellule staminali, e se si concepiscono bandi di ricerca che escludono, immotivatamente, progetti che utilizzino quelle cellule, ma si rimane ipocritamente indifferenti all’importazione (legale) delle stesse cellule dall’estero. Non lo è se si impone per via giudiziaria una presunta cura (il “metodo Stamina”), la si avalla per legge, salvo poi scoprire - come sostenuto fin dall’inizio da tutti gli scienziati - che era una tragica truffa. E se, pochi mesi dopo, si ripete l’errore di metodo cercando di finanziare una specifica sperimentazione clinica, ancora “per legge”.
Non è un paese per scienziati se questi sono considerati fantomatici untori di manzoniana memoria e li si indaga con l’ipotesi di aver deliberatamente introdotto un batterio (temuto ovunque nel mondo) che sta facendo strage di ulivi nel Salento. Quegli studiosi cercavano di capire il problema. Le regole dell’Ue prescrivono con rigore e esperienza cosa fare (e prontamente adottate in Francia sono state efficaci), ma una procura della Repubblica dice che l’esistenza di ulivi “ancora vivi pur se positivi per la Xylella” è un motivo che avvalora le tesi accusatorie. Un po’ come dire che, siccome alcuni fumatori non si ammalano di cancro al polmone, allora il fumo è innocuo.
E cosa dire di un Paese che persegue un modello di sviluppo improvvisato, investe un misero 1,2% del Pil in ricerca e sviluppo e impiega 4,6 ricercatori per mille occupati? Per inciso, le medie Ue sono circa il doppio.
Ma se questo non è un Paese per scienziati, cosa facciamo noi perché torni ad esserlo? Quanta responsabilità abbiamo nell’accettare che la Scienza sia squalificata, processata, manipolata, svenduta, sotto-finanziata?
Di certo non si promuove la Scienza - anzi la si tradisce - diffondendo dati manipolati. Né aiuta la Scienza chi va alla ricerca di finanziamenti top- down, ad hoc per il proprio orto. “Crepi quello degli altri”, anche se migliore. O chi è alla ricerca di amicizie e scorciatoie politiche, cancellando ogni logica valutativa su basi comparative, spogliando il Paese degli ultimi barlumi di razionalità e integrità necessari per provare a ricostruire una nuova politica del finanziamento pubblico per la Ricerca.
Una politica capace di prevedere un unico meccanismo competitivo e affidabile di erogazione di ogni singolo euro (un’Agenzia per la Ricerca, come chiede il Gruppo 2003) con bandi aperti a tutti, con tutti allo stesso nastro di partenza, neutralizzando chi s’approfitta del frazionamento delle fonti di finanziamento, dell’incompetenza degli erogatori, o è prono alla necessità propagandistica del decisore politico. Andrebbe impedito che un ente possa ricevere decine di milioni dallo Stato per accantonarli in depositi infruttiferi per anni, mentre i laboratori agonizzano e i nostri dottorandi (personale laureato) percepiscono un salario di mille euro al mese.
Non aiuta la Scienza quella parte di comunità scientifica che sceglie di tacere, anche se avrebbe gli argomenti per dire “no”, e si limita a “non esistere” per la società pur di non pagare il costo e la fatica d’essere sgradevole, scomoda o pressante. Anche quando i fatti lo richiedono, preferendo il quieto vivere del “buoni con tutti”, “per tutte le stagioni”, in fondo “non si sa mai, ci possono essere briciole anche per noi”.
Scienza, Ricerca e Accademia hanno un ruolo sociale. Formano generazioni libere, preparate e critiche. Non difendere questa libertà (e integrità decisionale) non lascia alibi. Tantomeno a chi guarda dolente a un Paese in compiaciuta contemplazione delle vestigia del passato, per nascondere che non sa progettare il presente e improvvisa sul futuro. La Scienza è il miglior strumento di cui disponiamo per comprendere il mondo e le opportunità offerte da un presente complesso, fragile e competitivo. Ciascuno dovrebbe capire qual è il proprio compito, il personale imperativo sociale, e impegnarsi a metterlo in pratica. Senza sconti per nessuno. Nemmeno per chi si professa scienziato, perché la Scienza può essere cosa discorde da loro e non perdona.
- ESPERIMENTO ITALIA. L’ANNO DELLA VERGOGNA (1994): NASCE IL PARTITO DEL "NUOVO" PRESIDENTE DELLA "REPUBBLICA" ... E C’E’ ANCORA!!!
- PER UNA SECONDA RIVOLUZIONE COPERNICANA, IN FILOSOFIA E PEDAGOGIA. DEWEY (in gran compagnia, ancor oggi) CONTRO LO SPIRITO CRITICO DELL’ILLUMINISMO ...
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- CHI E’ "PULCINELLA"? CHI IL MENTITORE?! Nespresso, la Israeli Espresso Club, il sosia di Clooney22 gennaio 2016, di Federico La Sala
Nespresso fa causa per uno spot di una concorrente con il sosia di Clooney
Chiesti 50mila dollari di risarcimento e rimozione spot
di Redazione ANSA ROMA 22 gennaio 2016
Clooney e Nespresso, binomio inconfondibile. Non per la compagnia di caffè israeliana, la Israeli Espresso Club, che ha cercato invece di confondere le idee a suo vantaggio ricorrendo ad un sosia della star hollywodiana per un suo spot. Mossa che che gli è subito costata una citazione in giudizio da parte della Nespresso che rivendica l’unicità del suo volto-immagine.
Durante la pubblicità della compagnia israeliana compare una scritta sullo schermo che avverte che l’attore, dai capelli argento e con in mano quello che sembra essere un sacchetto di Nespresso, "non è George Clooney. La Nespresso chiede 50,000 dollari di danni e la rimozione dell’annuncio pubblicitario.
Lo spot della società concorrente con il sosia di Clooney (da Youtube)
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- IL VANGELO DEL CONFLITTO, LA MISERICORDIA, I GESUITI, E LA "MEDIAZIONE HEGELIANA.20 gennaio 2016, di Federico La Sala
Il Vangelo del conflittodi Alberto Asor Rosa (la Repubblica, 20 gennaio 2016)
Nelle settimane passate è apparso in Italia un testo di Papa Bergoglio, che a me sembra di grande importanza. Si tratta dell’intervento da lui pronunciato a un Congresso internazionale di teologia (da lui stesso voluto e preparato), svoltosi a San Miguel in Argentina dal 2 al 6 settembre 1985, sul tema “Evangelizzazione della cultura e inculturazione del Vangelo”.
L’intervento, nella forma pubblicata da Civiltà cattolica, porta il titolo “Fede in Cristo e Umanesimo”. Ritengo però che il suo vero tema sia più esemplarmente testimoniato da quello del convegno.
Andrò per accenni, limitandomi a segnalare quello che, dal mio punto di vista, spicca per novità e intelligenza del discorso. In effetti, trovo, per cominciare dagli inizi, che ipotizzare questa doppia missione - che è anche un doppio movimento di andata e ritorno per ognuno dei due elementi che lo compongono, e cioè: “evangelizzazione della cultura” e “inculturazione del Vangelo”- significa offrire una visione nuova dei rapporti tra la “fede cristiana” e “il mondo”.
Bergoglio, infatti, non dice: “questa” o “quella cultura”. Dice: “cultura”. A chiarimento della tesi scrive: «Stiamo rivendicando all’incontro tra fede e cultura, nel suo duplice aspetto di evangelizzazione della cultura e di inculturazione del Vangelo, “un momento sapienziale”, essenzialmente mediatore, che è garanzia sia dell’origine (movimento di creazione) sia della sua pienezza e fine (movimento di rivelazione)». «Un momento sapienziale, essenzialmente mediatore...»: se la traduzione dallo spagnolo in italiano non ha deformato qualche senso, questo vuol dire che tra “fede” e “cultura” si può stabilire un confronto, i cui momenti di reciprocità sono destinati a influenzare sia l’una sia l’altra parte, producendo, attraverso la “mediazione”, un accrescimento di sapere e di conoscenza per tutti.
Bergoglio chiama in causa una parola-concetto tipicamente laica o quanto meno mondana: “mediatore”, mediazione. Tale impressione però si accentua, in misura significativa, nella lettura di un brano seguente, che qui riporto per intero, perché lo trovo denso di parole-concetti sorprendenti: «La base di questo sforzo è sapere che nel compito di evangelizzare le culture e di inculturare il Vangelo è necessaria una santità che non teme il conflitto ed è capace di costanza e pazienza. Innanzi tutto, la santità implica che non si abbia paura del conflitto: implica parresia, come dice San Paolo. Affrontare il conflitto non per restarvi impigliati, ma per superarlo senza eluderlo. E questo coraggio ha un enorme nemico: la paura. Paura che, nei confronti degli estremismi di un segno o di un altro, può condurci al peggiore estremismo che si possa toccare: l’ “estremismo di centro”».
In questo caso, la parola-concetto centrale è: “conflitto”. Si deve ammettere che siamo di fronte a una acquisizione inedita nel campo della cultura cristiano-cattolica. Il termine infatti ricorre nel pensiero e nelle problematiche del pensiero dialettico e sociologico europeo e americano degli ultimi due secoli: da Hegel a Marx, e poi Simmel, von Wiese, Dahrendorf... -Nessun equivalente, almeno della stessa portata, nel pensiero cristiano-cattolico dello stesso periodo, e si capisce perché: la predicazione evangelica sembrerebbe escludere una virata di tale natura.
Ma la sorpresa è destinata persino ad aumentare se si procede nell’analisi del ragionamento. «Affrontare il conflitto», scrive Bergoglio, «per superarl », ma «senza eluderlo»; si misura con «un enorme nemico: la paura». Paura di che? Paura dei possibili estremismi, che dal conflitto possono scaturire. Ma tale paura, se incontrollata, è destinata a condurre «al peggiore estremismo che si possa toccare: l’“estremismo di centro”, che vanifica qualsiasi messaggio». L’“estremismo di centro”! -In un paese come l’Italia, spesso arrivato a catastrofiche conclusioni proprio a causa di un sistematico e prevaricante “estremismo di centro”, tale messaggio dovrebbe risultare più comprensibile che altrove. Anche il riferimento alla parresia s’inserisce in questo contesto: solo chi parla alto e libero può vincere la paura.
Quali considerazioni si possono fare su posizioni, di questa natura? Su Bergoglio sono stati scritti molti articoli (bellissimi quelli di Eugenio Scalfari). Pochi, però, si sono soffermati sulla scaturigine storica delle sue prese di posizione, che è inequivocabilmente gesuitica. I gesuiti, nel corso della loro lunga storia, ne hanno combinate di tutti i colori, nella difesa perinde ac cadaver della Chiesa di Roma. E però...
 Molti anni or sono ho studiato a lungo la cultura gesuitica del Seicento in Italia. Mi risultò chiaro allora che carattere perspicuo della cultura gesuitica, nei momenti migliori, è sempre stato il tentativo «di operare la saldatura fra cultura laica e cultura ecclesiastica, fra tradizione e rinnovamento... »; e questo su base mondiale.
Molti anni or sono ho studiato a lungo la cultura gesuitica del Seicento in Italia. Mi risultò chiaro allora che carattere perspicuo della cultura gesuitica, nei momenti migliori, è sempre stato il tentativo «di operare la saldatura fra cultura laica e cultura ecclesiastica, fra tradizione e rinnovamento... »; e questo su base mondiale.Se le cose stanno così, la domanda (provvisoriamente) finale di questa ricostruzione è: quale rapporto esiste fra la centralità della parola-concetto “conflitto” e la centralità della parola-concetto “misericordia”, alla quale Papa Francesco ha voluto dedicare il Giubileo?
La risposta più semplice è: nessuno. “Misericordia” è parola evangelica, pochissimo usata in ambito laico, come pochissimo “conflitto” in ambito ecclesiale.
Sono passati trent’anni dalla prima formulazione, padre Jorge Mario Bergoglio, divenuto Papa Francesco, ha ripensato radicalmente le sue posizioni, rientrando nell’ambito più tradizionale della cultura ecclesiastica.
Come tutte le soluzioni troppo semplici, anche questa però si presta a un’obiezione di fondo. Una noticina al testo pubblicato da Civiltà cattolica informa infatti che il testo è stato ripresentato «in forma rivista dal Santo Padre». -Questo ci rende lecito pensare che nel pensiero di Papa Francesco “conflitto” e “misericordia” possano stare insieme. Cioè: il prodotto di una cultura laica può stare insieme con il prodotto tipico di una cultura evangelico-cristiana.
Non può esserci “misericordia” se non c’è stato “conflitto”; il “conflitto” è buono, anzi, addirittura indispensabile, se è necessario per superare la paura, e superare la paura è necessario per arrivare alla “misericordia”. Sarebbe troppo pretendere che Bergoglio, divenuto Pontefice, dopo averci additato come il conflitto sia necessario per attivare la misericordia, ci additi come la misericordia sia necessaria per attivare il conflitto, motivo quest’ultimo inesauribile - e positivo, quando c’è - delle azioni umane.
 Però la connessione possibile - il prima e il dopo, insomma, che però è anche o può essere anche, un dopo e un
prima - almeno a noi laici e non credenti, risulta - credo - ben chiara.
Però la connessione possibile - il prima e il dopo, insomma, che però è anche o può essere anche, un dopo e un
prima - almeno a noi laici e non credenti, risulta - credo - ben chiara. -
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- LO STATO E IL METRO DI MISURA. Ho una convinzione irremovibile (di Susanna Camusso)14 gennaio 2016, di Federico La Sala
- Pianeta Terra. Sull’uscita dallo stato di minorità, oggi......
 LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. Un omaggio a Kurt H. Wolff e a Barrington Moore Jr.
LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. Un omaggio a Kurt H. Wolff e a Barrington Moore Jr.
Spiace che neanche la sinistra misuri la democrazia con la libertà delle donne
di Susanna Camusso (The Huffington Post, 12/01/2016)
Ho una convinzione irremovibile: la libertà delle donne è metro di misura della democrazia. Non da oggi, non dalla notte di Capodanno, ma da quando ho preso coscienza penso che la libertà non sia uguale a quella degli uomini se le donne sono considerate un corpo di proprietà altrui, sganciato dalla loro testa che... Non esiste.
Convinzione che si rafforza quando nei conflitti, anche in quelli più recenti, ho visto, sentito, capito che si ripetevano azioni di guerra condotte sui corpi delle donne; quando ho seguito con ammirazione le donne di Kobane; quando mi sono indignata perché siamo pronti a onorare le vittime del terrorismo in tutto il mondo, ma poi dimentichiamo le ragazze rapite, convertite a forza, stuprate e uccise da Boko Haram, come fossero altro, diverse dagli altri morti.
La libertà delle donne è metro di misura della democrazia, ha la stessa forza degli altri fondamenti democratici? No, né per la destra, né, spiace dirlo, per la sinistra. Ricordo ancora il dibattito sulla rivoluzione iraniana, quando il ritorno al velo, i limiti all’istruzione, i guardiani o la Shari’a erano considerati conseguenze secondarie ed ininfluenti. Sbagliavamo. Per questo "Colonia", al di là delle ricostruzioni, mi chiama in causa perché di aggressione alla libertà delle donne si tratta. La sostanza non cambia se si è trattato di aggressione organizzata, collettiva, preparata o meno. L’aggressione alle donne è aggressione alla libertà delle donne.
Certo si sprecano in queste ore le classificazioni, atto di guerra, scontro di civiltà, terrorismo e per ognuna possiamo trovare motivazioni per negarle prima di tutto perché ciascuna di quelle pone la l’interpretazione e la giustificazione fuori di noi, della cultura europea. Sottintende che solo ad "altri", di una differente cultura o ancor di più di religione diversa, la libertà delle donne fa orrore e mette paura. Come dire che in Europa le donne sono considerate sempre inviolabili. Purtroppo, milioni di statistiche, fatti, evidenze, racconti, spiegano l’opposto.
Per questo è odioso, strumentale e anche insopportabile che si leghi quanto avvenuto a Colonia direttamente all’immigrazione o ai rifugiati. È salvifico per gli uomini, per l’intera cultura europea, per la finzione di non sapere cosa succede, con infinita frequenza, tra le mura delle nostre case. Anche non ritrovandomi in quelle definizioni penso comunque che sia indispensabile approfondire la riflessione. Lo scopo evidente è la proprietà e la trasformazione in oggetti dei corpi delle donne diffondendo paura. La paura è lo scopo precipuo del terrorismo. Cambia i comportamenti, genera richiesta di sicurezza, protezione e favorisce l’idea che per difendersi si possa limitare la libertà. Paura e modifica dei comportamenti mettono in forse la civiltà, come noi la intendiamo, fondata sulla libertà, esercitabile perché sancita dai principi democratici.
Fu faticoso alzare la voce sugli stupri di piazza Tahrir. Fu difficile perché per molti, troppi, veniva prima l’importanza di una lotta per la democrazia che la libertà e la sicurezza delle donne, senza neppure domandarsi che democrazia possa essere quella che può fare a meno della libertà di metà del mondo Molte domande suscita "Colonia" e molto ancora c’è da riflettere, non nel silenzio ma provando ad aprire un dibattito pubblico sul che fare, su cosa chiediamo a noi stesse e a noi stessi per affermare la piena libertà delle donne e, certo, anche sull’integrazione e sui modelli di accoglienza, su ciò che chiediamo a chi arriva per avere asilo e futuro. Dobbiamo riflettere su come rendere esplicita e inviolabile la libertà delle donne, senza dare per scontato, perché non lo è, che il nostro modo di essere sia rispettoso della loro libertà, della loro autodeterminazione, della loro libertà di scelta. Poi, dobbiamo porci la domanda, non ultima, se la religione, sfera privata per eccellenza, sia parte di questo ragionamento.
Penso che per troppo tempo abbiamo finto che non lo sia, che non ci sia relazione tra laicità dello Stato e libertà delle persone. L’Islam che si fa Stato, che applica la Shari’a (e non mi riferisco solo a Daesh), che vuole determinare la proprietà e la sottomissione delle donne a un uomo, non può più essere un problema di altre, delle donne musulmane prime vittime di questa radicale confessionalizzazione della politica e del governare. Mondi paralleli non esistono, nonostante le politiche d’integrazione siano state spesso questo. È una condizione che riguarda tutti e tutte perché se condividi spazio e tempo non possono esistere isole separate e intangibili.
 La lunga strada della laicizzazione e della della secolarizzazione dello Stato e dei governi è un patrimonio - ancora incompiuto - della cultura europea e non solo. Che sia Colonia, Delhi o Raqqa è al centro di un conflitto e di uno scontro che è tuttora in corso e che coinvolge il mondo intero.
La lunga strada della laicizzazione e della della secolarizzazione dello Stato e dei governi è un patrimonio - ancora incompiuto - della cultura europea e non solo. Che sia Colonia, Delhi o Raqqa è al centro di un conflitto e di uno scontro che è tuttora in corso e che coinvolge il mondo intero. - Pianeta Terra. Sull’uscita dallo stato di minorità, oggi......
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- LA RISATA DI KANT E LA TEOLOGIA POLITICA DELLA’ "ANDRO-POLOGIA" ATEA E DEVOTA.12 gennaio 2016, di Federico La Sala
 ’NDRANGHETA ("ANDRAGATHIA"). IL MONDO COME VOLONTA’ E RAPPRESENTAZIONE DEL MACROANTROPO ("UOMO SUPREMO", "SUPERUOMO", "DOMINUS IESUS"): FILOSOFIA, E TEOLOGIA POLITICA DELLA’ "ANDRO-POLOGIA" ATEA E DEVOTA....
’NDRANGHETA ("ANDRAGATHIA"). IL MONDO COME VOLONTA’ E RAPPRESENTAZIONE DEL MACROANTROPO ("UOMO SUPREMO", "SUPERUOMO", "DOMINUS IESUS"): FILOSOFIA, E TEOLOGIA POLITICA DELLA’ "ANDRO-POLOGIA" ATEA E DEVOTA....
 LA RISATA DI KANT: SCHOPENHAUER (COME RATZINGER) A SCUOLA DEL VISIONARIO SWEDENBORG.
LA RISATA DI KANT: SCHOPENHAUER (COME RATZINGER) A SCUOLA DEL VISIONARIO SWEDENBORG. CREATIVITA’: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETA’ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE.
CREATIVITA’: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETA’ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. -
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- COME LEGGERE IL "MEIN KAMPF": “How to read Hitler”. Intervista a Neil Gregor, storico del nazismo (di E. Franceschini).11 gennaio 2016, di Federico La Sala
LO STATO DEL FARAONE, LO STATO DI MINORITA’, E IMMANUEL KANT "ALLA BERLINA" - DOPO AUSCHWITZ:
 “come fu possibile la hitlerizzazione dell’Imperativo Categorico di Kant? E perché è ancora attuale oggi?” (Emil L. Fackenheim, Tiqqun. Riparare il mondo):
“come fu possibile la hitlerizzazione dell’Imperativo Categorico di Kant? E perché è ancora attuale oggi?” (Emil L. Fackenheim, Tiqqun. Riparare il mondo):Neil Gregor
“Bisogna leggere il Mein Kampf per disarmarlo”
Da ieri il manifesto di Hitler è nelle librerie tedesche in edizione critica e autorizzata. Con quali rischi? Parla Neil Gregor, uno dei massimi esperti mondiali di storia del nazismo
intervista di Enrico Franceschini (la Repubblica, 09.01.2016)
- Studiarlo serve a capire non solo il meccanismo ideologico che portò al genocidio degli ebrei
 Ma anche la minaccia dei genocidi nel mondo contemporaneo dal Ruanda alla Cambogia
Ma anche la minaccia dei genocidi nel mondo contemporaneo dal Ruanda alla Cambogia
LONDRA «Era giusto proibire il libro di Hitler nel 1945, ma oggi la Germania fa bene a pubblicarlo, perché possa essere studiato, per capire ancora meglio come nacque il genocidio degli ebrei durante il nazismo e per mettere in guardia contro i genocidi del presente».
 Neil Gregor, docente di storia all’università di Southampton, uno dei più grandi studiosi al mondo del Terzo Reich, guarda cadere l’ultimo tabù della Germania. Ieri, per la prima volta dal 1945, è tornato nelle librerie tedesche il “Mein Kampf”: edizione critica di due volumi, duemila pagine, un apparato di note e commenti monumentale, curato dal team dello storico Christian Hartmann dell’Istituto di Storia Contemporanea di Monaco di Baviera.
Neil Gregor, docente di storia all’università di Southampton, uno dei più grandi studiosi al mondo del Terzo Reich, guarda cadere l’ultimo tabù della Germania. Ieri, per la prima volta dal 1945, è tornato nelle librerie tedesche il “Mein Kampf”: edizione critica di due volumi, duemila pagine, un apparato di note e commenti monumentale, curato dal team dello storico Christian Hartmann dell’Istituto di Storia Contemporanea di Monaco di Baviera.Sono passati settant’anni dalla morte del Führer, novanta dalla prima edizione e appena sette giorni dalla scadenza dei diritti d’autore. Non è stata una sorpresa, ma vedere l’opera in vetrina dopo che per tutti questi anni il Land della Baviera ne aveva vietata la riedizione, è stato uno choc. A Monaco soprattutto, la città culla del movimento nazista, dove Hitler aveva scelto di avere la sua residenza e dove nel 1925 per i tipi dell’editore Franz Eher, era apparso con il titolo Una resa dei conti il primo volume dell’opera. Eppure l’interesse è stato tale da arrivare già ieri a 15mila ordini, 4mila in più della tiratura iniziale. Un successo di copie che sembra dar ragione agli editori.
Cosa pensa della pubblicazione del “Mein Kampf”, professor Gregor?
«Non penso che la Germania avesse molta scelta. Ritengo comunque che pubblicarlo sia stata la decisione giusta, per le ragioni che gli editori hanno anticipato da tempo, a cominciare dal fatto che il libro era disponibile comunque online a chiunque volesse leggerlo, per finire con il fatto che è passato molto tempo, la Germania è cambiata ed è comunque giusto potere studiare anche un testo simile per comprendere la storia del passato e i rischi del futuro».
Nel saggio “How to read Hitler” lei ha analizzato non solo gli argomenti, ma anche la lingua e la forma del “Main Kampf”. Siamo sicuri che non ci siano problemi a leggere oggi il Führer?
«Non credo. La Germania oggi è probabilmente la democrazia più stabile d’Europa. È inoltre un paese che ha ragionato a lungo sul proprio passato nazista, lo ha digerito con grande attenzione ed è consapevole di che cosa significa come retaggio storico e culturale. Il Mein Kampf è un esempio del retaggio del Terzo Reich, non differente da altri testi e manifestazioni politiche, artistiche, culturali di quel periodo che vanno egualmente analizzate».
Quale potrà essere la reazione dei circoli di estrema destra e filo-nazisti, in Germania e nel resto d’Europa?
«È vero che esistono gruppi di questo genere nella Germania odierna, come del resto ne esistono in Gran Bretagna, Italia e altri paesi del nostro continente. Ma è altrettanto vero che si muovono in una prospettiva differente rispetto al nazismo del Terzo Reich e alle idee propagate dal libro di Hitler. Sono gruppi anti- profughi, anti-immigrati, più concentrati sull’islamofobia che sull’antisemitismo, ben diversi dai predecessori ai quali si rifanno, seppure anch’essi pericolosi e da emarginare con fermezza. Il danno che possono fare relativamente alla pubblicazione del libro di Hitler, tuttavia, dovrebbe essere marginale, non mi aspetto che possa diventare la miccia di un risorgere del nazismo, con vecchi o nuovi slogan».
Andreas Wirsching, direttore dell’istituto che ha curato l’edizione, ha detto che questo lavoro «smaschera le informazioni false diffuse da Hitler, le sue bugie e rende riconoscibili tutte le mezze verità finalizzate agli effetti propagandistici»...
«Conosco il lavoro che è stato fatto dagli editori: hanno fornito nelle note i nomi, le date, il contesto storico, necessari a inquadrare il testo e a capirne meglio il significato. Un lavoro ben fatto, che mira per così dire a detossificare il libro, a dimostrare quanto folli, orribili e sbagliate fossero le tesi dell’autore».
Le opere di Mao, Stalin, Lenin, sono sempre state pubblicate senza suscitare polemiche, sebbene oggi quei leader siano giudicati dalla storia come dei dittatori sanguinari. Perché il “Mein Kampf” andrebbe considerato diversamente?
«La mia risposta è che in effetti il Mein Kampf non dovrebbe essere considerato diversamente. La differenza è che, dopo la morte di Hitler e la fine della Germania nazista, la nuova Germania democratica mise al bando quel testo per dare un messaggio simbolico di condanna totale del passato, un segno di rottura, mentre i libri di Lenin, Stalin, Mao continuavano a venire pubblicati, in Russia, Cina o in Europa orientale, con il sostegno di governi o regimi che non avevano preso le distanze da essi. La mia opinione è che la Germania fece bene a vietare il Mein Kampf nel 1945, ma oggi viviamo in un’epoca differente. Pubblicare le opere di un tiranno non vuol dire condividere le sue idee, vuol dire soltanto che è possibile studiarlo».
Come si studierebbero Napoleone, Genkis Khan, Giulio Cesare?
«Sì, ma Napoleone o Cesare non concepirono il genocidio di massa di un popolo. La ragione per studiare Hitler e il suo libro è diversa: serve a capire non solo il meccanismo ideologico che portò la Germania nazista verso il genocidio degli ebrei, ma anche a comprendere la minaccia del genocidio nel mondo contemporaneo, una minaccia che, dal Ruanda alla Cambogia al Darfur, purtroppo non è scomparsa».
Crede che in Israele la pubblicazione del ‘Mein Kampf” da parte della Germania verrà presa con maggiore ansia?
«Probabilmente sì e per ragioni interamente comprensibili. Molti cittadini di Israele hanno perso la propria famiglia nell’Olocausto ed è legittimo che guardino ancora con preoccupazione al risveglio di un simile orrore in qualunque forma. Ma penso che anche molti israeliani concordino che, a distanza di settant’anni, è un fenomeno da studiare per capire appunto come si è sviluppato. E inoltre Israele sa che la Germania, proprio per quello che fece Hitler agli ebrei, è oggi il suo miglior amico e sostenitore in Europa».
- Studiarlo serve a capire non solo il meccanismo ideologico che portò al genocidio degli ebrei
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA --- I tabù del mondo. Siamo tutti Edipo l’eroe maledetto della conoscenza (di M. Recalcati)10 gennaio 2016, di Federico La Sala
PSICOANALISI E FILOSOFIA. Indicazioni per una seconda rivoluzione copernicana .....
 Il protagonista della tragedia di Sofocle è diventato la figura emblematica dell’uomo vittima del suo destino
Il protagonista della tragedia di Sofocle è diventato la figura emblematica dell’uomo vittima del suo destino
 Condannato senza colpa a infrangere i due divieti fondativi: non uccidere tuo padre, non giacere con tua madre
Condannato senza colpa a infrangere i due divieti fondativi: non uccidere tuo padre, non giacere con tua madre
 Ma secondo Lacan più che l’incesto il re di Tebe incarna l’eccessivo desiderio di verità che è in noi
Ma secondo Lacan più che l’incesto il re di Tebe incarna l’eccessivo desiderio di verità che è in noiSiamo tutti Edipo l’eroe maledetto della conoscenza
di Massimo Recalcati (la Repubblica, 10.01.2016)
- In un primo tempo è oggetto passivo di una sentenza inappellabile, poi il suo ruolo sembra cambiare: diventa un sovrano, un salvatore Ma non si sfugge al passato
Per definire la vita umana Lacan ha più volte evocato la leggenda antica dello schiavo-messaggero che portava iscritto sulla propria nuca rasata il messaggio che avrebbe dovuto recapitare senza poterlo leggere. Tutti noi portiamo sulle nostre nuche le sentenze, le maledizioni, gli auspici, le speranze, i desideri, le gioie delle nostre madri e dei nostri padri senza mai poterle leggere direttamente. Ciascuno porta scritto sulla propria nuca il destino che l’Altro ci ha assegnato senza poterlo decifrare. La nostra vita è allora solo l’esito di una necessità inesorabile? Ecco arrivare la sagoma inquietante di Edipo, il figlio innocente che il destino ha voluto colpevole. L’oracolo consultato al momento della sua nascita legge la sua nuca: infrangerà i tabù più grandi, i tabù dei tabù: ucciderà suo padre e si unirà sessualmente con sua madre. È questo il suo dramma: la fine della sua vita coincide con il suo inizio senza alcuna possibilità di movimento.
Conosciamo la sua storia che per Freud è la nostra storia: l’oracolo sentenzia al padre Laio il destino disgraziato di suo figlio Edipo. Per evitare che la profezia si compia, il re consegna il figlio a un pastore con la raccomandazione spietata di ucciderlo. Abbandono e infanticidio sono alle radici del dramma del figlio Edipo. Nel racconto di Sofocle il primo ad infrangere la Legge non è il figlio ma il padre: Laio vuole fare uccidere il figlio perché altrimenti ne sarebbe ucciso. Figlicidio e parricidio si corrispondono drammaticamente come due facce della stessa medaglia. Tutto, proprio tutto, è già scritto per Edipo, sin dall’inizio. Il pastore mosso a pietà affida il bimbo a un altro pastore che a sua volta lo affida a una coppia regale della città di Corinto che non poteva avere figli. Edipo scopre il suo destino consultando il Dio Apollo e proprio per evitare che si compia decide di allontanarsi dalla sua città. Lungo la strada incontra però, senza riconoscerlo, il proprio padre e lo uccide in uno scontro mortale. In seguito risolverà l’enigma della Sfinge e diventerà il re di Tebe, sposo della sposa di Laio, di sua madre Giocasta. La tragedia di Edipo si condensa nella sua impossibilità a sfuggire al proprio destino: tutto era già scritto e più Edipo rifiuta la scrittura del proprio destino, più resta impigliato.
In un primo tempo Edipo è vittima passiva della sentenza dell’Altro che porta tatuata sulla sua nuca: è un figlio abbandonato e adottato. In un secondo tempo della sua vita diviene un eroe, un salvatore; libera Tebe risolvendo il mistero della Sfinge. Sembra aver modificato il suo destino: diventa un re che assicura prosperità al suo popolo e alla sua famiglia. Ma l’ombra tetra dell’epidemia cade sulla sua città a causa di una colpa oscura. Edipo vuole sapere la causa del flagello. Attiva con decisione un’inchiesta per scoprire il colpevole ma anche in questo caso volendo sfuggire al proprio destino lo incontra inesorabilmente. La sua inchiesta trascura di indagare se stesso; è tutta rivolta verso l’esterno. È il contrario di Socrate; se questi sa di non sapere, Edipo non sa di sapere. La sua determinatezza lo allontana, paradossalmente, dalla verità. Il nucleo della tragedia, scrive Ricoeur, «non è il problema del sesso, ma quello della luce». Mentre Edipo pensa di vedere, è cieco; è Tiresia, il veggente cieco, che invece può vedere rivelandogli la verità più scabrosa: «Sei tu l’impuro che infetta questa terra... tu cerchi l’assassino di Laio. L’assassino sei tu: questo ti dico... viene da te il tuo Male...».
Edipo preferisce la verità al suo bene e a quello di chi gli sta vicino e lo ama («tutto questo bene mi ha seccato!»). Edipo non patteggia, non media, non ascolta i consigli di Tiresia e di Giocasta, non è attaccato alla propria identità, alla sicurezza delle sue proprietà. La verità, per lui, conta di più di ogni altra cosa. La sua volontà di sapere assume la forma di una hybris radicale che sfida ogni tabù. E questa verità, alla fine, sarà accecante, violenta, traumatica. L’accecamento a cui si sottopone dopo la rivelazione di Tiresia denuncia la sua colpa irrimediabile: «Luce di questo giorno, tu devi essere l’ultima mia luce. Ecco chi sono: nato da chi non mi doveva generare. Vissuto accanto a chi non mi doveva vivere accanto. Chi non dovevo uccidere, io l’ho ucciso».
Edipo non ha il dono della visione immediata della verità propria dell’oracolo. Egli è solo un uomo. La sua ricerca della verità - come quella di tutti gli uomini - è un cammino necessariamente lento e faticoso. Egli paga la colpa del suo desiderio di sapere che non si frena di fronte a nessun limite. Se Edipo non avesse voluto sapere la verità della sua origine sarebbe rimasto padre, Re e marito. Egli non accetta la rimozione, la maschera, non si accontenta di quello che sa; vuole interrompere l’omertà borghese dell’Io, vuole andare sino in fondo.
È la forza tragica di questa figura maledetta. Edipo esce dall’oscurità del non-sapere potendo finalmente vedere quello che ha compiuto. La sua identità di Re, padre e liberatore si ribalta in quella di figlio parricida e incestuoso, destinato a vivere da reietto. È il punto su cui ha insistito, dopo Freud, Lacan: la tragedia del parricidio e dell’incesto è, in realtà, una tragedia della verità. Possiamo chiederci, con Edipo, quanta verità può sopportare un uomo? Nel suo caso la rivelazione della verità coincide con la realizzazione del suo destino; la sua innocenza diventa la sua colpa; la verità non è soltanto luce che libera la visione, ma può essere anche talmente insopportabile da rendere impossibile ogni visione.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- A CHE GIOCO GIOCHIAMO?! IL GIUBILEO, LUTERO, E L’ANNIVERSARIO DELLE 95 TESI.10 gennaio 2016, di Federico La Sala
A CHE GIOCO GIOCHIAMO?! IL GIUBILEO, LUTERO, E L’ANNIVERSARIO DELLE 95 TESI. Papa Francesco ha voluto giocare d’anticipo?
Giubileo catto-luteranoPer i protestanti la parola «Jubiläum» indica il 500esimo anniversario delle 95 Tesi che si celebrerà nel 2017. Papa Francesco ha voluto giocare d’anticipo?
di Lorenzo Tomasin (Il Sole-24 Ore, Domenica, 10.01.2016)
La parola giubileo, di origine ebraica, in alcune lingue europee significa «anniversario», «ricorrenza calendariale». In tedesco, ad esempio, tale è oggi il significato comune di Jubiläum: e nella terra Martin Lutero - ma anche in quelle di Calvino, Farel, Beda e Knox, i riformatori effigiati su un famoso muro di Ginevra - un giubileo s’attende per il 2017. È il cinquecentesimo anniversario della pubblicazione delle 95 tesi di Lutero. La suggestiva quasi-coincidenza del giubileo della Riforma e del giubileo proclamato, con un anno d’anticipo su quello, dalla chiesa di Roma, è stata notata in terra protestante, dove qualcuno ha persino temuto che l’uno rischi di (o addirittura miri a) mettere in ombra l’altro.
L’attenzione alla storia da parte del mainstream cattolico contemporaneo porterebbe a escludere una studiata sovrapposizione. Si tratta, forse, di una casualità, ma è pur vero che in tal modo un giubileo «straordinario», cioè non previsto dal calendario, dedicato alla «misericordia» (tutti i giubilei cattolici, a ben vedere, lo sono, visto che in questione c’è sempre la remissione dei peccati) finisce curiosamente per coincidere con i cinquecento anni dal 1516.
In quei mesi, che Lutero ricordava come quelli in cui «cominciai a scrivere contro il papato», la dottrina cattolica della misericordia fu messa in discussione nel suo presupposto fondamentale, cioè nella prerogativa papale di gestire il perdono e la remissione dei peccati come un patrimonio a sua disposizione, amministrandoli in modo ordinario o straordinario, a seconda delle necessità di fare cassa, o di monopolizzare un’anche più redditizia audience.
Ancora nella bolla emessa per l’attuale giubileo si parla ad esempio del perdono di «peccati che sono riservati alla Sede Apostolica». Dove riservati andrà sperabilmente riferito alla loro remissione, non - come la formula potrebbe far supporre - alla facoltà di commetterli.
Il testo delle tesi luterane del 1517 verteva in effetti su una disputa che non era né politica, né economica, ma appunto teologica, giacché di teologia, a quel tempo, il papato si occupava ancora tanto intensamente quanto strumentalmente. Una riduttiva vulgata connette la polemica luterana al mero impiego del denaro nella compravendita delle indulgenze: Leone X, come è noto, aveva bisogno di rimpinguare le esauste casse pontificie, giacché il Rinascimento oltre ai suoi splendori ebbe pure i suoi costi.
Ma è ben noto, almeno fuori d’Italia, che buona parte delle 95 degnità luterane verte proprio sul tema della misericordia e della remissione dei peccati, rovesciando la prospettiva per cui il perdono parte da un’indizione papale e piove sui fedeli e proponendo la conversione individuale del fedele come vera, unica e costante fonte della misericordia. L’obiezione valeva, peraltro, anche a rivisitare, contestualizzandola, la riflessione cristiana sulla povertà materiale (tesi 59: «San Lorenzo ha detto che il tesoro della chiesa sono i poveri, ma l’impiego di questo vocabolo esprimeva la concezione del suo tempo»: si trattava in effetti di uno degli argomenti che inducevano i fedeli a devolvere offerte).
Le 95 tesi vi contrappongono, come è noto, una visione spirituale più impegnativa - seppur ancora confusa e abbozzata -, ma insieme più concretamente storica, della chiesa (tesi 62: «Il vero tesoro della chiesa è il santo vangelo della gloria e della grazia di Dio»).
 Per un’altra curiosa e - ancora - certo casuale coincidenza, le parole di Lorenzo chiosate dalla luterana tesi 59 sono state ripetute qualche settimana fa dall’attuale papa. La concezione del nostro tempo (parafrasando Lutero) ha reso quella frase ben gradita ai media, soprattutto a quelli italiani, in cui i temi giubilari ricorrono con intensità maggiore che altrove, e generalmente in assenza di riferimenti diversi dalla prospettiva attuale del Vaticano o di pochi altri colli tiberini.
Per un’altra curiosa e - ancora - certo casuale coincidenza, le parole di Lorenzo chiosate dalla luterana tesi 59 sono state ripetute qualche settimana fa dall’attuale papa. La concezione del nostro tempo (parafrasando Lutero) ha reso quella frase ben gradita ai media, soprattutto a quelli italiani, in cui i temi giubilari ricorrono con intensità maggiore che altrove, e generalmente in assenza di riferimenti diversi dalla prospettiva attuale del Vaticano o di pochi altri colli tiberini.Così, le parole sul tesoro della chiesa sono state presentate come profondamente rivoluzionarie e innovative. Come in molti altri casi, la loro immediata efficacia ha coperto ogni riferimento alla loro storia, alla loro percezione e alla loro sedimentazione nel dibattito cristiano.
Da espressione coperta di una scaltra strategia di fund raising, esse sono state promosse a efficace slogan di un pauperismo che pure riconduce, in forme nuove, la religione a una funzione che pare prioritariamente economica, cioè a un discorso sui beni terreni, punto di partenza e punto d’arrivo di una misericordia tutta strumentale.
 Del resto, anche nella pratica cinquecentesca delle indulgenze il bando papale si traduceva in un’omelia sul denaro, che i banditori pontifici deprecavano nel momento stesso in cui invitavano a devolverlo per ottenere misericordia.
Del resto, anche nella pratica cinquecentesca delle indulgenze il bando papale si traduceva in un’omelia sul denaro, che i banditori pontifici deprecavano nel momento stesso in cui invitavano a devolverlo per ottenere misericordia.
 Avidità e pauperismo possono talora essere due facce della stessa medaglia, cioè della stessa ossessione per i beni secolari.
Avidità e pauperismo possono talora essere due facce della stessa medaglia, cioè della stessa ossessione per i beni secolari.Cinquecento anni dopo (e in un cattolicesimo ormai dimentico di quella storia), denominazione, natura e cronologia del giubileo della misericordia non sembrano filtrate da un’adeguata considerazione storica. Apparire innovativi, se non rivoluzionari, diventa così possibile nel solco di una indisturbata continuità e in un contesto culturale sempre più schiacciato sul presente, che tende semplicemente a ignorare la lunga prospettiva storica in cui atti e testi - quindi anche bolle e giubilei - vanno letti.
Adattandosi abilmente a un’epoca ormai indisponibile alla riflessione storica (e figurarsi a quella teologica...), la grande kermesse giubilare ritorna in forme e in parole che forse paiono talor a nuove, sui passi di una vicenda antica e, forse, semplicemente rimossa.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- LA FIABA, LA FAVOLA, E ... LA "CONFUSIONE" DI GRAMELLINI. Non sappiamo più raccontare le favole!!!8 gennaio 2016, di Federico La Sala
LA FIABA, LA FAVOLA, E ... LA "CONFUSIONE" DI GRAMELLINI.
- Innanzitutto invito a leggere l’articolo, e, nello stesso tempo, invito a tenere ben distinte le due parole "favola" e "fiaba" (due generi diversi di "racconti"), e, poi, a riflettere di più e meglio sull’inizio (tragico!) di "Pinocchio": "C’era una volta. - Un
re! - diranno subito i miei piccoli lettori. - No, ragazzi, avete sbagliato. C’era una volta un pezzo di legno"!!!
 SI TRATTA della "storia di un burattino"!!! Già ai suoi tempi, Collodi aveva capito che gli italiani e le italiane non sapevano più di cosa parla una *fiaba* (Vladimir Ja. Propp) e non sapevano più nemmeno raccontarla... E CE LO GRIDAVA IN FACCIA!!!
SI TRATTA della "storia di un burattino"!!! Già ai suoi tempi, Collodi aveva capito che gli italiani e le italiane non sapevano più di cosa parla una *fiaba* (Vladimir Ja. Propp) e non sapevano più nemmeno raccontarla... E CE LO GRIDAVA IN FACCIA!!!
 Italo Calvino aveva capito la lezione di Collodi e perciò cercò di mettere in salvo le "Fiabe italiane"! Nella *fiaba*, infatti, è nascosta la chiave stessa della nostra dignità di esseri umani, della nostra sovranità, della sovranità di cittadini e di cittadine di una sana e robusta Costituzione (art. 3)!!! Per questo non è male accogliere le sollecitazioni e provocazioni di Gramellini e e rifletterci su... (Federico La Sala)
Italo Calvino aveva capito la lezione di Collodi e perciò cercò di mettere in salvo le "Fiabe italiane"! Nella *fiaba*, infatti, è nascosta la chiave stessa della nostra dignità di esseri umani, della nostra sovranità, della sovranità di cittadini e di cittadine di una sana e robusta Costituzione (art. 3)!!! Per questo non è male accogliere le sollecitazioni e provocazioni di Gramellini e e rifletterci su... (Federico La Sala)
Non sappiamo più raccontare le favole
Un saggio americano: solo gli inglesi riescono a inventarle. Non hanno paura del lato oscuro
di Massimo Gramellini (La Stampa, 08/01/2016)
La rivista letteraria The Atlantic, americana, ha condotto un’inchiesta dettagliata ed è giunta alla conclusione che in quest’epoca di ansie assortite e lettori bisognosi di cure affabulatorie, soltanto gli inglesi siano ancora capaci di popolare l’immaginario dei bambini di ogni nazione ed età. Alla notizia che l’Inghilterra, magari con l’aggiunta dell’Irlanda, detenga l’esclusiva delle favole qualcuno storcerà il naso e opporrà le sue eccezioni, però è un fatto che il più formidabile parto fantastico degli ultimi decenni è stato il maghetto Harry Potter, britannico, la cui saga si inserisce in un filone avviato dai personaggi di Tolkien e C.S Lewis, britannici anch’essi. Sarà il rapporto più stretto con la natura e con i miti fondativi pagani, l’assenza di una religione troppo moralista e inibente, la passione diffusa per i saperi esoterici, ma gli inglesi (e gli irlandesi) sembrano avere conservato un seme di conoscenze antichissime e la capacità di diffonderle attraverso un codice di immagini e archetipi che non parla all’emisfero razionale del cervello, ma si rivolge direttamente al subconscio di tutti gli esseri umani.
Uno dei momenti più emozionanti della mia vita è stata la scoperta che, accanto al significato letterale, le favole ne celavano un altro simbolico. Uno dei momenti più tristi è stato accorgermi che di questa scoperta non importava niente quasi a nessuno. Eppure mi vengono ancora i brividi quando penso agli artisti illuminati che dalla notte dei tempi hanno rivestito i segreti dell’esistenza e persino le future rivelazioni della fisica quantistica con le metafore dei racconti per l’infanzia. Quando penso che la Bella e la Bestia è la storia dello spirito che si riconcilia con la materia. Che la spada nella roccia è un simbolo fallico e la sua estrazione da parte del giovane Artù un rito di iniziazione sessuale. Che il bacio del principe azzurro alla bella addormentata è la metafora di quel risveglio consapevole che sta alla base di ogni antica tradizione spirituale. Che la rinuncia al simbolo del potere - sia esso l’anello elfico che Frodo va a gettare nel vulcano di Mordor o la bacchetta di sambuco che Harry Potter decide di spezzare dopo averla vinta a lord Voldemort nel duello finale - è l’atto supremo di distacco che completa l’evoluzione interiore dell’eroe.
Non è importante comprenderli con la mente, certi significati reconditi. L’emozione della favola li porta egualmente là dove devono andare: al di sotto della corteccia dell’Ego, nel regno della coscienza che Jung chiamava il Sé. La lettura delle favole procede su due livelli. Il subconscio infatti non comprende le parole. Il suo alfabeto è fatto di immagini e suoni. Mentre il piccolo lettore ascolta le avventure di principi e principesse, da qualche parte dentro di lui si forma l’immagine simbolica su cui potrà fare affidamento per il resto della vita. Quando, smarrita la sbornia di “realtà” tipica dell’età dello sviluppo, sentirà il bisogno di attingere a una conoscenza eterna per lenire le proprie paure e sviluppare i propri talenti.
Tutto questo gli inglesi non lo hanno dimenticato. E hanno avuto la forza di ricordarlo al mondo. Non è solo questione di lingua. Anche gli americani scrivono in inglese, ma le loro trame per l’infanzia esprimono un intento educativo, e dunque pragmatico, che smorza sul nascere lo sbrigliarsi della fantasia. Huck Finn è un capolavoro e Mark Twain un genio, ma si tratta di un capolavoro e di un genio intrisi di realtà. Persino la metafisica Moby Dick di Melville è appesantita da decine di pagine francamente noiose sulle varie tipologie di balene, quasi che lo scrittore avesse voluto rimarcare la base scientifica della sua straordinaria creazione. La cultura nordamericana ha compresso l’irrazionale fin dalle origini, assieme ai nativi indiani che ne sarebbero stati i naturali cantori. La concretezza etica della società fondata dai Padri Pellegrini ha spinto i compositori di favole a interpretarle non come una vacanza del pensiero, ma come il rivestimento zuccheroso di una medicina fatta di regole morali da impartire sotto forma di apologo con morale incorporata.
E gli italiani? Avendo copiato gli americani praticamente in tutto, non potevamo che seguirli anche in questa strage della fantasia immolata sull’altare della cosiddetta realtà. Pinocchio è un gigante della narrativa universale, eppure fu ignorato per un certo periodo persino dai suoi contemporanei. Le biografie di Collodi pubblicate dai giornali dopo la sua morte liquidano il burattino in poche righe. L’autore stesso non ebbe piena consapevolezza della sua opera, che toccò a Benedetto Croce sdoganare almeno dal punto di vista letterario. Collodi era un massone e non c’è pagina di Pinocchio che non contenga un riferimento alchemico (a cominciare dal nome del protagonista che si rifà alla ghiandola pineale, il “terzo occhio” di cui ogni tradizione esoterica si ripropone l’attivazione). Ma non ha lasciato eredi. Oggi si scrivono favole anche molto poetiche, intasate soprattutto di animali che parlano e ragionano come gli umani, ma manca la magia della spiritualità che in un Paese cattolico come il nostro viene ancora associata esclusivamente alla religione. Mentre il misticismo pagano che è alla base delle fantasie immortali degli inglesi si nutre di boschi, di orfani e di lettori che abbiano voglia di lasciarsi lambire dalla loro ombra a costo di perdervisi.
- Innanzitutto invito a leggere l’articolo, e, nello stesso tempo, invito a tenere ben distinte le due parole "favola" e "fiaba" (due generi diversi di "racconti"), e, poi, a riflettere di più e meglio sull’inizio (tragico!) di "Pinocchio": "C’era una volta. - Un
re! - diranno subito i miei piccoli lettori. - No, ragazzi, avete sbagliato. C’era una volta un pezzo di legno"!!!
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- I TRE ANELLI, I TRE CAMMELLI, E L’EPIFANIA. «I Magi ci insegnano a cercare il senso delle cose». Il messaggio di Francesco.7 gennaio 2016, di Federico La Sala
- LA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO DI AMORE DEI "DUE SOLI"
- GIORDANO BRUNO, LE "TRE CORONE" E IL VANGELO ARMATO. Nuccio Ordine rilegge la grande opera di Bruno (e fa intravedere impensate connessioni con Dante, Boccaccio, Lessing e noi, tutti e tutte). Intervista di Maria Mantello.
- I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". NATHAN IL SAGGIO: CHE ILLUSIONE AFFIDARSI ALLA CHIESA ’CATTOLICA’!!! Sulla "autenticità" del suo anello, una recensione senza amore ("charitas") di Gianfranco Ravasi del lavoro di Lessing
Celebrazione dell’Epifania. Il messaggio di Francesco
«I Magi ci insegnano a cercare il senso delle cose»
Un messaggio a tutta la Chiesa, ma in particolare ai suoi ministri, sacerdoti e vescovi: la vostra è una missione, dice il Papa.
di Carlo Marroni (Il Sole-24 Ore, 07.01.2016)
È la festività dell’Epifania, celebrazione solenne nella basilica vaticana: «Annunciare il Vangelo di Cristo non è una scelta tra le tante che possiamo fare, e non è neppure una professione». Le parole di Francesco sono sul solco di un messaggio che è centrale sin dall’inizio del pontificato, quando mise in guardia il clero da assumere ruoli di “funzionari” di un’organizzazione. E su questo spirito che si innesta l’azione della Chiesa: «Essere missionaria non significa fare proselitismo, per la Chiesa, essere missionaria equivale ad esprimere la sua stessa natura: essere illuminata da Dio e riflettere la sua luce. Non c’è un’altra strada. La missione è la sua vocazione. Quante persone attendono da noi questo impegno missionario, perché hanno bisogno di Cristo, hanno bisogno di conoscere il volto del Padre». No al proselitismo, quindi: un altro tassello della pastorale bergogliana, che rimarca lo spirito profondo dello spirito missionario.
Nell’omelia dell’Epifania il papa ricorda che «l’esperienza dei Magi ci esorta a non accontentarci della mediocrità, a non “vivacchiare”, ma a cercare il senso delle cose, a scrutare con passione il grande mistero della vita. E ci insegna a non scandalizzarci della piccolezza e della povertà, ma a riconoscere la maestà nell’umiltà, e saperci inginocchiare di fronte ad essa». La povertà della Chiesa, sempre al centro, che nella simbologia natalizia trova la sua rappresentazione più plastica, come in qualche modo ha voluto rimarcare nella visita a sorpresa due giorni fa a Greccio, il borgo del reatino dove secondo la tradizione San Francesco istituì il presepe: «È qui, nella semplicità di Betlemme, che trova sintesi la vita della Chiesa». E sempre su questo tema il Papa, parlando a braccio, ha offerto una nuova interpretazione della figura dei pastori, che secondo quanto tramandato sarebbero stati i primi ad arrivare alla mangiatoia: «Nella notte di Natale Gesù si è manifestato ai pastori, uomini umili e disprezzati, alcuni dicono dei briganti. Furono loro i primi a portare un po’ di calore in quella fredda grotta di Betlemme».
Nell’omelia di ieri, semplice nelle parole ma complessa nel suo messaggio, il Pontefice ha voluto ricordare come «la Chiesa non può illudersi di brillare di luce propria. Non può». E ha citato «una bella espressione di sant’Ambrogio, utilizzando la luna come metafora della Chiesa: «Veramente come la luna è la Chiesa: rifulge non della propria luce, ma di quella di Cristo. Cristo - ha spiegato - è la vera luce che rischiara; e nella misura in cui la Chiesa rimane ancorata a Lui, nella misura in cui si lascia illuminare da Lui, riesce a illuminare la vita delle persone e dei popoli. Per questo i santi Padri riconoscevano nella Chiesa il mysterium lunae».
Nel corso dell’Angelus, inoltre, Francesco ha chiesto alla folla di piazza San Pietro - presente un gruppo folkloristico con tre cammelli - un applauso per esprimere, ha detto, «la nostra vicinanza spirituale ai fratelli e alle sorelle dell’Oriente cristiano, cattolici e ortodossi, molti dei quali celebrano domani il Natale del Signore. Ad essi giunga il nostro augurio di pace e di bene».
La conclusione delle festività natalizie segna il ritorno agli impegni anche di carattere istituzionale: il primo è previsto per lunedì prossimo, 11 gennaio, con l’incontro annuale con il corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede, dove è prevedibile che pronunci un discorso molto forte sui temi della pace, specie in questo inizio del 2016 segnato da nuove gravi tensioni, dalla crisi Iran-Arabia Saudita all’annuncio della Corea del Nord di un esperimento nucleare.
Inoltre il 17 gennaio, come annunciato da tempo, Francesco si recherà in visita alla Sinagoga di Roma. È il terzo Pontefice dopo Giovanni Paolo II e Benedetto XVI a varcare la soglia del Tempio maggiore della capitale. Alle sedici della domenica, su invito del Rabbino Capo, Riccardo di Segni e della Comunità, il Papa stringerà la mano ai cittadini di Roma di fede ebraica. Ad accoglierlo, oltre ai rappresentanti del mondo ebraico italiano religioso e civile, tra cui il presidente dell’Ucei, Renzo Gattegna, e ad un esponente del governo d’Israele, ci sarà soprattutto la gente, i giovani della comunità e anche gli ex deportati.
«Sarà una visita all’insegna del dialogo e della cordialità - ha dichiarato Ruth Dureghello, presidente della Comunità di Roma - È una bella occasione per continuare il percorso di dialogo che prosegue fra alti e bassi ma con la volontà consolidata di andare avanti».
E ieri si è appreso che la storica ebrea Anna Foa sostituisce la giornalista Ritanna Armeni nell’incarico di co-coordinatrice, con Lucetta Scaraffia, dell’inserto dell’Osservatore Romano «Donne Chiesa Mondo», iniziativa editoriale dal 2012 del quotidiano della Santa Sede diretto da Giovanni Maria Vian.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA --- A CHI APPARTIENE MAOMETTO? Lo Stato Islamico e l’Islam. Un contributo di Tamin Ansary.4 gennaio 2016, di Federico La Sala
Stato Islamico [Daesh]: a chi appartiene Maometto?Lo Stato Islamico usa la nostra storia dell’Islam per la sua guerra. Soltanto noi musulmani possiamo cambiare questo stato delle cose.
Un contributo di Tamim Ansary - nato a Kabul nel 1948, storico, vive a San Francisco.
Die Zeit online - 24 dicembre 2015
- traduzione dal tedesco di José F. Padova (Nota: A chi appartiene il Cristianesimo? Ai cattolici o ai protestanti? Per “rispondere” a questa domanda ci sono state le Guerre di Religione, i bruciati vivi sul rogo, cuius regio eius religio, devastazioni spaventose, Westfalia e le ripartizioni territoriali. Alla morte di Maometto, 632 d.C., iniziò una situazione analoga, con sciiti (devoti ai loro imam, vedi l’Iran odierno) e sunniti, di manica un poco più larga.
 Mi perdonino gli esperti questa banalizzazione. Nel campo di questa religione monoteista le cose si sono complicate nel 1492 (http://www.limesonline.com/il-califfato-di-spagna/37758) , quando il mirabile sviluppo di una civiltà si è bloccato - fino a oggi. In quel mondo tuttavia molti cominciano a farsi domande.)
Mi perdonino gli esperti questa banalizzazione. Nel campo di questa religione monoteista le cose si sono complicate nel 1492 (http://www.limesonline.com/il-califfato-di-spagna/37758) , quando il mirabile sviluppo di una civiltà si è bloccato - fino a oggi. In quel mondo tuttavia molti cominciano a farsi domande.)
Il vero potere di Daesh non sta nelle sue bombe e armamenti vari e neppure nella sua orrenda risolutezza. Esso si trova molto più nel modo geniale in cui l’organizzazione formula la sua immagine mondiale e la forgia come un’arma. È in corso un conflitto apocalittico fra ‘Islam e l’Occidente. «Non si tratta qui semplicemente di un’altra guerra, fratelli e sorelle, è l’inizio della fine, perché presto Dio riscriverà la storia e i suoi [figli] diletti sono predestinati come vincitori. Essi cancelleranno i satanici, gli altri, e unificheranno la Terra sotto il tetto dell’Islam. Chi vi si unisce farà parte dei benedetti da Dio. Chi perde la vita in battaglia raggiunge direttamente il paradiso, chi sopravvive diventa onorato membro di una società che vive esattamente secondo le regole che Dio ha trasmesso all’umanità attraverso il suo inviato Maometto».
Può Daesh venire sconfitto uccidendo il suo sedicente Califfo Al Bagdadi? Sterminando tutti i suoi adepti? Certamente no, perché si tratta soltanto di persone. Ma l’immagine mondiale, che sospinge la sua campagna militare, è una rete di idee che vive e respira nello scambio che ne fanno milioni di musulmani.
Il massacro di San Bernardino dimostra la sua potenza minacciosa. In quel luogo Tashfeen Malik, madre di un bambino di sei mesi, che viveva col marito in un esemplare sobborgo californiano, si mette in movimento con lui per falciare con il mitra persone che non aveva mai visto prima. Come ha potuto questa azione apparirle sensata e giusta?
Prima di partire per l’assassinio Tashfeen Malik ha giurato fedeltà allo “Stato Islamico” con un post su Facebook. Quando questo scritto è venuto alla luce, nessuno a dire il vero ha chiesto che cosa si sarebbe potuto intraprendere contro questa visione del mondo. Ben Carson, un candidato repubblicano alla Presidenza, ha detto che San Bernardino dovrebbe significare “la fine del dibattito” circa l’accoglienza dei profughi siriani. Donald Trump, che già si era dichiarato a favore della reintroduzione della tortura, ha preteso un divieto generale di entrata per i musulmani. Gran Bretagna, Francia e USA intensificano nel frattempo i bombardamenti in Siria.
È questo il piano? Chiudi i confini, bombarda il Medio Oriente, erigi un muro e mettigli in cima il filo spinato, perché i terroristi e le loro armi non entrino? Il filo spinato può tenere fuori le persone, ma le idee gli scorrono attraverso come acqua. Tuttavia deve essere sconfitta quella visione omicida del mondo che può fare apparire qualsiasi azione di insensata violenza come atto eroico.
A chi punta questa visione del mondo? Essa si indirizza soprattutto a quei musulmani marginalizzati, la cui vita non ha più alcun senso. I figli di musulmani emigrati in Europa o in America sono la prima linea di questo gruppo demografico - giovani uomini e donne, la cui identità è in crisi fin dalla nascita.
Conosco questo fenomeno per la mie esperienze fra i richiedenti asilo e i profughi afghani in America. Il loro primo contatto con il mainstream americano i bambini lo hanno avuto in quelle famiglie, in quelle scuole statali, in cui molti sono stati trattati con disprezzo per la loro appartenenza all’Islam. Se poi hanno cercato di comportarsi nel miglio modo possibile come americani, i loro sforzi sono andati a sbattere contro il sarcasmo e la derisione. Dopo queste lezioni sono tornati a casa dai loro genitori, i quali sognavano di una patria perduta, di un tempo e una cultura che i ragazzi non avevano mai conosciuto. Se i figli si comportavano lì come americani incombevano su di loro accuse e rimproveri. Così essi facevano del loro meglio per comportarsi come buoni afghani musulmani. Un giovane mi disse: «A casa faccio come se fossi afghano. Poi esco e faccio come fossi americano. Mi chiedo: quando sono veramente me stesso?».
Lo Stato Islamico (Daesh) conosceva il suo pubblico
Mentre l’espansionismo occidentale travolgeva la loro civiltà, nel mondo arabo le persone si attaccavano al loro solo sogno perduto - la fantasia romantica degli «incrollabili vincoli famigliari». Ma come dovunque altrove, anche qui è accaduto lo stesso: la modernità industriale e il capitalismo hanno dissolto le strutture della stirpe e del clan. La rete emotiva della società tradizionale è stata sostituita da un mondo di nuclei monofamiliari e di individui, ognuno dei quali segue il suo proprio singolo destino. I ruoli tipici tradizionali dei sessi non reggono più.
Poi sullo schermo appare lo Stato Islamico. Che conosceva il suo pubblico. Offriva una visione del mondo che era sintonizzata perfettamente su queste situazioni, questa schiera imponente di potenziali reclute.
L’ideologia dello Stato Islamico non ha niente a che fare con l’Islam, l’Islam è la religione della pace, perorano troppo spesso molte voci benpensanti. Tutto ciò è poco sincero. La visione del mondo delio Stato Islamico ha a che fare naturalmente con l’Islam. Se non fosse così non susciterebbe tanta eco. Effettivamente l’immagine del mondo [di Daesh] si inserisce perfettamente nella storia, tanto amata dai musulmani, delle loro origini. Molto tempo fa vi fu un piccolo gruppo di anime pure che si attenevano precisamente e minuziosamente alle direttive che Dio aveva loro imposto. Queste persone stavano di fronte a un nemico spietato, che le voleva eliminare. Ma la comunità aveva come guida l’unica persona sulla Terra che fosse ispirata direttamente dall’Unico Dio. Sotto la sua guida la piccola comunità si pose con successo in difesa e poi portò la lotta nel campo nemico. Essa conseguì vittoria dopo vittoria, finché dominò il mondo (o almeno la parte più importante di questo). Questa è la storia della quale lo Stato Islamico si serve. E ha la forza di un mito.
Questa storia, obiettivamente considerata, esiste, perché centinaia di milioni di persone la conoscono e con essa sono cresciute. Uccidere qualche persona che conosce questa storia non uccide la storia stessa. Una visione del mondo può essere eliminata soltanto da un’altra visione e quella che domina lo Stato Islamico non può sorgere da alcuna origine occidentale. Non può derivare da concetti e valori di una cultura occidentale laica, con idee come “Libertà”, “Democrazia”, “Capitalismo” e “Parificazione della donna” come punti di arrivo prestabiliti. Può avere forza soltanto se è nata dal mondo islamico, abbozzata da teologi musulmani, che godono di stima per la loro erudizione. Il punto-chiave: devono utilizzare la medesima storia delle origini della quale lo Stato Islamico fa uso, ma giungere a conclusioni differenti.
Ma da scritti, dottrine e tradizioni dell’Islam può veramente svilupparsi una visione del mondo progressista e modernistica? Naturalmente! Tutti gli ingredienti sono a portata di mano. La tolleranza nei confronti di chi crede diversamente, per esempio. Che cosa hanno fatto i primi musulmani, dopo essersi spostati da La Mecca a Medina, la loro nuova patria? Formularono il regolamento comunitario di Medina, la prima Costituzione apparsa al mondo. Le loro regole dovrebbero garantire che le diverse comunità vivano le une accanto alle altre con armonia, ognuna alla sua maniera.
E i diritti delle donne? Sotto la guida del profeta Maometto, nell’ambito interno della comunità svolsero un ruolo centrale alcune eminenti personalità femminili - come Chadisha, Aicha, Fatima. Nell’Islam primitivo lo status delle donne fu migliorato, per la prima volta fu concesso loro di ereditare denaro, avere proprietà, ottenere il divorzio. Per quei tempi furono passi radicali.
O il tema delle atrocità in guerra. Scritti musulmani e sentenze di Maometto fissarono regole e condizioni che avrebbero dovuto limitare gli eccessi in guerra - precoci precursori della Convenzione di Ginevra.
Tutti questi elementi sono parte della preistoria, mitica e originaria, dell’Islam. Sì, la visione jihadistica del mondo ha pienamente a che fare con l’Islam, ma non è la stessa cosa dell’Islam. È soltanto una delle molte visioni del mondo che si fanno originare dalle medesime fonti storiche. Nessun fondamento teologico di alcun genere smentisce che una forte visione opposta possa entrare in concorrenza con il jihadismo. Il risultato positivo dipenderà da questioni come la seguente: “Come può la sharia essere adattata a tempi in mutamento?”. Infatti, anche se gli esempi prima ricordati si spostassero come fossero stati formulati 1400 anni fa, questo non farebbe ancora dell’Islam una religione progressista.
Una questione di vita o di morte
Tuttavia si può pensare la sharia così che gli odierni musulmani possano agire diversamente da come avrebbero fatto nel VII secolo? I jihadisti dicono che questo non sarebbe possibile: la sharia non potrebbe adeguarsi ai tempi, ma i tempi dovrebbero adattarsi alla sharia. Ma si deve proprio intendere la sharia come un ammasso di prescrizione e istruzioni da prendere alla lettera? Non si può considerarla come un tesoro di principi profondi, che guidano il comportamento secondo la morale? E se sì, come vengono applicati questi principi? Nel mondo musulmano questa è oggi una questione di vita o di morte.
Essa non si deciderà alla fine sui campi di battaglia, ma nei seminari e nelle aule di studio. Perché possa avviarsi una interpretazione progressista dell’Islam, quest’ultimo deve oggi adattarsi alle realtà della vita islamica. I musulmani che vivono nel mondo occidentale si sentono marginalizzati e derubati della loro identità. La struttura sociale delle loro società di origine è inteso come in decadimento. I musulmani stanno sulle rovine del loro mondo davanti alla sfida di dare un senso alla loro vita.
Coloro che decidono politicamente in Occidente non possono sollevarli da tutto questo, ma hanno tuttavia una funzione da espletare. Essi possono rendere ciò più facile o più difficile per gli intellettuali musulmani. Quando in Europa o in America i politici vietano i copricapo religiosi, quando parlano di documenti d’identità speciali, quando chiudono le frontiere ai profughi musulmani oppure - come adesso negli Stati Uniti si dibatte durante la campagna elettorale - vogliono introdurre esami di religione, per fare sì che nel Paese entrino soltanto cristiani, essi li spingono nelle braccia dello Stato Islamico. È la conferma delle affermazioni dei jihadisti: che questo scatena una lotta apocalittica fra due potenti blocchi. Uomini come i candidati repubblicani Donald Trump, Ben Carson e Ted Cruz si comportano quasi come fossero adepti dormienti dello Stato Islamico. Quale pazzia! Infatti la vera competizione oggi ha luogo non già fra l’Islam e l’Occidente, bensì fra due visioni musulmane del mondo.
Immaginatevi di vivere da qualche parte nel mondo come musulmano. Vi trovereste nuovamente fra due visioni del mondo. Una delle quali indica che è iniziata una lotta di proporzioni epiche. Voi avete la possibilità di aggregarvi a lato di chi è predestinato ad essere il vincitore e potreste salire al rango di eroe immortale. L’altra visione spiega una volta di più che alcune persone sono civilizzate e degne, ma voi non ne fate parte. Voi non siete altro che gentaglia meritevole di abominio, che certo può vivere, ma che non ha nulla di buono da apportare. Vi si terrà continuamente d’occhio e vi si disprezzerà. Probabilmente finirete in prigione e sarete torturato. Ora vi chiedo: per quale visione del mondo optereste?
- traduzione dal tedesco di José F. Padova (Nota: A chi appartiene il Cristianesimo? Ai cattolici o ai protestanti? Per “rispondere” a questa domanda ci sono state le Guerre di Religione, i bruciati vivi sul rogo, cuius regio eius religio, devastazioni spaventose, Westfalia e le ripartizioni territoriali. Alla morte di Maometto, 632 d.C., iniziò una situazione analoga, con sciiti (devoti ai loro imam, vedi l’Iran odierno) e sunniti, di manica un poco più larga.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- COSTITUZIONE E "BUONA SCUOILA". Dall’ANP un vergognoso attacco alla democrazia scolastica (di Marina Boscaino)28 dicembre 2015, di Federico La Sala
- CHI INSEGNA A CHI CHE COSA COME?! QUESTIONE PEDAGOGICA E FILOSOFICA, TEOLOGICA E POLITICA
INSEGNAMENTO E COSTITUZIONE: CHI INSEGNA AI MAESTRI E ALLE MAESTRE A INSEGNARE?!
MARINA BOSCAINO - Dall’ANP un vergognoso attacco alla democrazia scolastica *
In un paese normale ci si sarebbe aspettati delle scuse accalorate ed il tentativo di allontanare in tutti i modi accuse e sospetti. Ma il nostro - il paese di Mussolini, Tambroni, Scelba, Pomicino, De Michelis, Craxi, Berlusconi, Scilipoti, Renzi - non è un paese normale. È accaduto che l’ANP (Assoziazione Nazionale Dirigenti Scolastici e Alte professionalità) abbia pubblicato delle slides per la formazione, che nei giorni scorsi hanno suscitato un grande e ragionevole scandalo.
 Veniva infatti in esse segnalato un identikit di “docente contrastivo” (leggi pensante, divergente, critico, dialettico, incapace di ossequio e di acquiescenza) indesiderabile nella “Buona Scuola”. Non solo. Il materiale per la formazione passava dalla compiaciuta considerazione che gli insegnanti “non avranno la certezza di una scuola vita natural durante, come adesso”, all’ossimorica celebrazione del dirigente “specialista del generale”.
Veniva infatti in esse segnalato un identikit di “docente contrastivo” (leggi pensante, divergente, critico, dialettico, incapace di ossequio e di acquiescenza) indesiderabile nella “Buona Scuola”. Non solo. Il materiale per la formazione passava dalla compiaciuta considerazione che gli insegnanti “non avranno la certezza di una scuola vita natural durante, come adesso”, all’ossimorica celebrazione del dirigente “specialista del generale”.Il deprecato regime della collegialità e dell’elettività - per ANP fortunatamente superato dall’attuale centralità del DS, normata dalla “Buona Scuola” - avrebbe consentito agli insegnanti di approvare nei Collegi e nei Consigli di istituto atti di indirizzo viziati addirittura da “conflitto di interessi”. Occorre dunque spazzare via le prerogative degli organi collegiali, sembra indicare il vademecum e liberarsi di tutta la residuale democrazia scolastica.
 Come intervenire? Semplice. È tutto descritto nelle slides: il Ptof va portato in Collegio Docenti "quando vi siano le condizioni per raccogliere il consenso" per "una discussione da contenere quanto più possibile" ed "evitando mozioni di tipo ostruzionistico e comunque illegittime"; e poi in Consiglio di Istituto cui spetta, secondo la 107, "approvare" il testo. E qui l’ANP si preoccupa perché "potrebbe significare che può modificarlo": "si tratta di un evento da evitare con ogni cura" e allora "il Dirigente avrà preparato accuratamente la delibera" "che sostanzialmente dovrà essere una ratifica". Ecco, in un’unica, sapiente mossa, spazzato via il diritto di rappresentanza di docenti, genitori, studenti, personale Ata, casomai anche tra questi ci fosse qualche “contrastivo”.
Come intervenire? Semplice. È tutto descritto nelle slides: il Ptof va portato in Collegio Docenti "quando vi siano le condizioni per raccogliere il consenso" per "una discussione da contenere quanto più possibile" ed "evitando mozioni di tipo ostruzionistico e comunque illegittime"; e poi in Consiglio di Istituto cui spetta, secondo la 107, "approvare" il testo. E qui l’ANP si preoccupa perché "potrebbe significare che può modificarlo": "si tratta di un evento da evitare con ogni cura" e allora "il Dirigente avrà preparato accuratamente la delibera" "che sostanzialmente dovrà essere una ratifica". Ecco, in un’unica, sapiente mossa, spazzato via il diritto di rappresentanza di docenti, genitori, studenti, personale Ata, casomai anche tra questi ci fosse qualche “contrastivo”.Un altro punto qualificante è la citazione relativa ai Marines - Don’t ask, don’t tell (“non chiedere, non dire”) - utile per invitare a non sollecitare proposte: concezione post renziana di dibattito, confronto, dialettica (sintetizzati - nello strano mondo di Anp - nel concetto di “ostruzionismo”).
Una serie di gaffes a dir poco imbarazzante, che inficia decisamente l’immagine dell’Anp, il senso della scuola come organo dello Stato e dell’esercizio della democrazia; e non come potentato di qualche modesto burocratino, arrogante e asfittico che gioca a fare il dittatore di provincia, vanificando decenni di battaglie per la democrazia scolastica e per la scuola della Repubblica.
Sorprendemente la risposta alle critiche, come si diceva, non sono state scuse; ma un ulteriore, incredibile rigurgito di arrogante autoritarismo. Infatti, in una riunione al Miur di qualche giorno fa, l’Anp si è difesa, etichettando l’intera questione come “strumentale” e opponendo alcune domande, che - qualora ce ne fosse bisogno - non fanno che aggravare la situazione e rendere ancora più esplicita l’assoluta incapacità di questa associazione di assumere una posizione differente da una volontaria esasperazione della conflittualità, quella tra dirigenti scolastici e docenti, indotta dalla legge 107.
“Basterà solo il richiamo ad uno dei più noti e sperimentati strumenti logici per vagliare la validità di un’affermazione: quello che va sotto il nome di “prova ex adverso”. Cosa accadrebbe se la categoria concettuale e comportamentale della “contrastività”, cui con orgoglio si richiamano non pochi dei nostri più accesi contestatori, fosse assunta a criterio regolatore della vita delle scuole, e delle comunità in genere? O, più banalmente, degli studenti nei confronti di quegli stessi docenti?”
Sono domande che minano alla base non solo i principi della democrazia scolastica e della libertà di insegnamento. Ma l’intero concetto di democrazia e partecipazione. Sono il segno scellerato di questo tempo triste ed angusto, quello degli omuncoli che - protetti evidentemente da chi percepiscono come più forte e più potente - alzano la testa. Finalmente senza censure e freni inibitori, legittimati da esempi più illustri e da una norma che serve da abbrivio per consentire interpretazioni di autorità arbitraria e liberticida, spacciati per efficienza ed ammantati di tecnicismi in salsa di modernità.
Siete davvero disponibili a lasciare i vostri figli, nipoti, le future generazioni in mano ad un manipolo sconsiderato, all’autoritarismo più becero? Noi no, perché consideriamo la libertà dell’insegnamento e la libera circolazione delle idee, la manifestazione delle opinioni e il pensiero divergente non una garanzia per i docenti. Ma una tutela per chiunque voglia iscrivere uno studente alla scuola pubblica con la convinzione di poter esigere da quella istituzione dello Stato il rispetto di qualsiasi identità, individualità, precipuità quello studente incarni, senza differenza di sesso, razza, convinzioni politiche, condizioni economiche e sociali, credo religioso.
Anche per quella scuola - la scuola della Costituzione, pubblica, laica, pluralista, democratica, inclusiva - hanno peraltro sacrificato la propria vita alcuni “contrastivi” d’eccellenza: Gramsci, Pertini, Gobetti, a cui sono intitolate alcune istituzioni scolastiche repubblicane; e non per caso. Senza la cui capacità di fare della propria “contrastività” esattamente il proprio “criterio regolatore”, il senso del proprio essere al mondo, il nostro Paese non avrebbe conosciuto quella democrazia che sta ignobilmente dilapidando.
Insomma: vergogna! L’ANP deve chiedere scusa. I dirigenti scolastici in servizio - quelli che non hanno partecipato ad una sola dei grandi momenti di mobilitazione degli ultimi anni contro lo scempio della scuola della Repubblica - si devono dissociare apertamente da dichiarazioni e intenzioni che sono - quelle sì - apertamente in contrasto con qualcosa con cui non si può entrare in conflitto legittimamente: la Costituzione, e non solo negli artt. 33 e 34.
E il ministro Giannini deve uscire dal suo offensivo silenzio e dire in modo esplicito cosa pensa di una vicenda che vilipende non solo la dignità professionale di docenti incapaci di ossequiare il capo di turno con acritica osservanza delle regole del quieto vivere; ma la democrazia intera in un Paese che ha perduto, assieme alla capacità di vigilare, anche quella di individuare limiti oltre i quali non è possibile andare. L’epica dell’uomo solo al comando, incarnata dal presidente del Consiglio segretario di partito, rischia di essere esportata definitivamente nel luogo in cui più che in ogni altro la libertà di espressione ha una funzione sacra, nel senso più laico della parola.
Marina Boscaino
- CHI INSEGNA A CHI CHE COSA COME?! QUESTIONE PEDAGOGICA E FILOSOFICA, TEOLOGICA E POLITICA
INSEGNAMENTO E COSTITUZIONE: CHI INSEGNA AI MAESTRI E ALLE MAESTRE A INSEGNARE?!
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI OGGI?! --- L’EUROPA E IL SUO FUTURO. Il volume del 2045 della "Oxford History of Modern Europe"23 dicembre 2015, di Federico La Sala
Il futuro dell’Europadi Timothy Garton Ash (la Repubblica, 23.12.2015)
ESTRATTO dal volume della collana Oxford History of Modern Europe pubblicato nel 2045:
- «I primi mesi del 2005 si possono considerare l’apogeo del cosiddetto progetto europeo. Nella primavera precedente dieci Stati dell’Europa centrale e orientale aderirono all’Unione Europea, dando vita al più ampio commonwealth di democrazie liberali della storia d’Europa. L’Unione propose un trattato costituzionale, noto come Costituzione europea. La moneta unica, l’euro, pareva valida e Paesi come Spagna, Portogallo e Grecia ebbero l’impressione di entrare in sinergia con il nucleo storico dell’Europa unita, attorno a Germania, Francia, Belgio e Olanda. Molti europei erano pervasi da una sensazione di ottimismo, vedevano nell’Ue un faro di progresso, come sistema di ordine internazionale regolamentato e come modello sociale. Lo scoppio della “rivoluzione arancione” pro europea in Ucraina convinse il presidente russo Putin che l’Ue, all’apparenza inoffensiva, costituiva una minaccia al suo potere. Persino lo scettico Tony Judt, nella sua storia dell’Europa post-45 pubblicata nel 2005 scrisse che “il XXI secolo potrebbe appartenere ancora all’Europa”. Il decennio successivo tuttavia dimostrò del tutto illusorie queste ipotesi grandiose.
 Le crisi che seguirono, a partire dalla bocciatura della costituzione europea nei referendum in Francia e Olanda, per passare alla crisi decennale di un’eurozona mal congegnata, l’annessione da parte russa di alcune aree dell’Ucraina, gli attacchi terroristici islamisti, il referendum britannico sull’uscita dall’Ue, milioni di profughi in fuga dal Medio Oriente e dall’Africa, nonché la crescita dei partiti euroscettici e xenofobi portarono i leader europei a vacillare storditi, come il pugile ucraino Klitschko sotto i colpi del suo sfidante britannico Fury.
Le crisi che seguirono, a partire dalla bocciatura della costituzione europea nei referendum in Francia e Olanda, per passare alla crisi decennale di un’eurozona mal congegnata, l’annessione da parte russa di alcune aree dell’Ucraina, gli attacchi terroristici islamisti, il referendum britannico sull’uscita dall’Ue, milioni di profughi in fuga dal Medio Oriente e dall’Africa, nonché la crescita dei partiti euroscettici e xenofobi portarono i leader europei a vacillare storditi, come il pugile ucraino Klitschko sotto i colpi del suo sfidante britannico Fury.
 Purtroppo i leader europei riuniti a Bruxelles nel dicembre 2015 per uno dei soliti interminabili vertici non seppero rendersi conto di quanto fosse profonda la crisi esistenziale dell’Unione.
Purtroppo i leader europei riuniti a Bruxelles nel dicembre 2015 per uno dei soliti interminabili vertici non seppero rendersi conto di quanto fosse profonda la crisi esistenziale dell’Unione.
 L’Unione Europea non crollò all’improvviso, alla maniera dell’Impero romano, come ebbe a dire uno storico, con orde di barbari a occupare i palazzi della burocrazia di Bruxelles.
L’Unione Europea non crollò all’improvviso, alla maniera dell’Impero romano, come ebbe a dire uno storico, con orde di barbari a occupare i palazzi della burocrazia di Bruxelles.
 Ebbe un declino più simile a quello del Sacro romano impero: i trattati, il cerimoniale e le istituzioni restarono formalmente in vita, ma sempre più svuotati del loro significato. Così la decisione di sciogliere formalmente l’Unione europea nel 2043 non fu altro che la tardiva presa di coscienza di una realtà politica preesistente».
Ebbe un declino più simile a quello del Sacro romano impero: i trattati, il cerimoniale e le istituzioni restarono formalmente in vita, ma sempre più svuotati del loro significato. Così la decisione di sciogliere formalmente l’Unione europea nel 2043 non fu altro che la tardiva presa di coscienza di una realtà politica preesistente».
Nessuno conosce il futuro. Nulla di quanto sopra descritto è inevitabile. Ma è uno scenario plausibile per il futuro dell’Ue. Dovremmo però fare il possibile per scongiurarlo. Churchill disse che la democrazia è la peggior forma di governo possibile, eccezion fatta per tutte le altre forme che si sono sperimentate nel tempo. L’Europa in cui viviamo è l’Europa peggiore possibile, eccezion fatta per tutte le altre Europe sperimentate fin qui. Nessuna alleanza è durata per sempre, ma dovremmo augurarci che l’Europa duri il più a lungo possibile.
L’élite europea criticherà questo mio approccio come troppo pessimista, addirittura disfattista. Mi accuseranno di esprimere un “punto di vista britannico”, incarnando inconsapevolmente proprio quel genere di pregiudizio nazionale che sostengono di voler sconfiggere. In realtà questo mio realismo pessimista costituisce una base ben più solida su cui ricostruire il traballante progetto europeo di quanto non lo sia l’interpretazione Whig della storia come continuo progresso, una pia illusione che caratterizza larga parte dell’euro-dibattito.
L’Europa è conciata male: il primo passo verso la guarigione sta nell’ammettere la gravità della malattia, non certo nel negarla. Siamo di fronte a tante problematiche: profughi, xenofobia, Eurozona, Ucraina, la Brexit - per molti dei quali non esistono soluzioni totali, ma solo parziali, che ci permettano di andare avanti. Non è il momento di grandi disegni. Molti colleghi europei stanno tornando all’idea di un’Europa a più velocità, con un nucleo centrale in testa e il resto che segue, pena l’emarginazione. Questa non è e non sarà la realtà.
Rifiutare la retorica dei grandi disegni progressisti non significa semplicemente ricadere nel pragmatismo disorganico, quello che Der Spiegel ha definito die Philosophie des Durchmuddelns (la filosofia del tirare a campare). Due fili cuciono insieme i diversi pezzi di stoffa di questo patchwork: un nuovo futuro e il possibile ritorno di un triste passato.
Di fronte a potenze emergenti come Cina, India, Brasile, non solo l’Europa ma l’Occidente non dettano più le regole. In questo mondo di giganti i Paesi europei hanno bisogno di una dimensione che solo la loro Unione può dare. È una tesi interessante, ma poco allettante, soprattutto agli occhi dei giovani spagnoli disoccupati o dei francesi che non riconoscono più il loro Paese. Il secondo filo è il passato europeo che potrebbe tornare nel nostro futuro. Abbiamo assistito a flashback della barbarie che ha caratterizzato il XX secolo in Europa. Guerra in Ucraina. Professionisti della classe media costretti a fare la coda alle mense dei poveri ad Atene. Terrore nelle strade di Parigi. Il cadavere del bimbo profugo restituito dal mare su una spiaggia del Mediterraneo. Antisemitismo, razzismo e espressioni di becero pregiudizio contro i musulmani. In qualche modo continuiamo a considerarle eccezioni, ma se diventassero la regola?
Il progetto della comunità politica europea è insolito in quanto il suo avversario, “l’altro” che ne definisce l’identità è il suo stesso passato. Per tre generazioni, le memorie individuali della guerra, dell’occupazione, dell’Olocausto, delle dittature fascista e comunista sono state la motivazione più forte e profonda a favore dell’integrazione europea. Dato che la maggioranza dei giovani europei non ha più queste memorie individuali, abbiamo più che mai bisogno della memoria collettiva che chiamiamo storia. Per evitare un brutto futuro dobbiamo far sì che le nuove generazioni non dimentichino il nostro triste passato che potrebbe oggi ritornare in forme nuove e vecchie. Come scrisse Bertolt Brecht: «L’utero da cui è sgusciato fuori è ancora fertile» . Ancora non è troppo tardi per riscrivere il volume del 2045 della Oxford History of Modern Europe, ma non abbiamo tempo fino al 2045 per farlo.
 Traduzione di Emilia Benghi
Traduzione di Emilia Benghi - «I primi mesi del 2005 si possono considerare l’apogeo del cosiddetto progetto europeo. Nella primavera precedente dieci Stati dell’Europa centrale e orientale aderirono all’Unione Europea, dando vita al più ampio commonwealth di democrazie liberali della storia d’Europa. L’Unione propose un trattato costituzionale, noto come Costituzione europea. La moneta unica, l’euro, pareva valida e Paesi come Spagna, Portogallo e Grecia ebbero l’impressione di entrare in sinergia con il nucleo storico dell’Europa unita, attorno a Germania, Francia, Belgio e Olanda. Molti europei erano pervasi da una sensazione di ottimismo, vedevano nell’Ue un faro di progresso, come sistema di ordine internazionale regolamentato e come modello sociale. Lo scoppio della “rivoluzione arancione” pro europea in Ucraina convinse il presidente russo Putin che l’Ue, all’apparenza inoffensiva, costituiva una minaccia al suo potere. Persino lo scettico Tony Judt, nella sua storia dell’Europa post-45 pubblicata nel 2005 scrisse che “il XXI secolo potrebbe appartenere ancora all’Europa”. Il decennio successivo tuttavia dimostrò del tutto illusorie queste ipotesi grandiose.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- L’EUROPA, GLI ULIVI, E L’AFFAIRE XYLELLA. La procura di Lecce salva gli ulivi e indaga commissario e scienziati (di M. Mastrogiovanni)20 dicembre 2015, di Federico La Sala
- TERRA!!! TERRA!!! PIANETA TERRA: FILOLOGIA E ’DENDROLOGIA’ (gr.: "déndron" - albero e "lògos" - studio/scienza) DELLA VITA ...
 RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". Per la rinascita dell’EUROPA, e dell’ITALIA. La buona-esortazione del BRASILE. Una "memoria"
RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". Per la rinascita dell’EUROPA, e dell’ITALIA. La buona-esortazione del BRASILE. Una "memoria"
Italia
La procura di Lecce salva gli ulivi e indaga commissario e scienziati dell’emergenza xylella
Salento. Sequestrati gli ulivi soggetti ad eradicamento forzato. Con i nuovi accertamenti scientifici di fatto vengono a cadere i presupposti per chiedere l’emergenza e la calamità naturale, in base alle quali si sta già usufruendo di ingenti fondi pubblici, sia ministeriali sia europei
di Marilù Mastrogiovanni (il manifesto, 20.12.2015)
Non uno ma nove diversi ceppi di xylella. E non dal 2013, ma probabilmente da molti anni prima. Oppure, altra ipotesi, introdotti recentemente in più tranche. La Procura di Lecce rimescola le carte, indica altre verità rispetto a quelle indicate dal CNR e dall’Università di Bari, dalla Regione Puglia e dal Ministero delle politiche agricole e sequestra preventivamente (con facoltà d’uso per garantirne la cura e la raccolta delle olive da parte dei proprietari) gli ulivi che il Commissario per l’emergenza xylella, Giuseppe Silletti, avrebbe ripreso a sradicare già dal 16 dicembre. Se non glielo avessero impedito gli agricoltori e i cittadini, frapponendosi tra le ruspe e gli ulivi.
E lo indaga.
Indaga Silletti e altri nove protagonisti del grande affaire xylella.
Antonio Guario, 64 anni, in qualità di ex dirigente dell’Osservatorio fitosanitario regionale di Bari;
Giuseppe D’Onghia, 59 anni, dirigente del Servizio Agricoltura area politiche per lo sviluppo rurale della Regione Puglia;
Silvio Schito, 59 anni, dirigente dell’Osservatorio fitosanitario regionale di Bari;
Giuseppe Blasi, 54 anni, capo dipartimento delle Politiche europee ed internazionali e dello Sviluppo rurale del Servizio fitosanitario centrale;
Nicola Vito Savino, 66 anni, professore universitario e direttore del centro di ricerca, sperimentazione e formazione in agricoltura Basile Caramia di Locorotondo;
Franco Nigro, 53 anni, micologo di Patologia vegetale dell’università di Bari;
Donato Boscia, 58 anni, responsabile della sede operativa del Cnr dell’istituto per la Protezione sostenibile delle piante;
Maria Saponari, 43 anni, ricercatrice del CNR dell’istituto per la Protezione sostenibile delle piante;
Franco Valentini, 44 anni, ricercatore dello IAMB.
Diverse le ipotesi di reato: diffusione di fitopatologia, falso ideologico, violazioni colpose delle disposizioni ambientali, deturpamento di bellezze naturali, turbativa violenta del possesso di cose immobili.
Dunque gli alberi d’ulivo sui quali pende l’ordinanza di abbattimento del commissario straordinario per l’emergenza xylella, Giuseppe Silletti, sono stati sequestrati preventivamente per impedire che si sradichino sulla base di decisioni poggiate su falsi presupposti, sia scientifici sia, di conseguenza, amministrativi.
Una figuraccia internazione, sia del Ministero delle politiche agricole, sia della comunità scientifica italiana, in particolare il CNR di Bari e l’Università di Bari, sia della Regione Puglia.
Il capo della procura di Lecce Cataldo Motta ha fissato i primi paletti di un’indagine condotta con ritmo serrato in un anno e mezzo e partita dall’esposto di due associazioni: Forum ambiente e salute e Spazi popolari.
“Siamo partiti dagli esposti ma poi le indagini hanno preso una piega diversa - ha tenuto a precisare il procuratore - agendo, come sempre accade, in maniera autonoma”.
Le indagini, coordinate dalle pm Elsa Valeria Mignone e Roberta Licci, che hanno incaricato un pool di esperti per verificare i presupposti scientifici su cui si sono basate le decisioni prese dalla Regione Puglia e comunicate alla Ue, hanno riscontrato l’esistenza di ben 9 ceppi di xylella fastidiosa, non uno solo, come affermato dai ricercatori del CNR.
Questo induce a concludere che è molto verosimile che la xylella sia presente nel Salento da molto tempo e che si sia nel tempo mutata geneticamente, come è normale facciano i batteri per adeguarsi all’ambiente in cui vivono. Oppure che sono state introdotte più tipologie di xylella che poi si sono mescolate tra loro.
I consulenti tecnici della procura avanzano diverse ipotesi ma di certo si può affermare che diversi tipi di xylella sono presenti da molti anni e da molto tempo prima rispetto a quando è stata comunicata la sua presenza alla Ue da parte dell’Istituto fitosanitario regionale, cioè il 15 ottobre 2013.
Di fatto vengono a cadere i presupposti per chiedere l’emergenza e la calamità naturale, in base alle quali si sta già usufruendo di ingenti fondi pubblici, sia ministeriali sia europei.
Si tratterebbe di indebita percezione di finanziamenti ministeriali ed europei? Le indagini su questo e su molto altro sono ancora aperte, inclusa l’analisi della memoria dei pc sequestrati al CNR di Bari, ancora sotto la lente d’ingrandimento della procura; per ora non è ipotizzato il dolo, semplicemente perché è difficile provarlo, ma sono ipotizzati “solo” la “colpa”, l’imperizia, la superficialità, la negligenza.
“E’ anche da precisare, ha dichiarato Motta, che la Ue non impone di sradicare gli alberi e che anzi l’Efsa (l’Autorità europea per la sicurezza alimentare) ha precisato che sradicare gli alberi non serve per eradicare il batterio, eppure è stata una scelta della Regione Puglia, quella di sradicare gli ulivi per bloccare l’avanzamento della presunta infezione da xylella.
La “Ue è stata indotta in errore in base a dati impropri e non del tutto esatti comunicati dagli uffici regionali”, ha detto Motta.
In una parola, sono state prodotte false dichiarazioni alla Ue.
Inoltre, ha detto Motta, le piantine di vite infettate da xylella fastidiosa per l’ormai famigerato seminario del 2010 tenutosi presso lo Iamb di Valenzano, sono entrate in Europa senza “passaporto verde”, cioè senza alcuna autorizzazione.
Abusive.
Il colpo di scena è stato che la procura è riuscita, con i suoi periti, a dimostrare con la logica e senza effettuare l’attesa prova di patogenicità del batterio xyella fastidiosa sugli ulivi (prova che ancora manca), che non c’è relazione diretta tra la presenza del batterio e il disseccamento.
“Abbiamo fatto delle analisi su ulivi sani, cioè senza sintomi di disseccamento, e c’era xylella; abbiamo fatto le stesse analisi su ulivi con gravi sintomi di disseccamento e la xylella non c’era”, ha detto Motta.
Il Piano Silletti bis dunque è definitivamente fallito: da una parte il sabotaggio dei cittadini, che hanno bloccato le ruspe, ponendo i loro corpi tra i mezzi meccanici e gli alberi, occupando le strade e la ferrovia; dall’altra le decine di ricorsi al Tar e i due ricorsi alla Corte di giustizia europea; infine la Procura, che ha bloccare lo sradicamento degli ulivi, sequestrandoli.
Questa è solo la punta dell’iceberg del grande affaire xylella fastidiosa, le indagini proseguono e c’è da star certi che altri colpi di scena seguiranno.
Il problema è che, come sempre accade in Italia, si possono perseguire gli esecutori di un delitto, ma i mandanti sono difficili da trovare.
Dovranno però, al di là delle indagini della Procura, dare conto ai pugliesi i responsabili politici di questo scempio: l’allora presidente della regione Puglia Nichi Vendola, l’ex assessore Fabrizio Nardoni, il ministro Martina, che dovrebbe immediatamente dimettersi (avendo comunicato falsità alla Ue e avendo speso soldi pubblici per un’emergenza e una calamità che non ci sono) il senatore Dario Stefàno, l’ex presidente della Commissione agricoltura Paolo De Castro e attuale direttore scientifico del Ciheam, organismo internazionale cui fa capo lo Iamb di Bari, che gode di immunità extraterritoriale, per cui la Procura non ha potuto sequestrare alcun documento o pc che non fosse volontariamente messo a disposizione dallo stesso Istituto agro mediterraneo di Bari.
Se la Ue è stata indotta in errore da false comunicazioni della Regione Puglia, del CNR di Bari e di conseguenza del Ministero, c’è dunque da aspettarsi un annullamento della procedura di infrazione avviata dalla Ue nei confronti dell’Italia, come chiesto dai tanti comitati a difesa degli ulivi sorti in Puglia.
* Direttrice del Tacco d’Italia e del supplemento digitale xylellareport.it
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- L’EUROPA E L’AFFAIRE XYLELLA. La procura di Lecce salva --- GLI OLIVI GIGANTI DEL SALENTO.20 dicembre 2015, di Federico La Sala
GLI OLIVI GIGANTI DEL SALENTO
di Alessandro Romano *
Da millenni, olivi giganti, secolari testimoni di epoche e stirpi diverse, si danno il cambio fra loro, accompagnando il cammino dell’uomo su questo territorio. Il volto stesso del Salento ha la chioma verde argentata e il tronco solido e rugoso di questi colossi della natura, che hanno sfamato, accresciuto, accudito con la loro generosità le genti salentine.
Come dimostrano anche le pitture vascolari rinvenute un pò ovunque, la coltivazione di questi alberi era praticata intensamente già ai tempi di Greci e Romani, e fu soltanto dopo la caduta dell’Impero nel 476 d.C. che entrò in crisi. Tornando prepotentemente in auge con i Bizantini, che colonizzarono l’Italia meridionale dopo le guerre con le popolazioni nordiche discese ad occupare la Penisola.
Questo è un breve viaggio per immagini, come facciamo sempre su questo sito, che vuol regalare le emozioni vivide, i “colori”, che queste foto non mancheranno di suscitare, specie nel visitatore forestiero, ma anche nel salentino distratto o cittadino (...per continuare a leggere e, soprattutto, per vedere le immagini, clicca su QUI).
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- Xylella, il procuratore di Lecce accusa: "Europa ingannata, lucrano sull’emergenza" (di Chiara Spagnuolo)20 dicembre 2015, di Federico La Sala
Xylella, il procuratore di Lecce accusa: "Europa ingannata, lucrano sull’emergenza"
Per il capo dei pm Cataldo Motta alla base del caos ci sarebbe una conoscenza incompleta del problema: "Il commissario ha privilegiato solo ipotesi che portavano all’eradicazione"
di CHIARA SPAGNOLO (la Repubblica/Bari, 19 dicembre 2015 - ripresa parziale)
"L’Unione europea è stata tratta in inganno con una falsa rappresentazione dell’emergenza xylella fastidiosa, basata su dati impropri e sull’inesistenza di un reale nesso di causalità tra il batterio e il disseccamento degli ulivi". Per questo l’inchiesta della Procura di Lecce "indagherà anche sui finanziamenti stanziati e usati per l’emergenza, considerato che di emergenza non si tratta".
Il giorno dopo il sequestro di tutti gli ulivi salentini per cui è stata disposta l’eradicazione e l’invio di avvisi di garanzia al commissario di governo e a nove fra dirigenti e ricercatori che si sono occupati del caso, è il capo della Procura leccese, Cataldo Motta, a spiegare il motivo di un provvedimento che ha posto fine ai tagli di alberi e forse anche all’esperienza del commissario Giuseppe Silletti. Alcuni ambientalisti, entrati nella stanza del procuratore poco prima della conferenza stampa, hanno applaudito e mostrato un cartello di ringraziamento ai pm che hanno condotto l’inchiesta. Sul cartello la scritta: "C’è un giudice a Lecce, anzi due. Grazie".
A quest’ultimo viene contestato di avere disposto Piani inappropriati e addirittura dannosi per l’ambiente salentino, a causa del massiccio uso di fitofarmaci. E di eradicazioni a tappeto, che non sembrano affatto risolutive. Il nodo sta tutto nel fatto che la xylella è presente in Puglia "da almeno venti anni" e che allo stato esistono ben nove ceppi diversi, che ne mostrano la mutazione genetica. "Ciò escluderebbe la necessità di interventi emergenziali - ha chiarito Motta - e la stessa legittimazione della quarantena, che è stata la base da cui l’Europa è partita per imporre misure drastiche".
Secondo quanto hanno accertato gli uomini del Corpo forestale (di cui fra l’altro il commissario Silletti è comandante regionale), alla base del caos xylella ci sarebbe innanzitutto una conoscenza incompleta del problema, "determinata dalla scarsità di confronto scientifico e dall’aver privilegiato solo alcune ipotesi, che portavano inevitabilmente alle eradicazioni". Per questo il sostituto procuratore Elsa Valeria Mignone - che ha coordinato l’indagine assieme alla collega Roberta Licci - si è augurata che "inizi proprio da ora un confronto scientifico vero sulla materia", al fine di individuare la strada giusta per combattere il disseccamento rapido degli ulivi.
Sul fatto che i tagli non siano la scelta migliore, i magistrati non hanno dubbi: "l’eradicazione del batterio non si fa con l’estirpazione delle piante - ha chiarito il procuratore capo - E anche l’Unione europea non ha mai imposto di abbattere immediatamente tutti gli alberi malati ma di contenere la malattia, provando prima altre soluzioni". Tentativi che, a quanto pare, non sono stati fatti. E sui quali, a questo punto, bisogna ragionare perché l’Ue chiede comunque risposte che fino a pochi giorni fa si pensava dovessero pagare dalle eradicazioni. Intanto gli indagati penseranno a difendersi. I reati contestati sono diffusione colposa della malattia delle piante, falso ideologico e materiale in atto pubblico, inquinamento ambientale e deturpamento delle bellezze naturali.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- Xylella, il procuratore di Lecce accusa... - Corbellini e Defez fanno di tutte le erbe un fascio e gridano: No ai processi del metodo scientifico!!!24 dicembre 2015, di Federico La Sala
Prima viene il paziente - l’ulivo, poi la "xylella fastidiosa"!!! Non è affatto bene fare di tutte le erbe un fascio, dare fuoco alla propria coda di paglia, e gridare in coro "al lupo, al lupo", a destra e a manca!!!
- Nel 1614 il medico ebreo sefardita Rodrigo De Castro pubblicava ad Amburgo il testo Medicus-politicus, che segna le origini della moderna etica medica con una ispirazione specifica nel richiamare l’attenzione pubblica verso la coincidenza tra virtù morali del medico e astensione dall’inganno o da pratiche fraudolente ai danni dei malati.
- Nel 2015 - La procura di Lecce salva gli ulivi e indaga commissario e scienziati dell’emergenza xylella
 Salento. Sequestrati gli ulivi soggetti ad eradicamento forzato. Con i nuovi accertamenti scientifici di fatto vengono a cadere i presupposti per chiedere l’emergenza e la calamità naturale, in base alle quali si sta già usufruendo di ingenti fondi pubblici, sia ministeriali sia europei (Marilù Mastrogiovanni, il manifesto, 20.12.2015).
Salento. Sequestrati gli ulivi soggetti ad eradicamento forzato. Con i nuovi accertamenti scientifici di fatto vengono a cadere i presupposti per chiedere l’emergenza e la calamità naturale, in base alle quali si sta già usufruendo di ingenti fondi pubblici, sia ministeriali sia europei (Marilù Mastrogiovanni, il manifesto, 20.12.2015).
No ai processi al metodo scientifico
di Gilberto Corbellini, Roberto Defez (La Stampa, 24.12.2015)
Se in Italia sopravvive ancora una comunità scientifica degna di tale nome, ovvero delle accademie scientifiche consapevoli del loro ruolo a difesa dei valori di libertà e indipendenza della scienza, dovrebbero battere urgentemente un colpo. Farsi sentire.
E due colpi li dovrebbero battere il Consiglio Superiore della Magistratura, che è organo a garanzia dell’autonomia e indipendenza del governo della giustizia nel nostro Paese, e i politici che negli anni recenti si sono opposti alla politicizzazione, alla manipolazione e agli abusi di potere perpetrati ai danni della scienza. Senza lasciar fuori il Presidente della Repubblica.
Coloro che si sono indignati contro i tentativi di imporre attraverso sentenze di magistrati le pseudo-cure Di Bella o Stamina o contro il rinvio a giudizio e la condanna in primo grado della Commissione Grandi Rischi, per non aver dato l’allarme per il terremoto dell’Aquila o contro la credenza che i vaccini causino l’autismo, dovrebbero tutti insorgere per quanto sta accadendo nel Salento in merito alla vicenda Xylella fastidiosa, il batterio che sta uccidendo o concorre a uccidere gli ulivi (per ora solo) in quella regione.
Perché si tratta di un caso emblematico di scelte autoreferenziali di un pubblico ministero nell’esercizio dei suoi poteri, che seleziona un ristretto manipolo di esperti scientifici.
Ma, come si scelgono i consulenti scientifici in una materia tanto complessa? Si prendono quelli la cui opinione coincide con quella di un magistrato, o si chiede consulenza ai massimi organi scientifici nazionali e casomai internazionali?
La vicenda è nota già a livello internazionale perché qualche mese fa Nature scrisse un articolo denunciando il «vilipendio» a mezzo inchiesta giudiziaria ai danni degli scienziati che stanno studiando il fenomeno di diffusione del batterio, e il ruolo dello stesso nella sindrome patologica che causa il disseccamento degli ulivi salentini.
Gli ulivi del Salento sono attaccati da un batterio che è considerato, per le sue caratteristiche altamente contagiose e per gli effetti patogeni devastanti sulle piante, una gravissima minaccia a livello mondiale.
Questo batterio causa o concorre a causare una malattia che chiude i vasi della pianta (una specie di arterioscleresi per gli umani) portando al disseccamento degli ulivi e uno dei modi per limitare l’epidemia è sradicare gli ulivi già colpiti, ridurre gli insetti che diffondono Xylella e creare un cordone sanitario che isoli le piante infette.
Nulla di nuovo sotto il sole: la microbiologia dispone di metodo standardizzati per studiare come un agente causale è implicato in una malattia. Come tutte le malattie infettive la sindrome che vede Xylella protagonista ha caratteristiche che dipendono dall’ecologia locale e quindi si dove esaminare sperimentalmente la questione, tenendo conto anche delle linee guida europee e internazionali finalizzate al contenimento del patogeno.
Naturalmente, come fu per l’Aids e la sua causa cioè l’Hiv, ci sono i negazionisti, che con argomenti pretestuosi manipolano le incertezze e generano sospetti sulla trasparenza dei ricercatori o su qualche legame con i soliti poteri economici e con le solite multinazionali che farebbe loro sostenere una posizione che non è tanto scientifica quanto dovuta a interessi loschi.
E’ uno scenario già visto, ma un Paese civile non dovrebbe essere così esposto a questo genere di manovre politiche ai danni della scienza e del metodo che essa utilizza. Di fatto gli scienziati sono indagati per una serie di reati, tra cui quello di aver diffuso colposamente la malattia e di aver presentato i fatti in modo da arrivare ad avvallare come soluzione l’eradicazione delle piante malate. Sulla scia di un immaginario collettivo che ricorda i processi per inquisizione o i linciaggi pubblici per accontentare gli umori rabbiosi di una popolazione alla ricerca di capri espiatori, di far parte di qualche complotto sovrannazionale inteso a distruggere la tradizione agricola salentina, iniziando dagli ulivi.
L’inchiesta del procuratore Cataldo Motta è stata criticata duramente dall’ex Presidente del Tribunale di Bari Vito Savino, che l’ha paragonata alle vicende Di Bella e Stamina.
Ora, la questione su cui vorremmo richiamare l’attenzione, al di là della gravità dei contenuti degli avvisi di garanzia inviati agli scienziati che stavano studiando il fenomeno, riguarda il rapporto tra scienza e magistratura, ovvero come i giudici affrontano emergenze che possono essere capite solo tramite gli strumenti scientifici.
La vicenda salentina è l’ennesimo caso nel quale l’intraprendenza di un magistrato si esercita in un vuoto normativo per quel che riguarda le modalità di acquisire prove che abbiano base scientifica. È accaduto diverse volte, a partire dalla vicenda Di Bella e in modo macroscopico con la vicenda Stamina, nella quale i giudici prescrivevano il trattamento Stamina nonostante si trattasse di un imbroglio.
Sarebbe nell’interesse della magistratura, ma soprattutto, del Paese pensare e predisporre uno strumento che renda meno discrezionale il modo di procedere dei giudici quando le questioni sono precisamente definite dalle regole non negoziabili del metodo scientifico.
*Università La Sapienza
**Biologo e genetista Cnr
-
-
- TERRA!!! TERRA!!! PIANETA TERRA: FILOLOGIA E ’DENDROLOGIA’ (gr.: "déndron" - albero e "lògos" - studio/scienza) DELLA VITA ...
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- "Il fantasma e il desiderio" e "Libertà". Note su due libri di Giulio Giorello (di Antonio Carioti)11 dicembre 2015, di Federico La Sala
Inafferrabile come uno spettroLa libertà di chi non si rassegna
Due libri di Giulio Giorello
di Antonio Carioti (Corriere della Sera, 11.12.2015)
Il pensatore ebreo del Seicento Baruch Spinoza, precursore dell’Illuminismo, non è solo il «filosofo preferito» di Giulio Giorello, ma anche il protagonista del primo racconto incluso nel volume dello stesso Giorello Il fantasma e il desiderio (Mondadori): oltre al coraggio intellettuale, l’autore ne mette in luce il rifiuto di farsi suggestionare e la fiducia nella capacità dell’intelligenza di resistere alle credenze irrazionali, come quella relativa all’esistenza degli spettri.
Tuttavia Spinoza sapeva molto bene che «gli uomini sono guidati più dagli affetti che non dalla ragione». E qui veniamo al secondo libro che Giorello ha pubblicato di recente. Si tratta del saggio Libertà (Bollati Boringhieri), nel quale l’autore afferma con estrema risolutezza - senza se e senza ma, per così dire - il primato filosofico e politico del principio che più gli sta a cuore.
I racconti del volume mondadoriano, omaggi un po’ giocosi al grande scrittore inglese di ghost stories Montague Rhodes James, esprimono questa concezione indirettamente, rivendicando al regno della fantasia un’estensione sconfinata: «Una ragione che ci sequestrasse l’illusione - si legge nel prologo - sarebbe una piccola tiranna che vieta una certa esperienza della libertà». Invece nelle pagine del saggio tutto è più argomentato, sistematico. E Spinoza viene chiamato in causa di nuovo, ma per la sua concezione politica, molto avanzata per i tempi in cui visse, nella quale si possono trovare le premesse del moderno costituzionalismo.
Efficace e letterariamente suggestivo è il richiamo omerico contenuto nel Trattato politico del pensatore nato ad Amsterdam. Ogni governante, in un sistema equilibrato, dovrebbe porre vincoli di legge a se stesso, come fa Ulisse nel canto XII dell’ Odissea , quando ordina ai suoi compagni di tapparsi le orecchie con la cera e di legarlo all’albero della nave, per consentirgli di ascoltare il canto delle Sirene senza soccombere alla tentazione di dar retta alle loro lusinghe, che avrebbero potuto condurre l’imbarcazione alla rovina.
Allo stesso modo il costituzionalismo liberale si è sforzato di porre limiti e bilanciamenti all’attività del potere politico e allo stesso esercizio della sovranità da parte del popolo, in modo da garantire al massimo i diritti individuali. Ma che succede, si domanda a questo punto Giorello, quando la storia muta direzione ed emergono nuove esigenze, impensabili o comunque trascurate nel passato? Si tratta di decidere se «sacrificare la garanzia costituzionale per favorire l’irruzione delle novità o bloccare ogni evoluzione del dettato costituzionale».
Si tratta di un dilemma quanto mai angoscioso, perché una democrazia può benissimo finire per suicidarsi, se resta sorda ai cambiamenti o, al contrario, se si lascia trascinare sulla cattiva strada da pulsioni più o meno apertamente liberticide. Giorello non ha la ricetta in tasca, ma la bussola che ne orienta i giudizi è di schietta matrice libertaria, così come i fantasmi anticonformisti dei suoi racconti. Più dell’intricata questione filosofica riguardante il rapporto tra necessità e autodeterminazione nell’agire umano, gli interessa una «libertà pratica»: non « dal mondo, ma nel mondo». Una libertà che «fa aggio sulla verità», nel senso che le deve essere permesso di mettere in discussione ogni dato ritenuto acquisito, anche in campo scientifico, affinché «l’inquietudine della ricerca non venga meno». E forse in questo caso l’autore sottovaluta, almeno in parte, i pericoli provenienti dai truffatori della pseudoscienza, che spesso si proclamano eretici rispetto all’ufficialità accademica.
Quanto alla politica, Giorello non nasconde la sua ammirazione per lo spirito indomabile di chi rifiuta di sottomettersi: tra gli esempi, accanto a Spinoza, nel libro troviamo Bobby Sands, morto in carcere nel 1981, e un altro nazionalista irlandese, James Connolly; Malcolm X e lo schiavo insorto Babo, coprotagonista del racconto di Herman Melville Benito Cereno. Purtroppo nella storia i rivoltosi sono poi diverse volte diventati despoti. Ma è un rischio da correre, avverte Giorello, perché peggio sarebbe adagiarsi nella rassegnazione.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! DENTRO LA PIU’ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA E POLITICA ITALIANA --- Il Logos disperso nella Foresta nera. Heidegger negli anni del suo «creativo tacere» (di Carlo Galli)11 dicembre 2015, di Federico La Sala
- VOLONTA’ DI POTENZA E DEMOCRAZIA AUTORITARIA. CARLO GALLI NON HA ANCORA CAPITO CHE, NEL 1994, CON IL PARTITO "FORZA ITALIA", E’ NATO ANCHE IL "NUOVO" PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
- STATO DI MINORITA’ E FILOSOFIA COME RIMOZIONE DELLA FACOLTA’ DI GIUDIZIO. Una ’lezione’ di un Enrico Berti, che non ha ancora il coraggio di dire ai nostri giovani che sono cittadini sovrani. Una sua riflessione - con una nota
Il Logos disperso nella Foresta nera
Martin Heidegger Il primo volume dei «Quaderni neri», scritti dal filosofo tedesco negli anni del suo «creativo tacere»
L’adesione al nazismo e la rapida presa di distanza dal regime perché ritenuto espressione di un «materialismo etico»
di Carlo Galli (il manifesto, 12.11.2015)
Il primo tomo dei Quaderni neri di Heidegger, relativi agli anni 1931-1938 (Bompiani, pp. 702, euro 28) - tradotto da Alessandra Iadicicco - documenta un solitario pensare in atto, verso il superamento dell’esistenzialismo di Essere e tempo (che l’autore reputa inadeguato), dell’idealismo tedesco e di ogni scientismo: in pratica, della filosofia moderna e della sua metafisica, e dell’intera tradizione filosofica, che Heidegger vuole mettere in discussione nei suoi presupposti originari.
Alla ricerca del cono d’ombra da cui ha origine il Logos occidentale, che ne è immemore, Heidegger destruttura la tradizione filosofica facendo della filosofia un domandare - un porre l’unica domanda sulla verità dell’Essere a partire dall’«esser-ci». E il domandare non approda alla conoscenza di un concetto ma all’essere esposti «all’assalto dell’Essere», all’emergenza di un’Origine, di un inizio che non si coglie mai, che sempre si ritrae ed eccede, che rispetto a ogni pensiero è più inquietudine che fondamento. La filosofia non è, come voleva Hegel, «il tempo appreso in pensieri»; è pensare contro l’epoca, è un «secondo inizio» dopo quello dei presocratici, tradito da Platone fino ai nostri giorni.
L’incivile selvatichezza
Lungo questo cammino di «demolizione», di solitaria e incivile selvatichezza, Heidegger incontra il nazismo, che definisce come «principio barbarico», come la nuova «posizione fondamentale» che consente di porre la domanda sull’Essere, e quindi di accedere alla negazione dell’intellettualismo e della mediocrità piccolo-borghese, come la «risolutezza del rinunciare e del domandare» (a cui è rivendicato anche il Discorso del rettorato). Nel nazismo l’«esser-ci» prende dunque il corpo del popolo, e il filosofo solitario si scopre seguace del Führer. La filosofia è azione, e il «secondo inizio» è appunto il «nazionalsocialismo spirituale».
La disillusione di Heidegger è rapida. Il nazismo è presto reinterpretato come una «visione del mondo» tra le tante, come una riverniciatura del mediocre mondo civilizzato, come «materialismo etico» cioè come marxismo rovesciato, come regno della piccolezza e della bassezza, come «americanismo», e il popolo è ridimensionato al Man, all’esistenza inautentica. Nessuna discontinuità, quindi, ma anzi la continuità del mondo piccolo-borghese, plebeo, democratico-egualitario, moderno - e intanto Heidegger scatena una violenta polemica contro i suoi critici nazisti -. I Quaderni ci mostrano poi Heidegger, ancora più solitario, teorizzare un «lungo e creativo tacere» e avviarsi verso le riflessioni sulla tecnica e sul nichilismo come verità della metafisica occidentale (in cui il nazismo viene inserito), su Nietzsche «non deturpato dai contemporanei» (cioè denazificato), e sui «venturi», i pochi che nella nuova storia comprenderanno radicalità della sua filosofia.
L’antisemitismo è qui più implicito che esplicito (nei Quaderni successivi si mostrerà più chiaramente); tuttavia Heidegger non rifiuta la tematica della razza ma lamenta semmai che il nazismo la tratti solo in modo biologistico e quindi non «spirituale». In ogni caso, è scioccante che l’essenza antiumana del nazismo non sia vista, che non faccia problema; che, benché l’adesione al nazismo non avvenga sulla base dell’antisemitismo, il «movimento» non appaia subito come ripugnante; che l’addio al nazismo (ma non al pregiudizio antisemita) sia motivato solo dal fatto che esso è moderno, interno alle logiche della tecnica e del progresso; e che la condanna della modernità sia emessa non a partire dal suo esito criminale ma dalla sua piatta mediocrità, dalla sua banalità, conseguenza dell’oblio dell’Essere.
Non certo da oggi ci si chiede come sia possibile che il pensatore capace di criticare la tragedia della vita quotidiana dei «piccoli uomini» non abbia visto la tragedia specifica indotta dall’antisemitismo proclamato dal nazismo. In realtà, come non si può dire che il nazismo di Heidegger sia un incidente biografico insignificante dal punto di vista teorico, un esempio della banalità del genio, così è sbrigativo sostenere che sia una grande «scorrettezza» politica, segno di un grande filosofare; ed è anche fuorviante affermare che l’antisemitismo sia la molla nascosta di tutto il suo pensiero.
Il dominio della modernità
Il problema è altro, teorico, e quindi ancora più grave. E sta nel fatto che la filosofia dell’Origine è autistica e indeterminata, priva di rapporti col mondo; e di conseguenza è indifesa davanti ai contenuti determinati in cui di volta in volta si imbatte; che la risolutezza demolitoria della «filosofia sulla filosofia» è vuota passività occasionalistica; e che Heidegger può essere portatore del pregiudizio razziale, e indifferente alle sue conseguenze, perché ha distrutto ogni possibilità di giudizio; per lui, la modernità è impresa di dominio perché è metafisico oblio dell’Essere, a cui si contrappone il risoluto domandare, il destrutturare: e tanto basta - e quindi gli è preclusa anche la negazione determinata del capitalismo come specifica forma di dominio.
Insomma, non è la filosofia ad adattarsi al pregiudizio, a venire dopo di esso per dargli una veste presentabile, ma è il pregiudizio ad accomodarsi in una filosofia che lo accoglie senza problema: una volta individuata filosoficamente la via della risolutezza, non importa a che cosa si sia risoluti; una volta identificata la modernità come supremo oblio e sradicamento, si lascia libero lo spazio per identificarne la figura più adeguata; e questa sarà, negli ultimi Quaderni, anche «l’ebraismo internazionale» come qui è il cristianesimo.
Prigioniero di se stesso
All’opposto filosofico, il giovane Hegel faceva dell’ebraismo l’emblema non della adeguazione ma della mancata conciliazione con la modernità, opponendolo al cristianesimo, capace di conciliarsi sviluppando dal proprio seno la filosofia. Ma mentre il pensiero di Hegel è progressivo, e non resta segnato dall’antisemitismo che ne è solo un tratto episodico e contingente, quello di Heidegger è tanto abissalmente indeterminato da non avere in sé la forza né l’intenzione di superare - se non, eventualmente, in esclusiva coerenza col proprio «domandare» - la contingenza che lo abita.
L’ansia di verità di Heidegger è muta o indifferente davanti alla più radicale non-verità (analogamente, anche il decisionismo vuoto di Carl Schmitt, pur non essendo mero travestimento del suo antisemitismo - autentico e costante -, non gli ha saputo evitare le trappole della contingenza storica).
Prigioniero di se stesso, come scrisse Hannah Arendt, che lo amò, passivo nella sua attività e gerarchico nella sua libertà, come scrisse Marcuse, che dopo il 1933 lo disprezzò pur riconoscendogli di essere stato da lui introdotto alla filosofia, Heidegger è rischioso fino all’aporia e all’assurdo se lasciato a se stesso, se non è letto con la consapevolezza che la filosofia non è esercizio da salotto o da talk show ma non è neppure domanda destrutturante posta nella solitudine più abissale e spettrale; che è relazione non solo con i venturi ma anche con i contemporanei; che vive nella città, insieme agli «ultimi uomini», anche se per separarsene, o per separarla e dividerla; che se non è una «visione del mondo», non è neppure un addio al mondo della comune umanità; che se la parola può darsi ormai solo come frammento, non può essere tanto criptica da risultare incomprensibile e da non saper comprendere la sofferenza del mondo (e anzi da fare del popolo più sofferente la figura della colpa filosofica dell’umanità).
Le domande del bambino
Scrive Heidegger nei Quaderni neri che una della due G del suo cognome significa Güte, «bontà, non compassione». Ecco che cosa manca al filosofo della Foresta Nera: la capacità di criticare il mondo ricercando che cosa ci fa «soffrire insieme agli altri», e che cosa ci fa agire insieme agli altri. Il «grande bambino che pone grandi domande», come egli definisce il filosofo, cioè se stesso, restò aggrappato a quelle domande e non volle darsi risposta, e quindi non seppe crescere e agire come uomo fra gli uomini. Perché il Male non potesse più abitare nella solitudine della sua filosofia, questa ha dovuto essere urbanizzata e civilizzata da altri: meno grandiosamente radicali, ma consapevoli che pensare contro la filosofia non può equivalere a pensare contro l’uomo
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- KANT, IL SAPERE, E L’ETICA: LA LEZIONE DI DON MILANI E DEI "RE MAGI"..9 dicembre 2015, di Federico La Sala
fuoritempio
Dal potere alla comunione
di Francesco Gesualdi *
Io non so se i magi siano realmente esistiti, né se siano mai andati a rendere omaggio a Gesù bambino inseguendo una stella. Né mi scandalizzerei se si trattasse di un’invenzione ai fini narrativi, una sorta di leggenda che ha cominciato a strutturarsi da esempi e immagini usati dai primi testimoni per rendere più comprensibile il loro messaggio.
Del resto chiunque si prefigga di trasmettere messaggi nuovi, di quelli che rompono con l’impostazione mentale dominante, sperimenta la necessità di ricorrere ad allegorie, metafore, accostamenti per trovare dei modi per farsi intendere.
E può succedere che certe rappresentazioni colpiscano così tanto l’immaginario collettivo da imporsi come fatti avvenuti. Forse nascono così le leggende, i fatti epici che finiscono per entrare se non nella storia, nella cultura e nelle visioni dei popoli.
Ma se la mitologia può servire a darci carica, bisogna stare attenti a non farne il centro dell’attenzione, altrimenti può impedirci di cogliere l’essenziale, come succede quando ci si concentra sul dito invece che sulla luna.
Come in molti altri episodi del Vangelo, anche nel racconto dell’Epifania l’essenziale che vi scorgo è il sovvertimento dell’ordine costituito nei suoi principi fondanti. Di mira in questo caso è il sapere, il suo ruolo, la sua legittimità.
Ai miei occhi, i magi che si prostrano davanti al bambino Gesù rappresentano la potenza del sapere che si inchina di fronte alla grandiosità dell’etica. È il riconoscimento che il sapere non può vivere senza la guida dell’etica, che ha bisogno del suo sostegno per capire che strada imboccare.
Mi rendo conto che il discorso si fa scivoloso perché assume un sapore oscurantista.
Ma l’etica a cui sto pensando non è quella delle ideologie, bensì l’etica dell’equità, della sostenibilità, della dignità umana, su cui Gesù ha così tanto insistito.
In un momento in cui la scienza è dominata dal potere industriale e le multinazionali pretendono di impossessarsi della natura, di manipolarla e brevettarla per arrogarsi il diritto di vendita esclusiva delle sementi, affamando milioni di contadini e spingendo l’agricoltura sempre di più verso la chimica, dovremo decidere se continuare a dare briglia sciolta a questo uso del sapere o se porgli dei limiti.
Allo stesso modo dovremo interrogarci sulla liceità di miliardi di euro investiti in farmaci contro le rughe, mentre non si investe nella prevenzione della malaria e altre malattie endemiche del Sud del mondo, solo perché i soldi si fanno vendendo prodotti di bellezza ai vecchi ricchi piuttosto che salvando le vite di giovani poveri.
Potremmo continuare col sapere usato ai fini bellici, ma senza scomodare la guerra, penso che ne abbiamo abbastanza per affermare che il sapere è vera ricchezza solo se è concepito come un bene comune da mettere al servizio dell’umanità per l’elevazione di tutti.
E mentre è poco fecondo se coltivato solo per l’erudizione personale, è sicuramente nocivo quando è usato come strumento di sopraffazione e violenza.
Non a caso la prima decisione che i magi dovettero prendere, dopo la visita a Gesù, fu se condividere le loro informazioni con Erode. E conosciute le intenzioni decisero per il no.
Da sempre il sapere è espressione di potere. Don Milani l’aveva capito così bene che si mise a fare scuola ai poveri nella convinzione che liberandoli dalla schiavitù dell’ignoranza li avrebbe messi in condizione di riscattarsi.
Ma a Barbiana eravamo costantemente stimolati a non usare il sapere per la carriera personale, bensì per la liberazione di tutti. Il motto era: «Uscirne da soli è l’avarizia, uscirne tutti insieme è la politica».
L’informazione stessa rischia di diventare una forma di consumismo se non si trasforma in azione. A che serve conoscere tutte le miserie del mondo se poi non ci trasformiamo in soggetti di cambiamento?
Mi piace pensare ai magi che andandosene dalla stalla di Betlemme vissero il sapere come una delle forme più alte di comunione.
* “discepolo” di don Milani, è fondatore del Centro Nuovo Modello di Sviluppo (www.cnms.it), ha da poco pubblicato “Risorsa umana. L’economia della pietra scartata”, San Paolo (v. Adista Documenti n. 26/15; il volume è acquistabile presso Adista)
* ADISTA, 12 DICEMBRE 2015 - Anno XLIX - n. 6300
-
> Frantz Fanon e la materia viva dell’oppressione: «Pelle nera, maschere bianche». «Robinson Crusoe», «La Capanna dello zio Tom», e la “Genesi del capitalista industriale”.3 dicembre 2015, di Federico La Sala
Frantz Fanon e la materia viva dell’oppressione
Nuova edizione e nuova traduzione di «Pelle nera, maschere bianche», l’opera giovanile dello psichiatra martinicano che rivela ancora oggi una forte capacità di interrogare il presente
E che fornisce strumenti per comprendere criticamente il perdurare del diffuso razzismo in Europa e Stati Uniti verso rom, afroamericani, arabi, indigeni
di Roberto Beneduce (il manifesto, 3.12.2015)
L’esplosione è ormai ogni giorno, e continuerà ancora a lungo. Sarebbe stato forse questo l’esordio di Pelle nera, maschere bianche (Ets, pp. 216, euro 20), se Frantz Fanon l’avesse scritto oggi. Perché le esplosioni che egli avvertiva nei muscoli, quando sentiva qualcuno dire «Toh, un negro!» o rivolgerglisi in petit nègre, le esplosioni i cui fuochi già vedeva dalla lontana Fort-de-France, sembrano moltiplicarsi nel nostro presente come un lugubre salmo. Altri corpi, sessant’anni dopo, sono ancora alle prese con quel maledetto «Toh, un negro!»: nelle strade di Los Angeles, a Parma, nella banlieue di Parigi, nei nuovi ghetti in cui il razzismo non cessa di riprodursi.
L’elenco delle circostanze in cui la violenza continua ad affiorare prendendo di mira neri, rom, musulmani, immigrati, insomma quell’umanità «al ribasso», dà al libro di un Fanon allora appena ventisettenne una forza unica, che pochi scritti mantengono allo stesso modo a distanza di oltre sessant’anni. E se ogni epoca rilegge i classici cercandovi risposte ai suoi dubbi, Fanon è un classico indubbiamente atipico: perché è lui che continua a interpellare il nostro presente, e a rendere necessarie nuove traduzioni dei suoi scritti, in grado di estrarre con maggiore adeguatezza idee e argomenti che in quelle precedenti non avevano trovato analoga attenzione. Quella di Silvia Chiletti raggiunge l’obiettivo.
La malta di un pensiero
Oggi Pelle nera, maschere bianche il lettore italiano può assaporarlo finalmente appieno: traduzione meditata, che restituisce la tensione originaria del testo fanoniano e penetra nelle pieghe di uno stile a tratti nervoso, fra parole che vogliono colpire, farsi dardi, proiettili, come lui stesso scriveva in una lettera al fratello Joby, che intendono «provocare», come ricordava il filosofo francese Francis Jeanson nella prefazione del 1952.
Traduzione doppiamente riuscita perché permette di cogliere nella costruzione del testo e nel suo originalissimo linguaggio i materiali e i vocabolari con i quali Fanon costruisce la sua malta: il sistematico procedere hegeliano, la fenomenologia di Merleau-Ponty, l’esistenzialismo di Sartre, e naturalmente la psicoanalisi, quella di Lacan: un autore «contestato come pochi», la cui appassionata difesa dei «diritti della follia» lo interrogano da molti punti di vista, e con il quale a tratti sembra quasi identificarsi («il fatto che i suoi avversari siano di gran lunga più numerosi dei suoi sostenitori, non sembra preoccupare questo logico della follia», aveva scritto l’anno prima nella tesi di specializzazione sull’atassia di Friedreich).
Le traduzioni inglesi che si sono succedute negli anni, da quella del 1967 di Lam Markmann a quella del 2008 di Philcox, passando attraverso l’edizione del 1986 con l’introduzione di Homi Bhabha, hanno conosciuto le stesse incertezze e rivelato come potessero essere riconosciuti, in quello che Mbembe ha definito un «lavoro gigantesco», profili nuovi e aspetti lasciati sino a quel momento in ombra. Per Bhabha, era «il linguaggio psicoanalitico della domanda e del desiderio» l’orizzonte scelto «nell’articolare il problema dell’alienazione culturale nella colonia». Giusto. Nel clima degli studi postcoloniali diventava questo l’orizzonte più significativo. E d’altronde Fanon, nell’esplicitare il suo progetto di dissoluzione del «doppio narcisismo» (quello dei Bianchi e quello dei Neri), scrive sin dalle prime pagine: «In effetti penso che solo un’interpretazione psicoanalitica possa rivelare le anomalie affettive responsabili dell’intero edificio di un tale complesso».
Quel linguaggio costituisce dunque un aspetto certo fondamentale, ma il rischio è quello di dimenticarne altri, altrettanto decisivi, finendo per dare un rilievo eccessivo a quello che è stato il Fanon «postcoloniale». Ogni lettura che voglia però isolare e far prevalere uno solo dei profili a svantaggio del Fanon clinico e militante, o del Fanon lucido analista della dell’apocalisse coloniale e profeta delle sue conseguenze sociali e psichiche, finirebbe col ripetere quel gesto di frammentazione contro il quale aveva protestato Ernesto de Martino quando chiedeva, per sé e per gli altri, che si fosse considerati «persone intere».
Questo rischio deve essere sorvegliato soprattutto al cospetto di una scrittura che si sviluppa con testarda coerenza nel corso degli anni, e non intende trascurare nulla nel realizzare il suo progetto. Se complesso di inferiorità esiste, scrive del resto Fanon, il processo è «economico innanzitutto, di interiorizzazione, o meglio, di epidermizzzione di questa inferiorità, in secondo luogo».
Marx e Merleau-Ponty, dunque, non solo Lacan: perché è dal corpo e dall’esperienza vissuta, dagli sguardi che lo hanno tormentato, che Fanon trae la linfa infinita delle sue riflessioni («non parlo che di cose vissute», questa l’epigrafe, tratta da Nietzsche, posta nella sua tesi di specializzazione).
E soprattutto un’attenzione incessante al tempo e alla storia («l’architettura del presente lavoro si situa nella temporalità»): il colonizzato, il nero che sogna la vendetta nel letto della bianca, l’indocinese nient’affatto docile, il bambino che vede Tarzan, la società antillana nevrotica perché dominata dall’idea del confronto con l’altro. Ciascun soggetto è ancorato al suocontesto, alla storia, e solo da quest’ultima traggono senso la sua esperienza e la sua sofferenza.
La nuova edizione di Pelle nera, maschere bianche, oltre a rispondere a un’attesa diffusa e giungere in un momento in cui la riflessione di Fanon è per più ragioni propizia (il lettore può trovare in italiano ormai tutti i suoi libri, nonché gli scritti psichiatrici, a torto giudicati minori), ha però un altro merito. L’introduzione di Vinzia Fiorino, nell’offrire preziose chiavi di lettura, spinge infatti Fanon a incontrare una riva inconsueta, o meglio «imprevista», come suggerisce la stessa autrice: quella del pensiero femminista italiano in una delle sue espressioni più note, Carla Lonzi.
Oltre le velenose diagnosi
Si tratta di un’operazione doppiamente coraggiosa. In primo luogo perché il dialogo fra Fanon e la donna (antillana, in particolare), individua senza dubbio una delle tensioni più feconde del suo pensiero, ma soprattutto perché in passato a Fanon non sono state risparmiate critiche di ogni genere: omofobo, misogino, sedotto dal mito del guerrigliero algerino con il quale avrebbe tentato di guarire la ferita narcisistica di una mascolinità martinicana ferita e umiliata... A scrivere queste velenose diagnosi, di cui hanno fatto giustizia interpreti rigorosi come Gibson o Sharpley-Whiting, sono state firme prestigiose: da Françoise Vergès a Albert Memmi, quest’ultimo giungendo a sostenere che l’opera di Fanon è essenzialmente motivata da bisogni personali, scandita da un’identificazione con la Francia («con il dominante») e dal «rifiuto di sé». Mediocre psicologismo, ha commentato giustamente Brigitte Riera, adottando un giudizio sin troppo benevolo nei confronti di una critica ingiusta e stizzosa.
Di un libro da leggere e rileggere con pazienza, con passione, devo ricordare almeno un ultimo aspetto, oggi particolarmente saliente. Se per Fanon «inventariare il reale» è «compito colossale», che ci lascia sempre con un senso di incompletezza, se non cessa mai di rivelarsi, nulla nascondendo - a chi sa leggere le sue parole - della propria esperienza, egli chiede (a sé e a noi) l’impegno forse più doloroso, non essere cioè schiavi del passato: «Non ho dunque altro da fare su questa terra che vendicare i Neri del XVII secolo? (...) Io sono il mio proprio fondamento. Ed è superando il dato storico, strumentale, che introduco il ciclo della mia libertà». Domanda sorprendente, affermazione radicale: nasce qui forse l’invito più decisivo di un pensiero che, mai amnesico nei confronti del passato, degli inganni del sapere (quello psichiatrico, in primo luogo), e delle radici oscure dell’alienazione, intende però curare la Storia stessa.
- La vita del «Nero» non è una questione di pelle
In un momento così difficile per l’Europa, la scelta di ripubblicare Pelle nera, maschere bianche di Frantz Fanon (Edizioni ETS, Collana «Studi culturali», pp. 216, euro 20, cura redazionale di Marica Setaro) non è solamente un’operazione culturale meritoria, è un atto politico. L’attualità di questo testo - spiega Vinzia Fiorino nell’introduzione - è del tutto evidente di fronte «ai significativi processi migratori che negli ultimi anni hanno visto riemergere antichi e beceri razzismi, afflati umanitari, inquietanti silenzi e insulsi balbettii».
Il rinnovato interesse per la figura di Fanon è anche contiguo alla ripresa degli studi su altri maestri del pensiero critico come Michel Foucault, Franco Basaglia e Carla Lonzi: una nouvelle vague che si spiega alla luce «delle trasformazioni epocali che nelle regioni del mondo economicamente più avanzate hanno ridisegnato nuove aree di marginalità e definito inedite perdite di status per figure sociali diverse».
La traduzionedi Silvia Chiletti restituisce la forza prorompente del linguaggio di Fanon, impegnato nel decostruire la realtà circostante per svelarne attraverso l’analisi critica dei discorsile contraddizioni socio-culturali. Tra i danni a lungo termine provocati dal colonialismo figura il desiderio di «lattificazione» innestato dalla società bianca occidentale. «Il Nero non è un uomo. (...) Il Nero è un uomo nero», spiega Fanon: «ciò vuol dire che a causa di tutta una serie di aberrazioni affettive egli si colloca all’interno di un universo da cui bisognerà tirarlo fuori». Agli occhi dello psichiatra lo svelamento del desiderio di «bianchezza» si impone dunque in prima istanza come una terapia (militante) per liberare «l’uomo di colore da se stesso».
Dal punto di vista politico, la critica ai sostenitori della «negritudine», che pure aveva attratto originariamente Fanon, allarga l’orizzonte in direzione di una lotta di più ampio raggio. Scrive Francis Jeanson nell’introduzione francese del 1952: «(Per Fanon), il postulare una salvezza futura delle società umane non apporta alcun rimedio alle disgrazie degli uomini di questo tempo. (...) L’uomo che si tratta di salvare non è l’astrazione di un’epoca inesistente, è il negro strappato dal suo villaggio, il fuciliere senegalese (...), esistenze attualmente in questione, di cui ciascuna è unica, insostituibile, vissuta senza ritorno...».
Le dialettiche di Hegel e Marx, ma anche le categorie psicoanalitiche di Freud e Adler, ne escono quindi fortemente ridimensionate e vengono ricondotte alla loro natura occidentale (centrica). Nello stesso tempo, se la «bianchezza» è un marcatore che«definisce la titolarità della sovranità e i confini della cittadinanza», la lotta per salvare il nero non può che divenire rivoluzionaria per l’intero sistema. La pelle e il corpo saranno il campo di battaglia, il «desiderio», una volta rivelata e superata la nevrosi, lo strumento di liberazione. (Alessandro Santagata)
Robinson Crusoe
Chi ha detto che il protagonista di Defoe è un modello positivo?
L’eterna epopea del naufrago eroe capitalista
di Lucio Villari (la Repubblica, 3.12.2015)
La moderna Europa occidentale - quella del benessere, della ricchezza, del capitalismo industriale e finanziario - deve molto agli schiavi neri, provenienti dall’Africa, al loro lavoro, al loro riprodursi e al contributo fondamentale che hanno dato alla nascita degli Stati Uniti sia quando soffrivano nelle piantagioni del Sud sia quando furono liberati, dopo una sanguinosa guerra civile, dalla loro condizione. Liberati, ricordiamolo, grazie anche all’indignazione morale suscitata da un mediocre romanzo apparso nel 1851. Uno dei libri più celebri e più letti in America e in tutto il mondo: La capanna dello zio Tom. La sua autrice, Harriet Elizabeth Beecher Stowe, fu definita da Lincoln “la piccola donna che vinse la guerra civile”.
Un romanzo del genere non sarebbe stato pensabile, ovviamente, in Europa, dove gli schiavi neri (in America, nel 1861, erano quattro milioni) non esistevano, ma forse avrebbe potuto essere scritto dal qualche discendente di imprenditori, commercianti, banchieri, avvocati, faccendieri, investitori in Borsa, vissuti tra il Seicento e il Settecento. Distinti gentiluomini che quei neri avevano portato in America con un flusso regolare e secolare di navi che partivano a pieno carico dalle coste occidentali dell’Africa. Fecero guadagni da capogiro e con i loro investimenti gettarono le basi della rivoluzione industriale europea.
Lo scrisse chiaramente un quasi coetaneo della Beecher Stowe, Karl Marx. In tante parti del Capitale e in particolare nel capitolo del Libro Primo “Genesi del capitalista industriale” attribuì anche alla tratta degli schiavi «uno dei momenti fondamentali dell’accumulazione originaria ». Ecco una sua frase: «La trasformazione dell’Africa in una riserva di caccia commerciale dei neri è tra i segni che contraddistinguono l’aurora dell’era della produzione capitalistica».
Dal punto di vista letterario le tante pagine che Marx ha dedicato al colonialismo e a uno dei suoi plusvalori più redditizi, la tratta degli schiavi, sono forse più efficaci della prosa della Beecher Stowe. Ad esempio: «La funzione preponderante che ebbe allora il sistema coloniale fu il “Dio straniero” che si mise sull’altare accanto ai vecchi idoli dell’Europa e che un bel giorno con una spinta improvvisa li fece ruzzolar via tutti insieme e proclamò che fare del plusvalore era il fine ultimo e unico dell’umanità».
La ricerca storica ha confermato che la Beecher Stowe e Marx avevano colto nel segno. Una recente indagine della nostra Banca d’Italia ha documentato che dall’Africa partirono, incatenati, per l’America 12 milioni e mezzo di persone. Il pensiero corre, evidentemente, alle centinaia di migliaia di profughi, fuggiaschi, esuli, perseguitati, migranti che continuano a solcare il Mediterraneo in cerca di salvezza, facendo però guadagnare milioni di euro a “imprenditori” africani, mediorientali, europei.
Vedremo sul lungo periodo come andrà a finire questa diversa ma singolare “tratta” di esseri umani. Comunque, tra il Seicento e il Settecento altri esseri umani, presi prigionieri e venduti come merce, diedero un reddito enorme ai “negrieri” e agli armatori delle navi negriere.
Che la cosa allora fosse del tutto normale per gli europei lo prova, tra i tanti documenti che conosciamo, un romanzo tra i più affascinanti della letteratura europea: La vita e le straordinarie sorprendenti avventure di Robinson Crusoe di York. L’opera è del 1719 ed ebbe un successo enorme. Robinson, vissuto, come è scritto nel titolo, “ventotto anni tutto solo in un’isola disabitata presso le coste dell’America”, è un’invenzione letteraria sulla quale si è detto tutto.
Ma ancora oggi a qualche lettore forse possono sfuggire alcune singolari pagine di Defoe che svelano alcuni lati inediti di Robinson, la cui vicenda umana e la cui capacità di sopravvivenza sono sempre state lette come simboli, come mito dell’intelligenza pragmatica, della solidità morale, della abilità consapevole. Anche il nostro Marx fu colpito dal fascino sottile del romanzo e, sempre nel Capitale, sottolineò che «tutte le relazioni tra Robinson e le cose che costituiscono la sua ricchezza sono semplici e trasparenti. In esse sono contenute tutte le determinazioni essenziali del valore ».
Ma un lettore più acuto e ironico fu James Joyce che in una conferenza tenuta a Trieste nel 1912 dichiarò: «Tutta l’anima inglese è in Crusoe: l’indipendenza virile, la crudeltà inconscia, l’intelligenza tardiva eppur efficace, l’apatia sessuale, la religiosità pratica, la taciturnità calcolatrice».
Ma né Marx né Joyce si erano accorti che il “marinaio” Robinson non era affatto un marinaio, ma un avventuriero in cerca di fortuna. Non contento di essere divenuto proprietario terriero in Brasile, aveva fiutato nuovi affari più redditizi. Era diventato un trafficante di schiavi. E fu in uno dei suoi viaggi come negriero che era naufragato in un giorno di settembre del 1659. La sua vita di prigioniero su un’isola deserta non cambiò il suo modo di essere e di pensare.
Defoe mostra un uomo la cui struttura morale e culturale resta inalterata nella solitudine di quegli anni, mantenendo i tratti duri e invincibili del proprietario, del padrone (questa è la prima parola che insegna a Venerdì), del colono bianco (nell’isola deserta, oltre all’abitazione fatta all’inizio con duro lavoro manuale «avevo la mia residenza di campagna; e anche lì, possedevo ora una discreta colonia»).
Tutto questo fa parte della struttura portante del racconto di Defoe, ma c’è in lui una strana consapevolezza nel far muovere, nel romanzo, il suo straordinario personaggio che, nonostante tutto, tende alla mediocrità opportunista più che, dopo quell’esperienza eccezionale, a significati e valori alti. Infatti, uscito vivo dalla prigionia, Defoe fa ritornare Robinson sull’isola, dove intanto si erano insediati degli scampati da altri naufragi e loschi figuri d’ogni genere. Torna con intenzioni precise: «suddivisi l’isola tra loro riservandomene la proprietà ». Anche da qui cominciava “l’accumulazione originaria”.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- LE FRONTIERE APERTE DELL’UNIVERSO. La «teoria del tutto» mi ricorda le tavole della legge della religione, più che la scienza (G. Amelino-Camelia)..27 novembre 2015, di Federico La Sala
FISICA E METAFISICA. "La «teoria del tutto» mi ricorda le tavole della legge della religione, più che la scienza. Io mi accontenterei: la materia che abbiamo conosciuto finora rappresenta solo il 4% della densità di energia dell’universo. Il resto è ancora da capire. Siamo lontani anche da una «teoria del molto». Il «tutto» lasciamolo perdere" (Giovanni Amelino-Camelia).
Le frontiere aperte dell’UniversoIl 2 dicembre del 1915 veniva pubblicata la versione definitiva della teoria della relatività.
Intervista con Giovanni Amelino-Camelia, fisico dell’università La Sapienza. «Di Einstein ce ne sono almeno tre: c’è il divo che fa le smorfie sulle magliette, il giovane che compie scoperte straordinarie e quello della maturità, che dà contributi trascurabili e perde la bussola»
intervista di Andrea Capocci (il manifesto, 27.11.2015)
Cento anni fa, Albert Einstein spediva all’Accademia Prussiana delle Scienze l’articolo Feldgleichungen der Gravitation («Le equazioni di campo della gravità»), in cui veniva presentata la versione «definitiva» della teoria della relatività generale, pubblicata poi il 2 dicembre del 1915. Era la conclusione di un percorso iniziato nel 1905, e che proseguirà ancora nei primi mesi del 1916. Dieci anni prima, Einstein aveva contribuito anche alla fondazione della meccanica quantistica e delle particelle. Grazie alla teoria della relatività generale, il fisico tedesco si conquistò un ruolo indiscutibile nella cultura non solo scientifica del ventesimo secolo.
Secondo molti, la vicenda di Einstein è irripetibile: la dimensione industriale della scienza attuale impedisce che un singolo scienziato dia un contributo così rilevante al progresso delle conoscenze. D’altra parte, Einstein continua a rappresentare un riferimento per generazioni di studenti e per l’immagine della scienza veicolata dai media.
Solo qualche anno fa, la rivista americana Discover individuava sei possibili nuovi «Einstein» in grado di rivoluzionare la fisica andando anche oltre Einstein stesso: unificando, cioè, la teoria della relatività e la meccanica quantistica. T ra loro anche un italiano: Giovanni Amelino-Camelia, cinquantenne fisico dell’università La Sapienza di Roma. Un ottimo interlocutore, dunque, per comprendere l’eredità scientifica di Einstein e i futuri sviluppi delle sue teorie.
«Prima però dobbiamo metterci d’accordo. Di Einstein non ce n’è uno solo: ce ne sono almeno tre». In che senso, professore?
C’è il divo, quello che fa le smorfie e va sulle magliette, che nasce ufficialmente nel 1919. È l’anno in cui Eddington conferma la validità della teoria della relatività generale. Einstein finisce sulle prime pagine e la stampa lo trasforma in un personaggio di fama mondiale. Quello è lo scienziato-icona che piace molto ai media, svampito e stravagante come ormai immaginiamo che debba essere uno scienziato. Ma è un Einstein che fa comodo a tutti. È simpatico, fa vendere, quando compare sulla copertina di una rivista funziona sempre. È un’icona dotata di un valore economico.
E gli altri?
C’è l’Einstein giovane, quello che tra il 1905 e il 1916 compie alcune delle scoperte più straordinarie della storia della scienza. Sarebbero tante anche per un’intera generazione di scienziati, figuriamoci per un uomo solo. Infine, c’è l’Einste della maturità che, dopo il 1919, dà un contributo scientifico trascurabile. Non si tratta di vecchiaia, perché nel 1919 ha solo quarant’anni. Eppure contraddice completamente il suo modo di lavorare. Perde la bussola, attacca la meccanica quantistica come un crociato. Secondo Wolfgang Pauli, un altro grande fisico poco più giovane di lui, le ricerche di Einstein di quel periodo sono «terribile immondizia». Solo il peso scientifico del personaggio costringe gli altri a prenderlo sul serio. Però così riesce anche ad avere un ruolo politico importante, a cavallo della seconda guerra mondiale.
A lei quale Einstein interessa di più?
Quando me lo chiedono, a me piace parlare del giovane scienziato, anche se è quello più difficile da raccontare. Ma se ci ricordiamo lo scienziato spettinato o quello pacifista, è grazie al giovane Einstein.
È lo scienziato delle grandi intuizioni...
Anche il suo intuito certe volte ci azzeccava e altre no, come tutti. La grande forza di Einstein fu piuttosto la adesione totale al metodo scientifico, che ci aiuta a liberarci dai pregiudizi. Einstein studiò i risultati di esperimenti che nessuno riusciva a interpretare. Ipotizzò per primo che la luce potesse comportarsi come una particella, il fotone, il primo mattone della meccanica quantistica. E fu ancora Einstein a sviluppare la teoria atomica della materia, studiando il moto casuale di un granello di polline in un liquido. Quegli undici anni sono un perfetto manuale del fare scienza confrontandosi con i dati e solo con loro, senza pensare alla teoria più «elegante» o più «bella». Studiandoli da vicino si impara molto più che la relatività o la meccanica quantistica.
A lei cos’altro hanno insegnato?
Ad esempio, che anche senza microscopio si può indagare i componenti più piccoli della realtà. Quando Einstein teorizzò atomi e molecole non c’erano gli strumenti di oggi, che riescono persino a fotografarli. Ma gli atomi, se esistevano, collettivamente dovevano produrre effetti visibili. Fu proprio studiando gli effetti macroscopici che Einstein scoprì i costituenti più piccoli della materia.
Oggi però i microscopi in cui misurare gli effetti quantistici esistono, sono gli acceleratori di particelle...
Ma persino al Cern non arrivano ad osservare le distanze più piccole, laddove la teoria della gravità e meccanica quantistica devono ancora essere comprese. Allora anche io, come Einstein, cerco di studiare sistemi più grandi. Fortunatamente, ce n’è uno grande abbastanza: è l’Universo. Gli effetti quantistici della gravità sono invisibili su scala planetaria. Ma su una particella che viaggia abbastanza a lungo nell’Universo gli effetti accumulati possono lasciare tracce osservabili. Se il nostro modello di gravità quantistica funziona, deve essere in grado di prevedere gli effetti che essa ha su queste particelle.
E dove troviamo queste particelle?
Per esempio, c’è un esperimento in Antartide chiamato IceCube, «cubetto di ghiaccio». In realtà, è un cubo di ghiaccio di un chilometro e mezzo di lato pieno di sensori. IceCube riesce a rilevare i neutrini, particelle di massa piccolissima provenienti dall’universo lontano, ben al di fuori dalla nostra Galassia. Per ora ne ha intercettati qualche decina. Se riuscissimo a capire da dove arrivano e quanta strada hanno fatto, potremmo confrontare i dati e i modelli. Ma c’è ancora molto da fare prima di mettere d’accordo gravità e meccanica quantistica.
Questa è la strada verso la «teoria del tutto»?
Non parlerei di «teoria del tutto». Il primo nemico di questa idea fu proprio Einstein. Già a fine Ottocento, quando Einstein era uno studente, le leggi di Newton sulla gravità e alle equazioni di Maxwell sull’elettromagnetismo sembravano aver spiegato l’intero universo. Anche a Max Planck, vent’anni prima, era stato sconsigliato di intraprendere studi di fisica, perché non c’era più niente da scoprire. Un paio di decenni dopo, quando Einstein aveva quarant’anni, quella fisica era stata rasa al suolo e sostituita da meccanica quantistica e relatività. La «teoria del tutto» mi ricorda le tavole della legge della religione, più che la scienza. Io mi accontenterei: la materia che abbiamo conosciuto finora rappresenta solo il 4% della densità di energia dell’universo. Il resto è ancora da capire. Siamo lontani anche da una «teoria del molto». Il «tutto» lasciamolo perdere.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- La libertà nei destini incrociati di “Io” e “Noi”. L’analisi di Axel Honneth sul principio cardine della modernità.26 novembre 2015, di Federico La Sala
L’analisi del filosofo Axel Honneth sul principio cardine della modernità
La libertà nei destini incrociati di “Io” e “Noi”
Una teoria innovativa che supera le tesi opposte di Hobbes e di Kant
L’autodeterminazione non può essere definita in modo negativo (ciò che “non” ostacola il mio agire) ma si sviluppa in una dimensione sociale e istituzionale
di Gustavo Zagrebelsky (la Repubblica, 26.11.2015)
- Questo testo è un estratto della prefazione a Il diritto della libertà di Axel Honneth (Codice pagg. 528, euro 35)
“Il diritto della libertà” di Axel Honneth tratta un tema mai esaurito o esauribile una volta per tutte. La prospettiva è la libertà sociale, formula nella quale l’aggettivo esprime in sintesi l’idea capitale attorno alla quale ruotano le quasi seicento pagine che si offrono oggi al pubblico di lingua italiana. La materia - filosofica, giuridica, sociologica - trattata è grande ma la struttura della trattazione è assai semplice. La si può dividere in due parti: “l’io della libertà”, la prima; “il noi della libertà”, la seconda.
L’“io” e il “noi” si comprendono in una concezione dell’io che nutre il noi e viceversa: la libertà singolare non può esistere se non entro la libertà plurale; all’individualizzazione non può non corrispondere la socializzazione della libertà. Nel titolo di un suo libro del 2010, Axel Honneth aveva usato, per esprimere in sintesi questo doppio lato della libertà, la formula Das Ich im Wir: un’espressione che già a prima vista si distingue dalle tante teorizzazioni del rapporto di riconoscimento dell’Io a fronte del Tu. La formula, come vedremo, potrebbe essere rovesciata in Das Wir im Ich. Sciogliendo questi motti, si può dire così: l’asse portante è che la libertà singolare non può esistere se non in connessione con la libertà plurale e che, viceversa, la libertà plurale non può dividersi da quella singolare.
Dire connessione, però, è dire troppo poco. Bisogna dire, piuttosto, intrinseco rapporto di mutua penetrazione e fecondazione, in un equilibrio difficile. La preponderanza dell’aspetto soggettivo condurrebbe, infatti, a una concezione individualistica della libertà, che Honneth respinge, così come la preponderanza dell’aspetto oggettivo, nei termini hegeliani dello “spirito oggettivo”, cioè della realtà sociale storicamente determinata, condurrebbe a una sorta di olismo, ch’egli ugualmente respinge, pur ponendosi dichiaratamente, sia pure criticamente, entro un’interpretazione della Filosofia del diritto di Hegel.
Tra la prima e la seconda parte del libro - dedicate, rispettivamente, alla trattazione di concetti e alla loro verifica storico- empirica - sono collocate - sotto il titolo La possibilità della libertà - due sezioni che costituiscono, per così dire, un “a parte” e potrebbero stare in piedi anche autonomamente. Sono dedicate al Daseingrund (termine qui tradotto con “ragion d’essere”, dove l’essere è piuttosto un “esserci”, cioè non un’astrazione ma una collocazione storico- concreta) della libertà giuridica e della libertà morale. Si tratta, per così dire, di due moniti contro l’estremizzazione: il giuridicismo e il moralismo, due fonti di pericolo per la convivenza sociale.
Questi due capitoli rappresentano la cerniera tra la prima parte, d’impostazione filosofica, e la seconda parte d’impostazione sociologica. In queste due parti si traduce la doppia faccia di un libro che, partendo dalle definizioni, giunge all’immersione nelle condizioni delle società in cui viviamo e nelle contraddizioni da cui sono segnate, rispetto alla libertà.
La parte filosofica contiene principi normativi: dai concetti, si traggono inclusioni ed esclusioni prescrittive teoriche; la parte pratica contiene verifiche circa le potenzialità e le difficoltà d’inveramento della libertà nelle strutture sociali del nostro tempo. Non, però, come separazione e contrapposizione astratte tra dover essere ed essere, ma come ricerca delle condizioni pratiche di vita di società libere: una ricerca dalle conclusioni piuttosto sconfortanti.
La libertà non è districabile dalla giustizia. Giustizia, nel nostro tempo (la “modernità”), equivale a garanzia di autodeterminazione. Nel nostro tempo: date le premesse assunte, che l’Autore definisce non-kantiane, la giustizia non appartiene al puro ideale, alle formule evanescenti come quella che la identifica con la generalizzabilità delle “massime” delle proprie azioni, ma è un dato storico-sociale.
La giustizia come autodeterminazione è lontanissima da quella che tale si considerava nell’antichità, obbiettiva, organica, sovra-individuale, obbligante. La giustizia, per noi, al contrario è “liberatrice”, ma con un vincolo: la “riproducibilità sociale”. Questo concetto, che rappresenta il cavallo di battaglia della sociologia, è assunto qui come qualcosa di simile a un imperativo categorico. L’autonomia che la compromette non è giustizia, ma corruzione della giustizia.(...) Il primo stadio della libertà è quello negativo, l’assenza di costrizioni esterne. La più semplice, elementare e intuitiva definizione è l’assenza di impedimenti. È la definizione di Thomas Hobbes, risalente al tempo della guerra civile di religione: «Libero è colui che, nelle cose che è capace di fare con la propria forza e il proprio ingegno, non è impedito di fare ciò che ha volontà di fare». (...)
Non ci si può fermare qui. Essere liberi nel corpo e nelle azioni, ma schiavi delle proprie passioni irrazionali e dei propri errori, è ancora libertà? Questa è la domanda di Rousseau, che pone la libertà nell’obbedienza alla legge che ogni singolo dà davvero a se stesso, cioè nell’autonomia. Questo principio sta alla base tanto della libertà del singolo quanto della libertà della società tutta intera. Come la libertà negativa implica la ripulsa delle costrizioni fisiche, così la libertà come autodeterminazione - che l’autore del libro chiama «riflessiva » - esige la purificazione dalle costrizioni morali che inquinano la retta (cioè non perturbata da vizi, passioni, errori) formazione della coscienza. Si tratta, dunque, della sovranità morale rispetto alle pressioni dell’“ambiente” che, con i suoi pregiudizi, le sue lusinghe, le sue seduzioni, i suoi inganni altera la percezione del sé e, alla fine, svuota la libertà del suo contenuto d’autonomia e lo riempie di forze psichiche eteronome. (...)
La libertà «sociale» di cui Honneth tratta non è un’alternativa rispetto alle altre due concezioni della libertà. È piuttosto il prolungamento, o l’implicazione necessaria, della libertà riflessiva, così come quest’ultima è lo sviluppo della libertà negativa.
A essere prese in considerazione sono le condizioni istituzionali della libertà, intese non come aggiunte esteriori, ma come necessità intrinseche al suo concetto. Su questo punto si insiste particolarmente, allo scopo - anche - di prendere le distanze, differenziandosene, dalle concezioni della democrazia discorsive nelle quali l’aspetto istituzionale, secondo l’Autore, è concepito come condizione esteriore della libertà.
È l’occasione, per Honneth, per prendere qualche distanza da Habermas, il suo predecessore alla direzione dell’Institut francofortese per la ricerca sociale. La teoria del discorso di Habermas, in quanto teoria, rimarrebbe, secondo Honneth, in una sfera di astrattezza; l’intersoggettività, che ne è il nucleo essenziale, restererebbe confinato in un a priori incapace di tradursi in idea politico- sociale concreta, alias “istituzionale”, di libertà. In altri termini, le istituzioni sarebbero il governo esteriore arbitrale del gioco degli intenti in campo, e l’obiettivo di formulare un’idea di libertà tale da incorporare la dimensione relazionale, intersoggettiva e quindi sociale, sarebbe mancato. (...)
Non c’è bisogno di richiamare la letteratura sociologica e psicologica che mette in luce il lato repressivo delle istituzioni e di ogni “istituzionalizzazione” dei comportamenti individuali e collettivi. La libertà consisterebbe, secondo questo punto di vista, nella de-istituzionalizzazione o, comunque, nell’assenza di predeterminazioni istituzionalizzate.
Il contrario della visione di Honneth, il quale pone precisamente nell’istituzione la possibilità di libertà. Le istituzioni non sono sorte, necessariamente, per reprimere, ma anche per promuovere la libertà: la libertà concreta, realistica, non velleitaria o puramente agitatoria. L’esercizio della libertà che non riesce a farsi istituzione”, secondo questa visione sociale della libertà, è sterile. (...)
Nelle prime pagine di questo libro si spiega come la libertà sia il tratto caratteristico della modernità, lo shibolet per poter prendere parte al discorso politico moderno. Ma proprio questo libro rafforza la comune consapevolezza della plurivocità della parola, dell’esistenza di numerose concezioni del concetto; il lettore è come condotto per mano, sempre in nome della libertà, anzi della libertà al suo più alto grado, a salire fino a un colmo che sta sul crinale dell’ambiguità: l’ambiguità che connota il concetto di istituzione e, così, anche la immedesimazione istituzionalizzata della libertà degli uni nella libertà di tutti: l’eterno problema dell’equilibrio tra gli uni e i tutti.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- I «QUADERNI NERI» DI HEIDEGGER 1931-1948. CONVEGNO INTERNAZIONALE A ROMA (23-25 NOV. 2015).22 novembre 2015, di Federico La Sala
PER LA PACE E PER IL DIALOGO, QUELLO VERO, PER "NEGARE A HITLER LA VITTORIA POSTUMA" (Emil L. Fackenheim, "Tiqqun. Riparare il mondo"):
- LO STATO DEL FARAONE, LO STATO DI MINORITA’, E IMMANUEL KANT "ALLA BERLINA" - DOPO AUSCHWITZ
 "LEZIONE SU KANT" A GERUSALEMME: PARLA EICHMANN "PILATO", IL SUDDITO DELL’"IMPERATORE-DIO".
"LEZIONE SU KANT" A GERUSALEMME: PARLA EICHMANN "PILATO", IL SUDDITO DELL’"IMPERATORE-DIO".
- ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN. FARE CHIAREZZA: RESTITUIRE L’ONORE A KANT E RICONCILIARSI CON FREUD.
 A EMIL L. FACKENHEIM. (...) il merito di aver ri-proposto la domanda decisiva: “come fu possibile la hitlerizzazione dell’Imperativo Categorico di Kant? E perché è ancora attuale oggi?”
A EMIL L. FACKENHEIM. (...) il merito di aver ri-proposto la domanda decisiva: “come fu possibile la hitlerizzazione dell’Imperativo Categorico di Kant? E perché è ancora attuale oggi?”
- RIPENSARE L’EUROPA. PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!
I «QUADERNI NERI» DI HEIDEGGER 1931-1948
- CONVEGNO INTERNAZIONALE
ROMA, 23-25 NOVEMBRE 2015
- CNR | Consiglio Nazionale delle Ricerche, V. Marrucini 2 e P. Aldo Moro 7
 Sapienza Università di Roma | Dipartimento di Filosofia, Villa Mirafiori, V. Carlo Fea 2
Sapienza Università di Roma | Dipartimento di Filosofia, Villa Mirafiori, V. Carlo Fea 2
I "Quaderni neri" non sono stati una pietra tombale sul pensiero di Heidegger. Al contrario, è avvenuto un fenomeno inconsueto, che va ben al di là dell’interesse suscitato solitamente dagli inediti di un filosofo. Si è aperto un intenso dibattito che ha varcato i confini dell’accademia e che mostra ancora una volta la rilevanza del pensiero di Heidegger nell’orizzonte contemporaneo.
Il convegno aprirà il confronto su un ampio spettro di questioni: non soltanto politiche, ma anche teologiche e filosofiche. E si interrogherà sul modo in cui i "Quaderni neri" stanno modificando, di fatto, la filosofia continentale.
Direzione scientifica: Donatella Di Cesare
Partecipano: Gérard Bensussan, Joseph Cohen, Donatella Di Cesare, Jesus Adrian Escudero, Sebastiano Galanti Grollo, Rico Gutschmidt, Alessandra Iadicicco, Alberto Martinengo, Gian Luigi Paltrinieri, Riccardo Pozzo, Peter Sloterdijk, Francesco Valerio Tommasi, Peter Trawny, Gianni Vattimo, Paolo Vinci, Vincenzo Vitiello, Judith Werner, Holger Zaborowski, Raphael Zagury-Orly
Informazioni organizzative: Alberto Martinengo (alberto.martinengo@unimi.it)
Informazioni per gli studenti: Marcello Di Trocchio (marcello.ditrocchio@gmail.com)
Con il patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania
Con il sostegno di Alexander von Humboldt-Stiftung, Sapienza Università di Roma, Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo e Storia delle Idee-CNR, Dipartimento Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale-CNR
- LO STATO DEL FARAONE, LO STATO DI MINORITA’, E IMMANUEL KANT "ALLA BERLINA" - DOPO AUSCHWITZ
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- Siamo dentro la guerra. Dopo Parigi. Bisogna rimettere la pace, e non la vittoria, al centro della nostra agenda politica.17 novembre 2015, di Federico La Sala
EditorialeSiamo dentro la guerra
Dopo Parigi. Bisogna rimettere la pace, e non la vittoria, al centro della nostra agenda politica
di Etienne Balibar (il manifesto, 17.11.2015)
Sì, siamo in guerra. O meglio, siamo ormai tutti dentro la guerra. Colpiamo e ci colpiscono. Dopo altri, e purtroppo prevedibilmente prima di altri, paghiamo il prezzo e portiamo il lutto. Ogni persona morta, certo, è insostituibile. Ma di quale guerra si tratta?
Non è semplice definirla, perché è fatta di diversi tipi, stratificatisi con il tempo e che paiono ormai inestricabili. Guerre fra Stato e Stato (o meglio, pseudo-Stato, come «Daesh»). Guerre civili nazionali e transnazionali.
Guerre fra «civiltà», o che comunque si ritengono tali. Guerre di interessi e di clientele imperialiste. Guerre di religione e settarie, o giustificate come tali. È la grande stasis del XXI secolo, che in futuro - ammesso che se ne esca vivi - sarà paragonata a modelli antichi, la Guerra del Peloponneso, la Guerra dei Trent’anni, o più recenti: la «guerra civile europea» fra il 1914 e il 1945.
Questa guerra, in parte provocata dagli interventi militari statunitensi in Medioriente, prima e dopo l’11 settembre 2001, si è intensificata con gli interventi successivi, ai quali partecipano ormai Russia e Francia, ciascun paese con i propri obiettivi. Ma le sue radici affondano anche nella feroce rivalità fra Stati che aspirano tutti all’egemonia regionale: Iran, Arabia saudita, Turchia, Egitto, e in un certo senso Israele - finora l’unica potenza nucleare.
In una violenta reazione collettiva, la guerra precipita tutti i conti non saldati delle colonizzazioni e degli imperi: minoranze oppresse, frontiere tracciate arbitrariamente, risorse minerarie espropriate, zone di influenza oggetto di disputa, giganteschi contratti di fornitura di armamenti. La guerra cerca e trova all’occorrenza appoggi fra le popolazioni avverse.
Il peggio, forse, è che essa riattiva «odi teologici» millenari: gli scismi dell’Islam, lo scontro fra i monoteismi e i loro succedanei laici. Nessuna guerra di religione, diciamolo chiaramente, ha le sue cause nella religione stessa: c’è sempre un «substrato» di oppressioni, conflitti di potere, strategie economiche. E ricchezze troppo grandi, e troppo grandi miserie. Ma quando il «codice» della religione (o della «controreligione») se ne appropria, la crudeltà può eccedere ogni limite, perché il nemico diventa anatema. Sono nati mostri di barbarie, che si rafforzano con la follia della loro stessa violenza - come Daesh con le decapitazioni, gli stupri delle donne ridotte in schiavitù, le distruzioni di tesori culturali dell’umanità.
Ma proliferano ugualmente altre barbarie, apparentemente più «razionali», come la «guerra dei droni» del presidente Obama (premio Nobel per la pace) la quale, ormai è assodato, uccide nove civili per ogni terrorista eliminato.
In questa guerra nomade, indefinita, polimorfa, dissimmetrica, le popolazioni delle «due sponde» del Mediterraneo diventano ostaggi. Le vittime degli attentati di Parigi, dopo Madrid, Londra, Mosca, Tunisi, Ankara ecc., con i loro vicini, sono ostaggi.
I rifugiati che cercano asilo o trovano la morte a migliaia a poca distanza dalle coste dell’Europa sono ostaggi. I kurdi presi di mira dall’esercito turco sono ostaggi. Tutti i cittadini dei paesi arabi sono ostaggi, nella tenaglia di ferro forgiata con questi elementi: terrore di Stato, jihadismo fanatico, bombardamenti di potenze straniere.
Che fare, dunque? Prima di tutto, e assolutamente, riflettere, resistere alla paura, alle generalizzazioni, alle pulsioni di vendetta. Naturalmente, prendere tutte le misure di protezione civile e militare, di intelligence e di sicurezza, necessarie per prevenire le azioni terroristiche o contrastarle, e se possibile anche giudicare e punire i loro autori e complici. Ma, ciò facendo, esigere dagli Stati «democratici» la vigilanza massima contro gli atti di odio nei confronti dei cittadini e dei residenti che, a causa della loro origine, religione o anche abitudini di vita, sono indicati come il «nemico interno» dagli autoproclamatisi patrioti. E poi: esigere dagli stessi Stati che, nel momento in cui rafforzano i propri dispositivi di sicurezza, rispettino i diritti individuali e collettivi che fondano la loro legittimità. Gli esempi del «Patriot Act» e di Guantanamo mostrano che non è scontato.
Ma soprattutto: rimettere la pace al centro dell’agenda, anche se raggiungerla sembra così difficile. Dico la pace, non la «vittoria»: la pace duratura, giusta, fatta non di vigliaccheria e compromessi, o di controterrore, ma di coraggio e intransigenza. La pace per tutti coloro i quali vi hanno interesse, sulle due sponde di questo mare comune che ha visto nascere la nostra civiltà, ma anche i nostri conflitti nazionali, religiosi, coloniali, neocoloniali e postcoloniali. Non mi faccio illusioni circa le probabilità di realizzazione di quest’obiettivo. Ma non vedo in quale altro modo, al di là dello slancio morale che può ispirare, le iniziative politiche di resistenza alla catastrofe possano precisarsi e articolarsi. Farò tre esempi.
Da una parte, il ripristino dell’effettività del diritto internazionale, e dunque dell’autorità delle Nazioni unite, ridotte al nulla dalle pretese di sovranità unilaterale, dalla confusione fra umanitario e securitario, dall’assoggettamento alla «governance» del capitalismo globalizzato, dalla politica delle clientele che si è sostituita a quella dei blocchi. Occorre dunque resuscitare le idee di sicurezza collettiva e di prevenzione dei conflitti, il che presuppone una rifondazione dell’Organizzazione - certamente a partire dall’Assemblea generale e dalle «coalizioni regionali» di Stati, invece della dittatura di alcune potenze che si neutralizzano reciprocamente o si alleano solo per il peggio.
Dall’altra parte, l’iniziativa dei cittadini di attraversare le frontiere, superare le contrapposizioni fra le fedi e quelle fra gli interessi delle comunità, il che presuppone in primo luogo poterle esprimere pubblicamente. Niente deve essere tabù, niente deve essere imposto come punto di vista unico, perché per definizione la verità non preesiste all’argomentazione e al conflitto.
Occorre dunque che gli europei di cultura laica e cristiana sappiano quel che i musulmani pensano circa l’uso della jihad per legittimare avventure totalitarie e azioni terroristiche, e quali mezzi hanno per resistervi dall’interno. Allo stesso modo, i musulmani (e i non musulmani) del Sud del Mediterraneo devono sapere a che punto sono le nazioni del «Nord», un tempo dominanti, rispetto al razzismo, all’islamofobia, al neocolonialismo. E soprattutto, occorre che gli «occidentali» e gli «orientali» costruiscano insieme il linguaggio di un nuovo universalismo, assumendosi il rischio di parlare gli uni per gli altri. La chiusura delle frontiere, la loro imposizione a scapito del multiculturalismo delle società di tutta la regione, questa è già la guerra civile.
Ma in questa prospettiva, l’Europa ha virtualmente una funzione insostituibile, che deve onorare malgrado tutti i sintomi della sua attuale decomposizione, o piuttosto per porvi rimedio, nell’urgenza. Ogni paese ha la capacità di trascinare tutti gli altri nell’impasse, ma tutti insieme i paesi potrebbero costruire vie d’uscita e costruire argini.
Dopo la «crisi finanziaria» e la «crisi dei rifugiati», la guerra potrebbe uccidere l’Europa, a meno che l’Europa non dia segno di esistere, di fronte alla guerra.
E’ questo continente che può lavorare alla rifondazione del diritto internazionale, vegliare affinché la sicurezza delle democrazie non sia pagata con la fine dello Stato di diritto, e cercare nella diversità delle comunità presenti sul proprio territorio la materia per una nuova forma di opinione pubblica.
Esigere dai cittadini, cioè tutti noi, di essere all’altezza dei loro compiti, è chiedere l’impossibile? Forse; ma è anche affermare che abbiamo la responsabilità di far accadere quel che è ancora possibile, o che può tornare a esserlo.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. TORNARE ALLE "COSE STESSE" (HUSSERL): ANDARE A NOI STESSI.15 novembre 2015
Pianeta Terra. Sull’uscita dallo stato di minorità, oggi......
 LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. Un omaggio a Kurt H. Wolff e a Barrington Moore Jr.
LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. Un omaggio a Kurt H. Wolff e a Barrington Moore Jr. AMORE EU-ANGELICO (" CHARITAS"), IN FRANCESE E’ "CHARITÈ", MA IN VATICANO SCRIVONO "DEUS CARITAS EST" E "DIEU EST AMOUR". CHE CONFUSIONE!!! E CHE "LATINORUM"!!!
AMORE EU-ANGELICO (" CHARITAS"), IN FRANCESE E’ "CHARITÈ", MA IN VATICANO SCRIVONO "DEUS CARITAS EST" E "DIEU EST AMOUR". CHE CONFUSIONE!!! E CHE "LATINORUM"!!! TORNARE ALLE "COSE STESSE" (HUSSERL): ANDARE A NOI STESSI.
TORNARE ALLE "COSE STESSE" (HUSSERL): ANDARE A NOI STESSI.
 NOTE SULLA VIA DELLA VITA, NON DELLA GUERRA E DELLA MORTE.
NOTE SULLA VIA DELLA VITA, NON DELLA GUERRA E DELLA MORTE. -
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- Il camminare eretti, l’umana dignità, e la "buona scuola" del paradigma aziendalista (di Carlo Ridolfi).13 novembre 2015, di Federico La Sala
Parole sbagliate
di Carlo Francesco Ridolfi (comune-info, 10 novembre 2015) *
Quando si inizia un discorso, sarebbe opportuno aver fatto pulizia nel linguaggio. Perché le parole pesano e lasciano tracce e se sono parole sbagliate possono lasciare tracce doloranti e dolorose. Così, ad esempio, se una volta dicevamo direttore didattico (e ci viene in mente Gianfranco Zavalloni, che ci diceva: “Io ho delle segretarie formidabili, che si occupano delle circolari e dei timbri. Io mi interesso della didattica”) e oggi dovremmo invece dire dirigente, cominceremmo già a torcerci verso quel paradigma aziendalista che sembra andare per la maggiore.
Così, in ugual modo, se chiamiamo utenti gli studenti, o se gli obiettivi didattici vengono riassunti in un testo che si intitola piano dell’offerta formativa, richiamandosi per logica ad una domanda e ad una logica di scambio mercantile.
Useremo quindi parole forse desuete, ma che ci convincono di più, per dire alcuni pensieri sull’educazione e sulla scuola.
Scrive in un suo (bellissimo) testo il senatore Walter Tocci:
- «Il primo e l’ultimo giorno di scuola sono i momenti che rimangono nella memoria della persona. (...) Il primo giorno di scuola coincide con la nascita e l’ultimo giorno con la fine della vita»[1].
Pulizia del linguaggio: l’usura delle parole di cui, a volte, sembra soffrire il nostro tempo, causa slittamenti di significato che hanno conseguenze pratiche spesso deleterie. Infatti quando si parla di educazione molti intendono scuola, attribuendo (i genitori) o assumendo su sé (gli insegnanti) il compito di trasmettere non solo nozioni, ma anche stili di vita, forme di pensiero, costumi e senso comune.
Così come Tocci, anche il (nostro) grande maestro Mario Lodi ci ricordava sempre che l’educazione non comincia (e non finisce) a scuola, ma che il bambino e la bambina arrivano già alla scuola dell’infanzia, e ancor più alla primaria, con un bagaglio culturale ed emotivo appreso in famiglia, dall’ambiente circostante, dai media, di cui è necessario tener conto.
In un’epoca e in un mondo nei quali l’ansia maggiore sembra essere quella della misurabilità delle prestazioni, così da quantificarne estensione e durata, la riflessione che ci è parsa più urgente è stata quindi quella di cercare una possibilità altra, che consideri la dimensione educativa come non necessariamente soggetta a calcolo e bilancio economicistico. Abbiamo quindi cominciato ad immaginare una scuola buona, dove il sostantivo non indica solo uno spazio o un tempo definito, ma una vita intera, e l’aggettivo recupera i suoi significati originari di tensione al bene, onestà, mitezza, cortesia, generosità, ma anche di qualità, di valore, di eleganza.
Cercheremo cioè di indicare una prassi del cammino, perché il punto di partenza dev’essere la corretta definizione di quanto la nostra azione possa essere efficace, se improntata a quel principio di responsabilità verso chi ci è prossimo, ponendo l’attenzione allo spazio reale in cui noi si possa agire.
Diceva Ernst Bloch:
- «L’obiettivo delle utopie sociali è l’instaurazione della massima felicità umana e di una libertà che non ostacoli l’aspirazione alla felicità; il contenuto, il modello cui rimanda il diritto naturale, non è l’umana felicità, bensì il camminare eretti, l’umana dignità, l’ortopedia del camminare eretti, ovvero che nessuna schiena si curvi dinanzi ai troni reali ecc., bensì la scoperta dell’umana dignità, la quale non viene più dedotta dai rapporti cui si deve adeguare, ma (tanto peggio per i dati di fatto!) dal nuovo, fiero concetto di uomo, d’un uomo che non striscia procedendo come un rettile, bensì di un uomo con la testa eretta, il quale ci impegna moralmente, distinguendoci e differenziandoci dagli animali»[2].
Si definisce qui già un obiettivo generale, che servirebbe da spartiacque per collocare la scuola buona. I processi educativi e quelli più compiutamente didattici devono servire a inserire l’alunno o l’alunna in un ambiente dato, al quale essi debbano conformarsi, oppure a fornire loro strumenti per contribuire alla trasformazione e al cambiamento progressivo di quello stesso ambiente? Rispondendo in un senso o nell’altro si ha già chiara l’idea di dove si va a parare.
Se ci è necessaria, quindi, una ortopedia del camminare eretti, può essere conseguente che la nostra azione risulterebbe inefficace se diretta o a uno spazio così generico e impalpabile da risultare presto soffiata via nel cielo delle idee, o a confini così angusti da ripiegarsi su se stessa in una quasi inevitabile eterogenesi dei fini. Fissare, ad esempio, il nostro campo di azione nel raggio delle persone e dei luoghi che possiamo raggiungere camminando sarebbe già un criterio di economia delle forze e di razionalità politica.
Potremmo partire, cioè, da un’azione educativa nella prossimità.
Ancora Walter Tocci:
- «L’ossessione normativa dell’ultimo ventennio ha irrigidito il sistema scolastico con una burocrazia sempre più asfissiante. Invece, nella Prima Repubblica, le leggi sono arrivate sempre in ritardo a certificare un mutamento che prima era stato maturato nella vita quotidiana della scuola. Le riforme erano processi complessi e multiformi: il ruolo dei grandi profeti come don Milani, Mario Lodi, Albino Bernardini che hanno suscitato la vocazione di milioni di insegnanti; l’elaborazione dei programmi nelle commissioni composte dai migliori intellettuali del Paese; le sperimentazioni che aprivano varchi nella nebbia del conformismo ministeriale; l’associazionismo cattolico e laico che formava i docenti ed elaborava nuovi percorsi didattici; le lotte sindacali che, per la prima volta in Italia, ponevano l’esigenza dell’educazione degli adulti con le 150 ore; gli enti locali che favorivano l’apertura alla creatività dei territori. I partiti sapevano assorbire questi fermenti per poi tradurli in programmi nazionali e infine nelle leggi dello Stato. In questo modo sono state create le eccellenze italiane di rilievo internazionale: la scuola dell’infanzia di certe regioni, il tempo pieno, gli istituti tecnici in relazione con i tessuti industriali etc.»[3].
Al politico possiamo quindi dire che una scuola buona non può essere la scuola pubblica che sembra essere sempre più orientata a diventare una scuola privata: privata di mezzi, di intelligenze, di agibilità.
All’imprenditore che abbia ben chiaro che i riferimenti obbligati per tutti noi sono quelli della Costituzione della Repubblica Italiana e, in particolare per lui, principalmente gli Articoli 41-42-43[4], ma anche i seguenti 44-45-46-47, possiamo ricordare che una virtuosa circolazione delle informazioni, delle conoscenze e delle competenze può arricchire sia il know-how dell’impresa che quello della società.
Al cittadino, sia esso, in questo caso, genitore o insegnante o tutt’e due, è giusto e possibile assegnare il compito di pensare a pratiche di scuola indipendente: a sperimentare - cioè - negli spazi pubblici là dove sia possibile, ma anche in spazi non pubblici che non siano per ciò stesso improntati esclusivamente al profitto - forme educative e prassi pedagogico-didattiche che pongano in concreto al centro i bambini e le bambine e le ragazze e i ragazzi.
Con quale metodo di lavoro?
1. Non dare nulla per scontato. Non esiste la didattica data una volta per tutte o la pedagogia buona per tutte le stagioni. La teoria e la pratica si devono confrontare con la situazione reale, con gli studenti in carne ed ossa.
2. Non adagiarsi sulle mode. Gli educatori dovrebbero essere curiosi per abitudine intellettuale e pratica.
3. Abbandonare la logica del sistema (dato e immodificabile) per entrare nella logica del processo (in cui esistono sia elementi di costante che possibili varianti).
4. Educare alla bellezza. Perché la scuola buona dev’essere anche bella. Non si tratta di una accademica scelta per pochi iniziati, di un’aristocratica tensione estetizzante, ma di un orizzonte a cui tendere continuamente, con la consapevolezza che l’educazione all’armonia delle forme e dei contenuti è la strada più agevole per una formazione di sensibilità civiche.
5. Decifrare il solfeggio dello spirito. La definizione, bellissima, è stata attribuita dagli articolisti di Le Monde nel ricordo del grandissimo antropologo Claude Lévi-Strauss. “Decifrare il solfeggio dello spirito” significa, ad esempio, in didattica della letteratura o dell’immagine, utilizzare gli strumenti dell’analisi strutturale e stilistica non per quelle insopportabili autopsie dei testi che sono le schede di valutazione, ma per una maggiore e sempre più approfondita esplorazione dei criteri e degli elementi intertestuali che può farci conoscere ancora meglio la bellezza dei testi stessi.
6. Agire insieme. Significa, prima di tutto, mettere in comune le rispettive conoscenze. Non solo in termini di apertura alla discussione e al confronto, ma anche, nella pratica quotidiana, nel rendere disponibili materialmente sia eleborazioni teoriche che azioni di pratica educativa. Significa, concettualmente ma anche in concreto, privilegiare la logica dell’open-source, piuttosto che quella del copyright e della proprietà privata delle idee.
Come scrive Beatrice Bonato :
- «Contro la perfezione imposta dalla società neoliberale o dal capitalismo tecno-nichilista, non è l’appiattimento che vorremmo salvare, quanto una rinnovata capacità di apprezzare ciò che non ha prezzo, e per cui è difficile non usare il linguaggio del dono. (...) La dimensione del dono potrebbe interessare da vicino e da più lati la questione dell’insegnamento, consentendo di rovesciare in un pregio quella resistenza alla logica mercantile e tecnica imputata alla scuola come il suo più grave ritardo»[5].
Perché, in definitiva, la scuola buona è una scuola da benedire come un regalo.
. * coordinatore per la Rete di Cooperazione Educativa - C’è speranza se accade @
Note
 1. Walter Tocci: La mancata riforma della scuola. Manuale di sopravvivenza agli abbagli mediatici. 2015.
1. Walter Tocci: La mancata riforma della scuola. Manuale di sopravvivenza agli abbagli mediatici. 2015.
 2. Ernst Bloch: Marxismo e utopia. A cura di Virginio Mazzocchi. Editori Riuniti. Roma, 1984.
2. Ernst Bloch: Marxismo e utopia. A cura di Virginio Mazzocchi. Editori Riuniti. Roma, 1984.
 3. Walter Tocci. Id.
3. Walter Tocci. Id.
 4. Art. 41: L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
4. Art. 41: L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
 Art. 42: La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sull’eredità.
Art. 42: La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sull’eredità.
 Art. 43: A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di interesse generale.
Art. 43: A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di interesse generale.
 5. Beatrice Bonato: Senso e non senso della competizione, in Aut Aut n. 358. La Scuola impossibile.
5. Beatrice Bonato: Senso e non senso della competizione, in Aut Aut n. 358. La Scuola impossibile. -
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- IDENTITA’, LINGUA BIFORCUTA, E SONNAMBULISMO. LA LEZIONE DEI NOSTRI PADRI E DELLE NOSTRE MADRI.10 novembre 2015
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- "INSIDE OUT". Se Cartesio sbarca al cinema... Un omuncolo testardo si contrappone sistematicamente al buon ragionatore che c’è in noi.8 novembre 2015, di Federico La Sala
Inside Out
Se Cartesio sbarca al cinema
di Piergiorgio Odifreddi (la Repubblica, 08.11.2015)
Sta circolando da qualche settimana in Italia il film Inside out, il cui titolo allude al tentativo della Pixar di “tirar fuori ciò che abbiamo dentro”. Cioè di mostrare visivamente i meccanismi mentali nelle loro componenti razionali ed emotive. I critici cinematografici, che evidentemente si intendono solo di cinema, l’hanno esaltato come un’esposizione quasi scientifica delle nuove frontiere neurofisiologiche, scomodando al proposito addirittura i nomi di Antonio Damasio e Oliver Sacks.
In realtà il film avrebbe fatto meglio a intitolarsi Outside in, perché non fa altro che “metter dentro ciò che siamo fuori”. Cioè ripete l’antico “errore di Cartesio”, che credeva che a guidare l’uomo fosse un homunculus dentro di lui, fatto a sua immagine e somiglianza in versione miniaturizzata. Il quale, come i protagonisti del film, sta seduto in un “teatro cartesiano” e osserva dal di dentro ciò che il suo principale a grandezza naturale percepisce dal di fuori.
Naturalmente, poiché un homunculus differisce da un homo solo nelle dimensioni, si può immaginare che nella sua testa ci sia un homunculissimus ancora più piccolo che lo osserva e lo dirige, e così via. L’ipotesi porta dunque a un regresso all’infinito, che non ha bisogno delle neuroscienze per essere confutato: basta la logica, in una delle innumerevoli variazioni del paradosso di Achille e la tartaruga.
_______________________________________________
Imparare a pensare
Che fatica essere logici
Un omuncolo testardo si contrappone sistematicamente al buon ragionatore che c’è in noi. Lo dicono le scienze cognitive. La scuola deve fornire a tutti gli adeguati strumenti critici
di Roberto Casati (Il Sole-24Ore, Domenica, 8.11.2015)
«Prendiamo persone con la stessa gravità di disturbi (misurata, per esempio, attraverso i test di memoria) e li confrontiamo su due fronti: il livello di scolarità e il livello di compromissione cerebrale, rilevata monitorando l’attività metabolica nelle aree tipiche dell’Alzheimer. Cosa osserviamo? Che i soggetti a scolarità alta hanno un peggiore quadro cerebrale: a parità di disturbi manifestati, il loro cervello è più sofferente.» (Stefano Cappa intervistato da Michele Farina, Quando andiamo a casa? Milano BUR, pag. 149).
Quando faccio leggere questa frase, noto una certa sorpresa nei miei interlocutori: sembra che un modo di proteggersi dall’Alzheimer sarebbe quello di non impegnarsi negli studi. In realtà la frase dice esattamente il contrario. «Nonostante siano a uno stadio più avanzato della degenerazione cerebrale, i pazienti a scolarità più alta dimostrano le stesse capacità di memoria di chi presenta un cervello meno devastato e un livello culturale minore. Perché compensano meglio». Adesso, forse, le cose ci sono più chiare. Ma come diceva il biologo americano Stephen Jay Gould, anche se abbiamo capito il senso corretto della frase, se la rileggiamo ci sembra di sentire un omuncolo che va su e giù per nostro cervello a ripetere che è meglio non studiare troppo se ci si vuole proteggere dall’Alzheimer. C’è qualcosa nel testo con cui si apre questo articolo che ci impedisce di arrivare facilmente al senso inteso.
Di omuncoli dispettosi è popolato il cervello raziocinante. Un altro omuncolo ci fa voltare sistematicamente la carta sbagliata nel classico test inventato dallo psicologo britannico Peter Wason: quattro carte sul tavolo davanti a noi, una rossa, una blu, una con scritto sette e una con scritto sei. Sappiamo che le carte hanno un retro colorato in rosso o blu, e un fronte con un numero pari o dispari. Domanda, qual è il numero minimo di carte da girare per verificare la regola «Tutte le carte rosse portano un numero pari»? Pensateci un attimo. Voltare la blu non serve. La rossa va bene (ovviamente: se ci fosse un numero dispari sull’altro lato, la regola sarebbe invalidata). Quali altre? La maggioranza degli intervistati dice che a questo punto basta voltare la sei. Va bene? In realtà, se scoprite che ha il retro blu, questo non vi dice nulla sulla regola. La carta da voltare è la sette. Se il retro della sette fosse rosso, la regola verrebbe violata.
Tutto chiaro, ma la tentazione di voltare anche la carta pari è sempre in agguato. Questo omuncolo testardo è un po’ la maledizione dell’insegnamento della logica perorato con passione nel libro di Paolo Legrenzi e Armando Massarenti (La buona logica. Imparare a pensare, Cortina) che Ermanno Bencivenga ha commentato su queste colonne il 18 ottobre.
L’insegnamento della logica ci informa sulle procedure corrette da mettere in opera quando si affrontano problemi che richiedono di ragionare. Ma non ci mette al riparo dall’omuncolo testardo, che continua a farsi strada nel pensiero. Nella fattispecie, il nostro omuncolo potrebbe venir definito “antispreco”: egli cercava di far tesoro di tutte le informazioni che ha trovato nella formulazione del problema, e in particolare del fatto che si era parlato di una carta pari, il sei, quando si metteva alla prova una regola che richiedeva di pensare ai numeri pari. L’omuncolo antispreco fa parte di quello che oggi gli psicologi cognitivi chiamano il “Sistema Uno”, una batteria di moduli cerebrali che formano l’ossatura delle nostre intuizioni sul mondo, a tutti gli effetti un’eredità biologica che ci permette di risolvere al volo problemi pratici impellenti come scansare ostacoli o fare due conti su cosa ci conviene nel futuro immediato.
Le caratteristiche principali di questi moduli sono la velocità, l’automaticità, e una certa testardaggine; dopotutto, servono a trarci d’impaccio in situazioni in cui il tempo è prezioso, e non hanno molta voglia di star lì a discutere. Al Sistema Uno viene contrapposto il Sistema Due, un modo di operare più lento e modulato dall’attenzione cosciente. Quando attraversiamo la strada a Vicenza noi nati e cresciuti in Italia agiamo in Sistema Uno, ci fidiamo delle nostre intuizioni sul traffico, sappiamo stimare i tempi, non dobbiamo pensare per guardare dalla parte giusta prima di avventurarci sull’asfalto pericoloso. La nostra azione è fluida, agire e pensare fanno un tutt’uno. Quando andiamo a Londra l’ambiente nuovo ci sfida, poniamo invece attenzione a ogni passo: siamo in pieno nel Sistema Due, sincopato, lento e dubitativo. E nonostante tutto anche a Londra l’omunculo “della guida a destra” si fa sentire (è veloce, automatico e testardo) e bisogna cercare di metterlo a tacere se si vuole portare a casa la pelle.
Studiare la logica, fare esercizi come quelli che troviamo in un manuale, ci permette di vedere che il Sistema Uno non sempre dà i risultati migliori. Ma adottare una modalità riflessiva, ovvero esercitare il controllo proprio del Sistema Due, non è cosa che si guadagna facilmente anche dopo aver studiato logica: non dimentichiamo che gli omuncoli automatici devono venir continuamente inibiti. Questo perché la competenza non si riflette automaticamente sulla performance.
Cos’altro possiamo fare, allora, per risollevare i destini della nazione, renderla più raziocinante? Uno dei suggerimenti più interessanti degli ultimi anni viene dal lavoro di Dan Sperber e Hugo Mercier, che hanno messo in luce come la funzione cognitiva principale del ragionamento non sia di migliorare le conoscenze di un dato individuo ma argomentare, cioè convincere gli altri della bontà dei nostri argomenti e valutare gli argomenti altrui in modo critico al fine di essere convinti solo quando è necessario. Segue dalla loro ipotesi che i ragionamenti svolti in coppia o in gruppo danno risultati migliori che quelli effettuati in solitudine. Lavorare in gruppo è un toccasana logico!
Un altro dei fattori che possono rinforzare l’applicazione del pensiero critico è acquisire una certa consuetudine con le procedure di verifica empirica di un’ipotesi che son pane per i denti delle discipline scientifiche. Per esempio, imparare che bisogna sempre controllare i fattori che potrebbero aver influenzato una misura, o imparare a diffidare della ricerca automatica di conferme per le proprie ipotesi.
Un’altra strategia è legata al fatto che si fanno meno errori di ragionamento quando si conosce ciò di cui si parla: imparare bene qualcosa è il primo passo per imparare a pensare bene (contrariamente all’idea di una conoscenza logica generale, passepartout).
Ma direi che non c’è una soluzione definitiva, che ci possa dire che abbiamo finalmente “imparato” a pensare. Gli omuncoli testardi non possono venir eliminati né sconfitti. Possono solo venir tenuti a bada, ed è sulle tecniche per imbrigliarli che potrebbe focalizzarsi una pedagogia innovativa che, mi pare, dovrà necessariamente far uso di checklist.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- Platone è meglio dell’«Italian Theory»: De Monticelli, "Al di qua del bene e del male" (di Mario Riciardi).8 novembre 2015, di Federico La Sala
Roberta De Monticelli si scaglia contro lo scetticismo morale che pervade i costumi degli italiani e che non risparmia i filosofi
Platone è meglio dell’«Italian Theory»
di Mario Ricciardi (Il Sole-24 Ore, Domenica, 8.11.2015)
- Roberta De Monticelli, Al di qua del bene e del male, Einaudi, Torino, pagg. 272, € 13,00
Per chi ha conosciuto Roberta De Monticelli leggendo i suoi scritti teoretici, e in particolare L’ascesi filosofica (Feltrinelli, 1995), i lavori più recenti di questa filosofa sono stati, se non una rivelazione, una sorpresa. Da qualche anno, infatti, De Monticelli ha intrapreso un percorso di riflessione che l’ha portata a confrontarsi con una questione centrale del dibattito pubblico: il rapporto tra moralità e politica. L’ha fatto scegliendo una forma letteraria che ha precedenti illustri nella nostra tradizione: il sermone civile, un discorso che aspira a essere al contempo argomentazione ed esercizio pedagogico. A questa evoluzione ha fatto seguito un parziale mutamento delle letture di riferimento e dello stile, di qui la sorpresa di cui dicevo.
Senza abbandonare del tutto i suoi autori, da Husserl a Jeanne Hersch, De Monticelli si è aperta nei suoi scritti recenti a orizzonti intellettuali diversi - come quello della teoria della giustizia e dell’etica pubblica post-rawlsiana - entrando in dialogo anche con interlocutori che non appartengono al mondo della filosofia: giuristi, studiosi di scienze sociali, intellettuali pubblici. La novità si avverte nella scrittura: che diventa tesa, procede a scatti, più vicina ai ritmi del parlato che a quelli del saggio accademico.
Si ha quasi l’impressione che, presa dall’urgenza di fare i conti con i temi della vita pubblica, Roberta De Monticelli abbia ingaggiato un corpo a corpo con un avversario temibile, cui non riesce ancora a dare un nome. L’ultima testimonianza di questo scontro è Al di qua del bene e del male. Per una teoria dei valori. Un libro che segna probabilmente un cambio di passo rispetto ai precedenti, perché abbandona la forma del sermone civile e ritorna a modalità argomentative più prossime a quelle tipiche della filosofia.
La spiegazione di questo cambiamento si trova verosimilmente nel fatto che l’autrice abbia avvertito il bisogno di fare un bilancio delle sue esplorazioni «nello stato presente dei costumi degli italiani» (per riprendere il titolo di uno scritto di Leopardi di cui si avverte spesso l’eco nei lavori recenti della De Monticelli).
In effetti, nelle pagine di Al di qua del bene e del male ci viene offerta una diagnosi di ciò che è andato storto nei nostri costumi, ovvero nel modo in cui agiamo, parliamo e pensiamo, e una proposta relativa alla cura di cui avremmo bisogno per tornare in salute. La ricostruzione dei sintomi da cui saremmo affetti è una delle parti più appassionanti e persuasive del libro: la cecità rispetto alla dimensione normativa del mondo sociale, ridotto a fatto bruto, l’indifferenza alle diverse dimensioni del valore, il rattrappirsi della sensibilità morale, l’apatia civile.
Più complessa è la parte terapeutica, che consiste essenzialmente in una serie di argomenti per confutare lo scetticismo morale. Qui la De Monticelli si impegna in una battaglia su diversi fronti: contro lo storicismo, contro il nichilismo, contro una certa lettura del pluralismo dei valori, e contro il relativismo.
Devo dire che la parte sul pluralismo è quella che mi ha convinto meno. L’interlocutore principale con cui si confronta l’autrice, Isaiah Berlin, non è mai arrivato a una formulazione soddisfacente delle proprie tesi sul pluralismo.
D’altro canto mi pare che la De Monticelli trascuri le tensioni concettuali della tesi dell’unità del valore di Ronald Dworkin, che viene presentato nel libro come il più illustre rappresentante di una tendenza antipluralista nel dibattito contemporaneo. Per menzionare l’esempio della libertà, ci sono buone ragioni per resistere alla normativizzazione di questo concetto. Distinguere la libertà dalla licenza è un’abile mossa che Dworkin si concede per eludere le obiezioni dei critici, ma il rispetto che dobbiamo alla verità ci impedisce di accettarla.
L’aspetto centrale di questo libro è costituito comunque dalla critica serrata alle tendenze intellettuali che, secondo la De Monticelli, avrebbero abdicato alla missione del Socrate dei dialoghi di Platone per abbracciare invece uno scetticismo morale che crea l’ambiente adatto per la corruzione dei costumi. Le pagine sul «pensiero della disperanza che si lamenta invano» sono vigorose e non prive di una certa perfidia.
L’autrice non si lascia incantare dai fumi dell’Italian Theory, l’eredità che l’operaismo degli anni settanta ha lasciato al mondo. Giustamente la De Monticelli respinge l’idea che si possa criticare il capitalismo finanziario o la globalizzazione senza tener conto degli sviluppi che l’economia politica ha avuto dalla seconda metà dell’Ottocento in poi.
Incapaci di fare i conti con gli argomenti libertari che, a partire dagli anni ottanta, hanno preso il sopravvento sul “consenso socialdemocratico”, gli Italian Theorists parlano d’altro. Chiudendosi nella riserva di dipartimenti in cui è improbabile imbattersi in una Roberta De Monticelli che rivolga loro domande imbarazzanti come quelle poste in questo libro sull’appropriazione di Heidegger e Schmitt da sinistra.
Anche sui due tristi figuri recuperati dall’Italian Theory ci sono pagine sferzanti. Del primo ci offre un breve ritratto intellettuale che chiude la questione del rapporto tra la sua filosofia e l’adesione al nazismo: sì, la sua filosofia era nazista. Altrettanto spietata è con lo scritto sulla “tirannia dei valori” di Schmitt.
L’autrice fa a pezzi “questo mediocre saggio” - che ha tanti estimatori nel nostro paese - lasciando il lettore liberale in uno stato di esultante simpatia, un po’ come il ragionier Filini quando Fantozzi urla cosa pensa della Corazzata Potëmkin.
In questa dimensione critica, in cui si nota più forte la continuità con i sermoni civili pubblicati negli ultimi anni, c’è un richiamo vigoroso che l’autrice rivolge ai propri colleghi: agli educatori, ai filosofi, agli intellettuali. Non abdicare alla missione di Socrate, la ricerca della verità, anche se questo comporta andare contro la corrente.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- E’ UN SEGRETO DI PULCINELLA. Un "Divertimento per li regazzi". Agamben docet (di Melania Mazzucco)7 novembre 2015, di Federico La Sala
Giorgio Agamben dedica il nuovo saggio alla maschera e ai suoi significatiLa filosofia è un segreto di nome Pulcinella
di Melania Mazzucco (la Repubblica, 7.11.2015)
- IL LIBRO Pulcinella ovvero Divertimento per li regazzi di Giorgio Agamben (nottetempo, pagg. 144 euro 27) Sopra, Pulcinella innamorato di Giambattista Tiepolo
Negli ultimi anni della sua vita, il pittore Giandomenico Tiepolo, che aveva soggiornato nelle corti d’Europa (in Germania e in Spagna) insieme al padre Giambattista, si trasferì nella villa che questi gli aveva lasciato in eredità, nella terraferma veneziana: a Zianigo, presso Mirano. Aveva decorato quella modesta villetta con la massima libertà - che un pittore del XVIII secolo poteva regalarsi solo dipingendo per se stesso. Aveva iniziato affrescando scene vagamente neoclassicheggianti di satiri e centauri, e quindi scene di vita contemporanea. Col Mondo Novo nel portego, la sala grande del pianterreno (1791), si offrì una meditazione sorridente e malinconica sul tempo tumultuoso che stava vivendo. La folla si accalca davanti al baraccone in cui un ciarlatano promette di mostrare le immagini del ‘mondo novo’; egli incombe su di loro, come il burattinaio sulle marionette. Tutti mostrano le spalle agli spettatori, ignari della nostra presenza (e della nostra ironia). Soltanto uno di essi ci guarda: un bambino che in quel mondo novo vivrà.
Ma tre di loro, raffigurati di profilo, sembrano immuni dalle illusioni e dal rumore del mondo: un uomo anziano in cui si è sempre riconosciuto Giambattista Tiepolo, Giandomenico stesso, e Pulcinella. Il pittore manovra il suo occhialino: disorientato, ha bisogno di una lente, ma non rinuncia a capire. Infine (1793-97), Giandomenico affrescò le pareti della stanza di nord est - forse il suo studiolo - con una serie di scene aventi un solo protagonista: Pulcinella, che volle come unico compagno e alter ago dei suoi anni estremi.
Fra il 1797 e la morte, avvenuta nel 1804, Giandomenico creò il Divertimento per li regazzi - un album di disegni in 104 fogli, un “incunabolo del fumetto”, interamente dedicato a Pulcinella. L’enigmatico napoletano di bianco vestito, dal cappello a cono mozzato e dal volto nero a becco di uccello, da quasi due secoli stregava gli spettatori, nobili, borghesi e plebei, di tutta Europa. Ma veniva da ancor più lontano, dalle atellane, dai drammi satireschi. Animato da una irresistibile energia vitale, disponibile a ogni avventura, citrullo per natura e strategia di sopravvivenza, refrattario a ogni autorità, dovere, morale, sempre bastonato e però invincibile, sostanzialmente immortale, il proteiforme Pulcinella era diventato la maschera più popolare del teatro all’italiana. Era comparso in numerose pitture. Lo stesso Tiepolo padre ne era stato ossessionato (disegnandolo per lo più come un gobbo, nano e mostruoso, mentre mangia, digerisce, orina ed evacua). Ma nessuno come Giandomenico ne fece il proprio riflesso spettrale.
Che Pulcinella fosse per lui assai più di una comica maschera di Carnevale lo svela già il frontespizio del Divertimento, quasi blasfema citazione di quello della giovanile raccolta di incisioni La Via Crucis: al sepolcro vuoto di Cristo e alle insegne della Passione, sostituisce il sepolcro vuoto di Pulcinella, e le sue insegne (la pentola, i maccheroni), contemplate da lui stesso. In questo povero Cristo senza miracoli, chino sull’assurdità della propria vita e di quella di tutti, si riconobbe: ne disegnò nascita, crescita, amori, avventure, erranze, lavori, gozzoviglie, morte - facendone lo specchio di ogni esistenza umana.
Alla straordinaria impresa artistica del Divertimento - poco conosciuta, perché sventuratamente smembrata fra troppe collezioni sparse in vari continenti - il filosofo Giorgio Agamben, tra i principali pensatori del nostro tempo, dedica la sua ultima opera: “ilare e scherzevole” ma solo apparentemente meno densa e “laboriosa” delle altre sue. Giacché, come fin dalla prima pagina ci ricorda, la commedia è filosofia: Platone teneva sotto il cuscino i mimi di Sofrone, e la commedia è più antica e profonda della tragedia. Nell’“oscurità dei tempi” in cui a entrambi è stato dato vivere - il pittore veneziano costretto ad assistere alla dissoluzione ingloriosa della Repubblica di Venezia, il filosofo italiano e cosmopolita a quella della nostra e dell’occidente - Pulcinella si rivela l’interlocutore più stimolante per una ricapitolazione, una “sobria meditazione sulla fine”. Non sarà futile notare che entrambi lo scelgono dopo aver valicato la soglia dei settanta anni.
Diviso in quattro scene scandite da corsivi ora autobiografici ora storicizzanti, e da frammenti di un’operetta morale (fulminanti dialoghi in napoletano fra Pulcinella e Tiepolo, ma in realtà fra Pulcinella e Agamben), accompagnato da alcuni disegni dell’album nonché da illustrazioni di altri quadri e ritratti (impaginate con finezza, in modo anti- didascalico, cosa di cui va reso merito anche alla casa editrice Nottetempo), costruito per brevi capitoli e divagazioni dotte che spaziano dall’antropologia al folclore, alla filosofia classica, alla linguistica, alla storia del teatro, dal dettaglio tecnico all’astrazione teoretica, il Divertimento delizierà i lettori abituali del filosofo Agamben, ma forse potrà avvicinargli anche qualcuno dei ‘regazzi’ che ha esitato davanti all’Homo sacer o Nudità. Regazzi si intenda in senso lato - come del resto intendeva Tiepolo: ché il suo album non era dedicato ai bambini, o ai fanciulli, ma agli spiriti liberi dalle costrizioni e dai conformismi.
Il Divertimento di Agamben è insomma una lezione socratica sul significato di una maschera che è insieme singola e solitaria, e plurima come gli angeli e la plebe (una “masnada”, un popolo, una collezione di repliche). Né personaggio né carattere né tipo, Pulcinella è un’idea: «che qualcuno o qualcosa sia irreparabilmente com’è; questo è Pulcinella» (l’idea dell’irreparabile, apparentemente tragica, riflette Agamben, è invece in se stessa comica).
Non sostantivo ma un avverbio: Pulcinella «non è un che ma soltanto un come »; non ha scelto di essere com’è, o di fare qualcosa, non ha volontà alcuna e le sue azioni, lungi dal mirare a un fine, sono insensate, lazzi senz’altro scopo che interrompere l’azione e vanificarla. Perfino il suo corpo, gallinaceo, ornitomorfo, non del tutto umano, cessa ogni rapporto col “logos”. Vivere la propria vita come Pulcinella può solo significare «per ogni uomo - afferrare la propria impossibilità di vivere ».
Tuttavia Agamben ci consegna anche la risposta a una domanda che tutti ci siamo posti. Qual è, alla fine, il segreto di Pulcinella? Non, come l’uso comune del linguaggio induce a credere, la cosa che tutti sanno. Ma che «nella commedia della vita non vi è un segreto, ma solo, in ogni istante, una via d’uscita».
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- Con Agamben nel mare di Pulcinella dove il mondo non affoga (di Angelo Guglielmi)5 dicembre 2015, di Federico La Sala
Con Agamben nel mare di Pulcinella dove il mondo non affoga
Mettendo in discussione il primato della prassi ricorda che vi è ancora politica al di qua o al di là dell’azione
- Giorgio Agamben «Pulcinella ovvero divertimento per li regazzi» Nottetempo pp. 142, € 27
di Angelo Guglielmi (La Stampa, 04/12/2015)
Nel 1789 La Repubblica marinara di Venezia, dopo secoli di autonomia e di progresso, morì, arrendendosi vilmente ai francesi di Bonaparte Tra i pittori allora operanti nella città vi erano Gianbattista Tiepolo (padre) e Giandomenico (figlio) e entrambi nella triste occasione si impegnarono in due (uno per ciascuno) corposi cicli di dipinti, disegni, incisioni dedicati a Pulcinella. L’uno (il padre) per denigrare e mettere in burla l’ignominia dei veneziani, l’altro (il figlio), che pure era indignato, trattò lo stesso tema (il titolo del suo ciclo è: Pulcinella ovvero divertimento per li regazzi ) con mano più lieve ma non solo per distinguersi dal padre e nemmeno perché d’animo più lieto.
Secondo Giorgio Agamben è perché era più bravo del padre (testimone Roberto Longhi), aveva una testa più fine e non gli era bastevole valorizzare il piglio della beffa. Così il ciclo di Giandomenico oltre l’illustrazione delle tavole è un sostanzioso studio sul personaggio Pulcinella, invero lo studio è di Giorgio Agamben che, inseguendo le tracce lasciate da Giandomenico, evidenzia per noi con dovizia di acume la complessità e particolarità di Pulcinella anche rispetto alle altre maschere della Commedia dell’Arte.
Che cosa ha di particolare Pulcinella? Certo come Arlecchino, Pantalone e gli altri incarnano altrettanti «tipi comici» evidenziati dalla maschera (ciascuno ha la sua) che indossano e con la quale recitano tutte le parti in commedia..
Ma dove sta la specificità di Pulcinella? Sì, anche Pulcinella come le altre maschere vive il personaggio che interpreta ma nel contempo ne prende le distanze e, facendosi discosto, si guarda guardare, e quel che guarda gli è indifferente o meglio lo ha già dimenticato. E’ come se, nota Agamben, «un filosofo gli fosse sempre accanto, muto testimone della sua vita».
Il modo di esprimersi di Pulcinella è «la goffaggine» non la parola, e la «goffaggine» non è una azione, è un gesto del corpo. Ma - sostiene Agamben - Pulcinella «non è, per questo, un impolitico» giacché «mettendo in questione il primato della prassi, ricorda che vi è ancora politica al di qua o al di là dell’azione». «Di qui la sua attualità, ogni volta che la politica attraversa una crisi decisiva - per Giandomenico, la fine dell’indipendenza di Venezia nel 1787, per noi l’eclisse della politica e il regno dell’economia planetaria».
Comunque (non scherziamo) la riflessione (filosofica o no) è estranea a Pulcinella. Pulcinella «non sceglie» e «non vuole», la sua caratteristica più evidente è «l’abulia». E per fortuna! Che disgrazia se avesse dovuto andare dietro agli arzigogoli della filosofia così contraddittori che se uno dice sì un altro (o lo stesso) dice no. Per esempio quando si sono impelagati nella differenza tra apparenza e sostanza hanno corso il rischio di sistemare la sostanza (la necessità) nell’esse (nell’essere) e l’apparenza nell’operare (nel fare). Finendo per giustificare quel che è accaduto a Auschwitz e ieri come oggi il pregiudizio sui diversi (ebrei, zingari, neri) colpevolmente giudicati per quel che sono e non per quel che fanno. Ma Pulcinella non c’entra con tutto questo, anche se lui che è nato a Napoli dice che a Napoli «’o mare nun se vede».
Ma come dargli torto, se il mare (come gli sta dicendo il filosofo che gli sta accanto) «non è altro che un infrangersi di una onda contro l’altra», e «quella che adesso è passata e le altre infinite che seguono...sono quelle che sono e, tuttavia, restano inconcluse, inconcludenti, possibili...». E Pulcinella illuminandosi conclude: «Ammén et requie matrerna! Aggio capito; je song’ o’ mare, song’ o’ mare...». E lo abbiamo capito anche noi.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- "Filosofia della crisi". Semplificare non aiuta la filosofia (di Pierluigi Panza)28 ottobre 2015, di Federico La Sala
- IL PROBLEMA DELLA GENESI, LA CRISI DELLE SCIENZE EUROPEE, E LA FENOMENOLOGIA TRASCENDENTALE....
 HUSSERL CONTRO L’HOMUNCULUS: LA ’LEZIONE’ DI ENZO PACI AI METAFISICI VISIONARI (ATEI E DEVOTI) DI IERI (E DI OGGI). Una ’traccia’ dal "Diario fenomenologico")
HUSSERL CONTRO L’HOMUNCULUS: LA ’LEZIONE’ DI ENZO PACI AI METAFISICI VISIONARI (ATEI E DEVOTI) DI IERI (E DI OGGI). Una ’traccia’ dal "Diario fenomenologico")
Semplificare non aiuta la filosofiadi Pierluigi Panza (Corriere della Sera, 28.10.2015)
Come sta la filosofia in questi anni di crisi? È in crisi, e si è piegata a scorciatoie, mode e costruzioni di consenso. Si è piegata, insomma, a ciò che la filosofia non dovrebbe mai essere. È questa la diagnosi, condivisibile, espressa nell’ultimo libro del filosofo Elio Franzini (Filosofia della crisi, Guerini e Associati, pp. 190, e 17,50), quasi una «cartella clinica» che evidenzia molte opacità nel paziente analizzato.
Le crisi sorgono nel momento in cui un modello, prevalendo sugli altri, li prevarica e mira alla loro soppressione. È quanto sta avvenendo in Occidente con l’imporsi di un «pensiero unico», di un nuovo «totalitarismo» che premia un solo modello di sviluppo economico, sociale e post-culturale. Un modello - di cui la fascinazione per i social network e il globalismo sono la più estrinseca manifestazione - che ha ucciso la ricerca e la critica. È amaro constatare come l’Europa, passata da non dissimili abbagli nella prima parte del Novecento, non riesca a tenere viva una pluralità di punti di vista. C’è infatti un metodo che unisce tutte le ricette che si propongono per superare «la crisi»: quello della semplificazione.
Oggi, insiste Franzini, assistiamo a riflessioni autoreferenziali, caratterizzate dalla volontà, spesso narcisistica, di semplificare quel che è complesso e storicamente stratificato. Una tendenza che incarna un’esigenza sempre più forte di divulgazione, ma che sfiora la banalizzazione e l’eccitazione per il nuovo.
Il «nuovismo» e la spettacolarizzazione a ogni costo sembrano gli unici strumenti che rendono «vendibile» e appetibile anche il pensiero. In questa fase, la filosofia dovrebbe invece riattivare un’interrogazione critica sugli strumenti del pensiero e non appiattirsi su «un riduzionismo fattualista». La strada è quella di riannodare il senso di un discorso esaminando le funzioni essenziali della filosofia: formare le idee, capire le cose, verificare la corrispondenza tra reale e razionale, dare un valore all’esperienza...
La radice di crisi, krino, ovvero separare (il grano dalle scorie), è la stessa che dà origine a krites, critica, giudicare. Pertanto è la critica che ci permetterà di superare la crisi. La tecnica, che si presenta come strumento di superamento della crisi, ne è invece parte integrante. Si tratta di ripartire dall’appendice alla Crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale (1937) di Edmund Husserl per riscoprire la relatività come base per superare l’obiettivismo, lo psicologismo e l’ingenuo positivismo e riscoprire che la filosofia è un cammino intersoggettivo razionale, un rischiaramento che avviene esercitando la funzione critica. «Nessuna linea conoscitiva, nessuna verità singola, dev’essere assolutizzata e isolata», scrive Husserl nella Crisi. È questo lo «stile» di vita della filosofia che la filosofia in tempo di crisi deve riscoprire.
- IL PROBLEMA DELLA GENESI, LA CRISI DELLE SCIENZE EUROPEE, E LA FENOMENOLOGIA TRASCENDENTALE....
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- La scuola volta le spalle alla filosofia. In Spagna l’ultima riforma rende la materia facoltativa. In Germania non è più nei programmi degli istituti superiori6 ottobre 2015, di Federico La Sala
Se la scuola volta le spalle alla filosofia
In Spagna l’ultima riforma rende la materia facoltativa, tra le proteste del mondo culturale
Ma il dibattito resta aperto. In tutti i paesi europei
di Alessandro Oppes (la Repubblica, 06.10.2015)
MADRID Le hanno tentate tutte, professori, filosofi, esperti di pedagogia, docenti di discipline umanistiche. Ma niente da fare. Non c’è posto nella scuola modello Rajoy - quella che ha ripristinato la religione obbligatoria e ha abolito l’educazione civica, troppo “ideologica” forse perché voluta dal socialista Zapatero - per la filosofia come pilastro del sapere.
L’ultima riforma dell’educazione, la Lomce, imposta dall’ormai ex-ministro José Ignacio Wert (sempre in coda nei sondaggi sul gradimento dei politici) dopo una lunga battaglia a suon di scioperi in cui studenti, presidi e genitori si presentavano uniti, relega la materia a un ruolo da comprimaria. Finora alle superiori si insegnavano tre discipline legate tra loro, filosofia, valori etici e storia della filosofia. Ora solo la prima sarà obbligatoria nel primo anno di “bachillerato”, il biennio che precede l’accesso all’università.
Per il resto, saranno gli assessorati all’educazione delle 17 regioni a decidere al principio che la legge definisce “libre configuración”, la libertà degli istituti di impartire corsi sui temi che preferiscono. La conseguenza paradossale è che in questo modo, nonostante una religiosità nettamente in calo, l’iscrizione ai corsi di religione ha subito un aumento 150 per cento perché alternativi alla disciplina dei “valori etici”, impartita da professori di filosofia ma considerata molto più ostica.
Nel corso dell’elaborazione della legge ci sono stati numerosi incontri tra rappresentanti del Ministero e delegazioni di insegnanti, ma senza alcuna concessione alle esigenze dei docenti. Il mondo della cultura non rinuncia però a mobilitarsi. Una lettera dal titolo La belleza de las humanidades, inviata al quotidiano El País, è stata condivisa da 200mila utenti Facebook. Parla di una filosofia «seppellita nell’oscuro baule dove sono già state relegate le sue sorelle musica, pittura, letteratura, storia». Sullo stesso giornale Antonio Campillo, presidente della Red Española de Filosofía, ricorda che «perfino le scuole per manager sanno che economisti e ingegneri hanno bisogno delle materie umanistiche ». Il dibattito continua.
__________________________________________________________________________________________
Filosofi
Oggi piacciono i guru del pensiero, i life coach
“Ma così diventa un fenomeno pop”
Perfino in Germania patria di Kant e Hegel non è più nei programmi degli istituti superiori *
La Spagna cancella la filosofia? «È la testimonianza che hanno vinto i manager, i fautori del pensiero monetizzabile». Roberto Esposito difende la «disciplina che ci allena a pensare e a sviluppare le nostre capacità logiche », e dice: «Non mi stupisco. Tutto questo fa parte di un processo di economicizzazione del sapere avviato da anni». Massimo Cacciari è ancora più duro: «Si vogliono formare persone disarmate dal punto di vista culturale, per le quali conta solo il risultato».
Un destino curioso quello della filosofia. Ha fondato la nostra civiltà ma si deve difendere da chi vorrebbe considerarla inutile. Il rischio anche nel nostro paese è vederla relegata tra le materie facoltative che lo studente può decidere se studiare o meno. Anche se finora “resistono” le tre ore settimanali nei licei classici, scientifici e delle scienze umane, ridotte a due negli altri licei, tra cui il musicale e l’artistico. Il processo di marginalizzazione procede però a grandi balzi in altri paesi europei.
In Germania, la patria dei filosofi, è sparita da tempo dalle scuole superiori, in Francia le ore di insegnamento sono state ridotte, mentre nelle nostre università si tende a relegarla ad una disciplina ancellare di altre materie.
 Emanuele Severino critica le mosse dei governi europei: «Più che una povertà filosofica si tratta di una povertà concettuale. Si sta imponendo la cultura di carattere tecno-scientifico. La scienza è oggi convinta di poter andare al di là di ogni limite, ma è la filosofia a dare valore alla scienza. La potenza della tecnica è dovuta a un teorema filosofico: che di limiti non ce ne siano». Dobbiamo dunque abituarci a un processo irreversibile? «Sì, almeno fin quando non ci si renderà conto che il paradiso della tecnica dà una felicità ipotetica. Che quel paradiso è in realtà un inferno».
Emanuele Severino critica le mosse dei governi europei: «Più che una povertà filosofica si tratta di una povertà concettuale. Si sta imponendo la cultura di carattere tecno-scientifico. La scienza è oggi convinta di poter andare al di là di ogni limite, ma è la filosofia a dare valore alla scienza. La potenza della tecnica è dovuta a un teorema filosofico: che di limiti non ce ne siano». Dobbiamo dunque abituarci a un processo irreversibile? «Sì, almeno fin quando non ci si renderà conto che il paradiso della tecnica dà una felicità ipotetica. Che quel paradiso è in realtà un inferno».* la Repubblica, 06.10.2015
L’allarme degli studiosi italiani“Non è una disciplina da yes-men per questo vogliono cancellarla”
di Raffaella De Santis (la Repubblica, 06.10.2015)
Un impoverimento che non ci è estraneo: «Negli anni ho notato un progressivo deterioramento - racconta Esposito - Nelle università c’è ormai la tendenza ad inserire i corsi di filosofia dentro quelli di pedagogia. Conta più il pedagogo che lo studioso ». Eppure, come fa notare Remo Bodei «la filosofia serve a creare la nostra personalità, ci aiuta a costruire l’identità, ci dà le coordinate per orientarci nel mondo. Senza essere un fautore della bottega filosofica, credo sia un errore ciò che sta accadendo in Europa. In Germania si studia filosofia solo nelle scuole di élite, mentre sono i valori umanistici a darci uno sguardo non specialistico».
Qualche anno fa abbiamo assistito ad un’improvvisa rinascita di interesse. Il filosofo d’un tratto ha preso il posto dello psicologo, è diventato un life coach, un guru, un maestro di vita. Per Esposito è proprio lì il segno dei tempi: «Il pensiero implica un lavoro, l’incontro con un ostacolo, non può essere usato per risolvere problemi. Ma oggi piace di più la pop filosofia».
Un senso comune piuttosto riduttivo associa la filosofia a ciò che è astratto (la classica immagine del filosofo con la testa fra le nuvole). Come se il sacrificio avvenisse in nome di un sapere più pratico e pragmatico. I filosofi sanno che non è così. Massimo Cacciari è preoccupato e spiega bene le implicazioni profonde dello studio filosofico: «La filosofia è una ricerca sulla nostra storia, sul nostro destino, indaga le ragioni profonde della storia della civiltà. È molto concreta, tutt’altro che astratta». E Maurizio Ferraris, poco incline al postmoderno e sostenitore di un “nuovo realismo” filosofico, ne parla come di un «antidoto contro dogmatismi, integralismi e intolleranze. Una nazione che sappia di filosofia - dice Ferraris - è una nazione che a livello diffuso è più aperta di una che non ne sappia niente. Detto questo, togliere la filosofia dai licei non comporterà la riduzione dei filosofi, come mostra il caso della Germania».
Poi su come la filosofia vada insegnata nelle scuole secondarie, i filosofi non si trovano sempre d’accordo. Per Ferraris l’approccio storico è quello più utile: «Meglio insegnare la storia della filosofia piuttosto che fare come i francesi che procedono per problemi filosofici. Così come è meglio insegnare la letteratura raccontando Dante, Petrarca e Boccaccio (e facendo leggerne i testi) piuttosto che invitando gli studenti a comporre endecasillabi su problemi teologici ».
Ma Cacciari avverte: «Se viene insegnata come una marcetta trionfale, passando da filosofo a filosofo, inanellando una catenina di opinioni, è un disastro. Altra cosa se la filosofia è una riflessione critica sul vocabolario della cultura europea, anche quella tecnico-scientifica ». Perché non è vero che scienza e filosofia sono antitetiche, è un altro luogo comune pensarle nemiche e credere di poter sacrificare la filosofia, ritenendola meno al passo con i tempi. Paolo Zellini, studioso che nei suoi libri ha indagato il rapporto tra matematica e filosofia, lo spiega bene: «Anche le formule filosofiche si capiscono meglio se si collegano alle formule matematiche. Quando Aristotele sostiene che l’ideale etico dell’uomo è nel giusto mezzo tra eccesso e difetto, sta utilizzando due categorie che tornano continuamente nei calcoli matematici». E tanto basta a vanificare anche l’argomento scienza contro discipline umanistiche.
Si può vivere senza filosofia? Giulio Giorello risponde: «Si può, certo, ma sarebbe una vita molto squallida. Da Platone ad Heidegger, la filosofia è un grande esercizio di libertà. E a chi fa notare che ci sono materie più “utili”, rispondo che è vero, ma la filosofia è utile proprio come esercizio superfluo dell’intelletto. Come diceva Re Lear “toglietemi tutto, ma non il superfluo” ». La conclusione di Cacciari è però amara: «Sta diventando opzionale tutto ciò che dà una prospettiva critica. La classe politica diventa ogni giorno più ignorante. È una tendenza generale, non solo italiana. Un processo irreversibile, non mi faccio nessuna illusione».
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- UNIVERSITA’ IULM-UNESCO 14-16 Febbraio 2011: Meeting sul’insegnamento della filosofia6 ottobre 2015, di Federico La Sala
MILANO. UNIVERSITA’ IULM -UNESCO --- 14-16 Febbraio 2011: Meeting sul’insegnamento della filosofia
USCIRE DALLA CAVERNA
USCIRE DALLO STATO DI MINORITA’
SAPERE AUDE!
- A 400 ANNI DALLA PUBBLICAZIONE DEL "SIDEREUS NUNCIUS" DI GALILEO GALILEI E A 200 DALLE INDICAZIONI DI IMMANUEL KANT SULL’USO CRITICO DELLA PROPRIA FACOLTA’ DI GIUDIZIO (PER UNA STORIA E PER UNA FILOSOFIA DAL PUNTO DI VISTA COSMOPOLITICO - E - PER LA PACE PERPETUA)
- Rimettere al centro della filosofia (e soprattutto del suo insegnamento), la lezione dell’illuminismo kantiano!!!
*** ***
DAL MEETING, UN ALLARME E UNA SOLLECITAZIONE. Una nota parziale (e - ovviamente - molto, molto riduttiva) sulla ricchezza degli interventi e delle discussioni dell’incontro): *
A) LA FILOSOFIA IN RITARDO (E IN PERICOLO NEL MONDO) E NON PRONTA A UNA DELLE SUE MISSIONI FONDAMENTALI - IL DIALOGO GLOBALE
B) RILANCIARE L’INSEGNAMENTO DELLA FILOSOFIA COME EDUCAZIONE ALLA PRATICA DELLA LIBERTA’, ALL’ESERCIZIO CRITICA DELLA FACOLTA’ DI GIUDIZIO, ALLA DEMOCRAZIA PLANETARIA - RIUNIRE SAGGEZZA E SCIENZA
C) NON INGESSARE L’UNESCO NELLA VALORIZZAZIONE E NELLA DIFESA DEL PATRIMONIO CULTURAL E DELL’UMANITA’ - PORTARE AVANTI E POTENZIARE L’ESPERIENZA DELLE "CATTEDRE UNESCO".
D) NECESSITA’ E URGENZA DI METTERE IN COMUNICAZIONE LA TRADIZIONE FILOSOFICA E LA POPOLAZIONE DEL "NUOVO MONDO" - I "NATIVI DIGITALI", L’UMANITA’ DIGITALE.
E) DOCUMENTO: "RACCOMANDAZIONI SULL’INSEGNAMENTO DELLA FILOSOFIA IN EUROPA E IN AMERICA SETTENTRIONALE"
Federico La Sala (16.02.2011)
-
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- IL VENTO DELLA STORIA. L’abbondanza e il capitale (di Piero Bevilacqua - storico)5 ottobre 2015, di Federico La Sala
L’abbondanza e il capitaledi Piero Bevilacqua ( Eddyburg, 30 Settembre 2015) *
Il capitalismo ha un grande e tenace nemico, una malattia che produce esso stesso incessantemente: l’abbondanza. Oggi l’abbondanza che lo minaccia è, come sempre, quella delle merci, ma in una misura che non ha precedenti. Ad essa, negli ultimi decenni, se ne è aggiunta un’altra, assolutamente inedita, che coinvolge un vasto e crescente ambito di servizi. Per alcuni beni la saturazione del mercato capitalistico è visibile a occhio nudo ormai da tempo. I capi d’abbigliamento si comprano ancora nei negozi, a prezzi che generano un certo profitto a chi li produce e a chi li vende. Ma per il vestiario esiste un mercato parallelo così esteso e abbondante che ormai sfiora la gratuità. Si può dire che nelle nostre società più nessuno ormai, nemmeno il più misero degli individui, ha il problema di vestirsi. Non dissimile fenomeno possiamo osservare nell’ambito dei servizi più avanzati: l’accesso all’informazione, alla cultura, all’arte, alla musica.
Certo, occorre almeno possedere un cellulare, pagare un contratto a un gestore. Ma è evidente che siamo invasi anche qui - insieme, certo, al ciarpame - da un’abbondanza di offerta, a prezzi decrescenti che tendono a creare uno spazio di fruizione fuori mercato. Sappiamo che il capitale anche da tali beni riesce a trarre ancora profitti, ma oggi è sotto i nostri occhi uno scenario di abbondanza di servizi e beni culturali, di umana emancipazione, potenziale e di fatto, che non ha precedenti. Solo cinquant’anni fa tutto questo era lontano dalla nostra immaginazione. Occorre sempre gettare un occhio al passato, per evitare di scorgere nel presente solo un cumulo di sconfitte.
Com’è noto, il capitale combatte la caduta tendenziale del saggio di profitto inventando nuovi beni e nuovi bisogni, dilatando il suo dominio sulla natura per trasformare il vivente in merci brevettabili, strappando al controllo pubblico servizi che un tempo erano dei comuni e dello stato. Ma il capitale, aiutato da circostanze storiche fortunatissime - la crisi e poi il crollo del blocco comunista, la burocratizzazione dei partiti democratici di massa e dei sindacati, la rivoluzione informatica - ha sventato la più grande minaccia da abbondanza che gli sia parata dinnanzi nella sua storia: quella degli ultimi decenni del XX secolo. Un oceano di beni stava per riversarsi nel mercato dei Paesi avanzati, un sovrappiù di merci che avrebbe costretto imprenditori e governi a innalzare i salari e soprattutto a ridurre drasticamente l’orario di lavoro. Si sarebbe arrivati a quel passaggio epocale previsto da Keynes nel saggio Possibilità economiche per i nostri nipoti (1928-30), che, con la crescita della produttività a «a un ritmo superiore all’1% annuo» avrebbe spinto le società industriali, nel giro di un secolo, a istituire una durata del lavoro a 15 ore settimanali.
In realtà, la crescita della produttività mondiale è stata superiore alle stesse previsioni di Keynes, con risultati però opposti rispetto alle sue aspettative. In un saggio prezioso per rilevanza documentaria e nitore espositivo, Abbondanza, per tutti (Donzelli, 2014) Nicola Costantino ha ricordato che il tasso di crescita annuo della produttività a livello mondiale, nel corso del XX secolo, ha oscillato tra il 2 e il 3%. Negli Usa, tra il 1950 e il 2000 è stato in media, del 2,5%, in Francia, nel solo settore industriale, tra il 1978 e il 1998, del 3,7%. Il che ha significato che la produttività oraria del singolo lavoratore, a un tasso di crescita del 2% annuo, è aumentata di ben 7 volte, molto di più delle 2,7 volte ipotizzate da Keynes e su cui egli fondava la previsione delle 15 ore settimanali.
Ma la giornata lavorativa non è stata accorciata, se non in Francia, in maniera contrastata e oggi rimessa in discussione. Ovunque, specie negli ultimi anni, la durata del lavoro quotidiano è cresciuta a dismisura. Negli USA, già prima della crisi era diventato generale il fenomeno del workaholic, l’alcolismo del lavoro, mentre oggi sempre di più gli americani lamentano la mancanza di tempo, il time squeeze, time pressure, time poverty (S.Bartolini, Manifesto per la felicità, Donzelli 2010). Lavorano tutto il giorno come dannati: ma almeno guadagnano bene? Niente affatto, essi sono in grandissimo numero poveri e indebitati. Come ha ricordato Maxime Robin su Le Monde diplomatique-Il Manifesto (Stati Uniti, l’arte di ricattare i poveri, settembre 2015) oggi in Usa i check casher, piccole banche per prestiti veloci, dilagano nei quartieri poveri più dei McDonald’s. Ma in genere tutti gli americani della middle class sono indebitati. «Uno statunitense nella norma è un cittadino indebitato che paga le rate in tempo». E le cose non son certo migliorate con la ripresa santificata dai media. Il 95% dei redditi aggiuntivi che si sono creati dopo la crisi - ricordava The Economist nel settembre 2013 - è andato all’1% delle persone più ricche. Al restante 99% sono andate le briciole del 5%. Tutto come prima, peggio di prima.
Che cosa dunque è accaduto? Perché dal mondo dell’abbondanza a portata di mano siamo precipitati nel regno della scarsità? La risposta essenziale è molto semplice. Perché il capitalismo dei paesi dominanti (Usa e Europa in primis), ricercando nuovi mercati e occasioni di profitto nei paesi poveri (la cosiddetta globalizzazione), innalzando la produttività del lavoro, ristrutturando e innovando le imprese, non incontrando resistenze in sindacati e partiti avversi, ha generato un’arma strategica formidabile: la Grande Scarsità, la scarsità del lavoro. Il lavoro inteso come occupazione, come job. I dati recenti sono impressionanti.Tra il 1991 e il 2011 - ricorda Costantino - mentre il Pil reale planetario è cresciuto del 66%, il tasso globale di occupazione è diminuito dell’1,1%. In 20 anni un quarto di beni in più con meno lavoro.
Ma una vasta e ben controllata disoccupazione è oggi un arma politica, non solo un effetto delle trasformazioni economiche. Tale scarsità, diventata permanente e sistematica, ha reso i rapporti tra capitale e lavoro, economia e politica, poteri finanziari e cittadini, drammaticamente asimmetrici e sbilanciati. Tutti invocano lavoro come gli affamati un tempo chiedevano il pane, fornendo al capitale una legittimazione mai goduta in tutta la sua storia. L’intera struttura dello stato di diritto ne risente, gli istituti della democrazia vengono progressivamente svuotati. Sindacati e partiti, funzionari del presente, invocano la “ripresa” come se il futuro possa “riprendere” le fattezze del passato.
E tuttavia tale artificiale scarsità non può durare a lungo. Non solo perché le innovazioni produttive in arrivo (stampanti 3D, intelligenza artificiale,ecc) stanno per rovesciarci interi continenti di merci e servizi, sostituendo perfino lavoro intellettuale con macchine. Ma anche perché l’abbondanza del capitale che la Grande Scarsità del lavoro oggi genera è una forma di obesità, una malattia sistemica. C’è troppo danaro in giro, masse smisurate di risorse finanziarie, rispetto alle necessità della produzione. Patrimoni concentrati in gruppi ristretti che non corrono il rischio dell’investimento produttivo in società ormai sature di beni e con una domanda debole, mentre la grande massa dei lavoratori è tenuta a basso salario perché i loro padroni devono poter competere a livello globale. Tutti i capitalismi nazionali comprimono i salari, allungano gli orari di lavoro, sperando nelle esportazioni e tutti, o quasi, languono nella generale stagnazione. Mentre i soldi si accumulano, generano altri soldi, muovono speculazioni nei mercati finanziari e preparano altre crisi.
Questo quadro che non teme smentite - poggia su una vasta e solida letteratura - ha una grande importanza per la sinistra. In esso è possibile scorgere che una vita di gran lunga migliore sarebbe possibile per tutti e che solo i rapporti di forza dominanti la ostacolano, facendo regredire la società nel suo insieme. Non c’è una crisi, intesa come un evento naturale. È stato il cedimento storico dei partiti della sinistra, dei sindacati, dei governi a favorire la vittoria della scarsità sull’abbondanza. Una grande battaglia perduta, ma da cui ci si può riprendere. Da questa lezione si può comprendere come niente di naturale è rinvenibile nella situazione presente: è tutto dipendente da scelte politiche, da puri rapporti di forza.
Si può così smascherare l’idea di una scarsità a cui occorre piegarsi come all’antico Fato. Così come l’idea di una “ripresa” affidata alle riforme del mercato del lavoro, alla flessibilità dei lavoratori, senza toccare la piramide delle ricchezze accumulate. Non ci sono i soldi, recita la litania dei politici, di gran parte degli economisti main stream, gli aguzzini intellettuali più attivi sulla scena pubblica, con il loro seguito di giornalisti orecchianti. È la più grande menzogna della nostra epoca. I soldi non ci sono per pensioni dignitose, per il reddito di cittadinanza, non ci sono per le borse di studio agli studenti, che disertano gli studi universitari, non ci sono per i nostri ricercatori e per la gioventù intellettuale, costretta a migrare all’estero. Ma ci sono in misura crescente e cumulativa nei patrimoni privati: in un solo anno, tra il 2011 e 2012, mentre infuriava la crisi, il numero degli individui con un patrimonio superiore a un milione di dollari è cresciuto nel mondo del 6%, in Italia del 10% . I soldi ci sono in quantità senza precedenti per le banche. E le centinaia di miliardi di euro che la BCE sta profondendo a piene mani, semplicemente stampandoli?
Dunque, una grande abbondanza (auspichiamo, di beni e servizi avanzati, frutto di una generale riconversione ecologica, di riduzione del lavoro ) è alla nostra portata. E bisogna infondere non solo nel nostro popolo, ma nella società italiana tutta intera questa grande pretesa. La pretesa della prosperità e del ben vivere per tutti. È una prospettiva di nuovi bisogni, che non solo è possibile soddisfare, ma coincide con una tendenza storica inarrestabile e che capitale e ceto politico possono solo ritardare, con danno generale. La redistribuzione dei redditi e del lavoro e la lotta alle disuguaglianze incarnano come mai nel passato l’interesse generale, una necessità indifferibile e universale. Oggi possiamo far sentire a tutti, anche agli scoraggiati e ai perplessi, che nelle nostre vele può tornare a soffiare il vento della storia.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- RETORICA, FILOSOFIA, E POLITICA. Uno spettro (di Marx) si aggira nella globalizzazione.3 ottobre 2015, di Federico La Sala
RETORICA, FILOSOFIA, E POLITICA:
Uno spettro (di Marx) si aggira nella globalizzazione
di Umberto Eco (La Stampa-TuttoLibri, 03.10.2015)
Non si può sostenere che alcune belle pagine possano da sole cambiare il mondo. L’intera opera di Dante non è servita a restituire un Sacro Romano Imperatore ai comuni italiani. Tuttavia, nel ricordare quel testo che fu il Manifesto del Partito Comunista del 1848, e che certamente ha largamente influito sulle vicende di due secoli, credo occorra rileggerlo dal punto di vista della sua qualità letteraria o almeno - anche a non leggerlo in tedesco - della sua straordinaria struttura retorico-argomentativa.
Nel 1971 era apparso il libretto di un autore venezuelano, Ludovico Silva, Lo stile letterario di Marx, poi tradotto da Bompiani nel 1973. Credo sia ormai introvabile e varrebbe la pena di ristamparlo. Rifacendo anche la storia della formazione letteraria di Marx (pochi sanno che aveva scritto anche delle poesie ancorché, a detta di chi le ha lette, bruttissime), Silva andava ad analizzare minutamente tutta l’opera marxiana.
 Curiosamente dedicava solo poche righe al Manifesto, forse perché non era opera strettamente personale. È un peccato: si tratta di un testo formidabile che sa alternare toni apocalittici e ironia, slogan efficaci e spiegazioni chiare e (se proprio la società capitalistica intende vendicarsi dei fastidi che queste non molte pagine le hanno procurato) dovrebbe essere religiosamente analizzato ancora oggi nelle scuole per pubblicitari.
Curiosamente dedicava solo poche righe al Manifesto, forse perché non era opera strettamente personale. È un peccato: si tratta di un testo formidabile che sa alternare toni apocalittici e ironia, slogan efficaci e spiegazioni chiare e (se proprio la società capitalistica intende vendicarsi dei fastidi che queste non molte pagine le hanno procurato) dovrebbe essere religiosamente analizzato ancora oggi nelle scuole per pubblicitari.Inizia con un formidabile colpo di timpano, come la Quinta di Beethoven: «Uno spettro si aggira per l’Europa» (e non dimentichiamo che siamo ancora vicini al fiorire preromantico e romantico del romanzo gotico, e gli spettri sono entità da prendere sul serio). Segue subito dopo una storia a volo d’aquila sulle lotte sociali dalla Roma antica alla nascita e sviluppo della borghesia, e le pagine dedicate alle conquiste di questa nuova classe «rivoluzionaria» ne costituiscono il poema fondatore - ancora buono oggi, per i sostenitori del liberismo.
Si vede (voglio proprio dire «si vede», in modo quasi cinematografico) questa nuova inarrestabile forza che, spinta dal bisogno di nuovi sbocchi per le proprie merci, percorre tutto l’orbe terraqueo (e secondo me qui il Marx ebreo e messianico sta pensando all’inizio del Genesi), sconvolge e trasforma paesi remoti perché i bassi prezzi dei suoi prodotti sono l’artiglieria pesante con la quale abbatte ogni muraglia cinese e fa capitolare i barbari più induriti nell’odio per lo straniero, instaura e sviluppa le città come segno e fondamento del proprio potere, si multinazionalizza, si globalizza, inventa persino una letteratura non più nazionale bensì mondiale.
È impressionante come il Manifesto avesse visto nascere, con un anticipo di centocinquant’anni, l’era della globalizzazione, e le forze alternative che essa avrebbe scatenato. Come a suggerirci che la globalizzazione non è un incidente avvenuto durante il percorso dell’espansione capitalistica (solo perché è caduto il muro ed è arrivato internet) ma il disegno fatale che la nuova classe emergente non poteva evitare di tracciare, anche se allora, per l’espansione dei mercati, la via più comoda (anche se più sanguinosa) si chiamava colonizzazione. È anche da rimeditare (e va consigliato non ai borghesi ma alle tute di ogni colore), l’avvertimento che ogni forza alternativa alla marcia della globalizzazione, all’inizio, si presenta divisa e confusa, tende al puro luddismo, e può venire usata dall’avversario per combattere i propri nemici.
Alla fine di questo elogio (che conquista in quanto è sinceramente ammirato), ecco il capovolgimento drammatico: lo stregone si trova impotente a dominare le potenze sotterranee che ha evocato, il vincitore è soffocato dalla propria sovraproduzione, è obbligato a generare dal proprio seno, a far sbocciare dalle proprie viscere i suoi propri becchini, i proletari.
Entra ora in scena questa nuova forza che, dapprima divisa e confusa, si stempera nella distruzione delle macchine, viene usata dalla borghesia come massa d’urto costretta a combattere i nemici del proprio nemico (le monarchie assolute, la proprietà fondiaria, i piccoli borghesi), via via assorbe parte dei propri avversari che la grande borghesia proletarizza, come gli artigiani, i negozianti, i contadini proprietari, la sommossa diventa lotta organizzata, gli operai entrano in contatto reciproco a causa di un altro potere che i borghesi hanno sviluppato per il proprio tornaconto, le comunicazioni. E qui il Manifesto cita le vie ferrate, ma pensa anche alle nuove comunicazioni di massa (e non dimentichiamoci che Marx ed Engels nella Sacra famiglia avevano saputo usare la televisione dell’epoca, e cioè il romanzo di appendice, come modello dell’immaginario collettivo, e ne criticavano l’ideologia usando linguaggio e situazioni che esso aveva reso popolari).
A questo punto entrano in scena i comunisti. Prima di dire in modo programmatico che cosa essi sono e che cosa vogliono, il Manifesto (con mossa retorica superba) si pone dal punto di vista del borghese che li teme, e avanza alcune terrorizzate domande: ma voi volete abolire la proprietà? Volete la comunanza delle donne? Volete distruggere la religione, la patria, la famiglia?
Qui il gioco si fa sottile, perché il Manifesto a tutte queste domande sembra rispondere in modo rassicurante, come per blandire l’avversario - poi, con una mossa improvvisa, lo colpisce sotto il plesso solare, e ottiene l’applauso del pubblico proletario... Vogliamo abolire la proprietà? Ma no, i rapporti di proprietà sono sempre stati soggetto di trasformazioni, la Rivoluzione francese non ha forse abolito la proprietà feudale in favore di quella borghese? Vogliamo abolire la proprietà privata? Ma che sciocchezza, non esiste, perché è la proprietà di un decimo della popolazione a sfavore dei nove decimi. Ci rimproverate allora di volere abolire la «vostra» proprietà? Eh sì, è esattamente quello che vogliamo fare.
La comunanza delle donne? Ma suvvia, noi vogliamo piuttosto togliere alla donna il carattere di strumento di produzione. Ma ci vedete mettere in comune le donne? La comunanza delle donne l’avete inventata voi, che oltre a usare le vostre mogli approfittate di quelle degli operai e come massimo spasso praticate l’arte di sedurre quelle dei vostri pari. Distruggere la patria? Ma come si può togliere agli operai quello che non hanno? Noi vogliamo anzi che trionfando si costituiscano in nazione...
E così via, sino a quel capolavoro di reticenza che è la risposta sulla religione. Si intuisce che la risposta è «vogliamo distruggere questa religione», ma il testo non lo dice: mentre abborda un argomento così delicato sorvola, lascia capire che tutte le trasformazioni hanno un prezzo, ma insomma, non apriamo subito capitoli troppo scottanti.
Segue poi la parte più dottrinale, il programma del movimento, la critica dei vari socialismi, ma a questo punto il lettore è già sedotto dalle pagine precedenti. E se poi la parte programmatica fosse troppo difficile, ecco un colpo di coda finale, due slogan da levare il fiato, facili, memorizzabili, destinati (mi pare) a una fortuna strepitosa: «I proletari non hanno da perdere che le loro catene» e «Proletari di tutto il mondo unitevi».
A parte la capacità certamente poetica di inventare metafore memorabili, il Manifesto rimane un capolavoro di oratoria politica (e non solo) e dovrebbe essere studiato a scuola insieme alle Catilinarie e al discorso shakespeariano di Marco Antonio sul cadavere di Cesare. Anche perché, data la buona cultura classica di Marx, non è da escludere che proprio questi testi egli avesse presenti.
© Editori Laterza EM Publishers Srl
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- L’INGENS SYLVA, LA PAURA DELLA LIBERTA’, L’HOMUNCULUS: CARLO LEVI, NELL’ORIZZONTE DI VICO, BENJAMIN, ED ENZO PACI.1 ottobre 2015, di Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI, FRANCESI, TEDESCHI, OGGI?! --- Saper ascoltare il silenzio degli intellettuali (di Jean-Luc Nancy)30 settembre 2015, di Federico La Sala
Radio Kapital : Jean-Luc Nancy
Saper ascoltare il silenzio degli intellettuali di Jean-Luc Nancy
(trad.effeffe)
- su Libération del 22 settembre
Ci rammarichiamo della scomparsa degli intellettuali organici della Repubblica, in grado di dire il giusto, il buono e il vero - anche se a volte criticando la stessa Repubblica. Deploriamo che al loro posto riecheggino bagliori sospetti, derive mal identificate e battage a tutto spiano, dispensatore di prediche ad ogni grado. Genera dibattito, foto, fa rumore. Ma non bisogna farsi indurre in errore. Bisogna ascoltare il silenzio e guardare quanto non si mostri.
Ci sono tanti intellettuali - per meglio dire: persone che pensano - alle prese con cose più serie dei proclami ripetuti delle certezze acquisite. Ce ne sono molti più di quanto non si pensi, alcuni noti, altri meno o per nulla: tutti quelli per cui le vere questioni contano più della firma ( il benedetto nome!) in calce agli articoli o petizioni. Non v’è dubbio che a volte bisogna riaffermare delle cose evidenti che paiono offuscate per alcuni, mentre per altri sembrano ripetitive: bisogna ( per quel che significhi “bisogna”) dare asilo ai rifugiati, che la loro fuga è causata dalle convulsioni di un mondo che non protegge più nulla dai propri appetiti più feroci, e di conseguenza dalle proprie devastazioni, e che dare rifugio significherebbe anche accogliere le questioni che vengono con il disastro ambulante.
Però bisogna innanzitutto valutare bene la posta in gioco. Non si tratta di un po’ più o un po’ meno di sovranità, d’Europa, di umanismo e di fratellanza. Si tratta di questo, del fatto che ognuna di queste parole, una per una, e di molte altre dopo di esse, non abbiano più alcun significato intelligibile. Oppure che non abbiamo più l’intelligenza del loro senso. Noi, tutti noi, tutti coloro che pensano (che se ne compiacciano o meno, che lo sappiano o meno) e per primi quelli la cui qualità d’”intellettuale” deve mettersi al servizio del senso e delle condizioni in cui un senso è possibile o meno.
Anche il pensiero conosce migrazioni, esilii, mutamenti, tracolli, fughe e asili. La postura sicura di sé della soluzione è quella di colui che decide, non del pensatore. Ci devono essere certo delle persone che decidono- ci deve essere anche chi sia in grado di criticarli. Ma non bisogna far passare come decisioni possibili vecchi significati che non sappiamo più argomentare - tanto “umanismo” che ” sovranità” o “popolo” o perfino “politica”.
Alcuni lo hanno detto e lo hanno scritto ormai sono molti anni: siamo entrati in un mutamento di civiltà. Vale a dire di questa civiltà occidentale diventata l’armatura globale di un’espansione tecnica e ideologica a cui si oppongono, nient’altro che i furori generati dallo sconvolgimento globale. È con questo che dobbiamo fare i conti: con un mondo che sei secoli di progresso hanno fatto crescere al punto che ogni crescita raggiunge: il punto di apoplessia o obsolescenza.
Altre civiltà ci sono passate. Maya, Ittiti, Micenei, Romani, Mongoli, molti altri hanno vissuto gli orrori della decomposizione e dello smarrimento. Le loro forze profonde hanno subito una metamorfosi. Questi mutamenti sono così ampi e lunghi che non si potranno cogliere che a posteriori. Ma è possibile, è necessario pensare a partire da questo orizzonte o prospettiva.
Il che non impedisce di pensare al presente. Al contrario. Questo offre per esempio ottime ragioni per vedere nei rifugiati dei messaggeri non solo di crisi e di guerra, ma anche e soprattutto di storia, della nostra storia, di quel che accade a noi e spinge noi stessi in una migrazione silenziosa, attiva e vigilante.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- MANZONI, MARX, E LA CRITICA DELL’ECONOMIA POLITICA E DELLA SUA TEOLOGIA "MAMMONICA"27 settembre 2015, di Federico La Sala
MANZONI, MARX, E LA CRITICA DELL’ECONOMIA POLITICA E DELLA SUA TEOLOGIA "MAMMONICA" (Benedetto XVI, "Deus caritas est", 2006). CON MARX, OLTRE...
IL MAGGIORASCATO: L’ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE, L’ALLEANZA DELLA LA MADRE CON IL FIGLIO, REGNA ANCORA COME IN TERRA COSI’ IN CIELO
 "SCORPIONE E FELICE". RIDENDO E SCHERZANDO, MARX TROVA "LA PIETRA FILOSOFALE" DEL SUO CAMMINO.
"SCORPIONE E FELICE". RIDENDO E SCHERZANDO, MARX TROVA "LA PIETRA FILOSOFALE" DEL SUO CAMMINO. -
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- SON IN BAMBOLA: "I NOSTRI INTELLETTUALI, INETTI, TRISTI E ASSERVITI AL PENSIERO UNICO".26 settembre 2015, di Federico La Sala
IN SILENZIO. "Spariscono gli anticorpi e dilaga il conformismo: giornalisti e pensatori sono in bambola".
"I NOSTRI INTELLETTUALI, INETTI, TRISTI E ASSERVITI AL PENSIERO UNICO"
di DARIO FO (Il Fatto, 26.09.2015)
Mettiamo in fila le cose: la legge delega sulle intercettazioni, la riforma del Senato, gli interventi sulla Rai, l’articolo 18 cancellato dal Jobs Act (che brutta parola, Jobs Act!)... Tutte cose che se fossero accadute quindici anni fa durante il regno del signore di Arcore avrebbero (ed è successo infatti! ) riempito piazze e pagine di giornali. Ma allora cos’è capitato, cosa ci è capitato, se oggi è il silenzio il rumore che fa più paura? C’è stato un addormentamento paradossale, una specie di anestesia generale. Ricordate quella vecchia favola, Il Pifferaio magico? Un suonatore di flauto incanta i ratti per condurli al fiume, dove annegano, liberando la città. Siccome la gente del paese non mantiene la parola e non lo paga, lui per vendetta con il suo flauto incanta anche i bambini e se li porta via.
Ecco, è successa la stessa cosa ai giornalisti che dovrebbero essere i primi ad avere presente l’importanza dell’informazione: a furia di suonare il flauto hanno sedato troppa gente! Ma non è solo un problema della stampa. Abbiamo oggi una classe d’intellettuali che in gran parte ha perso il tamburo, un formidabile strumento per svegliare i bambini imbambolati. Tacciono in molti: non hanno dignità e quindi non s’indignano. Ecco cos’è terribile e incredibile: la mancanza d’indignazione. Altro che tradimento dei chierici! Molti pensano: ma chi me lo fa fare di espormi? Un giorno magari avrò bisogno di qualcosa, di un favore, di un aiuto da chi ora sto criticando.
Tutto è giocato sui ricatti, sulla possibilità di avere un vantaggio. Chi fa informazione o opinione ha capito una cosa: bisogna stare al gioco. Se tu ti metti a criticare, se obietti, se fai anche solo riflessioni non gradite, vieni semplicemente cancellato. Ormai l’andazzo è questo: segnare sulla lavagna i nomi di coloro che si sono “comportati male”. Chi non si allinea è fuori. E per fuori intendo fuori da tutto.
Le conseguenze di questo pensiero non unico ma asservito, conformista e opportunista, sono terribili: spariscono gli anticorpi. Questo potenzialmente crea una società di inetti e di leccapiedi. Basta guardare i parlamentari che giustificano i loro voltafaccia con il caro vecchio “Io tengo famiglia”, una filastrocca dei tempi del Fascismo. Vedo un accerchiamento della libertà d’espressione, le persone che hanno coraggio vengono emarginate. Il potere vuole da sempre tacitare le voci in dissenso: ma in un sistema sano di solito trova un limite in chi si oppone. Gli intellettuali un tempo guidavano l’opinione pubblica: ma oggi chi osa alzare la testa?
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! DENTRO LA PIU’ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA E POLITICA ITALIANA --- La vera “riforma epocale” (di Michele Di Schiena)14 settembre 2015, di Federico La Sala
IN ITALIA
Renzismo e berlusconismo
La vera “riforma epocale”
di MICHELE DI SCHIENA*
Gli sviluppi della politica italiana dimostrano come il renzismo non sia altro che la riedizione, rinfrescata e emendata da certi eccessi, del berlusconismo dal quale ha mutuato anche quel modus operandi fatto di annunci spettacolari che puntano tutto sul futuro per distogliere l’attenzione dal presente, di allettanti promesse e di un ostentato ottimismo che non è “ottimismo della ragione” e neppure “della volontà”, ma lo strumento di una spiccata abilità comunicativa inteso ad alimentare una perenne “fata morgana”.
Il patto del Nazareno è quindi destinato a sopravvivere a tutte le sue morti apparenti perché Renzi non ha in alcun modo “cambiato verso” alla politica del nostro Paese ma sta facendo il “verso” dell’ex Cavaliere con le sue riforme istituzionali ed elettorali che rischiano di alterare i connotati della nostra democrazia, con una politica in materia di lavoro (Jobs act e art. 18) che precarizza ulteriormente il lavoro stesso senza promuovere una vera lotta alla disoccupazione, con la nuova legge sulla scuola che accresce a dismisura i poteri dei vertici dirigenziali e riduce quello degli organi collegiali e con le riforme della Rai e della PA anch’esse guidate dall’idea che occorre accentrare le funzioni di comando a scapito delle forme di partecipazione di base.
In linea con il berlusconismo si palesa anche l’inadeguatezza della lotta alla corruzione e all’evasione fiscale; talune scelte rivelatrici dell’insofferenza al controllo di legalità della Magistratura e certi ricorrenti tentativi di mettere a freno il controllo sociale dei sindacati e quello democratico degli organi di informazione. Per non parlare poi del grande annuncio della riduzione delle tasse, la cui compatibilità con le disponibilità finanziarie e i vincoli di bilancio è tutta da verificare, mentre il Senato ha già approvato pesanti tagli della spesa sanitaria tali da mettere a rischio ricoveri ospedalieri ed esami strumentali necessari con un grave ridimensionamento della prevenzione.
E ciò mentre nulla si muove per la lotta alla povertà. Né può sfuggire che le affinità tra l’ex Cavaliere e Renzi investono anche la politica estera: in Europa la supina giocosità berlusconiana ha ceduto il posto alla non meno accondiscendente seriosità renziana baldanzosa solo a uso interno.
Renzismo e berlusconismo sono quindi due facce della stessa medaglia ma il fatto è che le maggiori forze di opposizione non si dimostrano in grado di elaborare credibili progetti alternativi improntati a criteri di giustizia e di equità: una considerazione che nulla toglie ai meriti di alcune battaglie del movimento pentastellato centrate su problemi specifici e scandalose vicende.
Le sensibilità alternative al patto del Nazareno (che Berlusconi sembra intenzionato a risuscitare anche formalmente in vista dell’ipotizzato Partito della Nazione) premono indubbiamente a sinistra dentro e fuori il Pd ma non sembrano in grado di svolgere un ruolo di rilievo nell’interesse dei ceti sociali più deboli e soprattutto della nostra zoppa democrazia che rischia di languire nell’angosciante recinto degli equilibri consolidati e degli squilibri accettati.
Occorre quindi il risveglio di una sinistra che, ispirandosi alla cultura socialista e al solidarismo cristiano, ponga al primo posto, nella politica economica, non la generica “crescita” ma una lotta senza quartiere alle inaccettabili disuguaglianze sociali.
Ma occorre che facciano la loro parte anche le forze di tradizione illuminista e di cultura liberal-progressista che nei momenti difficili hanno sempre contribuito al rilancio della democrazia.
È necessario insomma il concorso di tutte quelle espressioni politiche e di quei movimenti che si riconoscono, per dirla con il grande giornalista Jan Daniel, nei valori universali che sono «il dato comune tra la saggezza greca, la cultura romana, il messaggio dei 10 comandamenti, il sermone della montagna, l’eredità delle rivoluzioni americana e francese, la morale universale di Kant, la dichiarazione dei diritti dell’Uomo e la Carta delle Nazioni Unite».
E, non ultima, l’esortazione del papa che nell’Evangelii Gaudium denuncia le iniquità del modello economico dominante e della cultura dello «scarto» che lo sostiene affermando che non si tratta più del fenomeno dello sfruttamento e dell’oppressione ma di qualcosa di nuovo, perché con l’esclusione resta colpita l’appartenenza alla società in cui si vive.
Abbiamo quindi un inestimabile patrimonio di valori che hanno anche ispirato e dato corpo alla nostra Costituzione la quale ha saputo tradurli in istituzioni democratiche, modelli di comportamento, direttive politiche e precetti volti a fare del nostro Paese una “grande potenza” di solidarietà, di giustizia e di pace.
Un tesoro di saggezza al quale si fa riferimento solo in occasione di talune ricorrenze o per sostenere questa o quella tesi ovvero questa o quella polemica senza mai ricorrere ad esso per farne la stella polare di progetti il cui metodo sia la partecipazione democratica e gli obiettivi la tutela della dignità della persona, la promozione del diritto al lavoro e una economia indirizzata a fini sociali.
* Presidente onorario aggiunto della Corte di Cassazione
* Adista/Segni nuovi, 12 SETTEMBRE 2015 • N. 30
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! DENTRO LA PIU’ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA E POLITICA ITALIANA --- "IL TRUCCO" - C’E’, MA NON SI VEDE! Una nota di Nicoletta Marini-Maio19 settembre 2015, di Federico La Sala
Dominijanni, Ida.
Il trucco. Sessua lità e biopolitica nella fine di Berlusconi.
Roma: Ediesse, 2014. Pp. 251. ISBN 9788823019171. € 14.00 (paperback).
Nell’imponente quantità di pubblicazioni sul berlusconismo, Il trucco. Sessualità e biopolitica nella fine di Berlusconi, di Ida Dominijanni , è finora l’unica solida riflessione teorica e femminista che ne analizzi gli aspetti fondativi, simbolici e strategici, mettendoli in relazione con la storia culturale e politica italiana degli ultimi quaranta anni e con la dimensione transnazionale.
Con profonda consapevolezza teorica, l’analisi della filosofa, femminista della differenza, saggista e storica editorialista del Manifesto , parte dalla nozione lacaniana dell’ “evaporazione del padre”- cioè la crisi dell’ordine simbolico incarnato dalla legge edipica - e si misura con il pensier o di Foucault, Arendt, Butler, Lonzi, Ž i ž ek , e Recalcati, per citare solo i riferimenti più eclatanti.
Ambizioso obiettivo del libro è la riconfigurazione teorica e storica del berlusconismo nel periodo che prende il via dalla stagione del “lungo sessantotto italiano” (33) e del femminismo, estenden dosi alla contemporaneità.
Dominijanni contesta le interpretazioni mainstream : la prima, che vede il berlusconismo come un’anomalia italiana del modello liberal democratico e un attacco ai principi costituzionali; la seconda, che insiste sulla realizzazion e politica della debordiana “società dello spettacolo”; la terza, infine, che denuncia una strategia politica di identificazione con un preciso blocco sociale che mira a difendere i propri interessi socio - economici, sullo sfondo del modello neoliberale e i ndividualista della postmodernità.
Queste tre linee interpretative colgono alcuni dei tratti salienti del regime berlusconiano, nota Dominijanni, ma ne offrono una visione parziale. Il trucco capovolge i discorsi sul berlusconismo, riportando al centro d ell’analisi l’azione dirompente che la sessualità, il corpo e gli affetti esercitano sulla politica. Discutendo il berlusconismo come un’“inedita forma di governamentalità biopolitica e post- patriarcale” (27) fondata sullo scambio di sesso, potere e denaro , la studiosa analizza la sfera della sessualità nella sua funzione, innanzi tutto, di strumento di codificazione del “regime del godimento” (25), basato sull’autoimprenditorialità del corpo e della sua libera offerta come merce di scambio negli ambiti soc io- culturali ed economici del neoliberalismo.
D’altra parte, è proprio la sessualità, sostiene Dominijanni, ad aver delegittimato il berlusconismo attraverso la denuncia dell’immagine fallace e strategica del sovrano.
Si tratta di una vera e propria ribell ione all’ordine simbolico post- patriarcale che prende forma nella presa di parola delle donne del sexgate e rivela la natura del “trucco” che dà il titolo al libro, cioè la fondamentale “impotenza” (17) del sovrano.
Tesi di fondo del libro è che la ventenn ale egemonia del berlusconismo sia stata neutralizzata non tanto sul terreno economico, quanto per l’appunto su quello della sessualità.
Dopo una premessa metodologica e un’introduzione teorica (“ Dalla fine . Spettri di Berlusconi”), l’analisi si snoda in nove serrati capitoli che discutono i tratti fondanti del berlusconismo nella loro valenza simbolica e storica.
Il rigore dell’argomentazione e l’originale storicizzazione dei fatti si intersecano con la vivacità giornalistica e lo spirito polemico dell’au trice, che sollecita una rilettura del presente alla luce dei dispositivi di potere messi in atto dal berlusconismo. Dominijanni decostruisce i concetti- chiave, le figure e le retoriche del berlusconismo, adottando un criterio di analisi deliberatamente sp iazzante ed efficace, quello degli spostamenti strategici “che hanno consentito alle ‘guerre culturali’ neoconservatrici degli ultimi decenni di costruire egemonia sopra e contro lo stesso terreno arato dalle rivoluzioni degli anni Sessanta e Settanta” (14 5) .
Questi spostamenti sono semantici, retorici, culturali e simbolici e comportano rilevanti conseguenze politiche.
Lo spostamento valoriale analizzato nel primo capitolo (“La partita della libertà”) investe il concetto di libertà.
Un esempio fra tutti. A llo scopo di auto- legittimarsi come “padre fondatore” (37), Berlusconi si è appropriato della Festa della Liberazione, liturgia fondativa della patria basata sull’eredità culturale e politica della Resistenza antifascista, riformulandola come “Festa della Libertà” (38), cioè una celebrazione unitaria e popolare, tesa ad includere tutte le posizioni politiche.
Con una simile deviazione semantica, Berlusconi ha trasformato il partito in “Popolo delle Libertà ,” affermando la propria identificazione con un’idea astratta di popolo e ufficializzando l’inclusione dell’Italia nell’area valoriale della politica liberale.
Dominijanni sottolinea che questo “slittamento semantico” ha condotto a uno “slittamento politico di prima grandezza” (40), in quanto Berlusconi int erpreta il termine “libertà” in modo ambivalente: da un parte, come volontà di trasgredire le norme stabilite dalla costituzione e, dall’altra, come affermazione della libertà imprenditoriale e consumistica imposta dal neoliberalismo.
In questo contesto, l a libertà diviene un’esperienza negoziabile e flessibile, che si realizza ai confini della legalità e può configurarsi sia come affermazione di un diritto che come consenso servile.
Altri spostamenti sono esaminati nel libro. Centrale è la discussione co ndotta nel terzo capitolo (“Parole che contano”), in cui l’autrice discute la funzione destrutturante della parola femminile nei discorsi delle donne coinvolte nel sexgate.
La presa di parola si articola infatti in modalità che vanno oltre le retoriche e i cliché rappresentati dalle donne “parlanti,” cioè l’intellettuale (Ventura), la moglie (Lario) e la prostituta (D’Addario e le altre). Lario, ad esempio, non solo denuncia il tradimento coniugale, ma il sistema di potere che usa le donne per potenziare il corpo del capo e provocare l’identificazione con la popolazione maschile.
Perfino le conversazioni “impietose” delle Olgettine ridicolizzano il corpo del capo, rendendolo una “copia comica e farsesca di se stesso ” (85).
Dominijanni fa notare come la politica berlusconiana abbia messo in atto il “dispositivo dell’internamento” contro queste donne, stigmatizzandole, censurandole e relegandole ai margini del discorso politico.
Questo ulteriore spostamento è strettamente con nesso a strategie retoriche e simboliche che Dominijanni analizza in altri capitoli del libro: lo “sconfinamento” (104) del pubblico nel privato , la ridefinizione in chiave libertina del conce t to di privacy (“Privato e pubblico, personale e politico”) e lo slittamento del rapporto fra morale e politica (“Penale, morale, politico”), in cui l’autrice discute lo “scarto di senso” (141) della narrazione berlusconiana, fondato sulla ridefinizione del rapporto tra libertà, potere politico e legge.
Particolarme nte originale è l’inquadramento storico del berlusconismo a partire dal Sessantotto e dal femminismo, un’intuizione che la studiosa articola nel sesto (“Papi e il nome del padre”) e nel settimo capitolo (“‘Veri’ uomini, ‘vere’ donne”).
Contestando le coord inate cronologiche del ventennio berlusconiano, Dominijanni vede nel berlusconismo la risposta “perversa” (33) e “regressiva” (175) alle istanze innescate dalla stagione del Sessantotto e del femminismo.
Il berlusconismo non ha realizzato quelle istanze, m a le ha invertite, trasformando la domanda di creatività, l’affermazione della liberazione sessuale, il bisogno di democrazia e il conflitto fra i sessi in regime del godimento, mercificazione, populismo mediatico e strategia di assoggettamento e ri- natura lizzazione dei ruoli di genere. In altre parole, il capitalismo neoliberale di cui il berlusconismo è la realizzazione italiana, ha marginalizzato le domande di ribellione e reso ambivalente la nozione di libertà femminile, secondo la quale la “vera” donna è figlia “ sia della rivoluzione femminista sia dell’egemonia neoliberale, e porta dunque sia il segno politico della libertà femminile, sia il segno della sua traduzione nella lingua economica della ‘libera scelta’ e dell’au toimprenditorialità” (194).
Un altro spostamento , quindi, forse il più rilevante sul piano socio- culturale e politico. L’analisi dei dispositivi di potere del berlusconismo elaborata da Dominijanni permette alla studiosa di interrogarsi sulla possibilità di nuovi spazi di soggettivazio ne e pratiche femministe.
Pur tralasciando la prospettiva queer, Dominijanni si confronta con una grande varietà di posizioni critiche contemporanee, fra cui il postfemminismo anglosassone, e contesta le rivendicazioni neo- femministe incentrate sulla lotta al femminicidio, la denuncia del sessismo dei comportamenti e del linguaggio e la richiesta di quote rosa (specie negli ultimi due capitoli: “Dopo il patriarcato. Femminismo e questione maschile” e “Dispositivo di sessualità, regime politico”).
Contro una riflessione critica che aspira semplicemente all’intercambiabilità di genere e non promuove pratiche diverse da quelle imposte dal post- patriarcato, Dominijanni riporta al centro del “conflitto politico fra i sessi” (27) la sfera della sessualità, che si pone come “tecnica del potere [...] decisiva per la soggettivazione” (27).
Il trucco è un libro provocatorio e coinvolgente, che sollecita nuovi interrogativi non solo sull’età berlusconiana, ma anche e soprattutto sul ruolo del femminismo nella vita culturale, sociale e politica della società contemporanea.
NICOLETTA MARINI-MAIO
Dickinson College
-
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- In principio era il Logos (non il "Logo")!!! Le radici dell’Eu-ropa e il "fascismo" (di tutte le ispirazioni).13 luglio 2015, di Federico La Sala
 In principio era il Logos (non il "Logo")!!!
In principio era il Logos (non il "Logo")!!! Le radici dell’Eu-ropa e il "fascismo" (di tutte le ispirazioni). Il "gioco" di ogni progetto e "duce" autoritario è stato sempre questo: "AF-FASCInARE" E "AG-GIOGARE" IL POPOLO. NELLO AJELLO ed EMILIO GENTILE fanno il punto sul "LOGO" DI MUSSOLINI.
Le radici dell’Eu-ropa e il "fascismo" (di tutte le ispirazioni). Il "gioco" di ogni progetto e "duce" autoritario è stato sempre questo: "AF-FASCInARE" E "AG-GIOGARE" IL POPOLO. NELLO AJELLO ed EMILIO GENTILE fanno il punto sul "LOGO" DI MUSSOLINI.HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI.
 RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO".
RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". -
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- L’Europa e l’"OXI" Grecia. Germania: etica protestante o riscrittura della storia? (di Paolo Ferrero).10 luglio 2015, di Federico La Sala
RIPENSARE L’EUROPA. PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!
 FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
Germania: etica protestante o riscrittura della storia?
 di Paolo Ferrero
di Paolo Ferrero
 Segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea *
Segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea *Tra le leggende metropolitane che circolano maggiormente attorno alla vicenda greca, vi è quella dell’etica protestante che caratterizzerebbe la Germania e che renderebbe incomprensibile ai loro occhi la mediterranea Grecia. Gli elementi della leggenda sono pochi e semplici: i tedeschi sono seri, laboriosi protestanti e nella lingua tedesca debito e colpa hanno la stessa etimologia. I greci hanno il sole caldo, una furbesca attitudine al commercio e sono eredi del buonismo neotestamentario. La morale della fiaba (favola!, fls) altrettanto chiara: i tedeschi hanno ragione, i greci torto e non si possono capire tra di loro.
Penso che questa rappresentazione sia completamente falsa, inventata. In realtà i tedeschi hanno poco o nulla a che vedere con la loro autorappresentazione. In realtà ci troviamo di fronte ad una vera e propria riscrittura della storia che le classi dominanti tedesche hanno fatto nel corso dell’ultimo secolo. Una riscrittura della storia che è diventata egemone a causa della sudditanza dei molti ma non per questo meno falsa.
In primo luogo la storia del debito. Nel corso del 1900 i tedeschi non hanno mai pagato i loro debiti. Non hanno pagato i debiti di guerra della prima guerra mondiale se non dopo trent’anni ed un enorme sconto. Grazie alla conferenza di Londra del 1953, non hanno pagato i debiti della seconda guerra mondiale se non in parte limitatissima e dilazionati anch’essi in trent’anni. Inoltre non hanno pagato alcun risarcimento agli stati invasi per i danni prodotti nella Seconda Guerra mondiale nonostante la Conferenza di Londra del ’53 avesse previsto il loro pagamento quando fosse avvenuta la riunificazione della Germania. Nel 1990 la Germania si è riunificata ma non ha voluto pagare nulla.
La Germania è lo stato europeo di gran lunga più insolvente e di gran lunga meno portato a mantenere la parola data e gli accordi sottoscritti, oltre ad essere lo stato europeo di gran lunga più devastante nei confronti dei suoi vicini.
L’invenzione della tradizione non riguarda però solo il debito, riguarda anche le origini del nazismo. Secondo la vulgata corrente il nazismo sarebbe il frutto dell’iperinflazione che colpì la repubblica di Weimar. I biglietti da un miliardo di marchi portate a carrettate per comprare un chilo di burro sarebbero all’origine del nazismo. Niente di più falso. L’Iper inflazione tedesca avvenne nel corso del 1923 e terminò nel 1924 con il piano statunitense (Dawes) che impose nel 1924 una nuova moneta. La grande inflazione terminò quindi nel 1924 e non ve ne fu più traccia negli anni successivi, che furono invece anni di significativa ripresa economica e produttiva. Nel 1923, cioè l’anno culmine della grande inflazione praticamente il Partito Nazista esisteva solo sulla carta e ad esempio nelle elezioni del dicembre 1924 non risulta pervenuto. Del resto nelle stesse elezioni del 1928, quattro anni dopo la fine della grande inflazione i nazisti elessero 12 deputati, un quinto di quanti ne eleggevano i comunisti e meno di un decimo di quanti ne eleggevano i socialisti. La grande inflazione non ha quindi prodotto nessun sviluppo del movimento nazista, anzi.
Il partito nazista inizia a crescere velocissimo nel 1930 (107) deputati che raddoppiano nel 1932 (230), fino a vincere le elezioni nel 1933. Che cosa era successo nel frattempo? Era successo che il governo Bruning fece fronte alla crisi del 1929 con una politica economica di austerità, identica a quella che la Merkel ha oggi imposto a tutta Europa e che produsse in brevissimo tempo una recessione gravissima e milioni di disoccupati. Il nazismo è il frutto diretto delle politiche di austerità e il nazismo ebbe buon gioco ad indicare l’origine della crisi nella speculazione e quindi nei banchieri indicati come i registi del complotto giudaico massonico. La super disoccupazione frutto delle politiche di austerità e non la iper inflazione (di 5 anni prima) sono stati all’origine del nazismo. Hitler è figlio diretto delle folli politiche di austerità del governo Bruning, le stesse che la Merkel applica all’Europa, non dell’inflazione. Anche questa gigantesca operazione di riscrittura della storia non è innocente ma tutta finalizzata alle politiche di destra oggi in auge.
Più che davanti all’etica protestante, ci troviamo quindi dinnanzi ad un depistaggio continuo. Più che con Max Weber - che per altro parlava del calvinismo e non del luteranesimo proprio della cultura tedesca - abbiamo a che fare con Orwell: "Chi controlla il passato controlla il futuro: chi controlla il presente controlla il passato". Non mancano del resto altri esempi: Lo stato maggiore dell’esercito tedesco, sconfitto militarmente nelle trincee della prima guerra mondiale, scaricò la responsabilità della sconfitta addosso ai partiti di sinistra e al movimento dei lavoratori, facendo una campagna - poi ripresa in grande stile dal nazismo - sulla "pugnalata nella schiena".
La storia tedesca nel corso del 1900 è stata completamente e sempre riscritta dalle sue classi dirigenti a proprio uso e consumo. La Merkel non è da meno, anzi. Il fatto di essere nata nell’ex DDR, fa sì che lei non prenda nemmeno in considerazione le responsabilità collettive della nazione tedesca per quanto riguarda il nazismo. Bisognerebbe quindi smetterla di raccontare le frottole che le classi dirigenti tedesche raccontano a proprio vantaggio come se fossero vere. Non facciamo un buon servizio al popolo greco, all’Europa e nemmeno al popolo tedesco, che andrebbe aiutato a liberarsi da queste classi dirigenti e dalle loro narrazioni rassicuranti quanto completamente false.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- LA VITTORIA DEL "NO" ("OXI") IN GRECIA. L’eresia di Syriza può salvare l’Europa della solidarietò egualitaria (di Slavoj Zizek)9 luglio 2015, di Federico La Sala
 CON MARX, OLTRE. PER LA CRITICA DEL CAPITALISMO E DELLA SUA TEOLOGIA "MAMMONICA" (Benedetto XVI, "Deus caritas est", 2006).
CON MARX, OLTRE. PER LA CRITICA DEL CAPITALISMO E DELLA SUA TEOLOGIA "MAMMONICA" (Benedetto XVI, "Deus caritas est", 2006).
 L’INDICAZIONE DELLA "X" ( "CHI") DEL "NO" ("OXI") DELLA GRECIA:
L’INDICAZIONE DELLA "X" ( "CHI") DEL "NO" ("OXI") DELLA GRECIA:- RELAXIONI CHIASMATICHE E CIVILTA’: "X"- FILOSOFIA. LA FIGURA DEL "CHI": IL NUOVO PARADIGMA.
L’eresia di Syriza può salvare l’Europa della solidarietò egualitaria
di Slavoj Zizek (la Repubblica, 09.07.2015)
LA VITTORIA del “no” al referendum greco, netta oltre ogni aspettativa, è un voto storico, espresso in una situazione disperata. In passato ho spesso citato la barzelletta che circolava negli ultimi dieci anni di vita dell’Unione Sovietica e che aveva come protagonista Rabinovitch, un ebreo intenzionato a emigrare. Il funzionario dell’ufficio emigrazione gliene chiede il motivo e Rabinovitch risponde: «I motivi sono due. Il primo è che ho paura che in Unione Sovietica i comunisti perdano il potere e che il nuovo governo incolpi noi ebrei di tutti i crimini dei comunisti - che si torni ai pogrom antisemiti...». «Ma è assurdo», lo interrompe il funzionario, «in Unione Sovietica non può cambiare nulla, il potere dei comunisti durerà in eterno!». «Beh» risponde calmo Rabinovitch, «quello è il secondo motivo ».
Mi hanno detto che ora ad Atene circola una nuova versione della storiella: un giovane greco va al consolato australiano di Atene per chiedere il visto di lavoro. «Perché vuole lasciare la Grecia?» gli chiede il funzionario. «Per due motivi», risponde il giovane. «Il primo è che ho paura che la Grecia esca dall’Ue, della nuova povertà e del caos che ne verranno...». «Ma è assurdo », lo interrompe il funzionario, «la Grecia rimarrà nella Ue e si assoggetterà alla disciplina finanziaria!». «“Beh», risponde calmo il greco, «quello è il secondo motivo... ». Vuol forse dire che, parafrasando Stalin, entrambe le scelte sono le peggiori? È ora di andare oltre i dibattiti sterili sui possibili errori di comportamento e valutazione da parte del governo greco. Le poste in gioco ormai sono troppo alte.
Il fatto che negli attuali negoziati tra la Grecia e gli amministratori Ue si arrivi sempre a un passo da un accordo senza raggiungerlo è in sè profondamente sintomatico, poiché in realtà non si tratta di vere e proprie questioni finanziarie - a questo livello, la differenza è minima. La Ue di solito accusa i greci di esprimersi solo in termini generali, facendo promesse vaghe senza entrare nello specifico, mentre la Grecia accusa la Ue di voler controllare anche i minimi dettagli e di imporre al nuovo governo greco condizioni più dure rispetto al passato. Ma dietro queste recriminazioni aleggia un altro conflitto, più profondo. Tsipras ha dichiarato recentemente che se avesse avuto occasione di andare a cena da solo con Angela Merkel avrebbero trovato una soluzione in due ore. La sua tesi è che lui e la Merkel, due politici, avrebbero affrontato il dissidio come contrasto politico, a differenza degli amministratori tecnocrati, come il capo dell’Eurogruppo Jeroen Dijsselbloem. Se c’è un cattivo per eccellenza in tutta questa storia è Dijsselbloem: «Se pongo le questioni sul piano ideologico non risolvo nulla» è il suo motto.
Questo ci porta al nodo della questione: Tsipras si esprime come se i problemi fossero parte di un processo politico aperto, in cui si devono prendere decisioni in fin dei conti “ideologiche” (basate su preferenze normative) mentre i tecnocrati della Ue si esprimono come se tutto si riducesse a specifici regolamenti e nel momento in cui i greci rifiutano questo approccio e sollevano questioni più prettamente politiche, li si accusa di mentire, di evitare soluzioni concrete e così via. Non c’è dubbio che la verità qui sta dalla parte greca: rifiutare il “piano ideologico” come fa Dijsselbloem equivale alla più pura ideologia, significa spacciare per regolamenti elaborati da esperti decisioni che sono in realtà fondate su scelte politico-ideologiche. La lotta in atto è la lotta per la Leitkultur economica e politica in Europa. Le potenze della Ue appoggiano lo status quo tecnocratico che da decenni mantiene l’Europa in uno stato d’inerzia.
Nel suo Notes Towards a Definition of Culture (Note sulla definizione di cultura) il grande conservatore T.S.Eliot osserva che in alcuni momenti l’unica possibile scelta è tra l’eresia e il non credere, per tener viva una religione bisogna cioè creare nel suo corpo principale una frattura settaria. È questa la nostra posizione oggi riguardo all’Europa: solo una nuova “eresia” (rappresentata in questo momento da Syriza) può salvare quello che vale la pena di salvare dei valori europei: la democrazia, la fiducia nelle persone, la solidarietà egualitaria... L’Europa che vincerà se Syriza verrà messa fuori gioco sarà un’”Europa dai valori asiatici” (che ovviamente nulla ha a che fare con l’Asia, ma molto con la tendenza netta e attuale del capitalismo contemporaneo a sospendere la democrazia).
Non è solo che il destino della Grecia è in mano all’Europa. Noi dell’Europa occidentale amiamo guardare alla Grecia da osservatori distaccati, che seguono con compassione e simpatia il dramma della nazione impoverita. Questa posizione di comodo poggia su una pericolosa illusione - ciò che accade in Grecia in questi ultimi giorni ci riguarda tutti, è in gioco il futuro dell’Europa.
Il problema è che la politica dei tecnocrati si basa su una finzione, quella di estendere i termini di restituzione del debito dando a intendere che verrà ripagato in toto. Perché ci si ostina in questa finzione? Non è che renda l’estensione del debito più accettabile agli elettori tedeschi; e non è neppure che la cancellazione del debito greco possa innescare pretese analoghe da parte di Portogallo, Irlanda, Spagna... È che ai vertici in realtà non si vuole che il debito venga del tutto ripagato. I finanziatori accusano i paesi indebitati di non mostrare sufficiente senso di colpa, li accusano di sentirsi innocenti. Le loro pressioni corrispondono perfettamente a quello che gli psicoanalisti definiscono come superio: il paradosso del superio sta nel fatto che, Freud ci insegna, più obbediamo alle sue richieste più ci sentiamo in colpa.
Immaginate un perfido insegnante che assegna ai suoi alunni compiti impossibili e ghigna con sadismo vedendoli in ansia e in preda al panico. Il vero obiettivo di prestare denaro ai debitori non è ottenere il rimborso del debito lucrando, ma perpetuare il debito a tempo indefinito, tenendo il debitore in perenne dipendenza e subordinazione... questo per la maggior parte dei debitori, perché ne esistono varie tipologie. Non solo la Grecia, ma anche gli Usa non saranno in grado neppure in teoria di ripagare il loro debito, come ormai è di pubblico dominio. Esistono quindi debitori (le grandi banche) in grado di ricattare i creditori perché non possono permettersi di farle fallire, debitori che possono controllare le condizioni di pagamento del loro debito (il governo Usa) e, infine, debitori che possono essere maltrattati e umiliati (Grecia).
I finanziatori fondamentalmente accusano il governo Syriza di non mostrare sufficiente senso di colpa, lo accusano di sentirsi innocente. È questo che disturba l’establishment Ue: il governo Syriza riconosce il debito, ma senza colpa. Si sbarazza della pressione del superio.
Ma ripetere all’infinito che la politica di Syriza rientra nei modesti confini della vecchia buona socialdemocrazia per convincere gli eurocrati che non è pericolosa e spingerli a concedere gli aiuti, in qualche misura non riesce nell’intento.
Syriza è in realtà pericolosa, pone effettivamente una minaccia all’attuale orientamento della Ue - il capitalismo globale odierno non può permettersi un ritorno al vecchio stato sociale. Quindi c’è dell’ipocrisia nelle rassicurazioni circa la sobrietà delle istanze di Syriza: in realtà il suo obiettivo è impossibile da realizzarsi entro le coordinate del sistema globale esistente. Servirà una seria scelta strategica: e se fosse giunto il momento di gettare la maschera della sobrietà e di chiedere invece apertamente il cambiamento ben più radicale necessario per ottenere un progresso, seppur modesto? Forse il referendum sarà il primo passo in questa direzione.
Traduzione di Emilia Benghi
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- "OXI" ("NO")! LA CARITA’ DELLA GRECIA NON E’ LA CARITA’ DELL’EUROPA!!!8 luglio 2015, di Federico La Sala
-
> LA CARITA’ DELLA GRECIA NON E’ LA CARITA’ DELL’EUROPA!!! --- “Debito”uguale “colpa”. Nella Germania dell’etica protestante i due concetti coincidono, mentre nella lingua di Omero sono lessicalmente distinti.8 luglio 2015, di Federico La Sala
“Debito”uguale “colpa” quella parola unica che separa i tedeschi dal mondo greco
 Nella Germania dell’etica protestante i due concetti coincidono, mentre nella lingua di Omero sono lessicalmente distinti
Nella Germania dell’etica protestante i due concetti coincidono, mentre nella lingua di Omero sono lessicalmente distinti
 È l’emblema di uno scarto storico-culturale che arriva fino a oggi
È l’emblema di uno scarto storico-culturale che arriva fino a oggidi Silvia Ronchey (la Repubblica, 08.07.2015)
- WALTER BENJAMIN. Il filosofo scriveva già nel 1921 che “Il capitalismo è un culto che non consente espiazione”
 MAXWEBER. L’essere in credito è connesso alla tradizione calvinista che lo studioso vedeva all’origine di tutto il sistema
MAXWEBER. L’essere in credito è connesso alla tradizione calvinista che lo studioso vedeva all’origine di tutto il sistema
 PLATONE. “Chreos” per la società ellenica è “ciò che serve”, un’accezione che si trova già nell’allievo di Socrate
PLATONE. “Chreos” per la società ellenica è “ciò che serve”, un’accezione che si trova già nell’allievo di Socrate
 LUCA Introduce nel suo Vangelo la variante “Rimetti a noi i nostri peccati”, dando luogo a infinite dispute teologiche
LUCA Introduce nel suo Vangelo la variante “Rimetti a noi i nostri peccati”, dando luogo a infinite dispute teologiche
Che cos’è il debito? In tedesco il sostantivo femminile Schuld designa insieme il debito e la colpa. «Il capitalismo è un culto che non consente espiazione, ma produce colpa e debito», scriveva già nel 1921 Walter Benjamin. La vittoria del no al referendum greco ha richiamato l’attenzione del mondo non solo sulla drammaticità della situazione politica ma anche sul conflitto culturale, sull’antinomia profonda connessa alla concezione del debito nell’evolversi della psiche collettiva: ancora una volta, sull’antica polarità tra Grecia e Germania.
Debito e colpa è il titolo di un libro appena uscito (Ediesse, pagg. 240, euro 12) che Elettra Stimilli ha dedicato alla centralità della figura del debito come colpa nell’indebitamento planetario che segna la più recente fase del capitalismo contemporaneo. Le forme di consumo illimitato basate sull’indebitamento privato, partite dall’America, sono diventate, argomenta Stimilli, il motore principale dell’economia. Dal 2009, con l’immediato globalizzarsi della crisi americana, l’aumento esponenziale del debito privato ha coinvolto il debito pubblico dei paesi economicamente avanzati fino ad arrivare ai debiti sovrani. La finanziarizzazione della vita quotidiana, la “democratizzazione del credito”, ha prodotto uno stato di indebitamento generalizzato in cui ognuno, sia come lavoratore sia come consumatore, è diventato per definizione anzitutto debitore.
Nella cultura attuale dell’occidente, la parola debito è eminentemente connessa a quell’etica protestante, che già Max Weber vedeva all’origine ideale e psicologica, prima ancora che materiale e sociale, del sistema capitalista, alla cui indubbia efficienza i teorici, da Karl Marx a Joseph Schumpeter, hanno sempre contrapposto, con diversi gradi di perplessità, la difficoltà etica della giustificazione teorica. Se per Max Weber il capitale nella sua forma moderna nasceva dalla concezione calvinista della grazia e del peccato per poi secolarizzarsi in ideologia profana, secondo Benjamin il capitalismo può considerarsi in sé una religione, il culto di un dio minore, privo di dogmi ma dalla legge implacabile. È proprio la connessione religiosa fra debito economico e colpa morale - attinta peraltro a un’intuizione degli scritti giovanili di Marx - che porta il povero insolvente, scriveva Benjamin, «a fare di sé una moneta falsa, a carpire il credito con inganno, a mentire, così che il rapporto di credito diventi oggetto di abuso reciproco».
Se in tedesco i concetti di debito e colpa si stringono in uno stesso nodo lessicale, la lingua greca, che sta all’origine del nostro pensiero e della nostra sintassi filosofica, distingue nettamente tra l’uno e l’altra. Nel greco antico, come ancora oggi nel greco moderno, debito si dice chreos , un sostantivo che deriva dal verbo chraomai , “usare”, e dalla locuzione chre , “ciò che serve”, che si usa e di cui c’è bisogno; è inoltre connesso con chreia , la “mancanza”. Il termine chreos viene usato ampiamente dagli storici, come Tucidide, dai filosofi, come Platone, e dai giuristi, fino alle Novelle di Giustiniano e ai Basilika : il greco bizantino assicurerà la continuità e trasmetterà la certezza del diritto romano nel suo transito millenario dall’età antica a quella moderna, attraverso i secoli solo in occidente oscuri del cosiddetto medioevo dominato dal diritto barbarico.
Ma la prima attestazione della parola chreos nella letteratura greca è già nell’ottavo canto dell’ Odissea , nel passo in cui Efesto incatena Ares e Afrodite dopo averli colti in adulterio. Tutti gli dèi ridono tranne Poseidone, che gli intima di scioglierli. Efesto rifiuta perché, dice, se lo facesse Ares fuggirebbe eludendo insieme due vincoli, quello materiale della catena e quello morale, il chreos , che lo lega ormai a Efesto. Questo secondo legame non è una servitù, impossibile tra dèi, piuttosto una comunanza di destino, un pegno. Il dio della guerra si è indebitato con il dio del fuoco, dell’ingegneria, dei fabbri, di tutti gli artigiani: cedendo all’amore, condividendo il fascino della dea, si è sottomesso al vincolo di un reciproco scambio.
Anche altrove il significato del chreos greco sfuma spesso in quello di una comunanza ferrea di destino, di una ineludibile necessità: designa “il debito che tutti devono pagare”, ossia, almeno a partire da Teognide, anzitutto e per definizione la morte. Un’accezione metaforica di chreos che si ritrova lungo tutta la letteratura greca, da Platone alla Sapienza di Salomone tradotta nella bibbia dei Settanta. La distinzione tra debito e colpa è evidente nel Nuovo Testamento, anzitutto in uno dei suoi passaggi più noti: la preghiera del discorso della montagna, che diventerà il padre nostro. Qui il greco della koiné usa, anziché chreos , il più materiale e umile sostantivo ophèilema , che si ritrova in Matteo 6, 12: “rimetti a noi i nostri debiti”. La clamorosa discrepanza dal testo di Luca 11, 4, che ha invece la variante “rimetti a noi i nostri peccati” e usa il ben distinto sostantivo amartìa, ha dato luogo a infinite dispute teologiche e fatto sospettare una comune ascendenza dall’ebraico hôb, hôbot, insieme debito e colpa. Ma proprio il fatto che il dettato neotestamentario debba adottare due voci diverse sottolinea l’estraneità dei due concetti nella psiche greca.
Lo squilibrio politico generato da un lungo e inestinguibile debito ha un precedente storico nel mondo greco. A provocare la caduta dell’impero di Bisanzio sei secoli fa è stato il debito con la repubblica di Venezia, incarnazione di quel capitalismo nascente che la percezione teologica e filosofica bizantina, erede di quella classica, non sarebbe mai riuscita ad assimilare né a comprendere. L’indebitamento dello stato bizantino con i banchieri dell’occidente spinse le sue élite verso l’oriente. La civiltà bizantina entrò allora nella sfera geopolitica dell’islam ottomano, da cui solo nel XIX secolo la Grecia è emersa.
- WALTER BENJAMIN. Il filosofo scriveva già nel 1921 che “Il capitalismo è un culto che non consente espiazione”
-
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- "X"- FILOSOFIA. LA FIGURA DEL "CHI": IL NUOVO PARADIGMA.5 luglio 2015
SULL’USCITA DALLO STATO DI MINORITÀ E SULLO SPIRITO CRITICO, OGGI.
"X"- FILOSOFIA. LA FIGURA DEL "CHI":
IL NUOVO PARADIGMA..
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- Se non fosse stato per la Grecia delle Termopili, non ci sarebbe stata nessuna Europa: saremmo tutti sudditi di qualche deposta asiatico.4 luglio 2015
Nel popolo greco un capitale simbolico
di Adriano Prosperi (la Repubblica, 04.07.2015)
DICEVA Machiavelli che “assaltare una città disunita, per occuparla mediante la sua disunione, è partito contrario”, cioè può produrre il risultato opposto: quello di unire e rendere compatto il popolo diviso. Forse il referendum greco potrebbe dimostrare la verità di questa osservazione. Vedremo, tra pochi giorni e ore. Ma la domanda avrebbero potuto e forse dovuto porsela gli statisti tedeschi e i loro ossequenti alleati europei e magari velare meglio l’aggressione nei confronti del regime greco.
Mai come in questo caso la regola della non ingerenza negli affari interni degli stati membri è stata così trasgredita. Tutti i capi di governo si sono schierati in maniera massiccia per il sì e contro Tsipras fin dal primo giorno. I media si sono uniformati. Assistiamo a episodi perfino grotteschi, come quello dell’inviato Rai che intervista cinque greci e vedi caso, scopre che tutt’e cinque sono decisi a votare sì. La disinformazione si unisce alle tante falsificazioni dei fatti: ad esempio, non è vero che la scelta sarà fra la dracma e l’euro, come ha sveltamente sintetizzato il premier Renzi.
Ma il nostro dovere, di tutti noi cittadini degli stati dell’unione europea, non è chiederci che cosa faranno gli elettori greci: la domanda è che cosa faranno le autorità che ci governano - la Germania di frau Merkel, il Fondo monetario internazionale - se e quando saranno riuscite a raggiungere il loro intento, cioè a delegittimare Syriza e il premier Tsipras. Perché una cosa è evidente: la natura politica e non economica o finanziaria dello scontro. Fin dall’inizio il governo espresso dalle elezioni greche ha dovuto fare i conti con un’ostilità fortissima. La stampa tedesca è stata perfino capace di superare il limite degli insulti personali nel descrivere l’abbigliamento del ministro Varoufakis.
Dobbiamo all’attenzione non imparziale del Wall Street Journal se dalle zone nascoste della battaglia è emerso il documento delle proposte greche e delle correzioni con pennarello rosso di Bruxelles: un documento impressionante, una nuova versione della favola del lupo e dell’agnello. Non imparziale l’editore, certo: tutti sanno quanto siano grandi i problemi che gli conquassi europei e la crescita della superpotenza tedesca stanno creando alle esigenze strategiche e finanziarie di quella americana. Ma intanto quelle che ci toccano sono le conseguenze di una eventuale umiliazione referendaria per il governo greco: se ci sarà, non per questo i vincitori avranno risolto il problema fondamentale, quello di una costruzione sbagliata in grave e generale crisi.
L’errore grave, tremendo, come dovrebbe riconoscere oggi qualche responsabile che invece ancora cinguetta sui giornali, è stato quello di una unione monetaria a cui non ha corrisposto un’unione politica. L’Europa non è uno stato federale. Come ricordava l’altro ieri Paul Krugman spiegando perché è stato un errore tremendo, in un vero stato federale come gli Stati Uniti quando in Florida scoppia una bolla immobiliare è Washington che protegge automaticamente gli anziani contro ogni rischio per le loro cure mediche e i loro depositi bancari.
In questa Europa anziani e malati e tutte le altre categorie dell’umanità debole sono vittime di misure di austerità imposte da una burocrazia politico-finanziaria tecnicamente irresponsabile all’insegna di un liberismo di facciata, con l’ossessione del fantasma dei diritti umani e politici, quelli dei lavoratori e dei migranti in primo luogo. E oggi le misure che si vorrebbero imporre alla Grecia garantiscono che il crollo diverrà spaventoso e che non sarà solo la popolazione greca a pagarne il conto. Una vittoria di Pirro, se ci sarà: non solo perché i costi finanziari sono stati altissimi, di centinaia di volte superiori agli spiccioli necessari alla Grecia per andare avanti pagando il suo debito in scadenza.
Ma perché vincere una battaglia aggraverà il problema di come convincere, lascerà aperta e più incerta la guerra per la costruzione di una vera Europa. Resterà il fatto dell’aver umiliato e spezzato il morale di un popolo che porta nel suo nome l’immenso capitale simbolico di avere inventato la democrazia e l’Europa.
Diceva il grande storico del mondo antico, Arnaldo Momigliano, che se non fosse stato per la Grecia delle Termopili, per Maratona e Salamina (vi combatté un soldato che si chiamava Socrate), non ci sarebbe stata nessuna Europa: saremmo tutti sudditi di qualche deposta asiatico.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- La radice e la memoria. Siamo tutti figli del logos. Oggi Atene grida al mondo che l’unità del denaro non produce di per sé alcuna comunità politica (di M. Cacciari).1 luglio 2015, di Federico La Sala
La radice e la memoria
Siamo tutti figli del logos
Ecco perché la Grecia resterà sempre la miglior patria d’Europa
- La cultura nata all’ombra del Partenone fa parte del mito fondativo del Vecchio continente - E i singoli Stati non devono ignorarlo se non vogliono disfarsi tra nazionalismi e calcoli economici - Quel pensiero ci raccoglie insieme, è la nostra radice e ha informato di sé la storia e il destino dell’Occidente - Oggi Atene grida al mondo che l’unità del denaro non produce di per sé alcuna comunità politica
di Massimo Cacciari (la Repubblica, 01.07.2015)
Può l’Europa fare a meno della Grecia? Se la domanda fosse stata rivolta a uno qualsiasi dei protagonisti della cultura europea almeno dal Petrarca in poi, questi neppure ne avrebbe compreso il significato. La patria di Europa è l’Ellade, la “migliore patria”, avrebbe risposto, come verrà chiamata da Wilhelm von Humboldt, fondatore dell’Università di Berlino. Filologia e filosofia si accompagnano, magari confliggendo tra loro, nel dar ragione di questa spirituale figliolanza. Non si tratta affatto di vaghe nostalgie per perdute bellezze, né di sedentaria erudizione per un presunto glorioso passato, coltivate da letterati in vacua polemica con il primato di Scienza e Tecnica.
Oltre le differenze di tradizione, costumi, lingue e confessioni religiose che costituiscono l’arcipelago d’Europa, oltre l’appartenenza di ciascuno a una o all’altra delle sue “isole”, si comprende che il logos greco ne è portante radice, che non si intende il proprio parlare, che si sarà parlati soltanto, se non restiamo in colloquio con esso. Quel logos ci raccoglie insieme e ha informato di sé la storia,il destino di Europa. Ciò vale per pensatori e movimenti culturali opposti, per Hegel come per Nietzsche.Vale per scienziati come Schroedinger, Heisenberg, Pauli. Vale anche per coloro che si sforzano di pensare ciò che nella civiltà europea resterebbe non-pensato o in-audito: anche costoro non possono costruire la propria visione che nel confronto con quella greca classica.
Per la cultura europea, dall’Umanesimo alle catastrofi del Novecento, la memoria della “migliore patria” è tutta attiva e immaginativa: non si dà formazione, non può essere pensata costruzione-educazione della persona umana nella integrità e complessità delle sue dimensioni senza l’interiorizzazione dei valori che in essa avrebbero trovato la più perfetta espressione. Un grande filosofo, Edmund Husserl, li ha riassunti in una potente prospettiva: nulla accogliere come quieto presupposto, tutto interrogare, procedere per pure evidenze razionali, regolare la propria stessa vita secondo norme razionali, volere che il mondo si trasfiguri teleologicamente in un prodotto della vita di questo stesso sapere. Una follia? Forse - ma una follia che ha veramente finito col dominare il mondo. Eurocentrismo? Certamente - ma autore dell’occidentalizzazione dell’intero pianeta.
La Grecia non assume più per noi alcun rilievo culturale e simbolico? Possiamo ormai contemplarla come l’Iperione di Hölderlin dalle cime dell’istmo di Coritno: «lontani e morti sono coloro che ho amato, nessuna voce mi porta più notizie di loro»? Come è spiegabile un simile sradicamento? L’anima bella “progressista” risponde con estrema facilità: quell’idea di formazione che aveva la Grecia al suo centro era manifestamente elitaria, anti-democratica; la sua fine coincide con l’affermazione dei movimenti di massa sulla scena politica europea. Io credo che la risposta sia ancora più semplice, ma estremamente più dolorosa. Tra l’ora attuale( noi, i “moderni”!) e la “patria migliore” c’è il suicidio d’Europa attraverso due guerre mondiali.
L’oblio dell’Ellade è il segno evidente della fine d’Europa come grande potenza. Si badi: grande potenza è anche lo Stato o la confederazione di Stati che intendano diventarlo. Essi dovranno, infatti, dotarsi tanto di armi politiche ed economiche quanto di una strategia volta alla formazione di classe dirigente e di una cultura egemonica. Sempre così è stato e sempre così avverrà. Quando vent’anni fa scrivevo Geofilosofia dell’Europa e L’Arcipelago ancora speravo che questo arduo cammino si potesse intraprendere. E ci si risparmi la fatica di ripetere che non è affatto necessario che ciò si realizzi nel senso di una volontà di potenza sopraffattrice.
L’Europa può ora pensare di dimenticare la Grecia, perché rinuncia a svolgere una grande politica, la quale può fondarsi soltanto sulla coscienza di costituire un’unità di distinti, aventi comune provenienza e comune destino. Se questa coscienza vi fosse stata, avremmo avuto una politica mediterranea, piani strategici di sostegno economico per i Paesi dell’altra sponda, un ruolo attivo in tutte le crisi mediorientali. E avremmo avuto grandi interventi comunitari per la formazione, gli investimenti in ricerca, l’occupazione giovanile. Tutto si tiene. Una comunità di popoli capace di svolgere un ruolo politico globale non può non avere memoria viva di sé, memoria di ciò che essa è nella sua storia, e non di un morto passato.
Tutti miti - diranno gli incantati disincantati dell’economicismo imperante. So bene - l’Europa attuale è quella costruita sulla base delle necessità economico- finanziarie. Gli staterelli europei usciti dalla seconda Guerra non avrebbero potuto sopravvivere senza l’unità del denaro. Oggi la Grecia grida al mondo che una tale unità non produce di per sé alcuna comunità politica. Se pensiamo all’Europa come a un colossale Gruppo finanziario, allora è “giusto” che una delle sue società di minore peso( magari mal gestita, da un management inadeguato) possa tranquillamente essere lasciata fallire.
L’importante è solo che non contagi le altre. Ma se l’Europa vuole ancora esistere in quanto tale,e non disfarsi in egoismi, nazionalismi e populismi, deve sapere che la Grecia appartiene al suo mito fondativo, e che nessuna credenza è più superstiziosa di quella, apparentemente così ragionevole e “laica”, che ritiene il puro calcolemus senso,valore e fine di una comunità.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- CHE COSA E’ IL PUTTANESIMO DELLO SPIRITO? LA LEZIONE IGNORATA DI GIAMBATTISTA VICO.31 maggio 2015, di Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- «Lo stesso intellettuale ignora assolutamente l’origine sociale delle sue forme concettuali» (A. Sohn-Rethel). L’intellettuale e la sindrome di Belen (di Nicola Martino)27 maggio 2015, di Federico La Sala
L’intellettuale e la sindrome di Belen
di Nicolas Martino (alfapiù, 26 maggio 2015)
«Lo stesso intellettuale ignora assolutamente l’origine sociale delle sue forme concettuali»1. È bene tenere a mente queste parole di Alfred Sohn-Rethel per provare a svolgere qualche riflessione a partire dall’ultimo numero di «aut aut» (365/2015) dedicato a indagare il lavoro intellettuale in epoca neoliberale e significativamente intitolato «Intellettuali di se stessi».
Già, perché l’intellettuale è ormai interamente colonizzato dalla forma di vita neoliberale che ha fatto di ogni vivente un imprenditore di se stesso, e quindi catturato in quel marketing del sé che non sembra lasciare alcuna via di scampo. Eppure proprio a partire da questa figura iperindividualizzata è possibile che emergano figure di vita comune, è possibile aprire un discorso che sottragga il lavoro intellettuale all’infelicità di un narcinismo (narcisimo + cinismo) esasperato. Questa, molto sinteticamente, la cornice approntata dai curatori, Dario Gentili e Massimiliano Nicoli, all’interno della quale si svolgono gli interventi dei curatori stessi, di Roberto Ciccarelli, Carlo Mazza Galanti, Federico Chicchi e Nicoletta Masiero, Andrea Mura, Alessandro Manna e Vincenzo Ostuni.
Quella dell’intellettuale è una storia lunga e complessa, recentemente ricostruita da Enzo Traverso in un volumetto snello quanto prezioso (recensito qui), che ha segnato di sé il Novecento, ma quella dell’intellettuale imprenditore di se stesso è relativamente recente ed è possibile farla risalire alla metà degli anni Settanta, in coincidenza con la grande controrivoluzione neoliberista, ed è il risultato della consumazione di quella figura dell’intellettuale separato chiamato a distinguere il vero dal falso e il bene dal male dall’alto del suo isolamento - consumazione indotta dalla trasformazione postfordista imperniata sulla fine della separazione tra lavoro manuale e lavoro intellettuale e sulla valorizzazione del lavoro intellettuale e creativo diffuso - e però anche del fallimento della risposta che a quella grande trasformazione tentò di dare quell’intellettualità di massa prepotentemente emersa sulla scena delle metropoli occidentali dopo i «Trenta gloriosi».
Ecco perché, dicevo, è bene tenere presenti le parole di Sohn-Rethel e cercare di tratteggiare l’origine sociale di quelle forme concettuali che hanno catturato l’intellettuale dentro la nuova ragione del mondo (per dirla con Dardot e Laval), per cercare delle exit strategies dalle gabbie di quella che qui chiamiamo «la sindrome di Belen» e dalla sua infelicità diffusa.
E questa origine, l’emergere dell’intellettuale di se stesso, l’aveva individuata subito Gilles Deleuze in una straordinaria intervista del 1977 sui «nouveaux philosophes». All’intervistore che gli chiedeva cosa pensasse di questa nuova schiera di giovani pensatori per lo più ex maoisti e normalisti, Deleuze risponde subito: «Nulla. Credo che il loro pensiero sia nullo» [...] ma al tempo stesso «più fragile è il contenuto del pensiero, più acquista importanza il pensatore, e tanto più grande è l’importanza che si attribuisce il soggetto d’enunciazione rispetto agli enunciati vuoti».
Insomma dopo l’avanguardia che aveva messo in discussione la funzione autore, in musica, in pittura, nel cinema e anche nella filosofia, si assisteva ora a «un massiccio ritorno a un autore o a un soggetto vuoto e alquanto vanitoso», ritorno che rappresentava «una sgradevole forza reazionaria», in virtù della quale però i nouveaux philosophes si presentavano come dei «veri innovatori» che introducevano in Francia il marketing letterario e filosofico2. E aveva proprio ragione Deleuze, perché un anno prima, nel 1976, BHL aveva inventato la pub-filosofia confezionando ad hoc un dossier su «Les Nouvelles Littéraires» e lanciando il fenomeno mediatico che avrebbe funzionato da modello per tanti altri che si sarebbero succeduti: i nuovi critici, i nuovi pittori, i nuovi designer, il nuovismo d’assalto degli anni Ottanta3.
Eccola dunque l’invenzione dell’intellettuale imprenditore di se, a cui va riconosciuto senz’altro il merito di aver intuito subito il senso della sussunzione del lavoro culturale sotto il capitale e le chanches offerte dalla società dello spettacolo. L’Italia non è stata da meno, e anzi è riuscita anche ad anticipare i cugini francesi con la velocità di ABO che già nel ’72, con una geniale operazione di marketing, fece affiggere a Roma dei manifesti dove sotto la sua figura comparivano le parole: «Io sono Achille Bonito Oliva, il critico, dunque il coglione». L’intellettuale mediatico e imprenditore di se, senza resti, è una delle possibilità aperte dalla controrivoluzione neoliberista, che disegna però le forme concettuali all’interno delle quali si trova catturato l’intellettuale in generale e il knowledge worker del Quinto Stato.
Ma l’intellettuale di se stesso non esiste fuori dalla restaurazione della funzione autore e quindi da una ipersoggettivazione individualista, narcinista e caricaturale. Sono queste forme concettuali che vanno abbandonate, ricordando per esempio che prima dell’«Italian Theory» c’è stata la «Conricerca», non un brand da spendere sul mercato internazionale della cultura, ma una pratica teorico-politica, oltre la funzione autore, per rovesciare lo stato di cose presente. Forse da qui si può ripartire per guarire dalla «sindrome di Belen» e costruire quelle forme di vita in comune che auspichiamo insieme agli autori di «aut aut» e che altro non possono essere se non «ciò a cui si riferiva Marx parlando del compositore di musica e dell’opera d’arte come anticipazione formale di una produzione senza dominio»4.
 Il fascicolo di «aut aut» viene presentato oggi 26 maggio a Villa Mirafiori (via Carlo Fea 2, Roma) - ore 17.30 aula XV. Intervengono i curatori, gli autori dei saggi e Giuseppe Allegri, Ilaria Bussoni, Ilenia Caleo, Viola Giannoli, Nicolas Martino, Elettra Stimilli.
Il fascicolo di «aut aut» viene presentato oggi 26 maggio a Villa Mirafiori (via Carlo Fea 2, Roma) - ore 17.30 aula XV. Intervengono i curatori, gli autori dei saggi e Giuseppe Allegri, Ilaria Bussoni, Ilenia Caleo, Viola Giannoli, Nicolas Martino, Elettra Stimilli. Alfred Sohn-Rethel, Il denaro. L’apriori in contanti, Editori Riuniti 1991, p.14. [↩]
Alfred Sohn-Rethel, Il denaro. L’apriori in contanti, Editori Riuniti 1991, p.14. [↩]
 Gilles Deleuze, À propos des nouveaux philosophes et d’un problème plus general, supplemento al n. 24 di «Minuit», maggio 1977; trad.it. A proposito dei nuovi filosofi e di un problema più generale, in Id., Due regimi di folli e altri scritti. Testi e interviste 1975-1995, Einaudi 2010. [↩]
Gilles Deleuze, À propos des nouveaux philosophes et d’un problème plus general, supplemento al n. 24 di «Minuit», maggio 1977; trad.it. A proposito dei nuovi filosofi e di un problema più generale, in Id., Due regimi di folli e altri scritti. Testi e interviste 1975-1995, Einaudi 2010. [↩]
 Per un’analisi del fenomeno mediatico dei nouveaux philosophes si veda anche François Aubral-Xavier Delcourt, Contro i «Nuovi filosofi», Mursia 1978. [↩]
Per un’analisi del fenomeno mediatico dei nouveaux philosophes si veda anche François Aubral-Xavier Delcourt, Contro i «Nuovi filosofi», Mursia 1978. [↩]
 Paolo Virno, I sognatori di una vita riuscita, in «Metropoli» n.1. 1979, p.45. [↩]
Paolo Virno, I sognatori di una vita riuscita, in «Metropoli» n.1. 1979, p.45. [↩] -
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- E I FILOLOGI E I TEOLOGI?!20 maggio 2015, di Federico La Sala
- MURATORI, BENEDETTO XVI, E "UNO SPROPOSITO MAIUSCOLO": LA LEZIONE DI VICO. Un breve testo dalla "Prefazione ai lettori" del "Trattato sulla carità cristiana" di Ludovico A. Muratori
EUCARISTIA = EUCARESTIA, COSI’ ANCORA PER GLI ESPERTI DI WIKIPEDIA E CATHOPEDIA:
A. "Per i cristiani l’eucaristia o eucarestia è il sacramento istituito da Gesù durante l’Ultima Cena, alla vigilia della sua passione e morte. Il termine deriva dal greco εὐχαρίστω (eucharisto: "rendo grazie"). Il Nuovo Testamento narra l’istituzione dell’eucaristia in quattro fonti: Matteo 26,26-28; Marco 14,22-24; Luca 22,19-20; 1 Corinzi 11,23-25" (WIKIPEDIA).
B. "L’Eucaristia o Eucarestia (traslitterazione del greco εὐχαριστία, eucharistía, "rendimento di grazie") è il Sacramento con il quale, dopo il Battesimo e la Cresima, culmina l’iniziazione cristiana" (CATHOPEDIA).
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- LA SCUOLA è una grande questione nazionale. La più grande (di Adriano Prosperi - La riforma della scuola e il segno della sconfitta)-19 maggio 2015, di Federico La Sala
La riforma della scuola e il segno della sconfitta
di Adriano Prosperi (la Repubblica, 19.05.2015)
LA SCUOLA è una grande questione nazionale. La più grande. Qui si intrecciano e qui si incontrano i drammi della disoccupazione giovanile e dell’integrazione di milioni di immigrati, qui si giocano le sorti presenti e future della cultura italiana come sapere e coscienza diffusa di cittadinanza. Che la questione della riforma della scuola venga vissuta come un conflitto tra governo e sindacati o tra governo e una specie di Fort Alamo della sinistra irriducibile, cioè come uno dei tanti conflitti sociali di un paese smarrito e impoverito, è qualcosa di intollerabile; è anche il segno della sconfitta che ci aspetta tutti alla prova di un passaggio decisivo.
La domanda che bisogna farci è: come siamo arrivati a questo punto? Per rispondere bisogna partire da lontano. L’on. Alfredo D’Attore in un’intervista al Manifesto di sabato 16 maggio, ha accusato Renzi di avere imbroccato una strada che «amplifica le disuguaglianze e scardina un sistema nazionale di formazione su base universalistica». In realtà la cosa è più antica. Si aprì all’epoca lontana in cui il partito progenitore di quello di D’Attorre approvò la riforma dell’Università del suo ministro Berlinguer. Fu allora che passò il paradigma economicista e classista della divisione tra serie A e serie B a tutti i livelli: tra le università condannate a un’autonomia che deresponsabilizzava lo Stato e cancellava la distinzione tra pubbliche e private, tra le lauree, divise fra triennali e quinquennali ma soprattutto tra quelle del sud e quelle del nord, tra insegnamento e ricerca - privata quest’ultima di investimenti necessari, declassata quella ad affabulazione oratoria da scuola media mentre passava in uso il linguaggio dei «crediti », grottesco scimmiottamento del valore supremo, il danaro, la banca. Intanto saliva il danaro richiesto per le tasse mentre si impoverivano biblioteche e laboratori. Intanto il mondo della docenza accademica si incanagliva nei suoi antichi difetti e il rapporto tra insegnamento e ricerca veniva sottomesso al potere dei rettori e a quello di consigli di amministrazione aperti al mondo della finanza e dell’impresa.
Il risultato è sotto gli occhi di tutti, anche se non lo si vuole vedere. Somme immense sono state investite nel funzionamento di una agenzia di valutazione scelta dall’arbitrio politico che ha inventato sistemi spesso grotteschi e sempre costosi di “valutazione”. Di fatto nelle università come nelle scuole tutte si è bloccato il ricambio con danni immensi per il paese.
E si è perduta l’idea della funzione comune di tutto l’insieme della scuola pubblica. Si capisce così perché dall’università non si levi oggi quel coro di voci in difesa della scuola che sarebbe giusto e necessario. Eppure è nella struttura pubblica del sistema scolastico a tutti i livelli che risiede la difesa della democrazia italiana dai pericoli che la assediano.
Chi si straccia le vesti davanti alla fine del bicameralismo dovrebbe farlo assai più davanti al percorso liquidatorio della scuola pubblica: un percorso da tempo avviato da una classe politica spesso penosamente incolta, selezionata con le liste bloccate, incapace di rispettare l’unica categoria insieme alla magistratura che eserciti la sua professione dopo avere studiato a lungo e dopo essersi sottoposta a pubblici concorsi.
Senza una scuola dello Stato italiano che garantisca a tutti i cittadini la stessa qualità di offerta educativa, senza docenti selezionati in università statali di pari dignità e livello, senza concorsi pubblici, è difficile sperare che rinasca quell’unica condizione fondamentale perché l’incontro tra professore e allievo torni a essere quello giusto: la passione del docente per quello che fa. È solo lei che potrà lasciare una traccia positiva nella vita del giovane. Lo attesta il dialogo tra il maestro Fiorenzo Alfieri e suo nipote Leonardo nel libro Strade parallele. Ma per questo occorre che il docente sia ben preparato e abbia tutto il riconoscimento sociale cui ha diritto. E che raggiunga il suo luogo di lavoro senza dipendere dalla chiamata di un preside. Non si dimentichi che la scuola ha creato la lingua degli italiani e con la lingua la letteratura ben prima che se ne occupassero il cinema e la televisione.
È nella scuola che i diritti astrattamente descritti nella Costituzione diventano esercizio quotidiano, materia primaria di confronto e di palestra civile nel rapporto tra culture, religioni, questioni di colore e di sesso. Così è sempre stato. Si pensi alla figura della maestra suicida di Porciano, ai tempi della legge Coppino, quell’Italia Donati che portava nel nome le speranze del paese appena unificato. Alla creazione di questa scuola si sono dedicati i maggiori ingegni dell’Italia risorgimentale.
Se gli italiani non sono più il “volgo disperso” descritto da Manzoni, se la Recanati di Leopardi non è più un “borgo selvaggio” ma ha uno splendido Liceo dove anche gli ultimi nipoti dello zappatore e della “donzelletta” possono studiare, è per merito di un percorso faticoso ma fondamentale di costruzione di una buona scuola. O vogliamo tornare alle biblioteche e ai soldi di famiglia, ai precettori privati e ai colleges per i più fortunati lasciando gli altri a incanaglirsi nelle scuole e nelle università di serie B?
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- "HOMO SUM". La pia ipocrisia di Enea eroe di regime. Una rilettura del personaggio virgiliano dall’abbandono di Didone al mito di Augusto14 maggio 2015, di Federico La Sala
PIETAS e CHARITAS. SIAMO sinceri! Enea non ci piace....
Note su un testo di G. Zagrebelsky
- LA LEZIONE DI CARLO LEVI - OGGI:
 "La prima di esse [delle guerre nazionali] è quella di Enea. Una storia mitologica deve avere delle fonti mitologiche; e in questo senso, Virgilio è un grande storico. I conquistatori fenici, che venivano da Troia, portavano con sé tutti i valori opposti a quelli della antica civiltà contadina. Portavano la religione e lo Stato, la religione dello Stato. (...) Poi venne Roma, e perfezionò la teocrazia statale e militare dei suoi fondatori troiani, che, vincitori, avevano però dovuto accogliere la lingua e il costume dei vinti. E Roma si urtò anch’essa nella difesa contadina, e la lunga serie delle guerre italiche fu il più duro ostacolo al suo cammino"; e, ancora, fino ad illuminare il suo presente storico, scrive con lucidità e spirito critico: "(...) La quarta guerra nazionale dei contadini è il brigantaggio. Anche qui, l’umile Italia storicamente aveva torto, e doveva perdere. Non aveva armi forgiate da Vulcano, né cannoni, come l’altra Italia. E non aveva dèi: che cosa poteva fare una povera Madonna dal viso nero contro lo Stato Etico degli hegeliani di Napoli" (C. Levi, Cristo..., cit., pp. 123-125).
"La prima di esse [delle guerre nazionali] è quella di Enea. Una storia mitologica deve avere delle fonti mitologiche; e in questo senso, Virgilio è un grande storico. I conquistatori fenici, che venivano da Troia, portavano con sé tutti i valori opposti a quelli della antica civiltà contadina. Portavano la religione e lo Stato, la religione dello Stato. (...) Poi venne Roma, e perfezionò la teocrazia statale e militare dei suoi fondatori troiani, che, vincitori, avevano però dovuto accogliere la lingua e il costume dei vinti. E Roma si urtò anch’essa nella difesa contadina, e la lunga serie delle guerre italiche fu il più duro ostacolo al suo cammino"; e, ancora, fino ad illuminare il suo presente storico, scrive con lucidità e spirito critico: "(...) La quarta guerra nazionale dei contadini è il brigantaggio. Anche qui, l’umile Italia storicamente aveva torto, e doveva perdere. Non aveva armi forgiate da Vulcano, né cannoni, come l’altra Italia. E non aveva dèi: che cosa poteva fare una povera Madonna dal viso nero contro lo Stato Etico degli hegeliani di Napoli" (C. Levi, Cristo..., cit., pp. 123-125).
- "PER LA CRITICA DELL’ECONOMIA POLITICA" DELLA RAGIONE ATEA E DEVOTA ... VICO E MARX CONTRO LA PRASSI (ATEA E DEVOTA) DELLA CARITA’ POMPOSA. Alcune note su un testo del Muratori
La pia ipocrisia di Enea eroe di regime
Una rilettura del personaggio virgiliano dall’abbandono di Didone al mito di Augusto
di Gustavo Zagrebelsky (la Repubblica, 14.05.2015)
- L’intervento di Zagrebelsky che in parte anticipiamo verrà letto stasera a Bologna (ore 21, aula magna di Santa Lucia, via Castiglione 36) nell’ambito della XIV edizione de “I Classici”, intitolata “Homo sum” Gli altri incontri sono il 21, con Massimo Cacciari, e il 28, con Ivano Dionigi
SIAMO sinceri! Enea non ci piace. Se dovessimo fare una graduatoria tra i personaggi dell’epopea troiana, in cima metteremmo probabilmente non lo spocchioso Achille, ma “il domator di cavalli Ettorre” dell’ Iliade. In fondo alla graduatoria, metteremmo proprio Enea il “pio”. In mezzo, l’astuto e inquieto Ulisse. Questo nostro atteggiamento ci dice che sono mutati i paradigmi. Ciò che piaceva allora, oggi infastidisce. E, in primo luogo, non ci piace la poesia al servizio del potere. Neppure Virgilio, infatti, ci è mai troppo piaciuto, perché fece della sua arte strumento di persuasione politica. Scrive bene, è levigato. Ma non riusciamo a dimenticare che è stato un poeta di regime, stipendiato dal committente interessato a farsi tessere panegirici «di natura quasi mussoliniana» (Canfora). Il suo eroe letterario è Enea, ma l’eroe politico è Augusto, il destinatario del mito. Instauratore il primo; restauratore, il secondo, dopo i torbidi delle guerre civili e il disfacimento della Repubblica. Non una poesia civile, ma una poesia interessata, dunque, e, perciò malsana.
“Pio” è Enea, anzi di più: la pietas è la ragione della sua esistenza. Questa pietas è ciò che Virgilio propone come la virtù del principe. Gli Dei sono sensibili alle prove di pietas e rispondono con due prodigi archetipici, il fuoco che non brucia e la stella cometa. Entrambi riguardano il piccolo Ascanio e lo consacrano come il capostipite della gens di Augusto. Dentro Ascanio c’è dunque il futuro di Roma.
Ma, sulla strada accidentata verso la nuova patria, Enea incontra la contraddizione maggiore: eros. Eros e pietas sono nemici. Eros impone la sosta; pietas , la partenza. È la storia con Didone, cui è attribuito uno spazio capitale nell’architettura del poema. Anche Ulisse, nel ritorno verso la “petrosa Itaca”, incontra l’amore. È la storia di Calipso. Dopo la caduta di Troia, tutti e due hanno una missione, ma molto diversa: il ritorno alla casa di Itaca; la fondazione di un regno nel Lazio. La differenza è grande.
L’ Odissea è l’epopea delle radici; l’Eneide, della potenza politica. Odisseo deve ritornare per ricostruire la sua casa e trovare la sua pace. Il disegno di Enea è fondare un regno guerriero, sulle rovine d’altri regni. Di più: il ritorno a Itaca è il compito che Ulisse dà a se stesso da se stesso. Per Enea è diverso: egli, “profugo del fato”, ma salvato dagli Dei, è portatore d’un destino che gli è imposto dalla sentenza di Zeus. La sua pietas è la soggezione fedele a questo destino. Basta mettere a confronto l’Ulisse nell’isola di Calipso e l’Enea nella città di Didone. Dopo sette anni di amori, Ulisse è preso dalla nostalgia della sua casa che Calipso non era riuscita a fargli dimenticare. Una forza irresistibile nasce dentro di sé, che lo chiama alla partenza. “Dentro di sé”: Ulisse è artefice delle sue proprie fortune e sfortune. Piange, Ulisse, in preda a vivo dolore, come quando la scelta sembra impossibile.
Ben diverso il distacco tragico e lacerante dell’eroe da Didone. Enea è costretto a lasciare Cartagine e la fuga, che a Didone appare come la crudele ricompensa del bene ricevuto, non può che essere da lei tacciata di perfidia: «La lealtà non è più al sicuro», dice la regina. Ma Virgilio ci fa sentire anche la voce di Enea; e lo fa in un verso emblematico: «Arde di andarsene via e di lasciare quelle amate regioni». Nella prima metà del verso vediamo Enea con gli occhi di Didone: un uomo che non vede l’ora di andarsene; nella seconda metà del verso, vediamo invece Enea con gli occhi di Enea stesso: ne è spia un aggettivo, «amate ( dulcis) regioni», che Virgilio usa tutte le volte che deve esprimere lo strazio dell’abbandono. Partire, dunque, non è la sua vera volontà, e l’Italia, checché ne dicano gli Dei, potrà essere la sua nuova patria, ma non sarà mai veramente il suo amor. E qui sta la pietas come virtù che sacrifica il singolo e i suoi sentimenti. Il desiderio di Enea sarebbe un altro, però, e lo dice, cercando di giustificarsi con Didone viva («non inseguo di mia volontà l’Italia») e con Didone morta: nell’ultimo e impossibile dialogo con l’ombra della regina, Enea dirà: «Dalla tua terra, regina, sono partito contro la mia volontà».
Aleggia, su questa storia, l’ombra dell’ipocrisia. In verità, Enea è dipinto con i tratti del codardo, al quale importa soltanto di salvare la faccia: vuole consolare “con giuste parole”, mostra grande amore, dice che non è colpa sua. Non segue di sua volontà l’Italia. Però, di nascosto fa preparare la flotta per partire. Sarà pure per evitare ch’ella faccia bruciare le navi: resta il fatto che è Didone che lo affronta e, forse, se non l’avesse fatto, se ne sarebbe andato alla chetichella.
La dedizione totale al fato si accompagna al cinismo verso chi ama. Piacerebbe poter pensare che nell’episodio di Didone sia nascosto un messaggio a non esagerare nella pietas spietata di cui Enea è campione: un messaggio rivolto ai potenti dell’Impero.
Didone è solo la prima vittima di una lunga serie di ammazzamenti. Il progetto della Roma fondata dai discendenti dei Troiani si scontra con l’ordine dei Latini, ed è la guerra; una guerra che, in certo senso, è una guerra civile ante litteram, perché i due popoli sono destinati a fondersi. Il poema si chiude con l’uccisione di Turno, il re dei Rutuli, rivale di Enea. Turno, vicino a essere ucciso, ricorda a Enea il suo vecchio padre Anchise. Ed Enea sembra quasi rinunciare a sferrare il colpo fatale: Turno, infatti, è subiectus, sottomesso; e l’indicazione che Enea ha ricevuto da Anchise è di «avere pietà di chi si sottomette». Poi però qualcosa trasforma Enea: l’ultima immagine che ne riceviamo è quella di lui che, «infiammato di rabbia furibonda» per avere visto il bàlteo, la cintura di cuoio che era stata di Pallante, il suo alleato, pendere dalla spalla del suo nemico, l’uccide. Il pio Enea non rifugge dalla vendetta, dall’inutile crudeltà.
Alla fine, siamo dunque consapevoli del potenziale di violenza che la fedeltà assoluta alla propria patria, ai propri dei, ai propri penati implica: una pietas empia per chi sta fuori di quelle cerchie. E che l’apologeta cristiano del III secolo Lattanzio rimprovera senza mezzi termini a Virgilio: «Non sapevi che cosa fosse la pietas, e hai ritenuto che proprio ciò che quello ha compiuto in modo disumano e odioso fosse un dovere imposto dalla pietà. Chi potrebbe dunque attribuire a Enea anche un briciolo di valore, lui che si è acceso di rabbia come paglia dimenticando lo spirito del padre, nel cui nome veniva supplicato, non è stato capace di tenere a freno l’ira? Non è affatto pius chi uccide qualcuno che non solo ha deposto le armi, ma gli rivolge una preghiera. La pietas è quella di chi non conosce guerre, di chi è in armonia con tutti, di chi è amico anche dei propri nemici, di chi ama tutti gli uomini come fratelli». Così, entriamo in un nuovo mondo segnato dalla fratellanza universale, un mondo in cui alla pietas imperiale si contrappone la charitas cristiana.
* Federico La Sala
- LA LEZIONE DI CARLO LEVI - OGGI:
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA --- Breve catalogo dei luoghi comuni sulla nostra libertà (di Chimamanda Ngozi Adichie)12 maggio 2015, di Federico La Sala
- DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"!. DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE...
Breve catalogo dei luoghi comuni sulla nostra libertà
di Chimamanda Ngozi Adichie (la Repubblica, 10.05.2015) *
OKOLOMA era uno dei miei più cari amici d’infanzia. Abitava nella mia stessa strada e si prendeva cura di me come un fratello maggiore. Se mi piaceva un ragazzo, gli chiedevo che ne pensava. Okoloma era spiritoso e intelligente e portava stivali da cowboy a punta. È morto nel dicembre del 2005 in un incidente aereo nel sud della Nigeria. Faccio ancora fatica a esprimere a parole cosa ho provato allora. Okoloma era uno con cui potevo discutere, ridere, parlare davvero. Era anche la prima persona ad avermi dato della femminista. Avrò avuto quattordici anni.
Eravamo a casa sua e discutevamo riempiendoci la bocca di idee traballanti ricavate dalle nostre letture. Non ricordo di cosa stessimo discutendo. Ma ricordo che, mentre snocciolavo i miei argomenti, Okoloma mi guardò e disse: «Sei proprio una femminista». Non era un complimento. Lo intuii dal tono, lo stesso con cui uno direbbe: «Quindi difendi il terrorismo ». Non sapevo l’esatto significato della parola “femminista”. E non volevo che Okoloma sapesse che non lo sapevo. Così ripresi la discussione facendo finta di niente, ripromettendomi di cercare la parola sul vocabolario non appena fossi tornata a casa.
Nel 2003 ho scritto un romanzo intitolato L’ibisco viola. Parla di un uomo che, tra le altre cose, picchia la moglie, e che non fa una bella fine. Mentre promuovevo il libro in Nigeria, un giornalista - un signore gentile e benintenzionato - mi ha voluto dare un consiglio (come forse saprete, i nigeriani sono sempre pronti a dare consigli non richiesti). Mi ha detto che secondo molte persone il mio era un romanzo femminista, e il suo consiglio - parlava scuotendo la testa con aria triste - era di non definirmi mai femminista, perché le femministe sono donne che non trovano marito e, dunque, infelici. Così ho deciso di definirmi una Femminista Felice.
Poi una professoressa universitaria nigeriana mi ha detto che il femminismo non faceva parte della nostra cultura, che il femminismo non era africano e che mi definivo femminista solo perché ero stata influenzata dai libri occidentali (cosa che mi ha fatto sorridere, perché molte delle mie prime letture sono state decisamente poco femministe: credo di aver letto ogni volume della serie di romanzi rosa Mills & Boon pubblicato prima che compissi sedici anni. E, ogni volta che provo a leggere i cosiddetti “classici del femminismo”, mi annoio e faccio fatica a finirli). A ogni modo, dato che il femminismo non era africano, ho deciso di definirmi una Femminista Felice Africana. Poi un caro amico mi ha detto che definirmi femminista voleva dire che odiavo gli uomini. Così ho deciso di definirmi una Femminista Felice Africana Che Non Odia Gli Uomini. A un certo punto ero diventata una Femminista Felice Africana Che Non Odia Gli Uomini e Che Ama Mettere il Rossetto e i Tacchi Alti Per Sé e Non Per Gli Uomini.
Naturalmente in questo c’era parecchia ironia, ma la vicenda dimostra che la parola «femminista» si porta dietro un bagaglio negativo notevole: odi gli uomini, odi i reggiseni, odi la cultura africana, pensi che le donne dovrebbero sempre essere ai posti di comando, non ti trucchi, non ti depili, sei perennemente arrabbiata, non hai senso dell’umorismo, non usi il deodorante.
Ora ecco un episodio della mia infanzia. Quando ero alle elementari a Nsukka, una città universitaria nel sudest della Nigeria, all’inizio dell’anno la mia insegnante ci fece fare un compito dicendo che la persona con il voto più alto sarebbe diventata capoclasse. Diventare capoclasse era una cosa importante. Il capoclasse scriveva ogni giorno i nomi degli alunni chiassosi, di per sé un esercizio di potere già abbastanza inebriante, e in più la maestra ti dava una bacchetta da tenere in mano mentre pattugliavi l’aula. Naturalmente non avevi il diritto di usarla. Ma ai miei occhi di bambina di nove anni era comunque una prospettiva eccitante. Volevo assolutamente diventare capoclasse. E presi il voto più alto. Poi, con mia grande sorpresa, la maestra disse che il capoclasse doveva essere un maschio. Si era dimenticata di precisarlo. Lo aveva dato per scontato. Il voto più alto dopo il mio lo aveva preso un bambino. E il nuovo capoclasse sarebbe stato lui. La cosa interessante è che il bambino in questione era un’anima mite e per nulla attratta dall’idea di pattugliare la classe con una bacchetta in mano. Mentre io non sognavo altro. Ma io ero una femmina e lui un maschio, e così fu lui a diventare capoclasse. Non ho mai dimenticato quell’episodio. Se facciamo di continuo una cosa, diventa normale. Se vediamo di continuo una cosa, diventa normale. Se solo i maschi diventano capoclasse, a un certo punto finiamo per pensare, anche se inconsciamente, che il capoclasse debba per forza essere un maschio.
*
 Traduzione Francesca Spinelli (Testo tratto da Dovremmo essere tutti femministi , Einaudi)
Traduzione Francesca Spinelli (Testo tratto da Dovremmo essere tutti femministi , Einaudi) -
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- Agorà pedagogica. Ridare vitalità alla scuola democratica della Repubblica! (di Alain Goussot)4 maggio 2015, di Federico La Sala
Agorà pedagogica
di Alain Goussot ("comune-info", 26 aprile 2015)
- Un paese che distrugge la sua scuola non lo fa mai solo per soldi, perché le risorse mancano o i costi sono eccessivi. Un paese che demolisce l’istruzione è già governato da quelli che dalla diffusione del sapere hanno solo da perdere
 Italo Calvino, L’apologo sull’onestà nel paese dei corrotti
Italo Calvino, L’apologo sull’onestà nel paese dei corrotti
di Alain Goussot*
In questo momento sta crescendo il movimento di protesta degli insegnanti contro il progetto del governo Renzi-Giannini, un progetto che, nei fatti trasforma la scuola in una azienda e legittima le diseguaglianze sociali contraddicendo in questo modo la carta costituzionale. È molto probabile che il governo e il ministero rimangano completamente sordi alla protesta e che facciano passare il disegno di legge, tenuto conto delle tredici deleghe in bianco che ha a disposizione si capisce che farà quello che vuole. Ma non ascoltare quello che sale dalla società e in particolare dal mondo degli insegnanti che sono a contatto quotidiano con gli alunni è un atteggiamento miope e che denota una concezione profondamente antidemocratica del governo.
Tuttavia, dal movimento di protesta nelle scuole contro il disegno di legge la Buona scuola potrebbe nascere un nuovo progetto democratico per la scuola italiana, un progetto pedagogico serio che affronti le questioni dell’eguaglianza delle opportunità nell’accesso ai sapere e alle conoscenze, all’istruzione per tutti, della formazione culturale generale e solida di un cittadino consapevole e in grado di pensare con la propria testa, di una integrazione tra un recupero dell’identità umanistica della cultura italiana e una serie formazione scientifica, di una scuola accogliente e davvero inclusiva, di una scuola ormai multiculturale e meticcia.
Un grande progetto di rinnovamento della scuola che sappia mettere al centro la pedagogia e una didattica ricca e viva, che sappia preparare gli insegnanti sia per entrare nella professione docente che per continuare ad aggiornarsi durante la carriera, una scuola che sappia dialogare con la comunità e le famiglie in una prospettiva co-educativa costruendo una grande alleanza pedagogica per un futuro di democrazia e di sviluppo umano basato sulla solidarietà, la giustizia, l’eguaglianza , il riconoscimento delle differenze e la libertà responsabile.
Per aiutarsi la scuola, gli insegnanti possono ispirare dal grande e ricco patrimonio d’idee prodotte dalla storia dell’educazione attiva, basta pensare a Maria Montessori, Mario Lodi, Gianni Rodari, Bruno Ciari, Dina Bertone Jovine, Aldo Visalberghi, Lamberto Borghi, Don Lorenzo Milani, Antonio Banfi, Piero Bertolini, Giovanni Maria Bertin ma anche John Dewey, Ovide Decroly, Adolphe Ferrière, Edouard Claparède, Roger Cousinet, Célestin Freinet, Lev Vygotskij, Anton Makarenko, Paulo Freire ecc. Insomma l’esperienza ricca e diretta di migliaia di insegnanti nelle loro scuole e nell’attività quotidiana combinata con le fonti storiche delle pedagogie attive e critiche (per arrivare fino ad oggi) può favorire un Rinascimento pedagogico che sappia rilanciare e ridare vitalità alla scuola democratica, meticcia e pluralista della Repubblica! La protesta radicale diventerà in questo modo progetto collettivo che interpella tutta la società e farà della scuola l’epicentro del rinnovamento culturale e sociale autentico del paese.
Credo che gli insegnanti debbano trasformare le loro scuole in bastioni della difese della democrazia e del diritto per tutti di accedere all’istruzione, devono fare delle loro scuole un Agorà pedagogica che sappia diventare spazio di discussione e dialogo educativo progettuale tra insegnanti, insegnanti alunni e genitori.
Anton Makarenko, il grande pedagogista ed educatore sovietico dopo la rivoluzione del 1917, parlava di collettivi pedagogici cioè di spazi organizzati dove educatori, insegnanti, genitori e anche ragazzi si confrontavano sulle grandi questioni della formazione dei futuri cittadini e dell’accesso di tutti ai sapere e alle conoscenze necessarie per essere delle donne e degli uomini effettivamente autonomie liberi. Paulo Freire, il grande pedagogista brasiliano, parlava di circoli culturali e pedagogici aperti a tutti come spazi di partecipazione democratica alla riflessione sui grandi temi dell’istruzione, dell’educazione, della giustizia, dell’ambiente, della democrazia partendo dalla formazione scolastica.
I collettivi pedagogici nelle scuole possono essere dei luoghi di elaborazione progettuale e anche di presa di coscienza collettiva e di sensibilizzazione di tutta la comunità sull’importanza della scuola come bene comune. I collettivi pedagogici possono essere composti da insegnanti, educatori, cittadini interessati e anche alunni. Luoghi aperti in cui si riflette e si costruisce assieme il futuro della scuola e questo in ogni territorio. Credo che sia la migliore risposta da dare, accompagnando le proteste, le manifestazioni e il movimento in atto nella direzione della costruzione partecipata dal basso di quel intellettuale collettivo di cui parlava Antonio Gramsci.
Collettivi pedagogici di diverse scuole possono collegarsi tra di loro e condividere argomenti di discussione e proposte questo sia nella medesima comunità che tra comunità territoriali diverse. In questo modo la protesta diventa un attore riflessivo e davvero rivoluzionario.
*Alain Goussot è docente di pedagogia speciale presso l’Università di Bologna. Pedagogista, educatore, filosofo e storico, collaboratore di diverse riviste, attento alle problematiche dell’educazione e del suo rapporto con la dimensione etico-politica, privilegia un approccio interdisciplinare (pedagogia, sociologia, antropologia, psicologia e storia).
 Ha pubblicato: La scuola nella vita. Il pensiero pedagogico di Ovide Decroly (Erickson); Epistemologia, tappe costitutive e metodi della pedagogia speciale (Aracneeditrice); L’approccio transculturale di Georges Devereux (Aracneeditrice); Bambini «stranieri» con bisogni speciali (Aracneeditrice); Pedagogie dell’uguaglianza (Edizioni del Rosone). Il suo ultimo libro è L’Educazione Nuova per una scuola inclusiva (Edizioni del Rosone)
Ha pubblicato: La scuola nella vita. Il pensiero pedagogico di Ovide Decroly (Erickson); Epistemologia, tappe costitutive e metodi della pedagogia speciale (Aracneeditrice); L’approccio transculturale di Georges Devereux (Aracneeditrice); Bambini «stranieri» con bisogni speciali (Aracneeditrice); Pedagogie dell’uguaglianza (Edizioni del Rosone). Il suo ultimo libro è L’Educazione Nuova per una scuola inclusiva (Edizioni del Rosone) - Un paese che distrugge la sua scuola non lo fa mai solo per soldi, perché le risorse mancano o i costi sono eccessivi. Un paese che demolisce l’istruzione è già governato da quelli che dalla diffusione del sapere hanno solo da perdere
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- Responsabilità. Oggi nessuno vuole più rispondere di nulla ma chi scarica sugli altri ogni fardello nei fatti si dichiara sostituibile e superfluo (di Donatella Di Cesare)6 aprile 2015, di Federico La Sala
Responsabilità
Oggi nessuno vuole più rispondere di nulla ma chi scarica sugli altri ogni fardello nei fatti si dichiara sostituibile e superfluo
di Donatella Di Cesare (Corriere della Sera, La Lettura, 05.04.2015)
«Non ne rispondo io - mi spiace». «Che si assuma la responsabilità chi di dovere!». «Sarà il caso di passare la palla ad altri». Quante volte al giorno capita di ascoltare frasi del genere? O persino di pronunciarle? Sfuggire alla responsabilità è una prassi diffusa nella vita privata come nella sfera pubblica. Dai piccoli gesti della quotidianità ai rapporti affettivi, dai legami sociali all’agire politico: non c’è ambito che non sia pervaso da una rinuncia sistematica alle risposte che ciascuno è chiamato a dare. E la rinuncia finisce per volgersi in vera abdicazione là dove le responsabilità aumentano.
Gli esempi sono molteplici: l’insegnante acquiescente che chiude gli occhi sulla prepotente bullaggine dell’allievo; il giornalista che sceglie sbrigativamente la parola più comoda o passa sotto silenzio quel che dovrebbe dire a gran voce; il magistrato che strizza l’occhio agli imputati, proscioglie quando dovrebbe condannare, allunga i tempi del processo fino alla prescrizione; il medico che tratta il paziente come un corpo malato, tra disattenzione e volontà di lucro; il politico che, mentre dovrebbe sollevare lo sguardo verso il bene comune, è chino sul proprio tornaconto.
La rinuncia ad assumere le proprie responsabilità erode ogni relazione, corrode la comunità. La corruzione nasce da qui. È un fenomeno etico, prima ancora che politico. Questo non vuol dire né diluirne la portata né ampliarne pericolosamente i confini. Ma non sarà mai possibile vederne con chiarezza gli effetti devastanti, se non si risale a quel luogo in cui la corruzione affiora. Ed è là dove il legame con l’altro si deteriora, dove chi dovrebbe rispondere preferisce sottrarsi. L’io si deresponsabilizza. Chiamato in causa, non si assume l’onere della decisione, e aggira l’impegno, evade l’obbligo che lo lega agli altri.
Così apre una falla, una incrinatura. E mentre una crepa si aggiunge alla precedente, la comunità, inevitabilmente, si sgretola. La corruzione non sta solo nelle mazzette - simbolo del disfacimento che prevale, dell’integrità che viene meno. Una comunità corrotta è quella i cui membri non rispondono di sé e non rispondono agli altri.
La leggerezza inebriante di cui si compiace l’io deresponsabilizzato è a ben guardare una trappola. Chi ha eluso il fardello della responsabilità, crede di averla fatta franca. Si prepara a schivare così tutti i fardelli a cui andrà incontro. L’onore senza l’onere diventa il suo stile di vita. Ma ogni volta che l’io abdica, che lascia agli altri la responsabilità a cui era stato chiamato, crede, e fa credere, di essere sostituibile. «Perché mai dovrei risponderne proprio io? Che se la veda qualcun altro!». Può darsi che il «qualcun altro» che viene dopo si comporti in modo analogo - in un continuo rinvio, un incessante riversarsi a vicenda pesi e obblighi.
Eppure nessuno è sostituibile. La responsabilità che incombe su di me, in questo momento, non può essere ceduta. Se la cedo, non solo apro una falla, ma accetto l’idea che qualcuno potrebbe rimpiazzarmi. Mentre nessuno, mai, può farlo. L’io deresponsabilizzato ammette invece di essere sostituibile, avvalora la sconcertante ipotesi della propria superfluità. Si crede in genere che la responsabilità sia un gesto ulteriore di un soggetto autonomo e sovrano.
Nella sua superba priorità questo soggetto, privo di vincoli, detterebbe legge a se stesso. Ma che cosa sarebbe l’io senza l’altro che sempre lo precede? Il mondo non è cominciato con me. Prima di me c’è sempre l’altro che mi convoca, mi interroga, e a cui sono chiamato a rispondere. Non per un atto di adesione volontaria - valutando se dire sì o no. Ma semplicemente volgendomi verso chi mi chiama. Prima ancora di ogni possibilità di scelta, perché è nella torsione verso l’altro che l’io si costituisce. Rispondo, dunque sono.
Senza la responsabilità, l’io non esisterebbe neppure. La mia esistenza si coagula ogni volta nell’obbligo che mi vincola all’altro. Se eludo l’obbligo, gli effetti ricadono sul mio stesso esistere. La leggerezza inebriante si rivela inconsistenza angosciosa. E quel detestabile io, che pretendeva di essere soggetto assoluto, rischia di restare tragicamente intrappolato nella sua errata idea di libertà astratta, senza più via d’uscita.
I filosofi non hanno mai parlato tanto di «responsabilità» come in questi ultimi decenni. Con Emmanuel Lévinas e con Hans Jonas la responsabilità è diventata, anzi, uno dei temi più discussi nel dibattito contemporaneo. Il che non sorprende. Perché viviamo nell’epoca di una crescente deresponsabilizzazione.
La complessità del mondo globale, la rilevanza assunta dalla scienza che, malgrado i progressi compiuti, appare sempre più incapace di offrire un orientamento e dar conto delle sue stesse scelte, la specializzazione estrema e il connesso ruolo dell’«esperto», al quale viene spesso lasciata la parola ultima, la frantumazione della responsabilità, che impedisce di scorgere le ripercussioni dei propri gesti: tutto ciò ha contribuito a privare i più della possibilità di decidere e di agire. È la razionalizzazione tecnica della vita a influire, però, in modo determinante.
Dove trionfa la tecnica viene meno la responsabilità. Non solo perché l’essere umano è diventato «antiquato» rispetto ai suoi stessi prodotti, costretto - come ha sostenuto Günther Anders - a rincorrerli disperatamente, nel tentativo vano di sincronizzarsi alla loro disumana rapidità. Ma anche perché l’ingranaggio della tecnica stravolge il rapporto tra mezzi e fini, nel senso che potenzia i mezzi e fa perdere di vista i fini, sia quelli individuali, sia quelli comuni, che rendono coesa una comunità. Si è in grado di fare molte più cose, ma non si sa bene a che scopo.
Così, mentre si moltiplicano le etiche applicate, dalla bioetica all’«etica degli affari», volte non di rado a rassicurare l’opinione pubblica sulla moralità di un settore, ad esempio quello delle imprese, mentre dunque l’etica può diventare a sua volta fonte di profitto, la «responsabilità» resta la terra incognita di questa tarda modernità, la stessa che abita un pianeta devastato, dove nulla sembra ci sia ancora da scoprire.
La responsabilità è infatti rispetto sia per gli altri, sia per quell’altro che sono le cose del mondo. Da quando gli esseri umani sono diventati più pericolosi per la natura, di quanto la natura fosse per loro, si rende necessaria un’etica che risponda all’esigenza di lasciare alle generazioni future un pianeta ancora vivibile.
Sono responsabile non solo verso l’altro che sempre mi precede, ma anche verso l’altro che viene dopo di me. E guardando al suo futuro non dovrei allora mai mancare di chiedermi se anche il più piccolo dei miei gesti non avrà ricadute su di lui. Proprio quello che non mi riguarda richiede la mia attenzione. Solo io sono responsabile - sta qui la suprema dignità umana.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- LA COSTITUZIONE NON E’ VOSTRA PROPRIETA’(di Sergio Mattarella - Camera dei deputati il 20 ottobre 2005).12 marzo 2015, di Federico La Sala
Non è vostra proprietà
di Sergio Mattarella
- intervento dell’allora on. Sergio Mattarella alla Camera dei deputati il 20 ottobre 2005 in occasione del voto sul Ddl di revisione costituzionale del centrodestra (il Fatto, 12.03.2015)
Signor Presidente, tra la metà del 1946 e la fine del 1947, in quest’aula, si è esaminata, predisposta ed approvata la Costituzione della Repubblica. Con l’attuale Costituzione, che vige dal 1948, l’Italia è cresciuta, nella sua democrazia anzitutto, nella sua vita civile, sociale ed economica. In quell’epoca, vi erano forti contrasti, anche in quest’aula. Nell’aprile del 1947 si era formato il primo governo attorno alla Democrazia cristiana, con il Partito comunista e quello socialista all’opposizione. Vi erano contrasti molto forti, contrapposizioni che riguardavano la visione della società, la collocazione internazionale del nostro paese. Vi erano serie questioni di contrasto, un confronto acceso e polemiche molto forti. Eppure, maggioranza e opposizione, insieme, hanno approvato allora la Costituzione. Al banco del governo, quando si trattava di esaminare provvedimenti ordinari o parlare di politica e di confronto tra maggioranza e opposizione, sedevano De Gasperi e i suoi ministri. Ma quando quest’aula si occupava della Costituzione, esaminandone il testo, al banco del governo sedeva la Commissione dei 75, composta da maggioranza e opposizione.
Il governo di allora, il governo De Gasperi, non sedeva ai banchi del governo, per sottolineare la distinzione tra le due dimensioni: quella del confronto tra maggioranza e opposizione e quella che riguarda le regole della Costituzione. Questa lezione di un governo e di una maggioranza che, pur nel forte contrasto che vi era, sapevano mantenere e dimostrare, anche con i gesti formali, la differenza che vi è tra la Costituzione e il confronto normale tra maggioranza e opposizione, in questo momento, è del tutto dimenticata.
Le istituzioni sono comuni: è questo il messaggio costante che in quell’anno e mezzo è venuto da un’Assemblea costituente attraversata - lo ripeto - da forti contrasti politici. Per quanto duro fosse questo contrasto, vi erano la convinzione e la capacità di pensare che dovessero approvare una Costituzione gli uni per gli altri, per sé e per gli altri.
Questa lezione e questo esempio sono stati del tutto abbandonati. Oggi, voi del governo e della maggioranza state facendo la “vostra” Costituzione. L’avete preparata e la volete approvare voi, da soli, pensando soltanto alle vostre esigenze, alle vostre opinioni e ai rapporti interni alla vostra maggioranza. Il governo e la maggioranza hanno cercato accordi soltanto al loro interno, nella vicenda che ha accompagnato il formarsi di questa modifica, profonda e radicale, della Costituzione.
Il governo e la maggioranza - ripeto - hanno cercato accordi al loro interno e, ogni volta che hanno modificato il testo e trovato l’accordo tra di loro, hanno blindato tale accordo. Avete sistematicamente escluso ogni disponibilità a esaminare le proposte dell’opposizione o anche soltanto a discutere con l’opposizione. Ciò perché non volevate rischiare di modificare gli accordi al vostro interno, i vostri difficili accordi interni.
Il modo di procedere di questo governo e di questa maggioranza - lo sottolineo ancora una volta - è stato il contrario di quello seguito in quest’aula, nell’Assemblea costituente, dal governo, dalla maggioranza e dall’opposizione di allora. Dov’è la moderazione di questa maggioranza? Non ve n’è! Dove sono i moderati? Tranne qualche sporadica eccezione, non se ne trovano, perché la moderazione è il contrario dell’atteggiamento seguito in questa vicenda decisiva, importantissima e fondamentale, dal governo e dalla maggioranza. Siete andati avanti, con questa dissennata riforma, al contrario rispetto all’esempio della Costituente, soltanto per non far cadere il governo. Tante volte la Lega ha proclamato e ha annunziato che avrebbe provocato la crisi e che sarebbe uscita dal governo se questa riforma, con questa profonda modifica della Costituzione, non fosse stata approvata. Ebbene, questa modifica è fatta male e lo sapete anche voi.
Con questa modifica dissennata avete previsto che la gran parte delle norme di questa riforma entrino in vigore nel 2011. Altre norme ancora entreranno in vigore nel 2016, ossia tra 11 anni. Per esempio, la norma che abbassa il numero dei parlamentari entrerà in vigore tra 11 anni, nel 2016! Sapete anche voi che è fatta male, ma state barattando la Costituzione vigente del 1948 con qualche mese in più di vita per il governo Berlusconi. Questo è l’atteggiamento che ha contrassegnato questa vicenda.
Ancora una volta, in questa occasione emerge la concezione che è propria di questo governo e di questa maggioranza, secondo la quale chi vince le elezioni possiede le istituzioni, ne è il proprietario. Questo è un errore. È una concezione profondamente sbagliata. Le istituzioni sono di tutti, di chi è al governo e di chi è all’opposizione. La cosa grave è che, questa volta, vittima di questa vostra concezione è la nostra Costituzione.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- Shoah, ecco l’anno zero di Heidegger. Pensare dopo Auschwitz significa uscire da una sintassi autistica (Donatella Di Cesare).9 febbraio 2015, di Federico La Sala
Shoah, ecco l’anno zero di Heidegger Dopo i Quaderni neri. La pubblicazione dei testi dove lo sterminio degli ebrei è definito un autoannientamento segna una svolta
Dopo i Quaderni neri. La pubblicazione dei testi dove lo sterminio degli ebrei è definito un autoannientamento segna una svolta
 Che rilancia la necessità di interrogare a fondo il pensiero del filosofo, senza dividersi tra fan e avversari
Che rilancia la necessità di interrogare a fondo il pensiero del filosofo, senza dividersi tra fan e avversaridi Donatella Di Cesare (Corriere della Sera, 09.02.2015)
Qualcuno definisce già il 2014 l’anno zero di Heidegger. L’affermazione è azzardata. Ma certo l’uscita dei Quaderni neri segna nel confronto con il pensiero del filosofo tedesco una svolta la cui portata e i cui esiti non possono oggi essere previsti. Tanto più che la pubblicazione è ancora in corso e il prossimo volume, che va dal 1942 al 1948, è atteso in Germania ai primi di marzo. Proprio per questo è indispensabile evitare le reazioni emotive, i giudizi precipitosi e sommari. Per quanto sia estremamente difficile, occorre invece continuare a interrogarsi e, anzi, mantenere aperte le domande. Serve, insomma, l’esercizio della filosofia.
D’altronde qui non si parla di un dettaglio biografico né di un «errore politico». In tal senso la questione è ben diversa da quella sollevata da Victor Farías e, anni più tardi, da Emmanuel Faye. I Quaderni neri sono testi scritti da Heidegger che ne aveva progettato la pubblicazione. E per di più sono testi strettamente connessi con la sua opera. Il nodo è filosofico . Dissento perciò dalla dichiarazione che ha rilasciato Gianni Vattimo all’«Ansa», perché se Heidegger cede alla metafisica nel definire gli ebrei e l’ebraismo - come io stessa ho indicato nel mio libro - quel che dice nei Quaderni neri non può essere derubricato a dottrina, da tenere separata dalla filosofia. Non sarà più possibile nel futuro, per qualsiasi studio critico, far finta che quest’opera non esista.
Se oggi possiamo leggere i Quaderni neri è grazie anzitutto al lavoro editoriale di Peter Trawny e alle sue riflessioni contenute nel volume Heidegger und der Mythos der jüdischen Weltverschwörung (Heidegger e il mito del complotto ebraico), che sta per essere pubblicato da Klostermann nella terza edizione. Decisivo è stato il convegno Heidegger et les «juifs» organizzato a Parigi, tra il 22 e il 25 gennaio scorso, da Joseh Cohen e da Raphael Zagury-Orly, che sono riusciti nell’ardua impresa di far discutere filosofi molto diversi: da Peter Sloterdijk a Alain Finkielkraut, da Maurice Olender a Bernard-Henri Lévy. Al di là dei singoli importanti contributi, è emersa l’esigenza di proseguire la discussione critica senza cadere in preclusioni o chiusure affrettate.
Più frastagliato appare il panorama della filosofia tedesca, ancora profondamente segnata dalla rimozione del nazismo e meno disposta a parlare apertamente di Auschwitz e della «questione ebraica». Ma rifiutare d’improvviso Heidegger, come ha fatto di recente Günter Figal, dimettendosi dalla carica di presidente della Società Martin Heidegger, non vuol dire forse eludere il confronto con quel che è accaduto solo qualche decennio fa?
Se nei Quaderni neri che sono stati pubblicati (i volumi 94-96 delle opere complete) è venuto alla luce, in tutta la sua rilevanza, l’antisemitismo metafisico, nei quaderni che stanno per uscire (il volume 97) è cancellato per sempre il silenzio sulla Shoah. Nello sterminio - come ho sottolineato nell’articolo uscito ieri su «la Lettura» - Heidegger vede un autoannientamento degli ebrei. «Solo quando quel che è essenzialmente “ebraico”, in senso metafisico, lotta contro quel che è ebraico, viene raggiunto il culmine dell’autoannientamento nella storia».
In una delle sue lezioni talmudiche Emmanuel Lévinas, allievo di Heidegger a Friburgo, ha detto che si potrebbe perdonare «chi abbia parlato senza coscienza». Ma le cose stanno diversamente quando si tratta di un «geniale Rav», un maestro chiamato a un grande destino. «Si possono perdonare molti tedeschi, ma ci sono tedeschi a cui è difficile perdonare. È difficile perdonare Heidegger». Queste parole, che assumono ora un significato ancor più profondo, non esimono tuttavia dal compito di studiare attentamente le pagine di Heidegger e di guardare alla Shoah in una prospettiva inedita. Perché la Shoah non è solo una questione storica, ma è una questione filosofica che coinvolge direttamente la filosofia.
Le responsabilità di una lunga tradizione di pensiero devono essere ancora accertate e discusse. Così come la storia dell’antisemitismo nella filosofia attende ancora di essere scritta. Si presume spesso di sapere che cosa sia l’antisemitismo, che cosa sia la Shoah. Soprattutto in Italia questo ha dato luogo a confusioni pericolose e a sterili polemiche, come quelle suscitate nel giorno della memoria.
Certo che, come diceva già Primo Levi, ci sono state genocidi sia prima, sia dopo Auschwitz. Se i paragoni sono necessari, perché la Shoah fa parte della storia, occorre tuttavia guardare alle peculiarità di un annientamento che ancor oggi sfuggono. Nei campi di sterminio - che vanno distinti dai campi di concentramento o di lavoro - l’industria della morte lavorava giorno e notte per la «soluzione finale», cioè per eliminare il popolo ebraico dal pianeta. Le camere a gas sono state il luogo incancellabile di un progetto sistematico di «depurazione».
Ma lo sterminio è stato senza precedenti anche perché non era mai avvenuto che si uccidesse in una catena di montaggio. Il processo di industrializzazione della morte, che assunse la precisione quasi rituale della tecnica, trovò nell’uso del gas un cambiamento di qualità. Le gassazioni su scala industriale hanno introdotto l’anonimato dei carnefici di fronte alle vittime senza nome e hanno consentito la frantumazione della responsabilità. Non è un caso che l’etica sia stata uno dei grandi temi dopo la Shoah. I principi che la filosofia ha ritenuto validi non hanno retto alla prova di Auschwitz, dove il limite etico ha perso ogni senso di fronte alla degradazione dell’umano, alla privazione della dignità, non solo della vita, ma persino della morte.
Pensare dopo Auschwitz significa uscire da una sintassi autistica per avviarsi non verso una libertà astratta, bensì verso una liberazione che, come quella dell’esodo, si realizza ogni volta con l’altro. L’esodo è il passo in fuori compiuto da un sé consapevole di essere sempre preceduto dall’altro che lo interroga, a cui è chiamato a rispondere. Non per un atto di adesione volontaria, ma perché è in quel volgersi che si costituisce come io, senza altra possibilità di scelta. E come l’altro precede il sé, così la responsabilità precede la libertà. Questa inversione del cammino è la sovversione ebraica che ha segnato la rottura nell’asse dell’Essere.
Non è, dunque, neppure un caso che a rilanciare, nella seconda metà del Novecento, la questione della responsabilità siano stati i filosofi ebrei, da Hans Jonas a Hannah Arendt e a Günther Anders, da Emmanuel Lévinas a Jacques Derrida, tutti allievi diretti o indiretti di Heidegger. Come spiegarlo? E sarebbe immaginabile il loro contributo senza il suo pensiero? Queste domande restano aperte. Ma una precisazione è indispensabile. Leggere Heidegger, confrontarsi con le frasi inquietanti dei Quaderni neri , non significa aderire a quel che ha scritto. La filosofia non è - come alcuni credono - un match calcistico, la sfida di una squadra contro l’altra; non si riduce al pro e al contro. Chi filosofa sopporta la complessità e abita nel chiaroscuro della riflessione.
Bibliografia
I taccuini postumi contengono la giustificazione dell’antisemitismo *
Il passo in cui Martin Heidegger si riferisce alle persecuzioni naziste come a un «autoannientamento» ( Selbstvernichtung ) degli ebrei si trova nel quarto volume dei Quaderni neri , che sarà pubblicato all’inizio di marzo in Germania dall’editore Klostermann. Negli anni Settanta il filosofo consegnò all’Archivio di Letteratura tedesca di Marbach sul Neckar 34 quaderni rilegati con una tela cerata nera, disponendo che fossero pubblicati a conclusione delle sue Opere complete (Gesamtausgabe ). Essi contengono riflessioni filosofiche annotate da Heidegger tra il 1931 (manca un quaderno risalente al 1930) e il 1969.
 Una prima parte di questi Quaderni neri , relativa al 1931-1941, è uscita lo scorso anno in Germania a cura di Peter Trawny, suscitando forti polemiche per alcuni brani antisemiti: si tratta dei volumi 94, 95 e 96 delle Opere complete. In Italia li sta traducendo Alessandra Iadicicco per Bompiani: un primo volume uscirà in settembre, gli altri due nel 2016, all’interno della collana «Il pensiero occidentale».
Una prima parte di questi Quaderni neri , relativa al 1931-1941, è uscita lo scorso anno in Germania a cura di Peter Trawny, suscitando forti polemiche per alcuni brani antisemiti: si tratta dei volumi 94, 95 e 96 delle Opere complete. In Italia li sta traducendo Alessandra Iadicicco per Bompiani: un primo volume uscirà in settembre, gli altri due nel 2016, all’interno della collana «Il pensiero occidentale».
 Il volume in arrivo presso Klostermann, curato sempre da Trawny, è invece il 97 delle Opere complete e include i Quaderni neri dal 1942 al 1948. All’analisi dei primi tre volumi Donatella Di Cesare, docente di Filosofia teoretica e vicepresidente della Martin Heidegger Gesellschaft (Società Martin Heidegger), ha dedicato il saggio Heidegger e gli ebrei. I «Quaderni neri», pubblicato nello scorso autunno da Bollati Boringhieri (pagine 352, e 17) . I contenuti del libro sono stati anticipati dall’autrice sulla «Lettura» del 2 novembre 2014. (a. car.)
Il volume in arrivo presso Klostermann, curato sempre da Trawny, è invece il 97 delle Opere complete e include i Quaderni neri dal 1942 al 1948. All’analisi dei primi tre volumi Donatella Di Cesare, docente di Filosofia teoretica e vicepresidente della Martin Heidegger Gesellschaft (Società Martin Heidegger), ha dedicato il saggio Heidegger e gli ebrei. I «Quaderni neri», pubblicato nello scorso autunno da Bollati Boringhieri (pagine 352, e 17) . I contenuti del libro sono stati anticipati dall’autrice sulla «Lettura» del 2 novembre 2014. (a. car.) Tweet e condivisioni
Tweet e condivisioni
 Lo «choc» va in Rete
Lo «choc» va in Rete
 Ma Vattimo lo difende *
Ma Vattimo lo difende *«Choc», «svolta»: dopo le rivelazioni sul pensiero di Martin Heidegger sono queste, sul web, le parole più ricorrenti. A suscitare reazioni è la tesi del filosofo secondo cui gli ebrei «si sono autoannientati», riportata ieri su «la Lettura», il supplemento del «Corriere», dalla studiosa Donatella Di Cesare. Rilanciata dal sito Corriere.it, la dichiarazione ha ottenuto grande popolarità in Rete (hashtag: #Heidegger ). Tra le reazioni quella del filosofo Gianni Vattimo che ha «difeso» Heidegger: «Ha sempre creduto di non essere corresponsabile con il nazismo». Per Vattimo ha sbagliato filosoficamente («un errore concettuale») ma non ci sono sufficienti ragioni per ritenerlo «un apologeta dello sterminio». (s.col.)
* Corriere della Sera, 09.02.2015
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- Un genio fallito, la banalità del male, e i Giusti. Una nota di Amedeo Vigorelli su Martin Heidegger12 febbraio 2015, di Federico La Sala
Editoriali *
Un genio fallito
Amedeo Vigorelli su Martin Heidegger *
La polemica su Heidegger e il nazismo è fuoruscita ormai dai circuiti accademici, per invadere il variopinto mondo della comunicazione e dei social network. Sono lontani i tempi in cui Jaspers, Adorno o Carnap, muovendo da opposte prospettive ideologiche (spiritualismo, marxismo, neopositivismo), mettevano sotto accusa il pensiero dell’essere del solitario di Meßkirch, bollandolo come intrinsecamente reazionario e politicamente compromesso con Nazionalsocialismo. E forse sono consumati anche i tempi in cui le popolose famiglie di ermeneuti, fenomenologi e decostruzionisti (francesi e italiani soprattutto) si confrontavano accesamente (ma in fondo pudicamente) tra loro, circa le implicazioni conservatrici del suo pensiero, la continuità o discontinuità tra il primo e il secondo Heidegger, dividendosi tra accusatori implacabili (Victor Farias) e avvocati difensori (François Fédier, Gianni Vattimo) che cercavano di salvarne la fama di pensatore imprescindibile della contemporaneità, ora con argomenti storici, ora con distinzioni un po’ acrobatiche tra ciò che può valere in teoria e ciò che vale nella pratica.
Ormai il dibattito (e lo scandalo) è fuoriuscito dai recinti universitari e minaccia le certezze del senso comune. Così il Corriere della Sera può intitolare: nei Quaderni neri del 1942-1948, di prossima pubblicazione (non dimenticate di comprare il libro), è rivelata finalmente la verità sull’antisemitismo di Heidegger, mediante le sue stesse parole. Con la Shoah “gli ebrei si sono autoannientati”: altro che piangersi vittime di una ingiustizia unica e di un male radicale senza precedenti e senza misura comune con la nostra umanità! L’articolo diventa “virale” (parola orrenda, ma che pare ormai obbligatorio usare) sui social network e proprio da qui Gianni Vattimo risponde, salvando l’Heidegger grande pensatore della tecnica dal pover’ uomo (un tipico professore tedesco), che aveva idee un po’ confuse sulla politica (mentre il nostro, come ben noto, ha idee chiarissime e coerentissime, in tal campo, da alcuni decenni almeno).
Che dire di fronte a un tal frastuono, che avrebbe indotto Leopardi, se ancora fosse vivo e in salute, a scrivere forse nuovi Paralipomeni alla Batracomiomachia? Direi che la questione vada impostata sul piano del giudizio morale e della deontologia professionale dei filosofi, prima e indipendentemente dal fatto che essa venga mai del tutto rischiarata dal metodo storico e filologico. Liberi gli studiosi di dividersi ancora per anni tra Destre e Sinistre (quasi Heidegger fosse il nuovo Hegel); liberi i giovani studenti di filosofia di appassionarsi e di soffrire sulla prosa oscura del novello Platone, compiangendo o scusando l’antica debolezza di quanti nei secoli hanno vagheggiato “la filosofia al potere”, per le peggiori tirannie e totalitarismi (del resto, le loro erano innocue utopie). Ma un criterio più semplice, invalso come etica della responsabilità (nella versione kantiana) o come consequenzialismo (nella versione empirista) può essere applicato anche ai maestri del pensiero.
Hannah Arendt lo ha invocato a proposito di Eichmann, nella celebre (e sempre fraintesa) definizione della banalità del male. Con essa, non voleva certo giustificare la responsabilità dei carnefici, rendendo corresponsabili le vittime del male sofferto. Ella intendeva piuttosto indicare nel pensare la vera fonte della responsabilità etica. La banalità insorge appunto nella rinunzia al pensiero, da parte di chi si professa semplice esecutore di ordini, con la buona coscienza del burocrate. Sembrerebbe, dunque, per principio escluso chi - come Heidegger - non ha mai rinunziato al pensiero, ma ne ha fatto l’attività esclusiva, sottratta alla pratica, dopo le dure lezioni della storia. Ma nell’età del totalitarismo (per alcuni, il Nazismo come male assoluto e unico; per altri, più smagati o disingannati, il Supercapitalismo o la Superciviltà odierna, con i suoi ormai riconosciuti tratti universalistici) non può esistere più separatezza contemplativa tra teoria e prassi, né buona coscienza professionale (burocratica, di ruolo, di ceto politico o accademico), che difenda l’intellettuale dall’accusa dell’ultimo uomo, che grida ormai dalle piazze ai potenti: il re è nudo. Certo, il più spregevole, con Nietzsche, ma anche il più simile a noi, quando osiamo guardarci nello specchio, ma non per un’auto-conferma narcisistica). Heidegger non è né più né meno corresponsabile del tedesco comune (quei “mirmidoni”, che la Merkel difende con tanto accanimento dalle minacce provenienti dalle “cicale” greche o magno-greche) della banalità del male novecentesco. Peccati di omissione, indifferenza, viltà, vanità, cedevolezza alle sirene del potere, hanno convissuto con la dignità dei pochi uomini morali, che hanno saputo sacrificare qualcosa del proprio amore di sé al senso (innato o coltivato) di giustizia.
Oggi li chiamiamo i giusti, e ne curiamo la preziosa memoria. Forse potremmo definirli semplicemente non banali, ossia individui che non si sono lasciati assorbire dalla massa, per confondere la propria singolare (e insostituibile) responsabilità. Quello di divenire persone è un peso come il sostenersi in vita, ma è alla portata di tutti ed è non meno necessario. Le giovani e promettenti leve intellettuali possono ben continuare ad aspirare alla gloria del genio, purché ricordino che anche il genio può miseramente fallire, quando coltiva unilateralmente il pensiero e smarrisce la propria umanità.
* Gariwo: la foresta dei giusti -> Analisi di Amedeo Vigorelli, docente di Filosofia morale all’Università degli Studi di Milano
-
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- FILOSOFIA IN STATO COMATOSO. Hegel, la talpa non parla più alla civetta (di Federico Vercellone).3 febbraio 2015, di Federico La Sala
- FILOSOFIA IN STATO COMATOSO. IL PARADOSSO DELL’IDENTITA’: IO E GLI ALTRI. REMO BODEI CERCA DI SVEGLIARSI E SI RIATTACCA AL VECCHIO E LOGORO FILO POPPERIANO.
Hegel, la talpa non parla più alla civettadi Federico Vercellone (La Stampa, 03.02.2015)
Quando Hegel afferma nei Lineamenti di filosofia del diritto che «la filosofia è il proprio tempo appreso nel pensiero» non si limita a proporre un ruolo egemone della filosofia nell’ambito del sapere, ma addirittura di riassumere nel proprio seno l’andamento stesso del mondo. Questo ruolo egemone viene assunto, secondo Hegel, dalla filosofia, e ciò significa che la filosofia stessa è responsabile nei confronti del proprio tempo, che l’astratto è ben più concreto di quel che erroneamente si ritiene. Questo può suonare molto eccentrico alle nostre orecchie abituate a pensare che la filosofia possa al massimo riflettere su quello che è o accade ma difficilmente influenzarlo.
Proprio su questi temi ritorna Remo Bodei riscrivendo il suo primo libro, Sistema ed epoca in Hegel, uscito nel 1975, ora ripubblicato, sempre da Il Mulino, in una nuova versione con il nuovo titolo La civetta e la talpa cui fa seguito, come sottotitolo, il titolo antico.
Che cosa significa per un filosofo e per un grande esegeta come Bodei riaggiustare la prospettiva su di un gigante come Hegel a distanza di quasi quarant’anni? Che aspetto assume il pensiero di Hegel dopo il tramonto del marxismo del quale, nella cultura filosofica del Novecento, le interpretazioni del pensiero hegeliano sono state molto spesso congiunte? Qual è il nuovo volto di Hegel dopo la caduta del Muro di Berlino, dopo il declino della cultura postmoderna dominata, fra l’altro, da una costellazione filosofica molto variegata che va da Deleuze, a Derrida a Martin Heidegger?
In questo importantissimo libro, che è ormai parte integrante della grande tradizione degli studi hegeliani italiani e insieme, dell’ermeneutica della cultura del nostro tempo, Bodei mostra, tra le altre cose, che l’epoca alla quale apparteniamo non è più in grado di mettere insieme la talpa del negativo hegeliano che scava e plasma la realtà con la civetta del pensiero che la organizza nel sistema del sapere speculativo.
Nell’universo globalizzato l’inquietudine del pensiero non potrà ma più coniugarsi con lo sguardo panoramico che si appaga della propria riuscita costruzione. In questa lacerazione ci tocca vivere e pensare.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- Il Nazareno Prima dei patti viene la dignità (di Maurizio Viroli).30 gennaio 2015, di Federico La Sala
MEMORIA E STORIA. L’Italia e... Il Nazareno Prima dei patti viene la dignità:
Il NazarenoPrima dei patti viene la dignità
di Maurizio Viroli (il Fatto, 30.01.2015)
Credo che non sia scritto in alcuna dichiarazione, ma per me è il più importante fra i diritti. Parlo del diritto alla dignità, quel sentimento interiore di piccola stima nei confronti di noi stessi per quel che abbiamo fatto e facciamo, e per quel che siamo.
Proprio perché sentimento interiore che emerge dal dialogo con la nostra coscienza e non dall’opinione degli altri, e ancora meno dal riconoscimento delle Costituzioni e delle leggi, nessuno, tranne noi stessi, può toglierci la dignità.
Ma è vero anche che ciascuno di noi porta con sé nel mondo il dato di essere italiano o italiana. Essere italiani oggi vuol dire essere sottoposti alle decisioni prese da un delinquente cacciato dal Parlamento in combutta con un giovanotto che asseconda il suo desiderio di continuare a essere arbitro della politica italiana, con l’avallo di una pletora di servi dell’uno e dell’altro incapaci di dire semplicemente “No!, le indecenze dei vostri incontri segreti non mi riguardano, il mio solo commento è il disprezzo”.
La dignità, ecco quello che ci ha tolto e ci toglie il patto fra Berlusconi e Renzi. Con quel loro accordo ci hanno detto e dicono ogni giorno, con il sorriso sprezzante di chi sa di poter fare ciò che vuole, che l’onestà, la rettitudine, la lealtà alla Repubblica non valgono assolutamente nulla. Conta essere evasori fiscali, sodali di corruttori di giudici, sostenitori di collusi con la mafia. Queste sono le persone con le quali si può eleggere il capo dello Stato, suprema magistratura di garanzia, riformare la legge elettorale, riscrivere la Costituzione.
Se sei una persona onesta e credi nella libertà repubblicana, nell’Italia di Renzi e di Berlusconi vali meno di niente. Ti deridono. Coprono le loro ripugnanti azioni con argomenti ispirati ai triti luoghi comuni della necessità politica. “Ci vuole una legge elettorale che assicuri solidi governi mediante generosi premi di maggioranza”; “bisogna abolire il Senato elettivo per semplificare e accelerare il processo legislativo”, gridano a gran voce. Sono balle che non troverebbero ascolto in nessun consesso civile.
La prova più eloquente che non c’è alcun bisogno di togliere di mezzo il Senato per legiferare è il fatto stesso che questo governo legifera, eccome. Delle due l’una: o Renzi mente quando sbandiera che il suo governo ha “fatto” tante leggi; o mente quando proclama che con l’attuale Costituzione è praticamente impossibile legiferare. In termini di filosofia politica, quella che mi onoro di insegnare da trent’anni fuori d’Italia, ovviamente, il comportamento di Renzi e dei suoi si fonda sul presupposto di poter ingannare i cittadini a suo piacere. Tanto non la capiscono. O fanno finta di non capire?
SONO DUNQUE due i motivi per i quali ci dobbiamo vergognare: essere di fatto governati da un delinquente assecondato da un giovinotto, essere trattati come deficienti. Quel che più avvilisce e indigna è che nessuno compie un passo deciso per uscire dalla palude, formare un partito di dignità repubblicana e civile, alzare una bandiera. Cosa aspettate, persone perbene che state a soffrire nel Pd e fate ormai fatica a guardarvi allo specchio perché sapete che non valete nulla e vi trattano da poveri idioti?
In politica una delle virtù essenziali è la capacità di cogliere l’occasione. Orbene, l’occasione è adesso. Se aspettate che vada al Quirinale il burattino di Renzi e Berlusconi, e poi disfino la Costituzione, sarà troppo tardi per qualsiasi efficacie azione politica.
“Dove eravate?”, vi chiederanno, e vi chiederò, quando Renzi e Berlusconi disfacevano pezzo a pezzo la Repubblica? Non saprete rispondere e sarete finiti una volta per tutte. Perdere una lotta politica non è una tragedia; perdere la dignità sì.
Se poi, per miracolo o per un momento di illuminazione di Renzi non andrà al Quirinale un prodotto dell’accordo con Berlusconi, tanto di guadagnato per la Repubblica. Ma in questo caso bisognerebbe chiedere a Renzi perché ha aspettato tanto a rompere con Berlusconi e perché gli ha concesso tanti favori?
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- UN MONDO «POPOLATO DA CIVILI FANTASMI CARTESIANI», IL {COGITO} ROVESCIATO, E IL «SE IO FOSSI DIO» AD AUSCHWITZ DI PRIMO LEVI (di Sergio Luzzatto).26 gennaio 2015, di Federico La Sala
UN MONDO «POPOLATO DA CIVILI FANTASMI CARTESIANI», IL COGITO ROVESCIATO, E IL «SE IO FOSSI DIO» AD AUSCHWITZ DI PRIMO LEVI ...
Primo Levi
«Se io fossi Dio» ad Auschwitz
Jean-Claude Milner analizza le tredici righe di «Se questo è un uomo» sulla preghiera di Kuhn, l’ebreo devoto: e le cartesiane ragioni per cui il chimico rigettò quella preghiera
di Sergio Luzzatto (Il Sole-24 Ore - Domenica, 25.1.15)
- Jean-Claude Milner, La puissance du détail. Phrases célèbres et fragments en philosophie, Grasset, Parigi, pagg. 276, € 19,00
Tutti i lettori dell’opera di Primo Levi sanno quanto lo scrittore torinese fosse capace di cogliere la potenza del dettaglio. Quanto fosse abile nel riconoscere e nel soppesare anche la più piccola dose di umana o disumana materia dissolta nella massa molare del mondo. Era questa un’arte che il giovane chimico aveva applicato già negli inferi di Auschwitz, e di cui aveva fatto immediato tesoro di ritorno fra i vivi. L’esperienza restituita in Se questo è un uomo va considerata anche un «esperimento mentale» (come lo ha definito Massimo Bucciantini) volto all’identificazione e alla pesatura degli ingredienti costitutivi del campo di sterminio. La narrazione di Se questo è un uomo potrebbe essere letta, al limite, come niente più che un’implacata e implacabile collezione di dettagli antropologici.
Così, giunge opportuna l’inclusione di Levi nel libro che un linguista e filosofo francese, Jean-Claude Milner, ha titolato La puissance du détail. Un intero capitolo del volume è dedicato a un singolo passo di Se questo è un uomo: la mezza pagina di chiusura del capitolo dove si racconta di una «selezione» ad Auschwitz-Monowitz. Le tredici righe di «Ottobre 1944» in cui Levi introduce e congeda - fra gli scampati della sua baracca alla selezione per le camere a gas - la figura di Kuhn.
- «A poco a poco prevale il silenzio, e allora, dalla mia cuccetta che è al terzo piano, si vede e si sente che il vecchio Kuhn prega, ad alta voce, col berretto in testa e dondolando il busto con violenza. Kuhn ringrazia Dio perché non è stato scelto. / Kuhn è un insensato. Non vede, nella cuccetta accanto, Beppo il greco che ha vent’anni, e dopodomani andrà in gas, e lo sa, e se ne sta sdraiato e guarda fisso la lampadina senza dire niente e senza pensare più niente? Non sa Kuhn che la prossima volta sarà la sua volta? Non capisce Kuhn che è accaduto oggi un abominio che nessuna preghiera propiziatoria, nessun perdono, nessuna espiazione dei colpevoli, nulla insomma che sia in potere dell’uomo di fare, potrà risanare mai più? / Se io fossi Dio, sputerei a terra la preghiera di Kuhn».
Secondo Milner queste tredici righe contengono, nella forma breve tipica di Se questo è un uomo, l’alfa e l’omega del giudizio di Primo Levi sulla metafisica dopo Auschwitz. E li contengono a partire da una riflessione che risulta modellata sulle Meditazioni di Cartesio: una meditazione di fine giornata, nel silenzio propizio alla contemplazione di Dio, con il carattere di un ragionamento sillogistico, e con l’assunzione di responsabilità consistente nel ragionare di cose ultime dicendo «io». Senonché l’esito della meditazione di Levi è un Cogito rovesciato. Ha la forza (forza folle, tiene a precisare Milner) di uno sputo metafisico.
Occorrerà - prima o poi - rileggere tutto Primo Levi alla luce dei suoi pronomi personali: cercare un qualche sistema periodico nell’uso leviano dell’«io», del «tu», del «noi», del «voi»... E chi si metterà all’opera dovrà fare i conti, giocoforza, con la mezza pagina sul vecchio Kuhn e con quel periodo ipotetico, «Se io fossi Dio»: con l’impressionante occorrenza di un io che, da Dio consapevole della Soluzione finale, sputa a terra la preghiera dell’ebreo salvato. Per il momento, bisogna contentarsi di seguire Jean-Claude Milner, la sua lettura di tredici righe fra le più impegnative che Levi abbia mai scritto.
Il Dio verso il quale Kuhn eleva dondolante la sua preghiera, per averlo salvato dalla selezione e magari perché torni a salvarlo una prossima volta, corrisponde al prototipo stesso del genio maligno di Cartesio. Il campo di sterminio esclude infatti, ipso facto, un cartesiano «dubbio radicale». Al di qua di ogni possibile dubbio filosofico, Auschwitz esiste. E siccome Auschwitz esiste, il Dio d’Israele non può esistere altro che come grande ingannatore. Kuhn è pazzo a pregare un Dio simile. E Kuhn è cieco a non vedere Beppo il greco. Il quale, nell’interpretazione di Milner, non corrisponde soltanto al prototipo del «sommerso»: l’uomo in dissolvimento, il «mussulmano» che attende inerte di andare in gas. Beppo il greco vale almeno altrettanto da incarnazione stoica, ventenne figura della saggezza.
Nessuno più lontano di Beppo dagli altri greci deportati ad Auschwitz che l’autore di Se questo è un uomo ha evocato, in un capitolo precedente, con toni da epopea: «Ammirevoli e terribili ebrei Saloniki tenaci, ladri, saggi, feroci e solidali, così determinati a vivere e così spietati avversari nella lotta per la vita». Nella sua immobilità di morituro, Beppo ha la capacità di sopportazione e di astensione di Epitteto. E oltreché una figura stoica, Milner riconosce in lui una figura platonica. Coricato, muto, lo sguardo fisso, Beppo è il Socrate del Fedone. Ma con una differenza decisiva. Ad Atene, la morte di Socrate realizza il compimento della filosofia. Ad Auschwitz, la morte di Beppo nulla garantisce in materia di immortalità dell’anima. «Beppo figura la saggezza amputata del logos».
L’animata preghiera di Kuhn rimanda a una fede ormai possibile unicamente come fede cieca e ipocrita, farisaica: mentre la rassegnata inerzia di Beppo, la sua saggezza ormai priva di pensiero e di linguaggio, conserva almeno la dignità della ragione classica. E anche perciò Levi scrive Se questo è un uomo, non Se questo è un ebreo: perché «lo sterminio colpisce l’umanità attraverso gli ebrei; ma il punto d’umanità che lo sterminio raggiunge attraverso gli ebrei e negli ebrei prende immediatamente il nome di un greco». Insomma: il poco o nulla che resta della ragione di Atene rivela a Levi, nella baracca di Monowitz, tutta la follia di Gerusalemme. Kuhn è pazzo non perché prega, ma perché prega da ebreo. Beppo è saggio non perché attende la morte, ma perché la attende da greco.
Altrettante impressioni e conclusioni - queste di Jean-Claude Milner - che meriteranno di essere attentamente valutate, ed eventualmente criticate da lettori e cultori di Primo Levi. Qui resta da sottolineare l’interesse di una lettura “cartesiana” dell’episodio di Kuhn alla luce di un passo che Milner curiosamente rinuncia a citare, mentre dall’edizione del 1958 se ne sta lì, bene in vista se non ben chiaro, nella primissima pagina di testo di Se questo è un uomo: la descrizione che Levi ha proposto del suo mondo mentale di prima della deportazione, un mondo «popolato da civili fantasmi cartesiani».
Nel 1976, Levi avrebbe spiegato come i suoi fantasmi cartesiani d’ante-Auschwitz andassero intesi quali «sogni e propositi forse mal realizzabili, ma non confusi, bensì razionali e logici». È una definizione che perfettamente si attaglia - in fondo - anche al suo Cogito rovesciato di Monowitz. Al vertiginoso suo periodo ipotetico, «Se io fossi Dio», e al salivare suo rigetto della preghiera di Kuhn.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- CAPO CARISMATICO E DEMOCRAZIA DI MASSA. Lettera di Norberto Bobbio a Luisa Mangoni.23 gennaio 2015, di Federico La Sala
CESARISMO, DEMOCRAZIA DI MASSA, E CAPO CARISMATICO. Come mai tutta la teoria politica marxistica non ha mai parlato volentieri del capo carismatico?
Lettera di Norberto Bobbio a Luisa Mangoni *
[...]
 TORINO , 16 marzo 1977
TORINO , 16 marzo 1977 Gentile signora,
Gentile signora, la ringrazio dell’estratto del suo articolo su cesarismo ecc. Un bel tema, che mi piacerebbe però vedere sviluppato meglio anche concettualmente. Lei per esempio accenna a un certo punto alla distinzione tra cesarismo e bonapartismo, poi se non sbaglio non la riprende più.
la ringrazio dell’estratto del suo articolo su cesarismo ecc. Un bel tema, che mi piacerebbe però vedere sviluppato meglio anche concettualmente. Lei per esempio accenna a un certo punto alla distinzione tra cesarismo e bonapartismo, poi se non sbaglio non la riprende più.
 Così il problema del rapporto tra cesarismo, democrazia di massa e capo carismatico, da cui parte, andrebbe meglio approfondito anche riguardo a Gramsci, che cita Michels a proposito del capo carismatico in un famoso passo sulla demagogia in senso negativo e sulla demagogia in senso positivo.
Così il problema del rapporto tra cesarismo, democrazia di massa e capo carismatico, da cui parte, andrebbe meglio approfondito anche riguardo a Gramsci, che cita Michels a proposito del capo carismatico in un famoso passo sulla demagogia in senso negativo e sulla demagogia in senso positivo.
 Il tema del capo carismatico è un tema che entra con forza nelle discussioni di quegli anni tra coloro che si rendono conto che è cominciata l’era della democrazia di massa (della “ribellione delle masse” per dirla con una espressione nota e negativa).
Il tema del capo carismatico è un tema che entra con forza nelle discussioni di quegli anni tra coloro che si rendono conto che è cominciata l’era della democrazia di massa (della “ribellione delle masse” per dirla con una espressione nota e negativa).
 Dal momento che lei ha dedicato l’ultima parte del suo articolo a Gramsci, perché non analizzare il suo pensiero anche su questo punto? Chi è “il demagogo superiore”? È anche lui un capo carismatico? Come mai tutta la teoria politica marxistica anche dopo Michels e dopo Weber non ha mai parlato volentieri del capo carismatico? (...)
Dal momento che lei ha dedicato l’ultima parte del suo articolo a Gramsci, perché non analizzare il suo pensiero anche su questo punto? Chi è “il demagogo superiore”? È anche lui un capo carismatico? Come mai tutta la teoria politica marxistica anche dopo Michels e dopo Weber non ha mai parlato volentieri del capo carismatico? (...)
 Cordiali saluti
Cordiali saluti
 Norberto Bobbio
Norberto Bobbio*
“Altro che cultura per me il fascismo fu solo retorica”
Nel carteggio del ’76 con Luisa Mangoni lo studioso difende le sue tesi: “Un’era di cortigiani e adulatori”
di Simonetta Fiori (la Repubblica, 23.01.2015)
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- CHI HA MAI SENTITO PARLARE DEL FILOSOFO CARLO LEVI?!6 gennaio 2015, di Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- "I TRADITORI DI SOCRATE": IL SOCRATISMO DI ROBERTA DE MONTICELLI E "LA CRISI DELLE SCIENZE EUROPEE".29 dicembre 2014, di Federico La Sala
"I TRADITORI DI SOCRATE". IL SOCRATISMO DI ROBERTA DE MONTICELLI E "LA CRISI DELLE SCIENZE EUROPEE".:
- ENZO PACI: "NICODEMO O DELLA NASCITA" (Testo ripreso da: Federico La Sala, Della Terra, il brillante colore, pp. 119-124)
I traditori di Socrate
di Roberta De Monticelli (Il Sole-24 Ore, Domenica, 28 dicembre 2014)
Enzo Paci pubblica nel 1968 per Il Saggiatore la traduzione italiana la Crisi delle scienze europee di Husserl. Sua la ricca e vivace introduzione: ma non una parola sulle circostanze in cui Husserl lo aveva scritto, fra il ’36 e il ’37, ultimo messaggio nella bottiglia all’umanità europea, nel rinnovato tradimento dei suoi chierici. Non una parola sul senso disperato di quell’espressione husserliana, il filosofo come «funzionario dell’umanità» sotto la penna di un uomo privato della sua funzione pubblica (come fu per le leggi antisemite). Ma soprattutto di un filosofo che vedeva tanto apertamente negati i due principi che Husserl propose come i due pilastri di un’Europa a venire. E cioè il principio di personalità - col suo corollario di (pari) dignità e diritti di tutte le persone; e l’universalismo della legge (di quella morale, certo - ma in linea di principio anche del diritto, sovra statuale e sovranazionale). Sono i due principi che dopo la guerra ponemmo a fondamento della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Essere Umano, e delle costituzioni delle Repubbliche rifondate, compresa la nostra.
Heidegger costruì il suo pensiero sulla negazione di quei due principi, e sulla loro sostituzione con due principi opposti: la concezione destinale della storia, con la rimozione dell’autonomia e della responsabilità morale degli individui; e l’adozione di un principio di comunità, radice e destino come esplicitamente più fondamentale di quello di personalità, e sulla base del quale fu possibile a H. esaltare il Fuehrerprinzip e i legami della terra e del sangue, salutando «l’intima grandezza del Nazionalsocialismo».
Ecco: come fu possibile non vedere in questi principi la demolizione della ragion pratica, oltre alla negazione violenta e sanguinaria dell’idea husserliana d’Europa? Di un’Europa che Husserl aveva visto come il paese che ci sradica, sì: perché al valore delle radici antepone la questione critica sulla propria identità, sull’ethos ricevuto, il vaglio di ogni tradizione e la veglia dell’interrogativo. Prima viene il chiedere ragione: perché? Questo che fai, perché lo fai? In che modo è giusto, o forse non lo è? Questo che dici, su quali basi d’evidenza lo dici?
Possono forse coesistere, quei due fondamenti del pensiero heideggeriano, con quell’idea di Europa che è sempre rinascente eccedenza dell’ideale sul reale e del diritto sul potere, del valore sul fatto e della ricerca sul dogma? Non possono, evidentemente. Ma vollero vederlo e insegnarcelo, i nostri maestri di allora? Macché. Non una parola, allora, non una parola per venti, trent’anni ancora su questo.
Non dal nostro maestro Paci, non da alcuno di quelli che, oh molto peggio, non hanno solo ignorato (come l’intera intellighentsja francese e poi italiana del secolo scorso, con poche luminose eccezioni) il nazismo di Heidegger, ma la sua radicale irresponsabilità logica e concettuale nell’uso del linguaggio, e anzi a tutt’oggi la imitano e la trasmettono, con i risultati che si sono visti, quanto alla presenza al nostro tempo dei filosofi della mia generazione, al nostro ruolo di coscienza critica e ragione indipendente nello spazio pubblico delle ragioni, di sentinelle della democrazia e di ispiratori di vera ricerca.
Parziale rimedio e simile stupore di fronte alla nostra indifferenza di quegli anni si trova nelle recenti Conversazioni su La crisi delle scienze europee di Husserl (reperibile presso Lulu.com all’indirizzo: http://www.lulu.com/shop/giovanni-piana/conversazioni-sulla-crisi-delle-scienze-europee-di-husserl/paperback/product-21316384.html) di un altro dei nostri maestri: Giovanni Piana, con il suo accorato flash sulla diversa umanità di maestro e allievo, al tempo in cui il primo (deposto dalla sua cattedra perché ebreo) denunciava il tradimento di Socrate, e il secondo scriveva infami lettere delatorie sui colleghi ebrei da rimuovere.
Oggi, mentre i Quaderni neri di Heidegger sono in via di traduzione italiana da Bompiani e anche a seguito del libro di Emmanuel Faye (Heidegger, l’introduzione del nazismo nella filosofia, L’asino d’oro edizioni, Roma 2012) appare a proposito Heidegger e gli ebrei. I Quaderni neri (Bollati Boringhieri, novembre 2014) di Donatella Di Cesare, che naturalmente meriterebbe una recensione a parte. E torna sulla questione con due tesi: l’attribuzione del nazismo di Heidegger essenzialmente al suo antisemitismo, e il salto di qualità metafisico che indubbiamente Heidegger avrebbe all’antisemitismo fatto compiere, sullo sfondo però di una tradizione antisemita che coinvolgerebbe l’intero pensiero filosofico occidentale, e non risparmierebbe, per citarne solo uno, neppure Kant. Proprio lui, il più ferreo assertore dell’universalismo morale, nelle due direzioni personalistica e cosmopolitica.
Ecco: proprio per questa ragione, e per un’esperienza personale di insegnamento simile a quella assai lucidamente esposta da Ermanno Bencivenga su queste pagine (30/11/2014), io non credo si possa ascrivere all’antisemitismo il peggiore tradimento di Socrate che la filosofia (non solo Heidegger) abbia perpetrato nel Novecento con le adesioni e i sostegni ai totalitarismi.
L’antisemitismo può essere un effetto accidentale della negazione di quel fondamento illuministico di una possibile civiltà che Husserl sentiva nutrire l’Inno alla gioia di Schiller e Beethoven. Ma quanta parte della filosofia accademica insegnata da noi, ancora per tutto il secolo scorso e forse ancora oggi, continua a vivere di quel pensiero ebbro e carismatico, «dittatoriale e irresponsabile» come «un incantesimo totalitario» (Jeanne Hersch), al seguito del quale la filosofia ha ancora per mezzo secolo dimenticato la sua vocazione socratica? E le dimissioni della ragione pratica hanno la loro bandiera ancora e sempre in una frase celebre di Heidegger, che un ragazzo mi ha orgogliosamente ribadito ieri a lezione: «Tanto peggio per la logica».
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- Mafia capitale è solo l’inizio. Il Paese che vive nella Terra di mezzo.5 dicembre 2014, di Federico La Sala
Il Paese che vive nella Terra di mezzo
di Roberto Saviano (la Repubblica, 05.12.2014)
SU “Mafia capitale” sappiamo tutto, abbiamo letto le cronache dell’operazione condotta dai Ros del generale Parente e dalla Procura di Roma guidata da Giuseppe Pignatone, abbiamo letto l’ordinanza del gip Flavia Costantini, ma non so se è chiaro a tutti cosa sia accaduto a Roma.
E COSA molto probabilmente sta accadendo altrove in Italia. Succede alla politica italiana ciò che sta accadendo alla società civile che guarda alla politica con schifo, senza riuscire a percepire le proprie responsabilità. Accade che in politica ci si venda, si ipotechi la propria anima per pochi spiccioli (ci sono mazzette da 750 euro prese senza la reale percezione della gravità della situazione come una legittima e piccola regalia). Accade che la politica non abbia autorevolezza e idee proprie, accade che la politica venga percepita come una occasione di guadagno, un mestiere che arriva senza dover studiare, senza curriculum ed esperienza.
La domanda è: ma come fanno personaggi che definiremmo “dalla storia ambigua”, come Salvatore Buzzi e Massimo Carminati, a diventare artefici, attori, protagonisti di vicende che assumono connotazioni grottesche? Un assassino e un ex terrorista, ex Nar, organico alla banda della Magliana. Il primo, Buzzi, aveva scontato la sua pena, il secondo Carminati era stato assolto, ma su di lui esistono pagine e pagine di informative e una stretta osservazione.
Ebbene Buzzi e Carminati in qualsiasi altro Paese condurrebbero la loro vita lavorativa sotto una strettissima sorveglianza, dovrebbero avere un comportamento talmente ligio da provare che si può uscire diversi dal carcere, da dimostrare che le assoluzioni sono opportunità di reinserimento e non salvacondotti.
E invece a Buzzi e Carminati la politica dà massima fiducia senza chiedere in cambio nessuna trasparenza. Ci si fida di loro, ciecamente. Vi siete chiesti come sia stata possibile una tale idiozia? In questi giorni il mantra è: colpevole è non solo chi è consapevole, ma anche chi non vuole vedere. E allora noi da che parte stiamo? Tra i colpevoli o tra quelli che non vogliono vedere? Dobbiamo scegliere, perché una terza via non esiste.
Come possono personaggi come Carminati e Buzzi apparire “affidabili”? Possono farlo perché siamo in Italia. Possono farlo perché in Italia ciò che si rifiuta e rifugge non è il rapporto con chi tutto sommato è peggio di noi, ma con chi è meglio. Con chi ha una immagine pulita si fa il tiro al bersaglio: il gioco è far cadere il simbolo positivo dal piedistallo. Ed ecco che chi si distingue per professionalità e rettitudine in una giunta comunale viene allontanato, con maggiore o minore clamore mediatico, a seconda delle circostanze, ma se intralci i giochi sei fuori.
I politicanti utilizzano e si legano a personaggi che non sono figure da poter demolire e che non vogliono cambiare il sistema e che abitano quel “mondo di mezzo” che Carminati, ha preso in prestito da Tolkien. «Ci stanno i vivi sopra e i morti sotto e noi stiamo nel mezzo. E allora vuol dire che ci sta un mondo, un mondo in mezzo, in cui tutti si incontrano. Anche la persona che sta nel sovramondo ha interesse che qualcuno del sottomondo gli faccia delle cose che non le può fare nessuno. Questa è la cosa... e tutto si mischia». Non è da leggere come è stato fatto sino ad ora come una “cerniera” tra teppa criminale e colletti bianchi. Questa è una vera e propria sintesi di filosofica economica.
Si parla chiaramente di un luogo trasversale dove ci si affida a chi “sa fare le cose”, chiunque egli sia. E qui arriva Salvatore Buzzi con le sue cooperative di disperati, di marginali, ex detenuti, immigrati che in un’Italia che non produce nulla, in un’Italia in cui le aziende muoiono, in un’Italia strangolata da un sistema fiscale irrazionale che in larga parte deve sopperire ai costi enormi e agli sprechi della politica, diventano una miniera d’oro.
In Italia è inevitabile che le emergenze diventino vere e proprie occasioni di profitto. La crisi dei rifiuti a Napoli ha irrorato la politica, la camorra e l’imprenditoria per oltre un decennio. Mare nostrum è stata una tragedia per tutti tranne che per Carminati e Buzzi. Per loro i barconi della speranza piuttosto che emergenza umanitaria, sono diventati un’enorme opportunità. «Ci fanno guadagnare più della droga», dicono. Quindi l’organizzazione mafiosa con a capo Carminati non guadagna con attività che tradizionalmente sono considerate criminali, ma con attività che invece godono di un’aura di nobiltà. Attività intoccabili, insospettabili.
Ma di umanitario e ideologico non è rimasto proprio nulla: l’ideologia non c’entra, gli affari sui rom, sull’emergenza case, sugli immigrati, li fanno paradossalmente proprio gli uomini di Alemanno, coloro i quali hanno partecipato alla giunta che meno si è distinta per solidarietà verso gli ultimi, verso i bisognosi e i disperati. Non c’è più colore politico, ecco perché verso gli estremisti della prima e dell’ultima ora non posso fare a meno di provare pena; non c’è colore: basti pensare che Carminati che proviene dalla estrema destra, si sceglie Buzzi come braccio destro, un uomo che proviene dalla estrema sinistra.
E poi ancora: dal momento che a predisporre e coordinare l’emergenza migranti è il tavolo di coordinamento nazionale presieduto dal ministero degli Interni, lì deve sedere un uomo che sia al soldo del duo Carminati-Buzzi. Quest’uomo è Luca Odevaine, che ricorda Mister Wolf di Pulp Fiction, il problem solver. Luca Odevaine è stato vice capo di Gabinetto della giunta Veltroni, poi capo della Polizia provinciale, poi capo della protezione civile con Zingaretti e infine al tavolo di Coordinamento nazionale sull’accoglienza per i richiedenti asilo. È lui, per intenderci, che prende in gestione la capitale quando muore Giovanni Paolo II. La trasversalità del sistema si basa su una macchina oleata fatta di mazzette grandi e piccole. Odevaine, secondo l’accusa, avrebbe percepito una mazzetta da cinquemila euro al mese.
Ma la cosa più interessante è che leggendo le carte dell’inchiesta si ha la sensazione che nessuno abbia reale consapevolezza del proprio status di corrotto. Quello che molti hanno preconizzato, ovvero che Tangentopoli fosse solo il punto di partenza di un’apocalisse politica e sociale definitiva si sta avverando. Ora i corrotti non solo si sentono legittimati a commettere illeciti, ma non hanno neanche più la consapevolezza della gravità dei loro comportamenti.
In tutto questo Matteo Renzi arriva tardi a commissariare il Pd di Roma. Prima della magistratura, la politica dovrebbe avere occhi, orecchie, dovrebbe ascoltare ogni sussulto, ogni sospiro. I segnali c’erano. E invece Renzi, che aveva tutti gli strumenti per sapere e per azzerare il Pd romano prima di questo terremoto giudiziario, lo fa dopo. Dall’altra parte - o dalla stessa parte anche se sembra si facciano guerra - c’è una destra sempre più disinvolta nell’occupare posizioni per trarne vantaggio, per condizionare la democrazia, anche usando la stampa locale che si presta al gioco, come è successo con Il Tempo diretto da Chiocci, che è arrivato a incontrare Carminati.
Mafia capitale è solo l’inizio. Altre inchieste in altre città dimostreranno che Roma non è un caso isolato. In altri Paesi europei esiste la corruzione, ma la corruzione non arriva a compromettere l’istituzione stessa: il corrotto è espulso dall’istituzione che è percepita come sacra e va salvaguardata. In Italia l’istituzione invece è utilizzata, lordata e non viene difesa.
Ma perché questo accade? Perché ormai si è impadronita di chiunque una consapevolezza: senza brigare non si va da nessuna parte. Senza forzature non succede niente, non cambia niente. Quindi in fondo la posizione bipartisan sembra essere questa: è inutile fingere di essere al di fuori o al di sopra. Tutti dobbiamo compromettere una parte del nostro lavoro, della nostra integrità, per ottenere qualcosa. Questa è la logica che emerge da “Mafia capitale”. Questa è la teoria del “Mondo di mezzo” di Carminati non portata alle estreme conseguenze, ma applicata a tutti noi. Da questo meccanismo nessuno si senta escluso, le mazzette trovate nelle buste con il logo di Roma Capitale ci riguardano, perché Roma Capitale siamo noi.
In questo Paese che non è capace di difendere il talento e l’impegno, dove tutti odiano tutti, dove tutti detestano chi ce la fa, in questo Paese tra il mondo dei vivi che sta sopra e il mondo dei morti che sta sotto, in mezzo ci siamo noi.
In mezzo c’è l’intero Paese che non riesce a reagire.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ... CHI PIU’ CHI MENO, TUTTI VIVONO DENTRO LA PIU’ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA E POLITICA ITALIANA, NEL REGNO DI "FORZA ITALIA"!!! --- Gli intellettuali (ahimè) ci sono (di Maurizio Viroli)4 ottobre 2014, di Federico La Sala
Gli intellettuali (ahimè) ci sono
di Maurizio Viroli (il Fatto, 04.10.2014)
Sarà contento Matteo Renzi - che or non è molto ha tuonato “basta con gli esperti e i professori professionisti della tartina che amano fare i pessimisti e ai convegni sono i primi a buttarsi sui buffet” - di apprendere dalle colonne de La Stampa pochi giorni fa a firma di Luigi La Spina, che l’Italia non ha più intellettuali.
Non solo, precisa l’autore, non si trovano “gli eredi di Croce e Gentile”, ma neppure quelli di Pasolini e delle sue “lucciaole”, di Sciascia contro i “professionisti dell’antimafia”, di Bobbio e delle sue polemiche con Togliatti, e via discorrendo. L’epidemia non ha badato agli schieramenti politici, e sono così caduti sia gli intellettuali organici e disorganici e gli “utili idioti” della sinistra, sia le “foglie di fico” dell’incolta destra. Una vera ecatombe. La via alle oscene riforme di Renzi, in fraterno sodalizio con Berlusconi, è aperta e luminosa.
Premetto che a mio parere sarebbe assai utile avere eredi di Croce ma del tutto deleterio avere eredi di Gentile perché sarebbero o mediocri studiosi o teorici dello stato totalitario o l’uno e l’altro, e proprio non se ne avverte la necessità. Né davvero arrecherebbero qualche bene allievi dello Sciascia che accusa di protagonismo Paolo Borsellino, mentre sarebbe una benedizione avere ancora il Bobbio che discute con Togliatti e anche il Bobbio che definisce Forza Italia un partito personale ed eversivo. Di quali intellettuali parla La Spina? Se si riferisce all’intellettuale cortigiano maestro nell’arte di adulare i potenti, allora altro che morte: ce ne sono a bizzeffe e scoppiano di salute ingrassati dai consigli di amministrazione, dai grandi giornali e dalle consulenze profumate.
DI QUELLA “razza dannata” come li apostrofava Rigoletto, nel nostro povero Paese, povero anche a causa loro, non c’è mai stata e mai ci sarà inopia. Se La Spina non ci crede legga sui giornali gli articoli di tanti suoi stimati colleghi grondanti di servo encomio all’apparire dell’astro Renzi, e prima ancora in occasione della rielezione di Giorgio Napolitano, e prima ancora quando Berlusconi regnava incontrastato. Per aiutarlo posso inviargli gli articoli di Marco Travaglio che raccolgono un florilegio di adulazioni davvero mirabile, se non fosse penoso. E La Spina è troppo colto per non sapere che gli editorialisti sono intellettuali a pieno titolo.
Se invece La Spina intende dire che non ci sono più intellettuali come Emile Zola che hanno il coraggio di denunciare la volgarità, la meschinità e l’arroganza dei potenti, allora non legge i libri che si stampano. Ci sono, eccome, studiose e studiosi giovani e vecchi che non hanno avuto e non hanno paura di smascherare e denunciare ieri il ripugnante sistema di potere di Berlusconi, oggi l’arroganza infantile di Renzi, le inaccettabili interferenze di Giorgio Napolitano sul Parlamento, il sistema della corruzione politica e gli intrecci fra la mafia e la politica, per citare soltanto alcuni dei problemi sui quali ancora intellettuali degni di rispetto scrivono. Non devono fuggire all’estero per sfuggire al carcere come Emile Zola, ma stai certo, caro La Spina, che gli intransigenti in Italia pagano in altri modi. Puoi disapprovare tutto ciò che scrivono, ma non dire che non ci sono più. Avresti dovuto trovare almeno una parola di rispetto.
SOTTOLINEA La Spina che gli intellettuali non hanno più la medesima incidenza sulla vita pubblica che avevano in passato. Non ne sarei così sicuro. Ho ascoltato la medesima considerazione anche trent’anni or sono, e proprio da Norberto Bobbio il più celebre e ascoltato dei nostri intellettuali del dopoguerra. Luigi Einaudi ha scritto Prediche inutili; data di pubblicazione: 1959. Verissimo che nei talk show buffoni e provocatori fanno miglior prova di chi offre dati seri e ragionamenti sensati. Ma allora il lamento va rivolto agli organizzatori di quelle indegne gazzarre, non agli intellettuali seri che o partecipano per avere una qualche sana incidenza o non partecipano per non abbassarsi a tanta volgarità.
Insomma, se siamo inutili, morti e sepolti perché il Presidente del Consiglio non perde occasione non per criticare i nostri argomenti, impresa per lui e i suoi troppo ardua, ma per sbeffeggiarci? O siamo morti, e allora lasciateci in pace; o siamo vivi e allora provate a discutere con un minimo di serietà. Mettetevi d’accordo.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- PAURA DELLA LIBERTA’: CARLO LEVI, NELL’ORIZZONTE DI VICO, BENJAMIN, ED ENZO PACI.8 settembre 2014, di Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- Se l’Italia non ha più intellettuali (di Luigi La Spina)29 settembre 2014
Se l’Italia non ha più intellettuali
di Luigi La Spina (La Stampa, 29/09/2014)
In questi anni si è celebrato uno strano funerale: dietro il carro del defunto nessun coro di lodi e di rimpianti, da parte degli amici, ma neanche irose condanne alla memoria, da parte dei nemici, solo il silenzio di chi si merita persino l’oblio di un nome ormai infamante, quello dell’intellettuale. Sì, in Italia, da qualche tempo, è sparito sulla scena pubblica un protagonista della storia politica e civile, una figura che, in vari modi e con diverso peso, aveva comunque esercitato, durante tutto il secolo scorso, un ruolo importante nell’influenzare il dibattito culturale nel nostro Paese.
Dove sono finiti gli eredi non solo di Croce e Gentile, ma di Pasolini e delle sue «lucciole», di Sciascia contro i «professionisti dell’antimafia», di Bobbio e delle sue polemiche con Togliatti? Dove si sono rifugiati gli epigoni del Gruppo ’63 in feroce battaglia contro Bassani e Cassola? Gli intellettuali che Arbasino mandava a Chiasso perché la cultura italiana si sprovincializzasse si sono persi forse tra i cantoni svizzeri? E dove sono gli echi delle furiose rivolte contro il Mussolini di De Felice e le imbarazzate perplessità davanti alla «guerra civile» sdoganata da Pavone? Chi ha visto gli intellettuali organici e quelli disorganici, gli «utili idioti» della colta sinistra e «le foglie di fico» dell’incolta destra? In quale casa editrice clandestina si stampano le riviste che hanno preso il posto del «Politecnico» di Vittorini, del «Mondo» di Pannunzio, del «Tempo presente» di Silone?
La data del decesso dell’intellettuale italiano non è stata ancora certificata da un preciso atto di morte, ma si presume sia avvenuta quando il talk show televisivo ha preso il posto del dibattito culturale sui giornali, bruciando in una incauta comparsata qualsiasi autorevolezza del malcapitato che si fosse esposto al ludibrio di una rissa accuratamente cercata in favore di audience. Quando la competenza su un argomento è stata sottoposta alle forche caudine di una dichiarazione condensata in venti secondi, di una battuta pseudobrillante, invece che distesa sulle solite fitte quattro pagine della vecchia «Rinascita».
L’accertamento più sicuro della definitiva scomparsa di qualsiasi influenza dell’intellettuale nella vita pubblica italiana, per la verità, è stato compiuto dalla politica, con il tipico cinismo di chi è costretto rapidamente a prendere atto della realtà. Finita l’egemonia culturale della sinistra, i partiti di quello schieramento hanno smesso di correre dietro a inutili «compagni di strada», per di più dispersi per strada, e quelli di destra hanno scambiato il vecchio complesso d’inferiorità sull’argomento con l’esibizione di un orgoglioso disprezzo per la «cultura con cui non si mangia». Così «il partito degli intellettuali» che vagava in Transatlantico con lo snobismo di chi doveva rivestire di una certa dignità le bassure della polemica quotidiana, si è ridotto a qualche sparuta presenza che cerca di dissimulare quella qualifica, diventata obbrobiosa, ostentando un linguaggio triviale e modi altrettanto volgari.
Alla morte del tipico intellettuale italiano, dedito agli studi umanistici, è subentrato forse lo studioso di scienza, un avvicendamento che molti si auguravano che avvenisse nella cultura del nostro Paese? Non pare. La scarsa influenza nella politica e nella società di chi si occupa in Italia di medicina, di biologia, di matematica, di fisica è testimoniata da un recente caso di cronaca, quello della vicenda «stamina»: nemmeno l’unanime rivolta di tutta la ricerca scientifica, capitanata dalla senatrice a vita Elena Cattaneo, contro questa ingannevole ricetta per una malattia gravissima ha costretto il ministero della Salute al divieto di utilizzarla e ha convinto alcuni magistrati a non autorizzarne la sperimentazione.
Pochi, certamente, hanno nostalgia di quell’intellettuale impegnato che spesso si impegnava per cause sbagliate e finiva nella macchietta del firmaiolo compulsivo degli appelli più improbabili. Di Zola non ce ne sono stati molti in Italia, purtroppo. Ma che l’unico dibattito culturale che ci appassioni sia quello, peraltro benemerito, sulla virtù dell’aceto di vino forse è un peccato.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- Non credo che siano spariti «gli intellettuali». Non sono scomparsi ma ora si danno all’intrattenimento (di G. E. Rusconi)30 settembre 2014, di Federico La Sala
Non è scomparso ma ora si dà all’intrattenimento
di Gian Enrico Rusconi (La Stampa, 30.09.2014)
Non credo che siano spariti «gli intellettuali». Certamente molti (specialmente di una certa età) sono effettivamente annichiliti dalla loro inattesa irrilevanza. Ma un pugno resiste e fa la sua bella figura nel circuito mediatico: i Cacciari, i Rodotà, i Magris non sono forse «intellettuali»? Certo, resistono solo quelli che fanno parte del giro dei grandi media, pur criticandolo. La maggior parte de- gli altri intellettuali sono o si sento- no fuori gioco.
Ma era davvero molto diverso quando, sino a non molto tempo fa, gli intellettuali interloquivano con la politica «dal suo interno», salvo accorgersi (alcuni di essi) che facevano soltanto tappezzeria per i loro politici di riferimento? In realtà è stata la politica che si è emancipata dai suoi intellettuali.
Prima con l’apparente deferenza della sinistra, poi con l’indifferenza del ventennio berlusconiano che ha artificiosamente esasperato lo scontro culturale e politico. Infine con allegra stra- fottenza è arrivata l’autosufficienza del renzismo.
Il problema non è di carente qualità intellettuale (tanto meno di moralità), ma di una accelerata mutazione dell’intero quadro politico e culturale cui gli intellettuali di tipo tradizio- nale non riescono più a tener testa. Il paradosso è che quanto sta accadendo è stato da tempo da loro stessi preannunciato con toni drammatici, spesso catastrofistici: dissoluzione dei contenuti ideologici («fine delle ideologie»), iper-personalizzazione della politica e carismatismo, etichettati come autoritarismo e populismo e quindi usati come epiteti. E infine l’affermazione inarrestabile della «democrazia mediatica». Adesso che questa si è materializzata compiutamente, i suoi critici ammutoliscono. 0 vengono ammutoliti.
Se si confrontano i concetti di «discorso pubblico», elaborati da un Bobbio, ma anche da un Habermas, con la realtà della comunicazione pubblica effettiva, si vede tutto l’equivoco con cui devono fare i conti gli intellettuali. Si pensi al concetto centrale di «società civile» che da modello normativo è diventato un termine passepartout, inutilizzabile.
Eppure ci sono segnali di tipo diverso che vanno interpretati. Oggi «il pubblico» si ritrova di preferenza in piazza, non solo in quella mediatica addomesticata dai conduttori televisivi, ma in quella reale, raccolta negli innumerevoli festival culturali e iniziative similari.
È lì che ricompare anche l’intellettuale alla ricerca di un nuovo ruolo. C’è il filosofo che intrattiene il pubblico sui sentimenti e sulle passioni; lo storico che narra le vicende in modo seducente senza affaticare la mente con analisi complicate; il politologo che con toni di complicità rivela le malefatte dei politici, facendo sentire gli ascoltatori novelli Machiavelli.
Non sto facendo gratuita ironia. Semplicemente constato che l’intellettuale da intrattenimento ha individuato il suo pubblico, al quale può mettere a disposizione le sue competenze per rivalorizzare il suo ruolo.
Ma se dall’intrattenimento vuol passare a quello che un tempo si chiamava formazione culturale, il suo compito è molto più impegnativo di quello dei vecchi «maestri». Questi disponevano di strutture universitarie di supporto funzionanti e di apparati editoriali al servizio delle loro competenze e del loro prestigio scientifico (non orientati quasi esclusivamente al mercato). Soprattutto c’erano culture politiche ricettive che fungevano da mediazione e da gratificante stimolo agli intellettuali.
Oggi c’è poco o nulla di tutto questo. Piazze piene, librerie vuote - si dice. Forse bisogna passare da qui. Ma per ricostruire un ceto intellettuale di tipo nuovo, competente e autorevole, ci vuole ben altro.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- Vivere bene, buon vivere, e il piatto di lenticchie (di Carlo Sini - Il buono della vita)1 ottobre 2014, di Federico La Sala
il buono della vita
Preferire i piaceri fecondi a quelli materiali (ma il corpo vuole la sua parte)
Dagli epicurei a Kant, fede e ragione dibattono da sempre sul peso delle piccole gioie dell’esistenza
di Carlo Sini (Corriere della Sera, 01.10.2014)
Vivere bene e buon vivere non sono sinonimi. Nella prima espressione risuona un’eco severa che allude ai sensi ultimi dell’umana esistenza; nella seconda una più gioviale attenzione ai piaceri della vita, alle loro sia pure effimere consolazioni. Le due cose peraltro non si escludono e spesso dipendono, più che da ragioni tra loro in conflitto, dalle indoli accidentali delle persone.
Non è escluso poi che l’una cosa segua l’altra. Agostino e Pascal pare che se la siano spassata non poco, prima della conversione e l’adesione a una più ascetica condotta di vita e anche Descartes, pur senza arrivare mai a digiuni o vigilie, cose lontane dal suo carattere «libertino» (come non pochi pensarono e ancora pensano che egli fosse), indubbiamente decise a un certo punto di abbandonare i piaceri della mondanità per dedicarsi alle severe soddisfazioni della scienza.
Credo che si debba porre una differenza tra il mondo pagano e quello cristiano. Anche i filosofi, i retori, gli scrittori pagani denunciarono la futilità di una vita dominata dai piaceri dei sensi, di una vita a rischio di dissoluzione e di inconcludenza, ma questo non significò una condanna specifica dei bisogni e delle attenzioni rivolte al corpo: gli antichi non conoscevano la nozione cristiana di peccato e d’altra parte la cura del corpo era parte essenziale della ricerca della salute e della battaglia contro l’invecchiamento e la corruzione fisica.
Consapevoli della precarietà della sorte umana, i saggi pagani non vedevano alcuna ragione plausibile nel negare al corpo piaceri, soddisfazioni e attenzioni sia pure moderati, secondo la regola aristotelica del giusto mezzo.
Un esempio emblematico è quello degli epicurei: nel loro «giardino» non ci si abbandonava a orge o a dissolutezze, come i maligni sospettavano, ma a una oculata amministrazione dei piaceri, secondo due regole generali: il non rendersene mai schiavi, cioè mantenerne il controllo senza per questo inibirseli; il diminuirne la frequenza e la portata, sia per renderli più agevoli, sia per gustarne meglio la novità e la fragranza. Nel mondo moderno questo calcolo dei piaceri venne ripreso dalla scuola anglosassone degli utilitaristi: preferire a quelli puramente materiali i piaceri fecondi, i piaceri più elevati, poiché, sostenevano, è preferibile essere un Socrate malato, che un maiale soddisfatto.
Nel mondo cristiano queste attenzioni rivolte ai piaceri del corpo ricorsero talora a un altro tipo di giustificazioni, decisamente un po’ disinvolte: si disse, da parte di alcuni, che era delittuoso e irriverente disprezzare le gioie della natura che il buon Dio dispensava ai suoi figli.
Ma in generale la questione, molto variamente affrontata da uomini d’azione, uomini di chiesa, politici o artisti, per i filosofi si declinò per lo più nel segno di una saggia ricerca di equilibrio. In un certo senso il fine della realizzazione di una vita buona, dei suoi fini altamente morali e sociali, trovò in un buon vivere opportunamente modulato un mezzo, un aiuto e un legittimo ristoro.
Né Spinoza, né Locke, né Kant si sarebbero complicata l’esistenza per accedere ai piaceri più sensuali: già la loro quotidiana dedizione al lavoro sarebbe stata in ciò un ostacolo insormontabile. Non risulta, per esempio, che abbiano fatto follie per i richiami del sesso o del denaro (sebbene la parsimonia di Kant fosse in proposito ben nota), ma amarono il decoro dei vestiti, il piacere del fumo o dei profumi, i diletti del teatro, le gioie occasionali della mensa come quelle della conversazione leggera e garbata.
Il vero motivo di questa moderazione, più che nelle buone ragioni fatte valere in proposito, sta però, a mio avviso, in un fattore molto particolare, indice, a suo modo, non di una moderazione, ma anzi di un eccesso: questa è la invasiva ossessione della ricerca e l’ansia per la verità, per non dire della aspirazione a una fama imperitura. Certo, anche gli artisti sono divorati dalla passione; non pensano ad altro che al lavoro creativo, vivendo esistenze molto disordinate e dispendiose. Ma è anche vero che spesso accompagnano all’impegno fasi intermedie nelle quali si abbandonano a eccessi di genere opposto, cioè ai piaceri fisici: la stimolazione quasi morbosa della loro fantasia si prende una vacanza, come a ripristinare un equilibrio proprio nel corpo.
I filosofi, a quanto pare, no e il motivo è ben comprensibile: anche loro conoscono giorni e notti di lavoro spossante, ma lo strumento essenziale della loro arte è la ragione, il pensiero lucido e attento. Forse prenderanno qualche stimolante (si dice che alcuni vi abbiano ricorso), ma la mente deve restare libera ed efficiente. Non è il caso di comprometterla per un piatto di lenticchie .
-
-
-
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- IL PARTITO DEL GRANDE SILENZIO (di Angelo d’Orsi)24 luglio 2014, di Federico La Sala
Palestina, il partito del grande silenzio
di ANGELO D’ORSI (il manifesto, 23 luglio 2013)
Ho trascorso la settimana in Spagna, a Malaga, a una Scuola estiva della Cattedra Unesco di quella Università. Il tema della sezione a cui ho partecipato come relatore era “L’impegno degli intellettuali”. Seguivo, naturalmente, la notizie sempre più angosciose provenienti dalla terra martire di Palestina, constatando l’assoluta “distrazione” del ceto politico, rispetto a quei fatti di sconvolgente gravità, e il totale disinteresse, salvo pochissime eccezioni, del “mondo della cultura”.
Ricordo altre stagioni, come l’invasione del Libano e la guerra contro Hezbollah, del luglio 2006, o il bombardamento di Gaza del dicembre 2008-gennaio 2009: stagioni in cui fiorirono appelli, e la mobilitazione di professori, giornalisti, letterati, scienziati,artisti fu vivace e intensa. Si denunciavano le responsabilità di Israele, la sua proterva volontà di schiacciare i palestinesi, invece di riconoscer loro il diritto non solo a una patria, ma alla vita. Oggi, silenzio. La macchina schiacciasassi di Matteo Renzi , nel suo micidiale combinato disposto con Giorgio Napolitano, si sta rivelando un efficacissimo apparato egemonico.
L’intellettualità “democratica”, facente capo per il 90% al Pd, appare allineata e coperta. I grandi giornali, a cominciare dal “quotidiano progressista” di De Benedetti, sempre in prima linea a sostenere le nuove guerre, dal Golfo alla Jugoslavia, appaiono organismi perfettamente oliati di sostegno al governo da un canto, e di adeguamento alla politica estera decisa da un pugno di signori e signore tra Washington, Londra, Bruxelles e Berlino (Parigi, caro Hollande, ne prenda atto, non conta un fico). Della radiotelevisione non vale neppure la pena parlare; come per l’Ucraina, ora, nella ennesima micidiale aggressione israeliana a Gaza, si sono raggiunti vertici non di disinformazione, ma di semplice rovesciamento della verità. La categoria del “rovescismo”, che mi vanto di aver creato, per la storiografia iper-revisionista, va ormai estesa ai media.
E devo constatare che mai in passato si erano raggiunti simili livelli: dove sono le zone franche? Fa impressione sfogliare la balbettante Unità, che un tempo non lontano, con tutti i suoi limiti, accanto a Liberazione (defunta) e al manifesto (che resiste!), era una delle poche voci critiche nel deprimente panorama all’insegna del più esangue conformismo.
Sulle pagine del manifesto (15 luglio) Manlio Dinucci ha spiegato bene le ragioni reali del “conflitto” in corso, e non ci tornerò. Qui mi preme piuttosto evidenziare, con sgomento, che il “silenzio degli intellettuali” che qualche anno fa Alberto Asor Rosa denunciava, deplorandolo fortemente, è divenuto non soltanto una condizione di fatto, ma una posizione “teorica” che, accanto a quella dell’equidistanza, sta trovando i suoi alfieri. Appunto, rientrando dalla mia settimana spagnola, di intense discussioni sulla necessità di impegnarsi, a cominciare dal mondo universitario, cado dalle nuvole leggendo lacerti di pensiero che configurano la nascita di una sorta di “Partito del silenzio”.
Il silenzio non viene soltanto praticato, sia «perché dovrei espormi?», sia perché la pressione della lobby sionista è fortissima e induce a tacere se proprio non vuoi esprimere la tua gioiosa adesione alla “necessità” degli israeliani “di difendersi”. Il silenzio, oggi, a quanto pare, è divenuto una divisa, una bandiera, e una ideologia.
Quei pochi che parlano, che osano aprire bocca, premettono il riconoscimento delle ragioni di Israele e condannano in primo luogo rapimento e uccisione dei tre ragazzi ebrei, poi uccisi (si tralascia di dire che si tratta di tre giovani coloni, ossia occupanti, con la violenza dell’esercito, terra palestinese), e il lancio di razzi Kassam contro le città del Sud di Israele, e cercano poi di cavarsela con un colpo al cerchio e una alla botte. Ma attenzione, se il colpo alla botte israeliana appare troppo sonoro, ecco che si scatena l’inferno, non di fuoco come su Gaza, ma di parole.
Molto praticato il genere “commenti” agli articoli on line, per esempio: sono tutti uguali, anche se variamente dosati nel tasso di violenza verbale. Mentre un gran lavorio di informazione al contrario, di diretta provenienza da fonti israeliane, viene dispiegato dagli innumerevoli piccoli dispensatori di verità nostrani. Per esempio un pur prudente articolo di Claudio Magris sul Corriere della Sera (17 luglio) che si permetteva di accennare alle ragioni dei palestinesi, ha ricevuto la sua buona dose di ingiurie. Non c’è che dire, il sistema funziona. E finisce per indurre al silenzio, o quanto meno alla prudenza. Che è l’altro nome del silenzio.
Ma non è questo silenzio, il silenzio del ricatto, che mi preoccupa di più. È, invece, il silenzio della scelta. Il silenzio teorizzato come terza via, tra coloro che incondizionatamente sono con Israele, e gli altri, quelli che sostengono la causa palestinese. Il silenzio come rispetto del dolore, o come via della ragionevolezza: contro gli opposti estremismi. Esemplare in tal senso Roberto Saviano, che, quasi commettendo autogol, cita Euromaidan per denunciare il tardivo schierarsi anche italiano dalla parte giusta, che per lui, ovviamente, è quella dei golpisti nazisti di Kiev. E ora, a suo dire, occorre schierarsi non con gli uni né con gli altri, ma «dalla parte della pace»: i “terroristi” di Hamas sono indicati come il primo nemico della pace, ovviamente.
È la linea (solita) di Adriano Sofri (la Repubblica, 17 luglio), altro guerriero democratico, che ripartisce torti e ragioni, equiparando i razzi di Hamas alle bombe israeliane, e invoca implicitamente silenzio, discrezione, rispetto: mette sullo stesso piano tutti. Tutte le vittime innocenti. Ma si può confondere la pietà umana, doverosa, col giudizio politico? Si può trasformare l’opinione in saggezza?
Sul medesimo giornale, Michele Serra sostiene che occorre tacere, che si devono abbassare la voce e gli occhi, davanti alla “tragedia” della guerra, lo stesso termine usato da Magris. Ma quale tragedia? Qui abbiamo la politica, e la politica ha degli attori, dei responsabili: come in passato la divisione tra vittime e carnefici è netta ed evidente (so che qualche anima bella mi accuserà di semplificare: la cosa è più complessa, non si può dividere così nettamente, ciascuna delle due parti ha un pezzo di responsabilità e via di seguito). Serra scrive: «Evidentemente il ‘ciclo dell’indignazione’ è un meccanismo logoro».
Dal ceto intellettuale mi aspetto assai più che l’indignazione, mi aspetto una rivolta morale: tutti, se non in perfetta malafede, oggi sanno quanta verità ci sono nelle parole di Primo Levi: «Quello che non potrò mai perdonare ai nazisti è di averci fatto diventare come loro».
Quanto bisogno avremo di sentire la sua voce risuonare, pacata e ferma, scandendo le parole, a voce bassa, ma chiarissima: «La tragedia è di vedere oggi le vittime diventate carnefici». E se questo era evidente a lui negli anni Ottanta del Novecento, cosa potrebbe mai dire oggi, davanti a quei corpi straziati di bimbi, alla vita cancellata in tutta la Striscia di Gaza, davanti a quelle macerie che occupano, quartiere dopo quartiere, isolato dopo isolato, di ora in ora, lo spazio affollato di case e persone?
Se non denunciamo le menzogne dei media, le complicità dei governi occidentali, con quello di Tel Aviv, in particolare l’oscena serie di accordi (militari, innanzi tutto) dell’Italia con Israele... Se ci consegniamo al silenzio, oggi, davanti a una ingiustizia così grave,così palese, così drammatica, quando parleremo? Insomma, non intendo tacere, e ricorrendo proprio alle parole di quel grande uomo, gridare: «Se non ora, quando?».
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- IL PARTITO DEL GRANDE SILENZIO. Nessuno vuole davvero fermare Israele (di Alessandro Dal Lago)26 luglio 2014, di Federico La Sala
Nessuno vuole davvero fermare Israele
di ALESSANDRO DAL LAGO (il manifesto, 25 Luglio 2014)
La striscia di Gaza è martirizzata da tredici anni, dall’inizio della seconda Intifada. Periodicamente Israele, in risposta ai lanci di razzi, al rapimento di un soldato o all’uccisione di giovani coloni, scatena offensive (dai nomi fantasiosi o truci, come “arcobaleno” o “piombo fuso” ecc.) dal cielo, dal mare e a terra.
Dall’inizio del millennio, sono morti circa 6.400 palestinesi e poco più di 1000 israeliani, senza dimenticare le centinaia di palestinesi vittime della guerra civile tra Hamas e Anp. Ogni volta, gli strateghi israeliani giurano che il conflitto in corso sarà l’ultimo, ma chiunque nel mondo sa che si tratta di una favola. Anche se la striscia di Gaza - una fascia costiera abitata da una popolazione pari a quella della Liguria, ma con una superficie quindici volte più piccola - fosse completamente ridotta in macerie, qualche razzo potrebbe essere ancora sparato e quindi il conflitto riprenderebbe...
Per comprendere il senso di una guerra apparentemente infinita, basta confrontare le carte della Palestina nel 1946 e oggi. Se allora gli insediamenti dei coloni ebrei erano una manciata, soprattutto nel nord, oggi è esattamente il contrario: una spruzzata di insediamenti palestinesi circondati da Israele e dai suoi coloni, con la striscia di Gaza isolata a sud-ovest. Non ci vuole molta fantasia per comprendere che la strategia di Israele, in nome di una sicurezza assoluta di cui non potrà mai godere, è quella di cacciare più palestinesi possibile, con le infiltrazioni dei coloni in Cisgiordania e con le azioni militari a Gaza.
Rapporti pubblicati da Human Rights Watch, agenzie Onu e Amnesty International mostrano ormai, senza possibilità di dubbio, che lo sradicamento dei palestinesi è perseguito con l’espulsione dalla terre coltivabili, l’interruzione periodica dell’energia elettrica e il blocco delle risorse idriche. D’altronde che l’esercito considerato il più “professionale” al mondo rada al suolo scuole gestite dall’Onu e uccida soprattutto civili la dice lunga sulla vera strategia di Israele verso i palestinesi.
Mai come oggi, i palestinesi di Gaza sono stati così soli. Hamas non gode della protezione dell’Egitto, come ai tempi di Morsi, né della simpatia dei sauditi e di quasi tutti gli stati arabi. Né riceve vera solidarietà da parte di Abu Mazen. E, ovviamente, in quanto organizzazione ufficialmente definita “terrorista”, è avversata da Stati Uniti ed Europa. Ma tutto questo non spiega, né tanto meno giustifica, il silenzio ipocrita dei governi occidentali e tanto meno della cosiddetta opinione pubblica indipendente sulle stragi di Gaza.
Lasciamo stare il nostro Presidente del consiglio e l’ineffabile ministro Mogherini, la cui ascesa spiega perfettamente il ruolo trascurabile della politica estera nella cultura governativa italiana. Ma che dire dell’incredibile squilibrio politico e morale nella valutazione ufficiale del conflitto?
Basti pensare che un B.-H. Lévy, l’eroe della fasulla rivoluzione libica e il mestatore di Siria, da noi passa come un profeta della pace e della giustizia. Che centinaia o migliaia di imbecilli, in Europa o altrove, trasformino il conflitto tra palestinesi e stato d’Israele in una crociata antisemita non può essere usato come un alibi per chiudere gli occhi davanti alle stragi di bambini e di civili. In questo quadro, la palma dell’ipocrisia va al governo americano, e in particolare a Obama, che pure aveva illuso il mondo all’inizio del suo primo mandato.
La banale verità è che la differenza tra democratici e repubblicani in materia di Palestina è semplicemente di stile. Brutalmente filo-israeliani quelli della banda Bush, preoccupati un po’ più delle forme della repressione gli obamiani, come dimostrano i famosi fuori-onda di Kerry.
Ma nessuno ha veramente intenzione di fermare Israele, oggi o mai. La solitudine dei palestinesi è la vergogna del mondo, dell’occidente come dei padroni del petrolio. Per non parlare di un’Europa inetta e imbelle.
-
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- quando qualcuno propose a Winston Churchill di tagliare la spesa sulla cultura per rinforzare ancora la contraerea, avrebbe risposto: “Ma allora, per cosa stiamo combattendo?”17 luglio 2014, di Federico La Sala
L’importanza di avere Pompei. In 3D
Un documentario per immagini e (poche) parole: per capire cosa combattiamo quando difendiamo questo luogo unico
di Tomaso Montanari (il Fatto, 17.07.2014)
Si racconta che quando qualcuno propose a Winston Churchill di tagliare la spesa sulla cultura per rinforzare ancora la contraerea, il primo ministro avrebbe risposto: “Ma allora, per cosa stiamo combattendo?”. Quando ho finito di vedere, in anteprima, Pompei 3D che andrà in onda stasera alle 21.10 su Sky3D ho pensato subito a questa celebre, e probabilmente apocrifa, battuta.
Già, perché la immagini, la musica e le parole di questo piccolo capolavoro coprodotto da Ballandi Arts e Sky3D sono capaci di spiegare a chiunque per che cosa stiamo combattendo quando combattiamo per Pompei.
DI QUESTA battaglia il documentario non parla. Non parla di crolli, di finanziamenti e di personale, di trattative sindacali o di speculazioni edilizie, di ministeri fallimentari e decreti inutili, di conflitti d’interesse e concessionari onnipotenti. Non parla, cioè, di tutto ciò per cui - inevitabilmente - Pompei è quasi ogni giorno sulle pagine dei giornali italiani e stranieri. Non mostra il degrado, non grida allo scandalo: e non perché a Pompei non ci sia (anche) del degrado, e non perché non ci sia (ancora) da gridare.
Ma perché, appunto, è vitale ricordarci perché gridiamo. Ed è importante particolarmente ora, quando grazie al soprintendente Massimo Osanna e a una pattuglia di giovani archeologi e architetti a Pompei si vede finalmente una luce.
Ebbene Pompei 3D riesce perfettamente a ricordarcelo. Perché le sue straordinarie immagini (ancor più impressionanti se si indossano gli appositi occhiali) sono state girate utilizzando anche un drone sperimentale particolarmente evoluto, che ha sorvolato Pompei in varie condizioni di luce, e anche in parti degli scavi inaccessibili ai turisti, e poco o per nulla filmate. E perché le parole scelte per commentarle non sono da meno.
Si è infatti scelto di rinunciare sia alla classica, didascalica, spiegazione (disponibile per altro in contemporanea su Sky Arte, nella puntata dedicata a Pompei nella serie sulle Sette meraviglie), sia alla passeggiata dell’esperto (che fa ormai troppo Alberto Angela) o alla terribile presenza dei personaggi in costume, un escamotage tristemente vicino alla mascherata dei gladiatori al Colosseo.
Qua invece non si vede anima viva (fatti salvi due dei dolci cani che custodiscono Pompei), e tutto è affidato ad un sapiente montaggio di testi letti da una voce fuori campo. Testi - e questo è il punto - di grandissimi scrittori che hanno lasciato testimonianze di viaggio, pensieri o poesie su Pompei.
Il filo conduttore è una indimenticabile pagina di Goethe che definisce la città morta “un posto mirabile, degno di sereni pensieri”.
MA LO SPETTATORE ha il privilegio di vedere Pompei attraverso gli occhi e le parole di Giacomo Leopardi (“Torna al celeste raggio / Dopo l’antica oblivion l’estinta/ Pompei, come sepolto / Scheletro, cui di terra /Avarizia o pietà rende all’aperto”) e di Shelley, di Dumas, di Dickens (“perdo il conto del tempo, e penso ad altre cose”) e Melville (“Pompei è uguale ad ogni altra città. La stessa antica umanità. Che si sia vivi o morti non fa differenza . Pompei è un sermone incoraggiante”). E così vediamo con i nostri occhi “il segno della corda del secchio sulla vera del pozzo, la traccia dei carri sul basolato delle strade” di cui parla Dickens, e guardiamo il Tempio di Iside mentre ascoltiamo le note del Flauto magico che esso ispirò a Mozart. Nulla ci viene spiegato: ma sentiamo di comprendere tutto. Per questo Pompei3D è un potente argomento contro coloro che, per stupidità o interesse, oppongono la qualità al successo mediatico, e considerano elitarista ogni tentativo di educare: qua le immagini ultramoderne e spettacolari dei droni convivono con il riuscito tentativo di raccontare Pompei come un pezzo della storia della cultura europea tra Otto e Novecento.
NON UNA CURIOSITÀ turistica, non solo materia per gli archeologi, non un problema amministrativo: ma una grande occasione per tornare civili e umani. Ecco perché meriterebbe di essere proiettato nelle scuole: ed ecco perché speriamo che non rimanga un episodio isolato.
E si trattiene il respiro quando si vede il calco del corpo della fanciulla che Primo Levi associò ad Anna Frank e alla scolara di Hiroshima in una poesia il cui incipit basta a spiegare perché Pompei ci sta a cuore, perché combattiamo per salvarla: “Poiché l’angoscia di ciascuno è la nostra”.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- CULTURA E CRITICA. RIPENSANDO ALLA STORIA DI AXEL SPRINGER.10 luglio 2014, di Federico La Sala
 ESPERIMENTO " ITALIA". L’ANNO DELLA VERGOGNA (1994): NASCE IL PARTITO-NAZIONE DEL "NUOVO" PRESIDENTE DELLA "REPUBBLICA" ... E C’E’ ANCORA!!! "FORZA ITALIA": VIVA IL "POPOLO DELLA LIBERTA’"!!!
ESPERIMENTO " ITALIA". L’ANNO DELLA VERGOGNA (1994): NASCE IL PARTITO-NAZIONE DEL "NUOVO" PRESIDENTE DELLA "REPUBBLICA" ... E C’E’ ANCORA!!! "FORZA ITALIA": VIVA IL "POPOLO DELLA LIBERTA’"!!!
 CULTURA E CRITICA. RIPENSANDO ALLA STORIA DI AXEL SPRINGER, E’ DA DIRE CHE L’ITALIA HA ’BATTUTO’ LA GERMANIA ALLA ’GRANDE’!
CULTURA E CRITICA. RIPENSANDO ALLA STORIA DI AXEL SPRINGER, E’ DA DIRE CHE L’ITALIA HA ’BATTUTO’ LA GERMANIA ALLA ’GRANDE’!
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETA’ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.9 luglio 2014, di Federico La Sala
 PER LA CRITICA DELLA FACOLTA’ DI GIUDIZIO E DELLA CREATIVITA’ DELL’ "UOMO SUPREMO" (KANT).
PER LA CRITICA DELLA FACOLTA’ DI GIUDIZIO E DELLA CREATIVITA’ DELL’ "UOMO SUPREMO" (KANT).
 CREATIVITA’: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETA’ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Da Emilio Garroni, una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
CREATIVITA’: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETA’ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Da Emilio Garroni, una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico. PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!
PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!
 FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA. Un breve saggio di Federico La Sala, con prefazione di Riccardo Pozzo.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA. Un breve saggio di Federico La Sala, con prefazione di Riccardo Pozzo. -
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- Quando Heidegger sul palco pensò: non sono un cretino (di Emanuele Trevi)7 luglio 2014, di Federico La Sala
- “come fu possibile la hitlerizzazione dell’Imperativo Categorico di Kant? E perché è ancora attuale oggi?” (Emil L. Fackenheim).
 HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI.
HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI.
Quando Heidegger sul palco pensò: non sono un cretino
di Emanuele Trevi (Corriere della Sera, 07.07.2014)
Perché si prendono certi impegni inutili e assurdi, che finiscono puntualmente per trasformarsi in figure di merda.
Lo volete sapere perché Martin Heidegger, un individuo così mite e distinto, diventò nazista - lui che non sarebbe stato capace di far male a una mosca? Pur esprimendo un discutibile amore per il suolo natio, non c’è, in effetti, un’oncia di vero nazismo nel pensiero del povero Martin.
E allora? Allora lui era nazista perché i nazisti lo chiamavano al telefono. Come va, Herr Professor? Appiamo pizogno ti lei! Zuo penziero è fontamentale per Cermania! Ma davvero?, si chiedeva lui, grande esperto di tutte le forme dello stupore umano. Non avranno sbagliato numero? No, era proprio lui che cercavano: l’autore di Essere e tempo. Lo facevano sentire importante. Considerato. Lo invitavano alle loro parate, alle inaugurazioni. Lo passavano a prendere in macchina. La moglie, quella che preparava le torte, era contenta. Gli faceva bene, al Professor, vedere qualcuno. A volte i nazisti lo mettevano su un palco tutto addobbato di svastiche e aquile, a discorrere di cose per loro incomprensibili. E mentre quei criminali sonnecchiavano, aspettando educatamente che lui arrivasse alla fine, prendeva corpo la più grande figura di merda della storia della filosofia.
Ma lui, poveretto, non ci arrivava. Come poteva? Rientrava forse nei suoi doveri di profondo pensatore quello di far caso a quei lugubri addobbi, a quella gentaglia che lo applaudiva, prima di riportarlo a casa? Il suo unico pensiero sarà stato: allora funziona. Allora non sono cretino.
- “come fu possibile la hitlerizzazione dell’Imperativo Categorico di Kant? E perché è ancora attuale oggi?” (Emil L. Fackenheim).
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- “I filosofi escano dal loro mondo chiuso”. Un inedito. Quando Althusser si chiedeva: “Ma la filosofia serve a qualcosa?”1 luglio 2014, di Federico La Sala
 Un inedito di Louis Althusser
Un inedito di Louis Althusser Il pensatore francese critica l’idealismo a favore del materialismo e spiega come va insegnata la disciplina
Il pensatore francese critica l’idealismo a favore del materialismo e spiega come va insegnata la disciplina “I filosofi escano dal loro mondo chiuso”
“I filosofi escano dal loro mondo chiuso” Quando Althusser si chiedeva “Ma la filosofia serve a qualcosa?”
Quando Althusser si chiedeva “Ma la filosofia serve a qualcosa?” di Louis Althusser (la Repubblica, 01.07.2014)
POICHÉ apparentemente nella vita pratica la filosofia non serve a granché, dato che non produce né conoscenze né applicazioni, ci si può allora domandare: a che cosa serve la filosofia? E si può perfino porre quest’altra strana domanda: non è che per caso la filosofia serva solo al proprio insegnamento e a null’altro? E se serve solo al proprio insegnamento, ciò cosa significa? Cercheremo di rispondere a queste difficili domande. Con la filosofia le cose vanno così.
di Louis Althusser (la Repubblica, 01.07.2014)
POICHÉ apparentemente nella vita pratica la filosofia non serve a granché, dato che non produce né conoscenze né applicazioni, ci si può allora domandare: a che cosa serve la filosofia? E si può perfino porre quest’altra strana domanda: non è che per caso la filosofia serva solo al proprio insegnamento e a null’altro? E se serve solo al proprio insegnamento, ciò cosa significa? Cercheremo di rispondere a queste difficili domande. Con la filosofia le cose vanno così.Basta riflettere su un aspetto piccolissimo (il fatto che i filosofi siano quasi tutti dei professori di filosofia), perché, senza neanche lasciarci il tempo di respirare, s’impongano alcune domande impreviste e sorprendenti. E queste domande sono tali che dobbiamo porle, senza avere i mezzi per rispondervi: per rispondere occorre fare un lungo periplo . E questo periplo non è altro che la filosofia stessa. Il lettore deve dunque armarsi di pazienza. La pazienza è una “virtù” filosofica. Senza di essa, non ci si può fare un’idea della filosofia.
Per procedere, diamo un’occhiata discreta a questi uomini: i professori di filosofia. Hanno mariti e mogli come voi e me, dei figli che hanno voluto. Mangiano e dormono, soffrono e muoiono, come tutti. Possono amare la musica e lo sport, fare politica o non farla. D’accordo, non è questo che fa di loro dei filosofi.
Ciò che fa di loro dei filosofi è che vivono in un mondo a parte, in un mondo chiuso: costituito dalle grandi opere della filosofia. Questo mondo apparentemente non ha un di fuori. Vivono con Platone, Cartesio, Kant, Hegel, Husserl, Heidegger, ecc. [...] La pratica della filosofia non è semplice lettura, né tanto meno dimostrazione. È interpretazione, interrogazione, meditazione : cerca di far dire alle grandi opere quello che vogliono dire, o possono voler dire , nella Verità insondabile che esse contengono, o meglio che indicano silenziosamente, “facendo segno” verso di essa.
Conseguenza: questo mondo senza un fuori è un mondo senza storia . Benché sia costituito dall’insieme delle grandi opere consacrate dalla storia, esso però non ha storia. La prova: per interpretare una passo di Kant, il filosofo farà ricorso sia a Platone che a Husserl, come se non ci fossero ventitré secoli tra i primi due e un secolo e mezzo tra il primo e l’ultimo, come se importasse poco il prima e il dopo.
Per i filosofi, tutte le filosofie sono per così dire contemporanee. Rispondono le une alle altre, facendosi eco, perché in fondo rispondono sempre a quelle stesse domande che costituiscono la filosofia. Da qui la celebre tesi: «la filosofia è eterna». Come si vede, affinché sia possibile la rilettura perpetua, il lavoro di meditazione ininterrotto, occorre che la filosofia sia al contempo infinita (ciò che “dice” è inesauribile) e eterna (tutta la filosofia è contenuta in nuce in ogni filosofo).
Questa è la base della pratica dei filosofi, o meglio dei professori di filosofia. Data questa situazione, fate attenzione se dite loro che insegnano la filosofia. Giacché è evidente che essi non insegnano come gli altri professori, i quali propongono ai loro allievi delle conoscenze da imparare, vale a dire dei risultati scientifici (provvisoriamente) definitivi.
Per il professore di filosofia che ha capito la lezione di Platone e Kant, la filosofia non si insegna. Ma allora cosa fa un professore di filosofia? Insegna ai suoi allievi a filosofare, interpretando davanti a loro i grandi testi o i grandi autori della filosofia, aiutandoli con il suo esempio a filosofare, inspirando loro il desiderio di filosofare. [...] Quello che ho appena descritto è, in forma relativamente pura, la tendenza idealistica, la pratica idealistica della filosofia.
Ma la filosofia può essere praticata anche in maniera completamente diversa. La prova è che nel corso della storia alcuni filosofi, diciamo i materialisti, hanno praticato la filosofia del tutto diversamente, e persino alcuni professori di filosofia tentano di seguire il loro esempio. Non vogliono più far parte di un mondo separato, di un mondo chiuso nella propria interiorità. Ne escono per abitare il mondo esterno : vogliono che tra il mondo della filosofia (che esiste) e il mondo reale si stabiliscano scambi fecondi. In linea di principio, ciò è per loro la funzione stessa della filosofia: mentre gli idealisti considerano che la filosofia è innanzitutto teorica, i materialisti considerano che la filosofia è innanzitutto pratica, viene dal mondo reale e produce, senza saperlo, degli effetti concreti nel mondo reale.
Notate che, nonostante la loro innata opposizione agli idealisti, i filosofi materialisti possono essere - per così dire - “d’accordo” con gli avversari su alcune questioni. Per esempio, a proposito della tesi “la filosofia non s’insegna” . Non le attribuiscono però lo stesso significato.
La tradizione idealistica difende questa tesi, innalzando la filosofia al di sopra delle conoscenze e invitando ciascuno a risvegliare dentro di sé l’ispirazione filosofica. La tradizione materialistica non innalza la filosofia al di sopra delle conoscenze, invita invece gli uomini a cercare al loro esterno, nelle pratiche, nelle conoscenze e nelle lotte sociali - ma senza tralasciare le opere filosofiche - di che imparare a filosofare. È una piccola differenza, ma carica di conseguenze.
 Presses Universitaires de France, 2-014. Traduzione di Fabio Gambaro
Presses Universitaires de France, 2-014. Traduzione di Fabio Gambaro
Istruzioni per l’uso nella battaglia delle idee
di Fabio Gambaro(la Repubblica, 01.07.2014)
PARIGI. «OGNI uomo è virtualmente un filosofo». È in questi termini che, ispirandosi a Gramsci, Louis Althusser concludeva nel 1975 un corposo volume intitolato Initiation à la philosophie pour les non philosophes (Presses Universitaires de France, pagg.386, euro 21). Rimasto inedito fino a oggi, il libro è stato ora pubblicato in Francia, dove il filosofo scomparso nel 1990 continua ad essere al centro di studi e ricerche.
Questa poco convenzionale «iniziazione alla filosofia per i non filosofi» fu scritta nella seconda metà degli anni Settanta, nel pieno della fase più intensamente politica di Althusser, e solo qualche anno prima della tragedia che avrebbe sconvolto la sua vita nel 1980, quando in un accesso di follia strangolò la moglie. Sono gli anni in cui l’autore di Pour Marx - per il quale un filosofo «è un uomo che si batte nella teoria» - rivisita criticamente il marxismo, convinto che la filosofia non sia altro che la continuazione della politica con altri mezzi, un campo di battaglia al cui interno lottano le idee, come nella realtà lottano le classi sociali.
Da qui la necessità di scrivere un «manuale» per fornire ai non specialisti gli strumenti per capire e affrontare questa guerra di teorie e concetti, utilizzando la filosofia contro ogni forma di rassegnazione politica e sociale. In queste pagine in cui denuncia i limiti dell’idealismo e difende la filosofia materialista, Althusser propone una stringente analisi dei concetti d’astrazione e d’ideologia, allontanandosi volontariamente dalla «filosofia dei filosofi per analizzare le pratiche concrete degli uomini».
La sua però non è semplicemente un’opera di divulgazione, dato che all’interno del suo ragionamento lo studioso sintetizza molte problematiche e categorie che costituiscono il nucleo della sua originale riflessione filosofica, a cominciare dal concetto di pratica. Non a caso, se Initiation à la philosophie pour les non philosophes all’epoca non fu pubblicato (probabilmente Althusser pensava di apportarvi ancora alcune correzioni, nonostante l’avesse già riscritto due volte), diversi passi del manoscritto verranno nondimeno riutilizzati in alcuni testi scritti successivamente.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- CARTA COSTITUZIONALE E BELLEZZA NON FANNO RIMA (di Tomaso Montanari, stocico dell’arte)27 giugno 2014, di Federico La Sala
 COSTITUZIONE, CITTADINANZA, E APPRENDISTI STREGONI ....
COSTITUZIONE, CITTADINANZA, E APPRENDISTI STREGONI ....
 “Non hai lavoro? È l’Italia, bellezza”! Costituzione e bellezza non fanno rima.
“Non hai lavoro? È l’Italia, bellezza”! Costituzione e bellezza non fanno rima.
 Una nota di Tomaso Montanari
Una nota di Tomaso Montanari
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- Le domande dello storico Piero Bevilacqua sull’etica civile delle grandi opere.20 giugno 2014, di Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- Benvenuta la parresìa (di uno storico dell’arte), soprattutto nella terra delle teste di paglia (di Tomaso Montanari)16 giugno 2014, di Federico La Sala
Benvenuta la parresìa, soprattutto nella terra delle teste di paglia
di Tomaso Montanari (Eddyburg, 15 Giugno 2014)
- Intervento di Tomaso Montanari in conclusione dei lavori del convegno su «Venezia e l’architettura moderna», promosso e organizzato dallo Iuav, e tenutosi all’Ateneo Veneto il 23 maggio 2014.
Confesso di non aver capito bene perché mi trovo qua. Sono molto onorato dall’invito a trarre le conclusioni di questa giornata, ma non sono sicuro di aver compreso le ragioni che hanno spinto il collega e amico Aldo Norsa ad affidare proprio a me - che non sono veneziano, e non sono architetto - questo ruolo in una giornata dedicata a «Venezia e l’architettura moderna», una giornata che ambisce ad indicare una via che permetta di «superare le incomprensioni».
Posso solo supporre che un certo simpatico sadismo del professor Norsa l’abbia spinto ad invitare uno storico dell’arte ormai, suo malgrado, noto per lo sforzo di usare una certa parresia, cioè un certo parlar chiaro, nelle cose che riguardano il nostro patrimonio artistico. E, d’altra parte, un bellissimo saggio di Richard Sennet, da poco anche tradotto in italiano, illumina il nesso tra diritto di parola e diritto allo spazio urbano: e proprio concentrandosi sul Ghetto di Venezia, e sulla sua trasfigurazione shakeaspeariana.
Verrebbe dunque voglia di esercitare subito questa parresia.
Il fatto che il programma della nostra giornata debba ammettere che non si potrà parlare del progetto che rischia di distruggere anche la memoria del Fontego dei Tedeschi perché la proprietà non ha autorizzato un simile dibattito, nega le ragioni stesse della nostra professione di ricercatori. Si tratta di un veto inammissibile: un segno concreto del totalitarismo del mercato che, deformando la città, arriva a deformare anche le regole più elementari della democrazia.
O ancora: sono desolato che una sovrabbondanza di impegni, o una cortesia di educazione, impedisca alla soprintendente Renata Codello di ascoltarmi (dopo che io ho disciplinatamente ascoltato la sua desolante allocuzione), ma vorrei comunque invitarla a ritirare immediatamente la sua querela contro Italia Nostra e contro Gian Antonio Stella, rei di averla duramente criticata per il suo appoggio all’irruzione delle Grandi Navi in Laguna e per le troppe autorizzazioni rilasciate alla speculazione edilizia che sta uccidendo Venezia. Ebbene, io sottoscrivo ogni parola di quelle denunce: non so se la soprintendente vuole farmi tacere, querelando anche me.
In ogni caso, non tirerò le conclusioni della giornata: perché l’hanno fatto ora benissimo gli studenti dello Iuav, che hanno portato una ventata di sano buon senso e di vigile spirito critico in una sala finora davvero troppo chiusa. Certo, verrebbe voglia di sottolineare alcune delle loro osservazioni: come quella che stigmatizzava l’idea di spostare dalla città storica tutti i servizi (dall’ospedale alle università), una scelta che non potrà che accelerare e aggravare lo spopolamento di Venezia. E poi sarebbe giusto chiedersi come è stato possibile infierire in modo così barbaro sullo spazio interno dell’Arsenale. O, ancora, che senso abbia progettare e costruire il cosiddetto M9, il Museo del Novecento di Mestre, senza ben sapere cosa vi verrà conservato. Il rischio concreto è che l’altisonante etichetta di ’museo’ copra l’ennesima location per mostre come quelle che mortificano da anni il Nordest del Paese: e già si annuncia la prossima, intitolata a Tutankhamon, Caravaggio, Van Gogh. E non è uno scherzo: è l’apoteosi di Marco Goldin.
Proverò, invece, a prospettarvi una semplice idea: quella di ribaltare il tema di questa giornata, di guardarlo in un altro modo. Invece che chiedersi (magari dolendosi) perché la modernità, attraverso, l’architettura, non sia riuscita a modificare Venezia, vorrei piuttosto chiedermi se Venezia, attraverso la conoscenza della sua architettura, non possa riuscire a modificare la modernità: la nostra idea di modernità.
Il risultato, insomma, non sarebbe un’altra Venezia, ma un’altra modernità. Nel chiedermelo, mi sono rammentato di questa affermazione di Vittorio Gregotti: «Ma io penso che ’Venezia città della nuova modernità’ abbia oggi anche un altro significato, perché credo che sia l’architettura moderna ad avere bisogno di Venezia, luogo della storia per eccellenza, da quando sono profondamente mutati, negli ultimi trent’anni, la natura e il significato della nozione di moderno» (1998).
Manfredo Tafuri più di tutti ci ha insegnato la connessione strettissima tra principi, mentalità, azioni dell’amministrazione, politica, idee architettoniche.
E un primo punto sul quale Venezia può insegnare molto, è un nodo cruciale di questa rete: vale a dire il rapporto tra pubblico e privato. La storia di Venezia sul lungo periodo è una storia di progettazione pubblica, collettiva. Perché, più che in qualunque altro posto del mondo, a Venezia non c’è confine tra architettura e urbanistica. Il fatto che la forma della città sia stata fissata, nella sua massima espansione possibile, in una data straordinariamente alta conferisce ad ogni innovazione di una singola architettura quella che vorrei chiamare una responsabilità urbanistica intrinseca.
A Venezia, in altre parole, non c’è sfasatura tra forma e funzione, tra natura e politica. E questa è una prima lezione per la modernità: la responsabilità della progettazione architettonica, la sua obbligatoria coincidenza con una visione urbanistica.
Questo è ancora più vero, se possibile, a proposito di un altro punto fatale per l’architettura moderna: il rapporto tra la città e il suo territorio. Un territorio che a Venezia si chiama Laguna. La Laguna ha vissuto perché lo ha voluto la Repubblica, che ha saputo tenere in equilibrio acqua e terra, forza dei fiumi e forza del mare. Piero Bevilacqua ha scritto che «la storia di Venezia è la storia di un successo nel governo dell’ambiente, che ha le sue fondamenta in un agire statale severo e lungimirante, nello sforzo severo e secolare di assoggettamento degli interessi privati e individuali al bene pubblico delle acque e della città». Ecco, questa storia è un progetto perfetto per un’altra modernità. Quella che oggi ci manca.
Naturalmente, si tratta una storia controversa e non mancarono le discussioni: celeberrima quella cinquecentesca tra Alvise Cornaro, che avrebbe voluto bonificare la Laguna, e Cristoforo Sabbadino, che ne difese vittoriosamente la continua manutenzione. Una lezione per la conservazione di tutto il nostro patrimonio: la lezione che Giovanni Urbani ha inutilmente provato a portare nel cuore del Novecento.
Come ci ha lucidamente mostrato Edoardo Salzano, questa storia gloriosa si è interrotta con l’avvento dell’Italia unita, ed è definitivamente collassata negli ultimi quarant’anni di malgoverno veneziano. Per fare entrare le Grandi Navi (turistiche, industriali e commerciali) si sono dragati e approfonditi i canali d’accesso in Laguna, e contemporaneamente se ne è abbandonata la secolare manutenzione. Il risultato è stato un abnorme aumento dell’acqua alta, culminato nella vera e propria alluvione del 1966. Fu proprio quell’enorme choc che mise Venezia di fronte all’alternativa: o riprendere il governo della Laguna e mantenere l’equilibrio, o essere mangiata dall’Adriatico.
Fu allora che emerse la terza via: il Mose, che permise di eludere la scelta tra responsabilità e consumo. L’idea era di continuare indefinitamente a violentare la Laguna e poi rimediare meccanicamente, con una gigantesca valvola che chiudesse le porte al mare. È come se un paziente ad altissimo rischio di infarto venisse persuaso dai medici a non sottoporsi ad alcuna dieta né ad alcun esercizio fisico, e a scommettere invece tutto su una costosissima e complicata operazione di angioplastica. Non verrebbe da pensare solo che i medici sono incompetenti: ma anche che hanno qualche interesse occulto nell’operazione. Follemente, la scelta della terapia è stata affidata direttamente ai chirurghi. Fuor di metafora: la salvezza di Venezia e del suo territorio è stata affidata ad un consorzio di imprese private (il Consorzio Venezia Nuova) interessate a realizzare il costosissimo meccanismo di riparazione del danno, il Mose appunto. E tutto è stato asservito a questo ente: anche il controllo del Magistrato delle Acque, che si è trovato a ratificare (invece che a sorvegliare) scelte operate in base all’interesse privato.
Sarebbe difficile spiegare un simile suicidio se non vedessimo che Venezia si distrugge ogni giorno in mille altri modi, prostituendosi, fino alla morte, ad un turismo cannibale.
Privatizzazione del destino della città ed economia della prostituzione: anche nella sua agonia Venezia addita alla nostra modernità le strade da non percorrere.
Ora, qui è il caso di chiedersi: ma in tutto questo l’architettura - gli architetti - da che parte sta? Dalla parte di quale modernità? Dalla parte dell’interesse pubblico, del governo pubblico dell’ambiente, di una visione condivisa di città, di una manutenzione dell’organismo urbano storico, oppure invece dalla parte dell’interesse privato, del governo privatizzato della res publica, dei rimedi meccanici ai danni antropici, del disequilibrio forzato?
Stanno dalla parte di Alvise Cornaro, o dalla parte di Cristoforo Sabbadino? Chi è più moderno? Dove sta la modernità? Tutte queste domande si possono riassumere in una sola domanda: quale sviluppo, quale modernità, noi vogliamo?
In pratica: siamo orientati verso l’aumento dei volumi, o no? Vogliamo continuare a mangiare e privatizzare lo spazio pubblico, o no? Vogliamo cavalcare lungo la rotta attuale, o invertirla? E, ancora più in dettaglio: vogliamo una città-location-per-eventi, o una città viva? Una disneyland per turisti o una città dei residenti? Vogliamo spettatori o vogliamo cittadini? Vogliamo collaborare alla dittatura del mercato, o vogliamo restaurare la democrazia.
Rispondiamo a queste domande e sapremo che tipo di architettura vogliamo fare. Paola Somma, in un aureo libretto sulla Biennale di architettura (significativamente intitolato: Mercanti in fiera), ha scritto: «Ovviamente, la Biennale non è la sola responsabile dello stravolgimento economico e sociale che ha trasformato Venezia prima in vetrina e poi in merce essa stessa. Ma ha attivamente cooperato con i governi e le istituzioni locali e nazionali e con i gruppi finanziari interessati a riconvertire le cosiddette città d’arte in fabbriche di eventi e in condensatori di rendita immobiliare e fondiaria». Le Biennali sono state vetrine di un’architettura vuotamente citazionista, simbolista, fondata su un superficiale e soggettivo gioco di analogie formali. Un’architettura spesso legata a doppio filo ad una selvaggia speculazione finanziaria. Le Biennali sono arrivate fino a legittimare un’aberrazione artistica, sociale e ambientale come la Torre di Cardin. Sono state il palcoscenico di un’architettura programmaticamente irresponsabile: e come tale, profondamente anti moderna. O almeno diametralmente opposta alla modernità suggerita dalla storia costruttiva di Venezia.
Che può essere riassunta in una sola parola: responsabilità. Che è anche la parola chiave di una modernità che voglia avere un futuro.
Salvatore Settis ha recentemente proposto agli architetti di adottare un giuramento che orienti la loro professione appunto nel senso della responsabilità: un giuramento sul modello di quello ippocratico. Un giuramento vitruviano. Ecco, se un simile giuramento di massa dovesse mai celebrarsi davvero - come speriamo - esso non potrebbe avvenire che in un unico luogo al mondo: a Venezia.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- AL SAN RAFFAELE. A Milano, convegno su "prospettive hegeliane"29 maggio 2014, di Federico La Sala
Un fantasma s’aggira nel mondo odierno. La filosofia hegeliana
Calare il pensiero del «Drago di Jena» nella contemporaneità
A Milano studiosi a convegno
di Giulio Goria e Giacomo Petrarca (l’Unità, 29.05.2014)
«NON SI FA FILOSOFIA COME SI STA IN PIEDI E SI CAMMINA». Cioè: non è da tutti. Senza dubbio oggi a parlare così s’incontra una generale derisione; o almeno l’incomprensione dei più. Giacché si capisce che un’espressione così lapidaria ed urticante stride con le comuni avvertenze adottate nell’agone democratico e liberale, quanto mai attento ad estendere il campo della pubblica discussione. Di ciò non v’è neppure più sorpresa. Quel che invece dovrebbe far nascere qualche sospetto in più è il fatto che il riso si diffonda anche nel cosiddetto circuito accademico; quello stesso circuito che, però, spesso si intesta la padronanza della filosofia. Con una differenza: che lì alla durezza della proposizione citata si accompagnerebbe la conoscenza della penna che l’ha scritta, quella di Hegel.
Ecco allora la tanto rischiosa impresa che ha riunito alcuni filosofi italiani presso l’università San Raffaele di Milano: prendere sul serio la lapidarietà dell’ammonimento hegeliano senza però farne argomento di sola tecnica accademica. Questo l’intento che questa settimana ha animato il convegno dedicato proprio «al drago di Jena», come il contemporaneo Schelling ebbe ad apostrofare Hegel.
Due giornate di studi in cui personalità di diversa provenienza ma accomunate tutte da indubbia originalità nel panorama filosofico italiano - Luca Illetterati, Massimo Adinolfi, Adriano Fabris, Gaetano Rametta, Massimo Donà, Vincenzo Vitiello - hanno dialogato con più giovani studiosi, dottorandi, ricercatori. Che sia stato un convegno tra esperti però non spiega affatto che si sia trattato di filosofia; con buona pace di chi vorrebbe ridurre al ristretto specialismo il senso delle parole hegeliane sopra citate.
Dove allora andare a cercarlo l’esercizio della filosofia, senza confonderne il fantasma con il corpo vivente? A sentire gli interventi della due giorni milanese si potrebbe abbozzare una risposta del genere: là dove c’è la fatica del pensiero per darsi collocazione nella realtà; e dunque, proprio nelle forme linguistiche, politiche e religiose che al mondo appartengono. «Prospettive hegeliane - che è il titolo del convegno milanese - allude dunque al modo in cui la filosofia, quella di ieri non più di quella di oggi, deve forse abitare il suo presente: portando la realtà in pensieri non meno che il pensiero nella molteplice e varia realtà; realtà che se risulta a portata di mano - o di quella mano inedita che sono le nostre protesi tecnologiche -, ad un tempo si dilegua e disperde in multiformi e sfuggevoli rivoli; tanti e tanto differenti sono gli alberi da render straordinariamente ardua la vista generale della foresta.
Sa la filosofia rimanere se stessa calandosi in queste impervie vie? Ha ancora uno sguardo sull’intero? Hegel viene in questione oggi perché il mondo sfugge al suo concetto:ma non è in questo modo richiesto, se non la si vuol far troppo facile, un pensiero di questo mondo, il che ci riporta nuovamente a Hegel e al suo bisogno di filosofia a partire dalle forme che il mondo assume? O la si mette così o non si fa che vuota retorica accademica rilanciando la domanda: «perché e come Hegel oggi?».
Insomma, né si confanno alla filosofia le prediche edificanti che vorrebbero rivolgersi al mondo appuntandogli una forma che dovrebbe - chissà poi per quale ragione - indossare. Né il discorso filosofico evita il rischio di mutare natura relegandosi alla dimensione accademica, per quanto inappuntabili possano essere i suoi risultati. In entrambi i casi cioè non cambia la sostanza: la filosofia ci farebbe - e troppo spesso oggi ci fa - la stessa figura di generale imbarazzo del bibliofilo protagonista del noto romanzo di Elias Canetti, Auto da fé, quando nel mondo si addentra: mondo senza testa o teste (accademiche) senza mondo?
Così le prospettive hegeliane cercate o almeno indicate nel convegno, ben prima di proporsi come un esito o una soluzione, sono la riproposizione di un gesto, di un esercizio, quello filosofico - antico quanto il proprio sorgere, dunque anche sempre nuovo; gesto che ponendo la domanda sul proprio tempo, sul proprio oggi, interroga anzitutto il senso del proprio interrogare, o meglio: la possibilità della propria interrogazione. Via stretta, forse, ma certo percorribile, per porsi in salvo - volendo restare nella metafora canettiana - dal rogo della propria biblioteca. Domanda, dunque, del pensiero sulle cose - anzitutto su quella peculiare cura per il mondo che è la filosofia stessa. Domanda vana, chiacchiera che annoia, e semmai solo insospettisce, la pratica scientifica? Forse sì.
Certo è che il convegno si sia svolto in un ateneo - il San Raffaele di Milano - segnato sin nelle viscere dalla vocazione verso le scienze mediche e non solo mediche. Che è un po’ come dire: talvolta alla filosofia riesce di prendere aria pura anche senza il soccorso del respiratore artificiale.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- IL "PENSIERO RESISTENTE" DEL COLONNELLO PROCOPIO: MARIO DAL PRA (di Riccardo Pozzo)4 maggio 2014, di Federico La Sala
Mario Dal Pra (1914-1992)
Pensiero resistente
Partigiano (è lui il celebre Colonnello Procopio di Giustizia e Libertà), è stato uno dei più rigorosi storici della filosofia
di Riccardo Pozzo (il Sole-24ore domenica, 04.05.2014)
La storia intellettuale e la storia della filosofia non si parlano. Diversi gli approcci metodologici, poca la letteratura secondaria in comune, diverso persino il modo di scrivere le note. Eppure, gli argomenti sono gli stessi: il pensiero e la sua storia. La ricerca di un modello italiano per la storia del pensiero inizia da una considerazione critica e fattuale di questo non parlarsi.
È il caso di citare i corifei del settore, riviste d’indiscussa autorità: in Italia, la «Rivista critica di storia della filosofia», fondata da Mario Dal Pra nel 1946, in Germania, l’«Archiv für Geschichte der Philosophie», risalente al 1888, e in America il «Journal of the History of Philosophy», fondato nel 1952. L’idea è che la relazione tra storia storica della filosofia e storia filosofica della filosofia sia sempre esistita e valga la pena tematizzarla nella sua flessibilità decennio per decennio.
Questione che fu degna dell’attenzione di Mario Dal Pra e del Centro di Studio per la Storia del Pensiero Filosofico e Scientifico del Cinquecento e del Seicento in relazione ai Problemi della Scienza, centro del Consiglio Nazionale delle Ricerche da lui fondato nel 1964 presso l’Università Statale di Milano.
Nato a Montecchio Maggiore il 29 aprile 1914, esattamente cent’anni orsono, Dal Pra si laureò in filosofia a Padova con una tesi diretta da Erminio Troilo. Prima professore di filosofia e storia al Liceo Scientifico di Rovigo (1937-1939) e poi al Liceo Classico di Vicenza (1939-1943). Si trasferì a Milano durante la seconda guerra mondiale, soprattutto per l’impegno assunto nella guerra partigiana (fu lui il celebre Colonnello Procopio di Giustizia e Libertà, decorato con due croci di guerra al merito partigiano).
Professore di filosofia e storia al Liceo Classico Carducci di Milano (1946-1951), nel dicembre 1951 divenne professore di Storia della Filosofia Antica e di Storia della Filosofia Medievale alla Statale di Milano, dove infine successe ad Antonio Banfi sulla cattedra di Storia della Filosofia, per lunghi anni la più prestigiosa del paese, e che non a caso continua a essere la sede della «Rivista critica di storia della filosofia» presso la quale appresero il mestiere generazioni di intellettuali milanesi. Ci lasciò il 21 gennaio 1992.
Storico del pensiero di prestigio internazionale (tra i suoi argomenti, lo scetticismo greco, Abelardo e la logica medievale, Hume, Condillac, il giovane Marx, il pragmatismo, americano e italiano, la storia della storiografia filosofica), Dal Pra ha contribuito alla filosofia teoretica e con il trascendentalismo della prassi, per un chiarimento del rapporto tra teoria e prassi in una prospettiva antimetafisica.
Scriveva Dal Pra di voler «evitare la ripetizione di disegni generali di storia del pensiero» e di essersi quindi «cautamente guardato», insieme con i suoi collaboratori, «dall’abbracciare disegni generali astratti», evitando di «dare alla storia del pensiero un significato rigorosamente univoco e uno svolgimento eccessivamente semplice e lineare».
Una ricerca storica scientificamente rigorosa, la sua, attenta a una costante «cautela critica» e a «complessi approcci filologici», che divenivano in tal modo l’antidoto «alla rarefazione di una visione chiusa e sistematica della vicenda storica della filosofia».
Certo, restare fedeli alla centralità del testo è un’impresa degna del più squisito neoumanesimo. Non è cosa ovvia: significa trovare il comune denominatore per lo scambio di pensieri, discorsi e discussioni su testi che ci hanno raggiunto dopo secoli e secoli.
Il testo è ciò che media fra contesto e idea, e chi si occupa di lessico e di testo media fra storia della filosofia e storia delle idee (o, meglio, intellectual history). La storia della filosofia non può avere più nulla a che vedere con il tentativo di sistematizzazione del sapere filosofico di un’epoca in relazione alle precedenti proposto da Hegel.
Una ricerca innovativa è pensabile, oggi, solo sulla base della complementarietà che lega le ricostruzioni della storia personale dei filosofi nel contesto delle loro regioni, istituzioni e dell’opinione pubblica loro contemporanea.
Ad esempio, si può pensare di ricostruire la storia della filosofia del l’età moderna addirittura a livello regionale, seguendo come unità di misura i bacini di utenza delle singole università. L’interazione tra storia della filosofia e storia delle istituzioni è in effetti il fondamento sul quale è costruita l’identità della storia della filosofia italiana secondo la lezione di Dal Pra.
Il futuro sta nella creazione di un modello italiano alla storia della filosofia che tenga conto degli aspetti lessicali del testo e della considerazione del paratesto.
Qui va esaltato il ruolo del CNR, che ha reso possibili innovazioni di rilievo in contesti felicemente interdisciplinari. Il 29 maggio 2014, un mese dopo il centenario della nascita di Mario Dal Pra, festeggeremo i cinquant’anni dell’Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo e Storia delle Idee (ILIESI-CNR), dell’istituto che per primo mise a disposizione degli studiosi una biblioteca digitale quando ancora i calcolatori occupavano stanze intere e che oggi raccoglie l’eredità del Centro di Studio per il Lessico Intellettuale Europeo, fondato da Tullio Gregory e Tullio De Mauro nel 1964 e del Centro di Studio per la Storia del Pensiero Antico, fondato da Gabriele Giannantoni nel 1979. Dal Pra sarà ricordato nei prossimi mesi da un numero monografico della «Rivista di storia della filosofia» e da diversi convegni.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- La mostruosa normalità di un sistema corruttivo.25 aprile 2014, di Federico La Sala
La mostruosa normalità di un sistema corruttivo
di Paolo Favilli (il manifesto, 25 aprile 2014)
L’uso senza limiti del linguaggio iperbolico in un dibattito politico quasi sempre privo di spessore analitico ci sta privando della possibilità di orientarci. Se la politica finanziaria connessa all’attuale gestione dell’euro diventa "Auschwitz". Se ogni approvazione di leggi da parte della maggioranza (spesso davvero ingiuste e intrise di conflitti d’interessi) diventa "colpo di stato". Se la reale tendenza al progressivo concentrarsi del potere in ristrette oligarchie diventa "ritorno al fascismo", ebbene la specificità e il peso di ogni fenomeno scompaiono ed orientarsi in «"una notte in cui tutte la vacche sono nere" è impresa assai difficile.
In un articolo apparso su questo giornale qualche giorno fa (15 aprile,Berlusconi-Napolitano «gli esiti criminali della politica separata») ho usato anch’io tinte molto forti. Si tratta, però, e credo che questa affermazione possa reggere l’onere della prova, di un linguaggio con alto grado di mimesi nei confronti della realtà. Il problema è che il fenomeno al centro di quello scritto, se analizzato davvero, è in grado di produrre disvelamenti, tanto sull’oggi che su un itinerario storico ventennale, che i facitori di opinione sembrano impossibilitati a sopportare. Meglio la rimozione.
Luigi Pintor diceva che dopo mezzogiorno con il quotidiano si potevano incartare le patate. Visto con quanta facilità si dimentica, mi si scuserà se faccio riferimento all’articolo citato. I dati di fatto non sono controvertibili. Dall’insieme delle sentenze relative a Berlusconi, Previti, Dell’Utri (su quest’ultimo si attende ancora quella definitiva della Cassazione che, come ricordiamo, non è giudice di merito) emerge un quadro criminale impressionante.
Il centro del quadro è rappresentato da un enorme e ramificato sistema corruttivo espanso in tutte le possibili varianti. Il sistema corruttivo è necessità funzionale come uscita di sicurezza per una molteplicità di comportamenti delinquenziali. La politica è una delle varianti più importanti tanto come uscita di sicurezza che come luogo privilegiato del circuito potere-denaro.
La triade suddetta è stata il fulcro, il soggetto agente della costruzione di un soggetto politico che per lunghi anni ha esercitato il potere ad ogni livello della vita pubblica. Ancora oggi il soggetto creato vent’anni fa è tutt’altro che marginale e le sue prospettive non sono necessariamente perdenti.
Naturalmente sarebbe una sciocchezza pensare che il successo di quella forza politica sia derivato da una logica criminale, ma quella logica, tenuto conto del ruolo centrale della triade, ha informato di sé aspetti importantissimi delle pratiche di governo. Inoltre è stato punto di riferimento legittimante di analoghe pratiche locali: il paradigma Cosentino si comprende meglio nell’ambito di tale insieme strutturale.
Per la prima volta nella storia dell’Italia repubblicana i gangli fondamentali della vita politica si trovano ad essere intrinsecamente legati a una operazione criminale. Di fronte a tutto ciò ci troviamo a vivere in una situazione di "normalità mostruosa", come potremmo definirla con un ossimoro. Mostruosa: sia come fenomeno straordinario, che suscita stupore, sia come fenomeno orribile. Normalità: in quanto lo svolgimento della vita politica non è assolutamente toccato dalla mostruosità.
Si pensi solo alla leggerezza con cui autorevoli editorialisti di autorevoli quotidiani hanno trattato questo enorme peso che grava su tutta la nostra vita etico-civile. Commentando la sentenza che ha fissato la pena (si fa per dire) rieducativa per il delinquente, ci viene data l’immagine di un uomo "dolorante dietro l’eterno sorriso (...) un uomo che merita rispetto", un uomo i cui errori sono quelli di non aver fatto le riforme promesse, un uomo che però ha definitivamente superato una "guerra giudiziaria" finita da tempo (Massimo Franco, Corriere della sera, 16 aprile).
E anche dal fronte pervicacemente antiberlusconiano (la Repubblica), dopo aver messo giustamente in rilievo lo "status particolare" che spiega l’agibilità politica concessa al delinquente, non si fa una piega di fronte alla "necessità" di farne un padre della patria, visto che Renzi avrebbe avuto una via "quasi obbligata" (Massimo Giannini, 16 aprile).
L’espressione "non ci sono alternative", non casualmente una delle preferite da Margaret Thatcher per giustificare la durissima repressione sociale, è, in genere, causa delle maggiori nefandezze. Nel nostro caso non si tratta di "necessità» bensì di una conclamata «sintonia» per una prospettiva di bipartitismo forzoso su cui Renzi e Berlusconi giocano il futuro delle loro fortune politiche.
Ma la questione centrale su cui gli autorevoli opinionisti svolazzano entrambi, l’uno auspicando il superamento definitivo di «una guerra finita da tempo», l’altro facendo appello allo stato di necessità, è la compatibilità del quadro che esce dalle sentenze Berlusconi, Dell’Utri, Previti, con qualsiasi ruolo di rilevanza politica, figuriamoci con quello di «padre della patria». In realtà, su questo, la guerra non c’è mai stata.
Il dilemma, in fondo, è piuttosto semplice: le sentenze dicono il vero o sono il frutto della falsificazione di una magistratura politicizzata? La seconda ipotesi è sostenuta, con forza, non solo dai condannati, ma da aree politiche e d’opinione relativamente ampie. Gli autorevoli devono dirci se la condividono o meno. Penso di sì, perché è l’unica ipotesi in perfetta coerenza con i loro svolazzamenti. Diranno che Berlusconi ha i voti e il loro è semplicemente realismo politico. Non di realismo si tratta, invece, ma dell’accettazione, della condivisione di quello stato di necrosi che caratterizza il tessuto connettivo civile in Italia.
Ovviamente è del tutto inutile chiedere ai molti «autorevoli» di uscire dal recinto in cui stanno comodi e protetti, ma forse non è inutile chiedere a chi sta fuori il recinto, in vari e articolati modi, di assumere il quadro che emerge dalle sentenze come uno dei problemi essenziali delle iniziative politiche in corso.
Il berlusconismo non è il fascismo, certo, ma il solo modo di uscirne davvero è quello della cesura netta, sia pure in forme diverse, con la quale l’Italia è uscita dal fascismo. Sappiamo bene che nemmeno le cesure sono in grado di tagliare davvero la vischiosità profonda dei processi storici, pur tuttavia sono i soli momenti che possono segnare una, seppur parziale, discontinuità radicale.
I compagni, i professoroni, i professori qualsiasi (come chi scrive), devono prendere coscienza che anche questa via d’uscita dal berlusconismo, e da tutti gli affinismi col berlusconismo, è una «via maestra». La battaglia difficile per l’affermazione della lista L’altra Europa con Tsipras non può ignorare il problema. L’Italia deve presentarsi in Europa anche con una forza che rappresenti davvero l’antitesi a un volto del paese sfigurato dal morbo criminal-politico. Frutto di quella «passata di peste» che Paolo Volponi, profeticamente, aveva visto sopraggiungere più di vent’anni fa.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- Gli scienziati: “Manifesto Per un’Europa di progresso” (Promoti e firmatari).7 aprile 2014, di Federico La Sala
“Manifesto
Per un’Europa di progresso”
- Martedì 8 aprile presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche di Piazzale Aldo Moro a Roma verrà presentato il “Manifesto per un’Europa di progresso” (ore 11.00, Sala Convegni).
Il mondo è in rapida trasformazione. Società ed economia della conoscenza hanno profondamente ridisegnato equilibri ritenuti consolidati. Aree geografiche depresse hanno conquistato, in tempi storicamente irrisori, potenziali enormi di sviluppo e crescita. Conoscenza, cultura e innovazione rappresentano più che mai il traino decisivo verso il futuro.
All’opposto l’Occidente, e alcuni aspetti del suo modello di sviluppo, sono entrati in una crisi profonda. L’Europa, in particolare, risulta investita da gravissimi e apparentemente irresolubili problemi: disoccupazione, crisi del tessuto produttivo, riduzione sostanziale del welfare. A pochi anni dalla sua formale consacrazione, con la nascita ufficiale della moneta comune, l’Europa rischia di deflagrare come sogno di una comunità di cittadine e cittadini che avevano ambito ad una nuova Nazione comune: più ampia non solo geograficamente, quanto nello spazio dei diritti, dei valori e delle opportunità. Lo storico americano Walter Laqueur ha parlato della “fine del sogno europeo”.
Le responsabilità sono diverse e distribuite e investono certamente l’eccessiva timidezza nel processo di costituzione politica del soggetto europeo: la responsabilità di presentare questo orizzonte politico, culturale e sociale con le sole fattezze della severità dei “conti in ordine”. L’Europa dei mercanti e dei banchieri, della restrizione e del rigore: una sorta di gendarme che impone limiti spesso insensati, piuttosto che sostegno nell’ampliare prospettive di visuale sugli sviluppi del futuro.
Proprio a causa di ciò, assistiamo, in corrispondenza della crisi, ad un’impressionante crescita di egoismi locali, di particolarismi e di veri e propri nazionalismi.
Fenomeni spesso intenzionalmente organizzati per sfruttare malesseri veri, e reali stati di sofferenza, ma che rischiano di produrre reazioni esattamente opposte a quanto oggi servirebbe alle popolazioni d’Europa.
Come scienziate e scienziati di questo continente - consapevoli che esiste un nesso inscindibile tra scienza e democrazia - sentiamo quindi la necessità di metterci in gioco. Di ribadire che il processo di costruzione degli Stati Uniti d’Europa è la più importante opportunità che ci è concessa dalla Storia. Che società ed economia della conoscenza - essenziali per il processo di reale evoluzione civile, pacifica, economica e culturale - si alimentano di comunità coese e collaborative, di comunicazioni intense e produttive e di uno spirito critico che permei strati sempre più vasti della società.
L’unica risposta possibile alla crisi incombente è allora la costruzione dell’Europa dei popoli, di un’Europa di Progresso! Realizzata sulla base dei principi di libertà, democrazia, conoscenza e solidarietà.
Nutriamo la stessa speranza con cui Albert Einstein e Georg Friedrich Nicolai nel “Manifesto agli Europei” del 1914 richiamarono alla ragione i popoli europei contro la sventura della guerra, e con cui Altiero Spinelli, Eugenio Colorni ed Ernesto Rossi ispirarono l’idea d’Europa nel loro “Manifesto di Ventotene” del 1943. Le stesse idee che ebbero indipendentemente fautori illustri anche in tutti i Paesi d’Europa.
Vogliamo riprendere ed estendere all’Europa lo spirito che nel 1839 portò gli scienziati italiani a organizzare la loro prima riunione e a inaugurare il Risorgimento di una nazione divisa.
Promotori (*) e Primi firmatari
Ugo AMALDI (CERN, Ginevra)
Giovanni BACHELET (Università di Roma “La Sapienza”)
Giorgio BELLETTINI (Università di Pisa e INFN)
Carlo BERNARDINI (*) (Università di Roma “La Sapienza”)
Sergio BERTOLUCCI (Direttore di ricerca, CERN, Ginevra)
Vittorio BIDOLI (INFN, Roma)
Giovanni BIGNAMI (Presidente Istituto Nazionale di AstroFisica - INAF)
Marcello BUIATTI (Università di Firenze)
Cristiano CASTELFRANCHI (Università Luiss, Uninettuno e ISTC-CNR)
Vincenzo CAVASINNI (*) (Università di Pisa e INFN)
Remo CESERANI (Università di Bologna e Stanford University, CA)
Emilia CHIANCONE (Presidente Accademia dei Quaranta)
Paolo DARIO (Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa)
Tullio DE MAURO (Università di Roma “La Sapienza”)
Luigi DI LELLA (CERN, Ginevra)
Rino FALCONE (*) (CNR Roma, Direttore Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione)
Stefano FANTONI (Presidente Agenzia Nazionale Valutazione Università e Ricerca)
Sergio FERRARI (già vice direttore ENEA)
Ferdinando FERRONI (Presidente Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN)
Fabiola GIANOTTI (CERN, Ginevra)
Mariano GIAQUINTA (Scuola Normale Superiore, Pisa)
Pietro GRECO (*)(Giornalista e scrittore, Roma)
Angelo GUERRAGGIO (Università Bocconi)
Fiorella KOSTORIS (Agenzia Nazionale Valutazione Università e Ricerca)
Francesco LENCI (*) (CNR Pisa e Pugwash Conferences for Science and World Affairs)
Giorgio LETTA (Vice Presidente Accademia dei Quaranta)
Lucio LUZZATTO (Istituto Toscano Tumori)
Tommaso MACCACARO (INAF)
Lamberto MAFFEI (Presidente Accademia dei Lincei)
Italo MANNELLI (Scuola Normale Superiore, Pisa e accademico dei Lincei)
Giovanni MARCHESINI (Università degli studi di Padova)
Ignazio MARINO (Thomas Jefferson University, Sindaco di Roma)
Annibale MOTTANA (Università di Roma 3 e accademico dei Lincei)
Paolo NANNIPIERI (*) (Università di Firenze)
Pietro NASTASI (*) (Università di Palermo)
Luigi NICOLAIS (Presidente Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR)
Giorgio PARISI (Università di Roma “La Sapienza”, accademico dei Lincei)
Maurizio PERSICO (Università di Pisa)
Giulio PERUZZI(*) (Università degli studi di Padova)
Caterina PETRILLO (Università degli studi di Perugia)
Pascal PLAZA (CNRS e Ecole Normale Supérieure, Paris)
Claudio PUCCIANI (*) (Vice Presidente Associazione Caffè della Scienza - Livorno)
Michael PUTSCH (CNR Genova, Direttore Istituto di Biofisica)
Carlo Alberto REDI (Università di Pavia)
Giorgio SALVINI (Università di Roma “La Sapienza”, già Presidente dell’Accademia dei Lincei)
Vittorio SILVESTRINI (Presidente della Fondazione IDIS - Città della Scienza, Napoli)
Settimo TERMINI (*) (Università di Palermo)
Glauco TOCCHINI-VALENTINI (National Academy of Sciences, CNR-EMMA-Infrafrontier-IMPC, Monte Rotondo, Roma)
Guido TONELLI (CERN, Ginevra e Università di Pisa)
Enric TRILLAS (Emeritus Researcher European Centre for Soft Computing, già Presidente CSIC, Spagna)
Fiorenzo UGOLINI (Università di Firenze)
Nicla VASSALLO (Università di Genova)
Virginia VOLTERRA (Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione - CNR)
Elena VOLTERRANI (*) (Provincia di Pisa e INFN)
John WALSH (INFN)
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- VICO, LA «SCUOLA» DEL GENOVESI, E IL FILO SPEZZATO DEL SETTECENTO RIFORMATORE.23 marzo 2014, di Federico La Sala
 STORIA D’ITALIA. INTELLETTUALI E SOCIETA’....
STORIA D’ITALIA. INTELLETTUALI E SOCIETA’....
 VICO, LA «SCUOLA» DEL GENOVESI, E IL FILO SPEZZATO DEL SETTECENTO RIFORMATORE. Una ’Introduzione’ di Franco Venturi, tutta da rileggere
VICO, LA «SCUOLA» DEL GENOVESI, E IL FILO SPEZZATO DEL SETTECENTO RIFORMATORE. Una ’Introduzione’ di Franco Venturi, tutta da rileggere
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- IL "CONTEMPORANEO" CROCE E L’ "ARCAICO" VICO. Due note sull’interpretazione crociana di Vico.17 marzo 2014
 GIAMBATTISTA VICO E LA STORIA DELLA STORIOGRAFIA FILOSOFICA...
GIAMBATTISTA VICO E LA STORIA DELLA STORIOGRAFIA FILOSOFICA...
 IL "CONTEMPORANEO" CROCE E L’ "ARCAICO" VICO. Due note sull’interpretazione crociana di Vico
IL "CONTEMPORANEO" CROCE E L’ "ARCAICO" VICO. Due note sull’interpretazione crociana di Vico
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- «L’eredità avvelenata». Confessioni che non lasciano dubbi. Heidegger, antisemita e vero nazista14 marzo 2014, di Federico La Sala
I Quaderni neri. Confessioni che non lasciano dubbiHeidegger, antisemita e vero nazista
Deluso dal regime, lo accusò di aver tradito gli ideali accettando «l’americanismo»
di Ranieri Polese (Corriere della Sera, 14.03.2014)
«Martin Heidegger fu un nazista? Sì». «Martin Heidegger fu un antisemita? Sì». Sulla «Frankfurter Allgemeine Zeitung» di ieri, Jürgen Kaube, dopo aver letto le quasi 1300 pagine dei famosi Quaderni neri - detti così per la copertina cerata come si usava una volta - che comprendono gli anni dal 1931 al 1941, da ieri in libreria e a disposizione di tutti, chiude così la questione che ha tormentato la storia della cultura europea dalla fine della guerra a oggi.
Se già era nota l’adesione di Heidegger al Partito nazionalsocialista (primo maggio 1933, poco dopo esser diventato rettore dell’università di Friburgo), finora si era escluso che avesse avuto opinioni antisemite. E invece in quei Quaderni , negli anni di guerra, ricorrono frasi e pesanti considerazioni contro gli ebrei. Ma anche il nazismo di Heidegger, ricorda Kaube, era stato considerato una breve parentesi, visto che il filosofo si dimetteva dall’incarico del rettorato già nell’aprile del 1934.
Ora, nelle pagine dei Quaderni , si vede invece che il periodo del ritorno agli studi, lontano da incarichi ufficiali, non fu un drastico ripensamento, l’ammissione di un errore - Heidegger lo disse nell’intervista concessa allo «Spiegel» nel 1966 - ma anzi il frutto di una delusione: i nazisti non erano all’altezza delle speranze che il filosofo nutriva nella loro azione.
Sempre ieri, il settimanale «Zeit» pubblicava il lungo articolo di Thomas Assheuer su questo Heidegger non più segreto. «Se anche in queste pagine fosse riconoscibile un pensiero, i Quaderni sono un delirio filosofico e un crimine del pensiero». Ricorda, Assheuer, i tanti tentativi di cancellare sospetti e dicerie sul coinvolgimento politico di Heidegger, salvando così il filosofo di Essere e tempo da accuse e infamie. Ora però questi taccuini, scritti senza cancellature né correzioni come i testi destinati alla pubblicazione, ci mostrano che il legame tra Heidegger e il nazismo si saldava con le esigenze del suo pensiero, in cerca di un «nuovo avvio», proprio come la Germania di quegli anni.
Ci vuole un Führer - Le note dei Quaderni cominciano nell’ottobre 1931, anno di crisi per la Germania (6 milioni di disoccupati). Per Heidegger il popolo (Volk ) ha bisogno di una rivoluzione nazionale, di una scossa che gli dia un «nuovo inizio». Finalmente arriva Hitler, «il Führer che ha risvegliato una nuova realtà, che dà al nostro pensiero la retta via e la forza d’urto». Nel 1933, dopo la presa del potere di Hitler, Heidegger, che già l’anno prima ha votato per il Partito nazionalsocialista, accetta la nomina a rettore dell’Università di Friburgo (21 aprile). Il primo maggio si iscrive al partito. Nel novembre, infine, partecipa a Lipsia alla riunione dei docenti tedeschi che affermano la loro fede in Adolf Hitler. Nell’aprile del 1934, però, si dimette dall’incarico di rettore.
I Quaderni ci mostrano uno Heidegger deluso dal nazismo perché non sembra volere «il nuovo inizio» sperato. Non è il movimento che «supera l’età moderna», ma invece la «conduce a compimento» indulgendo all’«americanismo» della radio e del cinema portati nelle campagne a imbastardire la sana e antica gente contadina. L’orrore per la tecnica diventa così l’identificazione del nemico nel popolo inglese, che ha inventato «le macchine, la democrazia e l’utilitarismo». E la guerra, quando arriva inevitabilmente, per lui segna veramente il nuovo slancio dei tedeschi.
Gli ebrei - È alla fine degli anni Trenta che compaiono nei Quaderni delle riflessioni sugli ebrei, che «non hanno un territorio», che sono dotati di una «spiccata destrezza a contare, a infiltrarsi, a mescolarsi con gli altri». In una nota del 1938-39 si legge: «Gli ebrei vivono, considerato il loro rimarcato talento nel far di conto, da più tempo di tutti secondo il principio della razza, ragion per cui sono quelli che si oppongono più strenuamente alla sua applicazione illimitata».
Frase che si comprende appieno tenendo conto del fatto che nel 1938 entravano in vigore ulteriori limitazioni ai diritti civili degli ebrei in Germania, e che ogni protesta, per esempio di imprenditori o negozianti (quelli che fanno di conto) costretti al fallimento, veniva brutalmente repressa. Ma anche - spiega Jürgen Kaube sulla «Faz» - Heidegger vuole difendere le leggi di Norimberga, promulgate nel 1935 per la «difesa del sangue tedesco», rinfacciando agli ebrei la loro secolare pratica della endogamia, del rifiuto cioè di matrimoni misti.
Con la guerra, 1939, compare nei Quaderni la categoria del Weltjudentum, l’ebraismo mondiale che sta dietro i Paesi che combattono contro la Germania. «L’ebraismo mondiale, istigato dagli emigranti lasciati uscire dalla Germania, è dovunque imprendibile e non ha la necessità, nonostante tutto lo spiegamento di forze, di partecipare ad azioni militari. Invece a noi non resta che sacrificare il miglior sangue dei migliori figli del popolo» (1941). Dove si legge un chiaro accenno a una sorta di complotto mondiale contro la Germania dietro a cui stanno gli ebrei.
Quei terribili inglesi - Non solo per lo Heidegger dei Quaderni gli inglesi personificano il male assoluto (tecnica, democrazia, utilitarismo). Ma hanno anche un’altra colpa grave. «Ma può essere un caso che il mio pensiero e le mie questioni nell’ultimo decennio siano stati rifiutati proprio in Inghilterra, e che non si sia fatta nessuna traduzione delle mie opere?».
Un’intervista per la storia - Heidegger, comunque, continua a far da protagonista. Proprio in questi giorni è uscito un libro sulla famosa intervista concessa dal filosofo a Rudolf Augstein, fondatore e direttore di «Spiegel». Era il 1966, dopo una lunga trattativa, Augstein raggiunge Heidegger nella sua Hütte , nella Foresta nera. Parlano a lungo, l’accordo è che non siano domande accusatorie, Heidegger dà la sua disinvolta versione dei fatti (dopo le dimissioni del ‘34): il Partito lo avrebbe boicottato. Ricordando quell’incontro, Augstein parlava di Heidegger come di uno «sciamano» che l’aveva incantato e in qualche modo stregato.
Quella tendenza a lasciare «verità ultime»
Corriere della Sera, 14.03.2014
La «Zeit» titolava ieri il pezzo sui Quaderni di Heidegger «L’eredità avvelenata». Perché eredità? Perché il filosofo aveva stabilito nel suo testamento che i Quaderni neri dovevano essere pubblicati come ultimi volumi della sua Opera omnia . Era abituato, Heidegger, a questi lasciti a futura memoria: anche l’intervista allo «Spiegel» chiese il filosofo che fosse pubblicata «solo dopo la sua morte». E così fu fatto. Sicuro di essere ascoltato e obbedito, il vecchio sapiente sfidava il tempo, si proiettava oltre la sua fine. Forse sapeva che, al di qua delle polemiche, lui sarebbe rimasto un caso da discutere. Magari da condannare. Ma non da dimenticare.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- PILO ALBERTELLI. Il coraggio di un professore (di Antonio Gnoli)10 marzo 2014, di Federico La Sala
Il coraggio di un professore
di Antonio Gnoli (la Repubblica, 10.03.2014)
Poteva essere solo un tranquillo professore di filosofia greca, in un regio liceo della capitale. Un promettente studioso. Allievo di Giovanni Gentile. E poi di Guido Calogero. Gli toccò in sorte un’altra vita. Impegnata e rischiosa. Quando pensò che il fascismo fosse il peggiore dei mali, decise di combatterlo. Divenne uno dei capi della resistenza romana. Fu catturato. Morì settant’anni fa nell’eccidio delle Fosse Ardeatine.
Si chiamava Pilo Albertelli. Il liceo, che ha preso il suo nome, l’ha ricordato la scorsa settimana. E l’editore Mimesis ha pubblicato due libri che dedicò all’eleatismo e a Platone. Se fosse sopravvissuto, avrebbe ripreso a insegnare, tormentando gli occhiali davanti a un frammento di Parmenide.
I suoi studi, dedicati al mondo antico, non gli impedirono di provare indignazione per il contemporaneo. E di cercare la libertà che i moderni avevano smarrito. Per essa lottò e si sacrificò. Con coraggio. Consapevole che il coraggio fosse una virtù misteriosa. Che non tutti possedevano. E si sorprese, di vederla crescere in lui, in quei giorni in cui la banda Koch lo torturò orrendamente. Non fece nomi. Strizzò gli occhi miopi. E rivide la sua Grecia. Simbolo dell’Europa migliore.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- NUOVI MANUALI DI FILOSOFIA. Uno a cura di Umberto Eco e Riccardo Fedriga, l’altro di Armando Massarenti e Emiliano Di Marco2 marzo 2014, di Federico La Sala
Nuovi manuali di filosofia /1
Innamoratevi del sapere
Che cosa significa conoscere, credere, vivere, esistere? È la displiplina che pone questioni che implicano il pensare: «E il pensare filosofico è ciò che distingue gli uomini dagli animali»
di Umberto Eco (Il Sole Domenica, 02.03.2014)
- Proprio mentre il Miur riduce le ore di insegnamento, suscitando le proteste dei maggiori filosofi italiani (vedi la rubrica Filosofia minima della scorsa settimana), escono due nuovi manuali. Uno a cura di Umberto Eco (di cui presentiamo qui la sintesi generale) e Riccardo Fedriga, l’altro di Armando Massarenti (responsabile di questo supplemento) e Emiliano Di Marco, con la prefazione di Stefano Rodotà che qui a fianco sottolinea l’importanza della filosofia per la formazione dei cittadini di domani. [...]
A parte l’etimologia originaria per cui «filosofia» significherebbe «amore per il sapere», definire la filosofia è impresa difficile perché il senso della parola cambia attraverso i secoli. Nella Grecia classica si riteneva che l’uomo iniziasse a filosofare (come diceva Aristotele) come reazione ad atti di meraviglia, ma rispondono a un atto di meraviglia sia la domanda «chi ha fatto tutte le cose che ci circondano?» (domanda certamente filosofica anche se comune a tutte le religioni) sia la domanda «come mai i ruminanti hanno le corna, salvo il cammello?» - che era questione a cui Aristotele aveva tentato di rispondere ma che oggi noi affidiamo alla ricerca scientifica e non alla filosofia.
Eppure se è la scienza che oggi deve spiegarci origine e natura dei ruminanti, e può dirci che essi sono il prodotto dell’evoluzione naturale, rimane una domanda prettamente filosofica a cui ancora oggi si risponde in modo assai vario, e cioè: «anche se i ruminanti fossero il prodotto dell’evoluzione naturale, c’è un disegno intelligente che ha stabilito leggi di natura per cui essi si sono evoluti in tal modo (per cui ha corna ciascun bue che nasca in ogni epoca e in ogni luogo)?».
Vi renderete conto che questo è ancora una volta il problema dell’esistenza (o meno) di Dio. La scienza può dirci che non è necessario ipotizzare un creatore per spiegare l’origine dell’universo e della vita, ma non può dimostrare che Dio non c’è - così come non può dimostrare che ci sia, anche se nel medioevo San Tommaso d’Aquino pensava che la ragione potesse confermare la fede e aveva elaborato cinque prove (filosofiche) dell’esistenza di Dio. Ma Kant ha poi sostenuto che questo tipo di prova non era razionalmente valido e che la presenza di Dio poteva essere solo postulata per ragioni morali. Ed ecco come la filosofia, per quanto si espanda il territorio proprio della scienza, mette ancora (per così dire) il suo naso dappertutto.
Potremmo allora dire che, anche se dall’antichità a oggi l’umanità ha delegato alla scienza la risposta ad alcune domande, ce ne sono altre per cui la scienza non ha risposta (per esempio che cosa sono il bene e la giustizia, se c’è un’idea di Stato migliore delle altre, perché esistono il male e la morte, e così via) e che sono oggetto perenne della ricerca filosofica. Tanto che qualcuno ha detto che la filosofia è la disciplina che si occupa delle domande per le quali non c’è risposta.
È una definizione esagerata. È vero che ci sono domande per cui non c’è risposta, ma ce ne sono anche nell’universo scientifico, per esempio quale sia il più alto dei numeri dispari: problema di cui si occupa la scienza matematica e a un livello che definiremo di filosofia della matematica. Ma la filosofia si occupa piuttosto di domande a cui le altre discipline non trovano risposta, tipo: Che cosa significa essere? È diverso dire io sono, nel senso che esisto, o dire che i cani sono mammiferi, oppure che io sono nato nell’anno tale, o ancora chiedersi che cosa sia il tempo.
Ci sono due diverse ragioni per cui accettiamo l’idea che un angolo retto abbia novanta gradi e quella che tutti gli uomini siano mortali? Se io penso che sia vero che i cani sono mammiferi, ora sta piovendo, i Re Magi hanno visitato Gesù Bambino, Napoleone è morto a Sant’Elena e l’angolo retto ha novanta gradi, tutte queste mie credenze sono "vere" nello stesso senso? E che cos’è la verità? Non è che queste domande non abbiano risposta ma certamente ne hanno avute troppe ed esistono diverse definizioni della verità.
E la domanda filosofica più drammatica è forse stata ed è «perché esiste qualcosa piuttosto che nulla?» Forse queste sono questioni difficili e qualcuno pensa che i filosofi siano dei perdigiorno a porsi domande del genere. Ma pensiamo a uno sventurato, oppresso dalla miseria o dalla malattia, che si chieda «ma perché sono nato? Non potevano i miei genitori non mettermi al mondo?» Il poveretto sta parlando di qualcosa di essenziale per lui, eppure sta facendo della filosofia, anche non se ne rende conto, così come il famoso personaggio di Molière non si era mai accorto di parlare in prosa.
Ed ecco altre domande tipicamente filosofiche che anche le persone normali si pongono: Ma c’è una giustizia in questo mondo? Ma perché bisogna soffrire? C’è una vita dopo la morte in cui le mie sofferenze saranno compensate? Il mio amato mi sembra il più bello di tutti, ma cosa vuole dire bello? È meglio che tutti siano uguali o che ciascuno venga compensato secondo i suoi meriti? Un angolo retto ha novanta gradi e io ci credo, ma che tutti gli uomini siano mortali è altrettanto vero, o basterebbe un immortale per rendere vana questa credenza?
Se, da un disco volante, scendessero sulla terra degli alieni penserebbero anche loro che un angolo retto ha novanta gradi? Ma chi ci ha detto che un angolo retto ha novanta gradi? Gli animali hanno un’anima? E io ce l’ho? E cosa è l’anima? E dove sta? E cosa è la memoria, visto che se uno perde del tutto la memoria sembra che non abbia neppure più un’anima?
Perché piango sulle vicende di personaggi romanzeschi anche se so che non sono vere? È meglio diventar ricchi mandando al diavolo tutti gli altri o vivere da altruisti? Mi dicono che un maiale è più intelligente di un cane ma perché io preferisco andare a spasso con un cane? Dipende dall’amicizia, dall’amore, dalla identificazione con qualcuno?
Ma cosa sono amicizia, amore, identificazione? Perché penso che la persona di cui mi sono innamorato sia la più perfetta tra tutte mentre se vivevo in un altro ufficio o in un’altra città ne avrei amata un’altra? Che differenza c’è tra convincere mediante dimostrazione di una verità matematica (per esempio il teorema di Pitagora) e persuadere qualcuno (per esempio a votare un partito piuttosto che un altro)? Se dimostrare un teorema ci pare "razionale", convincere a votare dipenderà da scelte "irrazionali"? O da scelte soltanto "ragionevoli"? La dimostrazione del teorema non fa leva sul sentimento mentre la decisione di voto si basa anche su preferenze, sentimenti, emozioni. Dovrei quindi fidarmi più dei geometri (dei tecnici) che dei politici? Quali differenze intercorrono tra ragione, intelletto, sentimento, convinzione, preferenza, scelta per abitudine? In che misura il nostro corpo interferisce col nostro cervello?
Si potrebbe continuare all’infinito: sono tutte questioni filosofiche, e non bisogna essere professori di filosofia per porsele. Le questioni filosofiche interessano ciascuno di noi.
Potete certamente decidere che tutte queste sono questioni che lasciano il tempo che trovano e che si può vivere benissimo divertendosi, facendo soldi o morendo di fame senza che esse ci tocchino da vicino. Ma - a parte che certi esseri umani non possono resistere alla meraviglia che li porta a farsi queste domande - nel corso della storia queste questioni "irrilevanti" hanno determinato il nostro modo di vivere, hanno spinto certi gruppi a guerre di religione, hanno influenzato profondamente le indagini degli scienziati, hanno determinato il nostro modo di intendere la vita, il divertimento, il guadagno e le nostre miserie, anche per coloro che non se ne sono mai resi conto.
Ci sono stati nella storia dell’umanità altri modi di reagire alla meraviglia per ciò che ci circonda. Per esempio le religioni, che sono materia di fede, e che sono state tramandate sotto forma di miti o di rivelazioni, mentre la risposta filosofica si basa su un uso della ragione. Sono esistite filosofie che hanno cercato di mostrare come le rivelazioni delle religioni non contrastino con una "sana" ragione (e si pensi a come Tommaso d’Aquino aveva elaborato cinque modi razionali per dimostrare l’esistenza di Dio), così come ci sono stati casi in cui la filosofia ha agito come critica delle religioni (come in Feuerbach o in Marx).
Ci sono state cosmologie, ovvero narrazioni più meno fantastiche su come è nato l’universo, o sulle genealogie degli dèi (per esempio Esiodo). Tutte queste "narrazioni" si distinguevano dal ragionamento filosofico, mediante il quale, invece, si cercava sempre di attenersi a quelle che venivano considerate le leggi della nostra mente.
Forse ci sono altre e numerose ragioni per capire e studiare la filosofia, e per suggerirle tutte le pagine di questo manuale appena bastano. Ma speriamo che questi pochi accenni siano sufficienti per invogliare qualcuno a comprendere che cosa voglia dire pensare. Perché il pensare, e il pensare filosofico, è quello che distingue gli uomini dagli animali.
Nuovi manuali di filosofia / 2
Il pensiero è nelle domande
di Stefano Rodotà (Il Sole Domenica, 2.3.14
Genere letterario tra i piú difficili, quello dei manuali è stato sempre accompagnato anche da diffidenze, ambiguità, ripulse. Nei tempi in cui maggiore si fa sentire il bisogno di spirito critico, ai manuali viene rivolta l’accusa d’essere strumento di indottrinamento, al fondo autoritario, teso a chiudere insegnamento e apprendimento entro schemi unilaterali, definiti una volta per tutte.
E questa considerazione si fa piú forte quando l’allargarsi degli orizzonti del sapere, l’irrompere delle nuove tecnologie, con lo straordinario ampliarsi dell’accesso diretto alla conoscenza in Rete, disegnano un contesto assai diverso da quelli del passato. Questa giusta preoccupazione, tuttavia, non fa venir meno la necessità di strumenti che mettano le persone, gli studenti in primo luogo, nella condizione migliore per cogliere le nuove opportunità.
Ma una guida per muoversi con consapevolezza in questo mondo davvero nuovo è cosa assai diversa dall’indicazione di un’unica linea attraverso la quale comprenderlo e interpretarlo. Si arriverebbe cosí non alla migliore comprensione di una conoscenza dilatata, ma ad improprie riduzioni di questa ricchissima dimensione. Tornando alla logica tradizionale del manuale, non è difficile accorgersi che essa è strutturata intorno a una sequenza di risposte.
Armando Massarenti e Emiliano Di Marco ribaltano questo schema, mettendo al centro le domande. Le domande che hanno sempre accompagnato la riflessione degli studiosi, ma pure quelle suscitate dalle loro ricerche. L’effetto è duplice. Da una parte, i contributi dei singoli pensatori trovano la giusta collocazione nel loro tempo. Dall’altra, le domande vengono presentate e strutturate in modo tale da essere a loro volta produttive di domande da parte del lettore. Un intreccio tra storicità e problematicità che si trasforma in una eccellente vaccinazione contro ogni forma di pensiero unico, contro improprie gerarchizzazioni, contro qualsiasi pretesa totalizzante.
Questo non vuol dire affatto che si persegua una sorta di appiattimento, che preclude la possibilità di cogliere i momenti alti della cultura, i mutamenti significativi. Al contrario, proprio la consapevolezza della portata effettiva di ciascun contributo di pensiero permette di penetrarne il significato e di sottrarsi alle ingannevoli e davvero strumentali operazioni di «attualizzazione» di questo o quell’autore, con una indebita distorsione del loro effettivo significato culturale.
Il lettore viene sollecitato a compiere continui «esperimenti mentali», viene stimolato da continue messe in guardia contro semplificazioni e ideologizzazioni. La sua cassetta degli attrezzi è progressivamente arricchita, la sua autonomia di giudizio critico si dilata. Questi libri divengono cosí non soltanto una stimolante operazione intellettuale, ma una buona azione civile, un vero contributo alla laicità e alla democrazia.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- "La filosofia di Giambattista Vico" e le scoperte di Benedetto Croce a Londra18 febbraio 2014, di Federico La Sala
 STORIA E STORIOGRAFIA. VITA E FILOSOFIA...
STORIA E STORIOGRAFIA. VITA E FILOSOFIA...
 LA TAVOLA DI VICO, LA TAVOLA DI CEBETE, E LE VERITA’ DI BENEDETTO CROCE SCOPERTE A LONDRA. Una nota - di Federico La Sala
LA TAVOLA DI VICO, LA TAVOLA DI CEBETE, E LE VERITA’ DI BENEDETTO CROCE SCOPERTE A LONDRA. Una nota - di Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- Dimmelo tu, dove! Lettera aperta a Massimo cacciari (di Roberta de Monticelli)11 febbraio 2014, di Federico La Sala
- RICERCA E MERAVIGLIA: AL SAN RAFFAELE, UNA GRANDE FESTA FILOSOFICA! IL "VECCHIO" PROBLEMA DEL PENSIERO DELLA COSTITUZIONE E DELLA COSTITUZIONE DEL PENSIERO E’ STATO RISOLTO !!!
 ALL’OMBRA DELL’UOMO DELLA PROVVIDENZA: 2002-2012, DIECI ANNI DI FILOSOFIA AL "SAN RAFFAELE". Un "avviso a pagamento" di Massimo Cacciari, Edoardo Boncinelli, Elena Loewenthal, Alberto Martinelli, Angelo Panebianco, Giovanni Reale, Marco Santambrogio, Emanuele Severino, Vincenzo Vitiello
ALL’OMBRA DELL’UOMO DELLA PROVVIDENZA: 2002-2012, DIECI ANNI DI FILOSOFIA AL "SAN RAFFAELE". Un "avviso a pagamento" di Massimo Cacciari, Edoardo Boncinelli, Elena Loewenthal, Alberto Martinelli, Angelo Panebianco, Giovanni Reale, Marco Santambrogio, Emanuele Severino, Vincenzo Vitiello
Lettera aperta
Le idee esistono, caro Cacciari
di Roberta De Monticelli (il Fatto, 11.02.2014)
Io avrei voluto, quella sera, occuparmi d’altro. Da molte, molte sere vorrei occuparmi d’altro: di idee. Ma come si fa, quando un collega illustre e con un’opera cospicua, il fondatore della mia Facoltà, un professore di filosofia - e un amico - di fronte al pubblico televisivo di Otto e mezzo, ci dice che le idee non esistono, non servono, non contano? E io che vorrei stare in loro compagnia ogni sera, ecco: come un povero, vecchio don Chisciotte ho frenato il mio ronzino, e ora levo la mia povera vecchia lancia arrugginita, con la mano stanca e le lacrime negli occhi, che li fanno ancora più guerci.
Le nostre povere idee. Perché, caro Massimo, trattarle così male, sia pure con due giornalisti, una più garrula dell’altro (che cosa ci sarà stato mai da essere così gai poi)? Già, perché a differenza di te, che pratichi con lucida coscienza - e coerenza, in fondo, da sempre - il “pensiero negativo”, loro annuivano nella luce della filosofia, sì sì. Per idee intendo quelle che dovrebbero muovere chi si impegna, da cittadino o da politico, in politica. Dunque intendo idee che non sono disgiunte da ideali o se preferisci, chiamali valori.
Non c’è bisogno allora che le idee siano troppo astratte. Ognuno capisce cosa vuol dire un po’ più di giustizia. Un po’ più di legalità. Un po’ meno corruzione. Un po’ più di rappresentanza dell’interesse pubblico negli uomini delle istituzioni, dai governanti ai parlamentari ai burocrati. Un po’ meno Mastrapasque. Un po’ meno Ilve, un po’ meno Terre dei Fuochi, un po’ meno colate di cemento sulle coste e le colline, un po’ meno mafia, familismo e clientele. Un po’ meno trucchi di pacchetti governativi, tipo finanziare una legge (la soppressione dell’Imu) con un’altra legge (l’han - no detto loro), con resistenza tagliata a colpi di ghigliottina. Vedi che se parliamo di ideali scendiamo subito terra a terra. E allora diamoci un colpo d’ala.
L’ala stanca e spennata di don Chisciotte ha subito un primo, duro colpo. La rappresentazione di un capo del governo e di un segretario di partito che “ovviamente” si muovono solo - rispettivamente - per mantenere e per conquistare personalmente il potere.
Sembra proprio così, in effetti: ma come è possibile a un filosofo che insegna Platone e Husserl non dico darlo per evidente, ma darlo per normale senza batter ciglio, come a dire, il fatto e la norma sono la stessa cosa? Normale questa loro contesa, e ciascuno dei due deve fare così - e perciò è ovvio che il governo intanto non governi -. L’ala freme: forse ora dirà che allora è meglio andare alle urne, visto questo straccio di brutta legge elettorale che stanno facendo? Non era questo, del resto, il patto iniziale? Povero don Chisciotte, da quando in qua pacta sunt servanda?
Arriva la seconda mazzata: niente si può fare e lì si deve restare, restare a ogni costo fino a quando ci sarà la ripresa. Ma non eri tu che ridevi, una volta, di quelli che in fondo a tutto vedono sempre e solo l’economia?
Cambiare idea si può: ma allora prima di combattere qualunque nefandezza bisogna calcolare i centesimi di PIL, che poi a quanto pare saranno proprio e solo centesimi? L’ala si ripiega dolente: cala un’altra mazzata, che questa volta volano tutte le povere piume rimaste.
La domanda era: il presidente del Senato ha fatto bene a decidere di costituire il Senato parte civile nel processo per la compravendita dei parlamentari? Fiato sospeso: ti prego, ti prego, almeno qui (mormorano in cuor loro i tuoi allievi). Risposta ieratica, lapidaria: no. Il Presidente del senato ha fatto male. E perché? Perché da che mondo è mondo nei Parlamenti si fanno cose che fanno schifo (hai detto proprio così: “cose che fanno schifo”.
Non hai detto, che so, che anche Lincoln corruppe - per far finire la schiavitù, però). Ma sollevare un “dovere morale” (così aveva detto, con un insolito colpo d’ala, il prudentissimo, assai realistico Presidente del Senato) - questo dev’essere proprio il colmo. Il razionale che contesta il reale! Ma dove andremo a finire? Un minuetto d’anime belle, al posto degli stivali della storia che sono insanguinati e se ne vantano? L’astratto moralismo contro la filosofia della storia?
Don Chisciotte cala la sua lancia inutile, spezzata. Fra le ammaccature delle sue povere ossa è questa quella che fa più male: che tutti gli spettatori di Otto e mezzo crederanno che questa sia la filosofia. È una filosofia, indubbiamente. Quella che prima ha tolto ideali alla sinistra. E poi ha tolto speranza alla ragione. E infine, ha tolto ragione alla politica. Viva il pensiero negativo. O mi sbaglio io caro Massimo? Dimmelo tu, dove!
- RICERCA E MERAVIGLIA: AL SAN RAFFAELE, UNA GRANDE FESTA FILOSOFICA! IL "VECCHIO" PROBLEMA DEL PENSIERO DELLA COSTITUZIONE E DELLA COSTITUZIONE DEL PENSIERO E’ STATO RISOLTO !!!
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA E A PENSARE BENE "DIO", "IO" E "L’ITALIA", CHI PIU’ CHI MENO, TUTTI VIVONO DENTRO LA PIU’ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA E POLITICA ITALIANA, NEL REGNO DI "FORZA ITALIA"!!! Un’inchiesta e una mappa di Francesco Tomatis - a cura di Federico La Sala6 gennaio 2014, di Federico La Sala
- PER CARITA’!!! Prof. Giovanni Reale, si svegli dal sonno dogmatico!!!
La dittatura culturale del marxismo
di Giovanni Reale (Corriere della Sera, 06.01.2014)
Caro direttore, dopo l’intervista che ho dato ad Armando Torno (Corriere della sera del 3 gennaio) e la replica, firmata da Antonio Carioti che registrava le tesi di Mario Vegetti (4 gennaio), desidero aggiungere alcune precisazioni. I marxisti, nel secondo dopoguerra, anche se non hanno mai vinto le elezioni, si sono imposti ad alto livello, instaurando una sorta di dittatura culturale. La Democrazia cristiana, inoltre, ha commesso molti errori proprio in campo culturale, al punto che il ministro della Pubblica istruzione Riccardo Misasi ha proposto il «sei politico», una promozione garantita a tutti. Con ironia gli antichi dicevano: nel caso in cui vengano a mancare cavalli e restino solo asini, si stabilisca per legge che tutti gli asini siano detti e considerati cavalli. E così siamo giunti alla situazione della scuola di oggi.
Io sono stato avversato dall’Accademia non solo di recente per la mia interpretazione di Platone, ma da sempre, a cominciare dai lavori su Aristotele degli anni Sessanta del secolo scorso, in cui denunciavo gli errori di ermeneutica del grande filologo Werner Jaeger, oggi da tutti riconosciuti. Ma allora sono stato accusato (da marxisti e da altri) di sostenere quelle tesi in quanto cattolico, e addirittura tomista (non lo sono mai stato). Inoltre, quando stavo per pubblicare la traduzione con commento della Metafisica di Aristotele, un potentissimo accademico di allora minacciò di rovinarmi la carriera se l’avessi data alle stampe.
Alla pubblicazione della mia Storia della filosofia antica in 5 volumi (allora da «Vita e pensiero»; oggi, in 10, da Bompiani), un giornalista disse al direttore di «Vita e Pensiero» che nessun quotidiano l’avrebbe recensita, perché scritta da un cattolico e per una casa cattolica. E da alcuni colleghi è stata proibita, in quanto giudicata «non scientifica».
Anche i miei allievi sono stati avversati. Maurizio Migliori si è in certo senso salvato, in quanto legato al gruppo vicino al «manifesto». Ma è stato più volte invitato a lasciarmi, in quanto cattolico. Ma Migliori credeva nel mio metodo, e giudicava le ricerche scientifiche come meta-politiche. Roberto Radice è stato addirittura bocciato al primo concorso (non ammesso neppure agli orali). E, in risposta, ha tradotto tutti gli Stoici antichi e poi le Enneadi di Plotino. E vinta la cattedra, ha creato la collana dei Lessici, con programma elettronico, dei filosofi antichi.
Le più forti opposizioni dei marxisti si sono verificate in occasione della pubblicazione dell’opera Il pensiero occidentale , che ho scritto con Dario Antiseri, per l’Editrice La Scuola. Ma inaspettatamente proprio dalla Russia è venuta la smentita dei detrattori nostrani. La traduzione russa ha avuto grande successo. Raissa Gorbaciova, professoressa di filosofia, ne ha fatto grandi elogi, e l’Università Statale di Mosca ha premiato Antiseri e me con il titolo di «Professor honoris causa». Nella giornata del premio, un professore ci ha elogiati, dicendo che, con la nostra opera, abbiamo insegnato «che cos’è la democrazia in filosofia», facendo capire che cosa dice ogni filosofo e perché lo dice, di qualsiasi tendenza sia.
L’opera ha avuto varie traduzioni, l’ultima delle quali è venuta dal Kazakistan, promossa dal ministero della Pubblica istruzione, ed è in corso la trattativa per la traduzione in cinese. Il Corriere della Sera ha di recente promosso un’edizione dell’opera in 14 volumi, con un imponente apparato iconografico ideato da Mario Andreose, con cui ho collaborato con entusiasmo (da giovane amavo dipingere, e tuttora scrivo libri sull’arte con Elisabetta Sgarbi, convinto che l’arte sia una delle vie attraverso le quali l’uomo ricerca la verità).
Al marxismo si è oggi sostituito un laicismo estremista, che è una forma di Illuminismo integralista, anticattolico e antireligioso, non meno pericoloso, in quanto dimentica una sacrosanta verità, espressa in modo perfetto da Edgar Morin: i lumi della ragione non vedono le ombre all’interno della loro chiaroveggenza; essi «per non accecare, hanno bisogno d’ombra; dobbiamo riconoscere il mistero della realtà, della vita, dell’essere umano».
Ai giovani, per concludere, vogliamo inviare un messaggio di fiducia. Dalle situazioni, anche le più difficili, come abbiamo più volte verificato di persona, è sempre possibile uscire, se si crede in ciò che si fa, e se ci si impegna a fondo, cercando di evitare ogni compromesso. E ricordiamo la splendida massima di Eraclito, il più profondo filosofo presocratico, che ci ha molto aiutato: «Se uno non spera, non potrà mai trovare l’insperabile, perché esso è difficile da trovare e impervio».
- PER CARITA’!!! Prof. Giovanni Reale, si svegli dal sonno dogmatico!!!
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- NATURA E INTELLIGENZA ASTUTA: UN’UMANITA’ SENZA GRAZIA. Una sollecitazione a pensare.5 gennaio 2014, di Federico La SalaCome la filosofia (e la teologia) senza grazia (gr.: "charis") e senza grazie (gr.: "charites") perde la testa e ricade nel sacco o, che è lo stesso, è incapace di salvare non solo capra cavolo lupo ma anche se stessa
 NATURA E INTELLIGENZA ASTUTA: UN’UMANITA’ SENZA GRAZIA. Una sollecitazione a pensare (non dal Festival di Filosofia ma) dal mondo di Esopo e di Fedro
NATURA E INTELLIGENZA ASTUTA: UN’UMANITA’ SENZA GRAZIA. Una sollecitazione a pensare (non dal Festival di Filosofia ma) dal mondo di Esopo e di Fedro
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! -- ANT E LA CRITICA DELLA SOCIETA’ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Da Emilio Garroni, una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.3 gennaio 2014, di Federico La SalaESTETICA (E NON SOLO) E DEMOCRAZIA. PER LA CRITICA DELLA FACOLTA’ DI GIUDIZIO E DELLA CREATIVITA’ DELL’ "UOMO SUPREMO" (KANT).
 CREATIVITA’: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETA’ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Da Emilio Garroni, una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
CREATIVITA’: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETA’ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Da Emilio Garroni, una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- Che fare? Ritrovare con coraggio lo spirito di verità. Ricominciare con umiltà e con buon senso. Diceva il Croce che è la più alta delle virtù (Corraso Stajano).2 gennaio 2014, di Federico La Sala
Lo spirito di verità per combattere la crisi della politica
di Corrado Stajano (Corriere della Sera, 02.01.2014)
Che il nuovo anno sia un po’ più sereno di quello appena finito. È accaduto di tutto, nella politica e nella società, nel 2013. La distanza tra istituzioni e cittadini è diventata ancora più profonda, un burrone. Le promesse dei governanti, il più delle volte bugiarde, simili a quelle fatte dalle mamme ai bambini per farli star buoni, suscitano rigetto. E si ha purtroppo l’impressione che la classe dirigente non voglia rendersene del tutto conto.
La positività a ogni costo, la leggerezza, il divieto di drammatizzare sembrano le parole d’ordine d’obbligo per coprire quel che sta accadendo in Italia più che altrove. Esistono certamente anche qui da noi le energie positive della società minuta, uomini e donne che si prodigano per tirar su i figli con decoro, mettono in moto idee intelligenti, creano iniziative utili alla comunità. Ma queste non poche volontà di agire in modo onesto e nuovo sono isole prive degli indispensabili ponti, in difficoltà perché fuori dai cerchi magici di chi detiene il potere.
I partiti sono in crisi profonda. Nel Novecento hanno rappresentato, con la forma della loro organizzazione politica, la fabbrica del consenso e della legittimazione. Ora sembrano scatole vuote, quel che conta è l’immagine, il marketing, non la sostanza del fare. Le forme strutturali della politica sono cambiate, prevale il «finanzcapitalismo», espressione di Luciano Gallino, che ha sostituito la forza dell’obsoleto capitalismo industriale.
La crisi di sfiducia è generalizzata. Il Parlamento è delegittimato, un passacarte del governo che a sua volta è appeso alla maniglia dei decreti legge e dei voti di fiducia indispensabili per andare avanti.
Non sembra che questo passaggio nodale di una crisi non solo economico-finanziaria, ma politico-culturale sia preso in considerazione. La politica lo scarta come una mosca fastidiosa. Manca anche il sospetto e il timore che in questo scompiglio possa essere a rischio l’idea stessa di democrazia, il sistema politico più alto creato dall’uomo.
Il 2013 non è stato un anno rispettoso dei principi fondamentali dell’eguaglianza, della tolleranza, dell’agire in nome del bene comune così ipocritamente e cinicamente reclamizzato.
Le elezioni politiche del 23-24 febbraio dello scorso anno e quelle del presidente della Repubblica non sono stati di certo eventi memorabili. Con i 101 del Pd che vergognosamente non hanno votato Prodi dopo averlo applaudito come proprio candidato poche ore prima. Con Grillo, il riccioluto dittatore urlante dell’antipolitica, privo di una base elementare di idee, che non ha votato neppure lui Prodi dopo averlo inserito tra i suoi candidati. Con il Pd che non ha accettato Rodotà perché non «suo» - era stato proposto dal Movimento 5 Stelle - dimentico che il professore è stato presidente del Pds ed è una persona di alta moralità e cultura. Il buio. Tutti insieme, allora, al Quirinale come nel finale di un melodramma, a implorare il presidente di restare ancora in sella.
Il governo delle larghe intese, poi, un antico miraggio, non uno strumento di emergenza. Non è stato l’aggettivo «condiviso» il più accarezzato degli ultimi anni? Il governo Letta-Alfano avrebbe dovuto essere un governo a termine, come il governo Dini del 1995, e invece non nasconde l’intenzione di durare, di segnare il tempo e, privo com’è di principi elementari comuni, non legittimato quindi a mutare il sistema istituzionale, si propone di affrontare problemi centrali per la dignità di una democrazia. Non sembra che abbia avuto, dopo i mortiferi vent’anni berlusconiani, un soprassalto di fervore. Qualche macchia nera, piuttosto. Basta ricordare il caso Cancellieri e il caso del sequestro di Alma Shalabayeva e della sua bambina, ora fortunatamente risolto, un oltraggio alla sovranità nazionale. Non doveva essere la nuova legge elettorale il primo ed essenziale compito del governo per sostituire l’inverecondo Porcellum? Gli interessi dei gruppi politici e dei singoli parlamentari, impauriti per quel che sarà il loro futuro, sembrano impedirlo. E poi suscita amarezza che non si sia sentito il dovere di abrogare subito le leggi indecenti sull’emigrazione, nate dall’odio razzista: quei poveri migranti con la bocca cucita che hanno riempito di indignazione il mondo sembra purtroppo che siano stati guardati con la normalità dell’indifferenza.
La continuità con la seconda Repubblica e anche con la prima sembra assicurata. I comportamenti, tatticismi, machiavellismi spiccioli, litigi tra alleati e non, ultimatum, rimpasti obbligati, patti di coalizione, non sembrano per nulla finiti in soffitta.
Con una novità. Letta ha annunciato un mutamento epocale: la generazione dei quarantenni prende il potere. Largo ai giovani. Accade naturalmente e periodicamente nella storia del mondo, anche se non così strombazzato. Peccato che le prime mosse non siano state brillanti per i portaborse di ieri, tra il pasticcio del salva-Roma, la Tasi, la mini-Imu, gli affitti d’oro, la milleproroghe, la Finanziaria rimpolpata dagli emendamenti - è accaduto in ogni legislatura - come il vitello grasso. Ma ci pensa Renzi, il segretario del Pd, a rappresentare il nuovo che avanza. In bicicletta, senza mani, corre a presentare il libro di Vespa.
Che fare? Ritrovare con coraggio lo spirito di verità. Ricominciare con umiltà e con buon senso. Diceva il Croce che è la più alta delle virtù.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- UN ANNO LUNGO VENTI ANNI. Note di chiarificazione30 dicembre 2013, di Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- Docenti, In-docenti, In-decenti. Le relazioni che salvano la scuola (e l’Italia!). Una nota di Alessandro D’Avenia12 dicembre 2013, di Federico La Sala
Le relazioni che salvano la scuola
di Alessandro D’Avenia (La Stampa, 12 dicembre 2013)
Il mio articolo su docenti, in-docenti, in-decenti ha suscitato un acceso dibattito, che voglio proseguire, cercando di sollevare non inutili «sensi di colpa» ma fecondi «amorosi sensi». Spesso i docenti perdono l’amore originario per il loro mestiere a causa delle condizioni del sistema. Burocrazia. Famiglie assenti o aggressive. Ragazzi più o meno sdraiati. Stipendio. Questi sono i demoni che infestano la nostra professione e sembrano trasformare un docente in un in- docente (neologismo, ci tengo a ribadirlo, da prendere alla lettera: colui che non riesce più a trasmettere).
L’in-docente, pur rimanendo competente nella materia, perde gradualmente le sue «abilità relazionali». Capita a tutti (anche solo a tratti) in questo mestiere, ma siamo sicuri che le cause ultime siano quelle segnalate? O quelle segnalate sono solo conseguenze di cui si traveste la vera causa?
La risposta è nella lettera di una docente di istituiti professionali che mi ha scritto a proposito del primo articolo: In un professionale mi sono trovata benissimo, perché lì c’era un nucleo stabile di insegnanti e un vice-preside che avevano a cuore la scuola e quei ragazzi. Mi sono sempre confrontata con i colleghi di scienze e di fisica sui contenuti e su come proporli, su come gestire alcune situazioni in classe; questo è stato molto importante e mi ha dato la possibilità di raccogliere qualche frutto. Il collega di scienze mi ripeteva sempre che per quei ragazzi era importante avere di fronte degli adulti che credono in quello che fanno; lì, pure in modi diversi, ci credevano (quasi) tutti. Di conseguenza i ragazzi avevano comunque il senso della scuola, di come fosse giusto comportarsi. Spesso si comportavano male lo stesso, ma c’era la consapevolezza di questo «male». Ho avuto sì delle sconfitte (insegnare a un professionale è come per un medico lavorare in oncologia: sai in partenza che il più delle volte non vinci tu), ma anche delle soddisfazioni. Ben diversa è stata l’esperienza in un altro professionale.
 Il problema maggiore è stata la mancanza di coesione fra gli
insegnanti: la maggior parte dei miei colleghi aveva letteralmente alzato «bandiera bianca», si era
arresa e puntava alla sopravvivenza personale. I pochi che provavano ad affrontare i problemi si
trovavano perciò di fronte a un muro. È stato un anno duro, perché non mi sono mai sentita
appoggiata.
Il problema maggiore è stata la mancanza di coesione fra gli
insegnanti: la maggior parte dei miei colleghi aveva letteralmente alzato «bandiera bianca», si era
arresa e puntava alla sopravvivenza personale. I pochi che provavano ad affrontare i problemi si
trovavano perciò di fronte a un muro. È stato un anno duro, perché non mi sono mai sentita
appoggiata.
 Docenti e dirigente si perdevano in una burocrazia puntigliosa, mentre alcuni problemi
enormi venivano ignorati perché «la scuola non ha gli strumenti». Venivano approvati progetti che
prevedevano gli interventi (purtroppo inutili) di alcuni pedagogisti ed educatori. Sicuramente, in
condizioni diverse (con insegnanti che vogliono insegnare e mantenere vivo il «senso della
scuola»), molti problemi sarebbero rimasti irrisolti, perché enormi, ma almeno la scuola si sarebbe
offerta per quello che è, una scuola appunto, e non un contenitore, in cui i ragazzi bivaccano allo
scopo di conseguire (immeritatamente) un titolo di qualifica professionale, senza la minima
intenzione di alzarsi dalla sedia a sdraio.
Docenti e dirigente si perdevano in una burocrazia puntigliosa, mentre alcuni problemi
enormi venivano ignorati perché «la scuola non ha gli strumenti». Venivano approvati progetti che
prevedevano gli interventi (purtroppo inutili) di alcuni pedagogisti ed educatori. Sicuramente, in
condizioni diverse (con insegnanti che vogliono insegnare e mantenere vivo il «senso della
scuola»), molti problemi sarebbero rimasti irrisolti, perché enormi, ma almeno la scuola si sarebbe
offerta per quello che è, una scuola appunto, e non un contenitore, in cui i ragazzi bivaccano allo
scopo di conseguire (immeritatamente) un titolo di qualifica professionale, senza la minima
intenzione di alzarsi dalla sedia a sdraio.Che cosa è ciò che la docente chiama il senso della scuola»? Mettendo a confronto le due situazioni risulta chiaro: le relazioni tra docenti. Posso essere il più esperto della materia, ma se non amo più comunicarla, non amo più le persone a cui devo comunicarla, non amo più le persone con cui devo comunicarla, non passa niente di quello che conosco. Il sistema scuola è costituito da relazioni: con gli altri docenti, con i ragazzi, con i genitori. In un mondo ormai basato sulla rete di persone e di saperi, la scuola è ancora fondata sul «broadcasting»: la «cattedra» emette messaggi indifferenziati ad un pubblico passivo.
Per un cervello del 2013-14, che ha un modo di ascoltare e apprendere reticolare e partecipativo, e sempre meno analogico e frontale, è come essere sintonizzati su frequenze diverse. La scuola deve passare dall’età della radio-tv a quella della rete. La rete costringe a tornare all’elemento umano della macchina. La lettera evidenzia che la differenza tra le due scuole non sono le mura, ma le relazioni tra docenti. Una scuola è a immagine delle relazioni dei docenti fra loro: funziona se funzionano queste relazioni.
E quando funziona una relazione? Quando è reale. E quando è tale? Quando produce effetti, perché reale, insegna la scienza, è ciò che produce un effetto.
La relazione docente-studente che effetti produce se reale? La curiosità, il metodo, l’amore per la materia e quindi la conoscenza, la crescita reciproca. Se non ci sono questi effetti è perché non c’è la relazione. Perché non carichiamo le lezioni su youtube dove i ragazzi potrebbero comodamente guardarle quando vogliono e noi evitare ogni fatica? Perché prepariamo «quella» lezione per «quella» classe per «quel» giorno? Perché è nella relazione curata in modo unico che si comunica.
La relazione docente-docente che effetti produce se reale? Il sostegno reciproco, l’approfondimento di passioni comuni, l’arricchimento di porzioni di sapere che ci sfuggono, in alcuni casi l’amicizia. I docenti però spesso si fanno la guerra per invidia, per paura, per stupidità, o semplicemente si lasciano succhiare la vita da quei demoni di cui parlavo all’inizio. Il docente si spegne per solitudine preceduta dal velenoso «silenzio degli in-docenti».
Solo l’umano rinnova i sistemi, non la tecnologia, e l’umano nella scuola è un intreccio di relazioni, ciascuna con beni specifici in gioco. Sparita la relazione sparisce il senso della scuola, statale o non, vecchia o nuova, di periferia o di centro che sia. Senza relazione emergono solo mura e funzionari (la fase terminale dell’in-docente è il funzionario). C’è scuola dove c’è relazione e costruzione di beni relazionali che senza quella relazione sarebbero irraggiungibili, come pretendere dall’acqua di fare a meno dell’idrogeno o dell’ossigeno: il senso della scuola è questo, il bene relazionale che solo la reciprocità educativa può produrre.
Non sono un donchisciotte a caccia di docenti ideali, ma di docenti nascosti dentro il loro silenzio, che possano ritrovare luce attraverso pratiche virtuose, come accade in tante scuole che ho visitato (professionali, tecnici, alberghieri, licei...) e che sarebbero da imitare: docenti che lavorano in équipe con attenzione rivolta non solo alla loro materia, ma ai colleghi e agli alunni come persone. Docenti che continueranno a fallire come ci capita tutti i giorni nonostante gli sforzi, perché fallire è proprio dell’umano e delle relazioni. Ma docenti che, singolarmente e insieme, oltre a fallire, porteranno i ragazzi a scegliere: stare al gioco relazionale e creare insieme qualcosa di buono o lasciarsi andare? La responsabilità dei ragazzi è una risposta non un presupposto.
Propongo per l’ultimo giorno di scuola di dicembre un’occupazione fatta dagli insegnanti. Tutti i docenti di una classe la occuperanno e terranno una lezione di mezz’ora sull’argomento che amano di più. Dovranno solo raccontarlo a studenti e colleghi seduti nella stessa classe, insieme. Si magnificherà il sapere e la propria passione di comunicarlo a colleghi e alunni, riuniti per quel che sono: una comunità di ricerca di ciò che ha valore. Assisteremo all’assenza degli in-decenti, al fiorire degli in-docenti, alla gioia dei docenti. Sognare una scuola per tutti in cui sarà possibile scegliere chi è capace di dare senso alla scuola è forse prematuro, ma sognare un giorno di scuola veramente libera nella scuola dell’obbligo è solo questione di scelte.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- MANDELA E LA FILOSOFIA. Lettera a Primo Moroni (in memoria) da ’Johannesburg’.8 dicembre 2013, di Federico La Sala
MANDELA E LA FILOSOFIA. Lettera a Primo Moroni (in memoria) da ’Johannesburg’
- Un breve saggio (in pdf). Cliccare sul titolo per aprirlo (e leggerlo):
 CHI SIAMO NOI IN REALTA’? Relazioni chiasmatiche e civiltà. Lettera da ‘Johannesburg’ a Primo Moroni
CHI SIAMO NOI IN REALTA’? Relazioni chiasmatiche e civiltà. Lettera da ‘Johannesburg’ a Primo Moroni -
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- QUESTO E’ " STATO"!!! L’ITALIA NELLA TRAPPOLA DEL MENTITORE ISTITUZIONALIZZATO.5 dicembre 2013, di Federico La SalaQUESTO E’ " STATO"!!! STORIA DELLA QUESTIONE INFAME: L’ITALIA (1994-2013), TRE PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA SENZA "PAROLA", E I FURBASTRI CHE SANNO (COSA SIGNIFICA) GRIDARE "FORZA ITALIA"!!!
 L’ITALIA NELLA TRAPPOLA DEL MENTITORE ISTITUZIONALIZZATO. Legge elettorale incostituzionale: tutti a casa compresi gli atti. Una nota di Andrea Viola - con note
L’ITALIA NELLA TRAPPOLA DEL MENTITORE ISTITUZIONALIZZATO. Legge elettorale incostituzionale: tutti a casa compresi gli atti. Una nota di Andrea Viola - con note
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- State diventando come i sudamericani di una volta. Intervista a Mario Vargas Llosa (di Andrea Nicastro)20 novembre 2013
L’Europa tradita dagli intellettuali è minacciata da banalità e cinismo
Vargas Llosa: state diventando come i sudamericani di una volta
intervista di Andrea Nicastro (Corriere della Sera, 20.11.2013)
MADRID - «L’Europa si è sudamericanizzata». «È diventata terra di populismi e irresponsabilità». Non per un qualche golpe militare, ma per la rinuncia alla propria intelligenza. «La cultura si è fatta spettacolo, si è banalizzata, ha perso la capacità di risvegliare lo spirito critico essenziale in democrazia». Nel vecchio continente «l’Italia è tra i malati più gravi». «Da voi la crisi non è solo economica, è anche morale, di Stato. E la colpa è di Silvio Berlusconi che, con il suo carisma e la simpatia, è capace di affossare ogni tentativo di rinascita».
Come un pendolo, da 50 anni, Mario Vargas Llosa si muove tra America Latina ed Europa. Quando arrivò per la prima volta nel vecchio continente, era un ragazzo con il senso d’inferiorità del cittadino delle repubbliche a sovranità limitata, spaccate da tremenda povertà e oltraggiosa ricchezza. Passò dall’infatuazione per Fidel Castro all’ammirazione per Margaret Thatcher.
Negli anni Ottanta, scrittore affermato e uomo maturo, era ormai diventato una mosca bianca tra gli intellettuali del Cono Sur . Gli stava stretta l’idea che per gli americani «di sotto» fossero possibili solo due regimi: la dittatura militare o il marxismo. Divenne uno dei pochi a pensare che privatizzazioni ed economia di mercato fossero la cosa giusta da fare, nonostante la giungla, gli indios e i tropici. Divenne la voce alternativa a Gabriel García Márquez, che, al contrario, restava ancorato alla fede nel modello cubano. Non era una posizione facile quella di Vargas Llosa. Nel 1990 si candidò alle elezioni presidenziali del Perù per un cartello di partiti di destra e il fallimento fu clamoroso. Nel 1994 la Biennale di Venezia non lo volle in giuria perché «al soldo della Cia» e «amico delle dittature». Altri tempi.
Oggi, Vargas Llosa parla con l’autorità del Premio Nobel con il «Corriere» e il «Mundo» sulla crisi europea e il suo ultimo libro, L’eroe discreto (Einaudi), che ne è in qualche modo la nemesi. E, orgoglioso della crescita economica e democratica latinoamericana, attacca, sempre da destra, l’Europa e soprattutto l’Italia.
Vargas Llosa, sotto la sua casa di Madrid ci sono montagne di spazzatura per lo sciopero dei netturbini. La sua porta è blindata per paura dei ladri. Di questi tempi l’Europa assomiglia più al Sudamerica che all’oasi di benessere cui eravamo abituati.
«È vero, l’Europa si è sudamericanizzata, ma curiosamente l’America Latina si è europeizzata. Una volta peruviani, colombiani, centro americani sgomitavano per venire a lavorare qui. Ora sono moltissimi gli europei, spagnoli in testa, che si cercano un futuro nel Cono Sur».
È finita l’età dell’oro europea?
«No, l’Europa non morirà. È solida, andrà avanti. Certe previsioni terroristiche sono ingiustificate. Certo, non si tornerà a vivere come prima, anche perché prima non potevamo permettercelo, però basterà una drastica marcia indietro e, purtroppo, il pagamento di un alto prezzo per gli errori commessi».
Quali errori?
«L’Europa ha accantonato le proprie idee per applicare ricette sudamericane. Populismo, corruzione, sprechi, vivere al di sopra delle proprie possibilità, cinismo nei confronti della politica, sono caratteristiche del sottosviluppo, eppure hanno avuto il sopravvento in molti Paesi europei. Non tutti, per fortuna. Quelli virtuosi, come la Germania, non hanno sofferto la crisi».
Perché è successo?
«Credo sia un problema culturale. Spendere più di ciò che si guadagna è un’irresponsabilità figlia del populismo, che, a sua volta, significa sacrificare il futuro per il presente. Invece di cercare la causa nel mondo esterno, l’Europa farebbe bene a capire come ha incubato il male che ora la strangola. Indebitarsi in maniera totalmente irresponsabile non è gratis».
Italia e Spagna più di altri.
«Però, mentre la Spagna mi sembra abbia toccato il fondo e cominci a risalire grazie a riforme coraggiose, l’Italia non esce dalla sindrome Berlusconi che sta ancora lì, è la pietra che affonda il Paese. Perché la culla della civiltà occidentale sia politicamente tanto immatura, capace di scegliere sempre l’opzione peggiore, è difficile da capire. Però non è un caso unico. Qual è il Paese più colto dell’Ameria Latina? È l’Argentina, eppure politicamente fa piangere, è una specie di Italia dell’emisfero sud. Lo diceva Camus: la persona più intelligente in un campo può essere la più inetta nell’altro».
In altri tempi gli intellettuali sarebbero riusciti a farsi sentire?
«A volte è meglio che stiano zitti. Si pensi a ciò che dicevano durante la guerra fredda. Difendevano mostruosità, regimi che commettevano le più grandi atrocità della storia, Stalin e Mao. Non intellettuali d’infimo rango, ma di altissimo livello. In Francia Jean-Paul Sartre diceva che “tutti gli anticomunisti sono dei cani” o che “in Urss la libertà di critica è totale”. Non molto diverso da ciò che sosteneva Alberto Moravia, o il guru degli intellettuali italiani, Elio Vittorini, che negò addirittura la pubblicazione al Gattopardo , dicendo che non era conveniente politicamente. C’è una grande responsabilità di quegli intellettuali».
Nel suo discorso per l’accettazione del Nobel, lei però ha parlato di spettacolarizzazione della cultura, non di politicizzazione.
«La banalità ha contribuito molto alla crisi. Se la cultura è solo intrattenimento, perde la capacità di instillare spirito critico. In quel vuoto si installa il cinismo. Se tutto il mondo ruba, nessuno si sente ladro. Se tutti sono corrotti, nessuno si giudica corrotto. Società libere hanno bisogno di spirito critico, di gente che creda di poter cambiare per il meglio e si impegni a farlo».
Lei sta per ricevere il XII Premio internazionale di giornalismo di «El Mundo», ma anche l’informazione è in crisi.
«Se i giornali vivranno o moriranno dipende da noi. Non c’è una legge di natura. Il problema è la domanda crescente di pettegolezzi e frivolezze a cui è difficile resistere, pena il fallimento economico. Anche i media più seri aprono le pagine alle sciocchezze. Pare un peccato veniale, ma fa moltissimo danno, perché se la gente si adagia, si perdono gli anticorpi verso i corrotti e finisce che i ladri risultano simpatici, guasconi che ce la fanno. Proprio come Berlusconi, che è carismatico e simpaticissimo, ma guardate il danno che ha fatto all’Italia».
Il suo ultimo romanzo, «L’eroe discreto», ha per protagonista un peruviano che resiste alla mafia. Ha messo sulla pagina il riscatto morale del Sudamerica, mentre l’Europa si confonde?
«La realtà ha smentito la mitologia dell’anticapitalismo sudamericano, secondo il quale gli indios volevano continuare a vivere nei loro campi a proprietà collettiva in una società idealmente marxista. Invece gli indios sono gente normale, che vuole buone scuole per i figli, ospedali, acqua potabile. Felicito, il mio protagonista, mi è stato ispirato da un vero peruviano, che ha pubblicato una lettera alla mafia dicendo che non avrebbe mai pagato il pizzo. Come il mio piccolo Felicito è quell’imprenditore basco che si ribellò all’Eta, o Roberto Saviano, che ha descritto la camorra e ora è minacciato. C’è una riserva morale ovunque. Speriamo basti» .
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- PSICOANALISI E POLITICA. Il Narcisismo e l’uso lucidissimo come arma politica dell’"antinomia del mentitore".19 novembre 2013, di Federico La SalaCRISI COSTITUZIONALE DI LUNGA DURATA. DUE PRESIDENTI GRIDANO: FORZA ITALIA!!! .... E IL LUNGO SONNO DELLA RAGIONE COSTITUZIONALE DELLE ISTITUZIONI E DEGLI INTELLETTUALI.
 BERLUSCONI E LA "MEZZA" DIAGNOSI DEL PROF. CANCRINI. Il Narcisismo e l’uso lucidissimo come arma politica dell’"antinomia del mentitore" - "L’Italia è il mio Partito": "Forza Italia"!!! --- Nevrosi narcisistica e politica. L’analisi di H.A. Rosenfeld
BERLUSCONI E LA "MEZZA" DIAGNOSI DEL PROF. CANCRINI. Il Narcisismo e l’uso lucidissimo come arma politica dell’"antinomia del mentitore" - "L’Italia è il mio Partito": "Forza Italia"!!! --- Nevrosi narcisistica e politica. L’analisi di H.A. Rosenfeld
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- Filosofi ondivaghi. Adinolfi confessa su l’Unità: W l’indulto per B. Il Kant de noantri ha vinto il Premio Dudù 2013, alla carriera.15 ottobre 2013, di Federico La Sala
Filosofi ondivaghi Adinolfi confessa su l’Unità: W l’indulto per B.
di M. Trav. (il Fatto, 15.10.2013)
Finalmente. Dopo giorni di supercazzole filosofiche a colpi di Benjamin, Platone, Beccaria e perfino Gesù Cristo, ieri il noto pensatore dell’Unità Massimo Adinolfi ha confessato: è favorevole all’amnistia e all’indulto sebbene “Berlusconi la sfanghi se in futuro sarà condannato”.
Ci voleva tanto a dirlo? Dopo aver intasato intere colonne dell’Unità per tentar di dimostrare che amnistia e indulto non si applicano a Berlusconi, ora si arrende: si applicano e a lui va benissimo così. Auguri, se la vedrà con i suoi eventuali elettori. Gli stessi che ancora il 7 agosto leggevano a sua firma frasi perentorie del tipo: “Bisogna difendere regole del diritto e certezza della pena prima di ogni altra cosa”. Frasi riferite proprio alle pretese di impunità di Berlusconi.
Ora invece l’Adinolfi scrive che quanti sostengono la verità, cioè che l’indulto si applicherà anche a Berlusconi, è portatore di una “livorosa morale contra personam”. Bravo, Adinolfi: la filosofa Santanchè e il filosofo Capezzone non saprebbero dire meglio. Il Kant de noantri ha vinto il Premio Dudù 2013, alla carriera.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- Un nota sul “disagio della civiltà”.1 ottobre 2013, di Federico La Sala
Un nota sul “disagio della civiltà”
Costituzione dogmatica della chiesa "cattolica"... e costituzione dell’Impero del Sol Levante.
di Federico La Sala *
Il ’delirio’ della Gerarchia della Chiesa ’cattolico’-romana è ormai galoppante!!! E se vogliamo aiutarla a guarire o, che è lo stesso, se vogliamo aiutarci a guarire (il ’delirio’ è generale, e non solo suo!!!) non possiamo non riprendere a pensare - a partire da noi stessi, e da noi stesse!!! Il problema è pensare proprio a partire da noi, dagli esseri umani in carne ed ossa - dalle persone, quale siamo e quale vogliamo essere, da quell’individuo che non sia un (o una) “Robinson”, come voleva il ’vecchio’ Marx non marxista e non hegeliano!!!
Basta con le robinsonate! La questione è la Relazione (Dio è Amore), e una relazione non edipica!!! Una relazione edipica (sia dal lato della donna sia dell’uomo) porta a postulare l’esistenza di un “dio” (un dio-uomo o un dio-donna) e, di qui, la concezione di un ’mondo’ dove il diritto di comandare in cielo e in terra sia del “dio” (del dio-uomo o del dio-donna)!!!
Da questo punto di vista, la Chiesa ’cattolico’-romana è solo l’ultimo baluardo di quel “dio” che garantisce la proprietà privata dei mezzi di produzione e l’educazione edipico-capitalistica. Perché i sacerdoti (se vogliono) non si possono sposare?!, o perché le donne non possono diventare sacerdot-esse?!, ma perché il “dio” è concepito come dio-uomo e, come tale, solo il dio-figlio può essere come il dio-padre... e la donna solo come la madre-dea.
Sulla terra (e per tutti e per tutte) il Dio-Figlio è il figlio-dio e il fratello di tutti e di tutte, ma in cielo solo Lui può essere il Padre... e lo Sposo della Madre - e, siccome è solo lui che può avere rapporti con il cielo (ma il messaggio di Gesù proprio perché è un buon-messaggio dice che tutti e tutte siamo tutti e tutte figli e figlie di Dio-Amore... e tutti e tutte possiamo avere rapporti con “Lui”!!!), deve essere anche ’donna’ (perciò si traveste così come si traveste) per ’generare’ e ’riprodurre’ se stesso, in circolo...e comandare su tutti, su tutte, e su tutto! Che follia, senza alcuna saggezza - sconsolatamente!!!
Vedere il caso del Giappone - nella cultura giapponese c’è la Dea in cielo, e l’imperatore sulla terra; ora-oggi!!!, dal momento che alla coppia imperiale è nata una bambina, si parla di cambiare la Costituzione per far sì che Lei possa accedere al trono ... ma il problema è più complesso - come si può ben immaginare - perché ... deve essere cambiata anche la Costituzione celeste dell’Impero del Sol Levante!!! Se no, l’Imperatrice con Chi si ’sposerà’?! Con la Dea?!!
Non è questa forse la ragione nascosta del “disagio della civiltà” dell’Oriente e dell’Occidente ..... e anche della sua fine, se non ci portiamo velocemente fuori da questo orizzonte edipico-capitalistico di peste, di guerra e di morte? Non è ora di andare al di là della tragedia, e riprendere il filo dall’ “Inizio” (filosoficamente, parlando)?! Cosa significa essere EU- ROPEUO*?!! In principio cosa c’era, il Logos buono o il Logos cattivo?! Sta a noi, tutti e tutte, deciderlo - qui ed ora (come sempre, del resto)!!!
Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- CON MARX, OLTRE: DAL "LAVORO - IN GENERALE" AL "RAPPORTO SOCIALE DI PRODUZIONE - IN GENERALE".30 settembre 2013, di Federico La Sala
 PER LA CRITICA DEL CAPITALISMO E DELLA SUA TEOLOGIA "MAMMONICA" (Benedetto XVI, "Deus caritas est", 2006).
PER LA CRITICA DEL CAPITALISMO E DELLA SUA TEOLOGIA "MAMMONICA" (Benedetto XVI, "Deus caritas est", 2006).
 CON MARX, OLTRE. UN NUOVO PARADIGMA: DAL "LAVORO - IN GENERALE" AL "RAPPORTO SOCIALE DI PRODUZIONE - IN GENERALE". Un saggio
CON MARX, OLTRE. UN NUOVO PARADIGMA: DAL "LAVORO - IN GENERALE" AL "RAPPORTO SOCIALE DI PRODUZIONE - IN GENERALE". Un saggio
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- IL "DIO" DEI MERCANTI E IL SILENZIO DEI FILOSOFI (OLTRE CHE DEI TEOLOGI). «Agàpe eros e philia» nell’orizzonte ratzingeriano. L’intervento di Vincenzo Paglia al festival di filosofia di Modena17 settembre 2013, di Federico La Sala
 FILOLOGIA E TEOLOGIA. LA ’CROCE’ (lettera alfabeto greco = X = "CHI") DI CRISTO NON HA NIENTE A CHE FARE CON IL CROCIFISSO DELLA TRADIZIONE COSTANTINIANA E CATTOLICO-ROMANA. "Se mi sbalio, mi coriggerete" (Giovanni Paolo II)-
FILOLOGIA E TEOLOGIA. LA ’CROCE’ (lettera alfabeto greco = X = "CHI") DI CRISTO NON HA NIENTE A CHE FARE CON IL CROCIFISSO DELLA TRADIZIONE COSTANTINIANA E CATTOLICO-ROMANA. "Se mi sbalio, mi coriggerete" (Giovanni Paolo II)-
 IL "DIO" DEI MERCANTI E IL SILENZIO DEI FILOSOFI (OLTRE CHE DEI TEOLOGI). «Agàpe eros e philia» nell’orizzonte ratzingeriano. L’intervento di Vincenzo Paglia al festival di filosofia di Modena - con note
IL "DIO" DEI MERCANTI E IL SILENZIO DEI FILOSOFI (OLTRE CHE DEI TEOLOGI). «Agàpe eros e philia» nell’orizzonte ratzingeriano. L’intervento di Vincenzo Paglia al festival di filosofia di Modena - con note
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- Nell’agorà del pensiero globale (di Riccardo Pozzo e Luca Scarantino)26 agosto 2013, di Federico La Sala
Nell’agorà del pensiero globale
di Riccardo Pozzo e Luca Scarantino (Il Sole 24 Ore, 25.08.2013)
Insolitamente fresco e ventilato, quest’anno ad Atene il mese di agosto si è rivelato propizio allo svolgimento del 23° Congresso mondiale di filosofia, che proprio nella capitale greca si è tenuto dal 4 al 10 di questo mese. «Philosophy as Inquiry and Way of Life»: questo il tema del Congresso, che rinviando a una dimensione altamente speculativa, il bios zetetikós, la vita come discussione e ricerca, si dava un compito nobile: ripensare i ruoli e le responsabilità della filosofia e dei filosofi nell’odierno mondo globale, così da individuare problemi, conflitti e iniquità legate allo sviluppo e alle trasformazioni di una civiltà ormai planetaria, interculturale e tecnologica.
In un’Atene erosa dalla crisi, in cui ogni strada del centro è costellata di mendicanti di ogni età e bambini di quattro-cinque anni si piegano su fisarmoniche più grandi di loro in questua di qualche centesimo, si è capito in fretta quale sia la posta in gioco delle dinamiche culturali contemporanee.
La capacità di pensare, di muoversi su scala globale è, anche, un antidoto contro la miseria. Certo, la filosofia greca ha dominato la scena con orgoglio. Il Congresso è stato l’occasione per celebrare il 2.400° anniversario della fondazione dell’Accademia di Platone; l’inaugurazione, forse la più suggestiva nella centenaria storia dei Congressi mondiali, ha avuto luogo nel meraviglioso anfiteatro di Erode Attico, ai piedi dell’Acropoli, e diverse sessioni si sono svolte nel quadro di siti archeologici unici al mondo: l’Accademia di Platone e nel Liceo di Aristotele, dove hanno parlato, tra gli altri, Enrico Berti, Nomuro Notomi e Dorothea Frede; la collina della Pnice, dove nacque la democrazia, e la chiesa di Aghia Fotinì, edificata sul luogo ove Platone ambientò il Fedro, sulle rive dell’Ilisso.
Nonostante le difficoltà che hanno accompagnato la preparazione, i colleghi greci hanno efficientemente accolto e guidato gli oltre 3mila partecipanti, il maggior numero nella storia dei Congressi mondiali, inaugurati a Parigi nel 1900 (l’Italia è l’unica nazione ad averlo ospitato tre volte: a Bologna nel 1911, a Napoli nel 1924 e a Venezia nel 1958).
Tra i relatori italiani presenti nelle sessioni plenarie, ricordiamo Evandro Agazzi, che ha presieduto la sessione d’apertura, e la filosofa della scienza Maria Carla Galavotti. In una sessione particolarmente affollata, Jürgen Habermas ha discusso il problema di come si possa costituzionalizzare il diritto internazionale, mentre sul nuovo realismo portava la relazione di Umberto Eco: un tema, quest’ultimo, cui era dedicata anche una tavola rotonda proposta da Maurizio Ferraris e condotta da Mario Alai, Enrico Berti, Riccardo Dottori e Riccardo Pozzo. Tra i platonisti riuniti attorno all’International Plato Society, è stata notevole la presenza dell’italiano Mauro Tulli.
Per la città il Congresso è stato anche un buon affare. «In cinque giorni - ci dice uno degli innumerevoli tassisti che stazionano ogni giorno davanti all’ingresso della Facoltà di filosofia - ho incassato oltre mille euro»: quasi il triplo della media abituale. Del resto, i manifesti del Congresso erano visibili ovunque in città.
Ma l’impatto di un incontro di questa portata non si riduce all’immediato beneficio per l’economia cittadina. Il Congresso mondiale è soprattutto un esercizio di apertura alla complessità filosofica, religiosa, culturale del mondo contemporaneo. I giornalisti locali ci chiedono in continuazione quale ne sia l’effetto pubblico, al di là della cerchia degli specialisti: la risposta è, come spesso accade in questi casi, difficile, ma appare con chiarezza se si pensa la Grecia come una parte dell’Europa.
Ci si sorprende allora a constatare come i filosofi europei, pur presenti in massa, siano tuttavia minoranza di fronte alle centinaia di studiosi russi, cinesi, indiani, sudamericani, alle decine di filippini, sudafricani, coreani, thailandesi, giapponesi, nigeriani, kazaki, agli esponenti di comunità filosofiche cui non siamo ancora abituati a pensare come protagonisti del "campus globale" in cui avviene l’elaborazione del pensiero contemporaneo. Eppure, tra i più apprezzati interventi del Congresso vanno segnalati quelli della thailandese Suwanna Satha-Anand, dell’israeliana Anat Biletzki, del cinese Chen Lai.
Sono state relazioni che hanno toccato, da punti di vista diversi ma complementari, temi universali quali la dialettica tra democrazia e religione, il "silenzio" come atto comunicativo, il confronto, a partire da un tema specifico, tra tradizioni filosofiche e culturali diverse...
Ma, al di là di queste relazioni plenarie, una miriade di simposi, tavole rotonde, sessioni di ogni genere ha fornito la misura del ruolo che le diverse tradizioni epistemiche, etiche, religiose, spirituali svolgono nell’elaborazione di un discorso culturale certo articolato ma ormai globale: temi che a lungo abbiamo considerato come appartenenti principalmente al pensiero occidentale appaiono sempre più come propri di tradizioni di pensiero affermate con forza da comunità intellettuali che emergono alla stessa velocità delle economie dei loro Paesi.
È mettendo in scena questa dimensione globale della riflessione filosofica che il Congresso ci invita ad abbandonare ogni prospettiva parziale e ad aprirci al resto del mondo. È un’esigenza che, come europei, ci tocca in modo particolare. Pensare, comunicare e in particolare fare filosofia oggi non è più possibile se non si impara a farlo su scala globale, parlando a un pubblico (Aristotele avrebbe detto: a un uditorio) che spazia al di là della comunità e della tradizione filosofica nella quale ci si è formati.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA --- E A "VIVERE LA FILOSOFIA". Una proposta originale nel saggio di Moreno Montanari (di U. Galimberti)3 luglio 2013, di Federico La Sala
Uscire dalla crisi con la filosofia
Una proposta originale nel saggio di Moreno Montanari
di Umberto Galimberti (la Repubblica, 03.07.2013)
Stiamo attraversando un periodo di crisi oggettiva e soggettiva. La crisi oggettiva è determinata dal fatto che le leggi del mercato confliggono con il mondo della vita: dai giovani che non trovano lavoro, agli occupati che lo perdono, dagli imprenditori che chiudono le loro imprese, all’aumento progressivo e generalizzato della soglia dalla povertà. E la domanda che spontanea e drammatica sorge è quella del filosofo Franco Totaro: «Ma i fini dell’economia sono anche i nostri fini?».
La crisi soggettiva è determinata dalla rassegnazione generalizzata, perché il conflitto non è più tra imprenditori e lavoratori, perché sia gli uni che gli altri si trovano dalla stessa parte e han-no come controparte il mercato. E come fai a prendertela con il mercato? Il mercato è nessuno, anche se il filosofo Romano Madera ci ricorda che, come leggiamo in Omero: «Nessuno è sempre il nome di Qualcuno», ma questo Qualcuno non è identificabile.
Da questa considerazione prende avvio il libro, di Moreno Montanari, Vivere la filosofia (Mursia, 2013, p. 154, 14 euro), la cui lettura consiglio a tutti, perché segnala come una possibile via d’uscita quella di tornare al messaggio che la filosofia, al suo nascere e prima di diventare disciplina di Accademie, ha consegnato all’uomo, invitandolo a rispettare la sua natura che, a differenza di quella animale, non si accontenta della realtà quale è data, ma la vuole trascendere, la vuole oltrepassare, rifiutando la rassegnazione, il cinismo, i vissuti di impotenza, gli atteggiamenti vittimistici e persino l’indignazione, se poiquesta lascia le cose così come sono.
La filosofia, infatti, non è nata come “teoria”, ma come “rifiuto a imprigionare la vita in ciò che è”, e quindi nell’accettazione rassegnata del dato, nell’inerzia che non promuove la problematizzazione dell’ovvio, dell’opinione diffusa e acriticamente accolta come inoltrepassabile, riducendo l’uomo, da attore della propria vita, a semplice spettatore e vittima di poteri che lo sovrastano e, soggiogandolo, ne decidono il destino. Si tratta della filosofia che si pone domande non tanto per trovare risposte teoriche, ma, come scrive María Zambrano, per indurre gli uomini ad «essere loro stessi risposte che mettono in moto la vita».
Per questo occorre superare lo sguardo individualistico che giudica lo stato delle cose dall’angolatura ristretta del proprio punto di vista, e guardarle nella prospettiva del Tutto, dove la scala dei valori subisce una radicale trasformazione. E allora diventeremo responsabili delle sorti dell’aria, dell’acqua, della biosfera, della vegetazione, della sorte degli animali, in una parola della Terra, nei confronti della quale non abbiamo ancora formulato alcuna etica, perché finora abbiamo limitato l’etica a regolare i conflitti tra gli uomini, ma non ancora a farsi carico degli enti di natura.
E già la Terra non regge, se è vero, come ci informa il “Global Footprint Network”, che se tutti vivessimo con lo stile divita americano avremmo bisogno di cinque terre, e con lo stile italiano di 2,7. Quello di guardare le cose dall’alto e non dal nostro particolare punto di vista, quello di pensarci parte di un Tutto e non al vertice del creato è il primo esercizio filosofico trasmessoci dagli antichi Greci, e divenuto per la prima volta nella storia umana particolarmente concreto con la globalizzazione.
Un altro esercizio filosofico è quello indicato da Platone come “esercizio di morte” dove l’aver presente che si deve morire, si trasforma, come scrive Pierre Hadot, nell’invito a “ricordarsi di vivere”, e quindi a fare una nuova gerarchia dei nostri bisogni e desideri soprattutto in riferimento a quelli superflui, una diversa gradazione delle nostre urgenze e dei nostri valori, una più significativa valorizzazione delle nostre relazioni affettive, in una parola un modo nuovo di essere uomo, non appiattito sulle istanze del presente, ma prospettico e rivolto al futuro, non col tratto passivo di chi spera o attende, ma con quello attivo, conforme alla natura propria dell’uomo che non si consegna alla realtà di fatto, ma vuole oltrepassarla.
Questi sono alcuni degli esercizi filosofici ben illustrati ed esemplificati da Moreno Montanari. Altri se ne aggiungono come la scrittura meditativa che riflette sui testi che leggiamo, disposti a farci modificare da loro non solo in ordine alle nostre idee ma soprattutto in ordine alla nostra esperienza, accompagnati in questo da quell’atteggiamento che è l’amore, che per Platone è “filo-sofo”, perché non possiede l’altro, come la filosofia, che non possiede la verità, ma la cerca perché la ama.
Si dirà: con questi esercizi filosofici si trasforma se stessi, ma non il mondo. Non è vero perché, come ci ricorda Michel Foucault ne La cura di sé:«Il punto di Archimede sul quale posso da parte mia sollevare il mondo è la trasformazione di me steso», perché «quando riusciamo a curare le ferite del nostro mal di vita - scrive Montanari - ne beneficiano tutte le persone che intrecciano la loro esistenza con la nostra, mentre quando ciò non riesce finiamo inevitabilmente per intossicarle». La lezione di “vivere la filosofia” è impartita, ora spetta a noi praticarla.
IL SAGGIO Vivere la filosofia di Moreno Montanari Mursia pagg. 314 euro 14
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- Maitre-à -penser. Sulla fine degli intellettuali (di Benedetto Vecchi)18 giugno 2013, di Federico La Sala
Maitre-à -penser. Sulla fine degli intellettuali
di Benedetto Vecchi (il manifesto, 18 Giugno 2013)
La sua morte è stata annunciata più volte, per essere in seguito altrettanto repentinamente smentita. Il primo che ne ha stilato un obituary, attraverso un libro segnato da una malcelata nostalgia per il passato alle sue spalle, la cui popolarità è inversamente proporzionale alla conoscenza delle tesi lì espresse, è Julien Benda, che ne Il tradimento dei chierici denunciava la scomparsa dell’intellettuale custode di valori universali a favore di un personaggio pubblico impegnato nell’agone politico.
Il tradimento, stava nella rinuncia alla sua separatezza dalla mondanità: separatezza tanto importante quanto indispensabile per continuare a illuminare la caverna dove uomini e donne vivono, diradando così le ombre che impediscono la ricerca della verità. Tempo un decennio - il Tradimento dei chierici fu pubblicato nel 1927 - e gli intellettuali diventarono una presenza abituale nella sfera pubblica, grazie alle loro prese di posizione contro il fascismo e il nazismo, ma anche per l’impegno, al di là dell’Oceano, nel New Deal del presidente Franklin Delano Roosevelt.
Sempre negli anni Trenta, dal carcere Antonio Gramsci scriveva le note sull’intellettuale organico come una conseguenza della modernità capitalistica. La partecipazione dell’intellettuale alla vita pubblica, più che decretarne la morte, segnalava il potere che esercitava nell’arena politica.
La gabbia della parcellizzazione
È stato dunque l’intellettuale organico la figura che, nel bene e nel male, si è imposta nel Novecento. Anche il maître-à-penser caro a Jean-Paul Sartre era un intellettuale che si incamminava sulla strada dell’impegno politico, rivendicando un’autonomia di giudizio dal partito che doveva rappresentare la classe, ma si considerava tuttavia organico a un progetto di trasformazione radicale della società. Doveva compiersi il giro di boa degli anni Settanta affinché fosse nuovamente annunciata la morte dell’intellettuale. Anche questa volta l’annuncio veniva dalla Francia e se ne fece portavoce, tra gli altri, Michel Foucault.
L’intellettuale organico e il maître à penser, veniva detto, erano figure divenute improponibili in una realtà che vedeva una parcellizzazione del sapere veicolata dall’industria culturale e dall’uso sempre più intensivo del sapere nella produzione di merci. Il problema, tuttavia, non era il ritorno alla condizione solitaria, separata dalla realtà sociale dell’intellettuale, bensì la politicizzazione dei saperi disciplinari.
L’intellettuale specifico, e la forma mondana che ha assunto, il tecnico, è una figura che non afferma né valori universali né l’adesione a una politica della trasformazione, ma che punta semmai a un uso politico delle proprie competenze. È questa la parabola che emerge da una serie di scritti dello storico Eric Hobsbawm pubblicati dopo la sua morte, avvenuta nell’ottobre del 2012, e tradotti in Italia da Rizzoli con il titolo La fine della cultura (pp. 310, euro 20), del breve scritto di Rino Genovese Il destino dell’intellettuale (manifestolibri, pp. 126, euro 15) e dall’ambizioso saggio del giovane ricercatore Francesco Antonelli Da élite a sciame (Le Lettere, pp. 362, euro 24).
Sono tre libri tra loro molto diversi, sia per stile enunciativo che per le «discipline» dei tre autori, storico il primo, filosofo il secondo, sociologo il terzo. In ogni caso, tutti e tre riflettono sulla morte dell’intellettuale.
Per Hobsbawm si è consumata nel secolo breve, dovuta a quel punto di non ritorno che è stata la sconfitta dei progetti politici di trasformazione radicale della società. Questo non significa che la sua scomparsa abbia lasciato un vuoto. Più prosaicamente, se la modernità ha visto manifestarsi l’intellettuale organico o specifico, nel capitalismo postmoderno il protagonista nella socializzazione del sapere è l’opinion maker, cioè il produttore di opinione pubblica che non fa leva sull’adesione a valori universali, né su una competenza specifica, ma soltanto su una competenza nell’uso di un mezzo di produzione «specifico», come radio, televisione, carta stampata e, più recentemente, la Rete.
Un vitale disincanto
Il libro dello storico inglese è costruito partendo dalla cosiddetta «autoriflessività» della modernità borghese per poi spaziare sul ruolo della cultura nella formazione delle identità nazionali, tanto in Europa che nel resto del mondo e di come tale ruolo si presenti in una forma caricaturale nei tanti etnonazionalismi che si sono presentati sulla scena pubblica dopo il crollo del socialismo reale. Annota con disincanto la marginalità che hanno ormai alcuni «manufatti culturali», indipendentemente dal successo di pubblico che hanno alcuni festival culturali dedicati, ad esempio, all’opera classica, al jazz e al teatro. Tutto questo per giungere alla conclusione sulla fine della cultura. L’accesso al sapere è garantito, ovviamente. È un diritto acquisito. La differenza è se tale diritto debba essere garantito dal mercato, come avviene in gran parte dei paesi capitalistici, o da una qualche forma di intervento pubblico in favore dei produttori di cultura.
Per quanto riguarda la figura dell’intellettuale, Hobsbawm riflette sull’eclissi dell’intellettuale organico (lo storico inglese ha letto e studiato gli scritti di Antonio Gramsci dal carcere ben prima che venissero tradotti in inglese) e sulla fragilità che ha sempre avuto la figura del maître-à-penser.
Anche su questo passaggio prevale il disincanto. Hobsbawm sostiene, e qui la sua posizione coincide quasi alla lettera con quanto ha sostenuto, alla metà degli anni Novanta, Edward Said in un ciclo di conferenze alla Reith Lectures e poi raccolto nel volume Dire la verità (Feltrinelli), che l’intellettuale deve esprimere il dissenso quando è necessario, esercitando così uno spirito critico, anche quando questo è in contraddizione con la sua posizione politica.
La posta in gioco è dunque l’autonomia dell’intellettuale da potere, sia di quello politico che di quello esercitato dall’industria culturale e dal mercato. Tutto ciò non contrasta la tendenza della produzione dell’opinione pubblica da parte di altre figure, come attori, attrici, sportivi, giornalisti, presentatori, ma facilita la messa a fuoco politica della costruzione di punti di vista critici sulla realtà.
Sulla stessa posizione è Rino Genovese nel Destino dell’intellettuale, saggio dolceamaro sull’incapacità del Sessantotto di immaginare una figura intellettuale diversa da quella dell’intellettuale organico che si chiude con l’auspicio di una rinnovata presa di parola degli intellettuali nella difesa di valori universali - verità, giustizia, libertà e uguaglianza - nella prospettiva di un relativismo culturale «forte», cioè consapevole del fatto che l’intellettuale è sempre «situato» in un contesto geopolitico.
I lavoratori della conoscenza
Gli scritti di Hobsbawm e quelli di Rino Genovese si fermano sul ciglio di quel nuovo modo di produzione dell’opinione pubblica, che invece è varcato da Francesco Antonelli nel suo Da élite a sciame. Anche qui l’autore parte da molto lontano; assume come dirimenti sia la riflessione di Benda che quella di Antonio Gramsci, mettendo in evidenza l’entrata nell’agone politico dei «colti» e assegnando al partito di massa il ruolo di medium dell’intellettuale pubblico.
Antonelli tuttavia è interessato a comprendere cosa viene dopo la morte dell’intellettuale pubblico, facendo sue alcune tesi sul capitalismo cognitivo, in particolare modo quelle che sottolineano non solo che il sapere e la conoscenza sono diventati mezzi produttivi, ma anche il fatto che la produzione di senso è ormai un settore produttivo come molti altri. Per questo preferisce parlare di intelligenza collettiva e di parallela obsolescenza sia degli intellettuali pubblici che di quelli specifici. Per l’autore, chi vive del lavoro intellettuale deve essere qualificato come un lavoratore della conoscenza. È questa la figura erede dell’intellettuale.
Rimangono tuttavia indefiniti alcuni aspetti legati alla figura dell’intellettuale. Il rapporto con il potere, in primo luogo. C’è poi la necessità di definire qual è il rapporto tra gli intellettuali-lavoratori della conoscenza e i i movimenti che tendono a trasformare la realtà. Infine: una volta che l’intellettuale è ormai un lavoratore della conoscenza, quale sono le modalità di organizzazione di questa componente del lavoro vivo?
Lo sciame indicato nel libro di Antonelli più che una risposta a questa ultima domanda indica semmai i comportamenti dei lavoratori della conoscenza, ma fornisce anche alcune tendenze presenti nella produzione dell’opinione pubblica.
Con l’eclissi dell’intellettuale e l’ascesa della Rete, infatti, la produzione dell’opinione pubblica richiede un «modello di business» per la produzione di senso. Già perché la supposta morte dell’intellettuale è contemporanea non solo alla pervasività dell’industria culturale, ma alla interdipendenza tra produzione e circolazione della conoscenza e formazione dell’opinione pubblica.
Come infatti dimostrano alcune vicende della politica italiana, che corre il rischio di diventare un laboratorio sociale, il ruolo dei media è rappresentabile come una efficace fabbrica del consenso, ma allo stesso tempo indicano che la politica e la produzione dell’opinione pubblica possono diventare un fattore diretto nella sviluppo di imprese che operano nella Rete, come dimostra il rapporto tra crescita di influenza del Movimento cinque stelle, la redditività economica dei blog, dei siti e delle imprese legate a quel movimento. Lo stesso si può dire dei social network, dove l’opinione pubblica è «spacchettata» e ridotta a un ammasso di dati che viene venduto per pianificare campagne pubblicitarie e politiche mirate.
In una situazione di questo tipo, decretare la morte dell’intellettuale è cosa facile. Eppure, quello spazio lasciato dalla sua scomparsa non rimane certo vuoto. La presenza di una coscienza critica, che più che illuminare la caverna dove viviamo serve a destrutturare i rapporti di potere vigenti e dunque a fornire materiali per una politica di trasformazione della realtà, è una presenza sempre più necessaria, sapendo che ogni riproposizione dell’aura dell’intellettuale è solo un’operazione di testimonianza e di nostalgia per un passato che non c’è più.
Meno battuta è la strada indicata da chi vede nel «lavoratore della conoscenza» il suo erede. Da qui la necessità di definire la sua autonomia dall’industria culturale e dalle imprese che operano in Rete. Una strada impervia, sicuramente, ma quella da perseguire per conseguire la produzione e la circolazione di una coscienza critica sulla realtà.
-
>LA PIU’ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA E POLITICA ITALIANA --- Bolle di mattone. La crisi italiana a partire dalla città. Come il mattone può distruggere l’economia (e non solo!). Note su un dibattito29 maggio 2013, di Federico La Sala
A proposito della "mostruosa fratellanza" tra pubblico e privato
di Maria Cristina Gibelli (il manifesto, 28 Maggio 2013)
- Un interessante dibattito a partire da un interessante e utile libro di Mario De Gaspari. La rendita immobiliare, come ci distrugge come si può, e di deve, tornare a combatterla, fin da oggi. *
In due recenti appuntamenti alla Casa della Cultura e alla Provincia di Milano si è discusso dell’ultima fatica di Mario De Gaspari: un libro snello ma importante dall’intrigante titolo e dall’inquietante sottotitolo Bolle di mattone. La crisi italiana a partire dalla città. Come il mattone può distruggere l’economia (Milano, Mimesis edizioni). Invitati a discuterne Roberto Camagni e Giancarlo Consonni nel primo incontro; Arturo Calaminici, Massimo Gatti e Maria Cristina Gibelli nel secondo).
Preceduto da una bella introduzione di Walter Tocci (http://www.eddyburg.it/2013/03/bolle-di-mattone-di-mario-de-gaspari.html), Bolle di mattone affina ulteriormente, grazie a un supporto teorico rigoroso, le riflessioni sull’intreccio fra rendita, speculazione immobiliare, finanza e comportamenti della pubblica amministrazione: temi già affrontati dall’Autore in altri scritti recenti , e sempre con uno sguardo acuto che gli deriva dalla sua ‘doppia personalità’ di intellettuale critico ma anche, nel passato recente, di amministratore locale (prima come sindaco di Pioltello, un comune dell’hinterland milanese, e poi come consigliere della Provincia di Milano).
Mario De Gaspari conosce quindi bene ciò che, con una locuzione efficace, definisce la “mostruosa fratellanza” fra pubblico e privato, fra chi dovrebbe amministrare per il bene collettivo e chi vuole trarre il massimo vantaggio dalla città della rendita: il settore finanziario immobiliare, e le sue “bolle di mattone” appunto, che ha ottenuto in passato e continua ad attendersi, anche in epoca di crisi, margini di gran lunga più elevati di qualsiasi altro settore produttivo.
Centrale in questo nuovo libro è una riflessione teorica su moneta bancaria, sviluppo e rendita che parte dai classici, Marx e Ricardo, e si estende a Keynes, Schumpeter e Minsky; fondamentale altresì la capacità di ricollocare la attuale e peculiare crisi del settore immobiliare e finanziario del nostro paese in una dimensione teorico-interpretativa complessa.
Importante è il parallelismo, che De Gaspari illustra benissimo, fra creazione di moneta bancaria (attraverso l’attivazione del credito alle imprese) e creazione di moneta urbanistica, il “cubo”, (attraverso l’attivazione di concessioni e diritti volumetrici). In entrambi i casi, i processi portano a crisi rovinose non appena si invertono le aspettative di mercato: allo scoppio delle bolle finanziarie e immobiliari.
Come ha sottolineato Roberto Camagni nella prima tavola rotonda, c’e una differenza sostanziale fra i due processi. Nel primo, il credito bancario genera uno spazio all’imprenditore all’interno della distribuzione del reddito nazionale, attraverso un processo inflazionistico, a fronte di una promessa di profitti da innovazione (come indica Schumpeter), e dunque a fronte di uno sviluppo produttivo. Nel secondo caso, si realizza lo stesso effetto, ma a fronte di una generazione di rendita (e di qualche sviluppo edilizio): una rendita che in Italia non viene assolutamente intaccata dalla fiscalità pubblica per effetto proprio della sopra evocata“mostruosa fratellanza”.
De Gaspari, nelle due occasioni di presentazione del libro, ci ha spiegato il ‘suo’ malessere (oltre a quello della città, che aveva costituito il titolo di un suo precedente bel libro): un malessere che deriva dalla peculiarità della ‘speculazione edilizia’ italiana e dalla debolezza della pianificazione.
Tutti i PRG (o loro succedanei) messi assieme valgono oggi in Italia - ci ha detto l’Autore - molto più di qualsiasi altra attività produttiva in termini di punti di PIL. Dopo 20 anni di liberismo e di deregolamentazione urbanistica, e in assenza di una riformata legge urbanistica nazionale e di una nuova legislazione di fiscalità immobiliare risolutamente orientata alla tassazione della rendita, i beni immobiliari si sono trasformati, con l’indebitamento sui mutui, in “risparmio abortivo” (una locuzione di Keynes).
Si tratterebbe attualmente, secondo quanto dichiarato recentemente dall’immobiliarista Puri Negri in un dibattito in televisione, di 400 miliardi di euro di crediti immobiliari complessivi in possesso delle banche più importanti. E questo dato evidenzia un intreccio fra mattone e finanza, fra filiera immobiliare e banche che appare sempre più soffocante e senza prospettive, in un contesto in cui il ‘cubo’ è diventato la moneta urbanistica corrente.
Ma anche i governi locali hanno fatto la loro parte: per fare cassa hanno infatti inventato la “zecca immobiliare” (come la definisce Walter Tocci nell’introduzione al libro), continuando a concedere sempre più estesi diritti edificatori e consumando con voracità risorse territoriali preziose, perché “nella strisciante concezione estremisticamente liberista della città del 2000 la rendita dei suoli è considerata una variabile assolutamente avulsa, indipendente, ininfluente (...) e il governo della città un fatto quasi privato delle amministrazioni comunali e le conseguenze economiche delle scelte urbanistiche, a livello locale e sul piano nazionale, del tutto trascurate” (De Gaspari: 110).
Nel dibattito che si è sviluppato in occasione delle due presentazioni del libro sono emerse alcune considerazioni interessanti, sia da parte di studiosi che di amministratori locali.
A fronte della crisi immobiliare che ha colpito un po’ ovunque nei paesi avanzati, altrove ci sono già state delle risposte che hanno saputo ridurre il danno; e, certamente, sono alcuni paesi ‘mediterranei’ che hanno subito più danni perché, con l’entrata nell’Euro, hanno goduto del vantaggio dato dall’opportunità di sostituire monete deboli con una moneta forte concessa con prestiti a basso tasso di interesse.
In Italia si è creata una grande quantità di moneta urbanistica, grazie alla concessione generosissima di diritti edificatori e alla altrettanto generosa attribuzione agli immobiliaristi di credito bancario con garanzia sui diritti stessi. Oltre un certo limite, ampiamente superato, di crescita irrazionale dei prezzi immobiliari, la crisi della bolla non poteva che esplodere.
In più, in Italia il contesto politico-istituzionale si caratterizza per una evidente mancanza di cultura e di una legislazione sulle procedure negoziali pubblico/privato capace di garantire adeguati vantaggi pubblici nello scambio.
Due esempi sono stati evidenziati nella discussione per porre in evidenza questa ingiustificabile propensione allo scambio ineguale fra pubblico e privato: la tassazione ‘ordinaria’ associata ai permessi di costruire; gli ‘extra-oneri’ ottenibili dai progetti in deroga. A differenza di altri paesi europei, nel nostro paese gli oneri concessori di legge continuano ad essere molto bassi: 244 euro/mq a Milano; 155 euro a Torino; 105 a Bologna; i più elevati a Firenze con 480 euro.
A puro titolo di paragone, in Francia, con la legge n. 2010-1658 del dicembre 2010 si è introdotta la Taxe d’aménagement che sopprime e unifica 11 tasse precedentemente vigenti, fissando un valore unico per gli oneri da versare alla PA: 748 euro per metroquadro di superficie netta di pavimento (SHON) nell’Ile-de-France e 660 euro nel resto del territorio nazionale. A questa tassa si è aggiunto nel 2012, in coerenza con gli obiettivi della Grenelle de l’Environment (la legge nazionale sull’ambiente del 2010), un ulteriore balzello (VSD/Versement pour sous-densité) per contenere i consumi di suolo e le basse densità edilizie in aree urbane e periurbane.
Un’altra significativa differenza riguarda la ripartizione fra pubblico e privato dei valori realizzati attraverso progetti di rigenerazione in deroga ai piani urbanistici vigenti. Da indagini mirate sui bilanci di grandi progetti di trasformazione realizzati a Roma e Milano, è emerso che la quota della rendita si aggira fra il 45% e il 55%, mentre alla città pubblica spetta circa il 5% del valore complessivo. Si tratta di valori bassissimi, se comparati con altre città europee che con i progetti negoziati arrivano a recuperare per la collettività fino al 30-32%.
E’ evidente, e De Gaspari ce lo spiega con accuratezza ma anche con grande disincanto, che la mostruosa fratellanza fra immobiliaristi, banche e PA che ha dato luogo a uno scambio così ineguale sta alla base della bassa qualità delle nostre città, della loro progressiva perdita di vivibilità, della mai risolta, anzi sempre più drammatica, questione delle abitazioni che evidenzia soprattutto nelle maggiori città “il paradosso della povertà nell’abbondanza. I grattacieli in costruzione e i senza tetto accampati sotto i ponteggi”.
L’Italia è un paese anomalo? Forse sì, perché gli amministratori locali sempre più si sono limitati a svolgere meramente un ruolo di ‘facilitatori’, con il risultato che la quota di invenduto/sfitto nelle grandi città risulta ormai patologica. E quando un invito a tassare la rendita arriva da amministrazioni locali in mano alla sinistra, sottolinea l’Autore, non può non sorgere un sospetto di rapporto collusivo con le cooperative rosse che godono, dal punto di vista fiscale, di un regime speciale.
E se 400 miliardi di euro di crediti immobiliari sono oggi in possesso della banche, se le banche spesso sono diventate proprietarie di un tale ingentissimo patrimonio dopo il fallimento di speculatori immobiliari cui avevano garantito prestiti elevatissimi, esse avranno tutto l’interesse a esercitare il loro potere di influenza per continuare (e anzi potenziare) i progetti speculativi.
Le banche si comportano dunque come ‘speculatori’: spingono per evitare riduzioni di prezzo degli immobili (che costituirebbero il solo modo per avviare un rilancio dell’edilizia) e usano la loro autorevolezza per valorizzare le loro garanzie fondiarie e immobiliari, onde evitare forti effetti negativi sui loro bilanci.
Come uscirne? Occorrerebbe ri-legittimare la pianificazione. Occorrerebbe porre argine alle procedure perequative - specie quelle ‘estese’, che distribuiscono diritti edificatori atterrabili ovunque -; porre argine alla flessibilità delle destinazioni d’uso e, sopratutto, porre argine alla inarrestabile concessione da parte dei comuni di diritti edificatori amplissimi e staccati da ogni razionale previsione sulla domanda effettiva: anzi, occorrerebbe revocarne molti elargiti in passato, come è nei poteri delle amministrazioni locali (importante, a questo proposito, la recente sentenza del Consiglio di Stato 6656/2012 che conferma la legittimità del nuovo PRG di un piccolo comune del Salentino che ha destinato a verde privato un’area precedentemente destinata a zona di completamento, affermando che « l’urbanistica e il correlativo esercizio del potere di pianificazione, non possono essere intesi, sul piano giuridico, solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, ma devono essere ricostruiti come intervento degli enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo e armonico del medesimo; uno sviluppo che tenga conto delle potenzialità edificatorie dei suoli, non in astratto, ma in relazione alle effettive esigenze di abitazione della comunità...”: http://www.eddyburg.it/2013/02/e-confermato-non-esistono-diritti.html).
Ma l’ottimismo non è aleggiato negli incontri milanesi, perché né il contesto politico nazionale attuale, né i comportamenti delle amministrazioni locali, per lo più acquiescenti, o anestetizzate, o con un complesso di inferiorità nei confronti degli immobiliaristi e delle banche, lo autorizzano.
* Fonte: Eddyburg
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- L’IDIOZIA SOCIALE (di Nicola fanizza).26 maggio 2013, di Federico La Sala
Sull’idiozia sociale
di Nicola Fanizza *
La genialità e l’idiozia, pur configurandosi come situazioni estreme e complementari della nostra coscienza sociale, sono comunque coestensive. L’idiozia abita a pieno titolo nei sotterranei del nostro immaginario e vive e vegeta proprio nel cono d’ombra della genialità. Si può dire che l’idiozia pervade a tal punto la nostra vita, è così immanente ad essa da risultare quasi del tutto assente. Da qui la scarsa attenzione nei confronti di una modalità della nostra esistenza che nelle sue molteplici declinazioni presenta risvolti davvero interessanti.
L’idiozia può essere divertente. Questo accade, specialmente, quando si presenta commista con la pazzia. A tale proposito, l’altro ieri, sulla Linea rossa della Metropolitana milanese, un folle vivente con la sua perfomance - un monologo, in cui trovavano posto simpatici rilievi sui viaggiatori, canzonature dei politici, ardite analogie e frammenti di lucida follia - ha sortito un inconsapevole sorriso su tutti i volti dei viaggiatori. Ho rivisto in lui i tratti del filosofo cinico che dice la verità (parresia) e, insieme, l’immagine dei Santi folli di Bisanzio, che, al fine di riattivare la comunicazione con la città che non li voleva più ascoltare, ricorrevano a gesti estremi, privi di senso e comunque spettacolari.
A volte l’idiozia è disarmante. Ciò accade in particolare quando ci troviamo di fronte all’idiozia dei bambini o degli stupidi. Nondimeno questi ultimi non sono tutti uguali, poiché accanto agli stupidi disarmanti come i bambini ci sono quelli che Ciano, icasticamente - in riferimento a Starace -, chiamava i «coglioni che fanno girare i coglioni». Quando li incontriamo, corriamo quasi sempre il rischio di perdere il controllo delle nostre azioni. La collera, infatti, in quelle rare e fuggitive occasioni, pervade a tal punto la nostra coscienza da offuscare le nostre stesse capacità razionali.
L’idiozia produce i maggiori disastri, quando si coniuga con l’insipienza di chi svolge una funzione di potere: gli ufficiali, specialmente, in caso di guerra, i docenti e i politici. Questi ultimi - in quanto conoscitori delle diverse tecniche e, insieme, possessori della phronesis (l’astuzia, la capacità di mediare fra le esigenze tecniche e la necessità di salvaguardare i legami sociali) - dovrebbero essere i migliori. Eppure non è sempre così.
Nondimeno, nell’inedito spazio sociale prodotto dalle dinamiche della globalizzazione - accanto alle idiozie di cui sopra -, è possibile cogliere il fantasma di una nuova forma di idiozia. Si tratta dell’idiozia sociale che si configura come un vero e proprio ossimoro. La cifra di tale ossimoro, tuttavia, può diventare intellegibile solo se si fanno i conti con il significato che la parola idiota aveva nella lingua greca. Il termine idiotes stava, infatti, a indicare l’uomo privato in contrapposizione all’uomo pubblico, il quale ultimo rivestiva cariche politiche proprio perché era colto, capace ed esperto. Ebbene, oggi, la dissoluzione dei vincoli sociali - determinata dalle politiche neoliberiste - si configura come lo sfondo da cui si origina l’idiozia sociale e, insieme, l’incanaglimento che sempre più pervade il tessuto delle nostre relazioni. Di fatto l’idiozia sociale si dà nella misura in cui ciò che è privato pervade lo spazio pubblico. Non sta pertanto in alcun modo a indicare l’insipienza, ma l’assenza dell’obbligo nei confronti degli altri.
L’idiozia sociale è ormai onnipervasiva. Gli interessi privati signoreggiano nello spazio pubblico, che è stato colonizzato da politici che hanno per lo più lo stesso stile. Quelli di destra - si dice - sono volgari; quelli di sinistra, invece, sono spocchiosi. Se è vero che la plebaglia con la sua volgarità trova sempre più spazio sulle reti televisive di Berlusconi (vedi il talk show Quinta Colonna), è altresì certo che la maggior parte i nipotini di Togliatti continua ad aver come proprio modello il gaga degli anni Trenta (D’Alema). Non si tratta di una grande differenza! La volgarità e la spocchia sono termini coestensivi e, insieme, coessenziali: ambedue rimandano, infatti, alla mancanza di rispetto nei confronti degli altri.
L’insipienza, la supponenza e il sussiego si configurano come i tratti più rilevanti che ineriscono allo stile dei nostri politici, i quali svolgono la loro funzione senza avvertire alcun obbligo nei confronti dello spazio pubblico. Alcuni anni fa mi è capitato di assistere - in occasione della presentazione a Mola di Bari di un libro di Gino Giugni - a uno spettacolo oltremodo vergognoso. Nonostante alcuni dirigenti del Pd avessero accolto a tempo debito l’invito del padre dello statuto dei lavoratori a presentare il suo libro, dichiararono senza alcun pudore di non aver trovato il tempo per leggerlo. E la stessa cosa è accaduta in altre occasioni: gli intellettuali squillo presentano i libri senza averli letti!
D’altra parte, i mezzi di comunicazione di massa ci offrono ogni giorno quantità industriali di idiozia condita in tutte le salse, e con l’arrivo della televisione e dei giornali e di facebook non c’è neppure bisogno di mescolarsi agli idioti, perché l’idiozia ci viene portata a domicilio in modo quasi gratuito.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- "C’ERA UN LORD IN LUCANIA...": VICO E LA BARBARIE DELLA RIFLESSIONE, OGGI (di Federico La Sala)..17 maggio 2013, di Federico La Sala
C’era un lord in Lucania.... *
Se pochi filosofi e letterati sanno dell’omaggio di Ugo Foscolo al filosofo delle “nozze e tribunali ed are” (“Dei sepolcri”, v. 91), moltissimi “addottrinati” ignorano ancora e del tutto che Vico per circa nove anni decisivi per la sua vita ha abitato a Vatolla, nell’antica Lucania (in particolare, nell’attuale Cilento, a poca distanza dall’antica Elea-Velia, Ascea, Paestum, Palinuro, Agropoli) e, al contempo, e che James Joyce a Giambattista Vico ha reso l’omaggio più grande che mai poeta potesse fare a un filosofo: "La strada di Vico gira e rigira per congiungersi là dove i termini hanno inizio. Tuttora inappellati dai cicli e indisturbati dai ricorsi, sentiamo tutti sereni, mai preoccupati al nostro doveroso compito... Prima che vi fosse un uomo in Irlanda c’era un lord in Lucania".
C’era un lord in Lucania (Italia): "The Vico road goes round and round to meet where terms begin. Still anappealed to by the cycles and onappaled by the recourses, we fill all serene, never you fret, as regards our dutyful cask... before there was a man in Ireland there was a lord in Lucan" (Cfr.: AA. VV., Introduzione a Finnegans Wake, trad. di Francesco Saba Sardi, Sugar Editore, Milano 1964. La citazione è ripresa dal saggio di Samuel Beckett, "Da Dante a Bruno, da Vico a Joyce", pp.9-26. La precisazione sulla Lucania e Vatolla è mia). E, ancora: nessuno sa che Giambattista Vico, stampata la sua prima “Scienza Nuova”, inviò a Londra, a Isaac Newton una copia del suo lavoro.
Dopo quasi due secoli, nei confronti di colui che ha osato disubbidire alle Leggi della Repubblica di Platone e riammettere a pieno titolo nello Stato, Omero, i “poeti”, e restituire alle donne tutta loro dignità, la rimozione continua: la cecità dei nipotini di Platone (come di Cartesio, Hegel, e Heidegger), i sacerdoti della casta atea e devota, è totale! Di fronte all’impresa e alla dipintura della Scienza Nuova perdono subito (e ancora) la loro ‘magistrale’ lucidità e ripiombano nella notte della loro “barbarie della riflessione”!
Quanto segue vuol essere solo una sollecitazione e un invito a rileggere tutta l’opera di Vico e, possibilmente, a valutare al meglio il suo grande contributo, a gloria dell’Italia, per la dignità dell’intero genere umano. Non altro.
Federico La Sala
INDICE (Testo in pdf - vedi in fondo)*:
PREMESSA
C’era un lord in Lucania....
 1. VICO CONTRO CARTESIO.
1. VICO CONTRO CARTESIO.
 2. UNA METAFISICA PER LA FISICA DI GALILEI E NEWTON. Note per una (ri)lettura del "De antiquissima italorum sapientia" (I parte)
2. UNA METAFISICA PER LA FISICA DI GALILEI E NEWTON. Note per una (ri)lettura del "De antiquissima italorum sapientia" (I parte)
 3. IL DESIDERIO, LA RAGIONE, E DIO. Note per la (ri)lettura del “De antiquissima italorum sapientia” (II parte)
3. IL DESIDERIO, LA RAGIONE, E DIO. Note per la (ri)lettura del “De antiquissima italorum sapientia” (II parte)
 4. ESSERE GIUSTI CON VICO. Riprendere l’indicazione di Eugenio Garin.
4. ESSERE GIUSTI CON VICO. Riprendere l’indicazione di Eugenio Garin.
 5. LE TRE EDIZIONI DELLA “SCIENZA NUOVA”: QUESTIONI DI METODO.
5. LE TRE EDIZIONI DELLA “SCIENZA NUOVA”: QUESTIONI DI METODO.
 6. PER LA CRITICA DELLE VERITA’ DOGMATICHE E DELLE CERTEZZE OPINABILI.
6. PER LA CRITICA DELLE VERITA’ DOGMATICHE E DELLE CERTEZZE OPINABILI.
 7. VICO CON NEWTON: "NON INVENTO IPOTESI"!
7. VICO CON NEWTON: "NON INVENTO IPOTESI"!
 8. LA "BIBBIA CIVILE" RAGIONATA E GLI INTELLETTUALI ITALIANI: IL CASO COLLETTI.
8. LA "BIBBIA CIVILE" RAGIONATA E GLI INTELLETTUALI ITALIANI: IL CASO COLLETTI.
 9. IL DESIDERIO DI IMMORTALITA’, LA STORIA, E LA PROVVIDENZA.
9. IL DESIDERIO DI IMMORTALITA’, LA STORIA, E LA PROVVIDENZA.
 10. FILIAZIONE DIVINA E PRATICA DELLA SCIENZA NUOVA: "LA MENTE EROICA". Il testo dell’orazione inaugurale del 1732
10. FILIAZIONE DIVINA E PRATICA DELLA SCIENZA NUOVA: "LA MENTE EROICA". Il testo dell’orazione inaugurale del 1732
 11. LA CARITA’ “POMPOSA” DI LUDOVICO A. MURATORI E IL GIUDIZIO DI VICO. Un breve estratto dalla “Prefazione ai lettori” del “Trattato sulla carità cristiana” di Ludovico A. Muratori
11. LA CARITA’ “POMPOSA” DI LUDOVICO A. MURATORI E IL GIUDIZIO DI VICO. Un breve estratto dalla “Prefazione ai lettori” del “Trattato sulla carità cristiana” di Ludovico A. Muratori
 12. PRINCIPI DI SCIENZA NUOVA [1730, 1744]: SPIEGAZIONE DELLA DIPINTURA PROPOSTA AL FRONTISPIZIO CHE SERVE PER L’INTRODUZIONE DELL’OPERA
12. PRINCIPI DI SCIENZA NUOVA [1730, 1744]: SPIEGAZIONE DELLA DIPINTURA PROPOSTA AL FRONTISPIZIO CHE SERVE PER L’INTRODUZIONE DELL’OPERA
 13. “LEMURUM FABULA”: IL PUTTANESIMO. LA BRUTTEZZA DELLA DIPINTURA TUTTA CONTRARIA [La Scienza Nuova 1730]
13. “LEMURUM FABULA”: IL PUTTANESIMO. LA BRUTTEZZA DELLA DIPINTURA TUTTA CONTRARIA [La Scienza Nuova 1730]
 14. MATERIALI SUL TEMA.
14. MATERIALI SUL TEMA.* TESTO IN PDF: VICO E LA BARBARIE DELLA RIFLESSIONE (Federico La Sala, maggio 2013).
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- "PRATICA DELLA SCIENZA NUOVA". VICO: "LA MENTE EROICA". Il testo dell’orazione inaugurale del 1732.12 maggio 2013, di Federico La Sala
 Al di là dei "corsi e ricorsi", il filo della tradizione critica. Contro la cecità e la boria dei dotti e delle nazioni ...
Al di là dei "corsi e ricorsi", il filo della tradizione critica. Contro la cecità e la boria dei dotti e delle nazioni ...
 LA MENTE ACCOGLIENTE. Una traccia per la rilettura della "Scienza Nuova". All’alta fantasia e al grande lavoro di Giambattista Vico, un omaggio
LA MENTE ACCOGLIENTE. Una traccia per la rilettura della "Scienza Nuova". All’alta fantasia e al grande lavoro di Giambattista Vico, un omaggio -
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- SULLA MODERNITA’ DI CARTESIO, RICREDIAMOCI. PAROLA DI VICO (di Federico La Sala).20 aprile 2013, di Federico La Sala
 PAROLA DI VICO. SULLA MODERNITA’ DI CARTESIO, RICREDIAMOCI.
PAROLA DI VICO. SULLA MODERNITA’ DI CARTESIO, RICREDIAMOCI.
 Cartesio va avanti mascherato, senza verità e senza grazia (“charis”): Renato, ambiziosissimo di gloria“, è un cattivo storico dell’“altro”, di “se medesimo” e, come cattivo storico, anche un cattivo filosofo! E’ un filosofo narcisista (...)
Cartesio va avanti mascherato, senza verità e senza grazia (“charis”): Renato, ambiziosissimo di gloria“, è un cattivo storico dell’“altro”, di “se medesimo” e, come cattivo storico, anche un cattivo filosofo! E’ un filosofo narcisista (...)
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- LA FIGURACCIA (E LA MENZOGNA) EPOCALE DI LUDOVICO A. MURATORI (E DI RATZINGER).9 aprile 2013, di Federico La Sala
 CRISTIANESIMO ("DEUS CHARITAS EST") E CATTOLICESIMO COSTANTINIANO ("DEUS CARITAS EST"). Il teologo Ratzinger scrive da papa l’enciclica "Deus caritas est" (2006) e, ancora oggi, nessuno (nemmeno Papa Francesco) ne sollecita la correzione del titolo. Che lapsus!!! O, meglio, che progetto!!!
CRISTIANESIMO ("DEUS CHARITAS EST") E CATTOLICESIMO COSTANTINIANO ("DEUS CARITAS EST"). Il teologo Ratzinger scrive da papa l’enciclica "Deus caritas est" (2006) e, ancora oggi, nessuno (nemmeno Papa Francesco) ne sollecita la correzione del titolo. Che lapsus!!! O, meglio, che progetto!!!
 LUDOVICO A. MURATORI E BENEDETTO XVI: LA STESSA CARITA’ "POMPOSA". Un breve testo dalla "Prefazione ai lettori " del "Trattato sulla carità cristiana" di Ludovico A. Muratori
LUDOVICO A. MURATORI E BENEDETTO XVI: LA STESSA CARITA’ "POMPOSA". Un breve testo dalla "Prefazione ai lettori " del "Trattato sulla carità cristiana" di Ludovico A. Muratori
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- L’ERRORE DI CARTESIO: VICO A FIANCO DI GALILEI E NEWTON.30 marzo 2013, di Federico La SalaRIVOLUZIONE SCIENTIFICA E RIVOLUZIONE COPERNICANA IN FILOSOFIA ....
 L’ERRORE DI CARTESIO: VICO A FIANCO DI GALILEI E NEWTON. Note per una (ri)lettura del "De antiquissima"
L’ERRORE DI CARTESIO: VICO A FIANCO DI GALILEI E NEWTON. Note per una (ri)lettura del "De antiquissima"
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- «Salviamo l’Istituto di Studi filosofici». Parla l’avvocato Gerardo Marotta (di Stefania Miccolis)23 marzo 2013, di Federico La Sala
«Salviamo l’Istituto di Studi filosofici»
Parla Marotta, che ha venduto tutto pur di mantere la struttura in vita
Nato nel 1975 ha ospitato i più grandi studiosi ma ora versa in gravi condizioni economiche
Circa trecentomila volumi si trovano chiusi in un capannone a Casoria
di Stefania Miccolis (l’Unità 23.3.13)
«CI HO MESSO TUTTA LA MIA PASSIONE, E QUESTO ISTITUTO È DIVENTATO IL PRIMO, HA SUPERATO TUTTI, ANCHE QUELLI AMERICANI, NON CE NE SONO DI UGUALI, HA CONQUISTATO UNA DIMENSIONE CHE NON TROVA TERMINI DI PARAGONE NEL MONDO, COME È SCRITTO IN UN RAPPORTO DELL’UNESCO». A parlare è l’avvocato Gerardo Marotta, una di quelle figure della Napoli colta ed elegante che non si incontrano più, e l’Istituto, che ha sede nel Palazzo Serra di Cassano a Napoli è l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Coperto da cappotto e cappello anche in casa, l’avvocato è come una miniatura; sommerso da migliaia di libri e dalle carte sparse ovunque, prima viene la sua voce e finalmente da dietro un giornale aperto spunta quella esile figura, e si scorgono due occhi piccoli, ma accesi che ti guardano e scrutano e capiscono:«’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, inizia a dire l’avvocato, è sorto per salvare la civiltà occidentale, mette a disposizione dei giovani tutto il mondo della cultura per formare le nuove generazioni!».
E ricorda quando sul divano di casa sua Elena Croce insieme a Enrico Cerulli, presidente dell’Accademia dei Lincei, gridava: «L’Europa è in declino, non c’e un minuto da perdere. Bisogna fondare un Istituto per gli studi filosofici e scientifici che si occupi di filosofia, scienze, letteratura, ecologia, urbanistica».
Il declino al quale si riferisce la figlia di Croce è quello della civiltà e della cultura e chissà cosa direbbe oggi (e l’avvocato si mette le mani alla testa) nell’ascoltare mistificatori della storia e barbari politicanti senza cultura. Quelli che recentemente hanno distrutto il Teatro Grande di Pompei rappresentano gli emuli di quei «luridi capobriganti» che Benedetto Croce ci racconta furono insediati al posto dei giacobini mandati a morte da Ferdinando IV al governo del Regno di Napoli.
L’Istituto nasce nel 1975 a Roma nella sede dell’Accademia Nazionale dei Lincei: «e subito demmo inizio all’attività a Napoli con la conferenza inaugurale di Norberto Bobbio su Giambattista Vico e la teoria delle forme di governo nella storia del pensiero politico, e da allora non ci siamo più fermati». I più grandi filosofi e i più importanti studiosi della comunità internazionale sono venuti a Napoli a tenere i loro seminari, su materie umanistiche ma anche scientifiche perché «lo scienziato deve essere anche filosofo».
Reinhart Koselleck, filosofo e storico tedesco ha dichiarato: «Ciò che caratterizza l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici è soprattutto la sua capacità di irradiare impulsi in tutti i campi del sapere verso tutti i paesi del mondo. Non conosco nessuna’altra istituzione scientifica che abbia impresso un segno così profondo nella cultura di tutta l’Europa».
L’avvocato Marotta alza la voce contro l’egoismo e l’individualismo, il vero appiattimento della cultura: molti studenti entrano nelle università, studiano per avviarsi verso una determinata carriera, si lanciano nelle professioni e si dimenticano della cultura. «Dalla facoltà escono degli egoisti! L’insegnamento monologico è un disastro perché genera una civiltà corrotta, ognuno pensa a sé, a fare i soldi, è come se la società si basasse sulla lotta per l’economia. Le forze retrive hanno ostacolato il formarsi di istituti e accademie, ed hanno perpetuato la formazione di una società corrotta senza coesione e senza amore per il bene pubblico».
L’Istituto versa oggi in gravi condizioni economiche: il piccolo grande uomo, l’avvocato Marotta, colui che come avrebbe detto Hegel impersona la seconda natura (così è anche il titolo del documentario che lo immortala, di Marcello Sannino) quella della cultura, si trova ora senza un soldo, perché ha venduto tutte le sue proprietà, tutti i suoi averi per mantenere in vita l’Istituto. Lo ha finanziato per quindici anni, poi è intervenuto Ciampi: «ne riconosceva il valore immenso culturale, capiva che l’Istituto era sorto per la difesa della civiltà europea».
Ciampi sfruttò dapprima l’8 per mille alla cultura, poi promosse una legge che destinava ogni anno all’Istituto due milioni e mezzo di euro. Con questi soldi sono state istituite centinaia di scuole di alta formazione nel Mezzogiorno, sono state date migliaia di borse di studio, è stato creato un Istituto superiore di studi ad Heidelberg dedicato al nome di Hans-Georg Gadamer, seminari costanti ogni anno vengono tenuti al Warburg Institute di Londra, e sono stati organizzati quarantamila tra lezioni e seminari in tutta Europa. «Ma purtroppo dal 1 gennaio 2010 il governo ci ha dimenticati». Nel 2011 la Camera prese posizione per tutelare sia l’Istituto per gli studi filosofici che quello per gli studi storici, espresse un ordine del giorno che ancora non si è tramutato in legge.
L’avvocato non riesce più a pagare i fitti dei tanti locali che contengono i libri, ed anche se la Regione Campania ha acquistato sotto l’amministrazione Bassolino un edificio nel centro della città, i lavori di ristrutturazione per la sistemazione della biblioteca a tutt’oggi non sono ancora iniziati.
L’enorme patrimonio librario, più di trecentomila volumi si trova ora in parte in un capannone a Casoria, chiuso in degli scatoloni, col rischio di sparire nell’oblio. Molti sono stati gli appelli per salvare l’Istituto, provenienti dagli intellettuali di tutto il mondo, dalla comunità europea. «Sono le accademie e gli istituti superiori ad aver salvato la cultura - continua l’avvocato ma oggi vivono in uno stato di quiescenza, il governo non le utilizza, non comprende la loro importanza».
Cita l’articolo uscito sull’Unità il 13 settembre 2012 di Edgar Morin: «Il progresso è fallito, ora una nuova civiltà», in cui Morin spiega come sia necessaria una «vigorosa reazione per ricercare nuove convivialità e ricreare uno spirito di solidarietà, intessere nuovi legami sociali per far riemergere quelle fonti spirituali che sono state soffocate». Ma lo aveva capito prima Croce quando nel 1946 scriveva sulla fine della civiltà «la fine della civiltà (...) è la rottura della tradizione, l’instaurazione della barbarie, ed ha luogo quando gli spiriti inferiori e barbarici (...) riprendono vigore preponderanza e signoria».
Il filosofo Hans-Georg Gadamer lo ribadisce: «La società è caratterizzata dall’anonimità. Siamo minacciati dall’epoca del progresso in cui viviamo», «è la grande vittoria dell’ondata tecnologica, ed è l’appiattirsi nella forma di insegnamento monologica, i cui caratteri distintivi sono la chiusura individualistica, la mancanza di ogni fede». «Si diffonde un pathos del disincanto che si può avvertire dappertutto e in particolare si è impadronito delle giovani generazioni».
L’avvocato Marotta vorrebbe che Napoli si rianimasse e si reinserisse nella grande storia. Desidera tenere viva l’eredità del grande pensiero europeo e edificare su queste premesse nuove forme di pensiero e di vita, desidera che l’Europa sopravviva alle minacce di questa epoca. Con le mani incrociate e lo sguardo rivolto verso l’alto dice: «Abbiamo ricevuto riconoscimenti in tutto il mondo, ma i governi italiani non mostrano preoccupazioni per il destino di questo Istituto. Vorrei vivere un altro anno ancora per sistemare le cose all’Istituto».
Noi gli auguriamo di vivere molti più anni, e sappiamo che rimarrà nell’immortalità: come dice il filosofo francese Jacques Deridda lui è l’homme des Lumières, un jour on lui donnera raison; c’est sûr, et mieux que jamais on comprendra qu’il a vu très loin, très tôt.
-
> «Salviamo l’Istituto di Studi filosofici». -- Riparte l’Istituto di studi filosofici. Nel direttivo Aldo Masullo (di Antonio Carioti).22 settembre 2017, di Federico La Sala
Riparte l’Istituto di studi filosofici
Entra nel direttivo Aldo Masullo
di Antonio Carioti (Corriere della Sera, 22.09.2017)
«È stato un momento di gioia intensa, ho risentito la presenza di mio padre più vivo che mai». Non nasconde la sua soddisfazione l’avvocato Massimiliano Marotta, presidente del Consiglio direttivo dell’Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli, per la conclusione dell’annosa vertenza giudiziaria che aveva messo a rischio il prestigioso polo culturale partenopeo.
 La questione risale al 2002, quando l’Istituto fondato dall’avvocato Gerardo Marotta, scomparso nel gennaio scorso, fu escluso da finanziamenti che gli spettavano. «Abbiamo fatto ricorso - ricorda Massimiliano Marotta - e la magistratura ci ha dato ragione, ma nel frattempo abbiamo dovuto ovviare alla crisi che si era determinata sacrificando i beni della nostra famiglia. Ora abbiamo raggiunto una transazione che, rinunciando al risarcimento dei danni subiti, ci consente di ripartire subito a pieno regime con le nostre attività, in primo luogo l’erogazione delle borse di studio ai giovani».
La questione risale al 2002, quando l’Istituto fondato dall’avvocato Gerardo Marotta, scomparso nel gennaio scorso, fu escluso da finanziamenti che gli spettavano. «Abbiamo fatto ricorso - ricorda Massimiliano Marotta - e la magistratura ci ha dato ragione, ma nel frattempo abbiamo dovuto ovviare alla crisi che si era determinata sacrificando i beni della nostra famiglia. Ora abbiamo raggiunto una transazione che, rinunciando al risarcimento dei danni subiti, ci consente di ripartire subito a pieno regime con le nostre attività, in primo luogo l’erogazione delle borse di studio ai giovani».Inoltre nel Consiglio direttivo dell’Istituto è entrato il filosofo Aldo Masullo. «Non si tratta di una nomina onorifica - sottolinea il direttore di studi dell’Istituto Geminello Preterossi - perché Masullo porterà un contributo prezioso di sostegno e di indirizzo al nostro lavoro».
-
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- Povera Italia senza filosofia (di Roberto Timossi)20 marzo 2013, di Federico La Sala
L’ANALISI
Povera Italia senza filosofia
di Roberto Timossi (Avvenire, 19 marzo 2013)
Dove va oggi la filosofia? Ma prima ancora: esiste ancora la filosofia in Italia? E se esiste, chi sono e cosa fanno i filosofi italiani? Si tratta di domande forti, che però è giusto porsi di fronte a uno sguardo globale sul pensiero filosofico nel XXI secolo come quello contenuto in un interessante libro di sintesi ragionata curato da Tiziana Andina, Filosofia contemporanea (Carocci).
Una considerazione preliminare su questo testo, e che altri hanno già giustamente fatto, è che i suoi autori sono tutti studiosi italiani, alcuni dei quali - come ha notato Mario De Caro su Il Sole 24 Ore del 27 gennaio - ancora ricercatori o «senza stabile collocazione accademica» ed altri «emigrati all’estero». Diciamo subito che queste due osservazioni di De Caro, per altro adombrate anche nell’introduzione della curatrice quando si definiscono «cervelli in fuga» gli intellettuali italiani che lavorano in università estere, dimostrano uno dei limiti della concezione del filosofo o di chi fa ricerca filosofica presente soprattutto in Italia, ma non del tutto estranea al common sense view internazionale.
Secondo questo punto di vista, infatti, filosofo è colui che si occupa professionalmente di filosofia, quindi insegna o fa ricerca nel mondo accademico, e normalmente si impegna nella chiarificazione logica dei concetti oppure si concentra sullo studio di un pensatore del passato più o meno recente, con taglio prevalentemente storico e solo talvolta sviluppandone alcuni aspetti teoretici.
Questo è ad esempio il fulcro di una critica contro i «sedicenti filosofi» che mi è capitato di recente di leggere da parte di Nicla Vassallo, una peraltro apprezzata docente di filosofia. In realtà, un buon filosofo non deve necessariamente essere un accademico (nella storia troviamo casi emblematici, come Baruch Spinoza che di mestiere faceva il tornitore di lenti); anzi, per certi versi se oggi la filosofia ha un problema è proprio quello di essere diventata troppo «accademica», ossia troppo condizionata dai metodi e dagli ambiti settoriali di indagine e di specializzazione dei percorsi universitari, laddove invece il filosofo non deve mai rinunciare alla critica dell’esistente e non deve perdere di vista «l’intero».
Allo stesso modo, il vero lavoro filosofico non è quello che si concentra sulla storia della filosofia e in particolare sullo studio di un pensatore del passato, ma è innanzitutto quello speculativo, nel quale il vero filosofo esprime una posizione originale frutto del suo libero pensiero. Questo d’altronde è probabilmente un limite «endemico» della filosofia italiana del Novecento, che ha quasi sempre sviluppato idee e orientamenti filosofici provenienti da fuori dei confini nazionali piuttosto che formulare un pensiero proprio ed originale: così è avvenuto prima con l’idealismo, poi con il marxismo e infine con l’esistenzialismo.
Di recente, la stessa mancanza di originalità speculativa si è ripetuta con l’affermarsi del filone analitico e con quello della filosofia ermeneutica di stampo continentale, mentre si è andato esaurendo in campo cattolico il filone neoscolastico senza nessuna convincente alternativa, se si fa eccezione di un’importante riscoperta di Rosmini.
I più noti pensatori italiani dei nostri giorni hanno finito per ruotare intorno a un dibattito piuttosto asfittico sul pensiero debole, sul nichilismo e sulla fine della metafisica, che è approdato o ad esiti relativistici con la «crisi della ragione» (secondo un celebre testo curato da Aldo Gargani) oppure all’abbandono tout court della ragione, ad una sorta di nuovo "irrazionalismo" (Gianni Vattimo, Pier Aldo Rovatti e alcune tendenze postmoderniste) al quale ha fatto da contraltare una forma di escatologia alternativa alla fede religiosa (Emanuele Severino) o addirittura un cristianesimo non religioso (ancora Gianni Vattimo) o dal «cielo vuoto» (Umberto Galimberti).
Da noi gli appartenenti alle "comunità accademiche" di solito danno forma a confronti di idee molto paludati e raramente si leggono critiche espresse apertis verbis; anzi, normalmente si recensiscono a vicenda sui principali quotidiani o sulle principali riviste. Basti in proposito citare l’attuale discussione molto in voga sul cosiddetto «nuovo realismo» lanciato da Maurizio Ferraris, che ruota intorno alla strana necessità di distinguere «quello che c’è» (l’ontologia) da «quello che sappiamo a proposito di quello che c’è» (l’epistemologia), come se non fosse evidente che per dire che cosa effettivamente esiste (quello che c’è) dobbiamo per forza prima conoscerlo (ossia sapere quello che c’è).
E questo vale tanto di più quando si apprende, anche da un recente articolo su La Repubblica del 19 febbraio, che «quello che c’è» per Ferraris è quanto ci dicono le spiegazioni della natura di matrice neo-darwiniana, perché ci pone di fronte alla riproposizione di un’ontologia non chiaramente distinta da un’epistemologia, bensì influenzata da un vecchio presupposto epistemologico: quello naturalistico. Quanto infine alla «fuga dei cervelli», mi pare che qui si tenda a ripetere meccanicamente un luogo comune, senza fare le dovute specificazioni.
La mia opinione è che i «cervelli» debbano viaggiare il più possibile per tutto il pianeta con l’obiettivo di acquisire nuove esperienze, nonché di frequentarsi e conoscersi direttamente; quindi ben venga la circolazione delle intelligenze e delle competenze, ben venga che molti studiosi di filosofia facciano ricerca all’estero e trovino una loro collocazione definitiva in centri di ricerca stranieri.
La questione è caso mai un’altra: che il «flusso dei cervelli» tra l’Italia e gli altri Paesi occidentali risulti bidirezionale in modo equivalente (per tanti ricercatori e docenti che escono, più o meno altrettanti dovrebbero entrare), mentre così non pare avvenire. Certamente ciò dipende (come dice in premessa il citato articolo di De Caro) «dalle recenti riforme universitarie e dai tagli finanziari» alla ricerca, che vanno sicuramente deprecati e contrastati; ma nel caso della filosofia dipende anche dal non riuscire ad avere nel nostro Paese centri di assoluta eccellenza in campo filosofico, come invece accade in nazioni come gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e la Germania.
Il problema principale per la filosofia in Italia non è tanto quello della mancanza di laboratori o di strumenti tecnici di ricerca come nel caso delle scienze sperimentali (anche se in generale le carenze ci sono e non si possono negare), quanto quello dell’assenza di «scuole» autonome ed originali, della perdita di specifiche tradizioni italiane come quelle di ispirazione cristiana.
Non a caso nel libro curato da Tiziana Andina i filosofi italiani direttamente menzionati sono relativamente pochi (primeggia Diego Marconi per la filosofia della mente) e quasi sempre con un ruolo marginale nel dibattito filosofico internazionale. Non è questa, si badi bene, la rivendicazione di un’impensabile «autarchia filosofica»; al contrario, proprio perché il filosofo deve essere per definizione cosmopolita, anche nell’offerta di cultura filosofica dovremmo essere in grado di confrontarci alla pari con le eccellenze degli altri Paesi. Qui quanto meno un senso di autocritica deve investire tutti coloro che in Italia svolgono un lavoro «filosofico».
Roberto Timossi
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- LA POTENZA DEL DESIDERIO E IL DESIDERIO DELL’ONNIPOTENZA: LA LEZIONE DI GIAMBATTISTA VICO.17 marzo 2013, di Federico La SalaLA POTENZA DEL DESIDERIO E IL PROBLEMA DI DIO. UNA IMPOSTAZIONE ALL’ALTEZZA DI NEWTON E KANT, CHE SI SPINGE IN UN’ORIZZONTE CHE VA OLTRE FREUD E LACAN ...
 GIAMBATTISTA VICO: LA LIBERTA’, LA PROVVIDENZA, E LA TEOLOGIA DELL’UMANITA’ "TUTTA DISPIEGATA". Un breve saggio - di Federico La Sala
GIAMBATTISTA VICO: LA LIBERTA’, LA PROVVIDENZA, E LA TEOLOGIA DELL’UMANITA’ "TUTTA DISPIEGATA". Un breve saggio - di Federico La Sala
 il “Dio” di Vico (...) è il (...) Dio evangelico, il Dio “Chàritas” (il dio della “Grazia”- “Chàris”, e delle “Grazie”, “Chàrites”)! E questo è, per Vico, anche il nome del “Dio provvedente” di tutte le nazioni (...)
il “Dio” di Vico (...) è il (...) Dio evangelico, il Dio “Chàritas” (il dio della “Grazia”- “Chàris”, e delle “Grazie”, “Chàrites”)! E questo è, per Vico, anche il nome del “Dio provvedente” di tutte le nazioni (...)
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- LA LEZIONE DI VICO E I FILOSOFI ITALIANI: IL CASO COLLETTI. Una nota per (ri)leggere la "Scienza Nuova"10 marzo 2013, di Federico La Sala
 PER UNA NUOVA ITALIA, PER UNA NUOVA NAPOLI, PER UNA NUOVA CITTA’ DELLA SCIENZA....
PER UNA NUOVA ITALIA, PER UNA NUOVA NAPOLI, PER UNA NUOVA CITTA’ DELLA SCIENZA....
 LA LEZIONE DI VICO E I FILOSOFI ITALIANI: IL CASO COLLETTI. Una nota per (ri)leggere la "Scienza Nuova"
LA LEZIONE DI VICO E I FILOSOFI ITALIANI: IL CASO COLLETTI. Una nota per (ri)leggere la "Scienza Nuova"
 Che questo suo “meraviglioso libro - come scrisse Paul Hazard alla fine della seconda guerra mondiale - proietti finalmente il suo splendore sull’orizzonte dell’Europa”!
Che questo suo “meraviglioso libro - come scrisse Paul Hazard alla fine della seconda guerra mondiale - proietti finalmente il suo splendore sull’orizzonte dell’Europa”!
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- PER UNA NUOVA CITTA’ DELLA SCIENZA, UN OMAGGIO A VICO E LA MASSIMA SOLIDARIETA’ A NAPOLI E A BAGNOLI.6 marzo 2013, di Federico La SalaL’ITALIA AL BIVIO. LA LEZIONE DI GIAMBATTISTA VICO, OGGI: "LEMURUM FABULA" (LA STORIA DEI LEMURI)
 PER UNA NUOVA CITTA’ DELLA SCIENZA, UN OMAGGIO A VICO E LA MASSIMA SOLIDARIETA’ A NAPOLI E A BAGNOLI.
PER UNA NUOVA CITTA’ DELLA SCIENZA, UN OMAGGIO A VICO E LA MASSIMA SOLIDARIETA’ A NAPOLI E A BAGNOLI.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- TEOLOGIA POLITICA DEL "MENTITORE" ED EVANGELO.Il cristianesimo paolino e il ritornello del filosofo-sacerdote. L’ultimo lavoro di Massimo Cacciari27 febbraio 2013, di Federico La Sala
 TEOLOGIA POLITICA DEL "MENTITORE" ED EVANGELO. PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO, CHE GIA’ DANTE E KANT SOLLECITAVANO
TEOLOGIA POLITICA DEL "MENTITORE" ED EVANGELO. PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO, CHE GIA’ DANTE E KANT SOLLECITAVANO
 PROMETEO, EPIMETEO, E APOLOGIA DELLO SPIRITO PLATONICO-HEGELIANO. Il cristianesimo paolino e il ritornello del filosofo-sacerdote. L’ultimo lavoro di Massimo Cacciari (con intervista e note di Roberto Esposito e Giorgio Montefoschi)
PROMETEO, EPIMETEO, E APOLOGIA DELLO SPIRITO PLATONICO-HEGELIANO. Il cristianesimo paolino e il ritornello del filosofo-sacerdote. L’ultimo lavoro di Massimo Cacciari (con intervista e note di Roberto Esposito e Giorgio Montefoschi)
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- per riflettere sulla "boria dei dotti" (G. Vico)!26 febbraio 2013, di Federico La Sala
 CRISI COSTITUZIONALE (1994-2013). GLI APPRENDISTI STREGONI E L’EFFETTO "ITALIA". LA CLASSE DIRIGENTE (INCLUSI I GRANDI INTELLETTUALI) CEDE (1994) IL "NOME" DEL PAESE AL PARTITO DI UN PRIVATO. Che male c’è?!
CRISI COSTITUZIONALE (1994-2013). GLI APPRENDISTI STREGONI E L’EFFETTO "ITALIA". LA CLASSE DIRIGENTE (INCLUSI I GRANDI INTELLETTUALI) CEDE (1994) IL "NOME" DEL PAESE AL PARTITO DI UN PRIVATO. Che male c’è?!
 BEPPE GRILLO E IL SUO PROGRAMMA: "RIPRENDIAMOCI QUELLE PAROLE"! 2004-2013: otto, nove anni di lavoro culturale e un grande successo politico. Un suo intervento su "la Repubblica" (2004)
BEPPE GRILLO E IL SUO PROGRAMMA: "RIPRENDIAMOCI QUELLE PAROLE"! 2004-2013: otto, nove anni di lavoro culturale e un grande successo politico. Un suo intervento su "la Repubblica" (2004)
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- ANCORA A CASA DI HEGEL E DI HEIDEGGER. E sognano che li salverà la dialettica.25 febbraio 2013, di Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- VICO E FACHINELLI: INDICAZIONI PER UNA SECONDA RIVOLUZIONE COPERNICANA.20 febbraio 2013, di Federico La Sala
 A Niccolo’ Copernico, nel 540esimo anniversario della nascita. Al di là dei "corsi e ricorsi", il filo della tradizione critica. Contro la cecità e la boria dei dotti e delle nazioni ...
A Niccolo’ Copernico, nel 540esimo anniversario della nascita. Al di là dei "corsi e ricorsi", il filo della tradizione critica. Contro la cecità e la boria dei dotti e delle nazioni ...
 ELVIO FACHINELLI E GIAMBATTISTA VICO: INDICAZIONI PER UNA SECONDA RIVOLUZIONE COPERNICANA.
ELVIO FACHINELLI E GIAMBATTISTA VICO: INDICAZIONI PER UNA SECONDA RIVOLUZIONE COPERNICANA.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---PENSANO ANCORA CHE LA RIVOLUZIONE COPERNICAN DI KANT SIA UNA RIVOLUZIONE TOLEMAICA!!! Un’analisi che lega tre recenti libri su Spinoza (di Vincenzo Vitiello - Se l’uomo è il centro. Le strade della filosofia nella crisi della politica).3 febbraio 2013, di Federico La Sala
 Se l’uomo è il centro
Se l’uomo è il centro
 Le strade della filosofia nella crisi della politica
Le strade della filosofia nella crisi della politica
 Stiamo assistendo alla fine della polis? Il pensiero ha ancora un destino
nella sfera pubblica o guarda oltre di essa?
Stiamo assistendo alla fine della polis? Il pensiero ha ancora un destino
nella sfera pubblica o guarda oltre di essa?
 Un’analisi che lega tre recenti libri su Spinoza: di Carlo Sini, Biagio De Giovanni e Massimo Adinolfi
Un’analisi che lega tre recenti libri su Spinoza: di Carlo Sini, Biagio De Giovanni e Massimo Adinolfi
 di Vincenzo Vitiello l’Unità 3.2.13
di Vincenzo Vitiello l’Unità 3.2.13
«CERTO È STRANO NON ABITARE PIÙ LA TERRA»: QUESTO MESTO VERSO DI RILKE DESCRIVE NON LA CRISI DEL NOSTRO TEMPO, MA IL SUO TRIONFO. Il trionfo dell’appropriazione umana della terra e del tempo, il trionfo della storia e della politica. A questa appropriazione, che, seguendo il racconto di Genesi (2, 19-20), inizia da quando Dio concesse all’uomo la facoltà di dar nome agli animali della terra e del cielo, la filosofia ha dato un contributo notevole, concependo la vita buona come quella vita che si realizza nella comunità degli uomini padroni della terra e di tutto quanto sulla terra cresce e vive. Mestizia di poeta separato dal mondo, quella di Rilke? O non piuttosto un sentimento, frustrato, di più profonda partecipazione alla vita del tutto? Forse la crisi della polis, sottraendo alla filosofia il suo tema principale - la res publica, come la suprema res humana - apre l’orizzonte del pensiero oltre la soglia dell’umano.
Si tratterebbe di una vera e propria rivoluzione in filosofia, che, in contrasto con quella «copernicana di Kant, definirei «tolemaica», dacché segna il passaggio dalla riflessione del mondo a partire dall’uomo alla considerazione dell’uomo muovendo dal mondo.
E qual filosofo della nostra modernità ha contribuito a questa trasformazione più e meglio di Spinoza?
Biagio de Giovanni, filosofo della politica che ha sempre accompagnato l’attività di studioso con l’impegno politico, in un suo recente libro, Hegel e Spinoza. Dialogo sul moderno, ha ampiamente argomentato che la risposta di Spinoza alla crisi del moderno - la scissione io-mondo - è più «avanzata» di quella hegeliana, perché non «redime» il finito, assorbendolo nel processo della universale ragione come suo momento necessario, ma lo «salva», e cioè lo «serba» nella sua finitezza, entro il «libero» spazio della sostanza eterna.
Altra volta ho rilevato la vicinanza di questa interpretazione della sostanza spinoziana all’Ereignis di Heidegger, l’evento puro che tutto pro-voca ed accoglie, e nulla impone. Vi torno su, in questa sede, perché Spinoza - lo Spinoza che de Giovanni non esita a dire «il mio Spinoza» -, pur teorizzando la razionalità dello Stato, procede oltre il «politico», verso quella fondazione etica della ‘comunità’ che non è in potere della comunità. Per l’autore del Tractatus teologico-politicus e del Tractatus politicus «sostanza» è il nome della «natura» in cui l’uomo abita, e solo perché abita in essa, può comunicare con altri, può, cioè, far comunità.
L’etica di Spinoza ha come tema la natura che non è solo punti, linee e figure geometriche, è sovratutto corpo vivente, Leib, e cioè: passione, sentimento, amore e odio, letizia e tristezza, immaginazione. È, nel linguaggio di Rilke, la Terra oltre la Città: la Terra che «salva» l’uomo nella sua finitezza e libertà. È questo il messaggio? Il nuovo messaggio della filosofia?
Nel 1991-92 - son passati vent’anni! - Carlo Sini tenne un corso alla Statale di Milano su La verità pubblica e Spinoza. Pubblicato la prima volta nel 2005, è stato riedito nel IV volume, tomo I, delle sue Opere, in questo inizio d’anno. Essendo stato già recensito su queste pagine, posso andar subito all’essenziale, che è già tutto nello stile del testo, che ha conservato l’andamento della lectio, della lettura. Della lettura non d’un libro, ma del mondo, quale si es-pone nel pensiero che si fa nell’atto stesso di dirsi, di scriversi. Questa la verità pubblica del mondo (e non sul mondo). Verità che non è, perché in via di farsi, come il mondo.
In questa pratica di pensiero Spinoza da «oggetto» diviene soggetto del pensiero, sorgente che non si conosce, meglio: che non è altrove che in ciò che essa alimenta. Pertanto non ha senso voler distinguere quello che è di Spinoza da quello che è di Sini - e non perché non lo si possa fare, ma perché facendolo, si cristallizza il pensiero, gli si toglie vita. Sini leggendo Spinoza, lo «continua» (per usare il verbo felicemente scelto da Massimo Adinolfi per il titolo del suo libro, appunto: Continuare Spinoza). Di qui l’arditezza delle analisi siniane, dalla negazione che gli attributi della sostanza siano due, pensiero ed estensione, o addirittura infiniti, alla affermazione che l’essenza della sostanza è «espressa» nel «sive» che congiunge-separa Dio e natura: Deus sive natura. Invero le due tesi dicono il medesimo: perché se «i due nomi (pensiero ed estensione) sono l’identico trascolorare della sostanza nella loro differenza», cosa mai può essere la sostanza fuor del «trascolorare»?
Il «sive» è il segno, la traccia che l’evento del trascolorare lascia nel pensiero, come nel corpo, in cui trascolora. Ma l’evento non è la traccia: pensieri e corpi, per dirla con Spinoza, non sono la sostanza. La verità pubblica del mondo non è il mondo. L’evento puro, il mondo, di cui il «sive» è segno o traccia, «non è pensabile (...)e non è da pensare».
L’evento puro del trascolorare dell’Indifferente nelle differenze non lo si pensa, lo si vive. In esso e di esso viviamo. Nella verità pubblica, oltre la verità pubblica: nella polis, oltre la polis. È un libero «trovarsi accanto» a uomini come a erbe e pietre e animali, oltre il «con-esserci» dell’ordine giuridico, delle leggi e della giustizia. Sini chiama mondo, quel che Rilke nomina terra. Pur nella grande differenza di metodo, intenti e scrittura, le analisi di de Giovanni e di Sini convergono nel risultato.
Lontani entrambi dal mito della terra incontaminata, trovano la terra, o, come entrambi amano dire, il mondo ciò che dà stabilità e potenza al fare nei conflitti della politica e pur nelle distruzioni delle guerre. Qui, nell’aiuola che ci fa feroci, e non altrove si «salva» il finito. O meglio: è già da sempre salvato. La nostra «salvezza» (de Giovanni), la nostra «eternità» (Sini), non è certo nella miseria delle nostra differenze, ma nella sovrabbondante ricchezza della sostanza, dell’evento, del mondo, che, peraltro, è solo in quelle differenze. Fuor di queste sarebbe solo Silenzio.
Mi chiedo se non sia questa un’ultima rassicurazione - necessaria all’uomo per non pensare alla morte: dell’uomo, del mondo, della Terra. Per Spinoza il filosofo pensa la vita, non la morte. Per Spinoza.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- IL NUOVO PROLETARIATO. Chi non è proletario alzi la mano (di Günther Anders)..19 gennaio 2013, di Federico La Sala
Su MicroMega
Chi non è proletario alzi la mano
Una condizione che non riguarda più soltanto una classe ma tutti gli uomini: un inedito
di Günther Anders (La Stampa, 17.01.2013)
- Günther Anders, pseudonimo di Günther Stern (Breslavia, 1902 - Vienna, 1992)
IL NUOVO PROLETARIATO
Non è più definito dagli standard di vita, ma dalla mancanza di libertà: nessuno si può salvare
CHI VA ALLE URNE
Non vota in qualità di «uomo libero» ma di uomo manipolato da media a loro volta manipolati
Non è corretto decretare la fine del proletariato perché non ci sarebbe più alcun proletario, quanto semmai perché oggi difficilmente si troverebbe ancora qualcuno che non lo sia. Il significato di quest’affermazione, che inizialmente può suonare assurda, risulterà chiaro soltanto qualora si stimasse come criterio per definire il proletariato non tanto lo standard di vita, bensì quello di libertà. In tal guisa sarebbero da considerarsi proletari non solo tutti gli operai, i dipendenti e gli impiegati pubblici, sebbene possiedano un’auto propria e addirittura la libertà di scegliere la marca, e benché viaggino ogni anno con l’aereo verso Maiorca o la Thailandia; ma anche i presunti «lavoratori autonomi».
Né i fisici, né gli inventori, né gli ingegneri (per non parlare degli imprenditori costretti a scegliere i loro prodotti in base ai rapporti di mercato) si realizzano per mezzo delle loro attività. O si può forse parlare di «autorealizzazione» quando un ingegnere progetta modelli di alcune parti di macchina, di una determinata macchina, che dovrebbe a sua volta contribuire alla produzione di un’arma atomica? Quest’ingegnere - e con lui il 99% dei suoi colleghi - vive e lavora altrettanto ciecamente di un operaio non-qualificato, il quale, senza sapere a quale scopo, senza che si interessi allo scopo, senza che se ne possa o debba interessare, spinge su e giù una levetta mille volte al giorno, eseguendo sempre lo stesso movimento. [...]
Il nostro essere-proletari consiste nella totale manipolazione della nostra vita, che insidia perfino il mondo e il tempo del nostro ozio e che non consente più a nessuno, neppure a colui che manipola, di riconoscere la propria illibertà. In altre parole: l’illibertà oggi consiste nella totale discrepanza, nella totale mancanza di relazione fra il lavoratore e il prodotto che egli rielabora; fra ciò che fa e l’effetto che contribuisce a provocare o, meglio, di cui è corresponsabile; fra ciò che gli viene venduto come piacere e la felicità che invero gli spetta.
Ma non esistendo più il proletariato in quanto «classe» secondo il significato classico - perché oramai tutti appartengono a questa categoria di schiavizzati - viene altresì meno ogni possibile discorso sulla «lotta di classe». E sarebbe altrettanto insensato presentarsi oggi come avanguardisti di una classe che non esiste più; e ripetere ancora il motto «proletari di tutto il mondo, unitevi! ».
Il lavoratore - ma, come vedremo fra poco, non soltanto lui - malgrado il suo diritto di voto, la sua adesione al sindacato ecc., è totalmente privo di libertà, ossia un proletario, per la ragione seguente: non ha la libertà di partecipare alle decisioni su quale prodotto deve creare - o meglio, contribuire a creare; non viene mai consultato sulla questione se i prodotti che egli contribuisce a creare (e gli effetti apocalittici che questi possono comportare) debbano essere in generale creati, oppure no. Così l’Unione Sovietica ha fatto erigere un gran numero di centrali nucleari senza concedere la libertà di discutere dei rischi impliciti in simili progetti.
Anche la maggior parte delle grandi potenze industriali dell’Occidente ha fatto costruire le centrali senza consultare i cittadini interessati o le popolazioni minacciate da esse; anzi, senza che le popolazioni potessero accedere a informazioni adeguate per essere anche soltanto nelle condizioni di votare.
Hanno piuttosto prodotto (con l’aiuto dei lavoratori naturalmente) la disinformazione mirata e sistematica e l’ignoranza della popolazione. I cosiddetti «responsabili» inoltre, dopo aver fatto costruire gli impianti dei reattori fino a una certa altezza, hanno poi sostenuto che lasciar cadere in rovina progetti sui quali il popolo aveva già investito così tanto capitale e lavoro sarebbe stata un’irresponsabile disgrazia per l’economia della nazione e il diritto al lavoro di ogni cittadino.
Sembra che ogni cittadino, per il semplice fatto d’aver delegato la sua voce, o meglio, la sua opinione, a un rappresentante, partecipi così, quantomeno indirettamente, alle decisioni cruciali. Ma il cittadino che si reca alle urne, un atto che garantisce solo un’apparente libertà, non vota affatto in qualità di «uomo libero», ma di un uomo che è stato manipolato e convinto dai mezzi di comunicazione (già a loro volta manipolati). La sua opinione, che l’opinione che esprime o delega sia davvero la sua, gli è stata in realtà indotta. La parola «opinione» (nonostante il famoso gioco di parole di Hegel) non ha nulla a che fare col possessivo «mio». Anziché dire «chi si esprime [der Meinende] possiede un’opinione [Meinung]», dovremmo dire: «l’opinione possiede chi la esprime». Sempre che si possa ancora chiamare opinione quel che egli «possiede» (per non parlare di quel giudizio che si fonda su una conoscenza specifica).
Ciò che il presunto libero cittadino «possiede» e che lascia esprimere dai suoi rappresentanti è piuttosto un’ignoranza creata (da persone interessate) attorno alla materia che si sta discutendo; un’ignoranza che non si presenta soltanto come opinione, ma come se si trattasse di un fondato giudizio di esperti. Alla creazione e alla diffusione di questa ignoranza - è il coronamento del presunto processo democratico - contribuiscono gli stessi lavoratori o dipendenti (come addetti alla distribuzione del, per esempio). Anche l’auto-istupidimento è un lavoro, per il quale il lavoratore non soltanto si fa pagare: egli addirittura lo rivendica come se fosse un prezioso diritto. In altre parole: il lavoratore - in Unione Sovietica come negli Stati Uniti - non ha la minima libertà decisionale su ciò a cui deve lavorare. E non possiede ancora la libertà di sentire la mancanza di questa libertà. È talmente privo di libertà che è un proletario.
(Traduzione di Devis Colombo)
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- Filosofi di tutto il mondo unitevi in rete e affilate “Il rasoio di Occam” di MicroMega (di Elisabetta Ambrosi)18 gennaio 2013, di Federico La Sala
Filosofi di tutto il mondo unitevi in rete e affilate “Il rasoio di Occam” di MicroMega
di Elisabetta Ambrosi (il Fatto, 18.01.2013)
Filosofi di tutta Italia, scaldatevi: è ora di scendere in rete. Se siete curiosi di sapere fino a che punto la teoria del vecchio Marx funziona ancora contro il nostro capitalismo marcio, o magari volete capire se le tesi dell’apocalittico Heidegger possono realmente tornare utili dopo Fukushima, da oggi c’è una palestra filosofica in più. Invece che sulle gambe, però, come nelle scuole peripatetiche, le argomentazioni cammineranno online. Il nuovo gymnasium della mente si chiama “Il rasoio di Occam” ( http: //ilrasoiodioccam. microme ga.net ), una “costola” filosofica di MicroMega - sempre diretta da Paolo Flores d’Arcais - che si affiancherà ai contenuti del celebre Almanacco, senza ovviamente replicarli.
L’idea è nata l’anno scorso, con l’obiettivo - spiega il coordinatore del sito Giorgio Cesarale - di creare uno spazio dove discutere questioni che hanno una rilevanza pubblica”. Alcuni esempi? Diritti umani, crisi economica, corruzione, fine vita, disuguaglianze e possesso di armi. Ma solo, rigorosamente, con un linguaggio filosofico. Insomma, niente “chiacchiere” (nel senso heideggeriano di banalizzazione dell’essere). Anche per questo, l’aggiornamento, almeno per ora, sarà settimanale, proprio per dare modo a visitatori di leggere (e ben “digerire”) l’intervento, in modo da intervenire a loro volta.
Sul sito graviteranno nomi di eccellenza, come Carlo Augusto Viano, Ernesto Screpanti (autori dei primi due articoli pubblicati: “Aporie della giustizia. Marx a lezione da Rawls” e “La razionalità sostanziale è finita in Cina”).
E poi Gianni Vattimo, Franca D’Agostini, Giulio Giorello, Sossio Giametta, Telmo Pievani, Maurizio Ferraris, Alessandro Petrucciani. C’è voglia, però, anche di far crescere giovani talenti filosofici (trai vari nomi: Giacomo Fronzi o Ernesto De Cristofaro), anche attraverso una sezione dedicata agli “emergenti. Ma “senza parricidi né rottamazioni”, precisa il coordinatore. ALTRO ASPETTO importante del sito: il suo carattere internazionale. Per q uesto alcuni articoli saranno scritti in inglese, mentre al tempo stesso importanti filosofi stranieri troveranno pronta ospitalità.
Ci sono riviste o siti a cui il rasoio di Occam si ispira? “In Italia non abbiamo un modello esplicito di riferimento: apprezziamo il Phenomenology Lab di Roberta de Monticelli, ma noi siamo aperti a tutte le scuole filosofiche, non solo a quella fenomenologica”, continua Cesarale. “Ci siamo invece ispirati alla rivista statunitense The Stone, legata al New York Times”. Portare la discussione filosofica sul web, fuori dall’Accademia, è un modo per dire che nelle università si discute sempre di meno? “Non c’è una polemica diretta, però di sicuro il nostro intento è quello di educare alla discussione un pubblico filosofico, che spesso invece non è abituato”.
Sul sito, gli studiosi o i semplici appassionati di filosofia troveranno anche una serie di strumenti: una biblioteca virtuale di classici online che raccoglierà i testi dei filosofi della nostra tradizione, sia in lingua italiana che originale.
DA AGOSTINO a Wittgenstein; una raccolta dei link più importanti di siti: blog multiautoriali, riviste, enciclopedie e biblioteche, centri di ricerca; infine - soprattutto per i più profani - i nomi e le biografie intellettuali dei maggiori filosofi italiani, da Giorgio Agamben a Salvatore Veca, passando per Massimo Cacciari, Umberto Eco, Roberto Esposito, Maurizio Ferraris, Giulio Giorello, Sergio Givone, Diego Marconi, Antonio Negri, Pier Aldo Rovatti, Emanuele Severino, Salvatore Veca (e si spera presto anche qualche donna).
Una curiosità: il nome del sito - dal celebre argomento del filosofo Guglielmo di Occam, secondo cui, ci spiega Cesarale, “bisogna eliminare problemi non risolvibili attraverso prova empirica o argomentazione logica”, era quello originariamente scelto per MicroMega. La politica troverà qualche spazio? “No. Noi ci occupiamo di questioni che hanno rilevanza politica, ma con un taglio scientifico-filosofico. E soprattutto, senza alcuna ideologia di partenza”.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- La lezione chiarissima di Kant e le riflessioni ancora "oscure" e "platoniche" (di Umberto Curi e Corrado Ocone)3 dicembre 2012, di Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- TOPOLINO E RUSSELL LIBERI PENSATORI, MA NON I FILOSOFI ITALIANI. IGNORATA E ’SNOBBATA’ LA LEZIONE SUI PARADOSSI DELL’AUTORIFERIMENTO.10 novembre 2012, di Federico La Sala
 COSTITUZIONE E PENSIERO. ITALIA: LA MISERIA DELLA FILOSOFIA ITALIANA E LA RICCHEZZA DEL MENTITORE ISTITUZIONALIZZATO ...
COSTITUZIONE E PENSIERO. ITALIA: LA MISERIA DELLA FILOSOFIA ITALIANA E LA RICCHEZZA DEL MENTITORE ISTITUZIONALIZZATO ...
 BERTRAND RUSSELL: LA LEZIONE SUL MENTITORE (IGNORATA E ’SNOBBATA’), E "L’ALFABETO DEL BUON CITTADINO".
BERTRAND RUSSELL: LA LEZIONE SUL MENTITORE (IGNORATA E ’SNOBBATA’), E "L’ALFABETO DEL BUON CITTADINO". DEMOCRAZIA, SCIENZA E RELIGIONE: TOPOLINO E RUSSELL LIBERI PENSATORI, MA NON I FILOSOFI ITALIANI.
DEMOCRAZIA, SCIENZA E RELIGIONE: TOPOLINO E RUSSELL LIBERI PENSATORI, MA NON I FILOSOFI ITALIANI. -
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- UN OMAGGIO A PAUL WATZLAWICK E ALLA SCUOLA DI PALO ALTO (CALIFORNIA)8 novembre 2012, di Federico La Sala
 PRAGMATICA DELLA COMUNICAZIONE." Istruzioni per rendersi infelici" ...
PRAGMATICA DELLA COMUNICAZIONE." Istruzioni per rendersi infelici" ...
 SCUOLA DI PALO ALTO (CALIFORNIA): PAUL WATZLAWICK.
SCUOLA DI PALO ALTO (CALIFORNIA): PAUL WATZLAWICK.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- SENZA KANT, E SENZA UNA TEORIA DELLO STATO, LA "NOSTRA" FILOSOFIA DEL CONFLITTO (LA "ITALIAN THEORY") ANCORA ALLA RICERCA DEL "COMUNE".4 novembre 2012, di Federico La Sala
 FILOSOFIA E POLITICA. IL PENSIERO DELLA COSTITUZIONE E LA COSTITUZIONE DEL PENSIERO
FILOSOFIA E POLITICA. IL PENSIERO DELLA COSTITUZIONE E LA COSTITUZIONE DEL PENSIERO
 SENZA UNA TEORIA DELLO STATO, LA "NOSTRA" FILOSOFIA DEL CONFLITTO CONTINUA IL SUO VIAGGIO: "DALL’OPERAISMO ALLA BIOPOLITICA". Sul lavoro di Dario Gentili ("Italian Theory"), una riflessione di Roberto Esposito - con alcune note
SENZA UNA TEORIA DELLO STATO, LA "NOSTRA" FILOSOFIA DEL CONFLITTO CONTINUA IL SUO VIAGGIO: "DALL’OPERAISMO ALLA BIOPOLITICA". Sul lavoro di Dario Gentili ("Italian Theory"), una riflessione di Roberto Esposito - con alcune note -
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- UNO SCHIAFFO DI LUCIANA CASTELLINA A TUTTA LA FILOSOFIA ITALIANA. Avere il coraggio di continuare a pensare il non ancora pensato.30 ottobre 2012, di Federico La Sala
 ANTROPOLOGIA, POLITICA, E FILOSOFIA: "SAPERE AUDE!" (I.KANT, 1784).NON SIAMO ALLA FINE DELLA STORIA. Ridisegnare un mondo migliore ...
ANTROPOLOGIA, POLITICA, E FILOSOFIA: "SAPERE AUDE!" (I.KANT, 1784).NON SIAMO ALLA FINE DELLA STORIA. Ridisegnare un mondo migliore ...
 UNO SCHIAFFO DI LUCIANA CASTELLINA A TUTTA LA FILOSOFIA ITALIANA. Avere il coraggio di continuare a pensare il non ancora pensato.
UNO SCHIAFFO DI LUCIANA CASTELLINA A TUTTA LA FILOSOFIA ITALIANA. Avere il coraggio di continuare a pensare il non ancora pensato.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- IN ITALIA, COME «A L’AQUILA LA VERITÀ NON SI DICE» (di Stefania Pezzopane - L’Aquila, le verità che ci hanno nascosto).29 ottobre 2012, di Federico La Sala
L’Aquila, le verità che ci hanno nascosto
di Stefania Pezzopane, Assessore al Comune dell’Aquila *
«A L’AQUILA LA VERITÀ NON SI DICE». CON QUESTE POCHE PAROLE PRONUNCIATE DA BERTOLASO A BOSCHI È STATO SEGNATO IL DESTINO CRUDELE DI UNA CITTÀ. Oggi più che mai sento tutto il dolore per l’inganno che abbiamo subito. L’ennesima ulteriore dimostrazione che prima del terremoto gli aquilani non sono stati messi in condizione di essere informati su quello che stava accadendo.
Sfido chiunque ora a difendere la commissione Grandi Rischi in nome di una ideologica difesa della scienza. Queste persone erano venute all’Aquila con il proposito predeterminato di rassicurarci. I giudici sono stati non solo coraggiosi ma veri difensori dello Stato. Uno Stato che in quei giorni ci ha scientificamente ignorati. Gli scienziati infatti, invece di fare il loro mestiere, hanno piegato la loro scienza e la loro coscienza ad una logica allucinante.
Una pagina vergognosa. Nel mio libro «La politica con il cuore», che ho scritto nel 2009, avevo apertamente denunciato l’inganno e la superficialità dei quali si era resa colpevole la commissione. Nessuno, neanche il Comune dell’Aquila che si è costituito parte civile fin dal 2010, ha mai avuto intenzione di processare la scienza.
Piuttosto ci interessa accertare atti e responsabilità di quei componenti della commissione che a L’Aquila è venuta, non purtroppo per indagare il fenomeno che da mesi colpiva il territorio, bensì per obbedire al comando del capo della Protezione civile Bertolaso che in una intercettazione telefonica con l’assessore Stati affidava agli scienziati il solo scopo di fare esclusivamente «un’operazione mediatica» e «tranquillizzare la gente».
La comunità scientifica e quei politici che insorgono contro questa sentenza, nulla sanno degli atti processuali e non aspettano, come sarebbe giusto, di vedere le motivazioni della sentenza, ma più comodamente usano la metafora ideologica e davvero poco razionale del «processo alla scienza». Il ministro Clini con le sue affermazioni di difesa della commissione fa veramente rigirare nella tomba Galileo Galilei.
Mi sarei aspettata dalla comunità scientifica una presa di distanza dai comportamenti di quei «cosiddetti scienziati» che, invece di comportarsi da tali, hanno piuttosto assecondato il bisogno politico della rassicurazione, invece del bisogno scientifico dell’informazione. Quando un giudice condanna un medico che per negligenza o imperizia ha prodotto menomazioni o morte ad un paziente, è forse un processo alla medicina? O non è molto più semplicemente il processo a quel medico negligente e incapace? Quando si processa un politico che ruba e lo si condanna giustamente, non è semplicemente il processo a quel politico e alle sue ruberie e non un processo alla politica? I medici competenti e i politici onesti ringraziano i giudici che condannano incapaci e disonesti.
Questa coraggiosa sentenza rende un po’ di giustizia agli aquilani truffati prima e dopo il terremoto ed ingannati in maniera vergognosa. Il terremoto dell’Aquila non poteva essere previsto, ma a noi aquilani non è stato detto questo, è stato detto esattamente il contrario, ovvero che non era prevedibile in quel dato momento un terremoto grave e che lo sciame sismico era un fenomeno di scaricamento dell’energia, cioè un elemento positivo e tranquillizzante.
Come può allora una comunità scientifica preferire una difesa ad oltranza di chi è condannato, invece di difendere la scienza dall’oltraggio delle interferenze della brutta politica che in quella circostanza e forse anche in altre ha usato commissioni, comitati per fini che nulla c’entrano con l’informazione scientifica.
La commissione in occasione del terremoto dell’Emilia Romagna e del Pollino si è comportata molto diversamente, così come la Protezione Cilvile in più di un’occasione dopo il 6 aprile ha lanciato allarmi meteo, addirittura invitando la popolazione a non uscire di casa. Non mi sembra che quegli allarmi abbiano prodotto se non qualche disagio, gravi ripercussioni. A L’Aquila sarebbe bastato non negare l’evidenza. Mentre nella città ferita, dopo le rassicurazioni, si sono contati 309 morti e migliaia di feriti. Ma l’Aquila pur truffata ed ingannata non si arrende.
* l’Unità, 29.10.2012
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- Noi scienziati diciamo bravi ai giudici de L’Aquila. Lettera a Napolitano ("International Seismic Safety Organization")15 novembre 2012, di Federico La Sala
Lettera a Napolitano
Noi scienziati diciamo bravi ai giudici de L’Aquila
- I soci fondatori e sostenitori dell’International Seismic Safety Organization: Alessandro Martelli, Lalliana Mualchin, Benedetto De Vivo, Indrajit K. Ghosh, Allen W. Hatheway, Jens-Uwe Klügel, Vladimir G. Kossobokov, Ellis L. Krinitzsky, Efraim *
Egregio Signor Presidente,
siamo molto preoccupati per le fuorvianti informazioni diffuse da alcune organizzazioni scientifiche, da alcune riviste e da alcuni quotidiani sulla sentenza di condanna in primo grado dei membri della commissione Grandi Rischi, che si riunirono a L’Aquila il 31 marzo 2009. La disinformazione su tale argomento ha indotto la comunità scientifica e l’opinione pubblica a ritenere erroneamente che le motivazioni del rinvio a giudizio dei componenti della Cgr consistano nel-l’aver essi “fallito nel prevedere il terremoto”; questa interpretazione erronea può influenzare la comunità scientifica e l’opinione pubblica contro una sentenza pronunciata nel nome del popolo italiano. Una lettera firmata da oltre 5.000 esponenti della comunità scientifica internazionale era stata inviata alla Sua attenzione già prima del rinvio a giudizio, sulla base di questo falso assunto.
ABBIAMO osservato, con disappunto, che tale erronea posizione persiste anche ora che il processo al Tribunale de L’Aquila, lungo e doloroso, ha portato alla condanna in primo grado di tutti i componenti della Cgr. Ci sembra che coloro che hanno preso posizione contro la sentenza non abbiano capito, e forse neppure letto, le motivazioni dell’accusa. Noi, invece, siamo convinti che la sentenza abbia messo in luce delle precise responsabilità dei componenti della Cgr, che sono stati accusati non per non aver saputo prevedere il terremoto, bensì per aver voluto convalidare una previsione di “non rischio” in corso, nonostante alcuni di questi scienziati avessero precedentemente pubblicato articoli in cui sostenevano il contrario sulla situazione a L’Aquila. Inoltre, la mancanza d’indipendenza di giudizio della Cgr, che ha rilasciato dichiarazioni in linea con il Dipartimento della Protezione civile, dimostra che il rapporto tra il mondo della ricerca e le istituzioni preposte alla salvaguardia della popolazione deve essere rivisto.
IL PROCESSO è stato pubblico ed è accuratamente documentato nei registri giudiziari. La documentazione processuale, già disponibile, dimostra che non si è messa in discussione, né tantomeno attaccata, la scienza. Lo scopo del processo è stato solo di accertare la verità, per il trionfo della giustizia, non certo di intimidire la scienza. Questo procedimento giudiziario costituirà un riferimento, dal punto di vista giuridico internazionale. Interpretandolo come un attacco alla scienza e agli scienziati, i detrattori dei suoi esiti travisano la realtà dei fatti. Noi crediamo, al contrario, che tali esiti siano di estrema importanza per stimolare i ricercatori a “fare scienza” in modo responsabile e imparziale, in particolare quando si tratta di indagare fenomeni naturali non prevedibili con precisione e suscettibili di gravissime conseguenze quali sono i terremoti. Siamo convinti che tutte le persone dotate di buon senso concorderanno sul fatto che gli scienziati, inclusi i membri del Cgr, sono tenuti a rispondere delle loro azioni in modo responsabile - così come anche tutti gli altri professionisti - in materia di Protezione civile. È giusto che il rispetto e l’onore concessi loro dalla comunità siano da essi ricambiati con un’attività svolta con integrità, altruismo e onestà.
Non ci sentiamo per nulla minacciati nella nostra professionalità dalla sentenza di condanna del Giudice Marco Billi del Tribunale de L’Aquila. Essa non riguarda la scienza, non è una condanna alla scienza. Siamo fortemente in disaccordo con chi paventa che, a seguito della sentenza del Tribunale de L’Aquila, gli scienziati, in futuro, avranno paura di fornire la propria opera a supporto alla Protezione civile. Riteniamo che una tale infondata visione sia il risultato diretto dell’errata interpretazione delle motivazioni dell’accusa e della sentenza di condanna che le ha recepite. Pensiamo che la conclusione di questo tragico evento possa rappresentare l’inizio di un percorso più virtuoso, dal punto di vista sia scientifico che etico, per il futuro dell’Italia.
GLI SCIENZIATI saranno, in futuro, più che disposti a mettere al servizio della comunità la loro esperienza, usando maggiore precauzione sia nell’analisi del rischio sia nella comunicazione alla popolazione, soprattutto per la salvaguardia della sicurezza della popolazione, alla quale dovranno essere comunque sempre comunicati, con onestà, i limiti delle conoscenze scientifiche. Infine, sottolineiamo che, anche se i terremoti non sono prevedibili con precisione, la politica della Protezione civile può essere efficacemente indirizzata anche dai risultati dei più recenti studi sia nel settore della sismologia sia in quello dell’ingegneria sismica, che tengano in considerazione l’evento massimo atteso, che può essere stimato in modo “robusto”, sia nel breve che sul lungo termine.
* I soci fondatori e sostenitori dell’International Seismic Safety Organization: Alessandro Martelli, Lalliana Mualchin, Benedetto De Vivo, Indrajit K. Ghosh, Allen W. Hatheway, Jens-Uwe Klügel, Vladimir G. Kossobokov, Ellis L. Krinitzsky, Efraim Laor, Giuliano Panza, Mark R. Petersen, Francesco Stoppa, Augustin Udias, Patrick J. Barosh
* il Fatto, 15.11.2012
-
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- LA PROTEZIONE INCIVILE: TERREMOTO, SCIENZIATI, E POLITICI. Ebbene gli scienziati che sguarniscono le difese per comparaggio con i colleghi sono come i chirurghi che scioperano quando devono ricucire la ferita (di Francesco Merlo)27 ottobre 2012, di Federico La Sala
La protezione incivile
di Francesco Merlo (la Repubblica, 27.10.2012)
La spavalderia è la stessa che Bertolaso esibiva sulle macerie quando si vestiva da guerrigliero geologico, da capitano coraggioso, gloria e vanto del berlusconismo, con certificati ammiratori a sinistra. Ma i testi delle telefonate che, in rete su repubblica. it, ora tutti vedono e tutti giudicano, lo inchiodano al ruolo del mandante morale. Quel «nascondiamo la verità», quel «mi serve un’operazione mediatica», quel trattare gli scienziati, i massimi esperti italiani di terremoti, come fossero suoi famigli, «ho mandato i tecnici, non mi importa cosa dicono, l’importante è che tranquillizzino », e poi i verbali falsificati...: altro che processo a Galileo! E’ Bertolaso che ha reso serva la scienza italiana.
Più passano i giorni e più diventa chiara la natura della condanna dell’Aquila. Non è stato un processo alla scienza ma alla propaganda maligna e agli scienziati che ad essa si sono prestati. E innanzitutto perché dipendono dal governo. Sono infatti nominati dal presidente del Consiglio come i direttori del Tg1 e come gli asserviti comitati scientifici dell’Unione sovietica. In Italia la scienza si è addirittura piegata al sottopotere, al sottosegretario Bertolaso nientemeno, la scienza come parastato, come l’Atac, come la gestione dei cimiteri. Dunque è solo per compiacere Guido Bertolaso, anzi per obbedirgli, che quei sette servizievoli scienziati sono corsi all’Aquila e hanno improvvisato una riunione, fatta apposta per narcotizzare.
Chiunque ha vissuto un terremoto sa che la prima precauzione è uscire di casa. Il sisma infatti terremota anche le nostre certezze. E dunque la casa diventa un agguato, è una trappola, può trasformarsi in una tomba fatta di macerie. In piazza invece sopra la nostra testa c’è il cielo che ci protegge. Ebbene all’Aquila, su più di trecento morti, ventinove, secondo il processo, rimasero in casa perché tranquillizzati dagli scienziati di Bertolaso. E morirono buggerati non dalla scienza ma dalla menzogna politica, dalla bugia rassicurante.
Purtroppo il nostro codice penale non prevede il mandante di un omicidio colposo plurimo e Bertolaso non era imputato perché le telefonate più compromettenti sono venute fuori solo adesso. E però noi non siamo giudici e non dobbiamo attenerci al codice. Secondo buon senso Bertolaso è moralmente l’istigatore dei condannati, è lui che li ha costretti a sporcarsi con la menzogna.
Tanto più perché noi ora sappiamo che questi stessi scienziati avevano previsto l’arrivo di un’altra scossa mortale, nei limiti ovviamente in cui la scienza può prevedere le catastrofi. Ebbene, il dovere di Franco Barberi, Bernardo De Bernardinis, Enzo Boschi, Mauro Dolce, Giulio Selvaggi, Gian Michele Calvi, Claudio Eva era quello di dare l’allarme. Gli scienziati del sisma sono infatti le sentinelle nelle torri di avvistamento, sono addestrati a decifrare i movimenti sotterranei, sono come i pellerossa quando si accucciano sui binari. Nessuno si sogna di rimproverarli se non “sentono” arrivare il terremoto. Ma sono dei mascalzoni se, credendo di sentirlo, lo nascondono.
Il processo dell’Aquila dunque è stato parodiato. E quell’idea scema che i giudici dell’Aquila sono dei persecutori che si sono accaniti sulla scienza è stata usata addirittura dalla corporazione degli scienziati. Alcuni di loro, per solidarizzare con i colleghi, si sono dimessi, lasciando la Protezione Civile nel caos, proprio come Schettino ha lasciato la Concordia. Il terremoto in Italia è infatti una continua emergenza: giovedì notte ne abbiamo avuto uno in Calabria e ieri pomeriggio un altro più modesto a Siracusa.
Ebbene gli scienziati che sguarniscono le difese per comparaggio con i colleghi sono come i chirurghi che scioperano quando devono ricucire la ferita.
Ma diciamo la verità: è triste che gli scienziati italiani si comportino come i tassisti a Roma, forze d’urto, interessi organizzati, cecità davanti a una colpevolezza giudiziaria che può essere ovviamente rimessa in discussione, ma che non è però priva di senso, sicuramente non è robaccia intrusiva da inquisizione medievale. Insomma la sentenza di primo grado può essere riformata, ma non certo perché il giudice oscurantista ha condannato i limiti della scienza nel fare previsioni e persino nel dare spiegazioni.
E il giudice dell’Aquila è stato sobrio. E’ raro in Italia trovare un magistrato che non ceda alla rabbia, alla vanità, al protagonismo. Ha letto il dispositivo della sentenza, ha inflitto le condanne e se n’è andato a casa sua come dovrebbero fare tutti i magistrati, a Palermo come all’Aquila. Pochi sanno che si chiama Marco Billi. Non è neppure andato a Porta a Porta per difendersi dall’irresponsabile travisamento che ai commentatori frettolosi può essere forse perdonato, ma che è invece imperdonabile al ministro dell’Ambiente Corrado Clini, il quale ha tirato in ballo Galileo e ci ha tutti coperti di ridicolo facendo credere che in Italia condanniamo i sismologi perché non prevedono i terremoti, che mettiamo in galera la scienza, che continuiamo a bruciare Giordano Bruno e neghiamo che la Terra gira intorno al Sole.
Il ministro dell’Ambiente è lo stesso che appena eletto si mostrò subito inadeguato annunziando che l’Italia del referendum antinucleare doveva comunque tornare al nucleare. Poi pensammo che aveva dato il peggio di sé minimizzando i terribili guasti ambientali causati dall’Ilva di Taranto. Non lo avevamo ancora visto nell’opera brechtiana ridotta a battuta orecchiata, roba da conversazione al Rotary, da sciocchezzaio da caffè. E sono inadeguatezze praticate sempre con supponenza, a riprova che c’è differenza tra un tecnico e un burocrate. In Italia puoi scoprire che anche il direttore generale di un ministero non è un grand commis di Stato ma un impiegato di mezza manica.
So purtroppo che è inutile invitare personaggi e comparse di questa tragica farsa ad un atto di decenza intellettuale, a restituire l’onore alla ricerca, alla scienza e alla giustizia, e a risalire su quelle torri sguarnite della Protezione Civile senza mai più umiliarsi con la politica. A ciascuno di loro, tranne appunto al dimenticabile Bertolaso che intanto si è rintanato nel suo buco, bisognerebbe gridare come a Schettino: «Torni a bordo...».
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- MINIMA IMMORALIA (di Fulvio Papi).28 ottobre 2012, di Federico La Sala
MINIMA IMMORALIA
di Fulvio Papi *
Stresa. Ho passato una parte dell’estate in un luogo lacustre a me carissimo per pubbliche e segrete ragioni, un tempo luogo di vacanze anche per gli italiani (Gadda vi veniva a trovare la zia, vi passò Piovene), ma oggi soprattutto richiamo pieno di seduzioni per stranieri.
Ogni mattina mi recavo all’edicola della stazione e così, dopo aver ritirato il quotidiano d’abitudine, mi fermavo a dare un’occhiata ai giornali stranieri che, per lo meno nella mostra, subissavano le nostre prestigiose (?) testate.
Non voglio far credere a nessuno che potessi passare da una lingua all’altra come se tutte me le avesse insegnate mia madre (che del resto sapeva male anche l’italiano). Ma una cognizione a un foglio e poi ad un altro per riuscire a capire l’essenziale non era impossibile.
Erano i tempi in cui si preparava la cosiddetta manovra economica poi votata con la fiducia da parte dei parlamentari che, salvo le eccezioni che ci sono sempre, o usurpano quel titolo, o lo onorano parlando da assoluti incompetenti.
Ma allora erano i tempi della cosa da fare. E sui fogli stranieri l’impressione comune non era quella di un incontro-scontro di ipotesi che avessero uno sguardo al complicatissimo avvenire del nostro paese nell’Europa e nel mondo, ma piuttosto che si trattasse di una sfilata su un palcoscenico di varietà nel quale ogni attore aveva il problema di far sentire la sua voce, eco di sgangherati ma solidissimi interessi di qualche corporazione piena di soldi che, di fronte al possibile naufragio, si accaparrava più salvagente possibili per non essere toccata nei propri privilegi. Che cosa ne è venuto fuori lo capisce chiunque sappia leggere i documenti. Tuttavia la cosa più interessante è più personale.
La frequentazione quotidiana dell’edicola mi fece conoscere un professore tedesco che parlava anche un ottimo francese. Egli elogiava il luogo, le sue sponde, i suoi colori, i suoi boschi e soprattutto l’isola Bella.
Allora per un gusto antipatico e un poco maligno (che di solito non credo di avere) gli dissi che tutti i grandi elogi fatti dagli scrittori tedeschi all’isola Bella, Goethe compreso, non derivavano affatto da proprie visite (come fu invece quella di Stendhal) ma da una ripetizione di una guida di viaggio tedesca che andava per la maggiore nell’ultimo Settecento.
Non era sapere mio ma un apprendimento da un valentissimo filologo italiano che ne aveva scritto nel 1923. Il mio interlocutore rimase tra l’incredulo e il perplesso. In ogni modo mi restituì la malignità dicendomi, nella sua lingua ma lentamente e in modo comprensibile: «lo sa che il suo è un paese di merda?».
Avesse detto un paese cui spettava qualche altra qualità, avrei potuto anche non capire e fingere di aver capito. Ma la parola tedesca Scheisse apparteneva al mio antico sapere filosofico poiché appariva nella Ideologia tedesca di Marx-Engels laddove il testo affermava che se il proletariato non avesse colto l’occasione rivoluzionaria, tutto sarebbe tornato nella alte Scheisse (vecchia m....).
Poiché la mia informazione quotidiana non è buona, rimasi quasi un po’ offeso. Il mio paese è pieno di ladri, di parassiti, di ignoranti (che comandano), di imbroglioni, di evasori fiscali (ai quali riserverei pene ottocentesche), di servi nell’anima prima che altrove, ma è anche un paese di gente che fa una vita d’inferno per lavorare, di giovani che, senza nessuna garanzia, si adattano a lavori differenti e precari, di persone colte che leggono anche libri difficili, di forze dell’ordine che (tolte le inevitabili mele marce) sono un esempio di efficienza e di senso del dovere, di scienziati che i centri di ricerca stranieri desiderano rapirci, di madri che fanno tre lavori per farcela ecc. ecc.
Questa Italia la sprezzante Scheisse non la meritava proprio. Poi con un minimo di pazienza ci siamo spiegati, e soprattutto il professore mi ha messo sotto il naso un giornale tedesco. Allora tutto rientrava in una nota autobiografia.
Fulvio Papi
* Odissea, Novembre-Dicembre 2011, n. 2, p. 4
-
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- FACHINELLI E FREUD NELLA “NAVE” DI GALILEI.9 ottobre 2012, di Federico La Sala
 AL DI LA’ DELLE "ROBINSONATE" (MARX) E AL DI LA’ DELL’EDIPO (FREUD). INDICAZIONI PER UNA SECONDA RIVOLUZIONE COPERNICANA. I soggetti sono due, e tutto è da ripensare...
AL DI LA’ DELLE "ROBINSONATE" (MARX) E AL DI LA’ DELL’EDIPO (FREUD). INDICAZIONI PER UNA SECONDA RIVOLUZIONE COPERNICANA. I soggetti sono due, e tutto è da ripensare...
 FACHINELLI E FREUD NELLA “NAVE” DI GALILEI. “Su Freud”, un’ottima introduzione a “La mente estatica” ("Sulla spiaggia").
FACHINELLI E FREUD NELLA “NAVE” DI GALILEI. “Su Freud”, un’ottima introduzione a “La mente estatica” ("Sulla spiaggia").
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- Pensiamo a nostro rischio e pericolo. Ecco la grande lezione di Faust (di George Steiner)23 settembre 2012, di Federico La Sala
 La passione per il sapere secondo il celebre saggista
La passione per il sapere secondo il celebre saggista
 Da sempre l’uomo è abitato dalla sete di conoscenza un sentimento disinteressato e inspiegabile
Da sempre l’uomo è abitato dalla sete di conoscenza un sentimento disinteressato e inspiegabile Pensiamo a nostro rischio e pericolo. Ecco la grande lezione di Faust
Pensiamo a nostro rischio e pericolo. Ecco la grande lezione di Faust di George Steiner (la Repubblica, 23.09.2012)
di George Steiner (la Repubblica, 23.09.2012)Tre narrazioni, tre storie primordiali, non esauribili in un’interpretazione e innumerevoli nelle loro varianti, raccontano di un legame fatale tra conoscenza e castigo. Nell’Eden l’albero della conoscenza spinge il genere umano alla trasgressione, a esilio e infelicità persistenti. Prometeo è condannato a una tortura senza fine per aver rubato la scaltrezza teorica e pratica agli dei gelosi. L’intraprendente intelletto di Faust si spinge troppo in là e fa precipitare la sua anima nell’inferno. Un crimine inestirpabile è collegato alla determinante eccellenza dello spirito umano.
Una smisurata vendetta si è abbattuta su coloro che insegnavano «come l’uom s’etterna» (Dante). I cacciatori di verità diventano a loro volta oggetto di caccia, come se una contraddizione organica opponesse l’esercizio dell’intelletto al sentirsi a casa propria nella vita naturale.
Eppure l’impulso a il frutto proibito, a rubare e dominare il fuoco, a porre le domande essenziali come fa Faust, è inestinguibile. Anche se il prezzo è la sopravvivenza personale o l’ostracismo sociale.
D’altronde questa sete, questa libido sciendi e questo “gnosticismo” sono smisuratamente più potenti dei loro oggetti, di qualsiasi specifica intenzionalità. Si può trattare di sfide metafisiche, estetiche, scientifiche al loro più alto grado: ricercare “l’Uno”, la “chiave dell’universo” come fa Plotino o l’odierna accelerazione nucleare.
Ma l’oggetto può anche essere rappresentato da una minuzia che appassiona, la tassonomia di un milione di specie di insetti, lo studio degli utensili da cucina dei sumeri o della Cina arcaica. In questo disequilibrio, in questo estremo disinteresse c’è un mistero permanente.
Gran parte della ricerca può in effetti perseguire benefici reali o potenziali, il fuoco prometeico e le tecnologie che ne deriveranno. Quello che conta maggiormente però è la ricerca in quanto tale, le nuove idee, l’arricchirsi della comprensione e della sensibilità, per quanto astruse, per quanto inapplicabili esse siano. È l’ignoto a calamitare e l’uomo è l’animale che pone domande.
Le radici di questa trascendente fatalità restano nascoste. L’intensità, l’efficienza esplorativa e creativa di questo impulso variano profondamente a seconda degli individui e delle comunità, tra Atene e Gerusalemme da una parte e ampi settori di un mondo più pastorale e contemplativo dall’altra.
L’“in-quietudine” a cui Hegel ascrive gli sviluppi filosofici, scientifici, artistici, può non essere universale. Forse le germinali allegorie della caduta dell’uomo attraverso la conoscenza, della sua tragedia prometeica e del suo patto faustiano, sono essenzialmente europee.
Ma là dove prevale questa “brama di sapere”, questa capacità creativa che si oppone all’innocenza, il suo imperativo può essere irresistibile.
Freud, lui stesso un brillante esempio di tale dinamismo, ne sottovalutò la forza travolgente. Essere posseduti da una problematica di tipo intellettuale, pura o applicata, da un’assoluta bramosia per la forma estetica, da costellazioni resistenti all’indagine nelle scienze, è provare una libido, che può portare alla follia e ad atti criminosi, più pressante di quella sessuale. Quale impulso orgasmico ha una potenza pari a quella del desiderio che si concentra, nel corso impassibile di otto anni, a trovare la soluzione al teorema di Fermat? Anche la sopravvivenza arriva a contare di meno.
Uomini e donne sono andati al rogo in nome di convinzioni teologiche, etiche, scientifiche per quanto astruse esse fossero. Oggi vengono spesi miliardi in esperimenti che non si sa se siano in grado o meno di gettare un’ipotetica luce sulla “materia oscura” cosmica.
Al pari dell’eros, ma con maggior determinazione e con costi privati e pubblici superiori, questa instancabile indagine dell’essere e della sostanza, questo affondo per certi versi maniacale alla rincorsa dell’intelligibilità, non è negoziabile. La passione cerebrale e sensoriale disinteressata non trova maggiori spiegazioni dell’amore. Essa si riallaccia alla nostra accettazione e alla nostra negazione della morte in un modo che possiamo mitologizzare ma non comprendere totalmente. (...)
Gli storici della cultura hanno spesso identificato l’arroganza scientifica, tecnocratica dell’uomo occidentale, la sua convinzione che «la vita irriflessa non è degna di essere vissuta» (in fondo, perché?), con il problema di Faust. La bibliografia a disposizione è pressoché incommensurabile.
Per quel che attiene alle vere origini e alla diffusione esponenziale alla fine del XVI secolo della leggenda di Faust, molto resta ancora incerto. In questa ghirlanda letteraria si possono annoverare capolavori che vanno da Marlowe a Goethe, da Goethe a Thomas Mann, Pessoa e Bulgakov. Ma anche per quanto riguarda altri mezzi di comunicazione, la sua presenza non è da meno: spettacoli di marionette (sua fonte più probabile), opere liriche, balletti, raffigurazioni sinfoniche, film, fumetti. Esistono anche delle “Faustine”.
Le ballate tratte dal Faust sono diventate grande musica. Esistono moltissime incisioni - tra le più belle di Rembrandt - e quadri di qualità variabile. In quale lingua occidentale «faustiano» non è diventato un aggettivo? Le sue innervazioni occupano un posto centrale.
Poesia, arte, musica, teoria della storia (si veda Spengler) si incontrano qui con la filosofia, con l’atto di indagine filosofica. Il personaggio di Faust ha «diritto a tutte le reincarnazioni possibili», osserva Valéry. Quella di Faust e l’“Altro” - lo si consideri diabolico o si pensi a lui come a l’Autre della nostra coscienza divisa - è la storia che mette in scena meglio di qualsiasi altra le vanità e gli splendori illeciti della speculazione filosofica.
La favola non ha perso nella modernità secolarizzata molto del suo fascino. Uno dei primi nomi in codice per la ricerca sugli armamenti termonucleari fu “Faustus”; il primissimo gioco di scacchi computerizzato disponibile sul mercato si chiamava “Mephisto”. (...)
Più che la filosofia stessa, è il linguaggio della letteratura o, più precisamente, della filosofia diventata letteratura, come in Kierkegaard o in Nietzsche, che esprime l’estremismo patologico, la compulsiva vanagloria della vocazione e dell’impresa del filosofo. Nel tema faustiano è racchiusa questa intuizione. Facendo un passo più in là di Hegel, Pessoa definisce la speculazione metafisica niente altro che “angoscia infinita”.
La filosofia ha un suo martirologio. Le antiche biografie, che restano sempre da verificare, raccontano di filosofi trucidati nelle contese civiche, messi a morte da despoti invidiosi, assassinati da fanatici come nel caso di Ipazia. Anche a proposito della morte di Pitagora girava voce che fossero avvenute azioni violente. Un epigramma, un trattato di metafisica o di cosmologia, le considerazioni politiche di Spinoza, possono diventare l’atto più temuto dall’ortodossia e dall’assolutismo.
Quando si aggira per la città un’ideologia può diventare uno spettro minaccioso (l’immagine famosa di Marx). La tradizione avverte che Gerusalemme uccide i suoi profeti e Atene i suoi pensatori. Non c’è vocazione più pericolosa dell’esercizio della ragione, essa stessa critica costante, aperta o mascherata, alle norme vigenti.
Sulla scia mitica dell’Apologia e del Fedone, le ultime ore di Socrate hanno ispirato nei secoli la letteratura, le belle arti e anche la musica, come nel caso di Satie. Nella coscienza occidentale, quella di Socrate è l’altra morte significativa divenuta un’icona.
L’interazione epistemologica e simbolica con il Golgota è il punto cruciale per Hegel, nella sua enigmatica affermazione che «l’Ora è la notte». Nella pittura europea, una pletora di freddezza accademica o di vero kitsch precede la Mort de Socrate di Jacques-Louis David con la sua amara menzogna (la presenza di Platone).
Nella imitatio di questo momento canonico, il suicidio forzato di Seneca e la sua tranquilla accettazione della morte diventano emblematici per la morale occidentale e il culto dell’integrità stoica. Il libretto dell’Incoronazione di Poppea di Monteverdi è mediocre, ma la musica che accompagna l’addio di Seneca ha qualcosa di magico. (...)
I poeti del risorgimento che lottavano per l’emancipazione dell’Italia dal papato celebrano la morte al rogo di Giordano Bruno, teorizzatore di eretiche infinità. Onorano Campanella che subì la tortura a causa del suo naturalismo precorritore e della sua visione utopica. In tempi più recenti si sono avuti elogi funebri, poesie elegiache e amare in memoria del fenomenologo e storico delle idee Jan Patocka, vessato dalla polizia segreta ceca fino a morirne.
Quanti studiosi di filosofia, seguaci di Confucio e intellettuali dissidenti sono stati umiliati, incarcerati, condannati a morte durante il sanguinario regime di Mao? Perché potessimo intendere il prodigio del canto inestinguibile di Orfeo o la prova dell’immortalità dell’anima, pur consapevoli della proposizione di Wittgenstein per cui la morte non ha significato rispetto all’esperienza umana, il prezzo è stato comunque salato. Si pensa a proprio rischio e pericolo.
(Traduzione di Fiorenza Conte e Renato Benvenuto) © 2012, Garzanti Libri s.p.a. © 2011 (per gentile concessione di Luigi Bernabò Associates
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- USCIRE DAL CORTILE DI GENTILE: RIFARE I CONTI CON KANT.18 settembre 2012, di Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- Festival di Filosofia: se la finanza e il denaro fanno sparire le «cose». Chiusa ieri la kermesse modenese dedicata alle «cose» (di Bruno Gravagnuolo)17 settembre 2012, di Federico La Sala
 Festival di Filosofia: se la finanza e il denaro fanno sparire le «cose»
Festival di Filosofia: se la finanza e il denaro fanno sparire le «cose»
 Chiusa ieri la kermesse modenese dedicata alle «cose», nullificate inflazionate o divenute immagini
Chiusa ieri la kermesse modenese dedicata alle «cose», nullificate inflazionate o divenute immagini di Bruno Gravagnuolo (l’Unità, 17.09.2012)
di Bruno Gravagnuolo (l’Unità, 17.09.2012)TANTO PER COMINCIARE ALL’INIZIO LE COSE NONESISTEVANO. Lo dice anche il Vangelo giovanneo: In principio era il Verbo. E quanto al Genesi le «cose» vengono create ex nihilo con un «sia fatto», mentre ad Adamo vien dato il potere poetante di nominarle, animali inclusi. Ma sapete qual è la novita? Che le cose oggi non esistono più, ridotte come sono a flussi immaginali, campi energetici o a catena di rifiuti non riciclabili, natura inclusa. È questa la percezione che ha animato il festival della filosofia di Modena, Carpi, Sassuolo, apertosi sabato e chiusosi ieri (200 incontri e 40 luoghi diversi) con contributi di Bodei, Baumann, Searle, Latour (da noi anticipato), Latouche, Sloterdijk, Cacciari, Severino e gli implacabili «menù filosofici» di Tullio Gregory.
Percezione del senso di sparizione e vuoto che assalgono gli «enti» e le cose. Non solo perché è l’epoca dei simulacri e della distruzione delle risorse non reintegrabili ma anche perché in fondo a ispirare la kermesse modenese è stato un libro di Remo Bodei, presidente del comitato scientifico, di tre anni fa: La vita della cose (Laterza, pp. 135, Euro 149). Tesi: occorre «decosificare» le cose per riscoprire la vitalità relazionale e l’energia umana in esse. Tramite l’arte e una rinnovata percezione d’esperienza emotiva, che ne faccia cosa e cose pubbliche. Stimolo «umanista» quello di Bodei, che non esaurisce la questione, di cui il libro fu un assaggio, a cominciare da un ermeneutica storica del problema.
E allora ecco un po’ di storia semantica. Intanto la «cosa» come noi la intendiamo merce, utensile, bene proprietario è relativamente moderna. Trapela in Cartesio come res cogitans e res extensa, soggetto e oggetto, e ha qualche antecedente negli scettici antichi, che reputavano gli enti singoli impenetrabili al conoscere (quasi come Kant).
All’inizio si trattava di «enti», del «to-de-ti», il qualcosa, il questo o quello. Oppure in ballo c’era il «to auto pragma», la «cosa stessa», intesa come processo intellettivo che definiva una singolarità, dentro l’universalità della mente e delle «categorie». La res latina poi conserva l’etimo greco di «rein», «parlare» in pubblico. Mentre la Ding germanica viene forse da denken, pensare, deliberare. Insomma, le cose erano fatti relazionali, linguistici. O anche copie e ombre dileguanti di un Eterno, fatto di molteplici essenze. Oppure ancora «feticci»: trasfigurazioni dell’umano in divino e viceversa. Mistero trasparente se si vuole, e non «cosalità» (la «cosa schiavo» come strumento vocale aveva la sacertà naturale di un animale).
Tutto cambia con l’avvento dell’«objectum», e della «cosa» quale «causa» (come da etimo: effetto materiale misurabile). Significa l’oggetto impenetrabile, straniato. Opposto al soggetto. E poi significa il mondo come «immensa raccolta di merci» e utensili interscambiabili: previa esibizione di titolo di credito monetario. Per Marx è il trionfo del valore di scambio e la spettralità delle «forme» allusive e cangianti. E però, è anche accumulo inerte del valore d’uso: arte, collezionismo, musei, estetica del quotidiano, design. La cosa dunque non più «ente» è minacciata da sé stessa: figurazione del valore e del denaro che dilegua, e svilimento e accumulo di valore già usato.
Non basta. La fisica moderna ci mette del suo: le cose come campi di energia, cristalli di particelle sfuggenti. E la rivoluzione linguistica da Saussure a Wittgenstein definirà le cose come puri campi semantici. Infine, con la rivoluzione digitale, accade qualcosa di impensato. E l’entropia «auto-nientificante» delle cose conosce un’ulteriore accelerazione: non contano le cose che si hanno. Ma le «funzioni» alle quali si è in grado di accedere, i «dispositivi» di cui si dispone, per ordinare on demand beni e servizi (rimpiazzabili).
Sparisce il dominio dell’uomo sull’uomo? No. Sta tutto concentrato in due «cose» ben precise: finanza e tecno-informazione (algoritmi, brevetti, motori di ricerca, new media, know-how per manovrare flussi globali ed assemblare). Certo la pioggia e il degrado delle cose consumate perdura. Ma ancor più che al tempo di Marx, le relazioni umane appaiono stregate, da «cose-figure» che appaiono e scompaiono. E che ci guardano e trapassano. Perciò masse arabe imponenti si fanno stregare da atavici «significanti» religiosi: per annichilare «cose blasfeme» che sfuggono e travolgono destini. Morale: riprendiamoci pure la «vita delle cose», come dice Bodei. Purché siano «cose-relazioni»: cioè conoscenza, natura, comunità, immaginazione, cura e desiderio. Ma per questo ci vorrebbe un’altra economia e un’altro nomos, per un altra terra e altre cose, mai viste.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- Il pensiero d’Italia in 80 medaglioni (di Arturo Colombo)14 settembre 2012, di Federico La Sala
Corriere 14.9.12 Michele Ciliberto è il direttore scientifico Il pensiero d’Italia in 80 medaglioni di Arturo Colombo
Come titolo, Il contributo italiano alla storia del pensiero, è molto impegnativo; spicca sul frontespizio di un volume (oltre 800 pagine, più illustrazioni) pubblicato dall’Istituto dell’Enciclopedia Treccani. Giuliano Amato nella presentazione spiega che intende offrire «uno sguardo lungo sulla relazione della cultura e della scienza fiorite in Italia, sguardo lungo che muove da un punto di partenza fissato in un’Europa che era ancora una, latina e cristiana, ma in eccezionale, per quanto non di rado aspro e turbolento, confronto con ebraismo e islam, e con l’Oriente greco».
Michele Ciliberto è il direttore scientifico di questa iniziativa meritoria dedicata alla filosofia (seguiranno altri cinque volumi su altrettanti settori specifici), e non esita a spiegare che «è la vocazione "civile" il tratto specifico dell’Italia, sul piano filosofico». Anzi, precisa che «il nesso tra filosofia, storiografia e politica è un tratto strutturale della tradizione italiana», portando esempi assai significativi, poi ripresi e approfonditi attraverso «medaglioni» affidati a specialisti: ecco Machiavelli, su cui si sofferma Giulio Ferroni, ecco Giordano Bruno, che ambisce farsi «capitano di popoli» (secondo lo stesso Ciliberto), ecco Botero, riproposto da Robertino Ghiringhelli...
Tentare, attraverso un articolo giornalistico, di offrire una sintesi della vasta panoramica di questo libro a più voci, non è difficile; è semplicemente impossibile, appena si prende atto che sono più di un’ottantina i personaggi, che animano queste pagine, partendo dal «medioevo plurale» (l’immagine è ancora di Ciliberto), dove accanto a Tommaso d’Aquino e a Marsilio da Padova, spicca, soprattutto per il suo progetto di utopia sociale, Dante, ben delineato da Cesare Vasoli, che attraverso l’opera «Monarchia» auspicava l’affermarsi di un’autorità sovrana «unica e universale» in grado di unificare il mondo «nel riposo e nella tranquillità della pace».
I collaboratori, coinvolti nel riproporre le figure leader, riescono così a comporre un simbolico mosaico in grado di coprire addirittura un millennio di storia - anzi, «di storia del pensiero italiano» - anche soffermandosi su personaggi che, almeno a prima vista, sembrerebbero meglio qualificati in altri spazi: penso a Leonardo da Vinci e all’importanza della sua «opera intellettuale testimoniata esclusivamente dai suoi manoscritti», su cui si soffermano Fabio Frosini e Carlo Vecce; oppure a Galileo, che Mariano Giaquinta descrive non solo come scienziato ma altresì per i suoi contributi in filosofia della natura.
Naturalmente, in base agli interessi e alle curiosità di ciascuno, ci soffermeremo su periodi diversi, scegliendo il contributo di singole personalità. Così il XX secolo, che tanti, troppi pretendono di esaurire sbrigativamente con la «dittatura del neoidealismo» (un «mito storiografico senza fondamento», taglia corto Ciliberto), non esclude certo l’opera di Croce e di Gentile, su cui intervengono Michele Maggi e Biagio De Giovanni. Ma lascia emergere, attraverso appositi profili, scienziati come Federico Enriques, o sociologi e politologi come Vilfredo Pareto e Gaetano Mosca (che è stato anche una firma del nostro «Corriere»), oppure delinea il ruolo «fra divulgazione filosofica e giornalismo culturale» di Giuseppe Prezzolini (ben descritto da Emma Giammattei).
Né basta. Perché l’ultima parte - dalla seconda metà del ’900 a oggi - riserva, oltre a specifici approfondimenti (è il caso del marxismo), non poche sorprese, che chiamano in causa il neoilluminismo italiano (di cui scrive Massimo Mori), le «filosofie cristiane» (affidate a Michele Lenoci) e perfino il «pensiero debole» (preso in esame da Costantino Esposito). Insomma, un’ottima bussola di orientamento, da tenere a portata di mano.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- IL SOGNO DI UNA "COSA" DI BENEDETTO XVI: UNA CHIESA "PER MOLTI", NON "PER TUTTI".13 settembre 2012, di Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- SULLE "COSE" DELL’ALTRO MONDO. LA LEZIONE MAGISTRALE DI KANT. L’antitetica dell ragion pura e il suo metodo.11 settembre 2012, di Federico La Sala
ANTITETICA DELLA RAGION PURAdi Immanuel Kant *
Se Tetica è ogni insieme di dottrine dommatiche, io intendo per Antitetica, non affermazioni dommatiche del contrario, ma il conflitto di conoscenze secondo l’apparenza dommatiche (thesin cum antithesi), senza che si annetta all’una piuttosto che all’altra uno speciale diritto all’assenso.
L’Antitetica, dunque, non si occupa punto di affermazioni unilaterali, ma prende a considerare le conoscenze universali della ragione solo pel conflitto di esse tra loro e per le cause di tal conflitto. L’Antitetica trascendentale è una ricerca intorno all’antinomia della ragion pura, le sue cause e il suo risultato.
Quando noi rivolgiamo la nostra ragione non semplicemente, per l’uso dei princìpi dell’intelletto, agli oggetti dell’esperienza, ma ci avventuriamo ad estenderla al di là dei limiti di questa, allora vengon fuori proposizioni sofistiche, che dalla esperienza non possono né sperare conferma, né temere confutazione; ciascuna delle quali non soltanto è in se stessa senza contraddizione, ma trova perfino nella natura della ragione le condizioni della sua necessità; solo che, disgraziatamente, il contrario ha dalla parte sua ragioni altrettanto valide e necessarie di affermazione.
Le questioni che si presentano naturalmente in una tale dialettica della ragion pura, son dunque: 1) In quali proposizioni propria mente la ragion pura è soggetta inevitabilmente a una antinomia. 2) Su quali cause si fonda questa antinomia. 3) Se nondimeno, e in qual modo, alla ragione, in questo conflitto, resti aperta una via alla certezza.
Un teorema dialettico della ragion pura deve, dunque, avere in sé questo, che lo distingua da tutte le proposizioni sofistiche: che non concerna una questione arbitraria, che non si solleva se non per un certo scopo voluto, ma sia una questione siffatta, che ogni ragione umana nel suo cammino vi si deve necessariamente imbattere; e in secondo luogo, che così essa come la contraria porti seco non soltanto un’apparenza artificiosa, che, se uno l’esamini, dilegua tosto, ma un’apparenza naturale e inevitabile, che, quando anche uno non ne sia più ingannato, illude pur sempre, sebbene non riesca più a gabbare; e però può bensì esser resa innocua, ma non può giammai venire estirpata.
Una tale dottrina dialettica non si riferirà all’unità intellettuale di concetti d’esperienza, ma all’unità razionale di semplici idee, le cui condizioni - poiché primieramente, come sintesi secondo regole, essa deve accordarsi con l’intelletto, e pure, insieme, come unità assoluta di essa, con la ragione, - se essa è adeguata all’unità della ragione, saranno troppo grandi per l’intelletto, e se proporzionata all’intelletto, troppo piccole per la ragione; dal che deve sorgere un conflitto, che non si può evitare, donde che si prendano le mosse.
Queste affermazioni sofistiche aprono dunque una lizza dialettica, dove ogni parte cui sia permesso di dar l’assalto ha il disopra, e soggiace di sicuro quella che è costretta a tenersi sulla difensiva. Quindi anche i cavalieri gagliardi, s’impegnino essi per la buona o per la cattiva causa, sono sicuri di riportare la corona della vittoria, se badano solo ad avere il privilegio di dar l’ultimo assalto senza essere più obbligati a sostenere un nuovo attacco dell’avversario.
Si può facilmente immaginare, che questo arringo pel passato è stato abbastanza spesso corso, che molte vittorie sono state guadagnate da ambo le parti; ma per l’ultima, che decide la cosa, si è sempre badato che il difensore della buona causa tenesse solo il terreno, e così fosse impedito all’avversario di impugnare più oltre le armi. Come giudici di campo imparziali, dobbiamo mettere affatto da parte, se sia la buona o la cattiva causa quella che i combattenti sostengono, e lasciar che essi se la sbrighino prima tra loro. Forse, dopo essersi l’un l’altro più stancati che danneggiati, essi scorgeranno da se stessi la vanità della loro lotta e si separeranno da buoni amici.
Questo metodo di assistere a un conflitto di affermazioni, o piuttosto di provocarlo da sé, non per decidere alla fine in favore dell’una o dell’altra parte, ma per ricercare se l’oggetto di esso non sia forse una semplice illusione, che ciascuno vanamente s’affanna ad acchiappare, e in cui ei non può nulla guadagnare, quand’anche non gli si resistesse punto: questo metodo, dico, si può chiamare metodo scettico.
Esso è da distinguere del tutto dallo scetticismo, principio di una inscienza secondo arte e scienza1, che spianta le fondamenta d’ogni cognizione, per non lasciarle, possibilmente, in nessuna parte alcuna certezza e sicurezza. Giacché il metodo scettico mira alla certezza, in quanto cerca di scoprire in un tale combattimento, onestamente inteso da ambo le parti e condotto con intelligenza, il punto dell’equivoco, per fare come i saggi legislatori, che dall’imbarazzo dei giudici nell’amministrazione della giustizia ricavano per sé un ammaestramento intorno a ciò che di manchevole e non abbastanza determinato è nelle loro leggi. L’antinomia, che si rivela nell’applicazione delle leggi, è per la nostra limitata sapienza la maggior prova d’esame della nomotetica, per rendere così attenta la ragione, che nella speculazione astratta non s’accorge facilmente dei suoi passi falsi, ai momenti della determinazione dei suoi princìpi.
Ma codesto metodo scettico è essenzialmente proprio solo della filosofia trascendentale; e in ogni modo, può farsene a meno in ogni altro campo di ricerche, solo in questo no.
Nella matematica il suo uso sarebbe assurdo: poiché in essa non può restar nascosta e sfuggire all’occhio nessuna falsa affermazione, in quanto le dimostrazioni vi debbono sempre procedere al filo dell’intuizione pura, e mediante una sintesi sempre evidente.
Nella filosofia sperimentale può bene un dubbio sospensivo esser utile; se non che, nessun malinteso, almeno, è possibile, il quale non si possa facilmente tòr via, e ad ogni modo nell’esperienza devono in definitiva trovarsi gli ultimi mezzi della decisione del dissidio, presto o tardi che essi abbiano a rintracciarsi. La morale può dare tutti i suoi princìpi anche in concreto e insieme le conseguenze pratiche, almeno in esperienze possibili, e così evitare il malinteso dell’astrazione.
Per contro, le affermazioni trascendentali, che si arrogano vedute che si estendono al di là del campo d’ogni possibile esperienza, né si trovano nel caso che la loro sintesi astratta possa esser data in qualche intuizione a priori, né son tali che il malinteso possa esser scoperto mercé una qualche esperienza. La ragione trascendentale non ci permette dunque altra pietra di paragone che il tentativo d’un accordo delle sue affermazioni tra loro stesse, e quindi, prima, di una gara di combattimento tra loro, libera e senza ostacoli; e a questa gara al presente noi vogliamo dar corso.
*Immanuel Kant, Critica della Ragion Pura, Editori Laterza Bari 1966, vol. II, pp. 350-353.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- SONNAMBULISMO DOGMATICO, ATEO E DEVOTO.11 settembre 2012, di Federico La Sala
-
-
> 12° - FESTIVAL DI FILOSOFIA - C’e’ cosa e cosa. Un occhio diverso sulla realtà. «Nell’Emilia del terremoto ricostruiamo dal pensiero» (di Marcello Parilli). Siamo noi a decidere l’inventario del mondo (di John R. Searle).«La Cina non è solo pragmatismo. L’Occidente ignora i suoi pensatori» (di Anne Cheng)11 settembre 2012, di Federico La Sala
Il Festival di filosofia /1
C’è cosa e cosa
Un occhio diverso sulla realtà
«Nell’Emilia del terremoto ricostruiamo dal pensiero»
di Marcello Parilli (Corriere della Sera, 11.09.2012)
In questa fetta di Emilia, colpita al cuore dal terremoto, fa quasi strano tornare a occuparsi di filosofia. Che non vuol dire scrollarsi di dosso la polvere dei calcinacci per dissertare di aria fritta, ma sentire la necessità e l’importanza di una ricostruzione interiore oltre a quella che rimette un mattone sopra l’altro. Sarà per questo che la dodicesima edizione del festivalfilosofia, in programma tra Modena, Carpi e Sassuolo dal 14 al 16 settembre, è dedicata alle «cose», quasi a evocare un legame invisibile tra il «dire» e il «fare».
«Il tema era stato scelto l’anno scorso, in tempi non sospetti - dice Michelina Borsari, direttrice di festivalfilosofia dalla prima edizione -, ma certamente il terremoto ha cambiato tutto, e non solo in negativo. Perché questo si è trasformato nel festival della rinascita, un segnale di speranza per una ricostruzione civile, collettiva e condivisa che non salvi soltanto gli edifici, ma soprattutto la socialità: le iniziative di solidarietà si sono moltiplicate, diversi ospiti parteciperanno gratuitamente e gli stessi dibattiti verranno "sincronizzati" sull’attualità: si discuterà di cosa significhi aver perso la casa ma anche dei modelli in base ai quali case e fabbriche dovranno essere ricostruite. Un’energia che ha coinvolto anche le amministrazioni, che hanno fatto il possibile per riconsegnare al festival piazze ed edifici agibili».
In questi undici anni il festival ha richiamato 1 milione 227 mila visitatori e organizzato quasi 1.800 eventi. Risultati sorprendenti per una materia così ostica. «La nostra sfida? Far uscire la filosofia da un cenacolo per pochi iniziati, rendere fruibile una materia rigorosa e complessa senza banalizzarla - dice Borsari -. Così abbiamo scelto la formula della lezione magistrale: a ogni relatore abbiamo affidato 50 minuti per sviluppare un argomento e 30 di dialogo diretto con il pubblico, con la richiesta di utilizzare un linguaggio chiaro e diretto, senza severità né ascetismi».
A guidare le oltre 50 lezioni magistrali che si terranno in piazze, chiese e cortili di Modena, Carpi e Sassuolo ci saranno, tra gli altri, Remo Bodei, Enzo Bianchi, Emanuele Severino e Massimo Cacciari, Andrei Linde e Antonio Masiero, Zygmunt Bauman, Michela Marzano, Carlo Sini, Richard Sennet e Giorgetto Giugiaro, Serge Latouche, Umberto Galimberti, Silvia Vegetti Finzi e Anne Cheng, fino a lectio sui generis come quella linguisticamente pirotecnica di Alessandro Bergonzoni o la tragicommedia «climatica e globale» scritta da Bruno Latour.
Le lezioni magistrali sono però solo il cuore di un’edizione 2012 che si preannuncia ricchissima di eventi (quasi 200, tutti gratuiti) che intendono esercitare una sorta di pedagogia pubblica attraverso la filosofia, codici diversissimi che vanno a costruire quell’intelaiatura di proposte «alte» e «basse» tra le quali ogni visitatore potrà costruire un personalissimo percorso: mostre (una trentina, tra cui Edward Weston, Lucio Riva e Antonio Porta), concerti e spettacoli (Fabio Volo, Giobbe Covatta, Francesco Guccini, Danilo Rea, ma anche le performance teatrali di Stefano Benni e Massimiliano Finazzer Flory o le gag dei Soliti Idioti), letture, giochi per bambini e le cene filosofiche curate da Tullio Gregory in oltre sessanta ristoranti delle tre città.
Una formula che appare funzionale ai tempi che stiamo vivendo: «Ci interessava rimettere la parola filosofica, quella razionale, non profetica, al centro di una scena pubblica caratterizzata dal disorientamento e dalla scarsa qualità della comunicazione - aggiunge Borsari -. Per questo abbiamo voluto creare ponti, passerelle che trasmettessero al nostro pubblico il sapere prezioso della filosofia mostrandone l’importanza per il tempo presente. Un’opera comune ai vari festival italiani, peraltro molto imitati all’estero, ai quali va riconosciuto il rinnovamento dell’offerta culturale nel nostro Paese. Non so se i festival siano la soluzione, ma certamente sono una risposta antropologica importante e di successo».
Un successo che si basa su un’ esigenza reale del pubblico: «Secondo l’università di Ferrara, il 40% dei nostri visitatori ha il diploma di terza media. Magari non comprendono tutto - conclude Michelina Borsari -, ma certamente hanno capito che la comprensione del tempo presente passa attraverso l’impegno diretto e quotidiano del soggetto. E il piccolo boom dell’editoria filosofica degli ultimi anni ne è una conferma».
Il Festival di filosofia /2
cos’è un oggetto? Dalla Lectio del noto filosofo docente a BerkeleySedie, sassi, molecole
Siamo noi a decidere l’inventario del mondo
di John R. Searle (Corriere della Sera, 11.09.2012)
Gli oggetti aleggiano dappertutto nella nostra cultura filosofica e scientifica. Fin da quando Aristotele ha discusso le sostanze primarie - sostanze che non sono predicabili - gli oggetti hanno svolto la funzione di elementi basilari della nostra metafisica. Come noto, Wittgenstein mosse un’obiezione al primato degli oggetti dicendo che il mondo non consisteva di oggetti, bensì di fatti, e che in verità si dovrebbe pensare agli oggetti come costituenti dei fatti.
Non cercherò di risolvere i dibattiti tra le varie concezioni del primato degli oggetti. Ritengo che entrambe le teorie che ho appena citato - quella di Aristotele e quella di Wittgenstein - siano confuse (Aristotele confonde la proprietà semantica della predicabilità con la proprietà ontologica del modo di esistenza: Wittgenstein presenta un contrasto tra fatti e oggetti che è falso, perché, naturalmente, l’esistenza di qualunque oggetto è un fatto). Tuttavia dirò qualcosa riguardo a ciò che sono gli oggetti in generale prima di procedere con il tema degli oggetti sociali.
Si ha la tentazione di pensare al mondo come se esso contenesse un inventario di oggetti: sedie, tavoli, montagne e molecole. Vi sono dibattiti sulla questione se numeri e altre specie di universali debbano avere valore di oggetti o meno. Tuttavia, ad ogni modo, la maggior parte dei filosofi concordano che ci sia un inventario di oggetti precedente al cominciamento della ricerca filosofica. Ritengo che questo sia un errore. Cosa abbia valore di oggetto è relativo al nostro apparato concettuale.
Così, per esempio, per me la parte d’albero che emerge dal terreno vale come l’intero albero; ma naturalmente, da un punto di vista biologico, le radici fanno parte dell’albero tanto quanto il tronco. Come scegliere di dividere il mondo e cosa decidere di far valere come un oggetto o due oggetti dipende da noi. Gli oggetti possono sussistere in parti separate: così, per esempio, un mazzo di carte può essere disperso in cinquantadue città diverse e tuttavia rimanere lo stesso singolo oggetto, lo stesso singolo mazzo di carte.
Può il mondo dividersi nel modo in cui noi scegliamo di dividerlo? Esso ci arriva indiviso, e dato il nostro apparato concettuale noi lo dividiamo in un modo o in un altro. Tuttavia, se per caso si pensasse che ci sia qualcosa di inevitabile nel nostro modo di dividerlo, si immagini che noi possediamo una specie di apparato sensoriale, ma che ciascuno di noi abbia le dimensioni di una galassia o quelle di un elettrone. Penso che si converrà che il tipo di cose che ora ci interessano in quanto oggetti - alberi, sedie, tavoli, montagne e case - non susciterebbero l’interesse né di galassie, né di elettroni coscienti.
La concezione che ho appena presentato viene talvolta definita «relativismo concettuale». Essa asserisce che la selezione dei concetti che usiamo per descrivere il mondo è relativa ai nostri interessi, relativa a noi. Ritengo che il relativismo concettuale sia assolutamente valido. Tuttavia esiste un tipo di relativismo metafisico che si suppone sia una conseguenza del relativismo concettuale: e quello è terribilmente sbagliato. Il relativismo metafisico asserisce che non solo i nostri concetti sono relativi a noi, ma che anche la realtà stessa è relativa a noi. Questo è un errore. Ecco perché.
Si ottiene di scegliere dei concetti, ma una volta che si è fatta la scelta di concetti, una volta che si sono poste le condizioni di verità per i propri predicati, non dipende più da noi, ma dalla realtà, se qualcosa sia una montagna, una molecola, un albero o meno. La selezione della parola «albero» per enunciare un determinato concetto e le condizioni di verità per l’applicazione di tale concetto dipendono in effetti da noi ma, una volta che si è compiuta tale selezione, non dipende più da noi se gli oggetti nel giardino davanti casa sono alberi. Che ci siano alberi è un fatto oggettivo indipendente dalla mente, anche se la selezione della parola «albero» e il concetto ad essa associato sono materia di scelta umana e di interessi umani.
Questo è un punto assolutamente essenziale e voglio che venga inculcato bene in testa. Il relativismo concettuale non implica il relativismo metafisico. Non implica alcuna relatività riguardo alla realtà, né alcuna relatività riguardo alla verità. Esso unicamente asserisce: come scegliere di dividere il mondo con i propri concetti dipende da noi ma, una volta che si è fatta tale scelta, dipende dal mondo se questo o quel fenomeno nel mondo soddisfano le condizioni date oppure no. Dipende da noi quali elementi del flusso dell’esperienza decidiamo di trattare come se ci presentassero degli oggetti.
Tuttavia gli oggetti, per quanto costruiti, hanno determinate caratteristiche formali in comune. Le due più importanti sono individuazione e identità. Al fine di trattare qualcosa come un oggetto, dobbiamo trattarlo come distinto da altri fenomeni. Dobbiamo essere in grado di individuarlo. Così, per esempio, se ho il concetto di un albero, devo sapere perché qualcosa è un albero e non, ad esempio, una pietra. E anche perché è un albero e non due alberi. Un’ulteriore caratteristica oltre all’individuazione è l’identità. È necessario che io sia in grado di fare valere qualcosa come il medesimo oggetto in occasioni diverse. Pertanto, non solo questo oggetto di fronte a me è un albero, ma è lo stesso albero rispetto all’albero che ho visto in precedenza.
Il Festival di filosofia /3
Anne Cheng del Collège de France
«La Cina non è solo pragmatismo. L’Occidente ignora i suoi pensatori»
di Marco Del Corona (Corriere della Sera, 11.09.2012)
«Sono nata da genitori cinesi anche se ho ricevuto un’ educazione e una formazione intellettuale francesi. Avrei dunque potuto scegliere di focalizzarmi verso interessi europei, ed è quel che ho cominciato a fare, occupandomi di filosofia inglese. Ma per ragioni legate alla mia storia familiare e personale ho deciso di virare verso la cultura dei miei antenati, e più nello specifico verso la storia delle idee». Anne Cheng è, si può dire, figlia d’arte: suo padre è l’accademico di Francia François Cheng. Ha la cattedra di «Storia intellettuale della Cina» e, come spiega in quest’intervista al Corriere, non si definisce solo come una sinologa. Il suo mestiere, piuttosto, è tendere ponti. Autrice di «Storia del pensiero cinese» (Einaudi), a chi le chiede come voglia descriversi, risponde che «a differenza dei miei colleghi sinologi, la Cina per me non è soltanto un oggetto di studio. È’, prima di tutto, un’esperienza personale di pensiero e di vita che mi sforzo di far passare attraverso le mie attività di didatta, attualmente al Collège de France a Parigi».
 Le sue lezioni al Collège possono essere rintracciate e scaricate in tre lingue (francese, inglese e mandarino) sul sito www.college-de-france.fr/site/anne-cheng/.
Le sue lezioni al Collège possono essere rintracciate e scaricate in tre lingue (francese, inglese e mandarino) sul sito www.college-de-france.fr/site/anne-cheng/.Le semplificazioni non descrivono la realtà ma, in un certo senso, si potrebbe dire che siano parzialmente vere. Noi occidentali spesso descriviamo i cinesi come «pragmatici» o «pratici», e una frequentazione della Cina e dei Paesi di cultura cinese rischia di corroborare una percezione così. Cosa c’è di vero in questo stereotipo?
«I pregiudizi riducono necessariamente la complessità delle cose e una mezza verità non è una verità. Bisogna sempre ricollocare le cose entro una prospettiva storica e ricordarsi che le rappresentazioni occidentali della Cina sono cambiate spesso, dall’Europa illuminista del Settecento, dove regnava una "sinomania", seguita da un Ottocento "sinofobo", con un ritorno alla sinomania nel Novecento, in epoca maoista. Da che la Cina ha imboccato la via del capitalismo, passa per "pragmatica", ma lo è davvero più dell’America o dell’Europa?».
La Cina contemporanea è stata per decenni influenzata dall’opera e dalle elaborazioni di un pensatore occidentale: Karl Marx. Ma dopo di lui, quali filosofi occidentali hanno conquistato uno spazio autentico e significativo di attenzione e dibattito nell’accademia della Repubblica Popolare?
«Il pensiero di Marx, o piuttosto una certa forma di marxismo, ha esercitato in effetti una grande influenza nella Cina moderna, e persino un monopolio esclusivo nella Cina divenuta comunista nel 1949. Comunque, sono una trentina d’anni che i dibattiti intellettuali, molto vivaci nella sfera pubblica (al contrario di quello che pensa l’Occidente), si sono ampiamente aperti ad altre fonti d’ispirazione, comprese quelle più sorprendenti, come la tradizione liberale angloamericana o addirittura i pensatori neoconservatori come Carl Schmitt».
Fuori dalle facoltà di lingue e culture orientali e dai corsi di studi prettamente sinologici, la filosofia cinese continua a essere poco o pochissimo studiata nelle università dell’Occidente...
«È vero, mentre le élite cinesi sono perfettamente a conoscenza di tutti gli aspetti delle tradizioni filosofiche occidentali, le élite occidentali sono spessissimo totalmente ignoranti sulla Cina in generale e più ancora sulla sua tradizione intellettuale. E questa è un’asimmetria scandalosa».
-
> FESTIVAL DI FILOSOFIA - È «cose» il tema dell’edizione 2012. Il sogno di definire cos’è la «cosa»: opera, mezzo, idolo o strumento (di Pierluigi Panza)13 settembre 2012, di Federico La Sala
Il sogno di definire cos’è la «cosa»: opera, mezzo, idolo o strumento
di Pierluigi Panza (Corriere della Sera, 13.09.2012)
È «cose» il tema dell’edizione 2012 del Festival Filosofia che si svolge a Modena, Carpi e Sassuolo da domani a domenica. Quasi 200 appuntamenti, in 40 luoghi, tra lezioni, mostre (domani si inaugura la retrospettiva del fotografo Edward Weston), spettacoli e letture in piazza, giochi per bambini e persino cene filosofiche.
Sono talmente tante le «cose» proposte che la rassegna risulta esorbitante, frutto di uno sforzo organizzativo enorme sostenuto dalla direttrice, Michelina Borsari, e da tutto il Consorzio. Si prevedono appuntamenti rari, come l’arrivo in Italia del logico John Searle e della cinese Anne Cheng; lezioni dei maestri stranieri come Bruno Latour, Serge Latouche, Peter Sloterdijk, Francisco Jarauta, Scott Lash e Krzysztof Pomian; quelle dei filosofi di casa nostra come Tullio Gregory, Remo Bodei, Massimo Cacciari, Emanuele Severino, Salvatore Natoli, Giovanni Reale, Sergio Givone, Umberto Galimberti, Maurizio Ferraris, Salvatore Settis (ecc. ecc.); un po’ di passerella con i presenzialisti Zygmunt Bauman e Marc Augé (se sono in ogni festival, quando studiano?) e anche uno spaccato da fiera Ligabue-style con gli intrattenitori Fabio Volo, Giobbe Covatta, Bergonzoni, poi Guccini e un po’ di musica...
«In sé» il problema posto dal festival è il problema di tutta la Metafisica, da Platone a Heidegger: cos’è la cosa? Cos’è l’ente? Bastasse un festival per rispondere, l’avrebbero già organizzato nella stoà di Atene. Il Festival di Modena cerca però di declinare l’interrogazione in molteplici direzioni. In questo è molto omnicomprensivo, anche se emerge una certa tendenza anticapitalistica in coloro che intervengono sulla «cosa sociale». La declinazione del concetto di «cosa», infatti, asseconda sia le tendenze neo-realiste che quelle ermeneutiche, sia l’interrogazione della cosa come mezzo e strumento di lavoro che quella come accadimento e anche bene o patrimonio, idolo e feticcio. Ciascuno può scegliere la «cosa» che vuole e vederla come vuole, dalle «Cose prime» di Severino, alla «Cosa ultima» di Cacciari a quelle intermedie. Tra le quali soffermerei lo sguardo su quelle terrestri legate al terremoto e al recupero del patrimonio (l’archeologo Settis e l’architetto Ciorra), ovvero al recupero di quella «materia signata», come aveva scritto Tommaso D’Aquino, che andrebbe trattata come una reliquia e non trasformata per uffici&residenze (come la Manifattura Tabacchi).
Senza scomodare Kant, Heidegger sarebbe uno snodo del tema scelto: Sentieri interrotti resta infatti una delle raccolte di riflessioni più utili per capire come il passaggio della cosa da mezzo a opera avvenga attraverso varie forme di accrescimento e disvelamento, di messa in opera. Questa è una chiave di lettura del festival. Un’altra è quella proposta dai nuovi realisti o tentata da Remo Bodei (presidente del Comitato scientifico del Consorzio per il festival) che mostrerà «come si possa restituire agli oggetti la loro qualità di "cose", ossia l’insieme degli investimenti affettivi, concettuali e simbolici che individui e società vi ripongono». Un’altra ancora è quella di indagare le connessioni tra cosa e passione con Enzo Bianchi (sul debito d’amore che costituisce la vita umana), Sergio Givone (sulla peculiare forma di dono che è il perdono) e Krzysztof Pomian (sulla logica del collezionismo).
Naturalmente bisognerà attendere le relazioni, anche se appaiono più esplorati i filoni pop-estetici legati a idoli, feticci e ipermerce che quelli teoretici vicini alla fenomenologia (Husserl è comunque trattato da Roberta de Monticelli in apertura) e quindi ai limiti dell’esperienza sensibile in rapporto ai fenomeni naturali, agli oggetti e loro percezione. Pochi sembrano voler riaffrontare il criticismo di Locke e Hume alla base dell’indagine kantiana sull’impossibilità di trovare un fondamento teorico alla conoscenza scientifica e l’interrogazione sulla possibilità di fare affermazioni sulla realtà oltre i limiti dell’esperienza. In fondo si privilegia una certa attenzione pragmatica alla Richard Rorty parlando sulle cose così come si sono affermate oggi (idoli, feticci, patrimonio, merci) piuttosto che cercare di fornire una legge capace di descriverle o coglierne «l’essenza». Bisogna del resto considerare che si tratta di un festival e non un convegno gnostico, che interseca più piani al di fuori di superati steccati disciplinari o di esclusive patenti accademiche nell’età della pluralità dei saperi e degli attori didattici. Il programma propone anche la sezione «La lezione dei classici» con studiosi che commenteranno i testi di Platone, Aristotele, Adam Smith, Hegel, Marx, fino a Husserl, Heidegger, Benjamin e Arendt.
Il festival, promosso dal «Consorzio per il festivalfilosofia» (ovvero i Comuni di Modena, Carpi e Sassuolo, la Provincia di Modena, la Fondazione Collegio San Carlo e la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena) lo scorso anno ha registrato oltre 176 mila presenze.
-
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- VITA E PENSIERO: LA LEZIONE 8DA RICORDARE) DI POCHI DOCENTI SU OLTRE 1200..9 settembre 2012, di Federico La Sala
Giuramento di fedeltà al Fascismo *
In base a un regio decreto emanato il 28 agosto 1931 i docenti delle università italiane avrebbero dovuto giurare di essere fedeli non solo allo statuto albertino e alla monarchia, ma anche al regime fascista. L’idea dell’inserimento della clausola di fedeltà al fascismo viene attribuita al filosofo Balbino Giuliano, che ricopriva in quegli anni la carica di Ministro per l’Educazione Nazionale nel governo Mussolini[1].
In tutta Italia furono solo una quindicina di personalità, su oltre milleduecento docenti, a rifiutarsi di prestare giuramento di fedeltà al fascismo perdendo così la cattedra universitaria. Il numero effettivo delle persone che non si sottoposero al giuramento oscilla di qualche unità a seconda delle fonti. L’indeterminazione è dovuta anche ad alcune situazioni particolari, di docenti che vi si sottrassero per vie diverse: Vittorio Emanuele Orlando, ad esempio, andò anticipatamente in pensione, mentre altri, come Giuseppe Antonio Borgese, si allontanarono dall’Italia fascista andando esuli all’estero[1]. Allo stesso modo non si sottopose al giuramento il docente ed economista Piero Sraffa, già da alcuni anni esule a Cambridge[1] .
I nomi dei docenti furono:
 Ernesto Buonaiuti (storia del cristianesimo)[2]
Ernesto Buonaiuti (storia del cristianesimo)[2]
 Giuseppe Antonio Borgese (estetica)[3]
Giuseppe Antonio Borgese (estetica)[3]
 Aldo Capitini (filosofia)
Aldo Capitini (filosofia)
 Mario Carrara (antropologia criminale)
Mario Carrara (antropologia criminale)
 Antonio De Viti De Marco (scienza delle finanze)
Antonio De Viti De Marco (scienza delle finanze)
 Gaetano De Sanctis (storia antica)
Gaetano De Sanctis (storia antica)
 Floriano Del Secolo (lettere e filosofia)[4]
Floriano Del Secolo (lettere e filosofia)[4]
 Giorgio Errera (chimica)
Giorgio Errera (chimica)
 Giorgio Levi Della Vida (lingue semitiche)
Giorgio Levi Della Vida (lingue semitiche)
 Piero Martinetti (filosofia)
Piero Martinetti (filosofia)
 Fabio Luzzatto (diritto civile)
Fabio Luzzatto (diritto civile)
 Bartolo Nigrisoli (chirurgia)
Bartolo Nigrisoli (chirurgia)
 Errico Presutti (diritto amministrativo)[3]
Errico Presutti (diritto amministrativo)[3]
 Francesco Ruffini (diritto ecclesiastico)
Francesco Ruffini (diritto ecclesiastico)
 Edoardo Ruffini Avondo (storia del diritto)
Edoardo Ruffini Avondo (storia del diritto)
 Lionello Venturi (storia dell’arte)
Lionello Venturi (storia dell’arte)
 Vito Volterra (fisica matematica)
Vito Volterra (fisica matematica)Molti degli accademici vicini al comunismo aderirono invece al giuramento seguendo il consiglio di Togliatti[1], con la giustificazione che il prestare giuramento permettesse loro di svolgere, come dichiarò Concetto Marchesi, «un’opera estremamente utile per il partito e per la causa dell’antifascismo»[5]. Analogamente, la maggior parte dei cattolici, su suggerimento del Papa Pio XI, ispirato probabilmente da Agostino Gemelli[1], prestò giuramento «con riserva interiore»[1][5].
Vi fu chi accondiscese al giuramento, tra questi Guido Calogero e Luigi Einaudi, seguendo l’invito di Benedetto Croce, «per continuare il filo dell’insegnamento secondo l’idea di libertà»[5] a impedire che le loro cattedre - secondo l’espressione di Einaudi - cadessero «in mano ai più pronti ad avvelenare l’animo degli studenti»[6].
FONTE. Da Wikipedia, l’enciclopedia libera. (ripresa aprziale).
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- TUTTI AL FESTIVAL DI FILOSOFIA. Alla ricerca delle “Cose” perdute ... e non solo! (di Aurelio Magistà - Le cose sotto la lente del filosofo)9 settembre 2012, di Federico La Sala
Le cose sotto la lente del filosofo
di Aurelio Magistà (la Repubblica, 09.09.2012)
- Venerdì inaugura a Modena, Carpi e Sassuolo l’appuntamento dedicato al pensiero più introspettivo. Tema di quest’anno le cose, affrontate da ogni punto di vista e in diversi luoghi delle tre città, per tre giorni lontani dallo stress del quotidiano
Una bambola tra le macerie del terremoto. Il simbolo della perdita di quelli che non sono più solo degli oggetti ma cose, giocattoli, sedie, piatti, giacche dove si sono depositati e dove ritroviamo i nostri affetti e i nostri ricordi. Questa immagine è la sintesi ideale del Festival della Filosofia, che comincia venerdì tra Modena, Carpi e Sassuolo ferite dal terremoto, e che ha per tema, appunto, “Cose”.
«Anche se sembra scelto apposta, l’argomento è stato deciso prima del sisma», spiega la direttrice Michelina Borsari, «e quando abbiamo cominciato a lavorarci, praticamente da sfollati, ci siamo chiesti se era opportuno confermarlo». A sciogliere i dubbi, da una parte la volontà dei sindaci delle tre città e delle istituzioni coinvolte, persuasi che il festival sia una prova di volontà e d’orgoglio, un modo per continuare a tenere l’attenzione su queste zone, e un aiuto economico; dall’altra parte, commovente, «la gara di solidarietà che si è aperta tra i protagonisti di questa e delle precedenti edizioni per offrirsi di venire “in solidarietà”, lasciando il compenso per la ricostruzione».
Perché il festival è anche questo, «Costa circa novecentomila euro ma ne porta quattro o cinque volte tanto», sintetizza Remo Bodei, presidente del comitato scientifico, Il progetto iniziale ha saputo assimilare anche il terremoto, che non sarà solo negli scenari, ma diverrà protagonista, per esempio con il grande dibattito sulla ricostruzione che chiuderà il festival, mettendo a confronto il “dopo” emiliano con gli altri dei sismi recenti, l’umbro marchigiano a quello dell’Aquila, o con le macerie che diventano un’installazione, o ancora con le tre macchine industriali esibite come simulacri per ricordare le aziende e i settori produttivi colpiti: il tessile, il meccanico e il ceramico. Qui, fra rovine e case pericolanti parlare di cose - perdute, ritrovate, minacciate - assume d’improvviso in significato più intenso e profondo.
Il programma come sempre è ricchissimo, dalle lezioni magistrali alle mostre, dagli spettacoli ai dibattiti fino alla gastronomia. Circa duecento eventi offriranno quasi tutte le prospettive possibili, partendo da una distinzione, «non pignola ma sostanziale», argomenta Bodei, tra «oggetto, che ha essenzialmente un valore di scambio e d’uso, e cosa, dal latino causa, ciò che ci sta a cuore, su cui si stratificano significati di cui spesso si finisce per smarrire il senso».
«Mai come oggi il mondo è stato saturo di oggetti», nota la Borsari. «e mai come adesso, qui per il terremoto,unpo’ovunqueperlacrisi,èfortelasensazione del rischio della perdita». Tanto più che le cose le perdiamo per mille ragioni, magari perché cresciamo (al festival Silvia Vegetti Finzi parlerà proprio di giocattoli), o perché passa il loro tempo, e la perdita cristallizza, a volte amplifica le emozioni che ci suscitano. Su questo sarà interessante ascoltare la conversazione di Brunetto Salvarani con Francesco Guccini, che ha scritto un Dizionario delle cose perdute, rievocando oggetti scomparsi o divenuti feticci da collezionisti, come «il pompetto del flit o il telefono di bachelite», spiega lui a Repubblica (il video: http://video.repubblica. it/spettacoli-e-cultura/guccini-ecco-il-miodizionario- delle-cose-perdute/89796/88189), «ricordandole senza nostalgia né malinconia, piuttosto con sorniona ironia». Mostrando che rievocarle significa raccontare le persone, in un “come eravamo” che conferma le parole di Protagora: «L’uomo è misura di tutte le cose»
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- "Dio è al di là delle frontiere che vengono erette". Così come l’Italia è al di là di tutti i partiti.2 settembre 2012, di Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ----"DIRE DIO" OGGI. Una riflessione in eredità (per credenti e non credenti) del cardinale Carlo M. Martini1 settembre 2012, di Federico La Sala
MESSAGGIO EVANGELICO, SPIRITO CRITICO, E INSEGNAMENTO: CHI INSEGNA A CHI CHE COSA E COME?
(...) quella che affrontiamo non è semplicemente una questione esegetica. La posta in gioco è ben più alta. Dietro la domanda: «Perché Gesù parlava in parabole», sta infatti una questione attualissima e gravissima: quella del «linguaggio religioso», del come parlare adeguatamente di Dio oggi (...)
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- Avere fiducia. Perché è necessario credere negli altri. Note sul libro di Michela Marxano (di Roberto Esposito - Sulla fiducia. Il senso della comunità al tempo della crisi)3 settembre 2012, di Federico La Sala
CEDIMENTO STRUTTURALE DELLA FIDUCIA:
Sulla fiducia. Il senso della comunità al tempo della crisi
di Roberto Esposito (la Repubblica, 3 settembre 2012)
Chi si aspettasse di trovare nel libro di Michela Marzano Avere fiducia. Perché è necessario credere negli altri, appena tradotto da Mondadori, un esercizio di tradizionale filosofia morale, rimarrebbe positivamente sorpreso. Non solo esso prende una salutare distanza da luoghi comuni sempre più diffusi - come quello della equivalenza tra verità e assoluta trasparenza -, ma annoda con esiti di particolare rilievo il linguaggio filosofico a quelli sociologico, antropologico, economico.
Del resto quale concetto, più di quello di fiducia, si pone nel punto di incrocio e di tensione tra il lessico teologico della fede, quello sociale della credenza e quello economico del credito? Per inquadrarlo in tutta la sua valenza l’autrice attiva uno sguardo genealogico che dall’età classica - ancora basata sull’onore ed il rispetto della promessa - arriva alla modernità, in cui la categoria di fiducia subisce una serie di contraccolpi che finiscono per rovesciare la société de confiance nella société de défiance - come si intitolano rispettivamente i saggi di A. Peyrefitte (Odile Jacob, 2005) e di Y Algan e P. Cahuc (Presse de l’Ecole normale supérieure, 2007).
Il punto di innesco di questo processo di secolarizzazione è costituito dalla critica cui i moralisti francesi, come Pascal, La Rochefoucauld e La Bruyère, sottopongono le antiche virtù eroiche dell’onore e della lealtà. Mandeville e Adam Smith assumono la medesima concezione disincantata, pur capovolgendone le conclusioni: sono proprio i vizi privati, e cioè gli interessi particolari, a costituire, nel loro insieme, la sorgente della ricchezza sociale. Ma questo passaggio dal negativo al positivo, presto traslato nell’immagine liberale della ‘mano invisibile’, si basa sulla sovrapposizione indebita tra la nozione, etica, di fiducia e quella, economica, di interesse: la “società di fiducia” di cui parla Smith poggia in realtà sulla generalizzazione della sfiducia reciproca.
È qui che l’autrice innesta il vettore forse più originale della propria ricerca, profilando con rapidi tratti il transito, genialmente intuito dall’economista scozzese John Law, dal sistema monetario incentrato sull’oro a quello fondato sull’emissione dei biglietti bancari e delle carte di credito. Il quale non può poggiare che sulla fiducia reciproca degli attori economici. Ma proprio qui inizia ad aprirsi quella frattura antropologica che oggi minaccia di diventare una vera e propria voragine: come conservare la fiducia nella solvibilità degli individui, delle banche o degli stessi Stati che le garantiscono, quando gli uomini si comportano in maniera palesemente egoistica? È come se tutto il castello dell’economia moderna poggiasse su un fondamento di carta destinato a strapparsi al primo urto.
La storia delle molteplici crisi finanziarie, dalla bancarotta del 1720 in Francia a quella dei nostri giorni, al di là delle ovvie differenze di tempo e di contesto, rimanda a questo vuoto originario, a partire dal quale la sfiducia tende sempre più rapidamente a sfondare le fragili pareti della fiducia: come scriveva Duclos nelle sue Memorie segrete, “la fiducia si ispira per gradi, ma basta un istante per distruggerla, e, allora è in qualche modo impossibile ristabilirla”. Senza una credibilità diffusa, l’intero sistema economico minaccia di crollare, ma per crearla occorre che da qualche parte si dia prova di meritarla.
È il cortocircuito in cui la speculazione finanziaria ha trascinato prima l’economia americana e poi il resto del mondo: il mancato pagamento dei subprimes ha portato alla caduta del prezzo degli alloggi ipotecati senza copertura. Ciò, a sua volta, ha determinato una generale crisi del credito e una conseguente perdita di fiducia nei confronti dell’intero sistema finanziario.
Tutto ciò è ben noto agli economisti. Che però tendono a restare chiusi all’interno del loro orizzonte, impedendosi così di vedere quella faglia che lo sottende, sulla quale concentra invece l’attenzione la Marzano. Quando il senso comune diventa quello efficacemente stilizzato nel film di Ridley Scott Nessuna verità (2008) “Non fidarti di nessuno. Inganna tutti”, la soglia di guardia è abbondantemente superata.
La fiducia, ridotta a credito economico, o a contratto giuridico, non è che l’ombra deformata della diffidenza. A quel punto, rotti gli argini etici che tengono insieme gli uomini, nulla può più arrestare la valanga. Quando, già nel 1937, Franklin D. Roosevelt affermava che l’egoismo è cattivo non solo moralmente, ma anche economicamente, coglieva l’anello decisivo della catena di crisi economiche che avrebbero squassato il sistema capitalistico.
Ad uscirne non bastano i - pur necessari - provvedimenti economici. E neanche solamente quelli politici. Serve un sommovimento generale delle coscienze che liberi l’idea, e la pratica, della fiducia dalla sua sudditanza all’ideologia dell’interesse. Alla sua base non vi può essere solo la fiducia in se stessi predicata dai nuovi addestratori di manager e trader, quanto il coraggio di fare la prima mossa - credere negli altri prima ancora che questi credano in te.
Con tutto il rischio che tale opzione comporta. Certo, guardarsi dalla sempre possibile cattiva fede altrui è opportuno, ma senza per questo presumere di dovere avere tutto sotto controllo. Un discorso - quello della Marzano - traducibile nelle categorie di comunità e di immunità: l’eccesso di protezione immunitaria contro il possibile pericolo conduce non solo alla rottura del legame sociale, ma anche al rischio mortale di una malattia autoimmune.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- Avere fiducia. Perché è necessario credere negli altri. Note sul libro di Michela Marxano (di Roberto Esposito - Sulla fiducia. Il senso della comunità al tempo della crisi)28 ottobre 2012, di Lino Pasquale Barbieri
...sono perfettamente d’accordo sull’ Analogia Funzionale del Sistema Immunitario e Simmetricamente aggiungerei che il Tema sotteso : " IL NEMICO E’ OVUNQUE " ahimè, DA DENTRO Nascosto alla Consapevolezza di molte Persone ( gli uni diffidenti e armati contro l’Altro/i ) . " IL NEMICO E’ OVUNQUE " che trasdotto concretamente nel " Vissuto Quotidiano dello Psico-Soma Individuale e Collettivo, Assume I Connotati di UNA PROPORZIONE ANALOGICA ovvero
L’ Aumento delle Patologie ALLERGICHE E DI INTOLLERAZE : ( stà ALLA METAFORA) " ARMARSI INVANO!!!" ,
se Vivo in uno Stato Subliminale ( non consapevolizzato) di ALLERTA CONTINUA ( Distress subclinico fin’anche a tratti Ossessivi e/o Ossessivi-Compulsivi ) IL Complesso A CASCATA " Psico-Neuro-Endocrino-Immunitario " sottoposto a Reiterati Rinforzi delle Costellazioni EmotiveInconsce, nel Tempo, Dichiarerà i Sintomi con sempre maggiore Intensità.( Vedi l’ncremento di Tiroiditi su base autoimmune nelle donne e significato Simbolico dell’Acting-out al Maestro d’ Orchestra metabolico-energetico LA TIROIDE.) Tutto ciò non và interpretato nei Termini Superficiali di Causalità Immediata, ma di Una Complessa Reiterazione nel Tempo degli Stimoli Distressici. In Realtà penso che il " Il Nemico sia in Casa " e finchè non ci si Scopre alla Consapevolezza " Si Proietta del "Proprio" sull’Altro/i, ( e sul mondo) fino ad assumere come Categorie Assolute e Contrapposte quelle "del BENE e del MALE" con tutte le conseguenze che derivano sul Piano Individuale e Collettivo ( come vediamo bene oggi é SOTTO GLI OCCHI DI TUTTI!) dello" Scatenamento degli Specifici ARCHETIPI . La Crisi è L’OPPORTUNITA’ per un " RESET" senza Moratorie,queste non sono possibili; IL TEMA DIVENTA " LO SPECCHIO " che va’ Ricomposto nei suoi frammenti ad Iniziare dagli Individui che seppur Feriti ristabiliscono un Contatto con la Responsabilita’ verso Sè medesini e assunzione di Fiducia per condivisione di Esperienza dal Basso ovvero RiconoscerSi nella NECESSITA’ come " ALLEANZA TRA PARI ". Un Cordiale Saluto da Lino Pasquale Barbieri -Ricerca Applicata- Fontanellato Parma cell.333-6467766 -Via del Fontanino 4
-
-
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- Petizione In favore dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. A:Ministro per i Beni e le Attività culturali, Presidente Regione Campania30 agosto 2012, di Federico La Sala
 Petizione In favore dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
Petizione In favore dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
 A:Ministro per i Beni e le Attività culturali, Presidente Regione Campania
A:Ministro per i Beni e le Attività culturali, Presidente Regione CampaniaAlla c. a. del ministro per i Beni e le Attività culturali, Lorenzo Ornaghi, e del presidente della Regione Campania, Stefano Caldoro
Illustre Ministro, Illustre Presidente,
la Biblioteca dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, messa insieme da Gerardo Marotta in mezzo secolo di pazienti ricerche presso fondi librari e antiquari in tutta Europa, costituisce il nucleo fondamentale dell’Istituto fondato nel 1975 a Roma, nella sede dell’Accademia dei Lincei, da Enrico Cerulli, Elena Croce, Pietro Piovani, Giovanni Pugliese Carratelli e Gerardo Marotta, che ne è anche il presidente. La Sovrintendenza ai beni librari della Regione Campania ha riconosciuto nel 2008 il valore di questa raccolta, che oggi conta circa trecentomila opere, dichiarando che essa «presenta i segni di uno sforzo ragionato di gestione e sviluppo, frutto, non di casuale sedimentazione, ma delle attività di studio, ricerca e formazione promosse dall’Istituto di appartenenza». La delibera, attestando «il grande valore bibliografico e culturale» della biblioteca, decreta «la necessità di salvaguardarne l’inscindibile legame con l’Istituto di emanazione» e «l’opportunità e l’utilità sociale di predisporne le migliori condizioni di fruizione pubblica».
Fu in questo spirito che la Regione, già nel 2001 con delibera n. 6039, individuò come sede della biblioteca i locali dell’ex-CONI in Piazza Santa Maria degli Angeli n. 1, a pochi passi da Palazzo Serra di Cassano, sede dell’Istituto, al fine di garantire la necessaria vicinanza tra la biblioteca e il luogo in cui quotidianamente si svolge un’intensa attività di seminari, così da assicurare la fruibilità del patrimonio librario al vasto pubblico di studiosi e ricercatori. Venne dunque formulato un progetto che, tenendo conto dei locali disponibili e dello spazio occupato dai volumi, consentisse, attraverso un sistema di scaffalature compatte, una sistemazione adeguata, congrua e razionale della raccolta.
Tuttavia, inspiegabilmente, l’attuale Giunta regionale emana nel 2011 un nuovo atto che opera una radicale inversione di rotta rispetto al complesso processo iniziato dieci anni prima: con la delibera n. 283 si inseriscono due elementi che minacciano di stravolgere letteralmente il progetto originario per cui erano stati stanziati anche specifici fondi europei. Viene difatti prospettata per i locali individuati l’utilizzazione «come fondo iniziale dei volumi che obbligatoriamente vengono trasmessi in copia alla Regione Campania da editori e aziende tipografiche allorquando pubblicati» e l’attivazione di una «Biblioteca pubblica “a scaffale aperto”». Ciò significherebbe non solo sfregiare l’armonica razionalità interna della raccolta dell’Istituto, che la rende specchio di una dimensione culturale internazionale, con l’inserimento di un fondo avente come unico criterio quello dell’appartenenza geografica regionale, ma significherebbe soprattutto impedire materialmente l’allocazione della biblioteca dell’Istituto, la cui dimensione è tale da occupare per intero lo spazio dei locali e solamente qualora sia rigorosamente seguito il progetto delle scaffalature compatte.
L’estenuante lentezza e l’infelice esito di questo processo testimoniano la trascuratezza con cui è stato considerato negli ultimi anni l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, che secondo l’UNESCO non ha termini di paragone nel mondo e che oggi, privato dei fondi necessari al suo pieno funzionamento, rischia di dover chiudere. È inaccettabile assistere a questo avvilimento dell’Istituto e alla sepoltura della sua biblioteca in un triste deposito, un ex capannone industriale di Casoria, per opera della miopia e dell’inerzia ostinata di alcuni dirigenti amministrativi.
Chiediamo, pertanto, che la Regione revochi la delibera del 21 giugno 2011 e ripercorra con urgenza la strada tracciata dalle delibere dell’amministrazione Bassolino e della Sovrintendenza bibliografica regionale, aprendo finalmente al pubblico un grande patrimonio librario, e che, su sollecitazione del Ministero dei Beni culturali, il Governo presenti un disegno di legge al Parlamento diretto a garantire un finanziamento stabile per l’Istituto che consenta di ripianare gli oneri finanziari derivati dal ritardo, quando non dal venir meno per alcuni anni, degli stessi contributi, e che permetta il pieno svolgimento delle sue attività di ricerca e della sua funzione civile.
PRIMI FIRMATARI
I firmatari
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- ACROPOLI DEI GIOVANI. Primo Presidio permanente istituito con il protocollo d’intesa tra l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e il Comune di Palomonte (SA).16 ottobre 2014, di Federico La Sala
Incontro inaugurale del Primo Presidio Permanente dell’Acropoli dei Giovani
di Acropoli dei Giovani *
- Sabato 18 ottobre alle ore 9.30, a Palomonte (Sa), presso la Sala Ricevimenti del Ristorante “El Sombrero”, Località Usciglito, si terrà la cerimonia inaugurale del Primo Presidio permanente dell’ACROPOLI DEI GIOVANI.
Il Primo Presidio permanente dell’Acropoli dei Giovani è stato e rientra nel nuovo progetto a largo raggio promosso dell’Istituto che prevede l’istituzione di Presidi a carattere permanente dell’Acropoli dei Giovani in altri comuni italiani, in particolare quelli del Mezzogiorno. I Presidi saranno luoghi di incontro, confronto e formazione dedicati ai giovani e aperti a tutti coloro che abbiano interesse a parteciparvi.
Con la proiezione del docu-film del regista Marcello Sannino “La seconda natura” e una lectio magistralis tenuta dall’avv. Gerardo Marotta, presidente dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, verrà dato l’avvio al ricco programma di incontri e di eventi con i quali l’IISF e il Comune intendono porre la cittadina di Palomonte a crocevia di un vasto progetto di formazione, di promozione e di crescita rivolto alle giovani generazioni nell’obiettivo di un sempre maggiore sviluppo culturale, sociale, economico e produttivo del territorio, nel rispetto dell’ambiente e nella continuità della tradizione storico-culturale. Il progetto, inoltre, nello spirito del long life learning, prevede iniziative dedicate a tutte le fasce d’età.
Il Primo Presidio permanente, così come gli altri Presidi, avrà, inoltre, fra i suoi compiti anche quello di approfondire e far propri i risultati della storiografia, concentrandosi inizialmente sulla storia patria e in particolare sulla storiografia umanistica.
Interverranno: l’On. Giovanni Fortunato, Consigliere della Regione Campania, l’avv. Gerardo Marotta, Presidente dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, il dott. Pietro Caporale, Sindaco del Comune di Palomonte, l’ing. Diego Famularo, Assessore al Patrimonio, Ricostruzione e Sviluppo del Comune di Palomonte, il prof. Aldo Tonini, responsabile delle Scuole Estive di Alta Formazione dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, la dott.ssa Bianca Desideri, responsabile didattico e organizzativo del progetto “Acropoli dei Giovani” dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, il prof. Gerardo Grossi, componente del comitato scientifico del Primo Presidio dell’Acropoli dei Giovani, il regista Marcello Sannino, la prof.ssa Anna Maria Siena Chianese, ufficio stampa dell’Acropoli.
 A Valentina Risi, Radio Mpa, il compito di condurre la mattinata.
A Valentina Risi, Radio Mpa, il compito di condurre la mattinata.
 Presenzieranno alla cerimonia inaugurale amministratori dei comuni facenti parte della comunità montana Alto-Medio Sele e Tanagro, dirigenti scolastici, docenti, studenti delle scuole di ogni ordine e grado, giovani, rappresentanti del mondo associativo, delle pro loco, del servizio civile, delle realtà produttive ed economiche locali.
Presenzieranno alla cerimonia inaugurale amministratori dei comuni facenti parte della comunità montana Alto-Medio Sele e Tanagro, dirigenti scolastici, docenti, studenti delle scuole di ogni ordine e grado, giovani, rappresentanti del mondo associativo, delle pro loco, del servizio civile, delle realtà produttive ed economiche locali.“Questo Primo Presidio permanente - evidenzia l’avvocato Gerardo Marotta - rappresenta una nuova sfida culturale promossa dal nostro Istituto. Il nuovo progetto dei Presidi dell’Acropoli dei Giovani, che si inserisce nelle numerose attività ed iniziative che da oltre un quarantennio porta avanti l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, - prosegue Gerardo Marotta - vuole fornire un ulteriore strumento per la valorizzazione delle energie intellettuali, civili e morali, soprattutto dei giovani, energie di cui sono ricchi i tanti comuni d’Italia e che costituiscono la premessa e, al tempo stesso, il fondamento per una maggiore estensione della coscienza civile e per lo sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno e dell’intero Paese.
E’ proprio in questo momento storico di grande crisi valoriale aggravata da quella economica, che sembrano aver sottratto alle giovani generazioni anche la speranza, che è più forte l’esigenza di essere ancor più vicini ai giovani, aiutandoli a “leggere”- conclude l’avvocato Marotta - con occhi attenti ed illuminati la realtà che li circonda, affondando l’analisi nel passato per comprendere il presente e costruire un futuro in cui la persona e non la finanza sia al centro di ogni agire”.
“Si avvicina la data del 18 ottobre e cresce a Palomonte - sottolinea il Sindaco Pietro Caporale - l’attesa per un momento di straordinaria importanza, che ritengo abbia in sé tutte le premesse e le caratteristiche di evento storico per la nostra comunità. Si materializzerà l’intesa, siglata il 12 agosto tra il Comune di Palomonte e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, con la solenne inaugurazione del Primo Presidio dell’Acropoli dei Giovani, un luogo di alta formazione rivolto ai giovani e non solo, voluto dall’avvocato Gerardo Marotta.
 Fondamentale e fortemente auspicata dall’avvocato Marotta, - prosegue il Sindaco Caporale - sarà la presenza di una numerosa rappresentanza di giovani alunni degli Istituti superiori del nostro territorio, uditori privilegiati per ascoltare una lectio magistralis dell’avvocato Marotta e che darà l’avvio a un ricco calendario di appuntamenti di alta formazione. Ringrazio anticipatamente, personalmente ed a nome dell’Amministrazione Comunale, l’avvocato Marotta ed i suoi collaboratori, i volontari “Amici della Biblioteca Palomonte”, che auspico sempre più numerosi, per l’impegno profuso in un’iniziativa che ritengo di eccezionale importanza per la crescita culturale del nostro territorio e che vedrà tutto il mio sostegno per una piena realizzazione”.
Fondamentale e fortemente auspicata dall’avvocato Marotta, - prosegue il Sindaco Caporale - sarà la presenza di una numerosa rappresentanza di giovani alunni degli Istituti superiori del nostro territorio, uditori privilegiati per ascoltare una lectio magistralis dell’avvocato Marotta e che darà l’avvio a un ricco calendario di appuntamenti di alta formazione. Ringrazio anticipatamente, personalmente ed a nome dell’Amministrazione Comunale, l’avvocato Marotta ed i suoi collaboratori, i volontari “Amici della Biblioteca Palomonte”, che auspico sempre più numerosi, per l’impegno profuso in un’iniziativa che ritengo di eccezionale importanza per la crescita culturale del nostro territorio e che vedrà tutto il mio sostegno per una piena realizzazione”.“L’ambizioso disegno di creare a Palomonte un polo culturale di riferimento sovracomunale, ora diventa realtà”, dichiara l’assessore comunale Diego Famularo. “Ringrazio l’avvocato Gerardo Marotta per aver creduto nel progetto culturale di Palomonte, il professor Gerardo Grossi, la dottoressa Bianca Desideri, membri del Comitato Scientifico dell’Acropoli dei Giovani, rispettivamente in qualità di responsabile scientifico per il Comune di Palomonte e responsabile didattico e organizzativo per conto dell’IISF e la professoressa Anna Maria Siena Chianese che curerà l’ufficio stampa, per il prezioso impegno che stanno riversando nel progetto, e tutti coloro che attraverso la loro dedizione e abnegazione, stanno contribuendo significativamente allo sviluppo e alla trasformazione del nostro territorio”.
Acropoli dei Giovani
-
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- LA LEZIONE DI BOCCACCIO. Dopo 700 anni (dalla nascita), tutta viva la sua sacrosanta indignazione e tutto libero il suo spirito critico.25 agosto 2012, di Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- Napoli, chiude l’Istituto Studi filosofici e i libri finiscono in un capannone (di Andrea Postiglione)23 agosto 2012, di Federico La Sala
Napoli, chiude l’Istituto Studi filosofici e i libri finiscono in un capannone
di Andrea Postiglione *
Neanche la vendita di tutti i suoi beni personali e i debiti contratti sono serviti a sventare il peggio. Alla fine l’avvocato Gerardo Marotta, fondatore dell’Istituto Italiano per gli Studi filosofici, ha dovuto arrendersi e trasferire i circa trecentomila volumi della biblioteca dell’ente in un capannone a Casoria, in provincia di Napoli. Si tratta di un patrimonio del valore di dieci milioni di euro, che comprende molti libri rari, tra cui testi di Benedetto Croce e Giordano Bruno. Colpa del governo, che ha tagliato i finanziamenti che servivano a pagare il fitto dei locali dove finora erano custoditi i libri, e della Regione Campania, che non ha ancora attuato una vecchia delibera che prevedeva l’istituzione di una biblioteca per accogliere le migliaia di libri dell’Istituto. Per ora, quindi, resteranno a disposizione degli studenti solo i cinquantamila volumi che Marotta conserva ancora a casa sua: “Finché non mi sfrattano”, dice Marotta. “L’avvilimento dei giovani che studiano da noi è stata una cosa tremenda - aggiunge - Quando si sono visti togliere anche i libri, i loro strumenti di lavoro, sono rimasti scoraggiati, avviliti. Si sono sentiti svuotati”
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA E A PENSARE BENE "DIO", "IO" E "L’ITALIA", CHI PIU’ CHI MENO, TUTTI VIVONO DENTRO LA PIU’ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA E POLITICA ITALIANA, NEL REGNO DI "FORZA ITALIA"!!! Un’inchiesta e una mappa di Francesco Tomatis - a cura di Federico La Sala20 agosto 2012
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- 2002-2012. Dieci anni di Filosofia al San Raffaele (di Massimo Cacciari, Edoardo Boncinelli, Elena Loewenthal, Alberto Martinelli, Angelo Panebianco, Giovanni Reale, Marco Santambrogio, Emanuele Severino, Vincenzo Vitiello).23 luglio 2012, di Federico La Sala
Dieci anni di Filosofia al San Raffaele *
Fin dalla sua fondazione nel 2002 - ricorre infatti in questo 2012 il Decennale dalla sua istituzione - la Facoltà di Filosofi a dell’Università Vita-Salute San Raffaele si è caratterizzata per il pluralismo degli orientamenti fi losofi ci, per il reclutamento di un corpo docente di altissima qualità, presto rinforzato da giovani ricercatori selezionati su basi meritocratiche, nonché per la natura innovativa dell’insegnamento impartito.
Ciò è testimoniato sul piano dei contenuti da un’offerta didattica rappresentata ai massimi livelli tanto nell’ambito della fi losofi a continentale (nelle aree teoretica, ermeneutica, metafi sica, estetica, fenomenologica), quanto in quello della fi losofi a analitica (logica, fi losofi a della mente e del linguaggio, fi losofi a della scienza, della matematica, logica e ontologia, semantica formale), a cui si aggiungono la storia della fi losofi a e la fi losofi a morale e politica.
A tutto questo si affianca, come elemento caratterizzante, un signifi cativo numero di insegnamenti raramente presenti nei corsi di laurea italiani, che spaziano dalle discipline scientifi - che come Genetica e antropologia, Fondamenti biologici della conoscenza, Linguistica generale, Intelligenza artifi ciale, Economia cognitiva, Neuroeconomia, Basi neurofi siologiche delle funzioni cognitive, ai corsi di Teologia biblica, Teologia moderna e contemporanea, Cultura ebraica, Civiltà islamica, Teoria politica, Geopolitica, Pensiero economico, Economia della globalizzazione.
Grazie a questo intreccio di diverse tradizioni di ricerca fi losofi ca, religiosa, intellettuale e culturale, agli studenti viene offerta una formazione che scaturisce dal vivo del pluralismo contemporaneo, in termini di confronto sia fra culture sia fra discipline e metodi diversi - formazione che è alla base del successo che i laureati della Facoltà di Filosofi a possono vantare nell’accesso al mondo del lavoro e della ricerca (master e dottorati di ricerca in Italia e all’estero).
Nel quadro di questo progetto, guidato da una tensione verso la libertà del pensiero e l’eccellenza degli studi (che caratterizza tutta l’Università Vita-Salute San Raffaele), hanno trovato e trovano spazio presso la Facoltà di Filosofi a alcuni dei più illustri pensatori e scienziati che il nostro Paese possa vantare.
Tra questi, a fianco dei docenti di ruolo come Michele Di Francesco, Roberta De Monticelli, Massimo Donà, Roberto Mordacci, Matteo Motterlini, Andrea Tagliapietra, si possono ricordare numerosi professori a contratto che hanno offerto e offrono il loro autorevole contributo, tra cui Salvatore Natoli, Umberto Curi, Enzo Bianchi, Guido Rossi, Luigi Luca e Francesco Cavalli-Sforza, Giacomo Rizzolatti, Andrea Moro, il compianto Enrico Bellone, Giorgio Cosmacini, Achille Varzi, Andrea Bonomi, Andrea Bottani, Massimo Piattelli Palmarini.
Per questi motivi, noi professori a contratto della Facoltà di Filosofi a vogliamo esprimere la nostra soddisfazione nel lavorare con tanti illustri colleghi e tanti giovani preparati e impegnati in un progetto così signifi cativo di didattica e ricerca, e siamo certi che le diffi coltà ben note sorte nella complessa e, per tanti versi, straordinaria impresa del San Raffaele, troveranno presto defi nitiva soluzione.
Il bilancio di questo primo decennio appare infatti decisamente positivo, e rappresenta il miglior viatico per guardare al futuro. Anche in un periodo diffi cile per il nostro Paese e per il complesso ospedaliero del San Raffaele, la Facoltà di Filosofi a non ha cessato di progettare e innovare. A maggior ragione ora che la situazione problematica attraversata dall’Ospedale San Raffaele si è risolta positivamente con l’arrivo di una nuova Proprietà interessata al suo rilancio e dopo che l’Università Vita-Salute è uscita indenne dalle diffi coltà, grazie ai suoi bilanci in ordine e all’impegno di tutto il corpo docente, ci sembra importante testimoniare come la tensione verso l’eccellenza che ha accompagnato fi n dalla nascita la Facoltà di Filosofi a sia tuttora viva e salda, e caratterizzi il suo presente e il suo futuro.
 Massimo Cacciari, Edoardo Boncinelli, Elena Loewenthal,
Alberto Martinelli, Angelo Panebianco, Giovanni Reale,
Marco Santambrogio, Emanuele Severino, Vincenzo Vitiello.
Massimo Cacciari, Edoardo Boncinelli, Elena Loewenthal,
Alberto Martinelli, Angelo Panebianco, Giovanni Reale,
Marco Santambrogio, Emanuele Severino, Vincenzo Vitiello.*
 Dieci anni
di Filosofia al
San Raffaele
Università Vita-Salute San Raffaele
Dieci anni
di Filosofia al
San Raffaele
Università Vita-Salute San Raffaele
 Facoltà di Filosofia
Facoltà di Filosofia -
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- LA FEDELTA’ ALLA COSTITUZIONE E IL TRADIMENTO IN POLITICA, IN AMORE E NON SOLO. L’arte di tradire bene (di Maurizio Viroli)7 luglio 2012, di Federico La Sala
L’arte di tradire bene
di Maurizio Viroli (il Fatto. 07.07.2012)
Anche Marco Travaglio deve riconoscerlo: Berlusconi aveva tutte le ragioni di bollare come traditori i parlamentari del Pdl che gli avevano votato contro nel novembre 2011. È vero che i parlamentari, afferma la Costituzione, rappresentano la Nazione, e dunque non sono tenuti a obbedire a nessuno, neppure al capo del loro partito, ma quando si parla di Pdl la Costituzione, si sa, conta poco.
Nella nostra tradizione culturale e religiosa, le parole ‘traditore’ e ‘tradimento’ hanno una forte accezione negativa. Evocano la figura di Giuda Iscariota, figlio di Simone, e le parole del Vangelo: “In verità vi dico che uno di voi mi tradirà” (Giovanni 13, 21 - 22), e la terribile immagine di Giuda, Bruto e Cassio nella bocca di Lucifero, il primo e più grande dei traditori, nel fondo dell’Inferno dantesco. Ma, avverte Giulio Giorello nel suo libro Il tradimento in politica, in amore e non solo (Longanesi, 2012), a guardare più attentamente, i traditori sono, nella realtà e nelle rappresentazioni artistiche e letterarie, figure ambigue che suscitano giudizi contrastanti.
LO STESSO GIUDA, ha sostenuto ad esempio Christian Petr nell’Elogio del traditore, vendette Cristo perché si rese conto che non intendeva affatto essere liberatore del suo popolo su questa terra. Non fu né avido né ingrato, ma chiaroveggente (p. 8). E soprattutto non va dimenticato che doveva essere uomo di forte coscienza morale se, sopraffatto dal rimorso, prima cercò di restituire i 30 sicli e poi si suicidò.
Anche i due eroi repubblicani Cassio e Bruto che Dante punisce come traditori, anche se ebbero il coraggio di uccidere Cesare nella vana speranza di fare rinascere la libertà repubblicana in Roma, non sono esenti da ombre. Plutarco ci dice, nelle sue celebri Vite parallele, che Cassio odiava Cesare più per motivi personali che politici. Leopardi, nel canto dedicato a Bruto minore, fa pronunciare all’eroe repubblicano parole sconsolate sulla vanità della virtù: “O misera virtù, eri solo una parola, e io ti adoravo come una cosa reale. Ma tu eri schiava del caso”.
È vero, sono ancora parole di Christian Petr, che “non proviamo mai pietà per il traditore” (p. 135), ma è del pari vero che nella politica rivoluzionaria più estrema, quella di Stalin, il tradimento è opera necessaria e lodevole. I testi che Giorello ha scelto sono eloquenti e sconvolgenti: “Non abbiamo esitato a tradire i nostri amici e a scendere a compromessi con i nostri nemici, per salvare il partito”, dichiara uno degli inquisitori di Stalin nel romanzo di Arthur Koestler Buio a mezzogiorno. La giustificazione del tradimento nella politica rivoluzionaria è inconfutabile, se si condividono le premesse, e se si accetta che esista un’istituzione umana, il partito e il suo segretario generale, che dispongono di una conoscenza assoluta della verità e quindi non possono errare: “Ma il parto del Mondo nuovo ha le sue doglie: per eliminare la politica ci vuole la politica, per eliminare la guerra ci vuole la guerra, per eliminare il tradimento ci vuole il tradimento” (p. 118).
Dai suoi esempi e dalle sue narrazioni, Giorello ricava un interrogativo generale sul significato e sul valore da attribuire al tradimento. Non soltanto nei casi delle grandi e tragiche figure dei traditori, ma “persino nel caso delle dispute del nostro Paese non è miope ridurre il ‘tradimento’ di questi o quegli a mero effetto di qualche più o meno sordida passione? ”. Quali che siano le motivazioni di chi tradisce, il tradimento rivela una valenza storica che supera le speranze e i timori degli attori che sono coinvolti. Tradire, rileva Giorello, è facile, ma tradire bene è difficile.
COSA VUOL dire tradire bene? A mio giudizio Giorello dà al termine ‘bene’ e all’idea del tradimento ben eseguito una connotazione estetica, più che svolgere un’argomentazione politica o morale. Nei casi più elaborati, scrive infatti, il tradimento assume “le caratteristiche di una vera e propria opera d’arte”. (pp. 8-9) Vero, ma si può aggiungere che l’opera d’arte degli antifascisti come Carlo Rosselli che si proclamarono orgogliosamente traditori della patria fascista perché si sentivano fedeli a un’altra idea di patria è altra cosa dall’opera d’arte del militante antifascista che diventa spia dell’OVRA e che con un raffinato gioco di simulazioni e dissimulazioni riesce a fare catturare dal regime i migliori dirigenti di ‘Giustizia e Libertà’.
Giorello rifugge dalle indicazioni morali e dagli ammonimenti politici e osserva che la condanna o l’apprezzamento per le varie figure di tradimento narrate nel libro sono scelte inevitabilmente personali. Posizione lodevole, che mette l’autore al riparo dall’accusa infamante, in Italia, di essere un moralista che aspira, addirittura, a educare.
Ma per aiutare il lettore e la lettrice a formulare il proprio giudizio meditato poteva forse arricchire il saggio con qualche considerazione sulla differenza, ad esempio, fra tradire un uomo e tradire un principio e invitare, con delicatezza, si capisce, a riflettere sul fatto che uno dei valori più alti che il cittadino dovrebbe fare proprio, per la nostra Costituzione, è proprio la fedeltà, vale a dire l’esatto contrario del tradimento.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- Il tradimento degli intellettuali (di Paolo Flores d’Arcais).24 giugno 2012, di Federico La Sala
Il tradimento degli intellettuali
di Paolo Flores d’Arcais (il Fatto, 24.06.2012)
Il Presidente della Repubblica è il custode della Costituzione o il garante dei partiti? Rappresenta la Nazione, cioè tutti i cittadini, o le nomenklature politiche e altri privilegiati di establishment? L’inquilino del Quirinale e i maggiorenti della Casta sembrano oggi avvinti in una sinergia di reciproco sostegno, a preventiva de-legittimazione e anatema per qualsiasi critica che possa mettere in discussione l’uno o gli altri.
Il Capo dello Stato aveva scelto la data del 25 aprile per un attacco in piena regola al movimento di Beppe Grillo, tacciato di qualunquismo. Il Presidente di tutti gli italiani può attaccare una forza politica, a meno che questa non metta a repentaglio la Costituzione repubblicana e il suo fondamento antifascista? Non avendo avuto nulla da ridire né sul partito di Berlusconi né sulla Lega, Napolitano si è inibito il diritto, istituzionale, politico e innanzitutto morale, di criticare chicchessia.
I partiti si sono schierati perinde ac cadaver in sua difesa, quando ha ostracizzato la “campagna di insinuazioni e sospetti costruita sul nulla”, cioè la pubblicazione delle intercettazioni del suo consigliere giuridico colto in aumma aumma con il testimone (poi indagato) Mancino per intralciare il lavoro di una Procura. Nessun reato? Probabilmente. Mentre in America per intralcio alla giustizia, crimine di particolare gravità, si finisce subito in galera. Si può in buona fede negare che vi sia stata almeno “immoral suasion”?
Schifani ha tuonato che “chi attacca Napolitano attacca il Paese”, con Bersani allineato “toto corde”, mentre Casini haaccusato “schegge della magistratura che forse hanno obiettivi intimidatori”, benché sappia benissim o che non solo il Procuratore antimafia Grasso, ma perfino il Procuratore generale della Cassazione Esposito (che a Mancino dice: “Io sono chiaramente a sua disposizione”) hanno dovuto riconoscere come ineccepibile il comportamento di Ingroia e Di Matteo. Chi ha obiettivi intimidatori?
Pesa, fin qui, il silenzio di tanti giuristi e intellettuali da sempre impegnati nella difesa della democrazia. La loro perplessità non ha nulla di risibile, anzi. Sono angosciati per una crisi gravissima, che potrebbe precipitare al buio e nel buio. Pensano che “lasciar correre” sul Presidente sia il male minore. Hannah Arendt diceva che i mali minori preparano il male peggiore. Napolitano ha spinto pubblicamente perché il Parlamento approvi la legge bavaglio. Siete davvero sicuri che sia questo il male minore?
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA E A PENSARE BENE "DIO", "IO" E "L’ITALIA" ---- OBBEDIENZA CIECA18 aprile 2012, di Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA E A PENSARE BENE "DIO", "IO" E "L’ITALIA", CHI PIU’ CHI MENO, TUTTI VIVONO DENTRO LA PIU’ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA E POLITICA ITALIANA, NEL REGNO DI "FORZA ITALIA"!!! Un’inchiesta e una mappa di Francesco Tomatis - a cura di Federico La Sala13 aprile 2012, di PaoloPerò, per favore, mettere Sini tra gli analitici/pragmatisti (perché poi assieme questi due orientamenti? Peirce non è certo un "analitico" nel senso che si usa oggi) è un po’ ridicolo. Sini è stato allievo di Barié e Paci, si è laurato su Hegel, si è occupato, tra i tanti, di Platone, Spinoza, Nietzsche, Husserl, Heidegger. E sì, anche di pragmatismo. Ma se proprio c’è da usare una categoria, Sini è un teoreta duro e puro. Bisogna essere rigorosi, se si vogliono fare certe liste (un po’ ridicole, secondo me). Paolo
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- FOTO DI GRUPPO ALL’INTERNO DELLA CAVERNA "ITALIA".14 aprile 2012, di Federico La Sala
FOTO DI GRUPPO ALL’INTERNO DELLA CAVERNA "ITALIA" ....
Caro Paolo
"la mappa sfiziosa dei nostri «maîtres à penser»" è qui utilizzata - al di là di quanto tu gentilmente precisi (relativamente a un’’etichetta sbagliata ) - come la metafora di una "foto di gruppo" fatta nella Caverna "Forza Italia" (1994-2012)!!!
Poi a proposito di "teoresi dura e pura" (e cecità costituzionale teologico-politica), se hai tempo, leggi un po’ le note intorno al tema dell’obbedienza cieca. Il discorso vale ancor di più per i grandi filosofi raccolti nella "foto di gruppo: cum grano salis, ovviamente!!!
Grazie per il tuo intevento e
M. saluti,
Federico La Sala
-
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- DOPO VENTANNI DI CANTATE A "FORZA ITALIA", UN MINIMO DI SOBRIETA’ E UN POCO DI "NUOVO REALISMO" PER SALIRE SUI "MONTI".10 aprile 2012
 AL DI LA’ DI HEGEL, HEIDEGGER, E RATZINGER. IL PROBLEMA DELL’UNO E LA VIA DEI "TRE SOLI". A scuola di Dante, Bruno, Galilei, e Kant
AL DI LA’ DI HEGEL, HEIDEGGER, E RATZINGER. IL PROBLEMA DELL’UNO E LA VIA DEI "TRE SOLI". A scuola di Dante, Bruno, Galilei, e Kant NUOVO REALISMO: CONOSCERE SE STESSI E CHIARISI LE IDEE, PER CARITA’! Una nota - di Federico La Sala
NUOVO REALISMO: CONOSCERE SE STESSI E CHIARISI LE IDEE, PER CARITA’! Una nota - di Federico La Sala Per ben comunicare (anche solo con se stessi o con stesse!), come insegna Dante, ci vogliono TRE SOLI (la cosiddetta - impropriamente - teoria dei "due soli")!!!
Per ben comunicare (anche solo con se stessi o con stesse!), come insegna Dante, ci vogliono TRE SOLI (la cosiddetta - impropriamente - teoria dei "due soli")!!! -
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- A che cosa dovremmo essere pronti (di Carlo Sini)29 marzo 2012, di Federico La Sala
A che cosa dovremmo essere pronti
di Carlo Sini (l’Unità, 29.03.2012)
Il presidente del Consiglio ha avanzato l’ipotesi che il Paese non sia pronto: ma pronto a che? Evidentemente a una trasformazione del mondo del lavoro che inevitabilmente comporterebbe (e già comporta) sacrifici economici rilevanti e significative rinunce alla tutela sociale dei lavoratori.
Questo timore che non siamo pronti sembra suggerire l’idea che non saremmo capaci di adeguarci al futuro del mondo che cambia e ai benefici che ne potranno trarre i più lesti e i più dotati di spirito preveggente. Sarà così, ma vorrei osservare che lo sguardo rivolto a un futuro capace di condizionare in maniera drastica il presente non può andare disgiunto da una altrettanto lucida capacità di ricordare il passato. Solo la corretta interpretazione del passato ci aiuta a capire davvero il presente e a valutare il futuro al quale si vorrebbe che gli italiani fossero pronti.
Tra le cose innumerevoli accadute nel passato vorrei ricordare per esempio che il capitalismo europeo realizza da sempre le sue fortune in modi molto squilibrati rispetto alle restanti popolazioni della terra. Diversi anni fa l’economista Hosea Jaffe calcolò, sulla base di dati ufficiali, che il mondo industrializzato produceva il 40% della ricchezza complessiva e ne ricavava un profitto pari al 60%, sottraendo al cosiddetto terzo mondo un 20% di ricchezza da esso prodotto: una cifra enorme. Il nostro benessere era dunque, e ancora è, superiore ai nostri meriti globali e se ora le cose si complicano non c’è da stupire.
Ma il punto è che, come dice la canzone, chi ha avuto ha avuto e chi ha dato ha dato: non è però il caso di scordare che pochi affaristi, poche istituzioni e governi hanno tratto enorme beneficio dallo squilibrio, mentre le masse dei lavoratori ne sono state rese partecipi in modi non solo parziali e inconsapevoli, ma soprattutto non durevoli. Il medesimo del resto accade ora: coloro che hanno provocato l’attuale crisi, persone e istituzioni, non pagano affatto il conto: lo pagano tutti gli altri. Il che significa che la mentalità che guida la produzione mondiale continuerà a frequentare logiche perverse. Dovremo pertanto aspettarci altre crisi, altri sacrifici e un crescente divorzio tra circolazione di ricchezza apparente, e comunque mostruosamente mal distribuita, e possibilità concrete di fruizione di valori d’uso da parte del mondo dei lavoratori e della società civile nel suo complesso.
Un’altra cosa da non dimenticare in Italia è poi il fallimento della istruzione media e superiore. In molti campi, nel dopoguerra, siamo stati all’avanguardia o addirittura i primi, ma abbiamo perso via via le nostre brillanti posizioni. Non abbiamo saputo proteggere e incrementate le iniziative vincenti, così come abbiamo lasciato che i migliori ingegni emigrassero altrove, sino alla situazione attuale: i giovani, se possono, guardano fuori d’Italia per trovare una formazione efficace, accompagnata dal sostegno delle istituzioni, e per sperare in un futuro lavorativo confortevole. Il fatto è che al benessere complessivo della società, così come esso è cresciuto in Italia dal dopoguerra a oggi, non si è accompagnato un progresso equivalente della cultura generale. Abili consumatori, non siamo stati altrettanto virtuosi nel far crescere le nostre tradizionali capacità intellettuali e morali, lasciando spazio a sacche diffuse di ignoranza e di brutale degrado.
Comprendiamo bene che il nostro attuale governo non ha certo la possibilità di risolvere gli squilibri mondiali e nemmeno quelli del nostro Paese: può solo tamponare una situazione drammatica. Né sembra in grado di avviare una seria riforma della formazione e degli studi: unica possibilità, per il mondo industrializzato, di mantenere una funzione guida nel mondo. Questa triste situazione davvero non giustifica poco credibili lezioni di futuro. Se continua così, l’unica cosa alla quale gli italiani dovranno essere pronti è a veder scivolare il Paese sempre più in basso, senza possibilità di rimedio.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- "Le Nuvole". Aristofane, la nostalgia di Atene forte e austera (di Franco Manzoni)28 marzo 2012, di Federico La Sala
Aristofane, la nostalgia di Atene forte e austera
Amaro sarcasmo sul declino dei costumi
di Franco Manzoni (Corriere della Sera, 28.03.2012)
Come educare le nuove generazioni? In che modo risolvere l’eterno conflitto tra padri e figli, vecchi e giovani, tradizione e novità? Aristofane cercò di rispondere a questo dilemma con la commedia Nuvole (titolo originale Nephélai). La maiuscola del titolo, senza articolo, pare necessaria proprio a indicare le nuove divinità, che l’autore afferma inventate dal personaggio Socrate. È uno dei testi più noti della drammaturgia antica e risulta di un’attualità sconvolgente ancora oggi. Con un preciso messaggio sul ruolo dell’intellettuale e su come controllare il futuro della società attraverso l’educazione dei giovani. Inoltre assume anche un andamento «noir», che inaspettatamente presenta un finale violento, quasi tragico: la distruzione del Pensatoio, dove un ridicolo Socrate viene rappresentato istruire i propri discepoli appeso dentro una cesta di vimini.
Sotto il terrore delle innovazioni, Aristofane reagisce indicando un solo responsabile. In questo far coincidere nel 423 a. C. la figura di Socrate con quella del corruttore supremo, l’autore testimonia quale poteva essere l’opinione dell’uomo della strada. Ma questa commedia riuscì a influenzare i giudici nel condannare a morte Socrate 24 anni dopo? Probabilmente no. Semmai le Nuvole sono una testimonianza di uno stato d’animo diffuso, visto che lo stesso Socrate fu bersaglio di altri comici, come Eupoli, Amipsia e Callia.
In ogni caso la parodia aristofanea non passò inosservata, tanto che nel 399 a. C. Socrate la ricordò nel celebre processo da lui subìto: «Avete potuto vedere voi stessi nella commedia di Aristofane, dove un tal Socrate si dondolava e diceva di vagare per l’aria e cianciava di tante altre sciocchezze, di cui io m’intendo poco o nulla» (Platone, Apologia di Socrate, 19c). Il testo della commedia, che ci è pervenuto, è costituito da due parti. In aggiunta all’opera quasi complessiva del 423 a. C., Aristofane riscrisse la parabasi, la parte della commedia in cui il poeta era uso esporre il proprio pensiero per mezzo del coro, nella quale rintracciamo il proposito dell’autore di riproporre in gara per l’anno 419-418 ancora le Nuvole.
Nel 423 a. C. durante le Dionisie (a fine marzo), la giuria assegnò infatti il primo posto alla Damigiana di Cratino e il secondo al Conno (ossia la Vulva) di Amipsia, relegando Nuvole all’ultimo. È possibile ipotizzare che sul giudizio abbiano influito le pressioni politiche di Alcibiade, favorevole a Socrate e deciso a difenderne l’onore. La sconfitta fu cocente per Aristofane, tanto che l’anno successivo, nella parabasi delle Vespe, l’autore affermò che la sua precedente opera non era stata capita. Ne deduciamo che non si sia conservato il testo integrale della rappresentazione del 423, ma un collage pronto per una nuova messinscena. Le fonti attestano comunque che le Nuvole non furono mai rappresentate una seconda volta.
Protagonista della commedia è Strepsiade (il nome letteralmente significa «colui che distorce» la giustizia), un contadino inurbato che da un infelice matrimonio ha avuto il figlio Fidippide, uno scialacquatore. Morso dai debiti del figlio, il vecchio medita di mandarlo a farsi istruire da Socrate. Ma il giovane rifiuta. Allora Strepsiade decide di andarci lui stesso. Ma alla fine Socrate scaccia il contadino. L’anziano costringe il figlio ad andare a scuola dal Maestro. I risultati? Quando arrivano i creditori il giovane, attraverso l’uso di sofismi, li allontana, deridendoli e insultandoli.
Strepsiade è felice. Ma il disastro è nell’aria. Piange per le percosse del figlio. Fidippide sostiene che è nel suo diritto battere il padre come Strepsiade picchiava lui bambino per educarlo. Il giovane dimostra al papà che lo ha pestato solo per il suo bene, a maggior ragione poiché «i vecchi sono due volte bambini». A Strepsiade non resta che la vendetta: con l’aiuto dei servi incomincia ad abbattere a colpi d’ascia il Pensatoio e, salito sul tetto, vi appicca il fuoco. Così, fra le grida di Socrate e dei suoi discepoli, il Pensatoio viene distrutto.
In piena guerra del Peloponneso, l’attenzione di Aristofane si rivolge ad un argomento fonte di accese discussioni. L’antica educazione, che aveva formato i soldati di Maratona, era messa in crisi dalla paidèia sofistica e dal pessimismo pacifista. Il conservatore Aristofane rimpiangeva l’Atene di un tempo, celebrata dai greci come creatrice di grandi ideali, la città che aveva liberato l’Ellade intera dall’invasione dei barbari persiani.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- STATUTO DEI LAVORATORI: L’ART. 18 E LA PAZZA IDEA CHE "IL LAVORO RENDE LIBERI" ("Arbeit macht frei") DALLA COSTITUZIONE.23 marzo 2012, di Federico La Sala
 MERCATO DEL LAVORO, ART. 18, E REPUBBLICA FONDATA SUL LAVORO
MERCATO DEL LAVORO, ART. 18, E REPUBBLICA FONDATA SUL LAVORO
 L’ART. 18 E E LA PAZZA IDEA CHE "IL LAVORO RENDE LIBERI" ("Arbeit macht frei") DALLA COSTITUZIONE. La riforma del Governo Monti è più dura di quella Berusconi del 2002. Materiali sul tema
L’ART. 18 E E LA PAZZA IDEA CHE "IL LAVORO RENDE LIBERI" ("Arbeit macht frei") DALLA COSTITUZIONE. La riforma del Governo Monti è più dura di quella Berusconi del 2002. Materiali sul tema
 LA CGIL PROCLAMA LO SCIOPERO GENERALE. Mai nella storia della Cgil erano state indette 16 ore di sciopero. Il via libera a larghissima maggioranza ( 95 favorevoli, 2 contrari, 13 astenuti) del Direttivo di Corso Italia conferma la straordinarietà della situazione.
LA CGIL PROCLAMA LO SCIOPERO GENERALE. Mai nella storia della Cgil erano state indette 16 ore di sciopero. Il via libera a larghissima maggioranza ( 95 favorevoli, 2 contrari, 13 astenuti) del Direttivo di Corso Italia conferma la straordinarietà della situazione.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- molte ragioni per non prendere sul serio il manifesto «per una costituente della cultura» lanciato dal giornale di Confindustria (di Tomaso Montanari - Un dubbio manifesto: la cultura della Domenica)10 marzo 2012, di Federico La Sala
Un dubbio manifesto: la cultura della Domenica
di Tomaso Montanari (Il Fatto Quotidiano, 09.03.2012)
Ci sarebbero molte ragioni per non prendere sul serio il manifesto «per una costituente della cultura» lanciato dal giornale di Confindustria: prima tra tutte «una determinata opacità, oscillante tra convenzionale deferenza per le competenze umanistiche e indifferenza o fatale estraneità al tema» (così, perfettamente, Michele Dantini sul “Manifesto”).
Tra gli stessi firmatari molti confessano (ovviamente in privato) di trovare il testo irrilevante («Me l’hanno chiesto, son cose che passano come acqua»), mentre altri raccontano di esser stati inclusi a loro insaputa, o addirittura dopo un diniego. Ma la solenne adesione dei ministri Passera, Profumo e Ornaghi e il successo che il “manifesto” sta riscuotendo nel paese più conformista del mondo, significano che esso ha interpretato nel modo più rassicurante un’opinione diffusa. Al famoso “la cultura non si mangia” di Giulio Tremonti, il giornale di Confindustria oppone un discorso che vuol essere «strettamente economico»: “la cultura si mangia eccome”.
Niente di nuovo: è questo il dogma fondante del trentennale pensiero unico sul patrimonio culturale, per cui «le risorse non si avranno mai semplicemente sulla base del valore etico-estetico della conservazione, [ma] solo nella misura in cui il bene culturale viene concepito come convenienza economica» (Gianni De Michelis, 1985). Su questo dogma si fonda l’industria culturale che sta trasformando il patrimonio storico e artistico della nazione italiana in una disneyland che forma non cittadini consapevoli, ma spettatori passivi e clienti fedeli.
È a questo dogma che dobbiamo la privatizzazione progressiva delle città storiche (Venezia su tutte), e un’economia dei beni culturali che si riduce al parassitario drenaggio di risorse pubbliche in tasche private, socializzando le perdite (l’usura materiale e morale dei pochi “capolavori” redditizi) e privatizzando gli utili, senza creare posti di lavoro, ma sfruttando un vasto precariato intellettuale.
È grazie a questo dogma che prosperano le strapotenti società di servizi museali, che lavorano grazie a un opaco sistema di concessioni e che stanno fagocitando antiche istituzioni culturali e cambiando in senso commerciale la stessa politica del Ministero per i Beni culturali.
È in omaggio a questo dogma che la storia dell’arte è mutata da disciplina umanistica in “scienza dei beni culturali” (e infine in una sorta di escort intellettuale), e che le terze pagine dei quotidiani si sono convertite in inserzioni a pagamento. Appare, insomma, realizzata la profezia di Bernard Berenson, che già nel 1941 intravide un mondo «retto da biologi ed economisti dai quali non verrebbe tollerata attività o vita alcuna che non collaborasse a un fine strettamente biologico ed economico». Di tutto ciò il manifesto confindustriale non si occupa, preferendo affermare genericamente che «la cultura e la ricerca innescano l’innovazione, e dunque creano occupazione, producono progresso e sviluppo».
Naturalmente questo è vero, ed è giusto dire che anche dal punto di vista strettamente economico investire in cultura “paga”. Ma il pericolo principale di questa stagione è la debolezza dello Stato e la voracità con cui i privati declinano la valorizzazione (leggi monetizzazione) del patrimonio. E che il manifesto del Sole non intenda per nulla smarcarsi da questa linea dominante, induce a crederlo il nome del primo firmatario, quell’Andrea Carandini che è un guru del rapporto pubblico-privato nei beni culturali, visto che è riuscito ad autoerogarsi fondi pubblici per restaurare il castello di famiglia chiuso al pubblico.
Né tranquillizza il fatto che il “manifesto” fosse accompagnato da un articolo di fondo del sottosegretario Roberto Cecchi, artefice del più smaccato trionfo degli interessi privati in seno al Mibac (dal caso clamoroso del finto Michelangelo alla svendita del Colosseo a Diego della Valle). Induce, infine, a più di un dubbio la sede stessa in cui il “manifesto” è comparso, quel Domenicale che da anni pratica (almeno nelle pagine di storia dell’arte) un elegante cedimento delle ragioni culturali a quelle economiche, con lo sdoganamento di “eventi” impresentabili e di “scoperte” improbabili.
Un meccanismo approdato a una filiera completa: 24 Ore Cultura produce le mostre (per esempio l’ennesima su Artemisia Gentileschi), Motta (dello stesso gruppo) ne stampa i cataloghi, il «Domenicale» le vende con una pubblicità martellante. Dopo il pirotecnico lancio iniziale, il «Domenicale» ha dedicato ad Artemisia altre quattro pagine, con foto di Piero Chiambretti che visita la mostra e con l’immancabile sfruttamento intensivo della condizione femminile di Artemisia (stupro incluso). Così, una mostra mediocre che si apre con la commercialissima trovata di un letto sfatto che si tinge del rosso della verginità violata di Artemisia si trova a essere la mostra più pompata della storia italiana recente.
È forse pensando a questo tipo di esiti che il “manifesto” consiglia l’«acquisizione di pratiche creative, e non solo lo studio della storia dell’arte»? Più che un programma per il futuro, la santificazione del presente. La risposta vera a quanti affermano che la “cultura non si mangia” è, innanzitutto, che «non di solo pane vive l’uomo»: la nostra civiltà non si è mai basata solo su un «discorso strettamente economico», e la cultura è una delle pochissime possibilità di orientare le nostre vite fuori del dominio del mercato e del denaro. Il punto non è «niente cultura, niente sviluppo», ma: lo sviluppo non ci servirà a nulla, se non rimaniamo esseri umani. Perché è a questo che serve la cultura.
Sarebbe stato assai meglio se, invece del fumoso e conformista “manifesto” confindustriale, gli intellettuali italiani avessero sottoscritto una dichiarazione antiretorica e pragmatica come quella pronunciata, qualche anno fa, da uno dei massimi storici dell’arte del Novecento, Ernst Gombrich: «Se crediamo in un’istruzione per l’umanità, allora dobbiamo rivedere le nostre priorità e occuparci di quei giovani che, oltre a giovarsene personalmente, possono far progredire le discipline umanistiche e le scienze, le quali dovranno vivere più a lungo di noi se vogliamo che la nostra civiltà si tramandi. Sarebbe pura follia dare per scontata una cosa simile. Si sa che le civiltà muoiono.
Coloro che tengono i cordoni della borsa amano ripetere che “chi paga il pifferaio sceglie la musica”. Non dimentichiamo che in una società tutta volta alla tecnica non c’è posto per i pifferai, e che quando chiederanno musica si scontreranno con un silenzio ottuso. E se i pifferai spariscono, può darsi che non li risentiremo mai».
-
> «Niente cultura, niente sviluppo», il manifesto lanciato dal giornale di Confindustria, un modello pericoloso (di Tomaso Montanari - Sponsor o mecenate. Ricordando Masaccio)11 marzo 2012, di Federico La Sala
Sponsor o mecenate. Ricordando Masaccio
di Tomaso Montanari (Corriere fiorentino, 10.03.2012
L’occasione era ghiotta: uno degli uomini più ricchi della città voleva costruirsi una cappella gentilizia, e aveva messo gli occhi sulla loro chiesa. Francesco Feroni era un nuovo ricco: da buon fiorentino aveva scelto di fare il mercante, e l’aveva fatto con grandissima determinazione (perfino troppa: non disdegnava neanche il mercato degli schiavi), trasferendosi ad Amsterdam e mettendo insieme una fortuna.
Nel 1673 si era sentito abbastanza ricco da poter tornare in patria, dove il denaro gli ottenne il titolo marchionale e un ruolo di spicco sulla scena pubblica del granducato di Toscana, che, sotto Cosimo III, si avviava ad un quieto, irreversibile tramonto. In questa storia di successo non poteva mancare una cappella familiare, un luogo in teoria dedicato al riposo eterno, ma in verità assai più utile per rafforzare, legittimare e perpetuare il potere e il prestigio terreni.
Il neomarchese Feroni era così lanciato verso questo traguardo che aveva pensato di comprarsi nientemeno che la Cappella Brancacci, pronto a distruggere gli affreschi di Masaccio, Masolino, e Filippino Lippi.
Da parte loro, i frati non avevano obiezioni: «per acquistarsi un benefattore di quella portata - racconta un loro confratello vissuto qualche decennio più tardi - nulla sarìa calso più non veder quei mostacci, con zimarre e mantelloni all’antica abbigliati».
Mentre già si pensava di demolire la culla della pittura rinascimentale, sorse spontanea quella che le fonti definiscono «una lega di difesa contro il minacciato vandalismo», una sorta di Italia Nostra del tardo Seicento, che coinvolse l’Accademia del Disegno e quindi convinse la granduchessa madre Vittoria della Rovere a dare «ordine espresso che non si toccassero tali dipinture». Il Feroni provò a replicare che egli «avria fatte segare con ogni diligenza le mura del primo ordine, ove sono le pitture più insigni, e gli artefici assicuravano di poterne venire a capo senza il minimo detrimento di cotali pitture». «Ma tant’è - continua il frate - la granduchessa, ferma qual salidissima colonna nel suo impegno, non volle a verun patto che le mura e le pitture della cappella fosser toccate». A quel punto, il Feroni e il suo denaro si arresero: e noi oggi abbiamo ancora la Cappella Brancacci.
Lo schema ci dovrebbe esser familiare: un patrimonio da mettere a reddito; uno sponsor disinvolto che è disposto a pagare, ma vuol piegare quel patrimonio al proprio interesse; un’opinione pubblica che insorge; il potere politico che, alla fine, interviene e salva il patrimonio. Ma oggi, oltre trecento anni dopo i fatti del Carmine, il rischio è che l’opinione pubblica non trovi più un potere politico disposto a difendere i beni comuni.
La retorica dominante sottomette, infatti, la cultura all’economia: il manifesto del giornale di Confindustria propone il fortunatissimo slogan «Niente cultura, niente sviluppo».
È un modello pericoloso, perché trasmette l’idea che la cultura non sia un fine in sé, ma un mezzo (nobile quanto si vuole) per raggiungere un fine più alto: in ultima analisi, quello del denaro. E se il patrimonio storico e artistico diventa un mezzo, le conseguenze non possono che essere quelle tratte dal marchese Feroni.
Si parla molto di ‘nuovo mecenatismo’: ma il mecenate è un donatore che non chiede nulla in cambio del proprio dono, se non la gloria e la riconoscenza della comunità. E di questi mecenati non c’è una grande abbondanza, come dimostra l’imbarazzante fuggi-fuggi di fronte alla proposta di adottare il restauro di un monumento, lodevolmente lanciata dal Comune di Firenze. Ci sono piuttosto degli sponsor, che calcolano con grande attenzione il ricavo economico dei loro investimenti sul patrimonio: e per ottenere un ricavo adeguato in tempi commercialmente utili, il bene (che sia il Colosseo, il Fondaco dei Tedeschi a Venezia o il Salone dei Cinquecento a Firenze) rischia di essere compromesso, moralmente o perfino materialmente.
La presidente di ConfCultura Patrizia Asproni si è detta scandalizzata che «oggi i privati che gestiscono i servizi museali, e quindi la loro valorizzazione economica, non controllano l’orario di apertura del museo, né il prezzo del biglietto. È evidente che queste restrizioni impediscono fortemente la libertà e la capacità di fare impresa e la conseguente messa a reddito del bene».
La signora Asproni sembra non ricordare che, secondo l’articolo nove della nostra Costituzione, il fine di quel bene non è la produzione di reddito (privato), ma di cultura (pubblica). Ed è per questo che è lo Stato, e non un privato in cerca di lucro, a dover mantenere quel patrimonio: e lo potrebbe fare destinando ad esso anche solo il 5% dell’attuale evasione fiscale. Perché è certo giusto ricordare che la cultura è una condizione essenziale per lo sviluppo: ma è fatale dimenticare che lo scopo vero della cultura è quello di sottrarre almeno una minima parte della nostra vita al dominio del denaro e del mercato, e di farci così rimanere esseri umani. Quando non lo saremo più, nessuno sviluppo economico potrà salvarci.
-
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- EGONOMIA. Così l’individuo senza società ha cancellato la politica (di Franco Cassano)1 marzo 2012, di Federico La Sala
Egonomia
Così l’individuo senza società ha cancellato la politica
- Ci sono sempre meno luoghi di formazione delle domande collettive e sempre più interessi privati
 Perché le democrazie stanno perdendo forza? E come possono ritrovarla?
Perché le democrazie stanno perdendo forza? E come possono ritrovarla?
 Ecco le riflessioni del sociologo che affronta il tema della necessità di superare l’idea che conti solo l’affermazione del singolo
Ecco le riflessioni del sociologo che affronta il tema della necessità di superare l’idea che conti solo l’affermazione del singolo
di Franco Cassano (la Repubblica, 01.03.2012)
Tutto è iniziato quando le conquiste degli anni Sessanta (diritti del lavoro, consumi di massa ed espansione dello stato sociale) hanno incrinato il compromesso tra capitalismo e democrazia nato in Occidente dopo la Seconda guerra mondiale. Lo stato nazionale, divenuto democratico, si rivela pericolosamente esposto alle pressioni provenienti dal basso: la massima "un uomo - un voto" ha una grammatica ugualitaria difficilmente compatibile con gli imperativi della redditività e del profitto. La controffensiva capitalistica che parte negli anni Settanta segue quindi una strategia nuova: essa non cerca lo scontro frontale, ma svuota la politica, ne ridimensiona drasticamente la sfera.
I flussi del capitale finanziario si sottraggono sempre più al controllo degli stati nazionali e, liberi da ogni vincolo, moltiplicano a dismisura la propria forza. La politica invece rimane ancorata alla vecchia casa dello stato nazionale, costretta a fronteggiare, con budget sempre più ridotti e contestati, le pressioni che vengono dai cittadini. Nel nuovo quadro dell’economia globalizzata il suo compito principale non è più quello di dirigere, ma di garantire un certo grado di coesione sociale; essa non può più coltivare disegni ambiziosi, ma solo rattoppare e tamponare. E’ allora che la politica e i suoi interpreti iniziano a perdere autorità e qualità: le loro "disinvolture" etiche, che le ideologie avevano permesso di riscattare e trasfigurare, non possono più nascondersi sotto la gonna di una grande giustificazione.
E questa politica degradata e improduttiva appare al senso comune sempre più solo come lo strumento attraverso cui una "casta" custodisce la propria auto-riproduzione. E’ una sorta di delitto perfetto: la decadenza della politica, che nasce soprattutto dal fatto che il grande capitale l’ha abbandonata al suo destino, viene tranquillamente imputata all’insaziabile appetito dei suoi protagonisti, mentre il potere vero gode della massima libertà di movimento e di tutte le franchigie.
Ma sarebbe profondamente sbagliato limitarsi ad osservare solo ciò che avviene nei piani alti della società, il conflitto tra le élites. Se la controffensiva liberista fosse rimasta nelle stanze del nuovo potere non sarebbe riuscita ad affermarsi, come poi è successo, e si sarebbe trovata di fronte ad una massa immensa di nemici. Invece essa ha sbaragliato l’avversario perché si è rivelata capace di produrre una forte e capillare egemonia. La grande narrazione che essa propone sa parlare anche al popolo, perché ha messo al centro dell’immaginario il tema dell’affermazione individuale, del successo: per realizzare i nostri sogni non abbiamo bisogno degli altri, ma solo di una grande fiducia in noi stessi. Il legame con gli altri può solo bloccarci, mentre, se saremo compiutamente individui, un intero mondo è a disposizione. Non è un caso che proprio negli anni Settanta questo mito conquisti il centro della scena: Rocky Balboa e Tony Manero sono i protagonisti di due film famosi, due favole popolari sul tema del successo e della redenzione individuale. Stallone e Travolta (testimonial perfetti in quanto figli di immigrati) diventano delle star perché i loro film parlano di eroi che provengono dai piani bassi della società. E anche se è vero che solo "uno su mille ce la fa", sono in mille a sognare di farcela specialmente quando le altre vie non sembrano praticabili.
E’ questa irruzione dell’individuo a completare dal basso quel ridimensionamento della politica a cui il grande capitale aveva dato inizio dall’alto. "La società non esiste, esistono solo gli individui", diceva la Thatcher, e l’unica mediazione possibile tra individui soli di fronte al proprio destino, è quella del mercato. Il primato del mercato tiene insieme i capitali senza confini e i sogni degli individui. E una società siffatta, che non vede più contraddizioni sociali, ma solo successi o sconfitte individuali, non sembra aver più bisogno della politica.
Dal Quarto Stato di Pellizza da Volpedo siamo passati alle solitudini di Hopper. I progetti e il cuore degli uomini sono trasmigrati fuori della politica. A quest’ultima spetta solo il compito di garantire la libertà di movimento degli individui e delle merci, e un grado minimo di ordine pubblico. La società civile non è più il luogo di formazione delle domande collettive, ma la trama degli interessi privati, non è l’agorà, ma il mercato.
Ma dopo tre decenni di egemonia incontrastata questa cura fondata sulla libertà dei capitali e dell’individuo inizia a mostrare la corda. La nostra società è attraversata da lacerazioni e disuguaglianze crescenti prodotte in gran parte dai giochi spericolati del capitale finanziario. Ma l’egemonia liberista inizia a logorarsi anche ai piani bassi, perché la carta dell’individualismo non riesce più a reggere il peso che le è stato scaricato addosso, a risalire il piano inclinato delle disuguaglianze crescenti. Certo, essa riesce ancora a tenere gli uomini lontani gli uni dagli altri, a impedire che riconoscano ciò che hanno in comune, ma remunera sempre di meno. Né sarà l’ideologia debole e ambigua della meritocrazia a riassestare l’edificio. Certo, essa può lubrificare i canali della mobilità sociale, ma si tratta di ben poca cosa se tanto commosso rigore serve solo a cooptare i migliori nelle aree più forti, mentre lascia cadere via con l’altra mano tutto il resto, le Grecie del mondo. Ma sono proprio le Grecie a smascherare il gioco, che si gioca solo fino a quando giova ai più forti. Se si avrà la forza di non lasciarle sole, potrebbero diventare l’inizio di un’altra storia.
Dal canto suo l’individuo, costretto a vivere in una costante precarietà ed incertezza, ha iniziato a sospettare di non essere più quello che ce la fa, ma uno dei novecentonovantanove. Anche per questo ogni tanto una politica diffusa sembra riaffacciarsi nella società: per macchie, per ondate che, pur disperdendosi, mostrano che le crepe dell’edificio in cui abitiamo si stanno allargando, anche se l’orchestra ha l’ordine di continuare a suonare. Eppure queste tensioni rifluiscono troppo spesso su se stesse, non riescono a decollare ed espandersi, a costruire una cornice teorica e pratica stabile per la politica, un nuovo paradigma di riferimento. E qui si torna a quanto si è detto all’inizio: fino a quando la politica si confronterà con le tensioni sociali rimanendo priva di ogni peso sulle grandi decisioni, non riuscirà a produrre soluzioni e finirà per avvitarsi nella spirale dello screditamento.
Se vuole ripartire la politica democratica deve far capire a tutti qual è il punto decisivo: essa deve tornare ad avere potere, costruire meccanismi di controllo sui movimenti del capitale finanziario, porre fine alla latitanza di quest’ultimo rispetto alle sofferenze di quel pianeta in cui si aggira come un uccello predatore. Essa deve mutare il proprio rapporto di forza con l’economia, ri-costruire un rapporto equilibrato tra capitalismo e democrazia, tra consumatori e cittadini, tra libertà ed uguaglianza, tra il presente e il futuro.
Si tratta di un passo tutt’altro che semplice: un paradigma in declino, si sa, continua ad avere influenza e ad essere popolare mentre quello in gestazione è visibile solo a pochi, che è facile scambiare per visionari. Ma la direzione di marcia è tracciata perché l’irresponsabilità del capitale finanziario è diventata indecente e la timidezza con cui essa viene affrontata dai governi del mondo è sempre meno accettabile. Ciò che appare innegabile è che confidare nella politica senza porre il problema del suo ricongiungimento con il potere è tempo gettato via. Chi esita e ha paura ricorda quella poesia di Brecht in cui gli abitanti di una casa in fiamme, invece di uscire si attardano a chiedere a Buddha che tempo fa fuori, se piove o tira vento. A costoro, risponde Buddha, non abbiamo niente da dire.
- Ci sono sempre meno luoghi di formazione delle domande collettive e sempre più interessi privati
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- Una costituente per la cultura25 febbraio 2012, di Federico La Sala
La “Costituente” per la cultura *
1 Una costituente per la cultura
Cultura e ricerca sono capisaldi della nostra Carta fondamentale. L’articolo 9 della Costituzione «promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione». Sono temi intrecciati tra loro. Perché ciò sia chiaro, il discorso deve farsi economico. Niente cultura, niente sviluppo. "Cultura" significa educazione, ricerca, conoscenza; "sviluppo" anche tutela del paesaggio.
2 Strategie di lungo periodo
Se vogliamo ritornare a crescere, se vogliamo ricominciare a costruire un’idea di cultura sopra le macerie che somigliano a quelle su cui è nato il risveglio dell’Italia nel dopoguerra, dobbiamo pensare a un’ottica di medio-lungo periodo in cui lo sviluppo passi obbligatoriamente per la valorizzazione delle culture, puntando sulla capacità di guidare il cambiamento. Cultura e ricerca innescano l’innovazione, e creano occupazione, producono progresso e sviluppo.
3 Cooperazione tra i ministeri
Oggi si impone un radicale cambiamento di marcia. Porre la reale funzione di sviluppo della cultura al centro delle scelte del Governo, significa che strategia e scelte operative devono essere condivise dal ministro dei Beni Culturali con quello dello Sviluppo, del Welfare, della Istruzione e ricerca, degli Esteri e con il premier. Il ministero dei Beni Culturali e del paesaggio dovrebbe agire in coordinazione con quelli dell’Ambiente e del Turismo.
4 L’arte a scuola e la cultura scientifica
L’azione pubblica contribuisca a radicare a tutti i livelli educativi, dalle elementari all’Università, lo studio dell’arte e della storia per rendere i giovani i custodi del nostro patrimonio, e per poter fare in modo che essi ne traggano alimento per il futuro. Per studio dell’arte si intende l’acquisizione di pratiche creative e non solo lo studio della storia dell’arte. Ciò non significa rinunciare alla cultura scientifica, ma anche assecondare la creatività.
5 Pubblico-privato, sgravi ed equità fiscale
Una cultura del merito deve attraversare tutte le fasi educative, formando i cittadini all’accettazione di regole per la valutazione di ricercatori e progetti di studio. La complementarità pubblico/privato, che implica l’intervento dei privati nella gestione del patrimonio pubblico, deve divenire cultura diffusa. Provvedimenti legislativi a sostegno dei privati vanno sostenuti con sgravi fiscali: queste misure presentano anche equità fiscale.
* Il Sole 24 Ore, 25 febbraio 2012
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- Una costituente per la cultura. Analfabetismo funzionale - Noi, analfabeti seduti su un tesoro (di Armando Massarenti)14 marzo 2012, di Federico La Sala
Noi, analfabeti seduti su un tesoro
di Armando Massarenti (Il Sole-24 ore/Domenica, 11 marzo 2012)
Due dati dovrebbero impressionarci come italiani, se vogliamo vederci (anzi, diciamo pure, venderci) come cittadini del mondo. Il primo è quello che riguarda la strepitosa immagine positiva che ancora siamo in grado di diffondere all’estero. Chiunque di noi si presenti come italiano in un qualunque ambiente di New York, Parigi, Tokyo, Pechino, Singapore, non riceverà che elogi e espressioni di ammirazione.
Perché? Perché nonostante tutto il nostro brand va fortissimo. E di che cosa è fatto questo brand? Vi sembrerà strano ma la parola che lo riassume è una sola: Cultura. Noi siamo il Paese della Cultura. Ovunque nel mondo. Nel mondo che conta e che si arricchisce. Lo dico con un’enfasi che non è la mia (e neppure l’uso disinvolto di parole del marketing come brand lo è, ma è per intendersi), perché non amo la retorica e per me cultura è anche tante altre cose assai più piccole (è anche ingegnosità minuta, fumetti, videogiochi, grafica, artigianato) e anche meno piccole ma in genere poco amate dagli umanisti: scienza, diritto, economia. Ma c’è poco da fare: è quello il brand che, quando siamo bravi, riusciamo a vendere, e dobbiamo andarne fieri. Anche nelle piccole cose: nel nostro design, nelle nostre automobili, nel nostro abbigliamento, nei nostri orologi di lusso, nei nostri mobili, in tutto il made in Italy c’è un riverbero della nostra gloriosissima storia, in un’immagine in cui lo straniero vede tutta la grandezza dell’antica Roma e del nostro Rinascimento, che condisce con i nostri musicisti, gli inventori dell’Opera lirica, i poeti, i grandi navigatori, i fondatori della scienza galileiana, cioè di quel metodo che è alla base del prodigioso progresso tecnico-scientifico degli ultimi quattro secoli in Europa e nel mondo. Ma di questo si parla nelle pagine centrali di questo numero, dove si può vedere bene, dati alla mano, che nei casi migliori la cultura «fattura», anche al nostro interno, nelle nostre regioni e province.
Passiamo dunque al secondo dato che dovrebbe impressionarci. Anzi, in questo caso, allarmarci. Noi italiani appariamo come primi ‐ primi assoluti! ‐ in una ben poco encomiabile lista. Tutto il mondo la può leggere e stupirsene. È pubblicata nella voce «functional illiteracy» di Wikipedia (la voce corrispondente «analfabetismo funzionale» non c’è nella versione italiana di Wikipedia, qualcuno la allestisca!), e dice che il 47 per cento degli italiani dai 14 ai 65 anni ha forti deficienze nella semplice comprensione di un testo. All’Italia seguono il Messico (43,2%), l’Irlanda (22,6%), Gran Bretagna (21,8), Usa (20), Belgio (18,4) giù giù (anzi su su) fino alla alfabetizzatissima Svezia (7,5%!).
Il 47 per cento di analfabeti vi sembra un’esagerazione? Prima di allarmarci potremmo provare a consolarci in due modi. Primo: obiettare che i dati della voce di Wikipedia si fermano al 2003. Magra consolazione. Il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco ci ha ricordato, nel suo recentissimo Investire in conoscenza e sul Sole 24 Ore-Domenica di due settimane fa, che negli anni successivi gli analfabeti funzionali sono saliti all’80%! E un allarme simile è confermato da uno dei nostri massimi linguisti, Tullio De Mauro. Anche la tv, dopo aver fortemente contribuito alla crescita e unificazione linguistica del Paese, ora sta assecondando il movimento opposto.
Secondo modo di consolarci: si tratta di «analfabetsimo funzionale» e non di analfabetismo tout court, dal quale siamo usciti con un grande sforzo collettivo con la ricostruzione del secondo dopoguerra. Magra, magrissima consolazione anche questa, alla quale si può rispondere con la famosa battuta di Eugenio Montale, che aveva già capito tutto: «Il rapporto tra l’alfabetismo e l’analfabetismo è costante, ma al giorno d’oggi gli analfabeti sanno leggere». Sanno leggere ’tecnicamente’, nel senso che per lo più riconoscono i caratteri, e sanno maldestramente far di conto. Peccato che nell’80 per cento dei casi non capiscano quello che leggono e non dispongano di quel minimo di attrezzatura intellettuale utile a orientarsi nel mondo. Non sono in grado per esempio di capire e compilare un modulo in cui vengano richieste non solo informazioni anagrafiche, ma anche riguardanti la propria posizione professionale, previdenziale o fiscale. E se nei paesi civili la media dei cittadini di questo tipo si assesta sul 20%, da noi le percentuali sono invertite!
Dove può andare il Paese più ricco di opere d’arte del mondo, che futuro può immaginare per il suoi giovani, per la qualità della vita, per riattivare quel «circolo virtuoso tra conoscenza, ricerca, arte, tutela e occupazione», se parte da questa miserevole dotazione di capitale umano?
Mettendo insieme le due immagini ‐ quella del brand e quella dell’analfabetismo ‐ viene da pensare al grande illuminista tedesco Ephraim Lessing, il quale suggellò il suo Grand Tour con una favola in cui i moderni italiani che si vantano di discendere dagli antichi romani vengono paragonati a vespe che uscendo dalla carogna di un cavallo esclamano: «Da quale nobile animale abbiamo tratto origine!». Quanto gli italiani sappiano diventare boriosi proprio in ragione della loro storia e al loro patrimonio lo ha poi ribadito un altro filosofo. «Il tratto principale del carattere nazionale degli Italiani - annotava Arthur Schopenhauer in un Taccuino del 1823 - è un’assoluta spudoratezza. Che consiste in questo: da un lato non c’è nulla di cui non ci si ritenga all’altezza, e quindi si è presuntuosi e arroganti; dall’altro non c’è nulla di cui ci si ritenga abbastanza esperti, e quindi si è codardi. Chi ha pudore, invece, è troppo timido per alcune cose, troppo orgoglioso per altre. L’Italiano non è né l’uno né l’altro, bensì, a seconda delle circostanze, o è pavido o è borioso».
Oggi dobbiamo avere l’umiltà di ricominciare da capo, di ripensare i saperi e le competenze, e acquisire piuttosto la consapevolezza di essere degli analfabeti seduti sopra un tesoro, sempre di più privi di quegli strumenti di base che ci permetterebbero non solo di capire, ma anche di far fruttare i formidabili talenti che ci circondano.
Smettiamola, con il nostro turismo d’accatto, di presentarci come degli straccioni che a un certo punto scoprono di avere il Colosseo (oggi usato come una specie di rotatoria per le automobili) e cercano di mungerlo il più possibile, senza aggiungerci nulla in termini di innovazione, intelligenza, conoscenza, capitale umano. Totò che vende la fontana di Trevi a un turista americano è un’altra immagine appropriata, e ancora attuale. Ci fa ancora ridere. Ridiamoci pure sopra. Ma allarmiamoci anche, perché Totò ci sta dicendo ancora la verità. Abbiamo capito che quell’opera ha un valore inestimabile, ma ne capiamo sempre meno il significato, mentre è proprio questo che gli altri Paesi civili ed emergenti comprendono e apprezzano, e spesso sfruttano economicamente, con maggiore lungimiranza, al nostro posto.
Ecco allora il vero senso di emergenza che il nostro Manifesto per la cultura vuole imprimere ai decisori pubblici attuali, e al Governo intero, che non possono sottrarsi a questa enorme responsabilità storica solo perché da trent’anni i loro predecessori lo hanno fatto. Il senso dell’urgenza sta in quei dati agghiaccianti, in quel misero 20% di italiani (8 milioni circa) che dispone di strumenti di lettura e scrittura minimi indispensabili. Siamo in gravissimo ritardo nel quadro internazionale e nell’ambito di una società globalizzata cosiddetta della «conoscenza». Se poi aggiungiamo i dati relativi ai ragazzi di 15-16 anni dei famosi test Pisa c’è da allarmarsi ancora di più.
Dunque prima ancora che dalla Cultura, partiamo dalle sue basi, dall’istruzione, e ripensiamola nei termini dell’unico possibile investimento per il nostro futuro dopo la crisi. Prendiamo il coraggio ‐ e i dati ‐ a due mani e diamoci da fare. Io sono certo, con la maggior parte di voi, che impegnandoci un po’ possiamo tranquillamente dimostrare che Lessing e Schopenhauer avevano torto.
-
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- Il made in Italy della filosofia. Se per capire la politica tutti leggono i nostri libri (di Roberto Esposito)24 febbraio 2012, di Federico La Sala
Il made in Italy della filosofia
Se per capire la politica tutti leggono i nostri libri
- Antologie, convegni, traduzioni: ecco perché oggi i pensatori italiani vengono studiati e citati dagli Usa all’Australia Il paradosso è che proprio ora quando tutto sembra in mano a tecnici ed economisti vengono ascoltati gli intellettuali che affrontano questi temi
di Roberto Esposito (la Repubblica, 24.02.2012)
Può apparire paradossale che mentre i filosofi italiani vengono invitati a scrivere in inglese dagli organi di valutazione accademica, la più aggiornata cultura filosofica americana da qualche anno parla italiano. Il fenomeno è sotto gli occhi di tutti. Non passa mese che in America non escano traduzioni, monografie e fascicoli di rivista dedicati alla Italian Theory, mentre si celebrano a ripetizione convegni su di essa, come recentemente alla Università di Cornell (The Common in Contemporary Italian Thought) e del Massachussets (Italian Social Theory), per non parlare di quello a New York sul New Realism. Dopo la pubblicazione del volume collettaneo Italian Difference (Melbourne 2009), della rivista Angelaki (Routledge 2011) su Italian Thought Today, degli Annali di Italianistica 2012 di Chapel Hill su Italian Critical Theory, dell’annata 2012 di Law, Culture and the Humanities, consacrata al pensiero italiano, è in uscita un altro fascicolo di "Diacritics" - la stessa rivista che negli anni Ottanta ha lanciato Derrida e i decostruzionisti francesi - sempre sulla Italian Theory. Quando anche sulla copertina di Foreign Affairs è apparso il volto di Croce (ne ha parlato su queste pagine Angelo Aquaro) - in corrispondenza con la pubblicazione del libro di B. e R. Copenhaver From Kant to Croce. Modern Philosphy in Italy (University of Toronto Press) - non è rimasto che prendere atto della cosa. Può piacere o meno, ma mentre si lamenta ritualmente l’arretratezza dei nostri studi, i filosofi italiani sfondano in America - non tanto nei dipartimenti di filosofia, ancora dominati dalla linea analitica, ma nell’ambito degli studi politici e sociali, dell’arte e della letteratura, postcoloniali e di genere.
Come si spiega questa svolta che muta radicalmente il panorama, cui fino a qualche anno fa eravamo assuefatti, di un Paese culturalmente emarginato? Cosa cercano, e cosa trovano, gli americani - ma il fenomeno è in rapida diffusione dovunque, dal Giappone al Brasile, dall’Australia alla Corea - nell’Italian Theory? Per rispondere a questa domanda è necessario innanzitutto richiamare il carattere non nazionale - ed anzi tendenzialmente antinazionale - del pensiero italiano. Fin da sempre - dalla stagione rinascimentale - la filosofia italiana ha guardato oltre i propri confini, irradiandosi all’esterno e contaminandosi con altre tradizioni. Ciò è dovuto innanzitutto all’assenza, per secoli, di uno Stato nazionale. Naturalmente questo elemento di extraterritorialità è stato spesso visto come una forma di ritardo storico rispetto ad altri, più precoci, contesti nazionali. Ma, al contempo, ha liberato il nostro pensiero da vincoli politici ed istituzionali che hanno condizionato altre filosofie. In Italia è mancato un pensiero dello Stato come quello di Hobbes o di Hegel - ma proprio perciò la politica è stata colta, da Machiavelli fino a oggi, nella sua energia sorgiva e nella sua forza creativa.
Allorché la globalizzazione ha ridimensionato pesantemente il rilievo degli Stati nazionali, una filosofia come quella italiana, fin da sempre orientata a pensare la politica prima e oltre lo Stato, si è trovata in una condizione migliore per afferrare le dinamiche contemporanee. Anche a prescindere da una valutazione di merito, un libro come Impero di Negri e Hardt ha questo sguardo globale, una capacità sintetica di cogliere la situazione del tempo che travolge le (a volte giuste) cautele analitiche, spostando di colpo lo scenario filosofico-politico. Se in Impero gli americani hanno riconosciuto, a ragione o a torto, il profilo espansivo dell’età di Clinton, in Stato di eccezione di Agamben hanno trovato quello, inquietante, dell’epoca di Bush.
A questo primo elemento ne va subito aggiunto un altro, anch’esso radicato nella nostra tradizione - vale a dire la tendenza a rompere gli steccati disciplinari con una inventività semantica assente in altre culture, irrigidite in ambiti specialistici senza contatto reciproco. Il successo mondiale di Umberto Eco, filosofo, semiologo, romanziere va interpretato anche in questa chiave transdisciplinare. Ciò vale, altrimenti, pure per il cosiddetto "pensiero debole", esportato fuori Italia soprattutto da Gianni Vattimo, capace di oltrepassare gli steccati dell’Accademia in direzioni molteplici che vanno dall’estetica a una certa teologia secolare, passando per gli studi queer e di genere. Come del resto è accaduto al femminismo italiano, conosciuto ed apprezzato in America soprattutto per i lavori di Adriana Cavarero. E l’attenzione per il Nuovo Realismo, di cui è in uscita da Laterza il "Manifesto" di Maurizio Ferraris, si inquadra all’interno dello stesso fenomeno. Ciò si accompagna all’interesse che nell’ultimo quindicennio ha investito l’interpretazione italiana della biopolitica. Teorizzata da Michel Foucault alla metà degli anni Settanta, questa categoria, rimasta in latenza per circa un ventennio, ha dovuto aspettare alcune interpretazioni italiane per conoscere una fortuna internazionale senza precedenti.
Alla sua origine, e con tutte le riserve che si possono legittimamente avanzare nei suoi confronti, vi è una singolare attitudine a coniugare uno sguardo radicale sull’attualità con paradigmi di portata generale, a partire da quelli di vita biologica e di natura umana nel loro rapporto ambivalente con il potere. Ancora una volta questo passaggio teoretico ha risposto a un mutamento profondo nella esperienza contemporanea, vale a dire alla rottura, ormai consumata, delle paratie che a lungo hanno separato scienze umane e scienze naturali, teoria e prassi, logica e storia. Se ci si riflette, il concetto di biopolitica è stato forse il primo a saldare, nel suo stesso nome, una frattura che ha percorso l’intero sapere occidentale.
Ma c’è ancora un punto da mettere in risalto, che riguarda il rapporto tra sapere e potere. Il pensiero italiano, fin da sempre, ha avuto una relazione tesa e agitata col potere, politico ed ecclesiastico. Machiavelli, come già Dante, è stato esiliato, Bruno bruciato, Galileo processato, Campanella imprigionato. Ma ancora nel Novecento, Croce si è opposto al regime, mentre Gramsci e Gentile, ai lati opposti della stessa barricata, hanno dato la vita per la propria filosofia. Ciò spiega che proprio nella fase forse più opaca della nostra recente storia politica, la filosofia italiana abbia prodotto alcuni dei suoi frutti migliori. Quello italiano, più che del potere, è un pensiero della resistenza. Non a caso uno dei filoni su cui oggi si concentra la curiosità degli scholars americani è quello operaista, originato dal volume Operai e capitale di Mario Tronti. Naturalmente ciò che in tale linea di pensiero ancora coinvolge non è la strategia per una classe operaia scomparsa in quanto tale, o profondamente mutata, da tempo. Quella che vi cercano gli studenti americani, ma anche i movimenti di protesta che riempiono le piazze di mezzo mondo, è una teoria della soggettività politica orientata al conflitto.
In un mondo sempre più diviso tra poveri e ricchi e sempre più bloccato nelle griglie dell’economia finanziaria, la filosofia italiana insegna da cinquecento anni che l’ordine non esclude il conflitto e che anzi solo quest’ultimo, se trattenuto nei confini della politica, può conferire ad essa la vitalità che sembra aver smarrito. Del resto già altre volte è accaduto di verificare una singolare asimmetria tra prassi politica effettiva e pensiero sulla politica: proprio quando, come nell’Italia di questi tempi, la politica sembra tacere, sovrastata dall’intreccio di tecnica ed economia, la filosofia politica sembra ritrovare, anche per reazione, uno slancio creativo che in altri momenti le manca.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- Non sapevamo chi siamo, e adesso? (di Enrico Pozzi)20 febbraio 2012, di Federico La Sala
Non sapevamo chi siamo, e adesso?
 La scomparsa del «capo» e l’«italianità» perduta. In un libro ebook sette studiosi si confrontano sul tema urgente dell’identità nazionale
e sui cambiamenti profondi del nostro Paese, la crisi e la forza dell’Italia
La scomparsa del «capo» e l’«italianità» perduta. In un libro ebook sette studiosi si confrontano sul tema urgente dell’identità nazionale
e sui cambiamenti profondi del nostro Paese, la crisi e la forza dell’Italia Orfani di un «patriarca» che ha dato mille facce al Sistema Paese
Orfani di un «patriarca» che ha dato mille facce al Sistema Paese
 La sfida. Uscire dall’eternità magica e entrare nella storia, collettivamente
La sfida. Uscire dall’eternità magica e entrare nella storia, collettivamente-***Viaggio in Italia. Alla ricerca dell’identità perduta, Aa.Vv. , A cura di Giulia Cogoli e Vittorio Meloni pagine 144
- Il volume da oggi scaricabile gratuitamente
- Oggi si presenta «Viaggio in Italia. Alla ricerca dell’identità perduta» (perFiducia, Intesa Sanpaolo), un libro che raccoglie le riflessioni di Aime, Dalla Zuanna, De Biase, Diamanti, Natoli, Pozzi e Zoja: sette studiosi si confrontano sull’identità degli italiani, i cambiamenti profondi del nostro paese, la crisi e la forza dell’Italia dei nostri giorni. Scarcabile gratis su www.perfiducia.com
 di Enrico Pozzi, psicologo (l’Unità, 20.02.2012)
di Enrico Pozzi, psicologo (l’Unità, 20.02.2012)Esistono due problemi diversi collegati all’identità. Il primo è il paradosso costitutivo dell’identità quando essa si applica ad attori dinamici, e soprattutto a soggetti viventi. Il secondo è: cosa sta avvenendo alla identità italiana in questo momento e quale rapporto intercorre tra le difficoltà identitarie percepite dai soggetti collettivi e individuali nel nostro paese e la crisi della leadership carismatica che stiamo vivendo? (...)
Dalla fine degli anni Ottanta, per una serie di motivi, la società italiana è entrata in una crisi anomica accentuata, in una perdita crescente di elementi vitali della sua coesione sociale che hanno prodotto un’angoscia talvolta evidente in alcuni segnali statistici, talvolta più incerta e sfuggente. Il nostro sistema sociale è entrato in un panico anomico, prima strisciante poi esplosivo, che si è tradotto in una domanda altrettanto panica di coesione magica del Sistema Paese.
Qui il richiamo è a Max Weber: l’anelito al ripristino della coesione si è espresso in una domanda diffusa di leadership carismatica. Le pagine straordinarie di Weber sul carisma e sul potere carismatico stanno in parti diverse del postumo Economia e società. Occorre leggerle tutte per capire la ricchezza multidimensionale del tipo ideale che propone. Un aspetto le accomuna: la indifferenza di Weber per la dimensione psicologica. Salvo che in un punto: caratteristica del capo carismatico è il possedere qualità straordinarie, ma come mai la gente pensa che un determinato individuo abbia effettivamente delle qualità straordinarie?
Questa frasetta pone il problema cruciale del consenso al carisma. La principale risposta è da ricercare, secondo me, nel panico anomico, e nella sofferenza psichica che l’anomia grave genera nell’io e nella identità dei membri di un gruppo sociale (nazione, organizzazione, famiglia ecc.).
Ma cosa c’entra il carisma con la coesione sociale? In che senso può agire come una «cura» per l’anomia? Osserviamo il frontespizio della prima edizione del Leviatano di Hobbes. Si tratta di una straordinaria visualizzazione della funzione coesiva della leadership carismatica o del corpo del sovrano.
Riportando questa immagine al momento in cui è stato scritto il testo una guerra civie, il massimo dell’anomia e dell’homo homini lupus -, abbiamo il Re a mezzobusto nella pienezza dei suoi regalia (spada, globo ecc.) collocato sullo sfondo di un paesaggio che condensa il suo regno fisico. Ma il corpo de Re è fatto dalle teste dei suoi sudditi. Corpo metonimico, al tempo stesso individuale e collettivo, che contiene nel suo Body Natural il suo Body Politic, secondo il modello classico di Ernst Kantorowicz.
Nel corpo fisico/ politico del Re, necessariamente tutt’uno come ogni corpo vivente, si ricompone magicamente il corpo lacerato del sociale. Nella persona mixta del sovrano si ripristina la coesione sociale perduta o minacciata, si placa l’angoscia anomica e trova risposta la domanda sociale di coesione del Noi, che è anche domanda di coesione dell’io e della identità individuale. In Hobbes sta la risposta alla domandina di Weber, cioè il modello di base del consenso al potere carismatico.
L’analisi freudiana del rapporto capo-folla traduce tutto questo in una dinamica direttamente psicologica. Nella sua ipotesi, il capo diventa il modello interiorizzato comune a ciascuno dei membri del gruppo: nella folla, ognuno si mette dentro, come parte della propria identità, il pezzetto di immagine di capo che è conforme ai suoi bisogni, aspettative o terrori. Lo stesso individuo il Capo è uno, nessuno e centomila, e raccoglie in sé quei seguaci che, ciascuno a proprio modo, si rispecchiano in lui. Il Capo come collante coesivo psichico del Noi, denominatore comune condiviso dagli individui del gruppo che lo riconosce come capo.
Il Berlusconi trionfante l’imprenditore, il presidente operaio, lo sportivo, il cabarettista, il ricco, Priapo, il presunto vincitore del Certamen capitolinum, il guaritore ecc. tra il ’94 e il ’96 si è presentato come le mille facce del Sistema Paese in cui ognuno poteva riconoscersi, identificarsi e sentirsi compreso, ma nel senso fisico: compreso nel corpo del sovrano, nel corpo metaforico di Berlusconi. Quel Berlusconi ha rappresentato la risposta transitoriamente adeguata, da un lato a un panico sociale duraturo, alla domanda angosciata di una coesione sociale antianomica; dall’altro, a una domanda di semplificazione cognitiva di una realtà percepita come eccessivamente complessa.
Il capo carismatico come un riduttore di complessità: invece del caos locale e globale, il riordinamento del mondo nella semplicità cognitivamente accessibile di un individuo. Una persona come mediatore e traduttore delle troppe cose che accadono intorno a me, la complessità riassunta e sussunta in lui, in una dimensione personale che io pover’uomo sento di poter ancora capire. Ma da anni ormai il Body Natural del leader carismatico sta chiedendo il conto al suo Body Politic. Le virtù straordinarie del carisma non trovano più nelle cose e nella sua persona quella continua prova di verità e verifica alla quale il capo carismatico è tenuto.
La funzione coesiva si è progressivamente indebolita, la terapia antinomica di tipo magico che il capo carismatico incarnava perde efficacia, il panico anomico collettivo e individuale riprende lentamente, poi sempre più in fretta, il sopravvento.
Non senza contraccolpi, il consenso si sfalda, e l’angoscia sociale cerca nuove risposte: talvolta, poveramente, nuovi capi; talaltra, in modo più maturo ma pur sempre incerto, nuove procedure e modalità di esercizio della sovranità.
Gabriel García Márquez ha scritto, con L’autunno del patriarca, una delle più potenti rappresentazioni narrative delle logiche, delle grandezze e delle molte miserie del potere carismatico in salsa sudamericana. Poi un giorno il dittatore muore, e c’è la chiusa bellissima del libro: ... perché noi sapevamo chi eravamo mentre lui restò senza saperlo per sempre col dolce sibilo della sua ernia di morto vecchio, troncato di netto dalla stangata della morte, (...) estraneo ai clamori delle folle frenetiche che scendevano nelle strade cantando gli inni di gaudio della notizia gaudiosa della sua morte ed estraneo per sempre alle musiche di liberazione e ai razzi di gioia e alle campane di giubilo che annunciarono al mondo la buona novella che il tempo incalcolabile dell’eternità era finalmente terminato.
La società italiana, in tutte le sue articolazioni, trova adesso davanti a sé l’opportunità di uscire dalla eternità magica del sole carismatico e di entrare di nuovo nella storia, nella collaborazione, nel compromesso, nel difficile negoziato tra le diversità: in altri termini, nella realtà e nel progetto di una identità collettiva tornata a essere dinamica, forse. La stessa opportunità si offre parallelamente alle identità individuali, sottratte allo «io sono come sono» della paura di vivere. Nessuno può dirsi certo che questa doppia opportunità venga colta, e che non si preferisca invece tornare nei porti tranquilli e mortiferi della regressione, del pensiero paranoico e delle aspettative magiche.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- TUTTI BERLUSCHINI.28 gennaio 2012, di Federico La Sala
E se fossimo tutti berluschini?
di Angelo d’Orsi (il Fatto. 28.01.2012)
Il primo era stato Alberto Asor Rosa, in articolo dell’estate 2008 a paragonare il berlusconismo al fascismo, spingendosi ad affermare che il primo era peggiore del secondo, suscitando non poche polemiche. Poi la battaglia quotidiana prevalse, contro il Cavaliere di Arcore, che andava collezionando epiteti di varia efficacia, a cominciare da quello di “Caimano”, con la variante, inventata da Marco Travaglio, ben nota ai lettori del Fatto Quotidiano, di “Cainano”. E cresceva intanto la produzione di libri sul fenomeno Berlusconi, sul suo “partito di plastica”, che qualcuno infine cominciò a prendere sul serio, esaminandone gli effetti pervasivi sulla vita pubblica, grazie a un sistema di cricche affaristiche, con contorno di escort, di cui gran collezionista risultava essere proprio il capo del governo, capitano di una nave tanto pronto a cianciare e farsi fotografare, quanto inetto al comando, assai più occupato a gestire affari e affarucci privati - d’ogni genere - che ad affrontare i problemi di un’Italia ormai piegata su se stessa, “Concordia” senza timoniere, ferita nella sua etica pubblica, più ancora che nella sua capacità produttiva.
Oggi scaffali di biblioteche e librerie sono debordanti di biografie e di studi sull’inventore di Forza Italia: memorabile quello del compianto Giuseppe Fiori (Il venditore, Garzanti 1995) ; ma da tempo si sono aggiunte analisi del fenomeno, anche in previsione di una uscita di scena dell’uomo, non foss’altro che per ragioni biologiche.
E LE ANALISI si sono infittite, anche sul piano giornalistico, dopo le “dimissioni coatte” dello scorso novembre. Analisi che interpretano forse una paura: che “quella roba lì” sia destinata a rimanere anche dopo la definitiva scomparsa del personaggio che l’ha messa in piedi? Dopo un memorabile fascicolo doppio di MicroMega - intitolato senza infingimenti, “Berlusconismo e fascismo” - sono arrivati altri libri, articoli, dibattiti. Oltre alla paura degli uni e al pessimismo di altri, tra le motivazioni, probabilmente, c’è un’attitudine scaramantica: ma è emerso altresì il bisogno di studiare il fenomeno berlusconiano, prescindendo dal capo, mettendone in luce i complessi aspetti politici, sociali, mediatici e di costume.
Si tratta di capire, insomma, se tanti di noi non siano stati contagiati dal virus, diventandone “portatori sani”, fino al suo manifestarsi in forma violenta. Una sorta di Invasione degli ultracorpi, l’angoscioso romanzo di Jack Finney, portato al cinema da Don Siegel. Ma allora - metà anni Cinquanta - si era in piena Guerra fredda e l’allusione possibile era ai comunisti che “sembrano come noi”, ma come noi non sono, e si impadroniscono un po’ alla volta delle nostre menti. Qui si tratta di capire se il berlusconismo, giunto apparentemente a fine corsa, abbia permeato di sé i nostri modi, abitudini, pratiche.
Se lo chiedono, per esempio, due libretti recenti, uno di un sociologo, Rino Genovese (Che cos’è il berlusconismo, Manifestolibri), l’altro, ancor più smilzo e sbrigativo, di un militante anarchico, Piero Flecchia (Da Mussolini a Berlusconi, Mimesis). Gli autori vanno a caccia delle costanti, delle manifestazioni che in un passato più o meno lungo hanno non solo preparato, ma evidenziato il berlusconismo.
Al di là insomma della traiettoria personale di Silvio Berlusconi, si tenta di mettere a fuoco il quesito: la sua affermazione prima, la durata poi, sono dovute, oltre che a capacità personali e incapacità dei suoi avversari (inevitabili le bordate, peraltro ormai inevitabilmente e giustamente divenute moneta corrente, contro una sinistra rinunciataria, debole, spesso connivente), e a specifiche cause storiche, anche a “precondizioni” antropologiche? E dietro affiora l’altro interrogativo: il berlusconismo - fusione di populismo, leaderismo, familismo, affarismo, immoralismo, antipoliticismo - sarebbe stato possibile senza Berlusconi?
Genovese risponde di sì: si tratta di un processo di “deformazione della democrazia” (che però ha risvolti sovranazionali) che può essere caratterizzata così: un fenomeno politico che vede lobby economico-finanziarie che non si accontentano di esercitare pressioni politiche, ma mirano (e con Berlusconi da noi giungono) alla conquista diretta del potere, in tal modo svuotando nella pratica il sistema democratico che rimane più o meno intatto nella sua forma esteriore.
UNA SORTA di parassitismo della democrazia, scaturito dal più generale fenomeno di “ibridazione del moderno”, la coesistenza sempre più problematica di modi, tempi, culture tipici della modernità (o addirittura postmodernità), e forme sconcertanti di arcaismo. In tale quadro, se il berlusconismo diventa paradigmatico a livello almeno europeo, la figura di Berlusconi non è essenziale, anche se, aggiungo, ha fornito all’Italia un primato sulla scena forse mondiale, con un’overdose di volgarità sconcertante, ma con peculiarità che a mio avviso non possono essere svalutate. E soprattutto, non va accolto il pessimismo totale di chi ritiene (come Genovese) che l’Italia sia ormai inguaribile. Oggi che il pifferaio sembra ritornato nel cono d’ombra da cui era balzato fuori un ventennio fa, il quesito deve essere: come facciamo non solo a impedire che torni a istupidire gli italiani, ma a risanare il corpo e l’anima dell’Italia dal morbo berlusconiano? Ma su questi due punti non bastano le analisi: sono necessarie le azioni.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- UN MANIFESTO: L’UNIVERSITÀ CHE VOGLIAMO Un appello di docenti e ricercatori universitari (promotori due storici: Piero Bevilacqua e Angelo d’Orsi)24 gennaio 2012, di Federico La Sala
Un manifesto: L’università che vogliamo
- In un mondo in cui si tenta di ridurre l saperi a meri strumenti della produzione di merci, un appello di docenti e ricercatori perché l’università sia la fucina dei futuri possibili
L’UNIVERSITÀ CHE VOGLIAMO Un appello di docenti e ricercatori universitari al ministro Profumo e al Governo Monti *
L’Università italiana sopravvive, difficoltosamente, in una condizione di disagio e di crescente emarginazione che ha pochi termini di confronto nella storia recente. Essa ha visto fortemente ridotte le risorse economiche per il suo funzionamento, molto prima che si manifestasse la crisi mondiale e malgrado le modeste dotazioni di partenza rispetto agli altri Paesi industrializzati. Tutti i saperi umanistici e buona parte delle scienze sociali sono da tempo sfavoriti, a beneficio di discipline che si immaginano più direttamente utili alla crescita economica, o genericamente al “Mercato”. Si tratta di una tendenza in atto da anni che ci accomuna all’Europa e a larga parte del mondo. A tutti gli insegnamenti viene richiesto di fornire un sapere utile, trasformabile in valore di mercato, altrimenti sono ritenuti economicamente non sostenibili.
Perciò oggi si sta scatenando negli atenei la definizione dei “criteri di valutazione”, al fine di misurare la “produttività” scientifica degli studiosi, come si misura una qualsivoglia quantità calcolabile. Anche per questo, le Università europee sono sotto l’assedio quotidiano di un flusso continuo di disposizioni normative, che soffocano i docenti in pratiche quotidiane di interpretazioni e applicazioni quasi sempre di breve durata. Sempre minore è il tempo per gli studi e la ricerca, mentre la vita quotidiana di chi vive nelle Facoltà - docenti, studenti, personale amministrativo - è letteralmente soffocata da compiti organizzativi interni mutevoli, spesso di difficile comprensione, quasi sempre pleonastici.
Noi crediamo che questo modello di Università europea, avviato con il cosiddetto “processo di Bologna” abbia rivelato il suo totale fallimento. Il numero dei laureati non è aumentato, le percentuali degli abbandoni nei primi anni sono rimaste pressoché identiche, diminuiscono le immatricolazioni, si fa sempre più ristretta l’autonomia universitaria, i saperi impartiti sono sempre più frammentati e tra di loro divisi, tecnicizzati, mai riconnessi a un progetto culturale, a un modello di società. Tutto ciò riguarda non solo il nesso saperi/mercato, ma anche il modello sociale, come è evidente alla luce dell’innalzamento delle tasse d’iscrizione, delle politiche di numero chiuso e della scelta di segmentare, alla luce di politiche classiste, il sistema universitario nazionale facendosi schermo del mito dell’eccellenza.
Al fondo di questo fallimento c’è una esperienza storica recente che illumina sinistramente l’intero quadro europeo. È quello che possiamo chiamare il grandioso scacco americano. Gli USA, elaboratori del modello che l’UE ha voluto tardivamente imitare, sono il Paese che in assoluto ha investito di più nella formazione universitaria e nella ricerca, finalizzate ad accrescere la potenza economica. Ma a dispetto dell’immenso fiume di risorse e la finalizzazione spasmodica delle scienze alla produzione di brevetti e scoperte strumentali, i risultati sono stati irrisori. La grande ondata di nuovi posti di lavoro qualificati non si è verificata. Anzi, gli investimenti nel sapere hanno accompagnato un fenomeno dirompente: la distruzione della middle class. Per concludere con una apoteosi: gli USA, che hanno visto trionfare negli ultimi decenni nuove tecnoscienze come l’informatica e la genetica, hanno trascinato il mondo nella più grave crisi economico-finanziaria degli ultimi 80 anni.
Questa lezione storica ci dice che il sapere tecnoscientifico, da sé, interamente finalizzato alla crescita economica e senza un progetto equo e solidale di società, privo della luce della cultura critica, è destinato a fallire. Inseguire gli USA su questa strada è aberrante. La crisi in cui versa il mondo rivela l’erroneità irrimediabile di una strategia da cui bisogna uscire al più presto.
Per tale ragione, i firmatari del presente Manifesto indicano i punti programmatici cui dovrebbe ispirarsi un progetto di università che avvii la fuoriuscita dal modello liberistico di un’Europa ormai sull’orlo del collasso. Occorre al più presto abolire il fallimentare sistema del 3+2 dall’organizzazione degli studi e ripristinare i precedenti Corsi di Laurea, prevedendo lauree brevi per le Facoltà che vogliono organizzarli.
Occorre abolire i crediti (i famigerati CFU) come criteri di valutazione degli esami. Il fatto che essi siano utilizzati anche nel resto d’Europa è una buona ragione per incominciare a scardinare il misero economicismo che è stato iniettato anche negli atenei del Vecchio Continente.
Occorre ripensare i criteri di valutazione che riguardano i saperi umanistici. Noi crediamo giusto che l’Università resti pubblica, sostenuta da risorse pubbliche. Una condizione che implica anche un controllo - certamente mediato, ma serio, non propagandistico - del buon uso delle risorse provenienti dal contributo fiscale di tutti i cittadini. Ma tale controllo deve riguardare soprattutto i Consigli di Amministrazione degli Atenei, che devono diventare assolutamente trasparenti, con adeguata pubblicità, nelle loro scelte e nei loro bilanci.
L’organo di autogoverno degli Atenei sul piano didattico e della ricerca non può essere comunque il CdA, ma il Senato Accademico, democraticamente eletto, in modo da rappresentare equamente tutte le discipline e tutte le figure di coloro che nell’Università lavorano e studiano.
Occorre ripristinare la figura del ricercatore a tempo indeterminato abolita dalla legge Gelmini. Occorre immediatamente dar vita a un meccanismo di rapido reclutamento di nuovi ricercatori, con liste nazionali di idoneità, che tengano conto della produzione scientifica, dell’esperienza maturata nell’attività didattica, nell’attività gestionale, e nell’organizzazione culturale: le Facoltà dovranno poter scegliere all’interno di quelle liste e chiamare liberamente gli idonei.
Ma è necessario al più presto bandire concorsi per la docenza in tutte le Facoltà. I docenti (compresi i ricercatori) italiani sono i più vecchi d’Europa e i numerosi pensionamenti hanno sguarnito gravemente tante Facoltà. Oggi si piangono ipocrite lacrime sulla disoccupazione della gioventù. Ma quale migliore occasione per il governo in carica di fornire risorse ai ricercatori senza lavoro, ai tanti giovani che passano dai dottorati ai master senza mai trovare un approdo, una istituzione in cui continuare studi e ricerche?
È infine necessario spendere le energie dei docenti per riorganizzare i saperi, il loro studio e la loro trasmissione nelle Università. La complessità sempre più interrelata del mondo vivente e della società ci impone un diverso modo di studiare, ci chiede un dialogo tra le discipline, una organizzazione degli studi che non esalti la solitaria eccellenza individuale, ma la cooperazione fra campi diversi della conoscenza, così come la società ci chiede la cura collettiva dei beni comuni.
 15 gennaio 2012
15 gennaio 2012 Promotori: Piero Bevilacqua (Storia contemporanea, Sapienza, Roma), Angelo d’Orsi (Storia del pensiero politico, Università di Torino).
Promotori: Piero Bevilacqua (Storia contemporanea, Sapienza, Roma), Angelo d’Orsi (Storia del pensiero politico, Università di Torino).
 Per aderire scrivere qui: universitachevogliamo@gmail.com
Per aderire scrivere qui: universitachevogliamo@gmail.com* http://eddyburg.it/article/articleview/18376/0/341/, 24.01.2012
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- Diritti delle coscienze e difesa delle libertà. Francesco Ruffini - Fedele a Dio mai al Fascio (di Pietro Ignazi).23 gennaio 2012, di Federico La Sala
Fedele a Dio mai al Fascio
di Piero Ignazi (Il sole 24 Ore, 22 gennaio 2012)
Francesco Ruffini, senatore del Regno e ministro della Pubblica istruzione fu uno dei maggiori studiosi di Diritto ecclesiastico, autore di un fondamentale saggio su La libertà religiosa in Italia. Storia dell’idea (1901). Ma soprattutto fu uno dei tredici professori universitari che non giurarono fedeltà al fascismo. Un Paese "senza" come il nostro fa bene a ricordarlo (con un’ampia "Introduzione" di Francesco Margiotta Broglio) e a riprendere le sue riflessioni affidate al «Corriere» di Luigi Albertini tra il 1912 e il 1925. Su quelle colonne e nelle lettere inviate all’amico editore, Ruffini commenta la faticosa tenuta delle libertà e della laicità dello Stato, insidiate dai fanatismi delle nuove ideologie e del vecchio clericalismo. L’incalzare del fascismo è visto sotto la lente particolare, e illuminante, dell’attacco alla libertà religiosa e allo Stato laico. Le leggi liberticide sulla stampa del 1924 introducono infatti il reato di vilipendio alla sola religione cattolica, erigendola esplicitamente a «religione di Stato».
In un articolo, il 17 luglio 1924, Ruffini individua nel discorso pronunciato pochi mesi prima da Giovanni Gentile, le premesse dell’attacco: «Uno Stato che non si interessa alla religione non è Stato; non è lo Stato che vuole essere lo Stato italiano ... In Italia se lo Stato è coscienza nazionale, coscienza dell’avvenire in funzione del passato, coscienza storica, esso è coscienza cattolica. Gli italiani perciò che vogliono essere italiani... conviene che si rivolgano alla loro religione». Da ciò Ruffini consegue che: «gli acattolici e gli agnostici sono posti fuori dalla Nazione e dal loro Stato». In sostanza, senza laicità non c’è libertà, solo tolleranza. Lo Stato laico è lo Stato di tutti. Lo Stato confessionale predilige alcuni ed emargina altri. Considerazioni tuttora valide?
È passato quasi un secolo da allora. Ripensando a quelle pagine coraggiose e fiere viene da chiedersi quanto siano diffusi i principi dello Stato laico, oggi. A questo interrogativo risponde una approfondita indagine sulla religione in Italia curata da Franco Garelli. Tra i tanti temi di questa interessantissima ricerca, vi è anche quello sui rapporti tra Stato e Chiesa e sul ruolo della Chiesa nello spazio pubblico nazionale.
Ruffini sarebbe rimasto amareggiato nel vedere che più di un terzo (38%) degli intervistati ritiene che lo Stato, pur rispettando tutte le confessioni, debba "valorizzare" quella in cui si identifica la maggioranza della popolazione. Per costoro lo Stato deve quindi farsi parte attiva per diffondere e sostenere le posizioni della Chiesa cattolica, dall’imposizione del crocefisso nei luoghi pubblici all’indottrinamento religioso nelle scuole, dal sostegno alle scuole private agli interventi legislativi in sintonia con le indicazioni della gerarchia. Per fortuna, però, la maggioranza ha un atteggiamento diverso, che oscilla dalla neutralità attiva, in un rapporto di collaborazione ma di separatezza con lo Stato, a quella passiva, in un rapporto di stretta separatezza. A questi si aggiunge un 20% che vuole «contenere la presenza pubblica delle religioni» affinché il vivere civile sia informato dai valori laici, da tutti condivisi.
Sarebbe comunque fuorviante pensare che i cattolici più ferventi siano quelli più tentati dall’integralismo e dal clericalismo. Tutt’altro: sono proprio i cattolici più assidui e convinti a volere una Chiesa "francescana" che rifiuti protezioni e vantaggi da parte dello Stato come, ad esempio, l’esenzione dell’Ici.
Il mondo cattolico è molto sfaccettato. E questa ricerca presenta i suoi diversi volti. Ad esempio, il rapporto degli italiani con la religione rivela che la quasi totalità degli italiani crede in Dio, ma ciascuno crede «a modo proprio», con modalità e riferimenti che a volte hanno ben poco a vedere con i fondamenti del cattolicesimo. Fino ad arrivare al paradosso dell’«appartenenza senza fede», cioè dell’adesione alla religione cattolica pur senza credere in Dio: un atteggiamento che coinvolge il 10% dei cattolici. Misteri della fede, è proprio il caso di dire. Del resto, se la ragione principale per cui gli italiani credono rimanda alla «pressione ambientale», al fatto di essere nati e cresciuti in un ambiente cattolico, la fede e i fattori spirituali non hanno quella centralità che dovrebbero avere: «le due dimensioni della fede a cui le chiese, e in particolare quella cattolica, hanno attribuito una importanza complementare» - il rapporto intimo e soggettivo con il sacro e il carattere veritativo della religione, cioè l’essere l’unica vera fede - non coinvolgono che 1/3 dei fedeli. Questa "debolezza" della fede riemerge quando si vanno a sondare le credenze fondamentali.
Qui «lo stato di confusione e di incertezza che regna nella mente di una parte di cattolici ... o l’attenzione distratta alle verità religiose» conferma la tendenza a una adesione selettiva, a una sorta di religione à la carte, che ciascuno si confeziona sulla base delle proprie sensibilità e motivazioni. Tra le varie incongruenze, una ha un valore particolare: gli italiani credono assai più nell’esistenza del paradiso (71%) che dell’inferno (57%). Questo dato illumina un tratto profondo dell’antropologia della nostra Nazione, quello che intreccia la fuga dalla responsabilità con la speranza ottimista-fatalista che le cose vadano bene. Anche nella religione ci affidiamo più alla speranza salvifica che al timore delle conseguenze delle nostre azioni. Quanti episodi della nostra storia nazionale possono essere letti sotto questa luce!
 Diritti delle coscienze e difesa delle libertà. Ruffini, Albertini e il «Corriere» 1912-1925, a cura
di Francesco Margiotta Broglio, Fondazione Corriere della Sera, Milano, pagg. 522, € 14,00;
Diritti delle coscienze e difesa delle libertà. Ruffini, Albertini e il «Corriere» 1912-1925, a cura
di Francesco Margiotta Broglio, Fondazione Corriere della Sera, Milano, pagg. 522, € 14,00; Franco Garelli, Religione all’italiana, il Mulino, Bologna, pagg. 254, € 17,00
Franco Garelli, Religione all’italiana, il Mulino, Bologna, pagg. 254, € 17,00 -
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- TEOLOGIA POLITICA VATICANA: IL CONCETTO DEL VOLTO DEL FIGLIO DI DIO, DELL’UOMO DELLA PROVVIDENZA, E LA LETTERA VATICANA CONTRO LO SPETTACOLO DI ROMEO CASTELLUCCI. E LA LETTERA DEL ,20 gennaio 2012, di Federico La Sala
IL CONCETTO DEL VOLTO DEL FIGLIO DI DIO SECONDO LA TRADIZIONE CATTOLICO-ROMANA E LA DOTTRINA RATZINGERIANA E LA LETTERA DEL VATICANO SULLO SPETTACOLO DI ROMEO CASTELLUCCI:
Berlusconi, il volto e il vuoto
di GIANNI BAGET BOZZO (La Stampa,26/7/2008).
Dal ‘94 ad oggi le elezioni politiche, e persino quelle regionali e locali, sono state vissute come un referendum pro o contro Berlusconi. Il volto di una persona è diventato il messaggio: un fatto singolare nella democrazia, che ha indotto a spiegare Berlusconi come il frutto di un potere personale, delle sue proprietà televisive, del suo carattere di comunicatore e imbonitore. Il voto sulla persona è stato vissuto dai partiti come un sequestro della democrazia storicamente legata ai partiti e quindi, per questo, illegittimo.
Nel 2008 le cose sono andate diversamente. Il partito democratico ha posto fine all’esperienza Prodi e ha proposto il suo messaggio in termini di cooperazione politica con il centrodestra. Le elezioni hanno determinato la sconfitta del Pd e la scomparsa della sinistra antagonista. E’ caduta la forza politica alternativa a Berlusconi ed egli è diventato, come persona, il titolare della legittimità politica senza alternative: una situazione che ricorda quella della Dc dopo le elezioni del ‘48. Perché tanto consenso attorno a un volto, un consenso che non ha mai investito l’insieme dei partiti di centrodestra in quanto tale, ma è rimasto legato alla persona, inscindibile da essa?
Questo crea un problema politico obiettivo perché non può essere una soluzione ma chiede una spiegazione: perché Berlusconi è diventato il volto della politica italiana.
Ciò indica che alla base di questo vi è un problema di Stato e non di governo. Un uomo solo riguarda il caso di emergenza, non una soluzione stabile. L’elettorato del centrodestra è nato da una crisi di Stato e non da questione di scelta politica, è nato da una crisi del consenso attorno alla Costituzione del ‘48 e allo Stato che su di essa si fondava. La crisi del consenso costituzionale si manifesta nel ‘92-‘93 con due eventi: l’autoscioglimento dei partiti democratici occidentali che avevano guidato la democrazia italiana di fronte al comunismo e il sorgere di un problema indipendentista del nord espresso da Bossi.
Ciò ha alterato il consenso attorno allo Stato, perché era impossibile far decadere il partito cattolico, il partito socialista e il partito liberale, che avevano retto la storia della democrazia italiana del Novecento e porre il Pds come chiave della legittimità politica.
La Costituzione del ‘48 supponeva il consenso dei partiti antifascisti che ne erano mallevadori, la sua costituzione materiale. La loro pluralità e differenza era la base della legittimità politica della Costituzione. Il documento stesso era un compromesso politico: e supponeva che i partiti fondatori, nella loro diversità, rimanessero la base politica dello Stato. La riduzione al solo Pds dei partiti antifascisti creava un vuoto politico, non sul piano del governo, ma sul piano dello Stato, cioè sul piano dell’accettazione della Costituzione come base politica della Repubblica.
A ciò si aggiunge il fatto che l’indipendentismo padano (che aveva allora figura etnica e si richiamava alla tradizione celtica del nord Italia come base di una differenza radicale) metteva in crisi l’impianto del sistema politico italiano fondato sulla centralità della questione meridionale. Poteva un partito rispondere a un tale stato di eccezione politica, quando tutte le tradizioni politiche diverse da quella comunista erano dissolte e vi era un vuoto obbiettivo, un vuoto che corrispondeva alla sfida indipendentista del Nord?
Ci voleva un volto, perché non c’erano più i partiti. Perché questo sia stato quello di Berlusconi non si può spiegare, esso è un fatto e non vi è dubbio che ciò corrisponde a un carisma politico, a una capacità di interpretare il popolo oltre i partiti. Berlusconi fu un evento straordinario, non prevedibile e quindi non facilmente giustificabile. Non entrava nella logica della politica e si pensava che non entrasse nelle regole della democrazia. Invece la tesi di Berlusconi fu quella di rappresentare la sovranità popolare e il suo potere costituente di un ordine politico diverso da quello dei partiti antifascisti ormai distrutto.
Solo il volto di un uomo poteva coprire il vuoto politico delle istituzioni. E ciò avvenne mediante l’alleanza con la Lega Nord e con l’Msi si creando così un’alternativa alla sinistra che non era mai esistita prima e che era assai diversa dalla Democrazia cristiana e dal Partito socialista.
Berlusconi ha rappresentato questo ruolo evitando ogni carattere salvifico persino autorevole, ha messo in luce la sua persona, non il suo carisma, lo ha fatto nelle sue debolezze, persino femminili, presentandosi come l’italiano medio, come rappresentante e non come salvatore. Il fatto di difendere la sua proprietà televisiva non gli ha nuociuto: anzi ha mostrato che egli era un potere della società e che poteva quindi bilanciare poteri istituzionali proprio perché aveva roba. Ciò che venne sentito come un difetto dai suoi oppositori, venne sentito come un vantaggio da parte del suo popolo.
Don Giuseppe Dossetti disse che, con la Costituzione del ‘48, il popolo italiano aveva abbandonato il suo potere costituente, Berlusconi mostrò che non era così e si pose come alternativa alla Costituzione del ‘48, entrando in conflitto con tutti i poteri di garanzia dal Quirinale, alla Corte Costituzionale, al Csm. Toccò così un difetto essenziale della Costituzione del ‘48: quello di fondare i poteri di garanzia e non quelli di governo.
Sovranità popolare contro Costituzione rigida: questa è l’essenza del dilemma berlusconiano che otterrebbe la sua perfezione se si rivedesse l’art. 138 e si riconoscesse che il popolo ha un potere costituente che né i partiti e né gli organi di garanzia istituzionale possono espropriare.
Lettera del Vaticano sullo spettacolo di Castellucci
IL CONTROVERSO SPETTACOLO DI CASTELLUCCI
La Segreteria di Stato risponde all’appello di padre Cavalcoli: «Il Papa auspica che ogni mancanza di rispetto incontri la reazione ferma e composta della comunità cristiana»
di ANDREA TORNIELLI (La Stampa, 19/01/2012)
CITTÀ DEL VATICANO Il Papa, « auspica che ogni mancanza di rispetto verso Dio, i santi e i simboli religiosi incontri la reazione ferma e composta della comunità cristiana, illuminata e guidata dai suoi pastori». Lo scrive la Segreteria di Stato in una lettera indirizzata al domenicano padre Giovanni Cavalcoli, del convento bolognese di San Domenico, che l’8 gennaio aveva inviato al Pontefice una missiva parlando dello spettacolo «Il concetto del volto del Figlio di Dio» di Romeo Castellucci, in programma al Teatro Parenti di Milano la prossima settimana. La lettera vaticana, datata 16 gennaio, è firmata dall’assessore della Segreteria di Stato, lo statunitense Brian B. Wells.
Padre Calavalcoli, nella lettera inviata a Benedetto XVI, scriveva a nome di un gruppo di fedeli definendo «indegno e blasfemo» lo spettacolo di Castellucci, un’opera «gravemente offensiva della persona del nostro Divin Salvatore Gesù Cristo». «Ci addolora inoltre in modo particolare - continuava il teologo domenicano - la consapevolezza che questo inqualificabile atto di empietà colpisca pure, benché indirettamente, la venerabile e da noi amata persona di vostra Santità», in quanto vicario di Cristo. Padre Cavalcoli osservava che l’avvenimento non rappresenta «un fenomeno casuale, isolato e senza radici», ma si inserisce in «una crescente ostilità nei confronti del cristianesimo che si sta diffondendo nel mondo, nonché di un sintomo ed effetto di un disagio e di una crisi spirituali profondi e diffusi ormai da decenni anche in Italia, in parte anche per una mancata o malintesa applicazione del Concilio Vaticano II».
Dopo aver citato le forze che dentro la Chiesa «remano contro» il Papa, Cavalcoli afferma che episodi come quello del controverso spettacolo di Castellucci «sono resi possibili non solo dagli attacchi della cosiddetta “cristianofobia”, ma anche da gravi vuoti e carenze dottrinali ed educative non dovutamente eliminati da parte di chi di dovere. Pensiamo in modo particolare - scrive il domenicano, riferendosi ai casi di pedofilia del clero - allo scandalo subito dai bambini, nei confronti del quale il Signore ha parole di estrema severità». «Siamo preoccupati - conclude Cavalcoli - per coloro che, come il Castellucci, cercano di trarre vantaggio da una situazione nella quale si fa desiderare una maggiore vigilanza da parte delle autorità civili ed ecclesiastiche».
Otto giorni dopo l’invio, dunque a stretto giro di posta, ecco la risposta della Segreteria di Stato, nella quale, citando la lettera del frate domenicano, si parla dell’opera teatrale «che risulta offensiva nei confronti del Signore nostro Gesù Cristo e dei cristiani». «Sua Santità - continua la missiva vaticana firmata dall’assessore Wells - ringrazia vivamente per questo segno di spirituale vicinanza e, mentre auspica che ogni mancanza di rispetto verso Dio, i santi e i simboli religiosi incontri la reazione ferma e composta della comunità cristiana, illuminata e guidata dai suoi pastori, le augura ogni bene per il ministero e invia di cuore l’implorata benedizione apostolica». La riproduzione originale della lettera della Segreteria di Stato è messa online da padre Cavalcoli sul sito Riscossa Cristiana e dal comitato San Carlo Borromeo.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- TEOLOGIA POLITICA. Carl Schmitt: La «teoria dell’acclamazione» nazista contro la democrazia borghese (di Giuseppe Bedeschi)20 gennaio 2012, di Federico La Sala
Schmitt, l’elogio dell’applauso
La «teoria dell’acclamazione» nazista contro la democrazia borghese
di Giuseppe Bedeschi (Corriere della Sera, 14.01.2012)
A Norimberga Carl Schmitt venne processato per il suo passato nazista: infatti, benché fosse caduto in disgrazia nel 1936 (a causa di un duro attacco sferratogli dalla rivista delle SS che gli rinfacciava la sua collaborazione con von Papen nel 1932), egli era stato una delle personalità culturali più prestigiose che avevano aderito al regime hitleriano. Era stato presidente dell’associazione dei giuristi nazionalsocialisti; aveva avallato con la sua autorità imprese efferate, come la «notte dei lunghi coltelli» del 30 giugno 1934 («l’azione del Führer - affermò allora - è stata un atto di autentica giurisdizione. Essa non sottostà alla giustizia, ma è essa stessa giustizia suprema»). Dal tribunale di Norimberga Schmitt venne prosciolto, ma fu dichiarato «persona non grata» nell’ambito delle istituzioni accademiche.
E tuttavia, benché messo al bando per il suo passato nazista, Schmitt continuò a esercitare un fascino notevole su personalità eminenti della cultura europea. Basti pensare a Raymond Aron - che stava certo agli antipodi, sia sul piano dottrinale sia su quello politico, del pensatore tedesco - il quale in una pagina delle sue Memorie (1983) ricordò di averlo conosciuto personalmente, di avere intrattenuto con lui rapporti epistolari, e poi ne diede questa ammirata caratterizzazione: «All’epoca della repubblica di Weimar Carl Schmitt era stato un giurista di eccezionale talento, riconosciuto da tutti.
Appartiene tuttora alla grande scuola dei sapienti tedeschi, che vanno oltre la propria specializzazione, abbracciano tutti i problemi della società e della politica e possono definirsi filosofi, come, a suo modo, lo fu Max Weber». Aron aggiunse che «uomo di alta cultura, Schmitt non poteva essere un hitleriano e non lo fu mai». Affermazione certo azzardata, questa di Aron, eppure in un certo senso vera, in quanto il filosofo tedesco aveva maturato il proprio pensiero molto prima che il nazionalsocialismo conquistasse il potere in Germania. Ma è altrettanto vero che la sua adesione al partito di Hitler, lungi dall’essere opportunistica (come alcuni hanno sostenuto), era pienamente coerente coi motivi più profondi della sua riflessione.
Tale riflessione era maturata nella repubblica di Weimar, travagliata dalle discordie dei partiti, dall’aspro contrasto degli interessi, dalle spinte centrifughe, dalle minacce rivoluzionarie e «golpiste» (nel 1919 ci fu un tentativo di rivoluzione comunista, represso nel sangue; nel 1920 il Putsch di destra di Kapp, nel 1923 il fallito tentativo di colpo di Stato di Hitler).
A questa situazione di sfacelo, tremendamente aggravata dalla crisi economica, che minacciava l’esistenza della nazione tedesca, Schmitt opponeva il suo concetto di popolo inteso come comunità coesa e organica (Gemeinschaft), che deve unificare completamente gli individui, e che è la base della «vera» democrazia. La quale non può essere confusa con la democrazia liberale, e con quella sua espressione caratteristica che è il parlamentarismo. Il liberalismo infatti si fonda, secondo Schmitt, sull’individuo isolato, sul privato egoista, dedito solo ai propri interessi. Ciò si vede anche, egli dice, nella procedura elettorale introdotta dal liberalismo, in cui il singolo esprime il proprio voto in una cabina, in una situazione di segretezza e di completo isolamento: sicché, proprio nel momento in cui si chiede al privato di diventare cittadino e di esercitare, col voto, una funzione pubblica, lo si relega nel suo ruolo di privato, di «borghese». (Questa critica ha avuto molta fortuna a sinistra: essa ritorna, nella sostanza, nella Critique de la raison dialectique di Sartre). Il risultato di tutto ciò è una maggioranza «puramente aritmetica», cioè nulla di coerente e nulla di stabile.
La vera democrazia, per Schmitt, è tutt’altro. Essa deve essere espressione autentica della volontà del popolo, la quale si manifesta nel modo più alto attraverso l’«acclamazione». «La forma naturale dell’immediata espressione del volere di un popolo - egli dice - è la voce che consente o che rifiuta della folla riunita, l’acclamazione». Attraverso il proprio «grido» (Zuruf) il popolo approva o disapprova, acclama un Führer, si identifica con lui. Grazie a questa investitura popolare del Führer, il regime nazionalsocialista era una vera democrazia, in quanto poggiava sulla sostanza del popolo tedesco, sulla unità della sua stirpe.
Un altro importante filone della riflessione filosofica di Schmitt è stato quello della «teologia politica»: un’espressione con la quale il filosofo tedesco intendeva dire che per un verso i concetti politici derivano da quelli teologici, e per un altro verso presentano una analogia strutturale con essi. «Tutti i concetti più pregnanti della moderna dottrina dello Stato sono concetti teologici secolarizzati. Non solo in base al loro sviluppo storico, poiché essi sono passati alla dottrina dello Stato dalla teologia, come ad esempio il Dio onnipotente che è divenuto l’onnipotente legislatore, ma anche nella loro struttura sistematica, la cui conoscenza è necessaria per una considerazione sociologica di questi concetti.
Lo stato di eccezione ha per la giurisprudenza un significato analogo al miracolo per la teologia. Solo con la consapevolezza di questa situazione di analogia si può comprendere lo sviluppo subito dalle idee della filosofia dello Stato negli ultimi secoli». A questa idea schmittiana di «secolarizzazione» sono state mosse molte critiche. Hans Blumenberg ha obiettato che essa delegittima la modernità, e quindi non è in grado di capire lo sforzo di autofondazione che è proprio della politica moderna.
Esce ora in edizione italiana, presso Laterza, un libro che raccoglie tutta la discussione fra Blumenberg e Schmitt (L’enigma della modernità. Epistolario 1971-1978 e altri materiali, pagine 227, 20): una discussione profonda, in cui due grandi personalità, con una storia filosofica e politica completamente diversa l’una dall’altra, si misurano, con tolleranza e al tempo stesso con tormentata passione, sul futuro spirituale dell’Europa e, più in generale, del mondo moderno.
-
>"Sul concetto di volto nel Figlio di Dio" di Romeo Castellucci andrà in scena, non sprechiamo un’occasione per riflettere. il regista è un vero e proprio filosofo della scena, e forse l’unico regista internazionale davvero interessato a un livello di riflessione profonda (di Antonio Audino).22 gennaio 2012, di Federico La Sala
"Sul concetto di volto nel Figlio di Dio" andrà in scena, non sprechiamo un’occasione per riflettere
di Antonio Audino (Il Sole-23 Ore, 20 gennaio 2012)
Lo spettacolo si farà. E anzi sarà l’occasione per capire esattamente cosa accade in scena, sperando che anche i cattolici che si ritengono offesi da questa produzione si ricredano. Già, perché ha ragione Romeo Castellucci, regista del tanto discusso "Sul concetto del volto di Dio" quando afferma che chi accusa di blasfemia quest’opera certamente non l’ha vista. Lo spettacolo ha girato in Italia e in Europa suscitando accese discussioni di carattere filosofico e culturale, trattandosi del lavoro di un creatore dal pensiero complesso e spesso impervio . Ma le repliche a Parigi hanno dovuto fronteggiare gli attacchi di alcuni gruppi di integralisti religiosi, convinti che lo scopo della messa in scena fosse l’idea di insozzare e vituperare un’immagine del Cristo. Ed è proprio l’eco di quelle proteste a riemergere in questi giorni in occasione del debutto milanese fissato per il 23 al Teatro Franco Parenti di Milano. Qui il livello di fuoco si alza, non solo interviene la curia meneghina, ma le fa eco addirittura la segreteria di Stato vaticana, che invita a una reazione «ferma e composta» rispetto a questo atto ritenuto offensivo per chi crede.
Davvero strano, eppure chi lo aveva visto a Roma o ad Avignone aveva percepito tutt’altro, si era trovato immerso in un’ acutissima riflessione sul sacro, sui nostri momenti di fragilità e di miseria umana, sul nostro bisogno di dialogo con un entità superiore, simboleggiata in scena dalla gigantografia di un Cristo umanissimo e dolente di Antonello da Messina.
Ora le iperboli visive e immaginative messe in gioco da Castellucci sono senza dubbio complesse e lasciano allo spettatore ogni possibilità di lettura. Ma certo quel padre continuamente sporco di feci, quel figlio amorevole che lo soccorre, davanti allo sguardo di quell’ecce homo, suggeriscono riflessioni umanissime, rovesciano il rapporto tra padre e figlio, facendolo rimbalzare su una triangolazione divina. Ora, qualunque cosa avesse fatto Castellucci o un altro artista ci sarebbe da chiedersi quanto oggi sia legittimo un intervento censorio da parte di chiunque. Ma il paradosso è che le cose non stanno affatto così.
Le feci sul volto di Cristo? Niente affatto: una colata di liquido nero copre alla fine l’immagine, preludendo allo spettacolo successivo del regista in cui un pastore protestante si cala un crespo nero sugli occhi fino alla morte, magari rimandando a un pensiero tutto cristiano sul Dio nascosto. E poi chi conosce il lavoro di Castellucci sa che il regista è un vero e proprio filosofo della scena, e forse l’unico regista internazionale davvero interessato a un livello di riflessione profonda. Resta da chiedersi il perché di tanto rumore per nulla. Ma evidentemente le gerarchie vaticane amano ancora far sentire la propria voce in termini censori e lanciare anatemi per ribadire il loro sguardo vigile sulla nostra società, così come gruppuscoli minoritari alzano la voce solo per far capire che ci sono. Intanto un appello in difesa dello spettacolo viene stilato da alcuni importanti critici di teatro (www.teatroecritica.net) E la lista delle adesioni si allunga di minuto in minuto.
-
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- Schiene dritte L’eretico Martinetti, italiano per caso Fu uno dei dodici professori che non giurarono al fascismo. E allo studente Lelio Basso disse: “Qui il maestro è Lei” (di Raffaele Liucci)6 gennaio 2012, di Federico La Sala
Schiene dritte
L’eretico Martinetti, italiano per caso
Fu uno dei dodici professori che non giurarono al fascismo. E allo studente Lelio Basso disse: “Qui il maestro è Lei”
di Raffaele Liucci (il Fatto, 06.01.2012)
PIERO MARTINETTI (1872-1943) fu tra i migliori italiani del Novecento. Professore di filosofia teoretica a Milano, formò generazioni di allievi (ma non di discepoli), da Guido Morpurgo-Tagliabue a Eugenio Colorni. Antifascista, fu uno dei 12 docenti (su oltre 1200!) che nel 1931 si rifiutarono di prestare giuramento di fedeltà al fascismo, perdendo così la cattedra. Cultore della filosofia come forma suprema dell’ascesi religiosa, non accettò mai la prepotenza della Chiesa, «la quale, sotto il pretesto del rispetto alla religione, mira a rendere impossibile qualunque altro pensiero». Convinto, sulla scia del prediletto Schopenhauer, che uomini e animali fossero uniti da una parentela universale, elaborò i primi barlumi di un pensiero animalista ante litteram, assai critico verso la vivisezione. Estraneo alle «scuole», alle conventicole e alle mode storicistiche di casa nostra, spesso ripeteva agli amici: «Io sono un cittadino europeo, nato per combinazione in Italia».
Per cogliere la tempra del suo carattere, basti un aneddoto. Quando il socialista Lelio Basso, condannato al confino di Ponza nel 1928, si presentò scortato dagli agenti all’esame di filosofia, Martinetti cominciò a interrogarlo, ma presto lo interruppe più o meno con queste parole: «Io non ho alcun diritto d’interrogarla sull’etica kantiana: resistendo a un regime oppressivo Lei ha dimostrato di conoscerla molto bene. Qui il maestro è Lei. Vada, trenta e lode».
Il suo epistolario, ora disponibile grazie alle amorevoli cure di Pier Giorgio Zunino, ci proietta nella cittadella interiore di un alieno, rispetto alla melassa italiota. Prendiamo il giuramento imposto dal regime agli accademici. Fior di antifascisti, da Marchesi a Calamandrei, si adeguarono. Lo abbiamo fatto, si giustificheranno nel dopoguerra, per impedire che a educare le nuove generazioni fossero soltanto gli scalzacani del duce. Può essere. Ma quale differenza con le scarne parole indirizzate da Martinetti al ministro della pubblica istruzione Balbino Giuliano: «Sono addolorato di non poter rispondere con un atto di obbedienza. Per prestare il giuramento richiesto dovrei tenere in nessun conto o la lealtà del giuramento o le mie convinzioni morali più profonde: due cose per me ugualmente sacre». Lo splendore dell’intransigenza.
Non a caso, sono soprattutto due i «chiarissimi professori» che escono ammaccati da questo carteggio. Il primo è padre Agostino Gemelli, il teorico della «riconquista cattolica» all’ombra dei labari littori, un ragno velenoso che farà di tutto per imprigionare nella propria tela il pensiero eretico di Martinetti. Il secondo è Giovanni Gentile, archetipo dell’accademico arrampicatore e manovriero, «servo a tutti», rovesciando un celebre motto di Kant. Rifulge, invece, Ernesto Buonaiuti, straordinaria figura di sacerdote modernista, perseguitato senza tregua dai pretastri in camicia nera.
Le pagine più affascinanti del carteggio sono forse quelle dell’ultimo decennio, dal ’32 in poi, quando Martinetti, costretto ad abbandonare l’università, si ritirò nel suo eremo piemontese di Castellamonte. Una vita solitaria e spartana, ma operosissima, mentre i suoi libri erano sequestrati dalla prefettura e messi all’indice dal Sant’Ufficio. Pochi i corrispondenti epistolari, fra i quali spicca Nina Ruffini, nipote del giurista Francesco, un altro dei professori che non giurarono. Nel crepuscolo della sua vita, Martinetti verga alcuni delle più perspicue riflessioni sulla natura del potere totalitario sviluppate in quegli anni.
Un’analisi che non lascia scampo. Un mondo in cui le vittime amano «le dittature, l’ordine dispotico, l’uguaglianza nel servaggio». L’Italia ridotta a un «branco di schiavi», cosicché i «pochi spiriti isolati appariscono come dei nemici del bene pubblico». E tuttavia, anche se «le tenebre prevalgono sempre, la luce non si spegne mai completamente». Per questo pubblicare libri resta «l’unica forma di bene che oggi sia lecito fare».
Morì il 23 marzo del ’43, senza fare in tempo a gioire per il crollo del regime.
Piero Martinetti, Lettere (1919-1942), a cura di Pier Giorgio Zunino con la collaborazione di Giulia Beltrametti, Olschki, pagg. LXXXI-264, • 36,00
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- INATTUALITA’ DEL PENSIERO DEBOLE: RAGIONE ANCORA ASTUTA! Pier Aldo Rovatti, che condivide con Gianni Vattimo la paternità del pensiero debole, prende posizione decisa in difesa della sua creatura5 gennaio 2012
 SULLA SPIAGGIA (1985). In memoria di Elvio Fachinelli ...
SULLA SPIAGGIA (1985). In memoria di Elvio Fachinelli ...
 INATTUALITA’ DEL PENSIERO DEBOLE: RAGIONE ANCORA ASTUTA! "Metodo e forza": ricordando Paci, tacendo di Fachinelli, Recalcati elogia Rovatti e se stesso. Una sua nota - a c. di Federico La Sala
Pier Aldo Rovatti, che condivide con Gianni Vattimo la paternità del pensiero debole oltre alla cura del volume che nel 1983 ne ha sancito la nascita, prende posizione decisa in difesa della sua creatura
INATTUALITA’ DEL PENSIERO DEBOLE: RAGIONE ANCORA ASTUTA! "Metodo e forza": ricordando Paci, tacendo di Fachinelli, Recalcati elogia Rovatti e se stesso. Una sua nota - a c. di Federico La Sala
Pier Aldo Rovatti, che condivide con Gianni Vattimo la paternità del pensiero debole oltre alla cura del volume che nel 1983 ne ha sancito la nascita, prende posizione decisa in difesa della sua creatura
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- Lettera alle teologhe e ai teologi italiani di alcuni presbiteri e teologi.31 dicembre 2011, di Federico La Sala
Lettera alle teologhe e ai teologi italiani di alcuni presbiteri e teologi
 in “Adista” n. 1 del 7 gennaio 2012 *
in “Adista” n. 1 del 7 gennaio 2012 *«Dove stai tu quando si soffrono cambiamenti climatici e cambiamenti di umore? Dove stai tu mentre il nostro pianeta va al collasso e le multinazionali e le banche, vendute al dio profitto e al dio denaro, governano il mondo? Dove stai tu quando si deve decidere se intervenire per sostenere un intervento armato della Nato nella terra degli altri? Dove stai tu quando si riducono tutte le spese per il sociale, la sanità e la scuola, mentre continuano ad aumentare i bilanci della difesa e si spendono cifre folli per le armi? Dove stai tu quando la gente dei Sud del mondo si sospinge fino alle spiagge di Lampedusa e viene ricacciata indietro o chiusa nei Cie, colpevoli soltanto di immigrazione? Dove stai tu quando qualcuno dice che l’ex primo ministro è meglio che un politico dichiarato gay, perché il primo è “secondo natura”? Dove stai tu quando il bilancio familiare è insufficiente e si vive una precarietà che riduce a brandelli sogni e progetti? Dove stai tu quando gli indignados scendono in piazza o fanno rete virtuale su internet?
E ancora... perché accettiamo solamente che qualcuno tenga le chiavi del Regno e decida chi farci entrare? Forse tu ci sei? E se ci sei, ci sei clandestinamente perché la tua teologia non appartiene a questi ambiti?
Quando il profeta Gioele (3,1-2) dice che tutti diventeranno profeti e gli anziani faranno sogni e i giovani avranno visioni, a chi si rivolge? Forse non parla a tutti gli uomini e le donne del nostro tempo? E allora, se fare sogni e interpretarli e diventare profeti è proprio della teologia, non è forse vero che tutti i credenti sono teologi? E perché non glielo diciamo più?».
 Alessandro Santoro (prete della Comunità delle Piagge di Firenze),
Alessandro Santoro (prete della Comunità delle Piagge di Firenze),
 Antonietta Potente (teologa domenicana),
Antonietta Potente (teologa domenicana),
 Andrea Bigalli (prete di S. Andrea in Percussina, Firenze),
Andrea Bigalli (prete di S. Andrea in Percussina, Firenze),
 Pasquale Gentili (parroco di Sorrivoli, Cesena),
Pasquale Gentili (parroco di Sorrivoli, Cesena),
 Benito Fusco (frate dei Servi di Maria),
Benito Fusco (frate dei Servi di Maria),
 Pier Luigi Di Piazza del Centro Balducci di Zugliano (Udine),
Pier Luigi Di Piazza del Centro Balducci di Zugliano (Udine),
 Paolo Tofani (parroco di Agliana, Pistoia)
Paolo Tofani (parroco di Agliana, Pistoia) -
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- Visto che la maggioranza degli economisti dell’estabilishment non pensa (né ha bisogno), tentiamo di comprendere la crisi (di Leonard Boff - La grande perversione).5 dicembre 2011, di Federico La Sala
La grande perversione
di Leonardo Boff *
Per risolvere la crisi economico-finanziaria della Grecia e dell’Italia è stato costituito, per esigenza della Banca Centrale Europea, un governo di soli tecnici senza la presenza di politici, nell’illusione che si tratti di un problema economico che deve essere risolto economicamente. Chi capisce solo di economia finisce col non capire neppure l’economia. La crisi non è di economia mal gestita, ma di etica e di umanità. E queste hanno a che vedere con la politica. Per questo, la prima lezione di un marxismo minimo è capire che l’economia non è parte della matematica e della statistica, ma un capitolo della politica. Gran parte del lavoro di Marx è dedicato alla destrutturazione dell’economia politica del capitale. Quando in Inghilterra si visse una crisi simile all’attuale e si creò un governo di tecnici, Marx espresse con ironia e derisione dure critiche perché prevedeva un totale fallimento, come effettivamente successe. Non si può usare il veleno che ha creato la crisi come rimedio per curare la crisi.
Per guidare i rispettivi governi di Grecia e Italia hanno chiamato gente che apparteneva agli alti livelli dirigenziali delle banche. Sono state le banche e le borse a provocare l’attuale crisi che ha affondato tutto il sistema economico. Questi signori sono come talebani fondamentalisti: credono in buona fede nei dogmi del mercato libero e nel gioco delle borse. In quale punto dell’universo si proclama l’ideale del greed is good, ovvero l’avidità è un bene? Come fare di un vizio (e diciamo subito, di un peccato) una virtù? Questi signori sono seduti a Wall Street e alla City di Londra. Sono volpi che non si limitano a guardare le galline, ma le divorano. Con le loro manipolazioni trasferiscono grandi fortune nelle mani di pochi. E quando è scoppiata la crisi sono stati soccorsi con miliardi di dollari sottratti ai lavoratori e ai pensionati. Barack Obama si è dimostrato debole, inchinandosi più a loro che alla società civile. Con i soldi ricevuti hanno continuato la baldoria, giacché la promessa regolazione dei mercati è rimasta lettera morta. Milioni di persone vivono nella disoccupazione e nel precariato, soprattutto i giovani che stanno riempiendo le piazze, indignati contro l’avidità, la disuguaglianza sociale e la crudeltà del capitale.
Persone formate al catechismo del pensiero unico neolibersita tireranno fuori la Grecia e l’Italia dal pantano? Quello che sta succedendo è il sacrificio di tutta una società sull’altare delle banche e del sistema finanziario.
Visto che la maggioranza degli economisti dell’estabilishment non pensa (né ha bisogno), tentiamo di comprendere la crisi alla luce di due pensatori che nello stesso anno, il 1944, negli Stati Uniti, ci hanno fornito una illuminante chiave di lettura. Il primo è il filosofo ed economista ungaro-canadese Karl Polanyi con il suo La grande trasformazione (1944; Einaudi, 1974), un In che consiste? Consiste nella dittatura dell’economia. Dopo la Seconda Guerra Mondiale che ha aiutato a superare la grande Depressione del 1929, il capitalismo ha messo a segno un colpo da maestro: ha annullato la politica, mandato in esilio l’etica e imposto la dittatura dell’economia. A partire dalla quale non si ha più, come si era sempre avuta, una società con mercato, ma una società di solo mercato. L’ambito economico struttura tutto e fa di tutto commercio, sorretto da una crudele concorrenza e da una sfacciata avidità. Questa trasformazione ha lacerato i legami sociali e ha approfondito il fossato fra ricchi e poveri in ogni Paese e a livello internazionale.
L’altro pensatore è un filosofo della scuola di Francoforte, esiliato negli Usa, Max Horkheimer, autore de L’eclissi della ragione (1947; Einaudi 1969). Qui si danno i motivi per la Grande Trasformazione di cui parla Polanyi che consistono fondamentalmente in questo: la ragione non è più orientata dalla verità e dal senso delle cose, ma è stata sequestrata dal processo produttivo e ridotta ad una funzione strumentale «trasformata in un semplice meccanismo molesto di registrazione dei fatti». Deplora che concetti come «giustizia, uguaglianza, felicità, tolleranza, per secoli giudicati inerenti alla ragione, abbiano perso le loro radici intellettuali». Quando la società eclissa la ragione, diventa cieca, perde significato lo stare insieme, rimane impaludata nel pantano degli interessi individuali o corporativi. È quello che abbiamo visto nell’attuale crisi. I premi Nobel dell’Economia, i più umanisti, Paul Krugman e Joseph Stiglitz hanno scritto ripetutamente che i “giocatori” di Wall Street dovrebbero stare in carcere come ladri e banditi.
Ora, in Grecia e in Italia, la Grande Trasformazione si è guadagnata un altro nome: si chiama la Grande Perversione.
* Teologo e filosofo
* Adista/Segni Nuovi, n. 92 del 10/12/2011
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- A Luigi Pareyson, nel ventennale della morte5 dicembre 2011, di Federico La Sala
"ESTETICA. TEORIA DELLA FORMATIVITA’ " (E NON SOLO). "ONTOLOGIA DELLA LIBERTA’ ", "VERITA’ E INTERPRETAZIONE", ....
A Luigi Pareyson, nel ventennale della morte, un convegno a Torino dedicato al suo pensiero estetico
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- NEGAZIONISMO CONCETTUALE. E il fascismo sparì dal dizionario (di Emilio Gentile).25 novembre 2011, di Federico La Sala
 E il fascismo sparì dal dizionario
E il fascismo sparì dal dizionario
 Una parola abusata per troppo tempo, che qualcuno ha proposto di abolire.
Una parola abusata per troppo tempo, che qualcuno ha proposto di abolire.
 Ma si può censurare la realtà storica?
Ma si può censurare la realtà storica?Anticipiamo uno stralcio del contributo dell’autore alla raccolta Società totalitarie e transizione alla democrazia. Saggi in memoria di Victor Zaslavsky, a cura di Tommaso Piffer e Vladislav Zubok, Il Mulino, pagg. 543, eur 37,00, in libreria dal 1° dicembre
di Emilio Gentile (Il Fatto Quotidiano, 25.11.2011)
MISONE IL CHENESE, annoverato da Platone fra i sette saggi dell’antica Grecia, era un filosofo contadino che l’oracolo di Delfi aveva detto essere il più saggio fra i Greci. Tuttavia, pochissime tracce del suo pensiero sono state tramandate. Ma fra le pochissime, ve n’è una che conferma la sua saggezza: «Indaga le parole a partire dalle cose, non le cose a partire dalle parole». Più che ai filosofi, la massima di Misone dovrebbe attagliarsi agli storici, che studiano la genesi e lo svolgimento delle esperienze umane del passato, alle quali sono quasi sempre associate parole nuove - qui diremo i concetti - usate da coloro, che quelle esperienze vissero, per denominarle e definirle lasciandole poi in eredità ai posteri. Le cose e le parole tramandate dalla storia sono l’oggetto della ricerca e dell’interpretazione degli storici. Ma gli storici non sono sempre concordi nell’interpretare le esperienze del passato come non lo sono nel definire il significato dei concetti ad esse associati.
Un caso fra i più recenti, universalmente noto, è la parola “fascismo”. La parola ebbe origine in Italia da un movimento politico, la cui esperienza iniziò, si svolse e si concluse fra il 1919 e il 1945. Durante lo stesso arco di tempo, la parola “fascismo” fu applicata ad altri movimenti politici sorti fuori d’Italia negli anni fra le due guerre mondiali, per essere poi ulteriormente estesa, dal 1945 ai giorni nostri, a movimenti, ideologie, regimi, mentalità, costumi e comportamenti i più svariati e i più disparati, disseminati in ogni parte del mondo, e persino in tempi e luoghi precedenti di molti anni la comparsa del fascismo in Italia. Con l’inflazione del termine, anche il suo significato è stato continuamente elasticizzato fino a perdere ogni consistenza propria e ogni attinenza con il fenomeno storico da cui ebbe origine.
La stessa sorte è toccata ad altre due nuove parole, “totalitario” e “totalitarismo”, che fecero la loro comparsa nella storia dopo l’ascesa del fascismo al potere alla fine del 1922. Le due parole furono coniate fra il 1923 e il 1925 per definire la natura e l’originalità del partito fascista, la sua organizzazione, il suo modo di agire e il nuovo regime politico cui esso diede origine. Dopo il 1926, la parola “totalitarismo” fu adoperata per definire altri nuovi regimi politici, che nell’organizzazione e nei metodi del potere avevano somiglianza con il totalitarismo fascista, come il comunismo sovietico e il nazionalsocialismo . Poi, dal 1945 ai giorni nostri, anche l’uso del termine “totalitarismo” ha subito una dilatazione inflazionistica, essendo applicato a movimenti, regimi, ideologie, mentalità e comportamenti i più vari e diversi, al punto da far perdere il significato storico originario del termine e la sua connessione con la “cosa” dalla quale aveva avuto origine.
Quasi novant’anni sono passati dalla comparsa nella storia del fascismo e del totalitarismo. Almeno fino all’inizio degli anni Cinquanta del Novecento, l’associazione fra fascismo e totalitarismo è stata considerata evidente. Invece, a partire dagli anni Cinquanta, ci sono stati studiosi i quali, pur senza avere un’adeguata conoscenza né della storia del fascismo né delle origini del totalitarismo, hanno negato l’associazione fra fascismo e totalitarismo, sostenendo, come fece la filosofa Hannah Arendt nel 1951, che il fascismo non fu totalitario, e che pertanto non aveva senso parlare di “totalitarismo fascista”, riservando l’uso del concetto di totalitarismo esclusivamente per lo stalinismo e il nazionalsocialismo. Altri studiosi hanno invece sostenuto che neppure questi due regimi possono essere definiti totalitari, giungendo quindi alla conclusione che il totalitarismo non è mai esistito, e che pertanto il concetto stesso non ha alcuna utilità. Esempio estremo di questa negazione è stata la proposta, formulata nel 1968 su un’autorevole enciclopedia di scienze sociali, di bandire il concetto di “totalitarismo” dalla storiografia e delle scienze sociali. Un’analoga proposta fu formulata nello stesso anno per il termine “fascismo”, adducendo come motivo l’uso spropositato del termine stesso.
Non mi risulta sia mai accaduto, nella storiografia e nelle scienze sociali, che la controversia su un concetto scaturito dalla realtà storica abbia indotto gli studiosi a concludere con la richiesta della sua messa al bando, cioè ad operare una operazione di censura, solo perché è stato usato a sproposito o perché gli studiosi non sono giunti a darne una definizione unanime. se tale condizione fosse sufficiente per decretare la messa al bando di un concetto storico, dovrebbero essere eliminati dalla storiografia e dalle scienze sociali concetti altrettanto controversi e di uso altrettanto spropositato, come despotismo, dittatura, libertà, rivoluzione, feudalesimo, rinascimento, capitalismo, democrazia, repubblica, bonapartismo, liberalismo, comunismo, socialismo, conservatorismo, radicalismo, e tutti gli altri ismi della storia. Quali conseguenze potrebbe avere un siffatto “negazionismo concettuale” per la storiografia, è facile immaginarlo.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- LA VERITA’ E’ FIGLIA DEL TEMPO E GLI IDEALI SONO FIGLI DI UN’EPOCA. ZAGREBELSKY RISPONDE AL "BUON USO DELL’INDIGNAZIONE" DI ROBERTA DE MONTICELLI.22 novembre 2011, di Federico La Sala
- Il SONNO PROFONDO DEI GIUDICI COSTITUZIONALISTI, LA "LOGICA" DEL MENTITORE E IL GOLPISTICO TRIONFO DEL PARTITO DI "FORZA ITALIA".
 SE VADO A CASA DI ZAGREBELSKY E ... COMINCIO A FARE IL MIO COMODO DICENDO "FORZA ZAGREBELSKY", CHE COSA HO FATTO E CHE COSA SONO?! L’ITALIA NON S’E’ DESTATA ED E’ STATA UCCISA!!! Una sonnolenta riflessione di Gustavo Zagrebelsky
SE VADO A CASA DI ZAGREBELSKY E ... COMINCIO A FARE IL MIO COMODO DICENDO "FORZA ZAGREBELSKY", CHE COSA HO FATTO E CHE COSA SONO?! L’ITALIA NON S’E’ DESTATA ED E’ STATA UCCISA!!! Una sonnolenta riflessione di Gustavo Zagrebelsky
Perché gli ideali non sono assoluti ma figli di un’epocadi Gustavo Zagrebelsky (la Repubblica, 22 novembre 2011)
Si può dissentire radicalmente sulle premesse e consentire pienamente sulle conclusioni? È la domanda che ci si pone al termine della lettura dell’ultimo, profondo, appassionato, angosciato ma non rassegnato libro di Roberta De Monticelli, La questione civile - Sul buon uso dell’indignazione (Raffaello Cortina Editore).
Il tema è la giustizia, massima virtù sociale; lo scopo è il risveglio alla giustizia attraverso "esercizi di disgusto". L’impianto è filosofico. Il discorso si svolge da Platone e Aristotele, indugia su quello che sembra il preferito, Immanuel Kant, per arrivare a Simone Weil e a Bobbio. Ma, la riflessione spazia: antropologia, psicologia, teologia, giurisprudenza, letteratura. Tutto può essere messo a frutto e fatto reagire, al di sopra delle divisioni disciplinari. Trattandosi di filosofia pratica, cioè orientata all’azione sul suo oggetto - la giustizia -, inevitabile è incontrare di continuo le brutture, le oscenità, le meschinità, gli arrivismi, l’ipocrisia, l’illegalità, la corruzione, le prepotenze, le viltà e il servilismo, cioè la catastrofe etica della nostra società.
Il libro, con una certa sorpresa del lettore, non inizia dalla giustizia. Vi arriva attraverso la bellezza. Bellezza e giustizia: che rapporto c’è? Dicendo bellezza, non si deve pensare a estetismo, snobismo, collezionismo d’arte e cose di questo genere. Se bellezza è armonia e proporzione dei rapporti - di elementi figurativi, architettonici, poetici e musicali, e anche sociali - allora possiamo dire che la bellezza è forma visibile della giustizia. Il rapporto è stretto, inscindibile. Vale l’eterna massima della filosofia scolastica: iustum, bonum, verum et pulchrum convertuntur. Queste qualità dell ’esistenza vivono l’una nell’altra. Non occorre intuizione metafisica per capirne i nessi. Risultano ancora più chiari rovesciando il positivo in negativo: l’ingiustizia è cattiva; il cattivo è falso; il falso è brutto. Si può arrivare alla giustizia a partire dalla bellezza, ma si sarebbe potuto anche dal bonum o dal verum. A partire da uno, si arriva agli altri.
Fin qui, tutto bene. Il passo successivo è da discutere. Giustizia, bontà, verità e bellezza sono "valori", "cose che valgono", non in termini economici, (non c’è un mercato dei valori secondo la legge della domanda e dell’offerta), ma in termini morali. Sono il lato positivo, prezioso, della vita. A meno di pervertimento in bruta animalità, dove vige il fatto compiuto, cioè la "giustizia del più forte", non ne possiamo fare a meno. Potremmo perfino dire che li chiamiamo valori, ma sono necessità, secondo il motto di Kant: se non c’è posto per la giustizia sulla terra, non ha senso la vita degli uomini.
De Monticelli dà grande importanza alla questione del fondamento. È convinta che i valori siano "dati", non perché li si possa constatare e ammirare in sé e per sé. Nel teatro greco, per esempio, "La Pace" si presentava come una fanciulla, avvolta in un peplo trasparente, e tutti esclamavano: "come è bella!". Di lei si poteva dire: "Come è bella!" perché la bellezza le era incorporata e gli spettatori ne facevano esperienza. Dunque, "i fatti stessi si qualificano come beni e come mali" (belli o brutti, giusti o ingiusti, ecc.) e a noi non resta che prendere atto del loro valore, come constatazione. Ne è convinta De Monticelli e chi, come Platone, crede che esista "la bellezza" che si riflette in "le cose belle". Se fosse così, sarebbe possibile fondare la morale in termini oggettivi: le cose belle sono belle perché portano in sé la bellezza, non perché l’attribuiamo loro, secondo la nostra concezione. Insomma: è bello ciò che è bello, non ciò che piace: piace perché è bello, non viceversa (lo stesso, per gli altri valori).
Come possiamo non insorgere - leggiamo nel libro - di fronte alle casette a schiera che deturpano le colline senesi dipinte da Simone Martini? Non è questo, oggettivamente, un insulto al bello, e dirlo non è forse una constatazione di fatto? "Nerone era crudele", non è la stessa cosa? Andiamo oltre: Adolf Hitler era un essere degenerato. Chi non sarebbe d’accordo? Dunque il brutto è incorporato nelle casette a schiera del Senese; la crudeltà, in Nerone; la degenerazione, in Hitler. Ripeto: chi non sarebbe d’accordo? Ma perché siamo d’accordo? Sono "le cose" (le villette, Nerone, Hitler) che parlano a noi, o siamo noi che parliamo a e di loro?
Siamo al problema del fondamento. Al "monismo" essenzialista - fatti e valori sono tutt’uno - sioppone la separazione "dualista": ciò che è non è detto che debba o non debba essere. Un muro separa i fatti dai valori: gli uni non "convertuntur" affatto negli altri. Riconsideriamo l’esempio estremo di Hitler. Ora (e, purtroppo, nemmeno da tutti) si ritiene sia stato uno dei massimi flagelli dell’umanità, ma non allora. C’era chi lo riteneva un nuovo messia, perfino tra gli uomini di chiesa. Per milioni di persone, in Germania e altrove, era il salvatore della civiltà europea contro la barbarie asiatica, impersonata dal comunismo sovietico. In nome del "valore" superiore della civiltà occidentale, si è stati perfino disposti a chiudere gli occhi davanti alla shoah: evidentemente, la difesa della vita degli ebrei si riteneva un non-valore, o un valore minore, di fronte ad altri valori, come il capitalismo o la religione cristiana.
C’era un valore assoluto, obiettivo, e, se sì, qual era? No, non c’era. C’era invece una lotta mortale tra valori soggettivi e relativi, con le rispettive armate schierate su fronti opposti. Noi sappiamo, ora, come sarebbe stato giusto, buono, vero, e bello schierarsi. Ma, come osservatori, dobbiamo ammettere che entrambe le parti, allora, ritenevano di combattere la buona battaglia e che ciascuna delle due vedeva incorporate nelle armi dell’altra il male, e nelle proprie il bene.
Dunque, è più probabile che la condizione esistenziale degli esseri umani non sia quella assunta da De Monticelli. Per lei, il valore delle cose, positivo o negativo, si manifesta nella loro esistenza. Dunque la precede. Per chi non pensa metafisicamente, invece, è l’esistenza che precede i valori. Il che è come dire ch’essi non sono dati ma sono i viventi a doverli dare; vengono dalla nostra libertà e responsabilità e non li troveremo fuori, ma in noi.
Sappiamo che entrambe le posizioni, monismo e dualismo, sono aperte a grandi rischi. Non sono quindi i rischi, gli argomenti per propendere per l’uno o per l’altro. La metafisica dei valori espone al dogmatismo, quando la loro gestione finisca, come è possibile, nelle mani di autorità etiche: stato, partito-chiesa, chiesa. L’anti-metafisica espone all’indifferenza o al soggettivismo estremo e distruttivo, quando prevale l’idea che le questioni di valore non abbiano senso o siano affari da gestire ciascuno per sé.
Piuttosto, riprendendo l’interrogativo iniziale, che è quello davvero importante per il vivere comune, possiamo dire che, quali che siano le opinioni circa il fondamento, sui contenuti si può perfettamente convenire. Gli uni riterranno di andar scoprendo valori; gli altri, di andar creandoli. Da punti di partenza diversi si può giungere alla medesima meta e, cosa consolante, si può, anzi si deve, operare insieme. A condizione di isolare le ali estreme: i dogmatici e i nichilisti. Per riprendere il titolo del libro di De Monticelli: a queste condizioni, far buon uso della comune indignazione è possibile.
- Il SONNO PROFONDO DEI GIUDICI COSTITUZIONALISTI, LA "LOGICA" DEL MENTITORE E IL GOLPISTICO TRIONFO DEL PARTITO DI "FORZA ITALIA".
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- DA RICORDARE: NEL 1944, ENZO PACI E PAUL RICOEUR ERANO INSIEME A WIETZENDORF.18 ottobre 2011, di Federico La Sala
ENZO PACI: "Parigi 30 marzo 1960. Ho trovato Ricoeur alla Gare de Lyon. Non ci vedevamo da quindici anni. Da Wietzendorf era partito all’improvviso. Dormivo. Non volle svegliarmi e lasciò un pane nel mio giaciglio [...]" (Enzo Paci, Diario fenomenologico, Milano 1961, pp. 97-08).
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- ACCADEMIA E BERLUSCONISMO. PREMIATO IL PRESIDENTE BERLUSCONI, PER IL RILANCIO DEL PLATONISMO ATEO E DEVOTO. "IO, PLATONE, SONO LA VERITA’": "FORZA ITALIA"!!!16 ottobre 2011PREMIO NOBEL PER LA "LETTERATURA", ALL’"ITALIA", AL PRESIDENTE DELLA "REPUBBLICA" DEL "POPOLO DELLA LIBERTA’"!!!
 ACCADEMIA E BERLUSCONISMO. PREMIATO IL PRESIDENTE BERLUSCONI, PER IL RILANCIO DEL PLATONISMO ATEO E DEVOTO. "IO, PLATONE, SONO LA VERITA’": "FORZA ITALIA"!!! Nelle piazze e nei campi di calcio il popolo ateo-devoto è tutto in festa, in un mare di bandiere "nazionali"
ACCADEMIA E BERLUSCONISMO. PREMIATO IL PRESIDENTE BERLUSCONI, PER IL RILANCIO DEL PLATONISMO ATEO E DEVOTO. "IO, PLATONE, SONO LA VERITA’": "FORZA ITALIA"!!! Nelle piazze e nei campi di calcio il popolo ateo-devoto è tutto in festa, in un mare di bandiere "nazionali"
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- L’epoca dei consulenti. In un dialogo (Zagrebelsky - E. Donaggio) uscito su "Alfabeta2" la questione della cultura piegata al servizio degli interessi politici5 ottobre 2011, di Federico La Sala
L’epoca dei consulenti
Zagrebelsky: Il rapporto col potere ha polverizzato gli intellettuali
 "Si abdica al proprio ruolo e così si finisce per condannarsi all’irrilevanza"
"Si abdica al proprio ruolo e così si finisce per condannarsi all’irrilevanza"
 "Il punto più basso è dare le proprie idee, le proprie parole, le proprie idee a chi ti paga"
"Il punto più basso è dare le proprie idee, le proprie parole, le proprie idee a chi ti paga"
 In un dialogo uscito su "Alfabeta2" la questione della cultura piegata al servizio degli interessi politici
In un dialogo uscito su "Alfabeta2" la questione della cultura piegata al servizio degli interessi politici
 Piuttosto che la ricerca della verità prevale la convenienza immediata e il desiderio di piccoli privilegi
Piuttosto che la ricerca della verità prevale la convenienza immediata e il desiderio di piccoli privilegi
 "L’indipendenza e la libertà finiscono per essere solo la rivendicazione di uno status"
"L’indipendenza e la libertà finiscono per essere solo la rivendicazione di uno status"di Enrico Donaggio (la Repubblica, 05.10.2011)
Che cosa ti sembra di vedere nel rapporto intellettuali-potere, con riguardo alla situazione del nostro Paese, in questo momento? «Una grande diversità di situazioni, tra due estremi: l’improduttiva futilità intellettualistica e il servilismo corruttivo del libero pensiero. Se siamo liberi, siamo superflui; se siamo utili, non siamo liberi. Queste tendenze, per ragioni diverse, hanno in comune l’incapacità della funzione intellettuale, in quanto tale, di svolgere una funzione sociale e si condannano all’irrilevanza e, alla fine, al disprezzo. Nell’insieme, coloro che si dedicano ad attività intellettuali risultano polverizzati, inconcludenti. Non mi pare che, per usare un’espressione gramsciana, essi costituiscano un "gruppo sociale autonomo e indipendente". Rivendicano, certo, autonomia e indipendenza, ma lo fanno forse in vista di un qualche compito comune, in forza del quale li si possa considerare in sé "gruppo sociale"? Ti faccio una domanda. Pensi che sarebbe possibile, nell’Italia di oggi, un’affaire Dreyfus?».
Che cosa intendi dire?
«Che certamente ci sono, nel nostro tempo e nel nostro Paese, grandi scandali del potere, del fanatismo, e della grettezza, alleati tra loro in azioni criminali d’ogni tipo. C’è, rispetto a queste cose, una mobilitazione intellettuale contro "l’emergenza civile"? E, se anche c’è o ci fosse, è o sarebbe in grado di smuovere le acque, fare da contraltare alle logiche del potere, in nome di principi e valori non riconducibili a quelle logiche? Domanda retorica. Sembra che l’ambiente intellettuale sia quello cui il potere si rivolge per trovare giustificazioni, coperture. E di solito le trova. Triste».
Vuoi dire che, da noi, gli intellettuali, in quanto tali, sono inconcludenti?
«Esattamente così! La loro funzione è come polverizzata in mille rivoli. La dispersione deriva dall’incapacità di definire i nodi fondamentali della loro riflessione. Per questo, la libertà e l’indipendenza ch’essi rivendicano non si traducono in una funzione sociale, ma si risolvono in una pretesa di status, non facile giustificare. Da qui, la facile ironia sulla prosopopea degli intellettuali, sulla loro vuota spocchia e, alla fine, sul loro parassitismo. Data la carenza di ruolo sociale, o ci si rifugia nella pura speculazione fine a se stessa, che è una sorta di consolazione del pensiero, oppure, rinunciando all’autonomia e all’indipendenza della funzione intellettuale, si cerca di collegarsi con chi sta dove il potere si esercita effettivamente, nell’economia e nella politica, per diventarne "consulenti". In due parole: il "consulente" sostituisce "l’intellettuale". Il nostro mondo è sempre più ricco di consulenti e sempre meno di intellettuali. C’è da ridere, se si pensa che quella del consulente è la versione odierna dell’"intellettuale organico" gramsciano. Questi si collegava alle grandi forze storiche per la conquista della "egemonia" e per svolgere così un compito certo ambiguo, ma indubbiamente grandioso; quello è l’imboscato nell’inesauribile miniera di ministeri, enti, istituti, fondazioni, aziende, ecc., offrendo servigi intellettuali e ricevendo in cambio protezione, favori, emolumenti. I consulenti si conoscono tutti "personalmente", ma s’ignorano "funzionalmente". Nell’insieme non adempiono una funzione intellettuale indipendente».
E c’è qualcosa di male? Non è bene che chi comanda sia informato, magari anche illuminato, da qualcuno che conosce le cose di cui parla?
«E come no. Ma, a condizione che il consulente non entri "nell’organico" del potente di turno. C’è differenza tra il fornire le tue conoscenze e offrire te stesso, tra il vendere e il venderti cioè, come si dice, essere "a libro paga". Il confine è teoricamente chiaro, praticamente vago. Nel primo caso mantieni la tua libertà, nel secondo la perdi: volontariamente la perdi, ma la perdi. C’è l’attesa, la speranza di ottenere qualcosa, e allora rispondi agli inviti; ai convegni non puoi mancare, perché se manchi, sembra che tu "non ci stia". Perdi il tuo tempo e disperdi la tua vita in convegni pseudo-culturali perché "non si sa mai" che qualcosa di buono ti possa prima o poi arrivare: i posti a disposizione sono tanti e ci può essere anche posto per te. Il punto più basso, l’intellettuale lo raggiunge quando si presta a dare il suo cervello, la sua intelligenza, la sua parola, all’uomo di potere che lo paga per scrivergli i suoi discorsi, i suoi articoli di giornale, le sue interviste. Addirittura, la consideriamo una professione intellettuale, quella del ghostwriter. Ti pare normale che chi scrive discorsi per altri, collaborando a un evidente plagio letterario, sia circondato dal massimo rispetto, ed egli stesso se ne compiaccia: come sono bravo, sono entrato in Tizio e Caio per far uscire dalla sua bocca le mie parole!».
Mah! Non è mica detto che si tratti poi di pura piaggeria. Possono essere grandi discorsi che, semplicemente, passano per un megafono di potenza tale - per esempio, negli Stati Uniti, la voce di un Presidente - che uno studioso, per quanto famoso non potrebbe neppure sognarsi.
«Pensi forse a un Arthur Schlesinger jr., grande saggista, che scriveva i discorsi per Adlai Stevenson e per i fratelli Kennedy? Ma, qui non è questione di qualità delle persone e delle loro prestazioni. Qui parlo della funzione stessa, come concetto. A proposito di Reagan (parliamo di lui e non di gente di casa nostra, per carità di patria), Noam Chomsky ha fatto osservazioni sulle esibizioni pubbliche di politici-attori che dovrebbero essere tenute presenti, come salutari avvertenze per l’uso, nell’ascolto delle loro parole: "quando in televisione si legge un ‘gobbo’ si fa una curiosa esperienza: è come se le parole vi entrassero negli occhi e vi uscissero dalla bocca, senza passare attraverso il cervello. E quando Reagan fa questo, quelli della tv devono disporre le cose in modo che di fronte a lui ci siano due o anche tre gobbi; in tal modo la sua faccia seguita a muoversi rivolgendosi da una parte e dall’altra, e allo spettatore sembra che stia guardando il pubblico, e invece passa da un gobbo all’altro. Ebbene, se riuscite a indurre la gente a votare per persone di questo tipo, praticamente avrete fatto il vostro gioco; l’avrete esclusa da ogni decisione politica. E bisogna fingere che nessuno rida. Se ci riuscite, avrete fatta molta strada verso l’emarginazione politica del popolo". Ecco, quello che voglio dire: gli intellettuali che si prestano a riempire la bocca dei politici di cose delle quali questi non hanno nessuna idea propria, oltre che umiliare la propria funzione, contribuiscono a svuotare di contenuto la democrazia, a ridurla a una rappresentazione».
Ma, non è meglio che i politici dicano cose sensate, piuttosto che insensate?
«No. Se non hanno nulla da dire, frutto del loro ingegno, è meglio che tacciano. E, se tacendo non si fa carriera politica, è meglio che non la facciano. Se poi dal loro ingegno escono sciocchezze, è bene che i cittadini elettori le constatino per quello che sono. Oltretutto, in questo modo, coprendo il vuoto dei politici con le loro non disinteressate "consulenze", contribuiscono a svuotare la politica stessa e, svuotandola, a renderla funzionale a interessi esterni. Non vorrei essere troppo brutale: si finisce per assecondare la sua tendenza a diventare funzione del potere che oggi più di tutti conta, il potere del denaro. Pecunia regina mundi».
Eppure, non credi che proprio questa funzione dell’intellettuale possa servire, al contrario, a dare alla cultura una forza nell’agone politico che altrimenti non avrebbe?
«Questa è l’illusione in cui spesso gli intellettuali rischiano di cadere, quando pensano di fare dei politici il megafono o l’imbuto delle loro idee. La realtà è che, quando non servono più, sono messi da parte. Ricordi la vicenda di Gianfranco Miglio con Bossi? E, ancor prima, con Eugenio Cefis? Oppure, di coloro che si sono messi alla corte Berlusconi pensando di potere fare la "rivoluzione liberale"? Dove sono finiti?».
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- Era il tempio della filosofia. Palazzo Serra di Cassano, sede del celebre Istituto italiano per gli studi filosofici, via Monte di Dio (di Francesco Tomatis - Il mondo dei Filosofi)12 settembre 2011, di Federico La Sala
IDEE
Il mondo dei Filosofi
di Francesco Tomatis (Avvenire, 12 settembre 2011)
Era il tempio della filosofia. Conduceva a esso una strada sospesa sull’acropoli, dal nome unico e indimenticabile: via Monte di Dio. Non parlo di Atene antica né della Grecia. Ma di una città odierna, estremo epigono della Magna Grecia: Napoli. Ascendevo a fatica per gradoni e gradini, fra fragori e improvvisi silenzi, umili panni stesi e lavate scarpette appese ad asciugare, a purificare al cielo altri commerci immondi, quando, con stupore e incanto, fra labirintici vicoli e vie sospese, case sfatte e bambini in gioco affaccendati e schiamazzanti, si dischiuse da un basso recesso un androne spazioso, trasparente, aperto su imponenti eppure leggere scalinate barocche, elevate all’eccelso. Salivo per la prima volta a Palazzo Serra di Cassano, sede del celebre Istituto italiano per gli studi filosofici, dove sugli estremi scalini di accesso mi accolse Luigi Pareyson appellandomi, dopo breve esitazione, il proprio “nipotino”. All’Istituto si succedettero - a partire dalla sua fondazione nel 1975 a opera illuminata del mecenate della filosofia, l’avvocato Gerardo Marotta - i maggiori filosofi viventi del nostro pianeta: da Hans-Georg Gadamer (che sino all’età veneranda di cento anni tenne ogni anno un proprio seminario) e Paul Fayerabend a Eugenio Garin e Paul Oscar Kristeller, da Luigi Pareyson e Paul Ricoeur a Ilya Prigogine ed Ernesto Grassi, da Jacques Derrida ed Emmanuel Lévinas a Raymond Klibansky e Valerio Verra. Purtroppo tutti ormai scomparsi. Non c’è né c’è mai stato al mondo simile luogo, unico, in cui sia stato possibile seguire le lezioni dei maggiori filosofi, provenienti da ogni nazione, università, tradizione.
Oggi non mancano di omaggiare il tempio filosofico con la loro presenza pensatori italiani del calibro di Massimo Cacciari (1944) e Gianni Vattimo (1936), Remo Bodei (1938) e Vincenzo Vitiello (1935), Umberto Curi (1941) ed Emanuele Severino (1929), Carlo Sini (1933) e Biagio de Giovanni (1931), Sergio Givone (1944) e Maurizio Ferraris (1956), Dario Antiseri (1940) e Salvatore Natoli (1942), Giacomo Marramao (1946) e Massimo Donà (1957) e altri ancora, ma sempre più rare sono le presenze straniere importanti. È solo conseguenza del quasi azzeramento dei finanziamenti pubblici, oppure scarseggia il “materiale umano”? Esistono ancora, in giro per il mondo, filosofi autentici, profondi pensatori, degni di questo nome? Lasciamo i lidi italiani, ove non mancano filosofi di estremo valore: oltre ai citati menzioniamo i decani, come Vittorio Mathieu (1923) o Carlo Arata (1924), Armando Rigobello (1924) o Manlio Sgalambro (1924), Virgilio Melchiorre (1931) o Giovanni Reale (1931), Giuseppe Riconda (1931) o Umberto Eco (1932), Giovanni Ferretti (1933) o Enrico Berti (1935).
In Francia sembrerebbe particolarmente vivace il dibattito filosofico, almeno in base alla presenza editoriale e giornalistica di suoi diversi esponenti. Si pensi ai notissimi Alain de Benoist (1943), André Glucksmann (1937) e Bernard-Henri Lévy (1948), brillanti opinionisti ma deboli filosofi nella ricerca critica del vero. Oppure a Alain Badiou (1937), Jean-Luc Nancy (1940), Jean-Marc Ferry (1946) e Jean-Luc Marion (1946), autori prolifici e interessanti, i quali muovono tuttavia a stento autonomi passi che vadano oltre i grandi filosofi passati per loro di riferimento, Husserl o Heidegger, Habermas o Ricoeur. Più umilmente, Jean-François Courtine (1944) si limita a un’acuta, intelligente storiografia filosofica, che spazia da Aristotele e Suárez, sino a Schelling e Heidegger.
Casi particolari, studiosi di confine, sono poi René Girard (1923), studioso che si muove tra la storia delle religioni, la critica letteraria e al’antropologia, Rémi Brague (1947), storico della filosofia araba e filosofo della religione, e François Jullien (1951), originale interprete in forma occidentale di diversi temi del pensiero cinese. Ma i pensatori più originali in Francia sono, ancora una volta, dei decani: Xavier Tilliette (1921), Edgar Morin (1921) e Pierre Legendre (1930). Il primo, gesuita e teologo, s’è dimostrato non solo il più acuto filologo e storiografo dell’idealismo tedesco, ma ha nel corso degli anni elaborato una propria filosofia cristiana, in dialogo coi filosofi che, davanti a Cristo, si siano interrogati sul mistero di Dio e della croce. La sua riflessione ha avuto un’importante influenza sull’enciclica di Giovanni Paolo II Fides et ratio, con la sottolineatura della circolarità feconda fra fede e ragione, filosofia e teologia nella comprensione della croce cristiana.
Il secondo, sociologo, ha elaborato un’epistemologia delle scienze umane e una filosofia dell’ecologia. Il terzo, filosofo del diritto e psicanalista lacaniano, ha proposto un’antropologia filosofica “dogmatica”, non reticente nel confrontarsi con il fatto che le culture vivano di verità non dimostrabili, riproponendo il problema del limite contro i molti assolutismi in cui l’attuale mondo relativista inevitabilmente ricade. In terre germaniche, eredi della felice stagione dell’idealismo classico tedesco (e del romanticismo) - la sola epoca avvicinabile, filosoficamente, a quella archetipica, la greca -, si è nel dopoguerra delineata una serie di scuole e di studiosi che eccellono nella storiografia filosofica. Dieter Henrich (1927) e Manfred Frank (1945) hanno finemente scandagliato l’intrecciarsi di idealismo e romanticismo nel pensiero tedesco. Oppure, primo fra tutti, Werner Beierwaltes (1931), il maggiore riscopritore e acuto interprete della tradizione filosofica del neoplatonismo, da Plotino a Cusano. Karl-Otto Apel (1922) e Jürgen Habermas (1929), invece, per quanto con maggiori intenti propositivi, non eccedono il solco tracciato a suo tempo dalla Scuola di Francoforte, limitandone anzi le potenzialità (il mito, per esempio, non viene preso in considerazione, a favore della sola razionalità), nel tentativo di far confluire in categorie a priori universali il pluralismo fattuale. Si distinguono per posizioni maggiormente singolari Robert Spaemann (1927), cattolico e attento al problema della libertà e del male, Bernhard Waldenfels (1934), teorico del dialogo interculturale, e Peter Sloterdijk (1947), abile riformulatore di considerazioni sociologiche in pillole di saggezza filosofica e visioni generali. In area linguistica inglese, ancora prevalenti sono le tradizioni empirista e analitica, con Hilary Putnam (1926), autodefinitosi “realista interno”, John Rogers Searle (1932) - attento alle neuroscienze e ideatore di un’“ontologia sociale” - e il logico Saul Aaron Kripke (1940) negli Stati Uniti d’America, Michael Dummet (1925) in Inghilterra, analitico “metafisico”. Oppure la filosofia politica, con suo primo rappresentante l’inglese Alasdair MacIntyre (1929), comunitarista, nonché gli americani Michael Walzer (1935) e Charles Larmore (1950), rielaboratori del liberalismo.
Da altre regioni del mondo giungono voci isolate, come quelle dello psicanalista sloveno Slavoj Zizek (1949), riformulatore di un comunismo utopico e di un cristianesimo senza Dio, o dell’ungherese postmarxista Ágnes Heller (1929). In Spagna spiccano fra tutti - da non confondersi con quello che è più un divulgatore che non un pensatore, Fernando Savater (1947) - Félix Duque (1943) e Arturo Leyte (1956), profondi conoscitori della filosofia tedesca, il primo originale interprete del mondo tecnologico contemporaneo, sino alle sue propaggini terroristiche.
O, ancora, il filosofo mistico e metafisico “ateo” Oscar del Barco (1928), argentino di Córdoba, il maggiore in area latinoamericana, e il canadese Charles Taylor (1931), indagatore di un io individuale e comunitario assieme, capace di reggere alla prova del confronto interculturale. Infine l’antesignano della filosofia della mente, Thomas Nagel (1937), di origini iugoslave ma presto divenuto statunitense. Del resto molti dei filosofi menzionati tengono periodicamente lezioni in università americane. Un discorso a sé va fatto per l’area africana, indiana, estremo-orientale. Benché recentemente sia stata sviluppata una riflessione sul pensiero tradizionale africano, i suoi artefici utilizzano ampiamente gli strumenti concettuali e le lingue occidentali.
Ad esempio Paulin Houndtondji (1942) non solo si è formato a Parigi, ma pubblica in lingua francese le sue opere. Attuale rappresentante dei filosofi giapponesi della Scuola di Kyoto, che fondono la tradizione buddhista zen con il pensiero heideggeriano studiato in Europa, è Toji Kamata (1951), i cui studi riguardano la filosofia delle religioni. Maggiormente originale è invece Osamu Nishitani (1950), filosofo della politica attento al problema della morte e della guerra. In Cina è ancora presto per parlare di libertà di pensiero e la criticità del pensare è vincolata, controllata, censurata, punita. Principalmente di storia della filosofia occidentale s’è occupato Yeh Hsiu Shan (1935).
Alla storia e attualizzazione della tradizione di pensiero cinese hanno dedicato le proprie ricerche T’ang I Chieh (1927) e Yang Kuo Jung (1957). Il taiwanese Ch’eng Ch’ung Ying (1935) si riallaccia soprattutto al neo-confucianesimo, insegnando negli Usa, ove anche s’è recentemente trasferito il pensatore cinese vivente forse più originale, soprattutto in campo estetico, Li Tse Hou (1930), costretto all’esilio dopo la presa di posizione contro la violenza di Tienanmen, nel 1989. L’India dipende fortemente dal mondo culturale anglosassone o europeo, salvo gli autori che si riconoscano in specifiche scuole tradizionali, tuttavia spesso intese più come religioni o spiritualità semplicemente da conservare, anziché luoghi di confronto filosofico. Due dei principali filosofi indiani viventi, ad esempio, il decano Jitendra Nath Mohanty (1928) e Arvind Sharma (1940), si sono formati all’estero, il primo in Germania alla scuola fenomenologica e il secondo negli Usa, elaborando un’interpretazione analitica della filosofia non dualista. Invece il gesuita indiano Kuruvilla Pandikattu (1957) teorizza filosoficamente un dialogo fra scienza e religione come base di quello interreligioso.
Il primo decennio del nuovo millennio registra dunque un deciso abbandono della riduzione della filosofia a mera analisi del linguaggio comune, diffusa nella seconda metà del secolo scorso in aree non solo anglofone. Sono oggi presenti diversi sociologi o storici delle idee che tentano invece di fare un’analisi delle pratiche sociali e individuali comuni, con attenzione ai possibili sviluppi futuri dei nuovi stili di vita delle masse. Ma questa tendenza rileva spesso scarsa elaborazione di pensiero originale, dimostrando invece come una certa civiltà della comunicazione diffusa sia autoreferenziale e incapace di aprirsi almeno ad ascoltare nuove esperienze o eventi veritativi. Maggiori prospettive sembrano dare quei filosofi che frequentano terreni di confine, come chi si confronti con le nuove scienze biologiche, dalle neuroscienze alla genetica, o chi abbia rinnovato il già tradizionale confronto con le esperienze religiose e le diverse culture. I più originali filosofi europei hanno da tempo infranto il veto di occuparsi di Dio, di fede e religione, con risultati fecondi in campo non solo teoretico ma anche morale e politico. Nel resto del mondo, orientale ed estremo-orientale in particolare, troviamo le prospettive più interessanti in quei pensatori - benché pochi - che comparano e anche intrecciano le diverse dimensioni della propria originaria tradizione culturale e spirituale, che sia induista o buddhista, taoista o confuciana, animista o cristiana, con prospettive filosofiche diverse, in particolare europee, vissute esperienzialmente nella propria stessa singolare persona.
La sperimentazione personale di molteplici forme culturali o di pensiero, senza sincretismi, ma in un dialogo vivente rivolto a una crescita sempre ulteriore, è quindi forse la novità maggiore che, offerta dal mondo globalizzato - e rilocalizzato -, i filosofi del nuovo millennio stanno recependo, facendosi modello sperimentale di vita futura sul nostro pianeta capace di porre in armoniose relazioni persone diverse, culture disparate, dimensioni umane di differenti livelli. È comunque una triste constatazione che non solo l’oppressione della libertà di espressione del pensiero, ma la stessa vita pacificata - come s’è realizzata in particolare in Occidente -, con il suo benessere presto compiuto in opulenza e generalizzata standardizzazione, non sia terreno fertile per i filosofi. Forse, essi nascono piuttosto nel contrasto: se non bellico, almeno nella viva contraddizione. Esaurita la schiera dei pensatori forgiati dai conflitti bellici mondiali, irripetibili, come Martin Heidegger e Ernst Jünger, Paul Ricoeur e Emmanuel Lévinas, Simone Weil o Albert Camus, Benedetto Croce o Dietrich Bonhoeffer, Pavel Florenskij e Edith Stein, Hannah Arendt o Luigi Pareyson, sembra oggi vigere una pausa, poco riflessiva. Ma dai più recenti conflitti diffusi, terroristici e ideologici, fanatistici o tecnocratici, in modo sommesso sta forse sorgendo una nuova generazione di pensatori - fatta di singoli solitari, di filosofi venturi.
Francesco Tomatis
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- NUOVO REALISMO. Il manifesto che divide la filosofia6 settembre 2011, di Federico La Sala
Il manifesto che divide la filosofia *
Ad aprire il dibattito è stato il manifesto del «nuovo realismo» pubblicato da Maurizio Ferraris su «la Repubblica» dell’ 8 agosto. Sulle stesse pagine è uscito poi un dialogo tra Ferraris e Gianni Vattimo, noto fautore del «pensiero debole» postmoderno, cui il nuovo realismo si contrappone. Sono quindi intervenuti sulla questione - affrontata anche nel recente «Almanacco di filosofia» di «MicroMega» - il direttore del «Foglio» Giuliano Ferrara, «Il Sole 24 Ore», Corrado Ocone sul «Riformista» e poi Paolo Legrenzi, Petar Bojanic, Pier Aldo Rovatti e Paolo Flores d’ Arcais.
 Nel frattempo in Gran Bretagna la rivista «Prospect» ha annunciato la fine del postmoderno in tutte le sue declinazioni, presentando la mostra «Postmodernism. Style and Subversion», che si inaugura il 24 settembre al Victoria and Albert Museum di Londra. Domani invece si apre a Milano, presso l’ Università Statale e l’ ateneo del San Raffaele, il VII Congresso della Società europea di filosofia analitica, cui partecipano, fino al 6 settembre, studiosi provenienti da 54 Paesi.
Nel frattempo in Gran Bretagna la rivista «Prospect» ha annunciato la fine del postmoderno in tutte le sue declinazioni, presentando la mostra «Postmodernism. Style and Subversion», che si inaugura il 24 settembre al Victoria and Albert Museum di Londra. Domani invece si apre a Milano, presso l’ Università Statale e l’ ateneo del San Raffaele, il VII Congresso della Società europea di filosofia analitica, cui partecipano, fino al 6 settembre, studiosi provenienti da 54 Paesi.* Corriere della sera, 31.08.2011
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- NUOVO REALISMO. Penati e il pensiero debole (di Bruno Gravagnuolo)7 settembre 2011, di Federico La Sala
Penati e il pensiero debole
di Bruno Gravagnuolo (l’Unità, 07.09.2011)
Due dibattiti di questa estate, senza apparente connessione. La fine del «pensiero debole», e il caso Penati. Che c’entrano l’uno con l’altro? Molto, perché il debolismo in filosofia, noto anche come post-moderno, è stato un alone di mentalità vincente e di massa che ha favorito cinismo e disincanto. In politica, nell’etica civile e nelle scienze umane o nell’arte. Sicché, quando oggi Maurizio Ferraris, peraltro ex debolista, sfida Vattimo su Repubblica, proponendo il suo «nuovo realismo», dice una banalità sacrosanta: senza fondamenti della conoscenza ci sono solo i ghirigori del nichilismo, l’irresponsabilità in etica e l’indifferentismo. Di là del fatto poi che Vattimo abbia platealmente contraddetto il suo debolismo. Con la sua indignazione giacobina contro Berlusconi, e il suo gravitare tra Di Pietro e neocomunisti. Ma al pensiero debole che dissolve ogni pensiero di sinistra ha fatto riscontro un pensiero forte di destra: populista, identitario, leaderistico, all’insegna dello stato spettacolo.
E qui veniamo al caso Penati. Il quale al di là degli sviluppi giudiziari va rubricato così: napoleonismo localistico, confusione tra politica e interessi, disinvoltura e opacità sulle grandi scelte che riguardano la vita dei cittadini. Bene, è stato ed è un partito debole e «lieve», a consentire l’onnipotenza dei potentati locali (da Bassolino in su e in giù). Potentiplebiscitati da spinte maggioritarie. Che blindano sindaci, governatori e amministratori, e li dotano di poteri insindacabili. Dunque, partito debole e notabili forti, appartenenza debole e pratiche rampanti. E cioè: il partito nazionale non conta e dipende dalle periferie. Morale: contro il riesplodere della questione morale non bastano le regole e i probi viri. Ci vuole un partito forte con un pensiero forte. Partito lieve e politica lieve fanno comodo solo all’avversario.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- NUOVO REALISMO. DATO L’ ADDIO A KANT, MAURIZIO FERRARIS SI PROPONE COME IL SUPERFILOSOFO DELLA CONOSCENZA (QUELLA SENZA PIU’ FACOLTA’ DI GIUDIZIO)9 settembre 2011, di Federico La SalaSTORIA DELLA FILOSOFIA: NEW REALISM o, che è lo stesso, NEW IDEALISM. Dopo Marx, dopo Nietzsche, dopo Freud, e dopo Foucault ...
 "NUOVO REALISMO", IN FILOSOFIA. DATO L’ ADDIO A KANT, MAURIZIO FERRARIS SI PROPONE COME IL SUPERFILOSOFO DELLA CONOSCENZA (QUELLA SENZA PIU’ FACOLTA’ DI GIUDIZIO). Una nota sul tema - di Federico La Sala
"NUOVO REALISMO", IN FILOSOFIA. DATO L’ ADDIO A KANT, MAURIZIO FERRARIS SI PROPONE COME IL SUPERFILOSOFO DELLA CONOSCENZA (QUELLA SENZA PIU’ FACOLTA’ DI GIUDIZIO). Una nota sul tema - di Federico La Sala
-
-
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- Il tradimento delle élites democratiche e delle forze politiche che dal 1994 in avanti le hanno rappresentate (di Lucia Ceci - Zagrebelsky e C. Non date la colpa al Papa).8 luglio 2011, di Federico La Sala
 Zagrebelsky e C.
Zagrebelsky e C.
 Non date la colpa al Papa
Non date la colpa al Papa di Lucia Ceci (il Fatto/Saturno, 08.07.2011)
di Lucia Ceci (il Fatto/Saturno, 08.07.2011)- F. Cassano, L’umiltà del male, Laterza, pagg. 96, • 14
- E. Mauro - G. Zagrebelsky, La felicità della democrazia, La-terza, pagg. 192, • 15
LA FINE DI UNA stagione si consuma sempre con una resa dei conti: chi è stato responsabile di cosa. Negli italici confini del secolo breve è capitato almeno tre volte: Caporetto, 8 settembre, tangentopoli. Il redde rationem investe le persone, i fatti, le cose. Ma gli intellettuali sono interessati anche ad altro: le cause. Accade dunque, nel crepuscolo del berlusconismo, che i professionisti dell’analisi di lungo periodo si adoperino per individuare il vizio d’origine di tanto sfa-celo. E poiché la scena, con le notti di Arcore, si consuma su un terreno etico in cui il privato si mesce col pubblico e ha il volto seducente e da tutti decifrabile di una prostituta minorenne, appare naturale chiamare in causa l’azionista di maggioranza dell’ethos pubblico italiano: la Chiesa cattolica.
In questi mesi di crisi torna a riaffacciarsi il teorema che evoca la presenza del papato nel territorio nazionale quale forza fiaccatrice degli anticorpi civili : dal fascismo a Scilipoti, passando per l’evasione fiscale, la corruzione, il bunga-bunga. Così, più che in altri momenti, ci troviamo a imparare da Ezio Mauro come, nello sfacelo delle istituzioni democratiche, la «riconquista» dei vescovi sia «quasi un Dio italiano che cammina, una sorta di via italiana al cattolicesimo».
E contemporaneamente ci imbattiamo nel dito di Gustavo Zagrebelsky, puntato contro «l’enorme concentrazione di potere mondano» di cui la Chiesa dispone. E nei suoi profetici richiami perché essa si purifichi dai beni della terra e dal potere sulla terra. Pena la salvezza della laicità e, dunque, della democrazia. Una Chiesa di santi. Una laicità senza se e senza ma.
Eppure non si può mettere sulle spalle di Pietro il peso dei guasti della democrazia in Italia. Ora è vero che la gerarchia cattolica ha rinunciato da troppo tempo a parlare di Dio. E sente piuttosto il dovere di intervenire su temi lontani dalle Sacre Scritture e dalle vite concrete delle donne e degli uomini. Che vuole raggiungere direttamente il legislatore nelle pieghe di un tessuto politico fragile e gregario. Ma non si può ignorare che l’essere cattolici si riduce all’esser stati battezzati, che i vescovi orientano sempre meno le menti, le scelte morali, le decisioni elettorali degli italiani. La longa manus della Chiesa (così la chiamano Mauro e Zagrebelsky) riesce solo a muovere un ceto politico impegnato nella spartizione di prebende, il cui cinismo resiste ai colpi di ogni indignazione.
Da parte mia mi sottrarrei volentieri al compito di individuare il germe che fornisce la cifra specifica del deficit di etica pubblica nell’Italia di oggi. Perché non sono capace di fare un ragionamento semplificato. Avrei bisogno di tirare in ballo crisi del sistema dei partiti, mutamenti di assetti internazionali, tradizioni civiche, culture politiche, guelfi e ghibellini. E il ragionamento sarebbe meno incalzante. Una cosa però la voglio dire.
Se proprio non posso sottrarmi alla semplificazione tirerei in ballo il tradimento delle élites democratiche e delle forze politiche che dal 1994 in avanti le hanno rappresentate. Perché in 17 anni di berlusconismo hanno guidato il Paese per 101 mesi, cioè 8 anni e mezzo, se mettiamo insieme i governi Dini, Prodi, D’Alema, Amato. Perché il loro narcisismo etico - per usare una categoria centrale nell’ultimo libro di Franco Cassano, L’umiltà del male - il loro atteggiamento di superiorità morale le ha rese incapaci di una mobilitazione in grado di innervare la politica.
Se il Grande Inquisitore è riuscito ad avvelenare i pozzi non è solo per la sua potenza, ma anche perché il campo gli è stato lasciato libero dalla presunzione di quelli che Dostojevski nella sua Leggenda chiama i dodicimila santi.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- LA FACOLTA’ DI GIUDIZIO E IL MAGISTERO DEI SANTI PADRI DELLA CHIESA CATTOLICA DI OGGI.7 luglio 2011, di Federico La Sala
 SONNO DOGMATICO, STATO DI MINORITA’, E INCAPACITA’ DI GIUDIZIO. DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! CARDINAL RAVASI, NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? SI TRATTA DELLA PAROLA FONDANTE E DISTINTIVA DELLA FEDE CRISTIANA!!! Ha dimenticato l’esortazione di Papa Wojtyla ("Se mi sbalio, mi coriggerete")?!
SONNO DOGMATICO, STATO DI MINORITA’, E INCAPACITA’ DI GIUDIZIO. DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! CARDINAL RAVASI, NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? SI TRATTA DELLA PAROLA FONDANTE E DISTINTIVA DELLA FEDE CRISTIANA!!! Ha dimenticato l’esortazione di Papa Wojtyla ("Se mi sbalio, mi coriggerete")?!
 LA FACOLTA’ DI GIUDIZIO E IL MAGISTERO DEI SANTI PADRI DELLA CHIESA CATTOLICA DI OGGI. Il cardinale Ravasi si rende conto che "è grave atrofizzare la facoltà, di cui è dotata la nostra mente, di sceverare tra vero e falso", ma continua a fare "sogni d’oro"! Un suo "mattutino" - con alcune note, a c. di Federico La Sala
LA FACOLTA’ DI GIUDIZIO E IL MAGISTERO DEI SANTI PADRI DELLA CHIESA CATTOLICA DI OGGI. Il cardinale Ravasi si rende conto che "è grave atrofizzare la facoltà, di cui è dotata la nostra mente, di sceverare tra vero e falso", ma continua a fare "sogni d’oro"! Un suo "mattutino" - con alcune note, a c. di Federico La Sala
 GIUDICARE E VALUTARE. (...) Montaigne, nei suoi Saggi non esitava ad affermare che «la cura e la spesa dei nostri padri mirano solo a riempirci la testa di sapere; di giudizio e di virtù, non se ne parla nemmeno!»
GIUDICARE E VALUTARE. (...) Montaigne, nei suoi Saggi non esitava ad affermare che «la cura e la spesa dei nostri padri mirano solo a riempirci la testa di sapere; di giudizio e di virtù, non se ne parla nemmeno!»
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- STATO DI MINORITA’ E FILOSOFIA COME RIMOZIONE DELLA FACOLTA’ DI GIUDIZIO. Una ’lezione’ di un Enrico Berti, che non ha ancora il coraggio di dire ai nostri giovani che sono cittadini sovrani.27 giugno 2011, di Federico La Sala
 FILOSOFIA, ANTROPOLOGIA E POLITICA. IL PENSIERO DELLA COSTITUZIONE E LA COSTITUZIONE DEL PENSIERO ....
FILOSOFIA, ANTROPOLOGIA E POLITICA. IL PENSIERO DELLA COSTITUZIONE E LA COSTITUZIONE DEL PENSIERO ....
 STATO DI MINORITA’ E FILOSOFIA COME RIMOZIONE DELLA FACOLTA’ DI GIUDIZIO. Una ’lezione’ di un Enrico Berti, che non ha ancora il coraggio di dire ai nostri giovani che sono cittadini sovrani. Una sua riflessione
STATO DI MINORITA’ E FILOSOFIA COME RIMOZIONE DELLA FACOLTA’ DI GIUDIZIO. Una ’lezione’ di un Enrico Berti, che non ha ancora il coraggio di dire ai nostri giovani che sono cittadini sovrani. Una sua riflessione
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- Quando manca la coscienza (di Barbara Spinelli)6 luglio 2011, di Federico La Sala
Quando manca la coscienza
di Barbara Spinelli (la Repubblica, 06.07.2011)
Vale la pena meditare su cosa significhi precisamente partito degli onesti, visto che a proporlo è stato il nuovo segretario del Pdl. ossia della formazione che sin qui non aveva la rettitudine come stella polare. Può darsi che Alfano abbia emesso un mero suono, un flatus vocis senza rapporto alcuno con la realtà, ma i realisti che credono nella consistenza delle parole hanno tutto l’interesse a ripensare vocaboli come onestà, morale pubblica, virtù politica. A meno di non essere incosciente, il ministro della Giustizia non può infatti ignorarlo: i passati diciassette anni non sono stati propriamente intrisi di probità (lui stesso ne è la prova vivente, avendo aiutato Berlusconi a inserire nella manovra economica un codicillo ad personam, che tutelando il premier dalla sentenza sul Lodo Mondadori nobilita a tutti gli effetti il concetto di insolvenza nel privato). Alle spalle abbiamo un’epoca corrotta, molto simile al periodo dei torbidi che Mosca conobbe fra il XVI e il XVII secolo, prima che i Romanov salissero al trono e mettessero fine all’usurpazione di Boris Godunov.
Meditare sull’onestà dei politici significa che da quest’epoca usciremo - se ne usciremo - a condizione di capire in concreto cosa sia la morale pubblica, e come la sua cronica violazione abbia prodotto una propensione al vizio quasi naturale, che va ben oltre la disubbidienza alle leggi. Soprattutto, significa guardare al fenomeno Berlusconi come a qualcosa che è dentro, non fuori di noi: la cultura dell’illegalità, i conflitti d’interesse vissuti non come imbarazzo ma come risorsa, non sono qualcosa che nasce con lui ma hanno radici più profonde, non ancora estirpate. Sono un male italiano di cui il premier è il sintomo acutizzato: chiusa la parentesi non l’avremo curato ma solo preteso d’averlo fatto. L’inferno non sono gli altri, ogni giorno lo constatiamo: dal dramma dei rifiuti a Napoli alle vicende che scuotono il partito di Bersani e D’Alema.
Il fatto è che ci stiamo abituando a restringere la nozione di morale pubblica. L’assimiliamo a una condotta certamente cruciale - l’osservanza delle leggi, sorvegliata dai tribunali - ma del tutto insufficiente. Perché esistano partiti onesti, altri ingredienti sono indispensabili: più personali, meno palpabili, non sempre scritti. Attinenti alle virtù politiche, più che a un dover-essere codificato in norme scritte. Precedenti le stesse Costituzioni.
Di che c’è bisogno dunque, per metter fine alla leggerezza del vizio che riproduce sempre nuovi boiardi e nuovi disastri trasversali come la monnezza napoletana e la corruttela? Gli ingredienti mancanti sono sostanzialmente due: una memoria lunga della storia italiana, e un’idea chiara di quelle che devono essere le virtù politiche a prescindere dalle norme scritte nel codice penale.
La memoria, in primo luogo. Non si parla qui di un semplice rammemorare. Le celebrazioni ci inondano e forse anche ci svuotano; esistono date che evochi continuamente proprio perché sono stelle morte. Per memoria intendo la correlazione stretta, e vincolante, tra ieri e oggi: ogni atto passato (come ogni omissione) ha effetti sul presente e come tale andrebbe analizzato. Diveniamo responsabili verso il futuro perché lo siamo del passato, di come abbiamo o non abbiamo agito.
 Il ragionamento di Tocqueville sull’individuo democratico vale anche per le sue azioni, specialmente politiche: la «catena aristocratica delle generazioni» viene spezzata, e lascia ogni anello per conto suo. Così come avviene per l’individuo, l’atto - sconnesso dalla vasta trama dei tempi - «non deve più nulla a nessuno, si abitua a considerarsi sempre isolatamente (...) Ciascuno smarrisce le tracce delle idee dei suoi antenati o non se ne preoccupa affatto. Ogni nuova generazione è un nuovo popolo (...) La democrazia non solo fa dimenticare a ogni uomo (a ogni azione) i suoi avi, ma gli nasconde i suoi discendenti e lo separa dai suoi contemporanei: lo riconduce incessantemente a se stesso e minaccia di rinchiuderlo per intero nella solitudine del suo cuore».
Il ragionamento di Tocqueville sull’individuo democratico vale anche per le sue azioni, specialmente politiche: la «catena aristocratica delle generazioni» viene spezzata, e lascia ogni anello per conto suo. Così come avviene per l’individuo, l’atto - sconnesso dalla vasta trama dei tempi - «non deve più nulla a nessuno, si abitua a considerarsi sempre isolatamente (...) Ciascuno smarrisce le tracce delle idee dei suoi antenati o non se ne preoccupa affatto. Ogni nuova generazione è un nuovo popolo (...) La democrazia non solo fa dimenticare a ogni uomo (a ogni azione) i suoi avi, ma gli nasconde i suoi discendenti e lo separa dai suoi contemporanei: lo riconduce incessantemente a se stesso e minaccia di rinchiuderlo per intero nella solitudine del suo cuore».La citazione si applica perfettamente alla calamità napoletana. Sono settimane che i leghisti sbraitano, negando la solidarietà con una città che precipita. Se la memoria funzionasse, non potrebbero. Dovrebbero dire, a se stessi e agli italiani, la verità: se Napoli e la Campania sono diventate un’immensa mefitica discarica di rifiuti tossici e non tossici, è perché il Nord da vent’anni ha perpetuato quello che Tommaso Sodano, ex senatore e oggi vice di de Magistris, chiama lo «stupro del Sud»: una «specie di guerra etnica, giocata con l’arma del rifiuto, alimentata dalla camorra, ma anche da una catena di falsificazione e di enti di controllo assenti». Il Nord è responsabile di quanto avviene a Sud, quali che siano le colpe delle amministrazioni campane. La sua industrializzazione ha prodotto rifiuti tossici smaltiti senza trattamento nel Sud, sancendo con la connivenza di clan camorristi la morte del Mezzogiorno, e avvelenando uomini, animali, fiumi, piantagioni (Tommaso Sodano, «La Peste«, Rizzoli 2010).
Il secondo ingrediente, essenziale, è la virtù personale del politico. Indipendentemente dal codice penale, essa dovrebbe escludere frequentazioni di mafiosi, connivenze con personaggi come Cosentino, assuefazione infine alla droga che è il conflitto d’interessi. Piano piano cominciamo a capire come mai, sul conflitto d’interessi berlusconiano, la sinistra non ha mai fatto nulla, anche quando governava: il conflitto era droga anche per lei. Come definire altrimenti il caso Franco Pronzato? Ecco infatti un uomo, vicinissimo ai vertici Pd, che nello stesso momento in cui agiva nel consiglio d’amministrazione dell’Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile), era coordinatore nazionale del trasporto aereo nel Pd. Pronzato ha percepito tangenti sulla rotta Roma-Isola d’Elba e il suo corruttore, Morichini, ha fatto favori finanziari a D’Alema. «L’incarico pubblico assegnato senza neppure mascherare la sua finalità lottizzatoria viene notato ora solo perché Pronzato va in carcere», ha scritto Gad Lerner su «Repubblica« (30 giugno).
Lo scandalo esiste solo quando la magistratura interviene: qui è il male italiano che precede Berlusconi, e per questo è urgente pensare la morale pubblica. Il mondo si rimette nei cardini così: individuando il punto dove la legge non arriva, e però cominciano le indecenze, le cattive frequentazioni, la triviale leggerezza del politico. Non tutte le condotte sono perseguibili penalmente (il doppio incarico di Pronzato non è illegale) ma politicamente non denotano né probità né prudenza: due virtù fra loro legate. Si parla di giustizialismo, del potere dei giudici sulla politica. Se questo accade, è perché la morale pubblica ha come unico recinto la magistratura, e non anche la coscienza.
 Borsellino ha detto, in proposito, cose che restano una bussola: «La magistratura può fare solo un accertamento giudiziale. Può dire: ci sono sospetti, anche gravi, ma io non ho la certezza giuridica (...) Però siccome dalle indagini sono emersi fatti del genere, altri organi, altri poteri, cioè i politici, cioè le organizzazioni disciplinari delle varie amministrazioni, cioè i consigli comunali o quello che sia, dovevano trarre le dovute conseguenze da certe vicinanze tra politici e mafiosi». Se le conseguenze non sono state tratte, «è perché ci si è nascosti dietro lo schermo della sentenza». (La presenza di grossi sospetti) «dovrebbe quantomeno indurre, soprattutto i partiti politici, non soltanto a essere onesti ma a apparire onesti, facendo pulizia al loro interno di tutti coloro che sono raggiunti comunque da episodi o da fatti inquietanti anche non costituenti reati». Era questo il fresco profumo di libertà che augurava all’Italia, prima d’esser ammazzato. Non era flatus vocis, il suo, anche se è stato preso per tale da un’intera classe politica.
Borsellino ha detto, in proposito, cose che restano una bussola: «La magistratura può fare solo un accertamento giudiziale. Può dire: ci sono sospetti, anche gravi, ma io non ho la certezza giuridica (...) Però siccome dalle indagini sono emersi fatti del genere, altri organi, altri poteri, cioè i politici, cioè le organizzazioni disciplinari delle varie amministrazioni, cioè i consigli comunali o quello che sia, dovevano trarre le dovute conseguenze da certe vicinanze tra politici e mafiosi». Se le conseguenze non sono state tratte, «è perché ci si è nascosti dietro lo schermo della sentenza». (La presenza di grossi sospetti) «dovrebbe quantomeno indurre, soprattutto i partiti politici, non soltanto a essere onesti ma a apparire onesti, facendo pulizia al loro interno di tutti coloro che sono raggiunti comunque da episodi o da fatti inquietanti anche non costituenti reati». Era questo il fresco profumo di libertà che augurava all’Italia, prima d’esser ammazzato. Non era flatus vocis, il suo, anche se è stato preso per tale da un’intera classe politica.Dopo Berlusconi, la morale pubblica sarà da reinventare: non uscirà come Afrodite dalle acque. S’imporranno farmaci forti, perché gli italiani osino fidarsi del Politico. Oggi non si fidano: i No-Tav pacifisti di Val di Susa dicono questo. Possiamo sprezzarli, possiamo denunciare la sindrome Nimby (Not In My Backyard, «non nel mio cortile»). Ma non senza dire, prima, che tutti soffrono la stessa sindrome, a cominciare dal Nord di Bossi.
-
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- IL PARADOSSO DELL’IDENTITA’ E LO STRABISMO DA RIDURRE. Per il ciclo "Le Parole della Politica", un "Manifesto per vivere in una società aperta" (di Remo Bodei).,22 giugno 2011, di Federico La Sala
Premessa sul tema. Note:
- HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI. (Federico la Sala)
Il paradosso dell’identità
Manifesto per vivere in una società aperta
Ecco le tesi che il filosofo Bodei presenta domani al ciclo "Le Parole della Politica" sul tema del rapporto tra noi e gli altri La xenofobia rappresenta il risvolto più rozzo di quelle comunità che sono determinate ad essere se stesse Più il mondo si allarga più si tende a reagire con la paura e l’egoismo con la paradossale rinascita di piccole patrie
di Remo Bodei (la Repubblica, 22.06.2011)
Da termine filosofico e matematico per designare l’eguaglianza di qualcosa con se stessa il termine identità è passato a indicare una forma di appartenenza collettiva ancorata a fattori naturali (il sangue, la razza, il territorio) o simbolici (la nazione, il popolo, la classe sociale). Ci si può meravigliare che esistano persone, per altri versi ragionevoli e sensate, che credano a favole come l’"eredità di sangue" o l’autoctonia di un popolo, che si inventino la discendenza incontaminata da un determinato ceppo etnico o la sacralità dell’acqua di un fiume. Eppure, si tratta di fenomeni da non sottovalutare e da non considerare semplicemente folkloristici e ridicoli.
Si potrebbe obiettare - come hanno notoriamente mostrato eminenti storici - che la maggior parte delle memorie ufficiali e delle tradizioni è non solo inventata, ma molto più recente di quanto voglia far credere. Tuttavia, le invenzioni e i miti, per quanto bizzarri, quando mettono radici, diventano parte integrante delle forme di vita, delle idee e dei sentimenti delle persone. (...) Bisogna capire a quali esigenze obbedisce il bisogno di identità, perché esso sia inaggirabile in tutti i gruppi umani e negli stessi individui, perché abbia tale durata e perché si declini in molteplici forme, più o meno accettabili.
Da epoche immemorabili tutte le comunità umane cercano di mantenere la loro coesione nello spazio e nel tempo mediante la separazione dei propri componenti dagli "altri". La formazione del "noi" esige rigorosi meccanismi di esclusione più o meno conclamati e, generalmente, di attribuzione a se stessi di qualche primato o diritto. La xenofobia rappresenta il risvolto più rozzo ed elementare della compattezza di gruppi e comunità che si sentono o si vogliono diversi dagli altri e che intendono manifestare per suo tramite la propria determinazione ad essere se stesse. Essa è l’espressione di un forte bisogno di identità, spesso non negoziabile.
Sebbene si manifesti attraverso un’ampia gamma di sfumature, nella sua dinamica di inclusione/esclusione, l’identità è sempre intrinsecamente conflittuale. Realmente o simbolicamente, circoscrive chi è dentro una determinata area e respinge gli altri. Eppure, per non soffocare nel proprio isolamento, ciascuna società deve lasciare aperte alcune porte, prevedere dei meccanismi opposti e complementari di inclusione dell’alterità. Lo straniero è così, insieme, ponte verso l’alterità e corruttore della compattezza dei costumi di una determinata comunità.
Per orientarsi e capire, occorre distinguere tre tipi di identità.
La prima si esprime in una specie di formula matematica "A=A": l’italiano è italiano e basta, il rumeno è rumeno è basta. Tale definizione naturalistica, auto-referenziale e immutabile, è la più viscerale ed ottusa, incapace di accettare confronti tra la propria e le altre comunità, di cui non vede letteralmente i pregi, ma che anzi sminuisce e disprezza. Essa fa costantemente appello alle radici, quasi che gli uomini siano piante, legati al suolo in cui nascono o, come credevano gli ateniesi antichi, quasi siano sbucati dal suolo come funghi.
In generale, più una società diventa insicura di se stessa, più vengono meno i supporti laici della politica. In tal modo, più si produce una specie di malattia del ricambio sociale, che si materializza nel rifiuto di assorbire l’alterità, e più si proiettano sullo straniero, che magari proviene da popoli di antica civiltà, le immagini del selvaggio, del nemico pericoloso. Certo i vincoli di appartenenza sono necessari a ogni gruppo umano e a ogni individuo, ma non sono naturali (come potremmo sopravvivere se non sapessimo chi siamo?): sono stati costruiti e sono continuamente da costruire, perché l’identità è un cantiere aperto. Per questo la nostra identità non può più essere quella che auspicava Alessandro Manzoni, nel Marzo 1821, per l’Italia ancora da unire: "Una d’arme, di lingua, d’altare,/ Di memorie, di sangue e di cor". Oggi alcuni di questi fattori non sono più richiesti, tranne la "lingua", anche per motivi pratici, e, possibilmente, il "cor", l’Intimo sentimento di appartenenza. La religione, soprattutto, non rappresenta più un fattore discriminante per ottenere la piena cittadinanza e non caratterizza (o non dovrebbe più caratterizzare) l’intera persona come soltanto "mussulmano" o "cristiano".
Il secondo modello si basa sulla santificazione dell’esistente per cui, quello che si è divenuti attraverso tutta la storia ha valore positivo e merita di essere esaltato. Si pensi al Proletkult sovietico degli anni Venti: il proletario è buono, bravo, bello. Si dimenticano così le ferite, le umiliazioni, le forme di oppressione, le deformazioni che la storia ha prodotto sulle persone. Lo stesso è accaduto nel proto-femminismo: la donna è da santificare così come è divenuta. Anche qui si trascura quanto dicevano, in maniera opposta, Nietzsche e Adorno. Secondo Nietzsche, quando si va da una donna, non bisogna dimenticare la frusta. Al che Adorno, giustamente, osservava che la donna è già il risultato della frusta.
Il terzo tipo di identità, quello che preferisco e propongo, è rappresentato da un’identità simile ad una corda da intrecciare: più fili ci sono, più l’identità individuale e collettiva si esalta. Bisogna avere accortezza e pazienza politica nell’inserire nel tessuto sociale individui e gruppi finora esclusi, perché al di fuori dell’integrazione non esistono realisticamente altre strade praticabili. Integrazione non vuol dire assimilazione, rendere gli altri simili a noi, ma non vuol dire nemmeno lasciarli in ghetti, in zone prive di ogni nessun contatto con la popolazione locale.
Dobbiamo ridurre lo strabismo, che diventa sempre più forte, tra l’idea che la globalizzazione sia un processo che cancella le differenze e l’esaltazione delle differenze stesse. Il grande paradosso odierno è, appunto, che quanto più il mondo tende ad allargarsi e ad integrarsi, tanto più sembra che a queste aperture si reagisca con chiusure dettate dalla paura e dall’egoismo, con la rinascita di piccole patrie.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- "MEDITATE CHE QUESTO E’ STATO". CON GRAMSCI, PRIMO LEVI E KURT H. WOLFF - SULLA ZATTERA DELLA MEDUSA, SU UN OCEANO DIPINTO, CON L’AMORE COGNITIVO.21 giugno 2011, di Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- ’NDRANGHETA E NON SOLO. LAMEZIA TERME DA’ IL VIA: IN COLLISIONE CON LA COLLUSIONE!!! «Trame. Festival dei libri sulle mafie» promosso dall’assessore alla Cultura, Tano Grasso, antesignano del movimento nazionale antiracket.20 giugno 2011, di Federico La Sala
 CALABRIA: RISCOSSA CIVILE. La ’ndrangheta non si sconfigge solo nelle aule dei Tribunali, ma anche con una politica culturale sul territorio che faccia terra bruciata del consenso di cui si alimenta.
CALABRIA: RISCOSSA CIVILE. La ’ndrangheta non si sconfigge solo nelle aule dei Tribunali, ma anche con una politica culturale sul territorio che faccia terra bruciata del consenso di cui si alimenta.
 LAMEZIA TERME DA’ IL VIA: IN COLLISIONE CON LA COLLUSIONE!!! «Trame. Festival dei libri sulle mafie» promosso dall’assessore alla Cultura, Tano Grasso, antesignano del movimento nazionale antiracket.
LAMEZIA TERME DA’ IL VIA: IN COLLISIONE CON LA COLLUSIONE!!! «Trame. Festival dei libri sulle mafie» promosso dall’assessore alla Cultura, Tano Grasso, antesignano del movimento nazionale antiracket.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- Viviamo in un momento di vera e propria patologia epistemica. Il ruolo degli intellettuali all’epoca di web e tv (di Nicla Vassallo)21 giugno 2011, di Federico La Sala
Tecnologie e sapere
Il ruolo degli intellettuali all’epoca di web e tv
Strumenti. La filosofia ci aiuta a svelare le complessità del mondo e a evidenziarne le carenze
Gli ostacoli. L’egocentrismo e il narcisismo di molti individui offuscano questa comprensione
di Nicla Vassallo (l’Unità, 21.06.2011)
L’intellettualità, la filosofia in particolare, ci aiuta a svelare le complessità del nostro mondo, ma pure a evidenziarne, addirittura a denunciarne le carenze. C’è tutta una parte di umanità contemporanea che nutre fiducia in chi non dovrebbe, che viene indotta a credere in valori che tali non sono, che vede bellezze dove si situano invece bruttezze, che coltiva l’ignoranza in luogo della conoscenza. La filosofia chiarisce i concetti necessari, oltre che per pensare e ragionare bene, per condurre esistenze degne di venire vissute. Tra questi concetti, non a caso domina quello di conoscenza. Perché senza aspirare alla conoscenza non saremmo esseri umani: questa è una lezione che, nata con la filosofia antica, non ha mai cessato di caratterizzare l’intera intellettualità occidentale. Senza conoscenza, ci troveremmo, se va bene, in uno stato vegetativo.
Quanti nemici, però. I vari egocentrismi, personalismi, narcisismi di molti individui hanno a lungo offuscato la possibilità di comprendere il mondo. Occorre tempo per scusare il loro oscurantismo in «fase terminale». Per la maggior parte, tali individui non condividono, con altri, valori importanti, quali la verità, ovvero la ricerca della verità, insieme al dire la verità. Individui che mentono a se stessi e si auto-ingannano finiscono col mentire agli altri e con l’ingannarli. Eccoci: viviamo in una sorta di Torre di Babele, non tanto per i linguaggi diversi che utilizziamo nel discorrere, quanto perché c’è chi abusa di questi linguaggi, li impiega non per trasmettere conoscenza, ma piuttosto per prevaricare l’altro-da-sé, per asservirlo alle più bieche ambizioni. In altri termini, circola troppa superbia, il che non ci aiuta a comprendere il mondo, né le relazioni umane che tessiamo.
La superbia (benché non solo) avvantaggia una cultura pop italiana, per lo più televisiva, di basso livello. Chi oggi viene considerato dalla maggioranza un intellettuale corrisponde in genere a un onnipresente televisivo, e la gran parte della televisione italiana contemporanea proferisce banalità, se non spesso falsità, o insulsaggini, infarcite di buona retorica, banalità che un tempo, per pudore, non si osavano pronunciare neanche tra sé e sé. C’è una spaccatura, ormai evidente, tra l’intellettuale vero e proprio, e chi applica, invece, gli ordini ricevuti dall’alto.
La differenziazione linguistico-culturale tra il vero intellettuale e quello che si atteggia a tale sta creando una sorta di classe privilegiata, una classe colta, consapevole, dotata degli strumenti per operare le scelte migliori, rispetto a una massa che di questi strumenti viene privata. Fanno gioco i complessi rapporti tra intellettuali atteggiati, schiavi del tiranno, masse e potere. Ma su ciò Elias Canetti ci aveva già messo in guardia in quel capolavoro che rimane Masse und Macht. Mentre gli intellettuali veri e propri? Non stanno a guardare; il loro margine di manovra rimane nondimeno decisamente ridotto, rispetto a un tempo. Farsi un nome, acquisire una fama immeritata, mirare a denari e successi, soggiogare la massa, testimoniare il falso o l’irragionevole non appartiene all’intellettualità degna di definirsi tale.
Possiamo confidare nella speranza che l’intellettualità vera e propria non sia una specie in via di estinzione. Alcuni intellettuali hanno rinunciato all’onnipresenza televisiva per dedicarsi alla scrittura: libri, carta stampata, ma pure blog - senza tralasciare i video su internet, dove l’intellettuale carica le riprese e i le riflessioni che desidera, senza dover badare a censure e ad ascolti.
Non dimentichiamo però che parecchi e cosiddetti grandi, vecchi intellettuali italiani detestano la tecnologia, sostanzialmente qualsiasi tecnologia. In effetti, il discorso sulla tecnologia rimane tra i più complessi, ed è sempre un dispiacere accorgersi che in troppi si esprimono contro la tecnologia senza alcuna cognizione di causa, senza distinguere tra ricerca scientifico-conoscitiva e le sue applicazioni tecnologiche, senza riconoscere le tante differenti tecnologie. Limitando l’attenzione alle tecnologie legate al trasferimento di conoscenza, in cui vengono coinvolti più modi e mezzi comunicativi, dobbiamo ammettere senza esitazioni che viviamo nella cosiddetta società dell’informazione.
Se un tempo contavano maggiormente gli scambi conversazionali, diretti, individuali, quotidiani, oggi telefoni, cellulari, sms, e-mail, blog, social network, piattaforme varie consentono inusitate potenzialità. Se un tempo ci si incontrava al caffè, in piazza, nei salotti culturali, oggi è internet a «unirci», apparentemente offrendo possibilità singolari alla vita comunitaria. Ma conosciamo sempre con chi stiamo interloquendo quando navighiamo su internet? Quali sono le informazioni false e quali quelle vere? Quali i testimoni inaffidabili e quali quelli affidabili? Chi e che cosa ci stanno trasferendo conoscenza, e chi e che cosa invece ci sta ingannando, manipolando, controllando, tradendo? La storia del mondo, quella antecedente all’avvento di internet, ci ha regalato molti «Grandi Fratelli». Occorre fare sì che il web non si trasformi nel «Grande Fratello» di orwelliana memoria.
Il pensiero va rivolto ora ai tanti giovani che, alle prese con l’esame di maturità, stanno considerando di iscriversi all’università. Ciò che verrà loro riferito si trasformerà in conoscenza? Non sono in pochi i ricercatori, professori, rettori che faticano con cellulari, sms, e-mail, blog, social network, piattaforme varie, ma pure con volumi, enciclopedie, giornali, riviste, radio, televisione. Proviamo a eliminare tutto ciò, cosa rimane? Ai giovani poco. E a tutti? Non sapremmo neanche il nostro nome (nome che ci viene riferito da altri, per esempio dal registro degli uffici municipali), mentre il nostro status conoscitivo, nonché pratico ne risulterebbe spogliato, depauperato. In quale epoca ci troveremmo? Probabilmente, ancora all’età della pietra.
Di cosa soffriremmo? Senz’altro di carenze cognitivo-affettive, incoerenze, ignoranze, paranoie. Anche le stesse scienze non avrebbero compiuto i progressi cui siamo ormai abituati: specie nella nostra epoca, gli scienziati sono difatti incapaci di scoperte, se non si basano sulle conoscenze di altri scienziati. Di più: capire la conoscenza ci aiuta a inquadrare con consapevolezza astrologi, complotti, credulità, dittature, gaffe, giornalismi, guerre, inganni, inquisizioni, internet, poteri, pubblicità.
Garantire ai giovani conoscenza è un nostro obbligo. Perché? Stando, per esempio, a David Hume, «un uomo delirante, o noto per la sua falsità e furfanteria non ha autorità alcuna su di noi». Per anni, tuttavia, non è stato così: a falsi e furfanti è stata attribuita grande autorità. Il suggerimento di Hume deve valore per i giovani, soprattutto per loro, benché non solo. Come accade che uomini deliranti e furfanti, noti per le loro falsità, continuino a esercitare autorità su gran parte del popolo? Come abbiamo potuto credere, almeno inizialmente, a Hitler quando giurava di non aver intenzioni belligeranti? Perché ci siamo fidati di un George Bush che sosteneva la presenza di armi di distruzioni di massa in Iraq, e non degli ispettori dell’Onu che la negavano?
Perché leggiamo un giornalista fazioso? Per ingenuità conoscitiva! Viviamo in un momento di vera e propria patologia epistemica, in cui le deviazioni dell’ignoranza e degli ignoranti ci affascinano.
Purtroppo, non capiamo che queste deviazioni conducono a devastazioni: per l’appunto alla Seconda Guerra Mondiale, alla Guerra in Iraq, o, più semplicemente, al giornalista che conduce una trasmissione come «Qui Radio Londra», sottintendendo di svolgere le essenziali funzioni informative che ha svolto la Bbc a partire dal 1938, quando invece si tratta di tutt’altro. Difendiamo la scuola e l’università pubbliche, finanziamole, facendo sì che in esse siano messi in panchina corrotti e ignoranti. Non solo i giovani devono poter aver un futuro, ma devono poter essere in grado di scegliere il futuro migliore, grazie a ottimi maestri che offrano tutti gli strumenti per condurre un’esistenza da esseri umani.
-
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- L’irruzione del futuro (di Barbara Spinelli)16 giugno 2011, di Federico La Sala
L’irruzione del futuro
di Barbara Spinelli (la Repubblica, 15 giugno 2011)
Forse, dopo la perdita di Milano e Napoli, la sconfitta al referendum è la più avvilente nella storia di Berlusconi. Si era messo in testa che ignorandolo l’avrebbe ucciso, l’aveva definito «inutile», e il giorno del voto se n’era andato pure al mare, esemplarmente. Niente da fare: il quorum raggiunto e i quattro sì che trionfano non sono solo un colpo inferto alla guida del governo.
È una filosofia politica a franare, come la terra che d’improvviso si stacca dalla montagna e scivola. È un castello di parole, di chimere coltivate con perizia per anni. «Meno male che Silvio c’è», cantavano gli spot che il premier proiettava, squisita primizia, nei festini. Gli italiani non ci credono più, il mito sbrocca: sembra l’epilogo atroce dell’Invenzione di Morel, la realtà-non realtà di Bioy Casares. Per il berlusconismo, è qualcosa come un disastro climatico.
Tante cose precipitano, nel Paese che credeva di conoscere e che invece era un suo gioco di ombre: l’idea del popolo sovrano che unge la corona, e ungendola la sottrae alla legge. L’idea che il cittadino sia solo un consumatore, che ogni tanto sceglie i governi e poi per anni se ne sta muto davanti alla scatola tonta della tv. L’idea che non esistano beni pubblici ma solo privati: il calore dell’aria, l’acqua da bere, la legge uguale per tutti, la politica stessa. L’idea, più fondamentale ancora, che perfino il tempo appartenga al capo, e che un intero Paese sia schiavo del presente senza pensare - seriamente, drammaticamente - al futuro.
Più che idee, erano assiomi: verità astratte, non messe alla prova. Non avendo ottenuto prove, il popolo è uscito dai dogmi. Lo ha fatto da solo, senza molto leggere i giornali, gettando le proprie rabbie in rete. È una lezione per i politici, i partiti, i giornali, la tv. La fiamma del voto riduce una classe dirigente a mucchietto di cenere.
Pochi hanno visto quello che accadeva: il futuro che d’un tratto irrompe, la stoffa di cui è fatto il tempo lungo che gli italiani hanno cominciato a valutare. Erano abituati, gli elettori, a non votare più ai referendum. Questa volta sono accorsi in massa: a tal punto si sentono inascoltati, mal rappresentati, mal filmati. Nessuna canzoncina incantatrice li ha immobilizzati al punto di spegnerli.
Berlusconi lo presentiva forse, dopo Milano e Napoli, ma come un automa è caduto nella trappola in cui cadde Craxi nel 1991 - andare al mare mentre si vota è un rozzo remake - e con le sue mani ha certificato la propria insignificanza. Impreparato, è stato sordo all’immenso interrogativo che gli elettori di domenica gli rivolgevano: se la sovranità del popolo è così cruciale come proclama da anni, se addirittura prevale sulla legge, la Costituzione, come mai il Cavaliere ha mostrato di temere tanto il referendum? Come spiegare la dismisura della contraddizione, che oggi lo punisce?
Il popolo incensato da Berlusconi, usato come scudo per proteggere i suoi interessi di manager privato, non è quello che si è espresso nelle urne. È quello, immaginario, che lui si proiettava sui suoi schermi casalinghi: un popolo divoratore di show, ammaliato dal successo del leader. Chi ha visto Videocracy ricorderà la radice oscena della seduzione, e le parole di Fabrizio Corona: «Io sono Robin Hood. Solo che tolgo ai ricchi, e dò a me stesso».
Nel popolo azzurro la libertà è regina, ma è tutta al negativo: non è padronanza di sé ma libertà da ogni interferenza, ogni contropotere. Ha come fondamento la disumanizzazione di chiunque si opponga, di chiunque incarni un contropotere.
Di volta in volta sono «antropologicamente diversi» i magistrati, i giornalisti indipendenti, la Consulta, il Quirinale. Ora è antropologicamente diverso anche il popolo elettore, a meno di non disfarsi di lui come Brecht consigliò al potere senza più consensi. Era un Golem, il popolo - idolo d’argilla che il demiurgo esibiva come proprio manufatto - e il Golem osa vivere di vita propria. Il premier lo aveva messo davanti allo sfarfallio di teleschermi che le nuove generazioni guardano appena, perché la scatola tonta ti connette col nulla. E quando ti connette con qualcuno - Santoro, Fazio, Saviano - ecco che questo qualcuno vien chiamato «micidiale» e fatto fuori.
Il popolo magari si ricrederà, ma per il momento ha abolito il Truman Show. Ha deciso di occuparsi lui dei beni pubblici, visto che il governo non ne ha cura. Non sa che farsene del partito dell’amore, perché nella crisi che traversa non chiede amore ai politici ma rispetto, non chiede miraggi ottimistima verità. Accampa diritti, ma non si limita a questo.
Pensare il bene pubblico in tempi di precarietà e disoccupazione vuol dire scoprire il dovere, la responsabilità. Celentano lunedì sera ha detto che siamo disposti perfino ad avere un po’ più freddo, in attesa di energie alternative al nucleare. Per questo si sfalda il dispositivo centrale del berlusconismo: la libertà da ogni vincolo è distruttiva per l’insieme della comunità. Era ammaliante, ma lo si è visto: perché simile libertà cresca, è indispensabile che il popolo sia tenuto ai margini della res publica.
Specialmente nei referendum, dove si vota non per i partiti ma per le politiche che essi faranno, il popolo prende in mano i tempi lunghi cui il governo non pensa, e gli rivolge la domanda cruciale: è al servizio del futuro, un presidente del Consiglio che ha paura dell’informazione indipendente, che ha paura di dover rispondere in tribunale, che elude la crisi iniziata nel 2007, che non medita la catastrofe di Fukushima e considera il no al nucleare un’effimera emozione? Pensa al domani o piuttosto a se stesso, chi sprezza la legalità pur di favorire piccole oligarchie, il cui interesse per le generazioni a venire è nullo? Ai referendum come nelle amministrative il tempo è tornato a essere lungo. Non a caso tanti dicono: si ricomincia a respirare.
La crisi ha insegnato anche questo: non è vero che il privato sia meglio del pubblico, che il mercato coi suoi spiriti animali s’aggiusti da sé, che la politica privatizzata sia la via. I privati non sono in grado di costruire strade, ferrovie, energia pulita per i nipoti. Vogliono profitti subito e a basso costo, senza badare alla qualità e alla durata. Berlusconi si presentò come il Nuovo ed era invece custode di un disordine naufragato nel 2007. Non era Roosevelt o Eisenhower, non ha edificato infrastrutture per le generazioni che verranno.
Ogni persona, dice Deleuze, è un «piccolo pacchetto di potere», e l’etica la costruisce su tale potere. Berlusconi pensava - forse pensa ancora - che questo potere fosse suo: che non fosse così diffuso in pacchetti. Pensava che il cittadino non avesse bisogno di verità; che il coraggio te lo dai nascondendola. Pensava (pensa) che il coraggio consista nel ridurre le tasse, e chi se ne importa se l’Italia precipita come la Grecia o se pagheranno i nipoti.
Pensava che, bocciato il legittimo impedimento, puoi farti una prescrizione breve, come se il popolo non avesse proscritto ogni legge ad personam. Il Cavaliere ha eredi nel Pdl. Ma all’eredità come bene consegnato al futuro non ha mai badato, convinto che la crisi sia come la morte (e lui come la vita) per Epicuro: «Finché Silvio c’è, la crisi non esiste. Quando la crisi arriva, Silvio non c’è». Tanti ne sono convinti, e lo incitano a «tornare allo spirito del ’94»: dunque a mentire sulle tasse, di nuovo.
Chi lo incita sa quello che dice? Ha un’idea di quel che è successo fra il 1994 e il 2011? Rifare il ’94 non è da servi liberi, ma da gente che ignora il mondo e ne inventa di falsi. Se fossero liberi e coraggiosi non sarebbero stupidi al punto di consigliare follie. Se insistono, vuol dire che sono servi soltanto. La loro retorica è così smisurata che neppure capiscono la nemesi, che s’è abbattuta sul loro padrone.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- Cacciari, sogni o sei desto? (di Rinaldo Gianola)1 giugno 2011, di Federico La Sala
Cacciari, sogni o sei desto?
di Rinaldo Gianola (l’Unità, 01.06.2011)
«Pisapia non ce la farà mai». «Non c’è dubbio che settori del Pd convergerebbero su Albertini». «Pisapia se vuole vincere deve chiedere subito l’apparentamento con il Terzo Polo». Chi ha pronunciato, una dietro l’altra, queste formidabili profezie?
Massimo Cacciari, ex sindaco di Venezia, filosofo, politico, teorico del Terzo Polo. Non ce lo siamo dimenticati, non è possibile. Cacciari non passa mai inosservato. I suoi articoli e le sue interviste sono il sale delle pagine politiche dei giornali. Le cerchiamo con la stessa passione con cui tanti anni fa lo seguivamo mentre distribuiva i volantini assai estremi al Petrolchimico di Marghera, forse la sua migliore stagione politica con quella industrialista dentro il Pci insieme a Luciano Barca.
Le analisi del filosofo, passato dalla complessità di Heidegger alla serenità spirituale e contabile di Don Verzè, offrono sempre un punto di vista originale, tendono a sparigliare le carte banali della politica, ma se possiamo permetterci una rispettosa osservazione ormai Cacciari non ci becca più, zero.
Pisapia ha vinto alla grande, non ha chiesto l’apparentamento a nessuno, e Albertini, come un vecchio boiardo, ha preferito la presidenza di Edipower a una possibile candidatura a sindaco di Milano per il Terzo Polo. Cacciari, forse, è troppo avanti, anche per i suoi amici. Montezemolo, Rutelli e il solito Albertini disertarono l’assemblea-evento al Teatro Parenti, il novembre scorso, che avrebbe dovuto benedire il nuovo Polo. Cacciari però non si arrende. Dopo il trionfo di Pisapia ha avvertito:«La sinistra non si illuda...». Giusto. Ma vuoi vedere che se torniamo a votare magari mandiamo a casa Berlusconi?
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- Le critiche agli intellettuali italiani dello storico torinese, Gian Enrico Rusconi, che ormai vive in Germania (di Simonetta Fiori - "Eravamo un laboratorio politico oggi abbiamo solo star e imitatori").30 maggio 2011, di Federico La Sala
 Gian Enrico Rusconi
Gian Enrico Rusconi Le critiche agli intellettuali italiani dello storico torinese che ormai vive in Germania
Le critiche agli intellettuali italiani dello storico torinese che ormai vive in Germania
 "Dagli anni Novanta la nostra cultura ha smesso di esercitare fascino e si è sbriciolata"
"Dagli anni Novanta la nostra cultura ha smesso di esercitare fascino e si è sbriciolata" "Eravamo un laboratorio politico oggi abbiamo solo star e imitatori"
"Eravamo un laboratorio politico oggi abbiamo solo star e imitatori" "Ad un certo punto la mia generazione sentì che era arrivata la sua occasione: ma abbiamo fallito, non capendo la socialdemocrazia"
"Ad un certo punto la mia generazione sentì che era arrivata la sua occasione: ma abbiamo fallito, non capendo la socialdemocrazia"
 "È mancata una riflessione seria sulla nazione, liquidata con critiche superficiali E siamo stati incapaci di guardare alla politica estera"
"È mancata una riflessione seria sulla nazione, liquidata con critiche superficiali E siamo stati incapaci di guardare alla politica estera" di Simonetta Fiori (la Repubblica, 30.05.2011)
di Simonetta Fiori (la Repubblica, 30.05.2011)TORINO. «No, il mio non è un esilio», dice Gian Enrico Rusconi, 73 anni, studioso dal profilo inusuale che incrocia storiografia e scienza politica, autore di libri su Weimar, sulla grande guerra, più recentemente su Cavour e Bismarck, brianzolo di nascita e torinese di adozione, da cinque anni residente a Berlino con un incarico alla Freie Universität. «Mi sento parte del nostro Paese, e il mio trasloco in Germania non deve essere frainteso con una fuga. Semmai patisco la tristezza di essere italiano, una condizione condivisa da molti connazionali».
Perché è triste essere italiani?
«Il berlusconismo ci espone al sarcasmo, questo è risaputo. Ma la mia impressione è che, al di là delle star come Eco, Magris o Abbado, la cultura italiana abbia smesso di essere interessante. Come se non avessimo più niente da dare. La mia esperienza riguarda il rapporto con la Germania, ma temo che le nostre relazioni culturali siano cambiate anche altrove. Fino a qualche tempo fa i nostri seminari erano affollati dai Winckler e dai Nolte, insomma dai maggiori storici tedeschi. Ora non siamo più Gesprächspartner, dei veri interlocutori, compagni di pensiero e di confronto».
Quando abbiamo smesso di esserlo?
«Negli anni Novanta s’è come sbriciolato lentamente e irreversibilmente un mondo intellettuale e politico che aveva esercitato fascino in tutta Europa. Abbiamo cominciato a ripeterci. Siamo diventati epigoni. Il berlusconismo è la fenomenologia di questa decomposizione, non la causa. Ancora negli anni Ottanta da Berlino si guardava all’Italia come a un laboratorio politico e intellettuale. Tutta la cultura tedesca, non solo la sinistra, seguiva la nostra riflessione su Gramsci, sull’eurocomunismo, sulla socialdemocrazia. Oggi siamo i maggiori esportatori della postdemocrazia: la novità che offriamo de facto è il populismo mediatico, una novità che fa paura».
Qual è stata l’occasione mancata?
«Posso riferirle la mia esperienza personale, di provinciale torinese affascinato da Roma e dalle sue seduzioni intellettuali. Tra gli anni Settanta e Ottanta mi capitava di andarci con una certa frequenza: forse un po’ la sopravvalutavo, più tardi ne avrei visto tutti i limiti. Era la Roma dei Lucio Colletti e degli Enrico Filippini, grandi personaggi che non mi risparmiavano il loro sarcasmo».
Filippini scrisse di lei che pur avendo una formazione tedesca era uno «studioso calmo», lontano dalla concitata tenebra di quella tradizione.
«Mah, chissà cosa avrà voluto dire. Provenivo da studi filosofici, la mia tesi riguardava la Scuola di Francoforte. Nel 1959 m’ero imbattuto nel libro che mi avrebbe cambiato la vita, Minima Moralia. Al principio della nostra amicizia, Colletti che era un marxista ortodosso ironizzava sulla mia ossessione francofortese, più tardi mi avrebbe riconosciuto che avevo visto un sacco di cose».
Questo però non c’entra con l’occasione mancata della cultura italiana.
«È interessante per il clima di quegli anni. Per me è stata paradigmatica la vicenda di Laboratorio Politico, la rivista einaudiana fondata nell’81 da Asor Rosa e Tronti e alla quale parteciparono personalità di ispirazione diversissima come Amato, Rodotà, Cacciari, Accornero, Bodei e Tarantelli. Eravamo un gruppo eterogeneo, ma molto ben amalgamato, all’incrocio tra discipline diverse come la politologia, la teoria delle istituzioni, la sociologia. Avevamo come la sensazione che fossimo alla vigilia di una svolta che però poi non c’è stata».
Che cosa doveva accadere?
«Doveva nascere una sinistra più matura e consapevole, concretamente riformista, che tuttavia non è mai nata. In quel momento la mia generazione inconsciamente sentiva che era arrivata la sua chance: era solo una questione di tempo e congiuntura. Non ce l’abbiamo fatta. Laboratorio politico si sciolse spontaneamente, un atto onesto, come se riconoscessimo il nostro fallimento».
Secondo lei perché non ha funzionato?
«È mancata una riflessione seria sulla nazione, liquidata con critiche superficiali. Non siamo riusciti a sottrarre la nozione di socialdemocrazia dal tabù che l’avvolgeva (socialdemocratico è rimasto a lungo un termine offensivo). E non abbiamo fatto nei tempi giusti quel che si sarebbe chiamato il revisionismo, ossia mettere a fuoco una visione meno mitica e più autocritica della Resistenza. Operazione culturale che sarebbe stata fatta malamente nel decennio successivo, sotto la spinta della seconda Repubblica. Le tesi di Renzo De Felice sul consenso e sull’attendismo furono prese di punta. Alla discussione si preferì l’aggressione. Lo ricordo sorpreso e amareggiato: s’aspettava di essere riconosciuto, non attaccato».
Ma De Felice aveva un doppio profilo: lo storico si distingueva dal personaggio, che cominciò proprio alla metà degli anni Ottanta a rilasciare interviste politiche.
«Sì, ma la demonizzazione di De Felice è stato un errore colossale. Ne è nato un defelicismo deteriore che ha fatto danno. Ne parlai all’epoca anche con Bobbio, che reagiva con il suo stile elusivo. Però sono sicuro che condivideva i miei argomenti, anche se i suoi allievi cercavano di tirarlo dalla loro parte. Prova ne sia che Bobbio e De Felice, pur nella netta distinzione, non hanno mai giocato l’uno contro l’altro».
Lei invece discusse con Bobbio a proposito dell’azionismo, accusato di una sorta di «esilio interno».
«Rilevavo una dimensione aristocratica della tradizione azionista, ma ad avercene oggi... Preferirei non aprire quella pagina. Mi fece molto male e, a distanza di vent’anni, non l’ho ancora capita. Penso che si sia trattato di un equivoco, e non mi furono risparmiate cattiverie: non da Bobbio, ma dai bobbiani».
Questa sulla nazione è una sua riflessione ricorrente. Lei critica l’intera intellighenzia italiana di aver snobbato il tema nazionale, riservandogli critiche frettolose.
«Sì, per motivi diversi. La cultura italiana è stata sensibile ad altri paradigmi ideologici, preda di una sorta di ossessione del fascismo e incapace di distinguere nazionalismo e sentimento nazionale. Lo denunciai al principio degli anni Novanta, quando la coesione nazionale m’apparve sfilacciata. Credo di essere stato tra i primi a domandarsi se esistevamo ancora come nazione. La mia attenzione al fenomeno leghista fu liquidata come un’ossessione da provinciale brianzolo. Fui trattato da ingenuo».
Lei in quel saggio premonitore, Se cessiamo di essere una nazione, accusava la «cultura cosiddetta alta» di essere afflitta dal complesso del provinciale rispetto alle grandi culture europee.
«Sì, è vero, gli italiani soffrono d’un complesso d’inferiorità che però è ingiustificato. Siamo molto bravi. Solo che a differenza di inglesi e tedeschi parliamo un dialetto che non capisce più nessuno. È come se ci vergognassimo per non essere stati all’altezza delle altre vicende nazionali, orgogliose nell’esibire i trofei e nascondere i fallimenti. Invece noi siamo grandi nel restituire le nostre debolezze. Per i centocinquant’anni, l’ambasciatore italiano a Berlino ha avuto la splendida idea di proiettare il Gattopardo, che ci racconta nelle nostre contraddizioni e incompiutezze. "Che grande storia, che grande popolo", commentava lo storico tedesco Michael Stürmer seduto vicino a me».
Ma larga parte della storiografia italiana, come lei ha rilevato, nel dopoguerra ha preferito concentrarsi sui fallimenti piuttosto che narrare una storia "affermativa".
«Non c’è dubbio. Con un altro limite, la nostra incapacità di guardare alla politica estera: ci è sempre mancata la lucida consapevolezza della collocazione dell’Italia nel mondo. Non siamo stati in grado di riconoscerne la grandezza, quando c’è stata, preferendo liquidare come Italietta la classe dirigente liberale di fine Ottocento. Ma quale Italietta!». Oggi il problema, discusso anche all’interno, è la mancanza di una comunità di storici capace di elaborare una riflessione sulla storia nazionale, allargando lo sguardo ad altri Paesi. Anche all’Università prevale una tendenza al localismo. «Vero. Mi verrebbe da aggiungere che lo smarrimento è percepibile anche in Germania: la generazione attuale degli storici appare come schiacciata sotto il peso della generazione precedente, che ha fatto i conti con il nazismo. Ma altrove hanno risorse che noi non abbiamo. Hanno un’università che funziona. Hanno una burocrazia efficiente. Hanno un orizzonte internazionale che a noi manca. Il nostro è un Paese declassato. Ed è inevitabile che questo si riverberi anche sulla comunità intellettuale».
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- Stabilire che cosa sia o non sia pensabile, o impensabile, è, conveniamolo, cosa da filosofi. O da filosofe, e quindi eccoci (di Francesca Rigotti, Nadia Urbinati, Nicla Vassallo -Il pensiero sbagliato del signor Berlusconi ).19 maggio 2011, di Federico La Sala
Il pensiero sbagliato del signor Berlusconi
 Aveva detto che perdere a Milano sarebbe stato “impensabile”.
Aveva detto che perdere a Milano sarebbe stato “impensabile”.
 Il voto dimostra che il premier non conosce la democrazia. E non sa pensare
Il voto dimostra che il premier non conosce la democrazia. E non sa pensaredi Francesca Rigotti, Nadia Urbinati, Nicla Vassallo (l’Unità, 19.05.2011)
Stabilire che cosa sia o non sia pensabile, o impensabile, è, conveniamolo, cosa da filosofi. O da filosofe, e quindi eccoci. Non è faccenda da venditori di fumo. Nemmeno da stregoni pubblicitari. Col pensiero la filosofia tratta dalla sua nascita e qualcosa da dire su ciò che è pensabile o meno ce l’ha. Limitiamoci a sostenere, con efficace minimalismo, che è pensabile ciò di cui si coglie il significato, che si può comprendere, che costituisce materia di conoscenza; ciò che può essere valutato, opinato, stimato, giudicato, deliberato. A meno di non sposare qualche forma di misticismo, l’impensabile corrisponde evidentemente al contrario del pensabile, ovvero a ciò che è assurdo in quanto incomprensibile e inconoscibile: vi è così un senso in cui l’impensabile non può nemmeno venir valutato, giudicato. «Una città (Milano) non governata da noi (del Popolo della Libertà) è impensabile», ha proclamato il Signor B. pochi giorni fa.
Il Signor B. pensa male, ragiona male. Lui, l’unto del Signore, si trova ora di fronte a un miracolo a Milano, che non è né il film di Vittorio De Sica (benché, filosoficamente, sogniamo col giovane protagonista un luogo dove «buongiorno voglia davvero dire buongiorno», luogo che negli ultimi tempi con Milano non riusciva a coincidere), né con quel non-miracolo che sarebbe dovuto risultare impensabile.
L’impensabile del Signor B. non si è ancora realizzato occorre attendere il ballottaggio; un sorta di miracolo, invece, sì e non ne è lui il fautore. Volendo ricorrere a John Locke, questo miracolo somiglia ad altri che, «quando sono ben testimoniati, non solo trovano credito per se stessi ma danno credito anche ad altre verità che hanno bisogno di tale conferma». Ad altre verità che riguardano da vicino la tenuta del governo, la sua plausibilità, nel nostro caso.
«Un miracolo è una violazione delle leggi di natura», obietta David Hume. Il miracolo a Milano ha però semplicemente violato le leggi dell’insulto, della menzogna, del narcisismo, della propaganda, delle promesse disattese. Un miracolo che attesta l’inizio della fine per il Signor B.? In realtà, è la rivincita della democrazia a attestarlo.
Il Signor B. non condivide nulla con Elisabetta I, mentre “la furberia e la pazzia” di quell’uomo non ha prodotto un evento straordinario: o, forse, sì, nel momento in cui l’impensabile-per-lui si avvicina. Ancora con le parole di Hume, «supponete che tutti gli storici che trattano dell’Inghilterra siano d’accordo nel dire che il 10 gennaio 1600 si ebbe la morte della regina Elisabetta e che tanto prima che dopo la morte essa fu vista dai medici e dall’intera corte, come è d’uso per le persone del suo rango; che il suo successore fu riconosciuto e proclamato dal parlamento; e che, dopo essere rimasta sepolta un mese, sia di nuovo riapparsa, abbia ripreso il trono e abbia governato l’Inghilterra per tre anni. Devo confessare che sarei sorpreso della concordanza di tante strane circostante, ma non avrei la minima inclinazione a credere ad un evento così miracoloso. Non dubiterei della sua pretesa morte e delle altre circostanze pubbliche che la seguirono; affermerei soltanto che la morte si era preteso che fosse tale e che né fu una morte reale, né sarebbe stato possibile che lo fosse. Invano mi obiettereste la difficoltà ed anzi l’impossibilità di trarre in inganno il mondo in un affare di tanta importanza, la saggezza e il solido buon senso di quella famosa regina, col minimo giovamento o col nessun giovamento che essa avrebbe potuto trarre da un così meschino artificio. Tutto ciò mi potrà stupire. Ma io risponderei ancora che la furberia e la pazzia degli uomini sono fenomeni tanto comuni che io preferirei credere che gli avvenimenti più straordinari derivino dal loro concorso».
Lo straordinario rimane lui, il Signor B., e vogliamo tanto che sia cosí: unicamente lui, o lui con pochi, a pensare che la democrazia consista solo nel vincere, e non anche nel perdere. Perché è davvero irragionevole considerare il contrario, e quindi rimane sperabile che gli illogici consistano in una minoranza: diversamente, la nostra sarebbe una società governata da folli, e i tiranni (capaci di concepire solo la vittoria, non la sconfitta) sono, appunto, dei folli.
Un governo che si basa sul consenso libero (ed espresso con voto segreto, ovvero protetto dalle tentazioni di raggiro e ricatto dei furbi) è per necessità un sistema aperto, oltre alla partecipazione, al suo esito. Alternanza democratica significa, appunto, accettare di perdere, sapendo che si tratta di una sconfitta temporanea. La bellezza della democrazia consiste nel fatto di garantire a tutti, al Signor B. incluso, l’opportunità di provare e riprovare. E allora, Signor B., è il caso che lei accetti la possibilità di perdere, poiché così potrà pensare di tornare a battagliare. Occorre pensare. Il pensabile. Ah! Che cosa splendida la democrazia, che non nega a nessuno un posto al sole della speranza!
*
 Francesca Rigotti è Professore di Comunicazione Istituzionale all’Università di Lugano:
Francesca Rigotti è Professore di Comunicazione Istituzionale all’Università di Lugano:
 Nadia Urbinati è Professore di Teoria Politica alla Columbia University;
Nadia Urbinati è Professore di Teoria Politica alla Columbia University;
 Nicla Vassallo è Professore di Filosofia Teoretica presso l’Università di Genova
Nicla Vassallo è Professore di Filosofia Teoretica presso l’Università di Genova -
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- "Roma non è nuova a questi scenari polverosi. Ha visto Romolo, ha visto Cesare Augusto e ha visto, al suo tramonto, Romolo Augustolo" (di Antonio Gramsci)8 aprile 2011, di Federico La Sala
 INDIVIDUO E SOCIETA’, OGGI. APRIRE GLI OCCHI: C’E’ DIO E "DIO", PATRIA E "PATRIA", E FAMIGLIA E "FAMIGLIA" .....
INDIVIDUO E SOCIETA’, OGGI. APRIRE GLI OCCHI: C’E’ DIO E "DIO", PATRIA E "PATRIA", E FAMIGLIA E "FAMIGLIA" .....
 ROMOLO AUGUSTOLO: L’ITALIA NON E’ NUOVA A QUESTI SCENARI. C’E’ CAPO E "CAPO" E STATO E "STATO": MUSSOLINI E LENIN A CONFRONTO. L’analisi di Gramsci, una bussola per non naufragare e una lezione di vita e di libertà
ROMOLO AUGUSTOLO: L’ITALIA NON E’ NUOVA A QUESTI SCENARI. C’E’ CAPO E "CAPO" E STATO E "STATO": MUSSOLINI E LENIN A CONFRONTO. L’analisi di Gramsci, una bussola per non naufragare e una lezione di vita e di libertà
 ANTONIO GRAMSCI (1924). "Roma non è nuova a questi scenari polverosi. Ha visto Romolo, ha visto Cesare Augusto e ha visto, al suo tramonto, Romolo Augustolo".
ANTONIO GRAMSCI (1924). "Roma non è nuova a questi scenari polverosi. Ha visto Romolo, ha visto Cesare Augusto e ha visto, al suo tramonto, Romolo Augustolo".
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- CONTRO LA LEZIONE DI KANT, SENZA "FACOLTA’ DI GIUDIZIO", TUTTI E TUTTE A SEGUIRE IL CIECO ATTIVISMO DI DEWEY !!!29 marzo 2011, di Federico La Sala
 LA SCUOLA, IL WEB, E LA LEZIONE DI KANT. "SAPERE AUDE!": IL CORAGGIO DI SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA E L’USCITA DALLO STATO DI MINORITA’ .....
LA SCUOLA, IL WEB, E LA LEZIONE DI KANT. "SAPERE AUDE!": IL CORAGGIO DI SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA E L’USCITA DALLO STATO DI MINORITA’ .....
 IL MONDO COME SCUOLA, LA FACOLTA’ DI GIUDIZIO, LA CREATIVITA’, I NATIVI DIGITALI, E L’ATTIVISMO CIECO DELLA CAVERNA DI IERI DI OGGI. Materiali per riflettere: testi di Gianni Rodari, Immanuel Kant, Emilio Garroni, Roberto Casati, e Armando Massarenti
IL MONDO COME SCUOLA, LA FACOLTA’ DI GIUDIZIO, LA CREATIVITA’, I NATIVI DIGITALI, E L’ATTIVISMO CIECO DELLA CAVERNA DI IERI DI OGGI. Materiali per riflettere: testi di Gianni Rodari, Immanuel Kant, Emilio Garroni, Roberto Casati, e Armando Massarenti
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- RIPENSARE L’UNO E I MOLTI ("UNO"), L’IDENTITA’ E LA DIFFERENZA!!! CONTIAMO ANCORA COME SE FOSSIMO NELLA CAVERNA DI PLATONE!!!20 febbraio 2011, di Federico La SalaIn philosophos!, in theologos!, in tyrannos!: RIPENSARE L’UNO E I MOLTI ("UNO"), L’IDENTITA’ E LA DIFFERENZA!!! CONTIAMO ANCORA COME SE FOSSIMO NELLA CAVERNA DI PLATONE. NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN ....
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- CONTRO IL "SONNO DOGMATICO"!!! Linee per un Piano di Offerta Formativa della SCUOLA dell’AUTONOMIA, DEMOCRATICA E REPUBBLICANA.16 febbraio 2011, di Federico La Sala
CHI INSEGNA A CHI, CHE COSA?
Una dichiarazione di indipendenza e un appello
2001
PER IL DIALOGO E LA PACE TRA LE GENERAZIONI E I POPOLI: Apriarno gli occhi, saniarno le ferite dei bambíni (deí ragazzi) e delle bambine (delle ragazze), dentro di noí e fuori di noí...Riannodiamo i fili della nostra rnemoria e della nostra dignità di esseri umani. Fermiamo la strage...
Linee per un Piano di Offerta Formativa della SCUOLA dell’AUTONOMIA, DEMOCRATICA E REPUBBLICANA. *
***
CHI siamo noi in realtà? Qual è íl fondamento della nostra vita? Quali saperi? Quale formazione?
SCUOLA, STATO, E CHIESA: CHI INSEGNA A CHI, CHE COSA?!
 IL "DIO" DEI NOSTRI PADRI E DELLE NOSTRE MADRI...
IL "DIO" DEI NOSTRI PADRI E DELLE NOSTRE MADRI...
 E IL "DIO" ZOPPO E CIECO DELLA GERARCHIA DELLA
CHIESA CATTOLICA, EDIPICO-ROMANA.
E IL "DIO" ZOPPO E CIECO DELLA GERARCHIA DELLA
CHIESA CATTOLICA, EDIPICO-ROMANA. Alla LUCE, e a difesa, DELLA NOSTRA DIGNITA’
DI CITTADINI
SOVRANI E DI CITTADINE SOVRANE E
Alla LUCE, e a difesa, DELLA NOSTRA DIGNITA’
DI CITTADINI
SOVRANI E DI CITTADINE SOVRANE E
 DI LAVORATORI
E LAVORATRICI DELLA SCUOLA PUBBLICA (campo
di RELAZIONE educativa, che basa il suo PROGETTO e la sua
AZIONE sulla RELAZIONE FONDANTE - il patto costituzionale
DI LAVORATORI
E LAVORATRICI DELLA SCUOLA PUBBLICA (campo
di RELAZIONE educativa, che basa il suo PROGETTO e la sua
AZIONE sulla RELAZIONE FONDANTE - il patto costituzionale
 sia la vita personale di tutti e di tutte sia la vita politica di
tutta la nostra società),
sia la vita personale di tutti e di tutte sia la vita politica di
tutta la nostra società), Per PROMUOVERE LA CONSAPEVOLEZZA (PERSONALE,
STORlCO-CULTURALE) E
Per PROMUOVERE LA CONSAPEVOLEZZA (PERSONALE,
STORlCO-CULTURALE) E
 L’ESERCIZIO DELLA SOVRANITA’ DEMOCRATICA
L’ESERCIZIO DELLA SOVRANITA’ DEMOCRATICA
 RISPETTO A SE STESSI E A SE
STESSE, RISPETTO AGLI ALTRI E ALLE ALTRE, E RISPETTO
ALLE ISTITUZIONI
RISPETTO A SE STESSI E A SE
STESSE, RISPETTO AGLI ALTRI E ALLE ALTRE, E RISPETTO
ALLE ISTITUZIONI
 ("Avere il coraggo di dire ai nostri giovani
che sono tutti sovrani": don Lorenzo Milani; "Per rispondere
ai requisiti sottesi alla libertà repubblicana una persona deve essere
un uomo o una donna indipendente e questo presuppone che essi
non abbiano un padrone o dominus, che li tenga sotto il suo potere,
in relazione ad alcun aspetto della loro vita. [...] La libertà richiede
una sorta di immunità da interferenze che diano la possibilità di
[...] tenere la propria testa alta, poter guardare gli altri dritto negli
occhi e rapportarsi con chiunque senza timore o deferenza": Philippe
Pettit)
("Avere il coraggo di dire ai nostri giovani
che sono tutti sovrani": don Lorenzo Milani; "Per rispondere
ai requisiti sottesi alla libertà repubblicana una persona deve essere
un uomo o una donna indipendente e questo presuppone che essi
non abbiano un padrone o dominus, che li tenga sotto il suo potere,
in relazione ad alcun aspetto della loro vita. [...] La libertà richiede
una sorta di immunità da interferenze che diano la possibilità di
[...] tenere la propria testa alta, poter guardare gli altri dritto negli
occhi e rapportarsi con chiunque senza timore o deferenza": Philippe
Pettit) e un LAVORO DI RETTIFICAZIONE E DI ORIENTAMENTO
CULTURALE, CIVILE, POLITICO e religioso (art.7 della Costituzione
e Concordato),
e un LAVORO DI RETTIFICAZIONE E DI ORIENTAMENTO
CULTURALE, CIVILE, POLITICO e religioso (art.7 della Costituzione
e Concordato),
 per evitare di ricadere nella tentazione
dell’accecante e pestifera IDEOLOGIA deII’INFALLIBILITA e
dell’ANTISEMITISMO (cfr. la beatificazione di PIO IX) e di un
ECUMENISMO furbo e prepotente, intollerante e fondamentalista
(cfr. il documento Dominus Jesus di Ratzinger, le dichiarazioni anti-
islamiche di Biffi, e il rinvio sine die dell’incontro fissato per il
3.10.2000 tra ebrei e cattolici) e di perdere la nostra lucidità e sovranita
politica,
per evitare di ricadere nella tentazione
dell’accecante e pestifera IDEOLOGIA deII’INFALLIBILITA e
dell’ANTISEMITISMO (cfr. la beatificazione di PIO IX) e di un
ECUMENISMO furbo e prepotente, intollerante e fondamentalista
(cfr. il documento Dominus Jesus di Ratzinger, le dichiarazioni anti-
islamiche di Biffi, e il rinvio sine die dell’incontro fissato per il
3.10.2000 tra ebrei e cattolici) e di perdere la nostra lucidità e sovranita
politica, e per INSTAURARE un vero RAPPORTO DIALOGICO e DEMOCRATICO,
tra ESSERI UMANI, POPOLI e CULTURE, non
solo d’Italia, ma dell’Europa e del Pianeta TERRA (e di tutto
I’universo, cfr. Giordano Bruno),
e per INSTAURARE un vero RAPPORTO DIALOGICO e DEMOCRATICO,
tra ESSERI UMANI, POPOLI e CULTURE, non
solo d’Italia, ma dell’Europa e del Pianeta TERRA (e di tutto
I’universo, cfr. Giordano Bruno), IO, cittadino italiano,figlío di Due IO, dell’UNiOne di due esseri
umani sovrani, un uomoj ’Giuseppe’, e una donna:’Maria’ (e, in
quanto tale, ’cristiano’ - ricordiamoci di Benedetto Croce; non cattolico
edipico-romano! - ricordiamoci, anche e soprattutto, di Sigmund
Freud),
.
IO, cittadino italiano,figlío di Due IO, dell’UNiOne di due esseri
umani sovrani, un uomoj ’Giuseppe’, e una donna:’Maria’ (e, in
quanto tale, ’cristiano’ - ricordiamoci di Benedetto Croce; non cattolico
edipico-romano! - ricordiamoci, anche e soprattutto, di Sigmund
Freud),
.
 ESPRIMO tutta la mia SOLIDARIETA a tutti i cittadini e a tutte
le cittadine della Comunità EBRAICA e a tutti i cittadini e a tutte lecittadine della comunità ISLAMICA della REPUBBLICA DEMOCRATICA
ITALIANA,
ESPRIMO tutta la mia SOLIDARIETA a tutti i cittadini e a tutte
le cittadine della Comunità EBRAICA e a tutti i cittadini e a tutte lecittadine della comunità ISLAMICA della REPUBBLICA DEMOCRATICA
ITALIANA, e
e PROPONGO
di riprendere e rilanciare (in molteplici forme e iniziative) la riflessione
e la discussione sul PATTO di ALLEANZA con il qúale tutti i
nostri padri (nonni...) e tutte le nostre madri (nonne...) hanno dato
vita a quell’UNO, che è il Testo della COSTITUZIONE, e il ’vecchio’
invito dell’Assemblea costituente (come don Lorenzo Milani
ci sollecitava nella sUa Lettera ai giudici, cfr. L’obbedienza non è più
una virtù) a "rendere consapevoli le nuove generazioni delle raggiunte
conquiste morali e sociali" e a riattivare la memoria
dell’origine dell’uno, che noi stessi e noi stesse siamo e che ci costituisce
PROPONGO
di riprendere e rilanciare (in molteplici forme e iniziative) la riflessione
e la discussione sul PATTO di ALLEANZA con il qúale tutti i
nostri padri (nonni...) e tutte le nostre madri (nonne...) hanno dato
vita a quell’UNO, che è il Testo della COSTITUZIONE, e il ’vecchio’
invito dell’Assemblea costituente (come don Lorenzo Milani
ci sollecitava nella sUa Lettera ai giudici, cfr. L’obbedienza non è più
una virtù) a "rendere consapevoli le nuove generazioni delle raggiunte
conquiste morali e sociali" e a riattivare la memoria
dell’origine dell’uno, che noi stessi e noi stesse siamo e che ci costituisce
 in quanto esseri umani e cittadini - sovraní, sla rispetto a
noi stessi e a noi stesse sia rispetto agli altri e alle altre, e sui piano
personale e sul piano politico,
in quanto esseri umani e cittadini - sovraní, sla rispetto a
noi stessi e a noi stesse sia rispetto agli altri e alle altre, e sui piano
personale e sul piano politico, e di RAFFORZARE E VALoRIZZARE, in TUTTA la sua fondamentale
e specifica portata, IL RUOLo e LA FUNZIONE della
SCUOLA DELLA nostra REPUBBLICA DEMOCRATICA.
e di RAFFORZARE E VALoRIZZARE, in TUTTA la sua fondamentale
e specifica portata, IL RUOLo e LA FUNZIONE della
SCUOLA DELLA nostra REPUBBLICA DEMOCRATICA.P.S.
NESSUNO E’ STRANIERO SULLA TERRA
 "A molti, individui o popoli, può accadere di ritenere, più o meno
consapevolmente, che ogni straniero è nemico. Per lo più questa
convinzione giace in fondo agli animi come una infezione laiente,
si manifesta solo in atti saltuari e incoordinati, e non sta all’origine
di un sistema di pensiero. Ma quando questo avviene, quando il
dogma inespresso diventa premessa maggiore di un sillogismo*,
"A molti, individui o popoli, può accadere di ritenere, più o meno
consapevolmente, che ogni straniero è nemico. Per lo più questa
convinzione giace in fondo agli animi come una infezione laiente,
si manifesta solo in atti saltuari e incoordinati, e non sta all’origine
di un sistema di pensiero. Ma quando questo avviene, quando il
dogma inespresso diventa premessa maggiore di un sillogismo*,
 allora, al termine della catena, sta il lager.
allora, al termine della catena, sta il lager.
 Esso è il prodotto di una
concezione del mondo portata alle sue conseguenze con rigorosa
coerenza: finché la concezione sussiste, le conseguenze ci minacciano"
Esso è il prodotto di una
concezione del mondo portata alle sue conseguenze con rigorosa
coerenza: finché la concezione sussiste, le conseguenze ci minacciano"*
 "Tutti gli stranieri sono nemici.
"Tutti gli stranieri sono nemici.
 I nemici devono essere soppressi.
I nemici devono essere soppressi.
 Tutti gli stranieri devono essere soppressi".
Tutti gli stranieri devono essere soppressi". Primo Levi, Se questo è un uomo, Prefazione, Torino, Einaudi,
1973, pp. I 3-14.
Primo Levi, Se questo è un uomo, Prefazione, Torino, Einaudi,
1973, pp. I 3-14. Andiamo alla radice dei problemi. Perfezioniamo la conoscenza
di noi stessi e di noi stesse. Riattiviamo la memoria dell’Unita,
apriamo e riequilibriamo il campo della nosha, personale e collettiva,
coscienza umana e politica.
Andiamo alla radice dei problemi. Perfezioniamo la conoscenza
di noi stessi e di noi stesse. Riattiviamo la memoria dell’Unita,
apriamo e riequilibriamo il campo della nosha, personale e collettiva,
coscienza umana e politica. Sigmund Freud aveva colto chiaramente la tragica confusione in
cui la Chiesa cattolico-romana si era cacciata (cfr. L’uomo Mosè e
la religione monoteistica): "scaturito da una religione del padre, il
cristianesimo divenne una religione del figlio. Non sfuggì alla fatalità
di doversi sbarazzare del padre" ... Giuseppe (gettato per la seconda
volta nel pozzo) e di dover teorizzare, per il figlio, il ’matrimonio’
con la madre e, nello stesso tempo,la sua trasformazione in
’donna’ e ’sposa’ del Padre e Spirito Santo, che ’generano’ il figlio!
Sigmund Freud aveva colto chiaramente la tragica confusione in
cui la Chiesa cattolico-romana si era cacciata (cfr. L’uomo Mosè e
la religione monoteistica): "scaturito da una religione del padre, il
cristianesimo divenne una religione del figlio. Non sfuggì alla fatalità
di doversi sbarazzare del padre" ... Giuseppe (gettato per la seconda
volta nel pozzo) e di dover teorizzare, per il figlio, il ’matrimonio’
con la madre e, nello stesso tempo,la sua trasformazione in
’donna’ e ’sposa’ del Padre e Spirito Santo, che ’generano’ il figlio!Karol Wojtyla, nonostante tutto il suo coraggio e tutta la sua sapienza, fa finta di niente e, nonostante il ’muro’ sia crollato e lo ’spettacolo’ sia finito, continua a fare l’attore e a interpretare il ruolo di Edipo, Re e Papa.
QUIS UT DEUS? Nessuno può occupare il posto dell’UNO. Non è meglio deporre le ’armi’ della cecità e della follia e, insieme e in pace, cercare di guarire le ferite nostre e della nostra Terra?
"GUARIAMO LA NOSTRA TERRA": è il motto della "Commissione per la verità e la riconciliazione" voluta da Nelson Mandela (nel 1995 e presieduta da Desmond Tutu). In segno di attiva solidarietà, raccogliamo il Suo invito...
 "La realtà è una passione. La cosa più cara" (Fulvio Papi). Cerchiamo
di liberare ii nostro cielo dalle vecchie idee. Benché diversi,
i suoi problemi sono anche i nostri, e i nostri sono anche i suoi...
"La realtà è una passione. La cosa più cara" (Fulvio Papi). Cerchiamo
di liberare ii nostro cielo dalle vecchie idee. Benché diversi,
i suoi problemi sono anche i nostri, e i nostri sono anche i suoi...
 E le ombre, se si allungano su tutta la Terra, nascondono la luce e portano il buio, da lui come da noi... "nell’attuale momento focale
della storia - come scriveva e sottolineava con forza Enzo Paci già
nel 1954 (cfr. E. Paci, Tempo e relazione, Milano, Il Saggiatore,
1965 - Il ed., p. 184) - la massima permanenza possibile della libertà
democratica coincide con la massina metamorfosí verso un
più giusto equilibrio sociale, non solo per un popolo ma per tutti i
popoli del mondo".
E le ombre, se si allungano su tutta la Terra, nascondono la luce e portano il buio, da lui come da noi... "nell’attuale momento focale
della storia - come scriveva e sottolineava con forza Enzo Paci già
nel 1954 (cfr. E. Paci, Tempo e relazione, Milano, Il Saggiatore,
1965 - Il ed., p. 184) - la massima permanenza possibile della libertà
democratica coincide con la massina metamorfosí verso un
più giusto equilibrio sociale, non solo per un popolo ma per tutti i
popoli del mondo".* Cfr. Federico La Sala, L’enigma della Sfinge e il segreto della Piramide. Considerazioni attuali sulla fine della preistoria ..., Edizioni Ripostes, Roma-Salerno, Febbraio 2001, pp. 49-53.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- MEETING DI ALTO-LIVELLO SULLA DIDATTICA DELLA FILOSOFIA, A MILANO - ALL’UNIVERSITA’ IULM (14-16 FEBBRAIO 2011)12 febbraio 2011, di Federico La Sala
-
> MEETING DI ALTO-LIVELLO SULLA DIDATTICA DELLA FILOSOFIA, A MILANO - ALL’UNIVERSITA’ IULM (14-16 FEBBRAIO 2011) ---- DAL MEETING, UN ALLARME E UNA SOLLECITAZIONE. Una nota (di Federico La Sala)16 febbraio 2011, di Federico La Sala
 USCIRE DALLA CAVERNA
USCIRE DALLA CAVERNA USCIRE DALLO STATO DI MINORITA’
USCIRE DALLO STATO DI MINORITA’SAPERE AUDE!
A 400 ANNI DALLA PUBBLICAZIONE DEL "SIDEREUS NUNCIUS" DI GALILEO GALILEI E A 200 DALLE INDICAZIONI DI IMMANUEL KANT SULL’USO CRITICO DELLA PROPRIA FACOLTA’ DI GIUDIZIO (PER UNA STORIA E PER UNA FILOSOFIA DAL PUNTO DI VISTA COSMOPOLITICO - E - PER LA PACE PERPETUA)
Rimettere al centro della filosofia (e soprattutto del suo insegnamento), la lezione dell’illuminismo kantiano!!!
*** ***
DAL MEETING, UN ALLARME E UNA SOLLECITAZIONE. Una nota parziale (e - ovviamente - molto, molto riduttiva) sulla ricchezza degli interventi e delle discussioni dell’incontro): *
A) LA FILOSOFIA IN RITARDO (E IN PERICOLO NEL MONDO) E NON PRONTA A UNA DELLE SUE MISSIONI FONDAMENTALI - IL DIALOGO GLOBALE
B) RILANCIARE L’INSEGNAMENTO DELLA FILOSOFIA COME EDUCAZIONE ALLA PRATICA DELLA LIBERTA’, ALL’ESERCIZIO CRITICA DELLA FACOLTA’ DI GIUDIZIO, ALLA DEMOCRAZIA PLANETARIA - RIUNIRE SAGGEZZA E SCIENZA
C) NON INGESSARE L’UNESCO NELLA VALORIZZAZIONE E NELLA DIFESA DEL PATRIMONIO CULTURAL E DELL’UMANITA’ - PORTARE AVANTI E POTENZIARE L’ESPERIENZA DELLE "CATTEDRE UNESCO".
D) NECESSITA’ E URGENZA DI METTERE IN COMUNICAZIONE LA TRADIZIONE FILOSOFICA E LA POPOLAZIONE DEL "NUOVO MONDO" - I "NATIVI DIGITALI", L’UMANITA’ DIGITALE.
E) APPROVAZIONE DOCUMENTO: "RACCOMANDAZIONI SULL’INSEGNAMENTO DELLA FILOSOFIA IN EUROPA E IN AMERICA SETTENTRIONALE"
Federico La Sala
-
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- "Berlusconi dimettiti!". Manifestazione a Milano, il 5 febbraio 2011, al Palasharp. Manifestazione con Zagrebelsky, Ginsborg, Eco e Saviano (di "Giustizia e Libertà).4 febbraio 2011, di Federico La Sala
La manifestazione
Palasharp di Milano, il 5 febbraio: ingresso libero
Berlusconi dimettiti! *
Libertà e Giustizia raccoglie la domanda di mobilitazione che arriva dai commenti all’appello Resignation - DIMISSIONI. Il testo ha raccolto decine di migliaia di firme in Italia, in Europa e anche negli Usa. Rilanciato dai social network, dai blogger e dai siti d’informazione, porta le prime firme di Gustavo Zagrebelsky, Paul Ginsborg e Sandra Bonsanti. Ma migliaia sono stati i commenti di chi ha lasciato un messaggio: “firmare non basta”, “facciamo qualcosa”, “Berlusconi lasci il governo del paese”. Libertà e Giustizia risponde a questa richiesta con “una prima manifestazione - spiega Sandra Bonsanti, presidente dell’associazione - per testimoniare la storia, la voce di chi non ha accettato passivamente l’imbarbarimento prodotto dalla politica e dalla cultura di Silvio Berlusconi e per gridare un ‘Basta’ allo smantellamento dello Stato”. L’appuntamento è per sabato, 5 febbraio, a partire dalle 15 (cancelli aperti dalle 13 e 30), al Palasharp di Milano (via Sant’Elia, 33 - MM Lampugnano) con Umberto Eco, Paul Ginsborg, Roberto Saviano, Gustavo Zagrebelsky, e la partecipazione di molti testimoni della società civile (*).
L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. La capienza del Palasharp è di 9 mila posti: si consiglia di arrivare con un certo anticipo.
Liberiamoci dalle macerie e cominciamo a ricostruire: come all’alba della Repubblica. La società civile chiede di partecipare attivamente e dare voce alle preoccupazioni sulla gravissima crisi politico-istituzionale scatenata dagli interessi privati di Berlusconi.
Troveremo insieme le parole per esigere le dimissioni prima di tutto e liberarci dal potere corrotto e corruttore di Silvio Berlusconi, dal fango, dagli attacchi alla Costituzione, alla magistratura tutta e in particolare alla Procura di Milano, all’informazione, alla dignità delle donne.
Con Zagrebelsky, Ginsborg, Eco e Saviano, tutti fortemente impegnati a fianco della società civile, mobilitiamoci allora per cominciare insieme a ricostruire l’Italia, il nostro Paese e per riappropriarci di parole che la storia e il sacrificio di milioni di italiani hanno reso eterne e inviolabili: libertà, giustizia, democrazia, repubblica, uguaglianza, lavoro, COSTITUZIONE. Troveremo insieme anche i modi per proseguire in questa mobilitazione per le dimissioni del presidente del Consiglio che sarà dopo questo primo appuntamento, l’impegno costante della società civile.
(*) Hanno confermato la loro partecipazione:
Giovanni Bachelet Bice Biagi Carla Biagi
Daria Bonfietti Susanna Camusso Lorenza Carlassare
Nando dalla Chiesa Concita De Gregorio
Beppino Englaro
Beppe Giulietti Irene Grandi
Maurizio Landini Gad Lerner
Milva Moni Ovadia Giuliano Pisapia
Maurizio Pollini Enrico Rossi
Elisabetta Rubini Oscar Luigi Scalfaro Salvatore Veca Lorella Zanardo
* LIBERTA’ E GIUSTIZIA: http://www.libertaegiustizia.it/2011/01/27/dimettiti-per-unitalia-libera-e-giusta-tutti-al-palasharp-di-milano-il-5-febbraio/
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- DEMOCRAZIA E DECADENZA (di Adriano Prosperi).3 febbraio 2011, di Federico La Sala
 DEMOCRAZIA E DECADENZA IN ITALIA - OGGI: UNA QUESTIONE EPOCALE, LAICA E RELIGIOSA!
DEMOCRAZIA E DECADENZA IN ITALIA - OGGI: UNA QUESTIONE EPOCALE, LAICA E RELIGIOSA!
 Un’analisi di Adriano Prosperi
Un’analisi di Adriano Prosperi
 (...) che questo problema sia stato ignorato clamorosamente dalla dirigenza della Chiesa cattolica italiana anche nei suoi recenti e imbarazzati pronunciamenti è qualcosa che rinvia ai caratteri profondi della religione italiana e non può essere spiegato soltanto dalla difesa del proprio potere e dalla ricerca dei favori governativi da parte di chi si arroga la funzione di maestro e censore della morale collettiva (...)
(...) che questo problema sia stato ignorato clamorosamente dalla dirigenza della Chiesa cattolica italiana anche nei suoi recenti e imbarazzati pronunciamenti è qualcosa che rinvia ai caratteri profondi della religione italiana e non può essere spiegato soltanto dalla difesa del proprio potere e dalla ricerca dei favori governativi da parte di chi si arroga la funzione di maestro e censore della morale collettiva (...)
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- IL "SIDEREUS NUNCIUS", OGGI. PER KEPLERO, COME PER KANT, LA VITTORIA DI GALILEO NON SOLO E’ SCIENTIFICA, MA E’ ANCHE VITTORIA TEOLOGICA E POLITICA!!!27 gennaio 2011, di Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- CHE VERGOGNA!!! "Vergogna di chi, di che cosa? Provare a rispondere" (di Carlo Galli).24 gennaio 2011, di Federico La Sala
La coscienza dell’Italiadi Carlo Galli (la Repubblica, 24.01.2011)
Perché "vergogna" è la prima reazione al nuovo scandalo Berlusconi? Vergogna di chi, di che cosa? Provare a rispondere a queste domande - tentativo doveroso, perché interpellano radicalmente la nostra coscienza civile e morale - ci porta alla radice dell’apparato categoriale della moderna politica democratica. In questo caso vergogna è il sentimento di umiliazione che nasce nei cittadini per alcuni comportamenti - non necessariamente per i reati, che devono ancora esser provati - del capo del governo.
I cittadini (alcuni, forse non tutti: ma questo è un diverso lato della questione) si sentono umiliati per fatti che non li riguardano direttamente e che nondimeno li toccano da vicino, intimamente. Quei comportamenti hanno a che fare con l’umiliazione di donne giovani e avvenenti (anche in questo caso, lasciamo impregiudicata la questione del reato specifico che si configurerebbe se fra di esse fosse stata coinvolta una minorenne), sistematicamente utilizzate, col loro consenso, come figuranti lascive in quadretti erotici, in tableaux vivants da Antico regime o da belle époque per quanto riguarda i riferimenti storici, ma soprattutto a favolosi e remoti (almeno si supponeva) sultanati orientali. E hanno a che fare anche con l’umiliazione di chi le umilia, di chi utilizzandole come giocattoli animati ne nega la qualità di persone, di chi abbassandole si abbassa.
Nell’umiliazione di quelle donne, e simultaneamente del loro padrone, vediamo in realtà umiliati i due beni più preziosi che la modernità politica - quella che ancora ci parla attraverso la Costituzione - ci ha consegnato: l’uguale dignità delle persone, di tutte; e la configurazione e la destinazione umanistica del potere, di ogni potere. Come il potere giudiziario non può comminare punizioni crudeli e inusuali, come il potere economico non può ridurre in schiavitù i più deboli, così il potere politico non può utilizzare le persone, divertirsi a consumarne corpi e anime.
Si dirà - è stato detto - che la prostituzione è sempre esistita, e che un po’ d’allegria non guasta; che, soprattutto atti sessuali fra adulti consenzienti, consumati nel privato - a prescindere da eventuali reati -, non devono interessare nessuno. E che il potere politico non c’entra nulla.
E invece - una volta resi pubblici perché la magistratura ha legittimamente indagato a partire da notizie di reato - quegli atti interessano e umiliano, non tanto per umana empatia, né per fame di gossip, ma perché sono intrinsecamente politici. Perché coinvolgono tutti e ciascuno; perché ferendo alcuni feriscono la dignità uguale e comune dei cittadini; perché trascinano tutti nella stessa vergogna; perché quello spettacolo ha noi tutti come destinatari, parla a noi e parla di noi - e anche perché si riflette, come un gioco di specchi, in mille stanze del potere, in mille alcove, al centro e alla periferia del Paese - . Ciò è tanto più vero nel caso di Berlusconi - che ha fatto di sé, del proprio corpo e della propria ricchezza personale, l’icona e il simbolo della politica, facendo coincidere il Tutto, l’Italia, con se stesso e con la propria privata dismisura -; ma sarebbe vero in generale per ogni primo ministro, presidente di partito e parlamentare (che rappresenta tutta la nazione) che si comportasse allo stesso modo.
È l’immagine universale dell’uomo (e della donna) a essere in gioco; e, insieme, l’immagine del potere politico, della forza che regola il nostro vivere civile. Se il portatore di quella forza è capace di umiliare, di non vedere l’umanità delle persone, di non relazionarsi agli altri con il doveroso rispetto - non importa se nel pubblico o nel privato, orizzonti e dimensioni che in determinate posizioni di potere sfumano l’uno nell’altro -, siamo umiliati tutti. Siamo in pericolo tutti.
La coscienza letteraria potrebbe vedere nell’intera vicenda la topica del Drago e delle fanciulle; la coscienza religiosa potrebbe scorgervi il volto benevolo e il potere corruttore dell’Anticristo; la coscienza di classe potrebbe individuarvi la potenza onnivora - veramente biopolitica - del capitale su corpi e menti reificate; la coscienza femminile potrebbe riconoscervi la quintessenza del potere maschile diffuso in tutta la società, che si concentra in una sola persona e nelle sue pratiche di dominio; la coscienza cinica potrebbe leggervi l’eterna storia del sesso e del potere, e chiedersi chi sottomette chi, se l’uomo le donne o le donne l’uomo - e concludere che non vi è nulla di straordinario o di allarmante nell’intera vicenda -. La coscienza civile, la coscienza moderna, si avvede - dopo lo sbalordimento iniziale - che una soglia è stata superata, e paventa in quella servitù volontaria, e in chi la incoraggia e la sollecita (e in chi, servizievole, la organizza), la negazione stessa, in radice, della democrazia. E spera che l’Italia si interroghi presto su se stessa e sulla propria sorte.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- LA PUTREFAZIONE MORALE E LA LEZIONE DI ERACLITO.19 gennaio 2011, di Federico La Sala
Il sermone della decenza
di Barbara Spinelli (la Repubblica, 19 gennaio 2011)
Dovrebbe esser ormai chiaro a tutti, anche a chi vorrebbe parlar d’altro e tapparsi le orecchie, anche a chi non vede l’enormità della vergogna che colpisce una delle massime cariche dello Stato, che una cosa è ormai del tutto improponibile: che il presidente del Consiglio resti dov’è senza neppure presentarsi al Tribunale, e che addirittura pretenda di candidarsi in future elezioni come premier. Molti lo pensano da tempo, da quando per evitare condanne il capo di Fininvest considerò la politica come un sotterfugio.
Non un piano nobile dove si sale ma uno scantinato in cui si «scende», si traffica, ci si acquatta meglio. La stessa ascesa al Colle resta, nei suoi sogni, una discesa in sotterranei sempre più inviolabili. Molti sono convinti che i suoi rapporti con la malavita, la stretta complicità con chi in due gradi di giudizio è stato condannato per concorso in associazione mafiosa (Dell’Utri), il contatto con un uomo - Mangano - che si faceva chiamare stalliere ed era il ricattatore distaccato da Cosa Nostra a Arcore - erano già motivi sufficienti per precludergli un luogo, il comando politico, che si suppone occupato da chi ha avuto una vita rispettosa della legge.
Ma adesso l’impegno a fermare quest’uomo infinitamente ricattabile perché incapace di controllare la sua sessualità deve esser esplicitamente preso dai responsabili politici tutti, dalla classe dirigente in senso lato, e non solo detto a mezza voce. È una specie di sermone che deve essere pronunciato, solenne come i giuramenti che costellano la vita dei popoli. Un sermone che non deleghi per l’ennesima volta il giudizio morale e civile alla magistratura. Che pur rispettando la presunzione d’innocenza, certifichi l’esistenza di un ceto politico determinato a considerare l’evidenza dello scandalo e a trarne le conseguenze prima ancora che i tribunali si pronuncino. Ci sono reati complessi da districare, per i giudici. Questo non vieta, anzi impone alla politica di delimitare in piena autonomia la dignità o non dignità dei potenti.
Non è più solo questione del conflitto di interessi, che grazie alla legge del 1957 avrebbe sin dall’inizio potuto vietare l’accesso a responsabilità politiche di un titolare di pubbliche concessioni (specie televisive). Chi è sospettato d’aver pagato prostitute o ragazze minorenni, d’aver indotto - sfruttando il proprio potere - un pubblico ufficiale a fare cose illecite, chi è talmente impaurito dall’arresto di Ruby dal presentarla in questura come nipote di Mubarak, chi ha avuto rapporti con mafiosi e corrotto testimoni o giudici, deve trovare chiuse le porte della politica, anche se i Tribunali ancora tacciono o se vi son state prescrizioni. Attorno a lui deve essere eretto una sorta di alto muro, che impersoni la legge, la riluttanza interiore d’un popolo a farsi rappresentare da un individuo dal losco passato e dal losco presente. Tra Berlusconi e la politica questo muro non è stato mai eretto, nemmeno dall’opposizione quando governava. Se non ora, quando? È così da millenni, nella nostra civiltà: una società ha anticorpi che espellono le cellule malate, o non li ha e decade. L’ostracismo fu un prodotto della democrazia ateniese, nel VI secolo a.C.
Eraclito scrive: «Combattere a difesa della legge è necessario, per il popolo, proprio come a difesa delle mura». Berlusconi non avrebbe dovuto divenire premier, e non perché si disprezzi il popolo che lo ha eletto: non avrebbe dovuto neanche potersi candidare. Comunque, oggi, non può restare o tornare in luoghi del comando che hanno una loro sacralità: non può, se la coerenza non è una quisquilia, nemmeno presentarsi come patrono del proprio successore. Non è un monarca che va in pensione.
Gli italiani più restii a vedere lo sanno, altrimenti non avrebbero acclamato in simultanea, da 16 anni, Berlusconi e tre capi dello Stato. È segno che in un angolo della coscienza, sognano quel decalogo che nelle parole di Thomas Mann «altro non è che la quintessenza dell’umana decenza»: il non rubare, il non pronunciare il nome di Dio invano, il non dire il falso, il non sbandierare valori senza rispettarli, il non adulterare ciò che è chiaro e puro confondendolo con il torbido e l’impuro. È come se i padri costituenti avessero presentito tutto questo, vietando plebisciti di capi di governo odi Stato: come se condividessero la diffidenza di Piero Calamandrei per l’inclinazione italiana alla «putrefazione morale, all’indifferenza, alla sistematica vigliaccheria».
La responsabilità del sermone è dunque per intero nelle mani dei parlamentari, liberi per legge da vincolo di mandato. Così come è in mano ai contro-poteri che costituzionalmente limitano il dominio d’uno solo (parlamento, magistratura, stampa). Contro-poteri su cui la sovranità popolare non ha il primato, se è vero che essa viene «esercitata nelle forme e nei limiti della Costituzione» (art 1).
Già una volta, nella «chiamata di correo» di Craxi, i politici caddero nel baratro, degradando se stessi. Fu il buco nero di Tangentopoli, e spiega come mai ancora abitiamo un girone dantesco fatto di menzogna e omertosi sortilegi. Il buco nero sono le parole di Craxi in Parlamento, il 3 luglio ’92: «Nessun partito è in grado di scagliare la prima pietra. (...) Ciò che bisogna dire, e che tutti del resto sanno, è che buona parte del finanziamento politico è irregolare o illegale.(...) Se gran parte di questa materia deve essere considerata materia (...) criminale, allora gran parte del sistema sarebbe un sistema criminale. Non credo che ci sia nessuno in quest’aula, responsabile politico di organizzazioni importanti, che possa alzarsi e pronunciare un giuramento in senso contrario a quanto affermo: presto o tardi, i fatti si incaricherebbero di dichiararlo spergiuro».
Difficile dimenticare il silenzio che seguì: nessun deputato si alzò, e ancor oggi la nostra storia stenta a non essere storia criminale. Ancor oggi si vorrebbe sapere perché i deputati che si ritenevano onesti rimasero appiccicati alla poltrona. Craxi pagò appropriatamente, perché le sentenze erano passate in giudicato e la legge è legge, ma pagò per molti: anche per Berlusconi, che con il suo aiuto costruì il proprio apparato di persuasione televisiva e profittò del crollo della Prima Repubblica sostituendola con un suo privato giro di corrotti e corruttori.
I deputati rischiano di restar seduti anche oggi, come allora: per schiavitù volontaria, o peggio. Il sermone oggi necessario deve essere un impegno a che simili ignominie non si ripetano. Proprio perché il conflitto d’interessi è sorpassato, e siamo di fronte a un conflitto fra decenza e oscenità, fra servizio dello Stato e servizio dei propri comodi, fra libertinaggio innocente e libertinaggio commisto a reati. Da molto tempo, c’è chi ha smesso di parlare di Palazzo Chigi: preferisce parlare di palazzo Grazioli come sede dell’esecutivo, e fa bene. Che si salvi, almeno, l’aura associata ai luoghi italiani del potere.
Domenica scorsa, Berlusconi ha fatto dichiarazioni singolari, oltre che ridicole. Definendo gravissima, inaccettabile, illegale, l’intromissione dei magistrati nella vita degli italiani ha detto: «Perché quello che i cittadini di una libera democrazia fanno nelle mura domestiche riguarda solo loro. Questo è un principio valido per tutti, e deve valere per tutti. Anche per me». L’uguaglianza fra cittadini equivale per lui alla libertà di fare quel che si vuole, in casa: anche un reato, magari. Non riguarda certo l’uguaglianza di fronte alla legge. L’antinomia stride, e offende. Siamo ben lontani dall’ingiunzione di Eraclito, se tutto diventa lecito nelle mura domestiche, e non appena succede qualcosa di criminoso l’uguaglianza cessa d’un colpo, e comincia l’età dei porci di Orwell, in cui tutti sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- LA LUNGIMIRANZA E LA LEZIONE DI CAMILLA CEDERNA (21 gennaio 1911 - 5 novembre 1997).15 gennaio 2011, di Federico La Sala
La prima intervista di mister B.
Alla vigilia della decisione della Consulta sul Legittimo impedimento, Ecco una chicca d’autore: l’incontro tra Camilla Cederna e il Cavaliere nel 1977. Dove c’è già tutto: dalle bugie alla corruzione, da don Verzé alla politica (l’Espresso, 11 gennaio 2011) *
Nel centenario della nascita di Camilla Cederna (21 gennaio 1911 - 5 novembre 1997) è in uscita per Rizzoli "Il mio Novecento", una raccolta della grande giornalista e scrittrice che per molti anni fu una prestigiosa firma de "L’espresso".
Tra gli articoli che compongono il volume ce n’è uno uscito sul nostro settimanale nell’aprile del 1977: un’intervista ritratto del giovane ed emergente imprenditore edile milanese Silvio Berlusconi. Come nota la stessa Cederna nel suo pezzo, è la prima intervista rilasciata da Berlusconi, che fino ad allora aveva deciso di tenere un profilo molto basso nei suoi rapporti con la stampa.
Il sito de "L’espresso" ripubblica qui di seguito l’articolo in questione, alla vigilia della decisione della Corte Costituzionale sul Legittimo impedimento. Come vedrete, nell’intervista-ritratto della Cederna c’era già quasi tutto di quello che sarebbe diventato, anni dopo, il fenomeno politico-mediatico Silvio Berlusconi.
*****
Serve una città? Chiama il Berlusconi .
Approfittando della vicinanza di un ospedale, il San Raffaele, diretto da un prete trafficone e sospeso a divinis, manda ai vari ministeri una piantina in cui la sua Milano 2 risulta zona ospedaliera. E la cartina falsa verrà distribuita ai piloti: così gli aerei cambiano rotte e non disturbano i residenti del complesso
di Camilla Cederna *
In un ambiente di lusso, saloni uno via l’altro, prati di moquette, sculture che si muovono, pelle, mogano e palissandro, continua a parlare un uomo non tanto alto, con un faccino tondo da bambino coi baffi, nemmeno una ruga, e un nasetto da bambola. Completo da grande sarto, leggero profumo maschio al limone. Mentre il suo aspetto curato, i suoi modini gentili, la sua continua esplosione di idee piacerebbero a un organizzatore di festini e congressi, il suo nome sarebbe piaciuto molto a Carlo Emilio Gadda. Si chiama infatti Silvio Berlusconi.
Un milanese che vale miliardi, costruttore di smisurati centri residenziali, ora proprietario della stupenda villa di Arcore dove vissero Gabrio Casati e Teresa Confalonieri (con collezione di pittori lombardi del Cinquecento, e mai nessun nudo per non offendere la moglie, religiosissima), quindi della villa ex Borletti ai margini del parco di Milano.
Allergico alle fotografie («magari anche per via dei rapimenti» spiega con un sorriso ironico solo a metà) è soddisfattissimo che nessuno lo riconosca né a Milano né in quella sua gemma che considera Milano 2. Siccome è la sua prima intervista, è contento di raccontarmi la sua vita felice. Media borghesia, il papà direttore di banca che, a liceo finito, non gli dà più la mancia settimanale; ma lui non si dispera, perché, mentre studia Legge, lavora in vari modi: suonando Gershwin o cantando le canzoni francesi alle feste studentesche. Non solo, ma fra un trenta e lode e l’altro, fa il venditore di elettrodomestici, e la sua strada è in salita: da venditore a venditore capo a direttore commerciale. Dopo la sua tesi di laurea sulla pubblicità (il massimo dei voti) inizia la sua vera attività entrando successivamente in due importanti imprese di costruzione.
A venticinque anni crea un complesso di case intorno a piazza Piemonte, ecco quindi la fortunatissima operazione di Brugherio, una lottizzazione destinata al ceto medio basso, mille appartamenti che van via subito; e preso dal piacere di raccontare, ogni tanto va nel difficile, dice «congesto», macrourbanistica, architettura corale, la connotazione del mio carattere è la positività, «natura non facit saltus». Il suo sogno sarebbe esser ricercato in tutto il mondo per fare città, e «chiamiamo il Berlusconi» dovrebbe essere l’invocazione di terre desiderose di espandersi. Di Milano 2, l’enorme quartiere residenziale nel comune di Segrate, parla come di una donna che ama, completo com’è di ogni bellezza e comfort, e centomila abitanti, che a dir che sono soddisfatti è dir poco. Lui legge tutte le novità di architettura e urbanistica, qualche best-seller ogni tanto, rilegge spesso l’Utopia di Tommaso Moro (infatti, lo ’scrisse’.. leggi l’articolo seguente-solleviamoci), sul quale vorrebbe scrivere un saggio. Si ritiene l’antitesi del palazzinaro, si ritiene un progressista, è cattolico e praticante, ha votato Dc; e «se l’urbanistica è quella che si contratta fra costruttori e potere politico, la mia allora non è urbanistica». Grazie, e vediamo cosa dicono gli altri di lui.
Lo considerano uno dei maggiori speculatori edilizi del nostro tempo che, valendosi di grosse protezioni vaticane e bancarie, vende le case e prende i soldi prima ancora di costruirle, lucrando in proprio miliardi di interessi. Si lega prima con la base Dc (Marcora e Bassetti), poi col centro, così che il segretario provinciale Mazzotta è il suo uomo. Altro suo punto di riferimento è il Psi, cioè Craxi, che vuol dire Tognoli, cioè il sindaco. E qui viene contraddetta la sua avversione verso l’urbanistica come compromesso tra politici e costruttori.
La società di Berlusconi è la Edilnord, fondata nel ’63 da lui e da Renzo Rezzonico, direttore di una società finanziaria con base a Lugano, liquidata nel ’71 per segrete ragioni. Viene fondata allora la Edilnord centri residenziali con le stesse condizioni della compagnia di prima: lo stesso capitale sociale (circa diecimila dollari), la stessa banca svizzera che fa i prestiti (la International Bank di Zurigo), ed ecco Berlusconi procuratore generale per l’Italia.
Nel ’71 il Consiglio dei Lavori Pubblici dichiara ufficialmente residenziale la terra di Berlusconi (comprata per 500 lire al metro quadrato nel ’63 e venduta all’Edilnord per 4250). Da Segrate (amministrazione di sinistra prima, poi socialista e Dc) vengono concesse all’Edilnord licenze edilizie in cambio di sostanziose somme di danaro. Umberto Dragone, allora capo del gruppo socialista nel consiglio comunale di Milano, pensa che l’Edilnord abbia pagato ai partiti coinvolti il cinque-dieci per cento dei profitti (diciottodiciannove miliardi) che si aspettava da Milano 2. (Qualche appartamento arredato pare sia stato dato gratis ad assessori e tecnici Dc e socialisti. Certo è che questo regalo lo ha avuto un tecnico socialista che vive lì con una fotomodella.)
«Il silenzio non ha prezzo, ecco il paradiso del silenzio» era scritto sulla pubblicità di questa residenza per alta e media borghesia. Ma il silenzio non c’è. L’aeroporto di Linate è lì a un passo, ogni novanta secondi decolla un aereo, intollerabili le onde sonore, superiori a 100 decibel. Così l’Edilnord si muove a Roma, manovrando i ministeri, per ottenere il cambio delle rotte degli aerei. (In quattro anni la Civilavia aveva già ordinato sei cambiamenti delle rotte degli apparecchi di Linate.) Approfittando della vicinanza di un ospedale, il San Raffaele, diretto da un prete trafficone e sospeso a divinis, don Luigi Maria Verzé, manda ai vari ministeri una piantina in cui la sua Milano 2 risulta zona ospedaliera e la cartina falsa verrà distribuita ai piloti (con su la croce, simbolo internazionale della zona di rispetto), così la Civilavia cambia rotte, ancora una volta.
Quanto a don Verzé, ottiene in cinque giorni, con decreto firmato dal ministro della Sanità Gui, la sostituzione del suo istituto privato e ancora in disarmo in istituto di ricerca a carattere scientifico (un titolo onorifico che viene dato solo in casi eccezionali), con annessa possibilità di avere finanziamenti. Lo Stato manda subito seicento milioni, mentre un miliardo e mezzo sarebbe stato versato dalla Regione. Di qui una polemica con Rivolta finché, due settimane fa, l’ex prete è stato condannato a un anno e quattro mesi per tentativo di corruzione ai danni dell’assessore Rivolta; l’istituto è ora frequentato da studenti e medici dell’università che lamentano la mancanza di strutture e strumenti validi.
Altre notizie. Berlusconi sta mettendo in cantiere la sua nuova Milano 3 nel comune di Basiglio a sud della città, con appartamenti di tipo «flessibile», cioè con pareti che si spostano secondo le esigenze familiari. In settembre comincerà a trasmettere dal grattacielo Pirelli la sua Telemilano, una televisione locale con dibattiti sui problemi della città, un’ora al giorno offerta ai giornali (egli possiede il quindici per cento del «Giornale» di Montanelli).
«Troppi sono oggi i fattori ansiogeni,» dice «la mia sarà una tv ottimista.» Staff di otto redattori, più tecnici e cameramen, quaranta persone in tutto. E pare che in questo suo progetto sia stato aiutato dall’amico Vittorino Colombo, ministro delle Poste e telecomunicazioni. Berlusconi aveva anche pensato di fondare un circolo di cultura diretto da Roberto Gervaso; la sua idea preferita però era quella di creare un movimento interpartitico puntato sui giovani emergenti, ma per adesso vi ha soprasseduto. Gli sarebbe piaciuto anche diventare presidente del Milan, ma la paura della pubblicità lo ha trattenuto. Massima sua aspirazione sarebbe infine quella di candidarsi al Parlamento europeo.
Ci tiene anche a coltivare al meglio la sua figura di padre, cercando di avere frequenti contatti coi suoi figlioletti. Quel che deplora è che dalle elementari di adesso sia stato esiliato il nozionismo: a lui le nozioni, in qualsiasi campo, hanno giovato moltissimo.
aprile 1977
fonte: http://espresso.repubblica.it/dettaglio/la-prima-intervista-di-mister-b/2142005
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- I filosofi hanno tradito il loro compito (di Roberta De Monticelli - Gli italiani e la sindrome della bandiera bianca).17 dicembre 2010, di Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- C’E’ VITA A SINISTRA? LE PAROLE PER RACCONTARE QUEL CHE RESTA DI UN’IDEA. Note di Carlo Galli Marc Lazar Anthony Giddens Gianni Vattimo Jürgen Habermas Fernando Savater27 dicembre 2010, di Federico La Sala
C’è vita a sinistra
LE PAROLE PER RACCONTARE QUEL CHE RESTA DI UN’IDEA
di Carlo Galli *
Fine delle ideologie, crisi del riformismo, globalizzazione: eppure c’è ancora chi scommette sul futuro di un concetto. Abbiamo chiesto a celebri pensatori e intellettuali europei di spiegare la loro visione e le prospettive possibili
La sconfitta della sinistra comunista, e le trasformazioni politiche ed economiche che sono seguite - la globalizzazione -, hanno reso il capitale più aggressivo (perché più esposto alla competizione), e hanno causato la crisi del compromesso socialdemocratico, cioè delle conquiste della sinistra riformista: i diritti sociali oggi sono visti come un costo e non come un valore. Ecco perché ha senso interrogarsi sulle prospettive di un’idea. Oggi il centro della società è il mercato, l’impresa e le sue esigenze di sviluppo, l’individualismo aggressivo; la frantumazione del ceto medio creato dalle passate politiche di welfare è già in atto, e la società si polarizza tra pochi ricchi e molti poveri; anche le forme giuridiche dell’uguaglianza - la legalità, i diritti civili - sono minacciate dall’insicurezza e dalla paura, i nuovi messaggi biopolitici che vengono dallo Stato; la democrazia è sostituita dal populismo.
La sinistra deve quindi trovare la capacità di criticare il presente, e ne deve nominare apertamente le contraddizioni; deve essere convinta che a un problema non c’è solo la soluzione proposta da chi detiene il potere, ma almeno un’altra, alternativa, che ha come finalità l’emancipazione di chi non ha potere, e la liberazione delle sue capacità di sviluppo autonomo, di vitale spontaneità (e pertanto deve essere antiautoritaria e laica). Deve essere riconoscibile, cioè deve essere coerentemente "parte" - nel momento in cui la società si frantuma in parti, anche se non coincidenti con le "classi" tradizionali -, e deve quindi entrare decisamente nei conflitti reali; ma deve anche farsi carico delle questioni generali di uguaglianza formale e sostanziale - pur mettendo in conto che i conflitti non potranno mai cessare. Deve produrre una nuova idea di società, una nuova "egemonia", da contrapporre all’egemonia della destra. Ciò significa combattere la paura e la disuguaglianza con la legalità, la giustizia e la speranza; e lottare per un nuovo compromesso, molto meno squilibrato dell’attuale, oltre che meno burocratico che nel passato, tra economia e diritti di libertà, tra mercato e Stato, tra privato e pubblico.
QUELLE PAROLE CHE LA SINISTRA DEVE RISCOPRIRE
di Marc Lazar *
La crisi della sinistra riformista europea oggi è oramai un’idea condivisa. Essa non ha motivo di vergognarsi del proprio passato. Ha contribuito a forgiare la democrazia e il welfare e, dunque, un’ampia parte dell’identità europea. Ciò nonostante, il suo modello di cambiamento graduale delle società nel quadro degli Stati-nazione è in via di esaurimento. La sinistra, più della destra, soffre la globalizzazione, le trasformazioni del capitalismo mondiale, il processo di individualizzazione, la sensazione sempre più ossessiva del declino del vecchio continente, le tentazioni di ripiegamento identitario sfruttate dai movimenti populisti.
La Storia dimostra che ciò che ha fatto la forza della socialdemocrazia è stata la sua capacità di adattamento alle evoluzioni delle società, il più delle volte generate esse stesse dalle metamorfosi del capitalismo. Un aggiornamento spesso difficile, nutrito da vivaci dibattiti interni sulle proposte definite "revisioniste", da Eduard Berstein (fine del secolo XIX) a Anthony Giddens (fine del secolo XX), passando per tanti altri pensatori e responsabili politici. E, tuttavia, con una domanda ossessiva dei nostri giorni al socialismo: il suo avvenire si iscrive nella linea dell’ideologia e dei suoi punti di riferimento, oppure suppone di varcare le frontiere tradizionali della sinistra e di esplorare altri orizzonti?
Per pensare la sinistra oggi e domani bisogna, più che mai, tornare alla famosa affermazione di Norberto Bobbio, per il quale il valore dell’uguaglianza traccia la linea di separazione dalla destra. La crisi economica del 2008 ha ricordato la pertinenza di quest’idea, adattata al mondo di oggi, che non significa egualitarismo, ma un’uguaglianza delle opportunità, rispettosa dei percorsi e delle aspirazioni individuali. Un’uguaglianza che deve rendere possibili non tanto degli Stati-forti, divenuti impossibili, quanto degli Stati ammodernati, regolatori e animatori, coordinati a livello europeo. Uguaglianza nel mondo e in Europa. Uguaglianza sociale tra i diversi gruppi e individui. Uguaglianza tra i sessi, mentre le donne rimangono sempre discriminate. Uguaglianza tra le generazioni, in un’Europa che subisce il complesso di Cronos, il dio greco che divorava i propri figli. Uguaglianza tra i territori, mentre oggi si approfondisce la divaricazione tra le regioni ricche e le zone più in difficoltà. Uguaglianza tra i cittadini e gli immigrati in regola che fanno ormai parte integrante della nostra Europa. Uguaglianza, ancora, in rapporto all’ambiente.
Ma c’è l’altro Bobbio, quello che nel 1955 constatava come gli intellettuali italiani sapessero perfettamente che cosa avrebbe dovuto essere la società italiana, ma ignoravano che cosa fosse. Cinquantacinque anni dopo, la sua riflessione si può allargare all’insieme dei partiti della sinistra europea, troppo chiusi su se stessi, in mano a oligarchie che stanno invecchiando, più che mai preoccupate di difendere i loro piccoli interessi. Conoscere la società nella sua complessità attuale, segnata da tendenze contraddittorie e antagonistiche, per ritrovare il popolo e, così, non lasciare più questa parola e ciò che comporta alle forze populistiche. La sinistra deve unirsi a lui in questo grido di dolore e di rabbia di cui parlava il sociologo Durkheim per definire il socialismo, ma anche in un grido di speranza, non per creare sogni che si trasformano generalmente in incubi, ma per ridare un senso alla politica. Per esempio, nell’accettare la forza della leadership nelle nostre democrazie, ma combinandola con l’estensione della partecipazione dei cittadini alla vita democratica. (traduzione di Luis E. Moriones)
LA LIBERTÀ È UN VALORE SOCIALE
di Anthony Giddens *
Nella politica di oggi la divisione tra sinistra e destra è assai meno netta che in passato, perché al capitalismo non si contrappone più un’alternativa socialista ben definita. Per di più, alcuni dei maggiori problemi che ci troviamo ad affrontare - ad esempio il cambiamento climatico, al centro di molti dibattiti contemporanei - trascendono la divisione classica tra sinistra e destra.
Eppure la distinzione ha ancora un senso. Essere di sinistra vuol dire avere a cuore alcuni valori essenziali; credere nell’importanza della solidarietà sociale, dell’uguaglianza, della tutela dei più vulnerabili, e nella «libertà sostanziale»: non solo quella economica, o la libertà davanti alla legge, ma una libertà reale per tutti i cittadini.
E significa anche attenersi a un certo quadro politico, in cui si conferisca grande importanza all’attivismo e alla capacità di intervento dei governi, necessaria a controbilanciare la tendenza dei mercati incontrollati di produrre instabilità economica e macroscopiche sperequazioni sociali, sostituendo ai valori sociali parametri puramente economici. (Traduzione di Elisabetta Horvat)
L’UGUAGLIANZA COME DIRITTO CULTURALE
di Gianni Vattimo *
La distinzione tra destra e sinistra è ancora ben viva e consiste, come sempre, nell’opposizione tra chi prende le differenze - di ricchezza, di salute, di forza, di capacità - come differenze "naturali", e parte di lì per costruire un progetto di sviluppo, proprio utilizzandole ed esasperandole; e chi invece vuole garantire una competizione non truccata, correggendo le differenze "di natura". Di qui il darwinismo sociale che ha sempre caratterizzato la destra, fino al razzismo fascista; e quello che si può chiamare il "culturalismo" della sinistra, che va oltre il dato "naturale". Il problema della sinistra è sempre stato quello di riconoscersi francamente per quel che è, come "cultura vs. natura": quando ha creduto di essere più fedele alla natura (come difesa dei diritti "naturali" o come scienza economica "vera") è sempre diventata totalitarismo. La forza della sinistra sta nel difendere il diritto di chi non ha "diritti", di chi non è "legittimato" né dalla natura (quella che sempre anche il Papa invoca) né della scienza (per lo più al servizio del potere). Il proletariato di Marx non è l’uomo "vero", è solo la classe generale, la grande massa degli espropriati che merita di farsi valere anche solo in nome del (borghese) principio democratico.
SE LA SOLIDARIETÀ NON È MAI FUORI MODA
di Jürgen Habermas *
Chi crede tuttora nella forza rivoluzionaria di autoguarigione delle crisi economiche gravita in nebulose profondità attorno al concetto del «politico», o soffia sulla «sollevazione prossima ventura». Il resto è disfattismo.
La «sinistra» deve il suo nome all’ordine degli scanni parlamentari all’Assemblea nazionale francese del 1789. Quanto al termine «socialismo», il suo significato era e rimane nient’altro che la messa in atto delle parole d’ordine della Rivoluzione francese. La libertà non può essere ridotta alla mera possibilità, per i soggetti partecipi di un sistema di mercato, di esprimere individualmente il proprio voto. Solo l’inclusione egualitaria di tutti i cittadini come co-legislatori, in un contesto di formazione di opinioni e volontà politiche informate, può assicurare a ciascuno gli spazi e i mezzi per determinare e plasmare autonomamente la propria personale esistenza.
L’uguaglianza non può essere solo quella formale davanti alla legge, ma deve comportare l’equa ripartizione dei diritti, che devono avere eguale valore per ciascuno, indipendentemente dalla sua posizione sociale. La solidarietà non deve degenerare in paternalistica assistenza agli emarginati; la partecipazione alla comunità politica con pari diritti non è conciliabile con la privatizzazione, che scarica i rischi e i costi originati a livello sociale complessivo su singoli gruppi o persone, senza indennità o risarcimenti di sorta.
E’ questo il modo in cui la sinistra intende i principi costituzionali, non certo spettacolari, che nelle nostre società democratiche informano il diritto vigente. La sinistra recluta i suoi aderenti tra i cittadini tuttora sensibili alle stridenti dissonanze tra questi principi di fondo e la realtà, da tempo accettata, di una società sempre meno solidale. Una società nella quale le élite si barricano, anche moralmente, nelle loro gated communities è fetida. I mali della sinistra rispecchiano il generale ottundimento di questo spirito normativo, e la crescente tendenza ad accettare come normale e ovvio un egoismo razionalista, che con gli imperativi del mercato è penetrato oramai fin dentro i pori di un ambiente di vita colonizzato.
Naturalmente il deficit della sinistra non è solo di tipo motivazionale, ma riguarda anche il piano cognitivo, ove si è mancato di affrontare tutta la complessità delle sfide reali - ad esempio, i rischi che corre oggi la moneta europea. Altrimenti la sinistra non si limiterebbe a lamentare la distruttività dei mercati finanziari incontrollati, ma ravviserebbe nella speculazione contro la moneta europea un’astuzia politica della ragione economica. Si attiverebbe contro l’asimmetria dell’UE, che a una completa unificazione economica affianca l’incompletezza di quella politica. E comprenderebbe infine che un’Europa democratica e solidale è un progetto di sinistra. (Traduzione di Elisabetta Horvat)
LA SFIDA DELLA SCUOLA, UN’EDUCAZIONE PER TUTTI
di Fernando Savater *
Oggi, la sinistra non può essere altro che quella che difende il concetto di società. Vale a dire, qualcosa di diverso dalla semplice giustapposizione di individui atomizzati e di interessi contrapposti in lizza. I membri di una società vedono se stessi come soci degli altri, vale a dire come collaboratori e complici di un beneficio che in qualche misura deve raggiungere tutti. La sinistra deve ricordare che la democrazia, in qualsiasi luogo del mondo, ha due nemici fondamentali: la miseria e l’ignoranza. Dove la miseria è tollerata, dove l’ignoranza non è combattuta, la democrazia si trasforma in una caricatura di se stessa. Pertanto, la sinistra - che ha già imparato che non può essere che democratica in un modo deciso e scrupoloso - deve tentare di mettere fuori legge le condizioni di povertà estrema - come a suo tempo si mise fuori legge la schiavitù - e deve far sì che l’educazione per tutti, pubblica, laica e senza esclusioni maliziose diventi il suo compito prioritario. Un’altra questione molto attuale che la sinistra deve affrontare è la crescita della corruzione sia politica che finanziaria (che normalmente agiscono insieme) e che minaccia di pervertire la democrazia in "cleptocrazia", mettendo le istituzioni o la sfera pubblica al servizio dei depredatori. (traduzione di Luis E. Moriones)
* la Repubblica, 27.12.2010
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- Così tramonta l’idea di un progresso consapevole. Il futuro condiviso o l’incertezza globale (di Remo Bodei).22 gennaio 2011, di Federico La Sala
 Il futuro condiviso o l’incertezza globale
Il futuro condiviso o l’incertezza globale
 Così tramonta l’idea di un progresso consapevole
Così tramonta l’idea di un progresso consapevoledi Remo Bodei (Corriere della Sera, 22.01.2011)
Sta drasticamente diminuendo la capacità di pensare a un futuro collettivo, di immaginarlo al di fuori delle proprie aspettative private. A molti, la Storia appare quindi orfana di quella logica intrinseca che si credeva dovesse indirizzarla verso un determinato obiettivo: il progresso, il regno della libertà, o la società senza classi. Tramonta una cultura, che - tra Ottocento e Novecento - aveva indotto miliardi di uomini a ritenere che gli eventi marciassero ineluttabilmente in una certa direzione, annunciata o prevedibile. A lungo, infatti, siamo stati abituati a ritenere che l’intervento umano consapevole fosse in grado di abbreviare il tempo necessario al prodursi dell’inevitabile, di «accelerare le doglie del parto» . Caduta, senza essere stata confutata, l’idea di un’unica Storia orientata, il senso del nostro vivere nel tempo sembra, ora più che mai, disperdersi in una pluralità di storie (con la s minuscola) non coordinate, in destini personali blandamente connessi alle vicende comuni. Ciò comporta un mutamento radicale nella nostra percezione del futuro e ci obbliga a una riflessione ulteriore sugli strumenti razionali per affrontarlo connettendo in maniera diversa le vicende individuali a quelle collettive.
Non potendoci più situare all’interno di un’epoca che si rapporta a un passato di tradizioni relativamente salde e ben individuate o a un futuro remoto di aspettative già stabilite, sembra riprodursi un’atmosfera intellettuale simile a quella descritta da Tocqueville nel 1840 per indicare lo stato d’animo prevalente degli americani: «In mezzo a questo continuo fluttuare della sorte, il presente prende corpo, ingigantisce: copre il futuro che si annulla e gli uomini non vogliono pensare che al giorno dopo» . L’avvenire riacquista la sua natura di assoluta contingenza o di luogo di esplicazione di forze che sfuggono al controllo degli uomini (si mostra cioè sostanzialmente improgrammabile o, di nuovo, nelle mani di Dio). Pare così realizzarsi l’affermazione di John Maynard Keynes, secondo cui «l’inevitabile non accade mai, l’inatteso sempre» . I contraccolpi di questa situazione sono molteplici e ancora da analizzare a fondo. In termini etico-politici, ne vedo sostanzialmente tre. In primo luogo, le valenze tradizionalmente legate al futuro come tempo dell’attesa, della redenzione e dell’imminenza del Regno di Dio o della Rivoluzione hanno virato di senso. La rappresentazione della propria esistenza come momento preparatorio a un’altra vita, in senso religioso, o come strumento laico di edificazione di un avvenire radioso- che però conosceranno solo i nostri pronipoti - diventa ardua da concepire e da difendere.
Molte situazioni della vita delle persone (dolore, malattia, vecchiaia, morte) vengono ora intimamente giudicate irredimibili, perché non possono più essere ritenute seriamente riscattabili né in un al di là religioso, in una condizione di beatitudine celeste, né in un futuro terreno di armonica ricomposizione dei conflitti. La trasformazione «alchemica» del negativo in positivo teorizzata da certe varianti della dialettica e le promesse di risarcimento delle sofferenze patite nel presente per mezzo delle gioie fatte balenare nell’avvenire sembrano essere improvvisamente diventate lettera morta. Ciò produce talvolta una sorta di implosione nell’arco dell’esistenza individuale, sottratta alla speranza ma non all’angoscia, alla rassegnazione o all’indifferenza. Interi blocchi di esperienza e ampie regioni di significato - prima considerati nell’ottica dell’eternità o del futuro remoto - vengono riformulati e trascritti secondo nuovi criteri di rilevanza. Quel che vale per le esperienze «negative» vale anche per quelle «positive» : il desiderio di fruire immediatamente, come doni irripetibili, dell’amore, dell’amicizia, del piacere o del benessere sembra concentrare, in istanti puntuali e discontinui, i «momenti d’essere» di una vita degna di se stessa.
La contrazione delle aspettative all’arco della sua sola esistenza fisica immerge il singolo nel tempo irredimibile della caducità, lo costringe a elaborare il lutto causato dal dover trapiantare le radici del proprio io dal solido e immutabile terreno dell’al di là o dai tempi epocali della Storia nel friabile e transeunte suolo del proprio corpo, della propria biografia o dell’entourage delle persone e delle istituzioni a lui più vicine.
A questo disagio si reagisce oggi mediante la prevalente strategia di mettere a coltura intensiva il presente, di farlo fruttare rapidamente, senza preoccuparsi di quel che avverrà nell’avvenire non immediato. Ciò comporta, però, la desertificazione del futuro e rischia di creare una mentalità opportunistica e predatoria. In secondo luogo, il tramonto delle grandi attese collettive, che sino a una decina di anni fa (quando il mondo era ancora diviso in due blocchi) orientavano, seppur ideologicamente, miliardi di uomini, porta tendenzialmente a una privatizzazione del futuro stesso e alla fabbricazione di utopie su misura, fatte in casa.
Gli ideali di abolizione delle disuguaglianze che colpiscono l’ «intera umanità» o di espansione della libertà al maggior numero di individui, con la parallela promessa di un avvenire aperto all’iniziativa di ciascuno, finiscono - soprattutto in Occidente - per diffondere le frustrazioni. Le società tradizionali possedevano infatti strumenti abbastanza efficaci sia per compensare gli uomini degli eventuali svantaggi della loro condizione, sia per giustificare le gerarchie. L’accettazione dei limiti e delle privazioni della vita trovava il proprio risarcimento nella prospettiva religiosa di una ricompensa in cielo. Le ideologie dominanti facevano sì che di rado venisse in mente ai più sfavoriti di aspirare ai livelli alti della scala sociale. Le società democratico-egualitarie moderne hanno invece aperto una falla nel dispositivo di inibizione delle aspettative, collaudato da millenni. Proclamando solennemente il diritto di tutti gli uomini all’effettiva eguaglianza e all’eliminazione di tutti gli ostacoli che potrebbero frenarla, legittimano le aspirazioni di ciascuno a superare la soglia della propria condizione di partenza per innalzarsi ai vertici della piramide sociale, alle cariche, alla ricchezza o al prestigio.
Di fronte al presagibile naufragio dei molti che non riusciranno mai a far collimare i propri ideali con la realtà, tali società hanno dovuto elaborare molteplici tecniche per gestire le frustrazioni che nascono dal fatto che le loro promesse non possono essere per principio esaudite. I progetti di donazione alla Storia di un senso collettivo costituivano, appunto, una delle forme di compensazione e di risarcimento differito per le attese individuali inappagate. Rinviando la realizzazione di una società perfetta alle future generazioni, legittimando il sacrificio delle generazioni presenti e mettendo la ragione al servizio di programmi epocali a lungo termine, riempivano di senso la vita degli individui. Oggi questo transfert, questo meccanismo di dilazione non funziona più.
Non si deve certo rimpiangere il passato e ignorare i preponderanti benefici del diffondersi dell’eguaglianza, ma rendersi conto di quali nuovi problemi ponga l’accorciamento dei piani di vita dei singoli e il ridursi della forza di proiezione in avanti delle istituzioni. In terzo e ultimo luogo, giunge a conclusione un ciclo bicentenario di pensiero e di prassi che aveva attribuito alla politica una funzione salvifica, promettendo a popoli o a classi una felicità futura grazie al suo innesto nel corso della Storia. Inserendosi nella corrente degli eventi, cavalcandone la cresta dell’onda, sintonizzandosi su processi già in atto, seguendone la «meccanica razionale» , la politica pensava di fruire dell’energia ascensionale del movimento storico per giungere felicemente alla meta. Oggi anche questa spinta propulsiva è venuta meno, perché non funziona più il dispositivo che la generava.
-
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- LA LOGICA DEL "MENTITORE" ISTITUZIONALIZZATA - E IL LAVORO DELLO STORICO: PAUL GINSBORG NON HA CAPITO ANCORA LA VERGOGNA DI ESSERE ITALIANO.22 ottobre 2010, di Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- KARL MARX RISPONDE A SALVATORE VECA.21 ottobre 2010, di Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- LA CACCIA AL "CARISMA" E TRE "PAPI" CONTRO LA COSTITUZIONE E CONTRO L’ITALIA.14 ottobre 2010, di Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- LA LEZIONE DIMENTICATA DEL "LIBER PARADISUS"(BOLOGNA, 1257) E LA RIFLESSIONE DI RANIERO LA VALLE.26 settembre 2010, di Federico La Sala
 L’AMORE EVANGELICO ("CHARITAS") E LA NASCITA DELLA DEMOCRAZIA DEI MODERNI. LA "CHARTA CHARITATIS" (1115), LA "MAGNA CHARTA" (1215), LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (1948), E LA FALSA "CARTA" DELLA CHIESA COSTANTININA DI OGGI (BENEDETTO XVI, "DEUS CARITAS EST", 2006).
L’AMORE EVANGELICO ("CHARITAS") E LA NASCITA DELLA DEMOCRAZIA DEI MODERNI. LA "CHARTA CHARITATIS" (1115), LA "MAGNA CHARTA" (1215), LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (1948), E LA FALSA "CARTA" DELLA CHIESA COSTANTININA DI OGGI (BENEDETTO XVI, "DEUS CARITAS EST", 2006). (...) la nobile città di Bologna, che ha sempre combattuto per la libertà, memore del passato e provvida del futuro, in onore del Redentore Gesù Cristo ha liberato pagando in danaro, tutti quelli che ha ritrovato nella città e diocesi di Bologna astretti a condizione servile; li ha dichiarati liberi e ha stabilito che d’ora in poi nessuno schiavo osi abitar nel territorio di Bologna affinché non si corrompa con qualche fermento di schiavitù una massa di uomini naturalmente liberi (...)
(...) la nobile città di Bologna, che ha sempre combattuto per la libertà, memore del passato e provvida del futuro, in onore del Redentore Gesù Cristo ha liberato pagando in danaro, tutti quelli che ha ritrovato nella città e diocesi di Bologna astretti a condizione servile; li ha dichiarati liberi e ha stabilito che d’ora in poi nessuno schiavo osi abitar nel territorio di Bologna affinché non si corrompa con qualche fermento di schiavitù una massa di uomini naturalmente liberi (...) -
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- KANT E SAN PAOLO. COME IL BUON GIUDIZIO ("SECUNDA PETRI") VIENE (E VENNE) RIDOTTO IN STATO DI MINORITA’ DAL GIUDIZIO FALSO E BUGIARDO ("SECUNDA PAULI").17 settembre 2010, di Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- LA FORTUNA... Chi sa veleggiare non naviga né con irrazionalità, né con casualità: sceglie, a ragione, rotte precise (di Nicla Vassallo - Il nostro rischio? Perdere conoscenza).19 settembre 2010, di Federico La Sala
 Il nostro rischio?
Il nostro rischio?
 Perdere conoscenza
Perdere conoscenza Conoscere è importante, soprattutto oggi in un un Paese come il nostro dove domina l’ignoranza
Conoscere è importante, soprattutto oggi in un un Paese come il nostro dove domina l’ignoranza di Nicla Vassallo (l’Unità, 19.09.2010)
di Nicla Vassallo (l’Unità, 19.09.2010)State leggendo questo articolo. Un semplice atto che presuppone parecchie conoscenze: saper leggere, sapere che l’Unità è un giornale, sapere in quale spazio/tempo vi trovate (se vi credeste nella Grecia antica, cosa comprendereste della situazione socio-politica contemporanea?), sapere che siete voi, non qualcun altro. Di più, necessitate di una conoscenza di background, di cui fa tra l’altro parte il sapere che un giornale è qualcosa che si sfoglia, non che si mangia, che non avete scritto il presente articolo, qual è il vostro nome (vi chiamate forse Nicla Vassallo?), e via dicendo. Chiudete gli occhi, per immaginare di perdere ogni conoscenza, queste incluse. La vostra esistenza? Ridotta a un mero vegetare, in cui non sapete quasi nulla. Esperimento inquietante, che mostra però l’importanza del conoscere.
GRANDE FRATELLO & CO. Apriamo gli occhi sull’oggi. Da una parte, i luoghi deputati (famiglie, libri, media, scuole, università, eccetera) a trasmettere conoscenza, non errori, risultano controllati e penalizzati viepiù, mentre si scacciano conoscenze e competenze per lasciar posto a insigni, immeritevoli appariscenze, che brillano per pressapochismo e ignoranza. Dall’altra, ci vengono propinate, troppo spesso, realtà virtuali, dimensioni fittizie, informazioni manipolate, che, erronee, finiscono col non trovare riscontro «là fuori», nel mondo esterno.
Se in ciò consta la nostra cultura, su quale patrimonio conoscitivo, condivisibile e condiviso, si erge? Oppure, è una non-cultura, se non un’anti-cultura, che galoppa alla volta di un mondo orwelliano, governato dal Grande Fratello: «In fin dei conti, come facciamo a sapere che due più due fa quattro? O che la forza di gravità esiste davvero? O che il passato è immutabile? Che cosa succede, se il passato e il mondo esterno esistono solo nella vostra mente e la vostra mente è sotto controllo?» (George Orwell, 1984, Mondadori, Milano, p. 85). D’accordo, errare humanum est, ma un illuminato Cicerone precisa che perseverare è azione da ignoranti, quindi non da diabolici a meno che, ovvio, ignoranti e diabolici non coincidano. Abitiamo, allora, in una cultura dell’ignoranza e dell’errore, sempre che di cultura si tratti. Se sommiamo l’ignoranza all’errore, erriamo nell’ignoranza e ignoriamo d’errare, tradendo le aspirazioni conoscitive, iscritte per Aristotee nella nostra natura. A venirci assicurata rimane una brutalità di dantesca memoria. Illusioni e allucinazioni umane, errori percettivi, ci conducono a vedere il bastone spezzato nell’acqua quando in realtà non lo è, l’acqua nel deserto quando in realtà non vi è.
Chiamandole illusioni e allucinazioni, implichiamo che qualcosa di non illusorio e non allucinatorio si dia in una realtà da conoscere, realtà che non creiamo, né fantastichiamo, realtà che esiste indipendentemente da noi. I realisti concordano. Ma chi ingiunge prontamente «Siamo realisti: fatti, non parole!», oltre a proferire parole, si nasconde dietro un logoro slogan, sconfessa la relazione tra parole e fatti, sorvola sul problema della verità. «Dire di ciò che esiste che non esiste, o di ciò che non esiste che esiste, è falso, mentre dire di ciò che esiste che esiste, e di ciò che non esiste che non esiste, è vero»: Aristotele sposa così (La metafisica, IV, 7, 1011b) una precisa concezione della verità, stando a cui le nostre affermazioni sono vere se corrispondono ai fatti, se trovano in essi una base oggettiva.
Quando affermiamo senza menzogne? Quando crediamo in ciò che diciamo. Sapere fare un’affermazione comporta, a ogni buon conto, saperla giustificare, essere cioè in grado di offrire buone ragioni per essa. Mettiamo che qualcuno affermi «Non esistono le condizioni per riaprire le trattative», e che, alla domanda «Per quale ragione lo credi?», replichi «Il Colosseo è eversivo»: non ci troviamo di fronte a una giustificazione, bensì a una farneticazione. Solo nel caso in cui disponiamo di una giustificazione, non di una farneticazione, la credenza che affermiamo ha buone probabilità di risultare vera, ovvero di aspirare allo status di conoscenza.
Giungere a conoscere per un caso fortuito? Non si appella alla fortuna la scommessa di Blaise Pascal sull’esistenza di Dio. Abbiamo ragioni di credere che Dio esiste perché la posta in gioco è la vita eterna. Si tratta di ragioni prudenziali (è prudente, conveniente credere che Dio esiste), non di ragioni epistemiche (ragioni per credere che sia vero che Dio esiste).
Meglio la convenienza o la verità? Se aspiriamo a conoscere, occorre optare per verità. Non per nulla, a partire da Platone, identifichiamo la conoscenza con la credenza vera supportata dalla giustificazione epistemica. Tuttavia, rimaniamo esseri fallibili, dalle capacità cognitive limitate, per cui le nostre credenze, pur giustificate, possono risultare false. Certo, per mera casualità, si danno credenze vere ingiustificate. Ma chi, dotato di sale in zucca, darebbe credito a uno scommettitore incompetente, stando a cui x vincerà? Diremmo forse che lo scommettitore in questione (che tira a indovinare, e che si differenzia così da quello pascaliano) sapeva che x avrebbe vinto, nel caso in cui x vinca? Lo scommettitore non sapeva, ha avuto soltanto una spacciata fortuna.
Già, la Fortuna, meglio non affidarsi a questa giovane bendata, se siamo savi. Una donna irrazionale, contrapposta, per errore, all’uomo razionale, donna che trova però un qualche riscatto in epoca rinascimentale, quando viene rappresentata con una vela in mano. Chi sa veleggiare non naviga né con irrazionalità, né con casualità: sceglie, a ragione, rotte precise. Navigare è impresa difficile, occorre per l’appunto saperlo fare non tutti ne sono in grado -, gli errori si pagano cari: andar per mare rimane la migliore metafora della nostra effettiva esistenza. Ci saranno pure naufragi fortunati e capitani che, come i prìncipi di Nicolò Machiavelli, si trasfigurano in tali, con poca fatica, grazie alla fortuna, «ma devono poi penare per restare al potere», al timone. Già, difficile governare una barca senza conoscenza, senza sapienza.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- Un paese in ginocchio (di Moni Ovadia)25 settembre 2010, di Federico La Sala
Un paese in ginocchio
di Moni Ovadia (l’Unità, 25.09.2010)
L’immagine dell’Italia trasmessa dai media, per una persona per bene di buon senso, è raccapricciante. Lo squallore della sua politica ha sfondato ogni soglia della decenza. Il governo si da con maniacale accanimento alla distruzione delle fondamenta dello stato democratico con lo strumento della demagogia populista più vieta, dell’intorbidamento delle acque per cancellare le differenze fra il giusto e l’ingiusto, fra la legalità e il crimine.
Con questa tecnica antica e oscena vengono demoliti a colpi di mazza i pilastri dell’intera società: i principi costituzionali, la scuola pubblica, la cultura, i fondamenti morali, i diritti civili e i diritti sociali. L’opposizione parlamentare, con rare eccezioni, sembra - anche ad ad un osservatore non particolarmente smaliziato - assistere allo scempio pavida, divisa, balbettante, capziosa, arrogante e stonata. È difficile non pensare che l’unica sua cura sia la propria autoconservazione.
Quanto alla «sinistra fuori dal parlamento» si è virtualizzata. Se non fosse per la coraggiosa Fiom, per un leader carismatico capace di guardare il futuro e per qualche sparuta testa pensante potrebbe bene figurare in un film di Moretti come associazione di reduci.
Spero con tutto il cuore di essere una cattiva Cassandra ma, sulla soglia dell’età della pensione, non riesco ad impedirmi di pensare che si tratti della bancarotta di quasi un’intera classe dirigente che ha sacrificato il benessere di un paese ai piedi di un grottesco omino, aspirante sovrano, truccato come un clown sinistro e sull’altare del cinismo e del conformismo. In questo sfacelo riesco a trarre conforto da quelle donne e quegli uomini dell’Italia reale che continuano a vivere, a lavorare e a lottare secondo i principi della dignità e della giustizia. Grazie a loro sento che essere italiano non è solo una iattura.
-
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA E A PENSARE BENE "DIO", "IO" E "L’ITALIA", CHI PIU’ CHI MENO, TUTTI VIVONO DENTRO LA PIU’ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA E POLITICA ITALIANA, NEL REGNO DI "FORZA ITALIA"!!! Un’inchiesta e una mappa di Francesco Tomatis - a cura di Federico La Sala15 settembre 2010, di Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- ZAGREBELSKY RIFLETTE SULLA PAROLA "ALLEVAMENTO" E SULLA "BUONA POLITICA", MA SENZA AVER CHIARO DI QUALE "ITALIA". Stralci della sua "Lezione di democrazia".13 settembre 2010, di Federico La Sala
LA LINGUA D’AMORE DEI NOSTRI PADRI E DELLE NOSTRE MADRI COSTITUENTI E LA COSTITUZIONE.
L’OCCUPAZIONE DELLA LEGGE E DELLA LINGUA ITALIANA: L’ITALIA E LA VERGOGNA.
 Se il potere si apre alla società civile
Se il potere si apre alla società civile
 La buona politica e la società civile
La buona politica e la società civile Troppo scarsa l’attenzione alle forme di associazione spontanea e volontaria che si occupano della collettività. Cambiare la legge elettorale costituisce un’autentica emergenza
Nella lezione tenuta alla Festa del Pd i rischi che sono di fronte alle democrazie di oggi. I pericoli maggiori vengono dalle derive populistiche e dalle chiusure di casta
Troppo scarsa l’attenzione alle forme di associazione spontanea e volontaria che si occupano della collettività. Cambiare la legge elettorale costituisce un’autentica emergenza
Nella lezione tenuta alla Festa del Pd i rischi che sono di fronte alle democrazie di oggi. I pericoli maggiori vengono dalle derive populistiche e dalle chiusure di casta di Gustavo Zagrebelsky
di Gustavo Zagrebelsky Pubblichiamo ampi stralci della "Lezione sulla democrazia" che Gustavo Zagrebelsky ha tenuto sabato alla Festa del Partito Democratico a Torino *
Pubblichiamo ampi stralci della "Lezione sulla democrazia" che Gustavo Zagrebelsky ha tenuto sabato alla Festa del Partito Democratico a Torino *"Politica" è una parola bastarda. Ha molti padri e madri. Non è sempre la stessa cosa. Dipende da chi la genera e per che cosa. Per chiarire, mi avvalgo d’una citazione di George Orwell. Nel 1948, scriveva (in Writers and Leviathan): «Questa è un’epoca politica. La guerra, il fascismo, i campi di concentramento, i manganelli, le bombe atomiche sono quello a cui pensare». Se non si parlava di campi di sterminio e di genocidio, era per la diffusa ignoranza di ciò che era effettivamente accaduto nel cuore dell’Europa. Auschwitz sarebbe in seguito assurto a simbolo di una certa concezione della politica. Il che è certo molto imbarazzante per la politica stessa.
Questa visione della politica è terrificante. Ha come madre la potenza sopraffattrice, nelle relazioni tra i popoli e tra parte e parte, tra i dominatori e gli oppressi, all’interno dei popoli. L’uso di categorie primordiali come, ad esempio, quelle di amore e odio, per dividere il campo dell’agone politico, sono il riflesso di questa concezione della politica basata sulla malevolenza tra gli esseri umani.
La concezione opposta della politica è espressa in una frase di Aristotele. Se là la politica è violenza e prepotenza, qui «compito della politica pare essere soprattutto il creare amicizia» tra cittadini, cioè legame sociale (Etica Eudemia, 1234 b).
Con le parole di Hannah Arendt (Was ist Politik? - inediti del 1950, pubblicati nel 1993, trad. it. Che cosa è la politica? Torino, Comunità 2001, pp. 5 ss.), ciò che è proprio di questa concezione della politica è l’essere collocata infra, in mezzo, tra le persone. La virtù politica è propria di coloro che amano stare "con" le altre persone, non "sopra", nemmeno "accanto" o, peggio, "altrove"; di coloro che conducono la loro vita insieme a quella degli uomini e delle donne comuni, stando dentro le relazioni personali e di gruppo, quelle relazioni che, nel loro insieme, fanno, di una semplice somma d’individui, una società.
Chi disdegna stare con le persone comuni, credendosi diverso, e il suo cuore batte piuttosto per i salotti, le accademie, le fondazioni culturali, le tavole rotonde, gli studi televisivi, potrà certo essere un’ottima persona. Ma non è adatto alla politica in questo senso. Ciò è così vero che, proprio gli uomini politici più distanti dalla vita della gente comune, che disprezzano, fanno a gara nel dar prova di atteggiamenti populistici e volgari, per far mostra d’essere uguali agli altri, "uno di loro"; in realtà offendendoli e insultandoli, nel momento in cui le trattano non come cittadini ma come plebe.
Forse non abbiamo mai pensato che tra tutti i regimi politici, la democrazia è l’unico che presuppone amicizia tra governanti e governati. I regimi autocratici o oligarchici, comportano separazione che, nel caso migliore, si traduce in indifferenza, in quello peggiore, in inimicizia e avversione. Solo la democrazia vive e si alimenta di un circuito di reciproca fiducia che può esistere solo a condizione che i governanti non si costituiscano in classe separata, solo a condizione che i cittadini comuni non li vedano come cosa diversa da sé.
Che significa classe separata? Innanzitutto che, una volta entrati in uno dei luoghi della politica, si sia acquisito il diritto di non uscirne mai più, fino a quando provveda la natura. I ceti o le caste delle società premoderne erano stratificazioni sociali alle quali si apparteneva dalla nascita alla morte. Oggi, al ceto politico di regola non si appartiene per diritto di nascita, anche se non manca, anzi si moltiplicano i casi di nepotismo, di familismo e di trasmissione ereditaria delle cariche politiche. In politica oggi, di norma, "si entra", o, come si dice autorevolmente, "si scende" (una volta si sarebbe detto "si sale" o si "ascende"), ma, una volta entrati non se ne vuole più uscire. Se proprio occorre lasciare un posto, ce n’è sempre un altro cui aspirare e che ci attende. Oggi quello che importa è entrare in un giro di potere. A che "giro" appartiene? ci chiediamo, vedendo qualcuno che "gira", per l’appunto, da un posto all’altro. Quando entri in un giro, non ne esci più, a meno che tu abbia tradito le aspettative di chi ti ci ha messo.
Questa è la separazione: tra chi, in un giro del potere, c’è e chi non c’è. E volete che chi non c’è non si senta mille miglia lontano da chi vi è dentro? Che non si consideri appartenere a un altro mondo? E, all’opposto, possiamo credere che chi è dentro non consideri chi è fuori un potenziale pericolo, un’insidia per la propria posizione acquisita, e non faccia di tutto per restarci aggrappato, impedendo accessi non graditi al proprio giro chiuso o, almeno, per gestirli secondo propri criteri, in modo che gli equilibri acquisiti non siano scossi? Ma questa è la sclerosi della politica.
Quando si sente dire che occorre promuovere il rinnovamento della classe dirigente e, per questo, bisogna "allevare" nuove leve politiche, il linguaggio - l’allevamento - tradisce perfettamente l’orizzonte culturale in cui si pensa debba avvenire il cosiddetto "ricambio", quel ricambio che tutti a parole dicono necessario ma che, secondo l’idea dell’allevamento, è perpetuazione dello status quo che produce cloni.
Di quest’atteggiamento di separatezza e, in definitiva, di inimicizia, testimonianza eloquente è l’atteggiamento del mondo politico nei confronti della cosiddetta "società civile", un’espressione e un concetto che non ha mai goduto di buona fama, soprattutto a sinistra. Questa è una lunga storia che sarebbe da ricostruire interamente, a partire da quando, dopo la Liberazione, effettivamente la pretesa dei partiti di rappresentare tutto ciò che di "politico" vi era da rappresentare, era giustificata. Ma oggi? Oggi, una società civile è difficile negare che esista. Dobbiamo capirci. Assai spesso - per squalificarne il concetto stesso - la si intende come "i salotti" dove s’incontrano persone disparate che presumono d’essere élite del Paese e si auto-investono di chissà quale compito salvifico, o come lobby più o meno segrete o gruppi d’interesse settoriale che curano i propri affari, legalmente e talora anche illegalmente tramite corruzione o collusione. Da tutto ciò, che ha niente a che fare con la democrazia, la politica dovrebbe guardarsi. Da questa "società civile", piuttosto "incivile", chi si occupa di politica dovrebbe cercare di stare lontano, il più possibile. Ora, chi vuole difendere il circolo chiuso della politica e i suoi sistemi di cooptazione demonizza la società civile identificandola con questi ambienti. Ma è un’operazione che sa di diversivo, cioè di tentativo di spostare l’attenzione su un falso obiettivo, effettivamente indifendibile.
La società civile esiste, ma è un’altra cosa: è l’insieme delle persone, delle associazioni, dei gruppi di coloro che dedicano o sarebbero disposti, se solo ne intravedessero l’utilità e la possibilità, se i canali di partecipazione politica non fossero secchi o inospitali, a dedicare spontaneamente e gratuitamente passione, competenze e risorse a ciò che chiamiamo il bene comune. Quante sono le persone, singole e insieme ad altre, che a partire dalle tante e diverse esperienze, in tutti gli ambiti della vita sociale, a iniziare dai più umili e a diretto contatto con i suoi drammi e le sue tragedie, sarebbero disposte a dare qualcosa di sé, non per un proprio utile immediato, ma per opere di più ampio impegno che riguardano la qualità, per l’appunto civile, della società in cui noi, i nostri figli e nipoti si trovano e troveranno a vivere? Da quel che mi par di vedere, tantissime. Quando si parla di politica e di sua crisi, perché l’attenzione non si rivolge a questo potenziale serbatoio di energie? Non per colonizzarle, ma per trarne, rispettandone la libertà, gli impulsi vitali. In fin dei conti, sono questi "servitori civili", quelli che più di altri conoscono i problemi e le difficoltà reali della vita nella nostra società. C’è più sapienza pratica lì che in tanti studi accademici, libri, dossier che spesso si pagano fior di quattrini per rimanere a giacere impilati. Perché c’è così poca attenzione e apertura, anzi spesso disprezzo, verso questo mondo?
La risposta alla domanda formulata sopra è semplice: la scarsa attenzione, se non l’ostilità, dipende dalla difesa di rendite di posizione politica che sarebbero insidiate dall’apertura. Non c’è da fare tanti giri di parole: è la sempiterna tendenza oligarchica del potere costituito. Viene in mente la frase dell’abate Siéyès con la quale inizia il celebre libello "Che cos’è il terzo stato", un testo che contribuì a creare autocoscienza in chi allora - la Francia pre-rivoluzionaria - chiedeva riforme: "Che cos’è il terzo stato? Tutto. Che cos’è stato finora nell’ordinamento politico? Niente. Che cosa domanda? Diventare qualcosa". Noi potremmo tradurre: "Che cos’è la società civile? Molto. Che cosa è nell’ordine politico? Quasi nulla. Che cosa occorre che diventi? Qualcosa".
Sotto questo punto di vista, c’è oggi in Italia una specifica situazione d’emergenza politica e democratica, rappresentata dalla legge elettorale vigente, con la quale rischiamo di essere chiamati alle urne, nel momento in cui - col favore dei sondaggi- piacerà a chi di dovere.
Questa legge sembra, anzi è, fatta apposta per garantire l’impermeabilità del ceto politico, la sua auto-referenzialità, per munire la sua separatezza. È una legge, nella sua essenza, dello stesso tipo di quelle vigenti nelle dittature di partito. Il fatto che non vi sia "il" partito, ma vi siano "i" partiti, non cambia il giudizio. La sua ratio, come direbbero i giuristi, può esprimersi così: dall’alto discende il potere e dal basso sale, o si fa salire, il consenso. Ma questa non è democrazia. E’, se si vuole," democratura", secondo la felice e, al tempo stesso orrenda, espressione dell’esule bosniaco Predrag Matvejevic. Col sistema elettorale attuale, i vertici dei partiti - tutti quanti - dispongono dell’intero potere di definire chi formerà la rispettiva corte in Parlamento. Non è poca cosa per loro e questo spiega il fatto che, a suo tempo, quando fu approvato, non ci sia stata una reazione adeguata. Il potere si è capovolto e cominciamo ad accorgercene. E ci accorgiamo di quanto ciò finisca per alimentare sentimenti, risentimenti e atteggiamenti anti-politici, da cui tutti, meno i demagoghi, hanno molto da perdere.
La ragione per non andare più a votare con questa legge elettorale non si riduce alla pur rilevantissima stortura ch’essa comporta: il fatto cioè che deputati e senatori siano nominati dall’alto, senza alcuna possibilità d’influenza degli elettori, altro che nel distribuire il numero di "posti" che spettano all’uno e all’altro partito, assegnati poi a questo o quello per beneplacito altrui. La posta è assai più grande: per i partiti è il dilemma tra l’apertura alla società o la chiusura; per i cittadini tra la politica e l’antipolitica, tra la partecipazione e l’esclusione politica, tra la fiducia nella democrazia e il risentimento contro la democrazia. Quando parliamo di democrazia, però, non pensiamo solo a partiti, elezioni, parlamenti, governi, e cose di questo genere. In una parola, non pensiamo solo a forme e istituzioni politiche, cioè a tecniche di governo. Pensiamo anche a una sostanza della società.
Ora, la domanda da porre è se ci può essere democrazia come forma in una società non democratica. La risposta è sì. Ci può essere. Ma che genere di democrazia? La democrazia come tecnica di governo, innestata su una realtà sociale non democratica, non fa che amplificarne e moltiplicarne i caratteri non democratici o antidemocratici, rappresentandoli, generalizzandoli e, per così dire, rendendoli obbligatori per tutti. Per esempio, noi non diremmo certo che una società a maggioranza razzista e xenofoba è democratica. Questa società può senz’altro governarsi in forme democratiche, cioè la maggioranza può imporre per legge la sua visione del mondo razzista e xenofoba. Questo ci dice che la democrazia, intesa solo come forma di reggimento politico, non è affatto più tranquillizzante di altre. Sotto certi aspetti, anzi, fa più paura, perché ha dalla sua la forza del numero. Questo spiega il fatto che la democrazia può essere, o diventare, odiosa al pari e forse più di altre forme politiche. Ciò accade quando alla forma (democratica) del potere corrisponde una sostanza non democratica della società.
Ma che cosa è una società non democratica? In breve: una società in cui esistono discriminazioni e disuguaglianze, tali che una parte, per così dire, viva bene sopra un’altra che vive male e questa differenza alimenta odio e violenza. Usciamo dal generico: è una società dove qualcuno possa dire: "questa è casa mia" e tu sei un intruso ch’io posso escludere e respingere a mio piacimento; dove, se non ti "integri", cioè non ti rendi irriconoscibile nella tua identità, non hai diritto di cittadinanza; dove la povertà e il disagio sociale sono abbandonati a se stessi, nella solitudine; dove il lavoro non è considerato un diritto, ma solo un fattore dell’impresa subordinato alla sua logica e dove i disoccupati e i precari sono solo un accidente fastidioso di un "sistema" e non un problema per tutti; dove l’istruzione e la cultura sono riservati ai figli di coloro che possono; dove la salute è il privilegio di chi può permettersi d’affrontare le spese che la sua cura comporta. Noi avvertiamo queste discriminazioni in modo sempre più acuto. La povertà, l’insicurezza e la solitudine aumentano, anche se spesso hanno vergogna di mostrarsi, come bene sanno coloro che operano nei servizi sociali, pubblici e privati. Il divario tra chi può curare la propria formazione culturale e chi non può aumenta, e spesso si manifesta in questa forma odiosa e umiliante per il nostro Paese: chi può manda i suoi figli fuori dell’Italia. La disuguaglianza giunge a segnare i corpi, divide quelli bene curati e quelli degradati: addirittura lo stato dei denti è diventato, anzi ri-diventato qual era un tempo, segno di condizione sociale.
E noi vorremmo che tutto ciò non ingeneri inimicizia sociale? Sarebbe ingenuo sperarlo. E vorremmo che chi sta dall’altra parte della società, quella che dal basso guarda a quella che sta in alto, non nutra diffidenza, per non dire di più, verso una democrazia che accetta questa loro condizione? Una condizione che non giustifica certo, ma spiega il carattere violento dei rapporti anche quotidiani tra le persone, di chi si sente più forte sul più debole e del debole come reazione al forte, nelle infinte situazioni in cui quel divario può essere fatto valere, nelle famiglie, nella strada, nelle scuole, nelle fabbriche, nei rapporti tra uomo e donna, tra "normale" e "diverso", eccetera. È all’opera l’incultura della sopraffazione che è l’esatto opposto dell’ethos necessario alla democrazia.
Qui, nella denuncia della mentalità dilagante, nella difesa e promozione di una cultura della convivenza e nell’azione per contrastare l’incultura della violenza, c’è un compito che ci riguarda tutti, in quanto questa società non ci piaccia affatto. Ci riguarda come cittadini cui la democrazia sta a cuore come un bene cui non vogliamo rinunciare. Ma riguarda anche i cittadini che militano in partiti politici che hanno la parola democrazia nelle proprie ragioni fondative o addirittura nel proprio simbolo. Ecco un’altra buona ragione per abbandonare l’idea che la politica si faccia principalmente nelle stanze dei palazzi del potere o negli uffici delle burocrazie di partito, che il buon politico sia quello esperto di "scenari", alchimie, tattiche e strategie. Tutto questo è importante, ma non basta. Siccome non basta, abbiamo il dovere di chiederci: dove siamo quando nel nostro Paese si avvelenano i rapporti tra le persone, nelle tragedie dell’immigrazione come in quelle delle famiglie di senza-lavoro e nei drammi del lavoro senza sicurezza; nelle proteste per una scuola che affonda come nella tragedia di chi è colpito dalla forza scatenata della natura: nei nostri uffici o tra chi ha bisogno di solidarietà? Ecco perché è necessario stringere i rapporti tra partiti e società, abbandonare l’idea e le pratiche che fanno pensare che gli uni possano fare a meno dell’altra, e viceversa.
* la Repubblica, 13.09.2010
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- Al Festivalfilosofia, 17, 18, 19 settembre 2010 (Modena, Carpi, Sassuolo), dedicato al tema della fortuna Nicla Vassallo terra’ una lectio magistralis su "Cultura dell’errore".9 settembre 2010, di Federico La Sala
Al Festivalfilosofia, 17, 18, 19 settembre 2010 (Modena, Carpi, Sassuolo), dedicato al tema della fortuna (http://www.festivalfilosofia.it/2010/), Nicla Vassallo (http://www.niclavassallo.net/) terra’ una lectio magistralis su "Cultura dell’errore", il 17 settembre a Carpi, alle ore 11.30, in Piazzale Re Astolfo:
 http://www.festivalfilosofia.it/2010/?mod=eventi&categoria=1622
http://www.festivalfilosofia.it/2010/?mod=eventi&categoria=1622 http://www.festivalfilosofia.it/2010/?mod=protagonisti&id=1910
http://www.festivalfilosofia.it/2010/?mod=protagonisti&id=1910 http://www.festivalfilosofia.it/2010/?servizi_stampa=1&mod=scarica_immagini&high=1
http://www.festivalfilosofia.it/2010/?servizi_stampa=1&mod=scarica_immagini&high=1 -
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- INSEGNARE ED EDUCARE NEL TEMPO DELL’OCCUPAZIONE DELLA LINGUA ITALIANA E DEL COLPO MORTALE (ATEO E DEVOTO) ALLA SCUOLA PUBBLICA..9 settembre 2010, di Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- IL PAESE DEI FURBI. Risposta di Vito Mancuso agli "amici di Mondadori" e commento di Philippe Ridet (Come vivere senza Berlusconi? - "Le Monde").7 settembre 2010, di Federico La Sala
Cari amici di Mondadori preferisco la giustizia
di Vito Mancuso (la Repubblica, 03.09.2010)
Giornali, radio, siti, tv, non vi è stato mezzo di comunicazione che non abbia ripreso e alimentato il dibattito sviluppatosi in seguito al mio articolo del 21 agosto «Io autore Mondadori e lo scandalo ad aziendam». Naturalmente ognuno ha detto la sua, sia in merito alla questione in sé sia a me che l’avevo sollevata, facendomi provare l’ebbrezza di un viaggio sulle montagne russe della psiche col passare da coscienza profetica a povero ingenuo, da eroe coraggioso a ipocrita opportunista.
Su quest’ultimo aspetto non ho nulla da replicare, registro solo lo spettacolo di individui così incapaci di prescindere dall’ego e concentrarsi sulle cose in sé da risultare impossibilitati a concepire che qualcuno faccia qualcosa senza volerci guadagnare. Molto più interessante è la dimensione oggettiva della questione, che ritengo di poter riassumere come segue.
1. Esistenza del problema: il problema da me sollevato esiste, non è per nulla nuovo perché risale al 1993 cioè a quando il proprietario della Mondadori entrò in politica, e spesso riaffiora come i sintomi di una malattia non curata. Persino i giornali e le tv (Tg1) che ne hanno sostenuto l’inesistenza in realtà col loro zelo hanno confermato che esiste, perché non si dedicano pagine e minuti preziosi a un falso problema. Si fa così solo con un problema vero di cui si vuole sostenere capziosamente la falsità.
2. Essenza del problema: nella sua specificità il problema consiste in quell’immenso agglomerato di potere che (caso unico in occidente) fa capo all’attuale premier e che genera il nodo da tutti conosciuto come «conflitto di interessi». Se il Gruppo Mondadori non fosse «sua» proprietà, la discutibile legge ad aziendam voluta dal «suo» governo rientrerebbe al massimo nelle normali pressioni che le singole lobby esercitano in ogni democrazia di libero mercato. Purtroppo però la proprietà del Gruppo Mondadori e la guida del governo coincidono, il che conduce chi riflette in modo disinteressato a non poter evitare di associare la legge di cui ha beneficiato il «suo» gruppo editoriale (pagando solo 8,6 milioni invece di 350) alle altre leggi ad personam finora volute dal «suo» governo, compresa la legge-bavaglio contro la libertà di stampa e il progetto di legge sul processo breve.
3. Prospettive di soluzione del problema: Eugenio Scalfari (le cui parole affettuose ricambio con gratitudine) affermava in risposta al mio articolo che il problema «si combatte politicamente». È vero, ma mi permetto di replicare che la politica, come l’essere secondo Aristotele, «si dice in molti modi», non tutti riservati ai politici di professione. Uno di questi modi è la pubblicazione che, come dice la stessa parola, è un gesto pubblico, spesso non privo di risvolti politici e mai privo di risvolti economici, soprattutto per autori da primi posti della classifica vendite. In questa prospettiva io chiedo due cose:
 A) l’autore ha il dovere di verificare la correttezza etica (e non solo giuridica) del proprio editore?
A) l’autore ha il dovere di verificare la correttezza etica (e non solo giuridica) del proprio editore?
 B) l’autore ha il dovere di chiedersi quali investimenti sostiene con il profitto da lui generato?
B) l’autore ha il dovere di chiedersi quali investimenti sostiene con il profitto da lui generato?A entrambe le domande si può rispondere di no, che un tale dovere dell’autore non c’è, sostenendo da un lato che l’autore si deve preoccupare solo della libertà di esprimere le proprie idee, del prestigio del catalogo, della professionalità dei funzionari editoriali e basta, e dall’altro lato che ciò che conta per lui è unicamente la capacità di promozione, distribuzione e vendita dell’editrice alla quale affida il suo testo.
Molti degli autori del Gruppo Mondadori intervenuti a seguito del mio articolo hanno sostenuto in parte o per intero queste prospettive, compresi Eugenio Scalfari, Corrado Augias e Adriano Prosperi.
Mentre nessuno si è posto la domanda B, nella risposta alla domanda A Scalfari ha distinto gli attuali dirigenti che guidano l’Einaudi dalla proprietà da cui i medesimi dirigenti dipendono, Augias ha dichiarato che il suo rapporto con la Mondadori «non è con una marca ma con uomini», Prosperi è stato il più duro giungendo a negare la stessa pertinenza del problema: «Mettersi ad aprire una discussione in termini moral-editoriali lascia il tempo che trova».
Io non sono d’accordo. Io penso che discutere pubblicamente delle pubblicazioni sia qualcosa di molto utile se non un dovere, e penso che alle due domande poste sopra si debba rispondere con un netto sì: l’autore ha il dovere di vagliare la correttezza etica della sua editrice (e del Gruppo al quale essa fa capo) e si deve chiedere a quali investimenti contribuisce con il profitto generato dalle vendite delle sue opere. Naturalmente mi posso sbagliare, posso essere ingenuo e mancare di realismo, ma questo è il mio pensiero. Il quale ritengo valga soprattutto per quegli autori che scrivono di etica, di politica, di filosofia e che sono giunti grazie al valore del proprio lavoro a vedersi riconosciuto il ruolo pubblico di «intellettuali», svolgendo così un compito abbastanza delicato verso la società.
Penso sarebbe auspicabile che tutti gli autori fossero attivi nel cercare di arginare l’immenso conflitto di interessi del quale da quasi un ventennio tutti noi italiani (di destra, di centro, di sinistra non importa) siamo prigionieri, ma so bene che non tutti possono sempre permettersi questa battaglia, perché esprimere pubblicamente il proprio pensiero è un privilegio abbastanza raro.
Primum vivere deinde philosophari, questa antica massima di saggezza vale per tutti, nessuno è chiamato a fare l’eroe. Per quanto mi riguarda poter esprimere liberamente il mio pensiero coincide con la possibilità di «combattere la buona battaglia», per riprendere la celebre espressione di san Paolo.
Naturalmente non condanno nessuno né chiamo nessuno a crociate, mi permetto solo di dire che provo ammirazione per tutti quegli intellettuali che, potendo permetterselo, evitano di contribuire con i proventi delle loro opere a finanziare quel conflitto di interessi che è «la madre di tutti i problemi». Sono consapevole altresì che ognuno si sceglie le battaglie ideali come meglio crede e io non intendo insegnare nulla a nessuno, tanto meno alle insigni personalità che in questo articolo ho chiamato in causa, cerco solo di dare il mio contributo perché l’Italia possa un giorno non essere più il paese dei furbi.
Quando avrò concluso il volume per il quale ho un contratto in essere con la Mondadori tirerò le logiche conseguenze di tutto questo ragionamento, come lo stesso farò per un piccolo saggio che avrei dovuto consegnare entro dicembre all’Einaudi per un volume a più autori a cura di Gustavo Zagrebelsky. Ai cari amici che ho in Mondadori ai quali mi legano stima e affetti incancellabili ho scritto ieri: «... magis amica iustitia».
Come vivere senza Berlusconi?
di Philippe Ridet (Le Monde, 7 settembre 2010 - traduzione: www.finesettimana.org)
Si deve ad un teologo discreto una delle cose più vivaci dell’estate italiana. Approfittando di una - molto - breve pausa sul fronte delle polemiche politiche, Vito Mancuso si poneva un grave problema tramite una lettera aperta al quotidiano la Repubblica del 21 agosto: poteva continuare a pubblicare, “in pace con la coscienza” i suoi libri da Mondadori, mentre a questa casa editrice, controllata da Mediaset - il settore dei Media della holding finanziaria della famiglia Berlusconi (Fininvest) -, veniva consentito un ristorno fiscale di svariate centinaia di milioni di euro? La sua risposta è no.
Bisogna riconoscere che questa presa di posizione, piuttosto rara, e questa denuncia di un ennesimo conflitto di interessi non ha scombussolato nessuno più di tanto. Gli scrittori e gli intellettuali sollecitati dalla stampa a reagire non si sono precipitati ad esprimere la loro solidarietà ad un uomo che ormai si rifiuta che il proprio lavoro possa, in qualsiasi modo, arricchire Berlusconi. Al contrario, non sono mancate le riserve, né i sarcasmi. Perché una presa di coscienza così tardiva? gli si è rimproverato, sospettandolo di avere orchestrato una campagna pubblicitaria. Perché tanta ingenuità? gli hanno detto altri, per i quali questa battaglia individuale è persa in partenza. Dal 1994, data della presa di controllo di Mondadori e della vecchia casa editrice torinese Einaudi da parte della Fininvest (per mezzo di un giudice la cui corruzione è stata accertata in seguito) nessuno ignora chi sia il proprietario di queste aziende. Questo non vuol dire tuttavia che gli autori pubblicati dalle case editrici del presidente del Consiglio non si siano posti il problema.
Roberto Saviano, l’autore del best-seller Gomorra, si è posto la questione della propria fedeltà alla Mondadori, quando, in primavera, Berlusconi aveva accusato gli scrittori che trattavano di “Mafia” di “rovinare l’immagine del paese”. Rassicurato da una lettera del presidente della Mondadori, Marina Berlusconi, figlia del Cavaliere, Saviano aveva messo a tacere i propri dubbi.
Ad oggi, quattro autori delle case editrici controllate da Mediaset - tra cui il Premio Nobel della letteratura del 1998 José Saramago (morto a giugno) - si sono visti rifiutare un libro a causa del contenuto ritenuto troppo ingiurioso nel confronti dell’azionista di maggioranza. Vuol dire forse che gli scrittori pubblicati da Mondadori o Einaudi hanno perso ogni capacità di indignazione, preferendo venire a patti col nemico per assicurarsi delle buone vendite?
In verità, è piuttosto un diffuso senso di stanchezza quello che si potrebbe notare. Stanchezza di fronte ad un dibattito continuamente rilanciato a partire dalla prima apparizione di Silvio Berlusconi al potere. Stanchezza all’idea di affrontare questo problema ricorrente: si può boicottare Berlusconi, vivere senza Berlusconi? Bisogna dire che l’impresa non è semplice. Se è facile denunciare l’onnipresenza del suo impero nell’economia italiana, è più difficile farne a meno. Prendiamo il caso di un antiberlusconiano duro e puro, che per nulla al mondo vorrebbe contribuire all’arricchimento del Cavaliere. Chiamiamolo signor Rossi. Per la televisone è abbastanza semplice, il signor Rossi dovrà evitare i tre canali del “Cavaliere” (Canale 5, Italia 1, Rete 4). Il sacrificio non è particolarmente costoso vista la mediocrità dei programmi. Tuttavia dovrà usare con parsimonia i canali della TV pubblica: il capo del governo ha nominato la maggior parte dei dirigenti.
Al cinema il signor Rossi non andrà a vedere i film prodotti da Mediaset o distribuiti da Medusa. Per la stampa eviterà il Giornale, di proprietà del fratello di Silvio Berlusconi. Il signor Rossi rinuncerà ugualmente al settimanale Panorama, come pure ad una quarantina di riviste.
Andando oltre, le cose si complicano. Occorrerà al signor Rossi l’attenzione puntigliosa del vegetariano alla ricerca dei grassi animali. La Finivest possiede infatti partecipazioni in due società italiane, la banca Unicredit e l’assicurazione Generali, che sono tra i maggiori investitori italiani. Con un effetto a cascata, queste partecipazioni piazzano la Fininvest al centro dell’economia e dell’industria del paese. Qualche esempio: se il signor Rossi deve cambiare i pneumatici dell’automobile o il materasso, dovrà rinunciare a Pirelli. Per un conto in banca eviterà Intesa San Paolo, la più grande banca italiana. Se prende l’autostrada, deve evitare la Milano-Torino. Tifoso di calcio, eviterà gli incontri del Milan, di cui Berlusconi è proprietario e presidente. Si vede da questo che la vita senza Berlusconi non è cosa agevole in Italia.
Vito Mancuso è comunque deciso a tentare la sorte. Venerdì 3 settembre, in un nuovo scritto su la Repubblica, ha rinnovato la sfida chiamando gli scrittori di Mondadori e Einaudi a “liberarsi da questo conflitto di interessi nel quale sono tutti prigionieri”. Ma aggiunge: “so bene che non tutti possono sempre permettersi questa battaglia, perché esprimere pubblicamente il proprio pensiero è un privilegio abbastanza raro. Primum vivere deinde philosophari, questa antica massima di saggezza vale per tutti, nessuno è chiamato a fare l’eroe”. Il signor Rossi ne sa qualcosa.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- L’ARCHIVIO DEGLI ERRORI: L’ "IO SONO" DI KANT E L’ "IO SONO" DELL’"UOMO SUPREMO" DEI "VISONARI" DELLA TEOLOGIA POLITICA ATEA E DEVOTA. Note per una rilettura "della Critica della Ragion pura" (di Federico La Sala).3 agosto 2010, di Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- Sarzana, un Festival della Mente per nascondere la devastazione del paesaggio di Luni (di Carlo Ruocco)2 settembre 2010, di Federico La Sala
Sarzana, un Festival della Mente per nascondere la devastazione del paesaggio di Luni
Data di pubblicazione: 31.08.2010
Autore: Ruocco, Carlo
La presentazione dell’iniziativa e la denuncia di due operazioni speculative nel nome dello “sviluppo”. Scritto per eddyburg, 31 agosto 2010 (m.p.g.)
Si è affermato negli anni come uno degli appuntamenti “cult” dell’estate italiana. Ma il Festival della Mente di Sarzana, giunto alla settima edizione, rischia di diventare un simbolo della divaricazione tra cultura e “politica del fare” soprattutto per quanto concerne ambiente, paesaggio, territorio, quasi una sottolineatura dell’inutilità della cultura nell’epoca del Mercato. A tenere la “lectio magistralis”, che tradizionalmente inaugura il Festival, è chiamato Salvatore Settis. Il titolo: “Paesaggio come bene comune, bellezza e potere”.
Il professor Settis parlerà in una città e in un’area, quella apuano-lunense, a cui la “politica del fare” sta cambiando radicalmente volto con buona pace del paesaggio, del consumo di territorio, della tutela del patrimonio archeologico, naturale, antropologico, in cui il “Mercato” e soprattutto la “Rendita” sono i moloch sul cui altare sacrificare ogni scelta di amministrazioni da sempre guidate dalla sinistra. Tre varianti a strumenti urbanistici, stanno per riversare tra Sarzana e la piana dell’antica Luni e del basso corso della Magra 230 mila metri quadrati di seconde case, centri benessere, capannoni artigianali, centri commerciali, strutture balneari e albeghiere, a cui andranno ad aggiungersi due porti turistici lungo le verdi sponde della Magra per ospitare mille barche il tutto arricchito da arginature alte tre o cinque metri per contenere esondazioni sempre più frequenti.
Settis svolgerà la sua appassionata arringa in difesa del paesaggio italiano di fronte alla platea raffinata del festival e al sindaco di Sarzana Massimo Caleo, un teorico locale del teorema cemento = sviluppo = occupazione. Mentre il Festival della Mente celebrerà l’unicità del paesaggio italiano, un geologo sarà al lavoro per preparare gli studi geotecnici del “Piano Botta”, una variante al piano regolatore del 1994, firmata dall’archistar Mario Botta e approvata nei giorni scorsi dalla Provincia.
Botta ha disegnato una Sarzana in mattoncini a vista su un’area di sessantaduemila metri quadrati, una “Sarzana Due” a meno di trecento metri dal centro storico medievale e rinascimentale tutt’affatto diversa nelle tipologie architettoniche, dai colori del paesaggio ligure. Oltre quarantasettemila metri quadrati di nuove superfici residenziali, commerciali, ricettive, di terziario privato e pubblico, in larga parte previste dal PRG del 1994, ma solo in minima parte realizzate. Proprio la mancata realizzazione in un arco di tre lustri avrebbe dovuto suggerire una rivisitazione del vecchio piano, rivedendo una previsione d’incremento demografico errata, riconsiderando una previsione di domanda che il Mercato non ha confermato neppure in anni di bolla speculativa.
L’Amministrazione, sollecitata da Unieco di Reggio Emilia, proprietaria dei terreni, il cui logo compare ormai in tutte le grandi operazioni cementizie dello spezzino, da Levanto a Lerici, a Sarzana, in una sorta di colonizzazione emiliana, ha proceduto a una rivisitazione del piano particolareggiato che garantisce la rendita, sventolando la parola d’ordine degli “inalienalibili diritti acquisiti” dei proprietari con buona pace delle sentenze del Consiglio di Stato.
Ha incaricato, ovviamente senza concorso, l’architetto Mario Botta, presentato dalle Coop e che per le Coop aveva redatto le prime bozze progettuali dei nuovi palazzi, che ridisegnavano il volto della città (tutte informazioni sfacciatamente messe nero su bianco nella delibera di incarico del 2007). Disegni dei palazzi già visibili nella brochure del Bilancio 2007 di Abitcoop Liguria quando erano ancora ignoti al consiglio comunale di Sarzana nel gennaio 2009. La Variante porta la dicitura “di iniziativa pubblica”!
Nella sua prima stesura il progetto prevedeva un grattacielo cilindrico alto 67 metri di mattoncini rossi. Nelle dichiarazioni del Maestro Botta doveva richiamare le torri dell’acqua del mantovano. Sarzana in provincia di Mantova..... Così la colonizzazione Unieco cambia il volto ligure di una città. Il progetto della torre è crollato sotto i colpi di un Comitato di cittadini. Il resto è rimasto, compresa l’assoluta mancanza di verde fruibile.
Come onestamente ammesso dallo stesso Botta “Con quelle volumetrie o si va in alto o si occupa ogni spazio orizzontale”. Ma la Rendita non consente di ridurre le volumetrie. Neppure se a suggerirlo pubblicamente al Principe è un Maestro dell’architettura.
Se Sarzana nel suo ingresso occidentale somiglierà a Treviso, a Sesto San Giovanni o a Lugano, poco importa. Millecento nuovi abitanti previsti, undicimila metri quadrati di superfici commerciali in una città che vanta il primato di ipermercati, undicimila metri quadrati di terziario, a Sarzana già oggi largamente invenduto. Conta il business da 160 milioni di euro. C’è chi si chiede: chi acquisterà? Ed evoca preoccupato i dati del rapporto 2009 della Direzione nazionale antimafia che indica la Liguria e Sarzana come luogo di riciclaggio. Mentre il “Piano Botta” muove i primi passi, i sindaci di Sarzana e Ameglia lanciano la crociata contro gli ambientalisti che, riuniti in un Coordinamento di associazioni e comitati, hanno dirottato la loro attenzione sulla più esaltante epopea del cemento, il Progetto Marinella. “Costoro si oppongono allo sviluppo, Si rischia di perdere un’occasione unica per mettere fine al degrado della zona”.
Promotrice del Progetto Marinella è la banca Monte dei Paschi, storica proprietaria di quasi tutti i terreni agricoli della bassa piana della Magra fino alle pendici del colle dei Cappuccini di Bocca di Magra. Acquisì quei terreni durante il fascismo per il fallimento di un ricco imprenditore del marmo, Fabricotti. Li acquisì come terreni agricoli, aspettando con la pazienza di una banca centenaria che la Dea Rendita desse i suoi frutti.
Il PRG di Sarzana del 1994 prevede solo interventi di ristrutturazione e recupero del vecchio borgo agricolo di Marinella. Troppo poco per le aspettative di Monte dei Paschi, che nel 1999 lancia il “Progetto unitario di Marinella”. Unitario perché comprende tutta la proprietà, che abbraccia i comuni di Sarzana e Ameglia. Nel tempo il progetto è cresciuto in concomitanza con l’avvento di Francesco Gaetano Caltagirone alla vicepresidenza della banca senese. Anche i partecipanti al progetto sono cresciuti, comprendendo l’immancabile Unieco, il Consorzio delle Cooperative di Produzione e lavoro emiliane, le società Condotte e Condotte Acque di Astaldi. Le cifre dell’affare parlano da sole e fanno impallidire il Piano Botta. 155 mila metri quadrati di edificato previsto, di cui quasi 87 mila di nuova edificazione. Un terzo della superficie è a destinazione residenziale in una Liguria a crescita zero. Anche il “commerciale” non scherza: 23 mila metri in un’area, secondo Confesercenti, già satura di ipermercati.
Gli amministratori di sinistra non se lo vogliono sentir ripetere: ma con il famigerato Piano casa di Berlusconi non avrebbero potuto prevedere neppure la metà di nuove edificazioni! Non mancano neppure 7200 metri quadrati di stabilimenti balneari: tradotto significa privatizzazione del litorale, soggetto a forte erosione, oggi in parte libero e selvaggio, quindi “degradato”. Infine la ciliegina: il “polo nautico” nel Parco del fiume Magra con una prevista escavazione di milioni di metri cubi di inerti per far posto a circa mille attracchi. Calcolare l’ammontare dell’operazione fa venire le vertigini a chi non si chiama Caltagirone. C’è chi azzarda 700 milioni di euro.
La lectio magistralis del professor Settis cadrà in questo contesto. A conferma che il Festival viene pensato a Milano. Sarzana lo ospita, perché è un evento che richiama pubblico e riflettori. Quindi denaro. Lo scorso anno lo sponsor, la Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia, per voce del suo presidente Matteo Melley, ha posto la questione: non si può guardare solo alle ricadute economiche; occorre iniziare a valutare le ricadute culturali.
Ebbene una frase di Settis, scelta per la brochure del programma, sembra già un invito alla riflessione sul contesto: "Anche la devastazione del paesaggio italiano, a cui assistiamo oggi, è un prodotto culturale ed appartiene all’orizzonte che ci circonda. Chiediamoci perché. Chiediamoci se il paesaggio può tornare ad essere un bene comune e come questo può dipendere da noi"
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- IL FESTIVAL DELLA MENTE, 2010. "La creatività sta morendo". L’allarme degli intellettuali (di Sara Ficocelli).3 settembre 2010, di Federico La Sala
IL FESTIVAL DELLA MENTE
 "La creatività sta morendo"
"La creatività sta morendo"
 L’allarme degli intellettuali
L’allarme degli intellettualiDa oggi a domenica 5 il Festival della Mente in Liguria. Da Staino a Diamanti, da Bonito Oliva a Ferraris, il mondo della scienza e della letteratura si raduna per parlare delle potenzialità dell’intelletto. E lancia l’allarme contro la mancanza di stimoli e incentivi
di SARA FICOCELLI *
SARZANA (La Spezia) - La mente è l’unico strumento che abbiamo per capire la realtà e gli altri, un’incognita che dà risposte e pone problemi. La mente è (anche) movimento, presente in trasformazione, creatività. Il Festival della Mente 1 di Sarzana, in provincia di La Spezia, alla sua settima edizione, da oggi al 5 settembre ospita i cervelli migliori del Paese e pone a tutti - soprattutto ai visitatori - una domanda: esiste ancora la creatività in Italia? E se sì, come viene manifestata dagli italiani e recepita dalle istituzioni? Repubblica.it lo ha chiesto ad alcuni dei partecipanti, che in tutto quest’anno sono 70. Intervistarli uno ad uno sarebbe stato un problema e così abbiamo scelto un rappresentante per ogni disciplina intellettuale, dalla filosofia alla politica sociale, dal fumetto alle neuroscienze. Il collage finale non dà spazio a equivoci: di creatività l’Italia ne ha da vendere, ma è una risorsa malata, resa ogni giorno più fragile dalla mancanza di stimoli e incentivi istituzionali.
Un patrimonio che rischia di atrofizzarsi per cedere il passo alla voracità di una società che vuole "tutto e subito, organizzata in base a una logica aziendale, secondo quello che io definisco ’peronismo mediatico’ ", spiega Achille Bonito Oliva, docente di Storia dell’arte contemporanea all’università La Sapienza di Roma. "La creatività è qualcosa che va per i fatti propri - continua il curatore della XLV Biennale di Venezia, a Sarzana per parlare del rapporto fra tempo, arte e linguaggio - e che noi dobbiamo incanalare nel modo giusto, con delle regole. Per farlo ci vorrebbe il sostegno delle istituzioni. Un privilegio che noi non abbiamo. L’immaturità e la capacità di improvvisazione, che ci caratterizzano, ci hanno permesso di restare creativi fino a oggi, ma la creatività senza metodo non ha utilità".
Come è vero che la potenza è nulla senza controllo, è anche vero che la creatività è nulla senza un’organizzazione sociale in grado di valorizzarla. Quando ciò non avviene, e quando anzi la nostra vivacità mentale viene strumentalizzata a fini politici, la creatività diventa addirittura negativa. "E’ facile dire che ha costituito una risorsa per un Paese che stenta ad essere tale - dice Ilvo Diamanti, docente di scienza e comunicazione politica all’università di Urbino - Quella che accompagna gli italiani è oggi più che altro una creatività negativa, quella che ti fa ’inventare’ il nemico dove non c’è, che ti fa vedere pericoli e realtà che non esistono". Secondo il sociologo, che a Sarzana parlerà di sicurezza e insicurezza, "la creatività non sempre è buona" e gli italiani sono stati incapaci di adeguarsi alla globalizzazione, trasformando il senso di spiazzamento derivante dal cambiamento in paura.
Questa stessa "fabbrica della paura", secondo Sergio Staino, convince i ventenni di oggi di non essere all’altezza, di non potercela fare ad utilizzare al meglio la propria creatività. "Quando parlo con i giovani - spiega il disegnatore satirico - lo sforzo più grande che faccio è quello di insegnargli a guardarsi intorno. Hanno paura, sono insicuri: qualcuno li ha convinti che, se non ce la fanno, è perché sono stupidi o poco grintosi. Ma naturalmente non è così. Bisognerebbe che le istituzioni lavorassero per infondere loro fiducia, ma finora nessun governo lo ha fatto davvero, nè a destra nè a sinistra. E questi sono danni sociali che l’Italia pagherà per i prossimi decenni". Staino interverrà al Festival della Mente con Altan, con un incontro dal titolo "Uno nasce e poi muore. Il resto sono chiacchiere": "La creatività è fatta di intuizioni minime e di quelle più grandi, che cambiano la Storia del mondo - continua - Topolino è nato nel 1929, in piena crisi economica, e questo perché i momenti di difficoltà sono la fucina dell’innovazione. Ma l’Italia non ha più interesse a investire in questo senso, e si trova tagliata fuori dal progresso".
Del resto però, come diceva Francis Bacon, "La creatività è come l’amore: non puoi farci niente". E da questa consapevolezza nasce la speranza che tutto non si fermi qui, che l’insicurezza e la paura vengano superate dalla potenza creatrice che gli italiani portano comunque dentro di sè. "L’Asia centrale - spiega Ludovica Lumer, studiosa di Neuroestetica dello University College London, che parlerà dell’identità tra arte e scienza - sta usando l’arte per formare la propria identità. L’Italia non lo sta facendo e la colpa non è delle nuove generazioni, ma dei governi, che non investono più in ricerca. L’arte, da Duchamp in poi (per quanto riguarda quella visiva) richiede a chi osserva di completare il processo creativo. Per questo le istutuzioni giocano un ruolo fondamentale".
Secondo lo psicanalista junghiano Luigi Zoja, che parlerà dell’"attualità dell’individuazione", qualche responsabilità ce l’hanno comunque anche le nuove generazioni, che sono "troppo introverse". "I giovani dovrebbero avere più coraggio. Ricordo il discorso che Steve Jobs fece ai neo-laureati di Stanford nel 2005: il senso delle sue parole è che bisogna buttarsi, richiare. Specialmente con una calsse politica come questa, che non li aiuta per niente". Un parere condiviso da Gianvito Martino, direttore della divisione di neuroscienze dell’Istituto Scientifico Universitario San Raffaele di Milano, secondo cui "la creatività, intesa come capacità di inventare, dei giovani ricercatori italiani, è frustrata sistematicamente da un sistema-paese che "penalizza" la ricerca in tutte le sue forme ed espressioni. Una situazione che determina una ridotta capacità brevettuale che, a sua volta, penalizza ulteriormente gli investimenti in ricerca. Non è quindi sorprendente che, poi, i ricercatori italiani dimostrino la loro creatività quando espratriano in Paesi in cui la ricerca conta veramente. Siamo in uno dei pochi Paesi industrializzati in cui non si produce ricchezza dalla conoscenza". Il neuroscienziato parlerà di staminali, e in particolare di come quelle del cervello potrebbero, in un futuro prossimo, essere usate per curare gravi malattie cerebrali: "Un campo di ricerca che vede tanti ricercatori italiani in prima fila".
Il quadro che emerge è dunque quello di un’Italia che, come ricorda il filosofo Maurizio Ferraris, che parlerà del rapporto tra "l’anima e l’iPad", "da una parte stimola al massimo una certa creatività, ossia l’arrangiarsi, l’improvvisare, l’apparenza. Dall’altra affossa le istituzioni necessarie per una creatività autentica, dalla scuola all’università. Dall’impasse in cui ci troviamo non può salvarci la creatività come improvvisazione, e forse nemmeno la creatività come esercizio e pazienza, ma qualcosa di più grande e vero: la coscienza, la responsabilità, il senso del bene comune e quello dello Stato. Ma a volte penso che per inoculare qualcosa del genere negli italiani il creativo non basti: ci vorrebbe l’esorcista".
-
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ----- CATTIVI MAESTRI AL SAN RAFFAELE (di Maurizio Viroli)23 luglio 2010, di Federico La Sala
Cattivi maestri al San Raffaele
di Maurizio Viroli (*) ( il Fatto Quotidiano, 23 luglio 2010)
Se qualcuno ancora non crede che il potere enorme di Berlusconi stia diffondendo servilismo e corruzione nella vita politica e sociale, non ha che da considerare quanto è avvenuto martedì 20 luglio in una prestigiosa istituzione accademica qual è l’Università Vita-Salute San Raffaele, in occasione della discussione della tesi in Filosofia di Barbara Berlusconi, figlia del presidente del Consiglio. In quella sede, il rettore dell’Università don Luigi Verzé, ha rivolto a Barbara Berlusconi questo invito: “Collabori alla fondazione di una facoltà di economia e ne diventi docente!”.
A queste parole, la professoressa Roberta De Monticelli, chiamata al San Raffaele per chiara fama nel 2003 a insegnare Filosofia della Persona, ha reagito inviando una lettera ai giornali dove ha espresso la sua ferma riprovazione di quella che definisce “una violazione non solo del principio della pari dignità formale degli studenti, non solo della forma e della sostanza di un atto pubblico quale una proclamazione di laurea, non solo della dignità di un corpo docente che il rettore dovrebbe rappresentare, ma anche dei requisiti etici di una istituzione universitaria d’eccellenza quale l’Università San Raffaele giustamente aspira a essere”. “Tengo a dissociarmi nettamente e pubblicamente - ha sottolineato Roberta De Monticelli - da queste parole e dalla logica che le sottende, logica che da una vita combatto, come combatto da sempre il corporativismo e i sistemi clientelari dell’Università italiana, e il progressivo affossamento di tutti i criteri di eccellenza e di merito, oltre che dell’Università stessa come scuola di libertà”.
Docenza ad personam
LA RISPOSTA dell’Università non si è fatta attendere: "Non si deve gridare allo scandalo: qualcuno si meraviglia se alla Cattolica i docenti si sono praticamente tutti formati nelle file di quell’Università? Chi frequenta don Luigi sa che egli considera i nostri discenti i nostri primi docenti e sa anche quanto a lui stia a cuore che il futuro di tutto il San Raffaele sia affidato preferibilmente a chi lo conosce meglio degli altri. Quello di restare, di continuare a studiare, di approfondire gli studi con la ricerca è l’invito che lui fa, da sempre, a ognuno".
E invece lo scandalo c’è e la difesa dell’Università lo mette ancora più in evidenza. Prima di tutto c’è una bella differenza fra rivolgere a tutti i neolaureati l’invito a proseguire gli studi, a dedicarsi seriamente alla ricerca e a distinguersi nella comunità intellettuale internazionale, e rivolgersi ad una particolare neolaureata, figlia di padre multimiliardario e presidente del Consiglio, per invitarla a dare il suo contributo (intellettuale?) alla fondazione di una facoltà di economia e diventarne docente.
Nel primo caso si tratta di una degna e nobile esortazione ai giovani, nel secondo di un invito ad personam (dev’esserci un’epidemia in Italia di iniziative di questo tipo) prefigurando una particolare attenzione volta soprattutto a compiacere il potente padre presente alla cerimonia. Le parole del Rettore sono un esempio mirabile di abilità nel mettere in pratica la regola aurea dell’adulazione che prescrive di lodare le persone che il signore ha care per ottenere benefici. Proprio perché la candidata è figlia di Berlusconi, il Rettore avrebbe dovuto astenersi da qualsiasi commento che mettesse in risalto il suo status particolare rispetto agli altri.
Ma ancora più notevole del gesto servile è stato l’elogio della corruzione che leggiamo nel comunicato dell’Università, dove si afferma che nessuno deve gridare allo scandalo di fronte alla consolidata pratica di chiamare preferibilmente i propri ex studenti a diventare docenti.
Malcostume e baronie
LO SCANDALO invece c’è, ed è serio, e consiste proprio nel costume di non selezionare i candidati ai dottorati di ricerca, ai posti di ricercatore e di professore - quale che sia la loro provenienza - in base ai titoli scientifici, ma in base al famigerato criterio di aver svolto tutto il corso di studi all’interno dell’istituzione. Questo costume ha fatto sì che nel corso degli anni centinaia di candidati scadenti siano stati preferiti ad altri con titoli molto migliori, per il solo fatto di essere‘portati’,così si dice in gergo, dal professore interno. E così le facoltà universitarie si sono riempite di studiosi mediocri (ma abilissimi adulatori) e i migliori sono stati costretti o ad abbandonare la ricerca,o a cercare la propria strada all’estero, in quelle università che non privilegiano “i propri discenti” cari al rettore Verzé e a tanti altri accademici, ma solo ed esclusivamente i titoli.
Suscita indignazione che la difesa della pratica di privilegiare i propri studenti appaia in un comunicato ufficiale volto a sostenere che le parole del Rettore non lasciavano intravvedere trattamenti di favore. Se l’intenzione del rettore voleva essere soltanto un’innocente esortazione a perseguire gli studi, perché citare a difesa la pratica di privilegiare i propri allievi? Ha ragione la professoressa De Monticelli, il cui comportamento è esempio di coraggio e di vera lealtà verso la sua università.
Quanto è avvenuto al San Raffaele documenta, ancora una volta, il malcostume accademico italiano noto sotto il nome di clientelismo: prima i nostri, poi, se ne avanza, gli altri. E se i nostri hanno anche il padre ricco e potente, meglio ancora. Sia chiaro: al favore non si risponde con la discriminazione, ma con la giustizia. Barbara Berlusconi ha il diritto di laurearsi e di percorrere, se questa è la sua vocazione, tutta la carriera accademica. Ma si chieda anche a lei di distinguersi per meriti propri, e lei dovrebbe essere la prima a pretendere di non aver alcun trattamento privilegiato, in modo che, se avrà riconoscimenti, potrà esserne in cuor suo, fiera e presentarsi davanti alla comunità scientifica e alle persone libere, sempre a testa alta. Il favore, non dimentichiamolo, esalta (si fa per dire) chi lo concede, ma umilia chi lo riceve.
(*) Docente di Teoria politica alla Princeton University
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI.4 giugno 2010, di Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- I FILOSOFI E LA VITA. Cos’ vivono i filosofi. Il ’900 con gli occhi dei pensatori (di U.to Galimberti).23 giugno 2010, di Federico La Sala
 Così vivono i filosofi
Così vivono i filosofi
 Il ‘900 con gli occhi dei pensatori
Il ‘900 con gli occhi dei pensatori Il figlio di Heidegger che parla del padre, di Jünger e di Schmitt. Albert Hofmann che racconta come scoprì l’Lsd
Il figlio di Heidegger che parla del padre, di Jünger e di Schmitt. Albert Hofmann che racconta come scoprì l’Lsd
 Raccolti in volume gli articoli e le interviste di Antonio Gnoli e Franco Volpi ai grandi testimoni del secolo
Raccolti in volume gli articoli e le interviste di Antonio Gnoli e Franco Volpi ai grandi testimoni del secolo
 Un intreccio fra la riflessione e l’esistenza. In primo piano gli studiosi che da sponde anche opposte hanno descritto il tracollo dei valori occidentali
Un intreccio fra la riflessione e l’esistenza. In primo piano gli studiosi che da sponde anche opposte hanno descritto il tracollo dei valori occidentali
 Gadamer assisté affascinato alle lezioni dell’autore di "Essere e tempo", ma se ne allontanò quando il maestro cavalcò il nazionalsocialismo
Gadamer assisté affascinato alle lezioni dell’autore di "Essere e tempo", ma se ne allontanò quando il maestro cavalcò il nazionalsocialismodi Umberto Galimberti (la Repubblica, 23.06.2010)
La crisi dei nostri giorni non ci avrebbe colto impreparati se solo avessimo letto e prestato attenzione a quei pensatori del Novecento che, su sponde filosofiche e politiche opposte e spesso tra loro in conflitto, avevano descritto il tracollo dei valori su cui l’Occidente aveva costruito se stesso, e il dispiegarsi di quel teatro dove il nichilismo, "l’ospite inquietante" annunciato da Nietzsche, dettava a tutti gli attori la loro nuova parte.
Oggi è possibile rimediare a questa lacuna con la lettura di un libro, I filosofi e la vita, (Bompiani, pagg. 214, euro 10,50) scritto da Antonio Gnoli e dal compianto e caro amico Franco Volpi, in cui sono raccolti una serie di articoli e le interviste che gli autori fecero ai filosofi del Novecento, o, se defunti, ai loro figli che ne custodiscono la memoria e gli epistolari. Ne risulta un interessante intreccio, dove il pensiero filosofico si contamina con le vicende della vita, ivi compresa la vita del filosofo, che talvolta ne condiziona il pensiero e talvolta lo lascia imperturbato nelle sue analisi lucide e penetranti.
È il caso di Heidegger, di cui Franco Volpi ha curato le traduzioni delle sue opere per Adelphi, che dissolve la metafisica dell’Occidente, decreta la fine della centralità dell’uomo nella storia, annuncia l’avvento della tecnica che ridurrà gli uomini a "im-piegati" degli apparati tecnici, quando non a semplice materia prima, «la più importante materia prima (die wichtigste Rohstoff)». L’intervista è al figlio Hermann Heidegger che rievoca i rapporti di suo padre col grande giurista tedesco Carl Schmitt, e soprattutto con Ernst Jünger, i cui scritti giovanili piacquero all’intellighentia nazista, anche se Jünger, come peraltro testimonia anche Hannah Arendt, nazista non lo fu mai.
È lo stesso Jünger a confermarlo nell’intervista rilasciata, in prossimità del suo centesimo compleanno, in cui ricorda che ebbe salva la sua vita grazie a Hitler, lettore dei suoi libri giovanili, contro il parere di Goebbels e Göring che volevano la sua testa. A Carl Schmitt, padrino di suo figlio Alessandro, Jünger un giorno chiese se avesse un mitra in cantina. E a Schmitt che gli chiedeva perché, Jünger rispose: «Perché lei ha pronunciato la sentenza: il Führer crea il diritto. Una frase, dal punto di vista politico molto pericolosa». E poi una profezia: «In questo evo il poeta dovrà andare in letargo. Ciò vuol dire che le azioni sono più importanti della poesia e del pensiero che le cantano e le riflettono. Sarà un evo molto propizio per la tecnica, ma sfavorevole alla cultura».
Cambiando scenario, un’intervista al novantenne Albert Hofmann, scienziato svizzero, chimico di professione e umanista per passione, che scoprì l’Lsd e, a partire dalla sua scoperta, prese a leggere «il modo in cui l’Occidente ha guardato e vissuto la propria instabilità e precarietà». Nato per un utilizzo psichiatrico, l’Lsd fu nominato "psichedelico" perché «atto a manifestare la psiche». Hofmann lo assumeva insieme a Jünger per «potenziare la sensibilità e sperimentare quel sentimento oceanico che ci fa sentire tutt’uno col mondo». A sentire Hofmann, anche Platone, Pausania, Marco Aurelio conoscevano l’uso di allucinogeni, come ad esempio il kykeon, la bevanda psicotropa impiegata nei misteri di Eleusi.
Non di droghe, ma di vino era appassionato Hans-Georg Gadamer che, all’arrivo di Volpi e Gnoli recatisi nella sua casa per intervistarlo, offre una bottiglia di eccellente Montepulciano. Gadamer era sulla soglia dei cent’anni, ma non aveva dimenticato quella frase che leggiamo nel Simposio di Platone. "In vino veritas". A fianco di tutti i grandi pensatori tedeschi: Husserl, Scheler, Hartmann. Heidegger, Gadamer, già a vent’anni, vive con scetticismo la fiducia che allora si nutriva nei confronti della scienza e della tecnica, e dopo aver letto le Considerazioni di un impolitico di Thomas Mann, prese a riflettere sulla distanza che si era venuta a creare tra «i valori spirituali della Kultur umanistica rispetto a quelli materiali della moderna Zivilisation».
Con Marcuse, Horkheimer, Ritter, Löwith, Hans Jonas e Leo Strauss, anche Gadamer assiste alle lezioni di Heidegger restandone affascinato, ma discostandosi quando il maestro pensò di «promuovere un rinnovamento dell’università cavalcando, con un’incredibile e inimmaginabile ingenuità, il movimento nazionalsocialista», quasi a sottolineare che non sempre la vita accompagna la grandezza del pensiero, ma anche che la grandezza del pensiero può trovarsi in uomini "pavidi" come Heidegger. Ad Heidegger va comunque riconosciuto il merito, osserva Gadamer, di aver individuato per primo e con più lucidità di tutti che «il progresso tecnico, nel bene e nel male, è diventato il nostro destino». E alla domanda: «Quale sistema politico assegnare alla tecnica per contenerla?», la risposta di Gadamer è: «La democrazia? Chissà».
Franco Volpi e Antonio Gnoli girarono in macchina tutta la Germania per intervistare i testimoni del pensiero del Novecento. Dobbiamo essere grati a questo loro peregrinare che ci consente di conoscere, per voce diretta, la loro interpretazione del secolo appena concluso. Scrive Gnoli: «La caratteristica assolutamente definitiva dei morti è la loro assenza. Ma essi tornano sotto altra forma, come un debito che abbiamo contratto con la loro vita che si è chiusa».
E questo vale non solo per i grandi filosofi intervistati, ma anche per Franco Volpi, vittima un anno fa di un incidente mortale sulla sua bici, a cui Massimo Donà ha dedicato il numero di Panta Decalogo (Bompiani, pagg. 670, euro 28) con belle foto di Volpi e Gnoli, i due girovaghi in cerca di testimoni del pensiero.
-
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- ALLA "CONFERENZA DI WANNSEE"? L’ITALIA COL BAVAGLIO: LA SOLUZIONE FINALE, "I PAPI", E I NIPOTI DI "PILATO" EICHMANN.25 maggio 2010, di Federico La Sala
LA CONFERENZA DI WANNSEE [942], OVVERO PONZIO PILATO (Titolo del capitolo settimo, del libro di Hannah Arendt, La banalità del male - Il titolo del capitolo ottavo è: "I doveri di un cittadino ligio alla legge").
 NOTA SULL’ORIENTAMENTO NEL PENSIERO (1786) - E NELLA REALTA’:
NOTA SULL’ORIENTAMENTO NEL PENSIERO (1786) - E NELLA REALTA’: "In verità si è soliti dire che un potere superiore può privarci della libertà di parlare o di scrivere, ma non di pensare.
"In verità si è soliti dire che un potere superiore può privarci della libertà di parlare o di scrivere, ma non di pensare.
 Ma quanto, e quanto correttamente penseremmo, se non pensassimo per così dire in comune con altri a cui comunichiamo i nostri pensieri, e che ci comunicano i loro? Quindi si può ben dire che quel potere esterno che strappa agli uomini la libertà di comunicare pubblicamente i loro pensieri, li priva anche della libertà di pensare, cioè dell’unico tesoro rimastoci in mezzo a tutte le imposizioni sociali, il solo che ancora può consentirci di trovare rimedio ai mali di questa condizione."
Ma quanto, e quanto correttamente penseremmo, se non pensassimo per così dire in comune con altri a cui comunichiamo i nostri pensieri, e che ci comunicano i loro? Quindi si può ben dire che quel potere esterno che strappa agli uomini la libertà di comunicare pubblicamente i loro pensieri, li priva anche della libertà di pensare, cioè dell’unico tesoro rimastoci in mezzo a tutte le imposizioni sociali, il solo che ancora può consentirci di trovare rimedio ai mali di questa condizione."
 (Immanuel Kant: "Che cosa significa orientarsi nel pensiero" [1786], Adelphi edizioni, Milano, 1996, pp. 62-63 ).
(Immanuel Kant: "Che cosa significa orientarsi nel pensiero" [1786], Adelphi edizioni, Milano, 1996, pp. 62-63 ). -
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- Il risveglio dal sonno dogmatico di Sigmund Freud e il caso Heidegger. Una lezione da non dimenticare.17 maggio 2010, di Federico La Sala
IL CASO HEIDEGGER E IL RISVEGLIO NELL’ORA DE PERICOLO DI SIGMUND FREUD.
A fine gennaio del 1933, Adolf Hitler giunge al potere. Nello stesso anno, Martin Heidegger diventa rettore dell’Università di Friburgo ed esprime pieno ed inequivocabile appoggio al regime nazista, con il suo famoso discorso su “L’autoaffermazione dell’università tedesca”. Per Heidegger non c’è alcun dubbio che Hitler sia il Messia del popolo tedesco, come ripeterà in uno scritto sul giornale degli studenti dell’Università, il 3 novembre del 1933: “Il Fuhrer stesso e lui soltanto è la realtà tedesca e la sua legge, oggi e da oggi in poi. Rendetevene conto sempre di più: da ora ogni cosa richiede decisione, e ogni azione responsabilità”. La notte scende sulla Germania, e su tutta l’Europa: in un’intervista del 1966, Heidegger, pur mai pentendosi dei suoi trascorsi nazionalsocialisti, dichiarerà che “Solo un Dio ci può salvare”. (per proseguire la lettura, clicca ->
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ----L’ITALIA, Il "MONOTEISMO" DELLA COSTITUZIONE, E IL "BAAL-LISMO" DEL MENTITORE (1994-2010).14 maggio 2010, di Federico La Sala
 L’ITALIA, Il "MONOTEISMO" DELLA COSTITUZIONE, E IL "BAAL-LISMO" DEL MENTITORE (1994-2010). IL SONNO DELLA RAGIONE COSTITUZIONALE GENERA MOSTRI, ATEI E DEVOTI ...
L’ITALIA, Il "MONOTEISMO" DELLA COSTITUZIONE, E IL "BAAL-LISMO" DEL MENTITORE (1994-2010). IL SONNO DELLA RAGIONE COSTITUZIONALE GENERA MOSTRI, ATEI E DEVOTI ... (...) l’esperienza insegna che i valori costituzionali possono venire erosi gradualmente, in forme oblique, attraverso una pioggia d’episodi minori che in conclusione ne faccia marcire le radici. E questo pericolo chiama in causa non solo il Capo dello Stato, bensì ciascuno di noi, la vigilanza di ogni cittadino (...)
(...) l’esperienza insegna che i valori costituzionali possono venire erosi gradualmente, in forme oblique, attraverso una pioggia d’episodi minori che in conclusione ne faccia marcire le radici. E questo pericolo chiama in causa non solo il Capo dello Stato, bensì ciascuno di noi, la vigilanza di ogni cittadino (...) -
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- BERTRAND RUSSELL: LA LEZIONE SUL MENTITORE (IGNORATA E ’SNOBBATA’), E "L’ALFABETO DEL BUON CITTADINO".2 febbraio 2010, di Federico La SalaSPIRITO CRITICO ED EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA DEMOCRATICA: BERTRAND RUSSELL: LA LEZIONE SUL MENTITORE (IGNORATA E ’SNOBBATA’), E "L’ALFABETO DEL BUON CITTADINO".
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- SCIENTISTI E ANTISCIENTISTI. PERCHE’ SCIENZA E SOCIETA’ NON SI CAPISCONO (di Massimiano Bucchi - rec. di Piergiorgio Odifreddi).22 marzo 2010, di Federico La Sala
 Un nuovo libro di Massimiano Bucchi sulle incomprensioni tra società e conoscenza
Un nuovo libro di Massimiano Bucchi sulle incomprensioni tra società e conoscenza Elogio della scienza
Elogio della scienza
 Quel che i media non riescono a dire della scienza
Quel che i media non riescono a dire della scienza Spesso le notizie scientifiche sui giornali sono esche per attrarre finanziamenti
Spesso le notizie scientifiche sui giornali sono esche per attrarre finanziamenti
 Ma non si può cancellare la differenza tra scientisti e antiscientisti
Ma non si può cancellare la differenza tra scientisti e antiscientistidi Piergiorgio Odifreddi (la Repubblica, 22.3.10) *
Si racconta che negli anni ’60 una multinazionale andò in giro per l’Africa, con uno schermo portatile e un generatore di elettricità, per mostrare nei villaggi sperduti un filmato sui grandi macchinari agricoli che produceva. Dopo varie proiezioni, si accorse però che il filmato non sembrava avere alcun effetto, e alla fine si decise a domandare agli spettatori che cosa avessero recepito. La sorprendente e unanime risposta che ricevette fu: la presenza di un pollo che passava a un certo momento in un angolo dello schermo, e di cui gli occidentali non si erano nemmeno accorti. La sorpresa svanì quando si rifletté sul fatto che, in fondo, ciascuno può percepire della realtà soltanto ciò che è in grado di riconoscere e comprendere.
Questo episodio è una perfetta metafora del rapporto tra la scienza e i media. Uno scienziato, e più in generale una persona acculturata di scienza, che legga i giornali, ascolti la radio o guardi la televisione, anzitutto ci troverà solo molto raramente notizie scientifiche, e praticamente mai in posizione di rilievo come la prima pagina. Ma quelle rare volte che ce le troverà, si accorgerà che in genere sono solo insignificanti polli notati da ignari selvaggi. I quali, nella migliore delle ipotesi, avranno anche sfogliato le pagine di Nature o Science, ma senza percepire altro che ciò che potevano riconoscere e comprendere.
A complicare le cose c’è poi il fatto che spesso, più che di polli, si tratta in realtà di pavoni. Cioè di notizie con la coda variopinta messe lì, apposta per attirare l’attenzione, da scienziati furboni e a volte senza scrupoli, che sanno benissimo a quali esche si abboccherà. E il motivo per cui ce le mettono, è ovviamente per ottenere visibilità e finanziamenti, che verranno spesi per perpetuare quel genere di ricerche che poi attrarranno altra attenzione mediatica, in una perversa e futile spirale che costituisce uno degli argomenti di Scientisti e antiscientisti di Massimiano Bucchi (Il Mulino, pagg. 128, euro 11,50).
 Il sottotitolo Perché scienza e società non si capiscono, senza punto interrogativo, promette una risposta che viene data nella conclusione: «scienza e società non si capiscono perché si intendono fin troppo bene», nel senso che ciascuna si appoggia all’altra in maniera analoga alla spirale descritta sopra, in cui i giornalisti diffondono colposamente notizie trash, spesso fornite dolosamente dagli scienziati. Ora, è sicuramente innegabile che ci siano questi aspetti deleteri del rapporto fra scienza e società, ma Bucchi tende ad enfatizzarli al punto da cancellare la differenza stessa tra scientismo e antiscientismo, considerandoli due facce di una stessa medaglia e ribattezzandoli addirittura, rispettivamente, «scientismo positivo e negativo».
Il sottotitolo Perché scienza e società non si capiscono, senza punto interrogativo, promette una risposta che viene data nella conclusione: «scienza e società non si capiscono perché si intendono fin troppo bene», nel senso che ciascuna si appoggia all’altra in maniera analoga alla spirale descritta sopra, in cui i giornalisti diffondono colposamente notizie trash, spesso fornite dolosamente dagli scienziati. Ora, è sicuramente innegabile che ci siano questi aspetti deleteri del rapporto fra scienza e società, ma Bucchi tende ad enfatizzarli al punto da cancellare la differenza stessa tra scientismo e antiscientismo, considerandoli due facce di una stessa medaglia e ribattezzandoli addirittura, rispettivamente, «scientismo positivo e negativo».L’operazione è sospetta, e in un certo senso analoga a quella di coloro che considerano anche la fede e l’ateismo come due facce di una stessa medaglia, come suggeriva il titolo del libro di Umberto Eco e Carlo Maria Martini Cosa crede chi non crede? Una domanda singolare, dello stesso tipo di "Cosa mangia chi non mangia?", alla quale non si può certo rispondere che mangia qualcosa di diverso dal cibo, come invece tendono a fare coloro che ritengono che l’ateismo sia un tipo diverso di religione, invece che la sua mancanza.
Questi giochi di parole tendono più a confondere i termini del dibattito, che non a chiarirli. Per chiarire cosa sia lo «scientismo», bisogna anzitutto notare che il termine ha già di per sé un connotato negativo, al contrario di «umanesimo». E che non c’è nessuna parola che descriva positivamente, o anche solo neutralmente, la constatazione che «i metodi caratteristici delle scienze naturali rappresentano l’unica fonte genuina di conoscenza fattuale, e solo essi possono produrre un’effettiva conoscenza dell’uomo e della società»: che è, appunto, il modo in cui Bucchi definisce lo scientismo.
L’antiscientismo è ovviamente l’opinione contraria, professata più o meno apertamente dalla quasi totalità della società umanista, che spesso si trincera dietro ad aperti fraintendimenti dell’impresa scientifica. Uno degli esempi più influenti, citato rispettosamente anche da Bucchi, è La struttura delle rivoluzioni scientifiche del filosofo Thomas Kuhn, al quale si appigliano tutti coloro che vorrebbero assegnare alla verità scientifica un carattere puramente storico. Chi non conoscesse i fatti e leggesse quel libro, così come La rivoluzione copernicana dello stesso autore, potrebbe infatti dedurne che il passaggio dal sistema tolemaico a quello copernicano abbia costituito un radicale cambiamento di prospettiva fisica, mentre invece i due sistemi sono perfettamente equivalenti dal punto di vista della descrizione dei moti planetari. E’ l’immagine metafisica del mondo che è cambiata, nel passaggio dal geocentrismo all’eliocentrismo, ma questo è un problema della filosofia, e non certo della scienza!
Analoghe considerazioni si potrebbero fare a proposito del falsificazionismo del filosofo Karl Popper, ampiamente citato da coloro che vorrebbero invece assegnare alla verità scientifica un carattere puramente negativo. Senza tener conto, ovviamente, del fatto che ciò di cui parlano sia Popper che Kuhn non è per niente la scienza reale che praticano gli scienziati, bensì quella fittizia che si immaginano i filosofi. I quali, avendo maggior accesso ai media, finiscono per imporre i propri fraintendimenti come se fossero, questi sì, verità assolute e positive.
Per forza di cose, i letterati sono ancora peggio dei filosofi, perché della scienza capiscono ancora meno, ma hanno un accesso ancora maggiore ai media. Un caso emblematico è la considerazione di cui godono le opere «scientifiche» di Wolfgang Goethe, che avrà anche scritto dei bei versi in tedesco, ma quando si è avventurato a pontificare nei campi dell’ottica o della chimica si è reso semplicemente ridicolo. Il suo romanzo Le affinità elettive faceva pateticamente partorire a due genitori una figlia con i tratti somatici dei rispettivi amanti, ai quali essi pensavano al momento del concepimento.
Dire che ciò che importa in quei libri è la forma, e non il contenuto, equivale ad ammettere che la letteratura non è impresa di verità, ma di bellezza. Il che potrà anche essere vero, ma conferma appunto la visione «scientista», che la conoscenza fattuale sta di casa altrove. Ma non certo nella mitologia o nella religione, che costituiscono i baluardi più avanzati dell’antiscientismo. Come si può infatti combinare con la scienza la credenza nelle anime e negli spiriti immateriali, quali angeli e demoni? O la fede nei miracoli, che sospendono le leggi di natura per permettere interventi soprannaturali?
Si ha un bel dire che l’antiscientismo non esiste, se non come altra faccia della medaglia dello scientismo! Non solo esso esiste, ma impera! E ogni passo avanti compiuto dall’immagine della scienza viene contrastato da cento passi indietro compiuti da filosofi, letterati e religiosi. L’ultimo in ordine di tempo è la decisione del ministro Gelmini di offrire sì, agli studenti del Liceo Scientifico, un baratto dell’anacronistico latino con la moderna informatica e un po’ più di scienze. Ma solo in un indirizzo facoltativo, attivato solo in alcune scuole, e avversato dall’esercito delle cariatidi che ancora pensano che il cervello maturi di più recitando rosa, rosae, rosae che non imparando a scrivere algoritmi!
Il fatto è che quello viene bollato come «scientismo» non è altro che una miscela di tre semplici ingredienti: buon senso, razionalità e rigore. Ciascuno di questi ingredienti è raro, ma se anche fosse casualmente distribuito al 50 per cento, la combinazione di tutti e tre sarebbe comunque posseduta solo dal 12,5 per cento della popolazione: il che spiega la percentuale bulgara degli antiscientisti, e la difficoltà degli «scientisti» di far sentire la propria voce.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- L’USO POLITICO DELLA MENZOGNA. LA VERITA’ COME UN OPTIONAL (di Francesca Rigotti).8 aprile 2010, di Federico La Sala
 Se la verità diventa un optional
Se la verità diventa un optional
 L’uso politico della menzogna
L’uso politico della menzognadi Francesca Rigotti (l’Unità, 8.4.2010)
La libertà - scriveva Albert Camus - consiste in primo luogo nel non mentire». Proviamo a pensarci su perché qui si tratta di cose serie, mica di canzonette. Qui sono in gioco termini/concetti come libertà e verità. E la libertà è, insieme alla giustizia, una delle grandi virtù delle istituzioni politiche, come la verità è la virtù principale dei sistemi di pensiero, e chi viola il principio di verità lede anche quello di libertà. Ora, l’uso politico della menzogna viene parzialmente accettato dalla filosofia politica, per esempio da Hannah Arendt, che la giustifica nel caso di delicate operazioni di segretezza.
A una corretta pratica democratica non è invece perdonata né la torbidezza né la menzogna e tantomeno il falsificare i fatti per ragioni di immagine, quando queste attività - sempre Arendt - vengano praticate nei confronti dei concittadini e non del nemico in guerra. Se in politica, il luogo delle scelte collettive e che interessano la collettività, si può mentire, non si deve per questo farlo, né la pratica del mentire deve essere, in politica, tollerata e perdonata, o addirittura incoraggiata.
La verità è infatti una virtù preziosa - come spiega Franca D’Agostini nel dotto quanto affascinante saggio «Verità avvelenata. Buoni e cattivi argomenti nel dibattito pubblico» (Bollati Boringhieri). La verità del nostro mondo, che vive nella legge della terra e nella radicale pluralità degli uomini da tale legge contemplata, è la verità che percepiamo con le nostre facoltà logiche.
Poi c’è la «verità» riferita da una parte politica e magari accettata da un gruppo di persone che non hanno la coscienza attiva di partecipare a un inganno. Questa è una «verità» allestita a fini di opportunità ma lesiva della libertà dei cittadini, anche di quelli che si lasciano volentieri ingannare, per il semplice motivo che la menzogna distrugge la fiducia, anche questa una delle grandi e dimenticate virtù della vita sociale democratica.
Un punto in più per la tesi che sostiene che la destra italiana che ci malgoverna non partecipa dei principi del pensiero liberale - quelli socialisti, poi, non sa neanche dove stiano di casa - benché proclami gli uni e gli altri.
Questo perché un pensiero fondativo non ce l’ha e può perciò praticare la menzogna e il mendacio pensando che chi caninamente latra più forte e in numero più alto riesca a sopraffare anche la verità. Ma questo non è vero e mentire per non voler riconoscere l’errore può costare caro, molto più caro che dover ricorrere al trapianto di capelli per aver commesso l’errore di non aver mai usato la brillantina Linetti.❖
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- I Dieci Comandamenti anche per chi non crede (di Armando Torno - con un testo diMassimo Cacciari e di Piero Coda).1 maggio 2010, di Federico La Sala
I Dieci Comandamenti anche per chi non crede
di Armando Torno (Corriere della Sera, 1° maggio 2010)
Decalogo è un termine greco. Vuol dire dieci (déka) parole (lógos). In molti hanno scelto di tradurlo con «I Dieci Comandamenti», anche perché in ebraico «parola» (davar) è sinonimo di comandamento. La Bibbia riporta due versioni, sostanzialmente omogenee, delle frasi che Mosè ascoltò sul Sinai e che furono incise sulle Tavole della Legge. Si trovano in Esodo 20, 1-6 e in Deuteronomio 5, 6-10.
Nella tradizione cattolica - che si discosta da quella ebraica e, tra l’altro, anche dalla protestante, più aderenti al testo biblico - Agostino distinse i tre Comandamenti iniziali dai successivi sette, attribuendo ai primi i doveri verso Dio e agli altri quelli verso gli uomini. Ma la codificazione del Decalogo dei catechismi cattolici venne formulata, dopo diverse proposte scolastiche (Pietro Lombardo, Tommaso d’Aquino eccetera), da Alfonso Maria de’ Liguori nel Settecento. Il santo napoletano scelse i Comandamenti come sommario di tutta la teologia morale e cercò di riassumere in ogni proposizione un settore di vita. Per esempio il sesto, «non commettere adulterio», non figura nella sua sistemazione ma viene allargato con il «non commettere atti impuri», comprendendo in tal modo tutta la morale sessuale.
Rileggere il Decalogo e interpretarlo nell’epoca che si sta vivendo, è stato un bisogno continuo dell’Occidente; era naturale che lo si dovesse fare anche nel nuovo millennio. Per tal motivo il progetto de il Mulino, di rimeditare attraverso un duplice intervento i Comandamenti (compreso quello dell’amore per il prossimo, già enunciato in Levitico 19,18), merita la massima attenzione. Il primo volume, dedicato a Io sono il Signore Dio tuo, frase che non può essere equiparata alle successive e introduce le Tavole della Legge, è firmato da Piero Coda e Massimo Cacciari.
Il percorso offerto dai due autori in queste pagine parte dalla semantica originaria del Nome per giungere alle riflessioni sul Deus-Trinitas. Infinite le suggestioni e le riflessioni. Se da un lato ci si deve confrontare con l’autopresentazione di Dio di Esodo 3,14 «Io sono colui che sono» (’ehjeh asher ’ehjeh), e che Piero Coda mostra in innumerevoli interpretazioni compresa quella che nacque dalla versione greca dei Settanta (ego eimi o on: si potrebbe rendere sino a «Io sono l’Essente»), dall’altro lato ci si chiede chi sia «l’Uno dell’Esodo». E qui Massimo Cacciari sa dare il meglio di sé indicando le vie che consentono di avvicinarsi al «segreto del Nome divino», anche se resta «inafferrabile e ineffabile». Sottolinea: «Non interessa tanto il Nome ma ciò che l’Essere di Dio può. La sua natura è di essere, non di essere nominato, e di essere ponendo "fuori" di sé tutta la propria potenza».
Sulla frase «Non avere altri dei di fronte a me» (Esodo 20,3; Deuteronomio 5,7), il primo ordine di Dio del Decalogo, c’è una letteratura infinita. Coda ricorda tra l’altro che Jhwh irrompe nella storia attraverso Israele e si propone come «l’imprescindibile garanzia della libertà dell’uomo»; Cacciari comincia il suo saggio chiarendo gli equivoci dei possibili politeismi e notando che anche quello pagano «ci appare ormai testimonianza di un passato irripetibile, capace al più di esercitare un fascino antiquario-letterario privo di qualsiasi valore religioso o filosofico». C’è un’osservazione di Martin Buber che merita di essere ricordata: «La dottrina della unicità ha la sua ragione vitale non nel fatto che ci si formi un giudizio sul numero di dèi che ci sono e si cerchi magari di verificarlo, bensì nella esclusività che regge il rapporto di fede, come esso regge il vero amore tra uomo e uomo; più esattamente: nel valore e nella capacità totale insito nel carattere esclusivo... L’unicità nel "monoteismo" non è, dunque, quella di un "esemplare", ma è quella del partner nella relazione interpersonale, finché questa non viene rinnegata nell’insieme della vita vissuta» (Königtum Gottes, Opere II, München 1964). Coda, inoltre, verifica la frase di apertura dei Comandamenti nel Nuovo Testamento; Cacciari dedica due attente riflessioni all’ Uno Essere e a L’Uno Signore dell’Essere utilizzando una notevole conoscenza dei testi filosofici e teologici. Da Rosenzweig a Spinoza, da Nietzsche a Hegel, da Kant a Weber si muove indicando la lettura più vicina a noi.
Che aggiungere? Forse un’immagine che molti ricordano e che potrebbe essere una didascalia per questo primo volume. Nel film hollywoodiano I dieci comandamenti del 1956, diretto da Cecil B. De Mille, Ramesse (Yul Brynner) dice a Nefertari (Anne Baxter) al suo ritorno dal Mar Rosso, dopo aver inseguito gli ebrei e Mosè: «Il suo dio... è Dio». Coda e Cacciari ci aiutano a comprendere meglio queste parole.
Il progetto della casa editrice il Mulino dedicato a I Comandamenti sarà realizzato in 11 volumi. Si tratta di una scelta che tiene conto anche dell’invito ad amare il prossimo, non presente nel Decalogo del Sinai ricevuto da Mosé, ma raccomandato già nel libro del Levitico (19,18) e ribadito con forza da Gesù nel Nuovo Testamento. Oltre il libro che inaugura la serie di Massimo Cacciari e Piero Coda Io sono il Signore Dio tuo (pp. 164, € 12), che sarà in libreria il 6 maggio ed è presentato in questa pagina con un estratto dei due saggi (si intitolano rispettivamente Il pensiero più alto e Questo Dio per la libertà), sono previste le seguenti uscite: Non ti farai idolo né immaginecon Salvatore Natoli e Pierangelo Sequeri, Non nominare il nome di Dio invano con Carlo Galli e Piero Stefani, Santificare la Festa con Massimo Donà e Stefano Levi della Torre, Onora il padre e la madre con Giuseppe Laras e Chiara Saraceno, Non uccidere con Adriana Cavarero e Angelo Scola, Non commettere adulterio con Eva Cantarella e Paolo Ricca, Non rubare con Paolo Prodi e Guido Rossi, Non dire falsa testimonianza con Tullio Padovani e Vincenzo Vitiello, Non desiderare la donna e la roba d’altri con Gianfranco Ravasi e Andrea Tagliapietra. Chiuderà Ama il prossimo tuo con Enzo Bianchi e Massimo Cacciari.
Massimo Cacciari: Non un precetto ma un’affermazione
La prima Parola (il primo dei «deka logoi ») non si presenta nella forma di un precetto («miswa »), ma di un’affermazione, di una perentoria autoaffermazione: «Io sono Jhwh, tuo Elohim» (Esodo, 20,2). Non si tratta di un comandamento, ma del necessario presupposto di tutta la Legge. È infatti impossibile comandare di credere nell’esistenza di Jhwh. E che senso avrebbe obbedire a ciò che venisse ritenuto un puro nome, cui nulla di reale corrisponde? Lo stesso Maimonide, che pure fonda sui principi dell’esistenza di Dio e della sua unità l’insieme della Legge, non li concepisce affatto come oggetto di fede, ma, anzi, come il risultato cui perviene la sana ragione, oggetto cioè di dimostrazione. Questo «Io, proprio Io, Jhwh», creduto o riconosciuto che sia, non potrà mai essere il contenuto di un comando, e tuttavia la Legge, l’unica Legge (legge assolutamente universale, a tutti rivolta - tanto che l’antica tradizione rabbinica diceva essere stata dettata dal Signore in 76 lingue, così che ogni gente potesse comprenderla), divina tutta in quanto giusta in tutte le sue parti, nel suo stesso interno differenziarsi e articolarsi, la Legge che stabilisce le forme della relazione tra uomo e Dio, ne presuppone la Rivelazione. Se la forza di quell’Io venisse meno, il Decalogo si ridurrebbe a «legge morale in noi», la Legge divina perderebbe il significato che deve assumere anche per la perfezione del vivere civile. Le stesse norme che suonano semplicemente etiche o cultuali debbono sempre essere comprese alla luce della Rivelazione del Nome.
Piero Coda: Il nome rivelato è come la sua firma
Nella costruzione raddoppiata: «Io sono colui che Io sono», il predicato è identico al soggetto. Essa può sottolineare un rafforzamento dell’ auto presentazione di Jhwh: «Io sono proprio chi Io sono». Ma, più profondamente, insinua anche una riaffermazione della trascendenza e dell’incognito di Dio nel momento stesso del suo farsi presente: «Solo Io so chi Io sono». È un invito a non fermarsi al Nome così come suona e che pure esprime quanto detto, ma a passarvi attraverso per lasciare che sia Dio a stabilire, mediante la memoria verbale del suo Nome, un rapporto vivo e personale di sé con noi. Altrimenti si cade nella tentazione di volersi impadronire del Nome di Dio, e addirittura di farsene un idolo. Per questo Jhwh comanda di non pronunciare invano il suo Nome e di non farsi di Lui immagine alcuna. Dio si rivela - precisa Paul Beauchamp - mediante un significante che non fa parte dell’organizzazione interna al discorso, ma lo fonda come una firma. «Io sono chi Io sono»: firma esterna al testo, dunque, benché ricorrente nel testo stesso. Queste parole bucano la pagina, hanno cioè un risalto eccezionale. Il Nome rivelato a Mosè mette così tutta la Bibbia sotto un’istanza alla prima persona, quella di Dio come soggetto libero e incatturabile che viene graziosamente incontro all’uomo chiedendogli a sua volta affidamento e fedeltà.
-
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- CALCIO, POLITICA, E CRITICA DELLA POLITICA SPETTACOLO: ONORE E GLORIA A MARCO MATERAZZI.26 gennaio 2010, di Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- Csm, radiato il giudice anti-crocifisso - Luigi Tosti. Il filosofo Massimo Cacciari: «Mi pare assurdo che uno si rifiuti di andare a lavorare».24 gennaio 2010, di Federico La Sala
Csm, radiato il giudice anti-crocifisso
di Elsa Vinci (la Repubblica, 23 gennaio 2010)
Perde la toga il giudice anti-crocifisso. Luigi Tosti, il magistrato di Camerino noto per essersi rifiutato di tenere udienza nelle aule con il simbolo del Cristianesimo, è stato rimosso dall’ordine giudiziario. La durissima sanzione è stata inflitta dalla sezione disciplinare del Csm, che nel 2006 lo aveva già sospeso dalle funzioni e dallo stipendio. Il giudice si era astenuto dal trattare 15 udienze tra il maggio e il luglio del 2005, comunicando il rifiuto con pochissimo anticipo. «Un atteggiamento mantenuto - ha sottolineato il procuratore generale della Cassazione - nonostante un ’aula priva di simboli religiosi messa a disposizione dal presidente del tribunale».
Per gli stessi fatti, un anno fa, la Suprema Corte aveva annullato una condanna a sette mesi per omissione di atti d ’ufficio, ma solo perché il magistrato era stato sostituito e le udienze erano state regolarmente celebrate. Tosti, che davanti alla "disciplinare" si è difeso da solo, annuncia ricorso. In Cassazione e a Strasburgo. «Non avevano scelta - ammette - o me o i crocifissi nelle aule di giustizia. Ne ho fatto un problema di carattere generale». E ricorda due sentenze di piazza Cavour, quella con cui la Corte giustificò il rifiuto di uno scrutatore di sedersi al seggio elettorale in cui era esposta la Croce, e il suo proscioglimento. Quando gli "ermellini" invitarono ad un «approfondimento».
È legittima l’esposizione del simbolo della cristianità nei luoghi pubblici? Offende la libertà di religione, viola il principio di laicità dello Stato? Nei tribunali il crocifisso è previsto da una circolare del 29 maggio 1926, firmata dal ministro Alfredo Rocco. Motivo di ripetute e recenti polemiche è stata la presenza della Croce nelle scuole pubbliche, voluta da due Regi Decreti del 1924 e del 1928. Il Consiglio di Stato ha deciso che va tenuta in cattedra «per la funzione simbolica altamente educativa a prescindere dalla religione degli alunni», ma lo scorso 3 novembre la Corte di Strasburgo ha imposto la rimozione nelle scuole italiane. Il governo ha già annunciato ricorso. «Il Csm non è né la Corte Costituzionale né la Corte Europea. Non doveva risolvere e non ha risolto la questione della legittimità o meno di tenere il crocifisso in un’aula di giustizia - ha spiegato il vicepresidente del Csm Nicola Mancino - Tosti è stato giudicato per essersi rifiutato di celebrare udienza fino a quando in tutti i tribunali d’Italia non fosse stato rimosso il simbolo. Con l’intenzione di risolvere una questione di principio è venuto meno agli obblighi e ai doveri di magistrato».
Un giudice di lungo corso come Felice Casson non ritiene che il crocifisso infici il principio di laicità dello Stato. «E’ il magistrato - dice - che deve giudicare in maniera laica e garantire la Costituzione». Taglia corto il filosofo Massimo Cacciari: «Mi pare assurdo che uno si rifiuti di andare a lavorare».
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- Csm, radiato il giudice anti-crocifisso - Luigi Tosti. Natoli: «La Chiesa faccia risuonare Cristo nella società».24 gennaio 2010, di Federico La Sala
 "Dominus Iesus": RATZINGER, LO "STERMINATORE DI ECUMENISMO".
"Dominus Iesus": RATZINGER, LO "STERMINATORE DI ECUMENISMO".
intervista a Salvatore Natoli
Natoli: «La Chiesa faccia risuonare Cristo nella società»
a cura di Lorenzo Fazzini (Avvenire, 21 gennaio 2010)
Più predicazione spirituale della Chiesa, meno strumentalizzazione (bipartisan) della fede dalla politica. Puntando maggiormente sulla dimensione spirituale (non spiritualistica) del messaggio evangelico. Solo così secondo il filosofo Salvatore Natoli, docente di filosofia teoretica all’università Bicocca di Milano, il confronto tra credenti e non credenti può riprendere quota.
Come può ripartire il dialogo tra laici e cattolici?
«Il cristianesimo è resurrezione, ma soprattutto liberazione dalla morte. E la prassi del darsi reciproco è centrale nella comunità cristiana. In questo aspetto anche i non credenti vedono che la rivelazione possiede qualcosa che fa bene agli uomini. Penso, in particolare, al tema del ’prendersi cura’: tale dimensione fa crescere la fiducia tra le persone e abbassa le tensioni. In questo mondo fatto di scontri, questo territorio è praticabile sia da chi ha fede sia da chi non crede. Per dirla con Spinoza, "homo homini Deus": l’uomo può diventare salvezza per l’altro».
Su quali argomenti vede praticabile tale confronto?
«Vi è un percorso su cui è più facile trovare una reciproca permeabilità, e un altro dove essa è più difficile. Il primo è appunto il prendersi cura: la modernità ha distrutto le comunità naturali dove la cura tra le persone era il semplice stare insieme: penso alla famiglia. E cosa meglio del cristianesimo è indice di questo prendersi a cuore degli esclusi? Anche la tradizione politica di ispirazione cattolica (cito Sturzo) faceva riferimento a questo ideale. Lo stesso cardinale Tettamanzi si è mosso in questa direzione ’universalistica’, per cui tra cristianesimo e diritti umani non vi è contraddizione ».
E l’itinerario più difficile?
«È quello dei diritti della libertà, un frutto maturo della modernità. Già il cristianesimo fa appello alla libertà come proposta mentre la democrazia ne è garanzia. Ma sui temi estremi della vita e della morte ora la Chiesa presenta il diritto naturale come valore assoluto, mentre per una lettura ’laica’ ciò rimane un nodo controverso. Lo sviluppo tecnologico ha cambiato profondamente il quadro d’insieme: quando si nasce e si muore? Quanto c’è di naturale nell’’artificiale’? L’autodeterminazione non è più naturale dell’artificiale? Certo, la Chiesa può esprimere le sue posizioni, ma non può imporle alla politica».
Lei cita il caso della solidarietà e la bioetica come elementi di ’dialogo facile’ e di quello ’difficile’ tra Chiesa e non credenti. Ma, rovesciando la prospettiva, non vi è un altrettanto rischio di strumentalizzazione?
«Certo. E ci vuole davvero lucidità ed equilibrio. La Chiesa ha il diritto di convertire, ma non di travalicare il campo. Poi vi è anche chi, secondo una prospettiva ’sociale’, usa la comunità ecclesiale a proprio vantaggio sui temi dei migranti. Ora, tanto più la Chiesa è spirituale, tanto meno è strumentalizzabile. Spirituale non vuol dire spiritualistica, ma partire dalla predicazione, ovvero dal fatto che il referente diretto della Chiesa non deve essere l’agone politico quanto la società intera».
Cattolici più attivi e meno militanti, dunque?
« Sì. Esemplifico: la risposta della Chiesa alla chiusura verso la mobilità delle persone consiste nel fatto che lei è abituata all’accoglienza. I cattolici non dicono che bisogna accogliere gli immigrati: li accolgono già. E quando parla dell’aborto, la Chiesa deve soprattutto cercare di convincere la gente a generare figli. A mio giudizio, compito della Chiesa è la pastoralità: produrre convinzione, entrare nelle coscienze piuttosto che in politica. Penso alla capacità di attrazione di una persona come il cardinale Martini, che suscitava una domanda di spiritualità. Bisogna riuscire a far sorgere la domanda: la figura di Gesù Cristo può pesare nella vita degli uomini? I cattolici devono far risuonare nella società il quesito di Cristo: Voi, chi dite che io sia?».
-
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- IN UN’ITALIA IN PIENA CRISI OSSESSIVA ("DUE" PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA GRIDANO "FORZA ITALIA" DAL 1994), E’ SPARITA LA PSICOANALISI. CHE GUAIO (Edoardo Sanguineti)!!!4 gennaio 2010, di Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- HANNO PERSO LA PAROLA. NON SANNO CHE LA LINGUA NON E’ (DI) UN "PADRE-PADRONE".18 gennaio 2010, di Federico La Sala
 Ma la nostra lingua non è un "padre-padrone"
Ma la nostra lingua non è un "padre-padrone"
 la sua bellezza è nella continua evoluzione
la sua bellezza è nella continua evoluzione Se l’amore per la lingua dovesse discendere dal timore dell’infrazione e non
Se l’amore per la lingua dovesse discendere dal timore dell’infrazione e non
 dall’adesione a un’identità, la lingua stessa non avrebbe nulla da guadagnarne
dall’adesione a un’identità, la lingua stessa non avrebbe nulla da guadagnarnedi STEFANO BARTEZZAGHI *
C’è qualcosa di persino commovente nell’ansia con cui una quota di parlanti, minoritaria ma cospicua, cerca risposte certe in merito alla nostra lingua nazionale. Esiste il verbo "perplimere"? "Qual è" vuole l’apostrofo, non lo vuole mai, lo vuole soltanto quando è seguito da un sostantivo femminile ("qual è il motivo", "qual’è la ragione")? "Piuttosto che" è sinonimo di "oppure", o no? È, quasi sempre, possibile dare una risposta certa: "perplimere" no, non esiste, almeno finora; "qual è" non vuole l’apostrofo in nessun caso; "piuttosto che" esprime una preferenza ("preferisco un dessert piuttosto che un liquore") e non un’alternativa ("mi va bene tutto: mi porti un dessert piuttosto che un liquore piuttosto che un piatto di formaggi piuttosto che della frutta... Scelga lei").
Ma tali risposte sono anche, quasi sempre, meno interessanti delle richieste che soddisfano: riportano a uno stato cristallizzato della lingua, mentre le domande ne testimoniano la continua erosione. Un linguista che sia un vero linguista, e non un burocrate della norma (sempre di per sé provvisoria, almeno in questa materia), sa che perplimere può diventare prima o poi un rispettabile lemma in un futuro dizionario; che l’infame apostrofo tra "qual" ed "è" può ricevere una sua legittimazione; che le grammatiche possono rassegnarsi all’uso ormai dominante del "piuttosto che". Un linguista non può minimamente legiferare, neppure in fatto di lingua, ma è al servizio di fenomeni spontanei che possono solo essere registrati e studiati. A legiferare è il parlante: quando è un singolo come il frate Antonino da Scasazza di Nino Frassica ("concorso Cuore T’Oro"), non può altro che far ridere platee televisive; quando è un’intera categoria, può spostare intere montagne.
Il fatto commovente è che, in assenza di autorità riconosciute in materia, quella larga minoranza prova nostalgia di un’istanza paterna nelle vicenda di una lingua che è appena riuscita, e a volte a stento, a essere madre. Chi ha sensibilità per la lingua spesso smarrisce il senso della di lei duttilità e mutevolezza: la desidererebbe strumento rigido, per sé e soprattutto per gli altri. Lo sportello dell’Accademia della Crusca è il luogo in cui si tenta di ragionare ed di far ragionare sulla differenza fra oggettive infrazioni alla lingua e violazioni della sensibilità stilistica soggettiva. Nelle risposte è spesso percepibile il sospiro con cui l’esperto dà torto a un richiedente di cui condivide quell’indignazione a cui però, in onesta coscienza professionale, non può dare supporto scientifico.
La lingua italiana è certo bistrattata: ma le cause di tale maltrattamento non sono direttamente linguistiche bensì culturali. Se l’amore per la lingua dovesse discendere dal timore dell’infrazione e non dall’adesione a un’identità (se la lingua madre fosse scambiata, cioè, per un padre padrone) la lingua stessa non avrebbe nulla da guadagnarne.
© la Repubblica, 18 gennaio 2010
-
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- Il silenzio degli intellettuali italiani mi preoccupa, troppo spesso tendono a rinuncia e pessimismo (di Khaled Fouad Allam -Il coraggio di creare un universalismo forte).29 dicembre 2009, di Federico La Sala
Il coraggio di creare un universalismo forte
di Khaled Fouad Allam (Il Sole-24 Ore, 27 dicembre 2009)
Il dibattito sulla proposta di legge sulla cittadinanza è appena iniziato alla Camera. È una questione complessa e difficile; la discussione è ricca e articolata, ma nessuno è in grado di offrire ricette miracolose. La sua complessità è legata al fatto che la questione della cittadinanza va oltre la questione dei diritti perché il contesto odierno è diverso da quello degli anni 70: mondo e individui sono cambiati. Su binari paralleli sono in atto globalizzazione e ricomposizioni identitarie; il dibattito sulla cittadinanza è essenzialmente un dibattito sulla società. Le società si interrogano sul significato di nazione, sul rapporto tra diritto e cultura, sul rapporto tra religione, diversità culturale e territorio, sul significato della democrazia: la cittadinanza interroga il divenire delle società a livello nazionale ed europeo.
Il contesto odierno è affine a quello di cui parlò Alexis de Tocqueville in L’ancien régime et la révolution: siamo nell’entre-deux, non siamo più nel prima ma non siamo ancora nel dopo, non c’è più l’ancien régime ma non è ancora la rivoluzione. Le tradizioni locali e nazionali tendono a misurarsi con la mondializzazione, il mondo in cui viviamo è decentrato perché le metropoli accolgono il mondo intero, diverse culture, tradizioni, certezze e incertezze. Per nessuno è facile governare tutto ciò, perciò oggi la cittadinanza non può più essere valutata come in passato.
I territori non sono più isolati, ma si viaggia su internet e attraverso le moderne autostrade; popoli e culture si confrontano; ma come trasformare tutto ciò in una comunità di destino? Come integrare il cinese, il musulmano, lo srilankese, mentre manca una cultura mondiale, manca una riformulazione dell’universalismo in cui il pianeta sia in grado di identificarsi, manca certo una riflessione profonda sul piano giuridico e sul piano culturale. Anche sul piano giuridico: nel caso dell’islam, è necessaria una riflessione sui diritti, in particolare sul diritto di famiglia, relativamente al quale la globalizzazione ha scardinato le antiche percezioni. La globalizzazione può avere una virtù pedagogica, spingendo le società più timorose del cambiamento verso una riformulazione giuridica e culturale, ad esempio nel rapporto tra uomini e donne.
Viviamo un tempo in cui il processo di globalizzazione induce a radicalizzare molte posizioni in un ripiegamento di tipo comunitario; le identità tendono a diventare sistemi di difesa di fronte alle nuove paure, alle insicurezze. Il risultato è che, sul piano legislativo, in quasi tutti i paesi europei le legislazioni sulla cittadinanza si avviano verso posizioni restrittive; s’instaura il dubbio sulla fedeltà degli individui alla nuova nazione d’appartenenza, e l’integazione è rimessa in causa Non parlerò del caso dell’islam perché ormai sembra che la questione integrazione riguardi esclusivamente i musulmani: secondo una tradizione storiografica che risale a Henri Pirenne, l’islam non sarebbe integrabile. Ma allora mi chiedo quale sia la soluzione: quella di cacciare tutti i musulmani come fece Isabella di Castiglia nel 1492, oppure ripetere ciò che è accaduto agli inizi degli anni 90 nell’ex Jugoslavia?
L’integrazione non è mai stata un processo facile, ma non abbiamo scelta. Gli esseri umani devono inventare la nuova comunità di destino: sentirsi italiano ed europeo non è impossibile per chi non vi è nato; si può benissimo amare Pergolesi e allo stesso tempo la musica indiana o quella araba; e si può amare sinceramente il paese di cui si è deciso volontariamente di diventare cittadino. Perché questo divenga il sentire condiviso, si deve creare una nuova cultura che ora non c’è.
Il silenzio degli intellettuali italiani mi preoccupa, troppo spesso tendono a rinuncia e pessimismo. Il risultato è che continuiamo a creare sacche di marginalità, creiamo cittadini che hanno paura di portare il proprio nome. I1 nuovo secolo ha bisogno d’altro: di coraggio e speranze per affrontare le difficoltà e le contraddizioni del nuovo mondo.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- VITA E FILOSOFIA. METTERSI IN GIOCO, CORAGGIOSAMENTE. PIER ALDO ROVATTI INCONTRA ELVIO FACHINELLI.22 novembre 2009, di Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- LA LEGGE DEL LAVORO, "NELLA VIGNA DEL SIGNORE", E’ QUESTA!!! RASSEGNARSI (?)!!! L’apologetica risposta di U. Galimberti a Luciano Ferrari .27 dicembre 2009, di Federico La Sala
-
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- ARATA: EGO SUM QUI SUM. OLTRE IL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE, MA NON OLTRE LA METAFISICA DELLA PRIMA PERSONA.26 ottobre 2009, di Federico La Sala
ARATA: EGO SUM QUI SUM. OLTRE IL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE, MA NON OLTRE LA METAFISICA DELLA PRIMA PERSONA.
Arata e il mondo contraddittorio senza l’ipotesi Diodi ANTONIO GIULIANO (Avvenire, 24.10.2009)
In un passo sconvolgente della Scrittura Mosè chiede a Dio di rivelare il suo nome. E il Signore risponde: «Io sono colui che sono». Una prova illuminante della vicinanza di un Dio personale, che non è simile a una forza oscura, come lo sarà invece il Fato per i Greci. Ma è anche vero che rivelandosi in un verbo, cioè in una forma dinamica, Jahweh vuol far capire all’uomo che non può impadronirsi di lui, del suo nome, della sua essenza. Dio rimane così misterioso e trascendente.
Il mistero divino con le sue cruciali e intriganti domande è il chiodo fisso di un decano illustre della filosofia contemporanea come Carlo Arata, classe 1924. «Il tema Dio - ha scritto il pensatore toscano - ha da sempre dominato monoideisticamente, al limite dell’ossessione, il mio pensare. Da oltre mezzo secolo».
Professore emerito di filosofia teoretica dell’Università di Genova, Arata ha condensato in un appassionato volume ’Ego Sum Qui Sum’. La Gloria di Dio, quella «Metafisica della Prima Persona» che prende spunto proprio dall’espressione dell’Esodo «Ego sum qui sum», «Io sono colui che sono». (Es 3, 14). Un ragionamento fondato sulla convinzione che «Dio non è Dio se non sa di esistere, se non dice: Io».
Il personalismo teologico di Arata è evidente anche in quest’ultima pubblicazione, Dio oltre il principio di non contraddizione, che raccoglie alcuni saggi del filosofo. Un testo essenziale ma di elevata riflessione speculativa tesa a dimostrare come l’autentico pensiero di Dio debba andare oltre la logica della filosofia occidentale. Se da Parmenide a Emanuele Severino (protagonista di vivaci dibattiti con l’autore), il principio di non contraddizione ha scalzato Dio come fondamento primo e ha sentenziato l’eternità di ogni ente, compito di Arata è evidenziare come Dio è «l’esaustività di ogni significato»: non tollera alcun condizionamento e si sottrae alla rigidità del principio di non contraddizione. Un approccio che invita la stessa filosofia a ripensare se stessa e a riflettere sui suoi principi primi.
Chiude il volume un omaggio sentito a uno dei suoi maestri, quel Gustavo Bontadini (1903-1990) esponente di primo piano del movimento neotomista che ebbe nell’Università Cattolica di Milano un importante centro di irradiazione. Arata non ha mai dimenticato il primo incontro con Bontadini nell’ottobre del 1945, dopo i difficili anni della guerra, segnati dall’impegno antifascista e dall’incredibile vicenda della sorella deportata politica sopravvissuta miracolosamente al campo di sterminio di Ravensbruck. Fu folgorato subito da Bontadini per il suo ’rigore’ filosofico. E da allora in Arata scattò la voglia di emularne la grandezza e quell’ardore condensato nell’espressione: «Se Dio non ci fosse il mondo sarebbe contraddittorio».
 Carlo Arata
Carlo Arata
 DIO OLTRE IL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE
DIO OLTRE IL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE
 Morcelliana. Pagine 120. Euro 10,00
Morcelliana. Pagine 120. Euro 10,00 -
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- Cosa ne pensa Emanuele Severino del caso Lombardi Vallauri? Emanuele Severino: «L’università può sospendere chi vuole»(di Armando Torno).21 ottobre 2009, di Federico La Sala
 Emanuele Severino: «L’università può sospendere chi vuole»
Emanuele Severino: «L’università può sospendere chi vuole»
 di Armando Torno (Corriere della Sera, 21.10.2009)
di Armando Torno (Corriere della Sera, 21.10.2009)Cosa ne pensa Emanuele Severino del caso Lombardi Vallauri? E di quello che vide protagonista Franco Cordero, escluso dall’in segnamento in Cattolica poco dopo di lui? Risponde il filosofo: «Mi sembra, e per quanto ricordo, che Lombardi Vallauri e Cordero siano stati e rimangano sostanzialmente cristiani, e quindi si è trattato di una lite in famiglia. Il mio caso risale alla fine degli Anni 60 e, se i due colleghi non hanno gradito la decisione dell’Università fondata da padre Gemelli, è perché alla Cattolica volevano rimanere».
Cosa capitò, invece, a Severino? Ecco le sue parole: «A differenza di loro, nei miei riguardi c’è stato un processo formalmente analogo, dal punto di vista giuridico e con le debite proporzioni, a quello di Galileo». Insomma, era questione diversa. Perché? «Il mio discorso filosofico - nota Severino- fa rientrare il cristianesi mo nella storia del nichilismo. Non si tratta di una lite in famiglia». Puntualizza: «Aggiungo che per le leggi italiane l’Università Cattolica può sospendere dall’insegnamento, ma non togliere lo stipendio al docente colpito qualora egli sia un professore che abbia vinto un concorso statale (come il sottoscritto, Cordero, Vallauri e tutti gli ordinari). Da parte mia, d’accordo con le autorità accademiche ed ecclesiastiche, ho preferito andarmene a Venezia soprattutto perché avevo attorno un gruppo di giovani studiosi, oggi tutti in cattedra, presidi eccetera, che invece sarebbero ri masti senza alcun sostentamento qualora io avessi scelto di percepire lo stipendio rinunciando a insegnare».
Per quel che riguarda il giudizio europeo sul caso Lombardi Vallauri, Severino osserva: «Ritengo, con tutta la stima per i colleghi, che se un’università libera decide che sia seguito un determinato indirizzo culturale, chi vi insegna non debba poi avere la pretesa di sceglierne uno diverso». E conclude: «Fortunatamente in un’università come quella del San Raffaele dove insegno, chi la guida, cioè il sacerdote don Luigi Maria Verzé, auspica ma non esige dai docenti un determinato indirizzo culturale».
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! --- Università, una ricerca internazionale boccia l’Italia: meglio di noi Corea, Taiwan e Australia. L’unico ateneo presente nelle top 200 é l’Alma Mater di Bologna.8 ottobre 2009, di Federico La Sala
Stazionaria ’La Sapiena’ al 205esimo posto
Università, una ricerca internazionale boccia l’Italia: meglio di noi Corea, Taiwan e Australia
Roma, 8 ott. (Adnkronos/Ign) - L’unico ateneo presente nelle top 200 é l’Alma Mater di Bologna. L’Harvard university, Stati Uniti, mantiene saldamente il primo posto del ranking internazionale. Segue l’ateneo britannico di Cambridge che si piazza in seconda posizione davanti a Yale
Roma, 8 ott. (Adnkronos/Ign) - Una vera e propria debacle per l’università italiana, superata anche da Corea e Taiwan. E’ quello che emerge dalla classifica internazionale annuale sui migliori 200 atenei al mondo, messa a punto da QS Intelligence Unit e pubblicata dal Times Higher Education. Nella lista la prima università del Belpaese si trova infatti al 174mo: si tratta dell’Alma Mater di Bologna che, rispetto allo scorso anno è salita in graduatoria guadagnando otto posizioni e si piazza prima della Sapienza, la più grande università italiana ferma al 205° gradino, come nel 2008.
L’Harvard university, Stati Uniti, mantiene saldamente il primo posto del ranking internazionale per il sesto anno consecutivo. Segue l’ateneo britannico di Cambridge che si piazza in seconda posizione davanti a Yale, che passa dal secondo al terzo posto. Il quarto in classifica è un altro college londinese l’Ucl (University College London), seguito da Oxford che si conferma al quinto posto, ex equo con l’Imperial College London. Seguono a ruota la University of Chicago e l’ateneo di Princeton, il Massachusetts Institute of Technology e il California Institute of Technology, in decima posizione.
L’Australia, arriva al 17° posto con l’Australian National University, seguita dal Canada in 18ma posizion. Sono invece 39 le università europee rappresentate tra le top 100 (erano 36 nel 2008) guidate dal famoso ETH di Zurigo che ottiene la 20ma posizione. La francia compare al 28° posto con l’Ecole normale Superieure di Parigi.
Tra le 100 migliori università si nota che scende il numero di università nordamericane (42 nel 2008; 36 nel 2009), mentre cresce la presenza delle università europee e asiatiche, in particolare Giappone, Hong Kong, Corea del Sud e Malesia. Senza dimenticare Singapore il cui ateneo si piazza al 30esimo posto.
Il Giappone conta infatti ben 11 istituti nella top 200, tra cui due new entry: l’Università di Tsukuba, (174ma) e la Keio University che ha debuttato al 142esimo. E tra le prime 100 posizioni gli atenei del Sol Levante sono aumentati da quattro a sei, guidati dall’Università di Tokyo al 22° posto (dal 19).
Meglio dell’Italia anche la Corea , che con l’Ateneo di Seul si colloca in 47esima posizione, l’University of Adelaide dell’Australia, che si colloca all’81mo posto, la Nagoya del Giappone al 92mo e Taiwan al 95mo. A sorpassarci sono anche l’India con l’Indian Institute of Technology di Bombay, 163ma in classifica, la Russia con il Saint-Petersburg State University, 168ma e la Spagna con l’Universita’ di Barcellona che e’ 171ma in classifica.
Dopo i primi scaglioni, al 205mo posto si trova ’La Sapienza’, che, rispetto allo scorso anno rimane stazionaria. Ormai giunta alla sesta edizione la classifica è usata non solo da studenti e genitori per scegliere il percorso di studio migliore, ma anche dalle aziende per identificare le università dalle quali assumere neolaureati e dagli accademici per selezionare le istituzioni dove lavorare e quelle con cui formare collaborazioni.
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- PAOLO FARINELLA HA SCRITTO UNA "LETTERA DI RIPUDIO" ... MA SCHIFANI, FINI, BOSSI, E TUTTI GLI ALTRI HANNO "SPOSATO" IL FALSO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E NON GLI HANNO SCRITTO ALCUNA "lettera di ripudio" E CANTANO ANCORA "Forza Italia"!!!14 settembre 2009, di Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- DOPO HEIDEGGER, SOLO POUNd CI PUO’ SALVARE. "Elogio libertario di Pound" (di Giulio Giorello).20 febbraio 2009, di Federico La Sala
 Tradotto per la prima volta in italiano un commento
Tradotto per la prima volta in italiano un commento
 sulla rivoluzione americana: il volto inedito del poeta
sulla rivoluzione americana: il volto inedito del poetaElogio li bertario di Ezra Pound
 Scambiò Mussolini per Jefferson. Ma il suo era un Canto contro i tiranni
Scambiò Mussolini per Jefferson. Ma il suo era un Canto contro i tirannidi Giulio Giorello (Corriere della Sera, 18.02.2009)
«Boston era allora grande come Rapallo » (la cittadina ligure prediletta da poeti come Pound e Yeats), quando i coloni del Massachusetts passarono all’azione contro il governo di sua maestà. Eppure, «la rivoluzione ebbe luogo nella mente del popolo», tra il 1760 e il 1764, prima che a Lexington (19 aprile 1775) «parlassero i fucili».
I Cantos di Ezra Pound narrano, fra tante vicende storiche, anche l’epica del «virginiano» Thomas Jefferson e del «puritano» John Adams, due degli estensori della Dichiarazione d’indipendenza (4 luglio 1776). Non fu solo guerra di separazione di tredici colonie dalla madrepatria, bensì creazione di una realtà nuova, capace di legare, nel bene e nel male, le sorti dei discendenti dei primi «migranti » dalla vecchia Europa con quelle dei nativi americani e degli stessi africani gettati oltre Atlantico dalla tratta degli schiavi. Una «rivoluzione», appunto, che Jefferson e Adams volevano «permanente », contro ogni tentazione dispotica che venisse dall’interno o dall’esterno del Paese.
Riassumendo in poche pagine per la North American Review (inverno 1937-38) lo scambio epistolare tra i due, Pound chiedeva polemicamente: «Dovremmo perdere la nostra rivoluzione prostituendoci a esotismi moscoviti o europei?». Rispondeva risolutamente di no, non nascondendo la critica al modello comunista e la diffidenza per quello nazista (come mostra il suo uso dell’aggettivo «teutonico»). Il testo compare ora in lingua italiana, corredato da un’introduzione di Luca Gallesi: Il carteggio Jefferson-Adams come tempio e monumento (Edizioni Ares). Ma «tempio» e «monumento » sono termini che potrebbero far pensare a qualcosa di immobile nel flusso della storia; mentre quella corrispondenza è «una dinamo ancora funzionante », che dovrebbe restituire il piacere per la libertà e l’odio per i tiranni.
Per l’autore dei Cantos l’eclisse dello spirito rivoluzionario nella sua patria era conseguenza della lacerazione della cultura «in frammenti inutilizzabili o incompetenti »: letterati che si disinteressano della propria storia, storici che ignorano l’economia, scienziati che si nascondono dietro il loro specialismo. Come nota Gallesi, il ripensamento del ruolo della moneta nel capitalismo avanzato era diventato il chiodo fisso di Pound. Prendendosela con Freud e i suoi seguaci, dichiara il poeta che «per ogni persona con uno stato d’ansia causato dal sesso, ve ne sono nove con uno stato d’ansia causato dalla mancanza del potere d’acquisto» del proprio denaro!
Forse, le nostre preoccupazioni non sono troppo diverse da quelle diffuse dopo la crisi del 1929. Ma io non penso tanto che dobbiamo cercare risposta ai guai di oggi nelle dottrine economiche care a Pound, quanto che possiamo sfruttare come un tesoro nascosto l’insofferenza per ogni dispotismo fatta rivivere dalla parola poundiana: mai sacrificare libertà e responsabilità dei singoli individui al sogno della centralizzazione burocratica o della sorveglianza totale, fosse pure in nome dell’efficienza, della sicurezza, o magari della sacralità della vita. Troppo incline, all’inizio, a cedere alle richieste dei «federalisti» (il nome negli Usa indica i fautori del centralismo) e «caparbio» nel contenere le esuberanze di Jefferson, John Adams, successore di Washington alla presidenza (1797-1801), finì col «giocarsi i successivi quattro anni» a vantaggio dell’amico-rivale.
Jefferson, divenuto il terzo presidente Usa (1801-1809), doveva presentarsi come il garante della democrazia contro ogni velleità di imitare, magari sotto altre forme, il potere britannico, con il suo monarca, la sua Camera dei Lord, la sua Chiesa di Stato e il suo imperialismo. Ma lasciò prosperare quella Banca centrale che anni prima aveva condannato come un «meccanismo » usurpatore dei diritti dei vari Stati dell’Unione. «Tu e io non dobbiamo morire prima di aver spiegato noi stessi l’uno all’altro», scriveva Adams a Jefferson nel 1813.
Per un caso della sorte, John e Thomas chiusero le loro esistenze lo stesso giorno, il 4 luglio 1826, nel cinquantesimo anniversario della Dichiarazione d’indipendenza. «Per più di mezzo secolo - commenta Pound - in America sono vissute, e per molti versi hanno regnato, due persone civili ». Civiltà è qui sinonimo non solo di buon governo, ma (come scrive nei Cantos) di «sincerità, onestà, dirittura»: vi acconsentirebbe anche il più tenace repubblicano!
I Cantos, definiti dal loro autore un esperimento di laboratorio, dovevano segnare il transito dal Purgatorio al Paradiso dell’umana avventura con l’elogio delle virtù di John Adams. Ma come doveva imparare a sue spese il poeta, «insegna la nuova luna che non dura la fortuna»: alla fine degli anni Trenta scoppiò «la guerra di merda » che non doveva risparmiare nemmeno l’artista.
Innamorato dell’Italia e curiosamente convinto che Mussolini fosse una sorta di rispecchiamento europeo dell’americano Jefferson, Pound venne ufficialmente accusato dalle autorità del suo Paese di tradimento, nel luglio 1943, per i suoi discorsi pacifisti alla radio fascista. Sorpreso a Roma l’8 settembre, aveva poi raggiunto la Val Pusteria, in Tirolo (a piedi!), per ritornare al suo appartamento sul lungomare di Rapallo. Dalle vicine colline di S. Ambrogio, dove era infine «sfollato», assistette al crollo del regime di Salò. Ai primi di maggio del 1945 due partigiani lo conducono al comando alleato di Lavagna. Il 24 è trasferito al Disciplinary Trading Center presso Pisa, cioè nelle mani della polizia militare Usa. Il 18 novembre è a Washington: dichiarato infermo di mente, rimarrà rinchiuso dodici anni al Saint Elizabeths Hospital. Il processo al «traditore» non è stato mai celebrato.
Che razza di democrazia è quella che sequestra i suoi pretesi nemici senza sottoporli al giudizio di un’equa giuria? La libertà, aveva scritto Pound nel suo saggio su Jefferson e Adams, «è ancora il diritto di fare qualsiasi cosa non danneggi il prossimo». Si può essere nel più ampio disaccordo con le idee politiche di Pound; ma mi pare bene riconoscere quanto sia preziosa l’invocazione che ricorre nei Canti pisani, scritti al tempo della prigionia «in una gabbia per belve»: democrazia ascolta, «libertà di parola senza libertà di parola via radio vale zero »! Il 18 aprile 1958 la Corte suprema Usa faceva ritirare l’accusa di tradimento: Pound poteva così ritornare in Italia.
Il lettore troverà nelle pagine ora tradotte l’idea che «se si vuole una classe politica responsabile» non bisogna «restare nella penombra», ma «fare come gli scienziati», risalendo da fatti isolati alla connessione dei fenomeni. Il poeta si spense a Venezia il 1˚novembre del 1972. All’irlandese Yeats, che aveva cantato «la terribile bellezza» dell’insurrezione di Dublino (Pasqua 1916), amava ripetere che «il bello è difficile ». Lo è anche restare un democratico. In entrambi i casi ne vale la pena.
Dopo l’intervento di Giulio Giorello sul pensiero politico del grande poeta americano Fa scandalo il «Pound libertario»
Accame: profeta del crollo economico. Sampietro: utopista autoritario
di Dino Messina (Corriere della Sera, 20.02.2009)
«Beautiful is difficult», scriveva Ezra Pound: la bellezza è difficile. E senz’altro è difficile capire come uno dei geni poetici del Novecento volesse conciliare Benito Mussolini e Thomas Jefferson, la libertà e la scelta per la Repubblica sociale. A sciogliere queste contraddizioni in un «elogio libertario di Ezra Pound» ci ha provato l’altro ieri sul Corriere della Sera il filosofo Giulio Giorello in un articolo dedicato a un saggio di Pound tradotto da Andrea Colombo per la prima volta in italiano, Il carteggio Jefferson- Adams come tempio e monumento (Edizioni Ares, introduzione di Luca Gallesi).
L’intervento di Giorello non è passato inosservato. Non ci riferiamo tanto al commento entusiastico di Luciano Lanna sulla prima pagina del Secolo d’Italia, «Pound (come Jünger) era un libertario », quanto all’attenzione che ad esso ha dedicato Giano Accame, ex direttore del Secolo d’Italia, ma soprattutto uno dei maggiori esperti italiani del pensiero politico di Pound. «Negli anni Novanta avevo pubblicato per Settimo Sigillo il saggio Pound economista. Contro l’usura
 ci dice Accame -. Un lavoro cui mi dedicai quando Pound, soprattutto per i lavori poetici, era stato ampiamente rivalutato dalla critica di sinistra, a cominciare dai fondamentali saggi del professor Massimo Bacigalupo, che collaborava al manifesto e, detto per inciso, era figlio del medico italiano dell’autore dei Cantos. Mi sembra che l’intervento di Giorello possa rappresentare l’inizio della rivalutazione non soltanto poetica, ma del pensiero complessivo di Pound, anche alla luce della crisi finanziaria internazionale ».
ci dice Accame -. Un lavoro cui mi dedicai quando Pound, soprattutto per i lavori poetici, era stato ampiamente rivalutato dalla critica di sinistra, a cominciare dai fondamentali saggi del professor Massimo Bacigalupo, che collaborava al manifesto e, detto per inciso, era figlio del medico italiano dell’autore dei Cantos. Mi sembra che l’intervento di Giorello possa rappresentare l’inizio della rivalutazione non soltanto poetica, ma del pensiero complessivo di Pound, anche alla luce della crisi finanziaria internazionale ».Che cosa c’entra, si potrebbe obiettare, il crollo dei mercati finanziari, evocato peraltro anche da Giorello, con il poeta americano che aveva scelto di vivere in Italia? «Pound - spiega Accame - si reputava un patriota, legato ai valori della Costituzione, che affidava al Congresso di Washington la custodia della moneta. Egli considerava un’abiura della sovranità popolare l’aver delegato la gestione della moneta e della finanza alla Banca centrale, un ente i cui responsabili non rispondono delle proprie azioni al popolo. Da questa concezione derivava la proposta ingenua di una moneta deperibile... Al di là degli aspetti utopistici e sconclusionati del suo pensiero economico, restano oggi, in questa situazione, i moniti profetici. Pound considerava i poeti come le antenne di un popolo».
Pensiero economico a parte, definire «libertario» uno scrittore che si schierò pubblicamente per la Repubblica sociale italiana può essere visto da alcuni intellettuali di sinistra come un’impostura. «Non è affatto un’impostura - risponde Accame - perché il sogno finale di tutti i grandi intellettuali fascisti, da Giovanni Gentile all’eretico Berto Ricci e all’artista Mario Sironi, era realizzare la grandezza italiana nella libertà. Il fatto poi che Pound fosse vicino al fascismo in declino rispondeva un po’ alla natura dei pionieri americani, gente costretta a fuggire perché negletta nella propria terra».
Internato in un campo di concentramento vicino a Pisa, dove scrisse i Canti pisani, da alcuni considerato il meglio della sua produzione, Pound passò poi dodici anni in un manicomio criminale a Washington, ma l’America non ebbe mai il coraggio di condannare per tradimento uno dei suoi geni. Nessuno può negare la tensione libertaria di testi composti in un campo di prigionia.
Tuttavia, osserva Luigi Sampietro, docente di letteratura angloamericana all’Università Statale di Milano e frequentatore tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Settanta di casa Pound a Brunnenburg, vicino a Merano, «non si deve confondere tensione democratica, certamente presente in Pound, e liberalismo, che è l’espressione culturale del mercato. In fondo Adams e Jefferson condussero una guerra economica, per la liberalizzazione del mercato, diedero l’indipendenza alla propria terra perché non volevano pagare tasse. Ezra Pound, invece, con la sua ossessione contro l’usura, da cui derivava il suo antiebraismo, e l’invenzione di una moneta deperibile basata sul valore accumulato con il lavoro, contrapposto al denaro neutro valido per tutti, si ispirava in fondo a principi antiliberali. Chi potrebbe realizzare, se non una dittatura con un’economia dirigista, la carta-lavoro ipotizzata dall’autore dei Cantos? ».
D’accordo con «l’elogio libertario» scritto da Giulio Giorello è lo scrittore Pietrangelo Buttafuoco, autore di Cabaret Voltaire (Bompiani). Tuttavia, dice Buttafuoco, il contesto politico-culturale del nostro Paese ci costringe sempre «alla scoperta dell’acqua calda. Sì, ha capito bene: scoperta dell’acqua calda. Perché fin quando non ci libereremo dell’incubo antifascista, non ci potremo accostare con serenità al grande patrimonio culturale del Novecento. E non solo, perché ricordo che in Italia la cultura marxista più retriva ha messo in dubbio persino i filosofi presocratici, considerandoli antesignani del pensiero negativo. Come per Pound, oggi assistiamo alla rivalutazione del Futurismo, dopo che per anni ci hanno annoiato con le scoperte della transavanguardia. Ci rendiamo conto soltanto adesso che il Futurismo è stato il maggiore movimento culturale italiano assieme al Rinascimento? Certo, ebbe anche una valenza politica».
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- ATTENTATO ALLA COSTITUZIONE? GIA’ FATTO!!!19 febbraio 2009, di Federico La Sala
-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA E A PENSARE BENE "DIO", "IO" E "L’ITALIA", CHI PIU’ CHI MENO, VIVE ALL’INTERNO DELLA PIU’ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA E POLITICA ITALIANA, NEL REGNO DI "FORZA ITALIA"!!! Un’inchiesta e una mappa di Francesco Tomatis - a cura di Federico La Sala23 settembre 2008, di Maria Paola Falqui
 IL FILOSOFO ITALIANO, IL CAVALIERE MAGNO, E...
IL FILOSOFO ITALIANO, IL CAVALIERE MAGNO, E...-
> MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! ---- Declino e metamorfosi della nostra democrazia. "Famiglia cristiana" accusa.24 settembre 2008, di Maria Paola Falqui
Famiglia cristiana accusa: «Paese verso la semidemocrazia»
ROMA «Italiani brava gente, si diceva una volta», ma di fronte agli ultimi episodi di intolleranza, secondo Famiglia cristiana, sembra che l’Italia stia «cambiando pelle». «Oggi - commenta Famiglia cristiana - a leggere certi recenti episodi di cronaca, sembra di essere diventati il Paese dell’intolleranza. Una intolleranza che non è di matrice razzista, ma che può diventarlo».
Ma il settimanale affronta anche un altro tema scottante. Neppure alle europee «potremo sceglierci i rappresentanti con lo strumento delle preferenze» perché Berlusconi, ricorda Famiglia Cristiana, ha deciso di servire la «porcata numero due» (come la chiamò il suo creatore, il leghista Calderoli), ovvero - scrive la rivista dei paolini nell’editoriale del prossimo numero - una copia delle disposizioni più antidemocratiche della legge elettorale con cui abbiamo votato alle ultime politiche».
Dalle leggi elettorali, osserva Famiglia cristiana nell’editoriale intitolato «Declino e metamorfosi della nostra democrazia», «dipende la qualità della democrazia» e «abolire le preferenze equivale a scippare i cittadini di un diritto di rappresentanza democratica». Per Berlusconi, commenta la rivista, le liste bloccate permettono di avere «professionisti che possono autorevolmente rappresentare il Paese in Europa», ma affermare questo è «un insulto all’intelligenza degli elettori».
Per capirlo «basta fare un giro tra Camera e Senato per vedere le aule affollate di portaborse, segretari, cortigiani e figli di papà». «Quando non si riconosce il ruolo dell’opposizione (e il suo leader viene definito inesistente), - commenta l’editoriale - quando si toglie autonomia al potere giudiziario, quando l’opinione pubblica (addomesticata o narcotizzata grazie al controllo dei media) non è più in grado di effettuare un costante controllo sulle scelte politiche, ci si avvia, come dice il sociologo Campanini, a una semi-democrazia, a un processo degenerativo che svuota il Parlamento delle sue funzioni, sulla scia della Russia di Putin o del Venezuela di Chavez».
* l’Unità, 24.09.2008
-