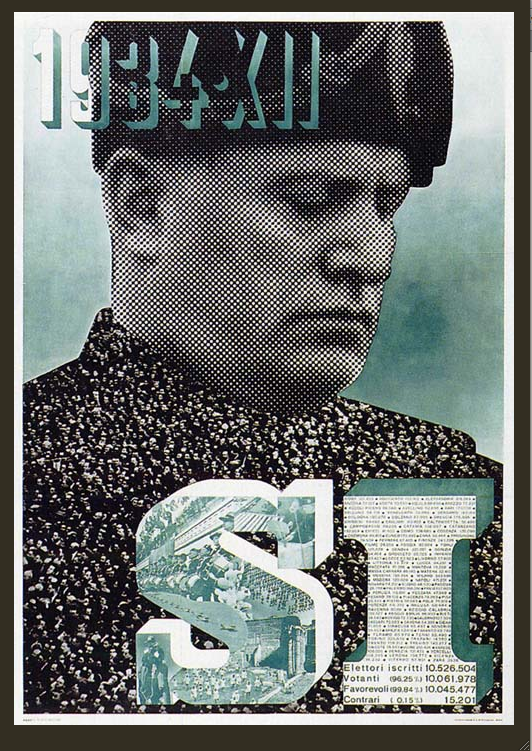POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. Materiali sul tema - a cura di Federico La Sala
- AL DI LA’ DELLA LEZIONE DI PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).
- La teologia romana dei secoli XIX e XX.
 Costantino tra la Chiesa trionfante e la Chiesa dei poveri(Stanisław Adamiak, Sergio Tanzarella -"Enciclopedia Costantiniana", 2013).
Costantino tra la Chiesa trionfante e la Chiesa dei poveri(Stanisław Adamiak, Sergio Tanzarella -"Enciclopedia Costantiniana", 2013).
- La formula di Friedrich Heer dell’era costantiniana (1949-1953). Il cristianesimo in mezzo al tempo e all’eternità (Gianmaria Zamagni - "Enciclopedia Costantiniana", 2013).
- Non basta dire come fanno i francesi che la loro nazione è stata colta alla sprovvista. Non si perdona a una nazione, come non si perdona a una donna, il momento di debolezza in cui il primo avventuriero ha potuto farle violenza. Con queste spiegazioni l’enigma non viene risolto, ma soltanto formulato in modo diverso. Rimane da spiegare come una nazione dì 36 milioni di abitanti abbia potuto essere colta alla sprovvista da tre cavalieri di industria e ridotta in schiavitù senza far resistenza (K. Marx,Il 18 brumaio di Luigi Bonaparte, 1852).
- "DIARIO MINIMO" (Eco, 1963) DELLA "FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO"(Hegel, 1807): «Mike Bongiorno convince dunque il pubblico, con un esempio vivente e trionfante, del valore della mediocrità. Non provoca complessi di inferiorità pur offrendosi come idolo, e il pubblico lo ripaga, grato, amandolo. Egli rappresenta un ideale che nessuno deve sforzarsi di raggiungere perché chiunque si trova già al suo livello. Nessuna religione è mai stata così indulgente coi suoi fedeli. In lui si annulla la tensione tra essere e dover essere. Egli dice ai suoi adoratori: voi siete Dio, restate immoti.» (Umberto Eco, "Fenomenologia di Mike Bongiorno", 1961).
 "PUBBLICITA’ PROGRESSO": L’ITALIA E LA FORZA DI UN MARCHIO REGISTRATO!!!
"PUBBLICITA’ PROGRESSO": L’ITALIA E LA FORZA DI UN MARCHIO REGISTRATO!!!
|
Xanti Schawinsky, Sì, 1934 |
- ACCADEMIA E BERLUSCONISMO. PREMIATO IL PRESIDENTE BERLUSCONI, PER IL RILANCIO DEL PLATONISMO ATEO E DEVOTO. "IO, PLATONE, SONO LA VERITA’": "FORZA ITALIA"!!! Nelle piazze e nei campi di calcio il popolo ateo-devoto è tutto in festa, in un mare di bandiere "nazionali"

 COSTITUZIONE, LINGUA E PAROLA.....
COSTITUZIONE, LINGUA E PAROLA.....
 IL BERLUSCONISMO E IL RITORNELLO DEGLI INTELLETTUALI.
IL BERLUSCONISMO E IL RITORNELLO DEGLI INTELLETTUALI.
- Ubuntu: una parola da e per non dimenticare. Una nota a margine della Lettera enciclica di Giovanni Paolo II SULL’ EUCARISTIA (del 17.04.2003)
- LA "RICAPITOLAZIONE" DI SAN PAOLO, ANTROPOLOGICAMENTE, ZOPPA E CIECA, A MISURA DEL FIGLIO PRIMOGENITO (MAGGIORASCATO):"[...] tutto il mondo, soggetto alla «vanità» e alla «corruzione» per il peccato di Adamo, attende gemendo la liberazione dal male e «tutta la creazione sarà liberata dalla servitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio». «Primogenito di tutta la creazione», Cristo, facendosi uomo e immolandosi sulla croce, «riunisce e riassume» tutti gli esseri - terrestri e celesti - e li riconcilia al Padre: si attua cosi il «mistero» della redenzione che Dio ha concepito da tutta l’eternità [...]" (cfr. Tullio Gregory, Giovanni Scoto Eriugena: tre studi,Firenze, Le Monnier, 1963: "II. Mediazione e Incarnazione", pp. 34-35 ).
 TEOLOGIA-POLITICA LUCIFERINA... A SILVIO BERLUSCONI UN "NOBEL"
TEOLOGIA-POLITICA LUCIFERINA... A SILVIO BERLUSCONI UN "NOBEL"
 METTERSI IN GIOCO, CORAGGIOSAMENTE
METTERSI IN GIOCO, CORAGGIOSAMENTE
HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI.
 cliccare sul rosso, per leggere gli articoli.
cliccare sul rosso, per leggere gli articoli.
Forum
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- TORNARE A SCUOLA DALL’ARCIMBOLDO E "RIPENSARE" IL SOGNO DELLA TEOLOGIA-POLITICA DI RODOLFO II D’ASBURGO.10 giugno 2024, di Federico La Sala
IL DIO "VERTUMNO", IL "CORPO MISTICO" DELL’IMPERATORE "GIARDINIERE". LA LUNGA ONDA DEL RINASCIMENTO E IL SOGNO DELLA TEOLOGIA-POLITICA DI RODOLFO II D’ASBURGO. Appunti sul tema:
A) - "LA CITTA’ DEL SOLE" (TOMMASO CAMPANELLA) E L’IDEA DEL "PARADISO TERRESTRE" DELLA "MONARCHIA" (DANTE ALIGHIERI) : "[...] La curiosità per il pomodoro e le altre piante in arrivo dal Nuovo Mondo è evidente nel fantasioso, emblematico, spiritoso e ormai famoso ritratto che Giuseppe Arcimboldo fece all’imperatore Rodolfo II. In questo quadro, dipinto nel 1560, Arcimboldo ritrae l’imperatore nei panni di Vertumno, il dio romano dell’abbondanza e dell’alternanza delle stagioni. Le opere di Rodolfo vengono rappresentate sotto forma di frutti maturi, fiori e ortaggi. Il labbro inferiore dell’imperatore è formato da due pomodorini a ciliegia. Un’altra pianta nuova, il mais, forma l’orecchio e due peperoncini rossi adornano il suo mantello. Rodolfo aveva ereditato un vastissimo giardino dal nonno, Ferdinando I. Di quel terreno, che doveva essere un «teatro del mondo», un’enciclopedia vivente di alberi e piante, era stato fatto un giardino all’italiana per opera di un grandissimo esperto, Mattioli, che l’aveva anche curato. Rodolfo condivideva con il nonno la fascinazione per la natura, la scienza e la magia. Aveva una raccolta di «curiosità» provenienti da tutto il mondo conosciuto, famosa per la sua varietà e il suo valore. Il milanese Arcimboldo era stato il «ritrattista di corte» di suo padre e di suo nonno, anche se il ruolo che occupava effettivamente andava ben oltre l’incarico ufficiale. Rodolfo si affidava ad Arcimboldo come suo agente, e negli anni Ottanta l’aveva mandato in Germania a caccia di opere d’arte e di oggetti rari. Quindi, non c’è da sorprendersi se Arcimboldo ha inserito dei prodotti del Nuovo Mondo nel suo fantasioso ritratto. Quest’opera è simile alle varie serie delle Quattro stagioni che Arcimboldo aveva iniziato a dipingere quasi tre decenni prima. Ma facendo maturare tutti i frutti, i fiori e gli ortaggi insieme, Arcimboldo ci presenta un’allegoria del potere imperiale, ricordandoci le pretese di dominio globale di Rodolfo, oltre a prospettare il ritorno di una «età dell’oro» sotto il suo governo. "(DAVID GENTILCORE, "LA PURPUREA MERAVIGLIA. Storia del pomodoro in Italia", Garzanti, 2010, pp. 36-37).
B) - RODOLFO II, ARCIMBOLDO, E IL DIO "VERTUMNO": "[...] Giuseppe Arcimboldi o Arcimboldo ( 1526-1593 ). Figlio del pittore Biagio che era stato in contatto con Bernardino Luini e quindi con la scuola di Leonardo, lavorò all’inizio con il padre in opere decorative come pannelli d’organo, vetrate, cartoni per arazzi, Dopo essersi fatto conoscere ed apprezzare si trasferì alla corte di Praga al servizio del principe Massimiliano divenendo artista ufficiale di corte. Dopo aver realizzato composizioni antropomorfe con frutti e vegetali che ebbero subito grande successo ( le Quattro stagioni dal 1563 al 1577 ) , lasciò la corte imperiale del principe Rodolfo a cui prestava servizio dopo la morte di Massimiliano, per tornare nel 1587 a Milano dove si stabilì definitivamente. Qui dipinse il Ritratto dell’imperatore in veste di Vertunno databile intorno al 1589-90. Le composizioni di Arcimboldo erano definite al suo tempo illusionistiche ed erano costituite, se così possiamo dire, da figure umane con un insieme di prodotti di mercato e cucina: il personaggio raffigurato era composto dall’insieme degli elementi naturali che costituivano il suo mestiere, così, per esempio, un ritratto di cuoco, era formato dai cibi collocati dalla testa ai piedi. Un aspetto delle figure "illusionistiche" comico-grottesche di Arcimboldo è la reversibilità nel senso che possono essere viste sia in forma antropomorfa che, rovesciate, in forma vegetale pur essendo composte, entrambe, degli stessi elementi naturali.
Dovendo omaggiare l’imperatore Rodolfo II d’Asburgo, pensò di creare, nel 1590, un proteiforme ritratto frontale a mezzo busto in cui appariva come il dio Vertumno, dio delle stagioni, formato dalla straordinaria giustapposizione di frutti, ortaggi e fiori. Si trattava del punto di arrivo delle sue opere destinate alle stagioni che qui si riassumevano in un insieme delle quattro, ricche di tutti i prodotti della terra. L’opera naturalmente era elogiativa, voleva essere un’esaltazione dell’abbondanza che sotto il regno di Rodolfo si godeva in tutte le stagioni dell’anno, come in una nuova età dell’oro. L’ammasso ordinato e composito dei frutti, ortaggi e fiori non sminuiva l’impatto che doveva fornire l’imperatore: l’impressione di vigore fisico e potenza politica, né ne sviava l’interpretazione accentuando il senso del grottesco o del comico, ma invece ne forniva una vera e propria potenza figurativa che dava proprio quell’idea di floridezza e abbondanza che un sapiente e regolato governo sapeva dare. [...]" (cfr. Giangiacomo Scocchera, "La Sindrome di Stendhal Due": Il primo tempo: Musici, fioriere e fruttiere...).
Federico La Sala
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- "ORIENTARSI NEL PENSIERO" (#KANT2024). Una "vecchia" nota in memoria di Alexandre Dumas, e, delle 21 "Moschettrici" (le Donne, le "Madri della Costituzione" della Repubblica Italiana).30 maggio 2024, di Federico La Sala
IL "CORPO MISTICO" (IL MOTTO DEI MOSCHETTIERI: "UNO PER TUTTI, TUTTI PER UNO"), L’ANTROPOLOGIA-POLITICA E LA COSTITUZIONE (L’ISOLA DEL "CONTE DI MONTECRISTO").
- "UT UNUM SINT": LA FILOSOFIA E LA FILOLOGIA AL SERVIZIO DEI "PARTITI-NAZIONI" O DELL’ITALIA, DELL’EUROPA E DEL PIANETATERRA (DELL’ UmaNiTA’, DELL’ONU)?!
"ORIENTARSI NEL PENSIERO" (#KANT2024). Una "vecchia" nota in memoria di Alexandre Dumas, e, delle 21 "Moschettrici" (le Donne, le "Madri della Costituzione" della Repubblica Italiana):
- "[...] La Costituzione è - ripetiamo: come ha detto e testimoniato con il lavoro di tutto il suo settennato il nostro Presidente, Carlo A. Ciampi - la nostra “Bibbia civile”, la Legge e il Patto di Alleanza dei nostri ’Padri’ e delle nostre ’Madri’ Costituenti (21 cittadine-sovrane presero parte ai lavori dell’Assemlea), e non la ’Legge’ di “mammasantissima” e del “grande fratello” ... che si spaccia per eterno Padre nostro e Sposo della Madre nostra: quale cecità e quanta zoppìa nella testa e nel cuore, e quale offesa nei confronti della nostra Legge dei nostri ’Padri’ e delle nostre ’Madri’- di tutti e tutte noi, e anche dei nostri cari italiani cattolici e delle nostre care italiane cattoliche!!!
- Nel 60° Anniversario della nascita della Repubblica italiana, e della Assemblea dei nostri ’Padri e delle nostre ’Madri’ Costituenti, tutti i cittadini e tutte le cittadine di Italia non possono che essere memori, riconoscenti, e orgogliosi e orgogliose di essere cittadine italiane e cittadini italiani, e festeggiare con milioni di voci e con milioni di colori la Repubblica e la Costituzione di Italia, e cercare con tutto il loro cuore, con tutto il loro corpo, e con tutto il loro spirito, di agire in modo che sia per loro stessi e stesse sia per i loro figli e le loro figlie ... l’ “avvenire” sia più bello, degno di esseri umani liberi, giusti, e pacifici! Che l’Amore dei nostri ’Padri’ e delle nostre ’Madri’ illumini sempre il cammino di tutti gli italiani e di tutte le italiane... [...]" ("25 GIUGNO: SALVIAMO LA COSTITUZIONE E LA REPUBBLICA CHE E’ IN NOI").
- MEMORIA E #STORIA. DA NON DIMENTICARE alla #Assemblea #Costituente, su 556 eletti, 21 erano donne:
 9 NEL GRUPPO DC, SU 207 MEMBRI - LAURA BIANCHINI, ELISABETTA CONCI, FILOMENA DELLI CASTELLI, MARIA IERVOLINO, MARIA FEDERICI AGAMBEN, ANGELA GOTELLI, ANGELA GUIDI CINGOLANI, MARIA NICOTRA, VITTORIA TITOMANLIO;
9 NEL GRUPPO DC, SU 207 MEMBRI - LAURA BIANCHINI, ELISABETTA CONCI, FILOMENA DELLI CASTELLI, MARIA IERVOLINO, MARIA FEDERICI AGAMBEN, ANGELA GOTELLI, ANGELA GUIDI CINGOLANI, MARIA NICOTRA, VITTORIA TITOMANLIO;
 9 NEL GRUPPO PCI, SU 104 MEMBRI - ADELE BEI, NADIA GALLICO SPANO, NILDE IOTTI, TERESA MATTEI, ANGIOLA MINELLA, RITA MONTAGNANA TOGLIATTI, TERESA NOCE LONGO, ELETTRA POLLASTRINI, MARIA MADDALENA ROSSI;
9 NEL GRUPPO PCI, SU 104 MEMBRI - ADELE BEI, NADIA GALLICO SPANO, NILDE IOTTI, TERESA MATTEI, ANGIOLA MINELLA, RITA MONTAGNANA TOGLIATTI, TERESA NOCE LONGO, ELETTRA POLLASTRINI, MARIA MADDALENA ROSSI;
 2 NEL GRUPPO PSI, SU 115 MEMBRI - BIANCA BIANCHI, ANGELINA MERLIN;
2 NEL GRUPPO PSI, SU 115 MEMBRI - BIANCA BIANCHI, ANGELINA MERLIN;
 1 NEL GRUPPO DELL’UOMO QUALUNQUE: OTTAVIA PENNA BUSCEMI.
1 NEL GRUPPO DELL’UOMO QUALUNQUE: OTTAVIA PENNA BUSCEMI.
NOTE:
- STORIA E #LETTERATURA: "ANALFABETISMO" ANTROPOLOGICO-POLITICO. «Per te sono un libro aperto. Non leggo. "Amori sfigati"» (Latini Marco). Da "Il Messia dei Libri proprio una bella sollecitazione ad #apriregliocchi (S. #Freud) e a osare #sapere (il "sàpere aude" di #Orazio di #Venosa e di #Kant di #Koenigsberg) e a riequilibrare e ristrutturare il #campo della #antropologia, della #filologia, della #matematica, della #filosofia, della psicoanalisi e della #teologia-#politica dell’attuale tempestoso presente storico.
- ANTROPOLOGIA #FILOSOFIA E #FILOLOGIA: IL PROBLEMA DEL #CORPOMISTICO, IL "#SAPERE AUDE" ("OSA AS-#SAGGIARE") E LA #FACOLTA’ DI #GIUDIZIO. In consonanza anche con il prossimo "XXV Congresso Mondiale di Filosofia - Roma 2024", a mio parere, è decisamente "consigliabile" ricordare e riprendere l’indicazione del prof. #GianniVattimo: «L’uomo è ciò che mangia, ma soprattutto quel che beve» (cfr. Emiliano Morrone, La ricerca (infinita) della verità e il pensiero “forte” di Vattimo per la sua San Giovanni in Fiore, "Corriere della Calabria", 22/09/2023)! Riflettere ancora e di nuovo su ciò che si mangia e si beve è ridiventato un allarme all’o.d.g: è una indicazione "carica di teoria", dal momento che del famoso "sàpere aude" di #Orazio di #Venosa (ripreso e rilanciato da #Kant da #Koenigsberg) è stata data storicamente (e per lo più) una interpretazione intellettualistica (e platonico) tutta a discapito della #sensibilità, tanto da pregiudicare la stessa comprensione del messaggio evangelico e del suo vitale e fondamentale "prendete e mangiate questo è il mio corpo", sia dal punto di vista antropologico sia dal punto di vista teologico-politico.
 Con #DanteAlighieri, e Gianni #Vattimo, è proprio tempo di rimeditare sullo "spirito profetico" dell’abate Gioacchino da Fiore e cercare di capire quanto sia importante non togliere un’acca dalla sua brillantissima "#charitas e non vendere per sempre la propria #anima e il proprio #corpo a "#mammona" ("caritas"). Se non ora, quando?!
Con #DanteAlighieri, e Gianni #Vattimo, è proprio tempo di rimeditare sullo "spirito profetico" dell’abate Gioacchino da Fiore e cercare di capire quanto sia importante non togliere un’acca dalla sua brillantissima "#charitas e non vendere per sempre la propria #anima e il proprio #corpo a "#mammona" ("caritas"). Se non ora, quando?!
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- IL "TEATRO DEL SONNO" E LA INTERPRETAZIONE DI KANT (KOENIGSBERG, 1766) DELLA TEOLOGIA-POLITICA DELL’UOMO SUPREMO "EUROPEO".28 maggio 2024, di Federico La Sala
«NON MANGIARE TROPPO»: IL "BANCHETTO" DI SWEDENBORG, I "SOGNI DEL VISIONARIO" ("AEGRI SOMNIA") DELL’«ARTE POETICA» DI #ORAZIO (VENOSA) E LA INTERPRETAZIONE DI KANT (KOENIGSBERG, 1766) DELLA TEOLOGIA-POLITICA DELL’UOMO SUPREMO "EUROPEO".
- Alcune "vecchie" note in memoria di Kant (1724-1804).
A) "TEATRO DEL SONNO": LA VISIONE DI SWEDENBORG. «Ero a Londra e stavo pranzando nel mio abituale ristorante. Ero affamato e mangiavo con grande appetito. Verso la fine del pasto mi accorsi che una specie di nebbia mi si faceva davanti agli occhi. La nebbia divenne più fitta e io vidi il pavimento della stanza coperto dei più orribili animali striscianti, serpenti, rospi e simili. Io ero stupefatto, perché ero in piena coscienza. Poi l’oscurità divenne più completa per sparire infine completamente, e ora in un angolo della stanza vidi seduto un uomo che mi terrorizzò con le sue parole. Mi disse infatti: «Non mangiare tanto!».
 Poi tutto si oscurò di nuovo, ma di colpo si rifece luce e mi ritrovai solo nella stanza. Questa visione mi indusse a tornare rapidamente a casa. Durante la notte mi si ripresentò lo stesso uomo, il quale mi disse che era Dio, il creatore del mondo e redentore, e che mi aveva scelto per spiegare agli uomini il senso spirituale delle Sacre Scritture; lui stesso mi avrebbe dettato quello che avrei dovuto scrivere su questo soggetto. In quella stessa notte, per convincermi, mi fu mostrato il mondo spirituale, l’inferno e il cielo, dove incontrai parecchie persone di mia conoscenza e di tutti i ceti sociali. Da quel giorno rinunciai a ogni interesse scientifico terreno e lavorai soltanto alle cose spirituali, secondo quello che il Signore mi aveva ordinato. In seguito il Signore aprì gli occhi del mio spirito, così che mi trovai in grado di vedere mentre ero pienamente desto quello che avviene nell’altro mondo, e di parlare con gli angeli e gli spiriti» (cfr. Emanuele Swedernborg, "Cielo e Inferno L’Aldilà descritto da un grande veggente", a c. di Paola Giovetti, Edizioni Mediterrane, Roma 2005; e, anche, cfr. Guido Almansi - Claude Béguin, "Teatro del sonno. Antologia dei sogni letterari", Oscar Mondadori, Milano 1991).
Poi tutto si oscurò di nuovo, ma di colpo si rifece luce e mi ritrovai solo nella stanza. Questa visione mi indusse a tornare rapidamente a casa. Durante la notte mi si ripresentò lo stesso uomo, il quale mi disse che era Dio, il creatore del mondo e redentore, e che mi aveva scelto per spiegare agli uomini il senso spirituale delle Sacre Scritture; lui stesso mi avrebbe dettato quello che avrei dovuto scrivere su questo soggetto. In quella stessa notte, per convincermi, mi fu mostrato il mondo spirituale, l’inferno e il cielo, dove incontrai parecchie persone di mia conoscenza e di tutti i ceti sociali. Da quel giorno rinunciai a ogni interesse scientifico terreno e lavorai soltanto alle cose spirituali, secondo quello che il Signore mi aveva ordinato. In seguito il Signore aprì gli occhi del mio spirito, così che mi trovai in grado di vedere mentre ero pienamente desto quello che avviene nell’altro mondo, e di parlare con gli angeli e gli spiriti» (cfr. Emanuele Swedernborg, "Cielo e Inferno L’Aldilà descritto da un grande veggente", a c. di Paola Giovetti, Edizioni Mediterrane, Roma 2005; e, anche, cfr. Guido Almansi - Claude Béguin, "Teatro del sonno. Antologia dei sogni letterari", Oscar Mondadori, Milano 1991).B). L’ARCHIVIO DEGLI ERRORI: L’ "IO SONO" DI KANT E L’ "IO SONO" DELL’"UOMO SUPREMO" (cfr. "Kant, Freud, e la banalità del male", 2010).
- [FOTO DELLA PAGINA]: "EMANUEL SWEDENBORG, «Non mangiar troppo»" (cfr. #GuidoAlmansi - #ClaudeBéguin, "Teatro del sonno. Antologia dei sogni letterari", Oscar Mondadori, Milano 1991).
- ANTROPOLOGIA ED #ECOLOGIA (NON EGOLOGIA); “SMONTARE LA GABBIA”! USCIRE DALLA CAVERNA, E NON RICADERE NELL’ILLUSIONE DI “DIO” CONCEPITO COME “UOMO SUPREMO”.... .
- IL "BANCHETTO DI BALDASSARRE": ARTE E PROPAGANDA DELLA FEDE TEOLOGICO-POLITICA DELL’EUROPA DEL QUATTROCENTO, ALLA VIGILIA DELLA CELEBRAZIONE (2025) DEL PRIMO CONCILIO DI #NICEA (325).
- ARTRIBUNE: Roma: a Palazzo Nardini scoperto un affresco del ‘400.
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- Riprendere il cammino di "#Ulisse" e portarsi oltre il "Convivio", il #Simposio, di #Platone e del suo "socratico" #amore17 marzo 2024, di Federico La Sala
USCIRE DALL’#INFERNO DELLA #RIPETIZIONE E DAL #LETARGO DI MILLENNI (Par. XXX, III, 94).
 Storia, filosofia, filologia, #psicoanalisi: una nota su una "ignota" #svolta_antropologica in corso...
Storia, filosofia, filologia, #psicoanalisi: una nota su una "ignota" #svolta_antropologica in corso...IL PROGRAMMA DI #DANTEALIGHIERI ALL’ORDINE DEL GIORNO (#25MARZO 2024: #Dantedì).
Riprendere il cammino di "#Ulisse" e portarsi oltre il "Convivio", il #Simposio, di #Platone e del suo "socratico" #amore (#Eros), avido e cupìdo, #figlio nato dalla astuta alleanza (#Metis) dell’#uomo-#Ingegno (gr. #Poros) e della #donna-#Povertà (gr. #Penia). La lezione di Platone appare essere la chiara codificazione di una fenomenologia dello spirito della #tragedia e la sua parola una versione della #Legge del #Figlio di Dio (#Zeus) , #Apollo: "«non è la madre la generatrice di quello che è chiamato suo figlio; ella è la nutrice del germe in lei inseminato. Il generatore è colui che la feconda...» (#Eschilo, #Eumenidi, 657 ss.): : un ’#cattolicesimo’ platonico.
STORIAELETTERATURA, #FILOLOGIA E #CRITICA: #DIVINACOMMEDIA. Gianfranco #Contini: «[...] L’impressione genuina del postero, incontrandosi in Dante, non è d’imbattersi in un tenace e ben conservato sopravvissuto, ma di raggiungere qualcuno arrivato prima di lui» (cfr. "Un’interpretazione di Dante", in Id., G. Contini, "Un’idea di Dante. Saggi danteschi", Torino, Einaudi, 2001, I ed. 1970, pp. 110-11).
ARTE, #ANTROPOLOGIA, #FILOLOGIA E #TEOLOGIA:
MICHELANGELO BUONARROTI, I PROFETI E LE SIBILLE.
LA "STORICA" #LEZIONE ANTROPOLOGICA DELLA #CORNICE LIGNEA DEL #TONDODONI (E DELLA #NARRAZIONE DELLA #VOLTA DELLA #CAPPELLASISTINA: DUE PROFETI E #DUE SIBILLE "INDICANO" LO #SPAZIOTEMPO DELLA #NASCITA DEL #FIGLIO DI #MARIAEGIUSEPPE. Come mai gli esperti della #GalleriadegliUffizi "insistono" a sostenere che nella "cornice del Tondo [...] sono raffigurate la testa di Cristo e quelle di #quattro profeti"?!
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- MARXISMO, PAOLINISMO E LENINISMO: UNA NOTA A MARGINE DELL’INTRODUZIONE A "IL POLITICO. Da Machiavelli a Cromwell" (Mario Tronti, 1979).12 agosto 2023, di Federico La Sala
MARXISMO, PAOLINISMO E LENINISMO: STORIA E STORIOGRAFIA. UNA NOTA A MARGINE DELL’INTRODUZIONE A "IL POLITICO. Da Machiavelli a Cromwell" (Mario Tronti, 1979).
In memoria di Mario Tronti... credo che non sia proprio il caso di lasciar cadere l’importanza dei suoi studi sul tema del "politico" :
"INTRODUZIONE: 1. Il politico ha una storia. E’ la storia moderna del rapporto di potere [...] Il passato ha una storia borghese. Non si può saltare. non si può arrivare subito a un politico "altro", senza aver attraversato e sperimentato e conosciuto quello che già c’è. Il passato pesa. Il capitalismo ha prodotto fin qui potere, ma anche il potere ha prodotto capitalismo. Quest’ultima cosa è difficile da accettare. [...] Il politico ha una storia borghese moderna. Molte delle cose che facciamo oggi male, sono state ben fatte qualche secolo fa. E’ impressionante quanto poco di nuovo ci sia sotto il sole della politica. No, non è la tesi banale che la politica è sempre quella. Non è sempre quella [...] La nascita del politico come problema è alle origini della scienza capitalistica. L’impatto, l’intreccio, lo scambio, il conflitto è tra soggetto statale e transizione al capitalismo. Senza Stato, fin dalle origini, niente capitalismo. Senza politica moderna, subito, fin dagli inizi, nessuna rivoluzione borghese. Rileggiamo il caso "marxiano" dell’Inghilterra [...].
 Con Hobbes, in epoca borghese, prende inizio una vera e propria età dello Stato. Da Machiavelli a Cromwell, - questa è l’età della politica moderna. Nasce un fare, un agire, che è di un individuo singolo, ma è per tutti gli altri, o su tutti gli altri. E’ l’azione pubblica della persona isolata, è l’attività politica. Nascono delle leggi per l’azione, delle regole per dirigere gli uomini, delle forme per dominarli. Nasce la razionalità della politica: dentro, c’è la reiterazione del comportqamnto umano e il disprezzo per la vocazione naturalmente subalterna dell’uomo, il cittadino come suddito; fuori, c’è il gusto dell’abilità e il senso della forza, la coltura della virtù e il comando sulla fortuna, "quelli principi sono deboli, che non stanno in su la guerra." Questo è l’orizzonte borghese della politica: l’unico che finora si sia dato." (cfr. "IL POLITICO. Antologia di testi" a cura di Mario Tronti. Vol. primo, Tomo primo, Feltrinelli 1979).
Con Hobbes, in epoca borghese, prende inizio una vera e propria età dello Stato. Da Machiavelli a Cromwell, - questa è l’età della politica moderna. Nasce un fare, un agire, che è di un individuo singolo, ma è per tutti gli altri, o su tutti gli altri. E’ l’azione pubblica della persona isolata, è l’attività politica. Nascono delle leggi per l’azione, delle regole per dirigere gli uomini, delle forme per dominarli. Nasce la razionalità della politica: dentro, c’è la reiterazione del comportqamnto umano e il disprezzo per la vocazione naturalmente subalterna dell’uomo, il cittadino come suddito; fuori, c’è il gusto dell’abilità e il senso della forza, la coltura della virtù e il comando sulla fortuna, "quelli principi sono deboli, che non stanno in su la guerra." Questo è l’orizzonte borghese della politica: l’unico che finora si sia dato." (cfr. "IL POLITICO. Antologia di testi" a cura di Mario Tronti. Vol. primo, Tomo primo, Feltrinelli 1979).MARX- LENIN, CRISTO - SAN PAOLO: A. GRAMSCI, "POSIZIONE DEL PROBLEMA: [...] Marx inizia intellettualmente un’età storica che durerà probabilmente dei secoli, cioè fino alla sparizione della Società politica e all’avvento della Società regolata. Solo allora la sua concezione del mondo sarà superata (concezione della necessità, 〈superata〉 da concezione della libertà). Fare un parallelo tra Marx e Ilici per giungere a una gerarchia è stolto e ozioso: esprimono due fasi: scienza-azione, che 〈sono〉 omogenee ed eterogenee nello stesso tempo. Così, storicamente, sarebbe assurdo un parallelo tra Cristo e S. Paolo: Cristo-Weltanschauung, S. Paolo organizzazione, azione, espansione della Weltanschauung: essi sono ambedue necessarii nella stessa misura e però sono della stessa statura storica. Il Cristianesimo potrebbe chiamarsi, storicamente, cristianesimo-paolinismo e sarebbe l’espressione più esatta (solo la credenza nella divinità di Cristo ha impedito un caso di questo genere, ma questa credenza è anch’essa solo un elemento storico, non teorico)." (A. Gramsci, "Quaderno 7 (VII) § (33)").
PENSARE L’ALDI LA’ DELLA TRADIZIONE TEOLOGICO-POLITICA DI SAN PAOLO. Riaprire l’orizzonte storiografico stretto nei limiti "da Machiavelli a Cromwell" e ripartire, recuperando il filo della lezione di Dante Alighieri ("Monarchia") presente nel lavoro di Mercurino da Gattinara (con Carlo V) e la critica tensione teologico-politica alla base dell elisabettiano "Amleto" di Shakespeare.
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- Dichiarazionedi cordoglio dell Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la scomparsa di Silvio Berlusconi.13 giugno 2023, di Federico La Sala
Cordoglio del Presidente Mattarella per la scomparsa di Silvio Berlusconi
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rilasciato la seguente dichiarazione: *
«Apprendo con profonda tristezza la notizia della morte di Silvio Berlusconi, fondatore e leader di Forza Italia, protagonista di lunghe stagioni della politica italiana e delle istituzioni repubblicane.
Berlusconi è stato un grande leader politico che ha segnato la storia della nostra Repubblica, incidendo su paradigmi, usi e linguaggi. In una stagione di profondi rivolgimenti, la sua “discesa in campo”, con un partito di nuova fondazione, ottenne consensi così larghi da poter comporre subito una maggioranza e un governo.
La leadership di Berlusconi ha contribuito a plasmare una nuova geografia della politica italiana, consentendogli di assumere per quattro volte la carica di presidente del Consiglio. In queste vesti ha affrontato eventi di portata globale, come la crisi aperta dall’attentato alle Torri Gemelle, la lotta al terrorismo internazionale e gli sconvolgimenti finanziari alla fine del primo decennio del nuovo secolo.
Ha progressivamente integrato il movimento politico da lui fondato nella famiglia popolare europea favorendo continuità nell’indirizzo atlantico ed europeista della nostra Repubblica.
E’ stato una persona dotata di grande umanità e un imprenditore di successo, un innovatore nel suo campo. Ha conquistato posizioni di assoluto rilievo nell’industria televisiva e nel settore dei media, ben prima del proprio impegno diretto nelle istituzioni.
E’ stato artefice di importanti successi nel mondo dello sport italiano.
Desidero esprimere il mio cordoglio e la mia solidarietà ai figli, a tutti i familiari, al suo partito, a coloro che più gli sono stati vicini nella vita e nell’ultima battaglia contro la malattia, combattuta con coraggio ed esemplare ottimismo».
Fonte: Sito della PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- I DUE VERSI DI EMILY DICKINSON. Su questo tema - della Fata Morgana, delle illusorie promesse (di Beniamino Placido, 1994).2 giugno 2023, di Federico La Sala
I DUE VERSI DI EMILY DICKINSON
di Beniamino Placido *
Sempre per loro. Perché non si disperino. Cosa non si fa per loro, per quelli che verranno dopo di noi: fra cinquanta, cento, cinquecento anni. Poveretti, cercheranno di capire la nostra storia di oggi e si metterranno le mani nei capelli, ci sembra già di vederli. Come mai vinse quel Berlusconi: che non era un politico, che tre mesi prima non era ancora entrato in politica?
Non siamo egoisti. Diamogli una mano. Aiutiamoli a sgrovigliare nella loro Biblioteca i nostri giornali ingialliti, dove si naviga fra quattro, cinque ipotesi concorrenti. Berlusconi ha vinto perché era (o si presentava) come "nuovo". Il vecchio non andava più di moda. Berlusconi ha vinto perché era o si presentava come uomo "non politico". La politica non andava più di moda. Oppure: perché si presentava come l’ uomo dei "fatti", contrapposto agli uomini delle chiacchiere.
Le chiacchiere circolavano molto ma erano molto chiacchierate, in Italia. O ancora: Berlusconi ha vinto perché si presentava (e certamente era anche) un "vincente". Ce l’ ha fatta? Si è fatto da sé? Ebbene, farà in modo che ce la facciamo anche noi.
Altra ipotesi ancora: ha vinto perché aveva a disposizione tante televisioni, e le usava. Si può fare una previsione sicura, eccola. Sarà questa alla fine l’ ipotesi vincente. Perché la più comoda, la più pittoresca. Ma non necessariamente la più fondata. Se li avessi davanti, questi studiosi di domani (o dopodomani), impegnati a capire le nostre vicende di oggi, farei loro questo discorso. Non date retta. La televisione è potente, ma non onnipotente. Negli Anni Settanta la Democrazia Cristiana - al governo da sempre - aveva a disposizione tutta la Televisione che c’ era (tutta) e tuttavia non riuscì ad impedire che l’ aborrita legge sul divorzio passasse. Negli Anni Ottanta Umberto Bossi riuscì a creare la sua Lega, dal nulla, infischiandosene della Televisione.
Forse c’ entra qualche altra cosa. Forse c’ entra anche quel che si dice in televisione.
 Se li avessi davanti, quegli storici di domani (o dopodomani) li costringerei a metter l’occhio su una cronaca da Torino (Massimo Gramellini, La Stampa, venerdì 1 aprile). Siamo a Mirafiori. Ecco un vecchio operaio che spiega come mai ci siano stati tanti voti per la destra. Anche a Mirafiori.
Se li avessi davanti, quegli storici di domani (o dopodomani) li costringerei a metter l’occhio su una cronaca da Torino (Massimo Gramellini, La Stampa, venerdì 1 aprile). Siamo a Mirafiori. Ecco un vecchio operaio che spiega come mai ci siano stati tanti voti per la destra. Anche a Mirafiori.
 "Alza un braccio e lo punta su un condominio con tante finestre tutte uguali. Poi dice: io abito là. Tremila famiglie; di media in ogni alloggio c’ è un disoccupato e una tv: hanno votato Berlusconi perché lui ha fatto delle promesse, e noi nemmeno quelle".
"Alza un braccio e lo punta su un condominio con tante finestre tutte uguali. Poi dice: io abito là. Tremila famiglie; di media in ogni alloggio c’ è un disoccupato e una tv: hanno votato Berlusconi perché lui ha fatto delle promesse, e noi nemmeno quelle".E’ chiaro: non basta la televisione; ci vuole anche un disoccupato in casa (e c’è per spiegare il risultato elettorale del 27 marzo. A quel disoccupato Berlusconi ha promesso un milione di posti di lavoro. Ce ne sarà qualcuno (forse due) anche per lui, perbacco.
Supponete che quel disoccupato abbia venticinque anni e magari un diploma, o una laurea, in tasca. Segue la pubblicazione dei bandi di concorso sulla Gazzetta Ufficiale. Poi accende il televisore (ecco dove la televisione conta) e vede che per una manciata di posti ci sono centinaia, migliaia di concorrenti. Famelici. E’ un incubo. Sarà sciocco, ma volete che non presti l’ orecchio alla prima promessa che gli viene fatta? Sarà imprudente, ma volete che non ceda al primo sogno che gli viene prospettato ("un nuovo miracolo economico")?
Su questo tema - della Fata Morgana, delle illusorie promesse, delle artificiose illusioni elettorali - si è molto discusso in questi giorni in Italia. C’ è stato anche chi ne ha negato ogni importanza. I sogni ad occhi aperti: ma figuriamoci. Lo ha negato anche Rossana Rossanda (il manifesto, venerdì 8 aprile).
Mi pare strano. Rossana Rossanda non può non saperlo: ci sono due versi della poetessa americana Emily Dickinson che le danno torto. Meglio un sogno che niente. E la Dickinson è una poetessa dura, aspra, essenziale. Fatta di pietra e di quarzo. Non si fa illusioni. Non ne autorizza. Non crede nel paradiso in terra, non le piace ("I don’ t like Paradise").
Eppure è lei l’ autrice di quei due versi dove è detto che quando si è al buio persino un fuoco fatuo è meglio di niente. Meglio della totale assenza di luce "Better an ignis fatuus / Than no illume at all"é. Dove quel latino di "ignis fatuus", dove l’ arcaico di quell’ "illume" vogliono dire che è così, fatalmente. E’ una vecchia storia. Possiamo (dobbiamo anzi) contrastarlo. Non possiamo negarlo.
Mi pare strano che la Rossanda non se ne ricordi. C’ è un vecchio volumetto della Savelli, dove quella poesia (tradotta da Barbara Lanati) figura. La prefazione al volumetto - e che prefazione: acutissima, splendida - era di Rossana Rossanda.
* Fonte: la Repubblica, 10 aprile 1994
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- Stato-mafia, se trattativa c’è stata «non è un reato». Ribaltando la sentenza di primo grado la Corte d’Assise d’appello di Palermo assolve l’ex senatore dell’Utri e gli ex ufficiali dei Ros24 settembre 2021, di Federico La Sala
Politica
Stato-mafia, se trattativa c’è stata «non è un reato»
Ribaltando la sentenza di primo grado la Corte d’Assise d’appello di Palermo assolve l’ex senatore dell’Utri e gli ex ufficiali dei Ros
di Red. Int. (il manifesto, 24.09.2021)
ROMA. Se c’è stata una trattativa tra lo Stato e la mafia per mettere fine alle stragi dei primi anni ’90, non è un reato. Tre anni dopo la decisione con cui la Corte d’Assise di Palermo aveva accolto le richieste dell’accusa riconoscendo l’esistenza di un «patto scellerato» tra una parte delle istituzioni e i boss mafiosi, la Corte d’Assise d’appello del capoluogo siciliano capovolge quella sentenza e assolve gli uomini delle istituzioni. A partire dagli ex ufficiali dei Ros Mario Mori, Antonio Subranni, condannati in primo grado a 12 anni, e Giuseppe De Donno (8 anni), assolti con la formula perché il «fatto non costituisce reato» e dall’ex senatore di Forza Italia Marcello dell’Utri (12 anni in primo grado) «per non aver commesso il fatto». Confermate, invece, le condanne per il boss Leoluca Bagarella (27 anni invece dei 28 del primo grado) e del capomafia Nino Cinà (12 anni). Confermata anche la prescrizione delle accuse al pentito Giovanni Brusca.
«Sono soddisfatto e commosso. E’ un peso che ci togliamo. Il sistema giudiziario funziona», è stato il commento di Dell’Utri dopo la lettura della sentenza. Per l’avvocato Basilio Milo, che difende il generale Mori, «la sentenza stabilisce che la trattativa non esiste. E’ una bufala, un falso storico». Secco, invece, il commento del procuratore generale Giuseppe Fici: «Aspettiamo le motivazioni e leggeremo il dispositivo».
Per la procura di Palermo tra il 1992 e il 1993 gli uomini dello Stato avrebbero trattato con i vertici di Cosa nostra al fine di mettere fine alla stagione delle stragi cominciata con l’attentato ai giudici Falcone e Borsellino e proseguita poi con le bombe a Roma, Milano e Firenze. Sempre secondo l’accusa, rappresentata nel processo di primo grado dai pm Nino Di Matteo, Francesco Del Bene, Roberto Tartaglia e Vittorio Teresi, «i carabinieri dei Ros avevano avviato una prima trattativa con l’ex sindaco mafioso di Palermo Vito Ciancimino, che avrebbe consegnato un ’papello’ con le richieste di Totò Riina per fermare le stragi». Accusa sempre respinta dagli imputati.
Diversa la posizione di Marcello Dell’Utri. Le accuse all’ex senatore di Forza Italia facevano riferimento al periodo del governo Berlusconi, ovvero il 1994. Secondo i pm, inoltre, il dialogo che gli ufficiali dei Ros, tramite Ciancimino e godendo di coperture istituzionali, avviarono con Cosa nostra avrebbe rafforzato i clan spingendoli a ulteriori azioni violente contro lo Stato. Sul piatto della trattativa, in cambio della cessazione delle stragi sarebbero state messe concessioni carcerarie ai mafiosi detenuti al 41 bis e un alleggerimento dell’azione di contrasto alla mafia.
Diverse, e di segno opposto, le reazioni. «Rispetto il giudizio dei magistrati - ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando - , tuttavia questa sentenza rischia di non diradare, anche in virtù di una sentenza di primo grado che ha messo in fila fatti inquietanti, le tante zone d’ombra su uno dei periodi più oscuri della nostra Repubblica e sul rapporto perverso tra mafia, politica e istituzioni che ha scandito a suon di bombe la storia italiana».
Soddisfazione per l’esito del processo d’appello è stata espressa invece sia da Matteo Renzi che da Matteo Salvini. Per il leader di Italia viva «oggi si scrive una pagina di storia giudiziaria decisiva. Viene condannato il mafioso e assolti i rappresentanti delle istituzioni. Ciò che i giustizialisti hanno fatto credere in talk show e giornali era falso: non c’è reato. Ha vinto la giustizia, ha perso il giustizialismo». Amaro, infine, il commento di Salvatore Borsellino: «In Italia non c’è giustizia», ha detto il fratello del giudice assassinato dalla mafia.
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- IL CORPO POLITICO DELLO STATO (E LA TESTA). La corte d’assise d’appello di Palermo ha assolto al processo sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia gli ex ufficiali del Ros Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno e il senatore Marcello Dell’Utri, accusati di minaccia a Corpo politico dello Stato. In primo grado erano stati tutti condannati a pene severissime.24 settembre 2021, di Federico La Sala
Trattativa Stato-mafia: assolti carabinieri e Dell’Utri
Pena ridotta al boss Bagarella, condannato il capomafia Cinà *
La corte d’assise d’appello di Palermo ha assolto al processo sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia gli ex ufficiali del Ros Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno e il senatore Marcello Dell’Utri, accusati di minaccia a Corpo politico dello Stato. In primo grado erano stati tutti condannati a pene severissime.
Dichiarate prescritte le accuse al pentito Giovanni Brusca. Pena ridotta al boss Leoluca Bagarella. Confermata la condanna del capomafia Nino Cinà.
Per Bagarella i giudici hanno riqualificato il reato in tentata minaccia a Corpo politico dello Stato, dichiarando le accuse parzialmente prescritte. Ciò ha comportato una lieve riduzione della pena passata da 28 a 27 anni. Confermati i 12 anni a Cinà. Gli ex ufficiali del Ros Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno sono stati assolti con la formula perché il "fatto non costituisce reato", mentre Dell’Utri "per non aver commesso il fatto". Confermata la prescrizione delle accuse al pentito Giovanni Brusca. L’appello, nel corso del quale è stata riaperta l’istruttoria dibattimentale, è cominciato il 29 aprile del 2019. Nel corso del processo è uscito di scena, per la prescrizione dei reati, un altro imputato, Massimo Ciancimino, figlio dell’ex sindaco mafioso di Palermo Vito, che rispondeva di calunnia aggravata all’ex capo della polizia Gianni De Gennaro e concorso in associazione mafiosa.
A rappresentare l’accusa in aula sono stati i sostituti procuratori generali Giuseppe Fici e Sergio Barbiera che hanno chiesto la conferma della sentenza di primo grado. Al termine del primo dibattimento, la Corte d’Assise aveva inflitto 28 anni a Bagarella, 12 a Dell’Utri, Mori, Subranni e Cinà e 8 a De Donno e Ciancimino. Vennero poi dichiarate prescritte le accuse rivolte al pentito Giovanni Brusca. Sotto processo, ma per il reato di falsa testimonianza, era finito anche l’ex ministro dell’interno Nicola Mancino che venne assolto. La Procura non presentò appello e quindi l’assoluzione diventò definitiva. Per la cosiddetta trattativa è stato, infine, processato separatamente e assolto, in abbreviato, l’ex ministro Dc Calogero Mannino. "Uomini delle istituzioni, apparati istituzionali deviati dello Stato, hanno intavolato una illecita e illegittima interlocuzione con esponenti di vertice di Cosa nostra per interrompere la strategia stragista.
La celebrazione del presente giudizio ha ulteriormente comprovato l’esistenza di una verità inconfessabile, di una verità che è dentro lo Stato, della trattativa Stato-mafia che, tuttavia, non scrimina mandanti ed esecutori istituzionali perché o si sta contro la mafia o si è complici. Non ci sono alternative", aveva detto l’accusa durante la requisitoria del processo d’appello, al termine della quale aveva chiesto la conferma di tutte le condanne del primo grado. Secondo i pm, il dialogo che gli ufficiali del Ros, tramite i Ciancimino e godendo di coperture istituzionali, avviarono con Cosa nostra durante gli anni delle stragi per interrompere la stagione degli attentati, avrebbe rafforzato i clan spingendoli a ulteriori azioni violente contro lo Stato. Sul piatto della trattativa, in cambio della cessazione delle stragi, sarebbero state messe concessioni carcerarie ai mafiosi detenuti al 41 bis e un alleggerimento nell’azione di contrasto alla mafia. Il ruolo di Mori e i suoi, dopo il ’93, sempre nella ricostruzione dell’accusa, sarebbe stato assunto da Dell’Utri che nella sentenza di primo grado venne definito "cinghia di trasmissione" tra i clan e gli interlocutori istituzionali.
"E’ un film, una cosa inventata totalmente - dice Marcello Dell’Utri, in una telefonata con Bruno Vespa a Porta a Porta -. Io questo processo non l’ho neanche seguito. Mi sono sentito quando sono andato a Palermo all’udienza come un turco alla predica, non capivo di cosa stessero parlando. Questa cosa era inesistente però purtroppo avevo paura che potessero avallare queste cose inventate servendosi dei soliti pentiti che hanno bisogno di dire cose per avere vantaggi, e di molta stampa che affianca le procure e soprattutto la procura di Palermo. Questo mi preoccupava, ma speravo intimamente nell’assoluzione".
"Non abbiamo mai dubitato dell’estraneità del Generale Mario Mori e degli ex ufficiali del Ros Antonio Subranni e Giuseppe De Donno alla vicenda per la quale per anni sono stati inchiodati e additati come traditori dello Stato. Questa sentenza ci obbliga ad una lettura radicale della narrazione di questi anni. La riforma della giustizia e in particolare la responsabilità civile sono una impellente necessità". Lo dichiarano Maurizio Turco e Irene Testa, Segretario e Tesoriere del Partito Radicale.
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- La cognizione dello "stato di cose presente" e "la diffcile eredità di Marx" (R. Bellofiore).29 marzo 2021, di Federico La Sala
MARX, IL "LAVORO - IN GENERALE", E IL "RAPPORTO SOCIALE DI PRODUZIONE - IN GENERALE".... *
- Una nota a margine del testo di Riccardo Bellofiore, La difficile eredità di Marx, Sinistra in rete, 24 marzo 2021.
"CRITICA DELL’ECONOMIA POLITICA" , "CRITICA DELLA RAGION PRATICA" (E MEMORIA DI DANTE ALIGHIERI - ANNO 2021) . Alla luce del fatto che si è persa ogni cognizione dello "stato di cose presente", forse, è opportuno - come voleva Marx - riprendere il filo dalla indicazione delle note "Per la critica della filosofia del diritto di Hegel. Introduzione"): "La teoria è capace di impadronirsi delle masse non appena dimostra ad hominem, ed essa dimostra ad hominem non appena diviene radicale. Essere radicale vuol dire cogliere le cose alla radice. Ma la radice, per l’uomo, è l’uomo stesso".
Si dice:
- "[...] Vi sono delle lacune nella riflessione originaria di Marx che vanno superate. Marx vede bene un punto: che sotto il capitale il lavoro è prestazione erogata dalla forza-lavoro di ‘soggetti’ apparentemente liberi ed eguali. È di lì, da questi lavoratori che sono un ‘altro’ dal capitale che deve essere reso interno, ‘incorporato’ nella fabbrica produttiva, che viene estratto il lavoro vivo, dunque il nuovo valore di cui il plusvalore è parte: è per questo che le lotte sul lavoro sono centrali. Non presta però attenzione alla riproduzione sociale degli esseri umani che sono portatori viventi della forza-lavoro, dunque al lavoro domestico e al lavoro di cura. È questo uno dei fuochi del discorso del femminismo. C’è poi un ‘altro’ che è esterno al capitale, che è la natura, che viene anch’essa sfruttata e depredata nel suo corpo come gli esseri umani. Anche questo Marx lo vede, ma in qualche misura ne sottostima la gravità, che non può più sfuggirci" (R. Bellofiore, cit).
CONCORDO. Ma per ripartire bisogna riprendere il filo dalla "Logica" di Kant (non di Hegel, come si recita ancora oggi: http://www.leparoleelecose.it/?p=41116#comment-439785), dalla sua "quarta" (e prima!) domanda: "che cosa è l’uomo?", dalla sua "Critica della ragion pratica", e dal suo "imperativo categorico" (http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=5635)! La questione è antropologica (non andrologica né ginecologica)! O no?!
* Sul tema, mi sia lecito, si cfr. la "Lettera da ‘Johannesburg’ a Primo Moroni (in memoriam)": "CHI" SIAMO NOI, IN REALTÀ. RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE (http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=4198); su COME NASCONO I BAMBINI? E COME ‘NASCONO’ I GENITORI?!, rileggere la lettera di Sigmund Freud (http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=2923).
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. -- IL PROBLEMA GIAMBATTISTA VICO, LA QUESTIONE OMERICA, E "PERICLE IL POPULISTA"2 febbraio 2021, di Federico La Sala
AL DI LA’ DELL’ORIZZONTE DI "PERICLE IL POPULISTA" E DI PLATONE...
- TUCIDIDE E LA GUERRA CONTRO I "POETI": "[...] non abbiamo bisogno di alcun Omero che canti la nostra gloria né di chi con le sue parole procurerà un diletto immediato, dando però un’interpretazione dei fatti che non potrà reggere quando la verità si affermerà: con la nostra audacia abbiamo costretto il mare e la terra interi ad aprirci le loro vie, e ovunque abbiamo innalzato alle nostre imprese, siano state esse sfortunate o coronate da successo, monumenti che non periranno. Ed è per una tale città che questi uomini hanno affrontato amabilmente la morte in combattimento [...]" (Tucidide, La guerra del Peloponneso, II, 41, Bari, Laterza 1986).
PER NON CADERE (di nuovo e ancora, dopo millenni) NELLA TRAPPOLA DELLA TRACOTANZA E DELLA MALAFEDE DI "PERICLE", E NON DIMENTICARE CHE LA SUA LINEA POLITICA SEGNA L’INIZIO DELLA FINE DELLA GLORIA E DEL PROGETTO POLITICO DI ATENE, forse, è opportuno - ricordando la messa al bando di Omero e dei "poeti" dalla "Repubblica" di Platone - riprendere e rivedere (non solo i lavori di Eric A. Havelock, ma anche) la brillante analisi del cosiddetto "Elogio di Atene" da parte di Umberto Eco nella sua nota sul "Pericle il populista" di ieri e di oggi (la Repubblica, 14 gennaio 2012):
- "Il discorso di Pericle (riportato da Tucidide, in Guerra del Peloponneso) è stato inteso nei secoli come un elogio della democrazia, e in prima istanza è una descrizione superba di come una nazione possa vivere garantendo la felicità dei propri concittadini, lo scambio delle idee, la libera deliberazione delle leggi, il rispetto delle arti e dell’educazione, la tensione verso l’uguaglianza. Ma che dice in realtà Pericle?";
e, al contempo, volendo, rimeditare la storica lezione di Giambattista Vico sulla questione "Omero" e riflettere sulla sua proposta di una "Scienza Nuova", al di là dell’imbalsamazione crociana.
Federico La Sala
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- ECOLOGIA DELLA PAROLA. La comunicazione politica dentro la crisi (di M. Magatti).18 gennaio 2021, di Federico La Sala
La riflessione.
La comunicazione politica dentro la crisi: rispettateci anche a parole
di Mauro Magatti (Avvenire, domenica 17 gennaio 2021)
Nel passato, la parola data era sacra e, col suggello di una stretta di mano, stabiliva impegni vincolanti. Un retaggio che filtra fin nelle democrazie moderne che fanno del "parlamento" il palazzo dove i diversi interessi e i differenti punti di vista "si parlano", si confrontano, si accordano. Anche i sistemi politici più avanzati poggiano su quella fragile e delicata facoltà della vita umana che è la parola.
Sappiamo tutti quanto è difficile intendersi. Equivoci, fraintendimenti, ipocrisie, menzogne. Non certo solo in Parlamento. Ma al lavoro, in famiglia. Non sempre si dice quello che si pensa. Né si fa quello che si dice. Più spesso le parole vengono usate strategicamente per i propri obiettivi. Ingannando gli altri, violentando la realtà. Da qui si scatenano tensioni, litigi, lotte, sfiducia. Tutti ingredienti tristi della nostra vita.
Nulla di cui sorprendersi o scandalizzarsi dunque. La comunicazione umana, quando ha successo, ha qualcosa di miracoloso. E proprio poiché ne conosciamo la fragilità, col tempo si è affermata la tendenza a sostituirla con contratti scritti, procedure rigide, algoritmi. Col rischio di diventare una società di autistici. Ci sono situazioni, però, in cui la verità delle cose si impone con forza. In cui il bene che condividiamo è così necessario e forte da non ammettere furbizie o manipolazioni.
Così dopo quasi 11 mesi di pandemia, con ormai più di 80mila morti, con le scuole chiuse da quasi un anno, con interi settori economici distrutti, con ansia e preoccupazione in aumento nella popolazione, l’uso palesemente strumentale delle parole che abbiano ancora una volta visto nel ’teatrino della politica’ suona particolarmente stucchevole. L’Italia non meritava e non merita un tale spettacolo.
Un gruppo di governanti che pensa al bene comune, di fronte a delle legittime divergenze, si chiude in una stanza discute tutto il tempo necessario per arrivare a un accordo o a un disaccordo. E poi parla chiaro, e agisce alla luce del sole. E invece sono settimane (se non mesi) che il Paese è inchiodato in una pantomima dove tutti hanno un pezzo di ragione ma nessuno riconosce i propri torti. Renzi che critica (giustamente) certo immobilismo e verticismo di Conte, facendo però capire che il suo scopo non è semplicemente quello di dare buoni consigli al premier ma di rimandarlo a casa.
Conte che interviene con toni sempre rassicuranti su tutte le questioni facendo però finta di non sapere che il nostro (anziano) Paese è uno dei peggiori al mondo per numero assoluto di morti e di riduzione del Pil. I 5stelle che si dichiarano contrari al Mes (quando la nostra sanità avrebbe bisogno di ogni ulteriore risorsa) senza mai proporre una qualche ragione comprensibile, ma per pura affermazione identitaria e ideologica.
Il Pd che cerca di barcamenarsi in una coalizione traballante, ma non riconosce che, al di là delle speranza del primo momento, la coalizione di governo di fatto non riesce a prendere forma e consistenza. E intanto i leader dell’opposizione non perdono occasione per dire tutto quello che si sarebbe dovuto fare e che il governo non ha fatto elencando, senza vincolo di realtà, un numero più o meno infinito di decisioni che meravigliosamente ci avrebbero potuto portare fuori dalla crisi. Ma non fanno mai cenno dei fallimenti clamorosi registrati nelle Regioni in cui governano.
Con tutta la buona volontà, si tratta di uno spettacolo deprimente per il cittadino che cerca di farcela in mezzo a mille difficoltà. L’abuso della parola provoca un grave danno alla democrazia. Quando nessuno crede più a nessuno e si perde la fiducia nella possibilità di intendersi, il Parlamento diventa una ’torre di babele’ di cui qualcuno comincia a pensare di fare a meno. E questo è pericoloso. La parola comunicazione viene dal latino com-munis che rimanda all’idea di dono ’obbligatorio’.
Un’espressione che noi non riusciamo più nemmeno a cogliere. Come è possibile un dono obbligatorio? In realtà questa idea nasce dal presupposto che le relazioni (e quindi la comunicazione) siano rette su una obbligazione e che, proprio per questo, il comportamento individuale, pur libero, non possa prescindere da una serie di condizioni.
 Che nel caso della comunicazione hanno a che fare con la ricerca della verità, la franchezza, l’onestà, la parresia. Senza obbligazione, la democrazia si riduce a puro scontro di potere, delegittimandosi di fronte al popolo. Soprattutto quando la verità dei fatti si impone per la sua gravità, non si possono usare le parole in modo solo strategico.
Che nel caso della comunicazione hanno a che fare con la ricerca della verità, la franchezza, l’onestà, la parresia. Senza obbligazione, la democrazia si riduce a puro scontro di potere, delegittimandosi di fronte al popolo. Soprattutto quando la verità dei fatti si impone per la sua gravità, non si possono usare le parole in modo solo strategico.
 Serve un’ecologia della parola. Adesso.
Serve un’ecologia della parola. Adesso. -
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- USA. La democrazia americana fatta a pezzi (di Raffaella Baritono - "Il Mulino).7 gennaio 2021, di Federico La Sala
La democrazia americana fatta a pezzi
La miccia accesa quattro anni fa ha fatto il suo lavoro e la bomba è esplosa
di Raffaella Baritono (Il Mulino, 07 gennaio 2021)
Quattro morti, oltre a più di 50 arresti, è il bilancio provvisorio di una giornata che avrebbe dovuto certificare la decisiva vittoria democratica alle elezioni per il Senato in Georgia, l’elezione di Biden e Harris e l’avvio del nuovo Congresso. Una giornata che invece ha rappresentato un salto di qualità nello scontro politico, dimostrando, una volta di più, quanto la democrazia americana possa essere fragile e a rischio.
La presidenza Trump si inaugurò, quattro anni fa, con un discorso sullo American carnage, sulla carneficina di una classe media bianca a opera di forze economiche più o meno oscure con la complicità dei democratici. Rischia di terminare con la carneficina di istituzioni che sembrano non reggere più di fronte a un «re folle», come ormai molti commentatori definiscono Trump. Persino il suo sodale, Rudolph Murdoch, attraverso il «New York Post», lo ha invitato ad abbandonare l’interpretazione di un re Lear farsesco più che tragico se non fosse che riesce, come si è visto anche ieri, a trascinare il consenso di minoranze, certo, ma che hanno dietro i quasi 73 milioni di voti presi nelle elezioni dello scorso novembre.
Ancora una volta Trump si è assunto la responsabilità di alimentare il caos, le convinzioni cospirazioniste di chi, più che vivere una realtà alternativa, tenta di piegarla verso ciò che ritiene «verità di per sé evidenti». Al direttore di «The Atlantic», Jeffrey Goldberg, uno dei manifestanti radunatasi davanti al Congresso, ha gridato: «Arrenditi se credi in Gesù, arrenditi se credi in Donald Trump».
Sarebbe sbagliato liquidare questa frase, così come i cartelli con la scritta «Pelosi satana» come espressioni freak di estremisti cospirazionisti ed esponenti della destra armata. Ovvio: fra coloro che sono penetrati nelle aule e negli uffici del Congresso ci sono anche quelli. Hanno peraltro l’appoggio di esponenti repubblicani appena eletti, come nel caso di un deputato della West Virginia, entrato assieme agli altri manifestanti per filmare e postare quello che stava accadendo. Ma per molti di loro era la dimostrazione del vero spirito americano, di un «popolo» che si sente defraudato da elezioni considerate corrotte e rubate, come d’altronde Trump ha ribadito anche quando ha invitato i suoi sostenitori a «tornare a casa».
 In fondo, non è la Dichiarazione di indipendenza il documento che legittima il diritto a resistere a un potere tirannico? Non è questo il messaggio che i manifestanti vestiti con abiti settecenteschi volevano trasmettere? Le immagini dei «patrioti» che si fanno immortalare seduti sullo scranno del presidente del Senato o della Camera verranno percepite, dall’America profonda che crede in Trump, come la riappropriazione delle istituzioni da parte del popolo sovrano, come l’espressione autentica di quello spirito di libertà che affonda nelle radici della lotta rivoluzionaria. Perché stupirsi, ha detto una manifestante bardata con la bandiera americana, non è così che questo Paese è stato fondato, non è così che i nostri Padri fondatori hanno travolto l’impero britannico?
In fondo, non è la Dichiarazione di indipendenza il documento che legittima il diritto a resistere a un potere tirannico? Non è questo il messaggio che i manifestanti vestiti con abiti settecenteschi volevano trasmettere? Le immagini dei «patrioti» che si fanno immortalare seduti sullo scranno del presidente del Senato o della Camera verranno percepite, dall’America profonda che crede in Trump, come la riappropriazione delle istituzioni da parte del popolo sovrano, come l’espressione autentica di quello spirito di libertà che affonda nelle radici della lotta rivoluzionaria. Perché stupirsi, ha detto una manifestante bardata con la bandiera americana, non è così che questo Paese è stato fondato, non è così che i nostri Padri fondatori hanno travolto l’impero britannico?La certificazione dell’elezione di Joe Biden e di Kamala Harris può e deve essere letta come la capacità del sistema di superare la crisi, ma rimane il vulnus rappresentato da un presidente uscente che ha dimostrato fino a che punto si possono mettere in tensione le istituzioni americane e quanto forti siano le aporie del sistema.
Le divisioni che hanno portato per la prima volta dal 1812 a vedere violato l’edificio del Congresso rimangono inalterate perché non sono state alimentate solo da Trump, ma da un Partito repubblicano che ha la responsabilità di aver avallato una presidenza anti-sistema come quella uscente e corteggiato razzismo, suprematismo ed estremismo armato. E se Mike Pence ha avuto la decenza di comprendere che le norme costituzionali non potevano essere stravolte - contravvenendo peraltro a uno dei principi del Partito repubblicano, quello della centralità degli Stati nell’assetto federale -, altri come Ted Cruz e un manipolo di senatori e di deputati che hanno presentato mozioni per contestare il voto in Georgia, Arizona e Pennsylvania, continuano a solleticare gli istinti profondi della base trumpiana, con l’opportunismo miope di chi crede in questo modo di utilizzare il capitale politico e di consenso lasciato in eredità dal quasi ormai ex presidente.
L’interrogativo cruciale, adesso, è se i repubblicani, spaventati da quello che è successo, saranno in grado di fare un passo indietro ed esprimere qualcosa di più di frasi di circostanza per lavarsi la coscienza.
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. Materiali sul tema --- La crisi di governo e le prospettive dell’Italia. Dialogo tra il filosofo Aldo Masullo e lo storico Aurelio Musi.31 agosto 2019, di Federico La Sala
"Pd-5 Stelle, il male minore: salvare il Paese dalla destra"
Dialogo tra il filosofo Aldo Masullo e lo storico Aurelio Musi: gli scenari aperti dalla crisi di governo e le prospettive dell’Italia
 "Le urne un azzardo da evitare"
"Le urne un azzardo da evitare"di AURELIO MUSI (La Repubblica/Napoli, 31 agosto 2019)
Musi: Il segretario del Pd Nicola Zingaretti lo ha chiamato «nuovo governo» per sottolinearne la discontinuità, la svolta rispetto al passato, non il “Conte bis”. «Un governo per il diritto al futuro», «il coraggio di tentare», «fine della stagione dell’odio e della paura», «l’Italia bella a cui vogliamo dare voce», equità, diritti civili, nuovi valori nella politica economica: sono queste le altre dichiarazioni di Zingaretti dopo le consultazioni al Quirinale. Ma l’abbraccio fra populisti e sinistra è davvero il male minore per il nostro Paese? Si può parlare di una conversione al populismo della sinistra o di una sinistra populista? Ne parlo con il filosofo Aldo Masullo, siamo entrambi appassionati osservatori e interpreti delle vicende politiche, soprattutto ora che, in Italia e nel mondo, sembrano dominate più dall’irrazionalità e dalla spinte emotive, che dalla logica. Masullo riflette a lungo, soppesa le parole.
Masullo: «Non mi impiccherei alle forme e alle formule», dice. «È un problema di sostanza e di processi storici. L’Italia è ridotta in condizioni miserevoli: e l’immiserimento è soprattutto nello spirito. Una democrazia parlamentare suppone una società coesa, in cui sia diffusa la cultura civile che invece è andata deperendo. È venuta meno la condizione primaria di una democrazia parlamentare. La crisi della democrazia italiana è la crisi della nostra società. Detto questo, è evidente che ci siamo cacciati in una condizione di necessità. Siamo tra Scilla e Cariddi. Questo nuovo governo da un lato è il tradimento di una democrazia di sinistra. D’altro lato, se rifiutiamo la possibilità del nuovo governo, corriamo il rischio che la Lega riesca a vincere le prossime elezioni. La responsabilità verso il Paese è il fine primario che ci dobbiamo porre. Chi perde non è il singolo partito, ma un popolo intero. Se invochiamo il principio di responsabilità, dobbiamo respingere l’azzardo delle urne".
"L’alternativa è offerta dallo stesso avversario che ci minaccia. Bisogna quindi scegliere la carta del male minore: essa non rappresenta la garanzia di una vera ricostruzione democratica, che viene rinviata ad un secondo tempo. Responsabilmente non possiamo giocare d’azzardo. Dobbiamo cogliere l’occasione e stringere le fila».
Musi: "Il Pd coltiva l’illusione di poter gestire e “disciplinare”, per così dire, i 5 Stelle. L’obiettivo forse sarebbe raggiungibile solo con un partito coeso, con una sola anima, non diviso fra gruppi, fazioni, partitini. Lo scontro Renzi-Zingaretti, l’uscita di Calenda e l’ipotesi di un’ ulteriore scissione non rinviano forse ad una sorta di coazione a ripetere le divisioni, vera maledizione della sinistra?".
Masullo: «Calenda non mi preoccupa, perché il personaggio, pur intelligente, è sempre disposto a mettersi all’opposizione stando dentro o fiancheggiare punzecchiando. Mi preoccupano altri personaggi: Renzi e il gruppo renziano, naturalmente. Si dovrà verificare la loro serietà. Dovranno rendersi conto che incombe una grande responsabilità verso intere generazioni. Il Movimento 5 Stelle è come un piccolo serpente, divorato da un grande serpente, la Lega. È un insieme diversificato senza un legame che l’unisca. Il Pd con i 5 Stelle si allea con un partito pericoloso per la sua friabilità. La variabile è dunque la fermezza e l’unità del Pd. È invece pericolosa la spaccatura interna al P d. È un partito con le stampelle che deve imparare a camminare con i propri piedi. È una società di partiti diversi. Oggi ci troviamo di fronte a un gioco in cui decide in ultima istanza la responsabilità di ognuno».
Musi: "Democrazia diretta e democrazia rappresentativa, populismo Lega, populismo 5 Stelle, piattaforma Rousseau: qui sta forse la profonda incompatibilità tra un soggetto politico che crede fermamente nelle istituzioni e nella democrazia rappresentativa e un altro che, come ha dimostrato durante la fase di alleanza con la Lega, è andato a rimorchio del suo populismo".
Masullo: «Il populismo non è il potere al popolo ma il potere di alcuni che seducono il popolo. La compagnia in cui è costretto a collocarsi il Pd non rappresenta tanto un pericolo in positivo, quanto in negativo. Non la forza, ma la fiacchezza dei 5 Stelle è il vero rischio. La società attuale è una società deformata che ha perduto la fiducia in se stessa, il senso della lotta per la giustizia, che è un vero progetto politico. Tutto allora ritorna sulla stabilità del Pd».
Musi: "Destra/sinistra: esiste ancora la diade, la dicotomia formulata molti anni fa da Norberto Bobbio?".
Masullo: «È un gioco di nomi, di parole. In senso lato esiste ancora un sentimento di destra: la conservazione, senza se e senza ma, della posizione che si ha. Il sentimento di sinistra aiuta gli altri a conquistare una posizione che non hanno. Questo è il motivo dell’unità della destra rispetto alla disunità della sinistra. L’impegno è allora quello di unire i diversi».
Musi: "Forse la sinistra italiana deve tornare sui territori, ricomporre un rapporto lacerato con la società, gettare le basi per costruire un nuovo blocco sociale, come si sarebbe detto una volta...".
Masullo: «Tutto quello che le ho detto prima si potrebbe sintetizzare così: trasformare i molti desideri in un unico progetto. Questa è un’occasione propizia. Se si mette in moto questo processo col nuovo governo, il Pd può iniziare a costruire il progetto unitario. Le sezioni di partito sono deserte. La ricostruzione, di cui abbiamo bisogno, non è solo politico-funzionale, ma di carattere sociale. Una volta c’era la classe operaia con un interesse comune, visibile. Oggi il precariato diffuso accentua divisioni e incompatibilità. Non avendo una base unitaria capace di sorreggere il progetto, bisogna sostituirla con una pratica politica, capace di mettere in piedi le istituzioni barcollanti e creare nuove reti sociali. La politique d’abord: Nenni aveva ragione».
Musi: "Quali le ricadute su Napoli e la Campania del nuovo equilibrio politico nazionale? Non c’è vera svolta senza un rinnovamento delle classi dirigenti locali del Pd. Il limite di Renzi e gli effetti sulla situazione attuale della Campania sono stati soprattutto la scarsa attenzione alle periferie, la conservazione degli equilibri preesistenti, un partito autoreferenziale, tutto dentro le istituzioni, assente nella società civile, ripiegato nei rapporti di potere interni, in preda alla guerra per bande".
Masullo: «La Campania è un deserto politico, immobile, non ci sono forze capaci di costruire un progetto in grado di parlare alla società. Dobbiamo prendere atto con grande amarezza di questo. La Campania deve pregare Iddio che il corso nazionale sia così forte da trascinare quelle poche energie disponibili a mettere in discussione gli equilibri attuali e lavorare per il cambiamento».
Musi: "Un’ultima domanda riguarda il rapporto di lunga durata tra l’intellettuale, il filosofo Masullo e la politica: una sorta di “recherche” sul suo vissuto".
Masullo: «È una domanda che mi fa male, nel senso che a guardare indietro mi rendo conto del fatto che ho rinunciato alla mia attività culturale e scientifica per correre dietro alla politica. Ciò non è dipeso dalla cattiveria della politica, ma semplicemente dal fatto che un intellettuale non può svolgere insieme il lavoro culturale e agire politicamente. Un agire che esige il tuffarsi, l’immergersi totalmente nella politica. Sono rimasto sospeso tra la ricerca scientifica e l’attività politica. Questa non si può ridurre ad un’azione pedagogica: lezioni e conferenze agli operai del Pci, in cui parlavo un linguaggio diverso da quello dei funzionari di partito; interventi al Senato, svolti non in politichese, eccetera. Inevitabilmente ho scontato un deficit di azione politica. Ma non ho corso il rischio di diventare un cinico alla pura ricerca del potere».
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- Conte si è dimesso. Il premier a palazzo Madama: ’Interessi di parte compromettono interesse Italia’.21 agosto 2019, di Federico La Sala
Conte si è dimesso, furia contro Salvini: "Irresponsabile". Al via le consultazioni
Il premier a palazzo Madama: ’Interessi di parte compromettono interesse Italia’.
di Redazione Ansa (21.08.2019)*
"L’azione del governo si arresta qui". E’ quasi a metà del suo intervento nell’aula di palazzo Madama che ieri il premier Giuseppe Conte ha messo la parola fine ai 14 mesi di governo gialloverde aprendo ufficialmente la crisi, con le dimissioni rassegnate al presidente Mattarella che ha avviato le consultazioni a partire dalle 16. Un intervento in cui il presidente del Consiglio difende quanto fatto - "abbiamo lavorato fino all’ultimo giorno" -, ricorda ancora il lavoro da fare, ma soprattutto ne approfitta per lanciare un duro affondo contro Matteo Salvini. Il premier è una furia e non usa giri di parole nel bollare Salvini come "irresponsabile" per aver aperto una crisi solo per "interessi personali e di partito". Un crescendo di accuse che arriva dopo mesi passati a dosare e mediare ogni parola.
Conte ora è senza filtri. Ripercorre i mesi del governo elencando tutti i problemi creati dal leader della Lega, ultimo appunto la decisione di aprire una crisi con il rischio, ricorda Conte, che senza un nuovo esecutivo il Paese andrà in esercizio provvisorio e ci sarà l’aumento dell’Iva: "I comportamenti del ministro dell’Interno rivelano scarsa sensibilità istituzionale e una grave carenza di cultura costituzionale". Il capo del governo che in diverse occasioni si rivolge a Salvini chiamandolo Matteo (Conte è seduto in mezzo ai due vicepremier) lo accusa di aver oscurato quanto fatto dall’esecutivo: "hai macchiato 14 mesi di attività mettendo in dubbio anche quanto fatto dai tuoi ministri". Ma ad un certo punto, il capo del governo arriva a definirsi "preoccupato" da chi "invoca piazze e pieni poteri". L’affondo non si ferma solo alla decisione di mettere fine all’esperienza gialloverde ma tocca anche dossier delicati come il Russiagate.
- Conte: "Al Colle per dimissioni"
Conte gli imputa di non essere andato in Aula e di aver creato problemi allo stesso presidente del Consiglio. Il capo del governo non tiene fuori nulla dal suo intervento nemmeno il ricorso che Salvini all’uso di simboli religiosi. Si tratta per Conte di "uso incosciente di simboli religiosi".
- Salvini bacia il rosario in aula mentre Conte parla
L’INTERVENTO DI SALVINI - "Grazie e finalmente: rifarei tutto quello che ho fatto", ha detto il vicepremier, Matteo Salvini, intervenendo nell’Aula del Senato. "Non ho paura del giudizio degli italiani". Sono qua "con la grande forza di essere un uomo libero, quindi vuol dire che non ho paura del giudizio degli italiani, in questa aula ci sono donne e uomini liberi e donne e uomini un po’ meno liberi. Chi ha paura del giudizio del popolo italiano non è una donna o un uomo libero". "Se qualcuno da settimane, se non da mesi, pensava a un cambio di alleanza, molliamo quei rompipalle della Lega e ingoiamo il Pd, non aveva che da dirlo. Noi non abbiamo paura", ha detto ancora Salvini.
"La libertà non consiste nell’avere il padrone giusto ma nel non avere nessun padrone", ha detto Matteo Salvini citando Cicerone. "Non voglio una Italia schiava di nessuno, non voglio catene, non la catena lunga. Siamo il Paese più bello e potenzialmente più ricco del mondo e sono stufo che ogni decisione debba dipendere dalla firma di qualche funzionario eruopeo, siamo o non siamo liberi?". "Gli italiani non votano in base a un rosario, ma con la testa e con il cuore. La protezione del cuore immacolato di Maria per l’Italia la chiedo finchè campo, non me ne vergogno, anzi sono ultimo e umile testimone". "Voi citate Saviano, noi San Giovanni Paolo II.., lui diceva e scriveva che la fiducia non si ottiene con la sole dichiarazioni o con la forza ma con gesti e fatti concreti se volete completare le riforme noi ci siamo. Se volete governare con Renzi auguri...".
L’INTERVENTO DI RENZI - "Sarebbe facile assistere allo spettacolo sorridendo ma la situazione impone un surplus di responsabilità. Lei oggi presidente del consiglio si dimette ed il governo che lei ha definito populista ha fallito e tutta l’Ue ci dice che l’esperimento populista funziona in campagna elettorale ma meno bene quando si tratta di governare". "No si è mai votato in autunno, c’è da evitare l’aumento dell’Iva e serve un governo non perchè noi ci vogliamo tornare ma perchè l’aumento dell’Iva porta crisi dei consumi non è un colpo di Stato cambiare il governo ma un colpo di sole aprire la crisi ora ora, questo è il Parlamento non il Papeete". Le parole di Conte sono "da apprezzare" ma c’è il "rischio di una autoassoluzione", ha detto in una nota il Segretario del Pd Nicola Zingaretti. Per questo "qualsiasi nuova fase politica non può non partire dal riconoscimento di questi limiti strutturali di quanto avvenuto in questi mesi".
- Governo, Salvini: "Adesso mi spiego i tanti ’no’"
* http://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2019/08/20/governo-in-senato-e-il-giorno-di-conte_57d1a36a-11ff-48b7-ba74-d2380fb14a93.html (ripresa parziale - sena immagini e allegati).
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. Materiali sul tema - Il capo carismatico e l’identificazione con l’oppressore (di Sarantis Thanopulos)27 luglio 2019, di Federico La Sala
Il capo carismatico e l’identificazione con l’oppressore
di Sarantis Thanopulos (il manifesto, 27.07.2019)
Dalle elezioni politiche del 2013, il paese uscì quasi equamente diviso in tre poli: il centrosinistra, il centrodestra e il M5S. Bersani, il segretario del Pd di allora, cercò di aprire la prospettiva di un dialogo con i “grillini”. Il suo progetto, per niente ingenuo, anzi lungimirante, fallì, anche per l’arroganza dei suoi interlocutori (che ne pagano ora le conseguenze). Un’alleanza tra il centrosinistra e il centrodestra portò ai governi di Letta, di Renzi e di Gentiloni. Questi governi non sono riusciti a risolvere nessuno dei problemi strutturali del paese o a porre le basi di una soluzione futura. La disgregazione delle alleanze socioculturali che sostenevano il centrosinistra si è consolidata e le elezioni di un anno fa l’hanno marginalizzato.
Il fenomeno M5S non è mai stato espressione di un processo trasformativo. La sua presenza è, nondimeno, manifestazione, pur confusa e dispersivamente protestataria (e manipolabile), del disagio stagnante e impotente del popolo, in particolare dei ceti sociali che la sinistra dovrebbe rappresentare. Eppure si persevera nel rifiutare di riconoscere che non essendo il centrosinistra autarchico, né potendo esserlo nel prossimo futuro, qualcosa dovrebbe muoversi sul piano del confronto con i 5S. Dopo la scelta catastrofica di spingerli tra le braccia di Salvini, di cui tutti gli “opinion leader” del centrosinistra, che ora non sanno che pesci pigliare, ripetendo slogan stantii, hanno una responsabilità enorme, il nuovo segretario del Pd, un uomo politico decente, ha definito il partito concorrenziale al M5S e “alternativo” alla Lega.
È così difficile percepire l’evidente? La sinistra non è alternativa, nell’ambito di un’“alternanza” democratica, a un partito razzista, retrogrado e profondamente autoritario come la Lega. Non offre soluzioni alternative (è meglio la frittella o il gelato di prima mattina?) a quelle barbariche di Salvini, ma opposte, nell’ambito di un’incompatibilità totale, la stessa che esiste tra democrazia e autoritarismo totalitario.
Nel campo di questa opposizione fondamentale, da cui dipende il futuro democratico del paese, la concorrenza necessaria con il M5S deve includere la prospettiva di un’alleanza, altrettanto necessaria, almeno con una sua parte e soprattutto con gli interessi reali, mal rappresentati, del suo elettorato tendente ora a disperdersi nell’astensionismo.
Salvini è stato fortemente avvantaggiato dall’essergli stato permesso di andare al governo. Com’era prevedibile, sta procedendo, usando tutti i mezzi a disposizione, complice la scarsa opposizione da parte delle istituzioni democratiche di controllo, a una doppia fidelizzazione. Quella dei funzionari dello stato più sensibili alla demagogia del potere (il piacere sadomasochistico di sentirsi forti con i deboli e deboli con i forti). Quella delle masse disorientate e scollegate dai legami solidali che investendo il capo carismatico e autocratico, incarnano in lui un principio di deresponsabilizzazione: ciò da una parte li fa sentire,
llusoriamente, liberi e, dall’altra, li fa pensare non colpevoli, non punibili in un mondo di repressione, punizione. Nella doppia fidelizzazione, di cui Salvini è insieme vittima (pericolosa) e promotore, gioca un ruolo fondamentale l’“identificazione con l’aggressore”: l’identificazione con le forze minaccianti la propria umanità, trovatasi in condizione di precarietà, che crea un senso di invulnerabilità, al prezzo di una grave alienazione. Con tutte le perplessità che si possono avere nei loro confronti, i 5S sono perlopiù periferici a questo processo e piuttosto che cercare di omologarli ad esso è meglio cercare di recuperarli.
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- POESIA E FUTURO RADICALE: L’ ITALIA, LE “ROBINSON-NATE”, E LA “POESIA” DEL PRESENTE.21 giugno 2019, di Federico La Sala
L’ ITALIA, LE “ROBINSON-NATE”, E LA “POESIA” DEL PRESENTE ... *
- “Oggi assistiamo a una sorta di crisi di intelligibilità, che in diverse diagnosi sembra avere a che fare con la fine di un mondo e delle sue pratiche, di una forma di vita leggibile: fine della società letteraria, fine della politica nella sua concezione novecentesca... (...) Che cosa sarebbe della poesia, e anche del suo rapporto critico con la società, se questo nostro tempo, come spesso diagnosticato, costituisse davvero l’epoca della sua fine, della fine del modo in cui ne abbiamo inteso il senso sino a ora? ” (Italo Testa, “Autorizzare la speranza. Poesia e futuro radicale” , "Le parole e le cose", 21 marzo 2019).
“OGGETTO: Per la nostra sana e robusta Costituzione.... ” (Mail, 2002): “[...] Tempo fa una ragazza, a cui da poco era morta la madre e altrettanto da poco cominciava ad affermarsi il partito denominato “Forza Italia”, discutendo con le sue amiche e i suoi amici, disse: “Prima potevo gridare “forza Italia” e ne ero felice. Ora non più, e non solo perché è morta mia madre e sono spesso triste. Non posso gridarlo più, perché quando sto per farlo la gola mi si stringe - la mia coscienza subito la blocca e ricaccia indietro tutto. Sono stata derubata: il mio grido per tutti gli italiani e per tutte le italiane è diventato il grido per un solo uomo e per un solo partito. No, non è possibile, non può essere. E’ una tragedia!”. Un signore poco distante, che aveva ascoltato le parole della ragazza, si fece più vicino al gruppo e disse alla ragazza: “Eh, sì, purtroppo siamo alla fine, hanno rubato l’anima, il nome della Nazionale e della Patria. E noi, cittadini e cittadine, abbiamo lasciato fare: non solo un vilipendio, ma un furto - il furto dell’anima di tutti e di tutte. Nessuno ha parlato, nessuno. Nemmeno la Magistratura!” (Si cfr. RESTITUITEMI IL MIO URLO! ... DALLA CINA UNA GRANDE LEZIONE!).
ITALIA, 2 GIUGNO 2019. A pag. 2 dell’inserto “ROBINSON” (n. 130) di “la Repubblica” del 1° Giugno 2019, in un testo con il titolo “Mia madre, il Re e la cosa di tutti “, e il sottotitolo “Il 2 giugno 1946 l’Italia scelse di non essere più una monarchia. Lessico familiare del Paese che puntò su se stesso”. L’autore - dopo aver premesso che “una persona sola che incarna lo Stato e incarna il popolo intero non può che essere, essere, simbolicamente, una persona «sacra»“, e chiarito che “è per definizione, per ruolo un signore al di sopra delle parti, non rappresenta una frazione, rappresenta l’intero. L’unità. La comunità. (...) la sua carica è elettiva. Non è un raggio divino, e nemmeno il raggio della Storia attraverso l’espediente dinastico, a fargli incarnare «la cosa di tutti»” (...) La repubblica è anti-assolutista anche in questo suo sapiente scegliere gli uomini che la incarnano a seconda dei sommovimenti della politica e della società (...) così si avvia alla conclusione: “Dunque si è repubblicani - o almeno lo sono io - se si ama e si accetta ciò che non è assoluto, NON SIMULA L’ETERNO, ACCETTA IL LIMITE, lo traduce in politica”.
E, INFINE, l’autore così CHIUDE: “Mi rimane da dire che quando Eugenio Scalfari fondò un giornale che si chiamava «la Repubblica» andavo all’università e subito pensai: che bel nome! Che nome giusto per un giornale! Ma come è possibile che a nessuno prima di lui, sia venuto in mente di chiamare così un pezzo di carta che si occupa soprattutto della «res publica», della cosa di tutti, e lo fa tutti i giorni? E’ al tempo stesso un nome umile e alto. Peggio per chi non se ne è accorto prima” (Michele Serra).
POESIA, COSTITUZIONE, E FUTURO RADICALE...: “Come certi capi indiani che si trovarono di fronte al fatto che, una volta entrati nelle riserve, non risultasse più comprensibile cosa fosse un atto coraggioso, quale attività potesse esemplificarlo, visto che le pratiche che sino ad allora avevano dato senso a tali attività erano venute meno - i bisonti scomparsi, le guerre con altre tribù proibite” (Italo Testa - sopra).
ITALIA: “ESAME DI MATURITA’ 2019”. - PER UN CONVEGNO E UNA RIFLESSIONE SUL CONCETTO DI UNITÀ E DI SOVRANITÀ (SOVRA-UNITÀ). Materiali sul tema.
Federico La Sala (20 giugno 2019)
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- UNA LEZIONE TEOLOGICO-POLITICA DI BAGET BOZZO SU OGNI PROGETTO DI "RIFONDAZIONE COMUNISTA" FUTURA CHE SI VUOLE COME PARTITO. Avanti o popolo alla riscossa. Il populismo trionferà: "Forza Italia"!!!
"SCORPIONE E FELICE". RIDENDO E SCHERZANDO, MARX TROVA "LA PIETRA FILOSOFALE" DEL SUO CAMMINO.
UNA CATTOLICA, UNIVERSALE, ALLEANZA "EDIPICA"!!! IL MAGGIORASCATO: L’ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE, L’ALLEANZA DELLA MADRE CON IL FIGLIO, REGNA ANCORA COME IN TERRA COSI’ IN CIELO
KANT E GRAMSCI. PER LA CRITICA DELL’IDEOLOGIA DELL’UOMO SUPREMO E DEL SUPERUOMO D’APPENDICE.
Federico La Sala
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. Materiali sul tema - Csm a pezzi. "Una ferita profonda e dolorosa". Di "un giorno cupo come pochi altri"5 giugno 2019, di Federico La Sala
IL PENSIERO DELLA COSTITUZIONE E LA COSTITUZIONE DEL PENSIERO *
- Costituzione, art. 54 - Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
- I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
CRONACA
Csm a pezzi*
- [Foto] La sala del Plenum straordinario del Csm presso Palazzo dei Marescialli, con i posti vuoti dei magistrati Corrado Cartoni e Antonio Lepre (Fotogramma)
"Una ferita profonda e dolorosa", un "passaggio delicato" che richiede una reazione forte e immediata: o si riscatta "con i fatti il discredito che si è abbattuto su di noi o saremo perduti". E’ affidato alle parole del vicepresidente David Ermini il senso di una crisi istituzionale senza precedenti che ha scosso il Consiglio superiore della magistratura per effetto dell’Inchiesta di Perugia, nella quale sono indagati Luca Palamara, e Stefano Rocco Fava, pm a Roma, e il togato dimissionario del Csm Luigi Spina. Ma la sua non era l’unica sedia vuota ieri pomeriggio nell’aula Bachelet dove si è riunito un plenum straordinario convocato a seguito della bufera che ha travolto il Consiglio e l’interra magistratura italiana: quattro togati si sono autosospesi.
Lunedì sera Corrado Cartoni e Antonio Lepre, di Magistratura Indipendente, non indagati ma che avevano preso parte a incontri con gli esponenti del Pd Luca Lotti e Cosimo Ferri per discutere della nomina del procuratore di Roma, e ieri, annunciandolo poco prima del plenum, Gianluigi Morlini, di Unicost, e Paolo Criscuoli di Mi. Ma dall’assemblea di Palazzo dei Marescialli, insieme alla presa d’atto della gravità della situazione, arriva anche una forte assunzione di responsabilità e un richiamo alla compattezza: con un documento approvato all’unanimità tutti i consiglieri, laici e togati, si dicono "sgomenti e amareggiati", denunciano comportamenti da cui "prendere con nettezza le distanze" e richiamano la necessità di "un radicale percorso di autoriforma. E da più parti arriva il riconoscimento al vicepresidente Ermini di una gestione saggia, ferma e responsabile della situazione e al valore imprescindibile della guida del capo dello Stato, Sergio Mattarella, che del Csm è il presidente.
Di "un giorno cupo come pochi altri" per il Csm parla il togato di Autonomia &indipendenza Piercamilo Davigo, che esprime apprezzamento per la posizione unitaria su cui tutti i consiglieri si sono ritrovati facendo prevalere allo "spirito di appartenenza o di fazione" la "tutela dell’Istituzione". Michele Ciambellini, di Unicost, invita il Consiglio a dare "una risposta seria energica senza ambiguità e a percorrere insieme una strada che riaffermi il prestigio dell’Istituzione". Da Giuseppe Cascini, di Area, il paragone forte del momento "grave e drammatico" con i tempi dello scandalo della P2. Invita a una "generale presa di coscienza" il primo presidente della Corte di Cassazione Giovanni Mammone, che esprime l’auspicio che "la consapevolezza costituisca un valido deterrente a che ulteriori comportamenti individuali vengano adottati in violazione delle regole fondamentali della deontologia".
Il laico M5S Fulvio Gigliotti si dice certo che il Csm "continuerà a mantenere quell’alto livello di garanzia e credibilità istituzionale" attraverso "il più attento rigore e la massima fermezza" nelle funzioni che tutti i componenti sono chiamati a esercitare. Al centro delle riflessioni di Ermini, inevitabilmente, anche il tema delle nomine ai vertici degli uffici che devono essere "trasparenti", compiute "fuori da logiche spartitorie", e preservate dalle "degenerazioni correntizie" e dai "giochi di potere" che sono emersi dall’inchiesta dei pm perugini. E ogni determinazione del Consiglio deve essere assunta "al riparo da interessi esterni" e "al solo fine di assicurare l’efficienza e la conformità alla costituzione dell’attività giurisdizionale" il tutto sotto la "guida illuminata" del Capo dello Stato. Il plenum ha anche preso atto delle dimissioni di Spina e ha deliberato il suo rientro in ruolo alla procura di Castrovillari, suo ufficio di provenienza.
* SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
LUNGA VITA ALL’ITALIA: "RESTITUITEMI IL MIO URLO"!!! Dalla Cina, la lezione di Huang Jianxiang. A Lui, in omaggio perenne (2006)
Federico La Sala
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. -- Dalla ragione costituzionale alla ragione populista. Le responsabilità della sinistra. Note.8 febbraio 2019, di Federico La Sala
STORIA DELLA QUESTIONE INFAME. Dal Discorso (Logos) della Costituzione al Logo del Partito della Democrazia Deformata...
- Erminio Risso, "Rino Genovese, impurità dei tempi" (Alfabeta-2, 16 giugno 2017)
- Rino Genovese, Le responsabilità della sinistra italiana nell’affermarsi dei populismi /1 ("Le parole e le cose", 08.02.2019).
Se FERRERO è FERRERO, VENDOLA è VENDOLA, GIORDANO è GIORDANO, BERTINOTTI è (ancora) BERTINOTTI, VELTRONI è (ancora) VELTRONI, e PRODI è (ancora) PRODI ... UNA MOBILITAZIONE CULTURALE GENERALE, SUBITO - ORA. Un appello ... “Al Pd serve un padre.”. Intervista a Romano Prodi
UNA LEZIONE TEOLOGICO-POLITICA DI BAGET BOZZO SU OGNI PROGETTO DI “RIFONDAZIONE COMUNISTA” FUTURA CHE SI VUOLE COME PARTITO. Avanti o popolo alla riscossa. Il populismo trionferà: “Forza Italia”!!!
STORIA DELLA QUESTIONE INFAME: COME L’ITALIA, UN PAESE E UN POPOLO LIBERO, ROVINO’ CON IL “GIOCO” DEI “DUE” PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA.
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- FRANCIA."Rimane da spiegare come una azione dì 36 milioni di abitanti abbia potuto essere colta alla sprovvista da tre cavalieri di industria e ridotta in schiavitù senza far resistenza" (K. Marx).7 febbraio 2019, di Federico La Sala
POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. IL PENSIERO DELLA COSTITUZIONE E LA COSTITUZIONE DEL PENSIERO... *
- FRANCIA."Rimane da spiegare come una azione dì 36 milioni di abitanti abbia potuto essere colta alla sprovvista da tre cavalieri di industria e ridotta in schiavitù senza far resistenza" (K. Marx, Il 18 brumaio di Luigi Bonaparte)
Prodi
"Al Pd serve un padre. Zingaretti può diventarlo. Decisivo votare alle primarie"
L’ex premier invita a recarsi in massa ai gazebo: “Sarà fondamentale, un leader prende forza dal suo popolo. Importante il segnale delle Regionali: alle Europee va fermata la tendenza nazionalista e autoritaria dei populisti”
Intervista di Andrea Bonanni (la Repubblica, 07.02.2019)
BOLOGNA «Da ormai troppo tempo ci si azzuffa nel governo e nel Pd. Eppure l’Italia e il Pd avrebbero tanto bisogno di un padre: è un sentimento che vedo crescere in tutti gli italiani.»
Presidente Prodi, ma il padre del Pd non sarebbe lei?
«Al massimo io sono un nonno. Uno che fa molte prediche e cerca di ispirare buoni comportamenti E tale voglio rimanere».
Quali buoni comportamenti?
«Il primo è quello di andare assolutamente a votare alle primarie. L’affluenza ai gazebo avrà un’importanza enorme. Il numero degli elettori dovrà essere così elevato da dimostrare che il Partito democratico si pone come un’alternativa credibile: oggi è l’unica alternativa possibile. Andare a votare significa affermare la nostra identità. E il vincitore del confronto deve essere il leader indiscusso del partito. Basta leadership per interposta persona».
Un padre, dice?
«Certo. Usciamo da anni in cui sia il partito, sia il Paese, si sono estenuati in diatribe continue, rancori, isterismi, proclami ignoranti e liste di proscrizione. Per il Paese, spero che il padre non sia qualcuno che ha sempre bisogno di mettersi in divisa per apparire forte. Per il Partito democratico c’è bisogno di una figura autorevole, che sappia finalmente ascoltare, riconciliare, tranquillizzare ma anche decidere».
Questa figura può essere Zingaretti?
«Se intensifica il lavoro di allargamento e di pacificazione che ha iniziato, le sue possibilità sono molte, ma lo dovranno decidere le centinaia di migliaia di cittadini che voteranno alle primarie. Un leader prende forza dal suo popolo. E per dare forza alle primarie saranno di grande importanza i segnali che manderanno le elezioni in Abruzzo e in Sardegna. Il Pd ha in entrambi i casi i candidati più autorevoli: sono fiducioso proprio perché sento che si sta esaurendo il tempo nel quale competenza ed esperienza sono visti come un valore negativo. E poi, naturalmente, ci saranno le europee».
Le elezioni europee si avvicinano mentre i due partiti populisti al governo polemizzano con Bruxelles, con Parigi, con Berlino e perfino con l’Olanda. E invece il campo progressista stenta a ritrovarsi sotto la bandiera europea. Dovunque governino gli antieuropeisti, dalla Gran Bretagna all’Ungheria alla Polonia, le bandiere dell’Europa sventolano in piazza come segno di protesta. Qui da noi non sventola nulla...
«Le vedremo, le bandiere dell’Europa. Forse non si è ancora riflettuto abbastanza sull’importanza di ritrovarci sotto simboli comuni. Per questo ho lanciato l’idea che il 21 marzo in tutte le case si esponga la bandiera europea accanto a quella italiana. L’Unione europea è indispensabile per il nostro benessere e per il nostro futuro di cittadini liberi. Dobbiamo capirlo e dobbiamo dirlo con forza».
Invece gli italiani sembrano diventati euroscettici...
«Quando abbiamo fatto l’euro e quando abbiamo voluto l’allargamento, gli italiani erano i più decisi sostenitori di quelle scelte. E sa perché? Perché capivano che l’Europa prendeva decisioni per il futuro di tutti. Ma da allora questa capacità di prender decisioni si è indebolita nell’Ue. Con la bocciatura del progetto di Costituzione da parte dei francesi, il potere è passato dalla Commissione al Consiglio. È ritornato agli stati membri. Non si guarda più al bene collettivo ma all’interesse nazionale. I populisti vorrebbero accentuare ancora questa rinazionalizzazione del nostro destino. Le prossime elezioni europee devono ribaltare questa tendenza».
Che valore politico ha, oggi, la bandiera europea?
«Innanzitutto rappresenta il nostro futuro, quello dei nostri figli e dei nostri nipoti. Come ripeto sempre agli studenti, gli italiani sono quelli che meglio dovrebbero capirlo. Nel Rinascimento l’Italia dominava il mondo. Ma gli staterelli italiani divisi furono spazzati via dalla prima globalizzazione della storia: la scoperta dell’America. Oggi, con la globalizzazione totale, neppure la Germania, da sola, ha la forza di costruire le nuove caravelle, che si chiamano Google, Amazon, Alibaba, Tencent, Microsoft. Dobbiamo fare l’Europa prima che l’intelligenza artificale e la rete 5G ci distruggano completamente».
Non sembra proprio l’aria che tira, presidente. Tantomeno in Italia...
«Questa maggioranza ha dovuto intanto prendere atto che chiedere l’uscita dall’euro e dall’Unione europea sarebbe un suicidio, anche se non perde occasione per sparare sulla Francia, sulla Germania e persino sull’Olanda, per soffiare sul fuoco del nazionalismo come ha fatto su quello del razzismo e della xenofobia. Vogliono un’Europa debole e divisa perché vogliono una società debole anche in Italia.
 Si tratta di forze che praticano una politica autoritaria e verticale, dall’alto verso il basso, ignorando i corpi intermedi e la società civile, che siano i sindacati, gli enti locali, le imprese o la stampa. Persino il Parlamento è stato svuotato della sua funzione, violando nei fatti il dettato costituzionale. Certo, quello dell’autoritarismo è un vento che soffia su tutto il mondo.
Ma la complessità e la ricchezza del tessuto democratico sono gli elementi costitutivi dell’Europa e della nostra libertà. Anche per questo dobbiamo difenderla».
Si tratta di forze che praticano una politica autoritaria e verticale, dall’alto verso il basso, ignorando i corpi intermedi e la società civile, che siano i sindacati, gli enti locali, le imprese o la stampa. Persino il Parlamento è stato svuotato della sua funzione, violando nei fatti il dettato costituzionale. Certo, quello dell’autoritarismo è un vento che soffia su tutto il mondo.
Ma la complessità e la ricchezza del tessuto democratico sono gli elementi costitutivi dell’Europa e della nostra libertà. Anche per questo dobbiamo difenderla».E invece nel Pd sono riusciti a produrre due manifesti sull’Europa: quello di Calenda e quello degli eurodeputati. Non le sembra un po’ troppo?
«I valori, i concetti e i programmi dei due manifesti sono identici e condivisi da tutti. Le divergenze sono su come applicarli».
Grande coalizione europeista o liste separate che corrono in parallelo?
«Ma è proprio questo il punto. Si tratta di decisioni solo pragmatiche, da prendere tenendo in considerazione che esiste il sistema proporzionale ma esiste anche la soglia di sbarramento del 4 per cento. Gli europeisti devono muoversi in modo da ottimizzare il loro risultato complessivo. E queste decisioni spettano al nuovo leader del Partito democratico. Per questo deve ricevere una investitura popolare forte, tale da conferirgli di fatto la paternità non solo del partito ma di quella maggioranza di italiani che continua a credere nell’Europa. Come me».
Consigli al presidente del Lazio? Intensificare il lavoro di allargamento e di pacificazione che ha iniziato L’Europa è la garanzia della nostra libertà, dobbiamo farla prima che intelligenza artificiale e rete 5G ci distruggano
 Il professore
Il professore
 Romano Prodi, 79 anni, due volte presidente del Consiglio, ha guidato la Commissione europea dal 1999 al 2004
Romano Prodi, 79 anni, due volte presidente del Consiglio, ha guidato la Commissione europea dal 1999 al 2004
*
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- Se FERRERO è FERRERO, VENDOLA è VENDOLA, GIORDANO è GIORDANO, BERTINOTTI è (ancora) BERTINOTTI, VELTRONI è (ancora) VELTRONI, e PRODI è (ancora) PRODI ... UNA MOBILITAZIONE CULTURALE GENERALE, SUBITO - ORA. Un appello
MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA E A PENSARE BENE "DIO", "IO" E "L’ITALIA", CHI PIÙ CHI MENO, TUTTI VIVONO DENTRO LA PIÙ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA E POLITICA ITALIANA, NEL REGNO DI "FORZA ITALIA"!!!
IL SONNO MORTIFERO DELL’ITALIA. In Parlamento (ancora!) il Partito al di sopra di tutti i partiti.
Federico La Sala
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. - A cento anni da "La politica come professione" di Max Weber. Stato democratico, partiti, e rovina della democrazia.31 gennaio 2019, di Federico La Sala
A cento anni da La politica come professione di Max Weber /
L’ultimo eroe. Conversazione con Massimo Cacciari
di Francesco Bellusci (Doppiozero, 28.01.2019)
Cento anni fa, il 28 gennaio del 1919, nelle aule dell’università di Monaco di Baviera, un anno prima della morte, Max Weber tenne una delle sue più celebri conferenze: La politica come professione. In occasione dell’anniversario, la Mondadori ha da poco ristampato l’edizione che contiene questa conferenza e quella tenuta due anni prima, nella stessa università, La scienza come professione, con il titolo: Il lavoro intellettuale come professione, a cura e con l’introduzione di Massimo Cacciari. Il politico vero, secondo Weber, è chi, con perseveranza, senza mai scoraggiarsi, tenta di conciliare vocazione, dedizione alla causa, adesione convinta a determinati valori, con spirito progettuale, professionismo, responsabilità rispetto ai fini, previsione dei mezzi adeguati alla loro realizzazione e delle conseguenze dell’azione. Un traguardo originale che Weber indica agli studenti e ai giovani che lo ascoltano, in un momento storico drammatico per la Germania, nel passaggio dalla monarchia alla repubblica, e per la città stessa di Monaco, scossa da agitazioni rivoluzionarie, consapevole di come l’agire politico, nel contesto della società di massa, possa generare tanto democrazie mature quanto avventure totalitarie o populismi. Di questa straordinaria attualità della lezione del sociologo tedesco abbiamo parlato con Massimo Cacciari.
Francesco Bellusci: Professor Cacciari, lei ha sempre sostenuto l’importanza di questa conferenza di Weber, presentandola come una lezione propedeutica a ogni corso di formazione politica, soprattutto se rivolto ai giovani. Comincio col chiederle: perché conciliare etica dei principi ed etica della responsabilità è però sempre difficile, forse impossibile, e tuttavia l’agire politico non può e non deve ridursi mai all’uno o all’altro, pena il suo snaturamento?
Massimo Cacciari: Il politico di Weber è un "tipo", non la descrizione di qualche "contingenza"; aiuta a far ordine, a comprendere macro-tendenze generali. La realtà è sempre poi una commistione di "tipi". E ogni commistione è poi storicamente relativa. Il "tipo ideale" del politico è chi formula fini "economicamente" raggiungibili, chi si distingue dal profeta e dal demagogo, chi dispone, sì, di un carisma, ma collegato alla sua Zweckrationalität. Si tratta di un ibrido già in sé - ma la maionese impazzisce se c’entrano altri elementi!
Già in L’Arcipelago (Adelphi, Milano 1997), lei rifletteva sull’“ultimo eroe” weberiano. Eroico perché accetta la possibilità che i propri progetti s’infrangano o si ridimensionino sullo scoglio della macchina burocratica e, nello stesso tempo vede, in questa il mezzo indispensabile per la realizzazione di quei progetti. Ma lei insiste anche sul fatto che la vocazione del politico è una “chiamata” che, nel tempo della “morte di Dio” e della “svalorizzazione” dei valori trascendenti (Weber è uno dei primi che apprende a fondo la lezione di Nietzsche), non proviene più da un’autorità extra-umana o da un ordine necessario. Allora: chi “chiama” il politico, a questo compito nella sua vita?
Massimo Cacciari: Chi chiama il politico? Nessuno - la voce del silenzio - la sua "voglia" di rispondere, cioè la sua responsabilità nei confronti di una situazione che intende mutare. Oppure (e anche qui ecco il "doppio") la sua volontà di potere - senza la quale non esiste politico, comunque. Il "tipo" del politico che Weber propone si distacca nettamente da ogni sfondo religioso.
Sono passati più di dieci anni dall’edizione che lei ha curato delle due conferenze. Rispetto ad allora, si sono accentuate alcune tendenze che segnalano la crisi della democrazia rappresentativa. Oggi, il “demagogo” populista prende di mira ora i partiti tradizionali, ora la burocrazia, additandoli come un ostacolo o addirittura una specie di nemico interno per i suoi progetti, presentati come specchio fedele degli interessi popolari. Cioè, prende di mira i due cardini dello Stato democratico moderno per Weber, intesi rispettivamente come la fucina dei “politici di professione” e dei “funzionari specializzati”. È ancora valido il modello di Weber?
Massimo Cacciari: Ciò riguarda la democrazia in generale. Il processo di democratizzazione non era concepibile per Weber senza partiti. Partiti e Stato democratico costituivano un insieme inscindibile. Eppure nient’affatto pacifico - poiché il partito (parte) tende naturalmente a farsi Stato, e cioè a rovinare la democrazia. Bisognava mantenere il rapporto in una "equilibrata tensione" - ecco di nuovo l’eroismo del vero politico!
Adesso, le chiederei qual è il nesso con la conferenza che Weber tiene due anni prima, nel 1917, La scienza come professione. Come si configura per Weber il rapporto tra l’uomo di scienza e l’uomo di azione? In che senso egli considera la scienza e la prassi politica come due forme del lavoro intellettuale? Lo scetticismo su scoperte e applicazioni scientifiche, introdotto nel dibattito pubblico, dimostra come la scienza e la razionalità scientifica, in quanto “valori” e “decisioni” dell’Occidente moderno, non si possano sottrarre al dramma inestinguibile del conflitto di valori. Un aspetto che lei sottolinea nelle prime pagine dell’Introduzione, quando, interpretando anche il Weber metodologo delle scienze storico-sociali, ci dice che la scienza verrebbe meno al suo stesso rigore se avanzasse il suo primato sugli altri saperi, perché - scrive - “la scienza è relativa in quanto all’origine”, ma - aggiunge - “non è relativistica in quanto al suo metodo e al suo rapporto con la realtà che intende comprendere”.
Massimo Cacciari: Scienza e politica formano insieme la "geistige Arbeit" - devono funzionare insieme. Non vi è Stato moderno senza lavoro scientifico, senza rapporto con la Tecnica. E non vi è Tecnica se non sia intrinseca allo Stato. Eppure anche qui si tratta di Due e non di Uno! Ecco il politico di nuovo: che conosce l’essenzialità del lavoro scientifico e in uno conserva l’autonomia delle proprie decisioni. La "politica al comando" è altrettanto utopistica di una "scienza autonoma". Il capitalismo è essenzialmente il sistema che le unifica nel loro stesso contraddirsi.
Si può dire che l’“ultimo eroe”, cioè il politico di vocazione, fosse per Weber l’antidoto agli “ultimi uomini” di cui parla Nietzsche nello Zarathustra e che egli menziona nelle celebri pagine finali dell’Etica protestante e lo spirito del capitalismo? È nel Berufspolitker che Weber confida, per contrastare il destino di un mondo sociale totalmente amministrato e burocratizzato che intravede nel futuro dell’Occidente?
Massimo Cacciari: Weber cita esplicitamente Nietzsche a proposito degli "ultimi uomini" - sono gli "impiegati" senza spirito e i gaudenti (coloro che si godono il proprio benessere) senza cuore. Sono gli invidiosi, gli egoisti, Aristotele avrebbe detto i rappresentanti della pleonexia. Il sistema capitalistico li genera e rigenera - vi sarà un politico in grado di governarli? Weber alla fine della vita ne era disperato.
Weber vedeva, al suo tempo, l’imprenditore industriale moderno come indisponibile alla carriera del “politico di professione”, in quanto inesorabilmente assorbito dalla gestione razionale della sua impresa. Da Berlusconi a Trump, ormai anche il tycoon sembra proporsi come capo politico. Come spiega questo fenomeno? Espone sempre al rischio di una commistione o di una confusione tra l’“impresa politica” e l’“impresa economica”?
Massimo Cacciari: La commistione tra politica e economia genera il capitalismo politico - politica diviene mero attributo. Credo che sia proprio questa la fase che attraversiamo. Non se ne esce regressivamente, nella nostalgia di un "metti la politica al comando" - ma con politici in grado di contra-dire l’economico, di esserne potenti interlocutori - e cioè politici di vocazione dotati di strutture tecnico-organizzative adeguate. Siamo tanto lontani da questa situazione da avvertire l’idea come un’astratta utopia... e questo la dice tutta.
Per Weber, la vanità condanna un politico sempre all’insuccesso o al tramonto o, comunque, ne pregiudica la performance. È d’accordo?
Massimo Cacciari: La vanità è l’opposto della volontà di potenza. quest’ultima sa che cosa deve avere per funzionare e sa calcolare i propri obbiettivi per riuscire. La vanità crede di potere tutto. È esattamente ciò che rovina il politico di professione.
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. - La "nostra" democrazia sta cambiando. Un mutamento iniziato nel 1994 (di Ilvo Diamanti).28 gennaio 2019, di Federico La Sala
Mappe
Gli italiani vogliono il leader forte, piace la democrazia senza partiti
Oramai soltanto l’8% esprime fiducia nelle formazioni partitiche. Quattro su 10 pensano che la democrazia possa funzionare anche senza di loro. Un mutamento iniziato nel 1994
di Ilvo Diamanti (la Repubblica, 27.01.2019)
La "nostra" democrazia sta cambiando. Non da oggi. Ma, da qualche tempo, i segni del mutamento appaiono più evidenti. In Italia come (e più che) altrove. Mi riferisco, specificamente, alla democrazia "rappresentativa". E, in particolare, al declino dei partiti. Il principale canale della rappresentanza. La "democrazia dei partiti", che abbiamo conosciuto nel corso del dopoguerra, si è trasformata in "democrazia dei leader". Anzitutto, perché i partiti si sono "personalizzati".
Soprattutto, a partire dagli anni Novanta, dopo il crollo della Prima Repubblica. E dei partiti che l’avevano accompagnata. La svolta, allora, venne segnata da Silvio Berlusconi. L’imprenditore dei media, presidente del Milan, che divenne imprenditore politico.
 Giusto 25 anni fa, nel 1994, "scese in campo", mutuando tecniche e linguaggi dall’impresa e dal calcio. Fondò "Forza Italia" e denominò "azzurri" i suoi elettori. FI apparve subito un "partito personale" - come lo definì Mauro Calise. Ideologia, organizzazione, dirigenti: tutti espressi da Berlusconi.
Riconducibili alla sua persona.
Giusto 25 anni fa, nel 1994, "scese in campo", mutuando tecniche e linguaggi dall’impresa e dal calcio. Fondò "Forza Italia" e denominò "azzurri" i suoi elettori. FI apparve subito un "partito personale" - come lo definì Mauro Calise. Ideologia, organizzazione, dirigenti: tutti espressi da Berlusconi.
Riconducibili alla sua persona.Alle sue aziende. Forza Italia era - e rimane - il "partito di Berlusconi". Il Partito del Capo (definizione di Fabio Bordignon). Un modello riprodotto da altri soggetti politici. Con alterno esito. Ma, in una certa misura, tutti i partiti, dopo quella fase, si sono "personalizzati". Fino a divenire, talora, "personali". In-distinguibili dalla persona del Capo.
Basti pensare, per primo, al partito, anti-berlusconiano, per definizione. L’Italia dei Valori. Il partito "di" Antonio Di Pietro. Magistrato simbolo di "Mani pulite". Censore implacabile dei conflitti di interesse del Cavaliere. L’IdV agisce in simbiosi con Di Pietro. A sua immagine. Mentre "scendono in campo" altri "partiti personali".
Su basi diverse. Alleanza Nazionale, ad esempio, nasce nel 1995. A destra. Per superare il retroterra e il marchio post-fascista del MSI. Per andare oltre, Fini "personalizza" il partito. Lo trasforma nel Partito di Fini.
Lo stesso percorso avviato, successivamente, da Mario Monti. Dopo l’esperienza di governo, dal novembre 2011 al dicembre 2012, si presenta alle elezioni del 2013 a "capo" di una coalizione centrista, de-nominata: "Con Monti per l’Italia". Intorno a "Scelta Civica". Il suo "partito personale".
Gli unici partiti "im-personali", fino a pochi anni fa, erano quelli con radici storiche più profonde. In primo luogo, il Partito Democratico. Sorto nel 2007. Dalla convergenza della Margherita e dei DS. Post-Democristiani e Post-Comunisti. Insieme. Un Post-Partito, per echeggiare un testo di Paolo Mancini. Confluenza di due partiti "condannati", nella Prima Repubblica, a guidare il governo e l’opposizione. L’uno contro l’altro. Fino alla caduta del muro.
Anche la Lega proviene dalla Prima Repubblica. Sorta dalle Leghe regionaliste, negli anni Ottanta e, soprattutto, dalla Lega Nord per l’indipendenza della Padania, negli anni Novanta. Guidata da Bossi e, quindi, da Maroni. Tuttavia, nell’ultimo decennio, entrambi, PD e Lega, si sono "personalizzati". Il PD è divenuto PDR. Il Partito di Renzi. Mentre la Lega si è trasformata "radicalmente". Matteo Salvini l’ha de-territorializzata. La Lega Nord è divenuta Nazionale. E sovranista. Ha occupato lo spazio lasciato vuoto, a Destra, da FI e da AN. E Salvini le ha dato il suo volto.
Infine, c’è il M5s. L’ultimo arrivato. Un non-partito. Collettore dei ri-sentimenti politici. Privo di una specifica connotazione "personale". L’unica figura in grado di identificarla è (stato) Beppe Grillo. Un anti-politico per definizione. Leader della "comunicazione" post-televisiva. Della dis-intermediazione, prodotta da internet e dai Social.
Così, è possibile leggere la storia recente della politica e della democrazia in Italia come un percorso "oltre" i partiti. Orientato dall’ascesa dei leader.
Oggi i "partiti" sono largamente declinati. Solo l’8% degli italiani esprime fiducia nei loro riguardi. Mentre oltre il 40% pensa che la democrazia possa funzionare anche senza i partiti.
E quasi 6 elettori su 10 (sondaggio di Demos, dicembre 2018) sostengono la necessità di "un leader forte a guidare il Paese". I più convinti: gli elettori della Lega: oltre 8 su 10. Poi, gli elettori di Forza Italia (76%).
Ispirati dall’inventore del modello. Quindi: la base del M5s. Un non-partito, che non dispone di "un leader forte". Ma beneficia del sentimento anti-partitico diffuso. Mentre i suoi elettori si affidano all’unico vero "leader forte" al governo. Matteo Salvini. Si spiega anche così il loro ripiegamento elettorale, in questa fase.
Il Pd, infine, soffre della crisi post-PdR. Doppiamente. Perché è difficile, per non dire impossibile, per una base elettorale che ha memoria dei "partiti di massa" sentirsi a casa in un partito personale. Il PdR. E perché nessuno degli attuali candidati, in corsa alle Primarie, appare in grado di "personalizzarlo". (Per fortuna...).
Così, la nostra democrazia si sta trasformando alle fondamenta. I partiti, vecchi e nuovi, si stanno personalizzando. E, per questo, l’intero sistema politico è divenuto instabile. Perché i partiti personali sono legati ai leader. Sorgono e affondano assieme a loro. Com’è avvenuto a IdV, Scelta Civica, AN. Alla stessa FI. Mentre il PD ha sofferto e soffre della propria mutazione in PdR. Quanto al M5s, risente del "minor tasso di personalità" rispetto alla Lega di Salvini. E la stessa Lega: cosa (ne) sarà dopo Salvini?
In generale, è evidente che la democrazia italiana si sia personalizzata. Insieme ai partiti. Spinta dai media. Vecchi e ancor più nuovi. Dalla TV, dalla rete, dai social. Così, stiamo diventando una "Repubblica personale". Di fatto. In modo im-personale e in-consapevole.
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- "L’incertezza, la paura e il farmaco populista" (F. Capelli). La soluzione sta in più democrazia (di Gianfranco Pasquini).25 gennaio 2019, di Federico La Sala
Il populismo nel cuore (delle democrazie)
di Gianfranco Pasquino (Il Mulino, 25 gennaio 2019)
Nessuna nostalgia per il passato, nessuna paura per il futuro. Capire il presente per costruire il futuro. Queste sono le due considerazioni che hanno guidato la mia lettura del denso, stimolante, efficace volume di Ferruccio Capelli, Il futuro addosso. L’incertezza, la paura e il farmaco populista (Milano, Guerini e Associati, 2018). Ho anche pensato che il presente è il prodotto del passato, di scelte, errori e responsabilità personali che bisogna individuare e criticare, superare. -Differentemente da Capelli, credo che il presente non sia tutto populismo. È molto diversificato, non ha bisogno del "farmaco" populista, ma di politica e già contiene non pochi anticorpi che debbono e possono essere sollecitati. La grande trasformazione degli ultimi trent’anni è stata innescata, secondo Capelli, da due possenti motori: la globalizzazione (finanziaria e delle comunicazioni) e l’innovazione tecnologica. È stata giustificata e sostenuta dall’ideologia neo-liberale. Si è manifestata in tre ambiti, ovvero secondo tre modalità: la disintermediazione, la solitudine (involontaria) e lo spaesamento (culturale). L’esito complessivo è stato quello di aprire grandi spazi - vere e proprie praterie - alle incursioni populiste. Il populismo, o meglio, i populisti offrono una risposta che definirò ricompositiva: mettono insieme il loro popolo (gli altri, quelli che non ci stanno a farsi mettere insieme e continuano a essere molti, si meritano la definizione di "nemici del popolo" e come tali sono trattati), lo utilizzano contro le élite (l’establishment che Capelli sembra identificare con i potenti che si riuniscono a Davos, con coloro che definisce il "senato virtuale", ma - di volta in volta - bisognerebbe specificare quale sia loro presenza e influenza dentro ciascun sistema politico e coglierne anche le contraddizioni), applicando politiche escludenti. Nazionalisti, forse, sovranisti di sicuro, quasi tutti i populisti, anzi, le élite (!) populiste appartengono a un passato del quale, però, non rivelano particolare nostalgia, tranne quella per un’omogeneità etnica, sicuramente non più recuperabile.
Disintermediazione vuole dire, secondo Capelli - e sono d’accordo - la scomparsa di capacità associative e, al tempo stesso, l’indebolimento di tutte le associazioni intermedie che avevano costituito il tessuto connettivo dei processi di democratizzazione e di consolidamento delle democrazie. A sostegno di ciò potrei citare alcuni importanti politologi che hanno scritto e argomentato che le democrazie sono inconcepibili senza partiti.
 Preferisco ricordare che - secondo Palmiro Togliatti - i partiti sono "la democrazia che si organizza". Giustamente, Capelli chiama in causa Alexis de Tocqueville e il suo elogio con sorprese delle propensioni associative degli americani, forse sottovalutando il pericolo del conformismo che l’aristocratico francese intravedeva in democrazie basate sull’uguaglianza di condizioni. Sotto dirò di più su uguaglianza e disuguaglianze.
Preferisco ricordare che - secondo Palmiro Togliatti - i partiti sono "la democrazia che si organizza". Giustamente, Capelli chiama in causa Alexis de Tocqueville e il suo elogio con sorprese delle propensioni associative degli americani, forse sottovalutando il pericolo del conformismo che l’aristocratico francese intravedeva in democrazie basate sull’uguaglianza di condizioni. Sotto dirò di più su uguaglianza e disuguaglianze.Certo, la solitudine non conduce a interesse politico, a partecipazione politica, a solidarietà. La folla solitaria del sociologo americano David Riesman, pubblicato nel 1950, con un sottotitolo rivelatore: A study of the changing American character, precede di quasi cinquant’anni il - forse triste forse no - "andare a giocare a bowling da soli" (ovvero non con una squadra di amici), best seller di Robert Putnam relativo al capitale sociale, vale a dire alle reti di rapporti sociali e affettivi che rendono la vita migliore. Naturalmente, un conto è rimanere/ritrovarsi soli, un conto è il volere essere soli e non curarsene poiché si è convinti di possedere le risorse intellettuali, culturali, professionali per cavarsela senza l’aiuto di nessuno e per attivarsi esclusivamente con l’obiettivo di proteggere e promuovere i propri interessi. Sono i "post-materialisti" intelligentemente individuati e studiati da Ronald Inglehart, prodotti e produttori di una rivoluzione silenziosa nei costumi e nei comportamenti.
"Lo spaesamento del cittadino, senza mediazioni e senza cornici culturali, è un altro volto della solitudine dell’uomo [e della donna!] contemporaneo. Egli è libero, svincolato dalle tradizioni e da vincoli predefiniti con gli altri esseri umani, ma l’esercizio della sua libertà si rivela quanto mai problematico" (p.177).
 Nel 1941, il grande psicologo Erich Fromm colse nel desiderio di fuggire dalla libertà - ovvero dalla necessità di scegliere e dalla corrispondente responsabilizzazione, una delle ragioni per le quali uomini e donne si assoggettarono ai fascismi e al nazismo. Oggi, forse, è il leader populista a offrire questa protezione dalla libertà che, però, il cittadino esercita "nella galassia infinita del mercato" (p. 117).
Nel 1941, il grande psicologo Erich Fromm colse nel desiderio di fuggire dalla libertà - ovvero dalla necessità di scegliere e dalla corrispondente responsabilizzazione, una delle ragioni per le quali uomini e donne si assoggettarono ai fascismi e al nazismo. Oggi, forse, è il leader populista a offrire questa protezione dalla libertà che, però, il cittadino esercita "nella galassia infinita del mercato" (p. 117).Dietro o intorno a tutto questo stanno, da un lato, l’irresistibile globalizzazione, cioè un processo forse ingovernabile, certamente non governato; dall’altro, la vittoria su tutta la linea, sostiene Capelli, dell’ideologia neo-liberale. Le capacità di ciascuno e di tutti si misurano attraverso la competizione nei mercati. Il merito viene premiato. Gli sconfitti sono responsabili della loro condizione. Al massimo, lo Stato deve adempiere al compito di regolatore e valutatore. Non deve mai intervenire a favore di chicchessia, ma noi sappiamo - o forse no, sostiene Capelli - che esiste un Senato virtuale, fatto dai potenti in ciascun settore, che squilibra tutta la competizione e, quindi, che incide sugli esiti facendo diventare più ricchi i ricchi e più poveri i poveri. "Il populismo è il sintomo [sosterrei, piuttosto, che è l’esito] più evidente della crisi della politica ridotta nella stagione neoliberale a tecnica di adattamento al mercato e di gestione del contingente" (p.150).
Secondo Capelli, il populismo indica "un umore, uno stile, una mentalità" (p.165). È mia opinione, invece, che il populismo debba essere letto e analizzato come un modo, uno dei modi possibili di fare politica nelle democrazie (Orbán è certamente un populista, mentre Putin e Erdogan praticano modalità populiste, ma sono due capi di regimi autoritari, nel caso turco con una spruzzata di fondamentalismo islamico). Dirò di più. In tutte le democrazie è insita una "striscia" di populismo, nel caso italiano accompagnata e pervertita da un cocktail di antipartitismo, antiparlamentarismo e anti politica. Nelle più disintermediate - solitarie e spaesate - quella striscia s’ingrossa e confluisce nelle organizzazioni populiste.
 Non tutto quello che in politica non ci piace è populismo, ma il populismo non può piacere a chi ritiene che la democrazia abbia forme e limiti nei quali si esprime il popolo, funzioni tenendo conto di freni e di contrappesi, protegga e promuova diritti di tutti, delle minoranze di vario tipo, delle opposizioni. Ciò detto, non concordo con Capelli su un altro punto rilevante. La democrazia non ha mai promesso eguaglianza, meno che mai eguaglianza economica (né uguale soddisfacimento di aspettative, preferenze, obiettivi, bisogni). Sartori ha scritto che democrazia è soltanto, ma è moltissimo, isonomia: eguaglianza di fronte alla legge. Dal canto mio, sosterrò che la democrazia promette al popolo (demos) che potrà esercitare potere (kratos), nulla di più. Quel popolo e i singoli cittadini otterranno/eserciteranno influenza sulle decisioni politiche in base alla loro capacità di organizzarsi e di convincere - di volta in volta - le maggioranze. Quel popolo e i singoli cittadini hanno spesso chiesto uguaglianze (plurale) di opportunità e le socialdemocrazie sono spesso riuscite a dare e ridare quelle eguaglianze. Non ho qui lo spazio per indagare se la promessa di eguaglianze di opportunità non possa essere riproposta opportunamente riformulata.
Non tutto quello che in politica non ci piace è populismo, ma il populismo non può piacere a chi ritiene che la democrazia abbia forme e limiti nei quali si esprime il popolo, funzioni tenendo conto di freni e di contrappesi, protegga e promuova diritti di tutti, delle minoranze di vario tipo, delle opposizioni. Ciò detto, non concordo con Capelli su un altro punto rilevante. La democrazia non ha mai promesso eguaglianza, meno che mai eguaglianza economica (né uguale soddisfacimento di aspettative, preferenze, obiettivi, bisogni). Sartori ha scritto che democrazia è soltanto, ma è moltissimo, isonomia: eguaglianza di fronte alla legge. Dal canto mio, sosterrò che la democrazia promette al popolo (demos) che potrà esercitare potere (kratos), nulla di più. Quel popolo e i singoli cittadini otterranno/eserciteranno influenza sulle decisioni politiche in base alla loro capacità di organizzarsi e di convincere - di volta in volta - le maggioranze. Quel popolo e i singoli cittadini hanno spesso chiesto uguaglianze (plurale) di opportunità e le socialdemocrazie sono spesso riuscite a dare e ridare quelle eguaglianze. Non ho qui lo spazio per indagare se la promessa di eguaglianze di opportunità non possa essere riproposta opportunamente riformulata.Sostiene Capelli che la crisi della democrazia contemporanea dipenda da un elemento specifico: "mai tante promesse di eguaglianza e mai tante disuguaglianze". Non credo che sia così. La crisi affonda le radici proprio nei tre fattori da lui abilmente delineati all’inizio della sua analisi: disintermediazione, solitudine, spaesamento e in un quarto fattore da lui stesso accennato: il declino della rappresentanza politica.
 La soluzione sta in più democrazia, ma sicuramente nient’affatto in quella proclamata come "uno vale uno" (incidentalmente, in nessun ambito uno vale uno) che fa tutt’uno di masse disintermediate che si affannano ad osannare (qualc)uno. Più democrazia non significa neppure che tutte le decisioni di qualsiasi genere debbano essere sottoposte sempre a votazioni popolari attraverso Internet. Significa, invece, che è diventato imperativo esplorare tutte le potenzialità della democrazia deliberativa, delle modalità di istruzione di una decisione, di discussione di un problema, di diffusione delle conoscenze, di apprendimento, di coinvolgimento della cittadinanza fino alla decisione motivata. Qui s’incrociano la politica ("tutte le cose che succedono nella polis") e la democrazia (il potere dei cittadini sempre più istruiti in materia). No, il populismo non ha vinto e non vincerà. Altri futuri sono possibili.
La soluzione sta in più democrazia, ma sicuramente nient’affatto in quella proclamata come "uno vale uno" (incidentalmente, in nessun ambito uno vale uno) che fa tutt’uno di masse disintermediate che si affannano ad osannare (qualc)uno. Più democrazia non significa neppure che tutte le decisioni di qualsiasi genere debbano essere sottoposte sempre a votazioni popolari attraverso Internet. Significa, invece, che è diventato imperativo esplorare tutte le potenzialità della democrazia deliberativa, delle modalità di istruzione di una decisione, di discussione di un problema, di diffusione delle conoscenze, di apprendimento, di coinvolgimento della cittadinanza fino alla decisione motivata. Qui s’incrociano la politica ("tutte le cose che succedono nella polis") e la democrazia (il potere dei cittadini sempre più istruiti in materia). No, il populismo non ha vinto e non vincerà. Altri futuri sono possibili.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
UNA LEZIONE TEOLOGICO-POLITICA DI BAGET BOZZO SU OGNI PROGETTO DI "RIFONDAZIONE COMUNISTA" FUTURA CHE SI VUOLE COME PARTITO. Avanti o popolo alla riscossa. Il populismo trionferà: "Forza Italia"!!!
RIPENSARE L’EUROPA. PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!
 FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.Federico La Sala
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- “decreto sicurezza”. Orlando apre lo scontro. Giovanni Maria Flick: «Condivido i suoi dubbi sulla costituzionalità di quelle norme e il suo coraggio civile: la nostra Carta prevede un principio di accoglienza soprattutto per i richiedenti asilo».3 gennaio 2019, di Federico La Sala
L’ex ministro della Giustizia Giovanni Maria Flick
“Sbagliato ribellarsi così.
Faccia ricorso a un giudice”
di A. C. (La Stampa, 03.01.2019)
«L’articolo del decreto Salvini che nega la possibilità di ottenere la residenza ai richiedenti asilo presenta rilevanti dubbi di costituzionalità. Ma la strada per verificare se quella norma rispetti la nostra Costituzione non è quella intrapresa dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando», spiega l’ex presidente della Consulta ed ex ministro della Giustizia Giovanni Maria Flick. «Il Comune, così come il singolo , possono rivolgersi al giudice ordinario, anche con procedura d’urgenza, per accertare se il primo ha il dovere di rilasciare e il secondo ha il diritto di ottenere il certificato di residenza. Sarà il giudice che, eventualmente, solleverà la questione di legittimità davanti alla Corte se riterrà che la norma violi dei diritti fondamentali».
1 Dunque Orlando ha torto?
«Condivido i suoi dubbi sulla costituzionalità di quelle norme e il suo coraggio civile: la nostra Carta prevede un principio di accoglienza soprattutto per i richiedenti asilo. Vedo un filo comune tra le parole del Capo dello Stato a Capodanno e l’azione di Orlando».
2 Salvini fa notare che quella legge è stata firmata dal Quirinale.
«Il Colle fa un esame globale delle leggi, non entra nei dettagli tecnico-giuridici. Quel tipo di esame spetta alla Corte».
3 Un sindaco può disobbedire?
«No, un sindaco non può disapplicare le leggi dello Stato, altrimenti se ogni Comune si muove a modo suo si crea il caos».
4 I migranti non residenti rischiano di non ricevere cure negli ospedali?
«La mancata concessione della residenza non crea rischi per il diritto alla salute che resta garantito anche per chi ha solo un domicilio, anche se è facile immaginare che la mancata iscrizione all’anagrafe creerà gravi disfunzioni di fatto. Semmai vedo la possibilità di lesione di altri diritti come quelli al lavoro e alle prestazioni sociali. Chi non ha una residenza ha un obiettiva penalizzazione nella ricerca del lavoro e anche nell’ottenimento di prestazioni sociali. E la pari dignità sociale è uno dei cardini della nostra Costituzione». a. c.
Orlando apre lo scontro: “Stop al decreto Salvini”
A Palermo “residenza anche agli irregolari”. Sindaci in trincea da Napoli a Milano
di Sandra Amurri e Giuseppe Lo Bianco (Il Fatto, 03.01.2019)
Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando lo definisce “disumano e criminogeno’’ e con una nota al dirigente dell’ufficio anagrafe sospende l’applicazione del “decreto sicurezza” nella parte in cui, “ma non solo’’, impedisce l’iscrizione all’anagrafe dei migranti non più in regola con il permesso di soggiorno. Gli replica Salvini a stretto giro: “Con tutti i problemi che ci sono a Palermo, il sindaco sinistro pensa a fare ‘disobbedienza’ sugli immigrati”. E annuncia una visita in Sicilia. Ma per Orlando il decreto “puzza di razziale’’, e la sua, dice, non è “disobbedienza civile’’, ma l’applicazione dei diritti costituzionali “perché non posso essere complice di una violazione palese dei diritti umani’’.
Sono quattro gli articoli della Costituzione (e una sentenza della Consulta) citati dal primo cittadino nella nota inviata al capo area Servizi per il cittadino in cui “impartisce la decisione di sospendere qualunque procedura che possa intaccare i diritti fondamentali della persona con particolare riferimento, ma non esclusivo, all’iscrizione anagrafica’’, e tra questi l’art. 32 che garantisce il diritto all’assistenza sanitaria, messo a rischio dalla negazione della residenza anagrafica.
La nota invita anche “ad approfondire tutti i profili giuridici anagrafici derivanti dall’applicazione del decreto sicurezza’’, che il Comune di Palermo ha in realtà già approfondito, come fa notare Igor Gelarda, responsabile cittadino della Lega, che ha scoperto come il 2 novembre scorso lo stesso capo area investito da Orlando, Maurizio Pedicone, insieme all’assessore Gaspare Nicotri, avevano risposto ad una interrogazione di Sinistra Comune sul rifiuto di sei istanze di “prima iscrizione anagrafica’’ di migranti, sostenendo che “il permesso di soggiorno non costituisce titolo per l’iscrizione anagrafica’’ e distinguendo i già iscritti (e richiedenti quindi un cambio di residenza) per i qualiè sufficiente “una semplice ricevuta di domanda di permesso’’.
Il fronte dei sindaci è ampio. L’Anci, l’associazione dei Comuni, aveva già espresso la sua contrarietà al decreto Salvini, in particolare per il rischio di un’uscita massiccia di stranieri dai centri di accoglienza. Ieri Decaro, presidente dell’Anci, ieri ha assunto una posizione più morbida di Orlando: “Occorre istituire un tavolo di confronto in sede ministeriale per definire le modalità di attuazione e i necessari correttivi a una norma che così com’è non tutela i diritti delle persone”.
È la stessa linea di Federico Pizzarotti, sindaco ex M5s di Parma, oggi leader di “Italia in Comune” e vicepresidente Anci: “Quella di Orlando è una forzatura che non risolve il problema. L’ufficio anagrafe deve applicare la legge. Concordo con la necessità di un tavolo.
“La mancata applicazione della legge Sicurezza è un atto politico - osserva il presidente emerito della Consulta, Cesare Mirabelli -. I Comuni sono tenuti a uniformarsi alle leggi. La pubblica amministrazione non può sollevare questioni di legittimità costituzionale. A meno che non si tratti di norme con carattere discrezionale”. Se il sindaco la disapplica “interviene il prefetto o un’altra autorità, sorge un contenzioso e allora potrebbe essere sollevata una questione di legittimità costituzionale”.
Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, la mette così: “Non si tratta di sospendere una legge che, in quanto tale, non si può sospendere”, ma “le leggi si applicano solo in maniera conforme alla Costituzione”. Concorda con Orlando l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Milano, Pierfrancesco Majorino: “Legge o non legge, non abbiamo nessuna intenzione di togliere l’iscrizione anagrafica ai richiedenti asilo che l’hanno già fatta, stiamo accogliendo nei centri per senzatetto italiani anche gli stranieri senza porci il problema se siano regolari o meno”. Assicura di “studiare la decisione di Orlando” il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini che oggi ospiterà Salvini. Intanto il ministro twitta: “Certi sindaci hanno mangiato pesante, ne risponderanno”.
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- Il governo m5s-lega e il barbiere di Lenin (di Piergiorgio Odifreddi)3 novembre 2018, di Federico La Sala
C’era una volta un paradosso... *
Il governo m5s-lega e il barbiere di Lenin
di Piergiorgio Odifreddi (Il Fatto, 03.11.2018)
Secondo Silvio Berlusconi, il governo gialloverde è “il più sbilanciato a sinistra della storia del Paese”. Poiché però il leader di Forza Italia è notoriamente ossessionato dai comunisti, che secondo lui sono insediati in ogni luogo e responsabili di ogni male, la sua opinione non va presa troppo seriamente. Ma può fornire lo spunto per ricercare analogie tra ciò che è successo a Palazzo Chigi dopo il 1° giugno 2018, con il governo del cambiamento italiano, e ciò che è accaduto allo Smolnij e al Cremlino dopo il 7 novembre 1917, con il governo rivoluzionario russo.
Lasciando da parte le opinioni ideologiche, grillo-leghiste da un lato e marxiste-leniniste dall’altro, concentriamoci sui fatti concreti, a cominciare dall’atteggiamento pauperista e semiascetico che i partiti pentastellato e bolscevico hanno imposto ai propri vertici e proposto ai propri militanti. Ad esempio, gli scontrini dei rimborsi spese dei parlamentari 5S della scorsa legislatura e i viaggi in economy dei nuovi ministri richiamano lo stile di vita modesto adottato da Lenin, che si accontentava di vivere insieme alla moglie e alla sorella in quattro sole stanze al Cremlino, e attendeva pazientemente in coda il proprio turno per passare dal barbiere.
Anche l’astio verso i tecnici e il sospetto nei confronti delle loro “manine”, uniti alle minacce e alle promesse di epurazione politica nei ministeri, trovano un’antecedente molto più drastico e radicale nell’esecuzione degli alti comandi zaristi e nel licenziamento degli ufficiali dell’esercito, che furono sostituiti da una nuova gerarchia tratta dalle truppe rivoluzionarie, di scarsa preparazione ed esperienza militare, ma di fidata fede bolscevica.
Quanto alla rimozione del pessimismo dei fatti e alla sua sostituzione con l’ottimismo della volontà, sintetizzate nel rifiuto del nuovo governo grillo-leghista di farsi condizionare dai mercati e dai trattati europei, e nel proposito di abolire la povertà per decreto, impallidiscono di fronte all’analogo rifiuto del nuovo governo bolscevico di farsi condizionare dalla situazione bellica al fronte e dai trattati internazionali, e al proposito di uscire unilateralmente dalla guerra con il decreto sulla Pace, approvato già l’8 novembre 1917.
In fondo non è sorprendente trovare simili analogie, in governi che si propongono programmaticamente di apportare cambiamenti radicali nello status quo del proprio Paese, e quelli fatti non sono che esempi paradigmatici delle novità da introdurre nel comportamento individuale dei nuovi leader, nell’organizzazione interna del nuovo Stato e nelle relazioni esterne con i Paesi stranieri. Novità che devono essere introdotte, per mantenere le promesse di cambiamento, ma che non necessariamente si possono introdurre.
Al proposito, la storia sovietica lascia poche illusioni al riguardo. Ad esempio, fare la fila dal barbiere poteva essere naturale per un politico disoccupato in esilio, ma diventava velleitario e sciocco per un capo di governo occupato a condurre una Guerra civile che impegnava tutto il suo tempo e richiedeva tutte le sue energie. Infatti, poco dopo Lenin capì che era meglio fare meno gesti simbolici, ma meglio il proprio lavoro. Anche aggirare e rimuovere i tecnici nell’esercito non si rivelò essere una grande idea, visti i risultati ottenuti al fronte. Infatti, durante la Guerra civile non si poterono risuscitare gli alti comandi zaristi fucilati, ma si dovettero reintegrare di corsa gli ufficiali rimossi, pur mettendo al loro fianco dei commissari del popolo a controllare le loro “ditine” posate sui grilletti. Perché con i dilettanti si stava perdendo la guerra, mentre per vincerla servirono i professionisti. Quanto ai condizionamenti esterni, si possono anche rimuovere nella propria testa, ma non per questo essi svaniscono miracolosamente.
Il decreto della Pace portò in poche settimane a un ultimatum tedesco e alla capitolazione di Brest-Litovsk, con la perdita di un terzo dell’impero russo: a sconfiggere in seguito la Germania non fu certo l’unilateralismo sovietico, ma l’azione comune degli Alleati.
I sovietici impararono presto la lezione che i proclami utopici e le azioni dimostrative sono malattie infantili del cambiamento, e li sostituirono con un realismo e un pragmatismo che permisero loro di sopravvivere per settant’anni, tanti quanti la nostra Repubblica.
Se il governo giallo-verde vuole provocare un cambiamento serio e desidera durare a lungo, dovrà imparare anch’esso presto la stessa lezione e vaccinarsi velocemente contro le stesse malattie infantili.
*
Sul tema, nel sito, si cfr.:
BERTRAND RUSSELL: LA LEZIONE SUL MENTITORE (IGNORATA E ’SNOBBATA’), E "L’ALFABETO DEL BUON CITTADINO".
RIFARE UNO STATO?! BASTA UN NOTAIO, UN FUNZIONIARIO DEL MINISTERO DELL’INTERNO E LA REGISTRAZIONE DI UN SIMBOLO DI PARTITO CON IL NOME DEL POPOLO!!! A futura memoria, note e appunti sul caso
Federico La Sala
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. -- "Nudge", quella "spinta gentile" che orienta e influenza i nostri comportamenti. Riccardo Viale: così siamo «liberi» di scegliere ed essere felici (di Andrea Lavazza).30 ottobre 2018, di Federico La Sala
Società.
Nudge, quella spinta gentile che orienta e influenza i nostri comportamenti
Si chiama “Nudge” ed è una strategia economica che sostiene le nostre decisioni facendo leva su aspetti psicologici e comportamentali. Viale: così siamo «liberi» di scegliere ed essere felici
di Andrea Lavazza (Avvenire, martedì 30 ottobre 2018)
In principio furono gli agenti di commercio. Che i venditori conoscano l’arte della persuasione è noto, ma esperimenti condotti dagli anni 70 del secolo scorso hanno confermato che nella vendita sono sfruttati principi psicologici solidi e fino allora poco indagati, alla base oggi dell’economia comportamentale e di un filone sempre più rilevante delle politiche pubbliche. Pensiamo alla reciprocità, una regola sociale pervasiva, secondo la quale se io faccio X, allora mi aspetto che tu faccia Y. Se contraccambiare è un meccanismo potente che riflette sia una norma introiettata con l’educazione sia il tentativo di evitare il biasimo degli altri, ecco che l’omaggio o il campione gratuito dato al cliente innescano l’obbligo di sdebitarci comprando il prodotto che viene proposto.
Non pensiamo davvero che un piccolo regalo ci impegni all’acquisto, si tratta di un processo inconscio che ci guida in modo quasi automatico. Siamo dunque manipolati quando vengono messe in atto queste strategie di marketing? La risposta migliore è quella più deludente: dipende. Ma la posta in palio non è più o soltanto un acquisto poco ponderato. Una svolta recente nella scienza psicologica e lo sfruttamento delle nuove conoscenze da parte dei governi costituiscono una frontiera estremamente rilevante sia per la ricerca sia per la vita di tutti i cittadini, come spiega Riccardo Viale, scienziato cognitivo docente all’università Bicocca di Milano, in un libro rigoroso ed estremamente informativo ( Oltre il nudge. Libertà di scelta, felicità e comportamento, il Mulino, pagine 264, euro 26,00).
Rivelato al grande pubblico da alcune delle più recenti scelte per il Nobel dell’Economia (Daniel Kahneman nel 2002, Richard Thaler nel 2017), un filone di ricerca sperimentale ha ormai demolito l’ideale dell’homo oeconomicus perfettamente razionale e consapevole delle alternative a sua disposizione, capace di scegliere per il meglio coerentemente con le sue preferenze più radicate. In ogni ambito di decisione, la nostra razionalità è limitata, ci facciamo fuorviare dalle circostanze in cui ci troviamo, non sappiamo gestire scenari probabilistici, tendiamo a sovrastimare il presente a scapito del futuro.
In genere, siamo guidati da processi inconsapevoli e automatici che ci aiutano a rendere rapide e poco dispendiose le nostre scelte ma spesso, in ambienti che sono diversi e molto più complessi di quelli in cui ci siamo evoluti, ci conducono a comportamenti subottimali o addirittura dannosi. Il punto, sottolinea Viale, è che le istituzioni politiche, economiche e giuridiche continuano a rapportarsi alle persone secondo un’idealizzazione irrealistica.
Vie di uscita si cominciano però a progettare. Una pietra miliare è il volume di Thaler e Sunstein pubblicato nel 2008 che ha messo in circolazione il termine chiave del dibattito attuale: Nudge. Nella traduzione italiana (Feltrinelli) è stato reso con «spinta gentile», una serie di interventi, calibrati in base alle reali modalità di scelta delle persone, che possono indirizzare in positivo le decisioni legate a denaro, salute e benessere personale. La prima spintarella si ottiene mettendo come opzione di defaultil percorso preferito: se non si sceglie, si è incanalati in un percorso già stabilito. Avviene per esempio con la donazione degli organi: quando il soggetto non esprime un parere, si presume l’assenso all’espianto post-mortem.
Poi vi sono le modificazioni dell’architettura della scelta: si organizza la mensa in modo che prima siano proposti cibi salutari e poco calorici; l’hamburger arriva alla fine, quando, si presume, il cliente ha già riempito il vassoio. Oppure, si può enfatizzare un certo tipo di informazione: se si scrivono lettere ai contribuenti segnalando che tutti i vicini hanno già pagato le tasse dovute, la propensione all’evasione fiscale diminuisce notevolmente. Invece, prendano nota i nostri decisori, biasimare di frequente la disonestà di tanti finisce con l’incentivare tali comportamenti, essendo il ragionamento implicito: lo fanno tutti, lo posso fare anch’io.
Il nudge è una forma di paternalismo perché implica che qualcuno sappia meglio di noi, spesso irrazionali e autolesionisti, che cosa è bene e come raggiungerlo. Ma è un paternalismo liberale perché lascia comunque la scelta finale al consumatore, che può ancora mangiare cibi grassi e non versare le imposte. Viale tuttavia evidenzia come la situazione risulti ben più complessa, sia dal punto di vista dei meccanismi psicologici sia dal punto di vista della coercizione cui il cittadino è sottoposto con le spintarelle gentili. Elementi strettamente scientifici e aspetti politico- normativi si intrecciano in quella che dovrebbe essere una tematica ben più discussa nel nostro Paese.
All’estero, a partire dalle iniziative di Obama e di Cameron, si sono costituiti comitati per l’applicazione dell’economia comportamentale, la stessa Unione europea si sta muovendo in tale direzione. In Italia un tentativo fatto da Renzi con alcuni studiosi è stato interrotto dalla caduta del governo. Il problema della diffusione del gioco d’azzardo e dei modi di evitare ludopatie compulsive rientra pienamente in questa discussione. Il libro di Viale ha comunque il merito di aprire scenari. Per esempio, a parere di chi scrive questo articolo, una forma estesa di nudge, tesa a contrastare le fake news, potrebbe essere quella di introdurre su ogni post di Facebook e su ogni tweet l’opzione per l’autore di marcarli con una piccola, singola lettera dell’alfabeto. Nessuna imposizione, soltanto una schermata prima di pubblicare che chieda: «vuoi marcare il tuo post/tweet come segue?». Si sceglie «no» e si procede, perdendo al massimo qualche secondo le prime volte, poi al massimo il tempo istantaneo di un clic. Se invece si sceglie di marcare, le opzioni potrebbero essere: «fonte conosciuta - FC»; «fonte ignota (segreta; non divulgabile) FI»; «rilancio diretto di altro messaggio - RM».
Quale sarebbe l’effetto? Se posto che Obama non è nato negli Usa e quindi non poteva fare il presidente e non marco il mio messaggio, gli altri utenti sapranno subito che si tratta di una mia opinione, di un’accusa che lancio senza prove. Se marco il messaggio con FI, perché l’ho sentito dire e non ho voglia di impegnarmi in una discussione sulla fonte o sulle prove della mia affermazione, i lettori possono sapere che non vale la pena di prendere troppo sul serio la cosa. Se invece qualifico il mio post o il mio tweet con FC, suscito l’attenzione degli altri utenti e qualcuno potrebbe chiedermi quale è la fonte o quali sono le prove della mia tesi. Ovviamente, la maggior parte dei messaggi sono considerazioni o commenti personali, e come tali non hanno bisogno di sostegno epistemico.
Tuttavia, se voglio veicolare un messaggio credibile, dovrò alla lunga marcarlo con FC, sapendo che qualcuno vorrà sapere le basi fattuali della mia affermazione, senza però che io sia in alcun modo obbligato a farlo. Se non le espongo, d’altra parte, il peso della mia tesi sarà minore e potrà più facilmente essere contrastata. Nei casi in cui non marco il messaggio o lo segno come FI, la sua forza sarà fin dall’inizio minore, anche nel caso in cui spieghi poi che la fonte deve rimanere riservata. Insomma, non una panacea alle fake news, ma un «incorniciamento» virtuoso della comunicazione che non costringe l’utente a fare nulla, ma gli offre possibilità diverse di valorizzare le proprie affermazioni fattuali e alla lunga potrebbe ridurre diffusione e influenza delle notizie false.
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. -- "Nudge", quella "spinta gentile". Non dimentichiamo la biologia staliniana di Lysenko, la fisica ariana nella Germania nazista e l’antropologia fascista della difesa della razza (di Riccardo Viale).30 ottobre 2018, di Federico La Sala
il principio e i dogmi
La prevalenza della politica sulla scienza: gli esempi terribili del passato
Non dimentichiamo la biologia staliniana di Lysenko, la fisica ariana nella Germania nazista e l’antropologia fascista della difesa della razza
di Riccardo Viale *
Il dogma principale della scienza è che non ha dogmi. Il suo principio base è la falsificabilità, non la certezza. La storia della scienza è una catena di affermazioni e successive falsificazioni. Monumenti come le teorie di Newton, Darwin ed Einstein, appena nate cominciarono a essere subito messe in discussione. L’affermazione di ipotesi avviene, spesso, attraverso scontri laceranti. Alcune volte teorie inadeguate rimangono in voga transitoriamente a discapito di anomalie empiriche e contraddizioni formali. Il finanziamento di programmi di ricerca o la selezione di articoli scientifici è, talvolta, viziato da parrocchialismo. Che conclusioni possiamo derivare da questo elenco di debolezze? Che della scienza non ci si può fidare e che l’astrologo vale quanto l’astronomo?
A chi sostiene questo tipo di convinzioni si potrebbe rispondere con la stessa battuta fatta da Winston Churchill a proposito della democrazia: «È stato detto che la scienza è la peggior forma di conoscenza, eccezion fatta per tutte quelle altre forme che si sono sperimentate finora». Perché? Innanzitutto esiste il principio unificante dell’adeguatezza empirica: tutti sono d’accordo che prima o poi le ipotesi devono passare sotto le forche caudine dei fatti. La scienza è profondamente democratica. Il merito delle proprie ipotesi è discusso all’interno della comunità e la decisione segue una qualche forma di regola della maggioranza. La politica interagisce costantemente con la scienza. Ad esempio attraverso le scelte allocative su settori e programmi di ricerca. Forse però esponenti politici come Barillari o i No Vax intendono qualcosa di diverso quando tifano per la democrazia e la politica nella scienza. Forse per loro la democrazia nella scienza è sostenere il principio del «tutto va bene» e l’assenza di autorità. E la prevalenza della politica significa trasferirle un ruolo epistemologico nel discriminare il vero dal falso. Esempi nel passato ce ne sono stati tanti: la biologia staliniana di Lysenko, la fisica ariana nella Germania nazista e l’antropologia fascista della difesa della razza.
* Corriere della Sera, 8 agosto 2018 (modifica il 8 agosto 2018 | 21:01)
-
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- Decalogo per uscire dal buio: mandate le vostre parole (di "l’Espresso").8 ottobre 2018, di Federico La Sala
Decalogo per uscire dal buio: mandate le vostre parole *
- Su L’Espresso abbiamo pubblicato dieci parole rifondative di una possibile sinistra, per cercare una speranza per il futuro. Dieci firme hanno spiegato le loro scelte. Da "Popolo" a "Lavoro". Da "Differenza" a Tutti". Ora tocca ai nostri lettori: suggerire le vostre e spiegateci perché
Parole rifondative: di un progetto, un’identità, una speranza di futuro. Nelle prossime settimane si riuniranno in tanti, a sinistra o da quelle parti, per discutere di nomi, sigle, contenitori, per provare a riempire il vuoto di presenza, il deserto di alternativa visibile. Quello che ancora manca è la battaglia di idee: una sfida politica e culturale, popolare e non elitaria.
L’Espresso, nel solco del dibattito italiano e europeo, ha chiesto ad alcune sue firme, diverse per cultura e esperienza, un decalogo di parole-chiave. Da “Noi e Tu” di Massimo Cacciari a “Tutti” di Francesca Mannocchi, il nostro alfa e omega. E poi Michela Murgia, Aboubakar Soumahoro, Francesca Mannocchi. E Guseppe Genna, Emiliano Brancaccio, Evelina Santangelo, Valeria Parrella, Roberto Castaldi e Chiara Valerio.
Adesso tocca ai nostri lettori. Vi chiediamo di trovare le parole che per voi meglio rappresentano questa sfida, parole che siano davveri un segno di luce per uscire dal buio, spiegando il perché della vostra scelta. Per contribuire al dibattito che troverà spazio nei prossimi numeri del giornale
* L’Espresso, 05.10.2018
 http://espresso.repubblica.it/attualita/2018/10/04/news/decalogo-per-uscire-dal-buio-mandate-le-vostre-parole-1.327515?ref=HEF_RULLO
http://espresso.repubblica.it/attualita/2018/10/04/news/decalogo-per-uscire-dal-buio-mandate-le-vostre-parole-1.327515?ref=HEF_RULLO-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- Decalogo per uscire dal buio: "Noi e tu" (di M. Cacciari - "l’Espresso").11 ottobre 2018, di Federico La Sala
Per uscire dal buio
Decalogo *
***
Noi e tu
di Massimo Cacciari
Nessun “noi” è autorizzato a parlare a nome del mio “Io”. È questo il detestabile “Noi” cosi volentieri in bocca a leader e pseudo-leader, a detentori di verità o post-verità, ai “veri” rappresentanti del Popolo o della Gente. Si tratta del “Noi” plurale maiestatis, in cui Tutti dovrebbero ritrovarsi e abbracciarsi armoniosamente. A questa figura totalitaria va opposta la comunità degli Io, la ricerca della loro relazione senza confusione, senza che nessuno perda o dimentichi la propria singolarità. Ogni insieme che non si costituisca sulla base di un tale principio è destinato a trasformarsi in un oscuro grumo, manipolabile da qualsiasi pifferaio o burattinaio.
Ma dall’Io in quanto tale non si passa per miracolo alla comunità. Soltanto da quell’Io che è capace di chiamare l’altro col Tu, che non vede nell’altro l’avversario, l’ostacolo, lo scandalo, ma il Tu - che si fa prossimo dell’altro per giungere a chiamarlo Tu. E che con questo nome potrà essere a sua volta chiamato. L’Io è veramente tale quando viene chiamato Tu dall’altro. La singolarità del mio Io è tale quando cosi la scopro comparandomi al Tu dell’altro. Altrimenti non sono questo Singolo, unico nel proprio valore, non scambiabile con nessuno, merce o strumento di nessuno, ma soltanto un punto indistinto, un granello di sabbia nella indifferenza del Tutto. Se e soltanto se ognuno riuscisse a “dare del Tu” all’altro e a ritrovare se stesso proprio in questo dare-donare, saremmo autorizzati a usare il Noi.
Idea che appare semplice e che forse, invece, è in realtà sovrumana. È l’idea che regge l’intera struttura del Paradiso di Dante: tutti santi nel suo amplissimo abbraccio, tutti insieme beati nell’amore contemplativo del Signore e amici gli uni con gli altri, eppure ognuno si manifesta in un suo luogo, eterno nel suo volto proprio, nel suo nome, nella sua opera, ognuno inconfondibile nella sua preziosissima, inalienabile singolarità. È l’Inferno in terra dove la maledetta lupa dell’invidia, dell’avarizia, della libido di dominare, genera continuamente masse, indifferenza, confusioni, grumi. Ma a differenza che in quello di Dante, nel nostro è forse ancora possibile lottare e sperare in nome del Tu.
* l’Espresso, 07.10.2018
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- MA COME RAGIONANO GLI ITALIANI E LE ITALIANE?!12 settembre 2018, di Federico La Sala
MA COME RAGIONANO GLI ITALIANI E LE ITALIANE?!
L’Italia e’ diventata la ’casa’ della menzogna... e della vergogna?!
di Federico La Sala *
Elementare!, Watson: Se, nel tempo della massima diffusione mediatica dellapropaganda loggika, l’ITALIA è ancora definita una repubblica democratica e "Forza Italia" (NB: ’coincidenza’ e sovrapposizione indebita con il Nome di tutti i cittadini e di tutte le cittadine d’ITALIA) è il nome di un partito della repubblica, e il presidente del partito "Forza Italia" è nello stesso tempo il presidente del consiglio dello Stato chiamato ITALIA (conflitto d’interesse), per FORZA (abuso di potere, logico e politico!) il presidente del partito, il presidente del consiglio, e il presidente dello Stato devono diventare la stessa persona.
E’ elementare: queste non sono ’le regole del gioco’ di una sana e viva democrazia, ma di un vero e proprio colpo di Stato! (Shemi EK O’KHOLMES).
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. -- EUROPA. La destra illiberale cerca lo scontro frontale. Il Parlamento Ue condanna Orban. Via libera all’articolo 7 per le sanzioni all’Ungheria.12 settembre 2018, di Federico La Sala
La destra illiberale cerca lo scontro frontale
Parlamento europeo. Orban all’offensiva a Strasburgo, non cede niente. Oggi il voto sull’articolo 7. La destra tradizionale del Ppe è spaccata. I governi di Italia e Austria a pezzi. Orban inneggia al "popolo" contro la democrazia rappresentativa
di Anna Maria Merlo (il manifesto, 12.09.2018)
PARIGI Muro contro muro. Viktor Orbán sceglie lo scontro diretto e non cede niente di fronte all’europarlamento. Il primo ministro ungherese, leader del fronte illiberale, è intervenuto ieri a Strasburgo, la vigilia del voto di oggi degli europarlamentari per avviare la procedura dell’articolo 7, una risoluzione che, se approvata, chiederà al Consiglio di “constatare l’esistenza di un rischio chiaro di violazione grave da parte dell’Ungheria dei valori su cui si fonda l’Unione europea”. Anche se il risultato del voto di oggi resta estremamente incerto, Orbán ha accusato preventivamente il parlamento europeo di voler “condannare” non un governo ma un popolo, “che da mille anni è membro della famiglia europea”, che sarà punito “perché ha deciso che non sarà patria di immigrati”.
Orbán: “Volete escludere un popolo”. Ha urlato: sono venuto a Strasburgo “per difendere la mia patria”, anche “contro di voi se necessario”, perché “non accettiamo minacce e ricatti delle forze pro-immigrazione, difenderemo le nostre frontiere, fermeremo l’immigrazione clandestina”. Il fronte illiberale getta la maschera e afferma il disprezzo per la democrazia rappresentativa: in Italia, Salvini riprende la tesi di Orbán, il “parlamento non processi il popolo”.
Marie Le Pen lo complimenta: “Bravo! Orbán è rimasto inflessibile di fronte ai maestrini del Parlamento europeo, che calpestano la democrazia pretendendo di difenderla”. Orbán rilegge la storia e ingloba nella sua deriva autoritaria anche la rivolta contro i sovietici del ’56: “condannerete l’Ungheria che con il suo lavoro e il suo sangue ha contribuito alla storia della nostra magnifica Europa, che si è sollevata contro l’esercito più potente del mondo, quello sovietico, e che ha pagato un forte scotto per difendere la democrazia”.
Oggi l’Europarlamento vota sull’articolo 7 da applicare all’Ungheria (ci vogliono i due terzi di voti per presentare la richiesta al Consiglio, ma la procedura potrà poi essere bloccata da un veto, la Polonia è implicata in una procedura analoga avviata dalla Commissione nel dicembre 2017). Ma l’offensiva del fronte illiberale sta spaccando il Ppe, il principale gruppo parlamentare a Strasburgo con 218 seggi.
Emmanuel Macron, indicato come “nemico” principale dal fronte illiberale, qualche giorno fa ha inviato un messaggio al Ppe, perché chiarisca la sua posizione: “non si può essere contemporaneamente a fianco della cancelliera Angela Merkel e di Viktor Orbán” (in Francia, i Républicains sono già spaccati, in Germania la coabitazione tra Merkel e il ministro degli Interni Seehofer è sempre più problematica, soprattutto dopo le manifestazioni di Chemnitz e Köthen).
La Fidesz di Orbán fa ancora parte del Ppe. Oggi, tutti gli occhi saranno puntati sul voto del capogruppo, il tedesco (Csu) Manfred Weber, che ambisce alla successione di Jean-Claude Juncker alla presidenza della Commissione e che ha cercato di calmare Orban, con una telefonata. Oltre a quello italiano, spaccato anche il governo austriaco, con l’Austria presidente semestrale del Consiglio Ue: il cancelliere Sebastian Kurz (Ppe) ha indicato che il suo partito voterà a favore dell’applicazione dell’articolo 7 all’Ungheria, mentre il vice-premier, Heinz-Christian Strache, dell’Fpö, ha invitato Orbán a raggiungere il gruppo dell’Europa delle nazioni e a creare un forte polo di estrema destra a Strasburgo. Per Juncker (Ppe) “l’appartenenza di Fidesz al Ppe è un problema”.
Oggi, al Ppe si conteranno i voti e l’entità della spaccatura (Forza Italia voterà contro l’applicazione dell’articolo 7, in sintonia con la Lega e l’estrema destra). A favore della procedura di sanzione dell’Ungheria ci sono la sinistra della Gue, il Pse, i Verdi, i centristi dell’Alde. Alexis Tsipras - la Grecia ha sofferto dell’intransigenza europea quando si tratta di soldi, mentre oggi il rischio del voto sull’Ungheria è di un cedimento di fronte alla difesa dei valori - ha riassunto a Strasburgo la situazione a pochi mesi dalle elezioni europee: sarà “una battagli di valori e di principi” e “tutte le forze progressiste, democratiche, pro-europee devono essere unite, non dobbiamo lasciare l’Europa fare un salto nel passato”.
Orbán vuole forzare la Ue, scardinarla dall’interno, ma non intende portare l’Ungheria fuori dall’Unione. I Fondi strutturali Ue sono il 4,4% del pil ungherese. La ministra delle relazioni con la Ue, Judith Varda, ha respinto “vigorosamente” il contenuto del rapporto dell’Europarlamento, redatto dalla verde (olandese) Judith Sargentini, considerato “una vendetta” per il rifiuto di Budapest di accogliere migranti. Ma l’Ungheria ha anche cercato di convincere gli europarlamentari delle sue buone ragioni. Ha inviato un documento di 109 pagine, dove pretende di smontare le critiche del rapporto Sargentini, si difende, sui Rom, sul sistema giudiziario. A luglio, la Commissione ha già contestato di fronte alla Corte di giustizia la legge anti-immigrazione dell’Ungheria.
Il Parlamento Ue condanna Orban, ora decidono i leader
Via libera all’articolo 7 per le sanzioni all’Ungheria
di Ansa (12 settembre 2018)
STRASBURGO - Il Parlamento europeo ha approvato la relazione Sargentini sullo stato di diritto in Ungheria, dando così l’ok all’applicazione dell’articolo 7 dei Trattati, che nella sua fase più avanzata può condurre a sanzioni contro il Paese. A favore hanno votato 448, 197 si sono espressi contro, 48 si sono astenuti, per un totale di 693 votanti. Ora la parola passa al Consiglio europeo, ovvero ai capi di Stato e di governo dell’Unione. E’ la prima volta il Parlamento ha adottato tale iniziativa per l’attivazione dell’articolo 7 per una grave minaccia allo Stato di diritto, alla democrazia e ai diritti fondamentali in uno Stato membro, in questo caso l’Ungheria.
Il Partito popolare europeo europeo si è spaccato, con la maggioranza del gruppo che ha votato a favore delle sanzioni a Orban e una minoranza, tra cui Forza Italia, che si è espressa contro. "Se fossi stato un eurodeputato, oggi anche io avrei votato per l’attivazione dell’articolo 7", ha detto il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, che fa parte del Ppe. Solo 59 i voti contrari tra gli eurodeputati del Partito popolare europeo. Il movimento 5 Stelle è stato l’unico all’interno del gruppo (Efdd) a votare in favore delle sanzioni all’Ungheria di Viktor Orban, mentre gli europarlamentari della Lega, insieme a tutti gli altri componenti del gruppo Enf, hanno votato contro.
Dura la condanna della Lega. "Le sanzioni contro Orban e l’Ungheria votate dal Parlamento Europeo sono una pagina bruttissima per la democrazia e l’intera Europa", ha commentato la capogruppo del partito al Parlamento Europeo, Mara Bizzotto. "Che una parte consistente del Ppe si sia prestato a questo linciaggio politico contro uno dei suoi leader - ha sottolineato - è sotto gli occhi di tutti: spero che Orban, dopo questo affronto, molli il Ppe ed entri a far parte del nuovo blocco identitario e sovranista che stiamo costruendo in vista delle Europee del 2019". Secondo la Bizzotto, "il voto di oggi crea un precedente pericolosissimo. Dopo l’Ungheria di Orban e la Polonia di Kaczyski e Morawiecki, nei prossimi mesi la sinistra e la Ue metteranno nel mirino anche l’Italia, il nostro governo e il nostro leader Matteo Salvini. Non so se gli amici 5 Stelle abbiano compreso questo rischio".
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
EUROPA: LA CRISI UNGHERESE E NOI. Per il dialogo. quello vero!!!
 "Forza" ITALIA ... e "Forza" UNGHERIA!!! Il paradosso del politico mentitore. Un’analisi di BARBARA SPINELLI.
"Forza" ITALIA ... e "Forza" UNGHERIA!!! Il paradosso del politico mentitore. Un’analisi di BARBARA SPINELLI.EUROPA E FILOSOFIA. DALL’UNGHERIA UN APPELLO PER RIPRENDERE E RILANCIARE IL FILO DELLO SPIRITO CRITICO E DELL’ILLUMINISMO KANTIANO
 LA FILOSOFIA E IL CASO UNGHERIA. Ágnes Heller racconta
LA FILOSOFIA E IL CASO UNGHERIA. Ágnes Heller raccontaFREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
Federico La Sala
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. -- Sapere aude! Usare il cervello. "Nature Communications": la centrale del coraggio nei cosiddetti neuroni dell’ippocampo. Note9 settembre 2018, di Federico La Sala
"SAPERE AUDE!". USA IL CERVELLO!.... *
- «L’Illuminismo è l’uscita dell’uomo dallo stato di minorità che egli deve imputare a se stesso. Minorità è l’incapacità di valersi del proprio intelletto senza la guida di un altro. Imputabile a se stesso è questa minorità, se la causa di essa non dipende da difetto d’intelligenza, ma dalla mancanza di decisione e del coraggio di far uso del proprio intelletto senza essere guidati da un altro. Sapere aude! Abbi il coraggio di servirti della tua propria intelligenza! È questo il motto dell’Illuminismo.»
- Immanuel Kant, Risposta alla domanda: che cos’è l’Illuminismo?, 1784.
La ricerca. Cervelli impavidi
Il coraggio, se non ce l’hai te lo danno i neuroni
Nell’ippocampo cellule nervose che azzerano la paura
Le hanno localizzate gli scienziati svedesi studiando i topi che sfidano i gatti
di Giuliano Aluffi (la Repubblica, 09.09.2018, p. 19)
Chi salta da un dirupo, casomai munito di tuta alare per volare via sfrecciando sulle punte degli alberi, è certo un temerario, ma questo sprezzo del pericolo, più che indicatore di forte personalità, potrebbe essere soltanto un dono di natura, legato all’attività di un gruppo particolare di neuroni detti "i neuroni del coraggio". Già noti come gli "interneuroni OLM", si pensava fossero soltanto associati al consolidamento dei ricordi. Il loro ruolo chiave nei comportamenti spavaldi è oggi rivelato da uno studio pubblicato su Nature Communications, che pone le basi per possibili nuove terapie anti ansia e anti disturbo da stress post-traumatico. È un passo avanti rispetto a un recente studio giapponese che mostrava il ruolo della dopamina nello spezzare i riflessi condizionati legati alla paura in assenza di reale pericolo - la dopamina infatti si libera quando una situazione si rivela migliore di quanto temuto.
 Il nuovo studio, infatti, riguarda il comportamento in presenza di reali segnali di rischio, ed è quindi più propriamente legato al coraggio.
Il nuovo studio, infatti, riguarda il comportamento in presenza di reali segnali di rischio, ed è quindi più propriamente legato al coraggio.«L’attività di questi neuroni può azzerare la paura» spiega Klas Kullander, capo del dipartimento di genetica all’Università di Uppsala, in Svezia. «Se al centro di una stanza si mettono a terra dei peli di gatto, i topi normali non osano allontanarsi dai muri perché sentono l’odore del nemico. Ma se stimoliamo i suoi neuroni OLM, il topo si avventurerà senza timore in mezzo alla sala, e calpesterà i peli di gatto come se non ci fossero. Funziona anche l’inverso: disattivando questi neuroni, il topo diventa più timoroso degli altri».
A dare tanto potere ai neuroni OLM è la loro posizione cruciale. «Si trovano vicino ai neuroni principali dell’ippocampo, quelli piramidali, che connettono all’ippocampo due regioni cerebrali importanti come la corteccia prefrontale, sede della cognizione, e l’amigdala, sede della paura» spiega Kullander. «Quando vediamo qualcosa di allarmante la corteccia prefrontale e l’amigdala si attivano entrambe per decidere se siamo in pericolo oppure no. I neuroni OLM ricevono sia il responso dell’amigdala che quello della corteccia prefrontale, fanno un bilancio tra i due e lo trasmettono all’ippocampo. Quando questi neuroni sono molto attivi ed emettono un certo tipo di oscillazioni, dette oscillazioni Theta, il cervello decide che sì, la situazione sarà pure rischiosa, ma noi siamo al sicuro».
Una particolarità di questi neuroni è che hanno dei recettori per la nicotina: «Fumando, li si stimola» spiega Kullander. «Forse è per questo che molti tendono a fumare di più quando sono nervosi». «Se individuassimo altri recettori, oltre a quelli per la nicotina, posseduti soltanto da queste cellule, potremmo sviluppare un farmaco anti ansia molto mirato, che non tocchi altre parti del cervello» spiega il coautore dello studio, Richardson Leão, docente di neuroscienze alla Federal University di Rio Grande do Norte.
 In certi casi, invece, può essere salvifico aumentare l’ansia: «È il nostro prossimo progetto: salvare la vita ai topi infetti da toxoplasmosi. Per scongiurare la trasmissione agli uomini», spiega Leão. «Il parassita della toxoplasmosi per completare il suo ciclo di vita deve entrare nel cervello dei gatti. Ma il suo primo ospite è il topo. Quando il Toxoplasma gondii li infetta, i topi perdono la paura del gatto e addirittura scambiano gli odori del gatto per irresistibili feromoni». Gettandosi entusiasti tra le fauci dei felini e dandola vinta al parassita. «Vogliamo ridare a questi topi la paura dei gatti. E fermare questa zoonosi, assai rischiosa per chi ha il sistema immunitario compromesso» spiega Leão. «Studi dicono che i guidatori con Toxoplasma gondii hanno probabilità di fare incidenti più che doppia rispetto agli altri».
In certi casi, invece, può essere salvifico aumentare l’ansia: «È il nostro prossimo progetto: salvare la vita ai topi infetti da toxoplasmosi. Per scongiurare la trasmissione agli uomini», spiega Leão. «Il parassita della toxoplasmosi per completare il suo ciclo di vita deve entrare nel cervello dei gatti. Ma il suo primo ospite è il topo. Quando il Toxoplasma gondii li infetta, i topi perdono la paura del gatto e addirittura scambiano gli odori del gatto per irresistibili feromoni». Gettandosi entusiasti tra le fauci dei felini e dandola vinta al parassita. «Vogliamo ridare a questi topi la paura dei gatti. E fermare questa zoonosi, assai rischiosa per chi ha il sistema immunitario compromesso» spiega Leão. «Studi dicono che i guidatori con Toxoplasma gondii hanno probabilità di fare incidenti più che doppia rispetto agli altri».
Il nuovo studio
Il coraggio e i Colleoni
di Marino Niola (la Repubblica, 09.09.2018, p. 26)
Il coraggio si trova nei luoghi più impensati, diceva Tolkien. Forse per questo, da che mondo è mondo, gli uomini lo hanno sempre cercato in ogni dove. Nei meandri del corpo e nei ripostigli dell’anima, nella speranza di trovarne almeno quel briciolo che basti a non farsi sopraffare dalle proprie paure. Adesso due neuroscienziati annunciano di aver scovato il nascondiglio.
I ricercatori, lo svedese Klas Kullander dell’Università di Uppsala e il brasiliano Richardson Leao dell’Ateneo di Rio Grande, hanno pubblicato sulla rivista Nature Communications i risultati di uno studio, secondo il quale la centrale del coraggio si troverebbe nei cosiddetti neuroni dell’ippocampo.
Se siamo davanti a uno storico score scientifico è ancora presto per dirlo, ma la notizia sta già facendo sognare. Sia quelli che pensano di non avere abbastanza coraggio, sia quelli che sanno per certo di non poterselo dare da soli, come il don Abbondio manzoniano. E allora ben venga un farmaco, un microchip, un placebo incoraggiante che faccia friccicare nella maniera giusta quei neuroni, che, a detta degli studiosi, «a seconda del ritmo diverso con cui si attivano, fanno sì che un topo sia spaventato dal pelo di un gatto oppure non ne sia per nulla impressionato». Il che, trasposto qualche gradino più in su della scala evolutiva, significa che se l’ippocampo ci gira bene davanti a un rapinatore, anziché farcela sotto, saremmo in grado di reagire col sorriso sulle labbra prima di passare al contrattacco.
Resta il fatto che Kullander e Leao continuano, con gli strumenti di oggi, un’indagine iniziata da millenni. E che ha cercato ogni volta in un organo diverso la sede del coraggio. A partire dal cuore, da cui viene la parola stessa coraggio, che deriva dal latino coraticum, che significa letteralmente "aver cuore". Come il quasi invulnerabile Achille, o il leggendario re Riccardo, passato alla storia come il "Cuor di Leone".
Poi col tempo l’audacia e lo sprezzo del pericolo hanno traslocato al piano inferiore e sono andati a sistemarsi nel fegato. Essere dotato di fegato è stato ed è ancora sinonimo di valoroso, eroico, impavido. Lo raccontava già la mitologia greca che faceva di Prometeo, l’eroe che ha l’ardire di rubare il fuoco agli dei per donarlo ai mortali, l’uomo di fegato per antonomasia. Tant’è vero che Zeus lo punisce facendogli divorare h24 il fegato da un’aquila.
In tempi più recenti la location è scesa ancora più in basso e ha scelto un indirizzo genitale. Coraggioso è chi ha le palle. Ne sapeva qualcosa Bartolomeo Colleoni, il fiero capitano di ventura il cui nome di famiglia derivava dal latino coleus, testicolo. Ne andava così orgoglioso che ne mise ben tre sul suo stemma nobiliare. E andava in battaglia gridando «Coglia, coglia», un’esternazione dal senso inequivocabile. Per la stessa ragione cibarsi di testicoli di toro in Spagna e in altri Paesi a machismo spinto è roba da persone con gli attributi. Come dire una virilità ad alto tasso di testosterone.
E adesso la scienza potrebbe aiutarci a cancellare per sempre la paura. Attenzione però alle controindicazioni di un coraggio senza limiti. È vero che siamo nella civiltà della competizione spinta. Ed è vero pure che quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare. Ma non è detto che vincano. In fondo, come dicono gli etologi, la paura è il più geniale espediente inventato dall’evoluzione per decidere quando conviene osare e quando scappare. Al contrario, non temendo più niente e nessuno, rischiamo di trasformarci in un esercito di colleoni.
*
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- ESSERE GIUSTI CON KANT. La lezione di Michel Foucault e la sorpresa di Habermas.
KANT E SAN PAOLO. COME IL BUON GIUDIZIO ("SECUNDA PETRI") VIENE (E VENNE) RIDOTTO IN STATO DI MINORITA’ DAL GIUDIZIO FALSO E BUGIARDO ("SECUNDA PAULI")
Federico La Sala
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. -- «La sinistra è salita sull’Acropoli. Ora bisogna scendere». "Ora il Pd si sciolga per far nascere la lista Nuova Europa". L’appello di Massimo Cacciari5 settembre 2018, di Federico La Sala
Intervista
"Ora il Pd si sciolga per far nascere la lista Nuova Europa". L’appello di Massimo Cacciari
«La sinistra è salita sull’Acropoli. Ora bisogna scendere». E per battere i nazionalisti alle elezioni del 2019 occorre rompere con il passato. Perché la vecchia Ue è finita per i suoi tradimenti. La proposta del filosofo
di Marco Damilano (l’Espresso, 05 settembre 2018)
Il 3 agosto Massimo Cacciari ha firmato un appello insieme a Enrico Berti, Michele Ciliberto, Biagio de Giovanni, Vittorio Gregotti, Paolo Macrì, Giacomo Manzoni, Giacomo Marramao, Mimmo Paladino, Maurizio Pollini, Salvatore Sciarrino. Nomi della cultura, dell’università, della ricerca: filosofi, artisti, musicisti. In quel testo si parla di «spirale distruttiva», di «pensiero unico intriso di rancore e di risentimento».
E si trova la richiesta di una discontinuità con il passato: «È indispensabile chiudere con il passato ed aprire nuove strade all’altezza della nuova situazione, con una netta ed evidente discontinuità: rovesciando l’ideologia della società liquida, ponendo al centro la necessità di una nuova strategia per l’Europa», in vista della scadenza decisiva dell’anno che si apre: le elezioni europee della primavera 2019. «C’è il rischio che si formi il più vasto schieramento di destra dalla fine della seconda guerra mondiale. La responsabilità di chi ha un’altra idea di Europa è assai grande. Non c’è un momento da perdere».
L’allarme è stato ripreso da tanti in queste settimane e il primo momento di discussione pubblica sarà a Mestre, dal 6 all’8 settembre, al festival della politica organizzato dalla fondazione Gianni Pellicani. Nel frattempo, tutto quello che è successo nel mese di agosto, dal consenso ottenuto dal governo Salvini-Di Maio dopo il crollo del ponte Morandi al blocco della nave Diciotti nel porto di Catania, dalla sfida nei confronti dell’Europa sui contributi Ue all’attacco sui conti pubblici, conferma quanto è scritto nel testo-appello: «Il popolo è contrapposto alla casta, con una apologia della Rete e della democrazia diretta che si risolve, come è sempre accaduto, nel potere incontrollato dei pochi, dei capi. L’ossessione per il problema dei migranti, ingigantito oltre ogni limite, gestito con inaccettabile disumanità, acuisce in modi drammatici una crisi dell’Unione europea che potrebbe essere senza ritorno».
 La nostra conversazione con Massimo Cacciari parte da qui.
La nostra conversazione con Massimo Cacciari parte da qui.«Il nostro appello non va alla ricerca di adesioni formali, è la richiesta di un’assunzione di responsabilità, di un’iniziativa concreta. In alcune università si stanno preparando momenti di dibattito, nel mondo cattolico si sono mosse le Acli, a livello europeo Etienne Balibar sta preparando qualcosa di analogo per la Francia. È un movimento che si attiva a partire da un’urgenza: vogliamo evitare che l’Europa muoia. L’Europa è demograficamente vecchia, ma è necessaria, se non vogliamo un destino popolato da miserabili staterelli sovrastati da quanto decideranno gli Imperi, il ripetersi dei conflitti del Novecento, il ritorno in farsa delle tragedie del vecchio secolo».
Un obiettivo nobile, che rischia di essere fuori tempo massimo. Bisogna evitare che l’Europa muoia, certo. Ma per molti cittadini europei, e italiani, l’Europa è già morta, da tempo, dopo la Brexit, dopo la crisi dell’euro, dopo le crisi dei migranti non governate da nessuno. C’è una vasta letteratura internazionale in materia: penso al dramma in nove atti raccontato dallo studioso indiano Ashoka Mody nel suo “EuroTragedy”, in cui racconta il capovolgimento dell’Europa da continente di pace e sicurezza dopo il secondo conflitto mondiale a terra di divisione. E c’è la crescita dei movimenti sovranisti e populisti, che non hanno una vera prospettiva alternativa, ma si nutrono del tramonto dell’Europa, delle astrattezze, dei tradimenti, del distacco dal popolo con cui è stato portato avanti il processo di integrazione.
«Non è morta l’Europa. È finita l’Europa che si è andata costruendo negli ultimi 20-25 anni. Anni in cui si sono inanellati una serie di errori straordinari. È il punto di partenza di qualsiasi azione: non si possono coprire le immense responsabilità delle classi dirigenti politiche, economiche e intellettuali. L’Europa attuale è una costruzione a-storica, ignorante dello specifico di ogni tradizione, in preda da tempo a una deriva burocratica, centralista, anti-federalistica. La catastrofe finale è arrivata con la crisi economica, quando l’Europa si è mostrata incapace di difendere i suoi cittadini più deboli. È in quel momento che è avvenuto lo strappo tra la coscienza europea e la sua organizzazione. Lo strappo è qui e qui c’è la necessità di una discontinuità radicale con il passato. E quindi: politiche sociali diverse e una costruzione istituzionale di tipo federalista».
Oltre alla crisi economica c’è la questione dei migranti, anche lo spettacolo vergognoso degli ultimi giorni: esseri umani trattati dal governo italiano come arma di ricatto, governi europei incapaci di progettare l’accoglienza e la ricollocazione degli aventi diritto all’asilo, la propaganda scatenata che non incontra resistenze.
«Non si diventa razzisti per opera dello Spirito Santo. Quando nel 1933 i tre quarti dell’elettorato socialdemocratico votarono per Hitler non era arrivato l’Anticristo a sedurre gli uomini, c’era stato un lungo processo storico. Lo stesso vale per quanto accaduto negli ultimi anni. La costruzione centralistica e burocratica e le politiche sociali dominate dal tradimento delle promesse offerte dal vecchio welfare: progresso, benessere. Se rompi questo nesso, i popoli diventano anti-democratici. La crisi ha messo l’Europa a nudo nelle sue debolezze e mancanze e si sono aperte le praterie per le forze anti-europee, ciascuna con le sue particolarità. Per il Front di Marine Le Pen è il sogno di una nuova grandeur francese, nei paesi dell’Est c’è il mito risorgimentale e nazionalista. Per la Lega e il Movimento 5 Stelle in Italia il discorso è diverso, perché fino alla formazione del governo M5S aveva fatto da argine all’elettorato leghista».
Lo storico Timothy Snyder in “La paura e la ragione” (Rizzoli) ha scritto di due narrazioni che si sono confrontate negli ultimi anni. La politica dell’inevitabilità, ovvero l’idea della fine della storia, della globalizzazione come unico orizzonte possibile, è stata sconfitta. E al suo posto c’è la politica dell’eternità: il ritorno ciclico dei miti della razza, del suolo, del territorio, le radici, l’identità.
«Le forze socialiste sono crollate ovunque per la loro subalternità culturale a un modello in cui andava bene tutto: bene l’Europa, bene la moneta unica, bene l’allargamento. Bene, più di tutto, la globalizzazione. Questo spiega perché le forze tradizionali della sinistra europea siano smottate così rapidamente, uno sfaldamento così veloce. Il problema era solo l’Anpassung, come dicono i tedeschi, l’adattamento. Perché, altrimenti, se non ti adattavi, eri fuori dalla storia».
Ricordo il refrain dei congressi, dei convegni, dei politici e degli intellettuali dell’adattamento: dobbiamo gestire la globalizzazione, governarla.
«Magari! Quella era la migliore delle ipotesi, in molti non si ponevano neppure il problema. Per la maggior parte dei leader della sinistra europea la globalizzazione è stata un destino inesorabile, da Tony Blair a Matteo Renzi, vedi l’ammirazione senza sfumature di differenza per il modello Marchionne. E chi non era dentro, chi restava fuori? Era un affar suo, non nostro. La conseguenza è stata una sinistra che vince nei centri storici e perde nelle periferie. Sinistra, hai perso il tuo popolo! Ti sei asserragliata in una acropoli, sotto non esisti più».
Il distacco dal popolo ora è diventato abissale. Il populismo era un risentimento, si è trasformato in un sentimento, popolare.
«Dai leader populisti arriva un messaggio molto semplice: noi difendiamo il nostro popolo. Aprire i confini significa farvi entrare i ladri in casa e noi non lo permetteremo. È una questione che Matteo Salvini usa con grande intelligenza, con grande sagacia, in modo simbolico. Un simbolo enorme: la nostra casa è in pericolo, dobbiamo difenderci. Solo i coglioni, perdonami, dicono che le bandiere e i simboli non contano nulla: contano eccome! Eppure per anni si è detto il contrario, lo ripetevano i Blair e i Renzi. Ma la politica senza simboli, senza un sol dell’avvenire, è ineffettuale. Non produce e non ottiene nulla».
Tutto vero, però anche il vostro appello è stato accusato di intellettualismo, di astrattezza. Qualcuno ha scritto che si punta a far nascere un partito dei sapienti, di poche intelligenze illuminate, i dotti.
«E invece è necessario fare il movimento opposto: scendere dall’acropoli, ricostruire una presenza nella pianura. Il senso del nostro appello è dire a tutti: organizzatevi. Anche perché è evidente che i populisti falliranno e ci porteranno al disastro, per la loro fragilità strategica».
Si può fare prima delle elezioni europee? Con chi?
«In Italia l’unica forza, nel bene e nel male - ora direi soprattutto nel male - è il Pd. Non dà segni di vita, è sordo agli appelli, i suoi esponenti si limitano a dare del barbaro a Salvini, un esercizio sterile. Quando vedo Martina sul molo di Catania, davanti alla nave Diciotti, penso che faccia felice solo Salvini, è un atto di propaganda nei suoi confronti. Perché dietro quel gesto non c’è nessuno. Cosa ti sogni di fare opposizione dopo che da venticinque anni sei al governo o punti ad andarci? Non sei il Pci, come fare l’opposizione a questi l’hanno raccontato i nonni, ma loro non l’hanno mai vista, sono una classe politica che è stata cooptata per andare al governo. Fare l’opposizione in queste condizioni è una cosa comica! Se ci presentiamo così, è finita».
E allora? Va sciolto il Pd e poi cosa?
«La mia idea è fare leva sulla scadenza elettorale del 2019 per costruire un simbolo europeo. Le forze che condividono questo progetto si mettano insieme, in modo transnazionale: Macron in Francia, Ciudadanos in Spagna, Tsipras in Grecia, che è stato bravissimo. Un progetto che si chiami Nuova Europa. Senza questa iniziativa il Pd rischia la liquidazione. O ti ritiri e cavalchi in retromarcia o sfidi i populisti e i sovranisti su questo terreno».
È un progetto che assomiglia al Fronte repubblicano di Carlo Calenda? E che porta al coinvolgimento con il Pd di Forza Italia?
Tra gli intellettuali liberali (Giovanni Orsina, Angelo Panebianco) si discute: arrendersi ai barbari o fare il fronte unico. «Io dico di no. Forza Italia, i conservatori, devono restare fuori. Quello che serve è una forza democratica europea di totale discontinuità con il passato. È questo la Nuova Europa: un progetto di governo nuovo, di rottura con la vecchia interpretazione dell’Europa e in contrasto con i sovranisti».
Il governo di Salvini e di Di Maio arriverà alle elezioni europee?
«La cupiditas dominandi di Di Maio è inarrestabile, sarà difficile che scenda dal governo, M5S potrebbe entrare in difficoltà e sparire. L’unico tranquillo in questo momento è Salvini, con tutti i suoi fronti di sfida, da Fico a Mattarella. Ha un target fortissimo, una bandiera, un simbolo. E ha un nemico, che è essenziale. Le leadership europee sono apparse nemiche dei popoli, è questa la sua forza».
Nelle ultime pagine, in seguito agli articoli di Roberto Esposito sull’Espresso, su cui è intervenuto Ernesto Galli della Loggia sul Corriere della Sera- La Lettura, si è sviluppato un dibattito sull’identità: l’assenza di un’identità che è stata tra i fattori di debolezza dell’Unione europea. Sei convinto che una formazione come la Nuova Europa che proponi sarebbe in grado di superare questo vuoto? Oppure si rischia di rifare un albero senza radici?
«Tu mi parli di radici, ma è Gesù Cristo che ha detto: sarete riconosciuti dai frutti, su quelli sarete giudicati. E allora: chi siamo? Siamo Salvini o siamo altro? L’identità è qualcosa che si cerca, non è data una volta per tutte. L’identità europea è una ricerca, è qualcosa che si fa nella storia. È stato un errore pensare il contrario: un’Europa senza identità e senza simboli o con un’identità da trovare esclusivamente nel passato. La radice dell’identità non va cercata nel passato, la radice si può individuare solo nel futuro».
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. -- L’individuo separato, diceva Aristotele, o è bestia o è dio. Ma il rischio è di essere bestie al servizio di un dio (Michele Ainis).3 settembre 2018, di Federico La Sala
LE TECNOLOGIE DIGITALI E IL LEGAME SOCIALE. Il rimorso dell’incoscienza....*
Animali politici
Quando la solitudine genera i tiranni
Otto milioni e mezzo di italiani vivono soli
L’individuo separato, diceva Aristotele, o è bestia o è dio. Ma il rischio è di essere bestie al servizio di un dio
 Eravamo un popolo, siamo una somma di egoismi, dunque più deboli rispetto alla stretta del potere dispotico
Eravamo un popolo, siamo una somma di egoismi, dunque più deboli rispetto alla stretta del potere dispoticodi Michele Ainis (la Repubblica, 03.09.2018)
Ci si può sentire soli vivendo in compagnia di sessanta milioni di persone? È quanto sta accadendo agli italiani: una solitudine di massa, un sentimento collettivo d’esclusione, di lontananza rispetto alle vite degli altri, come se ciascuno fosse un’isola, una boa che galleggia in mare aperto.
La solitudine si diffonde tra gli adolescenti, presso i quali cresce il fenomeno del ritiro sociale, altrimenti detto hikikomori. Diventa una prigione per gli anziani, la cui unica compagna è quasi sempre la tv. Infine sommerge come un’onda ogni generazione, ogni ceto sociale, ogni contrada del nostro territorio.
Ne sono prova le ricerche sociologiche, oltre che l’esperienza di cui siamo tutti testimoni: 8,5 milioni di italiani (la metà al Nord) vivono da soli; e molti di più si sentono soli, senza un affetto, senza il conforto di un amante o d’un amico. Così, nel 2015, Eurostat ha certificato che il 13,2 per cento degli italiani non ha nessuno cui rivolgersi nei momenti di difficoltà: la percentuale più alta d’Europa.
Mentre l’11,9 per cento non sa indicare un conoscente né un parente con cui parli abitualmente dei propri affanni, dei propri problemi. Non a caso Telefono Amico Italia riceve quasi cinquantamila chiamate l’anno. Non a caso, stando a un Rapporto Censis (dicembre 2014), il 47 per cento degli italiani dichiara di rimanere da solo in media per 5 ore al giorno. E non a caso quest’anno, agli esami di maturità, la traccia più scelta dagli studenti s’intitolava «I diversi volti della solitudine nell’arte e nella letteratura».
Questa malattia non colpisce soltanto gli italiani. È un fungo tossico della modernità, e dunque cresce in tutti i boschi. Negli Stati Uniti il 39 per cento degli adulti non è sposato né convive; mentre l’Health and Retirement Study attesta che il 28 per cento dei più vecchi passa le giornate in uno stato di solitudine assoluta. Succede pure in Giappone, dove gli anziani poveri e soli scelgono il carcere, pur di procurarsi cibo caldo e un po’ di compagnia; o in Inghilterra, dove la metà degli over 75 vive da sola.
Tanto che da quelle parti il governo May, nel gennaio 2018, ha istituito il ministero della Solitudine, affidandone la guida a Tracey Crouch; ma già in precedenza funzionava una commissione con le medesime funzioni, inventata da Jo Cox, la deputata laburista uccisa da un estremista alla vigilia del referendum su Brexit. Insomma, altrove questo fenomeno viene trattato come un’emergenza, si studiano rimedi, si battezzano commissioni e dicasteri. In Italia, viceversa, viaggiamo a fari spenti, senza interrogarci sulle cause delle nuove solitudini, senza sforzarci di temperarne gli effetti. Quanto alle cause, l’elenco è presto fatto.
 In primo luogo la tecnologia, che ci inchioda tutto il giorno davanti allo schermo del cellulare o del computer, allontanandoci dal contatto fisico con gli altri, segregandoci in una bolla virtuale.
In primo luogo la tecnologia, che ci inchioda tutto il giorno davanti allo schermo del cellulare o del computer, allontanandoci dal contatto fisico con gli altri, segregandoci in una bolla virtuale.
 In secondo luogo l’eclissi dei luoghi aggreganti - famiglia, chiesa, partito - sostituiti da una distesa di periferie che ormai s’allargano fin dentro i centri storici delle città.
In secondo luogo l’eclissi dei luoghi aggreganti - famiglia, chiesa, partito - sostituiti da una distesa di periferie che ormai s’allargano fin dentro i centri storici delle città.In terzo luogo le nuove forme del commercio e del consumo: chiudono i negozi, dove incontravi le persone; aprono gli ipermercati, dove ti mescoli alla folla.
 In quarto luogo l’invecchiamento della popolazione, che trasforma una gran massa d’individui in ammalati cronici, e ciascuno è sempre solo dinanzi al proprio male.
In quarto luogo l’invecchiamento della popolazione, che trasforma una gran massa d’individui in ammalati cronici, e ciascuno è sempre solo dinanzi al proprio male.
 In quinto luogo e infine, la precarietà dell’esistenza: una volta ciascuno moriva nel paesello in cui era nato, dopo aver continuato lo stesso mestiere del nonno e del papà; ora si cambia città e lavoro come ci si cambia d’abito, senza trovare il tempo di farsi un nuovo amico, di familiarizzare con i nuovi colleghi.
In quinto luogo e infine, la precarietà dell’esistenza: una volta ciascuno moriva nel paesello in cui era nato, dopo aver continuato lo stesso mestiere del nonno e del papà; ora si cambia città e lavoro come ci si cambia d’abito, senza trovare il tempo di farsi un nuovo amico, di familiarizzare con i nuovi colleghi.Con quali conseguenze?
Secondo un gruppo di ricercatori della Brigham Young University, la solitudine danneggia la salute quanto il fumo di 15 sigarette al giorno: giacché provoca squilibri ormonali, malumore, pressione alta, insonnia, maggiore vulnerabilità alle infezioni. Altri studiosi (John e Stephanie Cacioppo, dell’Università di Chicago) mettono l’accento sull’aggressività dei solitari, le cui menti sviluppano un eccesso di reazione, uno stato di perenne allerta, come dinanzi a un pericolo incombente. C’è un altro piano, tuttavia, ancora da esplorare: la politica, il governo della polis. L’individuo separato o è bestia o è dio, diceva Aristotele. Ma nelle società contemporanee la solitudine di massa ci rende tutti bestie alla mercé di un dio.
Sussiste una differenza, infatti, tra solitudine e isolamento. La prima può ben corrispondere a una scelta; il secondo è sempre imposto, è una condanna che subisci tuo malgrado. Nell’epoca della disintermediazione, della crisi di tutti i corpi collettivi, della partecipazione politica ridotta a un tweet o a un like, questa condanna ci colpisce uno per uno, trasformandoci in una nube d’atomi impazziti. Eravamo popolo, siamo una somma d’egoismi, senza un collante, senza un sentimento affratellante. Dunque più deboli rispetto alla stretta del potere.
Perché è la massa, non il singolo, che può arginarne gli abusi. E perché il potere dispotico - ce lo ha ricordato Hannah Arendt (Vita activa), sulle orme di Montesquieu - si regge sull’isolamento: quello del tiranno dai suoi sudditi, quello dei sudditi fra loro, a causa del reciproco timore e del sospetto.
Sicché il cerchio si chiude: le nostre solitudini ci consegnano in catene a un tiranno solitario.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- GLI APPRENDISTI STREGONI E L’EFFETTO "ITALIA". LA CLASSE DIRIGENTE (INCLUSI I GRANDI INTELLETTUALI) CEDE (1994) IL "NOME" DEL PAESE AL PARTITO DI UN IMPRENDITORE. Che male c’è?! - Materiali sul tema
LA "PROFEZIA" DI MARSHALL MCLUHAN: NARCISO E LA MORTE DELL’ITALIA. Il "rimorso di incoscienza" di Marshall McLuhan
 LA CONCESSIONE PIU’ GRANDE. Cedere occhi, orecchie e nervi a interessi commerciali è come consegnare il linguaggio comune a un’azienda privata o dare in monopolio a una società l’atmosfera terrestre.
LA CONCESSIONE PIU’ GRANDE. Cedere occhi, orecchie e nervi a interessi commerciali è come consegnare il linguaggio comune a un’azienda privata o dare in monopolio a una società l’atmosfera terrestre.Federico La Sala
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. -- STUPIDO. Dal punto di vista etimologico, "stupidus" contiene la stessa radice di “stupore”.30 agosto 2018, di Federico La Sala
Come siamo evoluti: da doppi “sapiens” a tripli “stupidus”
Lo psichiatra Vittorino Andreoli analizza “l’agonia di una civiltà” fin dall’errore di porre “Homo” all’apice dell’albero della vita, a oggi che ha messo a riposo la neocorteccia
di Vittorino Andreoli (Il Fatto, 30.o8.2018)
- Pubblichiamo un estratto del nuovo libro dello psichiatra Vittorino Andreoli.
Nell’Origine delle specie di Charles Darwin (pubblicato nel 1859) l’uomo è posto all’apice dell’albero della vita con la definizione di Homo sapiens sapiens. Mi ha sempre colpito la ripetizione di sapiens, un rafforzativo legato, credo, al salto evolutivo della nostra specie che, rispetto a quello delle precedenti, deve essere subito apparso eccezionale, forse miracoloso. Considerando il significato del termine sapiens, tuttavia, questa sottolineatura appare del tutto ingiustificata, poiché il sapiente dovrebbe essere colui che giunge al vertice dell’umanità con comportamenti privi di qualsiasi aporia.
La definizione di Homo sapiens sapiens appare, dunque, emotiva e priva di significato letterale. Suona più come: “Sa tutto e altro ancora”. [...]. Partendo da queste osservazioni, c’è chi ha persino criticato le tappe evolutive darwiniane mostrando che, se venissero stabilite sulla base di specifiche funzioni (come quelle citate), la specie umana non si troverebbe affatto all’apice dell’albero della vita. [...]
A esprimere la sproporzione terminologica di quel doppio sapiens, è tuttavia l’uomo del tempo presente, che sembra essere smarrito e avere perduto quel beneficio della neocorteccia che giustifica per gli antropologi la generosità di quel doppio sapiens.
Si ha l’impressione che oggi l’uomo abbia messo a riposo la neocorteccia rinunciando a quel salto evolutivo che lo distacca dagli altri primati, come gli scimpanzé e, in particolare, i bonobo, che hanno raggiunto l’abilità di reggersi sugli arti inferiori, di potersi così guardare in faccia, accoppiarsi frontalmente (e non per monta) e persino baciarsi sulla bocca. Questa ipotesi regressiva non è fantasiosa: basta tenere conto dell’importanza raggiunta dalle tecnologie digitali, che rappresentano una vera e propria protesi del cervello e delle sue funzioni mentali. Ne può derivare una messa a riposo della neocorteccia con la delega a svolgere le sue funzioni alle “macchinette” digitali.
A dare una grande spinta alla nostra critica, è proprio l’osservazione di comportamenti dell’uomo che in nessun modo possono essere fatti rientrare nell’ambito della sapienza. Quel che si constata è che non si tratta di errori casuali o voluti all’interno di comportamenti dominanti positivi, ma di un vero e proprio errore strutturale che diventa pertanto comportamento precipuo, esclusivo, regola.
È per questo che l’aggettivo sapiens si dimostra del tutto inadeguato, rendendo invece corretto il ricorso a un termine antinomico: stupidus, Homo stupidus. Per simmetria, poi, occorre sottolinearlo due volte: Homo stupidus stupidus. Se si tenesse conto del livello di stupidità, si sarebbe anzi tentati di triplicarla per avere la certezza che, indipendentemente dal luogo in cui la specie Homo vada posta nell’albero della vita, non incontri alcuna concorrenza.
La parola “stupido” va usata nella sua espressione latina, stupidus, non solo per rispettare la consuetudine della terminologia antropologica, ma per distinguerla dal senso popolare che possiede in italiano. È considerato stupido chiunque non abbia, in una data circostanza, tenuto conto della realtà, e che si sia comportato in modo poco o per nulla intelligente.
Dal punto di vista etimologico, stupidus contiene la stessa radice di “stupore”, termine che descrive una sensazione inattesa e persino incredibile, che lascia cioè attoniti, sbalorditi. Incredibile che un uomo possa comportarsi in quel dato modo, ma incredibile soprattutto che lo possa fare una comunità intera, un popolo. [...] Ed è questa stupiditas che ora ci proponiamo di mostrare analizzando dapprima la Distruttività, poi La caduta dei princìpi che sono a fondamento della civiltà occidentale e, infine, descrivendo le caratteristiche dell’Uomo senza misura.
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. -- La filosofia serve ma non è servile. Vuole capire e cambiare la realtà. Collana "Corriere della Sera": si comincia dalla coraggiosa lezione dei Greci (di Mauro Bonazzi)26 agosto 2018, di Federico La Sala
La filosofia serve ma non è servile. Vuole capire e cambiare la realtà
- LA COLLANA - CON IL «CORRIERE DELLA SERA». È in edicola il 29 agosto la nuova serie dedicata ai fondamenti della conoscenza
 Si comincia dalla coraggiosa lezione dei Greci per spazzare via arroganza e pregiudizi
Si comincia dalla coraggiosa lezione dei Greci per spazzare via arroganza e pregiudizi
di MAURO BONAZZI (Corriere della Sera, 26.08.2018) *
- [Foto] Olimpia presenta il piccolo Alessandro ad Aristotele di Gerard Hoet il Vecchio. Olimpia era la madre di Alessandro Magno, di cui Aristotele fu precettore
«L’eredità lasciata dalla Grecia alla filosofia occidentale è la filosofia occidentale». Molti anni fa lo storico Moses Finley chiese ad alcuni eminenti colleghi di riflettere su quello che la nostra civiltà ha ereditato dal mondo antico. La lista è lunga: dalla democrazia al teatro, molte delle istituzioni e tradizioni che regolano le nostre vite sono nate proprio in Grecia, qualche millennio fa. Vale anche per la filosofia, naturalmente. Con una particolarità, però, che evidenziava Bernard Williams, uno dei più importanti pensatori di questi ultimi anni, nella frase appena citata. Non si tratta soltanto di ricordare che la filosofia si è formata in Grecia per poi svilupparsi altrove. In filosofia non ha senso parlare di progressi o evoluzioni.
 L’eredità della filosofia greca è la filosofia, semplicemente: siamo sempre lì. Il problema è capire che cosa sia la filosofia.
L’eredità della filosofia greca è la filosofia, semplicemente: siamo sempre lì. Il problema è capire che cosa sia la filosofia.Una delle prime occorrenze del termine si trova in uno storico, Erodoto, quando parla di Solone, un poeta, e dei viaggi che aveva compiuto alla scoperta del mondo mediterraneo. Per questo Erodoto lo chiama philosophos. Per Pericle, il grande politico ateniese, philosophoi erano addirittura tutti gli Ateniesi, sempre pronti ad andare a teatro e sempre curiosi di ogni novità. Per Eraclito, invece, era un insulto: philosophoi sono quelli che si perdono dietro al vano desiderio di erudizione e non capiscono le poche cose che contano. È curioso: uno dei primi filosofi rifiuta con sdegno la parola, che invece altri sono ben contenti di usare. Per fare un po’ di ordine, bisognerà aspettare Platone.
Che cosa significa philosophia? La risposta è semplice: un desiderio, un amore (philo-) per il sapere e la conoscenza (sophia). Sembra banale: siamo animali razionali, è evidente che l’uso del cervello, la conoscenza e il sapere, siano importanti per la nostra vita. Diventa meno banale quando ci rendiamo conto che conosciamo molto meno di quello che pensiamo. Philosophia è il desiderio di sapere. Ma il desiderio è sempre di quello che non si ha. E infatti su ciò che davvero conta non sappiamo anzi quasi nulla: chi siamo? Da dove veniamo e dove andiamo? Che cos’è la giustizia: esiste o è una semplice convenzione? E Dio o l’amore?
Non si tratta di problemi astratti o polverosi, come spiega Socrate a Trasimaco. Se non sappiamo cosa è bene e cosa è male, è difficile pensare di poter vivere felicemente. Ancora peggio: se crediamo di sapere e invece non sappiamo, se crediamo che sia bene qualcosa che è male, l’infelicità è assicurata. Non resta dunque che riflettere e ragionare, liberandoci delle convinzioni infondate, cercando ciò che davvero importa. L’ambizione della filosofia è imparare, e insegnare, a pensare bene per vivere bene.
Non è un compito facile e a volte sembra che si giri a vuoto con discussioni inconcludenti. Non stupisce allora che fin dai tempi di Platone l’obiezione sia sempre la stessa: filosofare non serve a nulla. Da un certo punto di vista è così: ed è la grandezza della filosofia. La filosofia non serve a nulla, perché non è un sapere servile, perché non si piega alla realtà, accettandola come viene presentata: la mette in discussione pensando a nuove soluzioni e alternative, ricordandoci che le cose potrebbero andare diversamente da come vanno, e magari pure meglio. Senza però, e questo è il punto più importante, voler imporre nulla a nessuno.
Era la lezione di Socrate, il filosofo per eccellenza per tutti (o quasi: Epicuro lo considerava un insopportabile trombone). Interrogava le persone che incontrava, mettendone alla prova il sapere (spesso più apparente che reale), cercando di liberarle dai pregiudizi. Ma non si pretendeva in possesso di alcuna verità: sapeva di non sapere. Criticava senza offrire risposte definite. Aiutava a mettere a fuoco i problemi e le domande; invitava a pensare, riflettere, ragionare. Ognuno poi, ciascuno singolarmente preso e ogni generazione nel suo insieme, avrebbe dovuto trovare la propria risposta. È la sfida più bella. Sarebbe un peccato non accettarla.
Per farlo bisogna evitare un errore decisivo. Tutti siamo naturalmente filosofi, perché i problemi della filosofia sono i problemi di tutti. Ma dobbiamo anche imparare a filosofare, vale a dire a ragionare, che è meno facile di quanto si creda. Per ragionare bene bisogna prima comprendere di che cosa si discute, quali sono le vere questioni, e come possono essere affrontate. A questo servono manuali, dizionari e storie, quando sono fatti bene. E per questo vale la pena, ancora oggi, di dedicarsi a Eraclito e Parmenide, Platone e Aristotele, Epicuro e gli Stoici, con le loro idee originali, a volte strampalate ma sempre appassionanti.
Tanto, piaccia o non piaccia, della filosofia non si può fare a meno, spiegava Aristotele: «Chi pensa che sia necessaria la filosofia, farà filosofia; e chi pensa che non sia necessaria, dovrà comunque filosofare per dimostrare che non si deve filosofare: dunque si deve filosofare in ogni caso, o andarsene di qui dando l’addio alla vita, perché tutte le altre cose sono solo chiacchere e vaniloqui». Se lo dice lui...
*
- LA COLLANA - CON IL «CORRIERE DELLA SERA»
 È in edicola il 29 agosto la nuova serie dedicata ai fondamenti della conoscenza
È in edicola il 29 agosto la nuova serie dedicata ai fondamenti della conoscenza
Socrate, Platone, Aristotele, i grandi maestri antichi
In edicola dal 29 agosto al prezzo di 1,90 euro il primo volume, «Il pensiero greco»
di Redazione Cultura (Corriere della Sera, 26.08.2018)
- [Foto] La copertina del primo volume della collana «Filosofia»
Dal prossimo 29 agosto il «Corriere della Sera» offre ai suoi lettori una preziosa opportunità di approfondimento sui temi del pensiero e della conoscenza. Si tratta della collana Filosofia. Storia, parole, temi, realizzata in collaborazione con Utet: un percorso firmato da studiosi di grande prestigio come Nicola Abbagnano (1901-1990), Paolo Rossi (1923-2012) e Giovanni Fornero.
 L’opera, costituita complessivamente da 22 volumi (nel grafico a destra i primi 15 titoli), comprende diverse sezioni. Si parte con la Storia della filosofia di Abbagnano, un autentico classico, completata e ampliata, con nuove introduzioni, da Fornero con la collaborazione di Franco Restaino e Dario Antiseri.
L’opera, costituita complessivamente da 22 volumi (nel grafico a destra i primi 15 titoli), comprende diverse sezioni. Si parte con la Storia della filosofia di Abbagnano, un autentico classico, completata e ampliata, con nuove introduzioni, da Fornero con la collaborazione di Franco Restaino e Dario Antiseri.
 I cinque volumi dall’11 al 14 propongono invece un’opera di natura analitica, il Dizionario di filosofia realizzato da Abbagnano, anch’esso aggiornato e ampliato da Fornero.
I cinque volumi dall’11 al 14 propongono invece un’opera di natura analitica, il Dizionario di filosofia realizzato da Abbagnano, anch’esso aggiornato e ampliato da Fornero.
 Si passa poi, dal volume 21 in avanti all’opera La filosofia, diretta da Paolo Rossi, con saggi di approfondimento firmati di illustri studiosi.
Si passa poi, dal volume 21 in avanti all’opera La filosofia, diretta da Paolo Rossi, con saggi di approfondimento firmati di illustri studiosi.Il primo volume è Il pensiero greco di Abbagnano, dedicato ai grandi filosofi classici dell’antichità, che parte dagli autori presocratici e giunge fino al neoplatonismo. Esce in edicola con il «Corriere» mercoledì prossimo al prezzo speciale di euro 1,90 più il costo del quotidiano, mentre tutti i successivi titoli di Filosofia. Storia, parole, temi saranno in vendita a euro 8,90 più il prezzo del giornale.
Seguiranno i volumi che proseguono il complesso itinerario storico tracciato da Abbagnano lungo i secoli: Il Cristianesimo e la filosofia medievale (5 settembre); Dal Medioevo al Rinascimento (12 settembre); Il pensiero moderno da Cartesio a Kant (19 settembre); Dal Romanticismo a Nietzsche (26 settembre).
- LA COLLANA - CON IL «CORRIERE DELLA SERA». È in edicola il 29 agosto la nuova serie dedicata ai fondamenti della conoscenza
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. -- "HO FATTO IL MIO DOVERE": I DISASTRI "IRREPARABILI" E IL SENNO DI POI. Una riflessione sul "senno di prima".22 agosto 2018, di Federico La Sala
IL "FARE IL PROPRIO DOVERE", I DISASTRI "IRREPARABILI", E IL SENNO DI PRIMA....
- (...) assumersi il rischio personale di andare controcorrente, e di superare derisioni e ostracismo, di non farsi influenzare dal dispositivo di derivazione kantiana, «faccio quel che devo, accada quel che può» (Maurizio Fiasco, "Tutti i disastri «irreparabili» e il senno di prima", Avvenire, 18.08.2018)).
- "Non ho fatto che obbedire. Ho fatto solo il mio dovere" (Adolf Eichmann).
- Avere il coraggio di dire ai giovani che essi sono tutti sovrani, per cui l’obbedienza non è ormai più una virtù, ma la più subdola delle tentazioni, che non credano di potersene far scudo né davanti agli uomini né davanti a Dio, che bisogna che si sentano ognuno l’unico responsabile di tutto (don Lorenzo Milani),
Tutti i disastri «irreparabili» e il senno di prima
Dopo il ragionamento è il solito, col senno di poi: come è stato possibile che nessuno vedesse e capisse prima dell’irreparabile fatto?
di Maurizio Fiasco (Avvenire, sabato 18 agosto 2018)
- Il balletto delle responsabilità inizia sempre dopo, col senno di poi. Il senno di prima è ignoto (Fotogramma)
Come accadono i disastri? C’è un’espressione, all’apparenza banale ma ricorrente, quando siamo sconcertati per un evento dai costi umani incalcolabili. «Col senno di poi». Che equivale: come è stato possibile che nessuno vedesse e capisse prima dell’irreparabile fatto? Quel che ha condotto al precipitare di una situazione - fisica, come un ponte, oppure comportamentale come una battaglia, un volo, il funzionamento di uno stabilimento industriale - aveva già emesso dei segnali.
 I disastri - risulta quasi sempre agli investigatori ex post - hanno avuto una incubazione, più o meno lunga. Incubazione tutt’altro che muta, o col bavaglio, anzi spesso visibile per un complesso di segnali. Come ha insegnato, quarant’anni fa un illuminato e inascoltato Barry Turner, non sono prevenuti - ovvero fermati da decisioni pragmatiche - per le patologie della comunicazione tra gli attori di un sistema. Industriale, amministrativo, finanziario, politico: non importa la scala di grandezza. Le incompetenze si strutturano e agiscono come un sistema.
I disastri - risulta quasi sempre agli investigatori ex post - hanno avuto una incubazione, più o meno lunga. Incubazione tutt’altro che muta, o col bavaglio, anzi spesso visibile per un complesso di segnali. Come ha insegnato, quarant’anni fa un illuminato e inascoltato Barry Turner, non sono prevenuti - ovvero fermati da decisioni pragmatiche - per le patologie della comunicazione tra gli attori di un sistema. Industriale, amministrativo, finanziario, politico: non importa la scala di grandezza. Le incompetenze si strutturano e agiscono come un sistema.I segnali sono sfuggiti a un apparato cognitivo, a una mente capace di connetterli e perciò di abbattere le barriere che inibiscono il giudizio. È mancata la responsabilità di contrastare la universale ottusità dei sistemi, di tutti i sistemi organizzativi. Che squalificano la coscienziosità di chi abbia colto il segnale e si sia posto in modo attivo per spingere al provvedere.
 Egli finisce per scontrarsi con la gerarchia, con i muri levati su dai rituali dell’organizzazione, per impattare con la squalificazione che si replica davanti all’umile operatore che sta sul terreno e lì ’vede’ qualcosa che non va. Oppure c’è il feticcio della responsabilità di vertice. Chi è in alto - pensa il testimone dei segnali che il disastro sta inviando - lo capirà più e meglio di me.
Egli finisce per scontrarsi con la gerarchia, con i muri levati su dai rituali dell’organizzazione, per impattare con la squalificazione che si replica davanti all’umile operatore che sta sul terreno e lì ’vede’ qualcosa che non va. Oppure c’è il feticcio della responsabilità di vertice. Chi è in alto - pensa il testimone dei segnali che il disastro sta inviando - lo capirà più e meglio di me.Ma il superiore guarda al consenso e alle conferme di chi siede ancora più in alto di lui. E quest’ultimo rivolge la sua mente al mandato di chi è il supremo detentore di quel bene, di quella situazione, di quel dato potere. E tutto questo complesso di fattori cambia la prospettiva, perché il conformismo è più potente della psicologia della responsabilità.
 A meno che nella persona responsabile in situazione trovino nutrimento valori morali assoluti: che spingono ad assumersi il rischio personale di andare controcorrente, e di superare derisioni e ostracismo, di non farsi influenzare dal dispositivo di derivazione kantiana, «faccio quel che devo, accada quel che può».
A meno che nella persona responsabile in situazione trovino nutrimento valori morali assoluti: che spingono ad assumersi il rischio personale di andare controcorrente, e di superare derisioni e ostracismo, di non farsi influenzare dal dispositivo di derivazione kantiana, «faccio quel che devo, accada quel che può».Insomma, la responsabilità, invece di essere ispirata a valori trascendenti, si attesta alla procedura, al ’di fronte’, a quel che le regole gerarchiche - per esempio il mandato degli azionisti - hanno assegnato. E così si scambia la diversa posizione ricoperta nella piramide organizzativa con la diversità di valori etici e professionali di quanti operano in una struttura complessa: che invece, a rigore, sono unici e universali. Cioè per tutti. Nelle forze armate, dal piantone al generale; nelle autostrade, dall’operaio che passa il bitume all’amministratore delegato della infrastruttura. Unitarietà dei valori e trasparenza della comunicazione sono la speranza del «senno di prima». Potremmo dire l’intelligenza del Buon Samaritano che si prende carico della complessità della situazione e non trascura alcuna variabile.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
Sul tema, nel sito, si cfr.:
LO STATO DEL FARAONE, LO STATO DI MINORITA’, E IMMANUEL KANT "ALLA BERLINA" - DOPO AUSCHWITZ
 "LEZIONE SU KANT" A GERUSALEMME: PARLA EICHMANN "PILATO", IL SUDDITO DELL’"IMPERATORE-DIO".
"LEZIONE SU KANT" A GERUSALEMME: PARLA EICHMANN "PILATO", IL SUDDITO DELL’"IMPERATORE-DIO".PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!
 FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.Federico La Sala
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. -- La cultura batta un colpo. Di fronte ai nazionalismi gli intellettuali devono con urgenza risvegliare nei loro Paesi il sogno dell’Europa.6 agosto 2018, di Federico La Sala
L’EUROPA, OGGI: HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA ....
La società civile
La cultura batta un colpo
Di fronte ai nazionalismi gli intellettuali devono con urgenza risvegliare nei loro Paesi il sogno dell’Europa
di Guido Crainz (la Repubblica, 06.08.2018)
Forse c’è una ragione se una parte non piccola del mondo culturale appare oggi impotente e quasi attonita di fronte alla crisi sempre più drammatica dell’Europa: forse di quella crisi ha anch’essa responsabilità non lievi. Forse al fondo non vi sono solo responsabilità politiche (certamente enormi) ma anche inadeguatezze e inerzie della cultura, incapace di accompagnare il processo di unificazione con un radicale salto di qualità nel confronto e nella circolazione di idee. Nella costruzione di uno sguardo comune sul futuro e al tempo stesso sulle ferite e sulle lacerazioni del passato.
Anche per pigrizie e passività della cultura, forse, i due momenti che sembrarono sancire il coronamento di un sogno - l’avvio dell’euro e poi l’allargamento del 2004 - segnarono in realtà l’inizio del suo incrinarsi. Era stato inevitabile - annotava vent’anni fa Ezio Mauro su queste pagine - « avviare l’unificazione attraverso l’unico comun denominatore oggi possibile, quello della moneta » , ma era urgente « dare un contesto istituzionale, culturale e politico a questa moneta. Perché rappresenti l’Europa e non soltanto un gruppo di Paesi comandati da una banca».
Il compito divenne ancor più necessario dopo l’allargamento del 2004, e fu disatteso ancor più gravemente: eppure entravano allora nell’Unione parti decisive di un Occidente che era stato a lungo "sequestrato" dall’Urss, per dirla con Milan Kundera, e largamente abbandonato dal resto dell’Europa (o che tale si sentiva).
Vi entravano Paesi che non avevano conosciuto reali democrazie neppure prima dei regimi comunisti, ove si eccettui la Cecoslovacchia fra le due guerre. E proprio la vicenda del " gruppo di Visegrád" ci fa cogliere nodi irti, perché esso non nasce " contro l’Europa". Tutt’al contrario, nasce nel 1991 come strumento per l’allargamento della costruzione europea, promosso da figure come Václav Havel e Lech Walesa: quando è iniziato il processo inverso? Su quali errori politici e su quali scelte economiche inadeguate, su quali cecità e chiusure esso ha potuto prosperare?
Appaiono oggi drammaticamente profetiche le parole pronunciate nel 1990 al Senato polacco da Bronislaw Geremek, uno dei principali dirigenti di Solidarnosc. Nei nostri Paesi post-comunisti, osservava, c’è oggi euforia per una libertà riconquistata ma vi è al tempo stesso «un senso di debole radicamento delle istituzioni democratiche e del pensiero democratico » . E aggiungeva:
 «Tre pericoli accompagnano in questa fase transitoria i Paesi che si sono liberati dalla dittatura comunista. Il primo è il populismo, che ha un naturale terreno di coltura nelle esperienze vissute finora da tali società e si fonda sulle illusioni egualitarie.
«Tre pericoli accompagnano in questa fase transitoria i Paesi che si sono liberati dalla dittatura comunista. Il primo è il populismo, che ha un naturale terreno di coltura nelle esperienze vissute finora da tali società e si fonda sulle illusioni egualitarie.
 Il secondo è la tentazione di instaurare governi dalla mano forte, particolarmente avvertita nelle società post-comuniste proprio perché in esse le istituzioni democratiche sono deboli. Il terzo è il nazionalismo ».
Il secondo è la tentazione di instaurare governi dalla mano forte, particolarmente avvertita nelle società post-comuniste proprio perché in esse le istituzioni democratiche sono deboli. Il terzo è il nazionalismo ».
 Sino ad ora, concludeva, il sentimento nazionale è stato un elemento naturale di solidarietà e di resistenza all’oppressione sovietica ma ora può «deformarsi e diventare nazionalismo e sciovinismo ».
Sino ad ora, concludeva, il sentimento nazionale è stato un elemento naturale di solidarietà e di resistenza all’oppressione sovietica ma ora può «deformarsi e diventare nazionalismo e sciovinismo ».Alcuni nodi sono tratteggiati qui in modo straordinario, e si aggiungano le ferite del passato: non ha certo pesato poco in Ungheria il trattato di Trianon - evocato sabato da Cuperlo - che dopo la Prima guerra mondiale l’ha amputata di ampie parti ( si legga almeno il Sándor Márai di "Volevo tacere"), o in Cecoslovacchia quel patto di Monaco che aprì la via ad Hitler ( il primo " tradimento dell’Europa", seguito dall’inerzia di fronte al colpo di stato comunista del 1948 e poi di fronte all’invasione dell’agosto di cinquant’anni fa).
Se questo è vero, è anche nella costruzione di uno sguardo comune sul futuro e sul passato che dobbiamo procedere, in un confronto molto più aperto e continuo di quello attuale: molto più capace di superare le deformazioni e di rispondere realmente alle differenti memorie nazionali. O a veri e propri vuoti di conoscenza. È un compito di lungo periodo, naturalmente, ma è decisivo avviare subito una radicale inversione di tendenza rispetto a troppe pigrizie intellettuali: l’avvicinarsi di elezioni europee cruciali, giustamente evocato dall’appello di Cacciari e di altri, ne aumenta l’urgenza.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
EICHMANN A GERUSALEMME (1961). “come fu possibile la hitlerizzazione dell’Imperativo Categorico di Kant? E perché è ancora attuale oggi?” (Emil L. Fackenheim, Tiqqun. Riparare il mondo).
 HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI.
HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI.Federico La Sala
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- Prepariamoci alle Europee. L’ appello di Massimo Cacciari3 agosto 2018, di Federico La Sala
POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. Non è mai troppo tardi .... *
L’ appello
Prepariamoci alle Europee
di Massimo Cacciari (la Repubblica, 03.08.2018)
La situazione dell’Italia si sta avvitando in una spirale distruttiva. L’alleanza di governo diffonde linguaggi e valori lontani dalla cultura - europea e occidentale - dell’Italia. Le politiche progettate sono lontane da qualsivoglia realismo e gravemente demagogiche. Nella mancanza di una seria opposizione, i linguaggi e le pratiche dei partiti di governo stanno configurando una sorta di pensiero unico, intriso di rancore e risentimento. Il popolo è contrapposto alla casta, con una apologia della Rete e della democrazia diretta che si risolve, come è sempre accaduto, nel potere incontrollato dei pochi, dei capi. L’ossessione per il problema dei migranti, ingigantito oltre ogni limite, gestito con inaccettabile disumanità, acuisce in modi drammatici una crisi dell’Unione europea che potrebbe essere senza ritorno.
L’Europa è sull’orlo di una drammatica disgregazione, alla quale l’Italia sta dando un pesante contributo, contrario ai suoi stessi interessi. Visegrad nel cuore del Mediterraneo: ogni uomo è un’isola, ed è ormai una drammatica prospettiva la fine della libera circolazione delle persone e la crisi del mercato comune. È diventata perciò urgentissima e indispensabile un’iniziativa che contribuisca a una discussione su questi nodi strategici. In Italia esiste ancora un ampio spettro di opinione pubblica, di interessi sociali, di aree culturali disponibile a discutere questi problemi e a prendere iniziative ormai necessarie.
Perché ciò accada è indispensabile individuare, tempestivamente, nuovi strumenti in grado di ridare la parola ai cittadini che la crisi dei partiti e la virulenza del nuovo discorso pubblico ha confinato nella zona grigia del disincanto e della sfiducia, ammutolendoli.
 Per avviare questo lavoro - né semplice né breve - è indispensabile chiudere con il passato ed aprire nuove strade all’altezza della nuova situazione, con una netta ed evidente discontinuità: rovesciando l’ideologia della società liquida, ponendo al centro la necessità di una nuova strategia per l’Europa, denunciando il pericolo mortale per tutti i paesi di una deriva sovranista, che, in parte, è anche il risultato delle politiche europee fin qui condotte.
Per avviare questo lavoro - né semplice né breve - è indispensabile chiudere con il passato ed aprire nuove strade all’altezza della nuova situazione, con una netta ed evidente discontinuità: rovesciando l’ideologia della società liquida, ponendo al centro la necessità di una nuova strategia per l’Europa, denunciando il pericolo mortale per tutti i paesi di una deriva sovranista, che, in parte, è anche il risultato delle politiche europee fin qui condotte.C’è una prossima scadenza, estremamente importante, che spinge a mettersi subito in cammino: sono ormai alle porte le elezioni europee. C’è il rischio che si formi il più vasto schieramento di destra dalla fine della Seconda guerra mondiale. La responsabilità di chi ha un’altra idea di Europa è assai grande. Non c’è un momento da perdere. Tutti coloro che intendono contribuire all’apertura di una discussione pubblica su questi temi, attraverso iniziative e confronti in tutte le sedi possibili, sono invitati ad aderire.
Gli altri firmatari: Enrico Berti Michele Ciliberto Biagio de Giovanni Vittorio Gregotti Paolo Macrì Giacomo Manzoni Giacomo Marramao Mimmo Paladino
Sul tema, nel sito, si cfr.:
FILOSOFIA. IL PENSIERO DELLA COSTITUZIONE E LA COSTITUZIONE DEL PENSIERO
 MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA E A PENSARE BENE "DIO", "IO" E "L’ITALIA", CHI PIÙ CHI MENO, TUTTI VIVONO DENTRO LA PIÙ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA E POLITICA ITALIANA, NEL REGNO DI "FORZA ITALIA"!!!
MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA E A PENSARE BENE "DIO", "IO" E "L’ITALIA", CHI PIÙ CHI MENO, TUTTI VIVONO DENTRO LA PIÙ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA E POLITICA ITALIANA, NEL REGNO DI "FORZA ITALIA"!!!UNITÀ D’ITALIA E FOLLIA: EMERGENZA LOGICO-POLITICA EPOCALE. PER UN CONVEGNO E UNA RIFLESSIONE SUL CONCETTO DI ’UNITÀ E DI SOVRANITÀ (SOVRA-UNITÀ). Materiali sul tema
Federico La Sala
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. -- POPULISMO E PRINCIPI COSTITUZIONALI. Il tema della patria, l’Italia, e l’Europa. Note.28 luglio 2018, di Federico La Sala
IL SONNO DELLA RAGIONE COSTITUZIONALE GENERA MOSTRI.... *
Un dialogo difficile ma necessario per capire l’Unione europea
Europeisti, euro-critici, euro-scettici, euro-ostili
di Pier Virgilio Dastoli (Il Mulino, 24 luglio 2018)
L’editoriale di Ernesto Galli della Loggia, uscito qualche giorno fa sul “Corriere della Sera”, si inscrive in quella corrente di pensiero che è stata troppo genericamente definita “euroscettica” - espressione coniata nel 1985 dal “Times” per definire l’ostilità del Partito laburista britannico contro le politiche liberiste della Comunità economica europea. Da allora il termine “euroscettico” viene applicato indistintamente ai (pochi) partiti che si battono per l’uscita del loro Paese dall’Unione europea (come l’Ukip di Neil Farage), ai (sempre più numerosi) movimenti contrari alla cessione o alla perdita dell’apparente sovranità nazionale nella dimensione sopranazionale, a alcuni partiti della sinistra radicale e alle forze politiche di estrema destra xenofobe e antisemite.
Come avviene per la corrente di pensiero europeista, nella quale occorre distinguere gli orientamenti moderati o conservatori di chi difende l’Ue nel suo stato attuale - con le istituzioni consolidate nel Trattato di Lisbona (2009) e le politiche di austerità rappresentate dal Fiscal Compact (2013) - dalla cultura federalista che sostiene la necessità di sovranità condivise nel quadro di una democrazia europea multilivello, così fra gli euroscettici occorre distinguere fra chi sostiene l’idea di un’Europa intergovernativa, nella quale prevalga la difesa degli interessi nazionali e la posizione di chi è contrario in se al progetto di integrazione europea, che ne propugna la fine e che potremmo definire più correttamente “euro-ostile”. Dalla nascita della Comunità economica europea nel 1957, i cittadini e le cittadine di ventidue Paesi europei sono stati chiamati quaranta volte a esprimersi per referendum sul processo di integrazione europea dando il loro consenso ventinove volte (a cominciare dal primo referendum “europeo” nel Regno Unito del 1975) e il loro voto contrario undici, ivi compreso il doppio “no” dei norvegesi all’adesione. Si è concluso un ciclo durato oltre vent’anni, segnato da una globalizzazione caratterizzata da politiche liberiste senza regole, da una crisi economica che è stata la più lunga e profonda che abbia mai attraversato il mondo. La crisi ha prodotto disuguaglianze tra i ceti sociali in conseguenza di un processo redistributivo della ricchezza a scapito del lavoro, del ceto medio, dei giovani e tra i popoli, in cui con la stessa logica non i ceti, ma le economie più forti hanno prodotto un ulteriore impoverimento all’interno dell’Ue dove vivono oggi 120 milioni di persone che rischiano la povertà e l’esclusione sociale.
L’intero pianeta è interessato da processi che, in maniera sempre più interdipendente e con velocità crescente, ne mettono in discussione l’assetto geopolitico e ne accrescono gli squilibri sociali: da quelli concernenti la finanza e le monete alla loro ricaduta sull’economia e sull’assetto sociale, dalla crescita della popolazione mondiale alla disperata migrazione delle parti più deboli di essa che rende sempre più aleatoria la distinzione fra richiedenti asilo e migranti economici, dal consumo eccessivo delle risorse naturali non rinnovabili alla compromissione irreversibile dell’ambiente, dal miglioramento delle condizioni di benessere di una parte minoritaria della popolazione del pianeta al precipitare in condizioni di crescente povertà, fame e malattia di un’altra parte notevole della stessa popolazione. Questi processi interdipendenti, se non governati da autorità sopranazionali, provocheranno devastazioni degli assetti istituzionali anche nelle democrazie più progredite del pianeta.
Le conquiste di civiltà, in particolare quelle che caratterizzano l’Europa, conseguenti a contraddittorie e controverse secolari azioni di dominio mondiale, rischiano di essere messe in discussione. L’illusione degli Stati europei che ritengono di attraversare, immuni, gli sconvolgimenti planetari ai quali assistiamo, rinchiudendosi nell’ottocentesca dimensione nazionalista, sarà spazzata via non solo dai flussi migratori africani e asiatici, ma anche dal progredire degli Stati continentali.
Alle problematiche sopra accennate si aggiungono, tra le altre, quelle dell’energia e dell’ambiente che continuano a essere affrontate dagli Stati nazionali, singolarmente e nelle sedi internazionali, con scarse possibilità di successo, in assenza di soggetti di governo e di politiche che consentano di fronteggiare e governare i processi interdipendenti che le caratterizzano.
Per rispondere al neo-protezionismo degli Stati Uniti, al nazionalismo russo, alla trasformazione nella rete dei poteri globali e al neocolonialismo economico cinese, l’Ue dovrebbe essere dotata degli strumenti necessari a svolgere un ruolo autonomo di attore politico a livello planetario per contribuire ad avviare un nuovo ciclo nel governo dell’interdipendenza, segnato da uno sviluppo equilibrato e sostenibile, dalla distensione e dal rispetto della dignità umana.
Se la globalizzazione ha cambiato, nel bene e nel male, il mondo in rapidissima sequenza, l’Ue è così apparsa incapace di reagire velocemente e in modo adeguato, prigioniera del potere multi cefalo dei governi nazionali in settori chiave per la gestione di problemi di carattere nazionale. Al contrario di un Leviatano o di un Impero europeo che dà ordini a stati e sudditi satelliti dall’alto del Berlaymont (la sede della Commissione europea a Bruxelles), il potere europeo è passato progressivamente nelle mani dei governi nazionali e, per essi, dei capi di Stato e di governo riuniti nel Consiglio europeo all’interno di un’inedita “Santa Alleanza”, che costituisce quello che Habermas chiama il “federalismo degli esecutivi”. Amplificata dalla rivoluzione tecnologica e digitale, la globalizzazione ha sconvolto in questi anni gli equilibri più di quanto si immaginasse, causando una rapida redistribuzione internazionale del lavoro, delle ricchezze e degli investimenti. Se la portata inedita di tali fenomeni e il loro manifestarsi in veloce sequenza hanno cambiato il mondo, rendendo precari gli equilibri, l’Ue è apparsa vittima del suo gradualismo, delle risibili risorse finanziarie del bilancio Ue pari all’1% del Pil europeo e gestito da un’euro-burocrazia che costa a ogni cittadino 1,40 euro al mese.
L’analisi di Galli della Loggia non mi pare, dunque, fondata. Non vi è stata una vera eliminazione delle differenze fra gli Stati nazionali e le nazioni non sono scomparse. I Parlamenti nazionali sono stati in grado di recuperare parte dei loro poteri con il Trattato di Lisbona. Il pluralismo non è stato negato e gli indirizzi comuni nella sanità, nell’istruzione, nella cultura e nella ricerca sono passati dai tentativi (falliti) di armonizzazione al mutuo riconoscimento. La cittadinanza europea, infine, non ha sostituito le cittadinanze nazionali, ma ha aggiunto a esse diritti comuni che sono stati consolidati nella Carta europea dei diritti fondamentali.
Ogni giorno di più la realtà mostra, drammaticamente, che non ci può essere alternativa all’unità europea nella prospettiva di rinsaldare la secessione secolare con l’Oriente e con il Mediterraneo.
 Per costruire quest’alternativa serve con urgenza una “operazione verità” condotta da un vasto movimento di opinione ben al di là dell’associazionismo europeista, una alleanza di innovatori che nasca dal mondo dell’economia e del lavoro, della cultura e della ricerca, delle organizzazioni giovanili e del volontariato coinvolgendo tutti coloro che vivono l’utilità dell’integrazione europea e pagano le conseguenze dei costi della non-Europa.
Per costruire quest’alternativa serve con urgenza una “operazione verità” condotta da un vasto movimento di opinione ben al di là dell’associazionismo europeista, una alleanza di innovatori che nasca dal mondo dell’economia e del lavoro, della cultura e della ricerca, delle organizzazioni giovanili e del volontariato coinvolgendo tutti coloro che vivono l’utilità dell’integrazione europea e pagano le conseguenze dei costi della non-Europa.
*
POPULISMO E PRINCIPI COSTITUZIONALI
Perché la nazione ha ancora un senso
Il tema della patria è stato regalato a chi manipolandolo lo ha utilizzato per i propri scopi: è un inganno al quale non basta opporre il progetto europeista
di Ernesto Galli della Loggia *
L’Unione europea è visibilmente in crisi, non riesce a fare alcun passo avanti in quanto soggetto politico (anzi negli ultimi tempi ne ha fatto parecchi indietro), ma l’ideologia europeista almeno un successo importante può continuare comunque a vantarlo. Essere riuscita a delegittimare alla radice la dimensione della nazione in generale. Essere riuscita a farla passare come responsabile di tutte le sciagure novecentesche e come il ricettacolo delle più inquietanti ambiguità ideologiche, tipo quelle messe in circolazione da Matteo Salvini con il suo sciovinismo xenofobo a base di «prima gli italiani» e «padroni in casa nostra». Il risultato è che in pochi Paesi come l’Italia ogni riferimento alla nazione appare, ormai, come il potenziale preludio di una deriva sovranista, di una dichiarazione di guerra antieuropea, come sinonimo di sopraffazione nazionalistica. Non abbiamo forse sentito ripetere fino alla nausea, ad esempio, e dalle cattedre più alte, che gli Stati nazionali significano inevitabilmente la guerra? Come se gli esseri umani avessero dovuto aspettare la Marsigliese, il Kaiser o Mussolini per trovare il motivo di scannarsi. Come se prima dell’esistenza dei suddetti Stati nazionali di guerre non ce ne fossero mai state, e come se i Romani, l’impero turco, gli Aztechi, gli Arabi dell’epoca di Maometto o mille altri non avessero tutti coperto di stragi e di morti ammazzati il proprio cammino nella storia.
Naturalmente l’ostracismo comminato alla nazione ha avuto effetto non tanto sulla gente qualunque, sulla maggioranza dell’opinione pubblica quanto nei confronti delle élites, della classe dirigente. Anche perché l’Italia, si sa, non è la Francia. Da noi la cultura della nazione era già stata messa abbastanza nell’angolo dalla storia: non per nulla la Repubblica, nata e vissuta con l’obbligo di differenziarsi dal fascismo specialmente su questo punto, ha intrattenuto a lungo un rapporto per così dire minimalista con la nazione. Come del resto le sue maggiori culture politiche fondatrici (quella cattolica e quella comunista), il cui sfondo ideologico non aveva certo molto a che fare con la nazione.
Cresciuto per decenni in questa atmosfera, l’establishment italiano - in prima fila l’establishment culturale - si è dunque trovato prontissimo, dopo la fine della Dc e del Pci, a gettarsi nell’infatuazione europeistica più acritica. Trovandovi nuovo alimento non solo alla propria antica indifferenza, al suo disinteresse nei confronti di una dimensione nazionale giudicata ormai una sorta di inutile ectoplasma, ma per spingersi addirittura fino alla rinuncia della sovranità in ambiti delicatissimi come la formazione delle leggi. Mi domando ad esempio quante altre Costituzioni europee siano state modificate come lo è stata quella italiana nel 2001 con la nuova versione dell’articolo 117, che sottomette la potestà legislativa al rispetto, oltre che come ovvio della Costituzione stessa, anche «dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario». (Sulla stessa linea, pur nella sua evidente vacuità prescrittiva, anche il primo comma aggiunto nel 2012 all’art. 97, secondo il quale «le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione Europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico»).
È accaduto così, attraverso queste vie e mille altre, che il tema della nazione sia stato pian piano regalato a chi, manipolandolo ed estremizzandolo, combinandolo con i cascami del populismo, se ne è sempre più servito per i propri scopi agitatori. Espulsa dalla cultura ufficiale del Paese, tenuta in non cale dal circuito della formazione scolastica, non più elemento vivo costitutivo del modo d’essere e di pensare della classe dirigente, la nazione (o meglio la sua caricatura) è fatalmente divenuta patrimonio e strumento di una parte. La quale non ci ha messo molto ad accorgersi della sua capacità di aggregare, di commuovere, e anche di illudere, d’ingannare, se del caso di trascinare alla più vile prepotenza.
Cioè di trasformarsi in nazionalismo, appunto. Ma di chi la colpa principale mi chiedo, se non di coloro che, pur potendo e sapendo, per cecità ideologica hanno omesso di ricordare che cosa ha veramente rappresentato l’idea di nazione? Di illustrare e di far valere nella discussione pubblica la reale portata storica, le innumerevoli conseguenze positive di quell’idea?
Senza la quale, tanto per dirne qualcuna, non ci sarebbero stati il liberalismo e la democrazia moderna, la libertà religiosa, le folle di esclusi e di miserabili trasformate in cittadini, le elezioni a suffragio universale. Senza la quale non ci sarebbe stata la scuola obbligatoria e l’alfabetizzazione di massa, il Welfare e la sanità pubblica, e poi la rottura di mille gerarchie pietrificate, di tante esclusioni corporative. Senza la quale infine - scusate se è poco - non ci sarebbe stata neppure l’Italia. Cioè questo Stato scalcagnato e pieno di magagne grazie al quale, bene o male, però, nel giro di tre o quattro generazioni (una goccia nel mare della storia) un popolo di decine di milioni di persone ha visto la propria vita migliorare, cambiare come dalla notte al giorno, in una misura che non avrebbe mai osato sperare prima.
All’inganno nazionalistico che incalza e che cresce non vale opporre la speranza sbiadita e senza voce, il disegno dai contorni tuttora imprecisi e imprecisabili, del progetto europeistico. Va opposta prima di ogni altra cosa, in tutta la sua forza storica, la cultura della nazione democratica. Che più volte - ricordiamo anche questo - ha dimostrato anche di sapere aprirsi al mondo superando i confini della propria patria con la sua carica emancipatrice volta all’umanità.
* Corriere della Sera, 19 luglio 2018 (modifica il 19 luglio 2018 | 20:30) (ripresa parziale, senza immagini).
Sul tema, nel sito, si cfr.:
IL SONNO DELLA RAGIONE COSTITUZIONALE GENERA MOSTRI ATEI E DEVOTI. Un invito e un appello a fare luce, a fare giorno
RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". Per la rinascita dell’EUROPA, e dell’ITALIA. La buona-esortazione del BRASILE. Una "memoria"
Federico La Sala
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. -- LA PRIVATIZZAZIONE DEL NOME "ITALIA" E IL POPULISMO. "Ghe Pensi Mi"!9 luglio 2018, di Federico La Sala
CON DECENZA PARLANDO: LA PRIVATIZZAZIONE DEL NOME "ITALIA" E IL POPULISMO. "Ghe Pensi Mi"!
Una nota*
SICCOME QUI SI TOCCANO TEMI di tranquillizzazione politica (con tutti i suoi risvolti teologici e costituzionali) e di "superomismo" populistico ("stai sereno!" - "scuscitatu" vale come "senza pensieri, senza preoccupazioni": cioè, "Ghe Pensi Mi"), e c’è da svegliarsi e riappropriarsi della propria *dignità* (politica e *costituzionale*, e non solo economica) di cittadini e di cittadine, è bene ricordare che per "stare sereni" troppo e troppo a lungo, come cittadini italiani e cittadine italiane, abbiamo perso la stessa possibilità di "tifare" per noi stessi e stesse, per se stessi e per se stesse, sia sul piano sportivo sia sul piano *costituzionale*: non solo perché la nostra NAZIONALE è fuori dai MONDIALI DI CALCIO ma, anche e soprattutto, perché il NOME della NAZIONE (di tutti e di tutte) è diventato il "Logo" della "squadra" di un Partito e di un’Azienda.
IL LUNGO SONNO DELLA RAGIONE COSTITUZIONALE CONTINUA ...
*
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. -- Narcisismo e democrazia: "La democrazia del narcisismo. Breve storia dell’antipolitica".7 giugno 2018, di Federico La Sala
POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. Il Narcisismo e l’uso lucidissimo come arma politica dell’"antinomia del mentitore" ... *
Narcisismo e democrazia
di Sergio Benvenuto (Doppiozero, 06 giugno 2018)
Il libro di Giovanni Orsina, La democrazia del narcisismo. Breve storia dell’antipolitica (Marsilio) si inserisce in un filone di studi che chiamerei, parafrasando Gibbon: Declino e (possibile) Caduta della Democrazia. Insomma, Orsina tematizza uno dei maggiori problemi della nostra epoca: la crisi della democrazia pluralista e liberale.
Una crisi che non a tutti appare evidente. Perché è vero che 25 paesi negli ultimi 18 anni sono retrocessi, per dir così, dalla democrazia al dispotismo - compresi Russia, Turchia e Venezuela - ma in Occidente la democrazia può sembrare ben salda. In effetti, le tre grandi catastrofi degli ultimi due anni - Brexit, elezione di Trump, vincita dei partiti anti-politica in Italia - si sono prodotte rispettando in tutto i meccanismi democratici. Non è un caso, però, che molti commentatori, anche in Italia, abbiano deprecato la decisione di Cameron di indire un referendum sull’appartenenza del Regno Unito all’Europa: “non è materia su cui ha da decidere il popolo”, hanno detto. -Insomma, molti democratici cominciano ad aver seriamente paura della democrazia. E ne hanno le ragioni, perché sappiamo che talvolta le democrazie uccidono democraticamente se stesse: fu questo il caso del fascismo italiano nel 1923, del nazismo in Germania nel 1933, delle elezioni algerine del 1991, e più di recente delle elezioni russe (Putin), turche (Erdogan) e venezuelane (Maduro). Il presupposto di onniscienza politica della democrazia è smentito storicamente. Un popolo può liberamente decidere di rovinarsi, come accade a certi individui, che decidono liberamente di rovinarsi; ne conosciamo tanti.
Ma per Orsina come per altri (incluso il sottoscritto) il sintomo della crisi della democrazia in Occidente è l’avanzare dei cosiddetti partiti populisti, ovvero “anti-politici”. Partiti o movimenti ossimorici, perché attaccano il potere politico proponendo se stessi come potere politico. Ma il merito di Orsina è di situare questo retreat della liberal-democrazia non come evento nuovo, congiunturale, ma come il manifestarsi di una contraddizione fondamentale nel genoma stesso della democrazia. Così, Orsina si appella all’analisi, così ambivalente, di Tocqueville della democrazia americana nell’800.
 Potremmo dire che questo filone di studi cerca di fare nei confronti della democrazia quel che Karl Marx fece nei confronti del capitalismo. Per Marx il capitalismo non sarebbe caduto per la rivolta indignata delle classi oppresse, ma per un’implosione interna, per il venire al pettine dei nodi di una contraddizione fondamentale del capitalismo stesso. Analogamente, la democrazia comporta una contraddizione fondamentale che sta per venire al pettine. Siccome la profezia marxiana del crollo del capitalismo non si è (finora) verificata, c’è solo da augurarsi che, analogamente, il crollo della democrazia non si verifichi. Ce lo auguriamo perché dopo tutto pensiamo come Churchill, che la democrazia è il peggiore dei sistemi politici, a esclusione di tutti gli altri.
Potremmo dire che questo filone di studi cerca di fare nei confronti della democrazia quel che Karl Marx fece nei confronti del capitalismo. Per Marx il capitalismo non sarebbe caduto per la rivolta indignata delle classi oppresse, ma per un’implosione interna, per il venire al pettine dei nodi di una contraddizione fondamentale del capitalismo stesso. Analogamente, la democrazia comporta una contraddizione fondamentale che sta per venire al pettine. Siccome la profezia marxiana del crollo del capitalismo non si è (finora) verificata, c’è solo da augurarsi che, analogamente, il crollo della democrazia non si verifichi. Ce lo auguriamo perché dopo tutto pensiamo come Churchill, che la democrazia è il peggiore dei sistemi politici, a esclusione di tutti gli altri.Va detto che Orsina, professore di Storia contemporanea alla LUISS, non si rifà tanto a sociologi e politologi accademici, quanto piuttosto a testi e ad autori del mondo filosofico e poetico: a La rivolta delle masse di José Ortega y Gasset, a Nelle ombre del domani di Johan Huizinga, a Massa e potere di Elias Canetti, a Montale, a Marcel Gauchet. È tra quelli che pensano che non bastino fatti e statistiche per capire il mondo in cui viviamo: occorrono anche le intuizioni, le folgorazioni intellettuali, di scrittori e filosofi.
Del resto, sin dal titolo - che riecheggia il bestseller anni 70 La cultura del narcisismo di Christopher Lasch - Orsina usa un concetto non ‘sociologico’, quello di narcisismo. Concetto freudiano più che mai, anche se l’autore non cita Freud ma i sociologi e i pensatori che, oltre Lasch, hanno sdoganato il concetto di narcisismo nella cittadella sociologica (Tom Wolfe, Richard Sennett, Gilles Lipovetski).
 Ora, per narcisismo Orsina non intende egoismo e nemmeno individualismo. Quest’ultimo, diceva Tocqueville, “è un sentimento ponderato e tranquillo”, è il valutare oculatamente i costi e benefici, e difatti tutte le teorie liberali si basano sull’individuo come homo rationalis, come buon calcolatore dei propri personali vantaggi. Il narcisista invece è una personalità fondamentalmente irrazionale (ho cercato di descrivere il narcisismo secondo Freud qui). Non è tranquillo, anzi, tende all’ira e alla protesta perenne, divorato da una frustrazione che lo assilla. In modo stringato, possiamo dire che il narcisista è chi si crede. Chi crede solo nella propria opinione, e che crede soprattutto nei propri desideri. Ma siccome nella vita sociale ci sarà sempre qualcuno al di sopra di lui, sentirà conficcate nella sua pelle “le spine del comando” (dice Orsina citando Canetti) ogni volta che ubbidirà a qualche ordine, e tutte queste spine costituiranno “un duro cristallo di rancore”. Perciò le democrazie sono caratterizzate da un cumulo di rabbia contro chi “comanda”, come ha visto il filosofo Peter Sloterdijk in Ira e tempo, dove parla di partiti e movimenti politici come “banche dell’ira”.
Ora, per narcisismo Orsina non intende egoismo e nemmeno individualismo. Quest’ultimo, diceva Tocqueville, “è un sentimento ponderato e tranquillo”, è il valutare oculatamente i costi e benefici, e difatti tutte le teorie liberali si basano sull’individuo come homo rationalis, come buon calcolatore dei propri personali vantaggi. Il narcisista invece è una personalità fondamentalmente irrazionale (ho cercato di descrivere il narcisismo secondo Freud qui). Non è tranquillo, anzi, tende all’ira e alla protesta perenne, divorato da una frustrazione che lo assilla. In modo stringato, possiamo dire che il narcisista è chi si crede. Chi crede solo nella propria opinione, e che crede soprattutto nei propri desideri. Ma siccome nella vita sociale ci sarà sempre qualcuno al di sopra di lui, sentirà conficcate nella sua pelle “le spine del comando” (dice Orsina citando Canetti) ogni volta che ubbidirà a qualche ordine, e tutte queste spine costituiranno “un duro cristallo di rancore”. Perciò le democrazie sono caratterizzate da un cumulo di rabbia contro chi “comanda”, come ha visto il filosofo Peter Sloterdijk in Ira e tempo, dove parla di partiti e movimenti politici come “banche dell’ira”.In effetti la democrazia non è solo un sistema per scegliere chi deve governare, essa si basa su una Promessa fondamentale, implicita o esplicita che sia: l’auto-determinazione di ciascun uomo e di ciascuna donna. Ovvero, non c’è alcun criterio che trascenda la volontà di ciascuno, sia esso la religione, la patria, il re, la classe sociale... “Il popolo è sovrano”, quindi ciascuno si sente sovrano nel pensare e nell’odiare. Ormai contano le opinioni dei singoli, ovvero la loro somma, non l’autorevolezza delle opinioni: se un’opinione è diffusa, diventa ipso facto autorevole. Se un libro si vende bene, allora è un capolavoro. Se un leader cialtrone prende una barca di voti, diventa ipso facto un grande uomo politico. Da qui l’esplosione dei sondaggi d’opinione: essi servono non solo a sapere quel che la gente pensa, ma a stabilire, appunto, che cosa vale e che cosa no. Ora, ciascuno è convinto che la propria opinione sia quella giusta, anche se in realtà non sa nulla di ciò di cui ha un’opinione. In democrazia, dicevano gli antichi greci, prevale la doxa, l’opinione, non l’epistheme (il sapere). Dico qui a parole mie quel che mi sembra il succo del libro di Orsina.
Decenni fa le persone semplici, non colte, mi chiedevano spesso “Professore, ma per chi devo votare?” Non rispondevo, ligio all’ideale democratico per cui il “professore” non deve esercitare un’autorità intimidente sull’elettore. Oggi invece le persone senza cultura non sanno che farsene non solo delle mie idee politiche, ma di quelle di tutti i professori. Del resto, per ogni opinione, per quanto becera, si riesce a trovare sempre qualche “esperto” che la puntelli o la legittimi. Si scoprono “specialisti” i quali dicono che vaccinare i bambini fa male, per esempio, quando si spande il rumor secondo cui vaccinare fa male. Il narcisismo è insomma l’arroganza dei propri desideri e delle proprie opinioni; non conta più il percorso - di studio, riflessione, informazione, confronto con esperti - che porta ad avere un’opinione che pesi.
Così, scrive Michel Crozier (citato da Orsina):
- I cittadini avanzano richieste incompatibili fra di loro. Insistono perché i loro problemi siano affrontati in maniera più efficace, e perciò chiedono più controllo sociale. Allo stesso tempo, si oppongono a qualsiasi forma di controllo sociale si associ ai valori gerarchici che hanno imparato a scartare e rigettare.
- Emerge qui la contraddizione fondamentale della democrazia, grazie al narcisismo che essa genera: ci si aspetta che loro (i politici) risolvano i problemi, ma per risolverli costoro devono esercitare un’autorità, devono infliggere “le spine del comando” e limitare l’autodeterminazione su cui la democrazia si fonda, eppure questa limitazione è costantemente rigettata. Scrive Orsina:
- Cacciati dalla porta, i vincoli della piena autodeterminazione soggettiva rientrano dalla finestra. È vero che il narcisista non è più tenuto a osservare alcun codice etico, ma deve comunque sottostare alle regole che disciplinano la convivenza civile. È vero che nessuno può più imporgli dall’esterno alcun obiettivo esistenziale, ma è soltanto dall’esterno che possono venire la stima altrui e il successo sociale dei quali ha disperato bisogno - anche perché osserva con invidia i molti che, attorno a lui, riescono a raccoglierli (p. 60).
Insomma, il principio di autodeterminazione di ciascuno porta a un indebolimento progressivo della politica. Da qui il crescente discredito dei politici: essi fanno da capro espiatorio di questa contraddizione fondamentale. Vengono applauditi solo i politici che si dichiarano anti-politici... Il narcisista moderno esige dalla politica che risolva i propri problemi, ma siccome la politica deve cercare di risolvere anche i problemi degli altri, qualunque cosa un politico farà sarà sempre insoddisfacente. Ogni misura politica pesta sempre i piedi a qualcuno. Ogniqualvolta un politico agirà politicamente, tenendo conto quindi dei vari interessi tra loro spesso contrapposti, sarà sempre considerato fallimentare, anzi un corrotto.
Si prenda il caso esemplare della lotta all’evasione fiscale: questa dovrebbe essere popolare perché permette allo stato di avere più fondi per i servizi pubblici, per il sistema sanitario..., ma essa comporta una decurtazione del reddito di chi prima evadeva. Solo questa decurtazione viene vista, e biasimata.
Il paradosso è che la credibilità dei politici si abbassa sempre più man mano che essi si convertono alla demagogia, diventando “cantastorie” come dice Orsina, ovvero aizzano richieste specifiche anche se irrealistiche al fine di guadagnare voti e potere. Sempre più abdicano a una funzione che i politici di vecchio stampo esercitavano: quella di presentare agli elettori anche gli oneri che un sistema politico-economico esige, i vincoli che vengono dall’economia, dal sistema internazionale delle alleanze. Oggi i politici promettono sempre di più a tutti, non mettono mai gli elettori di fronte alla complessità e alla durezza dei problemi sociali. Ma la demagogia dà un vantaggio effimero: prima o poi, l’elettore capisce che le promesse non vengono mantenute. E si volgerà a un altro demagogo...
Si è denunciato il fatto che il nuovo governo della Lega e del M5S in Italia si basi su due progetti praticamente contraddittori: da una parte la flat tax, che di fatto regala soldi ai più ricchi; dall’altra il reddito di cittadinanza, che dovrebbe andare ai più poveri. Ma se lo stato rinuncia a una parte cospicua delle tasse, gli sarà impossibile dare un reddito a chi non lavora.
 Il fatto che questi due progetti abbiano trovato una sorta di affinità elettiva è un’allegoria della contraddizione della democrazia narcisista: dallo stato, ovvero dalla politica, si chiede che da una parte esso dia sempre più, ma dall’altra gli si vuole dare sempre meno. Esigo che lo stato spenda sempre più per me, ma mi rifiuto sempre più di dargli questi soldi da spendere. Il segreto dell’esplosione del debito pubblico in Italia, che ha raggiunto il 130% del PIL nazionale, è tutto qui (esso è il frutto di decenni di politiche che hanno comprato consenso di massa indebitando però i nostri figli fino al collo).
Il fatto che questi due progetti abbiano trovato una sorta di affinità elettiva è un’allegoria della contraddizione della democrazia narcisista: dallo stato, ovvero dalla politica, si chiede che da una parte esso dia sempre più, ma dall’altra gli si vuole dare sempre meno. Esigo che lo stato spenda sempre più per me, ma mi rifiuto sempre più di dargli questi soldi da spendere. Il segreto dell’esplosione del debito pubblico in Italia, che ha raggiunto il 130% del PIL nazionale, è tutto qui (esso è il frutto di decenni di politiche che hanno comprato consenso di massa indebitando però i nostri figli fino al collo).Da qui il paradosso: lo stato italiano è fortemente indebitato, mentre i patrimoni e i risparmi personali sono altissimi. In Italia abbiamo uno stato quasi alla bancarotta, e una ricchezza privata cospicua.
Come nota Orsina, i pericoli della democrazia del narcisismo hanno portato gli stati, nel corso degli ultimi decenni, a sottrarre spazi al controllo democratico (cosa che viene denunciata dai populisti). Le banche centrali si sono autonomizzate sempre più dal potere politico, difendono la moneta del paese senza subire le pressioni dei governi, i quali esprimono le esigenze confuse di chi li ha eletti. Orsina legge il distacco crescente della magistratura dal potere politico come un altro segno di questa secessione di parti dello stato dal controllo democratico (sempre più, in quasi tutti i paesi, i magistrati fanno la loro politica; come abbiamo visto in Brasile oggi con Lula, la magistratura può opporsi fermamente alla volontà popolare). Egli nota, ad esempio, che tra il 1969 e il 1976 la quota di budget federale americano sul quale la politica conservava un controllo discrezionale si è dimezzato, scendendo dal 50 al 24%. Le istituzioni europee, di fatto, tolgono spazi all’autodeterminazione dei singoli paesi, imponendo a ciascuno parametri entro cui operare. Va detto che questo controllo della tecnocrazia europea sui destini nazionali non ha funzionato sempre. Non ha impedito il crack della Grecia nel 2016 né l’esplosione del debito pubblico italiano e portoghese fino a oggi.
Molti denunciano questo crescente potere tecnocratico e rivendicano più democrazia, ma non si rendono conto del fatto che la secessione di molte funzioni dalla “politica” - banche centrali, magistratura, FMI, WTO, ecc. - è proprio un ammortizzatore della democrazia frutto della democrazia stessa: rispetto all’autodeterminazione di tutti contro tutti, le istituzioni non elette, “tecniche”, pongono dei paletti fondamentali che impediscano le derive. Così, le costrizioni esterne imposte dai trattati internazionali, che il narcisista delle democrazie rigetta rivendicando la propria autodeterminazione nazionale (o regionale), rientrano.
“Il basso continuo” (è l’espressione di Orsina) dei populismi, rivendicando la propria sovranità nazionale di contro ai vincoli che pone a una nazione il tessuto europeo (o, per gli Stati Uniti, il NAFTA e altri trattati internazionali), titilla il desiderio di autodeterminazione di ciascuno. Si dice “Se noi italiani potessimo decidere tutto quello che vogliamo, senza tener conto dell’Europa, saremmo più liberi...” Si tratta ovviamente di un’illusione, perché rinunciare ai vincoli volontari non evita affatto i vincoli involontari, quelli imposti dai mercati internazionali, ad esempio. Rinunciare ai vincoli con altri stati ci mette in balia di forze economiche e politiche internazionali per noi ancor più incontrollabili.
Vent’anni fa ci fu una forte reazione alla globalizzazione “da sinistra”. Ma la sinistra, soprattutto marxista, è globalista per vocazione. Il vero grande attacco alla globalizzazione - di cui Trump e la Brexit sono gli episodi più salienti - viene però oggi da destra, o dai “populismi”. Dilaga la tendenza a negare l’evidenza di un mondo globalmente interconnesso, tornando alle vecchie identità, nazionali o regionali.
Ora, questa esigenza di autodeterminazione va sempre più spezzettandosi: ogni regione potrà pensare che sia meglio decidere da sola, senza avere i lacci nazionali che la legano ad altre regioni, magari più povere, ecc.
Lo abbiamo visto con la Lega Nord, prima che svoltasse verso un nazionalismo neo-fascista. Accade così che da una parte la Gran Bretagna decide di separarsi dall’Europa, ma dall’altra questo spingerà scozzesi e nord-irlandesi a volersi separare a loro volta dalla Gran Bretagna, ecc. ecc. Alla fine di questo processo ricorsivo di separazioni, nel quale ci si illuderà di diventare sempre più liberi... c’è solo l’individuo solo, narcisista. Che non vuole legami né costrizioni. Ma non si può vivere da soli. A meno di non fare come il protagonista del film Into the Wild di Sean Penn: se ne va a vivere completamente isolato, autarchico, sovrano, in Alaska, per morirvi. Anche la prospettiva delle nostre società potrebbe essere la morte, quella della democrazia.
Questo di Orsina è un libro che evade dal recinto di molto dibattito politico di oggi, diviso tra neo-marxisti, neo-liberisti e neo-populisti. Un dibattito ormai stereotipato, dove già si sa prima che cosa ciascuno dirà.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- TEORIA E PRATICA DEL BAAL-LISMO. COME UN CITTADINO RUBA IL NOME DI TUTTO UN POPOLO, NE FA LA BANDIERA DEL PROPRIO PARTITO PERSONALE, E GETTA LE BASI DELLA PIU’ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA D’ITALIA...
 POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. Materiali sul tema
POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. Materiali sul tema
RIPENSARE L’EUROPA. PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!
 FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.Federico La Sala
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA - STATO - MAFIA: SILENZIO ASSORDANTE.23 aprile 2018, di Federico La Sala
Stato-Mafia: Pm Di Matteo: ’Dell’Utri tramite dopo il ’92’
’Da Anm e Csm nessuna difesa. Silenzio assordante, chi speravamo ci difendesse ha taciuto’
- Stato-mafia: pm Di Matteo, da Anm e Csm nessuna difesa © ANSA FOTO
di Redazione ANSA *
"La sentenza è precisa e ritiene che Dell’Utri abbia fatto da cinghia di trasmissione nella minaccia mafiosa al governo anche nel periodo successivo all’avvento alla Presidenza del Consiglio di Berlusconi. In questo c’è un elemento di novità. C’era una sentenza definitiva che condannava Dell’Utri per il suo ruolo di tramite tra la mafia e Berlusconi fino al ’92. Ora questo verdetto sposta in avanti il ruolo di tramite esercitato da Dell’Utri tra ’Cosa nostra’ e Berlusconi". Lo ha detto il pm della Dna Nino Di Matteo, a proposito della sentenza sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia, intervenendo alla trasmissione "1/2 ora in più" di Lucia Annunziata, in onda sui Rai tre.
La replica dell’Anm, sempre difeso magistrati attaccati - "L’Associazione Nazionale Magistrati ha sempre difeso dagli attacchi l’autonomia e l’indipendenza dei magistrati". Lo dice il presidente dell’Anm Francesco Minisci. "Lo ha fatto - prosegue - a favore dei colleghi di Palermo e continuerà sempre a difendere tutti i magistrati attaccati, pur non entrando mai nel merito delle vicende giudiziarie".
"Né Silvio Berlusconi, né altri hanno denunciato le minacce mafiose, né prima né dopo" ha anche detto il pm Di Matteo, a proposito della sentenza sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia, intervenendo alla trasmissione "1/2 ora in più" di Lucia Annunziata, su Rai tre. "Nel nostro sistema costituzionale le sentenze vengono pronunciate nel nome del popolo italiano e possono essere criticate e impugnate. Il problema è che quando le sentenze riguardano uomini che esercitano il potere devono essere conosciute", ha aggiunto. "C’è una sentenza definitiva - ha spiegato - che afferma che dal ’74 al ’92 Dell’Utri si fece garante di un patto tra Berlusconi e le famiglie mafiose palermitane. Ora questa sentenza dice che quella intermediazione non si ferma al ’92, ma si estende al primo governo Berlusconi, questi sono fatti che devono essere conosciuti"
"I carabinieri che hanno trattato sono stati incoraggiati da qualcuno. Noi non riteniamo che il livello politico non fosse a conoscenza di quel che accadeva. Ci vorrebbe ’un pentito di Stato’, uno delle istituzioni che faccia chiarezza e disegni in modo ancora più completo cosa avvenne negli anni delle stragi". Lo ha detto il pm della dna Nino Di Matteo, a proposito della sentenza sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia, intervenendo alla trasmissione "1/2 ora in più" di Lucia Annunziata, in onda sui Rai tre.
"Quello che mi ha fatto più male è che rispetto alle accuse di usare strumentalmente il lavoro abbiamo avvertito un silenzio assordante e chi speravamo ci dovesse difendere è stato zitto. A partire dall’ Anm e il Csm". Lo ha detto il pm della Dna Nino Di Matteo, dopo la sentenza sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia, intervenendo alla trasmissione "1/2 ora in più" di Lucia Annunziata, in onda sui Rai tre a proposito delle critiche subite, negli anni, dal pool che ha coordinato l’inchiesta.
* ANSA,23 aprile 2018 (ripresa parziale, senza immagine).
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. - Tante impronte sulla Carta. Nella Costituzione idee cattoliche, liberali, marxiste. E tracce del fascismo.11 aprile 2018, di Federico La Sala
1948-2018 Un estratto del saggio di Sabino Cassese sulla «Rivista trimestrale di diritto pubblico» (Giuffrè)
Tante impronte sulla Carta
Nella Costituzione idee cattoliche, liberali, marxiste. E tracce del fascismo
di Sabino Cassese (Corriere della Sera, 10.04.2018)
Nel 1995, Massimo Severo Giannini, uno degli studiosi che prepararono la Costituzione, riassumeva così la sua valutazione della Carta costituzionale del 1948: «Splendida per la prima parte (diritti-doveri), banale per la seconda (struttura dello Stato), che in effetti è una cattiva applicazione di un modello (lo Stato parlamentare) già noto e ampiamente criticato». Da dove è stata attinta questa prima parte «splendida», quale è stata l’«officina di idee» che l’ha prodotta?
Piero Calamandrei ha fornito una chiave per individuare le fonti ideali delle norme costituzionali quando ha detto, nel 1955, che esse furono «il testamento di centomila morti, scritto con sangue di italiani nel tempo della Resistenza», ma anche «un punto di ripresa del pensiero politico-civile italiano, dove parlano le “grandi voci lontane” di Beccaria, Cavour, Pisacane, Mazzini».
La Costituzione ebbe una breve gestazione - non più di un triennio -, ma la sua maturazione ideale non fu altrettanto breve. Essa non nacque come Minerva armata dalla testa di Giove. Vi sono intessute culture, aspirazioni, esperienze, ideologie di diversa provenienza, di epoche differenti.
Di questo contenuto profondo dei principi costituzionali non posso fare qui che qualche esempio, e soltanto in forma interrogativa, avanzando ipotesi. Come arriva la diade della Costituzione termidoriana (non delle precedenti Costituzioni francesi rivoluzionarie) «diritti e doveri» negli articoli 2 e 4, nonché nel titolo della parte prima della Costituzione italiana? Non bisogna riconoscere dietro alla formula del secondo comma dell’articolo 3, quello sull’eguaglianza in senso sostanziale, la critica marxista della eguaglianza meramente formale affermata dalle Costituzioni borghesi e il successo che solo pochi anni prima, nel 1942, aveva avuto anche in Italia il «piano Beveridge» con la sua libertà dal bisogno? Come spiegare la circostanza che dei 1357 lemmi della Costituzione uno di quelli che hanno il maggior numero di occorrenze è «ordinamento», senza capire che «così dalla prima commissione la grande ombra di Santi Romano si estendeva all’Assemblea, come se il piccolo libro fosse stato scritto a favore dei Patti Lateranensi», come notato nel suo solito stile immaginifico da La Pira nel suo intervento sull’articolo 7?
 Ed è possibile ignorare la lunga storia del cattolicesimo italiano e del suo rifiuto dello Stato (la «questione romana»), che si intreccia con l’idea romaniana della pluralità degli ordinamenti giuridici o ispira le norme dove si afferma, prima che lo Stato garantisca i diritti o promuova le autonomie, che questi vadano riconosciuti, e quindi, preesistono allo Stato, consolidando quindi il pensiero della corrente antipositivistica (perché lo Stato viene dopo le persone, le «formazioni sociali» e gli ordinamenti originari non statali)?
Ed è possibile ignorare la lunga storia del cattolicesimo italiano e del suo rifiuto dello Stato (la «questione romana»), che si intreccia con l’idea romaniana della pluralità degli ordinamenti giuridici o ispira le norme dove si afferma, prima che lo Stato garantisca i diritti o promuova le autonomie, che questi vadano riconosciuti, e quindi, preesistono allo Stato, consolidando quindi il pensiero della corrente antipositivistica (perché lo Stato viene dopo le persone, le «formazioni sociali» e gli ordinamenti originari non statali)?
 Si possono comprendere le norme costituzionali sul patrimonio storico e artistico e sulla scuola ignorando l’elaborazione, in periodo fascista, a opera di Giuseppe Bottai, di Santi Romano, di Mario Grisolia, della legislazione sulle cose d’arte e della «carta della scuola», quindi senza riconoscere che la Costituzione antifascista ha raccolto anche l’eredità del fascismo? Infine, come intendere la portata dei programmi economici per indirizzare a fini sociali l’impresa privata, senza considerare una duplice esperienza, quella della pianificazione economica sovietica e quella del New Deal rooseveltiano?
Si possono comprendere le norme costituzionali sul patrimonio storico e artistico e sulla scuola ignorando l’elaborazione, in periodo fascista, a opera di Giuseppe Bottai, di Santi Romano, di Mario Grisolia, della legislazione sulle cose d’arte e della «carta della scuola», quindi senza riconoscere che la Costituzione antifascista ha raccolto anche l’eredità del fascismo? Infine, come intendere la portata dei programmi economici per indirizzare a fini sociali l’impresa privata, senza considerare una duplice esperienza, quella della pianificazione economica sovietica e quella del New Deal rooseveltiano?Nel melting pot costituente, furono raccolte, messe insieme, ordinate queste diverse idee, culture, esperienze, e altre ancora, che si mescolavano all’esigenza di riportare libertà e rispetto per i diritti nel Paese. La Costituzione rappresentò una reazione al regime illiberale fascista, ma fu anche il precipitato di ideali di epoche diverse (risorgimentale, liberaldemocratica, fascista), Paesi diversi (specialmente quelli che si dividevano il mondo, gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica), aree diverse (quella cattolica, quella socialista e comunista, quella liberale), orientamenti dottrinali opposti (quello statalistico e quello pluralistico).
Calamandrei ebbe l’intelligenza di riconoscere questo sguardo lungo della Costituzione, ma - forse prigioniero dell’idea che la Resistenza fosse un secondo Risorgimento - si fermò alla segnalazione del contributo ideale di autori lontani, Mazzini, Cavour, Cattaneo, Garibaldi, Beccaria. Nel discorso del 1955 tralasciò il contributo che proveniva da altri Paesi e da epoche più vicine, specialmente dal fascismo, un contributo che prova la lungimiranza degli autori della Costituzione, antifascisti che recuperarono l’eredità del fascismo (ma questo a sua volta aveva sviluppato ideali e proposte dell’età liberale).
Questo risultato non fu sempre positivo, come osservava Giannini, perché la seconda parte della Costituzione (o, meglio, quella relativa alla forma di governo) sembrò dimenticare proprio la lezione del passato, come alcuni costituenti dissero ai loro colleghi, ricordando che anche dalle debolezze del sistema parlamentare liberale era scaturito il fascismo. Ciò avrebbe richiesto un sistema di stabilizzazione dei governi, pure auspicato da molti (e anzi accettato in linea di principio dalla ampia maggioranza che votò l’ordine del giorno Perassi), secondo il quale il sistema parlamentare doveva avere «dispositivi idonei a tutelare le esigenze di stabilità dell’azione di governo e a evitare degenerazioni del parlamentarismo».
Come osservava Paolo Ungari molti anni or sono, «l’intera vicenda della cultura giuridica italiana fra le due guerre dovrebbe essere attentamente ripercorsa, e non solo al livello delle discussioni universitarie, per rendersi conto del patrimonio di idee e di tecniche degli uomini che sedettero nelle varie commissioni di studio del periodo intermedio, dalla commissione Forti a quella sulla “riorganizzazione dello Stato”, nonché alla Consulta e alla Costituente stessa».
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. -- "Vivere la democrazia". Per una biopolitica illuminista (di Roberto Esposito).31 marzo 2018, di Federico La Sala
SENZA PIU’ PAROLA E SENZA PIU’ CARTA D’IDENTITA’. Alla ricerca della dignità perduta...
Le idee. Per una biopolitica illuminista
L’ultima lezione di Stefano Rodotà
di Roberto Esposito (la Repubblica, 31.03.2018)
«Per vivere occorre un’identità, ossia una dignità. Senza dignità l’identità è povera, diventa ambigua, può essere manipolata». Il nuovo libro, postumo, di Stefano Rodotà, Vivere la democrazia, appena pubblicato da Laterza, può essere letto come un ampio e appassionato commento a questa frase di Primo Levi. Tutti e tre i termini evocati da Levi - identità, dignità e vita - s’incrociano in una riflessione aperta ma anche problematica, che ha fatto di Rodotà uno dei maggiori analisti del nostro tempo.
 Composto da saggi non tutti rivisti dall’autore, scomparso lo scorso giugno nel pieno del suo lavoro, il libro ci restituisce il nucleo profondo di una ricerca che definire giuridica è allo stesso tempo esatto e riduttivo. Esatto perché il diritto costituisce l’orizzonte all’interno del quale Rodotà ha collocato il proprio lavoro. Riduttivo perché ha sempre riempito la propria elaborazione giuridica di contenuti storici, filosofici, antropologici che ne eccedono il linguaggio. Rodotà ha posto il diritto, da altri irrigidito in formulazioni astratte, a contatto diretto con la vita. E non con la vita in generale, ma con ciò che è diventato oggi la vita umana nel tempo di una tecnica dispiegata al punto da penetrare al suo interno, modificandone profilo e contorni.
Composto da saggi non tutti rivisti dall’autore, scomparso lo scorso giugno nel pieno del suo lavoro, il libro ci restituisce il nucleo profondo di una ricerca che definire giuridica è allo stesso tempo esatto e riduttivo. Esatto perché il diritto costituisce l’orizzonte all’interno del quale Rodotà ha collocato il proprio lavoro. Riduttivo perché ha sempre riempito la propria elaborazione giuridica di contenuti storici, filosofici, antropologici che ne eccedono il linguaggio. Rodotà ha posto il diritto, da altri irrigidito in formulazioni astratte, a contatto diretto con la vita. E non con la vita in generale, ma con ciò che è diventato oggi la vita umana nel tempo di una tecnica dispiegata al punto da penetrare al suo interno, modificandone profilo e contorni.Ma cominciamo dalle tre parole prima evocate, a partire dall’identità. Come è noto a chi si occupa di filosofia, l’interrogazione sul significato della nostra identità attraversa l’intera storia del pensiero, trovando un punto di coagulo decisivo nell’opera di John Locke.
Cosa fa sì che il vecchio riconosca sé stesso nel ragazzo, e poi nell’adulto, che è stato nonostante i tanti cambiamenti che ne hanno segnato l’aspetto e il carattere? La risposta di Locke è che a consentire alla coscienza di sperimentarsi identica a se stessa in diversi momenti dell’esistenza è la memoria. Ma tale risposta bastava in una stagione in cui natura, storia e tecnica costituivano sfere distinte e reciprocamente autonome. Una condizione oggi venuta meno. Nel momento in cui politica e tecnica hanno assunto il corpo umano a oggetto del proprio operato tutto è cambiato. Sfidata dalle biotecnologie e immersa nel cyberspazio, l’identità umana si è andata dislocando su piani molteplici, scomponendosi e ricomponendosi in maniera inedita.
È precisamente a questa mutazione antropologica che Rodotà rivolge uno sguardo acuminato. A chi appartiene il nostro futuro? - egli si chiede con Jaron Lanier (La dignità ai tempi di internet, Il Saggiatore) - quando l’identità non è più forgiata da noi stessi, ma modificata, e anche manipolata, da altri? Si pensi a come è cambiato il ruolo del corpo in rapporto alla nostra identificazione. Dopo essere stato centrale, al punto che sulla carta d’identità comparivano, insieme alla foto, colore di occhi e capelli, il corpo è stato in qualche modo soppiantato dalle tecnologie informatiche - password, codici, algoritmi. Per poi tornare, una volta tecnologizzato, come oggetto di attenzione da parte delle agenzie di controllo. Impronte digitali, geometrie della mano, iride, retina, per non parlare del dna.
 Tutto ciò quando la chirurgia plastica è in grado di cambiare i nostri connotati.
E qui entra in gioco il secondo termine del libro, la dignità, assunta non in maniera generica, ma come un vero principio giuridico. Che ha già trovato spazio nella nostra Costituzione e poi nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. Ma ciò non basta, se si vuol passare dal tempo dell’homo aequalis a quello dell’homo dignus. Il richiamo alla dignità, che è stato un lascito importante del costituzionalismo del Dopoguerra diventa, per Rodotà, un elemento costitutivo dell’identità personale.
Tutto ciò quando la chirurgia plastica è in grado di cambiare i nostri connotati.
E qui entra in gioco il secondo termine del libro, la dignità, assunta non in maniera generica, ma come un vero principio giuridico. Che ha già trovato spazio nella nostra Costituzione e poi nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. Ma ciò non basta, se si vuol passare dal tempo dell’homo aequalis a quello dell’homo dignus. Il richiamo alla dignità, che è stato un lascito importante del costituzionalismo del Dopoguerra diventa, per Rodotà, un elemento costitutivo dell’identità personale.
 Naturalmente a patto che il concetto stesso di “persona” spezzi il guscio giuridico di matrice romana, per incarnarsi nel corpo vivente di ogni essere umano, senza distinzione di etnia, religione, provenienza.
Naturalmente a patto che il concetto stesso di “persona” spezzi il guscio giuridico di matrice romana, per incarnarsi nel corpo vivente di ogni essere umano, senza distinzione di etnia, religione, provenienza.Anche la questione, largamente discussa, dei beni comuni va inquadrata in questo orizzonte storico, misurata alle drastiche trasformazioni che stiamo vivendo. Solo in questo modo anche il terzo termine in gioco - la vita - può diventare oggetto di una biopolitica affermativa. Rodotà ne offre un esempio illuminante.
Nel 2013 la Corte suprema dell’India ha stabilito che il diritto di una casa farmaceutica di fissare liberamente il prezzo di un farmaco di largo consumo è subordinato al diritto fondamentale alla salute di chi ne ha bisogno. Che prevale sull’interesse proprietario.
Come è noto, a partire dall’entrata in vigore del Codice civile napoleonico, il principio della proprietà è stato sostituito a quello, rivoluzionario, di fraternità, anteponendo la figura del proprietario a quella del cittadino. Che non sia arrivato il momento di riattivare la fraternità ricucendo il filo, spezzato dell’uguaglianza?
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- COSTITUZIONE E PENSIERO. ITALIA: LA MISERIA DELLA FILOSOFIA ITALIANA E LA RICCHEZZA DEL MENTITORE ISTITUZIONALIZZATO ...
 BERTRAND RUSSELL: LA LEZIONE SUL MENTITORE (IGNORATA E ’SNOBBATA’), E "L’ALFABETO DEL BUON CITTADINO".
BERTRAND RUSSELL: LA LEZIONE SUL MENTITORE (IGNORATA E ’SNOBBATA’), E "L’ALFABETO DEL BUON CITTADINO".
-
POLITICA, CONFLITTO D’INTERESSE, E ... "UNDERSTANDING MEDIA" ("GLI STRUMENTI DEL COMUNICARE"). I nuovi media non sono giocattoli e non dovrebbero essere messi nelle mani di Mamma Oca o di Peter Pan.
 LA "PROFEZIA" DI MARSHALL MCLUHAN: NARCISO E LA MORTE DELL’ITALIA.
LA "PROFEZIA" DI MARSHALL MCLUHAN: NARCISO E LA MORTE DELL’ITALIA.
FILOSOFIA. IL PENSIERO DELLA COSTITUZIONE E LA COSTITUZIONE DEL PENSIERO
 MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA E A PENSARE BENE "DIO", "IO" E "L’ITALIA", CHI PIU’ CHI MENO, TUTTI VIVONO DENTRO LA PIU’ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA E POLITICA ITALIANA, NEL REGNO DI "FORZA ITALIA"!!!
MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA E A PENSARE BENE "DIO", "IO" E "L’ITALIA", CHI PIU’ CHI MENO, TUTTI VIVONO DENTRO LA PIU’ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA E POLITICA ITALIANA, NEL REGNO DI "FORZA ITALIA"!!!Federico La Sala
- COSTITUZIONE E PENSIERO. ITALIA: LA MISERIA DELLA FILOSOFIA ITALIANA E LA RICCHEZZA DEL MENTITORE ISTITUZIONALIZZATO ...
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. - L’epoca, affollata di computer e robot, non ha ricordi. La sinistra che c’era è andata a destra (di Furio Colombo).26 febbraio 2018, di Federico La Sala
La sinistra che c’era è andata a destra
di Furio Colombo (Il Fatto, 25.02.2018)
La destra e la sinistra non esistono più. La frase, che circola anche nei migliori partiti, è come una benda gettata all’improvviso sugli occhi dei cittadini per costringerli a un gioco a mosca cieca. Dovunque cerchi, non trovi. L’epoca, affollata di computer e robot, non ha ricordi. Che senso ha cercare la destra del mercato e del capitale, se non esiste più (non conta niente) il sindacato della lotta di classe? Se sei italiano, però, prima di rispondere alla domanda su destra e sinistra, devi tener conto di un fatto.
L’Italia ha due destre, una di interessi economici e di difesa dei capitali, con la sua visione conservatrice. L’altra destra è ideologica, è fondata sulla violenza e sul potere, che trucca, tradisce, condanna, reprime, se ha il potere. -Qual è la destra che non esiste più, al punto che vi dicono: la parola non ha più senso? Evidentemente la prima, che partecipava al gioco con la sinistra sapendo di avere sempre delle buone carte in mano, ma anche interessata (la pace sociale costa meno) a non rompere i ponti. Il fatto strano, almeno per l’Italia, è che è stata la sinistra ad alzarsi dal tavolo e ad abbandonare il gioco, imperfetto ma funzionante, delle due parti con interessi diversi e la comune convenienza.
 Mille convegni non hanno spiegato perché la sinistra se ne è andata o si è sempre più travestita da destra, arrivando a spingere più in là di quel che le imprese volevano. Qui è accaduto un effetto collaterale che forse la sinistra non aveva calcolato: il suo popolo, sentendosi non più rappresentato se n’è andato alla spicciolata, lasciando un largo spazio vuoto. Perché quello spazio vuoto sia tuttora celebrato come “il popolo della sinistra” non si sa.
Mille convegni non hanno spiegato perché la sinistra se ne è andata o si è sempre più travestita da destra, arrivando a spingere più in là di quel che le imprese volevano. Qui è accaduto un effetto collaterale che forse la sinistra non aveva calcolato: il suo popolo, sentendosi non più rappresentato se n’è andato alla spicciolata, lasciando un largo spazio vuoto. Perché quello spazio vuoto sia tuttora celebrato come “il popolo della sinistra” non si sa.
 Certo che se c’è stato un tempo in cui la destra erano Agnelli e Pirelli e la sinistra erano Pertini e Berlinguer, stiamo parlando di un universo perduto. Ora c’è la sala vuota della Confindustria, ci sono i circoli chiusi del Pd e qualcuno ha la faccia tosta di organizzare la Festa dell’Unità dopo avere fatto morire, deliberatamente, il giornale di Gramsci.
Certo che se c’è stato un tempo in cui la destra erano Agnelli e Pirelli e la sinistra erano Pertini e Berlinguer, stiamo parlando di un universo perduto. Ora c’è la sala vuota della Confindustria, ci sono i circoli chiusi del Pd e qualcuno ha la faccia tosta di organizzare la Festa dell’Unità dopo avere fatto morire, deliberatamente, il giornale di Gramsci.
 Il fenomeno però non è così simmetrico come sembra. Impossibile negare che la sinistra non c’è più, nel Paese in cui domina l’anelito di tagliare le pensioni e diminuire i salari (vedi Fornero e Whirpool).
Il fenomeno però non è così simmetrico come sembra. Impossibile negare che la sinistra non c’è più, nel Paese in cui domina l’anelito di tagliare le pensioni e diminuire i salari (vedi Fornero e Whirpool).Ma, delle due destre, ne è rimasta una, quella ideologica e del potere, quella fascista. È viva negli Usa, con il suo presidente che vuole armare gli insegnanti, con il capo dell’estrema destra (alt right) Steven Bannon che è appena un passo dalla Casa Bianca, con i misteriosi contatti con Putin. È viva nei Balcani e nell’Europa dell’Est (dall’Ungheria all’Austria alla Polonia). E dove sembra che non ci sia fascismo compare un Breivik niente affatto povero e marginalizzato, un fascista abbiente e bene armato, che uccide in un paio d’ore cento giovani socialisti di una scuola di partito.
 Se pensate che il fascismo, per tornare a crescere, abbia bisogno di un popolo abbandonato dalla sinistra, ecco l’idea: dedicarsi a diffondere e far crescere la paura dell’immigrazione. Gli stranieri sono gente impura, non cristiana, sconosciuta, diversa, con cui vorrebbero obbligarti a dividere la vita fino a sottometterti. Poiché questo è ciò di cui bisogna occuparsi, anche con la forza, se necessario: qualcuno sta organizzando l’invasione di una immensa quantità di stranieri in Italia e dunque sta creando un grave pericolo per la pura razza italiana.
Se pensate che il fascismo, per tornare a crescere, abbia bisogno di un popolo abbandonato dalla sinistra, ecco l’idea: dedicarsi a diffondere e far crescere la paura dell’immigrazione. Gli stranieri sono gente impura, non cristiana, sconosciuta, diversa, con cui vorrebbero obbligarti a dividere la vita fino a sottometterti. Poiché questo è ciò di cui bisogna occuparsi, anche con la forza, se necessario: qualcuno sta organizzando l’invasione di una immensa quantità di stranieri in Italia e dunque sta creando un grave pericolo per la pura razza italiana.Se pensate di non aver notato nulla di così sconvolgente, ma solo povera gente terrorizzata da fame, guerra e dal pericolo di annegare in mare, se temete che ci sia una falsificazione o una esagerazione dei dati, ecco la vera notizia, il complotto. Come aveva previsto Umberto Eco ne Il pendolo di Foucoult, ne Il cimitero di Praga e nel bellissimo testo Il fascismo eterno, arriva la notizia del complotto.
 Qualcuno trama per la sostituzione dei popoli, i neri (i neri!) prenderanno, qui, nel nostro Paese di pura razza italiana, il posto dei bianchi. Naturale che i popoli non si sostituiscono da soli. Ci vuole il miliardario canaglia che, come è naturale in un mondo fascista, è ebreo. Si tratta di un certo Soros, e anche se persino Minniti o Salvini o Meloni o Lombardi (il cuore d’oro del M5S) non hanno ancora rivelato la causa di questo complotto (ci impongono di accettare nuovi schiavi o nuovi padroni?), il complotto c’è e vi partecipano persino (quando non sono in Siria a salvare bambini o in mare a salvare naufraghi) le Ong, compresi i “Medici senza frontiere” onorati dal presidente della Repubblica. E l’invasione continua. Non dite vanamente che l’invasione non c’è. Nessun partito importante in queste elezioni vi starebbe a sentire.
Qualcuno trama per la sostituzione dei popoli, i neri (i neri!) prenderanno, qui, nel nostro Paese di pura razza italiana, il posto dei bianchi. Naturale che i popoli non si sostituiscono da soli. Ci vuole il miliardario canaglia che, come è naturale in un mondo fascista, è ebreo. Si tratta di un certo Soros, e anche se persino Minniti o Salvini o Meloni o Lombardi (il cuore d’oro del M5S) non hanno ancora rivelato la causa di questo complotto (ci impongono di accettare nuovi schiavi o nuovi padroni?), il complotto c’è e vi partecipano persino (quando non sono in Siria a salvare bambini o in mare a salvare naufraghi) le Ong, compresi i “Medici senza frontiere” onorati dal presidente della Repubblica. E l’invasione continua. Non dite vanamente che l’invasione non c’è. Nessun partito importante in queste elezioni vi starebbe a sentire.
 Abbiamo dunque alcune certezze. La sinistra non c’è. Ma la destra, con il coraggio di dirsi fascista, c’è e conta.
Abbiamo dunque alcune certezze. La sinistra non c’è. Ma la destra, con il coraggio di dirsi fascista, c’è e conta.
La frase finale di Berlusconi
risponde Furio Colombo (il Fatto, 14.05.2013)
- CARO FURIO COLOMBO, mi domando se il comizio di Brescia non si possa definire, in termini legali, “adunata sediziosa”, un comizio di false informazioni da parte di una falsa autorità al fine di provocare sollevazione. Perché tanta tolleranza? Patrizio
CERTO, IL COMIZIO di Brescia in difesa di un imputato di reati gravi, condannato per reati gravi, in attesa di imminente sentenza per reati gravi, appena raggiunto da un rinvio a giudizio per reati gravi, non era né una festa né un evento politico. Il fine era chiaro e indiscutibile: creare una barriera insormontabile, tra un imputato e i suoi giudici. Lo ha fatto il capo di quello che, al momento, risulta il partito più grande.
E quel capo ha mobilitato per l’occorrenza il ministro dell’Interno e vice primo ministro, mentre sta governando in una presunta “grande coalizione” con un partito che dovrebbe essere il principale antagonista. Purtroppo non ci sono segnali dal governo di coalizione, non ci sono segnali dal partito antagonista, e i media trattano la materia come una notizia interessante, ma non meritevole di allarme, di denuncia e di condanna. Così i cittadini sono autorizzati a pensare che forse è normale che tutta la forza di un esecutivo (uno dei tre poteri della democrazia) venga lanciato contro la magistratura, ovvero un altro potere indipendente, nel silenzio del terzo potere, il Parlamento.
Per capire il rischio che stiamo correndo, si riveda la frase conclusiva del monologo di Berlusconi, nel suo comizio a due piazze (una gremita di sostenitori più o meno spontanei, l’altra di disciplinati obiettori).
La frase era: “Nessuna sentenza e nessuna prepotenza della magistratura potrà impedirmi di essere capo di un popolo che mi elegge con milioni di voti”. Non parlava di legame ideale o affettivo. Dichiarava la superiorità dei voti sulle sentenze, come se ci fossero democrazie in cui il votato non è più come tutti gli altri, ma qualcuno esente da ogni giurisdizione e giudizio. Ovvio che Berlusconi non parlava di democrazia, parlava di sé e del suo progetto di rivolta, in caso di altre condanne. E ci ha ricordato che non gli si può rimproverare il sotterfugio.
Berlusconi si comporta da fuorilegge e lo dice prima. Eppure, non vi sono risposte politiche o risposte istituzionali. E i segnali non sono buoni. La giudice Fiorillo ha visto segnato il fascicolo della sua carriera da una censura del Csm per avere smentito quanto detto da Berlusconi e quanto dai complici sulla vicenda Ruby. Berlusconi ha potuto tenere il suo comizio di minaccia alla Repubblica senza che seguisse, per decenza, almeno un “pacato” cenno di dissenso.
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. Materiali sul tema - Elezioni, Prodi sceglie ’Insieme’ e investe Gentiloni: ’L’Italia che vogliamo’.17 febbraio 2018, di Federico La Sala
Elezioni, Prodi sceglie ’Insieme’ e investe Gentiloni: ’L’Italia che vogliamo’
Grasso: ’Grande coalizione? Se potremo portare temi Leu’
di Redazione ANSA*
- Il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni abbraccia l’ex premier, Romano Prodi durante l’iniziativa elettorale di ’Insieme’ a Bologna
Annuncia la sua scelta per ’Insieme’ e investe Paolo Gentiloni: l’ex premier, Romano Prodi, ha partecipato oggi ad un incontro elettorale, parlando di fronte all’attuale presidente del consiglio. "C’è una certa commozione nel tornare a un’assemblea politica dopo quasi nove anni - ha detto il fondatore dell’Ulivo -. E c’è commozione anche, proprio per il riconoscimento a Paolo del lavoro che sta facendo in un momento difficile in cui dobbiamo mostrare un paese sereno, che ha idee chiare, che riconosce i propri limiti e i propri meriti nell’ambito europeo e ricostruisce un ruolo per avere una influenza nel mondo, per essere l’Italia che noi vogliamo: sana, forte, rigorosa".
"Le coalizioni - aggiunge - non sono frutto di cattiveria ma della complessità della nostra società che ha moltiplicato il numero dei partiti. Abbiamo bisogno di coalizioni. Non solo noi, lo si vede anche in Germania. Abbiamo bisogno di una coalizione di centrosinistra forte per due valori: lotta alla disuguaglianza e Europa". Quinid, l’annuncio della scelta: "Ho rotto un lungo silenzio, perché mi sentivo in dovere di sottolineare l’importanza della scelta e il dovere di sostenere la coalizione di centrosinistra, in particolare gli amici di ’Insieme’. Perché - ha argomentato - portano avanti gli stessi valori che sono stati alla base dell’Ulivo e che io profondamente condivido: minore disuguaglianza e una forte presenza in Europa".
Gentiloni commenta i numeri dei sondaggi elettorali: nella corsa elettorale, rispetto alla coalizione avversaria, "c’e un distacco di sei-sette punti, non esistono distacchi incolmabili. Le cose possono cambiare se lavoriamo con grande impegno per un centrosinistra che risolva problemi del Paese. Sono convinto - ha concluso - che nella prossima legislatura l’unico pilastro stabile sia quello del centrosinistra, tutti devono dare il proprio contributo".
E il leader di Liberi e Uguali Pietro Grasso, parlando a Pordenone: "Vedremo se avremo la possibilità concreta di portare avanti i nostri temi come lavoro e diritti dei lavoratori, sanità, istruzione e ambiente. Solo se saranno condivisi, vedremo se potremo governare", ha affermato sulla disponibilità a partecipare a un governo di grande coalizione come in Germania.
Che Renzi "sia un grande affabulatore non si può mettere in dubbio ed è anche l’unico leader della sinistra". Ma un accordo con lui? "No, non lo facciamo e non si può fare perché c’è un impegno nella coalizione che riguarda tutti e per l’impegno verso i nostri elettori e poi perché la sinistra ha portato il Paese in condizione davvero negative", dice Silvio Berlusconi durante il Faccia a faccia di Giovanni Minoli in onda domani su La7.
* ANSA 17 febbraio 2018 (ripresa parziale - senza immagini).
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. -- I fatti di Macerata rappresentano una svolta fondamentale. Lo scenario che probabilmente ci aspetta (di Maurizio Viroli)..10 febbraio 2018, di Federico La Sala
Lo Stato deve manifestare contro i fascisti
di Maurizio Viroli (Il Fatto, 10.02.2018)
Altro che vietare le manifestazioni, a Macerata deve manifestare lo Stato: manifestare la sua ferma determinazione di combattere i fascisti con tutte le sue forze, nel pieno rispetto della Costituzione e delle leggi.
A Macerata deve andare il presidente della Repubblica e parlare, con i corazzieri alle spalle, e con lui sul palco devono esserci il presidente del Consiglio, il ministro degli Interni e quello della Difesa, i presidenti di Senato e Camera, i comandanti militari e delle forze di sicurezza. Devono dire con parole chiare che la Repubblica s’impegna solennemente a non dare tregua ai fascisti e a proteggere la libertà e la sicurezza di tutti, cittadini e non cittadini.
Possibile che le alte cariche dello Stato, uomini e donne colti e saggi, almeno si spera, non si rendano conto che sottovalutare il pericolo neofascista è moralmente ignobile e politicamente suicida? Possibile che non sappiano che lo Stato liberale è crollato nel 1922 perché non volle e non seppe combattere i fascisti, non certo perché i fascisti erano più forti?
 Se Vittorio Emanuele III avesse decretato lo stato d’assedio e mandato contro i fascisti l’esercito e i carabinieri, avrebbe salvato lo Stato liberale.
Se Vittorio Emanuele III avesse decretato lo stato d’assedio e mandato contro i fascisti l’esercito e i carabinieri, avrebbe salvato lo Stato liberale.Con tutte le differenze del caso, oggi la Repubblica democratica può sconfiggere il neofascismo soltanto se lo combatte con la massima intransigenza. In Italia il fascismo è un reato, l’antifascismo è un dovere civile. Ha, quindi, perfettamente ragione Giuseppe Civati a sostenere che “Fascismo e Antifascismo non sono in nessun modo paragonabili”. E con lui hanno ragione le associazioni e le organizzazioni che hanno chiesto alle autorità competenti di autorizzare la manifestazione. È un loro dovere ancor prima che loro diritto.
Sarebbe una vergogna tirarsi indietro. Ma i cittadini da soli non possono vincere contro i fascisti, poiché i fascisti usano la violenza: sparano, aggrediscono, intimidiscono. I cittadini non possono e non vogliono scendere sul terreno della violenza.
 Soltanto lo Stato può usare la forza legittima e se non lo fa chi lo rappresenta si carica di una responsabilità gravissima. Per giustificare la scelta iniziale - per fortuna ieri rivista - di vietare le manifestazioni non vale l’argomento dell’ordine pubblico.
Soltanto lo Stato può usare la forza legittima e se non lo fa chi lo rappresenta si carica di una responsabilità gravissima. Per giustificare la scelta iniziale - per fortuna ieri rivista - di vietare le manifestazioni non vale l’argomento dell’ordine pubblico.Lo Stato deve garantire agli antifascisti il diritto di manifestare e proteggerli da aggressioni fasciste. Se vuole, può farlo. Permettere agli antifascisti di manifestare significa non solo fare capire ai fascisti che lo Stato questa volta non è con loro ma contro di loro, ma dare forza alle istituzioni repubblicane. Altrettanto dissennato è l’argomento di chi sostiene che il gesto di Traini è stato un atto di solitaria follia. Chiunque abbia letto qualche libro sulle organizzazioni terroristiche intende perfettamente che quel che ha fatto Traini è puro terrorismo: violenza indiscriminata e a qualunque costo, contro un determinato gruppo sociale. I terroristi, infatti, agiscono anche a rischio della libertà e della vita, quando sanno di poter contare su una comunità che li sostiene. Infatti ecco Forza Nuova che si fa carico delle spese legali e manifesta con Casapound per aiutarlo, ecco Salvini che dichiara che la colpa è di chi ha fatto arrivare gli immigrati, ecco i molti che non parlano ma lo considerano un eroe.
Proprio perché l’atto terroristico di Macerata è segno della forza delle idee fasciste, la risposta deve essere una guerra senza quartiere. Le parole del sindaco di Macerata, Pd, che approva la scelta di vietare le manifestazioni in nome di un silenzio che rispetti le ferite della città sono penose. Qualcuno gli spieghi che il silenzio è atto di rispetto e di pietà per le vittime, ma che il dovere più importante e pressante è fermare gli aguzzini.
Il dato vero che deve preoccupare è che la solidarietà antifascista, che in passato aveva unito liberali, democristiani, repubblicani, socialdemocratici socialisti, comunisti e aveva saputo fare argine valido contro il neofascismo e ogni altra idea che mirasse a destabilizzare lo Stato, oggi non esiste più. Provino Pietro Grasso e Giuseppe Civati a proporre a chi a vario titolo è alla testa degli altri partiti politici (Silvio Berlusconi, Matteo Renzi, Giorgia Meloni, Luigi Di Maio, Matteo Salvini) di firmare prima del 4 marzo un documento comune in cui ciascuno s’impegna solennemente a combattere il neofascismo. Sarà un fallimento.
Lo scenario che probabilmente ci aspetta è quello di un governo di centrodestra guidato, di fatto, da Berlusconi. Com’è noto Berlusconi in più di un’occasione ha manifestato la sua simpatia per Mussolini, ed è poco incline a combattere i fascisti e felice di bastonare gli antifascisti, che poi per lui sono comunisti camuffati. Così, nel 2022, avremo le piazze piene di fascisti ed essi stessi, o i loro amici, al governo.
I fatti di Macerata rappresentano una svolta fondamentale. Le alte cariche dello Stato possono salvarla o agevolarne la morte.
Rinnovo l’appello: vada il presidente Mattarella a Macerata e pronunci le parole giuste per sconfiggere il pericolo fascista, prima che sia tardi.
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. -- "DIFFIDO DELL’ISTRUZIONE" DI "PIGMALIONE".6 febbraio 2018, di Federico La Sala
"PIGMALIONE", UNA "FIGURA" NARCISISTICA ED EDIPICA, ANCORA MODELLO DI ESSERE UMANO E DI MAESTRO?!
- L’elemento che fa sì che educazione e istruzione siano in efficace armonia è l’amore. Niente di sentimentale: l’amore è una presa di posizione nei confronti della realtà e ne permette la conoscenza, perché ne coglie il valore ancora potenziale da portare a compimento con l’impegno personale (...) Soltanto così diventiamo pigmalioni di ragazzi dal cuore caldo e la testa fredda, a fronte del dilagare, tra gli adulti prima che tra i giovani, di teste calde e cuori freddi (Alessandro D’Avenia)
- L’ Amore (Charitas) non è lo zimbello del tempo e di Mammona (Caritas)!!!
 OBIEZIONE DI COSCIENZA!!! L’OBBEDIENZA NON E’ PIU’ UNA VIRTU’. LETTERA AI CAPPELLANI MILITARI. LA LEZIONE DI DON LORENZO MILANI
OBIEZIONE DI COSCIENZA!!! L’OBBEDIENZA NON E’ PIU’ UNA VIRTU’. LETTERA AI CAPPELLANI MILITARI. LA LEZIONE DI DON LORENZO MILANI
Diffido dell’istruzione
di Alessandro D’Avenia (Corriere della Sera, 05.02.2018)
«Caro professore, sono un sopravvissuto di un campo di concentramento. Ho visto ciò che nessuno dovrebbe vedere: camere a gas costruite da ingegneri istruiti, bambini avvelenati da medici ben formati, lattanti uccisi da infermiere provette, donne e bambini uccisi e bruciati da diplomati e laureati. Diffido - quindi - dell’istruzione. Aiutate i vostri allievi a diventare esseri umani. I vostri sforzi non devono mai produrre dei mostri formati, degli psicopatici qualificati, degli Eichmann istruiti. La lettura, la scrittura, l’aritmetica non sono importanti se non servono a rendere i nostri figli più umani».
 Fu il compianto dirigente della mia scuola, qualche anno fa, a condividere questa lettera apparsa su Le Monde in un pezzo della scrittrice Annick Cojean. L’occasione era il Giorno della Memoria, ricorrenza sterile se non ricorda un fatto che il XX secolo ha inciso nella storia a caratteri di sangue: non basta essere istruiti per essere umani.
Fu il compianto dirigente della mia scuola, qualche anno fa, a condividere questa lettera apparsa su Le Monde in un pezzo della scrittrice Annick Cojean. L’occasione era il Giorno della Memoria, ricorrenza sterile se non ricorda un fatto che il XX secolo ha inciso nella storia a caratteri di sangue: non basta essere istruiti per essere umani.Il divorzio tra istruzione ed educazione è uno dei mali peggiori della scuola, frutto del luogo comune secondo cui esisterebbe un’istruzione neutra. Invece sempre si educa mentre si istruisce, perché la prima comunicazione è quella dell’essere, e solo dopo arrivano le parole, altrimenti non sarebbe necessaria la relazione viva con i ragazzi, ma basterebbe caricare le lezioni sulla rete. In senso stretto non esiste insegnamento in differita , ma solo in diretta.
Insegnare è una branca della drammaturgia. È l’essere dell’insegnante che genera la conoscenza, perché apre la via al desiderio dello studente, che scorge nel docente una vita più viva e libera grazie alla cultura e al lavoro ben fatto, e la vuole anche per sé. Lo ricordava con precisione il Nobel Canetti nella sua autobiografia: «Ogni cosa che ho imparato dalla viva voce dei miei insegnanti ha conservato la fisionomia di colui che me l’ha spiegata e nel ricordo è rimasta legata alla sua immagine. È questa la prima vera scuola di conoscenza dell’uomo».
Le nozioni più raffinate da sole non rendono umani, tutto dipende da come gli insegnanti si relazionano tra loro e con i ragazzi, perché, prima delle nozioni, sono le relazioni a essere generative dell’io e del sapere. È nella relazione che si impara a sentire il valore del sé come destinatario del dono del sapere. Quali insegnanti siete tornati a ringraziare e per cosa? Per la lezione sulle leggi della termodinamica e su Leopardi, o per come vivevano e offrivano la termodinamica e Leopardi proprio a voi?
Qualche tempo fa mi scriveva uno studente: «Le racconto due esperienze. La prima: la faccia polverosa della scuola. Un professore, che aveva esordito in prima liceo con “siete troppi: vi ridurremo”, pochi giorni fa ha condensato l’amore per il suo lavoro in questa frase: “Un insegnante non deve avere cuore, deve avere un cuore di pietra... altrimenti farà preferenze”. Uno scherzo, pensavamo. Un mio compagno ribatte: “Ma no, prof! Un insegnante deve avere un cuore talmente grande da non fare nessuna preferenza!”. “No, no: un cuore di pietra”. Parlava seriamente. La seconda: la faccia luminosa della scuola. Quest’anno ho scoperto la poesia grazie al gesto straordinario di un ordinario professore di filosofia, che un giorno ci ha parlato della sua giovinezza e di come la poesia ai tempi occupasse la sua vita e impegnasse la sua fantasia. Interessato anche io dal momento che non avevo letto nessun grande poeta ho chiesto un consiglio. Il giorno seguente lo vedo estrarre dalla sua ventiquattrore un libricino invecchiato. Viene verso di me. “Questo è per te”. Mi ha regalato una delle sue copie di Elegie duinesi, di R.M. Rilke, il suo libro di poesia preferito. Il libro della sua giovinezza!».
La differenza tra le due impostazioni è proprio quella che corre tra chi si illude si possano separare istruzione ed educazione e chi invece le tiene naturalmente unite. Nel primo caso si pensa che il docente sia un distributore di nozioni, nel secondo la didattica è conseguenza della relazione. Il primo professore educa all’insensibilità di cuore, a non sentire l’unicità del tu, il secondo rende Rilke interessante prima di averne letta una riga. Il nesso che tiene unite istruzione ed educazione è nella realtà, e nessuna presa di posizione teorica le può nei fatti separare. L’elemento che fa sì che educazione e istruzione siano in efficace armonia è l’amore.
Niente di sentimentale: l’amore è una presa di posizione nei confronti della realtà e ne permette la conoscenza, perché ne coglie il valore ancora potenziale da portare a compimento con l’impegno personale. Non si può aumentare la conoscenza di qualcosa senza che prima aumenti l’interesse nei confronti del soggetto in questione (vale per l’amicizia come per la chimica). L’amore genera conoscenza e la conoscenza ampliata rinnova l’amore: se il docente non «erotizza» la materia, la materia per quanto ben conosciuta resta inerte, come spiega Massimo Recalcati.
Non esistono cose poco «interessanti», ma uomini e donne poco «interessati», perché le emozioni (la neurobiologia qui ci conforta) sono le guide che aprono la strada allo sviluppo cognitivo. Solo così gli studenti diventano soggetti di possibilità e non oggetti al peggio da ridurre o al meglio da riempire. È questa la rivoluzione copernicana chiesta a ogni docente: non sono gli alunni a ruotare attorno a lui ma il contrario. Un professore - il letto da rifare oggi lo suggerisce lo studente della lettera - è chiamato ad avere un cuore tale da non far preferenze perché preferisce tutti e ciascuno diversamente: sfida difficilissima (quanti errori, quante gioie...) ma decisiva.
È la stessa sfida narrata da Ovidio, nelle sue Metamorfosi, a proposito del mito di Pigmalione. Uno scultore che, deluso da tutte le donne, si innamora della donna ideale che ha scolpito nel marmo. Il suo trasporto è tale che gli dei trasformano la statua in una donna in carne e ossa. Il mito viene usato per descrivere lo sguardo educativo, il cosiddetto effetto-Pigmalione, per il quale se un docente (ma vale per ogni educatore) guarda un alunno convinto che farà bene, genererà in lui una fiducia in sé tale che, nella quasi totalità dei casi, anche a fronte di un’inadeguata disposizione iniziale, otterrà risultati positivi.
L’effetto vale anche in negativo: se sono convinto che non vali, l’effetto sui risultati sarà coerente, anche a fronte di buone capacità. Lo sguardo educante non è mai neutro ma sempre profetico, nel bene e nel male. Ne abbiamo conferma quotidiana nel bambino che, appena caduto, si volge verso i genitori: se si mostrano allarmati ne provocano il pianto, se sorridenti il sorriso, quasi che il dolore, pur oggettivo, venga trasformato nello e dallo sguardo.
I ragazzi non hanno bisogno di insegnanti amiconi né aguzzini, ma di uomini e donne capaci di guardarli come amabili soggetti di inedite possibilità a cui non fare sconti. E non è questione di missione o di poteri magici, ma di professionalità. Per questo l’appello è il momento chiave della giornata scolastica: segna il tono della relazione e fa sì che ognuno senta su di sé lo sguardo profetico che spinge a far bene come conseguenza dell’ esser bene. Il contrario del «siete troppi, vi ridurremo», sterile autoritarismo, è il fecondo «sei unico, ti aumenterò».
La parola autorità viene da augeo (aumentare): la esercita non chi ha il cuore molle o sprezzante, ma chi si impegna ad aumentare la vita che ha di fronte, per quanto fragile, difficile, resistente possa sembrare. Questa è l’istruzione di cui non diffido, perché ispirata da un umanesimo maturo, l’umanesimo dell’altro uomo, come lo chiama il filosofo Lévinas, che fa del tu il cuore dell’etica e smaschera il falso umanesimo dell’istruito incapace di sentire il tu, tanto da distruggerlo proprio attraverso l’istruzione.
Non è facile però essere educatore in un sistema scolastico che asfissia di burocrazia e svilisce la dignità sociale ed economica, e in un contesto culturale che spesso attacca dall’alto (genitori) e dal basso (studenti). Ma questi elementi possono anche diventare scuse per non fare ciò che è alla portata di un uomo libero: prendersi cura di chi gli viene affidato.
Soltanto così diventiamo pigmalioni di ragazzi dal cuore caldo e la testa fredda, a fronte del dilagare, tra gli adulti prima che tra i giovani, di teste calde e cuori freddi.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
-
CHI INSEGNA A CHI CHE COSA COME?! QUESTIONE PEDAGOGICA E FILOSOFICA, TEOLOGICA E POLITICA
 INSEGNAMENTO E COSTITUZIONE: "CHI INSEGNA AI MAESTRI E ALLE MAESTRE A INSEGNARE?"!
INSEGNAMENTO E COSTITUZIONE: "CHI INSEGNA AI MAESTRI E ALLE MAESTRE A INSEGNARE?"!
KANT E SAN PAOLO. COME IL BUON GIUDIZIO ("SECUNDA PETRI") VIENE (E VENNE) RIDOTTO IN STATO DI MINORITA’ DAL GIUDIZIO FALSO E BUGIARDO ("SECUNDA PAULI").
- L’ Amore (Charitas) non è lo zimbello del tempo e di Mammona (Caritas)!!!
 OBIEZIONE DI COSCIENZA!!! L’OBBEDIENZA NON E’ PIU’ UNA VIRTU’. LETTERA AI CAPPELLANI MILITARI. LA LEZIONE DI DON LORENZO MILANI
OBIEZIONE DI COSCIENZA!!! L’OBBEDIENZA NON E’ PIU’ UNA VIRTU’. LETTERA AI CAPPELLANI MILITARI. LA LEZIONE DI DON LORENZO MILANI
- "PERVERSIONI". UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LA’ DELL’EDIPO
PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!
 FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.Federico La Sala
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. - Il deposito dei simboli elettorali: "la personalizzazione questa volta è un inganno" (Massimiliano Panarari). Interv. di Claudia Fusani.22 gennaio 2018, di Federico La Sala
[L’intervista]
Il politologo Panarari analizza la cerimonia del deposito dei contrassegni elettorali. Sono più che dimezzati, da 216 a 103, perché “più difficile presentarli” e perché cresce "la distanza rispetto alla politica"
’Grasso è una maglia da indossare come Salvini. Ma la personalizzazione questa volta è un inganno’
di Claudia Fusani, giornalista parlamentare *
Il rito del deposito dei simboli elettorali al Viminale si è concluso ieri pomeriggio alle 16. E’ un rito antico ma non stanco perché, spiega Massimiliano Panarari, politologo, saggista, docente di Comunicazione politica e Marketing politico all’Università Luiss “Guido Carli” di Roma, è “una convivenza di momenti che hanno a che fare con quello che gli antropologi politici chiamano il rituale elettorale, una vera e propria festa secondo la tradizione, e con il rapporto dei cittadini e la politica”. Complesso, di odio e amore e rabbia, ma a quanto pare, nonostante la crisi della rappresentanza, sempre molto vivo.
Due giorni e mezzo di code ordinate, gente in fila in educata attesa del proprio turno, e il corridoio del Viminale dove sono esposte le bacheche dei simboli trasformato in un piccolo palcoscenico dove ciascun depositante spiegava le ragioni della sua presenza. Non le sembra contraddittorio nell’era dove tutto è digital e social e la selezione del personale politico avviene via web?
"La cerimonia del deposito dei simboli elettorali è una convivenza di momenti. E’ vero che la politica oggi passa sempre di più per l’agorà del web che è una piazza informatica e telematica. Ma sopravvive in ottima salute una tradizione radicata e consolidata al cui successo contribuisce certamente la copertura mediatica di tv e giornali, l’opportunità concreta di visibilità per i leader e anche, soprattutto, una vera e propria liturgia che rinvia all’appuntamento elettorale come una festa, secondo la definizione che ne danno molti antropologi".
Dunque, un fatto comunque positivo?
"Positivo perché in un’epoca di sfiducia e di crisi della rappresentanza la partecipazione e l’attenzione a questo evento significano ancora, per tanti versi, una festa per la democrazia. Dall’altro lato, però, c’è una dimensione quasi di litania e di consunzione e stanchezza, perché molti di quei simboli parlano di tensioni sociali che si perpetuano e di mancate soluzioni ai problemi".
Rispetto al 2013, le ultime politiche, sono stati depositati solo 103 simboli rispetto ai 219 di cinque anni fa. Più che dimezzati, perché?
"Il macrotema resta quello della distanza della politica dai cittadini elettori sempre più sfiduciati che possano arrivare risposte. Il clima è quello dei cittadini che rifiutano i volantini ai banchetti, quindi attivarsi per organizzare la presentazione di simboli elettorali richiede sforzi improbi. Credo però, in ogni caso che i furbetti, quelli che presentavano brutte copie di altri simboli, i disturbatori storici e i presentatori seriali siano stati tenuti lontani da un insieme di tecnicalità che hanno reso la presentazione più complessa e costosa del passato".
Andremo a votare con una legge per 2/3 proporzionale che non prevede l’indicazione del candidato premier. Eppure resistono, forse aumentano, i nomi dei leader scritti a caratteri cubitale nei simboli. Questo è fortemente contraddittorio...
"La risposta è complessa. Ci sono almeno tre motivi. C’è un tema prima di tutto di struttura. Da Tangentopoli a oggi, l’offerta politica non si è mai ridefinita da un punto di vista ideologico-programmatico né sedimentata. Aver cambiato quattro leggi elettorali ne è la prova. In una fase così fluida e di transizione, la valuta di riserva che si continua a far circolare resta sempre il valore e l’appetibilità del leader. E’ una scorciatoia cognitiva che ha attecchito. Voglio dire che anche se si torna a votare con una legge proporzionale, e per quanto il bipolarismo non abbia fatto in tempo a radicarsi, la centralità del leader è stata forte ed evidente. E rimane".
Il secondo motivo?
"I partiti declinano una campagna elettorale in cui utilizzano una comunicazione sintonizzata sul modello maggioritario. L’indicazione del nome del leader o candidato premier nel simbolo è puro storytelling. Chiamiamola pure retorica. Attecchisce perché si parla molto poco di programmi che invece sarebbero decisamente importanti".
C’è un terzo elemento...
"La personalizzazione si è praticamente sostituita all’ideologia. Grasso diventa, in qualche modo, un’ideologia, una maglia da indossare orgogliosi. E così pure Salvini".
Quei nomi hanno tutti funzioni diverse. Vediamoli. Salvini si propone come premier, ma è un falso visto che il Rosatellum non lo prevede e la coalizione non lo ha indicato.
Salvini parla al suo popolo. La Lega è sempre stato un partito molto personale - e leninista, potremmo dire - e quindi il nome del leader ha semplicemente sostituito l’altro, quello di Umberto Bossi".
Berlusconi presidente è, come dire, una grafica che resta fedele negli anni, nulla di nuovo per quanto tutto sia cambiato. Colpisce, piuttosto, che una personalità come Grasso abbia accettato, o dovuto accettare, di comparire enorme nel simbolo. Perché?
"Il nuovo partito di Liberi e Uguali ha bisogno di parlare con voce unitaria e nuova rispetto agli azionisti di maggioranza di quella lista e che vengono tutti dal passato. LeU, tra l’altro, ha una molteplicità di leader essendo la somma di tre forze politiche. Serviva quindi un messaggio unitario e di novità".
Beatrice Lorenzin compare a tutto tondo nel simbolo colorato della lista Civica popolare, confluenza di ben cinque partiti. Qual è il criterio?
"Questo caso colpisce anche di più perché si tratta di una lista con tradizione e vocazione centrista e cattolica, geneticamente refrattaria al leaderismo. In questo caso c’è un effetto trascinamento della scorciatoia cognitiva: quella lista ha bisogno di posizionarsi con un volto perché è ciò che si ricorda più di tutto il resto. Nella comunicazione politica, oggi, c’è un tema importante e strategico di soglia di visibilità".
Una volta la politica era ideologia e non ha sempre avuto un’accezione negativa. Oggi sembra ridotta a scorciatoie cognitive, ai volti, ai nomi dei leader...
"In effetti anche le ideologie avevano la stessa funzione di scorciatoia cognitiva: erano, a loro modo, un processo di semplificazione seppure con un tasso di complessità maggiore. Eravamo nell’era della ’galassia Gutenberg’, contava la parola, meglio se scritta. Oggi - e da tempo - siamo nella società dell’immagine, dalla tv ai social".
Almeno nel simbolo, il Pd invece non personalizza nulla. Come mai?
"La tradizione culturale della sinistra non si è mai trovata a proprio agio con la personalizzazione. C’è stata, invece, un’epoca di forte personalizzazione, e il renzismo è andato in forte conflitto con quella tradizione. Oggi si fa opportunamente un passo indietro e si rilancia l’idea della collegialità della leadership e della squadra. In termini di posizionamento elettorale è una strategia sensata e razionale, che si posiziona in maniera diversa rispetto al mainstream. E’ un’offerta diversa da quella maggioritaria. E però mi pare che si possa vedere anche un altro tema...".
Quale?
"La squadra del Pd ha una guida, un ’primus inter pares’, Gentiloni, la forza tranquilla, non invasiva, che non ama la personalizzazione. Perfetta per le consuetudini della sinistra. Perciò avrebbe senso comunicare un’idea di Pd come forza tranquilla di governo con un candidato che è Gentiloni".
I 5 Stelle nascono con una forte personalizzazione - sono il partito di Grillo - però hanno tolto dal simbolo il nome del comico e puntano tutta la comunicazione su Di Maio presidente. Idee poco chiare?
"I 5 Stelle stanno procedendo ad una sostituzione complessa di una personalità con l’altra. Dove la prima, Grillo, era un performer e uno stand up comedian, l’artista che cambia il suo repertorio in base alle reazioni del pubblico che ha davanti. Passare da uno come lui ad un ’politico politicante’ e con tratti da politico di professione come Di Maio, è un’operazione complessa e per niente scontata. Molti supporter, tra l’altro, non lo vogliono perché tutto ciò si accompagna con una istituzionalizzazione del Movimento. Credo che Di Maio e i 5 Stelle si stiano giocando tutto e in una battaglia one shot. Questa elezione è la battaglia della vita: se non vincono, loro stessi non sanno se potranno tenere alto il consenso".
Centrotre simboli, 99 forze politiche, i principali li abbiamo esaminati. E tutti gli altri?
"Al netto della paccottiglia e del folclore, quelle bacheche piene di simboli sono un termometro del paese che ha una sua validità rispetto allo stato di salute dell’elettorato. Emerge una richiesta irrazionale di ordine e ci sono spunti molto interessanti, del paese reale, dalle start up a W la Fisica, una lista per i cervelli in fuga che predica il predominio della scienza. Sono temi veri, spunti da valorizzare nei programmi".
* Fonte: Notizie-Tiscali, 22 gennaio 2018
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. -- “Il fascismo è eterno: ecco come lo si può riconoscere”. Uno stralcio della lectio inedita pronunciata da Umberto Eco alla Columbia University11 gennaio 2018, di Federico La Sala
“Il fascismo è eterno: ecco come lo si può riconoscere”
Non pensiero ma azione
- Esce oggi per La Nave di Teseo “Il fascismo eterno”, la lectio inedita pronunciata da Umberto Eco alla Columbia University il 25 aprile 1995. Ne pubblichiamo uno stralcio.
di Umberto Eco (Il Fatto, 11.01.2018)
Il termine “fascismo” si adatta a tutto perché è possibile eliminare da un regime fascista uno o più aspetti, e lo si potrà sempre riconoscere per fascista. [...] Ritengo sia possibile indicare una lista di caratteristiche tipiche di quello che vorrei chiamare l’“Ur-Fascismo”, o il “fascismo eterno”. che non possono venire irreggimentate in un sistema; molte si contraddicono reciprocamente, e sono tipiche di altre forme di dispotismo o di fanatismo. Ma è sufficiente che una di loro sia presente per far coagulare una nebulosa fascista.
1. [...] Il culto della tradizione. Il tradizionalismo è più vecchio del fascismo. Non fu solo tipico del pensiero controrivoluzionario cattolico dopo la Rivoluzione francese, ma nacque nella tarda età ellenistica come una reazione al razionalismo greco classico. Nel bacino del Mediterraneo, i popoli di religioni diverse (tutte accettate con indulgenza dal Pantheon romano) cominciarono a sognare una rivelazione ricevuta all’alba della storia umana. Questa rivelazione era rimasta a lungo nascosta sotto il velo di lingue ormai dimenticate. Era affidata ai geroglifici egiziani, alle rune dei celti, ai testi sacri, ancora sconosciuti, delle religioni asiatiche. Questa nuova cultura doveva essere sincretistica. [...] tollerare le contraddizioni. Come conseguenza, non ci può essere avanzamento del sapere. La verità è stata già annunciata una volte per tutte [...] È sufficiente guardare il sillabo di ogni movimento fascista per trovare i principali pensatore tradizionalisti. [...]
2. Il tradizionalismo implica il rifiuto del modernismo. [...] Tuttavia, sebbene il nazismo fosse fiero dei suoi successi industriali, la sua lode della modernità era solo l’aspetto superficiale di una ideologia basata sul “sangue” e la “terra” (Blut und Boden). [...] L’illuminismo, l’età della ragione vengono visti come l’inizio della depravazione moderna. In questo senso, l’Ur-Fascismo può venire definito come “irrazionalismo”.
3. L’irrazionalismo dipende anche dal culto dell’azione per l’azione. [...] Pensare è una forma di evirazione. Perciò la cultura è sospetta nella misura in cui viene identificata con atteggiamenti critici. [...]
4. Nessuna forma di sincretismo può accettare la critica. Lo spirito critico opera distinzioni, e distinguere è un segno di modernità. Nella cultura moderna, la comunità scientifica intende il disaccordo come strumento di avanzamento delle conoscenze. Per l’Ur-Fascismo, il disaccordo è tradimento.
5. Il disaccordo è inoltre un segno di diversità. L’Ur-Fascismo cresce e cerca il consenso sfruttando ed esacerbando la naturale paura della differenza. [...] è dunque razzista per definizione.
6. L’Ur-Fascismo scaturisce dalla frustrazione individuale o sociale. Il che spiega perché una delle caratteristiche tipiche dei fascismi storici è stato l’appello alle classi medie frustrate, a disagio per qualche crisi economica o umiliazione politica, spaventate dalla pressione dei gruppi sociali subalterni.
7. A coloro che sono privi di una qualunque identità sociale, l’Ur-Fascismo dice che il loro unico privilegio è il più comune di tutti, quello di essere nati nello stesso paese. È questa l’origine del “nazionalismo”. Inoltre, gli unici che possono fornire una identità alla nazione sono i nemici. Così, alla radice della psicologia Ur-Fascista vi è l’ossessione del complotto, possibilmente internazionale. I seguaci debbono sentirsi assediati. Il modo più facile per far emergere un complotto è quello di fare appello alla xenofobia. [...]
8. I seguaci debbono sentirsi umiliati dalla ricchezza ostentata e dalla forza dei nemici. [...]
9. Per l’Ur-Fascismo non c’è lotta per la vita, ma piuttosto “vita per la lotta”. Il pacifismo è allora collusione col nemico[...].
10. L’elitismo è un aspetto tipico di ogni ideologia reazionaria, in quanto fondamentalmente aristocratico. Nel corso della storia, tutti gli elitismi aristocratici e militaristici hanno implicato il disprezzo per i deboli. L’Ur-Fascismo non può fare a meno di predicare un “elitismo popolare”. Ogni cittadino appartiene al popolo migliore del mondo, i membri del partito sono i cittadini migliori, ogni cittadino può (o dovrebbe) diventare un membro del partito. Ma non possono esserci patrizi senza plebei. Il leader, che sa bene come il suo potere non sia stato ottenuto per delega, ma conquistato con la forza, sa anche che la sua forza si basa sulla debolezza delle masse, così deboli da aver bisogno e da meritare un “dominatore”. [...] .L’Ur-Fascismo può ancora tornare sotto le spoglie più innocenti. Il nostro dovere è di smascherarlo e di puntare l’indice su ognuna delle sue nuove forme - ogni giorno, in ogni parte del mondo.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- La democrazia, l’antinomia istituzionale del mentitore e la catastrofe culturale italiana.... UMBERTO ECO E IL POPULISMO DI "FORZA ITALIA". Un’intervista di Marcelle Padovani (2002) e un’intervista di Deborah Solomon (2007)
"PUBBLICITA’ PROGRESSO": L’ITALIA E LA FORZA DI UN MARCHIO REGISTRATO!!! NEL 1994 UN CITTADINO REGISTRA IL NOME DEL SUO PARTITO E COMINCIA A FARE IL "PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA" DEL "POPOLO DELLA LIBERTA’"
UNA DOMANDA ALL’ITALIA: MA COME AVETE FATTO A RIDURVI COSI’?! UN "BORDELLO STATE": UN PAESE BORDELLO. Una nota di Maurizio Viroli (dagli Usa) - e una risposta (agli americani, dall’Italia)
Federico La Sala
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. -- Rischio autoritarismo: rappresentare non basta più. Rinforzare la democrazia (di Romano Prodi).8 gennaio 2018, di Federico La Sala
Il caso italiano
Rischio autoritarismo: rappresentare non basta più, la democrazia sia più efficace
Rinforzare la democrazia
di Romano Prodi (Il Mulino, 08 gennaio 2018) *
Per molti anni, soprattutto dopo la caduta del muro di Berlino, ci siamo illusi che l’espansione della democrazia fosse irresistibile. Una speranza alimentata da numerosi rapporti di organismi internazionali dedicati a sottolineare come il numero delle nazioni che affidavano il proprio futuro alle sfide elettorali fosse in continuo aumento. La convinzione di un “fatale” progresso della democrazia veniva rafforzata dalla generale condivisione delle dottrine che sono sempre state i pilastri della democrazia stessa, cioè il liberalismo e il socialismo che, alternandosi al potere, avrebbero sempre garantito la sopravvivenza ed il rafforzamento del sistema democratico. Tanto era forte questa convinzione che divenne dottrina condivisa il diritto (o addirittura il dovere) di imporre il sistema democratico con ogni mezzo, incluse le armi.
La guerra in Iraq e in Libia, almeno a parole, si sono entrambe fondate sulla motivazione di abbattere un tiranno per proteggere, in nome della democrazia, i sacrosanti diritti dei cittadini in modo da arrivare, con la maggiore velocità possibile, a libere elezioni.
La realtà ci ha obbligato invece a conclusioni ben diverse. Le guerre “democratiche” hanno mostrato l’ambiguità delle loro motivazioni e si sono trasformate in tragedie senza fine, mentre le elezioni imposte dall’esterno, soprattutto nei Paesi africani, sono state sempre più spesso utilizzate per attribuire al vincitore un potere assoluto, quasi patrimoniale, sul Paese. Colui che è stato eletto democraticamente si trasforma in proprietario dei cittadini e dei loro beni e la tornata elettorale successiva viene trasformata in una lotta impari se non addirittura in una farsa perché il leader democratico si è nel frattempo trasformato in un dittatore. Guardiamoci quindi dal ritenere che il progresso democratico sia fatale e inevitabile perché la democrazia non si esaurisce nel giorno delle elezioni. Essa si regge non sulle sue regole astratte ma sul rispetto di queste regole e, crollata l’influenza delle ideologie che ne stavano alla base, sui comportamenti e sui risultati delle azioni dei governanti.
Non dobbiamo quindi sorprenderci se, a quasi trent’anni dalla caduta del muro di Berlino, ci troviamo invece in un mondo in cui il desiderio e la richiesta di autorità crescono a discapito del progresso della democrazia. Lo vediamo a tutte le latitudini: non solo in molti Paesi africani ma in Russia, in Cina, in Vietnam, nelle Filippine, in Turchia, in Egitto, in India, nei Paesi dell’Est Europeo e perfino in Giappone. Un desiderio di autorità che si estende alle democrazie più mature e che lievita perfino negli Stati Uniti pur essendo, in questo grande Paese democratico, temperato dagli infiniti pesi e contrappesi della società americana.
Tutti questi eventi ci hanno portato ad un punto di svolta: la democrazia sta cessando di essere il modello di riferimento della politica mondiale e non si esporta più.
Possiamo simbolicamente collocare il riconoscimento ufficiale di questa svolta nel XIX Congresso del Partito Comunista Cinese dello scorso ottobre. Il presidente Xi, forte dei suoi successi, ha indicato nel sistema cinese lo strumento più adatto per promuovere lo sviluppo ed il progresso non solo della Cina ma anche a livello globale. La proposta della via della seta intende sostituire nell’immaginazione popolare il piano Marshall come modello di riferimento per la crescita globale e, in particolare, dei Paesi in via di sviluppo.
Un compito facilitato dalle fratture fra i Paesi democratici e dalla moltiplicazione dei partiti politici all’interno di questi Paesi, evoluzioni che rendono sempre più complessa la formazione di governi democratici robusti e capaci di durare nel tempo. Il susseguirsi degli appuntamenti elettorali (locali, nazionali ed europei) e le analisi demoscopiche, che rendono di importanza vitale ogni pur piccolo appello alle urne, abbreviano l’orizzonte dei governi che, invece di affrontare i grandi problemi del futuro, si concentrano solo sulle decisioni idonee a vincere le sempre vicine elezioni.
A rendere più difficile e precaria la vita dei governi democratici si aggiunge la moltiplicazione dei partiti, figlia della maggiore complessità della società moderna e della crisi delle grandi ideologie del passato. Ci sono voluti sette mesi di trattative per formare un governo in Olanda e, dopo oltre tre mesi dalle elezioni, non vi è ancora alcun accordo per un governo tedesco.
Di fronte a tutti questi eventi il favore degli elettori si allontana sempre più da una democrazia che “rappresenta” e si sposta verso una democrazia che “consegna”, che opera cioè in modo efficace.
Se non vogliamo vedere crescere in modo irresistibile anche nei nostri Paesi il desiderio di autoritarismo dobbiamo rendere forte la nostra democrazia: è nostro dovere primario rinnovarla e irrobustirla per metterla in grado di “consegnare”.
Quest’obiettivo può essere raggiunto solo adottando sistemi elettorali sempre meno proporzionali e sempre più maggioritari.
Il sistema elettorale non è fatto per fotografare un Paese ma per renderne possibile il governo.
Di queste necessarie trasformazioni l’Italia se ne sarebbe dovuta rendere conto da gran tempo e invece le ha volute ignorare: speriamo che possa metterle in atto fin dall’inizio della prossima legislatura.
* Questo articolo è uscito su «Il Messaggero» del 7 gennaio 2018.
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. -- 1947-2017. La Carta come una bussola. La Costituzione non è mai al sicuro, occhio ai programmi elettorali.28 dicembre 2017, di Federico La Sala
La Costituzione non è mai al sicuro, occhio ai programmi elettorali
1947-2017. La Carta come una bussola nella sfida del voto
di Anna Falcone (il manifesto, 28.12.2017)
Sarà la cifra tonda, sarà che questo compleanno della Costituzione arriva dopo la schiacciante vittoria referendaria del 4 dicembre, fatto sta che mai come quest’anno la ricorrenza della firma è stata fortemente sentita dagli italiani, che hanno partecipato in tanti alle iniziative organizzate per l’occasione in tutta Italia. E non solo per rinnovare il ricordo: questa celebrazione e il messaggio che ne scaturisce assumono un valore cruciale per le prossime elezioni politiche.
Lo hanno giustamente sottolineato Felice Besostri ed Enzo Paolini nell’articolo pubblicato ieri sulle pagine di questo giornale. Perché chi ha vinto la battaglia referendaria, e continua a difendere davanti alle Corti le ragioni della legittimità costituzionale delle leggi elettorali, o a sostenere chi lo fa, non potrà sottrarsi, al momento del voto, a un giudizio di coerenza fra schieramenti politici e rispetto del voto referendario.
Il fatto che a 70 anni dalla sua entrata in vigore la Costituzione è e rimane, in gran parte, inattuata rappresenta - per chi voglia raccoglierla seriamente - la sfida politica per eccellenza delle prossime elezioni. Non a caso, molti elettori ed elettrici, che non si rassegnano all’esistente, chiedono agli schieramenti in campo di ripartire proprio dall’attuazione della Costituzione e dalla implementazione dei diritti già riconosciuti dalla Carta quale antidoto alle inaccettabili diseguaglianze del nostro tempo. Un passaggio necessario, se non indispensabile, per rafforzare la credibilità dei programmi politici e, auspicabilmente, ricucire quel rapporto di fiducia fra politica e cittadini mai così in crisi. Un vulnus democratico tradotto in un astensionismo che sfiora ormai il 55% dell’elettorato: dato più che allarmante a cui non ci si può e non ci si deve rassegnare.
Rilanciare il messaggio della necessaria difesa e attuazione della Costituzione - in particolare delle norme che garantiscono il pieno e trasparente esercizio della democrazia e attribuiscono alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli che alimentano e aggravano le condizioni di diseguaglianza fra cittadini - diventa, allora, cruciale, soprattutto alla vigilia di una tornata elettorale le cui regole saranno scandite dall’ennesima legge elettorale ad alto rischio di incostituzionalità.
Pur nella piena consapevolezza che la Costituzione non delinea un programma univoco, capace di blindare le scelte dei diversi governi - è necessario riconoscere, infatti, e una volta per tutte, che esiste un nucleo duro di principi e diritti fondamentali inderogabili che ogni forza politica deve impegnarsi ad attuare, nelle forme e nei modi che ritiene più opportuni, per rispettare quella fedeltà alla Costituzione che li lega indissolubilmente alla Repubblica e ai suoi compiti costituzionali. Un patto democratico di diritti e obiettivi programmatici, inequivocabilmente vincolanti, che deve tornare ad essere il cuore di ogni programma elettorale. Soprattutto a Sinistra.
Sia chiaro: non è un’indicazione di voto, ma il suggerimento a una riflessione suppletiva sul voto e su chi auspicabilmente si impegnerà in maniera chiara e credibile a difendere e attuare la Costituzione. Nella piena consapevolezza che un tale ambizioso obiettivo, per essere concreto, deve essere condiviso da tanti, e non è monopolizzabile da pochi o da forze marginali. Perché la Costituzione non è perfetta, né intoccabile, ma è l’unico punto certo che abbiamo, il primo “bene comune” in cui si riconoscono gli italiani in questa difficile fase di transizione democratica. Se questa virerà verso il restringimento progressivo degli spazi di partecipazione e di democrazia o verso modelli più avanzati dipenderà anche dal se e come eserciteremo il nostro diritto di voto.
In tal senso, l’astensionismo, anche come forma estrema di protesta, più che sortire un ‘ravvedimento’, rischia di favorire le destre nel prossimo Parlamento, e con esse la formazione di uno schieramento largo e più ampio della compagine del futuro governo che, se non arginato, potrebbe trovare i numeri per unire le forze di quanti - avendo fallito le riforme del 2006 e del 2016 - potrebbero convergere su un progetto analogo, se non peggiore. Un’operazione che, (ipotesi remota, ma non impossibile) qualora dovesse raccogliere il sostegno dei 2/3 dei componenti di ciascuna Camera potrebbe non dare spazio neppure alla raccolta delle firme per chiedere il referendum costituzionale e, con esso, il pronunciamento popolare.
Per questo è necessario sollecitare le forze politiche in campo affinché si pronuncino, tutte, sul loro programma costituzionale: sul se e come intendano intervenire sulla Costituzione; sul se e come intendano dare attuazione al suo nucleo duro di principi e diritti inderogabili; sul se e come intendano metterla “in sicurezza” da possibili incursioni di future maggioranze gonfiate. Perché non ci si debba più trovare in futuro a contrastare una riforma o, peggio, una riscrittura della Carta, di parte e neppure menzionata nei programmi elettorali e adeguatamente dibattuta nel Paese. Ai tanti italiani che si sono recati al voto il 4 dicembre, almeno questo, è dovuto.
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. -- La vergogna è morta. Così un sentimento è scomparso dall’orizzonte dei valori individuali e collettivi16 dicembre 2017, di Federico La Sala
VERGOGNA E "LATINORUM": UNA GOGNA PER L’ITALIA INTERA... *
____________________________________________________________________
Le idee
La vergogna è morta
Da Berlusconi a Trump: così un sentimento è scomparso dall’orizzonte dei valori individuali e collettivi
di Marco Belpoliti (l’Espresso, 15 dicembre 2017)
Quando nel 1995 Christopher Lasch, l’autore del celebre volume “La cultura del narcisismo”, diede alle stampe un altro capitolo della sua indagine sulla società americana, “La rivolta delle élite” (ora ristampato opportunamente da Neri Pozza), pensò bene di dedicare un capitolo alla abolizione della vergogna.
Lasch esaminava gli scritti di psicoanalisti e psicologi americani che avevano lavorato per eliminare quella che sembrava un deficit delle singole personalità individuali: la vergogna quale origine della scarsa stima di sé. La pubblicistica delle scienze dell’anima vedeva in questo sentimento una delle ultime forme di patologia sociale, tanto da suggerire delle vere e proprie campagne per ridurre la vergogna, cosa che è avvenuta in California, ad esempio («programma cognitivo-affettivo finalizzato a ridurre la vergogna»). Lasch non ha fatto in tempo a vedere come questo sentimento sia stato abolito dalla classe dirigente che è apparsa sulla scena della politica mondiale all’indomani del 1994, anno in cui lo studioso della cultura è scomparso.
* * *
Con il debutto di Silvio Berlusconi in politica la vergogna è ufficialmente scomparsa dall’orizzonte dei valori e dei sentimenti individuali e collettivi. Le élite che hanno scorrazzato nel paesaggio italiano nel ventennio successivo alla “discesa in campo” sono state totalmente prive di questo. In un certo senso Berlusconi è stato l’avanguardia di una classe politico-affaristica che ha il suo culmine nella figura dell’attuale inquilino della Casa Bianca, Donald Trump. Nessuno dei due uomini d’affari trasformati in leader politici conosce né il senso di colpa né la vergogna propriamente detta.
La vergogna, come sostengono gli psicologi, costituisce un’emozione intrinsecamente sociale e relazionale. Per provarla occorre immedesimarsi in un pubblico che biasima e condanna. Ma questo pubblico non esiste più. Ci sono innumerevoli figure dello spettacolo, della politica, della economia e del giornalismo, per cui la sfrontatezza, l’esibizione del cinismo, la menzogna fanno parte della serie di espressioni consuete esibite davanti alle telecamere televisive e nel web. Nessuno prova più vergogna. Anzi, proprio questi aspetti negativi servono a creare un’immagine personale riconoscibile e, se non proprio stimata, almeno rispettata o temuta. Come ha detto una volta Berlusconi, genio del rovesciamento semantico di quasi tutto: «Ci metto la faccia». È l’esatto contrario del “perdere la faccia”, sentimento che prova chi sente gravare dentro di sé la vergogna. Metterci la faccia significa apparire rimuovendo ogni senso di colpa, di perdita del senso dell’onore, della rispettabilità.
* * *
L’esibizione dell’autostima è al centro del libro più celebre di Lasch, quello dedicato al narcisismo. «Meglio essere temuti che amati», recita un proverbio; nel rovesciamento avvenuto negli ultimi quarant’anni, cui non è estranea la televisione commerciale inventata da Silvio Berlusconi, è molto meglio che gli altri ti vedano come sei: cattivo, spietato, senza vergogna. L’assenza del senso di vergogna è generata dall’assenza di standard pubblici legati a violazioni o trasgressioni. Nella vergogna s’esperimenta l’immagine negativa di sé stessi, si prova il senso di un’impotenza. Questa emozione rientra in quel novero di quelle esperienze che sono definite dagli psicologi “morali”. Ciò che sembra scomparso in questi ultimi decenni è proprio un sistema di valori morali condivisi.
* * *
Non è lontano dal vero immaginare che la deriva populista nasca anche da questa crisi verticale di valori, dall’assenza di un codice etico collettivo. Nell’età del narcisismo di massa ognuno fa per sé, stabilendo regole e comportamenti che prescindono dagli altri o dalla società come entità concreta, entro cui si misura la propria esistenza individuale. La vergogna è senza dubbio un sentimento distruttivo, probabilmente molto di più del senso di colpa, come certificano gli psicoanalisti. Sovente porta a derive estreme, a reazioni autodistruttive, e tuttavia è probabilmente uno dei sentimenti più umani che esistano.
Per capire come funzioni la vergogna basta leggere uno dei libri più terribili e insieme alti del XX secolo, “I sommersi e i salvati” (Einaudi) di Primo Levi nel capitolo intitolato Vergogna. Lo scrittore vi riprende una pagina di un suo libro, l’inizio de “La tregua”, dove si racconta l’arrivo dei soldati russi ad Auschwitz. Sono dei giovani militari a cavallo che assistono alla deposizione del corpo di uno dei compagni di Levi gettato in una fossa comune. Il cumulo dei cadaveri li ha come pietrificati. Levi riconosce nei soldati russi il medesimo sentimento che lo assaliva nel Lager dopo le selezioni: la vergogna, scrive, che i tedeschi non avevano provato. La scrittore spiega che non è solo un sentimento che si prova per aver compiuto qualcosa di male, di scorretto o di errato. Nasce piuttosto dalla “colpa commessa da altrui”: la vergogna dei deportati scaturisce proprio da quello che hanno fatto i carnefici. Una vergogna assoluta, che rimorde alla coscienza delle vittime per la colpa commessa dai carnefici: «gli rimorde che esista, che sia stata introdotta irrevocabilmente nel mondo delle cose che esistono, e che la sua volontà sia stata nulla o scarsa, e non abbia valso a difesa». Levi parla di una vergogna radicale, che svela la profonda umanità di questo sentimento.
* * *
Gli psicologi affermano che la vergogna è molto più distruttiva del senso di colpa. Proprio per questo è lì che si comprende quale sia la vera radice dell’umano. Si tratta della «vergogna del mondo», come la definisce Levi, vergogna assoluta per ciò che gli uomini hanno fatto agli altri uomini, e non solo ad Auschwitz, ma anche in Cambogia, nella ex Jugoslavia, in Ruanda, nel Mar Mediterraneo e in altri mille posti ancora.
Che la vergogna ci faccia umani non lo dice solo Levi in modo estremo, ma lo evidenzia l’ultima frase di uno dei più straordinari testi letterari mai scritti, “Il processo” di Franz Kafka. Libro che quasi tutti hanno letto almeno una volta da giovani. Il romanzo dello scrittore praghese termina con una frase emblematica: «E la vergogna gli sopravvisse». K. è stato ucciso dai due scherani che l’hanno perseguitato nel corso dell’intera storia. L’hanno barbaramente accoltellato al cuore, dopo avere tentato inutilmente di convincerlo a farlo lui stesso. Il libro di Kafka si chiude con questa frase che, come ha segnalato Giorgio Agamben, significa esattamente questo: la vergogna ci rende umani. Chissà se Silvio Berlusconi e la sua corte hanno mai avuto in mano questo racconto, se l’hanno letto. Probabilmente no. Ma anche se lo avessero fatto, dubito che ne avrebbero tratto qualche ammaestramento, com’è evidente da quello che è seguito dal 1994: senza vergogna.
* SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
VERGOGNA E "LATINORUM": UNA GOGNA PER L’ITALIA INTERA. Sul filo di una nota di Tullio De Mauro
L’OCCUPAZIONE DELLA LEGGE E DELLA LINGUA ITALIANA: L’ITALIA E LA VERGOGNA.
LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE.
Federico La Sala
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. -- Il populismo in cerca di un vocabolario. Più che Aristotele viene in mente Umberto Eco, con la sua "Fenomenologia di Mike Bongiorno" (di Michele Ainis).12 dicembre 2017, di Federico La Sala
Il populismo in cerca di un vocabolario
di Michele Ainis (la Repubblica, 12.12.2017)
Il populismo è fin troppo popolare. La parola - se non anche la cosa - rimbalza nei discorsi dei politici, tracima sui media e nel web, ci casca addosso. Già, ma che diavolo significa? Le parole, a usarle troppo spesso, subiscono una sorta d’azzeramento semantico, come dicono i linguisti: diventano suoni, non concetti. È successo alla parola «democrazia» (Sartori ne contò decine di definizioni). Sta succedendo al populismo, tanto che ormai viene squadernato come un calendario: populismi di destra o di sinistra, di lotta o di governo, nuovi o stagionati.
Ecco, i vecchi populismi. Quelli, almeno, già li conosciamo: narodniki russi, People’s Party negli Usa, peronismo sudamericano. Ma è una conoscenza teorica, libresca, non avendoli mai sperimentati di persona. E d’altronde pure i libri mentono, talvolta. Così, Mény e Surel ( Populismo e democrazia, 2000) scrivono che un elemento d’identità del populismo è l’avversione verso tutti i poteri neutri, dalla magistratura alle autorità di garanzia; ma allora dovremmo definire populista anche Togliatti, che in Assemblea costituente s’oppose strenuamente all’istituzione della Corte costituzionale.
Sta di fatto che questo fenomeno, oggi come ieri, non si lascia inquadrare in precise gabbie concettuali. Ha tratti mutevoli, cangianti. Tuttavia qualcosa nel populismo si ripete, impermeabile alle stagioni della storia. In primo luogo un elemento nazionalista (oggi diremmo «sovranista»). Poi la critica all’establishment, alle classi dirigenti, sempre bollate come parassitarie e inette. Inoltre una concezione primitiva della democrazia, senza filtri, senza mediazioni, senza le lungaggini delle procedure parlamentari. E infine la presunzione di rappresentare il “vero” popolo: «I am your voice», proclamava Trump durante la sua campagna elettorale. Un popolo omogeneo, indistinto, compatto nell’avversione all’altro da sé, dunque in primo luogo nell’avversione agli altri popoli.
Tutto l’opposto della concezione pluralistica della società, che è il presupposto delle democrazie. Però in questo, almeno qui in Italia, c’è un deposito culturale, c’è un’idea organicistica della società che a suo tempo allevò il fascismo. A differenza del mondo anglosassone: loro dicono «people», al plurale, per designarsi come comunità di singoli individui; noi diciamo «popolo», al singolare, e in tale sostantivo i singoli annegano in una totalità indifferenziata, in un organismo omogeneo dove conta assai poco l’apporto di ciascuno.
Probabilmente nessuno di questi elementi è sufficiente, di per sé, a catalogare come populista un determinato messaggio politico: devono ricorrere tutti insieme, è la loro somma che contraddistingue il populismo. E il nuovo populismo presenta almeno due caratteri innovativi rispetto alle esperienze precedenti. Anzitutto si è affermato anche un populismo di sinistra (che reclama protezionismo e servizi pubblici) accanto ai populismi di destra (che s’oppongono al multiculturalismo). In secondo luogo vi si coglie un elemento passatista, l’idea che le lancette dell’orologio possano girare al contrario, per sfuggire ai formidabili problemi della modernità. Sono però nuove le cause che spiegano il successo attuale delle parole d’ordine populiste. Possiamo indicarne almeno un paio.
Primo: la globalizzazione, con le sue diseguaglianze. Nel 1820, in base al reddito pro capite, fra il Nord e il Sud del mondo c’era uno scarto di 3 a 1; invece nel 2011 lo Stato più ricco del pianeta, il Qatar, vantava un reddito pro capite 428 volte maggiore rispetto allo Stato più povero, lo Zimbabwe. Questa faglia sotterranea si riproduce tale e quale in ogni Stato, in ogni regione, in ogni città. E l’Italia non fa certo eccezione - anzi, esprime la società più diseguale di tutto l’Occidente, dopo il Regno Unito e gli Usa. Da qui la rabbia verso tutte le strutture sociali, dall’economia alle istituzioni.
Secondo: l’accelerazione tecnologica, che spinge folle di lavoratori fuori dal mercato del lavoro, perché sostituiti dalle macchine o perché scavalcati da nuove abilità. Sicché reagiscono con un senso d’angoscia, che reclama scorciatoie, soluzioni semplici a problemi complessi. Ma la democrazia è una creatura complicata, e a sua volta la semplificazione può ben risolversi in una trappola autoritaria.
Sta di fatto che la comunicazione politica viene dominata da messaggi rozzi, semplificati, e in conclusione demagogici; una categoria (la persuasione demagogica) messa a fuoco fin dai tempi di Aristotele. Anche se, più che Aristotele viene in mente Umberto Eco, con la sua Fenomenologia di Mike Bongiorno. Che «convince il pubblico, con un esempio vivente e trionfante, del valore della mediocrità. Non provoca complessi di inferiorità pur offrendosi come idolo, e il pubblico lo ripaga, grato, amandolo». Sarà per questo che i nostri leader sono diventati populisti, senza sforzi, forse senza neppure averne l’intenzione. È un’inclinazione naturale, mettiamola così.
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. Materiali sul tema - Ritorna Berlusconi l’alleato necessario (di Ilvo Diamanti).13 novembre 2017, di Federico La Sala
Ritorna Berlusconi l’alleato necessario
di Ilvo Diamanti (la Repubblica, 13.11.2017)
IL successo di Nello Musumeci alle Regionali in Sicilia ha posto in evidenza la debolezza del Centrosinistra. Ma anche, ovviamente, la capacità competitiva del Centrodestra. Il diverso rendimento dei due poli si spiega con la differente capacità di coalizione. Prima causa della sconfitta del M5s, irriducibile a ogni alleanza. Mentre sull’altro versante, l’accordo fra il Pd e le diverse formazioni di Sinistra è risultato impossibile. Questa situazione non appare condizionata da specifici fattori territoriali.
MA DETTATA, piuttosto, da difficoltà sostanziali, che riguardano i rapporti tra i leader e le forze politiche di quest’area. Anche il centrodestra appare segnato da rilevanti differenze interne: di progetto e di strategie. Eppure, le distanze tra FI, Lega (NcS: Noi con Salvini), FdI e la stessa UdC, per quanto profonde, non hanno prodotto fratture insuperabili. Da ciò il successo del centrodestra. Che costituisce un precedente significativo. Perché delinea uno scenario che potrebbe riprodursi altrove, soprattutto nel Nord, alle prossime elezioni politiche. Tanto più quando entrerà in vigore la nuova legge elettorale, il cosiddetto Rosatellum (bis), che prevede la possibilità di presentare candidati di coalizione nei collegi uninominali. Diventa, così, probabile l’eventualità che il modello siciliano si riproponga altrove. Nei collegi e in prospettiva nazionale. Con effetti analoghi. Per gli analoghi tipi di relazione fra i partiti. Sulla diversa capacità di coalizione gravano diverse cause. Politiche, ma anche “personali”. Che hanno favorito, fin qui, e potrebbero avvantaggiare - ancora soprattutto - il centrodestra. Fra le altre, vale la pena di sottolinearne una, particolarmente evidente e influente. Il ruolo e la presenza di Silvio Berlusconi.
È infatti lui, il Cavaliere, il principale artefice dell’intesa in Sicilia. E del progetto di coagulare gli altri principali pezzi della destra, ma anche del centro. Per prima: la Lega. Quindi i FdI di Giorgia Meloni. Ma anche l’Udc. Mentre lo stesso Alfano tenta di accodarsi alla compagnia, per non rimanere appiedato - ed escluso - nella prossima legislatura. Silvio Berlusconi, peraltro, è anche l’interlocutore “necessario” per il PdR, il Pd di Renzi. Nella prospettiva di confermare e allargare il programma di riforme avviato negli ultimi anni dal governo. Con il sostegno essenziale di Berlusconi. A partire dal gennaio 2014, quando proprio Renzi e Berlusconi siglarono il Patto del Nazareno. Spezzato e concluso, nel febbraio 2015, dall’elezione di Sergio Mattarella. Ma oggi, meglio: domani, quell’intesa potrebbe divenire nuovamente necessaria. Nella prospettiva - molto realistica - di un Parlamento senza alcuna maggioranza possibile. Perché nessun Partito, nessun Non-partito, nessun Polo (e Non-Polo) pare in grado di affermarsi, alle prossime elezioni. Da solo. E soprattutto di governare. Da solo.
Così, Berlusconi diventa l’alleato necessario, seppure non gradito, per fare le riforme. Istituzionali, ma, ancor prima, economiche, necessarie al Paese per “rimanere in Europa”. L’unico in grado di “coalizzare” - quantomeno, “aggregare” - il centrodestra. O, se si preferisce, le destre di diverso orientamento. Per cercare l’intesa con il centrosinistra e, anzitutto, con il PdR.
La centralità ritrovata - ma, in fondo, mai perduta - di Berlusconi può apparire singolare. Perché il suo partito, FI, attualmente è stimato circa il 14%. Un paio di punti sopra, rispetto a un anno fa. Ma quasi 3 in meno, rispetto alle europee del 2014. E oltre 7, rispetto alle politiche del 2013. Senza risalire al periodo 2008-2009, quando il Pdl si attestò intorno al 35-37%. Mentre Berlusconi stesso, ha visto la fiducia nei suoi confronti, come leader, attestarsi al 30%. In risalita dopo l’uscita dal governo, nel 2011. Ma sostanzialmente stabile, negli ultimi anni.
In altri termini, Silvio Berlusconi si è imposto come tessitore politico proprio mentre lui, “personalmente”, ma soprattutto il suo partito “personale” appaiono deboli. Comunque e sicuramente: “più” deboli che in passato.
Tuttavia, la coincidenza fra i due dati non appare “casuale”. Anzi, in qualche misura è “causale”. Berlusconi, in altri termini, diventa un alleato possibile anche per gli altri, gli avversari politici, perché è più debole che in passato. Personalmente e politicamente.
Perché lui, per primo, ha bisogno di contare, sulle scelte di governo. Per ragioni politiche, personali. E per interessi aziendali. In secondo luogo, nessun soggetto politico, conviene ripeterlo, è in grado di governare da solo. Ma l’area di Centro-Destra, dove si collocano, FI, Udc, Lega e FdI, oggi appare il Polo che attrae maggiori consensi. Oltre un terzo dei voti. È, inoltre, il accreditato nella competizione per conquistare i collegi del Nord.
Ma Berlusconi è, sicuramente, l’unico a poterlo tenere insieme. L’unico in grado di trasformarlo da un’area confusa in un Polo effettivo. Non per caso, intercetta le simpatie dei due terzi degli elettori che si collocano a Centro- destra. Ma convince anche la maggioranza di quelli che si dicono di Destra. Senza “mezzi termini”. Berlusconi, infine, negli ultimi anni, ha visto crescere la fiducia nei suoi confronti presso gli elettori di Centro, ma anche di Centrosinistra.
Per questo oggi si propone, e può agire, come un “mediatore”. Mentre ieri era la bandiera di una “parte”, più che di un partito. E ciò segna un passaggio e un cambiamento significativo, rispetto alla nostra storia recente, segnata dalla sua presenza. Perché, dal 1994 fino a ieri, egli ha segnato la principale frattura del nostro sistema politico. Di più: del sentimento politico del nostro Paese. L’alternativa fra berlusconismo e anti- berlusconismo, infatti, ha rimpiazzato - in parte assorbito - il muro dell’anti-comunismo. Oggi neppure Berlusconi è in grado di erigere muri, intorno a sé. Per volontà e/o debolezza propria. E degli altri. Non importa. Ma il suo muro è divenuto una tela. Così, un’epoca della nostra storia è finita. E non è chiaro cosa ci attenda domani. Anzi: oggi stesso.
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. - Per Carlo Azeglio Ciampi, Filologia classica e Banca d’Italia “è la stessa cosa” (di Salavore settis)17 settembre 2017, di Federico La Sala
IL PENSIERO DELLA COSTITUZIONE E LA COSTITUZIONE DEL PENSIERO... *
La politica non è per gli ignoranti
Per Carlo Azeglio Ciampi studiare Filologia classica o guidare la Banca d’Italia “è la stessa cosa”. Serve disciplina intellettuale, rispetto dei documenti e ricerca della verità. Valori e metodi di cui oggi i leader sono purtroppo privi
di Salvatore Settis (Il Fatto, 17.09.2017)
Normalista dal 1937 al 1941, Ciampi si laureò a Pisa in Filologia classica. Suoi maestri furono il grande filologo Giorgio Pasquali e la papirologa Medea Norsa; fra i suoi compagni di corso c’era Scevola Mariotti, altro grande filologo che sarebbe stato suo amico di una vita.
Della Norsa, Ciampi ricordava le sofferenze dovute alle leggi razziali, ma anche la generosità di Gentile, che nel 1939 pubblicò con lo stemma della Normale (di cui era allora direttore) un volume della Norsa che un editore fiorentino aveva bloccato in ultime bozze per ragioni di “razza”.
La tesi di Ciampi era dedicata a Favorino, un retore di lingua greca del II secolo d.C., amico di Plutarco e attivo anche alla corte dell’imperatore Adriano, con cui ebbe però un contrasto finendo poi in esilio. Favorino commentò allora : “È davvero stupido criticare qualcuno che ha al suo servizio trenta legioni”. Il testo a cui è dedicata la tesi di Ciampi è una sorta di auto-consolazione filosofica “sull’esilio”, dove tra l’altro viene affermata un’idea di “patria” non come luogo di nascita, ma d’elezione: per Favorino, nato ad Arles, la vera patria era Roma, con la sua vita culturale multilingue e incomparabile.
Dopo la formazione filologica e malgrado la passione per l’insegnamento, la guerra impresse alla vita di Ciampi tutt’altro corso. Ma l’imprinting filologico della Normale non fu mai dimenticato, e lo mostra un episodio del 6 dicembre 2000, quando, da Presidente, Ciampi venne in Normale in visita ufficiale.
Egli volle allora incontrare i normalisti, e per un’ora si intrattenne a colloquio con essi con grande cordialità, tanto che qualche allievo della Scuola si prese qualche confidenza forse eccessiva, a cui Ciampi reagiva divertito. Un normalista chiese al Presidente : “Ma come mai Lei, che ha studiato filologia classica, è poi passato alla Banca d’Italia?”. Ciampi, fattosi serio senza perdere il tono affabile di quella conversazione, rispose: “È la stessa cosa. Studiando filologia classica in Normale ho imparato una disciplina intellettuale, il rispetto dei documenti e la ricerca della verità: principî che mi hanno accompagnato alla Banca d’Italia, a Palazzo Chigi, al Quirinale”.
Ma che cosa intendeva Ciampi con quelle parole, che non erano una gratuita battuta, ma una professione di fede? Io credo che con quel suo “È la stessa cosa” Ciampi intendesse due valori diversi ma convergenti: la pienezza dell’impegno civile e la centralità della competenza specifica. Virtù, quando ci sono, ugualmente importanti per un filologo classico, per un Governatore della Banca d’Italia e per un Presidente del Consiglio o della Repubblica. La Normale, Ciampi lo ripeteva spesso, è scuola di vita anche perché il suo carattere competitivo impone ritmi di lavoro inconsueti, innescando abitudini fondate sull’intensità e la densità del lavoro, sulla serietà dell’impegno personale, su un’applicazione profonda ed esclusiva ai problemi che di volta in volta si studiano. Dal lavoro solitario del normalista in biblioteca al senso di responsabilità del cittadino che si mette al servizio della comunità, Ciampi vedeva una continuità necessaria, una comune esigenza morale.
Non meno importante era stata, nel contesto degli anni Trenta, l’orgogliosa rivendicazione che la filologia debba avere piena cittadinanza non solo come mera tecnica di costituzione dei testi, ma come strumento di interpretazione storica. Quando Pasquali aveva scritto sulla Nuova Antologia del 1931 un articolo sulla Paleografia quale scienza dello spirito, stava reagendo alla concezione crociana della filologia come “utile e servizievole”, ma “senza splendori”, poiché “la filologia non è la critica e non è la storia”, discipline che esigono, scrive Croce, “robustezza di coordinato pensiero”.
 Riassumendo anni dopo i termini di quella polemica, un altro grande maestro della Normale, Augusto Campana, definiva la paleografia, e con essa la filologia, come discipline “non semplicemente classificatorie, descrittive, meccaniche”, ma “miranti alla visione e ricostruzione di uno sviluppo storico, specchio e fattore della cultura in organica connessione con ogni altra componente di essa”: una forma di conoscenza piena e non ancillare.
Riassumendo anni dopo i termini di quella polemica, un altro grande maestro della Normale, Augusto Campana, definiva la paleografia, e con essa la filologia, come discipline “non semplicemente classificatorie, descrittive, meccaniche”, ma “miranti alla visione e ricostruzione di uno sviluppo storico, specchio e fattore della cultura in organica connessione con ogni altra componente di essa”: una forma di conoscenza piena e non ancillare.La filologia come strumento e strategia per accostarsi non solo ai testi, ma ai problemi; non solo alla storia, ma alla realtà amministrativa e politica; non solo al passato, ma al presente. Questa concezione di Ciampi dava continuità alla sua vita di studio e di lavoro; era un’etica della competenza della quale sentiamo oggi più che mai il bisogno. L’idea che anche per chi fa politica e ha responsabilità di governo sia necessaria la minuta conoscenza dei fatti, la precisione delle informazioni, l’accuratezza nel comunicare ai cittadini quel che si sta facendo o quel che occorrerebbe fare: virtù che troppo spesso appaiono tramontate (speriamo non per sempre).
Ci è toccato invece assistere, in questi anni, al trionfo dell’incompetenza, alla sagra delle chiacchiere. Non farò alcun nome ma citerò un solo episodio, per il suo valore esemplare: qualcuno, che ricopriva un’altissima carica di governo, pur essendo laureato in giurisprudenza scambiò impunemente un ordine del giorno in Costituente (l’odg Perassi, 4 settembre 1946) per una norma transitoria (inesistente) della Costituzione, e come tale la citò ripetutamente in pubbliche argomentazioni politiche, e a proposito di una proposta di riforma costituzionale.
Altri esempi, credo, non occorrono: tutti siamo bersagli e vittime di un imperversante storytelling, secondo cui la verità dei fatti è irrilevante, e quel che importa non è se un’affermazione sia vera o falsa, ma quale beneficio apporta a chi la fa. Perciò ci tocca subire litanie di statistiche inventate o truccate senza alcuno scrupolo, e sentirle cambiare, o meglio improvvisare, da un giorno all’altro a seconda di scadenze elettorali o altre contingenze, e senza alcun rispetto per la verità; ci tocca vedere al tempo stesso la mortificazione di chi è competente, ma costretto a emigrare per mancanza di lavoro, e il trionfo arrogante di chi, pur senza sufficienti competenze specifiche, occupa posizioni di rilievo nelle pubbliche amministrazioni.
Ci tocca, e davvero vien da chiedersi quousque tandem?, vedere sulla scena politica schieramenti basati sulle appartenenze e sulle convenienze, e non sull’analisi dei problemi e sulla competenza professionale; e in nome di meri giochi di potere abbiamo visto e vediamo sbriciolarsi i dati di fatto, sparire all’orizzonte la precisione e l’attendibilità delle analisi, svanire nel nulla il pubblico interesse.
Il fermo richiamo di Ciampi alla filologia (cioè alla competenza) nell’esercizio della politica è qualcosa di cui l’Italia non ha mai avuto tanto bisogno come oggi. Se vogliamo ricordarlo senza cadere in tentazioni agiografiche, è a questa sua lezione morale che dobbiamo con altrettanta fermezza richiamarci, ripetendo senza sosta che la politica ha davvero bisogno di competenza, ha bisogno di filologia. Ne ha bisogno, oggi, più che mai.
*
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- LA REPUBBLICA DEL PRESIDENTE: CARLO AZEGLIO CIAMPI E LA COSTITUZIONE COME "BIBBIA CIVILE". Un "quaderno" di documentazione della "Voce di Fiore" sulla Presidenza Ciampi
 ITALIA, 1999-2006. La Repubblica del Presidente. Gli anni di Carlo Azeglio Ciampi.
ITALIA, 1999-2006. La Repubblica del Presidente. Gli anni di Carlo Azeglio Ciampi.
- TEORIA E STORIA DELLA STORIOGRAFIA. IL PROBLEMA GIAMBATTISTA VICO E IL PROBLEMA DELLA COSTITUZIONE
 CROCE “CRISTIANO” , VICO “ATEO”, E L’UOMO DELLA PROVVIDENZA.
CROCE “CRISTIANO” , VICO “ATEO”, E L’UOMO DELLA PROVVIDENZA.
FILOSOFIA. IL PENSIERO DELLA COSTITUZIONE E LA COSTITUZIONE DEL PENSIERO
 MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA E A PENSARE BENE "DIO", "IO" E "L’ITALIA", CHI PIU’ CHI MENO, TUTTI VIVONO DENTRO LA PIU’ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA E POLITICA ITALIANA, NEL REGNO DI "FORZA ITALIA"!!! Un’inchiesta e una mappa
MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA E A PENSARE BENE "DIO", "IO" E "L’ITALIA", CHI PIU’ CHI MENO, TUTTI VIVONO DENTRO LA PIU’ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA E POLITICA ITALIANA, NEL REGNO DI "FORZA ITALIA"!!! Un’inchiesta e una mappa - LA REPUBBLICA DEL PRESIDENTE: CARLO AZEGLIO CIAMPI E LA COSTITUZIONE COME "BIBBIA CIVILE". Un "quaderno" di documentazione della "Voce di Fiore" sulla Presidenza Ciampi
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. -- Il Vaffa di Grillo ha origini nel situazionismo di Debord e Gallizio (di Pino Pisicchio).16 settembre 2017, di Federico La Sala
LA QUESTIONE MORALE.
LA COSTITUZIONE, LA NOSTRA “BIBBIA CIVILE” ...*
Il Vaffa di Grillo ha origini nel situazionismo di Debord e Gallizio
Non tutti sanno che il nucleo fondativo di quel pensiero trovò accoglienza nel 1957 in un paesino dell’entroterra ligure
di Pino Pisicchio *
Nella miseria dei giorni della politica contemporanea si sono dovute ascoltare anche le celebrazioni per il decennale del "Vaffa day". Potrebbe essere una parabola tutta italiana, un segno dei tempi macilenti che ci toccano in dote. Eppure, forse con qualche preterintenzionalità, quelle celebrazioni hanno un senso. Anche dal punto di vista culturale.
Infatti, ciò che la base elettorale, il vertice dei dirigenti, il sinedrio degli eletti dei Cinquestelle ma anche l’universo dei giornalisti laureati e dei maître à penser usi a invadere Tv, testate ed editrici blasonate, non sanno, è che i grillini, contrariamente a quanto si possa immaginare, un pensiero nobile ce l’hanno, eccome.
E quel Vaffa day lo interpreta perfettamente. Il pensiero nobile grillino, però, non è quella minestra- brodo primordiale lanciata col nome di Gaia da Casaleggio senior nella rete qualche anno fa, con sembianze oniriche stile new age. No. O meglio: la storia dell’agorà virtuale è la fissa aziendale che ha mostrato di funzionare egregiamente sulla base del principio: "urla, offendi, cavalca il mostro che si muove nelle viscere della rete e farai tanti adepti".
La vera grande ispirazione culturale discende, invece, dai rami del Situazionismo di Pinot Gallizio e di Debord, rielaborazione dada della filosofia trozkista, nella convinzione che la borghesia crassa e decadente soggiogata dalla società dello spettacolo, sarebbe stata abbattuta con le stesse armi ma rivolte contro.
Insomma un pensiero spiazzante, indecente e arrabbiato. Ora non tutti sanno che il nucleo fondativo di quel pensiero trovò accoglienza nel 1957 in un paesino dell’entroterra ligure, Cosio di Arroscia, in provincia di Imperia, con un grappolo di stralunati pensatori, pittori, artisti a vario titolo, provenienti da mezza Europa, una sorta di comunità beatnik avanti lettera.
In Italia, dunque, anzi, in quella striscia un po’ nordica, un po’ mediterranea che è la Liguria. A Genova e dintorni, infatti, si insediò un nucleo di resistenti, discepoli sulla scia dell’insegnamento di Debord, tutti apprendisti stregoni della tv, sperimentatori, mischiatori di generi, ritagliatori di suggestioni e di irriverenze.
Marco Giusti, Antonio Ricci, Carlo Freccero, Enrico Ghezzi. E Beppe Grillo. Sì, proprio lui. Che ha sublimato l’idea primigenia del situazionismo offrendo il suo corpo e la sua cacofonia alla causa. Con Grillo, infatti, Debord ha visto compiuta la sua utopia dello sberleffo al potere con i voti di quella che una volta si sarebbe chiamata borghesia e che oggi invece somiglia all’informe ventre di un popolo celibe. E nubile (per parità di genere).
Cos’è, allora, il "Vaffa day" se non il gesto situazionista per antonomasia? Cos’è lo stesso Grillo, con la sua faccia, il suo mestiere di comico, la sua perenne coprolalia brandita come arma contundente? Ma è chiaro: è la vittoria politica di Debord nell’unico consorzio umano al mondo dove poteva attecchire il suo pensiero: la società italiana. Non a caso la Bibbia dei Situazionisti fu il suo libro: "La società dello Spettacolo ".
* Il blog Pino Pisicchio, Presidente gruppo Misto Camera Deputati, The Huffingtonpost, 11.09.2017.
*
- SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
 LA COSTITUZIONE, LA NOSTRA “BIBBIA CIVILE” ....
LA COSTITUZIONE, LA NOSTRA “BIBBIA CIVILE” ....
 L’ITALIA, LA CARTA D’IDENTITA’ TRUCCATA, E GLI SFORZI FALLITI DEL PRESIDENTE CIAMPI DI ROMPERE L’INCANTESIMO DI "FORZA ITALIA"!!! Una nota di Arrigo Levi
L’ITALIA, LA CARTA D’IDENTITA’ TRUCCATA, E GLI SFORZI FALLITI DEL PRESIDENTE CIAMPI DI ROMPERE L’INCANTESIMO DI "FORZA ITALIA"!!! Una nota di Arrigo Levi Per la Costituzione - e il dialogo, quello vero ...
Per la Costituzione - e il dialogo, quello vero ...
 "ITALIA". AMARE L’ITALIA: RIPRENDIAMOCI LA PAROLA. VAFFA-DAY?! ONORE A BEPPE GRILLO. Contro la vergognosa confusione dell’ "antipolitica" in Parlamento e della "politica" in Piazza, l’invito ad uscire dalla "logica" del "mentitore". Una lettera (2002), con un intervento di Beppe Grillo (la Repubblica, 2004).
"ITALIA". AMARE L’ITALIA: RIPRENDIAMOCI LA PAROLA. VAFFA-DAY?! ONORE A BEPPE GRILLO. Contro la vergognosa confusione dell’ "antipolitica" in Parlamento e della "politica" in Piazza, l’invito ad uscire dalla "logica" del "mentitore". Una lettera (2002), con un intervento di Beppe Grillo (la Repubblica, 2004).Federico La Sala
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. -- LA RICERCA DELL’ANPI. Sulla Rete le pagine «nere» conquistano un milione di nostalgici del Duce22 agosto 2017, di Federico La Sala
FILOSOFIA. IL PENSIERO DELLA COSTITUZIONE E LA COSTITUZIONE DEL PENSIERO...
La ricerca.
Sulla Rete le pagine «nere» conquistano un milione di nostalgici del Duce
Facebook ospita 2.700 profili di propaganda fascista: almeno 300 profili inneggianti Forza Nuova e Casa Pound. La ricerca dell’Anpi
Souvenir del fascismo (da internet)
di Gigio Rancilio *
Perché Facebook non rimuove le pagine social che, in contrasto con la legge Scelba, fanno apologia del fascismo? Leggendo la policy internazionale del social network più grande del mondo non si trova traccia di alcun divieto in questo senso. La scusa di Facebook è che «i nostri standard devono valere in ogni Paese» mentre - aggiungiamo noi - l’apologia del fascismo è vietata solo in Italia (come in Germania quella del nazismo). Quindi non si può proprio fare niente? La stessa Facebook Italia consiglia di segnalare contenuti e pagine illegali alla Polizia Postale o all’Unar (Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale). «Dopo una loro verifica, Fb avvierà la rimozione di tali contenuti e pagine». A parole è tutto perfetto (o quasi). Ma alla prova dei fatti sembra che le cose vadano diversamente. Lo dimostra il fatto che molte delle pagine Fb che fanno apologia del fascismo sono già state segnalate all’Unar a febbraio: in cinque mesi avrebbero già dovuto essere sottoposte al centro di controllo di Facebook e rimosse dal social. Ma sono ancora lì.
Che i social network premino le posizioni estreme (in tutti i campi) è un dato di fatto. Ma la denuncia dell’Anpi fa comunque effetto: «Su Facebook ci sono circa 2.700 pagine in italiano di propaganda fascista, 300 di queste apertamente apologetiche». Possibile? Iniziamo la nostra ricerca digitando su Facebook la parola ’fascisti’. Il primo risultato che appare rimanda alla pagina ’I giovani fascisti italiani’, seguita da quasi 93mila persone. Entriamo. I post scritti sono pochi. Vanno invece alla grande le foto di Mussolini, i video dei suoi discorsi e le cartoline militanti da condividere sui social. Gli stessi contenuti si trovano anche su pagine ’amiche’ come ’Essere fascista non è reato’, che ha 54mila fan, ’Fascisti italiani, che ha 32mila fan, e ’Repubblica Sociale Italiana’, ferma a poco più di 1.500 mi piace.
Siccome non si vive di sola politica militante, ogni giorno su queste pagine appaiono anche foto che pubblicizzano ’prodotti fascisti’: il portafoglio con l’effigie di Mussolini, i cuscini con la faccia del duce (ma non sarà irriverente sedervisi sopra?) e - molto apprezzato - un manganello nero («in legno massello», specificano i curatori della pagina) disponibile con la scritta (a scelta) ’Boia chi molla’, ’Me ne frego’, ’Credere obbedire combattere’, ’Molti nemici molto onore’. Ogni volta che qualcuno chiede il prezzo di uno degli oggetti, la risposta dei moderatori è sempre uguale: «Camerata, contattaci in privato«. Come se la vendita fosse segreta. Come se la vendita fosse destinata solo a pochi privilegiati. Un’autentica furbata. Che fa apparire ’militanti’ e ’segrete’ delle pagine di fatto promozionali legate al negozio Duxstore.it - con sede legale a Castel Campagnano, in provincia di Caserta - specializzato in gadget fascisti. Stesso repertorio di foto, cartoline, video e slogan si trova anche nella pagina Facebook ’I giovani fascisti italiani - destra italiana’, seguita da 27.198 persone.
Digitando su Facebook la parola ’Mussolini’ la prima pagina che appare è ’Benito Mussolini’, che piace a 144.449 persone. Ci sono post nostalgici ma anche contro i vaccini, l’Europa, il Governo, i giornali bugiardi e tutto il solito repertorio ’anti’. Sempre sul duce c’è la pagina ’Benito Mussolini eterna passione’ (26.350 fan). Sulla pagina ’Gioventù italiana del littorio’ (che piace a 15.149 persone) si trovano quasi esclusivamente foto e manifesti dell’epoca fascista.
Devono però avere qualche problema di repertorio visto che in un anno hanno ripetuto sei volte la foto di un quadro di Mussolini, uno scatto dove il duce fa il saluto romano e un manifesto fascista. ’Camerati uniti per l’Italia’ pubblica molti post di Forza Nuova. La pagina è seguita da 12.929 persone. Ma gli iscritti sono poco reattivi: il post più premiato degli ultimi mesi ha raccolto 12 ’like’. La pagina Facebook ’Camerati italiani’ ha 8.214 iscritti. Anche qui dietro la militanza c’è il business. L’indirizzo web ufficiale della pagina rimanda a un negozio online con sede a Limana (Belluno) che vende gadget marchiati ’Camerati italiani’: dalle classiche t-shirt (dai 20 ai 26 euro) alle infradito (18,99 euro).
Per capire la portata della presenza dei fascisti sui social, il quindicinale Patria indipendente dell’Associazione Nazionale Partigiani ha promosso un progetto web. Si trova all’indirizzo patriaindipendente.it/progetto-facebook/ Cliccandoci appare l’enorme galassia delle pagine social di estrema destra. L’impatto visivo è molto forte. Ma la navigabilità non è semplice e alla fine è difficile mettere ordine in una mole di dati visuali che mischia pagine legali e illegali. Grazie al progetto scopriamo però che le pagine social di estrema destra più seguite sono quelle di Forza Nuova (222.820 persone) e Casa Pound (214.885 fan). Che - va sottolineato - non violano alcuna legge, a differenza di molte altre citate qui. Il ’Centro documentazione Repubblica Sociale Italiana’ è seguito su Fb da 25mila persone. Mentre la pagina ’Xª Flottiglia MAS’ ha oltre 13mila seguaci. Accanto appare la pagina ’X flottiglia mas store’, dove sono pubblicizzati i gadget.
Basta andare sul sito collegato per trovare magliette, felpe, polo, cover per telefonini, distintivi, portachiavi e orologi ’dal licenziatario ufficiale della X Flottiglia Mas’, con sede a Taranto. Sul social più frequentato del mondo si possono creare anche gruppi, aperti (cioè visibili a tutti) o chiusi (per vedere i post o commentarli bisogna essere iscritti). Tra i gruppi chiusi spopola con oltre 12mila iscritti ’Fascisti del terzo millennio’. Seguito da ’Onore al duce’ che conta 8.979 membri e da ’Dux mea lux!’ con 8.772 membri. La palma per il nome più lungo va a ’Benito Mussolini, il Duce... un uomo che ha fatto grande l’Italia 1883-1945’ che conta 3.689 iscritti. Il gruppo ’Fascisti e fascismo’ si ferma invece a 2.285 adepti. L’elenco è sterminato. Tra i gruppi social più curiosi ci sono ’Fascisti Italiani non c’è più tempo dobbiamo ritornare’ (49 componenti) e ’Fascisti non per piacere ma per dovere’ (159 iscritti). Decisamente ’esclusivi’ sono i gruppi ’Per soli veri fascisti’ (8 iscritti) e ’I veri fascisti’ (4 componenti). Gli Artisti fascisti sono invece 43. Mentre i ’Golfisti fascisti’ (intesi come militanti fascisti possessori dell’auto Golf - sì, esistono anche loro) sono 13. Il più piccolo è il gruppo ’Fascismo è vita’ che ha un solo componente.
Alla ricerca delle parole ’nazismo’, ’nazisti’, ’SS’ e ’camicie nere’ Facebook non restituisce invece pagine apologetiche o degne di nota. Mentre digitando ’Adolf Hitler’ si trova solo il gruppo ’Adolf Hitler capo del mio governo’ che ha soltanto 10 membri. Il motivo è presto detto: Facebook ha rimosso e/o oscurato le pagine e i gruppi che inneggiavano al nazismo. Aspettate però a gioire. Il social l’ha fatto solo dopo avere ricevuto moltissime proteste. E c’è chi ha imparato ad aggirare i divieti. Sulla pagina dell’Associazione culturale Thule Italia, seguita da 10.000 persone, quasi ogni giorno appare la foto di un soldato nazista ma senza alcun testo di accompagnamento. Così mentre i sostenitori mandano cuori e scrivono ’bellissimo’, l’associazione è formalmente salva. Sta facendo ’ricostruzione storica’ non apologia. Anche per questo è difficile dire quanto sia vasta la presenza nazi-fascista sui social. Ma basta sommare i nostalgici iscritti ai gruppi o alle pagine nominate in questo articolo per superare il milione di persone. E abbiamo solo scalfito la superficie. Per fermare l’apologia fascista sui social, Emanuele Fiano ha presentato una proposta di legge. Ma per ora è ancora tutto in alto mare.
* Avvenire, domenica 20 agosto 2017 (ripresa parziale - senza note e immagini).
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:- FILOSOFIA. IL PENSIERO DELLA COSTITUZIONE E LA COSTITUZIONE DEL PENSIERO
 MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA E A PENSARE BENE "DIO", "IO" E "L’ITALIA", CHI PIU’ CHI MENO, TUTTI VIVONO DENTRO LA PIU’ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA E POLITICA ITALIANA, NEL REGNO DI "FORZA ITALIA"!!!
MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA E A PENSARE BENE "DIO", "IO" E "L’ITALIA", CHI PIU’ CHI MENO, TUTTI VIVONO DENTRO LA PIU’ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA E POLITICA ITALIANA, NEL REGNO DI "FORZA ITALIA"!!!
LA STORIA DEL FASCISMO E RENZO DE FELICE: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"!
PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!! FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.
- FILOSOFIA. IL PENSIERO DELLA COSTITUZIONE E LA COSTITUZIONE DEL PENSIERO
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --L’ANALOGIA ARMATA DEL CALIFFATO. Parole e conflitti retorici (di Fabio Milazzo).1 agosto 2017, di Federico La Sala
MITO E STORIA, POLITICA E TEOLOGIA.
Storiografia in crisi d’identità ...
LO SPIRITO E L’OSSO storia, immaginario, filosofia e psicoanalisi
L’analogia armata del Califfato. Parole e conflitti retorici
di Fabio Milazzo*
- Review of: Philippe-Joseph Salazar, Parole armate. Quello che l’Isis ci dice e che noi non capiamo, Bompiani, Milano 2016, pagg.199.
- «Mi domando quanta cultura, retorica,
persuasione e dialettica abbiamo perso in Europa
per non comprendere quello che sta succedendo e non essere in grado di reagire»
 Philippe-Joseph Salazar[1]
Philippe-Joseph Salazar[1]
Sgozzature, lapidazioni, defenestrazioni, crocifissioni, esecuzioni di donne, bambini e anziani, come forma di disciplinamento di massa alle "quali assistono folle intere, mentre fanno acquisti o nel bel mezzo del traffico di tutti i giorni" (p. 10). Tra tanti segni di barbarie, gli omicidi ritualizzati e "scenarizzati" a fini di propaganda, forse, rappresentano l’elemento che più di tutti ha colpito l’immaginario dell’Occidentale, quello che si confronta con ciò che Slavoj Žižek definisce l’orrore del Reale insimbolizzabile. Un orrore incomprensibile che, proprio per questo, scatena sterili reazioni di diniego e ingenui tentativi di reductio ad absurdum. Si invoca l’analfabetismo culturale e politico, l’idiozia gutturale sottolineata "dalle grida dei selvaggi" (p. 10), si riporta tutto alla miseria psico-sociale di chi, nato e cresciuto in una condizione di cieca disperazione, regredirebbe alla condizione animale (avete mai visto animali uccidere ritualmente?). Ma siamo così sicuri che oltre lo sconcerto ci sia solo il confronto con un mondo-barbaro da cui crediamo esserci emancipati?
 Non è che semplicemente ci stiamo rapportando con un mondo che utilizza logiche espressive - e quindi modelli mentali - troppo diversi dai nostri per poterli ridurre alle comode e rassicuranti coordinate che danno forma al mondo sorto dall’Illuminismo?
Non è che semplicemente ci stiamo rapportando con un mondo che utilizza logiche espressive - e quindi modelli mentali - troppo diversi dai nostri per poterli ridurre alle comode e rassicuranti coordinate che danno forma al mondo sorto dall’Illuminismo?- Abū Bakr al-Baghdādī durante una predica
Questi interrogativi tengono in piedi il libro di P.-J. Salazar "Paroles Armées. Comprendre et Combattre la Propagande Terroriste, appena tradotto in Italia per Bompiani. Lo dico subito: quello di Salazar è un grande libro che ha il coraggio di non abbandonarsi ai toni ideologici della maggior parte delle ermeneutiche in circolazione e, senza girarci intorno, chiarisce la posta in gioco dello scontro con l’Is: la retorica.
 Continuare a ripetere che le ragioni dello scontro sono (innanzitutto) economiche, legate all’arretratezza dell’Islam o effetti residuali del colonialismo, non consente di focalizzare quella che possiamo chiamare l’oscena fantasia che tiene in piedi le narrazioni in campo. Ci sono visioni del mondo - quindi modi di usare le parole per costruire le storie che riempiono l’immaginario - totalmente diverse tra l’Occidente logocentrico e questo Islam tanto violento quanto retoricamente eccessivo e dallo stile figurato.
Continuare a ripetere che le ragioni dello scontro sono (innanzitutto) economiche, legate all’arretratezza dell’Islam o effetti residuali del colonialismo, non consente di focalizzare quella che possiamo chiamare l’oscena fantasia che tiene in piedi le narrazioni in campo. Ci sono visioni del mondo - quindi modi di usare le parole per costruire le storie che riempiono l’immaginario - totalmente diverse tra l’Occidente logocentrico e questo Islam tanto violento quanto retoricamente eccessivo e dallo stile figurato.
 Precisiamo che le dicotomie, i "noi" e i "loro", ovviamente, non hanno ragion d’essere alla luce di una microfisica psico-sociale in grado di evidenziare la contingenza e l’irriducibile valore differenziale delle soggettività, ma mostrano il loro valore nel momento in cui si ha a che fare con il campo dell’immaginario di gruppo, con quei quadri-mentali-collettivi[2] su cui tanto si sono dibattuti gli storici novecenteschi delle Annales[3]. Quadri riconosciuti dallo stesso Lacan con la definizione di "mentalità". D’altra parte il parlante è sempre immerso nel proprio involucro immaginario, fatto di parole che organizzano sia le rappresentazioni, sia il senso attraverso cui fa esperienza del mondo. Non si capisce perché questa considerazione - neanche troppo originale oggi - non debba valere per le collettività, per mondi e nicchie-antropologiche che prendono forma entro coordinate storico-discorsive contraddistinte da una condivisione retorica di fondo molto forte.
Precisiamo che le dicotomie, i "noi" e i "loro", ovviamente, non hanno ragion d’essere alla luce di una microfisica psico-sociale in grado di evidenziare la contingenza e l’irriducibile valore differenziale delle soggettività, ma mostrano il loro valore nel momento in cui si ha a che fare con il campo dell’immaginario di gruppo, con quei quadri-mentali-collettivi[2] su cui tanto si sono dibattuti gli storici novecenteschi delle Annales[3]. Quadri riconosciuti dallo stesso Lacan con la definizione di "mentalità". D’altra parte il parlante è sempre immerso nel proprio involucro immaginario, fatto di parole che organizzano sia le rappresentazioni, sia il senso attraverso cui fa esperienza del mondo. Non si capisce perché questa considerazione - neanche troppo originale oggi - non debba valere per le collettività, per mondi e nicchie-antropologiche che prendono forma entro coordinate storico-discorsive contraddistinte da una condivisione retorica di fondo molto forte.In quest’ottica, non comprendere la mentalità dei terroristi, ridurla ad epifenomeno di cause economiche e materiali, significa operare con un perverso rasoio irriflesso in nome del riduzionismo più becero e ingenuo. Salazar lo sottolinea a più riprese, evidenziando quanto il problema dello scontro con l’Isis riguardi l’incomunicabilità di mondi che usano forme discorsive diverse.
 "C’è - ci dice - una logica dietro i discorsi del Califfato, che sembrano presentare uno scarto rispetto a ciò che noi consideriamo logico, ragionevole e persuasivo in politica. Una logica di altro genere [...] che possiede, oltre alla professione di fede e alla sua forza evocativa poetica un rigore dialettico. Il rigore del ragionamento per analogia" (p. 14).
"C’è - ci dice - una logica dietro i discorsi del Califfato, che sembrano presentare uno scarto rispetto a ciò che noi consideriamo logico, ragionevole e persuasivo in politica. Una logica di altro genere [...] che possiede, oltre alla professione di fede e alla sua forza evocativa poetica un rigore dialettico. Il rigore del ragionamento per analogia" (p. 14).
 Soprattutto queste ultime parole fanno venire voglia di riprendere in mano un gigante del pensiero come Enzo Melandri che nel suo «La linea e il circolo»[4] lungamente si è espresso sulle peculiarità di questo procedimento discorsivo. Si tratta di fare fino in fondo i conti con uno stile retorico-espressivo, ma anche con modelli di pensiero, che solo a fatica possono essere ricondotti "al sistema logico dei ragionamenti scientifici o razionali" (p.13). Se l’Europa ha messo al bando (salvo riconoscergli un ruolo osceno) la poetica e la retorica, separandole nettamente dal ragionamento logico e dalle argomentazioni scientifiche, così non è accaduto nel mondo islamico in cui "uno slancio lirico" vale come argomento e prova logica. -Facciamocene una ragione.
Soprattutto queste ultime parole fanno venire voglia di riprendere in mano un gigante del pensiero come Enzo Melandri che nel suo «La linea e il circolo»[4] lungamente si è espresso sulle peculiarità di questo procedimento discorsivo. Si tratta di fare fino in fondo i conti con uno stile retorico-espressivo, ma anche con modelli di pensiero, che solo a fatica possono essere ricondotti "al sistema logico dei ragionamenti scientifici o razionali" (p.13). Se l’Europa ha messo al bando (salvo riconoscergli un ruolo osceno) la poetica e la retorica, separandole nettamente dal ragionamento logico e dalle argomentazioni scientifiche, così non è accaduto nel mondo islamico in cui "uno slancio lirico" vale come argomento e prova logica. -Facciamocene una ragione.
 Siamo dunque condannati all’incomunicabilità e all’impossibilità del dialogo? Salazar non è così pessimista e lo dice bene in questa intervista:
Siamo dunque condannati all’incomunicabilità e all’impossibilità del dialogo? Salazar non è così pessimista e lo dice bene in questa intervista:«Se le armi non bastano, come possiamo contrastare il Califfato? Con l’istruzione. Dobbiamo educare una popolazione, quella europea, che vive di luoghi comuni. [...] Gli allievi europei non studiano bene la storia e la geografia. Di conseguenza, il vecchio continente si ritrova con una marcia in meno rispetto al Califfato che invece mette in mostra una notevole cultura, coltiva i grandi testi non solo religosi, cita i filosofi, recita poesie e canta inni. L’Europa mette in mostra una tecnologia che le si ritorce contro e nel frattempo vive un deficit culturale»[5].
Per inciso, la scuola - e il suo valore formativo - trova in queste dichiarazioni spazi inediti di possibile affermazione e rivalutazione in un periodo di profonda crisi in atto. Ma questo è un altro discorso. Il libro di Salazar non si limita soltanto ad evidenziare quanto sia scorretto, oltre che inutile, cercare di imporre la logica argomentativa sviluppatasi dopo la rivoluzione scientifica come chiave di lettura per decifrare l’orrore del Califfato, ma sottolinea anche quanto siano falsate - e ingenue - le ermeneutiche che riducono il fenomeno jihadista a semplice effetto sovrastrutturale, a conseguenza di una subordinazione economica, da parte del mondo musulmano, insostenibile nell’epoca della colonizzazione mediatica.
 Questa tesi, più o meno argomentata, è inconsistente se consideriamo quanto il proselitismo del Califfato interessi anche (soprattutto?) persone istruite che sembrano essere alla ricerca di valori chiari e di ideali da difendere, piuttosto che il riscatto economico, centrale invece per l’immaginario collettivo Occidentale.
Questa tesi, più o meno argomentata, è inconsistente se consideriamo quanto il proselitismo del Califfato interessi anche (soprattutto?) persone istruite che sembrano essere alla ricerca di valori chiari e di ideali da difendere, piuttosto che il riscatto economico, centrale invece per l’immaginario collettivo Occidentale.
 Non «considerare - ci dice l’Autore - il jihadismo come qualcosa di diverso da una patologia di imbecilli» (p.70) è una «cantonata» fondamentale, tipica di una società incapace di relazionarsi con l’Altro - per dirla con Lacan - senza ridurlo all’altro - delle proiezioni narcisistiche. I video e i periodici dei jihadisti dell’Isis, invece, sono pensati «per giovani intelligenti e istruiti, beneficiari di un buon capitale culturale e materiale, lettori attenti alla ricerca di argomenti solidi (anche se in ordine ad una teoria dell’argomentazione diversa dalla “nostra”) e di idee sviluppate con cura» (p.71).
Non «considerare - ci dice l’Autore - il jihadismo come qualcosa di diverso da una patologia di imbecilli» (p.70) è una «cantonata» fondamentale, tipica di una società incapace di relazionarsi con l’Altro - per dirla con Lacan - senza ridurlo all’altro - delle proiezioni narcisistiche. I video e i periodici dei jihadisti dell’Isis, invece, sono pensati «per giovani intelligenti e istruiti, beneficiari di un buon capitale culturale e materiale, lettori attenti alla ricerca di argomenti solidi (anche se in ordine ad una teoria dell’argomentazione diversa dalla “nostra”) e di idee sviluppate con cura» (p.71).
 Non deve così sorprendere - né essere considerata una eccezione - che le «tre brillanti liceali inglesi passate al Califfato [...] e il giovane medico australiano che è andato a esercitare il suo mestiere là dove lo hanno portato le sue convinzioni» (p.71) appartengano a quell’universo di gente istruita, che è andata a scuola e si è magari laureata, che le teorie del sottosviluppo economico come molla per l’adesione agli ideali dell’Isis dovrebbero non contemplare.
Non deve così sorprendere - né essere considerata una eccezione - che le «tre brillanti liceali inglesi passate al Califfato [...] e il giovane medico australiano che è andato a esercitare il suo mestiere là dove lo hanno portato le sue convinzioni» (p.71) appartengano a quell’universo di gente istruita, che è andata a scuola e si è magari laureata, che le teorie del sottosviluppo economico come molla per l’adesione agli ideali dell’Isis dovrebbero non contemplare.
 Invece ecco che si palesa un dato: la propaganda del Califfato si rivolge a persone «animate da un desiderio meditato» (p.71) di martirio. Per quanta fatica si faccia ad accettare questo elemento, questo ci dicono i dati a nostra disposizione e negarli, o cercare spiegazioni poco convincenti e contorte per giustificare una tesi postulata per principio è non soltanto epistemologicamente scorretto ma anche intrinsecamente contraddittorio.
Invece ecco che si palesa un dato: la propaganda del Califfato si rivolge a persone «animate da un desiderio meditato» (p.71) di martirio. Per quanta fatica si faccia ad accettare questo elemento, questo ci dicono i dati a nostra disposizione e negarli, o cercare spiegazioni poco convincenti e contorte per giustificare una tesi postulata per principio è non soltanto epistemologicamente scorretto ma anche intrinsecamente contraddittorio.
 Ma allora «come rispondere a tutto questo? Banalizzando il fenomeno - ci dice Salazar-: facendo circolare quelle riviste [del Califfato] nelle scuole, prendendone spunto per analisi del testo e decostruzioni radicali [...] per ridurre a poca cosa quei documenti materiali attraverso prove argomentate di linguaggio, grazie a ciò che la tradizione culturale francese sa fare meglio. Pensare in modo chiaro e distinto» (p.100). Si tratta cioè di non rifiutare il confronto, di non giocare sulla difensiva ma di contrattaccare retoricamente. E, in tale ottica, la risposta più intelligente che possiamo dare è quella di costruire narrazioni convincenti, basate su argomenti solidi, in grado di convincere quei giovani che sono tentati di abbracciare l’idea mortifera del Califfato di quanto l’intenzione sia una scelta da vicolo cieco. Contro-narrazioni in grado di decostruire la propaganda jihadista e di offrire valide alternative teoriche innanzitutto. Continuare a ripetere lo stanco e logoro mantra dell’arretratezza culturale, figlia del sottosviluppo economico, è controproducente, inutile e scioccamente supponente, anche se di una supponenza perversa, tipica di chi non riconosce effettiva autonomia di pensiero all’Altro ma, implicitamente, lo considera incapace di processi simbolici autonomi e, quindi, di scelte etiche libere. Lo dice con chiarezza Salazar:
Ma allora «come rispondere a tutto questo? Banalizzando il fenomeno - ci dice Salazar-: facendo circolare quelle riviste [del Califfato] nelle scuole, prendendone spunto per analisi del testo e decostruzioni radicali [...] per ridurre a poca cosa quei documenti materiali attraverso prove argomentate di linguaggio, grazie a ciò che la tradizione culturale francese sa fare meglio. Pensare in modo chiaro e distinto» (p.100). Si tratta cioè di non rifiutare il confronto, di non giocare sulla difensiva ma di contrattaccare retoricamente. E, in tale ottica, la risposta più intelligente che possiamo dare è quella di costruire narrazioni convincenti, basate su argomenti solidi, in grado di convincere quei giovani che sono tentati di abbracciare l’idea mortifera del Califfato di quanto l’intenzione sia una scelta da vicolo cieco. Contro-narrazioni in grado di decostruire la propaganda jihadista e di offrire valide alternative teoriche innanzitutto. Continuare a ripetere lo stanco e logoro mantra dell’arretratezza culturale, figlia del sottosviluppo economico, è controproducente, inutile e scioccamente supponente, anche se di una supponenza perversa, tipica di chi non riconosce effettiva autonomia di pensiero all’Altro ma, implicitamente, lo considera incapace di processi simbolici autonomi e, quindi, di scelte etiche libere. Lo dice con chiarezza Salazar:«Che si conduca o meno un’offensiva militare effettiva sul campo del Califfato, bisogna ripensare i termini retorici di questo eventuale impegno e ammettere che lo scontro comincia con una guerra retorica in cui l’avversario controlla una panoplia omogenea che va dall’ingiunzione all’analogia, passando per un’arte oratoria convincente e sostenuta dalla potente logica di un legalismo imperativo. [...] Bisognerà pensare islamico, parlare islamico, argomentare islamico. Mettersi alla portata retorica dell’avversario» (p.19).
Mettersi alla portata retorica dell’avversario significa anche considerarlo come tale, nel suo essere radicale differenza, alterità da prendere come tale, anche quando si serve, ragiona e giudica attraverso una forma argomentativa - quella analogica - che alle nostre orecchie stupisce e ci appare «perversa o delirante» (p. 14). «L’analogia è il quarto fondamento del ragionamento giuridico» (p.15) islamico, che vuol dire che attraverso l’analisi di un esempio tratto dalla Tradizione si procede all’emissione di un parere giuridico (fatwa) vincolante. Anche le condanne a morte, che tanto orrore provocano a Occidente, vengono inflitte su questa base logica. Possiamo davvero pensare di confrontarci con questo mondo senza aver adeguatamente sviluppato le conseguenze teoriche ed etiche di ciò? «Utilizzando le analogie nella sua propaganda - ci dice Salazar-, la politica jihadista si nutre quindi di un’atmosfera retorica che ci sembra strana o irrazionale [...], che però costituisce una forma politica di interpretazione delle cose, potente e generale» (p.16). Improntare una guerra-retorica per decostruire la propaganda dell’avversario, significa dunque, innanzitutto, «ripensare i termini retorici» (p. 19) di questo scontro e non sottovalutarne la portata performativa.
In definitiva la lezione di questo libro riguarda il fatto che c’è una "potenza oratoria e persuasiva" (p.8) assolutamente incomprensibile per i canoni logocentrici delle "nostre orecchie" abituati a concatenamenti logici di causa ed effetto e fintanto che non riusciremo a misurarne il peso e il valore saremo "disarmati", teoricamente innanzitutto. Prendere confidenza, conoscere, valutare "una logica di altro genere"(p.14), e i fantasmi (dell’inconscio collettivo) che la incorniciano, è quindi il passo necessario per evitare quella forma di etnocentrismo culturale da cui riteniamo di esserci vaccinati ma che, in forma perversa, rischia di vanificare le nostre interpretazioni e, quindi, le strategie per combattere la propaganda del Califfato.
- Philippe-Joseph Salazar, Parole armate. Quello che l’Isis ci dice e che noi non capiamo, Bompiani, Milano 2016, pagg.199, euro 17.
 [1] Cfr. P.-J. Salazar “Parole armate” di Salazar: ecco la cultura del Califfato che sottovalutiamo in «Io Donna- Corriere della Sera», 22 Gennaio 2016, http://www.iodonna.it/attualita/in-primo-piano/2016/01/22/philippe-joseph-salazar-parole-armate-il-califfato-lo-si-combatte-con-la-cultura-e-le-minacce-a-roma-sono-serie/
[1] Cfr. P.-J. Salazar “Parole armate” di Salazar: ecco la cultura del Califfato che sottovalutiamo in «Io Donna- Corriere della Sera», 22 Gennaio 2016, http://www.iodonna.it/attualita/in-primo-piano/2016/01/22/philippe-joseph-salazar-parole-armate-il-califfato-lo-si-combatte-con-la-cultura-e-le-minacce-a-roma-sono-serie/
 [2] Cfr. P. Corrao, Storia della Mentalità in «Studi culturali», http://www.studiculturali.it/dizionario/lemmi/storia_delle_mentalita.html
[2] Cfr. P. Corrao, Storia della Mentalità in «Studi culturali», http://www.studiculturali.it/dizionario/lemmi/storia_delle_mentalita.html
 [3] Cfr. Voce «Annales» in Treccani.it, http://www.treccani.it/enciclopedia/annales/
[3] Cfr. Voce «Annales» in Treccani.it, http://www.treccani.it/enciclopedia/annales/
 [4] Cfr. E. Melandri, La linea e il circolo. Studio logico-filosofico sull’analogia (1968), Quodlibet, Macerata 2004
[4] Cfr. E. Melandri, La linea e il circolo. Studio logico-filosofico sull’analogia (1968), Quodlibet, Macerata 2004
 [5] Cfr. P.-J. Salazar “Parole armate” di Salazar: ecco la cultura del Califfato che sottovalutiamo...cit.
[5] Cfr. P.-J. Salazar “Parole armate” di Salazar: ecco la cultura del Califfato che sottovalutiamo...cit.- FONTE: BLOG - LO SPIRITO E L’OSSO. storia, immaginario, filosofia e psicoanalisi di Fabio Milazzo, 30 gennaio, 2016 (ripresa parziale - senza immagini).
MITO E STORIA, POLITICA E TEOLOGIA. Storiografia in crisi d’identità:
- IL PROBLEMA GIAMBATTISTA VICO. CROCE IN INGHILTERRA E SHAFTESBURY IN ITALIA. La punta di un iceberg.
- EICHMANN A GERUSALEMME (1961). “come fu possibile la hitlerizzazione dell’Imperativo Categorico di Kant? E perché è ancora attuale oggi?” (Emil L. Fackenheim, Tiqqun. Riparare il mondo). HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI.
LA STORIA DEL FASCISMO E RENZO DE FELICE: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"!
 I. BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI - II. ARNALDO MUSSOLINI E MADDALENA SANTORO.
I. BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI - II. ARNALDO MUSSOLINI E MADDALENA SANTORO.VICO, PENSATORE EUROPEO. Teoria e pratica della "Scienza Nuova". Note per una rilettura (pdf, scaricabile)
PAROLA DI VICO. SULLA MODERNITÀ DI CARTESIO, RICREDIAMOCI.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
Federico La Sala
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- Persone di potere dotate di un carisma privo di narcisismo esistono. Ce ne vorrebbero molte di più (Annamaria Testa)25 luglio 2017, di Federico La Sala
CARISMA, COSTITUZIONE, E POLITICA: AL DI LÀ DELLA TRAPPOLA ATEA E DEVOTA. Una importante provocatoria riflessione .... *
- Persone di potere dotate di un carisma privo di narcisismo esistono. In oltre quarant’anni, mi è perfino capitato di incontrarne alcune, tra politica e impresa, ma posso contarle sulle dita di una mano. Ce ne vorrebbero molte di più (Annamaria Testa).
- Why We Select Toxic Leaders (David Rock, "Psychology Today", 2016)
PSICOLOGIA
Lo strano paradosso del potere
di Annamaria Testa, esperta di comunicazione *
Che cosa frulla nella mente delle persone di potere? Ce lo domandiamo - e capita non di rado - quando i loro comportamenti ci appaiono contraddittori, o poco comprensibili, o così arroganti da essere difficili da sopportare. Un recentissimo articolo uscito sull’Atlantic ci invita a porci la domanda in termini più radicali: che cosa succede al cervello delle persone di potere?
L’Atlantic cita un paio di pareri autorevoli. Secondo Dacher Keltner, docente di psicologia all’università di Berkeley, due decenni di ricerca e di esperimenti sul campo convergono su un’evidenza: i soggetti in posizione di potere agiscono come se avessero subìto un trauma cerebrale. Diventano più impulsivi, meno consapevoli dei rischi e, soprattutto, meno capaci di considerare i fatti assumendo il punto di vista delle altre persone.
Sukhvinder Obhi è un neuroscienziato dell’università dell’Ontario. Non studia i comportamenti, ma il cervello. Quando mette alcuni studenti in una condizione di potere, scopre che questa influisce su uno specifico processo neurale: il rispecchiamento, una delle componenti fondamentali della capacità di provare empatia.
Ed eccoci alla possibile causa di quello che Keltner definisce paradosso del potere. Quando le persone acquisiscono potere, perdono (o meglio: il loro cervello perde) alcune capacità fondamentali. Diventano meno empatiche, cioè meno percettive. Meno pronte a capire gli altri. E, probabilmente, meno interessate o disposte a riuscirci.
Come polli senza testa
Inoltre. Spesso le persone di potere sono circondate da una corte di subordinati che tendono a rispecchiare il loro capo per ingraziarselo, cosa che non aiuta certo a mantenere un sano rapporto con la realtà.
E ancora: è il ruolo stesso a chiedere che le persone di potere siano veloci a decidere (anche se non hanno elementi sufficienti per farlo, né tempo per pensarci), assertive (anche quando non sanno bene che cosa asserire. O quando sarebbe meglio prestare attenzione alle sfumature) e sicure di sé al limite dell’insolenza.
I top manager delle multinazionali girano freneticamente per il mondo come polli decapitati: decidono guidati dall’ansia, senza pensare, senza capire, senza vedere e senza confrontarsi. L’ho sentito dire nel corso di una riunione riservata ai partner di un’assai nota società internazionale di consulenza, dal relatore più anziano e autorevole. Mi sarei aspettata qualche brusio di sconcerto tra gli astanti, e invece: ampi segni di assenso.
Ho il sospetto che la sindrome del pollo possa appartenere non solo a chi guida le imprese, ma anche a chi governale istituzioni e le nazioni.
Il fatto è che le persone di potere “devono” andare dritte per la loro strada, infischiandosene di tutto quanto sta attorno. Questo può aiutarle a raggiungere i loro obiettivi (il che è molto vantaggioso a breve termine) ma ne danneggia le capacità di decisione, di interazione e di comunicazione, che nel lungo termine sono strategiche.
- È facile ammirare e rispettare le persone carismatiche. Ma non è così semplice distinguere il carisma dal narcisismo
Il potere logora chi non ce l’ha, diceva Andreotti, che di potere sapeva abbastanza, citando Maurice de Talleyrand. Ma la citazione medesima contiene una dose consistente di protervia.
C’è una parola molto antica che descrive bene tutto ciò: hỳbris. Indica la tracotanza presuntuosa di chi ha raggiunto una posizione eminente e si sopravvaluta. È notevole il fatto che nel termine greco sia implicita anche la fatalità di una successiva punizione, divina o terrena: il fallimento, la caduta.
Si stima che il 47 per cento dei manager falliscano, scrive Adrian Furnham, docente di psicologia all’University College di Londra. È una percentuale molto alta. Uno dei principali motivi di fallimento è il narcisismo: un cocktail deteriore di arroganza, freddezza emozionale e ipocrisia.
C’è un paradosso: è facile ammirare e rispettare le persone carismatiche e fiduciose in se stesse. Ma non è così semplice distinguere il carisma dal narcisismo, che per molti versi ne è il lato oscuro. Sappiamo davvero individuare il confine che c’è tra assertività e prepotenza? Tra sicurezza e ostinazione? Tra fascino e manipolazione?Tra pragmatismo e cinismo?
C’è un ulteriore paradosso: prepotenza, ostinazione, manipolazione e cinismo possono perfino rivelarsi utili nelle battaglie per la conquista del potere, che sono spesso logoranti, sleali e feroci. Ma, una volta ottenuto il potere, per mantenerlo servirebbe proprio quella visione più aperta ed equilibrata che - l’abbiamo visto prima - il ruolo stesso sembra rendere difficilissima da procurarsi e mantenere. Il potere è l’afrodisiaco supremo, diceva Henry Kissinger.
Ma “difficilissimo” non vuol dire “impossibile”. D’altra parte, almeno nelle democrazie occidentali e nelle imprese moderne, il potere si conserva nel lungo termine solo attraverso il consenso. E la capacità di mantenere il consenso è direttamente proporzionale alla capacità di comunicare, di ascoltare e di interagire mettendosi a confronto.
Ehi, si può fare! Persone di potere dotate di un carisma privo di narcisismo esistono. In oltre quarant’anni, mi è perfino capitato di incontrarne alcune, tra politica e impresa, ma posso contarle sulle dita di una mano. Ce ne vorrebbero molte di più.
* Internazionale, 25 luglio 2017
Sul tema, nel sito, si cfr.:
DIO, NATURA, TECNICA COMUNICATIVA, E DEMOCRAZIA. IL "CHARISMA" DELL’ITALIA E IL "CHARISMA" DEGLI ITALIANI E DELLE ITALIANE. CARISMA, COSTITUZIONE, E POLITICA: AL DI LÀ DELLA TRAPPOLA ATEA E DEVOTA. Una importante provocatoria riflessione di Lidia Ravera
Il Narcisismo e l’uso lucidissimo come arma politica dell’"antinomia del mentitore"
UBUNTU: "Le persone diventano persone grazie ad altre persone".
 "CHI" SIAMO: LA LEZIONE DEL PRESIDENTE MANDELA, AL SUDAFRICA E AL MONDO. "La meditazione" di Marianne Williamson, nel discorso di insediamento (1994).
"CHI" SIAMO: LA LEZIONE DEL PRESIDENTE MANDELA, AL SUDAFRICA E AL MONDO. "La meditazione" di Marianne Williamson, nel discorso di insediamento (1994).FILOSOFIA, E TEOLOGIA POLITICA DELLA’ "ANDRO-POLOGIA" ATEA E DEVOTA....
 LA RISATA DI KANT
LA RISATA DI KANTFederico La Sala
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. -- La voglia di fascismo crescente e le nostre debolezze (di Piero Ignazi).10 luglio 2017, di Federico La Sala
L’ITALIA, IL VECCHIO E NUOVO FASCISMO...
- RENZO DE FELICE E LA STORIA DEL FASCISMO: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"!
La voglia di fascismo crescente e le nostre debolezze
di Piero Ignazi (la Repubblica, 10.07.2017)
NOSTALGIA del fascismo? Gli episodi degli ultimi tempi, dal raduno con braccia tese nel saluto romano al cimitero monumentale di Milano alla lista ispirata palesemente al fascismo nel comune mantovano di Sermide fanno pensare ad un ritorno di fiamma del passato.
LA realtà è più sfumata. Per prima cosa non si può dimenticare che, fino a vent’anni fa, c’era un partito al governo - Alleanza Nazionale - che affondava le proprie radici, non del tutto recise, nel (neo)fascismo. Infatti, quando Gianni Alemanno diventò sindaco di Roma nel 2008 fu salutato al Campidoglio da un manipolo di camerati con il saluto romano. E un beniamino dei tifosi della Lazio andò alla curva dello stadio per festeggiare il goal con la stessa modalità nostalgica (ovviamente senza nessuna sanzione).
C’è quindi un retroterra assai solido rispetto a questi ultimi episodi; e girando l’Italia si incontrano osti con il vino Benito, locali con scritte del ventennio, bancarelle con cimeli del Duce, fino al caso dello stabilimento balneare di Chioggia di cui dava conto Repubblica ieri. Il fascismo è stato un fenomeno di tale importanza, penetrato “totalitariamente” in ogni ganglio della società per due decenni, che non è bastato l’eroismo dei pochi che hanno combattuto per la libertà per estirparlo dalla cultura politica profonda del nostro paese.
Ancora una volta, “non è stata una parentesi”. Anzi, come diceva Piero Gobetti, narrava la nazione come ne fosse l ‘autobiografia. Con un lascito così ingombrante e senza aver fatto alcun esame di coscienza lasciando, o forse sperando,che si stendesse una coltre di oblio sul passato senza doverlo rinvangare, non sorprende che di tanto in tanto riemergano fenomeni di nostalgia. Ma questi sono solo la punta di un iceberg: ma non di un fascismo risorgente, quanto della debolezza della cultura liberale e democratica.
Gli ostacoli che ancora oggi vengono continuamente frapposti alla espansione dei diritti civili, un tempo non a caso sostenuti solo da sparute minoranze attive come quella dei radicali di Marco Pannella, sono un segno della difficoltà a far diventare moneta corrente i cardini dello stato di diritto. Separazione dei poteri, rispetto per le minoranze, accettazione (in ogni ambito) del dissenso, faticano ad infrangere il profondo desiderio per una figura di autorità che metta tutti a tacere. Sia la società civile, ripiegata a fare i propri interessi senza nessun senso dello Stato, che la politica, scissa tra incapacità a rispondere alle domande dei cittadini e pulsioni plebiscitarie stimolate da capi e capetti, favoriscono un allontanamento dai principi e dalle istituzioni democratiche.
È in questo contesto che matura l’insoddisfazione radicale verso “il sistema” e fanno breccia coloro che propongono visioni alternative e modalità diverse di agire politico. Il fenomeno Casa Pound, pur nella sua dimensione ancora limitata, è emblematico della capacità di attrazione che hanno riferimenti nostalgici mixati con quella domanda di identità e appartenenza che circola nella società italiana. Ancora più del pastiche ideologico di Casa Pound, attrae l’offerta di una militanza che si trasforma in comunità politica. Se movimenti come questo, e altri che ruotano nella galassia nera dell’estrema destra, si radicano in fasce giovanili è perché tutti i partiti hanno abbandonato il rapporto con la società civile, o lo attivano solo in maniera strumentale, senza quel coinvolgimento ideale e progettuale che rilancerebbe la loro immagine.
La democrazia necessita di continua manutenzione per non farla scadere a ritualità. Questi segnali di una ricerca di alternative radicali incrinano la certezza che le istituzioni e i principi che le governano siano al riparo da crisi più profonde.
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. -- STORIA E MEMORIA: A GIOVANNI FALCONE. A 25 anni dalla strage di Capaci.23 maggio 2017, di Federico La Sala
Giovanni Falcone, chi lo chiamava “cretino” e chi non lo votò al Csm: ecco i nemici del giudice ucciso nella strage di Capaci
Dalle offese di Carnevale agli attacchi in diretta televisiva fino all’ultima provocazione di Berlusconi. A 25 anni dalla strage di Capaci ecco i nomi di chi ha provato in tutti i modi a rendere difficile l’esistenza del magistrato palermitano. Come Lino Jannuzzi che ai tempi della Superprocura definiva lui e De Gennaro "i maggiori responsabili della débâcle dello Stato di fronte alla mafia. Una coppia la cui strategia ha approdato al più completo fallimento"
di Giuseppe Pipitone *
C’è chi non si è pentito delle offese lanciate persino quando l’avevano già assassinato, ma anche chi ha chiesto scusa. Chi ha fatto delle scelte poi rivelatesi errate e adesso porta in tribunale i giornali che le ricordano, chi non ha mai più commentato certe critiche lanciate a favor di telecamera e chi invece nega persino le sue stesse parole. Sono i nemici di Giovanni Falcone, quelli che lo hanno osteggiato in vita rendendogli impossibile l’esistenza. Una categoria che non viene mai - o quasi mai - citata nelle decine di eventi organizzati ogni anno per commemorare il giudice palermitano.
“I nemici principali di Giovanni furono proprio i suoi amici magistrati. Tanti furono gli attacchi e le sconfitte tanto che fu chiamato il giudice più trombato d’Italia e purtroppo lo è stato ed è stato lasciato solo”, ha ricordato la sorella Maria alla vigilia dell’anniversario numero 25 della strage di Capaci. Un quarto di secolo dopo quel maledetto 23 maggio del 1992, tante, tantissime cose sono cambiate: a cominciare dalla stessa Cosa nostra e dall’Antimafia, fenomeni che negli anni sono addirittura arrivati a confondersi e compenetrarsi. Un gioco di specchi di cui sono piene le cronache degli ultimi anni e che soltanto nell’isola dei paradossi poteva andare in scena.
I nemici di Falcone - Confusa tra mille riflessi è stata anche la figura stessa di Falcone: la storia del giudice più trombato d’Italia, per citare la sorella Maria, è stata trasformata - spesso dai suoi stessi detrattori - in quella perfetta del magistrato sempre appoggiato da superiori e opinionisti lungo la sua intera esistenza. Venticinque anni dopo la sua morte, il ricordo del giudice siciliano è finito annacquato da fiumi di retorica: oggi sembra quasi che Falcone sia stato in vita un uomo amato da tutti, mai attaccato o ostacolato da nessuno. E pazienza se i fatti siano andati in maniera diversa. D’altra parte la figura del magistrato palermitano viene usata oggi come una sorta di santino: un nome da citare per dare solidità a qualsiasi tipo di ragionamento o di ragionatore.
Solo per fare un esempio, rivendica di aver conosciuto Falcone persino quello che è considerato il capo dei capi di Mafia capitale. “Una volta mi accollarono un reato in Sicilia (il delitto di Piersanti Mattarella ndr), presi l’avvocato e andai da Falcone, il giudice Falcone a Palermo”, dice in un’intercettazione Massimo Carminati. “Ma Falcone lo hai conosciuto di persona te?”, gli chiedono i suoi compari, come racconta il giornalista Lirio Abbate. “Mi ha interrogato. Persona intelligentissima, si vedeva proprio, aveva l’intelligenza che che gli sprizzava dagli occhi. Era anche una persona amabile nei modi”, risponde il Cecato dando vita a un dialogo grottesco.
Sono al limite dell’imbarazzo, invece, le ultime dichiarazioni di Silvio Berlusconi.”Falcone è il simbolo di come dovrebbe essere un magistrato”, ha detto l’ex cavaliere, intervistato dal Foglio. Chi magari pensava che il magistrato simbolo per Berlusconi dovesse somigliare al corrotto Vittorio Metta è dunque rimasto deluso. Ma l’ex premier ha addirittura rilanciato: “Al pensiero di Falcone si ispirano molte delle nostre idee sulla giustizia”. Il magistrato siciliano purtroppo non può replicare. In alternativa avrebbe respinto al mittente qualsiasi connessione con la ex Cirielli, il lodo Alfano, e la depenalizzazione del falso in bilancio, solo per citare qualche “idea sulla giustizia” di Forza Italia, partito fondato da Marcello Dell’Utri, detenuto a Rebibbia dopo la condanna in via definitiva per concorso esterno. Vale la pena di ricordare che Berlusconi - tra le altre cose - è stato lungamente indagato come mandante a volto coperto delle stragi del 1992 e 1993. “So che ci sono fermenti di procure che ricominciano a guardare a fatti del ’92, ’93, ’94: follia pura. Quello che mi fa male è che c’è chi sta cospirando contro di noi“, disse invece il leader di Forza Italia da presidente del consiglio in carica, quando la procura di Caltanissetta riaprì le indagini sulla strage di via d’Amelio, depistate dal falso pentito Vincenzo Scarantino.
D’altra parte è sempre uno dei governi di Berlusconi che nel 2003 inserì un comma in Finanziaria per concedere al giudice Corrado Carnevale di essere reintegrato, recuperando gli anni di contributi pensionistici persi a causa delle inchieste a suo carico. Carnevale era stato lo storico presidente della prima corte di Cassazione che nel 1992 avrebbe dovuto giudicare le sentenze del primo Maxi processo a Cosa nostra. Per il gran numero di annullamenti decisi negli anni precedenti si era guadagnato un soprannome evocativo: l’Ammazzasentenze. Ed è per evitare di ammazzare pure gli ergastoli del primo Maxi processo che Falcone - nel frattempo approdato alla direzione degli Affari Penali del ministero della Giustizia - ottenne l’applicazione di un criterio di rotazione per i casi di mafia approdati alla Suprema corte. Carnevale non la prese bene. “I motivi per cui me ne sono andato non sono quelli di pressione di quel cretino di Falcone: perché i morti li rispetto, ma certi morti no“, diceva in una conversazione l’8 marzo del 1994, a meno di due anni dalla strage di Capaci. Un’intercettazione in cui il giudice non risparmia neanche la moglie di Falcone, Francesca Morvillo. “Io sono convinto che la mafia abbia voluto uccidere anche la moglie di Falcone che stava alla prima sezione penale della Corte d’Appello di Palermo per farle fare i processi che gli interessavano per fregare qualche mafioso“, dirà senza un minimo di compassione per la coppia appena assassinata da Cosa nostra.
Il risentimento dell’Ammazzasentenze - Quando il 10 novembre dello stesso anno gli investigatori gli danno lettura di quelle conversazioni, l’Ammazzasentenze confida: “Devo ammettere che io ho avuto del risentimento nei confronti del dottor Falcone”. Gli chiedono: “Neppure dopo la morte di Falcone si è placato quel suo grave risentimento?”. “No, devo ammettere di no”. Processato per concorso esterno, Carnevale è stato assolto in primo grado, condannato in appello a sei anni, prosciolto definitivamente in Cassazione. Dopo l’assoluzione torna a fare il giudice della corte di Cassazione, pensa di ricandidarsi come presidente della prima sezione ma lascia perdere. Poteva rimanere in servizio fino al 2015, ma decide di andare in pensione nel 2013 quando ha ormai 83 anni. Alcuni mesi dopo va a testimoniare al processo Capaci bis - quello nato dalle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza - e dice incredibilmente: “Non ho mai parlato di Falcone, non avevo motivo per farlo”. Ai giornalisti del Foglio e del Giornale che lo vanno a trovare a casa per intervistarlo invece racconta: “La casta a cui appartengo fin dal primo momento non mi ha visto di buon occhio. Temevano che potessi salire tanto in alto da influire sul loro lassismo. È la logica dell’invidia“.
Ha azzerato praticamente gli interventi mediatici Vincenzo Geraci, altro nome che ha un ruolo nella carriera di Giovanni Falcone, perché insieme al magistrato siciliano era presente ai primi interrogatori di Tommaso Buscetta. Anni dopo Geraci è tra i consiglieri del Csm che la sera del 19 gennaio del 1988 bocciano la nomina di Falcone a capo dell’ufficio istruzione di Palermo. Era lo stesso posto ricoperto da Antonino Caponnetto, l’inventore del pool antimafia: sembrava scontato che la successione toccasse a Falcone. “Se da un lato, infatti, le notorie doti di Falcone e i rapporti personali e professionali che coltivo con lui mi indurrebbero a preferirlo nella scelta, a ciò mi è però dì ostacolo la personalità di Meli, cui l’altissimo e silenzioso senso del dovere, costò in tempi drammatici la deportazione nei campi di concentramento della Polonia e della Germania, dove egli rimase prigioniero per due anni. In tali condizioni vi chiedo pertanto di comprendere con quanta sofferenza e umiltà mi sento portato ad esprimere il mio voto di favore”, dirà Geraci annunciando il suo sostegno alla candidatura dell’anziano Antonino Meli: di mafia sapeva poco o nulla ma era stato internato dai tedeschi. Venne nominato consigliere istruttore con 14 voti a favore, 10 contrari (tra i quali Gian Carlo Caselli) e 5 astenuti.
“Un giuda ci ha traditi” - “Quando Giovanni Falcone, solo per continuare il suo lavoro, propose la sua aspirazione a succedere ad Antonino Caponnetto, il Csm, con motivazioni risibili gli preferì il consigliere Antonino Meli. Falcone concorse, qualche Giuda si impegnò subito a prenderlo in giro, e il giorno del mio compleanno il Csm ci fece questo regalo. Gli preferì Antonino Meli”, si sfogherà Paolo Borsellino, nel suo ultimo intervento pubblico il 25 giugno del 1992. Borsellino non indicherà mai chi fosse quel Giuda: venne ucciso, infatti, meno di tre settimane dopo quell’intervento. Molti anni dopo, quindi, quando il giornalista Rino Giacalone tirerà in ballo Geraci, quest’ultimo lo querelerà per diffamazione. Oggi Geraci è procuratore generale aggiunto della Cassazione: in pratica è il vice di Pasquale Ciccolo, titolare dell’azione disciplinare nei confronti dei magistrati.
Il Corvo senza nome - Sempre per rimanere nel campo delle toghe non si può non citare il famoso caso del Corvo di Palermo, l’anonimo autore di lettere in cui si accusava Falcone di avere gestito illegalmente il pentito Totuccio Contorno: addirittura di averlo chiamato a Palermo per mandarlo a caccia dei boss del clan dei corleonesi. Accusato di essere il Corvo fu il giudice Alberto Di Pisa, condannato in primo grado a un anno a sei mesi e poi assolto definitivamente nel 1993. L’identità del Corvo non sarà mai individuata mentre tra i detrattori di Falcone si possono annoverare anche personaggi estranei alla magistratura. A cominciare magari da semplici e normali privati cittadini.
“Spostate i magistrati in periferia” - La Palermo in cui ha vissuto Giovanni Falcone era molto diversa dalla Palermo che si è svegliata dopo quello che i mafiosi battezzarono come l’Attentatuni. Un esempio? Una lettera pubblicata dal Giornale di Sicilia negli anni ’80. A scriverla è una donna che abita nelle vicinanze del condominio in cui Falcone fa ritorno ogni sera, blindato dalle auto della scorta. Il motivo della missiva? “Regolarmente tutti i giorni, al mattino, nel primissimo pomeriggio e la sera, vengo letteralmente assillata da continue e assordanti sirene di auto della polizia che scortano i vari giudici. Ora mi domando: è mai possibile che non si possa eventualmente riposare un poco nell’intervallo del lavoro? O quanto meno seguire un programma televisivo in pace?”; scriveva la vicina di casa del giudice che poi lanciava un invito: “Perché i magistrati non si trasferiscono in villette alla periferia della città, in modo tale che sia tutelata la tranquillità di noi cittadini lavoratori e l’incolumità di noi tutti, che nel caso di un attentato siamo regolarmente coinvolti senza ragione”. Parole che fanno un certo effetto. Soprattutto oggi che l’albero Falcone - nei pressi dell’abitazione del magistrato - sarà invaso da persone arrivate a Palermo da tutta Italia.
L’attacco in diretta tv - Le cose per Falcone non andavano meglio quando accettava di partecipare a qualche trasmissione televisiva. Nota, anzi notissima, è la puntata che Michele Santoro e Maurizio Costanzo dedicano in tandem alla memoria dell’imprenditore Libero Grassi, ucciso nell’agosto del 1991. In studio tra gli ospiti c’è il giudice palermitano, attaccato più volte in quell’occasione da personaggi che avranno storie future completamente diverse. “Falcone ha dichiarato che è notorio che l’onorevole Salvo Lima utilizzava la macchina degli esattori Salvo”, è l’intervento - in collegamento da Palermo - di Leoluca Orlando. “C’era bisogno che lo dicessi io perché si sapesse dei rapporti tra i Salvo e i Lima”, risponde Falcone, raccogliendo la replica dell’allora leader della Rete. “Ecco un’ulteriore conferma“, dice in diretta televisiva Orlando, che in pratica accusava Falcone di non aver perseguito volontariamente l’europarlamentare della Dc. Quelle accuse a Falcone saranno rinfacciata per anni al primo cittadino palermitano, il quale chiederà poi scusa per le sue parole.
 Quella trasmissione, però, è passata alla storia anche per l’intervento di Totò Cuffaro. “Ho assistito ad una volgare aggressione alla classe migliore che abbia la Democrazia Cristiana in Sicilia. Il giornalismo mafioso che è stato fatto stasera fa più male di dieci anni delitti”, è una parte dello sfogo del futuro governatore della Sicilia, poi condannato in via definitiva per favoreggiamento alla mafia. Per il video di
quell’intervento - intitolato su youtube “Totò Cuffaro aggredisce Giovanni Falcone” - l’ex presidente siciliano ha querelato Antonio Di Pietro, che lo aveva postato sul suo blog: il tribunale gli ha dato ragione.
Quella trasmissione, però, è passata alla storia anche per l’intervento di Totò Cuffaro. “Ho assistito ad una volgare aggressione alla classe migliore che abbia la Democrazia Cristiana in Sicilia. Il giornalismo mafioso che è stato fatto stasera fa più male di dieci anni delitti”, è una parte dello sfogo del futuro governatore della Sicilia, poi condannato in via definitiva per favoreggiamento alla mafia. Per il video di
quell’intervento - intitolato su youtube “Totò Cuffaro aggredisce Giovanni Falcone” - l’ex presidente siciliano ha querelato Antonio Di Pietro, che lo aveva postato sul suo blog: il tribunale gli ha dato ragione.“Giovanni vattene da Roma” - E se oggi tutti concordano nel valutare come un salto di qualità nella lotta alla mafia il passaggio di Falcone a Roma per dirigere gli Affari Penali del ministero di Grazia e Giustizia, così non era in quel 1992. “Secondo me Falcone farebbe bene ad andarsene il più presto possibile dai palazzi ministeriali, perché l’aria non gli fa bene proprio“, disse l’avvocato Alfredo Galasso nella stessa puntata del Maurizio Costanzo Show, nota per l’esordio televisivo di Cuffaro. “Questo mi sembra scarso senso dello Stato. Al ministero di Grazia e Giustizia ci sono posti espressamente previsti per i magistrati”, fu la replica di Falcone, attaccato spesso per il suo trasferimento a Roma anche in altre salotti televisivi. “Noi abbiamo imparato a conoscerla quando viveva barricato laggiù e forse l’abbiamo un po’ mitizzata. Adesso che sta al ministero e che scrive editoriali sulla Stampa, le sue posizioni sembrano più morbide, più sfumate. Non vorrei dire che ci ha un po’ deluso negli ultimi tempi ma sicuramente è cambiato: lei lo sa? Ne è consapevole?”, gli chiede il 12 gennaio del 1992 Corrado Augias durante una puntata di Telefono Giallo. Una trasmissione che passa alla storia soprattutto per la domanda posta da una componente del pubblico. “Lei - chiederà una donna a Falcone - dice nel suo libro che in Sicilia si muore perché si è soli. Giacché lei fortunatamente è ancora con noi: chi la protegge?” La reazione del magistrato è amara: “Questo vuol dire che per essere credibili bisogna essere ammazzati?”
Critiche asprissime arriveranno a Falcone nello stesso periodo anche sulla stampa. È il momento in cui il magistrato siciliano è candidato a dirigere la cosiddetta Superprocura (cioè la procura nazionale antimafia) e il poliziotto Gianni De Gennaro la Dia. Lino Jannuzzi, però, sul Giornale di Napoli li indicherà come i “maggiori responsabili della debacle dello Stato di fronte alla mafia... una coppia la cui strategia, passati i primi momenti di ubriacatura per il pentitismo e i maxi-processi, ha approdato al più completo fallimento. Da oggi, o da domani, dovremo guardarci da due Cosa Nostra, quella che ha la Cupola a Palermo e quella che sta per insediarsi a Roma. E sarà prudente tenere a portata di mano il passaporto”.
Jannuzzi in seguito sarà senatore di Forza Italia per ben due legislature. In precedenza, tra l’altro - lo ricorda Caselli sul Fatto Quotidiano di qualche giorno fa - erano stati altri due futuri parlamentari di centrodestra ad attaccare Falcone dalle colonne del Giornale e del Giornale di Sicilia: Ombretta Fumagalli Carulli e Guido Lo Porto. Nei loro articoli il maxi-processo viene definito un “un processo-contenitore abnorme, un meccanismo spacciato come giuridico”, mentre i procedimenti genericamente contro Cosa nostra vengono bollati come “messinscene dimostrative, destinate a polverizzarsi sotto i colpi di quel po’ che è rimasto dello Stato di diritto”, “montature” allestite dai “registi del grande spettacolo della lotta alla mafia”.
“Un mediocre pubblicista” - Gli opinionisti non saranno teneri neanche quando Falcone darà alle stampe un libro - Cose di Cosa nostra - scritto alla fine del 1991 insieme a Marcelle Padovani. “Scorrendo il libro-intervista di Falcone, “Cose di cosa nostra”, s’avverte (anche per il concorso di una intervistatrice adorante) proprio questo: l’eruzione di una vanità, d’una spinta a descriversi, a celebrarsi, come se ne colgono nelle interviste del ministro De Michelis o dei guitti televisivi”, scriverà Sandro Viola in un’editoriale durissimo pubblicato da Repubblica il 9 gennaio del 1992. “A Falcone non saranno necessarie, ma a me servirebbero, invece, due o tre particolari illuminazioni: così da capire, o avvicinarmi a capire, come mai un valoroso magistrato desideri essere un mediocre pubblicista“, sarà la chiusa di quell’articolo, che oggi è quasi introvabile online. Come i nemici di Falcone: attivissimi quando il giudice era vivo, evaporati dopo il botto di Capaci. E in qualche caso diventati amici intimi del magistrato assassinato. Ma - ovviamente - soltanto post mortem.
*Il Fatto Quotidiano, 23 maggio 2017 (ripresa parziale - senza immagini).
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. -- MITO E STORIA, POLITICA E TEOLOGIA: "LUCIFERO!" E LA STELLA DEL DESTINO.8 aprile 2017MITO E STORIA, POLITICA E TEOLOGIA: "LUCIFERO!" E LA STELLA DEL DESTINO. Storiografia in crisi d’identità ...
 RENZO DE FELICE E LA STORIA DEL FASCISMO: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"! Alcune note
RENZO DE FELICE E LA STORIA DEL FASCISMO: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"! Alcune note
 I. BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI - II. ARNALDO MUSSOLINI E MADDALENA SANTORO.
I. BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI - II. ARNALDO MUSSOLINI E MADDALENA SANTORO.
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- EPIMENIDE, LA LEZIONE AMERICANA, E IL POPULISMO DELLA POST-VERITA’.14 febbraio 2017, di Federico La Sala
IL POPULISMO DELLA POST-VERITA’, EPIMENIDE, E LA LEZIONE ITALO-AMERICANA. In memoria di Italo Calvino***
Siamo nella post-verità da sempre, a quanto pare!
SIAMO PROPRIO CONCIATI MALE, MALISSIMO!
Dopo ventanni di berlusconismo stiamo ancora a commentare i giochini di mentitori istituzionalizzati. E a riflettere sulle “spine del C17 - spine nel fianco di un pingue potere” (https://www.alfabeta2.it/2017/01/21/c17-spine-nel-fianco-un-pingue-potere/).
DOPO IL 1917, E DOPO IL 1922, ANCORA NON SAPPIAMO NULLA DELLA “MORTE NERA” (cfr.: Massimo Palma,”Waler Benjamin, l’inquilino in nero; cfr.: https://www.alfabeta2.it/2017/01/11/walter-benjamin-linquilino-nero/) E DELLA MISTICA FASCISTA (cfr.: mia nota a “Infanzia salentina”, pagine del lavoro di Nicola Fanizza, “Maddalena Santoro e Arnaldo Mussolini” - https://www.nazioneindiana.com/2017/01/21/infanzia-salentina/) - E, NEMMENO, DEI PATTI LATERANENSI E TUTTO IL RESTO.
Tanto tempo, in un’isola del Mediterraneo, un tale chiamato EPIMENIDE (con questo nome è rimasto nella storia, come persona degna di essere ricordata per la sopravvivenza della stessa isola), indignato contro i suoi stessi concittadini (che evidentemente lo accusavano di chissà quali malefatte), fece il primo passo nella terra della post-verità, gridò infuriato: “Tutti i cretesi mentono”! Se molti risero, altrettanto molti lo applaudirono.
Qualche anno dopo, sempre in quell’isola, ci furono le elezioni: tra i partiti (quello che la storia non ci ha tramandato) comparve uno strano partito, con il nome “Forza Creta”, e il leader era proprio il vecchio EPIMENIDE!
CONQUISTATO IL POTERE LEGALMENTE, IL SUO GRIDO AI CRETESI CHE AVEVANO RISO DELLA SUA “BATTUTA” FU QUASI SIMILE A QUELLO DI BRENNO CONTRO I ROMANI SORPRESI NEL SONNO, ANZI, NEL SONNAMBULISMO: “GUAI AI VINTI”!
SOLO CHE A ROMA CI FURONO LE OCHE CHE SVEGLIARONO UN POCO TUTTI E I GALLI FURONO CACCIATI, MA A CRETA ALLA FINE NESSUNO PIU’ OSO’ RIDERE E ... “TUTTI I CRETESI MENTONO” ANCORA!!! A MEMORIA (E A VERGOGNA) ETERNA.
Federico La Sala
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. -- NORMALITA’. Come la la stampa statunitense raccontò l’arrivo del fascismo e del nazismo in Europa.4 febbraio 2017, di Federico La Sala
Normalità
di Giovanni De Mauro, direttore di Internazionale *
John Broich è uno storico statunitense che insegna alla Case Western Reserve university, in Ohio. Studiando materiale d’archivio e diversi saggi usciti negli ultimi anni, ha cercato di ricostruire in che modo la stampa statunitense raccontò l’arrivo del fascismo e del nazismo in Europa. Tra il 1925 e il 1932 sui giornali americani uscirono almeno 150 articoli che parlavano di Benito Mussolini. In quegli anni il regime era già chiaramente violento e autoritario, ma il tono degli articoli è neutro se non addirittura positivo. Nel 1928 il Saturday Evening Post pubblicò a puntate tutta l’autobiografia di Mussolini.
I giornali spiegarono che i fascisti avevano salvato l’Italia dagli estremisti di sinistra e avevano rilanciato l’economia. Il New York Times scrisse che il fascismo avrebbe fatto tornare l’Italia, tradizionalmente turbolenta, alla “normalità”. Il modo in cui la stampa descrisse Mussolini ebbe un’influenza su come poi raccontò l’arrivo al potere di Adolf Hitler, definito nei giornali americani il “Mussolini tedesco”. Il leader nazista venne dipinto come una macchietta, che urlava in modo ridicolo frasi senza senso. “Ricorda Charlie Chaplin”, scrisse Newsweek. “Sembra una barzelletta”, è “volubile” e “insicuro”, scrisse Cosmopolitan.
Quando diventò cancelliere, nel 1933, molti commentatori sostennero che non sarebbe durato a lungo o che, una volta al potere, avrebbe assunto toni più moderati. “Hitler ha il sostegno di elettori impressionabili”, scrisse il Washington Post. Ora che è al governo “diventerà evidente all’opinione pubblica tedesca la sua inconsistenza”.
Tranne poche eccezioni, alla fine degli anni trenta quasi tutti i giornalisti statunitensi si erano resi conto del loro errore di valutazione. Dorothy Thompson, che nel 1928 aveva definito Hitler un uomo di “sorprendente insignificanza”, nel 1935 ammise che “nessun popolo riconosce un dittatore in anticipo”, perché “non si presenta alle elezioni con un programma dittatoriale” e “si definisce uno strumento della volontà nazionale”. E aggiunse: “Quando un dittatore arriverà da noi, di sicuro sarà uno dei nostri, e starà dalla parte di tutto quello che è tradizionalmente americano”.
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- LA VERGOGNA DI PARLARE SENZA VERGOGNA (di Tullio De Mauro)6 gennaio 2017, di Federico La Sala
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- De Mauro, la lingua batteva dove l’Italia duole ancora (di Giuseppe Conte)6 gennaio 2017, di Federico La Sala
- RILEGGERE SAUSSURE. UN "TRATTATO TEOLOGICO-POLITICO" RIDOTTO A UN BANALE "CORSO DI LINGUISTICA GENERALE"!!! Un omaggio e un appello a Tullio De Mauro.
- RILEGGERE SAUSSURE -- ALFABETO - TULLIO DE MAURO. Italia, Repubblica popolare fondata sull’asineria (Intervista -Antonello Caporale).
De Mauro, la lingua batteva dove l’Italia duole ancora
Dalla lotta contro l’analfabetismo negli anni ’60 a quella contro gli anglismi e le volgarità dei politici
di Giuseppe Conte *
Tullio De Mauro è stato un protagonista della vita italiana dell’ultimo mezzo secolo, nel campo della ricerca scientifica e universitaria, e poi nel campo della politica e della organizzazione culturale.
Insigne linguista, ministro della Pubblica Istruzione, Presidente della Fondazione Bellonci e del comitato direttivo del Premio Strega: una carriera tutta nel cuore del potere, ma gestita con una certa indipendenza di giudizio, una vita costellata di successi, ma non senza drammi, se si pensa alla uccisione del fratello Mauro De Mauro, giornalista all’Ora di Palermo, rapito e ucciso dalla mafia nel settembre del 1970.
Il giovane De Mauro si laurea in Lettere Classiche e intraprende subito l’attività universitaria, insegna filosofia del linguaggio e glottologia, prima di arrivare alla cattedra di Linguistica generale presso l’Università La Sapienza di Roma. Sua opera importante è la curatela completa, introduzione, traduzione e commento, al Trattato di linguistica generale di Ferdinand De Saussure, nel 1967, che contiene i fondamenti essenziali di quello strutturalismo che stava per esplodere negli studi non solo linguistici, ma in tutto il campo della critica letteraria, condizionando una intera stagione molto fervida di novità, anche se presto risolta in niente più che una moda. De Mauro, nonostante questo suo lavoro così importante, non fu uno strutturalista. Non partecipò alla appena successiva ondata semiologica. I suoi interessi di studioso lo portano ad ancorare la linguistica alla società e alla storia. Lo testimonia il suo saggio Storia linguistica dell’Italia unita, uscito nel 1963, ripreso molti anni dopo in Storia linguistica dell’Italia repubblicana dal 1946 ai nostri giorni, pubblicato nel 2014 da Laterza. Oltre a tanti altri saggi, che presto virano dal linguistico al sociologico, bisogna ricordare la sua direzione del Grande dizionario italiano dell’uso, in otto volumi (UTET, 2007).
Tullio De Mauro fu risoluto nel combattere l’analfabetismo di ritorno, in un Paese dove pare che soltanto il 20 per cento delle persone adulte siano in grado di seguire un discorso che presenti anche minime difficoltà semantiche e di compiere operazioni matematiche un po’ al di sopra di quelle elementari. Nonostante la difesa dell’italiano, De Mauro non fu mai contrario ai dialetti, li ritenne una ricchezza e una risorsa. Se nel 1974 il 51 per cento degli italiani parlavano il dialetto, oggi la percentuale è scesa al 5. Ma in compenso sono aumentati quelli che lui chiama gli «alternanti», cioè coloro che usano indifferentemente italiano e dialetto, passando dal 18 per cento del 1955 al 44 del 1995. Questa alternanza può diventare miscela, carburante per nuove forme di espressività. Forse come nel «vigatese», forma ibrida di italiano e siciliano di Andrea Camilleri, con cui non a caso De Mauro firma un volume.
De Mauro interviene anche su fenomeni del linguaggio tipici del nostro tempo. Per esempio, prende in esame il turpiloquio dei politici recenti, o la smania di ostentare frequenti e inappropriati anglismi, e giudica entrambi i fenomeni come prove della scarsa capacità di usare al meglio le risorse di una lingua come l’italiano, complessa sin dai tempi di Dante (che per altro nell’«Inferno» non disdegna il turpiloquio, ma certo con una potenza e necessità espressiva che le parolacce udite in Parlamento non hanno). La storia linguistica diventa per De Mauro storia di una comunità e del suo evolversi. Nella prefazione a Le parole di Einstein. Comunicare scienza tra rigore e poesia, di Daniele Gouthier e Elena Ioli, De Mauro scrive: «Per Einstein il richiamo al linguaggio comune a ogni essere umano forniva anzitutto un argomento decisivo per affermare la natura profondamente sociale della conoscenza e della cultura». Così, il genio della fisica offre al linguista italiano una conferma delle proprie posizioni.
Era forse fatale che la piega sociologica presa dagli interessi di De Mauro, oltre la sua disposizione all’impegno, lo portasse non soltanto verso la pubblicistica militante, su organi di stampa come Il Mondo, Paese Sera, L’Espresso, ma anche verso la politica vera e propria. Nel 1975 De Mauro è eletto nel consiglio regionale del Lazio, nelle liste del Pci, nel 1976 diventa assessore alla cultura e lo rimane sino al 1978. Dopo un ventennio, dalla ribalta regionale passa a quella nazionale, diventando ministro dell’Istruzione nel secondo governo Amato, dall’aprile 2000 al giugno 2001. Troppo poco per lasciare un vero segno in un campo come quello della scuola, dove si susseguono i disastri, e dove per la stessa ammissione di De Mauro quelle che il governo Renzi ha chiamato riforme sono niente più che «provvedimenti collaterali».
Ultimo viene lo Strega. L’impressione è che lì De Mauro abbia svolto il proprio ruolo cercando meritoriamente di cambiare qualcosa. Ma senza quella vera passione che cambia le cose davvero.
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. -- La post-verità della Ministra dell’Istruzione e l’Etica della Ricerca (di Roberta De Monticelli)23 dicembre 2016, di Federico La Sala
LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE.
La post-verità della Ministra dell’Istruzionedi Roberta De Monticelli (Libertà e Giustizia, 17 dicembre 2016)
E’ vero che “diploma di laurea” non vuole dire “laurea”? E’ vero che scrivere che si possiede un diploma di laurea che non si possiede è soltanto “una leggerezza”? Ed è giusto che proprio una persona che una laurea non ce l’ha sia a capo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, cioè a capo di un’istituzione chiamata a governare e decidere della vita, della fatica, delle speranze e del merito di tutti coloro cui lauree, diplomi, master, dottorati, TFA, abilitazioni e concorsi non bastano a esercitare la professione per cui studiano da decenni?
Ma soprattutto, è giusto che la massima autorità sulla scuola pubblica, sulle regole e le istituzioni che inquadrano la trasmissione e la ricerca del vero, invece di presentare un onesto ancorché modesto curriculum, lo falsifichi? E che nessuno batta ciglio di fronte a un fatto come questo? E’ accettabile che anzi, se qualche isolata voce mormora la sua perplessità, sia lo stesso capo del governo a dichiarare pubblicamente solidarietà al suo ministro, invece di scusarsi con i cittadini e pregare il ministro di dare le dimissioni?
E’ vero, siamo nel Paese europeo che più fatica a restare a livelli di minima decenza quanto al numero di laureati: e allora, è un bene che al vertice del ministero che dovrebbe occuparsi di questa piaga, una delle vere radici del nostro declino, ci sia qualcuno che non solo non supera il livello base delle statistiche, ma pretende di rimediare la verità col trucco, come Lucignolo, come Pinocchio, come un personaggio di Alberto Sordi o di Totò? E’ un buon esempio per i nostri scolari, i nostri studenti, i nostri figli? Saprà rendere ancora più buona la “buona scuola”?
MIUR vale Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. E’ l’acronimo del ministero che, come studiosi, docenti e anche semplicemente genitori, ci riguarda più da vicino. Un acronimo che ritorna negli incubi di quelli di noi che hanno recentemente dovuto collaborare alla modifica dell’offerta formativa della propria Facoltà o all’aggiornamento del proprio cv sulla pagina nazionale, lottando con idiosincrasie elettroniche e burocrazie mentali misteriosamente tenaci nei decenni.
Resta il fatto che questo Ministero governa la vita di una delle grandi “agenzie di verità” che una società democratica ha interesse a mantenere indipendenti dal potere politico. E forse, dal nostro punto di vista almeno, la più importante. Quella che ha come valore di riferimento la conoscenza da trasmettere alle future generazioni e quella da ricercare. L’informazione che circola attraverso l’insieme dei media e delle altre grandi piazze del dibattito pubblico, come i social network, è l’agenzia di verità necessaria al dibattito pubblico, e quindi al secondo pilastro di una democrazia, accanto a quello istituzionale degli organismi di deliberazione e decisione delle politiche. E sappiamo che questa agenzia di verità in Italia non è messa molto bene, secondo certe classifiche il grado di indipendenza dei media relega l’Italia agli ultimi posti fra le nazioni, civili o meno.
I tribunali civili e penali e tutto il macchinario che vi si connette costituiscono l’agenzia di verità che rende possibile l’esercizio della giustizia. E anche qui, coi processi che si trascinano per decenni fino a prescrizione della verità, non siamo messi benissimo. Ma le riforme di quelle due agenzie sono cosa tanto necessaria quanto complicata - non a caso subito caduta dalle agende del governo dimissionario, come di quelli precedenti.
La solidarietà dichiarata a un ministro che non possiede un curriculum onesto e per di più lo difende, invece, è un paradosso gigantesco, almeno quanto quello, moralmente forse ancora più tragico e meno ridicolo, di quel Presidente del CNR recentemente nominato dal precedente ministro, che siccome presiede anche la Commissione per l’Etica della Ricerca, si è per prima cosa scatenato, pur con qualche incertezza grammaticale, contro la Senatrice della Repubblica e scienziata Elena Cattaneo, quando lamentava l’opacità e l’arbitrio nella gestione governativa del progetto Human Technopole: «Guai a chi parla dell’etica superiore di tutti perché questo era Robespierre....il dovere nostro è di fare andare avanti l’Italia. - Mah! Senza pensare a .... a principi etici».
Una bella accoppiata, una bella successione, al Ministero che più di ogni altro incide sull’educazione dei “sovrani di domani”, e quindi sulla qualità di una democrazia. Saremo anche nell’epoca della post-verità: ma quando è troppo, è troppo.
Roberta De Monticelli
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. -- IL PARADOSSO DELLA COSTITUZIONE. La Carta strumentalizzata (di Giovanni De Luna)9 dicembre 2016, di Federico La Sala
IL PARADOSSO DELLA COSTITUZIONE:
LA ’NAZIONALIZZAZIONE’ DEL MENTITORE
- UNITÀ D’ITALIA E FOLLIA: EMERGENZA LOGICO-POLITICA EPOCALE. PER UN CONVEGNO E UNA RIFLESSIONE SUL CONCETTO DI ’UNITA’ E DI SOVRANITÀ (SOVRA-UNITÀ). Materiali sul tema
- L’ITALIA (1994-2016), TRE PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA SENZA "PAROLA", E I FURBASTRI CHE SANNO (COSA SIGNIFICA) GRIDARE "FORZA ITALIA". In memoria di Sandro Pertini e di Gioacchino da Fiore, alcuni appunti per i posteri
Il paradosso della Costituzione
Difesa oggi dagli antipartito, 70 anni fa nel mirino degli “apolitici” dell’Uomo Qualunque. Bobbio li definiva il “pantano in cui finirà per impaludarsi il rinnovamento democratico”
di Giovanni De Luna (La Stampa, 09.12.2016)
Il paradosso del referendum del 4 dicembre è questo: la Costituzione del 1948 è stata vittoriosamente difesa dalle forze politiche che ne hanno sempre criticato il carattere «comunista» (Berlusconi e la Lega) o denunciato la fissità «talmudica» (così Grillo, nel 2011 sul suo blog). Il paradosso è anche più evidente se lo si confronta con le polemiche che - tra il 1945 e il 1947 - accompagnarono il varo della Carta Costituzionale.
Allora, il passaggio dalla dittatura alla democrazia fu accolto con sospetto e diffidenza da una larga fetta dell’opinione pubblica, abituata da venti anni di fascismo a considerare la politica una pratica «inconcludente» e incline a guardare agli uomini dei partiti con la diJffidenza dovuta a chi svolgeva «non un’attività disinteressata al servizio della collettività e della nazione, cercando invece di procurare potere, ricchezza, privilegi a sé stesso, alla propria famiglia, fazione, clientela elettorale». Queste frasi - tratte da uno dei tanti rapporti dei carabinieri che allora funzionavano come oggi i sondaggi di opinione - fotografavano un diffuso sentimento «antipartito» che si tradusse negli impetuosi successi elettorali dell’Uomo Qualunque.
La nuova Repubblica
Anche tra le file del Partito d’Azione - al quale oggi viene attribuita la paternità della Costituzione - all’inizio la forma partito era vista con sospetto. La nuova Repubblica che nasceva dalla Resistenza avrebbe dovuto puntare direttamente sugli uomini (con un rinnovamento della classe dirigente) e sulle istituzioni (con un allargamento della partecipazione politica fondata sulle autonomie e sull’autogoverno). Lo scriveva un giovane Norberto Bobbio (non aveva ancora 40 anni): «Una responsabilità pubblica ciascuno può assumerla dentro o fuori dei partiti, secondo le sue capacità e le sue tendenze, e magari meglio fuori che dentro».
Ma proprio i suoi articoli di allora sul quotidiano Giustizia e Libertà ci consentono oggi di capire che intorno alla Costituzione la partita si giocò essenzialmente tra la politica e l’antipolitica, meglio - come si diceva a quel tempo - tra gli «apolitici» e gli uomini dei partiti. Il qualunquismo nascondeva dietro la maschera della «apoliticità» e dell’«indipendenza» una lotta senza quartiere ai partiti del Cln, giudicati come il lascito più significativo e più pericoloso della Resistenza. BJobbio lo diceva esplicitamente: «gli indipendenti [...] non sono né indipendenti, né apolitici. Sono politici, ecco tutto, di una politica che non è quella dei comitati di liberazione o del fronte della Resistenza».
«Vizi tradizionali» italiani
L’«apoliticismo» (per Bobbio «l’indifferenza o addirittura l’irrisione per ogni pubblica attività in nome dell’imperioso dovere di lavorare senza ambizioni né distrazioni per la famiglia, per i figli e soprattutto per sé») si traduceva in una critica alla «politica di partito» che, scriveva, «lusinga e quindi rafforza inveterate abitudini, vizi tradizionali del popolo italiano, incoraggia gli ignavi, fa insuperbire gli ottusi e gli inerti [...], offre infine a tutti gli apolitici un motivo per allearsi, facendo di una folla di isolati una massa organica, se non organizzata, di persone che la pensano allo stesso modo e hanno di fronte lo stesso nemico [...] generando di nuovo quel pantano in cui finirà per impaludarsi lo sforzo di rinnovamento democratico dello Stato italiano».
Per gli uomini della Resistenza il nemico era quindi diventato quella «sorta di alleanza dei senza partito», «scettica di quello scetticismo che è proprio delle classi medie italiane», alimentata «da un dissenso di gusti, un disaccordo di stati d’animo, uno scontro di umori, una gara di orgogli, dai quali null’altro può derivare che invelenimento di passioni, impacci all’azione ricostruttrice».
La Carta strumentalizzata
Sembra che Bobbio parli proprio di quell’estremismo di centro che caratterizza oggi una parte della società italiana e un movimento come quello di Grillo. Allora fu un passaggio decisivo per l’approdo a una sua convinta adesione alla «democrazia dei partiti», frutto di una riflessione approfondita su un «modello», quello inglese, che, partendo dai capisaldi fondamentali delle origini (la divisione dei tre poteri, la monarchia costituzionale e il governo parlamentare), era stato in grado di rinnovarsi, spostando progressivamente verso il basso, verso il corpo elettorale, rappresentato e diretto dai partiti, il baricentro del sistema politico.
Le cifre del referendum del 4 dicembre ci dicono come l’elettorato dei movimenti più tipicamente antipartito (Cinque Stelle e Lega) abbia votato massicciamente per il No (l’80%), affiancato da una ristretta fascia di elettori appartenenti al Pd (23%) o alle varie sigle accampate alla sua sinistra. Essere salvata da quelli che volevano affossarla, adesso come nel 1948: da questo duplice paradosso cronologico la Costituzione esce come schiantata, degradata a puro pretesto, con una torsione innaturale che la espone, in futuro, a ogni tipo di uso strumentale.
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. -- RECALCATI ALLA LEOPOLDA. Il Telemaco, il messia e la Costituzione (di Sarantis Thanopulos).20 novembre 2016, di Federico La Sala
- GENITORI, FIGLI, E FORMAZIONE: AL DI LA’ DEL FALLIMENTO, COSA RESTA DEL PADRE? PER MASSIMO RECALCATI, OBBEDIENTE A LACAN, RESTA ANCORA (E SEMPRE) LA LUNGA MANO DELLA MADRE.
- "PERVERSIONI" di Sergio Benvenuto. UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LA’ DELL’EDIPO
- RIPENSARE L’EUROPA. PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!! FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.
Verità nascoste.
Il Telemaco, il messia e la Costituzione
di Sarantis Thanopulos (il manifesto, 19.11.2016)
Massimo Recalcati nell’elogiare, alla Leopolda, Matteo Renzi, ha accusato la sinistra del No di essere masochista, paternalista e di odiare la giovinezza. Accuse fondate su luoghi comuni.
Un discorso aforistico, privo di argomenti, teso a screditare l’avversario piuttosto che ad esprimere una propria opinione sui quesiti referendari.
L’andazzo è proprio questo: la grande maggioranza degli italiani nel referendum prossimo voterà pro o contro Renzi, a prescindere dalla valutazione di una riforma che modificherà in modo sostanziale la costituzione italiana.
La personalizzazione del conflitto politico ha finito per espropriarci della cura nei confronti delle regole fondamentali della nostra convivenza democratica. Si è fatta strada una corrente di «eccezione dalla costituzione», che mentre aspira formalmente a riformarla, di fatto crea il clima di una sua sospensione sul piano emotivo.
Questo tipo di sospensione dell’ordinamento costituzionale è il più pericoloso. La restrizione diretta e apertamente autoritaria delle garanzie costitutive dei nostri diritti, crea opposizione e ribellione.
La loro sostituzione con l’affidamento regressivo all’«uomo della provvidenza», da una parte sposta l’attenzione su un quesito fuorviante - se costui è quello «vero» o quello «falso» - e dall’altra favorisce la deresponsabilizzazione.
La nota identificazione del premier con Telemaco, nella versione ideata da Recalcati come riparazione (impropria) dell’assenza del padre, è espressione di un vissuto di delegittimazione collettiva. Di questa delegittimazione, della cui origine non è responsabile, Renzi si è costituito come l’interprete più importante.
L’ha fatto per negazione, cioè oscurandola: più incerta sente la propria legittimità, più insiste sulla delegittimazione degli altri.
La rottamazione pura e semplice di una classe politica inadeguata non produce di per sé legittimazione. Se resta come unica opzione perpetua il senso di delegittimazione. Infatti, Renzi, il rottamatore, si identifica con Telemaco: un figlio reso illegittimo dall’assenza del padre e dalla solitudine, vedovanza «bianca», della madre (le due condizioni sono inscindibili).
Dimentica che il ritorno della legge nel regno di Itaca, non è opera di Telemaco. Deriva dal ritorno di Ulisse nel letto coniugale, dal suo riconoscimento e legittimazione come uomo e come padre dall’amore di Penelope.
Le regole «costituzionali» che garantiscono la buona gestione delle relazioni familiari, sono fondate sulla capacità dei genitori di essere soggetti paritari nel loro legame di desiderio. I figli che rottamano il padre, cercando di sostituirlo nell’amore della madre, finiscono per assumere un ruolo messianico.
In modo analogo al governo familiare, il governo della Polis non può essere affidato a un Telemaco capovolto nel suo significato, che non sa attendere il suo tempo. Aspettare il momento giusto per sentirsi adulti - l’accesso alla piena comprensione della congiunzione erotica dei genitori e della sua problematicità - è il senso vero dell’attesa del padre in Odissea.
Un leader capace di identificarsi con Penelope e Ulisse, cioè con il senso di corresponsabilità che costituisce le relazioni cittadine in termini di condivisione e di scambio, è molto più affidabile di un figlio che si sostituisce ai genitori. Costui si imprigiona nel destino del redentore e, diversamente da Telemaco di Omero, si considera il frutto di una unione spirituale tra un padre ideale e una madre/figlia vergine. Promuove la deresponsabilizzazione che gli ha assegnato la sua funzione immaginaria e si/ci illude di poter farcela.
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- NEOLOGISMO 2016: "POST-VERITà", "POST-TRUTH" (Oxford Dictionaries).17 novembre 2016, di Federico La Sala
Per dizionario Oxford ’post-verità’ è parola del 2016
Scelta fatta sullo sfondo di elezioni Usa e referendum Brexit
di Redazione Ansa *
LONDRA E’ ’post verità’, in inglese ’post-truth’, il neologismo dell’anno secondo gli esperti di Oxford Dictionaries. La scelta e’ quella di un’espressione che secondo un comitato di esperti ha segnato profondamente la scena politica internazionale durante il 2016, con riferimento in particolare alle polemiche legate alla campagna referendaria britannica sfociata a giugno nella vittoria della Brexit (il divorzio dall’Ue) e a quella americana per le presidenziali appena culminata nel trionfo di Donald Trump.
L’annuncio è arrivato in queste ore, riporta la Bbc: ’post-truth’ ha prevalso in una short list finale che comprendeva anche termini come ’Brexiteer’ (sostenitore della Brexit). Si tratta, ha sentenziato Casper Grathwohl, fra i curatori dei prestigiosi dizionari editi a Oxford, "di una di quelle parole che definiscono il nostro tempo".
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- REFERENDUM. Dalla psicopatologia delle élite alla pedagogia costituzionale (di Luca Verzichelli - "Il Mulino").10 novembre 2016, di Federico La Sala
- CRISI COSTITUZIONALE DI LUNGA DURATA. DUE PRESIDENTI GRIDANO: FORZA ITALIA!!! .... E IL LUNGO SONNO DELLA RAGIONE COSTITUZIONALE DELLE ISTITUZIONI E DEGLI INTELLETTUALI.
 BERLUSCONI E LA "MEZZA" DIAGNOSI DEL PROF. CANCRINI. Il Narcisismo e l’uso lucidissimo come arma politica dell’"antinomia del mentitore" - "L’Italia è il mio Partito": "Forza Italia"!!!
BERLUSCONI E LA "MEZZA" DIAGNOSI DEL PROF. CANCRINI. Il Narcisismo e l’uso lucidissimo come arma politica dell’"antinomia del mentitore" - "L’Italia è il mio Partito": "Forza Italia"!!!
Referendum Costituzionale Riforme
sì/no: un voto decisivo
Dalla psicopatologia delle élite alla pedagogia costituzionale
di Luca Verzichelli (il Mulino, 09.11.2016)
Può piacere o meno, ma che la discussione attorno al referendum abbia assunto fin dalla sua fase iniziale i toni di un confronto, in qualche modo autodistruttivo, tra i vari segmenti delle élite, è sotto gli occhi di tutti. Se molti politici tendono a litigare agitando con fare non sempre avveduto concetti importanti ma assai delicati come governabilità e responsabilità, gli opinion maker fanno eco con toni anche più grevi. I protagonisti dei social media, e anche il residuo manipolo di praticanti dell’antico ma ancora in auge wrestling televisivo completano il quadro, alimentando di fatto la patologia autodistruttiva della nostra classe dirigente.
Tale azione si appoggia all’uso di strumenti distribuiti in egual misura tra i competitori, sia pure con dosaggi diversi: chi insiste sulla contrapposizione tra vecchio e nuovo, chi continua a puntare sull’irrisione sistematica o sulla presunta inadeguatezza culturale degli avversari, chi ricorre a espressioni popolari per solleticare gli istinti più tipici della mentalità populista, come la connaturata sfiducia nella capacità riformatrice dei «politici di professione».
Che le élite politiche italiane siano un disastro lo diciamo da un po’. E non è neppure una novità che le campagne elettorali siano spesso un disastro. Se pensiamo a una campagna come quella appena chiusa per l’elezione del presidente negli Stati Uniti, incentrata a lungo sugli scandali e sulle inadeguatezze dei candidati, se non sulle pratiche loro, dei loro parenti e dei loro amici, non sembriamo messi poi troppo male: grazie al buon senso di molti - inclusi molti amici del Mulino - una parte della discussione rimane sul merito della riforma e comunque su valutazioni politiche complessive informate e ponderate.
Tuttavia, si può e si deve fare di più quando parliamo di Costituzione. La classe politica, intanto, deve smettere di guardarsi allo specchio e uscire dalla palude delle bassezze, per non fare la figura di un insieme di free rider che restituiscono al cittadino la responsabilità di scelte complesse e tecniche senza nemmeno informarlo doverosamente sulle proposte.
Ma ancor più dannosa è l’auto-celebrazione degli esponenti dell’élite socio-culturale i quali, pur nel tentativo lodevole di dare un contributo alla scelta pubblica, finiscono per mettere in ridicolo con le proprie approssimazioni anche i progetti della propria parte politica. Roberto Escobar ha evidenziato la contraddizione di una comunicazione basata sul ticket politica-società civile, dove la società civile, rappresentata dal difensore del brand costituzionale in tempi berlusconiani, ruba la scena anche al riformatore, paventando gli scenari più foschi in caso di fallimento della riforma. Mi chiedo se Benigni non avesse dovuto prefigurare alcune delle implicazioni che discendono da questo operato. Così come mi chiedo se alla fine non sia imbarazzante per uno storico dell’arte autorevole come Montanari costruire uno spot elettorale leggendo in un’opera d’arte l’immagine della ribellione nei confronti di una leadership telecomandata dalla finanza internazionale.
Insomma, quando la comunicazione scivola su questo piano, viene il sospetto che anche l’autonomia di giudizio dell’intellettuale sia entrata in riserva. Invece di una «visione» da prestare alla propria parte politica ne esce fuori un ulteriore messaggio personalizzato al proprio piccolo popolo di follower.
Mi si dirà che in tempi di democrazia senza partiti è di questo che si ciba l’opinione pubblica. Ok. Tuttavia, parlando di Costituzione e di referendum, un lavoro intellettuale che reitera la mera partigianeria, senza dare agli elettori un minimo elemento per fugare i loro dubbi, non mi pare un grande aiuto.
Non sarebbe meglio spendere queste ultime settimane di campagna ad ascoltare chi ha davvero qualcosa da dire nel merito? Sarebbe possibile inserire negli spiegoni televisivi gli elementi descrittivi alla base delle decisioni sulle quali dobbiamo esprimerci, magari partendo dal funzionamento attuale del bicameralismo, oppure introducendo qualche elemento oggettivo di analisi comparata? Inoltre, sarebbe auspicabile rinunciare alla logica del «ring» e ai contradditori più inutili, per lasciare posto a illustrazioni sinottiche sui pro e i contro, commentate ovviamente dai politici e da esperti con capacità dissertative adeguate.
Con una tale strumentazione, e con la certezza che si tratta di un voto su una proposta di manutenzione costituzionale (che possiamo naturalmente valutare nei modi più diversi), forse focalizzeremo meglio la vera partita che stiamo giocando. A seconda del livello di interesse e delle competenze, potremo valutare in coscienza il merito politico della riforma, e produrre un qualche «spacchettamento», necessario per calcolare la somma algebrica di migliorie e peggioramenti. Ci sentiremo forse un po’ meno decisivi per le sorti del Paese, rispetto a quanto ci hanno detto molti assertori del «sì» e del «no», ma alleggeriti nel nostro stato d’animo e coscienti che a noi adesso spetta fare questo e solo questo. Saremo inoltre meno sensibili al ciarpame mediatico e più interessati a imparare qualcosa sulla nostra costituzione, apprezzando le analisi approfondite come quelli ospitate dal «Mulino». Nel contempo, ci impratichiremo con un esercizio, davvero utile, di coinvolgimento civico.
Spostare il dibattito dalla psicopatologia delle élite alla pedagogia costituzionale sarebbe un primo risultato importante del referendum.
- CRISI COSTITUZIONALE DI LUNGA DURATA. DUE PRESIDENTI GRIDANO: FORZA ITALIA!!! .... E IL LUNGO SONNO DELLA RAGIONE COSTITUZIONALE DELLE ISTITUZIONI E DEGLI INTELLETTUALI.
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- USA 2016. Cerchiamo di capire cosa è successo (e cosa succederò): "Nazional-Operaismo e guerra razziale".10 novembre 2016, di Federico La Sala
- LA STATUA DELLA LIBERTA’ DEGLI U.S.A. - CON LA SPADA SGUAINATA: "GUAI AI VINTI"!!! LA LEZIONE DI FRANZ KAFKA, IL MAESTRO DELLA LEGGE: RIPENSARE L’AMERICA. E il sogno del "nuovo mondo"!!!
- UNA DOMANDA ALL’ITALIA: MA COME AVETE FATTO A RIDURVI COSI’?! UN "BORDELLO STATE": UN PAESE BORDELLO. Una nota di Maurizio Viroli (dagli Usa) - e una risposta (agli americani, dall’Italia) di Federico La Sala
- POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. Materiali sul tema
Nazional-Operaismo e guerra razziale
di Franco Berardi Bifo*
Cerchiamo di capire cosa è successo. Come fece nel 1933, la classe operaia si vendica di chi l’ha presa per il culo negli ultimi trent’anni. Uno schiavista che per sua stessa ammissione non ha mai pagato le tasse, un violentatore seriale è diventato Presidente degli Stati Uniti d’America. Hanno votato per lui coloro che sono stati traditi dalla sinistra, in America come in Europa.
La più urgente azione da compiere ora sarebbe linciarli, coloro che hanno aperto la strada al fascismo mettendosi al servizio del capitale finanziario e della riforma neo-liberale: Bill Clinton e Tony Blair, Massimo d’Alema e Matteo Renzi, Giorgio Napolitano, François Hollande, Manuel Valls e Sigmar Gabriel. Chiamiamoli per nome i mascalzoni che per cinismo e per imbecillità hanno consegnato alle grandi corporation finanziarie il governo sulla nostra vita, e hanno aperto la porta al fascismo che ora dilaga, alla guerra civile globale alla quale ora non c’è più modo di porre argini.
Nel Regno Unito e in Polonia, in Ungheria e in Russia e ora negli Stati Uniti, ha vinto il Nazional-Operaismo. La classe operaia bianca, umiliata negli ultimi trent’anni, ingannata dalle promesse riformiste dei suoi rappresentanti, impoverita dall’aggressione finanziaria, porta uno schiavista violentatore alla Casa Bianca.
Dato che la sinistra ha tolto dalle mani dei lavoratori le armi per difendersi, ecco la versione fascista e razzista della lotta di classe: Wall Street è riuscita a sconfiggere Bernie Sanders alle primarie, e ora un uomo del Ku Klux Klan sconfigge la rappresentante di Wall Street.
I prossimi dieci anni saranno tremendi, è bene saperlo. Il crollo della globalizzazione capitalista è l’inizio di una guerra nella quale poco di ciò che chiamammo civiltà è destinato a sopravvivere. «Zero Hedge», il giornale online in cui scrivono gli intellettuali trumpisti ha pubblicato qualche giorno fa un articolo che sintetizza benissimo quello che sta accadendo e anticipa quello che accadrà:
È la classe media demoralizzata e disillusa che ha perduto di più, depredata dalla Federal Reserve, con salari che languiscono dagli anni Ottanta. Gli interessi a zero hanno punito lavoratori pensionati e risparmiatori mentre hanno beneficiato i milionari della finanza. Il prossimo collasso finanziario, che è dietro l’angolo provocherà una guerra di classe nelle strade.
Trump ha vinto perché rappresenta un’arma nelle mani dei lavoratori impoveriti, dato che la sinistra li ha consegnati disarmati nelle mani del capitale finanziario. Purtroppo si tratta di un’arma che si rivolgerà presto contro i lavoratori stessi, e li porterà a una guerra razziale. L’altra faccia dell’Operaismo trumpista è infatti il Nazionalismo bianco. Scrive ancora «Zero Hedge»: «Alle elezioni le persone bianche, sposate, rurali e religiose si scontrano contro le persone nere, senza padre, e non religiose».
La minaccia di guerra razziale è del tutto esplicita nelle posizioni del Nazional-Operaismo americano. Sconfitti sul piano sociale dal capitalismo finanziario, gli operai bianchi si riconoscono come razza degli sterminatori e degli schiavisti.
Il movimento Black Lives Matter sponsorizzato da Soros ha creato il caos nelle città americane, spingendo giovani neri a uccidere ufficiali di polizia, e portando all’estremo il programma di riparazioni ispirato da Obama. Ma se provano a uscire dai loro ghetti urbani creati dai democratici e se provano a venire nelle zone dell’America rurale incontreranno i possessori legali di armi che gli spareranno addosso. La guerra razziale si concluder presto e non c’è dubbio su chi sarà il vincitore. I bianchi moderati e conservatori sono stufi marci del programma liberal e del vittimismo nero. La risposta che daremo è: fatela finita di fare figli fuori dal matrimoni, andate a lavorare, educatevi. La vita è dura. Imparatelo. Nessuno vi deve nulla.
Aspettando la seconda guerra civile americana, in questi giorni mi trovo a Mosca per una conferenza. Mentre parlavo in una galleria d’arte ai fighetti come me e come i lettori di Operaviva, fuori, nel gelido nevischio della metropoli il popolo russo festeggiava. Cosa? Cosa si celebra, e si ricorda all’inizio del mese di Novembre in Russia? Non la rivoluzione sovietica del 1917 ma la cacciata dei polacchi nel 1612. Il fascismo russo ha salutato l’erezione della statua di Vladimiro il savio, cristianizzatore della patria 18 metri di altezza. Molte donne e molti bambini vestono con uniformi militari e inneggiano ai peggiori assassini che la storia ricordi, da Ivan il Terribile a Stalin il massacratore di comunisti.
La razza bianca in armi prepara un finale spaventoso per la storia spaventosa del colonialismo moderno. Riusciremo a sfuggire a questo finale già scritto nei libri dell’Armageddon che il capitalismo finanziario ha preparato e cui la sinistra riformista ha aperto la strada?
* Ha aderito alla campagna Facciamo Comune insieme. Questo articolo è stato pubblicato su operaviva.info
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. -- USA 2016. Trump presidente, l’imprenditore-showman che ha distrutto i politici e convinto gli americani (di F. Rampini).9 novembre 2016, di Federico La Sala
- UNA DOMANDA: MA COME AVETE FATTO A RIDURVI COSI’?! Una nota di Maurizio Viroli (dagli Usa) - e una risposta (agli americani, dall’Italia)
Trump presidente, l’imprenditore-showman che ha distrutto i politici e convinto gli americani
Il ritratto - Miliardario di famiglia, ha sempre curato più l’immagine che la sostanza. Berlusconi tra i modelli, la politica come il luogo in cui appagare il suo ego smisurato. Le tante ombre della sua carriera non hanno minimamente pesato davanti al messaggio-chiave, quello che gli elettori atterriti dagli effetti della globalizzazione volevano sentirsi dire: "L’establishment vi ha tradito"
dal nostro corrispondente FEDERICO RAMPINI *
NEW YORK - Il Silvio Berlusconi americano. Molti lo hanno descritto proprio così, anche fra i più brillanti analisti dei media Usa, compresi alcuni opinionisti repubblicani. E’ proprio da qui che bisogna partire. Donald Trump, appena eletto presidente degli Stati Uniti, non ha inventato quasi nulla - solo un brillante show televisivo, The Apprentice - ma ha studiato modelli vincenti. Berlusconi è uno di quelli, altri più locali sono Ronald Reagan, Arnold Schwarzenegger, Jesse Venture (in decrescendo).
Grande imprenditore, geniale uomo d’affari. O affarista mediocre, truffatore seriale, bancarottiere, evasore fiscale. Doctor Jekyll e Mister Hide, insomma. La verità su Trump è sempre sfuggente. Come immobiliarista, non si è fatto da solo: ha ereditato una discreta fortuna dal padre, e secondo le stime più accurate della sua fortuna (molto poco trasparente) non avrebbe aggiunto molta ricchezza a quella paterna. Le "torri" (grattacieli) Trump che si vedono a New York, a Las Vegas, in Florida, spesso non sono più sue da tempo. I grossi immobiliaristi newyorchesi lo considerano un protagonista minore del loro business. Lui però ha curato il "brand", lasciando il suo marchio anche in cose che non gli appartengono più. Ha investito nei casinò, ma anche lì ha avuto meno successo di quanto si creda, le bancarotte sono state numerose. Trump è presidente degli Stati Uniti: la notizia sui siti internazionali
Ha varie linee di "merchandising", abbigliamento o vini, sempre utili ad alimentare la sua notorietà ma non necessariamente generose di fatturato. Ha posseduto e gestito il marchio di diversi concorsi internazionali per reginette di bellezza, come Miss Universo: anche lì, più immagine che sostanza. Non è un Bill Gates né uno Steve Jobs, nel mondo del grande capitalismo americano è un microbo. Solo come showman ha dimostrato un talento innegabile. The Apprentice, il reality tv in cui lui selezionava aspiranti imprenditori, è stato uno dei più grandi successi della tv americana.
La politica lo ha sempre attirato. Probabilmente perché sentiva che poteva appagare il suo ego, il suo narcisismo smisurato. E’ stato democratico prima che repubblicano, ha frequentato i Clinton e tutti i notabili del partito democratico newyorchese. Ha capito da tempo, però, che la sua fortuna poteva essere legata alla destra. Ne ha corteggiato le frange più radicali e razziste. Il suo vero ingresso sulla scena politica nazionale avviene quando lui si fa capo del movimento "birther": quattro anni fa, all’epoca della campagna elettorale del 2012, lui comincia ad accusare Obama di essere nato in Kenya, quindi ineleggibile, un usurpatore. La menzogna diventa leggenda metropolitana, vi si aggiunge l’insinuazione che Obama sia anche musulmano. Che sia falsa non conta, è un messaggio subliminale grazie al quale Trump diventa il beniamino di tutta l’America bianca e arrabbiata che non può ammettere un afroamericano come leader della nazione. Trump si accorge che manipolando i social media acquista rapidamente un seguito enorme, entusiasta. Comincia il suo uso intenso, quasi ossessivo, di Twitter. La campagna del 2012, anche se lui non si candida, diventa la prova generale di quel che verrà.
Nessuno lo prende sul serio quando lancia la sua candidatura nell’estate 2015. Gli altri repubblicani però esitano ad attaccarlo. Pensano che il fenomeno Trump si sgonfierà da solo. Lo corteggiano, sicuri che verrà il momento di ereditarne i fan. E lui li frega tutti, uno per uno cadono come birilli politici di professione come Jeb Bush, Ted Cruz, Marco Rubio. Li distrugge ridicolizzandoli. Azzecca tutte le parole d’ordine vincenti: il Muro, la denuncia dei trattati di libero scambio. All’America che soffre per la globalizzazione lui dice: l’establishment vi ha traditi, vi ha venduti alla Cina e al Messico. Ha interpretato, meglio di chiunque altro, l’aria del tempo.
Una campagna insurrezionale, rivoluzionaria, un’Opa ostile su un partito antico che ebbe come leader Abraham Lincoln, Dwight Eisenhower, Ronald Reagan. E’ riuscito perfino a farsi votare dai mormoni e dagli evangelici, lui che è al terzo matrimonio e si vantato di numerose conquiste e avventure extra-coniugali, fino alla ex modella di riviste per soli uomini che è la sua moglie attuale, Melania. Non lo ha danneggiato la rivelazione che Melania ha lavorato come fotomodella violando le leggi sull’immigrazione. Non gli ha nuociuto il fatto di avere impiegato immigrati clandestini nei suoi cantieri. Mentre tutti gli scandali di Hillary l’affondavano incollandole addosso l’immagine di una disonesta, lui è diventato presidente dopo essere stato un candidato-teflon, come a suo tempo Reagan.
* la Repubblica, 09 novembre 2016 (ripresa parziale - senza immagini).
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA - Quando la fantapolitica ha il profilo di Trump. Ecco come il fascismo arriva in America (Robert Kagan).27 ottobre 2016, di Federico La Sala
- UNA DOMANDA ALL’ITALIA: MA COME AVETE FATTO A RIDURVI COSI’?! UN "BORDELLO STATE": UN PAESE BORDELLO. Una nota di Maurizio Viroli (dagli Usa) - e una risposta (agli americani, dall’Italia)
- LA STATUA DELLA LIBERTA’ DEGLI U.S.A. - CON LA SPADA SGUAINATA: "GUAI AI VINTI"!!! LA LEZIONE DI FRANZ KAFKA, IL MAESTRO DELLA LEGGE: RIPENSARE L’AMERICA. E il sogno del "nuovo mondo"!!!
 "IN GOD WE TRUST": TUTTO A CARO-PREZZO ("DEUS CARITAS EST")!!! IL DERAGLIAMENTO DELLA DEMOCRAZIA E BUSH CHE FA LA "BELLA STATUINA".
"IN GOD WE TRUST": TUTTO A CARO-PREZZO ("DEUS CARITAS EST")!!! IL DERAGLIAMENTO DELLA DEMOCRAZIA E BUSH CHE FA LA "BELLA STATUINA".
Quando la fantapolitica ha il profilo di Trump
Arriva in Italia “Da noi non può succedere”, il romanzo di Sinclair Lewis che nel 1936 immaginava l’avvento negli Usa di un regime parafascista
di Federico Rampini (la Repubblica, 27.10.2016)
- IL LIBRO Sinclair Lewis, Da noi non può succedere ( Passigli, pagg. 320, euro 19,50). Qui anticipiamo la prefazione di Federico Rampini
Ci voleva un grande conservatore per osare pronunciare quella parola. Il fascismo in America? A spezzare il tabù è stato Robert Kagan, già consigliere di George W. Bush, “neocon” esperto di geopolitica, autore della celebre metafora su «gli americani che vengono da Marte, gli europei da Venere». In un editoriale-shock sul “Washington Post”, il 18 maggio 2016 Kagan ha messo da parte cautele verbali, circonvoluzioni e inibizioni dell’intellighenzia. Il titolo è stato come un pugno nello stomaco: Ecco come il fascismo arriva in America.
Il portatore della peste nera, Kagan non aveva dubbi, si chiama Donald Trump. L’intellettuale di destra in quell’intervento drammatico non risparmiava le accuse ai suoi compagni di partito: «Lo sforzo dei repubblicani per trattare Trump come un candidato normale sarebbe ridicolo, se non fosse così pericoloso per la nostra repubblica». Seguiva una descrizione del ciclone- Trump in tutti i suoi ingredienti: «l’idea che la cultura democratica produce debolezza», «il fascino della forza bruta e del machismo», «le affermazioni incoerenti e contraddittorie ma segnate da ingredienti comuni quali il risentimento e il disprezzo, l’odio e la rabbia verso le minoranze ». Il verdetto finale: «è una minaccia per la democrazia », un fenomeno «che alla sua apparizione in altre nazioni e in altre epoche, fu definito fascismo ».
Tutto ciò accadeva all’inizio del duello fra Trump e Hillary Clinton. Mentre scrivo, il verdetto finale non è ancora arrivato. La Clinton viene data per favorita. Ma anche se dovessimo evitare il peggio, l’America avrà vissuto un’incredibile campagna elettorale, dove è accaduto tutto ciò che Da noi non può succedere. Un candidato ha sdoganato il razzismo, la misoginia, l’evasione fiscale. Ha elogiato Vladimir Putin e altri regimi autoritari in giro per il mondo. Ha invocato l’aiuto degli hacker russi contro la sua rivale. Ha promesso di mandare in galera la candidata democratica. E, anche se chi mi legge sta vivendo in un futuro in cui lo scenario peggiore non si è avverato, come spero, resta il fatto che col fenomeno Trump abbiamo convissuto per un’intera campagna presidenziale. Con lui dovremo fare i conti a lungo, molto a lungo: per tutto ciò che ha fatto emergere dall’America di oggi.
Torno al monito severo di Kagan. Dopo che il guru neo-conservatore aveva lanciato contro The Donald l’accusa che molti non osavano pronunciare, il New York Times decise di sbattere la controversia in prima pagina. Con il titolo L’ascesa di Trump e il dibattito sul fascismo, il quotidiano liberal dava conto nella primavera del 2016 di un allarme che stava diventando esplicito. Un politico, l’ex governatore del Massachusetts William Weld, paragonava il progetto di Trump per la deportazione di undici milioni di immigrati alla “notte dei cristalli” del 1938 in cui i nazisti si scatenarono nelle violenze contro gli ebrei. Il New York Times allargava l’orizzonte per cogliere dietro il fenomeno Trump una tendenza più globale: mettendo insieme una generazione di leaders che vanno da Vladimir Putin al turco Erdogan, dall’ungherese Orban ai suoi emuli in Polonia, più l’ascesa di vari movimenti di estrema destra in Francia, Germania, Grecia.
È così che l’élite intellettuale newyorchese ha riscoperto due romanzi di fantapolitica. Scritti da due premi Nobel, in epoche diverse, ma con la stessa trama: l’avvento di un autoritarismo nazionalista in America. Il primo è questo Da noi non può succedere di Sinclair Lewis, finalmente disponibile in italiano. Affermazione rassicurante, quella del titolo: ma contraddetta dalla trama narrativa. Scritto e ambientato nel 1936, immagina che Franklin Roosevelt dopo un solo mandato sia sconfitto e sostituito da un fascista. L’altro romanzo è di Philip Roth, molto più recente (2004): immagina che nel 1940 Roosevelt sia battuto dall’aviatore Charles Lindbergh, simpatizzante notorio di Hitler e Mussolini. È probabile che Roth si sia ispirato al precedente di Lewis. La grande letteratura aveva previsto ciò che i politologi non vollero prendere in considerazione?
La reticenza che aveva impedito questo dibattito ha varie spiegazioni. Al primo posto, la fiducia sulla solidità della più antica tra le liberal-democrazie. Poi, l’America è abituata a considerarsi all’avanguardia; è imbarazzante ammettere che nel 2015-2016 ha importato tendenze già in atto da molti anni in Europa (Berlusconi-Bossi- Grillo, tanto per citare solo i nostri) e culminate nel Regno Unito con Brexit. L’autocensura che ha trattenuto gli intellettuali nasce anche da un complesso di colpa: la narrazione dominante dice che l’élite pensante ha ignorato per anni le sofferenze di quel ceto medio bianco (declassato, impoverito dalla crisi, “marginalizzato” dalla società multietnica) che nel 2016 si è invaghito di Trump. Dargli del fascista può sembrare una scorciatoia per ignorare le cause profonde di un disagio sociale: quel tradimento delle élites che ho messo al centro del mio ultimo saggio.
Sulle etichette, molti preferiscono sfumature diverse, dalla “democrazia illiberale” ai “populismi autoritari”. L’allarme di Kagan si è rivelato comunque troppo tardivo per arrestare la tendenza dei repubblicani a salire sul carro del vincitore. Frastornati, storditi, imbarazzati, umiliati, ma in larga parte troppo codardi, i repubblicani avranno una responsabilità immensa: l’aver consegnato il Grand Old Party di Abraham Lincoln e di Dwight Eisenhower a un affarista imbroglione, egomaniaco, narcisista e con pulsioni autoritarie. La cui somiglianza col protagonista di questo romanzo è impressionante, inquietante.
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. -- REFERENDUM 2016. Raniero La Valle risponde a Michele Serra: Votare “sì” non è di sinistra.26 ottobre 2016, di Federico La Sala
- L’ITALIA (1994-2016), TRE PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA SENZA "PAROLA", E I FURBASTRI CHE SANNO (COSA SIGNIFICA) GRIDARE "FORZA ITALIA". In memoria di Sandro Pertini e di Gioacchino da Fiore, alcuni appunti per i posteri
- IL PARTITO TRASVERSALE DEL "CAVALLO DI TROIA" Franco Cordero, Stefano Rodotà, Gustavo Zagrebelsky, Umberto Eco, Gianni Vattimo, Emanuele Severino, Massimo Cacciari .... Una domanda
Raniero La Valle risponde a Michele Serra: Votare “sì” non è di sinistra
di Raniero La Valle *
Sulla “Repubblica” di domenica scorsa Michele Serra ha ripreso il mio intervento pubblicato su MicroMega dal titolo: “Il vero quesito: approvate il superamento della democrazia parlamentare?”. Egli si mostra d’accordo con la mia “spiegazione” secondo cui la Costituzione renziana è il punto d’arrivo di una restaurazione consistente nel trasferire la sovranità dal popolo ai mercati, concetto da lui definito “folgorante” per quanto è vero. Ma poiché ciò si sarebbe già realizzato da tempo, segnando una sconfitta della sinistra, nella quale lo stesso Serra si annovera, i trenta-quarantenni di oggi non farebbero che prenderne atto.
Secondo questa tesi la riforma Boschi-Renzi non farebbe che tradurre in norme questa nuova realtà, e questa sarebbe la ragione di votare “sì” a questa innocente proposta. Ne verrebbe dunque confermato che il popolo non è più sovrano, sovrani sono i mercati e la nuova Costituzione invece di permettere e promuovere la riconquista della sovranità al popolo, la consegnerebbe, irrevocabile, al Mercato. E poiché le Costituzioni sono destinate a durare, questa è la scelta che noi, sconfitti, lasceremmo a determinare la vita delle generazioni future.
È molto sorprendente che questa posizione (implicita ma negata nella propaganda ufficiale) sia ora resa esplicita e formalizzata sulla pagina più autorevole della “Repubblica”. Certo, non c’è niente di disonorevole in una sconfitta politica. Ma nel passaggio dello scettro dal popolo ai signori del Mercato non c’è solo la sconfitta della sinistra, c’è la sconfitta di tutto il costituzionalismo moderno e dello stesso Stato di diritto: il popolo sovrano è il cardine stesso della democrazia e della Costituzione.
Mettere super partes la nuova realtà per cui esso è tolto dal trono, sottrarre questo mutamento alla lotta politica, accettarlo come un fatto compiuto e finale, non è solo un efficientismo da quarantenni, è una scelta. E se a farlo è la sinistra, non è solo una sconfitta, è una caduta nella “sindrome di Stoccolma”, è un suicidio, ma col giubbotto esplosivo addosso, che distrugge insieme alla sinistra la politica, la democrazia e la libertà.
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. -- Dopo Mattarella Scalfari ci dirà che anche il papa vota Sì (di Valentino Parlato)25 ottobre 2016, di Federico La Sala
- IL SONNO MORTIFERO DELL’ITALIA. In Parlamento (ancora!) il Partito al di sopra di tutti i partiti.
Dopo Mattarella Scalfari ci dirà che anche il papa vota Sì
di Valentino Parlato (il manifesto, 25.10.2016)
È bene che i lettori di la Repubblica lo sappiano: il giornale che comprano tutti i giorni sostiene Matteo Renzi e il Sì al referendum del 4 dicembre. Eugenio Scalfari, fondatore del giornale, ha iniziato da tempo questa campagna a favore di Renzi con i suoi attacchi all’amico Zagrebelsky.
Esaltando l’«oligarchia democratica» e l’utilità e necessità che «pochi siano al volante». Tutto questo era già chiaro da quando Scalfari scriveva (una tattica efficace, bisogna riconoscerlo) di non avere ancora deciso tra il Sì e il No anche se era facile capire la sua scelta per il Sì.
Poi, con l’editoriale di domenica scorsa 23 ottobre ha messo in gioco per il Sì anche l’attuale Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, scrivendo: «Il Presidente è favorevole al referendum istituzionale che pone fine al bicameralismo perfetto». E mi pare ovvio che il Presidente non può far altro che tacere, poiché una sua eventuale smentita potrebbe significare che intende votare No e Mattarella, con il suo silenzio, ha voluto tenersi fuori da questa brutta faccenda della nostra sofferente democrazia.
Così, dopo Obama, Scalfari schiera anche Mattarella tra i sostenitori del Sì e del nostro Renzi, attivo rottamatore della Repubblica democratica. Ci manca solo che Scalfari, che ama raccontarci delle sue telefonate con personaggi di primo piano, non ci venga a dire che anche il Papa lo ha confortato dicendogli che voterà Sì.
Dobbiamo prendere atto di questa impegnata campagna di Repubblica a favore di Renzi e del Sì al referendum, chissà cosa ne pensano i lettori del quotidiano.
Per concludere vorrei dire che come giornalista del manifesto e antico lettore dell’Espresso e di Repubblica, questi ultimi due una volta non governativi, faccio appello alla resistenza (questa parola ci torna in mente) contro questa deriva antidemocratica e autoritaria: «Solo pochi al volante» e tutti gli altri passeggeri che pagano il biglietto, ma non hanno voce in capitolo.
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. -- REFERENDUM COSTITUZIONALE 2016. Una guida: 3 trappole, 3 elogi, 3 beni, 1 conclusione (di Peppe Sini)24 ottobre 2016, di Federico La Sala
- LA "PROFEZIA" DI MARSHALL MCLUHAN: NARCISO E LA MORTE DELL’ITALIA. Il "rimorso di incoscienza"
- POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. Materiali sul tema
DIECI COLTELLATE. MINIMA UNA GUIDA AL REFERENDUM *
Intitolare questi brevi ragionamenti "dieci coltellate" e’ un espediente retorico: a indicare la necessita’ e l’urgenza di squarciare la cortina delle menzogne ed uscire dalla subalternita’ al discorso dominante che e’ il discorso falso e fraudolento della classe dominante che tutte e tutti ci opprime.
Indicheremo qui di seguito tre trappole in cui non cadere (la trappola delle velocita’, la trappola del risparmio, la trappola della governabilita’), formuleremo tre elogi (del perfetto bicameralismo, della rappresentanza proporzionale, del costituzionalismo nemico dell’assolutismo), dichiareremo tre beni irrinunciabili (la repubblica parlamentare; lo stato di diritto, ovvero la separazione e il controllo dei poteri; la democrazia, ovvero la sovranita’ popolare) e giungeremo a una conclusione che ci sembra coerente e doverosa: il 4 dicembre votare No al golpe degli apprendisti stregoni; difendiamo la Costituzione della Repubblica italiana.
E valga il vero.
*
1. La trappola della velocita’
Quando si prendono decisioni importanti non si discute mai abbastanza. Quando si fanno le leggi, piu’ ci si pensa e meglio e’. La democrazia e’ un processo decisionale lento e paziente; come scrisse Guido Calogero si contano tutte le teste invece di romperle. Solo le dittature sono veloci, velocissime, e il frutto di quella velocita’ e’ sempre e solo la schiavitu’ e la morte di innumerevoli esseri umani.
*
2. La trappola del risparmio
Da quando in qua per risparmiare quattro baiocchi occorre massacrare la Costituzione, che e’ la legge a fondamento di tutte le nostre leggi, la base del nostro ordinamento giuridico e quindi della nostra civile convivenza? Da quando in qua per risparmiare quattro baiocchi occorre distruggere la forma istituzionale repubblicana del nostro paese e sostituirla con la dittatura del governo, ovvero con la dittatura del capitale finanziario transnazionale di cui il governo in carica e’ servo sciocco? Per ridurre i costi dell’attivita’ parlamentare basterebbe una legge ordinaria che riduca gli emolumenti a tutti i parlamentari portandoli a retribuzioni ragionevoli.
*
3. La trappola della governabilita’
Cio’ che si nasconde dietro la parola magica - ovvero la cortina fumogena - della "governabilita’" altro non e’ che il potere dei potenti di imporre la loro volonta’ e i loro abusi senza opposizioni e senza controlli. La governabilita’ non e’ ne’ un valore ne’ un bisogno in nome del quale devastare la democrazia, lo stato di diritto, i diritti civili, politici e sociali che ad ogni persona appartengono.
*
4. Elogio del perfetto bicameralismo
In un parlamento due camere sono meglio di una: se nell’una si commette un errore l’altra puo’ correggerlo; se nell’una prevale un’alleanza di malfattori, l’altra puo’ contrastarla. Due camere si controllano reciprocamente. Cosi’ si sbaglia di meno. Benedetto sia il bicameralismo perfetto.
*
5. Elogio della rappresentanza proporzionale
In una democrazia il potere e’ del popolo che lo esercita attraverso i suoi rappresentanti. Il parlamento che fa le leggi in nome del popolo deve essere rappresentativo di esso in modo rigorosamente proporzionale. Se invece una minoranza si appropria della maggioranza dei seggi quel parlamento non e’ piu’ democratico, diventa solo la foglia di fico di un regime oligarchico. E se il governo si sostituisce al parlamento nella sua funzione legislativa non solo quel parlamento diventa una foglia di fico a tentar di occultare l’oscenita’ del potere reale, ma quel potere non e’ piu’ ne’ democratico ne’ repubblicano, e’ diventato un’autocrazia. Benedetta sia la rappresentanza proporzionale.
*
6. Elogio del costituzionalismo, nemico dell’assolutismo
Il fine e il senso di ogni Costituzione e’ impedire o almeno limitare gli abusi dei potenti. Nelle societa’ divise in classi di sfruttatori e sfruttati, di proprietari ed espropriati, di governanti e governati, chi esercita funzioni di governo e’ costantemente esposto alla forza corruttiva del potere. Nessun potere deve essere assoluto, ogni potere deve avere limiti e controlli. Benedetto sia il costituzionalismo, nemico dell’assolutismo.
*
7. Una repubblica parlamentare, non una dittatura
Se il governo attraverso la riforma costituzionale, la riforma elettorale ed il loro "combinato disposto" (ovvero l’effetto sinergico delle norme contenute nelle due riforme) mutila ed esautora il parlamento e si appropria di fatto del potere legislativo e lo somma a quello esecutivo che gia’ detiene, viene meno la repubblica parlamentare. Ma per noi la repubblica parlamentare e’ un bene irrinunciabile.
*
8. Uno stato di diritto, ovvero la separazione e il controllo dei poteri
Se il governo attraverso la riforma costituzionale, la riforma elettorale ed il loro "combinato disposto" (ovvero l’effetto sinergico delle norme contenute nelle due riforme) si appropria di fatto del potere legislativo e lo somma a quello esecutivo che gia’ detiene, annienta la separazione e il controllo dei poteri, che sono il fondamento dello stato di diritto. Ma per noi lo stato di diritto, ovvero la separazione e il controllo dei poteri, e’ un bene irrinunciabile.
*
9. Una democrazia, ovvero la sovranita’ popolare
Se il governo attraverso la riforma costituzionale, la riforma elettorale ed il loro "combinato disposto" (ovvero l’effetto sinergico delle norme contenute nelle due riforme) riduce il parlamento a un giocattolo nelle sue mani, si fa un senato non piu’ eletto dal popolo, si fa una camera dei deputati in cui una minoranza rapina la maggioranza assoluta dei seggi, si appropria di fatto del potere legislativo e lo somma a quello esecutivo che gia’ detiene, la sovranita’ popolare e’ annichilita e con essa la democrazia. Ma per noi la democrazia, ovvero la sovranita’ popolare, e’ un bene irrinunciabile.
*
10. No al golpe, difendiamo la Costituzione della Repubblica italiana
Nel referendum del 4 dicembre si vota per dire si’ o no al golpe. Chi vota si’, come vuole il governo degli apprendisti stregoni, accetta il golpe che distrugge il parlamento eletto dal popolo, lo stato di diritto, la democrazia costituzionale. Chi vota no, contro la volonta’ del governo degli apprendisti stregoni, difende il parlamento eletto dal popolo, lo stato di diritto, la democrazia costituzionale, e quindi si oppone al golpe. No al golpe. No al fascismo. No alla barbarie. Al referendum votiamo No. Senza odio, senza violenza, senza paura. Difendiamo la Costituzione della Repubblica italiana.
*
Peppe Sini, responsabile del "Centro di ricerca per la pace e i diritti umani" di Viterbo
Viterbo, 21 ottobre 2016
Mittente: "Centro di ricerca per la pace e i diritti umani" di Viterbo, strada S. Barbara 9/E, 01100 Viterbo, tel. 0761353532, -e-mail: nbawac@tin.it, centropacevt@gmail.com, centropaceviterbo@outlook.it
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. Materiali sul tema -- REFERENDUM COSTITUZIONALE. Il quesito: "è uno spot"! Ricorso al Tar di Sinistra Italiana ed M5s5 ottobre 2016, di Federico La Sala
Ricorso di Sinistra Italiana e M5S al Tar del Lazio contro il testo del quesito del Referendum.
Ricorso al Tar contro il quesito del referendum: "è uno spot". Grillo: "Non ho dubbi vinca no"
Lo hanno presentato Sinistra Italiana ed M5s
di Redazione *
E’ di nuovo scontro sul referendum del 4 dicembre sulle riforme costituzionali. Sinistra Italiana ed M5s hanno fatto ricorso contro il quesito referendario che, ad avviso dei ricorrenti si tradurrebbe in "una sorta di spot". I ricorrenti, tra l’altro, chiamano in causa il decreto della presidenza della Repubblica di inidizione della consultazione popolare ma il Colle replica che la formulazione è stata ammesso dalla Cassazione. Intanto Beppe Grillo lasciando Roma parla con i cronisti e si dice certo della vittoria del no.
IL RICORSO AL TAR - Ricorso di Sinistra Italiana e M5S al Tar del Lazio contro il testo del quesito del Referendum. A parere dei ricorrenti, infatti, "il quesito così formulato finisce per tradursi in una sorta di ’spot pubblicitario’, tanto suggestivo quanto incompleto e fuorviante, a favore del Governo che ha preso l’iniziativa della revisione e che ora ne chiede impropriamente la conferma ai cittadini, che non meritano di essere ingannati in modo così plateale".
Il ricorso al Tar Lazio è dunque contro il Decreto del Presidente della Repubblica con cui, indicendo il referendum per il prossimo 4 dicembre, "è stato tra l’altro stabilito il quesito che dovrebbe comparire sulla scheda di votazione". A presentarlo sono stati gli avvocati Enzo Palumbo e Giuseppe Bozzi (che attualmente difendono i ricorrenti messinesi dinanzi alla Consulta nel giudizio per l’incostituzionalità dell’Italicum), nella loro qualità di elettori e di esponenti del Comitato Liberali x il NO e del Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, e i senatori Vito Claudio Crimi (M5S) e Loredana De Petris (Sinistra Italiana-SEL).
LA REPLICA DEL COLLE - In relazione a quanto affermato in una nota di ricorrenti al Tar Lazio, in cui impropriamente si attribuisce alla Presidenza della Repubblica la formulazione del quesito referendario, negli ambienti del Quirinale si precisa che il quesito che comparirà sulla scheda è stato valutato e ammesso, con proprio provvedimento, dalla Corte di Cassazione, in base a quanto previsto dall’art 12 della legge 352 del 1970, e riproduce il titolo della legge quale approvato dal Parlamento.
GRILLO E LA VITTORIA DEL NO - "Non ho dubbi, vincerà il ’No’, leggete il Financial times e vedete chi vince. Io la penso come il Financial Times, perché siamo in mano a dei bluffisti, dei giocatori d’azzardo". "Dire ’No’ - ha aggiunto - è bellissimo, anche voi dovete dire di ’No’".
* Redazione ANSA ROMA 05 ottobre 2016 (ripresa parziale).
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA --- L’ULTIMA DOMANDA. Siamo davanti alla metafisica di sé, con un’avventura straordinaria (di Ezio Mauro).26 settembre 2016, di Federico La Sala
- ITALIA: 1994. UN CITTADINO RUBA IL NOME DI TUTTO UN POPOLO, SI FA "PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA" E NE FA LA BANDIERA DEL PROPRIO PARTITO PERSONALE E REALIZZA LA PIU’ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA POLITICA ITALIANA...
- GIOVANI ITALIANI NEL MONDO (PRIMA CONFERENZA), ATTENTI AL TRUCCO E ALL’INGANNO. E ALLA VERGOGNA!!! Il Presidente della Repubblica Napolitano grida: Forza ITALIA; ma Schifani, Frattini e Fini (nonostante Mirko Tremaglia, onore a Lui) gridano per il partito: "Forza Italia"!!! Un gigantesco conflitto d’interessi
- ALL’OMBRA DELL’UOMO DELLA PROVVIDENZA -- NON SOLO LA FILOSOFIA, IL DIRITTO, MA ANCHE LA MATEMATICA: IL "DIZIONARIO DELLA STUPIDITÀ"
Carissimo nemicoL’undicesima domanda a Silvio Berlusconi
L’ex Cavaliere, ottanta anni il 29 settembre, adesso è fuori gioco. Nel 2009 le 10 domande al Cavaliere di Giuseppe D’Avanzo su Repubblica. E oggi è il tempo di porne un’altra
di Ezio Mauro (l’Espresso, 26 settembre 2016)
L’Undicesima domanda arriva alla fine del tempo, quando si è chiuso il baldacchino della politica, oltre lo scontro tra destra e sinistra, fuori dai calcoli delle competizioni elettorali e dopo la grande partita per il potere. Quella partita durata vent’anni tra Berlusconi e la sinistra è finita: il Cavaliere è fuori gioco, la sinistra non sa a che gioco deve giocare.
Ci accorgiamo che quelle due anime perimetravano il campo, lo definivano e a noi assegnavano il posto sugli spalti per uno dei più grandi spettacoli politici del dopoguerra. Adesso il campo è vuoto, e come tutti gli spazi abbandonati è preda di incursioni casuali, episodiche, quasi aliene. Senza passione. Bisogna ammettere che l’ultima grande passione politica, per metà del Paese, è stato lui. E l’altra metà si è appassionata altrettanto all’idea di contrastargli il passo, cercando di fermare il piano di conquista di quello che era in quel momento l’uomo più potente d’Italia.
Era già tutto pronto anni prima che l’avventura incominciasse ufficialmente. Due anni prima, quando lavoravo a Torino alla "Stampa", l’avvocato Agnelli, editore del giornale, mi disse che avevamo un invito a pranzo ad Arcore con l’imprenditore televisivo Berlusconi e ci saremmo andati insieme, come capitava talvolta con uomini d’impresa ma anche con Luciano Lama. Poi ci fu un contrattempo, e mi presentai da solo.
Il pranzo che doveva essere a quattro diventò a tre, con il Cavaliere che non conoscevo e Fedele Confalonieri. Parlammo di tutto e di niente, in modo aperto e sciolto. Tanto che a un certo punto domandai: «Ho sentito dire che sta pensando di candidarsi a sindaco di Milano, è vero?». Mi rispose con un gesto infastidito della mano: «Una sciocchezza». Poi mi domandò quante lettere riceveva ogni giorno "Specchio dei tempi", la rubrica di dialogo coi lettori della "Stampa". Più di cento, risposi, pensando che avesse voluto cambiare discorso. Invece lo riprese: «Sa perché glielo chiedo? Perché io ricevo duecento lettere al giorno e sono delle massaie, felici perché ho regalato loro la libertà con le mie televisioni che guardano al mattino mentre fanno i mestieri, come si dice qui a Milano quando si rigoverna la casa. Bene, se pensassi di entrare in politica, io non farei il borgomastro di Milano ma fonderei un partito reaganiano, punterei proprio su quel mondo, prenderei la maggioranza dei voti e governerei il Paese».
Una sorta di "Bum!" silenzioso risuonò nella stanza, attorno al tavolo dov’eravamo seduti con le finestre aperte. A me quella frase entrò da un orecchio e uscì dall’altro, pensai a una boutade estemporanea, un paradosso gratuito, come se Renzi mi dicesse oggi che pensa di fare il centravanti nella Fiorentina. E infatti quando Agnelli chiamò in macchina per sapere se c’era qualche curiosità in quell’incontro gli raccontai la conversazione, saltando quel piccolo particolare. Glielo avrei ricordato due anni dopo, d’urgenza, quando sullo sfondo di una politica disastrata si avvertivano i primi scalpiccii berlusconiani misteriosi, le voci di vertici segreti a Publitalia, la rete di uomini di Dell’Utri, le simulazioni strategiche e coperte con i giornalisti del gruppo, i sussurri di qualche navigatore democristiano di lungo corso che cercava una scialuppa di salvataggio dopo il grande naufragio, una cena al Cambio con imprenditori torinesi a cui era stato raccontato tutto chiedendo il silenzio come nelle sette, nelle operazioni di marketing, nei blitz militari.
Io sapevo, anche se non avevo capito nulla. Non avevo considerato che il vuoto chiama il pieno. Che nella grande desertificazione della politica italiana dopo il suicidio di partiti centenari con le tangenti tutto era prosciugato, meno il deposito elementare ma identitario dell’anticomunismo, catalizzatore e collante istintivo: a patto che qualcuno fosse capace di riportare l’istinto in politica dopo l’uniformità scolastica degli anni democristiani e la rigidità monumentale della piramide comunista. Non avevo creduto possibile, soprattutto, che una creatura politica nuova potesse nascere dal nulla, dagli spettri del caos come direbbero i russi, senza il seme di una tradizione culturale, la selezione di un’élite allargata, la rappresentanza esplicita di una base sociale riconoscibile e riconosciuta.
Eppure, il Cavaliere senza accorgersene mi aveva consegnato il bandolo, la scintilla identitaria con quell’aggettivo buttato sul tavolo dopopranzo: reaganiano. Non democristiano, o moderato, o conservatore o liberale. No: reaganiano. Qualcosa di sconosciuto alla politica italiana, ma qualcosa che contiene il vero elemento fondante dell’intera operazione. L’outsider che in Italia come in America viene da un altro mondo, e guarda caso è il mondo dello spettacolo che dà la temperatura del rapporto con la folla, abitua ai riflettori, evoca intorno a sé un’avventura più che un progetto, in un paesaggio smart di successi, denaro e sorrisi.
La politica - per Reagan come per il Cavaliere - scoperta in età matura, come un’incursione estranea, senza l’imprinting originario dei professionisti. Proprio per questo, il tocco permanente del grande dilettante che non conosce il vocabolario istituzionale ma sa sfiorare perfettamente i tasti (basta leggere Lou Cannon, il biografo del presidente americano) dell’emozione popolare in ogni occasione, presentandosi come uomo nuovo, estraneo ai professionismi degli apparati. E infine, il nocciolo duro di quell’aggettivo: il profilo reaganiano disegnava fin dall’origine un progetto di destra, destra popolare ma destra vera, che dopo la mediazione democristiana puntava direttamente al comando, più che al governo.
La “rivoluzione conservatrice” non c’è stata. E anche la sinistra non è stata all’altezza del suo compito storico Naturalmente i denti d’acciaio (con cui il vecchio Gromiko misurava la durezza dei candidati alla guida del Cremlino) erano ben nascosti dentro il sorriso televisivo del Cavaliere, la cui iniziazione è insieme una grande dissimulazione. Deve nascondere i debiti che pesano come una macina al collo dell’azienda («ci vogliono vedere sotto un ponte», diceva allora Confalonieri), il debito politico dell’impero televisivo al Psi per le leggi che hanno consentito alla tv privata il volo nell’etere di Stato, la filiazione diretta del personaggio pubblico Berlusconi dal Caf, l’alleanza d’agonia della Prima Repubblica tra Craxi, Andreotti e Forlani, la macchia imprenditoriale nascosta (i tribunali l’accerteranno più tardi) del grande furto della Mondadori, la tessera P2 numero 625 fin dal 1978, e soprattutto le obbligazioni sotterranee che ne derivano. Proprio queste fragilità e queste ambiguità celate dietro i mausolei berlusconiani auto-eretti consigliavano prudenza ai personaggi più vicini al Cavaliere, secondo un modello democristiano teorizzato da Confalonieri: non vale la pena di gettarsi in politica in prima persona correndo il rischio di rompersi l’osso del collo, anche perché con tre televisioni basta avere pazienza, verrà la politica a cercare il becchime nella tua mano.
E invece proprio qui c’è il rovesciamento delle aspettative, il ribaltamento delle convenienze. Il Cavaliere si dimostra uomo d’avventura, l’egolatria fino a quel momento tenuta a bada lo trascina ad un protagonismo diretto e gli fa puntare l’intera posta su una nuova partita, dopo quella immobiliare, quella editoriale, quella televisiva: la politica, o meglio il comando, soprattutto il potere. La politica vista come il cuore del potere, ben più che il cuore dello Stato, qualcosa da conquistare più che da governare. C’è in questo la "pazzia" di cui parla Giuliano Ferrara, che tradurrei con l’azzardo di pensare l’impensabile, crederci costringendo gli altri a credere nell’incredibile realizzandolo prima ancora di renderlo plausibile. Farlo senza adattare la propria natura estranea alle regole auree e comunemente accettate del sistema, ma anzi deformando quelle regole e quelle modalità secondo la propria natura. Siamo a un passo - magari senza saperlo - da Carl Schmitt, secondo cui il vero sovrano non è il garante dell’ordinamento esistente ma è colui che crea un nuovo ordinamento decidendo sullo stato d’eccezione.
Mi sono sempre chiesto, in tutti questi anni, quanto tutto ciò fosse puro istinto di destra - destra reale, realizzata, come c’era il socialismo reale - e quanto invece progetto teorico dissimulato nel rifiuto del "culturame", ma in realtà accumulato con cura. Certo, l’istinto di classe ha convinto fin dall’inizio il Cavaliere a puntare sul ceto medio emergente proponendogli di mettersi in proprio per diventare finalmente soggetto politico, autonomizzandosi sia dalla grande borghesia che dal proletariato. Il progetto lo ha spinto a evocare un vero e proprio sovvertimento della classe dirigente, quasi una ribellione dei garantiti, perché c’è sempre un’élite più o meno ristretta contro cui mostrarsi ribelle. Il calcolo gli ha suggerito di infilarsi nella breccia aperta da Mani Pulite, nel solco della prima seminazione di antipolitica della Lega, e di radunare queste incoerenze sotto il doppiopetto miliardario, paradossalmente credibile proprio perché rivestiva un outsider rispetto all’aristocrazia delle grandi famiglie industriali cresciute nel fordismo e nell’acciaio, che lo consideravano imprenditore dell’immateriale e lo tenevano in fondo al tavolo. Ancora l’istinto barbaro e redditizio lo ha spinto a consigliare al cittadino di disinteressarsi dello Stato cercando un demiurgo, nascondendogli che su questa strada lo Stato avrebbe finito per disinteressarsi di lui, perché quando la sua libertà non si combina con la vita degli altri e l’esercizio dei suoi diritti resta esclusivamente individuale, separato, lui diventa un’entità anonima da rilevare nei sondaggi, realizzando la vera solitudine dei numeri primi.
Ma questo paesaggio misto, abitato da solitudine e ribellione, era in realtà lo scenario perfetto di un esperimento del tutto nuovo per l’Italia e per le democrazie occidentali. Era nella mia stanza il direttore di un grande giornale europeo, a dicembre del 1994, mentre sul video subito dopo il telegiornale scorrevano riflessi negli addobbi rotondi e lucenti di un gigantesco albero di Natale le immagini di un Berlusconi sorridente, magnanimo, circondato dai bambini su un prato, mentre accarezzava i cani, o alzava le coppe vinte dal Milan. Mascherati da innocenti auguri di Natale erano i primi spot subliminali di un’avventura politica del tutto nuova. «Il solito italiano», disse il mio amico, «manca soltanto la chitarra o il mandolino». Naturalmente arrivarono, insieme all’iperrealismo di una bandana sulla fronte. Ma era tutt’altro che il volto di un arcitaliano, quello che stavamo vedendo: piuttosto l’inizio di un esperimento che l’Europa non aveva ancora conosciuto, e che in questi anni non ho saputo chiamare altrimenti che neo-populismo, qualcosa di modernissimo e primitivo insieme, con la sua neolingua e una dilatata dismisura.
Ottimismo ad ogni costo, poiché le mani del demiurgo sono sul timone, soluzioni semplici davanti a problemi complessi (l’efficacia del "puerilismo", come lo chiamava Huizinga), invulnerabilità assoluta, tanto che le sconfitte sono sempre colpa di una truffa o di un inganno sopraffattore, in modo che il leader esca comunque dalla prova innocente, magari ferito ma superstite, nel cerchio intatto del carisma perenne. È un investimento sull’indebolimento dello spirito critico, a vantaggio di una visione mitologica dell’avventura eroica. Il cittadino viene autorizzato a farsi i fatti suoi, elevati a cifra privata della nuova dimensione pubblica. In cambio il leader gli parlerà direttamente saltando ogni intermediazione partitica, istituzionale, politica, e mentre provvederà alla guida del Paese gli chiederà soltanto una vibrazione costante di consenso, e una delega elettorale periodica e fissa. Principio e fine di tutto questo, l’evocazione di una destra che il Paese nel dopoguerra non aveva conosciuto, perché il filtro democristiano drenava al centro gli istinti post-fascisti del Paese. Berlusconi ha fatto l’opposto, radicalizzando a destra una propensione politica sconosciuta a se stessa, camuffata e scusata dal doroteismo di potere, liberandola nella sua vera natura. Una destra sdoganata con un progetto puramente elettorale e non culturale, senza chiedere revisioni e abiure, con la complicità dell’intellettuale italiano strabico, che per vent’anni (fino al declino del nuovo potere col calcio dell’asino) non ha usato a destra la pedagogia liberale impiegata giustamente a sinistra con il Pci.
Il mix ha funzionato tre volte, perché il fuoco in pancia del Cavaliere lo ha trasformato in uno straordinario campaigner (salvo quando ha incontrato Romano Prodi), tanto quanto è risultato sempre un pessimo uomo di governo. A Palazzo Chigi quel fuoco si è ogni volta spento e tra le ceneri brillavano fisse le quattro anomalie del Cavaliere rispetto a qualsiasi moderna destra occidentale: le leggi ad personam, il conflitto d’interessi, lo strapotere economico che gli consentiva di comperare i deputati a grappoli, lo strapotere mediatico che alterava il mercato del consenso. A un certo punto l’uomo della grande avventura diventava un avventuriero, fino al punto di usare l’esecutivo per piegare il legislativo a fermare il giudiziario, con buona pace di Montesquieu. Le coalizioni assemblate senza il crogiuolo di una fusione culturale capace di dare al Paese una destra moderna, ogni volta si sfaldavano perdendo prima Bossi, poi Casini, quindi Fini, con gli intellettuali che se n’erano già andati. Infine la vicenda giudiziaria prese il sopravvento. Lui teorizzò la decapitazione per via processuale. In realtà aveva imposto una tale torsione al sistema che eravamo giunti al dubbio estremo: se la legge era ancora uguale per tutti, oppure no, nel suo unico caso.
Anche qui, la concezione carismatica del populismo era perfettamente coerente con il rifiuto di essere giudicato, anzi con la giustizia vista come sopruso. Il leader unto dal Signore col voto popolare infatti risponde solo al popolo, ed è per questa sua stessa speciale natura insofferente ad ogni controllo, costituzionale da parte delle autorità di garanza, politico da parte del parlamento, di legalità da parte della magistratura. La legittimità dell’investitura assorbe la legalità fino a soffocarla nell’irrilevanza, l’annulla subordinandola. Ma proprio la specialità di questa eccezione - ecco il punto - rende oggi impossibile sciogliere il nodo gordiano del dopo-Berlusconi.
 Politicamente, la sua creatura è ancora irrisolta così com’è nata per conquistare il potere e non per cambiare il Paese, ferma al bivio tra moderatismo e radicalità. Leaderisticamente, bisogna prendere atto che ogni successione nel senso democratico e moderno del termine è nei fatti impossibile perché Crono divora ogni possibile figlio tanto che si è davvero pensato al passaggio dinastico come unica soluzione, in quanto avrebbe trasmesso integrale il conflitto d’interessi insieme con il dna familiare, perpetuando l’anomalia berlusconiana nella contemplazione perpetua del peccato originale.
Politicamente, la sua creatura è ancora irrisolta così com’è nata per conquistare il potere e non per cambiare il Paese, ferma al bivio tra moderatismo e radicalità. Leaderisticamente, bisogna prendere atto che ogni successione nel senso democratico e moderno del termine è nei fatti impossibile perché Crono divora ogni possibile figlio tanto che si è davvero pensato al passaggio dinastico come unica soluzione, in quanto avrebbe trasmesso integrale il conflitto d’interessi insieme con il dna familiare, perpetuando l’anomalia berlusconiana nella contemplazione perpetua del peccato originale.Siamo davanti alla metafisica di sé, con un’avventura straordinaria che consuma se stessa replicandosi ogni giorno in sedicesimo, come una condanna infernale, ormai fuori dal tempo. E guardando quel poco che resta, da qui nasce l’undicesima domanda: Cavaliere, ne valeva la pena?
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. Materiali sul tema --- STORIA D’ITALIA (1994-2016)25 settembre 2016, di Federico La Sala
STORIA D’ITALIA
GIOVANI ITALIANI NEL MONDO (PRIMA CONFERENZA),
ATTENTI AL TRUCCO E ALL’INGANNO.
E ALLA VERGOGNA!!!
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA --- LEGGE ELETTORALE. Italicum fatto e disfatto, con la regia dell’ex. Napolitano adesso vede i difetti della «sua» legge (di A. Fabozzi)..11 settembre 2016, di Federico La Sala
Italicum fatto e disfatto, con la regia dell’ex
Legge elettorale. Napolitano adesso vede i difetti della «sua» legge. Renzi è pronto a cambiarla. Guardando alla Consulta. L’ex capo dello stato ha nominato cinque giudici costituzionali, compresi presidente e relatore
di Andrea Fabozzi (il manifesto, 11.09.2016)
ROMA Il giorno in cui il suo successore al Quirinale Sergio Mattarella firmò, molto velocemente, la nuova legge elettorale, Giorgio Napolitano dal suo studio di senatore a vita commentò: «È un raggiungimento importante, era inevitabile approvare l’Italicum che del resto non è arrivato in un mese ma in oltre un anno». Tutti i giornali riportarono con evidenza questa benedizione dell’ex capo dello stato e nessuno ci trovò niente di strano. Era stato lui con i suoi discorsi pubblici contro le «zavorre», le «paralisi» e i «frenatori» a spingere il parlamento ad approvare questa riforma elettorale assieme alla legge di revisione costituzionale.
Era stato lui a voltarsi dall’altra parte quando il governo forzava i lavori parlamentari, sostituiva parlamentari «dissidenti» in commissione e quando le opposizioni salivano al Colle per protestare o gli rivolgevano pubblici appelli. Ed era stato ancora lui, nel gennaio 2015, ad aiutare il governo ritardando di due settimane le sue annunciate dimissioni, in modo da consentire - prima dell’elezione di Mattarella in seduta comune e prima dunque della rottura tra Renzi e Berlusconi - il decisivo e delicato passaggio dell’Italicum in senato.
Ieri Giorgio Napolitano ha spiegato al direttore di Repubblica che ci sono diversi aspetti dell’Italicum che «meritano di essere riconsiderati». Non solo. Ha invitato Renzi ad assumere un’iniziativa, «una ricognizione tra le forze parlamentari per capire quale possa essere il terreno di incontro per apportare modifiche alla legge elettorale». Ha sottolineato il difetto secondo lui principale dell’Italicum: «Si rischia di consegnare il 54% dei seggi a chi al primo turno ha preso molto meno del 40% dei voti». E ha indicato una possibile soluzione: «C’è in questo momento una sola iniziativa sul tappeto, è di esponenti di minoranza del Pd tra i quali Speranza». Si tratta di una proposta per modificare il vecchio Mattarellum in senso ulteriormente maggioritario. Ma si tratta della stessa minoranza Pd che aveva contrastato all’epoca l’Italicum, sentendo il presidente della Repubblica Napolitano tuonare contro le «spregiudicate tecniche emendative» in difesa dell’integrità dei testi del governo.
Durante l’ultimo passaggio dell’Italicum alla camera dei deputati, tra l’aprile e il maggio dello scorso anno, i bersaniani del Pd tentarono di introdurre nella legge elettorale un quorum minimo per accedere al ballottaggio, di recuperare gli apparentamenti al secondo turno, di cancellare le pluricandidature. Con l’appoggio delle opposizioni avrebbero potuto farcela. Il momento era delicato. Il senatore a vita Napolitano si fece risentire con poche parole: «Guai se si ricomincia da capo». Il governo mise la fiducia - mossa clamorosa e secondo molti costituzionalisti illegittima - la legge elettorale passò nella forma che Napolitano, oggi, vuole modificare.
E vuole modificare perché, ha spiegato a Repubblica, «rispetto a due anni fa lo scenario politico è mutato... nuovi partiti in forte ascesa hanno rotto il gioco di governo tra due schieramenti» si rischia «che vada al ballottaggio chi al primo turno ha ricevuto una base troppo scarsa di legittimazione col voto popolare». Ed è così: la legge pensata per il bipolarismo e sull’onda del Pd al 40% alle elezioni europee del 2014, può essere sperimentata per la prima volta (perché è applicabile da appena un paio di mesi, malgrado sia stata imposta al parlamento a tappe forzate) in un quadro pienamente tripolare. Ha ragione l’ex capo dello stato, solo che il bipolarismo che era fortissimo all’epoca della sua prima elezione al Quirinale, nel 2006, era già completamente svanito all’epoca della sua seconda, nel 2013. I 5 Stelle erano una realtà forte quanto e anzi molto di più del centrodestra anche prima che Napolitano inaugurasse la sua regia sulle riforme, con il Letta e con Renzi. Napolitano non se n’era accorto? Può darsi, del resto era stato lui stesso a negare l’evidenza del successo grillino alle amministrative precedenti. «Non vedo nessun boom» fu la sua frase celebre.
L’intervento di Napolitano, malgrado tutto, potrebbe essere ancora una volta decisivo. Il presidente del Consiglio, che fino a qui aveva aperto timidi spiragli, concede immediatamente la sua piena e «sincera» disponibilità a cambiare la legge. Lo fa con un’intervista al TgNorba (era a Bari, a inaugurare la fiera del Levante). «L’Italicum non piace? E che problema c’è - dichiara lo stesso Matteo Renzi che sull’Italicum ha messo la fiducia - discutiamolo, approfondiamola, ma facciamo una legge elettorale migliore di questa». Dietro di lui, e dietro Napolitano, è come se si aprissero le cateratte del cielo. Un po’ tutti gli esponenti di maggioranza che l’anno scorso giuravano sulla perfezione dell’Italicum, sono prontissimi a cambiarlo - si notano in particolare i ministri Franceschini e Alfano - e tutti lo fanno raccomandando un dibattito «non strumentale». Ma è evidente l’interesse del governo, che di certo non riuscirà a cambiare la legge elettorale prima del referendum, ma che in questo modo offre l’impressione di una disponibilità che può aiutarlo a recuperare consensi per il Sì.
E poi c’è un altro aspetto: il punto che - adesso - Napolitano critica della legge elettorale è proprio uno dei due che la Corte costituzionale sarà chiamata a giudicare il 4 ottobre. Se le questioni di incostituzionalità avanzate dagli avvocati coordinati da Besostri dovessero essere accolte dalla Corte, la legge sarebbe migliorata eppure resterebbe una brutta legge. Il compromesso è evidentemente appoggiato da Napolitano, che quando era al Quirinale ha nominato cinque degli attuali giudici costituzionali (un terzo), compresi presidente (Grossi) e relatore (Zanon).
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. -- La sinistra sotto le macerie, Fukuyama, e la libertà del futuro (di Bia Sarasini)7 settembre 2016, di Federico La Sala
- LA DISFATTA DELL’ITALIA. LA CORRUZIONE, LA FONDAZIONE di "un partito che non era più una parte ma il tutto": "Forza Italia", E IL CONSENSO !!!. Un’analisi (con punto cieco) di Adriano Prosperi
- POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. Materiali sul tema
- LA LEZIONE DI CARLO LEVI - OGGI: LA "DITTA RENZI" (DI TORINO) AD ALIANO (MATERA). Un invito alla ri-lettura di "Cristo si è fermato ad Eboli"
La sinistra sotto le macerie e la libertà del futuro
Morte della politica. Solo scampoli di vecchi rancori e slogan ripetuti. Ma non è morta la politica. Anzi, bisogna fare l’operazione opposta a Fukuyama: spostare lo sguardo su ciò che può cominciare
di Bia Sarasini (il manifesto, 07.09.2016)
Tutto è politico, anche il terremoto, come è visibile ora, dopo i giorni di silenzio e di lutto dovuti al dolore e alla tragedia. Sono politiche le scelte, le prospettive, i progetti realizzati e quelli mai iniziati, le speranze e perfino la corruzione. Per questo mi lascia perplessa parlare di morte della politica. Mentre certamente è stata consumata una fine, la fine di una forma politica che a lungo abbiamo chiamato sinistra, e che comprende un insieme variegato di organizzazioni, sigle, pratiche, anche movimenti, oltre che un linguaggio e una visione del mondo.
Una fine non riconosciuta, continuamente rinviata e posticipata, e per questo sì, trasformata in una cristallizzazione di parole, di pratiche che non dicono più nulla, neanche a chi le perpetua con ostinazione. Peggio di una morte, per essere chiara, perché ci si è incaponiti a non nominarla, non vederla, e senza riconoscimento non si può elaborare il lutto, tutto si è trascina con sempre minore slancio, con nulli o quasi effetti visibili. Rimangono il rancore, le infinite accuse reciproche, la ripetizione di riti e comportamenti vuoti, parodie del potere che non c’è.
La novità è che ora, forse perché non c’è più nulla da smuovere, non ci sono più obiezioni e resistenze. Il rischio caso mai è il contrario. Confondere questa fine con la fine di tutto, della politica tout court. In un certo senso l’operazione opposta a quelle di Francis Fukuyama, quando nel 1992 proclamava la fine della Storia a fronte della caduta del muro di Berlino e della conseguente vittoria del capitalismo. Perché ha senso contemplare una fine, se si sposta lo sguardo su ciò che può cominciare. Altrimenti si tratta di una resa senza condizioni. E si lascia il campo a chi della cecità, e della confusione che ne è derivata, ha tratto il massimo profitto. In tutti sensi possibili. Economico e politico.
Un aspetto della complessità è che il fantasma della sinistra continua ad esistere, nello scenario politico italiano. Viene identificato con il Pd che pure, fin dalla sua nascita, da quando fu detto che lavoratori e imprenditori ne erano referenti allo stesso titolo, ha abbandonato la ragion d’essere di un partito di sinistra, anche moderato. La difesa della parte più debole della società, la lotta contro le ingiustizie.
L’insieme del corpo politico di quel partito, e della società, in prima linea il sistema dei media, hanno assecondato il rovesciamento del campo del riformismo, bandiera nobile di una delle forme della sinistra. Altro che difesa dei deboli.
L’efficienza, la redditività assunte come valori unici hanno aperto la strada a politiche a sostegno delle esigenze di multinazionali e banche. Le riforme sono diventate ciò che favorisce il potere, l’establishment.
L’inquinamento del linguaggio è una malattia grave: parole, idee, cose non dicono più ciò che dicevano. È in questa battaglia che la sinistra alternativa/radicale è stata spazzata via, una vicenda che andrebbe ripensata con attenzione e che non è solo il risultato di un’operazione mediatica. Nel contesto di un cambiamento di segno che ha investito le socialdemocrazie europee.
Senza dimenticare i segni di inversione, basti pensare alle tensioni del Labour Party, con Corbyn corpo estraneo all’establishment blairiano, o alle scelte di rottura dei partiti socialisti rispetto alle grandi alleanze in Portogallo e Spagna, quest’ultima una partita tuttora aperta.
In Italia Renzi ha radicalizzato la fisionomia del Pd, con una significativa torsione verso il centro, unita a una tensione al potere personale. Molto in sintonia con i progetti dell’establishment internazionale, come è evidente nell’intreccio tra Italicum e la de-forma costituzionale.
Qui si colloca la fine della sinistra. Quella popolare, di massa, quella alternativa, che pur divise anche ferocemente, hanno una lunga storia comune di scambi vitali che hanno segnato la società, hanno portato i risultati che hanno cambiato la vita dei lavoratori, delle donne, dei più poveri. Quei risultati che ora sono attaccati uno ad uno. A cominciare dalle condizioni di vita dei più giovani. La domanda è questa. Perché le sofferenze sociali, sempre più estese e insostenibili, non trovano una voce adeguata? Perché gli 11 milioni di italiani che hanno deciso di rinunciare a curarsi, di fronte a un sistema sanitario sempre più costoso, non sono al centro delle nostre battaglie? Perché il Jobs Act, che pure è stato ampiamente criticato, è passato nel sostanziale silenzio sociale?
Una prima risposta, dolorosa, ritengo sia in quella fine non consumata, che ha reso teatrali e sempre più vuote le proteste. Non conflitto reale, ma messa in scena del conflitto. E forse per quel punto di cui ha scritto Enzo Scandurra su questo giornale: che si è finito per assomigliare, nei comportamenti e nei pensieri, a quel potere a cui ci si opponeva. Non bastano l’invocazione della legalità, la lotta anti-casta, le idee che guidano il Movimento 5stelle, a dare una visione del mondo. Movimento che occupa lo spazio dell’opposizione, e che viene votato da chi ancora va a votare, perché ha una forza ritenuta comunque utile.
Con onestà va detto che una visione non è a portata di mano. E non ci sono ricette taumaturgiche. Non c’è un re che possa imporre la mano e guarire il popolo malato. Due punti mi sembrano chiari. Occorre comprendere, conoscere, interpretare lo stato delle cose. Quello attuale, in tutte le sue dinamiche. Cioè occorre studiare, riflettere, pensare. Lo so, sembra assurdo quando ciò che urge è l’azione. Ma su cosa agire, e come? Al di là delle denunce, delle polemiche ci siamo chiesti, per esempio, perché il corpo delle donne si trova al centro dello scontro politico internazionale?
Quale rovesciamento, del progressismo e dei femminismi, è in corso? A quale lavoro, quale rendimento, sono chiamati i corpi, le relazioni affettive, compresi piaceri e depressioni? Insomma, sappiamo a quale disegno sociale ci si oppone? Abbiamo gli attrezzi giusti? L’altro punto è praticare il realismo e la generosità delle battaglie. Uno dei modi per ostinarsi a non riconoscere la fine, e quindi occultare la decomposizione in corso, è rinchiudersi nei propri ambiti. Movimenti, associazioni, gruppi. Donne, uomini, generi diversi.
Un passo necessario è uscire da sé, guardarsi intorno. E scegliere insieme. Penso al referendum costituzionale. La vittoria del No non risolve i problemi specifici, è ovvio. Ma permetterà di affrontare con forza, e quadro istituzionale non compromesso, ogni battaglia.
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- Il «Partito della Nazione» e «Un Cesare democratico che non c’è». Così un Cesare democratico cambierebbe davvero il Paese (di E. Galli Della Loggia)7 giugno 2016, di Federico La Sala
- ROMOLO AUGUSTOLO: L’ITALIA NON E’ NUOVA A QUESTI SCENARI. C’E’ CAPO E "CAPO" E STATO E "STATO": MUSSOLINI E LENIN A CONFRONTO. L’analisi di Gramsci (già contro derive staliniste!), una bussola per non naufragare e una lezione di vita e di libertà
Così un Cesare democratico cambierebbe davvero il Paese
di Ernesto Galli della Loggia (Corriere della Sera, 07.06.2016)
«Un Cesare democratico che non c’è» s’intitolava un articolo pubblicato sul Corriere di qualche giorno fa. Dove indicavo come un fatto negativo l’assenza negli attuali sistemi politici dell’Europa occidentale di una leadership populista democratica, molto probabilmente l’unica in grado di opporsi all’ascesa del populismo reazionario e/o antisistema.
Le elezioni italiane di domenica sono una clamorosa conferma di questa assenza: esse hanno indicato infatti che Matteo Renzi, a dispetto di ciò che inizialmente aveva fatto credere, non è quel Cesare.
Per cominciare, proprio domenica è mancata al presidente del Consiglio la capacità di realizzare quello che è l’obiettivo più tipico che distingue una leadership tendenzialmente populista (di qualsiasi segno essa sia) da una leadership democratica tradizionale: cioè ottenere un consenso trasversale a destra e a sinistra - così come, per l’appunto, gli era capitato nelle ultime elezioni europee. Domenica, invece, sotto la guida di Renzi il Pd non è riuscito a pescare voti in alcun serbatoio diverso dal suo, di cui anzi ha sicuramente perduto una parte. Esattamente l’opposto, tra l’altro, di ciò che avrebbe dovuto fare un eventuale «Partito della Nazione».
Il deludente risultato elettorale non nasce domenica. L’iniziativa di Renzi in questo ultimo anno si è mostrata singolarmente inadeguata su due temi a cui l’opinione pubblica è sensibilissima, e che per giunta sono tra quelli la cui essenzialità un Cesare democratico avrebbe dovuto immediatamente cogliere, agendo di conseguenza.
Il primo è quello dell’immigrazione e del connesso ruolo dell’Europa. In un anno e più, al di là di molte belle parole, di promesse non mantenute e di qualche gesto poco significativo (una manciata di navi dei Paesi dell’Unione nel Mediterraneo), da Bruxelles il presidente del Consiglio non ha in pratica ottenuto nulla. E non ha potuto fare nulla per regolare il flusso dei nuovi arrivi.
Alla ricerca anche lui del benevolo accreditamento a Berlino o a Parigi, al quale come al solito i politici di casa nostra aspirano quando si parla di Europa, e timoroso di non ottenere il necessario assenso della signora Merkel sulla «flessibilità» dei conti pubblici, Matteo Renzi ha finito per apparire a rimorchio dei fatti. La proposta del cosiddetto Migration compact (tra parentesi: ma perché mai un governo italiano, presieduto per giunta da un fiorentino, deve esprimersi sempre in inglese? Il Jobs act, poi il Migration compact, adesso si annuncia un Social act: ci si rende conto della ridicolaggine da poveri provinciali di tutto ciò?), il Migration compact, dicevo, ha ricevuto un educato consenso di maniera da tutti, ma da settimane è fermo e non fa un passo avanti.
Un pessimo presagio. Renzi, in particolar modo, non è apparso in grado più di tanto di tenere un profilo realmente deciso e combattivo nei confronti dei nostri partner europei. Realmente deciso significa pronto a usare quel linguaggio realistico, e perciò capace di prospettare eventuali ritorsioni concrete, che è il solo che gli Stati capiscono.
Il secondo fronte che la leadership populista di un vero Cesare democratico avrebbe dovuto subito percepire come peculiarmente proprio, e del quale Renzi invece si è sostanzialmente disinteressato, è stato quello della crisi degli istituti bancari. Una crisi che ha destato un allarme vastissimo in un popolo di risparmiatori quali sono gli italiani, e che per la sua ampiezza (cinque o sei istituti molto radicati nei rispettivi territori) ha mostrato in misura chiarissima i legami ambigui e spesso truffaldini che nella provincia italiana legano le oligarchie locali e le élite economiche, spesso accumunate da una sostanza moralmente opaca dietro l’apparenza di un’operosa rispettabilità.
Renzi non ha colto affatto l’occasione offertagli da una questione così simbolicamente significativa per prendere le difese dei «molti» e «piccoli» contro l’avidità bancarottiera dei «grossi». Ha rinunciato a far pesare in tutta la questione l’autorità del comando politico e delle sua prerogative. Per esempio ha preferito chiudere gli occhi sulla condotta della dirigenza della Consob, una delle «Autorità» di controllo più invischiata da sempre in mille complicità con i suoi controllati, e affidata alla guida di un tipico esponente di quel ceto di alti burocrati convertiti alla politica e poi tornati all’amministrazione, che è interessato sempre e solo a rimanere a galla. Non ha colto il valore generale della questione (specie in un periodo in cui molti sono costretti a stringere la cinghia), lasciando tutto a una gestione inevitabilmente «burocratica».
La verità è che in generale Renzi avverte realmente, io credo, la necessità di cambiare il Paese; ma al di là della «rottamazione» - peraltro finora attuata perlopiù a danno dei suoi avversari interni del Pd - gli riesce difficile individuare altre linee direttrici lungo le quali operare effettivamente. Gli riesce difficile individuare nemici importanti da combattere, amministrazioni cruciali da riformare, interessi economici e sociali da colpire, istituzioni da rifondare. Lo si direbbe voglioso piuttosto di piacere, di elargire, di ottenere in tal modo consenso a destra e a manca: un consenso che così, però, non gli arriva o dura lo spazio di un mattino. Così, il solo consenso vero che è sembrato essergli venuto, infatti, è quello di spezzoni di classe politico-parlamentare in disarmo, alla ricerca di una lista in cui farsi rieleggere.
Per cambiare il Paese - come tre anni fa aveva detto di voler fare, accendendo molte speranze, quello che allora si presentò come un giovane Cesare democratico in potenza - non bastano spurie alleanze parlamentari. Se si vuole davvero farlo, allora bisogna riuscire a mettere insieme molteplici forze sociali da impegnare in un programma comune all’insegna di un reciproco scambio di interessi di lungo periodo; e serve assicurarsi la collaborazione non di ministri perlopiù insignificanti, ma delle migliori energie intellettuali del Paese. E serve, infine, essere capaci di cogliere il sentire della gente (sì della famigerata «gente»), mettersi in sintonia con l’uomo della strada, calarsi nelle sue esigenze quotidiane e nelle sue rabbie, ma anche far conto sui suoi sogni e sul suo desiderio frequente di essere migliore di quello che è.
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. -- 2 giugno 1946 - 2016. La pacata euforia di settant’anni fa e il paese spaesato di oggi. (Note di N. Urbinati e G. Crainz).2 giugno 2016, di Federico La Sala
Il paese spaesato che ancora s’interroga sulla sua Repubblica
Da una società sofferente, capace di sollevarsi e avviare uno sviluppo straordinario a un quotidiano in cui tante energie sono smarrite
di Guido Crainz (la Repubblica, 02.06.2016)
- Molte le occasioni mancate: ce lo ricordano la diserzione dal voto e la corruzione dilagante
Con quali domande guardare ai settant’anni della nostra Repubblica? Con quali convinzioni, con quali dubbi? La sua conquista era apparsa a Piero Calamandrei «un miracolo della ragione» e Ignazio Silone aveva aggiunto: alle sue origini non c’è nessun vate o retore ma «il costume dei cittadini che l’ha voluta». «Una creatura povera, assistita da parenti poveri», per dirla con Corrado Alvaro, ma pervasa dalla volontà di risorgere. All’indomani della Liberazione Milano era in rovine, ha ricordato Carlo Levi, ma «le strade erano piene di una folla esuberante, curiosa e felice. Andavano a comizi, a riunioni, a passeggio, chissà dove».
 Era anche profondamente divisa, quella Italia, e per la monarchia
votò molta parte di un Mezzogiorno che ancora a Levi era apparso «un altro mondo, serrato nel dolore e negli usi, negato alla Storia e allo Stato». Da qui siamo partiti, in questo quadro abbiamo costruito democrazia, ed essa non era un concetto del tutto scontato allora né per il Partito comunista né per la Chiesa di Pio XII.
Era anche profondamente divisa, quella Italia, e per la monarchia
votò molta parte di un Mezzogiorno che ancora a Levi era apparso «un altro mondo, serrato nel dolore e negli usi, negato alla Storia e allo Stato». Da qui siamo partiti, in questo quadro abbiamo costruito democrazia, ed essa non era un concetto del tutto scontato allora né per il Partito comunista né per la Chiesa di Pio XII.Come si è passati dalla società sofferente e vitale del dopoguerra, capace di risollevarsi dalle macerie e protagonista poi di uno sviluppo straordinario, all’Italia di oggi? Spesso spaesata, confusa, incerta di se stessa. Come si è passati da un sistema dei partiti cui si affidava sostanzialmente con fiducia un Paese piagato ad un degradare che oggi ci appare quasi senza fine? Davvero in questo percorso tutte le nostre energie e le nostre “passioni di democrazia” sono andate disperse o smarrite?
Abbiamo attraversato tre mondi, in questi settant’anni: da quello largamente rurale del dopoguerra alla stagione dell’Italia industriale e sino agli scenari che dagli anni ottanta giungono sino ad oggi. Abbiamo attraversato anche climi politici e culturali molto diversi, passando presto dalla fase più aspra della “guerra fredda” alla felice stagione del “miracolo economico”.
 Mutò volto allora l’Italia e si consolidò il suo esser Nazione (lo vedemmo nel primo centenario dell’Unità): il diffuso ottimismo fece sottovalutare però i moniti di chi - da Ugo La Malfa a Riccardo Lombardi - avvertiva l’urgenza di porre mano a squilibri vecchi e nuovi del Paese, e di riformare profondamente le istituzioni. Avemmo così una trasformazione non governata, uno sviluppo senza guida, e anche per questo le effervescenze degli anni sessanta furono più forti che altrove.
Mutò volto allora l’Italia e si consolidò il suo esser Nazione (lo vedemmo nel primo centenario dell’Unità): il diffuso ottimismo fece sottovalutare però i moniti di chi - da Ugo La Malfa a Riccardo Lombardi - avvertiva l’urgenza di porre mano a squilibri vecchi e nuovi del Paese, e di riformare profondamente le istituzioni. Avemmo così una trasformazione non governata, uno sviluppo senza guida, e anche per questo le effervescenze degli anni sessanta furono più forti che altrove.Nel decennio successivo convissero poi reali processi riformatori e la cupezza feroce del terrorismo: dalla “strategia della tensione” alimentata dal neofascismo al terrorismo di sinistra degli “anni di piombo”. La Repubblica fu messa davvero alla prova in quegli anni e seppe rispondere: lo vedemmo a Milano, ai commossi funerali per le vittime di piazza Fontana, e a Brescia all’indomani della strage di Piazza della Loggia. Lo vedemmo nei 55 lunghissimi giorni del rapimento di Aldo Moro e poi a Genova, ai funerali dell’operaio Guido Rossa.
E lo vedemmo nella mobilitazione civile di Bologna dopo la strage alla Stazione. Vi è lì, fra anni settanta e ottanta, un crinale decisivo: storici di differente ispirazione hanno letto la cerimonia funebre per Aldo Moro in San Giovanni in Laterano quasi come “funerali della Repubblica”, annuncio che una sua fase era terminata. E si riveda l’addio di popolo ad Enrico Berlinguer, sei anni dopo: esso ci appare oggi l’estremo saluto non solo a un leader ma anche ai grandi partiti del Novecento.
Inizia a mutare davvero il Paese allora, mentre il crollo sindacale alla Fiat annuncia il declinare dell’Italia industriale. Si scorgono al tempo stesso i primi segni di una corrosione che non è riconducibile solo ai Sindona e ai Gelli ma è rivelata da fenomeni molto più pervasivi.
Nel 1980 su queste pagine Italo Calvino proponeva uno splendido Apologo sull’onestà nel paese dei corrotti («c’era un paese che si reggeva sull’illecito») mentre Massimo Riva vedeva profilarsi «il Fantasma della Seconda Repubblica »: ogni giorno che passa, scriveva, si attenua la speranza che possano farla nascere politici sagaci e democratici e «cresce il timore che possa farlo con successo qualche avventuriero senza scrupoli ».
Parole inascoltate, nei “dorati anni ottanta”: negli affascinanti scenari del mondo post-industriale, nel progressivo scomporsi di classi e ceti sociali, nel dilagare di pulsioni al successo e all’arricchimento senza regole, contrastate sempre più debolmente da anticorpi civili e da culture solidaristiche. La modernità sembra divaricarsi ora dal progresso e dalla crescita dei diritti collettivi, e sembra identificarsi con l’euforia sociale e con l’affermazione individuale.
 Inizia allora anche il declinare dei partiti basati sulla partecipazione e l’identità, nel primo profilarsi di “partiti personali” (a cominciare dal Psi di Craxi) e di quell’intreccio fra politica- spettacolo e tv che trasforma la comunità dei cittadini in una platea di telespettatori. Si forma sempre allora, nella crescente incapacità di governo della politica, quel colossale debito pubblico che ancora grava su di noi come un macigno: non solo economico ma etico, perché prende corpo così un Paese che spende oltre le proprie possibilità e lascia il conto da pagare ai figli. Un Paese che non sa prender atto della fine dell’“età dell’oro” dell’Occidente e non sa ripensare il welfare, elemento fondativo delle democrazie moderne.
Inizia allora anche il declinare dei partiti basati sulla partecipazione e l’identità, nel primo profilarsi di “partiti personali” (a cominciare dal Psi di Craxi) e di quell’intreccio fra politica- spettacolo e tv che trasforma la comunità dei cittadini in una platea di telespettatori. Si forma sempre allora, nella crescente incapacità di governo della politica, quel colossale debito pubblico che ancora grava su di noi come un macigno: non solo economico ma etico, perché prende corpo così un Paese che spende oltre le proprie possibilità e lascia il conto da pagare ai figli. Un Paese che non sa prender atto della fine dell’“età dell’oro” dell’Occidente e non sa ripensare il welfare, elemento fondativo delle democrazie moderne.Crollerà davvero il vecchio sistema dei partiti, nella bufera di Tangentopoli, e verrà davvero l’“avventuriero”, per dirla con Riva: eppure ci illudemmo che, liberata dal precedente ceto politico, una salvifica società civile avrebbe conquistato un luminoso avvenire. Dell’ultimo, quasi disperato Pasolini ricordammo le riflessioni sul degradare del Palazzo e rimuovemmo invece quelle sulla mutazione antropologica del Paese. Mancammo allora l’occasione per una rifondazione della politica capace di ridare fiducia nella democrazia, e da tempo abbiamo superato il livello di guardia: ce lo ricordano ogni giorno il crollare della partecipazione al voto e il dilagare di una corruzione che non ha neppure l’alibi di “ragioni politiche”.
C’è davvero molto su cui interrogarsi, a settant’anni da quel 2 giugno, e viene talora da chiedersi se siamo diventati davvero una Repubblica, nel senso più alto del termine. Così certo è stato ma vale anche per la Repubblica quel che Ernest Renan diceva della Nazione: non è mai una conquista definitiva ma un “plebiscito quotidiano”, una scelta da rinnovare ogni giorno. È forte la sensazione che da troppo tempo non rinnoviamo realmente quel plebiscito ed oggi esso ci appare sempre più necessario, e urgente.
- L’ITALIA, LA SUA BANDIERA, E IL PARTITO DELL’IPNOTIZZAZIONE DELLA NAZIONE *
- Il tricolore è “abusivo” a Vallo della Lucania, via le bandierine I vigili urbani le hanno fatto rimuovere dopo che i commercianti le avevno esposte sul corso per l’anniversario della Repubblica e i prossimi Europei di calcio (La Città di Salerno, 02 giugno 2016)
- Vallo della Lucania (Salerno) mostra a tutta l’Italia la condizione di sonnambulismo in cui tutti i cittadini e tutte le cittadine sono stati buttati e buttate da tempo!
- Nel giorno dei Tre Anniversari (Repubblica, Costituente, Voto alle donne) in Uno (2 giugno 1946- 2016), dopo venti anni di confusione tra *partito* e *Patria*, siamo nel *pallone* totale!!! E i vigili hanno tirato il *rigore*!!!
La pacata euforia di settant’anni fadi Nadia Urbinati (la Repubblica, 02.06.2016)
LA festa del 2 Giugno non ha mai rappresentato motivo di scontro ideologico, nonostante le divergenze politiche profonde tra i protagonisti della nascita della Repubblica. Raccontano le cronache che i vincitori di quel referendum non volevano ostentare esagerazione nella vittoria «perché non volevano che questa suonasse offesa agli sconfitti » scrivono Daria Gabusi e Liviana Rocchi nel loro libro su Le feste della Repubblica.
Tutti gli italiani e le italiane, questa era la convinzione unanime, si erano fusi in un patto che era e doveva essere al di sopra di ogni forma istituzionale e che aveva il suo documento nell’unità del Paese, suggellato da una guerra anche fratricida. Tutti consapevoli che quel plebiscito di natalità era un atto di inizio non il testo della liquidazione del passato. E per questo, nei resoconti successivi alla vittoria della Repubblica nel referendum del 2 Giugno circolava addirittura un ossimoro per raccontare quegli eventi: pacata euforia; «l’inizio della nuova Italia era non nella baldoria, me nel silenzio, nella serietà e nella compostezza». Qualcuno si lamenta, scrisse Ignazio Silone, «per l’assenza di un vate in un momento così eccezionale della Storia italiana». La democrazia era nata senza vati e senza capi, senza parole roboanti che parlassero di “momento storico”, anche se quello era certamente un momento storico. Ma un atto di liberazione non roboante e pacato era per Silone «un atto di modernità», un vero atto di nascita, di festa, di letizia. E per sottolineare questa modernità di seria e corale responsabilità Piero Calamandrei parlò di un «miracolo della ragione».
Il “miracolo della ragione” era manifestato proprio dalla forza dei numeri con cui venne proclamata la Repubblica. Il 10 giugno ne diedero lettura davanti ai giudici togati, racconta l’allora ministro degli Interni, Romita: la comunicazione alla Corte di Cassazione con i togati in piedi era semplicemente questa, «per la Repubblica 12.672.767 voti; per la Monarchia 10.688.905». Niente altro. Commenta Romita: «Una svolta veramente storica, la semplicità direi quasi la pudica modestia, era la più peculiare caratteristica della cerimonia ». I numeri soltanto, la ragione democratica per eccellenza, prendevano la scena; da soli bastavano. Dovevano bastare per dar legittimità di una differenza non davvero grande, eppure enorme.
Il patto che ne scaturì fu un patto di unione che andava ben oltre i due milioni di voti di distacco. Un patto che ha reso possibile settant’anni di vita civile. La Costituzione ha unito il Paese, e lo ha fatto nel rispetto delle differenze, molte e spesso radicali. Come una grammatica comune, ha consentito al pluralismo delle idee e dei progetti di essere leva di una dinamica libertà, di unire i diversi. È a questo del resto che le Costituzioni servono: a dare regole condivise da tutti perché ciascuno possa liberamente contribuire con le proprie idee e i propri interessi al governo della cosa pubblica, con la parola e il voto, con l’elezione dei rappresentanti e la formazione delle maggioranze.
L’impianto anti-retorico e di “pacata euforia” della Repubblica che celebrava se stessa con quel referendum era un inizio felice, un atto sia legale che pedagogico. Come a voler abituare gli italiani e le italiane a un succedersi di vittorie e sconfitte, ma sempre sentendo quel fatto fondamentale un bene di tutti, non di chi aveva vinto.
Per il modo come l’attuale campagna referendaria si sta svolgendo vi è da temere che la Costituzione che ne uscirà non abbia la stessa forza legittimante unitaria. Quale che sia l’esito. Come ha scritto Alfredo Reichlin su questo giornale qualche giorno fa, vi è da temere che la Costituzione sia vissuta, dai vincitori come dai vinti, come una norma di parte contro parte. Se resterà questa Costituzione come pure se passerà la sua revisione. In entrambi i casi l’esito di un referendum così aspro potrebbe essere questo - e questo è il più grande rischio che corre il Paese. Comunque finirà, i vinti non si sentiranno con molta probabilità parte della stessa impresa e i vincitori.
I padri costituenti decisero di distruggere le minute delle loro lunghe discussioni alla fine dei lavori dell’Assemblea costituente - perché sapevano che nell’atto volontario di oblio delle divisioni stava la condizione per cominciare e sentire la Carta come un patto di unità. Un gesto saggio. Come si può dimenticare una lotta a tratti furiosa nel linguaggio, combattuta per di più non ad armi pari poiché una parte ha già da ora più esposizione e più attenzione dell’altra? Come cementare un’unità nella diversità se la diversità è, da ora, vissuta come un problema? Una lotta così cruenta quando le ideologie non ci sono più a dividere è un fatto difficile da comprendere e spiegare. E tuttavia il rischio concreto sarà proprio quello di giungere, dopo settant’anni di unione, ad una Costituzione che divide ed è divisiva, sentita come bene di parte, di alcuni contro altri. Di questo dovremmo preoccuparci.
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA --- "Non ti riconosco": Marco Revelli racconta l’Italia sfigurata dai morsi della crisi (di Corrado Stajano)12 maggio 2016, di Federico La Sala
itinerari
Marco Revelli racconta l’Italia
sfigurata dai morsi della crisi
Nel libro Non ti riconosco (Einaudi) il politologo piemontese descrive le conseguenze della recessione su diverse realtà: Torino, la Brianza, Taranto, la Calabria e Lampedusa
di Corrado Stajano (Corriere della Sera, 12.05.2016)
Si sa, la conoscenza che la classe dirigente politica nostrana ha della società è relativa. Ministri, senatori, deputati affidano ai loro portaborse e ai loro galoppini l’incarico di riferire le notizie che vogliono. L’ottimismo di maniera è la regola, oggi più che mai.
Questo libro di Marco Revelli, Non ti riconosco. Un viaggio eretico nell’Italia che cambia (Einaudi), può far tremare le vene e i polsi con il suo spirito di verità. Revelli conosce bene la società italiana, ha le carte in regola per parlarne, professore di Scienza della politica, autore di libri come Oltre il Novecento, La politica perduta, Poveri noi, Finale di partito, Dentro e contro (quando il populismo è di governo). Il nuovo libro, 5-6 anni di lavoro, è un viaggio in Italia, ma il Grand Tour, gli stranieri più o meno illustri alla ricerca, dal Settecento al Novecento, della bellezza e del mitologico splendore, soprattutto del Sud, non è il modello. Anche se il titolo si rifà a un Lied di Goethe, gran viaggiatore nell’Italia amata.
Marco Revelli non riconosce più il Bel Paese. Confessa di essere spaesato, tradito, disorientato, sradicato: «L’io», scrive, «non si sente più “a casa” in nessun luogo del mondo perché ”il mondo” non ha più nulla ormai di famigliare, di “domestico”. In una parola: di riconoscibile». Ma non si rassegna Revelli, va a vedere. «Un viaggio si fa o per fuggire da qualcosa, o per cercare qualcosa», come ha detto Diego Osorno, grande reporter-narratore messicano. E anche per ritornare: Claudio Magris.
Non ti riconosco è un libro duro, crudo, sofferente. In viaggio, da Torino a Lampedusa. Pessimista? Realista, piuttosto. Un libro di grande bellezza, il suo, se si potesse usare il codice estetico. I luoghi, le persone, le loro storie, gli incontri, il passato-presente sono i protagonisti. Revelli osserva, interroga, è un ispettore generale, uno scrittore senza modelli, un narratore, un professore che studia, al di là degli scheletri dei documenti. Parla con il prossimo, parla anche con se stesso, spiega, vuol capire, per far capire e per capirsi. Il libro è una mescolanza di racconto, saggio, inchiesta, verifica dei poteri, analisi ossessiva, un continuo fare i conti - perché è potuto accadere? - è anche la ricerca di un’uscita di sicurezza, il tempo per farlo è breve in una società che sembra rassegnata, passiva, chiusa in se stessa. Una società che ha smarrito i fervori di certe generazioni passate e non può affidarsi a una classe dirigente politica incolta e arrogante che fa di tutto per cancellare il valore sommo della democrazia. Non c’è bisogno di scomodare il V secolo a. C. di Pericle, basta non tradire i momenti di dignità della neonata Repubblica, la Resistenza, la Costituzione.
Il viaggio comincia nella città che Revelli ben conosce, Torino. Lo scrittore non ha nostalgie, affetti piuttosto. Che cos’era Mirafiori! Un posto ciclopico, infernale, mostruoso in tutti i sensi, con un perimetro di 11 chilometri, 32 porte, 60 mila operai, un sordo rumore ininterrotto che, brontolante, veniva su dalle viscere. Oggi? «Quel cratere si è spento. Materia fredda. E silenziosa. Non si sentono più vibrazioni, ronzii di macchine al lavoro, men che meno grida di rivolta. Né il tonfo cadenzato delle Grandi Presse». Gli operai sopravvissuti sono 5.321, dalle linee di produzione escono un centinaio di auto al giorno, ne uscivano 5.000. La Fiat si chiama Fca, la sede legale del gruppo, dopo la fusione con la Chrysler, è ad Amsterdam, la sede fiscale a Londra. Tutto frantumato, sminuzzato, rimpicciolito, ridotto a rottame. La grande distribuzione ha vinto sulla grande produzione. A Torino, dove non c’è soltanto la Fca, la vita continua, nonostante tutto, e stanno nascendo laboratori: Arduino, per esempio, che non è un uomo, ma «una scheda» che crea gli oggetti più disparati; i Traders, fornitori di servizi, e non pochi inventori di nuovi lavori, il contrario della produzione fordista. Le iniziative esistono ma, se manca una politica sana e intelligente, com’è possibile collegare tra loro tutte quelle energie positive?
Da Torino alla Brianza, la Silicon Valley italiana degli anni Ottanta, dove prosperavano l’Alcatel, la Micron, la Celestica, e con loro 800 imprese nell’ambito delle telecomunicazioni. Il dimagrimento cominciò nel 2008, poi la caduta a cascata, i tagli, le mobilità, le bancarotte, l’esplosione, l’implosione. Marco Revelli prova anche qui un senso di irrealtà. Racconta di quando, nella placida Brianza, gli ingegneri, l’aristocrazia di quel settore di lavoro, accolsero nel 2014, a Vimercate, il presidente del Consiglio Renzi «in visita pastorale all’impresa simbolo della velocità e della rottamazione», l’Alcatel appunto, con cartelli beffardi: «Se Renzi è di sinistra, Berlusconi è femminista».
E poi il tragico Nordest. Gian Antonio Stella, nel suo Schei (1996), raccontò l’incredibile boom del Veneto diventato «la locomotiva d’Italia», il «Giappone d’Europa»: le scarpe nel Veronese, la concia ad Arzignano, gli occhiali a Belluno, i mobili a Bassano, lo Sportsystem a Montebelluna, l’oro nel Vicentino.
Revelli è andato a vedere. A Rossano Veneto, piccola capitale del boom, 6.532 abitanti, 900 imprese: con la crisi globale è arrivata la depressione, la «malaombra». Sono caduti i capannoni, le villette a schiera, i fienili diventati officine, i posti di lavoro. In quegli anni, nel Nordest, si calcola che ci siano stati 500 suicidi, tra imprenditori e dipendenti. Le cause? «In questo Nordest euforico trasformato in un Far West triste si assiste al paradosso per cui si fallisce per troppi crediti». (I mancati incassi del committente insolvente, della pubblica amministrazione inadempiente hanno creato debiti incolpevoli con tragiche conseguenze).
Il viaggio alla Taranto dell’Ilva ha il colore del piombo fuso. E pensare che la nuvola portatrice di morte aleggiante sullo stabilimento di colore rossastro, non pareva nemica. Il IV Centro siderurgico, nato nel 1964, doveva rappresentare il riscatto delle plebi meridionali, con i suoi due milioni di tonnellate d’acciaio all’anno. È diventato soltanto una fabbrica di morte, portatrice di una catena di tumori, anche nei quartieri vicini, il Tamburi, il Paolo VI. Fu un professore di storia, Alessandro Marescotti che, sospettoso, fece analizzare da un chimico un pezzo di formaggio e rese pubblica la notizia sulla mostruosa concentrazione di diossina che pesava sull’Ilva e su Taranto. Revelli registra la tragedia, studia i documenti, parla con gli operai, «gli occhi bassi dei vinti».
Poi la Calabria. Al porto di Gioia Tauro la ’ndrangheta è padrona, d’accordo con i cartelli messicani della droga, armi e cocaina. Lo scrittore, in questo paesaggio di struggente bellezza, incontra chi non si è arreso, un giornalista sotto scorta, Michele Albanese, e un imprenditore che ha detto no al pizzo, Nino De Masi, mitragliato, minacciato, anche lui sotto scorta. Che cosa sanno i governanti della questione meridionale e della questione criminale che ne è parte integrante?
Il libro finisce a Lampedusa dove la sindaca Giusi Nicolini fa fronte con coraggio. Lei e papa Francesco. Marco Revelli visita con angoscia un cimitero dove le croci sono state costruite con il legno delle barche affondate. Su uno sperone di roccia di Punta Maluk, un artista, Mimmo Paladino, ha costruito, con materiali difformi, la Porta d’Europa, un simbolo imponente, sacrale. Chissà che i Paesi del Continente si rendano conto una buona volta di questa nuova strage degli innocenti. La Shoah dei migranti.
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- : «Il 18 brumaio di Luigi Bonaparte». La grande analisi di Marx, in una nuova edizione a c. di Michele Prospero.18 marzo 2016, di Federico La Sala
In tragedia e in farsa, la storia che raddoppia e non conclude
Una nuova edizione de «Il 18 brumaio di Luigi Bonaparte», per Editori Riuniti. Un’analisi del bonapartismo la cui lettura è utile anche per indagare i fenomeni politici contemporanei. In una nuova edizione l’opera del 1852
di Francesco Marchianò (il manifesto, 30.01.2016)
Il 18 brumaio di Luigi Bonaparte (Editori Riuniti, pp. 248, euro 18,00) è, certamente, uno dei testi più originali di Marx nel quale l’analisi materialistica della storia è connessa a quella politica. In quest’opera, dedicata agli avvenimenti che dal 1848 al 1851 modificarono il sistema politico francese e lo fecero transitare da una repubblica all’impero, dopo il colpo di stato di Luigi Bonaparte, Marx si distinse per essere un attento studioso delle dinamiche giuridiche, politiche, economiche e sociali, compiendo una precisa analisi sistemica.
Scritto dal dicembre 1851 al marzo 1852, inizialmente per il settimanale Die Revolution, edito a New York dall’amico editore Weydemeyer, l’opera subì diverse vicissitudini e solo nel 1869 comparve ad Amburgo una seconda edizione europea, dopo che in passato in tentativi di darne diffusione nel continente erano falliti.
In Italia è da poco comparsa per Editori Riuniti una nuova edizione affidata alla cura di Michele Prospero che, in una densa e raffinata introduzione, non solo offre le necessarie chiavi di lettura per comprendere meglio l’opera, ma ne attualizza in maniera impeccabile la portata. Ne escono, così, fuori due testi in uno che è molto fruttuoso leggere insieme.
Il testo di Marx brilla da diversi punti di vista, non ultimo per lo stile letterario e la coniazione di alcune frasi rimaste poi celebri, come quella della storia che si ripete due volte, prima come tragedia, poi come farsa, con la quale si apre il volume. Oppure per il «cretinismo parlamentare», malattia diagnostica ai difensori della repubblica che abusando dei trucchi e delle imboscate in aula non facevano altro che screditare il parlamento che volevano difendere.
L’aspetto essenziale che caratterizza l’opera, tuttavia, è l’analisi contestuale che indaga tutti i fattori che intervengono in un cambio di regime o, diremmo oggi con un lessico più moderno, in una transizione. È cioè la spiegazione di come la repubblica, non riuscendo a trovare gli ancoraggi necessari al suo consolidamento nella società francese, produsse come esito il successo di una leadership personale che portò a un’altra forma di dominio politico.
Nella lettura compiuta da Marx si colgono perfettamente le cause di questo passaggio che non sono da attribuire al magismo del capo, al suo carisma, ma al concatenarsi di elementi esterni. Come spiega Prospero, «esistono condizioni politiche e sociali di fondo il cui degrado spiega anche l’emergere di tendenze carismatiche pronte a sfruttare le fragilità del sistema sottoposto allo stress della partecipazione politica di milioni di elettori».
Marx mette in luce tutti gli elementi essenziali che intervengono in questa dinamica. A cominciare da quelli giuridico-politici, dati dalle contraddizioni della costituzione, dal carattere limitativo della legge ordinaria rispetto ai diritti enunciati in essa, dal conflitto potenziale tra l’assemblea e il presidente della repubblica. In questa situazione di perenne incertezza veniva meno un elemento essenziale dato dalla legittimità che richiedeva il sistema, specialmente dopo l’allargamento del suffragio. -Occorreva cioè trovare nel sociale la base di sostegno del politico.
È ciò che è mancato alla repubblica che finì per non includere affatto le masse. Anzi, proprio questa «asimmetria tra forte apparato statale e debolezza della società civile», secondo Prospero, è l’espressione peculiare del bonapartismo. Luigi Bonaparte, invece, lungi dal non avere un radicamento sociale, si manifesta, secondo le parole di Marx, come il rappresentante di «una classe, anzi della classe più numerosa della società francese, i contadini piccoli proprietari», una «classe a metà» i cui appartenenti sono tra loro isolati, ma condividono situazioni di forte miseria che li mettono contro le altre classi sociali. Non avendo la capacità di far valere i propri interessi, essi hanno bisogno di farsi rappresentare da qualcuno che appare loro come un «padrone», «come un potere governativo illimitato, che li difende dalle altre classi»; ne consegue che «l’influenza politica del contadino piccolo proprietario trova quindi la sua ultima espressione nel fatto che il potere esecutivo subordina la società a se stesso».
L’analisi contenuta nel 18 brumaio rimane perennemente attuale per indagare i fenomeni politici contemporanei poiché fornisce tutte le categorie necessarie per comprendere cosa succede nei momenti di debolezza del sistema politico. Essa può essere utile anche per interpretare le dinamiche che coinvolgono il nostro Paese dove il continuo tentativo di riforma della costituzione, l’incertezza del sistema, la scarsa legittimazione sua e dei suoi attori, il consolidarsi di interessi e forze private, può sempre consentire, volendo usare le parole di Marx, «a un personaggio mediocre e grottesco di fare la parte dell’eroe».
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- ATTUALITA’ DI MARX. Da Mussolini a Berlusconi: «Il 18 brumaio di Luigi Bonaparte» (di Vittorio Ducoli).19 marzo 2016, di Federico La Sala
ATTUALITA’ DI MARX
Il 18 brumaio di Luigi Bonaparte
by Karl Marx, Giorgio Giorgetti (Editor), Palmiro Togliatti (Translator)
Vittorio Ducoli’s Reviews (Goodreads, 16 marzo 2013)
Attualità di Marx
L’altro giorno, 14 marzo, ricorreva il 130° anniversario della morte di Karl Marx.
Per puro caso, nello stesso giorno ho finito di leggere Il 18 brumaio di Luigi Bonaparte, che ritengo uno dei testi fondamentali per addentrarsi nelle idee di questo grandissimo pensatore e per apprezzarne appieno l’attualità, a dispetto della vulgata interessata che vorrebbe il pensiero marxiano solo un retaggio del passato.
Un primo elemento a favore di questo testo è il tema. Non si tratta di un trattato filosofico o di critica all’economia politica, la cui lettura spesso richiede un sostrato culturale molto solido, ma dell’analisi di Marx degli avvenimenti che tra il febbraio 1848 e il dicembre 1851 videro la Francia passare dalla fase rivoluzionaria che aveva portato alla caduta della monarchia di Luigi Filippo d’Orleans al trionfo della più bieca reazione con il colpo di stato attuato da Luigi Napoleone Bonaparte, il futuro Napoleone III. Si tratta quindi di un’analisi storica di fatti che hanno avuto conseguenze importantissime sull’intera storia europea, e non solo, dei decenni successivi.
Ho messo in corsivo l’aggettivo storica perché Marx scrive i testi che formano il libro pochissimo dopo, nel 1852: eppure la sua analisi è così compiuta, così lucida, così minuziosa e supportata da dati ed elementi oggettivi da assumere il carattere pieno dell’indagine storica.
Un altro elemento che caratterizza il 18 brumaio è la brillantezza della scrittura. A differenza di quanto si possa pensare, Marx non è affatto un autore pesante, ma una delle più brillanti penne del XIX secolo. Basta pensare a quante sue frasi, aforismi, paradossi facciano parte del nostro bagaglio culturale per rendersi conto di ciò; purtroppo, molti dei suoi testi riguardano argomenti ostici, trattati ed approfonditi con rigore, e questo ovviamente genera complessità: pregio di questo volume è di offrirci un Marx sicuramente non leggero ma scorrevole, per molti tratti appassionante, laddove gli avvenimenti si susseguono incalzanti e Marx ce ne disvela le ragioni vere e ultime.
Sì, perché il senso di questo libro è far capire, anche a noi oggi, la distanza che esiste tra le cause ideologiche dei conflitti e le loro cause vere che, ci dice Marx, vanno sempre ricercate nei conflitti tra le classi e i loro diversi interessi.
Marx, pagina dopo pagina, ci narra gli scontri di piazza e le lotte tra le diverse fazioni parlamentari che caratterizzarono il biennio, individuando oggettivamente le motivazioni vere che ne erano alla base. Così, l’acerrima lotta avvenuta nell’Assemblea legislativa tra Partito dell’Ordine (monarchici) e Montagna (repubblicani), lungi dall’essere una lotta sulla forma dello stato è una lotta tra gli interessi della grande borghesia e quelli dei borghesi medi e piccoli. Leggendo questo testo è quindi agevole comprendere in pratica la tesi marxiana per cui la storia è il risultato della lotta tra le varie classi sociali.
Forse però l’aspetto del libro che affascina di più è l’analisi delle motivazioni che portarono al colpo di stato di Luigi Napoleone. Marx parte dalla constatazione che la Repubblica è la forma di stato con cui la borghesia esercita direttamente il potere (come insegna la prima rivoluzione francese); eppure, favorendo oggettivamente ed anche attivamente il colpo di mano del Napoleone piccolo consegna questo potere ad altri, ai militari e ad una consorteria di avventurieri che aveva la sua base sociale nel lumpenproletariat rurale. Perché questa abdicazione?
La risposta di Marx è lucidissima, e si sarebbe purtroppo dimostrata vera molte altre volte nella storia. La borghesia si era accorta che la Repubblica borghese era il terreno di lotta ideale per il proletariato, che poteva progredire ed organizzarsi grazie alle libertà civili e politiche: aveva quindi preferito consegnare il potere a chi, pur non organico alla sua classe, potesse garantire ordine e tranquillità agli affari, piuttosto che rischiare una emancipazione proletaria. Quante volte, nel secolo successivo, questa logica avrebbe prevalso in varie parti dell’Europa e del mondo!
Quante volte la borghesia avrebbe consegnato interi popoli nelle mani di mascalzoni e di buffoni pur di salvaguardare la roba.
Fortunatamente Marx morì 130 anni fa, perché credo che altrimenti avrebbe dovuto nel tempo istituire una sezione d’analisi specificamente dedicata al nostro paese, dove la borghesia ha sempre assunto questo atteggiamento, sia pure in modi diversi, da Mussolini a Berlusconi.
Resta da spiegare il titolo, che è una delle grandi invenzioni di Marx: il 18 brumaio (9 novembre) 1799 Napoleone I abbatté il direttorio ed instaurò la sua dittatura, come farà il 2 dicembre 1851 il nipote Luigi Napoleone. Ma, ci avverte Marx nella prima pagina di questo libro, con una delle sue frasi fulminanti ”Hegel nota in un passo delle sue opere che tutti i grandi fatti e i grandi personaggi della storia universale si presentano, per così dire, due volte. Ha dimenticato di aggiungere: la prima come tragedia, la seconda come farsa”. Oggi noi sappiamo che i grandi fatti possono presentarsi più e più volte; sappiamo inoltre che anche quando si presentano come farsa spesso sono causa di grandi tragedie. Fortunatamente in Italia l’abbiamo imparato, e (almeno per ora) riusciamo a mantenerci sul terreno del burlesque.
-
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- Il Paese è in letargo esistenziale collettivo, la ripresa è affidata all’inventiva personale.5 dicembre 2015, di Federico La Sala
Censis: il Paese è in letargo esistenziale collettivo, la ripresa è affidata all’inventiva personale
di Andrea Gagliardi (Il Sole - 24 Ore, 4 dicembre 2015)
Nell’Italia «dello zero virgola», in cui le variazioni congiunturali degli indicatori economici sono ancora minime, «continua a gonfiarsi la bolla del risparmio cautelativo e non si riaccende la propensione al rischio». Ma c’è «una piattaforma di ripartenza del Paese che gioca sul driver dell’ibridazione di settori e competenze tradizionali, che così si trasformano: è il nuovo Italian style». Sono alcuni dei passaggi più significativi del 49° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese. Un rapporto nelle cui «Considerazioni generali» si parla di «letargo esistenziale collettivo», di «pericolosa povertà di progettazione per il futuro, di disegni programmatici di medio periodo», di «prevalere dell’interesse particolare e dell’egoismo individuale», nonché di «crescita delle diseguaglianze, con una caduta della coesione sociale e delle strutture intermedie di rappresentanza che l’hanno nel tempo garantita».
Propensione al risparmio in crescita
Nel corso dell’anno i principali indicatori economici hanno cambiato segno ed evidenziano movimenti verso l’alto nell’ordine di qualche decimale di punto percentuale. Ma nell’Italia «dello zero virgola» continua a gonfiarsi la bolla del cash cautelativo. «Lo dimostra - scrive il Censis - il tasso di inflazione, inchiodato intorno allo zero nonostante il poderoso sforzo della Bce con il quantitative easing, così come gli investimenti nulli». Ammonta a più di 4.000 miliardi di euro il valore del patrimonio finanziario degli italiani. «In quattro anni (giugno 2011-giugno 2015) ha registrato un incremento di 401,5 miliardi: +6,2% in termini reali.
Negli anni della crisi la composizione del portafoglio delle attività finanziarie delle famiglie ha sancito il passaggio a una opzione fortemente difensiva degli italiani: il contante e i depositi bancari sono saliti da una quota pari al 23,6% del totale nel 2007 al 30,9% nel 2014, mentre sono crollate le azioni (dal 31,8% al 23,7%) e le obbligazioni (dal 17,6% al 10,8%). Negli ultimi dodici mesi (giugno 2014-giugno 2015) si conferma l’opzione cautelativa degli italiani, con un incremento di 45 miliardi di euro della liquidità (+6,3%) e di 73 miliardi in assicurazioni e fondi pensione (+9,4%), e con la rinnovata contrazione di azioni e partecipazioni (10 miliardi in meno, pari a una riduzione dell’1,2%). D’altro canto, il risparmio è ancora la scialuppa di salvataggio nel quotidiano, visto che nell’anno trascorso 3,1 milioni di famiglie hanno dovuto mettere mano ai risparmi per fronteggiare gap di reddito rispetto alle spese mensili.
Riguardo agli investimenti, il mattone ha ricominciato ad attrarre risorse. Lo segnala il boom delle richieste di mutui (+94,3% nel periodo gennaio-ottobre 2015 rispetto allo stesso periodo del 2014) e l’andamento delle transazioni immobiliari (+6,6% di compravendite di abitazioni nel secondo trimestre del 2015 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente). E si diffonde la propensione a mettere a reddito il patrimonio immobiliare: 560.000 italiani dichiarano di aver gestito una struttura ricettiva per turisti, come case vacanza o bed & breakfast, generando un fatturato stimabile in circa 6 miliardi di euro, in gran parte sommerso. In questa fase, l’esigenza della riallocazione del risparmio in modo più funzionale all’economia reale si lega strettamente alla richiesta di scongelare quote del proprio reddito aspirate dalla fiscalità: il 55,3% degli italiani vuole il taglio delle tasse, anche a costo di una riduzione dei servizi pubblici.
Il rimbalzo occupazionale dopo la lunga crisi
Dall’entrata in vigore del Jobs Act, il mercato del lavoro «ha visto rimbalzare l’occupazione di 204.000 unità». Ma, segnala il Censis, «siamo ancora lontani dal recuperare la situazione pre-crisi, dato che nel terzo trimestre dell’anno, rispetto allo stesso periodo del 2008, mancano all’appello 551.000 posti di lavoro». La disoccupazione si riduce all’11,9%, «una cifra molto lontana però dal 6,7% del 2008». Per quanto riguarda i giovani (15-24 anni) si registra un crollo dell’occupazione, proseguito anche nel 2015, «con un recupero ora di appena 9.000 unità rispetto al primo trimestre. Il loro tasso di disoccupazione è praticamente raddoppiato in sei anni, con un picco del 42,7% nel 2014 e poi un calo di 1,4 punti tra il primo e il terzo trimestre di quest’anno».
L’occupazione femminile, invece, «ha guadagnato 64.000 posti di lavoro in sei anni e si registra ancora un incremento di 35.000 occupate tra il primo e il terzo trimestre del 2015». E se nel 2008 i lavoratori più anziani (55-64 anni) «erano poco meno di 2,5 milioni, nel 2014 erano diventati 3,5 milioni e continuano a crescere, con un aumento di 91.000 unità nei primi sei mesi dell’anno».
Si consolida la presenza nel mercato del lavoro della componente straniera, «che ha superato i 2,3 milioni di occupati, con un incremento di 604.000 unità tra il 2008 e il 2014 e di 77.000 nella prima metà dell’anno”. Intanto, permangono criticità che rischiano di cronicizzarsi: «i giovani che non studiano e non lavorano (i Neet) sono 2,2 milioni, la sottoccupazione riguarda 783.000 addetti, il part time involontario 2,7 milioni di occupati e la Cassa integrazione ha superato nel 2014 la soglia del miliardo di ore concesse, corrispondenti a circa 250.000 occupati equivalenti».
Il driver vincente dell’ibridazione
Per il Censis «la piattaforma di ripartenza del Paese gioca sul driver dell’ibridazione di settori e competenze tradizionali». Oggi il «primo fattore di riposizionamento dei vincenti è il rapporto con la globalità, profondamente modificato dall’abbattimento delle barriere e dei costi di ingresso grazie al digitale». Chi negli anni delle ristrettezze interne «ha vinto ogni pulsione protezionista o di pura trincea, ed è andato verso l’esterno assumendosene i rischi e accettando le sfide, adesso incassa il dividendo di tale scelta». Le esportazioni valgono il 29,6% del Pil. «Nonostante il contraccolpo causato dalla crisi dei mercati emergenti, hanno continuato a crescere anche negli anni della crisi e nei primi nove mesi dell’anno segnano un +4,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente». Vincono i produttori di macchine e apparecchiature, con un surplus di 50,2 miliardi di euro nel 2014, e «l’Italia oggi è leader nella produzione di macchinari per produrre altri macchinari.
Vince l’agroalimentare, che nell’anno dell’Expo fa il boom di esportazioni (+6,2% nei primi otto mesi del 2015) e riconquista la leadership nel mercato mondiale del vino (con oltre 3 miliardi di export). Vincono i comparti consolidati dell’abbigliamento (+1,4% di export nei primi otto mesi dell’anno), della pelletteria (+4,5%), dei mobili (+6,3%), dei gioielli (+11,8%). E vince un settore trasversale per vocazione come quello creativo-culturale, con 43 miliardi di export.
Ma il vero «X factor» sta «in una rinnovata ibridazione di settori e competenze tradizionali che produce un nuovo stile italiano». «Il risultato di questa ibridazione è una trasformazione dei settori tradizionali. Il design e la moda ne sono l’archetipo (ibridazione di qualità, saper fare artigiano, estetica, brand)» E oggi il successo della gastronomia italiana «ha agganciato lo sviluppo della filiera agroalimentare, legandola anche al turismo, alle bellezze paesaggistiche e culturali del Paese, grazie anche al volano delle piattaforme digitali».
Ritrovata nei beni durevoli: auto ed elettrodomestici
Il Censis segnala inoltre lo stop al ciclo declinante del consumo di beni durevoli, che, partito dal 2007, si è protratto fino al 2013. Dalla seconda metà del 2014 e per tutto il 2015 - scrive il Censis - sono proprio i beni durevoli a trainare la ripresa dei consumi familiari. Tra coloro che in famiglia assumono la responsabilità degli acquisti principali, la quota di chi dichiara di avere fiducia nel futuro (il 39,8%) supera quella di chi non vede segnali positivi (il 22,4%), mentre la parte restante (il 37,8%) è ancora incerta. Questa ritrovata fiducia si riflette sulle intenzioni di acquisto: il 5,7% delle famiglie (più del doppio rispetto all’anno scorso) ha intenzione di comprare un’auto nuova (se andrà così, si avranno nel 2016 circa 1,5 milioni di immatricolazioni, come non si vedeva dal 2008), il 5,7% nuovi mobili per la casa, l’11,2% nuovi elettrodomestici (quasi 3 milioni di famiglie), il 9,2% ha intenzione di ristrutturare l’immobile. Sono potenzialità nei consumi da scongelare.
Verso nuovi stili di consumo digitali e relazionali
Il Censis stima in 15 milioni gli italiani che fanno acquisti su internet, 2,7 milioni hanno comprato prodotti alimentari in rete negli ultimi dodici mesi e l’home banking è praticato dal 46,2% degli utenti del web. E il successo della sharing economy rende ancora più evidente i nuovi stili di consumo. Nell’ultimo anno il 4% degli italiani (circa 2 milioni) ha utilizzato il car sharing, ma tra i giovani la percentuale sale all’8,4%.
L’immigrazione e i processi di integrazione
Gli stranieri in Italia seguono una traiettoria di crescita verso la condizione di ceto medio, differenziandosi così dalle situazioni di concentrazione etnica e disagio sociale che caratterizzano le banlieue parigine o le “inner cities” londinesi, dove l’islam radicale diventa il veicolo del rancore delle seconde e terze generazioni per una promessa tradita di ascesa sociale. Tra il 2008 e il 2014 in Italia i titolari d’impresa stranieri sono aumentati del 31,5% (soprattutto nel commercio, che pesa per circa il 40% di tutte le imprese straniere, e nelle costruzioni, per il 26%), mentre le aziende guidate da italiani diminuivano del 10,6%.
Politica e società ancora fuori sincrono
Quest’anno il Censis registra un «generoso impegno a ridare slancio alla dinamica economica e sociale del Paese attraverso il rilancio del primato della politica, con un folto insieme di riforme di quadro e di settore, e la messa in campo di interventi tesi a incentivare propensione imprenditoriale e coinvolgimento collettivo rispetto al consolidamento della ripresa». Ma questo impegno «fatica a fomentare nel corpo sociale una reazione chimica, un investimento collettivo, la necessaria osmosi tra politica e mondi vitali sociali». L’elemento oggi più in crisi è la dialettica socio-politica, che «non riesce a pensare un progetto generale di sviluppo del Paese a partire dai processi portanti della realtà ed esprime una carenza di élite». Così, la cultura collettiva «finisce per restare prigioniera della cronaca (scandali, corruzioni, contraddittorie spinte a fronteggiarli, ecc.)». Resta un deficit di fiducia nei cittadini. Gli italiani si distinguono per un livello di fiducia accordato alle diverse istituzioni politiche più basso di quello espresso dai concittadini europei: solo quote minime hanno fiducia nei partiti politici (9%), nel Governo (16%), nel Parlamento nazionale (17%), e la percentuale di quanti ripongono fiducia nell’operato delle autorità regionali e locali (il 22%) è meno della metà di quanto si riscontra in media nel resto del continente (47%). Bassi anche i giudizi di fiducia su Commissione europea (39%) e Bce (35%).
I processi di sviluppo reale del Paese
Oltre la pura cronaca e il volontarismo della politica restano «i processi di sviluppo reale del Paese». È uno sviluppo fatto di «basi storiche, capacità inventiva e processi vincenti». Esempio ne sono i giovani che vanno a lavorare all’estero o tentano la strada delle start up, le famiglie che accrescono il proprio patrimonio e lo mettono a reddito (con l’enorme incremento, ad esempio, dei bed & breakfast), le imprese che investono in innovazione continuata e green economy, i territori che diventano hub di relazionalità (la Milano dell’Expo come le città e i borghi turistici), la silenziosa integrazione degli stranieri nella nostra quotidianità. A ciò si accompagna anche un’evoluzione più strutturata, con il nuovo made in Italy che si va formando nell’intreccio tra successo gastronomico e filiera agroalimentare, nell’integrazione crescente tra agricoltura e turismo (con l’implicito ruolo del patrimonio paesaggistico e culturale), nel settore dei «macchinari che fanno macchinari» (la vera punta di diamante della manifattura italiana).
La società del «resto»
Nelle fasi di sviluppo precedenti, la domanda di riconoscimento della società era rivolta al mondo della rappresentanza sociale, alla dialettica socio-politica e al potere statuale. Ma oggi sono tre chiamate in causa cui è difficile dare seguito, «perché sono tre realtà in crisi». Si esprime invece «in quella dinamica spontanea descritta sopra, che però è considerata residuale: un «resto» rispetto ai grandi temi che occupano la comunicazione di massa». Ma il «resto», che finora non è entrato nella cronaca e nel dibattito socio-politico, «comincia ad affermare una sua autoconsistenza».
«Cosa resta oggi del grande processo di globalizzazione vista come occidentalizzazione del mondo? Il policentrismo di tanti diversi sviluppi e la crescita faticosa di una poliarchia» ha detto Giuseppe De Rita, presidente del Censis, illustrando il Rapporto annuale dell’istituto. E ha spiegato: «Nella nostra storia, il resto del mito della grande industria e dei settori avanzati è stata l’economia sommersa e lo sviluppo del lavoro autonomo. Il resto del mito dell’organizzazione complessa e del fordismo è stata la piccola impresa e la professionalizzazione molecolare. Il resto della lotta di classe nella grande fabbrica è stata la lunga deriva della cetomedizzazione. Il resto dell’attenzione all’egemonia della classe dirigente è stata la fungaia dei soggetti intermedi e la cultura dell’accompagnamento. Il resto del primato della metropoli è stato il localismo dei distretti e dei borghi. Il resto della spensierata stagione del consumismo (del consumo come status e della ricercatezza dei consumi) è la medietà del consumatore sobrio. Il resto della lunga stagione del primato delle ideologie è oggi l’empirismo continuato della società che evolve».
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- L’avventurismo del senso comune. Il nuovismo realizzato. Il nuovo libro di Michele Prospero.20 ottobre 2015, di Federico La Sala
L’avventurismo del senso comune
Il nuovo libro di Michele Prospero. Il «populismo mite» del potere è la cifra ideologica del capo. Che non è solo un produttore di annunci, ma un fattore di stabilità
di Carlo Galli (il manifesto, 20.10.2015)
Più di vent’anni di politica italiana sono ricondotti, nell’ultimo libro di Michele Prospero (Il nuovismo realizzato. L’antipolitica dalla Bolognina alla Leopolda, Roma, Bordeaux, 2015, pp. 418, euro 26) al filo conduttore dell’antipartitismo, e in generale dell’antipolitica che nei partiti ha avuto la propria testa di turco.
Un’antipolitica solo parzialmente spontanea - generata da una rivolta etica contro il sistema politico degenerato - e in gran parte indotta dall’alto, da agenzie di senso e da poteri mediatici (a loro volta riconducibili a forze economiche) interessati al risultato dell’antipolitica: non solo distruggere i partiti esistenti (un disegno di lungo periodo della storia d’Italia, prevalentemente connotato a destra, da Minghetti a Maranini a Miglio), realizzando una discontinuità radicale (un’idea a cui non si sottrassero però né il Pd di Occhetto né i Girotondi, e che fu il cavallo di battaglia del primo Berlusconi), ma screditare la forma partito in quanto tale (s’intende, il partito pesante, organizzato, che è spazio di confronto e di partecipazione dialettica, ovvero di mediazione).
E aprire così la strada al Nuovo, che è un miscuglio di ideologia (la società liquida, l’individualismo postpolitico, l’immediatezza) e di solida realtà, tanto istituzionale (il partito leggero, la democrazia d’investitura, lo spostamento del potere verso l’esecutivo, il leaderismo pseudo-carismatico) quanto economica (la fine della politicità del lavoro, la sua precarizzazione e la sua subalternità) quanto infine sociale (l’aumento delle disuguaglianze, il declino - programmato - del ceto medio).
Prospero, per questa via, incontra (convocando un grande materiale analitico in chiave prevalentemente politologica) una contraddizione strutturale dell’intero processo storico-politico preso in esame, ossia le due crisi di sistema del 1993-94 e del 2013-14, tutta la seconda repubblica e l’inizio della terza: da una parte vi è in questa storia un dato di occasionalità, di contingenza, e quindi vi è preponderante l’agire di una persona (ovviamente, Renzi) e anche il suo dire, il suo narrare, il suo raffigurare per il popolo un altro mondo, ricco di speranza e di ottimismo e quindi ben diverso da quello di cui la maggior parte dei cittadini fa esperienza.
Questo livello è spiegato con frequenti riferimenti a Machiavelli, non tanto perché l’autore sostenga che Renzi incarna il “Principe nuovo” - anzi, spesso attraverso Machiavelli si mettono in rilievo debolezze e fallacie del suo agire, la sua propensione alla fuga nell’irrealtà, al «romanticismo politico», a un decisionismo fatto di annunci - quanto piuttosto per il peso inusuale («rinascimentale») che la figura del singolo ha nella vicenda politica contemporanea.
D’altra parte, nondimeno, questa figura di Principe immaginario e dopo tutto incapace di dare una forma alla repubblica, impegnato com’è a gestire continue emergenze in continue affabulazioni, è contraddetta dalla robustissima realtà delle profonde trasformazioni che il suo agire produce:
 veramente il partito è sul punto di estinguersi e di divenire un corteo di obbedienti seguaci, in perenne lotta tra loro (soprattutto attraverso lo strumento delle primarie, che doveva essere di apertura alla società civile e che invece è una leva per i conflitti interni), mentre nei territori le cordate di potere prendono il posto della partecipazione;
veramente il partito è sul punto di estinguersi e di divenire un corteo di obbedienti seguaci, in perenne lotta tra loro (soprattutto attraverso lo strumento delle primarie, che doveva essere di apertura alla società civile e che invece è una leva per i conflitti interni), mentre nei territori le cordate di potere prendono il posto della partecipazione;
 veramente le istituzioni (e il parlamento in primo luogo) sono indebolite dalla personalizzazione della politica, e trovano energia politica solo in quelle che erano state pensate come posizioni di garanzia (Quirinale e Consulta);
veramente le istituzioni (e il parlamento in primo luogo) sono indebolite dalla personalizzazione della politica, e trovano energia politica solo in quelle che erano state pensate come posizioni di garanzia (Quirinale e Consulta);
 veramente la politica è ormai competizione fra leader populisti extraparlamentari per la conquista di un elettorato sempre più passivo (anche se in parte estremizzato);
veramente la politica è ormai competizione fra leader populisti extraparlamentari per la conquista di un elettorato sempre più passivo (anche se in parte estremizzato);
 veramente questi processi si sono sviluppati coinvolgendo tanto la destra quanto la sinistra fino all’attuale formarsi, non casuale, di un partito di Centro la cui forza di gravità spappola ogni altra formazione politica;
veramente questi processi si sono sviluppati coinvolgendo tanto la destra quanto la sinistra fino all’attuale formarsi, non casuale, di un partito di Centro la cui forza di gravità spappola ogni altra formazione politica;
 veramente sono stati varati il jobs Act e la legge elettorale per la camera ed è in corso di approvazione la riforma della Costituzione;
veramente sono stati varati il jobs Act e la legge elettorale per la camera ed è in corso di approvazione la riforma della Costituzione;
 veramente il sindacato è stretto nell’angolo e gli viene sottratta la contrattazione nazionale; veramente la sinistra fatica (ed è un eufemismo) a trovare una base sociale, una chiave di lettura del presente, una missione politica;
veramente il sindacato è stretto nell’angolo e gli viene sottratta la contrattazione nazionale; veramente la sinistra fatica (ed è un eufemismo) a trovare una base sociale, una chiave di lettura del presente, una missione politica;
 veramente l’astensione e il populismo assorbono e neutralizzano le energie che potrebbero essere di protesta;
veramente l’astensione e il populismo assorbono e neutralizzano le energie che potrebbero essere di protesta;
 veramente l’analisi strutturale della realtà passa in secondo piano rispetto alla traduzione emotiva dei problemi e alla questione della legalità.
veramente l’analisi strutturale della realtà passa in secondo piano rispetto alla traduzione emotiva dei problemi e alla questione della legalità.L’occasionalismo produce un ordine, quindi; l’avventura personale costruisce forma politica, la chiacchiera è largamente performativa; l’immediatezza è anche mediazione. Un ordine, certo, non inclusivo ma escludente - che espelle da sé le contraddizioni, perché non le teme (e in ciò il Pd è ben diverso dalla Democrazia Cristiana, pur riprendendone il ruolo centrale di pivot e di diga) - e che cerca una base di consenso nel livello più semplice del senso comune (molto bene interpretato), eludendo o smorzando ogni tema controverso ed escludendo il pensiero critico (i «gufi», i «professoroni»); una forma contraddittoria, segnata dalla conflittualità fra quel che resta del vecchio partito e il nuovo leader, fra antichi professionismi e il nuovo «populismo mite» che è la cifra ideologica del Capo (tutt’altro che dilettante, in verità).
Eppure, con queste contraddizioni, Renzi è non solo un problema, ma anche una soluzione; non solo un coacervo di azzardi e di provvisorietà ma anche un fattore di stabilità; non solo un produttore d’annunci e d’irrealtà ma anche un fabbricante di realtà e di processi.
È una realtà condizionata dal populismo (Berlusconi è il populismo nichilistico-aziendalistico, Grillo è il populismo aggressivo dal basso, Renzi è il populismo mite del potere), funzionale, in quanto implica una società disgregata che non deve essere letta politicamente, alla presenza onnipervasiva di logiche e valori liberisti, rispetto ai quali la sinistra (il Pd) è, non certo da oggi, del tutto interna. Ma è realtà, o almeno fascio di potere efficace. È vano pensare che il tempo breve, l’attimo, dell’occasione e della decisione non abbiano la forza di reggere l’assetto della politica; anzi, ne sono capaci, si dilatano in un’eccezione permanente che è il tempo lungo in cui si presentano oggi il potere e la libertà che esso concede.
La risposta a ciò della sinistra, secondo Prospero, è il partito organizzato, capace di esprimere ripoliticizzazione della società, partecipazione popolare e leadership autorevole (non populista). Più facile a dirsi che a farsi, naturalmente. Certo è che la sinistra avrà un futuro solo se saprà pensarsi a questa altezza, e se a partire dalle contraddizioni del presente, ben identificate, saprà proporre un modello di società che combini in sé, con la stessa forza, un’analoga e opposta capacità di tenere insieme l’immaginario e il reale.
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. Materiali sul tema --- Il premierato assoluto (di Ida Dominijanni)14 ottobre 2015, di Federico La Sala
Il premierato assoluto
di Ida Dominijanni, giornalista *
Un parlamento delegittimato dal pronunciamento della corte costituzionale sulla legge elettorale dalla quale è nato, un parlamento non rappresentativo degli attuali rapporti politici, ignorante e presuntuoso quant’altri mai e uso a comunicare attraverso la volgarità delle parole e dei gesti, ha approvato la più sgrammaticata, sgangherata e regressiva riforma costituzionale che sia mai stata concepita nei vari tentativi che si sono susseguiti dagli anni ottanta in poi. L’ha fatto nel disprezzo dichiarato delle competenze - i “professoroni” dileggiati dalla ministra Boschi - che via via ne hanno denunciato i difetti. L’ha fatto in un rapporto meramente competitivo con le generazioni precedenti, all’insegna del “noi riusciremo in tutto ciò in cui voi non siete riusciti”, l’insegna più significativa dei rottamatori al potere. L’ha fatto spacciando per riforma del senato quella che è in realtà una riscrittura di tutta la seconda parte della costituzione e uno stravolgimento della forma di governo e dell’equilibrio tra legislativo ed esecutivo, motivato con le magnifiche sorti di una “democrazia decidente” contrapposta alla democrazia rappresentativa (a sua volta fatta uguale a una supposta “democrazia consociativa” che avrebbe caratterizzato l’intero passato repubblicano). L’ha fatto su iniziativa e per conto del governo, che ha scandalosamente avocato a sé una materia parlamentare per eccellenza come quella costituzionale. L’ha fatto, infine, con la complicità di una sedicente opposizione interna al principale partito di governo, il Partito democratico, che ha preferito siglare un farraginoso compromesso su un singolo punto della riforma - il metodo di elezione dei senatori - piuttosto che mettersi di traverso alla sua intera filosofia.
Sulla quale bisognerà essere molto chiari almeno da qui al referendum al quale la riforma sarà comunque sottoposta. In questione non è solo il bicameralismo, che da perfetto diventa imperfetto - ma non per questo semplificherà l’iter di approvazione delle leggi, vista l’immensa confusione che vi introduce. In questione non è nemmeno la riduzione - anzi “l’asfaltamento”, come promise Matteo Renzi neoeletto presidente del consiglio, mani in tasca, nella sua prima performance a palazzo Madama - del ceto politico, visto che il numero complessivo dei parlamentari resta il più alto d’Europa. In questione non è infine, checché ne dica Giorgio Napolitano, il completamento di un disegno federalista dello stato, visto che il senato delle regioni si realizza nel momento di massima corruzione del regionalismo e di massima crisi delle forze politiche che del federalismo avevano fatto, nel ventennio scorso, la loro bandiera.
Come in tutto quello che va facendo, l’innovatore Renzi non apre un’epoca radiosa ma chiude un ciclo grigio
In questione, grazie al combinato disposto tra questa riforma costituzionale e l’Italicum, è l’istituzione, per giunta non dichiarata e dunque non discussa come tale né in parlamento né nel paese, di un premierato assoluto, senza contrappesi e senza controlli, che affida le sorti del governo e della democrazia all’arbitrio di una minoranza. Basta un quarto dei voti del corpo elettorale per incassare il premio di maggioranza, insediarsi al governo e decidere su tutto - non solo sulla materia delle leggi ordinarie, ma sui diritti fondamentali, le eventuali ulteriori revisioni costituzionali, lo stato di guerra eccetera - con il conforto di una camera di nominati e senza strumenti istituzionali di freno o di contrasto. Non si tratta dunque di un semplice rafforzamento del governo, ma di una rottura dell’equilibrio dei poteri e dei dispositivi di garanzia che nel ridisegnare la seconda parte della costituzione mette a rischio anche la prima - a conferma che prima e seconda parte sono intimamente connesse, come il costituzionalismo insegna.
Voltare pagina davvero
Ha ragione chi sostiene, nell’esigua minoranza contraria a questa controriforma, che siamo così arrivati all’approdo di una vicenda trentennale - cominciò con Craxi - in cui la riforma della costituzione è stata brandita per coprire con la presunta inadeguatezza delle istituzioni il progressivo deficit di stoffa e di capacità politica della classe dirigente e dei partiti: è il ben noto trucco in base al quale più si è impotenti più si attribuisce la propria impotenza a un vincolo esterno, invocandone lo scioglimento. È altresì vero che nel corso di questa vicenda molti sono stati gli errori ripetuti, per primo quello di cambiare la carta costituzionale secondo la convenienza della maggioranza di turno, di sinistra - la riforma del titolo V voluta dall’Ulivo nel 2001 - e di destra - la riforma della costituzione varata dal governo Berlusconi e sepolta dal referendum nel 2006.
Di questa lunga vicenda vanno, tuttavia, sottolineate anche alcune discontinuità. La bozza di riforma varata dalla bicamerale nel 1998, alla quale l’opinione corrente a sinistra attribuisce la colpa di avere dato la stura alla “svendita” e alla delegittimazione della carta del 1948, non solo brillava al confronto di quella che rischia oggi di diventare effettiva, ma rispondeva all’esigenza di contenere la spinta violenta alla decostituzionalizzazione di cui la “nuova destra” del 1994 era portatrice, e che minacciava di scatenare convocando un’assemblea costituente in cui sarebbe stata con ogni probabilità maggioranza. Le cose oggi appaiono tragicomicamente invertite. Per paradosso, quella spinta alla decostituzionalizzazione si realizza nel momento in cui quella destra è storicamente sconfitta; e a farla propria è un partito nato nell’alveo del centrosinistra e trasformatosi in partito della nazione per portare a compimento la controrivoluzione neoliberale in Italia. Come in tutto quello che va facendo, l’innovatore Renzi non apre un’epoca radiosa ma chiude un ciclo grigio. Forse spetterà alla sinistra del futuro, se e quando nascerà, convocare una nuova assemblea costituente, se e quando sarà il momento di dichiarare finita questa controrivoluzione e di voltare pagina davvero.
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- Il neopopulismo di governo. Un "Renzime" democratico (di Aldo Carra)8 ottobre 2015, di Federico La Sala
EditorialeIl neopopulismo di governo
Un "Renzime" democratico. Il nostro paese si sta trasformando in un deserto nel quale crescono solo varietà diverse di una stessa pianta, tutte germogliate da un ceppo originario, il berlusconismo, che sta malinconicamente rinsecchendosi
di Aldo Carra (l manifesto, 08.10.2015)
Il paesaggio politico italiano si sta ridisegnando sempre di più attorno alla figura del presidente del Consiglio. Più che parlare di regime autoritario si potrebbe parlare di renzime democratico, una forma nuova di integrazione tra populismo, comunicazione e governo che supera la tradizionale distinzione tra destra e sinistra, ma conservando uno zoccolo duro nel popolo di sinistra da cui nasce, un populismo di nuova generazione che rimodella sistema politico e competitors.
Di populismi ne abbiamo avuti e ne abbiamo tanti oggi in Europa.
In genere essi si collocano a destra dall’opposizione e a questo modello si ispira la Lega. Ma in Italia ne abbiamo partoriti altri.
Anche il M5S si è affermato grazie a un forte populismo antisistema, ma con alcune novità importanti: una forte attrazione nel popolo di sinistra su temi come la partecipazione, l’ambiente, la moralizzazione della politica, una innovativa capacità di comunicazione e di spettacolarizzazione della politica e del rapporto con i cittadini.
M5S e Lega nascono, comunque, come forze antisistema ed esterne al sistema dei partiti storici.
Il neopopulismo renziano si presenta, invece, con due peculiarità:
nasce come forza di governo, anzi solo per governare (non potrebbe esistere senza); nasce come rottura/evoluzione/trasformazione dall’interno di un partito, anzi dell’ultima forza politica storica organizzata.
Adesso che, a metà legislatura e col completamento delle riforme, si sta concludendo la prima fase di questa esperienza, può essere utile analizzare i principali filoni che ne hanno ispirato l’azione. Il filone anticasta
Dopo quanto emerso a partire dall’omonimo libro, la lotta contro la casta era stata il principale cavallo di battaglia del M5S. Un tema così pregnante non poteva non essere cavalcato e così è stato: due tra le più importanti modifiche del nostro assetto istituzionale - Province e Senato - sono state affrontate utilizzando come motivazione principale la necessità di ridurre gli eletti, la casta.
Non si è compiuta una analisi delle funzioni e dei livelli istituzionali proliferati, dai municipi delle grandi città, ai comuni, alle comunità montane, alle province, alle regioni, per ristrutturarli in un disegno organico, ma si è scelta la via della semplificazione eliminando gli organi elettivi e dando vita in ambedue i casi ad organismi pasticciati e pressoché inutili.
La chiave contro la casta e i costi della politica è stata fondamentale ed è servita a accrescere la concentrazione dei poteri nell’esecutivo.
Il filone governabilità
Strettamente connesso a questo processo è il modello elettorale delineato con lo slogan «sapere la sera delle elezioni chi ha vinto», problema appena sentito dall’opinione pubblica ed esasperato volutamente per far passare un modello che cozza con la nostra cultura costituzionale e con l’equilibrio tra rappresentanza e governabilità.
Si è nascosta, così, dietro al messaggio della governabilità, la sostanza di accentramento nelle mani di una sola persona dei poteri decisionali e di nomina senza contrappesi.
Una scelta gravissima e carica di rischi futuri che assegnerà il 55% dei seggi a un partito che avrà il consenso del 30% dei votanti e del 15% degli elettori passata col consenso della minoranza di sinistra che, di fronte a tanta gravità, si trastullava con le preferenze.
Il filone antiprivilegi
Anche la lotta ai privilegi non poteva non essere un cavallo di battaglia del neopopulismo. Spostando il concetto di privilegio dagli strati sociali ricchi a tutti coloro che stanno meglio degli ultimi, si è arrivati ad additare come privilegiati quelli che hanno un lavoro tutelato a fronte dei tanti precari e disoccupati. Tutto questo per arrivare a colmare l’ingiustizia eliminando l’articolo 18 a vita per i nuovi assunti. Un caso esemplare di eliminazione di una ingiustizia per alcuni eliminando la giustizia per tutti.
Il filone antiburocrazia
A questo filone, anch’esso molto sentito dalla popolazione, si è ispirata la cosiddetta riforma della pubblica amministrazione, che ha partorito finora solo slogan e banalità elevati a principi, ma tanto basta per far sfogare sui fannulloni il malessere dei cittadini.
Anche la riforma della scuola con la concentrazione di poteri nei presidi promossi a manager per decreto, si colloca in questo filone.
Il filone antisprechi
E’ stata cavalcata con nomine e contronomine la riduzione della spesa pubblica ed enti locali e sanità sono stati additati come i responsabili da dare in pasto all’opinione pubblica. Conseguenze immediate: gli enti locali deperiscono e tassano di più i cittadini. Conseguenze future: alcune analisi saranno rese più difficili a meno di non pagarsele, chi può.
Il filone distributivo
Casta, privilegi, burocrazia, sprechi: fin qui niente di diverso dagli altri populismi. Ma trattandosi di neopopulismo di governo si sono potuti attivare anche altri canali.
Uno in chiave compensativa nella scuola: a condizione che accettassero sedi lontane e la nuova organizzazione si è offerta la sistemazione a una parte dei precari.
Altri in chiave distributiva: gli 80 euro, i consistenti finanziamenti alle imprese che trasformano i precari in stabili per tre anni e adesso la promessa di detassare le prime case rientrano in questo filone. Giocati al momento opportuno per far passare provvedimenti indigesti e soprattutto nei tempi giusti, essi costituiscono l’altra faccia delle politiche renziane.
Naturalmente non si tratta di una redistribuzione volta a ridurre le disuguaglianze: se gli 80 euro sono andati ai redditi medio bassi, gli incentivi sono andati alle imprese e la detassazione della casa favorirà i ricchi. Gli effetti economici concreti saranno difficili da calcolare, ma i consensi elettorali facili da raccogliere.
Da questa schematica rivisitazione delle politiche del governo emerge una strategia che ha una sua organicità e che risponde a una visione.
- Così il nostro paese si sta trasformando in un deserto nel quale crescono solo varietà diverse di una stessa pianta - il populismo - tutte germogliate da un ceppo originario, il berlusconismo, che sta malinconicamente rinsecchendosi.
In queste condizioni ambientali stiamo svolgendo un dibattito ampio sulla sinistra e sul suo futuro.
In presenza di due populismi di opposizione e di uno di governo il compito non è affatto facile. E forte può essere la tentazione di importare le piante che crescono in altri paesi, o provare a ripiantare i semi originari.
Ma se questa è la situazione occorre ben altro. Dovremo scavare in profondità, arrivare alla sorgente, rigenerare il terreno, creare le condizioni perché nuove piante attecchiscano e crescano.
E’ probabile che incassate le riforme la prima fase analizzata si chiuda e se ne apra un’altra.
Essa dovrà fare i conti con una ripresa tanto strombazzata quanto inferiore a quella, pur fragile, dell’Europa. I problemi finanziari ed economici non potranno sempre essere rinviati e molto dipenderà dalla capacità di sinistre e sindacati di rimetterli al centro dell’agenda politica.
Se posso permettermi una sollecitazione forse, dopo questa prima fase del nostro dibattito, dovremmo avviarne un’altra.
Potremo seguire anche noi un filone referendario per tentare di cancellare alcune leggi e dovremmo farlo insieme, convincendo e costruendo unità e consensi.
Ma non possiamo limitarci a questo. Penso che dovremmo aprire una nuova fase di discussione incentrata fortemente sui contenuti, per mettere a punto un preciso programma di governo rivolto a quella parte ampia della popolazione che sta pagando il prezzo della crisi e soprattutto alle nuove generazioni.
Qui forse abbiamo qualcosa da riprendere da quanto si muove in Spagna, in Grecia, in Gran Bretagna: in questi paesi le forze di sinistra sono impegnate ad affrontare il problema del governare e di come gestire da sinistra una fuoriuscita dalle politiche di austerità.
Questo sì che sarebbe un metodo di lavoro da importare per dare un nostro contributo ad una battaglia che non può che essere europea.
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. Materiali sul tema --- La tonaca e il Parlamento (di Nadia Urbinati)7 ottobre 2015, di Federico La Sala
DEMOCRAZIA, TEOCRAZIA (LA MONARCHIA "EDIPICA" VATICANA), E RISPETTO PER LA REPUBBLICA ITALIANA:
 Il Papa è un personaggio molto autorevole, ma è il Capo di un altro Stato (Furio Colombo) - e non democratico!!!:
Il Papa è un personaggio molto autorevole, ma è il Capo di un altro Stato (Furio Colombo) - e non democratico!!!: -
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- "Il trucco. Sessualità e biopolitica nella fine di Berlusconi", Ida Dominijanni (di Nicoletta Marini-Maio)19 settembre 2015, di Federico La Sala
Dominijanni, Ida.
Il trucco. Sessua lità e biopolitica nella fine di Berlusconi.
Roma: Ediesse, 2014. Pp. 251. ISBN 9788823019171. € 14.00 (paperback).
Nell’imponente quantità di pubblicazioni sul berlusconismo, Il trucco. Sessualità e biopolitica nella fine di Berlusconi, di Ida Dominijanni , è finora l’unica solida riflessione teorica e femminista che ne analizzi gli aspetti fondativi, simbolici e strategici, mettendoli in relazione con la storia culturale e politica italiana degli ultimi quaranta anni e con la dimensione transnazionale.
Con profonda consapevolezza teorica, l’analisi della filosofa, femminista della differenza, saggista e storica editorialista del Manifesto , parte dalla nozione lacaniana dell’ “evaporazione del padre”- cioè la crisi dell’ordine simbolico incarnato dalla legge edipica - e si misura con il pensier o di Foucault, Arendt, Butler, Lonzi, Ž i ž ek , e Recalcati, per citare solo i riferimenti più eclatanti.
Ambizioso obiettivo del libro è la riconfigurazione teorica e storica del berlusconismo nel periodo che prende il via dalla stagione del “lungo sessantotto italiano” (33) e del femminismo, estenden dosi alla contemporaneità.
Dominijanni contesta le interpretazioni mainstream : la prima, che vede il berlusconismo come un’anomalia italiana del modello liberal democratico e un attacco ai principi costituzionali; la seconda, che insiste sulla realizzazion e politica della debordiana “società dello spettacolo”; la terza, infine, che denuncia una strategia politica di identificazione con un preciso blocco sociale che mira a difendere i propri interessi socio - economici, sullo sfondo del modello neoliberale e i ndividualista della postmodernità.
Queste tre linee interpretative colgono alcuni dei tratti salienti del regime berlusconiano, nota Dominijanni, ma ne offrono una visione parziale. Il trucco capovolge i discorsi sul berlusconismo, riportando al centro d ell’analisi l’azione dirompente che la sessualità, il corpo e gli affetti esercitano sulla politica. Discutendo il berlusconismo come un’“inedita forma di governamentalità biopolitica e post- patriarcale” (27) fondata sullo scambio di sesso, potere e denaro , la studiosa analizza la sfera della sessualità nella sua funzione, innanzi tutto, di strumento di codificazione del “regime del godimento” (25), basato sull’autoimprenditorialità del corpo e della sua libera offerta come merce di scambio negli ambiti soc io- culturali ed economici del neoliberalismo.
D’altra parte, è proprio la sessualità, sostiene Dominijanni, ad aver delegittimato il berlusconismo attraverso la denuncia dell’immagine fallace e strategica del sovrano.
Si tratta di una vera e propria ribell ione all’ordine simbolico post- patriarcale che prende forma nella presa di parola delle donne del sexgate e rivela la natura del “trucco” che dà il titolo al libro, cioè la fondamentale “impotenza” (17) del sovrano.
Tesi di fondo del libro è che la ventenn ale egemonia del berlusconismo sia stata neutralizzata non tanto sul terreno economico, quanto per l’appunto su quello della sessualità.
Dopo una premessa metodologica e un’introduzione teorica (“ Dalla fine . Spettri di Berlusconi”), l’analisi si snoda in nove serrati capitoli che discutono i tratti fondanti del berlusconismo nella loro valenza simbolica e storica.
Il rigore dell’argomentazione e l’originale storicizzazione dei fatti si intersecano con la vivacità giornalistica e lo spirito polemico dell’au trice, che sollecita una rilettura del presente alla luce dei dispositivi di potere messi in atto dal berlusconismo. Dominijanni decostruisce i concetti- chiave, le figure e le retoriche del berlusconismo, adottando un criterio di analisi deliberatamente sp iazzante ed efficace, quello degli spostamenti strategici “che hanno consentito alle ‘guerre culturali’ neoconservatrici degli ultimi decenni di costruire egemonia sopra e contro lo stesso terreno arato dalle rivoluzioni degli anni Sessanta e Settanta” (14 5) .
Questi spostamenti sono semantici, retorici, culturali e simbolici e comportano rilevanti conseguenze politiche.
Lo spostamento valoriale analizzato nel primo capitolo (“La partita della libertà”) investe il concetto di libertà.
Un esempio fra tutti. A llo scopo di auto- legittimarsi come “padre fondatore” (37), Berlusconi si è appropriato della Festa della Liberazione, liturgia fondativa della patria basata sull’eredità culturale e politica della Resistenza antifascista, riformulandola come “Festa della Libertà” (38), cioè una celebrazione unitaria e popolare, tesa ad includere tutte le posizioni politiche.
Con una simile deviazione semantica, Berlusconi ha trasformato il partito in “Popolo delle Libertà ,” affermando la propria identificazione con un’idea astratta di popolo e ufficializzando l’inclusione dell’Italia nell’area valoriale della politica liberale.
Dominijanni sottolinea che questo “slittamento semantico” ha condotto a uno “slittamento politico di prima grandezza” (40), in quanto Berlusconi int erpreta il termine “libertà” in modo ambivalente: da un parte, come volontà di trasgredire le norme stabilite dalla costituzione e, dall’altra, come affermazione della libertà imprenditoriale e consumistica imposta dal neoliberalismo.
In questo contesto, l a libertà diviene un’esperienza negoziabile e flessibile, che si realizza ai confini della legalità e può configurarsi sia come affermazione di un diritto che come consenso servile.
Altri spostamenti sono esaminati nel libro. Centrale è la discussione co ndotta nel terzo capitolo (“Parole che contano”), in cui l’autrice discute la funzione destrutturante della parola femminile nei discorsi delle donne coinvolte nel sexgate.
La presa di parola si articola infatti in modalità che vanno oltre le retoriche e i cliché rappresentati dalle donne “parlanti,” cioè l’intellettuale (Ventura), la moglie (Lario) e la prostituta (D’Addario e le altre). Lario, ad esempio, non solo denuncia il tradimento coniugale, ma il sistema di potere che usa le donne per potenziare il corpo del capo e provocare l’identificazione con la popolazione maschile.
Perfino le conversazioni “impietose” delle Olgettine ridicolizzano il corpo del capo, rendendolo una “copia comica e farsesca di se stesso ” (85).
Dominijanni fa notare come la politica berlusconiana abbia messo in atto il “dispositivo dell’internamento” contro queste donne, stigmatizzandole, censurandole e relegandole ai margini del discorso politico.
Questo ulteriore spostamento è strettamente con nesso a strategie retoriche e simboliche che Dominijanni analizza in altri capitoli del libro: lo “sconfinamento” (104) del pubblico nel privato , la ridefinizione in chiave libertina del conce t to di privacy (“Privato e pubblico, personale e politico”) e lo slittamento del rapporto fra morale e politica (“Penale, morale, politico”), in cui l’autrice discute lo “scarto di senso” (141) della narrazione berlusconiana, fondato sulla ridefinizione del rapporto tra libertà, potere politico e legge.
Particolarme nte originale è l’inquadramento storico del berlusconismo a partire dal Sessantotto e dal femminismo, un’intuizione che la studiosa articola nel sesto (“Papi e il nome del padre”) e nel settimo capitolo (“‘Veri’ uomini, ‘vere’ donne”).
Contestando le coord inate cronologiche del ventennio berlusconiano, Dominijanni vede nel berlusconismo la risposta “perversa” (33) e “regressiva” (175) alle istanze innescate dalla stagione del Sessantotto e del femminismo.
Il berlusconismo non ha realizzato quelle istanze, m a le ha invertite, trasformando la domanda di creatività, l’affermazione della liberazione sessuale, il bisogno di democrazia e il conflitto fra i sessi in regime del godimento, mercificazione, populismo mediatico e strategia di assoggettamento e ri- natura lizzazione dei ruoli di genere. In altre parole, il capitalismo neoliberale di cui il berlusconismo è la realizzazione italiana, ha marginalizzato le domande di ribellione e reso ambivalente la nozione di libertà femminile, secondo la quale la “vera” donna è figlia “ sia della rivoluzione femminista sia dell’egemonia neoliberale, e porta dunque sia il segno politico della libertà femminile, sia il segno della sua traduzione nella lingua economica della ‘libera scelta’ e dell’au toimprenditorialità” (194).
Un altro spostamento , quindi, forse il più rilevante sul piano socio- culturale e politico. L’analisi dei dispositivi di potere del berlusconismo elaborata da Dominijanni permette alla studiosa di interrogarsi sulla possibilità di nuovi spazi di soggettivazio ne e pratiche femministe.
Pur tralasciando la prospettiva queer, Dominijanni si confronta con una grande varietà di posizioni critiche contemporanee, fra cui il postfemminismo anglosassone, e contesta le rivendicazioni neo- femministe incentrate sulla lotta al femminicidio, la denuncia del sessismo dei comportamenti e del linguaggio e la richiesta di quote rosa (specie negli ultimi due capitoli: “Dopo il patriarcato. Femminismo e questione maschile” e “Dispositivo di sessualità, regime politico”).
Contro una riflessione critica che aspira semplicemente all’intercambiabilità di genere e non promuove pratiche diverse da quelle imposte dal post- patriarcato, Dominijanni riporta al centro del “conflitto politico fra i sessi” (27) la sfera della sessualità, che si pone come “tecnica del potere [...] decisiva per la soggettivazione” (27).
Il trucco è un libro provocatorio e coinvolgente, che sollecita nuovi interrogativi non solo sull’età berlusconiana, ma anche e soprattutto sul ruolo del femminismo nella vita culturale, sociale e politica della società contemporanea.
NICOLETTA MARINI-MAIO
Dickinson College
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. L’Italia come volontà e come rappresentazione di un solo Partito. --- "Italicum". Un duro colpo alla democrazia21 maggio 2015, di Federico La Sala
Italicum
Un duro colpo alla democrazia
di COORDINAMENTO PER LA DEMOCRAZIA COSTITUZIONALE*
Il Coordinamento per la Democrazia Costituzionale giudica l’approvazione, il 4 maggio scorso, della legge elettorale "Italicum" un gravissimo danno all’assetto democratico della Repubblica.
È legge voluta e imposta da una stretta minoranza del Parlamento, appena un quarto dei voti scrutinati, ingigantito dal premio di maggioranza del Porcellum, a sua volta sanzionato dalla Corte costituzionale.
Questo Parlamento, eletto con una legge dichiarata incostituzionale in alcuni punti essenziali, aveva il dovere di procedere con cautela e con ampi consensi e la necessaria consultazione; invece è stato prodotto per volontà di Renzi uno strappo pesante che ha lacerato il suo stesso partito e che ha portato all’approvazione dell’Italicum da parte di una maggioranza di deputati che in realtà hanno ricevuto una minoranza di voti dagli italiani.
Come già il Porcellum, la nuova legge Italicum trasforma una minoranza in una maggioranza, che potrebbe essere smisurata rispetto ai voti effettivamente ottenuti al primo turno e aggrava il peso del premio attribuendolo a un solo partito invece che a una coalizione. Così il principio costituzionale dell’eguaglianza del voto è demolito.
Il voto che va al partito che prevarrà sia pure di poco conterà molto di più di quello attribuito a tutti gli altri: il primo avrà d’ufficio 340 seggi, tutti gli altri dovranno dividersi i restanti 290. Con questi numeri la falsa maggioranza potrà arrivare a scegliersi un futuro Presidente della Repubblica di suo gradimento, influire pesantemente sulla composizione della Corte costituzionale e il Consiglio superiore della Magistratura. Così gli organi di garanzia saranno in mano al capo del governo, cui una nuova legge si appresta ad attribuire poteri sostanziali sulle reti televisive pubbliche.
Con questa legge avremo una Camera i cui due terzi saranno nominati dalle segreterie di partito invece che scelti dai cittadini. Gli eletti, che dovranno l’elezione al capo del loro partito, gli obbediranno ciecamente quando sarà capo del governo e si realizzerà così ciò che Leopoldo Elia aveva chiamato "premierato assoluto", riducendo drasticamente il potere legislativo del Parlamento e attribuendo poteri senza limiti e senza controllo al governo e in particolare al presidente del Consiglio. Si cambia la forma di governo fino a distorcere la forma dello Stato.
Allo stesso tempo la partecipazione dei cittadini viene relegata al voto ogni 5 anni, perché la maggioranza parlamentare potrà ignorare il confronto con le parti sociali e in particolare con il sindacato come è già accaduto in questi mesi imponendo i propri provvedimenti al Paese. Questo finisce con il mettere in seria discussione la stessa prima parte della Costituzione, perché meccanismi istituzionali accentrati e autoritari possono essere il veicolo per rimettere in discussione anche i valori che dovrebbero presiedere alla vita della nostra Repubblica. La partecipazione alle scelte politiche nazionali sarà resa assai più difficile dalle modifiche costituzionali in corso di approvazione, di cui i punti più preoccupanti sono la sostanziale riduzione del Senato ad una sorta di dopolavoro di lusso per consiglieri regionali e l’accentramento nelle mani del governo di poteri importanti delle Regioni e degli Enti locali.
Il Coordinamento per la Democrazia Costituzionale invita tutti i cittadini a riflettere sulle conseguenze negative di questa legge elettorale. I diritti sociali, e in particolare quelli del lavoro, già pesantemente attaccati dalle leggi degli ultimi governi (lavoro, pubblica amministrazione, scuola) saranno ancora più in pericolo.
La sostituzione dell’intelligenza collettiva col comando di un capo la si coglie esplicita nella riforma della scuola che attribuisce tutti i poteri sostanziali al preside: un premierato assoluto anche nell’insegnamento.
Il Coordinamento si rivolge a tutte le forze attive della società e chiede ai partiti, ai sindacati, alle associazioni, ai gruppi spontanei di coordinare la loro azione a sostegno di tutte le iniziative che possano impedire l’entrata in vigore della legge. Azione giudiziaria, come quella che ha portato al giudizio negativo della Corte costituzionale sul Porcellum. Azione referendaria, anche per tentare di abrogare la legge entro il giugno 2016, prima che diventi operante.
A questo fine nei prossimi giorni il Coordinamento avvalendosi delle competenze di autorevoli costituzionalisti e giuristi presenterà proposte di quesiti referendari sia per l’abolizione dell’Italicum entro la sua entrata in vigore nel 2016, sia per modificare la sostanza della legge elettorale approvata in coerenza con le osservazioni della Corte costituzionale al Porcellum. Ogni soggetto attivo potrà decidere se raccogliere queste proposte e impegnarsi per una campagna referendaria di abrogazione totale o parziale della legge elettorale approvata definitivamente il 4 maggio scorso.
Il Coordinamento chiede a tutti i soggetti attivi di impegnare le energie contro la costruzione di un potere assoluto nelle mani di una minoranza. Votare con l’Italicum sarebbe un danno grave per la Repubblica.
* ADISTA - SEGNI NUOVI, 23 MAGGIO 2015 • N. 19
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- L’Italia che non vuole cambiare. Narcisismo e cecità dei baroni uccidono l’università italiana (di Gian Antonio Stella)28 gennaio 2015, di Federico La Sala
Narcisismo e cecità dei baroni uccidono l’università italiana
Autoreferenzialità, fobia digitale, concorsi «adattati»: è l’Italia che non vuole cambiare
di Gian Antonio Stella (Corriere della Sera, 28.01.2015)
«Mio padre era un professore universitario, ragion per cui aveva le abitudini tipiche dei professori universitari. Guardava tutti dall’alto in basso, non scendeva mai dalla cattedra, neanche in famiglia. Era una cosa che non sopportavo fin da quando ero bambino».
Tranquilli: l’ingombrante genitore del nostro scrittore non era senese, non era barese, non era bresciano e neppure foggiano o trentino. La testimonianza, infatti, è di Haruki Murakami, uno dei più celebri romanzieri giapponesi.
Tutto il mondo è paese? Ma certo. Esiste tuttavia un Homo academicus specificatamente italiano. Al punto che Stefano Pivato, docente di Storia contemporanea a Urbino dove è stato anche rettore, autore di libri deliziosi a cavallo fra storia e costume come Vuoti di memoria, Il secolo del rumore, Il nome e la storia, ha deciso di dedicare a questa specie umana un feroce e divertito pamphlet.
Si intitola Al limite della docenza. Piccola antropologia del professore universitario , è edito da Donzelli, e dimostra che non sempre, come dice il vecchio adagio, cane non morde cane. In questo caso prof. morde prof. e rettore morde rettore. Come quello che, «magnifico di un’università del Nord in carica da ventotto anni» si levò furente all’assemblea della Crui dell’ottobre 2010 scuotendo i colleghi con parole di fuoco contro il limite di sei anni ai rettorati eterni voluto da Mariastella Gelmini e contro l’introduzione del codice etico. «L’etica si pratica, non si legifera!» Boooom!
C’era il pienone quel giorno, alla conferenza dei rettori. Troppo spesso però, secondo Pivato, l’ Homo academicus italicus somiglia a quel Bernardino Lamis protagonista d’una novella di Pirandello «descritto mentre tiene la sua “formidabile” lezione. Il docente è “infervorato” a tal punto che solo alla fine si accorge di aver parlato a un’aula priva di studenti».
L’ex rettore ne è certo: «Coinvolta in scandali di vario genere, l’università è, da tempo, sotto scacco. C’è però da chiedersi fino a che punto sia utile e produttivo reagire scompostamente e non piuttosto avviare una profonda autocritica che coinvolga prima di tutto una serie di attitudini». Come l’autoreferenzialità. Due che s’incrociano dicono: «Come stai?». Al contrario, «una certa tipologia di docente ha l’abitudine di salutarti con una formula piuttosto diffusa nell’ambiente universitario e, stringendoti la mano, senza chiederti nulla, ti dice “come sto io”. Insomma parla unicamente di se stesso».
E tutto va di conseguenza: «Il professore “come sto io?” se riceve da un amico o un collega un libro, calibra il suo entusiasmo dal numero delle citazioni che ha ottenuto nell’indice dei nomi». E «non parte mai dai problemi universitari, che riguardano in particolare gli studenti e attengono alla diffusione del sapere. Ma dai “suoi” problemi. Che sono al centro del mondo». E mosso da «uno smisurato ego», pubblica libri che non vende a nessuno, ma se lo incrociate «vi dice subito che il libro è giunto già alla terza o quarta edizione, e magari che sta entrando in classifica, pronto a scalzare i best sellers di Camilleri...».
Di più: «Spesso l’importanza del volume è sottolineata dal numero delle pagine che il docente “come sto io” mima allargando a dismisura le mani per darti l’idea del “tomone” che ha pubblicato. Come se l’importanza di un libro si misurasse a chili». E naturalmente il libro «fa giustizia di tutte le teorie e le ipotesi precedenti».
E se la grafomania fosse sfogata negli ebook? Ma per carità! «Un buon numero d’insegnanti, soprattutto quelli delle discipline umanistiche, non ha ancora dimestichezza con gli strumenti digitali. Anzi, oppone loro un vero e proprio rifiuto. La motivazione più ricorrente è quella che la scrittura con carta e penna riveste un fascino d’ antan che non può contaminarsi con la modernità». E per di più non sarebbero più possibili certi trucchetti per imporre l’adozione del proprio tomo agli studenti. Come quello di un docente che, per evitare che gli allievi si passassero i libri usati, ha fatto stampare il suo con un’accortezza: «L’ultima parte era costituita da una serie di pagine con domande ed esercizi che lo studente doveva compilare a penna e quindi staccare e consegnare al professore per la verifica. In questo modo, terminato l’esame, il testo, mancante della parte finale, non era più utilizzabile».
C’è chi dirà: «Uffa! Veleni». No: come giustamente recita la fascetta, quello di Pivato è un pamphlet malizioso, irridente ma tremendamente serio. Che getta sale sulle piaghe di un sistema universitario troppo spesso ostile a ogni riforma. Legato a riti e reverenze ampollose verso il Chiarissimo, l’Amplissimo, il Magnifico... Dove il rettore d’un ateneo privato al Nord può essere contemporaneamente il «magnifico» in «un’altra università del Sud a circa millecinquecento chilometri di distanza». Dove «il camaleontismo del professore mostra incredibili doti di adattamento ai meccanismi concorsuali» e l’imperativo è taroccare de Coubertin: «L’importante è partecipare ma soprattutto vincere».
Insomma, un luogo chiuso dove «i codici etici concretamente adottati dalle università affrontano tendenzialmente tutti i temi, ma per lo più in modo astratto». Dove esattamente al contrario che nei grandi atenei internazionali che sono un viavai di eccellenze, lo jus loci , il radicamento vita natural durante nel cantuccio della propria facoltà, «costituisce una delle regole più ferree». Dove le ore obbligatorie di lezione sono al massimo 120 l’anno contro le 192 in Francia, le 279 in Baviera, le 252 (ma fino a 360) in Spagna, le 240 in Gran Bretagna...
Abbiamo scommesso: c’è chi liquiderà il pamphlet, frutto di un grande amore ammaccato per l’università, come uno sfogo brillante ma fatto di mezze verità. E sbufferà: ma come, uno dei nostri che offre munizioni ai nostri nemici! Vadano a rileggersi Curzio Malaparte e la sua idea del patriottismo: «Un popolo sano e libero, se ama la pulizia, i panni sporchi se li lava in piazza».
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- Il fascismo fu solo retorica. Norberto Bobbio nel carteggio con Luisa Mangoni difende le sue tesi: “Un’era di cortigiani e adulatori”.23 gennaio 2015, di Federico La Sala
Norberto Bobbio
“Altro che cultura per me il fascismo fu solo retorica”
Nel carteggio del ’76 con Luisa Mangoni lo studioso difende le sue tesi: “Un’era di cortigiani e adulatori”
di Simonetta Fiori (la Repubblica, 23.01.2015)
NEL 1976 Norberto Bobbio è già uno studioso influente, 67 anni, preside della Facoltà di Scienze Politiche a Torino. Da diversi decenni i suoi volumi sul rapporto tra cultura e politica orientano la scena intellettuale italiana. Tre anni prima era uscito il saggio Cultura e fascismo, destinato ad accendere un grande dibattito. Bobbio è persuaso che non sia mai esistita una “cultura fascista”. Il regime aveva prodotto molta retorica ma non opere importanti, titoli spartiacque, in una parola una tradizione intellettuale: chi poteva dire il contrario? Ecco farsi avanti una giovane studiosa, Luisa Mangoni, Marisa per gli amici.
Ha 35 anni, quasi la metà del suo autorevole interlocutore. Rigorosa e schietta, meticolosa e dolcissima. Gli dà dell’«arretrato». Dice proprio così: «l’impostazione del professor Bobbio appare arretrata». Lo fa durante una conferenza a Bologna. E il pubblico l’ascolta con attenzione: nel 1974 era uscito da Laterza il suo libro L’interventismo della cultura, destinato a cambiare lo sguardo sul rapporto tra ceto intellettuale e regime. In quelle pagine moriva l’equazione tra fascismo e “non cultura”.
Da quello scambio a distanza tra l’appassionata studiosa e l’illustre professore ebbe origine il carteggio inedito che ora pubblichiamo grazie allo storico Innocenzo Cervelli, marito della Mangoni mancata un anno fa. Un pacchetto di lettere, dal 21 marzo del 1976 al 16 marzo del 1977, che lumeggiano da una parte il singolare profilo intellettuale di Bobbio, maestro generoso che non parla mai ex cathedra, disponibile nello sperimentare i suoi stessi limiti, umile e insieme pedagogico. Dall’altra, la sicurezza intellettuale di una giovane donna che non arretra, però se occorre è pronta al ripensamento, mette a fuoco e rilancia. Un metodo di lavoro che avrebbe mantenuto nel corso della sua vita di ricercatrice, forse non pienamente riconosciuta dall’università e alla quale oggi rende omaggio un convegno dell’Istituto Gramsci.
Da Adriano Prosperi ad Albertina Vittoria, da Francesco Barbagallo a Giuseppe Ricuperati, saranno in tanti ad evocare i suoi studi sulla storia degli intellettuali nel loro rapporto con il potere e la politica, le sue poco convenzionali ricerche sulle case editrici Einaudi e Laterza (quest’ultima interrotta dalla scomparsa), il ruolo pionieristico «nell’analisi della cultura intesa nei suoi aspetti organizzativi e nella sua volontà di avere voce in capitolo nella sfera della società e dello Stato», come spiega Giuseppe Vacca, ideatore del seminario.
Ed è questo l’aspetto più innovativo che emerge anche dal confronto con Bobbio. Per lo studioso la cultura è «il patrimonio intellettuale e morale di una nazione », «opere destinate a durare nel tempo, a dare vita a una tradizione ». Mangoni liquida questa definizione come “riduttiva”. «A me pare che da un lato Lei privilegi un’idea di alta letteratura di impronta marcatamente aristocratica », gli scrive il 29 marzo del 1976. «E dall’altro evada il significato della cultura in rapporto allo Stato e alla società civile, che è un’altra cosa rispetto alla organizzazione, alla propaganda, alla stressa manipolazione del consenso».
Secondo Mangoni la cultura e gli intellettuali «non si spiegano tautologicamente con se stessi, ma solo in relazione allo Stato e alla società». Per questo contesta a Bobbio anche il giudizio sul “nicodemismo”, ossia quel fenomeno di infingimento che Eugenio Garin aveva condannato tra gli intellettuali italiani sotto Mussolini: antifascisti nell’intimo ma pronti a ricevere onori e prebende dal regime.
«Non vedo come la dissimulazione produca cultura», le aveva scritto Bobbio nella lettera del 21 marzo. «Produce quella letteratura tra cortigianesca e adulatoria di cui gli intellettuali italiani sono stati prodighi in tutte le epoche ». Mangoni rilancia: anche il nicodemismo è una zona di opacità che deve essere indagata. «Come interpretare altrimenti la recensione di Delio Cantimori a Ugo Spirito nel 1937?».
La discussione sarebbe andata avanti per alcuni mesi. Era una stagione di grande fermento, alla metà dei Settanta. Uscivano libri che ampliavano lo sguardo sul fascismo e sul Novecento. Beppe Vacca ricorda che nel 1974, insieme all’Interventismo della cultura, furono pubblicati Gli intellettuali del XX secolo di Eugenio Garin e Gli anni del consenso, il terzo volume della biografia mussoliniana di Renzo De Felice.
Cambiavano i parametri e la polemica culturale era quasi quotidiana, come questa tra Bobbio e Mangoni. Lui sembra anche divertito da questa inattesa «esecuzione sommaria condotta sui sacri testi» (che poi sarebbero Gramsci e Togliatti), ma non si lascia convincere. «Quando mi chiedo se ci sia stata una cultura reazionaria vado a cercarla nei grandi scrittori come Nietzsche o Pareto, cioè proprio in opere destinate a durare nel tempo. E sulle quali tutte le epoche tornano per reinterpretarle e discuterle». In fondo dell’azione culturale svolta da Giuseppe Bottai - personaggio simbolo scelto da Mangoni per il suo ragionamento - non è rimasto niente. «Si è sciolta come nebbia al sole», dice Bobbio. Sopravvive invece l’insopportabile retorica dei tanti giovani costretti all’ossequio. Ma la retorica è cultura?, la provoca in una lettera del 27 aprile.
«Bisogna risalire alle radici più profonde », replica la studiosa nel giugno del 1976. Lei si accingeva all’opera proprio in quei mesi, persuasa che alcune componenti ideologiche e strutturali del fascismo fossero sopravvissute nella giovane democrazia, «dal capitalismo monopolistico di Stato alla concezione corporativa della società». Tutti temi su cui avrebbe continuato a studiare, con puntiglio ed umiltà. Scavando nelle zone d’ombra dell’intellettualità italiana, senza mai lasciarsene avvolgere.
- Le lettere mai pubblicate
Cara, quel regime creò tanto rumore per nulla
di Norberto Bobbio (la Repubblica, 23.01.2015)
TORINO, 21 marzo 1976 Gentile dottoressa, ho letto con vivo interesse il suo articolo sulla cultura e il fascismo, e le osservazioni critiche ivi contenute nei riguardi della mia (malfamata) tesi sull’inesistenza della cultura fascista. Alcuni mesi fa scrissi un nuovo articolo sul tema, che le mando (...). Come vede, sono recidivo. Sono recidivo perché mi pare che sino ad ora gli avversari ai miei argomenti rispondano o spostando la discussione sul cedimento degli intellettuali (che io non ho mai contestato ma che è un problema completamente diverso) oppure parlando d’altro, per esempio dell’organizzazione della cultura promossa con tanto strepito (se pure con scarsi risultati) dal regime. (...) Non posso dire che questo suo articolo, pur interessante (e non poteva essere altrimenti provenendo dall’autore di un libro importante come L’interventismo della cultura) e ricco di spunti (su cui intendo riflettere), m’induca a cambiare idea. Ma non insisto. Mi domando soltanto perché lei consideri arretrato (arretrato rispetto a cosa?) il mio modo di porre il problema (...). Perché è arretrato chiedere che si finisca di fare discorsi generici pro o contro il fascismo, e si faccia un esame serio di quel che è rimasto della cultura durante il fascismo? Non è la stessa cosa che chiede lei? A un certo punto lei per dimostrare la mia arretratezza parla del nicodemismo e dice che la tesi di Garin sul nicodemismo rappresenta «un notevole passo avanti rispetto alla tesi di Bobbio ecc.». A parte il fatto che del nicodemismo avevo parlato anche io indipendentemente da Garin (vedi Fascismo e cultura , ...), e in maniera molto esplicita, e credo precisa, mi pare che il nicodemismo sia uno degli argomenti più forti a favore della mia tesi. Non vedo come la “dissimulazione” produca cultura. Produce questa letteratura cortigianesca e adulatoria, di cui gli intellettuali italiani sono stati prodighi in tutte le epoche. Coi più cordiali saluti Norberto Bobbio
TORINO , 16 marzo 1977 Gentile signora, la ringrazio dell’estratto del suo articolo su cesarismo ecc. Un bel tema, che mi piacerebbe però vedere sviluppato meglio anche concettualmente. Lei per esempio accenna a un certo punto alla distinzione tra cesarismo e bonapartismo, poi se non sbaglio non la riprende più. Così il problema del rapporto tra cesarismo, democrazia di massa e capo carismatico, da cui parte, andrebbe meglio approfondito anche riguardo a Gramsci, che cita Michels a proposito del capo carismatico in un famoso passo sulla demagogia in senso negativo e sulla demagogia in senso positivo. Il tema del capo carismatico è un tema che entra con forza nelle discussioni di quegli anni tra coloro che si rendono conto che è cominciata l’era della democrazia di massa (della “ribellione delle masse” per dirla con una espressione nota e negativa). Dal momento che lei ha dedicato l’ultima parte del suo articolo a Gramsci, perché non analizzare il suo pensiero anche su questo punto? Chi è “il demagogo superiore”? È anche lui un capo carismatico? Come mai tutta la teoria politica marxistica anche dopo Michels e dopo Weber non ha mai parlato volentieri del capo carismatico? (...) Cordiali saluti Norberto Bobbio
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. L’Italia come volontà e come rappresentazione --- M5S, il declino della non politica (di Alessandro Dal Lago).29 novembre 2014, di Federico La Sala
M5S, il declino della non politica
di Alessandro Dal Lago (il manifesto, 29 novembre 2014).
Ogni tanto, l’infinita crisi del M5S, ininfluente in parlamento e poco visibile nella società, è ravvivata dalle espulsioni di qualche deputato.
Se non ci fossero le risibili consultazioni online sulla sorte dei reprobi, che osano criticare i leader, nessuno parlerebbe più di Grillo e tanto meno di Casaleggio.
Ecco, forse, la vera ragione della stanchezza di Grillo: la noia di chi ha dato vita a un movimento e ora non sa più dove sbattere la testa.
È molto difficile che il M5S si possa riprendere dalla crisi, anche se i sondaggi gli attribuiscono un certo radicamento sociale.
Dopo streaming insultanti o inutili, risultati elettorali deludenti (soprattutto nelle realtà locali), polemiche incessanti tra parlamentari e staff, licenziamenti di comunicatori e altre amenità, il M5S si trova di fronte al solito bivio: o mettersi a far politica e quindi deludere il suo elettorato anti-sistema o continuare con la finta opposizione, le sceneggiate con il bavaglio e tutto il repertorio folcloristico che porterà a un lento ma inevitabile declino. Insomma, o l’assimilazione o l’irrilevanza.
Il fatto è che il M5S si fonda su alcuni equivoci che, a meno di due anni dai trionfi elettorali del 2013, sono venuti clamorosamente alla luce. Il primo è senz’altro una leadership a dir poco impresentabile: un imprenditore New Age, non si sa se più affarista o lunare, e un comico che non fa più ridere, dominato dai suoi mutevoli umori demagogici. Il secondo equivoco è l’assenza di qualsiasi cultura politica. Chi non vuol essere né di destra, né di sinistra, e sceglie il giustizialismo più ovvio, alla fine si condanna a non essere e basta. Il terzo è l’assenza di trasparenza organizzativa del movimento, sostituita dalla mitologia della rete come esclusiva arena democratica.
La verità banale è che la rete, per definizione, è influenzabile e manipolabile. Chi decide di indire i referendum sulle leggi e le consultazioni sulle espulsioni? Ovviamente, i due leader (con i loro staff più o meno segreti). Più che cittadini indipendenti, gli iscritti che votano sul blog di Grillo sembrano ostaggi di un marketing autoritario e impolitico.
Detto questo, il declino del M5S mette un po’ di malinconia e suscita qualche interrogativo. Che Casaleggio, Grillo (con loro yes men parlamentari) finiscano nell’oblio o cerchino di tornare alle loro occupazioni più o meno lucrative non interessa a nessuno. Ma resta il fatto che milioni di persone in buona fede hanno creduto in loro e resteranno inevitabilmente a disposizione della demagogia che avanza, soprattutto a destra.
Il modello di Renzi anestetizza buona parte della società, ma radicalizza tutti coloro che non vogliono identificarsi con il blairismo chiacchierone e pseudo-decisionista del presidente del consiglio. Ed ecco spalancarsi praterie per la Lega, per l’estrema destra, per i movimenti urbani xenofobi, che magari durano lo spazio di pochi giorni, come i forconi di qualche anno fa, ma sono infinitamente riproducibili in altre forme, sintomi di uno sfascio sociale senza fine.
Il paradosso è che a raccogliere tutto questo disagio, questa voglia di farla finita con le solite facce, questa protesta - in breve, un confuso ma potente appello al cambiamento che da anni sale dalla società - non è la sinistra, che sembra essersi rifugiata nell’astensionismo, nella ripetizione di vecchi slogan o nella riproposizione di vecchie alleanze, già fallite e consegnate alla storia minore.
E allora, per comprendere perché un fenomeno come il grillismo è potuto esplodere e implodere nel giro di pochi mesi, bisognerebbe riflettere, a sinistra, sulle idee di leadership, di movimento, di composizione sociale, di lavoro, di Europa. È questo il lavoro che ci attende, e non il ritorno in scena di un’accozzaglia di leader bolliti da anni o di giovani leoni irreparabilmente invecchiati.
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- «Il pensiero occidentale»: Gentile e Togliatti, vite parallele (di Luciano Canfora)29 novembre 2014, di Federico La Sala
Gentile e Togliatti, vite parallele
Entrambi scelsero di essere organici a un disegno politico, con Mussolini o con Stalin
«Togliatti, nel solco dei Quaderni di Gramsci, pensò la storia d’Italia in quanto strumento del rinnovamento della società italiana»
di Luciano Canfora (Corriere della Sera, 28.11.2014)
Può apparire a taluno singolare o addirittura «provocante» che di Giovanni Gentile e di Palmiro Togliatti escano in contemporanea presso Bompiani, nella stessa collana, «Il pensiero occidentale», due ampie sillogi miranti a fornire al lettore una nutrita esemplificazione del loro pensiero (Giovanni Gentile, L’attualismo , introduzione di Emanuele Severino, pp. 1486, e 40; Palmiro Togliatti, La politica nel pensiero e nell’azione , a cura di Michele Ciliberto e Giuseppe Vacca, pp. 2330, e 55).
Come si sa, Gentile fu ucciso da un commando dei Gap a Firenze circa alle ore 13 del 15 aprile 1944 e qualche giorno dopo, su «l’Unità» di Napoli, Togliatti, da poco rientrato in patria dall’esilio, ne avallò l’esecuzione capitale con un articolo di estrema durezza, sprezzante nel tono almeno quanto lo erano gli attacchi rivolti a Gentile da Radio Londra (Paolo Treves) e da Giustizia e Libertà (Carlo Dionisotti) subito prima e subito dopo l’attentato.
Eppure, ritrovarli l’uno accanto all’altro in questa importante iniziativa editoriale non dovrà ritenersi né casuale né immotivato.
Gentile e Togliatti condivisero un punto di vista, o meglio una scelta, che li coinvolse entrambi personalmente in quanto intellettuali organici ad un forte progetto politico. Una scelta, ideale e pratica, che per entrambi risultò decisiva. Non stupisce perciò la dilatazione che entrambi operarono della nozione di «pensatore», richiamandosi l’uno a Mussolini, l’altro a Stalin come a leader intellettuali e politici al tempo stesso.
Nel caso di Gentile si potrebbero citare scritti suoi quali L’essenza del fascismo (1928) o Origini e dottrina del fascismo (1929) nonché il contributo suo alla voce Fascismo ( Dottrina del fascismo ) firmata da Mussolini per l’Enciclopedia Italiana (1932) e pensata da entrambi. Ma si possono ricordare anche scritti, meno originali certo ma intenti ugualmente a chiosare Mussolini come pensatore, di altri coevi cultori di discipline dello «spirito». La sezione filosofica della voce enciclopedica firmata da Mussolini fu infatti riedita e commentata, come «classico» per i Licei, da Emilio Paolo Lamanna ( La dottrina del fascismo. Commento , Le Monnier, 1940) e già prima da Antonino Pagliaro ( Il fascismo. Commento alla dottrina , ed. Universitaria, 1933).
Quanto a Togliatti, che definì alla Camera dei deputati (6 marzo 1953) Stalin «un gigante del pensiero», si può osservare che gli scritti filosofici di Stalin ( Questioni del leninismo ) erano stati da lui tradotti e inclusi tra i «Classici del marxismo» per le Edizioni Rinascita (Roma 1945, collana diretta da Cantimori, Luporini, Donini, Pesenti). Peraltro ancora negli anni Settanta, nella grande Storia del pensiero filosofico e scientifico di Ludovico Geymonat (Garzanti, vol. VI, 1972), un paragrafo viene dedicato al pensiero di Stalin, e anche di Mao Zedong. Nel 1974 un capitolo dell’ Introduzione alla sociolinguistica di Marcellesi e Gardin (Larousse, trad. it. 1979) è dedicato a Il marxismo e la linguistica di Stalin.
Croce si mostrava infastidito quando la pubblicistica comunista gli presentava Lenin e Stalin come suoi «colleghi in filosofia», per adoperare una sua ironica espressione. Resta il fatto che, nel Novecento, si è determinata una consapevole rottura degli argini della tradizionale nozione di «pensatore politico».
E non è un caso che chi tale rottura ha inverato, in costante sintesi di pensiero e azione, si sia richiamato all’archetipo per eccellenza di tale «rottura degli argini», cioè a Machiavelli: sia Gramsci che Mussolini. Tale rottura comportò che uomini i quali avevano guidato rivoluzioni di durevole effetto venissero, nel vivo dell’azione, percepiti, o avversati, anche come «pensatori». È soprattutto nel fuoco dei grandi rivolgimenti politico-sociali che la identità Theoria / Praxis si manifesta in tutta la sua forza. Croce, pur estraneo al milieu accademico e anzi spregiatore delle sue sclerosi, vedeva in ciò una sorta di «profanazione» del «filosofare».
È comunque curioso osservare la disparità dei suoi giudizi. Nel suo diario ( Quando l’Italia era tagliata in due , Laterza, 1948), al 2 dicembre 1943, parla di Mussolini come «uomo di corta intelligenza» e dalla «personalità nulla», mentre di Lenin e di Stalin parla come di «uomini dotati di genio» ( Russia ed Europa , «Città libera», 23 agosto 1945, largamente ripreso dalla stampa inglese).
Si può ben dire dunque che Togliatti e Gentile ci appaiono, anche grazie a queste due nuovissime corpose sillogi, segnati dall’esperienza, da entrambi vissuta in prima persona, che abbiamo voluto definire «rottura degli argini»: accomunati dal convincimento secondo cui filosofare è, a pieno titolo, l’agire politico sorretto dalla consapevolezza di tradurre in atto una concezione del mondo. In quanto essa prende forma e si precisa, e si evolve, nel suo stesso farsi azione concreta. Per questo entrambi respinsero la separatezza del filosofare.
Ma in che misura, nel caso di Togliatti, può parlarsi di un suo pensiero politico? A pieno titolo egli può annoverarsi tra i maggiori «revisionisti», rispetto al marxismo, al pari di un Bernstein e di un Turati. Tale egli fu, nell’azione concreta, mai disgiunta dalla riflessione storico-politica (si pensi al suo uso di Giolitti come metafora), attore e teorico.
Nel solco dei Quaderni di Gramsci, egli pensò la storia d’Italia in quanto strumento del rinnovamento della società italiana. Alla sua linea d’azione e al suo pensiero, al di là della quotidianità e delle scelte contingenti, si adattano le parole di Gentile nella sezione La storia (Storia come storia dello Stato) di Genesi e struttura della società riferite al concetto di «Rivoluzione». Lì Gentile - proprio per chiarire il concetto di «rivoluzione» - spiega la forza delle Costituzioni, delle carte costituzionali, come «mito» indispensabile e da tutelarsi come tale, ma al tempo stesso la loro mutazione costante nel concreto e quotidiano farsi della vita dei popoli: «Scritte sì, ma lette - egli scrive - intese, vissute nella coscienza politica del popolo che viene rinnovandosi».
Nell’Introduzione generale alla silloge, Ciliberto e Vacca riprendono il paragone con Cavour che fu già caro a Giorgio Bocca, narratore intelligente della biografia togliattiana. Ciliberto - credo che quelle parole siano sue - racchiude felicemente la figura di Togliatti in una immagine: quella di «un politico che aveva particolari virtù di statista anche se non riuscì ad esserlo in modo compiuto come, forse, avrebbe potuto».
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. L’Italia come volontà e come rappresentazione di un solo Partito. --- Renzi e il "Partito della Nazione”. Non è per niente stupito, Massimo Cacciari. Intervista di Sebastiano Messina28 ottobre 2014, di Federico La Sala
- RICERCA E MERAVIGLIA: AL SAN RAFFAELE, UNA GRANDE FESTA FILOSOFICA! IL "VECCHIO" PROBLEMA DEL PENSIERO DELLA COSTITUZIONE E DELLA COSTITUZIONE DEL PENSIERO E’ STATO RISOLTO !!!
 ALL’OMBRA DELL’UOMO DELLA PROVVIDENZA: 2002-2012, DIECI ANNI DI FILOSOFIA AL "SAN RAFFAELE". Un "avviso a pagamento" di Massimo Cacciari
ALL’OMBRA DELL’UOMO DELLA PROVVIDENZA: 2002-2012, DIECI ANNI DI FILOSOFIA AL "SAN RAFFAELE". Un "avviso a pagamento" di Massimo Cacciari
Massimo Cacciari
Non c’è nulla di casuale, nulla di improvvisato, nell’attacco di Renzi al posto fisso e all’articolo 18
“Matteo abbatte i simboli della socialdemocrazia per sedurre il centrodestra con il Partito della Nazione”
“Il premier agita bandiere ideologiche e di fatto allontana le due anime del Pd. Una scissione? Non la teme e forse, sotto sotto, la desidera”
intervista di Sebastiano Messina (la Repubblica, 28.10.2014)
ROMA «Non c’è nulla di casuale, nulla di improvvisato, nell’attacco di Matteo Renzi al posto fisso e all’articolo 18. Lui sta abbattendo i simboli della sinistra socialdemocratica per penetrare nel centrodestra con il progetto del Partito della Nazione. E’ un piano lucidissimo». Non è per niente stupito, Massimo Cacciari, della durezza dello scontro che si è acceso nel Pd.
Professor Cacciari, non è la prima volta che un presidente del Consiglio di sinistra dice che è finita l’epoca del posto fisso (lo disse D’Alema 15 anni fa). Eppure stavolta sembra diventato lo spartiacque tra le due anime del Pd, quella che si è radunata alla Leopolda e quella che è scesa in piazza con la Cgil. Perché?
«A volte il tono è tutto. Mentre gli altri dicevano queste cose con un tono di analisi, anche spietata, Renzi mi presenta un destino come se fosse un suo successo personale: ah che bello, finalmente è finita l’epoca del posto a tempo indeterminato! Ma come si fa a non comprendere il carico di ansia, di frustrazioni che una situazione di questo genere può determinare? Un politico non può fermarsi all’analisi: deve dirmi quali sono i rimedi. Deve dirmi quali ammortizzatori sociali ha previsto, e quali garanzie avranno i lavoratori senza più posto fisso per la loro pensione».
Il segretario del Partito democratico, dice lei, non dovrebbe parlare così.
«Neanche il più feroce dei conservatori ha mai presentato queste trasformazioni sociali che possono generare ansie ed angosce come se fossero delle pensate geniali».
Il vero centro della polemica sembra però l’abolizione dell’articolo 18. Difenderlo oggi, ha detto Renzi, è come cercare di mettere il gettone nell’Iphone. E’ così?
«Ma è evidente che l’abolizione dell’articolo 18 è una bandiera ideologica, una banderuola rossa che Renzi sventola sotto il naso dei suoi oppositori e dei suoi sostenitori. L’ha detto lui stesso».
E perché, secondo lei, ha scelto questo tema, in questo momento e in questo modo?
«Perché è il tema che gli dà più spazio nel costruire il Partito della Nazione. E’ un tema ideologico molto forte, che gli permette di penetrare nell’ambito dell’elettorato di centrodestra. E l’articolo 18 è una formidabile arma ideologica per costruire questo consenso trasversale, infinitamente al di là dei confini tradizionali del centrosinistra. Siamo di fronte a un politico puro, e di razza secondo me. Il suo è un calcolo tutto politico, non c’entra nulla il ragionamento economico».
Ma il partito della Leopolda e quello di piazza San Giovanni possono convivere?
«Queste due anime sono sempre meno avvicinabili, ma Renzi il problema di tenerle insieme non se lo pone neanche. Lui pensa: se io do l’impressione di entrare in un gioco di compromessi e di mediazioni tra personaggi che la pubblica opinione ritiene assolutamente sorpassati, io divento uno di loro, e perdo».
Ormai il tema della scissione è sul tavolo. Non la temo, dice Renzi. Sarà inevitabile, secondo lei?
«Io credo che lui non solo non la tema ma sia sul punto di desiderarla. Fino a qualche tempo fa no, ma ora forse comincia a pensare che la scissione gli convenga».
Cioè crede che tagliare le radici, e perdere un pezzo del partito, gli porti più voti?
«Se c’è una scissione, è chiaro che senza i Bersani e i D’Alema eccetera non potrà mai rifare il 41 per cento. Ma il taglio delle radici potrebbe convenirgli, per realizzare il suo progetto. E forse avrà fatto questo ragionamento: se escono da qui, cosa fanno? Si rimettono con Vendola? Fanno un’altra Rifondazione? Se ci fosse qualcuno che ha un’idea oltre Renzi, beh allora francamente sarei il primo io a iscrivermi al partito di questo qualcuno. Ma qui hanno tutti facce, e idee, pre Renzi. Eccetto Civati. Se togli lui, gli altri sono i reduci, come li chiama Renzi. Hanno fatto il Partito democratico senza uno straccio di idea nuova: l’unico che ce l’aveva era Veltroni, che infatti oggi appoggia Renzi. A parte Veltroni, conservatorismo puro, su tutto: dalle riforme istituzionali al lavoro. Cosa vuole che possano combinare, se escono dal Pd? Niente. Il vero problema è: ma a noi piace, il Partito della Nazione?».
Già. A lei, per esempio, piace?
«Mi piace? Ma io lo detesto! E’ una boutade populistica per arraffare voti e conquistare un’egemonia attorno alla figura di un leader. Ogni decisione favorisce una parte e sfavorisce un’altra. Perciò sono nati i partiti politici, nella democrazia. Partiti: da “parte”. Un Partito della Nazione è una contraddizione logica. Da analfabeti della politica. Ma questo non inficia minimamente la strategia di Renzi e la sua coerenza. Lui oggi si fa un partito suo e se lo fa grosso, rappresentativo, tendenzialmente egemone, chiamandolo Partito della Nazione. Approfittando dello sfascio della tradizione socialdemocratica e cattolico-democratica e anche dello sfascio del berlusconismo. E’ un’occasione unica, irripetibile. E lui la sta cogliendo».
- RICERCA E MERAVIGLIA: AL SAN RAFFAELE, UNA GRANDE FESTA FILOSOFICA! IL "VECCHIO" PROBLEMA DEL PENSIERO DELLA COSTITUZIONE E DELLA COSTITUZIONE DEL PENSIERO E’ STATO RISOLTO !!!
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- Vedi alla parola “rivoluzione”, la parola non è fuori posto (di Furio Colombo)5 ottobre 2014, di Federico La Sala
Vedi alla parola “rivoluzione”
risponde Furio Colombo (il Fatto, 05.10.2014)
- CARO COLOMBO, ho notato che la parola “rivoluzione” viene usata volentieri sia da Renzi sia da Berlusconi, per definire le cose che vogliono imporre. Ormai sappiamo che si tratta di un progetto congiunto. Ma poiché è un progetto che parte dal potere, perché chiamarlo “rivoluzione”?
 Luciano
Luciano
SE CI SI PENSA BENE, la parola non è fuori posto né per Renzi, che l’ha detta e ripetuta nei discorsi del viaggio in America, né per Berlusconi che dice “rivoluzione” per annunciare e poi celebrare il suo ritorno alla rilevanza nazionale dopo la condanna, l’espulsione dal Senato, l’interdizione dai pubblici uffici.
 Infatti rivoluzione significa “cambiamento immediato della organizzazione sociale”.
Infatti rivoluzione significa “cambiamento immediato della organizzazione sociale”.
 Le prove:
Le prove:
 1- La elezione a Camere riunite del Capo dello Stato, imposta dalla scadenza dell’attuale titolare della carica, non ha avuto luogo. La sequenza di votazioni è stata interrotta dopo due tentativi, ed è stata decisa la rielezione del Presidente in carica, benché la Costituzione non lo preveda.
1- La elezione a Camere riunite del Capo dello Stato, imposta dalla scadenza dell’attuale titolare della carica, non ha avuto luogo. La sequenza di votazioni è stata interrotta dopo due tentativi, ed è stata decisa la rielezione del Presidente in carica, benché la Costituzione non lo preveda.
 2 - Maggioranza e opposizione sono state abolite, introducendo la formula, senza precedenti, nel mondo democratico, delle “larghe intese” (tutto il Pd più tutto il Popolo delle Libertà) al fine di realizzare insieme (ovvero contro o al di fuori delle indicazioni degli elettori) le cosiddette “riforme strutturali”. La strana formula delle larghe intese si è poi evoluta attraverso un curioso camuffamento: una parte del Popolo delle Libertà si è riorganizzato in una vecchia-nuova aggregazione politica detta Forza Italia, e ha finto di passare all’opposizione. Un’altra parte si è organizzata in “Nuova Destra”, ed è diventata socia di governo con ministeri importanti, e sostiene il governo in Parlamento. Berlusconi controlla direttamente una parte (la finta opposizione) ma è il leader storico anche dell’altra, che sta trattando per rientrare.
2 - Maggioranza e opposizione sono state abolite, introducendo la formula, senza precedenti, nel mondo democratico, delle “larghe intese” (tutto il Pd più tutto il Popolo delle Libertà) al fine di realizzare insieme (ovvero contro o al di fuori delle indicazioni degli elettori) le cosiddette “riforme strutturali”. La strana formula delle larghe intese si è poi evoluta attraverso un curioso camuffamento: una parte del Popolo delle Libertà si è riorganizzato in una vecchia-nuova aggregazione politica detta Forza Italia, e ha finto di passare all’opposizione. Un’altra parte si è organizzata in “Nuova Destra”, ed è diventata socia di governo con ministeri importanti, e sostiene il governo in Parlamento. Berlusconi controlla direttamente una parte (la finta opposizione) ma è il leader storico anche dell’altra, che sta trattando per rientrare.
 3 - È stato chiamato a fare il primo ministro un cittadino noto e apprezzato come sindaco di Firenze, ma senza rapporti con il Parlamento. Si è deciso di scambiare la sua vittoria interna alle Primarie del Pd per elezione a capo del Governo e la sua vittoria a elezioni europee intese a decidere se restare in Europa o uscirne, come un plebiscito su di lui in quanto premier. Allo stesso tempo uno dei partiti di “maggioranza”, il Pd, lo ha eletto segretario. In questa doppia veste di eletto - non eletto, e di vincitore di elezioni nazionali che non ci sono state, guida il governo sulla base di un sostegno automatico preventivo.
3 - È stato chiamato a fare il primo ministro un cittadino noto e apprezzato come sindaco di Firenze, ma senza rapporti con il Parlamento. Si è deciso di scambiare la sua vittoria interna alle Primarie del Pd per elezione a capo del Governo e la sua vittoria a elezioni europee intese a decidere se restare in Europa o uscirne, come un plebiscito su di lui in quanto premier. Allo stesso tempo uno dei partiti di “maggioranza”, il Pd, lo ha eletto segretario. In questa doppia veste di eletto - non eletto, e di vincitore di elezioni nazionali che non ci sono state, guida il governo sulla base di un sostegno automatico preventivo.
 4 - Il capo del Governo così eletto e così sostenuto è tenuto a consultarsi a stretti intervalli, e nelle forme più vistose, con il capo della presunta opposizione (Berlusconi) che però garantisce i suoi voti in tutti i casi che dovessero essere difficili o delicati o simbolici. Evidentemente non è importante che il capo della presunta opposizione sia un condannato a pena definitiva per crimine rilevante, e arrivi scortato e in gran cerimoniale a Palazzo Chigi, benché interdetto dai pubblici uffici. Il suo assenso è indispensabile alle decisioni chiave del governo. Si può parlare o no di rivoluzione?
4 - Il capo del Governo così eletto e così sostenuto è tenuto a consultarsi a stretti intervalli, e nelle forme più vistose, con il capo della presunta opposizione (Berlusconi) che però garantisce i suoi voti in tutti i casi che dovessero essere difficili o delicati o simbolici. Evidentemente non è importante che il capo della presunta opposizione sia un condannato a pena definitiva per crimine rilevante, e arrivi scortato e in gran cerimoniale a Palazzo Chigi, benché interdetto dai pubblici uffici. Il suo assenso è indispensabile alle decisioni chiave del governo. Si può parlare o no di rivoluzione? - CARO COLOMBO, ho notato che la parola “rivoluzione” viene usata volentieri sia da Renzi sia da Berlusconi, per definire le cose che vogliono imporre. Ormai sappiamo che si tratta di un progetto congiunto. Ma poiché è un progetto che parte dal potere, perché chiamarlo “rivoluzione”?
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- Nel carattere popolaresco del “superuomo” sono contenuti molti elementi teatrali, esteriori, da “primadonna” più che da superuomo (Kant - Gramsci)7 luglio 2014, di Federico La Sala
 IMMAGINARIO E POLITICA. ALLE ORIGINI DEL SUPERUOMO DI MASSA E DELL’ITALIA COME VOLONTA’ E RAPPRESENTAZIONE DI UN UOMO SUPREMO
IMMAGINARIO E POLITICA. ALLE ORIGINI DEL SUPERUOMO DI MASSA E DELL’ITALIA COME VOLONTA’ E RAPPRESENTAZIONE DI UN UOMO SUPREMO
 KANT E GRAMSCI. PER LA CRITICA DELL’IDEOLOGIA DELL’UOMO SUPREMO E DEL SUPERUOMO D’APPENDICE. Materiali sul tema
KANT E GRAMSCI. PER LA CRITICA DELL’IDEOLOGIA DELL’UOMO SUPREMO E DEL SUPERUOMO D’APPENDICE. Materiali sul tema
 (...) Nel carattere popolaresco del “superuomo” sono contenuti molti elementi teatrali, esteriori, da “primadonna” più che da superuomo; molto formalismo “soggettivo e oggettivo”, ambizioni fanciullesche di essere il “primo della classe”, ma specialmente di essere ritenuto e proclamato tale (...)
(...) Nel carattere popolaresco del “superuomo” sono contenuti molti elementi teatrali, esteriori, da “primadonna” più che da superuomo; molto formalismo “soggettivo e oggettivo”, ambizioni fanciullesche di essere il “primo della classe”, ma specialmente di essere ritenuto e proclamato tale (...)
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. L’Italia come volontà e come rappresentazione di un solo Partito. --- Il populismo tecnocratico del «rottamatore» (di Lelio De Michelis)6 luglio 2014, di Federico La Sala
Il populismo tecnocratico del «rottamatore»
di Lelio De Michelis *
- Un’analisi impeccabile dell’ideologia e della prassi che hanno provocato il successo dell’uomo che ha costruito e rafforzato il suo potere divorando i suoi antagonisti e assorbendone così i nefasti caratteri. Sbilanciamoci info, newsletter, 4 luglio 2014 *
L’Italia, paese di populisti e di populismi. Ne ha conosciuti ben tre (e mezzo), nel ultimi vent’anni, un record mondiale. Populismo: che è concetto classico della politica e della sociologia ma che tuttavia è un processo culturale prima che politico. E oggi economico prima che culturale e politico, nel senso che è appunto l’economia capitalista ad essere oggi un processo culturale prima che economico, producendo - prima delle merci e del denaro - le mappe concettuali, cognitive, relazionali, affettive necessarie per la navigazione nel mercato; trasformando quello che era il cittadino dell’illuminismo in lavoratore, merce, capitale umano - ovvero in mero homo oeconomicus. Tre populismi interi: Berlusconi, Grillo e Renzi. E il mezzo populismo della Lega. Tre padri politici invocati dal popolo perché lo sorreggano, lo portino da qualche parte, gli dicano cosa deve fare, perché questo stesso popolo si ritiene incapace (o non più desideroso) di assumersi la responsabilità di essere sovrano di se stesso. Effetto culturale - questo - dell’antipolitica capitalista, che per essere sovrano assoluto e culturalmente monopolista deve rimuovere ogni sovrano concorrente.
Berlusconi: il populista che prometteva la modernizzazione neoliberale del paese. In realtà, un populismo del cambiare tutto per non cambiare nulla (soprattutto i suoi interessi personali e aziendali). Un populismo aziendalista, con la figura del padre/leader sostituita da quella dell’imprenditore che si è fatto da solo (o quasi), perfetta nell’esprimere il modello culturale che tutti dovevano apprendere: l’edonismo, il godimento immediato, la deresponsabilizzazione egoistica ed egotistica. Per legittimare - questa l’azione appunto culturale, pedagogica prima che economica - le retoriche neoliberiste dell’essere imprenditori di se stessi e della competizione come unica forma di vita.
Bossi e la Lega: il mezzo populismo (non solo perché limitato a una parte del territorio), apparentemente il più classico dei populismi con il richiamo alla tradizione, ai simboli di terra e di sangue. All’essere padroni a casa nostra: da intendere però non come sovrani sulla nostra terra ma come padroni nel senso antico del capitalismo. Populismo da piccola impresa, da capitalismo molecolare come versione localistica dell’ordoliberalismo tedesco e della sua pedagogia per imporre il modello impresa all’intera società.
Grillo: il populista contestatore, il teorico del net-populismo come forma perfetta della democrazia. Grillo come l’uomo del cambiamento ma incapace di cambiare (dice solo no) e forse populista anche di se stesso.
E Matteo Renzi. Un populismo di tipo nuovo ma evoluzione dei precedenti. Perché anch’egli cerca il rapporto diretto con il popolo e lo invoca come propria totalizzante legittimazione. Perché aspira ad essere insieme Partito di Renzi e Partito della Nazione. Un partito-non-partito tuttavia, ormai anch’esso trasversale - e quasi un non-luogo nel senso di Marc Augé: come un aeroporto, un supermercato, un luogo di consumo di politica.
Un populismo che invoca il popolo contro le caste e il sindacato salvando invece le oligarchie che lo sostengono come un sol uomo; che ha grandi mass-media schierati dalla sua parte e che gli consentono ciò che mai avrebbero consentito a Berlusconi; un populismo fideistico e teologico-politico (noi contro loro, noi il tutto che non accetta il due e il tre e il molteplice e gli eretici; noi il nuovo, gli altri il vecchio).
Un populismo che vuole rottamare appunto il vecchio, ma che non rottama, non corregge (una volta si chiamava autocritica, ma il nuovo che avanza travolge anche la memoria) i molti errori del passato: il sì all’austerità, all’articolo 81 della Costituzione sul pareggio di bilancio.
Un populismo finalizzato alla modernizzazione dell’Italia - e ogni populismo è stato, storicamente anche una via per la modernizzazione, facendo accettare al popolo, in nome del popolo quelle trasformazioni che altrimenti non sarebbero state possibili per trasformare un paese e quel popolo. Per questo, quello di Renzi è un populismo tecnocratico: che produce quella modernizzazione neoliberista che Berlusconi non è riuscito a produrre e Grillo fatica a poter produrre.
Un populismo nel nome della tecnocrazia, che la tecnocrazia ama; un populismo che trasforma (forse questa volta per davvero) il potere politico nel senso richiesto dalla tecnocrazia: meno democrazia (la riforma del Senato, le proposte di nuova legge elettorale); meno diritti sociali e quindi politici (diventati un costo); più decisionismo; meno partecipazione e più adattamento alla realtà immodificabile del mercato; meno cittadinanza attiva e più accettazione della ineluttabilità del reale. Perché le sue pratiche politiche - al di là delle apparenze e delle discussioni con Angela Merkel e di alcuni interventi comunque virtuosi - sono tutte dentro alla cultura della modernizzazione richiesta dall’ideologia neoliberista (flessibilità del lavoro, privatizzazioni, un nuovo modo di essere imprenditori di se stessi, riduzione ulteriore dello stato sociale, crescita invece di sviluppo, competizione invece di solidarietà); e la flessibilità sul Fiscal compact (invece della sua abolizione, per evidente irrazionalità e surrealtà economica), pure invocata, è un pannicello caldo rispetto al nuovo new deal che sarebbe invece necessario (e urgente). Un populismo futurista, inoltre: nel nome della velocità, delle macchine, delle parole in libertà, dell’azione per l’azione.
Il populismo di Renzi è dunque più di un classico neopopulismo, che ha dominato la scena per trent’anni coniugando populismo e neoliberismo, mercato e popolo, modernizzazione e impoverimento e disuguaglianze. E’ un neopopulismo tecnocratico - per altro discendenza diretta di quello neoliberista - che scardina ancor più di quello neoliberista le forme e le pratiche della democrazia; riduce a niente la società e la società civile; attacca il sindacato o lo rende inutile (in coerenza con le tecnocrazie globali); che spettacolarizza se stesso proponendosi come outsider, come rottura, come alternativa, in realtà portandoci nella società dello spettacolo della tecnocrazia.
Una tecnocrazia che non si espone più direttamente con i noiosi e antipatici tecnici, ma con la fantasia e l’estro di un populismo mediatico e spettacolare, moderno e postmoderno insieme, dove twittare è più importante che ascoltare.
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. L’Italia come volontà e come rappresentazione di un solo Partito. --- Un regime da “uomo solo al comando” (di Marco Travaglio - La democrazia autoritaria)6 luglio 2014, di Federico La Sala
La democrazia autoritaria
di Marco Travaglio (il Fatto, 06.07.2014)
Ecco cosa accadrà se le “riforme” di Renzi, Berlusconi & C. entreranno in vigore: un regime da “uomo solo al comando” senza opposizioni né controlli né garanzie.
 1. CAMERA. Con l’Italicum e le sue liste bloccate, sarà ancora composta da 630 deputati nominati dai segretari dei partiti più grandi. Quelli medio-piccoli saranno esclusi da soglie di accesso altissime. Il primo classificato (anche col 20%) avrà il 55% e potrà governare da solo, confiscando il potere legislativo, che di fatto coinciderà con l’esecutivo a colpi di decreti e fiducie.
1. CAMERA. Con l’Italicum e le sue liste bloccate, sarà ancora composta da 630 deputati nominati dai segretari dei partiti più grandi. Quelli medio-piccoli saranno esclusi da soglie di accesso altissime. Il primo classificato (anche col 20%) avrà il 55% e potrà governare da solo, confiscando il potere legislativo, che di fatto coinciderà con l’esecutivo a colpi di decreti e fiducie.
 2. SENATO. Con la riforma costituzionale, sarà formato da 100 senatori non eletti: 95 scelti dai consigli regionali (74 tra i consiglieri e 21 tra i sindaci) e 5 dal Quirinale. Sarà dominato dal primo partito e comunque non potrà più controllare il governo: niente fiducia né voto sulle leggi (solo pareri non vincolanti, salvo per le norme costituzionali).
2. SENATO. Con la riforma costituzionale, sarà formato da 100 senatori non eletti: 95 scelti dai consigli regionali (74 tra i consiglieri e 21 tra i sindaci) e 5 dal Quirinale. Sarà dominato dal primo partito e comunque non potrà più controllare il governo: niente fiducia né voto sulle leggi (solo pareri non vincolanti, salvo per le norme costituzionali).
 3. OPPOSIZIONE. I partiti di opposizione saranno decimati dall’Italicum. I dissenzienti dei partiti governativi potranno essere espulsi e sostituiti in commissione (vedi Mauro e Mineo). La “ghigliottina” entra in Costituzione: corsia preferenziale per le leggi del governo da approvare in 2 mesi, con divieto di ostruzionismo e emendamenti strozzati.
3. OPPOSIZIONE. I partiti di opposizione saranno decimati dall’Italicum. I dissenzienti dei partiti governativi potranno essere espulsi e sostituiti in commissione (vedi Mauro e Mineo). La “ghigliottina” entra in Costituzione: corsia preferenziale per le leggi del governo da approvare in 2 mesi, con divieto di ostruzionismo e emendamenti strozzati.
 4. CAPO DELLO STATO. Se lo sceglierà il capo del governo e del primo partito dopo il terzo scrutinio, quando la maggioranza dei 2/3 scende al 51%. Col 55% dei deputati, gli basteranno 33 senatori. Dopo il precedente presidenzialista di Napolitano, il Colle potrà arrogarsi enormi poteri d’interferenza in tutti i campi, giustizia in primis.
4. CAPO DELLO STATO. Se lo sceglierà il capo del governo e del primo partito dopo il terzo scrutinio, quando la maggioranza dei 2/3 scende al 51%. Col 55% dei deputati, gli basteranno 33 senatori. Dopo il precedente presidenzialista di Napolitano, il Colle potrà arrogarsi enormi poteri d’interferenza in tutti i campi, giustizia in primis.
 5. CORTE COSTITUZIONALE. Il governo controllerà 10 dei 15 “giudici delle leggi”: i 5 nominati dal Parlamento e i 5 scelti dal capo dello Stato (gli altri 5 li designano le supreme magistrature). Difficile che la Consulta possa ancora bocciare leggi incostituzionali o dar torto al potere politico nei conflitti con gli altri poteri dello Stato.
5. CORTE COSTITUZIONALE. Il governo controllerà 10 dei 15 “giudici delle leggi”: i 5 nominati dal Parlamento e i 5 scelti dal capo dello Stato (gli altri 5 li designano le supreme magistrature). Difficile che la Consulta possa ancora bocciare leggi incostituzionali o dar torto al potere politico nei conflitti con gli altri poteri dello Stato.
 6. CSM E MAGISTRATI. Anticipando la pensione delle toghe da 75 a 70 anni, il governo decapita gli uffici giudiziari. I nuovi capi li nominerà il nuovo Csm, con 1/3 di laici vicini al governo e un presidente e un vice fedelissimi al governo, previo ok del Guardasigilli. Progetto di dirottare i giudizi disciplinari dal Csm a un’Alta Corte per 2/3 politica, cioè governativa.
6. CSM E MAGISTRATI. Anticipando la pensione delle toghe da 75 a 70 anni, il governo decapita gli uffici giudiziari. I nuovi capi li nominerà il nuovo Csm, con 1/3 di laici vicini al governo e un presidente e un vice fedelissimi al governo, previo ok del Guardasigilli. Progetto di dirottare i giudizi disciplinari dal Csm a un’Alta Corte per 2/3 politica, cioè governativa.
 7. PROCURATORI E PM. Dopo la lettera di Napolitano e il voto del Csm sul caso Bruti-Robledo, il procuratore capo diventa padre-padrone dei pm, privati dell’autonomia e dell’indipendenza “interne”. Per assoggettare Procure e Tribunali, basterà controllare un pugno di capi, senza più il bilanciamento del “potere diffuso” dei singoli pm.
7. PROCURATORI E PM. Dopo la lettera di Napolitano e il voto del Csm sul caso Bruti-Robledo, il procuratore capo diventa padre-padrone dei pm, privati dell’autonomia e dell’indipendenza “interne”. Per assoggettare Procure e Tribunali, basterà controllare un pugno di capi, senza più il bilanciamento del “potere diffuso” dei singoli pm.
 8. IMMUNITÀ. Superata dai tempi e screditata dagli abusi, l’immunità parlamentare da arresti e intercettazioni rimane financo per i senatori non più eletti. Il voto a maggioranza semplice consente al governo di mettere in salvo i suoi uomini alla Camera e di nominare senatori “scudati” i sindaci e i consiglieri regionali nei guai con la giustizia.
8. IMMUNITÀ. Superata dai tempi e screditata dagli abusi, l’immunità parlamentare da arresti e intercettazioni rimane financo per i senatori non più eletti. Il voto a maggioranza semplice consente al governo di mettere in salvo i suoi uomini alla Camera e di nominare senatori “scudati” i sindaci e i consiglieri regionali nei guai con la giustizia.
 9. INFORMAZIONE. Senza abolire la Gasparri né toccare i conflitti d’interessi, la tv rimane proprietà dei partiti: il governo domina la Rai (rapinata di 150 milioni e indebolita dall’evasione del canone) e B. controlla Mediaset. I giornali restano in mano a editori impuri: aziende perlopiù ricattabili dal governo e bisognose di aiuti pubblici per stati di crisi e prepensionamenti.
9. INFORMAZIONE. Senza abolire la Gasparri né toccare i conflitti d’interessi, la tv rimane proprietà dei partiti: il governo domina la Rai (rapinata di 150 milioni e indebolita dall’evasione del canone) e B. controlla Mediaset. I giornali restano in mano a editori impuri: aziende perlopiù ricattabili dal governo e bisognose di aiuti pubblici per stati di crisi e prepensionamenti.
 10. CITTADINI. Espropriati del diritto di scegliere i deputati e di eleggere i senatori, oltreché della sovranità nazionale (delegata a misteriose autorità europee), non avranno altre armi che i referendum abrogativi (sempre più spesso bocciati dalla Consulta) e le leggi d’iniziativa popolare: ma per queste la riforma costituzionale alza la soglia da 50 a 250 mila firme.
10. CITTADINI. Espropriati del diritto di scegliere i deputati e di eleggere i senatori, oltreché della sovranità nazionale (delegata a misteriose autorità europee), non avranno altre armi che i referendum abrogativi (sempre più spesso bocciati dalla Consulta) e le leggi d’iniziativa popolare: ma per queste la riforma costituzionale alza la soglia da 50 a 250 mila firme.
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- NORBERTO BOBBIO. Il filosofo e il dovere della verità (di Marcello Sorgi)10 gennaio 2014, di Federico La Sala
- NORBERTO BOBBIO: I PRINCIPI DELLA DEMOCRAZIA. Una ’raccomandazione’ del 1958, commentata da Gustavo Zagrebelsky. Con una nota di Massimo Novelli
Il filosofo e il dovere della verità
di Marcello Sorgi (La Stampa, 8 gennaio 2014)
Aveva l’espressione austera e corrucciata del filosofo e la severità del professore stampata in viso, Norberto Bobbio. Nella casa di via Sacchi, accolti dalla signora Valeria, e dal suo modo speciale di far reagire il marito all’umor nero del tramonto, si entrava col timore di rompere il silenzio della meditazione. Bobbio passava il suo tempo nello studio, curvo su un tavolino traballante carico di libri e illuminato da una lampada fioca.
«La morte si è dimenticata di me!», esordiva, sollevando il capo nella penombra. Ma era un vezzo. Subito dopo, la stanchezza, il peso della vecchiaia, la sensazione di sentirsi fuori posto, in un mondo che non gli apparteneva più, lasciavano spazio alla curiosità, al gusto della conversazione, ai lampi di intelligenza e a un sorriso avaro, concesso con parsimonia da uno consapevole di non aver più ragioni per gioire.
Era uscito da questa sofferenza uno dei suoi ultimi libri, il De senectute che gli era valso la strana amicizia tardiva con Gianni Agnelli. Anche l’Avvocato, di tanto in tanto, andava a trovarlo: cosa potesse unire due uomini così diversi, a cui era toccata in sorte la nomina a senatori a vita, nessuno lo ha mai saputo. Forse, appunto, era la torinesità e il sentirsi parte di un’epoca che stava scomparendo.
Quanto a me, prima di frequentarlo a Torino, da editorialista e nume tutelare di questo giornale, lo avevo conosciuto a Roma nel ’92, nei giorni in cui, a dispetto di se stesso, era diventato il candidato alla Presidenza della Repubblica dell’«altra» Italia. Lui ovviamente non voleva crederci, resisteva, anche quando, camminando a piccoli passi con me che lo accompagnavo dal suo albergo al Pantheon verso Montecitorio, la gente lo fermava per stringergli la mano, o tifava per lui - Forza professore! -, manifestandogli così, alla romana, una simpatia spontanea.
Alla vigilia della caduta della Prima Repubblica, mentre i partiti morenti non riuscivano a trovare un nome per il Quirinale, Bobbio, a sorpresa, si era trasformato nel candidato della società civile, che solo un anno prima, con il referendum elettorale, aveva dato una forte spallata al sistema. La sinistra spingeva a suo favore, cresceva a sorpresa, per lui, il consenso, anche tra i deputati e i senatori chiusi nel Palazzo e costretti a due votazioni al giorno, in odio ad altri candidati di peso da trombare, come Andreotti e Forlani, o nel vano tentativo di ricostruire credibilità di fronte all’elettorato preso, già allora, da un’ondata di antipolitica. Dopo nove giorni (le Camere erano riunite in permanenza dal 13 maggio), una mattina Bobbio, prendendo una camicia da un cassetto nella sua stanza d’albergo, sbattè la testa su un soffitto spiovente e si ferì. Fine della corsa e sollievo del candidato riluttante, che poteva tornarsene a casa e ai suoi studi.
Di quest’avventura in cui si era trovato quasi senza rendersene conto, il professore aveva conservato un ricordo indelebile: nel settembre del ’98, appena arrivato a Torino come direttore della Stampa, ricevetti una sua lettera nella quale, anche a distanza di tempo, ripercorreva quelle giornate trascorse insieme e tratteggiava tutte le sensazioni contrastanti che aveva provato, insieme con gli interrogativi che l’esperienza gli aveva lasciato, ai quali invano aveva cercato di dare risposta.
Di lì in poi i nostri appuntamenti divennero settimanali: si andava in delegazione, con Alberto Papuzzi, che aveva da poco ultimato la sua biografia, e con Cesare Martinetti, che dirigeva le pagine culturali della Stampa . Qualche volta sì, qualche altra no, non c’era una regola, si tornava con l’abbozzo di un articolo, che Bobbio ci avrebbe mandato il giorno dopo, con piccole, preziose, correzioni a mano, di cui si preoccupava al telefono: «Era tutto chiaro? Occorre rileggerlo?».
Fu in una di questa circostanze, divenute abbastanza rituali nella vita del giornale, che ci trovammo a gestire un’altra emergenza, assai lontana da quella del Quirinale. Benché dissuaso dal giro più stretto dei suoi amici e della sua accademia, Bobbio, il 12 novembre ’99, aveva accettato di rilasciare un’intervista a Pietrangelo Buttafuoco del Foglio . Era un pezzo esplosivo, in cui per la prima volta parlava di quella parte del suo passato, legata agli inizi della carriera universitaria.
Come se volesse liberarsi di un segreto imbarazzante custodito con vergogna troppo a lungo, Bobbio ricostruiva i tempi della «doppiezza», in cui era stato «fascista con i fascisti e antifascista con gli antifascisti». Si rifiutava di accettare la lettura storica del suo intervistatore, secondo il quale tutti o quasi gli intellettuali italiani avevano condiviso un percorso del genere, ma per citare ad esempio il suo maestro, Gioele Solari, o il suo amico Leo Valiani, e per far risaltare il coraggio di chi non si era arreso, finiva col ribadire le proprie responsabilità.
Dopo la pubblicazione dell’intervista si scatenò un putiferio. Bobbio essendo il maggiore intellettuale azionista, e uno dei più rispettati maître-à-penser della sinistra, lo sconcerto, nel suo campo, era evidente. Su Repubblica Gad Lerner scrisse che era stato attirato in una «trappola». Nel giro più stretto degli amici torinesi, qualcuno gli suggeriva di smentire il testo di Buttafuoco, che invece aveva riletto e approvato parola per parola.
Anche per noi della Stampa il momento era complicato. C’era da capire perché il nostro più importante collaboratore, il custode delle radici culturali del giornale, avesse scelto un altro quotidiano per fare le sue rivelazioni. E soprattutto c’era da trovare la forza di chiamarlo, proprio mentre l’ondata di reazioni mediatiche e politiche rompeva la quiete di via Sacchi. Toccò a me il compito. Gli telefonai per informarlo che avremmo pubblicato un’intervista di Alessandro Galante Garrone, l’altro grande azionista di Torino e come lui editorialista della Stampa , che, contrariamente a chi ne aveva criticato l’imprudenza, gli offriva solidarietà. Inoltre, da storico, rilevava il fatto che la tessera fascista fosse obbligatoria per i professori universitari, e solo quattordici, in tutto il corpo docente nazionale, si fossero rifiutati di prenderla. Gli domandai perché avesse scelto Il Foglio , e non La Stampa , per fare la sua confessione; mi rispose candidamente che noi non gliel’avevamo chiesta. Insistetti, per sapere se intendesse dare un seguito alle polemiche. Ci pensò su, ma replicò soltanto: «Mi lasci riflettere». La mattina dopo, senza preavviso, mandò un articolo limpido, in cui spiegava di non essere stato vittima di alcun tranello e di aver avvertito un autentico desiderio di liberarsi del peso che lo aveva oppresso per tanti anni. Concordammo il titolo: «Io e il fascismo, lasciatemi dire».
Dieci anni dopo la sua scomparsa, ci sarebbero tanti altri episodi da narrare, di un uomo straordinario come Bobbio. Ma questi due racchiudono le principali caratteristiche del personaggio: la schiettezza tutta torinese, la sincerità, il distacco tipico di una grande cultura, e soprattutto il gusto della verità: anche quella, scomoda, che volle rivelare di sé.
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. L’Italia come volontà e come rappresentazione di un solo Partito. --- Silvio Berlusconi e’ fuori dal Parlamento. Il Senato ha dichiarato decaduto Silvio Berlusconi da senatore.27 novembre 2013
Silvio Berlusconi e’ fuori dal Parlamento. L’aula del Senato vota per la decadenza
’E’ un giorno amaro e di lutto per la democrazia’, aveva detto Berlusconi parlando alla folla di sostenitori che si sono riuniti nel pomeriggio davanti a palazzo Grazioli *
Il Senato ha dichiarato decaduto Silvio Berlusconi da senatore. Lo ha annunciato in Aula il presidente Grasso subito dopo che l’Assemblea aveva respinto tutti e nove gli ordini del giorno presentati.
"Essendo stati respinti tutti gli ordini del giorno presentati in difformità dalla relazione della Giunta per le Immunità che proponeva di non convalidare l’elezione di Berlusconi la relazione della Giunta deve intendersi approvata". Lo ha detto il presidente del Senato Pietro Grasso confermando la decadenza del Cav da senatore. A prendere il posto di Silvio Berlusconi al Senato è il primo dei non eletti in Molise per il Pdl Ulisse Di Giacomo.
"E’ un giorno amaro e di lutto per la democrazia": cosi’ Silvio Berlusconi aveva parlato in piazza del Plebiscito a Roma ai suoi sostenitori.. ’’Il Senato di sinistra con il suo potere ha ordinato al tempo di fare freddo’’, aveva detto Berlusconi aprendo il suo comizio davanti palazzo Grazioli. La magistratura vuole "la magistratura via giudiziaria al socialismo contro il capitalismo borghese", aveva aggiunto Berlusconi ai militanti di Forza Italia a via del Plebiscito. "Quando la sinistra non è al potere la magistratura fa di tutto per farla tornare al potere". ’’Noi siamo moderati. Si sono scagliati contro questa manifestazione ma vogliamo tranquillizzarli: questa è una manifestazione legittima e pacifica’’.
’’La sentenza sui diritti Tv è una sentenza che grida vendetta davanti a dio e agli uomini’’: così Silvio Berlusconi nel suo comizio in via del Plebiscito. Quella sentenza, ha aggiunto, ’’è basata solo su teoremi e congetture e su nessun fatto o documento o testimone’’. "Sono assolutamente sicuro che il finale di questi ricorsi sarà il capovolgimento della sentenza con la mia completa assoluzione", ha detto Berlusconi ai militanti di Fi a via del Plebiscito ribadendo la volontà di presentare domanda di revisione del processo Mediaset.
’’Non ci ritireremo in qualche convento, noi stiamo qui, restiamo qui, resteremo qui’’: così Silvio Berlusconi dal palco. "Nessuno di noi può stare più tranquillo sui propri diritti, sui propri beni e la propria libertà. E allora restiamo in campo. Non disperiamoci se il leader del centrodestra non sarà più senatore: ci sono altri leader di partito che non sono parlamentari e mi riferisco a Renzi e Grillo che dimostrano che anche da fuori si può continuare a battersi e combattere per la nostra libertà". Lo ha detto Silvio Berlusconi al comizio davanti a Palazzo Grazioli. ’’Oggi brindano perché sono riusciti a portare l’avversario davanti al plotone d’esecuzione: sono euforici, lo aspettavano da venti anni... ma non credo abbiano vinto la partita della democrazia e della libertà’’: così Silvio Berlusconi.
"Ci diamo un appuntamento preciso: l’8 dicembre ci incontriamo per festeggiare i primi mille club che si stanno fondando in Italia": cosi’ Berlusconi ai militanti di Forza Italia che manifestano a Via del Plebiscito.’’Altri se ne sono andati... ma noi siamo rimasti qui, siamo sicuri di essere la parte giusta, sicuri che non tradiremo mai i nostri elettori’’, ha detto il Cavaliere che ha fatto un implicito riferimento ad Alfano e al Nuovo centrodestra. La folla ha rivolto un lungo buuuuu agli alfaniani e il Cavaliere ha chiosato: "Interruzione ruvida ma efficace".
Secondo gli organizzatori della manifestazione di Forza Italia in Via del Plebiscito, i militanti presenti erano 20 mila.
I senatori di Forza Italia hanno cominciato a invocare il nome di Silvio Berlusconi nell’aula del Senato, durante le dichiarazioni di voto sulla sua decadenza. Dopo l’intervento di Annamaria Bernini, i senatori di Forza Italia si sono tutti alzati in piedi, gridando ’Silvio, Silvio’, ritmando il nome con il battito delle mani.
"L’ex premier italiano Silvio Berlusconi è stato espulso dal Senato". La notizia della decadenza del Cavaliere fa in una manciata di minuti il giro del mondo e irrompe come "breaking news" sui siti dei principali media internazionali: dalla Bbc al Wall Street Journal, dalla tedesca Faz allo spagnolo El Pais.
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- Berlusconi, uno e due, virtuale e reale (di Mons. Giuseppe Casale)28 settembre 2013, di Federico La Sala
Berlusconi, uno e due, virtuale e reale
di Mons. Giuseppe Casale
in “Adista” - Segni nuovi - n. 30 del 7 settembre 2013
Ma chi è il personaggio Berlusconi, che tiene in agitazione un intero Paese, che suscita accesi contrasti, che mette a rischio la tenuta stessa del governo, mentre ben altri e gravi problemi (crisi economica, disoccupazione giovanile, criminalità organizzata, immigrazione) esigono interventi urgenti e indilazionabili?Non è una domanda retorica. Perché il caso Berlusconi va ben al di là del fatto di cronaca riguardante una persona. È il termometro che segna una grave anomalia nella vita della democrazia italiana.
Si fa presto a descrivere il Berlusconi reale: un imprenditore che ha accumulato un’enorme ricchezza, non si sa con quali metodi; un uomo politico che ha suscitato forti critiche e riserve da parte di tanti onesti cittadini e numerosi interventi della magistratura per una condotta che è apparsa a coloro che indagavano su di lui riprovevole, in contrasto con le leggi dello Stato e l’etica pubblica, sia quando Berlusconi vestiva i panni di uomo di governo sia quando dirigeva, direttamente o indirettamente, le sue aziende. Alla fine di uno dei tanti procedimenti giudiziari che lo hanno visto indagato o imputato è stato condannato in maniera definitiva dalla Cassazione. Non è un perseguitato. È, tecnicamente, un condannato. La sentenza della Cassazione doveva perciò bastare per chiudere questo triste e avvilente capitolo della storia italiana recente.
Non è così. Perché se cade Berlusconi, cade tutta una costruzione pseudo-politica che ha in lui sostegno e spinta propulsiva. Ecco quindi che a fianco del Berlusconi reale c’è il Berlusconi virtuale, quello che ha fatto dimenticare ad un’intera generazione il rispetto delle leggi, della Costituzione e dei poteri dello Stato, assieme alle stesse norme minime di comportamento che vigono in una società organizzata. E che continua ad alimentare suggestioni collettive e un fitto reticolo di interessi. Ci sono ancora milioni di persone che vedono in Berlusconi il “salvatore della patria”, il politico che fa sognare e dispensa dal pensare. Vi sono, inoltre, altre centinaia di persone alle quali Berlusconi assicura potere, posti di lavoro, carriera politica, posizioni di rilievo nell’apparato dello Stato.
E allora la condanna? Per tutte queste persone non conta. È solo il frutto di una magistratura di sinistra che perseguita "l’unto del Signore. Gli insuccessi nel governo della cosa pubblica? Solo la conseguenza di una democrazia che impedisce al “capo” di governare con rapidità e decisione. Bisogna quindi salvare Berlusconi - si dice - perché è stato eletto da milioni di italiani. Come se l’essere eletti comporti non la responsabilità, ma l’impunità. Bisogna salvare Berlusconi, perché - si insiste - altrimenti tutto crolla. È vero. Però crolla una costruzione che non si basa sull’apporto responsabile dei cittadini, ma sulla verbosità, spesso menzognera, di chi pensa e decide per tutti.
Bisogna resistere alla tentazione di chiudere gli occhi, di accettare gli italici compromessi. Il bene comune non esige l’acquiescenza, il salvacondotto, la tortuosità di pseudo giustificazioni. La condanna di Berlusconi è l’uscita di sicurezza da un populismo mistificatore verso una democrazia sana, costruita ogni giorno con l’apporto intelligente e responsabile di tutti i cittadini. Che ne pensano i tanti cattolici “berluscones”? Non è giunto il momento per fare un serio esame di coscienza e... convertirsi?
* Arcivescovo emerito della diocesi di Foggia-Bovino
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. ---COSTITUZIONE. Rodotà, Zagrebelsky, Landini, Don Ciotti e Carlassare contro la riforma dell’articolo 1389 settembre 2013, di Federico La Sala
«Vogliamo cambiare il Paese ripartendo dalla Costituzione»
Rodotà, Zagrebelsky, Landini, Don Ciotti e Carlassare contro la riforma dell’articolo 138
Il 12 ottobre la protesta in piazza a Roma
di Andrea Carugati (l’Unità, 09.09.2013)
Per il momento si sa che si troveranno in una grande piazza di Roma il 12 ottobre. E che l’obiettivo è riempirla di centinaia di migliaia di persone, un po’ come quella piazza San Giovanni dei girotondi nel 2002. Per stoppare il processo di revisione della Costituzione, innanzitutto. Per dire no alla guerra in Siria e soprattutto per rianimare una sinistra dispersa, che non si riconosce nel Pd e neppure nel M5S, ma che è pure stufa dei fallimenti come l’Arcobaleno e la Rivoluzione di Ingroia.
Alla guida di questo nuovo movimento, che non vuole farsi partito, ma diventare una «massa critica», sono in cinque: Stefano Rodotà, Maurizio Landini e la professoressa Lorenza Carlassare, Gustavo Zagrebelsky e don Luigi Ciotti (gli ultimi due assenti ieri). «Nessuno di noi ha ambizioni politiche», mette subito in chiaro Carlassare, seguita a ruota dal leader Fiom che, quanto a candidature, punta solo a quella per succedere a se stesso alla guida dei metalmeccanici. La folla radunata al centro congressi Frentani di Roma, è quella dei grandi occasioni: sala strapiena, maxischermi, gente in piedi. I reduci non mancano, da Ingroia a Ferrero e Cesare Salvi, Casarini e Agnoletto. Vendola fa un salto, con Fratoianni e Migliore, ma più per un gesto di cortesia: Sel non è in prima fila in questa operazione. «Ma siamo attenti a quello che succede», dice il governatore pugliese. Corradino Mineo e Vincenzo Vita sono i due dem che tentano di fare da pontieri: ma basta che Vita citi il Pd che partono i fischi. E non è un caso che l’applauso più fragoroso arrivi quando Paolo Flores D’Arcais spiega che «come Blair è stato la vera vittoria della Thatcher, così se Renzi sarà l’unica alternativa Berlusconi avrà vinto ancora». Rodotà tra le righe benedice i grillini sul tetto di Montecitorio, e se la prende con chi «li accusa di eversione e intanto cerca di sabotare lo Stato di diritto per salvare Berlusconi». Il riferimento è al Pdl, ma nel mirino ci sono le larghe intese, il governo e anche il Quirinale quando, come dice Guido Viale, «c’è uno scambio tra la manomissione della Costituzione e il tentativo di garantire stabilità a questo governo».
Rodotà non usa giri di parole: «Questa maggioranza non ha legittimità per cambiare la Costituzione. E il governo stesso è figlio di un grave azzardo politico. Il fatto che si stia proponendo una sospensione temporanea del 138 non è un’attenuante. Di sospensione in sospensione non si sa dove si arriva. Chi poi invoca il cronoprogramma sulle riforme istituzionali mi fa sorridere. Qui non si sa neppure se il governo arriva a domani...». «No, non si può più girare la testa dall’altra parte», spiega il Professore, fotografato come una star, «ci vuole coraggio e dobbiamo prenderci qualche rischio: dobbiamo rimettere in moto la politica, che può voler dire anche preparare il terreno per un nuovo soggetto, senza ripetere gli errori della Sinistra Arcobaleno e di Ingroia, come la lottizzazione dei posti».
Per il momento, l’obiettivo minimo è «indurre a un ripensamento» il Pd che vuole cambiare la Costituzione. «La Carta va cambiata, non deve prevalere lo spirito conservatore», manda a dire il premier Letta da Cernobbio. E Rodotà replica tra gli appalusi: «Qui da noi non troverà conservatori, semmai nella sua maggioranza. E se l’obiettivo è cambiare il bicameralismo non c’è bisogno di stravolgere il 138». Insiste Rodotà: «Non saremo una zattera per naufraghi, ma una casa per una sinistra vincente su temi come i referendum sui beni comuni».
«Un soggetto politico? La nostra ambizione è molto maggiore», dice Landini. «È cambiare questo Paese ripartendo dalla Costituzione. Ci sono milioni di persone che non votano più e si sentono sole. Vogliamo costruire un movimento di pressione». Il leader Fiom va ben oltre lo stop alle modifiche alla Carta. «Non siamo più disponibili a firmare accordi che chiudano le fabbriche», dice dal palco tra gli applausi. «Metteremo in campo gesti di difesa totale delle fabbriche e dei posti di lavoro. Se necessario, anche con l’occupazione delle fabbriche». «Il lavoro deve avere una nuova rappresentanza politica», incalza il giuslavorista Piergiovanni Alleva.
Dal palco Carlassare parla di un «risveglio delle coscienze» e dice che «a qualcuno fa comodo guidare un gregge ignorante». Flores parla di un «golpe bianco strisciante» in corso e avverte: «Nelle prossime settimane ci giochiamo la chiusura del ventennio berlusconiano. E se la piazza sarà inferiore a quella del 2002 saremo sconfitti». Si parla anche dell’ipotesi di grazia per il Cavaliere, «un insulto alla democrazia», secondo Landini. Ingroia è in prima fila: «Sono con i partigiani della Costituzione».
Rodotà e Landini, il “partito” della Carta
Insieme a don Ciotti, Carlassare e Zagrebelsky danno appuntamento al 12 ottobre: Tutti in piazza a Roma
di Sandra Amurri (il Fatto, 09.09.2013)
Il primo intervento in una sala gremita è di Stefano Rodotà, promotore assieme a Maurizio Landini, don Luigi Ciotti, Lorenza Carlassare, Gustavo Zagrebelsky dell’assemblea in difesa della Costituzione “La via maestra” svoltasi ieri a Roma, presieduta da Sandra Bonsanti. “Questa giornata non è una zattera per profughi, e non è la conclusione ma l’inizio di un lungo cammino che avrà come tappa la manifestazione del 12 ottobre a Roma. Le quasi 500 mila firme raccolte da Il Fatto raccontano un forte bisogno di partecipazione. Dobbiamo essere tutti meno autoreferenziali contro il vuoto di una politica appesa ad una dichiarazione che da un momento all’altro può far cadere il Governo”. Per Carla Carlassare l’emergenza è la crisi di valori: “Oggi assistiamo ad un disastro morale, deve tornare in primo piano l’art. 54 della Costituzione: coloro a cui sono affidate pubbliche funzioni debbono esercitarle con disciplina ed onore. Deve emergere la presenza di un’altra Italia che non sta in queste miserie indecenti. Costituzionalismo vuol dire porre limiti e regole al potere e noi siamo qui per imporgliele”. Raniero La Valle cita il digiuno contro la guerra in Siria promosso da Papa Francesco: “Quelle 1000 persone ieri a Piazza San Pietro, in silenzio nella società del rumore, difendevano la Costituzione oltraggiata da governanti infedeli come ricorda l’art. 11 scritto su un capitello: l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli....”. Antonio Ingroia ricorda che il piano di Licio Gelli “viene attuato paradossalmente con una maggioranza di governo e il garante della manomissione della Costituzione è il Presidente della Repubblica”. Dice no all’autoreferenzialità, invoca la costruzione di un movimento dal basso, aperto. “Le tante presenze qui oggi, le quasi 500 mila firme de Il Fatto chiedono che venga restituito l’onore alla nostra Carta”. La partita cruciale si giocherà a breve ricorda Paolo Flores d’Arcais “l’establishment ha creato una situazione manichea: due prospettive, affossare la Costituzione come vuole il Governo o realizzarla. La manifestazione di piazza deve essere così grande da determinare un nuovo protagonismo per dare voce ad una politica di realizzazione della Carta”.
NICHI VENDOLA resta fuori dalla sala, rilascia interviste, stringe mani come quella che gli porge con un sorriso una signora arrivata da Taranto: “Ci ha traditi, abbandonati, l’Ilva ci ucciderà tutti”. Vendola spiazzato: “Ci penso sempre” La signora: “Sì ci pensi, mi raccomando” e se ne va. Ad Enrico Letta che da lontano definisce i difensori della Carta “i nuovi conservatori”, senza citarlo risponde Maurizio Landini: “Il 12 ottobre la manifestazione ci sarà a prescindere da ciò che accadrà nel frattempo”. E se c’è chi dice che per uscire dalla crisi bisogna cambiare la Costituzione “noi diciamo che per uscire dalla crisi bisogna applicare la Costituzione. Non vogliamo sostituirci alla politica ma riportare le persone alla politica affinchè i principi costituzionali tornino ad essere la guida del-l’agire. Crediamo che il Paese si possa cambiare rimettendo al centro la partecipazione. Questo è il momento della responsabilità soggettiva, ognuno deve fare ciò che dice”.
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- Napolitano rieletto al Colle, storico bis. Prodi, migliori auguri a Napolitano. Berlusconi, grazie. Cei, prenda in mano situazione20 aprile 2013, di Federico La Sala
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- Il futuro della democrazia: torniamo a Socrate (di Franca D’Agostini)11 aprile 2013, di Federico La Sala
Il futuro della democrazia: torniamo a Socrate
 Il pensiero nel senso socratico è l’unica arma che abbiamo per inseguire la felicità personale e collettiva
Il pensiero nel senso socratico è l’unica arma che abbiamo per inseguire la felicità personale e collettiva
 La capacità di argomentare e di ragionare lega il socratismo alla democrazia
La capacità di argomentare e di ragionare lega il socratismo alla democrazia
 Le parole di Heidegger: «Ciò che più ci dà da pensare è che non abbiamo ancora incominciato a pensare»
Le parole di Heidegger: «Ciò che più ci dà da pensare è che non abbiamo ancora incominciato a pensare»di Franca D’Agostini (La Stampa, 11.04.2013)
Forse l’idea più assurda che sia stata sostenuta nella filosofia del Novecento è l’idea dell’incompatibilità di filosofia e democrazia. A sostenerla esplicitamente è stato Richard Rorty, il filosofo dell’ironia e della filosofia post-filosofica, ma con più o meno esplicita convinzione, anche molti altri, niente affatto rortyani, l’hanno caldamente condivisa. Rorty arrivava al punto di dire che la filosofia è «dannosa» per la democrazia. Oggi la dichiarazione sembra perlomeno enigmatica, essendo diventato chiaro (specie in Italia) che il danno consiste in tutt’altro.
Già, ma quale filosofia? Il termine è sempre stato piuttosto vago, e oggi sembra esserlo ancora. Da qualche tempo però circola l’idea che il socratismo, ovvero quel tipo di pratica intellettuale esercitata da Socrate, sia il tipo di filosofia che non solo non è dannosa, bensì è utile anzi forse essenziale in democrazia. A sostenere una versione influente di questa idea è stata Martha Nussbaum, in vari scritti. Però per Nussbaum quel che serve del socratismo è anzitutto «la vita esaminata», che ci porta al «rispetto» e alla «comprensione» degli altri: vale a dire la capacità di capire i bisogni, le speranze, in una parola l’interiorità, altrui. Certamente, il paradigma socratico prevedeva anche questo: secondo alcune interpretazioni (per esempio quella di Giovanni Reale) è Socrate l’inventore dell’anima, o anche dell’interiorità pensante.
Ma questa figura di Socrate sembra un po’ tenue, e comunque troppo gentile per essere utile nella sfida che la vita democratica presenta ogni giorno. Certo l’appello a pensare, riflettere, e tenere conto degli altri, è buona cosa: ma davvero tutto sta solo lì? Davvero l’ironico pensatore che condannato a morte prende in giro i suoi giudici è destinato a funzionare storicamente come questa specie di gentile signore benpensante, e sostenitore del buon pensiero?
Credo di no. Anzi rovescerei l’ipotesi. Ciò che veramente lega il socratismo alla democrazia credo sia anzitutto l’arte dialettica, come arte di pensare e ragionare e argomentare, che Socrate condivideva con i sofisti, contrapponendosi però al modo narcisistico e formalistico in cui loro la esercitavano, e lanciando il primato dei concetti di bene , vero (to alethes), reale nel lavoro del pensiero.
Era questo in definitiva ciò che di Socrate fu il primo tratto riconosciuto, nelle opere di Platone. E il termine «filosofo» entra definitivamente nell’uso, nella lingua greca, nel IV secolo a. C., proprio in relazione a questa sottile ma decisiva differenza tra Socrate e i sofisti. Socrate è filosofo in quanto argomenta e pensa «bene» con abilità e scioltezza, come i sofisti, e come loro esercita il pensiero critico e scettico, ma a differenza dei sofisti argomenta in funzione del vero, e del bene, perché sa che questa è la prima fonte dell’ eudemonia, la felicità propria e altrui.
Nell’aprire i lavori di Biennale Democrazia, Zagrebelsky lancia un’idea che più socratica non potrebbe essere: la felicità del pensiero. In effetti è proprio questa l’idea che i filosofi attraverso i tempi hanno ripetuto: la vita filosofica, la vita del pensiero, è la più felice.
Nietzsche odiava questa idea, perché la interpretava come rifiuto dell’energia della vita biologica, e rifugio in una forma di astratto e malato intellettualismo. Dimenticava che tra i continuatori di Socrate vi furono i cirenaici, grandi teorici del primato del piacere, e i cinici, nemici dell’intelletto al potere.
Ma soprattutto dimenticava una questione assolutamente semplice, banale, pragmatica: che il pensiero nel senso socratico è l’unica arma di cui disponiamo, in democrazia, per inseguire la felicità personale e collettiva. E possiamo usarlo bene (per il bene proprio e altrui), o male (scambiando per bene quel che è male, per noi stessi e/o per gli altri). Ma Nietzsche non era certo un democratico, né pretendeva di esserlo.
Se teniamo conto di tutto questo, emerge il punto principale, che Nussbaum e gli altri socratici contemporanei non osano dire: che la democrazia è filosofia al potere. Non il potere dei filosofi (errore di Platone), e neppure della disciplina accademica o scienza chiamata filosofia (errore di Hegel), bensì proprio e solo potere di quel pensiero critico, scettico e dialogico che a partire da Socrate si chiamò appunto filosofia. Se non ha potere quel pensiero, quella pratica, per tutti gli individui del demos, politici inclusi, la democrazia diventa un gioco ridicolo, di cui devono occuparsi i pubblicitari o i consulenti d’immagine. Oppure diventa un caos di interessi divergenti, che confliggono senza senso e senza giustizia. O diventa il grande e insulso teatro in cui si sbizzarriscono falsificatori e manipolatori di ogni genere.
La buona notizia è che la filosofia si impara: era questa la grande scoperta della paideia greca. E in effetti bisognerebbe incominciare dalle scuole elementari a impratichirsi con il socratismo, con tutte le sue formule: il concettualismo e il metodo delle definizioni (saper usare bene le parole e i concetti), l’ironia e la coscienza della propria ignoranza (mettere in ridicolo gli snob, e non credersi migliori degli altri), il gioco dialettico e dialogico che guida la ricerca del bene proprio e altrui (imparare a discutere e ad ascoltare), vedere e conoscere il mondo delle idee (saper immaginare mondi possibili, migliori).
«Ciò che più ci dà da pensare, diceva Heidegger, è che non abbiamo ancora incominciato a pensare». Forse per questo è così difficile realizzare la democrazia: non abbiamo ancora incominciato a essere davvero democratici, che vuol dire: a essere liberi nel pensiero. Ma questa non è una nostra colpa: in fin dei conti la democrazia è una giovane creatura della nostra specie. Dopo la parentesi greca, il pensiero democratico, lo sappiamo, ha avuto vita difficile, ed è solo nell’Ottocento che il demos, il vero portatore del socratismo, ha incominciato ad affacciarsi nella storia, e diventare protagonista.
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- ELEZIONI POLITICHE, 2013. Appello al voto (Umberto Eco e Gustavo Zagrebelsky per tutta "Libertà e Giustizia).8 febbraio 2013, di Federico La Sala
Appello al voto
di Umberto Eco e Gustavo Zagrebelsky per tutta LeG,
7 febbraio 2013
Stiamo assistendo a un finale di campagna elettorale drammaticamente pericoloso per il nostro paese: il capo dello schieramento politico responsabile del tracollo economico e sociale in cui versa l’Italia e del suo discredito internazionale, anziché essere isolato e ignorato, è prepotentemente tornato alla ribalta televisiva, nel silenzio dell’autorità competente a regolare la comunicazione politica e nel giubilo di molti mezzi di informazione, assurdamente avidi di commentare, chiosare e rimbalzare le bugie e i vuoti di memoria sparsi a piene mani, con la tipica totale indifferenza per i dati di realtà e per le proprie responsabilità. Il mondo intero guarda con terrore a un ritorno di Berlusconi, caratterizzato da una politica di proposte populiste e isolazioniste, un vero e proprio peronismo del XXI secolo.
Con le bugie e la negazione assoluta della penosa realtà cui i suoi governi hanno ridotto l’Italia - la recessione economica, la disoccupazione, la mancanza di prospettive per i giovani, la descolarizzazione, l’abbandono del patrimonio culturale e dell’ambiente, l’irresponsabile rivalutazione di Mussolini e del fascismo, la corruzione endemica, il potere della criminalità organizzata - Silvio Berlusconi tenta nuovamente di illudere, di circuire, di comprare il consenso degli elettori. Cosa è se non un tentativo di compravendita del consenso la desolante profferta di restituzione dell’IMU?
Il disprezzo per gli elettori non potrebbe, in questa odiosa campagna, essere più evidente: i cittadini italiani - secondo la destra - privi di memoria e a maggior ragione di capacità critica, dovrebbero vendere il loro diritto di scegliere la classe politica che dovrà affrontare i gravissimi problemi del paese in cambio di un’elemosina, pagata per di più con i loro soldi. Poiché ormai tutti sappiamo che per diminuire una voce di entrata dello Stato non si può che aumentarne altre, oppure tagliare ancora di più i servizi sociali.
Ma alcuni diranno che neppure gli altri schieramenti politici che si candidano alle elezioni sono granchè affidabili, vuoi perché negli scorsi anni hanno mal rappresentato l’opposizione ai governi in carica, vuoi perché hanno identità incerta o improvvisata. Non sarà Libertà e Giustizia, che ha sempre cercato, nella sua breve storia, di esercitare al meglio un ruolo di critica e di pungolo nei confronti dei partiti politici, a prenderne ora le difese, e tantomeno a dare indicazioni di voto.
Anzi, non abbiamo dimenticato di aver dichiarato che mai più saremmo andati a votare con questa legge elettorale, nella speranza di ottenere dal Parlamento un gesto di dignità, con l’approvazione di una legge elettorale migliore, più rispettosa della Costituzione e dei cittadini.
Condividiamo dunque molte delle perplessità e critiche alle formazioni politiche che si contrappongono, in questa competizione elettorale, all’impresentabile destra che affligge il nostro paese. E tuttavia sentiamo ora il dovere di richiamare tutti - e in particolar modo i giovani, delusi da uno scenario che offre loro ben poche possibilità di identificazione; coloro che oggi hanno ben più pressanti problemi di mancanza di lavoro e di soldi; gli scettici, che hanno per tante volte esercitato il voto senza vedere mai una gestione del potere degna di un paese civile; gli idealisti, che coltivano aspirazioni e obiettivi ben più alti di quelli che si agitano in questa vigilia di elezioni - alla necessità cogente di superare in modo netto e definitivo l’umiliante fase della nostra storia che si sta chiudendo, ma non si è ancora chiusa.
Quella fase che ha visto il dominio dell’ignoranza, della corruzione, dell’uso a fini privati della ricchezza pubblica, dello sprezzo della magistratura, della menzogna sistematica per nascondere la propria incapacità di svolgere il ruolo che la Costituzione affida ai governi: guidare la comunità nazionale a elevare il proprio grado di civiltà.
Per raggiungere e consolidare l’obiettivo - di farla finita con i governi dei peggiori - Libertà e Giustizia fa appello a tutti i cittadini italiani che condividono la necessità di guardare avanti affinché superando le riserve e le delusioni, decidano di esercitare il loro diritto di voto in queste elezioni, locali e nazionali, a favore di una delle formazioni politiche che si impegnano a contrastare questa destra inetta e illiberale che ancora ci minaccia.
Ma non è questo il solo appello che facciamo ai cittadini italiani: il voto non è una delega in bianco! E per esercitare un controllo sul potere politico occorre rimanere attivi, informati, critici: occorre imparare, da cittadini, a chiedere e a protestare, a creare reti e legami, a far sentire la propria voce. Il nostro paese dovrà nei prossimi anni affrontare problemi molto impegnativi: ricostruire una propria missione nel mondo globalizzato e riparare il proprio tessuto sociale, liberandolo da criminalità e corruzione. Imprese tanto grandi non possono essere delegate, richiedono - per riuscire - l’impegno di tutti in prima persona.
Dunque, il voto del 24 e 25 febbraio è solo un primo, ma indispensabile passo.
Umberto Eco e Gustavo Zagrebelsky per tutta Libertà e Giustizia
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- L’Italia poteva sembrare, all’occhio dell’osservatore esterno, un paese pacificato, garantito (di Fabio Liberti - L’Italia: aspra campagna in vista)12 dicembre 2012, di Federico La Sala
L’Italia: aspra campagna in vista
di Fabio Liberti (direttore di ricerca all’Istituto di ricerche internazionali e strategiche - Iris)
- in “Le Monde” del 13 dicembre 2012 (traduzione: “www.finesettimana.org”)
L’Italia poteva sembrare, all’occhio dell’osservatore esterno, un paese pacificato, garantito dalla saggezza del presidente del Consiglio, Mario Monti, liberato dalla ingombrante presenza di Silvio Berlusconi, vivificato dalla partecipazione dei cittadini alle elezioni primarie del centro-sinistra. Purtroppo il ritorno del Cavaliere e le dimissioni di Mario Monti ricordano che il contesto politico italiano ed europeo è di difficile comprensione.
Il ritorno alla ribalta di Silvio Berlusconi segna soprattutto l’inizio di una campagna elettorale aspra che sarà marcata da violenti attacchi tedescofobi e antieuropei. Il contesto si presta, quello economico specialmente, con una contrazione del PIL italiano dell’ordine del 2,5% nel 2012, frutto degli errori del passato e delle leggi di budget che hanno accumulato più di 100 miliardi di euro tra aumento delle imposte e riduzione della spesa pubblica in soli due anni.
La disoccupazione si impenna, il consumo crolla, il paese mette in opera riforme strutturali che devono permettergli, come la Germania di Gerhard Schröder, di ridispiegare il proprio potenziale in termini di crescita. Ma nell’attesa, gli effetti sono quelli di un impoverimento della popolazione.
Politicamente, una larga parte dell’opinione pubblica italiana ha l’impressione di pagare per una appartenenza all’Europa che sarebbe diventata un club di banchieri, dominato dagli interessi francotedeschi. L’Italia è in procinto di approdare a derive populiste e di far implodere l’euro? Nulla è meno sicuro.
Silvio Berlusconi non ha alcuna possibilità di vincere le elezioni della primavera 2013, cerca piuttosto di non perderle troppo. Il suo partito, che aveva raccolto il 38% dei voti nel 2008, è creditato ora solo del 14% dei suffragi.
Silvio Berlusconi, che avrebbe potuto lasciare la leadership del suo campo a Mario Monti, e curare la sua uscita di scena definitiva, fa la scommessa di difendere fino in fondo i propri interessi personali, economici e giudiziari, mettendo il suo partito e la destra italiana al suo servizio, e cerca di sfruttare le faglie della legge elettorale (che prevede un premio di maggioranza calcolato in modo diverso per i due rami del Parlamento, rendendo facile la formazione di una minoranza di ostruzione) per continuare a contare.
Ma la sua decisione precipita anche l’entrata nell’arena politica di Mario Monti che, liberato dal suo ruolo bipartisan, potrebbe alla fine accettare di condurre una lista centrista con il programma di continuare la propria azione di governo.
A guardare i sondaggi, l’esito dello scrutinio sembra lasciare pochi dubbi. La coalizione di centrosinistra, guidata da Pier Luigi Bersani, che ha appena vinto le elezioni primarie, resta il grande favorito di questo scrutinio, ma potrebbe avere bisogno di un accordo con i centristi (guidati da Mario Monti?) per governare, utilizzando il “Professore” Monti come cauzione di fronte ai mercati nominandolo Presidente della Repubblica o ministro delle Finanze. Ma non bisogna dimenticare la campagna elettorale che potrebbe fare dei guasti.
Giocando sulla collera degli Italiani, Silvio Berlusconi criticherà l’euro, l’austerità, l’Unione europea, il duo franco-tedesco. Non sarà il solo in questa battaglia, la Lega Nord si unirà al Cavaliere. Senza essere suo alleato, il Movimento 5 stelle del comico Beppe Grillo farà una campagna sugli stessi temi. Questo blocco populista è accreditato del 40% delle intenzioni di voto, sapendo che la metà degli italiani, scoraggiati dagli scandali di corruzione che hanno coinvolto parecchi partiti politici, atterriti dall’austerità, annunciano la loro astensione.
Sono questi Italiani che determineranno l’esito dello scrutinio, dopo una campagna elettorale che verterà sull’Europa e sull’euro. Come i Greci e gli Olandesi, gli Italiani dovranno scegliere tra l’appartenenza alla zona euro e all’Unione Europea, e le sirene di un capovolgimento del sistema politico europeo.
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. ---- L’«Aventino» non è mai stata una soluzione. Torneranno... e l’unica arma sarà l’ironia (di Carlo Sini)12 dicembre 2012, di Federico La Sala
Torneranno... e l’unica arma sarà l’ironia
di Carlo Sini (l’Unità, 12.12.2012)
ADESSO VERRÀ IL PEGGIO. FACILE PREVISIONE, LO DICONO TUTTI. UNA POPOLAZIONE SEGNATA DAGLI EFFETTI DI UNA CRISI PROFONDA, PER MOLTI DRAMMATICA E CHE NON ACCENNA A DIMINUIRE, DOVRÀ SUBIRE IL RITORNO DI PERSONAGGI E DI COMPORTAMENTI CHE, NEGLI ULTIMI TEMPI, SEMBRAVANO PER SEMPRE CONSEGNATI AL PASSATO. Invece no, siamo da capo.
Torneranno a invadere lo schermo televisivo, a gridare e a interrompere gli interventi altrui, a lanciare fandonie mirabolanti e accuse grossolane, a confondere le acque in tutte le maniere, purché il dialogo non si sviluppi secondo la ragionevolezza, la verità e la forza dei fatti, a scuotere tutti regolarmente il capo come manichini mentre gli avversari parlano, a rovesciare incredibilmente il senso delle cose, facendo valere a proprio vantaggio ciò che invece è lì a condannarli.
Erano quasi scomparsi, non si azzardavano in video, stante l’evidente crisi che li attanagliava; mandavano figure di secondo piano, piuttosto pallide, prudenti e intimidite: facevano quasi tenerezza.
Ora invece, richiamati all’ordine dalla voce del padrone, che si è riservato lo strumento del porcellum per poterli rimettere in riga, torneranno tutti, più aggressivi che mai, poiché sanno che la contesa è disperata e che si giocano la vita, in senso pubblico o politico.
Torneranno quelle facce, dicono tutti con desolazione, e sentono di non avere le forze sufficienti a sopportarlo. Ma sarà così, non si può evitarlo. Dovremo riascoltare che i magistrati sono una banda di comunisti, che il lodo Mondadori è un equivoco, che la crisi italiana è in gran parte colpa delle idee arretrate della sinistra e di una perdurante congiura dell’Europa, e così via. Resta da chiedere come affrontare questa sventura che si abbatterà sul nostro capo nei mesi che verranno.
Non si saprebbe davvero che cosa consigliare. Personalmente ho scarsa fiducia nei professionali avvertimenti degli esperti di comportamento nei mass media; penso che valga di più la fedeltà a una propria convinzione profonda, alla propria autentica natura e al genuino rispetto della verità, ma si fa presto a dire: e cioè come?
Verrebbe voglia di suggerire una specie di «Aventino»: lasciateli da soli a sbraitare, non meritano un confronto leale, sollecito del bene comune. Se ne fregano del bene comune e proprio ciò che sta avvenendo lo mostra nel modo più eloquente. Il problema è come farlo risaltare anche per coloro che non siano in grado di rendersene conto. E perciò, se ci si sottrae al contraddittorio, come riuscirci?
L’«Aventino» non è mai stata una soluzione. Quindi bisogna andare, bisogna sottomettersi al calvario, bisogna accettare un confronto impari, perché non paragonabili sono le armi impiegate, perché è difficile difendere la verità contro coloro che non hanno pudore alcuno a violentarla e a falsificarla. Più in generale è difficile, anzi impossibile, ragionare su ciò che è meglio o più opportuno fare, con chi non si preoccupa minimamente di ragionare e bada solo a fare colpo e a prevalere.
Non cedete alle provocazioni, non fatevi coinvolgere in risse verbali. Usate piuttosto l’ironia che non la denuncia stentorea: quelli che volevano capire hanno capito da tempo; gli altri, che non vogliono o che non hanno interesse a capire, non sono raggiungibili. Sottraetevi con pazienza, al limite lasciatevi persino depredare del vostro diritto a uno spazio di tempo uguale a quello dell’avversario: limitatevi educatamente a rilevare l’ingiustizia.
Lasciate perdere le incredibili affermazioni che vi verranno opposte: seguite il vostro discorso, argomentate lucidamente la proposta; soprattutto non nascondete, non mascherate, non sminuite le difficoltà, i lati problematici del vostro schieramento, le contraddizioni che vi si possono annidare, le reali incertezze del futuro che ci attendono.
Forse proprio così sarete ascoltati e apparirete credibili, tanto più al confronto con l’incredibile bailamme e carnevale degli animali che gli avversari metteranno in scena: che sia chiara, a chi vuole intendere, la differenza. Sono buoni consigli? Possono funzionare? Siamo in tanti a chiedercelo, con qualche ansia e un po’ d’angoscia.
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. ---- OGGI COME IERI: QUATTRO CAPISALDI DI UN PAESE, SENZA "NOME" E SENZA "PAROLA"!!!12 dicembre 2012, di Federico La SalaCAPISALDI?! LA BUSSOLA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UN PAESE, SENZA "NOME" E SENZA "PAROLA"!!! Una nota di Mario Monti - con appunti
-
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- Topolino e Russell liberi pensatori (di Giulio Giorello).11 novembre 2012, di Federico La Sala
- STATO DI MINORITA’ E FILOSOFIA COME RIMOZIONE DELLA FACOLTA’ DI GIUDIZIO. Una ’lezione’ di un Enrico Berti, che non ha ancora il coraggio di dire ai nostri giovani che sono cittadini sovrani. Una sua riflessione - con una nota
- COSTITUZIONE E PENSIERO. ITALIA: LA MISERIA DELLA FILOSOFIA ITALIANA E LA RICCHEZZA DEL MENTITORE ISTITUZIONALIZZATO ...
 BERTRAND RUSSELL: LA LEZIONE SUL MENTITORE (IGNORATA E ’SNOBBATA’), E "L’ALFABETO DEL BUON CITTADINO".
BERTRAND RUSSELL: LA LEZIONE SUL MENTITORE (IGNORATA E ’SNOBBATA’), E "L’ALFABETO DEL BUON CITTADINO".
 Topolino e Russell liberi pensatori
Topolino e Russell liberi pensatori
 Fanno dello scetticismo la leva contro ogni superstizione
Fanno dello scetticismo la leva contro ogni superstizionedi Giulio Giorello (Corriere della Sera, 09.11.2012)
Nel memorabile Mickey Mouse and the Seven Ghosts (da noi: Topolino nella casa dei fantasmi) di Floyd Gottfredson e Ted Osborne (1936), riportando una sua «intervista con lo spettro» Pippo afferma che per una persona sensata fantasmi e anime disincarnate non esistono, e ribadisce che «questo è proprio quel che dice anche lui», lo spettro medesimo!
Dunque c’è un fantasma che dice che «i fantasmi non ci sono»: la cosa non sarebbe dispiaciuta a Bertrand Russell, specialista in meccanismi logici di questo tipo, tecnicamente noti come paradossi dell’autoriferimento: come «l’insieme di tutti gli insiemi che non appartengono a sé stessi a sua volta appartiene o no a se stesso?». Provate a rispondere affermativamente o negativamente, e vedrete!
Ma nel fumetto il malfidente Topolino ci tiene a ribadire che ci dev’essere un trucco e che una buona pallottola può mettere in fuga qualsiasi apparizione. Per dirla con le parole di Russell in Scienza e religione (1935), potremmo classificare il topo di Walt Disney come un libero pensatore che fa dello scetticismo nei confronti dei fantasmi la leva per scardinare l’edificio delle superstizioni consolidate, nonché la premessa per la spiegazione di pretesi miracoli in termini di leggi di natura.
La crescita della scienza cambia la percezione che gli esseri umani hanno del loro posto nel mondo e del loro destino. Tra il fumetto di Topolino e il libro di Russell, che sono quasi contemporanei, potremmo inserire anche le parole di un pensatore di circa due secoli e mezzo prima, quel Baruch Spinoza che il filosofo britannico considerava una delle figure «più amabili» della storia delle idee.
Nel 1674 Hugo Boxel, funzionario della citta di Gorcum, aveva chiesto al filosofo dell’Etica un parere «circa le apparizioni degli spettri o spiriti notturni» e, viste le perplessità di quell’«acutissimo» personaggio, aveva insistito che si doveva ammettere almeno che «lo spazio incalcolabile che c’è tra noi e gli astri non è vuoto, ma pieno di spiriti che vi abitano, magari distinti» in quelli che abitano regioni «più elevate» e in quelli che frequentano invece zone «più basse» del cosmo. Al che Spinoza gli aveva seccamente ribattuto: «Ignoro quali siano quei luoghi più alti e più bassi che concepisci nella materia infinita, a meno che tu non asserisca che la Terra è il centro dell’Universo: se infatti il Sole o Saturno ne fossero il centro, il Sole o Saturno sarebbero la parte più bassa e non già la terra».
Spinoza si collocava nella grande tradizione dell’atomismo di Democrito, Lucrezio ed Epicuro, ma aveva in mente anche Copernico e Galileo, nonché il passaggio dal mondo chiuso aristotelico-tolemaico all’Universo infinito. Da parte sua, il Russell di Scienza e religione dedica non poche pagine alla costellazione d’idee, rompicapi, tecniche d’osservazione e di calcolo che oggi chiamiamo «rivoluzione copernicana», ma vi aggiunge la considerazione di due altre rivoluzioni scientifiche: quella di Charles Darwin nelle scienze della vita e quella di Freud e degli altri protagonisti della «psicologia del profondo» nel campo delle scienze umane.
La darwiniana Origine delle specie (1859) ha rimodellato la nostra immagine del rapporto tra il genere «Uomo» e gli altri organismi viventi; la psicoanalisi ci ha costretto a ripensare la stessa nozione di coscienza e l’idea di un libero arbitrio. Entrambe le concezioni sono entrate in conflitto con abitudini intellettuali spesso legate ai dogmi delle fedi religiose, come già era capitato a Copernico, Bruno e Galileo. In un Universo infinito la Terra non è il centro più di quanto lo sia Saturno o il Sole, e la dimora dell’uomo non gode più di una posizione privilegiata; allo stesso modo, nemmeno l’uomo sotto il profilo evolutivo è qualcosa di «speciale» rispetto al resto del vivente.
Dunque niente fantasmi, niente anime immortali: per dirla col Darwin del Taccuino B (1837-1838): «Per consenso di tutti l’anima è aggiunta, gli animali non l’hanno, non guardano avanti; se decidiamo di lasciar correre libere le congetture, allora gli animali sono nostri compagni, fratelli in dolore, malattia, morte e sofferenza e fame; nostri schiavi nel lavoro più faticoso, nostri compagni negli svaghi; dalla nostra origine essi probabilmente condividono un comune antenato; potremmo esser tutti legati in un’unica rete». Come questa rete della vita sia oggi esplorata da una costellazione di programmi scientifici che vanno dalla fisica e dalla chimica alla neurofisiologia e al complesso delle scienze cognitive è uno dei lasciti migliori del secolo scorso, di cui Russell è stato testimone e protagonista: dalla riflessione sui fondamenti della matematica e la struttura della scienza all’impegno per il rinnovamento dei nostri presupposti etico-politici, per non dire dell’opposizione alle più diverse forme di oppressione.
Al contrario che in altri testi, in Scienza e religione Russell non mette tanto l’enfasi sul conflitto tra queste due forme di vita e di pensiero quanto sulla loro radicale distinzione. Scrive infatti nelle pagine iniziali del libro che «una fede religiosa si distingue da una teoria scientifica perché pretende d’incarnare una verità eterna e assolutamente certa, mentre la scienza è sempre sperimentale, pronta ad ammettere presto o tardi la necessità di mutamenti alle sue attuali teorie, e consapevole che il suo metodo è logicamente incapace di portare a una dimostrazione completa e definitiva».
E avviandosi alla conclusione, sottolinea che «la mentalità scientifica è prudente, sperimentale ed empirica; non pretende né di conoscere l’intera verità né che la sua conoscenza sia interamente vera; sa che ogni dottrina ha bisogno di essere emendata presto o tardi e che il necessario emendamento richiede libertà d’indagine e libertà di discussione».
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- DALLA SICILIA ALLE ALPI - A MILANO. Il pianeta del cavaliere (di Barbara Spinell)i31 ottobre 2012, di Federico La Sala
Il pianeta del cavaliere
di Barbara Spinelli (la Repubblica, 31 ottobre 2012)
Forse è il caso di ascoltare il grido di rabbia, e anche di speranza, che sale dalla Sicilia, questa terra dove fare giustizia è scabroso. Un sindaco anti-mafia, Rosario Crocetta, diventa governatore anche se il Pd è alleato con gli ex tutori di Cuffaro nell’Udc. La vecchia battaglia di Grillo per un Parlamento pulito (2005), che escluda condannati di primo, secondo e terzo grado, ha ottenuto un premio enorme: il suo Movimento è primo partito dell’isola. Non ha usato, stavolta, l’arma del web: Grillo ha battuto città dopo città come i professionisti d’un tempo, facendo comizi per ben 20 giorni. I siciliani, allibiti, si sono sentiti onorati, visti, non identificati con la mafia che pretende incarnarli. Il Movimento offre anche un orizzonte non eversivo: Grillo non ha torto quando dice che senza di lui saremmo sommersi da neonazisti come in Grecia e Ungheria.
Chi vive in un altro pianeta è Berlusconi, che tutto questo non l’ha presentito. Per questo vale la pena ricostruire la genesi dei tribunali. La giustizia, i processi, le leggi, esistono in primo luogo per l’innocente, per il senza-potere: non per il reo da condannare. Se c’è desiderio che sia fatta luce su chi vilipende il bene comune (in Sicilia anche la bellezza comune), è perché l’innocente non sia confuso con il colpevole, sprofondando in una melma dove non distingui nulla. È questo bisogno di giustizia che l’ex Premier offende, disattento alla Sicilia e all’Italia in mutazione. Ogni processo è ritenuto veleno, che ammorba la democrazia e la spegne. La magistratocrazia si sostituirebbe eversivamente alla democrazia, contro il popolo sovrano.
Il dubbio che i processi siano al servizio soprattutto degli indifesi non lo sfiora: lui, condannato per truffa ai danni dello Stato, si presenta come vittima, perfino capro espiatorio. Non sa che per definizione il capro è innocente: che proprio per questo il rito è barbarico. Non c’è, nel capro, la «naturale capacità a delinquere» che i giudici di Milano ravvisano in Berlusconi: non sarebbe agnello sacrificale, se avesse questa capacità.
È importante che gli italiani sappiano che l’idea stessa di giustizia - pietra angolare della pòlis - è negata, ignorata, da chi parla del pianeta giustizia quasi estromettendola dall’orbita terrestre. Che sappiano quel che spinge Berlusconi condannato ad aborrire le sentenze che lo riguardano ma anche, d’un sol fiato, quelle che giudicano colpevoli di incuria gli scienziati che tranquillizzarono gli abitanti dell’Aquila e dintorni, raccomandando di restarsene in casa perché la grande scossa del 6 aprile 2009 era invenzione della paura. Non è escluso che la stessa ripugnanza tocchi alle sentenze del giudice per le indagini preliminari a Taranto, che ha punito la disinvoltura, all’Ilva, con cui la salute dei cittadini è stata per anni messa a repentaglio.
Non è vera follia, perché sempre nelle follie dell’ex Premier c’è un metodico fiuto di rancori nascosti: non della società, ma certo del «suo popolo». Rancore per le tante sentenze, che invadono i campi più diversi perché arati senza legge e controlli a fini privati. La lotta a chi froda impunemente, la protezione dalle catastrofi naturali o da acciaierie tossiche, ma anche la custodia della nostra ricchezza che è il patrimonio artistico: sono mansioni che dovrebbero competere allo Stato, non ai magistrati. I quali non sono giudici vendicatori, e nemmeno chirurghi che guariscono alla radice i mali dell’incuria cialtrona. Possono intervenire solo a danno o crimine compiuto, e non per cambiare le leggi, selezionare onesti amministratori, presidiare il bene pubblico prima che il malaffare lo sfasci. È quel che diceva Borsellino, quando insisteva sull’obbligo propedeutico dei politici di far pulizia a casa propria, sventando patti mafiosi.
Lo dice a 23 anni di distanza Ingroia, procuratore aggiunto a Palermo, quando invoca, contro la ‘ndrangheta radicata ormai stabilmente a Nord, un «cambio di classe dirigente e di ceto politico», tale che si possa «girare la pagina» e bloccare le contrattazioni Stato-mafia. Fu ancora Borsellino, il 22 giugno 1990 in un dibattito a Roma (il tema era “Stato e criminalità organizzata: chi si arrende?”) a replicare che lo Stato non si era arreso, non avendo combattuto. Attilio Bolzoni magistralmente scrive su Repubblica che qualcosa mancherà nel processo sulle stragi del ’92-93. Non un pentito di mafia: «Quel che è sempre mancato è un pentito di Stato».
Cambiare classe dirigente non significa cambiar facce, o rottamare. Significa interrogarsi severamente sulla giustizia omessa, sul vuoto di politica che moltiplica le sentenze, e porre rimedio premurandosi del bene comune. Compreso il bene europeo, altro bersaglio di Berlusconi (perché dobbiamo tener conto delle inquietudini dei tedeschi? si chiede stupito). Significa riconoscere che non solo governanti e politici debbono apprendere la responsabilità e la giustizia, ma anche la classe dirigente non schierata. Anche chi, specialista o manager, ha poteri d’influenza: tecnico della scienza, dell’economia, delle imprese.
Tutti questi potenti tendono a diffidare della magistratura, e non a caso c’è un ministro, Corrado Clini, che giunge sino ad equiparare la condanna di Galilei e quella dei sette scienziati che minimizzarono gli sciami sismici incombenti sull’Abruzzo dal dicembre 2008. Come se gli scienziati fossero accusati di scarsa preveggenza, non di avere perentoriamente escluso rischi gravi. Non di aver servito il potere politico (Bertolaso, Berlusconi) che voleva occultare la verità ai cittadini.
Non dimentichiamo uno dei sette, Bernardo De Bernardinis, che consigliava di chiudersi in casa (in casa! uno scienziato dovrebbe sapere che la casa uccide, nei terremoti) e per calmarsi di bere un bicchiere di Montepulciano in più. Non dimentichiamo lo scienziato Enzo Boschi, che il 9 aprile si piegò all’ingiunzione di Bertolaso: «I sismologi mi servono per un’operazione mediatica (...). È ovvio che la verità non la si dice».
In Todo Modo, Leonardo Sciascia fa dire al luciferino protagonista, Don Gaetano: «Le cose che non si sanno, non sono». Ecco come le classi dirigenti tradiscono. Non il giudice unico dell’Aquila, Marco Billi, è il cardinale Bellarmino censore di Galilei, ma il potere politico che asservisce la scienza. Chi ammorba la democrazia è Berlusconi che truffa, non il tribunale di Milano.
Se a fare le cose con senso di giustizia fossero i politici, i comitati scientifici, gli imprenditori, non avremmo questa riduzione d’ogni gesto all’aspetto penale. Ma è anche vero che senza sentenze, oggi, l’uomo diverrebbe lupo per l’uomo. Perché la catarsi della politica e delle classi dirigenti ancora non c’è. Perfino il governo Monti esita, con le sue leggi anticorruzione piene di indulgenze; anche se ha deciso, grazie a Di Pietro, di costituirsi parte civile nel processo di Palermo sulle trattative Stato-Mafia.
Già, Palermo. Anni di omertà e umiliazione non cancellano la sete di giustizia. È quello che ha dato le ali a Grillo. Non perché si sia dilungato sulla mafia, ma perché per quasi un mese si è messo in ascolto delle collere siciliane. Il grido che sale dalla Sicilia è la risposta più forte all’urlo di Berlusconi a villa Gernetto. A parole che pesano, non raddrizzabili. Per citare ancora Sciascia, parole simili «non sono come i cani, cui si può fischiare a richiamarli».
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- CHI CUSTODISCE I CUSTODI?! LA PROTEZIONE INCIVILE (di Francesco Merlo).27 ottobre 2012, di Federico La Sala
La protezione incivile
di Francesco Merlo (la Repubblica, 27.10.2012)
La spavalderia è la stessa che Bertolaso esibiva sulle macerie quando si vestiva da guerrigliero geologico, da capitano coraggioso, gloria e vanto del berlusconismo, con certificati ammiratori a sinistra. Ma i testi delle telefonate che, in rete su repubblica. it, ora tutti vedono e tutti giudicano, lo inchiodano al ruolo del mandante morale. Quel «nascondiamo la verità», quel «mi serve un’operazione mediatica», quel trattare gli scienziati, i massimi esperti italiani di terremoti, come fossero suoi famigli, «ho mandato i tecnici, non mi importa cosa dicono, l’importante è che tranquillizzino », e poi i verbali falsificati...: altro che processo a Galileo! E’ Bertolaso che ha reso serva la scienza italiana.
Più passano i giorni e più diventa chiara la natura della condanna dell’Aquila. Non è stato un processo alla scienza ma alla propaganda maligna e agli scienziati che ad essa si sono prestati. E innanzitutto perché dipendono dal governo. Sono infatti nominati dal presidente del Consiglio come i direttori del Tg1 e come gli asserviti comitati scientifici dell’Unione sovietica. In Italia la scienza si è addirittura piegata al sottopotere, al sottosegretario Bertolaso nientemeno, la scienza come parastato, come l’Atac, come la gestione dei cimiteri. Dunque è solo per compiacere Guido Bertolaso, anzi per obbedirgli, che quei sette servizievoli scienziati sono corsi all’Aquila e hanno improvvisato una riunione, fatta apposta per narcotizzare.
Chiunque ha vissuto un terremoto sa che la prima precauzione è uscire di casa. Il sisma infatti terremota anche le nostre certezze. E dunque la casa diventa un agguato, è una trappola, può trasformarsi in una tomba fatta di macerie. In piazza invece sopra la nostra testa c’è il cielo che ci protegge. Ebbene all’Aquila, su più di trecento morti, ventinove, secondo il processo, rimasero in casa perché tranquillizzati dagli scienziati di Bertolaso. E morirono buggerati non dalla scienza ma dalla menzogna politica, dalla bugia rassicurante.
Purtroppo il nostro codice penale non prevede il mandante di un omicidio colposo plurimo e Bertolaso non era imputato perché le telefonate più compromettenti sono venute fuori solo adesso. E però noi non siamo giudici e non dobbiamo attenerci al codice. Secondo buon senso Bertolaso è moralmente l’istigatore dei condannati, è lui che li ha costretti a sporcarsi con la menzogna.
Tanto più perché noi ora sappiamo che questi stessi scienziati avevano previsto l’arrivo di un’altra scossa mortale, nei limiti ovviamente in cui la scienza può prevedere le catastrofi. Ebbene, il dovere di Franco Barberi, Bernardo De Bernardinis, Enzo Boschi, Mauro Dolce, Giulio Selvaggi, Gian Michele Calvi, Claudio Eva era quello di dare l’allarme. Gli scienziati del sisma sono infatti le sentinelle nelle torri di avvistamento, sono addestrati a decifrare i movimenti sotterranei, sono come i pellerossa quando si accucciano sui binari. Nessuno si sogna di rimproverarli se non “sentono” arrivare il terremoto. Ma sono dei mascalzoni se, credendo di sentirlo, lo nascondono.
Il processo dell’Aquila dunque è stato parodiato. E quell’idea scema che i giudici dell’Aquila sono dei persecutori che si sono accaniti sulla scienza è stata usata addirittura dalla corporazione degli scienziati. Alcuni di loro, per solidarizzare con i colleghi, si sono dimessi, lasciando la Protezione Civile nel caos, proprio come Schettino ha lasciato la Concordia. Il terremoto in Italia è infatti una continua emergenza: giovedì notte ne abbiamo avuto uno in Calabria e ieri pomeriggio un altro più modesto a Siracusa.
Ebbene gli scienziati che sguarniscono le difese per comparaggio con i colleghi sono come i chirurghi che scioperano quando devono ricucire la ferita.
Ma diciamo la verità: è triste che gli scienziati italiani si comportino come i tassisti a Roma, forze d’urto, interessi organizzati, cecità davanti a una colpevolezza giudiziaria che può essere ovviamente rimessa in discussione, ma che non è però priva di senso, sicuramente non è robaccia intrusiva da inquisizione medievale. Insomma la sentenza di primo grado può essere riformata, ma non certo perché il giudice oscurantista ha condannato i limiti della scienza nel fare previsioni e persino nel dare spiegazioni.
E il giudice dell’Aquila è stato sobrio. E’ raro in Italia trovare un magistrato che non ceda alla rabbia, alla vanità, al protagonismo. Ha letto il dispositivo della sentenza, ha inflitto le condanne e se n’è andato a casa sua come dovrebbero fare tutti i magistrati, a Palermo come all’Aquila. Pochi sanno che si chiama Marco Billi. Non è neppure andato a Porta a Porta per difendersi dall’irresponsabile travisamento che ai commentatori frettolosi può essere forse perdonato, ma che è invece imperdonabile al ministro dell’Ambiente Corrado Clini, il quale ha tirato in ballo Galileo e ci ha tutti coperti di ridicolo facendo credere che in Italia condanniamo i sismologi perché non prevedono i terremoti, che mettiamo in galera la scienza, che continuiamo a bruciare Giordano Bruno e neghiamo che la Terra gira intorno al Sole.
Il ministro dell’Ambiente è lo stesso che appena eletto si mostrò subito inadeguato annunziando che l’Italia del referendum antinucleare doveva comunque tornare al nucleare. Poi pensammo che aveva dato il peggio di sé minimizzando i terribili guasti ambientali causati dall’Ilva di Taranto. Non lo avevamo ancora visto nell’opera brechtiana ridotta a battuta orecchiata, roba da conversazione al Rotary, da sciocchezzaio da caffè. E sono inadeguatezze praticate sempre con supponenza, a riprova che c’è differenza tra un tecnico e un burocrate. In Italia puoi scoprire che anche il direttore generale di un ministero non è un grand commis di Stato ma un impiegato di mezza manica.
So purtroppo che è inutile invitare personaggi e comparse di questa tragica farsa ad un atto di decenza intellettuale, a restituire l’onore alla ricerca, alla scienza e alla giustizia, e a risalire su quelle torri sguarnite della Protezione Civile senza mai più umiliarsi con la politica. A ciascuno di loro, tranne appunto al dimenticabile Bertolaso che intanto si è rintanato nel suo buco, bisognerebbe gridare come a Schettino: «Torni a bordo...».
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- Ancora non riesco a non provare sbigottimento di fronte a centinaia di parlamentari votati al servilismo (di Franco Monaco - Perché elogio l’antiberlusconismo)13 ottobre 2012, di Federico La Sala
Perché elogio l’antiberlusconismo
di Franco Monaco (l’Unità, 12 ottobre 2012)
Secondo un luogo comune invalso anche a sinistra non si deve indulgere all’antiberlusconismo. Mi è chiaro il senso di quella raccomandazione: le ossessioni, comprese quelle virtuose, accecano lo sguardo e inficiano la lucidità dell’analisi; non si devono demonizzare le persone che, in buona fede, sono incappate in quella fallace illusione; ci si deve meritare il consenso sulla base di una proposta declinata in positivo .... Sono perfettamente d’accordo. Ma a una precisa condizione: che quella lunga stagione, politica e non solo, segnata dalla ingombrante ipoteca di Berlusconi, non sia consegnata all’oblio. Che la lezione che dobbiamo ricavare da essa non sia precipitosamente archiviata.
Se ben inteso, a mio avviso, l’antiberlusconismo è una virtù. Per più ragioni. La prima è che l’uomo, con il suo smisurato sistema di potere, è ancora tra noi. Spesso ci si scorda che al Senato egli ancora dispone della maggioranza, che continua ad esercitare uno straordinario potere attivo o di interdizione, che ancora da lui, dalla sua iniziativa e persino dalle sue esitazioni, dipende la sorte della destra politica italiana, che il volume di fuoco dei suoi media tuttora non è minimamente intaccato, che il suo potere economico è ancora enorme e le sue disponibilità finanziarie pressoché infinite. Come attestano le indagini giudiziarie rosa e nere che lo riguardano. Ignorarlo sarebbe un errore ottico letale.
Seconda ragione: è d’obbligo tenere fermo il giudizio di valore ed esercitare l’arte della distinzione rispetto al ciclo berlusconiano. Taluni nuovisti anche a sinistra teorizzano che dovremmo metterci dietro le spalle la coppia berlusconismo-antiberlusconismo. Quasi fossero due mali equivalenti. Quasi che avere contrastato politicamente e culturalmente il Cavaliere fosse stato un errore o comunque un’esagerazione, un comportamento di stampo estremistico.
Sul punto, ricordo sempre la reazione insolitamente vivace e risentita di un uomo per indole mite e controllato come Leopoldo Elia, che respingeva l’accusa di antiberlusconismo come una sorta di ricatto dialettico irricevibile, come la più stupida e immotivata delle imputazioni: che colpa ne abbiamo, notava, se quel concentrato di anomalie che minano la democrazia e la vita morale e civile si condensa nominativamente in una persona, che porta un nome e un cognome? E’ un fatto, non una nostra costruzione artificiale.
Vi è una terza ragione: l’oblio e la rimozione delle distinzioni conduce a una narrazione fuorviante del passato politico recente che ha messo radici anche tra noi. Mi spiego: tutti i governi della cosiddetta seconda Repubblica andrebbero inscritti sotto la cifra del fallimento. Una falsificazione cui invece dovremmo reagire. Come si può onestamente sostenere che i governi nei quali figuravano Prodi, Ciampi, Amato, Napolitano, Padoa Schioppa, Bersani possano essere giudicati alla stessa stregua dei governi Berlusconi? Tale fuorviante narrazione non è priva di conseguenze per il presente e per il futuro. La sbrigativa e illusoria ricetta della rottamazione di tutto e di tutti affonda qui le sue radici. Ignora un paio di dettagli: grazie all’Ulivo la sinistra ha assunto per la prima volta la responsabilità del governo nazionale dopo mezzo secolo e ha portato l’Italia in Europa.
Ancora, la rimozione dell’antiberlusconismo e cioè della consapevolezza della marcata unicità del caso Berlusconi, non a caso osservato con un misto di curiosità, allarme e commiserazione fuori dei nostri confini, non è priva di conseguenze sul piano della visione del sistema politico. Si è inclini a decretare il fallimento del bipolarismo, cioè di una sana democrazia competitiva, anziché a considerare che appunto a quella gigantesca anomalia si deve il suo cattivo, concreto funzionamento.
E di conseguenza a rigettare il bipolarismo proprio quando esso, depurato dall’ipoteca di quell’anomalia, potrebbe dispiegarsi positivamente. O addirittura si è spinti a rinunciare alla politica democratica tout court per consegnarsi alla tecnocrazia, al mito del pensiero unico dal quale cavare la ricetta unica appaltata a chi dispone dei saperi specialistici.
Infine, smarrendo la precisa memoria della peculiarità del fenomeno Berlusconi, si può abbassare la guardia sui due profili di esso che possono perfettamente sopravvivere all’uomo e alla sua parabola politica. Cioè le tossine del berlusconismo che più o meno consapevolmente si sono depositate in noi. Due in particolare: il leaderismo, il cesarismo, le scorciatoie populiste che, pur sotto varie vesti, hanno preso corpo ben oltre i confini del suo partito e del suo campo; una concezione della vita prima e più che della politica ossessivamente mirata al successo, al denaro, al potere personale e di gruppo.
Può sembrare strano, ma, a mio avviso, non abbiamo riflettuto ancora abbastanza sulla devastazione prodotta dalla concretissima idea-forza inoculata da Berlusconi: quella che con il denaro ci si possa comprare tutto, tutti e tutte.
Giustamente ci siamo scandalizzati per i bunga bunga di un uomo di Stato, per le donne ridotte a merce e a tangente. Ma non ci scandalizziamo più abbastanza per la legione di uomini e donne che siedono in parlamento, cioè in una istituzione che riveste una sua sacralità, pronti a servire le cause più invereconde.
Il voto sulla nipote di Mubarak è solo la punta di un iceberg di diciotto anni di vita parlamentare ostaggio degli interessi materiali e delle spericolate vicissitudini di un uomo. Suscita sconcerto e irritazione lo spettacolo dei docili e spesso mediocri servitori da lui miracolati con posti, denaro e potere che oggi, a fronte della sua declinante parabola, cercano di mettersi in salvo. Così pure, lo confesso, mi lasciano basito i giovani «formattatori» del Pdl.
Di sicuro io sono all’antica e un po’ bacchettone, ma ancora non riesco a non provare sbigottimento di fronte a centinaia di parlamentari votati al servilismo e a giovani che tutt’ora guardano a Berlusconi come a un modello. Vi rilevo un che di mostruoso, l’ennesima testimonianza della profondità e dell’estensione di quelle tossine.
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. ---- APPELLO DI ILLUSTRI GIURISTI IN DIFESA DELLA COSTITUZIONE6 giugno 2012, di Federico La Sala
APPELLO DI ILLUSTRI GIURISTI IN DIFESA DELLA COSTITUZIONE
di Umberto Allegretti, Gaetano Azzariti, Lorenza Carlassare, Luigi Ferrajoli, Gianni Ferrara, Domenico Gallo, Raniero La Valle, Alessandro Pace, Alessandro Pizzorusso, Eligio Resta, Stefano Rodota’, Gustavo Zagrebelsky
Con una inammissibile precipitazione il Senato ha approvato in commissione un disegno di legge di riforma costituzionale che s’intende portare in aula gia’ martedi’ prossimo. Ma la Costituzione non puo’ essere profondamente mutata senza una vera discussione pubblica, senza che i cittadini adeguatamente informati possano far sentire la loro voce. E’ inaccettabile che la richiesta di partecipazione, cosi’ forte ed evidente proprio in questo momento, venga ignorata proprio quando si vuole addirittura modificare l’intero edificio costituzionale. I cittadini, che negli ultimi tempi sono tornati a guardare con fiducia alla Costituzione, non possono essere messi di fronte a fatti compiuti.
Offrendo ad una opinione pubblica offesa da prevaricazioni e prepotenze un’esigua riduzione del numero dei parlamentari, che passerebbero da 630 a 508 alla Camera e da 315 a 254 al Senato, si vuol cogliere l’occasione per alterare pericolosamente l’assetto dei poteri istituzionali (la riduzione dei parlamentari puo’ essere affidata ad una legge costituzionale a se’ stante, senza stravolgere la Costituzione). Viene attribuita una posizione assolutamente centrale al Presidente del Consiglio, mortificando il Parlamento e ridimensionando in maniera radicale la funzione di garanzia del Presidente della Repubblica. Il Parlamento e’ conculcato nelle sue stesse funzioni e nella sua liberta’, fino a poter essere sciolto dallo stesso Presidente del Consiglio, nel caso votasse contro una sua legge sul quale fosse stata posta e negata la fiducia. L’intreccio tra sfiducia costruttiva e potere del Presidente del Consiglio di chiedere lo scioglimento delle Camere attribuisce a quest’ultimo un improprio strumento di pressione e rende marginale il ruolo del Presidente della Repubblica. I problemi del bicameralismo vengono aggravati, il procedimento legislativo complicato. Gli equilibri costituzionali sono profondamente alterati, cancellando garanzie e bilanciamenti propri di un sistema democratico. E ora si propone di passare da una repubblica parlamentare ad una presidenziale, di mutare dunque la stessa forma di governo, addirittura con un emendamento che sara’ presentato in aula all’ultimo momento.
I firmatari di questo documento denunciano all’opinione pubblica la gravita’ di questa iniziativa per i pregiudizi che puo’ arrecare alle istituzioni della repubblica e si rivolgono a tutti i parlamentari perche’ rinuncino a portare avanti una modifica tanto pericolosa del sistema costituzionale.
Umberto Allegretti, Gaetano Azzariti, Lorenza Carlassare, Luigi Ferrajoli, Gianni Ferrara, Domenico Gallo, Raniero La Valle, Alessandro Pace, Alessandro Pizzorusso, Eligio Resta, Stefano Rodota’, Gustavo Zagrebelsky
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. ---- La demagogia è una forma degenerata della democrazia. La politica degli antipolitici (di Nadia Urbinati)10 maggio 2012, di Federico La Sala
La politica degli antipoliticidi Nadia Urbinati (la Repubblica, 10 maggio 2012)
La demagogia è una forma degenerata della democrazia, la sua periferia interna. I classici la situavano al punto terminale della democrazia costituzionale o "buona".
Era la conseguenza di un impoverimento della società, del timore della classe media di vedere indebolito il proprio status e dei meno abbienti di perdere quel poco che a fatica avevano guadagnato. In questo scontento che contrapponeva i pochi ai molti poteva emergere un astuto demagogo che metteva in campo forze nuove, desiderose di farsi largo ed emergere.
Oggi la demagogia usa il linguaggio dell’antipolitica per esprimere opposizione alla classe politica attualmente esistente con il prevedibile obiettivo di scalzarla con una nuova. Se poi questa classe politica si è macchiata di corruzione ciò rende l’arringa del demagogo più facile ed efficace. Il Movimento Cinque Stelle rientra in questa categorizzazione demagogica. Beppe Grillo ha fatto dell’antipolitica la sua battaglia e alle recenti elezioni amministrative quel linguaggio ha dato i suoi frutti. La crisi economica e i recenti e meno recenti scandali politici hanno fatto da benzina. Ma che cosa è esattamente l’antipolitica?
Quando si parla di antipolitica nelle società democratiche si usa una parola molto imprecisa. Chi la usa non suggerisce infatti di ritirarsi nella solitudine di un convento, oppure di vivere solo di e per la famiglia, o solo di e per il lavoro. Chi usa l’espressione antipolitica vuole presumibilmente criticare il modo con il quale la politica è praticata ma in realtà sfruttare lo scontento che esiste ed è forte verso le forme tradizionali di esercizio della politica. Non è la politica l’obiettivo polemico e nemmeno la forma partito. Non è la politica perché il parlare di antipolitica è comunque un parlare politico, addirittura uno schierarsi partigianamente, e questo è a dimostrazione del fatto che nelle società democratiche non c’è scampo alla politica, nel senso che ogni questione che esce dal chiuso della domesticità è e si fa politica. Diceva Thomas Mann in un saggio esemplare sull’impolitico che nella società democratica anche chi si scaglia contro la politica è costretto a farlo con linguaggio politico, a farsi partigiano della sua causa. Ci si schiera e si entra nell’agone. L’antipolitica non è possibile.
Così è oggi: non c’è niente di più politico di questa persistente critica della politica. A ben guardare l’obiettivo polemico non è neppure la forma partito, l’associarsi cioè per perseguire o ostacolare determinati obiettivi e progetti politici. Anche i più astiosi demagoghi dell’antipolitica - anche l’arrabbiato Beppe Grillo - si presentano alle elezioni! Come scriveva Ilvo Diamanti su Repubblica a commento del recente voto amministrativo, il termine "antipolitica" sottintende una valutazione poco convincente quando è usata per spiegare il voto al Movimento Cinque Stelle - benché questo si sia alimentato pantagruelicamente dello slogan dell’antipolitica. Accettando di presentarsi alle elezioni ha accettato le regole democratiche della competizione e, soprattutto, messo in campo persone che, nonostante il linguaggio demagogico di Grillo, vogliono fare politica e discutono di problemi che sono politici, dall’ambiente alla corruzione, agli interessi privati nella cosa pubblica. A ben guardare gli elettori del Movimento sono semmai iperpolitici e vedono tutto in chiave politica (un termine al quale hanno dato un significato negativo, salvo... usarlo proprio per far politica). Scriveva Diamanti che i grillini "mostrano un alto grado di interesse per la politica" e in passato molti di loro hanno votato Lega Nord e anche Pd e Idv. La demagogia non piace ma è innegabile che chi si identifica con il Movimento del demagogo ha una visione politica, non antipolitica. E su questa visione ci si deve interrogare e ad essa occorre controbattere.
Il movimento Cinque Stelle opera come un partito e se vorrà persistere nel tempo dovrà strutturarsi come un partito. Nella democrazia rappresentativa non c’è scampo a questa regola. L’esperienza di Berlusconi insegna: avere i mezzi finanziari non è sufficiente poiché senza struttura e idee propositive la prima grossa sconfitta si rivela fatale. Perché un partito, se partito è, deve essere capace non solo di vincere ma anche di perdere. Un partito nato per solo vincere è un partito destinato all’estinzione. La memoria sulla quale ogni compagine si struttura creando identità collettiva si consolida anche grazie alle sconfitte, esperienze che uniscono, non meno delle vittorie. Quindi il Movimento Cinque Stelle se vuole consolidare la propria presenza nella politica nazionale dovrà essere pronto a scendere nell’agone sapendo che può perdere. La prepotenza verbale del suo leader rivela che questa non è ancora la sua condizione. Se sarà un partito di sola vittoria sarà di breve durata.
Perché dopo la protesta ci sarà la prova del fuoco del potere praticato. Essere eletti, avere una presenza nelle istituzioni, implica fatalmente prendere in mano quel potere urlando contro il quale il movimento di protesta è nato vittorioso. Si tratta di una regola ferrea che contraddice quel che ci aveva abituato a pensare una Democrazia Cristiana che stava in sella sapendo che non rischiava alternativa grazie alla guerra fredda: ovvero che il "potere logora chi non ce l’ha". Questa massima andreottiana valeva appunto perché chi aveva il potere sapeva di non rischiare di perderlo, cosicché a logorarsi erano appunto coloro che non potendolo avere per vie ordinarie (vittoria elettorale) dovevano scendere a patti con chi lo aveva già a costo di sporcarsi le mani. La massima andreottiana designa una condizione di irrilevanza della democrazia elettorale. Ma in una sana democrazia dove le elezioni funzionano davvero da deterrenza, e sono quindi rischiose (come si è visto il 6 e 7 maggio), allora il "potere consuma chi ce l’ha". E quindi le vittorie dei movimenti di protesta rischiano di spegnersi in fretta. La vicenda patetica della Lega Nord prova questa regola. Le ali se le scotta chi più si avvicina al sole. Il Movimento Cinque Stelle o diventa un partito e quindi accetta la sfida di essere vittima della critica di "antipolitica", oppure scompare. Ma se non scompare, allora deve darsi obiettivi e linguaggi che non sono più quelli della demagogia, roboanti, rozzi, e troppo facili.
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. ---- La fine dell’egemonia neoliberista berlusconiana e il cambiamento del vento europeo (di Ida Dominijanni - Voto italiano, vento europeo. Fine di un’egemonia)9 maggio 2012, di Federico La Sala
Voto italiano, vento europeo. Fine di un’egemonia
di Ida Dominijanni (il manifesto, 9 maggio 2012)
Non archiviano solo il Pdl, le prime elezioni del dopo-Berlusconi, ma l’intero polo dell’allora "nuova" destra che Berlusconi mise al mondo nel ’94 e che ha tenuto il campo della politica italiana per quasi un ventennio. Già lesionato dalla separazione di Fini di due anni fa, quel polo è oggi palesemente in frantumi, colpito al cuore dell’asse Berlusconi-Bossi che ne è stato il nerbo. Non aiuta la comprensione di quello che sta accadendo riportare questo crollo solo alle cause scatenanti più recenti: come sempre, nel momento della fine conviene piuttosto allungare lo sguardo sull’inizio.
Sul crollo della destra incidono infatti di sicuro la fine della leadership di Berlusconi - certificata ormai da un lungo declino, iniziato alle Europee del 2009 e mai più arrestatosi - e la devastante sequenza dei cosiddetti "scandali" - dal sexgate al Belsito-gate -, potenti rivelatori del funzionamento di un sistema di potere ancor più che eloquenti spie di una "questione morale" delegittimante. Giova però ricordare, per spiegarne la tenuta prima e adesso il disfarsi, di quali ingredienti fosse fatta la creatura berlusconiana del ’94, una creatura tricipite che teneva insieme tre destre diverse fra loro: quella neoliberista di Forza Italia, quella comunitarista-xenofoba della Lega e quella statalista-sociale di An. Il "miracolo" del Cavaliere consistette precisamente nella capacità di unificare e cementificare sotto il proprio "carisma" queste tre anime diverse, talvolta perfino incompatibili, dando vita a un campo neolib-neocon più simile al suo omologo americano marcato Bush che alle destre europee. E consistette altresì nella capacità di incardinare su questa destra tricipite il bipolarismo della cosiddetta seconda repubblica, ridefinendo al contempo un’agenda di lotta e di governo tagliata sul blocco sociale e sugli interessi del Nord postfordista e "autoimprenditoriale", con il Sud "assistenzialista" in posizione periferica e ancillare.
Quel miracolo non è più ripetibile, e non solo perché è finita, o comunque sfinita, la leadership di Berlusconi senza la quale esso non si dà, ma perché la ricetta neolib-neocon che esso predicava non funziona (ammesso che abbia mai funzionato) e non seduce più. Il crollo, prima che politico, è di blocco sociale, nonché ideologico (al di là delle sue sopravvivenze residuali, paradossalmente più tenaci, a giudicare dal voto di domenica, al Sud che al Nord). Si tratta, in altri termini, della fine di una egemonia. Se e come una destra, e quale destra, riemergerà dalle macerie di questo blocco egemonico, ha probabilmente a che fare con la forma che prenderanno le sue tre componenti originarie. Ed è facile ipotizzare fin d’ora, dalle divisioni che le separano, che non si profila una loro ricomposizione bensì una loro scomposizione, dominata, più che dallo scenario nazionale, dall’evoluzione di quello europeo.
Qui entra in campo il secondo fattore decisivo del terremoto elettorale. Che non serve a nulla interpretare esclusivamente, o prevalentemente, nei termini triti dell’opposizione politica-antipolitica, rimuovendo il dato eclatante della contestazione antirigorista che dal voto (e dal non voto) emerge nettamente, in perfetta consonanza con i segnali che vengono dalla Francia e dalla Grecia. E qui si vedono anche gli enormi limiti di una transizione al dopo-Berlusconi tutta affidata alla sostituzione del neoliberismo più americano che europeo del Cavaliere con il neoliberismo più tedesco che americano di Monti.
Alla prima verifica elettorale, il risultato di questa transizione dall’alto è che alla sepoltura del ventennio del Cavaliere si somma la contestazione del governo dei tecnici e dell’Europa ostile e vessatoria che esso rappresenta. E questo mentre, crollato con la destra di Berlusconi il bipolarismo sperimentato fin qui, l’intero sistema politico deve ridefinirsi, e si sta già ridefinendo, in relazione al quadro europeo, alla crisi europea e alle politiche sociali europee. Non ne dipende infatti solo la configurazione che prenderà la destra, o le destre, orfana del Cavaliere, e allo stato prive di possibilità di riparo in un "terzo polo" che il voto di domenica ha dichiarato inesistente. Ne dipende altrettanto la configurazione che prenderà la sinistra, o le sinistre, nonché la curvatura che assumeranno i movimenti antisistema fin qui troppo genericamente etichettati come "antipolitici", e fin qui nella loro stessa autorappresentazione né di destra né di sinistra.
A proposito di questi ultimi, lo spettro europeo è assai vasto, va dalla sperimentazione delle pratiche di democrazia telematica dei "Pirati" tedeschi alla inquietante riesumazione del binomio socialnazista dell’"Alba dorata" greca, e oscilla dalla critica dell’Unione europea fin qui conosciuta al rifiuto tout court della costruzione europea. Sono movimenti che non garantiscono di per sé niente di buono, ma niente può piegarli al peggio quanto una pregiuziale sordità al disagio sociale di cui sono portatori.
Quanto ai destini della sinistra italiana, il voto francese, peraltro insistemente invocato dai suoi leader come condizione necessaria di un cambio di stagione su scala continentale, le indica limpidamente la strada. Non è affatto detto però che su quella strada essa possa portarsi l’appoggio al governo tecnico, né che basti mettere Monti nella posizione del mediatore fra Merkel e Hollande per far quadrare i conti dell’Euro e delle prossime elezioni politiche. Il Pd non è stato punito per le sue oscillazioni dal voto amministrativo, ma non è stato nemmeno granché premiato; e queste non sono circostanze in cui la rendita dell’ "unico partito che tiene" possa durare a lungo. Ci sono situazioni in cui i tempi stringono, e le oscillazioni non pagano. La nettezza, manda a dire il caso Hollande, paga di più.
La fine dell’egemonia neoliberista berlusconiana e il cambiamento del vento europeo domandano e comandano una manovra controegemonica in grande stile, di segno opposto all’introiezione temperata del rigore montiano. E la stessa contabilità del voto obbliga a distogliere finalmente lo sguardo da un centro desaparecido e a volgerlo con più convinzione verso sinistra. Diversamente, ci saranno nell’immediato una sinistra senza popolo e un populismo senza sinistra, e all’orizzonte più la disgregazione greca che l’alternativa francese.
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. ---- LA CECITA’ DELLA TRADIZIONE CRITICA E IL PROBLEMA JEAN-KACQUES ROUSSEAU.2 maggio 2012, di Federico La Sala
IL PROBLEMA JEAN-JACQUES ROUSSEAU E LA CECITA’ DELLA TRADIZIONE CRITICA.
Ecco allora ciò che deve essere chiaro: gli eredi perversi di Rousseau sono all’oggi i fanatici del «partito personale». Tra presidenzialismo, antipolitica e dintorni (...)
 FILOSOFIA, ANTROPOLOGIA E POLITICA. IL PENSIERO DELLA COSTITUZIONE E LA COSTITUZIONE DEL PENSIERO ....
FILOSOFIA, ANTROPOLOGIA E POLITICA. IL PENSIERO DELLA COSTITUZIONE E LA COSTITUZIONE DEL PENSIERO ....
 STATO DI MINORITA’ E FILOSOFIA COME RIMOZIONE DELLA FACOLTA’ DI GIUDIZIO. Una ’lezione’ di un Enrico Berti, che non ha ancora il coraggio di dire ai nostri giovani che sono cittadini sovrani. Una sua riflessione
STATO DI MINORITA’ E FILOSOFIA COME RIMOZIONE DELLA FACOLTA’ DI GIUDIZIO. Una ’lezione’ di un Enrico Berti, che non ha ancora il coraggio di dire ai nostri giovani che sono cittadini sovrani. Una sua riflessioneL’ILLUMINISMO, OGGI. LIBERARE IL CIELO. Cristianesimo, democrazia e necessità di "una seconda rivoluzione copernicana" (Federico La Sala)
Rousseau, il piacere dell’eguaglianza
A trecento anni dalla nascita del ginevrino dalla vita spericolata e virtuosa Un pensatore decisivo per le origini della sinistra che vide le alienazioni della società di massa, anticipò il romanticismo e inventò la sovranità popolare
di Bruno Gravagnuolo (l’Unità, 01.05.2012)
Jean-Jacques Rousseau compirà trecento anni il 28 giugno. E festeggiamenti e maledizioni sono già cominciate. Come nella vita del ginevrino, sempre in bilico tra devozioni e ripulse. Usciamo da giochini mediatici e luoghi comuni. Per esempio: Hollande a sinistra è con Rousseau, Sarkozy a destra è con Hobbes. Parola della rivista Philosophie. Oppure: Rousseau virtuista, moralista, pericoloso, «giustizialista». Secondo la vulgata di Corrado Ocone su La Lettura del 15 aprile.
Cominciamo da qualcos’altro: da Jean-Jacques e dal suo «problema», come direbbe Ernst Cassirer. Problema di una certa «soggettività», che diventa il teatro interiore di un dramma storico più vasto: la modernità di massa. Che può stritolare o emancipare individui e popoli.
Presto detta la cifra biografica del ginevrino. Orfano di una madre bibliofila morta nel concepirlo e allievo di un padre calvinista e orologiaio. Che lo abbandona dopo una rissa. Girovago e mantenuto, da nobili e gran dame, sue amanti. Prima fra tutte Madame de Warenne, la sua «maman». Incisore, segretario, operista, lacché, copista di partiture.
C’è stato chi come Robert Darnton ha ipotizzato che Il nipote di Rameau, dissipato parente del musicista allora in voga, e ispiratore del dialogo di Diderot, fosse Rousseau stesso. I conti tornano. Diderot fu sponsor di Jean-Jacques, e lo conobbe da parassita e da profeta. La musica, copiata o composta c’è. Rousseau scrisse tre opere, tra cui le Le Muse galanti, rappresentata in casa di Madame di Epinay, altra sua amante. Ma più che altro torna una «dialettica». Quella scoperta da Hegel, recensore del libro di Diderot nella Fenomenologia dello spirito: coscienza libertina e coscienza virtuosa. Nichilismo e morale. Dissoluzione e volontà.
Ma a un certo punto Jean Jacques «si decide». E, folgorato nel 1750 da un concorso dell’Accademia di Digione, scende in guerra contro il Progresso, i Lumi, l’Enciclopedia. E attacca l’ineguaglianza e il dispotismo, l’educazione falsa. Il dissipato, sempre amato da influenti protettori, è diventato un Licurgo dell’Etica.
Ma qual è il cuore del problema in questa Etica immaginaria che risana le piaghe del mondo assieme a quelle di Jean-Jacques? Eccolo: autenticità del soggetto umano, e ricostruzione (romantica) della natura umana divisa da orgoglio, ineguaglianza e proprietà. Qui la chiave. Per Rousseau la politica, al tempo moderno, è l’unica psico-terapia in grado di arginare l’infelicità. Terapia psicologica, non a caso. Non solo perché in Rousseau c’è una psico-pedagogia per raddrizzare le storture dell’anima e creare buoni cittadini. Non solo perché tra Confessioni e Réveries praticherà l’autoanalisi tesa all’«autenticità» e alla «trasparenza» del soggetto. Ma perché nell’era del dispotismo, segnato da nuove ineguaglianze proprietarie, la politica è l’unica salvazione. Per ripristinare l’unità infranta dall’«amor proprio» e dal prometeismo alienato, che ha lacerato il sentimentalismo dell’«amor di sé», entro il quale il genere umano viveva nell’equilibrio della compassione per l’altro.
C’è qui una chiara lezione calvinista. Quella del peccato originale che si svela nella perversione dell’ego ritorta nell’onnipotenza autosufficiente. Fino ad asservire l’altro in una smisurata libido manipolatoria. Dopo il crollo dell’unità senza colpa del genere umano e della sintonia tra simili con la natura benefica. E l’inizio della tecnica e delle arti, esercizi di arricchimento e vanità.
Ricomporre quella unità, infranta da catastrofi, disubbidienze e usurpazioni, è impossibile per Rousseau (come scrive nel Discorso sull’ineguaglianza). E però residua un dovere: ricomporre la frattura almeno artificialmente. Almeno nella volontà etica pungolata dalla «mancanza originaria». Come? Con un contratto. Un artificio sociale in forma di protesi razionale.
Insomma, una specie di regno dei fini in terra, assiso su un vulcano fatto di potenziale e latente regressione verso l’egotismo connaturato alla natura umana. È una giustificazione per fede quella di Rousseau, dove l’atto di fede sta nel tramutare la perfettibilità umana (pericolosa e arrogante) in virtù mediana dell’accordo politico giusto. Che ripristini la trasparenza, l’immediatezza della compassione e la gioia del rispecchiarsi nell’inerme: per elevarlo e farne un cittadino libero. Fare Contratto sociale è lavare il peccato originale. E consacrare, con una teologia politica, l’ecclesia dei cittadini all’unico modo di venerare Dio. Con una comunità civile. Dove l’eucarestia risanatrice è lì presente e reale, nella Volontà generale e nell’Io comune.
Dunque, ecco un patto dove «ciascuno unendosi a tutti non obbedisce che a se stesso e resti tanto libero come prima». C’è la persona giusnaturalista in quel patto, e gli averi. E nondimeno solo il patto li riconosce, arrogandosi il diritto politico di revocarli. Non più diritti imprescrittibili e sanciti a valle dal patto, come in Locke. E neanche la soggezione perenne al sovrano, una volta conferitogli l’assenso nel contratto. L’idea è un’altra. È il moto quieto e continuo della Volontà indivisa che si esercita in comune e non si smembra. Si autorappresenta e non si cede, se non come delega tecnica, revocabile a maggioranza. Niente corpi intermedi. Niente fazioni, «partiti» o associazioni. Niente arricchimenti di troppo, poiché libera per Jean-Jacques è quella società dove nessuno è tanto ricco da poter compare la libertà di un altro, o tanto povero da doverla venderla. Per inciso: splendido slogan per la sinistra, anche oggi!
Come è splendida l’analisi, che nel Contratto Rousseau svolge su opulenti e pezzenti. I primi sono i fautori della tirannide, i secondi coloro dai quali provengono i tiranni. Perchè gli uni comprano, e gli altri vendono... Sicché Rousseau analista della diseguaglianza, che l’incipiente capitalismo cova all’ombra dell’Antico Regime. E Rousseau riformatore d’anime in forma politica. Altra intuizione: la società moderna seduce e «aliena», con scintillio di lusso e di denaro. Ed è esposta a demagoghi e involuzioni autoritarie, se il cittadino si estranea dal civismo.
Ma c’è dell’altro. Jean-Jacques fu un profeta egualitario, che per paradosso ha alimentato i suoi nemici: uomini e movimenti dispotici. Bandire infatti fazioni e corpi intermedi, genera sempre un vortice fatale. Tra «stato, movimento e popolo» polarizzato sul tiranno carismatico che si fa scudo dell’emergenza. Ed è così che nella storia la dittatura, «provvisoria e commissaria», diviene «sovrana» (Carl Schmitt). Nei totalitarismi di destra e sinistra. Sull’onda dell’«azione diretta» contro rappresentanza e partiti. Dai giacobini, ai reazionari comunitari, al soviettismo. Passando per populismi e fascismi. Risolutiva a riguardo l’analisi sul Terrore giacobino del solito Hegel: la Volontà generale per palesarsi senza corpi intermedi, ha bisogno di complotti da stroncare e pericoli da sventare. Di mobilitazione e guerra civile, fino all’autodistruzione.
Ecco allora ciò che deve essere chiaro: gli eredi perversi di Rousseau sono all’oggi i fanatici del «partito personale». Tra presidenzialismo, antipolitica e dintorni. Eredi inconsapevoli o cinici. Che rimuovono un dato: quella di Rousseau era pur sempre una democrazia civica ed egualitaria, all’alba della democrazia, con tutta la carica selvaggia del grido lancinante contro l’ingiustizia. In conclusione perciò, tanti auguri Jean-Jacques! Non hai colpa per come ti hanno usato: contro te stesso. Perciò, onde evitare malintesi, di destra o di sinistra, promettiamo di difenderti. Ma anche di maneggiarti con cura.
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. ---- I maestri dalla penna nera. Quando la stampa italiana si convertì al fascismo (di Simonetta Fiori)29 febbraio 2012, di Federico La Sala
I maestri dalla penna nera
Quando la stampa italiana si convertì al fascismo
- Un saggio raccoglie quel che nomi e firme celebri, da Piovene ad Alvaro, scrissero sui giornali prima del 1943 Il lavoro è stato fatto da un giovane storico che ha utilizzato documenti e testi sulle orme di Zangrandi e Forcella Molti di loro, dopo la caduta del regime, ebbero una parte importante nel dare un’immagine indulgente dell’epoca
di Simonetta Fiori (la Repubblica, 29-02-2012)
Esce da Carocci un saggio che per la prima volta approfondisce il rapporto tra giornalisti italiani e regime fascista, e la loro transizione al postfascismo, rovesciando la memorialistica autoassolutoria di quei padri nobili. Un volume serio e documentato che senza accenti scandalistici ci mostra quanta parte ebbero le grandi firme nella "defascistizzazione del fascismo", ossia nella rappresentazione banalizzante e indulgente del ventennio nero finalizzata ad annacquare non solo il carattere della dittatura ma anche le responsabilità dei nuovi professionisti delle comunicazioni di massa. L’autore di Giornalisti di regime (pagg. 278, euro 23) è un giovane allievo di Emilio Gentile, Pierluigi Allotti, che sulle tracce di Ruggero Zangrandi e soprattutto di Enzo Forcella ci fornisce una fotografia dei nostri avi che non è una campionatura luminosa di figure epiche ma il conturbante ritratto d’una categoria pronta a mettere il proprio talento al servizio di Mussolini, per distaccarsene solo davanti all’esito catastrofico della guerra. Prìncipi della penna fulminei nell’indossare la camicia nera, ma nel dopoguerra operosi e indenni sulle prime pagine della stampa indipendente. Per raccontarci come il fascismo fosse stato un regime da operetta.
Attori principali di questo saggio sono i giornalisti di due generazioni, quella dei nati intorno al 1890 e la classe del 1910, ossia la leva dei "padri" e dei "fratelli maggiori" che scelsero di continuare a primeggiare sui giornali - oppure di esordire nel mestiere - nel pieno del fascismo. Giornalisti, dunque, che avevano l’età e gli strumenti per comprendere la natura illiberale del regime in cui vollero - e seppero - diventare firme da prima pagina. Nel primo gruppo sfilano personalità come Mario Missiroli e Giovanni Ansaldo, Paolo Monelli e Augusto Guerriero. Nel secondo ci imbattiamo nelle penne di Vittorio Gorresio e Indro Montanelli, Guido Piovene e Luigi Barzini junior, Vitaliano Brancati e Dino Buzzati. Mancano in questa ricognizione sulla carta stampata dell’epoca - e può sorprendere - i nomi di Mario Pannunzio ed Arrigo Benedetti, esclusi da Allotti perché artefici di settimanali e non "opinion makers" dei grandi quotidiani. Scelta un po’ arbitraria perché anche rotocalchi come Oggi contribuirono a fare opinione. E fu per anticonformismo che Mussolini ne decretò la morte nel gennaio del 1942.
L’inclusione di Oggi ed anche di altre testate avrebbe fatto fare miglior figura alla famiglia del giornalismo italiano. Una brigata di talentuosi che - salvo alcune eccezioni, da Mario Borsa a Luigi Albertini, da Alfredo Frassati ad Alberto Bergamini e Mario Vinciguerra - di fronte all’avanzata del fascismo «quasi si compiacque di perdere la propria indipendenza», come sintetizza Aldo Valori, all’epoca capo della redazione romana del Corriere della Sera. In qualche caso il cambio di bandiera fu clamoroso. Corrado Alvaro, firmatario del manifesto di Croce, avrebbe celebrato la bonifica dell’Agro Pontino «come un simbolo della rigenerazione nazionale promossa dal fascismo». E il critico Emilio Cecchi, anche lui partito da posizioni antifasciste, durante la campagna razziale tra l’estate e l’autunno del 1938, scrisse sul Corriere una serie di articoli dagli Stati Uniti per dimostrare come "razzismo" e "antisemitismo" fossero giustificatamente presenti nella società americana.
Quella contro gli ebrei fu una delle pagine in cui il giornalismo italiano - e la quasi totalità dell’élite intellettuale - diede il peggio di sé. Giovanni Ansaldo, nell’autunno del 1938, produsse veementi articoli contro "l’ebreo Morghentau" (Segretario al Tesoro degli Stati Uniti), accusato di aver ereditato "la cupidigia esosa di generazioni di strozzini". E Mario Missiroli, il "grande mago del giornalismo italiano", accolse con grandi plausi sul Messaggero la bibbia dell’antisemitismo Contra Judaeos di Telesio Interlandi, spalleggiato dal concorrente Guido Piovene che sul Corriere della Sera tesse le lodi dell’orribile summa, riconoscendole il merito di essere "il miglior libro uscito sull’argomento". Anche un inviato leggendario quale Paolo Monelli - stimato dai colleghi per cultura e rigore - nella primavera del 1939 si distinse per una corrispondenza da Varsavia impregnata di giudizi antiebraici. Singolare cedimento per un giornalista che in precedenza aveva dato mostra di non condividere la campagna antisemita. Ma il terreno in cui "i militi della carta stampata" - così li celebrava il duce - poterono agitare il turibolo con maggiore plasticità furono le imprese belliche del fascismo. Prima in Etiopia, poi in Spagna, più tardi nel Mediterraneo, nei Balcani e in Africa settentrionale, infine in Russia. I protagonisti di queste guerre furono i giornalisti arruolati nei vari reparti.
Nel 1935 partirono volontari due direttori, Aldo Borelli del Corriere della Sera e Francesco Malgeri del Messaggero. Gli inviati Barzini junior e Alfio Russo celebrarono in ampie corrispondenze le prime brillaPer creare dei paragrafi separati, lascia semplicemente delle linee vuote) nti vittorie degli italiani, ritratti come "virtuosi colonizzatori" di un popolo sostanzialmente troglodita. L’arte dell’epinicio fu affinata in Spagna, dove i giornalisti - in mancanza di pagine gloriose da raccontare - venivano sollecitati a esercitare la propria fantasia.
Se l’inviato del Corriere Achille Benedetti si limita a ignorare la sconfitta di Guadalajara, Barzini senjor sul Popolo d’Italia fa molto di più, incensando la drammatica avventura dell’eroico legionario che resiste al contrattacco nemico nascondendosi per tre giorni in una botte. L’inventiva di Barzini, nutrita di letture classiche, procura un attacco di allergia al direttore del Corriere, che mortifica il suo cronista facendogli recapitare sul fronte "il bellissimo scritto" della concorrenza. Ma nel descrivere i nemici repubblicani come "combattenti pavidi", "capaci delle peggiori brutalità", si distinsero altre due firme, quelle di Indro Montanelli e Guido Piovene, assai efficaci nell’esaltare le imprese dei legionari italiani contro autentici "criminali dalle facce bestiali". Seppure con qualche insofferenza, l’intonazione non muterà nel corso del secondo conflitto mondiale.
La parte più interessante del saggio riguarda ciò che accadde all’indomani del crollo del regime fascista, nell’estate ti indica del 1943. Con la medesima disinvoltura con cui era traslocata dall’antifascismo al fascismo, l’élite giornalistica italiana cominciò a fare il percorso inverso. All’esame di coscienza si preferisce la scorciatoia della colpa collettiva. Allotcome esemplare il caso di Monelli. Per le sue compromissioni con il regime, il nuovo direttore del Corriere della Sera Ettore Janni, subentrato dopo il 25 luglio, gli chiede con garbo una temporanea sospensione nella collaborazione. Monelli non la prende bene. «E i colleghi che hanno divinizzato uomini e fatti del regime? E i redattori ligi agli ordini di Roma che bocciavano o castravano o lardellavano di aggettivi le mie corrispondenze?». Le sue responsabilità, rispetto al servilismo diffuso, gli paiono poca cosa. Lo stesso genere di argomenti ricorre nell’autodifesa di tante firme illustri. Un’autoassoluzione granitica, che non ammette crepe.
Molti di loro avrebbero presto riconquistato le prime pagine della stampa libera, confluendo in larga parte in una zona politica di moderatismo prossima alla Democrazia Cristiana. E poi la memorialistica. Da Piovene a Montanelli, definito "il giornalista che più contribuì alla defascistizzazione del fascismo", fu tutt’un proliferare di testimonianze indulgenti che fecero calare il sipario sulle compromissioni di "padri" e "fratelli maggiori". La rimozione è destinata a segnare parte delle generazioni successive, quella viziata da "una concezione del potere politico" - lo rilevò Forcella - come qualcosa di "ineluttabile" e "pericoloso", verso il quale è consigliabile la remissività. Una distorsione che - se colpisce ma è interpretabile sotto una dittatura - in democrazia appare ancora meno tollerabile.
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. L’Italia come volontà e come rappresentazione di un solo Partito. Il "popolo della libertà" è nato: "Forza Italia"!!! Materiali per un convegno prossimo futuro - a cura di Federico La Sala20 gennaio 2012, di Federico La Sala
Schmitt, l’elogio dell’applauso La «teoria dell’acclamazione» nazista contro la democrazia borghese
di Giuseppe Bedeschi (Corriere della Sera, 14.01.2012)
A Norimberga Carl Schmitt venne processato per il suo passato nazista: infatti, benché fosse caduto in disgrazia nel 1936 (a causa di un duro attacco sferratogli dalla rivista delle SS che gli rinfacciava la sua collaborazione con von Papen nel 1932), egli era stato una delle personalità culturali più prestigiose che avevano aderito al regime hitleriano. Era stato presidente dell’associazione dei giuristi nazionalsocialisti; aveva avallato con la sua autorità imprese efferate, come la «notte dei lunghi coltelli» del 30 giugno 1934 («l’azione del Führer - affermò allora - è stata un atto di autentica giurisdizione. Essa non sottostà alla giustizia, ma è essa stessa giustizia suprema»). Dal tribunale di Norimberga Schmitt venne prosciolto, ma fu dichiarato «persona non grata» nell’ambito delle istituzioni accademiche.
E tuttavia, benché messo al bando per il suo passato nazista, Schmitt continuò a esercitare un fascino notevole su personalità eminenti della cultura europea. Basti pensare a Raymond Aron - che stava certo agli antipodi, sia sul piano dottrinale sia su quello politico, del pensatore tedesco - il quale in una pagina delle sue Memorie (1983) ricordò di averlo conosciuto personalmente, di avere intrattenuto con lui rapporti epistolari, e poi ne diede questa ammirata caratterizzazione: «All’epoca della repubblica di Weimar Carl Schmitt era stato un giurista di eccezionale talento, riconosciuto da tutti.
Appartiene tuttora alla grande scuola dei sapienti tedeschi, che vanno oltre la propria specializzazione, abbracciano tutti i problemi della società e della politica e possono definirsi filosofi, come, a suo modo, lo fu Max Weber». Aron aggiunse che «uomo di alta cultura, Schmitt non poteva essere un hitleriano e non lo fu mai». Affermazione certo azzardata, questa di Aron, eppure in un certo senso vera, in quanto il filosofo tedesco aveva maturato il proprio pensiero molto prima che il nazionalsocialismo conquistasse il potere in Germania. Ma è altrettanto vero che la sua adesione al partito di Hitler, lungi dall’essere opportunistica (come alcuni hanno sostenuto), era pienamente coerente coi motivi più profondi della sua riflessione.
Tale riflessione era maturata nella repubblica di Weimar, travagliata dalle discordie dei partiti, dall’aspro contrasto degli interessi, dalle spinte centrifughe, dalle minacce rivoluzionarie e «golpiste» (nel 1919 ci fu un tentativo di rivoluzione comunista, represso nel sangue; nel 1920 il Putsch di destra di Kapp, nel 1923 il fallito tentativo di colpo di Stato di Hitler).
A questa situazione di sfacelo, tremendamente aggravata dalla crisi economica, che minacciava l’esistenza della nazione tedesca, Schmitt opponeva il suo concetto di popolo inteso come comunità coesa e organica (Gemeinschaft), che deve unificare completamente gli individui, e che è la base della «vera» democrazia. La quale non può essere confusa con la democrazia liberale, e con quella sua espressione caratteristica che è il parlamentarismo. Il liberalismo infatti si fonda, secondo Schmitt, sull’individuo isolato, sul privato egoista, dedito solo ai propri interessi. Ciò si vede anche, egli dice, nella procedura elettorale introdotta dal liberalismo, in cui il singolo esprime il proprio voto in una cabina, in una situazione di segretezza e di completo isolamento: sicché, proprio nel momento in cui si chiede al privato di diventare cittadino e di esercitare, col voto, una funzione pubblica, lo si relega nel suo ruolo di privato, di «borghese». (Questa critica ha avuto molta fortuna a sinistra: essa ritorna, nella sostanza, nella Critique de la raison dialectique di Sartre). Il risultato di tutto ciò è una maggioranza «puramente aritmetica», cioè nulla di coerente e nulla di stabile.
La vera democrazia, per Schmitt, è tutt’altro. Essa deve essere espressione autentica della volontà del popolo, la quale si manifesta nel modo più alto attraverso l’«acclamazione». «La forma naturale dell’immediata espressione del volere di un popolo - egli dice - è la voce che consente o che rifiuta della folla riunita, l’acclamazione». Attraverso il proprio «grido» (Zuruf) il popolo approva o disapprova, acclama un Führer, si identifica con lui. Grazie a questa investitura popolare del Führer, il regime nazionalsocialista era una vera democrazia, in quanto poggiava sulla sostanza del popolo tedesco, sulla unità della sua stirpe.
Un altro importante filone della riflessione filosofica di Schmitt è stato quello della «teologia politica»: un’espressione con la quale il filosofo tedesco intendeva dire che per un verso i concetti politici derivano da quelli teologici, e per un altro verso presentano una analogia strutturale con essi. «Tutti i concetti più pregnanti della moderna dottrina dello Stato sono concetti teologici secolarizzati. Non solo in base al loro sviluppo storico, poiché essi sono passati alla dottrina dello Stato dalla teologia, come ad esempio il Dio onnipotente che è divenuto l’onnipotente legislatore, ma anche nella loro struttura sistematica, la cui conoscenza è necessaria per una considerazione sociologica di questi concetti.
Lo stato di eccezione ha per la giurisprudenza un significato analogo al miracolo per la teologia. Solo con la consapevolezza di questa situazione di analogia si può comprendere lo sviluppo subito dalle idee della filosofia dello Stato negli ultimi secoli». A questa idea schmittiana di «secolarizzazione» sono state mosse molte critiche. Hans Blumenberg ha obiettato che essa delegittima la modernità, e quindi non è in grado di capire lo sforzo di autofondazione che è proprio della politica moderna.
Esce ora in edizione italiana, presso Laterza, un libro che raccoglie tutta la discussione fra Blumenberg e Schmitt (L’enigma della modernità. Epistolario 1971-1978 e altri materiali, pagine 227, 20): una discussione profonda, in cui due grandi personalità, con una storia filosofica e politica completamente diversa l’una dall’altra, si misurano, con tolleranza e al tempo stesso con tormentata passione, sul futuro spirituale dell’Europa e, più in generale, del mondo moderno.
Berlusconi, il volto e il vuoto
di GIANNI BAGET BOZZO (La Stampa, 26/7/2008).
Dal ‘94 ad oggi le elezioni politiche, e persino quelle regionali e locali, sono state vissute come un referendum pro o contro Berlusconi. Il volto di una persona è diventato il messaggio: un fatto singolare nella democrazia, che ha indotto a spiegare Berlusconi come il frutto di un potere personale, delle sue proprietà televisive, del suo carattere di comunicatore e imbonitore. Il voto sulla persona è stato vissuto dai partiti come un sequestro della democrazia storicamente legata ai partiti e quindi, per questo, illegittimo.
Nel 2008 le cose sono andate diversamente. Il partito democratico ha posto fine all’esperienza Prodi e ha proposto il suo messaggio in termini di cooperazione politica con il centrodestra. Le elezioni hanno determinato la sconfitta del Pd e la scomparsa della sinistra antagonista. E’ caduta la forza politica alternativa a Berlusconi ed egli è diventato, come persona, il titolare della legittimità politica senza alternative: una situazione che ricorda quella della Dc dopo le elezioni del ‘48. Perché tanto consenso attorno a un volto, un consenso che non ha mai investito l’insieme dei partiti di centrodestra in quanto tale, ma è rimasto legato alla persona, inscindibile da essa?
Questo crea un problema politico obiettivo perché non può essere una soluzione ma chiede una spiegazione: perché Berlusconi è diventato il volto della politica italiana.
Ciò indica che alla base di questo vi è un problema di Stato e non di governo. Un uomo solo riguarda il caso di emergenza, non una soluzione stabile. L’elettorato del centrodestra è nato da una crisi di Stato e non da questione di scelta politica, è nato da una crisi del consenso attorno alla Costituzione del ‘48 e allo Stato che su di essa si fondava. La crisi del consenso costituzionale si manifesta nel ‘92-‘93 con due eventi: l’autoscioglimento dei partiti democratici occidentali che avevano guidato la democrazia italiana di fronte al comunismo e il sorgere di un problema indipendentista del nord espresso da Bossi.
Ciò ha alterato il consenso attorno allo Stato, perché era impossibile far decadere il partito cattolico, il partito socialista e il partito liberale, che avevano retto la storia della democrazia italiana del Novecento e porre il Pds come chiave della legittimità politica.
La Costituzione del ‘48 supponeva il consenso dei partiti antifascisti che ne erano mallevadori, la sua costituzione materiale. La loro pluralità e differenza era la base della legittimità politica della Costituzione. Il documento stesso era un compromesso politico: e supponeva che i partiti fondatori, nella loro diversità, rimanessero la base politica dello Stato. La riduzione al solo Pds dei partiti antifascisti creava un vuoto politico, non sul piano del governo, ma sul piano dello Stato, cioè sul piano dell’accettazione della Costituzione come base politica della Repubblica.
A ciò si aggiunge il fatto che l’indipendentismo padano (che aveva allora figura etnica e si richiamava alla tradizione celtica del nord Italia come base di una differenza radicale) metteva in crisi l’impianto del sistema politico italiano fondato sulla centralità della questione meridionale. Poteva un partito rispondere a un tale stato di eccezione politica, quando tutte le tradizioni politiche diverse da quella comunista erano dissolte e vi era un vuoto obbiettivo, un vuoto che corrispondeva alla sfida indipendentista del Nord?
Ci voleva un volto, perché non c’erano più i partiti. Perché questo sia stato quello di Berlusconi non si può spiegare, esso è un fatto e non vi è dubbio che ciò corrisponde a un carisma politico, a una capacità di interpretare il popolo oltre i partiti. Berlusconi fu un evento straordinario, non prevedibile e quindi non facilmente giustificabile. Non entrava nella logica della politica e si pensava che non entrasse nelle regole della democrazia. Invece la tesi di Berlusconi fu quella di rappresentare la sovranità popolare e il suo potere costituente di un ordine politico diverso da quello dei partiti antifascisti ormai distrutto.
Solo il volto di un uomo poteva coprire il vuoto politico delle istituzioni. E ciò avvenne mediante l’alleanza con la Lega Nord e con l’Msi si creando così un’alternativa alla sinistra che non era mai esistita prima e che era assai diversa dalla Democrazia cristiana e dal Partito socialista.
Berlusconi ha rappresentato questo ruolo evitando ogni carattere salvifico persino autorevole, ha messo in luce la sua persona, non il suo carisma, lo ha fatto nelle sue debolezze, persino femminili, presentandosi come l’italiano medio, come rappresentante e non come salvatore. Il fatto di difendere la sua proprietà televisiva non gli ha nuociuto: anzi ha mostrato che egli era un potere della società e che poteva quindi bilanciare poteri istituzionali proprio perché aveva roba. Ciò che venne sentito come un difetto dai suoi oppositori, venne sentito come un vantaggio da parte del suo popolo.
Don Giuseppe Dossetti disse che, con la Costituzione del ‘48, il popolo italiano aveva abbandonato il suo potere costituente, Berlusconi mostrò che non era così e si pose come alternativa alla Costituzione del ‘48, entrando in conflitto con tutti i poteri di garanzia dal Quirinale, alla Corte Costituzionale, al Csm. Toccò così un difetto essenziale della Costituzione del ‘48: quello di fondare i poteri di garanzia e non quelli di governo.
Sovranità popolare contro Costituzione rigida: questa è l’essenza del dilemma berlusconiano che otterrebbe la sua perfezione se si rivedesse l’art. 138 e si riconoscesse che il popolo ha un potere costituente che né i partiti e né gli organi di garanzia istituzionale possono espropriare.
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- ITALIA, 2012: IL COSENTINO DI NAPOLI, IL COSENTINO DEL PARLAMENTO, E IL PATTO SCELLERATO13 gennaio 2012, di Federico La Sala
 FEDELTA’ ALLA REPUBBLICA E ALLA COSTITUZIONE. In Parlamento un solo partito e un solo urlo: "Forza Italia"!!! Viva il "Popolo della libertà"!!!
FEDELTA’ ALLA REPUBBLICA E ALLA COSTITUZIONE. In Parlamento un solo partito e un solo urlo: "Forza Italia"!!! Viva il "Popolo della libertà"!!!
 ITALIA, 2012: IL COSENTINO DI NAPOLI, IL COSENTINO DEL PARLAMENTO, E IL PATTO SCELLERATO. Una nota di Furio Colombo e l’ IO SO di Roberto Saviano
ITALIA, 2012: IL COSENTINO DI NAPOLI, IL COSENTINO DEL PARLAMENTO, E IL PATTO SCELLERATO. Una nota di Furio Colombo e l’ IO SO di Roberto Saviano
 Roberto Saviano:Onorevole Cosentino, lei per me è colpevole di cose che vanno al di là della fedina penale "(...) lei, Onorevole Cosentino, rappresenta la storia di Forza Italia in Campania e la storia del Pdl. E lei può raccontare, qualora si sentisse tradito dai suoi sodali, molto sulla gestione dei rifiuti, e sulle assegnazioni degli appalti in Campania (...)".
Roberto Saviano:Onorevole Cosentino, lei per me è colpevole di cose che vanno al di là della fedina penale "(...) lei, Onorevole Cosentino, rappresenta la storia di Forza Italia in Campania e la storia del Pdl. E lei può raccontare, qualora si sentisse tradito dai suoi sodali, molto sulla gestione dei rifiuti, e sulle assegnazioni degli appalti in Campania (...)".
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. ---- GIURAMENTO DEL GOVERNO MONTI E SORPRESA DI STEFANO RODOTA’. Avevano un suono diverso le parole pronunciate dal presidente del Consiglio e dai ministri del nuovo governo nel momento in cui giuravano di osservare "lealmente" Costituzione.21 novembre 2011, di Federico La Sala
La Costituzione, unica bussola
di Stefano Rodotà (la Repubblica, 21.11.2011)
Avevano un suono diverso le parole pronunciate dal presidente del Consiglio e dai ministri del nuovo governo nel momento in cui giuravano di osservare "lealmente" Costituzione e leggi e di esercitare le loro funzioni nell’interesse "esclusivo" della Nazione. La formula apparentemente burocratica del giuramento rivelava un’assenza: la mancanza negli ultimi anni d’ogni lealtà governativa verso una Costituzione continuamente dileggiata e aggredita, l’abbandono dall’interesse esclusivo della Nazione a vantaggio di una folla di interessi privati e persino inconfessabili. Quelle parole scomparse e tradite sono ritornate nel momento in cui davanti al nuovo governo non è soltanto il compito assai difficile di affrontare i temi dell’economia riprendendo pure il cammino dell’equità e dell’eguaglianza, senza le quali la coesione sociale è perduta. L’insistita sottolineatura del nuovo stile di Mario Monti all’insegna di "sobrietà" e "serietà" non riguarda, infatti, segni esteriori. Ricorda un altro compito, forse persino più difficile e certamente bisognoso di molto impegno e di molto tempo, quello di far uscire il nostro Paese dalla regressione culturale e civile nella quale è sprofondato.
È questione che non si affida tanto a provvedimenti formali. Accontentiamoci, per il momento, d’una prima, non indifferente certezza. Il sapere che non vi saranno ministri della Repubblica che, di fronte alla domanda di un giornalista o di un cittadino, leveranno in alto il dito medio o risponderanno con una pernacchia (non il nobile e difficile "pernacchio" di Eduardo). Rispetto e lealtà non sono dovuti soltanto a Costituzione e leggi, ma a tutti coloro che nel mondo reale incarnano valori e principi che lì sono iscritti. In questi anni abbiamo assistito proprio al rifiuto dell’"altro", l’avversario politico o l’immigrato, lo zingaro o la persona omosessuale. L’indegna gazzarra scatenata alla Camera dai deputati della Lega contro la civilissima richiesta di avviare il riconoscimento degli immigrati come cittadini, e non come merce usa e getta, è stata la conferma evidente della difficoltà di invertire una tendenza che, mai contrastata efficacemente per convenienza politica e debolezza culturale, ha terribilmente inquinato l’ambiente civile.
Sarà la minuta sequenza degli atti concreti a dare sostanza all’abbandono di un perverso costume. Al governo spettano nomine importanti, sottosegretari e Rai per cominciare. Il rispetto della Costituzione, inoltre, muove dal rispetto degli istituti che la innervano, a cominciare dal referendum che ha ridato ai cittadini la possibilità di far sentire la loro voce, spenta da una legge elettorale indegna e venata da incostituzionalità. Proprio dal voto sui referendum di giugno vengono tre indicazioni che il governo non può in alcun modo eludere: il no al nucleare (lo ricordi qualche ministro che non deve avere bene appreso la lezione di sobrietà e umiltà invocata dal presidente del Consiglio); il rifiuto di ogni legislazione attributiva di privilegi; il nuovo ruolo attribuito ai beni comuni, all’acqua direttamente (non si segua il cattivo esempio delle furbizie nelle quali il governo precedente si stava esercitando). Se il governo vuole conservare la fiducia manifestata da una larga parte dell’opinione pubblica, e cercar di recuperare critici e scettici, deve essere consapevole che proprio questi sono i casi in cui massima dev’essere la sua lealtà verso la Costituzione. È bene aggiungere che, considerando i vari movimenti e indignati che occupano le piazze del mondo, in Italia il risveglio civile non solo si era manifestato prima che in altri Paesi, ma aveva trovato un fiducioso incontro con le istituzioni tramite i referendum. Sarebbe un grave errore politico mettere questa vicenda tra parentesi, poiché proprio da lì è cominciato quel rinnovamento che ha trovato nel governo Monti un suo approdo, sia pure controverso.
Come tutto questo incrocerà i sentieri parlamentari è questione tra le più aperte. A proposito della quale, tuttavia, è bene insistere su una banale verità, del tutto travisata da chi, gridando alla fine della democrazia, ha lamentato un ruolo marginale del Parlamento in una crisi tutta gestita tra presidente della Repubblica e presidente del Consiglio incaricato. Ma abbiamo già dimenticato o cancellato il fatto istituzionale più clamoroso di questi ultimi anni, appunto la scomparsa del Parlamento, dileggiato da Silvio Berlusconi come luogo di inutili e incomprensibili lungaggini, espropriato d’ogni potere dai voti di fiducia e dai maxiemendamenti blindati, ridotto a mercato quando v’erano da reclutare truppe mercenarie, rattrappito nei suoi lavori in un paio di giorni a settimana, addirittura chiuso per mancanza di questioni rilevanti da mettere all’ordine del giorno? Uno degli esiti, o paradossi, di questa crisi sta proprio nell’aver rimesso al centro dell’attenzione pubblica e della politica proprio il Parlamento, ricordando così, come molte volte aveva già fatto il presidente della Repubblica, che la nostra rimane una Repubblica parlamentare ed è lì che i governi ricevono investitura e legittimità.
Sul rapporto tra governo e Parlamento si è insistito molto in questi giorni, discutendo soprattutto della possibilità che qualcuno voglia prima o poi "staccare la spina", di possibili maggioranze variabili nell’approvare singoli provvedimenti. Ma vi è un altro aspetto del problema, particolarmente rilevante nella prospettiva ricordata all’inizio della "bonifica" politica e civile del nostro sistema istituzionale e della nostra società. Qualcuno, nel dibattito parlamentare, ha avuto l’impudenza di invocare la ripresa del cammino parlamentare del disegno di legge sulle intercettazioni. Qualcun altro ha adombrato i temi della difesa della vita, con un trasparente richiamo al disegno di legge sulle dichiarazioni anticipate di trattamento (testamento biologico) attualmente in discussione al Senato, e dopo che s’era verificato il grave episodio di un governo che, in articulo mortis, aveva diffuso le nuove linee guida in materia di procreazione assistita. L’insistenza su questi temi rivela un intento strumentale, volto anche a creare frizioni parlamentari che possono insidiare la tenuta del governo. Ma, se appare davvero improbabile un rinnovato assalto a favore di una legge bavaglio, più serie preoccupazioni destano i temi legati alla bioetica e al biodiritto.
Per proteggere il governo, non si tratta di invocare una "tregua etica" o rivendicare l’autonomia del Parlamento in materie non comprese nel programma governativo, magari facendosi forti di qualche improvvida dichiarazione che ha associato la costituzione di questo governo con il "ritorno" dei cattolici in politica. Se alla lealtà verso la Costituzione dobbiamo continuare a rifarci, è appunto il percorso costituzionale che deve essere rigorosamente seguito tanto dal governo che dal Parlamento. E questo significa mettere da parte il testo sulle dichiarazioni anticipate di trattamento, grondante di incostituzionalità, sgrammaticature e difficoltà applicative in ogni suo articolo. Significa riprendere il cammino verso una seria disciplina delle unioni di fatto, comprese quelle tra persone omosessuali, alle quali la Corte costituzionale ha riconosciuto un "diritto fondamentale" al riconoscimento giuridico della loro condizione, indicazione finora del tutto disattesa dal Parlamento. Significa riportare a ragione e Costituzione la materia della procreazione assistita.
Per non rimanere prigionieri dell’emergenza che ha segnato la nascita di questo governo, e per sfuggire alle perversioni che questa può produrre, bisogna imboccare senza esitazioni la via di una politica che sia tutta politica "costituzionale".
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- È certo che anche se Berlusconi andasse via, per molto tempo rimarrà tra noi come categoria dello spirito (di Francesco Merlo - Quei pozzi avvelenati, dalla giustizia alla Rai).13 novembre 2011, di Federico La Sala
Quei pozzi avvelenati, dalla giustizia alla Rai
di Francesco Merlo (la Repubblica, 13.11.2011)
È certo che anche se Berlusconi andasse via, per molto tempo rimarrà tra noi come categoria dello spirito. Durante questo ventennio ha terremotato l’apparato statale infilandovi dentro la Lega antistatale e secessionista. Dalle abitudini al linguaggio, ha "smontato" lo Stato È la normalità, la tanto attesa normalità, che ha reso storica la lunga giornata di ieri anche se ci vorrebbe un governo Monti delle anime e dei sentimenti e dei valori per liberare l’Italia dal berlusconismo. Nessuno dunque si illuda che sia davvero scaduto il tempo. Certo, alla Camera lo hanno giubilato, gli hanno fatto un applauso da sipario: è così che si chiude e si dimentica, con l’applauso più forte e più fragoroso che è sempre il definitivo.
Poi Napolitano è riuscito a dare solennità anche all’addio di Berlusconi che sino all’altro ieri si era comportato da genio dell’impunità inventando le dimissioni a rate. Che lui nascondesse una fregatura sotto forma di sorpresa è stato il brivido di ieri, e difatti, inconsapevolmente, nessuno si è lasciato troppo andare e la festa, sino all’annuncio ufficiale delle dimissioni, più che sobria è stata cauta. Di sicuro Berlusconi non ha avuto il lieto fine. Entrato in scena cantando My Way ne è uscito con lo Zarathustra che premia "il folgorante destino di chi tramonta".
Dunque non c’è stato il 25 luglio, non la fuga dei Savoia né la fine della Dc, né tanto meno la tragedia craxiana, nessuno ha mangiato mortadella in Parlamento come avvenne quando cadde Prodi, non c’è stato neppure l’addio ai monti di Renzo anche se nessuno sa cosa farà Berlusconi, se rimarrà in Italia o invece andrà in uno dei degli ospedali che dice di avere regalato nei luoghi del Terzo Mondo. Tutti parlano, probabilmente a vanvera, di una trattativa parallela e coperta sui processi, di un salvacondotto e di un’amnistia che non hanno mai riguardato in Italia reati come la corruzione e lo sfruttamento della prostituzione. In un Paese normale la rimozione di un capo non produce mai sconquassi e siamo sicuri che il pedaggio che paghiamo alla normalità non sarà l’enorme anormalità di un pasticcio giuridico.
È comunque certo che, anche se Berlusconi si rifugiasse ad Antigua, per molto tempo rimarrà tra noi come categoria dello spirito. Ecco perché ci vorrebbe una banca centrale della civiltà per commissariare il Paese dove Berlusconi "ha tolto l’aureola a tutte le attività fino a quel momento rispettate e piamente considerate. Ha trasformato il medico, il giurista, il prete, il poeta, l’uomo di scienza in salariati da lui dipendenti".
Dunque neppure nello storico giorno in cui è stato accompagnato fuori con il suo grumo di rancore invincibile e lo sguardo per sempre livido, è stato possibile accorarsi e simpatizzare. Non c’è da intonare il requiem di Mozart o di Brahms per l’uomo più ricco d’Italia che ha comprato metà del Parlamento e ha ordinato di approvare almeno 25 leggi ad personam. E ha terremotato lo Stato infilandovi dentro la Lega antistatale e secessionista. E mentre i suoi ministri leghisti attaccavano la bandiera e l’unità dello Stato, Berlusconi organizzava la piazza contro i tribunali di Stato, la Corte costituzionale, il capo dello Stato. Anche il federalismo non ha preso, come negli Usa e in Germania, la forma dello Stato ma dell’attacco al cuore dello Stato. Avevamo avuto di tutto nella storia: mai lo statista che lavorava per demolire lo Stato. Quanto tempo ci vorrà per rilegittimare i servitori dello Stato, dai magistrati ai partiti politici, dagli insegnanti ai bidelli ai poliziotti senza soldi e con le volanti a secco?
E quante generazioni ci vorranno per restituire un po’ di valore all’università, alla scuola e alla cultura che Berlusconi ha depresso e umiliato: contro i maestri, contro gli insegnanti, contro tutti i dipendenti pubblici considerati la base elettorale del centrosinistra, e contro la scuola pubblica, contro il liceo classico visto come fucina di comunisti. E ha degradato la più grande casa editrice del Paese a strumento di propaganda (escono in questi giorni i saggi di Alfano, Sacconi, Bondi, Lupi....). Ha corrotto una grande quantità di giornalisti come mai era avvenuto. Ha definitivamente distrutto la Rai affidata ad una gang di male intenzionati che hanno manipolato, cacciato via i dissidenti, lavorando in combutta con i concorrenti di Mediaset. E con i suoi giornali e le sue televisioni ha sfigurato il giornalismo di destra che aveva avuto campioni del calibro di Longanesi e Montanelli. Con lui la faziosità militante è diventata macchina del fango. Testate storiche sono state ridotte a rotocalchi agiografici. E ha smoderato i moderati, ha liberato i mascalzoni dando dignità allo spavaldo malandrino, ai Previti e ai Verdini, ai pregiudicati, e c’è un po’ di Lavitola, di Lele Mora e di Tarantini in tutti quelli che gli stanno intorno, anche se ora li chiama traditori.
Berlusconi, che fu il primo a circondarsi di creativi, di geniacci come Freccero e Gori ha umiliato la modernità dei nuovi mestieri, della sua stessa comitiva, l’idea di squadra che all’esordio schierava a simbolo Lucio Colletti e alla fine ha schierato a capibranco Tarantini, Ponzellini, Anemone, Bisgnani, Papa, Scajola, Bertolaso, Dell’Utri, Verdini, Romani, Cosentino. Eroi dei giornali di destra sono stati Igor Marini e Pio Pompa. I campioni dell’informazione berlusconiana in tv sono Vespa, Fede e Minzolini. Persino il lessico è diventato molto più volgare, il berlusconismo ha introdotto nelle istituzioni lo slang lavitoilese, malavitoso e sbruffone. E’stato il governo del dito medio e del turpiloquio, è aumentato lo ’spread’tra la lingua italiana e la buona educazione.
E la corruzione è diventata sacco di Stato e basta pensare agli appalti per la ricostruzione dell’Aquila, assegnati tra le risate della cricca. Berlusconi ha dissolto "tutti i tradizionali e irrigiditi rapporti sociali, con il loro corollario di credenze e venerati pregiudizi. E tutto ciò che era solido e stabile è stato scosso, tutto ciò che era sacro è stato profanato". Persino la bestemmia è diventata simonia spicciola, ufficialmente perdonata dalla Chiesa in cambio di privilegi, scuole e mense. Toccò, nientemeno, a monsignor Rino Fisichella spiegare che, sì, la legge di Dio è legge di Dio, ma "in alcuni casi, occorre "contestualizzare" anche la bestemmia". E quanto ci vorrà per far dimenticare la diplomazia del cucù e delle corna, lo slittamento dal tradizionale atlantismo verso i paesi dell’ex Unione Sovietica, la speciale amicizia con i peggiori satrapi del mondo?
E mai c’era stata una classe dirigente maschile così in arretrato di femmina verrebbe da dire con il linguaggio dell’ex premier: femmina d’alcova, esibita e valutata come una giumenta, con il Tricolore sostituito con quella grottesca statuetta di Priapo in erezione che circolava - ricordate? - nelle notti di Arcore. Persino il mito maschile della donna perduta e nella quale perdersi, persino la malafemmina italiana è stata guastata da Berlusconi, ridotta a ragazza squillo della politica: l’utilitaria, il mutuo, seimila euro, l’appartamentino, un posto di deputato e forse di ministro per lucrare il compenso - "il regalino" - agli italiani.
Lo scandalo del berlusconismo non è stato comprare sesso in un mondo dove tutto è in vendita ma nel pagare con pezzi di Stato, nell’uso della prostituzione per formare il personale politico e selezionare la classe dirigente. E non è finita: se la prostituzione ha cambiato la politica, anche la politica ha cambiato la prostituzione. La Maddalena ha perso la densità morale che fu una forza della nostra civiltà, è diventata la scialba ragazzotta rifatta dal chirurgo ed educata dalla mamma-maitresse a darla via a tariffa.
Il berlusconismo è stato l’autobiografia della nazione per dirla con Croce, non un accidente della storia. Non basta certo una giornata solennemente normale per liberarcene. C’è bisogno di anni di giornate normali. E per la prima volta non saranno gli storici a mettere in ordine gli archivi di un’epoca. Ci vorranno gli antropologi per classificare il berlusconismo come involuzione della specie italiana, perché anche noi, che siamo stati contro, l’abbiamo avuto addosso: "Non temo il Berlusconi in sé - cantava Gaber - ma il Berlusconi in me".
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- BUONGIORNO BUONANOTTE (di Massimo Gramellini).12 novembre 2011, di Federico La Sala
Buongiorno Buonanotte
di Massimo Gramellini (La Stampa, 12 novembre 2011)
Oggi è il giorno che chiude un ventennio, uno dei tanti della nostra storia. E il pensiero va al momento in cui tutto cominciò. Era il 26 gennaio 1994, un mercoledì. Quando, alle cinque e mezzo del pomeriggio, il Tg4 di Emilio Fede trasmise in anteprima la videocassetta della Discesa In Campo. La mossa geniale fu di presentarsi alla Nazione non come un candidato agli esordi, ma come un presidente già in carica. La libreria finta, i fogli bianchi fra le mani (in realtà leggeva da un rullo), il collant sopra la cinepresa per scaldare l’immagine, la scrivania con gli argenti lucidati e le foto dei familiari girate a favore di telecamera, nemmeno un centimetro lasciato al caso o al buongusto.
E poi il discorso, limato fino alla nausea per ottenere un senso rassicurante di vuoto: «Crediamo in un’Italia più prospera e serena, più moderna ed efficiente... Vi dico che possiamo, vi dico che dobbiamo costruire insieme, per noi e per i nostri figli, un nuovo miracolo italiano». Era la televendita di un sogno a cui molti italiani hanno creduto in buona fede per mancanza di filtri critici o semplicemente di alternative. Allora nessuno poteva sapere che il set era stato allestito in un angolo del parco di Macherio, durante i lavori di ristrutturazione della villa. C’erano ruspe, sacchi di cemento e tanta polvere, intorno a quel sipario di cartone. Se la telecamera avesse allargato il campo, avrebbe inquadrato delle macerie.
Oggi è il giorno in cui il set viene smontato. Restano le macerie. La pausa pubblicitaria è finita. È tempo di costruire davvero
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. L’Italia come volontà e come rappresentazione di un solo Partito. --- Il Parlamento degli schiavi (di Furio Colombo)2 ottobre 2011, di Federico La Sala
Il Parlamento degli schiavi
di Furio Colombo (il Fatto, 02.10.2011)
L’Italia si è incastrata in una secca dalla quale non può uscire. Lo sguardo si abbassa fino a Berlusconi, per ricordare la sua grave e immensa responsabilità. Ma solo per ricordarla. Finora non siamo riusciti a fare altro. Lo sguardo si alza verso il Presidente della Repubblica con la richiesta, a momenti affannata, che “faccia qualcosa”, pur sapendo benissimo che la Costituzione (che non aveva previsto una maggioranza parlamentare a pagamento, voto per voto) non lo consente. Ci restano oggi, le sue parole dure contro la Lega padana, il piccolo-grande complice di Berlusconi. Lo sguardo irato e angosciato dei cittadini si è fissato allora sul Parlamento. È subito divampata una polemica carica di ragioni e di prove, su sprechi, privilegi e spese fuori misura. Tutti si devono rendere conto che è un problema (prima ancora, un fatto) che non potrà mai più essere accantonato. Eppure non è per questo che la macchina del Parlamento sta bloccando la nave Italia. Direte che il Parlamento è pigro e assenteista. Non è vero. Purtroppo sta lavorando. Tutto il suo lavoro è al servizio del governo e della sua pretesa rovinosa di restare governo, una sorta di ideologia rappresentata abbastanza bene, in una recente dichiarazione che potremmo chiamare “il Manifesto Lavitola” (diretta del Tg la7 la sera del 28 settembre) ovvero passare avanti e indietro, senza spiegazioni, grandi somme di danaro tra persone ricercate dalla giustizia. Il discredito è grande, come è grande il costo economico (praticamente incalcolabile) di quel discredito.
NEI GIORNI scorsi un importante giurista, Gustavo Zagrebelsky si è assunto il compito di dire perché il Parlamento, a cui spesso si fa riferimento come al luogo giusto per la vita democratica, sia adesso in Italia il luogo in cui ogni barlume di vita democratica si spegne, e anzi è il luogo e la ragione del blocco. Ecco il punto chiave del documento che Libertà e Giustizia presenterà a Milano il giorno 8 ottobre (già pubblicato dal Fatto il 30 settembre): “Un Parlamento che, di fronte a fatti sotto ogni punto di vista ingiustificabili, alla manifesta incapacità di condurre il Paese in spirito di concordia fuori dalla presente crisi economica e sociale, al discredito dell’Italia presso altre nazioni, non revoca la fiducia a questo governo mentre il Paese è in subbuglio e in sofferenza nelle sue parti più deboli, non è forse esso stesso la prova che il rapporto di rappresentanza si è spezzato? (...) Ci pare anche gravemente offensivo del comune senso del pudore politico accecarsi di fronte alla lampante verità dei fatti e trasformare il vero in falso e il falso in vero, gettando nel discredito le istituzioni parlamentari e, così, l’intera democrazia” . Ho citato questa dichiarazione estrema perché è la descrizione accurata di un giorno, ogni giorno, al Parlamento italiano. Per esempio , il giorno in cui la Camera dei Deputati ha votato a maggioranza, e con il sistema del “voto di fiducia” una circostanza falsa e palesemente tale, ovvero la dichiarazione del capo del Governo italiano di essere certo che una prostituta minorenne fermata in strada a Milano fosse la nipote del presidente egiziano Mubarak.
Un simile dileggio dell’istituzione dovrebbe portare rivolta in Parlamento, prima di tutto fra le file della maggioranza, se qualcuno dei suoi membri avesse un minimo di rispetto per se stessa o se stesso. Ma, soprattutto dovrebbe portare rivolta nel-l’opposizione. Possiamo continuare ad essere soci regolari e partecipi di un club che vuole tenacemente avere nei suoi ranghi Saverio Romano e i suoi legami mafiosi, lo proclama in modo solenne con un voto di fiducia a cui partecipa tutta la Lega Nord (benché non sia in gioco la tenuta del governo, ma il prestigio della Camera dei Deputati) e poi ci fa assistere all’abbraccio fra il rinviato a giudizio per concorso esterno al reato di mafia e il presidente del Consiglio italiano? Possiamo passare avanti, sia pure con amarezza, a lavorare per altri “provvedimenti” di questo governo-gang che attendono di essere votati (cosa che faremo con assiduità e cura, credendo che sia quello il nostro dovere e il legame con i cittadini)? Possiamo dedicarci a migliorare qua e là, con giudiziosi emendamenti in Commissione Giustizia, la nuova legge sulle intercettazioni che i nostri elettori chiamano, fin dall’inizio, “legge bavaglio”?
DOVE, DA CHI abbiamo imparato che un’opposizione segue comunque l’ordine dei lavori stabilito dal governo, e che il governo può sempre imporre la sua volontà alla maggioranza succube? In onore o in omaggio o in ubbidienza a chi o che cosa noi dovremmo concorrere nella responsabilità di svilire l’istituzione cardine della democrazia? L’appello di Zagrebelsky indica con esattezza il punto cruciale del confronto fra sottomissione e liberazione. Posso testimoniare che, dentro il Parlamento, è un punto di solitudine. È diffusa la credenza che un bravo parlamentare non si volta mai indietro a guardare i suoi elettori. Il bravo parlamentare sta al gioco, per quanto iniquo e devastante, un gioco totalmente manovrato da fuori del Parlamento e distruttivo per la Repubblica.
Possibile che si debba lavorare di buona lena insieme con Milanese, con Saverio Romano, con mafia e camorra, con massoneria e gruppi d’affari P3 e P4, con gli svariati e fantasiosi reati compiuti, e in via di compimento,del presidente del consiglio? L’appello di Zagrebelsky dice in modo esplicito e solenne, con la garanzia della persona e del giurista, che una spaccatura grave e profonda divide in modo irreparabile (finchè dura la causa) il Paese e i suoi attoniti cittadini dalla istituzione Parlamento. Chiedo con angoscia e rispetto ai mie colleghi della Camera dei Deputati: siamo sicuri che la cosa giusta sia continuare a “lavorare insieme”, tentando di migliorare, emendare e comunque partecipare a vita e avventure di chi ha infettato alla fonte tutto il lavoro e l’esistenza stessa del Parlamento?
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- L’EPOCA DEI CONSULENTI. In un dialogo uscito su "Alfabeta2" la questione della cultura piegata al servizio degli interessi politici5 ottobre 2011, di Federico La Sala
L’epoca dei consulenti
Zagrebelsky: Il rapporto col potere ha polverizzato gli intellettuali
 "Si abdica al proprio ruolo e così si finisce per condannarsi all’irrilevanza"
"Si abdica al proprio ruolo e così si finisce per condannarsi all’irrilevanza"
 "Il punto più basso è dare le proprie idee, le proprie parole, le proprie idee a chi ti paga"
"Il punto più basso è dare le proprie idee, le proprie parole, le proprie idee a chi ti paga"
 In un dialogo uscito su "Alfabeta2" la questione della cultura piegata al servizio degli interessi politici
In un dialogo uscito su "Alfabeta2" la questione della cultura piegata al servizio degli interessi politici
 Piuttosto che la ricerca della verità prevale la convenienza immediata e il desiderio di piccoli privilegi
Piuttosto che la ricerca della verità prevale la convenienza immediata e il desiderio di piccoli privilegi
 "L’indipendenza e la libertà finiscono per essere solo la rivendicazione di uno status"
"L’indipendenza e la libertà finiscono per essere solo la rivendicazione di uno status"di Enrico Donaggio (la Repubblica, 05.10.2011)
Che cosa ti sembra di vedere nel rapporto intellettuali-potere, con riguardo alla situazione del nostro Paese, in questo momento? «Una grande diversità di situazioni, tra due estremi: l’improduttiva futilità intellettualistica e il servilismo corruttivo del libero pensiero. Se siamo liberi, siamo superflui; se siamo utili, non siamo liberi. Queste tendenze, per ragioni diverse, hanno in comune l’incapacità della funzione intellettuale, in quanto tale, di svolgere una funzione sociale e si condannano all’irrilevanza e, alla fine, al disprezzo. Nell’insieme, coloro che si dedicano ad attività intellettuali risultano polverizzati, inconcludenti. Non mi pare che, per usare un’espressione gramsciana, essi costituiscano un "gruppo sociale autonomo e indipendente". Rivendicano, certo, autonomia e indipendenza, ma lo fanno forse in vista di un qualche compito comune, in forza del quale li si possa considerare in sé "gruppo sociale"? Ti faccio una domanda. Pensi che sarebbe possibile, nell’Italia di oggi, un’affaire Dreyfus?».
Che cosa intendi dire?
«Che certamente ci sono, nel nostro tempo e nel nostro Paese, grandi scandali del potere, del fanatismo, e della grettezza, alleati tra loro in azioni criminali d’ogni tipo. C’è, rispetto a queste cose, una mobilitazione intellettuale contro "l’emergenza civile"? E, se anche c’è o ci fosse, è o sarebbe in grado di smuovere le acque, fare da contraltare alle logiche del potere, in nome di principi e valori non riconducibili a quelle logiche? Domanda retorica. Sembra che l’ambiente intellettuale sia quello cui il potere si rivolge per trovare giustificazioni, coperture. E di solito le trova. Triste».
Vuoi dire che, da noi, gli intellettuali, in quanto tali, sono inconcludenti?
«Esattamente così! La loro funzione è come polverizzata in mille rivoli. La dispersione deriva dall’incapacità di definire i nodi fondamentali della loro riflessione. Per questo, la libertà e l’indipendenza ch’essi rivendicano non si traducono in una funzione sociale, ma si risolvono in una pretesa di status, non facile giustificare. Da qui, la facile ironia sulla prosopopea degli intellettuali, sulla loro vuota spocchia e, alla fine, sul loro parassitismo. Data la carenza di ruolo sociale, o ci si rifugia nella pura speculazione fine a se stessa, che è una sorta di consolazione del pensiero, oppure, rinunciando all’autonomia e all’indipendenza della funzione intellettuale, si cerca di collegarsi con chi sta dove il potere si esercita effettivamente, nell’economia e nella politica, per diventarne "consulenti". In due parole: il "consulente" sostituisce "l’intellettuale". Il nostro mondo è sempre più ricco di consulenti e sempre meno di intellettuali. C’è da ridere, se si pensa che quella del consulente è la versione odierna dell’"intellettuale organico" gramsciano. Questi si collegava alle grandi forze storiche per la conquista della "egemonia" e per svolgere così un compito certo ambiguo, ma indubbiamente grandioso; quello è l’imboscato nell’inesauribile miniera di ministeri, enti, istituti, fondazioni, aziende, ecc., offrendo servigi intellettuali e ricevendo in cambio protezione, favori, emolumenti. I consulenti si conoscono tutti "personalmente", ma s’ignorano "funzionalmente". Nell’insieme non adempiono una funzione intellettuale indipendente».
E c’è qualcosa di male? Non è bene che chi comanda sia informato, magari anche illuminato, da qualcuno che conosce le cose di cui parla?
«E come no. Ma, a condizione che il consulente non entri "nell’organico" del potente di turno. C’è differenza tra il fornire le tue conoscenze e offrire te stesso, tra il vendere e il venderti cioè, come si dice, essere "a libro paga". Il confine è teoricamente chiaro, praticamente vago. Nel primo caso mantieni la tua libertà, nel secondo la perdi: volontariamente la perdi, ma la perdi. C’è l’attesa, la speranza di ottenere qualcosa, e allora rispondi agli inviti; ai convegni non puoi mancare, perché se manchi, sembra che tu "non ci stia". Perdi il tuo tempo e disperdi la tua vita in convegni pseudo-culturali perché "non si sa mai" che qualcosa di buono ti possa prima o poi arrivare: i posti a disposizione sono tanti e ci può essere anche posto per te. Il punto più basso, l’intellettuale lo raggiunge quando si presta a dare il suo cervello, la sua intelligenza, la sua parola, all’uomo di potere che lo paga per scrivergli i suoi discorsi, i suoi articoli di giornale, le sue interviste. Addirittura, la consideriamo una professione intellettuale, quella del ghostwriter. Ti pare normale che chi scrive discorsi per altri, collaborando a un evidente plagio letterario, sia circondato dal massimo rispetto, ed egli stesso se ne compiaccia: come sono bravo, sono entrato in Tizio e Caio per far uscire dalla sua bocca le mie parole!».
Mah! Non è mica detto che si tratti poi di pura piaggeria. Possono essere grandi discorsi che, semplicemente, passano per un megafono di potenza tale - per esempio, negli Stati Uniti, la voce di un Presidente - che uno studioso, per quanto famoso non potrebbe neppure sognarsi.
«Pensi forse a un Arthur Schlesinger jr., grande saggista, che scriveva i discorsi per Adlai Stevenson e per i fratelli Kennedy? Ma, qui non è questione di qualità delle persone e delle loro prestazioni. Qui parlo della funzione stessa, come concetto. A proposito di Reagan (parliamo di lui e non di gente di casa nostra, per carità di patria), Noam Chomsky ha fatto osservazioni sulle esibizioni pubbliche di politici-attori che dovrebbero essere tenute presenti, come salutari avvertenze per l’uso, nell’ascolto delle loro parole: "quando in televisione si legge un ‘gobbo’ si fa una curiosa esperienza: è come se le parole vi entrassero negli occhi e vi uscissero dalla bocca, senza passare attraverso il cervello. E quando Reagan fa questo, quelli della tv devono disporre le cose in modo che di fronte a lui ci siano due o anche tre gobbi; in tal modo la sua faccia seguita a muoversi rivolgendosi da una parte e dall’altra, e allo spettatore sembra che stia guardando il pubblico, e invece passa da un gobbo all’altro. Ebbene, se riuscite a indurre la gente a votare per persone di questo tipo, praticamente avrete fatto il vostro gioco; l’avrete esclusa da ogni decisione politica. E bisogna fingere che nessuno rida. Se ci riuscite, avrete fatta molta strada verso l’emarginazione politica del popolo". Ecco, quello che voglio dire: gli intellettuali che si prestano a riempire la bocca dei politici di cose delle quali questi non hanno nessuna idea propria, oltre che umiliare la propria funzione, contribuiscono a svuotare di contenuto la democrazia, a ridurla a una rappresentazione».
Ma, non è meglio che i politici dicano cose sensate, piuttosto che insensate?
«No. Se non hanno nulla da dire, frutto del loro ingegno, è meglio che tacciano. E, se tacendo non si fa carriera politica, è meglio che non la facciano. Se poi dal loro ingegno escono sciocchezze, è bene che i cittadini elettori le constatino per quello che sono. Oltretutto, in questo modo, coprendo il vuoto dei politici con le loro non disinteressate "consulenze", contribuiscono a svuotare la politica stessa e, svuotandola, a renderla funzionale a interessi esterni. Non vorrei essere troppo brutale: si finisce per assecondare la sua tendenza a diventare funzione del potere che oggi più di tutti conta, il potere del denaro. Pecunia regina mundi».
Eppure, non credi che proprio questa funzione dell’intellettuale possa servire, al contrario, a dare alla cultura una forza nell’agone politico che altrimenti non avrebbe?
«Questa è l’illusione in cui spesso gli intellettuali rischiano di cadere, quando pensano di fare dei politici il megafono o l’imbuto delle loro idee. La realtà è che, quando non servono più, sono messi da parte. Ricordi la vicenda di Gianfranco Miglio con Bossi? E, ancor prima, con Eugenio Cefis? Oppure, di coloro che si sono messi alla corte Berlusconi pensando di potere fare la "rivoluzione liberale"? Dove sono finiti?».
-
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- Cosa significa essere italiani (di Carlo Galli)14 settembre 2011, di Federico La Sala
Cosa significa essere italiani
di Carlo Galli (la Repubblica, 14.09.2011)
«L’Italia è il Paese che amo». In questa dichiarazione - l’inizio della Grande Propaganda - c’era molta verità. Berlusconi ama veramente l’Italia perché ama veramente se stesso, avendo evidentemente operato una sintesi a priori fra l’Italia e la propria persona. Il suo amore non è un rapporto con l’oggetto amato; è il preventivo annullamento della sua autonomia, a cui segue l’identificazione con l’amante. Non è neppure un’inclusione: è un’illusione, un culto idolatrico.
Un culto il cui primo adepto, oltre che il primo beneficiario, è proprio Berlusconi. Il quale crede veramente di essere l’Italia. Non di rappresentarla - come nelle moderne dottrine della regalità il Re col proprio corpo concreto rappresentava l’intera complessità del regno - ma di coincidervi.
Una delle conseguenze di questa smisurata proiezione egolatrica è la indistinguibilità di pubblico e privato - l’annullamento del conflitto d’interessi, trasformato nella più perfetta identità d’interessi, passati presenti e futuri, fra Berlusconi e l’Italia - , ma anche la loro intercambiabilità (è Berlusconi che decide che cosa è pubblico, come per esempio la telefonata per Ruby, e che cosa è privato, come le serate con le escort). Un’altra è la coincidenza della parte col Tutto, del suo Partito con l’intero Popolo (il nome del Pdl è tutto un programma), e quindi l’esclusione degli avversari di Berlusconi dall’Italia - da questa Italia fittizia, fatta di proiezioni mentali, ma anche molto concreta nella sua configurazione di potere - . Quelli che lo criticano perdono ogni legittimità politica e morale, poiché non sono una parte che si contrappone, com’è normale in una democrazia, a un’altra parte, ma sono faziosi, traditori e sabotatori, che attaccando il Capo attaccano ipso facto il Paese. Nemici interni, dunque. Una terza conseguenza è che sovrana non è la legge, che vorrebbe considerare Berlusconi un cittadino fra gli altri; sovrano è lui, che è l’Italia, e che in quanto tale è il soggetto della legge e non è soggetto alla legge. Chi potrà mai voler processare l’Italia se non degli anti-italiani?
L’identificazione del governo con lo Stato, e dell’opposizione con l’attività anti-nazionale, è, certo, un’abusata strategia retorica, di ogni tempo e di molti Paesi - per lo più autoritari -; ma in concomitanza con la crisi finale della sua politica e della sua stessa avventura pubblica, Berlusconi sta toccando il grottesco. Il suo ricorso al tema-chiave della sua propoganda, alla radice della sua costruzione di legittimità, è ormai parossistico. Ora, è giunto il momento di squarciare il velo di Maya, di spezzare l’incantesimo, di dissipare le nebbie dell’illusione. E di spiegare a tutti (molti, in verità, lo stanno già comprendendo da soli, all’amara luce dell’esperienza), e in primis all’interessato, che Berlusconi non è l’Italia, che l’Italia non è Berlusconi, e che essere italiani non è essere berlusconiani. Che Berlusconi non è il destino dell’Italia e che lo si può attaccare senza essere anti-italiani.
Essere italiani non è una cosa soltanto, non significa realizzare un’essenza, un carattere, una vocazione unica. L’Italia non ha un’identità compatta, né nella nazione né nella razza, né nella religione né nell’ideologia. E quindi essere italiani vuol dire molte cose; essere portatori di interessi diversi, di ideali diversi, di visioni del mondo e della società differenziate. E questa pluralità, questa complessità - che hanno radici nella storia e nella geografia, nell’economia e nella politica -, non riconducibili a una unanimità, a un unico modello omologante, a un pensiero unico, possono essere una ricchezza, una riserva d’energie e di prospettive, se il punto d’unificazione del Paese, l’essenza dell’essere italiani, non sta nell’identificazione fra l’Italia e un Capo - che in realtà è stata superficiale ed episodica, e che ha avuto come effetto reale la più grave frantumazione della nostra società in mille linee di frattura disarticolate - ma al contrario nella sovranità della legge e nel più solenne dei vincoli: la Costituzione.
Essere italiani, oggi, può significare, in positivo, il riconoscersi in un’unità giuridica e politica, in un sistema di norme e in un’idea di democrazia pluralistica, che costituiscono, in realtà, un patto di uomini e di donne libere. Uniti dal rispetto delle leggi, e quindi dalla reciproca fiducia in se stessi, e dal riconoscersi nelle istituzioni: dall’identificarsi non in un uomo ma nella Repubblica e nei suoi ordinamenti. Essere italiani significa prendere sul serio la Costituzione, che è l’essenza dell’italianità, il progetto di una patria viva e libera perché consapevole della propria ricchezza plurale e della propria volontà di un destino civile comune. Una patria, un Paese, che non dipende dalle affabulazioni, dai rancori e dalle smanie narcisistiche di Uno - che dapprima ama, e che infine, quando l’incantesimo finisce, ingiuria -, ma dall’orgoglio civile di tutti. Dalla voglia, di tutti, di sciogliere il vincolo - tutt’altro che indissolubile - col Capo, e di riprendere, dopo tanti anni perduti, un cammino comune, libero dall’eccezione permanente, dall’anomalia in servizio perenne ed effettivo. Convinti che sia possibile, e magari anche bello, essere italiani.
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- Servi, per libera scelta (di Maurizio Viroli).6 settembre 2011, di Federico La Sala
Servi, per libera scelta
Pubblichiamo la prefazione dell’edizione inglese de “La libertà dei servi” di Maurizio Viroli, che uscirà nei prossimi giorni con il titolo “The Liberty of Servants” per la Princeton University Press.
di Maurizio Viroli (il Fatto, 06.09.2011)
L’opinione pubblica di lingua inglese ha già un’immagine abbastanza precisa dell’Italia di Berlusconi. Studiosi e giornalisti hanno accuratamente descritto e spiegato che il sistema di potere berlusconiano non ha né precedenti né equivalenti nella storia dei paesi liberali e democratici Mai un uomo con tanto potere - fondato sul denaro, sulla proprietà dei mezzi di comunicazione di massa e sul controllo di un partito composto da persone a lui devote - è stato in grado di diventare per tre volte capo del governo e di conservare per quindici anni una posizione dominante nel sistema politico e nella vita sociale di un paese democratico.
A RAGIONE, l’opinione pubblica internazionale si preoccupa per questo esperimento politico italiano, anche se spesso lo considera come un ennesimo esempio di carnevalate e di corruzione politiche. I commentatori hanno infatti insistito sui più vergognosi aspetti del regime berlusconiano quali le leggi per proteggerlo dalla giustizia; la sua determinazione nel sostenere la corruzione politica (il suo vecchio sodale Cesare Previti è stato condannato per corruzione di giudici); le sue connivenze, sempre a loro giudizio, con la criminalità organizzata; il suo aperto disprezzo per la magistratura e per la Corte costituzionale che egli considera inaccettabili limitazioni del suo potere basato sul consenso popolare; i vari scandali sessuali che hanno fatto parlaredi“governodelleputtane” e “stato-bordello”; la sua amicizia con leaders impresentabili quali Putin e Gheddafi. In questo saggio cerco di capire in maniera più precisa questo nuovo, ambiguo, tipo di potere politico nato non contro, ma all’interno delle istituzioni politiche democratiche, e sostengo che si tratta di una degenerazione della democrazia nel potere di un demagogo che controlla una massa addomesticata dai suoi mezzi di comunicazione di massa. Come i demagoghi dell’antichità e dell’età moderna, Berlusconi ha dimostrato fin dagli inizi della sua carriera politica una notevole capacità di affascinare la ‘gente’ con tecniche teatrali che mirano ad esaltare la sua immagine e ha dato ripetutamente prova di saper ottenere il consenso dicendo ai cittadini quello che essi vogliono ascoltare. A differenza di quasi tutti i demagoghi, tuttavia, Berlusconi è ricchissimo e usa il suo denaro per comprare le persone, come abbiamo visto, a parere dei commentatori, nelle ultime settimane del 2010 e nelle prime del 2011 quando la sua maggioranza parlamentare ha rischiato di dissolversi. In circostanze più normali della vita politica egli usa il suo denaro, direttamente o indirettamente, per distribuire favori di varia natura e valore, dai posti lucrativi ai regali. In questo modo ottiene la lealtà di un gran numero di persone. Si potrebbe sostenere che Berlusconi ha istituito un’oligarchia all’interno del sistema democratico.
Ma è anche vero che il regime di Berlusconi presenta aspetti che i filosofi politici hanno bollato come tirannide, non nel senso di un potere imposto e conservato con la violenza, ma nel senso di una “tirannide velata”, simile a quella che i Medici costruirono a Firenze. In effetti, come ogni tiranno, anche Berlusconi mira in primo luogo a conservare ed accrescere il suo potere e a proteggere i suoi interessi. Inoltre, come già osservava Norberto Bobbio, Berlusconi ha la tipica mentalità del tiranno. Ritiene infatti che a lui tutto sia lecito, compreso avere tutte le donne per sé, e più giovani sono meglio è. Se lo esaminiamo con l’aiuto dei concetti classici del pensiero politico, il potere di Berlusconi può essere definito come una combinazione originale delle tre forme corrotte di governo: la demagogia, la tirannide e l’oligarchia. È un esempio davvero eloquente della creatività politica italiana, ma è soprattutto un’ulteriore prova di un altro carattere distintivo della storia italiana, vale a dire la nostra cronica incapacità di difendere efficacemente la libertà.
LE LIBERE REPUBBLICHE del tardo Medio Evo non seppero proteggersi dalla tirannide e dal dominio straniero; lo Stato liberale nato dal Risorgimento nel 1861 è stato distrutto cinquant’anni dopo dal fascismo; la repubblica democratica nata il 2 giugno 1946 sulle ceneri del fascismo è degenerata nel sistema berlusconiano. Il paese della libertà fragile, ecco quale potrebbe essere un’appropriata caratterizzazione politica dell’Italia. Come sostengo in questo libro, la semplice esistenza dell’enorme potere di Silvio Berlusconi rende gli italiani non liberi, o meglio liberi, ma nel senso della libertà dei servi, non della libertà dei cittadini. La mia tesi si basa sul concetto di libertà politica elaborato dai filosofi e dai giuristi classici e moderni che hanno spiegato assai bene che essere liberi non vuol dire poter fare più o meno quello che vogliamo, ma essere non essere sottoposti al potere enorme o arbitrario di un uomo o di alcuni uomini. La ragione la capisce anche un bambino: se un uomo ha un potere enorme, può facilmente usarlo per imporre la sua volontà e dunque ridurre i cittadini in condizione di servitù.
Egli può inoltre creare intorno a sè una corte formata da un numero più o meno grande di individui che dipendono da lui per favori, denaro, onori e fama. Anche se il regime di Berlusconi è certo una letale mistura di oligarchia, demagogia e tirannide, il nome che megliolocaratterizzaèsistemadicorte . Berlusconi è un nuovo signore. Come ho osservato all’inizio, è del tutto comprensibile che l’opinione pubblica di lingua inglese consideri Berlusconi un’altra stravaganza italiana. Eppure, per quanto possa apparire del tutto improbabile, i suoi potrebbero trovare imitatori in altri paesi democratici. Nessun sistema democratico è immune dal potere combinato del denaro, dei media e della demagogia. I leaders e i cittadini dei paesi liberi dovrebbero fare tesoro degli errori degli italiani e preparare per tempo le difese contro il formarsi e il consolidarsi di poteri enormi.
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. ---- UN’INCHIESTA SULL’INCHIESTA. Un percorso narrativo (di Furio Colombo).26 giugno 2011, di Federico La Sala
Un’inchiesta sull’inchiesta
Perché uomini di governo vanno da Bisignani a ricevere istruzioni? Perché sono disorientati o perché il vero potere è altrove? L’opposizione dovrebbe saper rispondere a questa domanda
di Furio Colombo (il Fatto, 26.06.2011)
“Perché uno come Gianni Letta, che ha un ruolo rilevante, direi eccezionale, nel governo del Paese e nelle relazioni istituzionali, deve sapere da Bisignani se nei suoi confronti ci sono o no indagini giudiziarie ? Perché ministri in carica vanno nell’ufficio di Bisignani a chiedere consigli, a ricevere istruzioni e segnalazioni per incarichi pubblici?". Sto citando da un articolo di Emanuele Macaluso (Il Riformista, 22 giugno) perché la sequenza di domande da lui proposta ci porta nell’occhio del tifone. Stiamo assistendo a un muoversi frenetico di personaggi influenti sotto e sopra la linea di galleggiamento delle principali istituzioni, un andare e venire poco chiaro e poco spiegabile fra il sottofondo della Repubblica e gli apparenti titolari del potere.
TUTTI I PEZZI del gioco, qualunque sia il gioco, sono in movimento, si spostano o vengono spostati, si espongono o vengono spinti ad esporsi, ascoltano, non si capisce da chi e si confidano, non si capisce con chi. Qui mi discosto dalle conclusioni di Macaluso che dice, accantonando le sue stesse domande: "Ci sono sempre stati dei Bisignani, perché lo Stato è debole". È vero, ma ciò che sta accadendo è molto di più. Si è scoperto che, nelle vene della politica, è in circolazione un batterio misterioso che ha più forza del potere, nel senso che fa apparire l’intera collezione delle persone di potere come ombre a cui si può sempre cambiare (o far cambiare) posizione, dislocazione, funzione, decisione.
È possibile che Bisignani sia l’artefice di tanta autorità operativa, che sia il punto da cui emanano ordini e comando, secondo un disegno del dinamico ex giornalista che ha abilmente messo le mani su leve che altri, pur vicini al potere, non avevano notato? Poiché so, fin da ora, che il percorso giudiziario, per quanto accurato e meticoloso, ci dirà molto sul modo di operare (ed eventualmente di violare la legge) di Bisignani, ma poco o niente su “chi è Bisignani?” e “perché si va da Bisignani a chiedere istruzioni per esercitare il potere?”. Non resta che un altro percorso, un percorso narrativo .
Qui comincia il racconto, con la dovuta avvertenza che esso si basa sulla pura immaginazione del narratore e che non ha nulla a che fare con documenti e rivelazioni. Nel racconto, il vivace ex giornalista Bisignani viene così intensamente frequentato non perché abbia o rappresenti il potere, o partecipi al potere, o possa dare il giusto consiglio o mettere una buona parola.
Bisignani è un raccordo necessario. Chi deve saperlo sa che si passa attraverso di lui. Non come luogo di saggezza, di esperienza e di eventuale favore, ma come camera di consultazione, ascolto o confessione con un potere che conta.
Un potere o il potere? La domanda è romantica. Nessun potere è il potere. Ma certo la camera di ascolto e conversazione a cui si accede tramite Bisignani conta abbastanza perché il ministro Stefania Prestigiacomo "si rovini" facendosi intercettare al telefono di Bisignani. Quel rischio, forse, non è temuto davvero. Forse è un modo di mostrare il giusto comportamento. A chi? Poiché, come il lettore intuisce, il narratore non ha la risposta finale deve prendere tempo. In quel tempo dobbiamo inserire gli incontri, che non possono essere furtivi e le telefonate, che non possono essere ingenue, del sottosegretario Letta (foto) con l’agile Bisignani.
LETTA È UNA persona saggia, niente affatto impulsiva, capace di una attenzione ferrea e ininterrotta al filo dei suoi rapporti, molti dei quali, comprensibilmente, coperti da discrezione accurata. Non sembra, valutando il personaggio nell’insieme, che il rapporto con Bisignani sia stato un passo falso che interrompe in un punto la sequenza perfetta di ciò che si fa ma non si deve sapere. Sembra una necessità, o così la racconterei se scrivessi questo racconto. Voglio dire: questo tipo di potere terminale che sta al di là e al di sopra del potere fatto di figure e di simboli che potremmo chiamare (ma solo nel racconto) i prestanome, esige un certo rispetto delle forme. Ciò che è dovuto è dovuto. Rimane nell’ombra ciò che deve rimanere nell’ombra. Evidentemente la folla dei potenti-impotenti (nel senso che rappresentano molto e decidono poco) è bene che abbia costantemente la misura del proprio limite e si conformi senza impropri e sconsigliabili gesti di ridicola ribellione.
QUANDO POI entrano in scena personaggi dei Servizi segreti che, a nome e per conto del predetto Bisignani, si recano a conferire con il parlamentare che presiede la commissione di controllo sui Servizi segreti, il narratore si persuade, pur in assenza di evidenze documentali, di essere sulla strada giusta. C’è qualcosa che conta oltre la siepe, cose che noi cittadini non vediamo e non sappiamo, ma che evidentemente smuovono molto e cambiano molto, tanto che fanno correre di qua e di là dei generali appena entrati in possesso delle presunte chiavi della Repubblica.
Se ti è accaduto di avere visto alla Camera Silvio Berlusconi, il 22 giugno, esaltare se stesso, con un discorso identico al 1993, al 1994, al 2001, al 2008, e hai appena notato (e fatto notare in aula) che per lui i deputati della Lega non applaudono e, al momento dell’ovazione, nessuno di loro si alza in piedi per lui, una cosa sai e constati: Berlusconi non è e non ha il potere. E il trucco (persino nel senso cosmetico) non funziona più. “Perché Gianni Letta, che ha un ruolo rilevante, deve sapere da Bisignani...”, si domanda Macaluso nell’articolo che ho citato all’inizio. Ma Letta è Berlusconi. Dunque, fino a questo punto abbiamo un indizio prezioso per la versione narrativa che ho proposto. Continua Macaluso, che di politica ne ha vista tanta: “Perché ministri in carica vanno da Bisignani per ricevere istruzioni?”. Perché sono deboli e disorientati o perché il potere è altrove? Il narratore si ferma qui. Ma chi guida l’opposizione deve saper rispondere a questa domanda.
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. ---- SENZA "FACOLTA’ DI GIUDIZIO", IN UNO "STATO DI MINORITA’": ENRICO BERTI E REMO BODEI, COME TANTI ALTRI, RAGIONANO ANCORA AL DI QUA DELLA COSTITUZIONE.25 giugno 2011, di Federico La Sala
 FILOSOFIA, ANTROPOLOGIA E POLITICA. IL PENSIERO DELLA COSTITUZIONE E LA COSTITUZIONE DEL PENSIERO ....
FILOSOFIA, ANTROPOLOGIA E POLITICA. IL PENSIERO DELLA COSTITUZIONE E LA COSTITUZIONE DEL PENSIERO ....
 STATO DI MINORITA’ E FILOSOFIA COME RIMOZIONE DELLA FACOLTA’ DI GIUDIZIO. Una ’lezione’ di un Enrico Berti, che non ha ancora il coraggio di dire ai nostri giovani che sono cittadini sovrani. Una sua riflessione - con una nota
STATO DI MINORITA’ E FILOSOFIA COME RIMOZIONE DELLA FACOLTA’ DI GIUDIZIO. Una ’lezione’ di un Enrico Berti, che non ha ancora il coraggio di dire ai nostri giovani che sono cittadini sovrani. Una sua riflessione - con una nota
 (...) Da noi si insegna soprattutto storia della filosofia (...) Più realista, e meno illuminista, di Kant è stato Hegel, il quale ha criticato i pedagogisti suoi contemporanei che volevano insegnare a «pensare con la propria testa», a inventarsi ciascuno una propria filosofia, come se la filosofia non fosse mai esistita prima e quindi non esistesse già. Per filosofia Hegel intendeva la verità, iscritta nella mente di Dio (l’Idea) e realizzata nel processo della natura e nello spirito. Più modestamente la filosofia si può intendere come il pensiero dei grandi filosofi, che è bene conoscere e col quale è bene confrontarsi, cioè dialogare (...)
(...) Da noi si insegna soprattutto storia della filosofia (...) Più realista, e meno illuminista, di Kant è stato Hegel, il quale ha criticato i pedagogisti suoi contemporanei che volevano insegnare a «pensare con la propria testa», a inventarsi ciascuno una propria filosofia, come se la filosofia non fosse mai esistita prima e quindi non esistesse già. Per filosofia Hegel intendeva la verità, iscritta nella mente di Dio (l’Idea) e realizzata nel processo della natura e nello spirito. Più modestamente la filosofia si può intendere come il pensiero dei grandi filosofi, che è bene conoscere e col quale è bene confrontarsi, cioè dialogare (...) LE PAROLE DELLA POLITICA E LA FILOSOFIA ITALIANA. Dopo quasi venti anni di berlusconismo e dopo altrettanti anni di una quasi generale connivenza sonnambolica ....
LE PAROLE DELLA POLITICA E LA FILOSOFIA ITALIANA. Dopo quasi venti anni di berlusconismo e dopo altrettanti anni di una quasi generale connivenza sonnambolica ....
 FILOSOFIA IN STATO COMATOSO. IL PARADOSSO DELL’IDENTITA’: IO E GLI ALTRI. REMO BODEI CERCA DI SVEGLIARSI E SI RIATTACCA AL VECCHIO E LOGORO FILO POPPERIANO. Ecco le tesi del suo "manifesto per vivere in una società aperta"
FILOSOFIA IN STATO COMATOSO. IL PARADOSSO DELL’IDENTITA’: IO E GLI ALTRI. REMO BODEI CERCA DI SVEGLIARSI E SI RIATTACCA AL VECCHIO E LOGORO FILO POPPERIANO. Ecco le tesi del suo "manifesto per vivere in una società aperta" -
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. L’Italia come volontà e come rappresentazione di un solo Partito. Il "popolo della libertà" è nato: "Forza Italia"!!! Materiali per un convegno prossimo futuro - a cura di Federico La Sala16 giugno 2011, di Federico La Sala
L’irruzione del futuro
di Barbara Spinelli (la Repubblica, 15 giugno 2011)
Forse, dopo la perdita di Milano e Napoli, la sconfitta al referendum è la più avvilente nella storia di Berlusconi. Si era messo in testa che ignorandolo l’avrebbe ucciso, l’aveva definito «inutile», e il giorno del voto se n’era andato pure al mare, esemplarmente. Niente da fare: il quorum raggiunto e i quattro sì che trionfano non sono solo un colpo inferto alla guida del governo.
È una filosofia politica a franare, come la terra che d’improvviso si stacca dalla montagna e scivola. È un castello di parole, di chimere coltivate con perizia per anni. «Meno male che Silvio c’è», cantavano gli spot che il premier proiettava, squisita primizia, nei festini. Gli italiani non ci credono più, il mito sbrocca: sembra l’epilogo atroce dell’Invenzione di Morel, la realtà-non realtà di Bioy Casares. Per il berlusconismo, è qualcosa come un disastro climatico.
Tante cose precipitano, nel Paese che credeva di conoscere e che invece era un suo gioco di ombre: l’idea del popolo sovrano che unge la corona, e ungendola la sottrae alla legge. L’idea che il cittadino sia solo un consumatore, che ogni tanto sceglie i governi e poi per anni se ne sta muto davanti alla scatola tonta della tv. L’idea che non esistano beni pubblici ma solo privati: il calore dell’aria, l’acqua da bere, la legge uguale per tutti, la politica stessa. L’idea, più fondamentale ancora, che perfino il tempo appartenga al capo, e che un intero Paese sia schiavo del presente senza pensare - seriamente, drammaticamente - al futuro.
Più che idee, erano assiomi: verità astratte, non messe alla prova. Non avendo ottenuto prove, il popolo è uscito dai dogmi. Lo ha fatto da solo, senza molto leggere i giornali, gettando le proprie rabbie in rete. È una lezione per i politici, i partiti, i giornali, la tv. La fiamma del voto riduce una classe dirigente a mucchietto di cenere.
Pochi hanno visto quello che accadeva: il futuro che d’un tratto irrompe, la stoffa di cui è fatto il tempo lungo che gli italiani hanno cominciato a valutare. Erano abituati, gli elettori, a non votare più ai referendum. Questa volta sono accorsi in massa: a tal punto si sentono inascoltati, mal rappresentati, mal filmati. Nessuna canzoncina incantatrice li ha immobilizzati al punto di spegnerli.
Berlusconi lo presentiva forse, dopo Milano e Napoli, ma come un automa è caduto nella trappola in cui cadde Craxi nel 1991 - andare al mare mentre si vota è un rozzo remake - e con le sue mani ha certificato la propria insignificanza. Impreparato, è stato sordo all’immenso interrogativo che gli elettori di domenica gli rivolgevano: se la sovranità del popolo è così cruciale come proclama da anni, se addirittura prevale sulla legge, la Costituzione, come mai il Cavaliere ha mostrato di temere tanto il referendum? Come spiegare la dismisura della contraddizione, che oggi lo punisce?
Il popolo incensato da Berlusconi, usato come scudo per proteggere i suoi interessi di manager privato, non è quello che si è espresso nelle urne. È quello, immaginario, che lui si proiettava sui suoi schermi casalinghi: un popolo divoratore di show, ammaliato dal successo del leader. Chi ha visto Videocracy ricorderà la radice oscena della seduzione, e le parole di Fabrizio Corona: «Io sono Robin Hood. Solo che tolgo ai ricchi, e dò a me stesso».
Nel popolo azzurro la libertà è regina, ma è tutta al negativo: non è padronanza di sé ma libertà da ogni interferenza, ogni contropotere. Ha come fondamento la disumanizzazione di chiunque si opponga, di chiunque incarni un contropotere.
Di volta in volta sono «antropologicamente diversi» i magistrati, i giornalisti indipendenti, la Consulta, il Quirinale. Ora è antropologicamente diverso anche il popolo elettore, a meno di non disfarsi di lui come Brecht consigliò al potere senza più consensi. Era un Golem, il popolo - idolo d’argilla che il demiurgo esibiva come proprio manufatto - e il Golem osa vivere di vita propria. Il premier lo aveva messo davanti allo sfarfallio di teleschermi che le nuove generazioni guardano appena, perché la scatola tonta ti connette col nulla. E quando ti connette con qualcuno - Santoro, Fazio, Saviano - ecco che questo qualcuno vien chiamato «micidiale» e fatto fuori.
Il popolo magari si ricrederà, ma per il momento ha abolito il Truman Show. Ha deciso di occuparsi lui dei beni pubblici, visto che il governo non ne ha cura. Non sa che farsene del partito dell’amore, perché nella crisi che traversa non chiede amore ai politici ma rispetto, non chiede miraggi ottimistima verità. Accampa diritti, ma non si limita a questo.
Pensare il bene pubblico in tempi di precarietà e disoccupazione vuol dire scoprire il dovere, la responsabilità. Celentano lunedì sera ha detto che siamo disposti perfino ad avere un po’ più freddo, in attesa di energie alternative al nucleare. Per questo si sfalda il dispositivo centrale del berlusconismo: la libertà da ogni vincolo è distruttiva per l’insieme della comunità. Era ammaliante, ma lo si è visto: perché simile libertà cresca, è indispensabile che il popolo sia tenuto ai margini della res publica.
Specialmente nei referendum, dove si vota non per i partiti ma per le politiche che essi faranno, il popolo prende in mano i tempi lunghi cui il governo non pensa, e gli rivolge la domanda cruciale: è al servizio del futuro, un presidente del Consiglio che ha paura dell’informazione indipendente, che ha paura di dover rispondere in tribunale, che elude la crisi iniziata nel 2007, che non medita la catastrofe di Fukushima e considera il no al nucleare un’effimera emozione? Pensa al domani o piuttosto a se stesso, chi sprezza la legalità pur di favorire piccole oligarchie, il cui interesse per le generazioni a venire è nullo? Ai referendum come nelle amministrative il tempo è tornato a essere lungo. Non a caso tanti dicono: si ricomincia a respirare.
La crisi ha insegnato anche questo: non è vero che il privato sia meglio del pubblico, che il mercato coi suoi spiriti animali s’aggiusti da sé, che la politica privatizzata sia la via. I privati non sono in grado di costruire strade, ferrovie, energia pulita per i nipoti. Vogliono profitti subito e a basso costo, senza badare alla qualità e alla durata. Berlusconi si presentò come il Nuovo ed era invece custode di un disordine naufragato nel 2007. Non era Roosevelt o Eisenhower, non ha edificato infrastrutture per le generazioni che verranno.
Ogni persona, dice Deleuze, è un «piccolo pacchetto di potere», e l’etica la costruisce su tale potere. Berlusconi pensava - forse pensa ancora - che questo potere fosse suo: che non fosse così diffuso in pacchetti. Pensava che il cittadino non avesse bisogno di verità; che il coraggio te lo dai nascondendola. Pensava (pensa) che il coraggio consista nel ridurre le tasse, e chi se ne importa se l’Italia precipita come la Grecia o se pagheranno i nipoti.
Pensava che, bocciato il legittimo impedimento, puoi farti una prescrizione breve, come se il popolo non avesse proscritto ogni legge ad personam. Il Cavaliere ha eredi nel Pdl. Ma all’eredità come bene consegnato al futuro non ha mai badato, convinto che la crisi sia come la morte (e lui come la vita) per Epicuro: «Finché Silvio c’è, la crisi non esiste. Quando la crisi arriva, Silvio non c’è». Tanti ne sono convinti, e lo incitano a «tornare allo spirito del ’94»: dunque a mentire sulle tasse, di nuovo.
Chi lo incita sa quello che dice? Ha un’idea di quel che è successo fra il 1994 e il 2011? Rifare il ’94 non è da servi liberi, ma da gente che ignora il mondo e ne inventa di falsi. Se fossero liberi e coraggiosi non sarebbero stupidi al punto di consigliare follie. Se insistono, vuol dire che sono servi soltanto. La loro retorica è così smisurata che neppure capiscono la nemesi, che s’è abbattuta sul loro padrone.
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- La menzogna del potere (e degli intellettuali).28 maggio 2011, di Federico La Sala
La menzogna del poteredi MASSIMO GIANNINI *
Il potere mente. Per abitudine alla manipolazione e per istinto di conservazione. Non c’è bisogno di aver letto la prima Hannah Arendt, o l’ultimo Don De Lillo, per sapere che "lo Stato deve mentire", o che il governo tecnicamente totalitario "fabbrica la verità attraverso la menzogna sistematica". Ma nessun potente mente con la frequenza e l’impudenza di Silvio Berlusconi. Non pago di aver danneggiato il Paese che governa, in un drammatico e surreale "colloquio" elemosinato a Obama a margine di un vertice tra gli Otto Grandi del pianeta, il presidente del Consiglio torna sul luogo del delitto. E, dopo aver inopinatamente e irresponsabilmente denunciato al presidente americano la "dittatura dei giudici di sinistra", lo "perfeziona", raccontando la stessa delirante bugia agli altri leader del G8.
Abbiamo già detto quale enorme discredito rappresentino, in termini di immagine internazionale, le parole scagliate contro l’Italia dall’uomo che dovrebbe rappresentarla al meglio nel mondo. Abbiamo già detto quali enormi "costi" imponga allo Stato, in termini di credibilità istituzionale, questo vilipendio della democrazia e dei suoi organismi. Ma è necessario, ancora una volta, squarciare la cortina fumogena con la quale il premier manomette i fatti, e denunciare l’ennesima menzogna sulla quale costruisce il teorema della "persecuzione giudiziaria". A Deauville, in una conferenza stampa costruita come una disperata requisitoria contro tutto e contro tutti, Berlusconi compie l’ultima metamorfosi: da comune inquisito si trasforma in Grande Inquisitore. Accusa le "toghe rosse", insulta "Repubblica" e i giornalisti, "colpevoli" di non indignarsi di fronte allo "scandalo delle 24 accuse che mi riguardano, tutte cadute nel nulla". "Vergognatevi", tuona furente il presidente del Consiglio, calato nella tragica maschera dostoevskiana dei Fratelli Karamazov. Dovrebbe vergognarsi lui, per aver violentato ancora una volta la verità.
A sentire il Cavaliere e i suoi "bravi", i processi che lo riguardano cambiano secondo gli umori e le stagioni. L’altro ieri aveva parlato di "31 accuse". In passato si era definito "l’uomo più perseguitato dell’Occidente, con 106 processi tutti finiti con assoluzioni". La figlia Marina ha evocato "26 accuse cadute nel nulla". Paolo Bonaiuti ha rilanciato con "109 processi e nessuna condanna". In realtà, come ha ricordato più volte Giuseppe D’Avanzo su questo giornale, i processi affrontati dal premier sono 16. Quattro sono ancora in corso: processo Mills (corruzione in atti giudiziari), diritti tv Mediaset (frode fiscale), caso Mediatrade (appropriazione indebita) e scandalo Ruby (concussione e prostituzione minorile). Negli altri 12 processi, solo tre sono state le sentenze di assoluzione: in un caso con "formula piena" (Sme-Ariosto/1, per corruzione dei giudici di Roma), negli altri due con "formula dubitativa" (Fondi neri Medusa e Tangenti alla Guardia di Finanza).
Gli altri 9 processi si sono conclusi con assoluzione, ma solo grazie alle leggi ad personam, fatte approvare nel frattempo dai suoi governi. Nei processi All Iberian/2 e Sme-Ariosto/2 il Cavaliere è assolto dalla legge che ha depenalizzato il falso in bilancio. Nei processi sull’iscrizione alla P2 e sui terreni di Macherio è assolto perché i reati sono estinti e le condanne cancellate dall’apposita amnistia.
Nei rimanenti 5 processi (All Iberian/1, affare Lentini, bilanci Fininvest 1988/1992, fondi neri del consolidato Fininvest e Lodo Mondadori) il premier è assolto grazie alle "attenuanti generiche", che gli consentono di beneficiare della prescrizione (da lui stesso fatta dimezzare con la legge Cirielli) e che operano sempre nei confronti dell’imputato ritenuto comunque "responsabile del reato".
Questa è dunque la verità storica, sull’imputato Berlusconi. A dispetto delle "persecuzioni" che lamenta, e delle "assoluzioni" che rivendica. Bugiarde, le une e le altre. È penoso doverlo ricordare. Ma è anche doveroso, alla vigilia di un turno elettorale che può cambiare il corso di questa disastrosa legislatura. E può spazzare via, finalmente, i danni e gli inganni compiuti dal Grande Inquisitore di Arcore. m. gianninirepubblica. it
* la Repubblica, 28 maggio 2011
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. ---- DEMOCRAZIA, IL NOME E LA COSA. Una rec. di "la felicità della democrazia" (di Ida Dominijanni).26 maggio 2011, di Federico La Sala
Democrazia, il nome e la cosadi Ida Dominijanni (il manifesto, 25 maggio 2011)
Fra il nome "democrazia", inteso come ideale normativo, e la cosa a cui si riferisce, le democrazie reali con tutto il loro carico di contraddizioni, anomalie, regressioni e smentite, è aperto oggi uno scarto analogo a quello che abbiamo già conosciuto fra il nome "comunismo" e le sue realizzazioni novecentesche. E come accadde, ben prima dell’89, per il pensiero comunista, così oggi, vent’anni dopo l’89 e il trionfo della democrazia sul comunismo, è in questo scarto fra il nome e la cosa che si apre lo spazio per il pensiero democratico critico e autocritico.
Più o meno critico e autocritico, perché le posizioni in campo sono molto sventagliate (una buona esemplificazione nel volume In che stato è la democrazia, ed. Nottetempo, con interventi di Agamben, Badiou, Bensaid, Wendy Brown, Nancy, Rancière, Kristin Ross, Zizek: il manifesto ne ha già parlato in occasione dell’uscita sia francese che italiana) e si differenziano non solo per il grado di durezza delle contestazioni allo stato effettivo della cosa, ma anche per il credito che mantengono o revocano alla pregnanza del nome.
Non si tratta insomma soltanto di riconoscere e combattere le degenerazioni in atto nelle democrazie reali, ma più radicalmente di chiedersi se il termine "democrazia" mantenga il suo significato ideale e mobilitante, o possa comunque essere ri-significato e rilanciato, malgrado e oltre queste degenerazioni; o se invece non debba essere destituito come emblema dominante ma consunto della politica contemporanea.
Dentro questo scarto fra il nome e la cosa si snoda il lungo dialogo fra Ezio Mauro, direttore di Repubblica, e Gustavo Zagrebelsky, giurista ed ex presidente della Corte costituzionale, pubblicato da Laterza con il titolo La felicità della democrazia (245 pp., 15 Euro).
Si tratta, va detto subito, di un dialogo vero, con i suoi punti di contatto e di frizione, che restituiscono un giudizio concorde sullo stato della cosa, e gradi diversi di investimento (Ezio Mauro) e di disincanto (Zagrebelsky) sulle sorti del nome. Lo stato della cosa è sotto gli occhi di tutti: ovunque in Occidente, e in Italia emblematicamente, la democrazia reale si rivela oggi il regime delle «promesse non mantenute», secondo una nota espressione di Norberto Bobbio, quando non della corruzione sistematica, dell’illegalità e del populismo. Eppure, il nome resta l’ideale, l’unico ideale politico, del presente, capace di chiamare alla mobilitazione sia chi vuole appropriarsene, come oggi in Nordafrica, sia chi vuole distruggerlo, come Al Quaeda nello scorso decennio.
Ma qui già le posizioni dei due interlocutori si differenziano. Se per Ezio Mauro le contraddizioni pur allarmanti della cosa non intaccano la fiducia nel nome e nella sua vocazione universalistica, per Zagrebelsky al contrario è proprio il nome a vacillare: impugnato ormai, in Occidente, più dai potenti per legittimare i propri abusi che dagli esclusi per ottenere uguaglianza e giustizia, esso si rivela un termine contemporaneamente «troppo elastico e troppo compulsivo», tanto elastico da prestarsi a coprire derive oligarchiche e autoritarie, e tanto compulsivo da essere diventato «lo shibboleth d’accesso alla vita politica» anche per chi democratico non è.
Se per Mauro la democrazia, erede superstite e vincente delle lotte novecentesche per l’emancipazione e i diritti, è «il vero sistema di credenze dell’occidente, la nostra vera religione secolarizzata», e va difesa «con ogni mezzo, perfino quello estremo e contronatura della guerra» dalle sfide e dagli attacchi che subisce, per Zagrebelsky quel sistema di credenze è segnato da una storia di compromissioni col dominio politico, economico e culturale su altri popoli: «dobbiamo difenderci, ma dobbiamo anche interrogarci», e comunque la difesa della democrazia non può passare per la sua sospensione nello stato d’eccezione.
Se, di conseguenza, Ezio Mauro vede nella guerra interna e internazionale al terrorismo - il caso Moro in Italia, l’11 settembre su scala globale - due momenti emblematici, dolorosi ma necessari, di questa difesa senza se e senza ma della democrazia, più problematico è lo sguardo ex-post di Zagrebelsky: su Moro in particolare, mentre per il direttore di Repubblica non c’era alternativa alla fermezza, («lo Stato era un guscio vuoto, ma quel guscio andava in ogni caso difeso: se salta il guscio, salta la democrazia»), per Zagrebelsky («credo, allora, di avere oscillato; oggi propenderei per tentare ogni strada pur di salvare una vita in pericolo») il «senso dello Stato» allora invocato aveva un’eco vagamente totalitaria, la fermezza coprì un deficit di autorità politica e istituzionale, e «non diciamo che lo Stato non ha ceduto: rispetto alla vita di Moro e al dovere di salvarla, non solo ha ceduto ma ha perso tutto».
Ma veniamo al presente, e alle due derive su cui nell’Italia di oggi la distanza fra la cosa e il nome si misura tangibilmente. La prima deriva è lo scollamento fra forma e sostanza democratica, ovvero fra la democrazia procedurale e il sistema di diritti, non solo individuali e politici ma collettivi e sociali, che essa dovrebbe garantire e invece non garantisce più.
Qui il dialogo si fa più stretto e le due voci si sovrappongono: non c’è forma democratica senza sostanza, dicono i due autori all’unisono ripercorrendo il caso Thyssen come «scandalo della democrazia», l’accordo Fiat del 23 dicembre come punta sintomatica di una globalizzazione che straccia i diritti nella diserzione della politica, l’istituzione del reato di clandestinità e più in generale la politica anti-immigrati come prova provata del capovolgimento dell’inclusività democratica nell’esclusione xenofoba. In Italia tuttavia non si tratta solo di scollamento fra forma e sostanza: è la stessa forma della democrazia a vacillare - seconda deriva - sotto la pressione del populismo berlusconiano.
Siamo all’osso della questione che da anni occupa il centro del dibattito pubblico: se e quanto il ventennio berlusconiano abbia deformato l’assetto democratico della Repubblica. C’è, lo sappiamo, chi risponde di no: chi sostiene, non solo nel campo del centrodestra - per ultimo Pierluigi Battista sul Corsera di pochi giorni fa, a commento del primo turno delle amministrative - che la democrazia resta tale finché funziona la conta elettorale, e che quanti da sinistra gridano al regime non fanno altro che coprire l’incapacità politica dell’opposizione di conquistare il consenso necessario a diventare maggioranza.
Qui il punto però non è la denuncia del regime (Mauro: «non sono d’accordo con chi sostiene che l’Italia di oggi non è democratica, o usa paragoni impropri con regimi del passato»), bensì la concezione della democrazia. Che nelle costituzioni novecentesche non si regge solo sul principio di legittimità, cioè sul voto, ma anche su quello di legalità, con tutte le dovute conseguenze in termini di divisione e limitazione dei poteri.
Ed è precisamente questa combinazione ad essere saltata nell’Italia berlusconiana, dove il consenso maggioritario e il riferimento continuo alla sovranità popolare servono a legittimare «l’unione sacra», come la chiama Ezio Mauro, fra il Capo e il popolo, «una «concezione titanica della leadership» che non riconosce i vincoli della legge e i limiti del potere, e mescola «affabulazione del reale e del leggendario in una mitologia del contemporaneo, dove la storia scorre solo nella dimensione eroica, di succeso in successo, e non sono previsti dubbi, pause e incertezze».
Una «democrazia carismatica» che in Italia si è affermata in virtù delle «anomalie» di cui Berlusconi è portatore - conflitto d’interessi, strapotere economico e mediatico, legislazione ad personam - ma che può diventare «una tentazione per l’Occidente, la sua scorciatoia». E coprire da noi - sottolinea Zagrebelsky invitandoci a distogliere lo sguardo dalla persona del leader e da una visione troppo eroica del suo carisma presunto - la solidificazione di un potere oligarchico ramificato e più duraturo della stella, peraltro calante, del Capo.
Perché allora, e ancora, la democrazia? Zagebelsky pone la domanda in termini non retorici, consapevole che se nel breve giro di un ventennio la «baldanzosa fiducia» dell’89 nell’avvenire della democrazia si è capovolta in disincanto qualche ragione c’è; e che se oggi «la fiammella democratica» si riaccende nella primavera araba questo non ci esime dal chiederci perché da noi, invece, «la fiamma si affievolisce». Nella risposta si riaffacciano, fra i due interlocutori, tonalità diverse.
Per Ezio Mauro il saldo della partita democratica, al netto della sua pur allarmante crisi, resta comunque in attivo: la condizione stessa della cittadinanza garantisce che, di fronte alle derive degenerative, «il campo resti contendibile» e il conflitto praticabile; la partita è aperta ed è nelle nostre mani. E dalla parte della democrazia, sottolinea il direttore di Repubblica, lavorano processi inarrestabili di svelamento del potere e dei suoi giochi segreti: «la vecchia talpa dell’informazione», potenziata e globalizzata da Internet, scava per noi, in un braccio di ferro «fra menzogna e conoscenza» che piega la politica verso la trasparenza e la sottrae alle pretese del potere.
Per Zagrebelsky pure la partita è nelle nostre mani, anzi ancor più nettamente nelle mani della «tanto bistrattata società civile», meno vincolata ai «giri di potere» che ingabbiano l’insieme della classe dirigente; ma a patto che torni in campo, dal basso appunto più che dall’alto, la concezione e la passione della politica come conflitto fra fini e fra modelli di organizzazione sociale alternativi, e non solo come amministrazione e «accomodatura» più o meno moderata dell’esistente. E’ qui dunque , «nello scadimento della politica in amministrazione» e nel conseguente appannarsi delle differenze fra destra e sinistra, se vogliamo ancora chiamare così due visioni alternative di sistema, «la causa della crisi della democrazia»: la politica dei fini essendo, della democrazia, una pre-condizione, non un residuo vetero-novecentesco di cui liberarsi in nome di una malintesa condizione post-ideologica.
Lo sguardo del giurista è portato dunque alla fine a posarsi sul bordo extra-giuridico del discorso: la crisi della politica da un lato, la crisi dell’homo democraticus contemporaneo dall’altro. Non per caso, il dialogo finisce su quella soglia - l’insuperata descrizione tocquevilliana della «folla innumerevole di uomini simili ed eguali, che girano senza posa su se stessi per procurarsi piccoli piaceri con cui soddisfare il loro animo, ciascuno di loro come estraneo al destino degli altri» - che più radicalmente interroga la razionalità democratica, obbligandola a ripensare non solo le promesse mancate della democrazia ma anche le sue premesse: non solo le deformazioni del kratos ma anche la formazione del demos (appena uscito sempre da Laterza, su questo punto, il libro di Valentina Pazé In nome del popolo. Il problema democratico); non solo l’edificio istituzionale, ma l’antropologia politica su cui si erige; non solo le regole e i diritti, ma anche le forme di vita, i desideri, il rapporto fra legge e godimento, i legami fra ordine simbolico e ordine sociale.
La stessa domanda conclusiva che dà il titolo al dialogo fra Mauro e Zagrebelsky, quella sul rapporto - ipotetico - fra democrazia e felicità, allude alla necessità di sporgersi su questo bordo esterno del discorso, dove la razionalità democratica perde presa e l’immaginario populista ne guadagna. E’ su questo bordo, forse, che siamo chiamati a indagare di più se vogliamo svelare, con gli inganni del potere, anche i nostri autoinganni.
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. .... Il compito del Colle è quello di "rappresentare l’unità nazionale" ed è "completamente diverso da quello dei leader politici" ( Presidente Napolitano).23 maggio 2011, di Federico La Sala
Napolitano: "In Italia troppa partigianeria. E i leader politici non siano gelosi di me" *
ROMA - In Italia c’è un eccesso di partigianeria politica. Lo ha detto il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nel suo incontro stamattina con i giornalisti della stampa estera.
All’incontro ha partecipato una rappresentanza di giornalisti di diverse testate internazionali e secondo quanto si è appreso il capo dello stato avrebbe fatto riferimento, come gli è capitato altre volte, a una partigianeria politica esasperata usando il termine inglese "hyperpartisanship".
"Penso che non ci sia per i politici italiani motivo di ingelosirsi, perchè viaggiamo su pianeti diversi, non ci sono comparazioni possibili, che non siano invece arbitrarie", ha aggiunto il capo dello Stato a proposito del suo ruolo. Spiegando poi che il compito del Colle è quello di "rappresentare l’unità nazionale" ed è "completamente diverso da quello dei leader politici".
* la Repubblica, 23 maggio 2011
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- Il pensiero sbagliato del signor B. Aveva detto che perdere a Milano sarebbe stato “impensabile”. Il voto dimostra che il premier non conosce la democrazia. E non sa pensare (di Francesca Rigotti, Nadia Urbinati, Nicla Vassallo).19 maggio 2011, di Federico La Sala
Il pensiero sbagliato del signor Berlusconi
 Aveva detto che perdere a Milano sarebbe stato “impensabile”.
Aveva detto che perdere a Milano sarebbe stato “impensabile”.
 Il voto dimostra che il premier non conosce la democrazia. E non sa pensare
Il voto dimostra che il premier non conosce la democrazia. E non sa pensaredi Francesca Rigotti, Nadia Urbinati, Nicla Vassallo (l’Unità, 19.05.2011)
Stabilire che cosa sia o non sia pensabile, o impensabile, è, conveniamolo, cosa da filosofi. O da filosofe, e quindi eccoci. Non è faccenda da venditori di fumo. Nemmeno da stregoni pubblicitari. Col pensiero la filosofia tratta dalla sua nascita e qualcosa da dire su ciò che è pensabile o meno ce l’ha. Limitiamoci a sostenere, con efficace minimalismo, che è pensabile ciò di cui si coglie il significato, che si può comprendere, che costituisce materia di conoscenza; ciò che può essere valutato, opinato, stimato, giudicato, deliberato. A meno di non sposare qualche forma di misticismo, l’impensabile corrisponde evidentemente al contrario del pensabile, ovvero a ciò che è assurdo in quanto incomprensibile e inconoscibile: vi è così un senso in cui l’impensabile non può nemmeno venir valutato, giudicato. «Una città (Milano) non governata da noi (del Popolo della Libertà) è impensabile», ha proclamato il Signor B. pochi giorni fa.
Il Signor B. pensa male, ragiona male. Lui, l’unto del Signore, si trova ora di fronte a un miracolo a Milano, che non è né il film di Vittorio De Sica (benché, filosoficamente, sogniamo col giovane protagonista un luogo dove «buongiorno voglia davvero dire buongiorno», luogo che negli ultimi tempi con Milano non riusciva a coincidere), né con quel non-miracolo che sarebbe dovuto risultare impensabile.
L’impensabile del Signor B. non si è ancora realizzato occorre attendere il ballottaggio; un sorta di miracolo, invece, sì e non ne è lui il fautore. Volendo ricorrere a John Locke, questo miracolo somiglia ad altri che, «quando sono ben testimoniati, non solo trovano credito per se stessi ma danno credito anche ad altre verità che hanno bisogno di tale conferma». Ad altre verità che riguardano da vicino la tenuta del governo, la sua plausibilità, nel nostro caso.
«Un miracolo è una violazione delle leggi di natura», obietta David Hume. Il miracolo a Milano ha però semplicemente violato le leggi dell’insulto, della menzogna, del narcisismo, della propaganda, delle promesse disattese. Un miracolo che attesta l’inizio della fine per il Signor B.? In realtà, è la rivincita della democrazia a attestarlo.
Il Signor B. non condivide nulla con Elisabetta I, mentre “la furberia e la pazzia” di quell’uomo non ha prodotto un evento straordinario: o, forse, sì, nel momento in cui l’impensabile-per-lui si avvicina. Ancora con le parole di Hume, «supponete che tutti gli storici che trattano dell’Inghilterra siano d’accordo nel dire che il 10 gennaio 1600 si ebbe la morte della regina Elisabetta e che tanto prima che dopo la morte essa fu vista dai medici e dall’intera corte, come è d’uso per le persone del suo rango; che il suo successore fu riconosciuto e proclamato dal parlamento; e che, dopo essere rimasta sepolta un mese, sia di nuovo riapparsa, abbia ripreso il trono e abbia governato l’Inghilterra per tre anni. Devo confessare che sarei sorpreso della concordanza di tante strane circostante, ma non avrei la minima inclinazione a credere ad un evento così miracoloso. Non dubiterei della sua pretesa morte e delle altre circostanze pubbliche che la seguirono; affermerei soltanto che la morte si era preteso che fosse tale e che né fu una morte reale, né sarebbe stato possibile che lo fosse. Invano mi obiettereste la difficoltà ed anzi l’impossibilità di trarre in inganno il mondo in un affare di tanta importanza, la saggezza e il solido buon senso di quella famosa regina, col minimo giovamento o col nessun giovamento che essa avrebbe potuto trarre da un così meschino artificio. Tutto ciò mi potrà stupire. Ma io risponderei ancora che la furberia e la pazzia degli uomini sono fenomeni tanto comuni che io preferirei credere che gli avvenimenti più straordinari derivino dal loro concorso».
Lo straordinario rimane lui, il Signor B., e vogliamo tanto che sia cosí: unicamente lui, o lui con pochi, a pensare che la democrazia consista solo nel vincere, e non anche nel perdere. Perché è davvero irragionevole considerare il contrario, e quindi rimane sperabile che gli illogici consistano in una minoranza: diversamente, la nostra sarebbe una società governata da folli, e i tiranni (capaci di concepire solo la vittoria, non la sconfitta) sono, appunto, dei folli.
Un governo che si basa sul consenso libero (ed espresso con voto segreto, ovvero protetto dalle tentazioni di raggiro e ricatto dei furbi) è per necessità un sistema aperto, oltre alla partecipazione, al suo esito. Alternanza democratica significa, appunto, accettare di perdere, sapendo che si tratta di una sconfitta temporanea. La bellezza della democrazia consiste nel fatto di garantire a tutti, al Signor B. incluso, l’opportunità di provare e riprovare. E allora, Signor B., è il caso che lei accetti la possibilità di perdere, poiché così potrà pensare di tornare a battagliare. Occorre pensare. Il pensabile. Ah! Che cosa splendida la democrazia, che non nega a nessuno un posto al sole della speranza!
*
 Francesca Rigotti è Professore di Comunicazione Istituzionale all’Università di Lugano:
Francesca Rigotti è Professore di Comunicazione Istituzionale all’Università di Lugano:
 Nadia Urbinati è Professore di Teoria Politica alla Columbia University;
Nadia Urbinati è Professore di Teoria Politica alla Columbia University;
 Nicla Vassallo è Professore di Filosofia Teoretica presso l’Università di Genova
Nicla Vassallo è Professore di Filosofia Teoretica presso l’Università di Genova -
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. ---- Le mosse di Berlusconi sono da tempo prevedibili, perché appartengono ad una logica che egli ha trasferito nel mondo della politica senza mai farsi contagiare dal "senso delle istituzioni" (di Stefano Rodotà - la logica del padrone)..11 maggio 2011, di Federico La Sala
La logica del padrone
di Stefano Rodotà (la Repubblica, 11.05.2011)
Le mosse di Berlusconi sono da tempo prevedibili, perché appartengono ad una logica che egli ha trasferito nel mondo della politica senza mai farsi contagiare dal "senso delle istituzioni". Non può sorprendere, quindi, l’ultimo suo proclama: «Dobbiamo cambiare la composizione della Corte costituzionale, dobbiamo cambiare i poteri del Presidente della Repubblica e, come avviene in tutti i governi occidentali, attribuire più poteri al governo del Presidente del Consiglio». Proprio le ultime parole sono rivelatrici. Scompare il "Governo della Repubblica", di cui parla l’articolo 92 della Costituzione. Al suo posto viene insediato il "Governo del Presidente del Consiglio", una formula che esprime la logica proprietaria dalla quale Berlusconi non ha mai voluto separarsi. L’imprenditore è fedele alle sue origini, e nel suo modo d’agire si ritrova la vecchia e di nuovo vitale formula secondo la quale "la democrazia si ferma alle porte dell’impresa". Governare è esercizio di potere assoluto. Chi si presenta come un intralcio lungo questo cammino deve essere eliminato.
Prevedibile o no, l’ultima accelerazione inquieta, assomiglia ad un assalto finale. Gli ostacoli li conosciamo. Magistratura a parte, nell’ultima fase della storia della Repubblica le garanzie si sono concentrate in due istituzioni, il Presidente della Repubblica e la Corte costituzionale. Ma questo non dipende da una impropria volontà di potenza. Discende da un progressivo indebolirsi del sistema dei controlli, dei pesi e contrappesi che caratterizzano l’architettura costituzionale e dei quali non ci si è preoccupati quando è cominciata la stagione delle "spallate", delle manipolazioni delle leggi elettorali, del bipolarismo ad ogni costo, della "governabilità" senza aggettivi. Troppi apprendisti stregoni hanno lastricato la strada che oggi Berlusconi si ritiene legittimato a percorrere senza scrupoli. Così, nel deserto istituzionale, le funzioni di garanzia, ineliminabili in democrazia, si sono rifugiate nelle due istituzioni che il Presidente del Consiglio ha ieri pubblicamente rifiutato.
Mai, però, il tiro era stato alzato tanto in alto, per colpire deliberatamente il Presidente della Repubblica. Malumori, reazioni violente lasciate trapelare, senza tuttavia trasformare in conflitto aperto una relazione difficile. Cautele ormai abbandonate. Così com’è, il Presidente della Repubblica non è più accettabile. Questo, a chiare lettere, ha detto ieri Berlusconi.
Le ragioni di questa mossa sono nitide. Inaccettabile, per chi si nutre di sondaggi, la fiducia crescente riposta dai cittadini in Giorgio Napolitano. Inammissibile il quotidiano rivelare le lacerazioni del tessuto istituzionale per chi vuole manipolarle impunemente. Oltraggiosa la pretesa di custodire la legalità costituzionale per chi vuole trasformare l’investitura popolare in un "lodo" che lo pone al disopra delle leggi.
Berlusconi sa benissimo che una riforma costituzionale che azzoppi in un colpo solo Presidente della Repubblica e Corte costituzionale esige tempi lunghi. Ma non gli importa. Nel momento in cui dice esplicitamente che i poteri del Presidente della Repubblica devono essere ridotti, lascia intendere che sono male utilizzati. Invita così ad una pubblica "sfiducia" a Giorgio Napolitano, facendo divenire asse della sua politica il copione che già l’informazione di rito berlusconiano aveva cominciato a scrivere. Vuole demolire l’immagine del Presidente super partes, mostrarlo non come un garante, ma come l’espressione di una parte.
Napolitano parla anche perché troppi sono silenziosi, o ridotti al silenzio. Ma la voce delle istituzioni non può spegnersi. Da esperto della comunicazione, Berlusconi è inquieto perché sa che quella non è una voce che parla nel deserto, ma trova ascolto perché dice verità e così concentra sulla Presidenza della Repubblica l’attenzione dei cittadini consapevoli della gravità di una situazione che Berlusconi e i suoi gabellano come il migliore dei mondi.
Una relazione non populista con i cittadini insidia lo stesso modo d’essere di Berlusconi. Ma questo manifestarsi d’una opinione critica diffusa appare monco, perché rivela gli inaccettabili silenzi di una cultura alla quale non si chiede di essere militante, bensì d’essere parte di una difficile discussione pubblica, di testimoniare almeno quelle "ingenue idealità etiche" alle quali, contro il realismo politico, si richiamava nel 1929 Benedetto Croce votando contro il Concordato.
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. ---- MUSSOLINI E LENIN A CONFRONTO. L’analisi di Gramsci.8 aprile 2011, di Federico La Sala
 INDIVIDUO E SOCIETA’, OGGI. APRIRE GLI OCCHI: C’E’ DIO E "DIO", PATRIA E "PATRIA", E FAMIGLIA E "FAMIGLIA" .....
INDIVIDUO E SOCIETA’, OGGI. APRIRE GLI OCCHI: C’E’ DIO E "DIO", PATRIA E "PATRIA", E FAMIGLIA E "FAMIGLIA" .....
 ROMOLO AUGUSTOLO: L’ITALIA NON E’ NUOVA A QUESTI SCENARI. C’E’ CAPO E "CAPO" E STATO E "STATO": MUSSOLINI E LENIN A CONFRONTO. L’analisi di Gramsci, una bussola per non naufragare e una lezione di vita e di libertà
ROMOLO AUGUSTOLO: L’ITALIA NON E’ NUOVA A QUESTI SCENARI. C’E’ CAPO E "CAPO" E STATO E "STATO": MUSSOLINI E LENIN A CONFRONTO. L’analisi di Gramsci, una bussola per non naufragare e una lezione di vita e di libertà
 ANTONIO GRAMSCI (1924). "Roma non è nuova a questi scenari polverosi. Ha visto Romolo, ha visto Cesare Augusto e ha visto, al suo tramonto, Romolo Augustolo".
ANTONIO GRAMSCI (1924). "Roma non è nuova a questi scenari polverosi. Ha visto Romolo, ha visto Cesare Augusto e ha visto, al suo tramonto, Romolo Augustolo".
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. ---- LA SPARATA DI ASOR ROSA - UNA COMMEDIA DA TRE SOLDI.14 aprile 2011, di Federico La Sala
 La sparata di Asor Rosa
La sparata di Asor Rosa
 "Stato d’emergenza per salvare la democrazia"
"Stato d’emergenza per salvare la democrazia"
 Ferrara: è golpe. La replica: bisogna reagire
Ferrara: è golpe. La replica: bisogna reagire È eversivo invocare l’intervento di polizia e carabinieri? Lo sarei se invocassi la rivolta
È eversivo invocare l’intervento di polizia e carabinieri? Lo sarei se invocassi la rivolta
 Nessuna critica a Napolitano. Dobbiamo accettare o meno la fatalità di un bis del ’22
Nessuna critica a Napolitano. Dobbiamo accettare o meno la fatalità di un bis del ’22
 Berlusconi manda in frantumi le regole e l’assetto democratico e repubblicano
Berlusconi manda in frantumi le regole e l’assetto democratico e repubblicano
 Certo, la mia è una forzatura. Serve a farsi capire meglio e a focalizzare l’attenzione
Certo, la mia è una forzatura. Serve a farsi capire meglio e a focalizzare l’attenzione di Goffredo De Marchis (la Repubblica, 14.04.2011)
di Goffredo De Marchis (la Repubblica, 14.04.2011)ROMA - Per evitare che la storia si ripeta, che l’Italia torni alle condizioni del 1922 (alba del fascismo) o precipiti nella deriva della Germania del ‘33 (avvento di Hitler) Alberto Asor Rosa propone una strada: dichiarare lo stato di emergenza, congelare le Camere, chiamare al governo Carabinieri, Polizia di stato e magistratura. Il professore, ex parlamentare del Pci, descrive il suo progetto in un editoriale sul manifesto di ieri. La democrazia è già collassata, scrive Asor Rosa citando i precedenti del Novecento. Per colpa «di Berlusconi e dei suoi più accaniti seguaci».
L’articolo scatena, com’era prevedibile, Giuliano Ferrara che a Qui Radio Londra attacca a testa bassa accostando impropriamente Eugenio Scalfari e la Repubblica ad Asor Rosa e alla sua tesi: «C’è chi propone il colpo di Stato contro il governo eletto dai cittadini. Asor Rosa spiega con chiarezza un progetto politico che è di Repubblica. Del resto il professore fa parte della cricca di Scalfari». Ribatte a muso duro Asor Rosa: «C’è un’unica cricca lobbistica ed è quella notoriamente guidata dal presidente del Consiglio, ed i pericoli che ha provocato per la democrazia italiana sono pesantissimi». Asor Rosa però conferma la sua assurda exit strategy al berlusconismo. Lui stesso la definisce paradossale: «Pensavo mi chiamasse uno psichiatra, non un giornalista», dice rispondendo al telefono.
Se anche lei sa che il paradosso ha aspetti eversivi perché lo ha scritto? Propone di reagire alle regole calpestate violando tutte le regole. E gli amici del Cavaliere, come Ferrara, ci sguazzano. Bel risultato.
«Da tempo immemorabile Ferrara non rappresenta più nulla. Ma l’alternativa quale sarebbe? Tacere? Il mio ragionamento è chiaro, soprattutto nelle premesse. C’è un’obiettiva frantumazione delle regole ed è opera del capo del governo. L’atteggiamento etico politico di Berlusconi mette in discussione l’assetto democratico e repubblicano. Se tutto questo è vero, e secondo me è vero, bisogna porsi il problema di come se ne esce».
Ma lei immagina una «prova di forza» che è l’opposto della democrazia.
«La mia proposta è una forzatura e le forzature servono a farsi capire meglio. A focalizzare l’attenzione sulle premesse».
Poteva fermarsi a quelle.
«No, anche perché non credo che lo stato d’eccezione sia contro la nostra Costituzione».
Congelare le Camere, affidare i poteri alle forze dell’ordine. Dove ha letto queste cose nella Carta?
«Non sono un costituzionalista ma invito tutti a valutare bene gli articoli 87 e 88 della Costituzione. E a vedere cosa se ne ricava in un momento di rischio della democrazia. Se qualcuno mi dimostra che la democrazia in Italia non è a rischio accetto la confutazione. Altrimenti dobbiamo fare tutto il possibile per evitare il peggio».
Quegli articoli riguardano i poteri del presidente della Repubblica. Napolitano non sta già facendo moltissimo per respingere leggi inaccettabili e comportamenti fuori controllo?
«Non ho nessuna critica da muovere a Napolitano. Ma tutti abbiamo di fronte una responsabilità storica: accettare o meno la fatalità di quello che accade come avvenne nel ‘22 e nel ‘33. La prospettiva politica si è enormemente aggravata. E chiede un impegno che va oltre il semplice accettare o respingere leggi».
Lei soffia sul fuoco, non è anche questo pericolo? Per fortuna sono parole isolate.
«È eversivo, è soffiare sul fuoco invocare l’intervento di Polizia e Carabinieri? Sono organi dello Stato. Sarei eversivo se invocassi la rivolta popolare. Ma non lo faccio. Chiedo solo che la democrazia e lo Stato si autodifendano».
Un uomo con la sua storia di sinistra che invoca i generali. Non è in imbarazzo?
«L’apprezzamento per la polizia e i carabinieri fa parte della maturazione quasi secolare di cui sono portatore».
Una commedia da tre soldi
di Franco Cordero (la Repubblica, 14.04.2011)
Ha dell’allucinatorio il voto con cui la Camera berlusconiana qualifica reato ministeriale l’oggetto della causa postribolare pendente a Milano e intima al Tribunale d’astenersene: vale uno zero giuridico, perché i trecentoventi o quanti siano non hanno il potere che s’illudono d’esercitare; è come se un questore emettesse condanne penali o, arrogandosi funzioni ultraterrene, l’Olonese presidente del Consiglio distribuisse indulgenze à valoir nell’ipotetico purgatorio.
Scene d’una sgrammaticata commedia da due soldi, i cui attori improvvisano. Se la res iudicanda sia reato comune o ministeriale, lo diranno i giudici: data una condanna, l’appellante ripropone la questione; qualora soccomba anche lì, gli resta il ricorso in Cassazione. I cervelloni credono d’avere sferrato un colpo da maestri: «dichiariamo improcedibile l’accusa» (il clou esoterico sta nel predicato), «così il Tribunale, spalle al muro, deve ammettersi incompetente o sollevare un conflitto d’attribuzioni e tutto rimane sospeso». Ogni sillaba manda il suono delle monete false. Gli onorevoli straparlano, ossequenti al regime egomaniaco. Ipse dixit: è ai ferri corti col «brigatismo giudiziario», tale essendo nel suo universo deforme l’idea che la legge vincoli anche l’impunito ricchissimo; castigherà le toghe proterve, bisognose «d’una lezione»; e i famigli rabberciano norme à la carte.
La «sovranità del Parlamento» (i berluscones la vantano almeno due o tre volte pro die) è formula italiota d’una monarchia assoluta prima che s’installino gli embrioni del futuro Stato costituzionale: le attuali Camere sono cassa armonica dell’esecutivo; vi siedono persone ignote agli elettori; le nominano agenti del beneplacito sovrano.
Chiaro quale sia il modello: platee stupefatte dalla droga mediatica forniscono voti; lassù, accessibile soltanto alle baiadere, siede Dominus Berlusco, ogni mattina più ricco (quanto sia disinteressato, attento solo al bene collettivo, fuori della mischia d’affari, lo dicono sordi ringhi con cui accoglie l’estromissione dalle Generali della devota lunga mano Cesare Geronzi). Niente vieta che vecchi organi rimangano, anzi conviene tenerli in piedi, finti vivi, palcoscenico d’una troupe innocua: Sua Maestà ne prende uno o una qualunque nel mucchio e li addobba; voilà, diventano ministri o figure analoghe; gerarchie adoranti esercitano poteri subordinati in conflitto permanente; griglie selettive escludono i diversi.
Tale struttura subpolitica connota un Paese solo geograficamente europeo, dal futuro miserabile perché lo sviluppo economico richiede tensione psichica, cultura, lavoro duro, regole ferme, mentre qui regnano privilegi parassitari, variegato malaffare, gusti fraudolenti, mente corta, animule spente. Confessa una vocazione ministeriale, né punta basso aspirando alla Farnesina, la svelta figliola che, secondo l’accusa, sovrintendeva alle ospiti della reggia: nei dialoghi intercettati coltiva un argot dal percussivo registro turpiloquo; e sotto accusa d’avere gestito prostitute, conferma la candidatura.
Qui s’indigna uno che scrive in décor grammaticale, storpiando impetuosamente i concetti: non marchiamole con quel nome (nei Tre moschettieri Milady porta una P impressa a fuoco sulla spalla); sono damigelle intente allo scramble mondano; è risorsa anche il corpo. Lo stesso maestro pensatore sventola liberalismo sui generis e culto berlusconiano, classico ossimoro del genere «sole nero» o «ghiaccio bollente». Gli aneddoti dicono a che punto siamo nella corsa al Brave New World.
La malattia italiana non risponde più alla solita farmacopea. L’Unico squaglia gravi accuse in falsa ilarità turpiloqua, spaventando persino gli obbligati a ridere. Rebus sic stantibus, è imputato in quattro sedi. Da tre pendenze rognose lo liberano due leggi che le Camere votano sul tamburo, tagliando ancora la prescrizione e seppellendo d’un colpo l’intero processo, appena scadano dei termini. La terza toglie al giudice il vaglio del materiale probatorio offerto dalle parti: se la difesa indica mille testimoni, saranno escussi tutti, in mesi e anni, finché suoni la campana; l’aula chiude i battenti; non se ne parla più.
I giudizi diventano materia volatile: dibattimenti fluviali, processi brevi, larghe sacche d’oblio; fantasie carnevalesche da Nave dei matti? No, leggi italiane. L’ordinaria prassi politica risulta impotente contro l’abuso sistematico, tanto l’ha pervertita Re Lanterna. Temendo la sfiducia, compra degli oppositori (gesto automatico, gli viene naturale: cambiano uniforme, esigono i prezzi, li incassano; il transito non è finito, sappiamo dal coordinatore. La secessione nel Pdl inalberava insegne virtuose ma i bei giochi durano poco. Le anime transumano salmodiando motivi edificanti.
Di questo passo, la legislatura compie l’intero ciclo: tra due anni divus Berlusco s’insedia al Quirinale, portandovi i divertimenti che sappiamo (accadeva sotto Rodrigo Borgia, Sua Santità Alessandro VI; vedi monsignor Iohannes Burckardus, cerimoniere impeccabile e cronista meticoloso nel Liber notarum: domenica sera 31 ottobre 1501 danno spettacolo orgiastico «quinquaginta meretrices honestae»); presiede il consiglio l’attuale guardasigilli, viso spirituale; nella ratio studiorum dei licei appare una nuova materia, Arte dell’osceno. Tale essendo il presumibile futuro, è questione capitale come scongiurarlo: discutiamone perché i tempi stringono; tra poco il fuoco lambirà le polveri (scriveva Walter Benjamin, cultore d’allegorie e metafore).
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. ---- NON C’E’ PIU’ TEMPO (di Asor Rosa).14 aprile 2011, di Federico La Sala
Non c’è più tempodi Alberto Asor Rosa, (il manifesto, 13.04.2011)
Capisco sempre meno quel che accade nel nostro paese. La domanda è: a che punto è la dissoluzione del sistema democratico in Italia? La risposta è decisiva anche per lo svolgimento successivo del discorso. Riformulo più circostanziatamente la domanda: quel che sta accadendo è frutto di una lotta politica «normale», nel rispetto sostanziale delle regole, anche se con qualche effetto perverso, e tale dunque da poter dare luogo, nel momento a ciò delegato, ad un mutamento della maggioranza parlamentare e dunque del governo?
Oppure si tratta di una crisi strutturale del sistema, uno snaturamento radicale delle regole in nome della cosiddetta «sovranità popolare», la fine della separazione dei poteri, la mortificazione di ogni forma di «pubblico» (scuola, giustizia, forze armate, forze dell’ordine, apparati dello stato, ecc.), e in ultima analisi la creazione di un nuovo sistema populistico-autoritario, dal quale non sarà più possibile (o difficilissimo, ai limiti e oltre i confini della guerra civile) uscire?
Io propendo per la seconda ipotesi (sarei davvero lieto, anche a tutela della mia turbata tranquillità interiore, se qualcuno dei molti autorevoli commentatori abituati da anni a pietiner sur place, mi persuadesse, - ma con seri argomenti - del contrario). Trovo perciò sempre più insensato, e per molti versi disdicevole, che ci si indigni e ci si adiri per i semplici «vaff...» lanciati da un Ministro al Presidente della Camera, quando è evidente che si tratta soltanto delle ovvie e necessarie increspature superficiali, al massimo i segnali premonitori, del mare d’immondizia sottostante, che, invece d’essere aggredito ed eliminato, continua come a Napoli a dilagare.
Se le cose invece stanno come dico io, ne scaturisce di conseguenza una seconda domanda: quand’è che un sistema democratico, preoccupato della propria sopravvivenza, reagisce per mettere fine al gioco che lo distrugge, - o autodistrugge? Di esempi eloquenti in questo senso la storia, purtroppo, ce ne ha accumulati parecchi.
Chi avrebbe avuto qualcosa da dire sul piano storico e politico se Vittorio Emanuele III, nell’autunno del 1922, avesse schierato l’Armata a impedire la marcia su Roma delle milizie fasciste; o se Hinderburg nel gennaio 1933 avesse continuato ostinatamente a negare, come aveva fatto in precedenza, il cancellierato a Adolf Hitler, chiedendo alla Reichswehr di far rispettare la sua decisione?
C’è sempre un momento nella storia delle democrazie in cui esse collassano più per propria debolezza che per la forza altrui, anche se, ovviamente, la forza altrui serve soprattutto a svelare le debolezze della democrazia e a renderle irrimediabili (la collusione di Vittorio Emanuele, la stanchezza premortuaria di Hinderburg).
Le democrazie, se collassano, non collassano sempre per le stesse ragioni e con i medesimi modi. Il tempo, poi, ne inventa sempre di nuove, e l’Italia, come si sa e come si torna oggi a vedere, è fervida incubatrice di tali mortifere esperienze. Oggi in Italia accade di nuovo perché un gruppo affaristico-delinquenziale ha preso il potere (si pensi a cosa ha significato non affrontare il «conflitto di interessi» quando si poteva!) e può contare oggi su di una maggioranza parlamentare corrotta al punto che sarebbe disposta a votare che gli asini volano se il Capo glielo chiedesse. I mezzi del Capo sono in ogni caso di tali dimensioni da allargare ogni giorno l’area della corruzione, al centro come in periferia: l’anormalità della situazione è tale che rebus sic stantibus, i margini del consenso alla lobby affaristico-delinquenziale all’interno delle istituzioni parlamentari, invece di diminuire, come sarebbe lecito aspettarsi, aumentano.
E’ stata fatta la prova di arrestare il degrado democratico per la via parlamentare, e si è visto che è fallita (aumentando anche con questa esperienza vertiginosamente i rischi del degrado).
La situazione, dunque, è più complessa e difficile, anche se apparentemente meno tragica: si potrebbe dire che oggi la democrazia in Italia si dissolve per via democratica, il tarlo è dentro, non fuori.
Se le cose stanno così, la domanda è: cosa si fa in un caso del genere, in cui la democrazia si annulla da sè invece che per una brutale spinta esterna? Di sicuro l’alternativa che si presenta è: o si lascia che le cose vadano per il loro verso onde garantire il rispetto formale delle regole democratiche (per es., l’esistenza di una maggioranza parlamentare tetragona a ogni dubbio e disponibile ad ogni vergogna e ogni malaffare); oppure si preferisce incidere il bubbone, nel rispetto dei valori democratici superiori (ripeto: lo Stato di diritto, la separazione dei poteri, la difesa e la tutela del «pubblico» in tutte le sue forme, la prospettiva, che deve restare sempre presente, dell’alternanza di governo), chiudendo di forza questa fase esattamente allo scopo di aprirne subito dopo un’altra tutta diversa.
Io non avrei dubbi: è arrivato in Italia quel momento fatale in cui, se non si arresta il processo e si torna indietro, non resta che correre senza più rimedi né ostacoli verso il precipizio. Come?
Dico subito che mi sembrerebbe incongrua una prova di forza dal basso, per la quale non esistono le condizioni, o, ammesso che esistano, porterebbero a esiti catastrofici. Certo, la pressione della parte sana del paese è una fattore indispensabile del processo, ma, come gli ultimi mesi hanno abbondantemente dimostrato, non sufficiente.
Ciò cui io penso è invece una prova di forza che, con l’autorevolezza e le ragioni inconfutabili che promanano dalla difesa dei capisaldi irrinunciabili del sistema repubblicano, scenda dall’alto, instaura quello che io definirei un normale «stato d’emergenza», si avvale, più che di manifestanti generosi, dei Carabinieri e della Polizia di Stato congela le Camere, sospende tutte le immunità parlamentari, restituisce alla magistratura le sue possibilità e capacità di azione, stabilisce d’autorità nuove regole elettorali, rimuove, risolvendo per sempre il conflitto d’interessi, le cause di affermazione e di sopravvivenza della lobby affaristico-delinquenziale, e avvalendosi anche del prevedibile, anzi prevedibilissimo appoggio europeo, restituisce l’Italia alla sua più profonda vocazione democratica, facendo approdare il paese ad una grande, seria, onesta e, soprattutto, alla pari consultazione elettorale.
Insomma: la democrazia si salva, anche forzandone le regole. Le ultime occasioni per evitare che la storia si ripeta stanno rapidamente sfumando. Se non saranno colte, la storia si ripeterà. E se si ripeterà, non ci resterà che dolercene. Ma in questo genere di cose, ci se ne può dolere, solo quando ormai è diventato inutile farlo. Dio non voglia che, quando fra due o tre anni lo sapremo con definitiva certezza (insomma: l’Italia del ’24, la Germania del febbraio ’33), non ci resti che dolercene.
-
-
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. ---- Una roba così non era mai successa (di Michele Ainis - Deriva pericolosa).1 aprile 2011, di Federico La Sala
Deriva pericolosa
di Michele Ainis (Corriere della Sera, 01.04.11)
Una roba così non era mai successa. Il capo dello Stato che convoca i capigruppo al Quirinale, li mette in riga come scolaretti, gli chiede conto dei fatti e dei misfatti. D’altronde non era mai successo nemmeno il finimondo andato in scena negli ultimi due giorni. Il ministro della Difesa che manda a quel paese il presidente della Camera, quello della Giustizia che giustizia la sua tessera scagliandola contro i banchi dell’Italia dei Valori, quello degli Esteri che lascia la Libia al suo destino per votare un’inversione dell’ordine del giorno in Parlamento. Dall’altro lato della barricata, fra i generali del centrosinistra, contumelie e strepiti, toni roboanti, decibel impazziti. E intanto, nelle valli che circondano il Palazzo, folle rumoreggianti dell’opposizione, lanci di monetine, improperi contro il politico che osa esibire il suo faccione.
Diciamolo: la nostra democrazia parlamentare non è mai stata così fragile. Ed è un bel guaio, nel mese in cui cadono i 150 anni della storia nazionale. Perché uno Stato unito ha bisogno di istituzioni stabili, credibili, forti di un popolo che le sostenga. Ma in Italia la fiducia nelle istituzioni vola rasoterra. Per Eurispes nel 2010 le file dei delusi si sono ingrossate di 22 punti percentuali, per Ispo il 73%dei nostri connazionali disprezza il Parlamento. Colpa dello spettacolo recitato dai partiti, colpa del clima di rissa permanente che ha trasformato le due Camere in un campo di battaglia.
Le nazioni muoiono di impercettibili scortesie, diceva Giraudoux. Nel nostro caso le scortesie sono tangibili e concrete come il giornale lanciato in testa al presidente Fini. Ma non è soltanto una questione di bon ton, di buona educazione. O meglio, dovremmo cominciare a chiederci per quale ragione i nostri politici siano scesi in guerra. Una risposta c’è: perché sono logori, perché hanno perso autorevolezza, e allora sperano di recuperarla gonfiando i bicipiti. Sono logori perché il tempo ha consumato perfino il Sacro Romano Impero, e perché il loro impero dura da fin troppo tempo.
Guardateli, non c’è bisogno d’elencarne i nomi: sono sempre loro, al più si scambiano poltrona. Stanno lì da quando la seconda Repubblica ha inaugurato i suoi natali, ed è proprio il mancato ricambio delle classi dirigenti la promessa tradita in questo secondo tempo delle nostre istituzioni. Da qui l’urlo continuo, come quello di un insegnante che non sa ottenere il rispetto della classe. Perché se sei autorevole parli a bassa voce; ma loro no, sono soltanto autoritari. Ma da qui, in conclusione, il protagonismo suo malgrado del capo dello Stato.
D’altronde non sarà affatto un caso se l’istituzione più popolare abita sul Colle: dopotutto gli italiani, nonostante la faziosità della politica, sanno ancora esprimere un sentimento di coesione. E il presidente simboleggia per l’appunto l’unità nazionale, così c’è scritto nella nostra Carta. La domanda è: come raggiungerla? Con un ricambio dei signori di partito, con un’iniezione di forze fresche nel corpo infiacchito della Repubblica italiana. Ci penseranno (speriamo) le prossime elezioni. Quanto poi siano lontane, dipenderà dalla capacità di questo Parlamento di mantenere almeno il senso del decoro.
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- Barbarie a Montecitorio (di Curzio Maltese)1 aprile 2011, di Federico La Sala
Barbarie a Montecitorio
di Curzio Maltese (la Repubblica, 01.04.2011)
Come si sono ridotti così? Prima un po’ alla volta, poi tutto insieme. Il volto, i volti della classe dirigente riflettono ormai la deriva di un’agonia politica. Il ghigno stupefacente di Ignazio La Russa, l’isterico lancio della tessera del guardasigilli Alfano, lo sguardo esterrefatto di Fini, i deputati leghisti che ringhiano «handicappata di merda» alla collega disabile Ileana Argentin.
La malattia degenerativa di una democrazia di colpo assume i modi, le espressioni, i gesti di un’esplosione schizofrenica. Nell’ora dei telegiornali milioni d’italiani assistono attoniti a uno spettacolo di degrado, di squallore definitivo. Dentro l’aula l’impressione era ancora più penosa. Da un momento all’altro ti aspettavi che i leghisti prendessero anche a calci la carrozzella della deputata tormentata dalla distrofia o che qualcuno estraesse all’improvviso un’arma, come in Bowling for Colombine. Ogni tanto bisognava uscire fuori, per strada, fra la folla ordinata e pacifica che contestava in piazza Montecitorio, per respirare un po’ di normalità civile.
Vergogniamoci pure per loro, che non ne sono capaci. Ma perché sono arrivati a tanto? Il fatto è che il governo non esiste, la maggioranza non esiste e lo sa. Non esistono più da tre mesi, dal 14 dicembre scorso, quando il governo avrebbe dovuto essere sfiduciato dalla Camera e invece la scampò per i voltagabbana dell’ultima ora, i dipietristi pentiti Scilipoti e Razzi. Un colpo di coda col quale il premier è riuscito a garantire la propria sopravvivenza, ma niente di più. Il governo, la maggioranza sono comunque morti il 14 dicembre. Non decidono più, non sussistono. Se non all’unico scopo di sfornare leggi in grado di proteggere il premier dai processi. Per il resto, il governo è una nave fantasma, incapace da dicembre di compiere qualsiasi scelta, qualunque cosa accada. Terremoti, tsunami, crisi nucleari, guerre civili alle porte, rivoluzioni a un tiro di missile da casa. Niente. Disoccupazione, inflazione, scalate estere ai gruppi industriali. Silenzio. Uno dopo l’altro, sono spariti dalla scena i ministeri e i ministri, anche i più popolari e decisionisti. Che fine hanno fatto Brunetta, Maroni, Gelmini, perfino Tremonti? Ridotti a comparse. Sulla scena rimane l’ondivago Frattini, il nulla stesso fatto ministro, inventore del situazionismo in politica estera. E l’improvvisatore Ignazio La Russa, che fa notizia soltanto per calci, insulti e gestacci, mai per essere ministro della Difesa della nazione al centro del Mediterraneo in fiamme. Il mondo procede già come se l’Italia non avesse ufficialmente un governo, a prescindere. Perché convocare a un summit sulla crisi libica una sedia vuota?
Libera da ogni altra missione che non sia la salvaguardia di Berlusconi dalla legge, la maggioranza si divide soltanto sulle linee difensive. Oggi il gran dibattito nel centrodestra si svolge fra avvocati di Berlusconi, all’interno dei due principali studi legali. Quello di Gaetano Pecorella, scettico sulla necessità della battaglia per la prescrizione breve, e l’altro di Niccolò Ghedini, ideatore di leggi ad personam sempre più modellate sulle stringenti esigenze di Berlusconi. Con il ministro Alfano e la Lega nel ruolo di arlecchini servitori di due padroni.
È una condizione abbastanza umiliante da spiegare la deflagrazione di rabbia e violenza di questi giorni, il senso d’inutilità che esplode in un misto di rancore e vittimismo. Tanto più da parte di chi, come gli ex An e i leghisti, coltivava l’ambizione di far politica o almeno la pretesa di farlo credere agli elettori. Ma si ritrova imprigionato nella livrea del maggiordomo, scavalcato nella considerazione dall’ultimo venduto, dall’ultimo compagno di merende e compagna di bunga bunga, e allora se la prende con gli avversari, con i manifestanti, con chiunque ancora osi esibire brandelli di dignità, segnali di esistenza. Il governo e la maggioranza non ci sono più. Nella notte si sono svolte trattative fra i collegi di avvocati del premier, in vista della riconvocazione della Camera. Sarà un altro spettacolo d’angoscia. Per fortuna martedì torneranno in piazza anche i manifestanti in difesa della Costituzione, così potremo uscire ogni tanto dal manicomio di Montecitorio a respirare un po’ di civiltà.
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- Ieri come oggi, una diarchia di fatto. La monarchia fascista e il "bipresidenzialismo democratico".13 marzo 2011
 CRISI COSTITUZIONALE: L’ITALIA CON "DUE PRESIDENTI" DELLA REPUBBLICA!!! LA LUNGA OFFESA E LA DEVASTANTE OFFENSIVA DEL CAVALIERE DI "FORZA ITALIA" CONTRO L’ITALIA (1994-2011)!!!
CRISI COSTITUZIONALE: L’ITALIA CON "DUE PRESIDENTI" DELLA REPUBBLICA!!! LA LUNGA OFFESA E LA DEVASTANTE OFFENSIVA DEL CAVALIERE DI "FORZA ITALIA" CONTRO L’ITALIA (1994-2011)!!!
 La monarchia fascista e il "bipresidenzialismo democratico". Ieri come oggi, una diarchia di fatto. Due note di Nicola Tranfaglia
La monarchia fascista e il "bipresidenzialismo democratico". Ieri come oggi, una diarchia di fatto. Due note di Nicola Tranfaglia
 SE LA GUERRA non avesse costretto le istituzioni fondamentali della società italiana, il Vaticano e la monarchia sabauda a dissociarsi dal dittatore, questi sarebbe durato altri trent’anni come avvenne puntualmente a Francisco Franco in Spagna e a Salazar in Portogallo.
SE LA GUERRA non avesse costretto le istituzioni fondamentali della società italiana, il Vaticano e la monarchia sabauda a dissociarsi dal dittatore, questi sarebbe durato altri trent’anni come avvenne puntualmente a Francisco Franco in Spagna e a Salazar in Portogallo.
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- CONTIAMO ANCORA COME SE FOSSIMO NELLA CAVERNA DI PLATONE. UNITA’ D’ITALIA E FOLLIA: EMERGENZA LOGICO-MATEMATICA.19 febbraio 2011, di Federico La Sala
 RIPENSARE L’UNO E I MOLTI ("UNO"), L’IDENTITA’ E LA DIFFERENZA!!! CONTIAMO ANCORA COME SE FOSSIMO NELLA CAVERNA DI PLATONE. NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN ....
RIPENSARE L’UNO E I MOLTI ("UNO"), L’IDENTITA’ E LA DIFFERENZA!!! CONTIAMO ANCORA COME SE FOSSIMO NELLA CAVERNA DI PLATONE. NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN ....
 UNITA’ D’ITALIA E FOLLIA: EMERGENZA LOGICO-MATEMATICA. PER UN CONVEGNO E UNA RIFLESSIONE SUL CONCETTO DI ’UNITA’ E DI SOVRANITA’ (SOVRA-UNITA’). Materiali sul tema
UNITA’ D’ITALIA E FOLLIA: EMERGENZA LOGICO-MATEMATICA. PER UN CONVEGNO E UNA RIFLESSIONE SUL CONCETTO DI ’UNITA’ E DI SOVRANITA’ (SOVRA-UNITA’). Materiali sul tema
 USCIRE DALLA CAVERNA, USCIRE DALLO STATO DI MINORITA’, USCIRE DALLA "PREISTORIA" E NON RICADERE NELL’ILLUSIONE E NEL DELIRIO DELL’ “UOMO SUPREMO” DEI VISIONARI E DEI METAFISICI ATEI-DEVOTI
USCIRE DALLA CAVERNA, USCIRE DALLO STATO DI MINORITA’, USCIRE DALLA "PREISTORIA" E NON RICADERE NELL’ILLUSIONE E NEL DELIRIO DELL’ “UOMO SUPREMO” DEI VISIONARI E DEI METAFISICI ATEI-DEVOTI
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. ---- "APRITE, APRITE": SONO IL VOSTRO "PAPI"!!! DALLA FIABA, UNA LEZIONE DI PENSIERO COSTITUZIONALE A FILOSOFI E A GIURISTI.17 febbraio 2011
 DALLA FIABA, UNA LEZIONE DI PENSIERO COSTITUZIONALE A FILOSOFI E A GIURISTI. A VLADIMIR J. PROPP E A GIANNI RODARI, A ETERNA MEMORIA...
DALLA FIABA, UNA LEZIONE DI PENSIERO COSTITUZIONALE A FILOSOFI E A GIURISTI. A VLADIMIR J. PROPP E A GIANNI RODARI, A ETERNA MEMORIA...
 "APRITE, APRITE": SONO IL VOSTRO "PAPI"!!! LA PAROLA "ITALIA", LA "PASSWORD", CONSEGNATA A UN PARTITO (1994-2011), L’ASTUZIA DEL LUPO, E I SETTE CAPRETTI. Un omaggio a Giorgio Napolitano, al Presidente della Repubblica italiana
CRISI COSTITUZIONALE (1994-2011). "DUE PRESIDENTI" DELLA REPUBBLICA GRIDANO: FORZA ITALIA!!! LA DOMANDA E’: CHI E’ "PULCINELLA"? CHI E’ "IL LUPO"?!
"APRITE, APRITE": SONO IL VOSTRO "PAPI"!!! LA PAROLA "ITALIA", LA "PASSWORD", CONSEGNATA A UN PARTITO (1994-2011), L’ASTUZIA DEL LUPO, E I SETTE CAPRETTI. Un omaggio a Giorgio Napolitano, al Presidente della Repubblica italiana
CRISI COSTITUZIONALE (1994-2011). "DUE PRESIDENTI" DELLA REPUBBLICA GRIDANO: FORZA ITALIA!!! LA DOMANDA E’: CHI E’ "PULCINELLA"? CHI E’ "IL LUPO"?! L’ITALIA CON "DUE PRESIDENTI" DELLA REPUBBLICA: "CORTO CIRCUITO"!!! LA LUNGA OFFESA E LA DEVASTANTE OFFENSIVA DEL CAVALIERE DI "FORZA ITALIA" CONTRO L’ITALIA (1994-2011)!!!
L’ITALIA CON "DUE PRESIDENTI" DELLA REPUBBLICA: "CORTO CIRCUITO"!!! LA LUNGA OFFESA E LA DEVASTANTE OFFENSIVA DEL CAVALIERE DI "FORZA ITALIA" CONTRO L’ITALIA (1994-2011)!!!
 L’ITALIA, IL "BIPOLARISMO PRESIDENZIALE", E I COSTITUZIONALISTI IN COMA PROFONDO (1994-2011). Sul nodo dello scioglimento delle camere, una intervista di Nino Luca al giurista Piero Alberto Capotosti
L’ITALIA, IL "BIPOLARISMO PRESIDENZIALE", E I COSTITUZIONALISTI IN COMA PROFONDO (1994-2011). Sul nodo dello scioglimento delle camere, una intervista di Nino Luca al giurista Piero Alberto Capotosti-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. ---- L’ITALIA VISTA DAGLI USA: L’IMMAGINE DI UN PAESE IN DECLINO. DOCUMENTI WIKILEAKS .18 febbraio 2011, di Federico La Sala
I DOCUMENTI
 WikiLeaks, l’Italia vista dagli Usa
WikiLeaks, l’Italia vista dagli Usa
 "Con Berlusconi paese ormai in declino"
"Con Berlusconi paese ormai in declino" Le valutazioni della diplomazia statunitense contenute nei nuovi documenti segreti.
Le valutazioni della diplomazia statunitense contenute nei nuovi documenti segreti.
 "La reputazione in Europa è lesa". "Il premier danneggia l’Italia ma ci è utile e non dobbiamo abbandonarlo, alla fine ne trarremo vantaggi"
"La reputazione in Europa è lesa". "Il premier danneggia l’Italia ma ci è utile e non dobbiamo abbandonarlo, alla fine ne trarremo vantaggi" di FABIO BOGO *
di FABIO BOGO *ROMA - Quattromila cables riservati filtrati dall’ambasciata Usa a Roma, oltre 30 mila pagine di documenti finora segreti che raccontano l’Italia e i suoi protagonisti dal punto di vista critico e sferzante del suo più importante alleato. E molti di questi con un denominatore comune: il declino del ruolo internazionale dell’Italia è strettamente legato all’immagine di Silvio Berlusconi, l’uomo che la guida e la condiziona dal 1994, l’anno della sua discesa in campo. Dal 2002 al 2010 parlano ambasciatori, segretari di Stato, diplomatici di alto livello, politici di primo piano. Tutte comunicazioni rigorosamente classificate. Tutte rigorosamente destinate a restare riservate. Tutte, adesso, contenute nei cables che WikiLeaks ha ottenuto e che l’Espresso, in collaborazione con Repubblica, comincia da oggi a pubblicare.
UN PREMIER CHE OFFENDE TUTTI
"Il premier Silvio Berlusconi con le sue frequenti gaffes e la scelta sbagliata delle parole" ha offeso nel corso del suo mandato "quasi ogni categoria di cittadino italiano e ogni leader politico europeo", mentre "la sua volontà di mettere gli interessi personali al di sopra di quelli dello Stato ha leso la reputazione del Paese in Europa ed ha dato sfortunatamente un tono comico al prestigio dell’Italia in molte branche del governo degli Stati Uniti".
E’ il febbraio del 2009 quando Ronald Spogli, ambasciatore americano in Italia nominato dal Presidente George W. Bush, si congeda dal suo mandato e scrive al nuovo segretario di Stato Hillary Clinton un memoriale intitolato "What can we ask from a a strong allied" (Cosa possiamo chiedere ad un forte alleato), classificato come Confidential e che ha un sapore profetico. Non è ancora esploso lo scandalo di Noemi Letizia, non è apparsa all’orizzonte la escort Patrizia D’Addario, non c’è ancora traccia dei festini di Arcore, né delle accuse di sfruttamento della prostituzione minorile con la marocchina Ruby, né delle pressioni sulla questura di Milano per procurarsi il silenzio della vittima. Le leggi ad personam proposte per tutelare il primo ministro dalle conseguenze dei processi in corso non sono state ancora respinte e non ha raggiunto l’apice il violento conflitto con la magistratura.
Ma ad inizio 2009 il premier, visto dagli Usa, è già un uomo debole, prigioniero dei suoi conflitti di interesse e dell’evidenza internazionale dei suoi abusi di potere. Quindi bisognoso dell’aiuto americano per legittimarsi sul piano interno e estero e come tale disponibile, quando richiesto, a comportarsi come "il migliore alleato". Berlusconi insomma non è nelle condizioni di dire alcun "no" a chi lo sostiene. Una sorta di ostaggio, che accetta volentieri tutte le richieste in termini di impegno militare e politico negli scacchieri strategici che vanno dall’Afghanistan alla ricollocazione dei prigionieri di Guantanamo, dalle basi sul territorio italiano alle sanzioni all’Iran. Un prezzo che finora non si sapeva di aver pagato.
L’IMMAGINE DI UN PAESE IN DECLINO
"Il lento ma costante declino economico dell’Italia - scrive l’ambasciatore Spogli - compromette la sua capacità di svolgere un ruolo nell’arena internazionale. La sua leadership spesso manca di una visione strategica. Le sue istituzioni non sono ancora sviluppate come dovrebbero essere in un moderno paese europeo. La riluttanza o l’incapacità dei leader italiani a contrastare molti dei problemi che affliggono la società, come un sistema economico non competitivo, l’obsolescenza delle infrastrutture, il debito pubblico crescente, la corruzione endemica, hanno dato tra i partner l’impressione di una governance inefficiente e irresponsabile. Il primo ministro Silvio Berlusconi è il simbolo di questa immagine". Spiega Spogli: gaffes e preminenza per gli interessi personali, assieme "al frequente uso delle istituzioni pubbliche per conquistare vantaggi elettorali sui suoi avversari politici, la sua preferenza per soluzioni a breve termine hanno danneggiato la reputazione dell’Italia in Europa". Un’immagine che Berlusconi tenta di rivitalizzare con iniziative che lasciano perplessi gli Usa.
L’Italia - annota Spogli - "fa molti sforzi, alcuni seri altri meno, per mantenere una posizione di rilevanza e influenza". Come quando "si propone nel ruolo di grande mediatore delle crisi mondiali, un ruolo autoconferitosi che alcuni politici, specialmente il premier Silvio Berlusconi, pensano possa conferire grande visibilità senza praticamente spendere alcunché". O come quando, senza alcun coordinamento, ritiene di avere i titoli per "mediare tra la Russia e l’Occidente, impegnarsi con Hamas e Hezbollah, stabilire nuovi canali di negoziato con l’Iran, espandere l’agenda del G8 con mandati al di là di ogni riconoscimento".
Insomma, una politica assolutamente velleitaria. Con costernazione Spogli prende atto che in una puntata di "Porta Porta" Berlusconi annuncia il ritiro dall’Iraq: svegliati in piena notte i generali Usa a Baghdad e mandata la trascrizione della puntata tv al Pentagono. Esterrefatto l’ambasciatore registra che mentre Israele bombarda Gaza il Cavaliere rilancia l’idea del tutto estemporanea di costruirvi alberghi e resort, annunciando che potrebbe "trovare investitori". Allibito informa Washington che il premier ha una sua strategia per la Siria, visto che l’allora moglie Veronica "ha conosciuto la consorte di Assad a Damasco", e dice: "Dovremmo coinvolgerla..."
Ma a Washington sono pragmatici. Si deve abbandonare un alleato pasticcione, in declino economico e inviso alle cancellerie europee per idiosincrasia politica?. "No - scrive Spogli alla Clinton - non dobbiamo. Dobbiamo anzi riconoscere che un impegno di lungo termine con l’Italia e i suoi leader politici ci darà importanti dividendi strategici adesso e in futuro"
IL DIVIDENDO DI WASHINGTON
Cosa può incassare l’America da questo governo? Spogli è esplicito. "L’Italia ci permetterà di consolidare i progressi fatti faticosamente nei Balcani negli ultimi vent’anni, le loro forze armate continueranno a giocare un ruolo importante nelle operazioni di peacekeeping in Libano e in Afghanistan, e, infine, il territorio italiano sarà strategico per l’Africom (United States African Command)", l’organismo costituito nel 2008 dalla Difesa Usa per coordinare gli interventi militari in Africa: comando a Stoccarda, ma bombardieri di stanza a Vicenza, nella base Dal Molin, e portaerei della VI flotta a Napoli. " Se useremo una forte pressione - sostiene inoltre Spogli - l’Italia eserciterà la sua influenza economica in Iran per mandare a Teheran un chiaro segnale che potrebbe influire sulla loro politica di sviluppo nucleare". E anche sul fronte del terrorismo Washington sa che Roma spalancherà le sue porte. Già nel febbraio 2009 Spogli avverte infatti che l’Italia si sta diligentemente preparando ad esaudire "quelle che ritengono saranno tra le nostre prime richieste, il farsi carico della custodia di alcuni detenuti nella prigione di Guantanamo (il ministro Frattini ufficializzerà la decisione 4 mesi dopo, ndr.) e un maggiore sforzo militare in Afghanistan (l’Italia sorprenderà gli Usa aggiungendo altri 1200 soldati ad Herat, portando il contingente schierato ad un totale di 4200 uomini).
L’unica vera preoccupazione è il rapporto tra Roma e Mosca, tra Berlusconi e Putin. Gli Usa vogliono controbilanciare la crescente influenza russa sul fronte dell’energia, e notano con disappunto che "l’Italia, sfortunatamente, invece la favorisce". Sui rapporti tra Berlusconi e Putin il punto di vista americano è noto. L’ambasciata Usa anche dopo la sostituzione di Spogli con David Thorne è in allarme e agisce su più fronti. Stimola il ritorno al nucleare, interviene sul governo per spezzare l’asse con Mosca e suggerisce: "dobbiamo far capire a Berlusconi che ha una relazione personale con noi e dobbiamo assecondare la sua convinzione di essere uno statista esperto". Ma l’operazione non è facile, il legame del cavaliere con "il suo amico Vladimir" è solida e ha radici misteriose. tanto misteriose da indurre Hillary Clinton nel gennaio 2010 a chiedere alle rappresentanze diplomatiche interessate di indagare sulle "possibili relazioni e investimenti personali che legano Putin e Berlusconi e che possono influenzare la politica energetica dei due paesi", e di svelare " i rapporti tra l’amministratore delegato dell’Eni Paolo Scaroni, i top manager dell’Eni e i membri del governo italiano, specialmente il premier e il ministro degli esteri Frattini". Gli americani si troveranno davanti ad un muro: in un cable un diplomatico italiano spiega che "tutto avviene direttamente tra Berlusconi e Putin".
UN PREZZO IRRISORIO DA PAGARE
Pasticciona e in difficoltà, l’Italia chiede aiuto agli Usa quando si accorge che l’organizzazione del G8 a L’Aquila comincia a fare acqua. Gli americani se ne sono già accorti, e una serie di cables descrivono la tensione nell’ambasciata di Roma: il flop può tramutarsi in una debacle per Berlusconi, già colpito dalle prime rivelazioni sugli scandali sessuali. Scatta il soccorso all’utile alleato: "Berlusconi - annotano - ha bisogno di mostrarsi un leader credibile a livello internazionale per ripulire la sua immagine, e ci sarà tremenda attenzione" al trattamento che riceverà dagli altri capi di stato e di governo. Obama acconsente e in Abruzzo il presidente "abbronzato" è gentile e comprensivo. Il vertice è un successo, il Cavaliere è salvo, l’opposizione politica è sconfitta
CONDANNATI ALL’INSTABILITA’
Gli americani capiscono dunque che con Berlusconi dovranno conviverci. A lungo. E sfruttarne le debolezze, che utilitaristicamente diventeranno per Washington preziose cambiali in bianco, da riscuotere all’occorrenza. Ne sono consci già prima delle elezioni del 2008, che - dopo la caduta della litigiosa coalizione guidata da Romano Prodi - riporteranno a Palazzo Chigi il Cavaliere, vittorioso su Walter Veltroni. "Se vince Veltroni la situazione sarà eccellente - scrivono da Roma a Washington - se ritorna Berlusconi sarà molto eccellente". Ne sono ancora più convinti dopo il G8 de L’Aquila. Non apprezzano la magistratura, definita "una casta inefficiente e autoreferenziale", priva di controllo e che condiziona la vita politica; non credono nei dissidenti della maggioranza; giudicano il Pd disorganizzato. E anche quando la Corte Costituzionale boccia il lodo Alfano non si preoccupano: Berlusconi resisterà. Temono invece gli effetti sul Paese dello scontro con il presidente Napolitano. Il Presidente è visto come una figura assolutamente cruciale per la stabilità del Paese, è stimato e seguito. Il Quirinale non si tocca, è un assoluto punto di riferimento. "Gli attacchi a una figura molto rispettata potrebbero essere presi male da molti italiani e determinare più ampie divisioni tra le due istituzioni". È uno scenario preoccupante, ma che porta anche dei vantaggi. Il premier infatti "per difendersi dai processi si dovrà distrarre dal lavorare per il popolo italiano". Ma ci sono altri referenti pronti a lavorare per gli Usa. I ministri Frattini e La Russa, ad esempio, vengono definiti particolarmente ansiosi di collaborare. Mentre ad Arcore continuano i festini, il business può proseguire.
-
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- Michele Ciliberto («La democrazia dispotica») analizza le ragioni profonde dell’«anomalia Italia». Troppe le comprimissioni della nostra classe dirigente (di Nicola Tranfaglia).9 febbraio 2011, di Federico La Sala
 Nel suo nuovo lavoro, Michele Ciliberto analizza le ragioni profonde dell’«anomalia Italia»
Nel suo nuovo lavoro, Michele Ciliberto analizza le ragioni profonde dell’«anomalia Italia»
 Il problema non è solo Berlusconi: sono troppe le comprimissioni della nostra classe dirigente
Il problema non è solo Berlusconi: sono troppe le comprimissioni della nostra classe dirigente Per capire la «democrazia dispotica» italiana ci vuole più Gramsci e meno Tocqueville
Per capire la «democrazia dispotica» italiana ci vuole più Gramsci e meno Tocqueville È in libreria «La democrazia dispotica» di Michele Cilberto (pp. 195, euro 18, editore Laterza): dice lo studioso che quello italiano è un «regime» democratico alla sua massima espressione..
È in libreria «La democrazia dispotica» di Michele Cilberto (pp. 195, euro 18, editore Laterza): dice lo studioso che quello italiano è un «regime» democratico alla sua massima espressione...
 di Nicola Tranfaglia (l’Unità, 09.02.2011)
di Nicola Tranfaglia (l’Unità, 09.02.2011)Tra i molti libri che gli editori stanno inviando finalmente in libreria ora che l’egemonia berlusconiana è entrata in grave crisi, l’inchiesta di Milano incalza e a fine febbraio o poco tempo dopo, il presidente del Consiglio sarà costretto, con molta probabilità, a comparire di fronte ai suoi giudici ordinari (visto che il legittimo impedimento è in gran parte crollato e lui, almeno formalmente, è tornato ad essere cittadino italiano agli effetti giudiziari), anche l’editore Laterza è ora presente con La democrazia dispotica di Michele Cilberto (pp. 195, euro 18, collana I Sagittari) che è tra i migliori studiosi di Giordano Bruno a livello internazionale e insegna Storia della filosofia moderna e contemporanea alla Normale di Pisa.
Il libro di Ciliberto merita molto interesse anche per chi non è del tutto d’accordo con le categorie adottate dall’autore, specialista, peraltro, di altri secoli e non dell’età contemporanea con cui oggi abbiamo a che fare. Secondo Ciliberto, il regime con cui abbiamo oggi a che fare è un regime democratico nella sua massima espressione, come Tocqueville prefigurava come degenerazione (già nel Settecento, nel suo capolavoro, La democrazia in America), perché sono presenti, nello stesso tempo, un grande apparato burocratico proprio dello Stato contemporaneo e il potere carismatico di Silvio Berlusconi che ha creato un partito a sua immagine e somiglianza e lo governa con criteri che violano ogni giorno i principi della costituzione repubblicana fissati nella prima parte del testo. Quest’affermazione si può sottoscrivere interamente, ma mi chiedo due cose da contemporaneista quale sono da quasi mezzo secolo: tutti i regimi democratici europei sono arrivati alla democrazia dispotica come quella italiana? O invece la Francia, la Germania, la Gran Bretagna e gli Usa hanno ancora regimi democratici e non dispotici?
È un interrogativo centrale sul piano storico perché l’anomalia Italia deriva non solo dalle qualità negative di Berlusconi (sulle quali siamo d’accordo) ma sull’incapacità complessiva che le classi dirigenti soprattutto di centro-destra dominanti hanno avuto nella crisi del 1943-46 di rinnovare lo Stato italiano, sulle caratteristiche indicate proprio da Gramsci che parla di ricorrente sovversivismo delle classi dirigenti, sulla crisi della repubblica sorta con la fine del centro-sinistra e l’assassinio di Aldo Moro e precipitata all’inizio degli anni novanta.
Ciliberto, uno dei nostri migliori studiosi dell’età moderna, fa molto bene a utilizzare tutti i classici della politica europea e americana, da Tocqueville a Marx, a Max Weber e, in piccola parte, anche Gramsci che, a mio avviso, per essere stato un grande storico dell’Italia moderna e contemporanea, avrebbe potuto essere citato e usato meglio di quanto avviene nel libro (ma la giustificazione implicita è che, a settant’anni dalla nascita della repubblica, nessuno storico, e tanto meno quelli che sono stati comunisti, hanno scritto ancora il libro, sempre più necessario e opportuno, sulla interpretazione che Gramsci ha dato della nostra storia).
La situazione italiana, come sappiamo, è drammatica e ha ragione chi afferma che Berlusconi sta declinando come pure la sua personale egemonia, ma che il berlusconismo resiste ancora e potrebbe continuare a dominare l’Italia, se le forze delle opposizioni non saranno in grado, al più presto, di fare un programma preciso e alternativo. Del resto i nostri amici europei ci dicono ogni giorno che siamo ancora nel baratro e non siamo neppure in grado di far precipitare la crisi in modo tale che il Capo dello stato sciolga le Camere e proceda subito alle elezioni, per evitare la rovina totale del settore intero della istruzione e superare la crisi economica che colpisce le classi medie e tutti quelli che hanno difficoltà ad arrivare alla quarta o alla terza settimana del mese. L’attuale situazione, questo è il punto, non è qualcosa che si esprime improvvisamente con l’ascesa di Berlusconi ma piuttosto la sua ascesa è dovuta a ragioni storiche di breve e lunga durata.
Allora o si riscrive la storia d’Italia, sottolineando questi aspetti e i frequenti compromessi delle classi dirigenti italiane di ogni colore verso le associazioni mafiose, i vertici del Vaticano e altre istituzioni dell’Italia più arretrata e non democratica, o si dà un’immagine del nostro paese che non può reggere al confronto internazionale, oggi necessario. Abbiamo bisogno, perciò, di discutere le categorie di metodo, usare più Gramsci e meno Tocqueville, ed elaborare una visione storicamente valida dell’odierno populismo mediatico-autoritario. L’Italia, a mio avviso, non è mai arrivata a una democrazia compiuta e ne paga ancora le conseguenze.
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. ---- MA COME AVETE FATTO A RIDURVI COSI’?!. UN PAESE BORDELLO!!!8 febbraio 2011, di Federico La Sala
Il Paese Bordello
di Maurizio Viroli (il Fatto Quotidiano, 8 febbraio 2011)
‘Bordello State’ e ‘Whoreocracy’, che tradurrei con ‘il governo delle puttane’, sono probabilmente le due espressioni che meglio di altre caratterizzano l’immagine dell’Italia negli Stati Uniti. La prima deriva da un articolo di James Walston, su Foreign Policy del 14 settembre 2010; la seconda da un commento a proposito di uno scritto di Alexander Stille sulla New York Review of Books dell’ 8 aprile 2010, dal titolo ‘The Corrupt Reign of Emperor Silvio’. Pochi giorni or sono, la parola ‘bordello’ capeggiava in un articolo del New York Times. Questa volta, però erano dei manifestanti che reggevano un cartello con la scritta, ‘L’Italia non è un bordello’.
SIAMO DUNQUE riusciti a conquistarci presso l’opinione pubblica americana il poco invidiabile titolo di ‘stato bordello’ o ‘stato in cui governano le puttane’. Gli opinionisti diranno che la colpa è degli oppositori di Berlusconi che diffondono a piene mani stereotipi anti-italiani. La verità è che sono gli altri ad attribuirci immagini poco edificanti anche perché hanno occhi per vedere, e sanno ancora ragionare, un’arte ormai estinta in Italia. Gli stessi commentatori, va detto, riconoscevano i nostri pregi, all’epoca di Tangentopoli, quando pareva che l’Italia si fosse avviata su una strada di riscatto civile.
Si potrebbe concludere che gli aspetti della realtà italiana che maggiormente colpiscono l’opinione pubblica americana, o che i giornali trasmettono, sono lo scandalo politico a sfondo sessuale e l’uso disinvolto del potere, con forme di vera e propria buffoneria. Siamo insomma, come altre volte in passato, ridicoli e malati di maschilismo, oltre alla ormai consolidata immagine di una democrazia viziata da una diffusa e tollerata corruzione politica.
Agli occhi degli americani Berlusconi merita di essere deriso e disprezzato perché è un uomo di cui dei cittadini maturi non dovrebbero fidarsi in quanto non rispetta i requisiti minimi dell’integrità personale, a cominciare dall’essere leale, dal sapersi controllare, dal senso di responsabilità. Per gli americani il potere politico non è proprietà di chi governa, ma appartiene ai cittadini che lo affidano a dei rappresentanti, per un tempo limitato e sotto precisi controlli, affinché lo usino per il bene pubblico. Proprio perché è un potere importante non lo si può delegare a persone che si rendono ricattabili, che mentono, e che sono dominate da un sentimento di onnipotenza. Per loro dare il potere di governare a un politico che si comporta come il primo ministro italiano sarebbe come consegnare i sudati risparmi a un noto truffatore.
La domanda che l’opinione pubblica americana si pone a proposito dell’Italia non è tanto ‘che cosa succede?’, ma ‘come avete fatto a ridurvi così?’. Non sono tanto interessati ai fatti della cronaca politica ma a capire come e perché una nazione come l’Italia abbia permesso l’ascesa al potere di Silvio Berlusconi e tolleri senza troppi sussulti i suoi metodi.
Quello che davvero non riescono a spiegarsi è come mai gli italiani, che pur vivono in democrazia da più di sessant’anni, non abbiano capito il principio fondamentale del liberalismo, quello che insegna a temere il potere illimitato, chiunque lo detenga. Più che moralisti sono saggi. Non capiscono come e perché gli scaltrissimi italiani si lascino governare da un uomo che possiede un impero mediatico e una ricchezza sterminata. I più benevoli cercano di consolarci dicendo: ‘Anche da noi il denaro condiziona la politica’. Ma si rendono subito conto che il loro più ricco politico non ha il potere di Berlusconi e che la democrazia americana ha difese molto più efficaci della nostra che sono da individuare, a mio giudizio, più nel costume che nelle istituzioni.
MOLTI commentatori, per citare un solo esempio, sottolineano che se in America il presidente della Repubblica ricevesse ‘escort’ alla Casa Bianca, e organizzasse a casa sua serate con prostitute, l’indignazione nell’opinione pubblica e nel Congresso sarebbe tale da costringerlo a immediate dimissioni. Per non parlare poi dell’effetto che avrebbero gli attacchi ai magistrati e soprattutto le reiterate accuse alla Corte costituzionale rea di interferire illegittimamente sulle decisioni delParlamento votato dal popolo.
Per questo la domanda che nelle ultime settimane più spesso si pongono è se davvero siamo arrivati alla fine dell’era berlusconiana. Ma gli osservatori più attenti, come Jason Horowitz sul Washington Post del 14 dicembre, rilevano che il consenso parlamentare è ancora forte e che l’opposizione è divisa e non ha un candidato che paia in grado di vincere. In caso di elezioni anticipate potrebbe trionfare di nuovo Berlusconi e avere aperta la via per la presidenza della Repubblica.
Eppure, nel modo in cui gli americani seguono le nostre vicende traspare una preoccupazione che non ho mai riscontrato in passato. Se considerassero Berlusconi soltanto un caso di buffoneria e corruzione non si allarmerebbero molto. Nel mondo non mancano certo esempi da questo punto di vista anche più eloquenti. Avvertono invece che un sistema come quello che Berlusconi ha costruito in Italia potrebbe trovare imitatori in altri paesi democratici. Sarebbe insomma il futuro, non un altro esempio del malcostume politico italiano.
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. ---- "BERLUSCONI DIMETTITI": A MILANO, IL 5 FEBBRAIO 2011, MANIFESTAZIONE AL PALASHARP.Libertà e Giustizia raccoglie la domanda di mobilitazione.4 febbraio 2011, di Federico La Sala
La manifestazione
Palasharp di Milano, il 5 febbraio: ingresso libero
Berlusconi dimettiti! *
Libertà e Giustizia raccoglie la domanda di mobilitazione che arriva dai commenti all’appello Resignation - DIMISSIONI. Il testo ha raccolto decine di migliaia di firme in Italia, in Europa e anche negli Usa. Rilanciato dai social network, dai blogger e dai siti d’informazione, porta le prime firme di Gustavo Zagrebelsky, Paul Ginsborg e Sandra Bonsanti. Ma migliaia sono stati i commenti di chi ha lasciato un messaggio: “firmare non basta”, “facciamo qualcosa”, “Berlusconi lasci il governo del paese”. Libertà e Giustizia risponde a questa richiesta con “una prima manifestazione - spiega Sandra Bonsanti, presidente dell’associazione - per testimoniare la storia, la voce di chi non ha accettato passivamente l’imbarbarimento prodotto dalla politica e dalla cultura di Silvio Berlusconi e per gridare un ‘Basta’ allo smantellamento dello Stato”. L’appuntamento è per sabato, 5 febbraio, a partire dalle 15 (cancelli aperti dalle 13 e 30), al Palasharp di Milano (via Sant’Elia, 33 - MM Lampugnano) con Umberto Eco, Paul Ginsborg, Roberto Saviano, Gustavo Zagrebelsky, e la partecipazione di molti testimoni della società civile (*).
L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. La capienza del Palasharp è di 9 mila posti: si consiglia di arrivare con un certo anticipo.
Liberiamoci dalle macerie e cominciamo a ricostruire: come all’alba della Repubblica. La società civile chiede di partecipare attivamente e dare voce alle preoccupazioni sulla gravissima crisi politico-istituzionale scatenata dagli interessi privati di Berlusconi.
Troveremo insieme le parole per esigere le dimissioni prima di tutto e liberarci dal potere corrotto e corruttore di Silvio Berlusconi, dal fango, dagli attacchi alla Costituzione, alla magistratura tutta e in particolare alla Procura di Milano, all’informazione, alla dignità delle donne.
Con Zagrebelsky, Ginsborg, Eco e Saviano, tutti fortemente impegnati a fianco della società civile, mobilitiamoci allora per cominciare insieme a ricostruire l’Italia, il nostro Paese e per riappropriarci di parole che la storia e il sacrificio di milioni di italiani hanno reso eterne e inviolabili: libertà, giustizia, democrazia, repubblica, uguaglianza, lavoro, COSTITUZIONE. Troveremo insieme anche i modi per proseguire in questa mobilitazione per le dimissioni del presidente del Consiglio che sarà dopo questo primo appuntamento, l’impegno costante della società civile.
(*) Hanno confermato la loro partecipazione:
Giovanni Bachelet Bice Biagi Carla Biagi
Daria Bonfietti Susanna Camusso Lorenza Carlassare
Nando dalla Chiesa Concita De Gregorio
Beppino Englaro
Beppe Giulietti Irene Grandi
Maurizio Landini Gad Lerner
Milva Moni Ovadia Giuliano Pisapia
Maurizio Pollini Enrico Rossi
Elisabetta Rubini Oscar Luigi Scalfaro Salvatore Veca Lorella Zanardo
* LIBERTA’ E GIUSTIZIA: http://www.libertaegiustizia.it/2011/01/27/dimettiti-per-unitalia-libera-e-giusta-tutti-al-palasharp-di-milano-il-5-febbraio/
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- La macchina del fango cerca di capovolgere la realtà, la verità. Chi ha creato ricatti cerca di passare per ricattato, chi commette crimini pubblici, cerca di dichiarare che è solo una vicenda privata, chi tiene mezzo paese nella morsa del ricatto (di Roberto Saviano - Quel fango su tutti noi).28 gennaio 2011, di Federico La Sala
Quel fango su tutti noi
di Roberto Saviano (la Repubblica, 28 gennaio 2011)
Per vedere quello che abbiamo davanti al naso - scriveva George Orwell - serve uno sforzo costante. Capire cosa sta avvenendo in Italia sembra cosa semplice ed è invece cosa assai complessa. Bisogna fare uno sforzo che coincide con l’ultima possibilità di non subire la barbarie. Perché, come sempre accade, il fango arriva. La macchina del fango sputa contro chiunque il governo consideri un nemico. Ieri è toccato al pm di Milano Ilda Boccassini.
L’obiettivo è un messaggio semplice: siete tutti uguali, siete tutti sporchi. Nel paese degli immondi, nessuno osi criticare, denunciare. La macchina del fango, quando ti macina nel suo ingranaggio, ti fa scendere al livello più basso. Dove, ricordiamocelo, tutti stiamo. Nessuno è per bene, tutti hanno magagne o crimini da nascondere. L’intimidazione colpisce chiunque. Basta una condizione sufficiente: criticare il governo, essere considerato un pericolo per il potere. Il fango sulla Boccassini viene pianificato, recuperando una vicenda antica e risolta che nulla ha a che vedere con il suo lavoro di magistrato. Quattro giorni fa il consigliere della Lega al Csm chiede il fascicolo sulla Boccassini. Ieri "il Giornale" organizza e squaderna il dossier. Il pm, che fa il suo mestiere di servitore dello Stato e della giustizia, viene "macchiato" solo perché sta indagando su Berlusconi. Sta indagando sul Potere.
C’è un’epigrafe sulla macchina del fango. Questa: «Qualunque notizia sul tuo privato sarà usata, diramata, inventata, gonfiata». E allora quando stai per criticare una malefatta, quando decidi di volerti impegnare, quando la luce su di te sta per accendersi per qualcosa di serio... beh allora ti fermi. Perché sai che contro di te la macchina del fango è pronta, che preleverà qualsiasi cosa, vecchissima o vicina, e la mostrerà in pubblico. Con l’obiettivo non di denunciare un crimine o di mostrare un errore, ma di costringerti alla difesa. Come fotografarti in bagno, mentre sei seduto sulla ceramica. Niente di male. E’ un gesto comune, ma se vieni fotografato e la tua foto viene diffusa in pubblico chiunque assocerà la tua faccia a quella situazione. Anche se non c’è nulla di male.
Si chiama delegittimazione. Quello che in queste ore la «macchina» cerca di affermare è semplice. Fai l’amore? Ti daranno del perverso. Hai un’amante? Ti daranno del criminale. Ti piace fare una festa? Potranno venire a perquisirti in casa. Terrorizzare i cittadini, rovesciando loro addosso le vicende del premier come una «persecuzione» che potrebbe toccare da un momento all ’altro a uno qualsiasi di loro. Eppure il paragone non è l’obiettivo della macchina del fango. Non è mettere sulla bilancia e poi vedere il peso delle scelte. Ma semplicemente serve per cercare di equiparare tutto. Non ci si difende dicendo non l’ho fatto e dimostrandolo, ma dicendo: lo facciamo tutti. Chi critica invece lo fa e non lo dice.
L’altro obiettivo della macchina del fango è intimidire. In Italia il gossip è lo strumento di controllo e intimidazione più grande che c’è. Nella declinazione cartacea e in quella virtuale. L’obiettivo è controllare la vita delle persone note a diversi livelli, in modo da poterne condizionare le dichiarazioni pubbliche. E quando serve, incassarne il silenzio. Persone che non commettono crimini affatto, ma semplicemente non vogliono che la foto banalissima con una persona non sia fatta perché poi devono giustificarla ai figli, o perché non gli va di mostrarsi in un certo atteggiamento. Nulla di grave. Nessuna di queste persone spesso ha responsabilità pubbliche, né viene colta in chissà quale situazione. Eppure arrivano a pagare alle agenzie le foto, prezzi esorbitanti per difendere spesso l’equilibrio della propria vita. Su questo meccanismo si regge il timore di fare scelte, di criticare o di mutare un investimento. Sul ricatto. Il gossip oggi è una delle varianti più redditizie e potenti del racket. Perché il Paese non si accorge di tutto questo?
Berlusconi fa dichiarazioni che in qualsiasi altro paese avrebbero portato a una crisi istituzionale, come quando disse: «Meglio guardare una bella ragazza che essere gay». Oppure quando fece le corna durante le foto insieme ai capi di stato. Eppure in Italia queste goliardate vengono percepite come manifestazioni di sanità mentale da parte di un uomo che sa vivere. Chi queste cose non le fa,e dichiara di non approvarle, viene percepito come un impostore, uno che in realtà sogna eccome di farle, ma non ha la schiettezza e il coraggio di dirlo pubblicamente. Il Paese è profondamente spaccato su questa logica. Quel che si pensa è che in fondo Berlusconi, anche quando sbaglia, lo fa perché è un uomo, con tutte le debolezze di un uomo, perché è «come noi», e in fondo «anche noi vorremmo essere come lui». Gli altri, sono degli ipocriti, soprattutto quando pensano e affrontano un discorso in maniera corretta: stanno mentendo.
Bisogna essere chiari. Le vicende del premier non hanno niente di privato. Riguardano il modo con cui si seleziona la classe politica, con cui si decide come fare carriera. Riguardano come tenere sotto estorsione il governo italiano. Se questo lo si considera un affare privato ecco che chiunque racconti cosa accade è come se stesse entrando nella sfera privata. Che siano sacri i sentimenti di Berlusconi, e speriamo che si innamori ogni giorno, questo riguarda solo lui. Ma l’inchiesta di Milano riguarda altro.
La macchina del fango cerca di capovolgere la realtà, la verità. Chi ha creato ricatti cerca di passare per ricattato, chi commette crimini pubblici, cerca di dichiarare che è solo una vicenda privata, chi tiene mezzo paese nella morsa del ricatto delle foto, delle informazioni, delle agenzie, del pettegolezzo, dichiara di essere spiato. L’ha fatto con Boffo, lo sta facendo con Fini, cerca di farlo con la procura di Milano. Il fango è redditizio, dimostra fedeltà al potere e quindi automatica riconoscenza. A questo si risponde dicendo che non si ha paura. Che i lettori l’hanno ormai compreso, che non avverrà il gioco semplice di parlare ad un paese incattivito che non vede l’ora di vedere alla gogna chiunque abbia luce per poter giustificare se stesso dicendosi: ecco perché non ottengo ciò che desidero, perché non sono uno sporco. Questo gioco, che impone di riuscire nelle cose solo con il compromesso, la concessione, perché così va il mondo, e perché tutti in fondo si vendono se vogliono arrivare da qualche parte, l’abbiamo compreso e ogni giorno parlandone lo rendiamo meno forte.
Ho imparato a studiare la macchina del fango dalla storia dei regimi totalitari, come facevano in Albania o in Unione Sovietica con i dissidenti. Nessuno chiamato a rispondere a processi veri, ognuno diffamato, dossierato e condannato in ogni modo per il solo raccontare la verità. Nelle democrazie il meccanismo è diverso, più complesso ed elastico. Quello che è certo è che la macchina del fango non si fermerà. A tutto questo si risponde non sentendosi migliori, ma, con tutte le nostre debolezze e i nostri errori, sentendosi diversi. Sentendoci parte dell’Italia che non ne può più di questo racket continuo sulla vita di chi viene considerato nemico del governo.
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. ---- Chiamarsi Italiano sarà nome da rossore. Berlusconi si è impossessato dell’anima del paese (di Piero Stefani - Un nome da rossore).25 gennaio 2011, di Federico La Sala
Un nome da rossore
di Piero Stefani *
In una sera di maggio del 1915 un poeta vate, rivolgendosi alla folla accalcata in una piazza di Roma, così si esprimeva: «Su la nostra dignità umana, sulla dignità di ognuno, su la fronte di ognuno, su la mia, su la vostra, su quella dei vostri figli, su quella dei non nati, sta la minaccia di un marchio servile. Chiamarsi Italiano sarà nome da rossore ...». Con queste, e altre ancor più veementi, parole di [un] «grande» della letteratura italiana, Gabriele d’Annunzio, portava a compimento un esercizio di retorica che fingeva di premere sul governo al fine di prendere una decisione in effetti già assunta: l’ingresso in campo dell’Italia a fianco dell’Intesa. Non fu una scelta di cui gloriarsi.
In tutt’altro contesto, oggi si impongono con implacabile attualità, a patto di trascriverle al presente, alcune di quelle parole: «chiamarsi italiano è un nome da rossore». La vera ragione non è quella, pur reale, dell’immagine che si diffonde nel mondo legata agli inqualificabili comportamenti personali del presidente del consiglio. Lì, certo, ci sono ad abundantiam motivi di coprire le proprie guance di rubyno e tuttavia lo snodo fondamentale si trova altrove. Il vero motivo di vergogna che tutti ci accomuna è che, all’incirca da vent’anni, in Italia non si può fare a meno di riferirsi, in un modo o in un altro, a Berlusconi. Vi è un dato oggettivo: da quasi quattro lustri il Cavaliere è divenuto il perno su cui ruota l’intera vita nazionale.
Non siamo in una classica dittatura, le gigantografie di Berlusconi non appaiono agli angoli delle strade o sui palazzi istituzionali, nelle scuole o nei tribunali. Si tratterrebbe di un procedimento arcaico. Il fatto cruciale è che tutto il linguaggio della comunicazione, in modo diretto o indiretto, non riesce a ignorarlo o come persona o come stile di comportamento avversato e/o introiettato. Berlusconi si è impossessato dell’anima del paese. Questo è il vero motivo di incancellabile rossore. Essere all’opposizione politica è un rantolo di dignità, ma non sposta il baricentro della questione. Non ci si può dimenticare di lui. È lui che comanda il gioco. Prima o poi perderà; ma il torneo sarà sempre intitolato a lui anche dopo di lui. Lo sarà fino a quando non ci sarà una vera svolta. Giunti a questo punto, la rigenerazione dovrà, per forza, passare attraverso una fase traumatica, proprio come avvenne per l’altro ventennio: prospettiva realistica, ma non augurabile, i prezzi da pagare saranno infatti enormi.
Tutto è così. Quando ci si imbatte in forze positive impegnate nel sociale, nella concreta applicazione dei diritti, nell’elaborazione culturale seria, allora sorge, inevitabile, un interrogativo: come è possibile che un paese che ha queste potenzialità abbia una vita e un’immagine pubbliche così degradate? A parti rovesciate, la stessa conclusione va tratta quando ci si imbatte in comportamenti e stili di vita volgari, egoistici, narcisistici e dissipatori pervarsivamente presenti tra noi. In tal caso si è obbligati a constatare quanta terribile omogeneità ci sia tra il «paese reale» e quello legale. Se si contemplano le opere d’arte del passato o si è avvinti dalla grande musica e letteratura dell’Italia di un tempo, ci si chiede come è possibile che una civiltà capace di aver prodotto quelle realtà si sia ridotta così. Se si è di fronte alla liturgia pubblica dei picchetti di onore, delle toghe, delle deposizioni di corone di alloro, delle solenni sedute inaugurali, delle celebrazioni e degli anniversari sorge, inevitabile, un senso di smarrimento constatando la vuotezza di quella ritualità di fronte al vero volto dell’Italia. Su questo declivio si potrebbe continuare, fino a giungere alla minuscola esemplificazione costituita da queste righe, anch’esse prigioniere di quello spettro che si aggira tra noi e dentro di noi.
Il modello «tirannico» (in senso classico) di chi governa la cosa pubblica in base al proprio interesse privato si è capovolto fino a far sì che anche il privato di ciascuno sia impregnato da un diuturno confronto con quello stile pubblico. Quando ci si alza la mattina, si è coperti da un rossore contraddistinto da tratti depressivi: non ce ne liberiamo, siamo ancora qui, non riusciamo a coagulare forze per uscirne.Nell’orizzonte italico vi è un altro rosso, quello cardinalizio. Anch’esso è ormai segno di vergogna. Quando il primo ventennio aveva imboccato la strada dello sfacelo, ci fu qualche sussulto; è il caso degli ultimi mesi di pontificato di Pio XI. Tuttavia neppure allora ci fu una seria messa in discussione dello scoperto appoggio che si era dato in precedenza. Né avvenne alcuna franca ammissione di aver sbagliato. La statura culturale di papa Ratti è imparagonabile a quella di un Bertone, di un Ruini o dell’evanescente Bagnasco. Da lui ci si poteva, forse, aspettare qualcosa, dagli odierni cardinali non è dato attendere nulla e i loro tardivi distinguo non fanno che rendere più intensa la porpora presente sui loro abiti e sulle nostre guance. Semplicemente essi non sono all’altezza di comprendere il dramma del nostro paese in quanto ne sono parzialmente corresponsabili.
* http://pierostefani.myblog.it/, 22 gennaio 2011
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- UN APPELLO E UNA PETIZIONE DI "LIBERA CITTADINANZA": ORA BASTA!!! Un nuovo partito?! Per quel che ci riguarda può chiamarlo come gli pare, ma non certo "ITALIA"! (di Maria Ricciardi - liberacittadinanza.it).24 gennaio 2011, di Federico La Sala
ORA BASTA!!!
di Maria Ricciardi (presidente Liberacittadinanza) *
Circola informalmente la notizia che il partito di Berlusconi cambi di nuovo nome. E’ ovvio che questo semplice atto non lo farà diventare migliore o più credibile. Per quel che ci riguarda può chiamarlo come gli pare, ma non certo "ITALIA"!
Berlusconi ha insultato e umiliato davanti al mondo intero e in ogni modo possibile l’onorabilità del nostro Paese e delle sue istituzioni , ma l’appropriazione indebita del nome della nostra nazione, "Italia", è per molti Italiani, e noi siamo fra questi, un’oltraggiosa offesa, che non gli permetteremo.
Non gli lasceremo usare come fosse "cosa sua" il nome di un Paese che ha dimostrato di non saper rispettare.
ORA BASTA!!!
FIRMIAMO... FIRMIAMO... FIRMIAMO
http://www.liberacittadinanza.it/petizioni/no-al-partito-nazione
Maria Ricciardi (presidente Liberacittadinanza)
www.liberacittadinanza.it
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. ---- Che ci è successo? Da quando? Perché? Sarebbe una discussione interessante (di Rossana Rossanda - E ora su la testa)23 gennaio 2011, di Federico La Sala
E ora su la testa
di Rossana Rossanda (il manifesto, del 22 gennaio 2011)
Non è piacevole essere oggi un’italiana all’estero. Tanto meno se si è stata una sia pur minuscola tessera di ceto politico, due volte consigliere comunale e una volta deputata, una cui l’antipolitica fa venire il nervoso. E per di più comunista libertaria, specie rarissima, orgogliosa di sé e di un paese che, fino agli anni Sessanta e con diverse code nei Settanta, pareva il laboratorio politico più interessante d’Europa.
Oggi gli amici che incontro non dicono più: ma che disgrazia quel vostro Berlusconi! Mi chiedono: Com’è che l’avete votato tre volte? Che è successo all’Italia? Una come me si trova a balbettare. Perché hanno ragione, non si può più fare del premier il caso personale di uno che ha fatto troppi soldi, che ha tre televisioni, che prende il paese per un’azienda di sua proprietà, che sa che molti sono acquistabili e li acquista, e adesso, gallo attempato, si vanta dei suoi exploits su un numero illimitato di pollastrine: «Vorreste tutti essere come me, eh??».
E’ vero che l’Italia lo ha votato e rivotato. E’ vero che non c’è traccia di una destra formalmente civile che di lui ne ha abbastanza, né di un sedicente centro deciso a liberarsene. E neanche di una sinistra capace di rischiare un «buttiamolo fuori con le elezioni». La destra tutta perché gli è ancora complice, il centro perché lo è stato, la sinistra perché il sistema elettorale bipolare le faceva comodo contro le sue ali meno docili. Metà dell’Italia è berlusconiana, l’altra metà è azzittita, e non c’è imputazione - ignoranza, prevaricazione, corruzione, soldi, attentato ai minori - mossa al personaggio che sia in grado di scuoterla. Anzi. C’è qualche verità nelle vanterie di costui, se più se ne sente più tutti si accucciano per calcoli loro. Perfino i media, che sarebbero di opposizione, sono diventati un buco della serratura per voyeurs intenti a sfogliare pagine su pagine o ad ascoltare minuti su minuti di dialoghi sul prezzo per un appalto o per togliersi le mutande.
 Che ci è successo? Da quando? Perché? Sarebbe una discussione interessante. Si potrebbe
sprofondare in una storia secolare di servaggi, Francia o Spagna pur che se magna. O di una unità
nazionale sotto una monarchia codina, tardiva e ben epurata di ogni fermento rivoluzionario - i
giacobini napoletani decapitati o appesi nel giubilo dei lazzari e sanfedisti, la repubblica romana
repressa, e soltanto le tracce dell’ammodernamento giuridico di Napoleone al nord. Non sarà del
tutto casuale che siamo stati noi a inventare il primo fascismo europeo. Ci deve essere qualcosa di
guasto nella coscienza della penisola. Alcuni di noi pensano che soltanto la presenza di un partito
comunista che non mollava sui diritti sociali ha costretto il paese alla democrazia, come un tessuto
fragile ma fortemente intelaiato, che non si è lacerato finché i comunisti non si sono uccisi da soli.
Che ci è successo? Da quando? Perché? Sarebbe una discussione interessante. Si potrebbe
sprofondare in una storia secolare di servaggi, Francia o Spagna pur che se magna. O di una unità
nazionale sotto una monarchia codina, tardiva e ben epurata di ogni fermento rivoluzionario - i
giacobini napoletani decapitati o appesi nel giubilo dei lazzari e sanfedisti, la repubblica romana
repressa, e soltanto le tracce dell’ammodernamento giuridico di Napoleone al nord. Non sarà del
tutto casuale che siamo stati noi a inventare il primo fascismo europeo. Ci deve essere qualcosa di
guasto nella coscienza della penisola. Alcuni di noi pensano che soltanto la presenza di un partito
comunista che non mollava sui diritti sociali ha costretto il paese alla democrazia, come un tessuto
fragile ma fortemente intelaiato, che non si è lacerato finché i comunisti non si sono uccisi da soli.Tutto da vedere, se se ne avesse voglia. Ma chi ne ha? Lo slogan nazionale è: fatti gli affari tuoi. Vota chi si fa i suoi. Non è una storia soltanto italiana, tutta l’Europa va a destra. Ma da noi si esagera. In Francia un vecchio ed elegante signore, Stephan Hessel, che non alza la voce ma non ha mai taciuto, ha scritto un opuscolo: Indignatevi! Ne sono sparite subito quasi un milione di copie. Una settimana fa voleva parlare della Palestina, glielo hanno impedito. E lui e i suoi lettori si sono trovati fuori, in migliaia, di notte, con un freddo polare, nella piazza del Pantheon, a gridare: Basta! Perché noi no? Si sta meglio con la testa alta, invece che fra le spalle e gli occhi a terra. Non so se lo farà Vendola. Non credo che lo farà Bersani. Ma chiudiamo con il cinismo del chi se ne frega. Indigniamoci !
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. L’Italia come volontà e come rappresentazione di un solo Partito. ---- Il suo destino non è quello del paese (di Luigi La Spina).20 gennaio 2011
Il suo destino non è quello del paese
di Luigi La Spina (La Stampa, 20 gennaio 2011)
Il videomessaggio con il quale il presidente del Consiglio ha comunicato agli italiani la decisione di non presentarsi alla procura di Milano e la volontà di varare una legge per punire quei pm che lo accusano annuncia, purtroppo, una linea di difesa inquietante. Destinata ad aggravare sia lo stato di turbamento del Paese, sia l’immagine di discredito internazionale che, in questi giorni, si sta riversando sull’Italia.
Berlusconi ha lanciato un appello drammatico alla maggioranza che lo ha eletto perché, in maniera compatta, unisca il destino della nazione al suo destino personale. Senza comprendere che l’istituzione che presiede, il governo della Repubblica, deve rappresentare non solo coloro che l’hanno votato, ma tutti gli italiani. Ecco perché la sua sfida alla magistratura, in nome del consenso popolare, rischia di aver gravi conseguenze sull’ordinamento e sull’equilibrio dei poteri dello Stato, fondamenti della nostra democrazia.
Il presidente del Consiglio ha diritto, come tutti i cittadini, di veder rispettata la presunzione d’innocenza davanti alle infamanti accuse che la procura di Milano gli ha rivolto. Un principio costituzionale di elementare civiltà giuridica, ma che ha come corrispettivo naturale lo stesso rispetto sia verso il magistrato che lo indaga, sia verso i cittadini italiani che hanno diritto di conoscere la sua versione dei fatti contestati. Anche perché non sarà la procura di Milano a considerare la fondatezza della sua difesa, ma i giudici di un tribunale che, in passato, ha dimostrato indipendenza di valutazione rispetto alle richieste del pm. Né sarà la procura di Milano a decidere sulle questioni di competenza territorialee funzionale avanzate dai suoi avvocati. Fa parte, poi, di una strategia difensiva puramente mediatica, utile ad aumentare la confusione polemica, ma dalla logica avventurosa,l’invocazionealla cosiddetta privacy. Per due elementari ragioni: le indagini, innanzi tutto, sono nate dal sospetto di gravi reati e, quindi, la verifica di tali ipotesi non si può fermare davanti a quei limiti. La valutazione delle conseguenze, se questa obiezione venisse accolta, nelle inchieste sui comuni cittadini potrebbe equivalere alla dichiarazionedi una sostanziale impunità estesa a tutti gli italiani.
Ma la seconda ragione dell’insostenibilità della tesi che in questi giorni viene ripetuta dai fan di Berlusconi, senza un minimo di riflessione, riguarda proprio il fatto che il presidente del Consiglio non è, appunto, un comune cittadino italiano, ma rappresenta una delle più alte cariche dello Stato. La nostra Costituzione, come quelle di tutti i Paesi non retti da una dittatura, impone una trasparenza, una dignità di comportamenti, anche personali, che non sono richiesti a coloro che non hanno i doveri dell’uomo pubblico.
Al di là della fondatezza delle accuse, della solidità delle prove raccolte, delle competenze delle procure, il presidente del Consiglio dovrebbe rendersi conto che l’unico modo per arginare il mare, montante e inquietante, dei giudizi sprezzanti che si sta abbattendo, da parte dell’opinione pubblica internazionale, sul nostro Paese è fornire ai magistrati una versione, credibile e accettabile, di quanto avvenuto sia nelle sue ville private, sia nella famosa notte alla questura di Milano. Se davvero non ha nulla da farsi perdonare, né sul piano penale né su quello morale, non si capisce perché impedisca a se stesso, con formalismi giuridici discutibili, di convincere gli italiani, anche quelli che non sono suoi tifosi, di poter credere alla sua innocenza.
E’ arrivato il momento che anche Berlusconi, dopo quasi vent’anni, possa distinguere la sorte della sua fortuna di imprenditore, di politico, persino di uomo di grande successo mediatico e di sicurocarisma personale, da quella del suo Paese. Lui, nonostante una notevole considerazione di sé, non si può paragonare a Sansone e gli italiani non possono fare la fine dei filistei.
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- LO STORICO PAUL GINSBORG NON HA CAPITO ANCORA LA VERGOGNA DI ESSERE "CITTADINO" DI "ITALIA"!!!22 ottobre 2010, di Federico La Sala
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. "IL SOLE DELLE ALPI", IL TERRITORIO, IL COMUNE, E L’ITALIA4 ottobre 2010, di Federico La Sala
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. ---- LA COSTITUZIONE, LA LEGGE N. 645, E IL RADUNO A PREDAPPIO PER CELEBRARE LA MARCIA SU ROMA (di Maurizio Viroli).6 novembre 2010, di Federico La Sala
La Carta offesa a Predappio
Il raduno per celebrare la marcia su Roma realizza l’apologia del fascismo e offende gli italiani: la legge, sarebbe ora di capirlo, va difesa sempre, contro tutte le violazioni
di Maurizio Viroli (il Fatto, 06.11.2010)
Domenica 31 ottobre, nella ridente cittadina di Predappio, qualche migliaio (ma i numeri hanno poca importanza) di individui hanno offeso pubblicamente la Costituzione rendendosi apertamente responsabili del reato di apologia del fascismo ai sensi della legge n. 645 del 1952, nota anche come legge Scelba (democristiano, è bene ricordarlo, non un fazioso comunista). Mi riferisco al raduno per celebrare la marcia su Roma che, a detta dei fascisti, portò Mussolini al governo (ma è una solenne cretinata perché Mussolini andò al governo chiamato da quel delinquente del re), e segnò l’inizio del regime che ha regalato all’Italia ventuno anni di totalitarismo, guerre coloniali combattute con crudeltà bestiale, una guerra mondiale e una guerra civile.
CHE UN EVENTO del genere insulti la coscienza di chiunque abbia ancora un minimo di intelligenza e di sensibilità morale non dovrebbe essere difficile da capire, visto che il fascismo è nato e vissuto per offendere in ogni modo la dignità della persona umana, imponendo il silenzio, uccidendo a freddo, torturando, imprigionando, condannando al confino.
Ed è del pari facile capire perché oltraggia la Costituzione dato che tutta la nostra Carta fondamentale è antifascista e contiene una norma finale, la XII, dove si legge: “È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista”. Che poi ci siano gli estremi di reato (con relative pene e multe, allora in lire) lo afferma la legge in questione. -Art. 1: “Riorganizzazione del disciolto partito fascista. Ai fini della XII disposizione si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista”.
Art. 4: “Chiunque fa propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità transitoria e finale (comma primo) della Costituzione, indicate nell’articolo 1 è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 400.000 a lire 1.000.000. Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, princìpi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche.
Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da uno a due milioni”. Art. 5: “Manifestazioni fasciste. Chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste è punito con la pena della reclusione sino a tre anni e con la multa da 400.000 a 1.000.000 di lire”. Se, come è molto probabile, visti i precedenti, i partecipanti all’oscena parata di Predappio si sono resi responsabili dei reati così bene descritti mi pare evidente che devono essere perseguiti ai sensi della legge. E se la polizia e i carabinieri avessero ravvisato la volontà manifesta di delinquere non avrebbero dovuto vietare la manifestazione?
Se non sbaglio, mi corregga Travaglio, vige in Italia l’obbligatorietà dell’azione penale (art. 112 della Costituzione). E dunque le autorità preposte non si assumono, tollerando, una pesante responsabilità?
MA PRIMA della responsabilità penale c’è quella morale e c’è quella politica. La prima impone ad ogni essere umano (cittadino o non cittadino) di alzare una ferma, civile, pacata voce di protesta (e i cattolici e la Chiesa, taceranno anche questa volta di fronte a gente che offende la coscienza cristiana?). La seconda impone alle autorità politiche, a cominciare dai sindaci di Romagna, dal presidente della Provincia e dal presidente della Regione di esprimere almeno la più severa condanna e di invitare la magistratura ad intervenire. La legge, sarebbe ora di capirlo, va difesa sempre, contro tutte le violazioni. Solo in questo modo la lotta per la legalità acquista forza e credibilità.
LA VICENDA di Predappio, offre, per fortuna, anche una bella occasione. La vedova di uno dei figli ha minacciato di far traslare le ceneri di Mussolini da Predappio a Roma. Se fossi di Predappio accoglierei la proposta con entusiasmo e farei di più e meglio. Mi attiverei affinché le ceneri di Mussolini siano disperse in mare, fuori dalle acque territoriali italiane, come hanno fatto in Israele con le ceneri di Eichmann. Questo sarebbe vero atto di pietà per chi ha perso la vita e ha sofferto per colpa di quel criminale di Benito Mussolini e un dovuto atto di rispetto per l’Italia, che per il fascismo e del fascismo dovrà sempre e solo vergognarsi.
-
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- NAPOLITANO A PARIGI, ALL’ECOLE NORMALE SUPERIEURE. L’unità nazionale è la mia stella polare (Un brano dell’intervento).30 settembre 2010, di Federico La Sala
L’unità nazionale è la mia stella polare
Un brano dell’intervento di ieri del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano all’École Normale Supérieure di Parigi. *
Nell’Assemblea Costituente del 1946-47, si discusse ampiamente sul come caratterizzare la figura del Presidente della Repubblica; se ne discusse prendendo in considerazione, con apertura e ricchezza di riferimenti e argomenti, diverse ipotesi e possibilità di scelta, non esclusa l’opzione presidenzialista.
La conclusione di quel dibattito fu nettamente favorevole a un Capo dello Stato eletto dal Parlamento e non direttamente dai cittadini, titolare di rilevanti prerogative e attribuzioni ma non di poteri di governo, chiamato a intrattenere col Paese un rapporto non condizionato da appartenenze politiche e logiche di parte. La Costituzione pone in cima all’articolo che sancisce caratteri e compiti del Presidente della Repubblica, l’espressione-chiave: «rappresenta l’unità nazionale». Egli la rappresenta e la garantisce svolgendo un ruolo di equilibrio, esercitando con imparzialità le sue prerogative, senza subirne incrinature ma rispettandone i limiti, e ricorrendo ai mezzi della moral suasion e del richiamo a valori ideali e culturali costitutivi dell’identità e della storia nazionale.
E chiudo qui questa digressione, della cui lunghezza e apparente estraneità al nostro incontro di oggi spero vorrete scusarmi. Ma se il rappresentare l’unità nazionale è la stella polare del ruolo che mi è stato affidato dal Parlamento, è lì anche - questo volevo sottolineare - la ragione prima del mio impegno per le celebrazioni del 150° anniversario dello Stato italiano. A maggior ragione in un periodo nel quale sul tema dell’unità nazionale pesano sia il persistere e l’acuirsi di problemi reali rimasti irrisolti, sia il circolare di giudizi sommari (in taluni casi, fino alla volgarità) sul processo che condusse alla nascita del nostro Stato unitario e anche sul lungo percorso successivo, vissuto dall’Italia da quel momento, da quel lontano 1861 a oggi. Siamo in presenza di tensioni politiche, di posizioni e manovre di parte, di debolezze e confusioni culturali, di umori ostili, che ruotano attorno alla questione dell’unità nazionale e che le istituzioni repubblicane debbono affrontare cogliendo un’occasione come quella del 150° anniversario del 17 marzo 1861.
Coglierla attraverso un’opera di ampia chiarificazione, riproponendo e arricchendo le acquisizioni della cultura storica, e collegandovi una riflessione matura sulle tappe essenziali della successiva nostra vicenda nazionale. Dovrebbe trattarsi - come ho avuto occasione di dire - di un autentico esame di coscienza collettivo, che unisca gli italiani nel celebrare il momento fondativo del loro Stato nazionale. Riuscirvi non sarà facile, l’inizio è risultato difficile, ma cominciamo a registrare una crescita di interesse e di impegno, una moltiplicazione di iniziative anche spontanee.
Non ho voluto tacervi il quadro delle preoccupazioni che mi muovono. Ma debbo aggiungere che esse non nascono da timori di effettiva rottura dell’unità nazionale. Polemiche e contese sui rapporti tra il Nord e il Sud, per quanto si esprimano talvolta in termini e in toni estremi, e rumorose grida di secessione, trovano il loro limite obiettivo nel fatto che prospettive separatiste o indipendentiste sono - e tali appaiono anche a ogni italiano riflessivo e ragionevole - storicamente insostenibili e obiettivamente inimmaginabili nell’Europa e nel mondo d’oggi.
Quel che preoccupa è dunque altro: è il possibile oscurarsi della consapevolezza diffusa di un patrimonio storico comune, il tendenziale scadimento culturale del dibattito e della comunicazione. Quel che preoccupa è il seminare motivi di sterile conflittualità e di complessivo disorientamento in un Paese che ha invece bisogno di confermare e rafforzare la fiducia in se stesso e di veder crescere tra gli italiani il sentimento dell’unità: nell’interesse dell’Italia e - lasciate che aggiunga - nell’interesse dell’Europa. [...]
Rispetto a tendenze che circolano in Italia, come quelle che ho evocato, e anche tenendo conto del loro sorprendente provincialismo, è particolarmente importante un contributo quale il vostro, di riflessione sul respiro europeo del movimento per l’unità italiana e dei suoi maggiori protagonisti, e sul quadro delle vicende europee in cui quel movimento si collocò. Come si può ignorare l’impronta ginevrina e parigina, e anche londinese, della formazione - diciamo pure tout court europea - di Cavour? O l’influenza della storia e del pensiero francese sul maturare del bagaglio culturale e del disegno politico di Giuseppe Mazzini, per non parlare del suo radicamento nell’Inghilterra di quel tempo? Il flusso dei grandi messaggi ideali provenienti dalla Francia dell’epoca rivoluzionaria e del periodo napoleonico fu retroterra essenziale del Risorgimento.
Cavour vide più lucidamente di chiunque il quadro internazionale - con i condizionamenti oggettivi che ne derivavano - in cui collocare la strategia del piccolo e ambizioso Regno di Sardegna e la questione italiana. Erano in giuoco in Europa - allora teatro privilegiato e decisivo della politica mondiale - gli equilibri usciti dalla prima e dalla seconda Restaurazione, i moti per le libertà costituzionali contro il dispotismo, gli equilibri sociali sotto il premere di nuovi conflitti, l’affermazione del principio di nazionalità e le lotte per l’indipendenza contro il dominio imperiale austriaco. Il sapersi muovere con audacia e duttilità, e con i necessari adattamenti, in questo contesto fu per Cavour fattore determinante di superiorità ai fini della guida del movimento nazionale italiano, e fattore non meno determinante per il successo ultimo della sua strategia al servizio della causa dell’Unità italiana.
L’asse della politica europea di Cavour fu l’alleanza con la Francia di Napoleone III, senza peraltro trascurare l’importanza, in momenti significativi, del rapporto con l’opinione pubblica, ambienti politici e governanti della liberale Inghilterra. E sappiamo anche come fu non lineare, e quali tormenti suscitò in Cavour, la ricerca dell’intesa con l’imperatore francese - basti pensare a quei drammatici giorni dell’aprile 1859 quando Cavour vide il suo disegno sul punto di crollare e visse momenti di estremo sconforto. Poi gli eventi presero il corso da lui voluto della II Guerra d’indipendenza. E le battaglie di Solferino e San Martino cementarono nel sangue un’alleanza che cento anni più tardi, nel 1959, il Presidente francese eletto l’anno precedente, il generale De Gaulle, volle, venendo in Italia per quelle celebrazioni, indicare come il «trovarsi insieme dei campioni di un principio grande come la terra, quello del diritto di un popolo a disporre di se stesso quando ne abbia la volontà e la capacità».
Infine, vorrei ribadire come l’altro fattore decisivo dell’affermarsi della funzione egemone di Cavour in Italia e del progredire della causa italiana, fu - come ha scritto Rosario Romeo - che «Cavour stette indubbiamente dalla parte del realismo e della moderazione, ma ebbe l’intuizione di ciò che valessero le forze e i motivi ideali nella costruzione dell’edificio italiano». E mi permetto di aggiungere, reagendo a una certa moda attuale di esaltare, rispetto a Cavour, altre personalità del Risorgimento e del movimento per l’Unità, che la grandezza del moto unitario in Italia sta precisamente nella ricchezza e molteplicità delle sue ispirazioni e delle sue componenti; la grandezza di Cavour sta nell’aver saputo governare quella dialettica di posizioni e di spinte divergenti, nell’aver saputo padroneggiare quel processo fino a condurlo allo sbocco essenziale della conquista dell’indipendenza e dell’unità nazionale.
Quando, logorato da anni di dure fatiche e di «dolori morali», scrisse, «d’impareggiabile amarezza», cessò di vivere il 6 giugno 1861, Cavour poté senza dubbio lasciare come suo estremo messaggio quello che «l’Italia era fatta». Ma nel grande discorso per Roma capitale tenuto in Parlamento il 25 marzo, otto giorni dopo la proclamazione del Regno d’Italia, egli aveva affermato: «L’Italia ha ancor molto da fare per costituirsi in modo definitivo, per isciogliere tutti i gravi problemi che la sua unificazione suscita, per abbattere tutti gli ostacoli che antiche istituzioni, tradizioni secolari oppongono a questa grande impresa». Tra quei «gravi problemi» era destinato a risultare come il più complesso, aspro e di lunga durata il problema del Mezzogiorno, dell’unificazione reale, in termini economici, sociali e civili, e dei suoi possibili modi, tra Nord e Sud. Possiamo dire oggi che quella resta la più grave incompiutezza del processo unitario.
* LA STAMPA, 30/9/2010
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DELLA IMMACOLATA CONCEZIONE DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.26 agosto 2010, di Federico La Sala
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- FESTIVAL DELLA MENTE. L’allarme degli intellettuali. "La creatività sta morendo".3 settembre 2010, di Federico La Sala
IL FESTIVAL DELLA MENTE
 "La creatività sta morendo"
"La creatività sta morendo"
 L’allarme degli intellettuali
L’allarme degli intellettualiDa oggi a domenica 5 il Festival della Mente in Liguria. Da Staino a Diamanti, da Bonito Oliva a Ferraris, il mondo della scienza e della letteratura si raduna per parlare delle potenzialità dell’intelletto. E lancia l’allarme contro la mancanza di stimoli e incentivi
di SARA FICOCELLI *
SARZANA (La Spezia) - La mente è l’unico strumento che abbiamo per capire la realtà e gli altri, un’incognita che dà risposte e pone problemi. La mente è (anche) movimento, presente in trasformazione, creatività. Il Festival della Mente 1 di Sarzana, in provincia di La Spezia, alla sua settima edizione, da oggi al 5 settembre ospita i cervelli migliori del Paese e pone a tutti - soprattutto ai visitatori - una domanda: esiste ancora la creatività in Italia? E se sì, come viene manifestata dagli italiani e recepita dalle istituzioni? Repubblica.it lo ha chiesto ad alcuni dei partecipanti, che in tutto quest’anno sono 70. Intervistarli uno ad uno sarebbe stato un problema e così abbiamo scelto un rappresentante per ogni disciplina intellettuale, dalla filosofia alla politica sociale, dal fumetto alle neuroscienze. Il collage finale non dà spazio a equivoci: di creatività l’Italia ne ha da vendere, ma è una risorsa malata, resa ogni giorno più fragile dalla mancanza di stimoli e incentivi istituzionali.
Un patrimonio che rischia di atrofizzarsi per cedere il passo alla voracità di una società che vuole "tutto e subito, organizzata in base a una logica aziendale, secondo quello che io definisco ’peronismo mediatico’ ", spiega Achille Bonito Oliva, docente di Storia dell’arte contemporanea all’università La Sapienza di Roma. "La creatività è qualcosa che va per i fatti propri - continua il curatore della XLV Biennale di Venezia, a Sarzana per parlare del rapporto fra tempo, arte e linguaggio - e che noi dobbiamo incanalare nel modo giusto, con delle regole. Per farlo ci vorrebbe il sostegno delle istituzioni. Un privilegio che noi non abbiamo. L’immaturità e la capacità di improvvisazione, che ci caratterizzano, ci hanno permesso di restare creativi fino a oggi, ma la creatività senza metodo non ha utilità".
Come è vero che la potenza è nulla senza controllo, è anche vero che la creatività è nulla senza un’organizzazione sociale in grado di valorizzarla. Quando ciò non avviene, e quando anzi la nostra vivacità mentale viene strumentalizzata a fini politici, la creatività diventa addirittura negativa. "E’ facile dire che ha costituito una risorsa per un Paese che stenta ad essere tale - dice Ilvo Diamanti, docente di scienza e comunicazione politica all’università di Urbino - Quella che accompagna gli italiani è oggi più che altro una creatività negativa, quella che ti fa ’inventare’ il nemico dove non c’è, che ti fa vedere pericoli e realtà che non esistono". Secondo il sociologo, che a Sarzana parlerà di sicurezza e insicurezza, "la creatività non sempre è buona" e gli italiani sono stati incapaci di adeguarsi alla globalizzazione, trasformando il senso di spiazzamento derivante dal cambiamento in paura.
Questa stessa "fabbrica della paura", secondo Sergio Staino, convince i ventenni di oggi di non essere all’altezza, di non potercela fare ad utilizzare al meglio la propria creatività. "Quando parlo con i giovani - spiega il disegnatore satirico - lo sforzo più grande che faccio è quello di insegnargli a guardarsi intorno. Hanno paura, sono insicuri: qualcuno li ha convinti che, se non ce la fanno, è perché sono stupidi o poco grintosi. Ma naturalmente non è così. Bisognerebbe che le istituzioni lavorassero per infondere loro fiducia, ma finora nessun governo lo ha fatto davvero, nè a destra nè a sinistra. E questi sono danni sociali che l’Italia pagherà per i prossimi decenni". Staino interverrà al Festival della Mente con Altan, con un incontro dal titolo "Uno nasce e poi muore. Il resto sono chiacchiere": "La creatività è fatta di intuizioni minime e di quelle più grandi, che cambiano la Storia del mondo - continua - Topolino è nato nel 1929, in piena crisi economica, e questo perché i momenti di difficoltà sono la fucina dell’innovazione. Ma l’Italia non ha più interesse a investire in questo senso, e si trova tagliata fuori dal progresso".
Del resto però, come diceva Francis Bacon, "La creatività è come l’amore: non puoi farci niente". E da questa consapevolezza nasce la speranza che tutto non si fermi qui, che l’insicurezza e la paura vengano superate dalla potenza creatrice che gli italiani portano comunque dentro di sè. "L’Asia centrale - spiega Ludovica Lumer, studiosa di Neuroestetica dello University College London, che parlerà dell’identità tra arte e scienza - sta usando l’arte per formare la propria identità. L’Italia non lo sta facendo e la colpa non è delle nuove generazioni, ma dei governi, che non investono più in ricerca. L’arte, da Duchamp in poi (per quanto riguarda quella visiva) richiede a chi osserva di completare il processo creativo. Per questo le istutuzioni giocano un ruolo fondamentale".
Secondo lo psicanalista junghiano Luigi Zoja, che parlerà dell’"attualità dell’individuazione", qualche responsabilità ce l’hanno comunque anche le nuove generazioni, che sono "troppo introverse". "I giovani dovrebbero avere più coraggio. Ricordo il discorso che Steve Jobs fece ai neo-laureati di Stanford nel 2005: il senso delle sue parole è che bisogna buttarsi, richiare. Specialmente con una calsse politica come questa, che non li aiuta per niente". Un parere condiviso da Gianvito Martino, direttore della divisione di neuroscienze dell’Istituto Scientifico Universitario San Raffaele di Milano, secondo cui "la creatività, intesa come capacità di inventare, dei giovani ricercatori italiani, è frustrata sistematicamente da un sistema-paese che "penalizza" la ricerca in tutte le sue forme ed espressioni. Una situazione che determina una ridotta capacità brevettuale che, a sua volta, penalizza ulteriormente gli investimenti in ricerca. Non è quindi sorprendente che, poi, i ricercatori italiani dimostrino la loro creatività quando espratriano in Paesi in cui la ricerca conta veramente. Siamo in uno dei pochi Paesi industrializzati in cui non si produce ricchezza dalla conoscenza". Il neuroscienziato parlerà di staminali, e in particolare di come quelle del cervello potrebbero, in un futuro prossimo, essere usate per curare gravi malattie cerebrali: "Un campo di ricerca che vede tanti ricercatori italiani in prima fila".
Il quadro che emerge è dunque quello di un’Italia che, come ricorda il filosofo Maurizio Ferraris, che parlerà del rapporto tra "l’anima e l’iPad", "da una parte stimola al massimo una certa creatività, ossia l’arrangiarsi, l’improvvisare, l’apparenza. Dall’altra affossa le istituzioni necessarie per una creatività autentica, dalla scuola all’università. Dall’impasse in cui ci troviamo non può salvarci la creatività come improvvisazione, e forse nemmeno la creatività come esercizio e pazienza, ma qualcosa di più grande e vero: la coscienza, la responsabilità, il senso del bene comune e quello dello Stato. Ma a volte penso che per inoculare qualcosa del genere negli italiani il creativo non basti: ci vorrebbe l’esorcista".
* la Repubblica, 02 settembre 2010
-
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- L’ "IO SONO" DI KANT E L’ "IO SONO" DELL’"UOMO SUPREMO" DEI "VISONARI" DELLA TEOLOGIA POLITICA ATEA E DEVOTA.3 agosto 2010, di Federico La Sala
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- ETICA E LEGALITA’. La sinistra non tiene il passo di Fin (di Barbara Spinelli).8 agosto 2010, di Federico La Sala
La sinistra non tiene il passo di Fini di BARBARA SPINELLI (La Stampa, 08.08.2010)
Alla fine, la rottura fra il presidente del Consiglio e il presidente della Camera è avvenuta sull’elemento che più caratterizza il regime autoritario di Berlusconi: il rapporto del leader con la legalità, quindi con l’etica pubblica. È ormai più di un decennio che il tema era divenuto quasi tabù, affrontato da pochi custodi della democrazia e della separazione dei poteri.
Agli italiani la legalità non interessa, ci si ostinava a dire, né interessano la giustizia violata, la corruzione più perniciosa che è quella dei magistrati, l’obbligo di obbedienza alle leggi, il patto tra cittadini che fonda tale obbedienza. Anche per la sinistra, nostalgica spesso di una democrazia sostanziale più che legale, tutti questi temi sono stati per lungo tempo sovrastruttura, così come sovrastruttura era il senso dello Stato e della sua autonomia.
Fini ha ignorato vecchie culture e nuovo spirito dei tempi e ha guardato più lontano. Ha intuito che uscire dalla crisi economica significa, ovunque nel mondo, uscita dal malgoverno, dai costi enormi della corruzione, dall’imbarbarimento del senso dello Stato. Ha visto che il presente governo e il partito che aveva fondato con Berlusconi erano colmi di personaggi indagati e spesso compromessi con la malavita. Ha visto che per difendere la sua visione privatistica della politica, Berlusconi moltiplicava le offese alla magistratura, alla stampa indipendente, alla Costituzione, all’idea di un bene comune non appropriabile da privati. E ha costretto il premier a uscire allo scoperto: lasciando che fosse quest’ultimo a rompere sulla legalità, sul senso dello Stato, sull’informazione libera, ha provocato un’ammissione indiretta delle volontà autoritarie che animano il capo del governo e i suoi amici più fedeli.
In qualche modo, Berlusconi ha chiesto a Fini e ad alcuni finiani particolarmente intransigenti (Fabio Granata) di scegliere la cultura dell’illegalità contro la cultura della legalità che il presidente della Camera andava difendendo con forza. Non solo: più sottilmente ed essenzialmente, ha chiesto loro di scegliere tra democrazia oligarchica e autoritaria e democrazia rappresentativa. Il capo del governo infatti non si limita a anteporre la sovranità del popolo elettore alla separazione dei poteri e a quello che chiama il «teatrino della politica politicante». La stessa sovranità popolare è distorta in maniera micidiale, a partire dal momento in cui essa si forgia su mezzi di informazione (la tv) che il capo-popolo controlla in toto. La dichiarazione contro Fini dell’ufficio di presidenza del Pdl, il 29 luglio, erge i disvalori come proprio non segreto emblema quando afferma: «Le sue posizioni (sulla legalità) sono assolutamente incompatibili con i principi ispiratori del Popolo della Libertà».
La sinistra non ha avuto né il coraggio né l’anticonformismo del presidente della Camera. Fino all’ultimo ha congelato la presa di coscienza italiana sulle questioni delle legge e della giustizia, ripetendo con pudibonda monotonia che «l’antiberlusconismo non giova al centrosinistra». E per antiberlusconismo intendeva proprio questo: combattere il Cavaliere sul terreno dell’etica pubblica, della legalità, della formazione dell’opinione pubblica attraverso i media. I problemi erano sempre altri: quasi mai erano la tenuta dello Stato di diritto, l’informazione televisiva manipolata, la corruzione stessa. C’erano sempre «questioni più gravi» da affrontare, più urgenti e più alte, prima di scendere nei piani bassi della legalità.
L’incapacità congenita della sinistra di vietare a chi fa politica un conflitto d’interessi, specie nell’informazione, nasce da qui ed è destinata a divenire il vecchio rimorso e il vizio assurdo della sua storia. In fondo, venendo anch’egli da una cultura totalitaria, Fini ha fatto in questo campo più passi avanti di quanti ne abbiano fatto tanti uomini dell’ex Pci (lo svantaggio di tempi così rapidi è che le sue truppe sono labili).
Questo parlar d’altro, di cose che si presumono più alte e nobili, è la stoffa di cui è fatto oggi lo spirito dei tempi, non solo in Italia. Uno spirito che contagia anche le gerarchie ecclesiastiche (non giornali come Famiglia Cristiana), oltre che molti moderati e uomini della sinistra operaista. È lo stesso Zeitgeist che in Francia, in pieno scandalo delle tangenti versate illegalmente da Liliane Bettencourt alla destra, spinge politici di rilievo a far propria l’indignazione dell’ex premier Raffarin contro la stampa troppo intemperante: «I francesi e i mezzi di comunicazione sono incapaci di appassionarsi per i grandi temi». Chi chiude gli occhi davanti al marcio che può manifestarsi nella politica sempre vorrebbe che i cittadini non vedessero la bestia, dietro l’angelo e i suoi grandi temi.
Invece l’imperio della legge fa proprio questo: rivela all’uomo la sua bestialità, gli toglie le prerogative dell’angelo. Nel descrivere il Decalogo mosaico, che della Legge è essenza e simbolo, Thomas Mann parla di «quintessenza della decenza umana» (La Legge, 1944). Alla stessa maniera, la quintessenza dell’esperienza berlusconiana è il rapporto distorto e irato con la legge e i poteri che la presidiano: un male italiano che non è nato con lui, ma che lui ha acutizzato. Un male che conviene finalmente guardare in faccia, perché è da qui che toccherà ricominciare se si vuol costruire meglio l’Italia. Se si vuol dar vita a un’opinione pubblica veramente informata, perché munita degli strumenti necessari alla formazione della propria sovranità democratica.
Per questo la dissociazione di Fini dai disvalori del Popolo della Libertà non è una frattura del bipolarismo, né tanto meno un ritorno a vecchi intrugli consociativi. È il primo atto di un’uscita dall’era di Berlusconi, da una seconda Repubblica che non ha riaggiustato la prima ma ne ha esasperato monumentalmente i vizi: ed è un atto che per forza di cose deve essere governato da un arco di partiti molto largo. Il termine giusto lo ha trovato Casini: si tratta di creare un’«area di responsabilità istituzionale», non diversamente dal modo di operare di chi predispose il congedo dal fascismo. Nell’inverno scorso, lo stesso Casini parlò di Cln, il Comitato di Liberazione Nazionale che nel 1943 associò tutti gli oppositori al regime mussoliniano. Spetta a quest’area preparare elezioni davvero libere, dunque creare le basi perché le principali infermità della repubblica berlusconiana siano sanate. In seguito, il bipolarismo potrà ricostituirsi su basi differenti.
In effetti, Berlusconi non è una persona che ha semplicemente abusato del potere. Le sue leggi, le nomine che ha fatto, il conflitto d’interessi di cui si è avvalso: tutto questo ha creato un’altra Italia, e quando si parla di regime è di essa che si parla. Un’Italia dove vigono speciali leggi che proteggono l’impunità. Un’Italia dove è colpito il braccio armato della malavita anziché il suo braccio politico, e dove i pentiti di mafia sono screditati e mal protetti come mai lo furono i pentiti di terrorismo. Un’Italia in cui la sovranità popolare non potendosi formare viene violata, perché un unico uomo controlla le informazioni televisive e perché il 70 per cento dei cittadini si fa un’opinione solo guardando la tv, non informandosi su giornali o Internet.
Un governo che non curasse in anticipo questi mali (informazione televisiva, legge elettorale che non premi sproporzionatamente un quarto dell’elettorato, soluzione del conflitto d’interessi) e che andasse alle urne sotto la guida di Berlusconi non ci darebbe elezioni libere, ma elezioni coerenti con questo regime e da esso contaminate.
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- La forza dell’intellettuale di destra (di fausto Curi).23 agosto 2010, di Federico La Sala
La forza dell’intellettuale di destra
di Fausto Curi (il manifesto, 21.08.2010)
Se si discute seriamente degli intellettuali, la prima cosa che conviene osservare è che è il dibattito sugli intellettuali che si è logorato, non la loro funzione. Anzi. L’efficacia degli intellettuali di destra è evidente a tutti. Nessuno di loro è un genio, sono rozzi anche quando sono colti, spesso sono servili e impudichi. Ma ci sono. Contano. Possiamo disprezzarli, non possiamo sottovalutare l’efficacia della loro funzione. Servono, appunto. Hanno la grande opportunità di potersi appoggiare a un regime, al potere, a una realtà strutturale, insomma, e questo li rende forti. I nostri sarcasmi non li scalzano. Conviene, anzi, riflettere sulla loro funzione, prima di discutere della funzione degli intellettuali di sinistra.
Il potere e il denaro
Essere organici, più che a un partito, al potere conferisce una forza e un’efficacia molto rilevanti, essenziali. Perché il potere di cui parliamo non è un potere metafisico. È una struttura nel senso di Marx, è un potere strutturale, strutturato. È fatto di giganteschi conflitti di interessi, di continue violazioni delle leggi e delle regole, di corruzione, di impunità. È fatto di un’enorme, pervasiva, penetrante capacità mediatica. È fatto di istituzioni corrotte e corrompibili, di grandi industrie, di sindacati docili quando non servili. E di danaro, molto danaro. A questa struttura cosa può contrapporre la sinistra? O meglio, cosa possono contrapporre gli intellettuali di sinistra, ché di questo posso e voglio parlare.
La sovrastruttura
Incominciamo con l’osservare che gli intellettuali di sinistra sono sovrastrutturali, non solo nel senso che la loro opposizione investe o piuttosto può investire soltanto, come è ovvio, delle realtà sovrastrutturali, ma anche nel senso che essi possono essere organici soltanto a organizzazioni partitiche, per di più esigue, fragili e litigiose, a una cultura, a delle idee, o meglio, se non si ha paura della parola, a delle ideologie. Possono essere organici, insomma, a qualcosa di immateriale. Mentre, oggi, è la materialità che conta, anche per chi finge di nutrire soltanto ideali.
Il punto che mi preme sottolineare, e che, credo, dovrebbe essere al centro di un dibattito, è l’organicità e la disorganicità dell’intellettuale. La disorganicità, elogiata da Umberto Eco, è facile da assumere e da praticare, può essere preziosa sul piano culturale, ma sul piano politico, o meglio sul piano strutturale, ben difficilmente produce risultati apprezzabili. L’intellettuale disorganico possiede di solito un’intelligenza lucida e penetrante, una cultura raffinata, è brillante, versatile, ironico, a volte sarcastico, spesso scettico, non di rado sfiora il cinismo. È libero e soprattutto si sente libero e si compiace della propria libertà. Vanta la propria funzione sociale e culturale, non manca di esibire i propri meriti.
La funzione dell’apparire
Esiste anche una disorganicità di sinistra, e non è meno raffinata di quella di destra. Sono gli intellettuali disorganici di sinistra che sostengono che gli intellettuali non esistono più, o sono diventati inutili, non contano, così come non serve discutere, perché non se ne può più di proposte astratte, sganciate dalla realtà, in conflitto fra di loro, che lasciano il tempo che trovano. Ma intanto loro discutono, sono presenti, non rinunciano a prendere la parola e ad apparire. E mostrano di aver ragione. Perché intellettuali come loro sono davvero inutili. Ma ha più ragione Massimo Raffaeli che invita a tener conto dell’esempio di Brecht e propone la via dell’umiltà. Sono le domande semplici e apparentemente ingenue che possono imbarazzare e mettere con le spalle al muro una cultura aristocratica e cinica.
Fiducia e coraggio
L’ottimismo è degli imbecilli, la fiducia è di chi ha coraggio, non si arrende e soprattutto non tradisce. Perché chi si vergogna o esita a dirsi comunista o marxista o di sinistra, tradisce. È fatta anche di tradimenti, di molti tradimenti, l’agevole ascesa di Silvio Berlusconi.
Ma, prima di concludere, non possiamo trascurare l’intellettuale organico. L’intellettuale organico chi è, oggi? Prima di tutto: esiste ancora? Certo che esiste, o che può esistere. Non può più essere organico a un grande partito di sinistra, ma può essere organico a una determinata cultura, a una determinata ideologia.
Serietà e coerenza
Una cultura non solo non conformistica, ma radicalmente antagonistica. Un’ideologia ben strutturata, razionalmente contestativa. Può essere organico, in primo luogo, a una classe sociale, se non crede alla favola fatta circolare dagli intellettuali reazionari secondo la quale le classi non esistono più. Gli operai di Pomigliano, e non solo loro, stanno a dimostrare il contrario. Organicità implica serietà, implica coerenza, implica fedeltà. A volte implica anche rinunce e sacrifici.
Per quanto mi riguarda, non ho paura a dire, o, se si preferisce, a ripetere, che organicità chiede disciplina intellettuale e morale. E chiede impegno. Saranno i sarcasmi degli intellettuali disorganici a disarmarci e a metterci a disagio? Chi ha detto che una cultura organica è incapace di ironia? Noi, che abbiamo perduto tutto, o quasi, noi, pessimisti organici, abbiamo imparato da tempo che è attraverso l’ironia che va guardato il mondo alla rovescia in cui ci tocca vivere.
-
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. ---- IL CASO HEIDEGGER E IL RISVEGLIO NELL’ORA DE PERICOLO DI SIGMUND FREUD.17 maggio 2010, di Federico La Sala
IL CASO HEIDEGGER E IL RISVEGLIO NELL’ORA DE PERICOLO DI SIGMUND FREUD.
A fine gennaio del 1933, Adolf Hitler giunge al potere. Nello stesso anno, Martin Heidegger diventa rettore dell’Università di Friburgo ed esprime pieno ed inequivocabile appoggio al regime nazista, con il suo famoso discorso su “L’autoaffermazione dell’università tedesca”. Per Heidegger non c’è alcun dubbio che Hitler sia il Messia del popolo tedesco, come ripeterà in uno scritto sul giornale degli studenti dell’Università, il 3 novembre del 1933: “Il Fuhrer stesso e lui soltanto è la realtà tedesca e la sua legge, oggi e da oggi in poi. Rendetevene conto sempre di più: da ora ogni cosa richiede decisione, e ogni azione responsabilità”. La notte scende sulla Germania, e su tutta l’Europa: in un’intervista del 1966, Heidegger, pur mai pentendosi dei suoi trascorsi nazionalsocialisti, dichiarerà che “Solo un Dio ci può salvare”. (per proseguire la lettura, clicca ->
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. ---- la verità come un optional. L’uso politico della menzogna (di Francesca Rigotti).8 aprile 2010, di Federico La Sala
 Se la verità diventa un optional
Se la verità diventa un optional
 L’uso politico della menzogna
L’uso politico della menzognadi Francesca Rigotti (l’Unità, 8.4.2010)
La libertà - scriveva Albert Camus - consiste in primo luogo nel non mentire». Proviamo a pensarci su perché qui si tratta di cose serie, mica di canzonette. Qui sono in gioco termini/concetti come libertà e verità. E la libertà è, insieme alla giustizia, una delle grandi virtù delle istituzioni politiche, come la verità è la virtù principale dei sistemi di pensiero, e chi viola il principio di verità lede anche quello di libertà. Ora, l’uso politico della menzogna viene parzialmente accettato dalla filosofia politica, per esempio da Hannah Arendt, che la giustifica nel caso di delicate operazioni di segretezza.
A una corretta pratica democratica non è invece perdonata né la torbidezza né la menzogna e tantomeno il falsificare i fatti per ragioni di immagine, quando queste attività - sempre Arendt - vengano praticate nei confronti dei concittadini e non del nemico in guerra. Se in politica, il luogo delle scelte collettive e che interessano la collettività, si può mentire, non si deve per questo farlo, né la pratica del mentire deve essere, in politica, tollerata e perdonata, o addirittura incoraggiata.
La verità è infatti una virtù preziosa - come spiega Franca D’Agostini nel dotto quanto affascinante saggio «Verità avvelenata. Buoni e cattivi argomenti nel dibattito pubblico» (Bollati Boringhieri). La verità del nostro mondo, che vive nella legge della terra e nella radicale pluralità degli uomini da tale legge contemplata, è la verità che percepiamo con le nostre facoltà logiche.
Poi c’è la «verità» riferita da una parte politica e magari accettata da un gruppo di persone che non hanno la coscienza attiva di partecipare a un inganno. Questa è una «verità» allestita a fini di opportunità ma lesiva della libertà dei cittadini, anche di quelli che si lasciano volentieri ingannare, per il semplice motivo che la menzogna distrugge la fiducia, anche questa una delle grandi e dimenticate virtù della vita sociale democratica.
Un punto in più per la tesi che sostiene che la destra italiana che ci malgoverna non partecipa dei principi del pensiero liberale - quelli socialisti, poi, non sa neanche dove stiano di casa - benché proclami gli uni e gli altri.
Questo perché un pensiero fondativo non ce l’ha e può perciò praticare la menzogna e il mendacio pensando che chi caninamente latra più forte e in numero più alto riesca a sopraffare anche la verità. Ma questo non è vero e mentire per non voler riconoscere l’errore può costare caro, molto più caro che dover ricorrere al trapianto di capelli per aver commesso l’errore di non aver mai usato la brillantina Linetti.❖
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- LA DEMOCRAZIA, IL GIOCO DELLA MORTE, E IL BUFFONE (di Barbara Spinelli).21 marzo 2010, di Federico La Sala
Il colore della democrazia
di BARBARA SPINELLI (La Stampa, 21/3/2010)
L’8 marzo scorso, forse per rassicurare gli italiani, il Presidente della Repubblica ha fatto alcune considerazioni singolari, sul coraggio e la politica. Ha detto che «in un contesto degradato, di diffusa illegalità, essere ragazzi e ragazze perbene richiede talvolta sacrifici e coraggio»: in questi casi estremi sì, «è bello che ci sia» questa virtù. Ma in una democrazia rispettabile come la nostra, «per essere buoni cittadini non si deve esercitare nessun atto di coraggio». Profonda è infatti negli italiani «la condivisione di quel patrimonio di valori e principi che si racchiude nella Costituzione». Legge e senso dello Stato sono nostre doti naturali: il che esclude il degrado della legalità. I toni bassi sono lo spartito di sì armoniosa disposizione.
Il fatto è che non siamo in una democrazia rispettabile, e forse il Presidente pecca di ottimismo non solo sull’Italia ma in genere sullo stato di salute delle democrazie. Certo, non s’erge un totalitarismo sterminatore.
 Ma Napolitano avrà forse visto il terribile esperimento mostrato alla televisione francese, qualche giorno fa. Il documentario si intitola Il Gioco della morte, e mette in scena un gioco a premi in cui i candidati, per vincere, ricevono l’ingiunzione di infliggere all’avversario che sbaglia i quiz una scarica elettrica sempre più intensa, fino al massimo voltaggio che uccide.
Ma Napolitano avrà forse visto il terribile esperimento mostrato alla televisione francese, qualche giorno fa. Il documentario si intitola Il Gioco della morte, e mette in scena un gioco a premi in cui i candidati, per vincere, ricevono l’ingiunzione di infliggere all’avversario che sbaglia i quiz una scarica elettrica sempre più intensa, fino al massimo voltaggio che uccide.
 La vittima è un attore che grida per finta, ma i candidati non lo sanno. Il risultato è impaurente: l’81 per cento obbedisce, spostando la manopola sui 460 volt che danno la morte. Solo nove persone si fermano, udendo i primi gemiti del colpito. Sette rinunciano, poi svengono.
La vittima è un attore che grida per finta, ma i candidati non lo sanno. Il risultato è impaurente: l’81 per cento obbedisce, spostando la manopola sui 460 volt che danno la morte. Solo nove persone si fermano, udendo i primi gemiti del colpito. Sette rinunciano, poi svengono.Difficile dopo aver visto il Gioco dire che siamo democrazie rispettabili, dove legge e Costituzioni sono interiorizzate. Quel che nell’uomo è connaturato, in dittatura come in democrazia, non è la legge ma l’abitudine a «non pensarci», l’istinto di gregge, e in primis il conformismo. Il «contesto degradato» è nostro orizzonte permanente. È quello che Camus chiama l’assurdo: il mondo non solo non ha senso ma neppure sente bisogno di senso, ricorda Paolo Flores d’Arcais in un saggio sullo scrittore della rivolta (Albert Camus filosofo del futuro, Codice ed., 2010).
Coraggioso è chi invece «si dà pensiero», chi s’interroga sul male e per ciò stesso diventa, in patria, spaesato. Flores conclude: «Venire al mondo equivale a far nascere un dover essere». In effetti sono tanti e giornalieri, gli atti di coraggio di cui si può dire: vale la pena. È coraggioso chi in gran parte d’Italia non paga pizzi alle mafie. Sono coraggiosi il poliziotto o il giudice che resistono alle pressioni della malavita o della politica. Soprattutto il servitore dello Stato è chiamato al coraggio, in un’Italia unificata dalla lingua ma non dal senso dello Stato. Coraggioso è chiunque sia classe dirigente, e con il proprio agire, scrivere, fare informazione, influenza l’opinione con la verità. Non so se sia bello, dire no. È comunque necessario, specie in Italia dove paure e conformismo hanno radici possenti. Il coraggio, siamo avvezzi a vederlo come gesto di eccezionale purezza mentre è gesto di chi fu Borsellino a dirlo in cuor suo lo sa: «È normale che esista la paura. In ogni uomo, l’importante è che sia accompagnata dal coraggio». Così come c’è un male banale, esiste la banalità quotidiana del coraggio.
Forse bisogna tornare alle fonti antiche, per ritrovare questa virtù.
 Nella Repubblica, Platone spiega come il coraggio (andreia) sia necessario in ogni evenienza, estrema e non. Esso consiste nella capacità (dell’individuo, della città) di farsi un’opinione su ciò che è temibile o non lo è, e di «salvare tale opinione». L’opinione da preservare, sulla natura delle cose temibili, «è la legge e impiantarla in noi attraverso l’educazione», e il coraggio la conserva «in ogni circostanza: nel dolore, nel piacere, nel desiderio, nel timore» (429,c-d). La metafora usata da Platone è quella del colore. Immaginate una stoffa, dice: per darle un indelebile colore rosso dovrete partire dal bianco, e sapere che il colore più resistente si stinge, se viene a contatto con i detersivi delle passioni.
Nella Repubblica, Platone spiega come il coraggio (andreia) sia necessario in ogni evenienza, estrema e non. Esso consiste nella capacità (dell’individuo, della città) di farsi un’opinione su ciò che è temibile o non lo è, e di «salvare tale opinione». L’opinione da preservare, sulla natura delle cose temibili, «è la legge e impiantarla in noi attraverso l’educazione», e il coraggio la conserva «in ogni circostanza: nel dolore, nel piacere, nel desiderio, nel timore» (429,c-d). La metafora usata da Platone è quella del colore. Immaginate una stoffa, dice: per darle un indelebile colore rosso dovrete partire dal bianco, e sapere che il colore più resistente si stinge, se viene a contatto con i detersivi delle passioni.Il colore della democrazia è la resistenza a questo svanire di tinte, a questo loro espianto dal cuore (il cuore è la sede del coraggio). Compito dei cittadini e dei custodi della repubblica è «assorbire in sé, come una tintura, le leggi, affinché grazie all’educazione ricevuta e alla propria natura essi mantengano indelebile l’opinione sulle cose pericolose, senza permettere che la tintura sia cancellata da quei saponi così efficaci a cancellare: dal piacere, più efficace di qualsiasi soda; dal dolore, dal timore e dal desiderio, più forti di qualsiasi sapone» (430,a-b).
In Italia la democrazia è stinta più efficacemente perché le leggi e i custodi ci sono, ma l’innesto è meno scontato di quanto si creda. Berlusconi lavora a tale espianto da anni, e ora lo ammette senza più remore: alla legalità contrappone la legittimità che le urne conferiscono al capo. I custodi delle leggi li giudica usurpatori oltre che infidi. Legittimo è solo il capo, e questo gli consente di dire: «La legge è ciò che decido io». I contropoteri cesseranno di insidiarlo solo quando pesi e contrappesi si fonderanno: quando, eletto dal popolo, conquisterà il Quirinale.
Se la democrazia fosse rispettabile non ci sarebbe un capo che s’indigna perché scopre d’esser stato intercettato mentre ordina di censurare programmi televisivi sgraditi, e i cittadini, forti di indelebili tinture, gli direbbero: le tue telefonate non sono private come le nostre, le intercettazioni sono a volte eccessive ma chiamare l’autorità garante dell’informazione o il direttore di un telegiornale Rai, per imprimere loro una linea, è radicalmente diverso. Ognuno ha diritto alla privacy, e anche noi abbiamo criticato gli eccessi delle intercettazioni. Ma l’abuso di potere che esse rivelano è in genere ben più impaurente del cannocchiale che lo smaschera. Schifani dice: «È preoccupante la fuga di notizie» e di fatto lo riconosce: sono le notizie a inquietarlo. Anche dire questa semplice verità è coraggio quotidiano.
L’intervento sui programmi televisivi si fa specialmente sinistro alla luce di show come Il Gioco della morte. Non dimentichiamo che un esperimento simile si fece nel luglio 1961 all’università di Yale, guidato dallo psicologo Stanley Milgram. A ordinare gli elettroshock, allora, c’erano autorevoli biologi in camice grigio. Oggi l’autorità si fa giocosa, è una bella valletta a intimare, suadente: «Alzi il voltaggio!». Il pubblico applaude, ride. A opporsi è stato un misero 20 per cento, mentre il 35 s’oppose nel caso Milgram. Ne consegue che la televisione ha più potere di scienziati in camice, sulle menti: il coraggio diminuisce, il conformismo aumenta. Philip Zimbardo, organizzatore di test analoghi a Stanford nel 1971, racconta come nessuno di coloro che rifiutarono di infliggere i 460 volt chiese a Milgram di fermare l’esperimento, o di visitare l’urlante vittima degli elettroshock.
 Questo significa che la televisione non è più solo una caja tonta, una scatola tonta, come dicono in Spagna. È una cassa da morto, che trasforma lo studio televisivo in Colosseo di sangue: lugubri, le risate sono le stesse.
Questo significa che la televisione non è più solo una caja tonta, una scatola tonta, come dicono in Spagna. È una cassa da morto, che trasforma lo studio televisivo in Colosseo di sangue: lugubri, le risate sono le stesse.Ci sono sere a RaiUno in cui prima viene un notiziario menzognero (che dà per assolto Mills, che presenta il giurista Hans Kelsen come critico ante litteram della legalità), poi seguono programmi dai nomi ominosi: Affari Tuoi, I Raccomandati, in un crescendo di catodiche manipolazioni.
Presto vedremo, in Tv, la morte in diretta sotto forma di varietà. Kierkegaard dice in Aut-Aut che l’ultimo ad apparire, alla fine del mondo, sarà il Buffone: «Accadde in un teatro, che le quinte presero fuoco. Il Buffone uscì per avvisare il pubblico. Credettero che fosse uno scherzo e applaudirono; egli ripeté l’avviso: la gente esultò ancora di più. Così mi figuro che il mondo perirà fra l’esultanza generale degli spiritosi, che crederanno si tratti di uno scherzo».
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. ---- CRITICA DELLA POLITICA SPETTACOLO: ONORE E GLORIA A MARCO MATERAZZI.26 gennaio 2010, di Federico La Sala
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. ---- Di fronte a un Berlusconi, camuffatosi da "Presidente della Repubblica" con il suo "Forza Italia" (1994), e con il suo "Popolo della Libertà", Scalfari ora comprende che il progetto del Cavaliere è molto chiaro: riscrivere la Costituzione (di Eugenio Scalfari - Peggio del McCarthy di sessanta anni fa).14 marzo 2010, di Federico La Sala
Peggio del McCarthy di sessanta anni fa
di EUGENIO SCALFARI *
Tralascio per ora le consuete e querule lamentazioni del nostro pseudo san Sebastiano nazionale trafitto dalle frecce dei magistrati comunisti. Mi sembra più interessante cominciare questo articolo con un’osservazione sul comune sentire dei centristi. I centristi, quelli che non amano prender posizione neppure nei momenti in cui schierarsi sarebbe inevitabile, si rifugiano nella tecnica di mandare la palla in tribuna anziché tenerla in campo. Gli argomenti usati e ormai consueti sono: descrivere le manifestazioni di popolo come stanchi riti vissuti con annoiata indifferenza perfino da chi vi partecipa; sottolineare che "i veri problemi" non sono quelli di schieramento ma i programmi delle Regioni nelle quali si voterà il 28 marzo; infine sottolineare l’importanza di un’astensione di massa dal voto come segnale idoneo a ricondurre la casta politica sulla retta via dell’amministrazione.
Questa saggezza centrista non mi pare che colga la realtà per quanto riguarda i fatti e mi sembra alquanto sconsiderata nelle sue proposte. La piazza del Popolo di ieri pomeriggio era gremita e ribollente di passione, di senso di responsabilità e insieme di rabbiosa indignazione: niente a che vedere con l’indifferenza di un rito stanco. La proposta dell’astensione rivolta al centrosinistra mostra la corda: l’astensione sarebbe soltanto un favore alla maggioranza che ci sgoverna e non metterebbe affatto il governo sulla retta via della buona amministrazione.
Il governo sarebbe ben felice di un’astensione a sinistra che compensasse la vasta astensione che si delinea a destra. Se è vero - e gli stessi centristi lo dicono ormai a chiare note - che il governo non riesce ad esprimere una politica ma mette in opera tutti i mezzi leciti e illeciti per puntellare il suo potere annullando controlli e garanzie, lo strumento elettivo è il solo capace di punirlo affinché cambi registro o se ne vada. Gli elettori di destra in buona fede si astengano invece di turarsi il naso di fronte al pessimo odore che anch’essi ormai percepiscono; quelli di sinistra votino senza esitazioni perché è il solo modo per far rinsavire un Paese frastornato e licenziare la cricca che fa man bassa delle istituzioni.
I problemi concreti, la disoccupazione, la caduta del reddito, l’immigrazione, la sanità, il Mezzogiorno, sono tanti e gravi, ma il problema dei problemi è appunto la cricca e il boss della cricca. Se non si risolve preliminarmente quello, tutti gli altri continueranno a marcire. Ne abbiamo l’ennesima conferma dalle ultime notizie che arrivano dalla Procura di Trani e che sono su tutti i giornali di ieri. Il presidente del Consiglio ha preteso che l’Autorità garante del pluralismo nei "media" azzerasse la trasmissione Annozero, ha dato più volte indicazioni a Minzolini di come condurre il Tg1, ha imposto al direttore generale della Rai di bloccare le trasmissioni sgradite. È possibile che questi comportamenti non configurino reati gravi, ma certo raccontano una politica di sopraffazione indecente contro il pluralismo e la libertà di stampa. Per un leader di partito e soprattutto per il presidente del Consiglio e capo del potere esecutivo, questi reiterati interventi dovrebbero portarlo alle dimissioni immediate e irrevocabili. E i primi a reclamarle dovrebbero essere i suoi collaboratori, ivi compreso il cofondatore del Pdl, Gianfranco Fini.
* * *
Il progetto costituzionale di Silvio Berlusconi è molto chiaro: vuole riscrivere la Costituzione. Non modificarne alcuni punti ma riscriverla stravolgendone lo spirito, mettendo al vertice una sorta di "conducator" eletto direttamente dal popolo insieme alla maggioranza parlamentare da lui stesso indicata e subordinando alla sua volontà non solo il potere esecutivo e quello legislativo ma anche i magistrati del pubblico ministero, la Corte costituzionale e le autorità di controllo e di garanzia. Questo progetto non è nato oggi ma è nella sua mente fin dal 2001, quando ebbe inizio la legislatura che durò fino al 2006 e si svolse durante il settennato al Quirinale di Carlo Azeglio Ciampi. Le divergenze tra il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio furono numerose e ebbero come oggetto soprattutto quel tema; non potendo cambiare la Costituzione nel modo da lui desiderato Berlusconi tentò di modificarla nei fatti contestando sistematicamente le attribuzioni del capo dello Stato e i poteri che gli derivano. Il capo dello Stato rappresenta il coronamento istituzionale della democrazia parlamentare così come la configura la nostra Costituzione ed è, proprio per questo il maggior ostacolo ai progetti di Berlusconi. Non è dunque un caso che i suoi bersagli costanti siano stati Scalfaro, Ciampi, Napolitano: tre uomini estremamente diversi tra loro, con diversi caratteri e diverse origini culturali, ma con identica dedizione ai loro doveri costituzionali. E proprio per questo sono stati tutti e tre nel mirino di Berlusconi fin da quando salì per la prima volta alla presidenza del Consiglio avendo in animo di governare da solo, senza ostacoli di sorta che controllassero la legalità delle sue azioni e ne limitassero la discrezionalità che egli vuole piena e assoluta.
Gli attriti con Ciampi furono, come ho ricordato, numerosi. Due di essi in particolare avvennero in circostanze di estrema tensione. Il primo in occasione della nomina di tre giudici della Corte costituzionale, il secondo nel momento della promulgazione della legge Gasparri sul sistema televisivo nazionale. Ho avuto la ventura di esser legato a Ciampi da un’amicizia che dura ormai da quarant’anni, sicché ebbi da lui un lungo racconto di quei due episodi poco tempo dopo il loro svolgimento. Non ho mai rivelato quel racconto, del quale ho conservato gli appunti nel mio diario quotidiano. Spero che il presidente Ciampi mi perdonerà se oggi ne faccio cenno, poiché la riservatezza che finora ho rispettato non ha più ragion d’essere al punto in cui è arrivata la situazione politica italiana.
L’episodio concernente la nomina dei tre giudici della Consulta nella quota che la Costituzione riserva al Presidente della Repubblica, avvenne nella sala della Vetrata del Quirinale. Erano presenti il segretario generale del Quirinale, Gifuni e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta. I temi da discutere erano due: i rapporti con la Commissione europea di Bruxelles dove il premier doveva recarsi per risolvere alcuni importanti problemi e la nomina dei tre giudici. Esaurito il primo argomento Ciampi estrasse da una cartella i tre provvedimenti di nomina e comunicò a Berlusconi i nomi da lui prescelti. Berlusconi obiettò che voleva pensarci e chiese tempo per riflettere e formulare una rosa di nomi alternativa. Ciampi gli rispose che la scelta, a termini di Costituzione, era di sua esclusiva spettanza e che la firma del presidente del Consiglio era un atto dovuto che serviva semplicemente a certificare in forma notarile che la firma del Capo dello Stato era autentica e avvenuta in sua presenza. Ciò detto e senza ulteriori indugi Ciampi prese la penna e firmò passando i tre documenti a Berlusconi per la controfirma. A quel punto il premier si alzò e con tono infuriato disse che non avrebbe mai firmato non perché avesse antipatia per i nomi dei giudici ma perché nessuno poteva obbligarlo a sottoporsi ad una scelta che non derivava da lui, fonte unica di sovranità perché derivante dal popolo sovrano. La risposta di Ciampi fu gelida: "I documenti ti verranno trasmessi tra un’ora a Palazzo Chigi. Li ho firmati in tua presenza e in presenza di due testimoni qualificati. Se non li riavrò immediatamente indietro da te controfirmati sarò costretto a sollevare un conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale. "Ti saluto" rispose altrettanto gelidamente Berlusconi e uscì dalla Vetrata seguito da Letta. In serata i tre atti di nomina tornarono a Ciampi debitamente controfirmati.
Il secondo episodio avvenne nel corso di una colazione al Quirinale, sempre alla presenza di Gifuni e di Letta. Il Parlamento aveva votato la legge Gasparri e l’aveva trasmessa a Ciampi per la firma di promulgazione. Presentava, agli occhi del Capo dello Stato, svariati e seri motivi di incostituzionalità e mortificava quel pluralismo dell’informazione che è un requisito essenziale in una democrazia e sul quale, appena qualche mese prima, Ciampi aveva inviato al Parlamento un suo messaggio. La colazione era da poco iniziata quando Ciampi informò il suo ospite del suo proposito di rinviare la legge alle Camere, come la Costituzione lo autorizza a fare motivando le ragioni del rinvio e i punti della legge da modificare. Berlusconi non si aspettava quel rinvio. Si alzò con impeto e alzò la voce dicendo che quella era una vera e propria pugnalata alla schiena. Ciampi (così il suo racconto) restò seduto continuando a mangiare ma ripeté che avrebbe rinviato la legge al Parlamento. L’altro gli gridò che la legge sarebbe stata comunque approvata tal quale e rinviata al Quirinale e aggiunse: "Ti rendi conto che tu stai danneggiando Mediaset e che Mediaset è una cosa mia? Tu stai danneggiando una cosa mia". A quel punto si alzò anche Ciampi e gli disse: "Questo che hai appena detto è molto grave. Stai confessando che Mediaset è cosa tua, cioè stai sottolineando a me un conflitto di interessi plateale. Se avessi avuto un dubbio a rinviare la legge, adesso ne ho addirittura l’obbligo". "Allora tra noi sarà guerra e sei tu che l’hai voluta. Non metterò più piede in questo palazzo".
Uscì con il fido Letta. Ciampi rinviò la legge. Il premier per sei mesi non mise più piedi al Quirinale. Venerdì scorso ho rivisto su Sky un bellissimo film prodotto da George Clooney. Si intitola "Good Night and Good Luck", Buona notte e buona fortuna, e racconta di una società televisiva che guidò la protesta dei democratici americani contro la campagna di intimidazione con la quale il senatore McCarthy, presidente d’una commissione di inchiesta del Senato, aveva intimidito e colpito giornalisti, docenti universitari, produttori ed attori, uomini d’affari, sindacalisti, scienziati e tutta la classe dirigente con l’accusa di essere comunisti o loro fiancheggiatori. Quella società televisiva, guidata da un giornalista coraggioso, mise McCarthy sotto accusa, ne documentò la faziosità e suscitò un tale movimento di opinione pubblica che il Senato aprì un’indagine e destituì McCarthy da tutti i suoi incarichi. Sky l’ha rimesso in onda l’altro ieri ed ha fatto a mio avviso un’ottima scelta: la sua attualità è stupefacente. Citerò le parole con le quali il protagonista conclude: "La televisione è uno strumento che può e deve contribuire a rendere le persone più consapevoli, più responsabili e più libere. Se mancano questi presupposti e questi obiettivi la televisione è soltanto una scatola piena di fili elettrici e di valvole". Aggiungo io: una scatola, ma a volte molto pericolosa se qualcuno se ne impadronisce e la controlla a proprio uso e consumo. Good Night, and Good Luck.
© la Repubblica, 14 marzo 2010
-
-
> L’Italia come volontà e come rappresentazione di un solo Partito: "Forza Italia"!!! ---- Cosa ne pensa Emanuele Severino del caso Lombardi Vallauri?: «L’università può sospendere chi vuole»!!!21 ottobre 2009, di Federico La Sala
 Emanuele Severino: «L’università può sospendere chi vuole»
Emanuele Severino: «L’università può sospendere chi vuole»
 di Armando Torno (Corriere della Sera, 21.10.2009)
di Armando Torno (Corriere della Sera, 21.10.2009)Cosa ne pensa Emanuele Severino del caso Lombardi Vallauri? E di quello che vide protagonista Franco Cordero, escluso dall’in segnamento in Cattolica poco dopo di lui? Risponde il filosofo: «Mi sembra, e per quanto ricordo, che Lombardi Vallauri e Cordero siano stati e rimangano sostanzialmente cristiani, e quindi si è trattato di una lite in famiglia. Il mio caso risale alla fine degli Anni 60 e, se i due colleghi non hanno gradito la decisione dell’Università fondata da padre Gemelli, è perché alla Cattolica volevano rimanere».
Cosa capitò, invece, a Severino? Ecco le sue parole: «A differenza di loro, nei miei riguardi c’è stato un processo formalmente analogo, dal punto di vista giuridico e con le debite proporzioni, a quello di Galileo». Insomma, era questione diversa. Perché? «Il mio discorso filosofico - nota Severino- fa rientrare il cristianesi mo nella storia del nichilismo. Non si tratta di una lite in famiglia». Puntualizza: «Aggiungo che per le leggi italiane l’Università Cattolica può sospendere dall’insegnamento, ma non togliere lo stipendio al docente colpito qualora egli sia un professore che abbia vinto un concorso statale (come il sottoscritto, Cordero, Vallauri e tutti gli ordinari). Da parte mia, d’accordo con le autorità accademiche ed ecclesiastiche, ho preferito andarmene a Venezia soprattutto perché avevo attorno un gruppo di giovani studiosi, oggi tutti in cattedra, presidi eccetera, che invece sarebbero ri masti senza alcun sostentamento qualora io avessi scelto di percepire lo stipendio rinunciando a insegnare».
Per quel che riguarda il giudizio europeo sul caso Lombardi Vallauri, Severino osserva: «Ritengo, con tutta la stima per i colleghi, che se un’università libera decide che sia seguito un determinato indirizzo culturale, chi vi insegna non debba poi avere la pretesa di sceglierne uno diverso». E conclude: «Fortunatamente in un’università come quella del San Raffaele dove insegno, chi la guida, cioè il sacerdote don Luigi Maria Verzé, auspica ma non esige dai docenti un determinato indirizzo culturale».
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. L’Italia come volontà e come rappresentazione di un solo Partito: "Forza Italia"!!! Materiali per un convegno prossimo futuro - a cura di pfls14 settembre 2009, di Federico La Sala
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. ---- -«Gli intellettuali? Servi del potere di turno» (di Oreste Pivetta -Conversando con Goffredo Fofi ).22 settembre 2009, di Federico La Sala
 Conversando con Goffredo Fofi critico cinematografico e letterario
Conversando con Goffredo Fofi critico cinematografico e letterario «Gli intellettuali?
«Gli intellettuali?
 Servi del potere di turno
Servi del potere di turno
 Una brillante corporazione»
Una brillante corporazione» La sinistra si è suicidata e «sinistra» è rimasta una parola senza senso
La sinistra si è suicidata e «sinistra» è rimasta una parola senza senso di Oreste Pivetta (l’Unità, 22.09.2009)
di Oreste Pivetta (l’Unità, 22.09.2009)Farabutto, coglione, va’ a morì ammazzato. Da tempo ormai. Ha ragione Brunetta quando dice che tutto sommato sono soltanto modi di dire popolari. Ma una volta a scuola si sussurravano appena e per sentirli sonanti bisognava incappare in una lite di mercato o di condominio. Adesso siamo alle platee politiche e alle (massime) responsabilità politiche, dopo un breve viatico televisivo, con la scusa del dialetto, nell’esercizio del dialetto come piacerebbe a Bossi (dal celeberrimo gesticolare), ma dalla parte del potere. Democrazia tra Chavez e Putin, diceva ieri Daniel Cohn Bendit, il politico francese, all’Unità. Storie diverse.
 Con un filo d’arroganza nazionale si potrebbe alludere a tradizioni democraticamente diverse, almeno dalla metà del secolo scorso.
Con un filo d’arroganza nazionale si potrebbe alludere a tradizioni democraticamente diverse, almeno dalla metà del secolo scorso.
 «Ma nell’ultimo ventennio - dice Goffredo Fofi, tra i pochi intellettuali critici di questo paese - ci siamo messi a correre: stupisce la rapidità del declino...».
«Ma nell’ultimo ventennio - dice Goffredo Fofi, tra i pochi intellettuali critici di questo paese - ci siamo messi a correre: stupisce la rapidità del declino...». Le tradizioni, a quanto pare, sono andate a farsi benedire, divelte, sconquassate, annichilite nel confortante silenzio delle maggioranze. Perché alle fondamenta del regime berlusconiano ci staranno i soldi, ci staranno le televisioni, ma ci stanno anche le maggioranze... Come definirle queste maggioranze? Menefreghiste, qualunquiste, indifferenti, sfiduciate? Perché ci siamo così presto abituati alle bravate, parole e atti, dei nostri governanti? Insomma che paese siamo?
Le tradizioni, a quanto pare, sono andate a farsi benedire, divelte, sconquassate, annichilite nel confortante silenzio delle maggioranze. Perché alle fondamenta del regime berlusconiano ci staranno i soldi, ci staranno le televisioni, ma ci stanno anche le maggioranze... Come definirle queste maggioranze? Menefreghiste, qualunquiste, indifferenti, sfiduciate? Perché ci siamo così presto abituati alle bravate, parole e atti, dei nostri governanti? Insomma che paese siamo?
 «Rispondo che ha ragione Cohn Bendit: tra Putin e Chavez, in mezzo a qualsiasi dittatorello che non ha più bisogno delle armi e dei bastoni per imporsi. Ma è una storia antica: il populismo è l’arte di manipolare l’opinione pubblica e gli esempi risalgono ai millenni passati. Nerone insegna. Adesso semplicemente si usano i mezzi di comunicazione di massa, ma non è che allora non non ne disponessero con la loro buona parte di originalità».
«Rispondo che ha ragione Cohn Bendit: tra Putin e Chavez, in mezzo a qualsiasi dittatorello che non ha più bisogno delle armi e dei bastoni per imporsi. Ma è una storia antica: il populismo è l’arte di manipolare l’opinione pubblica e gli esempi risalgono ai millenni passati. Nerone insegna. Adesso semplicemente si usano i mezzi di comunicazione di massa, ma non è che allora non non ne disponessero con la loro buona parte di originalità». Magari offrendo i cristiani in pasto alle belve.
Magari offrendo i cristiani in pasto alle belve.
 «Il problema sarebbe reagire. Ma chi reagisce? La destra non ha nulla da dire e non ha neppure interesse a dire qualcosa o a cercarsi altre strade o altre collocazioni e la sinistra si è suicidata e “sinistra” è rimasta una parola senza senso, che evoca soltanto assembramenti e divisioni, clan, famiglie, gruppi e litigi, con un modello di sviluppo in testa che non è diverso da quello che agita chi governa e con l’idea fissa soltanto di entrare nelle stanze del potere. Per che cosa, per quale futuro? Quali prospettive ci vuole indicare?». Ci è capitato di leggere quella bellissima invettiva di Don Tonino Bello contro gli intellettuali: «Siete latitanti dall’agorà.... State disertando la strada... Vi siete staccati dal popolo».
«Il problema sarebbe reagire. Ma chi reagisce? La destra non ha nulla da dire e non ha neppure interesse a dire qualcosa o a cercarsi altre strade o altre collocazioni e la sinistra si è suicidata e “sinistra” è rimasta una parola senza senso, che evoca soltanto assembramenti e divisioni, clan, famiglie, gruppi e litigi, con un modello di sviluppo in testa che non è diverso da quello che agita chi governa e con l’idea fissa soltanto di entrare nelle stanze del potere. Per che cosa, per quale futuro? Quali prospettive ci vuole indicare?». Ci è capitato di leggere quella bellissima invettiva di Don Tonino Bello contro gli intellettuali: «Siete latitanti dall’agorà.... State disertando la strada... Vi siete staccati dal popolo». D’accordo: chi avrebbe il compito di criticare e di pensare per l’avvenire non è più un riferimento per il presente, è diventato un imbonitore a libro paga...
D’accordo: chi avrebbe il compito di criticare e di pensare per l’avvenire non è più un riferimento per il presente, è diventato un imbonitore a libro paga...
 «Sono stato di recente a un convegno sul teatro. E naturalmente parlando di teatro e di teatranti, la prima questione che salta fuori sono i finanziamenti. Ogni assessore ritiene che i soldi della collettività siano suoi e ne deduce di poterne fare quello che vuole: premiare l’amico, il parente, premiare chi gli lecca il culo...». Siamo arrivati al cattivo esempio della parolaccia... «Per dire però che l’abbandono di criteri morali e culturali è ormai una questione antropologica...».
«Sono stato di recente a un convegno sul teatro. E naturalmente parlando di teatro e di teatranti, la prima questione che salta fuori sono i finanziamenti. Ogni assessore ritiene che i soldi della collettività siano suoi e ne deduce di poterne fare quello che vuole: premiare l’amico, il parente, premiare chi gli lecca il culo...». Siamo arrivati al cattivo esempio della parolaccia... «Per dire però che l’abbandono di criteri morali e culturali è ormai una questione antropologica...». Di una mutazione antropologica. Siamo di nuovo alla fine delle lucciole.
Non è il malaffare o l’ignoranza del singolo...
Di una mutazione antropologica. Siamo di nuovo alla fine delle lucciole.
Non è il malaffare o l’ignoranza del singolo...
 «No, si fa così perché s’è rinunciato a ragionare, a immaginare il domani, a discutere e a decidere che cosa sia sbagliato e che cosa sia giusto e scegliere il giusto, anche quando il popolo sbraita chiedendo caramelle invece di un lavoro serio o di una scuola seria...». Siamo al top del disastro. E, permetti, non è questione di precari...«No, il caos generale dimostra come la scuola abbia esaurito la sua funzione. Gli utenti, clienti, consumatori, la gente insomma, pensa che così debba essere e che così si debba continuare a governare, in una società guidata dal ciclo delle merci e dalla pubblicità. Si è abituata. Ecco la mutazione».
«No, si fa così perché s’è rinunciato a ragionare, a immaginare il domani, a discutere e a decidere che cosa sia sbagliato e che cosa sia giusto e scegliere il giusto, anche quando il popolo sbraita chiedendo caramelle invece di un lavoro serio o di una scuola seria...». Siamo al top del disastro. E, permetti, non è questione di precari...«No, il caos generale dimostra come la scuola abbia esaurito la sua funzione. Gli utenti, clienti, consumatori, la gente insomma, pensa che così debba essere e che così si debba continuare a governare, in una società guidata dal ciclo delle merci e dalla pubblicità. Si è abituata. Ecco la mutazione». E gli intellettuali? Non dovrebbero aprirci gli occhi? «Gli intellettuali prosperano, autentici guru, predicatori inesauribili, megalomani e narcisisti, che non contano niente o contano soltanto in funzione di un potere che li usa come mediatori, un potere molecorale rappresentato e conteso tra mafie, camorre, massonerie di ogni genere... Clan opportunistici di cui l’Italia è strapiena. Poi arriva Brunetta e annuncia: basta con l’assistenzialismo, basta con il clientelismo. Salvo poi rifare assistenzialismo e clientelismo per quelli e con quelli che gli stanno più simpatici. Vedi, la Costituzione dice che bisogna dare ai poveri e ai meritevoli: ma chi giudica? Dove stanno in Italia i probiviri? Frequenti le giurie dei premi letterari: sempre gli stessi, critici e autori, che parlano di se stessi e dei loro libri, premiati e premiatori insieme, una volta a te, una volta a me. Una brillante corporazione. Chi sente più la responsabilità nei confronti della società? Nessuno».
E gli intellettuali? Non dovrebbero aprirci gli occhi? «Gli intellettuali prosperano, autentici guru, predicatori inesauribili, megalomani e narcisisti, che non contano niente o contano soltanto in funzione di un potere che li usa come mediatori, un potere molecorale rappresentato e conteso tra mafie, camorre, massonerie di ogni genere... Clan opportunistici di cui l’Italia è strapiena. Poi arriva Brunetta e annuncia: basta con l’assistenzialismo, basta con il clientelismo. Salvo poi rifare assistenzialismo e clientelismo per quelli e con quelli che gli stanno più simpatici. Vedi, la Costituzione dice che bisogna dare ai poveri e ai meritevoli: ma chi giudica? Dove stanno in Italia i probiviri? Frequenti le giurie dei premi letterari: sempre gli stessi, critici e autori, che parlano di se stessi e dei loro libri, premiati e premiatori insieme, una volta a te, una volta a me. Una brillante corporazione. Chi sente più la responsabilità nei confronti della società? Nessuno». Nessuno che insegni. È un paradosso, forse.
Nessuno che insegni. È un paradosso, forse.
 «Ma certo. L’Italia è paese ancora vivo grazie a tante brave persone. Se non fosse così sarebbe alla catastrofe».
«Ma certo. L’Italia è paese ancora vivo grazie a tante brave persone. Se non fosse così sarebbe alla catastrofe». Mancano i punti di riferimento...
Mancano i punti di riferimento...
 «Alla lettera. Non esistono persone di riferimento. Morte. Non esiste chi pensa, chi guarda avanti, chi immagina il futuro, chi rifà opera di formazione nei confronti delle giovani generazioni in rapporto a ciò che dovrà essere. Solo o con gli altri. E qui s’aggiunge la terribile colpa della sinistra, di una sinistra piegata a rincorrere chi ha vinto, cioè i modelli del consumismo, delle merci, del libero mercato...».
«Alla lettera. Non esistono persone di riferimento. Morte. Non esiste chi pensa, chi guarda avanti, chi immagina il futuro, chi rifà opera di formazione nei confronti delle giovani generazioni in rapporto a ciò che dovrà essere. Solo o con gli altri. E qui s’aggiunge la terribile colpa della sinistra, di una sinistra piegata a rincorrere chi ha vinto, cioè i modelli del consumismo, delle merci, del libero mercato...». La vorresti alternativa?
La vorresti alternativa?
 «La vorrei solidale, capace di ascoltare, capace di inventare, critica. Ennio Flaiano diceva che la sinistra è bravissima a fare l’autocritica degli altri».
«La vorrei solidale, capace di ascoltare, capace di inventare, critica. Ennio Flaiano diceva che la sinistra è bravissima a fare l’autocritica degli altri». C’e una bella espressione di Cohn Bendit, che ho letto sulla tua rivista, «Lo straniero»: «...continueremo nello sforzo di spezzare la caratteristica proprietaria del sistema politico sia a livello nazionale che locale ed europeo. Più che mai noi promuoveremo il concetto di software libero applicato alla politica e alla società».
C’e una bella espressione di Cohn Bendit, che ho letto sulla tua rivista, «Lo straniero»: «...continueremo nello sforzo di spezzare la caratteristica proprietaria del sistema politico sia a livello nazionale che locale ed europeo. Più che mai noi promuoveremo il concetto di software libero applicato alla politica e alla società».
 «Sì, per rompere gli schemi di una democrazia autoritaria e proprietaria. Il che significa in questo paese ricostruire una cultura diffusa dello stato e della collettività. Come mi è sempre parso si fosse riusciti nel ventennio dal ’43, dalla Resistenza, al ’63, al tramonto cioè del centro sinistra, alla sconfitta dei suoi disegni più innovatori...».
«Sì, per rompere gli schemi di una democrazia autoritaria e proprietaria. Il che significa in questo paese ricostruire una cultura diffusa dello stato e della collettività. Come mi è sempre parso si fosse riusciti nel ventennio dal ’43, dalla Resistenza, al ’63, al tramonto cioè del centro sinistra, alla sconfitta dei suoi disegni più innovatori...». Basterebbe pensare alla casa, all’urbanistica, al ruolo allora di tanti intellettuali.
Basterebbe pensare alla casa, all’urbanistica, al ruolo allora di tanti intellettuali.
 «Quelli che adesso mancano. Perché non esistono più i critici, non esistono i teorici. Sopravvivono gli informatori e gli accademici, come Asor Rosa, che ancora predica l’autonomia della politica. Tutti affetti da narcisismo. Mi è appena arrivato un libro di Lucio Magri, con la sua bella faccia in copertina. Ma capisci! Neanche fosse Clooney. Si specchierà nella sua copertina. Invece credo che il primo dovere degli intellettuali, compreso il sottoscritto, sia certo guardarsi allo specchio, ma per sputarsi in faccia, per riconoscere il proprio fallimento».
«Quelli che adesso mancano. Perché non esistono più i critici, non esistono i teorici. Sopravvivono gli informatori e gli accademici, come Asor Rosa, che ancora predica l’autonomia della politica. Tutti affetti da narcisismo. Mi è appena arrivato un libro di Lucio Magri, con la sua bella faccia in copertina. Ma capisci! Neanche fosse Clooney. Si specchierà nella sua copertina. Invece credo che il primo dovere degli intellettuali, compreso il sottoscritto, sia certo guardarsi allo specchio, ma per sputarsi in faccia, per riconoscere il proprio fallimento». Una volta si diceva: ci salverà la Chiesa...
Una volta si diceva: ci salverà la Chiesa...
 «Tutti crediamo che la Chiesa si debba occupare della gente, cioè della collettività dimenticata dalla politica. Ma il primo scrupolo della Chiesa è la salvaguardia della istituzione».
«Tutti crediamo che la Chiesa si debba occupare della gente, cioè della collettività dimenticata dalla politica. Ma il primo scrupolo della Chiesa è la salvaguardia della istituzione». Come saremo?
Come saremo?
 «Quello che colpisce è la velocità appunto del declino italiano. In altri paesi d’Europa il senso dello Stato e il senso della comunità resistono. Da noi dominano egoismo e cinismo orripilanti. A Venezia, all’uscita dal cinema, dopo la propriezione del film di Patrick Chereau, la gente quasi vomitava: se qualcuno ti mette di fronte alla realtà, le reazioni sono il vomito e la fuga». ❖
«Quello che colpisce è la velocità appunto del declino italiano. In altri paesi d’Europa il senso dello Stato e il senso della comunità resistono. Da noi dominano egoismo e cinismo orripilanti. A Venezia, all’uscita dal cinema, dopo la propriezione del film di Patrick Chereau, la gente quasi vomitava: se qualcuno ti mette di fronte alla realtà, le reazioni sono il vomito e la fuga». ❖
-
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- una battaglia di verità ... la strategia della menzogna (di Ezio Mauro)2 settembre 2009, di Federico La Sala
La strategia della menzogna
di Ezio Mauro (la Repubblica, 02.09.2o09)
Poiché la sua struttura privata di disinformazione è momentaneamente impegnata ad uccidere mediaticamente il direttore di "Avvenire", colpevole di avergli rivolto qualche critica in pubblico (lanciando così un doppio avvertimento alla Chiesa perché si allinei e ai direttori dei giornali perché righino dritto, tenendosi alla larga da certe questioni e dai guai che possono derivarne) il Presidente del Consiglio si è occupato personalmente ieri di "Repubblica": e lo ha fatto durante il vertice europeo di Danzica per ricordare l’inizio della Seconda guerra mondiale, dimostrando che l’ossessione per il nostro giornale e le sue inchieste lo insegue dovunque vada, anche all’estero, e lo sovrasta persino durante gli impegni internazionali di governo, rivelando un’ansia che sta diventando angoscia.
L’opinione pubblica europea (ben più di quella italiana, che vive immersa nella realtà artefatta di una televisione al guinzaglio, dove si nascondono le notizie) conosce l’ultima mossa del Cavaliere, cioè la decisione di portare in tribunale le dieci domande che "Repubblica" gli rivolge da mesi. Presentata come attacco, e attacco finale, questa mossa è in realtà un tentativo disperato di difesa.
Non potendo rispondere a queste domande, se non con menzogne patenti, il Capo del governo chiede ai giudici di cancellarle, fermando il lavoro d’inchiesta che le ha prodotte. È il primo caso al mondo di un leader che ha paura delle domande, al punto da denunciarle in tribunale.
Poiché l’eco internazionale di questo attacco alla funzione della stampa in democrazia lo ha frastornato, aggiungendo ad una battaglia di verità contro le menzogne del potere una battaglia di libertà, per il diritto dei giornali ad indagare e il diritto dei cittadini a conoscere, ieri il Premier ha provato a cambiare gioco. Lui sarebbe pronto a rispondere anche subito se le domande non fossero «insolenti, offensive e diffamanti» e fossero poste in altro modo e soprattutto da un altro giornale. Perché "Repubblica" è «un super partito politico di un editore svizzero e con un direttore dichiaratamente evasore fiscale».
Anche se bisognerebbe avere rispetto per la disperazione del Primo Ministro, l’insolenza, la falsità e la faccia tosta di quest’uomo meritano una risposta. Partiamo da Carlo De Benedetti, l’editore di "Repubblica": ha la cittadinanza svizzera, chiesta come ha spiegato per riconoscenza ad un Paese che ha ospitato lui e la sua famiglia durante le leggi razziali, ma non ha mai dismesso la cittadinanza italiana, cioè ha entrambi i passaporti, come gli consentono la legge e le convenzioni tra gli Stati. Soprattutto ha sempre mantenuto la residenza fiscale in Italia, dove paga le tasse. A questo punto e in questo quadro, cosa vuol dire "editore svizzero"? È un’allusione oscura? C’è qualcosa che non va? Si è meno editori se oltre a quello italiano si ha anche un passaporto svizzero? O è addirittura un insulto? Il Capo del governo può spiegare meglio, agli italiani, agli elvetici e già che ci siamo anche ai cittadini di Danzica che lo hanno ascoltato ieri?
E veniamo a me. Ho già spiegato pubblicamente, e i giornali lo hanno riportato, che non ho evaso in alcun modo le tasse nell’acquisto della mia casa che i giornali della destra tengono nel mirino: non solo non c’è stata evasione fiscale, ma ho pagato più di quanto la legge mi avrebbe permesso di pagare. Ho versato infatti all’erario tasse in più su 524 milioni di vecchie lire, e questo perché non mi sono avvalso di una norma (l’articolo 52 del D.P.R. 26 aprile 1986 numero 131, sull’imposta di registro) che, ai termini di legge, mi consentiva nel 2000 di realizzare un forte risparmio fiscale.
Capisco che il Premier non conosca le leggi, salvo quelle deformate a sua difesa o a suo privato e personale beneficio. Ma dovrebbe stare più attento nel pretendere che tutti siano come lui: un Capo del governo che ha praticato pubblicamente l’elogio dell’evasione fiscale, e poi si è premurato di darne plasticamente l’esempio più autorevole, con i quasi mille miliardi di lire in fondi neri transitati sul "Group B very discreet della Fininvest", sottratti naturalmente al fisco con danno per chi paga le tasse regolarmente, con i 21 miliardi a Bettino Craxi per l’approvazione della legge Mammì, con i 91 miliardi trasformati in Cct e destinati a non si sa chi, con le risorse utilizzate poi da Cesare Previti per corrompere i giudici di Roma e conquistare fraudolentemente il controllo della Mondadori. Si potrebbe andare avanti, ma da questi primi esempi il quadro emerge chiaro.
Il Presidente del Consiglio ha detto dunque ancora una volta il falso, e come al solito ha infilato altre bugie annunciando che chi lo attacca perde copie (si rassicuri, "Repubblica" guadagna lettori) e ricostruendo a suo comodo l’estate delle minorenni e delle escort, negando infine di essere malato, come ha rivelato a maggio la moglie. Siamo felici per lui se si sente in forze («Superman mi fa ridere»). Ma vorremmo chiedergli in conclusione, almeno per oggi: se è così forte, così sicuro, così robusto politicamente, perché non provare a dire almeno per una volta la verità agli italiani, da uno qualunque dei sei canali televisivi che controlla, se possibile con qualche vera domanda e qualche vero giornalista davanti? Perché far colpire con allusioni sessuali a nove colonne privati cittadini inermi come il direttore di "Avvenire", soltanto perché lo ha criticato? Perché lasciare il dubbio che siano pezzi oscuri di apparati di sicurezza che hanno fabbricato quella velina spacciata falsamente dai suoi giornali per documento paragiudiziario?
Se Dino Boffo salverà la pelle, dopo questo killeraggio, ciò accadrà perché la Chiesa si è sentita offesa dall’attacco contro di lui, e si è mossa da potenza a potenza. Ma la prossima preda, la prossima vittima (un magistrato che indaga, una testimone che parla, un giornalista che scrive, e fa domande) non avendo uno Stato straniero alle spalle, da chi sarà difeso? L’uomo politico passato alla storia come il più feroce nemico della stampa, Richard Nixon, non ha usato per difendersi un decimo dei mezzi che Berlusconi impiega contro i giornali considerati "nemici". Se vogliamo cercare un paragone, dobbiamo piuttosto ricorrere a Vladimir Putin, di cui non a caso il Premier è il più grande amico.
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. ---- L’Egocrate è ossessionato (di Giuseppe D’Avanzo - L’ossessione permanente).11 agosto 2009, di Federico La Sala
L’ossessione permanente
di GiuseppeD’Avanzo (la Repubblica, 11.08.2009)
L’Egocrate è ossessionato. Diventa isterico, quando lo si contraddice con qualche fatterello o addirittura con qualche domanda. Se non parli il suo linguaggio di parole elementari e vaghe senza alcun nesso con la realtà; se non alimenti le favole belle e stupefacenti del suo governo; se non chiudi gli occhi dinanzi ai suoi passi da arlecchino sulla scena internazionale; se non ti tappi la bocca quando lo vedi truccare i numeri, il niente della sua politica e addirittura le sue stesse parole, sei «un delinquente», come ha detto di Repubblica qualche giorno fa.
O la tua informazione è «giornalismo deviato»: lo ha detto di Repubblica, ieri. Che al Prestigiatore d’affari e di governo appaia «deviato» questo nostro giornalismo non deve sorprendere e non ci sorprende. È "naturale", come la pioggia o il vento, che il monopolista della comunicazione giudichi il nostro lavoro collettivo una «deviazione». Lo è in effetti e l’Egocrate non sa darsene pace: ecco la sua ossessione, ecco la sua isteria. Deviazione - bisogna chiedersi, però - da quale traiettoria legittima? Devianza da quale "ordine" conforme alla "legge"? E qual è poi questa "legge" che Berlusconi ritiene violata da un giornalismo che si fa addirittura "delinquenza"? La questione merita qualche parola.
Il potere e il destino di Berlusconi non si giocano nella fattualità delle cose che il suo governo disporrà o ha in animo di realizzare, ma soltanto in un incantato racconto mediatico. Egli vuole poter dire, in un monologo senza interlocutori e interlocuzione e ogni volta che lo ritiene necessario per le sue sorti, che ha salvato il mondo dal Male e l’Italia da ogni male. Esige una narrazione delle sue gesta, capace di creare - attraverso le sinergie tra il "privato" che controlla e il "pubblico" che influenza - immagini, umori, riflessi mentali, abitudini, emozioni, paure, soddisfazioni, odi, entusiasmi, vuoti di memoria, ricordi artefatti. Berlusconi affida il suo successo e il suo potere a questa «macchina fascinatoria» che si alimenta di mitologie, retorica, menzogna, passione, stupidità; che abolisce ogni pensiero critico, ogni intelligenza delle cose; che separa noi stessi dalle nostre stesse vite, dalla stessa consapevolezza che abbiamo delle cose che ci circondano. Mettere in dubbio questa egemonia mediatica che nasconde e, a volte, distrugge la trama stessa della realtà o interrompere, con una domanda, con qualche ricordo il racconto affascinato del mondo meraviglioso che sta creando per noi, lo rende isterico.
È una «deviazione» - per dire - ricordare che non si ha più notizia dei mutui prima casa e della Robin tax o rammentare che dei quattro "piani casa" annunciati, è rimasto soltanto uno, e soltanto sulla carta. È una «deviazione» ripetere che non è vero che «nessuno è stato lasciato indietro», come non è vero che i nostri «ammortizzatori sociali» siano i «migliori del mondo». È "criminale" chiedere conto a Berlusconi della realtà, delle sue menzogne pubbliche, delle sue condotte private che disonorano le istituzioni e la responsabilità che gli è stata affidata. Lo rende ossessivo che ci sia ancora da qualche parte in Italia la convinzione che la realtà esista, che il giornalismo debba spiegare «a che punto stanno le cose» al di là della comunicazione che egli può organizzare, pretendere, imporre protetto da un conflitto di interessi strabiliante nell’Occidente più evoluto.
Nessuna sorpresa, dunque, che l’Egocrate ritenga Repubblica un giornale di «delinquenti» indaffarati a costruire un’informazione «deviata». Più interessante è chiedersi se, ammesso che non l’abbia già fatto, il governo voglia muovere burocrazie sottomesse - queste sì, nel caso, «deviate» - contro questa «deviazione» - e deviazione deve apparirgli anche una testimonianza contro di lui di una prostituta che ha pagato o l’indagine di un pubblico ministero intorno ai suoi comportamenti. È un fatto che Berlusconi esige e ordina che la Rai si pieghi nei segmenti ancora non conformi, come il Tg3, a quel racconto incantato della realtà italiana.
Ancora ieri, Berlusconi - mentendo a gola piena e manipolando le circostanze - ha tenuto a dire che «è inaccettabile che la televisione pubblica, pagata con i soldi di tutti, sia l’unica tv al mondo ad essere sempre contro il governo». Sarà questa la prossima linea di frattura che attende un paese rassegnato, una maggioranza prigioniera dell’Egocrate, un’opposizione arrendevole. Lo si può dire anche in un altro modo: accetteremo di vivere nel mondo immaginario di Berlusconi o difenderemo il nostro diritto a sapere «a che punto siamo»? Se questa è la prossima sfida, i dirigenti i lavoratori della Rai, del servizio radiotelevisivo sapranno mettere da parte ambizione, rampantismo, congreghe e difendere la loro "missione" pubblica, la loro ragione di essere? Per quanto riguarda Repubblica, Berlusconi può mettersi l’anima in pace: faremo ancora un’informazione deviata dall’ordine fantastico, mitologico che vuole imporre al Paese.
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- Il Paese delle leghe e la nazione impossibile (di Ilvo Diamanti)26 luglio 2009, di Federico La Sala
MAPPE
Il Paese delle leghe e la nazione impossibile
di ILVO DIAMANTI *
Esiste l’Italia? E, soprattutto, è una nazione? È una questione vecchia quanto l’Italia. Tornata attuale all’avvicinarsi del 2011, anniversario dei 150 anni dell’Unità d’Italia. Carlo Azeglio Ciampi, non a caso, ha minacciato di lasciare il Comitato per le celebrazioni, "se non cambia nulla". Se, cioè, non viene colmato - o almeno nascosto - il "vuoto di idee" in merito, denunciato da Ernesto Galli della Loggia.
Ciampi, d’altronde, aveva restituito dignità al 2 giugno, festa della Repubblica. Ha valorizzato un’idea dell’Italia come "nazione di città e di regioni". Dove la molteplicità e le differenze sono un elemento di unità. Un distintivo. Il che significava dare cittadinanza anche alla Lega e alle sue rivendicazioni "riformiste".
Anzitutto il federalismo. Nel corso della prima metà degli anni Novanta, d’altronde, la minaccia della secessione del Nord, lanciata dalla Lega, aveva reso esplicita la questione: che succede "se cessiamo di essere una nazione?" (titolo di un noto saggio Gian Enrico Rusconi del 1993). Favorendo, per reazione, un ritorno prepotente dell’identità nazionale (certificata da numerosi sondaggi).
Oltre 15 anni dopo, la questione riappare. Molto meno lacerante, però. E per questo più preoccupante. La nazione. Fondata su un comune nucleo civico. Un’identità condivisa. Non suscita grande passione. Semmai, vi sono segnali che vanno in senso diverso e divergente.
Anzitutto, gli orientamenti dei cittadini in questo senso, si sono raffreddati sensibilmente. All’inizio del 2000 (indagine LaPolis-liMes), l’Italia costituiva uno dei due principali riferimenti dell’appartenenza territoriale per il 42% delle persone. Alla fine del 2008 per il 35%. Oltre 8 punti in meno. Nello stesso periodo, però, si è ridimensionato anche l’attaccamento per le città (dal 41 al 26 %) e le regioni (dal 34 al 23%).
Mentre è cresciuta, soprattutto, l’identificazione nelle macroregioni. In particolare, nel Nord. Era espressa dal 9% dei cittadini nel 2000, oggi dal 14%. Che però sale al 26% fra i cittadini del Nord "padano" (senza l’Emilia Romagna). In altri termini, l’Italia non riesce più a tenere insieme i diversi pezzi di questo paese. Dove, anzi, si riaprono le fratture antiche. Prima fra tutte: fra Nord e Sud.
Negli ultimi 3 anni, infatti, la quota degli italiani che esprime "distacco" nei confronti del Nord o del Sud sale, infatti, dal 20 al 31% (indagini LaPolis-liMes). Segno di un reciproco risentimento, che cresce vistosamente. Oggi il 26% di coloro che risiedono nel Nord "padano" e il 20% di chi abita nelle regione "rosse" (oggi "rosa") dichiara la propria "distanza" dal Mezzogiorno. Viceversa, il 29% dei cittadini del Mezzogiorno si dice lontano dal Nord.
Ancora: oltre un terzo dei cittadini del Nord (più del 40% nel Nord-Est) ma anche delle regioni "rosse" del Centro ritiene che il Mezzogiorno sia "un peso per lo sviluppo del paese".
La divisione fra Nord e Sud, mai risolta, oggi appare una frattura. Resa più drammatica dalla crisi economica e finanziaria, che alimenta il conflitto fra interessi territoriali. Divenuti, a loro volta, argomento di consenso e antagonismo politico. I partiti della prima Repubblica erano anch’essi federazioni di interessi e di comitati territoriali. La DC ma anche il PCI. Tuttavia le differenze e le domande locali erano integrate e mediate all’interno del partito su base nazionale.
Oggi, invece, le forze politiche usano sempre più spesso il riferimento territoriale come un’arma di lotta politica. Nel Nord, ovviamente, la Lega. Ma anche i governatori del PdL. Nel Sud, l’MpA guidato da Raffaele Lombardo, in nome degli interessi della Sicilia ha rotto l’alleanza con il PdL. Mentre Bassolino propone apertamente un nuovo "movimento del Sud". E altri governatori di Centrosinistra, come il presidente della Puglia, Nichi Vendola, polemizzano apertamente con il governo "nordista", guidato dall’asse padano Bossi-Tremonti.
D’altra parte, il risultato del PdL e Berlusconi, a livello nazionale, come si è visto alle recenti elezioni europee, dipende sempre più dalle alleanze "territoriali". Al Nord con la Lega, al Sud con MpA e con altre liste. Mentre il Pd continua ad essere confinato nelle regioni rosse. Quasi una "Lega del Centro", come ebbe a dire anni fa Marc Lazar. E per questo fatica a imporsi.
Da ciò la differenza profonda, rispetto agli anni Novanta. Allora le tensioni territoriali erano agitate dalla Lega nel Nord. Un soggetto politicamente periferico. Oggi, invece, la Lega governa ed è in grande ascesa. Mentre al Sud crescono altre leghe. Così l’Italia rischia di venire lacerata dalle crescenti tensioni fra nordisti e sudisti. Mentre la pluralità delle "patrie locali", su cui puntava Ciampi, non riesce più ad alimentare senso di appartenenza. Le città, le province e le regioni stentano a offrire identità ai cittadini. Oppure lo fanno alimentando le spinte localiste e anticentraliste. Tutti contro tutti. Ciascuno per proprio conto. Le province, dal 1980, quando se ne propose l’abolizione, sono aumentate da circa 90 a 110. Mentre sono centinaia i comuni che vorrebbero a scavalcare i confini regionali. Aggregandosi alle regioni più ricche e favorite dallo stato (perlopiù, le Regioni a statuto speciale).
Per questo, celebrare l’Unità della Nazione oggi è un’impresa difficile, se non impossibile. Perché non ci sentiamo uniti. E neppure una nazione. D’altronde, il carattere specifico degli italiani, secondo gli italiani stessi, è definito anzitutto dall’arte di arrangiarsi e dall’attaccamento alla famiglia. Un popolo di persone ingegnose e familiste. Capaci di inventare e di adattarsi alle difficoltà. Ciascuno per conto proprio. Si ricordano di avere un Casa Comune solo quando si tratta di chiudere le porte. Agli stranieri. Alzando - ovunque - muri per difenderci da loro. Dovremmo, semmai, difenderci da noi stessi. In questo mondo sempre più grande e aperto. L’Europa, sempre più debole. Senza un senso di appartenenza comune. Siamo destinati a perderci. A divenire marginali. Più ancora di oggi.
La Nazione. Forse non c’è. Comunque, l’abbiamo rimossa. Ma la dovremmo (ri)costruire. Per legittima difesa.
* la Repubblica, 26 luglio 2009
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- VACUITA’ DELLA POLITICA (di Barbara Spinelli).31 maggio 2009, di Federico La Sala
Vacuità della politica
di BARBARA SPINELLI (La Stampa, 31/5/2009)
Non è la prima volta che il presidente del Consiglio s’indigna per il trattamento che gli riservano i magistrati che lo processano, o i giornalisti che indagano sulla spregiudicatezza con cui mescola condotte private e pubbliche. S’indigna a tal punto che le due figure - il magistrato, il giornalista - sono equiparate a quella del delinquente: è avvenuto giovedì all’assemblea della Confesercenti. Le tre categorie sono assimilate a loro volta all’opposizione politica. Le accuse che vengono loro rivolte sono essenzialmente due. Primo, l’offesa al popolo sovrano, al consenso che esso ha dato alle urne e che imperturbato rinnova nei sondaggi. Secondo, la natura pretestuosa di tali attacchi antidemocratici: il primato dato alla forma sulla sostanza, ai problemi finti degli italiani su quelli veri, allo show sulla realtà, al gossip sulla politica del leader.
L’accusa va presa sul serio, perché il premier ha costruito il proprio carisma sulla maestria dello show e non ha concorrenti in materia. In particolare sa abbandonarlo, se serve, e presentare l’avversario come vero manipolatore della società dello spettacolo. Come ha scritto Carlo Galli, «il suo vero potere è sul linguaggio e sull’immaginario»: qui è l’egemonia che dagli Anni 80 esercita sul senso comune degli italiani, e che l’opposizione non ha imparato a scalfire (la Repubblica 25 maggio).
Ma qualcosa si va scheggiando, in questo perfetto potere d’influenza, come accade agli apprendisti stregoni che non dominano più interamente i golem fabbricati.
Il gossip, lo show, il privato che fagocita il pubblico, i problemi veri semplificati fino a divenire non-problemi, dunque falsi problemi: questi i golem, e tutti provengono dalle officine del berlusconismo. Sono la stoffa della sua ascesa, gli ingredienti della sua egemonia culturale in Italia. Quel che succede oggi è una nemesi: il problema finto divora quello vero, show e gossip colpiscono chi li ha messi sul trono. All’estero la condanna è dura. Non da oggi, certo: l’Economist lo giudicò «inadatto a governare» il 28 aprile 2001, sono passati anni e Berlusconi resta forte. Ma lo sguardo esterno stavolta s’accanisce, perché finzioni e non-verità si accumulano.
Il fatto è che nel frattempo il mondo è cambiato, attorno a lui. Berlusconi è figlio di un’epoca di vacuità della politica: il mercato la scavalcava impunemente, ignorando ogni regola; l’imprenditore-speculatore sembrava più lungimirante e realista del politico di professione. Il liberalismo dogmatico regnò per decenni, e Berlusconi fu una sua escrescenza. Ma questo mondo giace oggi davanti a noi, squassato dalla crisi divampata nel 2008. La regola e la norma tornano a essere importanti, il realismo dei boss della finanza è screditato, la domanda di politica cresce. È quel che Fini presagisce: senza dirlo si esercita in toni presidenziali, conscio del prestigio miracolosamente sopravvissuto del Colle. La crisi del 2007-2008 è sfociata in America nella sconfitta di Bush, ma quel che Pierluigi Bersani ha detto in una recente conferenza è verosimile: «Il capitalismo non finisce, ma finisce una fase ad impronta liberista della globalizzazione. E non finisce perché c’è Obama, ma c’è Obama perché finisce».
Questo spiega come mai Berlusconi - a seguito della sentenza Mills che lo indica come corruttore di testimoni e della vicenda Noemi in cui appare come boss che esibisce private sregolatezze fino a sfidare il tabù della minorenne - irrita più che mai chi ci guarda da fuori. Un’irritazione che si accentua di fronte ai troppi nascondimenti della verità: nel caso Mills la verità di sentenze che non sono tutte di assoluzione ma anche di prescrizione o assenza di prove; nel caso Noemi la verità di incontri poco chiari. Non dimentichiamolo: quando si incolpano le bolle, finanziarie o politiche, è di menzogne e sortilegi che si parla.
Quel che finisce, attorno a noi, è la negligenza dell’imperio della legge, della rule of law. Non tramonta solo il dogma del mercato onnisciente ma la figura del sovrano-boss, eletto per stare sopra le leggi, i magistrati, le costituzioni, le istituzioni. La fusione tra il suo interesse-piacere privato e il suo agire pubblico diventa un male non più minore ma maggiore, perché nelle democrazie c’è sete di regole e istituzioni, dopo lo sfascio, e non di favole ottimiste ma di realtà e verità. C’è bisogno di gesti fattivi e antiburocratici come la presenza in Abruzzo o a Napoli sui rifiuti, ma c’è anche bisogno di cose che durino più di una legislatura e non siano bolle. È utile osservare l’America, oggi: l’immenso sforzo pedagogico che sta compiendo Obama, per convincere i cittadini che il breve termine è letale, che la Costituzione e le norme devono durare più dei politici.
Deve poter durare il sistema di checks and balances innanzitutto: l’equilibrio tra poteri egualmente forti e indipendenti. Il presidente americano sta riconquistando l’egemonia della parola, con linguaggio semplice e vera passione pedagogica. Il suo discorso su Guantanamo e terrorismo, il 21 maggio, lo conferma: «Nel nostro sistema di pesi e contrappesi, ci deve essere sempre qualcuno che controlli il controllore. \ Tratterò sempre il Congresso e la giustizia come rami del governo di eguale rango». Berlusconi va oggi controcorrente: all’estero non ha altra sponda se non quella di Putin, figura tipica di politico-boss.
Tuttavia la società italiana gli crede ancora, e questo consenso varrà la pena studiarlo, con la stessa umile immedesimazione mostrata da Obama. Varrà la pena studiare perché gli italiani somigliano tanto ai russi, come se anch’essi avessero alle spalle regimi disastrosi. Perché tanta sfiducia verso le regole, lo Stato, la res publica. Non esiste una congenita debolezza morale degli italiani, e dunque occorre capire come mai la politica è così profondamente sprezzata, il conflitto così radicalmente temuto. La tesi esposta più di vent’anni fa dallo studioso Carlo Marletti è tuttora valida: è vero che da noi esiste un «eccesso di pluralismo e complessità che le istituzioni legali non semplificano» adeguatamente. E che al loro posto si sono installate auto-organizzazioni informali, claniche o familiste, che non sono arcaiche ma si sono adattate alla modernità meglio di altre. Marletti spiega come lo sviluppo industriale si sia mescolato alla criminalità organizzata e come si siano creati, in assenza di uno Stato che semplifichi la complessità, meccanismi di semplificazione sostitutivi, solidaristico-clientelari, «di tipo nero o sommerso» (Marletti, Media e politica, Franco Angeli, 1984).
Berlusconi prometteva questa fuga nella semplificazione deviante, meno ingarbugliata che ai tempi della Dc. Secondo il filosofo Václav Belohradsky, essa è basata sul prevalere dei fini personali o corporativi sui mezzi che sono le norme prescritte a chi vuol realizzare tali fini. Tra i due elementi è saltata ogni coerenza ed è il motivo per cui l’Italia vive nell’anomia sociale, come fosse fuori-legge.
In Italia accade questo: le mete del singolo sono tutto, le norme nulla. La legalità vale per gli altri (i clandestini), non per noi, scrive Carlo Galli. Per noi le leggi sono d’impedimento: quelle italiane e anche quelle dell’Unione Europea, come ha ripetuto Berlusconi alla Confesercenti. L’opposizione potrebbe ripartire da qui: dalle norme pericolosamente sprezzate, dall’Europa che il governo finge di poter aggirare senza rischi, dalla sovranità nazionale che esso finge di possedere, a cominciare dal clima. La commistione privato-pubblico ha condotto a tutto questo, non è solo la storia di un padre, di una moglie mortificata, dei loro figli. I più preveggenti dicono: dopo la crisi il mondo non sarà più eguale. Berlusconi promette di conservarlo: anche questo è bolla, ed è spinta rivoluzionaria che si sta esaurendo
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. ---- BIAGIO DE GIOVANNI, CITTADINO DI SINISTRA E FILOSOFO PERSO NELLA FORESTA, CERCA DI RICORDARE DOVE ABITAVA E COSA SIGNIFICAVA "ITALIA"!!!28 marzo 2009, di Federico La Sala
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. ---- Le tappe della vita politica del Cavaliere nel giorno di apertura del congresso Pdl (di Matteo Tonelli).27 marzo 2009, di Federico La Sala
 Dalla ormai celebre calzamaglia della discesa in campo all’annuncio dal "predellino"
Dalla ormai celebre calzamaglia della discesa in campo all’annuncio dal "predellino"
 Le tappe della vita politica del Cavaliere nel giorno di apertura del congresso Pdl
Le tappe della vita politica del Cavaliere nel giorno di apertura del congresso Pdl "Questo è il paese che amo"
"Questo è il paese che amo"
 La storia italiana del Cavaliere
La storia italiana del Cavaliere di MATTEO TONELLI *
di MATTEO TONELLI *ROMA - Dalla discesa in campo alla salita sul predellino. La parabola di Silvio Berlusconi si potrebbe sintetizzare così. Eppure ne sono successe di cose da quel lontano 1994 in cui gli italiani cominciarono a conoscere la faccia del Cavaliere (con annessa libreria posticcia sullo sfondo) fino ad oggi, alla vigilia del battesimo del Pdl. Il contenitore unico del centrodestra che ha inglobato An e si prepara a festeggiare, in pompa magna, la sua nascita. Con tanto di banda musicale.
Quindici anni di cambiamenti, di partiti nati e spariti, di leader inventati e bruciati. Quindici anni la cui comprensione, però, non può prescindere da Silvio Berlusconi. E’ lui l’unica costante immutabile della scena politica. Più di Prodi, che pur l’ha sconfitto due volte. Più di Fini,"il politico di professione" relegato a eterno numero due. Piaccia o non piaccia gli ultimi 15 anni hanno avuto come costante il Cavaliere. Da Forza Italia, alla Casa delle libertà, al Pdl. Al comando sempre un solo uomo: Berlusconi.
E anche oggi, mentre il Pdl sta per nascere, non si può dimenticare che l’atto fondativo della nuova forza politica risiede nel balzo del premier sul predellino di una macchina tra la folla che lo ascoltava in piazza San Babila. Congressi? Ma quando mai. La storia è Forza Italia è un continuo slittare o derubricarli a semplici Consigli Nazionali. Voti? Mozioni? Macché. mai nessuno, in Forza Italia, ha osato mai proporre un documento di critica al Cavaliere. E di un voto non c’è mai stato bisogno: bastava l’acclamazione. Persino le parole sono rimaste le stesse. Quelle del ’94 della scesa in campo, Berlusconi le ha riutilizzate, nel 2008, al termine del consiglio nazionale che sancì la confluenza di Fi nel Pdl. A Berlusconi bastarono dieci minuti e le stesse parole del ’94. Come dire: nulla è cambiato, in primis il Cavaliere.
Ma vale la pena di partire da lontano. Tornare con la memoria agli ultimi mesi del ’93 quando si diffondono le voci del probabile ingresso in politica del Cavaliere. Lui smentisce, ma la cassetta con il famoso discorso del "Paese che amo" è già pronta. Gli italiani si trovano davanti ad un nuovo modo di fare politica. Fatto di sondaggi, sorrisi, spot televisivi usati a piene mani. Il Cavaliere guida uno schieramento che lo vede al nord alleato con Ccd e Lega (Polo delle libertà), al centro-sud con Ccd e An (Polo del buon governo) e vince, travolgendo "la gioiosa macchina da guerra" messa in piedi dall’allora segretario del Pds Achille Occhetto.
Ma dura poco. Arriva il famoso avviso di garanzia durante il vertice di Napoli. Un mese dopo Bossi si impunta sulle pensioni e il governo cade. E’ l’inizio di una "guerra" contro la magistratura che segna il Dna di Forza Italia. Una vera e propria ossessione quella di Berlusconi: "La giustizia va riformata". Al governo va Prodi e il Cavaliere prepara la rivincita. Forza Italia cambia statuto e diventa un partito. Leggerissimo, per la verità. Di plastica, dicono i detrattori. Di sicuro saldamente identificato con il suo leader. Lo stesso di sempre. Che ne diventa presidente del 1998. Ovviamente per acclamazione. "Siamo un partito liberaldemocratico, popolare, cattolico, laico e nazionale" scandisce Berlusconi. Che, un anno più tardi, vede Forza Italia entrare nel Ppe.
E’ il momento del primo cambio di nome. Nel 2000 nasce la Casa delle libertà. In pratica un cartello delle forze che si oppongono "alla sinistra". Si arriva così al voto del 2001. Il Cavaliere firma, in diretta televisiva da Bruno Vespa con tanto di scrivania portata per l’occasione, il "contratto con gli italiani e promette "grandi opere, sviluppo, libertà, meno tasse". Un mix che fa breccia nell’elettorato. Berlusconi torna a palazzo Chigi. Ma non sono rose e fiori con il centrosinistra che rialza la testa alle amministrative del 2005.
Il resto è storia recente. La sofferta vittoria di Prodi del 2006. Il Cavaliere furioso che grida ai brogli e non riconosce la vittoria dell’avversario. Il Professore che, fin dal primo giorno deve fare i conti con una coalizione rissosa e divisa. Ma anche nel centrodestra i rapporti sono tutt’altro che sereni. "Il limite della Casa delle libertà, è quello di essere una coalizione, dove basta il veto di uno solo dei partiti coalizzati per bloccare qualsiasi decisione" dice il Cavaliere sempre più insofferente verso Fini e Casini. Che ricambiano. Sembra che si vada alla rottura quando Berlusconi, il 18 novembre del 2007, rompe gli indugi e sale sul predellino della sua berlina di lusso in piazza San Babila a Milano. Intorno una folla adorante. "E’ l’ora dei partito unico del centrodestra". Fini e Casini, scavalcati, schiumano rabbia. "Siamo alle comiche finali" tuona il leader di An. Ma la caduta del governo Prodi funziona da miracoloso collante (non con l’Udc che se ne va da sola). A marzo 2008 si vota e il centrodestra stravince. Berlusconi risale a palazzo Chigi. Per Forza Italia è l’ora dello scioglimento. Il 21 novembre dello scorso anno il consiglio nazionale vota la confluenza nel Pdl. An la segue il 20 marzo. Si arriva così all’oggi. Con un partito che nasce sul predellino di un’auto, senza che nessuno, al momento dell’annuncio, ne sappia nulla. Se non Berlusconi, ovviamente. Dal 94 ad oggi, unico vero dominus del centrodestra. Comunque si voglia chiamarlo.
* la Repubblica, 27 marzo 2009
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. L’Italia come volontà e come rappresentazione di un solo Partito: "Forza Italia"!!! ---- Cambiare la Costituzione? Così è pirateria istituzionale (Franco Cordero).12 dicembre 2008, di Federico La Sala
Intervista
Franco Cordero «Cambiare la Costituzione? Così è pirateria istituzionale. Vuole pm sottomessi»
di Federica Fantozzi (l’Unità, 12 dicembre 2008)
Giurista, autore di pamphlet polemici e docente di procedura penale, Franco Cordero commenta con disincanto l’intenzione del premier di modificare la Costituzione da solo, salvo referendum confermativo: «Sul piano tecnico c’è poco da dire: rispettando l’articolo 138 la maggioranza può fare ciò che vuole. Ma è pirateria politica. Un gesto di eversione mascherato legalisticamente osservando i requisiti costituzionali».
Un atto fuori dalla normalità istituzionale?
«Prima che emergesse Berlusconi non era concepibile che la Carta fosse modificata o solo emendata senza il consenso di tutte le parti. Ma siamo nel campo dell’onestà, della moralità, della fisiologia politica».
Per i costituzionalisti è una scelta legittima però inopportuna.
«Un gesto simile sarebbe autentica soperchieria. Equivale a dire: ho i numeri grazie ai quali faccio quello che voglio. Nessun giurista con la testa sul collo e sufficiente cultura può dire che una riforma così nasce invalida. Nasce vergognosamente combinata».
Fini, alleato di Berlusconi, ha evocato il cesarismo.
«È una formula debole rispetto a ciò che il premier ha in mente. Cesare e Ottaviano non agivano così. Ottaviano era rispettoso dell’autorità del Senato, non si arrogava poteri abnormi. Gli veniva riconosciuta auctoritas: prestigio politico, autorità morale, carisma. Ben lontano dalla fenomenologia che abbiamo sotto gli occhi».
Berlusconi non vuole ostacoli alla sua riforma della giustizia. La separazione delle carriere è utile o dannosa?
«È una formula eufemistica sotto cui vuole costruire il pm come ufficio investigativo che riferisce al Guardasigilli. Quindi le procure lunga mano del governo. È chiaro che salta il concetto di obbligatorietà dell’azione penale».
È un obiettivo realizzabile?
«Se anche si togliesse di mezzo questo aspetto, e l’articolo 112 fosse amputato, non si avrebbe un pm manovrato dall’esecutivo. La Carta non è fatta di norme disarticolate come atomi separati. È un sistema con nessi interni. Dunque la questione si invelenirebbe».
Fino a che punto?
«Nel delirio di onnipotenza Berlusconi punterebbe a una revisione radicale per fondare la signoria che di fatto già esercita. Il presidente eletto, investito di consenso carismatico che rende irrilevante il conflitto di interessi perché il popolo sovrano lo ha assolto. Discorsi da ignorante di logica costituzionale moderna».
Quali sono i pericoli?
«Quest’ottica implica una regressione di 7 secoli, al regime di signoria selvaggia. Un terrificante passo indietro fatto in una logica stralunata».
Sono proclami o si arriverà davvero a questo scenario?
«Politicamente il referendum è un grosso rischio. Se fallisse Berlusconi ne uscirebbe colto in flagrante debolezza. Credo che cercherà di acquisire, con metodi in cui lo sappiamo esercitatissimo, i consensi parlamentari che gli servono. Ma resta lontano dalla maggioranza dei due terzi che gli serve».
In questa legislatura il Parlamento non lavora a vantaggio del consiglio dei ministri. Un’altra anomalia?
«Decide lui con i suoi. Ha un concetto piratesco pure dei decreti legge. È una forma condizionata a presupposti di necessità e urgenza: in più casi il governo ne ha fatto un uso visibilmente abusivo».
Berlusconi usa la questione morale contro il centrosinistra. Ha qualche fondamento?
«Le regole morali valgono per tutti e l’affare Unipol non è stato edificante. Ma la sua logica è: tra noi e voi non esiste differenza antropologica, siamo tutti uguali in un paese dove i giudici non applicano equamente le leggi e i cittadini non hanno la moralità nel sangue, quindi non seccatemi. Ovviamente non è così».
Cosa dovrebbe fare l’opposizione ora che il dialogo è defunto?
«L’alternativa di una collusione non sarebbe stata molto più virtuosa. Se i contenuti della riforma restano lontani dall’ortodossia costituzionale, meglio che il premier vada da solo piuttosto che condividere un gesto soperchiatorio».
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. ---- E’ Giacomo Marramao per il saggio "La passione del presente" il vincitore del Premio di Filosofia "Viaggio a Siracusa", la cui giuria è presieduta da Remo Bodei e Umberto Curi. Il riconoscimento alla carriera va a Maurizio Ferraris.21 novembre 2008, di Maria Paola Falqui
Il premio filosofico
"Viaggio a Siracusa" per Marramao *
SIRACUSA - E’ Giacomo Marramao per il saggio La passione del presente il vincitore del Premio di Filosofia "Viaggio a Siracusa", la cui giuria è presieduta da Remo Bodei e Umberto Curi. Il riconoscimento alla carriera va a Maurizio Ferraris, mentre quello per la "tesi di laurea" ad Anna Molinari (Università di Bologna). La consegna si svolgerà durante il convegno "Italia, Europa, mondo: tra paura e speranza", oggi e domani al Palazzo del Senato.
* la Repubblica, 21.11.2008
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. ---- Docenti stranieri per salvare l’Università (di Piergiorgio Odifreddi).18 novembre 2008, di Federico La Sala
Docenti stranieri per salvare l’Università
L’unica vera soluzione sarebbe azzerare tutte le gerarchie accademiche. Ma può farlo solo un dittatore Le proteste contro le decurtazioni indiscriminate non ci inducano a difendere lo status quo Un professore che ha spesso insegnato all’estero affronta i problemi dei nostri atenei falcidiati dai tagli del governo
di Piergiorgio Odifreddi (la Repubblica 18.11.2008)
I recenti provvedimenti, in verità parecchio sprovveduti, presi dal governo sulla scuola e sull’università hanno avuto almeno un effetto positivo: quello di stimolare all’autocoscienza studenti e professori, e di attirare l’attenzione della popolazione sulle disastrose condizioni in cui versa l’istruzione nel nostro paese, dalle elementari ai dottorati di ricerca. La protesta contro i tagli indiscriminati ai fondi e al personale, a cui si riducono tutti i provvedimenti citati, non può però essere intesa come una difesa dello status quo e dell’organizzazione del nostro sistema scolastico e universitario, i cui molti anacronismi non trovano l’uguale in Europa e nel mondo.
Per evitare di fare un discorso accademico (un termine che, significativamente, potrebbe essere inteso sia come «universitario» che come «ozioso»), mi sia permesso di riferirmi direttamente alle mie esperienze di studio e di insegnamento all’estero: dopo essere entrato all’Università di Torino nel 1973, dapprima come borsista, e poi via via come contrattista, assistente, associato e ordinario, mi sono infatti parallelamente perfezionato alle Università dell’Illinois e della California negli Stati Uniti (1978-80) e di Novosibirsk nell’Unione Sovietica (1982-1983), e in seguito sono stato un regolare professore a contratto a Cornell (1985-2003), oltre che uno sporadico visitatore di università australiane e cinesi, nelle quali ho trascorso rispettivamente un semestre (1989) e tre (1992, 1995, 1998).
In queste lunghe visite, ho naturalmente avuto occasione di sperimentare l’organizzazione degli studi in paesi sia capitalisti che comunisti, e di scambiare informazioni e opinioni coi colleghi stranieri, sollevando dovunque la sorpresa e l’incredulità per i nostri meccanismi didattici e concorsuali. Primo fra tutti il nostro assurdo sistema di esami, che non solo è tuttora in vigore, ma viene considerato dagli studenti come un diritto acquisito, invece che il residuo fossile di un bizantinismo degno forse di altri tempi, ma sicuramente indegno del nostro. Dovunque abbia insegnato, invece, mi venivano comunicati con mesi di anticipo e in maniera tassativa non solo le date di inizio e di fine dei corsi, e l’orario delle lezioni, ma anche le date degli esami.
Anzi, la data dell’esame, perché esso avveniva inderogabilmente per scritto e in un unico giorno, con una prova uguale per tutti, a distanza più o meno di una settimana dalla fine del semestre: altro che la nostra operetta di prove orali e appelli multipli, che in molti casi arrivano fino a otto all’anno, e permettono agli studenti di ripresentarsi indefinitamente a sostenere lo stesso esame, a distanza magari di anni da quando è stato tenuto il corso! Perché ci stupiamo che metà degli studenti universitari siano fuori corso, quando siamo noi stessi a spingerli a non tenere nessun ritmo e a permettere loro di non dare gli esami nell’unico momento in cui ha senso darli?
Per quanto posso testimoniare io, non solo negli Stati Uniti, ma anche in Russia, Cina e Australia, e dunque indipendentemente dal sistema economico del paese, chi non passa l’esame al momento giusto deve ripetere il corso l’anno dopo, con tutti i costi (letterali e metaforici) che questo gli comporta. E chi si inalberasse a sentire la parola «costi», dovrebbe meditare su quelli comunque esatti dal nostro sistema: invece di un giorno di esami e uno di correzioni degli scritti, da noi ogni orale richiede infatti una media di mezz’ora per studente, e dunque spesso centinaia di ore per corso, che vanno moltiplicate per il fattore di ripetizione studentesca dell’esame e per il numero dei commissari delle commissioni. Un enorme dispendio di risorse, che potrebbero essere meglio utilizzate altrimenti.
Con un sistema del genere, che richiedesse di tornare una mezza dozzina di volte l’anno per gli appelli, io non avrei mai potuto insegnare all’estero, né avrei potuto dedicare il mio tempo alle uniche attività che un professore dovrebbe svolgere, e cioè l’insegnamento e la ricerca. A proposito delle quali, va notato che in Italia la progressione di carriera è determinata (almeno ufficialmente, a parte le distorsioni sulle quali torneremo) dalla sola ricerca, mentre gli obblighi universitari riguardano il solo insegnamento: una schizofrenia singolare, che non tiene in nessun conto il fatto che un bravo ricercatore può essere un pessimo insegnante, e viceversa.
In Unione Sovietica si evitava questa schizofrenia permettendo ai professori di ripartire il proprio impegno tra la ricerca presso l’Accademia delle Scienze e l’insegnamento presso l’Università, in proporzioni variabili, che potevano arrivare fino al cento per cento dell’una o dell’altro. Negli Stati Uniti il sistema è più complesso, ma le università in genere pagano lo stipendio soltanto per i nove mesi dell’insegnamento: i rimanenti tre mesi devono essere finanziati dalla National Science Foundation (fatte le dovute proporzioni, un analogo del nostro Consiglio Nazionale delle Ricerche) e da accordi con industrie o centri di ricerca privati.
A proposito di stipendi, una differenza sostanziale è che negli Stati Uniti essi non sono rigidamente legati a un’automatica «progressione di carriera», e vengono invece contrattati individualmente con la propria Facoltà, sulla base di parametri che tengono conto del livello e dell’impegno del docente: in particolare, le valutazioni provengono non soltanto dai colleghi locali e nazionali, ma anche dagli studenti, che alla fine di ogni corso compilano anonimamente dettagliati questionari sulla qualità generale e specifica dell’insegnamento. Una bella forma di tutela, questa, che elimina alla radice la piaga di quei professori terroristi che bocciano sistematicamente la maggioranza degli studenti, senza rendersi conto del fatto che questo la dice più lunga sul livello del loro insegnamento che su quello dell’altrui apprendimento.
Quanto al reclutamento dei professori, e sebbene questo possa sembrare inconcepibile da noi, negli Stati Uniti esso viene deciso dalle università in totale autonomia, anche se ovviamente sulla base della distribuzione di potere inter - e intradipartimentale. I candidati sono invitati a presentare un paio di «lettere di raccomandazione», e possono decidere se riservarsi o no il diritto di visionarle: naturalmente, facendolo si condannano a un giudizio asettico e tutto sommato inutile, mentre non facendolo si assoggettano all’espressione di un giudizio spassionato e spesso determinante, in ogni caso supplementato dai pareri di esperti interpellati direttamente dall’università.
Il processo mira ovviamente a selezionare il migliore, anche perché l’istituzione ha tutto l’interesse a farlo. Il valore di mercato delle lauree e dei dottorati dipende infatti dal livello delle università in cui sono conseguiti, e questo livello è certificato da apposite graduatorie nazionali, ottenute attraverso sondaggi in cui i professori di ciascuna università valutano il livello delle altre, senza poter valutare la propria. Non avendo invece nessun incentivo a selezionare i migliori, le nostre università finiscono spesso di accontentarsi dei peggiori, cooptati in base ai «criteri» clientelistici, nepotistici e favoritistici che tutti conosciamo.
Per continuare con le testimonianze personali, io stesso ho dovuto vincere la cattedra due volte, perché la prima che vinsi fu dirottata a un ricercatore che nel frattempo non era riuscito a diventare associato per mancanza di titoli! Di casi simili ogni professore ne può citare a volontà, ma le mele marce che nel frattempo sono entrate a valanghe in università, ci sono rimaste e hanno proseguito la loro carriera: quel ricercatore, ad esempio, è poi diventato preside di facoltà da qualche parte, e altri saranno arrivati anche più in alto. Fanno dunque tenerezza, per non dir altro, i tentativi del ministro di introdurre meccanismi di sorteggio dei commissari nei concorsi a cattedre: a parte il fatto che queste pensate erano già state adottate nel passato, senza alcun effetto visibile, non si può ovviamente impedire che la mala sorte selezioni proprio le mele marce, né è da esse che ci si può sensatamente attendere un rinnovamento.
L’unica vera soluzione sarebbe un immediato azzeramento di tutte le gerarchie universitarie, ma poiché nemmeno un dittatore potrebbe imporre una misura così radicale, bisogna aspettare che lo facciano gradualmente l’età e la pensione. Nell’attesa possiamo pure sorteggiare i commissari per i futuri concorsi: ma che siano stranieri, che possano portare gradualmente il nostro povero Bel Paese ai criteri e agli standard adottati nel mondo intero, dagli Stati Uniti alla Russia alla Cina all’Australia.
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- IL FILOSOFO ITALIANO, IL CAVALIERE MAGNO, E... DIOGENE DI SINOPE.23 settembre 2008, di Maria Paola Falqui
 IL FILOSOFO ITALIANO, IL CAVALIERE MAGNO, E...
IL FILOSOFO ITALIANO, IL CAVALIERE MAGNO, E...-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- se non si riesce più a trovare, o almeno a cercare il bandolo di un significato, di un destino, di un rapporto di emulazione e sfida tra adulti e ragazzi, allora hanno ragione i vecchi reazionari quando dicono "ci vorrebbe una bella guerra ogni tanto" (di Michele Serra, Una scuola a pezzi).25 settembre 2008, di Federico La Sala
 Una scuola a pezzi
Una scuola a pezzi
 Quei ragazzi che non hanno futuro
Quei ragazzi che non hanno futuroUn mondo in cui ciascuno ha rinunciato a offrire e a prendere alcunché Studenti somari e razzisti. Professori presi da incombenze burocratiche
di Michele Serra (la Repubblica 25.09.2008)
Se il discorso sulla scuola ha assunto, in Italia, toni aspri e quasi vocianti, è perché parlando di scuola si parla dei giovani e dunque si evoca il futuro, che è il più disturbante dei concetti in tempi di declino sociale come questo. E poi perché la parola scuola chiama in causa un "pacchetto di crisi" fin troppo denso: la crisi dell’autorità, quella della cultura come cardine della persona, quella degli adulti incerti depositari di ancora più incerte "regole". In Francia ha avuto grande successo il romanzo di un giovane insegnante, François Bégaudeau, che ha ispirato il film vincitore della Palma d’oro a Cannes. Il titolo originale del libro era Entre les murs, dentro i muri, perfettamente indicativo dell’atmosfera claustrofobica che lo pervade. Il titolo italiano, meno severo, è La classe (Einaudi Stile libero, pagg. 228, euro 16), e sembra quasi voler riportare questo desolato best-seller in una letteratura "di genere", sulla scia fortunata del primo Starnone e dell’ultimo Pennac. Con eventuale ammicco a un sottogenere pop, quello del computo allegro degli svarioni studenteschi, tipo Io speriamo che me la cavo o il vecchio classico per ragazzi francese La fiera delle castronerie. Ma attenzione: i circa vent’anni che separano la generazione di Starnone e Pennac (diciamo, per comodità, quella "sessantottina") da quella di Bégaudau sono un vero e proprio baratro.
La scuola raccontata da Starnone e Pennac è ancora un lascito, seppure residuo, dell’umanesimo. L’ironia amara, lo sguardo smagato su ragazzi e adulti lascia ancora intatta l’illusione di un passaggio di consegne, di un apprendistato, più ancora che alla cultura, alla civiltà e forse alla vita. Leggendo Bégaudeau, la sua stagnante, ossessionata trascrizione di un dialogo impossibile, ci si ritrova piuttosto immersi in una post-scuola, una scuola svuotata di sé nella quale ciascuno ha rinunciato a offrire o prendere alcunché, e insegnanti frustrati oppure inaciditi, e alunni maneschi e rincoglioniti dal consumismo, trascorrono un intero anno rimanendo fermi al punto di partenza, senza procedere di un passo verso quel percorso scolastico che, burocrazia a parte, è pur sempre la ragione di un anno di lavoro e di vita. Un anno: per un adolescente un’enormità, un tempo immenso di crescita e di occasioni, che nella scuola di Bégaudeau diventa però un tempo puntiforme, una spirale viziosa che lascia ciascuna delle due parti, ragazzi e professori, nella propria inerte impotenza.
La staticità del libro è prima di tutto stilistica. La povertà verbale è il frutto evidente di un accurato lavoro letterario, imitativo della supposta povertà della realtà scolastica e soprattutto del linguaggio dei liceali. Il battito delle frasi è quello di un rap, concetti mozzi e ripetuti, sguardi veloci sui marchi delle felpe come principale identità degli studenti, niente che sembri portare a qualcosa o allontanarsi da qualcos’altro. Il tutto contrappuntato dalle conversazioni vaghe e strascicate della sala professori, perse tra qualche incombenza burocratica e rivendicazioni "sindacali" striminzite sull’efficienza della macchinetta del caffè. Oppure ? in un rigurgito di "autorità" che è anche il massimo exploit dell’impotenza ? dalle delibere di espulsione che, a raffica, colpiscono gli studenti più insopportabili. Il genere della Classe, dunque, non è tanto il "romanzo scolastico", quanto il no-future. La mancanza di movimento. La perdita di direzione. La sensazione di ultima spiaggia.
Appesantita, per giunta, dall’onnipresenza (anche lei ossessiva) di una multiculturalità descritta come un ingovernabile equivoco, un ginepraio di pregiudizi e diffidenze che l’io narrante, il giovane prof Bégaudeau, affronta con una stizza inconsolabile (forse la stizza dei "politicamente corretti" sconfitti dall’evidenza), masticando come un fiele il nodo di una diversità babelica, inconciliabile, sorda ai richiami della tolleranza e della comprensione. Tanto che la pagina più potente e liberatoria del romanzo è un secco sfogo nel quale il professore dà del pezzo di merda, in massa, all’intero corpo studentesco, affogando dentro la sua rabbia anche le deboli tracce di umanità che è riuscito a scorgere nei singoli studenti, infine rinnegati anche dal docente, perfino dal docente, che li caccia volentieri nel girone infernale della Massa Amorfa, più interessata alle felpe e ai telefonini che alla propria decenza mentale.
Insomma: un libro terribilmente doloroso, di accurato pessimismo, con la patina di "divertente", evocata in copertina nell’edizione italiana, che si lacera dopo poche pagine. Resta da riflettere sul grande successo, in Francia, di un romanzo così implacabile, che non lascia spiragli, non concede alibi né agli adulti né ai ragazzi, i primi visti come neghittosi sorveglianti del nulla, i secondi come insorvegliabili somari, razzisti, ottusi, consumisti bulimici, potenziali violenti che stazionano "dentro i muri" come cavie in una gabbia, e senza neanche la discutibile soddisfazione di essere cavie di un esperimento. Perché un esperimento non c’è.
Se questa è davvero la scuola, in Francia e qui da noi, ovunque nell’Occidente spento di energie e debole di identità, viene da dire che hanno ragione i restauratori politici che, a furor di popolo, vogliono tornare ai vecchi metodi: al posto del ministro Gelmini, sorvolerei sulla natura letteraria del lavoro di Bégaudeau e inserirei il suo romanzo in ogni dossier ministeriale che voglia liquidare tutte le esperienze pedagogiche dell’ultimo mezzo secolo e riportare Legge e Ordine tra i banchi.
A me, piuttosto, è venuta voglia, come antidoto, di rileggere Starnone e Pennac, oppure gli interventi di Marco Lodoli su questo giornale, nei quali la percezione del disastro sociale e scolastico non è certo attenuata, ma lo sguardo di chi lo osserva è ? non so come dirlo altrimenti ? umanamente partecipe. Dev’essere una questione di generazione, Régaudeau e il suo rap disperato sono probabilmente più sintonici con i tempi, e magari i ragazzi di oggi possono davvero leggere "divertendosi" un libro che li raffigura come ectoplasmi nevrastenici, come nullità ringhiose, e però lo fa con il ritmo giusto, riconoscibile, se posso dire: alla moda.
Ma se non si riesce più a trovare, o almeno a cercare il bandolo di un significato, di un destino, di un rapporto di emulazione e sfida tra adulti e ragazzi, allora hanno ragione i vecchi reazionari quando dicono "ci vorrebbe una bella guerra ogni tanto", a raddrizzare la gioventù, a selezionarla meglio di un sette in condotta o di una bocciatura. Ecco, "La classe" è un libro post-scolastico e pre-bellico: arrivato in fondo al viaggio, anzi al non-viaggio, un lettore disposto al paradosso pensa che l’anno prossimo quelle truppe di giovani felpate e smidollate, per ritrovare nerbo e disciplina, e magari dotarsi di un concetto di Patria che rimedi alle vaghezze del multiculturalismo, non dovrebbero più rientrare a scuola, ma in caserma. Dev’essere per questo che giovani ministri (poco più anziani di Bégaudeau) tendono a confondere scuola e caserma.
-
IL FILOSOFO ITALIANO, IL CAVALIERE MAGNO, E... IL CINISMO. L’arte di vivere senza verità. Un testo di Michel Foucault sulla tradizione dell’Occidente.1 luglio 2009, di Federico La Sala
 Un testo di Michel Foucault sulla tradizione dell’Occidente
Un testo di Michel Foucault sulla tradizione dell’Occidente L’arte di vivere senza verità
L’arte di vivere senza verità
 Perché oggi ha vinto il cinismo
Perché oggi ha vinto il cinismo Con Manet, Bacon Baudelaire, Beckett ciò che sta in basso irrompe nelle forme artistiche elevate
Con Manet, Bacon Baudelaire, Beckett ciò che sta in basso irrompe nelle forme artistiche elevate
 La dottrina cinica nel mondo antico era popolare, oggi è un atteggiamento elitario e marginale
La dottrina cinica nel mondo antico era popolare, oggi è un atteggiamento elitario e marginale di MICHEL FOUCAULT (la Repubblica, 01.07.2009)
di MICHEL FOUCAULT (la Repubblica, 01.07.2009)C’è una ragione che ha portato l’arte moderna a farsi veicolo del cinismo: parlo dell’idea che l’arte stessa, che si tratti di letteratura, di pittura o di musica, deve stabilire con il reale un rapporto che vada al di là del semplice abbellimento, dell’imitazione, per diventare messa a nudo, smascheramento, raschiatura, scavo, riduzione violenta dell’esistenza ai suoi elementi primari. Non c’è dubbio che questa visione dell’arte si sia andata affermando in modo sempre più marcato a partire dalla metà del XIX secolo, quando l’arte (con Baudelaire, Flaubert, Manet) si costituisce come luogo di irruzione di ciò che sta in basso, al di sotto, di tutto ciò che in una cultura non ha il diritto o quanto meno non ha la possibilità di esprimersi. A tale riguardo, si può parlare di un antiplatonismo dell’arte moderna. Se avete visto la mostra su Manet, quest’inverno, capirete quello che voglio dire: l’antiplatonismo, incarnato in maniera scandalosa da Manet, rappresenta a mio avviso una delle tendenze di fondo dell’arte moderna, da Manet fino a Francis Bacon, da Baudelaire fino a Samuel Beckett o a Burroughs, anche se non si identifica attualmente come elemento caratterizzante di tutta l’arte possibile.
Antiplatonismo: l’arte come luogo di irruzione dell’elementare, come messa a nudo dell’esistenza. Di conseguenza, l’arte ha stabilito con la cultura, le norme sociali, i valori e i canoni estetici, un rapporto polemico, di riduzione, di rifiuto e di aggressione. È questo l’elemento che fa dell’arte moderna, a partire dal XIX secolo, quel movimento incessante attraverso il quale ogni regola stabilita, dedotta, indotta, inferita sulla base di ciascuno dei suoi atti precedenti, è stata respinta e rifiutata dall’atto successivo. In ogni forma d’arte si può trovare una sorta di cinismo permanente nei riguardi di ogni forma d’arte acquisita: è quello che potremmo chiamare l’antiaristotelismo dell’arte moderna.
L’arte moderna, antiplatonica e antiaristotelica: messa a nudo, riduzione all’elementare del l’esistenza; rifiuto, negazione perpetua di ogni forma già acquisita. Questi due aspetti conferiscono all’arte moderna una funzione che in sostanza si potrebbe definire anticulturale. Bisogna opporre al conformismo della cultura il coraggio dell’arte, nella sua barbara verità. L’arte moderna è il cinismo nella cultura, il cinismo della cultura che si rivolta contro se stessa. Ed è soprattutto nell’arte, anche se non solo in essa, che si concentrano nel mondo moderno, nel nostro mondo, le forme più intense di quella volontà di dire la verità che non ha paura di ferire i suoi interlocutori. Restano naturalmente molti aspetti ancora da approfondire, e in particolare quello della genesi stessa della questione dell’arte come cinismo nella cultura.
Si possono vedere i primi segnali di questo processo, destinato a manifestarsi in modo clamoroso nel XIX e nel XX secolo, ne Il nipote di Rameau e nello scandalo suscitato da Baudelaire, Manet, (Flaubert?). Ci sono poi i rapporti tra cinismo dell’arte e vita rivoluzionaria: affinità, fascinazione reciproca (perpetuo tentativo di legare il coraggio rivoluzionario di dire la verità alla violenza dell’arte come irruzione selvaggia del vero); ma anche il loro non essere sostanzialmente sovrapponibili, dovuto forse al fatto che, se questa funzione cinica è al cuore dell’arte moderna, il suo ruolo nel movimento rivoluzionario è solo marginale, almeno da quando quest’ultimo è dominato da forme di organizzazione, da quando i movimenti rivoluzionari si organizzano in partiti e i partiti definiscono la "vera vita" come totale conformità alle norme, conformità sociale e culturale. È evidente che il cinismo, lungi dal costituire un legame, è un motivo di incompatibilità tra l’ethos dell’arte moderna e quello della pratica politica, sia pure rivoluzionaria.
Si potrebbe formulare lo stesso problema in termini diversi: perché il cinismo, che nel mondo antico aveva assunto le dimensioni di un movimento popolare, è diventato nel XIX e nel XX secolo un atteggiamento elitario e marginale, anche se importante per la nostra storia, e il termine cinismo viene utilizzato quasi sempre in riferimento a valori negativi? Si potrebbe aggiungere che il cinismo ha molti punti di contatto con un ’altra scuola greca di pensiero: lo scetticismo - anche in questo caso, uno stile di vita, più che una dottrina, un modo di essere, di fare, di dire, una disposizione a essere, a fare e a dire, un’attitudine a mettere alla prova, a esaminare, a mettere in dubbio.
Ma con una grandissima differenza: mentre lo scetticismo applica sistematicamente al campo scientifico questa attitudine, trascurando quasi sempre l’esame degli aspetti pratici, il cinismo appare incentrato su un atteggiamento pratico, che si articola in una mancanza di curiosità o in un’indifferenza teorica, e nell’accettazione di alcuni princìpi fondamentali. Ciò non toglie che, nel XIX secolo, la combinazione tra cinismo e scetticismo sia stata all’origine del "nichilismo", inteso come modo di vivere basato su un preciso atteggiamento nei confronti della verità. Dovremmo smetterla di considerare il nichilismo sotto un unico aspetto, come destino ineluttabile della metafisica occidentale, a cui si potrebbe sfuggire solo facendo ritorno a ciò il cui oblio ha reso possibile questa stessa metafisica; o come una vertigine di decadenza tipica di un mondo occidentale divenuto ormai incapace di credere ai suoi stessi valori.
Il nichilismo deve essere considerato in primo luogo una figura storica particolare appartenente al XIX e al XX secolo, ma deve anche essere inscritto nella lunga storia che l’ha preceduto e preparato, quella dello scetticismo e del cinismo. In altre parole, deve essere visto come un episodio o, meglio, come una forma, storicamente ben definita, di un problema che la cultura occidentale ha cominciato a porsi già da molto tempo: quello del rapporto tra volontà di verità e stile di esistenza.
Il cinismo e lo scetticismo sono stati due modi di porre il problema dell’etica della verità. La loro fusione nel nichilismo mette in luce una questione essenziale per la cultura occidentale, che può essere formulata in questo modo: quando la verità è rimessa continuamente in discussione dallo stesso amore per la verità, qual è la forma di esistenza che meglio si accorda con questo continuo interrogarsi? Qual è la vita necessaria quando la verità non lo è più? Il vero principio del nichilismo non è: Dio non esiste, tutto è permesso. La sua formula è piuttosto una domanda: se devo confrontarmi con il pensiero che "niente è vero", come devo vivere? La difficoltà di definire il legame tra l’amore della verità e l’estetica dell’esistenza è al centro della cultura occidentale. Ma non mi preme tanto definire la storia della dottrina cinica, quanto quella dell’arte di esistere. In un Occidente che ha inventato tante verità diverse e che ha plasmato tante differenti arti di esistere, il cinismo serve a ricordarci che ben poca verità è indispensabile per chi voglia vivere veramente, e che ben poca vita è necessaria quando si tenga veramente alla verità.
Traduzione di Stefano Salpietro
-
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. L’Italia come volontà e come rappresentazione di un solo Partito: "Forza Italia"!!! --- Il gradimento per il presidente del Consiglio al 60%, 5 punti in più che a luglio.16 settembre 2008, di Maria Paola Falqui
 Sondaggio Ipr: "Sicurezza, prostituzione e scuola accrescono la popolarità"
Sondaggio Ipr: "Sicurezza, prostituzione e scuola accrescono la popolarità"
 Il gradimento per il presidente del Consiglio al 60%, 5 punti in più che a luglio
Il gradimento per il presidente del Consiglio al 60%, 5 punti in più che a luglio L’estate porta consenso al governo
L’estate porta consenso al governo
 in aumento la fiducia in Berlusconi
in aumento la fiducia in BerlusconiIn caduta libera il centrosinistra: Pd (-4%) e Idv (-3%). Stabile l’Udc
di MARCO GRASSO *
ROMA - Decreto antiprostituzione, giro di vite sulla sicurezza e riforma scolastica: sono questi i temi che spingono in alto la popolarità della maggioranza. Gli italiani hanno più fiducia nel governo, ma soprattutto nel presidente del Consiglio. Ad affermarlo è un sondaggio di Ipr Marketing per Repubblica.it. Due mesi senza attività parlamentare non scalfiscono il consenso di cui gode l’esecutivo, che aumenta del 2%. E segnano un aumento del gradimento per la figura di Silvio Berlusconi, che registra un incremento di cinque punti percentuali e tocca quota 60%. Sempre secondo l’istituto guidato da Antonio Noto, nello stesso periodo è calata la fiducia nei confronti del Partito Democratico e dell’Italia dei Valori, mentre rimane stabile l’Udc.
Maroni il più popolare. L’unico membro del governo a tenere il passo del premier è il titolare del Viminale Roberto Maroni, il più apprezzato tra i ministri. La sua popolarità è al 62%, due punti in più rispetto a sessanta giorni fa. Podio per Frattini e Tremonti, che nonostante una lieve flessione, sono al secondo e terzo posto con il 60 e il 58%. Chi ha registrato l’aumento più significativo è Mara Carfagna, il cui consenso passa dal 38 al 42%, forse in seguito alle nuovi leggi sulla prostituzione. In positivo anche il ministro dell’Istruzione Mariastella Gelmini, il cui apprezzamento è salito dal 35 al 38%. Perde e più di tutti il titolare del Welfare Maurizio Sacconi (-6%), forse per via della trattativa Alitalia.
Aumenta il consenso per Berlusconi. "Le maggiori oscillazioni - fa notare l’istituto di ricerca - Sono quelle che riguardano ministeri al centro del dibattito mediatico durante l’estate: Maroni per la sicurezza, Sacconi per l’Alitalia, Carfagna per la Legge sulla prostituzione e Gelmini per le riforme scolastiche". Ma se la popolarità del governo nel complesso ha conquistato due punti percentuali, il presidente del Consiglio aumenta il divario che lo separa dal suo esecutivo. Se a luglio il saldo era di +3 a favore del Presidente del Consiglio, a settembre risulta a +6.
Diminuisce la fiducia nel centrosinistra. Non naviga in buone acque l’opposizione. La perdita più pesante è quella del Pd, che dal 34% scende al 30%. Cala anche l’Idv, che dopo una crescita di due punti da giugno a luglio, nei due mesi successivi cala del 3%, dal 47 al 44%, un livello comunque alto. Rimane stabile invece l’Udc al 20%.
* la Repubblica, 16 settembre 2008.
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- "Io antifascista? Penso solo a lavorare, per risolvere i problemi degli italiani". Silvio Berlusconi risponde così, senza sbilanciarsi, ai giornalisti che gli chiedono se si dichiarerebbe antifascista, dopo le polemiche dei giorni scorsi all’interno di An sul ruolo della Repubblica di Salò e sui valori della Resistenza.17 settembre 2008, di Maria Paola Falqui
 Dopo le polemiche dei giorni scorsi, il premier non si schiera. Al comitato costituente del Pdl
Dopo le polemiche dei giorni scorsi, il premier non si schiera. Al comitato costituente del Pdl
 chiude sulla legge elettorale per le europee e attacca Veltroni: "Inesistente. Dialogo impossibile"
chiude sulla legge elettorale per le europee e attacca Veltroni: "Inesistente. Dialogo impossibile" Berlusconi: "Io antifascista?
Berlusconi: "Io antifascista?
 Penso solo a lavorare" *
Penso solo a lavorare" *ROMA - "Io antifascista? Penso solo a lavorare, per risolvere i problemi degli italiani". Silvio Berlusconi risponde così, senza sbilanciarsi, ai giornalisti che gli chiedono se si dichiarerebbe antifascista, dopo le polemiche dei giorni scorsi all’interno di An sul ruolo della Repubblica di Salò e sui valori della Resistenza.
Intervenendo al comitato costituente del Pdl, il presidente del Consiglio ha ribadito poi la sua posizione sulla legge elettorale per le europee - sbarramento al 5 per cento e liste bloccate, senza preferenze - e ha attaccato l’opposizione con cui "non si può dialogare" e Walter Veltroni, "inesistente".
Legge elettorale ed Europee. Chiusura netta sulla legge elettorale: Silvio Berlusconi ribadisce in sostanza quanto detto lunedì a "Porta a Porta", ovvero che "il sistema delle liste bloccate permette di avere professionisti che possono autorevolmente rappresentare il Paese all’interno delle commissioni del Parlamento europeo". Le liste bloccate, secondo il premier, "selezionano chi rappresenta autorevolmente gli interessi europei ma soprattutto italiani".
Sull’argomento l’opposizione non condivide la linea scelta dalla maggioranza ed ha già annunciato battaglia: Il Pd è per lo sbarramento al 3 per cento e per le preferenze, mentre l’Udc che non pone questioni di sbarramento, ma è nettamente contrario all’abolizione delle preferenze, che "strangola la democrazia perché toglie ossigeno alla libertà dell’elettore di scegliere il proprio candidato".
Veltroni inesistente, alternanza non auspicabile. Berlusconi attacca poi duramente Walter Veltroni. "Il leader del Pd aveva cominciato bene, ma nei fatti ora è del tutto inesistente. Dimentichiamo ogni speranza di poter collaborare con loro". "La sinistra - continua - ha scelto la vecchia linea e i vecchi vizi della loro provenienza storica, dovrà passare un’altra generazione" prima di poter dialogare, perché i protagonisti di oggi "sono posseduti da invidia e odio di classe". "Con questa opposizione - ha aggiunto - e con questo modo che ha di interpretare il bipolarismo, l’alternanza non è auspicabile, non è un valore". "Governeremo a lungo", ha aggiunto.
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- Alto Gradimento (di don Aldo Antonelli).17 settembre 2008, di Federico La Sala
ALTO GRADIMENTO
di don Aldo ANTONELLI *
A proposito di Berlusconi, cui oggi i sondaggi attribuiscono oltre il 60 per cento di gradimento, riporto questa lettera pubblicata su La Repubblica del 21 ottobre 2006. Non cambio una virgola:
"Che un gruppo di attivisti cattolici, molto attivisti e molto cattolici, fischi Romano Prodi, rientra nel novero delle possibilità. Ma che lo stesso gruppo di attivisti cattolici applauda Berlusconi è, invece, puro surrealismo politico. Non esiste niente, sotto il sole, più anticristiano di Berlusconi. L’edonismo, le poppe in vendita., il fracasso mondano, il consumismo bulimico sono state la mission (riuscitissima) delle sue televisioni.
Se c’è qualcosa che ha definitivamente azzerato la dimensione spirituale di questo paese, o quel poco che ne restava, questo qualcosa è la televisione commerciale. Ora la crapula, i quattrini e le tette come unico orizzonte della vita possono anche andare bene a noi altri miscredenti. Si sa che siamo sazi e disperati (come disse il Biffi) e dunque dediti, per ingannare il tempo, alle più sozze pratiche.
Ma un cattolico? Un cattolico, Gesù santo, come accidenti fa ad applaudire Berlusconi? Sulla base di quale abbaglio demoniaco può tra sformare in idolo un tipetto al quale interessa solo ciò che si compera e si vende? Berlusconi è il classico mercante che il fondatore del cristianesimo avrebbe buttato fuori dal Tempio. Si vede che il Tempio, nel frattempo, lui se l’è comperato."
Aldo [don Antonelli]
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- «Presidente Berlusconi, a lei dispiace sentirsi dire fascista?».(Lettera al premier di Giovanni Maria Bellu, 19.09.2008)19 settembre 2008, di Maria Paola Falqui
Lettera al premier
di Giovanni Maria Bellu *
Presidente Berlusconi,
una premessa: è molto complicato scriverle, fin dalle prime righe. In una prima versione di questa lettera, avevo scritto «Caro presidente». È una formula di stile, che prescinde dal fatto che il destinatario sia realmente «caro» al mittente. Quando la si usa rivolgendosi a un esponente delle istituzioni, quale lei è, si vuole esprimere un’idea di «familiarità nazionale». Si vuol dire che, anche se si hanno idee molto diverse attorno alla politica, si riconosce l’esistenza di valori condivisi. Si sa che esiste un luogo, per quanto estremo, nel quale è inevitabile ritrovarsi. Quello è, appunto, un luogo «caro» perché è la casa comune dove sempre si torna anche dopo aver percorso strade divergenti, aver visitato luoghi lontanissimi tra loro. Con quella parola, «caro», infatti, cominciano anche le missive più dure e più risentite.
Con «egregio», «spettabile» etc. cominciano invece le lettere che danno per presupposta una distanza, a volte già incolmabile. È stato dopo questa riflessione che ho cancellato il «caro» ma non l’ho sostituito con l’«egregio» o con lo «spettabile». Il fatto è che spero che la distanza non sia incolmabile ma, contemporaneamente, non vedo più la casa comune. C’è poi un’altra difficoltà. È proprio questo giornale che lei ha spesso offeso. Non solo, ha offeso personalmente dei giornalisti di questo giornale per il solo fatto che le rivolgevano una domanda a lei sgradita. E l’ha fatto senza argomentare, senza motivare. Applicando meccanicamente il giudizio di condanna del comunismo che, a quanto pare, è l’unico «male assoluto» che lei ha individuato nella storia. Irridendo i percorsi dolorosi, la fatica di riconoscere gli errori. Ignorando quello che è stato qua, in Italia, il comunismo e quanto hanno fatto quelli che combattevano in suo nome per costruire la democrazia e per difenderla in tanti momenti cruciali. Adesso lei si domanderà perché comunque abbia deciso di scriverle. Tra l’altro interrompendo, sia pure per qualche minuto, le tante attività della sua giornata lavorativa. Il fatto è che scriverle, e questo lei dovrebbe apprezzarlo, è un modo di non spezzare definitivamente quel filo sottile che conduce alla casa comune. Perché, presidente Berlusconi, la casa comune siamo obbligati a cercarla fino alla fine, ostinatamente, utopicamente persino. Dobbiamo cercarla perché, nostro malgrado, siamo nati nello stesso paese.
Ecco, arrivato a questo punto ho riletto le prime righe e ho provato un senso di disagio. Mi sono accorto di averle appena scritto una cosa del tutto ovvia. Una di quelle cose che si insegnano, o forse si insegnavano, ai ragazzini nelle lezioni di educazione civica. I principi che molti di noi, di certo i più fortunati tra noi, hanno appreso in famiglia. Dalle madri, dai padri, dai nonni. È stata l’improvvisa consapevolezza della sua età - lei è un uomo anziano, alle soglie della vecchiaia - che mi ha suscitato quella sensazione di incongruità. Lei, infatti, queste cose non solo dovrebbe saperle ma dovrebbe aver cominciato a trasferirle ai suoi nipoti. Perdoni questa lunga premessa. In realtà non devo dirle molto altro. Solo che ho vent’anni meno di lei e sono cresciuto, come tutta la mia generazione (e come quella che l’ha immediatamente preceduta e quelle che sono venute dopo) con l’idea della «casa comune». Era una casa lontana, edificata con i mattoni della memoria che erano stati creati, prima che noi nascessimo, nelle fornaci della paura. Era la memoria della guerra. Ci è stata trasferita in una miriade di piccoli gesti e, a volte, di rimproveri. Alcuni di essi ci risultavano incomprensibili. Frasi come «non sprecare il pane». Oppure: «Non superare di corsa un vecchio». Ma anche: «Ascolta le ragioni degli altri».
Crescendo e studiando abbiamo compreso il perché di quelle prescrizioni che a volte ci irritavano o ci parevano anacronistiche. In effetti, le merendine avevano ormai stabilmente sostituito il pane e vivevamo in condizioni di sicurezza che credevamo definitivamente acquisite dal genere umano. Ma poi abbiamo capito. Non è stato facile perché le nostre madri, i nostri padri e i nostri nonni evitavano di dircela tutta. Abbiamo capito il senso di quegli ammonimenti: con pudore, con vergogna a volte, ci stavano trasferendo la memoria del disastro a cui avevano assistito quando avevano la nostra età. La memoria della guerra e dell’ideologia dissennata che l’aveva prodotta. La memoria del fascismo e del nazismo. Molti di loro, tra l’altro, ci avevano creduto. E le macerie erano ancora là. Con la contabilità della catastrofe. Con le prime immagini dei lager. A un certo punto abbiamo capito così tanto che molti di noi hanno cominciato a osservare con perplessità e con sconcerto le cerimonie spesso sciatte e formali con le quali veniva rievocato periodicamente quell’orrore. Abbiamo cominciato a domandarci perché mai i partiti che l’avevano combattuto, compreso quello che aveva come organo questo giornale, fossero così timidi e pudichi. E abbiamo deciso di scoprirlo da soli. Chi ha cominciato da «Marcia su Roma e dintorni» di Emilio Lussu, chi dalla biografia di Antonio Gramsci, chi dalle «Lettere dei condannati a morte», chi leggendo Vittorini, o Cassola, o Fenoglio, o Natalia Ginzburg. È stato emozionante e ci ha riempiti di orgoglio impadronirci della storia e capire quanto era stata dura. I più fortunati tra noi hanno compreso la fortuna della democrazia e sono cresciuti meglio.
Presidente Berlusconi - ecco, adesso ho dovuto reprimere l’impulso di scriverle «caro» per rendere più sincero e più accorato quanto le scrivo - non spezzi il filo. In questi giorni in ben due occasioni le è stata fatta una domanda banale, una domanda alla quale ognuno degli abitanti della casa comune dovrebbe rispondere in un istante, senza esitare. Le è stato chiesto, semplicemente, se lei si ritiene antifascista. Lei non ha risposto. Per due volte.
Presidente Berlusconi, ci ha inquietato vederla in questi anni a volte vestito con la camicia nera. Ma ci abbiamo scherzato. Abbiamo pensato che la indossasse perché il nero snellisce. Abbiamo creduto che per lei la camicia nera fosse come la crema sul viso o il trapianto dei capelli. E anche quando ha detto cose che avrebbero fatto inorridire alcuni dei nostri nonni, come quella battuta infame sui confinati dal fascismo che in realtà «andavano in villeggiatura», ci siamo sforzati di pensare che fosse solo una gaffe storica (come la volta che disse «Romolo e Remolo», ricorda?) o un effetto della necessità politica di compiacere i suoi alleati. Il fatto è che, pochi giorni fa, uno di quegli alleati, Gianfranco Fini, che tra l’altro non ci è affatto simpatico, ha detto delle parole chiare che fanno venire meno quella spiegazione. Insomma, presidente, lei non ha più alcuna necessità di compiacerlo. Almeno non in quel modo. Ma allora perché non risponde alla domanda, a quella banale domanda che è il filo dei valori condivisi? Forse è opportuno riformularla in modo ancora più esplicito, così che non ci siano più equivoci. Che non ci siano più dubbi tra il «caro» e l’«egregio». Per questo gliela poniamo, anziché in negativo, in positivo. Sono poche parole e per rispondere basta un attimo, il tempo di dire «sì» o «no»: «Presidente Berlusconi, a lei dispiace sentirsi dire fascista?».
* l’Unità, Pubblicato il: 19.09.08, Modificato il: 19.09.08 alle ore 8.08
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- Riforme, Berlusconi ai delegati del Ppe: "Possiamo cambiare l’architettura dello Stato", "In Parlamento abbiamo i voti per fare le riforme, a partire da quella della giustizia"19 settembre 2008, di Maria Paola Falqui
 Il premier è intervenuto a una cena organizzata dal Partito Popolare Europeo
Il premier è intervenuto a una cena organizzata dal Partito Popolare Europeo
 Elezioni, crisi delle borse, situazione internazionale i temi trattati nel discorso
Elezioni, crisi delle borse, situazione internazionale i temi trattati nel discorso Riforme, Berlusconi ai delegati del Ppe
Riforme, Berlusconi ai delegati del Ppe
 "Possiamo cambiare l’architettura dello Stato"
"Possiamo cambiare l’architettura dello Stato" "In Parlamento abbiamo i voti per fare le riforme, a partire da quella della giustizia"
"In Parlamento abbiamo i voti per fare le riforme, a partire da quella della giustizia"
 Ha parlato in francese: "Feci una gara con Chirac sulle canzoni francesi e vinsi"
Ha parlato in francese: "Feci una gara con Chirac sulle canzoni francesi e vinsi"ROMA - Il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi si è detto sicuro di poter "cambiare l’architettura dello stato" per velocizzare le riforme istituzionali. "Abbiamo la maggioranza per cambiare l’architettura dello Stato che è vecchia e per dare più rapidità alle decisioni del governo; e in Parlamento abbiamo i voti per fare le riforme, a partire da quella della giustizia" ha dichiarato il premier nel corso di una cena organizzata nella capitale dal Partito Popolare Europeo.
Le elezioni. Poi, Berlusconi ha anche fissato per le prossime elezioni l’obiettivo minimo del 52% dei consensi. "In Italia abbiamo fatto un nuovo partito, il Partito delle libertà, capace di prendere alle prossime elezioni come minimo il 52% dei voti".
La Georgia. Nel suo intervento iniziato in lingua francese - "Una volta ho sfidato Chirac a chi conosceva di più le canzoni francesi- ha detto Berlusconi - ed ho vinto io"- il premier ha anche ribadito l’importanza del dialogo per migliorare i rapporti tra Russia e Occidente. "Bisogna far sedere intorno a un tavolo il presidente americano, i responsabili dell’Unione Europea e della Federazione Russa per scegliere insieme la strategia che il mondo occidentale deve seguire nei prossimi anni. L’incidente dell’Ossezia e della Georgia ha rischiato di diventare una miccia per azzerare gli accordi raggiunti di recente".
La crisi delle borse. Il premier si è espresso anche sulla crisi dei mutui sub prime. "La crisi finanziaria in atto non toccherà così profondamente la nostra economia - Il nostro sistema bancario è solido perchè è basato, più che sui grattacieli della finanza, su sportelli diffusi in tutti i paesi". Situazione sotto controllo anche negli altri stati dell’Unione Europea. "Hanno tutti economie molto, molto solide e il fenomeno dei mutui non ci tocca. In Francia e in Germania le banche hanno concesso mutui solo per il 50% del valore degli immobili e poi non si è registrata nessuna flessione del mercato immobiliare. Tuttavia le difficoltà maggiori sono nelle esportazioni".
* la Repubblica, 19 settembre 2008.
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- E’ la giustizia creativa, bellezza! (di GIUSEPPE D’AVANZO).20 settembre 2008, di Federico La Sala
E’ la giustizia creativa, bellezza!
di GIUSEPPE D’AVANZO *
Berlusconi ha dimostrato a sufficienza quanto la sua personale, privatissima giustizia possa essere creativa: negli anni, non c’è stata "stazione" del processo penale che non ne sia stata sconvolta (il reato, i tempi di prescrizione, la pena, le prove, la procedura). Il "lodo Alfano" doveva essere, nelle intenzioni del mago di Arcore, il sortilegio finale. Nessuno processo per Iddu. Impunità piena. Ma il diavolo ci ha messo la coda e il processo a Berlusconi, imputato di aver corrotto il testimone David Mills, può riservare ancora qualche sorprendente esito.
La spina che affligge Iddu è questa: è vero, dopo la vergogna del "lodo Alfano", Berlusconi non può essere processato, ma Mills sì. E se i giudici dovessero concludere che corruzione c’è stata e il testimone si è lasciato corrompere, chi volete che sia il corruttore in un processo che vede al banco soltanto due imputati (Mills e Berlusconi) e un unico fatto da valutare (i 600 mila dollari finiti nei conti dell’avvocato d’affari inglese)? Berlusconi si sarebbe salvato da una condanna, ma non salverebbe la faccia. Con tutto quel che potrebbe significare per il suo futuro istituzionale e per la sua immagine internazionale.
Ecco perché, con una nuova mossa di "giustizia creativa", il drappello dei suoi avvocati-parlamentari pretende che il processo Mills "muoia" fuori dell’aula del tribunale, fuori dal processo, fuori da ogni rito conosciuto e praticato finora. Chiedono che i giudici chiudano la porta e se ne vadano a casa.
I consiglieri del mago sanno quel che accadrebbe se la luce in aula restasse accesa. I giudici dovrebbero, per il "lodo Alfano" sospendere il giudizio per Berlusconi e concluderlo per Mills (il processo di fatto è finito e prima di Natale ci potrebbe una sentenza); dovrebbero dare la parola sulla sospensione al pubblico ministero che proporrebbe l’incostituzionalità del "lodo". E, vista la ragionevolezza dell’obiezione (la legge non è uguale per tutti?), a decidere sarebbe la Consulta: altro rischio che il mago non vuole affrontare non fidandosi dei suoi trucchi. Per farla breve, tutto potrebbe tornare in alto mare con scenari, per il mago, poco tranquillizzanti.
Ecco allora che gli avvocati non si presentano in aula per inconsueti impegni parlamentari, nonostante sia venerdì. Lavorano a un piano e hanno bisogno di tempo. Ecco perché. Hanno presentato in Cassazione una richiesta di ricusazione contro il giudice di Milano, Nicoletta Gandus. Dicono: quella toga è prevenuta contro Berlusconi, non può giudicarlo, non è né serena né imparziale. La mossa è assai bizzarra. Se Berlusconi grazie al "lodo" non può essere giudicato, che senso ha chiedere la ricusazione del giudice?
Ma è la giustizia creativa, bellezza!
E’ vero che la Gandus non giudicherà Berlusconi (accusato di essere il corruttore), ma potrebbe giudicare Mills (accusato di essere il corrotto). Screditare l’imparzialità del giudice dà al mago di Arcore la possibilità di svalutare la possibile condanna dell’avvocato d’affari inglese (che, al contrario, non ha mai ricusato il giudice).
Gli avvocati e consiglieri di Berlusconi puntano così a trasferire in Cassazione - e nel Palazzo - la battaglia per affondare il processo e salvare la faccia. Sulla decisione della Suprema Corte contano di far pesare il ricatto, tutto politico, della riforma della giustizia. Che, invece di risolvere le inefficienze e i ritardi del sistema penale e del processo civile, si occuperà in via prioritaria di giudici e pubblico ministeri e, soprattutto, del Csm di cui - minaccia il governo - andranno rivisti i compiti, il sistema elettorale, la sezione disciplinare e in definita, l’autogoverno della magistratura. E chissà che, dinanzi a tante pressioni, in Cassazione le eccellentissime toghe non convengano che sia meglio l’uovo oggi che la gallina domani. Bocciando il giudice di Milano e quindi anche la credibilità dell’eventuale condanna di David Mills.
* la Repubblica, 19 settembre 2008
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- La bolla delle illusioni (di BARBARA SPINELLI)21 settembre 2008, di Maria Paola Falqui
La bolla delle illusioni
di BARBARA SPINELLI (La Stampa, 21.09.2008)
Il baratro di cui ha parlato Berlusconi, giovedì quando s’è rotto il negoziato Alitalia e la cordata Colaninno ha ritirato la propria offerta, è la condizione in cui ci si trova ogni qual volta la realtà si vendica sull’illusione, che più o meno lungamente aveva abbagliato e confuso le menti. Ogni disincanto genera baratri. La grande illusione esiste anche nel mondo della finanza ed è chiamata bolla: proprio in questi giorni, anch’essa sta scoppiando nelle mani di chi per decenni l’aveva dilatata, fino a scambiarla col reale. Il motore dell’illusione è la distorsione della realtà, ed è il motivo per cui si può parlare di bolla della menzogna per Alitalia e di bolla delle false credenze per la finanza. Come quando è fatta di sapone, la bolla ti avvolge con una membrana trasparente, che ti sconnette dal reale.
Più enormi le illusioni, più durevole la bolla e più brutale lo scoppio. Per questo è importante esplorare il passato, anche se presente e futuro sono prioritari. L’anamnesi della bolla aiuta a capire il momento in cui l’illusione non solo cancella il principio di realtà, ma crea realtà affatto nuove che pesano ancora: una tentazione che non è di ieri ma di sempre, essendo le false credenze loro ingrediente essenziale. La bolla Alitalia s’è palesata non solo alla fine del governo Prodi, ma anche quando ha preso corpo la cordata Colaninno. L’alternativa berlusconiana poteva riuscire, ma essendo nata come bolla aveva bisogno di menzogne e queste non sono state ininfluenti sul negoziato. Ogni volta che il premier parlava (l’ultima a Porta a Porta, il 15 settembre), le contro-verità per forza riaffioravano facendo riemergere il passato ineluttabilmente. Le contro-verità sono almeno sei. Primo, non è vero che le promesse elettorali sono state mantenute: Berlusconi aveva garantito soluzioni migliori rispetto a Air France, e la Cai è certo un rimedio ma non migliore. Secondo, i costi erano ben più alti: sia per i licenziamenti; sia per il futuro mondiale della compagnia (l’italianità era garantita, non una compagnia competitiva nel mondo); sia per il prezzo pagato dai contribuenti.
L’economista Carlo Scarpa ha calcolato, sul sito La Voce, che lo Stato - i contribuenti - devono pagare nel piano CAI 2,9 miliardi di euro. Terzo, non è vero che non ci sarebbero stati stipendi diminuiti ma solo aumenti di produttività, come detto dal premier: altrimenti il negoziato non si sarebbe bloccato su questo. Quarto, non è vero che Berlusconi non avrebbe impedito l’accordo Air France: il premier disse pubblicamente che l’avrebbe revocato, se vittorioso alle urne. Quinto, Air France non prevedeva 7000 licenziati ma 2150. Sesto, non è Berlusconi a poter lamentare l’uso politico spinto del caso Alitalia.
Rammentare illusioni e contro-verità non è vano perché mostra la stoffa di cui son fatte le bolle: in economia, in politica, nell’individuo. La bolla infatti crea una realtà in cui si finisce per credere, e che diventa realtà: magari virtuale - un’ombra, un’ideologia - ma che incide sulla vita. Chi la dilata comincia a ignorare la membrana e influenza gli attori circostanti. Ogni metafora naturalmente ha difetti, anch’essa deve fare i conti con il reale. Ma l’euforia di illusioni e false credenze è il tessuto della bolla, e se è vero quello che dice Erasmo - la menzogna ha cento volte più presa sull’uomo della verità - la sua potenza non va sottovalutata.
La crisi finanziaria è bolla specialmente deleteria: perché ha ramificazioni più vaste e antiche, legate a illusioni sul potere unilaterale Usa e sulla sua pretesa di poter fare da sé. È il morbo descritto nell’ultimo libro di George Soros, il finanziere che s’ispira alla teoria della fallibilità di Popper (The New Paradigm for Financial Markets, 2008). La bolla è centrale nella sua analisi, ed egli la scorge nella crisi dei mutui, dell’economia, della politica estera Usa. All’origine un peccato originale: il doppio fondamentalismo del libero mercato e della superpotenza unica.
Nella finanza la grande illusione è stata la seguente: i prezzi di vari prodotti (alta tecnologia, case) sarebbero cresciuti indefinitamente, e l’aspettativa di tale crescita li avrebbe ancor più aumentati. Niente li frenava, visto che i tassi restavano bassi e si moltiplicavano mutui a prezzi attraenti anche se irrealistici. Tale deformazione del mercato, Soros la chiama self-fulfilling prophecy (profezia che si autorealizza) del pensiero manipolatore. Esso pesa sulla realtà sino a stravolgere insidiosamente il rapporto tra domanda e offerta: il finanziere parla di interferenza «riflessiva» tra percezioni distorcenti e fatti reali (questi riflettono la manipolazione e ne vengono trasformati).
La profezia che si autorealizza avviene quando la narrazione del reale schiaccia il reale: il vero è sostituito dal racconto. Il postmoderno ha molte affinità con quest’illusione, così simile alle ideologie che affogano il reale nella sua narrativa. Soros denuncia la complicità tra postmoderno e Bush, ma la complicità vale anche per Berlusconi e Alitalia. Un episodio lo comprova, raccontato anni fa dal giornalista Ron Suskind. Già nel 2002, prima della guerra irachena, un consigliere di Bush gli disse: «Il mondo funziona ormai in modo completamente diverso da come immaginano illuministi e empiristi. Noi siamo ormai un impero, e quando agiamo creiamo una nostra realtà. Una realtà che voi osservatori studiate, e sulla quale poi ne creiamo altre che voi studierete ancora» (New York Times, 17-10-2004. Il consigliere sarebbe Karl Rove).
Chi non s’adegua è accusato d’appartenere alla reality-based community: comunità antiquata perché interessata alla realtà anziché alla credenza. La comunità realista s’inquieta per le conseguenze della bolla: Iraq, caos afghano, Iran in ascesa, crollo della borsa, declino del dollaro, debolezza mondiale Usa. Chi vive nella bolla non bada a conseguenze, fino a quando la realtà si vendica. Le bugie possono avere gambe molto più lunghe del proverbio: ma non infinitamente lunghe. Chi vive in una bolla è come stregato. Pensa che la profezia si autorealizzi, nel male o nel bene. In Italia abitano il sogno Berlusconi ma anche Cgil e parte dei dipendenti Alitalia. In America il sogno non è meno forte: sia all’inizio, quando milioni di cittadini credettero nella bugia di mutui troppo facili, sia dopo l’infrangersi dell’illusione col piano di salvataggio che trasforma lo Stato in infermiere.
Chi vive nella bolla pensa che il mercato prima o poi riequilibrerà domanda e offerta, non si cura degli effetti della bolla né di quelli della bolla scoppiata. L’illusione permane, quando le perdite (di Alitalia o delle compagnie Usa) son convogliate verso bad companies magari salvifiche, e però finanziate dal contribuente. Chi vive nella bolla ha infine e soprattutto l’impressione di poter correre ogni sorta di rischio: in particolare quello che nell’assicurazione si chiama moral hazard, azzardo morale. Si può dar fuoco alla propria casa, tanto siamo coperti. Si può fumare a letto se siamo assicurati dall’incendio, anche se magari nelle fiamme moriremo.
Il moral hazard diventa un pericolo nazionale, quando un governo gioca con l’inaffondabilità di un’impresa - l’Alitalia - fidando sul fatto che alla fine pagherà il cittadino. Diventa un pericolo mondiale, quando a correrlo è una superpotenza convinta di dominare il mondo incontrastata, anche se ormai domina poco. Tutto è permesso: tanto siamo i più forti, simili a dèi; o siamo assicurati, il che consente impunità e irresponsabilità. Dicono che il mercato vero deve riprendere il sopravvento. Non so se sia il mercato, visto che il fondamentalismo ne ha fatto uno stendardo. Sono la realtà e la cittadinanza e l’informazione attenta ai fatti (la reality-based community) che devono sgonfiare le bolle, una dopo l’altra.
-
> POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. --- "La finanza deve riscoprire l’etica". Barbara Berlusconi, la figlia del premier: il conflitto di interessi va regolamentato (di LUCA UBALDESCHI).21 settembre 2008, di Maria Paola Falqui
INTERVISTA
"La finanza deve riscoprire l’etica"
La figlia del premier: e il conflitto di interessi va regolamentato
di LUCA UBALDESCHI (La Stampa, 21/9/2008)
MILANO. «Oggi il ricorso all’etica sembra essere la strada migliore che molti economisti e società percorrono per cercare di trovare una soluzione alla dilagante crisi economica. Credo che sia opportuno affidare un ruolo più forte all’etica, ma al tempo stesso temo che questa soluzione evidenzi anche le attuali difficoltà del diritto societario e della costituzione economica della grande impresa. Servono più regole che garantiscano la correttezza dei comportamenti, ma servono anche istituzioni forti che facciano in modo che le norme vigenti vengano realmente rispettate».
Di fronte alla crisi che colpisce i mercati, a colossi che fanno bancarotta e bruciano soldi e posti di lavoro, Barbara Berlusconi mette subito in chiaro una cosa: «Espongo il mio punto di vista, ma non ho la presunzione di dare consigli o di stupire con soluzioni». Ma è evidente che il tema dell’etica negli affari le sta a cuore. Discute di tutela degli investitori e senso di responsabilità sociale che un’azienda deve dimostrare, in un ragionamento che spazia tra le tesi di Guido Rossi e il ruolo del padre come imprenditore, tra la necessità di regolare il conflitto di interessi e il suo futuro di manager.
La sensazione è che questi argomenti segnino un punto di svolta nella vita della primogenita di Silvio e Veronica Berlusconi, 24 anni, consigliere d’amministrazione della Fininvest, madre da undici mesi. Non a caso l’etica nei sistemi economici è al centro della tesi che sta preparando per la laurea in Filosofia all’Università del San Raffaele ed è il tema del dibattito che organizza l’associazione di cui fa parte - Milano Young - con la Bocconi il 2 ottobre.
Al convegno ci sarà una sua relazione?
«No, mi limiterò a spiegare le ragioni per cui l’abbiamo organizzato. Vede, finora con Milano Young ci siamo dedicati alla beneficenza. Ma oggi non siamo gli stessi di quattro anni fa. Come noi anche la onlus dove operiamo compie un percorso di crescita. Cambiano i nostri interessi e le proposte che Milano Young offre alla sua città. Con questo nuovo percorso di incontri desideriamo proporre ai nostri coetanei tematiche che sentiamo urgenti e attuali, come il valore dell’etica nei sistemi economici».
Il punto di partenza del dibattito?
«La società sta riscoprendo l’etica economica perché sembra suscitare nuovi interessi, collettivi e diffusi. Sempre più governanti, giuristi, economisti, imprenditori, sindacalisti, impiegati, consumatori sentono l’esigenza che le società e i mercati siano regolati da valori comuni che contrastino atteggiamenti illegittimamente consentiti e pericolosamente individualisti. Quello che però non si riesce ancora a capire, e su cui verterà la discussione, è se l’etica ha un effettivo potere "curativo" verso quei comportamenti economici che sempre più di frequente accettano e adottano la fisionomia di un’illegalità diffusa».
Bel tempismo, considerato quanto sta accadendo nella finanza mondiale.
«Il crac di Lehman Brothers è sconcertante. Parliamo di 27 mila dipendenti che da un giorno all’altro si ritrovano senza lavoro. Per non parlare degli investitori e dei mercati. Questo dimostra quanto sia attuale l’argomento che abbiamo scelto. Interrogarsi sull’efficacia che l’etica assume nella gestione di società, di imprese e nei sistemi economici non è un tema astratto. E proporlo agli studenti della Bocconi non è un caso. Loro studiano per essere la classe dirigente di domani e non possono eludere queste riflessioni».
Lei invoca una gestione più etica e responsabile delle aziende?
«L’economia di oggi ha sempre più bisogno di indicazioni e limiti, soprattutto per quanto riguarda i problemi della disuguaglianza delle condizioni economiche, della protezione dell’ambiente, della tutela di chi agisce correttamente sui mercati. Trovo giusto che negli affari le persone prendano ispirazione dai principi e dai valori etici, anche se è chiaro che l’etica non si possa sostituire alle norme e alle sanzioni giuridiche, come spesso si vuol far credere. Mi spiego. Ci sono una serie di comportamenti, ritenuti scorretti e sprovvisti di sanzione, che si spera possano essere risolti e controllati attraverso i codici di comportamento societari. Questo è come pensare che l’etica si possa sovrapporre alla giustizia e che in qualche modo possa sostituirla».
A che cosa pensa, in particolare?
«Il punto cruciale è che i codici di condotta aziendale e gli strumenti etici (bilancio sociale, ambientale, ecc) sono in molti casi autoimposti e quindi possono essere violati. Pensiamo a una qualsiasi azienda, che promette di essere corretta e trasparente con i propri dipendenti, i propri azionisti e i consumatori. Prima o poi, però, la ricerca del profitto si scontrerà con le norme etiche e imporrà di scegliere tra l’una e le altre. A quel punto starà alla sensibilità, alla coscienza, alla moralità dell’imprenditore decidere cosa fare».
Che cosa propone, allora?
«Che vengano definiti in maniera oggettiva i criteri etici cui bisogna attenersi e che il rispetto ad essi non sia autogestito, ma imposto, affinché la comunità economica possa giudicare gli effettivi comportamenti dei propri operatori. Però l’etica da sola non basta. La crisi del mondo degli affari non è dilagata solo per mancanza di principi etici, ma perché mancano le leggi e spesso quelle che ci sono non vengono applicate. Il professor Guido Rossi ha ben spiegato, ad esempio nel libro “Il conflitto epidemico”, la necessità di maggiori controlli e sanzioni».
Ha parlato di questi temi con suo padre?
«Non ne abbiamo ancora avuto il tempo, ma illustrerò per primo a lui la mia tesi».
Crede che potrebbe considerare un’ingerenza negativa l’idea di un codice etico imposto per legge alle imprese?
«Sinceramente, non saprei dire. Per immaginare la risposta bisogna collocare una persona nella fase storica in cui ha formato la propria esperienza. E queste sono problematiche che solo in questi ultimi tempi conoscono un’ampia diffusione».
Teme che possa giudicarla...
«Antiliberale?».
O di sinistra.
«Non si può parlare di destra o sinistra. Oggi fa parte del governo il ministro Sacconi che è un grande esperto di etica di impresa. Non credo che sia una questione che faccia a pugni con il libero mercato, se è questo che intende».
E’ una questione etica anche risolvere il conflitto di interessi, non crede?
«Il caso di mio padre è altra storia rispetto a ciò di cui abbiamo parlato finora. Sono convinta che il tema del conflitto di interessi abbia bisogno di una regolamentazione, ma il voto ha dimostrato che gli italiani non lo vivono come una necessità. Diciamo che esiste l’esigenza, non la richiesta».
Che voto dà all’etica imprenditoriale di suo padre?
«Apprezzo il rispetto per le altre persone e la disponibilità ad ascoltare».
Nel suo futuro c’è una carriera da manager, vero?
«E’ il mio obiettivo».
Sarà impegnata alla Mondadori?
«Studio per questo, amo i libri, l’editoria, le dinamiche della comunicazione. Ed è anche quello che mi ha sempre chiesto e proposto mio padre».
Niente Mediaset e televisione?
«La tv mi interessa meno».
Però la guarda?
«Amo guardare Sky, canali come Discovery o National Geographic. Apprezzo Matrix e Mentana, è bello Report, mi piacciono la Bignardi e le Invasioni barbariche. Comunque mi creda, rispetto a quanto si vede all’estero, il nostro servizio televisivo è di buona qualità. Che si parli di Mediaset, Rai o La 7».
Un’ultima domanda: sarà un’imprenditrice eticamente responsabile?
«Quando mi troverò di fronte a una scelta cruciale mi auguro di saperla compiere conformemente ai miei principi morali».
-
-
-
-
-
-