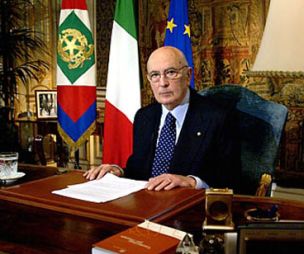
L’ASTUZIA DEL LUPO E I SETTE CAPRETTI. "APRITE, APRITE": SONO IL VOSTRO "PAPI"!!! LA PAROLA "ITALIA", LA "PASSWORD", CONSEGNATA A UN PARTITO (1994-2011). Un omaggio a Giorgio Napolitano, al Presidente della Repubblica italiana - a cura di Federico La Sala
- [...] "Aprite miei cari figli, è la vostra mamma che porta dolciumi per voi." Purtroppo per lui, il lupo, sbadato, aveva posato le sue zampe nere sull’orlo della finestra e fu quindi subito riconosciuto. I capretti gridarono scherzosamente: "Uuh! Uuh! Signor lupo zampe nere, ti sei tradito!" [...]
- COSTITUZIONE ED EDUCAZIONE CIVICA. LA LEZIONE DI GAETANO FILANGIERI, IL PARTITO DI "FORZA ITALIA" E IL COLPO DI STATO DI SILVIO BERLUSCONI.

- L’ITALIA NELLO STALLO, IL "GOLPE MORALE", E IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
 PER L’ITALIA E PER LA COSTITUZIONE, CARO PRESIDENTE NAPOLITANO, CREDO CHE SIA ORA DI FARE CHIAREZZA. PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI
PER L’ITALIA E PER LA COSTITUZIONE, CARO PRESIDENTE NAPOLITANO, CREDO CHE SIA ORA DI FARE CHIAREZZA. PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI
Il lupo e i sette capretti
dei F.lli Grimm *
C’era una volta una capra che allevava da sola i suoi sette piccoli capretti. Essa li amava teneramente, ma le davano molte preoccupazioni, perché erano spesso disubbidienti e sbadati. Inoltre temeva sempre per la loro vita, perché questi piccoli imprudenti pensavano solo a giocare, sgambettando senza tregua ai margini della foresta, là dove si aggirava il loro nemico di sempre ed il più sanguinario: il grande lupo.
Un giorno prima di andare nel bosco a cercare freschi germogli d’arboscelli per il pasto della sera, la capra radunò i suoi piccoli per metterli di nuovo in guardia. "Devo assentarmi per alcune ore, non lasciate entrare nessuno dentro casa. Siate diffidenti perché il lupo è astuto, può falsare la sua voce e mascherare il suo aspetto. Ma voi potrete riconoscerlo a colpo sicuro dalle zampe che sono nere." "Saremo saggi e prudenti" promisero i capretti, "non apriremo la porta a nessuno se non mostrerà le zampe bianche."
La capra se ne partì abbastanza tranquilla. Qualche minuto dopo alcuni colpi furono battuti alla porta. "Aprite, aprite miei cari piccoli, è vostra madre che ha dimenticato il suo scialle e le sue cesoie." "Uuh! Uuh!" dissero scherzosamente i sette capretti, "abbiamo riconosciuto la tua brutta voce, brutto diavolo di un lupo e non ti apriremo la porta."
Il lupo se ne andò via umiliato, ma lungo il cammino comperò un pezzetto di zucchero filato che succhio per addolcire la sua voce rauca. Ritornò di soppiatto e da dietro la porta disse con una voce melliflua: "Aprite miei cari figli, è la vostra mamma che porta dolciumi per voi." Purtroppo per lui, il lupo, sbadato, aveva posato le sue zampe nere sull’orlo della finestra e fu quindi subito riconosciuto. I capretti gridarono scherzosamente: "Uuh! Uuh! Signor lupo zampe nere, ti sei tradito!"
Contrariato e affamato il lupo concepì un nuovo inganno. Corse zoppicando dal fornaio e gli disse: "Mi sono ferito, mettetemi un impiastro di pasta cosparso di farina, mi allevierà il dolore."
A quei tempi era un rimedio abituale, pertanto il fornaio non sospettò i neri disegni del lupo che ripartì con la zampa destra imbiancata come desiderava. Ingannati dalla voce mielosa e dalla zampa bianca i poveri capretti alla fine aprirono la porta. Apparve il lupo, terribile, con la schiuma alla bocca, tutto nero, con fuori una grande e avida lingua rossa.
"Aiuto! Soccorso!" belarono i poveri piccoli, saltando sotto la tavola, nel letto, nell’armadio o nella vasca da bagno, nella speranza di sfuggire all’orribile bestia. Ma il lupo, eccitato e morto di fame, li trovò tutti e l’inghiottì in un boccone uno dopo l’altro, con il pelo e gli zoccoli. Uno solo di loro scampò alla carneficina, perché si era nascosto nell’orologio a pendolo, rannicchiato sotto il pesante bilanciere di rame.
Dopo poco tempo mamma capra bussò alla porta e trovando la sua casa devastata, scoppiò in singhiozzi. Nessun belato rispondeva alla sua chiamata. Comprese allora che il lupo l’aveva preceduta. Ad un tratto la poveretta drizzò le orecchie: dalla cassa dell’orologio proveniva un debole rumore e infine, sotto la pressione dei piccoli zoccoli, la sua porticina si aprì e ne uscì un capretto in lacrime che si precipitò ad abbracciare la madre raccontandole le astuzie del lupo e la triste fine dei suoi fratelli.
La capra disse tra sé: "Non deve essere andato molto lontano dopo una tale scorpacciata. Ingordo com’è, può darsi ci sia una speranza di ritrovare vivi i tuoi fratelli."
Afferrata la sua borsa per il cucito, si diresse di corsa verso la foresta. La capra non dovette andar lontano. Sazia, sdraiata ai piedi di un albero, la cattiva bestia si muoveva curiosamente. Con molta abilità la capra gli tagliò la pancia con un gran colpo di forbici.
Il lupo dormiva così bene che si mosse appena e non si accorse di niente. Con grande gioia della loro madre i capretti uscirono sani e salvi, uno dopo l’altro, dallo stomaco del lupo. Per ordine della capra essi portarono sei grosse pietre che furono poste nella pancia del lupo che fu ricucito alla perfezione.
Corsero poi tutti insieme ad appostarsi sul parapetto di un ponte. Quando il lupo si svegliò, fu preso da una gran sete. Appesantito, corse verso la riva del fiume e per bere si sporse, ma trascinato dal peso delle pietre, colò a picco e s’annegò. I capretti e la loro mamma ne furono molto felici.
* PAROLE D’AUTORE: FIABE CLASSICHE
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- COSTITUZIONE ED EDUCAZIONE CIVICA. LA LEZIONE DI GAETANO FILANGIERI, IL PARTITO DI "FORZA ITALIA" E IL COLPO DI STATO DI SILVIO BERLUSCONI.
 "PUBBLICITA’ PROGRESSO": L’ITALIA E LA FORZA DI UN MARCHIO REGISTRATO!!!
"PUBBLICITA’ PROGRESSO": L’ITALIA E LA FORZA DI UN MARCHIO REGISTRATO!!!

 L’ITALIA NELLO STALLO, IL "GOLPE MORALE", E IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
L’ITALIA NELLO STALLO, IL "GOLPE MORALE", E IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
 "Il Quirinale da solo non basta", ma solo il Quirinale può rimuovere l’inaudita vergogna di un Presidente di un Partito dal nome di "Forza Italia", di "Popolo della libertà", di "Italia"!!!
"Il Quirinale da solo non basta", ma solo il Quirinale può rimuovere l’inaudita vergogna di un Presidente di un Partito dal nome di "Forza Italia", di "Popolo della libertà", di "Italia"!!!
 PER L’ITALIA E PER LA COSTITUZIONE, CARO PRESIDENTE NAPOLITANO, CREDO CHE SIA ORA DI FARE CHIAREZZA. PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI
PER L’ITALIA E PER LA COSTITUZIONE, CARO PRESIDENTE NAPOLITANO, CREDO CHE SIA ORA DI FARE CHIAREZZA. PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI
Forum
-
> L’ASTUZIA DEL LUPO E I SETTE CAPRETTI. -- PERDERE LA TESTA E RICADERE NEL SACCO, NELLA TRADIZIONALE CAVERNA DELL’ "HOMO HOMINI LUPUS".10 febbraio 2023, di Federico La Sala
FILOLOGIA E ANTROPOLOGIA: NATURA, INTELLIGENZA ASTUTA, E GRATITUDINE ...
Una sollecitazione a pensare al "mondo divenuto favola" (lezione di Esopo, Fedro, e Nietzsche): come la filosofia, la teologia, e la politica mondiale, senza più Grazia (gr.: XAPIS, "CHARIS") e senza più Grazie (gr.: XAPITES, "CHARITES") perde la testa e ricade nel sacco, nella tradizionale "luminosa" caverna dell’ "homo homini lupus est" ... Dov’è l’etica? E dove la carità (gr. XAPITAS, "CHARITAS") della stessa grazia ("charis")?!
 MEMORIA: "L’AMORE NON è LO ZIMBELLO DEL TEMPO" (W. Shakespeare, Sonetto 116).
MEMORIA: "L’AMORE NON è LO ZIMBELLO DEL TEMPO" (W. Shakespeare, Sonetto 116).- Il lupo e il contadino
- Un lupo supplicò un contadino di nasconderlo ma, quando il pericolo fu passato, saltò fuori e volle mangiarsi il suo salvatore. «Non è giusto che tu mangi chi ti ha aiutato!» esclamò il contadino, ma il lupo ribatté: «Nessuno mai ricorda i benefici ricevuti. Perché dovrei essere io il primo a ricordarlo?». «Ti prego, lupo, sentiamo cosa ne pensano i passanti, prima di decidere».
- Si trovava a passare di là un vecchio cane e confermò che il suo padrone, dopo anni di fedele servizio lo trattava, ora che non gli era più utile, con immensa ingratitudine. Giunse anche un cavallo e ammise di aver ricevuto lo stesso trattamento del cane.
- Il contadino oramai disperava di dissuadere il lupo dal mangiarlo e quindi di salvarsi quando, d’improvviso, vide arrivare una volpe e, confidando nella sua astuzia, le fece un cenno d’intesa e rivolgendosi al lupo disse: «Interroghiamo anche quest’ultimo passante, poi farai quello che vorrai». «Volpe cara, questo lupo non vuole essermi grato di averlo nascosto nel sacco dai cacciatori che lo inseguivano. Cosa ne pensi?».
- E la volpe: «Un lupo così grosso in un sacco così piccolo? Non posso crederlo. Fatemi vedere.» Il lupo rientrò nel sacco e subito la volpe aiutò il contadino a chiuderlo ben bene con un grosso nodo. L’uomo prese allora un bastone, riempì di legnate il lupo ch’era dentro il sacco e poi si girò verso la volpe e atterrò anche lei con un gran colpo in testa esclamando poi: «Sai, volpe? A forza di dirmelo hanno convinto anche me che la gratitudine non esiste affatto!».
PSICOANALISI E "DISAGIO NELLA CIVILTÀ" (S. FREUD, 1929): "Il sentimento di gratitudine è una delle espressioni più evidenti della capacità di amare. La gratitudine è un fattore essenziale per stabilire il rapporto con l’oggetto buono e per poter apprezzare la bontà degli altri e la propria. (Melanie Klein).
-
> L’ASTUZIA DEL LUPO E I SETTE CAPRETTI. --- Gianni Rodari, il comunista delle filastrocche (di Vanessa Roghi).18 gennaio 2021, di Federico La Sala
Cultura
Gianni Rodari, il comunista delle filastrocche
ITINERARI. Dall’adesione al partito al metodo rivoluzionario del marxismo critico. Il suo punto di riferimento è Gramsci, perfettamente inscritto nella tradizione umanistica italiana. Essere nel Pci nell’Italia del 1945 non è come esserlo solo due anni dopo. I comunisti sono chiamati, insieme a tutte le forze laiche e cattoliche, a scrivere la Costituzione
di Vanessa Roghi (il manifesto, 17.01.2021)
- [Foto] Gianni Rodari
Chiamato nel 1950, dal Pci, a scrivere un’autobiografia per tracciare il suo percorso politico durante il ventennio, Gianni Rodari racconta il momento della scelta, durante la guerra di Etiopia. «In quell’epoca i miei filosofi erano Nietzsche, Stirner e Schopenhauer e trovavo ridicolo l’Impero». Amici operai sono il tramite a letture proibite: «In casa di uno di questi conobbi uno che ‘era stato un comunista’ nel 1921, il compagno Furega Francesco, muratore, della sezione di Gavirate, che mi raccontò a suo modo la nascita del fascismo».
Grazie a questo gruppo clandestino Rodari legge «una ‘vita di Lenin’, una di Stalin, e l’autobiografia di Trockij e la storia della Rivoluzione dello stesso Trockij. Queste opere ebbero due risultati: quello di portarmi a criticare coscientemente il corporativismo e quello di farmi incuriosire sul marxismo come concezione del mondo».
FINITA LA GUERRA, Gianni Rodari diventa un militante del Pci. Il suo punto di riferimento (suo e di tanti) è ovviamente Antonio Gramsci, perfettamente inscritto nella tradizione umanistica italiana, è la miglior difesa contro l’accusa che viene mossa al Pci di essere una mera espressione dello stalinismo in salsa mediterranea. Questo diventa chiaro con i Quaderni dal carcere (1947) che Palmiro Togliatti sceglie di far pubblicare dall’editore Einaudi e non da un editore comunista: Gramsci è esso stesso parte della cultura nazional popolare, è di tutti, e tutti con Gramsci devono fare i conti.
Nel 1948 Gianni Rodari scrive: «in Gramsci vive un tipo nuovo di «uomo di cultura. (...) La sua lotta contro Croce è un continuo smascheramento di posizioni teoriche e teoretiche che si presentano come posizioni universali e disinteressate dello spirito, per rilevarne il significato ed il valore storico di strumenti della conservazione sociale».
 Il marxismo è un metodo, è costante ricerca, è scoperta della realtà, svelamento della conservazione.
Il marxismo è un metodo, è costante ricerca, è scoperta della realtà, svelamento della conservazione.INSIEME A GRAMSCI, il marxismo di Rodari si nutre di Bertolt Brecht di cui traduce nel 1945 La linea politica. Il poeta tedesco rappresenterà un riferimento costante sul senso di essere scrittori e comunisti: «Tebe dalle Sette Porte, chi la costruì? Ci sono i nomi dei re, dentro i libri. Son stati i re a strascicarli, quei blocchi di pietra?». Nella Storia degli uomini pubblicata a puntate su Vie nuove nel 1958 così come nella Storia universale, Rodari risponde: «C’erano solo gli uomini con due braccia per lavorare». Lo scrittore comunista, dunque, non ha solo come suo ideale committente il movimento operaio ma si impegna ad ascoltarne la voce nella storia.
ESSERE NEL PCI nell’Italia del 1945 non è come esserlo solo due anni dopo. I comunisti infatti sono chiamati, insieme a tutte le forze laiche e cattoliche, a scrivere la Costituzione e fondare la Repubblica. Ma, dopo il 1947, con l’estromissione del Pci dal governo e l’inizio della guerra fredda, la divisione del mondo in blocchi si ripercuote concretamente nell’attività dei militanti italiani. Serve un giornalismo che racconti i motivi di questa frattura e delinei i caratteri dell’’uomo nuovo’ comunista: questo fa Rodari sull’Unità. E quando il Pci gli chiede di scrivere per i bambini, lui accetta. «La generazione che il Pci ha rastrellato durante la Resistenza è quella che meno si è preoccupata di vocazioni personali».
Anche la direzione de Il Pioniere nel 1950 è un incarico che Rodari accetta per disciplina: lo obbliga infatti a lasciare Milano e trasferirsi a Roma. Ed è proprio per il suo ruolo centrale nella costruzione di una stampa popolare per ragazzi che interviene nel 1951 nella nota polemica sui fumetti con Nilde Iotti e Palmiro Togliatti: una polemica spesso presentata come la prova del fatto che Rodari fosse un comunista «eretico». In realtà una normale discussione, tipica del tempo (tesi, antitesi, sintesi del segretario) in cui alla fine Rodari e Togliatti non sono poi così distanti.
IOTTI INFATTI STIGMATIZZA il fumetto americano, violento. Rodari contesta l’opinione che non possano darsi fumetti «diversi da quelli americani» e conclude auspicando «la nascita di una nuova letteratura per l’infanzia» che comprenda accanto ai libri i fumetti. Togliatti rilancia dicendo che auspica «di riuscire a creare una letteratura e una pubblicistica per bambini e ragazzi che attirino, piacciano, educhino». E questo proverà a fare Gianni Rodari, sui periodici comunisti degli anni Cinquanta.
Nel 1956 rimane nel Pci, nel 1958 però passa a Paese sera, lasciando l’Unità. Secondo alcuni critici la militanza comunista di Rodari si farebbe più blanda a partire dal 1960, in coincidenza con la pubblicazione dei suoi libri con Einaudi. Rodari è consapevole di questa diffidenza politica che per conto suo rigetta: sa di essere la «quinta colonna comunista nella grammatica italiana», come scrive parafrasando una stroncatura di Guareschi sul Borghese. Che la sua è la «via sbagliata al socialismo».
Il solco che si apre fra Rodari e la «politica culturale» del Pci è però compensato dal rapporto fecondo che lo scrittore ha con i suoi compagni che da Reggio Emilia al movimento dei genitori democratici rappresentano quella via italiana al socialismo che Rodari rivendicherà sempre, facendolo rimanere saldo dentro al partito (Perché ho dedicato il mio libro alla città di Reggio Emilia, 1974).
Le critiche mosse alla sua svolta linguistica sono il sintomo di quel marxismo critico che «non utopizza: ha già la cosa nella mano, e nella cosa stessa ha messo la sua morale e il suo idealismo», come ha scritto Antonio Labriola. Rodari, invece, a un certo punto, inizia a «utopizzare»: sarà l’incontro con la fiaba o con lo strutturalismo e la linguistica, o con i maestri dell’Mce, ma a Rodari l’utopia sembra importante come la vista o l’udito. Inevitabile, dunque, il mutare del suo sguardo sul comunismo sovietico che vede crollare come progetto proprio per l’incapacità politica di educare alla fantasia, indispensabile tassello dell’utopia.
SCRIVE NEL 1979: «faccio obiezioni alle uniformi uguali, rispondono ‘l’uniforme educa, serve alla disciplina’. Mai esprimere un parere personale. Tutti accettano le spiegazioni date. Non so come in una scuola del genere possa mai nascere un movimento, un’iniziativa dal basso. Del resto, è un problema di tutto il sistema di democrazia socialista»
 Scrive su questo una poesia: «La signora B dovette scendere a Brest/ le mancava il timbro dell’albergo/ compagni compagni cos’è come accade/ non avete fatto una rivoluzione/ per aumentare i timbri/ ma per distruggerli/ io non vi farò la lezione/ non dirò al russo che ha pagato per me/ che nella sua rivoluzione mancava qualcosa/ anch’io sono comunista/ tale mi chiamo per dare un nome alla speranza».
Scrive su questo una poesia: «La signora B dovette scendere a Brest/ le mancava il timbro dell’albergo/ compagni compagni cos’è come accade/ non avete fatto una rivoluzione/ per aumentare i timbri/ ma per distruggerli/ io non vi farò la lezione/ non dirò al russo che ha pagato per me/ che nella sua rivoluzione mancava qualcosa/ anch’io sono comunista/ tale mi chiamo per dare un nome alla speranza».Essere comunista è, dunque, un modo di dare un nome alla speranza. Rodari rigetta l’alternativa imposta ai poeti dal comunismo: essere poeti rivoluzionari o essere poeti della rivoluzione. La rivoluzione è un metodo. Guarda con diffidenza gli apocalittici suoi coetanei, con simpatia il movimento del 1977 con i suoi slogan in rima, figli delle sue filastrocche. Il Pci non gli riconoscerà mai alcun incarico ufficiale nel nazionale, e abbandonerà il Giornale dei genitori che Rodari dirige dal 1968. Amareggiato, in una lettera scrive: «Se quando in Italia si parla di letteratura infantile bisogna fare al primo posto il nome di un comunista, con tutto quel che la cosa comporta, qualche merito ce l’ho anch’io».
*
Graphic novel: «Sepolti vivi», la protesta di trecento minatori
Tra Cabernardi e Percozzone, vicino a Ancona, nelle Marche si trovava, nel dopoguerra, la più grande miniera di zolfo di Europa, di proprietà della Montecatini che, nel 1952, aveva deciso di chiudere e chiudendo licenziare tutti gli operai. Così nacque la protesta che vide più di 300 minatori asserragliarsi al 13° livello della miniera per più di un mese. Gianni Rodari, scrisse in quella occasione una lunga inchiesta su Vie nuove, rotocalco comunista: Viaggio sulla terra dei sepolti vivi, intrecciando, nel racconto, la battaglia politica e le storie private di chi fu protagonista dell’occupazione. Una di queste storie è quella di Ernesto Donini, un giovane minatore di Pergola che «voleva vedere la moglie, Maria, dopo ventiquattro giorni, almeno per un istante». Così i due escogitarono un modo di incontrarsi per un breve saluto all’uscita di sicurezza, presidiata dai celerini.
 «Tredici livelli di miniera significano ventisei rampe di scale, ogni rampa supera un dislivello pari a cinque o sei piani di una casa moderna. Questa ’uscita di sicurezza’ assomiglia da vicino alla tormentosa invenzione di uno scrittore fantastico». Al loro incontro Ciro Saltarelli e Silvia Rocchi si sono ispirati per un graphic novel pubblicato da El (Einaudi ragazzi, pp. 96, euro 14). Inedito e bellissimo omaggio al fantastico scrittore. (vanessa roghi)
«Tredici livelli di miniera significano ventisei rampe di scale, ogni rampa supera un dislivello pari a cinque o sei piani di una casa moderna. Questa ’uscita di sicurezza’ assomiglia da vicino alla tormentosa invenzione di uno scrittore fantastico». Al loro incontro Ciro Saltarelli e Silvia Rocchi si sono ispirati per un graphic novel pubblicato da El (Einaudi ragazzi, pp. 96, euro 14). Inedito e bellissimo omaggio al fantastico scrittore. (vanessa roghi)* Scheda. «Enciclopedia» per lo scrittore
A conclusione del centenario della nascita di Gianni Rodari, Electa dedica allo scrittore il secondo titolo della nuova collana Enciclopedia: «Rodari, A-Z», autori vari, a cura di Pino Boero e Vanessa Roghi, pp. 320, euro 34). Una sequenza di voci correlate e indipendenti, insieme a una biografia illustrata con fotografie, copertine di libri per raccontare un fantasioso editorialista, ironico polemista, grande riformatore della scuola, attento osservatore del rapporto fra grandi e piccoli, nonché esploratore della letteratura e artefice di racconti incantati che hanno affascinato molte generazioni. Come fosse un abecedario letterario, il volume è composto da 84 voci scritte da 56 autori. Come spiegano i curatori, «è un invito a un cambio di prospettiva. Abbiamo pensato che Rodari non dovesse essere guardato con una lente di ingrandimento ma semmai con un cannocchiale, da lontano». Così, a spiare la sua figura da lontano, sono docenti, pedagogisti, giornalisti, intellettuali e accademici, si va dal mondo dell’editoria e dell’infanzia a quello della militanza politica, dai luoghi della vita e del lavoro alle passioni per i libri e le riviste.
-
> L’ASTUZIA DEL LUPO E I SETTE CAPRETTI. "APRITE, APRITE" --- COSTITUZIONE, INFANZIA, E FIABA. Vita e opere di Gianni Rodari, l’eterno bambino31 gennaio 2020, di Federico La Sala
“Le fiabe sono il luogo di tutte le ipotesi”: vita e opere di Gianni Rodari, l’eterno bambino
A 100 anni dalla nascita vogliamo celebrare Gianni Rodari, lo scrittore che, con le sue storie rivolte ai bambini di tutto il mondo, ha rivoluzionato la letteratura per ragazzi, dando voce a luoghi e personaggi che neanche si pensava l’avessero, la voce. Facendo (ri)scoprire a diverse generazioni il piacere della lettura
di Martina Marasco *
L’approfondimento sui libri e la vita dell’autore
A volersi impegnare, forse si può trovare un adulto di oggi che non conosca neanche una filastrocca, una poesia o una favola di Gianni Rodari - ma bisogna impegnarsi parecchio.
A 100 anni dalla sua nascita vogliamo celebrare lo scrittore che, con le sue storie rivolte ai bambini di tutto il mondo, ha rivoluzionato la letteratura per ragazzi, dando voce a luoghi e personaggi che neanche si pensava l’avessero la voce, facendo (ri)scoprire a diverse generazioni il piacere della lettura.
Giovanni Rodari nasce il 20 ottobre 1920 a Omegna, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola. Resta in Piemonte fino alla morte del padre, nel 1929, quando si trasferisce a Ranco, un paesino in provincia di Varese sulle sponde del Lago Maggiore. Lì si diploma come maestro a soli 17 anni e inizia a insegnare nella scuola elementare del paese. Resta nel varesotto fino al 1943, quando, durante la seconda guerra mondiale, è costretto a prestare servizio presso l’Ospedale Militare di Baggio.
Nonostante abbia iniziato a pubblicare i suoi libri molto più tardi, gli anni a Varese si manifesteranno più volte nel corso della sua poetica. Basti pensare al celebre incipit di Favole al telefono, “C’era una volta il ragionier Bianchi di Varese”, o ai racconti della signorina Bibiana, alla leggenda del lago di Varese o a parecchie delle sue filastrocche - citiamo, tra le tante, il Terzo indovinello: “Un dottore di Cesena andò a letto senza cena. La domanda impertinente è la seguente: aveva fame perché era un dottore o perché a Cesena non c’è il Lago Maggiore?”.
È nel 1944 che comincia ad avvicinarsi al Partito Comunista e a intraprendere il mestiere che lo accompagnerà per gran parte della sua vita: il giornalista. Dopo la Liberazione, infatti, comincia a lavorare dapprima all’Unità con la rubrica La domenica dei piccoli e poi, nel 1950, si trasferisce a Roma dove fonda, insieme a Dina Rinaldi, il giornale per ragazzi il Pioniere.
L’anno successivo Gianni Rodari è scomunicato. Il Vaticano, infatti, contesta duramente il lavoro dello scrittore, dichiarandolo “un ex-seminarista cristiano diventato diabolico” (in relazione al fatto che, prima dell’insegnamento, la madre lo spinse in seminario) e ordina di bruciare nei cortili degli oratori le copie del Pioniere, e i primi libri di Rodari, come Il libro delle filastrocche (1951) o Il romanzo di Cipollino (1951).
Ma per tornare a leggere Rodari, non bisogna aspettare poi molto: Giulio Einaudi, infatti, pubblica intorno alla metà degli anni ‘50 quelli che sono ancora oggi i suoi capolavori: Filastrocche in cielo e in terra, Favole al telefono, Il pianeta degli alberi di Natale, Il libro degli errori: il successo è immediato, e nel 1970 Rodari è insignito del Premio Andersen.
Nel 1973 viene pubblicato il suo capolavoro pedagogico, l’unico saggio indirizzato non ai bambini, ma agli insegnanti, ai genitori e a coloro che avevano a che fare con i più piccoli: Grammatica della Fantasia; introduzione all’arte di inventare storie.
I temi vengono a galla con facilità: il bisogno di un assoluto laicismo all’interno della scuola, l’importante impronta antifascista, gli ideali pacifisti e la centralità dell’espressione del bambino - un aneddoto vuole che i primi editor dei suoi romanzi furono proprio i suoi alunni del varesotto - la libertà di espressione e la morale innecessaria, che lascia al bambino la possibilità di trarre le proprie conclusioni.
Nel 1980 Rodari si fa ricoverare a Roma per un’operazione alla gamba sinistra; quattro giorni dopo, muore a causa collasso cardiaco. Dagli anni ‘80 a oggi i suoi libri sono stati pubblicati in moltissime edizioni, letti e studiati, senza la percezione che le storie narrate siano scritte 70 anni fa.
Forse la potenza dell’autore sta proprio in questo, nella sua capacità di essere attuale dopo tanto tempo, di far emozionare i bambini di oggi e i bambini di ieri nei genitori di oggi, senza risultare obsoleto o fuori luogo, fuori tempo.
Favole al telefono (1962)
- Favole al telefono Gianni Rodari
“C’era una volta il ragionier Bianchi di Varese. Era un rappresentante di commercio e sei giorni su sette girava l’Italia intera vendendo medicinali. La domenica tornava a casa sua, e il lunedì ripartiva. Ma prima che partisse la sua bambina gli diceva: ‘Mi raccomando, papà: tutte le sere una storia’”.
Così, ogni sera, il ragioniere cercava un telefono a gettoni e chiamava la sua bambina, per raccontarle una storia. Le storie non erano mai troppo lunghe - con quello che costava una telefonata - ma lo erano abbastanza per far addormentare col sorriso tutti i bambini del mondo.
Favole al telefono contiene gioielli di poesia difficili da imitare: uno specchio della sensibilità per cui l’autore è famoso. Un esempio fra tutti, la favola Inventare i numeri.
“Quanto costa questa pasta?”
 “Due tirate d’orecchi”.
“Due tirate d’orecchi”.
 “Quanto c’è da qui a Milano?”
“Quanto c’è da qui a Milano?”
 “Mille chilometri nuovi, un chilometro usato e sette cioccolatini”.
“Mille chilometri nuovi, un chilometro usato e sette cioccolatini”.
 “Quanto pesa una lacrima?”
“Quanto pesa una lacrima?”
 “Secondo: la lacrima di un bambino capriccioso pesa meno del vento, quella di un bambino affamato pesa più di tutta la Terra”.
“Secondo: la lacrima di un bambino capriccioso pesa meno del vento, quella di un bambino affamato pesa più di tutta la Terra”.Il libro degli errori (1964)
- Il libro degli errori Gianni Rodari
In una lettera a Giulio Bollati, Rodari spiega di aver scritto un libro che raggruppa filastrocche e racconti basati sugli errori di ortografia. L’errore è la materia: l’autore vuole far passare l’errore ideologico nascosto da quello ortografico. C’è un’Itaglia sbaiata nelle antologie scolastiche, e a quindici anni dalla caduta del fascismo i testi sono pieni di realtà da correggere.
L’errore si fa anche portavoce della disubbidienza alle regole, quelle sbagliate, se si vuole davvero cambiare il mondo. Un libro necessario, italianissimo. Dice Rodari: “Gli errori hanno molti richiami regionali: la zeta dei milanesi, le doppie dei meridionali. Un libro molto italiano. Credi che vi possa interessare?”.
Ladro di “erre” può essere un ottimo esempio:
“[...] io non mi meraviglio
 che il ponte sia crollato,
che il ponte sia crollato,
 perché l’avevano fatto
perché l’avevano fatto
 di cemento “amato”.
di cemento “amato”.Invece doveva essere
 “armato”, s’intende,
“armato”, s’intende,
 ma la erre c’è sempre
ma la erre c’è sempre
 qualcuno che se la prende.
qualcuno che se la prende.Il cemento senza erre
 (oppure con l’erre moscia)
(oppure con l’erre moscia)
 fa il pilone deboluccio
fa il pilone deboluccio
 e l’arcata troppo floscia.
e l’arcata troppo floscia.In conclusione, il ponte
 è colato a picco,
è colato a picco,
 e il ladro di ‘erre’
e il ladro di ‘erre’
 è diventato ricco [...]”.
è diventato ricco [...]”.La grammatica della fantasia (1973)
- Grammatica della Fantasia Gianni Rodari
“L’incontro decisivo tra i ragazzi e i libri avviene sui banchi di scuola. Se avviene in una situazione creativa, dove conta la vita e non l’esercizio, ne potrà sorgere quel gusto della lettura col quale non si nasce perché non è un istinto. Se avviene in una situazione burocratica, se il libro sarà mortificato a strumento di esercitazioni (copiature, riassunti, analisi grammaticale eccetera), soffocato dal meccanismo tradizionale: “interrogazione-giudizio”, ne potrà nascere la tecnica nella lettura, ma non il gusto. I ragazzi sapranno leggere, ma leggeranno solo se obbligati”.
Pubblicato nel 1973, La grammatica della fantasia è la summa di una serie di lezioni che Gianni Rodari aveva tenuto, nel 1972, a maestri, genitori, educatori nella città di Reggio Emilia. Unica opera saggistica, come suggerisce il sottotitolo Introduzione all’arte di inventare storie, La grammatica della fantasia si propone di insegnare agli adulti e ai bambini come leggere, scrivere e raccontare storie, imparando a sfruttare il mezzo più importante che abbiamo, ossia la parola, senza dimenticarsi della fantasia, che dovrebbe essere necessaria nell’educazione. Parafrasando le parole dello stesso Rodari, il valore della liberazione che può avere la parola è fondamentale per tutti; non perché tutti siano artisti, ma perché nessuno sia schiavo.
Le filastrocche
- Filastrocche in cielo e in terra Gianni Rodari
Il libro delle filastrocche (1950), Il treno delle filastrocche (1952), Filastrocche in cielo e in terra (1960), Filastrocche del cavallo parlante (1970), La filastrocca di Pinocchio (1974); postume, Filastrocche lunghe e corte (1981), Il secondo libro delle filastrocche (1985), Filastrocche per tutto l’anno (1986). Le filastrocche di Rodari sanciscono la sua celebrità, vengono lette nelle scuole, fatte imparare a memoria. Ci sono le Favole al rovescio, col lupo che scappa da Cappuccetto Rosso o la Bella Addormentata che non dorme; ci sono pellerossa che vanno a trovare Gesù bambino nel Presepe, scuole in cui, sui banchi, ci sono i grandi e non i piccini, pani così grandi che saziano tutto il mondo, c’è Napoli senza sole, ci sono l’ago, l’ama, Don Chisciotte e persino il Re Sole. Tra le tante, tantissime, ne vogliamo riportare una delle più significative; si intitola Promemoria.
Promemoria
“Ci sono cose da fare ogni giorno:
 lavarsi, studiare, giocare,
lavarsi, studiare, giocare,
 preparare la tavola,
preparare la tavola,
 a mezzogiorno.
a mezzogiorno. Ci sono cose da fare di notte:
Ci sono cose da fare di notte:
 chiudere gli occhi, dormire,
chiudere gli occhi, dormire,
 avere sogni da sognare,
avere sogni da sognare,
 orecchie per non sentire.
orecchie per non sentire. Ci sono cose da non fare mai,
Ci sono cose da non fare mai,
 né di giorno né di notte,
né di giorno né di notte,
 né per mare né per terra:
né per mare né per terra:
 per esempio, la guerra”.
per esempio, la guerra”.* Il Libraio, 27.01.2020 (ripresa parziale - senza immagini).
-
> L’ASTUZIA DEL LUPO E I SETTE CAPRETTI. -- Così i bambini imparano a distinguere sincerità e bugia. La lectio di Silvia Vegetti Finzi (Festivalfilosofia 2028).13 settembre 2018, di Federico La Sala
Parte il Festivalfilosofia
Mamma, ho assaggiato la verità
Da venerdì 14 settembre a Modena, Carpi e Sassuolo la 18ª edizione, dedicata al vero.
La lectio di Silvia Vegetti Finzi: così i bambini imparano a distinguere sincerità e bugia
di SILVIA VEGETTI FINZI (Corriere della Sera, 13.09.2018)
Niente è più difficile che definire la verità, tanto che i dizionari se la cavano con una tautologia: per lo Zingarelli la verità è «la qualità di ciò che è vero», per la Treccani il «carattere di ciò che è vero». Solo quando compare l’alternativa tra vero e falso, la verità diviene evidente. Altrimenti è come l’aria: si avverte solo quando manca. Poiché mentire è un’abilità assai precoce e i bambini in proposito la sanno lunga, per prima cosa diamo loro la parola.
Premetto che per essere tale una bugia deve presumere l’intenzione di mentire, ma questa consapevolezza richiede un’evoluzione psichica piuttosto complessa che dobbiamo conoscere per non accusare e punire ingiustamente i bambini per colpe che non sono in grado di comprendere.
Dapprima la verità si riferisce all’esistenza concreta, alla realtà immediata, all’evidenza delle cose. Per i più piccoli la verità si dispiega dinnanzi ai loro occhi, è quello che vedi, che senti, che puoi toccare e assaggiare. Sino a tre anni confondono fantasia e realtà, desiderio e verità. Quando si sentono accusati mentono spontaneamente senza preoccuparsi della verosimiglianza delle loro giustificazioni, come Marcello che incolpa il fratellino di due mesi di aver rotto il lampadario con una pallonata. Nel frattempo, prima di punire un bambino meglio chiedersi: «Perché mente?», «lo abbiamo messo davvero in condizione di essere sincero?».
A quattro la verità è nei fatti per cui è più grave rompere quattro bicchieri senza farlo apposta che uno intenzionalmente. Ma già a sette anni i bambini colgono appieno il valore della verità quando osservano: «È preziosa»; «è una cosa che ti fa star bene», «è nella famiglia», come risulta dalle interviste raccolte dall’insegnante Marta Versiglia , nelle classi seconda e quarta di una scuola elementare di Piacenza.
Verso i nove anni la verità s’interiorizza, diventa una questione personale: «Per me la verità è dire cose che so solo io», «è un segreto», una «emozione che ti comunica un senso di gioia e di liberazione». Mentre prima era nei fatti, ora diventa un impegno morale: «La mia verità è fare cose belle e non cose brutte», «la verità la devi dire altrimenti più nessuno crederà in te».
Il verbo «dovere», sempre più frequente col progredire dell’età, rappresenta la voce degli educatori, genitori e insegnanti, ma già emergono atteggiamenti di autonomia morale. Le motivazioni espresse rivelano una differenza profonda tra la morale maschile, razionale, generica e astratta, e la morale femminile, più attenta ai rapporti interpersonali e ai sentimenti. Per Pietro la verità è pace nel mondo, per Corrado amicizia, per Fabio giustizia, per Guido fiducia e rispetto.
Jasmin invece, come altre compagne, situa la verità nei rapporti reciproci, nello scambio di parole e di affetti: «La verità è essere sinceri anche nei momenti peggiori, non incolpare nessuno e chiedere scusa quando abbiamo sbagliato noi». Per Angela la verità bisogna dirla per non vergognarsi di fronte alle amiche. Per Carlotta per non far male agli altri. Per Michela: «È fiducia nei propri genitori - e osserva - alcune volte però, ma poche, non bisogna dirla per non far stare male le persone». «Io come tutti avrò detto delle bugie - confessa Alba - però crescendo sono consapevole di ciò che sta succedendo».
Emerge tuttavia il sospetto che la bugia non riguardi soltanto i bambini. Scrive un alunno di quarta: «A volte anche i grandi mentono» ma subito si rassicura: «Lo fanno per il nostro bene».
Spesso ci dimentichiamo che i bambini crescono in costante relazione con adulti che mentono quanto e ben più di loro. Mentono per gioco quando li lusingano esclamando: «Sei un campione!» o «ecco la mia principessa». E mentono in modo ben più grave quando, convinti di proteggerli, nascondono o falsificano questioni fondamentali, senza riflettere sulle conseguenze dei loro atti. Gli effetti della menzogna sono diversi se il bambino è soggetto oppure oggetto di una affermazione reticente o falsa.
La bugia del bambino fa parte di un processo di sviluppo che evolve da una spontanea reazione di difesa alla consapevolezza della propria volontà, della propria responsabilità. Quella dell’adulto costituisce invece un’azione responsabile da valutare in termini morali, considerando intenzioni e conseguenze, senza concedersi facili alibi.
Il bambino che sa di mentire si vergogna della sua debolezza mentre quello ingannato dalle persone che ama si sente impotente e smarrito. Tuttavia, nonostante sia un’esperienza dolorosa, l’incontro con la bugia ha un aspetto positivo perché lo aiuta a superare la pretesa di un sapere onnipotente, rivelandogli che ognuno conserva in sé una zona di segreto e di mistero.
Nonostante ogni smentita, la convinzione che il desiderio sia in grado di soddisfarsi da solo perdura nel sogno, nelle fantasie, nel gioco, nel pensiero magico, nelle favole e nei miti.
L’immaginazione, per quanto irreale, svolge una funzione consolatoria e creativa. Basta pensare all’amico immaginario che il bambino troppo solo evoca per farsi compagnia. Se il genitore lo deride o gli ingiunge di non dire stupidaggini, si sentirà ferito e, chiudendosi in se stesso, smetterà di esprimere il suo mondo interiore. La bugia, iscritta nel tessuto della comunicazione, negli equivoci che costellano ogni scambio, si rivela patologica quando diviene una modalità reiterata, quasi coatta di interagire con sé stessi e con gli altri, quando il bambino inganna e si inganna e come forma di vita, come modalità predominante di difesa e di reazione.
Dapprima il bambino, che fa propria la verità dei familiari, è convinto di essere ciò che gli altri pensano di lui. Solo con la pubertà si porrà il compito di definire sé stesso, di delineare la sua identità. Un compito particolarmente arduo in questi anni quando gli adolescenti, alle prese con la difficoltà di crescere, vengono attratti dalle suggestioni del mondo virtuale, dove tutto appare possibile e reversibile. Che cosa possono fare gli educatori per proteggerli e guidarli? Oltre alle regole di comportamento quotidiano, ormai note, è fondamentale rendere le esperienze dei ragazzi concrete e vive, affascinanti e promettenti. Il mondo reale deve proporre un futuro realizzabile attraverso la responsabilità dei propri desideri e la condivisione degli obiettivi.
In ogni caso la verità è una condizione necessaria all’integrità personale e alla vita sociale: di menzogna si muore. Dopo tante variabili, una domanda torna ad assillarci: è possibile raggiungere la coincidenza del vero e del fatto, del sentire e del dire?
Come sostiene Karl Jaspers, la verità non è mai un possesso assoluto e definitivo ma tensione e ricerca. Per noi che viviamo nell’esserci del tempo, la verità è un obiettivo al tempo stesso impossibile e ineludibile. Eppure è questa contraddizione che ci rende umani.
Il festival
Da venerdì 14 a domenica 16 settembre Modena, Carpi e Sassuolo ospitano la diciottesima edizione del Festivalfilosofia che quest’anno è dedicato al tema della verità. In programma circa 200 eventi in vari luoghi delle tre città: lezioni magistrali, mostre, concerti, incontri, letture, per bambini, spettacoli, cene filosofiche. Tra gli ospiti, Silvia Vegetti Finzi che terrà la sua lectio magistralis sul tema «I bambini e la verità» sabato 15 a Carpi (piazza Martiri, ore 20.30)
-
> L’ASTUZIA DEL LUPO E I SETTE CAPRETTI. - Come nelle favole, a 24 ore dall’inizio tutto svanisce. Silvio mette in trappola i due vincitori. Napolitano per Gentiloni.23 marzo 2018, di Federico La Sala
Silvio mette in trappola i due vincitori
di Lucia Annunziata (La Stampa, 23.03.2018)
Per diciannove giorni esatti, due uomini, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, hanno girato l’Italia in lungo e in largo, in un tour della vittoria, raccontando a tutti di aver vinto le elezioni. Intessendo intorno a questo concetto un racconto fatto di emozioni («saremo sempre fedeli a chi ci ha scelto») e parole d’ordine («nulla sarà come prima») che ha rapito anche le migliori menti nella seduzione di una idea - l’inevitabilità di un governo Lega-M5S, dannazione, disperazione, entusiasmo, come preferite, in Europa, in Usa, in Russia.
Ma, come nelle favole, a 24 ore dall’inizio della prima scelta che avvia la strada per formare un esecutivo, tutto svanisce, e i due uomini, Salvini e Di Maio, come la ragazza che porta la ricottina al mercato, scoprono che la vittoria nelle urne è stata solo un rapido sguardo riflesso in uno specchio. Avevano fatto un accordo che contentava entrambi: al primo la presidenza del Senato, al secondo la presidenza della Camera. Intesa viatico di un futuro accordo di governo.
Salvo scoprire che per fare un governo ci vuole ben altro dei voti fin qui raccolti, e molto molto altro che una semplice somma numerica.
È bastato che si rialzasse dal suo dispiacere il vecchio leone della politica italiana, per scompigliare ogni progetto. Nelle prime ore dopo i risultati sembrava morta, Forza Italia. Vergognosa, schiacciata dal sorpasso inflittogli dalla Lega. Poi, tre giorni fa l’arrivo a Roma di Silvio Berlusconi.
A differenza degli altri leader che hanno solo partiti, il Cavaliere può contare anche su una poderosa macchina che ha costruito negli anni, e che, sebbene sminuita di peso, schiera un’ampia articolazione di ruoli e intelligenze, come Ghedini e Letta, giornali e televisioni, relazioni istituzionali e fedeltà consolidate. Fili sono stati tirati da questa macchina, progetti sono stati abbozzati. Discreti approcci, telefonate, amicizie riascoltate, una tela è stata sistemata, a Roma, per provare a rimettere l’esuberanza salviniana in un progetto logico. Un richiamo al realismo di un accordo: alla Lega l’incarico di governo, a Forza Italia la presidenza del Senato. Carica, quest’ultima da non sottovalutare, essendo la seconda dopo il Presidente, e la guida della più incerta delle ali del Parlamento, dove le maggioranze sono più ristrette e dunque più decisive.
Come mai questo ovvio accordo fra alleati non fosse stato definito finora, è una domanda superflua. La matematica anche in politica è una scienza esatta: un Salvini in uscita dalla coalizione con Forza Italia, per fare un governo con i Cinquestelle sarebbe stato il leader di una forza politica del 18 per cento che si univa a una forza politica con il 33 per cento. Un progetto suicida per se stesso e per tutta la destra.
L’accordo con i Cinquestelle era dunque, dopotutto, solo un po’ di scena, da parte di Salvini, per spingere la coalizione ad assicurargli l’incarico di fare il governo.
E per rendere nullo ogni accordo fin qui fatto tra Lega e Pentastellati non è stato nemmeno necessario fare una telefonata o mandare una nota: per Di Maio una cosa è giocare con Salvini, altro è allearsi con Berlusconi. L’intesa che doveva sconvolgere l’Italia si è rivelata alla fine solo un classico «teatrino» politico.
Potremmo persino felicitarci per questa lezione di realismo che scuote tutti ancora prima dell’insediamento del nuovo Parlamento. Se non fosse che ora sul tavolo non rimane uno straccio di idea su future maggioranze. Il Pd ex partito di governo oggi disorientato, diviso, è senza una strategia. Certo non gli sarà facile accodarsi a un centrodestra unito; d’altra parte non è nemmeno pronto a costruire un rapporto con l’acerrimo nemico M5S. In ogni caso, la lacerazione interna, dopo la sconfitta, lo tira su aree politiche opposte.
Gli M5S che finora pensavano di poter giocare usando i due forni, la Lega e il Pd, magari mettendoli su piani di competizione, oggi si ritrovano a dover cambiare del tutto schema.
Se il voto per le presidenze di Camera e Senato che inizia stamattina vedrà un centrodestra compatto sul nome di Romani, come è stato detto ieri sera dopo il vertice dei capigruppo, la destra sarà l’unica area con una strategia chiara.
Se c’è un incrocio dove nei prossimi giorni ogni accordo sarà fatto o disfatto, questo è l’incrocio fra piazza Venezia e via del Plebiscito, dove si erge Palazzo Grazioli, da anni casa del Cavaliere.
Napolitano, sgambetto a Renzi. “Gentiloni uomo giusto per il bis”
Il premier resta il più corteggiato: sempre alti i consensi nei sondaggi
di Fabio Martini (La Stampa, 22/02/2018)
ROMA. Dopo Romano Prodi, Walter Veltroni, Emma Bonino e Carlo Calenda, un po’ a sorpresa anche l’ex Capo dello Stato Giorgio Napolitano si produce in un energico endorsement a favore di Paolo Gentiloni e indirettamente fa lo “sgambetto” a Matteo Renzi. Durante una cerimonia all’Ispi, l’istituto di studi di politica internazionale, il presidente emerito ha scelto parole impegnative per motivare un premio che veniva conferito al premier: «Paolo Gentiloni è divenuto punto essenziale di riferimento per il futuro prossimo e non solo nel breve termine, della governabilità e stabilità politica dell’Italia», «un’attitudine all’ascolto e al dialogo e uno spirito di ricerca senza preclusioni da ministro degli Esteri e poi da presidente del Consiglio». Un elogio che è arrivato a sottolineare virtù irrituali: «La qualità della sua educazione famigliare e scolastica gli offre strumenti importanti per operare ai più alti livelli anche in futuro».
Un’ escalation di dichiarazioni di “voto” per Paolo Gentiloni che si incrocia con una tentazione coltivata in silenzio da Matteo Renzi, ma alla fine scartata: rendere esplicito in extremis una clamorosa “incoronazione” del presidente del Consiglio. Una tentazione che aveva qualche buon motivo ma anche una controindicazione che lo stesso leader del Pd confida: «In caso di largo intese, che noi non cerchiamo ma che potrebbero rendersi necessarie, è del tutto evidente che il candidato unico di una coalizione, per andare a palazzo Chigi, deve essere espresso dalla coalizione più forte». In altre parole, Gentiloni ha più chances di restare in campo se mantiene il suo attuale profilo “bipartisan”, anziché essere il candidato di un partito e di una coalizione. E poi c’è un’altra ragione che Renzi ha spiegato così ai suoi: «Se noi cambiamo lo spirito e la lettera del nostro Statuto soltanto perché i sondaggi suggeriscono qualcosa, allora un partito non ha più senso».
E tra i motivi che hanno sconsigliato un cambio di cavallo all’ultima ora, anche il timore di uno spaesamento tra gli elettori. È vero che è stabilmente elevata la fiducia che tutti i sondaggi attribuiscono a Gentiloni, tanto è vero che un mese fa un istituto tra i più quotati valutò in due punti percentuali in più una eventuale “cessione di sovranità” a favore del premier. Ma è altrettanto vero che nei comizi del Pd la presenza di Renzi - ovvero la sua evocazione da parte degli altri dirigenti - suscita ancora applausi e consensi e dunque esiste uno “zoccolo duro” da non deludere.
Certo, in queste ore Matteo Renzi sta cercando la carta per invertire una tendenza al ribasso che da sette mesi non si è più fermata. Anche perché negli ultimi giorni di campagna elettorale, Renzi lo sa bene, i numeri sono suscettibili di cambiamenti repentini e, come lui stesso ricorda, «nel 2013 nell’ultima settimana i Cinque Stelle recuperarono molti voti e il Pd ne perse». Oggi Renzi parlerà a Firenze e, annuncia, farà un discorso «alto, diverso dal solito».
A rendere il quadro ancora più incerto contribuisce una legge elettorale la cui traduzione dei voti in seggi parlamentari si sta rivelando un enigma. E proprio per questo motivo si sta intensificando la pressione anche da parte di personalità oramai fuori dalla mischia politica. Eppure, a dispetto di endorsement prestigiosi le chances per Gentiloni di una nuova stagione a palazzo Chigi sono legate a crescenti incognite. Certo, decisiva sarà la ripartizione dei seggi parlamentari tra i partiti, ma la novità che sta frenando le speranze dei fans di Gentiloni è un’altra ed appartiene alla sfera del non-detto: Berlusconi e Salvini, pur nella rivalità, hanno capito che se non raggiungeranno la maggioranza, dovranno convivere e spalleggiarsi nella ricerca di una soluzione per la guida di un governo - breve, di scopo o lungo - da condividere col Pd. E, al momento, il punto di intesa possibile non può non essere un premier vicino al centrodestra.
-
> L’ASTUZIA DEL LUPO E I SETTE CAPRETTI. -- LA COSTITUZIONE, I "DUE CORPI DEL RE", E I DUE PATTI DEL CITTADINO.28 febbraio 2018, di Federico La SalaLA SOVRANITÀ, LA DIGNITÀ DI OGNI CITTADINO E DI OGNI CITTADINA, E "I DUE CORPI DEL RE". La lezione di Kantorowicz...
 LA COSTITUZIONE, I "DUE CORPI DEL RE", E I DUE PATTI DEL CITTADINO. L’ analisi di Barbara Spinelli (2006)
LA COSTITUZIONE, I "DUE CORPI DEL RE", E I DUE PATTI DEL CITTADINO. L’ analisi di Barbara Spinelli (2006)
 I due corpi del re vanno tenuti disgiunti, perché resti vivo l’inaugurale patto che dissuade dalla guerra di tutti contro tutti, e che fonda un rapporto non effimero, non continuamente modificabile, fra i cittadini e chi li comanda.
I due corpi del re vanno tenuti disgiunti, perché resti vivo l’inaugurale patto che dissuade dalla guerra di tutti contro tutti, e che fonda un rapporto non effimero, non continuamente modificabile, fra i cittadini e chi li comanda.
-
> L’ASTUZIA DEL LUPO E I SETTE CAPRETTI. "APRITE, APRITE": SONO IL VOSTRO "PAPI"!!! --- Non sappiamo più raccontare le favole (di Massimo Gramellini).9 gennaio 2016, di Federico La Sala
- LA FIABA, LA FAVOLA, E ... LA "CONFUSIONE" DI GRAMELLINI.
- Innanzitutto invito a leggere l’articolo, e, nello stesso tempo, invito a tenere ben distinte le due parole "favola" e "fiaba" (due generi diversi di "racconti"), e, poi, a riflettere di più e meglio sull’inizio (tragico!) di "Pinocchio": "C’era una volta. - Un re! - diranno subito i miei piccoli lettori. - No, ragazzi, avete sbagliato. C’era una volta un pezzo di legno"!!!
 SI TRATTA della "storia di un burattino"!!! Già ai suoi tempi, Collodi aveva capito che gli italiani e le italiane non sapevano più di cosa parla una *fiaba* (Vladimir Ja. Propp) e non sapevano più nemmeno raccontarla... E CE LO GRIDAVA IN FACCIA!!!
SI TRATTA della "storia di un burattino"!!! Già ai suoi tempi, Collodi aveva capito che gli italiani e le italiane non sapevano più di cosa parla una *fiaba* (Vladimir Ja. Propp) e non sapevano più nemmeno raccontarla... E CE LO GRIDAVA IN FACCIA!!!
 Italo Calvino aveva capito la lezione di Collodi e perciò cercò di mettere in salvo le "Fiabe italiane"! Nella *fiaba*, infatti, è nascosta la chiave stessa della nostra dignità di esseri umani, della nostra sovranità, della sovranità di cittadini e di cittadine di una sana e robusta Costituzione (art. 3)!!! Per questo non è male accogliere le sollecitazioni e provocazioni di Gramellini e e rifletterci su...
Italo Calvino aveva capito la lezione di Collodi e perciò cercò di mettere in salvo le "Fiabe italiane"! Nella *fiaba*, infatti, è nascosta la chiave stessa della nostra dignità di esseri umani, della nostra sovranità, della sovranità di cittadini e di cittadine di una sana e robusta Costituzione (art. 3)!!! Per questo non è male accogliere le sollecitazioni e provocazioni di Gramellini e e rifletterci su...
- INSEGNAMENTO E COSTITUZIONE: CHI INSEGNA AI MAESTRI E ALLE MAESTRE A INSEGNARE?!
Non sappiamo più raccontare le favole
Un saggio americano: solo gli inglesi riescono a inventarle. Non hanno paura del lato oscuro
di Massimo Gramellini (La Stampa, 08/01/2016)
La rivista letteraria The Atlantic, americana, ha condotto un’inchiesta dettagliata ed è giunta alla conclusione che in quest’epoca di ansie assortite e lettori bisognosi di cure affabulatorie, soltanto gli inglesi siano ancora capaci di popolare l’immaginario dei bambini di ogni nazione ed età. Alla notizia che l’Inghilterra, magari con l’aggiunta dell’Irlanda, detenga l’esclusiva delle favole qualcuno storcerà il naso e opporrà le sue eccezioni, però è un fatto che il più formidabile parto fantastico degli ultimi decenni è stato il maghetto Harry Potter, britannico, la cui saga si inserisce in un filone avviato dai personaggi di Tolkien e C.S Lewis, britannici anch’essi. Sarà il rapporto più stretto con la natura e con i miti fondativi pagani, l’assenza di una religione troppo moralista e inibente, la passione diffusa per i saperi esoterici, ma gli inglesi (e gli irlandesi) sembrano avere conservato un seme di conoscenze antichissime e la capacità di diffonderle attraverso un codice di immagini e archetipi che non parla all’emisfero razionale del cervello, ma si rivolge direttamente al subconscio di tutti gli esseri umani.
Uno dei momenti più emozionanti della mia vita è stata la scoperta che, accanto al significato letterale, le favole ne celavano un altro simbolico. Uno dei momenti più tristi è stato accorgermi che di questa scoperta non importava niente quasi a nessuno. Eppure mi vengono ancora i brividi quando penso agli artisti illuminati che dalla notte dei tempi hanno rivestito i segreti dell’esistenza e persino le future rivelazioni della fisica quantistica con le metafore dei racconti per l’infanzia. Quando penso che la Bella e la Bestia è la storia dello spirito che si riconcilia con la materia. Che la spada nella roccia è un simbolo fallico e la sua estrazione da parte del giovane Artù un rito di iniziazione sessuale. Che il bacio del principe azzurro alla bella addormentata è la metafora di quel risveglio consapevole che sta alla base di ogni antica tradizione spirituale. Che la rinuncia al simbolo del potere - sia esso l’anello elfico che Frodo va a gettare nel vulcano di Mordor o la bacchetta di sambuco che Harry Potter decide di spezzare dopo averla vinta a lord Voldemort nel duello finale - è l’atto supremo di distacco che completa l’evoluzione interiore dell’eroe.
Non è importante comprenderli con la mente, certi significati reconditi. L’emozione della favola li porta egualmente là dove devono andare: al di sotto della corteccia dell’Ego, nel regno della coscienza che Jung chiamava il Sé. La lettura delle favole procede su due livelli. Il subconscio infatti non comprende le parole. Il suo alfabeto è fatto di immagini e suoni. Mentre il piccolo lettore ascolta le avventure di principi e principesse, da qualche parte dentro di lui si forma l’immagine simbolica su cui potrà fare affidamento per il resto della vita. Quando, smarrita la sbornia di “realtà” tipica dell’età dello sviluppo, sentirà il bisogno di attingere a una conoscenza eterna per lenire le proprie paure e sviluppare i propri talenti.
Tutto questo gli inglesi non lo hanno dimenticato. E hanno avuto la forza di ricordarlo al mondo. Non è solo questione di lingua. Anche gli americani scrivono in inglese, ma le loro trame per l’infanzia esprimono un intento educativo, e dunque pragmatico, che smorza sul nascere lo sbrigliarsi della fantasia. Huck Finn è un capolavoro e Mark Twain un genio, ma si tratta di un capolavoro e di un genio intrisi di realtà. Persino la metafisica Moby Dick di Melville è appesantita da decine di pagine francamente noiose sulle varie tipologie di balene, quasi che lo scrittore avesse voluto rimarcare la base scientifica della sua straordinaria creazione. La cultura nordamericana ha compresso l’irrazionale fin dalle origini, assieme ai nativi indiani che ne sarebbero stati i naturali cantori. La concretezza etica della società fondata dai Padri Pellegrini ha spinto i compositori di favole a interpretarle non come una vacanza del pensiero, ma come il rivestimento zuccheroso di una medicina fatta di regole morali da impartire sotto forma di apologo con morale incorporata.
E gli italiani? Avendo copiato gli americani praticamente in tutto, non potevamo che seguirli anche in questa strage della fantasia immolata sull’altare della cosiddetta realtà. Pinocchio è un gigante della narrativa universale, eppure fu ignorato per un certo periodo persino dai suoi contemporanei. Le biografie di Collodi pubblicate dai giornali dopo la sua morte liquidano il burattino in poche righe. L’autore stesso non ebbe piena consapevolezza della sua opera, che toccò a Benedetto Croce sdoganare almeno dal punto di vista letterario. Collodi era un massone e non c’è pagina di Pinocchio che non contenga un riferimento alchemico (a cominciare dal nome del protagonista che si rifà alla ghiandola pineale, il “terzo occhio” di cui ogni tradizione esoterica si ripropone l’attivazione). Ma non ha lasciato eredi. Oggi si scrivono favole anche molto poetiche, intasate soprattutto di animali che parlano e ragionano come gli umani, ma manca la magia della spiritualità che in un Paese cattolico come il nostro viene ancora associata esclusivamente alla religione. Mentre il misticismo pagano che è alla base delle fantasie immortali degli inglesi si nutre di boschi, di orfani e di lettori che abbiano voglia di lasciarsi lambire dalla loro ombra a costo di perdervisi.
-
> L’ASTUZIA DEL LUPO E I SETTE CAPRETTI. ---22 gennaio 2016, di Federico La Sala
- DALLA FIABA, UNA LEZIONE DI PENSIERO COSTITUZIONALE A FILOSOFI E A GIURISTI. A VLADIMIR J. PROPP E A GIANNI RODARI, A ETERNA MEMORIA...
 L’ASTUZIA DEL LUPO E I SETTE CAPRETTI. "APRITE, APRITE": SONO IL VOSTRO "PAPI"!!!
L’ASTUZIA DEL LUPO E I SETTE CAPRETTI. "APRITE, APRITE": SONO IL VOSTRO "PAPI"!!!
I sogni atavici che vincono su ogni principio di realtàdi Marino Niola (la Repubblica, 22.06.16)
In principio era la fiaba. Lo diceva Paul Valéry condensando in un geniale lampo poetico, secoli di teoria sull’origine di questi racconti pieni d’incanto e di magia. Adesso anche la ricerca linguistica conferma che le fiabe sono antiche quanto il mondo. Perché, da quando hanno preso la parola, gli umani non hanno più smesso di raccontare storie di re e draghi, principesse e sortilegi, animali parlanti e piante pensanti. Lo dice la parola stessa, fabula, che deriva dal verbo latino fari, cioè parlare. E dunque quelle storie che abbiamo tanto amato da bambini - e che riassaporiamo con un pizzico di nostalgia grazie al cinema e alla letteratura - non sono invenzioni recenti. Quei personaggi fatati, le loro azioni e le loro funzioni non sono una cosa libresca.
 Sono figlie della tradizione orale. Volano di bocca in bocca da millenni, molto prima che gli scrittori antichi e medievali, e più tardi Charles Perrault, Giovan Battista Basile, i fratelli Grimm, Alexander Afanasiev, Vladimir Propp, Italo Calvino mettessero nero su bianco e le fissassero per sempre.
Sono figlie della tradizione orale. Volano di bocca in bocca da millenni, molto prima che gli scrittori antichi e medievali, e più tardi Charles Perrault, Giovan Battista Basile, i fratelli Grimm, Alexander Afanasiev, Vladimir Propp, Italo Calvino mettessero nero su bianco e le fissassero per sempre.I primi ad esserne convinti erano proprio Wilhelm e Jacob Grimm, certi che molti di questi fortunati plot narrativi precedessero l’invenzione della scrittura. In fondo il nostro immaginario è stato formattato ab origine, in un tempo così remoto in cui gli uomini si facevano domande su se stessi, sulla natura, sul destino usando la lingua alata della fantasia. Vista così la Bella e la bestia diventa una parabola proto animalista per raccontare il rapporto di attrazione-repulsione tra le specie. E la Sirenetta? È stata scritta nell’Ottocento, è vero. Ma non è tutta farina del sacco del danese Hans Christian Andersen. Perché in realtà sciami di donne pesce, seduttive e trasgressive, surfeggiano da sempre sui mari dell’immaginazione. Stesso discorso per i prìncipi che diventano rospi, o per le zucche trasformate in carrozza. Metamorfosi che esprimono un’idea di mondo che va al di là del principio di realtà: nulla è veramente impossibile, ma tutto è immaginabile. E alla fine la fortuna premia chi spera l’insperabile. Che sia Cenerentola o che sia Pretty woman. E questa è la morale della favola.
 Aladino e Cenerentola risalgono all’età del bronzo
Aladino e Cenerentola risalgono all’età del bronzo
 Uno studio della Royal Society
Uno studio della Royal SocietyC’era una volta nella preistoria... Quanto antiche sono le favole
di Elena Dusi (la Repubblica, 22.01.2016)
La principessa prigioniera nel castello è arrivata dopo. Le fiabe affondano le loro radici in epoche molto più remote rispetto al medioevo di re, streghe e cavalieri. Storie come il Fabbro e il diavolo o la Bella e la bestia, secondo due antropologi delle università di Durham e di Lisbona, venivano già raccontate rispettivamente 6mila e 4mila anni fa, in quell’età del bronzo in cui la vita dell’uomo era ancora prevalentemente nomade e le favole erano trasmesse per via orale, raccontate intorno al fuoco in una lingua antenata degli idiomi indoeuropei e oggi sostanzialmente estinta.
Sulla rivista “Royal Society Open Science”, Sara Graça da Silva dell’università di Lisbona e Jamshid Tehrani dell’università di Durham elencano una cinquantina di favole in cui il “c’era una volta” rimanda alla preistoria. Al nostro patrimonio più antico risalgono il Fabbro e il diavolo e la Bella e la bestia, ma anche Tremotino, Giacomino e il fagiolo magico, il Genio nella bottiglia, Cenerentola, Pelle d’asino, la Pappa dolce, il Giovane gigante, le Tre piume, le Tre filatrici.
Quasi tutte queste fiabe sono finite millenni più tardi nella raccolta dei fratelli Grimm. E proprio Wilhelm e Jacob, a metà Ottocento, furono i primi a suggerire che i racconti di sapore germanico e medievale da loro messi insieme fossero il frutto di una tradizione più vasta e antica. «Credo che le storie tedesche - scriveva Wilhelm - non appartengano solo alla nostra madrepatria ma siano comuni a olandesi, inglesi, scandinavi».
Applicando le stesse tecniche con cui la genetica ha ricostruito l’albero genealogico delle popolazioni antiche, da Silva e Tehrani hanno tracciato le ricorrenze delle favole nelle varie lingue indoeuropee. Il corpus cui hanno fatto riferimento è l’immenso Aarne Thompson Uther Index, un catalogo di duemila trame di racconti fiabeschi di oltre 200 società di tutto il mondo.
«Abbiamo cercato - scrivono gli studiosi le trame delle favole di magia nelle 50 lingue indoeuropee». Una similitudine fra le storie germaniche e quelle indo-iraniane, ad esempio, indica che quel particolare esisteva nel momento in cui i due popoli erano uniti. Poiché questa data è nota grazie agli studi sulle migrazioni antiche, i ricercatori sono risaliti all’antenato comune più antico di ogni fiaba. In molti casi lo hanno trovato più in là di quanto non pensassero, e in un’area molto più estesa di quanto credessero i fratelli Grimm.
«Nel caso della Bella e la bestia e di Tremotino - spiegano ancora i due - alcuni esperti avevano suggerito un’origine mitologica greca o romana. Ma noi abbiamo ritrovato queste storie nel più antico fra gli antenati comuni dei linguaggi indoeuropei». E non è certo un caso, in una fase della storia in cui la metallurgia dava il nome alle epoche, che un elemento ricorrente fosse il fabbro che stringe un patto con il diavolo. «La struttura di questa storia - scrivono i due ricercatori - si ripete in maniera fissa in tutto il mondo indoeuropeo, dall’India alla Scandinavia».
«Sono millenni che ci raccontiamo sempre le stesse favole» conferma Antonio Faeti, primo titolare della cattedra di letteratura per l’infanzia all’università di Bologna. «Il marinaio che non torna, la fanciulla che scappa dall’orco, il mercante che ne sa una più del diavolo sono elementi ricorrenti nelle fiabe di tutto il mondo. Perfino gli indigeni d’America hanno racconti comuni ai nostri. E quando il tedesco Wilhelm Hauff scrisse la Storia del califfo cicogna, nessuno si accorse che l’autore fosse un tedesco anziché un arabo».
Se i due ricercatori di oggi sono riusciti ad assegnare una data alle nostre favole più antiche, lo stesso Italo Calvino nella sua raccolta di saggi Sulla fiaba citava gli studi di Vladimir Propp e si diceva sicuro che le storie di magia risalissero alla preistoria. «Anzi, le fiabe, analizzate e spogliate di tutti gli elementi posteriori, sono il principale e quasi l’unico documento che ci resta di quelle lontanissime età». «Le leggi cambiano, le favole no» riassume Faeti. «Sono il riconoscimento della nostra anima perpetua e hanno la caratteristica di non mentire mai».
La storia della Bella e la bestia deriva da Amore e psiche di Apuleio, fa notare Bianca Lazzaro, che dirige la collana fiabe e storie dell’editore Donzelli e sta riproponendo le raccolte della tradizione dialettale italiana. «Si tratta di un “meme”: l’unità minima di trasmissione culturale delle fiabe di tutto il mondo. Le prove per recuperare l’amato o l’amata e l’odio della matrigna per la figliastra ne sono un esempio». Tutte le favole scritte oggi, secondo lo scrittore Guido Conti, sono in fondo la rielaborazione in chiave attuale di un archetipo ripescato dalla tradizione. «La mia cicogna Nilou si inserisce nella scia dei personaggi che volano. Ma offre elementi moderni, come la solidarietà e l’aiuto offerto a chi fugge da una guerra».
- DALLA FIABA, UNA LEZIONE DI PENSIERO COSTITUZIONALE A FILOSOFI E A GIURISTI. A VLADIMIR J. PROPP E A GIANNI RODARI, A ETERNA MEMORIA...
-
> "APRITE, APRITE": SONO IL VOSTRO "PAPI"!!! LA PAROLA "ITALIA", LA "PASSWORD", CONSEGNATA A UN PARTITO -- Napolitano su Berlusconi: "Patologiche ossessioni" (di Goffredo De Marchis)14 ottobre 2015, di Federico La Sala
Napolitano su Berlusconi: "Patologiche ossessioni"
di GOFFREDO DE MARCHIS (la Repubblica, 14 ottobre 2015)
ROMA. "Ce l’avevano con Calderoli". Giorgio Napolitano risponde ironicamente alla plastica contestazione delle opposizioni: l’uscita dall’aula di Forza Italia e 5stelle, il cartello di Domenico Scilipoti con scritto "2011" (l’anno delle dimissioni di Berlusconi). Durante il suo intervento, la minoranza manifesta la propria distanza dall’ex capo dello Stato, padre della riforma come lo ha definito Maria Elena Boschi. "Sono usciti subito dopo il discorso di Calderoli. Poi ce n’è stato un altro. Non potevo essere io la causa di quell’esodo", scherza Napolitano.
È un modo per non rovinare un giorno di festa per il senatore a vita. Che nell’intervento rivendica il suo ruolo, difende la risposta riformatrice finora mai data "per la ricerca del perfetto o del meno imperfetto". Ma che adesso è arrivata.
Sempre sul filo dell’ironia reagisce ai ripensamenti di alcuni protagonisti della legge. Berlusconi innanzitutto. "Deluso da qualche atteggiamento? Ma qui entriamo nel campo della psicologia. E io non voglio fare commenti politici, figuriamoci quelli psicologici".
Al capogruppo forzista Romani invia tuttavia una durissima lettera che affida ai commessi (e viene immortalata dai fotografi). "Ho letto attribuite a Berlusconi - scrive l’ex capo dello Stato - parole ignobili, che dovrebbero indurmi a querelarlo, se non volessi evitare di affidare alla magistratura giudizi storico-politici; se non mi trattenesse dal farlo un sentimento di pietà verso una persona vittima ormai della proprie, patologiche, ossessioni".
A Pier Ferdinando Casini, con cui parla per 10 minuti in aula subito dopo il voto, confida il suo stupore per le parole dell’ex Cavaliere: "Lui si ricorda solo il 2011 ma dimentica il 2010 quando diedi 45 giorni al suo governo per affrontare un voto di fiducia".
Comunque le contestazioni le aveva messe nel conto. "Per svelenire il clima ho evitato di partecipare alle votazioni sugli emendamenti". Non è bastato. Ma non voleva rinunciare alla seduta finale in virtù del ruolo attivo che la Costituzione affida anche ai senatori a vita. A proposito, dispiaciuto per le parole di Elena Cattaneo che descrivendo la riforma ha parlato di "ircocervo istituzionale"? "La senatrice è libera. Quando l’ho nominata sapevo bene che aveva un’estrazione politica e culturale diversa dalla mia". Resta, racconta Casini, un pizzico di amarezza ma senza drammi anche perché Napolitano ha una certa esperienza. E alla fine, l’ex presidente non rinuncia a fare un salto alla buvette. In fondo, ieri ha vinto anche lui.
-
> L’ASTUZIA DEL LUPO E I SETTE CAPRETTI. "APRITE, APRITE": SONO IL VOSTRO "PAPI"!!! - C’È QUALCOSA che sembra mancare, nel dibattito sul futuro presidente della Repubblica (di Guido Crainz - Il nuovo inquilino e la casa comune)20 gennaio 2015, di Federico La Sala
Il nuovo inquilino e la casa comune
di Guido Crainz (la Repubblica, 20.01.2015)
C’È QUALCOSA che sembra mancare, nel dibattito sul futuro presidente della Repubblica: la piena consapevolezza del ruolo che dovrà svolgere in un quadro costituzionale destinato a mutare, poiché stiamo andando verso un superamento del bicameralismo paritario.
CON questo superamento, connesso ad un sistema elettorale fortemente maggioritario, diventano ancor più importanti le figure e gli organi di garanzia: in primo luogo il capo dello Stato e la Corte costituzionale. Se così è, fra l’altro, appare fondata l’ipotesi di inserire nella riforma costituzionale l’innalzamento del quorum necessario per l’elezione del presidente.
L’alternarsi dei nomi possibili non deve dunque oscurare la vera questione che è in gioco, esattamente come lo è nel dibattito sul bicameralismo: la possibilità stessa di rimodellare la Repubblica. E la assoluta responsabilità che è necessaria nel metter mano alla casa comune. In questo scenario, diverso dal passato, si colloca dunque la discussione sulla qualità e il profilo del futuro presidente, ma si colloca anche - o si do- vrebbe collocare - un mutamento radicale nella mentalità e nei comportamenti dei “grandi elettori”. Senza sciogliere questo nodo affonderebbero anche buone candidature: e il far prevalere logiche di corrente o altri fini, se non ritorsioni, sarebbe un vero attentato alla Costituzione che si pensa di riscrivere.
La partita che si è aperta è indubbiamente difficile, e qualcosa accresce il senso di insicurezza: nella tormentata transizione iniziata nel 1994 sono stati fondamentali tre presidenti che hanno respirato l’aura della fondazione della Repubblica, intrisi della cultura che ha presieduto ad essa. O meglio, delle diverse culture che l’hanno ispirata e ne hanno garantito l’attuazione: la cultura cattolica, quella laica e azionista, e quella comunista (del comunismo italiano, capace di assumere progressivamente la Costituzione come valore primario).
Oggi questa preziosa risorsa si è inevitabilmente esaurita, ed è legittimo sentirne la mancanza: tanto più che in settant’anni il ruolo del presidente è indubbiamente mutato. Certo, non ha svolto quasi mai quel ruolo di “notaio” che Luigi Einaudi aveva incarnato e che periodicamente viene invocato: non è stato così, ad esempio, in una gran parte della “prima repubblica” (da Gronchi a Pertini, per tacere di Segni o di Cossiga).
Con il suo crollo poi il quadro cambia profondamente e di fronte all’anomalo centrodestra berlusconiano, poco rispettoso e talora estraneo alle regole, è diventato sempre più importante il ruolo di garanzia del presidente. Ben lungi dal poter esser “notarile” esso ha comportato invece un impegno attivo, talora di contrasto a misure illegittime o confliggenti con lo spirito e la lettera della Carta.
Sin dall’inizio, sin dalla lettera che Oscar Luigi Scalfaro inviò nel 1994 a Berlusconi, incaricato di formare il suo primo governo: lo impegnava al rispetto della Costituzione e dell’Italia “una e indivisibile”, oltre che delle alleanze internazionali e della “politica di pace”.
Lettera senza precedenti, ma resa necessaria dagli umori secessionisti cavalcati allora dalla Lega e dalla richiesta di rompere il trattato di Osimo sul nostro confine orientale avanzata dal Movimento Sociale.
E fu provvidenziale anche il veto posto a Cesare Previti come ministro della Giustizia. Era solo l’inizio di una storia ventennale in cui presidenza della Repubblica e Corte costituzionale si sono trovate a fronteggiare le iniziative di Berlusconi che più apertamente stridevano con la Costituzione: del resto la considera scritta da «forze ideologizzate che hanno guardato alla Costituzione russa come a un modello» (parole sue).
Non andrebbero mai dimenticati i non lontani tempi delle leggi ad personam sul sistema televisivo e sulla giustizia (sino ai lodi di Schifani e di Alfano), e c’è proprio da sperare che non ritornino. Che non sia necessario porre continui argini ad anomalie e a pretese anticostituzionali ma sia possibile davvero rimodellare le istituzioni della Repubblica. Prendendo avvio dal primo fondamento: il senso di responsabilità istituzionale di coloro che sono chiamati a farlo. Questo Parlamento ha la possibilità di dare al Paese il segno di una svolta, dopo le pessime prove di due anni fa: auguriamoci tutti che ne sia capace.
-
> L’ASTUZIA DEL LUPO E I SETTE CAPRETTI. --- Napolitano rieletto al sesto scrutinio con 738 voti. Prodi, migliori auguri. Berlusconi, grazie. Cei, prenda in mano situazione20 aprile 2013, di Federico La Sala
-
> L’ASTUZIA DEL LUPO E I SETTE CAPRETTI. --- IL DISCORSO di Roberto Benigni. Si può amare la nostra Costituzione? (di Gustavo Zagrebelsky)22 dicembre 2012, di Federico La Sala
Si può amare la nostra Costituzione?
di Gustavo Zagrebelsky (la Repubblica, 22 dicembre 2012)
IL DISCORSO di Roberto Benigni sulla Costituzione è stato per molti una rivelazione: rivelazione, innanzitutto, di principi fino a lunedì scorso, probabilmente, ignoti ai più; ma, soprattutto, rivelazione di ciò che sta nel nucleo dell’idea stessa di Costituzione. In un colpo solo, è come se fosse crollata una crosta fatta di tante banalità, interessate sciocchezze, luoghi comuni, che impedivano di vedere l’essenziale.
Non si è mancato di leggere, anche a commento di quel discorso, affermazioni che brillano per la loro vuotaggine: che la Costituzione è un ferrovecchio della storia, superata dai tempi, figlia della guerra fredda e delle forze politiche di allora. Benigni, non so da chi, è stato definito "un comico", "un guitto".
Il suo discorso è stato la riflessione d’un uomo di cultura profonda e di meticolosa preparazione, il quale padroneggia in misura somma una gamma di strumenti espressivi che spaziano dall’ironia leggera, alla tenerezza, all’emozione, all’indignazione, alla passione civile. La Costituzione, collocata in questo crogiuolo d’idee e sentimenti, ha incominciato o ricominciato a risuonare vivente, nelle coscienze di molti.
È stato come svelare un patrimonio di risorse morali ignoto, ma esistente. Innanzitutto, è risultata la natura della Costituzione come progetto di vita sociale. La Costituzione non è un "regolamento" che dica: questo si può e questo non si può, e che tratti i cittadini come individui passivi, meri "osservanti".
La Costituzione non è un codice di condotta, del tipo d’un codice penale, che mira a reprimere comportamenti difformi dalla norma. È invece la proposta d’un tipo di convivenza, secondo i principi ispiratori che essa proclama. Il rispetto della Costituzione non si riduce quindi alla semplice non-violazione, ma richiede attuazione delle sue norme, da assumersi come programmi d’azione politica conforme.
L’Italia, o la Repubblica, "riconosce", "garantisce", "rimuove", "promuove", "favorisce", "tutela": tutte formule che indicano obiettivi per l’avvenire, per raggiungere i quali occorre mobilitazione di forze. La Costituzione guarda avanti e richiede partecipazione attiva alla costruzione del tipo di società ch’essa propone. Vuole suscitare energie, non spegnerle. Vuole coscienze vive, non morte. Queste energie si riassumono in una parola: politica, cioè costruzione della pòlis.
A differenza d’ogni altra legge, la cui efficacia è garantita da giudici e apparati repressivi, la Costituzione è, per così dire, inerme: la sua efficacia non dipende da sanzioni, ma dal sostegno diffuso da cui è circondata. La Costituzione è una proposta, non un’imposizione. Anche gli organi cosiddetti "di garanzia costituzionale" - il Presidente della Repubblica e la Corte costituzionale - nulla potrebbero se la Costituzione non fosse già di per sé efficace. La loro è una garanzia secondaria che non potrebbe, da sola, supplire all’assenza della garanzia primaria, che sta presso i cittadini che la sostengono col loro consenso. Così si comprende quanto sia importante la diffusione di una cultura costituzionale. L’efficacia del codice civile o del codice penale non presuppone affatto che si sia tutti "civilisti" o "penalisti".
L’efficacia della Costituzione, invece, comporta che in molti, in qualche misura, si sia "costituzionalisti". Non è un’affermazione paradossale. Significa solo che, senza conoscenza non ci può essere adesione, e che, senza adesione, la Costituzione si trasforma in un pezzo di carta senza valore che chiunque può piegare o stracciare a suo piacimento.
Così, comprendiamo che la prima insidia da cui la Costituzione deve guardarsi è l’ignoranza. Una costituzione ignorata equivale a una Costituzione abrogata. La lezione di Benigni ha rappresentato una sorpresa, un magnifico squarcio su una realtà ignota ai più. È lecito il sospetto che sia ignota non solo a gran parte dei cittadini, ma anche a molti di coloro che, ricoprendo cariche pubbliche, spensieratamente le giurano fedeltà, probabilmente senza avere la minima idea di quello che fanno.
La Costituzione, è stato detto, è in Italia "la grande sconosciuta". Ma c’è una differenza tra l’ignoranza dei governanti e quella dei governati: i primi, ignoranti, credono di poter fare quello che vogliono ai secondi; i secondi, ignoranti, si lasciano fare dai primi quello che questi vogliono. Così, l’ignoranza in questo campo può diventare instrumentum regni nelle mani dei potenti contro gli impotenti.
A questo punto, già si sente l’obiezione: la Costituzione come ideologia, paternalismo, imbonimento, lavaggio del cervello. La Costituzione come "catechismo": laico, ma pur sempre catechismo. La Costituzione presuppone adesione, ma come conciliare la necessaria adesione con l’altrettanto importante libertà? Questione antica.
Non si abbia paura delle parole: ideologia significa soltanto discorso sulle idee. Qualunque costituzione, in questo senso, è ideologica, è un discorso sulle idee costruttive della società. Anche la costituzione che, per assurdo, si limitasse a sancire la "decostituzionalizzazione" della vita sociale, cioè la totale libertà degli individui e quindi la supremazia dei loro interessi individuali su qualunque idea di bene comune, sarebbe espressione d’una precisa ideologia politica.
L’idea d’una costituzione non ideologica è solo un’illusione, anzi un inganno. Chi s’oppone alla diffusione della cultura della costituzione in nome d’una vita costituzionale non ideologica, dice semplicemente che non gli piace questa costituzione e che ne vorrebbe una diversa. Se, invece, assumiamo "ideologia" come sinonimo di coartazione delle coscienze, è chiaro che la Costituzione non deve diventare ideologia.
La Costituzione della libertà e della democrazia deve rivolgersi alla libertà e alla democrazia. Deve essere una pro-posta che non può essere im-posta. Essa deve entrare nel grande agone delle libere idee che formano la cultura d’un popolo. La Costituzione deve diventare cultura costituzionale.
La grande eco che il discorso di Benigni ha avuto nell’opinione pubblica è stata quasi un test. Essa dimostra l’esistenza latente, nel nostro Paese, di quella che in Germania si chiama WillezurVerfassung, volontà di costituzione: anzi, di questa Costituzione. È bastato accennare ai principi informatori della nostra Carta costituzionale perché s’accendesse immediatamente l’immagine d’una società molto diversa da quella in cui viviamo; perché si comprendesse la necessità che la politica riprenda il suo posto per realizzarla; perché si mostrasse che i problemi che abbiamo di fronte, se non trovano nella Costituzione la soluzione, almeno trovano la direzione per affrontarli nel senso d’una società giusta, nella quale vorremmo vivere e per la quale anche sacrifici e rinunce valgono la pena. In due parole: fiducia e speranza. Ma senza illusioni che ciò possa avvenire senza conflitti, senza intaccare interessi e posizioni privilegiate: la "volontà di costituzione" si traduce necessariamente in "lotta per la Costituzione" per la semplice ragione che non si tratta di fotografare la realtà dei rapporti sociali, ma di modificarli.
La Costituzione vive dunque non sospesa tra le nuvole delle buone intenzioni, ma immersa nei conflitti sociali. La sua vitalità non coincide con la quiete, ma con l’azione. Il pericolo non sono le controversie in suo nome, ma l’assenza di controversie. Una Costituzione come è la nostra, per non morire, deve suscitare passioni e, con le passioni, anche i contrasti. Deve mobilitare. Tra i cittadini c’è desiderio di mobilitazione, cui mancano però i punti di riferimento. I quali dovrebbero essere offerti dalle strutture organizzate della partecipazione politica, innanzitutto i partiti che dicono di riconoscersi nella Costituzione. Ma tra questi spira piuttosto un’aria di smobilitazione, come quando ambiguamente si promettono (o minacciano, piuttosto) "stagioni", "legislature" costituenti, senza che si chiarisca che cosa si vorrebbe costituzionalizzare, al posto della Costituzione che abbiamo. Possibile che non si veda a quale riserva d’energia così si rinuncia, in cambio di flosce e vaghe prospettive?
-
> L’ASTUZIA DEL LUPO E I SETTE CAPRETTI. "APRITE, APRITE": SONO IL VOSTRO "PAPI"!!! --- "È tornato: Signore, pietà". Benigni riparte da Silvio. Su RaiUno "La più bella del mondo", dedicato ai princìpi fondamentali della Costituzione.18 dicembre 2012, di Federico La Sala
 Benigni riparte da Silvio
Benigni riparte da Silvio
 "È tornato: Signore, pietà"
"È tornato: Signore, pietà"- Su RaiUno "La più bella del mondo", dedicato ai princìpi fondamentali della Costituzione. Prima, monologo sull’attualità: "Berlusconi s’è ripresentato per la sesta volta. Ha detto che la settima si riposa.". L’appello all’impegno e alla politica: "L’indifferenza e il non voto sono i nemici, se ti tiri fuori dai il potere alla folla, che sceglie sempre Barabba"
 di ALESSANDRA VITALI *
di ALESSANDRA VITALI *ROMA - Neanche cinque minuti e già pronuncia la parola "Silvio". Benigni entra in scena come d’abitudine sulle note di Il partito del pinzimonio, la marcetta di Nicola Piovani, gioca con i ringraziamenti, il pubblico, la Rai, Napolitano "che ha telefonato al Papa che mi ha detto di ringraziare nostro Signore, e invece pure lui mi ha detto che dovevo ringraziare qualcuno di più importante: grazie, Silvio". L’avevamo lasciato un anno fa con Berlusconi - nello show di Fiorello #ilpiùgrandespettacolo, quando definì quelle dell’allora premier "le più belle dimissioni degli ultimi 150 anni" - e da Berlusconi riparte. "Due brutte notizie in questo mese, una è la fine del mondo, l’altra è terrificante: s’è ripresentato, è la sesta volta. Ma ha detto che la settima si riposa. È come i sequel dei film dell’orrore, lo Squalo 6, la Mummia, Godzilla contro Bersani...". Poi arriva al cuore della storia: "I nemici della Costituzione sono l’indifferenza alla politica che è amore per la vita, e il non voto. Non ti tirare fuori, se ti tiri fuori è terribile, dai il potere alla folla che sceglie sempre Barabba".
È La più bella del mondo, atteso ritorno di Benigni in tv, celebrazione della Carta preceduta da una visita al Colle dove Napolitano gli ha consegnato proprio una copia della Costituzione. Per lo show costi da kolossal tv, quasi - pare - sei milioni di euro nei quali rientrerebbero anche le 12 puntate di Tutto Dante previste su RaiUno in primavera. Quanto agli ascolti, fanno fede i precedenti: da Fiorello picco di 16 milioni di spettatori e oltre il 50% di share; a Sanremo, per il 150esimo dell’Unità d’Italia, è entrato all’Ariston su un cavallo bianco e è uscito con picchi del 60%; il 35,68% di Il V dell’Inferno, su RaiUno nel novembre 2007, il 46% di L’ultimo del Paradiso, su RaiUno nel dicembre 2002.
Nel Teatro 5 di Cinecittà Benigni ha davanti cinquecento invitati (moltissimi giovani, niente vip, solo i vertici Rai). Schema collaudato, un monologo sull’attualità poi l’esegesi dei princìpi fondamentali, i primi dodici articoli. L’inizio è tutto per Berlusconi. "Oggi è uscito da Palazzo Grazioli, c’era la folla, metà fischiava e metà applaudiva quelli che fischiavano. E quello che ha scritto la stampa estera...".
"L’avete visto a Canale 5? Credevo che fosse un’intervista del ’94, diceva che doveva salvare l’Italia dai comunisti, vi levo l’Ici, vi levo l’Imu, pensavo ’ma guarda nel ’94 la gente come ci cascava’. Ora ha una nuova fidanzata, una sola: è bello vedere che sta cercando di smettere". "Silvio ha un sogno, vuol diventare presidente della Repubblica, in tutti i luoghi pubblici ci sarebbe una sua foto, sarebbe l’unico modo di vederlo in una caserma dei carabinieri". "Ha detto che se Monti si candida lui fa un passo indietro e allora Mario, facci questo favore, poi magari dopo due giorni smentisci, come fa lui".
Risate e applausi e si passa al tema della serata. "Nella Costituzione - dice - c’è la strada per risolvere tutti i problemi, si proclama la dignità umana. È la nostra mamma, ci protegge da qualsiasi cosa". Si schiera dalla parte della politica, "l’indifferenza è un grave errore, io vi dico di amare più che rispettare la politica, è la cosa più alta per organizzare la pace, la serenità e il lavoro. Non avere interesse per la politica è come dire di non avere interesse per la vita". C’è il ricordo dei padri costituenti e dei padri della patria, i nomi, le persone, "autore di passaggi fondamentali della Costituzione è stato un pugliese di 29 anni, Aldo Moro". Applausi quando pronuncia la parola "partigiani". L’articolo 3, che prescrive l’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge senza senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, "l’hanno scritto a Woodstock, è Imagine di John Lennon trent’anni prima. Me li immagino a Montecitorio, come fricchettoni, che si passano il cannone...".
Insiste sull’articolo 4, "se non c’è il lavoro crolla tutto, la Repubblica e la democrazia che sono il corpo e l’anima delle nostre istituzioni. Quando non c’è lavoro perdiamo tutti perché quando lavoriamo modifichiamo noi stessi, è quella la grandezza del lavoro. Nella busta paga troviamo noi stessi: quella paga non è avere, è essere". Sottolinea i verbi degli articoli, laddove la Costituzione "riconosce", "garantisce", "promuove", "tutela", "sentite come suona forte e delicato". All’articolo 6 non trattiene la battuta, "la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche: è fatta apposta per Di Pietro".
Vola alto all’articolo 7, Chiesa e Stato, "fu Gesù Cristo, il primo laico, a dire date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio". All’articolo 9, "la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione", cita la sindrome di Stendhal "che arrivò a Firenze e svenne per tanta bellezza. Noi abbiamo avuto la sindrome di Bondi: invece di svenire l’uomo, venivano giù i monumenti". Si arriva all’articolo 11, "l’Italia ripudia la guerra". "È l’unico che comincia con ’l’Italia’, non con ’la Repubblica’: perché sia chiaro che tutti, anche i conigli d’Italia, ripudiano la guerra. ’Ripudia’, un no definitivo, perché la guerra deforma la gente. Nessuna guerra ha mai prodotto un beneficio maggiore del dolore che ha provocato". "Sentite: ’promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo’: è un confronto di sogni, sembra che ci dicano che l’Italia come patria non ci basta, bisogna diventare mondo, rimanendo italiani. È grazie ad articoli come questi, che in Europa c’è la pace da sessant’anni. L’idea dell’Unione europea è un sogno. Noi, prima generazione della storia del mondo, stiamo unendo un continente in pace. Non bisogna chiudersi nel proprio guscio, i nostri costituenti ci dicono di non tornare indietro, di mantenere la nostre radici ma non che sprofondino nel buio della Storia ma che vadano in su, come mani che si stringono".
Il lungo excursus si conclude con l’articolo 12, il tricolore. E con un monito. "Tutto questo, noi lo abbiamo ereditato. Ma per farlo davvero nostro, lo dobbiamo conquistare. Qui ci sono le regole per vivere tutti insieme, in pace, lavorando. Dico una cosa - continua Benigni - che solo un Papa o un buffone possono dire: domattina dite ai vostri figli che sta per cominciare un giorno che prima di loro non ha mai vissuto nessuno, ditegli di andare a testa alta, di essere orgogliosi di appartenere a un popolo che ha scritto queste cose fra i primi nel mondo. E che abbiano fiducia e speranza". Il saluto è sulle note di Beautiful that way di Piovani, dal tema principale di La vita è bella, che Benigni canta nella versione italiana. Parole di pace che l’israeliana Noa ha cantato in tutto il mondo e con le quali Benigni saluta e abbraccia il pubblico in piedi e augura buon Natale. E si commuove.
* la Repubblica, 17 dicembre 2012
-
> L’ASTUZIA DEL LUPO E I SETTE CAPRETTI. "APRITE, APRITE": SONO IL VOSTRO "PAPI"!!! ---- TOPOLINO E RUSSELL LIBERI PENSATORI, MA NON I FILOSOFI ITALIANI.11 novembre 2012, di Federico La Sala
 REPUBBLICA ITALIANA, 1994-2012: UN POPOLO, UN PRESIDENTE E IL presidente MENTITORE ISTITUZIONALIZZATO con il suo popolo.....
REPUBBLICA ITALIANA, 1994-2012: UN POPOLO, UN PRESIDENTE E IL presidente MENTITORE ISTITUZIONALIZZATO con il suo popolo.....
 DEMOCRAZIA, SCIENZA E RELIGIONE: TOPOLINO E RUSSELL LIBERI PENSATORI, MA NON I FILOSOFI ITALIANI.
DEMOCRAZIA, SCIENZA E RELIGIONE: TOPOLINO E RUSSELL LIBERI PENSATORI, MA NON I FILOSOFI ITALIANI.
-
> L’ASTUZIA DEL LUPO E I SETTE CAPRETTI. ---L’ITALIA E LA LIBERTA’ DI DIFFAMAZIONE.28 settembre 2012, di Federico La Sala
LIBERTA’ DI DIFFAMAZIONE
di Michael Braun,
corrispondente del quotidiano berlinese Die Tageszeitung e della radio pubblica tedesca *
L’Italia ha un nuovo martire: Alessandro Sallusti. Condannato a 14 mesi di carcere per diffamazione, oggi si presenta - ed è presentato dalla quasi totalità dei suoi colleghi - come la vittima di una legge aberrante che (così si afferma) punisce un “reato di opinione” e non ha uguali nelle altre democrazie.
Ma le cose stanno davvero così? Uno sguardo al codice penale tedesco ci dice subito che la diffamazione è reato punibile con due anni di carcere, e se avviene a mezzo stampa la pena sale addirittura fino a cinque anni. Insomma: chi, utilizzando le pagine di un giornale, denigra qualcuno ricorrendo ad affermazioni palesemente false rischia la galera anche in Germania.
Ciò detto potrei aggiungere che anche a me questa condanna, senza condizionale, sembra esagerata. Ma questo punto è già sottolineato da tanti, praticamente da tutti, giornalisti e politici. Un altro punto rischia invece di scomparire: cioè che, in veste di direttore, Sallusti si è reso complice di un reato grave, e che prima di assurgere al ruolo di martire ha vestito i panni dell’autore di un atto illecito.
Vogliamo ricordare che cosa scriveva cinque anni fa un certo Dreyfus (la vocazione al martirio, a quanto pare, era già tutta presente) sul giudice Giuseppe Cocilovo? Quel giudice aveva autorizzato una ragazzina tredicenne ad abortire, dietro richiesta della ragazza e di sua madre. Il quotidiano Libero commentava così: “Un magistrato ha applicato il diritto - il diritto! - decretando: aborto coattivo. (...) Qui ora esagero, ma prima domani di pentirmi, lo scrivo: se ci fosse la pena di morte, e se mai fosse applicabile in una circostanza, questo sarebbe il caso. Per i genitori, il ginecologo, il giudice. Quattro adulti, contro due bambini. Uno assassinato, l’altro (in realtà) costretto alla follia”.
Dopo la sentenza contro Sallusti ora Il Giornale (dove il condannato nel frattempo è trasmigrato come direttore) decreta: “L’articolo sotto accusa: duro, ma è un’opinione”. Davvero? Potremmo già disquisire sull’aggettivo “duro”. Invocare la pena di morte per quattro persone che non si sono resi colpevoli neanche della più minima illegalità vi sembra duro? A me sembra una violenza inaudita. Ma non è questo il punto.
La pena di morte viene invocata da quel Dreyfus con un argomento inventato di sana pianta: che la ragazzina sarebbe stata costretta all’aborto da quattro adulti mentre risulta che lei stessa voleva interrompere la gravidanza. Questa sì che è tecnica di diffamazione: capovolgere i fatti, voler costringere le ragazzine a non abortire e poi strillare in modo non solo scomposto, ma menzognero. Il reato di diffamazione esiste per una precisa ragione: per permettere al diffamato di difendere il suo onore contro attacchi basati su racconti non veritieri. Altro che reato di opinione. Se qualcuno si alzasse affermando che Sallusti è - per esempio - uno spacciatore, un pedofilo, un contrabbandiere o un amico dei mafiosi come reagirebbe l’illustre direttore? Guardandosi allo specchio, facendo spallucce e dicendo fra sé e sé, “è solo un’opinione”? Non credo. E bene farebbe a querelare.
Bene ha fatto pure il giudice Cocilovo a querelare Sallusti. Del resto il condannato continua a dare versioni lievemente distorte perfino della storia processuale. Scrive: “Non ho accettato trattative private con un magistrato (il querelante) che era disponibile a lasciarmi libero in cambio di un pugno di euro, prassi squallida e umiliante più per lui, custode di giustizia, che per me”. Par di capire che Cocilovo volesse sfruttare l’occasione per portare a casa un bel gruzzoletto. È squallido e umiliante, più per Sallusti che per altri, che il direttore non riesca mai a raccontare le cose se non attraverso una lente deformata: Cocilovo esigeva l’ammissione di colpa e il pagamento di ventimila euro non a lui, ma a Save the Children.
Ma ancora oggi Sallusti non è in grado di realizzare che la diffamazione c’è effettivamente stata, che non è un’opinione affermare il falso a spese dell’onore di un’altra persona, facendola passare per l’aguzzino di una ragazzina. Giustissimo l’intento di tanti direttori e giornalisti di difendere la libertà di stampa, giustissima la domanda se la pena comminata non sia esagerata. Ma da qui a difendere un diffamatore (o un direttore che pubblica e copre i diffamatori) ci corre. Non risulta che Sallusti si sia mai scusato per quell’articolo.
-
> L’ASTUZIA DEL LUPO E I SETTE CAPRETTI. --- Opinionista o killer mediatico? (di Franco Monaco)29 settembre 2012, di Federico La Sala
Opinionista o killer mediatico?
di Franco Monaco* (il manifesto, 29 settembre 2012)
Chiarisco subito onde fugare equivoci: la pena del carcere è troppo, si provveda a cambiare la legge. Ciò detto non posso tacere un certo disagio per la corale levata di scudi a cominciare da Quirinale, palazzo Chigi, ministro della Giustizia. Il caso Sallusti non si risolve nel suo spiacevole epilogo. Un epilogo che peraltro speriamo non sia effettivamente il carcere. Il nostro ordinamento è nel suo complesso abbastanza garantista da autorizzarci a confidare che in carcere Sallusti non ci andrà. E comunque il caso dovrebbe suggerire meno enfasi, più misura, più consapevolezza della molteplicità e della complessità dei problemi che, profittando dell’occasione, merita mettere a tema. Provo a raccoglierne alcuni attraverso una sequela di interrogativi.
La legge, giusta o sbagliata che sia, non va rispettata? La magistratura non ha il dovere di applicarla? La legge non è uguale per tutti, giornalisti compresi? La libertà di stampa non è un diritto che, come tutti i diritti, non è esente da limiti? Che c’entra la libertà di opinione con la pubblicazione di notizie false (a quanto sembra, consapevolmente false) e calunniose? Le vittime non vanno difese, neppure quando si rifiutano loro le scuse e la doverosa rettifica? Basta che un articolo non sia firmato perché non ne risponda nessuno? Il Quirinale ha diritto di sindacato su sentenze definitive?
Non è contraddittorio che, tra coloro che più strillano in queste ore, vi siano politici che propongono il carcere per i giornalisti in tema di intercettazioni, con palese intento intimidatorio? E’ normale che si faccia scrivere sotto pseudonimo un signore radiato dall’albo dei giornalisti per comportamenti immorali e illegali? Nulla da dire sul fatto che quel signore sia stato portato in parlamento per premiarlo dei servizi resi come "agente Betulla" nel quadro della vergognosa campagna diffamatoria verso Prodi, Fassino e altri sul caso, costruito ad arte, Telekom Serbia, che per un intero anno ha occupato le prime pagine de Il Giornale?
A fronte di questo cumulo di problemi, politici e media si sono tutti e unanimemente concentrati sulla ingiusta condanna comminata a Sallusti, rappresentato come martire della libertà di stampa, e persino sull’asserito accanimento dei magistrati.
Mi chiedo: non merita, così, distrattamente, spendere una parola sul giornalismo inteso come killeraggio verso gli avversari politici? Quel giornalismo di cui i Sallusti e i Farina sono campioni. Come se tale giornalismo, quello che ha confezionato il cosiddetto metodo Boffo, non gettasse discredito sul nobile e impegnativo mestiere del giornalista. Come se esso non avesse responsabilità nell’imbarbarimento della nostra vita civile e politica. Come se, di quell’uso della penna e del computer come armi per distruggere le persone, non vi siano state innumerevoli vittime (certo più anonime di Sallusti ma segnate per sempre) per le quali non il capo dello Stato ma proprio nessuno ha levato la voce e mosso un dito.
Ribadisco: condivido l’esigenza di correggere la legge sul punto delle sanzioni. Magari suggerirei di farlo senza la precipitazione e l’ossessione del caso singolo che sono sempre cattive consigliere quando si legifera sulla delicata materia dei diritti. Ma è difficile sottrarsi all’impressione che, al fondo di tanto, troppo zelo, stiano due pulsioni magari inconsapevoli: un riflesso corporativo della corporazione dei giornalisti e lo spirito partigiano o corrivo dei politici, quelli di destra che corrono in soccorso di uno dei loro, quelli di sinistra che devono ostentare il loro animus liberale e longanime verso gli avversari. Meglio sarebbe dare prova di distacco e compostezza.
*Senatore Pd
-
-
> L’ASTUZIA DEL LUPO E I SETTE CAPRETTI. --- LA DEMAGOGIA DI STATO E IL MESSAGGIO DELLA LIBERAZIONE. Il Presidente Napolitano richiama e sollecita a non «abbandonarsi a una cieca sfiducia», a non «finire per dar fiato a qualche demagogo di turno»26 aprile 2012, di Federico La Sala
 ITALIA, 1994-2012: POPULISMO E BAAL-LISMO DI STATO. L’Italia come volontà e come rappresentazione di un solo Partito. Il "popolo della libertà": "Forza Italia"!!!
ITALIA, 1994-2012: POPULISMO E BAAL-LISMO DI STATO. L’Italia come volontà e come rappresentazione di un solo Partito. Il "popolo della libertà": "Forza Italia"!!!
 LA DEMAGOGIA DI STATO E IL MESSAGGIO DELLA LIBERAZIONE. Il Presidente Napolitano richiama e sollecita a non «abbandonarsi a una cieca sfiducia», a non «finire per dar fiato a qualche demagogo di turno»
LA DEMAGOGIA DI STATO E IL MESSAGGIO DELLA LIBERAZIONE. Il Presidente Napolitano richiama e sollecita a non «abbandonarsi a una cieca sfiducia», a non «finire per dar fiato a qualche demagogo di turno»
 (...) il Capo dello Stato ricorda che tutti i partiti «hanno mostrato limiti e compiuto errori», che «occorre impegnarsi perché dove s’è creato del marcio venga estirpato» (...)
(...) il Capo dello Stato ricorda che tutti i partiti «hanno mostrato limiti e compiuto errori», che «occorre impegnarsi perché dove s’è creato del marcio venga estirpato» (...)
-
> L’ASTUZIA DEL LUPO E I SETTE CAPRETTI. "APRITE, APRITE": SONO IL VOSTRO "PAPI"!!! --- Quella virtù di dire no che ha salvato il Paese dalle forzature autoritarie (Gustavo Zagrebelsky)30 gennaio 2012, di Federico La Sala
Quella virtù di dire no che ha salvato il Paese dalle forzature autoritariedi Gustavo Zagrebelsky (la Repubblica, 30 gennaio 2012)
Poche parole, a poche ore dalla morte del presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro: un uomo politico e un servitore della Costituzione rigoroso, roccioso e intransigente e, proprio per questo, molto amato e anche molto osteggiato.
"Non c’è da temere mai di fronte alle pressioni esterne. L’unico che può temerle è chi è ricattabile": sono parole sue, rivolte ai giudici ma valide con riguardo a qualunque magistratura e tanto più valide in quanto riferite alle più alte cariche della Repubblica. Di queste, la prima e fondamentale "prestazione" costituzionale che si ha necessità e diritto di pretendere, soprattutto nei tempi di incertezza o di crisi, è la rassicurazione che viene dalla serenità e dalla forza, cioè dalla certezza che non vi possono essere cedimenti e deviazioni.
Altri, col tempo e con la riflessione necessari, scriveranno di lui e della sua opera nella storia della Repubblica, una storia che la copre dall’inizio all’altro ieri. Allora si faranno bilanci. Nella commozione del momento, vorrei ricordarlo con parole nelle quali egli probabilmente si riconoscerebbe volentieri, quasi come in un suo motto: "Sia il vostro parlare sì, sì; no, no; il di più viene dal maligno" (Mt 5, 37).
Una delle cause del degrado e della corruzione della vita pubblica nel nostro Paese, egli l’imputava ai troppi sì che si dicono da parte di chi avrebbe il dovere di dire di no, in modo di stabilire il confine del lecito e dell’illecito e quindi il territorio entro il quale può legittimamente valere il gioco democratico. Quelle che seguono sono sue parole: «Il compito del Capo dello Stato non è quello di essere equidistante tra due parti politiche. Sarebbe fin troppo facile. Si dà ragione una volta all’uno e una volta all’altro e si sta a posto con la coscienza.
No, il compito del Capo dello Stato è quello di garantire il rispetto della Costituzione su cui ha giurato. Di difenderla a ogni costo, senza guardare in faccia nessuno. Tra il ladro e il carabiniere non si può essere equidistanti: se qualcuno dice di esserlo vuol dire che ha già deciso di stare con il ladro». L’imparzialità di cui la Costituzione ha bisogno non è dunque un’equidistanza senza carattere, ma presuppone che si stabilisca quali sono le parti le cui pretese sono legittime e che da queste siano tenute separate quelle che non lo sono.
Soprattutto nei momenti di turbolenza e di tentativi di forzatura, il Capo dello Stato non può esimersi dal compito - un compito che nell’ordinaria vita costituzionale gli è risparmiato - di stabilire i confini tra il lecito e l’illecito costituzionale. Tra questi due poli non può esservi imparzialità. In una Costituzione pluralista e inclusiva com’è la nostra, il terreno dell’inclusione costituzionale è assai ampio ma non è certo illimitato. Una Costituzione che "costituzionalizzasse" tutto e il contrario di tutto sarebbe non una costituzione ma il caos.
È perfino superfluo ricordare che gli anni del settennato presidenziale di Scalfaro furono un periodo di accesissime polemiche e non infondati timori per la "tenuta" delle istituzioni costituzionali. Al centro delle tensioni si trovò proprio la Presidenza della Repubblica e la sua interpretazione della Costituzione. Non furono solo polemiche verbali ma anche attacchi personali il cui obbiettivo era trasparente. Il drammatico discorso televisivo delle 9 della sera del 3 novembre 1993, il discorso del "non ci sto", fu al tempo stesso una denuncia e una risposta. La reazione dell’opinione pubblica non iniziata alle segrete cose fu, inizialmente, di sconcerto. Non si comprendeva che cosa stesse accadendo, anche se si avvertiva l’eccezionalità del momento e delle parole appena udite, che alludevano a manovre tanto più inquietanti quanto meno limpide.
Col senno di poi, comprendiamo che quelle tre parole dicevano a chi doveva intendere: "ho compreso" e un "sappiate che cedimenti non sono alle viste". Che cosa "ho compreso"? Si dice che fosse in atto un attacco, un ricatto al Capo dello Stato da parte di uomini della maggioranza d’allora, che non lo consideravano malleabile. La parte finale del discorso allude certamente a ciò. Ma la parte iniziale è quella che deve essere riascoltata oggi. Vi si parla non di un atto grande e conclamato, contro la Costituzione e le sue istituzioni. Si parla di degrado e corruzione attraverso piccoli cedimenti, di per sé pocoevidenti, ma tali da sommarsi l’uno all’altro e di fare massa, fino al momento in cui, quando ci se ne fosse accorti e si fosse voluto reagire, sarebbe stato troppo tardi.
Qui, nel "bel paese là dove il sì suona" troppo frequentemente, i "no" scalfariani sono stati una scossa salutare. Egli stesso ne era orgoglioso. Nelle sue numerose e generose interviste, conferenze, lezioni degli ultimi anni, usava ricordare agli uditori, che avevano evidentemente bisogno di parole di rigore e le salutavano con entusiasmo, i tre rotondi "no" (senza "il di più" satanico) che seguirono alla richiesta di elezioni anticipate dopo la rottura dell’alleanza Lega-Forza Italia nel 1994.
Quei "no" hanno salvato la Costituzione da quella che sarebbe stata una prima interpretazione anti-parlamentare destinata a fare scuola, secondo la quale il presidente del Consiglio può pretendere nuove elezioni per essere "plebiscitato" contro un Parlamento che non sta alle sue volontà. Scalfaro è stato la prima pietra d’inciampo nella marcia verso qualcosa d’inquietante, una sorta di "democrazia d’investitura" personalistica che non sappiamo dove ci avrebbe portato. Se, oggi, il presidente della Repubblica ha potuto resistere alle pressioni per elezioni anticipate, a seguito delle dimissioni del governo Berlusconi, lo dobbiamo anche alla fermezza mostrata allora dal presidente Scalfaro.
Ma altri, importantissimi "no" sono stati pronunciati. Non possiamo dimenticare con quale alto senso della laicità delle istituzioni repubblicane, egli - cattolicissimo - rivendicò davanti al Papa il suo essere presidente di tutti gli italiani, credenti e non credenti, cattolici e non cattolici, quando è tanto facile acquisire meriti e farsi belli agli occhi della gerarchia ecclesiastica, appellandosi alla tradizione cattolica, maggioritaria in Italia. Così, le questioni di fede o non fede, con lui, non erano mai motivi di divisione. Ciò che mi pare contasse davvero era l’evangelica rettitudine del sentire e dell’agire. Questo spiega l’ottimo rapporto personale - ch’egli soleva ricordare - con tanti galantuomini d’altri partiti, talora lontani politicamente dal suo e, al contrario, il pessimo rapporto con chi galantuomo non era, ancorché del suo stesso partito.
Infine, il suo impegno per la difesa della Costituzione, nel quale fino all’ultimo non risparmiò le sue energie. Presiedette il comitato Salviamo la Costituzione, al quale si deve un contributo decisivo alla vittoria nel referendum del 2006, che impedì una trasformazione profonda e ambigua delle nostre istituzioni. Ecco un altro no. Alla Costituzione andavano costantemente i suoi pensieri, consapevole ch’essa rappresenta uno dei frutti più elevati della cultura e della politica del nostro Paese. E insieme alla Costituzione, la Resistenza che ne è la radice storica e morale.
Nel discorso alle Camere riunite, in occasione del giuramento, il 28 maggio 1992, rese omaggio agli uomini e alle donne che parteciparono alla lotta di Liberazione. La Costituzione "io non l’ho pagata nella Resistenza [...] Altri non la votarono ma la pagarono con la vita. Non dimentichiamolo mai". Retorica, diranno coloro ai quali questa Costituzione non aggrada. Parole profonde, diranno invece coloro che hanno consapevolezza del valore storico di quel periodo della nostra storia e del suo frutto più importante. E questi ti saranno per sempre in debito di affetto e di riconoscenza, presidente Scalfaro.
-
> L’ASTUZIA DEL LUPO E I SETTE CAPRETTI. "APRITE, APRITE": SONO IL VOSTRO "PAPI"!!! ---- Riflessioni sul bel paese uno e indivisibile (del Presidente della Repubblica - Giorgio Napolitano).24 novembre 2011, di Federico La Sala
Napolitano riflessioni sul bel paese uno e indivisibile *
Il ciclo delle celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità non può considerarsi ancora esaurito: lo dicono notizie e annunci che continuano ad affluire. Ma un bilancio sostanziale è certamente possibile, e vorrei sottolinearne alcuni aspetti. Innanzitutto l’eccezionale diffusione e varietà di iniziative, e il carattere spontaneo che molte di esse hanno presentato: non sollecitate e coordinate dall’alto, da nessun luogo “centrale”, Presidenza della Repubblica o Governo. Si è davvero trattato di un gran fiume di soggetti che si sono messi in movimento, in special modo al livello locale, fin nei Comuni più piccoli - istituzioni, associazioni di ogni genere, gruppi e persone.
È stato un gran fervore di richiami di antiche memorie, anche famigliari, e di impegni di studio, di discussione, di comunicazione. Quel che si è mosso, poi, nelle scuole è stato straordinario: quanti insegnanti, per loro conto, e quanti studenti, a ogni livello del sistema d’istruzione, si sono messi d’impegno e hanno dato in tutte le forme il loro contributo! E anche in termini quantitativi che cosa è stata la partecipazione dei cittadini anche alle manifestazioni nelle piazze e nelle strade e dai balconi delle case, in un’esplosione mai vista di bandiere tricolori e di canti dell’Inno di Mameli!
Ce lo aspettavamo? In questa misura e in questi toni, no: nemmeno quelli tra noi, nelle massime istituzioni nazionali, che ci hanno creduto di più e hanno deciso di dedicarvisi più intensamente. È stata una lezione secca per gli scettici, e ancor più per coloro che prevedevano un esito meschino, o un fallimento, dell’appello a celebrare i centocinquant’anni dell’unificazione nazionale. Soprattutto, è stata una grande conferma della profondità delle radici del nostro stare insieme come Italia unita. Si può davvero dire che le parole scolpite nella Costituzione - «la Repubblica, una e indivisibile» - hanno trovato un riscontro autentico nell’animo di milioni di italiani in ogni parte del Paese. E non in contrapposizione ma in stretta associazione - come nell’articolo 5 della Carta - all’impegno volto a riconoscere e promuovere le autonomie locali. Nello stesso tempo, si può ritenere che il così ampio successo registratosi vada messo in relazione col bisogno oggi diffuso nei più diversi strati sociali di ritrovare - in una fase difficile, carica di incognite e di sfide per il nostro Paese - motivi di dignità e di orgoglio nazionale, reagendo a rischi di mortificazione e di arretramento dell’Italia nel contesto europeo e mondiale.
L’aver fatto leva sull’occasione del Centocinquantenario, l’aver puntato su celebrazioni condivise, è stato dunque giusto e ha pagato. Non bastava però lanciare un appello generico: occorreva richiamare in modo argomentato fatti storici ed esperienze, fare i conti con interrogativi e anche con luoghi comuni, favorire quella che non esito a chiamare una riappropriazione diffusa, da parte degli italiani, del filo conduttore del loro divenire storico, del loro avanzare - tra ostacoli e difficoltà, cadute e riabilitazioni, battute d’arresto e balzi in avanti - come società e come Stato nei secoli XIX e XX. Gli interventi che ho svolto, nel succedersi delle iniziative per il Centocinquantenario, hanno segnato i momenti e i contenuti dello sforzo compiuto: spero che il leggerli, raccolti in volume, ne renda il senso complessivo, lo sviluppo coerente.
Qual è la conclusione che oggi ne traggo? Che non si è trattato di un fuoco fortuito, di un’accensione passeggera che già sta per spegnersi, di una parentesi che forse si è già chiusa. No, si è trattato di un risveglio di coscienza unitaria e nazionale, le cui tracce restano e i cui frutti sono ancora largamente da cogliere. Non ci porti fuori strada l’impressione che appena dopo aver finito di celebrare il Centocinquantenario in un clima festoso e riflessivo, aperto e solidale, si sia ritornati alle abituali contrapposizioni, alle incomunicabilità, alle estreme partigianerie della politica quotidiana.
Quel lievito di nuova consapevolezza e responsabilità condivisa che ha fatto crescere le celebrazioni del Centocinquantenario continuerà a operare sotto la superficie delle chiusure e rissosità distruttive, e non favorirà i seminatori di divisione, gli avversari di quel cambiamento di cui l’Italia e gli italiani hanno bisogno per superare le ardue prove di oggi e di domani.
Giorgio Napolitano
* Avvenire, 23.11.2011
-
>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FATTO SI E’ DIMESSO: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI DIRITTO HA RESISTITO E VINTO. Una nuova storia per un Paese pronto a cambiare - è possibile (di Clara Sereni).14 novembre 2011, di Federico La Sala
 Una nuova storia per un Paese pronto a cambiare
Una nuova storia per un Paese pronto a cambiare
 Ci è già capitato di rimboccarci le maniche dopo le macerie della guerra. È la sfida che dobbiamo vincere anche oggi
Ci è già capitato di rimboccarci le maniche dopo le macerie della guerra. È la sfida che dobbiamo vincere anche oggi di Clara Sereni (l’Unità, 14.11.2011)
di Clara Sereni (l’Unità, 14.11.2011)Non c’è dubbio: se abitassi ancora a Roma, sabato sera sarei stata di fronte al Quirinale, a cantare e applaudire, a manifestare soprattutto gratitudine nei confronti del Presidente della Repubblica, di cui ci sentiamo in qualche modo tutti un po’ figli: perché lui si è costituito in Padre della Patria.
Da lui ci siamo sentiti protetti, e ne avevamo davvero bisogno. La sua tranquilla durezza nell’indicare la strada da percorrere è stata - è - un’assunzione di responsabilità tremenda che ci ha ricondotto tutti alla realtà, fuori da perifrasi e bizantinismi. Come quando un padre ti prende per mano, la tiene saldamente nella sua e - magari strattonandoti un po’ - ti fa incamminare nella direzione che serve.
Invece davanti a palazzo Grazioli probabilmente non sarei andata, perché malgrado le monetine io non le abbia mai tirate di fronte al Raphael in quel certo giorno idealmente c’ero anch’io, e non ne sono fiera, per quella rabbia nei confronti di Craxi che aveva dentro un elemento di violenza e ferocia. Lo stesso che ho sentito crescere dentro di me per ogni insulto, per ogni menzogna, e che nella gioia di ieri sera, per fortuna, non ho visto. E lo considero un piccolo miracolo, il segno di una maturità che non ero certa avessimo conquistato.
Oggi siamo in un altro mondo, dentro un’altra storia. In qualche modo più vicina, se è possibile un paragone, alla fine del fascismo che non ad eventi che la mia generazione ha vissuto in prima persona: come se martedì la maggioranza abbia vissuto il proprio 25 luglio, fra sabato e oggi stia accadendo qualcosa che assomiglia all’8 settembre, ma poi toccherà a tutti noi arrivare fino al 25 aprile. È facile obiettarmi che quel primo Cavaliere ha portato l’Italia in guerra, e che il secondo Cavaliere non ci lascia con i carri armati nelle strade: certo, ma le metafore e i parallelismi sono sempre approssimativi, la storia non si ripete mai nello stesso modo, anche se si può dire senza tema di smentita che i cavalieri, a questo nostro Paese, non portano fortuna. Del resto, mi sembra che almeno due elementi ci riportino a quei tempi, a quelle date, a quelle sfide. A tempi di guerra.
Intanto, perché la crisi in cui ci troviamo è una ferita, perdiamo sangue e le trasfusioni non bastano mai. Poi, perché il panorama che vediamo è di devastazione, di macerie: fisiche (lo scempio del territorio e le sue conseguenze), materiali (l’economia non è solo questione di banche, riguarda quel che riusciamo a mettere nel piatto oggi e domani e in futuro), istituzionali (Costituzione e Parlamento così strapazzati e stiracchiati non li avevamo mai visti), morali. E forse nel novero della macerie ho dimenticato qualcosa. Gli italiani sono come le olive, capaci di tirar fuori il meglio di sé quando sono sotto pressione, dunque credo che ce la faremo anche stavolta, e anche bene: le energie e le competenze dissipate in questi anni non sono perdute per sempre, si può ben tornare a coltivarle e farle crescere. Ma c’è almeno un elemento di difficoltà, rispetto al secondo dopoguerra: allora eravamo un Paese giovane, mentre ora siamo invecchiati e male.
E inoltre allora ereditavamo una struttura statuale devastata e fortemente inquinata e condizionata dal fascismo. Certo, niente di paragonabile a oggi. Eppure non possiamo dimenticare che i bombardamenti più duri hanno colpito in questi anni proprio le strutture portanti dello Stato: il Parlamento, l’istruzione e la cultura, la magistratura, il lavoro, il farsi stesso di leggi e provvedimenti.
Ci vuole lucidità, nell’affrontare tutto questo: non cedere al panico, non aspettarsi miracolistiche vie d’uscita. Prodi (che continuo a ritenere il miglior presidente del Consiglio che l’Italia abbia avuto) pagò la delusione di aspettative messianiche non suscitate certo da lui: vediamo di non ripetere l’errore. L’auspicabile governo Monti può cominciare a fare un primo ordine, e sarà già molto se riuscirà a far questo da qui alla scadenza naturale della legislatura - e insisto su naturale.
Dopo, toccherà a tutti noi - di fronte a un panorama un po’ sgombrato dalle macerie - ricominciare a progettare. Sapendo di dover smettere di essere figli e farci compiutamente adulti. Sapendo di doverci liberare con un’analisi seria delle cellule di berlusconismo che si sono radicate dentro di noi, nessuno escluso. Con le radici profonde del fascismo l’Italia non ha mai fatto i conti fino in fondo, e non smettiamo di pagarne le conseguenze; ma proprio perché ne abbiamo già fatto l’esperienza, perché su questo nodo mai sciolto tante speranze si sono infrante e tanto dolore è nato, stavolta possiamo non ripetere l’errore. Se ne saremo capaci, allora sì che veramente potremo festeggiarci a pieno titolo, ed essere soggetti di una Storia nuova.
-
> L’ASTUZIA DEL LUPO ---- ITALIA, 12 NOVEMBRE 2011. DIMISSIONI DEL GOVERNO BERLUSCONI. Il comunicato del Quirinale12 novembre 2011, di Federico La Sala
 ITALIA, 12 NOVEMBRE 2011. Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha ricevuto oggi alle ore 21.00 al Palazzo del Quirinale il Presidente del Consiglio dei Ministri, onorevole Silvio Berlusconi ...
ITALIA, 12 NOVEMBRE 2011. Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha ricevuto oggi alle ore 21.00 al Palazzo del Quirinale il Presidente del Consiglio dei Ministri, onorevole Silvio Berlusconi ...
 DIMISSIONI DEL GOVERNO BERLUSCONI. Il comunicato del Quirinale
DIMISSIONI DEL GOVERNO BERLUSCONI. Il comunicato del Quirinale
 Le consultazioni del Capo dello Stato si svolgeranno nella giornata di domani
Le consultazioni del Capo dello Stato si svolgeranno nella giornata di domani
-
> LA PAROLA "ITALIA", LA "PASSWORD", CONSEGNATA A UN PARTITO (1994-2011). --- FARE PRESTO: L’ITALIA E’ NELLE SUE MANI - ANCORA!!!11 novembre 2011
Materiali sul tema:
 L’appello del Presidente Napolitano: "Dobbiamo riguadagnare fiducia come paese" (dal sito del Quirinale)
L’appello del Presidente Napolitano: "Dobbiamo riguadagnare fiducia come paese" (dal sito del Quirinale)
 http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Discorso&key=2292
http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Discorso&key=2292 L’appello del quotidiano di Confindustria: "Fate presto" (Il Sole 24Ore)
L’appello del quotidiano di Confindustria: "Fate presto" (Il Sole 24Ore)
 http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2011-11-09/fate-presto-225103.shtml?uuid=AapjvGKE
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2011-11-09/fate-presto-225103.shtml?uuid=AapjvGKE Crisi e mercati, possiamo farcela (Corriere della Sera)
Crisi e mercati, possiamo farcela (Corriere della Sera)
 http://www.corriere.it/editoriali/11_novembre_10/debortoli_possiamo-farcela_5eb5c08c-0b60-11e1-ae33-489d3db24384.shtml
http://www.corriere.it/editoriali/11_novembre_10/debortoli_possiamo-farcela_5eb5c08c-0b60-11e1-ae33-489d3db24384.shtml Il testo della legge di stabilità (Il Fatto quotidiano)
Il testo della legge di stabilità (Il Fatto quotidiano)
 http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/11/09/maxiemendamento-ecco-testo/169583/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/11/09/maxiemendamento-ecco-testo/169583/ Berlusconi, 17 anni di potere (La Repubblica)
Berlusconi, 17 anni di potere (La Repubblica)
 http://www.repubblica.it/static/speciale/2011/caduta-di-berlusconi-fine-di-un-epoca/index.html
http://www.repubblica.it/static/speciale/2011/caduta-di-berlusconi-fine-di-un-epoca/index.html-
> LA PAROLA "ITALIA", LA "PASSWORD", CONSEGNATA A UN PARTITO (1994-2011). --- Effetti collaterali (di Ida Dominijanni)12 novembre 2011, di Federico La Sala
Effetti collaterali
di Ida Dominijanni (il manifesto, 12.11.2011)
Mettiamo che tutto vada liscio nella road map delineata dal presidente della Repubblica, e sostenuta pure dal presidente degli Stati uniti. Mettiamo pure che tutto, oltre che liscio, vada per il meglio: che Mario Monti riesca a risollevare i conti pubblici e ad abbassare lo spread facendo il contrario di quello che è prevedibile che faccia, cioè con la patrimoniale, senza macelleria sociale, senza vendere il Colosseo e rilanciando l’occupazione, la produzione e i consumi. Mettiamoci infine l’auspicio che dal suo governo nasca una legge elettorale accettabile. Bene, anche in questo scenario fantascientifico i danni collaterali dell’operazione sarebbero, come quelli delle cosiddette operazioni di polizia internazionale, superiori ai risultati, e tali da compromettere gravemente l’uscita dal ventennio berlusconiano. Se ne contano, allo stato attuale, almeno tre, con conseguenti corollari e paradossi.
Primo danno, la fine, politicamente certificata, dell’autonomia della politica. La piramide istituzionale italiana si consegna, per mano del suo massimo vertice, alla governance economica europea e mondiale. La quale, ormai l’abbiamo capito, non avrà pace finché non piazzerà dei propri uomini alla guida dei paesi più esposti alla crisi dell’Eurozona: così in Italia con Monti, così in Grecia con Papademos. E’ ovvio che per legittimare questa situazione vengano mobilitate tutte le ragioni emergenziali possibili, e in parte indiscutibilmente reali, dall’insostenibilità del debito al crollo di credibilità dell’Italia. Il ragionamento però, come sempre quando impazza la psicologia dell’emergenza, andrebbe ribaltato: come siamo arrivati a questa situazione? E perché, mentre ci si arrivava, non è stata né tentata né concepita una strada per uscire dallo stato terminale della politica con la politica, se non per dare qualche risposta almeno per intralciare con qualche domanda le mosse rovinose dell’economia e dei cosiddetti mercati?
La risposta sta nel secondo danno collaterale, che è la resa incondizionata, e per giunta fuori tempo massimo, alla religione neoliberista. Che impera in tutto l’Occidente da oltre un trentennio, ci ha portato alla catastrofe economico-finanziaria degli ultimi quattro anni e ha ormai come obbiettivo, anche questo l’abbiamo capito, non il condizionamento ma l’asservimento, se non l’azzeramento, della politica tout court: il capitale ha deciso che deve governare direttamente, senza alcuna mediazione, né degli stati né dei governi né dei parlamenti. Però mentre negli Stati uniti la presidenza Obama ha perlomeno messo in scena, pur perdendolo, un conflitto fra primato dell’economia e primato della politica (conflitto oggi peraltro ottimamente alimentato da Occupy Wall Street), l’Europa incarna nella sua stessa architettura, monca di una Costituzione e di istituzioni politiche credibili, una forma inedita di sovranità economica assoluta.
In Italia, la congiuntura - indubbiamente assai difficile - che vede coincidere la fine del ventennio berlusconiano con la resa dei conti del trentennio liberale avrebbe potuto offrire l’occasione per uscire dall’uno e dall’altro con una sostanziale inversione di rotta. Senonché qui viene in primo piano un nodo finora sottaciuto del fronte antiberlusconiano. Nel quale hanno troppo a lungo e troppo pacificamente convissuto due tendenze opposte: quella che dal berlusconismo vuole uscire uscendo altresì dal liberismo, e quella che viceversa ne vuole uscire con un liberismo più affilato, ancorché più presentabile, di quello che Berlusconi è riuscito a praticare. Il risultato è il passaggio dal feticismo della merce (e del corpo-merce) di Berlusconi al feticismo dei mercati fatto proprio dalla sinistra liberaldemocratica. Vale allora la pena almeno di accennare, pur senza poterlo sviluppare, a un punto concettuale che oggi diventa politicamente decisivo. Solo in Italia la distinzione lessicale fra liberismo e liberalismo alimenta l’illusione di una distinzione concettuale e politica fra i due termini che oggi, e non da oggi, non si dà. Come molti - da Michel Foucault a Wendy Brown a Luciano Gallino nel suo ultimo libro - hanno ampiamente dimostrato, quello che in Italia chiamiamo neoliberismo, e che altrove si chiama neoliberalismo, non è una dottrina meramente economica che lascia immune il liberalismo politico classico o che può esserne corretta: è una dottrina economica e politica che estende la forma dell’impresa alla società e alle istituzioni, e che la liberaldemocrazia se la sta semplicemente ingoiando, su una sponda e sull’altra dell’Atlantico. Lo stato d’eccezione che a turno ci è toccato o ci tocca sperimentare - negli Usa di Bush di ieri sotto l’emergenza antiterrorismo come nella Grecia e nell’Italia di oggi sotto l’emergenza della crisi - ne sono una diretta conseguenza, prima o poi destinata all’implosione.
Il terzo danno collaterale riguarda la Costituzione italiana e riporta d’attualità il discorso, di fatto archiviato, su quella europea. Non è per caso, in questo scenario di neoliberismo trionfante, che la seconda non sia mai nata, e che la prima traballi da anni. Una ripresa di iniziativa politica continentale dal basso per la Costituzione europea sarebbe oggi l’unica risposta adeguata all’Europa della Bce e del duo Merkel-Sarkozy, e l’ultimo a essere insensibile al tema sarebbe lo stesso Giorgio Napolitano. Del quale, per venire alla Costituzione italiana, non è certo in discussione il ruolo di garante fin qui svolto. Non si può tuttavia eludere il fatto che l’Italia ha vissuto negli ultimi anni, sotto l’emergenza della «anomalia» berlusconiana, una sorta di regime di coabitazione semipresidenzialista che non mancherà di lasciare traccia per il futuro, e che altri in futuro potrebbero interpretare in modo meno commendevole. Così come non mancherà di lasciare traccia l’inedito istituto delle dimissioni a tempo del presidente del Consiglio, e l’eclissarsi del ruolo del parlamento e dei partiti in una situazione straordinaria come quella attuale.
Con il che torniamo al punto di partenza, non senza enumerare i paradossi in partenza accennati. Per paradosso, all’esito di questa situazione la bandiera dell’autonomia della politica viene impugnata da chi l’ha maggiormente affossata sostenendo un regime come quello berlusconiano in cui politica ed economia erano indistinguibili (si veda la manifestazione annunciata per oggi dal Foglio, Libero e il Giornale). E la bandiera della critica all’Europa tecnocratica viene impugnata da chi, come la Lega, dell’Europa politica è sempre stato acerrimo nemico. Un rovesciamento delle parti in cui noi stessi, al manifesto, non ci sentiamo propriamente a nostro agio, ma tant’è.
Ancora un punto, quello che in queste ore appassiona di più le cronache. Giustamente, da parte delle posizioni sia Pd sia Pdl più caute nell’appoggiare la soluzione-Monti, viene la richiesta che se governo tecnico dev’essere, che lo sia davvero: che sia composto di tecnici, che non coinvolga i partiti più del necessario e del dovuto, che abbia un programma definito e un tempo limitato. E’ una cautela consapevole del big bang che questo governo può innescare nei singoli partiti e nelle coalizioni sia di centrodestra sia di centrosinistra, e nello stesso bipolarismo. Un big bang che tuttavia di tutti i danni non sarebbe certo il maggiore, e anzi forse non sarebbe un danno. Sotto di esso però, neanche tanto nascosto, c’è un altro pericolo: che il passaggio-Monti serva a ratificare definitivamente quel ruolo ancillare del Pd rispetto a un equilibrio centrista garante dei «poteri forti» al quale fin dall’89 si tenta di inchiodare il resto di quella che fu la più grande sinistra d’Occidente. E non è un affatto un caso che questo nodo torni al pettine all’uscita dall’anomalia berlusconiana, come ultimo e decisivo atto della «normalizzazione europea» del laboratorio italiano.
-
-
> IL PRESIDENTE NAPOLITANO: «Non abbiamo bisogno di contrapposizioni». «Svolgo il mio mandato in condizioni difficili»6 ottobre 2011, di Federico La Sala
«GUAI A CONTRAPPORRE L’IDEA FEDERALISTA ALL’ESIGENZA DI UNITÀ»
Napolitano: «Svolgo il mio mandato in condizioni difficili»
Il presidente della Repubblica: L’Italia ha bisogno di tutto fuorché di essere divisa da pregiudizi e contrapposizioni
«Non abbiamo bisogno di contrapposizioni» *
MILANO.- «Ringrazio tutti voi e in particolare quel mare di bambini che mi ha accolto in modo gioioso e che dà anche a me la fiducia necessaria per svolgere il mio mandato in condizioni difficili giorno per giorno» così ha parlato il presidente della Repubblica in visita a Biella «L’Italia di tutto ha bisogno fuorchè di essere divisa da pregiudizi e da contrapposizioni che non ci portano da nessuna parte». E ha rilanciato:«Occorrono spirito di sacrificio e slancio innovativo per ricollocare l’Italia in un mondo che è così cambiato».
RIDURRE IL DEBITO PUBBLICO - La sfida di uscire dalla crisi si può affrontare solo nel quadro dell’Europa unita, in cui «l’Italia deve rimanere» con il ruolo e «l’impegno dei paesi fondatori dell’Europa, accettandone i vincoli di disciplina per poi poter fare appello alla solidarietà». «Dobbiamo avere una finanza pubblica risanata - ha aggiunto Napolitano - e liberarci del fardello del debito e nello stesso tempo dobbiamo creare i presupposti della crescita e dell’occupazione». E facendo riferimento all’industria del tessile, bastione dell’economia biellese ha poi aggiunto: «Spero che mi possiate arruolare con una tessera speciale tra i tessitori dell’Unità dell’Italia».
AUTONOMIA, FEDERALISMO, UNITÀ - In un discorso pubblico ad Aosta, il presidente è poi tornato, come ha già fatto più volte nei giorni scorsi, sul tema del federalismo e sull’unità del Paese. «Guai a contrapporre una parte del Paese ad un’altra - ha detto -. Guai a contrapporre un’idea di autonomia e anche di ispirazione federalista all’esigenza di unità italiana nel quadro più ampio dell’unità europea». Per Napolitano la strada del federalismo va percorsa, ed è un dovere costituzionale farlo, ma con «grande serietà» ed evitando i proclami. «Non ci sono dubbi sul dovere costituzionale di attuazione del titolo V della Costituzione» sul federalismo, ha spiegato il capo dello Stato. Ma «il pezzo di strada che ancora manca deve essere fatto con grande serietà, ponderazione e non con proclamazioni».
 Redazione Online
Redazione Online* Corriere della Sera, 06 ottobre 2011 18:34
-
> L’ASTUZIA DEL LUPO E I SETTE CAPRETTI. --- Napolitano ha rotto un pezzo dell’incantesimo che blocca il Paese in questa lunga agonia del berlusconismo (di Ezio Mauro - La coscienza dello Stato)..2 ottobre 2011, di Federico La Sala
La coscienza dello Stato
di Ezio Mauro (la Repubblica, o1.10.2011)
Ieri Giorgio Napolitano ha rotto un pezzo dell’incantesimo che blocca il Paese in questa lunga agonia del berlusconismo. Spazzando via false credenze, mitologie e leggende politiche che pure hanno imprigionato e condizionato l’attività di questo governo, il Capo dello Stato ha detto chiaramente quel che la politica (anche di opposizione) non riesce a spiegare: non esiste un popolo padano, pensare ad uno Stato lombardo-veneto che competa nella sfida della globalizzazione mondiale è semplicemente grottesco, e una via democratica alla secessione è fuori dalla realtà.
Dopo queste parole, vivere nella finzione non sarà più possibile. Ci vuole coraggio istituzionale - quindi responsabilità - nel pronunciarle, perché l’Italia politica ha accettato per anni che crescesse dentro la cultura della destra berlusconiana questa leggenda nera della secessione possibile, della Padania immaginaria, fino alla buffonata delle false sedi ministeriali al Nord, col ritratto di Bossi appeso ai muri. Oggi, semplicemente e finalmente, lo Stato dimostra di avere coscienza e nozione di sé, e dice di essere uno e indivisibile, frutto di una vicenda nazionale e di una storia riconosciuta.
È una frustata alla politica, Lega, governo e maggioranza in primo luogo: ma anche all’opposizione. Napolitano infatti denuncia la rottura del rapporto tra eletti ed elettori, come se la politica si sentisse irresponsabile. E proprio nel giorno in cui le firme per il referendum abrogativo hanno raggiunto un milione e duecentomila, chiama in causa per questo il Porcellum: voluto e votato da Berlusconi e dalla Lega, colpevole di aver spostato la scelta dei parlamentari nelle mani dei capi-partito, spezzando il collegamento tra i cittadini e i loro rappresentanti. Per questo il Presidente chiede espressamente una nuova legge elettorale per ripristinare la fiducia nelle istituzioni.
Guai se le parole del Quirinale restassero inascoltate, al punto in cui è giunta la disaffezione dei cittadini verso il sistema politico-istituzionale. È un invito a dire la verità, a farla finita con gli inganni, a restituire la parola ai cittadini, a "cambiare aria" nel Palazzo. Se accadrà, anche la finzione di governo che si arrocca a Palazzo Chigi avrà vita breve.
-
> L’ASTUZIA DEL LUPO E I SETTE CAPRETTI. ---- UN SIMULACRO DI GOVERNO E I COLPI DI CODA DI UN ANIMALE FERITO. Perché va strappato il bavaglio alla libertà (di Stefano Rodotà).29 settembre 2011, di Federico La Sala
Perché va strappato il bavaglio alla libertà
Un simulacro di governo e una maggioranza a pezzi vogliono impadronirsi della vita e della libertà delle persone, con un attacco senza precedenti contro i diritti fondamentali. Si dice che i colpi di coda dell’animale ferito siano i più pericolosi. È quello che sta accadendo.
di Stefano Rodotà (la Repubblica, 29.09.2011)
Dopo che l’articolo 8 del decreto sulla manovra economica ha cancellato aspetti essenziali del diritto del lavoro, ora si proclama la volontà di far approvare, con procedure accelerate e voti di fiducia, leggi che mettono il bavaglio all’informazione e negano il diritto di morire con dignità. Sarebbero così cancellati altri diritti. Quello di ogni cittadino ad essere informato, continuando così a vivere in una società democratica invece d’essere traghettato verso un mondo di miserabili arcana imperii. Quello all’autodeterminazione, dunque alla stessa libertà del vivere, che scompare nel testo sul testamento biologico. Tutte mosse in contrasto con la Costituzione. Bisogna essere consapevoli, allora, che non si tratta soltanto di opporsi a singole leggi, ma di impedire una inammissibile revisione costituzionale.
Bloccata nella primavera scorsa da una vera rivolta popolare, che aveva svegliato dal torpore i gruppi d’opposizione, torna ora, minacciosa e incombente, la legge bavaglio. Sappiamo quale sia il suo obiettivo. Impedire le intercettazioni, impedire la conoscenza dei loro contenuti. Conosciamo le sue giustificazioni. Tutelare la privacy dei cittadini, evitare uno Stato di polizia. Mai giustificazione fu più bugiarda. Se davvero le notizie riguardanti il Presidente del consiglio e la sua corte dei miracoli fossero state solo affare privato, irrilevanti per la vita pubblica e le responsabilità che essa impone, il Presidente della Cei non le avrebbe messe al centro di un vero atto d’accusa, d’una richiesta perentoria di rigenerazione della politica. Non che ci fosse bisogno di questo sigillo ecclesiale. Ma esso vale come conferma di una opinione comune.
Ricordiamo le regole di base. Nell’articolo 6 del Codice di deontologia dell’attività giornalistica (non una raccomandazione, ma una norma giuridica) si dice che "la sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica". Ho sottolineato le parole "alcun rilievo". Chi può in buona fede sostenere che il torbido intreccio tra inclinazioni personali e bisogno di soddisfarle a qualsiasi costo, che ha avvolto il Presidente del consiglio in una rete di relazioni pericolose e sulla soglia dell’illegalità, sia del tutto irrilevante per il giudizio su di lui e sul suo modo di governare? Può farlo una maggioranza che si è piegata all’imposizione e che, votando a favore di un testo che accreditava la convinzione di una Ruby nipote di Mubarak, ha scritto la pagina parlamentare più vergognosa della storia repubblicana. Ma non può farlo un sistema dell’informazione consapevole della dignità della sua funzione. Di fronte ad una norma come quella ricordata, vi è un dovere di rendere note le notizie, perché esse diventano essenziali per un corretto rapporto tra comportamento delle persone pubbliche e valutazioni dei cittadini.
Cade così la tesi della violazione della sfera privata, perché le figure pubbliche hanno una ridotta aspettativa di privacy. Non è una tesi inventata per aggredire Berlusconi, come ha insinuato qualche appartenente alla lunga schiera degli ignoranti pubblici. E’ una linea che risale ad una decisione della Corte suprema americana del 1964 e che ha trovato conferme dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, in particolare in un caso di pubblicazione di notizie riguardanti la presidenza Mitterrand, dove è stata addirittura ritenuta legittima la violazione del segreto istruttorio, perché la pubblicazione della notizia corrispondeva alla esigenza del pubblico di essere informato. La ragione è evidente e la Corte lo ha ripetuto molte volte: "la libertà d’informazione ha importanza fondamentale in una società democratica".
Questa è la premessa ineludibile quando si vuole affrontare la disciplina delle intercettazioni, Che cosa, invece, si cercò di fare in primavera e si cerca di rifare oggi? Non impedire la pubblicazione di informazioni prive di rilievo, ma creare una situazione di totale opacità a protezione di figure pubbliche che vogliono sottrarsi al legittimo controllo dell’opinione pubblica. E si vuole raggiungere questo fine con una duplice strategia: limitare il potere della magistratura di disporre intercettazioni, per impedire indagini su reati sgraditi e restringere così il flusso delle informazioni a disposizione dei cittadini; e impedire la pubblicazione delle intercettazioni legittime. Un doppio bavaglio, dunque, tanto meno giustificato, quanto più la discussione pubblica indicava una soluzione che offriva garanzie. Una udienza-filtro, nella quale eliminare le informazioni irrilevanti e mantenere segrete quelle di rilevanza ancora dubbia, sì che diventano legittimamente pubblicabili solo le parti delle intercettazioni significative per le indagini e il giudizio.
Nel testo approvato dalla Commissione Giustizia della Camera era stata aperta una breccia in questa direzione, pur in un testo complessivamente inaccettabile per moltissimi motivi, uno dei quali riguarda una disciplina dei blog che, a parte la sostanziale ignoranza di questo mondo, introduce una inammissibile forma di censura. Ma le mosse annunciate dal Governo vanno oltre quel testo, usando pretestuosamente un vecchio e pessimo disegno di legge Mastella, travolto dalla critica dei mesi scorsi, per bloccare la pubblicazione fino alla conclusione delle indagini preliminari o dell’udienza preliminare (fino alla sentenza d’appello, per gli atti nel fascicolo del pubblico ministero). Almeno due anni di silenzio. Non avremmo saputo nulla della vicenda che portò alle dimissioni del Governatore della Banca d’Italia, nulla delle mille corruzioni che infestano l’Italia. Un black-out della democrazia, che creerebbe all’interno della società un grumo che la corromperebbe ancor più nel profondo. Le notizie impubblicabili non sarebbero custodite in forzieri inaccessibili. Sarebbero nelle mani di molti, di tutte le parti, dei loro avvocati e consulenti che ricevono le trascrizioni delle intercettazioni, gli atti d’indagine, gli avvisi di garanzia, i provvedimenti di custodia cautelare. Questo materiale scottante alimenterebbe i sentito dire, le allusioni, la semina del sospetto. Renderebbe possibili pressioni sotterranee, ricatti. Creerebbe un "turismo delle notizie", la pubblicazione su qualche giornali o siti stranieri di informazioni "proibite" che poi rimbalzerebbero in Italia.
Ancor più inquietante è il testo sul testamento biologico, violentemente ideologico, che cancella il diritto fondamentale all’autodeterminazione. Il legislatore si fa scienziato, in contrasto con sentenze della Corte costituzionale, escludendo dai trattamenti terapeutici alimentazione e idratazione forzata. Azzerando il consenso informato, riconsegna il corpo delle persone al potere politico e al potere medico, lo riduce ad oggetto, ripercorrendo la strada che ha portato alle grandi tragedie del Novecento.
Torna così la questione sollevata all’inizio. Come reagire? Grandissima è la responsabilità del Parlamento, all’interno del quale le forze d’opposizione devono adottare strategie eccezionali, perché eccezionale è la minaccia. Guai alla tentazione di misurare le iniziative sulle convenienze interne ai partiti. Per questo serve anche l’attenzione sociale, frettolosamente archiviata dopo le amministrative e i referendum, verso i movimenti che nei mesi passati si sono identificati con la Costituzione e che nulla perdoneranno ad attori politici che trascurassero questa enorme risorsa. Per questo il ruolo del sistema dell’informazione è cruciale, come lo è stato in primavera.
-
> NOTA DEL COLLE PER UNA LETTURA "PIU’ ATTENTA"!!! Saverio Romano ha giurato oggi al Quirinale in veste di nuovo ministro dell’Agricoltura, ma il presidente della Repubblica non ha mancato di manifestare le sue perplessità per le pesanti ombre giudiziarie che gravano sull’esponente dei Reponsabili.24 marzo 2011, di Federico La Sala
IL CASO
 Romano ministro dell’Agricoltura
Romano ministro dell’Agricoltura
 Napolitano: "Chiarisca la sua posizione"
Napolitano: "Chiarisca la sua posizione"Con lo spostamento di Galan ai Beni culturali, l’esponente dei Responsabili ha giurato al Quirinale. Il capo dello Stato: "Chiarire presto pesanti imputazioni a suo carico". Il nuovo membro del governo è sotto inchiesta per mafia e corruzione. Lui: "Mai stato imputato, il comunicato del Colle dice cose non vere". La replica: "Mai usato termini del genere". Opposizione all’attacco: "Il Cavaliere è sotto ricatto" *
ROMA - Va in porto il rimpasto di governo a lungo inseguito da Silvio Berlusconi, ma non senza intoppi. Saverio Romano ha giurato oggi al Quirinale in veste di nuovo ministro dell’Agricoltura, ma il presidente della Repubblica non ha mancato di manifestare le sue perplessità per le pesanti ombre giudiziarie che gravano sull’esponente dei Reponsabili. Nonostante questo, davanti alle sempre più pressanti richieste di Iniziativa Responsabile, fondamentale per la sopravvivenza dell’esecutivo, Berlusconi ha dovuto andare avanti comunque.
La nota del Colle. "Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano - si legge in una nota del Colle - dal momento in cui gli è stata prospettata la nomina dell’onorevole Romano a ministro dell’Agricoltura, ha ritenuto necessario assumere informazioni sullo stato del procedimento a suo carico per gravi imputazioni". "A seguito della odierna formalizzazione della proposta da parte del presidente del Consiglio, il presidente della Repubblica ha proceduto alla nomina non ravvisando impedimenti giuridico-formali che ne giustificassero un diniego - prosegue il comunicato - Egli ha in pari tempo auspicato che gli sviluppi del procedimento chiariscano al più presto l’effettiva posizione del ministro".
Parla il neoministro. La prima reazione di Romano è il "dispiacere" per la nota del Quirinale": "Non sono mai stato imputato". Pertanto, ipotizza una "confusione" da parte dell’ufficio stampa del Colle, visto che il comunicato diffuso è "contrario alla realtà" e "inoltre usa terminolgie improprie". Napolitano, assicura il neoministro, "non pensa quello che è stato scritto". "Io sono con la coscienza a posto", aggiunge. Romano prende il posto di Galan, spostato ai Beni culturali, poltrona lasciata vuota dall’ufficializzazione delle annunciate dimissioni di Sandro Bondi. Proprio ieri il Giornale di Sicilia aveva rivelato l’intenzione del gip palermitano Giuliano Castiglia di non voler archiviare l’inchiesta che vede il neoministro indagato per concorso esterno in associazione mafiosa. Contro Romano resta in piedi inoltre anche un procedimento per corruzione, aggravata dal fatto che sarebbe stata finalizzata a favorire Cosa Nostra, nato dalle dichiarazioni di Massimo Ciancimino.
Il Quirinale replica. Passa poco e si fa vivo l’ufficio stampa del Colle che pur non commentando le affermazioni di Romano, invita a una lettura "più attenta" della nota "nella quale non viene attribuita la qualificazione di ’imputato’". Un modo per sottolineare come il Quirinale non si senta chiamato in causa dalle frasi del neoministro.
Le reazioni. "La posizione di Napolitano dimostra in maniera incontrovertibile che Berlusconi non è più in grado di agire liberamente nella sua attività di governo. Ha dovuto sottostare al diktat dei Responsabili e nominare ministro Saverio Romano nonostante le note e annunciate perplessità del Quirinale - afferma il capogruppo di Fli alla Camera Italo Bocchino - è ormai evidente che siamo in una situazione senza precedenti che mette a repentaglio la libertà di azione del presidente del Consiglio". Per Massimo Donadi dell’Idv "un indagato per mafia non può fare il ministro". E anche il Pd parla di "debolezza" di Berlusconi che, "per puntellare la sua malandata maggioranza, ha dovuto sottostare a un vero e proprio ricatto".
Soddisfatto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e leader di Forza del Sud Gianfranco Miccichè: "Finalmente da oggi il Sud può contare su un altro suo uomo in Consiglio dei ministri". A fianco del neoministro si schiera il titolare della Difesa Ignazio La Russa: "Romano, assolutamente incensurato, ha solo una pendenza in corso, cioè una richiesta di archiviazione di un avviso di garanzia. La Costituzione dice che uno è innocente fino alla Cassazione, ma doversi difendere dalle lungaggini di una richiesta di archiviazione che ancora non è arrivata, mi pare veramente pretendere troppo da chiunque".
Quando Berlusconi disse... Era il 23 dicembre e il premier repingendo le accuse di "calciomercato" e di compravendita di parlamentari aveva aggiunto: "Non abbiamo nemmeno promesso cariche di governo. Si sono liberati posti in seguito all’uscita di Fli, ci sono 12-13 posti da assegnare ma nemmeno uno di questi posti verrà assegnato a coloro che per convinzione hanno dato supporto alla maggioranza in sostituzione di altri". La realtà, però, dice altro.
Le tensioni tra i Responsabili. Il gruppo, secondo quanto riferito, si è riunito per festeggiare l’ingresso di Romano nell’esecutivo. Ma da aprte di alcuni deputati sarebbe partita la richiesta delle promesse nuovo nomine: "Ora è arrivato il tempo per la nomina dei sottosegretari". E’ a questo punto che sarebbero emerse le contrapposizioni tra le varie componenti del gruppo: i Popolari dell’Italia di domani, fedeli a Romano, avrebbero rinnovato l’interesse per alcuni "incarichi di responsabilità " ma la richiesta sarebbe stata giudicata "eccessiva" dai presenti. A quel punto si sarebbe scatenata la ’bagarre’: Pid contro il resto dei gruppi.
* la Repubblica, 23 marzo 2011
-
> "APRITE, APRITE": SONO IL VOSTRO "PAPI"!!! ---- L’ITALIA CON "DUE PRESIDENTI" DELLA REPUBBLICA E I COSTITUZIONALISTI IN COMA PROFONDO (1994-2011).17 febbraio 2011
 L’ITALIA CON "DUE PRESIDENTI" DELLA REPUBBLICA: "CORTO CIRCUITO"!!! LA LUNGA OFFESA E LA DEVASTANTE OFFENSIVA DEL CAVALIERE DI "FORZA ITALIA" CONTRO L’ITALIA (1994-2011)!!!
L’ITALIA CON "DUE PRESIDENTI" DELLA REPUBBLICA: "CORTO CIRCUITO"!!! LA LUNGA OFFESA E LA DEVASTANTE OFFENSIVA DEL CAVALIERE DI "FORZA ITALIA" CONTRO L’ITALIA (1994-2011)!!!
 L ’ITALIA, IL "BIPOLARISMO PRESIDENZIALE", E I COSTITUZIONALISTI IN COMA PROFONDO (1994-2011). Sul nodo dello scioglimento delle camere, una intervista di Nino Luca al giurista Piero Alberto Capotosti
L ’ITALIA, IL "BIPOLARISMO PRESIDENZIALE", E I COSTITUZIONALISTI IN COMA PROFONDO (1994-2011). Sul nodo dello scioglimento delle camere, una intervista di Nino Luca al giurista Piero Alberto Capotosti
-
> "APRITE, APRITE": SONO IL VOSTRO "PAPI"!!! ---- LA MISURA E’ COLMA. PREPARIAMOCI A TUTTO (di Ezio Mauro - di Antonio Padellaro).16 febbraio 2011, di Federico La Sala
Prepariamoci a tutto
di Antonio Padellaro (il Fatto, 16.02.2011)
Ripeterlo è perfino inutile. In qualsiasi altra democrazia al mondo un premier indagato per prostituzione minorile non sarebbe restato un minuto di più al suo posto. Pensate a Cameron, a Sarkozy, a Zapatero. Come avrebbero potuto tirarla in lungo accusando di qualsiasi cosa magistratura e informazione senza rischiare una rivolta di piazza? Figuriamoci se rinviati a giudizio con una motivazione di un giudice terzo, il gip, che parla di “evidenza delle prove”.
Ma in Italia c’è Berlusconi e anche in queste ore di marasma e di vergogna, mentre tutti i notiziari del globo aprono con la notizia che è senza precedenti, a Palazzo Grazioli il partito del tanto peggio può ancora alzare la voce. Fregatene, resisti, vai avanti: così lo consiglia la corte dei venduti e dei parassiti che pur di non essere ricacciati nel nulla da cui sono stati tirati fuori (il vero miracolo italiano) lo sospingono di nuovo sul ring disposti a farlo massacrare pur di salvarsi.
Un uomo con un residuo di lucidità avrebbe già capito dal rumoroso silenzio di Bossi che perfino il più fedele alleato ne ha le scatole piene. E quella gelida frase del cardinal Bagnasco: “Occorre trasparenza” non suona forse come la campana a martello del Vaticano?
Con il Caimano ferito tutto è possibile. Ma se non darà ascolto alle voci del buon senso che gli indicano come unica via d’uscita le dimissioni immediate per poi giocarsi l’intera posta sul tavolo delle elezioni anticipate. Se, insomma, tenterà l’ultimo disperato arrocco trincerandosi dentro Palazzo Chigi con la sua maggioranza gonfiata da deputati comprati un tanto al chilo, allora toccherà all’opposizione uscire allo scoperto con un gesto forte, drammatico, senza precedenti come lo è il momento che viviamo. Se n’è già parlato: le dimissioni in blocco di tutti i gruppi e di tutti i parlamentari dell’opposizione. Camera e Senato già ridotte a enti inutili dall’inettitudine del governo non potrebbero sopravvivere. Un gesto estremo. Ma prepariamoci a ogni evenienza.
La misura è colma
di Ezio Mauro (la Repubblica, 16.02.2011)
Ci sono elementi di prova sufficienti per mandare subito Silvio Berlusconi a processo. Questa la decisione del gip, ieri, dopo aver vagliato le fonti di prova dei procuratori, in 15 pagine. Dunque l’inchiesta è chiusa e si apre il processo, dal 6 aprile. L’atto d’accusa, che ha già fatto il giro del mondo, riguarda due reati gravissimi per un Primo Ministro: concussione e prostituzione minorile.
Secondo l’accusa si tratta di reati collegati tra loro. Il Capo del governo ha esercitato una pressione illecita sulla questura di Milano per far liberare nottetempo la giovane Ruby, proprio perché voleva impedire che la ragazza parlasse delle notti ad Arcore da minorenne, compreso il bunga bunga di Stato. La vera cifra di questa vicenda è l’abuso di potere. Una concezione di sé e del mondo all’insegna della dismisura sia nel privato che nel pubblico, un potere che non riconosce limiti, sproporzionato e dunque abusivo nella sua pretesa di essere impudente e impunito, fuori da ogni regola, ogni legge e ogni controllo.
Ieri la "struttura Delta" (che si muove sul confine tra azienda e Stato, politica e marketing) aveva organizzato per il Premier una missione di Stato in Sicilia, tra la propaganda e la paura davanti alla nuova ondata migratoria. Ma il Presidente del Consiglio, dopo la decisione del gip, è tornato d’urgenza a Roma dai suoi avvocati annullando tutti gli impegni, e soprattutto la conferenza stampa già fissata. Perché - ecco il punto capitale - non è in condizione di dire agli italiani la verità sui suoi scandali, e non sa assumersene la responsabilità davanti al Paese.
Ora il suo istinto populista lo spingerà a incendiare il Palazzo, attaccando i magistrati e travolgendo le istituzioni, fino alla distruzione del tempio. La politica che lo circonda non ha l’autonomia per distinguere il suo futuro dal destino del Premier, ma è condannata a seguirlo nel pozzo della sua ossessione. Ecco perché la strada maestra, a questo punto, è una sola: il voto, col giudizio dei cittadini. I quali hanno definitivamente capito che la misura è ormai colma.
-
> "APRITE, APRITE": SONO IL VOSTRO "PAPI"!!! --- Il Gip di Milano ha disposto il giudizio immediato nei confronti di Silvio Berlusconi per i reati di concussione e prostituzione minorile. Il processo si aprirà il 6 aprile davanti alla quarta sezione penale composta da 3 donne.15 febbraio 2011, di Federico La Sala
BUFERA GIUDIZIARIA SUL PREMIER
Scandalo Ruby, il gip di Milano: "Berlusconi a giudizio immediato"
Il Cavaliere a processo il 6 aprile per concussione e prostituzione. Il Viminale e la ragazza parti lese Bersani: dimissioni e voto subito
MILANO Il Gip di Milano ha disposto il giudizio immediato nei confronti di Silvio Berlusconi per i reati di concussione e prostituzione minorile. Il processo si aprirà il 6 aprile davanti alla quarta sezione penale composta da 3 donne: Giulia Turri, Carmen D’Elia e Orsola De Cristofaro. La decisione ha immediatamente fatto esplodere la polemica tra i partiti con la maggioranza che parla di «uso politico della giustizia» e l’opposizione, col segretario del Pd Pierluigi Bersani in testa, che chiede le «dimissioni» del premier e le «elezioni anticipate».
Tutto inizia con una nota firmata dal presidente dell’ufficio Gip, Gabriella Manfrin: «In data odierna il giudice per le indagini preliminari Cristina Di Censo, ha depositato il decreto con cui si dispone giudizio immediato a carico dell’onorevole Silvio Berlusconi». La procura gli contesta di aver abusato della qualità di presidente del Consiglio per indurre i funzionari della questura di Milano, la notte tra il 27 e il 28 maggio dell’anno scorso, ad affidare Ruby alla consigliera regionale Nicole Minetti e per avere avuto rapporti sessuali con la minorenne ad Arcore tra il 14 febbraio e il 2 maggio. Parti offese vengono indicati il ministero dell’interno, la giovane marocchina e i tre funzionari della Questura presenti quella notte, Pietro Ostuni, Giorgia Iafrate e Ivo Morelli. «Ora andremo in udienza», si limita a dire il capo dei Pm Edmondo Bruti Liberati. L’accusa sarà sostenuta dagli stessi Pm che hanno svolto le indagini: Ilda Boccassini, Antonio Sangermano e Pietro Forno. «Ce lo aspettavamo», ha dichiarato Piero Longo, uno dei legali del premier.
Sul fronte politico, tra i primi a intervenire il capogruppo Pdl alla Camera Fabrizio Cicchitto: «Il governo va avanti resistendo a questi tentativi di manomettere l’equilibrio politico del Paese». «Mai nella storia d’Italia vi è stato un uso della giustizia così finalizzato alla lotta politica. È inevitabile un intervento del Capo dello Stato». Sollecita il ministro per l’Attuazione del Programma Gianfranco Rotondi. E a scendere in campo è anche il ministro della giustizia Angelino Alfano: «Evidentemente il Gip non ha tenuto conto del voto della Camera», dice aggiungendo che il tema «attiene alla sovranità e all’indipendenza del Parlamento» sulle quali non è il governo «che deve intervenire». Non c’è però nessun motivo per le dimissioni del premier: «E la presunzione d’innocenza?».
Il capogruppo del Pd alla Camera Dario Franceschini invita invece Berlusconi «a difendersi davanti ai giudici» e risparmiare «al Paese la figura di un presidente del Consiglio processato per prostituzione minorile». No comment infine da parte della Lega: «Non rispondo a questa domanda». Taglia corto il ministro dell’Interno, Roberto Maroni.
* La Stampa, 15/02/2011
-
> "APRITE, APRITE" --- QUIRINALE. Napolitano smentisce che, nel faccia a faccia, il Cavaliere abbia evocato la piazza nel caso di condanna e conferma che l’incontro "ha in effetti visto il serio confronto tra rispettivi punti di vista e argomenti".13 febbraio 2011, di Federico La Sala
 IL CASO
IL CASO Quirinale, Napolitano avverte Berlusconi
Quirinale, Napolitano avverte Berlusconi
 "Stop a tensioni o legislatura rischia"
"Stop a tensioni o legislatura rischia" Nota del presidente della Repubblica dopo l’incontro di ieri con il premier:
Nota del presidente della Repubblica dopo l’incontro di ieri con il premier:
 "Confronto serio, mai evocato il ricorso alla piazza" *
"Confronto serio, mai evocato il ricorso alla piazza" *ROMA - Nell’incontro di ieri con il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, il Presidente della Repubblica "ha insistito su motivi di preoccupazione, che debbono essere comuni, sull’asprezza raggiunta dai contrasti istituzionali e politici, e sulla necessità di un sforzo di contenimento delle attuali tensioni in assenza del quale sarebbe a rischio la stessa continuità della legislatura". E’ quanto si legge in una nota diffusa dal Quirinale. Parole che confermano le voci che descrivevano un presidente della Repubblica preoccupato per i continui conflitti istituzionali.
Napolitano, poi, smentisce che, nel faccia a faccia, il Cavaliere abbia evocato la piazza nel caso di condanna. E, in merito alla ’temperatura’ del colloquio il Quirinale - smentendo alcune ricostruzioni di stampa definite fantasiose - conferma che l’incontro "ha in effetti visto il serio confronto tra rispettivi punti di vista e argomenti".
* la Repubblica, 12 febbraio 2011: http://www.repubblica.it/politica/2011/02/12/news/napolitano_incontro-12371416/?ref=HREA-1
-
> "APRITE, APRITE": IL GOLPISMO DEL LUPO ---- Napolitano: "Il giusto processo è già garantito dalla Costituzione"!!!11 febbraio 2011, di Federico La Sala
GIUSTIZIA
Napolitano: "Il giusto processo è già garantito dalla Costituzione"
Dura presa di posizione del capo dello Stato a poche ore dal lungo incontro avuto con Berlusconi a Quirinale: "Fuori da questo quadro solo le tentazioni di conflitti istituzionali e di strappi mediatici" * i
ROMA - In Italia, grazie all’attuale Costituzione, a tutti è garantito un giusto processo. E’ questo in sintesi il messaggio che il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha voluto mandare al Paese incontrando stamani al Quirinale il comitato di presidenza del Csm. Il capo dello Stato, fra le altre cose, ha ricordato, come ha già detto durante la Giornata dell’Informazione che "nella Costituzione e nella legge possono trovarsi i riferimenti di principio e i canali normativi e procedurali per far valere insieme le ragioni della legalità nel loro necessario rigore e le garanzie del giusto processo". "Fuori di questo quadro - ha puntualizzato Napolitano - ci sono solo le tentazioni di conflitti istituzionali e di strappi mediatici che non possono condurre, per nessuno, a conclusioni di verità e di giustizia".
Una presa di posizione molto netta, al limite della bacchettata, che si è inevitabilmente ripercossa sull’incontro durato oltre un ora e un quarto avvenuto oggi pomeriggio al Quirinale tra il capo dello Stato e il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Un faccia a faccia, alla presenza anche del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni Letta, preceduto da notevole carico di tensione, dopo che fino all’altro ieri la presidenza della Repubblica lo aveva derubricato come ’inopportuno’ in seguito alle violente parole di Berlusconi sui pubblici ministeri e il documento del Pdl che definiva i magistrati di Milano "una avanguardia rivoluzionaria".
Sul contenuto e il clima dell’incontro per il momento non è trapelata alcuna indiscrezione. L’intervento di Napolitano ha però riscosso il plauso dal vicesegretario del Pd Enrico Letta. "Credo che le parole che il capo dello stato ha espresso prima dell’incontro con Berlusconi siano chiarissime. Noi difendiamo quelle parole, hanno tracciato un quadro e non si può andare oltre. Berlusconi ha varcato la soglia, non si può andare avanti così, perciò rinnoviamo la nostra richiesta di dimissioni per dare rapidamente la parola a cittadini di decidere da chi deve essere governato il paese".
* la Repubblica, 11 febbraio 2011
-
> "APRITE, APRITE": IL GOLPISMO DEL LUPO, LA PAROLA "ITALIA" ---- ATTACCO ALLO STATO (E COMA PROFONDO DELLE ISTITUZIONI e degli intellettuali). Carlo Galli non ha ancora capito la portata dell’autoinvestitura simbolica da parte del Presidente di un Partito a Presidente della Repubblica con il gioco del Nome!!! (di Carlo Galli - Attacco allo Stato)11 febbraio 2011, di Federico La SalaSTORIA D’ITALIA (1994-2011): HO FATTO, FACCIO, E FARO’ "CAUSA ALLO STATO"!!! Signor Presidente del Consiglio, "perché vuol fare causa allo Stato?". Ma devo ancora dirlo: chi è il "vero" Presidente della Repubblica?! IO: "Forza Italia"!, Viva il "Popolo della libertà"!!!
 ATTACCO ALLO STATO (E COMA PROFONDO DELLE ISTITUZIONI). Carlo Galli non ha ancora capito la portata dell’autoinvestitura simbolica da parte del Presidente di un Partito a Presidente della Repubblica con il gioco del Nome!!!
ATTACCO ALLO STATO (E COMA PROFONDO DELLE ISTITUZIONI). Carlo Galli non ha ancora capito la portata dell’autoinvestitura simbolica da parte del Presidente di un Partito a Presidente della Repubblica con il gioco del Nome!!!
-
> "APRITE, APRITE" ---- LA CACCIA AL "CARISMA" E TRE "PAPI" CONTRO LA COSTITUZIONE E CONTRO L’ITALIA.14 ottobre 2010, di Federico La Sala
-
> "APRITE, APRITE": ---- Porta Pia, festa grottesca (di Nicola Tranfaglia)21 settembre 2010, di Federico La Sala
Porta Pia, festa grottesca
La commistione tra autorità civili e religiose assomiglia al tentativo di far commemorare gli antifascisti da quelli che erano stati, negli anni ’30 e ’40, alleati con i loro nemici
di Nicola Tranfaglia (il Fatto, 21.09.2010)
Erano le cinque e un quarto del mattino quando il 20 settembre l’artiglieria italiana sparò i primi due colpi di cannone contro le mura di Roma all’altezza di Porta Maggiore e Porta Pia. La resa avvenne verso le undici del mattino dopo che Pio IX ha ordinato ai pontifici di presentare la bandiera bianca. I morti tra i bersaglieri sono 49, tra i pontifici 19. Pio IX, riuniti i diplomatici presso lo Stato Pontificio, definisce l’assalto “un attentato sacrilego” e dovranno passare altri cinquantanove anni prima che Mussolini e Pio XI firmino il Trattato del Laterano e i Patti annessi.
La pace tra Stato e Chiesa
DA QUEL MOMENTO regna, per così dire, la pace tra Stato e Chiesa ma la dittatura fascista lo ha fatto per avere la Chiesa dalla sua parte e non certo per realizzare la formula di Camillo Benso, conte di Cavour, che in anni lontani aveva detto: “Libera Chiesa in libero Stato.” E il Vaticano, a sua volta, ha ottenuto dallo Stato quel che non aveva mai avuto dalla classe dirigente liberale sul piano economico come su quello politico. Ed oggi, nel Ventunesimo secolo dopo che nel 1988 è stato rinnovato con qualche modifica il Concordato del 1929 e la Chiesa cattolica ha messo sull’attenti gran parte della classe politica, di governo e di opposizione, si può dire che la celebrazione del 1870 avviene nelle migliori condizioni possibili per la Santa Sede. Roma diventa Capitale con la legge appena approvata e il sindaco Alemanno che, da fascista che era è diventato un berlusconiano fervente, può celebrare oggi i centoquarant’anni della Breccia di Porta Pia non soltanto con il capo dello Stato ma anche con il cardinale segretario di Stato Tarcisio Bertone, come se la Chiesa fosse stata anch’essa dalla parte dell’Italia appena unificata piuttosto che contro a rispondere con le cannonate ai bersaglieri che premevano dal di fuori.
Ed è questo il centro della giornata di ieri e il significato che le autorità locali e centrali intendono fornire agli italiani, dimenticando quello che davvero l’arrivo dei bersaglieri aveva significato in quel mattino del 20 settembre 1870.
Non è un caso che oltre cinquanta tra associazioni, movimenti e forze politiche hanno deciso di festeggiare domenica la ricorrenza per non mischiarsi alle celebrazioni ufficiali. Ma se si guarda all’imponente serie di manifestazioni e di occasioni di visite e di mostre previste in questi giorni non si capisce davvero come Stato e Chiesa possano festeggiare insieme un avvenimento così limpido e chiaro.
L’Italia liberale del Risorgimento, dopo meno di dieci anni dall’unificazione nazionale, aveva deciso di scegliere Roma come sua Capitale e approfittando di un atteggiamento non negativo di due grandi potenze del tempo come la Francia e l’Inghilterra aveva mandato una spedizione ufficiale di soldati e di bersaglieri per entrare a Roma e far finire il Potere temporale dei Pontefici. E questo significato di fondo non si può rovesciare, celebrando la ricorrenza con la Santa Sede e con quel cardinale Bertone, segretario di Stato, che quando divenne vescovo di Genova si preoccupò immediatamente di chiudere gli archivi della diocesi per impedire che gli storici facessero luce sul ruolo del Vaticano nella fuga in Sudamerica dei criminali nazisti che si trovavano in Italia o che erano appena arrivati dalla Germania. Un amico mi ha detto, in questi giorni, che la commistione tra le autorità civili e religiose assomiglia al tentativo di far commemorare gli antifascisti da quelli che erano stati, negli anni Trenta e Quaranta, alleati con i loro nemici.
E si potrebbe dire ancora molto di peggio di fronte a questo spettacolo. A differenza dei francesi, noi non abbiamo nella nostra Costituzione all’inizio un articolo dedicato alla laicità dello Stato ma in vari punti del dettato costituzionale emerge con chiarezza il profilo laico della nostra democrazia parlamentare che riguarda i credenti come i non credenti e che dovrebbe spingere tutte le forze politiche, a cominciare da quelle di centrosinistra, a difendere il significato della Breccia di Porta Pia e la difesa della formula cavouriana. Nella cosiddetta “Prima Repubblica”, e soprattutto da parte di chi aveva partecipato ai lavori dell’Assemblea Costituente, anche tra cattolici come Aldo Moro era centrale la rivendicazione della laicità dello Stato come elemento fondamentale dell’attività politica e istituzionale.
Oggi, soprattutto dopo l’89 e la caduta delle grandi ideologie che avevano diviso il mondo negli anni della Guerra fredda, le classi dirigenti italiane e in particolare quelle più vicine e legate alla classe politica, sembrano aver perduto il senso delle distinzioni tra una sfera laica e una sfera religiosa. La destra berlusconiana, così priva di valori etici e politici, ha bisogno dell’appoggio del Vaticano e il papa attuale non ha avuto difficoltà fino a ieri ad appoggiarne l’azione di governo.
La sinistra e il Vaticano
QUANTO alla sinistra, la fine del comunismo ha favorito l’avvicinamento degli ex comunisti al Vaticano e ormai da anni essi si confondono con gli altri esponenti politici devoti alla Chiesa. Pochi di fatto - e noi dell’Italia dei Valori siamo tra questi - ritengono che, al di là della fede cattolica di ciascuno, che sia necessario sostenere con chiarezza una posizione che si riallacci a quella liberale e democratica dell’Ottocento ma anche del Novecento e del nuovo secolo: la parità di tutte le fedi religiose, la difesa della sfera politica dalle intromissioni della Chiesa e delle Chiese. E proprio questa incertezza della politica e il suo degrado evidente conducono alla situazione di oggi che è nello stesso tempo grottesca e paradossale: si vuol ricordare la Breccia di Porta Pia e lo si fa con il sindaco fascista berlusconiano e con il segretario di Stato del Vaticano.
-
> "APRITE, APRITE": IL GOLPISMO DEL LUPO --- «È stata la risposta più responsabile a una sfida eversiva» (di Natalia Lombardo - Intervista a Stefano Rodotà).17 agosto 2010, di Federico La Sala
intervista a Stefano Rodotà
«È stata la risposta più responsabile a una sfida eversiva»
a cura di Natalia Lombardo (l’Unità, 17 agosto 2010)
«Conosco Napolitano, per aver fatto quella nota vuol dire che è arrivato proprio al colmo dell’indignazione », commenta il giurista Stefano Rodotà.
Ci può spiegare in quali casi si applica l’articolo 90 della Costituzione?
«Nel caso di attentato alla Costituzione, un caso estremo che hanno preso in considerazione i padri costituenti, prevedendo una procedura precisa: è il Parlamento che incrimina il presidente della Repubblica, con una maggioranza qualificata. Una tale situazione determina una crisi costituzionale. Ma vediamo i dati di realtà: c’è una contrapposizione insistita, non del Capo dello Stato verso il presidente del Consiglio, ma, al contrario, un attacco del premier contro il presidente della Repubblica. Già il giorno prima dell’aggressione al Duomo di Milano, Berlusconi parlando ai Dc attaccò Napolitano e la Corte Costituzionale. Quelli contro la Consulta, con toni ignoranti della funzione e della composizione, sono proseguiti; quelli personali a Napolitano sono stati meno plateali ma sono continuati».
Fino a questi ultimi giorni, con l’intervista a l’Unità...
«Infatti, Berlusconi non ha parlato esplicitamente, ma di fronte a certe dichiarazioni da esponenti della sua maggioranza, un presidente del Consiglio che abbia il senso delle istituzioni e dello Stato sarebbe dovuto intervenire. Ecco che torniamo all’articolo 90: l’irresponsabilità politica del presidente della Repubblica esige che, di fronte agli attacchi, sia il governo a coprirlo. Ora non solo questo non avviene, ma gli attacchi vengono dal governo. Tutto ciò ci porta a una situazione eversiva, quindi è del tutto comprensibile la nota di Napolitano: un atto di grande responsabilità, di rispetto delle istituzioni e della persona. Di fronte a un tentativo eversivo il Capo dello Stato deve mettere ognuno di fronte alle sue responsabilità. E lo ha fatto».
I precedenti di impeachment in Italia?
«L’unico fu quello di Cossiga, io ero in Parlamento e sottoscrissi la richiesta di un dibattito parlamentare. Era nato dagli attacchi continui che lui portò alla Costituzione».
Il Pdl, non solo Bianconi, sostiene che valga di più una«costituzione materiale », il dettato della Carta superato dalla prassi, e su questo attaccano Napolitano. Da giurista cosa ne pensa?
«Per il fatto che Napolitano abbia dato l’incarico a Berlusconi dopo che ha vinto le elezioni? Ma si è sempre fatto così, non poteva non farlo. Il cambiamento c’è stato nella legge elettorale, ma la nostra resta una Repubblica parlamentare. Lo stesso Napolitano ha ricordato più volte che i cambiamenti avvenuti non sono arrivati al punto da trasformare la Repubblica parlamentare in presidenziale, o con un regime plebiscitario per cui l’investito dal popolo è sottratto alla fiducia parlamentare. Non basta infatti l’incarico dal Quirinale, il presidente del Consiglio deve avere la fiducia dal Parlamento. Riassumendo: l’articolo 90 è quello che è, la situazione vede il tentativo di delegittimare Napolitano quando il premier avrebbe dovuto difenderlo: tutto questo rivela la volontà di spazzare il terreno, eliminare il controllo da parte dei due massimi organi custodi della legalità costituzionale: il Capo dello Stato e la Consulta».
Pdl e Lega gridano al «golpe» nell’ipotesi di un governo tecnico.
«Se con le dimissioni di Berlusconi Napolitano sciogliesse subito le Camere, senza verificare se può esserci un’altra eventuale maggioranza, questo sì incrinerebbe il tessuto costituzionale, perché attribuirebbe al presidente del Consiglio un potere che non ha. Non siamo in Inghilterra. Napolitano ha fatto questo tentativo alla caduta del governo Prodi, Scalfaro lo fece con Berlusconi stesso nel ‘95 e lì si trovò un’altra maggioranza».
Berlusconi lo chiama «ribaltone».
«Fu un Parlamento, non un’assemblea, a sostituire un governo con un altro. E la scelta di Dini da parte di Scalfaro era avvenuta sulla base dell’indicazione di Berlusconi stesso, che allora riconosceva la legittimità di queste procedure che ora rifiuta. Tra l’altro Napolitano ha fatto notare la gravità di una crisi interna e internazionale, quindi sarebbe una forzatura sciogliere le Camere in presenza di un’altra maggioranza. Se poi questa non c’è allora è inevitabile. Insomma,il discorso va ribaltato »
-
> "APRITE, APRITE": IL GOLPISMO DEL LUPO ----- IL PREDONE (di Giuseppe D’Avanzo).25 giugno 2010, di Federico La Sala
Il predone
di GIUSEPPE D’AVANZO *
PENSIAMO ogni volta di aver conosciuto di Berlusconi il volto peggiore, l’intenzione più maligna, la mossa più fraudolenta. Bisogna convincersene, quell’uomo sarà sempre in grado di mostrare un’intenzione ancora più maligna, una mossa ancora più fraudolenta, un volto ancora peggiore. Sappiamo che cosa è e rappresenta la cosa pubblica per il signore di Arcore, non dobbiamo scoprirlo oggi. È l’opportunità di ignorare e distruggere le inchieste giudiziarie che hanno ricostruito con quali metodi e complici e violenze Silvio Berlusconi ha messo insieme il suo impero. Non scopriamo adesso che il signore di Arcore si è fatto Cesare per evitare la galera (lo ha detto in pubblico senza vergogna il suo amico Fedele Confalonieri). E tuttavia, pur consapevoli che il potere berlusconiano sia esercitato in modo esplicito a protezione dei suoi interessi privati, lascia di stucco l’affaire Brancher.
La storia la si conosce. C’è questo signore, Aldo Brancher. Non se ne apprezza un pregio. Si sa che è stato assistente di Confalonieri in Fininvest. Con questo ruolo, tiene i contatti con socialisti e liberali nella prima repubblica. Detto in altro modo, è l’addetto alla loro corruzione. Il pool di Milano documenta nel 1993 che Brancher elargisce 300 milioni di lire al Psi e 300 al segretario del ministro della Sanità liberale (Francesco De Lorenzo) per arraffare a vantaggio della Fininvest un piano pubblicitario dello Stato.
Lo arrestano. Resta tre mesi a san Vittore. Non scuce una frase. Condannato in primo grado e in appello per falso in bilancio e finanziamento illecito, vede la luce in Cassazione grazie alla prescrizione del secondo reato e alla depenalizzazione del primo corrette, l’una e l’altra, dalle leggi "privatistiche" del governo Berlusconi. Il salvataggio del Capo e della Ditta gli vale, a titolo di risarcimento, l’incarico di messo tra il partito del presidente e la Lega di Bossi, uno scranno in Parlamento, un seggio di sottosegretario di governo. E da qualche giorno anche di ministro. Ministro senza incarico, senza missione, senza alcuna utilità per il Paese. Un ministro talmente superfluo che gli cambiano anche la delega dopo la nomina.
Fin dall’annuncio del suo ingresso nel governo, è chiaro a tutti - se non agli ingenui - che Aldo Brancher diventa ministro per un’unica necessità: egli deve opporre nel giudizio che lo vede imputato di appropriazione indebita nel processo Antonveneta il legittimo impedimento che Berlusconi si è affatturato per liberarsi dalle sue rogne giudiziarie. Ora che Brancher chiede di salvarsi dal giudizio perché ministro, anche gli ingenui hanno capito.
C’è qualcosa di umiliante e di illuminante in quest’affaire perché ci mostra in quale abisso di degradazione sono state precipitate le nostre istituzioni. Ci manifesta quale arretramento di secoli la nostra democrazia deve affrontare. Ci dice che le istituzioni coincidono ormai con le persone che le incarnano, anzi con la persona, quel solo uomo - il Cesare di Arcore - che le "possiede" tutte come cosa sua, Ditta sua, nella sua piena disponibilità proprietaria al punto che può eleggere il suo "cavallo" senatore o ministro uno dei suoi complici, pretendendo oggi per il ministro (e domani per il senatore, chissà) la stessa impunità che ha assegnato a se stesso.
Voglio dire che quel che abbiamo sotto gli occhi con il caso Brancher è nitido: il cesarismo, il bonapartismo, il peronismo - chiamatelo come volete - di Silvio Berlusconi non riconosce alle istituzioni, alle funzioni pubbliche dello Stato alcuna oggettività, ma soltanto la soggettività che egli - nel suo potere e volontà - di volta in volta decide di assegnare loro. Il governo è suo, di Berlusconi, perché il popolo glielo ha dato e così del governo ci fa quello che gli pare. Se vuole, lo trasforma - come per Brancher - in una casa dell’impunità per corifei e turiferari. Quel che l’affaire illumina è il lavoro mortale di indebolimento delle istituzioni. Di quelle istituzioni nate per arginare l’abuso e l’istinto di sopraffazione, per garantire sicurezza e stabilità, diffondere fiducia e cooperazione e diventate, nella democrazia plebiscitaria del signore di Arcore, strumento inutile, ferro rugginoso e inservibile.
Se la nomina a ministro può mortificarsi a capriccio e complicità vuol dire che la politica può fare a meno delle istituzioni. Certo, non si possono accantonarle formalmente, ma svuotarle, sì. Di ogni significato, rilevanza, legittimità, come accade al governo con l’uomo diventato ministro per evitare il giudice. Osserviamo ora la scena che Berlusconi ha costruito in questi due anni di governo. Il Parlamento è soltanto l’esecutore muto degli ordini dell’esecutivo. La Corte costituzionale e la magistratura devono essere presto subordinate al comando politico. La presidenza della Repubblica, priva della legittimità popolare, è soltanto un impaccio improprio. Il governo, già consesso obbediente agli ordini del sovrano, diviene ora e addirittura il premio per chi, con il suo servizio al Capo, si è guadagnato il vantaggio di rendersi legibus solutus come il sovrano. Tocchiamo qui con mano il conflitto freddo che si sta consumando tra una concezione della democrazia incardinata nella Costituzione, nei principi di una democrazia liberale basata sull’oggettività delle funzioni pubbliche e la convinzione che il voto popolare renda onnipotenti e consenta ogni mossa anche l’annichilimento delle istituzioni.
Umiliante e illuminante, l’affaire Brancher è anche educativo perché liquida almeno un paio di luoghi comuni del dibattito pubblico, specialmente a sinistra. Chi di fronte alle minacce estorsive del sovrano (o impunità o processo breve che blocca centinaia di migliaia di processi; o impunità o paralisi della macchina giudiziaria) trova sempre conveniente scegliere la "riduzione del danno" e "il male minore" saprà oggi quel che avrebbe già dovuto sapere da tre lustri: il Cesare di Arcore non ha inibizioni. È un predone. Lo guidano i riflessi. Quel che serve, lo trova d’istinto. Se gli si offre un arsenale, lo utilizza, statene certi, perché è ridicolo aspettarsi da Berlusconi self-restraint. Non esisteranno mai mali minori con lui, ma soltanto mali che annunceranno il peggio. Il secondo luogo comune dice che "l’antiberlusconismo non porta da nessuna parte". L’affaire Brancher conferma che non c’è altra strada che contrastare il berlusconismo se si vuole proteggere il Paese e le sue istituzioni da una prova di forza pre-politica, fuori delle regole che ci siamo dati. È anche questo il caso Brancher, una prova di forza. Che toccherà non solo all’opposizione contrastare. Fini, la Lega, i soliti neutrali potranno subirla senza mettere in gioco la rispettabilità di se stessi?
* la Repubblica, 25 giugno 2010
-
> "APRITE, APRITE": IL GOLPISMO DEL LUPO, LA PAROLA "ITALIA" CONSEGNATA A UN PARTITO (1994-2010), E I SETTE CAPRETTI. ---- IL NOSTRO 11 SETTEMBRE - LA PATRIA DELL’OBLIO COLLETTIVO (di Barbara Spinelli).6 giugno 2010, di Federico La Sala
La patria dell’oblio collettivo
di BARBARA SPINELLI (La Stampa, 6/6/2010)
Vorrei tornare sulle parole di Piero Grasso a proposito di mafia e politica, dette il 26 maggio a Firenze davanti alle vittime della strage dei Georgofili. L’intervista rilasciata a Francesco La Licata dal Procuratore nazionale Antimafia chiarisce infatti alcuni punti essenziali, e pone quesiti alla classe politica e a tutti noi. La domanda che formula, implicita ma ineludibile, è questa: come funziona la memoria collettiva in Italia? Come vengono sormontati i lutti, e vissuti i fatti tragici, i mancati appuntamenti con la giustizia?
In questo giornale ho cercato prime risposte, evocando la richiesta, formulata il 7-8-98, di archiviazione dell’indagine su Berlusconi e Dell’Utri per le stragi a Roma, Firenze e Milano nel ’93-’94: richiesta firmata da Grasso assieme a quattro magistrati, e accolta poi dal gip di Firenze. Nella richiesta era chiaro il nesso fra Cosa nostra e il soggetto politico nato dopo Tangentopoli (Forza Italia), ma mancavano prove di un’«intesa preliminare». Quell’atto mi parve più esplicito di quanto detto dal procuratore il 26 maggio, e su tale differenza mi sono interrogata. Ma l’interrogativo, più che Grasso, concerne in realtà i politici, e tramite loro l’Italia intera: giornalisti, elettori, ministri ed ex ministri di destra e sinistra.
Per chiarezza, vorremmo citare i principali passaggi della richiesta di archiviazione e confrontarli con quello che Grasso afferma oggi. Nella richiesta (da me impropriamente chiamata «verbale», domenica scorsa) è scritto: «Molteplici (sono) gli elementi acquisiti univoci nella dimostrazione che tra Cosa Nostra e il soggetto politico imprenditoriale intervennero, prima e in vista delle consultazioni elettorali del marzo 1994, contatti riconducibili allo schema contrattuale, appoggio elettorale-interventi sulla normativa di contrasto della criminalità organizzata». E ancora: il rapporto tra i capimafia e gli indagati (Berlusconi e Dell’Utri, citati come autore-1 e autore-2 e rappresentanti il nuovo «soggetto politico imprenditoriale» in contatto con Cosa nostra) «non ha mai cessato di dimensionarsi (almeno in parte) sulle esigenze di Cosa nostra, vale a dire sulle esigenze di un’organizzazione criminale». Il testo firmato da Grasso è inedito, ma gli argomenti che esso contiene appaiono in documenti che la classe politica conosce bene: il decreto di archiviazione dell’inchiesta di Firenze, e quello che archivia la successiva inchiesta di Caltanissetta su Berlusconi, Dell’Utri e le stragi di Capaci e via D’Amelio (3-5-02). Il testo è pubblicato da Giuseppe Lo Bianco e Sandra Rizza in un libro, «L’agenda nera», che uscirà il 10 giugno per Chiarelettere.
Ha ragione dunque il procuratore a dire che nella sostanza non c’è nulla di nuovo in quello che ha ricordato giorni fa a Firenze («Cosa nostra ebbe in subappalto una vera e propria strategia della tensione», per creare disordine e dare «la possibilità a una entità esterna di proporsi come soluzione per poter riprendere in pugno l’intera situazione economica, politica, sociale che veniva dalle macerie di Tangentopoli. Certamente Cosa nostra, attraverso questo programma di azioni criminali, che hanno cercato d’incidere gravemente e in profondità sull’ordine pubblico, ha inteso agevolare l’avvento di nuove realtà politiche che potessero poi esaudire le sue richieste»). Secondo alcuni il procuratore avrebbe oggi alzato il tiro, ma non è vero: semmai dice meno cose, su Forza Italia. Ed ecco la conclusione cui giunge nell’intervista: «L’idea che io mi sono fatto di quel terribile momento storico del ‘92 e del ‘93, molto prima dello scorso 26 maggio, era rintracciabile in moltissimi interventi pubblici, oltre che in tre libri pubblicati dal 2001 al 2009. Ritenevo e ritengo ancora quella ricostruzione storica una sorta di patrimonio della memoria collettiva definitivamente acquisito».
Proprio qui tuttavia è il punto che duole. L’osceno italiano di cui parla spesso Roberto Scarpinato, procuratore generale di Caltanissetta, e cioè il potere reale esercitato «fuori scena», di nascosto, esclude l’esistenza di un «patrimonio della memoria collettiva definitivamente acquisito». A differenza dell’America, o della Germania che di continuo rivanga il proprio passato nazista, l’Italia non ha una memoria collettiva che archivi stabilmente la verità e la renda a tutti visibile. Da noi la memoria storica si dissipa, frantumando e seppellendo fatti, esperienze, sentenze. E di questo seppellimento sono responsabili i politici, per primi.
Senza voler fare congetture, si può constatare che Grasso forse dice meno di quel che sottoscrisse nel ‘98, anche se dice pur sempre molto. Sono i politici a parlare più forte di quanto parlarono tra il ‘98 e oggi.
Sono i politici ad allarmarsi giustamente per le sue parole, a chiedere più verità, come se non avessero già potuto allarmarsi in occasione dei tanti atti giudiziari riguardanti quello che Grasso chiama «il nostro 11 Settembre: dall’Addaura, a Capaci, a via D’Amelio, fino alle stragi di Roma, Firenze, Milano e a quella mancata dello stadio Olimpico di Roma». Non sono i giudici ad aver dimenticato le deposizioni di Gabriele Chelazzi, il pm fiorentino titolare dell’inchiesta sui «mandanti esterni» delle stragi del ‘93, davanti alla commissione nazionale Antimafia il 2-7-02. Nella lettera ritrovata dopo la sua morte, Chelazzi si lamenta con i suoi uffici e scrive: «Mi chiamate alle riunioni solo per dare conto di ciò che sto facendo, quasi che fosse un dibattito».
È così che la memoria fallisce. Che l’osceno resta fuori scena, ostacolato solo dalle intercettazioni. Atti giudiziari e libri vengono sepolti nei ricordi perché sono trasformati in opinioni, per definizione sempre opinabili. Il vissuto viene trasferito nel mondo del dibattito e le sentenze diventano congetture calunniose. È quello che permette a Giuliano Ferrara, sul Foglio del 31 maggio, di squalificare le parole di Grasso definendole «ipotesi e ragionamenti» dotati di «uno sfondo politico e nessun avallo giudiziario». Il patrimonio della memoria collettiva, lungi dall’esser «definitivamente acquisito», è permanentemente cestinato.
I politici partecipano allo svuotamento della memoria usandola quando torna utile, gettandola quando non conviene più. Lo stesso allarme di oggi, non è detto che durerà. È come se nella mente avessero non un patrimonio, ma un palinsesto: un rotolo di carta su cui si scrive un testo, per poi raschiarlo via e sostituirlo con un altro che lascia, del passato, flebilissime tracce. L’intervista di Violante al Foglio, l’1 giugno, è significativa: in essa si dichiara che è arrivato il momento di «capire senza rimestare», di «mettere ordine» tra fatti forse non legati. Manca ogni polemica con il pesante attacco a Grasso, sferrato il giorno prima dal quotidiano.
Dice Ferrara che «non si convive inerti con un’accusa di stragismo a chi governa». Può darsi, ma l’Italia ha dimestichezze antiche con l’inerzia. Se non le avesse, non dimenticherebbe sistematicamente i drammi vissuti, e come ne è uscita. Non dimenticherebbe che del terrorismo si liberò grazie ai pentiti. Che tanti crimini sono sventati grazie alle intercettazioni. Come ha detto una volta Pietro Ichino a proposito dei ritardi della sinistra sul diritto di lavoro, in Italia «si chiudono le questioni in un cassetto gettando la chiave». È il vizio di tanti suoi responsabili (nella politica, nell’informazione) pronti a convertirsi ripetutamente. Pronti al trasformismo, a voltar gabbana. Chi non sta al gioco, chi nel giornalismo ha memoria lunga e buoni archivi, viene considerato uno sbirro, o un rimestatore, o, come Saviano, un idolo da azzittire e abbattere. Occorre una politica più attiva e meno immemore, se davvero si vuole che i giudici non esercitino quello che vien chiamato potere di supplenza.
-
> "APRITE, APRITE": IL GOLPISMO DEL LUPO ---- "PERTINI non avrebbe firmato" ... Lavoro -Legge anti articolo 18, il Quirinale studia il testo. il no di Napolitano (di Massimo Giannini).15 marzo 2010, di Federico La Sala
 Il Quirinale studia il testo ma l’orientamento è di rinviarlo alle Camere
Il Quirinale studia il testo ma l’orientamento è di rinviarlo alle Camere
 Non convince l’accordo raggiunto fra governo, Confindustria, Uil e Cisl
Non convince l’accordo raggiunto fra governo, Confindustria, Uil e Cisl Lavoro, il no di Napolitano
Lavoro, il no di Napolitano
 alla legge anti articolo 18
alla legge anti articolo 18 di MASSIMO GIANNINI *
di MASSIMO GIANNINI *"PERTINI non avrebbe firmato", c’era scritto su una decina di magliette fuori ordinanza, esibite sabato scorso, alla manifestazione viola sulle regole. Di fronte a questi sia pure isolati episodi di "fuoco amico", si può immaginare lo stato d’animo di Giorgio Napolitano. Non solo irritazione, ma anche indignazione. Proprio nelle stesse ore, infatti, il presidente della Repubblica sta meditando seriamente di rinviare alle Camere una delle ultime leggi volute dal governo. Si tratta del famigerato ddl 1167-B, quello che introduce la possibilità preventiva di ricorrere all’arbitro, invece che al giudice, in caso di controversie di lavoro.
In quel testo, approvato definitivamente dal Senato la scorsa settimana, c’è una norma che rischia di cambiare radicalmente il profilo del nostro diritto del lavoro, e il suo sistema di garanzie. Dall’articolo 31 in poi c’è scritto che le controversie tra il datore di lavoro e il suo dipendente potranno essere risolte anche da un arbitro, in alternativa al giudice. In sostanza, modificando l’articolo 412 del codice di procedura civile, si prevedono due possibilità alternative per la risoluzione dei conflitti: o la via giudiziale oppure quella arbitrale. L’innovazione principale è che già al momento della firma del contratto di assunzione, anche in deroga ai contratti collettivi, al lavoratore potrebbe essere proposto (con la cosiddetta clausola compromissoria) che in caso di contrasto futuro con l’azienda le parti si affideranno a un arbitro, e non a un giudice. Ebbene questa legge, che il Capo dello Stato ha già visionato sommariamente, suscita in lui forti perplessità. La sta esaminando insieme al "nucleo di valutazione" del Colle, formato da Salvatore Sechi, Donato Marra e Loris D’Ambrosio. Non ha ancora preso una decisione definitiva. Ma, allo stato attuale, sembra intenzionato a non firmare la legge. E a rinviarla al Parlamento con messaggio motivato, per una nuova deliberazione. Secondo i poteri che gli assegna l’articolo 74 della Costituzione e che può attivare anche per provvedimenti non necessariamente inficiati da "vizi palesi" di legittimità costituzionale.
La norma è stata già contestata dalla Cgil. Guglielmo Epifani la considera uno strumento che aggira le tutele previste dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. "Quel testo - osserva - viola chiaramente la Costituzione, e noi siamo pronti a fare ricorso alla Consulta". Non a caso la Cgil ha posto anche questa "aggressione ai diritti dei lavoratori" al centro del suo sciopero di venerdì scorso. Il ragionamento di Epifani è semplice: l’arbitrato è un istituto assai meno garantista per il lavoratore, rispetto alla tutela giurisdizionale assicurata da un magistrato della Repubblica. Oltretutto, se l’opzione per la via arbitrale gli viene prospettata all’atto dell’assunzione, tanto più in una fase di drammatica crisi occupazionale, il lavoratore rischia di essere esposto ad un "ricatto" implicito, che lo coglie nel momento della sua massima debolezza negoziale. Per questo la Cgil va avanti con il suo appello già firmato da giuslavoristi come Luciano Gallino, Umberto Romagnoli, Massimo Paci, Tiziano Treu e giuristi come Massimo Luciani e Andrea Proto Pisani. E per questo, proprio lunedì della scorsa settimana una delegazione della sinistra guidata da Paolo Ferrero è salita al Quirinale, per chiedere al presidente della Repubblica di respingere l’ennesimo "schiaffo" ai diritti costituzionali. Napolitano ha preso immediatamente a cuore la questione. Forse anche per queste ragioni il ministro del Welfare Sacconi si è affrettato a gettare acqua sul fuoco: "Il diritto sostanziale del lavoro, incluso l’articolo 18 dello Statuto, non è stato minimamente toccato". Per prevenire possibili censure di costituzionalità al provvedimento, e per "disarmare" l’offensiva di Epifani, il governo giovedì scorso ha anche raggiunto un "avviso comune" con gli altri sindacati, Cisl e Uil, e con la Confindustria: "Le parti - si legge nella dichiarazione congiunta - riconoscono l’utilità dell’arbitrato, scelto liberamente e in modo consapevole, in quanto strumento idoneo a garantire una soluzione tempestiva delle controversie in materia di lavoro a favore delle effettività, delle tutele e della certezza del diritto... e si impegnano a definire con tempestività un accordo interconfederale, escludendo che il ricorso delle parti alle clausole compromissorie poste al momento dell’assunzione possa riguardare le controversie relative alla risoluzione del rapporto di lavoro".
Il governo, insomma, ha cercato di giocare d’anticipo. Ma quanto vale un accordo "restrittivo" tra le categorie produttive (e neanche tutte), rispetto a una norma di legge che in linea teorica non pregiudica comunque il ricorso all’arbitrato, in aggiramento dell’articolo 18 e all’atto dell’assunzione? Questo è il dubbio, sul quale si sta esercitando il Colle nell’esame del testo della legge. Un dubbio che è largamente suffragato dai pareri di giuristi e dai costituzionalisti. Come Mario Dogliani, professore emerito di diritto costituzionale all’Università di Torino: "La legge presenta rischi evidentissimi. Se il lavoratore, al momento dell’assunzione, sceglie le modalità con cui il trattamento di fine rapporto verrà effettuato, è chiaro che la tutela legislativa viene svuotata. Il rapporto di lavoro è tutelato, in Italia, dalla legge in primis, quindi dalla legge di fronte a un giudice. Con le nuove norme si può escludere questo tipo di tutela. Mentre il giudice è un soggetto garantito dalla legge, l’arbitro applica principi di giustizia indipendentemente da ciò che stabilisce la legge". O come Luigi Ferrajoli, docente di teoria generale del diritto all’Università Roma Tre: "Ci sono almeno due profili di incostituzionalità. Il primo è la violazione dell’articolo 24, che stabilisce "tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi". Si tratta di un diritto fondamentale, inalienabile e indisponibile, che la nuova legge viola palesemente, portando un colpo non solo all’articolo 18 ma all’intero diritto del lavoro. Il secondo profilo di incostituzionalità è contenuto nell’articolo 32 della legge, che vincola il giudice a un mero controllo formale sul "presupposto di legittimità" delle clausole generali e dei provvedimenti dei datori di lavoro, escludendone "il sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro". Anche qui c’è una forte riduzione degli spazi della giurisdizione e quindi del diritto dei lavoratori alla tutela giudiziaria. È una chiara violazione, oltre che dell’articolo 24 della Costituzione, anche dell’articolo 101, secondo cui i giudici sono soggetti soltanto alla legge". O ancora come Piergiovanni Alleva, docente di diritto del lavoro all’Università Politecnico delle Marche: "Certamente questa legge non è costituzionale". O infine come Tiziano Treu: "Nel settore privato un arbitrato senza regole affidate al singolo è contrario ai principi costituzionali di tutela del lavoro, connessi agli articoli 1, 4 e 35 della Costituzione. Nel settore pubblico l’arbitrato libero viola l’articolo 97 della Costituzione, perché l’arbitro potrebbe decidere addirittura su assunzioni e promozioni, al di fuori delle regole del concorso pubblico". Insomma, nel dossier allo studio del Quirinale le opinioni critiche dei giuristi sono tante, e tutte ben argomentate. E non manca, ovviamente, anche un’antologia della giurisprudenza costituzionale. Per esempio una sentenza della Consulta, la 232 del 6-10 giugno 1994: "Come in più occasioni stabilito da questa Corte (da ultimo sentenze n.206 e n. 49 del 1994) l’istituto dell’arbitrato non è costituzionalmente illegittimo, nel nostro ordinamento, esclusivamente nell’ipotesi in cui ad esso si ricorra per concorde volontà delle parti... In tutti gli altri casi... ci si pone in contrasto con l’articolo 102 primo comma della Costituzione, con connesso pregiudizio del diritto di difesa di cui all’articolo 24 della stessa Costituzione". Appunto: nel caso della legge appena approvata il problema è il seguente: se è vero che al momento dell’assunzione il consenso congiunto delle parti sulla via arbitrale ci sarebbe (ancorché condizionato dalla posizione di oggettiva debolezza del lavoratore) è legittimo trasformarlo in un’ipoteca sulle scelte future, precludendo per sempre al lavoratore la via giurisdizionale? Questi sono i quesiti che potrebbero spingere Napolitano a decidere un rinvio della legge. Sul tema del lavoro, e della difesa dei lavoratori, il Capo dello Stato ha fatto sentire più volte la sua voce: "C’è ragione di essere seriamente preoccupati per l’occupazione, per le condizioni di chi lavora e di chi cerca lavoro... Mi sento perciò vicino ai lavoratori che temono per la loro sorte... così come ai giovani precari che vedono con allarme avvicinarsi la scadenza dei loro contratti, temendo di restare senza tutela. Parti sociali, governo e Parlamento dovranno farsi carico di questa drammatica urgenza, con misure efficaci ispirate a equità e solidarietà... Dalla crisi deve, e può uscire un’Italia più giusta... ". Il presidente l’aveva detto nel messaggio di auguri agli italiani, alla fine dello scorso anno. Il rovello giuridico e politico che lo tormenta, oggi, è proprio questo: la nuova legge sull’arbitrato rientra nelle "misure efficaci ispirate a equità e solidarietà" che lui stesso aveva auspicato? Ed è da norme come quella che può venir fuori "un’Italia più giusta"?. Questione di ore, e lo capiremo. Ma allo stato attuale il presidente una risposta sembra se la sia già data. E quella risposta è no.
m.giannini@repubblica.it
© la Repubblica, 15 marzo 2010
-
> "APRITE, APRITE": IL GOLPISMO DEL LUPO, LA PAROLA "ITALIA" ---- BERTRAND RUSSELL: LA LEZIONE SUL MENTITORE (IGNORATA E ’SNOBBATA’), E "L’ALFABETO DEL BUON CITTADINO".2 febbraio 2010, di Federico La SalaCOSTITUZIONE, LINGUA, E PAROLA: BERTRAND RUSSELL: LA LEZIONE SUL MENTITORE (IGNORATA E ’SNOBBATA’), E "L’ALFABETO DEL BUON CITTADINO".
-
> "APRITE, APRITE": IL GOLPISMO DEL LUPO, LA PAROLA "ITALIA" CONSEGNATA A UN PARTITO (1994-2009), E I SETTE CAPRETTI. ----- EMERGENZA NAZIONALE (di Carlo Federico Grosso)30 gennaio 2010, di Federico La Sala
Emergenza nazionale
di CARLO FEDERICO GROSSO (La Stampa, 30/1/2010)
Fra politica e magistratura sono tempi di grande tensione. Ma ieri, all’inaugurazione solenne dell’anno giudiziario in Cassazione davanti al parterre delle alte cariche dello Stato, i toni sono stati misurati e composti. È bene che sia stato così, anche se i problemi esistono, sono profondi e non sono certamente le chiacchierate di un mattino a dissiparli.
Il Primo Presidente e il Procuratore Generale della Cassazione hanno pronunciato parole condivisibili. Sullo sfondo vi era, ovviamente, il tema del «processo breve» appena votato in Senato dalla maggioranza con l’intento di salvaguardare il premier dai processi in corso. Entrambi i due alti magistrati hanno sottolineato che un processo rapido costituisce, comunque, esigenza imprescindibile di ogni società civile. Ma hanno soggiunto che l’obiettivo non può essere conseguito tramite leggi di giornata, asfittiche e di corto raggio; deve essere invece perseguito attraverso riforme organiche di vasto respiro, accompagnate da un potenziamento delle risorse umane e materiali destinate all’esercizio della giurisdizione.
Parole ineccepibili, che il mondo del diritto pronuncia da anni, ma che, per anni, sono state ignorate dalla politica che, giorno dopo giorno, ha lasciato che la giustizia s’impoverisse. Ha ragione il Primo Presidente a denunciare l’intollerabilità di una situazione che, nella gerarchia mondiale in materia di giustizia, vede l’Italia solo al centocinquantesimo posto, al pari del Gabon, della Guinea e dell’Angola. Ma occorre ricordare che, se ciò è capitato, è soprattutto colpa di chi, al governo e in Parlamento, a tutto ha pensato tranne che a rendere efficiente la macchina giudiziaria dotandola, per legge, dei mezzi e degli strumenti necessari.
Ed occorre, ulteriormente, ricordare, ancora una volta con le parole del Primo Presidente, che senza un disegno riformatore di ampio respiro della legislazione penale e dell’organizzazione giudiziaria sarebbe vano pretendere di «imporre ex lege una risposta di giustizia che possa in concreto essere breve ed efficace a fronte di un crescente carico di domanda». In altre parole, prescrivere per legge un processo breve senza dotare gli addetti dei mezzi e degli strumenti idonei a rispettare i tempi stabiliti, significa introdurre, semplicemente, una mannaia destinata a cancellare processi, condanne, soluzioni giudiziarie. Un disastro ulteriore, e forse definitivo.
Il ministro della Giustizia, stando alle notizie di agenzia, ha cercato di abbozzare, riconoscendo che la condizione della giustizia italiana, specie di quella civile, costituisce «una vera e propria emergenza nazionale», ed annunciando «un piano straordinario di smaltimento delle pendenze». In realtà, sarebbe necessario un progetto complessivo di intervento sui codici civili e penali, sugli organici del personale giudiziario, sulla distribuzione delle sedi giudiziarie, sulla copertura dei posti vacanti. Non un intervento straordinario, ma un ordinario, serio, riassetto globale del sistema legislativo e giudiziario.
Un’ultima annotazione. Sempre il ministro, in un unico accenno leggermente polemico in una giornata «pacificante» ricca di composto equilibrio istituzionale, ha dichiarato di avere rispetto per l’indipendenza dell’ordine giudiziario, ma ha sottolineato che «i giudici sono soggetti alla legge» e che «la legge la fa il Parlamento libero, democratico, espressione del popolo italiano», quello stesso popolo italiano in nome del quale i giudici pronunciano le loro sentenze.
Anche questa è annotazione, di per sé, assolutamente condivisibile, costituendo, ciò che è stato detto, fotografia della divisione dei poteri propria dello Stato di diritto. Occorre tuttavia ricordare, al ministro e a noi tutti, che il Parlamento, nel legiferare, è sovrano, ma è, comunque, tenuto a rispettare la Costituzione (cosa sovente dimenticata in questi ultimi tempi). Nel dibattito di ieri in Cassazione è stato d’altronde ignorato un profilo di grande importanza. Si è parlato ampiamente della necessità di riformare con legge ordinaria la giustizia penale e civile per renderla efficiente (cosa sulla quale sono tutti, bene o male, a parole d’accordo); si è però taciuto sulle ventilate riforme costituzionali attraverso le quali una parte consistente del personale dei partiti intenderebbe rimodulare i rapporti di potere fra politica e magistratura.
È, questo, un profilo di grandissima delicatezza. Non si vorrebbe infatti che, con la scusa del riequilibrio fra i poteri dello Stato, si intendesse in realtà proteggere in modo abnorme il mondo politico intriso di malaffare. La speranza è che il clima con il quale il tema della giustizia ordinaria è stato affrontato ieri nell’inaugurazione dell’anno giudiziario in Cassazione consenta di affrontare con altrettanta distensione anche quello, assai meno pacifico, che concerne la ventilata riforma costituzionale. Per intanto si attende con una certa apprensione che cosa accadrà, oggi, nelle inaugurazioni dell’anno giudiziario in ciascuna sede di Corte d’Appello.
-
> "APRITE, APRITE": IL GOLPISMO DEL LUPO, LA PAROLA "ITALIA" ---- SONDAGGIO EURISPES, CRESCE LA FIDUCIA IN NAPOLITANO, IN CALO IL GOVERNO, SALE LA MAGISTRATURA.25 gennaio 2010, di Federico La Sala
 Sondaggio sulla fiducia nelle istituzioni. Il capo dello Stato piace al 70% degli italiani
Sondaggio sulla fiducia nelle istituzioni. Il capo dello Stato piace al 70% degli italiani
 Diminuiscono i consensi all’esecutivo. Pollice verso anche per scuola, sindacati e partiti
Diminuiscono i consensi all’esecutivo. Pollice verso anche per scuola, sindacati e partiti Eurispes, cresce fiducia in Napolitano
Eurispes, cresce fiducia in Napolitano
 In calo il governo, sale la magistratura *
In calo il governo, sale la magistratura *ROMA - Aumenta la fiducia degli italiani nel presidente della Repubblica Giorgio Napolitano: crede in lui il 70% della popolazione. In leggero calo, invece, la fiducia verso l’operato del governo, che cala dal 27,7% dello scorso anno al 26,7%. Male anche per scuola, sindacati e partiti. Crescono invece i giudizi favorevoli nei confronti della magistatura. Questi i dati più rilevanti del sondaggio Eurispes sulla fiducia degli italiani nelle istituzioni contenuto nel rapporto Italia 2010 che verrà presentato venerdì prossimo. In termini assoluti, il dato è positivo: la fiducia nelle istituzioni, infatti, è salita in un anno di ben 28,5 punti percentuali, passando dal 10,5% del 2009 al 39% del 2010. Di pari passo è diminuita del 10% la quota di italiani che esprimono un calo della fiducia, che si attesta al 45,8%.
In vetta Giorgio Napolitano. Il 70% degli italiani si fida di Napolitano, con un aumento di 6 punti percentuali rispetto all’anno scorso. Il capo dello Stato, dunque, è sempre più un punto di riferimento per gli italiani. Questo vale soprattutto per gli over 65, che gli accordano la fiducia nel 73,3% dei casi e tra coloro che hanno tra 45 e 64 anni (73,7%). In ogni caso, il consenso tocca tutte le fasce di età e non scende mai al di sotto del 60%.
Cala il governo. In lieve calo, invece, la fiducia nel governo: i pareri positivi sono il 26,7% contro il 27,7% dell’anno precedente. Il dato - precisa Eurispes - è comunque costante negli ultimi anni, sia che si tratti di un governo di centrodestra che di uno di centrosinistra. Mostrano maggiore fiducia i cittadini del Nord-est (29,4%) e quelli di destra e centrodestra, mentre il livello più basso è nelle isole (22,8%) e negli elettori di sinistra e centrosinistra.
Si attesta su livelli simili la fiducia nel Parlamento: 26,9% contro il 26,2% del 2009. Percentuali più alte si registrano tra gli elettori di destra, centrodestra e centro, mentre i cali più vistosi si hanno a sinistra e nel centrosinistra.
Sale la magistratura. Insieme al presidente della Repubblica, l’istituzione che quest’anno acquista nuovo credito è la magistratura. Il consenso è in crescita da 5 anni e oggi quasi un italiano su due dà fiducia ai magistrati. Se, infatti, nel 2009 i fiduciosi erano il 44,4%, quest’anno c’è stato un balzo del 3,4% che porta la percentuale al 47,8%. Ad avere meno fiducia nella magistratura sono gli italiani di destra (35,6%) e centrodestra (35,4%), molto più fiduciosi quelli di centro (53%). A sinistra (58,1%) e al centrosinistra (58,5%) l’apprezzamento è ancora più alto.
La scuola. Si tratta di un’istituzione che continua a perdere fiducia, soprattutto tra le fasce giovanili. Il 52,7% dei ragazzi tra i 18 e i 24 anni ha dichiarato di avere poca fiducia e il 10,1% non ne ha per nulla. E, nonostante l’appartenenza politica del ministro dell’istruzione, il poco credito risulta molto forte tra le persone di destra (43,2%) e centrodestra (50,3%), anche se aumenta nella sinistra (53,7%) e nel centrosinistra (50,4%).
I partiti. Il 45,5% degli intervistati non nutre alcuna fiducia nei partiti e il 42,4% ne ha poca, a fronte di un 12,1% che si dichiara fiducioso. Una opinione quasi uniforme in tutte le aree geografiche del Paese e che prescinde dall’area politica di appartenenza. E tuttavia, rispetto all’anno precedente, questa fiducia aumenta del 5%. Da sottolineare poi che l’85,3% condivide l’idea che i partiti dovrebbero cercare di raggiungere il massimo di concordia possibile per il bene del paese. Quanto alla legge elettorale, la stragrande maggioranza (83,1%) è favorevole alla reintroduzione delle preferenze.
Sindacati. Risutati negativi anche per i sindacati, che perdono consensi soprattutto a sinistra (il 68,5% ha poca o nessuna fiducia) e nel centrosinistra (67,1%).
Altre istituzioni. Sale invece la fiducia nei confronti delle associazioni di volontariato (82,1%) e della Chiesa (47,3%), con un aumento dell’8,5% rispetto all’anno precedente. Migliora il dato per la pubblica amministrazione (+3,7%), anche se il tasso di sfudicia resta altissimo (+73,8%). Buoni risultati anche per le forze dell’ordine, in costante aumento sia per carabinieri che per polizia e guardia di finanza.
* la Repubblica, 25 gennaio 2010
-
> "APRITE, APRITE": IL GOLPISMO DEL LUPO, LA PAROLA "ITALIA" CONSEGNATA A UN PARTITO (1994-2009), E I SETTE CAPRETTI. ----CARO GESU’ BAMBINO... Lettera di Natale di Antonio Di Pietro.23 dicembre 2009, di Federico La Sala
-
> "APRITE, APRITE": IL GOLPISMO DEL LUPO, LA PAROLA "ITALIA" CONSEGNATA A UN PARTITO (1994-2009), E I SETTE CAPRETTI. --- CARO PRESIDENTE NAPOLITANO, CREDO CHE SIA ORA DI FARE CHIAREZZA. .... E DI SPIEGARE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E AL CITTADINO SILVIO BERLUSCONI LE RAGIONI DELL’ "ODIO POLITICO" CHE "LO FA SOFFRIRE".14 dicembre 2009, di Federico La Sala
-
> "APRITE, APRITE": IL GOLPISMO DEL LUPO ---- "Nuovo impegno collettivo per riscattare il senso alto della politica". In relazione alle espressioni pronunciate dal Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica esprime profondo rammarico e preoccupazione.10 dicembre 2009, di Federico La Sala
MESSAGGI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (www.quirinale.it):
 "Nuovo impegno collettivo per riscattare il senso alto della politica"
"Nuovo impegno collettivo per riscattare il senso alto della politica""Si avverte la necessità di un nuovo impegno collettivo per riscattare il senso alto della politica e costruire una società democratica più equa e più solidale, tollerante e inclusiva, che sappia fare tesoro della propria eredità storica nel guardare al futuro in modo aperto". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, nel messaggio inviato in occasione del XIII Meeting sui diritti umani dal tema "Riconciliare l’Italia. Riconciliare il mondo", promosso dalla Regione Toscana.
Una inizitiva che vede "il coinvolgimento attivo di migliaia di studenti per approfondire il tema della riconciliazione, contro il razzismo, contro la violenza, contro ciò che divide anzichè unire. E’ sulla formazione dei giovani - ha aggiunto il Capo dello Stato - che si deve far leva per assicurare uno sviluppo equilibrato della nostra società, per radicare il principio che in ogni democrazia accanto ai diritti, ad iniziare proprio dai diritti dell’uomo, vi sono dei doveri, per suscitare un rinnovato spirito di solidarietà".
 "L’Italia ha bisogno dello ’spirito di leale collaborazione’ concordamente auspicato al Senato"
"L’Italia ha bisogno dello ’spirito di leale collaborazione’ concordamente auspicato al Senato"In relazione alle espressioni pronunciate dal Presidente del Consiglio in una importante sede politica internazionale, di violento attacco contro fondamentali istituzioni di garanzia volute dalla Costituzione italiana, il Presidente della Repubblica esprime profondo rammarico e preoccupazione. Il Capo dello Stato continua a ritenere che, specie per poter affrontare delicati problemi di carattere istituzionale, l’Italia abbia bisogno di quello "spirito di leale collaborazione" e di quell’impegno di condivisione che pochi giorni fa il Senato ha concordemente auspicato.
-
> "APRITE, APRITE": IL GOLPISMO DEL LUPO, LA PAROLA "ITALIA" CONSEGNATA A UN PARTITO (1994-2009), E I SETTE CAPRETTI. ----"Sono rammaricato e preoccupato, serve leale collaborazione tra i poteri dello Stato". L’ira di Napolitano contro Berlusconi10 dicembre 2009, di Federico La Sala
 Il presidente della Repubblica reagisce con una nota ufficiale alle parole del premier
Il presidente della Repubblica reagisce con una nota ufficiale alle parole del premier
 "Sono rammaricato e preoccupato, serve leale collaborazione tra i poteri dello Stato"
"Sono rammaricato e preoccupato, serve leale collaborazione tra i poteri dello Stato" L’ira di Napolitano contro Berlusconi
L’ira di Napolitano contro Berlusconi
 "Attacco violento alle istituzioni" *
"Attacco violento alle istituzioni" *ROMA - Il presidente della Repubblica reagisce. Con parole gravi, e inusuali per l’inquilino del Colle. Napolitano è preoccupato e rammaricato per le frasi pronunciate da Berlusconi a Bonn contro giudici, Consulta e i tre ultimi capi dello Stato. Parla di "attacco violento alle istituzioni". Torna ad invocare "leale collaborazione" tra i poteri dello Stato.
La nota del Colle parla chiaro. "In relazione alle espressioni pronunciate dal presidente del Consiglio in una importante sede politica internazionale, di violento attacco contro fondamentali istituzioni di garanzia volute dalla costituzione italiana, il presidente della repubblica esprime profondo rammarico e preoccupazione".
Nel comunicato si precisa che "il capo dello Stato continua a ritenere che, specie per poter affrontare delicati problemi di carattere istituzionale, l’Italia abbia bisogno di quello "spirito di leale collaborazione" e di quell’impegno di condivisione che pochi giorni fa il senato ha concordemente auspicato".
* la Repubblica, 10 dicembre 2009
-
> "APRITE, APRITE": IL GOLPISMO DEL LUPO, LA PAROLA "ITALIA" CONSEGNATA A UN PARTITO (1994-2009), E I SETTE CAPRETTI. --- PAROLA POLITICA E PAROLACCE (di Aldo Antonelli,prete).24 novembre 2009, di Federico La Sala
PAROLA POLITICA E PAROLACCE
di don Aldo Antonelli
Un ministro, semplice manovale d’azienda, dipendente di Berlusconi prima e più che ministro della repubblica, oltre a sfarfagliare sulla filosofia d’azienda, mentisce spudoratamente anche sui fatti. O non sa, il che è grave o sapendo mentisce, il che è ancora più grave. Ieri sera, con una faccia da bronzo da far invidia al peggiore dei bulli di quartiere, Alfano ha ripetuto il ritornello che Berlusconi stesso ama ripetere con ossessione cercando di convincere perfino se stesso: "Tutti i suoi guai giudiziari sono iniziati con la sua discesa in campo"! Falso, falso e falso.
Berlusconi viene indagato per traffico di stupefacenti, undici anni prima della nascita di Forza Italia. Nel 1983 (l’accusa è archiviata). È condannato in appello (e amnistiato) per falsa testimonianza nel 1989, venti anni fa. Nel 1993, un anno prima della sua prima candidatura al governo, la procura di Torino già indaga sul Milan e i pubblici ministeri di Milano sui bilanci di Publitalia. Al di là di queste date, è documentato dagli atti giudiziari che Silvio Berlusconi e il gruppo Fininvest finiscono nei guai non per un assillo "politico" dei pubblici ministeri, ma per le confessioni di un ufficiale corrotto del Nucleo regionale di polizia tributaria di Milano. Ammette che le "fiamme gialle" hanno intascato 230 milioni di lire per chiudere gli occhi nelle verifiche fiscali di Videotime (nel 1985), Mondadori (nel 1991), Mediolanum Vita (nel 1992) , tutti controlli che precedono l’avventura politica dell’Egoarca.
Di fronte a questo diluvio a cascata di menzogne il cardinal Bertone, da parte sua, trova scandaloso che qualcuno dica "parolacce". Per la sua morale la parolaccia è più grave della menzogna; ho l’impressione che sia rimasto un bambino mai cresciuto. Ciò che lo preoccupa è la politica di facciata e non il vuoto della politica e ancor meno la politica asservita agli interessi aziendali e personali dell’Egoarca. Lo preoccupano le parole scorrette che offendono il galateo e non le parole mendaci che stravolgono e imprigionano le coscienze e ancor meno le leggi ad personam che istituzionalizzano e consacrano ruberie, falsi in bilancio e abusi di potere.
Qui ritorna anche il discorso sulle parole, meglio, sulla parola, ma ad un altro e ben più alto livello. La filosofa spagnola Maria Zambrano ha analizzato bene il legame profondo che c’è tra la parola e la politica, così che una parola degradata e vuota produce una politica fatta di menzogna e di violenza. Marco Campedelli, sul notiziario della rete Radié Resh ("In Dialogo" - settembre 2009), si chiede perché la parola sia fonte sorgiva per la politica e risponde: «Per il fatto che la parola nella sua costituzione essenziale è parola dialogica, parola come relazione, e dunque parola che crea la polis, la città degli uomini».
Prosegue: «Una politica inumana, disumana, nasce da una parola che ha perso il senso, una parola la cui dimora è stata abbandonata dalla vita. E’ allarmante come nel nostro Paese una massa di persone siano attratti e affascinati da "Signori nessuno" che infilano una dopo l’altra come perle in una collana, parole piatte, vuote e più drammaticamente parole violente e disumane. Pensiamo come il nostro Nord-Est sia la patria della Lega. Se noi analizzassimo il linguaggio della Lega capiremmo che il rapporto tra parola e violenza, tra parola ed esclusione, tra parola e discriminazione è all’origine di un modo nuovo di "pensare" dove la parola caccia dalla sua dimora il "Tu" e vi pone al centro il trono grottesco dell’"Io"».
Se il cardinal Bertone avesse parlato, per esempio, in questi termini, avrebbe dato prova di esser cresciuto e avrebbe dato testimonianza di una Chiesa che è chiamata dal vangelo a pronunciare parole di senso, parole di vita, parole di profezia. Smettendo i panni del bandidore di moralismi vuoti e di parole banali.
Aldo Antonelli
-
> "APRITE, APRITE": IL GOLPISMO DEL LUPO, LA PAROLA "ITALIA" CONSEGNATA A UN PARTITO (1994-2009), E I SETTE CAPRETTI. ---- L’estinzione dello Stato (di Stefano Rodotà).21 novembre 2009, di Federico La Sala
L’estinzione dello Stato
di Stefano Rodotà (la Repubblica,2o.11.2009)
Possono le istituzioni sopravvivere in un ambiente in cui la loro delegittimazione diviene una deliberata strategia politica? Che cosa accade quando il rispetto della Costituzione è costretto a rifugiarsi in luoghi sempre più ristretti? Stiamo percorrendo una anomala e inquietante via italiana all’estinzione dello Stato?
L’Italia sta diventando un perverso laboratorio dove elementi altrove controllabili si combinano in forme tali da infettare l’intero sistema. E il contagio si diffonde dalla politica all’intera società, dove ogni giorno vengono messi in scena il degrado del linguaggio, il disprezzo delle regole, l’esercizio brutale del potere. Di fronte a pretese e interventi particolarmente devastanti, come quelli che stravolgono la legalità in nome dell’interesse di uno solo, si evoca lo "stato d’eccezione", una categoria politica costruita per giustificare l’esercizio autoritario del potere di governo e che, tuttavia, rivela una sua nobiltà intellettuale che non si ritrova nelle miserabili prassi italiane di questi tempi. Che sono ormai così diffuse e radicate da impedire che si parli dello stato d’eccezione come di qualcosa appunto eccezionale. Come si è parlato di "emergenza permanente", per imporre logiche autoritarie e manomettere i diritti, così è ragionevole definire lo stato delle cose italiane come uno "stato d’eccezione permanente".
Sono gli stessi principi costituzionali ad essere regolarmente violati, a cominciare da quello di eguaglianza. Non dimentichiamo che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il "lodo Alfano" proprio per il suo contrasto con quel principio. Dobbiamo ricordarlo ancora oggi di fronte alle proposte di approvare una legge costituzionale che riproponga i contenuti di quel testo: anche questo tipo di legge deve rispettare l’eguaglianza. Lo ha sottolineato fin dal 1988 la Corte costituzionale, affermando che i «principi supremi» dell’ordinamento italiano non possono essere «sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali». Tra questi principi spicca proprio quello dell’eguaglianza tra i cittadini.
Ma la diseguaglianza è stata codificata da molte leggi, è penetrata profondamente nella società, sta creando categorie di "sottocittadini". Nella vergogna del "processo breve" vi è la maggior vergogna dell’esclusione dai benefici degli immigrati clandestini. Questa erosione delle basi della convivenza nega l’universalità dei diritti fondamentali, legittima il rifiuto dell’altro e del diverso, e così apre le porte a quei fenomeni di razzismo e omofobia che rischiano di diventare una componente stabile del panorama italiano.
Una volta messi da parte i principi, la distorsione del sistema istituzionale diventa inevitabile e quotidiana, e non è più sufficiente a spiegarla il richiamo del conflitto d’interessi incarnato dal presidente del Consiglio. Si è manifestata una nuova forma di "Stato patrimoniale", dove si mescolano risorse pubbliche e private, l’influenza politica si sposa con la pressione economica, le aziende della galassia berlusconiana diventano snodi politici determinanti. Lo rivelano, tra l’altro, non solo il continuum Mediaset/Rai e gli annunci di normalizzazione di canali televisivi ancora un po’ fuori dal coro, ma anche le manovre che riguardano l’assetto complessivo delle telecomunicazioni, la proprietà dei giornali, il sistema finanziario.
Un potere che si è progressivamente concentrato in poche mani, con una idea proprietaria dello Stato che cancella gli altri soggetti istituzionali e azzera ogni controllo. Conosciamo la deriva che sta travolgendo il Parlamento, espropriato d’ogni funzione, e che ha portato alla clamorosa decisione di una "serrata" di dieci giorni della Camera dei deputati, decisa dal suo Presidente per denunciare l’impossibilità di lavorare. Un fatto davvero senza precedenti, che avrebbe dovuto provocare reazioni forti, che è stato piuttosto ricondotto alle schermaglie tra Fini e Berlusconi. La funzione legislativa è saldamente nelle mani del Governo attraverso i decreti legge e le leggi delega, e grazie al diffondersi delle "ordinanze di protezione civile", sottratte a qualsiasi controllo parlamentare e che contengono sempre più spesso norme di carattere generale, ben al di là delle emergenze che le giustificano. Ma è soprattutto la dimensione costituzionale ad essere evaporata. La Costituzione non appartiene più al Parlamento, tant’è che d’ogni legge in corso di discussione si discute se il presidente della Repubblica la firmerà o no, quali siano i rischi di una dichiarazione d’illegittimità da parte della Corte costituzionale. I custodi della Costituzione sono altrove, e la stessa Carta costituzionale rischia di veder mutato il suo significato se una istituzione centrale, il Parlamento, si comporta come se le fosse estranea.
Molte aree istituzionali vengono così desertificate, prendendo anche a pretesto vere o presunte inefficienze. Si documentano i ridottissimi tempi di lavoro del Parlamento e se ne trae spunto per denunciare i deputati fannulloni, non per indicare misure per rivitalizzare il Parlamento, possibili già oggi. La stessa tecnica è adoperata per attaccare la magistratura e legittimare l’ennesima legge ad personam, quella sul processo breve, giustificata con l’argomento della ingiustificata durata dei processi. Ma è del 1999 la riforma dell’articolo 111 della Costituzione che parla di una loro "ragionevole durata", sono anni che la Corte europea dei diritti dell’uomo ci condanna per le lungaggini della giustizia, sono decenni che il dissesto dell’amministrazione giudiziaria può essere definito "una catastrofe sociale". Così sensibile al problema, la maggioranza di centrodestra non ha mosso un dito nella fase di governo tra il 2001 e il 2006, assai interventista in materia di giustizia, ma non per approvare misure e attribuire risorse per tagliare i tempi processuali, bensì per andare all’assalto dell’indipendenza della magistratura. E oggi vuole profittare di questa situazione per sottrarre Berlusconi ai processi e assestare un colpo ulteriore all’efficienza e alla credibilità della magistratura.
Un "dialogo" sulle riforme costituzionali, e la stessa politica quotidiana dell’opposizione, non possono ignorare tutto questo. E bisogna ricordare che la Costituzione si conclude con un articolo che oggi esige particolare attenzione. È scritto nell’articolo 139: «La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale». Questo non vuol dire, banalmente, che non si può tornare alla monarchia. Significa che il nostro sistema costituzionale presenta una serie di caratteristiche che definiscono la "forma repubblicana" e che non possono essere modificate senza passare ad un regime diverso. È proprio quello che non si stanca di ripetere, con sobrietà e fermezza, il Presidente della Repubblica
-
> "APRITE, APRITE": IL GOLPISMO DEL LUPO, LA PAROLA "ITALIA" CONSEGNATA A UN PARTITO (1994-2009) ---- Il piano di Silvio Berlusconi per farsi patria (di Giovanni Maria Bellu).31 ottobre 2009, di Federico La Sala
La patria non è lui
di Giovanni Maria Bellu *
In fondo il ragionamento non fa una grinza: io sono l’Italia, dice il premier, e dunque chi mi «sputtana», in realtà «sputtana» la patria. È giusto. La patria è sacra. Bisogna amarla in tutte le circostanze. C’è una guerra? E tu devi combattere per la patria. Un’immane catastrofe naturale? E tu devi ricostruire la patria. Mica puoi prendertela con lei. Sputtanarla, poi...
Il piano di Silvio Berlusconi per farsi patria ha avuto un’accelerazione formidabile dopo l’individuazione di alcune organizzazioni anti-italiane operanti nel territorio nazionale: la Corte costituzionale che ha vilipeso il lodo Alfano, argine giuridico creato a difesa della patria, e il presidente della Repubblica il quale si ostina a considerare patria quel territorio delimitato a nord dalle Alpi, attraversato longitudinalmente dagli Appennini e circondato dal Mar Mediterraneo.
Al contrario, per esempio, del ministro Maria Vittoria Brambilla che, rivela qua accanto il nostro Congiurato, reputa Silvio Berlusconi parte del patrimonio turistico nazionale, come il Colosseo, il campanile di Giotto e Piazza San Marco. O del ministro ombra degli Esteri Franco Frattini che, ci racconta il collega danese Mads Frese, continua a tenere impegnati i nostri sempre più imbarazzati ambasciatori nella titanica impresa di convincere la stampa estera che Silvio Berlusconi e il Canal Grande sono la stessa cosa.
Impresa, oltretutto, resa ancora più complessa dal verbo temerariamente scelto dal premier per denunciare le attività antipatriottiche. All’uditore straniero che per seguire le recenti cronache politiche italiane ha dovuto arricchire il suo vocabolario di parole che non aveva studiato nel corso di lingua, il verbo «sputtanare», più che un’attività anti-italiana, evoca le attività del premier medesimo.
Ma non illudiamoci che lo sgomento del mondo sia sufficiente a salvarci. Silvio Berlusconi non se n’è mai curato, come dimostra l’assoluto sprezzo del ridicolo con cui continua ad affrontare gli impegni internazionali. Gli basta essere patria in patria. Cioè nel luogo dei suoi interessi e dei suoi affari. Ha un piano. Rozzo ed efficace, come ci spiega Claudia Fusani: utilizzare il consenso di cui ancora gode per accelerare la svolta presidenzialista. Modificare il sistema costituzionale. Delegittimare il capo dello Stato e prenderne il posto. Fantapolitica? C’è stato un tempo, nemmeno tanto lontano, in cui la descrizione del quadro attuale sarebbe stata liquidata come fantasia pura. La stiamo vivendo. Ed è qua che lo sbalordimento mondiale per il premier si estende a tutti noi. Leggiamo, alle pagine 4 e 5, le cronache sugli scandali in corso in Francia, Spagna, Inghilterra. Robetta rispetto alla nostra. Bazzecole. Eppure la stampa le denuncia, i politici sono costretti a dare spiegazioni, a dimettersi, a restituire il maltolto, anche quando si tratta di poche centinaia di sterline. «È un problema di diverse sensibilità», dice magnanimamente a Roberto Brunelli Michael Braun, corrispondente a Roma del tedesco Die Tagesszeitung. Già, solo la sensibilità democratica di chi ci vive può salvare la patria. Quella vera.
(Filo rosso del 14 ottobre 2009)
* Nemici Il blog a cura di Giovanni Maria Bellu 13/10/2009 09:30
-
> "APRITE, APRITE": IL GOLPISMO DEL LUPO, LA PAROLA "ITALIA" ---- è il momento di dire quello che conosciamo (di Barbra Spinelli - Le parole per battere la mafia).26 ottobre 2009, di Federico La Sala
Le parole per battere la mafia
L’intervento agli stati generali di Libera: è il momento di dire quello che conosciamo
di BARBARA SPINELLI (La Stampa,26/10/2009
Da anni ci interroghiamo su questo male che non viene estirpato, la mafia: in particolare sulla lunga storia di trattative fra una parte dello Stato e la malavita, con poteri occulti che mediano fra due potenze facendone entità paragonabili. Anche per il potere della malavita, non solo per il potere legale, dovrebbero valere le parole di Montesquieu: «Chiunque abbia potere è portato ad abusarne; egli arriva sin dove non trova limiti. Perché non si possa abusare del potere occorre che il potere arresti il potere».
Forse però è venuto il momento di dire quello che sappiamo, e non solo di farci domande. Di dire, come fece Pasolini il 14 novembre 1974 a proposito delle trame eversive italiane, che in realtà: noi sappiamo. Sono anni che sappiamo, anche se non abbiamo tutte le prove e gli indizi. Sappiamo che le trattative sono esistite, prolungandosi fino al 2004. Sappiamo che viviamo ancor oggi - con le leggi che ostacolano la lotta alla mafia, con lo scudo fiscale che premia l’evasione - sotto l’ombra di un patto. Sappiamo il sangue che mafia, camorra, ’ndrangheta hanno versato lungo i decenni. Sappiamo il sacco di Palermo, e di tante città: sacco che continua. Sappiamo che l’Italia si va sgretolando davanti a noi come fosse un castello che abbiamo accettato di fare di carta, anziché di mattoni e di buon cemento non fornito dalla mafia - sì, noi l’abbiamo accettato, noi che eleggiamo chi ha il potere di favorire o frenare la malavita. Sappiamo che basta leggere le sentenze - anche quelle che assolvono gli imputati per mancanza di prove o, peggio, per prescrizione - per conoscere le responsabilità di politici che, per aver conquistato e mantenuto il potere grazie alla malavita, non dovrebbero essere chiamati coi nomi, nobili, di rappresentanti del popolo o di statisti.
Tutte queste cose, come avviene nei paesi che vivono sotto il giogo di un potere totalitario, le sappiamo grazie a persone che hanno deciso di denunciare, di testimoniare, e non solo di testimoniare ma di rimboccarsi le maniche e cominciare a costruire un’Italia diversa: tra i primi l’associazione Libera, e i giudici che hanno indagato su mafia e politica sapendo che avrebbero pagato con la vita, e uomini come Roberto Saviano, e giornalisti che esplorano le terre di mafia come Anna Politkovskaja esplorava, sapendo di essere mortalmente minacciata, gli orrori della guerra russa contro i ceceni.
Sono i medici dell’Italia. Ma medici che osservano un giuramento di Ippocrate speciale, di tipo nuovo: resta il dettato che comanda l’azione riparatrice, risanatrice. Nella sostanza, l’obbligo di non nuocere, di astenersi da ogni offesa e danno volontario. Ma cade il comandamento del segreto, vincolante in Ippocrate, che comanda: «Tutto ciò ch’io vedrò e ascolterò nell’esercizio della mia professione, o anche al di fuori della professione nei miei contatti con gli uomini, e che non dev’essere riferito ad altri, lo tacerò considerando la cosa segreta».
Il paragrafo del giuramento cade, perché troppo contiguo alla complicità, al delitto di omertà: questa parola che offende e storpia la radice da cui viene e che rimanda all’umiltà, all’umirtà. La vera umiltà consiste nell’infrangere il segreto, nel far letteralmente parlare le pietre e il cemento, le terre e i mari inquinati, poiché è denunciando il male che esso vien conosciuto e la guarigione può iniziare. Per questo l’informazione indipendente è così importante, in Italia: spesso lamentiamo un’opinione pubblica indifferente, ma, prima di esser aiutata a divenire civica, essa deve essere bene informata: con parole semplici, non specialiste, con esempi concreti. I medici di cui ho parlato - medici dell’Italia e delle sue parole e della sua natura malate - combattono proprio contro questo silenzio, che protegge i mafiosi, copre oscuri patti fra Stato e mafia, lascia senza protezione le loro vittime. I medici danno alle cose un nome, e su questa base agiscono.
C’è un modo di servire lo Stato che chiamerei paradossale: si serve lo Stato, pur sapendo che esso è pervertito, che nella nostra storia c’è stato più volte un doppio Stato. Uomini come Falcone, Borsellino, il giudice Chinnici, don Giuseppe Puglisi, don Giuseppe Diana e i tanti uomini delle scorte avevano questa fedeltà paradossale allo Stato. Uomini così sono come esuli, come De Gaulle che lasciò la Francia quando fu invasa da Hitler e dall’esilio londinese disse: la Francia non coincide con la geografia; quel che rappresento è «una certa idea della Francia», che ha radici nella terra ma innanzitutto nella mente di chi decide di entrare in resistenza e sperare in un mutamento.
La riconquista del territorio e della legalità è come la speranza, anch’essa sempre paradossale. Prende il via da una perdita del territorio, dalla consapevolezza che se lo Stato non ha più presa su di esso, ciascuno di noi perde la terra sotto i piedi. E quando dico territorio perduto dico le case che franano non appena s’alza la tempesta, i terremoti che uccidono più che in altre nazioni, l’abitare che diventa aleatorio, brutto, perché la costruzione delle case avviene con cemento finto, fatto di sabbia più che di ferro, procurato dalle mafie. Come nella lettera di Paolo ai Romani, è dalla debolezza che si parte, altrimenti non ci sarebbe bisogno di sperare: «Ciò che si spera, se visto, non è più speranza; infatti, ciò che uno già vede, come potrebbe ancora sperarlo? Ma se speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo con perseveranza».
Ecco, per ora speriamo quel che non ancora vediamo: una cultura della legalità, una politica del territorio restituito a chi vuole abitarlo decentemente. Per ora abbiamo una certa idea dell’Italia, della lotta alla mafia. Ma se sappiamo quel che accade da tanto tempo, pur non avendo tutte le prove, già metà del cammino è percorsa e l’agire diventa non solo necessario ma possibile. Anche questo Paolo lo spiega bene, quando elenca le tappe della speranza. Prima viene l’afflizione, la conoscenza del dolore. L’afflizione produce la pazienza, e questa a sua volta la virtù provata. È sul suolo della virtù provata che nasce la speranza, e a questo punto la prospettiva cambia. A questo punto sappiamo una cosa in più, preziosa: non si comincia con lo sperare, per poi agire. Si comincia con la prova dell’azione, e solo dalla messa alla prova nascono la speranza, la sete di trovare l’insperato, l’anticipazione attiva - già qui, ora - di un futuro possibile. Ha detto una volta Giancarlo Caselli una cosa non dimenticabile: «Se essi sono morti (parlava di Falcone, Borsellino) è perché noi tutti non siamo stati vivi: non abbiamo vigilato, non ci siamo scandalizzati dell’ingiustizia; non lo abbiamo fatto abbastanza, nelle professioni, nella vita civile, in quella politica, religiosa». Per questo corriamo il rischio, sempre, di disimparare perfino la speranza.
-
> "APRITE, APRITE": IL GOLPISMO DEL LUPO, LA PAROLA "ITALIA" CONSEGNATA A UN PARTITO (1994-2009), E I SETTE CAPRETTI. ---- Tra mafia e Stato (di Lirio Abbate).21 ottobre 2009, di Federico La Sala
Tra mafia e Stato
di Lirio Abbate *
Brusca rivela: Riina disse che il nostro referente nella trattativa era il ministro Mancino. Ma dopo l’arresto del padrino, i boss puntarono su Forza Italia e Silvio Berlusconi
E’ la vigilia di Natale del 1992, Totò Riina è euforico, eccitato, si sente come fosse il padrone del mondo. In una casa alla periferia di Palermo ha radunato i boss più fidati per gli auguri e per comunicare che lo Stato si è fatto avanti. I picciotti sono impressionati per come il capo dei capi sia così felice. Tanto che quando Giovanni Brusca entra in casa, Totò ù curtu, seduto davanti al tavolo della stanza da pranzo, lo accoglie con un grande sorriso e restando sulla sedia gli dice: "Eh! Finalmente si sono fatti sotto". Riina è tutto contento e tiene stretta in mano una penna: "Ah, ci ho fatto un papello così..." e con le mani indica un foglio di notevoli dimensioni. E aggiunge che in quel pezzo di carta aveva messo, oltre alle richieste sulla legge Gozzini e altri temi di ordine generale, la revisione del maxi processo a Cosa nostra e l’aggiustamento del processo ad alcuni mafiosi fra cui quello a Pippo Calò per la strage del treno 904. Le parole con le quali Riina introduce questo discorso del "papello" Brusca le ricorda così: "Si sono fatti sotto. Ho avuto un messaggio. Viene da Mancino".
L’uomo che uccise Giovanni Falcone - di cui "L’espresso" anticipa il contenuto dei verbali inediti - sostiene che sarebbe Nicola Mancino, attuale vice presidente del Csm che nel 1992 era ministro dell’Interno, il politico che avrebbe "coperto" inizialmente la trattativa fra mafia e Stato. Il tramite sarebbe stato l’ex sindaco mafioso di Palermo, Vito Ciancimino, attraverso l’allora colonnello Mario Mori e il capitano Giuseppe De Donno. L’ex responsabile del Viminale ha sempre smentito: "Per quanto riguarda la mia responsabilità di ministro dell’Interno confermo che nessuno mi parlò di possibili trattative".
Il contatto politico Riina lo rivela a Natale. Mediata da Bernardo Provenzano attraverso Ciancimino, arriva la risposta al "papello", le cui richieste iniziali allo Stato erano apparse pretese impossibili anche allo zio Binu. Ora le dichiarazioni inedite di Brusca formano come un capitolo iniziale che viene chiuso dalle rivelazioni recenti del neo pentito Gaspare Spatuzza. Spatuzza indica ai pm di Firenze e Palermo il collegamento fra alcuni boss e Marcello dell’Utri (il senatore del Pdl, condannato in primo grado a nove anni per concorso esterno in associazione mafiosa), che si sarebbe fatto carico di creare una connessione con Forza Italia e con il suo amico Silvio Berlusconi. Ma nel dicembre ’92 nella casa alla periferia di Palermo, Riina è felice che la trattativa, aperta dopo la morte di Falcone, si fosse mossa perché "Mancino aveva preso questa posizione". E quella è la prima e l’ultima volta nella quale Brusca ha sentito pronunziare il nome di Mancino da Riina. Altri non lo hanno mai indicato, anche se Brusca è sicuro che ne fossero a conoscenza anche alcuni boss, come Salvatore Biondino (detenuto dal giorno dell’arresto di Riina), il latitante Matteo Messina Denaro, il mafioso trapanese Vincenzo Sinacori, Giuseppe Graviano e Leoluca Bagarella.
Le risposte a quelle pretese tardavano però ad arrivare. Il pentito ricorda che nei primi di gennaio 1993 il capo di Cosa nostra era preoccupato. Non temeva di essere ucciso, ma di finire in carcere. Il nervosismo lo si notava in tutte le riunioni, tanto da fargli deliberare altri omicidi "facili facili", come l’uccisione di magistrati senza tutela. Un modo per riscaldare la trattativa. La mattina del 15 gennaio 1993, mentre Riina e Biondino si stanno recando alla riunione durante la quale Totò ù curtu avrebbe voluto informare i suoi fedelissimi di ulteriori retroscena sui contatti con gli uomini delle istituzioni, il capo dei capi viene arrestato dai carabinieri.
Brusca è convinto che in quell’incontro il padrino avrebbe messo a nudo i suoi segreti, per condividerli con gli altri nell’eventualità che a lui fosse accaduto qualcosa. Il nome dell’allora ministro era stato riferito a Riina attraverso Ciancimino. E qui Brusca sottolinea che il problema da porsi - e che lui stesso si era posto fin da quando aveva appreso la vicenda del "papello" - è se a Riina fosse stata o meno riferita la verità: "Se le cose stanno così nessun problema per Ciancimino; se invece Ciancimino ha fatto qualche millanteria, ovvero ha "bluffato" con Riina e questi se ne è reso conto, l’ex sindaco allora si è messo in una situazione di grave pericolo che può estendersi anche ai suoi familiari e che può durare a tempo indeterminato". In quel periodo c’erano strani movimenti e Brusca apprende che Mancino sta blindando la sua casa romana con porte e finestre antiproiettile: "Ma perché mai si sta blindando, che motivo ha?". "Non hai nulla da temere perché hai stabilito con noi un accordo", commenta Brusca come in un dialogo a distanza con Mancino: "O se hai da temere ti spaventi perché hai tradito, hai bluffato o hai fatto qualche altra cosa".
Brusca, però, non ha dubbi sul fatto che l’ex sindaco abbia riportato ciò che gli era stato detto sul politico. Tanto che avrebbe avuto dei riscontri sul nome di Mancino. In particolare uno. Nell’incontro di Natale ’92 Biondino prese una cartelletta di plastica che conteneva un verbale di interrogatorio di Gaspare Mutolo, un mafioso pentito. E commentò quasi ironicamente le sue dichiarazioni: "Ma guarda un po’: quando un bugiardo dice la verità non gli credono". La frase aveva questo significato: Mutolo aveva detto in passato delle sciocchezze ma aveva anche parlato di Mancino, con particolare riferimento a un incontro di quest’ultimo con Borsellino, in seguito al quale il magistrato aveva manifestato uno stato di tensione, tanto da fumare contemporaneamente due sigarette. Per Biondino sulla circostanza che riguardava Mancino, Mutolo non aveva detto il falso. Ma l’ex ministro oggi dichiara di non ricordare l’incontro al Viminale con Borsellino.
Questi retroscena Brusca li racconta per la prima volta al pm fiorentino Gabriele Chelazzi che indagava sui mandanti occulti delle stragi. Adesso riscontrerebbero le affermazioni di Massimo Ciancimino, figlio di don Vito, che collabora con i magistrati di Palermo e Caltanissetta svelando retroscena sul negoziato mafia- Stato. Un patto scellerato che avrebbe avuto inizio nel giugno ’92, dopo la strage di Capaci, aperto dagli incontri fra il capitano De Donno e Ciancimino. E in questo mercanteggiare, secondo Brusca, Riina avrebbe ucciso Borsellino "per un suo capriccio". Solo per riscaldare la trattativa.
Le rivelazioni del collaboratore di giustizia si spingono fino alle bombe di Roma, Milano e Firenze. Iniziano con l’attentato a Maurizio Costanzo il 14 maggio ’93 e hanno termine a distanza di 11 mesi con l’ordigno contro il pentito Totuccio Contorno. Il tritolo di quegli anni sembra non aver portato nulla di concreto per Cosa nostra. Brusca ricorda che dopo l’arresto di Riina parla con il latitante Matteo Messina Denaro e con il boss Giuseppe Graviano. Chiede se ci sono novità sullo stato della trattativa, ma entrambi dicono: "Siamo a mare", per indicare che non hanno nulla. E da qui che Brusca, Graviano e Bagarella iniziano a percorrere nuove strade per riattivare i contatti istituzionali.
I corleonesi volevano dare una lezione ai carabinieri sospettati (il colonnello Mori e il capitano De Donno) di aver "fatto il bidone". E forse per questo motivo che il 31 ottobre 1993 tentano di uccidere un plotone intero di carabinieri che lasciava lo stadio Olimpico a bordo di un pullman. L’attentato fallisce, come ha spiegato il neo pentito Gaspare Spatuzza, perché il telecomando dei detonatori non funziona. Il piano di morte viene accantonato.
In questa fase si possono inserire le nuove confessioni fatte pochi mesi fa ai pubblici ministeri di Firenze e Palermo dall’ex sicario palermitano Spatuzza. Il neo pentito rivela un nuovo intreccio politico che alcuni boss avviano alla fine del ’93. Giuseppe Graviano, secondo Spatuzza, avrebbe allacciato contatti con Marcello Dell’Utri. Ai magistrati Spatuzza dice che la stagione delle bombe non ha portato a nulla di buono per Cosa nostra, tranne il fatto che "venne agganciato ", nella metà degli anni Novanta "il nuovo referente politico: Forza Italia e quindi Silvio Berlusconi".
Il tentativo di allacciare un contatto con il Cavaliere dopo le stragi era stato fatto anche da Brusca e Bagarella. Rivela Brusca: "Parlando con Leoluca Bagarella quando cercavamo di mandare segnali a Silvio Berlusconi che si accingeva a diventare presidente del Consiglio nel ’94, gli mandammo a dire "Guardi che la sinistra o i servizi segreti sanno", non so se rendo l’idea...". Spiega sempre il pentito: "Cioè sanno quanto era successo già nel ’92-93, le stragi di Borsellino e Falcone, il proiettile di artiglieria fatto trovare al Giardino di Boboli a Firenze, e gli attentati del ’93". I mafiosi intendevano mandare un messaggio al "nuovo ceto politico ", facendo capire che "Cosa nostra voleva continuare a trattare".
Perché era stata scelta Forza Italia? Perché "c’erano pezzi delle vecchie "democrazie cristiane", del Partito socialista, erano tutti pezzi politici un po’ conservatori cioè sempre contro la sinistra per mentalità nostra. Quindi volevamo dare un’arma ai nuovi "presunti alleati politici", per poi noi trarne un vantaggio, un beneficio".
Le due procure stanno già valutando queste dichiarazioni per decidere se riaprire o meno il procedimento contro Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri, archiviato nel 1998. Adesso ci sono nuovi verbali che potrebbero rimettere tutto in discussione e riscrivere la storia recente del nostro Paese.
-
> "APRITE, APRITE" --- Fiabe, leggende, poesie, canti, danze, consuetudini, riti. L’inesorabile distruzione delle nostre radici culturali (di Sandra Puccini).20 ottobre 2009, di Federico La Sala
 UNESCO. Ha classificato come “patrimonio dell’umanità” i nostri beni storico-artistici.
UNESCO. Ha classificato come “patrimonio dell’umanità” i nostri beni storico-artistici.
 Un riconoscimento che fa dell’Italia un paese unico in Europa. Non dimentichiamolo.
Un riconoscimento che fa dell’Italia un paese unico in Europa. Non dimentichiamolo. L’inesorabile distruzione delle nostre radici culturali
L’inesorabile distruzione delle nostre radici culturali
 Fiabe, leggende, poesie, canti, danze, consuetudini, riti
Fiabe, leggende, poesie, canti, danze, consuetudini, riti Su questi temi, come per altri, si sta tagliando
Su questi temi, come per altri, si sta tagliando
 Il ministero sta annientando le competenze antropologiche
Il ministero sta annientando le competenze antropologiche Il cambio. Chi fa le leggi si inventa miti celtici e altra paccottiglia volgare
Il cambio. Chi fa le leggi si inventa miti celtici e altra paccottiglia volgare
 Revisionismo- Un paese che si vergogna della sua storia, “revisionismo”
Revisionismo- Un paese che si vergogna della sua storia, “revisionismo” di Sandra Puccini (l’Unità, 20.10.2009)
di Sandra Puccini (l’Unità, 20.10.2009)Nel 1911 si teneva a Roma l’Esposizione universale per celebrare il cinquantenario dell’Unificazione italiana. In quella occasione, in un tempo nel quale la diversità degli italiani era considerata un valore e una ricchezza per comporre i lineamenti dell’identità nazionale, accanto a mostre d’arte e di architettura, venne allestita nella capitale la più grande raccolta di oggetti popolari mai realizzata nel nostro paese. Artefice e organizzatore della Mostra fu Lamberto Loria: un celebre etnografo che, dopo dieci anni di viaggi tra i popoli extraeuropei, aveva deciso di rivolgere alla cultura delle nostre classi subalterne la sua esperienza.
Sono passati quasi cento anni e ci avviciniamo velocemente alla celebrazione del centocinquantesimo anniversario di quell’evento. Ma siamo ben lontani dall’entusiasmo di allora: lo dimostrano i ritardi, le rimozioni, le polemiche e le discussioni anche aspre che circondano la preparazione dell’anniversario. Ma c’è poco da stupirsi: i tempi sono oggi cambiati e la diversità (ogni tipo di diversità) è inquietante, fa paura e serve a mettere paura. Del resto molti di coloro che ci governano sono imprigionati in una visione dell’identità meschina e ristretta pari solo all’ignoranza gretta che guida le loro proposte politiche (straparlano di dialetti, evocano il nome di Cattaneo che certo si rivolterà nella tomba e si vantano di usare il tricolore come carta igienica).
Competenze e interessi etno-antropologici avevano preso forma e rilievo dal 1869, quando a Firenze erano sorti insieme la prima cattedra di Antropologia e il suo Museo Nazionale (tra i primi a nascere nel mondo occidentale), saldandosi agli studi folklorici: così da documentare a tutto campo tanto la ricchezza dei così detti “beni immateriali”, quanto la vita dei popoli. Fiabe, leggende, poesie, canti, danze, consuetudini, riti, feste e poi cibi, usi, attrezzi di lavoro, abiti e apparati cerimoniali.
Nell’insieme, un patrimonio enorme fatto di oggetti, immagini, narrazioni, comportamenti che l’Unesco ha classificato come “patrimonio dell’umanità” e che - proprio come i nostri beni storico-artistici - fa dell’Italia un paese unico in Europa. Un patrimonio vitale, la cui tutela e organizzazione richiede ovviamente competenze disciplinari specifiche e aggiornate. Nel nostro paese sono almeno un migliaio i musei della civiltà, del mondo o del lavoro contadino, delle tradizioni popolari, del folklore, etnografici, antropologici e via continuando con le molte denominazioni che essi assumono (e che hanno assunto) nel tempo e nello spazio.
Naturalmente questi luoghi, per essere allestiti, promossi, gestiti, richiedono l’uso di saperi particolari: precisamente quelli che vanno sotto il nome di demo-etno-antropologici, che si formano attraverso corsi universitari e scuole di specializzazione. Conoscenze professionali riconosciute dallo stesso Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Tutti i tipi di musei che ho ricordato sono luoghi della trasmissione della memoria, vere macchine del tempo che mettono in comunicazione il passato con il presente, i bambini con gli anziani, le tradizioni degli altri con le nostre. E forse, proprio attraverso il contatto con le piccole e le grandi cose della vita quotidiana, aiutano ad immaginare un futuro radicato nella realtà storica e antropologica della nostra società.
Il lungo preambolo era necessario. Parlo di temi culturali, che non hanno a che fare con la perdita di posti di lavoro o con la precarietà: ma che tuttavia impoveriscono le nostre possibilità di conoscenza. Già da qualche anno la direzione dell’Istituto Centrale per la Demoantropologia è stata affidata a storici dell’arte: un nonsenso, malgrado molti musei etno-antropologici abbiano anche un notevole valore estetico.
Ma in questi giorni il Ministero dei Beni culturali (con l’avallo dei sindacati di categoria) ha stabilito che i nuovi profili professionali dei dipendenti non comprendano più le competenze antropologiche, accorpandole a quelle a quelle storico-artistiche. Se questo progetto si realizzasse, non solo verrebbero mortificate le professionalità di tutti quelli che lavorano nei nostri musei, ma si farebbe tabula rasa della storia ultracentenaria legata allo sviluppo delle discipline antropologiche italiane. Inoltre si amputerebbe il nostro patrimonio culturale di quelle conoscenze specifiche che sono state (e continuano ad essere) legate alla rappresentazione della vita delle classi subalterne.
Naturalmente, il mondo dei museografi e delle istituzioni antropologiche prepara iniziative e mobilitazioni. Ma mi chiedo - e vi chiedo - se non sia questa, in un paese che sembra vergognarsi della sua storia, l’ennesima forma di “revisionismo” o meglio, di obliterazione delle nostre radici culturali. Intanto dall’altra parte dalla parte di chi fa le leggi e probabilmente i regolamenti - si inventano miti celtici e altra paccottiglia volgare.
-
> "APRITE, APRITE": IL GOLPISMO DEL LUPO ---- A Torino, per Norberto Bobbio, Napolitano torna a rivolgere un appello al senso della misura e al rispetto delle istituzioni perchè «anche il Paese ne avverte la necessità».15 ottobre 2009, di Federico La Sala
La Stampa, 15/10/2009 (12:15)
Napolitano: "Quello del Capo dello Stato è un potere neutro"
TORINO. Torna a rivolgere un appello al senso della misura e al rispetto delle istituzioni perchè «anche il Paese ne avverte la necessità» il Capo dello Stato Giorgio Napolitano, intervenuto oggi al convegno che commemora i cento anni della nascita di Norberto Bobbio.
Citando le parole del filosofo piemontese laddove richiamava «un pò di quilibrio da parte di tutti», il capo dello Stato si è chiesto: «Sono parole, se ripetute ora, destinate a lasciare il tempo che trovano? Fare, non dico «l’elogio della mitezza» ma il più naturale appello al senso della misura, al confronto costruttivo, al rispetto delle istituzioni e alla considerazione dell’interesse comune, è dunque solo un dar prova di ingenuità? Ebbene, fosse pure questo - ha ribadito Napolitano accompagnato dall’applauso della platea - io non desisterò dal mio appello, rivolto come sempre in tutte le direzioni. Sono convinto che molti italiani -ha aggiunto- al di là delle loro diverse, libere scelte elettorali, lo condividano, ne avvertano la necessità».
-
> "APRITE, APRITE": IL GOLPISMO DEL LUPO ---- L’IPOCRISIA INFINITA (di Barbara Spinelli).29 novembre 2009, di Federico La Sala
L’ipocrisia infinita
di BARBARA SPINELLI (La Stampa, 29/11/2009)
Da qualche tempo son molti i politici italiani che pretendono d’aver abbandonato ogni falsità, d’aver infine compiuto l’intrepido gesto che sfata le ipocrisie, d’aver imboccato la via stretta della verità. Dopo parecchio vagare ammettono che in questione non è più l’agire del governo ma il privato destino d’un presidente del Consiglio che non è protetto da processi pendenti, e che potrebbe essere indagato per concorso in stragi mafiose.
Sentono che la terra trema sotto Palazzo Chigi e dicono, come Casini, che è inane sfasciare la giustizia pur di sbrigare un caso singolo: meglio «eliminare le ipocrisie» e riconoscere che serve una legge, la decisiva, per «salvaguardare Berlusconi». La Corte Costituzionale gli ha negato l’immunità, ma egli ha pur sempre vinto le elezioni e deve poter governare: diamogli dunque lo scudo che cerca, visto che alternative non ci sono.
Nella sostanza è il discorso di Berlusconi che vince: la magistratura impedisce alla democrazia di funzionare, quindi è eversiva. È in atto una guerra civile, insinua: uno spettro che in Italia tacita in special modo gli ex comunisti.
Le cose potrebbero tuttavia non stare così, e ci si può chiedere se uscendo da un’ipocrisia non si entri in un nuovo gioco mascherato, che vela anziché svelare. Chi ha detto che l’unica via sia lo scudo immunitario?
L’altra via stretta è la possibilità che Berlusconi si difenda non dai processi ma nei processi, come Andreotti. O la possibilità che il ceto politico tragga le conseguenze, allontanando un leader non condannato ma debilitato da troppi processi e congetture. È accaduto per molti dirigenti in molte democrazie occidentali. Quel che sorprende in Italia è che quest’alternativa, se si esclude Di Pietro, nessuno la propone: subito è detta sovversiva. Essa non presuppone il governo dei giudici, o addirittura dei pentiti. La decisione spetta alla politica, e se questa tace o s’accuccia, c’è solo la voce dei magistrati, per quanto sommessa, a esser udita. L’altra cosa sorprendente è che la tesi sul contrasto tra voto popolare e legalità intimidisca più l’opposizione che la destra.
Su questo giornale, il 23 novembre, c’è stata una presa di posizione forte, di Fabio Granata che è vicepresidente della Commissione antimafia e fedele di Fini, contro chi scredita i processi di mafia. Intervistato da Guido Ruotolo, Granata denuncia il «berlusconismo che rischia di cancellare la nostra identità: quella di chi crede nei valori della legalità, dell’antimafia, della giustizia, del senso dello Stato». Nel Pdl, egli è «guardato come un appestato», «accusato di essere giustizialista».
Ciononostante resiste: «Ho visto la gente impazzita di rabbia e dolore ai funerali di Paolo Borsellino, che (...) faceva parte della famiglia missina. Quella enorme e disperata domanda di giustizia l’ho tenuta nel cuore e per questo non potrei non sostenere chi dal ’92 cerca irriducibilmente di affermarla. Meglio un giorno da Borsellino che cento anni da Vito Ciancimino. Liberare l’Italia dalle mafie dovrebbe rappresentare il primo punto all’ordine del giorno dell’azione di qualsiasi governo». Granata non ritiene colpevoli Berlusconi e Dell’Utri ma approva le inchieste di Palermo, Caltanissetta, Firenze (le procure che investigano sulle stragi del ’92-’93). Loda il «lavoro tenace» del giudice Antonio Ingroia (il procuratore aggiunto di Palermo che indaga sul patto Stato-mafia): «Lo ricordo perfettamente accanto a Paolo Borsellino, quel giorno alla sala mortuaria per riconoscere il corpo maciullato di Falcone».
La cosa strana non è che queste parole vengano da destra. Borsellino era vicino alla destra, e quest’ultima ha una lunga tradizione di lotta alla mafia, a causa del senso dello Stato acuto (a volte sfrenato) che la anima.
Ci fu l’attività di Cesare Mori in Sicilia, fra il 1924 e il ’29: attività peraltro ostacolata da dignitari fascisti che temettero il suo assedio.
Apparteneva alla destra storica il senatore Leopoldo Franchetti, il primo che perlustrò il fenomeno mafioso, scrivendo nel 1876 un rapporto sulle Condizioni politiche e amministrative della Sicilia: un classico sulla malavita. Apparteneva alla destra storica Emanuele Notarbartolo, il direttore del Banco di Sicilia che volle far pulizia e fu ucciso dalla mafia il 1° febbraio 1893. Il mandante era un senatore mafioso, processato e poi assolto.
Strano è il cedimento-fatalismo dell’opposizione, al centro e nel Pd.
Ambedue vedono la legislatura divorata dai guai giudiziari d’un singolo, ma nell’essenza si dichiarano imbelli. È come se ritenessero del tutto impensabile una contromossa della politica che non sia l’accomodamento, o come diceva Gaetano Mosca nel 1900: il «lasciar andare, la fiaccona». Come se dicessero: il leader non può governare e il dilemma si risolve non ricongiungendo democrazia e legalità, ma disgiungendole. Fondando il primato della politica non su atti trasformativi, ma tutelativi.
Forse senza rendersene conto, il Pd interiorizza l’alternativa democrazia-legalità. Martedì a Ballarò Luciano Violante ne è parso prigioniero: da una parte la democrazia, dall’altra la legalità. Ha mancato di ricordare che le due cose o sono sinonimi, oppure non si ha né democrazia né legalità. Voleva probabilmente dire che non sono i giudici a far cadere un governo, tanto meno i pentiti. Ha finito col dire che non è neppure la politica (partiti, parlamento) a poterlo fare. Torna a galla l’idea leninista secondo cui la democrazia sostanziale può confliggere con quella legale. È una fortuna che Napolitano abbia detto in modo chiaro, venerdì, che spetta invece a politica e parlamento sanare i presenti squilibri.
Tutto questo avviene forse perché le indagini su politica-mafia sono a una svolta. Si accumulano verbali sempre più sinistri, che legano Berlusconi e Dell’Utri alle stragi. Ce n’è uno in particolare, quello del pentito Romeo, secondo cui nei primi ’90 «c’era un politico di Milano (il nome fattogli dal pentito Spatuzza è Berlusconi) che aveva detto a Giuseppe Graviano (un capomafia) di continuare a mettere le bombe», indicando perfino «i siti artistici dove metterle». I verbali non inducono ancora la magistratura a aprire un’indagine, ma la loro portata è oltremodo conturbante. Un sospetto malefico pesa sul presidente del Consiglio: che oltre al conflitto di interessi economici, ne esista un altro che lo espone a minacce di pentiti e carcerati mafiosi.
Il governo in realtà sostiene ben altro: la sua lotta alla mafia sarebbe dura; secondo alcuni, è sotto pressione proprio per questo. Nell’agosto scorso Berlusconi ha affermato di voler «passare alla storia come il presidente del Consiglio che ha sconfitto la mafia». Né mancano dati promettenti: la legge del carcere duro inasprita (legge 41 bis), i beni mafiosi sequestrati, un gran numero di capi malavitosi arrestati.
Al contempo tuttavia son favoriti i colletti bianchi che fanno affari con la mafia. C’è lo scudo fiscale, che chiede all’evasore una restituzione minima di quel che dovrebbe (il 5 per cento), e in cambio gli consente, restando anonimo, di cancellare reati come il riciclaggio di denaro sporco (lo spiega il giudice Scarpinato sul Fatto del 15-11-09). C’è la legge sulle intercettazioni, che ostacola le inchieste sulla mafia. C’è il Comune di Fondi, in mano alle destre: tuttora non sciolto, malgrado la collusione con la mafia sia certificata da oltre un anno. Contestata da don Ciotti, c’è una legge che mette in vendita parte dei beni confiscati alla mafia, col pericolo che prestanome incensurati li riacquistino. C’è infine il processo breve: un processo morto, per i colletti bianchi collusi.
La svolta secerne sospetti a raggiera. Quelli che Franchetti chiamava i facinorosi della classe media (amministratori, politici) potrebbero aver l’impressione che il cuore dello Stato sia nelle loro mani. È sospettato il presidente del Senato Schifani, per rapporti con i fratelli Graviano e assistenza giuridica al costruttore Lo Sicco, oggi in galera per mafia. È indagato Nicola Cosentino, sottosegretario al Tesoro, per concorso esterno in associazione camorristica. Ambedue restano al loro posto, sotto gli occhi non tanto dei magistrati quanto della mafia, esperta in ricatti. Che sia l’ora della politica è evidente. Le democrazie vivono e muoiono nel funzionare o non funzionare del comportamento politico, non di quello giudiziario.
-