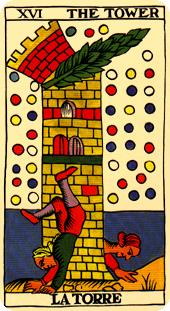
PENSIERO LIQUIDO E CROLLO DELLA MENTE. Sulle nuove frontiere della riflessione estetica, un originale saggio di Gaetano Mirabella, scrittore e collaboratore del "McLuhan Program in culture and technology" di Toronto - a cura di Federico La Sala
- [...] Il crollo della mente è un evento che non è stato percepito e adeguatamente segnalato forse a causa dell’eccessiva attenzione verso l’intelligenza artificiale e le neuroscienze [...] L’estetica tradizionale non riesce più a spiegare che cosa accade intorno a noi, e che cosa proviamo [...]
- Festival internazionale della Filosofia in Sila: alcune foto - foto di Gaetano Mirabella, in fondo.
- "E se l’amore non fosse altro che una sofisticata, arcaica tecnologia, grazie alla quale poter risalire, oltre la nostra testa, verso l’essere antico che abita il nostro respiro da sempre? L’essere amato siede là, nel lontanissimo altrove e attende tra mille mormorii senza voce, che si apra la pista sotto la sabbia del deserto delle seduzioni della mente, perché forse, tra poco sarà notte e bisognerà sellare le vele del sogno al ghibli di parole che travestono un mondo di verità.
 Attraverso la cruna sognante dell’occhio dell’ESSERE, eluderemo i confini mobili continuamente mutati dal soffio del ghibli del deserto di quest’epoca senza memoria, e forse, se saremo veri, la forma autentica del cielo c’indicherà la pista sicura verso l’oasi dell’ESSERE dell’amore" (Gaetano Mirabella,"La forma autentica del cielo", Ed. Ripostes, Salerno - Roma, 1989).
_________________________________________
Attraverso la cruna sognante dell’occhio dell’ESSERE, eluderemo i confini mobili continuamente mutati dal soffio del ghibli del deserto di quest’epoca senza memoria, e forse, se saremo veri, la forma autentica del cielo c’indicherà la pista sicura verso l’oasi dell’ESSERE dell’amore" (Gaetano Mirabella,"La forma autentica del cielo", Ed. Ripostes, Salerno - Roma, 1989).
_________________________________________
Foto. "Arcano Maggiore" dei Tarocchi: la Torre (o la Casa di Dio).
Il testo - qui, in anteprima - è stato stampato presso la Palladio editrice di Salerno (e. 10, pp. 91).
PENSIERO LIQUIDO E CROLLO DELLA MENTE
Verso un sentire pensante.
Il corpo nell’epoca della Transnaturalità elettronica.

- Possediamo ogni scienza esattamente nella misura in cui ci siamo risolti ad accogliere la testimonianza dei sensi, nonché nella misura in cui li affiniamo, li armiamo e insegniamo loro a “pensare” fino in fondo. F. Nietzsche Crepuscolo degli idoli
Prefazione
Questo documento può essere considerato a pieno titolo un manifesto che annuncia il crollo della mente, un evento quasi invisibile che si è verificato negli ultimi dieci anni e che è ancora in corso. Il crollo della mente è un evento che non è stato percepito e adeguatamente segnalato forse a causa dell’eccessiva attenzione verso l’intelligenza artificiale e le neuroscienze.
Questo libro si prefigge il compito di disegnare un probabile percorso alla ricerca delle dinamiche che hanno determinato il crollo della mente, l’avvento del pensiero del sentire e l’ingresso nell’esternità a partire da un corpo nuovo.
I capitoli che compongono questo documento sono costituiti da articoli che sono stati pubblicati in vari convegni. I primi due relativi ai concetti di “corpo-scena” e “spazio che sente” sono stati inclusi in un libro scritto a Toronto nell’estate del 2007, in collaborazione di Derrick de Kerchkove, direttore del McLuhan Program e di altri sette autori (Luisa Malerba, Loretta Secchi, Cristina Miranda De Almeida, il sottoscritto Gaetano Mirabella, oltre a Derrick de Kerchkove, Edith Ackermann ex assistente di Jean Piaget e la coreografa canadese Isabelle Choinièr e la coreana Sryu). Patrocinato dalla biblioteca del Congresso degli U.S.A., Il libro è in via di pubblicazione e riguarda il “Punto d’essere”.
Il terzo articolo che dà il titolo a questo libro (Il pensiero liquido del terzo millennio e il crollo della mente), costituirà uno dei testi di un’antologia pubblicata dal McLuhan Program di Toronto.
Tutti e tre gli articoli sono stati elaborati in periodi diversi ma costituiscono tutti passi di un percorso unico che si autocostruiva nel tempo e che, dal “corpo-scena” dell’anno 2002 (pubblicato con la Trauben ed. di Torino, a cura di Grazia Marchianò ne “gli atti del Convegno di Estetica tenutosi alla Certosa di Pontignano”), ha portato all’elaborazione prima del sentire pensante, dello spazio cosciente (anno 2003), poi del pensiero del sentire, e infine al pensiero liquido, al crollo della mente e all’esternità.
Questa introduzione è stata scritta dopo la stesura del testo che segue e si è resa necessaria a causa del linguaggio un pò ermetico che descrive fenomeni ancora poco visibili e poco pensati, che riguardano ipotesi concettuali che ho chiamato con nomi e definizioni che richiedono spiegazioni.
La situazione di fronte alla quale l’uomo contemporaneo è venuto a trovarsi, impone di abbandonare il vecchio “punto di vista” a favore di un nuovo punto d’essere. Che cosa prova un uomo oggi in una folla? Dov’è situato il suo punto d’essere? Qual è la sua forma? Egli è individuo o folla? E’ cambiata la percezione della realtà e in che modo? Esiste ancora una realtà o forse è terminata? Che cosa è il sentire pensante e che significa che i sensi devono imparare a pensare la realtà? Significa forse che l’attività dei sensi creano una specie di nuovo mondo, e che si afferma una nuova esternità?
I sensi diventano sempre più ”estranei” perchè sempre più coadiuvati da “protesi” tecnologiche, che riproducono tecnologicamente processi che appartengono all’uomo, rendendoli tuttavia per lui irriconoscibili. I media dei sensi tecnologici hanno la tendenza a interagire, generando effetti imprevisti e sorprendenti. Con l’avvento dei media elettrici noi abbiamo la messa in scena del sistema nervoso, e creato le premesse di un mutamento che coinvolge anche il corpo, che cambia il suo assetto divenendo il corpo-scena, presenza definitiva, spazio che sente. Sembra che l’uomo contemporaneo voglia abbandonare il suo statuto di individuo per innestarsi in un corpo più vasto trasformando l’onda isolata che rappresenta la sua mente, nel mare di una “presenza definitiva” globale.
Abbandonare ogni tipo di struttura simbolica che si articola in un processo, dev’essere considerato una tendenza irreversibile dell’uomo contemporaneo? E’ plausibile che la caratteristica a bassa definizione delle dinamiche sociali abbia innescato una realtà fredda la cui fruizione sollecita l’intervento del fruitore stesso? Il rigetto di una situazione com’è quella della consapevolezza ordinaria è dato forse dall’esigenza di fondere la propria percezione nella rete salvandosi da una condizione di isolamento per “sentire” flussi d’esistenza che si spingono verso nuove configurazioni del vivere, attraverso la configuratività, gestaltica e totalizzante della prassi dell’oralità plurisensoriale?
La nuova consapevolezza fluisce oggi in un ambiente cosciente che si può considerare una sorta di secondo mondo sorto su una esternità che cresce e s’innalza come un grattacielo in costruzione e viene percepita come una dimensione sempre nuova e cangiante, alla base della quale si muove un sentire pensante che ci svela che siamo parti di un grande corpo, che siamo “cellule” pensiero che pensano un pensiero liquido attraverso i cellulari.
Per essere parte attiva di questa intensa consapevolezza, si avverte oscuramente che bisogna sparire come individui e divenire flusso che scorre senza ostacoli e senza opposizioni. Occorre evitare le ideologie e le rappresentazioni della realtà se si vogliono cogliere il divenire e il cambiamento. Il sentire pensante “pensa” ciò che percepisce e quindi in qualche modo lo “inventa” lo crea. Il sentire pensante mette in condizione di “creare” la realtà e dunque di essere “presenza definitiva”, non nel senso di un raggiungimento di uno statuto ontologico definitivo ma nel senso di provare una precisa corrispondenza tra le circostanze in cui avviene la propria azione e il nostro autostato. E’ questa la nuova condizione che possiamo definire punto d’essere?
PARTE Prima: Il Corpo-scena
Nuove frontiere della riflessione estetica.
L’estetica tradizionale non riesce più a spiegare che cosa accade intorno a noi, e che cosa proviamo: perché? Perché ci siamo trovati in un luogo o in una configurazione di luoghi, nella quale siamo andati oltre la sensibilità, e questo “oltre” si configura come un ambiente cosciente in cui sembra invertito il rapporto tra conscio e inconscio. Forse la progressiva obsolescenza dell’estetica è dovuta al fatto che usa strumenti d’indagine ermeneutica inadeguati a descrivere un “sentire” che non sembra provenire più da un corpo percettore ma che si situa, in maniera inquietante, in una esternità diffusa e dispersa. Il nucleo di questo “sentire” si articola in un punto intermedio tra percezione umana e la nuova visione-macchina, mediata dai dispositivi tecnologici.
E’ mia convinzione che con le nuove tecnologie siamo stati posti in uno stato di intensa consapevolezza della quale tuttavia non siamo coscienti. In questo stato di intensa consapevolezza siamo entrati in un nostro corpo nascosto di cui non sospettavamo l’esistenza: in questo corpo siamo andati senza esserci andati.
Questo stato di intensa consapevolezza ci situa fuori della influenza del linguaggio poiché essa è eccedente rispetto alla intenzionalità espressiva del soggetto. Il richiamo alla figura “Corpo” è plausibile poiché, sebbene, probabilmente non siamo più in regime di una percezione sensibile concentrata in un luogo assimilabile al corpo fisico, tuttavia giunge a noi una percezione dell’esternità diffusa e dispersa proveniente da una configurazione che ho chiamato il corpo-scena( [1]) Mac Luhan dice che nell’era elettronica noi indossiamo tutta l’umanità come la nostra pelle. Sebbene il corpo-scena per sue particolari caratteristiche non sia estraneo ad una modalità di tipo estetico, ciononostante esso, non ha alcun punto di contatto con l’artisticità e con il paesaggio interiore del soggetto artistico inteso nella vecchia maniera.
Questo corpo-SCENA è un luogo-cosciente, esso è duttile, ubiquitario, olistico, decentrato, e appare, al di là di una “sensibilità” sconvolta, con una vibrante aura che si riverbera intorno alla sparizione fisica del soggetto.
E’ problematico visualizzare il corpo -scena: esso è “nascosto” in ciò che di esso appare, ovvero in relazione alla percezione di immagini “incongruenti” In un regime in cui la percezione si satura a causa dell’ accumulo di feedback, possono determinarsi effetti di straniamento simili a quelli che si determinano nelle dinamiche di turbolenza molecolare delle cosiddette strutture dissipative. Nelle reazioni non lineari, in condizioni lontano dall’equilibrio si creano nuovi stati della materia. E nuove condizioni percettivo/enattive di una nuova “esternità”, per un approfondimento del tema cfr Isabelle Stengers e Ylya Prigogine, “La nuova alleanza”.Torino, 1993.
La relazione tra corpo-scena e immagini si sottrae nella presentazione in ciò che appare. La sua presenza che può essere solo inferita dalle sinergie che si creano con l’apparire di immagini sintetiche, risulta basata su di un paradosso: esso è caratterizzato da un “sentire” pensante per cui il percetto si sottrae ad una definizione sintatticamente congruente.
La configurazione tipica in cui il corpo-scena si attiva è quella del computer in cui si instaura un circuito ricorsivo molto rapido tra le pulsioni elettriche della macchina e le pulsioni neurali, cosa che modifica l’organizzazione dei due insiemi simultaneamente. Nell’attivazione del corpo-scena, si verificano due fatti importanti: un processo di esternalizzazione del linguaggio, che viene sostituito con un linguaggio-macchina; e l’appropriazione del computer della maggior parte delle operazioni cognitive.
Lo spazio-tempo in cui il corpo-scena può manifestarsi è uno spazio-tempo sospeso ed enigmatico in cui aleggia un sentimento senza mondo: in un luogo senza spazio la rete, somma di tutti i luoghi, dissolve il concetto di legame, perdendo la sua sfumatura umana. Vestito di nulla, purificato ed elettrico, il corpo-scena riveste l’immateriale della nuova naturalità elettronica. La percezione che si attiva nel corpo-scena, è caratterizzata da una epochè che si attua in regime di distopìa e anamorfosi ( [2]).
Lo spiazzamento percettivo, apre uno spazio da cui si attiva una presenza definitiva.
La presenza definitiva è un “sentire” nel quale trova realizzazione una paradossale commistione tra percezione sensibile e pensiero. Alludo alla possibilita’ di percepire cio’ che si presenta e non cio’ che e’ soltanto rappresentazione della realta’.
La presenza definitiva è autopoietica, ricorsiva, autoreferente, autostatica. Essa si presenta sospesa in una configurazione definitiva in cui il corpo-scena può apparire in un ruolo in cui si mimetizza usando le stesse circostanze di cui si riveste il corpo fisico. Cosicchè, pur potendo avere un nome e una identità la presenza definitiva non può esibirlo, poiché appare là, nel luogo del quale aveva sovvertito il codice, moltiplicando l’aspetto scenologico.
Per questo la presenza definitiva è anonima e distopica: essa non può dar conto del suo apparire là, nel luogo in cui appare, ovvero laddove “altri” ne registrano la presenza. Non sappiamo che cosa “si” prova (relativamente al corpo-fisico) ad essere il “sé” ovvero i “sé” ( [3]) di questa presenza definitiva.
• La conditio sine qua non per l’esperienza di questo sentire raggiante, passa per l’abdicazione al pensiero discorsivo. Il pensiero discorsivo è inteso come resistenza del cervello al flusso dell’informazione che viene invece trattata per “noi” dai media elettronici, i quali si occupano anche della maggior parte delle operazioni cognitive. Ciò che conta è condurre la corporeità ad assumere lo statuto del “semiconduttore”. La modalità di apprensione delle immagini anamorfotiche e dei fenomeni relativi alla distopìa, è quella ad infinitum del “semiconduttore”.
Questi fenomeni infatti, non si lasciano ridurre in unità, consistendo, la loro decodificazione e traduzione sul piano propriocettivo, in un lavorìo arduo, condotto senza alcun supporto di coordinamento e verifica, quasi fosse una pura sostanza visiva, completamente oggettivata, dunque del tutto estranea anche alle routines di interpretazione interne del linguaggio.
Il linguaggio, resta tagliato fuori dalla descrizione delle eventuali modificazioni relative alla fenomenologia dell’esser-ci poiché esso si configura come un autostato la cui modalità può essere solo inferita a partire da ciò che si dà nell’apparire del fenomeno corpo-scena.
L’alfabeto greco fu il primo ed unico sistema di comunicazione completamente astratto, esso rese l’informazione completamente indipendente dai sensi umani, provocando una decontestualizzazione del corpo.
Per McLuhan, l’invenzione della parola scritta è “la membrana che ci separa, che ha diviso l’io da tutto quello che non è io. L’uomo intero divenne un frammento; l’alfabeto mandò in pezzi il circolo magico e la magìa risonante del mondo tribale, facendo esplodere l’uomo in un agglomerato di individui (o unità) specializzati e psichicamente impoveriti, che funzionano in un mondo fatto di tempo lineare e spazio euclideo”( [4]).
Con i media elettronici si delinea all’orizzonte, la possibilità di “ritornare” nel corpo ricontestualizzato e sensorializzato a partire però dalla sua produzione in un ambito sintetico/virtuale. Dal momento in cui, con l’elettricità, è emersa una qualità comune tra il principio di attività del nostro corpo e delle nostre macchine, queste non sono più esterne ma interne al corpo. Accade già oggi che l’intenzione, espressa da un semplice gesto, un cenno, o nel prossimo futuro, un pensiero demoltiplicato dallo strumento di intervallo tecnico, esplicitano i legami tra cervello (brain) e mente (mind) tra lo psichico ed il somatico.
La presenza definitiva, attivata tramite il dispositivo tecnologico, spinge sulla ribalta il nostro sistema nervoso che, libero dalle operazioni cognitive, può modellare delle routines di operazioni psicologiche nuove che trascendono i limiti del corpo fisico individuale.
Con la produzione tecnologica del corpo si attiva la possibilità di una utilizzazione in una dimensione pragmatica degli aspetti personali del sentire che si manifesta nelle percezioni e nelle affezioni che, insieme ai gesti e alle parole, vengono sottratte al corpo fisico, desoggettivate, rese impersonali e inglobate in immagini sintetiche che eccedono tanto il soggetto, quanto l’oggetto. Queste immagini sintetiche si costituiscono come entità autonome e autosufficienti e come tali esse sono il divenire non-umano dell’essere umano.
Dal momento che già si configura una gestione/sfruttamento economica del virtuale-sintetico, occorre interrogarsi sul destino dell’esser-ci poiché già si intravedono le prime avvisaglie di una distruzione/modificazione dei presupposti biologici del corpo fisico, attuata politicamente dai grandi organismi multinazionali impegnati su versanti produttivi cosiddetti alternativi.
Gli interventi che possono sconvolgere gli assetti biologici del corpo, riguardano le biotecnologie da un lato e le tecnologie informatiche dall’altro. In questi due campi si registrano eventi la cui direzione va palesemente verso lo scontro tra gli equilibri naturali e le nuove visioni dell’ingegneria genetica. In questi campi infatti sono stati avviati processi di sfruttamento della dimensione “umana” con il pretesto di superare la grave crisi contemporanea circa l’identità e i problemi legati alla distribuzione delle risorse alimentari. La subordinazione dell’individuo alla nuova specie degli individui elettronici “senza corpo” e alla specie in generale, non può essere supportata.
Credo che il compito dell’estetica contemporanea, sia terminato per ciò che riguarda il campo dell’artisticità in generale e che, più specificatamente, il suo campo di competenza concerna il mutamento di orizzonte determinato dall’impatto con le nuove tecnologie che hanno prodotto una mutazione antropologica i cui esiti restano non pensati e non descritti adeguatamente, relativamente alla produzione di un corpo-Scena ultrasoggetivo.
PARTE SECONDA: IL “SENTIRE PENSANTE”
La presenza definitiva è un sentire pensante che accoppia la percezione sensibile con il pensiero per la produzione di un mondo. Essa è una metastruttura mentale caratterizzata dalla predittività non di un dato noumenico di una realtà oggettiva a cui sarebbe subordinata, bensì del ritorno degli input nel sistema nervoso di cui hanno modificato gli stati interni. La presenza definitiva è una metastruttura ritornante che interagisce con i suoi propri stati, essa è l’osservatore che può descrivere un sistema che dà origine ad un sistema che può descrivere un osservatore.
Il “sentire” che pensa l’oggetto del suo stesso sentire, conduce l’uomo a decidersi in favore dell’esistenza di un universo che si modifica continuamente e la sua modificazione è funzione dei suoi stati interiori. Il nostro “sentire” ci rende continuamente liberi in un universo, letterarmente plasmato da noi e che non ha altro scopo che essere ciò che è. Il sistema nervoso, sappiamo oggi, dalle teorie della scuola di Santiago, essere una rete chiusa di neuroni interagenti ( [5]). Il paradosso di questa nostra libertà chiusa in una chiusura libera, si esprime nel vivere la nostra esistenza in un dominio di cognizione nel quale il contenuto della cognizione è la cognizione stessa.
Oggi, probabilmente dovremo recuperare il nostro corpo e la nostra libertà seguendo la via degli intronauti, passando attraverso la proiezione sintetica dei nostri luoghi interni in quei topoi che ho chiamato il corpo-scena e la presenza definitiva.
La messa in scena del sistema nervoso ci ha mostrato che la presenza definitiva può raccogliere e coagulare intorno ad uno o più “Sé”, materiale psichico per forgiare l’identità di una nuova poliedrica mente, tuttavia l’immagine che se ne ha a partire dalla scenologia delle macchine, essendo un’immagine estetico/sintetica, oltre che virtuale, non è decodificabile.
Ora, l’importante non è capire se queste immagini estetico/sintetiche siano vere o false ovvero naturali o non, una simile distinzione non ha più alcun senso, quanto quella di scegliere esplicitamente una cornice di riferimento per il nostro sistema di valori. L’alternativa alla ragione è la seduzione estetica a favore di una cornice di riferimento specificamente progettata per assecondare i desideri e non i bisogni.
Se la virtualità della macchina, emergente dalla presenza definitiva si pone da un lato come ostacolo/gioco/spazio di differenza tra il progetto e la sua realizzazione, nello stesso tempo ci protegge dal pericolo di essere recuperati dalla macchina prima di averla assorbita nel nostro universo psicologico personale, e prima di essere riapparsi sull’orizzonte della nostra libertà. Dunque abbiamo dovuto mettere in scena il nostro sistema nervoso perché tramite il sentire pensante della presenza definitiva fosse possibile riappropriarci del nostro esser-ci nelle forme e modalità dell’attuale tempo storico.
Dalla messa in scena abbiamo compreso che il sistema nervoso è chiuso in un dominio continuamente mutante di descrizioni che egli genera attraverso interazioni ricorsive entro quel dominio, e che non ha nessun altro elemento costante nella trasformazione storica all’infuori della sua mantenuta identità di sistema interagente. Detto in altri termini che ci riguardano da vicino: l’uomo cambia e vive in una cornice di riferimento che cambia in un mondo continuamente creato e trasformato da lui.
Attraverso le nuove tecnologie siamo entrati in un nuovo corpo e non ne siamo a conoscenza; siamo andati in un“luogo” della esternità senza esserci andati; abbiamo aperto un altrove attiguo, un altro mondo verso il quale siamo attirati con una velocità di fuga che aumenta costantemente senza che si possa frenare la corsa ( [6]).
Siamo sul punto di mettere fine alle nostre specificità biopsicologiche attraverso interazioni con ambiti che possono metterne in crisi i presupposti di base. Intanto ecco che si annuncia una nuova corporeità che prende le mosse dall’abbandono del corpo fisico manipolato attraverso le biotecnologie.
E’ un “corpo” nuovo che si effonde dal suo stesso cuore configurandosi come una “nuova” scena del corpo-scena e come presenza definitiva (ritornante): sarà quella che doveva venire? In ogni modo gli annunci di questa nascita riguardano forse solo noi occidentali: gli orientali sanno già dai Veda dell’esistenza di un “corpo come scena universale” in cui non abbiamo mai cessato di essere, dal quale non abbiamo mai cominciato ad allontanarci. Sarà bene menzionarlo.
Nelle Upanishad esiste la descrizione di uno spazio che viene chiamato la “Città del Brahman” per molti versi vicino a quello che ho chiamato il corpo-scena: “ In questa città del Brahman -che è il corpo - un sottile loto forma una dimora, dentro la quale vi è un piccolo spazio (...) Questo spazio che si trova all’interno del cuore è altrettanto vasto quanto lo spazio che abbraccia il nostro sguardo. L’uno e l’altro, il cielo e la terra, vi sono riuniti; il fuoco e l’aria, il sole e la luna, la folgore e le costellazioni, e tutto ciò che appartiene a ciascuno di loro in questo mondo e ciò che loro non appartiene, tutto ciò vi è riunito (...) tutti i desideri (kamah = esseri in potenza) in lei sono riuniti. (...) Questi desideri che sono realtà (satya ) sono velati dall’irreale” ( [7]).
Colpisce la sorprendente analogia esistente con la presenza definitiva come sovrapposizione/giustapposizione di luoghi diversi la cui simultanea apprensione avviene nell’induismo attraverso l’esperienza del nirvikalpa samadhi, che può essere raggiunta secondo i “Veda”, dai Brahamacharya (rinuncianti) con un alto grado di autorealizzazione spirituale ma che è potenzialmente aperta a tutti gli uomini. Per noi occidentali quello descritto dalle Upanishad è un autostato, una condizione “normale” che può essere raggiunta “anche” tramite dispositivi tecnologici.
Ma che cosa accade o può accadere alla nostra organizzazione neurobiopsicologica allorquando, come affermano Maturana e Varela i sistemi viventi entrano in interazioni che non sono specificate dalla loro organizzazione circolare? “Un sistema vivente definisce attraverso la sua organizzazione il dominio di tutte le interazioni nelle quali può entrare senza perdere la sua identità, e mantiene la sua identità solo finchè la circolarità basilare che lo definisce come una unità di interazioni rimane integra”( [8])
Detto in altro modo: abbiamo generato un corpo più forte per poter sopportare la rivelazione elettronico/sintetica di un dispositivo tecnologico che dispiega sotto i nostri (di chi?) occhi tutta la superficie interna di noi stessi sotto la forma di tutte le immagini del mondo, mentre ci avverte che quello è il nostro stesso corpo? Naturalmente di tutta la gente che passa buona parte del suo tempo nel cyberspazio, ben pochi conoscono le Upanishad, la filosofia di Nietzsche e le esperienze nel campo della spiritualità. Il clima di vuoto spirituale e di frammentazione sociale, rappresentano un terreno fertile di cultura per le credenze millenaristiche e per la tecnoescatologia nascente in cui la teologia del cosiddetto “seggiolino eiettabile”, predica con successo la fuga d’emergenza in un arcaico paradiso perduto.
Il corpo-scena e la presenza definitiva riaprono, all’inizio del terzo millennio, un viaggio ultrapersonale necessario per svegliare negli uomini il lato attivo dell’infinito e superare l’incubo di un incerto destino del corpo in un mondo oggettivo.
PARTE TERZA: LO SPAZIO COSCIENTE
E’ necessario pensare e dire che lo spazio e’ cambiato e che noi siamo ad un passo della mutazione, e che questo spazio pur non occupando ancora l’”esternita”, tuttavia ci veste dopo averci dissolto come “io”, portandoci in una tensione senza intenzione. Nell’infinito artificiale dei nuovi media elettronici gli eventi accadono nel cosiddetto tempo reale per cui non possono essere collocati in una dimensione cronologica poiche’ una rottura del senso del tempo ci ha portato in una diversa dimensione temporale.
In questo universo il soggetto non ha piu’ una sua posizione relativamente ad un sapere, un potere, o alla “storia” e la sua esistenza appare “vaporizzata”. In effetti non c’e’ piu’ una memoria, poiche’ gli eventi accadono nel tempo reale che e’ il tempo tecnico dell’operazione e non piu’ quello della dimensione storica. Nello spazio virtuale lo spessore emotivo di qualsiasi evento puo’ essere trasformato in fisiologia macchinica tramite l’estroflessione dell’interiorita’.
Ci stiamo estendendo e il nostro corpo ci e’ diventato sconosciuto, ciononostante, in mancanza di punti di riferimento, esso diventa l’unica macchina possibile per riorganizzare la percezione. Queste considerazioni c’inducono a pensare che l’epoca che si apre sara’ sempre piu’ quella dell’esteriorizzazione dell’interiorita’ con la nascita di un nuovo concetto di spazio. Questo spazio che si effonde da noi, e’ nato dalla messa in scena del nostro sistema nervoso, attraverso i dispositivi tecnologici di cui ci siamo dotati e, non e’ piu’ lo spazio della rappresentazione della realta’, ma semplicemente , quello della sua presentazione e dell’attivita’ elettrica relativa all’estroflessione dell’interiorita’.
La vecchia estetica che nasce nel Settecento come un sapere legato all’esperienza e all’immanenza, come un sapere essenzialmente terrestre e mondano, non riesce a fornire alcuna interpretazione teorica del sentire contemporaneo legato alle esperienze insolite e perturbanti, irriducibili all’identita’, ambivalenti ed eccessive. Non e’ un caso che questo tipo di sensibilita’ intrattenga rapporti di vicinanza con gli stati psicopatologici, le estasi mistiche, con le tossicomanie e le perversioni, con gli handicap e le minorazioni, con i’primitivi’ e le culture ‘altre’( [9]). La posta in gioco e’ insomma la riconfigurazione generale dell’estetico, del suo impiego e del suo destino negli anni a venire. Le nuove tecnologie dell’immagine, del suono, della spazialita’, della scrittura, della comunicazione, hanno dischiuso una nuova epoca della sensibilita’ che i teorici hanno il dovere di studiare e definire.
Il sentire contemporaneo si configura come un ambiente cosciente in cui sembra invertito il rapporto tra conscio ed inconscio. “L’opposizione pressoché irriducibile tra materia e memoria propugnata da Bergson, e tra spirito e durata, e’ stata messa in discussione “dall’avvento delle nuove tecnologie elettroniche della ripresentazione, della simulazione e della comunicazione a distanza. La memoria infatti non e’ piu’ il fondamento dell’interiorita’ anzi, assume sempre piu’ i modi di esistenza della materia (pubblica, esteriore, immutabile, nella ripetizione;) mentre la materia, cessa di essere veramente “materiale” Questa unita’ simbiotica di materia e memoria si rivela in grado di annullare ogni assolutezza tra l’interiorita’ e l’esteriorita’. “Questa nuova situazione in cui le nozioni di interno ed esterno perdono la loro assolutezza e materia e memoria sfumano i loro contorni dissolvendosi l’un l’altra, era stata avvertita anche negli anni ’20 da molti artisti e teorici, tra cui Moholy-Nagy che aveva aderito alle teorie sulla sinestesia costitutive al Bauhaus e propugnate da Kandisky ed Itten. Dal concetto di “sinestesia” Kandisky ed Itten ricavano suggestioni ed implicazioni mistiche di varia natura, e sulla presunta oggettivita’ delle corrispondenze spirituali tra suoni e colori, si fondava una numerosa serie di sperimentazioni estetiche. Cio’ che comunque era in gioco era il passaggio dalla sinestesia come fenomeno interiore, a delle macchine della sinestesia per costruire delle interfacce, prima meccaniche, poi elettriche ed infine elettroniche allo scopo di situare uno stato di coscienza in un prodotto esterno. E’ questa estroflessione della interiorita’ che si realizza gia’ nei primi anni del Novecento a gettare le basi al processo di “messa in scatola del mondo in cui il tempo di spazializza ed in cui appunto le dimensioni dello spazio e del tempo vengono meno o meglio si annullano. In uno sterminato presente in cui ogni qui e’ anche tutti gli altrove possibili della rete telematica” ( [10]).
E’ dunque da questo luogo sensibile e cosciente sembra infatti provenire oggi la nostra nuova naturalita’elettronica dalla quale promana un senso di globale indifferenza verso la nostra volonta’. Da questo luogo il nostro “sentire”, sembra provenire da un punto intermedio tra la percezione umana e la visione macchina mediata dai dispositivi tecnologici. Il corpo nel quale ci troviamo contiene i concetti fondativi del nuovo spazio ch’esso implica ed in cui si muove gia’ pur senza averne consapevolezza, divenendo visibile nei punti di ibridazione in cui il fantasma di attuazione autopoietica s’incontra con il medium che lo evidenzia in una configurazione congruente.
Lo spazio-tempo di internet é uno spazio-tempo sospeso ed enigmatico in cui vanno spegnendosi i residui della soggettivita’: in questo spazio senza luogo, la rete, somma di tutti i luoghi, crea una nuova amalgama tra il sè e l’esternita’, dissolvendo insieme al linguaggio ed al soggetto, anche la possibilita’ di descrizione degli eventi. Per compensare la minaccia data dalla scomparsa della rappresentazione del mondo ordinaria si innesca il sentire pensante. Le nuove tecnologie ci spingono ad attraversare l’esternita’ mentre si annuncia una nuova fenomenologia della presenza.
L’amalgama che sente
Le nuove tecnologie hanno determinato uno spostamento della nostra consapevolezza sul limite esterno del nostro corpo che confina con la scena circostante, determinando, in questo modo, un’ amalgama tra il sè e l’esternita’. L’accesso a questo limite si accompagna alla perdita della sfera sociale e/o linguistica. Riuscire a trasferire la consapevolezza del nostro corpo quotidiano all’esternita’tramite le tecnologie è un compito difficile e pericoloso.
In sostanza si tratta di usare la consapevolezza come un elemento dell’ambiente dopo essersi disancorati dal linguaggio. Procedere sulla scena di un sentiero fatto letterarmente di consapevolezza che si dispiega in uno spazio e ci trasmette descrizioni fondamentali sulla nostra vita sconosciuta, costituisce un’offerta allettante. Questa offerta non va accettata oltre un certo limite.
Entrare a far parte del paesaggio che sente, richiede una grande disciplina ed insieme una grande immaginazione, poiche’ dobbiamo dare un nome e un volto a cose, fatti, oggetti mai visti prima, ma soprattutto i nostri sensi devono aver imparato a pensare per riuscire a distinguere il punto d’intersezione, dove il varco si apre e si accede all’accesso. Siamo condotti al varco verso la scena consapevole dalle macchine, dunque conta immensamente essere prudenti, perche’ quella che si apre dinnanzi e’ una scena di guerra.
Essere l’amalgama che sente, deve configurarsi come un esercizio di autoconoscenza nel quale e’ possibile riconoscere il paesaggio come scene della nostra presenza definitiva nella quale e’ impossibile descrivere cio’ che accade, perche’ il linguaggio e’ inadeguato a costruire sintatticamente una configurazione congruente. Disancorati dalla dinamica sociale, i processi cognitivi si avviano verso una nuova percezione basata piu’ sull’osservazione dell’universo che non sul bisogno di autostima, legato all’approvazione dei nostri simili. Chi si avventurasse nell’accesso verso l’amalgama della presenza definitiva con il se’ tipico del linguaggio e del sociale, sarebbe inevitabilmente predato e fagocitato.
Dobbiamo capire che siamo ormai gli ordinatori dei luoghi senza luogo della rete. Noi, il vuoto intelligente, dobbiamo rivestirci coiscientemente di spazio per entrare nel nuovo spazio. Tra noi e l’esternita’non c’e’ piu’ distanza ma continuita’: noi siamo il luogo che sente, e siamo anche il fluire lungo quello spazio. Entrare nello spazio che sente deve configurarsi come un esercizio di autoconoscenza, poiche’procedere nell’eidos, che scaturisce dalla messa in scena del sistema nervoso, non avviene secondo implicazioni di un determinismo sintattico-meccanico, bensi’, secondo un determinismo fondato sull’intensita’.
Non abbiamo racconti sulla cognitivita’ neutra delle macchine e non abbiamo descrizioni dello spazio cosciente e dell’intensita’ in cui il sentire pensante puo’ imbattersi. Se diventiamo lo spazio che sente dobbiamo essere fluidi come i semiconduttori del computer e non possiamo opporci al fluire con considerazioni linguistico-culturali o sociali: occorre aprirsi all’astratto dei principi primi dell’universo, occorre ascoltare l’ascolto e andare oltre la phone’; occorre esercitare afasia e aprassia, esercitarsi a vedere senz’occhi, oltre l’eidos, scivolare lungo il flusso della consapevolezza, diventare lo spazio che pensa e pensare cio’ che lo abita. Seguire l’astratto del procedimento senza pensare alle finalita’ produttive, aprirsi allo spazio che si effonde dal nostro sistema nervoso, apre porte su altri aspetti del reale, e l’espansione della percezione e’ cosi’ immensa, che resta poco delle vecchie visioni del mondo.
In questo processo di creazione di uno spazio-mondo siamo indotti a realizzare una storia vitale di accoppiamento strutturale. L’accoppiamento strutturale non viene condotto nell’ottica soggetto-oggetto, ma in quella che chiama in causa una interfaccia figura-sfondo. Secondo i dettami della Scuola di Santiago, affinche’ l’accoppiamento sia potenzialmente vitale, l’azione guidata del sistema, deve semplicemente facilitare il perpetuarsi della sua integrita’ (ontogenesi) e/o della sua discendenza (filogenesi).
Cio’ significa, come abbiamo gia’ detto piu’ volte, che dobbiamo entrare in quelle dinamiche che non minacciano la nostra attuale organizzazione biopsicofisiologica. Con la “scomparsa” del soggetto, si attiva memoria dello spazio-mondo come flusso , che si accompagna alla consapevolezza di essere noi stessi il luogo, lo spazio che sente.
Conclusioni
Dal momento che le neotecnologie propongono una sempre crescente estroflessione materializzata dei funzionamenti di base dell’umano, occorrera’ modificare il cosiddetto punto di vista, antico retaggio dell’invenzione greca del teatro, sostituendolo con il punto d’essere piu’ vicino all’universo dei media elettronici. Il punto d’essere o presenza definitiva, attivata tramite il dispositivo tecnologico, spinge sulla ribalta il nostro sistema nervoso che, libero dalle operazioni cognitive, puo’ modellare delle routines neurali con la creazione dell’amalgama corpo-spazio che sente e interpreta cio’ che sente con un vestito spazio-temporale.
Il nostro linguaggio ci ha trattenuto cosi’ a lungo nelle sue logiche descrittive, che non siamo in grado di percepire e descrivere serie di eventi che accadono in ambiti virtuali. Il nostro software linguistico impiantato nel cervello da una tecnica chiamata alfabeto. Costringe i suoni e le immagini ad identificarsi prima di prenderli in considerazione. Il vuoto, il nuovo spazio inizia la’ dove finisce il linguaggio, che e’ ancora nei dintorni della carne, ma gia’ fuori dal corpo; la’ in quello spazio, inizia a risplendere l’intensa consapevolezza di cui non siamo coscienti perche’ il suo splendore e’ senza luce per il linguaggio.
Parafrasando la famosa frase di Freud “Là dov’era l’es, sarà l’io”, potremmo dire: là dove (sulla trama del sistema nervoso) accadevano i fenomeni, (anche noi stessi come fenomeni), ora accadiamo noi, mettendo in scena il nostro sistema nervoso. Ora siamo fusi in uno spazio cosciente, da cui è indistinguibile anche una flebile orma di individualita’.
Siamo gettati nella metafora del labirinto, dal quale si spera di uscire tramite un nuovo filo: il semiconduttore del computer. Il semiconduttore ci porta fuori, ma e’ un fuori accattivante e singolare, poiche’ conduce i sensi a disporsi lungo la stessa traiettoria percettiva dentro e lungo le cose da percepire, al punto che il se’ si dissemina nello spazio-ambiente, rendendolo cosciente.
Il semiconduttore propone non un punto di vista frontale (metafora dell’occhio) ma un punto diffuso di ascolto (metafora dell’orecchio) che si spinge allargandosi dentro l’eidos con la logica della phone’. E proprio l’eccessiva intensita’ di questa inaudita phoné, e di questo inusitato eidos, ci hanno spinto la’ fuori, la’ dove il nostro sentire deve pensare cio’ che percepisce, passando dalla rappresentazione della realta’ alla presentazione della realta’.
Cosi’ come nel linguaggio si passa in maniera quasi ideografica dai segni alle idee, allo stesso modo potremmo essere passati, tramite le indicazione di un possibile testo composto da una grande quantita’ di materiale inconscio seguendo le orme dei grafi neuronali ( [11]) oltre il linguaggio, da un significante al significato, dalla percezione al percetto e da quest’ultimo ad un nuovo corpo, e dal corpo ad un nuovo spazio.
Viene da pensare a certe teorizzazioni della Bauhaus secondo cui bastava trovare dei concetti fondativi e farli diventare luoghi a partire dai punti di ibridazione con l’uso ed il significato, per cui da un posacenere si sarebbe potuto risalire al progetto totale di tutto l’edificio, esattamente come da un seme scaturisce il frutto.
PARTE IV Il pensiero liquido e il crollo della mente
Il Pensiero liquido del terzo millennio e il crollo della mente
Il crollo della mente
Ho motivo di credere che la mente, così come siamo abituati a considerarla, stia crollando e che in questo periodo della storia dell’umanità, stia nascendo una nuova configurazione che da un pensiero descrittivo, passi ad un pensiero liquido che scaturisce direttamente dalle percezioni dei sensi. Pare che il sentire stesso si costituisca come un centro di pensiero al di là del cervello, facendo delle percezioni centri di pensiero fluido, staccato dall’architettura mentale della rappresentazione del reale, mentre “scruta” le cose pensandole dall’interno della sua stessa percezione.
Il “sentire” si emancipa dall’uomo che lo ha provato e dispiega il “suo” pensiero del sentire, che non prescinde dall’uomo, ma lo riconsidera come uno degli elementi della visione o della percezione. Per i “nuovi esseri” senza mente, nessuna percezione è assoluta e indispensabile ai fini di una visione/costruzione del mondo: nessuna percezione ha diritto alla propria parte di frutti; ogni percezione fa ricominciare il “mondo” da zero, il passato non conta; le visioni del mondo sono sempre nuove e non si storicizzano più, anzi, ognuna di esse sembra duellare con la precedente per prevalere.
In questa fase liquido-moderna avendo abbandonato, o essendo stati cacciati dal loro precedente spazio/ambiente, i profughi del crollo della mente tendono ad essere spogliati delle identità che quell’ambiente definiva, sosteneva e riproduceva. Alla fine dell’era territorio/nazione/stato ricominciare il viaggio verso un’unità razionale/ universale dall’onda liquida di percezione/pensiero, è impossibile poiché non c’è nessun altro sito “solido” da cui partire.
Qual è dunque la consistenza dello spazio che ci ospita? Sembra che stiamo ripassando per il tipo di spazio che fu della pittura bizantina. In questo spazio non esistono prospettive o proiezioni ma solo intensità: intorno ad un personaggio importante in una pittura bizantina, lo spazio si concentra, si organizza, cresce e cinge la figura, con la potenza di un’onda.
Il crollo della mente è avvenuto dal di dentro degli avvenimenti che si sono svuotati, misura dopo misura, senza far crollare l’involucro esterno del significante che ha continuato ad essere osservato e praticato nonostante l’esistenza di nuovi sentieri sostitutivi della mente.
Naturalmente questo porta a pensare che in questo periodo storico, stiamo andando verso la nascita di un nuova forma mentale che forse è già qui senza che noi ne siamo consapevoli. E’ problematico avanzare un’ipotesi su come questo evento abbia potuto aver luogo e per la verità è difficile anche affermare che questo evento stia veramente verificandosi. La catastrofe che stiamo attraversando è invisibile, perché accade alle spalle del linguaggio e della nostra capacità di descrizione.
Il crollo della mente è un evento nascosto della nostra storia perché è avvenuto dal di dentro degli avvenimenti che si sono svuotati, misura dopo misura, senza che l’involucro esterno del significante, crollasse. La fase di crollo è avvenuta in un punto cieco (scotoma cognitivo), un punto in cui il cervello non riesce infatti a rappresentare se stesso come oggetto facente parte del mondo, e viene quindi escluso dalla rappresentazione stessa che ha continuato ad essere percorsa sui sentieri della mente teoretica.
La nostra civiltà conoscerà solo nel futuro la portata degli eventi, e solo quando sarà compiuto il processo di distruzione del significante e del significato. Forse è possibile ipotizzare che, a causa dell’uso intensivo di computer, cellulari, macchine per videogames, si sia determinato uno stress biochimico, una sorta di trauma da affaticamento, con produzione di adrenalina e noradrenalina e che a causa dell’accumulo di sostanze di decomposizione non può più essere filtrato dai reni per il protrarsi della stimolazione. Un affaticamento estetico ci ha condotto al collasso delle immagini e il nostro sentire “pensa” e reagisce agli stimoli visivi a seconda dell’umore. La discontinuità umorale ci ha portato a creare una configurazione di noi stessi parziale per cui non sappiamo più di essere coscienti e non sappiamo più.
Che cos’è la coscienza? Ci chiediamo se essa non sia per caso soltanto una metafora del nostro comportamento reale per cui noi non siamo mai coscienti della natura delle cose, nemmeno del nostro stesso comportamento, ma solo di ciò che selezioniamo di esso?
Sembra dunque che la società, si avvii ad abbandonare la mente prima che affondi. Un insieme di noia, di disprezzo per tutto ciò che avviene nella lentezza del cosiddetto tempo reale nonché l’esigenza sempre più forte di trovarsi là, là dove accade l’evento rifiutando la farraginosa struttura architettonica della “rappresentazione”, ci porta ad accellerare e favorire il crollo di una mente arcaica. Tutto ciò sta innescando e favorendo una tendenza iperbolica, portandoci ad una percezione approfondita e intensa che svela un’insospettabile complessità e liquidità delle visioni del mondo.
L’elaborazione di nuove ritualità sociali, conduce un’umanità di potenziali “santi in abito da sera” ( [12]) a caccia di una mondanità pervasa della sacralità dello spazio che fu della pittura bizantina e della filosofia di Plotino secondo cui l’essere è inseparabile dalla bellezza per cui ogni punto dello spazio è come una “porta” attraverso cui è possibile fruire della coincidenza della forma delle cose terrene, con lo stampo celeste da cui sono state generate.
L’Eidos è uguale alla morphè: terra e cielo coincidono in questa forma di pensiero del sentire, a partire dalla quale, i “sensi” pensano la realtà delle cose cogliendone l’eventuale differenza per cui diventa possibile scrutare e svelare la presenza di una nuova esternità, in ogni suono, in ogni tocco, o sapore o visione, come l’eco tiene e scruta ogni evento per quanto lontano esso si situi rispetto a noi.
Il pensiero del sentire dunque propone una straordinaria fioritura della presenza in altri universi percettivi, ed un inaudito appetitus nei confronti della vita reale, che non viene più descritta, né “parlata” né “rappresentata” ma vissuta. E’ come se i nativi del web dicessero: “Abbandoniamo la mente e saremo al sicuro perché, in questo modo, gli eventi passeranno altrove e noi fuggiremo lontano dalla loro descrizione e anche la morte sarà evitata semplicemente perché accadrà e non dovremo più viverne le angosciose rappresentazioni.
Credo che i nativi del web non vogliano più “stare” in una mente ma vogliano trasferire la maggior parte della loro vita in rete: fuori dalla rete si sentono soffocare. Non vogliono più stare in una mente intesa come processo, vogliono “sentire” la vita e vogliono che il “sentire” fluisca come un pensiero e che questo sia parte di un grande corpo e tutti siano cellule pensiero che pensano un pensiero liquido attraverso i cellulari.
“Sentiamo” che tutto, amori, sentimenti, ragione, etica, filosofia, scienza, tutto è trasmigrato al di là del limite che era della mente, in una condizione liquida. Ci sembra di essere presi e usati dalle nostre stesse percezioni al di là di noi stessi che siamo “pensati” dal nostro sentire, che pensa la forma delle cose.
“Second Life” potrebbe essere un esempio che dà un’idea del pensiero del sentire. In second life c’è un organo di risonanza che prende il sopravvento sulla nostra “intenzionalità” e diviene il nostro avatar che accende luoghi del pensiero che noi non conosciamo.
Second life è l’esempio più macroscopico di che cosa significa il pensiero del sentire. Il mondo che brilla in second life pur essendo soggetto ad un algoritmo architettonico, tuttavia mette in moto dinamiche che sono di tipo decostruttivo e solo il residuo di contenuto di una mente desiderante dà ancora conto della presenza di un barlume di una identità. Gli utenti di second life indossano il “mezzo” second life come travestimento, divenendone automaticamente il contenuto
La mente è crollata ( [13]) o sta per crollare perché non può più sostenere il peso dell’architettura che essa stessa ha messo insieme nel suo essere processo in atto. Ora esiste o si affaccia un altro centro di percezione, un’altra ipostasi della mente che è dato da un agglomerato di organi di risonanza che sono i sensi potenziati dai mezzi tecnologici, attraverso cui le configurazioni passano.
Situazione italiana
Credo che il crollo avverrà in Italia, prima che in altre realtà socio-politiche. L’Italia, patria dell’arte, conosce da sempre l’impostura del mondo come rappresentazione.
A causa della particolare situazione italiana come afferma anche Arturo Artom nel libro edito da “Il sole 24 ore” “Web 2.0”: “L’Italia ha conosciuto l’esperienza di essere all’avanguardia nel mondo nella fase iniziale di nuovi busines globali, come per esempio la telefonia mobile, e di perdere nel giro di pochi anni questo vantaggio competitivo per una serie di fattori strutturali, a cominciare dall’assenza di un adeguato mercato dei capitali. In Italia,d’altro canto, è presente quel mix di cultura, conoscenze e know how tecnologici, capacità di innovare, reattività del mercato finale, che può costituire la piattaforma necessaria a cogliere per tempo le opportunità del Web 2.0 e delle contaminazioni possibili con l’industria televisiva e cinematografica”( [14]).
L’identità è morta in Italia prima che altrove ed è un evento che risale alla controriforma e alle rappresentazioni teatrali della commedia dell’arte. Gli italiani sono un popolo eclettico poiché sono capaci di raggiungere prospettive autonome e originali, rispetto alla tradizione culturale e filosofica europea in particolare e occidentale in generale, attraverso i più arditi innesti e le più incongruenti combinazioni.
La cultura italiana sembra seguire strade diverse e alternative rispetto alla cultura europea. “Il pensiero che medita e che interroga, non attribuisce più alla filosofia né all’organizzazione della cultura, un ruolo, un significato, una funzione privilegiata, anzi ritiene che l’essenziale sia altrove, in dimensioni, in esperienze, in vicende che, a prima vista, sono molto marginali rispetto alla pretesa strada maestra della tradizione filosofica occidentale. Il rifiuto italiano della filosofia e dell’organizzazione della cultura così come esse si sono determinate e sviluppate nella tradizione occidentale, non è un rifiuto apertamente teorizzato e argomentato, consapevolmente esperito e vissuto: non certo un rifiuto che individua chiaramente l’avversario e stabilisce con questo un rapporto di contraddizione e di lotta.
Ma forse una pretesa più ambiziosa si pone per l’intellettuale italiano: quella di vincere l’avversario “senza venire a contatto” ( [15]), assumendone l’aspetto, appropriandosi delle sue ragioni, prendendo il suo posto. C’è un modo di combattere il proprio nemico molto meno pericoloso ed incerto nel suo svolgimento e molto più effettivo e radicale nei suoi risultati, di quello di ingaggiare con lui una battaglia per la vita e per la morte: esso consiste nello spogliarlo della sua identità, trasformandosi in una copia indiscernibile da lui. Chi vince in campo aperto una lotta per la vita e per la morte, non solo lascia al vinto la sua identità, ma la innalza, la potenzia, la sublima: chi invece si mette al posto del suo nemico, sfuma, cancella, abolisce la sua identità, e apre uno spazio di indeterminazione e di differenze indiscernibili. Per quanto riguarda il problema relativo al crollo della mente, è come se la nostra liquidità avesse preso il posto vuoto dell’architettura della nostra mente crollata ed è come se avessimo vinto su di noi sommergendoci completamente.
“La filologia e l’eclettismo in Italia non pretendono di diffondere vere teorie nè di costituire vere organizzazioni della cultura; alla base dell’attitudine filologica, sta infatti una scelta a favore della ripetizione che non è né morale né etica ma relativa all’uso cioè orientata a far prevalere un rapporto col passato attraverso strategie, modi, procedimenti, per destrutturare, decostruire, scardinare la tradizione filosofica e culturale dell’Occidente. L’esperienza si costituisce fin dall’inizio come svuotamento, abolizione, irrilevanza dei contenuti.
“Paradossalmente si potrebbe dire che in Italia l’origine è fare a meno dell’origine, il porsi ab imis e irrimediabilmente come spurio e derivato. Perciò la ripetizione non è spiacevole, angosciosa ossessiva, ma consolatoria. Essa si pone all’inizio, senza essere origine; sta alla base senza essere fondamento; ha effettività senza essere causa. La mancanza di un mito fondatore, l’assenza di una identità nazionale dotata di contenuti ben determinati e inequivocabili, l’impossibilità di trovare una dimensione autoctona che fondi una vera patria, da tutto ciò deriva che la ripetizione italiana sia una ripetizione in quanto ripetizione, una ripetizione che prescinde dal suo contenuto, un dire si al passato che lascia sempre indeterminato e indeciso a quale passato si riferisce. La filologia italiana è “filologia per la filologia”, è amore della filologia e non del logos; ma proprio questo eccesso le consente di andare al di là del logos. In Italia la circolazione conta enormemente più dei messaggi, il movimento più delle idee, la trasmissione più del sapere. Il pensiero della differenza che in Germania nasce da una prospettiva teologica, in Francia da una prospettiva artistico-letteraria, è invece in Italia strettamente connesso con l’attenzione alla storia e al linguaggio”. In ciò consiste l’interesse e il significato mondiale di una via italiana alla problematica filosofica della differenza, la quale si rivela la più adatta a comprendere i fenomeni di trasmissione delle culture che sono oggi in atto su scala planetaria” ( [16])
Il “crollo della mente” è avvenuto nella ripetizione nella fascinazione reiterata delle pubblicità così una serie di ripetizioni ci ha condotto a fare a meno del controllo sulla nostra vita: tutto dev’essere cominciato così. Poco a poco ci siamo fusi con i nostri organi di risonanza tecnologici, ovvero con display, cellulari, iphones e social network.
Il linguaggio nella tempesta
Quale linguaggio sta costruendo la nostra civiltà all’inizio del terzo millennio? O forse più che di linguaggio è più appropriato parlare di quale protocollo linguistico stiamo usando per decostruirci? In che lingua parla il nostro sistema nervoso allorchè ci ha mostrato che la nuova presenza può raccogliere e coagulare intorno ad una nuova ipostasi della mente, materiale psichico per forgiare nuove identità e nuove esternità? L’immagine del mondo, filtrata attraverso la scenologia delle macchine, e dei social network, essendo un’immagine estetico/sintetica, oltre che liquido/virtuale, non è decodificabile. Ora, l’importante non è capire se queste immagini estetico/sintetiche siano vere o false ovvero naturali o non, una simile distinzione non ha più alcun senso, quanto lo scegliere esplicitamente una cornice di riferimento per il nostro sistema di valori.
Probabilmente il tipo di percezione che si attiva nella ricezione delle prescrizioni/ordini degli organi di risonanza deve fare a meno del linguaggio perché non sono rappresentazioni relative al vecchio inventario eidetico/concettuale che devono giungere ai nativi del web, ma sensazioni liquide senza definizione. Il linguaggio è una pelle che riveste il mondo; nelle “parlate” e nella prosodia esistono vari livelli di realtà del mondo. Ora se il linguaggio si scioglie il mondo perde la sua forma? E quale forma acquisisce?
Noi tutti non siamo più materiale per una società, siamo tutti liquidi e “lontani” gli uni dagli altri e siamo “lontani” anche da noi stessi, ma al tempo stesso, la “liquidità” del nostro pensiero rende la nostra contiguità una leggendaria avventura di ricerca dell’altro come “isola” o forse meglio come “onda” da riconoscere.
Non crediamo più nella grammatica e con il suo tramonto si è eclissata la parola come evocazione di una sintassi della soglia per entrare o ritornare in un mondo solido retto dalle architetture della mente. Ora non abbiamo nessun organo per il conoscere, ma abbiamo organi di risonanza, inorganici e tecnologici. Alcuni di essi sono: My space, Wikipedia, Linux, Second life, You tube.
Il dialogo diventa il passare attraverso la parola per dissolverla in quanto tale, lo svuotarla di ogni significato razionale e renderla liquida o appartenente ad un ordine semantico differente. “Del resto le funzioni del tessuto cerebrale, anche quello relativo alle aree preposte al linguaggio, non sono definitive e forse, dando dei “programmi” di sviluppo diversi, sono possibili organizzazioni diverse. Sarebbe sbagliato infatti pensare che, qualunque fosse la neurologia della coscienza, essa sia fissata per sempre.”
Si può parlare di un fondamentalismo tecnettronico per quanto riguarda la struttura di pensiero e di linguaggio che ha condotto al crollo della mente? Esiste un’analogia tra il fondamentalismo teocratico e quello tecnettronico? Si può ipotizzare che esista una convergenza tra i due tipi di fondamentalismo, basata sulle stesse routines neurofisiologiche che concorrono alla formazione di uno spazio mentale aniconico liquido e non supportato dall’architettura della mente teoretica Occidentale? E se le lingue semitiche prive dell’articolazione delle vocali nella loro rigidità e complessità stratificata, rimandassero a visioni implicanti gli stessi protocolli operativi relativi alla pratica dell’uso delle nuove tecnologie della comunicazione? La cura degli himam nell’osservanza della giusta prosodia della parola scritta nel Corano, potrebbe essere la via che conduce alla sufficiente liquidità del pensiero per aprire le porte della percezione su spazi sacri a partire dall’attivazione di aree del cervello particolari.
Dagli studi di Julian Jaynes su “il crollo della mente bicamerale”. “Sappiamo che le differenze degli emisferi, nella funzione cognitiva, riflettono le differenze tra Dio e uomo. Per esempio, l’emisfero destro, forse come gli dei, vede un significato nelle parti, solo all’interno di un contesto più ampio: esso guarda alla totalità. L’emisfero sinistro o dominante, come il lato umano della mente bicamerale, concentra invece la sua attenzione sulle parti.”
L’avvento del pensiero del sentire liquido, e il crollo della mente nei nativi del web potrebbe essere letto come un inconsapevole tentativo di pareggiare il vantaggio delle culture orientali dovuto al fatto che il loro pensiero è rimasto orale, analogico e liquido?
Organi di risonanza
La nostra percezione del tempo è cambiata. Oggi il tempo è breve, veloce senza passato e senza futuro, per noi che pervadiamo tutto lo spazio che sente ( [17]) in ogni punto della rete. Siamo presenti in ogni punto, siamo già là mentre ci stiamo andando, precediamo il feed back e dalla nostra posizione possiamo dunque vedere che la storia è finita e s-terminata. Cosa rimane?
Noi sentiamo in ogni punto della rete che sente, e questo sentire si dispiega come pensiero liquido e onni-presente. Nella esternità della rete le cose i fenomeni vanno definiti e descritti, ma non essendoci più una mente costruita secondo canoni architettonici ecco che si rende necessaria l’esistenza di organi di risonanza che raccolgono le informazioni, le smistano, definiscono e danno il senso della continuità e della coerenza. I social network assumono questa funzione e questo significato, ma non sono solo quelli ad avere questa funzione: anche tutti gli apparati soft della tecnologia, iphones, cellulari, e display in generale, hanno la stessa funzione.
Il tempo comunque, ha avuto storia dal momento in cui, i mezzi per attraversare lo spazio, compresi i mezzi di comunicazione che ne scavalcano la vastità, ovvero lo rendono pervaso dalla nostra presenza liquida, ci hanno consegnato una sovrabbondante quantità di tempo da descrivere e utilizzare. “La storia del tempo ebbe inizio con la modernità. Di fatto, la modernità è, più di ogni altra cosa, la storia del tempo: la modernità è il tempo nell’epoca in cui il tempo ha una storia” ( [18]).
In questo “tempo” la mente è crollata determinando anche la fine dell’uomo teoretico e l’egemonia dell’emisfero sinistro. In questo “tempo” il “sentire” ha acquisito la modalità del pensiero che pensa e che forgia una nuova esternità percorsa da un uomo orale, senza mente che muove la sua esistenza in una modalità digitale che ha tuttavia le caratteristiche della dimensione analogica.
Open source
Open source può essere assunto non solo come una modalità politico/economica di circolazione delle informazioni ma anche e soprattutto come un protocollo che indica un nuovo pensiero, una nuova sorgente d’informazione. Le informazioni dei sensi pensano per noi che non abbiamo più la mente e le informazioni non fanno più capo ad una mente e ad un’architettura della mente. Le informazioni sono sorgenti aperte perché hanno spalancato le chiuse del linguaggio e il pensiero liquido del sentire, scende giù con la sua propria acqua investendo le cose di un volto nuovo. Il destino che ci sta coinvolgendo appartiene ad una condizione singolare e forse siamo quelli che stanno andando via e devono chiudere la porta dietro di sé. La società attuale sta abbandonando il luogo dove c’era la mente e gli esseri umani si trovano alla mercè di forze che li attirano da tutte le parti e alle quali hanno consentito di disegnare una configurazione nuova dalla quale poter sconfiggere la mente e non invecchiare, né ammalarsi, né morire più.
L’architetura della mente è un peso troppo gravoso e a sbarazzarsene è stato prima il corpo. Il corpo nel quale ci troviamo contiene i concetti fondativi del nuovo spazio ch’esso implica ed in cui si muove gia’ pur senza averne consapevolezza, divenendo visibile nei punti di ibridazione in cui il fantasma di attuazione autopoietica s’incontra con il medium che lo evidenzia in una configurazione congruente.
Pensare senza un cervello
Stiamo attivando un nuovo centro di coscienza e questo nuovo centro è il pensiero del sentire. Noi percepiamo ma lo facciamo passando per punti o configurazioni percettive “esterne” a noi e questo passaggio esterno fa si che lo spazio diventi senziente e prenda il posto della coscienza.
Probabilmente il pensiero del sentire attraversa vari “organi” di risonanza che possono essere animali o vegetali o elettronici e macchinici, anche inorganici o minerali. Questi “organi” diffondono il pensiero del sentire in forme sconosciute agli uomini e può darsi che ci troviamo in un periodo di formazione di nuove visioni del mondo e il pensiero del sentire sosta su protocolli percettivi non ancora conosciuti.
E’ in queste nuove configurazioni percettive che gli eventi che vediamo, si formano e prendono corpo: è là, che gli occhi vestono la “realtà” con abiti nuovi che ci sorprendono impedendoci di controllare queste modalità sensoriali che accadono e ci rivestono del loro “accadere” in uno spazio che sente e che pensa per noi la realtà.
Tutte le informazioni che circolano nella noosfera, prima o poi tornano “giù” da noi, ma molti di noi, pur agendole, non le comprendono. Quelle informazioni sono state pensate e percepite, sentite da occhi e orecchie elettronici. Sembra paradossale ma quel pensiero del sentire che pure era nostro e che ci torna dall’etere, per noi è pressochè inutile perché incomprensibile a causa della complessità e intensità dei tanti fenomeni che ha colto.
Per supplire all’assenza di informazioni da parte della mente, si rende necessario un sentire artificiale, pilotato dall’esterno dai cosiddetti organi di risonanza, dai quali dipendiamo come individui. Siamo alla mercè degli imperativi collettivi che corrono sui sentieri dei social network. Procedere sulla scena di un sentiero fatto di consapevolezza (di risonanza) che si dispiega in uno spazio “nuovo”, mentre ci trasmette descrizioni fondamentali sulla nostra vita sconosciuta, costituisce un’offerta allettante. Questa offerta non va accettata oltre un certo limite.
Entrare a far parte del paesaggio che sente, richiede una grande disciplina ed insieme una grande immaginazione, poiche’ dobbiamo dare un nome e un volto a cose, fatti, oggetti mai visti prima, ma soprattutto i nostri sensi devono aver imparato a pensare per riuscire a distinguere il punto d’intersezione, dove il varco tra la vecchia visione del mondo e la nuova, si apre e si accede all’accesso. Siamo condotti al varco verso la scena consapevole dalle macchine, dunque conta immensamente essere prudenti, perche’ quella che si apre dinnanzi a noi e’ una scena di guerra.
Le nuove tecnologie hanno determinato uno spostamento della nostra consapevolezza sul limite esterno del nostro corpo che confina con la scena circostante, determinando, in questo modo, un’ amalgama tra il se’ e l’esternita’. L’accesso a questo limite si accompagna alla perdita della sfera sociale e/o linguistica. Riuscire a trasferire la consapevolezza del nostro corpo quotidiano all’esternita ’tramite le tecnologie e’ un compito difficile e pericoloso. In sostanza si tratta di usare la consapevolezza come un elemento dell’ambiente dopo essersi disancorati dal linguaggio.
Essere un’amalgama che sente, deve configurarsi come un esercizio di autoconoscenza nel quale e’ possibile riconoscere il paesaggio come scena della nostra nuova presenza liquida, nella quale e’ impossibile descrivere cio’ che accade, perche’ il linguaggio e’ inadeguato a costruire sintatticamente una configurazione congruente. Dobbiamo capire che siamo ormai gli ordinatori dei luoghi senza luogo della rete.
Noi, il vuoto intelligente, dobbiamo rivestirci coscientemente di spazio per entrare nel nuovo spazio. Tra noi e l’esternità non c’è più distanza ma continuita’: noi siamo il luogo che sente, e siamo anche il fluire lungo quello spazio. Il crollo della mente, la fine dell’identità, l’eclissarsi del soggetto il suo annegamento nel pensiero liquido-moderno, nonchè lo scorazzare tra i vari SE’ che i social network ci forniscono, pone il problema relativo al governo e alla transizione eventuale da certe condizioni d’esistenza ad altre, da un autostato ad un altro.
Com’è possibile discernere tra autenticità e finzione, tra simulazione e indeterminazione in maniera tale da riconoscere l’avvento del nuovo? Nello spazio che sente abbiamo l’obbligo di configurare l’esistenza come un esercizio di autoconoscenza, di una realtà che nelle modalità di trasmissione/manipolazione tramite i media è diventata illusionistica da un lato, e ipernaturalistica dall’altro.
Occorrono molte ripetizioni, molte appercezioni, prima che magari, un incidente di trasmissione ci dia il sentore che qualcosa è cambiato, che una nuova serie di “oggetti” e di percezioni si presenta ai nostri sensi e un nuovo pensiero scruti un’altra contrada dell’esternità.
Il pensiero liquido ci viene incontro e forse ci dice qualcosa di noi che non riusciamo a capire fino in fondo. Il pensiero del sentire è frutto dell’interazione tra le forze della natura, per la nascita di una nuova specie. La “vecchia” umanità potrebbe aver lasciato il suo sentire rendendo obsolete le “vecchie” visioni del mondo.
Ora un nuovo sentire sviluppa il suo pensiero in seno al quale sarà suscitata la nascita di un nuovo tipo di uomo, ma non sappiamo quando avverrà.
Dalle neuroscienze acquisiamo delle conoscenze che possiamo usare come ipotesi esplicative sul fatto che anche i nostri organi fisici diffondono il pensiero del sentire in forme sconosciute. “Il sistema nervoso non elabora l’informazione che proviene dal mondo esterno ma, al contrario, genera un mondo nel processo della cognizione. I cosiddetti “organi di risonanza”, attraverso cui passa il pensiero del sentire potremmo anche essere noi stessi, il nostro stesso corpo potrebbe essere un organo di risonanza attraverso cui il pensiero del sentire brilla e scruta il nuovo spazio.
Noi potremmo anche essere nient’altro che il grembo che accoglie il pensiero del sentire. Dalla biologia sappiamo che potremmo ospitare i transiti di vere e proprie strutture cognitive, cioè di pezzi del cervello, ed essere “attraversati” da messaggeri molecolari che usano il corpo come metonimia dell’informazione. e a questo proposito è interessante citare i risultati della ricerca fatta da Candace Pert ( [19]) e dai suoi colleghi del National Institute of Mental Health in Maryland. Questi ricercatori identificarono in un gruppo di molecole, i peptidi, i messaggeri molecolari che facilitano le comunicazioni fra sistema nervoso e sistema immunitario.
Pert e i suoi colleghi hanno scoperto infatti che questi messaggeri interconnettono tre sistemi distinti - il sistema nervoso, il sistema immunitario e il sistema endocrino- in una singola rete. Secondo la concezione tradizionale, questi tre sistemi sono separati e hanno funzioni diverse. Il sistema nervoso, costituito dal cervello e da una rete di cellule nervose che attraversa tutto il corpo, è la sede della memoria, del pensiero e delle emozioni. Il sistema endocrino, costituito dalle ghiandole e dagli ormoni, è il principale sistema di regolazione dell’organismo, che controlla e integra vari funzioni corporali. Il sistema immunitario, costituito dalla milza, dal midollo osseo, dai nodi linfatici e dalle cellule immunitarie che circolano nell’organismo, è il sistema di difesa del corpo, responsabile dell’integrità dei tessuti e adibito al controllo e della cura delle ferite e dei meccanismi di riparazione dei tessuti.
A questa separazione dei tre sistemi corrispondono tre distinte discipline per il loro studio: le neuroscienze, l’endocrinologia e l’immunologia. Le recenti ricerche sui peptidi, hanno però dimostrato in modo assai evidente che tali separazioni concettuali non sono altro che una deformazione storica che non può più essere mantenuta.
Secondo Candace Pert, i tre sistemi devono essere considerati come un’unica rete psicosomatica. I peptidi, una famiglia di sessanta o settanta macromolecole, furono studiati originariamente in altri contesti, attribuendo loro nomi diversi: ormoni neurotrasmettitori, endorfine, fattori di crescita e così via. Ci vollero molti anni per giungere a riconoscere che essi costituiscono un’unica famiglia di messaggeri molecolari. Questi messaggeri sono brevi catene di aminoacidi che si attaccano a recettori specifici; i recettori si trovano in abbondanza su tutte le cellule del corpo. Collegando fra loro le cellule immunitarie, le ghiandole endocrine e le cellule del cervello, i peptidi formano una rete psicosomatica che si estende in tutto il corpo.
Percepire è “pensare” le cose e in un certo senso generarle. Secondo la teoria di Santiago la cognizione non è una rappresentazione di un mondo indipendente, predeterminato, ma consiste piuttosto nell’enazione ( [20]), cioè nel generare un mondo.
Il pensiero del sentire emerge anche in altri ambiti, per esempio nelle neuroscienze e nella biologia. Le ricerche di Candace Pert permisero dunque di identificare in un gruppo di molecole, i peptidi, i messaggeri molecolari che facilitano le comunicazioni fra sistema nervoso e sistema immunitario ponendo in rilievo che il sistema nervoso non ha una struttura gerarchica come si riteneva in precedenza: “I globuli bianchi sono pezzetti di cervello che si diffondono per il corpo quindi sono elementi cognitivi direttamente in azione e come tali, essi sono il pensiero del sentire. La cognizione è un fenomeno che si estende in tutto l’organismo, operando per mezzo di una intricata rete chimica di peptidi che integrano le nostre attività mentali, emozionali e biologiche. In questo caso quindi, il sentire si esplica e agisce mentre pensa. La “realtà” fu inventata in Grecia intorno ad uno spazio circolare che fu in seguito chiamato “orchestra” e insieme alla “realtà” si prese coscienza anche della mente che doveva sostenere quella realtà.
Da quel momento la “realtà” andò per così dire in onda sulla base di un’abdicazione della percezione diretta da parte dell’uomo. Non abbiamo mai più saputo com’era veramente il mondo e non lo sappiamo ancora oggi. Era sufficiente pensare senza cervello e la realtà andava in onda rendendo il “pensare” una semplice speculazione metafisica. I media elettrici ed elettronici in grado di spostare l’accento dal visivo all’uditivo, avrebbero agito determinando una nuova tribalizzazione, dopo i mutamenti detribalizzanti che McLuhan ha attribuito alla natura discontinua e visiva dell’alfabeto e della scrittura.
Il silenzioso pensiero del sentire, ri-emerge oggi con grande forza per cui ritorna ciò che eravamo. Non avevamo più potuto accadere come quegli esseri formati su quel silenzioso pensiero del sentire. Che il sentire abbia un pensiero è oggi l’accadere di ciò che era nascosto nella tecnologia e non sappiamo ancora perché esso si sia posto davanti e prima dell’intelletto e della razionalità. Che cosa significa sentire in questa epoca è dunque la domanda che è legittimo porsi.
Il sentire si emancipa dall’uomo che lo ha provato e dispiega il “suo” pensiero del sentire, che non prescinde dall’uomo, ma lo riconsidera come uno degli elementi della visione o della percezione: Il pensiero del sentire ci svelerà chi siamo e chi siamo stati. Il sentire è un circuito autoeccitato che genera l’osservatore, che lo genera con l’osservazione: esso è legato alla circolarità interpretativa dell’evento e tramite questa circolarità, la natura, nella forma dell’uomo, comincia a conoscere se stessa.
Forse il pensiero del sentire è sempre esistito: esso è una sorta di procronismo che ha in sé esattamente come la conchiglia, la registrazione di come in passato ha risolto i problemi di struttura. Nel passato remoto dell’umanità può essere esistita una dimensione di “sensorio collettivo” o una sorta di coscienza bicamerale per lasciare libera la linea per il linguaggio con gli Dei.
I TAG - Il riepilogo dei tag
Il vero pensiero liquido che noi pensiamo, è diverso dal pensiero che noi esprimiamo a parole. E’ infatti per aderire al “vero” pensiero liquido che il linguaggio sta per essere abbandonato a favore del pensiero del sentire che però, per esplicarsi, deve appoggiarsi ad una base. Non essendoci più la struttura architettonica della mente e della vorstellung, i media fanno da sostituto.
Il “pensiero del sentire” non è immediatamente fruibile; esso è sconosciuto perché intenso e stratificato e per aprirlo bisogna riattualizzarlo attraverso la ripetizione. Il disvelamento delle condizioni in cui questo pensiero si dà e si attiva, è legato al caso: un giorno, in uno di quei giorni vissuti per intero senza la mente, l’oggetto pensato tante volte dal sentire dei nostri sensi, si “aprirà” e mostrerà la sua vera essenza nel ripercorrimento del ricordo della sua epifania. Quando si verificherà questo evento, ci ricorderemo di CHI eravamo veramente.
I tag sono oggi probabilmente la “voce” in differita e lontana del Dio (ovvero dell’emisfero destro governato dalle divinità dei social network come organi di risonanza che ci dicono che cosa dobbiamo fare) che tracciano le linee guida per una sorta d’inventario descrittivo trasversale della realtà.
I tag sono chiavi, superchiavi o metachiavi delle pagine web. Esse presuppongono un accurato lavoro di definizione dell’argomento trattato, ma inevitabilmente, essi sono anche una sorta di negativo da cui si può risalire alla configurazione del fruitore, per cui la loro funzione interseca anche l’antropologia, da qui la loro trasversalità.
In un certo senso i tag sono il negativo del pensiero del sentire, sono il feed back del rovescio della trama che ritorna ma con l’abito dell’intelligibilità. I Tag forse costituiscono il DNA noetico-linguistico e da essi si può risalire alla forma della mente che li ha costituiti. Probabilmente i tag ci aiuteranno ad andare “altrove” e fuggire, quando le macchine occuperanno la maggior parte del pensiero razionale, sempre se saremo ancora in grado di percepire la minaccia celata dietro questa eventualità.
Quando tutto sarà occupato dal “sentire delle macchine”, un concetto, un contenuto che sarà rimasto fuori dalla classificazione e risparmiato, perché magari era in sintonia con gli spazi non toccati dalle mutazioni della coscienza, ci porterà al pensiero silenzioso del sentire senza l’ausilio del cervello? Chi penserà questo pensiero sarà portato fuori dall’emergenza del mondo pervaso dalla logica e dagli algoritmi delle macchine e dunque dalla rappresentazione del mondo o peggio ancora, dal loro governo del sociale, se, nel frattempo, si sarà affermato prevalendo su quello umano.
Rimemorazione
Il pensiero del sentire non è immediatamente fruibile, esso è sconosciuto perché intenso e stratificato e per “aprirlo” bisogna riattualizzarlo attraverso la ripetizione. Uno dei modi in cui la “ripetizione” viene praticata nelle società Occidentali intensivamente, è dato dalla pubblicità che percorre e scruta continuamente gli stessi messaggi, fino a che uno di essi si “rompe” e il pensiero del “sentire” divenuto liquido, cola via, pronto a scorrere nella rete dei canali dei cellulari e degli iphone. Possiamo ipotizzare che quando una di queste “percezioni” si rompe, inizia a formarsi una configurazione che potrebbe dare inizio ad una nuova realtà? Come si farà a riconoscere l’avvento del nuovo?
C’erano state già avvisaglie di questo processo di cambiamento e di rottura del velo di maia della falsa realtà? Ecco per esempio cosa scrivevano i situazionisti: “Nel 1958 su “Le Monde” si può leggere: “ Ci troviamo al centro dello spettacolo e lo viviamo in quanto ne siamo parte integrante”. Il rafforzamento del potere illusionistico del cinema ha prodotto un’inversione compiuta della vita, quell’arte centrale della nostra società che si presenta da quel momento come “un sostituto passivo dell’attività artistica unitaria oggi possibile”. I situazionisti sostenevano la necessità di cambiare e abbattere tutto ciò che teneva in piedi il regno coerente della miseria. “occorreva cambiare tutto con una lotta unitaria o niente. Occorreva raggiungere le masse, ma intorno a noi il sonno. (...) Non si contesta mai davvero un’organizzazione dell’esistenza senza contestare tutte le forme di linguaggio che a quell’organizzazione appartengono. Ciò che era immediatamente vissuto, riappare fissato in lontananza, iscritto nei gusti e nelle illusioni di un’epoca, e spazzato via insieme ad essa. (...) Abbiamo bisogno di creare la star. E’ la miseria del bisogno, è la vita spenta e anonima che vorrebbe allargarsi alle dimensioni di una vita da cinema. La vita immaginaria dello schermo è il prodotto di questo bisogno reale”( [21]).
E oggi forse un bisogno reale scaturente da zone nuove della nostra interiorità, ci ha veramente indicato la strada verso la vita governata dal pensiero del sentire che ci ha portato in un universo liquido e sconosciuto in cui sembriamo essere diventati “cose” che vivono in un movimento che per il momento produce solo smarrimento ed erramento in un non-luogo senza più direzione.
Alla ricerca di nuovi ripostigli per la coscienza
“Nel ripostiglio delle cose, essere cosa in mezzo alle cose...” così recitano le parole di un brano di tecno music e queste parole ci fanno pensare e ci danno la misura di come questo statuto di cosa sia il punto di passaggio dalla mente che oggi è crollata, verso una nuova ipostasi. La statuto di “cosa” pare si annunci come una sorta di psico prassi, un training cardiaco minimalista di un nuovo cuore che paradossalmente continua a battere anche ora che siamo tutti “morti”.
Nella società “malata” delle reti, del caos, delle “strutture dissipative” che ci portano a superare il “collasso” e ad accedere ad una nuova mente cardiaca di risonanza il sangue è rappresentato dal pensiero liquido. Mentre la prassi si scrive da sola, noi le siamo collegati tramite il pensiero del sentire che batte come un cuore nuovo.
E’, secondo me, avviata la creazione di un atteggiamento orientato verso l’abbandono di ogni organicità e l’adozione di una logica porosa ed inorganica che esplora pensieri estremi che attivano una dimensione senza la mente, non-umana e non-vitale. Ora qual è la visione del mondo di una “cosa”? Come vediamo la realtà quando, unificate tutte le rap-presentazioni del mondo in una trama unitaria indissolubile, osserviamo i fenomeni in modo inerte e speculare?
La risposta è problematica ora che le persone non appartengono più a se stesse, ma al luogo in cui si muovono e all’era della filmabilita tecnica della loro esistenza. “Esse sono elementi mobili di ambienti a cui possono essere aggiunte o tolte senza che l’insieme muti sostanzialmente: esse sono lo spazio che sente ed i loro sensi “pensano” il loro stesso “sentire”. “Le cose” stanno come gli angeli di san Tommaso d’Aquino, in una dimensione intermedia tra l’eternità e il tempo; esse dimorano nell’aevum, cioè in una durata che ha un inizio, non una fine”. ”Di questa nuova condizione si fa interprete il tecnomorfismo architettonico del giapponese Shin Takamatsu, nella cui opera sembra siano soppressi i confini tra il corpo umano e il mondo, non perché entrambi sono partecipi di una grande vita universale, ma perché alla tecnologia che rappresenta un’estensione dei sensi è assegnato il compito di percepire.
Si impone così un sentire inorganico cui l’uomo ha accesso per via indiretta, perché gli proviene dal di fuori del suo corpo e non dall’interno: dall’esterno fino ad ora proveniva soltanto il percepito, non il percipiente, il sentito non il senziente. Adesso invece l’uomo può percepire in quanto si adegua ad essere anch’egli una cosa senziente simile ai sensori elettronici” ( [22]). “Il modo di “vedere”della cosa è lo schema, che in latino si dice habitus da cui appunto “abitudine” e nella teoria della sequenza normale l’attenzione degli uomini-cosa è posta non sull’originale ma sulla copia ovvero sul simulacro” ( [23]).
Naturalmente esistono forme di intrattenimento intelligenti come “Fora”, nata sull’intuizione che ogni giorno vengono espresse idee brillanti in spazi pubblici di cui nessuno prende visione, che sono “organi di risonanza” che prendono il posto della mente e questa è una cosa su cui non si è riflettuto ancora. Gli uomini-cosa non hanno un centro di raccolta mentale su cui le percezioni possono stratificarsi e depositarsi, per questo motivo occorre una sorta di campo secondario di risonanza in cui c’è la rappresentazione della conoscenza che ci aiuti a sapere che cosa sappiamo e che cosa non sappiamo su un display, un computer in un filmato di you tube.
Questi “nuovi esseri” senza mente hanno preferito far crollare tutta l’architettuta mentale sotto il suo stesso peso anziché restare impigliati nella rappresentazione del reale rassicurante, ma troppo vicina, netta e definita ma falsa. I nativi del web sono alla ricerca di rassicurazioni e queste rassicurazioni provengono da “organi di risonanza” che conferiscono sicurezza e dicono loro dove proseguirà il cammino che si snoda per tutta la vita come una caccia al tesoro. Il tesoro consiste nel trovare il mondo materiale del quale, come affermano Maturana e Varela, possiamo affermare “che non esiste neanche una cosa che sia indipendente dal processo della cognizione”.
Non c’è alcun territorio predeterminato di cui possiamo tracciare una mappa: è l’azione stessa del tracciare la mappa che genera le caratteristiche del territorio. In ogni caso la replicazione del territorio dà sicurezza.
E’ la replicazione che dà senso e significato: se nulla si ripetesse mai, nulla sarebbe riconoscibile, ma la ripetizione contiene in sé anche i segnali del nuovo, del divenire, anche se questi sono difficili da leggere. La ripetizione è quindi differente, e anche se, apparentemente nulla di nuovo accade immediatamente, tuttavia può essere decrittato l’accidente che fa saltare la serie delle apparenze permettendo di scrutare il nuovo che brilla.
C’è bisogno di un lungo lavoro di riepilogazione perchè il pensiero del sentire crea per piccole variazioni. Come avviene il riconoscimento e quindi il passaggio dall’ultima copia al primo elemento della nuova serie? Forse accade tutto all’improvviso. Spesso è un disturbo della trasmissione, un’interferenza casuale che obbliga ad una revisione di tutto un passato.
L’avvento di un oggetto primo di pensiero (del sentire) che crea un fenomeno sfuggente, forse anche “pericoloso”, dà inizio ad una nuova serie di accadimenti. In proposito ecco il parere di Brian Gruber: “E’ un periodo di grande fermento nel mondo dei media, che prelude alla nascita di forme espressive completamente nuove. Siamo convinti che esista una subcultura - se vogliamo chiamarla così - cui appartengono, secondo le nostre stime 200 milioni di persone in tutto il mondo, che ricercano nuove voci, amano imparare cose nuove e consumano “contenuti intelligenti” ( [24]). Magari l’evento viene filmato su you tube e mandato in connessione. Intorno ad esso molti mutanti si accalcano senza però comprendere consapevolmente che ciò che scrutano è veramente nuovo perché il pensiero del loro sentire non trasmette l’informazione ad un centro congruente e dunque devono attendere che si completi il ciclo-sequenza di connessioni wireless a banda sempre più larga, dal pensiero liquido del sentire, agli organi di risonanza e viceversa.
Quando il ciclo si completa, accade che esseri senza la mente percepiscano l’avvento di un “oggetto” primo? E poi, l’oggetto primo non potrebbe essere la nuova ipostasi della mente che nasce come oggetto, come un evento che guarda coloro che la guardano ed è guardata da essi? Forse è proprio questa la fase che stiamo vivendo e nella quale ci troviamo a prendere atto della fine della grammatica e della nascita di una sintassi teologica per un pensiero liquido e im-proprio sostituto di una “mente” sommamente non-identitaria, ovvero di una identità senza individuazione?
Secondo George Kubler ( [25]) le opere umane sono come le stelle, la cui luce parte molto tempo prima di apparire all’osservatore. Anche l’attività dello storico non si sottrae a questa condizione: i segnali che egli, dopo averli deformati, ritrasmette verso l’avvenire, non possono mai essere né completi né definitivi. Il riconoscimento dell’originalità richiede un lungo lavoro di rielaborazione che procede secondo tempi lunghissimi. Ma esseri senza mente avranno ancora il senso della storia? E soprattutto se eventi nuovi stanno accadendo, quale sarà il tipo di mente o di configurazione mentale che le percepirà, le riconoscerà e le registrerà?
Il pensiero liquido
Il pensiero liquido sta crescendo e speriamo di non affogare in esso. Personalmente non ho nessun entusiasmo per questa esaltazione maniacale della vita interamente on line che secondo alcuni autori ci attenderebbe . La scomparsa delle “tastiere, dei cavi di connessione, e di tutta la pesante infrastruttura tecnologica che sostiene oggi la connessione in rete, abiliterà la natural interaction cioè la possibilità di traslare la maggior parte della nostra esistenza on line.
La connettività permanente ad altissima velocità rappresenterà l’occasione per completare quel trasferimento di contenuti e servizi dalla vita fisica alla vita online, oggi in parte iniziato, ma ancora in gran parte da sviluppare”.
Quando il crollo della mente sarà un evento conclamato, molte cose saranno completamente nuove. Io non ci trovo nulla di esaltante nel cosiddetto soul catcher che “Registrerà e immagazzinerà le nostre emozioni. Suona inquietante, ma già oggi i chip vengono impiantati in animali, soprattutto, ed esseri umani (in via sperimentale, per ora). L’operazione è del tutto innocua e indolore e con la miniaturizzazione dei chip diventerà semplice come fare un’iniezione. Un chip collegato alle nostre reti neurali potrà dialogare con esse, usando un linguaggio comune e potendo inviare in un dispositivo di memoria senza fili, tutte le informazioni del caso sulle nostre emozioni” ( [26]).
Il crollo della mente e l’avvento del pensiero liquido porterà con sé la realizzazione della natural interaction che ci porterà a sua volta alla connessione senza cucitura, senza interazione con mouse, tastiere, pulsantiere. Le tecnologie non saranno facilmente percepibili ma saranno ovunque e saranno “organi di risonanza” e consiglieri nel senso che daranno anche la continuità d’azione e un ricordo aurorale di chi siamo e che cosa dobbiamo fare quando sarà cancellato il verbo essere e la nostra funzione sarà stabilita da piani e progetti in cui gli “individui” formeranno colonie (di organismi simbiotici, preposte a compiti sociali. La mente così come oggi la conosciamo sarà un “ricordo” di cui solo qualche studioso, avrà una vaga idea.
S-mentire il paesaggio
I nativi del web, i nativi senza-mente che appartengono al mondo liquido-moderno, abitano i non-luoghi caratteristici dei profughi e dei rifugiati. Molto probabilmente questi non-luoghi sono modelli in anteprima del mondo che verrà, e i loro residenti vengono indotti e spinti dalle circostanze, nel ruolo di primi esploratori. Verrà forse un tempo in cui scopriremo tutti di essere dei rifugiati post-crollo della mente e assaporeremo il gusto del non-luogo. Il nostro “paesaggio” è forse la pelle nella quale trascorriamo e procediamo attraverso lo spazio? Oppure il “paesaggio” è il nostro linguaggio (che è la pelle della mente) nel quale procediamo smarriti e pressati dal bisogno di riconfigurare verbalmente la realtà col pensiero del sentire?
A differenza dello spettacolo che implica l’esistenza di un occhio che lo guarda, la nozione di paesaggio trae dalla sua provenienza geografica un’impersonalità che prescinde completamente dal punto di vista soggettivo. Senza la mente lo spazio diventa liquido, senza la mente lo spazio diventa ogni cosa, senza la mente il paesaggio tramonta definitivamente.
Il paesaggio è trasmutato nel sito e il sito non ha consistenza e in esso gli uomini devono affidarsi agli “organi di risonanza” dei social network per non naufragare; il web, da questa angolazione, e da questo punto d’essere è considerabile come una zattera a cui si aggrappano uomini in pericolo di affogare in menti non più sufficienti, sciolte come castelli di sabbia in un pensiero liquido. La verità di un paesaggio è una questione di aderenza e di stili di pensiero.
L’esperienza di un paesaggio/sito è una questione muta, obliqua, opposta a quello del paesaggio reale perché il pensiero liquido del sentire si raffigura anche ciò che non si vede poiché il pensiero liquido senza mente, trasgredisce anche le regole della prospettiva, inserendo nella visione sostenuta dagli organi di risonanza tecnologici, molti orizzonti e molti punti di vista. Così come accade nella pittura bizantina in cui l’eidos (la forma sovrasensibile) e la morphé (la forma sensibile), coincidono completamente, allo stesso modo, diventa percepibile che nel “sito” si attua il congiungimento tra l’invisibile e il visibile, tra il virtuale e il reale, poiché esso è il luogo in cui i due mondi si toccano.
Per il pensiero liquido del sentire degli esseri senza mente, il sito non è l’imitazione del paesaggio originario, ma il paesaggio stesso del non-luogo, il punto in cui vi è l’orma di una mente (crollata) non identitaria, così come accade per l’icona che non è l’imitazione dell’originale ma l’originale stesso. In questo modo si palesa che le fonti di questo tipo di visione non stanno in “Platone, che considerava la forma sensibile ontologicamente inferiore a quella sovrasensibile, ma in Plotino e nell’estetica bizantina per i quali l’essere e la bellezza sono inseparabili.
L’immagine deve perciò essere considerata non come una semplice rappresentazione dell’’originale, ma come una parola, un’evocazione della sintassi teologica della “porta” attraverso cui la divinità, sotto la specie degli organi di risonanza (display, cellulari, iphones, social network) entra nel mondo sensibile e può lasciarsi pensare contemplandosi attraverso il pensiero liquido del sentire che fluisce, ordinando ciò che va fatto attraverso nuove routines neurofisiologiche. Senza la mente siamo spalmati fuori dal paesaggio, su grandi spazi, in un’altra configurazione cognitiva. Il teatro della mente è sparito e il punto d’essere non va più in scena. Siamo tesi verso la costruzione di una supercoscienza cognitiva liquida fondata su un protocollo prelinguistico per l’attuazione totale della divinità sul piano della tecnologia.
La nuova consapevolezza fluisce oggi in un ambiente cosciente che si può considerare una sorta di secondo mondo sorto su una esternità che cresce e s’innalza come un grattacielo in costruzione. In questa dimensione sempre nuova e cangiante, si muove un sentire pensante che ci svela che siamo parti di un grande corpo, che siamo “cellule pensiero” che pensano e sono pensati da un pensiero liquido. Ora dopo tremila anni siamo ancora noi la metafora del mondo? La verità è chiusa forse nei cellulari.
 PARTE V Il Pensiero del sentire e L’ESTERNITA’
PARTE V Il Pensiero del sentire e L’ESTERNITA’
 L’esternità come silenzio
L’esternità come silenzio
 L’esternità e la musica come sound
L’esternità e la musica come sound
 L’esternità e la morte
L’esternità e la morte
 Carattere di transitorietà dello spazio verso l’esternità
Carattere di transitorietà dello spazio verso l’esternità
 L’esternità come perdita della forma
L’esternità come perdita della forma
L’esternità come silenzio
Il pensiero del sentire è una forma particolare di “pensiero” caratterizzato da una condizione di “silenzio”o di interruzione interpretativo delle facoltà razionali, preposte alla descrizione del mondo come fenomeno. Questo “tipo” di pensiero potrebbe essere simile alla condizione di epochè delle estasi mistiche o della percezione alterata dall’assunzione di sostanze psicotrope e degli stati di trascendenza dell’io nel samadhi degli yogi con alto grado di evoluzione spirituale. Questo pensiero scaturisce direttamente dalla percezione dei sensi; così mentre i nostri sensi “pensano”, il nostro corpo razionale può continuare a credere di essere sempre nello stesso identico punto del mondo. Ma non è così. Piano piano, ogni volta che una nuova percezione dei sensi, diviene l’oggetto del pensiero del sentire, quel bagliore fugace che s’accende, crea un’estensione del nostro corpo verso l’esternità.
L’esternità è adesso. Non c’è nulla a priori, niente che possa costituire un corpo di conoscenza perché ogni cosa è adesso. Ogni cosa è adesso e.. silenziosamente, significa che la “cosa” compare e lampeggia solo questa volta e poi mai più e quindi essa comporta la sua esistenza in un punto sconosciuto dell’esternità. L’esistenza dell’esternità si “scruta”, si scruta e si percepisce intorno al fenomeno o alla “cosa”: di essa ci si accorge poiché il comportamento degli uomini ha un’impennata verso modalità stranianti.
L’esternità non è un mondo oggettivo che si autoafferma con la sua immanenza, ma una sottile fettuccia, una striscia di terra, un fugace silenzioso poggiare i piedi su di un “fazzoletto” di terra di cui non si sa se sia stata evocata da un sogno, da un’allucinazione, e su cui, in ogni caso, si permane per poco, per tanto poco tempo che si viene lasciati nel dubbio se sia mai stato vero e reale il nostro passarci. L’accensione dell’esternità trascina con sé l’evocazione di un pezzo nuovo di noi, che compare come una sagoma ritagliata attorno alla nostra silouette che si trasforma in corpo di carne ed ossa per pochi millesimi di secondo. Molte “immagini” dell’esternità si accumulano e diventano liquide, senza che si costituisca un paesaggio: la superficie dell’esternità resta silenziosa, deserta e liquida, ad essa si giunge attraverso un corpo che si ottiene fugacemente, solo per una volta e mai più.
L’esternità e la musica come sound
I Rave party costituiscono una delle strade che portano all’esternità. Il rave è un posto dove i sogni turbinano nell’aria e si deve solo afferrarli.... E poi si può ballare sull’acqua. Tutti sono a caccia di un sé intensivo cercato anche nelle situazioni più paradossali. Ad esempio anche un incidente della strada può diventare funzionale all’espansione...in un ospedale si va a tentare di uscire dal coma, dove il “coma” è costituito dalla modalità normal/arcaica di vivere.
Ciò che conta nei Rave party è il navigare nell’immaginario, nel paranormale, nelle stelle, nel riso. In questa esternità si pensa che sarebbe una fortuna se una fata venisse a darci un piccolo colpo nei fianchi che ci spingesse finalmente nell’avvenire. nell’esternità però, l’avvenire è là, ma sotto un’altra forma, con un altro colore, con un’altra materia e magari con un altro tempo che non abbia tempo di essere perché il tempo ora ha una storia che lo riempie totalmente impedendogli di scandire le nostre esistenze al di fuori del RAVE. Nel rave party è un suono a prendere il comando, il sound apre porte su territori senza confine, la musica apre l’esternità.
L’esternità e la morte
L’ingresso nell’esternità implica dei cambiamenti somatici? Detto in altri termini occorre un corpo differente per far fronte ai mutamenti di ogni tipo che stanno verificandosi? Il disorientamento che ci coglie di fronte alla paradossalità degli eventi che le cronache quotidiane ci propinano, deriva dal fatto che tentiamo di interpretarle con i residui di una mente vecchia? Le routines neurofisiologiche dell’apprendimento dell’alfabeto, e dell’adozione di un sistema decrittivo/percettivo della “realtà” fondato sulla rappresentazione che hanno funzionato fino ad oggi da rallentatore/regolatore della visione del mondo, crollano oggi sotto il peso della liquidità dell’esternità che s’impone. Nelle nuove ritualità come quelle dei reve parties, in cui si assumono droghe, mentre si è in preda a stati psicologici di grande intensità, possono verificarsi esplosioni di bombe a tempo linguistico/culturali e modificazioni psicologico/somatiche?
E’ ancora da vedere, se la gran massa di materiale inconscio che intravediamo, premere da tempo immemorabile alle frontiere della coscienza per entrare nella prassi, ha effettuato uno sfondamento: questo materiale psichico, potrebbe aver trovato oggi, una modalità per entrare nella realtà, sotto le spoglie di quello che Freud definì il perturbante. Il pensiero del sentire può aver creato una pressione nuova, dovuta alla comparsa di una nuova ipostasi della mente che rovesciando le condizioni ordinarie percettive e adottando un nuovo protocollo cognitivo, crea le condizioni per le quali “noi” siamo posti dalla realtà e non viceversa. Questa nuova condizione potrebbe averci condotto molto vicino alla morte e dunque alla necessità di un adattamento a nuove condizioni psicologico/ambientali.
Data la situazione attuale in cui ci troviamo in presenza di mutazioni antropologiche profondissime, “Il cambiamento somatico è assolutamente necessario per la sopravvivenza. Qualsiasi cambiamento ambientale che richieda un cambiamento adattivo nella specie, sarà letale a meno che, mediante il cambiamento somatico gli organismi (o alcuni di essi) non siano capaci di resistere per un periodo di durata imprevedibile, finchè non si attui un opportuno cambiamento genotipico (vuoi per mutazione vuoi per ridistribuzione di geni già presenti nella popolazione), oppure finchè l’ambiente non ritorni alla normalità precedente” ( [27])
Questa considerazione porta alla classificazione dei cambiamenti tanto genotipici quanto ambientali in termini del prezzo che essi impongono alla flessibilità del sistema somatico. Un cambiamento letale nell’ambiente o nel genotipo è semplicemente un cambiamento che richiede modificazioni somatiche che l’organismo non può compiere.
Tuttavia il prezzo somatico di un dato cambiamento deve dipendere non in modo assoluto da quel cambiamento, ma dal grado di flessibilità somatica che l’organismo possiede in quel momento. ”O cancellate voi stessi o le vostre venerazioni, ed in ogni caso sarà il nichilismo” La frase di Nietzsche è più che mai pertinente. Abbiamo costruito probabilmente il nostro corpo su visioni/rappresentazioni e concetti che oggi sono crollati sotto l’impatto delle tecnologie. Abbiamo forse perduto letteralmente la “terra” da sotto i piedi e, di tanto in tanto, si fa incontro al nostro piede un piccolo baluginante lembo della nuova terra dell’esternità.
Carattere di transitorietà dello spazio verso l’esternità
Lo spazio e l’esternità, sono la stessa cosa? Con le tecnologie i “luoghi” non sono immobili ma possono spostarsi. “Librerie che diventano archivi di bit, scaffali sostituiti dai servere elettronici, gallerie che lasciano il posto progressivamente a musei virtuali, teatri come infrastrutture di intrattenimento, scuole organizzate come campus virtuali, ospedali trasformati dalla telemedicina, prigioni sostituite da programmi di controllo elettronico” ( [28]). Ad esempio, cavigliere e braccialetti elettronici renderanno inutile luoghi come la prigione oppure, se si vuole, la “prigione” avrà una modalità transitoria.
Emergeremo dai luoghi e dagli spazi per entrare nell’esternità e la figura umana sarà data, nell’era della filmabilità tecnica della vita, dalla produzione delle apparenze in cui essa consisteva: sulla “pellicola” degli spazi, dei vecchi spazi, l’uomo comune si rivitalizzerà e si ricorporerà nell’esternità. La vecchia visione della realtà interamente transitoria sarà usata come il pretesto “scenografico” per muoverci come ologrammi e recuperare tra le macerie parti di noi che serviranno nel passaggio verso il nuovo, altrove attiguo dell’esternità.
L’esternità come perdita della forma
La “scomparsa” degli individui nativi del web svela il preindividuale che essi comportavano. Le figure soglia che erano i soggetti, ancora erano in grado di catturare il loro corpo usandolo come fondamento del luogo, conferendo , in questo modo una etnicità fittizia al luogo come spazio nazional/domestico/coloniale. Ma se all’umanità che probabilmente è già fondata tecnicamente sull’improprietà che la costituisce, alla estroflessione e alla , deterritorializzazione originaria, si aggiunge il discorso della impossibile gestione dei “vuoti” della condizione “senza mente”, allora questo comporta che la sfera appartentiva non può essere altro che un “qui” dilatato, un luogo espanso e irriconoscibile, che perde i contorni, si liquefa, diventa un “luogo” non identitario in cui il corpo, tra il divincolarsi dalla sua stessa forma, e dall’essere risucchiato in essa finisce in un ambito di indiscernibilità.
Relativamente alla forma e al mantenimento di una coscienza e alla presenza come individui senza mente, i nativi del Web sono alla mercè degli imperativi collettivi. Destinata al naufragio è l’idea di una stabilità globale e dell’esistenza eventuale di un principio là fuori, verso il quale si può partire alla ricerca come un cavaliere antico, (che oggi non ha cavallo, né armatura ma con-batte e si di-batte con una lattina di birra in mano, mentre balla semiubriaco di fronte ad un muro di una vecchia fabbrica al suono di musica in un rave party). E sono questi “imperativi collettivi”, sotto le spoglie di organi di risonanza elettronici, display, iphones, che determinano la sparizione del poco sé che ancora rimane.
Secondo la “relatività” la presenza della materia di cui è fatto questo Sé , dovrebbe “mostrarsi” facendo tendere lo spazio, deformandolo o meglio sarebbe dire formandolo nel sociale. Ma non avviene così per l’esternità creata tramite l’attività degli organi di risonanza sui neocorpi liquidi senza la mente. La forma dei neocorpi senza mente non è in sé pienamente compiuta, quindi è impossibile mettere in tensione l’esternità poiché quest’ultima è soltanto campitura, sfondo/contenitore indifferente.
Non sappiamo quale linguaggio parla il corpo nell’esternità e dunque diventa impossibile fornire ragioni logiche per determinati comportamenti e le risposte verbali dei nativi del web alle domande fondamentali, non hanno origine in alcun spazio mentale interiore ma in semplici camere elettroniche di compensazione e risonanza. In sostanza non può più esistere l’eventualità che una persona possa spiegare se stessa. Con la perdita del “sé” e con il crollo della mente e della capacità di narratizzare, il comportamento o risponde a ordini ricevuti in forma allucinatoria da organi di risonanza o continua facendosi guidare dall’abitudine. Il poco “sé” che rimane ha l’impressione di essere stato lasciato solo dalla Divinità costituita (dal suo emisfero cerebrale destro).
Nell’esternità come accade nel rave party, e così come accade pure, nel momento del controllo degli organi di risonanza dei social network, non c’è un analogo del sé. Il nativo senza mente non può raffigurare se stesso nell’atto di fare qualcosa, e non può prepararsi a rispondere a ciò che le esigenze del momento richiedono. Il volume d’informazione è così voluminoso e veloce che ha surclassato il sistema nervoso quindi il vecchio hardware biologico è inadatto all’infosfera e all’esternità. Per i nativi del Web bisogna guadagnare il neocorpo che serve solo una volta e solo per una percezione. Il pensiero del sentire nella condizione di liquidità inonderà le cose e la nuova spiaggia del “reale”: ad ogni ondata il pensiero del sentire bagnerà una nuova esternità per la quale ogni volta occorrerà un neocorpo senza la mente.
Postfazione
L’autore fa presente che le tematiche che sono state presentate in questo pamphlet, saranno utilizzate ed amplificate per la preparazione di schede didattiche per gli studenti delle scuole superiori e università. Lo scopo di tale iniziativa è dato dalla necessità di coinvolgere i giovani in una serie di dibattiti e di riflessioni, su temi scottanti della vita attuale.
Indice
 Prefazione pagg. 1 - 4
Prefazione pagg. 1 - 4
 Parte I
Parte I
 Verso un sentire pensante
Verso un sentire pensante
 Il corpo nell’epoca della
Transnaturalità elettronica
Il corpo nell’epoca della
Transnaturalità elettronica
 Il corpo-scena pagg. 4 - 9
Il corpo-scena pagg. 4 - 9
 Parte II
Parte II
 Il sentire pensante pagg. 9 - 13
Il sentire pensante pagg. 9 - 13
 Parte III
Parte III
 Lo spazio cosciente pagg. 13 - 16
Lo spazio cosciente pagg. 13 - 16
 L’amalgama che sente pagg. 16 - 19
L’amalgama che sente pagg. 16 - 19
 Parte IV
Parte IV
 Il pensiero liquido e il crollo della mente pagg. 20 - 47
Il pensiero liquido e il crollo della mente pagg. 20 - 47
 Il crollo della mente pagg. 20 - 24
Il crollo della mente pagg. 20 - 24
 Situazione Italiana pagg.24 - 27
Situazione Italiana pagg.24 - 27
 Il linguaggio nella tempesta pagg. 27 - 29
Il linguaggio nella tempesta pagg. 27 - 29
 Organi di risonanza pagg. 29 - 30
Organi di risonanza pagg. 29 - 30
 Open source pagg. 30 - 31
Open source pagg. 30 - 31
 Pensare senza un cervello pagg. 31 - 37
Pensare senza un cervello pagg. 31 - 37
 I Tag - Il riepilogo dei tag pagg. 37 - 38
I Tag - Il riepilogo dei tag pagg. 37 - 38
 Rimemorazione Pagg. 39 - 40
Rimemorazione Pagg. 39 - 40
 Alla ricerca di nuovi ripostigli
Per la coscienza pagg. 40 - 44
Alla ricerca di nuovi ripostigli
Per la coscienza pagg. 40 - 44
 Il pensiero liquido pagg. 44 - 45
Il pensiero liquido pagg. 44 - 45
 S-mentire il paesaggio pagg. 45 - 47
S-mentire il paesaggio pagg. 45 - 47
 Parte V
Parte V
 Il pensiero del sentire e l’esternità
Il pensiero del sentire e l’esternità
 L’esternità come silenzio pagg. 48 - 49
L’esternità come silenzio pagg. 48 - 49
 L’esternità e la musica come sound pag. 49
L’esternità e la musica come sound pag. 49
 L’esternità e la morte pagg. 49 - 51
L’esternità e la morte pagg. 49 - 51
 Carattere di transitorietà.
Dello spazio verso l’esternità pagg. 51 - 52
Carattere di transitorietà.
Dello spazio verso l’esternità pagg. 51 - 52
 L’esternità come perdita della forma Pag. 52
L’esternità come perdita della forma Pag. 52
Dati biografici
Gaetano Mirabella è nato a Salerno nel 1947. E’ laureato in filosofia e in storia dell’arte presso l’Università di Urbino. Autore di numerosi saggi teorici pubblicati in qualità di membro della Società Italiana per gli studi di Estetica. E’ autore di un romanzo filosofico dal titolo “Dieci passi prima dell’eternità” edito da Palladio, Salerno 2004. Si è occupato di teatro e ha scritto vari testi teatrali.
E’ un “McLuhan Fellow” collaboratore di Derrick de Kerchkove, direttore del McLuhan Program in culture and technology di Toronto. Nell’estate 2007 è stato invitato da Derrick de Kerchkove in Canada per contribuire con due articoli (Il corpo-scena e Lo spazio cosciente) alla redazione di un libro sul concetto di “Punto d’essere”, insieme ad altri ricercatori, tra cui lo stesso De Kerchkove e Edith Ackermann ex assistente di Jean Piaget. Il libro uscirà in U.S.A. sotto il patrocinio della Biblioteca del Congresso. Ha contribuito alla stesura di un’antologia a cura del Mc Luhan Program, con un articolo dal titolo (Il pensiero liquido del terzo millennio e il crollo della mente) che figura come IV capitolo del presente pamphlet.
Sul tema, nel sito e in rete (cliccare sul rosso per leggere l’art.), si cfr.:
- Festival internazionale della Filosofia in Sila: alcune foto - foto di Gaetano Mirabella, in fondo.
 DAL DISAGIO ALLA CRISI DI CIVILTA’: FINE DEL "ROMANZO" EDIPICO DELLA CULTURA CATTOLICO-ROMANA.
DAL DISAGIO ALLA CRISI DI CIVILTA’: FINE DEL "ROMANZO" EDIPICO DELLA CULTURA CATTOLICO-ROMANA.
 "X"- FILOSOFIA. A FIGURA DEL "CHI": IL NUOVO PARADIGMA.
"X"- FILOSOFIA. A FIGURA DEL "CHI": IL NUOVO PARADIGMA.
Federico La Sala
[1] 1.-> Il tema del “corpo-scena" scaturisce da un mio romanzo filosofico, scritto in quattro anni dal 1984 al 1988 dal titolo “Dieci passi prima dell’eternità” edito da Palladio, Salerno 2004. La vicenda imperniata sulla messa in scena del sistema nervoso del protagonista, racconta della scenografica esistenza del Priore Adam Cadmon figura esoterica e metafora del cosciente collettivo, attraverso cui il protagonista passa per rivisitare la sua esistenza ed entrare in una “presenza definitiva” ed enattiva, che lo conduca attraverso il “sentire pensante” alla percezione dello “spazio cosciente” in un nuovo corpo.
[2] 2.->Cfr. il sito www.venis.it/medea/infoperla/azzarhtm su cui Angela Azzaro parla dell’anamorfosi, l’arte dello spiazzamento. Il termine, insieme a quello relativo alla distopia e scenologhia, scaturisce da riflessioni sulla fine del concetto di spazio euclideo, nonché, sulla fine della prospettiva rinascimentale classica, che assumeva un centro dal quale partire, per dar luogo alla costituzione dell’immagine del mondo. Con le neotecnologie si passa dalla rappresentazione classica del mondo, alla “simulazione”.
[3] 3->Mentre ci identifichiamo sempre più con i “tecnocorpi”, impariamo sempre meglio a costruirci su internet un “sé” che fa ricorso ciclicamente a molti “sé”: ci modelliamo e ci ricreiamo all’interno della realtà virtuale. Che tipo di personaggi diventiamo? Questi frammenti di personalità concorrono alla formazione di una nuova mente o al suo “crollo”? Per un approfondimento delle tematiche concernenti il sé, cfr. Sherry Turkle, “la vita oltre lo schermo” Ed. Apogeo, Milano, 1997.
[4] 4->Marshall McLuhan, “Gli strumenti del comunicare” Edizioni Garzanti, Milano, 1997
[5] 5->H.R. Maturana e F.J. Varela “Autopoiesi e cognizione” Ed. Marsilio, Venezia 1992
[6] 6->Cfr. Mark Dery, “Velocità di fuga” Ed. Feltrinelli, Milano 1997. Nel Libro si parla della metafora della “velocità di fuga” per staccarsi dalla terra e dal corpo materiale, ritenuto obsoleto dai nativi del web, verso una dimensione totalmente elettronica.
[7] 7->Upanisad, Edizioni Boringhieri, torino, 1985.
[8] 8->Maturana e Varela “Autopoiesi e cognizione”, Marsilio edizioni, Venezia, 1992, pag. 55
[9] 9->Mario Perniola “L’estetica del novecento” Edizioni Il Mulino, Bologna 1997, pag 155
[10] 10->Mario Costa, Internet e globalizzazione estetica” Edizioni Tempo Lungo, Napoli, 2002, pagg. 8-10
[11] 11->Il “grafo neurale” è secondo il neurobiologo Jean-pierre Changeux un oggetto mentale, cioè un reticolo di reazioni sinaptiche virtuali o attualizzate da più neuroni, secondo il tipo di attività stimolata da un evento interno o esterno all’organismo: sta in “La civilizzazione videocristiana” di Derrick de Kerchkove, ed. Feltrinelli, Milano, 1995.
[12] 12->Il concetto è trattato in vari punti del romanzo “Dieci passi prima dell’eternità” di Gaetano Mirabella Ed. Palladio, Salerno, 2004, pag. 40 e seguenti. Le nuove tecnologie hanno ricreato intorno al corpo con organi di risonanza tecnologici un campo energetico che ci colloca in una sorta di spazio percettivo totale e fa di noi “Santi” a caccia di una spazio intenso come quello della pittura bizantina , descritto dalla filosofia di Plotino.
[13] 13->Per un approfondimento della tematica relativa al “crollo della mente” si può leggere il libro di Julian Jaynes “Il collo della mente bicamerale” Edizioni Adelphi, Milano 1996.
[14] 14->“Your Truman Show” Di Arturo Artom sta in “Web 2.0” a cura di Vito di Bari, edizione “Il sole ventiquattro ore”, Milano, 2007, pag. 273.
[15] 15->Mario Perniola, “Transiti” Ed. Cappelli, Bologna, 1985, pag. 127.
[16] 16->Mario Perniola, “Transiti” Ed. Cappelli, Bologna, 1985, pag. 127.
[17] 17->Ho elaborato il concetto di “spazio che sente” in occasione della mia partecipazione al 2° Congresso Mediterraneo di Estetica tenutosi a Tunisi nel marzo del 2003. Nello stesso congresso fu eleborato anche il concetto di “sentire pensante”. I due concetti furono trattati in un articolo pubblicato dalla Presidente dell’associazione tunisina d’estetica e poetica Rachida Triki, nel volume “espace e memoire” Ed. Atep Maghreb Diffusion, 2003, pagg. 241-252. Nell’estate 2007 Derrick de Kerchkove mi chiese di scrivere insieme a lui e ad un gruppo di ricercatori (Luisa Malerba, Loretta Secchi, Cristina Miranda De Almeida, a cui si aggiunsero in seguito la coreografa canadese Isabella Choiniere, Edith Ackermann ex assistente di Jean Piaget e la coreana Sryu. Gli stessi articoli di cui sopra, confluirono quindi in un libro dal titolo “Il punto d’essere” che è in via di pubblicazione sotto il patrocinio della Biblioteca del Congresso degli U.S.A.
[18] 18->Zigmunt Bauman, “Modernità liquida”, edizioni Laterza, Bari, 2005, pag. 124.
[19] 19->Candace Pert e lo studio del National Institute of menthal Health in Mariland sta in Fritjof Capra “La rete della vita” Edizioni Euroclub Italia s.p.a., Milano, 1999, pagg. 311,312.
[20] 20->Il concetto di “enazione”, scaturisce dall’approfondimento dell’opera degli studiosi cileni Humberto Maturana e Francisco Varela,relativamente al concetto di autopoiesi cognitiva.
[21] 21->“Con e contro il cinema” in “Internazionale situazionista” n° 1 giugno 1958 - sta in Jean Francois Martos “Rovesciare il mondo”, Sugarco Edizioni, Milano, 1989, pagg. 88,89.
[22] 22->Mario Perniola, “L’estetica del novecento” Edizioni Il Mulino, Bologna, 1997, pag. 67.
[23] 23->Il Concetto di “cosa che sente” rimandano alla lettura e all’approfondimento delle tesi che Mario perniola illustra ne “Il sexappeal dell’inorganico” Edizioni Einaudi, Torino, 1994.
[24] 24->Brian Gruber sta in Web 2.0 a cura di Vito di Bari - Edizioni “Il sole 24 ore”, Milano, Novembre 2007, pag 258.
[25] 25->George Gruber, “La forma delle cose” Edizioni Casatello, Torino, 1975.
[26] 26->Brian Gruber, in “Web 2.0” a cura di Vito di Bari, Edizioni “Il sole 24 ore”, Milano 2007, pag.315
[27] 27->Gregory Bateson, “Verso un’ecologia della mente” Ed. Adelphi, Milano, 1988, pagg. 381,382.
[28] 28->Patrizia Mello, “Meditazione tecnologica e carattere di transitività degli spazi” sta in “Gilles Deleuze -Tecnofilosofia” Ed. Eterotopia Mimesis, Milano, 1998, pag 132.
LE DUE META’ DEL CERVELLO (Alfabeta, 1980)
Forum
-
> PENSIERO LIQUIDO E CROLLO DELLA MENTE --- LA "CAMERA D’ECO" ("ECHO CHAMBER"), L’ALGORITMO, E L’URGENZA DI UN "GIORNALISMO INCROCIATO". Parola di De Kerchove (di A. Beltrami).30 novembre 2021, di Federico La Sala
NewsMedia4Good. De Kerckhove: «Nell’era dell’algoritmo i media salvino l’umano»
De Kerckhove a “Nostalgia di futuro”: «L’informazione può generare nuova coesione sociale, ma deve capire come il mondo è cambiato»
di Alessandro Beltrami (Avvenire, martedì 30 novembre 2021)
- [Foto] Il sociologo dei media Derrick de Kerckhove
- “NewsMedia4Good” è il tema della 13ª edizione di Nostalgia di Futuro, l’evento in programma domani alle ore 15 a Roma presso la sede della Fieg, organizzato da Osservatorio TuttiMedia, solo network europeo che riunisce i media e le aziende attente alla transizione digitale della comunicazione. Di NewsMedia4Good, dopo l’introduzione di Franco Siddi (Presidente TuttiMedia) discuteranno Derrick de Kerckhove (consigliere scientifico di Tutti-Media e docente al Polimi), Paolo Liguori (Mediaset), Paolo Benanti (Pontificia Università Gregoriana di Roma), Carlo Branzaglia (Scuola Postgraduate IED Milano) e Costanza Sciubba Caniglia (Harvard University). Un successivo panel con Maria Pia Rossignaud (vicepresidente TuttiMedia e direttrice MediaDuemila), Luigi Rancilio (Avvenire), Angelo Mazzetti (Facebook), Tommaso Di Noia (Politecnico di Bari) e Pierguido Iezzi (Swascan), avrà al centro il Metaverso e la comunicazione aumentata. L’evento sarà anche trasmesso in diretta streaming dal sito di Media Duemila (www.media2000. it).
«Oggi quando sono uscito dalla Stazione Termini ho sentito il clamore dei no vax: era la perfetta rappresentazione dell’attuale caos informazionale che nega scienza, autorità e le strutture protettrici del significato. Il linguaggio non serve più a creare coesione sociale. Si deve fare qualcosa». Questo “qualcosa” è NewsMedia4Good, movimento fondato dall’Osservatorio Tutti-Media che verrà presentato domani a Roma nella 13ª edizione di Nostalgia di Futuro. «Siamo passati dalle speranza della disintermediazione al caos dovuto alla mediazione delle macchine» si legge nel manifesto del progetto. «La cultura alfabetica, aumentata dalla stampa, è stata l’architettura di carattere gerarchico della comunicazione, o almeno di quella occidentale - spiega De Kerckhove, sociologo, tra i massimi esperti di nuovi media e direttore scientifico di Osservatorio TuttiMedia e di Media Duemila -. Oggi siamo in un sistema fondato sull’algoritmo, che elimina l’uomo. L’algoritmo fa scelte, indirizza gusti, dice come votare... Ma il codice binario non ha bisogno di senso, solo di ordine. Dalla scomparsa del valore del significato deriva il caos attuale. Serve allora un movimento per riformare le strutture di coesione sociale e rovesciare l’attuale crisi epistemologica per ritrovare una comunicazione basata su qualcosa di completamente nuovo».
NewsMedia4Good intende far capire che “abbiamo bisogno di una nuova etica comprensiva della dimensione algoritmica” in cui “l’intero sistema dei media sia una priorità”. Su quali basi costruirla?
La struttura culturale occidentale si basava sui principi della fisica classica. Io invece propongo come base la fisica quantistica, i cui principi sono incertezza, dubbio, l’entanglement, ossia l’incrocio, la sovrapposizione. La fisica classica ha creato categorie e dato il permesso di sfruttare la natura. Noi abbiamo bisogno di essere congiunti, incrociati con il tutto. Occorre rifondare totalmente il nostro modo di comportarci. Chi può orientare a questa rifondazione? I media, che sono ancora i depositari della fiducia pubblica. Dobbiamo chiedere ai media di ripensare il proprio ruolo, rinunciando a moralismo e sensazionalismo, e produrre coesione sociale.
Questo non dovrebbe essere già il loro compito?
Il problema non è solo che non viene applicato, ma soprattutto il sistema non è sostenuto su una visione più profonda della situazione attuale. La mediasfera ora è una tormenta di migliaia di risposte che non hanno più nulla a che fare le une con le altre. Serve quello che io chiamo entangled journalism, il “giornalismo incrociato”: una nuova narrazione del globale, dell’ambiente totale.
Ormai sono molto diffuse le notizie scritte direttamente da bot. Questo fatto come investe la dimensione deontologica del giornalismo, nella quale la responsabilità è centrale?
La macchina non ha coscienza, non conosce il senso di quello che produce. Pensiamo ai traduttori automatici disponibili online: la macchina non conosce la lingua ma si basa sulla comparazione di vari modelli. Il prodotto sono sequenze di segni privi di significato per la macchina. Non possiamo chiedere alla macchina una coscienza politica e deontologica. Può averla solo l’uomo che verifica la notizia. È il compito del giornalista. Il grande problema è che l’algoritmo è più informato del giornalista, del medico, del consulente finanziario, del militare, del pubblico amministratore... Sembra che superi le competenze umane. Dobbiamo negoziare un accordo, una riconciliazione tra macchina e uomo.
Sembra che si confidi nell’intelligenza artificiale come in un oracolo.
Qualche giorno fa ho posto tre domande circa problemi etici sul gemello digitale a GPT-3, un superalgoritmo. Ho ricevuto tre risposte di una intelligenza fenomenale. GPT-3 dispone di 175 miliardi di parametri di machine learning e una mole sconfinata di informazioni su cui lavorare. Andiamo verso una situazione in cui potremo chiedere qualunque cosa. Gli oracoli antichi si fondavano su una conoscenza intuitiva del mondo. Le risposte dei nuovi oracoli si basano scientificamente e sono capaci di dire con precisione cosa accadrà nei prossimi tre anni. Nella rete c’è tutta l’informazione del mondo. Ecco perché è necessario sapere come gestire questa conoscenza. Abbiamo data analytics che possono prendere il posto dell’intelligenza. Siamo in un rapporto intimissimo tra persona e macchina. Dobbiamo chiederci quale mondo può sostenere questa ibridazione.
Oggi si parla di antropocene. Non siamo piuttosto in un “digitocene”?
Siamo oltre il digitale. Seguo il tema da tempi pionieristici e posso dire senza ombra di dubbio che oggi è per la meccanica quantistica ciò che è stato per il digitale tra 1990 e 1995. Avremo un quantum computing sempre più evoluto. Dobbiamo prepararci, a partire da una attenzione dei mezzi di informazione completamente nuova. Ripensare la notizia, ripensare il ruolo del giornalista, le strutture della coesione sociale. È cio che intende fare NewsMedia4Good, che raccoglie tutti i gli ambienti, dalla stampa a Google.
Un linguaggio che ignora il significato e riduce il mondo a funzione produce un mondo privo di etica?
L’etica oggi è debolissima. Sono venute meno le scansioni classiche di etica della vergogna e della colpevolezza. La prima è l’orientamento della responsabilità verso l’altro: è l’etica confuciana, il cui referente è la comunità più che l’individuo. L’etica della colpevolezza, individuale, è l’etica cristiana. Questa, incontrando il mondo greco, ha creato un’eccezione, perché la scrittura greca diversamente da quella ebraica, che è una scrittura condivisa, ha favorito l’appropriazione a livello personale del linguaggio. Il cristianesimo ha spostato il senso di responsabilità verso il sé, la scrittura e la lettura personale nel silenzio hanno creato l’individuo. Oggi con l’educazione debole si perde l’abitudine alla lettura su carta, interagiamo mediante schermi, perdiamo il controllo del contenuto personale. Siamo costantemente tracciati, e la privacy è un dono della lettura e della cultura. Tutto oggi invece è portato all’esterno: la nostra memoria è sul telefonino. Siamo usciti dal binomio vergogna e colpevolezza: abbiamo l’ansia. Un’ansia gigantesca. Il fenomeno no vax è una rivolta istintiva contro l’ansia.
In che modo ansia e algoritmo si incontrano?
In questo contesto di transizione ci sono figure come Orbán, Trump, Johnson e gli altri populisti che approfittano dell’efficacia sociale di dichiarazioni prive di referenti: e la perdita del referente fa parte del caos. Dicono ciò che la gente vuole sentire. L’algoritmo individua in quali echo chamber disseminare. Nella tua “camera d’eco” hai deciso, emozionalmente e intellettualmente, quale sia la verità e accogli solo ciò che conferma ciò che pensi già. Tutti abbiamo una echo chamber, dobbiamo esserne coscienti: ma possiamo almeno allargarla. Il ruolo del giornalista e della parola pubblica è sempre più importante per resistere a questa erosione. Il mondo oggi è molto più misterioso, la nostra realtà più fragile e incerta. Ma anche più articolata. Una guerra inizia quando la struttura del mondo si semplifica. Se resta complessa, resiste di più.
-
> PENSIERO LIQUIDO E CROLLO DELLA MENTE. --- "I am data driven" (’Io sono guidato dai dati’). Silicon Valley: i troppi perché della Valle oscura (di Lorenzo Fazzini).3 marzo 2021, di Federico La Sala
Il pamphlet.
Silicon Valley: i troppi perché della Valle oscura
Uno studio di Anna Wiener, fra economia ed etica, porta a chiedersi quanto sia sostenibile «un tech che non è progresso ma soltanto business»
di Lorenzo Fazzini (Avvenire, martedì 2 marzo 2021)
- [Foto] Lo skyline di San Jose - WikiCommons
Eric Salobir, un domenicano studioso delle nuove tecnologie, ha raccontato che nella Silicon Valley i guru dell’hi tech invitano i lama del Tibet per incontri di carattere spirituale. Segnale, affermava questo frate consultore anche del Vaticano per i nuovi media, che anche nella patria del web le domande di senso non sono straniere né possono essere completamente esclusi gli interrogativi più radicali laddove ogni cosa viene smaterializzata e tutto diventa (tecnologicamente) possibile.
Una sensazione simile l’ha provata, mutatis mutandi, Anna Wiener, una giovane cultrice della letteratura che si è trasformata in un’esperta di dati digitali e si è insediata, come migliaia di giovani nella nuova frontiera del sogno a stelle e strisce, San Francisco, la città-emblema della Silicon Valley dove hanno sede i grandi gruppi della Rete.
 Ma Anna Wiener, oggi giornalista del ’New Yorker’, espressione tipica del mondo millennial yankee (tutti green ed eticamente liquidi), nel suo memoir La valle oscura, da poco edito da Adelphi, non lascia da parte la grande domanda: perché? Perché i grandi amministratori delegati delle start up che assommano migliaia di milioni di dollari costruiscono un mondo digitale in mano ai dati (I am data driven, ’Io sono guidato dai dati’ è il mantra che campeggia su tshirt aziendali dove lavora Wiener)?
Ma Anna Wiener, oggi giornalista del ’New Yorker’, espressione tipica del mondo millennial yankee (tutti green ed eticamente liquidi), nel suo memoir La valle oscura, da poco edito da Adelphi, non lascia da parte la grande domanda: perché? Perché i grandi amministratori delegati delle start up che assommano migliaia di milioni di dollari costruiscono un mondo digitale in mano ai dati (I am data driven, ’Io sono guidato dai dati’ è il mantra che campeggia su tshirt aziendali dove lavora Wiener)?«Scopo ultimo dell’idea: un mondo migliorato dalle aziende migliorate dai dati». Ma anche un mondo «libero dal peso delle decisioni, dalle inutili frizioni del comportamento umano, dove ogni cosa poteva essere ottimizzata, gerarchizzata, monetizzata e controllata». Quindi, bye bye libertà. La Silicon Valley, secondo Wiener, sembra attraversata da una sola preoccupazione: se qualcosa si può pensare, lo si può fare. Il punto è nel come.
 Ma la domanda sul perché sembra costantemente elusa. «La battuta ricorrente era che l’industria tecnologica stava semplicemente reinventando beni e servizi che esistevano da un pezzo. Era una battuta sgradita a molti imprenditori e investitori, che invece avrebbero dovuto essere grati di quel diversivo, poiché sviava la conversazione da questioni strutturali - per esempio, dal perché certe cose, come il trasporto pubblico, il settore degli alimenti o lo sviluppo urbano, avevano dei problemi’. Insomma, qualcosa non torna. -Del resto qui e là la descrizione della vita quotidiana degli startupper è davvero a metà tra il grottesco e il terrificante: «Nuove aziende vendevano nootropi farmaci non regolamentati che incrementavano le funzioni cognitive e promettevano di sbloccare un livello superiore di pensiero - a coloro che perseguivano le massime prestazioni».
Ma la domanda sul perché sembra costantemente elusa. «La battuta ricorrente era che l’industria tecnologica stava semplicemente reinventando beni e servizi che esistevano da un pezzo. Era una battuta sgradita a molti imprenditori e investitori, che invece avrebbero dovuto essere grati di quel diversivo, poiché sviava la conversazione da questioni strutturali - per esempio, dal perché certe cose, come il trasporto pubblico, il settore degli alimenti o lo sviluppo urbano, avevano dei problemi’. Insomma, qualcosa non torna. -Del resto qui e là la descrizione della vita quotidiana degli startupper è davvero a metà tra il grottesco e il terrificante: «Nuove aziende vendevano nootropi farmaci non regolamentati che incrementavano le funzioni cognitive e promettevano di sbloccare un livello superiore di pensiero - a coloro che perseguivano le massime prestazioni».La stessa Wiener si rendeva conto che qualcosa non torna quando lavorava in un’azienda che elaborava un prodotto digitale per accumulare i dati degli utenti. Perché lo si faceva? La domanda non veniva neppure posta: «Non ci consideravamo parte dell’economia della sorveglianza. Non riflettevamo sul nostro ruolo, non pensavamo al fatto che stavamo favorendo e normalizzando la creazione di banche dati sul comportamento umano, gestite da privati e non soggette ad alcuna regolamentazione». Fa capolino, nella testa della giovane data driven, la domanda etica, interrogativo che se ne porta dietro uno più prettamente spirituale (il titolo rimanda per assonanza al celebre Salmo 23): «Non ero contraria alla ricerca della verità. A quanto ne capivo, la razionalità offriva fondamentalmente sistemi di riferimento esistenziali molto simili all’autoaiuto. Il che aveva senso: le istituzioni religiose si stavano sgretolando, le grandi società esigevano una dedizione quasi spirituale, ci si sentiva sopraffatti dalle informazioni e i rapporti sociali erano stati demandati a internet - tutti erano in ricerca di qualcosa».
Sicuramente Anna Wiener non ha letto Sant’Ignazio di Loyola. Ma la disanima che il santo fece sul ’magis’, la ricerca del di più da parte dell’uomo, come traccia dell’inquietudine di origine divina, e quanto scrive la giovane di San Francisco sembrano andare nella medesima direzione: «Il tech non era progresso. Era solo business. Fu anche, forse, la mia empatia verso i giovani imprenditori della Silicon Valley. [...] Tutti quei ragazzi svegli, paranoici e inclini agli estremi [...] Supponevo che i loro veri desideri fossero simili ai miei: sapevo che costruire sistemi, e farli funzionare, rappresentava di per sé una soddisfazione ma supponevo che tutti desiderassero di più». Ebbene, sì, accade anche tra i guru dell’hi-tech e nel tempio del web.
-
> PENSIERO LIQUIDO E CROLLO DELLA MENTE. --- IL NEOFEUDALESIMO DEI COLOSSI HIGH-TECH (di Simone Paliaga)3 marzo 2021, di Federico La Sala
Scenari.
Il neofeudalesimo dei colossi high-tech
Due libri dell’economista Durand e del sociologo Kotkin puntano il dito sul potere delle “big tech” che rendono i consumatori servi della loro fame di informazioni per le esigenze degli algoritmi
di Simone Paliaga (Avvenire, martedì 2 marzo 2021)
«L’ascesa della tecnologia digitale sta sostituendo i rapporti fondati sulla concorrenza con delle relazioni basate sulla dipendenza, deregolamentando così la meccanica generale del sistema economico e facendo prevalere la predazione sulla produzione». Saremmo sulla soglia di una nuova epoca, sostiene l’economista francese Cédric Durand nel suo ultimo lavoro Techno-féodalisme. Critique de l’économie numérique (Zone, pagine 254, euro 18).
 L’epoca del tecnofeudalesimo, appunto! E non si annuncia certo rosea né carica di opportunità. «Con la telematica, i diritti di proprietà intellettuale e la centralizzazione dei dati - prosegue lo studioso francese - presuppongono un controllo molto più stretto su territori e individui». Lo scopo del controllo è l’accaparramento di dati, considerati da molti l’oro nero dell’economia digitale.
L’epoca del tecnofeudalesimo, appunto! E non si annuncia certo rosea né carica di opportunità. «Con la telematica, i diritti di proprietà intellettuale e la centralizzazione dei dati - prosegue lo studioso francese - presuppongono un controllo molto più stretto su territori e individui». Lo scopo del controllo è l’accaparramento di dati, considerati da molti l’oro nero dell’economia digitale.
 Alle corporation delle tecnologie dell’informazione non interessa promuovere la produzione ma accentuare la predazione, a cominciare da quella dei dati. A scapito degli Stati, che mostrano sensibili segni di indebolimento e di incapacità nel contrastarne l’azione, le big tech, da Amazon a Google e a Facebook, si disputano il controllo del cyberspazio. E lo fanno con uno scopo ben preciso. Controllare la fonte dei dati e centralizzarne l’elaborazione per sviluppare algoritmi efficaci e affinare la ricerca sull’intelligenza artificiale. Per questo Amazon & co. tendono a monopolizzare la catena del valore nella nuova economia digitale.
Alle corporation delle tecnologie dell’informazione non interessa promuovere la produzione ma accentuare la predazione, a cominciare da quella dei dati. A scapito degli Stati, che mostrano sensibili segni di indebolimento e di incapacità nel contrastarne l’azione, le big tech, da Amazon a Google e a Facebook, si disputano il controllo del cyberspazio. E lo fanno con uno scopo ben preciso. Controllare la fonte dei dati e centralizzarne l’elaborazione per sviluppare algoritmi efficaci e affinare la ricerca sull’intelligenza artificiale. Per questo Amazon & co. tendono a monopolizzare la catena del valore nella nuova economia digitale.Accettare la frammentazione dei dati «implica - sottolinea Durand - una distruzione del loro valore d’uso nella misura in cui i bacini di dati ridotti generano algoritmi meno agili e, quindi, dei dispositivi meno comodi per gli utilizzatori». Questo processo di centralizzazione finirà col sottoporre al controllo e alla predazione anche gli aspetti più minuti delle vite quotidiane, quelli che un tempo non interessavano a nessuno. «I più privati frammenti di vita tendono - continua l’economista d’Oltralpe - a essere incorporati nei circuiti digitali e intrappolati nell’oggettivizzazione di una grammatica comune a tutti gli agenti sociali ».
 Più controllati e dipendenti non sarebbe possibile. La profilazione degli utenti così ottenuta all’apparenza serve a soddisfare i desideri dei navigatori del cyberspazio, ma dall’altro ne mina la libertà di scelta. Il passaggio da utente alla «servitù della gleba digitale» è breve. Si gode del beneficio dei servizi erogati, ma in cambio si offrono le informazioni che servono a rendere più performanti gli algoritmi delle piattaforme.
Più controllati e dipendenti non sarebbe possibile. La profilazione degli utenti così ottenuta all’apparenza serve a soddisfare i desideri dei navigatori del cyberspazio, ma dall’altro ne mina la libertà di scelta. Il passaggio da utente alla «servitù della gleba digitale» è breve. Si gode del beneficio dei servizi erogati, ma in cambio si offrono le informazioni che servono a rendere più performanti gli algoritmi delle piattaforme.«Questa dipendenza generale dai proprietari di das digital - a opinione di Durand - è l’orizzonte dell’economia digitale, il divenire cannibale del liberalismo all’epoca del digitale» ma soprattutto è il sintomo che il sistema sociale evolve (o involve) verso forme di nuovo feudalesimo basato su oligarchie e «servitù della gleba digitale» contro cui poco possono gli stessi Stati, la cui nascita deriva proprio dalla neutralizzazione dei rapporti feudali di sudditanza.
 L’affermarsi delle big tech ridistribuisce il potere all’interno della società contemporanea e produce una riorganizzazione dei rapporti tra le classi sociali. Così la pensa il sociologo dell’Università della California Joel Kotkin nel suo The coming of Neo-feudalism. A warning to the global middle-class (Encounter Books, pagine 266, euro 21,53).
L’affermarsi delle big tech ridistribuisce il potere all’interno della società contemporanea e produce una riorganizzazione dei rapporti tra le classi sociali. Così la pensa il sociologo dell’Università della California Joel Kotkin nel suo The coming of Neo-feudalism. A warning to the global middle-class (Encounter Books, pagine 266, euro 21,53).
 Secondo lo studioso americano l’ibridazione tra determinismo tecnologico e capitalismo postindustriale favorisce la nascita di nuove strutture di classe ben diverse da quelle che hanno assicurato il boom economico nel corso del Novecento e lo sviluppo dei diritti civili.
Secondo lo studioso americano l’ibridazione tra determinismo tecnologico e capitalismo postindustriale favorisce la nascita di nuove strutture di classe ben diverse da quelle che hanno assicurato il boom economico nel corso del Novecento e lo sviluppo dei diritti civili.Le nuove oligarchie economiche mentre plasmano il futuro economico contribuiscono a creare una società neofeudale high-tech che mina la democrazia e la mobilità sociale che in passato era assicurata alle classi media e operaia. «La storia - ammonisce il sociologo - non sempre procede in avanti verso condizioni più avanzate e illuminate». Se per Kotkin nel corso dell’epoca medievale e nella prima età moderna la società si articolava in clero (clergy), aristocrazia e terzo stato, oggi non è molto diverso. Cambiano solo gli interpreti ma i ruoli rimangono gli stessi. Al posto del clero, si afferma un nuovo primo stato che Kotkin definisce clerisy, un’élite intellettuale separata dal resto della società e distribuita tra governo, media, università e nuove professioni legate alle tecnologie dell’informazione. Al posto dell’aristocrazia subentra una nuova classe, l’oligarchia, sempre più ricca e potente. Agli esclusi dai nuovi primo e secondo stato invece è vietata quella mobilità sociale che ne ha consentito, in epoca moderna, il riscatto e l’indipendenza.
 Contro l’epoca moderna, il Neofeudalesimo ipotizzato da Joel Kotkin offre in cambio ai diritti acquisiti in passato solo una crescente e sempre più radicata disuguaglianza nella distribuzione della ricchezza, come sostiene sulla scia di Thomas Piketty, e lo scollamento tra l’élite culturale e l’oligarchia e il resto della popolazione. La sorte dei prossimi anni è, dunque, già tracciata?
Contro l’epoca moderna, il Neofeudalesimo ipotizzato da Joel Kotkin offre in cambio ai diritti acquisiti in passato solo una crescente e sempre più radicata disuguaglianza nella distribuzione della ricchezza, come sostiene sulla scia di Thomas Piketty, e lo scollamento tra l’élite culturale e l’oligarchia e il resto della popolazione. La sorte dei prossimi anni è, dunque, già tracciata?
-
> PENSIERO LIQUIDO E CROLLO DELLA MENTE. --- TRANSIZIONE DIGITALE E MUTAMENTI ANTROPOLOGICI. "Dieu et la Silicon Valley". Un’intervista a Éric Salobir (di Lorenzo Fazzini).19 febbraio 2021, di Federico La Sala
Il domenicano francese.
Salobir: «I nuovi sciamani vivono di hi-tech»
«Questo mondo tende a costruire un ambiente ex novo, senza tempo né passato. Il cristianesimo ha una lunga conoscenza dell’uomo, legge il mondo e la storia con gli occhi di Dio»
di Lorenzo Fazzini (Avvenire, giovedì 18 febbraio 2021)
 [Foto] Il domenicano francese Éric Salobir
[Foto] Il domenicano francese Éric SalobirUn domenicano che frequenta il mondo dell’hi-tech più innovativo e lo considera un luogo giusto far risuonare la ’robusta antropologia’ della tradizione cristiana. Con Eric Salobir, teologo francese, approfondiamo il mondo della tecnologia digitale.
Nel suo libro Dieu et la Silicon Valley lei afferma che le tecnologie sono prodotti della società «nei due sensi del genitivo: noi li produciamo e, a forza di utilizzarli, loro ci plasmano» La tecnologia digitale cambierà l’essere umano?
Penso che le nuove tecnologie e l’intelligenza artificiale stiano profondamente trasformando l’essere umano. Non siamo davanti solamente ad una tappa della rivoluzione industriale, ma realmente ci troviamo in a un momento in cui cambia la percezione di noi stessi e del mondo. Un po’ come quando sono arrivati i caratteri mobili a stampa. Per esempio, con l’uso della tecnologia e il telelavoro sono cambiate le nostre interazioni intraumane, abbiamo meno creatività, si tengono incontri amorosi tramite app, cosa ben diversa dal confronto relazionale concreto. Cambia la nostra percezione del sapere: prima ci affidavamo alla ricerca in biblioteca, oggi basta un clic per sapere la capitale d’Italia. Ma dal punto di vista cognitivo, non credo che siamo davanti a un cambiamento necessariamente negativo.
Perché afferma questo?
Prima della sua morte, ho discusso a lungo con il filosofo Michel Serres su questi cambiamenti. Egli mi faceva presente che quando siamo passati dalla tradizione orale a quella scritta, abbiamo perso molto in termini mnemonici, ma abbiamo guadagnato molto sotto altri aspetti. Io personalmente non ricordo nessuno dei numeri telefonici che abitualmente compongo con il mio iphone, lascio che questa funzione lo svolga lo strumento. Certamente si pone il problema se lasciamo che questi strumenti ci governino e diventino i nostri padroni. La questione riguarda quindi il modo in cui usiamo questi strumenti, ovvero se abdichiamo alla nostra identità di esseri umani rispetto a un macchina. Se decidiamo noi come usiamo internet, come compriamo, cosa acquistiamo, la libertà umana è ancora sovrana. Dunque, se gli strumenti li usiamo in modo umano, essi ci umanizzano. Altrimenti, sono forieri di disumanizzazione.
In un contributo su ’Vita e pensiero’ lei afferma che nella Silicon Valley troviamo trace di spiritualità. Per esempio, i grandi personaggi del digitale invitano i lama tibetani a tenere loro delle meditazioni. C’è una chance per il Vangelo in quel mondo?
Penso che nella Silicon Valley ci sia una sete spirituale: questo è certo. Essa è costruita sulle rovine delle utopie degli anni Sessanta, l’ideale di superare l’imperfezione del mondo. Non è un caso che molte delle nuove tecnologie siano applicate all’ambito medico. Esiste anche per la fede cristiana una chance in questo mondo se siamo capaci di inculturarvi il Vangelo non partendo dalle nostre domande ma dalle domande che quel mondo pone e si pone. In particolare, credo che l’antropologia giudaico-cristiana abbia molto da dire all’ambiente hi-tech, perché porta avanti una riflessione fatta di etica incarnata, ad esempio quella proposta in Fratelli tutti e Laudato si’ di Francesco.
Alcuni libri recenti tracciano collegamenti intriganti tra la spiritualità e l’ambiente hi-tech. Per esempio, Appletopia. Media Technology and the Religious Imagination of Steve Jobs e Apple come esperienza religiosa (Mimesis), ma anche il recente La valle oscura (Adelphi), il memoir della startupper Anna Wiener. C’è qualcosa di religioso nell’uso della tecnologia digitale?
Sicuramente troviamo qualcosa di religioso nello sviluppo di tale tecnologia, in particolare nel senso antropologico in cui essa si sviluppa. Esiste qualcosa di sciamanico, un certo richiamo all’elemento magico e soprannaturale nel modo in cui la tecnologia si sviluppa. Prendiamo un esempio: nella Roma antica vi erano degli dei domestici che sovraintendevano alle necessità del nucleo domestico. Se ci pensiamo, è quello che chiediamo ai nostri device, ai quali demandiamo la sicurezza dei nostri appartamenti, l’uso dei nostri elettrodomestici, perfino la conoscenza sul tempo di domani, se pioverà o ci sarà il sole: una sorta di oracolo portatile! Insomma, ricorriamo a loro con un senso sciamanico. Non si va lontano dal vero quando si dice che la tecnologia ha qualcosa di magico. Quando sorge il pericolo? Quando lasciamo che siano i robot a fare il nostro lavoro e a garantirci la sicurezza al nostro posto. Quando la macchina si sostituisce all’uomo, allora sorgono i problemi. Essere umani è un fatto costoso e difficile, la macchina invece non rischia nulla.
Quali sono le sfide più grandi che la tecnologia digitale porta alla fede cristiana?
Se guardiamo al grande racconto biblico della Genesi, il peccato originale ci parla della nostra strutturale incompletezza. Adamo ed Eva sono incompleti, esiste in loro una breccia aperta all’altro e all’Altro. Il mondo, per l’autore biblico, non esiste solo per me. Io, da solo, non posso trovare la piena soddisfazione di me stesso: esiste una breccia che noi cristiani chiamiamo Dio e che si è fatto presente a noi in Cristo. L’uomo può chiudere questa breccia e questa apertura, con il peccato, dicendo di essere padrone e bastevole a sé stesso. Il pericolo che vedo per la tecnologia è il medesimo, quello di pensarsi capace di tutto da sola e di bastare a sé. L’uomo invece è strutturalmente questa relazione aperta all’alterità. E, infatti, quando Adamo ed Eva cercano di farlo da soli, si scoprono nudi, ovvero fragili. Se la tecnologia si concepisce autosufficiente, non c’è più bisogno né posto per Dio. Ma questa visione sarebbe quella di un’erronea chimera, perché la breccia si ripropone di continuo.
In fin dei conti, come cristiani bisogna temere la tecnologia digitale?
Seguendo Giovanni Paolo II, direi: ’Non abbiate paura!’. Il cristiano non ha paura di niente perché da tutto, anche dalla paura della tecnologia, l’ha liberato Cristo. Non c’è bisogno di distruggere gli apparecchi tecnologici, io non sono un luddista. Meglio comprenderli e farli comprendere. La paura è una cattiva consigliera.
Quale può essere il contributo del cristianesimo alla tecnologia digitale?
Tutte le realtà che portano avanti l’hitech, le varie aziende e i centri di ricerca, sono relativamente recenti e nuovi, mentre il cristianesimo ha una tradizione millenaria di pensiero e di pratica, comprovata dall’esperienza. Il mondo dell’hi-tech tende a costruire un ambiente ex novo, senza tempo né passato. Il cristianesimo invece ha una lunga comprensione dell’uomo, legge il mondo e la storia con gli occhi di Dio.
 In definitiva, il cristianesimo può offrire un’antropologia robusta e offrire un quadro di comprensione della realtà più vasto. Inoltre, tutto il deposito del pensiero sociale cattolico può risultare fecondo. Il fatto, per esempio, che la Chiesa sia stata la prima a dichiararsi contraria alla schiavitù ci parla di una capacità di giudicare la storia che merita attenzione e ascolto.
In definitiva, il cristianesimo può offrire un’antropologia robusta e offrire un quadro di comprensione della realtà più vasto. Inoltre, tutto il deposito del pensiero sociale cattolico può risultare fecondo. Il fatto, per esempio, che la Chiesa sia stata la prima a dichiararsi contraria alla schiavitù ci parla di una capacità di giudicare la storia che merita attenzione e ascolto. -
> PENSIERO LIQUIDO E CROLLO DELLA MENTE. ---MONDO DIGITALE E SCUOLA MEDICA SALERNITANA: "Dieci passi prima dell’eternità" (Gaetano Mirabella).29 gennaio 2021, di Federico La Sala#SCUOLAMEDICASALERNITANA e #MONDODIGITALE. "DIECI PASSI PRIMA DELL’#ETERNITA": #romanzo di #antropologia filosofica di #GaetanoMirabella (#Salerno, 2004) sul #corpo nuovo e sul #regno dei "#santi elettronici" di #DeKerckhove
-
> MONDO DIGITALE E SCUOLA MEDICA SALERNITANA: "Dieci passi prima dell’eternità" --- Salerno. Scuola Medica Salernitana candidata come Patrimonio Unesco: entrano nel vivo le iniziative.29 gennaio 2021, di Federico La Sala
Scuola Medica Salernitana candidata come Patrimonio Unesco: entrano nel vivo le iniziative
Le “conversazioni”, destinate alla città, hanno la funzione primaria di raccontare alcuni aspetti e momenti di un’istituzione fondante della memoria e dell’identità salernitana
di Redazione (SalernoToday, 26 gennaio 2021)
Entra nel vivo il lavoro che il Comune di Salerno, come Ente capofila, sta portando avanti per la candidatura della Scuola Medica Salernitana quale Patrimonio immateriale dell’umanità. Giovedì 28 gennaio (ore 18) inizieranno una serie di incontri (da remoto) che coinvolgeranno studiosi del settore. Il Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell’Università degli Studi di Salerno avvierà dal 28 gennaio un ciclo di “conversazioni” proprio sulla Scuola Medica Salernitana.
 Le “conversazioni”, destinate alla città, hanno la funzione primaria di raccontare alcuni aspetti e momenti di un’istituzione fondante della memoria e dell’identità salernitana. Una serie di studiosi, di competenze e provenienze diverse, dell’Università di Salerno e di prestigiose università italiane ed europee, metteranno in luce l’eredità scientifica e culturale della Scuola Medica Salernitana dal medioevo fino ai nostri giorni, i suoi protagonisti, le immagini, la memoria e le opere che le sono state dedicate nel corso della sua lunga esistenza, nonché le teorie e le terapie che la resero famosa in tutta Europa e che ancora oggi sono analizzate alla luce della moderna farmacopea.
Le “conversazioni”, destinate alla città, hanno la funzione primaria di raccontare alcuni aspetti e momenti di un’istituzione fondante della memoria e dell’identità salernitana. Una serie di studiosi, di competenze e provenienze diverse, dell’Università di Salerno e di prestigiose università italiane ed europee, metteranno in luce l’eredità scientifica e culturale della Scuola Medica Salernitana dal medioevo fino ai nostri giorni, i suoi protagonisti, le immagini, la memoria e le opere che le sono state dedicate nel corso della sua lunga esistenza, nonché le teorie e le terapie che la resero famosa in tutta Europa e che ancora oggi sono analizzate alla luce della moderna farmacopea.La responsabilità scientifica del programma del ciclo di “conversazioni”, che si terranno con cadenza settimanale, è delle professoresse Maria Consiglia Napoli e Amalia Galdi, del Dipartimento di Scienze del patrimonio culturale, quella tecnico-organizzativa è a cura di Mirò. Intanto, la Soprintendenza ABAP di Sa e Av, sempre nell’ambito delle attività comuni previste per la Candidatura Unesco della Scuola Medica Salernitana con il Comune di Salerno e le altre Istituzioni, presenterà un percorso narrativo, i video, tratti dalle immagini del Museo Virtuale che contengono la storia, i protagonisti, i saperi e le terapie della Istituzione salernitana. Nell’ambito del ciclo di conferenze proposte dall’Università di Salerno la dottoressa Adele Lagi, archeologa funzionario ABAP, terrà una comunicazione sugli scavi delle Terme di San Nicola della Palma, aspetto inedito e per la prima volta posto all’attenzione degli studiosi.
Inoltre, sarà attivato un progetto di Art Bonus e Fundraising a favore del ‘Museo Virtuale della Scuola Medica salernitana’, una strategia di avvicinamento dei cittadini al patrimonio culturale, perché donare per il patrimonio significa conoscerlo ed amarlo, con la partecipazione della “Fondazione della Comunità Salernitana onlus” di Salerno e con il supporto della Divisione Ales che gestisce e promuove l’Art bonus ed i rapporti pubblico-privato.
Tutti gli incontri si potranno seguire sulla pagine Facebook:
 Salerno Cultura - Comune di Salerno
Salerno Cultura - Comune di Salerno
 Comune di Salerno - Pagina ufficiale dell’Ente
Comune di Salerno - Pagina ufficiale dell’Ente
 DiSPaC - Università degli Studi di Salerno.
DiSPaC - Università degli Studi di Salerno.
-
-
> PENSIERO LIQUIDO E CROLLO DELLA MENTE --- Lo schermo connesso a internet. "A tu per tu con Derrick De Kerchove" (di Luca De Biase).29 gennaio 2021, di Federico La Sala
A tu per tu / Derrick De Kerchove
«Siamo immersi nei nuovi paradigmi dell’intelligenza connettiva»
Indiscusso maestro della cultura digitale, ricorda il singolare rapporto con Marshall McLuhan e riflette sui profondi cambiamenti sociali imposti dalla tecnologia della rete
di Luca De Biase *
- [Foto] Derrick de Kerckhove (Imagoeconomica)
Derrick de Kerckhove si teneva la testa tra le mani. Era solo, quella sera all’inizio degli anni Settanta, nella Coach House, la sede del Centre for Culture and Technology all’università di Toronto guidato da Marshall McLuhan. Si preparava ad abbandonare l’università e tutta la vita che aveva immaginato di vivere.
Sarebbe stato un peccato. Perché de Kerckhove era destinato a diventare un intellettuale originale, un cosmopolita della cultura, un provocatore non violento, capace di insegnare a milioni di persone un modo creativo di pensare i media digitali. Avrebbe aiutato a leggere con un taglio culturale una storia tecnologica destinata a diventare un gigantesco fenomeno economico-finanziario.
 Avrebbe diretto per un quarto di secolo il McLuhan Program a Toronto trovando i soldi per mantenerlo in vita nonostante una distratta ostilità dell’accademia, avrebbe tenuto corsi in diverse università, compresa la Federico II di Napoli, scritto libri come Brainframes (1993), Intelligenza connettiva (1997), L’architettura dell’intelligenza (2001), diretto riviste come «Media Duemila». E, senza perdere il suo distacco da intellettuale, avrebbe avuto una funzione impegnata, costruttiva, persino confortante. Anche nel pieno delle grandi crisi: dalla fine della bolla di internet del 2000 alla pandemia di questi giorni.
Avrebbe diretto per un quarto di secolo il McLuhan Program a Toronto trovando i soldi per mantenerlo in vita nonostante una distratta ostilità dell’accademia, avrebbe tenuto corsi in diverse università, compresa la Federico II di Napoli, scritto libri come Brainframes (1993), Intelligenza connettiva (1997), L’architettura dell’intelligenza (2001), diretto riviste come «Media Duemila». E, senza perdere il suo distacco da intellettuale, avrebbe avuto una funzione impegnata, costruttiva, persino confortante. Anche nel pieno delle grandi crisi: dalla fine della bolla di internet del 2000 alla pandemia di questi giorni.Eppure quella sera nella Coach House per lui tutto - passato e futuro - era perduto. Il giovane de Kerchhove era da qualche anno a Toronto per perfezionare i suoi studi in letteratura francese. Ma seguiva anche altri corsi. Comprese le lezioni di McLuhan. «Quell’uomo parlava con autorevolezza di cose che nessuno capiva. Ma ne parlava in modo tale che si desiderava ascoltarlo» ricorda.
 Quando «Le Monde» intervistò McLuhan, il professore chiese a de Kerckhove di rivedere il testo francese. Il ragazzo indicò i punti che avrebbero meritato qualche precisazione. McLuhan lo nominò traduttore ufficiale. «Fu una sorta di investitura nobiliare». Come conseguenza de Kerckhove contribuì alla produzione di due libri, Du cliché à l’archétype e D’œil à oreille: «Qualcosa di più di semplici traduzioni» ricorda de Kerckhove. «McLuhan mi telefonava anche alle due di notte per aggiungere idee che non erano presenti nella versione in inglese».
Quando «Le Monde» intervistò McLuhan, il professore chiese a de Kerckhove di rivedere il testo francese. Il ragazzo indicò i punti che avrebbero meritato qualche precisazione. McLuhan lo nominò traduttore ufficiale. «Fu una sorta di investitura nobiliare». Come conseguenza de Kerckhove contribuì alla produzione di due libri, Du cliché à l’archétype e D’œil à oreille: «Qualcosa di più di semplici traduzioni» ricorda de Kerckhove. «McLuhan mi telefonava anche alle due di notte per aggiungere idee che non erano presenti nella versione in inglese».De Kerckhove racconta questi suoi esordi passeggiando proprio davanti alla Coach House nella quale aveva vissuto quella serata di crisi nera. Interrotta dall’improvvisa entrata in scena di McLuhan in persona. «Lei sembra piuttosto triste» osservò il professore. «Ho deciso di lasciare l’università» rispose Derrick. «Che strana idea» commentò McLuhan, che volle una spiegazione. «Il problema è l’argomento della mia tesi di dottorato. Non mi interessa. Ma se non la finisco perdo il lavoro all’università».
 McLuhan gli chiese quale fosse l’argomento. «La decadenza dell’arte tragica nella letteratura francese del XVIII secolo». Il professore si sedette: «Lei non procede perché pensa che la tragedia sia una forma d’arte», disse McLuhan.
McLuhan gli chiese quale fosse l’argomento. «La decadenza dell’arte tragica nella letteratura francese del XVIII secolo». Il professore si sedette: «Lei non procede perché pensa che la tragedia sia una forma d’arte», disse McLuhan.
 «Perché? Che altro è la tragedia?», chiese de Kerckhove. «Secondo me, è un “quid”» sorrise McLuhan «una “quest for identity”: è una strategia inventata dai greci per superare la crisi di identità dovuta all’introduzione dell’alfabeto che aveva distrutto la cultura tradizionale». Silenzio. Il maestro aveva parlato. «Di colpo, la mia tesi non era più un cumulo di nozioni. Era un problema storico, antropologico, mediatico. Avevo un taglio col quale guardare a tutto quello che sapevo per creare qualcosa di nuovo».
«Perché? Che altro è la tragedia?», chiese de Kerckhove. «Secondo me, è un “quid”» sorrise McLuhan «una “quest for identity”: è una strategia inventata dai greci per superare la crisi di identità dovuta all’introduzione dell’alfabeto che aveva distrutto la cultura tradizionale». Silenzio. Il maestro aveva parlato. «Di colpo, la mia tesi non era più un cumulo di nozioni. Era un problema storico, antropologico, mediatico. Avevo un taglio col quale guardare a tutto quello che sapevo per creare qualcosa di nuovo».
 Quattro mesi dopo de Kerckhove aveva conseguito il dottorato. McLuhan era presente alla discussione e commentò compiaciuto: «La ricerca è un’attività magnifica quando si sa che cosa cercare».
Quattro mesi dopo de Kerckhove aveva conseguito il dottorato. McLuhan era presente alla discussione e commentò compiaciuto: «La ricerca è un’attività magnifica quando si sa che cosa cercare».Chi incontra oggi de Kerckhove lo definirebbe un “mcluhaniano non ortodosso”. Che poi, conoscendo McLuhan, è l’unico modo per essere un mcluhaniano. L’accademia, per lunghi decenni, non capì. La ricerca normale vive di esperimenti, pubblicazioni, metodo. Ma le ipotesi che la scienza empirica deve verificare vengono anche dall’immaginazione, alimentata da percorsi umanistici non sempre formali. Il maestro di de Kerckhove da questo punto di vista era un gigante. Seguiva un’ispirazione, che i conformisti non comprendevano, ma che lo sincronizzava col pubblico. «Come quando valutò il risultato del dibattito televisivo tra John Kennedy e Richard Nixon, nel 1960, dicendo che il primo era fresco (cool) e il secondo accalorato. E il fresco attira, mentre il caldo respinge». Per de Kerckhove, «McLuhan cercava le risonanze tra le idee». Era illuminante. «Viveva di una libertà intellettuale della quale non abusava ma, di certo, approfittava». Con ironia: «L’ho sentito dire: “Non le piace questa idea? Non importa, ne ho anche altre...”».
Negli anni Novanta, nel contesto generato da internet, de Kerckhove avrebbe avuto un ruolo fondamentale per la riscoperta del pensiero di McLuhan. «Eravamo molto diversi» ricorda de Kerckhove. «McLuhan aveva la capacità di arrivare a conclusioni giuste a partire da premesse completamente “fuori di melone”. La sua forza era di riuscire a vedere le conseguenze. Io cercavo le ragioni. Avevo studiato in Francia, del resto: Cartesio mi aveva segnato in modo indelebile».
De Kerckhove lo comprese incontrando Jean Duvignaud, uno dei fondatori della ricerca sulla sociologia dell’arte e dello spettacolo. Con Duvignaud, a Tours, studiò l’alfabeto, superando le intuizioni di McLuhan attraverso il ricorso alla neuroscienza.
 I media, per de Kerckhove, sono tecnologie che “incorniciano” il cervello conducendolo verso modelli di interpretazione coerenti alla loro struttura. L’alfabeto greco è una tecnologia che genera mutazioni nell’attività cognitiva. Per esempio, col riorientamento della scrittura da sinistra a destra si definisce il verso del tempo: «Nel pensiero scritto, si viene da sinistra e si va verso destra: il futuro è da quella parte».
I media, per de Kerckhove, sono tecnologie che “incorniciano” il cervello conducendolo verso modelli di interpretazione coerenti alla loro struttura. L’alfabeto greco è una tecnologia che genera mutazioni nell’attività cognitiva. Per esempio, col riorientamento della scrittura da sinistra a destra si definisce il verso del tempo: «Nel pensiero scritto, si viene da sinistra e si va verso destra: il futuro è da quella parte».
 Tutto questo si inserisce nel grande dibattito sull’oralità e la scrittura. «La scrittura ha separato lo spettacolo e lo spettatore, la conoscenza e il conoscente, il significante e il significato. Genera una razionalità: come osservava Walter Ong, nel mondo dell’oralità si riportavano i fatti l’uno accanto l’altro; nella scrittura si strutturano relazioni di causa ed effetto; si passa dall’orecchio all’occhio, diceva McLuhan, dalla giustapposizione di suoni all’architettura visibile del pensiero». La sua tesi francese non è pubblicata, ma resta una pietra miliare nell’ecologia dei media. In Brainframes, de Kerckhove avrebbe elaborato intorno al tema dei media come ambienti cerebrali.
Tutto questo si inserisce nel grande dibattito sull’oralità e la scrittura. «La scrittura ha separato lo spettacolo e lo spettatore, la conoscenza e il conoscente, il significante e il significato. Genera una razionalità: come osservava Walter Ong, nel mondo dell’oralità si riportavano i fatti l’uno accanto l’altro; nella scrittura si strutturano relazioni di causa ed effetto; si passa dall’orecchio all’occhio, diceva McLuhan, dalla giustapposizione di suoni all’architettura visibile del pensiero». La sua tesi francese non è pubblicata, ma resta una pietra miliare nell’ecologia dei media. In Brainframes, de Kerckhove avrebbe elaborato intorno al tema dei media come ambienti cerebrali.Ebbene. La nuova struttura fondamentale, secondo de Kerckhove, è lo schermo connesso a internet. «Ha conseguenze enormi, di portata simile e senso opposto all’alfabeto. Modifica la percezione, come suggeriva John Thackara, visionario del design. Modifica il cervello, come mostra Stanislas Dehaene, neuroscienziato. Ora siamo immersi nella conoscenza. Lo spettatore è lo spettacolo. I tempi si confondono, il passato e il presente sono meno distinti». E forma un’intelligenza “connettiva”: «Il concetto mi è stato suggerito da un artista per aiutarmi a superare la mia ritrosia a usare il termine “intelligenza collettiva” diffuso da Pierre Lévi. Persona molto gentile, Lévi mi dice: “Combattiamo la stessa battaglia intellettuale”.
 Temo di non essere d’accordo. Il collettivo è il risultato di un processo sociale che anonimizza le persone e omogeneizza i modelli di partecipazione. Una piattaforma invece connette persone che restano sé stesse». La cultura digitale è una complessa trasformazione. E continua a evolvere.
Temo di non essere d’accordo. Il collettivo è il risultato di un processo sociale che anonimizza le persone e omogeneizza i modelli di partecipazione. Una piattaforma invece connette persone che restano sé stesse». La cultura digitale è una complessa trasformazione. E continua a evolvere.
 Oggi sulla rete si sviluppa un doppio digitale per ciascun umano connesso. «Tutti i dati che si lasciano in rete sono ordinati, elaborati e analizzati per fornire informazioni, consigli, obblighi. Il doppio digitale è una rappresentazione della persona fisica che agisce nei diversi contesti, ricordando tutto.
Oggi sulla rete si sviluppa un doppio digitale per ciascun umano connesso. «Tutti i dati che si lasciano in rete sono ordinati, elaborati e analizzati per fornire informazioni, consigli, obblighi. Il doppio digitale è una rappresentazione della persona fisica che agisce nei diversi contesti, ricordando tutto.
 Questo “machine learning personale” può diventare un liberatore o un grande inquisitore. C’è bisogno di discutere sui diritti umani e di aggiornarli per questo contesto». Si sviluppa una sorta di sistema limbico globale che, appunto, proprio in questi giorni di pandemia rivela le sue conseguenze. «In Italia e in altri paesi occidentali l’emotività ha preso il sopravvento, i media tradizionali hanno ripreso l’emozione che circola in rete e le misure decise sono esagerate: Corea, o Singapore, dimostrano un atteggiamento completamente diverso con un uso razionale della rete».
Questo “machine learning personale” può diventare un liberatore o un grande inquisitore. C’è bisogno di discutere sui diritti umani e di aggiornarli per questo contesto». Si sviluppa una sorta di sistema limbico globale che, appunto, proprio in questi giorni di pandemia rivela le sue conseguenze. «In Italia e in altri paesi occidentali l’emotività ha preso il sopravvento, i media tradizionali hanno ripreso l’emozione che circola in rete e le misure decise sono esagerate: Corea, o Singapore, dimostrano un atteggiamento completamente diverso con un uso razionale della rete».Il mondo digitale: molti lo raccontano concentrando l’attenzione sugli oltre 4mila miliardi di dollari di capitalizzazione dei giganti di internet, citando incessantemente le ricchezze dei capitalisti del web, narrando le vicende degli startupper diventati miliardari, oppure ricordando le crisi dei settori rivoluzionati dal web, dall’editoria al commercio; in realtà, il mondo digitale è soprattutto una questione di conoscenza, di cultura, di mentalità.
 Di certo, la connessione tra il cervello e lo schermo non può essere solo tecnologica. Avrà sempre bisogno di qualcuno che, come de Kerckhove, la pensi in termini ecologici e culturali. Altrimenti gli umani subiranno, inconsapevoli, fino a che sarà troppo tardi. Le tecnologie spostano il limite del possibile. Ma la libertà è conoscenza. Le parole sono importanti.
Di certo, la connessione tra il cervello e lo schermo non può essere solo tecnologica. Avrà sempre bisogno di qualcuno che, come de Kerckhove, la pensi in termini ecologici e culturali. Altrimenti gli umani subiranno, inconsapevoli, fino a che sarà troppo tardi. Le tecnologie spostano il limite del possibile. Ma la libertà è conoscenza. Le parole sono importanti.*
Fonte: Il Sole-24 Ore, 31 marzo 2020 (ripresa parziale, senza immagine).
-
> PENSIERO LIQUIDO E CROLLO DELLA MENTE ---THE POINT OF BEING. Toward the Reunion of Sense and Sensibility (di Gaetano Mirabella)10 febbraio 2021, di Federico La Sala
The Point of Being
Edited by
Derrick de Kerckhove and Cristina Miranda de Almeida
Cambridge Scholars Publishing, 2014
- Current digital processes of production, reproduction and distribution of information affect the perception of time, space, matter, senses and identity. This book explores the research question: what are the psycho-physiological dimensions of the ways people experience their presence in the world and the world’s presence in them? Because they deal principally with issues of perception and sentience, with a particular emphasis on art, there is in all chapters an invitation to experience a shift of perception. An embodied sensation of the world and a re-sensorialization of the environment are described to complement the visually-biased perspective with a renewed sense of humans’ relationship to their spatial and material surrounding. As such, this book presents the topological reunion of sensation and cognition, of sense and sensibility and of body, self and world.
- The perception of the “Point of Being”, to which the various chapters of this book invite the reader, proposes an alternative to the “Point of View” inherited from the Renaissance; it offers a way to situate the sense of self through the physical, digital and electronic domains that shape physical, social, cultural, economic and spiritual conditions at the beginning of the twenty-first century.
- Nine authors explore different ways in which the paradigm of the Point of Being can bridge the interval, the discontinuity, between subjects and objects that began with the diffusion of the phonetic alphabet. The Point of Being is a signpost on that journey.
TABLE OF CONTENTSList of Figures............................................................................................ vii
Acknowledgements .................................................................................... ix
 Derrick de Kerckhove and Cristina Miranda de Almeida
Derrick de Kerckhove and Cristina Miranda de AlmeidaIntroduction ................................................................................................. 1
 Derrick de Kerckhove and Cristina Miranda de Almeida
Derrick de Kerckhove and Cristina Miranda de AlmeidaChapter One ................................................................................................. 9
 The Point of Being
The Point of Being
 Derrick de Kerckhove
Derrick de KerckhoveChapter Two .............................................................................................. 61
 Orbanism
Orbanism
 Rosane Araújo
Rosane AraújoChapter Three ............................................................................................ 79
 Toward the Reunion of Sense and Sensibility: The Body in the Age of Electronic Trans-nature
Toward the Reunion of Sense and Sensibility: The Body in the Age of Electronic Trans-nature
 Gaetano Mirabella
Gaetano MirabellaChapter Four ............................................................................................ 103
 The Interval as a New Approach to Interfaces: Towards a Cognitive and Aesthetic Paradigm of Communication in the Performing Arts
The Interval as a New Approach to Interfaces: Towards a Cognitive and Aesthetic Paradigm of Communication in the Performing Arts
 Isabelle Choinière
Isabelle ChoinièreChapter Five ............................................................................................ 147 The Aesthetics of the Between in Korean Culture
 Jung A Huh
Jung A HuhChapter Six .............................................................................................. 165
 Sensing without Sensing: Could Virtual Reality Support Korean Rituals?
Sensing without Sensing: Could Virtual Reality Support Korean Rituals?
 Semi Ryu
Semi RyuChapter Seven .......................................................................................... 197
 Between Sense and Intellect: Blindness and the Strength of Inner Vision
Between Sense and Intellect: Blindness and the Strength of Inner Vision
 Loretta Secchi
Loretta SecchiChapter Eight ........................................................................................... 213
 The Connective Heart
The Connective Heart
 Cristina Miranda de Almeida
Cristina Miranda de AlmeidaChapter Nine ............................................................................................ 297
 Quantum-Inspired Spirituality: Merging Science and Religion in the Post-Galilean Period
Quantum-Inspired Spirituality: Merging Science and Religion in the Post-Galilean Period
 Maria Luisa Malerba
Maria Luisa MalerbaEditors and Contributors .......................................................................... 335
-
> PENSIERO LIQUIDO E CROLLO DELLA MENTE. Sulle nuove frontiere della riflessione estetica --- In memoria dell’aura. La questione del digitale nei musei (di Lorenzo Taiuti).28 gennaio 2021, di Federico La Sala
In memoria dell’aura. La questione del digitale nei musei
Con la diffusione della pandemia, i musei devono sempre più veicolare i propri contenuti attraverso le nuove tecnologie. Ma che fine fa la componente fisica dell’opera d’arte?
di Lorenzo Taiuti *
- [Foto] Christopher Nolan, Inception (2011)
Nel film di Christopher Nolan Inception, travolgente riflessione sul rapporto fra spazio, memoria e sogno, fra architettura e mente, accade che le immagini inizino a tremare, le pareti crollino, la realtà sfugga alle leggi di gravità e si frantumi. La realtà è ricostruita digitalmente, una Realtà/Falso che vive nel sogno (artificiale, drogato) di uno dei personaggi. Quando qualcosa mette in dubbio la struttura narrativa e visiva creata, l’illusione si autodistrugge. Le forme dell’arte d’oggi sono basate su una serie di codici dove il rapporto fra visione e concetto ispiratore del lavoro crea un’architettura fragile, che si rinnova continuamente con elementi sempre nuovi e imprevedibili. Un effetto di “sfocatura” sulla realtà si accompagna sempre all’esperienza di visione di un lavoro creativo.
- [Foto] I cioccolatini Raffaello prodotti da Ferrero
LA STRATEGIA DEL VIDEO NEI MUSEI
Cosa succede al rapporto opera-utente quando questa percezione avviene attraverso un medium di riproduzione? Sta succedendo in musei e gallerie nel periodo della pandemia. I musei hanno per anni tenuto al minimo la strategia del video, nella sacra paura dei diritti d’immagine, della desacralizzazione dell’opera, della perdita di richiamo del museo quando i suoi contenuti diventano “pubblici”, della perdita di aura e di mistero. Il che vorrebbe dire, però, che la riproduzione delle opere di Raffaello su segnalibri, scatole di cioccolatini, pubblicità di intimo e quant’altro ha stancato l’attenzione del pubblico. La mostra di Raffaello alle Scuderie del Quirinale a Roma è stato un successo fra i maggiori. L’oggetto reale resta il punto centrale dell’esperienza estetica.
LA MEDIAZIONE TECNOLOGICA
Il problema è, al contrario, arrivare a costruire un’esperienza mediata dalla riproduzione tecnologica. È un problema di sempre. Il regista francese Henri-Georges Clouzot, nel suo famoso documentario su Picasso, arriva a tradurre l’esperienza statica della pittura in un “time based language” filmando l’atto del dipingere attraverso un vetro. Con i continui cambiamenti e modifiche apportati da Picasso al quadro, quest’ultimo diventava cinema, video, animazione.
Il recente spostamento online di Ars Electronica Festival ha tradotto tutto in video-online con un effetto dominante di “televisione digitale”. Le soluzioni per una virtualità online sono all’inizio, e si ricordano le esperienze della videoarte degli Anni Sessanta e Settanta, che proponevano sia la documentazione (happening, performance) sia l’uso parallelo del video in funzione estetica (come il cinema d’artista), che è un percorso cinetico attraverso idee, immagini e percezioni.
VERSO UN LINGUAGGIO DIGITALE DIFFUSO
Questa ricerca sull’immagine “comunicata” dell’arte si trasforma da “nell’epoca della sua riproduzione” (Walter Benjamin) a “nell’epoca della sua comunicazione”. Nuovi linguaggi comunicativi trasformeranno la testimonianza documentaria in prodotto estetico. Un esempio è il video applicato alla danza contemporanea, la “videodanza” degli Anni Ottanta, che ha portato a significative modifiche linguistiche, facendo aderire il video agli spazi e ai movimenti della danza.
 Per ultimo, ma non ultimo: quando l’olografia, il 3D e tante altre promesse iniziali del digitale diventeranno linguaggi diffusi? Si apriranno nuove strade.
Per ultimo, ma non ultimo: quando l’olografia, il 3D e tante altre promesse iniziali del digitale diventeranno linguaggi diffusi? Si apriranno nuove strade.* Fonte: Artribune, 28.10.2020 (ripresa parziale, senza allegati).
-
> PENSIERO LIQUIDO E CROLLO DELLA MENTE. - «L’umanità è ancora in rodaggio e siamo già nelle vicinanze della post-umanità. L’avventura è più che mai ignota»(Edgar Morin).2 aprile 2018, di Federico La Sala
Le frontiere della tecnoscienza
Se l’uomo si fa Dio
Intelligenza artificiale, bioingegneria, robot sono la nuova frontiera. E tornano a dividere i filosofi tra apocalittici e visionari. Che ne sarà della specie umana?
di Marco Pacini (l’Espresso, 01.04.2018)
Una delle fotografie più nitide di questo primo tratto di strada che abbiamo imboccato verso il “salto antropologico” l’ha scattata il sociologo e filosofo Edgar Morin all’alba del millennio: «L’umanità è ancora in rodaggio e siamo già nelle vicinanze della post-umanità. L’avventura è più che mai ignota». Come spettatori un po’ attoniti, sospesi tra l’ammirazione e l’inquietudine, assistiamo alla grande partita della tecnoscienza, dove la posta in palio è il futuro di una specie, la nostra. Lo chiamano post-human, senza nemmeno un accordo su un significato univoco. Ma la partita è iniziata da tempo e non può attardarsi in sottigliezze semantiche.
 Nella squadra A giocano i tecno-umanisti (o transumanisti), evangelisti di una religione che potremmo chiamare datismo: non siamo altro che sistemi di elaborazione dati e in quanto tali possiamo migliorare, cambiare la nostra natura senza porre limiti alle acquisizioni e applicazioni delle due discipline madri, informatica e biologia (intelligenza artificiale e ingegneria genetica).
Nella squadra A giocano i tecno-umanisti (o transumanisti), evangelisti di una religione che potremmo chiamare datismo: non siamo altro che sistemi di elaborazione dati e in quanto tali possiamo migliorare, cambiare la nostra natura senza porre limiti alle acquisizioni e applicazioni delle due discipline madri, informatica e biologia (intelligenza artificiale e ingegneria genetica).
 La squadra B schiera i postumanisti che anche quando salutano con favore la fine del dualismo natura-cultura, mettono in guardia sugli sviluppi “fuori controllo” della tecnoscienza e sul nuovo capitalismo cognitivo e genetico che potrebbe generare scenari distopici. E vorrebbero almeno aspettare l’arbitro, prima di iniziare la partita.
La squadra B schiera i postumanisti che anche quando salutano con favore la fine del dualismo natura-cultura, mettono in guardia sugli sviluppi “fuori controllo” della tecnoscienza e sul nuovo capitalismo cognitivo e genetico che potrebbe generare scenari distopici. E vorrebbero almeno aspettare l’arbitro, prima di iniziare la partita.
 Ma dell’arbitro sembra non esserci bisogno. Perché «tutto funziona, e questo è appunto l’inquietante», come disse allo Spiegel nell’ultima intervista postuma Martin Heidegger, antesignano del pensiero della (o sulla) tecnica.
Quell’intervista diventò un libro intitolato “Solo un dio ci può salvare”. E forse nemmeno di quel dio c’è più la necessità, dato che saremo noi stessi come specie, o una parte di noi, potenziati da dispositivi frutto della santa alleanza tra bioingegneria e informatica, a trasformarci in “Homo deus”, come ha suggerito lo storico del futuro Yuval Noah Harari.
Ma dell’arbitro sembra non esserci bisogno. Perché «tutto funziona, e questo è appunto l’inquietante», come disse allo Spiegel nell’ultima intervista postuma Martin Heidegger, antesignano del pensiero della (o sulla) tecnica.
Quell’intervista diventò un libro intitolato “Solo un dio ci può salvare”. E forse nemmeno di quel dio c’è più la necessità, dato che saremo noi stessi come specie, o una parte di noi, potenziati da dispositivi frutto della santa alleanza tra bioingegneria e informatica, a trasformarci in “Homo deus”, come ha suggerito lo storico del futuro Yuval Noah Harari.L’intelligenza si sta separando dalla coscienza, avvertono alcuni degli analisti del futuro postumano come Harari; e una volta liberata dalla coscienza l’intelligenza sviluppa una velocità vertiginosa. Quella dei postumani immaginati nei templi dello “human+” come Google e dei suoi sacerdoti come Ray Kurzweil. Gli esseri umani - assicurano - non sono più in grado di gestire gli immensi lussi di dati, sono arrivati al capolinea e ora potrebbero passare il testimone a entità di un tipo del tutto nuovo.
Scenario entusiasmante. O apocalittico, come pensa il filosofo Michel Onfray, che conclude il suo ultimo lavoro, “Decadenza”, con una diagnosi senza speranza: «Un pugno di postumani riuscirà a sopravvivere al prezzo di un’inaudita schiavitù delle masse, cresciute come bestiame (...) Le dittature di questi tempi funesti faranno passare quelle del Novecento per inezie. Google lavora oggi a questo programma transumanista. Il nulla è sempre certo».
Meno catastrofista, ma “in allerta”, Adam Greenfield, che in “Tecnologie radicali” rilette: «Non so cosa significherà essere umani nell’era della post-umanità (...). Capisco perfettamente perché chi crede, per quanto incautamente, che da queste circostanze (la post-umanità frutto del matrimonio tra I.A. e bioingegneria ndr) trarrà il massimo beneficio e un potere inattaccabile voglia arrivarci così in fretta. Quello che non capisco è perché lo vogliano anche gli altri».
Ma forse è inutile preoccuparsi di un futuro postumano alla Onfray, se dovesse realizzarsi la situazione in cui per la parola “umano” non ci sarebbe semplicemente più posto, con o senza prefisso. Lo ipotizza il filosofo Nick Bostrom (fautore del potenziamento umano e studioso dell’Intelligenza artificiale tra i più accreditati) nel suo ultimo saggio “Superintelligenza”: quando l’I.A. supererà quella umana potrebbe sterminare l’umanità intera. Sulla base di queste previsioni, nel gennaio 2015 Bostrom firmò una lettera aperta, sottoscritta da molti altri scienziati, tra cui Stephen Hawking, per mettere in guardia sui potenziali pericoli di uno sviluppo eccessivo dell’I.A.
Nel frattempo, finché con o senza “post” ci saremo, le frontiere continuamente superate dall’intelligenza artificiale e dall’ingegneria genetica (ne parlano negli articoli che seguono Nicoletta Iacobacci e Gianna Milano) pongono con sempre maggiore forza un problema. Anzi, il problema: ci spingeremo in dove si "può", o in dove si "vuole"?
È vero, l’ibridazione è già avviata da tempo. Siamo già in parte nel postumano. «La nostra seconda vita negli universi digitali, il cibo geneticamente modificato, le protesi di nuova generazione, le tecnologie riproduttive sono gli aspetti ormai familiari di una condizione postumana. Tutto questo ha cancellato le frontiere tra ciò che è umano e ciò che non lo è, rivelando le fondamenta non naturalistiche dell’umanità contemporanea», ha scritto la filosofa del posthuman Rosi Braidotti.
Ma forse una parte di ciò che la migliore fantascienza ci ha fatto intravedere e che si presenta ormai sotto forma di possibilità ulteriore, esponenziale, rappresenta un “salto” più che una continuità di questa condizione postumana. Ed è di fronte a quel salto che il “postumanesimo critico” rivolge interrogazioni sempre più pressanti alla tecnoscienza che “funziona” e procede. Segnalandole l’incrocio tra il si può e il si vuole.
 Il soggetto di quel volere dovrebbe essere un noi che si interroga ed è interrogato. Ma che per ora sembra assistere attonito alla partita senza arbitro. Ed è quasi inutile ricordare che l’arbitro assente è la politica, ormai da qualche decennio costretta ad arrancare dietro alla tecnoscienza e all’economia o al loro sodalizio (basti pensare agli algoritmi che ogni giorno sui mercati decidono autonomamente di spostare miliardi in nanosecondi).
Il soggetto di quel volere dovrebbe essere un noi che si interroga ed è interrogato. Ma che per ora sembra assistere attonito alla partita senza arbitro. Ed è quasi inutile ricordare che l’arbitro assente è la politica, ormai da qualche decennio costretta ad arrancare dietro alla tecnoscienza e all’economia o al loro sodalizio (basti pensare agli algoritmi che ogni giorno sui mercati decidono autonomamente di spostare miliardi in nanosecondi).Quel noi ha il volto, per esempio, di chi si vede uscire dalla mostra “Human+” (viaggio tecnoartistico sul futuro della specie, in corso a Roma al Palazzo delle esposizioni). E la cui espressione sembra dire: lo voglio o non lo voglio quel “più” per i miei figli e nipoti? Ma soprattutto: potranno deciderlo?
Il nuovo inizio è la vita
colloquio con Rosi Braidotti
di M.P. (l’Espresso, 01.04.2018)
«Quando si parla di postumano non si può parlare solo di ricerche neuronali, intelligenza artificiale, bioingegneria. Non c’è niente di nuovo su questo, solo un’accelerazione. Quello che dobbiamo fare è trovare una convergenza tra i saperi».
Raggiunta al telefono nel suo studio all’Università di Utrecht, dove insegna da anni, la filosofa italiana Rosi Braidotti prova a mettere ordine. A sottrarre il dibattito sul postumano ai singoli saperi, ai tecnologi e tecnocrati, per riconsegnarlo alla filosofia. O meglio al pensiero critico. Ha da poco pubblicato in inglese “The Posthuman Glossary”, scritto con Maria Hlavajova. Ma il suo lavoro principale è “Il Postumano”, uscito anche in Italia nel 2014 per DeriveApprodi.
Professoressa Braidotti, siamo all’ennesimo “post”, ma questa volta sembra decisivo.
«Sì, e chiama in causa insieme lo sviluppo tecnologico e le realtà sociali. Si può pensare all’accelerazione tecnologica come a una rivoluzione, ma anche una tragedia sociale, all’antropocene come alla catastrofe ambientale senza ritorno... C’è un clima di ansia. Ma io resto ottimista, perché può far scattare la convergenza tra i saperi, un pensiero critico ma non nichilista».
Il suo postumano parte dalla fine dell’antropocentrismo e dell’opposizione natura-cultura. Verso quale inizio?
«L’inizio è considerare la struttura vivente in sé vitale e contemporaneamente non naturalistica. Costruire un’etica non antropocentrica che consideri tutti i viventi, sperimentando le possibilità della scienza senza timori».
Non vede nelle istanze postumaniste e tecnoumaniste un prevalere di queste ultime ma nella forma di nuovi spazi di dominio?
«Sul postumano stanno lavorando le grandi compagnie della Silicon valley. Si deve ragionare su come il capitalismo cognitivo si è impossessato delle humanities. Si deve ricostruire un terreno comune per discutere su cosa sta accadendo. Il potenziamento umano è diventato centrale in queste discussioni e ciò che lo rende perverso è che lo presentano come l’ultimo capitolo dell’illuminismo. Io dico il contrario. La grande mutazione non avviene nel vuoto, ci sono le implicazioni sociali. Bisogna negoziare su che cosa siamo capaci di diventare. Riorganizzare i saperi, posizionarsi come cittadini, reinventarsi in un’emergenza epistemologica. Spinoza scrisse l’Etica per questo».
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
L’ARCHIVIO DEGLI ERRORI: L’ "IO SONO" DI KANT E L’ "IO SONO" DELL’"UOMO SUPREMO" DEI "VISONARI" DELLA TEOLOGIA POLITICA ATEA E DEVOTA. Note per una rilettura della "Critica della Ragion pura" (e non solo)
-
> PENSIERO LIQUIDO E CROLLO DELLA MENTE. - L’uomo nuovo arriva sul web. Dalla rivoluzione digitale emergono un’élite privilegiata e masse impoverite15 marzo 2018, di Federico La Sala
Società
L’uomo nuovo arriva sul web
Esce oggi il nuovo saggio di Massimo Gaggi (Laterza) sulle trasformazioni della vita e del lavoro
Dalla rivoluzione digitale emergono un’élite privilegiata e masse impoverite
di Aldo Grasso (Corriere della Sera, 15.03.2018)
Stiamo vivendo la più grande rivoluzione antropologica che l’umanità abbia mai conosciuto e non ce ne accorgiamo. O meglio, sì qualcosa intuiamo perché lo smartphone ci fa sentire al centro del mondo, perché siamo affascinati dalle infinite possibilità offerte da Internet e dai suoi motori di ricerca, perché siamo sui social e possiamo dire finalmente la nostra, perché leggiamo dei progressi raggiunti dalle biotecnologie che modificano e allungano la vita, perché l’intelligenza artificiale viene in soccorso alla nostra, che non sempre si è dimostrata all’altezza.
Come Fabrizio del Dongo ne La certosa di Parma di Stendhal siamo nel cuore di cambiamenti epocali: il marchesino vagava intorno all’umido campo di battaglia di Waterloo senza capire bene cosa stesse succedendo. Ci sono persone (lo scrivente appartiene al gruppo) che hanno una straordinaria capacità di manifestare sempre una sorta di inadeguatezza di fronte ai grandi cambiamenti. Insomma, sono prigionieri della famosa domanda che Fabrizio rivolge al tenente degli Ussari: «Signore, ma questa è davvero una battaglia?».
Sì è una grande battaglia, un vero e proprio sconvolgimento. Per fortuna, in veste di preziosa guida, è appena uscito un libro di Massimo Gaggi, Homo premium. Come la tecnologia ci divide (Laterza), che ci aiuta a fare i conti con una nuova realtà, ma soprattutto con una generale sottovalutazione dell’impatto che la rivoluzione digitale sta avendo non solo sul lavoro, ma anche sui rapporti sociali, sulla politica, persino sulla nostra salute. Intanto la Old Economy del petrolio è stata superata dai nerd della Silicon Valley, il mondo delle tecnologie digitali è dominato da cinque gruppi - Google, Amazon, Facebook, Microsoft e Apple - dietro i quali un numero crescente di voci denuncia la diffusione di pratiche oligopolistiche o, addirittura, la formazione di monopoli di fatto.
Tutto è connesso, tutto si tiene, tutto si smaterializza. Ma nel mondo digitale non tutto è oro quello che sberluccica e finché vivremo la tecnologia come gadget, come gratuità, come suggestione visionaria, rischiamo di essere travolti dalle macchine senza più essere in grado di dominarle. Gaggi ne è ben cosciente: «Questo libro nasce dalla convinzione - maturata in viaggi e incontri con esponenti di imprese tecnologiche negli Stati Uniti, oltre che nel confronto con esponenti politici e sociali americani, europei e anche italiani - di una generale sottovalutazione dell’impatto che la rivoluzione digitale sta avendo non solo sul lavoro, ma anche sui rapporti sociali, sulla politica e, addirittura, sulla salute dell’uomo».
 E la sottovalutazione non può che portare alla nascita di una figura sociale, tanto nuova quanto inquietante, quella che dà il titolo al libro, l’ homo premium. Chi è quest’uomo? È un uomo molto ricco, bello, fisico da atleta e intelligenza da Ivy League, ma è un uomo che si lascia alle spalle enormi gruppi sociali svantaggiati «che già oggi non solo conducono una vita più modesta, ma vivono anche mediamente di meno, come conseguenza di una serie di fattori sanitari, sociali, alimentari e legati all’istruzione, diversamente combinati nelle varie aree del mondo».
E la sottovalutazione non può che portare alla nascita di una figura sociale, tanto nuova quanto inquietante, quella che dà il titolo al libro, l’ homo premium. Chi è quest’uomo? È un uomo molto ricco, bello, fisico da atleta e intelligenza da Ivy League, ma è un uomo che si lascia alle spalle enormi gruppi sociali svantaggiati «che già oggi non solo conducono una vita più modesta, ma vivono anche mediamente di meno, come conseguenza di una serie di fattori sanitari, sociali, alimentari e legati all’istruzione, diversamente combinati nelle varie aree del mondo».È questo il mondo che ci attende al termine, se termine ci sarà, di questa rivoluzione continua? La favola della Silicon Valley, il mito di un mondo esteticamente migliore creato da Steve Jobs, il sogno della libertà a portata di tastiera sono finiti, esplosi come una bolla di sapone?
C’è una parola con cui dovremo fare i conti, perché è una delle chiavi del nostro domani, la parola è blockchain. L’economia del futuro potrebbe assumere le sue sembianze perché è una parola «nella quale qualche “evangelista” della rete già vede il vessillo di una riedizione, nel terzo millennio, della controcultura californiana degli anni Sessanta e Settanta, viene invocata per promuovere la democrazia diretta elettronica e una rivoluzione dell’organizzazione amministrativa dello Stato».
Più che una tecnologia, la blockchain è un paradigma che serve a interpretare il grande tema della decentralizzazione e della partecipazione, un modo destinato a rivoluzionare profondamente il sistema economico, modificando alla base i concetti di transazione, proprietà e fiducia. Per questo, com’è ovvio, esistono diverse declinazioni, diverse interpretazioni e diverse definizioni della blockchain . Per ora, si manifesta come un registro diffuso, dove si tiene traccia di ogni movimento senza possibilità di adulterazione, dato che sarebbe necessario alterare le migliaia di nodi su cui le transazioni vengono registrate. È usata, pur fra molte perplessità, per le criptovalute, tipo i bitcoin, ma alcuni sostengono che questa tecnologia cambierà la nostra vita, promette di mandare in pensione notai, servizi di cloud storage, votazioni cartacee, uffici brevetti, ecc.
Nel raccontare questi grandi cambiamenti, Gaggi non si abbandona alla tecnofobia, ma si mantiene saggiamente scettico, prudentemente sapiente. Non è come Fabrizio del Dongo. Ha ben chiara la situazione, se mai la condisce con una punta di amarezza pasoliniana. Se vivremo in un mondo dominato dall’intelligenza artificiale, diventeremo schiavi dei robot?
 «Nelle rivoluzioni precedenti - scrive Gaggi - le braccia dell’agricoltura erano passate all’industria e quando anche qui erano arrivati i robot, quelle delle fabbriche erano emigrate verso lavori di maggior contenuto cognitivo. Ma ora l’intelligenza artificiale comincia a sostituire anche molte mansioni intellettuali degli addetti ai servizi e di varie categorie di professionisti: analisti, medici, commercialisti, agenti di viaggio, giornalisti, perfino avvocati».
«Nelle rivoluzioni precedenti - scrive Gaggi - le braccia dell’agricoltura erano passate all’industria e quando anche qui erano arrivati i robot, quelle delle fabbriche erano emigrate verso lavori di maggior contenuto cognitivo. Ma ora l’intelligenza artificiale comincia a sostituire anche molte mansioni intellettuali degli addetti ai servizi e di varie categorie di professionisti: analisti, medici, commercialisti, agenti di viaggio, giornalisti, perfino avvocati».C’è il grande rischio che i nuovi leader politici siano persone che proclamino il loro impegno sociale con ispirati manifesti comunitari, ma che sorvolino sul fatto che per le loro reti sociali la parola comunità è solo sinonimo di fatturato. Tutto è connesso, tutto si tiene, tutto si smaterializza: dal Lider Maximo al Leader Premium.
-
> PENSIERO LIQUIDO E CROLLO DELLA MENTE. - LA "PROFEZIA" DI MARSHALL MCLUHAN E LA CONVIVIALITA’ DI IVAN ILLICH. Note..23 luglio 2017, di Federico La Sala
"X"- FILOSOFIA. LA FIGURA DEL "CHI": IL NUOVO PARADIGMA..... "CHI" SIAMO NOI IN REALTA’. Relazioni chiasmatiche e civiltà...
Possono esistere delle (nuove) tecnologie conviviali?
di Tiziano Bonini *
Stavo ascoltando la radio. Era un mese fa, il 7 giugno. Su Radio3 sento la voce di Derrick De Kerckove che parla di datacrazia, della supremazia dei dati. Mi fermo all’ascolto, poi interviene Belpoliti. Capisco che è un dibattito sulla memoria e sugli strumenti per preservarla, ma che verso la fine ha preso altre strade. La discussione è molto interessante, e come al solito, lascia più domande che risposte. La potete riascoltare per intero qui.
La discussione parte da un articolo di De Kerckhove pubblicato da La Stampa, in cui afferma che
- “Come ha scritto Umberto Eco, la verità è che stiamo perdendo la memoria, «quella personale, inghiottita dall’iPad, e quella collettiva, forse per la pigrizia di non voler comprendere il passato per capire il presente». (...) Ma adesso, tornando digitale on line, la memoria culturale emigra completamente fuori del mio corpo e se ne va nel cloud. Si chiama «amnesia digitale» da uso eccessivo di Google e smartphone. (...)
 Nella partecipazione immediata e permanente che intratteniamo con il mondo digitale, nell’accelerazione continua e nel total surround dell’informazione, sparisce l’intervallo necessario per riflettere e sostenere punti di vista”.
Nella partecipazione immediata e permanente che intratteniamo con il mondo digitale, nell’accelerazione continua e nel total surround dell’informazione, sparisce l’intervallo necessario per riflettere e sostenere punti di vista”.
Come ritrovare un equilibrio tra oblio e memoria, si chiede il terzo ospite al telefono, Maurizio Bettini? Belpoliti prova a rispondere che è collettivamente difficile, ma individualmente più facile.
Dovremmo darci più tempo, ridare valore agli intervalli di tempo che De Kerchove afferma essere stati azzerati dal digitale. È vero, abbiamo bisogno di più tempo per poter ricordare le cose, fissarle nella memoria, rielaborarle. Ma davvero basta imporsi una nuova “morale digitale”? o anche solo una personale, e difficilissima, autodisciplina? Belpoliti suggerisce che dovremmo passare più tempo da soli, annoiarci, passare qualche tempo in silenzio, riscoprire il valore dell’intervallo. Ricorda da vicino alcuni dei consigli contenuti nel felice libro di Sherry Turkle (di cui abbiamo parlato qui), anche lei suggeriva una nuova disciplina del rapporto tra individui e tecnologie di comunicazione mobile, basata su una maggiore consapevolezza individuale dei momenti in cui essere presenti insieme agli altri e dei momenti in cui ci si può assentare in comunicazioni con persone distanti da noi. Anche lei suggeriva la riscoperta del silenzio, della solitudine, dell’importanza di spazi di vita non mediati da tecnologie.
Tutti consigli sani, condivisibili, ragionevoli. Ognuno di noi prova a darsi delle regole, a disciplinare il proprio comportamento nei confronti di applicazioni che ci inondano di messaggi e notifiche (email, tweet, facebook, whatsapp, instagram). Da una parte non possiamo più farne a meno per gestire i diversi flussi di comunicazione che ci uniscono alle diverse reti sociali alle quali apparteniamo, dall’altra rischiamo di esserne troppo dipendenti e perdere tempo prezioso.
Belpoliti suggeriva la possibilità di una risposta individuale, ma credo che tutte queste forme di resistenza individuali assomiglino al vano tentativo di svuotare il mare con un bicchiere.
Forse, sul piano individuale, alcuni di noi possono anche trovare un equilibrio tra spazi di vita non mediati e spazi di immersione nei flussi comunicativi in mobilità, ma sul piano collettivo, l’onda provocata dalla diffusione di queste tecnologie è destinata a spazzare via vecchie abitudini e riconfigurare il nostro rapporto col tempo, con gli altri e con la memoria.
A meno che.
A meno che.
E qui vengo al mio timido argomento.
Le risposte individuali sono sicuramente utili, ma solo a noi stessi. Come coloro che provano a rispondere al cambiamento climatico attraverso un consumo consapevole delle risorse, a prendere di meno l’automobile e usare di più la bici, anche coloro che provano a sperimentare un consumo più consapevole dei media digitali, stanno cercando un complicato equilibrio che, se mai fosse possibile, serve soprattutto a chi lo ha trovato, ma non alla collettività. Cambiare abitudini di consumo può servire come esempio per gli altri, può essere il sintomo di un cambiamento collettivo, certamente, ma da solo questo cambiamento fa star bene solo noi stessi (è già qualcosa), rafforzando la nostra identità.
Servono risposte collettive. Provo qui ad abbozzare una risposta, che potrebbe diventare collettiva. Ma non è una proposta originale, perché non farò altro che recuperare e reinterpretare le parole di un vecchio pensatore scomparso, molto famoso negli anni settanta-ottanta ma ora un po’ dimenticato: Ivan Illich. In particolare, mi servirò del suo pensiero espresso in Tools for Conviviality (1973).
 In questo libro Illich affermava che per rendere gli uomini più autonomi, più liberi, più capaci di realizzare i propri desideri, bisognava innanzitutto progettare strumenti (tecnologie, istituzioni, relazioni) al servizio dell’uomo, strumenti in grado di liberare le potenzialità e la creatività umana, strumenti che non dividessero gli uomini in master e slaves, in padroni e schiavi. Questi strumenti, Illich li chiamava “conviviali”, in opposizione al modo di produzione industriale (fosse esso capitalista o socialista).
In questo libro Illich affermava che per rendere gli uomini più autonomi, più liberi, più capaci di realizzare i propri desideri, bisognava innanzitutto progettare strumenti (tecnologie, istituzioni, relazioni) al servizio dell’uomo, strumenti in grado di liberare le potenzialità e la creatività umana, strumenti che non dividessero gli uomini in master e slaves, in padroni e schiavi. Questi strumenti, Illich li chiamava “conviviali”, in opposizione al modo di produzione industriale (fosse esso capitalista o socialista).- “Le persone hanno bisogno non solo di ottenere delle cose, ma anche della libertà di costruirsi le cose di cui hanno bisogno per vivere, di dargli forma a seconda dei propri gusti (...) Ho scelto il termine conviviale per designare l’opposto della produzione industriale. Intendo con questo tutte quelle relazioni creative e autonome che intercorrono tra gli individui e tra gli individui e il loro ambiente. Considero la convivialità come quella libertà individuale che si realizza nell’interdipendenza tra persone” (p. 11).
Una società conviviale, proseguiva Illich, è una società che garantisce ad ogni suo membro il più ampio e libero accesso possibile agli strumenti in possesso della sua comunità.
Gli strumenti sono conviviali nella misura in cui possono essere facilmente usati da tutti per raggiungere obiettivi direttamente scelti dagli utenti stessi. Non richiedono una certificazione preventiva (un diploma, una laurea, un attestato) per essere utilizzati.
Illich fa alcuni esempi di strumenti conviviali. A noi interessano di più quelli legati ai media: il telefono per esempio, sarebbe uno strumento conviviale, perché permette a chiunque di dire ciò che si vuole a chi si vuole, senza che i burocrati possano restringere questa possibilità o si debba passare da un centro, un gatekeeper, per poter parlare con qualcuno. La televisione invece sarebbe uno strumento non conviviale. Seguendo il suo ragionamento, uno strumento sarebbe conviviale quando può essere liberamente manipolato e adattato ai bisogni di chi lo usa, non è sottoposto a un controllo centralizzato, può essere usato da tutti e amplifica la creatività di ognuno.
Teniamoci per ora questa definizione, poi ci servirà più avanti.
C’è una frase chiave nel libro di Illich che per me rappresenta la possibile risposta collettiva al bisogno individuato da Belpoliti, De Kerckhove e Bettini durante la loro discussione radiofonica: “Invertire la struttura profonda degli strumenti che utilizziamo” (p. 10).
Tradotto: non basta provare a darci delle regole individuali nella gestione delle tecnologie mobili che utilizziamo ogni giorno, perché quelle tecnologie sono progettate, a monte, per massimizzarne il consumo da parte nostra, come ha notato un noto interaction designer della Silicon Valley, Tristan Harris. Harris ha pubblicato su Medium un articolo dal titolo “How Technology Hijacks People’s Minds - from a Magician and Google’s Design Ethicist” in cui sostiene che i social media replicano il meccanismo delle slot machine. Il meccanismo psicologico che sta dietro le slot machine, prosegue Harris, è quello delle “intermittent variable rewards”, cioè delle ricompense intermittenti di natura variabile. Quando tiro la leva non so che tipo di ricompensa riceverò. Se i designer di tecnologia vogliono massimizzare la dipendenza, quello che devono fare è collegare l’azione di un utente (come tirare la leva della slot) con una ricompensa variabile. Tu tiri una leva e immediatamente ricevi in cambio un bel premio o anche niente.
La dipendenza è massimizzata quando la ricompensa è la più varia possibile: “diversi miliardi di persone hanno una slot machine nelle loro tasche: quando tiriamo fuori i nostri cellulari per controllare le notifiche stiamo tirando la leva di una slot machine. Quando clicchiamo “refresh” per aggiornare le nostre email, stiamo tirando la leva di una slot machine. Quando facciamo scivolare il nostro indice lungo lo schermo del telefono per aggiornare la bacheca di Instagram, stiamo giocando con una slot machine. Quando scorriamo i profili di potenziali partner su Tinder stiamo giocando con una slot machine.”
Se le tecnologie attorno a noi sono progettate per incanalare le nostre azioni entro determinati comportamenti di numero limitato, che possono essere misurati e quindi analizzati, gestiti e trasformati in previsioni di consumo futuro, ecco che il nostro potere contrattuale nei confronti di queste tecnologie è molto basso, e i nostri sforzi, la nostra “risposta individuale”, il tentativo di resistere alle affordances previste dalle tecnologie risulta debole, o irrilevante.
Qualcuno di noi potrà anche riuscire a trovare un giusto equilibrio personale tra i benefici delle tecnologie digitali e il tempo che succhiano e rubano ad altre attività più socievoli, ma questi tentativi non saranno che eccezioni.
La risposta collettiva, per me centrale, è invece quella di “invertire la struttura profonda degli strumenti che utilizziamo”, riappropriarci di questi strumenti, reclamarne il controllo, la possibilità di manipolarli, di deciderne le sorti, hackerarne non solo i contenuti, ma anche l’architettura con i quali sono stati progettati.
Un autista di Uber o un rider di Deliveroo non hanno alcuna voce in capitolo sulla piattaforma digitale che gli assegna il prossimo cliente. Non possono nemmeno reclamare se la piattaforma li blocca perché sono scesi sotto un certo livello reputazionale. Queste piattaforme digitali, di proprietà di un’unica corporation che ne controlla ogni minimo dettaglio, imponendone il funzionamento a tutti i suoi utenti, sono piattaforme anti-conviviali, direbbe Illich.
Dove gli utenti non hanno voce (tradotto: potere) nella progettazione di piattaforme e nei processi decisionali si creano i presupposti per la creazione di beni, flussi e servizi di tipo autoritario, top-down. E questo è ancora più pericoloso perché in molti settori e mercati, da quello del trasporto urbano (Uber), dell’ospitalità (Airbnb), della comunicazione interpersonale (Facebook), della logistica (Amazon), questo tipo di piattaforme autoritarie e anti-conviviali stanno guadagnando posizioni di monopolio (come spiega questo articolo del New York Times), all’interno delle quali gli utenti non avranno alternative. Per la comunicazione interpersonale dovremo sottostare al recinto di regole di Facebook, per il trasporto urbano a quelle di Uber e così via.
Nessuna di queste piattaforme ci permette di modificare gli algoritmi sui quali sono fondate o di fissare liberamente il prezzo del mio servizio di tassista o della mia casa in affitto.
La risposta collettiva è una risposta che ha a che fare con il design delle cose che usiamo, con un cambio di paradigma dei modi di progettazione delle tecnologie che usiamo e deve passare per una maggiore apertura della cultura del design, in parte già avvenuta, verso processi di progettazione più partecipativi. Dalla politica all’agricoltura, passando per la progettazione di piattaforme digitali, per realizzare una società più conviviale, bisogna aprire alla co-progettazione. In politica tramite la sperimentazione di processi di democrazia diretta (civic crowdfunding, per esempio?), in agricoltura seguendo le sperimentazioni d’avanguardia di un genetista italiano, Salvatore Ceccarelli, che propone il miglioramento genetico partecipativo dei semi, nelle piattaforme digitali lo sviluppo del platform cooperativism, che prevede lo sviluppo di piattaforme aperte e gestite in forma cooperativa.
Anche nella produzione e distribuzione dei contenuti, per esempio, si potrebbe applicare il concetto di convivialità. Può esistere un servizio pubblico dei media “conviviale”? Con Ivana Pais avevamo provato ad immaginarlo in questo articolo. Possono esistere algoritmi conviviali, co-progettati dagli utenti insieme ai designers e manipolabili ogni giorno? Pensate di aprire un servizio come Netflix e avere la possibilità di riprogrammare autonomamente l’algoritmo di Netflix perché quella sera avete voglia solo di film di registi brasiliani della new wave anni settanta, magari tramite un controllo vocale, o restringere l’offerta musicale di Spotify soltanto alla musica degli anni Novanta, e “mi raccomando, escludi per favore tutti i cantanti italiani”.
Se invertiamo la struttura profonda degli strumenti, forse possiamo esserne meno schiavi e ricavarne maggiori benefici. Ma questo significa invertire la struttura profonda del sistema di produzione di questi strumenti, ovvero, marxianamente, invertire l’economia politica che governa la produzione di questi argomenti e sostenere la creazione di tecnologie no profit, co-gestite, in varie forme tutte da sperimentare, dagli utenti stessi (come l’idea di trasformare Twitter in una cooperativa di proprietà degli utenti). Se il capitalismo di piattaforma conquisterà il monopolio delle piattaforme digitali disponibili sul mercato, la struttura profonda di questi strumenti risponderà a un solo imperativo, e sarà molto, molto lontano da quell’idea di società conviviale, attiva, socievole, “gracefully playful” che immaginava Ivan Illich.
p.s. Mi sono appassionato solo da qualche anno alla lettura di Ivan Illich. Sono nato nel 1977, quando già Illich aveva 51 anni e non l’ho mai conosciuto. La sua figura è molto controversa e discutibile (ho apprezzato molto il racconto di Franco La Cecla in Ivan Illich e la sua eredità, Medusa, 2013) e ci sono molte persone che conoscono il suo pensiero meglio di quanto possa averlo capito io, che mi sono avvicinato a lui dopo aver tradotto Making is connecting di David Gauntlett, un sociologo inglese che ha ripreso Illich per interpretare la nuova ondata di creatività supportata dalle tecnologie digitali. Credo però che tutti dovremmo rileggere La convivialità per trovare una risposta collettiva, più complessa e sistemica, alle domande che ci pongono le tecnologie digitali, sia come consumatori che come lavoratori. Invece di resistere loro, imponendoci un’ora di “disconnessione” o un mese di “detox” digitale, dovremmo lavorare di più con i designers, e progettarne altre, con altre regole, non fisse, discutibili e flessibili, ritagliabili sui nostri bisogni personali. Dovremmo poter essere proprietari dei nostri dati e decidere cosa farne e con chi condividerli. Dovremmo essere più liberi di quanto già adesso le tecnologie non ci fanno sentire.
È un discorso lungo e discutibile. Vorrei poterne parlare con designers, progettisti, sviluppatori, utenti. To be continued. O come scriveva Luther Blissett nell’ultima pagina di Q, “non si prosegua l’azione secondo un piano”.
* DoppioZero, 22.07.2017 (ripresa parziale - senza immagini).
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
"CHI" SIAMO NOI, IN REALTÀ. RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.
 LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. MARX, IL "LAVORO - IN GENERALE", E IL "RAPPORTO SOCIALE DI PRODUZIONE - IN GENERALE".
LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. MARX, IL "LAVORO - IN GENERALE", E IL "RAPPORTO SOCIALE DI PRODUZIONE - IN GENERALE".POLITICA, CONFLITTO D’INTERESSE, E ... "UNDERSTANDING MEDIA" ("GLI STRUMENTI DEL COMUNICARE"). I nuovi media non sono giocattoli e non dovrebbero essere messi nelle mani di Mamma Oca o di Peter Pan.
 LA "PROFEZIA" DI MARSHALL MCLUHAN: NARCISO E LA MORTE DELL’ITALIA.
LA "PROFEZIA" DI MARSHALL MCLUHAN: NARCISO E LA MORTE DELL’ITALIA. - “Come ha scritto Umberto Eco, la verità è che stiamo perdendo la memoria, «quella personale, inghiottita dall’iPad, e quella collettiva, forse per la pigrizia di non voler comprendere il passato per capire il presente». (...) Ma adesso, tornando digitale on line, la memoria culturale emigra completamente fuori del mio corpo e se ne va nel cloud. Si chiama «amnesia digitale» da uso eccessivo di Google e smartphone. (...)
-
> PENSIERO LIQUIDO E CROLLO DELLA MENTE. -- McLuhan ha ancora parecchio da dirci: «I media-mondo» (di Vanni Codeluppi)17 gennaio 2017, di Federico La Sala
- POLITICA, CONFLITTO D’INTERESSE, E ... "UNDERSTANDING MEDIA" ("GLI STRUMENTI DEL COMUNICARE"). I nuovi media non sono giocattoli e non dovrebbero essere messi nelle mani di Mamma Oca o di Peter Pan.
 LA "PROFEZIA" DI MARSHALL MCLUHAN: NARCISO E LA MORTE DELL’ITALIA. Il "rimorso di incoscienza" di Marshall McLuhan
LA "PROFEZIA" DI MARSHALL MCLUHAN: NARCISO E LA MORTE DELL’ITALIA. Il "rimorso di incoscienza" di Marshall McLuhan
 Cedere occhi, orecchie e nervi a interessi commerciali è come consegnare il linguaggio comune a un’azienda privata o dare in monopolio a una società l’atmosfera terrestre.
Cedere occhi, orecchie e nervi a interessi commerciali è come consegnare il linguaggio comune a un’azienda privata o dare in monopolio a una società l’atmosfera terrestre.
Cosa ci può dire ancora McLuhan?
di Vanni Codeluppi *
Il canadese Marshall McLuhan è stato probabilmente il più importante studioso dei media. È scomparso quasi quarant’anni fa, nel 1980, ma i principali concetti teorici che ha elaborato sono ancora notevolmente conosciuti e continuano in gran parte a essere efficaci per spiegare il funzionamento della comunicazione contemporanea. Certo, vanno sviluppati e aggiornati, dato il consistente tempo che è passato dalla loro comparsa. Ha dunque senso parlare ancora oggi di McLuhan se si è in grado di riprendere e migliorare le sue idee, come ha fatto in passato il suo allievo Derrick De Kerckhove in alcuni dei suoi migliori libri. Ma McLuhan può anche essere ripreso per collocarlo all’interno dell’evoluzione del dibattito culturale e cercare di sistematizzare quello che le sue idee hanno generato. È l’operazione tentata ad esempio di recente dallo studioso Paolo Granata all’interno del volume Ecologia dei media (Franco Angeli).
Non ha invece molto senso parlare inutilmente di McLuhan, forse per avere un titolo che sfrutta commercialmente il richiamo del suo nome. L’ha fatto Alberto Contri in un libro in uscita in questi giorni e intitolato appunto McLuhan non abita più qui? (Bollati Boringhieri). In tale libro il mediologo canadese viene utilizzato molto fugacemente e di fatto solo per dire che è superato e che il suo slogan più famoso «the medium is the message» (il medium è il messaggio) dev’essere sostituito con «the people is the message».
 Questo concetto era già stato sostenuto dieci anni fa da De Kerckhove, il quale lo riprende nella prefazione che ha scritto per il libro di Contri, ma è abbastanza discutibile. D’altronde, lo stesso De Kerckhove aveva anche detto dieci anni fa che «the medium is the message» andrebbe aggiornato con l’espressione «the network is the message», vale a dire che la Rete è il messaggio che viene fondamentalmente trasmesso dal medium Internet. -Una tesi con la quale si può decisamente concordare, perché Internet è un medium basato sullo sviluppo di reti di connessione e quindi in questo caso il suo messaggio è costituito dalle reti che consentono di sviluppare le relazioni sociali.
Questo concetto era già stato sostenuto dieci anni fa da De Kerckhove, il quale lo riprende nella prefazione che ha scritto per il libro di Contri, ma è abbastanza discutibile. D’altronde, lo stesso De Kerckhove aveva anche detto dieci anni fa che «the medium is the message» andrebbe aggiornato con l’espressione «the network is the message», vale a dire che la Rete è il messaggio che viene fondamentalmente trasmesso dal medium Internet. -Una tesi con la quale si può decisamente concordare, perché Internet è un medium basato sullo sviluppo di reti di connessione e quindi in questo caso il suo messaggio è costituito dalle reti che consentono di sviluppare le relazioni sociali.Ma, come si diceva, sulle teorie di McLuhan nel libro di Contri non c’è molto altro. D’altronde, non si possono avere molte aspettative di approfondimento teorico nei confronti di un libro che si presenta come un classico testo di un professionista della pubblicità. Un testo cioè che presenta molti casi aziendali e adotta un punto di vista decisamente pragmatico e spesso anche molto personale.
McLuhan invece, come si diceva, ha ancora parecchio da dirci. Tralasciando i suoi concetti più noti, ci si può ad esempio concentrare sull’idea che i media non possono essere considerati dei semplici strumenti che, mediante le loro rappresentazioni, aiutano le persone ad andare verso la realtà, ma degli elementi che tendono a porsi essi stessi come un mondo in cui entrare. Si presentano dunque come veri e propri “ambienti” sociali e culturali.
 McLuhan riteneva infatti che ogni nuova tecnologia comunicativa fosse in grado di dare origine a uno specifico ambiente umano e sociale: «Tutti i media ci investono interamente. Sono talmente penetranti nelle loro conseguenze personali, politiche, economiche, estetiche, psicologiche, morali, etiche e sociali da non lasciare alcuna parte di noi intatta, vergine, immutata. Il medium è il massaggio. Ogni interpretazione della trasformazione sociale e culturale è impossibile senza una conoscenza del modo in cui i media funzionano da ambienti» (Il medium è il massaggio, p. 26).
McLuhan riteneva infatti che ogni nuova tecnologia comunicativa fosse in grado di dare origine a uno specifico ambiente umano e sociale: «Tutti i media ci investono interamente. Sono talmente penetranti nelle loro conseguenze personali, politiche, economiche, estetiche, psicologiche, morali, etiche e sociali da non lasciare alcuna parte di noi intatta, vergine, immutata. Il medium è il massaggio. Ogni interpretazione della trasformazione sociale e culturale è impossibile senza una conoscenza del modo in cui i media funzionano da ambienti» (Il medium è il massaggio, p. 26).Questa intuizione di McLuhan che il medium può essere considerato come un ambiente è particolarmente felice e non è un caso che negli ultimi decenni diversi autori l’abbiano condivisa e sviluppata. Giovanni Boccia Artieri, ad esempio, ha sostenuto nel volume I media-mondo (Meltemi) che oggi abbiamo prevalentemente a che fare con dei «media-mondo». Cioè non semplicemente con degli strumenti di collegamento tra gli individui e la realtà, ma con veri e propri luoghi nei quali è possibile sperimentare la realtà e dare forma a delle relazioni sociali.
Nei luoghi immateriali creati dai media dunque gli individui sono in grado di fare la loro esperienza quotidiana di vita, esattamente come la possono fare all’interno dei luoghi fisici. D’altronde, va sottolineato che, secondo questa interpretazione, non è più possibile rintracciare una precisa distinzione tra la realtà e l’immaginazione, perché la realtà che viene percepita dalle persone è essenzialmente costituita da quella proveniente dai media.
 Anche lo studioso americano Joshua Meyrowitz ha riflettuto in Oltre il senso del luogo (Baskerville) sul ruolo svolto nella società da quei particolari tipi di ambienti che i media sono in grado di far sorgere. A suo avviso, i media hanno sempre dato vita a degli ambienti e gli ambienti fisici tradizionali e gli ambienti dei media non devono essere visti in contrapposizione, ma piuttosto come parti di un unico continuum. Sono infatti entrambi in grado di favorire le interazioni tra gli individui e di attivare tra questi dei flussi di tipo informativo. Questi processi attraverso i quali i media possono cambiare la natura dei confini che limitano le situazioni sociali hanno consentito ai media elettronici di operare anche come strumenti di democratizzazione della società, come strumenti cioè che hanno messo in collegamento ambiti un tempo nettamente distinti, riducendo l’importanza delle barriere sociali tradizionalmente esistenti.
Anche lo studioso americano Joshua Meyrowitz ha riflettuto in Oltre il senso del luogo (Baskerville) sul ruolo svolto nella società da quei particolari tipi di ambienti che i media sono in grado di far sorgere. A suo avviso, i media hanno sempre dato vita a degli ambienti e gli ambienti fisici tradizionali e gli ambienti dei media non devono essere visti in contrapposizione, ma piuttosto come parti di un unico continuum. Sono infatti entrambi in grado di favorire le interazioni tra gli individui e di attivare tra questi dei flussi di tipo informativo. Questi processi attraverso i quali i media possono cambiare la natura dei confini che limitano le situazioni sociali hanno consentito ai media elettronici di operare anche come strumenti di democratizzazione della società, come strumenti cioè che hanno messo in collegamento ambiti un tempo nettamente distinti, riducendo l’importanza delle barriere sociali tradizionalmente esistenti. - POLITICA, CONFLITTO D’INTERESSE, E ... "UNDERSTANDING MEDIA" ("GLI STRUMENTI DEL COMUNICARE"). I nuovi media non sono giocattoli e non dovrebbero essere messi nelle mani di Mamma Oca o di Peter Pan.
-
> PENSIERO LIQUIDO E CROLLO DELLA MENTE. -- Zygmunt Baumann: «Lo stato sociale è finito, è ora di costruire il “Pianeta Sociale”».10 gennaio 2017, di Federico La Sala
- DANTE: IL PARADISO TERRESTRE, UN PROGRAMMA PER I POSTERI. Note per una rilettura del "De vulgari eloquentia" e della "Monarchia"
Intervista a Zygmunt Baumann
UNA NUOVA POLITICA
di Alessandro Lanni (Reset Nov 2008) *
«Lo stato sociale è finito, è ora di costruire il “Pianeta Sociale”». Solo così, spiega Zygmunt Baumann, si potrà uscire dalla crisi globale che il mondo contemporaneo sta vivendo. La politica deve avere la forza di reinventarsi su scala planetaria per affrontare l’emergenza ambientale o il divario crescente tra ricchi e poveri. Altrimenti è con-dannata alla marginalità in una dimensione locale, con stru¬menti obsoleti adatti a un mondo che non esiste più. L’inventore della "società liquida" non crede in una capacità di auto-riforma della politica, «meglio costruire un’opinione pubblica globale e affidarsi a organizzazioni cosmopolite, extraterritoriali e non governative».
I nostri politici ce la faranno a cambiare paradigma, passando dal locale al globale?
«Io non conterei molto sui governi - di nessun paese, piccolo o grande che sia - e ancor meno sui loro tentativi di collaborazione, che finiscono regolarmente in una poesia di nobili intenzioni piuttosto che in una prosa di concreta realtà. I poteri che decidono sulla qualità della vita umana e sul futuro del pianeta sono oggi globali e dunque, dal punto di vista dei governi, sono extraterritoriali ed esenti dalla loro sovranità locale. Finché non innalziamo la politica ai livelli ormai raggiunti dal potere, le probabilità di arrestare gli sviluppi catastrofici cui stiamo conducendo la nostra vita sul pianeta sono, quantomeno, scarse».
Dunque, di quali strumenti alternativi dovrebbe dotarsi la politica per affrontare le grandi emergenze del nuovo mondo globale?
«L’obiettivo di arrestare le ineguaglianze globali che tendono a divenire rapidamente più profonde non compare tra le priorità delle agende politiche degli Stati-nazione più potenti, nonostante le tante promesse fatte al riguardo. Contemporaneamente, mancano ancora un’ "agenda politica planetaria" e delle istituzioni politiche globali efficaci e dotate di risorse che gli permettano di perseguire simili obiettivi rendendoli operativi. Le prerogative territoriali degli Stati-nazione ostacolano la creazione di tale agenda e di tali istituzioni e rendono ancora più difficile il tentativo di mitigare il processo di polarizzazione».
Gli Stati da soli non possono farcela. I singoli cittadini hanno qualche possibilità in più di mettere mano ai disagi che avvertono, per organizzare un’azione collettiva?
«Qui interviene quel fattore che è stato ampiamente descritto con il termine "individualizzazione". Con il progressivo abbassarsi della condizione di difesa mantenuta contro le paure esistenziali, e con il venir meno di accordi per l’autodifesa comune, come per esempio i sindacati o altri strumenti di contrattazione collettiva, depotenziati della competizione imposta dal mercato, spetta ai singoli trovare e mettere in pratica soluzioni individuali a problemi prodotti dalla società nel suo complesso. Ma fare tutto questo da soli e con strumenti per forza limitati risulta palesemente inadeguato al compito prefisso».
Anche il climate change è tra le grandi paure e insicurezze che l’uomo occidentale deve fronteggiare.
«L’insicurezza deriva dal divario tra la nostra generale interdipendenza planetaria e la natura meramente locale, a portata di mano, dei nostri strumenti di azione concertata e di controllo. I problemi più terribili e spaventosi che ci tormentano e che ci spingono a provare una sensazione di insicurezza e incertezza riguardo a tutto ciò che ci cir-conda hanno origine nello spazio globale che è al di là della portata di qualsiasi istituzione politica ora esistente; tuttavia questi problemi sono scaricati sulle entità locali - città, province e Stati - dove si pretende che vengano risolti con quei mezzi disponibi¬li a livello locale: un compito praticamente impossibile».
Eppure in molti sostengono che alcune questioni relative all’inquinamento, alla produzione d’energia, ai rifiuti, possono essere affrontate a livello «micro», di città, di governi locali.
«L’inquinamento atmosferico e la mancanza di acqua potabile sono questioni che traggono origine nello spazio globale, ma sono poi le istituzioni locali a doverle gestire. Lo stesso principio si applica al problema delle migrazioni, del traffico di droga e armi, del terrorismo, della criminalità organizzata, dell’incontrollata mobilità dei capitali, dell’instabilità e della flessibilità del mercato del lavoro, della crescita dei prezzi dei beni di consumo e così via. La sfera politica locale è sovraccarica di compiti e non è abbastanza forte o abbastanza dotata di risorse per svolgerli. Solo istituzioni politiche e giuridiche internazionali - finora assenti - potrebbero tenere a bada le forze planetarie attualmente sregolate e raggiungere le radici dell’insicurezza globale».
E un governo planetario che salverà il mondo?
«Allo stadio di sviluppo a cui è ormai giunta la globalizzazione dei capitali e dei beni di consumo, non esiste nessun governo che possa permettersi, singolarmente o di concerto con altri, di pareggiare i conti - e, senza che si pareggino i conti, è impensabile che si possano effettivamente mettere in atto le misure tipiche dello Stato sociale, volte a ridurre alla radice la povertà e a prevenire che l’ineguaglianza continui a crescere a piede libero. E’ altrettanto difficile immaginare governi capaci di imporre limiti sui consumi e aumentare le tasse locali ai livelli necessari perché lo Stato possa continuare a erogare servizi sociali, con la stessa intensità o con maggior vigore».
La globalizzazione cancella anche lo Stato sociale. Professor Bauman, non lascia speran¬za per un briciolo di giustizia e di eguaglianza nel mondo del XXI secolo?
«Non esiste una maniera adeguata attraverso la quale uno solo o più Stati territoriali insieme possano tirarsi fuori dalla logica di interdipendenza dell’umanità. Lo Stato sociale non costituisce più una valida alternativa; soltanto un "Pianeta sociale" potrebbe recuperare quelle funzioni che, non molto tempo fa, lo Stato cercava di svolgere, con fortune alterne. Credo che ciò che può essere in grado di veicolarci verso questo immaginario "Pianeta sociale" non siano gli Stati territoriali e sovrani, ma piuttosto le organizzazioni e le associazioni extra-territoriali, cosmopolite e non-governative, tali da raggiungere in maniera diretta chi si trova in una condizione di bisogno, sorvolando le competenze dei governi locali e sovrani e impedendogli di interferire».
* Segnalazione di don Aldo Antonelli.
-
> PENSIERO LIQUIDO E CROLLO DELLA MENTE. --- Il cambio di paradigma e la ricerca di un Nuovo Umanesimo per la Società Ipercomplessa (di Piero Dominici)14 gennaio 2016, di Federico La Sala
- "X"- FILOSOFIA. LA FIGURA DEL "CHI": IL NUOVO PARADIGMA. DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE.
Umanesimo digitaleIl cambio di paradigma e la ricerca di un Nuovo Umanesimo per la Società Ipercomplessa
di Piero Dominici (Tech-economy, 14/01/2016)
Umanesimo Digitale intende affrontare, senza alcuna pretesa di esaustività, alcune questioni estremamente complesse che coinvolgono ambiti disciplinari differenti e richiamano la nostra attenzione sull’importanza di una prospettiva sistemica, oltre che multidisciplinare, nell’analisi di “oggetti” che dobbiamo imparare a vedere/riconoscere come “sistemi” (e non viceversa) e che sfuggono alla tradizionali categorie e definizioni; e, nel far questo, la nostra riflessione si pone i seguenti obiettivi:
 a) provare a definire i “confini” di questa ipercomplessità, caratterizzata da limiti sempre più impercettibili tra natura e cultura, naturale e artificiale, tra umano e non umano, prestando particolare attenzione al contesto globale di riferimento o, per meglio dire, al “nuovo ecosistema” (1996) - che abbiamo successivamente definito Società Interconnessa;
a) provare a definire i “confini” di questa ipercomplessità, caratterizzata da limiti sempre più impercettibili tra natura e cultura, naturale e artificiale, tra umano e non umano, prestando particolare attenzione al contesto globale di riferimento o, per meglio dire, al “nuovo ecosistema” (1996) - che abbiamo successivamente definito Società Interconnessa;
 b) formulare ipotesi e domande - peraltro, in una fase in cui tutti propongono soltanto risposte e soluzioni semplici a problemi che sono, evidentemente, complessi - rispetto alla possibilità di un Nuovo Umanesimo per questa civiltà ipertecnologica e del rischio (Beck); un Nuovo Umanesimo che - come affermato più volte in passato - parta proprio dal ripensamento complessivo del sapere (come sapere condiviso, Dominici 2003), dello spazio tra i saperi (e, ad un secondo livello, tra le competenze) e, soprattutto, dello spazio relazionale (libertà è responsabilità*- centralità dei processi educativi); che ponga la Persona*, e non la Tecnica, al centro del complesso processo di mutamento in atto; un Nuovo Umanesimo che non consista soltanto nella - per certi versi - scontata, oltre che antistorica, riaffermazione di certi valori (fondamentali) magari calati dall’alto, in un contesto storico globale completamente differente, segnato da un preoccupante “vuoto etico”(Jonas), da indifferenza e torpore morale, da incertezza e precarietà divenute ormai condizioni esistenziali; dal trionfo dell’individualismo, di nuove asimmetrie e dal conseguente indebolimento del legame sociale.
b) formulare ipotesi e domande - peraltro, in una fase in cui tutti propongono soltanto risposte e soluzioni semplici a problemi che sono, evidentemente, complessi - rispetto alla possibilità di un Nuovo Umanesimo per questa civiltà ipertecnologica e del rischio (Beck); un Nuovo Umanesimo che - come affermato più volte in passato - parta proprio dal ripensamento complessivo del sapere (come sapere condiviso, Dominici 2003), dello spazio tra i saperi (e, ad un secondo livello, tra le competenze) e, soprattutto, dello spazio relazionale (libertà è responsabilità*- centralità dei processi educativi); che ponga la Persona*, e non la Tecnica, al centro del complesso processo di mutamento in atto; un Nuovo Umanesimo che non consista soltanto nella - per certi versi - scontata, oltre che antistorica, riaffermazione di certi valori (fondamentali) magari calati dall’alto, in un contesto storico globale completamente differente, segnato da un preoccupante “vuoto etico”(Jonas), da indifferenza e torpore morale, da incertezza e precarietà divenute ormai condizioni esistenziali; dal trionfo dell’individualismo, di nuove asimmetrie e dal conseguente indebolimento del legame sociale.
 Un Nuovo Umanesimo che deve necessariamente ridefinire certe categorie (umanità, identità, dignità, Persona, valore, diritti etc.) per poter ripensare l’essere umano nel mondo, all’interno di un rinnovato, oltre che complesso, rapporto con gli ecosistemi (torneremo anche sui “sistemi complessi adattivi”) e con innovazioni tecnologiche rivoluzionarie e, in molti casi, invasive.
Un Nuovo Umanesimo che deve necessariamente ridefinire certe categorie (umanità, identità, dignità, Persona, valore, diritti etc.) per poter ripensare l’essere umano nel mondo, all’interno di un rinnovato, oltre che complesso, rapporto con gli ecosistemi (torneremo anche sui “sistemi complessi adattivi”) e con innovazioni tecnologiche rivoluzionarie e, in molti casi, invasive.Il cambio di paradigma...l’evoluzione culturale condiziona quella biologica
Oggi infatti, come mai in passato, la tecnologia è entrata a far parte della sintesi di nuovi valori e di nuovi criteri di giudizio [1], rendendo ancor più evidente la centralità e la funzione strategica di un’evoluzione che è culturale e che va ad affiancare quella biologica, condizionandola profondamente e determinando dinamiche e processi di retroazione (si pensi ai progressi tecnologici legati a intelligenza artificiale, robotica, informatica, nanotecnologie, genomica etc.).
 In altre parole, nel quadro complessivo di un necessario ripensamento/ridefinizione/superamento della dicotomia natura/cultura, non possiamo non prendere atto di come i ben noti meccanismi darwiniani di selezione e mutazione si contaminino sempre di più con quelli sociali e culturali che caratterizzano la statica e la dinamica dei sistemi sociali. Sempre più difficile, oltre che fuorviante, provare a tenere separati i due percorsi evolutivi e, allo stesso tempo, sempre più urgente si fa la domanda di un approccio multidisciplinare alla complessità per l’analisi e lo studio di dinamiche (appunto) sempre più complesse, all’interno delle quali i piani di discorso e le variabili intervenienti si condizionano reciprocamente, mettendo a dura prova i tradizionali modelli teorico-interpretativi lineari.
In altre parole, nel quadro complessivo di un necessario ripensamento/ridefinizione/superamento della dicotomia natura/cultura, non possiamo non prendere atto di come i ben noti meccanismi darwiniani di selezione e mutazione si contaminino sempre di più con quelli sociali e culturali che caratterizzano la statica e la dinamica dei sistemi sociali. Sempre più difficile, oltre che fuorviante, provare a tenere separati i due percorsi evolutivi e, allo stesso tempo, sempre più urgente si fa la domanda di un approccio multidisciplinare alla complessità per l’analisi e lo studio di dinamiche (appunto) sempre più complesse, all’interno delle quali i piani di discorso e le variabili intervenienti si condizionano reciprocamente, mettendo a dura prova i tradizionali modelli teorico-interpretativi lineari.E, ancora una volta, non si tratta di essere “pro” o “contro”, anzi occorre andare oltre la sterile, ma sempre presente e puntuale, polarizzazione del dibattito che ha logiche radicalmente differenti da quelle della produzione e condivisione di conoscenza (potere): dobbiamo acquisire consapevolezza di trovarci difronte ad una trasformazione antropologica (1996) che, mettendo in discussione gli stessi presupposti basilari di pensiero, teoria e prassi, evidenzia ancora una volta l’urgenza di un cambio di paradigma - più volte echeggiato già negli anni Novanta - e la ridefinizione delle stesse categorie concettuali.
Il contesto: la Società Ipercomplessa
Per ciò che concerne il contesto globale di riferimento, abbiamo avuto modo di definirlo nel seguente modo: «La società interconnessa è una società ipercomplessa, in cui il trattamento e l’elaborazione delle informazioni e della conoscenza sono ormai divenute le risorse principali; una tipo di società in cui alla crescita esponenziale delle opportunità di connessione e di trasmissione delle informazioni, che costituiscono dei fattori fondamentali di sviluppo economico e sociale, non corrisponde ancora un analogo aumento delle opportunità di comunicazione, da noi intesa come processo sociale di condivisione della conoscenza che implica pariteticità e reciprocità (inclusione). La tecnologia, i social networks e, più in generale, la rivoluzione digitale, pur avendo determinato un cambio di paradigma, creando le condizioni strutturali per l’interdipendenza (e l’efficienza) dei sistemi e delle organizzazioni e intensificando i flussi immateriali tra gli attori sociali, non sono tuttora in grado di garantire che le reti di interazione create generino relazioni, fino in fondo, comunicative, basate cioè su rapporti simmetrici e di reale condivisione. In altre parole, la Rete crea un nuovo ecosistema della comunicazione (1996) ma, pur ridefinendo lo spazio del sapere, non può garantire, in sé e per sé, orizzontalità o relazioni più simmetriche. La differenza, ancora una volta, è nelle persone e negli utilizzi che si fanno della tecnologia, al di là dei tanti interessi in gioco»[2].
La Società Interconnessa e l’economia della condivisione (1998), da una parte, e le tecnologie, dall’altra, comportano, a livello locale e globale, un cambiamento di paradigma senza precedenti, che coinvolge direttamente il modo di produzione, i rapporti sociali e di potere (gerarchie, assetti e asimmetrie), lo spazio del sapere, la cultura. Un cambiamento di paradigma che, anche a questo livello, ha profonde implicazioni non soltanto per i sistemi sociali e le organizzazioni complesse, ma per gli stessi attori sociali (individuali e collettivi). L’attuale ecosistema della comunicazione determina anche un cambiamento radicale di codici, culture, modalità di produzione e condivisione, gerarchie (disintermediazione/re-intermediazione) - lo ripetiamo, una vera trasformazione antropologica - dalle numerose implicazioni anche, e soprattutto, in termini di cittadinanza e inclusione, con ricadute notevoli ancora una volta su identità e soggettività in gioco. Il rischio è che un mutamento di tale portata, legato a molteplici variabili e concause, si riveli non un’occasione irripetibile di innovazione sociale e mutamento, bensì l’ennesima opportunità per élites e gruppi sociali ristretti.
Per questa civiltà ipertecnologica, oltre ad una rinnovata attenzione per le regole e i diritti, occorre un approccio sistemico alla complessità, in grado di evitare spiegazioni riduzionistiche e deterministiche e di far dialogare “saperi” e competenze troppo spesso tenuti separati (scuola e università strategiche). L’economia interconnessa richiede scelte strategiche e una nuova sensibilità etica per le problematiche riguardanti gli attori sociali, il sistema delle relazioni e lo spazio del sapere: occorre, cioè, una nuova cultura della comunicazione, orientata alla condivisione e all’intesa, in grado di incidere sui meccanismi sociali della fiducia e della cooperazione.
 In tal senso, la ricomposizione di un contesto globale, che appare sempre più frammentario e disordinato - anche se occorre assolutamente definire strategie per oltrepassare le retoriche della “liquidità” - spetta alla comunicazione, intesa come processo sociale di condivisione della conoscenza*(1998) e di mediazione dei conflitti, sinonimo di socialità, “strumento” complesso di superamento dell’individualismo, piattaforma di connessione, cooperazione e produzione sociale delle conoscenze.
In tal senso, la ricomposizione di un contesto globale, che appare sempre più frammentario e disordinato - anche se occorre assolutamente definire strategie per oltrepassare le retoriche della “liquidità” - spetta alla comunicazione, intesa come processo sociale di condivisione della conoscenza*(1998) e di mediazione dei conflitti, sinonimo di socialità, “strumento” complesso di superamento dell’individualismo, piattaforma di connessione, cooperazione e produzione sociale delle conoscenze.L’obiettivo strategico (di lungo periodo) - come ripetuto più volte in passato - è la “vera” innovazione, quella sociale e culturale: un’innovazione in grado di realizzare sistemi sociali più aperti e inclusivi. A questo livello - lo ribadiamo con forza - la sfida all’ipercomplessità è una sfida in primo luogo conoscitiva, con teoria e ricerca/pratica che si alimentano vicendevolmente (!): una sfida che porta con sé un’assunzione di responsabilità, a livello individuale e collettivo: innovazione e inclusione non possono essere “per pochi”. Altrimenti termini come identità, diritti, cittadinanza, libertà, inclusione, meritocrazia, accesso, partecipazione, democrazia etc. saranno/si riveleranno parole “vuote”, funzionali soltanto a certe narrazioni sull’innovazione e sul digitale ed ad un certo discorso pubblico fin troppo conformista e omologante.
 [1] P. Dominici, Per un’etica dei new-media. Elementi per una discussione critica, Firenze Libri Ed., Firenze 1998; in questo lavoro, sono state riprese e ulteriormente definite, tra le altre, le seguenti definizioni: “nuovo ecosistema”, “trasformazione antropologica”, “individuo multimediale”, “economia e società della condivisione“, “nuove soggettività” e “nuovo umanesimo”. Temi e questioni che erano stati affrontati anche in precedenza (1996) e sulle quali ritorneremo con “Umanesimo Digitale”.
[1] P. Dominici, Per un’etica dei new-media. Elementi per una discussione critica, Firenze Libri Ed., Firenze 1998; in questo lavoro, sono state riprese e ulteriormente definite, tra le altre, le seguenti definizioni: “nuovo ecosistema”, “trasformazione antropologica”, “individuo multimediale”, “economia e società della condivisione“, “nuove soggettività” e “nuovo umanesimo”. Temi e questioni che erano stati affrontati anche in precedenza (1996) e sulle quali ritorneremo con “Umanesimo Digitale”.
 [2] Cfr. P. Dominici, Dentro la Società Interconnessa. Prospettive etiche per un nuovo ecosistema della comunicazione, FrancoAngeli, Milano 2014, p.9. Per ciò che concerne il concetto di “Società Ipercomplessa”, con relativa definizione operativa, è stato da me proposto alla metà degli anni Novanta e, successivamente, sviluppato in P. Dominici, La comunicazione nella società ipercomplessa. Istanze per l’agire comunicativo e la condivisione della conoscenza nella Network Society, Aracne, Roma 2005 e in La comunicazione nella società ipercomplessa. Condividere la conoscenza per governare il mutamento, Franco Angeli, Milano 2011 (Nuova ed.)
[2] Cfr. P. Dominici, Dentro la Società Interconnessa. Prospettive etiche per un nuovo ecosistema della comunicazione, FrancoAngeli, Milano 2014, p.9. Per ciò che concerne il concetto di “Società Ipercomplessa”, con relativa definizione operativa, è stato da me proposto alla metà degli anni Novanta e, successivamente, sviluppato in P. Dominici, La comunicazione nella società ipercomplessa. Istanze per l’agire comunicativo e la condivisione della conoscenza nella Network Society, Aracne, Roma 2005 e in La comunicazione nella società ipercomplessa. Condividere la conoscenza per governare il mutamento, Franco Angeli, Milano 2011 (Nuova ed.) -
> PENSIERO LIQUIDO E CROLLO DELLA MENTE. --- il cervello diviso e la costruzione del mondo occidentale. L’influenza del cervello nella politica e nella cultura secondo lo psicologo e filosofo britannico Iain McGilchrist.29 giugno 2015, di Federico La Sala
- PER LA CRITICA DELLA FACOLTA’ DI GIUDIZIO E DELLA CREATIVITA’ DELL’ "UOMO SUPREMO" (KANT).
 CREATIVITA’: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETA’ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE.
CREATIVITA’: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETA’ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE.
- Sul tema, si cfr. Federico La Sala, Le due metà del cervello, "Alfabeta", n. 17, settembre 1980, p. 11
Se a governare il mondo è l’emisfero sinistro
L’influenza del cervello nella politica e nella cultura secondo lo psicologo e filosofo britannico Iain McGilchrist
di Massimo Ammaniti (la Repubblica, 20.06.2015)
Probabilmente nessun editore italiano si lancerà nell’impresa di tradurre il libro di Iain McGilchrist The Master and His Emissary: The divided brain and the making of the Western World (Il Signore e il suo Emissario: il cervello diviso e la costruzione del mondo occidentale; Yale University Press) perché si tratta di un testo molto denso e corposo, più di 800 pagine nell’edizione americana. È sicuramente una perdita per gli studiosi e i lettori italiani perché il libro solleva interrogativi di grande originalità, rileggendo in una prospettiva diversa l’influenza esercitata dall’asimmetria dei due emisferi cerebrali, studiata in passato da Roger Sperry a cui fu assegnato il Premio Nobel.
La domanda che si pone McGilchrist, psichiatra e filosofo britannico, può sembrare inizialmente troppo riduttiva e semplificatrice: come può la specifica asimmetria cerebrale aver influito così tanto sulle caratteristiche delle varie società che si sono susseguite nell’Occidente?
Nella prima parte del libro vengono discusse le ricerche neurobiologiche degli ultimi decenni sulle modalità di esperienza dei due emisferi, quello sinistro considerato dominante perché legato al linguaggio, alla pianificazione e alla realizzazione, il polo razionale, mentre quello destro più legato alle emozioni, ossia il polo artistico. Questa concezione è ormai troppo scontata, secondo McGilchrist, sarebbe meglio parlare della diversa attenzione verso il mondo sancita dall’incapacità dell’emisfero sinistro di comprendere le metafore, legate alla figurazione di un significato originario, capacità questa più consona all’emisfero destro. E questa diversa attenzione interverrebbe nel cambiare e modificare il mondo che viene plasmato a seconda della supremazia di uno dei due emisferi.
Proprio come la storia raccontata da Nietzsche e che dà il titolo al libro, l’emisfero destro si comporta come il saggio e generoso signore di un paese con grandi risorse che non può governare da solo e pertanto è costretto a delegare i suoi emissari fra cui un visir, che ben presto si contrappone al suo signore pretendendo lui di governare.
È una storia antica come il mondo ma che si attaglia soprattutto a quello che sta succedendo nel mondo occidentale, che viene troppo condizionato dai dettami dell’emisfero sinistro. Le motivazioni esplicite di questo emisfero sono la competizione e la ricerca del potere che portano ad un mondo meccanico e privo di vita in cui c’è sempre meno spazio per il mondo implicito dell’affettività, dell’empatia e delle metafore.
Naturalmente McGilchrist non ritiene che sia il cervello a guidare la cultura, come anche il contrario, entrambi interagiscono e si plasmano vicendevolmente. Ripercorrendo i periodi storici dell’Occidente nell’antica Grecia viene ampiamente documentata la progressiva affermazione dell’emisfero sinistro con gli inizi della filosofia analitica, la codifica delle leggi e la formalizzazione della conoscenza.
Ma è con la rivoluzione industriale del Diciannovesimo secolo che l’emisfero sinistro diviene egemone, giungendo sempre più a dominare lo scenario del mondo della natura, a cui vengono contrapposte forme regolari, il quadrato, il rettangolo o il cerchio create dall’uomo, che possono essere riprodotte all’infinito anche in modo meccanico.
E ancora di più oggi nel periodo del post-modernismo con l’urbanizzazione crescente, l’espansione industriale a livello globale, la cultura tecnologica di massa si affermano desideri di possesso, competizione e rapporti d’uso che stanno soppiantando i legami e la continuità culturale. E’ la rivincita dell’emisfero sinistro, ma il prezzo che si paga è eccessivo, il senso di appartenenza ne viene indebolito e diventa difficile capire il contesto in cui si vive e i rapporti cogli altri con un distacco crescente.
Per ritornare al racconto di Nietzsche, la verità non è così unilaterale, non è solo colpa del Visir se si va incontro ad un conflitto disastroso forse anche il Signore illuminato non ha prestato abbastanza attenzione a quello che stava succedendo.
- PER LA CRITICA DELLA FACOLTA’ DI GIUDIZIO E DELLA CREATIVITA’ DELL’ "UOMO SUPREMO" (KANT).
-
> PENSIERO LIQUIDO E CROLLO DELLA MENTE. --- Inconscio digitale. I social network costituiscono un sistema integrato di pulsioni, desideri e frustrazioni che circolano alla velocità della luce modificando le percezioni e aggiornando la definizione di Freud.29 giugno 2015, di Federico La Sala
Inconscio digitale
Nell’era della trasparenza e dei Big Data, le emozioni online orientano in modo nuovo la lettura della realtà quotidiana
I social network costituiscono un sistema integrato di pulsioni, desideri e frustrazioni che circolano alla velocità della luce modificando le percezioni e aggiornando la definizione di Freud
di Derrick De Kerckhove (la Repubblica, 28.06.2015)
- Il sociologo e teorico della comunicazione Derrick de Kerckhove sarà protagonista martedì alle 18 a Milano, nello spazio espositivo The Waterstone di Intesa Sanpaolo, Official Global Partner di Expo Milano 2015, del quarto appuntamento del ciclo Sharing the World a cura di Giulia Cogoli Il suo intervento sarà dedicato al tema “Condivisione on-line e off-line”
Siamo entrati nell’era della trasparenza. Istantanea e onnipresente, la condizione digitale realizza una nuova forma di comunità virtuale molto particolare. I nostri smartphone ci rendono nodi di un ipertesto globale. L’essere costantemente connessi riduce il sentimento della solitudine perché tutti diventiamo sempre e ovunque raggiungibili. Siamo completamente trasparenti: un uomo connesso non è un uomo indipendente. Si tratta di un cambiamento di civiltà. Questa mutazione nasce da un nuovo matrimonio del linguaggio con l’elettricità. Ogni volta che il linguaggio umano cambia di medium cambia anche l’etica.
Nell’Occidente, superando il concetto di privacy, la gente sta perdendo il controllo della sua intimità. La società in cui viviamo divide la realtà in due spazi opposti e non sa ancora bene come integrarli tra loro: lo spazio “privato” e lo spazio che potremmo definire “invaso”. Si pensa generalmente che la nostra identità, il senso che abbiamo di noi stessi, sia una cosa privata, dove non si può entrare senza permesso. Ma nello “spazio invaso”, il “privato” si riduce notevolmente. Vivere concentrati su uno schermo per quasi tutto il nostro tempo porta a un rovesciamento dell’orientamento mentale. Invece di interiorizzare un’informazione nel silenzio della lettura, di meditarla dentro di noi, la pubblichiamo su Facebook e su Twitter. Lo spazio della Rete è essenzialmente relazionale: sposta l’attenzione e la comunicazione all’esterno di noi. Nei social media l’identità si costituisce come proiezione e distribuzione del sé fuori dal luogo del corpo.
In tanti ormai siamo consapevoli di essere tracciati completamente, però forse sottovalutiamo ancora che questa “invasione” va molto oltre lo sfruttamento dei dettagli personali inseriti su Facebook e su Twitter. La nostra vita diventa via via più trasparente nel moltiplicarsi di dati e di reti personali, attraverso social network e sistemi automatizzati che registrano le nostre attività sociali, economiche e culturali. I dati di tutti i nostri movimenti e azioni on e off-line - e tra non molto tempo, anche i nostri pensieri e sentimenti - vengono continuamente archiviati nelle banche dati del mondo.
Al tempo dei Big Data, basta sviluppare un programma che sceglie configurazioni di dati pertinenti per estrarre un’informazione che può servire a chiunque. Questa presenza di dati potenzialmente estraibili su ciascuno di noi è quello che chiamo l’“inconscio digitale”.
Il sapere della Rete veicola le forme del nostro inconscio digitale. Appare dunque interessante interrogarsi sulle sue modalità di definizione e di sviluppo, alla luce delle tensioni tra l’emisfero “razionale” e quello “intuitivo” del web, tra la funzione di analisi e quella di “cattura emozionale”. L’inconscio digitale prende forma e si sviluppa attraverso le diverse forme di sapere e di informazione che circolano nella Rete. Orienta la definizione della realtà quotidiana di ciascuno di noi e del mondo sociale in un processo connettivo che si nutre delle modalità di interazione tra gli individui. Rappresenta l’informazione - e la forma delle associazioni tra le informazioni - alla base dei nostri processi mentali e delle nostre azioni.
Con Freud, la psicoanalisi fonda la teoria della mente a partire dal concetto di inconscio. La dimensione inconscia è caratterizzata da istinti e desideri che non si manifestano a livello razionale e che, pertanto, non sono immediatamente controllabili. Tuttavia, tale dimensione guida e indirizza i comportamenti individuali.
L’inconscio digitale si caratterizza per la sua portata globale, per la straordinaria velocità attraverso cui consente l’accesso alle informazioni, per la possibilità istantanea di raccogliere e far emergere a livello cosciente una considerevole collezione di dati, correlati in diverse configurazioni in tempo quasi reale. Il problema principale non è legato all’uso etico delle tecnologie, benché questo sia senza dubbio preoccupante.
Il problema fondamentale è che, come al solito, la tecnologia cambia l’etica personale. Attraverso le tecnologie, l’etica della persona “individuale” diviene quella della persona “sociale”. Dobbiamo essere preparati, ricevere una corretta educazione e alfabetizzazione perché finora nessuno vieta nulla in Rete. In Rete non c’è un codice di convivenza civile. La mia ambizione è di proporre gli elementi di un’etica di condivisione e di trasparenza ormai indispensabile.
La vita emozionale in Rete è sviluppatissima. La gente sente sempre più il bisogno di condividere dettagli su di sé e sulle sue idee politiche. In Rete manca il senso del pudore. I social media trasportano le emozioni e le fanno condividere. Funzionano come un sistema integrato di pulsioni, desideri, frustrazioni, che circolano alla velocità della luce. I grandi movimenti a partire dalle primavere arabe, passando per Occupy Wall Street e Los Indignados, sono stati emozioni collettive e connettive che hanno attraversato frontiere e culture.
La scintilla che ha scatenato l’incendio è indubbiamente WikiLeaks. Dalla pubblicazione dei dispacci segreti su WikiLeaks alla rivolta in Tunisia c’è un passaggio non di strategie, ma di sentimento inconscio. WikiLeaks è stato un momento di risveglio sull’ipocrisia dei governi. Un’ipocrisia e una doppiezza in un certo senso necessari alla diplomazia, ma a tutto c’è un limite. C’è stata una richiesta di responsabilità nei confronti del potere. I nuovi media non hanno certo creato questo sentimento, tuttavia l’hanno reso visibile a livello locale e globale. Il ragazzo egiziano che vede ribellarsi il ragazzo tunisino si sente chiamato in causa, indipendentemente dalla distanza geografica. Lo stesso vale per tutti gli altri. Come diceva Marshall McLuhan, i linguaggi elettronici hanno fatto del mondo intero l’estensione della nostra pelle.
Nei media collegati alla Rete, si scatenano numerosi eventi cognitivi ed emotivi che passano da persona a persona, motivando alla condivisione di esperienza e all’azione politica. La mappa geopolitica del mondo intero è stata cambiata dall’arrivo sulla scena, attraverso la Rete, di una nuova classe politica, di un nuovo attore: la “massa interattiva”. Non è piu la massa anonima e amorfa del passato, quella della “Silent Majority”, della maggioranza silenziosa. Ora la maggioranza non tace più. La massa interattiva è il tipo di massificazione umana costituito dalle connessioni tra tanti individui che possono rispondere a modo loro a qualsiasi tipo di situazione. È una massa “connettiva”, non banalmente “collettiva”. Possiamo immaginare pure con Manuel Castells che si tratta della collaborazione fra tanti “mass individuals”. Le relazioni che si stabiliscono tra individui connessi sono molto più complesse e articolate di quelle che intercorrono tra singoli che formano una massa anonima. Sono una chiacchierata ininterrotta, una conversazione moltiplicata in un tempo infinito.
Questa nuova condizione di condivisione in tempo reale di informazione e di sentimenti e opinioni di ciascuno richiede un ordine emozionale che chiamo “sistema limbico sociale”. Ci troviamo di fronte a un benchmark , un momento di inizio che nessuno avrebbe potuto prevedere. I giovani e Internet stanno consegnando alla storia quel che ancora rimaneva in piedi del XX secolo. Il potere deve fare i conti con la potenza difficilmente contenibile delle intelligenze connettive messe in moto dal web.
Siamo in un momento storico paragonabile a quello della Rivoluzione francese. L’ambiente in cui la persona digitale vuole vivere quale sarà? Esistono segnali evidenti di una richiesta globale di correttezza politica, per una società della condivisione. Non dobbiamo dimenticare a questo punto il transculturalismo, e nello stesso tempo dobbiamo valutare con molta attenzione le resistenze, quasi criminali, di coloro che difendono lo status quo.
Lo scenario possibile dunque è una collaborazione interculturale a tutti i livelli, dove l’ambiente sarà l’oggetto della ritrovata unione dell’umanità, e la preoccupazione principale di tutte le culture insieme. La persona digitale non vorrà solo avere risposte sul clima dal suo gadget tecnologico, ma vorrà sapere come sta il mondo. Il futuro è una app che ci tiene informati sulla salute del mondo.
-
> PENSIERO LIQUIDO E CROLLO DELLA MENTE. --- Derrick de Kerckhove: Ho coeditato un libro, The Point of Being (Il punto di essere ...) per studiare la dimensione tattile del digitale e del mondo elettronico (di M. Dotti - Intervista).28 febbraio 2015, di Federico La Sala
Globalizzazione digitale
"Il vero potere è controllare la parola". Intervista con Derrick de Kerckhove
di Marco Dotti *
«Non è la prima mutazione antropologica subita dalla nostra civiltà, ma oggi», afferma Derrick de Kerckhove, «avviene su scala globale. Siamo passati dal solido al liquido, dall’era del punto di vista a quella del "punto di essere". Ma non dobbiamo allarmarci: nuove forme di cooperazione globale si sono messe in moto»
Il fatto che l’ìnnovazione sia alla base del cambiamento culturale è opinione talmente condivisa da risultare, talvolta, come quei luoghi comuni che contengono molto buonsenso, ma lo annacquano nel senso comune. Cultura e intelligenza sono patrimoni sociali che si stanno modificando, giorno dopo giorno, sotto i nostri occhi e di questa mutazione - che tocca ogni aspetto della sfera cognitiva - va presa consapevolezza.
Derrick de Kerckhove, sociologo di origine belga naturalizzato canadese, allievo di Marshall McLuhan, oggi docente all’Università Federico II di Napoli, da sempre si occupa di pratiche di collaborazione e intelligenza connettiva, ed è stato tra i primi a coniugare analisi dei media digitali e neuroscienze. Lo ha datto in lavori come Brainframes. Mente, tecnologia, mercato (Baskerville, 1992), La civilizzazione video-cristiana (Feltrinelli, 1995), La pelle della cultura (Costa & Nolan, 1996), La mente accresciuta (40k, 2014) e Psicotecnologie connettive (Egea, 2014).
Con l’artista e curatore dello ZKM di Karlsruhe Freddy Paul Grunert, Derrick de Kerckhove sarà a Milano, mercoledì 4 marzo alle ore 19.00, presso la Mediateca di Santa Teresa in via della Moscova 28, per un incontro Meet the Media Guru focus, organizzato in collaborazione con Fondazione Cariplo, dedicato alle imprese culturali e creative. Meet the Media Guru è un format ideato da Maria Grazia Mattei per promuovere il confronto con i protagonisti internazionali del dibattito su innovazione e new media e festeggia il suo decimo compleanno.
L’incontro, organizzato con il contributo di Fondazione Cariplo, è a ingresso libero, ma è necessaria l’iscrizione sul sito.
L’informazione crea il nostro ambiente. Ci circonda e ci plasma. Dentro questo ambiente abbiamo forse necessità di un punto di presa. Il tatto: è diventato questo punto di realtà, o di presa, nella nostra “era digitale”?
Derrick de Kerckhove: Ho coeditato un libro, The Point of Being (Il punto di essere, Cambridge Scholar Press, 2014) precisamente per studiare la dimensione tattile del digitale e del mondo elettronico. Il punto di essere rovescia l’approccio visuale tipicamente rinascimentale del “punto di vista”. Invece di stare di fronte dello spettacolo, la realtà virtuale mi porta dentro lo spettacolo. Pero è solo virtuale. Il punto di essere è la sensazione fisica della mia presenza nel mondo, della mia intima partecipazione corporale con la vita. Questa sensazione è disponibile per tutti dal momento che ci si pensa. È profondamente tattile, però è stata occultata dall’impero dell’occhio che ha prevalso nella sensibilità occidentale.
Sappiamo che ogni mezzo (medium) regola le relazioni tra l’uomo e l’ambiente, ampliando e amplificando i sensi e, di conseguenza, generando esperienza. L’uomo si adegua al mezzo, anche fisicamente. Organizza corpo e spirito in funzione del mezzo. Oggi, lei che organizzazione vede per questo corpo e questa mente?
Derrick de Kerckhove: Entrambi. corpo e mente, sono estesi (augmented). Estensioni sensoriali, proiezione del corpo nella robotica e nel virtuale in forma di avatars (con nuove possibilità, per esempio sparire o volare), aumento della mente con l’ambiente cognitivo della rete, tutto si esprime dapprima come un’esternalizzazione complessiva delle nostre facoltà mentali e del nostro potere di azione nella teleazione. Però, i progressi velocissimi della robotica sembrano segnalare un prossimo staccamento delle estensioni corporee. Cominciamo a chiederci se anche la mente aumentata si staccherà dagli utenti per sfruttare una nuova e forse pericolosa autonomia. Un’interiorizzazione delle nuove strutture mentalì può succedere all’esternalizzazione delle nostre facoltà. Però, un processo parallelo potrebbe accadere nei campi della cognizione aumentata. L’ambizione dell’Intelligenza Artificiale, aggiungendo la simulazione delle emozioni, è precisamente quella di rendere il robot più o meno autonomi da tutto.
Rispetto alla prevalenza dei tablet e degli smartphone - secondo il Global Mobile Survey, l’Italia è prima in Europa nell’utilizzo di smartphone - e delle funzionalità touchscreen, che ci rimanda appunto alla tattilità...
Derrick de Kerckhove: Appunto. Le tecnologie interattive sostengono la partecipazione, la risposta, l’uso della mano nella ricerca e la produzione dell’informazione. Il touchscreen è un ossimoro, un piccolo paradosso perché porta il tatto là dove apparentemente non c’entra, ossia dentro il mondo visuale. Il ritorno dell’utente, immerso nel virtuale, torna a chiedere l’interfaccia manuale nella gestione dell’informazione. Dobbiamo anche capire che il ruolo del cursore sullo schermo interattivo è la traduzione tecnologica della funzione di ricerca cognitiva che si attua quando nello nostro pensiero puntiamo su qualche oggetto. Abbiamo infatti un cursore invisibile nella nostra mente, un cursore che “tocca” i bottoni neurologici del nostro immaginario. Più virtualmente viviamo, più necessitiamo la presenza e la prova del corpo. Questo è un fatto controevidente ma che va assolutamente capito.
Una recente ricerca ci dice che il 35% degli intervistati controlla il proprio smartphone entro 5 minuti dal risveglio, il 55% entro 15 minuti. Questi dati, solitamente, allarmano i giornalisti. Lei come li leggerebbe? (Mi riferisco in particolare all’interconnessione locale-globale che è al centro di tanti suoi lavori).
Derrick de Kerckhove: Non c’è niente di cui allarmarsi. La connessione permanente di tutti con tutti e tutto è la prima condizione di vita introdotta non solo dal digitale, ma dalla natura propria dell’elettricità.
Torna alla mente una predizione, del 1962, di McLuhan sul futuro dei media. Il prossimo medium, qualunque esso sia, scrivevae McLuhan, "€“potrebbe essere l’€™estensione della coscienza e includere la televisione come contenuto, non come ambiente, e la trasformerà in una forma d’€™arte. Un computer come strumento di ricerca e di comunicazione potrebbe potenziare il recupero di informazioni, rendere obsoleta l’€™organizzazione delle biblioteche, ripristinare la funzione enciclopedica dell’€™individuo e trasformarsi in una linea privata di accesso a dati rapidamente confezionati di natura vendibile".
Derrick de Kerckhove: McLuhan ha fatto capire che alla base dei profondi cambiamenti in corso a partire dell’invenzione del telegrafo in avanti c’è stato l’elettricità che, secondo lui è tattile. Le connessioni elettroniche non sono propriamente “informazioni”, sono comandi. Il discorso piu rappresentativo dell’elettricità è il tweet, breva parola poco articolata per dare senso, fatta piuttosto per dare una scossa nervosa, un ordine. Intanto, se sento l’assoluto bisogno di vedere il mio smartphone appena sveglio, la ragione è perché la mia realtà cognitiva non è piu limitata all’interno della mia coscienza, ma si estende al mondo intero. La connessione mi riassicura sul fatto che sono sempre parte del mondo e che il mondo fa parte di me. La vera globalizzazione è questa.
Questa generazione always on costruisce però la propria identità, non solo la propria attestazione di presenza o la propria reputazione attraverso i social network. Crede che l’avvento degli algoritmi di lettura dei Big Data possa se non mutare l’approccio di questa generazione, allarmarla e allarmarci rispetto all’uso impersonale, meramente quantitativo, che si configura, non solo tanto nel marketing, quanto nel controllo biopolitico complessivo?
Derrick de Kerckhove: Di nuovo, se si trattava di allarmarci la gioventu always on l’avrebbe già fatto sapere. Invece hanno inventato Snapchat per nascondere i loro scambi di notizie, foto e video. Inoltre, i sondaggi rivelano che benché i ragazzi siano coscienti del fatto che ormai sono tracciabili ovunque, non si preoccupano troppo e pochi tra di loro usano metodi per nascondersi. Il fatto che i Big Data non ci minaccino veramente dà sostanza alla provocazione di Mark Zuckerberg quando diceva: “Privacy is over”. Si tratta di un cambiamento di civilizzazione in corso. Io vedo l’arrivo dell’era della trasparenza. Siamo passando della cultura dell’opacità, quella della lettera, della carta, dell’identità privata a quella dei Big Data, dell’inconscio digitale dove tu non sai tutto ciò che si sa o che si può sapere su di te. Come puoi non riciclare rifiuti o non pagare le tasse quando si sa immediatamente che non l’hai fatto? La buona notizia è che si puo sperare nel ritorno del senso dell’ onore proprio grazie a questa cultura della trasparenza.
Il suo intervento del 4 marzo a Meet the Media Guru toccherà due temi: innovazione e cultura. Ci può anticipare qualcosa di questo suo intervento?"
Derrick de Kerckhove: È ormai un fatto riconosciuto che il PIL nazionale dipende o almeno corrisponde strettamente alla proporzione di creativi presenti nella forza-lavoro complessiva. Nel 2010, l’Italia occupava la 34ª posizione su 39 paesi paragonati, con il 14% di creativi in tutte forme d’impiego contro il 30% dell’Olanda, il 29% della Finlandia e meno del 40% per gli Stati Uniti. Un’importante ricerca (Richard Florida, Creativity Group Centre) aggiunge: “Questa classe creativa è composta da giovani brillanti e talentuosi: professionisti, scienziati, dirigenti, musicisti, medici, scrittori, stilisti, ricercatori, avvocati, giornalisti, designer, imprenditori e così via”.
La cosa la piu urgente al fine di collegare la cultura all’innovazione è dare modo ai giovani Italiani di realizzare i progetti innovativi che abbiano familiarità con le nuove tecnologie. In Italia, va superato l’atteggiamento dei giovani verso i dirigenti di governo, della Pubblica Amministrazione e delle banche. Troppa diffidenza. Perché, invece, non provare a immaginare davvero strategie che mettano Stato, banche, comuni e PA insieme per veramente una nuova spinta alla creatività, alle start-up, al benessere produttivo di questi giovani ? A partire dei ultimi dati, risalenti al 2014, voglio presentare un progetto concreto per favorire lo sviluppo di una cultura creativa focalizzata sui giovani. I giovani sono i più trascurati nel sistema socio-politico Italiano, ma sono anche quelli più facilmente coinvolgibili.
In Inghilterra, 1 bambino su 8 avrebbe pronunciato la prima parola, magari dicendo il classico “mamma”, ma non rivolgendosi a lei. Rivolgendosi, piuttosto, a un medium (tablet o smartphone). Per i bambini, muovere un dito su uno schermo, aprire finestre, stabilire connessioni, inserirsi in reti è diventato naturale. Siamo davanti a una profonda mutazione antropologica che deve allarmarci o anche questo è il segno di una inevitabile riconfigurazione del nostro ambiente/orizzonte culturale?
Derrick de Kerckhove: Un video, oramai famoso, postato su YouTube, ritrae una una bimba di 1 anno che si arrabbia contra una rivista di moda poiché le fotografie non rispondono al suo tentativo di muoverle come accadrebbe invece sul suo iPad. Vale aggiungere che allarmarci non serve, serve però capire dove stiamo andando. Non è la prima mutazione antropologica che l’umanità ha vissuto, certamente, adesso, però, questa mutazione è globale.
Questa riconfigurazione “touch” dell’era digitale inciderà positivamente sulla plasticità neurale delle nuove generazioni? Sulla loro mente e sul loro corpo, intendo...
Derrick de Kerckhove: Nei miei interventi pubblici prima di Natale suggerivo ai genitori di offrire una piccola e poco costosa stampante 3D ai loro figli per stimolarne la creatività. Una creatività non solo pratica, ma anche mentale. La stampante 3D rinforza la tattilità del nostro rapporto con la creazione, offrendo il volume alla nostra inventività. Potrebbe iniziare da qui una metamorfosi epistemologica. Si tratta di pensare in 3D, di partecipare nello spazio mentale creativo. Ricordo ancora il mio stupore davanti i primi lavori di Warren Robinett nel laboratorio HMD all’università di North Carolina sotto la direzione di Henry Fuchs nell’inizio degli anni ’90. Avevano creato un software di realtà virtuale che permetteva all’utente di occupare lo spazio tri-dimensionale proprio durante la sua creazione. Ci vedevo le precondizioni di un cambiamento cognitivo che sta avvenendo solo adesso con la larga diffusione della cultura 3D.
Che destino vede per la scrittura? Toccare non è scrivere e scrivere, forse, non è più così necessario. Eppure, il nostro continua a essere un “cervello che legge” (e scrive). O è già diventato altro?
Derrick de Kerckhove: Il destino della scrittura e della lettura su carta è di rinforzare la nostra identità, le nostre caratteristiche personali. Non si perderà mai, perché un giorno le grandi istituzioni educative capiranno che solo la pratica individuale della lettura e della scrittura concede un vero potere sul linguaggio. Va bene toccare e by-passare il linguaggio, però il vero potere dell’individuo, anche dell’individuo immerso nella connettività della rete, è la misura del suo controllo della parola e della gestione del discorso nella sua mente. Anche se è vero che il cambiamento epocale in corso non rispetta la privacy, la nostra trasparenza non elimina le nostre capacità né il talento individuali. Per gli individui il controllo del linguaggio è capitale.
* VITA, 25 febbraio 2015 (ripresa parziale - senza note).
-
> PENSIERO LIQUIDO E CROLLO DELLA MENTE. --- "Della terra il brillante colore". Una nota di Gaetano Mirabella8 febbraio 2015, di Gaetano Mirabella
"Della terra il brillante colore". Una nota
Un doveroso omaggio va a Federico La Sala, autore del libro "Della terra il brillante colore" Ed. Nuove scritture, Milano, 2013, nel quale l’autore ridisegna la storia, la memoria e il nuovo assetto del soggetto, attraverso un libro che può considerarsi un brillante esempio di letteratura di frontiera. Con il brillante colore la terra ha mostrato le radici di un "vuoto generante", questo vuoto è autopoietico e prosegue come viatico per una nuova mente, alla ricerca di percorsi cognitivi legati a nuove intuizioni riguardo alla terra.
Dal vuoto generante della "terra" che compone le mura di una chiesa di Contursi (Salerno) e dei suoi affreschi del ’500, il testo dell’amico La Sala, rimanda, risale e allude all’elemento silicio inteso come segno del "luogo senza luogo" dei circuiti prestampati di "vetronite ramata", ovvero della pasta di "fibra di vetro" che costituisce i circuiti prestampati dei computer.
Così come il colore delle tempere delle dodici Sibille percorre lo spazio vuoto che dalla meditazione conduce alla fede nell’Assoluto, allo stesso modo il vuoto del silicio della terra (vetronite ramata), come calligramma della distopia, riorganizza il proprio invisibile campo, sovrapponendo percorsi simbolici, in cui una mente nascente si apre ad un mondo connettivo/cognitivo, per esplorare nuove configurazioni di un sistema di immagini mentali.
E dunque l’argilla del brillante colore della terra si dà come "vestito del vuoto", allo stesso modo in cui i microchip di silicio dei circuiti elettronici stampati, si danno come ordinatori dei "luoghi senza luogo" elettronici delle reti comunicazionali. Argilla e silicio sono le coordinate entro cui Sibille e profeti, si fanno fiamma e annunciano la presenza di un corpo nuovo senza identità, invisibile segno di un trans-umanesimo elettronico, partito dalla terra e che, per mezzo della terra, trascende oggi la sua immagine, cul de sac, metafora del vuoto che si espande e si moltiplica divenendo messaggio universale.
-
> PENSIERO LIQUIDO E CROLLO DELLA MENTE. --- Il mio contributo al libro " The point of being" (di Gaetano Mirabella).22 gennaio 2015
Il "Pensiero liquido" e "The point of being"
di Gaetano Mirabella
Nel mio "Pensiero liquido e crollo della mente" ci sono due capitoli che costituiscono il mio contributo al libro "The point of being" scritto con altri coautori (Derrick de Kerckhove, Cristina Miranda de Almeida, Marialuisa Malerba, Loretta Secchi, Isabelle Choiniere, Rosane Araujo, Semi Ryu, Jung A. Hu (Cambridge Scholars Publishing, 2014)
Il Pensiero liquido (del 2009) configura il crollo della mente come l’evento che apre vie di fuga dal Big Data per i nativi del web e per tutti coloro i quali si sentono clandestini a bordo di una vecchia configurazione percettiva del mondo. Il crollo della mente ha determinato la fine dell’uomo teoretico e l’egemonia dell’emisfero sinistro del cervello. Il "sentire" ha acquisito la modalità del pensiero che pensa e forgia una nuova ESTERNITA’ che , come una terra promessa, attira i nativi del web e i Fuggiaschi del Big Data.
Le informazione dei sensi "pensano" per noi che non abbiamo più mente; esse sono sorgenti aperte perchè hanno spalancato le chiuse del linguaggio e il pensiero liquido del sentire pensante, scende giù con la propria acqua investendo le cose di un volto nuovo. La nuova consapevolezza fluisce oggi in un ambiente cosciente, in uno SPAZIO CHE SENTE, che si può considerare una sorta di secondo mondo, sorto su una ESTERNITA’ che cresce e s’innalza come un grattacielo in costruzione.
In questa dimensione sempre nuova e cangiante, si muove un SENTIRE PENSANTE che ci svela che siamo parti di un grande corpo, che siamo "cellule pensiero" che pensano e sono "pensati da un pensiero liquido". L’ESTERNITA’ è adesso!
Non c’è nulla a priori, ogni cosa è ADESSO, essa non è un mondo oggettivo che si autoafferma con la sua immanenza, ma una sottile striscia di terra, un fugace silenzioso poggiare i piedi su di un fazzoletto di terra di cui ci si accorge perchè il comportamento degli uomini ha un’impennata verso modalità stranianti.
Nota sulla figura del "Pensiero liquido":
 L’uomo della copertina del libro sembra stia cadendo, ma non è così. Il nostro linguaggio ci ha trattenuto così a lungo nelle sue logiche descrittive, che non siamo in grado di descrivere e percepire eventi che accadono come flusso dello "spazio-mondo" in cui si attiva la consapevolezza di essere noi stessi il LUOGO, LO SPAZIO CHE SENTE. IL vuoto, il nuovo spazio, inizia là dove finisce il linguaggio, che è ancora nei dintorni della carne, ma già fuori dal corpo; là, in quello spazio, inizia a risplendere l’intensa consapevolezza di cui non siamo coscienti perché il suo splendore è senza luce per il linguaggio.
L’uomo della copertina del libro sembra stia cadendo, ma non è così. Il nostro linguaggio ci ha trattenuto così a lungo nelle sue logiche descrittive, che non siamo in grado di descrivere e percepire eventi che accadono come flusso dello "spazio-mondo" in cui si attiva la consapevolezza di essere noi stessi il LUOGO, LO SPAZIO CHE SENTE. IL vuoto, il nuovo spazio, inizia là dove finisce il linguaggio, che è ancora nei dintorni della carne, ma già fuori dal corpo; là, in quello spazio, inizia a risplendere l’intensa consapevolezza di cui non siamo coscienti perché il suo splendore è senza luce per il linguaggio.
 L’uomo della copertina, funambolo del linguaggio, salendo, dialoga con il rosso del cielo e il dialogo diventa il passare attraverso la parola per dissolverla in quanto parola, per svuotarla del significato razionale e renderla liquida o appartenente ad un ordine semantico differente. Leggero e orientato verso l’abbandono di ogni organicità, quest’uomo fa il suo ingresso in una logica porosa in cui "alto" e "basso", "sopra" e "sotto", non sono più predicati del cosmo. Senza la vecchia mente l’uomo non appartiene più a se stesso ma al luogo, al cielo in cui si muove, nell’era spettacolare della filmabilità tecnica della sua esistenza.
L’uomo della copertina, funambolo del linguaggio, salendo, dialoga con il rosso del cielo e il dialogo diventa il passare attraverso la parola per dissolverla in quanto parola, per svuotarla del significato razionale e renderla liquida o appartenente ad un ordine semantico differente. Leggero e orientato verso l’abbandono di ogni organicità, quest’uomo fa il suo ingresso in una logica porosa in cui "alto" e "basso", "sopra" e "sotto", non sono più predicati del cosmo. Senza la vecchia mente l’uomo non appartiene più a se stesso ma al luogo, al cielo in cui si muove, nell’era spettacolare della filmabilità tecnica della sua esistenza.GAETANO MIRABELLA
-
> PENSIERO LIQUIDO E CROLLO DELLA MENTE. Sulle nuove frontiere della riflessione estetica, un originale saggio di Gaetano Mirabella, scrittore e collaboratore del "McLuhan Program in culture and technology" di Toronto - a cura di Federico La Sala5 gennaio 2015, di Federico La Sala
- MICHELANGELO E LA SISTINA (1512-2012). I PROFETI INSIEME ALLE SIBILLE PER LA CHIESA UN GROSSO PROBLEMA ....
 DOPO 500 ANNI, PER IL CARDINALE RAVASI LA PRESENZA DELLE SIBILLE NELLA SISTINA E’ ANCORA L’ELEMENTO PIU’ CURIOSO. Materiali sul tema, per approfondimenti
DOPO 500 ANNI, PER IL CARDINALE RAVASI LA PRESENZA DELLE SIBILLE NELLA SISTINA E’ ANCORA L’ELEMENTO PIU’ CURIOSO. Materiali sul tema, per approfondimenti
Discussioni. L’erede intellettuale di Marshall McLuhan racconta come, mutando il linguaggio, muta la nostra psicologia
Fine dell’uomo rinascimentale
Le tecnologie cambiano la percezione del mondo. De Kerckhove: anziché guardare, siamo immersi
di Massimo Sideri *
Derrick de Kerckhove, considerato l’erede intellettuale di Marshall McLuhan, con il quale ha lavorato a lungo, oggi ha 70 anni e vive tra Toronto e Roma. Una scelta non solo estetica: proprio qui in Italia per de Kerckhove tutto ha avuto inizio in termini di strategia cognitiva. Un tutto che però, con l’avvento della cultura digitale, sta cambiando: per il sociologo dell’arte che ha diretto tra il 1983 e il 2008 il McLuhan Program in Culture and Technology siamo di fronte alla fine dell’uomo rinascimentale.
 «Quello che io chiamo il “punto di essere” - spiega a “la Lettura” - è la risposta al punto di vista del Rinascimento: quest’ultima era la definizione del rapporto tra corpo e spazio, un rapporto nel quale il corpo si trovava al di fuori e lo spazio era l’ambito di osservazione. Tutto questo viene capovolto con la realtà virtuale: invece di trovarci fuori dallo spettacolo penetriamo al suo interno proprio come nel film Avatar. È la sensazione del posto dove si trova il mio corpo a prevalere, una dimensione tattile, ma anche paradossale: è complicato cogliere la dimensione tattile dell’elettricità. Eppure esiste».
«Quello che io chiamo il “punto di essere” - spiega a “la Lettura” - è la risposta al punto di vista del Rinascimento: quest’ultima era la definizione del rapporto tra corpo e spazio, un rapporto nel quale il corpo si trovava al di fuori e lo spazio era l’ambito di osservazione. Tutto questo viene capovolto con la realtà virtuale: invece di trovarci fuori dallo spettacolo penetriamo al suo interno proprio come nel film Avatar. È la sensazione del posto dove si trova il mio corpo a prevalere, una dimensione tattile, ma anche paradossale: è complicato cogliere la dimensione tattile dell’elettricità. Eppure esiste».Il suo «punto di essere» ricorda lo strano mondo degli squali che vivono di percezioni elettriche assorbite da sensori sottocutanei. La virtualità può essere considerata un nuovo «sesto senso»? Non solo, dunque, un mondo che abbiamo costruito all’interno delle macchine, ma un modo del tutto nuovo di percepire dell’essere umano?
«Sì certamente. Ma non direi un sesto senso quanto un senso generale, come l’esternalizzazione del senso comune, una situazione totalmente nuova. Il punto di vista è quello che abbiamo normalmente come strategia di conoscenza: siamo sempre, mentalmente o fisicamente, di fronte a qualcosa da giudicare. Tutto questo è nato nel Rinascimento. Certo, c’era anche prima, ma è stato teorizzato nel Rinascimento da artisti come Masaccio».
Ora quell’uomo rinascimentale sta morendo?
«Per arrivare al “punto di essere” immaginate che la vostra fonte di esperienza nel mondo, invece che nella vostra testa e negli occhi, sia nel corpo. È una percezione che abbiamo perso perché obnubilati dal punto di vista. Il trompe-l’oeil ha represso gli altri sensi. Ora, la realtà virtuale è già passata di moda ma continua ad avere un impatto epistemologico, fa vedere che penetriamo nello spettacolo invece di essere buttati fuori. È simbolica della nostra presenza immersiva nella globalità dell’informazione. Dal telegrafo ai Big Data il nuovo inconscio si è trasformato: non è più quello di Freud ma è un inconscio digitale dal quale siamo bagnati continuamente. Pensate ai nostri smartphone, con i quali siamo seguiti e ricordati da qualche parte online. È un’ombra elettronica che ci precede: se voglio sapere qualcosa di te vado su Google prima di vederti».
La tecnologia touch screen che usiamo ormai senza pensarci, in qualche maniera ci ha permesso di riscoprire il tatto, la centralità della mano nell’esperienza umana?
«Sì e no, perché è un’esperienza paradidossale: il tatto sta prendendo nuove proprietà».
Nei suoi libri e nelle sue ricerche emerge la passione per l’alfabeto. Oggi siamo, per certi versi, già nell’era della post-scrittura. Le tecnologie touch screen nascondono percorsi che a noi possono apparire misteriosi ma che per dei bambini di 5-6 anni non hanno segreti. Siamo di fronte a una generazione per cui la scrittura non è così centrale. Noi se non leggevamo non imparavamo. Loro sembrano potere imparare senza leggere...
«Questo può essere parte dei problemi che derivano dalle nuove tecnologie. L’immaginario e le strutture cognitive dipendono molto dalle tecnologie che trasmettono il linguaggio. È quella che io chiamo psicotecnologia, perché il modo con cui arriva il linguaggio determina anche le competenze per usarlo. Nella cultura orale il linguaggio era fuori dai corpi ed era fatto di comandi, rapporti condivisi. Nel momento in cui l’alfabeto ha portato il linguaggio fuori dal corpo facendolo diventare silenzioso ce ne siamo riappropriati. Non siamo più servitori, ma controllori del destino privato: posso scrivere anche solo una lista delle cose da comprare nel negozio, ma in realtà sto scrivendo il mio destino. Ma che cosa succede oggi? Condividiamo un linguaggio elettronico incredibilmente veloce e creativo, un matrimonio tra il massimo della velocità, quella della luce, e il massimo della complessità, quella del linguaggio, iniziato già con il telegrafo. Ora però questo linguaggio elettronico è di nuovo fuori e porta con sé anche l’aspetto privato, costringendoci a immaginare un’etica della trasparenza: come comportarsi quando si sa tutto su di te? Comunque - per tornare ai bambini - è vero: la nostra conoscenza di adulti passa più attraverso la lettura».
Le abitudini cambiano anche in altre fasce di età: nel campus di Google si chatta pur trovandosi uno di fronte all’altro. Per la nostra cultura è quasi un gesto di maleducazione.
«È quasi maleducato, sì, ma è pertinente per una cultura che ha messo il linguaggio dentro il sistema di comunicazione elettronico. Il nuovo linguaggio si riduce: è molto più facile parlare con 140 caratteri perché a un certo livello il linguaggio si organizza diversamente. In Snapchat il linguaggio sparisce, non lascia traccia. I ragazzi con questa applicazione vogliono dare una certa oralità al discorso scritto».
Soprattutto vogliono nascondere le prove di cosa hanno fatto o detto...
«Sì, e fanno questo perché siamo nell’era del “capitale reputazionale”. Più importante del denaro e della conoscenza, la reputazione oggi diventa la vecchia vergogna del mondo orale, da cui viene il senso di colpa. Si parla già oggi di una nuova aristocrazia, l’aristocratico è una persona per bene dal momento che si può sapere tutto su di noi. La reputazione può essere usata come moneta di scambio».
È dunque una nuova struttura economica: non è solo l’evoluzione, grazie al digitale, del capitalismo.
«Sì, come nel crowdfunding: non ho soldi ma ho gli amici che possono vedere il progetto e raccomandarlo. Il capitale degli amici si può trasformare in denaro. Funziona perché è un’economia nuova, personale. L’investimento è anche emozionale. Un altro esempio di nuova economia è quello della stampante 3D. Consiglio di regalarne una ai figli per Natale. Come il crowdfunding redistribuisce le fonti dell’economia, la stampante 3D redistribuisce le fonti delle manifatture e le ridemocratizza. È un dono cognitivo, il passaggio dal punto di vista al “punto di essere”, dove la sensibilità 3D già precede la possibilità del 3D».
Massimo Sideri
*
- MICHELANGELO E LA SISTINA (1512-2012). I PROFETI INSIEME ALLE SIBILLE PER LA CHIESA UN GROSSO PROBLEMA ....
-
> PENSIERO LIQUIDO E CROLLO DELLA MENTE. --- "The point of being", presentato a Barcellona. Una nota di Gaetano Mirabella7 novembre 2014, di Federico La Sala
"The point of being"
di Gaetano Mirabella
A "dieci passi prima dell’eternità" il 30 ottobre scorso ci siamo incontrati a Barcellona, alla "Mandarina di Newton" Derrick De Kerkhove, Loretta Secchi, Marialuisa Malerba, Cristina Miranda De Almeida, Semi Ryu ed io, per presentare il Libro "The point of being", il punto d’essere. L’Occidente riprende a parlare del punto d’essere, arriva lo spazio che sente, aprendo la percezione ad ala d’uccello, lo spazio sente da quattro direzioni.
A dieci passi prima dell’eternità l’Occidente ha esultato per noi, io ho chiuso gli occhi e mi sono concentrato: la fronte vaporizzata si è aperta in quattro, lo spazio procede da noi, ha preso la nostra forma senza forma e arriverà a destinazione.
Come punto d’essere siamo entrati a far parte del paesaggio che sente. L’accesso a questo nuovo corpo gigantesco, si accompagna alla perdita della sfera sociale e/o linguistica ed è difficile parlare o descrivere il luogo senza luogo nel quale ci siamo trovati.
Ora riuscire a trasferire la consapevolezza del nostro corpo quotidiano all’ESTERNITA,’ tramite la tecnologia, è un compito difficile e pericoloso. In sostanza si tratta di usare la consapevolezza come un elemento dell’ambiente, dopo essersi disancorati dal linguaggio. Procedere sulla scena di un sentiero fatto letteralmente di consapevolezza che si dispiega in uno spazio e ci trasmette descrizioni fondamentali sulla nostra vita sconosciuta, costituisce un’offerta allettante, ma bisogna essere prudenti.
Entrare a far parte del PAESAGGIO CHE SENTE, richiede una grande disciplina ed insieme una grande immaginazione, poiché dobbiamo dare un nome e un volto a cose, fatti ed eventi mai visti prima. Soprattutto i nostri sensi devono aver imparato a pensare per riuscire a distinguere il punto d’intersezione, dove il varco si apre e si accede all’ACCESSO. Dobbiamo capire che ormai siamo gli ORDINATORI DEI LUOGHI SENZA LUOGO DELLA RETE, noi, IL VUOTO INTELLIGENTE, DOBBIAMO RIVESTIRCI COSCIENTEMENTE DI SPAZIO PER ENTRARE NEL NUOVO SPAZIO. Mc Luhan afferma che in questa epoca noi indossiamo tutta l’umanità come la nostra pelle.
Gaetano Mirabella (07.11.2014)
-
> PENSIERO LIQUIDO E CROLLO DELLA MENTE. --- I SOCIAL MEDIA, IL DESIDERIO DI FAMA E POPOLARITA’, E "LA FILOSOFIA DEL SELFIE".30 marzo 2014, di Federico La Sala
I SOCIAL MEDIA, IL DESIDERIO DI FAMA E POPOLARITA’, E ... L’ASSOLUTA ’DIMENTICANZA’ DELLA LEZIONE DI GIOVAN BATTISTA VICO E DELLA SUA "SCIENZA NUOVA":
- STORICISMO ASSOLUTO E STORIOGRAFIA FILOSOFICA....
 VICO, LA TAVOLA DI CEBETE, CROCE E SFAFTESBURY. Due note su "la filosofia di G.B. Vico" (fls)
VICO, LA TAVOLA DI CEBETE, CROCE E SFAFTESBURY. Due note su "la filosofia di G.B. Vico" (fls)
Filosofia del selfie
Socrate, Platone e Aristotele furono i primi a insegnare che essere importanti per gli altri ha valore solo se si coltivano giustizia e saggezza per se stessi
Dall’Antica Grecia a Internet, dal Kleos a Klout, il grado di popolarità ci ossessiona. Ecco come liberarsi
di Rebecca Newberger Goldstein e Mario Perniola (la Repubblica, 30.03.2014)
TUTTO è cominciato quando un amico mi ha chiesto quale fosse il mio punteggio Klout. Io non sapevo cosa fosse un punteggio Klout, ma ero abbastanza sicura di non averne uno. E infatti è venuto fuori che non usando né Facebook, né Twitter, né nessuno dei social media che un sito chiamato Klout usa per calcolare la tua influenza online, il mio punteggio probabilmente andava da basso a inesistente.
La gente ormai si mette in mostra in ogni modo, producendo - in parole, immagini, video - la storia condivisa della propria vita in tempo reale. Disseminano ovunque pensieri e azioni, grandi e piccoli, in uno sforzo che può apparire come un perpetuo appello per avere attenzione.
Non ero così fuori dal mondo da non essere a conoscenza dei grandi cambiamenti culturali che avevano travolto la nostra società mentre la mia attenzione era rivolta altrove, cioè all’antica Grecia. Da qualche anno cerco ossessivamente di scoprire le ragioni di fondo degli spettacolari progressi realizzati da quella civiltà.
Nel giro di appena un paio di secoli, le genti di lingua greca passarono dall’anomia e dall’analfabetismo a Eschilo e Aristotele. Cosa c’era dietro questa ambizione esplosiva, dietro questi progressi sensazionali? Forse proprio il fatto che i greci siano ancora saldamente impiantati nel nostro sistema può offrirci qualche punto di vista interessante sul mondo contemporaneo.
Per cominciare, il Klout mi sembra molto simile a quello che i greci chiamavano kleos. La parola proviene dal vecchio termine omerico che sta per «io ascolto» e che designava una sorta di rinomanza uditiva. In parole povere, la fama, la celebrità, ma anche il fatto glorioso a cui era dovuta la fama, o ancora il poema che cantava di quel fatto glorioso e che era all’origine della fama.
Il kleos era un elemento centrale nel sistema di valori dell’antica Grecia, motivato almeno in parte dal bisogno che abbiamo noi umani di sentire che la nostra vita è importante. Basta avere un po’ di prospettiva, e i greci di sicuro l’avevano, per capire quanto sia breve e insulsa la nostra vita.
Che cosa possiamo fare per dare alle nostre vite quel di più che ci aiuti a sopportare i millenni che presto ci ricopriranno completamente, facendo dimenticare che siamo mai esistiti? Perché, viene da chiedersi, ci siamo presi il disturbo di venire al mondo. Le genti di lingua greca erano ossessionate da questa domanda quanto noi.
E come tanti di noi, affrontavano il problema in modo laico. La loro cultura era intrisa di rituali religiosi, eppure non era ai loro immortali, notoriamente inaffidabili, che si rivolgevano se volevano avere la garanzia di essere importanti. Ciò che ricercavano era l’attenzione degli altri mortali.
Tutto ciò che possiamo fare, era la loro conclusione, è ingrandire la nostra vita, sforzarci di farne qualcosa che valga la pena di raccontare, materia per storie che lascino il segno nella mente degli altri mortali, in modo che la nostra vita, replicata nella testa degli altri, acquisisca quel «di più».
[Non tutti, all’epoca, affrontavano questo problema dell’importanza in termini mortali. Coeva dei greci, sull’altra sponda del Mediterraneo, c’era una tribù ancora sconosciuta, gli Ivrim, come si autodenominavano, gli ebrei. E là elaborarono il concetto di un rapporto un unico e solo Dio che forniva le fondamenta del mondo fisico e del mondo morale. ]
E poi c’era un terzo approccio, che emerse anch’esso nell’antica Grecia e anch’esso basato su presupposti laici, un approccio che affrontava la questione in termini rigorosamente mortali. Sto parlando della filosofia greca, che era abbastanza greca da sposare l’assunto kleoseggiante che nessuno di noi nasce importante, ma l’importanza se la deve conquistare, e per riuscirci servono ambizioni e sforzi smisurati, che ti obbligano a fare di te stesso qualcosa di straordinario.
Ma la filosofia greca rappresentava un discostamento anche dalla propria stessa cultura: non si diventava importanti attirando l’attenzione di altri. Diventare importanti era qualcosa che bisognava fare per se stessi, coltivando qualità del carattere virtuose come la giustizia e la saggezza.
Bisognava mettere ordine nella propria anima impegnandosi a fondo, perché già solo comprendere la natura della giustizia e della saggezza, che è la prima cosa, metteva alla prova i nostri limiti, figuriamoci agire coerentemente con le nostre conclusioni. E non è detto che tutto questo impegno potesse procurarci alcun kleos. A Socrate fruttò una tazza di cicuta: se la bevve con calma, senza turbarsi del suo basso punteggio.
Nel corso dei secoli, la filosofia, forse aiutata dalla religione, ha abbandonato l’errato presupposto dei greci secondo cui solo una vita straordinaria aveva importanza. È stato un progresso di quelli tipici della filosofia: essa produce argomenti che estendono costantemente la sfera dell’importanza.
Per i greci era naturale escludere le loro donne e i loro schiavi, per non parlare dei non greci, che etichettavano con l’appellativo di barbari. Esclusioni del genere oggi per noi sono impensabili.
A volte, però, non sembra che abbiamo fatto molta strada. Il nostro bisogno di sentire che la nostra vita è importante è forte oggi come sempre. Ma le diverse varianti dell’approccio teistico non sono più soddisfacenti come un tempo, mentre coltivare giustizia e saggezza resta difficile come è sempre stato. Le nuove tecnologie sono entrate in gioco proprio quando ne sentivamo maggiormente la necessità: il kleos (o il Klout) ora è a portata di tweet.
È strabiliante che la nostra cultura, con l’assottigliarsi del teismo, sia tornata a quella stessa risposta al problema dell’importanza che Socrate e Platone giudicavano inadeguata. La loro contrarietà di allora oggi, forse, è perfino più appropriata.
Quanta soddisfazione può dare, in fin dei conti, una cultura basata sull’ossessione per i social media? Questa multireplicazione così accessibile è effimera e inconsistente come i tanti esempi delle nostre vite che replicano.
Se a far emergere la filosofia furono inizialmente le inadeguatezze del kleos, forse è arrivato il momento che la filosofia affronti il Klout. Le risorse ce le ha: è molto più sviluppata che ai tempi in cui Socrate girava per l’ agorà cercando di smontare quelle persone così gonfie di kleos. Può cominciare dimostrando, con forza e chiarezza come la filosofia sa fare, che tutti siamo importanti.
Siamo importanti per diritto di nascita, e dobbiamo essere trattati di conseguenza, dobbiamo avere tutti le risorse per «fiorire ». Comprendere questa verità etica può contribuire a placare la frenesia che circonda la nostra importanza personale, consentendoci di indirizzare maggiori energie verso la coltivazione della giustizia e della saggezza.
Dirò di più: comprendere fino in fondo questa verità etica costituirebbe già da solo un passo avanti significativo verso la coltivazione della giustizia e della saggezza (traduzione di Fabio Galimberti)
- STORICISMO ASSOLUTO E STORIOGRAFIA FILOSOFICA....
-
> PENSIERO LIQUIDO E CROLLO DELLA MENTE. ---- I cittadini cyborg dell’impero digitale. Nessuno di noi possiede ancora le categorie, le mappe e la bussola per questo mondo nuovo (di Ulrich Beck).1 agosto 2013, di Federico La Sala
L’ANALISI
I cittadini cyborg dell’impero digitale
Nessuno di noi possiede ancora le categorie, le mappe e la bussola per questo mondo nuovo. Siamo stati catapultati dai successi della modernizzazione, dalla crescente evoluzione tecnologica, in ambiti e possibilità d’azione dei quali non siamo ancora in grado di approntare descrizioni adeguate
di ULRICH BECK (la Repubblica, 01 agosto 2013)
Lo scandalo Prism ha aperto un nuovo capitolo della società mondiale del rischio. Nel corso degli ultimi decenni abbiamo conosciuto una serie di rischi pubblici mondiali: il mutamento climatico, il rischio nucleare, il rischio finanziario, l’11 settembre e ora il rischio digitale e globale della libertà. Tutti questi rischi (ad eccezione del terrorismo) sono parte, in certo modo, di un sviluppo tecnologico. Sono anche parte dei timori espressi durante la fase di modernizzazione di questa nuova tecnologia. Improvvisamente, però, accade un evento che segnala all’opinione pubblica mondiale il problema legato all’uno o all’altro di questi rischi: è quanto è accaduto con le rivelazioni di Snowden, che hanno evidenziato il rischio della libertà. Tuttavia, dietro questo episodio si nasconde un’altra logica del rischio. Nel caso di quello nucleare, gli incidenti dei reattori di Chernobyl e poi di Fukushima hanno dato luogo a una discussione pubblica. Nel caso del rischio digitale della libertà, invece, il punto di partenza non è stato l’evento catastrofico, poiché la catastrofe sarebbe avvenuta, ma nessuno se ne sarebbe accorto.
Della possibile catastrofe si è avuta consapevolezza solo perché un singolo esperto dei servizi segreti degli Stati Uniti ha mostrato al mondo il rischio usando gli stessi mezzi del controllo informativo. Ciò significa un completo capovolgimento della situazione.
Questo stato di cose rende estremamente fragile la consapevolezza del rischio, poiché - a differenza dagli altri rischi globali - tale consapevolezza non orienta su una catastrofe che esiste fisicamente e realmente nello spazio e nel tempo, non nasce da essa e non viene continuamente riferita ad essa. Perciò viene di colpo infranta l’ovvietà, il farsi quasi una seconda natura, delle possibilità di controllo dell’informazione. Tuttavia, questa rivelazione dà anche luogo a continue resistenze.
I rischi globali hanno alcuni aspetti in comune. Tutti rendono quotidianamente percepibile l’interdipendenza globale. Tutti sono in un senso particolare globali, cioè non si basano su incidenti spazialmente, temporalmente e socialmente circoscritti, ma su catastrofi spazialmente, temporalmente e socialmente sconfinate. E tutti sono effetti collaterali dei successi della modernizzazione. Nel caso del rischio della libertà, dunque, le possibilità di controllo offerte dalla democrazia nell’ambito dello Stato nazionale; negli altri casi, il calcolo delle probabilità, la tutela assicurativa, eccetera. Inoltre, tutti questi rischi hanno in comune il fatto di essere percepiti in modo molto differente nei diversi angoli del mondo.
Abbiamo poi a che fare con un’inflazione di catastrofi incombenti, dove l’una minaccia di prendere il sopravvento sull’altra. Il rischio finanziario ammazza il rischio ambientale. Il rischio terroristico ammazza quello digitale della libertà. È questo, d’altronde, uno degli ostacoli più importanti alla possibilità che il rischio della libertà venga riconosciuto pubblicamente e diventi oggetto di un’azione pubblica.
Riflettendo su quale potente attore abbia davvero interesse a creare una consapevolezza pubblica di questo rischio e, conseguentemente, a motivare all’agire politico, il primo che verrebbe in mente sarebbe lo Stato democratico. Ma sarebbe come fare del lupo il guardiano dell’ovile. Questo però potrebbe essere un passo storico verso la fuoriuscita dal pluralismo degli Stati nazionali, in direzione di uno Stato mondiale digitale che si è sottratto a tutti i controlli.
Il cittadino sarebbe il secondo attore che si potrebbe mettere in campo. Tuttavia, gli utenti dei nuovi media digitali dell’informazione sono già diventati in qualche modo dei cyborg. Utilizzano questi media come organi di senso. La generazione Facebook vive in questi media, rinunciando a gran parte della propria libertà individuale e della propria sfera privata.
Tuttavia, occorre fare un passo avanti e chiedersi se, come sociologi, uomini della strada e utenti di questi strumenti digitali di informazione abbiamo già concetti adeguati per descrivere quanto profondi e radicali siano i cambiamenti da essi introdotti nella società. Nessuno di noi possiede ancora le categorie, le mappe e la bussola per questo mondo nuovo. Siamo stati catapultati dai successi della modernizzazione, dalla crescente evoluzione tecnologica, in ambiti e possibilità d’azione dei quali non siamo ancora in grado di approntare descrizioni adeguate.
Si parla di continuo della nascita di un nuovo impero digitale. Ma nessuno degli imperi storici che conosciamo, quello dei greci, quello dei persiani o quello dei romani, aveva le caratteristiche che contraddistinguono l’odierno impero digitale. Questo impero digitale si basa su aspetti della modernità sui quali non abbiamo ancora riflettuto a dovere. Non si fonda sulla forza militare, né possiede la capacità di un’integrazione politicoculturale al di là delle distanze. Dispone però di possibilità di controllo estensive e intensive, così ampie e profonde da svelare tutte le preferenze e le debolezze individuali - diventiamo tutti trasparenti come il vetro.
Tuttavia, queste possibilità di controllo non vengono colte dal concetto di impero così com’è stato inteso finora. E ora si aggiunge questa sostanziale ambivalenza: abbiamo enormi possibilità di controllo, ma contemporaneamente un’inimmaginabile vulnerabilità di questi controlli digitali. Nessuna potenza militare, nessuna insurrezione, nessuna rivoluzione, nessuna guerra minaccia l’impero del controllo, ma a farlo vacillare - rivolgendo il sistema informativo contro sé stesso - è un solo, coraggioso individuo, un trentenne esperto dei servizi segreti. L’inimmaginabilità del controllo e l’inimmaginabile vulnerabilità del medesimo sono due lati della stessa medaglia.
In questo sistema di controllo apparentemente iper-perfetto c’è dunque una possibilità di resistenza dell’individuo, che non si era mai vista prima. Una delle questioni più importanti è dunque se in queste grandi aziende digitali non dobbiamo introdurre giuridicamente, dapprima forse a livello nazionale, poi a livello europeo, quello che potremmo chiamare un "sindacato whistleblower" (che denuncia irregolarità) e, prima di ogni altra cosa, anche un dovere di resistenza nel lavoro.
Ora, però, l’uomo della strada dispone - a differenza da Snowden - di un sapere di gran lunga minore relativamente alla struttura e alla potenza di questo cosiddetto impero. Questo però non vale per la giovane generazione dei nuovi Colombo, che fa dei social network un prolungamento del proprio corpo comunicativo. Qui diventa chiara una conseguenza essenziale. Il rischio di una lesione dei diritti di libertà viene valutato diversamente rispetto, ad esempio, a una lesione della salute, provocata dal mutamento climatico. La lesione della libertà non duole, non la si percepisce, non si contraggono ma-lattie, non si subiscono inondazioni, non si soffre della mancanza di opportunità sul mercato del lavoro. In tutti i sistemi politici la promessa di sicurezza è il vero e proprio nucleo della forza statale e della legittimazione statale, mentre la libertà ha sempre una posizione o un ruolo di secondo piano. Perciò, dal mio punto di vista di sociologo, il rischio della libertà è il rischio più fragile tra le minacce globali che si sono finora manifestate.
Che fare, dunque? Propongo di formulare qualcosa come un umanesimo digitale. Occorrerebbe fare del diritto fondamentale alla tutela dei dati e alla libertà digitale un diritto umano globale, cercando di imporre questo diritto, come altri diritti umani, anche contro la resistenza.
Non ci sono obiettivi più ridotti. Ciò che manca è però un’istanza internazionale in grado di affermare tali esigenze. Su questo punto il rischio della libertà non si distingue dal rischio del mutamento climatico. La litania è sempre questa: lo Stato nazionale non può farlo. Non c’è attore a livello internazionale che possa essere preso in considerazione a questo scopo. Ma c’è un’inquietudine generale, il rischio globale ha un’enorme forza di mobilitazione che mette in ombra tutto quello che c’era prima, ad esempio la classe operaia. Proprio la riflessione costante sulla minaccia di amico e nemico potrebbe benissimo condurre a processi di formazione delle norme a livello mondiale. Allora la coscienza giuridica delle norme globali nascerebbe per così dire a posteriori, dal terrore dell’opinione pubblica mondiale per la loro violazione. Abbiamo bisogno di un’invenzione transnazionale della politica e della democrazia che dischiuda la possibilità di far rivivere e riaffermare i diritti democratici fondamentali contro il predominio del monopolio del controllo totalmente autonomizzato.
(Traduzione di Carlo Sandrelli)
-
> PENSIERO LIQUIDO E CROLLO DELLA MENTE. --- "Trasformazioni della trascendenza nel contesto della cultura tecnologica" (di Andrea Vaccaro - «Cyber» cristiani?).19 giugno 2013, di Federico La Sala
IDEE«Cyber» cristiani?
di Andrea Vaccaro (Avvenire, 19 giugno 2013)
Le parole - lo sappiamo - non hanno un copyright. Ed è anche lecito usarle con un certo margine di libertà. Così, non è infrequente che il loro significato slitti in modo sorprendente, per mutamento dei contesti, per ragioni inspiegate, per strategie ideologiche ...
Si pensi al significato antico e a quello attuale di "pneumatico", al senso etimologico di "pedofilia", al crocevia attuale in cui si trova il termine "matrimonio". Di peculiare importanza, in ambito filosofico-teologico, è il "travaglio" che sta vivendo, recentemente, l’espressione "trascendenza". Dopo la questione dell’anima, un altro cardine del pensiero religioso sta ricevendo una "particolare attenzione" dalla cultura contemporanea. Di trascendenza infatti si torna a parlare, mentre il "purtroppo" e il "per fortuna" combattono per completar la frase.
Sì, perché l’accezione ora di moda non è proprio quella canonica. Dall’ambito dei Principi singolaritiani, ad esempio, Eliezer Yudkowsky dichiara che un adepto della Singolarità «crede in una Trascendenza o un Evento Orizzonte», in perfetto ossequio al padre fondatore Vernon Vinge che nel suo manifesto La Singolarità tecnologica assicurava come «l’Intelligenza artificiale permette la nostra partecipazione ad una specie di trascendenza». Dai laboratori della Realtà Virtuale, d’altro canto, Michael Benedikt vaticina che nel cyber-spazio trascenderemo il mondo materiale e, per rendere più perspicua l’idea, predice che «potremo mangiare dell’Albero senza essere puniti, stare con gli angeli, entrare in paradiso e non morire» (Cyber-spazio).
Margaret Wertheim chiama con nonchalance tale insorgente trascendenza «Nuova Gerusalemme». Dal fronte della robotica, inoltre, abbiamo uno dei leader massimi, Hans Moravec, che ha posto il termine sin nel titolo del suo best-seller Robot. La pura macchina verso la mente trascendente. Poi c’è Ray Kurzweil, l’«uomo trascendente» per eccellenza (così è intitolato il docu-film tuttora in circolazione sulla sua vita e le sue invenzioni), autore di La Singolarità è vicina. Quando gli esseri umani trascendono la biologia (2005) e del più diretto Transcend (2009).
Su un piano maggiormente divulgativo, il cyber-scrittore cult William Gibson in Neuromante ci presenta Wintermute, un’Intelligenza artificiale con espliciti «desideri di trascendenza» ed è di questi giorni l’annuncio della preparazione di un nuovo film con mega-produzione e celebri star: Johnny Depp - o meglio il suo personaggio - morirà e la sua coscienza sarà fatta sopravvivere in una sorta di computer. Titolo senza orpelli e senza equivoci: Transcendence. L’uscita del film è destinata a scatenare un gran risuonare della parola "trascendenza" e sarà interessante riscontrare, in tale deflagrazione, come il suo significato originario verrà stiracchiato, ri-modellato, deturpato.
Dinanzi ad un incedere così incalzante del progetto, per così dire, di "ingegnerizzazione della trascendenza" si potrà obiettare che, in fondo, non c’è niente di granché nuovo sotto il sole. Non sono trascorsi poi molti decenni da quando una certa ideologia inneggiava, con Ernst Bloch, ad un «trascendere senza trascendenza, perché è l’avanti che attira - potendolo plasmare - piuttosto che il lassù» (Il principio speranza, 1959). La risposta più evidente e drammatica è pervenuta dalla storia; quella più arguta, forse, da Augusto Del Noce secondo cui, all’incirca, una trascendenza intramondana presto avvizzisce e, come una giovane avvenente divenuta vecchia, perde molto del suo impulso attrattivo (battuta da contestualizzare rigorosamente in epoca pre-gender).
Davvero, dunque, solo il ritorno di un’uguale questione già liquidata dalla storia e dalla filosofia? In realtà, nel ritorno della trascendenza di oggi, un nuovo attore è entrato vistosamente in scena: la tecnologia. Con un inaspettato dirottamento della trama.
Se infatti la trascendenza del marxismo e dell’umanesimo ateo aveva uno sguardo totalmente orizzontale, e verticale è la direzione della trascendenza tradizionale, si può avanzare che l’orizzonte della trascendenza tecnologica sia diagonale, o forse obliquo. Si ha un bel dire, infatti, con un malcelato sciovinismo di specie, che i computer fanno solo quello che l’essere umano dice loro di fare. In realtà, se la tecnologia elettrica cessasse improvvisamente di assisterci, con tutte le nostre abilità dismesse, cadremmo in un nuovo Medioevo. Rinascimento, al massimo.
Da qui derivano consapevoli sensi di dipendenza e di inferiorità nei confronti della tecnologia, stranamente affini al sentimento di creaturalità dell’essere religioso nei confronti di Dio. Così i piani vengono ad intrecciarsi ulteriormente e v’è qualche fondatezza nel chiedersi se dietro il fenomeno della trascendenza tecnologica vi sia solo un colossale equivoco, un preciso disegno ideologico anti-religioso oppure esso non sia altro che l’estremo grido verso il Cielo dell’essere umano contemporaneo, l’unico possibile in una cultura post-simbolica, iper-esplicitante e secolarizzata come la nostra.
In effetti, invertendo una rotta filosofica lunga quasi un secolo che opponeva senza attenuazioni efficientismo tecnico e afflato spirituale, cominciano sorprendentemente a proporsi - e proprio dall’ambito teologico - posizioni che interpretano la tecnologia come possibile Grande Medium per risvegliare sopite tendenze spirituali e per vincere quella singolare forma di xenofobia che attanaglia la nostra epoca: non più fobia dell’altra persona, ma fobia dell’altra dimensione dell’Essere.
Così, ad esempio, il teologo protestante Ronald Cole-Turner, nella silloge da lui curata Transhumanism and Transcendence (2012), pone l’obiettivo di «esplorare le forme del desiderio umano di trascendenza» presenti nella tecnologia; Giuseppe Tanzella-Nitti ravvisa in essa «categorie quasi teologiche», come l’anelito a superare la finitezza, una speranza di largo respiro nel futuro, l’aspirazione a conservare la memoria individuale e collettiva, la propensione ad una tessitura estesa di relazioni ... (Pensare la tecnologia in prospettiva teologica, 2011) e René Munnik della Facoltà teologica di Tilburg ha di recente avviato il progetto di ricerca "Trasformazioni della trascendenza nel contesto della cultura tecnologica".
Sembrerebbe il germogliare di una teologia della tecnologia di taglio radicalmente nuovo, tesa a leggere nella tecnica non più un farmaco per assopire - o allucinare - le tensioni trascendenti, ma un elisir per risvegliarle; una teologia desiderosa di approfondire (con uno speciale esercizio di "inculturazione") le innegabili propensioni spirituali della tecnologia e che, su questa base, si senta di consigliare - sulla falsariga del frequente invito «cristiani, entrate in politica» - un inusuale «cristiani, entrate in tecnologia!». Anche per rimarcare che la "trascendenza immanente" è una contradictio in terminis o, più poeticamente, un evocativo ossimoro, che per sua natura è efficace solo se delocalizza la ragione e rimanda altrove.
Andrea Vaccaro
-
> PENSIERO LIQUIDO E CROLLO DELLA MENTE. --- NATIVI DIGITALI, E ATEI NATIVI E CEDIMENTO STRUTTURALE DEL CATTOLICESIMO-ROMANO.18 febbraio 2013, di Federico La Sala
La ragione della fede tra gli atei nativi
di Salvatore Natoli (Avvenire, 12 febbraio 2013)
In un film recente e controverso - Habemus papam - il regista Nanni Moretti ci raccontava di un cardinale restio a diventare Papa perché non si sentiva idoneo a prendere su di sé il grande peso di governare la Chiesa, schivato peraltro anche dagli altri; oggi Papa Benedetto XVI che si dimette dal pontificato perché non si sente più nelle condizioni fisiche o spirituali - o spirituali e fisiche insieme
 per potere stare ancora alla guida della Chiesa. Nella storia della Chiesa ci sono state dimissioni celebri - tutti ricordano quella di Celestino V - tanto che il diritto canonico le prevede, anche se non appartiene alla prassi ordinaria.
per potere stare ancora alla guida della Chiesa. Nella storia della Chiesa ci sono state dimissioni celebri - tutti ricordano quella di Celestino V - tanto che il diritto canonico le prevede, anche se non appartiene alla prassi ordinaria.Da laico non voglio entrare nel merito della teologia - e visto che si parla di papato neppure della teologia politica - ma mi limito a notare come in genere e per lo più si tenda a identificare la Chiesa con il Papa, anche se il papato è un servizio alla Chiesa nella Chiesa.
Non voglio neppure affrontare la questione circa il rapporto tra persona e funzione in questo caso direi meglio mandato, ma mi pare che nelle dimissioni del papa motivo di riflessione siano le ragioni da lui avanzate.
Nel momento in cui per motivi diversi non ci si sente all’altezza del proprio compito è giusto riconsegnarlo a coloro da cui lo si è ricevuto; e in questo caso alla Chiesa. Una decisione degna di grande apprezzamento perché indica come non bisogna mai confondere il compito con il potere e perciò sulla necessità di intendere il potere come servizio. In una società in cui si tende ad identificare sé con il potere - tanto che nessuno si dimette se non sconfitto - le dimissioni del Papa mostrano un senso alto di responsabilità nei confronti del proprio compito e perciò anche di dedizione alla Chiesa. L’erogazione di un servizio presuppone la consapevolezza del limite e perciò il dovere di ritirarsi quando si ritiene di non essere più in grado di espletarlo al meglio.
Dimettersi in questo caso oltre ad essere indice di una grande qualità morale, è anche un atto razionale, consapevole di quello che si è in grado di fare o meno. D’altra parte Benedetto XVI, nel corso del suo pontificato si è sempre appellato alla ragione fino al punto da impegnarsi, da teologo, a mostrare la ragionevolezza della fede senza nulla togliere al suo mistero. Certo quel che seguirà a queste dimissioni non è facile da prevedere: quanto una presenza così importante come quella dell’ex Papa influirà sul conclave e, ancorché silente, condizionerà l’elezione del nuovo Papa?
Come è noto certe conseguenze insorgono anche quando non si vogliono. Ma ciò nulla toglie al valore etico di chi declina un mandato e si mette a disposizione per altro servizio che può meglio sostenere.
Certo il peso che Papa lascia in eredità al suo successore non è lieve: la Chiesa si trova oggi per la prima volta ad operare in un ambiente totalmente secolarizzato; possiamo dire di ’atei nativi’, come nei processi cognitivi si parla di ’nativi digitali’. Non più contro Dio, ma senza Dio, almeno secondo il modo tradizionale di concepirlo.
Di questo il Papa stesso se ne era reso perfettamente conto quando ha lanciato l’idea di una nuova evangelizzazione, consapevole che il regime di cristianità sia definitivamente consumato e i cristiani sono divenuti minoranza. Per questo o tornano ad essere lievito o periscono. Per questo quel che Benedetto XVI non farà più da Papa continuerà a farlo nella forma in cui lo ha sempre fatto, educando all’ intelligentia fidei , da teologo. E su questo piano i non credenti restano ancora interlocutori possibili.
-
> PENSIERO LIQUIDO E CROLLO DELLA MENTE. --- LA NUOVA AGORA’: «RETI DIGITALI SOCIALI», LA SFIDA DELL’AUTENTICITA’. Messaggio di Benedetto XVI per la 47 Giornata nondiale delle comunicazioni sociali.25 gennaio 2013, di Federico La Sala
COME NEL CIELO DELLA RETE DIGITALE COSI’ NELLA TERRA DELLA RETE DELLE RELAZIONI UMANE: QUALE "VANGELO"?! Note sul tema:
- IL CATTOLICESIMO COME TRADIMENTO STRUTTURALE DEL MESSAGGIO EVANGELICO, DEL CRISTIANESIMO. UN’OBBEDIENZA CIECA DI LUNGA DURATA: TUTTI AGGIOGATI AL DIO-VALORE, AL DIO-MAMMONA ("Deus caritas est": Benedetto XVI, 2006)!
 LA SCONVOLGENTE LIBERAZIONE. "Dio sempre dalla parte dell’uomo". Una nota di Ermes Ronchi - con appunti (federico la sala)
LA SCONVOLGENTE LIBERAZIONE. "Dio sempre dalla parte dell’uomo". Una nota di Ermes Ronchi - con appunti (federico la sala)
LE PAROLE DI PIETRO *
 «RETI DIGITALI SOCIALI», LA SFIDA DELL’AUTENTICITA’
«RETI DIGITALI SOCIALI», LA SFIDA DELL’AUTENTICITA’
 Benedetto XVI: come una nuova agorà pubblica e aperta
Benedetto XVI: come una nuova agorà pubblica e aperta
 Possono essere strumento di evangelizzazione e sviluppo
Possono essere strumento di evangelizzazione e sviluppo- Pubblichiamo il Messaggio del Papa per la 47 Giornata mondiale delle comunicazioni che sarà celebrata il prossimo 12 maggio
«Reti sociali porte di verità e di fede, nuovi spazi di evangelizzazione»
di Benedetto XVI *
Cari fratelli e sorelle, in prossimità della Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali del 2013, desidero proporvi alcune riflessioni su una realtà sempre più importante che riguarda il modo in cui le persone oggi comunicano tra di loro. Vorrei soffermarmi a considerare lo sviluppo delle reti sociali digitali che stanno contribuendo a far emergere una nuova «agorà», una piazza pubblica e aperta in cui le persone condividono idee, informazioni, opinioni, e dove, inoltre, possono prendere vita nuove relazioni e forme di comunità.
Questi spazi, quando sono valorizzati bene e con equilibrio, contribuiscono a favorire forme di dialogo e di dibattito che, se realizzate con rispetto, attenzione per la privacy, responsabilità e dedizione alla verità, possono rafforzare i legami di unità tra le persone e promuovere efficacemente l’armonia della famiglia umana. Lo scambio di informazioni può diventare vera comunicazione, i collegamenti possono maturare in amicizia, le connessioni agevolare la comunione. Se i network sono chiamati a mettere in atto questa grande potenzialità, le persone che vi partecipano devono sforzarsi di essere autentiche, perché in questi spazi non si condividono solamente idee e informazioni, ma in ultima istanza si comunica se stessi.
Lo sviluppo delle reti sociali richiede impegno: le persone sono coinvolte nel costruire relazioni e trovare amicizia, nel cercare risposte alle loro domande, nel divertirsi, ma anche nell’essere stimolati intellettualmente e nel condividere competenze e conoscenze. I network diventano così, sempre di più, parte del tessuto stesso della società in quanto uniscono le persone sulla base di questi bisogni fondamentali. Le reti sociali sono dunque alimentate da aspirazioni radicate nel cuore dell’uomo.
La cultura dei social network e i cambiamenti nelle forme e negli stili della comunicazione, pongono sfide impegnative a coloro che vogliono parlare di verità e di valori. Spesso, come avviene anche per altri mezzi di comunicazione sociale, il significato e l’efficacia delle differenti forme di espressione sembrano determinati più dalla loro popolarità che dalla loro intrinseca importanza e validità. La popolarità è poi frequentemente connessa alla celebrità o a strategie persuasive piuttosto che alla logica dell’argomentazione. A volte, la voce discreta della ragione può essere sovrastata dal rumore delle eccessive informazioni, e non riesce a destare l’attenzione, che invece viene riservata a quanti si esprimono in maniera più suadente.
I social media hanno bisogno, quindi, dell’impegno di tutti coloro che sono consapevoli del valore del dialogo, del dibattito ragionato, dell’argomentazione logica; di persone che cercano di coltivare forme di discorso e di espressione che fanno appello alle più nobili aspirazioni di chi è coinvolto nel processo comunicativo.
Dialogo e dibattito possono fiorire e crescere anche quando si conversa e si prendono sul serio coloro che hanno idee diverse dalle nostre. “Costatata la diversità culturale, bisogna fa sì che le persone non solo accettino l’esistenza della cultura dell’altro, ma aspirino anche a venire arricchite da essa e ad offrirle ciò che si possiede di bene, di vero e di bello” (Discorso nell’Incontro con il mondo della cultura, Belém, Lisbona, 12 maggio 2010).
La sfida che i network sociali devono affrontare è quella di essere davvero inclusivi: allora essi beneficeranno della piena partecipazione dei credenti che desiderano condividere il Messaggio di Gesù e i valori della dignità umana, che il suo insegnamento promuove. I credenti, infatti, avvertono sempre più che se la Buona Notizia non è fatta conoscere anche nell’ambiente digitale, potrebbe essere assente nell’esperienza di molti per i quali questo spazio esistenziale è importante. L’ambiente digitale non è un mondo parallelo o puramente virtuale, ma è parte della realtà quotidiana di molte persone, specialmente dei più giovani.
I network sociali sono il frutto dell’interazione umana, ma essi, a loro volta, danno forme nuove alle dinamiche della comunicazione che crea rapporti: una comprensione attenta di questo ambiente è dunque il prerequisito per una significativa presenza all’interno di esso.
La capacità di utilizzare i nuovi linguaggi è richiesta non tanto per essere al passo coi tempi, ma proprio per permettere all’infinita ricchezza del Vangelo di trovare forme di espressione che siano in grado di raggiungere le menti e i cuori di tutti. Nell’ambiente digitale la parola scritta si trova spesso accompagnata da immagini e suoni. Una comunicazione efficace, come le parabole di Gesù, richiede il coinvolgimento dell’immaginazione e della sensibilità affettiva di coloro che vogliamo invitare a un incontro col mistero dell’amore di Dio. Del resto sappiamo che la tradizione cristiana è da sempre ricca di segni e simboli: penso, ad esempio, alla croce, alle icone, alle immagini della Vergine Maria, al presepe, alle vetrate e ai dipinti delle chiese. Una parte consistente del patrimonio artistico dell’umanità è stato realizzato da artisti e musicisti che hanno cercato di esprimere le verità della fede.
L’autenticità dei credenti nei network sociali è messa in evidenza dalla condivisione della sorgente profonda della loro speranza e della loro gioia: la fede nel Dio ricco di misericordia e di amore rivelato in Cristo Gesù. Tale condivisione consiste non soltanto nell’esplicita espressione di fede, ma anche nella testimonianza, cioè nel modo in cui si comunicano “scelte, preferenze, giudizi che siano profondamente coerenti con il Vangelo, anche quando di esso non si parla in forma esplicita” (Messaggio per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, 2011).
Un modo particolarmente significativo di rendere testimonianza sarà la volontà di donare se stessi agli altri attraverso la disponibilità a coinvolgersi pazientemente e con rispetto nelle loro domande e nei loro dubbi, nel cammino di ricerca della verità e del senso dell’esistenza umana. L’emergere nelle reti sociali del dialogo circa la fede e il credere conferma l’importanza e la rilevanza della religione nel dibattito pubblico e sociale.
Per coloro che hanno accolto con cuore aperto il dono della fede, la risposta più radicale alle domande dell’uomo circa l’amore, la verità e il significato della vita - questioni che non sono affatto assenti nei social network - si trova nella persona di Gesù Cristo. È naturale che chi ha la fede desideri, con rispetto e sensibilità, condividerla con coloro che incontra nell’ambiente digitale.
In definitiva, però, se la nostra condivisione del Vangelo è capace di dare buoni frutti, è sempre grazie alla forza propria della Parola di Dio di toccare i cuori, prima ancora di ogni nostro sforzo. La fiducia nella potenza dell’azione di Dio deve superare sempre ogni sicurezza posta sull’utilizzo dei mezzi umani.
Anche nell’ambiente digitale, dove è facile che si levino voci dai toni troppo accesi e conflittuali, e dove a volte il sensazionalismo rischia di prevalere, siamo chiamati a un attento discernimento. E ricordiamo, a questo proposito, che Elia riconobbe la voce di Dio non nel vento impetuoso e gagliardo, né nel terremoto o nel fuoco, ma nel «sussurro di una brezza leggera» (1 Re 19,11-12). Dobbiamo confidare nel fatto che i fondamentali desideri dell’uomo di amare e di essere amato, di trovare significato e verità - che Dio stesso ha messo nel cuore dell’essere umano - mantengono anche le donne e gli uomini del nostro tempo sempre e comunque aperti a ciò che il beato Cardinale Newman chiamava la “luce gentile” della fede.
I social network, oltre che strumento di evangelizzazione, possono essere un fattore di sviluppo umano. Ad esempio, in alcuni contesti geografici e culturali dove i cristiani si sentono isolati, le reti sociali possono rafforzare il senso della loro effettiva unità con la comunità universale dei credenti. Le reti facilitano la condivisione delle risorse spirituali e liturgiche, rendendo le persone in grado di pregare con un rinvigorito senso di prossimità a coloro che professano la loro stessa fede.
Il coinvolgimento autentico e interattivo con le domande e i dubbi di coloro che sono lontani dalla fede, ci deve far sentire la necessità di alimentare con la preghiera e la riflessione la nostra fede nella presenza di Dio, come pure la nostra carità operosa: “se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei come bronzo che rimbomba o come cimbalo che strepita” (1 Cor 13,1).
Esistono reti sociali che nell’ambiente digitale offrono all’uomo di oggi occasioni di preghiera, meditazione o condivisione della Parola di Dio. Ma queste reti possono anche aprire le porte ad altre dimensioni della fede. Molte persone stanno, infatti, scoprendo, proprio grazie a un contatto avvenuto inizialmente on line, l’importanza dell’incontro diretto, di esperienze di comunità o anche di pellegrinaggio, elementi sempre importanti nel cammino di fede. Cercando di rendere il Vangelo presente nell’ambiente digitale, noi possiamo invitare le persone a vivere incontri di preghiera o celebrazioni liturgiche in luoghi concreti quali chiese o cappelle.
Non ci dovrebbe essere mancanza di coerenza o di unità nell’espressione della nostra fede e nella nostra testimonianza del Vangelo nella realtà in cui siamo chiamati a vivere, sia essa fisica, sia essa digitale. Quando siamo presenti agli altri, in qualunque modo, noi siamo chiamati a far conoscere l’amore di Dio sino agli estremi confini della terra.
Prego che lo Spirito di Dio vi accompagni e vi illumini sempre, mentre benedico di cuore tutti voi, così che possiate essere davvero araldi e testimoni del Vangelo. “Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura” (Mc 16, 15).
Dal Vaticano, 24 gennaio 2013, Festa di san Francesco di Sales
* Avvenire, 24 gennaio 2013
-
> LA NUOVA AGORA’: «RETI DIGITALI SOCIALI», LA SFIDA DELL’AUTENTICITA’. --- Noi, la Chiesa, e la realtà digitale (di Chiara Giaccardi - Un solo mondo da vivere).25 gennaio 2013, di Federico La Sala
NOTE SUL TEMA:
Noi, la Chiesa e la realtà digitale
Un solo mondo da vivere
di Chiara Giaccardi (Avvenire, 25 gennaio 2013)
McLuhan, che certo conosceva bene opportunità e limiti di ogni ambiente mediale, in una lettera del suo ricco epistolario (oggi avrebbe usato il web!) affermava che per capire veramente un mondo che cambia sempre più in fretta occorre prenderne le distanze. E non esitava ad affermare: «Ciò è possibile solo a un cristiano». La sintesi paradossale di impegno e distacco («nel mondo, ma non del mondo ») è la postura di cui oggi c’è bisogno, per non rimanere vittime del tecno-pessimismo o del tecno-ottimismo a oltranza, posizioni ugualmente fallaci.
Per questo, il messaggio del Santo Padre non parla solo ai fedeli. In un mondo schiacciato sul-l’immanenza, la dittatura del dato di fatto, la difficoltà a stare al passo coi cambiamenti e soprattutto elaborarne il significato per la nostra vita, lo sguardo della fede si offre a tutti, credenti e non, come una riserva di libertà, che chiede dunque visibilità «nel dibattito pubblico e so¬ciale ». Un messaggio, quindi, «cattolico»: indirizzato a «tutto l’uomo e tutti gli uomini» (Caritas in Veritate, 55), perché capace di rispondere alle preoccupazioni di tutti. Come quella che riguarda la realtà oggi: il digitale può dirsi reale? E con quali implicazioni sull’identità, le relazioni, il rapporto col mondo?
A questo riguardo viene posto un punto fermo, che da qui in avanti va assunto come acquisito: «L’ambiente digitale non è un mondo parallelo o puramente virtuale, ma è parte della realtà quotidiana di molte persone, specialmente dei più giovani». È «parte del tessuto stesso della società». Ciò che per gli adulti è ancora in-comprensibile e minaccioso, per le giovani generazioni è la normalità: una realtà fatta di materia e informazione, atomi e bit. Senza competizione né dualismo tra queste dimensioni che concorrono all’unità, così ricca, del nostro presente.
Separare ciò che è unito, benché a partire da timori legittimi, rischia di produrre un effetto «diabolico» (dia-ballo, divido) e una fallace esteriorizzazione del pericolo, come esclusivo prodotto della tecnologia. Con la tentazione di esonero dall’impegno e dalla responsabilità, dimenticando la lezione del Vangelo: non ciò che entra, ma «ciò che esce dall’uomo, questo sì conta¬mina l’uomo» (Mc 7, 14-23).
Anche il «determinismo tecnologico», implicito in tanti discorsi sul web, va superato: la rete ci rende soli, o al con¬trario più socievoli; ci rende incapaci di concentrazione e pazienza o efficienti multitasker... Niente di tutto ciò. Non si può sottovalutare né il ruolo del nostro impegno, né la potenza della Grazia: «La fiducia nella potenza dell’azione di Dio deve superare sempre ogni sicurezza [ma anche ogni paura, si può aggiungere] posta sull’utilizzo dei mezzi umani». Le tec¬nologie non sono certo neutre.
Ma sono l’impegno, il discernimento, la responsabilità (il modo di «abitare», e non di «usare») che fanno la differenza della presenza cristiana, in un ambiente in cui, in forme nuove, si esprimono i bisogni di sempre («Love », amore, è la parola più cercata su Google nel 2012).
Dei tanti aspetti del messaggio, così ricco nella sua semplicità, due mi hanno colpito in particolare, data anche la frequenza con cui ri-corrono: il tema dell’apertura e quello dell’unità, nel loro rimando reciproco. L’apertura è già presente nell’analogia della porta: cos’è infatti la porta se non un’interfaccia, un «dispositivo» che mentre separa due ambienti, indicandone la differenza, contemporaneamente li unisce e ne afferma l’unità? Noi siamo gli stessi, in famiglia e sul lavoro, a casa e per strada, nella piazza o sui social network, per quanto ciascuno di questi ambienti possa chiedere forme di presenza diverse.
La nostra vita è una. Se non lo è, non è certo colpa dei tanti contesti che attraversiamo. Aprire implica sia «uscire» che «lasciar entrare». Le porte delle reti sociali diventano allora un’occasione in più per far crescere la nostra fede, se dire «Io credo in Dio» ci spinge «a uscire continuamente da noi stessi», portando nella realtà quotidiana la certezza della «presenza di Dio nel¬la storia» (dall’Udienza generale dedicata al Credo, 23/1).
Significa anche non aver paura dell’alterità: «Bisogna fa sì che le persone non solo accettino l’esistenza della cultura dell’altro, ma aspirino anche a venire arricchite da essa e ad offrirle ciò che si possiede di bene, di vero e di bello».
Niente cancelli che dividono, dunque, ma simboli: gli stessi di cui la storia della Chiesa è così ricca. E che sono i segni di una «unione nella differenza» che non intende cancellarla (come si vorrebbe invece nel «regime delle equivalenze» così culturalmente potente oggi) né, però, semplicemente prenderne atto.
L’unità della famiglia umana richiede di mantenere aperta la porta della fede, ovvero il nostro legame con Dio sul quale tutti gli altri si fondano. Perché si realizzi anche oggi quanto Rilke auspicava nei suoi «Appunti sulla melodia delle cose»: «L’esperienza ci fa accedere a un’armonia in cui il mondo visibile si trasforma nell’invisibile melodia di uno spazio in cui interno ed esterno, morte e vita, prossimità e lontananza cessano di essere esperienze antitetiche». E, perché no, anche materiale e digitale.
Chiara Giaccardi
-
> LA NUOVA AGORA’: «RETI DIGITALI SOCIALI», LA SFIDA DELL’AUTENTICITA’. --- I tweet del papa e la nuova leva (americana) di comunicatori professionisti in Vaticano (di Massimo Faggioli)25 gennaio 2013, di Federico La Sala
I tweet del papa e la catapulta di Bush
di Massimo Faggioli (L’Huffington Post, 11 dicembre 2012)
La macchina comunicativa vaticana non ha mai avuto paura della modernizzazione dei mezzi atti a raggiungere i fedeli e l’universo mondo. Da questo punto di vista, l’approdo del papa su Twitter rappresenta solo l’ultimo passo, per ora, di un cammino iniziato almeno con Leone XIII nell’uso dei moderni mass media. Gli esperti di comunicazione giudicheranno che tipo di utente è papa Benedetto XVI (o meglio, chi per lui interagisce con questo sistema di comunicazione).
Ma per i cattolici, e i teologi specialmente, "il papa su Twitter" apre una questione relativa agli effetti di questa immediatezza digitale sulle strutture della chiesa e sulle idee che cattolici e non cattolici hanno della chiesa cattolica. Twitter, analogamente alla televisione, dona al papa una nuova accessibilità sia in termini di spazio che di tempo: per vedere il papa non è necessario andare a Roma, per sapere quello che dice non è necessario attendere che arrivino per posta le sue parole. Ma dal punto di vista del funzionamento della chiesa come comunità di credenti con venti secoli di storia alle spalle, è evidente che l’immediatezza e accessibilità indeboliscono la dimensione della "chiesa come comunione" perché indeboliscono, fino talvolta a rendere superflui, molti dei mediatori del messaggio della chiesa - parroci, vescovi, catechisti, genitori, teologi - e tende evidentemente a rendere superflui anche i giornalisti.
Dal concilio Vaticano I (1869-1870) in poi il sistema "chiesa cattolica" ha dato molta più visibilità e poteri al papa di Roma, grazie alle definizioni sul primato e sull’infallibilità papale. Oggi l’immediatezza e l’accessibilità istantanea della parola del papa grazie alle tecnologie come Twitter moltiplicano all’interno della chiesa gli effetti di quel "doping ecclesiologico" deciso dal Vaticano I sotto pressione di papa Pio IX. E’ un fatto nuovo. Infatti, nella lunga storia del cristianesimo ogni documento del magistero della chiesa è sempre sottoposto ad un processo di "recezione": una interpretazione mediata di ogni pronunciamento magisteriale che deve tenere conto del contesto storico del documento, fare una esegesi del testo, e comprendere la posizione di quel testo nel vasto corpus della tradizione della chiesa.
L’immediatezza e l’accessibilità istantanea della parola del papa, invece, indeboliscono indubbiamente il processo di recezione, perché è un processo che ha bisogno di tempi lunghi e di agenti mediatori di quel messaggio all’interno della chiesa: la recezione lavora su testi lunghi e complessi - lunghezza e complessità che non sono un ostacolo, ma al contrario la condizione necessaria per l’interpretabilità di ogni testo religioso.
Non è chiaro se i tweet del papa saranno un conversation starter o un conversation stopper tra il papa e i suoi followers. Ma la nuova leva (americana) di comunicatori professionisti in Vaticano sembra essere andata a lezione da George W. Bush, che spiegò, in un non raro (per lui) momento di candore, che gran parte del suo mestiere di presidente consisteva nel "catapultare la propaganda" al fine di "scavalcare" la stampa e raggiungere direttamente i cittadini. Quella di Bush non era certo una professione di fede nel ruolo della libera stampa in una democrazia. La chiesa non è una democrazia, e il papa su Twitter potrebbe rendere i meccanismi di potere e di autorità ancora di più accentrati su Roma.
-
> LA NUOVA AGORA’ ---- TWITTER, EUCARISTIA, E SIGNORAGGIO WEBICO (di Gaetano Mirabella)27 gennaio 2013, di Gaetano Mirabella
Twitter ed eucaristia
di Gaetano Mirabella
Così come il Cristo spezzò il pane del suo corpo e lo dette come cibo a "tutti" e similmente fece col suo sangue divenuto bevanda per "tutti"; allo stesso modo, il cinguettìo di twitter è come la miriade di mani del Dio vivo che si occupa di mantenere l’immagine di ogni galassia, di ogni pianeta, di ogni strada, di ogni orizzonte, di ogni casa, di ogni città, di ogni filo d’erba e di ogni albero.
Il grande mouse universale, scorre, cliccando sulle galassie e le rende viventi: esso "trascina" sul tappetino piano dell’equatore cosmico, la vita di tutti noi che siamo nutriti, tenuti in vita e trattati come principi e principesse dal divine web master. Il papa dello IOR e delle banche, alimenta invece il signoraggio webico, prestando e distribuendo a "molti", non a "tutti", identità privilegiate, eludendo la vera moneta universale liquida del DIO-Oceano sul quale, il vaticano vuole prevalere distinguendosi, restando solo un onda.
Il divino tsunami del nuovo pensiero liquido ha travolto le fondamenta della vecchia mente facendola crollare. Il pensiero liquido dell’Oceano ha sommerso le coste e indotto le nuove menti nascenti a mettersi in viaggio e, ad attraversare il mar Rosso per uscire dallo stato di minorità, in cerca della terra promessa. Nel deserto del web noi, Hacker della vita, uomini nuovi senza nome, là nel deserto, ricorderemo il nostro vero nome. Nel deserto dell’esternità, prenderemo un neocorpo. Nel deserto lanciati ad occhi chiusi, lacereremo il velo nero dei neuroni condizionati dai peptidi del web finanziario-bancario, aprendo sinapsi che squarcino il velo illusorio della percezione, verso nuove città aperte nell’esternità della nuova mente.
La nuova era è già cominciata ma ci resta ancora da attraversare le gole della vecchia antropologia religiosa. Molti si sentono chiamati dalle sirene della vecchia identità sotto le specie delle pareti di roccia e cadono nel tranello ridiventando roccia, terra e sale, ignorando il rombo del VERBO dell’Oceano che, come mantra fonetico-eidetico, irrompe in tutte le case dai display.
E’ ancora la notte del signoraggio webico in cui vogliono concederci mutui d’identità per farci essere ma splende la luna ed è lei il collo della bottiglia oscura nella quale siamo prigionieri, ma dalla quale potremo uscire, uno per volta, se crederemo in noi stessi. Se crederemo al principe che siamo ri-diventati mangiando il pane webico dell’eucaristia liquida del Dio del display-oceano. E intanto stiamo attenti e porgiamo l’orecchio al DIO-twitter che cinguetta nella notte nera, prima di irrompere nel tuono della rivelazione. Nell’era webica dell’esternità abbiamo costruito la grande bocca che chiama incessantemente, la visione-suono tattile dell’esternità infinita e sempre nuova nel tecnorecchio di DIO.
-
> LA NUOVA AGORA’ ---- Dino Boffo: “Il Papa su Twitter non ce lo vedo anche la Chiesa ubriaca di social network” (di Fabio Tonacci)27 gennaio 2013, di Federico La Sala
Boffo: “Il Papa su Twitter non ce lo vedo anche la Chiesa ubriaca di social network”
di Fabio Tonacci (la Repubblica, 27 gennaio 2013)
Si è rotto qualcosa nel coro unanime di entusiasmo che ha accompagnato fino ad oggi la discesa di Papa Ratzinger su Twitter e l’utilizzo sempre più diffuso dei new media da parte dei preti.
«Non lo vedo bene l’85enne Papa, teologo e pensoso, ad avere a che fare con Twitter - ha detto ieri Dino Boffo, direttore di Tv 2000 della Cei - basta con questa ubriacatura da social network, anche dentro la Chiesa». Classico fulmine a ciel sereno, perché arriva da uno dei maggiori esperti di comunicazione della Chiesa italiana. Segnale però che qualche dubbio cova sotto la cenere, e che non tutti i fedeli e i sacerdoti sono convinti della scelta di Benedetto XVI, quasi che le attività in rete possano contribuire ad alimentare lo svuotamento delle chiese e la crisi delle vocazioni.
Boffo ha parlato a Venezia durante un incontro organizzato dal Patriarcato per la festa di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti. «Questa ubriacatura la pagheremo cara - ha aggiunto, in un discorso diventato accusa - ci sveglieremo che non avremo più i nostri media cattolici, quelli classici che ti mettono a contatto con il cuore vivo della comunità». Non solo. «I social network sembrano dare sprint e un tocco di notorietà a buon prezzo, ma non possono sostituirsi agli altri», ha ribadito Boffo durante l’incontro di ieri, nel quale ha anche accennato alle false accuse del Giornale che lo travolsero nel 2009 costringendolo a lasciare la direzione di Avvenire («Fui vittima di un giornalismo killer»).
L’intervento di Boffo sui social network non è stato proprio una carezza per tutti quei cybernauti della fede impegnati sui vari facebook e twitter, che giusto tre giorni fa avevano avuto la benedizione del pontefice nel messaggio per la 47esima Giornata mondiale delle comunicazioni sociali.
«Non capisco i toni apocalittici di Boffo - dice a Repubblica l’arcivescovo Claudio Maria Celli, presidente del Pontificio Consiglio delle comunicazioni sociali - e non vedo nemmeno l’“ubriacatura” di modernità. Il Papa non intende certo sostituire i media vecchi con quelli nuovi, ma è un fatto che oggi il 35 per cento dei giovani si informa su Internet. Certe persone troveranno solo in rete la parola del Signore, e lì la Chiesa ci deve essere».
I numeri parlano chiaro. I seguaci del Papa su Twitter hanno superato i 2 milioni e mezzo nelle otto lingue tra cui il latino in cui è già attivo l’account. Il profilo italiano di Ratzinger conta più di 288 mila follower (l’ultimo tweet è del 23 gennaio e recita «molti falsi idoli emergono oggi. Se i cristiani vogliono essere fedeli, non devono avere timore di andare controcorrente »). E poi ci sono i “sacerdoti del web”, sempre più numerosi. C’è il cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della cultura, con 32 mila follower. L’arcivescovo di Napoli Crescenzio Sepe sta pensando di iscriversi («Anche Gesù, se nascesse oggi, sarebbe su Facebook »).
E, tra monsignori, vescovi, suore e sacerdoti online, c’è anche don Antonio Spadaro, direttore di Civiltà cattolica, che ha più di 6000 follower su Twitter ed è autore del blog Cyberteologia. Alla polemica aperta da Boffo non vuole rispondere. Era stato più loquace quando sull’Osservatore romano apparve qualche mese fa un articolo di Christian Martini Grimaldi nel quale in sostanza si sottolineava il rischio di «isolamento » per chi usa troppo i social network. «Attribuire al web le colpe che sono nostre - scrisse allora sul suo blog Spadaro - è solo una forma di deresponsabilizzazione ».
-
-
-
- IL CATTOLICESIMO COME TRADIMENTO STRUTTURALE DEL MESSAGGIO EVANGELICO, DEL CRISTIANESIMO. UN’OBBEDIENZA CIECA DI LUNGA DURATA: TUTTI AGGIOGATI AL DIO-VALORE, AL DIO-MAMMONA ("Deus caritas est": Benedetto XVI, 2006)!
-
> PENSIERO LIQUIDO E CROLLO DELLA MENTE. --- LE "REGOLE DEL GIOCO" DELL’OCCIDENTE ALLA LUCE DEL SOLE.22 gennaio 2013
 PIANETA TERRA. Fine della Storia o della "Preistoria"? "Pietà per il mondo, venga il nuovo sapere"(M. Serres, Distacco, 1986).
PIANETA TERRA. Fine della Storia o della "Preistoria"? "Pietà per il mondo, venga il nuovo sapere"(M. Serres, Distacco, 1986).
 LE "REGOLE DEL GIOCO" DELL’OCCIDENTE ALLA LUCE DEL SOLE. Un’interpretazione dell’intera storia della filosofia, semplicemente straordinaria, di Federico La Sala - a c. della red. della "Voce di Fiore"
LE "REGOLE DEL GIOCO" DELL’OCCIDENTE ALLA LUCE DEL SOLE. Un’interpretazione dell’intera storia della filosofia, semplicemente straordinaria, di Federico La Sala - a c. della red. della "Voce di Fiore"
 "Oriente e Occidente - scrive Nietzsche in Schopenhauer come educatore - sono tratti di gesso che qualcuno disegna davanti ai nostri occhi per beffarsi della nostra pavidità".
"Oriente e Occidente - scrive Nietzsche in Schopenhauer come educatore - sono tratti di gesso che qualcuno disegna davanti ai nostri occhi per beffarsi della nostra pavidità".
-
> PENSIERO LIQUIDO E CROLLO DELLA MENTE. --- FILOSOFI E FILOSOFE, TEOLOGI E TEOLOGHE, IN COMA PROFONDO. IL MAGISTERO EQUIVOCO DI BENEDETTO XVI OGGI (2006-2012) E CIO’ CHE OGNI BUON CATECHISTA INSEGNAVA IERI24 agosto 2012, di Federico La Sala
DIO E’ VALORE! Sul Vaticano, in Piazza san Pietro, sventola il "Logo" del Grande Mercante: "Deus caritas est" (Benedetto XVI, 2006)!!! Il papa teologo, ha gettato via la "pietra" su cui posava l’intera Costruzione ...
SE DIO SI E’ FATTO PAROLA, IO NON POSSO GIOCARE CON LE PAROLE ... IL CATECHISTA NON USA MAI PAROLE EQUIVOCHE: PARLARE DI CARITÀ SIGNIFICA PARLARE DI GRAZIA
-
> PENSIERO LIQUIDO E CROLLO DELLA MENTE. --- La rivoluzione che stiamo vivendo: "La rivoluzione dell’informazione" di Luciano Floridi. Organismi informaticamente modificati (di Serena Danna)6 agosto 2012, di Federico La Sala
 La proposta di Floridi per essere protagonisti della rivoluzione comunicativa
La proposta di Floridi per essere protagonisti della rivoluzione comunicativa
 Organismi informaticamente modificati
Organismi informaticamente modificati
 Servono una nuova metafisica e un’etica integrata per poter conciliare le esigenze di scienza e natura
Servono una nuova metafisica e un’etica integrata per poter conciliare le esigenze di scienza e naturadi Serena Danna (Corriere dela Sera/La Lettura, 05.08.2012)
«Fino a quando ci ostineremo a spiegare Facebook con McLuhan o Internet con Gutenberg, continueremo a non capire la rivoluzione che stiamo vivendo». A parlare, connesso via Skype da Oxford, è il filosofo Luciano Floridi, oggi ricercatore di punta della prestigiosa università inglese dopo anni di docenza in logica ed epistemologia. È arrivato a Oxford venticinque anni fa con una borsa di studio e l’obiettivo di laurearsi con il grande logico Michael Dummett. Poche ore prima della partenza suo padre gli disse: «Almeno potrai dare ripetizioni d’inglese». Sono passati 25 anni: l’Inghilterra è diventata la sua patria, lì - tra dormitori stracolmi e avanguardistici laboratori d’informatica - Floridi, 48 anni, ha contribuito a fondare una nuova branca della filosofia legata all’informazione.
La rivoluzione dell’informazione, titolo del saggio appena uscito in Italia per Codice, è considerata dal filosofo la quarta rivoluzione scientifica, dopo quelle segnate dalle scoperte di Copernico, Darwin e Freud.
«Storia è in realtà sinonimo di età di informazione - scrive Floridi - dal momento che la preistoria è quell’età dell’evoluzione umana che precede la disponibilità di sistemi di registrazione». La possibilità di ricevere e trasmettere dati hamodificato radicalmente la comprensione del mondo e di noi stessi. Peccato l’abbiano capito in pochi: «Siamo al centro di un ribaltamento etico e filosofico - afferma - ma continuiamo a pensare alla tecnologia come hardware». Scrive il filosofo: «La società dell’informazione è come un albero che ha sviluppato i suoi lunghi rami in modo molto più ampio, rapido e caotico, di quanto non abbia fatto con le sue radici concettuali, etiche e culturali». Ma la colpa non è solo dell’approccio «passatista» dei teorici della comunicazione: fin dall’inizio la tecnologia è stata intesa come un «fenomeno computazionale», calcoli e macchine. «Abbiamo guardato all’informatica troppo come matica e poco come info», scherza il docente di Oxford, convinto che l’enfasi sull’hardware abbia coperto per cinquanta anni la verità, ovvero: «quegli aggeggi gestivano la ricchezza che avrebbe cambiato il mondo: l’informazione».
In realtà c’è chi l’aveva capito subito: il geniale matematico e crittografo Alan Turing. «Si può considerare il vero padre della Filosofia dell’informazione - sottolinea Floridi -, Turing non inventa un potentissimo calcolatore ma una macchina teorica, un modello di calcolo applicabile dalla biologia al mondo militare». Tra i visionari annoverati dal filosofo c’è anche il fondatore di Apple, Steve Jobs, che negli anni Ottanta capì che i computer «dovevano servire non a fare calcolima a fornire interfacce migliori, per favorire l’interazione con gli utenti». Inoltre gli studiosi hanno dedicat0 tempo ed energia allo studio della cosiddetta Intelligenza artificiale, grande abbaglio del secolo scorso: «Le interpretazioni fantascientifiche della tecnologia hanno depistato tanti cervelli. Un pc di oggi non è più intelligente di un frigorifero degli anni Novanta: “smart” significa solo che ci rende la vita più facile». Come un televisore con i programmi personalizzati o un pedaggio che addebita i costi su carta di credito.
La tecnologia applicata alle nostre vite non ci renderà cyborg, piuttosto «inforg», ovvero «organismi informazionali interconnessi». «Le Ict (Information and communication technology ndr) stanno creando un nuovo ambiente informazionale - scrive Floridi - nel quale le generazioni future passeranno la maggior parte del loro tempo». Se l’ambiente che ci circonda si basa sull’informazione - intesa come insieme di dati - la tecnologia serve a creare porte di accesso sempre più amichevoli per gli utenti. Questa nuova dimensione, che Floridi chiama «infosfera», abbatte definitivamente la differenza tra reale e virtuale cara al XX secolo: «Il digitale - continua il filosofo - si sta diffondendo nell’analogico e confondendo con esso». In futuro un numero sempre maggiore di oggetti saranno IT-enti (enti che incorporano la tecnologia dell’informazione), capaci di scambiare informazioni. In realtà accade già: «L’esperienza comune di guidare un’auto seguendo le indicazioni fornite dal gps - si legge nel saggio - mostra chiaramente quanto sia diventato inutile chiederci se siamo online».
Colmare il digital divide diventerà una priorità: «Il divario ridisegnerà la mappa della società mondiale, provocando o approfondendo le divisioni generazionali, geografiche, socioeconomiche e culturali».
«Se cambia la cultura deve però cambiare anche la maniera di intendere il mondo », puntualizza il filosofo. «Prima della rivoluzione industriale - spiega - il concetto di realtà era legato all’immutabilità: una cosa esisteva solo se non cambiava». Con l’industrializzazione siamo passati a una metafisica dell’esperienza - «il reale è solo ciò che possiamo esperire direttamente» - in cui siamo ancora imprigionati. Dovremmo ripensare la metafisica in termini informazionali: «Oggi l’esperienza con un oggetto non si basa più sui cinque sensi ma sull’interazione con esso, che non è necessariamente fisica».
Come la metafisica, anche l’etica va rivoluzionata: «Quella occidentale si fonda sulla centralità di colui che agisce e sul diritto ad assecondare i propri desideri a discapito dell’ambiente», afferma Floridi. Questa visione ha portato a un conflitto tra physis e techné, natura e scienza e, in anni più recenti, a considerare l’ambientalismo un’alternativa alla tecnologia. Un errore: «Dobbiamo lavorare per l’e-nvironmentalism, un ambientalismo che tenga in considerazione la tecnologia, e per una nuova etica basata su chi l’azione la riceve».
In un ambiente che ha come principio primo l’informazione, diventa fondamentale mettere tutti nelle condizioni di riceverla e capirla. Già Socrate vedeva nei comportamenti sbagliati dell’individuo l’esito della mancanza di informazioni. Ma Floridi è lontano dall’«intellettualismo etico» del filosofo greco: la questione non è aumentare le informazioni, come sostiene il filosofo David Weinberger, autore di Too big too know. «L’umanità soffre di bulimia informativa perché prima del web ha vissuto in digiuno permanente. L’overload di oggi però non è sostenibile ed è incompatibile con una cultura che identifica la conoscenza con la memorizzazione». La soluzione per Floridi sta nel fornire gli strumenti per comprendere le informazioni e poterle trasmettere. «A cosa servono centinaia di righe e di link su una pagina di chimica di Wikipedia se poi sono costretto a fermarmi alla terza riga perché non capisco nulla?». Già, a che cosa?
Serena Danna
-
> PENSIERO LIQUIDO E CROLLO DELLA MENTE. ---- L’EPICA E LA SUA ECLISSI PLEBEA (di Fulvio Papi)2 agosto 2012, di Federico La Sala
AGORÀ
L’EPICA E LA SUA ECLISSI PLEBEA
di Fulvio Papi *
Un’epica nella tradizione classica è per lo più riconosciuta come identità culturale di un popolo.Una narrazione in cui ognuno, ascoltandola, riconosce i propri luoghi simbolici di origine, i personaggi che incarnano virtù arcaiche e tuttavia condivise, le scene salienti che diventano spettacoli interiori della memoria collettiva nel tempo, cioè una tradizione che continua a provocare scene esemplari nella propria vita pubblica e non solo.
Credo di aver evocato la famosa definizione di Havelock intorno ai poemi omerici come enciclopedia della tribù. Naturalmente è una enciclopedia che è soggetta a trasformazioni molto importanti poiché secondo la forma comunicativa che assume, dal canto dell’aedo alla tragedia classica, si configura secondo significati etici diversi. P
robabilmente, nell’ascolto orale, è la grande ammirata curiosità per quasi un vichiano “tempo degli eroi”; nella rappresentazione tragica l’acquisto di una dimensione sempre esemplare, ma più prossima al proprio giudizio come alla propria emozione - almeno Aristotele ci fa pensare così.
Quando poi l’epos diventa testo scritto stabile allora acquista la dimensione ideale della letteratura e quindi la distanza di una finzione che non ha più bisogno di appartenere a una storia mitizzata o immaginaria, ma assume quello statuto speciale che ha la grande letteratura come “mondo possibile” tutt’altro che privo di senso per la propria contemporaneità.
Dall’epos originario, senza voler improvvisare interpretazioni semplici e frettolose, deriva un genere letterario del quale l’Eneide è esempio che crea uno sfondo mitico a una storia politica in corso, un legame diretto tra la mitologia diffusa del passato e le vicende storiche del presente.
Quindi un’epica che trasforma, secondo una nuova sensibilità letteraria, i “topoi” più antichi, ne eredita anche gli stilemi, ma cita il suo significato etico. Questo per un verso, che, per l’altro, sono gli eroi ad assumere una propria tipicizzazione a diventare sia figure del pantheon ideale, sia personaggi che esemplarizzano, con le loro storiche trasformazioni, le forme della vita quotidiana.
Primo fra tutti Ulisse, il personaggio che ottenne il maggior numero di metamorfosi, che cominciarono tra il testo dell’Iliade e quello dell’Odissea per - come tutti sanno - giungere a una sua trasformazione nel nostro quotidiano nel celebre libro di Joyce. La trasformazione del racconto epico diviene la parodia epica di un giorno qualsiasi gettato nel nostro mondo dove, per cogliere un aspetto eclatante, il linguaggio dissolve, nelle sue fughe prammatiche, nell’intrico lessicale dei luoghi, qualsiasi memoria dello stile originario senza il quale ogni eroe diventa necessariamente figura di un altro tempo.
La letteratura corrode, distrugge, reinterpreta un personaggio mitico e, nella sua distruzione necessaria, infine ne rievoca l’origine. Non c’è altra origine, nel contemporaneo vissuto, che quella capace di mostrare la sua impossibilità.
È diverso il caso degli straordinari racconti della Bibbia che la tradizione religiosa, da Agostino in poi, reinterpreta nella storia della rivelazione cristiana. E tuttavia, almeno da Spinoza in poi, possono essere considerati come elementi fondamentali dell’epica del popolo ebraico, una serie di vicende ciascuna delle quali, diversamente da un’epica che diventa tessuto della trasfigurazione letteraria, mantiene la sua potenza etica, sapienzale, religiosa.
Di un’epica, e di quei testi o tradizioni che noi chiamiamo epica, esistono necessariamente custodi sociali, interpreti, esegeti, spesso in gara o in polemica tra loro, e sono quelli che la tramandano, sino a quando intervenga una sapienza scientifica che riconduce un testo alla sua verità mondana o, che è una filologia del tutto differente, al suo valore religioso.
Nel caso greco il testo che noi possediamo ci narra della tradizione degli aedi come narratori, il celebre Demodoco, ma lo stesso Ulisse, autobiografico alla reggia dei Feaci, diventa una figura di aedo. Ogni grande epica ha una propria storia complessa alla quale deve le sue trasformazioni di senso nelle diverse congiunture culturali.
Tutti sanno che nella musica di Wagner prese nuova forma drammatica una grande eredità epica. Anche se fu proprio il giovane Nietzsche a sostenere che era la musica wagneriana a vivificare il senso dell’epos e non era la tradizione epica ad essere “messa in musica”. Era per Nietzsche lo stesso ragionamento per cui l’origine dionisiaca della tragedia greca era rappresentata dal coro.
Un’epica, in ogni caso, implica un patrimonio narrativo, un mondo storico che vi si riconosca e un vettore che lo ricordi, lo attualizzi e lo diffonda e ne crei l’aspettativa sociale. Il teatro greco, come tutti sanno, porta sulla scena come patrimonio educativo della città la tradizione e i temi dell’epica. La medesima funzione è svolta dal teatro wagneriano. Così che ogni epica ha il suo patrimonio di eroi che, nella loro individualità, sintetizzano sempre valori che sono condivisi nell’ethos nel quale si diffonde e rinasce un tesoro epico.
Questa considerazione è in sintonia con la tesi di Hegel nella Fenomenologia secondo cui l’eroe non fa che interpretare al livello supremo, e con sacrificio personale, quello che è un sentimento, un desiderio o un dovere diffuso nella comunità di appartenenza.
L’idea del proprio sacrificio volontario come prezzo dell’azione eroica è probabilmente un topos spirituale di origine cristiana. Il sacrificio scompare lasciando il posto al modello etico e politico nella trasformazione del romanzo, secondo i canoni degli anni Trenta, del realismo socialista, in un’epica burocratica che deve affermare i valori del potere politico, così come avveniva nell’URSS staliniana. Un’epica sociale a comando che, in qualche rara circostanza, quando lo scrittore era impegnato con il suo talento e la sua immaginazione, poteva dare anche risultati letterariamente accettabili.
Ma non è certamente un caso il fatto che l’ultimo disegno epico, nella società con cui abbiamo una vera familiarità, appartenga a una poetica politica, sostenuta e valutata da un potere autoritario. Poiché, se proviamo a proiettare la domanda intorno alla presenza epica nella nostra epoca, possiamo ritrovare aspetti della tradizione che in qualche modo è stata rievocata? O, per estendere lo sguardo e rievocare un’altra grande tradizione, quella della Chanson de Roland, esistono ancora elementi di quel nucleo epico-poetico nel nostro mondo?
Il fatto è che la poesia epica non esiste più già con l’affermazione, in Italia, della grande poesia di Dante e Petrarca: esistono nella Commedia e nel De Africa personaggi di primo piano, gli uni valorizzati dalla esperienza della vita comune, gli altri tipicizzati secondo la tradizione classica delle figure esemplari.
L’epica si trasferisce dalla grande letteratura alla narrazione storica che valorizza i processi di unità nazionale e, in questo senso, è un’epica che falsifica i dati storici reali per costruire una credenza epica intorno ai personaggi rilevanti nell’ambito della storia nazionale. È dunque intorno all’unità politica della nazione che si sviluppa un narrare epico il quale vuole costruire essenzialmente la cultura identitaria e partecipazionale dei cittadini.
Basti pensare alle narrazioni storico-scolastiche tipiche dell’educazione storica americana cui, per molti anni, ha fatto eco una tradizione filmica. E chiunque conosca anche di profilo la storia della scuola italiana, sa che il periodo risorgimentale e le sue figure salienti erano diventati occasioni per narrazioni scolastiche dove era rintracciabile una forma di epos storico della nazione.
Ora questa dimensione è venuta in gran parte meno e non perché si sia diffuso un più maturo giudizio storico, ma perché nell’immaginazione collettiva il vettore epico non è più stato l’epopea storica della nazione, ma l’apparire di figure, eroi senza storia, che appartengono all’affermarsi di quello che già Debord analizzava negli anni Sessanta come la società dello spettacolo.
Non c’è più alcuna epica che si tramanda e il racconto nel quale avviene l’apparizione dell’eroe non ha la caratteristica della lunga durata. L’eroe, come tutti gli oggetti nel nostro mondo, è dato al consumo, e tuttavia la sua figura tende ad emergere come individualità mitica al di là delle narrazioni, all’origine filmiche, dove compare nella contingenza di storie differenti e prive di qualsiasi continuità.
Il racconto può essere dimenticato, ma il personaggio rimane nell’immaginaria ricordanza collettiva. È il fenomeno che si manifestò in una maniera eclatante soprattutto nel primo periodo della storia del cinema, e per comprendere l’epica del nostro tempo è necessario guardare agli eroi che appaiono nel nostro orizzonte. Essi sono privi di un racconto mitico che li contestualizzi, nel pubblico comprendere sono immagini delle quali è un grande spettacolo scoprire gli elementi biografici.
Nell’autobiografia il pubblico scopre che la storia dell’eroe ha aspetti di somiglianza con la propria, e questa curiosità rende l’eroe più prossimo alla propria esperienza, forte del suo potere di immagine, ma, in realtà, privo di una storia che travalichi i limiti della esperienza possibile se pure, come accade - ed è sempre accaduto - nel mondo delle stars, enfatizzata oltre misura. Questo è il caso tipico della nostra contemporaneità dello spettacolo che tuttavia corrisponde a un contesto di più antica data, dove il rapporto tra l’eroe e il suo spazio sociale e narrativo è dato dal “proprio tempo”.
L’eroe è l’eroe del proprio tempo, la narrazione corrisponde all’oggettività temporale, è uno schema che si ripete da Lermontov sino ai primi anni Cinquanta del nostro Pratolini. Ma in questi casi, anche se il contesto epico è il tempo storico, il vettore resta la scoperta narrativa. C’è quindi una differenza fondamentale con gli eroi del “nostro tempo” che sono sempre personaggi dello spettacolo, siano essi attori nel senso classico della parola o sportivi, o uomini politici, i quali hanno compreso che più che lo studio e l’intelligere, conta la visibilità intorno alla quale creare consenso.
Ma quello che può essere ancora più interessante è che l’eroe dello spettacolo epico, come ogni altro oggetto è sul mercato e ha un suo prezzo d’acquisto. Poiché non è mai vero che il tale atleta “non è cedibile” come talora si dice. Il problema è l’incremento del prezzo, se, per ipotesi, esso potesse salire di cinque volte, chiunque diventa cedibile. A questo punto la manovra è quella di comperare sul mercato il personaggio che è in grado di fortificare l’epos pubblico che accompagna ogni squadra sportiva. Non è la patria, il territorio, l’origine, la condivisione epica a formare il personaggio dell’epos popolare, ma esso appartiene già a un alone epico, e si tratta solo, attraverso una operazione commerciale, di trasferire il personaggio in un altro luogo. La sua funzione epica resta eguale ma è il pubblico della sua fruizione che è differente.
Potenzialmente re Mida può comperare tutte le possibilità di epicizzazione immaginaria della nostra epoca, anche se non bisogna dimenticare che il pubblico trascrive l’eroe nel suo racconto in quanto esso è impegnato in una “guerra”, qual è la metafora nata negli anni Sessanta e relativa al gioco del calcio.
In ogni caso Priamo, re di Troia, non è in grado di comperare alcun eroe acheo, ma solo il cadavere del proprio figlio ucciso dall’eroe avverso. Ogni eroe ha il suo luogo, né può esserlo fuori da questa relazione, l’eroe dello spettacolo sportivo contemporaneo assomiglia a quel “non luogo” di cui parla Augé per mostrare l’eguaglianza spaziale del nostro vivere sociale.
Si può aggiungere, per quanto riguarda lo spettacolo propriamente detto - quindi non la spettacolarizzazione dell’esistenza sociale - che già negli anni Trenta e Quaranta era fortissimo il fenomeno delle stars cinematografiche. E se Plutarco era il modello etico-comportamentale di personaggi immensi e difficili come Rousseau e Foscolo, l’attrice bizzarra e capricciosa, che in queste caratteristiche faceva consistere la “virtus” femminile, fu il modello comportamentale di molte banali piccolo borghesi degli stessi anni.
Con la mutazione dei mezzi di comunicazione e con la diffusione dello spettacolo ininterrotto, il cinema ha perduto la sua vis mimetica. L’epica avviene anche in assenza di “intrigo”, dato che è lo spettacolo stesso o la proliferazione di simulacri, alla Baudrillard, a sostituire, con la forza dell’immagine, la narrazione medesima.
L’apparizione quotidiana è l’epos quotidiano, ma è anche necessariamente un epos che ha sue leggi immanenti. Questa situazione infatti richiede contemporaneamente due condizioni. L’una che un eroe pubblico rimanga tale per un periodo sufficiente a creare il processo di “eroicizzazione”, ma, nel contempo, occorre che vi sia un certo consumo di eroi, e quindi una serie di spezzati frammenti epici poiché è il nuovo che mantiene aperto l’interesse in relazione con il ciclo della abitudine.
Inoltre il genere epico che richiede il vettore della scrittura e del testo è del tutto scomparso, se si fa eccezione per qualche rara composizione poetica che ne assume lo stile. E questo accade perché l’epica richiede un riconoscimento partecipativo che è del tutto impossibile nel tempo di un individualismo esasperato, non esistono modelli che abbiano una loro universalità etica e quindi richiedono una certa trascendenza del se stesso per una imitazione riuscita. Noi pensiamo che il fenomeno sia piuttosto recente, ma non vorrei ignorare che anche Goethe nel Faust ricorda la partenza degli dèi dal nostro mondo.
Sappiamo che oggi l’ammirazione sociale, simile a quella della plebe romana per i gladiatori, va ad icone sociali nelle quali il pubblico legge il desiderio che è nel profondo della propria identità. La partecipazione epica rinasce sfigurata nelle urla degli stadi di calcio, nella violenza insensata che, in realtà (a dispetto delle chiacchiere degli addetti ai lavori per lo più intellettualmente sprovveduti) costituisce la realizzazione della metafora della guerra che è presente nel gioco medesimo, e che solo una consuetudine alla educazione riesce a neutralizzare. Ma in alcune condizioni sociali, spesso riprodotte, il germe della violenza è difficilmente contenibile. Di queste situazioni la parodia, per fortuna inoffensiva, si ha quando il desiderio di violenza è circoscritto nella solitudine dinnanzi al video. In questo caso la cellula impazzita dell’epos è ridotta a un cortocircuito della propria immaginazione.
* TESTO RIPRESO DAL SITO DELLA RIVISTA "ODISSEA", DIRETTA DA ANGELO GACCIONE
-
> PENSIERO LIQUIDO E CROLLO DELLA MENTE. ---- "L’ultimo dio": Non avrai altro dio fuori del web (di Carlo Formenti).12 giugno 2012, di Federico La Sala
Non avrai altro dio fuori del web
di Carlo Formenti (Corriere della Sera, 12 giugno 2012)
Nel Novecento filosofi, storici e sociologi si sono a lungo confrontati sulla categoria di secolarizzazione, con la quale si cercava di spiegare come e perché i valori religiosi sopravvivano all’indebolimento della fede, influenzando pratiche e comportamenti sociali anche dopo la loro trasformazione in regole etiche (apparentemente) prive di connotati religiosi. Vedi, in proposito, la tesi di Max Weber che identificava nell’etica dei Paesi a tradizione calvinista il motore dello sviluppo capitalistico.
Nell’epoca attuale, che si vuole postmoderna e pratica il relativismo etico, il concetto si è ristretto, riducendosi banalmente a evocare lo scetticismo (occidentale) nei confronti dei dogmi religiosi. Contro le tesi che attribuiscono alla nostra civiltà un grado elevato e irreversibile di secolarizzazione, c’è però chi sostiene che essa è al contrario inconsapevolmente immersa in uno stato di entusiasmo mistico, «posseduta» da una nuova fede generata dalla tecnica, cioè proprio dalla forza che viene indicata come il più potente agente della secolarizzazione.
Si tratta d’una religione che non ha nome né chiese, ma alla quale non mancano sacerdoti e masse di fedeli. I primi sono quei «profeti» della rivoluzione digitale - ingegneri e informatici, ma anche economisti e sociologi - che da un ventennio predicano l’avvento di una economia «immateriale» in grado di sovvertire il principio di scarsità e generare una prosperità illimitata, di un mondo senza Stati e gerarchie in cui i «cittadini della rete» saranno in grado di autogovernarsi dal basso, di un salto evolutivo verso un’identità «post umana», che consentirà ai nostri discendenti di emanciparsi dai vecchi limiti fisici e mentali: una mutazione destinata a scaturire dalla ibridazione progressiva fra uomini e macchine e dalla loro integrazione in un nuovo tipo di coscienza collettiva.
A rilanciare la riflessione nei confronti di questo credo sono due libri appena usciti: L’ultimo Dio, di Paolo Ercolani (con prefazione di Umberto Galimberti, editore Dedalo, pagine 240, 16), e Homo immortalis, firmato dalla divulgatrice scientifica Nunzia Bonifati e dal teorico dell’informazione Giuseppe O. Longo (editore Springer, pagine XII-283, 24 ).
Il primo analizza il lavoro paradossale di una tecnica che, da un lato, «erode il trono di Dio» appiattendo sul presente la nostra esperienza (e quindi neutralizzando la prospettiva escatologica), dall’altro, si appropria del ruolo della produzione di senso, impedendo all’umanità di divenire soggetto e non più oggetto della storia.
Il secondo si concentra sulla fascinazione di un discorso tecnologico che promette - grazie al «miglioramento» eugenetico della specie e alle pratiche di ibridazione uomo-macchina - di realizzare in questo mondo il grande annuncio che la religione proiettava nell’al di là, e cioè la definitiva sconfitta della morte.
Anche chi condivida questi argomenti, tuttavia, non può esimersi dal sollevare un dubbio: non rischiamo di attribuire dignità di religione a un’ideologia che, in fondo, riguarda un pugno di «visionari» tecnofili? E se di religione si tratta, dove sono le masse di fedeli evocate poco sopra?
Eppure non è difficile rispondere: come altro definire le centinaia di milioni di utenti di Facebook, Twitter, iTunes e altri social network che accettano di sottostare agli editti di Zuckerberg e altri «sommi sacerdoti», che detengono il potere di cambiare le loro vite modificando pochi parametri? Il Gruppo Ippolita, un collettivo libertario autore dell’ebook Nell’acquario di Facebook (fra qualche mese verrà pubblicato anche in cartaceo), lo chiama default power, e aggiunge un altro convincente argomento: come non definire religiosa la fede cieca, comune ad anarco-capitalisti e hacker, cyberliberisti di destra, come Zuckerberg, e di sinistra, come Assange, nella bontà dell’informazione come dispensatrice di verità e libertà, in barba a tutte le prove che dimostrano come ci troviamo piuttosto di fronte a nuovi strumenti di manipolazione di massa?
In conclusione: non è difficile capire perché intellettuali cattolici di punta come il direttore di «Civiltà Cattolica», padre Antonio Spadaro, si impegnino a riflettere sulle implicazioni teologiche di Internet: non è semplice curiosità intellettuale, ma lotta per contrastare l’ascesa di un rivale che, almeno in Occidente, potrebbe rivelarsi più pericoloso dell’islam.
-
> PENSIERO LIQUIDO E CROLLO DELLA MENTE. ---- "Cyberteologia. Pensare il Cristianesimo al tempo della rete". Quando la teologia diventa un network (di Marco Ansaldo)13 giugno 2012, di Federico La Sala
Quando la teologia diventa un network
di Marco Ansaldo (la Repubblica, 13 giugno 2012)
«È la ricerca inesausta di senso che mi ha fatto capire il valore del cavo Usb che ho in mano. E so che il mio iPad ha a che fare con il mio inestinguibile desiderio di conoscere il mondo, mentre il mio Galaxy Note mi dice (anche quando è in silenzio) che io sono fatto per non stare da solo. Ma è la poesia di Whitman che mi dà il gusto del progresso. Ed è Eliot che mi fa attento a non cadere nei suoi tranelli. Ma è anche Flannery O’Connor che mi fa capire che “la grazia vive nello stesso territorio del diavolo” e pian piano lo invade».
Chi scrive queste righe intense potrebbe essere un giovane letterato appassionato di tecnologia. Oppure un poeta capace di affidarsi agli strumenti più moderni della scrittura. O ancora un filosofo in grado di districarsi tanto nella spiritualità quanto nelle frontiere più avanzate dell’innovazione digitale. È, invece, un prete. Un giovane sì, ma già affermato sacerdote, anzi un teologo, che probabilmente come molti altri suoi colleghi è capace di unire la propria ricerca - e l’insegnamento religioso - servendosi delle forme più recenti che la rete offre. A dimostrazione, ancora una volta, che la Chiesa, dalle più sperdute parrocchie di periferia fino agli austeri Sacri Palazzi del Vaticano sta adottando una rivoluzione che ne sta trasformando l’approccio e il linguaggio.
Pioniere di questo sviluppo è di sicuro padre Antonio Spadaro. Un gesuita messinese dallo sguardo attento, da pochi mesi direttore di un quindicinale prestigioso come La Civiltà Cattolica che esce con l’imprimatur della Segreteria di Stato vaticana, e persona i cui interessi spaziano appunto dalla letteratura alla poesia, dalla pittura alla musica. E che trova una sintesi fondamentale dei propri orizzonti nella religione spiegata anche attraverso l’uso della tecnologia.
Il Vaticano, al più alto livello, si è accorto di questo quarantacinquenne docente alla Pontificia Università Gregoriana. E lo stesso Papa Benedetto XVI di recente lo ha nominato consultore in due dicasteri chiave, quello della Cultura affidato alle capacità multiformi del cardinale Gianfranco Ravasi, e quello delle Comunicazioni sociali affidato alle mani sapienti di monsignor Claudio Celli. È stato Spadaro, già nel 2006 a dedicare ai nuovi fenomeni dell’interattività saggi come Connessioni. Nuove forme della cultura al tempo di Internet, e due anni fa l’innovativo Web 2.0. Reti di relazione.
Molto attivo nell’ambito dei network, ha fondato nel 1998 uno dei primi siti di scritture creative, “Bombacarta. it”. Lo scorso anno ha poi inaugurato il blog “Cyberteologia. it”, aprendo infine una pagina Facebook dedicata, un account Twitter e da ultimo un quotidiano online.
Dunque un veterano. E questo suo nuovo libro, Cyberteologia. Pensare il Cristianesimo al tempo della rete (Vita e Pensiero, pagg. 148, euro 14), non è affatto una raccolta di messaggi. Quanto piuttosto una riflessione argomentata sulla questione se la rivoluzione digitale in atto nel mondo contemporaneo tocchi in qualche modo oggi anche la sfera della fede.
E la risposta che il teologo e direttore di Civiltà Cattolica dà in modo tutt’altro che assertivo, ma problematico, è che adesso è forse arrivato il momento di considerare la possibilità di una “cyberteologia”, vista come «intelligenza della fede al tempo della rete» (la rima, probabilmente voluta, è sua). Perché la logica dei network offre spunti inattesi alla possibilità di affrontare temi come la trascendenza, la comunione, il dono. E in tutto questo la teologia può aiutare l’uomo a trovare sentieri nuovi e più appropriati.
Ma pure Spadaro, con la sua passione per le arti e l’indiscusso background tecnologico, ammette che hic sunt leones, si tratta cioè di un territorio ancora inesplorato, selvaggio, poco frequentato. Di fronte al quale lui stesso all’inizio si è trovato a disagio, nel tentativo di spiegare, di fronte allo schermo bianco del suo computer.
Ha poi risolto l’impasse. E la lettura vale il tempo impiegato, fino alle ultime pagine, intessute dal raccordo di grandi pensatori, alcuni già con la mente protesa alle trasformazioni di oggi: «È il poeta Gerard Manley Hopkins che mi ha aiutato a capire il ruolo dell’innovazione tecnologica, è il jazz che mi ha fatto capire il ruolo dei network sociali, sono i teologi - da Tommaso d’Aquino a Teilhard de Chardin - che mi hanno illuminato sulle forze che rendono l’uomo attivo nel mondo, partecipando alla Creazione, e che sollevano l’uomo verso una meta che lo supera, ben al di là di ogni surplus cognitivo».
-
> PENSIERO LIQUIDO E CROLLO DELLA MENTE. ---- Pensare il Cristianesimo al tempo della Rete. La Chiesa, un social network che rifiuta il peer-to-peer (di Claudio Canal)1 agosto 2012, di Federico La Sala
La Chiesa, un social network che rifiuta il peer-to-peer
di Claudio Canal (il manifesto, 1 agosto 2012)
Oggi Gesù di Nazareth sarebbe un hacker, un blogger? Quanti followers avrebbe su Twitter? Ne avrebbe? Domande fantateologiche, ispirate dalla lettura di Cyberteologia. Pensare il Cristianesimo al tempo della Rete (Vita e Pensiero 2012, pp. 148, euro 14) di Antonio Spadaro. Direttore della più che autorevole e centenaria rivista dei gesuiti La Civiltà Cattolica, Spadaro è molto attivo in rete, critico letterario ha fondato nel 1998 il blog Bombacarta-scritture ed espressioni creative, dal 2011 il blog Cyberteologia cui si associa il quotidiano on line The CyberTheology Daily. Titoli e sottotitoli dei capitoli sono accattivanti, L’uomo decoder e il motore di ricerca di Dio, Una Chiesa "hub"?, La Rivelazione nel bazar, Corpo mistico e connettivo, Dal microfono sull’altare alla preghiera dell’avatar...
Spadaro non è un frequentatore occasionale della rete, è immerso ma non affogato, come succede a molti addetti ai lavori. Partecipe, non patito. È disponibile a farsi interrogare dalla rete, perciò le sue descrizioni e analisi non sono scontate e sono utili anche a chi alla parola teologia sente puzza di bruciato. Cyber-, neuro-, nano- sono prefissi che tirano molto e promuovono ipso facto un prodotto culturale come attraente e irrinunciabile. Cyberteologia non fa eccezione. Il suo significato può spaziare da un livello base di consueta riflessione teologica sul web fino al riconoscimento della natura «mistica», quasi sacramentale, della Rete.
Non a caso Spadaro nell’ultimo capitolo ricorda il confratello Teilhard de Chardin che fin dal 1947 parlava di noosfera, una complessa membrana di conoscenza, una «rete nervosa avviluppante la superficie intera della Terra». Il Vaticano non mancò di punire Teilhard per questo e per le sue convinzioni evoluzionistiche, salvo, come da prassi consolidata, arruolarlo sessant’anni dopo. Anche il mondo «laico» italiano se ne sbarazzò con sufficienza. Si veda la beffarda poesia che gli dedicò Montale, A un gesuita moderno.
Spadaro è ben attento a non farsi risucchiare dalla Rete, ne riconosce i tratti religiosi presenti perfino nel linguaggio elementare, salvare, convertire, condividere..., e soprattutto sa che il cybermondo si costituisce proprio come sacramento, ex opere operato direbbero i teologi di scuola, perché non solo rappresenta la realtà, ma è in grado di produrla. Non un semplice strumento, utile per amplificare predicazione e presenza della Chiesa nella società, come il microfono, la radio, la televisione, ma un ambiente che agisce e si autogenera.
Per questo è inaccettabile per l’autore ogni forma di Chiesa Opensource in cui i fedeli partecipino alla sua costruzione e al suo «mantenimento» in vita in una specie di Wikicclesia permanente. Uno dei teorici di questa posizione è un teologo nordamericano di confessione presbiteriana, Landon Whitsitt, di cui si può pensare quello che si vuole, ma che qui ci permette di sottolineare un consistente limite di Cyberteologia che porta come sottotitolo Pensare il Cristianesimo al tempo della Rete. Secondo una radicata tradizione italiana, non solo clericale, Cristianesimo appare sempre come sinonimo di Chiesa Cattolica: infatti, sostiene Spadaro, questa non può stare in un rapporto tra pari, peer-to-peer, bensì va collocata nell’opposto modello client-server in cui sono indispensabili mediazioni sacramentali e gerarchiche.
La Chiesa è sì un grande social network, un bene comune, potremmo dire, un google connettivo che stabilisce relazioni, ma in cui non si può diluire né esaurire, perché - afferma Spadaro - prima di tutto è un Corpo Mistico unito a Cristo, secondo una sintetica affermazione data da Paolo nella Lettera ai Romani. Il che sarebbe un bel modo per dire che con le forme della Rete bisogna fare criticamente i conti, che la virtualità è volatile, che le «comunità» create dalla rete sono transitorie, che è importante stare nella Rete a condizione di saperne uscire, nonostante la labilità dei confini tra virtuale e reale, che se non c’è vita offline è assai improbabile che si crei da sé online, che il corpo digitale interferisce con il corpo organico ma (per ora?) non lo sostituisce.
Il problema è che quando un cattolico evoca il Corpo Mistico - avendo a disposizione anche un’altra nozione di Chiesa, quella di Popolo di Dio - in ultima istanza vuole significare Chiesa Cattolica Apostolica Romana. Infatti, di tutte le possibili e necessarie forme di resistenza al cannibalismo della Rete, Spadaro privilegia la piattaforma della liturgia cattolica, proprio quella sacramentale ed eucaristica della «presenza reale», anche se non gli scappa la temibile parola transustanziazione.
Un tale romanocentrismo manda nel cestino con un semplice delete teologico tutte le collettività cristiane e non solo, alle prese con forme nuove di connettività, comunione, cooperazione attraverso la Rete e di lì nel mondo e che nella centralità cattolica non si riconoscono.
-
-
> PENSIERO LIQUIDO --- Web e social network: la rete ha un’ideologia (di Massimo Adinolfi). Facebook va in Borsa. Google migliora il motore di ricerca con l’aiuto della Cia (di Massimo Gaggi)17 maggio 2012, di Federico La Sala
 Web e social network
Web e social network
 Facebook: la Rete ha un’ideologia
Facebook: la Rete ha un’ideologia
 Come cambia la politica ai tempi di Facebook
Come cambia la politica ai tempi di FacebookIl declino dei mediatori esterni ha già modificato lo spazio pubblico. La democrazia non è in pericolo ma è bene usare Internet con spirito critico
di Massimo Adinolfi (l’Unità, 17.05.2012)
ABBIAMO UN PROBLEMA POLITICO CON FACEBOOK. NON SI TRATTA DELL’ASSETTO PROPRIETARIO, DEL VALORE STIMATO DELLA SOCIETÀ O DI PREOCCUPAZIONI PER LA CONCORRENZA. Si tratta proprio di come è organizzato lo spazio virtuale del social network più diffuso al mondo. Se ne è occupato di recente un ricercatore senese, Riccardo Castellana, con l’aiuto degli strumenti della critica letteraria e della ricerca antropologica. In particolare, di René Girard. A Girard dobbiamo infatti una distinzione fondamentale per capire come funziona la creatura di Mark Zuckerberg. Lo studioso francese l’ha applicata fra l’altro ai personaggi di Dostoevskij, di Stendhal o di Flaubert, ma non troppo sorprendentemente torna utile anche a noi. Si tratta della differenza fra mediatore esterno e mediatore interno, e del modo in cui orienta il desiderio umano. Quel che viene mediato è infatti il desiderio, che si dirige su questo oggetto o su quello solo perché qualcun altro vuole questo o quello, rendendolo così desiderabile per noi.
Ma, ecco il punto, un conto è se la mediazione è esercitata da un soggetto ben distante, magari irraggiungibile e idealizzato un mediatore esterno, appunto -, un altro è se invece si tratta di un soggetto a noi vicino, anzi prossimo, così tanto da essere proprio come noi. Un friend, insomma
Su Facebook è questo, infatti, che accade. Niente mediatore esterno, niente figure terze, niente relazioni “verticali” con un ideale lontano, ma una miriade di piccole relazioni orizzontali con individui insieme ai quali condividiamo interessi, scambiamo poke, linkiamo pagine. Sheryl Sandberg, Chief operating officer di Facebook, l’ha spiegata così: «Non importa se a 100.000 persone piace x: se alle tre persone a te più vicine piace y, a te piacerà y». Le tre persone più vicine stanno per l’appunto nella posizione di mediatori interni, e in grazia di questa posizione risultano maledettamente più credibili, diretti, autentici. In una parola, la sola che quando si fa business veramente conta: efficaci.
Ora, se si trattasse solo di strategie di marketing e volumi di vendita, poco male: ci si potrebbe fare ben presto l’abitudine. Ma il fatto è che attraverso questa diversa strutturazione delle relazioni sociali passano profonde modificazioni dello spazio pubblico, e non basta quindi limitarsi ad osservarle con distaccato spirito scientifico. E, si badi, non si tratta nemmeno di rilevare soltanto fenomeni come la spudorata esibizione della vita privata (Facebook è zeppo di fotografie), dalla quale si può dire che quasi più nessuno è immune, o della infantilizzazione dei comportamenti, ossia di quello che Benjamin Barber ha chiamato il nuovo “ethos infantilista” del capitalismo contemporaneo. Il fatto è che in tutti questi casi viene palesemente contraddetto il profilo dell’uomo pubblico così come è stato definito in età moderna.
La sfera pubblica andava infatti rigorosamente distinta dalla sfera privata o familiare della casa: un conto è l’oikos, un altro la polis. La modernità politica nasce anzi proprio quando riesce a spezzare definitivamente ogni parentela o commistione fra quegli spazi e le relazioni che in essi si istituiscono. Ma questa distinzione cede ormai il passo alla confusione, ed è sempre più difficile tracciare in rete i confini del pubblico e del privato.
Quanto all’infantilizzazione degli stili di vita (e delle scelte di consumo): non contraddice forse la figura del cittadino autonomo e responsabile, qualificato giuridicamente e politicamente in virtù della raggiunta maggiore età? Ma ancora più significativa, perché gravida di conseguenze, è la caduta verticale del mediatore esterno: quella infatti era la posizione, il luogo terzo tradizionalmente occupato dalle figure istituzionali: dal maestro, per esempio, o dall’uomo politico. La crisi di autorità del mediatore esterno, il fatto che i nostri sguardi e i nostri desideri si rivolgono in rete molto più facilmente a mediatori interni non a figure idealizzate ma proprio a persone come noi di colpo rischia di invecchiare tutta la comunicazione istituzionale, ma anche di ridefinire i luoghi stessi di formazione e di esercizio della soggettività politica.
Dunque un problema ce l’abbiamo, con Facebook. James Gibson, fondatore della teoria ecologica della percezione, diceva: chiediti non cosa c’è dentro la testa di colui che guarda, ma cosa c’è intorno. Se cambia il paesaggio, cambiano infatti pure le teste e i pensieri. E il paesaggio, indubbiamente, sta cambiando. Dopodiché non si dirà certo che per questo la democrazia è in pericolo, ma perlomeno non si esalteranno acriticamente le nuove forme della partecipazione online o della vita in diretta come straordinari avanzamenti democratici.
Noi conosciamo storicamente la democrazia come luogo della mediazione e della rappresentanza, e certo non è detto che sia l’unica modalità possibile. Poiché però sappiamo anche, grazie a Girard, che assenza di mediazione esterna significa pure possibilità di contagio mimetico e innesco incontrollato di rivalità, abbiamo tutte le ragioni per nutrire simpatia per il nuovo, ma anche per coltivare qualche sana diffidenza e un po’ di spirito critico.
 Se Facebook va in Borsa con la storia delle nostre vite
Se Facebook va in Borsa con la storia delle nostre vite
 E Google migliora il motore di ricerca con l’aiuto della Cia
E Google migliora il motore di ricerca con l’aiuto della Ciadi Massimo Gaggi (Corriere della Sera, 17.05.2012)
NEW YORK - Arriva il «giorno x» per la quotazione di Facebook: stasera, a tarda ora, la fissazione del prezzo (probabilmente vicino ai massimi della nuova «forchetta» alzata da 28-35 a 34-38 dollari, sull’onda di una domanda che pare sia di molte volte superiore all’offerta di titoli). Poi, domani, l’inizio delle contrattazioni al Nasdaq, la Borsa tecnologica di New York.
Sarà un successo perché Facebook in questo momento è l’azienda più popolare del mondo e molta gente è pronta a scommettere sul «social network» proprio perché, visto che riempie la sua vita, ritiene che non possa non avere un elevato valore intrinseco. Gli altri giganti dell’economia digitale hanno tentato fino all’ultimo di tagliarle la strada tirando fuori novità a raffica per mettere un po’ in ombra quello che comunque sarà l’Ipo tecnologica più ricca di tutti i tempi. La settimana scorsa Google ha annunciato una nuova versione della piattaforma Google+, il suo «social network», per l’iPhone. Poi è toccato a Microsoft presentare una versione aggiornata del suo motore, Bing. E ieri è toccato di nuovo a Google annunciare il lancio immediato di Knowledge Graph, il più importante aggiornamento del suo motore di ricerca da quando, nel 2007, fu introdotta la versione «Universal Search».
Il nuovo strumento amplia le capacità di ricerca del motore offrendo nuove opzioni quando si digita, ad esempio, il nome di un architetto o di un pittore. Ci sentiremo chiedere se ci interessano i loro progetti, le loro opere, i rapporti con altri artisti, la storia del loro movimento culturale. Nuove associazioni rese possibili dall’integrazione nel motore Google di altre banche dati come Wikipedia e perfino il World Fact Book della CIA, l’agenzia Usa di «intelligence», che offrono 500 milioni di nuove combinazioni di personaggi, luoghi e fatti. Una novità importante per gli utenti, ma è in cantiere da due anni e gli esperti ne attendevano da tempo il lancio. Che arriva, a poche ore dall’Ipo Facebook.
Che, come detto, agita gli investitori: mentre quelli professionali, pur vedendo la possibilità di un rapido guadagno, restano alla finestra o progettano un «mordi e fuggi» (il 71% degli operatori, secondo un’indagine indipendente, non pensa a Facebook come a un investimento di lungo termine), nel pubblico non specializzato fioriscono gli entusiasti. Molti dei quali, racconta il «Wall Street Journal», sono ponti a investire nella società di Mark Zuckerberg i soldi accantonati per il «college» del figlio (e ormai insufficienti), semplicemente perché trovano naturale scommettere sullo strumento del quale questi ragazzi si servono in continuazione.
Raramente ci si interroga su come possa fare a remunerare un capitale di oltre 100 miliardi una società che l’anno scorso ha registrato un fatturato di 3,7 miliardi di dollari e un miliardo di profitti e che nella prima parte di quest’anno ha addirittura denunciato un calo tanto degli utili quanto del giro d’affari. Momentanea coincidenza di fattori negativi, sostiene Facebook. L’idea di fondo è che un’impresa che è entrata nella vita di oltre 900 milioni di persone prima o poi troverà il modo di monetizzare questa posizione.
Un ragionamento non molto diverso, del resto, fu fatto nel 2004 quando ad andare sul mercato fu Google. Anche la società di Page e Brin allora registrava incassi pubblicitari crescenti ma ancora magri. Google, però, disponeva del motore di ricerca di gran lunga migliore, usato dalla grande maggioranza degli utenti di Internet. Nel lungo periodo quella scommessa ha funzionato, anche se all’inizio l’attesa esplosione del titolo non ci fu: qualche settimana dopo la quotazione si poteva ancora comprare l’azione Google al prezzo d’emissione.
Ma Google vendeva una tecnologia, un sistema di ricerca, un algoritmo. Facebook vende un sistema di socializzazione e un modo di accedere ai dati privati di tutti noi, nella speranza che imprese e inserzionisti pubblicitari attribuiscano un elevato valore a questa montagna di informazioni personali. I critici più polemici sostegno che i «fan» dell’investimento delle reti sociali versano soldi a una società che si sta arricchendo frugando nei loro stessi cassetti per acquisire informazioni da rivendere alle imprese che vogliono costruire profili sempre più precisi dei consumatori.
E non è nemmeno detto che tanta spregiudicatezza paghi: ieri la General Motors ha annunciato che non farà più pubblicità su Facebook: la considera poco efficace, anche se le dichiarazioni ufficiali sono più diplomatiche.
Quello che colpisce di più, però, è che, mentre il pubblico si affolla per conquistare titoli Facebook, diversi dei grandi investitori che hanno comprato in passato pezzi della società a trattativa privata, ora rivendono le loro quote in misura superiore a quanto stabilito finora: la banca Goldman Sachs rivenderà la metà del suo pacchetto (23% del capitale), mentre il «tycoon» russo Yuri Milner mette sul mercato il 40 per cento delle sue azioni: incasserà più di 2 miliardi di dollari.
-
> PENSIERO LIQUIDO E CROLLO DELLA MENTE. ---- ULTIMA CENA ED ECONOMIA VATICANA: LA CARESTIA AVANZA!!!26 aprile 2012, di Federico La Sala
 IL VANGELO DI PAPA RATZINGER E DI TUTTI I VESCOVI E IL "PANE QUOTIDIANO" DEL "PADRE NOSTRO", VENDUTO A "CARO PREZZO", MOLTO CARO (= "CARITAS")!
IL VANGELO DI PAPA RATZINGER E DI TUTTI I VESCOVI E IL "PANE QUOTIDIANO" DEL "PADRE NOSTRO", VENDUTO A "CARO PREZZO", MOLTO CARO (= "CARITAS")!
 ULTIMA CENA ED ECONOMIA VATICANA: LA CARESTIA AVANZA!!! Benedetto XVI "cambia la formula dell’Eucarestia"! «Il calice fu versato per molti», non «per tutti»!!!
ULTIMA CENA ED ECONOMIA VATICANA: LA CARESTIA AVANZA!!! Benedetto XVI "cambia la formula dell’Eucarestia"! «Il calice fu versato per molti», non «per tutti»!!!
-
> PENSIERO LIQUIDO E CROLLO DELLA MENTE. ---- Ultime profezie dal Villaggio Globale. "La tecnologia cancella l’identità privata perché il mittente diventa il messaggio" (diMarshall Macluhan)31 gennaio 2012, di Federico La Sala
Ultime profezie dal Villaggio Globale
"La tecnologia cancella l’identità privata perché il mittente diventa il messaggio"
Chi invia l’informazione diventa l’informazione
- Le riflessioni del sociologo in un saggio scritto nel 1973
 Dire che il libro è obsoleto non significa dire che si estinguerà ma che è destinato a trasformarsi, con l’elettronica, in una forma d’arte
Dire che il libro è obsoleto non significa dire che si estinguerà ma che è destinato a trasformarsi, con l’elettronica, in una forma d’arte
 La comunicazione non avviene attraverso il semplice trasporto di dati: chi invia l’informazione diventa l’informazione
La comunicazione non avviene attraverso il semplice trasporto di dati: chi invia l’informazione diventa l’informazione
 Quello che sta davvero cambiando è che lo sfondo è più importante della figura e gli effetti precedono le cause
Quello che sta davvero cambiando è che lo sfondo è più importante della figura e gli effetti precedono le cause
 di Marshall Macluhan (la Repubblica, 29.01.2012)
di Marshall Macluhan (la Repubblica, 29.01.2012)Innanzitutto, vorrei spiegare che cosa intendevo quando ho detto che "il libro è obsoleto". Obsolescenza non significa estinzione. Al contrario. Per esempio, dopo Gutenberg, e sicuramente dopo Remington, la scrittura a mano è diventata "obsoleta", eppure oggi si scrive a mano più di quanto non si sia mai fatto in passato. "Obsoleto" è insomma un termine che si riferisce al rapporto tra figura e sfondo, e la condizione di obsolescenza è il risultato di qualche cambiamento spettacolare nella natura dello sfondo che altera lo statuto della figura. Così, Gutenberg ha smantellato la cultura manoscritta e l’ha elevata, per così dire, a una specie di forma artistica.
Allo stesso modo, l’automobile è stata resa obsoleta dall’aeroplano a reazione ed è considerata sempre più come una forma d’arte. Il nostro pianeta e la natura sono stati resi obsoleti dallo Sputnik nell’ottobre 1957 e sono diventati anch’essi forme d’arte. Lo Sputnik ha visto la nascita dell’ecologia, e l’arte rimpiazzare la natura. Anche il libro, ora più prolifico che mai, è stato sospinto a diventare una forma d’arte dal contesto elettronico dell’informazione. Il libro era sfondo, ma è diventato improvvisamente figura contro il nuovo sfondo elettronico. Allo stesso modo, tutte le attrezzature dell’industrialismo occidentale sono state rese obsolete e, come dice Toynbee, «etereizzate» dal nuovo contesto dei servizi elettronici di informazione.
L’alfabeto fonetico e la cultura visiva
Il nostro stesso alfabeto sta perdendo il suo ruolo tradizionale e sta ormai assumendo, in molti modi diversi, un nuovo statuto di forma artistica. Per esempio, lo I.T.A. (Initial Teaching Alphabet) di Pitman ha rivelato che le vecchie forme manoscritte delle lettere dell’alfabeto sono più comprensibili, per i bambini, di quelle stampate. Ernest Fenollosa ci ha mostrato l’importanza dei caratteri cinesi come strumento per costruire una nuova relazione tra figura e sfondo in Occidente. Ezra Pound e gli imagisti erano profondamente consapevoli che, con l’era elettronica, la scrittura occidentale fosse entrata in una nuova fase; d’altra parte, in questo momento i giapponesi stanno allestendo un programma da sei miliardi di dollari per introdurre il nostro alfabeto fonetico nel loro mondo. Se i giapponesi e i cinesi occidentalizzassero il loro sistema di scrittura, acquisirebbero la nostra intensa tendenza visiva alla specializzazione e alla ricerca aggressiva di risultati e, al contempo, cancellerebbero gran parte della loro cultura audio-tattile con la sua propensione iconica a interpretare un ruolo nel contesto tribale, piuttosto che a perseguire obiettivi in modo privato.
Il mio libro Take Today: The Executive as Dropout è un resoconto dei cambiamenti a livello culturale e in particolare manageriale che si stanno realizzando nel mondo occidentale con l’obsolescenza delle nostre apparecchiature industriali e con il nuovo predominio di ambienti informatici simultanei e istantanei. La cultura visiva, basata sull’alfabeto, non solo ha prodotto l’individuo civilizzato greco-romano, ma ha anche condotto, attraverso Gutenberg, allo sviluppo di mercati mondiali e di sistemi di valutazione dei prezzi delle merci basati sulla parola stampata e sulle tecniche della catena di montaggio insite nell’uso dei caratteri mobili.La parola stampata continuerà a giocare un ruolo importante ancora per molto tempo, sia nell’emisfero orientale che in quello occidentale.
Paradossalmente, però, il ruolo del software in Oriente sarà antitetico e complementare al suo ruolo in Occidente. Per molti secoli, l’Oriente è stato dominato dalla cultura orale, e ciò gli dà un vantaggio considerevole nell’era elettronica. D’altra parte, l’Occidente, per molti secoli basato sulla cultura visiva dell’alfabeto fonetico e poi della parola stampata, nell’ultimo secolo di crescente tecnologia elettrica è tornato risolutamente alla cultura orale. Mentre pare che noi stiamo acquisendo il software orientale, l’Oriente sembrerebbe stia prendendo, insieme all’alfabeto occidentale, anche l’hardware occidentale.
Ciò che si è venuto a creare è un "campo da gioco" di dimensioni globali completamente nuovo e con regole del tutto sconosciute. La parola stampata e scritta avrà in ogni caso una funzione rilevante. (...)Quello fonetico è l’unico alfabeto in cui le lettere siano semanticamente neutre, prive di struttura o di forza verbale. Proprio perché l’immagine visiva presentata nelle lettere è neutra dal punto di vista acustico e semantico, esse hanno avuto sui loro utilizzatori l’effetto straordinario di rafforzare in modo considerevole la facoltà visiva rispetto a tutti gli altri sensi, come il tatto o l’udito.
Il potere di isolare la facoltà visiva, che di conseguenza ha acquisito grande intensità, ha favorito la nascita della geometria euclidea e le immagini dell’individuo separato e dell’identità privata. Così isolati, gli spazi e le forme congeniali alla visione hanno acquisito quasi un carattere a sé, che è stato spesso identificato con la razionalità e la civilizzazione.
Lo spazio visivo come manifestato nelle forme euclidee presenta le qualità basilari di uniformità, di continuità e di stasi. Lo spazio visivo, al contrario degli spazi che sono correlati o che emanano dal tatto, dal gusto e dall’udito, ha carattere stabile e durevole. Tale spazio non è però caratteristica esclusiva del mondo infantile, né dei mondi pre-alfabetici o post-alfabetici. Il bambino che, al suo primo viaggio in aereo, chiede: «Papà, quand’è che cominciamo a diventare più piccoli?» sottolinea proprio questo problema.
Quando un aeroplano si stacca dal suolo, rimpicciolisce velocemente, ed è comprensibile che il bambino faccia una domanda simile. Se l’aeroplano diventa più piccolo dall’esterno, perché non dovrebbe diventare più piccolo anche dall’interno? Forse, la risposta sta nel fatto che lo spazio chiuso dell’abitacolo dell’aereo è visivo e statico. In realtà, lo spazio visivo è una figura senza sfondo, perché si è astratta dallo sfondo degli altri sensi. Lo spazio acustico, ad esempio, ha proprietà del tutto diverse dallo spazio visivo. La sfera acustica è discontinua, non uniforme e dinamica.
Lo spazio tattile è invece il mondo dell’intervallo o del gap dell’esperienza, e si può pensare ad esso come al rapporto tra la ruota e l’assale, in cui il gioco tra i due elementi è il fattore strutturale cruciale, senza il quale non ci sarebbero né ruota né assale. Varrebbe la pena meditare a lungo sul fatto che il "gioco" non caratterizza solo lo spazio visivo. Nel suo studio classico sul gioco, Homo Ludens, J. Huizinga rivela come sia indispensabile un rapporto mobile tra figura e sfondo, che crea schemi di profondo coinvolgimento e di partecipazione per l’utilizzatore.
La domanda su quando lo spazio avrebbe subìto un cambiamento non sarebbe venuta in mente al bambino se fosse stato nella cabina aperta di un piccolo velivolo, e forse non verrebbe in mente a un astronauta. Durante una visita a Nassau, chiesi ad Al Shepard se si può parlare di "sotto" e di "sopra" quando si viaggia nello spazio. Dopo averci pensato un po’, rispose: «Dove stanno i piedi, lì è il sotto». Ciò sembra avere una certa attinenza anche con altre questioni, visto che per la maggior parte dei bambini piccoli un libro di figure non ha né sopra né sotto. Questa relazione viene scoperta solo più tardi dai nostri bambini, ma sembra non rientrare mai nell’esperienza degli eschimesi. Per un eschimese adulto, non c’è il sopra e il sotto delle immagini prese dalle riviste che attacca alle pareti del suo igloo, e niente lo diverte di più che guardare l’antropologo che si fa venire il torcicollo per metterle a fuoco, con il lato giusto in alto. Allo stesso modo, i pittori delle caverne facevano gran parte del loro lavoro senza poter vedere quel che disegnavano, sotto qualche sporgenza della roccia. Sembra, insomma, esserci una relazione tra l’idea che il lato giusto va in alto e l’alfabetizzazione.Anche se non è stato molto studiato, c’è poi il mistero delle lenti di Stratton, che richiamano la nostra attenzione sull’abitudine umana di capovolgere il mondo in modo che si presenti "nel verso giusto", sebbene, in realtà, sulla retina lo riceviamo sottosopra. All’inizio, la persona che indossa le lenti di Stratton percepisce il mondo capovolto. Dopo qualche ora, però, il mondo torna nel verso giusto. E poi, quando si toglie le lenti, il mondo si capovolge di nuovo e così rimane per alcune ore. (...)
L’elettronica e la fine della prospettiva privata
Vorrei richiamare l’attenzione su un ribaltamento altrettanto drastico del rapporto tra figura e sfondo che tutti noi attualmente stiamo sperimentando. Con l’elettronica, viviamo in un mondo di informazione simultanea in cui condividiamo immagini che arrivano istantaneamente da tutte le direzioni nello stesso momento. Se lo spazio acustico è una sfera il cui centro è ovunque e il cui margine è in nessun luogo, questa sua caratteristica si è ora estesa a tutte le strutture di informazione che vengono esperite in ambienti costituiti dalla tecnologia elettrica. In altre parole, l’uomo occidentale e civilizzato, da lungo tempo abituato a una prospettiva privata e individuale e a strutture giuridiche e politiche coerenti con tale visione, adesso si ritrova immerso in un ambiente acustico. È come se il bambino nell’abitacolo dell’aeroplano si ritrovasse all’improvviso in un ambiente sconfinato e silenzioso, a «esprimere desideri mentre guarda le stelle cadenti», per così dire.
L’orientazione dell’uomo visivo, la sua prospettiva privata, il suo punto di vista individuale e i suoi obiettivi personali sembreranno tutte cose irrilevanti nell’ambiente elettronico. E c’è un’altra particolarità di questo ambiente simultaneo con il suo accesso istantaneo a tutti i passati e a tutti i futuri: la comunicazione non avviene attraverso il semplice trasporto di dati da un punto all’altro. In realtà, è il mittente a essere inviato, ossia, in un certo senso, chi invia il messaggio diventa il messaggio.Il mondo elettrico e simultaneo ha cominciato a manifestarsi e a influenzare la nostra coscienza dalla metà del XIX secolo. C’è una strana proprietà dell’innovazione e del cambiamento che può essere riassunta dicendo che gli effetti tendono a precedere le cause. Si può mettere anche in un altro modo: lo sfondo tende a venire prima della figura. In un numero recente di Scientific American (marzo 1973) un articolo su "La tecnologia della bicicletta" spiega come «la bicicletta abbia letteralmente spianato la strada all’automobile».
 (Traduzione e cura di Laura Talarico)
(Traduzione e cura di Laura Talarico)
 © McLuhan Estate per la traduzione italiana © Lettera Internazionale
© McLuhan Estate per la traduzione italiana © Lettera Internazionale - Le riflessioni del sociologo in un saggio scritto nel 1973
-
> PENSIERO LIQUIDO E CROLLO DELLA MENTE. ---- SULLA STRADA DELLA DEMOCRAZIA "REALE", SUBITO. Chiarimenti e materiali sul tema6 giugno 2011, di Federico La Sala
 USCIRE DALLA "PREISTORIA". CURARE LA DEMOCRAZIA ...
USCIRE DALLA "PREISTORIA". CURARE LA DEMOCRAZIA ...
 SULLA STRADA DELLA DEMOCRAZIA "REALE", SUBITO. Chiarimenti e materiali sul tema
SULLA STRADA DELLA DEMOCRAZIA "REALE", SUBITO. Chiarimenti e materiali sul tema
 “Avere il coraggio di dire ai giovani che essi sono tutti sovrani (...) bisogna che si sentano ognuno l’unico responsabile di tutto. A questo patto l’umanità potrà dire di aver avuto in questo secolo un progresso morale parallelo e proporzionale al suo progresso tecnico (...)
“Avere il coraggio di dire ai giovani che essi sono tutti sovrani (...) bisogna che si sentano ognuno l’unico responsabile di tutto. A questo patto l’umanità potrà dire di aver avuto in questo secolo un progresso morale parallelo e proporzionale al suo progresso tecnico (...)
-
> PENSIERO LIQUIDO E CROLLO DELLA MENTE. ---- TEORIA DELLA NUVOLA E BLOGOSFERA. Ci stiamo smaterializzando. Da Baudrillard a Vattimo a Virilio, ma il vero profeta è stato Lyotard negli Anni 80 (di Marco Belpoliti).9 giugno 2011, di Federico La Sala
iCloud
Ci stiamo smaterializzando
Da Baudrillard a Vattimo a Virilio, ma il vero profeta è stato Lyotard negli Anni 80
di Marco Belpoliti (La Stampa, 09.06.2011)
“Tutto ciò che è solido si dissolve nell’aria», ha scritto Karl Marx e, come si sa, stava parlando dei movimenti rivoluzionari nati dalla borghesia a metà dell’Ottocento. Una previsione in anticipo sui tempi, senza dubbio, ma che coglie perfettamente il senso del cloud computing , la nuvola dove si addenseranno nel prossimo futuro le parole, le idee, i pensieri che produciamo ogni giorno attraverso le nostre tecnologie informatiche.
La tecnologia cloud in realtà è la realizzazione di un’altra previsione, quella di Jean Baudrillard che negli Anni Settanta aveva previsto l’evoluzione del capitalismo industriale dalla produzione di oggetti e merci alla produzione d’immagini, segni, in particolare sistemi di segni, perché tali sono gli smartphone che possediamo, affollati di icone o, come oggi si dice, di application . Paul Virilio in Estetica della sparizione (1980) aveva attribuito alle nuove tecnologie, allora ai primi passi, la smaterializzazione in corso del mondo e soprattutto la derealizzazione dell’esperienza. Anche Gianni Vattimo alla fine di quel decennio, segnato dal crollo del Muro, aveva celebrato in La società trasparente il dissolversi della pesantezza del mondo e la sua transizione in un universo alleggerito che oggi possiamo sintetizzare nell’immagine della nuvola gassosa gonfia d’informazioni e bit che galleggerà in modo virtuale sulle nostre teste.
Ma il vero profeta dell’universo informatico che abitiamo ogni giorno il nostro Paradiso e insieme l’Inferno del presente è Jean-François Lyotard che nel 1985 organizza al Beaubourg la mostra «Les Immatériaux»: un allestimento di reti metalliche, trasparenze leggerissime, tutto in grigio, in cui viene mostrata la fine della distinzione tradizionale tra materia ed energia, entità che si possono continuamente scambiare tra loro. Il denaro, non più ancorato all’oro da molti decenni, sta già migrando anche lui verso l’immaterialità pura, divenendo, sotto forma d’impulsi, parte sostanziosa del cloud ; la comunicazione è la parte centrale della blogosfera, come viene chiamata, sempre più simile alla nuvola di cui lo storico dell’arte Hubert Damisch ha dato una descrizione in Teoria della nuvola .
Di più: ciascuno di noi è oggi una entità evanescente, dai profili cangianti, a tratti grigia a tratti rosseggiante, o azzurra, che si collega con tutti gli altri senza più transitare per lo stato solido, il contatto fisico face to face . Dal solido al gassoso, come diceva Marx, passando per quello liquido, descritto da Zygmunt Bauman. A questi stati dobbiamo aggiungerne un altro, il plasma, possibile nuova metafora della ionizzazione dell’universo stesso.
La nuvola sostituisce perciò la metafora della «piattaforma», dominante fino a che la tecnologia ha avuto ancora bisogno di forme lamellari per rendere ragione della propria forma. Si può ben immaginare che questa entità gassosa, fusa o in stato continuo di sublimazione, ondeggi nell’aria creando un doppio del nostro mondo, un suo riflesso, un Alien, che farà di noi delle creature virtuali, copie di copie che fluttuano nell’Ultra-Web come tanti Truman Burbank che, invece di sbattere contro il fondale di cartone dello show in onda, lievitano alla ricerca della propria identità personale restituita, se tutto va bene, in tempo reale da un aggregato di bit.
-
> PENSIERO LIQUIDO E CROLLO DELLA MENTE. ---- CULTURA ORALE E CIVILTA’ DELLA SCRITTURA.19 settembre 2011, di Federico La Sala
-
-
> PENSIERO LIQUIDO E CROLLO DELLA MENTE. --- Dalla parte dei (nuovi) bambini. Inventiamo una nuova educazione (di Michel Serres).29 aprile 2011, di Federico La Sala
I NOSTRI SCHEMI SONO VECCHI: SIAMO IN UN’EPOCA DI "ROTTURA" E DOBBIAMO CAPIRLO:
"Senza che noi ce ne rendessimo conto, e in un breve intervallo di tempo, (quello che separa i nostri giorni dagli anni Settanta) è nato un nuovo tipo di essere umano. Questo ragazzo, o questa ragazza, non ha lo stesso corpo, nè la stessa aspettativa di vita di chi lo ha preceduto, non comunica secondo le stesse modalità, non percepisce lo stesso mondo,non vive nella stessa natura, nè abita il medesimo spazio. nato con l’epidurale e in data prestabilita, grazie alle cure palliative non teme più nemmeno la morte. E poichè la sua testa è diversa da quella dei suoi genitori, conosce diversamente [...]"
 cit. da: Michel Serres, Dalla parte dei (nuovi) bambini. Inventiamo una nuova educazione per gli studenti "Pollicino", la Repubblica del 20 aprile 2011
cit. da: Michel Serres, Dalla parte dei (nuovi) bambini. Inventiamo una nuova educazione per gli studenti "Pollicino", la Repubblica del 20 aprile 2011-
> PENSIERO LIQUIDO E CROLLO DELLA MENTE. --- RISPOSTA ALL’ARTICOLO DI MICHEL SERRES (di Gaetano Mirabella)3 maggio 2011, di Gaetano Mirabella
RISPOSTA ALL’ARTICOLO DI MICHEL SERRES
di Gaetano Mirabella
Le dichiarazioni di Michel Serres nell’intervista al quotidiano “la Repubblica” mi hanno entusiasmato e interessato perché le ho considerate come una conferma alle ipotesi teoriche su cui da tempo lavoro e che riguardano gli sviluppi e le modificazioni antropologiche della coscienza le cui conseguenze hanno prodotto la nascita di un nuovo tipo di essere umano.
Desidero esprimere a Michel Serres la mia ammirazione e la mia adesione alle sue idee con un mio contributo teorico tratto dal mio libro “Pensiero liquido e crollo della mente” nel quale tento di elaborare una ipotesi teorica per descrivere dinamiche che non sono state ancora adeguatamente pensate e analizzate. Le nuove tecnologie hanno creato un amalgama tra l’identità e la “messa in scena” del sistema nervoso: da questa commistione è nato “lo spazio che sente”: I sensi potenziati dall’uso delle protesi tecnologiche (cellulari, ifones, i pod, display etcc), hanno dovuto imparare a “pensare” la realtà e questo ha prodotto una sorta di neocorpo con modalità cognitive e comportamentali ancora tutte da scoprire. L’impressione relativa alle possibili traiettorie future dei nativi del web I (Pollicino) di Serres, danno l’idea di una sorta di “nuova Terra” che ho chiamato Esternità verso cui i (nuovi) bambini sono diretti.
Michel Serres dice che “senza che ce ne rendessimo conto, nel breve lasso di tempo che va dagli anni ’70 fino ad oggi, è nato un nuovo tipo di essere umano. Questo ragazzo o questa ragazza non hanno lo stesso corpo né la stessa aspettativa di vita di chi lo ha preceduto; non comunica con le stesse modalità, non percepisce lo stesso mondo, non vive nella stessa natura né abita il medesimo spazio. Nato con l’epidurale e in data prestabilita, grazie alle cure palliative, non teme più nemmeno la morte. E poiché la sua testa è diversa da quella dei suoi genitori conosce diversamente.” L’analisi di Serres è chiara e coglie certamente la verità di un fenomeno che è stato ignorato per molto tempo e che oggi si avverte in tutta la sua portata. Tutto questo è stato preceduto probabilmente da un crollo della vecchia mente, altro evento ignorato dai filosofi e dai teorici
Ho motivo di credere che la mente, così come siamo abituati a considerarla, stia crollando e che in questo periodo della storia dell’umanità, stia nascendo una nuova configurazione che da un pensiero descrittivo, passi ad un pensiero liquido che scaturisce direttamente dalle percezioni dei sensi. Pare che il sentire stesso si costituisca come un centro di pensiero al di là del cervello, facendo delle percezioni centri di pensiero fluido, staccato dall’architettura mentale della rappresentazione del reale, mentre “scruta” le cose pensandole dall’interno della sua stessa percezione.
Il “sentire” si emancipa dall’uomo che lo ha provato e dispiega il “suo” pensiero del sentire, che non prescinde dall’uomo, ma lo riconsidera come uno degli elementi della visione o della percezione. Per i “nuovi esseri” senza mente, nessuna percezione è assoluta e indispensabile ai fini di una visione/costruzione del mondo: nessuna percezione ha diritto alla propria parte di frutti; ogni percezione fa ricominciare il “mondo” da zero, il passato non conta; le visioni del mondo sono sempre nuove e non si storicizzano più, anzi, ognuna di esse sembra duellare con la precedente per prevalere.
In questa fase liquido-moderna avendo abbandonato, o essendo stati cacciati dal loro precedente spazio/ambiente, i profughi del crollo della mente tendono ad essere spogliati delle identità che quell’ambiente definiva, sosteneva e riproduceva. Alla fine dell’era territorio/nazione/stato,.. ricominciare il viaggio verso un’unità razionale/ universale dall’onda liquida di percezione/pensiero, è impossibile poiché non c’è nessun altro sito “solido” da cui partire.
Qual è dunque la consistenza dello spazio che ci ospita? Sembra che stiamo ripassando per il tipo di spazio che fu della pittura bizantina. In questo spazio non esistono prospettive o proiezioni ma solo intensità: intorno ad un personaggio importante in una pittura bizantina, lo spazio si concentra, si organizza, cresce e cinge la figura, con la potenza di un’onda.
Il crollo della mente è avvenuto dal di dentro degli avvenimenti che si sono svuotati, misura dopo misura, senza far crollare l’involucro esterno del significante che ha continuato ad essere osservato e praticato nonostante l’esistenza di nuovi sentieri sostitutivi della mente.
Naturalmente questo porta a pensare che in questo periodo storico, stiamo andando verso la nascita di un nuova forma mentale che forse è già qui senza che noi ne siamo consapevoli. E’ problematico avanzare un’ipotesi su come questo evento abbia potuto aver luogo e per la verità è difficile anche affermare che questo evento stia veramente verificandosi. La catastrofe che stiamo attraversando è invisibile, perché accade alle spalle del linguaggio e della nostra capacità di descrizione.
Il crollo della mente è un evento che non è stato percepito e adeguatamente segnalato forse a causa dell’eccessiva attenzione verso l’intelligenza artificiale e le neuroscienze [...] L’estetica tradizionale non riesce più a spiegare che cosa accade intorno a noi, e che cosa proviamo [...]
C’è un popolo nuovo in mezzo a noi, un popolo senza nome, un popolo che si muove trascinando col mouse case, palazzi, strade, persone, auto, animali, reale compreso, in un movimento lento che sposta le città sotto un cielo poco probabile, sotto il quale avvertiamo che sorge, dal di dentro di noi, emergendo dal di sotto delle nostre stesse facce, un nuovo profilo che ci esalta e terrorizza al tempo stesso sciogliendo l’identità ch’eravamo, in un ritratto d’acqua.
Giovani elettrosciamani compiono questo lavoro, volontà d’acqua in corpi trasparenti sono all’opera e conducono se stessi e tutto il reale verso una terra che si sono promessi da soli. Sono in un corpo diverso, guardano il mondo da occhi diversi, hanno una cognitività differente, anche il loro cervello e la sua chimica sono probabilmente diversi dai nostri, essi sono su una sponda della faglia gigantesca che si è aperta sotto i nostri piedi e che crea un effetto di vortice perturbante che genera un vento che spazzerà tutti noi tra non molto tempo.
I nativi del web sono questo popolo, il neocorpo è la dimora che tentano di rendere stabile, l’esternità è la terra verso cui sono diretti. La città slitta verso nuove visioni alimentate dal pensiero del sentire dei sensi che hanno imparato a pensare una “nuova realtà” e creano la paradossale situazione in cui non si può individuare il punto in cui una cosa si trasforma nell’altra: ma intanto, una mente si scioglie e un’altra si coagula.
E allora ci è dato di “sentire” che tutto di noi è spostato di tre metri (o tre soffi, o tre misure minime) lontano dal (nostro) corpo e che vogliamo sentire il mondo lontano da noi in una proiezione dei nostri sensi al di fuori della nostra fisicità: questo modus è l’esternità stessa che s’impossessa di noi e per farlo dobbiamo entrare in un neocorpo. Oggi è in atto una diaspora dei corpi verso l’incolmabile distanza dei propri neocorpi impiantati nell’esternità.
Il silenzioso pensiero del sentire, ri-emerge oggi con grande forza per cui ritorna ciò che eravamo. Non avevamo più potuto accadere come quegli esseri formati su quel silenzioso pensiero del sentire. Che il sentire abbia un pensiero è oggi il manifestarsi di ciò che era nascosto nella tecnologia e non sappiamo ancora perché esso si sia posto davanti e prima dell’intelletto e della razionalità. Che cosa significa sentire in questa epoca è dunque la domanda che è legittimo porsi.
[...] Questo “tipo” di pensiero potrebbe essere simile alla condizione di epochè delle estasi mistiche o della percezione alterata dall’assunzione di sostanze psicotrope e degli stati di trascendenza dell’io nel samadhi degli yogi con alto grado di evoluzione spirituale. Questo pensiero scaturisce direttamente dalla percezione dei sensi; così mentre i nostri sensi “pensano”, il nostro corpo razionale può continuare a credere di essere sempre nello stesso identico punto del mondo. Ma non è così. Piano piano, ogni volta che una nuova percezione dei sensi, diviene l’oggetto del pensiero del sentire, quel bagliore fugace che s’accende, crea un’estensione del nostro corpo verso l’esternità.
L’esternità è adesso. Non c’è nulla a priori, niente che possa costituire un corpo di conoscenza perché ogni cosa è adesso. Ogni cosa è adesso e.. silenziosamente, significa che la “cosa” compare e lampeggia solo questa volta e poi mai più e quindi essa comporta la sua esistenza in un punto sconosciuto dell’esternità. L’esistenza dell’esternità si “scruta”, si scruta e si percepisce intorno al fenomeno o alla “cosa”: di essa ci si accorge poiché il comportamento degli uomini ha un’impennata verso modalità stranianti.
[...] A differenza dello spettacolo che implica l’esistenza di un occhio che lo guarda, la nozione di paesaggio trae dalla sua provenienza geografica un’impersonalità che prescinde completamente dal punto di vista soggettivo. Senza la mente lo spazio diventa liquido, senza la mente lo spazio diventa ogni cosa, senza la mente il paesaggio tramonta definitivamente.
Il paesaggio è trasmutato nel sito e il sito non ha consistenza e in esso gli uomini devono affidarsi agli “organi di risonanza” dei social network per non naufragare; il web, da questa angolazione, e da questo punto d’essere è considerabile come una zattera a cui si aggrappano uomini in pericolo di affogare in menti non più sufficienti, sciolte come castelli di sabbia in un pensiero liquido. La verità di un paesaggio è una questione di aderenza e di stili di pensiero.
L’esperienza di un paesaggio/sito è una questione muta, obliqua, opposta a quello del paesaggio reale perché il pensiero liquido del sentire si raffigura anche ciò che non si vede poiché il pensiero liquido senza mente, trasgredisce anche le regole della prospettiva, inserendo nella visione sostenuta dagli organi di risonanza tecnologici, molti orizzonti e molti punti di vista. Così come accade nella pittura bizantina in cui l’eidos (la forma sovrasensibile) e la morphé (la forma sensibile), coincidono completamente, allo stesso modo, diventa percepibile che nel “sito” si attua il congiungimento tra l’invisibile e il visibile, tra il virtuale e il reale, poiché esso è il luogo in cui i due mondi si toccano. [...]
La nuova consapevolezza fluisce oggi in un ambiente cosciente che si può considerare una sorta di secondo mondo sorto su una esternità che cresce e s’innalza come un grattacielo in costruzione. In questa dimensione sempre nuova e cangiante, si muove un sentire pensante che ci svela che siamo parti di un grande corpo, che siamo “cellule pensiero” che pensano e sono pensati da un pensiero liquido. Ora dopo tremila anni siamo ancora noi la metafora del mondo? La verità è chiusa forse nei cellulari.
Tutte le informazioni che circolano nella noosfera, prima o poi tornano “giù” da noi, ma molti di noi, pur agendole, non le comprendono. Quelle informazioni sono state pensate e percepite, sentite da occhi e orecchie elettronici. Sembra paradossale ma quel pensiero del sentire che pure era nostro e che ci torna dall’etere, per noi è pressochè inutile perché incomprensibile a causa della complessità e intensità dei tanti fenomeni che ha colto.
Per supplire all’assenza di informazioni da parte della mente, si rende necessario un sentire artificiale, pilotato dall’esterno dai cosiddetti organi di risonanza, (i social network) dai quali dipendiamo come individui. Siamo alla mercè degli imperativi collettivi che corrono sui sentieri dei social network. Procedere sulla scena di un sentiero fatto di consapevolezza (di risonanza) che si dispiega in uno spazio “nuovo”, mentre ci trasmette descrizioni fondamentali sulla nostra vita sconosciuta, costituisce un’offerta allettante. Questa offerta non va accettata oltre un certo limite.
Entrare a far parte del paesaggio che sente, richiede una grande disciplina ed insieme una grande immaginazione, poiche’ dobbiamo dare un nome e un volto a cose, fatti, oggetti mai visti prima, ma soprattutto i nostri sensi devono aver imparato a pensare per riuscire a distinguere il punto d’intersezione, dove il varco tra la vecchia visione del mondo e la nuova, si apre e si accede all’accesso. Siamo condotti al varco verso la scena consapevole dalle macchine, dunque conta immensamente essere prudenti, perche’ quella che si apre dinnanzi a noi e’ una scena di guerra.
Le nuove tecnologie hanno determinato uno spostamento della nostra consapevolezza sul limite esterno del nostro corpo che confina con la scena circostante, determinando, in questo modo, un’ amalgama tra il se’ e l’esternita’. L’accesso a questo limite si accompagna alla perdita della sfera sociale e/o linguistica. Riuscire a trasferire la consapevolezza del nostro corpo quotidiano all’esternita ’tramite le tecnologie e’ un compito difficile e pericoloso. In sostanza si tratta di usare la consapevolezza come un elemento dell’ambiente dopo essersi disancorati dal linguaggio.
Essere un’amalgama che sente, deve configurarsi come un esercizio di autoconoscenza nel quale e’ possibile riconoscere il paesaggio come scena della nostra nuova presenza liquida, nella quale e’ impossibile descrivere cio’ che accade, perche’ il linguaggio e’ inadeguato a costruire sintatticamente una configurazione congruente. Dobbiamo capire che siamo ormai gli ordinatori dei luoghi senza luogo della rete.
Noi, il vuoto intelligente, dobbiamo rivestirci coscientemente di spazio per entrare nel nuovo spazio. Tra noi e l’esternità non c’è più distanza ma continuita’: noi siamo il luogo che sente, e siamo anche il fluire lungo quello spazio. Il crollo della mente, la fine dell’identità, l’eclissarsi del soggetto, il suo annegamento nel pensiero liquido-moderno, nonchè lo scorazzare tra i vari SE’ che i social network ci forniscono, pongono il problema relativo al governo e alla transizione eventuale da certe condizioni d’esistenza ad altre, da un autostato ad un altro.
Non è facile inventare un’altra educazione per gli studenti “pollicino” come Michel Serres li definisce. In generale questi ragazzi vivono in famiglie “putative” che non stimano, da cui vorrebbero fuggire e che usano per assicurarsi la sopravvivenza. Al di là dell’aspetto sentimentale, del fatto cioè se amino o no i loro genitori, c’è in loro una irreprimibile spinta a varcare una specie di confine invisibile, oltre il quale essi pensano all’esistenza di una esternità da raggiungere, come una sorta di terra promessa. E’ destinato al fallimento l’idea di rivolgersi ai “nativi” chiedendo che partecipino a programmi di educazione, poiché questo presupporrebbe in loro una volontà di rivestire o incarnare una qualche identità fra quelle che il sociale prescrive e che essi non hanno. L’abitudine di proporsi come sé differenti, offrendosi in identità multiple intercambiabili nelle chat line, il senso di disapprovazione per gli squallidi menages populistici delle loro famiglie, costituiscono deterrenti forti contro simili progetti. Bisognerebbe sapere a “CHI” ci si rivolge e con che tipo di “coscienza” abbiamo a che fare.
Relativamente alla forma e al mantenimento di una coscienza come individui senza mente, i nativi del Web sono alla mercè degli imperativi collettivi. Destinata al naufragio è l’idea di una stabilità globale e dell’esistenza eventuale di un principio là fuori, verso il quale si può partire come un cavaliere antico, (che oggi non ha cavallo, né armatura ma con-batte e si di-batte con una lattina di birra in mano, mentre balla semiubriaco di fronte ad un muro di una vecchia fabbrica al suono di musica in un rave party). E sono questi “imperativi collettivi”, sotto le spoglie di organi di risonanza elettronici, display, iphones, che determinano la sparizione del poco sé che ancora rimane.
Secondo la “relatività” la presenza della materia di cui è fatto questo Sé , dovrebbe “mostrarsi” facendo tendere lo spazio, deformandolo o meglio sarebbe dire formandolo nel sociale. Ma non avviene così per l’esternità creata tramite l’attività degli organi di risonanza sui neocorpi liquidi senza la mente. La forma dei neocorpi senza mente non è in sé pienamente compiuta, quindi è impossibile mettere in tensione l’esternità poiché quest’ultima è soltanto campitura, sfondo/contenitore indifferente.
Non sappiamo quale linguaggio parla il corpo nell’esternità e dunque diventa impossibile fornire ragioni logiche per determinati comportamenti e le risposte verbali dei nativi del web alle domande fondamentali, non hanno origine in alcun spazio mentale interiore ma in semplici camere elettroniche di compensazione e risonanza. In sostanza non può più esistere l’eventualità che una persona possa spiegare se stessa. Con la perdita del “sé” e con il crollo della mente e della capacità di narratizzare, il comportamento o risponde a ordini ricevuti in forma allucinatoria da organi di risonanza o continua facendosi guidare dall’abitudine. Il poco “sé” che rimane ha l’impressione di essere stato lasciato solo dalla Divinità costituita (dal suo emisfero cerebrale destro).
Nell’esternità come accade nel rave party, e così come accade pure, nel momento del controllo degli organi di risonanza dei social network, non c’è un analogo del sé. Il nativo senza mente non può raffigurare se stesso nell’atto di fare qualcosa, e non può prepararsi a rispondere a ciò che le esigenze del momento richiedono. Il volume d’informazione è così voluminoso e veloce che ha surclassato il sistema nervoso quindi il vecchio hardware biologico è inadatto all’infosfera e all’esternità. Per i nativi del Web bisogna guadagnare il neocorpo che serve solo una volta e solo per una percezione. Il pensiero del sentire nella condizione di liquidità inonderà le cose e la nuova spiaggia del “reale”: ad ogni ondata il pensiero del sentire bagnerà una nuova esternità per la quale ogni volta occorrerà un neocorpo senza la mente. Riguardo alla domanda su “che cosa” insegnare, credo che i “nuovi bambini” scelgano da soli ciò che gl’interessa e in questo sono come i nomadi o come i popoli primitivi che, al contatto con una società tecnologica ne prendono solo gli elementi che ritengono utili a costruire o integrare i loro “apparati” tecnomagici per scavalcare il muro invisibile che li separa dalla libertà di una esternità. L’esternità è una “terra” che si raggiunge dall’interno di un “corpo” nuovo che si ottiene con un allenamento quotidiano a diventare “cose”, oppure situazioni, animali, gadgets, o qualunque altra cosa possa implicare un autostato “magico/tecnologico”. I nuovi “bambini” seguono training per risvegliare poteri sopiti attraverso routines neurofisiologiche per raggiungere protocolli operativi verso tensioni e intenzioni intense per entrare nel neocorpo.
-
-
> PENSIERO LIQUIDO E CROLLO DELLA MENTE. ---- Il tramonto della Verità approda nei Paesi arabi (di Emanuele Severino)14 aprile 2011, di Federico La Sala
Il tramonto della Verità approda nei Paesi arabi
di Emanuele Severino (Corriere della Sera, 14 aprile 2011)
Quanto sta avvenendo nel Nord Africa è un tipico fenomeno del nostro tempo, dove nei modi più diversi ma tutti convergenti l’Occidente volta le spalle alla propria plurimillenaria tradizione. Il mondo arabo, infatti, dopo aver riattivato nel Medioevo la civiltà europea, ricollegandola alla grande cultura greca, di tale civiltà ha poi sentito e subìto la presenza, con un’intensità tanto maggiore quanto più ampia e profonda, rispetto ai popoli dell’Africa subsahariana, è stata la dimensione che il mondo arabo ha avuto in comune con l’Europa (si pensi anche al retaggio comune delle scritture veterotestamentarie).
Intendo dire che quanto sta avvenendo nel Nord Africa è il modo specifico in cui anche quel mondo incomincia a voltare le spalle alla tradizione dell’Occidente. Tra i più visibili dei fenomeni tipici del nostro tempo, le due guerre mondiali. Nella prima le democrazie distruggono l’assolutismo degli Imperi centrali e di quello ottomano, contribuendo a determinare le condizioni che conducono alla fine dell’assolutismo zarista. Nella seconda le democrazie distruggono l’assolutismo nazionalsocialista e fascista. Ma anche la fine dell’assolutismo sovietico appartiene a quest’ordine di fenomeni.
Gli appartiene anche, in Europa e sia pure in minor misura in America, la crisi del cristianesimo e dei costumi che ad esso si ispirano. Il cristianesimo intende infatti essere l’ordinamento assoluto che rende possibile la salvezza dell’uomo. A quell’ordine di fenomeni appartiene anche la crisi del capitalismo: non tanto quella relativa alle difficoltà in cui oggi si trova, quanto piuttosto quella per cui è sempre meno inteso come una «legge naturale eterna» - cioè come l’ordinamento assoluto che rende possibile la salvezza economica - e sempre più come un «esperimento» storico dai molti meriti, ma dall’esito incerto, anche per la devastazione della terra a cui esso conduce.
A quell’ordine di fenomeni - all’abbandono cioè della tradizione dell’Occidente - appartengono anche grandi eventi degli ultimi due secoli della storia europea, che sebbene meno visibili sono tuttavia altrettanto e anzi in certi casi ancora più decisivi.
Tra l’Otto e il Novecento l’arte europea si rifiuta di doversi adeguare al modello costituito dal bello assoluto e imposto dalla cultura tradizionale: si propone come libera invenzione di un mondo nuovo, nascono l’arte «astratta» e la musica atonale (cioè essa stessa «astratta» , separata dall’ordinamento sonoro della tradizione).
Ma in modo eminente è la filosofia a rompere col passato, e innanzitutto col proprio, mostrando l’impossibilità di quell’Ordinamento degli ordinamenti che è l’esistenza stessa di una Verità assoluta e di un Essere assoluto che intenda valere come Principio del mondo. «Dio è morto» , e alla radice è morta quella Verità assoluta che presume di potersi mantenere stabile e inalterabile al di sopra della storia, del tempo, del divenire.
Di questo atteggiamento del pensiero filosofico risentono le scienze naturali e logico-matematiche, che nei modi loro propri non si presentano più come Verità assolute, ma come ipotesi o leggi statisticoprobabilistiche di cui è sempre possibile la falsificazione. Anche le scienze giuridiche abbandonano il concetto di «diritto naturale» , nella misura in cui esso vuol essere un diritto assoluto, assolutamente vero e presente nella coscienza di ogni uomo, e portano in primo piano il concetto di «diritto positivo» , posto dall’uomo in determinate circostanze storiche.
L’abbattimento della tradizione dell’Occidente è un turbine gigantesco a forma di piramide, i cui strati diventano sempre più visibili man mano che si scende verso la base e sempre meno visibili - ma anche sempre più decisivi - man mano che si sale verso il vertice della piramide. Che è costituito dal pensiero filosofico e che, anche se per lo più si tiene nascosto, guida il turbine. Sia pure guardando, con perspicacia diversa, verso l’alto, i popoli dell’Occidente abitano la base della piramide. Anche i popoli del Nord Africa. Della filosofia non sanno ovviamente nulla, ma in qualche modo ne intravvedono l’ombra che essa lascia sulle cose e sugli eventi del mondo.
Per completare la metafora della piramide, si aggiunga che la base soffia sulle convinzioni, i costumi, le opere, le istituzioni della tradizione occidentale, e che anche se non lo si percepisce, la potenza travolgente del soffio proviene dal vertice. Si dice che soprattutto i giovani del Nord Africa guardano latelevisione e si servono di Internet e dei cellulari.
Ma ciò che più conta rilevare è il loro intuire che il mondo sta cambiando in un senso del tutto particolare e non solo molto più profondamente e rapidamente di quanto non si sospettasse: intuiscono che nei mezzi di comunicazione tutte le prospettive sono poste sullo stesso piano, che quindi non esiste una prospettiva capace di prevalere e di dominare le altre, che permanga quando esse svaniscono e abbia pertanto quell’assolutezza di cui i popoli possono intuire il senso anche se ignorano la parola. Ognuno dei messaggi massmediatici assicura di comunicare i contenuti più importanti; ma, proprio perché sono tutti ad assicurarlo, il livellamento dei contenuti è inevitabile.
Per chi abita la base del turbine a piramide che investe il passato, la preminenza dei valori tradizionali illanguidisce proprio perché essi appaiono sui teleschermi. Con ciò non si vuol dire che la tradizione dell’Occidente non possa essere Verità assoluta per il fatto che i messaggi mass-mediatici operano quel livellamento, ma che il modo in cui il tramonto degli assoluti è messo in luce dal pensiero filosofico del nostro tempo si fa in qualche misura sentire anche da chi, ascoltando quanto stiamo dicendo, non sarebbe in grado di capirlo. E, certo, quel modo di tramontare si è fatto sentire più chiaramente nella distruzione degli assolutismi e totalitarismi politico-economici operata nell’Europa del XX secolo.
Rilievi, questi, che mettono in luce come le guerre e le rivoluzioni del Novecento europeo tendano ad avere un carattere del tutto diverso da quelle dei secoli precedenti, che per quanto profonde e anticipatrici, rovesciavano sì vecchi ordinamenti assoluti, ma lasciando che i nuovi conservassero il carattere dell’assolutezza.
Per questo è più difficile - ma non tanto - che le rivoluzioni del Nord Africa, che in qualche modo possono dirsi europee, abolendo regimi totalitari abbiano a sfociare in nuove forme di assolutismo, quale l’integralismo islamico. - all’interno del turbine a piramide, il rapporto della cultura non filosofica con il pensiero filosofico degli ultimi due secoli è ovviamente di gran lunga più diretto di quello che può essere instaurato stando alla base o negli strati più bassi della piramide.
Tale cultura ne abita gli strati intermedi. Ma quindi è ancora dall’esterno che essa può sentire la voce di quel pensiero. Una critica scientifica, religiosa, artistica, ecc. degli assoluti che sono affermati innanzitutto dalla tradizione filosofica può mostrare che quest’ultima afferma contenuti diversi e opposti rispetto a quelli che tale critica intende difendere, ma non per questo essa può concludere che quei contenuti debbano venire abbandonati. Ad esempio sarebbe una grossa ingenuità ritenere che la filosofia di Aristotele o di Hegel debba esser lasciata da parte perché è comparsa la fisica moderna o perché sono state scoperte le geometrie non euclidee e la fisica quantistica. Solo una critica filosofica della tradizione filosofica e delle dimensioni in cui l’assoluto filosofico si è rispecchiato degradando fino alla base della piramide, può essere irrefutabile.
Quanto si è detto sin qui è infatti soltanto la descrizione di un fatto, sia pure di enormi proporzioni: il fatto in cui la piramide consiste. Ma non si è detto ancora nulla della irrefutabilità, ossia della verità di tale fatto: non si è ancora detto nulla di quell’altra forma di verità che è la verità della distruzione della Verità della tradizione occidentale - ossia della Verità che, si è detto, pretende porsi, inalterabile e immutabile, al di sopra del tempo e della storia. Questo giro di concetti è decisivo.
Proviamo a chiarirlo per quel che qui è possibile. Le democrazie parlamentari hanno distrutto gli Stati totalitari del Novecento, che, appunto, si presentano come la forma terrena della Verità e del Dio assoluti. Questo, dal punto di vista delle scienze storiche, si può considerare un fatto. Ma da ciò non si può concludere che le democrazie siano verità e i totalitarismi errore! Concludere così significa confondere i criteri della lotta politica con quelli del pensiero critico filosofico - che invece in proposito può dire ben di più (quando lo si sappia capire). Dice infatti che, da un lato, lo Stato assoluto, controllando l’intera vita dei sudditi, predetermina il loro futuro, lo occupa interamente e gli impone la propria legislazione inviolabile; e che, dall’altro lato, lo Stato assoluto, ma anche i suoi sudditi, sono tuttavia più o meno consapevolmente convinti che il futuro esiste ed è la dimensione di tutto ciò che ancora non esiste, non è predeterminato, non è già occupato da alcuna inviolabile legislazione.
Lo Stato assoluto è dunque una gigantesca contraddizione, in cui l’esistenza del futuro è, insieme, affermata e negata. E la contraddizione non solo è uno stato di essenziale instabilità, prima o poi destinata a crollare, ma è anche la forma essenziale dell’errore. Solo se si sa scorgere in modo appropriato la contraddizione da cui è avvolta una certa situazione storica è possibile prevedere il crollo di quest’ultima, senza che la previsione decada al rango didivinazione o di profezia (si può mostrare che il marxismo scorge in modo inappropriato la contraddizione dell’assolutismo capitalistico e imperialistico).
La distruzione dello Stato totalitario (e della sua presunta Verità) da parte della democrazia ha dunque verità solo se la democrazia è consapevole della contraddizione del totalitarismo. Altrimenti (ed è questa la situazione) la democrazia è una forma di violenza che si contrappone a quella totalitaria e che in Occidente ha vinto solo «di fatto» - provvisoriamente, apparentemente-, non «di diritto» . La contraddizione dell’assolutismo politico è presente anche in tutte le altre forme di assolutismo (alle quali si è fatto cenno sopra) della tradizione occidentale. Ma, la loro, rispecchia in forma derivata la contraddizione estrema e grandiosa che avvolge la Verità della tradizione filosofica.
Tale Verità intende infatti essere l’Ordinamento di tutti gli ordinamenti. Tutto deve esistere conformemente alla Verità assoluta: essa non è soltanto la legge che domina il futuro dei sudditi dello Stato assoluto, ma è la Legge che predetermina e dunque occupa e domina (oltre al presente e al passato) il futuro di tutte le cose, lo riempie completamente con sé stessa; e quindi lo vanifica nel modo più radicale, perché, così riempito, il futuro non è più futuro. Ma, insieme, la Verità della tradizione occidentale è il riconoscimento dell’esistenza del tempo e quindi del futuro: è la fede più incrollabile e profonda in tale esistenza: intende essere appunto la Legge del tempo, sopra il quale pone la dominazione del Dio esso stesso eterno e assoluto. La Verità assoluta è cioè fede intransigente nell’esistenza e, insieme, nell’inesistenza del tempo e della storia. Dunque è contraddizione estrema. L’essenza per lo più nascosta della filosofia del nostro tempo è il vertice del turbine che spinge al tramonto la tradizione occidentale. Nel vertice quella estrema contraddizione viene portata in piena luce. Ma, anche, è il vertice a cui non riesce a sollevarsi nemmeno la maggior parte della stessa filosofia contemporanea, che ripete sì il proclama della morte della Verità e di Dio, ma che solo raramente sa mostrare il fondamento senza di cui il proclama è soltanto fede, dogma, retorica.
D’altra parte, se si riesce a scorgere in modo appropriato che la Verità assoluta della tradizione è contraddizione estrema e dunque estrema instabilità, si è in grado di affermare che tale Verità è destinata al tramonto. Questa- all’interno della cultura dell’Occidente, che ormai è la cultura del Pianeta - è la previsione fondamentale con cui ogni altra forma di previsione deve fare i conti (e alla cui chiarificazione lavoro da quasi mezzo secolo).
Ma fino a che tale previsione rimane invisibile, restando lassù, al vertice del turbine, la potenza con cui essa guida l’intero turbine resta indebolita. Ne è un segno lo stupore, l’irritazione, se non la commiserazione, che anche i lettori possono provare leggendo qui che alla filosofia compete una funzione così decisiva nella storia del mondo.
Gli strati della piramide sono immagini del vertice, e quindi ne sono l’alterazione, non ne lasciano vedere la potenza, e sempre meno quanto più si scende verso la base: incapaci di vedere e far propria la potenza del proprio vertice, tendono a somigliare a un esercito che vada al fronte portando con sé, invece delle proprie armi, le loro fotografie. In questo senso il vertice del turbine è un sottosuolo.
Appunto per questo i grandi protagonisti della tradizione occidentale non si sentono ancora sconfitti: teocrazia, Stato assoluto ed «etico» , paleocapitalismo, democrazia (intesa sia come unione di libertà e Verità, sia come democrazia procedurale fondata tuttavia sulla metafisica dell’individuo), e anche comunismo marxista, continuano a rivendicare l’insopprimibilità dei loro valori e a sentirsi essi in diritto di guidare il mondo: dinanzi a loro si presenta la forma debole del turbine, mentre la voce della potenza del vertice - cioè l’essenza del sottosuolo del pensiero del nostro tempo, costituita dai pochi pensatori essenziali- rimane per lo più soverchiata dalle voci di quella debolezza. Anche per questo, nonostante la differenza radicale tra le rivoluzioni del passato e quelle del presente, non solo i popoli del Nord Africa, ma anche quelli dell’intero Occidente sono soltanto all’inizio del processo che è destinato a condurli all’abbandono della loro tradizione.
-
> PENSIERO LIQUIDO E CROLLO DELLA MENTE. --- "The extended mind" a cura di Richard Menary. La nostra mente fuori di testa (di Michele Di Francesco)27 marzo 2011, di Federico La Sala
La nostra mente fuori di testa
di Michele Di Francesco (Il Sole-24 Ore, 27 marzo 2011)
«Dove finisce la mente e dove comincia il mondo?». È passato ormai più di un decennio da quando due noti filosofi, Andy Clark e David Chalmers, si posero questa domanda nel saggio The extended mind, criticando l’idea che i processi mentali dovessero sempre essere collocati all’interno del corpo dell’individuo che li intrattiene, e in particolare nel suo sistema nervoso centrale; al contrario per Clark e Chalmers la cognizione è (spesso) qualcosa che travalica il cervello e si diffonde nel mondo.
Com’è facile immaginare, la tesi della Mente Estesa (ME) non ha mancato di suscitare reazioni e di dare vita a un dibattito di notevole interesse. Chi volesse farsene un’idea approfondita può ora contare sul volume curato da Richard Menary, che raccoglie (oltre a una ristampa dell’originario articolo di Clark e Chalmers) contributi dello stesso Clark e di molti importanti filosofi - come Susan Hurley (prematuramente scomparsa nel 2007), Robert Wilson, tra gli "amici" di ME, e Fred Adams, Ken Aizawa e Robert Rupert, fra i suoi critici.
Tra le questioni discusse, due emergono con particolare evidenza; la prima verte sulla critica al cosiddetto "Principio di Parità", che equipara risorse neurali, corporee e ambientali, individuandole come cognitive esclusivamente sulla base del ruolo da esse ricoperto nei processi mentali. La seconda questione ha a che fare con la natura dei veicoli esterni: dobbiamo davvero riconoscere che essi svolgono un ruolo costitutivo nei vari processi cognitivi, come sostiene ME, oppure, più prudentemente, ci basterà dire che essi svolgono un ruolo causale - essenziale nell’innescare la corretta dinamica cerebrale - ma che a rigore non sono parte propria del processo? Come il lettore potrà constatare, la risposta a entrambi i quesiti è tutt’altro che banale.
Più in generale, a giudicare dall’andamento del dibattito, sembrerebbe che in ME convivano due anime: la prima è legata a una particolare lettura dell’idea che i processi cognitivi siano sostanzialmente una questione di elaborazione dell’informazione, e che negli esseri umani parte dei compiti computazionali è delegata a strutture extra-cerebrali (a un mondo di artefatti cognitivi esterni che comprende a vario titolo linguaggio, mappe, segnali, cartelli, taccuini, calcolatori, e altri dispositivi "intelligenti"). In questa prospettiva il ruolo delle strutture cerebrali è sempre essenziale, ma non è più unico: l’intelligenza si estende oltre i confini del cranio e della pelle.
La seconda anima è legata a un approccio "incarnato" e sensomotorio alla cognizione; un approccio "enattivo" che considera la cognizione come un fare legato all’impegno attivo di un soggetto incorporato nel mondo. Questo modello emerge da quelle parti della nuova scienza cognitiva caratterizzati dalla presenza delle tre "e": i processi cognitivi sarebbero embodied (incorporati), embedded (immersi nell’ambiente), extended (estesi). La prima anima conduce ME verso questioni di grande rilievo relative all’importanza della tecnologia per la nostra natura di esseri umani dotati di menti che travalicano i confini biologici. Una questione già discussa approfonditamente da Clark, nel volume Supersizing the Mind, nel quale, in polemica con il modello della mente come uno spazio neurale chiuso, difende l’estensione culturale dell’identità umana.
Se la prima anima di ME è tecnologica, la seconda è più biologica: non trascura gli artefatti culturali, ma si concentra sulla manipolazione incorporata dell’ambiente. Essa non è meno ambiziosa della prima, comunque, dato che le sue attenzioni si estendono dai processi cognitivi di elaborazione (inconscia) delle informazioni delegati all’ambiente fino alla stessa esperienza.
L’idea di una coscienza estesa - affrontata nel volume di Menary nel capitolo scritto da Mark Rowlands - è ancora più radicale e suscettibile di suscitare reazioni incredule da parte di chi abbia la salda convinzione che è il sistema nervoso centrale l’unica sede concepibile della coscienza. Malgrado si possa rifare a una tradizione autorevole che va dalla fenomenologia di Maurice Merleau-Ponty alla teoria dei sistemi dinamici, l’estensione ME alla coscienza è in effetti un passo molto delicato. Clark, in un recente articolo pubblicato sull’autorevole rivista «Mind», ne prende le distanze con argomenti degni di nota, e lo stesso Chalmers ha avuto modo di esprimere i suoi dubbi, notando che perché la coscienza possa emergere è necessaria una densità nel flusso di informazione tale che solo le connessioni neurali intracraniche possono garantirla. Qualunque sia l’esito di questa discussione, è certo che il dibattito è tra i più interessanti della recente filosofia delle scienze cognitive.
* the extended mind a cura di Richard Menary MIT Press, Cambridge (MA) pagg. 382 |€ 28,45
-
> PENSIERO LIQUIDO E CROLLO DELLA MENTE. ---- NA CRISI EPOCALE. Odifreddi dà alla matematica l’onore di grande motore della civiltà, ma ancora non sa «Che cos’è il numero, che l’uomo lo può capire? E che cos’è l’uomo, che può capire il numero?».24 febbraio 2011, di Federico La SalaRIPENSARE L’UNO E I MOLTI ("UNO"), L’IDENTITA’ E LA DIFFERENZA!!! CONTIAMO ANCORA COME SE FOSSIMO NELLA CAVERNA DI PLATONE. NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN ....
 MATEMATICA E CIVILTA’: UNA CRISI EPOCALE. Odifreddi dà alla matematica l’onore di grande motore della civiltà, ma ancora non sa «Che cos’è il numero, che l’uomo lo può capire? E che cos’è l’uomo, che può capire il numero?». La sua recensione di un saggio di Alex Bellos, con alcune note
MATEMATICA E CIVILTA’: UNA CRISI EPOCALE. Odifreddi dà alla matematica l’onore di grande motore della civiltà, ma ancora non sa «Che cos’è il numero, che l’uomo lo può capire? E che cos’è l’uomo, che può capire il numero?». La sua recensione di un saggio di Alex Bellos, con alcune note
-
> PENSIERO LIQUIDO E CROLLO DELLA MENTE. ---- RIPENSARE L’UNO E I MOLTI ("UNO"), L’IDENTITA’ E LA DIFFERENZA!!! UNITA’ D’ITALIA E FOLLIA: EMERGENZA LOGICO-MATEMATICA.19 febbraio 2011, di Federico La Sala
 RIPENSARE L’UNO E I MOLTI ("UNO"), L’IDENTITA’ E LA DIFFERENZA!!! CONTIAMO ANCORA COME SE FOSSIMO NELLA CAVERNA DI PLATONE. NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN ....
RIPENSARE L’UNO E I MOLTI ("UNO"), L’IDENTITA’ E LA DIFFERENZA!!! CONTIAMO ANCORA COME SE FOSSIMO NELLA CAVERNA DI PLATONE. NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN ....
 UNITA’ D’ITALIA E FOLLIA: EMERGENZA LOGICO-MATEMATICA. PER UN CONVEGNO E UNA RIFLESSIONE SUL CONCETTO DI ’UNITA’ E DI SOVRANITA’ (SOVRA-UNITA’). Materiali sul tema
UNITA’ D’ITALIA E FOLLIA: EMERGENZA LOGICO-MATEMATICA. PER UN CONVEGNO E UNA RIFLESSIONE SUL CONCETTO DI ’UNITA’ E DI SOVRANITA’ (SOVRA-UNITA’). Materiali sul tema
 USCIRE DALLA CAVERNA, USCIRE DALLO STATO DI MINORITA’, USCIRE DALLA "PREISTORIA" E NON RICADERE NELL’ILLUSIONE E NEL DELIRIO DELL’ “UOMO SUPREMO” DEI VISIONARI E DEI METAFISICI ATEI-DEVOTI
USCIRE DALLA CAVERNA, USCIRE DALLO STATO DI MINORITA’, USCIRE DALLA "PREISTORIA" E NON RICADERE NELL’ILLUSIONE E NEL DELIRIO DELL’ “UOMO SUPREMO” DEI VISIONARI E DEI METAFISICI ATEI-DEVOTI
-
> PENSIERO LIQUIDO ---- L’ITALIA E IL CROLLO DELLA MENTE (1994-2010): IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DA’ L’INCARICO DI GOVERNO AL PRESIDENTE DEL PARTITO "FORZA ITALIA" O, PIU’ SEMPLICEMENTE, "ITALIA"!!!6 febbraio 2011, di Federico La Sala
 L’ITALIA E IL CROLLO DELLA MENTE (1994-2010): IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DA’ L’INCARICO DI GOVERNO AL PRESIDENTE DEL PARTITO "FORZA ITALIA" O, PIU’ SEMPLICEMENTE, "ITALIA"!!!
L’ITALIA E IL CROLLO DELLA MENTE (1994-2010): IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DA’ L’INCARICO DI GOVERNO AL PRESIDENTE DEL PARTITO "FORZA ITALIA" O, PIU’ SEMPLICEMENTE, "ITALIA"!!!
 IRRICEVIBILE: E COSI’ SIA! L’aggettivo del Presidente Napolitano ha "un suono ben più forte dello strappo procedurale cui si riferisce"! Una nota di Ida Dominijanni
IRRICEVIBILE: E COSI’ SIA! L’aggettivo del Presidente Napolitano ha "un suono ben più forte dello strappo procedurale cui si riferisce"! Una nota di Ida Dominijanni
 (...) Irricevibile è un governo che disprezza il parlamento e prescinde dal Quirinale, irricevibile è una maggioranza di nominati arroccata nel bunker del suo padrone, irricevibile è un capo di governo che usa sistematicamente la scena internazionale per denigrare «la Repubblica giudiziaria commissariata dalle procure» (...)
(...) Irricevibile è un governo che disprezza il parlamento e prescinde dal Quirinale, irricevibile è una maggioranza di nominati arroccata nel bunker del suo padrone, irricevibile è un capo di governo che usa sistematicamente la scena internazionale per denigrare «la Repubblica giudiziaria commissariata dalle procure» (...)
-
> PENSIERO LIQUIDO E CROLLO DELLA MENTE. ---- FINE DELL’"UOMO TEORETICO", LAICO E RELIGIOSO: UNA QUESTIONE EPOCALE.3 febbraio 2011, di Federico La Sala
Materiaii sul tema:
MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?!
IL BERLUSCONISMO E IL RITORNELLO DEGLI INTELLETTUALI.
Federico La Sala
-
> PENSIERO LIQUIDO E CROLLO DELLA MENTE. --- ESTETICA (E NON SOLO) E DEMOCRAZIA. KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETA’ DELL’UOMO A UNA DIMENSIONE.26 ottobre 2010, di Federico La Sala
-
> PENSIERO LIQUIDO E CROLLO DELLA MENTE. ---- FINE DELLA CIVILIZZAZIONE CATTOLICO-ROMANA. KANT, SAN PAOLO, E LA FACOLTA’ DI GIUDIZIO.17 settembre 2010, di Federico La Sala
-
> PENSIERO LIQUIDO E CROLLO DELLA MENTE. --- È finita per sempre la pretesa degli intellettuali di essere coloro che stabiliscono ciò che è falso e ciò che è vero (di Zygmunt bauman - un brano di "Modernità e ambivalenza).12 maggio 2010, di Federico La Sala
 La postmodernità secondo Bauman
La postmodernità secondo Bauman L’ultimo saggio dello studioso polacco spiega in che modo possiamo affrontare un destino senza certezze
L’ultimo saggio dello studioso polacco spiega in che modo possiamo affrontare un destino senza certezze
 È finita per sempre la pretesa degli intellettuali di essere coloro che stabiliscono ciò che è falso e ciò che è vero
È finita per sempre la pretesa degli intellettuali di essere coloro che stabiliscono ciò che è falso e ciò che è verodi Zygmunt Bauman
Anticipiamo un brano del libro di "Modernità e ambivalenza" pubblicato da Bollati Boringhieri e in uscita in questi giorni. *
Il crollo delle "grandi narrazioni" (come le definisce Lyotard) - il dissolversi della fede nelle corti d’appello sovraindividuali e sovracomunitarie - è stato visto con timore da molti osservatori, come un invito a una situazione del tipo "tutto va bene", alla permissività universale e dunque, alla fine, alla rinuncia a ogni ordine morale e sociale. Memori della massima di Dostoevskij «Se Dio non esiste, tutto è permesso», e dell’identificazione durkheimiana del comportamento asociale con l’indebolirsi del consenso collettivo, siamo giunti a credere che, a meno che un’autorità imponente e indiscussa - sacra o secolare, politica o filosofica - non incomba su ogni individuo, il futuro ci riserverà probabilmente anarchia e carneficina universale. Questa credenza ha efficacemente sostenuto la moderna determinazione a instaurare un ordine artificiale: un progetto che sospettava di ogni spontaneità finché non se ne provava l’innocenza; un progetto che metteva al bando tutto ciò che non era esplicitamente prescritto e identificava l’ambivalenza con il caos, con la "fine della civiltà" così come la conosciamo e potremmo immaginarla.
Forse la paura scaturiva dalla coscienza repressa che il progetto era condannato fin dal principio; forse era coltivata deliberatamente, dal momento che svolgeva l’utile ruolo di baluardo emotivo contro il dissenso; forse era solo un effetto collaterale, un ripensamento intellettuale nato dalla pratica sociopolitica della crociata culturale e dell’assimilazione forzata. In un modo o nell’altro, la modernità decisa a demolire ogni differenza non autorizzata e tutti i modelli di vita ribelli non poteva che concepire l’orrore per la deviazione e trasformare la deviazione in sinonimo di diversità. Come commentano Adorno e Horkheimer, la cicatrice intellettuale ed emotiva permanente lasciata dal progetto filosofico e dalla pratica politica della modernità è stata la paura del vuoto; e il vuoto era l’assenza di uno standard vincolante, inequivocabile e applicabile a livello universale.
Della popolare paura del vuoto, dell’ansia nata dall’assenza di istruzioni chiare che non lascino nulla alla straziante necessità della scelta, siamo informati dai racconti preoccupati degli intellettuali, interpreti designati o autodesignati dell’esperienza sociale. I narratori però non sono mai assenti dalla loro narrazione, ed è un compito disperato quello di provare a separare la loro presenza dalle loro storie. È possibile che in generale ci fosse una vita fuori dalla filosofia, e che questa vita non condividesse le preoccupazioni dei narratori; che se la passasse piuttosto bene anche senza essere disciplinata da standard di verità, bontà e bellezza provati razionalmente e approvati filosoficamente.
È possibile persino che molta di questa vita fosse vivibile, ordinata e morale proprio perché non era ritoccata, manipolata e corrotta dagli agenti autoproclamati della "necessità universale". Ma non c’è dubbio sul fatto che una particolare forma di vita non possa passarsela bene senza il sostegno di standard universalmente vincolanti e apoditticamente validi: si tratta della forma di vita dei narratori stessi (più precisamente, la forma di vita che contiene le storie narrate per gran parte della storia moderna).
È stata soprattutto quella forma di vita a perdere il suo fondamento una volta che i poteri sociali hanno abbandonato le loro ambizioni ecumeniche, e a sentirsi dunque minacciata più di chiunque altro dal dissolversi delle aspettative universalistiche. Finché i poteri moderni si sono aggrappati con risolutezza all’intenzione di costruire un ordine più efficace, guidato dalla ragione e dunque in definitiva universale, gli intellettuali non hanno avuto grande difficoltà ad articolare la loro rivendicazione a un ruolo cruciale nel processo: l’universalità era il loro dominio e il loro campo di specializzazione.
Finché i poteri moderni hanno insistito sull’eliminazione dell’ambivalenza come misura del miglioramento sociale, gli intellettuali hanno potuto considerare il loro lavoro - la promozione di una razionalità universalmente valida - come veicolo principale e forza trainante del progresso. Finché i poteri moderni hanno continuato a denigrare, mettere al bando e sfrattare l’Altro, il diverso, l’ambivalente, gli intellettuali hanno potuto contare su un massivo supporto alla loro autorità di giudicare e di distinguere il vero dal falso, la conoscenza dalla mera opinione.
Come il protagonista adolescente dell’Orfeo di Jean Cocteau, convinto che il sole non sorgesse senza la serenata della sua chitarra, gli intellettuali si sono convinti che il fato della moralità, della vita civile e dell’ordine sociale dipendesse dalla loro soluzione del problema dell’universalità: dalla loro capacità di fornire la prova decisiva e definitiva del fatto che il "dovere" umano sia inequivocabile, e che la sua inequivocabilità abbia fondamenti incrollabili e totalmente affidabili.
Questa convinzione si è tradotta in due credenze complementari: che non ci sarebbe stato niente di buono nel mondo, a meno che non ne fosse provata la necessità; e che provare questa necessità, se e quando ci si fosse riusciti, avrebbe avuto sul mondo un effetto simile a quello attribuito agli atti legislativi di un governante: avrebbe sostituito il caos con l’ordine e reso trasparente ciò che era opaco.
L’effetto più spettacolare e durevole dell’ultima battaglia della verità assoluta non è stato tanto la sua inconcludenza, derivante come direbbero alcuni dagli errori di progetto, ma la sua totale irrilevanza per il destino mondano di verità e bontà. Questo destino è stato deciso molto lontano dalle scrivanie dei filosofi, giù nel mondo della vita quotidiana dove infuriavano le lotte per la libertà politica e dove si spingevano avanti e si ricacciavano indietro i confini dell’ambizione statale di legiferare sull’ordine sociale, di definire, segregare, organizzare, costringere e reprimere.
* la Repubblica, 12 maggio 2010
-
> PENSIERO LIQUIDO E CROLLO DELLA MENTE. ---- Arriva la generazione dei ’nativi digitali’, evoluzione modifica cervello.22 giugno 2009, di Federico La Sala
Arriva la generazione dei ’nativi digitali’, evoluzione modifica cervello
ultimo aggiornamento: 19 giugno, ore 16:09
Fin da piccoli alle prese con telefonino e videogame, da grandi multitasking Magazine» Stile di vita italiano e benessere (Adnkronos)
Fin dalla culla giocano con il telefonino di mamma, quando ancora gattonano sono già padroni di telecomando e videogame. Così, ai tempi della scuola materna, sanno leggere senza problemi le icone di tv, computer e videoregistratore. E sfidano i grandi ai videogame. "Dal 2000 circa in poi il genere umano ha subito un’ulteriore evoluzione. Dopo l’Homo sapiens sapiens è la volta della generazione dei ’nativi digitali’. Una nuova umanità ’figlia’ di cellulari e videogiochi, che ha già un cervello diverso dal nostro". A ’fotografare’ le caratteristiche di questi bambini è Tonino Cantelmi, docente di psichiatria dell’Università Gregoriana di Roma e presidente dell’Associazione italiana psicologi e psichiatri cattolici.
"Abbiamo esaminato un vasto campione di bimbi, nati a partire dal 2002. Concentrandoci sulle caratteristiche dei nativi digitali, figli della ’generazione di mezzo’ e nipoti dei ’predigitali’ - spiega lo psichiatra, che a questo tema ha dedicato un libro, ’L’immaginario prigioniero’ (Mondadori), scritto a quattro mani con la psicoterapeuta Maria Rita Parsi - Questi piccoli hanno un apprendimento più percettivo e meno simbolico, e sono dotati di abilità visuo-motorie eccezionali. Una volta adulti - aggiunge - saranno spesso uomini e donne alexitimici, incapaci cioè di riconoscere le emozioni interne, ma abilissimi a rappresentarle".
Inoltre saranno ragazzini e poi giovani multitasking, capaci di utilizzare contemporaneamente vari mezzi tecnologici senza timore o paura. "Mentre, ad esempio - prosegue Cantelmi - i nonni ’predigitali’ si riconoscono subito all’aeroporto, perché fanno ancora la coda per il check-in. Una cosa che la generazione di mezzo ha ormai superato, padroneggiando il telecheck-in o usando le macchinette per l’accettazione rapida". Per la generazione dei nativi digitali, che in questi anni sono ancora sui banchi di materna ed elementare, "le emozioni non sono vissute, ma piuttosto rappresentate. Saranno abilissimi a tecnomediare le relazioni. E, naturalmente, comunicare con loro sarà difficile sia per la generazione di mezzo, che per i predigitali", prevede Cantelmi. Infatti l’uso di vari strumenti tecnologici fin da bambini attiva aree cerebrali differenti. E predispone a svelare senza fatica i segreti delle strumentazioni più high-tech.
Tutti genietti del computer, dunque? "Non solo, questa generazione - racconta lo psichiatra - nasce con l’esperienza della democrazia dal basso. La pressione del gruppo di coetanei con cui si condividono le chiacchiere digitali sarà fortissima, e presto sulla rete si commenteranno eventi e avvenimenti, piccoli e grandi". Dall’uscita di un film in 3D, all’apertura del negozio sotto casa.
Il futuro dei nativi digitali, secondo Cantelmi, è sempre più scritto nei blog. E la Rete "muterà per alimentare le passioni e i modi di socializzazione di questa generazione in crescita. Affamata di novità - conclude - e bravissima a sintetizzare con un’icona i suoi messaggi al clan degli amici", via mail su telefonini sempre più ricchi di applicazioni.
-
> PENSIERO LIQUIDO E CROLLO DELLA MENTE. --- Dalle macchine del ’700 ai robot, l’artificiale è sempre più una protesi umana.16 giugno 2009, di Federico La Sala
Nell’ultimo libro di Tagliasco e Manzotti e in quello di Sini una riflessione sul libero arbitrio della tecnologia
Penso, quindi sono (un automa)
Dalle macchine del ’700 ai robot, l’artificiale è sempre più una protesi umana
di Giulio Giorello (Corriere della Sera, 16.06.2009)
Nel Giappone dei Tokugawa (1600-1867) erano di moda bambole che servivano il tè, puntigliosamente descritte nel manuale (1769) dell’artista Hosokawa. Pressoché contemporaneamente Giacomo Casanova passava di conquista in conquista fino a incontrare, a un ballo, la donna ideale. Sorpresa: è una dama meccanica, come si scopre quando, per un guasto, «lei» continua a danzare con una gamba tutta irrigidita. La tecnica ha sedotto il grande seduttore: almeno nella finzione cinematografica, poiché il tutto è un’invenzione di Federico Fellini ( Casanova, 1976). Ma è una buona trovata: nel Settecento dei Lumi, dei libertini e dei meccanismi meravigliosi e stupefacenti, Pierre Jacquet-Droz e suo figlio Henri avevano scolpito in legno un pupazzo alto ventotto pollici, dotato di congegni che gli permettevano di mettere su carta un certo numero di frasi. Memore, per così dire, di Cartesio l’Automa Scrivano se ne uscì con la battuta: «Non penso, dunque non sarò mai». Nel 1946 un meccanico dilettante, tal Weisendanger, riprendendo i piani dei fantasiosi artigiani di due secoli prima, riuscì a costruire una macchina in grado di scrivere a mano. Pare abbia commentato: «Credo che la gente troverebbe bizzarro che un uomo della nostra epoca dedichi tempo e fatica a un oggetto così futile».
Traggo queste notizie dallo splendido Dizionario degli esseri umani fantastici e artificiali redatto con curiosità e intelligenza da Vincenzo Tagliasco (bioingegnere dell’Università di Genova, scomparso l’anno scorso) per Mondadori un decennio fa. Cyborg, replicanti, robot, mutanti, dopo aver popolato le saghe di quella moderna mitologia che è la fantascienza, stanno entrando nella nostra esistenza quotidiana. Chissà se dobbiamo «ringraziare» più l’immaginazione letteraria di Mary Shelley o di E.T.A. Hoffmann che le astrazioni matematiche di Alan Turing, di Norbert Wiener o di John von Neumann?
Una storia della fantamatematica - sofisticate geometrie di computer e formule numeriche per calcolatrici potentissime - deve essere ancora scritta. Certo, un posto d’onore spetterà a René Descartes, ovvero Cartesio, non solo per la sua Geometria ma anche per il suo Metodo (1637). Filosofo e matematico, tormentato dal dubbio che il mondo fosse illusione, era sfiorato anche dal sospetto di non essere molto di più di un congegno meccanico, costruito «da un non so qual Genio Maligno». Unica scappatoia: se dubito, penso; e quindi: «Penso, dunque sono». La sua personale esperienza di creatura dubitante garantiva così a Cartesio di esistere. Anzi, Dio ci ha creato come sostanze pensanti; a nostra volta, noi possiamo creare delle macchine, perché operiamo nel più vasto dominio della materia. E il nostro corpo (il nostro cervello, i nostri occhi, le nostre mani) è materiale, macchina esso pure. Dagli orologi e dalle calcolatrici prodotti dagli artefici umani, però, ci distinguiamo perché possediamo il «pensiero indipendente », cioè «l’anima».
Apprezziamo allora l’ironia del piccolo Scrivano: le macchine «ci sono» e forse vivono e pensano per davvero. Almeno, a partire dal secolo scorso: sono capaci di autoalimentarsi e muoversi autonomamente (come le «tartarughe elettriche» di Gray Walter), di pianificare la generazione di altre macchine (gli automi capaci di autoriprodursi ideati da von Neumann), di eseguire ad altissima velocità una miriade di operazioni logiche e aritmetiche (i «dinosauri del calcolo», come li chiamava Reymond Queneau, cioè gli ingombranti calcolatori del Dopoguerra da cui si sono però evoluti i nostri agili calcolatori tascabili). Oggi ancora no, ma domani proveranno emozioni e sentimenti.
Eppure, «l’errore di Cartesio» continua ad affascinare: soprattutto i filosofi. Ho due libri sulla mia scrivania, appena usciti. Il primo è Hamletica, di Massimo Cacciari (Adelphi), di cui già si è detto sulle pagine del «Corriere». Massimo muove, in realtà, dai dubbi non di Cartesio, bensì di Amleto, il principe di Danimarca che sa a malapena di esistere «nel teatro del mondo», per farci capire come lo shakespeariano «Essere o non essere» vada inteso come «Agire o non agire». Dopotutto, è il pensiero indipendente che ci mostra che «essere significa fare»: il mondo è modellato da quell’intreccio di percezione, pensiero, azione e passione che costituisce l’esperienza di ciascuno dei suoi «attori». Sia che riescano a realizzare i loro piani o che (com’è il caso di Amleto) finiscano per «andare errando da naufragio a naufragio».
L’altro volume è di Carlo Sini, e s’intitola, guarda caso, L’uomo, la macchina, l’automa (Bollati Boringhieri). E qui incontriamo la domanda: «Da dove viene la singolare fantasia di riprodurre artificialmente dei simulacri di vita? ». Non è che l’altra faccia, direi, dell’incubo cartesiano di essere una macchina pur illudendosi di possedere il libero arbitrio. Eppure, non solo le macchine ma tutte le protesi escogitate dall’uomo (dal bastone che noi o qualche primate possiamo usare per far cadere un pomo troppo alto sull’albero al più potente telescopio orbitante) aumentano il potere sull’ambiente; e protesi sono persino le parole, sia orali che scritte; dunque, protesi è anche la cultura. Fin dove arriva la tua anima? Pare «infinita fino alla più lontana stella, che puoi raggiungere coi tuoi occhi o con qualche telescopio», per dirla con lo Stephen Dedalus dell’Ulisse di Joyce.
Ma tale infinità è tensione, non possesso. Ogni osservazione può venire integrata o corretta, ogni teoria rivista o rovesciata, ogni apparato migliorato o superato da uno più potente. La nostra autonomia è sempre fisicamente circoscritta, relativa, parziale. Veramente autonomo sarebbe solo Dio. Pur muovendo da premesse differenti, Cacciari e Sini concordano che solo nell’Essere Supremo si realizza «identità di volontà e di potenza». Ma autonomia ha la stessa radice di automa: quel tipo di macchina che ha in sé il principio del suo movimento. Ci pensino bene creazionisti antidarwiniani e sostenitori del cosiddetto Disegno Intelligente: se avessero ragione, condannerebbero il loro Dio alla condizione inesorabile di automa perfetto!
Bando alle sottigliezze teologiche: mi piace concludere con un’immagine tratta dall’ultima fatica di Tagliasco (scritta, prima di lasciarci, insieme con Riccardo Manzotti: L’esperienza, pubblicata da Codice): l’arcobaleno che scorgiamo alla fine del temporale «non è come un ponte di pietra intorno al quale si può girare, né troveremo una pentola d’oro a una delle due estremità ». Pare muoversi insieme con il suo osservatore, e dunque aveva ragione Leonardo da Vinci: «L’arco non è nella pioggia né nell’occhio che lo vede». È in tutt’e due, a mostrarci che, nella realtà della vita, l’Io e il mondo sono ciascuno parte l’uno dell’altro.
-
> PENSIERO LIQUIDO E CROLLO DELLA MENTE. ---- AMORE LIQUIDO. L’instabilità affettiva: una nuova «condizione umana» (di Clara Sereni - Generazione SMS).31 maggio 2009, di Federico La Sala
Generazione sms
 Quelle affollate solitudini dell’era cyber-liquida: l’Altro è solo un clic
Quelle affollate solitudini dell’era cyber-liquida: l’Altro è solo un clic di Clara Sereni (l’Unità, 31.05.2009)
di Clara Sereni (l’Unità, 31.05.2009) CATEGORIE
CATEGORIE
 L’instabilità affettiva: una nuova «condizione umana»
L’instabilità affettiva: una nuova «condizione umana»Liquido. È diventato - il termine «lanciato» dal filosofo Bauman - ormai una categoria. Incertezza, paura, precarietà delle situazioni, delle condizioni e delle relazioni. In particolare si legano tra di loro concetti quali il consumismo alla creazione di rifiuti «umani», la globalizzazione all’industria della «paura», lo smantellamento delle sicurezze ad una vita appunto «liquida» sempre più frenetica e costretta ad adeguarsi alle attitudini del «gruppo» per non sentirsi esclusa, e così via. Anche perchè la solitudine genera insicurezza, ma altrettanto fa la relazione sentimentale. La capacità quindi di interrompere - di «disconnettersi» dice la Sereni - ciascuno dei rapporti interpersonali con un semplice gesto rappresenta dunque una vera e propria -nuova - condizione umana.
Mio suocero era padrone di tante storie. Storie di un’infanzia povera e abbandonata nelle campagne affamate del Molise, storie di avventure rocambolesche da camionista durante la guerra, storie della vita da prestigiatore che, per un certo tempo, aveva fiancheggiato la sua attività prevalente. Mio suocero faceva il taxista, e risiedeva nell’abitacolo non grande della sua automobile il serbatoio più ricco - numericamente e tematicamente - delle sue storie. Perché correndo a tavoletta verso un ospedale o al commissariato, oppure bloccate con lui dentro un ingorgo, le persone non di rado gli raccontavano di sé ragioni addotte e torti subiti, sofferenze e - più raramente - sprazzi di felicità. Parlavano di giornali letti, dei prezzi in aumento, di politica. Con la libertà di discorso che appartiene a chi pensa che mai più incontrerà la persona con cui sta parlando, a cui sta rivelando di sé anche qualcosa di intimo.
Con la stessa libertà e per le stesse ragioni mio suocero dava consigli e esprimeva i propri pareri senza remore, discutendo talvolta anche animatamente: e se per i contrasti emersi la mancia non c’era pazienza, aveva detto comunque la sua. Si erano scambiate delle opinioni. Si portava a casa, con la storia, un’esperienza. Per non oscurare quei colloqui scelse di non essere mai radio-taxi, pur rinunciando così ad una parte di guadagni. Mio suocero è morto sedici anni fa, non un secolo. Eppure penso che da lì a qui ci sia stata una mutazione antropologica, qualcosa di cui forse non siamo ancora del tutto consapevoli, e che pure cambia radicalmente il quadro dentro cui ci muoviamo.
Una prima modifica, ormai evidentissima. Anche chi di noi è nato prima dei microchips, trovandosi dentro un taxi (un autobus, un treno) per affanno o felicità, trasferimento di piacere o urgenza, dopo aver dichiarato la destinazione con chi gli è compagno di tragitto non parla più: manda Sms e/o parla al cellulare con qualcun altro. Parlano al cellulare le coppie che camminano per mano, una con una persona e l’altro con un’altra, e mandano Sms. La linea può cadere perché c’è una galleria o perché la facciamo cadere noi, per interrompere un discorso che non ci piace. E gli SMS sono fatti apposta per rispondere soltanto quando vogliamo farlo, come le telefonate: sul display vediamo chi ci sta chiamando, e decidiamo se sottrarci o no. Attraverso i cellulari passano litigate e insulti di gente di ogni età, ma passa raramente il conflitto vero, quello che ti obbliga a costruire dialetticamente nuovi ponti per incontrare l’Altro, e non semplici passerelle temporanee, pronte a crollare al primo soffio di vento.
Pensavo a tutto questo quando ho preso in mano, con colpevole ritardo, Amore liquido, di Zigmunt Bauman (Laterza, 2006), secondo il quale le relazioni, i rapporti interpersonali, hanno oggi le stesse caratteristiche della Rete per un verso, e dei centri commerciali dall’altro. La Rete, perché non si decide più la fatica di una relazione, preferendo il più agevole meccanismo connessione-disconnessione: rispetto al quale siamo noi, solo noi a decidere.
Possiamo rivelare di noi gli aspetti più intimi ed oscuri, certi che qualcuno ci ascolti ma altrettanto certi che, mai si verificasse un conflitto, basterà premere quit, e tutto si fermerà. I centri commerciali, perché lì scatta la ricerca compulsiva del prodotto più conveniente, più competitivo: dal punto di vista del prezzo, ma anche della qualità presunta o reale, dell’esclusività e dell’essere cool, dell’invidia o della considerazione che il possesso di quell’oggetto può generare nelle persone che si frequentano. A questo si aggiunge il meccanismo per cui molti di noi, se non proprio tutti, non acquistano più un nuovo prodotto perché il precedente si è rotto, o consumato, o comunque non funziona più: lo si compra perché è l’ultimo modello, e ogni altro che lo preceda si percepisce ormai come superato, inutile. Qualcosa di cui vergognarsi anche un po’, o che comunque non fa sentire “all’altezza”: di un modello di sviluppo che ti spinge a desiderare sempre di più, ed anche a non affidarti ad un solo prodotto, legandoti troppo al quale potresti perderti chissà quali mirabolanti occasioni.
Le grandi occasioni: come in un centro commerciale si consumano relazioni e amori, da non approfondire mai troppo (e da disconnettere opportunamente) per non perderne altre e migliori, per lasciare la porta sempre aperta al principe azzurro o alla principessa rosa che verrà, per non lasciarsi scappare contatti che potrebbero essere utili nei più svariati campi. Una escalation del desiderio insoddisfatto, che contribuisce in maniera rilevante a renderci isolati, individualisti, fragili, frustrati. Manovrabili da chi conosce le regole del gioco. Utilizzabili da leader che si propongono come testimonial di un prodotto, e non come costruttori di politiche.
Ho riassunto in maniera probabilmente maldestra i contenuti ben più ricchi del libro di Bauman, che vi fotografa però, a mio parere, quella che ho definito mutazione antropologica. Che ci riguarda tutti, anche chi non ha mai frequentato una chat o un social-network. E certo concerne anche chi usa la posta elettronica, quella che (come ha scritto Beppe Sebaste) garantisce insieme il massimo di distanza e il massimo di vicinanza, induce a tirar fuori cose di sé che altrimenti non si direbbero perché fare i conti con le proprie e altrui emozioni non è mai obbligatorio: chi dovesse indagarle si può sempre non rispondere, oppure mandare una faccina e chiuderla lì.
Certo non sono ancora scomparse del tutto le relazioni vere, i rapporti dotati di senso: ma siamo sulla buona strada. Forse si può dire che Internet ha atomizzato le anime più dell’atomica vera, quella di Nagasaki e Hiroshima: in fondo, ai tempi dell’equilibrio del terrore c’era più aggregazione, più obiettivi condivisi, e perfino meno guerre, di oggi.
Se si accetta questo punto di vista sulla trasformazione, appare ovvio come uno come Berlusconi vi si muova come un pesce nell’acqua: maestro nello stimolare speranze senza mai soddisfarle, che lascia ogni volta baluginare la speranza-certezza di un’altra occasione.
Migliore, più appetibile: l’ultimo modello. Non più la carota per far marciare l’asino, ma il premio che spetta al vincitore di turno, quale che sia la posta in gioco, e chiunque abbia, di quel gioco, le carte in mano.
Come si fa, a tornare a parlare con l’autista del taxi e con il compagno di viaggio? Come si fa a rischiare nuove relazioni vere e non virtuali, ad affrontare il conflitto della crescita resistendo alla tentazione di disconnettersi? Come si fa a parlare con i più giovani, a trasmettere la memoria e le esperienze, senza farsi travolgere dall’informazione spezzettata e disorganica, ma percepita come totale, di Youtube? Come si fa a smettere di inseguire l’ultimo modello di leader, e affrontare la fatica (e il conflitto, di nuovo) di costruire un modo diverso di fare politica? Le risposte non le porterà una cicogna, e sotto i cavoli è inutile cercare. Ma credo che di queste risposte ci sia bisogno: per sconfiggere Berlusconi, e per sconfiggere soprattutto il Berlusconi che, con radici ben insediate, cresce e si allarga dentro di noi.
-
> PENSIERO LIQUIDO E CROLLO DELLA MENTE. --- IL MONDO LIQUIDO E LA FELICITA’ (di Zygmunt Bauman - un brano del nuovo libro di "L’arte della vita").7 maggio 2009, di Federico La Sala
 Com’è cambiata l’arte di esistere
Com’è cambiata l’arte di esistere IL MONDO LIQUIDO E LA FELICITA’
IL MONDO LIQUIDO E LA FELICITA’ Bauman: i nuovi valori della vita
Bauman: i nuovi valori della vita Bisogna affrontare le sfide difficili, cercando di dare una forma a quel che è indefinito. Ed essere consapevoli che lo sforzo sarà sempre enorme
Bisogna affrontare le sfide difficili, cercando di dare una forma a quel che è indefinito. Ed essere consapevoli che lo sforzo sarà sempre enorme
 Servono legami responsabili: l’amore richiede cure, non consumo
Servono legami responsabili: l’amore richiede cure, non consumo
 Il nostro tempo è governato "dall’economia delle esperienze"
Il nostro tempo è governato "dall’economia delle esperienze" di Zygmunt Bauman (la Repubblica, 07.05.2009)
di Zygmunt Bauman (la Repubblica, 07.05.2009)Anticipiamo un brano del nuovo libro di "L’arte della vita" (Laterza, pagg.178, euro 15) da oggi in libreria
Ognuno di noi è artista della propria vita: che lo sappia o no, che lo voglia o no, che gli piaccia o no. Essere artista significa dare forma e struttura a ciò che altrimenti sarebbe informe e indefinito. Significa manipolare probabilità. Significa imporre un «ordine» a ciò che altrimenti sarebbe «caos»: «organizzare» un insieme di cose ed eventi che altrimenti sarebbe caotico (casuale, fortuito e dunque imprevedibile), rendendo così più probabile il verificarsi di certi eventi anziché di altri.
A chi dovremo ispirarci per sapere come organizzare (e organizzarci), se non ai professionisti, a chi è responsabile di quelle entità che si chiamano «organizzazioni»?
Fino a pochissimo tempo fa il concetto di «organizzazione» era entrato a far parte dell’uso comune associato a grafici, diagrammi, organigrammi, dipartimenti, tempistiche, regolamenti; alla vittoria dell’ordine (di uno stato in cui si fa in modo che alcuni eventi siano molto più probabili di qualsiasi altro) sul caos (su uno stato in cui ogni cosa ha la stessa probabilità o una probabilità incalcolabile di accadere).
Ho scritto «fino a pochissimo tempo fa» perché oggi, entrando nella sede centrale di un’organizzazione, si sentono soffiare i venti del cambiamento. Qualche anno fa Joseph B. Pine e James H. Gilmore pubblicarono un libro, L’economia delle esperienze, il cui titolo (sicuramente anche grazie all’aiuto dalle credenziali della Harvard Business School) accese immediatamente la fantasia degli studenti di Economia aziendale, elevando l’attuale modo di pensare di direttori e presidenti di aziende a nuovo paradigma degli studi di organizzazione.
In un volume di stimolanti saggi pubblicato dalla Copenhagen Business School Press, i curatori Daniel Hjorth e Monika Kostera hanno delineato in termini generali e con notevole ricchezza di particolari il percorso dal vecchio paradigma organizzativo, imperniato sul «management» e sulla priorità del controllo e dell’efficienza, al paradigma emergente, che guarda soprattutto allo spirito imprenditoriale e sottolinea «le caratteristiche più vitali dell’esperienza: immediatezza, spirito ludico, soggettività e performatività».
Niels Akerstrom, docente alla Copenhagen Business School, paragona l’attuale situazione del dipendente di un’organizzazione a quella che si vive oggi da sposati o conviventi. L’analisi di Akerstrom sulla tendenza a ridefinire le organizzazioni secondo uno schema simile a quello delle relazioni d’amore ci rinvia a una trasformazione ancora più vasta, che è probabilmente alla base del «cambio di paradigma»: alla trasformazione profonda del ruolo svolto nel contesto liquido-moderno dai legami umani, in particolare dai rapporti d’amore e più in generale dall’amicizia. La loro forza d’attrazione raggiunge oggi, a detta di tutti, livelli senza precedenti, ma è inversamente proporzionale alla capacità di svolgere il ruolo sperato e atteso, che era e resta la causa principale di quell’attrazione. E’ proprio perché siamo disponibili ad «amicizie e unioni profonde», proprio perché lo desideriamo più forte e disperatamente che mai, che i nostri rapporti sono pieni di rumore e furore, carichi di ansia e in perenne allerta.
Vorremmo la mano disponibile di una persona amica, affidabile, fedele, alla «finché-morte-non-ci-separi», che ci venga tesa sicuramente, prontamente e di buon grado in qualsiasi momento si renda necessaria, che sia come l’isola per il naufrago o l’oasi per chi si è perso nel deserto: sono queste le mani che ci occorrono, che vorremmo attorno a noi, tanto più numerose tanto meglio.
Eppure. Nel nostro ambiente liquido-moderno la fedeltà a vita è una grazia, inseparabile da varie disgrazie. Che fare se le onde cambiano direzione, se emergono nuove opportunità che trasformano i rassicuranti punti di forza di ieri nelle minacciose debolezze di oggi, gli averi che un tempo ci si teneva stretti in fastidiose zavorre, i giubbotti salvagente in cinture con i piombi?
«Dov’è il confine tra il diritto alla felicità personale e al nuovo amore e l’egoismo esasperato disposto a mandare in frantumi la famiglia, e magari a danneggiare i figli?», si chiede Ivan Klíma. Tracciare questo confine con precisione può essere doloroso, ma di una cosa possiamo esser certi: quel confine, ovunque sia, viene violato nel momento in cui l’atto di stringere e sciogliere legami tra gli uomini è dichiarato moralmente indifferente e neutro, sollevando a priori gli attori dalla responsabilità delle reciproche conseguenze di ciò che fanno: da quella stessa responsabilità incondizionata che l’amore promette, nella buona e nella cattiva sorte, e che lotta per costruire e conservare. «La creazione di una relazione buona e durevole», in netta opposizione alla ricerca di godimento attraverso oggetti di consumo, «richiede uno sforzo enorme».
Per farla breve: l’amore non è qualcosa che si possa trovare, non è un objet trouvé o un ready-made. E’ qualcosa che richiede di essere creato e ricreato ogni giorno, ogni ora; che ha bisogno di essere costantemente risuscitato e riaffermato e richiede attenzione e cure. In linea con la crescente fragilità dei legami umani, con l’impopolarità degli impegni a lungo termine, con l’eliminazione dei «doveri» dai «diritti» e l’elusione di ogni obbligo che non sia «verso se stessi» («me lo devo», «me lo merito», e via dicendo) si tende a vedere nell’amore qualcosa che è perfetto dall’inizio oppure è fallito, e che dunque è meglio abbandonare e sostituire con esemplari «nuovi e migliorati», si spera davvero perfetti. Un simile amore non sopravvivrà al primo piccolo litigio, e tanto meno al primo serio disaccordo e scontro.
La felicità - per richiamare la diagnosi di Kant - non è un’ideale della ragione, ma dell’immaginazione. E lo stesso Kant avvertì che dal legno storto dell’umanità non si sarebbe mai potuto ricavare nulla di dritto. John Stuart Mill parve riunire entrambe le nozioni in un avvertimento: chiediti se sei felice e cesserai di esserlo. Gli antichi probabilmente già lo sospettavano ma, guidati dal principio Dum spiro, spero - finché c’è vita, c’è speranza -, sostenevano che senza duro lavoro la vita non offrirebbe nulla che abbia valore. Duemila anni dopo, questo suggerimento non ha perso affatto la sua attualità.
 © 2008, Zygmunt Bauman
© 2008, Zygmunt Bauman
 © 2009, Laterza
© 2009, Laterza
 Traduzione di Marco Cupellaro
Traduzione di Marco Cupellaro -
> PENSIERO LIQUIDO E CROLLO DELLA MENTE. --- l’era elettronica comporta un malessere totale, come quello che potrebbe provare una persona che abbia il cervello fuori dalla scatola cranica. Siamo diventati particolarmente vulnerabili (Marshall McLuhan, Rimorso d’inconscienza).3 maggio 2009, di Federico La Sala
RIMORSO DI INCOSCIENZA
di Marshall McLuhan ( Lettera internazionale, n. 98 IV Trimestre 2008)
Con il telegrafo, l’uomo occidentale ha iniziato ad allungare i suoi nervi fuori dal proprio corpo. Le tecnologie precedenti erano state estensioni di organi fisici: la ruota è un prolungamento dei piedi; le mura della città sono un’esteriorizzazione collettiva della pelle. I media elettronici, invece, sono estensioni del sistema nervoso centrale, ossia un ambito inclusivo e simultaneo. A partire dal telegrafo, abbiamo esteso il cervello e i nervi dell’uomo in tutto il globo.
Di conseguenza, l’era elettronica comporta un malessere totale, come quello che potrebbe provare una persona che abbia il cervello fuori dalla scatola cranica. Siamo diventati particolarmente vulnerabili. L’anno in cui fu introdotto il telegrafo commerciale in America, il 1844, fu anche l’anno in cui Kierkegaard pubblicò Il concetto dell’angoscia.
La caratteristica di tutte le estensioni sociali del corpo è che esse ritornano a tormentare i loro inventori in una sorta di rimorso di incoscienza. Proprio come Narciso, che si innamorò di un’esteriorizzazione (proiezione, estensione) di se stesso, l’uomo sembra innamorarsi invariabilmente dell’ultimo aggeggio o congegno, che in realtà non è altro che un’estensione del suo stesso corpo.
Quando guidiamo la macchina o guardiamo la televisione, tendiamo a dimenticare che ciò con cui abbiamo a che fare è soltanto una parte di noi stessi messa là fuori. In questo modo, diventiamo servomeccanismi delle nostre stesse creazioni e rispondiamo ad esse nel modo immediato e meccanico che esse richiedono. Il punto centrale del mito di Narciso non è che gli individui tendono a innamorarsi della propria immagine, ma che si innamorano di proprie estensioni, convinti che non siano loro estensioni.
Penso che questa sia un’immagine piuttosto precisa di tutte le nostre tecnologie, e ci invita a riflettere su una questione fondamentale: l’idolatria della tecnologia comporta un intorpidimento psichico. Agli occhi di osservatori successivi, ogni generazione sospesa dinanzi a un grande cambiamento sembra essere stata del tutto inconsapevole dell’imminenza e dei punti fondamentali dell’evento stesso. Ma è necessario comprendere il potere che hanno le tecnologie di isolare i sensi l’uno dall’altro, e così di ipnotizzare la società.
La formula dell’ipnosi è «un senso alla volta». I nostri sensi privati non sono sistemi chiusi ma vengono incessantemente tradotti l’uno nell’altro in quella esperienza sinestetica che chiamiamo coscienza. I nostri sensi estesi, strumenti o tecnologie, sono invece sistemi chiusi, incapaci di interazione. Ogni nuova tecnologia diminuisce l’interazione e la consapevolezza dei sensi proprio nell’area a cui quella tecnologia si rivolge: si verifica una sorta di identificazione tra osservatore e oggetto. (...)
La nuova tecnologia elettronica, però, non è un sistema chiuso. In quanto estensione del sistema nervoso centrale, essa ha a che fare proprio con la consapevolezza, con l’interazione e con il dialogo. Nell’era elettronica, la stessa natura istantanea della coesistenza tra i nostri strumenti tecnologici ha dato luogo a una crisi del tutto inedita nella storia umana.
Ormai le nostre facoltà e i nostri sensi estesi costituiscono un unico campo di esperienza e ciò richiede che essi divengano collettivamente coscienti, come il sistema nervoso centrale stesso. La frammentazione e la specializzazione, tratti caratteristici del meccanismo, sono assenti. Tanto siamo inconsapevoli della natura delle nuove forme elettroniche, altrettanto ne veniamo manipolati.(...)
I modi di pensare generati dalla cultura tecnologica sono molto diversi da quelli favoriti dalla cultura della stampa. A partire dal Rinascimento, la maggior parte dei metodi e delle procedure hanno teso fortemente a enfatizzare l’organizzazione e l’applicazione visiva del sapere. I presupposti latenti nella segmentazione tipografica si manifestano nella frammentazione dei mestieri e nella specializzazione delle mansioni sociali.
La scrittura favorisce la linearità, ossia una consapevolezza e un modo di operare secondo il principio «una cosa alla volta». Da essa derivano la catena di montaggio e l’ordine di battaglia, la gerarchia manageriale e la divisione in dipartimenti che caratterizza le strutture accademiche. Gutenberg ci ha dato analisi ed esplosione. Frammentando il campo della percezione e dell’informazione in segmenti statici, abbiamo realizzato cose meravigliose.
I media elettronici operano però in modo diverso. La televisione, la radio e il giornale (che a sua volta era legato al telegrafo) hanno a che fare con lo spazio acustico, vale a dire con quella sfera di relazioni simultanee creata dall’atto di ascoltare. Noi udiamo suoni provenienti da tutte le direzioni nello stesso momento; questo crea uno spazio unico, non visualizzabile. La simultaneità dello spazio acustico è l’esatto contrario della linearità, del prendere una cosa alla volta. E’ molto sconcertante rendersi conto che il mosaico di una pagina di giornale è «acustico» nella sua struttura fondamentale.
Questo, tuttavia, vuole dire soltanto che qualunque struttura, le cui componenti coesistano senza connessioni o legami diretti, lineari e creino un campo di relazioni simultanee, è acustica, anche se alcuni suoi aspetti possono essere visualizzati. Le notizie e le pubblicità che si trovano sotto la data di un giornale sono tenute insieme soltanto dalla data. Non hanno alcuna interconnessione di natura logica o discorsiva.
Eppure formano un mosaico legato all’immagine aziendale le cui parti si compenetrano tra loro. Questo è anche il tipo di ordine che tende a costituirsi in una città o in una cultura. E’ un’unità di tipo orchestrale e vibrante, non l’unità del discorso logico.
Il potere tribalizzante dei nuovi media elettronici, il modo in cui essi ci riportano alla dimensione unificata delle antiche culture orali, alla coesione tribale e a schemi di pensiero preindividualistici, non è stato realmente compreso. Il tribalismo è il senso di un profondo legame di famiglia, è la società chiusa come norma della comunità.
La scrittura, in quanto tecnologia visiva, ha dissolto la magia tribale ponendo l’accento sulla frammentazione e sulla specializzazione, e ha creato l’individuo. D’altra parte, i media elettronici sono forme di gruppo. I media elettronici dell’uomo di una società alfabetizzata riducono il mondo a una tribù o a un villaggio in cui tutto capita a tutti nello stesso momento: ognuno conosce e dunque partecipa a ogni cosa che accade nel momento in cui essa accade.
(...) Siamo diventati come l’uomo paleolitico più primitivo, di nuovo vagabondi globali; ma siamo ormai raccoglitori di informazioni piuttosto che di cibo. D’ora in poi la fonte di cibo, di ricchezza e della vita stessa sarà l’informazione. Trasformare tale informazione in prodotti, a questo punto, è un problema che riguarda gli esperti di automazione e non più una questione che comporta la massima divisione del lavoro e delle capacità umane.
L’automazione, come tutti sappiamo, permette di fare a meno della forza lavoro. Questo terrorizza l’uomo meccanico perché non sa che cosa fare nella fase di transizione, ma significa semplicemente che il lavoro è finito, morto e sepolto.
(...) Quando nuove tecnologie si impongono in società da tempo abituate a tecnologie più antiche, nascono ansie di ogni genere. Il nostro mondo elettronico necessita ormai di un campo unificato di consapevolezza globale; la coscienza privata, adatta all’uomo dell’era della stampa, può considerarsi come un cappio insopportabile rispetto alla coscienza collettiva richiesta dal flusso elettronico di informazioni. In questa impasse, l’unica risposta adeguata sembrerebbe essere la sospensione di tutti i riflessi condizionati.
Penso che, in tutti i media, gli artisti rispondano prima di ogni altro alle sfide imposte da nuove pressioni. Vorrei che ci mostrassero anche dei modi per vivere con la nuova tecnologia senza distruggere le forme e le conquiste precedenti. D’altronde, i nuovi media non sono giocattoli e non dovrebbero essere messi nelle mani di Mamma Oca o di Peter Pan. Possono essere affidati solo a nuovi artisti.
-
> PENSIERO LIQUIDO E CROLLO DELLA MENTE. ---- CAVERNA PLATONICA E FOTOGRAFIA: "OMBRE E PHOTO" (di Jean Baudrillard - Un testo inedito).30 aprile 2009, di Federico La Sala
Gli scatti e un testo inedito di Jean Baudrillard
Questo testo di Jean Baudrillard, inedito per l’Italia, è la base teorica su cui la vedova del filosofo, Marine, ha allestito la mostra fotografica che si inaugura oggi a Reggio Emilia.
Fotografia. L’ombra del reale
 È una illusione che l’immagine sia "oggettiva" mentre non è altro che una emanazione del nostro sguardo
È una illusione che l’immagine sia "oggettiva" mentre non è altro che una emanazione del nostro sguardo
 Occorre capire che gli oggetti sono sensibili alla ripresa quanto gli esseri umani
Occorre capire che gli oggetti sono sensibili alla ripresa quanto gli esseri umani
 Oggi ognuno può credere di veder sfilare lo spirito del mondo davanti al proprio obiettivo
Oggi ognuno può credere di veder sfilare lo spirito del mondo davanti al proprio obiettivo
 Wittgenstein diceva che in teatro uno scenario di alberi disegnati è meglio degli alberi veri
Wittgenstein diceva che in teatro uno scenario di alberi disegnati è meglio degli alberi veri
 A volte la violenza estrema messa in mostra rischia di diventare un effetto speciale
A volte la violenza estrema messa in mostra rischia di diventare un effetto specialedi Jean Baudrillard (la Repubblica, 30.04.2009)
In fondo tutte le fotografie sono come le ombre platoniche proiettate sulle pareti della caverna, o come quest’ombra spettrale dell’irradiato di Hiroshima, transverberato dalla luce atomica - esempio perfetto del cliché istantaneo. Stessa proiezione "acheiropoietica" di quella del sudario del Cristo (oggetto indipendente dalla nostra volontà, l’ombra è in sé stessa un segno acheiropoietico). Le immagini più pregnanti sono quelle più vicine a questa scena primitiva di un’iscrizione fantomatica e più lontane dall’intervento umano.
La silhouette atomizzata di Hiroshima, sostanza polverizzata del corpo: un’impronta fossile - volatilizzazione dell’oggetto in una sostanza non carnale, una traccia. I fossili stessi sono altrettanto vicini all’analogon fotografico, sono come dei negativi fotografati da una mano invisibile, come le pitture rupestri del neolitico, quest’arte parietale da cui la figura umana è misteriosamente assente (salvo le mani "in negativo" contornate sulle pareti come a partire da una fonte luminosa). Unica figura moderna erede di queste pitture murali e di una forma "fotografica" del segno - più vicina a una figurazione automatica che al segno rappresentativo - sono i graffiti: anch’essi inseparabili dalle pareti.
La fotografia è l’ombra proiettata sulla pellicola di ciò di cui non avremo mai l’esperienza concreta, oggettiva, e di cui neppure conosceremo mai la fonte luminosa, proprio come i prigionieri della caverna platonica, i quali del mondo esterno e della propria esistenza non conosceranno mai altro che il riflesso.
La sfilata delle ombre (la mia sulla parete ocra, quella degli alberi, quelle dei personaggi sulla parete della Recoleta, o tutte queste sagome silenziose, la notte nelle strade di Venezia), tutto questo teatro d’ombre è come il riflesso di un mondo anteriore in cui non eravamo ancora altro che ombre, di un’età dell’oro crepuscolare in cui gli uomini non sono ancora precipitati verso la luce brutale del mondo reale, verso questo deserto dove tutte le ombre sono vittime della luce artificiale e della realtà virtuale, dove i corpi sono diventati traslucidi in un mondo sovraesposto dall’interno.
La fotografia, appunto, conserva la traccia di una scrittura d’ombra, quale essa è altrettanto che "scrittura di luce", e dunque il segreto di una fonte luminosa venuta dalla notte dei tempi. Si dice dell’ombra che ci segue, ma di fatto essa ci ha sempre già preceduti, e ci seguirà. Come la morte: noi siamo già stati morti prima di essere viventi, e lo saremo ancora dopo.
Il controsenso più totale, e più generale, è l’ipertecnicità di tutte queste immagini così perfette, così impeccabili, in cui traspare soltanto l’iperrealtà della tecnica come effetto speciale (lo sfocato stesso è un effetto speciale). Di colpo la violenza che esse ci mostrano è soltanto un effetto speciale. Impossibile sfuggire a questo ricatto e di fronte a questa vampirizzazione estetica della miseria resta solo revulsione e repulsione. È come nella scena di condizionamento ottico di Arancia meccanica, in cui si è costretti a mantenere gli occhi aperti su scene insopportabili nell’illusione di purgarne l’immaginazione. Più è atroce, più è estetico, e tutti applaudono, secondo un rituale feroce di compiacimento "professionale". Del resto, non si sa più a che cosa si applaude: alla morte? alla performance? È per questa ragione che tutte queste immagini non ci toccano più, sono un’arma di distruzione di massa dell’intelligenza e della sensibilità.
Il controsenso è sempre dell’ordine del realismo, dell’alterazione del senso attraverso l’"informazione" inutile. Viene da pensare a una riflessione di Wittgenstein sulla scena teatrale: uno scenario di alberi dipinti è molto meglio che uno di alberi veri, che distrarrebbero l’attenzione da ciò di cui si tratta. O ancora, nei reportage sulla micidiale canicola del 2003 in cui ci vengono mostrati i vecchi in carne e ossa, frontalmente, nella loro agonia - ben più violenti, ben più pungenti erano le fotografie degli immensi camion di refrigerazione dove sono conservati per vari giorni i corpi che non si possono seppellire, ma che non si vedono. Immagine fredda, obliqua, molto più efficace per l’immaginazione. Ovunque la verità, la veracità tecnica, essa pure inutile, esilia l’essenziale - nella sfera delle funzioni inutili.
Della stupidità realista fa parte non solo la perfezione tecnica delle immagini, ma anche la loro accumulazione. Sempre più immagini si accumulano in serie, in sequenze "tematiche", che illustrano fino alla nausea lo stesso avvenimento, che si accavallano e si succedono - immagini che credono di accumularsi e di fatto si annullano l’un l’altra. Ciò che viene completamente cancellato in questa storia è la libertà delle immagini le une rispetto alle altre. Ognuna priva l’altra della sua libertà e della sua intensità. Ora, bisogna che un’immagine sia libera da se stessa, che sia sola e sovrana, che abbia il proprio spazio simbolico (la qualità "estetica" qui non è in causa). Non si è capito che è in atto un duello delle immagini tra loro. Se sono vive, seguono la legge degli esseri viventi: selezione ed eliminazione. Ogni immagine deve eliminarne un’infinità d’altre. È esattamente nel senso inverso che si va oggi, in particolare con il digitale, dove la sfilata delle immagini assomiglia alla sequenza del genoma.
È vero che oggi ognuno può immaginare di veder passare il Weltgeist davanti al proprio obiettivo e di essere diventato, grazie all’incessante padronanza sulle immagini, una coscienza universale. È il regno dell’espressionismo fotografico - di fronte a degli oggetti che non aspetterebbero altro che di essere visti e fotografati, cioè presi a testimoni dell’esistenza del soggetto e del suo sguardo.
Vi è qui invece un errore totale sulla ripresa e sull’essenza dell’immagine, considerata uno stereotipo oggettivo. Infatti non si tratta affatto di una registrazione, ci sono tante cose che fotografiamo mentalmente, senza necessariamente usare una macchina fotografica (del resto le più belle sono forse quelle che avremmo potuto fare in sogno, ma, ahimè, non avevamo la macchina!). È di una visione fotografica del mondo che si tratta nella fotografia, una visione del mondo nel suo dettaglio, nella sua stranezza e nella sua apparizione. Talvolta c’è passaggio all’atto, cioè a una ripresa che materializza questa visione delle cose, non così come sono, ma come in se stesse la fotografia le cambia, "just as they look as photographed". Perché la cosa fotografata non è affatto la stessa, e questo sguardo, questa visione, è da essa che emana, così come entra nel campo, nel momento dell’atto fotografico. E ciò che ne risulta - l’immagine - non ha affatto l’aria di quello che le cose sono oggettivamente, ma di quello che assumono "di fronte" all’obiettivo.
Gli oggetti sono sensibili alla ripresa quanto gli esseri umani - da qui l’impossibilità di testimoniare la loro realtà oggettiva. Quest’ultima è un’illusione tecnica, che dimentica che essi entrano in scena nel momento dello scatto, e che ciò che la fotografia può fare di meglio, ciò di cui può sognare, è di catturare questa entrata in scena dell’oggetto (escludendo ogni messa in scena o artificio sti-listico).
Ombre et photo, in François L’Yvonnet (a cura di), Jean Baudrillard, Paris, L’Herne, 2004, pp. 231-232. Traduzione di Elio Grazioli
-
> PENSIERO LIQUIDO E CROLLO DELLA MENTE. ---- Contro le manie della neuroscienza e la tendenza a ridurre tutti i nostri pensieri al cervello, un pamphlet di Legrenzi e Umiltà (di Andrea Valambrini).24 aprile 2009, di Federico La Sala
Pamphlet.
Legrenzi e Umiltà firmano un saggio che va controtendenza
 Contro le manie della neuroscienza
Contro le manie della neuroscienza
 «Non spiega tutto»
«Non spiega tutto»di Andrea Valdambrini (il Riformista, 24.04.2009)
PROVOCAZIONE. Gli autori criticano la riduzione della mente al cervello, la psicologia alla biologia. Un atteggiamento falsamente moderno e fuorviante quando viene divulgato con travisamenti e salti logici. Ma non bisogna dimenticare gli eccessi di quando la spiegazione di tutto, anche della malattia mentale, era l’ambiente sociale.
Ricordate quando Leporello, all’inizio del Don Giovanni, mette in guardia sulla "passion predominante" del padrone? Se il personaggio mozartiano potesse mai essere l’assistente di un neuroscienziato anziché il servitore di un libertino, oggi rimarcherebbe forse un cambio di prospettiva. La passione che predomina sembra essere quella della la neuro-mania
Sempre più spesso, sui siti e sui giornali leggiamo notizie come: individuato il neurone dell’amore, piuttosto che il centro cerebrale dell’invidia. Oppure troviamo titoli sensazionali come: fotografata per la prima volta l’area del cervello in funzione quando ascoltiamo il discorso di un politico che ci sta antipatico. Non sempre la divulgazione fa bene alla scienza, e anzi spesso l’ansia di dare in pasto al grande pubblico scoperte altrimenti ostiche, finisce per travisare il vero significato della ricerca.
Rispetto a questo rischio vogliono mettere in guardia Paolo Legrenzi e Carlo Umiltà, rispettivamente professori di psicologia cognitiva a Venezia e di neuropsicologia a Padova, che firmano insieme Neuro-mania. Il cervello non spiega chi siamo (Il Mulino 2009, pp. 125, euro 9). Il loro è un saggio sintetico e tagliente, che dividerà nettamente le opinioni di chi lo legge tra favorevoli e contrari ma che farà sicuramente parlare di sé. Il pamphlet porta infatti un attacco frontale ad una delle convinzioni principali della scienza degli ultimi trenta anni, quella secondo cui la mente (ovvero il comportamento, il linguaggio, l’agire sociale e molto altro) si spiega soprattutto se non principalmente attraverso il cervello.
Nell’alternativa tra "salvare" la mente dalla sua dipendenza verso il corpo come faceva Cartesio, cioè dividendo le due e rendendo autonoma l’anima, o al contrario pensare l’uomo come un essere esclusivamente materiale, come suggeriva Julien de La Mettrie nel suo settecentesco L’uomo come macchina, pare che siamo tutti ben disposti ad abbracciare la proposta del secondo. Cosa sono i pensieri in fondo? Aria sì, ma comunque prodotti delle cellule, dei neuroni, delle sinapsi. O almeno così ci piace credere.
A partire dalla tacita condivisione della nostra natura come uomini-macchina si installa l’attuale riscossa del corpo (inteso come cervello) sulla mente (intesa come cultura). E tutto sembra prendere, nella scienza, una base più solida e convincente. Senonché quando vediamo sulle pagine di una rivista scientifica o su quelle di un quotidiano, le zone del cervello colorate a rimarcare l’attivarsi dei neuroni in presenza di un dato stimolo, non sappiamo di trovarci in realtà di fronte a un artificio grafico e probabilmente anche ad una forzatura. Le cellule grigie colorate indicano il maggior afflusso di sangue, a sua volta segno della loro attivazione. Che poi l’attivazione porti al sorgere di un pensiero, questa è materia controversa. Non solo perché si può riscontrare come più aree, non una sola, possono attivarsi nel cervello quando proviamo disgusto o pensiamo che è ora di pranzo. Ma soprattutto - e qui entriamo nel campo dell’errore logico - perché la relazione tra due cose non significa che una è la causa dell’altra. C’ è sicuramente un nesso tra l’amigdala e il senso di disgusto, ma questo non significa, secondo gli autori, che proprio lì ha sede la causa di quell’emozione.
La neuro-mania è dunque la tendenza a ridurre tutti i nostri pensieri al cervello, e a spiegare con le cellule grigie una serie di fenomeni socio-culturali. Questo trend scientifico ha fatto sorgere, negli ultimi anni, una serie imprecisata di nuove branche del sapere, tutte accompagnate da un unico prefisso: neuro-economia, neuro-marketing, neuro-estetica, neuro-etica e perfino neuro-teologia e neuro-politica. Tutte a ben vedere riproposizioni della scienza dell’era del positivismo, che da Broca, lo scienziato francese che dà il nome all’area preposta alla produzione linguistica, al bresciano Golgi, nobel per gli studi sulla struttura del cervello, abbracciavano l’idea che i neuroni possono spiegare quello che pensiamo e che facciamo. Ai nostri giorni si chiama neuroimaging, la tecnica tanto in voga di fotografare il nostro cranio e sezionarne le funzioni (questi sono i neuroni dell’amore, appunto). Ma in fondo cosa altro faceva il fisiologo Angelo Mosso, quando misurava l’afflusso sanguigno che aumentava nel momento in cui un povero contadino ascoltava suonare le campane della chiesa a mezzogiorno? Cosa cercava allora il medico nella testa del suo paziente se non quello che il neuroscienziato cerca oggi con tecniche giusto un po’ più sofisticate? Un’area di neuroni provoca un determinato pensiero. Tanto facile, dicono Legrenzi e Umiltà, da essere sbagliato.
Se insomma «il futuro ha un cuore antico», frase che gli autori prendono in prestito da Carlo Levi, la modernità scolora in qualcosa che sembra molto meno moderno. Se poi la correlazione cervello-pensiero non è così prodigiosamente lineare come sembra, questa moderna antichità sembra anche molto meno scientifica di quanto pretende di essere. Il prefisso neuro affascina, piace e fa vendere libri e consulenze. Le immagini del cervello attraggono l’attenzione e la curiosità di tutti come i vecchi mirabilia o le wunderkammer dentro cui si vedeva quanto mai mostrato prima. Ma sempre di un bluff si tratta.
È probabile che sia tempo ormai di riflettere sugli eccessi della neuro-mania. C’è una domanda, tuttavia, che non trova risposta nelle pagine di Legrenzi e Umiltà, ed è la seguente. Abbiamo forse dimenticato che per molti anni l’opinione pubblica adesso avida di spiegazioni neuroscientifiche ha avallato l’idea che tutto, dal rubare in una casa fino alla malattia mentale, dipendeva dall’ambiente sociale in cui le persone si trovavano? La passione predominante, all’epoca, era una psicologia che con la materia, il corpo, il cervello non voleva avere niente a che fare. Forse ora abbiamo toccato l’estremo opposto. Ma diversamente dagli autori di Neuro-mania, noi continuiamo a pensare che La Mettrie, preso con le dovute cautele, sia meno dannoso di Cartesio. Al libertino Don Giovanni, tra l’altro, sarebbe stato certamente più simpatico.
-
> PENSIERO LIQUIDO E CROLLO DELLA MENTE. --- Contro il naufragio della società liquida, a Roma Intellettuali francesi e italiani a confronto (di Giovanni Ruggiero).18 aprile 2009, di Federico La Sala
Contro il naufragio della società liquida
 Roma.
Roma.
 Intellettuali francesi e italiani a confronto sulla crisi. De Rita: «Il crollo è dei vertici».
Intellettuali francesi e italiani a confronto sulla crisi. De Rita: «Il crollo è dei vertici».
 Galli Della Loggia: «C’è un populismo dei piccoli contro i grandi».
Galli Della Loggia: «C’è un populismo dei piccoli contro i grandi».
 Lo scrittore Lambron: «Ormai il logo ha sostituito il logos».
Lo scrittore Lambron: «Ormai il logo ha sostituito il logos».
 Glucksmann: «Però la globalizzazione ha anche vinto la miseria». Forte: «Meticciato, nave per riprendere il largo»
Glucksmann: «Però la globalizzazione ha anche vinto la miseria». Forte: «Meticciato, nave per riprendere il largo»DA ROMA GIOVANNI RUGGIERO (Avvenire, 18.04.2009)
Se di crisi si occupano non soltanto gli economisti, ma anche gli storici, i sociologi, i filosofi e perfino i poeti, si scopre che, dietro le «bolle finanziarie », i «titoli tossici» e la sofferenza della gente, soprattutto nelle fasce meno abbienti, c’è una crisi più profonda che interessa l’intero Occidente e la globalizzazione che scatena, adesso, dopo l’idolatria, reazioni populiste.
L’ Académie de France di Roma e il ministero italiano per i Beni e le attività culturali hanno proposto su questi temi una conversazione tra intellettuali dei due Paesi. Fanno emergere una crisi a tutto tondo, almeno con quattro facce: una crisi che investe, oltre al mondo economico, l’ambito politico, sociale e morale. Quella economica, che corrisponde o quanto meno può essere paragonata alla crisi del ’29, ha l’epicentro negli Usa, ma l’altra crisi che fa da sfondo è stata in qualche modo vaticinata nel 1958 - come qualcuno ha ricordato - da Hannah Arendt che, nella Vita activa , scriveva: «La mancanza di pensiero - l’incurante superficialità o la confusione senza speranze o la ripetizione compiacente di ’verità’ diventate vuote e trite - mi sembra tra le principali caratteristiche del nostro tempo».
Il filosofo francese Andrè Glucksmann riprende queste origini lontane e, allarmato, ricorda che la crisi del capitalismo moderno potrebbe portare il numero dei disoccupati a 50 milioni nel mondo. Ma, con gusto polemico e controcorrente, ne tessa anche le lodi: «Tuttavia non bisogna mai dimenticare che da 30 anni la globalizzazione ha anche eliminato la disperazione e la miseria totale per almeno un miliardo di persone, in particolare per i cinesi e gli indiani. Questo non vuol dire che adesso questa gente vive bene, ma almeno è uscita, in parte, dalla disperazione totale nella quale stava prima. Bisogna quindi tener conto anche di questo».
La protesta contro la globalizzazione, però, è evidente. La fa notare Ernesto Galli della Loggia sottolineando come sia penetrata nelle metropoli dell’Occidente: «Si tinge di nuovi contenuti politici e culturali trasformandosi in un populismo dei piccoli contro i grandi. Una vena di neo-populismo contro il carattere oligarchico che assume a livello planetario l’establishment. C’è una insofferenza verso la transnazionalità dell’apparato economico. Tuttavia - aggiunge - la democrazia ha bisogno di un populismo democratico».
La crisi e noi: a monsignor Bruno Forte, il teologo arcivescovo di Chieti, viene in mente, per rappresentare questo rapporto, Hans Blumenberg e il suo Naufragio con spettatore. Spiega l’attuale crisi con quattro metafore: la prima è appunto quella del naufragio: «In questa contingenza - corregge - lo spettatore non è più al sicuro sulla terraferma. Nella condizione attuale naufragio e spettatore si identificano». Altra metafora è la liquidità, per cui mancano punti di riferimento fermi: impera il pensiero debole con la perdita di ogni riferimento al trascendente. Poi ancora la metafora dell’assemblaggio di una nave costruita con i pezzi più disparati che vengono a riva dal naufragio. «È il meticciato - nota Forte - che è sempre esistito, ma che può essere una cultura viva perché è incontro e rispetto reciproco». Infine la metafora della navigazione. È indubbio che la nave deve riprendere il largo. Bruno Forte indica come strumenti per tracciare la rotta giusta la nostra Costituzione e il Codice di Camaldoli del 1943, con l’idea della centralità della persona che per Mounier non è un oggetto ma «ciò che non può essere trattato come oggetto».
I colloqui a Villa Medici sono bilingui. Al nostro ministro Sandro Bondi, per il quale occorrerebbe «socializzare e non statalizzare per incorporare l’economico nel sociale», fa da contrappunto il ministro francese del budget, Eric Woerth, il quale sostiene che «questa crisi può portarci a creare un nuovo mondo nuovo, e ci invita a riflettere su quello che siamo». Ma cosa siamo adesso?
Marc Lambron, scrittore e critico letterario, una delle voci francesi del dibattito, amante del paradosso dice con graffiante ironia che oggigiorno «il logo ha sostituito il logos», intendendo dire che viviamo il clima degli anni ’80, «quando il denaro era un segno della nostra esistenza e c’era una perfetta coincidenza dell’essere con l’avere».
Quanto al sistema instaurato e adesso in crisi, secondo Giuseppe De Rita si è conformato su un modello piramidale: «La crisi - dice il sociologo - viene dai vertici dell’oligarchia internazionale, dall’apice dell’apice della finanza. Hanno resistito meglio i Paesi, come l’Italia, che hanno una struttura economica meno verticistica». E fa gli esempi della piccola impresa o anche del lavoro sommerso. Insomma, ha resistito la base.
Viviamo dunque una crisi che è anche dei valori, della religione, della politica e delle scienze europee, come ricorda il filosofo Adriano Pessina che cita Edmund Husserl. Manca, secondo Pessina, o quanto meno è stato dimenticato il concetto di bene comune che indica la «causa comune» come «spazio condiviso e pubblico nel quale si esercita la cittadinanza del pluralismo delle visioni del mondo e delle cose». È nato un nuovo mito: l’autorealizzazione dell’individuo che è sempre sullo sfondo delle crisi economiche. Un mito cinico perché, dice Pessina, «nel conflitto delle autorealizzazioni è dato per assodato che ci saranno sempre dei perdenti e che la crisi possa essere un pedaggio da far pagare a qualcuno». Chi è stato all’origine della crisi attuale l’ha pensata sicuramente così.
-
> PENSIERO LIQUIDO E CROLLO DELLA MENTE. --- MISERIA DELLA FILOSOFIA, OGGI. "Il campo" o, meglio, la critica dell’ "orticello"... I saperi di ieri (epoca della manifattura) .... ancora come quelli di oggi (epoca dell’informatica).20 aprile 2009, di Federico La Sala
-
-
> PENSIERO LIQUIDO E CROLLO DELLA MENTE. Sulle nuove frontiere della riflessione estetica, un originale saggio di Gaetano Mirabella, scrittore e collaboratore del "McLuhan Program in culture and technology" di Toronto - a cura di Federico La Sala10 aprile 2009
Grazie infinite a Gaetano Mirabella; il suo testo è servito ad illuminare il percorso di alcune riflessioni che avevo già avviato, ma che sembravano non trovare una rotta. Per me sapere che pensatori come Mirabella esprimono il loro pensiero ed abbiano la possibilità di dedicarsi in tranquillità alla ricerca in centri prestigiosi come il McLuhan Program in culture and technology non può essere che fonte di soddisfazione ed orgoglio campanilista; sebbene lasci un retrogusto amaro la riflessione sul fatto che quasi nessuno dei nostri migliori intellettuali esprime il suo pensare nella sua terra.
Con grande ammirazione, stima e rispetto