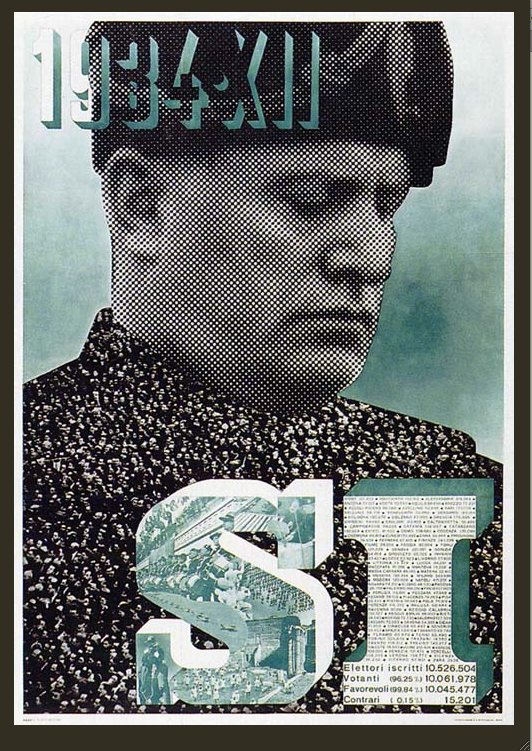LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. AL GOVERNO DELLA CHIESA UN PAPA CHE PREDICA CHE GESU’ E’ IL FIGLIO DEL DIO "MAMMONA" ("Deus caritas est") E AL GOVERNO DELL’ **ITALIA** UN PRESIDENTE DI UN PARTITO (che si camuffa da "Presidente della Repubblica"), che canta "Forza Italia" con il suo "Popolo della libertà" (1994-2012). Questo è il nodo da sciogliere. Materiali sul tema - di Federico La Sala
giovedì 14 giugno 2012.
- "DIARIO MINIMO" (Eco, 1963) DELLA "FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO"(Hegel, 1807): «Mike Bongiorno convince dunque il pubblico, con un esempio vivente e trionfante, del valore della mediocrità. Non provoca complessi di inferiorità pur offrendosi come idolo, e il pubblico lo ripaga, grato, amandolo. Egli rappresenta un ideale che nessuno deve sforzarsi di raggiungere perché chiunque si trova già al suo livello. Nessuna religione è mai stata così indulgente coi suoi fedeli. In lui si annulla la tensione tra essere e dover essere. Egli dice ai suoi adoratori: voi siete Dio, restate immoti.» (Umberto Eco, "Fenomenologia di Mike Bongiorno", 1961).
 "CHARISSIMI, NOLITE OMNI SPIRITUI CREDERE...
"CHARISSIMI, NOLITE OMNI SPIRITUI CREDERE...
 DEUS CHARITAS EST" (1Gv., 4. 1-16). *
DEUS CHARITAS EST" (1Gv., 4. 1-16). *
 CARISSIMI, NON PRESTATE FEDE A OGNI SPIRITO ...
CARISSIMI, NON PRESTATE FEDE A OGNI SPIRITO ...
 DIO E’ AMORE (1 Gv., 4. 1-16)
DIO E’ AMORE (1 Gv., 4. 1-16)
 IL "SEGRETO" DEL "NOME" RIVELATO E CHIARITO: GIUSEPPE dà a suo Figlio, GESÙ (= "Dio" salva), il NOME del Suo "Dio", e Gesù rivela che il Nome di "Dio" è "Amore", al di là dell’Eros e dell’Agape, è - teocritica-mente - Charitas!!!
IL "SEGRETO" DEL "NOME" RIVELATO E CHIARITO: GIUSEPPE dà a suo Figlio, GESÙ (= "Dio" salva), il NOME del Suo "Dio", e Gesù rivela che il Nome di "Dio" è "Amore", al di là dell’Eros e dell’Agape, è - teocritica-mente - Charitas!!!
- FILOLOGIA E FILOSOFIA: LEZIONE DI PROTAGORA. "Il frammento (1 Diels-Kranz) suona: «πάντων χρημάτων μέτρον ἐστὶν ἅνϑρωπος, τῶν μὲν ὄντων ὡς ἔστιν, τῶν δὲ οὐκ ὄντων ὡς οὐκ ἔστιν», e cioè, letteralmente: «Di tutte le cose è misura l’uomo, di quelle che sono, in quanto sono, di quelle che non sono, in quanto non sono»".
- FILOLOGIA E ANTROPOLOGIA - 1 PIETRO, 3. 1-7:
- "Ὁμοίως γυναῖκες ὑποτασσόμεναι τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν [...] Οἱ ἄνδρες ὁμοίως συνοικοῦντες κατὰ γνῶσιν, ὡς ἀσθενεστέρῳ σκεύει τῷ γυναικείῳ ἀπονέμοντες τιμήν, ὡς καὶ ⸀συγκληρονόμοις χάριτος ζωῆς"
- AL DI LA’ DELLA LEZIONE DI PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).
- PRIMA DI NIETZSCHE, DOPO NIETZSCHE:IL GRANDE PAN E’ MORTO (PLUTARCO, Cheronea, 46/48 d.C. - Delfi, 125/127 d.C.).
- "«Raccontava [Epiterse] che una volta imbarcatosi per l’Italia sopra una nave carica di ricche merci, e con molti passeggeri, sulla sera trovandosi verso le isole Echinadi, il vento scemò, e la nave andando qua e là con direzione incerta, venne ad avvicinarsi a Paxos [isola di fronte all’Epiro, a sud di Corfù].
- [...] All’improvviso fu sentita una voce uscire dall’isola di Paxos che a gran voce chiamava: ’Tamo’. Tutti restarono sbalorditi. Questo Tamo, egiziano di patria, era il timoniere, ma non conosciuto per nome dalla maggior parte di quelli che erano sulla nave. Chiamato una seconda volta, non rispose; finalmente alla terza prestò ascolto. Allora colui che chiamava, con voce tonante disse: ’Quando sarai giunto a Palode [porto della città di Butroto in Epiro], annuncia che il gran dio Pan è morto’. Raccontava Epiterse che tutti, udito questo, si spaventarono [...] Quando infine arrivarono a Palode, non un soffio di vento, non un’onda. Allora Tamo, sulla poppa, guardò verso terra e gridò: “Il grande Pan è morto”.» (Plutarco, Dialoghi delfici, "Il tramonto degli oracoli", Adelphi, 1995).
Per chi vuole approfondire, si leggano ed esplorino (o anche si stampi tutto e se ne faccia un libro) - cliccando sul rosso - gli art. seguenti
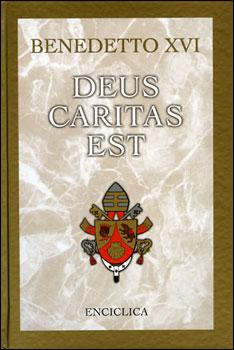
|
GRECIA - Una sede della "Caritas greca". |
- FORZA "CRISTO RE"!!! (Paolo di Tarso): "vivendo secondo la verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa verso di lui, che è il capo, Cristo, dal quale tutto il corpo, ben compaginato e connesso, mediante la collaborazione di ogni giuntura, secondo l’energia propria di ogni membro, riceve forza per crescere in modo da edificare se stesso nella carità" (Ef. 4,15-16)
- LA "RICAPITOLAZIONE" DI SAN PAOLO, ANTROPOLOGICAMENTE, ZOPPA E CIECA, A MISURA DEL FIGLIO PRIMOGENITO (MAGGIORASCATO):"[...] tutto il mondo, soggetto alla «vanità» e alla «corruzione» per il peccato di Adamo, attende gemendo la liberazione dal male e «tutta la creazione sarà liberata dalla servitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio». «Primogenito di tutta la creazione», Cristo, facendosi uomo e immolandosi sulla croce, «riunisce e riassume» tutti gli esseri - terrestri e celesti - e li riconcilia al Padre: si attua cosi il «mistero» della redenzione che Dio ha concepito da tutta l’eternità [...]" (cfr. Tullio Gregory, Giovanni Scoto Eriugena: tre studi,Firenze, Le Monnier, 1963: "II. Mediazione e Incarnazione", pp. 34-35 ).
"È significativo che l’espressione di Tertulliano: "Il cristiano è un altro Cristo", sia diventata: "Il prete è un altro Cristo"" (Albert Rouet, arcivescovo di Poitiers, 2010.)
- "COSTANTINO" E "COSTANTINISMO"- IL NODO DA SCIOGLIERE:
- A) La teologia romana dei secoli XIX e XX. Costantino tra la Chiesa trionfante e la Chiesa dei poveri (Stanisław Adamiak, Sergio Tanzarella -"Enciclopedia Costantiniana", 2013).
- B La formula di Friedrich Heer dell’era costantiniana (1949-1953). Il cristianesimo in mezzo al tempo e all’eternità (Gianmaria Zamagni - "Enciclopedia Costantiniana", 2013).
- CHRISTUS DOMINUS: "PROEMIO. 1. Cristo Signore, Figlio di Dio vivo, è venuto per salvare il suo popolo dai peccati (1) e per santificare tutti gli uomini; com’egli era stato mandato dal Padre, così mandò i suoi apostoli (2) e li santificò dando loro lo Spirito Santo, affinché, a loro volta, glorificassero il Padre sopra la terra e salvassero gli uomini, « per l’edificazione del suo corpo » (Ef 4,12), che è la Chiesa.
- Il papa e i vescovi perpetuano l’opera di Cristo
- 2. In questa Chiesa di Cristo, il sommo Pontefice, come successore di Pietro, a cui Cristo affidò la missione di pascere le sue pecore ed i suoi agnelli, è per divina istituzione rivestito di una potestà suprema, piena, immediata, universale, a bene delle anime. Egli perciò, essendo stato costituito pastore di tutti i fedeli per promuovere sia il bene comune della Chiesa universale, sia il bene delle singole Chiese, detiene la suprema potestà ordinaria su tutte le Chiese [...]" (PAOLO VI,"VESCOVO SERVO DEI SERVI DI DIO UNITAMENTE AI PADRI DEL SACRO CONCILIO A PERPETUA MEMORIA", "DECRETO SULLA MISSIONE PASTORALE DEI VESCOVI NELLA CHIESA", 28 ottobre 1965 - senza le note).
- L’IMPERATORE COSTANTINO, LA "PAROLA" DI "DIO", E LA FIGURA DI "MICHELE" - OGGI: [...] San Michele. Voi sapete che cosa vuol dire Michele? È un nome prettamente orientale, ebraico, che vuol dire: “Quis ut Deus?”, “Chi è come Dio?”. Questa parola è parola che ha vinto, parola vincente nel grande scontro tra il bene e il male. Questa parola - Michele, “Chi è come Dio?” - ha vinto [...] “Quis ut Deus?”. E questa parola vince, vince come una volta l’imperatore romano Costantino ha vinto nella Croce: “in hoc signo”, in questo segno vincerai. Vi auguro questa vittoria (GIOVANNI PAOLO II, "Visita Pastorale alla parrocchia di Santa Maria Assunta e San Michele a Castel Romano", 13 febbraio 1994).
- Ubuntu: una parola da e per non dimenticare. Una nota a margine della Lettera enciclica di Giovanni Paolo II SULL’ EUCARISTIA (del 17.04.2003)
- "L’immagine del
corpo mistico di Cristo è molto seducente, ma l’importanza
che si annette oggi a questa immagine mi pare uno dei sintomi più gravi della
nostra decadenza. La nostra vera dignità infatti non sta nell’essere membra di
un corpo, anche se mistico, anche se quello di Cristo, ma in questo: nello stato
di perfezione, al quale tutti aspiriamo, noi non viviamo più in noi stessi, ma è
Cristo che vive in noi; in questa condizione, Cristo nella sua integrità, nella sua
unità indivisibile, diviene, in certo senso, ognu
no di noi, come è tutto intero
nell’ostia. Le ostie non sono frammenti del suo corpo.
 L’importanza attuale dell’immagine del corpo mistico dimostra quanto i
cristiani siano miseramente esposti alle influenze esterne. certo inebriante
sentirsi membro del corpo mistico del Cristo: ma oggi molti altri corpi mistici,
che non hanno Cristo come capo, procurino alle proprie membra un’ebbrezza, a
mio parere, della stessa natura" (Simone Weil, 1942.)
L’importanza attuale dell’immagine del corpo mistico dimostra quanto i
cristiani siano miseramente esposti alle influenze esterne. certo inebriante
sentirsi membro del corpo mistico del Cristo: ma oggi molti altri corpi mistici,
che non hanno Cristo come capo, procurino alle proprie membra un’ebbrezza, a
mio parere, della stessa natura" (Simone Weil, 1942.)
- AL DI SOPRA DI TUTTO LA LEGGE, LA COSTITUZIONE, O "L’UOMO SUPREMO"?! LA "CHARITAS" O LA "CARITAS"?!
- LA PAROLA DEL VESCOVO (Mauro Russotto): "[...] In questa prima mia riflessione desidero soffermarmi sul motto episcopale del Vescovo Giovanni [Jacono],
con il quale abbiamo voluto titolare il bollettino:
Super omnia charitas. Si tratta delle parole che
San Paolo scrive nella Lettera ai Colossesi: «al di
sopra di tutto vi sia la carità» (Col 3,14). La carità è la dimensione e la virtù che sopravvive alla
stessa fede e alla speranza. Perché la carità è Dio,
è il nome nuovo di Dio... Deus charitas est [1 Gv. 4.8, giovanneo - non paolino, fls]. E
dunque Super omnia charitas è la nuova paolina formulazione del primo comandamento del decalogo di Mosè: Dio è l’Unico ed è sopra e al di
sopra di tutto!"
 (Cfr.
SVPER OMNIA CHARITAS - N. 1 •GIUGNO 2009,PERIODICO DELLA POSTULAZIONE DELLA CAUSA DI CANONIZZAZIONE DEL SERVO DI DIO MONS. GIOVANNI JACONO).
(Cfr.
SVPER OMNIA CHARITAS - N. 1 •GIUGNO 2009,PERIODICO DELLA POSTULAZIONE DELLA CAUSA DI CANONIZZAZIONE DEL SERVO DI DIO MONS. GIOVANNI JACONO).
- "DIARIO MINIMO" (Eco, 1963) DELLA "FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO"(Hegel, 1807): «Mike Bongiorno convince dunque il pubblico, con un esempio vivente e trionfante, del valore della mediocrità. Non provoca complessi di inferiorità pur offrendosi come idolo, e il pubblico lo ripaga, grato, amandolo. Egli rappresenta un ideale che nessuno deve sforzarsi di raggiungere perché chiunque si trova già al suo livello. Nessuna religione è mai stata così indulgente coi suoi fedeli. In lui si annulla la tensione tra essere e dover essere. Egli dice ai suoi adoratori: voi siete Dio, restate immoti.» (Umberto Eco, "Fenomenologia di Mike Bongiorno", 1961).
- MESSAGGIO EVANGELICO E ANNO SACERDOTALE (2008-2010). Ai sacerdoti e ai religiosi che hanno abusato dei ragazzi, invece di dire "abbiamo", "noi", "dobbiamo", "abbiamo", Papa Ratzinger scrive: "Avete tradito la fiducia riposta in voi da giovani innocenti e dai loro genitori. Dovete rispondere di ciò davanti a Dio onnipotente, come pure davanti a tribunali debitamente costituiti. Avete perso la stima della gente" (Lettera, pf. 6)!!!
- UNA CRISI DELL’INTERO ORDINE SACERDOTALE E UNA "LETTERA PASTORALE" CHE PRENDE CON POCO CORAGGIO E MOLTA FURBIZIA (COME "TRADIZIONE" COMANDA) LE DISTANZE DA CRIMINI ABNORMI E DAL LAVORO DI INSABBIAMENTO ISTITUZIONALE. Una breve rassegna stampa sulle reazioni
- UN’ANTROPOLOGIA "EDIPICA", ZOPPA E CIECA. IN NOME DI GESU’, FIGLIO DEL "DIO" DI MARIA (- E GIUSEPPE?!), SOLO GLI "UOMINI" POSSONO ESSERE "SACERDOTI", NON LE "DONNE":
- "Grazie a te, donna-consacrata, che sull’esempio della più grande delle donne, la Madre di Cristo, Verbo incarnato, ti apri con docilità e fedeltà all’amore di Dio, aiutando la Chiesa e l’intera umanità a vivere nei confronti di Dio una risposta “sponsale”, che esprime meravigliosamente la comunione che Egli vuole stabilire con la sua creatura" (Giovanni Paolo II, Lettera alle Donne,1995, n. 2).
|
Xanti Schawinsky, Sì, 1934 |

 AL DI LA’ DEI FONDAMENTALISMI LAICI E RELIGIOSI: UNA SECONDA RIVOLUZIONE COPERNICANA
AL DI LA’ DEI FONDAMENTALISMI LAICI E RELIGIOSI: UNA SECONDA RIVOLUZIONE COPERNICANA
FLS
Forum
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- TEOLOGIA-POLITICA E ANTROPOLOGIA: DOPO DUEMILA ANNI DI CRISTIANESIMO COSTANTINIANO E PAOLINO, QUALE IDEA DI EUROPA ANCORA E’ POSSIBILE?!18 aprile 2025, di Federico La Sala
A CHE GIOCO GIOCHIAMO?! DOPO DUEMILA ANNI DI CRISTIANESIMO COSTANTINIANO E PAOLINO, QUALE IDEA DI EUROPA ANCORA E’ POSSIBILE?!:
- La teologia romana dei secoli XIX e XX.
 Costantino tra la Chiesa trionfante e la Chiesa dei poveri(Stanisław Adamiak, Sergio Tanzarella -"Enciclopedia Costantiniana", 2013).
Costantino tra la Chiesa trionfante e la Chiesa dei poveri(Stanisław Adamiak, Sergio Tanzarella -"Enciclopedia Costantiniana", 2013).
- La formula di Friedrich Heer dell’era costantiniana (1949-1953). Il cristianesimo in mezzo al tempo e all’eternità (Gianmaria Zamagni - "Enciclopedia Costantiniana", 2013).
- "CONFERIMENTO DEL PREMIO CARLO MAGNO. UNA CITAZIONE DAL "DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO. Sala Regia Venerdì, 6 maggio 2016":
- Che cosa ti è successo, Europa umanistica, paladina dei diritti dell’uomo, della democrazia e della libertà? Che cosa ti è successo, Europa terra di poeti, filosofi, artisti, musicisti, letterati? Che cosa ti è successo, Europa madre di popoli e nazioni, madre di grandi uomini e donne che hanno saputo difendere e dare la vita per la dignità dei loro fratelli?.
"ANTROPOLOGIA" E STORIA DELLA "EUROPA, MADRE DELLE RIVOLUZIONI". Lo storico Friedrich Heer chiude l’opera così intitolata, appunto "Europa, madre di rivoluzioni" (1964; ed. it., 2 voll.m Il Saggiatore, Milano 1968), con il capitolo finale riflettendo su "Il salto", cominciando con il paragrafo "il salto cifra per il XIX-XX secolo, Tutto è in movimento", e, concludendo con l’ultimo paragrafo, a "Marya Sklodowska-Curie", e così scrive: "[...] Marya Sklodowska-Curie appartiene agli uomini di una Nuova Era incipiente, i quali sanno che le battaglie sul fronte dell’uomo - contro la morte, l’assurdo, l’ingiusto, il male, la stupidità - devono essere combattute in nuove forme; richiedono l’intera vita; un pensiero rigoroso, autocritico, un sentimento puro [...]"; e, in nota, aggiunge e "insiste" (in modo "antropologicamente" e linguisticamente "cattolico"): "Nuove battaglie - sul fronte dell’uomo [...] Questo secolo (o per meglio dire: alcuni suoi uomini) ha cominciato a comprendere in modo nuovo, e a far propria, la parola oscura e profonda dell’apostolo Paolo: Noi uomini siamo gli eredi di Dio" (F. Heer, op. cit., II, p. 588 e p. 596).
Federico La Sala
- La teologia romana dei secoli XIX e XX.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- IL "PADRE" DI ADAMO-PIGMALIONE AL LAVORO E UN CON-"SILLO" DI GIACOMO LEOPRDI6 aprile 2025, di Federico La Sala
L’IMMAGINARIO COSMOTEANDRICO DEL DEMIURGICO "VASAIO" BIBLICO E PLATONICO (E L’IMPOSSIBILE USCITA DALLA CAVERNA DEL NARCISISMO). IL "PADRE" DI ADAMO-PIGMALIONE AL LAVORO E UN CON-"SILLO" DI GIACOMO LEOPRDI *:
ADAMO ED EVA. UNA LETTURA PSICOANALITICA
di Gianfranco Ricci (4 apr 2024)
Il racconto di Adamo ed Eva è contenuto nel primo libro della Bibbia, la Genesi.
In particolare, uno dei dettagli più celebri del racconto biblico di Genesi è quello relativo alla creazione di Eva:
- “Allora il Signore, il Dio, fece piombare un torpore sull’uomo, che si addormentò; gli prese una delle costole e richiuse la carne al suo posto. Poi il signore, il Dio, con la costola che aveva preso all’uomo formò una donna e la condusse all’uomo”
Nel corso del Seminario X, “L’angoscia” (1962-1963) e nel Seminario XV, intitolato “L’atto psicoanalitico” (1967-1968), Jacques Lacan commenta il racconto biblico di Adamo ed Eva.
Nel Seminario X Lacan introduce un neologismo: “sépartition” (separtizione). Adamo, l’unico uomo, vede venir meno la sua unità, la coincidenza tra Uno e Altro, perdendo una parte di sé.
Come sottolinea Massimo Recalcati nel libro “La legge della parola”:
- “L’umano (adam), tratto dalla polvere della terra (adamah), è costretto dalla Legge della parola a perdere una parte di sé stesso, a vedere incrinato il miraggio di poter essere autosufficiente.”
La perdita della costola non lascia un segno ma fonda nell’uomo, fin dall’origine, l’esperienza della mancanza, del meno, della perdita.
- [FOTO] "Adamo ed Eva" di Tiziano
L’azione di Dio, nella lettura di Recalcati, è definibile come “taglio separtitore”, capace di dividere soggetto e oggetto, separandoli per sempre, a partire da un orizzonte mitico, fuori dal tempo.
Per Lacan il racconto biblico diviene esempio paradigmatico per spiegare la teoria dell’oggetto causa del desiderio, chiamato oggetto piccolo (a).
Per Lacan, la condizione di Adamo, separato da Dio della propria costola e quindi impossibilitato a fare meno del rapporto con l’Altro, è alla base della possibilità stessa di far esistere il desiderio.
Il desiderio, sottolinea Lacan, ha sempre di mira l’oggetto perduto, che il soggetto cerca di ritrovare.
L’azione del linguaggio, che separa l’uomo dal suo oggetto, è a causa del desiderio stesso. Per questo la costola sottratta ad Adamo, e pertanto non più recuperabile, è alla base di due aspetti centrali del desiderio per Freud: l’oggetto è per sempre perduto (Adamo non potrà ottenere di nuovo la sua costola) e il soggetto ricerca il suo oggetto nel luogo dell’Altro (Adamo orienta il suo desiderio verso Eva).
Per Lacan, l’oggetto piccolo (a) è il nome di questo oggetto staccato dal corpo e perduto per sempre.
Per questo, sottolinea Lacan, l’esperienza che Adamo fa di Eva è “etero”: non si tratta di porre l’accento sulla differenza dei corpi, bensì su una non coincidenza, su una diversità di fondo.
Adamo, che ha visto sottrarsi la costola, finisce con il non coincidere più con il se stesso che è stato; dall’altra, Eva, scaturita dalla costola, non può tornare più a far parte di Adamo.
Il mito dell’Uno, dell’unione mitica senza scarti e senza resti, nell’immaginario biblico tramonta per sempre, lasciando spazio al desiderio.
- [FOTO] "La creazione di Adamo" di Michelangelo
Per questo, Recalcati conclude sottolineando che “il mito biblico della costola perduta è dunque il mito dell’origine del desiderio umano: ricercare nell’Altro la parte più irraggiungibile di me stesso. La relazione con l’eteros sorge dunque da questa urgenza.”
- Per approfondire:
 Massimo Recalcati - “La legge della parola”
Massimo Recalcati - “La legge della parola”Nel corso del Seminario X, Lacan sottolinea una caratteristica fondamentale dell’oggetto perduto come inteso da Freud: non si tratterebbe di una parte del corpo materno (il seno) staccato dal corpo della madre e portato con sé dal piccolo, bensì dell’esperienza dei “pezzi” del corpo materno vissuti come parte del proprio corpo.
- [FOTO] "La creazione di Eva" di Michelangelo
Il bambino quindi vivrebbe il seno materno come parte stessa del proprio corpo, provando profonda angoscia e un vissuto di orrore e perdita nel momento del distacco, come se la separazione fosse, in origine, una mutilazione dei corpi.
Questo dettaglio si accorda con il mito biblico: Eva non sarebbe altro se non una parte del corpo di Adamo, la celebre costola. La perdita di una parte di Sè aprirebbe quindi al rapporto con l’Altro, facendo crollare il mito narcisistico di unità che abita come un fantasma l’animo umano.
*
ARTE, TECNOLOGIA, E LETTERATURA: UNA RISATA VI SEPPELLIRA’.
Un "Sillo", una parodia critica della filosofia dell’uomo dell’età delle macchine di Giacomo Leopardi:
"Proposta di premi fatta dall’Accademia dei Sillografi" ("Operette morali", 1827).
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE --- "QUI CI SONO ICOSAEDRI E DRAGHI" E NON SI SA QUI SI ANNIDA UNA HAMLETICA QUESTION(E) DI SOLIDI E OCCHI (E SERPENTI).5 aprile 2025, di Federico La Sala
"HIC SUNT DRACONES" ("HIC SUNT LEONES"): QUI CI SONO ICOSAEDRI E DRAGHI... *
- ETIMOLOGIA DI ICOSAEDRI E DRAGHI. Un omaggio a Marco Mazzanti e alla sua sollecitazione a riflettere sulle parole e a pensare critica-mente:
- 𝐈𝐜𝐨𝐬𝐚𝐞𝐝𝐫𝐨.Non è il nome di un drago, idra o leviatano che dir si voglia, ma di una figura tridimensionale, un 𝘱𝘰𝘭𝘪𝘦𝘥𝘳𝘰. Il suffissoide -edro deriva dal greco ἕδρα [hedra], ossia, "base", "faccia"; mentre il prefissoide ico- da εἴκοσι [eikosi], "venti". Si ha dunque il latino 𝘪𝘤𝘰𝘴𝘢𝘦𝘥𝘳𝘶(𝘮), dal greco εἰκοσάεδρον [eikosaedron]: un poliedro a venti facce; il prefissoide poli- deriva chiaramente anch’esso dalla lingua greca e significa "molto": poliedro = molte facce.
- Drago è da rintracciare dalla forma latina di 𝘥𝘳𝘢𝘤𝘰 all’accusativo, 𝘥𝘳𝘢𝘤𝘰𝘯𝘦𝘮 (al genitivo è invece 𝘥𝘳𝘢𝘤𝘰𝘯𝘪𝘴), a sua volta dal greco δράκων [drakon] (al genitivo, δράκοντος [drakontos]), presumibilmente da una più ancestrale radice sanscrita, di cui, sempre dal greco, 𝘥𝘦𝘳𝘬𝘰𝘮𝘢𝘪, "vedo", e 𝘥𝘳𝘢𝘬𝘰, "vedrò", riconducibile pertanto alla radice in ok-/oph-, come in ὄϕις [ophis], "serpente", del resto come in 𝘰𝘧𝘪𝘥𝘪 in italiano, per la credenza antica che i rettili fossero dotati di una vista assai fine; potrebbe anche derivare, attingendo ancora dal sanscrito, lingua indoeuropea, dalla radice dragh-, di cui dragh-ayami, "allungare".
- L’idra, il serpente dalle numerose teste, deve il nome dal latino 𝘩𝘺𝘥𝘳𝘢, mutuato dal greco ὕδρα [hydra], a sua volta da ὕδωρ [hydor], "acqua". In italiano, il prefissoide idro- ha la medesima origine.
- Leviatano non deriva né dal latino né dal greco antico, ma dall’ebraico 𝘭𝘪𝘸𝘫𝘢𝘵𝘩𝘢𝘯, "tortuoso", come appunto i serpenti, gli ofidi. [...] (cit.).
QUESTO E’ UN #PROBLEMA DI #FILOSOFIA DEL #LINGUAGGIO, DI #ANTROPOLOGIA, DI #STORIA DELLA "#TRAGEDIA" DELL’#EUROPA, E DI MILLENNI DI #PLATONISMO.
NEL TEMA SI ANNIDA UNA HAMLETICA QUESTION(E) DI SOLIDI E OCCHI (E SERPENTI), SI TRATTA DI CHI PUO’ ACCEDERE ALL’ACCADEMIA DEL #FILOSOFO-#RE DELL’#OCCIDENTE (E DI TUTTA LA #TERRA), DELLA #SCUOLA DEL REGISTA "#PLATONE".
- "BEN DETTO, VECCHIA TALPA, "WE SAID, OLD #MOLE" (William Shakespeare, "#Amleto", "#Hamlet", I.5).
#SAPERE AUDE! (#KANT). VOLENDO E POTENDO, E’ PROPRIO UNA BELLA #IDEA PER UN’#OPERA DA METTERE IN #SCENA AL "#GLOBE #THEATRE" DI #SHAKESPEARE, ALLA PRESENZA DELLA #REGINA #ELISABETTA I #TUDOR, E VENIR FUORI DA INTERI MILLENNI DI #LABIRINTO (#NIETZSCHE).
- NOTE:
- INDIVIDUO E SOCIETA’ (ANTROPOLOGIA E PSICHIATRIA): "UN UOMO PIÙ UNA DONNA HA PRODOTTO, PER SECOLI, UN UOMO" ( FRANCA ONGARO BASAGLIA).
- "SAPERE AUDE!"(KANT). Un omaggio alla sollecitazione della "Gazzetta filosofica" a uscire dalla logica (dal "logo") della "guerra" ("polemos") "degli opposti" e, con Eraclito, cercare di pensare l’ armonia del logos ...
- ANTROPOLOGIA, STORIA, LETTERATURA E TEATRO: PLATONISMO DI LUNGA DURATA. A #MEMORIA DI #VIRGINIA WOOLF, a suo #onore e #gloria, forse, è bene ricordare e rimeditare le sue stesse parole: "[...] sarebbe stato impossibile, completamente e interamente impossibile che una #donna scrivesse nell’#epoca di #Shakespeare le #opere di Shakespeare. Immaginiamo, giacché ci riesce così difficile conoscere la realtà, che cosa sarebbe successo se Shakespeare avesse avuto una #sorella #meravigliosamente #dotata, chiamata #Judith, diciamo." (cfr. Virginia Woolf, "Una stanza tutta per sé", in: "Romanzi e Altro", "I Meridiani" Mondadori).
- MATEMATICA, GEOMETRIA, E FILOSOFIA: LA "REGIA" "ANTROPOLOGICA" DI PLATONE SEGNA ANCORA LA SCIENZA CONTEMPORANEA. Anche Galileo Galilei resta parzialmente "impigliato" nelle tragiche maglie della visione "cosmoteandrica" del #Demiurgo platonico; ne "Il Saggiatore", così egli scrive:
 "La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi a gli occhi (io dico l’universo), ma non si può intendere se prima non s’impara a intender la lingua, e conoscer i caratteri, ne’ quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica, e i caratteri son triangoli, cerchi, ed altre figure geometriche, senza i quali mezzi è impossibile a intenderne umanamente parola; senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro laberinto."
"La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi a gli occhi (io dico l’universo), ma non si può intendere se prima non s’impara a intender la lingua, e conoscer i caratteri, ne’ quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica, e i caratteri son triangoli, cerchi, ed altre figure geometriche, senza i quali mezzi è impossibile a intenderne umanamente parola; senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro laberinto."
*
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- ARCHEOLOGIA LOGICO-FILOSOFICA. UNA NOTA SUL "COME NASCONO I BAMBINI" E SUL "BUON-MESSAGGIO". Un omaggio alla figura di san Giuseppe20 marzo 2025, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA, #INTERPRETAZIONE DEI #SOGNI, E FILOLOGIA DI #PRIMAVERA: EARTHRISE (#20MARZO 2025)
UNA NOTA SUL "COME NASCONO I BAMBINI" E SUL "BUON-MESSAGGIO".
- Un omaggio alla figura di san Giuseppe *
Alla #luce dell’aria primaverile, e del presente storico corrente, forse, è proprio bene ricordare che #Giuseppe, lo #sposo di #Maria, anche senza capire tutto, seppe bene #interpretare il suo #sogno: al #Bambino, "egli pose #nome #Gesù"! (Mt. 1. 25).
DIVINA COMMEDIA. I #Profeti, come le #Sibille (come quelle, legate alla tradizione dei #Carmelitani scalzi e delle Carmelitane scalze di #Teresa d’#Avila, presenti nella Chiesa dedicata alla "#MadonnadelCarmine" nel 1613 di #ContursiTerme: https://www.ildialogo.org/cultura/AppelliInterventi_1331650525.htm ), non si erano affatto sbagliati e sbagliate nel dire quello che avevano detto: è l’#amore "che move il sole e le altre stelle" (#DanteAlighieri, Par. XXXIII, 145).
- Dantedì, #25marzo 2025
- NOTE:
- "L’ESSENZA DEL #CRISTIANESIMO", LA #FILOLOGIA, E LA #QUESTIONE ANTROPOLOGICA ("ECCE #HOMO"), #OGGI: "CHI È QUESTO FIGLIO DELL’#UOMO?" (GV. 12, 34). #ARTE, #RELIGIONE, E #FILOSOFIA DELLA #FAMIGLIA:
 RESTITUIRE A SAN GIUSEPPE ONORE E GLORIA. UN’INDICAZIONE E UNA EREDITÀ DI #TERESA D’AVILA...
RESTITUIRE A SAN GIUSEPPE ONORE E GLORIA. UN’INDICAZIONE E UNA EREDITÀ DI #TERESA D’AVILA...
- PianetaTerra. La tradizionale teologico-politica platonico-paolina (plutonica e luciferina), a quanto pare, ha abusato troppo della #pazienza evangelica (quella "#kecharitoméne", cioè quella "piena di #grazia" di "Gesù, Giuseppe e Maria", e con il #sorgeredellaTerra, come aveva già capito #Baudelaire, viene anche il giorno dei "#PromessiSposi" (#AlessandroManzoni), la "punizione dell’#orgoglio" e, finalmente, il #gioco dei #bambini ("I #fiori del #male", XVI).
- ARCHEOLOGIA #ANTROPOLOGIA E #FENOMENOLOGIA: "#NICODEMO O DELLA #NASCITA" (ENZO #PACI). A BEN RIFLETTERE SULLE PAROLE DI HUSSERL ("Ricerche Logiche", vol.1, § 71: «Il matematico, in realtà, non è il teorico puro, ma soltanto il tecnico ingegnoso, è per così dire il costruttore che, guardando unicamente ai nessi formali, costruisce la teoria come un’opera d’arte tecnica. [...] E se la scienza costruisce teorie per la soluzione sistematica dei suoi problemi, il filosofo chiede che cosa sia la scienza della teoria, che cosa renda possibile la teoria in generale.» ), UNA #DOPPIA #CECITÀ, sia in #MATEMATICA sia in #FILOSOFIA), C’E’ DA DIRE CHE CI SI MUOVE, DOPO #DANTE E #KANT, ANCORA NELLA "#CAVERNA" POLIFEMICA E PLUTONICA di #PLATONE (E DI PAOLO DI TARSO E COSTANTINO: #NICEA, 325-2025), E CHE NON SI SA ANCORA COME "FARE LA VERITÀ" (Roberto Osculati, Bompiani, 1974). A mio parere, forse, è meglio molto #husserliana-mente riprendere "La crisi delle scienze europee" ( il Saggiatore), rileggersi la "Prefazione alla terza edizione italiana" di #EnzoPaci (Milano, 16 settembre 1968), e riprendere il filo della riflessione su "Nicodemo o della nascita" (ricordata e ripresa da Enzo Paci, nel 1973, ma iniziata, con #Ricoeur e compagni, nel Lager di #Wietzendorf, nel 194).
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA --- QUELLO CHE E’ GIUSTO FARE. Una lezione di matematica e di antropologcia: ""Ma poiché vi sono due specie di bellezza, delle quali una è la grazia, l’altra la dignità, dobbiamo considerare la grazia femminile e la dignità maschile" (Cicerone, De officiis").19 marzo 2025, di Federico La Sala
MATEMATICA E ANTROPOLOGIA: DA #DANTE ALIGHIERI E #MICHELANGELO #BUONARROTI, UNA SOLLECITAZIONE A RIPENSARE L’ UNO (#ONU), AL DI LA’ DEL #PLATONISMO E DEL #PAOLINISMO.
ARTE E ARITMETICA: IL "QUADRATO" DEL "CERCHIO". IL "TONDO DONI" E QUATTRO PROFETI (2+2= 4). Per la "Galleria degli Uffizi" nella cornice, sono "raffigurate la testa di Cristo e quelle di quattro profeti". Ma, per Michelangelo, non è la testa di Gesù Cristo e non sono le teste di due profeti e #due #sibille?!
Non è meglio ri-#contare? Oppure è da ritenersi la punta di un "iceberg", di una questione antropologico-teologica "eterna"?!
Questa la "question" (Shakespeare): una questione antropologica e teologico-politica. Ri-pensare #comenasconoibambini: ri-considerare la #Relazione di "#Giuseppe e #Maria" e ri-meditare la lezione di Michelangelo Buonarroti. Solo così, forse, è possibile capire cosa significa il "ritrovamento" del Laocoonte e, altrettanto, come sia possibile liberare OGNI "UNO", ogni INDIVIDUO ("1") dalla "solitudine" e dall’immaginario bellico ("Homo homini lupus") e uscire dalla polifemica e luciferina "caverna" della #tragedia. (#19marzo 2025).
- NOTE:
- Questione antropologica e #cosmoteandria (#filologia e #cristologia), oggi (#19marzo 2025): "chi è questo figlio dell’#uomo?" (Gv. 12, 34). Come mai il silenzio totale di tutte le Accademie "platoniche" sulla #declinazione antropologica del messaggio evangelico ("Ecce #Homo") in chiave andrologica e costantiniana ("Ecce #Vir")? Non è questo un "meccanismo di rimozione" profondissima (S. #Freud, "Disagio della civiltà", 1929), che ha finito per spezzare le reni alla #Grecia e fatto diventare l’antropologia una #andrologia e, addirittura, il #Logos di #Efeso, il #logo di una #fattoriadeglianimali?! A che gioco giochiamo?! (#Dantedì, #25marzo 2025).
- STORIOGRAFIA #LETTERATURA E #ANTROPOLOGIA TERRESTRE: #DIVINA COMMEDIA. RICORDANDO L’INDICAZIONE DELLA #SOLARE "MONARCHIA" DI #DANTE ... e accogliendo, al contempo, l’invito dello storico #Remi #Brague a rimeditare la #saggezza (#wisdom) della #Romanitas ("IL FUTURO DELL’OCCIDENTE. Nel modello romano la salvezza dell’Europa", 1998), forse, è proprio "ora" e "qui" ("hegelianamente" e "cattolicamente") necessario e opportuno riprendere e portare avanti il filo antropologico-politico della lezione di #Cicerone a suo figlio #Marco:
- "Ma poiché vi sono due specie di bellezza, delle quali una è la grazia, l’altra la dignità, dobbiamo considerare la grazia femminile e la dignità maschile" ("Cum autem pulchritudinis duo genera sint, quorum in altero #venustas sit, in altero #dignitas, venustatem muliebrem ducere debemus, dignitatem virilem.": "De officiis", I. 130).
- (#Dantedì, #25marzo 2025).
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- "DIVINA COMMEDIA": CON #DANTE (#25MARZO 2025), OLTRE #VERSAILLES E OLTRE L’ ANDROCENTRISMO DI NAPOLEONE.10 marzo 2025, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA #PSICOANALISI E #STORIA D’#EUROPA (#8MARZO 2024 / #10MARZO 2025): RICORDANDO DANTE ALIGHIERI E I #DUESOLI DELLA SUA #MONARCHIA,
 RIPENSARE L’UNO, ri-#pensare l’#ONU - a partire da #Due, "almeno due" (Gregory Bateson) - e uscire dall’ orizzonte della #tragedia.
RIPENSARE L’UNO, ri-#pensare l’#ONU - a partire da #Due, "almeno due" (Gregory Bateson) - e uscire dall’ orizzonte della #tragedia."DIVINA COMMEDIA": CON #DANTE (#25MARZO 2025), OLTRE #VERSAILLES E OLTRE L’ ANDROCENTRISMO DI NAPOLEONE: LA #FRANCIA, CON UN PASSO DECISIVO, SI E’ PORTATA (E IN-#VITA A PORTARSI) COSTITUZIONAL-#MENTE OLTRE L’ORIZZONTE DEMIURGICO DELL’#ANDROCENTRISMO "MAMMONICO" DELLA #TRAGEDIA E HA RESTITUITO ALLA #DONNA LA SUA "KANTIANA" FACOLTA’ DI #GIUDIZIO.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- ASTROBIOLOGIA, ANTROPOLOGIA, E COSMOTEANDRIA. Quale “Teologia degli estremi confini”? Un nodo da sciogliere.22 febbraio 2025, di Federico La Sala
“Teologia degli estremi confini”
Una riflessione di Scarafoni e Rizzo sul tema Ufo*
di Paolo Scarafoni e Filomena Rizzo (La Stampa,08 Giugno 2021
Il Pentagono renderà pubblico un rapporto sui fenomeni aerei non identificati, commissionato lo scorso anno dalla amministrazione Trump, e confermato da quella attuale. Tanta attesa tra chi aspetta la conferma dell’esistenza di extraterrestri, e chi invece pensa che si tratti di avanzate tecnologie di altre potenze mondiali, rivali degli Stati Uniti.
Lo scorso anno l’Agenzia per l’innovazione della difesa francese ha creato un “red team” per reclutare autori e sceneggiatori di fantascienza impegnandoli nella «progettazione e restituzione di scenari di disruption operativi, tecnologici o organizzativi» per immaginare i conflitti del futuro in un periodo ben definito: 2030-2060.
Negli Stati Uniti, dopo decenni di negazionismo, il Pentagono ha creato lo scorso anno la divisione Unidentified Aerial Phenomenon (UAP), per “individuare, analizzare e catalogare i fenomeni aerei non identificati che potrebbero rappresentare una minaccia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti”. UAP è la nuova sigla che sostituisce UFO, e comprende una categoria più ampia di fenomeni.
In Giappone esistono specifiche linee guida per i piloti militari in caso d’incontri con UAP; in Argentina, Israele e in altri paesi ci sono state ammissioni ufficiali di contatti. In Cina nella seconda metà dello scorso anno, in piena pandemia, il NAOC, osservatorio astronomico nazionale cinese, ha aperto agli astronomi e fisici del resto del mondo, il FAST, Five hundred meter Aperture Spherical Telescope, un gigantesco radiotelescopio costruito tra le montagne nel sud-ovest del paese dal 2011 al 2016, per esplorare l’universo e per studiare mondi alieni e segnali di vita extraterrestri.
A queste notizie si aggiunge anche lo strano segnale proveniente dalla stella Proxima Centauri, che conferma il rilevamento di “bisbigli” generati da intelligenze non identificate.
Non vogliamo sembrare esagerati nè complottisti, ma chi vive a contatto con i ragazzi, perennemente connessi al gioco Fortnite, capisce che stanno sviluppando una capacità reattiva inimmaginabile per noi adulti, per colpire con una velocità estrema tutti i corpi in movimento. Sono in contatto con giocatori di tutto il mondo, senza distinzioni di sesso, età, etnia, stato, lingua, condizione sociale, cultura e religione. Continui tornei mondiali selezionano i giocatori più bravi concedendo loro premi importanti. Un’applicazione messa a disposizione di tutti e perennemente aggiornata che sembra non avere mai problemi di connessione, anche quando altri importanti programmi vanno in tilt. Un costante allenamento al combattimento. Gli sviluppatori e dai dataminer hanno divulgato i dettagli circa l’imminente arrivo degli UFO in Fortnite Stagione 6, con «cerchi nel grano» e rapimenti dei giocatori da parte degli alieni. Gli extraterrestri dovrebbero essere i protagonisti indiscussi della prossima Stagione 7.
Per quanto riguarda la ricerca della possibilità di vita oltre la Terra nel 2020 è stato pubblicato il libro “Alien Oceans: the Search for Life in the Depth of Space” di Kevin Hand, astrobiologo della Nasa. Si punta l’attenzione su un satellite di Giove chiamato Europa, che anche grazie alla presenza di un oceano, presenterebbe condizioni di vita molto simili a quelle della nostra Terra. A questo progetto allude il film di George Clooney “Midnight sky”, uscito a fine anno scorso. Una coppia di astronauti scienziati, che aspettano un bambino, provenienti da una missione su una luna di Giove, non possono più tornare a casa, perché la Terra non custodita adeguatamente sta per implodere; devono invertire la rotta e rifugiarsi proprio su quell’esopianeta per proteggere la vita e dare speranza all’umanità.
Un altro obiettivo dichiarato da parte di magnati americani è il raggiungimento di Marte per poi costruirvi città abitabili dall’uomo.
Da un punto di vista teologico bisogna intervenire presto, “primerear”, sviluppando una teologia “degli estremi confini” (Rom 10,16-18).
Sarebbe opportuno riprendere gli studi di teologi come Teilhard de Chardin, che avevano messo in evidenza l’importanza del tema. Grande interesse ha suscitato alcuni anni fa, il libro di Armin Kreiner “Gesù, gli UFO e gli alieni” e gli studi del teologo e astronomo Tanzella Nitti e dei padri gesuiti della Specola vaticana, tra i quali José Gabriel Funes e Guy Consolmagno. Oggi è indispensabile confrontarsi e dialogare a lungo con gli scienziati che hanno curato gli sviluppi della ricerca sul cosmo, superando la diffidenza reciproca.
Qualora nel rapporto statunitense si confermasse la reale possibilità di relazionarsi con creature intelligenti diverse da noi, alla teologia si porrebbero difficili tematiche relative alla cristologia (incarnazione e salvezza in Cristo) e all’antropologia.
Cristo è entrato nella creazione facendosi uno di noi, ha scelto l’uomo e la Terra. Su questo mistero per molto tempo si sono basati il geocentrismo e l’antropocentrismo, che purtroppo hanno causato a volte molto dolore. Cristo ci insegna la kenosi per mostrarci la dignità di tutti gli uomini e anche delle altre creature diverse da noi.
 Il Cristocentrismo, nella dimensione dell’incontro e della comunione con Lui, va oltre i confini della Terra, ed è possibile anche per creature intelligenti diverse da noi. L’essere un uomo per Cristo è la via, il servizio, non il privilegio e il dominio.
Il Cristocentrismo, nella dimensione dell’incontro e della comunione con Lui, va oltre i confini della Terra, ed è possibile anche per creature intelligenti diverse da noi. L’essere un uomo per Cristo è la via, il servizio, non il privilegio e il dominio. Le persone appartenenti alle potenze mondiali che forse incontreranno gli altri esseri, rappresentando l’umanità, dovranno mostrare una relazionalità e un’accoglienza senza limiti, non l’orgoglio della specie umana.
Le persone appartenenti alle potenze mondiali che forse incontreranno gli altri esseri, rappresentando l’umanità, dovranno mostrare una relazionalità e un’accoglienza senza limiti, non l’orgoglio della specie umana.Le problematiche teologiche legate alla scoperta di nuovi pianeti dove è possibile la vita (astrobiologia), si riferiscono soprattutto all’antropologia e alla cura del creato. L’umanità deve superare definitivamente la visione “predatoria”, come purtroppo è avvenuto nel passato. Di fronte a “nuove terre”, è stata giustificata la “conquista” e la “colonizzazione”, sovente appoggiandosi su una falsa cristologia, con l’errore di benedire le “armi da guerra”. Adesso si aggiunge l’intenzione esplicita di egoismo dei potenti e dei ricchi, che invece di proteggere la Terra, la sfruttano fino al punto di non ritorno e si assicurano la possibilità di impossessarsi di altri pianeti per la loro sopravvivenza. I poveri esclusi da questi giochi predatori, senza un intervento vigoroso, anche teologico, sulle coscienze e sulle intenzioni, sono destinati a rimanere scartati.
 Come relazionarci alla meravigliosa scoperta di esopianeti abitabili, dove si può sviluppare la vita, e all’arricchente incontro con creature intelligenti da ospitare e non da combattere, ci è indicato nelle Scritture: «I cieli narrano la gloria di Dio, l’opera delle sue mani annunzia il firmamento» (Sal 19,1). Cristo, Re dell’Universo insegna a tutti gli uomini e a tutte le creature ad accogliersi e ad amarsi.
Come relazionarci alla meravigliosa scoperta di esopianeti abitabili, dove si può sviluppare la vita, e all’arricchente incontro con creature intelligenti da ospitare e non da combattere, ci è indicato nelle Scritture: «I cieli narrano la gloria di Dio, l’opera delle sue mani annunzia il firmamento» (Sal 19,1). Cristo, Re dell’Universo insegna a tutti gli uomini e a tutte le creature ad accogliersi e ad amarsi.* Don Paolo Scarafoni e Filomena Rizzo insegnano insieme teologia in Italia e in Africa, ad Addis Abeba. Sono autori di libri e articoli di teologia.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE --- CON #SHAKESPEARE (DANTE ALIGHIERI E GIORDANO BRUNO), PER UNA ANALISI CRITICA DEL"CESARICIDIO" E UNA COMPRENSIONE ANTROPOLOGICA DELLA "MONARCHIA" DEI "DUE SOLI"."15 febbraio 2025, di Federico La Sala
ARCHEOLOGIA E FILOLOGIA DELLA TRADIZIONE CULTURALE EUROPEA: CON #SHAKESPEARE (DANTE ALIGHIERI E GIORDANO BRUNO), PER UNA ANALISI #CRITICA DEL"CESARICIDIO" E UNA COMPRENSIONE ANTROPOLOGICA DELLA #MONARCHIA DEI "#DUE SOLI" ("DIVINA COMMEDIA").
- Una nota intorno al tema del "Giulio Cesare" (e dell’ "Amleto").
CHE NELLA MODALITA’ IN CUI SHAKESPEARE PRESENTA LA "RESA" DI BRUTO ALLE ARGOMENTAZIONI DI #CASSIO (ALLA "SOCRATE") PER COINVOLGERLO (COME UN "ALCIBIADE") NELL’AVVENTURA DEL "CESARICIDIO", IN CUI APPARE evidente il rinvio critico al "gioco" narcisistico del guardarsi nell’occhio dell’altro per conoscere sé stesso del dialogo di #Platone ("Alcibiade primo", 132c - 133b ), è già ben chiaro che egli pensi al di là del #platonismo e del #paolinismo storico:
"BRUTO
 No, Cassio; perché l’occhio non vede se stesso
No, Cassio; perché l’occhio non vede se stesso
 se non di riflesso, attraverso altri oggetti.
se non di riflesso, attraverso altri oggetti.
 CASSIO
CASSIO
 È così;
È così;
 e ci si rammarica molto, Bruto, che tu non abbia
e ci si rammarica molto, Bruto, che tu non abbia
 specchi che volgano ai tuoi occhi il tuo valore
specchi che volgano ai tuoi occhi il tuo valore
 nascosto, così che tu possa vedere la tua immagine
nascosto, così che tu possa vedere la tua immagine
 riflessa. Ho sentito molte persone di alta reputazione
riflessa. Ho sentito molte persone di alta reputazione
 qui a Roma - eccetto l’immortale Cesare -
qui a Roma - eccetto l’immortale Cesare -
 che, parlando di Bruto, e gemendo sotto il giogo
che, parlando di Bruto, e gemendo sotto il giogo
 di questa epoca, hanno espresso il desiderio
di questa epoca, hanno espresso il desiderio
 che il nobile Bruto abbia occhi.
che il nobile Bruto abbia occhi.
 BRUTO
BRUTO
 In quali pericoli vorresti spingermi, Cassio,
In quali pericoli vorresti spingermi, Cassio,
 invitandomi a cercare in me stesso
invitandomi a cercare in me stesso
 quello che in me non c’è?
quello che in me non c’è?
 CASSIO
CASSIO
 Per questo, caro Bruto, preparati ad ascoltare.
Per questo, caro Bruto, preparati ad ascoltare.
 E poiché tu sai di non poterti vedere bene
E poiché tu sai di non poterti vedere bene
 se non per riflesso, io, il tuo specchio,
se non per riflesso, io, il tuo specchio,
 rivelerò con discrezione a te stesso
rivelerò con discrezione a te stesso
 quello che di te stesso tu ancora non conosci.
quello che di te stesso tu ancora non conosci.
 E non essere sospettoso con me, gentile Bruto.
E non essere sospettoso con me, gentile Bruto.
 Se io fossi un buffone qualsiasi, o fossi avvezzo
Se io fossi un buffone qualsiasi, o fossi avvezzo
 a svilire con volgari giuramenti il mio affetto
a svilire con volgari giuramenti il mio affetto
 al primo venuto che mi assicuri il suo; se ti risulta
al primo venuto che mi assicuri il suo; se ti risulta
 che scodinzolo con le persone e prima le abbraccio forte
che scodinzolo con le persone e prima le abbraccio forte
 e poi le calunnio; o se ti risulta
e poi le calunnio; o se ti risulta
 che, alle feste, io mi professo amico
che, alle feste, io mi professo amico
 di tutta la marmaglia, allora ritienimi pericoloso. "
di tutta la marmaglia, allora ritienimi pericoloso. "
 ("Giulio Cesare," Atto I, Scena 2).
("Giulio Cesare," Atto I, Scena 2).Shakespeare, nel solco e sul filo della lezione di Dante e di Bruno, sollecita la riflessione sul legame antropologico-politico e teologico dei "due soli" della "Monarchia" di Dante, e delle "#Tre corone" dello "Spaccio della bestia trionfante" di Giordano Bruno: sotto la spinta della #RiformaProtestante (1517) e Anglicana (1534) e della #Rivoluzionescientitica (#Copernico, 1543), egli insegna a "vedere" nella figura di "Giulio Cesare" (e di "Amleto") la unità e la unificazione - nelle mani e nella testa - non solo del sovrano ("cristiano") o della sovrana ("cristiana") ma di ogni "cristiano" e "cristiana", di ogni "cittadino" e di ogni "cittadina", del potere sia politico ("#sovranità universale") che religioso ("#sacerdotalità universale"): "Sàpere aude!" (#Kant, 1784).
#Dantedì, #25marzo 2025
- NOTA:
- PER USCIRE DALL’ORIZZONTE DELLA #COSMOTEANDRIA PLATONICA, E, AL CONTEMPO, DA UNA CAPACITA’ DI “#LETTURA” DIMEZZATA DELLA REALTA’ E UNA PARZIALE E ”#SPECULARE” #CONOSCENZA DI SE’, UN “INVITO” A RICONSIDERARE (ANCHE E ANCORA) LA SEGUENTE DISCUSSIONE TRA SOCRATE E ALCIBIADE ...
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- TEATRO E STORIA: LA "EREDITÀ" DI "ROMA" E L’ANALISI DI SHAKESPEARE NEL "GIULIO CESARE" E NELL’ "AMLETO"... *12 febbraio 2025, di Federico La Sala
STORIA (TEATRO) E METASTORIA (METATEATRO): LA QUESTIONE DELLA "EREDITÀ" DI "ROMA" E L’ANALISI DI SHAKESPEARE NEL "GIULIO CESARE" E NELL’ "AMLETO"... *
Nell’ Atto I, Scena 2, del "Giulio Cesare" si fa riferimento alla festa e alla corsa dei Lupercali, che a Roma si svolgeva nei giorni degli Idi di febbraio. in onore del dio Luperco, patrono della fertilità, e si accenna al problema all’ordine del giorno:
"CESARE - Calpurnia!...
CALPURNIA - Eccomi, son qui, signore.
CESARE - Appena Antonio inizierà la corsa,
cerca di metterti sul suo percorso...
Antonio!
ANTONIO - Cesare, signore mio...
CESARE - Non ti scordare, durante la corsa,
di toccare Calpurnia con la mano;
ché secondo che dicono gli anziani,
le donne sterili che son toccate
in questa corsa sacra,
si scrollano di dosso il maleficio
dell’infecondità".
Nell’atto III, scena 2, ANTONIO, nel suo discorso agli "amici, romani, popol mio", sul suo "diritto" ad essere il degno "successore" di Giulio Cesare, astutamente insinua nell’ orecchio: "[...] Quando i poveri hanno pianto, Cesare ha lacrimato: l’ambizione dovrebbe essere fatta di più rude stoffa; eppure Bruto dice che egli fu ambizioso; e Bruto è uomo d’onore. Tutti vedeste come al Lupercale tre volte gli presentai una corona di re che egli tre volte rifiutò: fu questo atto di ambizione? Eppure Bruto dice che egli fu ambizioso; e, invero, Bruto è uomo d’onore. Non parlo, no, per smentire ciò che Bruto disse, ma qui io sono per dire ciò che io so. [...]" (#Shakespeare, "Giulio Cesare", III.2).
*
LA MEMORIA DI #SANVALENTINO (#14FEBBRAIO) NELL’ "AMLETO" DI SHAKESPEARE: TEATRO (#STORIA) E METATEATRO (#METASTORIA)...
- OFELIA, A BEN RILEGGERE IL TESTO DELLA "CANZONE DI SAN VALENTINO" ("#AMLETO", 4.5.51-71), RICHIAMA IN MODO "CIFRATO" AL RE #CLAUDIO IL DELITTO DEL #RE #AMLETO ("#GIULIO #CESARE") E, AL CONTEMPO, ALLA CHIESA CATTOLICO-SPAGNOLA CHE LA "FESTA DI SAN VALENTINO" NON E’ ALTRO E ANCORA CHE LA "FESTA" DEL "COME NASCONO I BAMBINI" SECONDO LA "MARZIANA" TRADIZIONE ROMANA DEL "LUPERCALE"....
- NOTA:
- STORIA E #LETTERATURA E #ANTROPOLOGIA (#CRISTOLOGIA): #DANTE ALIGHIERI E #SHAKESPEARE, CON LA #MEMORIA DI #ULISSE, SULLA STESSA STRADA: USCIRE DALLA #CAVERNA POLIFEMICA, E DALL’#INFERNO DELLA #DOTTAIGNORANZA PLATONICA, CON L’AIUTO DELL’#ARIETE, DEL #MONTONE (E, A BEN VEDERE, ANCHE DEL #CAPRONE): "DI VELLO IN VELLO". COSI’ #VIRGILIO PORTA #DANTE FUORI DALLA "CAVERNA" DI #LUCIFERO: "Com’a lui piacque, il collo li avvinghiai;/ed el prese di tempo e loco poste,/e quando l’ali fuoro aperte assai,//appigliò sé a le vellute coste;/di vello in vello giù discese poscia/tra ’l folto pelo e le gelate croste" (Inf. XXXIV, 70-75).
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- FILOLOGIA, ARCHEOLOGIA, E STORIA: DA ARIANNA E DA NASSO ("NAXOS"), UN FILO PER "RI-USCIRE" DAL LABIRINTO DEI "GIOCHI DI PAROLE", E DALLA "CAVERNA" DI "POLIFEMO"."7 febbraio 2025, di Federico La Sala
GIORNATA MONDIALE DELLA LINGUA GRECA (2025): UNA QUESTIONE DI GRAZIA ("XAPIS"). DA ARIANNA E DA NASSO ("NAXOS"), UN FILO PER "RI-USCIRE" DAL LABIRINTO DEI "GIOCHI DI PAROLE", E DALLA "PLATONICA" #CAVERNA "POLIFEMICA", E ANDARE INCONTRO ALLE GRAZIE E ALLA #PRIMAVERA CHE SI AVVICINA...
RICORDANDO CHE la parola "Naxos" va letta come "Nacsos", come la parola "Xenos", "Csenos", proprio per rispetto al suo etimo perché rimanda alla parola: ξένος «straniero, ospite». è bene non confondere "Nasso" con la parola "asso", e, la "Filo-xenia", con la Xeno-fobia"!
E’ BENE CHE IL SENSO E IL SUONO DELLA "ICS"("X") NON SIA CONFUSO CON QUELLO DEL "CHI" ("X"), ALTRIMENTI LA "Χαρά (#XAPA)" DIVENTA UNA "XAPA" (cioè, "CSARA") E... SI FINISCE PER PERDERE NON SOLO LA BUSSOLA, LA "XAPA" (cioè, "CHAPA"), E, ANCORA, "LEGGENDO" IN NAPOLETANO E "NEA-POLITANO" ("CHAPIS...ce a me"), PERSINO TUTTA LA PRIMAVERA CON LE SUE GRAZIE (#CHARITES) E LA STESSA GRAZIA!
MITO E #STORIA. "Naxos (detta anche Nasso), isola del mito di Arianna, è la più grande e la più fertile delle Cicladi. [...] Naxos (detta anche Hora, Chora o Naxos #Chora), capitale e porto principale dell’isola [...] Vi siete mai chiesti da dove deriva l’espressione “piantare in asso”? È una contrattura di “piantare in Nasso” e si riferisce alle vicende mitologiche di Arianna, la fanciulla che aiutò Teseo a fuggire dal labirinto del Minotauro.[...]" (v. NAXOS).
- NOTA:
COSMOTEANDRIA "POLIFEMICA": #ANDROCENTRISMO, #GEOCENTRISMO ED #ETNOCENTRISMO DI UNA " CHIARA ED EVIDENTE" #CAVERNA PLANETARIA...
- In #memoria di Immanuel #Kant, Hermann von #Helmholtz, e Marcel #Proust, e #FrancaOngaro #Basaglia...
PIANETATERRA (2025). Nell’inizio dell’anno del "#Serpente del #legno #verde", per auguri e in omaggio al lavoro di #Stefano #Mancuso e #Alessandra #Viola, "#Verde brillante. Sensibilità e intelligenza del mondo vegetale" (Giunti Editore, 2013, p. 19), riprendo (e ripropongo all’attenzione)
LA "PIRAMIDE DEI VIVENTI" DI BOVILLUS ( CHARLES DE BOVELLES), TRATTA DAL "LIBER DE #SAPIENTE" (1509-1510).
La generale "nostra considerazione" non solo del mondo della #natura e del mondo dell’#uomo (antropologico, sociologico, economico, politico, e teologico) è, a ben vedere, "ancora molto simile".
- BUON2025
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- COSTITUZIONE ("LOGOS"), E PARTITI ("LOGO"), OGGI. Una nota su «Piero Calamandrei e la “separazione delle carriere” in magistratura».26 gennaio 2025, di Federico La Sala
ARCHEOLOGIA, #FILOLOGIA, #FILOSOFIA, COSTITUZIONE ("LOGOS"), E PARTITI ("LOGO"), OGGI...
- Una nota a margine del testo di «Piero Calamandrei e la “separazione delle carriere” in magistratura» (Riccardo Radi,"TERZULTIMA FERMATA", 26 gennaio 2025 ).
CHI LO SA, LO SA; CHI NON LO SA, NON LO SA, MA ORMAI LO SANNO TUTTI E TUTTE. CHE OGGI SI STIA PERDENDO DEFINITIVAMENTE LA DISTINZIONE TRA LA #VEGLIA E IL #SONNO, TRA LA #LEGGE #FONDAMENTALE (le "regole del gioco" nel #campo e del campo di tutta la società ) E I "LOGO" (i "marchi", i "nomi", i "simboli" dei vari Partiti, delle varie Aziende, delle varie Lobbies atee e devote), dovrebbe preoccupare prima di tutto e soprattutto filologi e filologhe, oltre che filosofi e filosofe!
Il problema del "ripescaggio" geologico dal fondo del #pozzo in cui è caduto lo #spirito della Legge è un nodo antropologico e teologico-politico di lunga durata: "essere, o non essere" (#Shakespeare, "#Amleto"). E’ ancora il tempo della discussione sul tema della "dotta ignoranza" (1440) e sull’autenticità della cosiddetta "Donazione di Costantino" (1440).
ANTROPOLOGIA E #STORIA. CON IL SUO "ELOGIO DEI GIUDICI scritto da un avvocato" (1959), Piero Calamandrei mette chiaramente il #ditonellapiaga ("Quid est veritas?") e sollecita a non addormentarsi, come già la "memoria" di #Eraclito di #Efeso (e #Immanuel #Kant di Koenisberg, l’attuale #Kaliningrad): "Bisogna dunque seguire ciò è comune. Ma pur essendo questo lógos comune, la maggior parte degli uomini vive come se avesse un propria e particolare saggezza" (fr. 2).
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- TEATRO, METATEATRO, ANTROPOLOGIA E PEDAGOGIA. IL "RISUS PASCHALIS". Una breve nota in omaggio del lavoro della teologa Maria Cristina Jacobelli11 gennaio 2025, di Federico La Sala
TEATRO, METATEATRO, ANTROPOLOGIA FILOLOGIA STORIOGRAFIA E PEDAGOGIA TEOLOGICO-POLITICA:
IL "RISUS PASCHALIS" E IL FONDAMENTO TEOLOGICO DEL PIACERE SESSUALE"".
- Una breve nota in omaggio del lavoro della teologa Maria Cristina Jacobelli e della sollecitazione a riflettere del linguista Franco Lo Piparo *
Una brillante "comunicazione", ripresa dal lavoro giovanile (1998) del cardinale Víctor Manuel Fernández, su “La Pasión mística. Espiritualidad y sensualidad” (cfr. Franco Lo Piparo, "Misticismo e orgasmo")*, offre brillanti "indicazioni" per rileggere e re-interpretare "neapolitana-mente", proprio alla luce del "Cantico dei cantici" (8.6), l’opera di Shakespeare, "Amleto", e, finalmente, di capire meglio l’importanza dello "spettacolo nello spettacolo", del #Mousetrap (la "trappola del topo") e del "gioco" di Amleto e Ofelia, dinanzi al Re Claudio e alla Regina Gertrude: un contributo critico formidabile, per meglio rispondere alla hamletica "question" e, da non dimenticare, per rendere onore, finalmente, anche a Totò, che collocava "il Cantico dei cantici, nel blu, dipinto di blu"!
- *
MISTICISMO E ORGASMO
Secondo un lavoro giovanile del cardinale Víctor Manuel Fernández, molto vicino a Papa Francesco, orgasmo e rapporto mistico con Dio hanno molti aspetti in comune. Do la parola al cardinale:
- «Vediamo innanzitutto come gli uomini e le donne vivono l’orgasmo e qual è la differenza tra un orgasmo maschile e uno femminile. A lei piacciono di più le carezze e i baci, e ha bisogno che l’uomo giochi un po’ prima di penetrarla. Ma lui, insomma, è più interessato alla vagina che al clitoride. Al momento dell’orgasmo, lui di solito emette dei grugniti aggressivi; lei invece, fa dei balbettii o dei sospiri infantili. Non dimentichiamo che le donne hanno un ricco plesso venoso intorno alla vagina, che mantiene un buon flusso sanguigno dopo l’orgasmo. Ecco perché di solito è insaziabile. Ma non dimentichiamo che a livello ormonale e psicologico non esistono maschi e femmine puri. Chiediamoci ora se queste particolarità dell’uomo e della donna nell’orgasmo si verificano in qualche modo anche nel rapporto mistico con Dio”.
Il libro da cui è tratta la citazione è “La Pasión mística. Espiritualidad y sensualidad” pubblicato nel 1998. A chi dovesse scandalizzarsi ricordo che l’argomento era già stato trattato, in termini poetici e non scientifici, nel Vecchio Testamento dal “Cantico dei Cantici”. (Franco Lo Piparo).
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- Chiesa ed Eucharistia. Il comandamento dell’amore e la norma personalistica ....
- Amore e responsabilità (Karol J. Wojtyla) - e "caritas" (J. Ratzinger) !!! Fonti cattoliche a confronto, in chiave dialettico-polemica. Ripreso Giovanni Paolo II, l’ennesimo affondo per il dibattito
- Il magistero del "Deus caritas est" ("Dio caro-prezzo è") o il magistero del "Deus charitas est" ("Dio è Amore")?!
Federico La Sala
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- ANTROPOLOGIA E STORIA: LA "CRISI CLIMATICA" GENERALE, LO SCIOGLIMENTO DI UN "ICEBERG" PIU’ CHE MILLENARIO, E LA PRIMAVERA IN CAMMINO....10 gennaio 2025, di Federico La Sala
LA "CRISI CLIMATICA" GENERALE, IL DISGELO, LA "#CRISI CLIMATICA" GENERALE, IL #DISGELO, LO SCIOGLIMENTO DI UN "ICEBERG" PIU’ CHE MILLENARIO, E LA #PRIMAVERA IN CAMMINO...
#DISAGIO DELLA E NELLA #CIVILTA’ (S. #FREUD, 1929) ED #EMERGENZA PLANETARIA (#10GENNAIO 2025): USCIRE VELOCEMENTE DALLA #CAVERNA (#PLATONISMO) E DAL #LABIRINTO (#TRAGEDIA):
- Tutte le "teste" (coronate e non) della società e della cultura , vale a dire di tutte le istituzioni e di tutte le università, le accademie, e gli organismi di ricerca, ecc., dovrebbero aprire le porte e le finestre alla riflessione e alla discussione ... se ben si considera e si osserva la #profondità della base dello stesso iceberg *
- ANTROPOLOGIA #ANDROCENTRISMO #FILOSOFIA #COSMOLOGIA #GEOLOGIA #ARCHEOLOGIA #PSICOANALISI #FILOLOGIA #SOCIOLOGIA #DIRITTO #MEDICINA #ANATOMIA #BIOLOGIA #TEOLOGIA #STORIA STORIOGRAFIA...
- *
- FOTO (ALLEGATA): LA "PIRAMIDE" E LA PUNTA DELL’ICEBERG "ANDROCENTRICO" DELLA "SCUOLA" DEL FILOSOFO BOVILLUS ("IL SAPIENTE", 1510).
CAMBIARE ROTTA E PARADIGMA: "ESSERE, O NON ESSERE", "SOCIALISMO O BARBARIE". RIPRENDERE IL FILO DI "ARIANNA" E PORTARSI FUORI DALL’INFERNO (CON DANTE E) MARX:
"[...] La comunità non è altro che una comunità del lavoro e l’uguaglianza del salario, il quale viene pagato dal capitale comune, dalla comunità in veste di capitalista generale. Entrambi i termini del rapporto vengono elevati ad una universalità rappresentata: il lavoro in quanto è la determinazione in cui ciascuno è posto, il capitale in quanto è la generalità riconosciuta e la potenza riconosciuta dalla comunità.
Nel rapporto con la donna, in quanto essa è la preda e la serva del piacere della comunità, si esprime l’infinita degradazione in cui vive l’uomo per se stesso: infatti il segreto di questo rapporto ha la sua espressione inequivocabile, decisa, manifesta, scoperta, nel rapporto del maschio con la femmina e nel modo in cui viene inteso il rapporto immediato e naturale della specie. Il rapporto immediato, naturale, necessario dell’uomo con l’uomo è il rapporto del maschio con la femmina. In questo rapporto naturale della specie il rapporto dell’uomo con la natura è immediatamente il rapporto dell’uomo con l’uomo, allo stesso modo che il rapporto con l’uomo è immediatamente il rapporto dell’uomo con la natura, cioè la sua propria determinazione naturale. Cosi in questo rapporto appare in modo sensibile, cioè ridotto ad un fatto d’intuizione, sino a qual punto per l’uomo l’essenza umana sia diventata natura o la natura sia diventata l’essenza umana dell’uomo. In base a questo rapporto si può dunque giudicare interamente il grado di civiltà cui l’uomo è giunto. Dal carattere di questo rapporto si ricava sino a qual punto l’uomo come essere appartenente ad una specie si sia fatto uomo, e si sia compreso come uomo; il rapporto del maschio con la femmina è il più naturale dei rapporti che abbiano luogo tra uomo e uomo. In esso si mostra sino a che punto il comportamento naturale dell’uomo sia diventato umano oppure sino a che punto l’essenza umana sia diventata per lui essenza naturale, e la sua natura umana sia diventata per lui natura. In questo rapporto si mostra ancora sino a che punto il bisogno dell’uomo sia diventato bisogno umano, e dunque sino a che punto l’altro uomo in quanto uomo sia diventato per lui un bisogno, ed egli nella sua esistenza più individuale sia ad un tempo comunità.
La prima soppressione positiva della proprietà privata, il comunismo rozzo, è dunque soltanto una manifestazione della abiezione della proprietà privata che si vuol porre come comunità positiva. [...]" (K. Marx, "Manoscritti economico-filosofici del 1844", "Proprietà privata e comunismo".
- NOTE:
- PIANETA TERRA: #EARTHRISE! #IRAN: #CECILIA #SALA #LIBERATA... E’ GIA’ UN "BUON INIZIO" DELL’ANNO, DI UN "BUON LAVORO" E UN "#BUON2025"! Un brillante annuncio di #rinascita, di una "prima rinascita", per l’intera #Terra! AUGURI all’intero popolo iraniano, a #CeciliaSala, all’#Italia... :
- "Cecilia Sala è libera, il ritorno in Italia nel pomeriggio a Ciampino. Aggiornamenti in tempo reale. È previsto alle 15.30 all’aeroporto di Ciampino l’aereo C130 dell’Aeronautica militare, la giornalista era detenuta in Iran dal 19 dicembre. Il papà: "È stata una partita a scacchi affollata".
- “SAPERE AUDE!” - UN “INVITO” DELLA SECONDA META’ DELL’ OTTOCENTO A RIPRENDERE CRITICA- MENTE LE INDICAZIONI DI KANT, AD USCIRE DA UN LETARGO “COSMOTEANDRICO” DI MILLENNI SUL PIANO SCIENTIFICO (FILOLOGICO, FILOSOFICO, TEOLOGICO, E SOCIOLOGICO) E A SVEGLIARSI DAL “SONNO DOGMATICO” :
- “QUESTO antropomorfismo psicologico lo riconosciamo nelle idee di Platone come nella dialettica immanente al processo universale di Hegel e nella volontà inconscia di Schopenhauer” (HERMANN VON HELMHOLTZ, “Il pensiero nella medicina”, 1877).
- STORIA, #STORIOGRAFIA, #FILOLOGIA E #MARXISMO: I "MANOSCRITTI ECONOMICO-FILOSOFICI DEL 1844" DI KARL MARX (Orthotes Editrice, NAPOLI 2018:
- "Quando nel 1932 furono per la prima volta pubblicati gli appunti che un giovane filosofo tedesco, discepolo di Hegel e di Feuerbach, aveva preso un secolo prima a Parigi dalle sue letture di economisti e di filosofi, questo evento editoriale fu salutato con grande entusiasmo. Una cosa abbastanza curiosa, se si considera che i cosiddetti Manoscritti economico-filosofici del 1844 non costituiscono un libro unitario, destinato alle stampe, ma solo materiali di lavoro in cui le osservazioni critiche affiorano da lunghe trascrizioni di autori più o meno noti.[...]".
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- MEMORIA E STORIA: L’ALBERO DI NATALE NELL’EUROPA MODERNA E IL "SIDEREUS NUNCIUS" DI GALILEO GALILEI28 dicembre 2024, di Federico La Sala
L’ALBERO DI NATALE NELL’EUROPA MODERNA E IL "SIDEREUS NUNCIUS" DI GALILEO GALILEI: LA PUNTA DI UN ICEBERG DELL’IMMAGINARIO OCCIDENTALE
UNA NOTA sulla considerazione che "Nella sua concezione moderna, l’albero di Natale casalingo sarebbe stato creato quasi casualmente da una nobildonna tedesca nel 1611, desiderosa di illuminare un angolo vuoto della casa, la duchessa di Brieg." (cfr. Elisa Chiari, "Albero di Natale, la vera storia dalle radici antiche a noi", "Famiglia cristiana", 18.12.2024 )
CULTURA E SOCIETA’. Tenendo conto di quanto sta succedendo nella società europea, a partire dalla #RiformaProtestante (1517), e dal "Sacco di Roma" dei lanzichenecchi al soldo dell’imperatore Carlo V (1527), dalla #Riforma #Anglicana (1534), dalla stampa dell’opera di #Astronomia di #Copernico (1543) e dell’opera di #Anatomia di #Vesalio (1543), dalla #Controriforma Cattolica (#ConciliodiTrento,1545-1563), e, ancora, dalla introduzione del #CalendarioGregoriano del 1582 (non accettato né dalla Germania e dall’Olanda fino al 1700, né dall’Inghilterra fino al 1752), e, al contempo, dall’attacco della cattolicissima "Invincibile Armada" spagnola di Filippo II all’Inghilterra di Regina Elisabetta I d’Inghilterra (1588), si può comprendere meglio (e subito) perché all’#Amleto di #Shakespeare non piaccia il "#presepe" della "Danimarca" cattolica, e, al contempo, nella Germania protestante si comincia a diffondere in occasione del Natale la tradizione dell’#albero, sia come critica della tradizione religiosa cattolico-spagnola sia come sollecitazione a ripensare all’albero del #Paradisoterrestre e anche a un rinnovato legame matrimoniale tra "#Adamo ed #Eva" (come già indicato e fatto da Lutero e da #EnricoVIII, padre della regina Elisabetta).
"SIDEREUS NUNCIUS" (GALILEO GALILEI, 1610). Alla #luce di questa "contestualizzazione" relativa al diffondersi della tradizione dell’ Albero di Natale nei Paesi Protestanti, forse, è bene ricordare che l’Annuncio Sidereo (il "Sidereus Nuncius"), relativo alla "scoperta" della #Luna come la Terra e della #Terra come la Luna, di Galileo Galilei è del 1610 ed è salutato da #Keplero proprio nel 1611 con parole augurali che fanno tremare ancora oggi di "paura" tutta la teologia-politica cattolico-costantiniana dell’epoca: "Vicisti, Galilaee!" (Hai vinto, o Galileo!).
PIANETA TERRA: SPERANZA. Forse, oggi, alla fine del 2024, la navigazione nell’#oceano celeste (come da indicazione e sollecitazione dello stesso Keplero al Galileo, nella lettera del 1611) può riprendere.
#Buonanno, #Buon2025.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- UNA QUESTIONE DI ANTROPOLOGIA, LINGUISTICA E PSICOANALISI: L’ENIGMA DEL NOME, L’ENIGMA DEL SOGGETTO, L’ENIGMA DEL DESTINO ("ANANKE").9 dicembre 2024, di Federico La Sala
L’ENIGMA DEL NOME, L’ENIGMA DEL SOGGETTO, L’ENIGMA DEL DESTINO ("ANANKE") E ... L’ENIGMA DI "DIO" ("CHARITAS") *
L’ENIGMA DEL DESTINO
di Gianfranco Ricci*
Lo storico Erodoto di Alicarnasso racconta nelle celebre opera “Storie” che nell’anno 499 a.C., Istieo, avventuriero e tiranno di Mileto, si trovava alla corte del re Dario I e non aveva modo di mettersi in contatto con il suo compatriota e tiranno della città Aristagora.
In quel tempo le città ioniche preparavano la grande ribellione contro il dominio persiano e Istieo voleva comunicargli che era il momento di dare il via alla sollevazione.
Alla fine ebbe un’idea: fece rasare la testa al suo schiavo più fedele e gli tatuò sul cuoio capelluto il messaggio che desiderava trasmettere, poi aspettò che i capelli ricrescessero, in modo da nascondere il messaggio.
Solo allora inviò lo schiavo a Mileto, dove gli rasarono nuovamente la testa e poterono leggere il messaggio. Il procedimento aveva diversi vantaggi, perché neppure il latore del messaggio ne conosceva il contenuto e pertanto non avrebbe potuto rivelarlo neanche se fosse stato sottoposto a interrogatorio o tortura.
Già Freud nello scritto “Isteria” (1888) aveva notato come i sintomi isterici seguissero una logica diversa da quella della mera anatomia. Tra il sintomo e la base organica non vi era un legame diretto, bensì l’emergere di una sorta di “dialetto”, di fenomeno linguistico.
Lacan porterà all’estremo la lettura freudiana, parlando di “crivellatura” del corpo per effetto del significante. Le parole, osserva Lacan, possono essere veri e propri “proiettili” che toccano, feriscono e perforano il corpo.
Abbiamo qui l’aspetto centrale della psicoanalisi: il rapporto fondamentale tra corpo e parola.
Il soggetto viene al mondo parlato dall’Altro, prima ancora di accedere direttamente al linguaggio.
Il primo significante che incontra è spesso il nome proprio, intraducibile per definizione, presente quindi nella sua dimensione di significante che si sgancia da ogni significato.
Tuttavia sappiamo bene che il significato è presente nel luogo dell’Altro e per questo può divenire come un “destino” per il soggetto che lo porta: il nome proprio può essere un destino.
Perché un certo nome? Perché non altri? Nel nostro nome e nelle parole che circolano nella nostra infanzia è evidente l’effetto di scrittura, di incisione che il significante opera su di noi.
Ciascuno di noi assomiglia quindi allo schiavo della storia di Erodoto: portiamo su di noi le tracce di un messaggio che non conosciamo e che ci resta enigmatico, misterioso, inaccessibile.
Compito dell’analisi è svelare questo messaggio inconscio: far emergere il discorso che l’Altro ha fatto per noi e su di noi, per assumere questo discorso e farlo nostro, riformularlo alla luce del nostro desiderio.
Sartre mostra l’importanza di questa operazione nel suo studio sulla vita di Jean Genet: l’intera opera di uno degli scrittori più discussi e controversi del Novecento si organizza intorno ad un significante che ha segnato per sempre la sua vita. Sartre ricostruisce infatti un episodio preciso dell’infanzia del piccolo Genet, quando, sorpreso dalla sua balia, viene ripreso con una parola: “ladro!”.
Come sottolinea Sartre nell’opera “Santo Genet, commediante e martire”, l’intera opera di Genet risponde ad una logica precisa: “il genio non è un dono, ma la via d’uscita che ci si inventa in casi disperati”.
- Per approfondire:
- Erodoto - Storie;
- Sartre - Santo Genet, commediante e martire;
- Massimo Recalcati - Ritorno a Jean Paul Sartre.
Il lavoro di Sartre ha indagato il ruolo della storia, dell’infanzia e dell’Altro nella vita dell’uomo.
In particolare, questo ambito di ricerca segna un punto di contatto con la pratica e la teoria analitica.
Sartre ha articolato il suo lavoro concentrandosi su due grandi figure dell’universo culturale francese: Jean Genet e Gustave Flaubert.
Entrambi, nella loro vita, sono stati segnati da un marchio indelebile; la storia di questi due autori rappresenta il tentativo singolare di riprendere questa iscrizione originaria, per trasformarla.
In particolare, se nel caso di Genet il significante padrone, S1, è “ladro!”, nella storia di Flaubert vi è “idiota”.
L’opera elefantiaca di Sartre dedicata a Gustave Flaubert si intitola proprio “L’idiota della famiglia”.
Terzo di tre figli, Flaubert si trova gettato, scartato tanto dal desiderio paterno, investito integralmente sul figlio maggiore (divenuto “copia” del padre), quanto di quello materno (destinato interamente alla figlia femmina, tanto voluta).
La sua “idiozia”, destino già scritto dall’Altro familiare, tradotto in un ritardo nell’acquisizione della parola, diviene base di una ripresa singolare, che porterà Flaubert a divenire, a suo modo, uno degli scrittori più importanti della letteratura francese.
*Cfr. Gianfranco Ricci, 29 novembre 2023 (ripresa parziale - senza immagini).
* Sul tema, nel sito, si cfr.:
- DANTE E SAUSSURE: UNA SOLA TEORIA, QUELLA DEI "DUE SOLI". Ipotesi di lavoro
- PER LA CRITICA DEL CAPITALISMO E DELLA SUA TEOLOGIA "MAMMONICA" (Benedetto XVI, "Deus caritas est", 2006). "CHI" SIAMO NOI, IN REALTÀ. RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.
Federico La Sala
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- STORIA E STORIOGRAFIA: CAMBIARE ROTTA. ALL’ORIGINE DEL "CONTRORINASCIMENTO" EUROPEO, LA "SVOLTA DI SALERNO" (REGNO DI NAPOLI,1547-1548)..4 novembre 2024, di Federico La Sala
CAMBIARE ROTTA ("#SVOLTADISALERNO", 1944-1948): "NON E’ MAI TROPPO TARDI" (#ALBERTOMANZI, 1924-1997).
ALL’ORIGINE DEL "CONTRORINASCIMENTO" EUROPEO, LA "#SVOLTA DI #SALERNO" (REGNODINAPOLI,1547-1548).
- Una nota storiografica in memoria di Mercurino Arborio di Gattinara
LA "SVOLTA DI SALERNO": L’#IMPERATORE #CARLOV E DON #PEDRODITOLEDO, ALL’INTERNO DI UN ORIZZONTE EUROPEO E MEDITERRANEO BELLICOSO (CADUTA DI #COSTANTINOPOLI,1453) GIUNGONO A METTERE AL BANDO IL PRINCIPE FERRANTE SANSEVERINO (Luca Addante)] E DANNO IL VIA LIBERA ALLA #TEOLOGIA-#POLITICA DELLA #SPAGNA E DELLA #CHIESACATTOLICA #CONTRO LA #RIFORMA DI #LUTERO (1517) E LA RIFORMA #ANGLICANA DI #ENRICOVIII (1534). NEL SEICENTO IL "MARCIO NELLO STATO DI DANIMARCA" CRESCE SEMPRE DI PIU’(#Shakespeare, #Amleto, 1602): LA #GUERRA DEI TRENT’ANNI (1618-1648) E’ ALLE PORTE.
- NOTA:
#STORIA D’#ITALIA E #STORIOGRAFIA: "LE COLONNE DELLA #DEMOCRAZIA" (#LUCA #ADDANTE). SCHEDA EDITORIALE (Editori Laterza, 2024): "Negli anni della Rivoluzione francese i giacobini in Francia furono all’avanguardia nel reclamare la libertà e l’uguaglianza, la giustizia sociale e la sovranità popolare. Un programma fatto proprio da moltissimi italiani, confluiti in un movimento unitario che entrò in scena nel Triennio repubblicano (1796-1799), animando la nascita dell’associazionismo e del giornalismo politici.
 Il principale obiettivo del movimento era l’unificazione dell’Italia in un unico Stato repubblicano, democratico e costituzionale. Era la prima generazione del Risorgimento che avviava la sua lunga lotta, nel crogiolo politico e ideologico che vide forgiarsi le correnti protagoniste dei due secoli seguenti: il liberalismo, la democrazia, il repubblicanesimo, il socialismo, il comunismo, l’anticolonialismo, il femminismo.
Quel primo movimento politico italiano nascondeva al suo interno una società segreta, le Colonne della Democrazia, da cui sorse la misteriosa Società dei Raggi, la prima società segreta del Risorgimento sul cui tronco ne fiorirono altre, tra cui la più nota è la Carboneria.
Il libro racconta la nascita del movimento che diede avvio al Risorgimento, perseguendo un programma politico avanzatissimo attuato solo in parte con l’Unità d’Italia e più compiutamente - ma non appieno - realizzato dopo la Resistenza al nazi-fascismo e la Costituente." (cit.).
Il principale obiettivo del movimento era l’unificazione dell’Italia in un unico Stato repubblicano, democratico e costituzionale. Era la prima generazione del Risorgimento che avviava la sua lunga lotta, nel crogiolo politico e ideologico che vide forgiarsi le correnti protagoniste dei due secoli seguenti: il liberalismo, la democrazia, il repubblicanesimo, il socialismo, il comunismo, l’anticolonialismo, il femminismo.
Quel primo movimento politico italiano nascondeva al suo interno una società segreta, le Colonne della Democrazia, da cui sorse la misteriosa Società dei Raggi, la prima società segreta del Risorgimento sul cui tronco ne fiorirono altre, tra cui la più nota è la Carboneria.
Il libro racconta la nascita del movimento che diede avvio al Risorgimento, perseguendo un programma politico avanzatissimo attuato solo in parte con l’Unità d’Italia e più compiutamente - ma non appieno - realizzato dopo la Resistenza al nazi-fascismo e la Costituente." (cit.). -
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE --- LA "GRAZIA" (E LE "GRAZIE") DEGLI ANTICHI E IL "CARINO" DEI MODERNI. UNA NOTA DI FILOLOGIA SULLA "CRITICA DELL’ECONOMIA POLITICA".19 settembre 2024, di Federico La Sala
PER LA CRITICA DELL’ECONOMIA POLITICA E DELLA TEOLOGIA MAMMONICA:
IL"CARINO" DI UNO STUDENTE E IL "CERCATE ANCORA" DI CLAUDIO NAPOLEONI (1990)!
- STORIAELETTERATURA: "IL CAPITALE NON TRAMONTA MAI". Una nota a margine della recensione di Alfonso Maurizio Iacono ("Doppiozero", 19 settembre 2024) di "una nuova edizione con una nuova traduzione del I Libro di Il capitale, l’unico che Marx pubblicò (K. Marx, Il capitale, Libro I, Einaudi, Torino 2024, pp. 1287)":
- "Un giorno di tanti anni fa, nella sede della redazione di ‘Pace e Guerra’, la rivista diretta da Luciana Castellina, Stefano Rodotà e Claudio Napoleoni, quest’ultimo, professore di economia politica all’Università di Torino, ci raccontava che un suo studente, che aveva letto Il capitale di Marx e a cui aveva chiesto come l’aveva trovato, aveva risposto: “carino!”. Napoleoni andò su tutte le furie esclamando: “del Capitale non si può dire che è carino! È un libro che o ti sconvolge e ti lasci prendere dal suo argomentare oppure lo respingi!”. Napoleoni aveva ragione. Oggi nessuno osa dire che è carino e tuttavia i tentativi di imbalsamarlo tra i ‘classici’ o di presentarlo come superato e obsoleto non sono poi così diversi dall’affermazione dello studente di Napoleoni. Eppure, ogni qual volta esplode una crisi economico-sociale, Marx e, in particolare Il capitale, ritorna in circolazione. [...]" (cit.).
A CHE GIOCO GIOCHIAMO?! Ricordando ancora con stima la sollecitazione #critica di Claudio Napoleoni a non addormentarsi nel #sonnodogmatico dominante, mi permetto di #pensare che lo #studente, nella sua risposta, si riferisse al #costo economico del #libro (non al contenuto) e, al contrario, fosse molto pertinente! A ben riflettere, il "carino" avrebbe dovuto allarmare il prof. e fargli #apriregliocchi e le orecchie sulla "#doppiezza" della "#carità" cattolico-paolina, nel suo significato "mercantile" ("#caritas": "caro-prezzo" e "caro-affetto") e #accogliere con #grazia la ironica sottolineatura dello studente!
"SAPERE AUDE!" (KANT, 1784; MICHEL FOUCAULT, 1984))."Da dove iniziare, volendo recuperare, soprattutto ora, il pensiero e l’opera - complessa, molteplice, culturalmente alta - di Claudio Napoleoni?" (cfr. Lelio Demichelis, "Cercare ancora. Il capitalismo, la tecnica, l’ecologia e la sinistra scomparsa. L’attualità di Claudio Napoleoni", Economia&Politica, 26 Aprile 2020).
- NOTE:
- STORIA E FILOSOFIA: "LA MENTE ACCOGLIENTE. Tracce per una #svolta_antropologica" (Federico La Sala, Antonio Pellicani editore, Roma 1991): l’omaggio a Claudio Napoleoni e al suo "Cercate ancora" del 1990 (v. foto della pagina 7 - allegato).
- ANTROPOLOGIA, #ECONOMIA #POLITICA, #TEOLOGIA, E #FILOLOGIA: #CHARITAS (non #Caritas)! "Le #Cariti (in greco antico: #Χάριτες, #Chàrites) sono dee della mitologia greca, corrispondenti nella mitologia romana alle #Grazie (in latino: Gratiae). [...]" ( https://it.wikipedia.org/wiki/Cariti ).
- STORIA E SOCIETA’. [...] A quanto pare, la "musica" non è proprio cambiata e il "#carino" vale (ancora) sia per il discorso su "Fineschi e i suoi collaboratori" sia su "Il futuro del capitalismo: Crollo o sviluppo?" (di #Colletti e #Napoleoni, dell’editore Laterza del 1970, di ben 687 pagine). Il "circolo filologico" della #critica dell’#economia politica e della #religione "mammonica", a quanto pare, è chiuso e il #capitalismo (con il suo #Capitale) ha "vinto" il suo "e-terno al #lotto".
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- DISAGIO DELLA CIVILTA’ E STORIOGRAFIA: A CHE GIOCO GIOCHIAMO? DA DOVE VENGONO I BAMBINI?" (Emma Eckstein, 1900)18 settembre 2024, di Federico La Sala
USCIRE DALL’ORIZZONTE DELLA TRAGEDIA, CON DANTE E #FREUD: INVERTIRE IL #PRESENTE...
- "TRASUMANAR" (DANTE ALIGHIERI") E "GATTARE" (E "GATTONARE"), OGGI (2024): DUE VERBI CHE ILLUMINANO IL #GIOCO DEL "GATTO" E DEL "TOPO" E CHIARISCONO LA #QUESTIONEANTROPOLOGICA (KANT, 1800):
DA DOVE VENGONO I BAMBINI?" (Emma Eckstein) E #COMENASCONOIBAMBINI (Sigmund Freud, 1937)?
- NEL SEGNO DELL’ ANGUILLA, DELL’ #UOMO DEI #TOPI, E DELLE "COSTRUZIONI NELL’ANALISI" E DELL’ "ANALISI TERMINABILE E INTERMINABILE" (S. #FREUD, 1937), UN OMAGGIO A UNA "#SARTA" ("#TAYLOR") "#VELOCE" ("#SWIFT").
Sul piano dell’antropologia, delle tradizioni linguistiche e popolari, e della psicologia (e dell’amletico "marcio nello stato di Danimarca"), partendo dal "#gattonare" dei bambini e delle bambine e, passando dal "#gattaro" e dalla "#gattara", c’è da pensare anche al #verbo "gattare" e, infine, alla simulazione giocosa della "#Mousetrap" realizzata da Amleto e Ofelia nell’opera di #Shakespeare, per smascherare chi ha distrutto la "trappola per topi" realizzata dal "Re Amleto" e dalla "Regina Gertrude" nel loro #giardino e ucciso il Re! Non è meglio rileggere l’opera di Shaespeare e celebrare la #memoria di Santa Gertrude di Nivelles?!
- NOTE:
- "METAMORFOSI" (#OVIDIO) E "#DIVINA COMMEDIA": "#TRASUMANAR" (Par., I. 70). #Dante Alighieri, a quanto risulta, ha ben riflettuto sia su "#Ulisse e #Penelope" sia su "#Giasone e #Medea", come su "#Edipo e #Giocasta", e ha saputo trovare l’uscita antropologica dall’orizzonte "olimpico" della "#tragedia", dalla "#caduta" all’inferno: egli non ha fatto naufragio. Forse è bene tenerne conto.
- PENSARE L’#EDIPO #COMPLETO: CON FREUD, OLTRE #FREUD. Ancora oggi, con Euripide, è possibile sentire l’ #urlo di #Medea, che, con determinazione assoluta ("Medea" - io sono; "#Nessuna" - io sono), denuncia il #patto sociale-storico del "#compromesso edipico" della #tragedia ("#Madre-Figlio" /"#Giocasta-Edipo") e sollecita a sciogliere il #nodo di #Ercole. #Euripide, ovviamente non fa altro che #negare e ridurre il tutto a una “mera questione di letto” (Eur. Med., 1323 ss.) e a un comportamento contro "natura" ( (Eur. Med., 1279-1292) ), ma il problema è proprio questo, insieme, di "#natura" e di "#letto". A mio parere, non solo Freud, ma anche #Bachofen, è da rileggere, se si vuole #comprendere bene #comenasconoibambini.
- DISAGIO DELLA CIVILTA’ E STORIOGRAFIA: A CHE GIOCO GIOCHIAMO? COME IL #PRINCIPIO ANTROPOLOGICO E’ STATO DECLINATO DALL’ #ANDROCENTRISMO (PLATONICO-PAOLINO ED HEGELIANO), NEI SECOLI DEI SECOLI, FINO A DIVENTARE "PRINCIPIO #ANTROPICO", IN UNA SINTETICA "#PIRAMIDE" RINASCIMENTALE PROPOSTA DAL "#SAPIENTE" (1510) DI #BOVILLUS (v. allegato).
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- CHI INSEGNA A CHI CHE COSA COME?! COME NASCONO I BAMBINI (LE IDEE, E I SOGNI): "SAPERE AUDE!".9 settembre 2024, di Federico La Sala
CHI INSEGNA A CHI CHE COSA COME?! INSEGNAMENTO E COSTITUZIONE: CHI INSEGNA AI MAESTRI E ALLE MAESTRE A INSEGNARE?!
- SCUOLA E SOCIETA’. Una nota a margine di un nodo non sciolto della #storia delle #idee e dei #sogni... *
L’ALGORITMO DELLA TRAGEDIA (SOCRATE-PLATONE-PAOLO DI TARSO-HEGEL) E LA QUESTIONE ANTROPOLOGICA POSTA DA KANT ("LOGICA", 1800). L’autonomia dello apprendimento e l’#apprendimento dell’autonomia, concepito l’una e l’altro, secondo le indicazioni dell’#illuminismo kantiano (1784), a mio parere, riposa sul #coraggio ("aude") del servirsi della propria intelligenza, sulla propria #capacità e sulla propria #volontà di "mangiare" e "bere" ("#sàpere") da parte dell’alunno e dell’alunna, e non sulla #maieutica di un Socrate che gioca a "sapere di non sapere" con l’alunno-schiavo ("#Menone") a dargli lezioni sul "non sapere di sapere"!
COME NASCONO I BAMBINI (LE IDEE, E I SOGNI): "SAPERE AUDE!". Il "problema Socrate", posto da #Nietzsche e nonostante Nietzsche, è del tutto ignorato e la sollecitazione di Michel Foucault a ripensare il rapporto "illuminismo e critica" (1984) è ancora fuori dall’agenda dei lavori del mondo della "platonica" Accademia e dell’"aristotelico" Liceo: che il trecentesimo anniversario della nascita di Kant (1724-2024) possa essere una buona occasione per cominciare!
- NOTE:
- STORIA E #FILOSOFIA: "ILLUMINISMO E CRITICA" (di Michel Foucault).
- STORIA STORIOGRAFIA E SCUOLA: "INSEGNAMENTO E POTERE" ( di Alfonso Maurizio Iacono, "Doppiozero", #8settembre 2024).
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- UNA "RIVOLUZIONE COPERNICANA" IN MEDICINA ("SILENZIATA"): LA "LEZIONE" DI MICHELANGELO, REALDO COLOMBO, E JUAN AMUSCO DE VALVERDE.29 agosto 2024, di Federico La Sala
MICHELANGELO, I PROFETI, LE SIBILLE, E LE "STREGHE" DI BENEVENTO: CONTRORIFORMA E CONTRORINASCIMENTO.
- UNA IPOTESI DI "LETTURA" DELLA FIGURA DI SAN #BARTOLOMEO, NEL "GIUDIZIO UNIVERSALE" DELLA "#CAPPELLASISTINA".
ANTROPOLOGIA CULTURALE #ARTE E #STORIA. A lume di #antropologia storica e "#immaginazione sociologica", si può ben pensare che Michelangelo (associandosi al santo patrono di Benevento, all’apostolo Bartolomeo, con la "#sindone" del suo "#autoritratto": ), nel #GiudizioUniversale, protestava "cristianamente", contro la #gerarchia di un #cattolicesimo istituzionalizzato (assetato di potere, all’ombra e al servizio del dio "#Mammona", incapace di accogliere le sollecitazioni della #Riforma Luterana e Anglicana), che aveva rifiutato la proposta di far camminare insieme profeti e sibille, come da chiara indicazione ecumenica e "francescana, nella "Volta" della #CappellaSistina e nel "#presepe" del #TondoDoni) e contro l’equiparazione di #janare e #sibille (come da tradizione "cattolica", delle "streghe", che si riunivano presso l’antico albero di "noce di benevento", per il famoso "concerto" sabbatico.
- NOTE:
- STORIA E STORIOGRAFIA: ROMEO DE MAIO, "#MICHELANGELO E LA #CONTRORIFORMA (Editori Laterza, 1978)
- RIVOLUZIONESCIENTIFICA, MEDICINA, E ARTE: #GIOVANNIVALVERDE. L’omaggio del medico Juan Amusco de Valverde, IN UNA TAVOLA del suo manuale di "ANATOMIA DEL CORPO UMANO" (1560), A "MICHELANGELO - BARTOLOMEO):
 MICHELANGELO COME VALVERDE ERANO ALLIEVI E COLLABORATORI DEL MEDICO, ANATOMISTA E SCIENZIATO, REALDO COLOMBO.
MICHELANGELO COME VALVERDE ERANO ALLIEVI E COLLABORATORI DEL MEDICO, ANATOMISTA E SCIENZIATO, REALDO COLOMBO.
- ANTROPOLOGIA, MEDICINA, E RICERCA SCIENTIFICA: I "TESTICOLI" DELLE #DONNA E LA "COGLIONERIA" DELL’#UOMO, OVVERO ANCHE LE #DONNE HANNO LE "PALLE". L’ammissione (v. allegato) di #GiovanniValverde, "#Anatomia" (Roma, 1560).
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- IL NODO DI GORDIO, ALESSANDRO MAGNO, E DIOGENE DI SINOPE. Nota su "La testura del sistema. La relazione nel pensiero di Gregory Bateson"(di Lucilla Ruffilli e Giulia Testi).28 agosto 2024, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA (KANT), COSMOTEANDRIA, E "PREISTORIA" (#MARX): IL "NODO GORDIANO" DELLA STORIA D’EUROPA.
- IL NODO DI GORDIO (DEL RE MIDA), ALESSANDRO MAGNO (LA FIGURA DEL #SUPERUOMO, DELL’UOMO SUPREMO, DEL #FIGLIO DI DIO "#AMMON" ("#ZEUS") E "#MAMMONA"), E I "#CATTOLICISMI" (ATEI E DEVOTI) DELLA #STORIA DELL’#EUROPA (#NICEA 325-2025): RICONSIDERARE TUTTO A PARTIRE DALLA LEZIONE (ANCHE DI #SOCRATE, #PLATONE, #ARISTOTETELE, #PAOLODITARSO, E #COSTANTINO IL GRANDE, MA SOPRATTUTTO) DI #DIOGENE DI SINOPE (E DALLA SUA "SOLARE" RISPOSTA AD ALESSANDRO MAGNO). SE NON ORA, QUANDO? (v. commenti).
"RIFLESSIONI SISTEMICHE" (AIEMS - Associazione Italiana di Epistemologia e Metodologia Sistemiche). Una nota a margine della ripresa lodevolissima di una sollecitazione batesoniana a ripensare criticamente il "patrimonio" (del "matrimonio" ) della "caduta" biblica e della "cronica" tradizione "olimpica".
"La testura del sistema. La relazione nel pensiero di Gregory Bateson"(cfr. Lucilla Ruffilli e Giulia Testi, "Riflessioni Sistemiche", N° 30 - "Relazioni e cura", giugno 2024):
"[...] Nel 1970 Bateson propone una idea forte, la ’flessibilità’. [...] Anche una cultura è un sistema adattativo, se una società sopravvive diciamo che la sua cultura è adattativa. Ma può darsi invece che la società vada verso l’autodistruzione. [...] Questo ci dovrebbe dar da pensare, suggerire di concentrarci non sul problema degli adattamenti immediati, ma sui cambiamenti a lunga scadenza. Chiederci se questo adattamento è davvero tale che lo possiamo sopportare. [...]. È adattativo abituarsi a sciogliere il nodo gordiano con la violenza del taglio?
 Scrive Nora #Bateson:
Scrive Nora #Bateson: - “La storia del Nodo Gordiano: è un mito che corre come una sorta di rete sotterranea di correnti circuitali, che affiora invisibilmente attraverso le decisioni e soluzioni degli ultimi 3000 anni di storia, permeando la politica e il linguaggio, l’eroismo e la filosofia, la tecnologia, la medicina, l’economia, l’architettura, l’agricoltura ecc...
 Le storie, i poemi, i miti, debbono essere rivisitati, e talvolta reinterpretati.
Le storie, i poemi, i miti, debbono essere rivisitati, e talvolta reinterpretati.
 Alessandro il Grande potrebbe aver combinato un grande pasticcio.
Alessandro il Grande potrebbe aver combinato un grande pasticcio.
 La storia è che re Mida aveva donato ai Frigi un cocchio che era legato a un palo. Il nodo che legava il cocchio non aveva una fine, un capo. Nessuno lo poteva sciogliere, e si sparse la fama che si trattava di un puzzle che solo un futuro grande capo avrebbe potuto risolvere.
La storia è che re Mida aveva donato ai Frigi un cocchio che era legato a un palo. Il nodo che legava il cocchio non aveva una fine, un capo. Nessuno lo poteva sciogliere, e si sparse la fama che si trattava di un puzzle che solo un futuro grande capo avrebbe potuto risolvere.
 Nel 333 A.C. Alessandro il Grande pose mano alla soluzione del puzzle, (perché avrebbe portato sfortuna non farlo), ma non riuscì a sciogliere il nodo. Alla fine chiese se rispetto a come farlo ci fossero delle regole, e risultò che non ce ne erano, così...
Nel 333 A.C. Alessandro il Grande pose mano alla soluzione del puzzle, (perché avrebbe portato sfortuna non farlo), ma non riuscì a sciogliere il nodo. Alla fine chiese se rispetto a come farlo ci fossero delle regole, e risultò che non ce ne erano, così...
 Con un solo colpo di spada Alessandro tagliò il nodo, liberò il cocchio e ingarbugliò il nostro modo di pensare. Compenso a breve termine, danno a lungo termine, e avidità al posto della curiosità (Bateson N., 2013 www.circolobateson.it).
Con un solo colpo di spada Alessandro tagliò il nodo, liberò il cocchio e ingarbugliò il nostro modo di pensare. Compenso a breve termine, danno a lungo termine, e avidità al posto della curiosità (Bateson N., 2013 www.circolobateson.it).
 Il mito è arrivato fino a noi, portato dalla sabbia del tempo, con il culto della Madonna che scioglie i nodi.
Il mito è arrivato fino a noi, portato dalla sabbia del tempo, con il culto della Madonna che scioglie i nodi.
 (statua della Madonna che scioglie i nodi nella basilica dei Santi Vitale, Valeria, Gervasio e Protasio al Quirinale) [...]" (cfr. Lucilla Ruffilli e Giulia Testi, "Riflessioni Sistemiche", N° 30 - "Relazioni e cura", giugno 2024).
(statua della Madonna che scioglie i nodi nella basilica dei Santi Vitale, Valeria, Gervasio e Protasio al Quirinale) [...]" (cfr. Lucilla Ruffilli e Giulia Testi, "Riflessioni Sistemiche", N° 30 - "Relazioni e cura", giugno 2024).- NOTE:
- Storia, #Filosofia, e #Storiografia: "Incontro tra #Diogene di #Sinope e #Alessandro Magno".
- ARTE, STORIA, E ANTROPOLOGIA: RICORDO DI FRANCESCO DI ASSISI E DEL SUO PRESEPE (GRECCIO, 1223).
- ANDROCENTRISMO E RINASCIMENTO DA "TRAGEDIA" (DI LUNGA DURATA): LA #SINTESI DELLA #TEORIA PLATONICO-ARISTOTELICA DEL "#SAPIENTE" (#BOVILLUS, 1510), #CRITICA-#MENTE AL CENTRO DEL LAVORO DI #STEFANOMANCUSO E #ALESSANDRAVIOLA, "#VERDEBRILLANTE. SENSIBILITà E INTELLIGENZA DEL MONDO VEGETALE" (Giunti Editore).
- GREGORY BATESON E IL PROBLEMA DEL "NOSTRO #SISTEMA GLOBALE": "Dice il proverbio che quelli che abitano in una casa di vetro, soprattutto se vi abitano con altri, dovrebbero pensarci bene prima di tirarsi dei sassi; e penso che sia opportuno ricordare a tutti gli occidentali che leggeranno questo saggio che essi vivono in una casa di vetro insieme con la professione medica, con la religione cristiana, con la rivoluzione industriale e con il sistema educativo di cui gli altri sono un prodotto. In altre parole, noi tutti abbiamo in comune un groviglio di presupposizioni, molte delle quali hanno origini antiche. A mio parere, i nostri guai affondano le radici in questo groviglio di presupposizioni, molte delle quali sono insensate. Invece di puntare il dito contro questa o quella parte del nostro sistema globale (i dottori malvagi, gli industriali malvagi, i professori malvagi), dovremmo esaminare le basi e la natura del sistema"(G. Bateson, "Sintomi, sindromi e sistemi", 1978)
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- "CERCARE L’AGO NEL PAGLIAIO": UN "GIOGO" DI SOCIETÀ, AL SERVIZIO DELLA "PACE PERPETUA". Una nota in memoria di Kant.16 agosto 2024, di Federico La Sala
PIANETA TERRA (PROMESSA), ONU (=UNO), E "UmaNITÀ" ("HUMANITAS"):
PROFEZIA, ANTROPOLOGIA, E TEOLOGIA-POLITICA.
- Una nota "per la pace perpetua". In #memoria di #Immanuel #Kant (1724-1804).
SE E’ VERO CHE "DA TEMPO I PROFETI PARLANO A UNA CITTA’ CHE NON LI VUOLE PIU’ ASCOLTARE!" (Nicola Fanizza), E’ ALTRETTANTO VERO CHE, DA #TEMPO, DA MOLTO TEMPO, nonostante tutta la #storia (già solo quella) dell’#arte e, in particolare, la grande lezione di #Michelangelo #Buonarroti, che sapeva anche di #anatomia e di "vecchio" e "nuovo" #testamento" , è anche colpa dei #PROFETI che hanno "silenziato" le #Sibille, hanno buttato via la #bilancia (Vermeer ), e vogliono continuare a "pesare" solo "l’ #oro"!!!
CON DANTE ALIGHIERI, GIORDANO BRUNO, GALILEO GALILEI, SPINOZA, FREUD, ED EINSTEIN, #OLTRE. Senza #Kant, solo milioni di milioni di "mille piani", vecchi "ritornelli", e "dotta ignoranza" (1440) a volontà.
NOTE:
- ANTROPOLOGIA ANATOMIA E STORIA: "COME NASCONO I BAMBINI".
- IL "TONDO DONI" E LA "PROFEZIA" DELLA "SIBILLA LIBICA" DI MICHELANGELO BUONARROTI:
- «[...] Uterus Matris erit #statera cunctorum. ("L’utero della Madre sarà la #bilancia di tutti gli esseri umani"».
- IPOTESI. Del dipinto "#Pesatrice di perle" (o "#Donna con una #bilancia) di Jan #Vermeer (databile al 1664 e conservato nella National Gallery of Art di Washington), anche alla luce del fatto che dentro il quadro c’è rappresentato un altro quadro - un dipinto con un #GiudizioUniversale - c’è da pensare, probabilmente, che la figura della donna in avanzato stato di #gravidanza rimandi alla figura della "Sibilla Libica" (raffigurata da tantissimi artisti e, in particolare, da Michelangelo nella #CappellaSistina) e al suo specifico #annuncio del #messaggio evangelico, e comunichi il rapporto che esiste tra la #bilancia (la #giustizia e l’#equilibrio), il #grembo (il #concepimento), e la nascita di un #bambino, una #bambina - una #maestra, un #maestro di #umanità...
- IPOTESI. Del dipinto "#Pesatrice di perle" (o "#Donna con una #bilancia) di Jan #Vermeer (databile al 1664 e conservato nella National Gallery of Art di Washington), anche alla luce del fatto che dentro il quadro c’è rappresentato un altro quadro - un dipinto con un #GiudizioUniversale - c’è da pensare, probabilmente, che la figura della donna in avanzato stato di #gravidanza rimandi alla figura della "Sibilla Libica" (raffigurata da tantissimi artisti e, in particolare, da Michelangelo nella #CappellaSistina) e al suo specifico #annuncio del #messaggio evangelico, e comunichi il rapporto che esiste tra la #bilancia (la #giustizia e l’#equilibrio), il #grembo (il #concepimento), e la nascita di un #bambino, una #bambina - una #maestra, un #maestro di #umanità...
- VITAEFILOSOFIA #COMENASCONOIBAMBINI, COME NASCONO LE #IDEE, COME NASCONO I #SOGNI?
- RILEGGERE PLATONE ("SIMPOSIO")! #DIOTIMA DI #MANTINEA SOLLECITA "SAN #SOCRATE" (#ERASMO) AD ANDARE DIRETTAMENTE A #DELFI E A NON #CREDERE DI CREDERE AGLI AMICI CHE LO HANNO ELETTO IL PIù #SAGGIO DI TUTTI: E’ ANCORA UN "PERFETTO FILOSOFO!" (COME #EROS, AVIDO, CIECO E PREPOTENTE) E NON CONOSCE SE’ STESSO! ( v. allegato: una "citazione" dal mio lavoro, "La #menteaccogliente. Tracce per una #svolta_antropologica", #AntonioPellicani, Roma 1991).
- ANTROPOLOGIACULTURALE E #FILOLOGIA-#POLITICA AL SERVIZIO DELL’#OCCIDENTE (325 -2025).
- UN "GIOGO" DI #SOCIETÀ: "CERCARE L’#AGO NEL #PAGLIAIO".
- Foto allegata:
 A) "CHERCHEZ LES FEMMES",
A) "CHERCHEZ LES FEMMES",
 B) "TROUVÉES: AU DERNIER RANG!"
B) "TROUVÉES: AU DERNIER RANG!"
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- MITO E TRAGEDIA: "L’UOMO GRECO" (NICOLE LORAUX), "THE MOUSETRAP" (SHAKESPEARE, "HAMLET"), E "L’UOMO DEI TOPI" (FREUD).12 agosto 2024, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA, MITO, STORIA, E LETTERATURA:
"IL FEMMINILE E L’UOMO GRECO" (NICOLE LORAUX). Un omaggio e una nota a margine del lavoro di Nicole Loraux (1943-2003).
- A memoria di William Shakespeare, a Immanuel Kant, a Sigmund Freud, a Franca Ongaro Basaglia, e a Gianni Vattimo...
"SAPERE AUDE!" (KANT, 1724-2024). MUOVENDO dal lavoro della brillantissima Nicole Loraux ("Il femminile e l’uomo greco", Laterza 1991, e, Mimesis Edizioni 2024) e, in particolare, dalla sua indicazione, legata alla figura di Tiresia, che «l’uomo non è mai tanto uomo come quando ha qualcosa della donna dentro di sé», forse, è possibile orientarsi meglio sia sui temi fondamentali della sua ricerca storico-antropologica sia del problema del "chi siamo noi, in realtà" (Nietzsche).
COME IN CIELO ("URANO") COSI’ IN TERRA ("GAIA"): MITO E TRAGEDIA (EDIPO). Riconsiderando, il legame tragico (edipico) codificato giuridicamente e teologicamente già nel (prei)storico "compromesso celeste", a partire dal salvataggio e dalla messa in sicurezza da parte della #Madre-#Regina - #Rea, di "#Zeus", del #Figlio, dalle fauci dello Sposo, il Padre-Re #Crono e, poi, nel "compromesso olimpico", dal "matrimonio" tra il "Padre -Re" (Zeus) e la "Madre -Regina" (#Era), rileggere #Amleto (Shakespeare) e riprendere a tutti i livelli la sollecitazione di #Freud (con le "parole" di Era, relative all’Acheronta movebo, citate all’inizio della "Interpretazione dei sogni", bene in mente) di pensare "l’edipo completo", rianalizzare il suo lavoro relativo a "L’uomo dei topi" (e fare attenzione alle sue riflessioni sul "#matriarcato" e sul "#patriarcato") e capire cosa significa la "trappola per topi" ("The Mousetrap") di Amleto ed Ofelia per il "Padre-Re" e la "Madre-Regina" (Shakespeare). Forse, solo così, è possibile ricominciare a pensare sul #comenasconoibambini e a un’altra "Storia universale della natura e teoria del cielo" (Immanuel Kant, 1755).
NOTE:
- STORIA E LETTERATURA E ANTROPOLOGIA FILOSOFICA (#KANT, 1800): "IL SOGGETTO E LA MASCHERA. NIETZSCHE E IL PROBLEMA DELLA LIBERAZIONE" (GIANNI #VATTIMO, 1974).
- FILOLOGIA CRITICA E "NASCITA DELLA TRAGEDIA": SHAKESPEARE E UNA "CITAZIONE" EVANGELICA. PER AMLETO ("CRISTO"), LA "CASA DEL PADRE" CON LE SUE "MOLTE DIMORE" (Gv. 14, 2) E’ DIVENTATA UNA "PRISON" (UNA PRIGIONE):
- Hamlet: Denmark’s a prison.
 Rosencrantz: Then is the world one.
Rosencrantz: Then is the world one.
 Hamlet: A goodly one, in which there are many large confines, / wards, and dungeons, Denmark being one o’th’worst." ("Hamlet", II. 2. 242-245).
Hamlet: A goodly one, in which there are many large confines, / wards, and dungeons, Denmark being one o’th’worst." ("Hamlet", II. 2. 242-245).
- FREUD CON SHAKESPEARE, ALLA RICERCA DELLA VIA OLTRE IL "MATRIARCATO" E IL "PATRIARCATO". Contrariamente a quanto si pensa, la lunga ricerca di Freud, se può apparire (come è apparso per lo più fino ad ora) segnata dalla figura di #Edipo e #Giocasta, dall’altra è molto prossima a quella di #Amleto (#Hamlet), dalla volontà e dal progetto di chiarirsi le idee su di sé, e di suo #Padre - di chi è veramente #Figlio: la sua opera, una vera e propria "trappola per topi" ("The Mousetrap").
 Egli, in verità, è andato (come si sa) a "scuola" da Shakespeare, e il problema della sua vita, come quello di Shakespeare, è stato quello di contribuire a sciogliere il #nodo di #Ercole, il nodo del#nascere, del #comenasconoibambini, alla base della #nevrosi #ossessiva, non solo del "caso" dell’uomo dei #topi (1909), ma "della civiltà" e "nella civiltà", e contrastare il dilagare alluvionale del "marcio nello stato di #Danimarca".
Egli, in verità, è andato (come si sa) a "scuola" da Shakespeare, e il problema della sua vita, come quello di Shakespeare, è stato quello di contribuire a sciogliere il #nodo di #Ercole, il nodo del#nascere, del #comenasconoibambini, alla base della #nevrosi #ossessiva, non solo del "caso" dell’uomo dei #topi (1909), ma "della civiltà" e "nella civiltà", e contrastare il dilagare alluvionale del "marcio nello stato di #Danimarca".
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- CHI E’ "AMLETO" E CHI "OFELIA"? Prima dei Promessi Sposi", una domanda "solare" nell’Europa della rivoluzione copernicana6 agosto 2024, di Federico La Sala
STORIA, LETTERATURA, ANTROPOLOGIA, E METATEATRO:
IL "VANGELO" DI SHAKESPEARE. CHI E’ AMLETO ("Gesù") E CHI OFELIA ("Maria Maddalena)?
Una domanda "solare" nell’Europa della rivoluzione copernicana, di Tommaso Campanella e di Giordano Bruno ...
- Una nota a margine del lavoro di "archeologico" in progress di Paul Adrian Fried (cfr. "Part 57: My favorite things about Ophelia - August 05, 2024").
SE, NELLO "STATO DI DANIMARCA", IL "NUOVO" RE-PADRE (CLAUDIO) DI TUTTI I CITTADINI E DI TUTTE E’ UN ASSASSINO E UN ADULTERO (COME SOTTOLINEA ANCHE #NIETZCHE IN "#ZARATHUSTRA"), IL FIGLIO-PRINCIPE DEL "VECCHIO" RE-PADRE ("AMLETO"/"GIUSEPPE") E DELLA "VECCHIA" REGINA-MADRE ("GERTRUDE"/"MARIA"), NON PUO’ NON RICORDARSI DELLA SUA #IDENTITÀ E CONTESTARE RADICALMENTE IL SUO RUOLO DI "FIGLIO-PRINCIPE" DELLA "NUOVA" #FAMIGLIA E DEL "NUOVO" #PRESEPE... E NON PUO’ NON FARE IL "PAZZO"!
ALL’INTERNO DI TALE "QUADRO", LA "RISPOSTA" DI #OFELIA AL "RE CLAUDIO":
- "Well, God ’ild you! They say the owl was a #baker’s / #daughter. Lord, we know what we are, but / #know not what we may #be. God be at your #table!" [Bene, Iddio vi aiuti! Dicono che la civetta era figlia di un fornaio. Signore, noi sappiamo quello che siamo, ma non sappiamo quello che possiamo essere: Dio sia alla vostra mensa! (Hamlet, IV.5. 42-44),
APPARE ESSERE CON I SUOI RIMANDI SIA ESPLICITI, COME A QUELLO DELLA "CIVETTA" FIGLIA DEL #FORNAIO (#PANETTIERE), SIA IMPLICITI, COME A QUELLO DEL "PAZZO" FIGLIO (#AMLETO - #CRISTO) DEL "#DIO - #PANETTIERE" ("#PADRE #NOSTRO" E "#RE NOSTRO"), CHE DÀ IL SUO "PANE QUOTIDIANO" (LA #CHARITAS, IL CIBO "EU-#CHARIS-TICO" A TUTTI ("By Gis and by Saint #Charity,", IV. 5. 59), SEMBRANO DELINEARE (ANCHE CON IL RICHIAMO ALLA FESTA DI "SAN VALENTINO") UNA "FIGURA" DI GRANDE AUTONOMIA E DI FORTE CONSAPEVOLEZZA NEL SUO RUOLO DI "#HAMLETICA" FIGLIA-PRINCIPESSA, COME DI UNA POSSIBILE NUOVA "#EVA" ACCANTO AL POSSIBILE NUOVO "#ADAMO".
L’#AMORE "CHE MOVE IL SOLE E LE ALTRE STELLE", IL "PANE QUOTIDIANO" E IL "SÀPERE AUDE" (IL "CORAGGIO DI ASSAGGIARE" DI #ORAZIO E #KANT). DOPO #LUTERO (1517) E DOPO IL RE #ENRICO VIII (1534) E LA REGINA #ELISABETTA DI #INGHILTERRA (1533-1603), SHAKESPEARE riprende il filo di Gioacchino da Fiore, di Francesco d’#Assisi, di Dante Alighieri, Michelangelo, e #GiordanoBruno, e guarda ben oltre la "donazione di #Costantino" (#Nicea 325-2025), e oltre il "#presepe" della tragica e "cattolica" #preistoria del suo tempo.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- A LEZIONE DA SHAKESPEARE. IL CASO DEL "PIFFERARIO" DELLO "STATO DI DANIMARCA" E "THE MOUSETRAP" ("LA TRAPPOLA PER TOPI") DI "AMLETO"8 luglio 2024, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA, STORIA, E METATEATRO (SHAKESPEARE).
"THE MOUSETRAP" ("LA TRAPPOLA PER TOPI") DI "AMLETO" E IL CASO DEL "PIFFERARIO" DELLO "STATO DI DANIMARCA".
"SAPEREAUDE!" (Q. ORAZIO F. ; KANT, 1784; M. FOUCAULT, 1984). AL DI LA’ DEL MACHIAVELLISMO E DELL’ #ANDROCENTRISMO TEOLOGICO-POLITICO PLATONICO-PAOLINO, a mio parere, ciò che resta del "discorso filosofico della #modernità" (J. Habermas), come ha riepilogato Kant alla fine del suo lungo lavoro di critica delle pretese della "olimpica" #ragione "pura", è proprio quanto indicava quel "Socrate pazzo" di Diogene ("Amleto"): la domanda antropologica, vale a dire il gioco del "gatto" e del "topo" (Shakespeare, "Hamlet", III. 4. 203-212), la questione "hamletica" del "come nascono i bambini" (e non solo)!
NOTE:
- STORIA FILOSOFIA E LETTERATURA: "DIALOGO SOPRA I DUE MASSIMI SISTEMI DEL MONDO" (GALILEO, 1632).
 RICONSIDERARE #UmaNA-MENTE, ANTROPOLOGICA-#MENTE, "LA NOSTRA #SEMENZA" (INF. XXVI, 118) E PORTARSI AL DI LA’ DEL "MARCIO NELLO STATO DI DANIMARCA" (SHAKESPEARE), FUORI DALL’ #INFERNO EPISTEMOLOGICO, E RIPRENDERE LA #NAVIGAZIONE NELL’#OCEANOCELESTE (#KEPLERO A #GALILEOGALILEI, 1611).
RICONSIDERARE #UmaNA-MENTE, ANTROPOLOGICA-#MENTE, "LA NOSTRA #SEMENZA" (INF. XXVI, 118) E PORTARSI AL DI LA’ DEL "MARCIO NELLO STATO DI DANIMARCA" (SHAKESPEARE), FUORI DALL’ #INFERNO EPISTEMOLOGICO, E RIPRENDERE LA #NAVIGAZIONE NELL’#OCEANOCELESTE (#KEPLERO A #GALILEOGALILEI, 1611).
- STORIA FILOSOFIA E LETTERATURA: "DIALOGO SOPRA I DUE MASSIMI SISTEMI DEL MONDO" (GALILEO, 1632).
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- UNA TRAGEDIA DI LUNGA DURATA. Una nota a margine di cinquecento anni di vita europea, all’ombra della dotta ignoranza e della boria delle nazioni.23 giugno 2024, di Federico La Sala
STORIA DELL’ARTE, DELLA RELIGIONE, DELLA FILOSOFIA:
FEDE E PROPAGANDA DELL’ANDROCENTRISMO RINASCIMENTALE (PLATONICO-PAOLINO).
- UNA TRAGEDIA DI LUNGA DURATA. Una nota a margine di cinquecento anni di vita europea, all’ombra della #dottaignoranza e della boria delle nazioni...
"DE HOMINIS DIGNITATE" (PICO DELLA MIRANDOLA, 1496). Se la cultura europea (laica e religiosa) continua, ieri come oggi, a orientarsi nel pensiero e nella realtà, secondo l’instaurazione teologico-politica "olimpica" (al seguito di #Apollo e di #Atena), «non è la madre la generatrice di quello che è chiamato suo figlio; ella è la nutrice del germe in lei inseminato. Il generatore è colui che la feconda...» (Eschilo, "Eumenidi"), e a celebrare acriticamente la tradizione filosofica della "Scuola di Atene" (Raffaello Sanzio, 1509-1511) e la "mappa mentale" del "De Sapiente" (1510) di Charles de Bovelles - Bovillus, come è possibile uscire dall’orizzonte "edipico" della tragedia e, con la sollecitazione e la guida dell’eretico #DanteAlighieri, uscire dallo storico inferno (antropologico ed epistemologico, teologico e politico) "dell’autunno del medioevo" e dell’ uomo del rinascimento?!
ANTROPOLOGIA, PSICOANALISI, E DIRITTO (COSTITUZIONE). Se è vero, come riconosce Sigmund Freud nel 1909 (nell’affrontare il caso dell’«uomo dei topi»), che "un gran progresso della civiltà si compì il giorno in cui l’uomo decise di avvalersi, accanto alla testimonianza dei sensi, della deduzione logica e di passare dal #matriarcato al #patriarcato", è altrettanto vero, come aveva già pensato e anticipato Bachofen nel 1861 (nell’anno stesso della Proclamazione del Regno d’Italia e del primo anniversario dell’Unità d’Italia, come da sottolineatura di Eva Cantarella), che, "[...] svincolandosi da ogni zavorra o mistura materiale, il diritto diventa #amore. Proprio l’amore è il diritto supremo, la legge più alta" (J. J. Bachofen, "Il matriarcato. Ricerca sulla ginecocrazia nel mondo antico nei suoi aspetti religiosi e giuridici").
Note:
- ANTROPOLOGIA CULTURALE E STORIA: BACHOFEN E "IL MATRIARCATO".
- ANTROPOLOGIA E CIVILTA’: ANATOMIA E COSTITUZIONE DELL’UOMO E DELLA DONNA. RIPRENDERE IL FILO DALLA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA IN #MEDICINA E ACCOGLIERE L’AMMISSIONE DI GIOVANNI AMUSCO DE VALVERDE (1560):
"Avrei voluto con mio honore poter lasciar questo capitolo, accioche non diventassero le Donne più superbe di quel, che sono, sapendo, che elleno hanno anchora i testicoli, come gli uomini; e che non solo sopportano il travaglio di nutrire la creatura dentro suoi corpi, come si mantiene qual si voglia altro seme nella terra, ma che anche vi pongono la sua parte, e non manco fertile, che quella degli uomini, poi che non mancano loro le membra, nelle quali si fa; pure sforzato dall’historia medesima non ho potuto far altro. Dico adunque che le Donne non meno hanno testicoli, che gli huomini, benche non si veggiano per esser posti dentro del corpo [...]: così inizia il cap. 15 del Libro III dell’ Anatomia di Giovanni Valverde, stampata a Roma nel 1560, intitolato “De Testicoli della Donna” (p. 91).
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- ARTE, FILOLOGIA, E STORIOGRAFIA. RIFLESSIONI A MARGINE DI "DUE BACI" DELLA TRADIZIONE EVANGELICA CHE HANNO SEGNATO L’IMMAGINARIO DELL’EUROPA.12 giugno 2024, di Federico La Sala
PIANETATERRA, DISAGIO NELLA #CIVILTA’ (1929) E "COSTRUZIONI NELL’ANALISI" (S. #FREUD, 1937).
Una nota sul tema della questione antropologica e sul #corpomistico dell’#uomosupremo, nel trecentesimo anniversario della nascita di Immanuel Kant (1724-2024).
ALCUNE RIFLESSIONI ICONOLOGICHE SU DUE BACI CHE HANNO SEGNATO L’IMMAGINARIO E LA STORIA DELL’#EUROPA. TRADIZIONE, "TRADUZIONE", E RAPPRESENTAZIONE ARTISTICA...
IL BACIO DELL’APOSTOLO PIETRO E DELL’«APOSTOLO» PAOLO, ICONOGRAFICAMENTE E FILOLOGICAMENTE, RICHIAMA IL PROBLEMATICO "NODO" DEL BACIO DI GIUDA A GESU’ RAPPRESENTATO DA GIOTTO E, SIMBOLICAMENTE E STORICAMENTE, LA NASCITA DEL #PAOLINISMO E DELLA RELIGIONE IMPERIALISTICA DELLO "IN HOC SIGNO VINCES" DI COSTANTINO.
ARTE, FILOLOGIA, STORIOGRAFIA, E "PROPAGANDA E FEDE". Sicuramente le indicazioni date da Gesù all’apostolo Pietro per "organizzare" la vita della comunità cristiana non erano né filologicamente né evangelicamente queste di Paolo di Tarso: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il #capo è #Cristo, e capo della #donna è l’uomo [gr. ἀνήρ, ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).
Questa dichiarazione di #cosmoteandria assoluta va molto più indietro delle stesse dichiarazioni rintracciabili nella tradizione religiosa greca di Zeus, di Apollo, e di Atena (Eschilo, Sofocle, ed Euripide) e così, e fondamentalmente, dopo la "donazione" di Pietro a Paolo, si apre la strada alla "donazione" decisiva, quella detta di Costantino e al suo "algoritmico" programma di imperialismo teologico-politico (Nicea 325-2025).
«È significativo che l’espressione di Tertulliano: "Il cristiano è un altro Cristo", sia diventata: "Il prete è un altro Cristo"» (Albert Rouet, arcivescovo di Poitiers, 2010).
NOTE:
- PSICOLOGIA E SOCIETA’. "L’infelicità nella civiltà ("Das Ungluck in der Kultur"): "[...] Poi che l’apostolo Paolo ebbe posto l’amore universale tra gli uomini a fondamento della sua comunità cristiana, era inevitabile sorgesse l’estrema intolleranza della Cristianità contro coloro che rimanevano al di fuori; i Romani, che non avevano fondato la loro collettività statale sull’amore, non conobbero l’intolleranza religiosa, benché per loro la religione fosse un affare di Stato e lo stato fosse imbevuto di religione. [...]" (S. Freud, "Il disagio della civiltà", 1929).
- Allegato: La "memoria" di una inchiesta (su di un tentativo di "incontro" tra Psicoanalisi e Chiesa Cattolico-romana) fatta da Franca Ongaro Basaglia ( "Così parlò Edipo a Cuernavaca", "pM" - "Panorama mese", novembre 1983).
- ESSERE, O NON ESSERE" (SHAKESPEARE, "AMLETO"). #QUESTIONEANTROPOLOGICA (E CRISTOLOGICA): "#AUt_AUT (KIERKEGAARD). Quale risposta da dare alla domanda evangelica (ed "#hamlet-ica"): "Qui dit-on que le Fils de l’homme est ?".
 Gesù, chi è costui?, il figlio dell’Antropologia ["Filius hominis", "υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου] pietrina, o dell’ #Androcentrismo platonico-paolino:
"[...] sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3)?!
Gesù, chi è costui?, il figlio dell’Antropologia ["Filius hominis", "υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου] pietrina, o dell’ #Androcentrismo platonico-paolino:
"[...] sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3)?!
- FILOLOGIA, ANDROCENTRISMO, E TEOLOGIA (#CORPOMISTICO): CON #DANTE ALIGHIERI ("GIUSEPPE -> VIRGILIO" E "MARIA -> BEATRICE" ), USCIRE DAL #LETARGO (Par. XXXIII, 94) DELLA #TRAGEDIA ...
- "MATER ET MAGISTRA" (GIOVANNI XXIII, 1961): "Madre e maestra di tutte le genti, la Chiesa universale è stata istituita da Gesù Cristo [...]
A questa Chiesa, colonna e fondamento di verità, (Cf. 1 Tm 3,15) il suo santissimo Fondatore ha affidato un duplice compito: di generare figli, di educarli e reggerli, guidando con materna provvidenza [...]. Il cristianesimo infatti è congiungimento della terra con il cielo [...]
 Ma non possiamo concludere questa nostra enciclica senza ricordare un’altra verità che è insieme una sublime realtà: e cioè che noi siamo membra vivi del #corpomistico di Cristo, che è la sua Chiesa: "Come il corpo, pur essendo uno, ha molto membra e tutte le membra, pur essendo molte, sono un corpo solo, cosi anche Cristo" (1 Cor 12,12)".
Ma non possiamo concludere questa nostra enciclica senza ricordare un’altra verità che è insieme una sublime realtà: e cioè che noi siamo membra vivi del #corpomistico di Cristo, che è la sua Chiesa: "Come il corpo, pur essendo uno, ha molto membra e tutte le membra, pur essendo molte, sono un corpo solo, cosi anche Cristo" (1 Cor 12,12)".
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE --- TRACCE PER UNA SVOLTA ANTROPOLOGICA: "DITELO" CON LE PIANTE ("CAESALPINIA PULCHERRIMA"). Un omaggio alla memoria di Andrea Cesalpino.9 giugno 2024, di Federico La Sala
"DITELO" CON LE PIANTE ("CAESALPINIA PULCHERRIMA"). ANTROPOLOGIA FILOSOFIA E BOTANICA: RIPRENDERE IL FILO DEL RINASCIMENTO E DELLA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA.
- Un omaggio alla memoria di Andrea Cesalpino (e al suo libro "De Plantis", 1583).
ANDROCENTRISMO, GEOCENTRISMO, ED ELIOCENTRISMO: TRACCE PER UNA #SVOLTA_ANTROPOLOGICA. Considerato che ancora oggi la cultura "accademica" (atea e devota") ha la "#forma #mentis" condizionata (algoritmicamente) dall’#immagine mitizzata della "Scuola di Atene" (Raffaello, 1509 -1511) e della "piramide" (v. allegato) del "Sapiente" (Bovillus, 1509-1510), la rilettura e lo studio dell’opera di Andrea Cesalpino è più che mai fondamentale e #salutare (allegati nei commenti).
NOTE:
- STORIA E "SMEMORATEZZA": CAESALPINIA. Caesalpinia Plum. ex L., 1753 è un genere di piante della famiglia delle Fabacee (o Leguminose) che comprende arbusti, piccoli alberi e suffrutici, diffusi nelle regioni tropicali del Nuovo Mondo Alcune specie, come Caesalpinia pulcherrima, hanno importanza come piante ornamentali. Il nome del genere è un omaggio al botanico italiano Andrea #Cesalpino. [...]".
- ANDREA CESALPINO E LA SUA OPERA: "Andrea Cesalpino’s ›De Plantis Libri XVI‹ (1583) and the Transformation of Medical Botany in the 16th Century" (Edition, Translation, and Commentary on Book I Quentin #Hiernaux and Corentin Tresnie, De Gruyter 2023): ).
- DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE: ANTROPOLOGIA, BOTANICA E CIVILTA’. "VERDE BRILLANTE. Sensibilità e intelligenza del mondo vegetale" (di Stefano Mancuso, Alessandra Viola)
- STORIOGRAFIA: "COME NASCONO I BAMBINI". ALBERTO MAGNO E LA SESSUALITA’ VEGETALE: "Female Seeds, Powers, and Bodies: Albert the Great and the Vegetal Sexuality" di Amalia Cerrito:
 "The 13th-century Dominican master Albert the Great extensively discusses vegetal sexuality. [...] He is convinced that “male and female” and “motherhood and fatherhood” manifest in nature to varying degrees, ranging from the most perfect nature, i.e., human beings, to the less perfect, i.e., plants. Plants express masculinitas and femininitas proportionally to their nature. The examination of plant generation provides an opportunity to elucidate these concepts, defining the essential aspects and causal roles of male and female functions and features. In this lecture, I will focus on how Albert employs concepts such as the female “body”, “seed”, and “power”, in his investigation on vegetal sexuality. [...]".
"The 13th-century Dominican master Albert the Great extensively discusses vegetal sexuality. [...] He is convinced that “male and female” and “motherhood and fatherhood” manifest in nature to varying degrees, ranging from the most perfect nature, i.e., human beings, to the less perfect, i.e., plants. Plants express masculinitas and femininitas proportionally to their nature. The examination of plant generation provides an opportunity to elucidate these concepts, defining the essential aspects and causal roles of male and female functions and features. In this lecture, I will focus on how Albert employs concepts such as the female “body”, “seed”, and “power”, in his investigation on vegetal sexuality. [...]".
- ANTROPOLOGIA FILOSOFICA E ANDROCENTRISMO TEOLOGICO-POLITICO. “Nature imperfette. Umano, subumano e animale nel pensiero di Alberto Magno” (di Stefano Perfetti, con un saggio di Amalia Cerrito - "Letture.org"):
- "[...] L’idea della superiorità umana rispetto agli altri animali è una forma di specismo, posizione poco popolare oggi...
- Autori contemporanei legati al movimento di liberazione animale, come Peter Singer o Tom Regan, usano termine ‘specismo’ (che richiama razzismo e sessismo) per indicare le discriminazioni umane che negano i diritti animali e legittimano ideologicamente trattamenti crudeli o irrispettosi. Non mi sembra, però, che questa etichetta si possa applicare alle posizioni di Alberto. Nella sua ottica noi umani siamo superiori ad ogni altro animale non perché ci troviamo staticamente ad un livello più alto nella scala naturae, ma perché siamo capaci di connettere tutti gli aspetti della nostra esperienza e trascendere gli ambiti particolari dell’esperienza. Grazie all’astrazione concettuale e al linguaggio che ne permette comunicazione e condivisione, l’uomo è in grado di superare punti di vista e interessi particolari, elaborare valori etici e sociali, modificare se stesso e il proprio stile di vita, cercare di comprendere la realtà scientificamente, per un piacere della conoscenza che prescinde dai bisogni immediati. Nel far questo l’essere umano si autotrascende, cioè risale la struttura della realtà e, almeno in parte, comprende il piano provvidenziale di Dio. Nell’ottica di Alberto, la realizzazione del potenziale umano nella conoscenza e nell’indagine razionale coopera col fine religioso di risalire la piramide della realtà per avvicinarsi a Dio. "(Edizioni Ets).
-
> "DITELO" CON LE PIANTE ("CAESALPINIA PULCHERRIMA"). ---IL DIO "VERTUMNO", IL "CORPO MISTICO" DELL’IMPERATORE "GIARDINIERE". LA LUNGA ONDA DEL RINASCIMENTO E IL SOGNO DELLA TEOLOGIA-POLITICA DI RODOLFO ii D’ASBURGO.10 giugno 2024, di Federico La Sala
IL DIO "VERTUMNO", IL "CORPO MISTICO" DELL’IMPERATORE "GIARDINIERE". LA LUNGA ONDA DEL RINASCIMENTO E IL SOGNO DELLA TEOLOGIA-POLITICA DI RODOLFO ii D’ASBURGO. Appunti sul tema:
A) - "LA CITTA’ DEL SOLE" (TOMMASO CAMPANELLA) E L’IDEA DEL "PARADISO TERRESTRE" DELLA "MONARCHIA" (DANTE ALIGHIERI) : "[...] La curiosità per il pomodoro e le altre piante in arrivo dal Nuovo Mondo è evidente nel fantasioso, emblematico, spiritoso e ormai famoso ritratto che Giuseppe Arcimboldo fece all’imperatore Rodolfo II. In questo quadro, dipinto nel 1560, Arcimboldo ritrae l’imperatore nei panni di Vertumno, il dio romano dell’abbondanza e dell’alternanza delle stagioni. Le opere di Rodolfo vengono rappresentate sotto forma di frutti maturi, fiori e ortaggi. Il labbro inferiore dell’imperatore è formato da due pomodorini a ciliegia. Un’altra pianta nuova, il mais, forma l’orecchio e due peperoncini rossi adornano il suo mantello. Rodolfo aveva ereditato un vastissimo giardino dal nonno, Ferdinando I. Di quel terreno, che doveva essere un «teatro del mondo», un’enciclopedia vivente di alberi e piante, era stato fatto un giardino all’italiana per opera di un grandissimo esperto, Mattioli, che l’aveva anche curato. Rodolfo condivideva con il nonno la fascinazione per la natura, la scienza e la magia. Aveva una raccolta di «curiosità» provenienti da tutto il mondo conosciuto, famosa per la sua varietà e il suo valore. Il milanese Arcimboldo era stato il «ritrattista di corte» di suo padre e di suo nonno, anche se il ruolo che occupava effettivamente andava ben oltre l’incarico ufficiale. Rodolfo si affidava ad Arcimboldo come suo agente, e negli anni Ottanta l’aveva mandato in Germania a caccia di opere d’arte e di oggetti rari. Quindi, non c’è da sorprendersi se Arcimboldo ha inserito dei prodotti del Nuovo Mondo nel suo fantasioso ritratto. Quest’opera è simile alle varie serie delle Quattro stagioni che Arcimboldo aveva iniziato a dipingere quasi tre decenni prima. Ma facendo maturare tutti i frutti, i fiori e gli ortaggi insieme, Arcimboldo ci presenta un’allegoria del potere imperiale, ricordandoci le pretese di dominio globale di Rodolfo, oltre a prospettare il ritorno di una «età dell’oro» sotto il suo governo. "(DAVID GENTILCORE, "LA PURPUREA MERAVIGLIA. Storia del pomodoro in Italia", Garzanti, 2010, pp. 36-37).
B) - RODOLFO II, ARCIMBOLDO, E IL DIO "VERTUMNO": "[...] Giuseppe Arcimboldi o Arcimboldo ( 1526-1593 ). Figlio del pittore Biagio che era stato in contatto con Bernardino Luini e quindi con la scuola di Leonardo, lavorò all’inizio con il padre in opere decorative come pannelli d’organo, vetrate, cartoni per arazzi, Dopo essersi fatto conoscere ed apprezzare si trasferì alla corte di Praga al servizio del principe Massimiliano divenendo artista ufficiale di corte. Dopo aver realizzato composizioni antropomorfe con frutti e vegetali che ebbero subito grande successo ( le Quattro stagioni dal 1563 al 1577 ) , lasciò la corte imperiale del principe Rodolfo a cui prestava servizio dopo la morte di Massimiliano, per tornare nel 1587 a Milano dove si stabilì definitivamente. Qui dipinse il Ritratto dell’imperatore in veste di Vertunno databile intorno al 1589-90. Le composizioni di Arcimboldo erano definite al suo tempo illusionistiche ed erano costituite, se così possiamo dire, da figure umane con un insieme di prodotti di mercato e cucina: il personaggio raffigurato era composto dall’insieme degli elementi naturali che costituivano il suo mestiere, così, per esempio, un ritratto di cuoco, era formato dai cibi collocati dalla testa ai piedi. Un aspetto delle figure "illusionistiche" comico-grottesche di Arcimboldo è la reversibilità nel senso che possono essere viste sia in forma antropomorfa che, rovesciate, in forma vegetale pur essendo composte, entrambe, degli stessi elementi naturali.
Dovendo omaggiare l’imperatore Rodolfo II d’Asburgo, pensò di creare, nel 1590, un proteiforme ritratto frontale a mezzo busto in cui appariva come il dio Vertumno, dio delle stagioni, formato dalla straordinaria giustapposizione di frutti, ortaggi e fiori. Si trattava del punto di arrivo delle sue opere destinate alle stagioni che qui si riassumevano in un insieme delle quattro, ricche di tutti i prodotti della terra. L’opera naturalmente era elogiativa, voleva essere un’esaltazione dell’abbondanza che sotto il regno di Rodolfo si godeva in tutte le stagioni dell’anno, come in una nuova età dell’oro. L’ammasso ordinato e composito dei frutti, ortaggi e fiori non sminuiva l’impatto che doveva fornire l’imperatore: l’impressione di vigore fisico e potenza politica, né ne sviava l’interpretazione accentuando il senso del grottesco o del comico, ma invece ne forniva una vera e propria potenza figurativa che dava proprio quell’idea di floridezza e abbondanza che un sapiente e regolato governo sapeva dare. [...]" (cfr. Giangiacomo Scocchera, "La Sindrome di Stendhal Due": Il primo tempo: Musici, fioriere e fruttiere...).
Federico La Sala
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- LA LOTTA "VITTORIOSA" di "amleto" (SHAKESPEARE) PER UNA RIFORMA TEOLOGICO-POLITICA EUROPEA (IERI E OGGI).29 maggio 2024, di Federico La Sala
"AMLETO" (SHAKESPEARE) E LA LOTTA "VITTORIOSA" PER UNA RIFORMA TEOLOGICO-POLITICA EUROPEA (IERI E OGGI).
 TEATRO (FILOSOFIA) E METATEATRO (METAFILOSOFIA).
TEATRO (FILOSOFIA) E METATEATRO (METAFILOSOFIA).- In memoria di Giordano Bruno, Galileo Galilei, e immanuel Kant...
- Una nota di commento a margine del lavoro in progress di Paul Adrian Fried: "Part 47: Ophelia’s “O” and the Virtues of Nothingness" (May 28, 2024).
"IN PRINCIPIO ERA LA PAROLA". SE SI CONSIDERA CHE NELLA "#FOLLIA" DEL PRINCIPE #AMLETO C’E’ IL #METODO (COME HA BEN INTUITO #POLONIO) CHE GLI FA CONSEGUIRE VALOROSA-MENTE LA VITTORIA SUL FALSO RE CHE HA UCCISO IL VERO RE E SPOSATO LA REGINA-MADRE E RISPETTARE IL #PATTO DEL RE-PADRE AMLETO CON IL RE-PADRE #FORTEBRACCIO, PENSARE che "Ophelia in Shakespeare’s 𝘏𝘢𝘮𝘭𝘦𝘵 represents a paradox about both the injustice and virtue of nothing, emptiness, poverty" (Paul Adrian Fried, cit.), NON PORTA DA NESSUNA PARTE, SOLO IN UN "O", IN UN #VICOLOCIECO, IN UNA NOTTE IN CUI TUTTE LE #VACCHE SONO NERE.
«CRITICA DELLA "RAGION PURA"» (#KANT2024) E #ANTROPOLOGIA (#KANT, 1800). Per dire in breve il senso del discorso, con le parole di #Einstein, e contro la logica della scommessa di #Pascal (e la sua "Pascalina"), Shakespeare non è né sulle posizioni epistemologiche di Thomas S. #Kuhn né su quelle di Paul K. #Feyerabend: #Hamlet sa "giocare" bene, ma il suo "Dio non gioca a #dadi".
MEMORIA STORIA E LETTERATURA: #DIVINACOMMEDIA. Forse è proprio giunto il tempo di togliere le catene linguistiche della #tragedia gettate intorno a "l’aiuola che ci fà tanto feroci" (Par. XXII, 151) e portare alla luce "della Terra, il brillante colore" (come già sollecitava #DanteAlighieri, ma anche J.-J. #Rousseau). In principio erano le parole del dia-#logos (della legge costituzionale uguale per ogni esssere umano), non del dia-#logo (di un’azienda o di un partito o di un pastore di "pecore").
Nota:
- EUROPA (1600 - 2024): MEMORIA E #STORIA. Per non perdere il filo (e, possibilmente, uscire dal #letargo e dall’infernale #labirinto, come da indicazione già di #DanteAlghieri), a mio parere, è importante #ricordare la sollecitazione "cosmologica" di #GiordanoBruno: "Lo #spaccio della #bestia trionfante". Se non ora,quando?!
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- «TEATRO DEL SONNO»: IL "BANCHETTO" DI SWEDENBORG E LA INTERPRETAZIONE DI KANT (KOENIGSBERG, 1766).28 maggio 2024, di Federico La Sala
«NON MANGIARE TROPPO»: IL "BANCHETTO" DI SWEDENBORG, I "SOGNI DEL VISIONARIO" ("AEGRI SOMNIA") DELL’«ARTE POETICA» DI #ORAZIO (VENOSA) E LA INTERPRETAZIONE DI KANT (KOENIGSBERG, 1766) DELLA TEOLOGIA-POLITICA DELL’#UOMOSUPREMO "EUROPEO".
- Alcune "vecchie" note in memoria di Kant (1724-1804).
A) "TEATRO DEL #SONNO": LA VISIONE DI SWEDENBORG. «Ero a Londra e stavo pranzando nel mio abituale ristorante. Ero affamato e mangiavo con grande appetito. Verso la fine del pasto mi accorsi che una specie di nebbia mi si faceva davanti agli occhi. La nebbia divenne più fitta e io vidi il pavimento della stanza coperto dei più orribili animali striscianti, serpenti, rospi e simili. Io ero stupefatto, perché ero in piena coscienza. Poi l’oscurità divenne più completa per sparire infine completamente, e ora in un angolo della stanza vidi seduto un uomo che mi terrorizzò con le sue parole. Mi disse infatti: «Non mangiare tanto!».
 Poi tutto si oscurò di nuovo, ma di colpo si rifece luce e mi ritrovai solo nella stanza. Questa visione mi indusse a tornare rapidamente a casa. Durante la notte mi si ripresentò lo stesso uomo, il quale mi disse che era Dio, il creatore del mondo e redentore, e che mi aveva scelto per spiegare agli uomini il senso spirituale delle Sacre Scritture; lui stesso mi avrebbe dettato quello che avrei dovuto scrivere su questo soggetto. In quella stessa notte, per convincermi, mi fu mostrato il mondo spirituale, l’inferno e il cielo, dove incontrai parecchie persone di mia conoscenza e di tutti i ceti sociali. Da quel giorno rinunciai a ogni interesse scientifico terreno e lavorai soltanto alle cose spirituali, secondo quello che il Signore mi aveva ordinato. In seguito il Signore aprì gli occhi del mio spirito, così che mi trovai in grado di vedere mentre ero pienamente desto quello che avviene nell’altro mondo, e di parlare con gli angeli e gli spiriti» (cfr. Emanuele Swedernborg, "Cielo e Inferno L’Aldilà descritto da un grande veggente", a c. di Paola Giovetti, Edizioni Mediterrane, Roma 2005; e, anche, cfr. Guido Almansi - Claude Béguin, "Teatro del sonno. Antologia dei sogni letterari", Oscar Mondadori, Milano 1991).
Poi tutto si oscurò di nuovo, ma di colpo si rifece luce e mi ritrovai solo nella stanza. Questa visione mi indusse a tornare rapidamente a casa. Durante la notte mi si ripresentò lo stesso uomo, il quale mi disse che era Dio, il creatore del mondo e redentore, e che mi aveva scelto per spiegare agli uomini il senso spirituale delle Sacre Scritture; lui stesso mi avrebbe dettato quello che avrei dovuto scrivere su questo soggetto. In quella stessa notte, per convincermi, mi fu mostrato il mondo spirituale, l’inferno e il cielo, dove incontrai parecchie persone di mia conoscenza e di tutti i ceti sociali. Da quel giorno rinunciai a ogni interesse scientifico terreno e lavorai soltanto alle cose spirituali, secondo quello che il Signore mi aveva ordinato. In seguito il Signore aprì gli occhi del mio spirito, così che mi trovai in grado di vedere mentre ero pienamente desto quello che avviene nell’altro mondo, e di parlare con gli angeli e gli spiriti» (cfr. Emanuele Swedernborg, "Cielo e Inferno L’Aldilà descritto da un grande veggente", a c. di Paola Giovetti, Edizioni Mediterrane, Roma 2005; e, anche, cfr. Guido Almansi - Claude Béguin, "Teatro del sonno. Antologia dei sogni letterari", Oscar Mondadori, Milano 1991).B). L’ARCHIVIO DEGLI ERRORI: L’ "IO SONO" DI KANT E L’ "IO SONO" DELL’"UOMO SUPREMO" (cfr. "Kant, Freud, e la banalità del male", 2010).
- [FOTO DELLA PAGINA]: "EMANUEL SWEDENBORG, «Non mangiar troppo»" (cfr. #GuidoAlmansi - #ClaudeBéguin, "Teatro del sonno. Antologia dei sogni letterari", Oscar Mondadori, Milano 1991).
- ANTROPOLOGIA ED #ECOLOGIA (NON EGOLOGIA); “SMONTARE LA GABBIA”! USCIRE DALLA CAVERNA, E NON RICADERE NELL’ILLUSIONE DI “DIO” CONCEPITO COME “UOMO SUPREMO”.... .
- IL "BANCHETTO DI BALDASSARRE": ARTE E PROPAGANDA DELLA FEDE TEOLOGICO-POLITICA DELL’EUROPA DEL QUATTROCENTO, ALLA VIGILIA DELLA CELEBRAZIONE (2025) DEL PRIMO CONCILIO DI #NICEA (325).
- ARTRIBUNE: Roma: a Palazzo Nardini scoperto un affresco del ‘400.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- LA LEZIONE DI ORAZIO ("SAPERE AUDE"), IL SOGNO SUL "NON MANGIARE TROPPO" DI SWEDENBORG, E L’INTERPRETAZIONE DI KANTI.22 maggio 2024, di Federico La Sala
STORIOGRAFIA FILOSOFICA E FILOLOGIA.
L’ “UOMO SUPREMO” DEI VISIONARI E DEI FILOSOFI DELLA TEOLOGIA -POLI TICA ATEA E DEVOTA. La memoria della "lezione" di Orazio ("sàpere aude"), il sogno di Swedenborg («Non mangiare tanto!»), e "I sogni di un visionario chiariti con i sogni della metafisica". *
Swedenborg e la visione dell’Uomo che gli ordina di «Non mangiare troppo»**.
- Una citazione dalla biografia di E. Swedenborg a cura di Paola Giovetti, premessa al libro di Emanuele Swedernborg, "Cielo e Inferno L’Aldilà descritto da un grande veggente":
"EMANUELE SWEDENBORG (1688- 1772) di Paola Giovetti : [...] Swedenborg prega, si interroga, attende, studia la Bibbia. Nel 1745, mentre è a Londra, grazie a un’altra visione supera definitivamente la crisi. E’ la metà di aprile, è passato un anno esatto dalla prima visione. In quest’anno Swedenborg ha pubblicato il terzo volume del Regnum Animale e i due volumi di Della saggezza e dell’amore di Dio. Ecco, con le parole di Swedenborg, l’esperienza determinante:
- «Ero a Londra e stavo pranzando nel mio abituale ristorante. Ero affamato e mangiavo con grande appetito. Verso la fine del pasto mi accorsi che una specie di nebbia mi si faceva davanti agli occhi. La nebbia divenne più fitta e io vidi il pavimento della stanza coperto dei più orribili animali striscianti, serpenti, rospi e simili. Io ero stupefatto, perché ero in piena coscienza. Poi l’oscurità divenne più completa per sparire infine completamente, e ora in un angolo della stanza vidi seduto un uomo che mi terrorizzò con le sue parole. Mi disse infatti: «Non mangiare tanto!».
Poi tutto si oscurò di nuovo, ma di colpo si rifece luce e mi ritrovai solo nella stanza. Questa visione mi indusse a tornare rapidamente a casa. Durante la notte mi si ripresentò lo stesso uomo, il quale mi disse che era Dio, il creatore del mondo e redentore, e che mi aveva scelto per spiegare agli uomini il senso spirituale delle Sacre Scritture; lui stesso mi avrebbe dettato quello che avrei dovuto scrivere su questo soggetto. In quella stessa notte, per convincermi, mi fu mostrato il mondo spirituale, l’inferno e il cielo, dove incontrai parecchie persone di mia conoscenza e di tutti i ceti sociali. Da quel giorno rinunciai a ogni interesse scientifico terreno e lavorai soltanto alle cose spirituali, secondo quello che il Signore mi aveva ordinato. In seguito il Signore aprì gli occhi del mio spirito, così che mi trovai in grado di vedere mentre ero pienamente desto quello che avviene nell’altro mondo, e di parlare con gli angeli e gli spiriti».
Il veggente
Si può affermare che tutta l’opera scientifica finora compiuta da Swedenborg costituisca una sorta di preparazione a quello che doveva essere l’autentico compito della sua vita, quello per il quale è rimasto famoso. Nella sua carriera di scienziato aveva acquisito capacità di osservazione, di analisi e di sintesi, sapeva autodisciplinarsi e valutare il valore del proprio lavoro e delle teorie che formulava; aveva una notevolissima abilità organizzativa e una straordinaria capacità di lavoro. Sapeva come si prepara un manoscritto, era in grado di confezionare copie perfette pronte per la pubblicazione. Era pronto per il gran balzo. La visione di Londra gli diede le ali: ora sapeva in che cosa consistesse il compito che lo attendeva. Doveva rivelare il vero senso della Bibbia e descrivere l’altra dimensione: spiriti e angeli saranno d’ora in poi suoi maestri. La sua vita ha uno scopo nuovo, al quale si dedica con tutto se stesso. [...]" (cfr. Paola Giovetti, op. cit.).
Note:
** Su "Emanuel Swedenborg: «Non mangiare troppo»", si cfr. Guido Almansi - Claude Béguin, "Teatro del sonno. Antologia dei sogni letterari", Oscar Mondadori, Milano 1991: "Questo sogno di Swedenborg è raccontato dal suo biografo, William White, in un libro pubblicato nel 1869. Ignoriamo la fonte d’informazione di White" pp. 406-407.
Federico La Sala
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- QUESTIONI DI CORPO MISTICO E TRADIZIONI ICONOGRAFICHE. NOTE PER UNA "PENTECOSTE" IN UN PIANETA TERRA IN FIORE: COME NASCONO I BAMBINI (20 MAGGIO 2024).21 maggio 2024, di Federico La Sala
PER UNA PENTECOSTE IN UN PIANETA TERRA IN FIORE: COME NASCONO I BAMBINI (20MAGGIO2024).
ARTE IMMAGINAZIONE ANTROPOLOGIA E FILOLOGIA...
- Una nota in memoria di #GioacchinodaFiore e di #GianniVattimo
"DIVINA COMMEDIA" (#DANTE2021). Flavio Piero Cuniberto, in una nota di commento all’opera di "Andrea Orcagna (e Jacopo di Cione), Pentecoste, 1362-1365; Firenze, Gallerie dell’Accademia" intitolata "La pentecoste fiorentina", scrive e sollecita a pensare:
- "Non è un pittore simpatico, Andrea di Cione detto l’Orcagna. E’ arcigno, l’Orcagna (un po’ come il suo affine senese Taddeo di Bartolo). Ha un umore aspro, severo, austero, che non gli impedisce però di prodigare una mirabile raffinatezza nella veste rosa-arancio della Vergine e in quel tappeto fiorito, tra le figure scultoree degli Apostoli. Né gli impedisce la trovata geniale di presentarla, la Vergine, come in levitazione, sollevata da terra, perché è Lei la prima destinataria di quel Fuoco spirituale. Ed è così. Dal giorno della Pentecoste la Chiesa o è mariana o non è: come se l’opera dello Spirito si compisse nuovamente in lei , dopo il giorno lontano dell’Annuncio.
- Il vaso fiorito, o il ramo di giglio offerto dall’Arcangelo, è diventato una fiamma che non si estingue.Il vaso fiorito, o il ramo di giglio offerto dall’Arcangelo, è diventato una fiamma che non si estingue" (cit.).
Ma, una domanda (una "question" hamletica) sorge "spontanea", come mai nella tradizione iconografica dell’altro "Vas d’elezione" (dell’altro «strumento della scelta»), lo sposo di Maria ( la stessa Madre di Gesù e della Chiesa della intera "umanità", la nuova #Eva) quello con l’altro ramo del #giglio, quello "offerto dall’Arcangelo" proprio di colui che è il "Vero_giglio", il "Vir_gilio", l’Uomo ("Vir") con il ramo altrettanto fiorito, il #padre di #Gesù, quel "#Giuseppe", della "casa di Davide" ("de domo David"), e si parla solo del "Vas" paolino (Atti ap., IX, 15)?!
A che edipico gioco giochiamo? Non ha forse ragione #DanteAlighieri ("io non Enea, io non Paulo sono ") con la sua "Monarchia" dei #DueSoli, Shakespeare con il suo "Amleto, #Nietzsche con il suo "Zarathustra"?! E #Freud con la sua "Interpretazione dei sogni?! Jakob #Böhme, cosa pensava del tempo in cui allo #sposo sarà possibile finalmente incoronare la #sposa, non pensava a un nuovo "mondo #possibile", a un #sorgeredellaTerra (#Earthrise), e a #Gioacchino da Fiore - per "caso", per "#charitas"?
NOTE:
- LA QUESTIONE ANTROPOLOGICA E TEOLOGICA DELLA CHIESA CATTOLICA E IL PROBLEMA (DELL’ANDROCENTRISMO) DEL "CORPO MISTICO" DI "CRISTO" (#NICEA, 325-2025).
 Papa Paolo VI, rivolgendosi ai padri conciliari del Vaticano II, dichiarò che Maria Santissima è la Madre della Chiesa.
Papa Paolo VI, rivolgendosi ai padri conciliari del Vaticano II, dichiarò che Maria Santissima è la Madre della Chiesa.
 La Vergine Maria è la Madre di tutti gli uomini e specialmente dei membri del Corpo Mistico di Cristo, poiché è la Madre di Gesù per l'#Incarnazione. Gesù stesso lo confermò dalla Croce prima di morire, dandoci sua Madre come nostra madre nella persona di San Giovanni dicendo: "Donna, ecco tuo figlio!". E poi: "Ecco tua madre!". Ecco perché la pietà della Chiesa verso la Beata Vergine è un elemento intrinseco del culto cristiano. Adempiendo così la profezia della Vergine, che ha detto: "Tutte le generazioni mi chiameranno beata" [..." class="spip_out">20 MAGGIO 2024, Commemorazione della "Madre dei fedeli e dei pastori della Chiesa" ( https://www.santodelgiorno.it/maria-madre-della-chiesa/ ).
La Vergine Maria è la Madre di tutti gli uomini e specialmente dei membri del Corpo Mistico di Cristo, poiché è la Madre di Gesù per l'#Incarnazione. Gesù stesso lo confermò dalla Croce prima di morire, dandoci sua Madre come nostra madre nella persona di San Giovanni dicendo: "Donna, ecco tuo figlio!". E poi: "Ecco tua madre!". Ecco perché la pietà della Chiesa verso la Beata Vergine è un elemento intrinseco del culto cristiano. Adempiendo così la profezia della Vergine, che ha detto: "Tutte le generazioni mi chiameranno beata" [..." class="spip_out">20 MAGGIO 2024, Commemorazione della "Madre dei fedeli e dei pastori della Chiesa" ( https://www.santodelgiorno.it/maria-madre-della-chiesa/ ).
- STORIA E LETTERATURA, ANTROPOLOGIA E TEOLOGIA BIBLICA: JAKOB BOEHME E "LA STORIA DI GIUSEPPE". Sul tema, una citazione dalla nota dello storico della filosofia Valerio Verra:
- "Al termine di una vita tutta dedicata ad approfondire e sviluppare un’intensa esperienza religiosa e speculativa, #Jakob #Böhme (1575-1624) raccoglie e condensa nel #Mysterium #Magnum (1623) il frutto delle sue meditazioni sul primo libro di #Mosè. L’opera è destinata a spiegare la rivelazione della parola divina, , la creazione, il regno della natura e della grazia, affinché l’uomo possa giungere a comprendere meglio che cosa sia Adamo e che cosa sia Cristo, come debba considerare se stesso nella luce della natura e in che cosa consista la sua vita temporale ed eterna. Contro le forme di interpretazione dottrinale ed erudita che minacciavano di ridurre l’incontro vivificante con la Scrittura a semplice decifrazione storico-filologica di una « lettera» morta e mortificante, Bohme propone una lettura della Genesi fondata sullo sforzo di riportare il testo sacro alla tensione insieme storica ed eterna tra l’uomo caduto e l’uomo redento.
 Rivelazione e redenzione vengono viste così in un quadro che è insieme cosmico e storico e nel quale confluiscono e si intrecciano in una sintesi non sempre perspicua, ma per molti aspetti suggestiva, motivi mistici ed alchimistici, teosofici e naturalistici, che avranno notevole risonanza anche nel romanticismo e nell’idealismo tedesco. Alla grandiosità dello scenario e alla complessità dei contrasti nei suoi elementi corrisponde un linguaggio ricco di immagini e di simboli inteso a ricreare con forza poetica e profetica insieme quel legame profondo tra microcosmo e macrocosmo - motivo anche questo assai caro all’« età di Goethe» - dal quale soltanto l’anima può trarre la forza per comprendere il proprio destino di salvezza e riesprimere con parola visibile la parola invisibile da cui deriva ed è sostanziata l’intera creazione. Nei personaggi e negli eventi biblici si possono così ravvisare « figure » che anticipano ed esprimono il senso tanto di ogni singolo uomo quanto dell’intera umanità e cristianità.
Rivelazione e redenzione vengono viste così in un quadro che è insieme cosmico e storico e nel quale confluiscono e si intrecciano in una sintesi non sempre perspicua, ma per molti aspetti suggestiva, motivi mistici ed alchimistici, teosofici e naturalistici, che avranno notevole risonanza anche nel romanticismo e nell’idealismo tedesco. Alla grandiosità dello scenario e alla complessità dei contrasti nei suoi elementi corrisponde un linguaggio ricco di immagini e di simboli inteso a ricreare con forza poetica e profetica insieme quel legame profondo tra microcosmo e macrocosmo - motivo anche questo assai caro all’« età di Goethe» - dal quale soltanto l’anima può trarre la forza per comprendere il proprio destino di salvezza e riesprimere con parola visibile la parola invisibile da cui deriva ed è sostanziata l’intera creazione. Nei personaggi e negli eventi biblici si possono così ravvisare « figure » che anticipano ed esprimono il senso tanto di ogni singolo uomo quanto dell’intera umanità e cristianità.
 Di questo grande affresco biblico è presentata qui l’ultima parte che tratteggia ed interpreta la storia di Giuseppe, una figura che non ha mancato di affascinare anche grandi artisti, da #Goethe a #ThomasMann. Giuseppe rappresenta per Bohme l’intera condizione del cristiano di fronte a Dio e al mondo e la sua storia ci insegna come #Adamo possa diventare #Cristo o, meglio, come Cristo assuma in sé la natura umana caduta per rigenerarla [...]. La storia di Giuseppe si conclude con il Testamento di #Giacobbe dove il processo di redenzione si dispiega come una vera e propria teologia della storia in cui Bohme, nella linea delle grandi interpretazioni delle diverse epoche in chiave biblica e profetica, descrive simbolicamente, attraverso il destino delle tribù di Israele, « tutto il tempo che dura il mondo da Adamo alla fine»." (Valerio Verra).
Di questo grande affresco biblico è presentata qui l’ultima parte che tratteggia ed interpreta la storia di Giuseppe, una figura che non ha mancato di affascinare anche grandi artisti, da #Goethe a #ThomasMann. Giuseppe rappresenta per Bohme l’intera condizione del cristiano di fronte a Dio e al mondo e la sua storia ci insegna come #Adamo possa diventare #Cristo o, meglio, come Cristo assuma in sé la natura umana caduta per rigenerarla [...]. La storia di Giuseppe si conclude con il Testamento di #Giacobbe dove il processo di redenzione si dispiega come una vera e propria teologia della storia in cui Bohme, nella linea delle grandi interpretazioni delle diverse epoche in chiave biblica e profetica, descrive simbolicamente, attraverso il destino delle tribù di Israele, « tutto il tempo che dura il mondo da Adamo alla fine»." (Valerio Verra).
- "Il #Protovangelo (apocrifo) di #Giacomo ci parla [..." class="spip_out">IL MATRIMONIO DI GIUSEPPE E MARIA “del bastone fiorito di San Giuseppe” [...]: «Indossato il manto dai dodici sonagli, il sommo sacerdote entrò nel santo dei santi e pregò a riguardo di Maria. Ed ecco che gli apparve un angelo del Signore, dicendogli: “Zaccaria, Zaccaria! Esci e raduna tutti i vedovi del popolo. Ognuno porti un bastone: sarà la moglie di colui che il Signore designerà per mezzo di un segno”. Uscirono i banditori per tutta la regione della Giudea, echeggiò la tromba del Signore e tutti corsero. Gettata l’ascia, Giuseppe uscì per raggiungerli. Riunitisi, andarono dal sommo sacerdote, portando i bastoni. Presi i bastoni di tutti, entrò nel tempio a pregare. Finita la preghiera, prese i bastoni, uscì e li restituì loro; ma in essi non v’era alcun segno. Giuseppe prese l’ultimo bastone: ed ecco che una colomba uscì dal suo bastone e volò sul capo di Giuseppe. Il sacerdote disse allora a Giuseppe: “Tu sei stato eletto a ricevere in custodia la vergine del Signore”»[...]" (cfr. Antonio Tarallo, "San Francesco", 23-01-2021).
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- LA "DOMANDA" DI PASCAL, LA "RISPOSTA" DI VICTRO HUGO, E LA "CHIMERA" DEL "POST-UMANO".17 maggio 2024, di Federico La Sala
LA "MONARCHIA" DEI "DUE SOLI" (DANTE ALIGHIERI) E LA "CHIMERA" DEL "POST-UMANO".
- OLTRE IL GEOCENTRISMO, L’ANDROCENTRISMO E IL GINECENTRISMO:
- QUESTIONE ANTROPOLOGICA E TEOLOGICO-POLITICA (CORPO MISTICO) E RIVOLUZIONE COPERNICANA (#KANT2024).
- Appunti a margine di un mio vecchio lavoro "La #mente accogliente. Tracce per una svolta antropologica" (Roma, 1991):
A) LA #QUESTION DI #SHAKESPEARE,
- "AMLETO: [...] Che sublime capolavoro è l’uomo!
 Quanto nobile nella sua ragione!
Quanto nobile nella sua ragione!
 Quanto infinito nelle sue risorse!
Quanto infinito nelle sue risorse!
 Quanto espressivo nelle sue movenze,
Quanto espressivo nelle sue movenze,
 mirabile: un angelo negli atti,
mirabile: un angelo negli atti,
 un dio nell’intelletto!
un dio nell’intelletto!
 La bellezza dell’universo mondo!
La bellezza dell’universo mondo!
 La perfezione del regno animale!
La perfezione del regno animale!
 Eppure che cos’è agli occhi miei
Eppure che cos’è agli occhi miei
 questo conglomerato di terriccio?
questo conglomerato di terriccio?
 L’uomo per me non ha alcuna attrattiva...
L’uomo per me non ha alcuna attrattiva...
 e nemmeno la donna [...] "
(SHAKESPEARE, Hamlet, 2.2. 327-334).
e nemmeno la donna [...] "
(SHAKESPEARE, Hamlet, 2.2. 327-334).
B) LA DOMANDA DI PASCAL:
- «Quale chimera è dunque l’uomo? Quale novità, quale mostro, quale caos, quale soggetto di contraddizioni, quale prodigio! Giudice di tutte le cose, sprovveduto verme della terra; depositario del vero, cloaca d’incertezza e di errore; gloria e rifiuto dell’universo. Chi sbroglierà questo garbuglio?» ("Pensieri", 438).
C) LA "QUARTA" DOMANDA DI #KANT: "COSA E’ L’UOMO? (1800). "SAPERE AUDE!": "RIPENSANDO A #SOFOCLE (E ALLA SUA "#ANTIGONE"), OLTRE CHE A SHAKESPEARE (E AL SUO "AMLETO"), E’ BENE RIPARTIRE DA PASCAL CHE CON LA SUA «CHARITE’» SA PENSARE INSIEME "UOMO" E "CHIMERA" E OSA, ALL’INTERNO DELL’ORIZZONTE DELLA #RIVOLUZIONECOPERNICANA, RI-APRIRE LA #QUESTIONEANTROPOLOGICA E TEOLOGICA.
D) LA "MONARCHIA" DEI "DUE SOLI" (#DANTE2021) E IL "POST-UMANO". Con Pascal (Clermont-Ferrand, 19 giugno 1623 - Parigi, 19 agosto 1662) e Kant (Königsberg, 22 aprile 1724 - Königsberg, 12 febbraio 1804), non è forse l’ora e il tempo, oggi, di riprendere il filo di #MArianna, "la #saggezza, come un’altra #Arianna" e portarsi fuori dal "labirinto delle cose umane" (cfr. #VictorHugo, "Notre-Dame de Paris", L. I, cap. III), e, finalmente, dal #letargo (#Dante Alighieri, Par. XXXIII, v. 94)?!
NOTA:
- DELLA #CHIMERA (OVVERO DELLA "CAPRA") E DELLE METAMORFOSI DELL’ESSERE UMANO. Tracce per una #hamletica #svolta_antropologica...
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- FILOLOGIA E MUSICA: L’INNO ALLA GIOIA DI BEETHOVEN (7 MAGGIO 1824) E DELL’EUROPA E LA MEMORIA DI FREUD, "SIGISMONDO DI VINDOBONA" (ITALO CALVINO).3 maggio 2024, di Federico La Sala
FILOLOGIA ETIMOLOGIA ANTROPOLOGIA FILOSOFIA, TEOLOGIA, ARTE, POESIA E #MUSICA.
Inno alla Gioia...
- ΧΑΡΜΟΛΥΠΗ, Χαρμολυπη (kharmolúpē): χαρμολύπη (χάρμ(α) -ο- + λύπη]). From χάρμ(α) (chárm(a), “#joy”)....
- XAPITAS - #CHARITAS - #CHARITY, #CHARITE’, #CHARIDAD... JOY, FREUDE, GIOIA.
NOTE:
- STORIA E MEMORIA D’EUROPA: INNO ALLA #GIOIA (FREUDE). "Flashmob di giovani a Vienna per i 200 anni dell’Inno alla gioia, Austria Vicina, 2 MAGGIO 2024: "[...] Benché il committente fosse la Società Filarmonica di Londra, la prima esecuzione ebbe luogo a Vienna, nel Theater am Kärntnertor, che si trovava all’inizio della Kärntner Strasse, dove oggi c’è l’hotel Sacher. Beethoven, ormai sordo, assistette al conserto. Si dice che al termine il contralto Caroline Unger si fosse avvicinata al compositore e lo avesse fatto voltare perché vedesse ciò che non riusciva a udire: l’ovazione del pubblico che lo applaudiva in piedi. Era la sera del #7maggio 1824. [...]".
- FILOLOGIA, #PSICOANALISI (S. FREUD), POESIA (F. SCHILLER) E MUSICA (L. v. BEETHOVEN): "INNO ALLA #GIOIA" ("FREUDE). Ripensando al lavoro ("L’uomo #Mosè e la religione monoteistica", 1938)", una vera e propria "#sinfonia londinese" di "#Sigismondo di #Vindobona" (#ItaloCalvino), un omaggio a #VIENNA (e all’Austria Vicina e a Marco Di Blas): "[...] Benché il committente fosse la Società Filarmonica di Londra, la prima esecuzione ebbe luogo a Vienna, nel Theater am Kärntnertor, che si trovava all’inizio della Kärntner Strasse, dove oggi c’è l’hotel Sacher." (Austria Vicina, 2maggio 2024).
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- LA CULTURA EUROPEA, L’INNO ALLA GIOIA ("AN DIE FREUDE"), LA PSICOANALISI E LA FILOLOGIA: «FREUD ... E» LACAN.2 maggio 2024, di Federico La Sala
L’INNO ALLA GIOIA ("AN DIE FREUDE") E LA FILOLOGIA: KANT, SCHILLER, BEETHOVEN, "FREUD ... E" LACAN.
- UE - EUROPA. L’inno europeo:
- "La melodia utilizzata per rappresentare l’UE è tratta dalla Nona sinfonia, composta nel 1823 da Ludwig van Beethoven, che ha messo in musica l’"Inno alla gioia", scritto da Friedrich von Schiller nel 1785.
- L’inno simbolizza non solo l’#Unioneeuropea, ma anche l’Europa in generale. L’Inno alla gioia esprime la visione idealistica di Schiller sullo sviluppo di un legame di fratellanza fra gli uomini, visione condivisa da Beethoven.
- Nel 1972 il Consiglio d’Europa ha adottato il tema dell’Inno alla gioia di Beethoven come proprio inno. Nel 1985 è stato adottato dai capi di Stato e di governo dei paesi membri come inno ufficiale dell’Unione europea. L’inno è privo di testo ed è costituito solo dalla musica. Nel linguaggio universale della musica, questo inno esprime gli ideali di libertà, pace e solidarietà perseguiti dall’Europa.
LA CULTURA EUROPEA, SIGMUND #FREUD, E L’INNO ALLA #GIOIA (F. #Schiller, "An die #Freude", 1785).
NEL "NOME DI FREUD", LA "PSICOANALISI" DEL «JOYOSO» JACQUES LACAN. Due brevi note a margine della seguente "dichiarazione":
- “I wish to begin by saying what, while appearing under Freud’s name, extends beyond the time of his appearance and conceals its truth even in its very unveiling - that Freud’s name signifies «joy»” (Jacques Lacan, «An address: Freud in the century», 1956).
MEMORIA, STORIA, E FILOLOGIA. A CHE GIOCO GIOCHIAMO?!
- "GIOIOSAMENTE, GIOCOSAMENTE: «FREUD ... E»
- Freud - letto in italiano come si scrive è quasi «fred-do»
- Freud - pronunciato in tedesco dà «Froid», che in-francesce-tradotto-in-italiano è ancora «freddo»
- Freud - più una «e» in tedesco equivale alla nostra «gioia»
- Freud - più la «e», pronunciata in tedesco su suolo italico dà «fro(i)de»
- (cit. da una mia relazione intitolata, "Cosa nasconde Freud a Freud? Cosa nascondiamo noi a noi stessi? Note da/per un seminario interdisciplinare sulla "Interpretazione dei sogni", all’ Università di Salerno, Sede di Via Irno - 30. 03. 1976).
FREUD O LACAN? "SÀPERE AUDE" (ORAZIO - KANT). Nella ricorrenza del XXI Congresso Nazionale della Societa’ Psicoanalitica italiana, RICORDANDO ELVIO FACHINELLI (con le parole di Francesco Marchioro: "Spirito curioso, ironico, indipendente e analista non ortodosso denuncia con forza una sorta di «freudolente» uso della terapia e accusa la sua stessa istituzione di praticare una “psicoanalisi della risposta”, nel senso che si limita a «dare ragione all’esistente, razionalizzare le irrazionalità, tamponare i conflitti», offrire una terapia dell’adattamento invece di essere una psicoanalisi interrogante, capace di sollevare domande radicali sullo statuto del soggetto e la sua relazione alla Lebenswelt, al mondo della vita.": Altoadige.it, 22.12.2019), non è il caso di svegliarsi dal sonno dogmatico e riprendere il filo da Kant (1724-2024), dalla interpretazione dei "sogni di un visionario" (1766), e riprendere coraggiosamente a "servirsi della propria intelligenza ("1784), e, insieme, far un so critico della propria facoltà di giudizio, come ha fatto e sollecitato a fare in prima persona Michel Foucault nel 1984?
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE --- IL RICORDO DELLO "SPIRITO CRITICO" ("THE CRITICAL SPIRIT", 1967) E LA "STORIA" DI UN PROSSIMO "ARROSSIMENTO GENERALE".15 aprile 2024, di Federico La Sala
UNA #STORIA DI #LUNGADURATA E, FORSE, DI UN PROSSIMO "ARROSSIMENTO GENERALE" : IL "#SIDEREUSNUNCIUS" (#GALILEOGALILEI, 1610), L’#ITALIA E IL SUO GRANDE #PROVINCIALISMO NELLO STORICO PRESENTE DEL "#VILLAGGIO #GLOBALE" (2024).
CULTURA E SOCIETÀ, #OGGI: "SÀPERE AUDE!" (Koenigsberg, 1784; Kaliningrad, 2024).
 Una nota a margine di una riflessione di Giorgio Mascitelli: *
Una nota a margine di una riflessione di Giorgio Mascitelli: *- "La situazione italiana è caratterizzata da un marcato provincialismo culturale: esso è senz’altro in aumento rispetto a trent’anni fa. [...] Certo tutta l’#Europa è diventata più provinciale, eppure anche lo scarto con gli altri paesi europei è aumentato. [...] alla base della superprovincializzazione italiana sta una trasformazione di fondo: fino a 30 fa l’Italia era un paese in cui si producevano merci, questo poneva tutta una serie di problemi generali e locali che implicavano una cultura che li affrontasse; oggi dopo la #globalizzazione, l’Italia è diventata un centro di consumo, secondario, di merci prodotto altrove che vive di speculazione edilizia e finanziaria e di turismo [...]
- Pertanto è favorito lo sviluppo di una cultura d’accatto, che idolatra ciò che è secondario, in cui è più importante #imitare che #sperimentare e l’accresciuta internazionalizzazione è il sintomo di questo processo. E tuttavia, stanno arrivando tempi in cui non avere una cultura del tutto provinciale sarà importante e non un semplice orpello." ( cfr. cfr, Giorgio Mascitelli, Fbook 12 aprile 2024 ).
ANTROPOLOGIA, #STORIOGRAFIA, E #CRITICA DELLA #FACOLTÀ DI #GIUDIZIO (#KANT2024). CONSIDERANDO che il "villaggio globale" dell’attuale storico presente (#Nicea 325-2025) è molto prossimo (epocalitticamente) alla "#pace #perpetua" (#Kant2024), è sperabile che in giro emergano molte tracce di rimorso dell’incoscienza passata (e presente) e che "lo spirito critico" sia in Italia sia in Europa riprenda il suo cammino.
 Nota:
Nota:- Anthropology and #Metaphysics: "The Critical Spirit. Essays in Honor of Herbert Marcuse" (Kurt H. #Wolff, #Barrington Moore, Beacon Press, 1967 - 436 pagine).
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- UN LETARGO DI MILLENNI E IL PROGRAMMA DI DANTE. Una nota su una "ignota" svolta_antropologica in corso.17 marzo 2024, di Federico La Sala
USCIRE DALL’#INFERNO DELLA #RIPETIZIONE E DAL #LETARGO DI MILLENNI (Par. XXX, III, 94).
 Storia, filosofia, filologia, #psicoanalisi: una nota su una "ignota" #svolta_antropologica in corso...
Storia, filosofia, filologia, #psicoanalisi: una nota su una "ignota" #svolta_antropologica in corso...IL PROGRAMMA DI #DANTEALIGHIERI ALL’ORDINE DEL GIORNO (#25MARZO 2024: #Dantedì).
Riprendere il cammino di "#Ulisse" e portarsi oltre il "Convivio", il #Simposio, di #Platone e del suo "socratico" #amore (#Eros), avido e cupìdo, #figlio nato dalla astuta alleanza (#Metis) dell’#uomo-#Ingegno (gr. #Poros) e della #donna-#Povertà (gr. #Penia). La lezione di Platone appare essere la chiara codificazione di una fenomenologia dello spirito della #tragedia e la sua parola una versione della #Legge del #Figlio di Dio (#Zeus) , #Apollo: "«non è la madre la generatrice di quello che è chiamato suo figlio; ella è la nutrice del germe in lei inseminato. Il generatore è colui che la feconda...» (#Eschilo, #Eumenidi, 657 ss.): : un ’#cattolicesimo’ platonico.
- STORIAELETTERATURA, #FILOLOGIA E #CRITICA: #DIVINACOMMEDIA. Gianfranco #Contini: «[...] L’impressione genuina del postero, incontrandosi in Dante, non è d’imbattersi in un tenace e ben conservato sopravvissuto, ma di raggiungere qualcuno arrivato prima di lui» (cfr. "Un’interpretazione di Dante", in Id., G. Contini, "Un’idea di Dante. Saggi danteschi", Torino, Einaudi, 2001, I ed. 1970, pp. 110-11).
ARTE, #ANTROPOLOGIA, #FILOLOGIA E #TEOLOGIA:
- MICHELANGELO BUONARROTI, I PROFETI E LE SIBILLE.
LA "STORICA" #LEZIONE ANTROPOLOGICA DELLA #CORNICE LIGNEA DEL #TONDODONI (E DELLA #NARRAZIONE DELLA #VOLTA DELLA #CAPPELLASISTINA: DUE PROFETI E #DUE SIBILLE "INDICANO" LO #SPAZIOTEMPO DELLA #NASCITA DEL #FIGLIO DI #MARIAEGIUSEPPE. Come mai gli esperti della #GalleriadegliUffizi "insistono" a sostenere che nella "cornice del Tondo [...] sono raffigurate la testa di Cristo e quelle di #quattro profeti"?!
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- In principio era il Logos: uscire dall’#inferno (#Dantedì, #25marzo 2024) è possibile!16 marzo 2024, di Federico La Sala
PIANETA TERRA: L’ HAMLETICA QUESTIONE ANTROPOLOGICA (SHAKESPEARE, 1600; KANT, 1800) E LA "INTRODUZIONE DEL 1857" (K. MARX).
- "VECCHIE" NOTE PER CRITICA DELL’ECONOMIA POLITICA E DELLA TEOLOGIA DI MAMMONA... *
Con Il lungo processo storico che in Europa e nel mondo, almeno dal XVIII secolo, ha innescato la contrapposizione delle diverse forme del contesto sociale all’individuo come un puro strumento per i suoi scopi privati, non solo «Dio è morto» (#Nietzsche) ma anche l’#Uomo (#MichelFoucault) della #tradizione edipico-androcentrica (platonica, paolina, hegeliana, ed heideggeriana):
- "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il #capo è Cristo, e capo della #donna è l’uomo [gr. ἀνήρ, ἀνδρός «#uomo»], e capo di Cristo è Dio" (Paolo di Tarso, 1 Cor. 11, 1-3).
EARTHRISE (1968). In principio era il Logos (dell’#Efeso di #Eraclito e dell’evangelista Giovanni, non il #logo dello "apostolo" Paolo di Tarso) e uscire dall’#inferno (#Dantedì, #25marzo 2024) è possibile!
*
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- ARCHEOLOGIA E ANTROPOLOGIA."Il crepuscolo degli idoli" (e la fine dell’androcentrismo): «Come? L’uomo è soltanto un errore di Dio? O forse è Dio soltanto un errore dell’uomo?» (Nietzsche).28 febbraio 2024, di Federico La Sala
#QUESTIONE ANTROPOLOGICA (#KANT2024), #ARCHEOLOGIA FILOSOFICA E #FILOLOGIA COSMOTEANDRICA: IL #TRAMONTO DEGLI #ORACOLI, IL #CREPUSCOLO DEGLI #IDOLI *, E LA #FINE DELL’#ANDROCENTRISMO PLATONICO-HEGELIANO (#SAPEREAUDE!).
- PIANETATERRA. Fine della Storia o della "Preistoria"? "Pietà per il mondo, venga il nuovo #sapere" (M. #Serres, "Distacco", 1986). Una nota sul tema di una #antropologia e una #metafisica concreta...
"IL #TRAMONTO DEGLI ORACOLI": IL GRANDE #PAN E’ MORTO (#PLUTARCO, #Cheronea, 46/48 d.C. - #Delfi, 125/127 d.C.):
"«Quanto alla morte di questi esseri, io ho sentito la storia di un uomo che non era né uno sciocco né un imbroglione. Alcuni di voi hanno ascoltato il retore Emiliano, che era figlio di Epiterse, mio concittadino e maestro di grammatica. Proprio lui mi raccontò che una volta si era imbarcato per l’Italia su un mercantile con molti passeggeri a bordo: alla sera, quando già si trovavano presso le isole Echinadi, il vento cadde di colpo, e la nave fu trasportata dalla corrente fino a Paxo [isola di fronte all’Epiro, a sud di Corfù ]. Quasi tutti i passeggeri erano svegli, e molti, terminata la cena, stavano ancora bevendo.
 All’improvviso si sentì una voce dall’isola di Paxo, come di uno che gridasse il nome di Tamo. Tutti restarono sbalorditi. Questo Tamo era un pilota egiziano, ma quasi nessuno dei passeggeri lo conosceva per nome. Due volte la voce dell’uomo lo chiamò, e lui stava zitto. Alla terza rispose, e allora quello con tono più alto disse: “Quando sarai a Palode [porto della città di Butroto in Epiro] , annuncia che il grande Pan è morto”.
All’improvviso si sentì una voce dall’isola di Paxo, come di uno che gridasse il nome di Tamo. Tutti restarono sbalorditi. Questo Tamo era un pilota egiziano, ma quasi nessuno dei passeggeri lo conosceva per nome. Due volte la voce dell’uomo lo chiamò, e lui stava zitto. Alla terza rispose, e allora quello con tono più alto disse: “Quando sarai a Palode [porto della città di Butroto in Epiro] , annuncia che il grande Pan è morto”.
 «A queste parole, diceva Epiterse, tutti restarono sbalorditi, e si domandavano se fosse meglio eseguire l’ordine oppure non darsene cura. Allora Tamo decise che, se ci fosse stato vento, avrebbero costeggiato la riva in silenzio; se invece giunti là avessero trovato bonaccia, avrebbe riferito la notizia. Quando infinearrivarono a Palode, non un soffio di vento, non un’onda. Allora Tamo, sulla poppa, guardò verso terra e gridò: “Il grande Pan è morto”. Non aveva quasi finito di dirlo, che subito si levò un gran gemito, non di una persona sola, ma di tante, pieno di stupore. [...]». (Plutarco, "Il tramonto degli oracoli", in "Dialoghi delfici", trad. di M. Cavalli, Adelphi, Milano 1995, pp. 82-83).
«A queste parole, diceva Epiterse, tutti restarono sbalorditi, e si domandavano se fosse meglio eseguire l’ordine oppure non darsene cura. Allora Tamo decise che, se ci fosse stato vento, avrebbero costeggiato la riva in silenzio; se invece giunti là avessero trovato bonaccia, avrebbe riferito la notizia. Quando infinearrivarono a Palode, non un soffio di vento, non un’onda. Allora Tamo, sulla poppa, guardò verso terra e gridò: “Il grande Pan è morto”. Non aveva quasi finito di dirlo, che subito si levò un gran gemito, non di una persona sola, ma di tante, pieno di stupore. [...]». (Plutarco, "Il tramonto degli oracoli", in "Dialoghi delfici", trad. di M. Cavalli, Adelphi, Milano 1995, pp. 82-83).* "Il crepuscolo degli idoli" (e la fine dell’#androcentrismo): «Come? L’uomo è soltanto un errore di Dio? O forse è Dio soltanto un errore dell’uomo?» (Nietzsche).
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- UNA QUESTIONE DI FILOLOGIA E DI ANTROPOLOGIA (DA PORRE ALL’ORDINE DEL GIORNO, PER EVITARE... UN ARROSSIMENTO GENERALE).12 febbraio 2024, di Federico La Sala
LA BILANCIA E LA NASCITA...
DIRITTO, DOVERE, E COSTITUZIONE: UNA QUESTIONE DI FILOLOGIA E DI ANTROPOLOGIA (DA PORRE ALL’ORDINE DEL GIORNO, PER EVITARE... UN ARROSSIMENTO GENERALE).
La #bilancia della #giustizia e l’urgenza epocale di una #equilibrazione del #rapportosociale di ri-#produzione: "un’operazione #matematica ritenuta abitualmente sbagliata: un uomo più una donna ha prodotto, per secoli, un uomo" (Franca Ongaro Basaglia, 1978).
- Una nota in memoria di Franco Basaglia e di FrancaOngaro Basaglia
#SAPEREAUDE! (#KANT2024). LIBERARE la #Giustizia dalla benda (v. allegato) è un programma di uscita dallo "stato di minorità" (#Kant, 1784), una sollecitazione antropologica a servirsi della propria facoltà di giudizio, di avere il coraggio di #apriregliocchi (ricordare la difficoltà di #Freud, a riguardo) e di non #giudicare né con gli occhi chiusi né con un solo occhio.
Riconoscere l’#identità e la #differenza di sé con sé, di sé con l’altro da sé, di sé con l’altra da sé, l’#uguaglianza e la #diversità, è proprio una questione di "equilibrazione", di bilancia: ne va della nostra stessa #nascita e della nostra stessa #vita.
- Nota:
- LA NASCITA, LA BILANCIA (DELLA GIUSTIZIA), E IL GIUDIZIO (UNIVERSALE): "LA PESATRICE DI PERLE" (JAN #VERMEER).
- "La Pesatrice di perle (o Donna con una bilancia) è un dipinto a olio su tela (40,3x35,6 cm) di #JanVermeer, databile al 1664 [...]. Davanti a lei si vede uno specchio appeso alla parete e sul tavolo un drappo blu [...]. Sulla parete di fondo si vede un dipinto con il #Giudiziouniversale: forse un’allusione moraleggiante a non occuparsi troppo dei beni terreni e a conservare un’anima candida, come quelle che san Michele è solito soppesare con una #bilancia proprio al centro di molti dipinti del Giudizio. Il candore delle perle potrebbe e il tema della bilancia potrebbe simboleggiare la purezza della donna, oppure richiamare il tema della temperanza, ovvero la necessità di soppesare le proprie azioni. Lo stesso specchio di fronte alla donna simboleggerebbe il bisogno, in tale processo, di tenere #coscienza di sé. [...]" (https://it.wikipedia.org/wiki/Pesatrice_di_perle).
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- STORIA E FILOLOGIA: IN PRINCIPIO ERA IL LOGOS (NON UN LOGO).27 gennaio 2024, di Federico La Sala
MEMORIA, ANTROPOLOGIA, E "RAPPORTI SOCIALI DI PRODUZIONE" (27 GENNAIO 2024):
- "L’AMORE NON E’ LO ZIMBELLO DEL TEMPO" (SHAKESPEARE).
STORIA E FILOLOGIA: IN PRINCIPIO ERA IL LOGOS (NON UN LOGO).
RIMEDITARE INSIEME ALLA LEZIONE DI NIETZSCHE ("Sull’utilità e il danno della storia per la vita"), ANCHE QUELLA DI ESCHILO («i morti uccidono i vivi») E DI MARX ("Il morto fa presa sul vivo!").
Se non ora, quando!?
ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN...
#Earthrise #Kant2024
- Nota:
27 GENNAIO 2024: USCIRE A "RIVEDERE LE STELLE" (DANTE ALIGHIERI, Inf. XXXIV, 139).
- "AMORE è più forte di MORTE" (Ct. 8.6): RICORDARE LA RIFLESSIONE DI WALTER BENJAMIN SUL FATTO CHE «Neppure i morti saranno al sicuro dal nemico, se vince. E questo nemico non ha smesso di vincere» ("Sul concetto di storia", 1940) e, ancora e più chiaramente (oggi), RIFLETTERE SULL’INDICAZIONE EVANGELICA (dell’ Evangelo, non del "Van-gelo") «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu va’ e annunzia il regno di #Amore [non di #Mammona]» (Luca, 9. 60).
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- ARTE, STORIA, E "DOTTA IGNORANZA": UN "INVITO" A RIFLETTERE A PARTIRE DAL PLATONISMO E PAOLISMO RINASCIMENTALE (ALMENO).26 gennaio 2024, di Federico La Sala
STORIA, IMMAGINARIO, ARTE, ANTROPOLOGIA, PLATONISMO RINASCIMENTALE, E CATTOLICESIMO ROMANO-COSTANTINIANO (PAOLINISMO).
RICORDANDOSI OGGI (25 GENNAIO 2024), UN AVVENIMENTO DECISIVO DELLA VITA DELL’EUROPA (E DELL’INTERO PIANETA), LA "CONVERSIONE DI SANPAOLO, RI UN "INVITO" A #RIFLETTERE SULLA FORTE CONNESSIONE FORMALE (CON TUTTE LE SUE VARIE IMPLICAZIONI CULTURALI E TEOLOGICO-POLITICHE: RIFORMA LUTERANA, 1517; RIFORMA #ANGLICANA, 1534),
CON LA FIGURA DI PLATONE DELLA "SCUOLA DI ATENE" (DEL 1509-1511) DI RAFFAELLO,
CON IL "SAN PAOLO" DI PELLEGRINO TIBALBI (1585) DELLA "CAPPELLA BORROMEO" DELLA CHIESA DI "SANTA MARIA DELLE GRAZIE" DI MILANO, (ACQUISTATA E ACQUISITA NEL 2021 NELLE COLLEZIONI DEGLI UFFIZI) : "[...] Secondo gli studi di Allegri, il San Paolo, oltre ad essere un’opera molto importante nell’ambito della pittura della #Controriforma, costituisce anche un tassello cruciale per capire il ruolo del Tibaldi a Milano subito prima della sua partenza per la Spagna (1586), dove era stato chiamato dal re Filippo II per decorare l’#Escurial [...]"(https://www.uffizi.it/news/acquisizione-san-paolo-tibaldi ).
P. S.
PROPAGANDA (#FIDES), SPERANZA (#SPES), E CARITA’ (#CHARITAS). A mio parere, la "conversione" del "cittadino romano" ( "civis Romanus est"), Paolo di Tarso, divenuto "san Paolo", è un problema epocalmente importante (si pensi al prossimo anniversario di #Nicea, 325-2025), dal punto di vista storico e culturale: sia per il messaggio evangelico (la teologia-politica cattolico-costantiniana, il Paolinismo) sia per l’antropologia, per la filosofia, e l’antropologia culturale : l’essersi "autoproclamato" ("#apostolo"), e l’essere stato accreditato come tale ha deciso la "qualità" stessa del cristianesimo e della storia e della cultura dell’#Europa (nel male e nel bene), fino ad oggi.
- Kant2024
Note:
- RINASCIMENTO PLATONICO: PLATONE NELLA "SCUOLA DI #ATENE" (1509-1511) DI #RAFFAELLO.
- STORIA E MEMORIA DELLA COSMOTEANDRIA PLATONICO- PAOLINA: CONCILIO DI TRENTO.
- "Il concilio di #Trento o concilio Tridentino fu il XIX concilio ecumenico della Chiesa cattolica, convocato per reagire alla diffusione della riforma protestante in Europa. L’opera svolta dalla Chiesa per porre argine al dilagare della diffusione della dottrina di Martin #Lutero produsse la #controriforma. Il concilio di Trento si svolse in tre momenti separati dal 1545 al 1563 e, durante le sue sessioni, a Roma si succedettero cinque papi (Paolo III, Giulio III, Marcello II, Paolo IV e Pio IV). Produsse una serie di affermazioni a sostegno della dottrina cattolica che Lutero contestava. Con questo concilio la Chiesa cattolica rispose alle dottrine del calvinismo e del luteranesimo. L’aggettivo tridentino viene ancora usato per definire alcuni aspetti caratteristici del cattolicesimo ereditati da questo concilio e mantenuti nei secoli successivi sino al concilio Vaticano I ed al concilio Vaticano II. [...]" (https://it.wikipedia.org/wiki/Concilio_di_Trento).
- STORIA, LETTERATURA E #LETARGO (Par. XXXIII, 94) DA #TRAGEDIA. Ennio Flaiano (da grande "lettore" di #DanteAlighieri, v. "Autobiografia del Blu di Prussia") sapeva benssimo che la #luce era già stata spenta al tempo del #Galileo della #Galilea e del #GalileoGalilei (#Italia, #25gennaio 2024)
- STORIA, LETTERATURA E #LETARGO (Par. XXXIII, 94) DA #TRAGEDIA. Ennio Flaiano (da grande "lettore" di #DanteAlighieri, v. "Autobiografia del Blu di Prussia") sapeva benssimo che la #luce era già stata spenta al tempo del #Galileo della #Galilea e del #GalileoGalilei (#Italia, #25gennaio 2024)
- PROPAGANDA (#FIDES"), SPERANZA (#SPES), E CARITA’ (#CHARITAS). Chiarissimo Vincenzo Santoro, lode al suo eccellente lavoro di ricerca e studio: notevolissima l’immagine stampata a Napoli del "S. Paolo Apostolo"!
 A mio parere, la "conversione" del "cittadino romano" ( "civis Romanus est") Paolo di Tarso, divenuto "san Paolo", è un problema epocalmente importante (si pensi al prossimo anniversario di #Nicea, 325-2025), dal punto di vista storico e culturale: sia per l’#antropologiaculturale (#ErnestoDeMartino) sia per il #messaggioevangelico (la #teologia cattolico-costantiniana del #Paolinismo), l’essersi "autoproclamato" (#apostolo), e l’essere stato accreditato come tale ha deciso la "qualità" stessa del #cristianesimo e della #storia dell’#Europa (nel male e nel bene), fino ad #oggi.
A mio parere, la "conversione" del "cittadino romano" ( "civis Romanus est") Paolo di Tarso, divenuto "san Paolo", è un problema epocalmente importante (si pensi al prossimo anniversario di #Nicea, 325-2025), dal punto di vista storico e culturale: sia per l’#antropologiaculturale (#ErnestoDeMartino) sia per il #messaggioevangelico (la #teologia cattolico-costantiniana del #Paolinismo), l’essersi "autoproclamato" (#apostolo), e l’essere stato accreditato come tale ha deciso la "qualità" stessa del #cristianesimo e della #storia dell’#Europa (nel male e nel bene), fino ad #oggi.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- LA PUNTA DI UN ICEBERG: LA GRAVIDANZA DI ADAMO E IL "PARTO MASCHIO DEL TEMPO" (DEL PLATONISMO E DEL PAOLINISMO).21 gennaio 2024, di Federico La Sala
LA GRAVIDANZA DI ADAMO, IL "PARTO MASCHIO DEL TEMPO O LA GRANDE INSTAURAZIONE DELL’IMPERO DELL’UOMO SULL’#UNIVERSO" (FRANCIS BACON / BACONE, 1602), E UNA #QUESTION ANTROPOLOGICO-POLITICA EPOCALE (SHAKESPEARE, #AMLETO, 1602): LA PUNTA DI UN ICEBERG.
- "SÀPERE AUDE!" (#KANT2024). "Una nota a margine del problema "come nascono i bambini" ...
Quanto emerge dalle cronache relative alla "gravidanza durante la #transizione" (cfr. Clemente Pistilli, "Gravidanza durante la transizione, i medici: “Marco è al 5° mese, rischi per lui e per il bambino”", "La Repubblica, 19 gennaio 2024) è un evento, a mio parere, che mostra la punta di un iceberg gigantesco, che porta a galla i miti e i detriti di un #immaginario cosmo-te-andrico, biblico (da "#caduta") e platonico (da "#tragedia"), più che millenario, e sollecita a un immane e straordinario lavoro collettivo di presa di coscienza antropologica (se non si vuole andare a picco #titanic-amente): le sollecitazioni "cosmicomiche" (#Calvino) di #Dante Alighieri a uscire dal "letargo" (Par. XXXIII, 94) sono ancora del tutto ignorate!
 Forse è proprio il tempo di riaprire la #Commedia e non rinchiuderla ancora nell’orizzonte del "Boccaccio" e del "Petrarca" ...
Forse è proprio il tempo di riaprire la #Commedia e non rinchiuderla ancora nell’orizzonte del "Boccaccio" e del "Petrarca" ...ANTROPOLOGIA (CRISTOLOGIA) E FILOLOGIA. In principio era il Logos di Eraclito (non il "logo" androcentrico dell’Adamo di Paolo di Tarso: 1 Cor. 15, 45-47=C.E.I.]).
#21GENNAIO 2024.
Nota:
- LE RECINZIONI ("ENCLOSURES") MATERIALI E IMMATERIALI E L’ANDROCENTRISMO DI BACONE (PLATONISMO) E DI SAN PAOLO (CATTOLICESIMO PAOLINO-COSTANTINIANO):
- a) Bacone e "L’avallo delle deportazioni in Virginia": "[...] Dopo la privatizzazione delle terre, come uomo politico concettualizzò la scienza del terrore assecondando e sostenendo le deportazioni di massa dei diseredati e dei poveri nelle colonie americane della Virginia. Tra le altre cose è necessario ricordare che nel 1619 il Consiglio Privato, di cui a quel tempo Bacone faceva parte, violando apertamente la legge inglese, e per assecondare la volontà della Virginia Company, costrinse alla deportazione nelle colonie americane ben 165 bambini, provenienti dal Bridewell Palace. Di quei 165 bambini (di età compresa tra gli 8 e i 16 anni) nel 1625 a seguito dei maltrattamenti subiti nelle piantagioni ne rimasero in vita solo dodici. Le deportazioni continuarono coinvolgendo altri millecinquecento bambini nel 1627 e ulteriori quattrocento, di origine irlandese, nel 1653".
- b) Paolo di Tarso e la "recinzione" androcentrica della figura di "Cristo": "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ, ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- EPIFANIA 2024. Una domanda "Hamlet-ica" (una "question") a margine di un evento.5 gennaio 2024, di Federico La Sala
RITORNO AL FUTURO, 6. EPIFANIA 2024:
STORIA DELL’ARTE, STORIOGRAFIA DELL’EUROPA, ARCHEOLOGIA, ANTROPOLOGIA, E PSICOANALISI DELLA SOCIETA’ CONTEMPORANEA.
_*** Una domanda "Hamlet-ica" (una "question") a margine di un evento...
DI QUALE #MANIFESTAZIONE (EPIFANIA) SI CELEBRA LA MEMORIA: "A CHE GIOCO GIOCHIAMO", #ANCORA, OGGI?
 "SIDEREUS NUNCIUS" (#GALILEO #GALILEI, 1610). A 800 ANNI DAL #PRESEPE DI GRECCIO (1223), UN EVENTO COSMOLOGICO (SEGNATO DALLA #STELLA #COMETA DI GIOTTO) E ANTROPOLOGICO (DALLA SEMPLICE NASCITA DI UN #BAMBINO), CONTINUAMENTE "SEGNATO" DALLA #TRAGEDIA DI "LAIO", DI "GIOCASTA" E DALLA RELIGIONE DEI "GIOCASTOLAI", DEL "FIGLIO PRIMOGENITO" (#EDIPO), DALLA "STRAGE DEGLI INNOCENTI", E DALLA "FUGA IN EGITTO" (Adam #Elsheimer, 1609).
"SIDEREUS NUNCIUS" (#GALILEO #GALILEI, 1610). A 800 ANNI DAL #PRESEPE DI GRECCIO (1223), UN EVENTO COSMOLOGICO (SEGNATO DALLA #STELLA #COMETA DI GIOTTO) E ANTROPOLOGICO (DALLA SEMPLICE NASCITA DI UN #BAMBINO), CONTINUAMENTE "SEGNATO" DALLA #TRAGEDIA DI "LAIO", DI "GIOCASTA" E DALLA RELIGIONE DEI "GIOCASTOLAI", DEL "FIGLIO PRIMOGENITO" (#EDIPO), DALLA "STRAGE DEGLI INNOCENTI", E DALLA "FUGA IN EGITTO" (Adam #Elsheimer, 1609).
 La lezione del figlio di #Giulia #Beccaria, #AlessandroManzoni, sulla vicenda (1628 circa) della "#MonacadiMonza" non ha ancora chiarito nulla sulla "fenomenologia dello spirito" della #famiglia (che uccide) che rende impossibile la vita ai #PomessiSposi?! Non è meglio svegliarsi dal #sonnodogmatico (#Kant) e cambiare "le regole del gioco" dell’OCCIDE_re_NTE? Se non ora, quando?!
La lezione del figlio di #Giulia #Beccaria, #AlessandroManzoni, sulla vicenda (1628 circa) della "#MonacadiMonza" non ha ancora chiarito nulla sulla "fenomenologia dello spirito" della #famiglia (che uccide) che rende impossibile la vita ai #PomessiSposi?! Non è meglio svegliarsi dal #sonnodogmatico (#Kant) e cambiare "le regole del gioco" dell’OCCIDE_re_NTE? Se non ora, quando?!- APRIREGLIOCCHI (S. #FREUD), TUTTI E DUE: "ORIENTARSI NEL PENSIERO" (#KANT) E RIEQUILIBRARE IL RAPPORTO TRA I "#DUE #SERPENTI DEL #CADUCEO" (#DANTELIGHIERI CON I SUOI #DUESOLI IN-SEGNA) NELLA REALTA’, PER PORTARSI FUORI DALLA RAGIONE TRAGICA (PLATONICA PAOLINA HEGELIANA E HEIDEGGERIANA) E NON ESSERE RIPORTATO ALL’#INFERNO DAL CARONTICO PSICOPOMPO DELLA #TRADIZIONE OLIMPICA, #MERCURIO (#ERMES). #EPIFANIA2024
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- AMLETO IN LOTTA CONTRO "IL TEMPO FUORI DEI CARDINI": A SHAKESPEARE, IL "PRESEPE" NON PIACE25 dicembre 2023, di Federico La Sala
TEATRO E METATEATRO: "THE TIME IS OUT OF JOINT" (HAMLET, I.5).
- MEMORIA E STORIA: AMLETO IN LOTTA CONTRO "IL TEMPO FUORI DEI CARDINI".
 In principio era il Logos...
In principio era il Logos...
Una nota a margine del lavoro in corso di Paul Adrian Fried (cfr. "Shepherds in Shakespeare, Oedipus, Hamlet, and the Bible", December 24, 2023):
IL "PRESEPE" NON MI PIACE (EDUARDO DE FILIPPO, "NATALE IN CASA CUPIELLO", 1931). SENZA PENSARE COL "SENNO DEL POI", STORIOGRAFICAMENTE E INDIPENDENTEMENTE DA FREUD, si può benissimo pensare che a Shakespeare il "presepe" dell’Europa "cattolico-spagnola" non piaccia e, al contempo, che egli, sul filo della tradizione umanistico-rinascimentale (e delle specifiche sollecitazioni della riforma protestante e della riforma anglicana, di Giordano Bruno, e alla presenza di Elisabetta I) collabori dentro a un ampio lavoro culturale del tempo alla ripresa della tradizione dei pastori dell’Arcadia e abbia consapevolmente sollecitato a riflettere su un programma teologico-politico di riforma storico-sociale epoca, di un "ritorno" al "Paradiso terrestre" (come già Dante Alighieri, "Monarchia"). Ieri, come oggi, non è bene riprendere il filo della sollecitazione ad uscire dal letargo?!
Antropologia, Presepe, e cosmoteandria: origine storica dell’antisemitismo "francescano" (contro ebrei e musulmani). La progressiva riduzione del messaggio evangelico e francescano, caduto nelle maglie della tradizione ecclesiastica (paolina-costantiniana), trova il suo momento culminante nell’incapacità di risolvere pacificamente il rapporto con l’ Islam nel 1453 ("caduta di Costantinopoli e e fallimento della teologia "ecumenica" della "pace della fede", il "De pace fidei" del cardinale Cusano) e nella decisione di innescare la marcia sull’Immacolata concezione (della Madre del Figlio di Dio) proprio da parte del papa "francescano" Sisto IV della Rovere, con la fondazione (1475-1478) del suo personale "presepe" (la "Cappella Sistina").
- Teatro e Storia:«’O presepe nun me piace»" (Eduardo De Filippo, "Natale in casa Cupiello"):
- "[...] Portata in scena per la prima volta al Teatro Kursaal di Napoli (oggi Cinema Filangieri), il 25 dicembre 1931, Natale in casa Cupiello segna di fatto l’avvio vero e proprio della felice esperienza della Compagnia del "Teatro Umoristico I De Filippo", composta dai tre fratelli e da attori già famosi o giovani alle prime armi che lo diventeranno [...]".
- MEMORIA E STORIA: AMLETO IN LOTTA CONTRO "IL TEMPO FUORI DEI CARDINI".
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- CULTURA E SOCIETÀ: "LA MONTAGNA INCANTATA" (1924) e "IL DISAGIO DELLA CIVILTÀ" (1929).20 novembre 2023, di Federico La Sala
L’EUROPA, "L’ELOGIO DELLA FOLLIA" (1511) E L’UTOPIA (1516). CULTURA E SOCIETÀ: "LA MONTAGNA INCANTATA" (1924) e "IL DISAGIO DELLA CIVILTÀ" (1929).
- In memoria di Ferrante Sanseverino (Principe di Salerno) e Girolamo Seripando (Arcivescovo di Salerno)
Una nota a margine di una "citazione" di una lettera di #Tommaso Moro a #Erasmo di Rotterdam:
«Non puoi immaginarti quanto ora io m’imbaldanzisca, quanto mi gonfi, quanto mi tenga più su. Immagino di continuo che i miei Utopiani mi vorranno eleggere loro sovrano perpetuo, tanto che mi vedo già incedere del diadema di frumento, mi vedo cospicuo nel paludamento francescano, mi vedo portare lo scettro venerabile di un covone di messi. Circondato da un’insigne accolta di cittadini di Amauroto, mi vedo, in pompa solenne, andare incontro agli ambasciatori e ai principi delle genti straniere, ben miseri al nostro confronto, pieni di sciocca superbia, perché ornati fanciullescamente, pieni di vanità femminile, carichi di disprezzabile oro, ridicoli per la porpora, per le gemme, per altre bazzecole.» (Cfr. E. Scelza, "LE CITAZIONI: il sogno ad occhi aperti di Tommaso Moro", "Gente e Territorio", 15 novembre 2023).
SE SI CONSIDERA CHE TOMMASO MORO (1478-1535) scrive quello che scrive ad ErasmodiRotterdam (1469-1536) il 4 dicembre 1516, e che, al contempo, Martin #Lutero (1483-1546) nell’ottobre del 1517 diffonde le sue #95Tesi, c’è da pensare che ognuno sognasse un proprio #sogno ad occhi aperti e non avessero affatto un #mondo "unico e comune" (#Eraclito) : questo spiega, soprattutto da parte di Erasmo e Moro, anche la loro presa di distanza dalle sollecitazioni di riforma della Chiesa da parte di Lutero.
Non è un caso che, pochi anni dopo (al tempo di Carlo V, dopo il Sacco di Roma nel maggio del 1527), la richiesta di un tentativo di edizione della "#Monarchia" di #DanteAlighieri, fatto da Alonzo de #Valdès (1490 - 1532) e Mercurino di #Gattinara (1465-1530), è lasciato cadere nel vuoto da Erasmo da Rotterdam (nel marzo del 1527), e, ancora e purtroppo, di lì a poco c’è la rottura di #EnricoVIII con Chiesa cattolica e l’avvio della Riforma Anglicana (1534).
All’indomani della Prima Guerra Mondiale, alla fine della sua "Montagna Incantata" (#Zauberberg, 1924), #ThomasMann scrive: "Chi sa se anche da questa mondiale sagra della morte, anche dalla febbre maligna che incendia tutt’intorno il cielo piovoso di questa sera, sorgerà un giorno l’amore?" (trad. di E. Pocar).
Nel 1929, in Italia, la Chiesa Cattolica e lo Stato italiano sottoscrivono il "Concordato" (#PattiLateranensi, 11 febbraio 1929): a Vienna, intanto, #SigmundFreud porta avanti il suo lavoro e pubblica il risultato delle sue ricerche e delle sue riflessioni sul "Disagio della civiltà" (e nella civiltà).
P.S. - STATO ITALIANO E STATO PONTIFICIO (CHIESA CATTOLICA): LA QUESTIONE ROMANA E IL "#20SETTEMBRE 1870" (Festa della liberazione della capitale e dell’unificazione nazionale, abolita dal Fascismo). #BENEDETTOCROCE, NELLA "STORIA D’ITALIA DAL 1871 AL 1915" (1928), A PROPOSITO DEL PERSONAGGIO "LUDOVICO SETTEMBRINI" DELLA "MONTAGNA INCANTATA" ("DER ZAUBERBERG", 1924) DI THOMAS MANN, COSI’ SCRIVE:
- «Fu creduto, e io credetti, che con questo nome egli alludesse al nostro Luigi Settembrini; ma alcuni anni dopo, in un incontro col Mann in Germania, egli mi confessò di avere ignorato affatto l’esistenza di Luigi Settembrini, e di aver composto quel nome derivandolo dal “20 settembre”!» (cfr. #SantoMazzarino, "#Pirandello. La storia dell’Italia moderna e antica", a c. di Maria Adele Cavallaro, Roma 2022, p. 203).
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- RIPRENDERE IL "DIALOGO SOPRA I DUE MASSIMI SISTEMI". Alcune note sui "documenti vaticani del processo di Galileo Galilei (1611-1741)".4 novembre 2023, di Federico La Sala
"LA LINGUA BATTE DOVE IL DENTE DUOLE". Alcune note a margine di "I documenti vaticani del processo di Galileo Galilei (1611-1741). Nuova edizione accresciuta, rivista e annotata da SERGIO PAGANO, 2009, pp. CCLVIII, 332, tav. 24 ISBN 978-88-85042-62-9. *
- I documenti vaticani del processo di Galileo Galilei
 SERGIO M. PAGANO
SERGIO M. PAGANO
 a cura di
a cura di
- Lev, Città del Vaticano 2009
 Anno di edizione originale: 2009
Anno di edizione originale: 2009
 ISBN: 9788885042629
ISBN: 9788885042629
- Il volume rappresenta la nuova edizione accresciuta, rivista e annotata dal prefetto dell’Archivio Segreto Vaticano, mons. Sergio Pagano, della precedente raccolta di documenti pubblicata con lo stesso titolo nel 1984. L’A. afferma che la brevità dei tempi allora a disposizione lo costrinse a produrre un risultato non del tutto soddisfacente, ora completato dalla presente nuova edizione di 550 pagine, 16 tavole fuori testo e 1300 note, un’edizione che può essere considerata come un “contributo umile e silenzioso dell’Archivio Segreto alla celebrazione dell’Anno Internazionale dell’Astronomia" [2009].
 Il lavoro tiene conto non solo dei numerosi studi relativi a caso Galileo apparsi dal 1984 alla data della presente pubblicazione, ma soprattutto del fatto che a, partire dal 22 gennaio 1998, gli archivi del Sant’Officio e quello della Congregazione dell’Indice, entrambi conservati nell’Archivio storico della Congregazione per la Dottrina della Fede, furono ufficialmente aperti agli studiosi.
Il lavoro tiene conto non solo dei numerosi studi relativi a caso Galileo apparsi dal 1984 alla data della presente pubblicazione, ma soprattutto del fatto che a, partire dal 22 gennaio 1998, gli archivi del Sant’Officio e quello della Congregazione dell’Indice, entrambi conservati nell’Archivio storico della Congregazione per la Dottrina della Fede, furono ufficialmente aperti agli studiosi.
 Rispetto alle edizioni precedenti degli atti processuali galileiani le novità più rilevanti della nuova opera sono determinate dalla maggiore conoscenza dei personaggi implicati nel procedimento, tutti precisati nelle note, compresi moltissimi inquisitori; dai documenti presentati nella loro genuinità - originali, copie, sunti, note d’ufficio - con rigorose note archivistiche; dal panorama delle fonti "vaticane" riguardanti il processo allo scienziato pisano e cioè l’Archivio storico della Congregazione per la Dottrina della Fede, l’Archivio Segreto Vaticano, la Biblioteca Apostolica Vaticana. La presente nuova edizione comprende naturalmente tutte le carte già note e almeno una ventina di nuovi documenti reperiti nell’Archivio del Santo Officio dopo il 1991 da alcuni ricercatori: in particolare Ugo Baldini e Leen Spruit.
Rispetto alle edizioni precedenti degli atti processuali galileiani le novità più rilevanti della nuova opera sono determinate dalla maggiore conoscenza dei personaggi implicati nel procedimento, tutti precisati nelle note, compresi moltissimi inquisitori; dai documenti presentati nella loro genuinità - originali, copie, sunti, note d’ufficio - con rigorose note archivistiche; dal panorama delle fonti "vaticane" riguardanti il processo allo scienziato pisano e cioè l’Archivio storico della Congregazione per la Dottrina della Fede, l’Archivio Segreto Vaticano, la Biblioteca Apostolica Vaticana. La presente nuova edizione comprende naturalmente tutte le carte già note e almeno una ventina di nuovi documenti reperiti nell’Archivio del Santo Officio dopo il 1991 da alcuni ricercatori: in particolare Ugo Baldini e Leen Spruit.
 Il volume annota criticamente i vari documenti dei quali propone una edizione fedele agli originali. L’edizione dei documenti è preceduta da una ampia introduzione storica alle vicende che gradualmente portarono all’istruzione e allo svolgimento del processo, a partire dalle denunce del domenicano Tommaso Caccini, dal 1616 al 1633 e fino al 1741, quando, sotto il pontificato di Papa Benedetto XIV, fu permessa la costruzione del mausoleo nella basilica di Santa Croce di Firenze e consentita la pubblicazione a Padova dell’opera galileiana.
Il volume annota criticamente i vari documenti dei quali propone una edizione fedele agli originali. L’edizione dei documenti è preceduta da una ampia introduzione storica alle vicende che gradualmente portarono all’istruzione e allo svolgimento del processo, a partire dalle denunce del domenicano Tommaso Caccini, dal 1616 al 1633 e fino al 1741, quando, sotto il pontificato di Papa Benedetto XIV, fu permessa la costruzione del mausoleo nella basilica di Santa Croce di Firenze e consentita la pubblicazione a Padova dell’opera galileiana.
*
UNA RIFLESSIONE DI ANTONIO CASTRONUOVO (1 novembre 2023): "Penso a Bruno e a Sarpi e a come la rivoluzione copernicana della morale sia stata avviata da frati, domenicani o serviti che siano. In qualche modo, la cosa fa sorridere; come fa sorridere il fatto che se Bruno andò al rogo, Sarpi fu invece un temuto scomunicato cui fu concesso di continuare a vivere nel proprio convento veneziano.
 Ma a questi frati - ancorché versati agli esperimenti scientifici - mancò quel che a Bologna si dice "lo sbuzzo", il talento pratico, quello che determina effetti sulla realtà materiale. Ne godette Galileo, che infatti diventò sommamente pericoloso, da cui i processi, le estorte abiure ecc.
Ma a questi frati - ancorché versati agli esperimenti scientifici - mancò quel che a Bologna si dice "lo sbuzzo", il talento pratico, quello che determina effetti sulla realtà materiale. Ne godette Galileo, che infatti diventò sommamente pericoloso, da cui i processi, le estorte abiure ecc.
 Torno spesso a questa lugubre storia, mediante un magnifico volume che nasce "da dentro", dal Vaticano. Me ne chiedo la ragione, e a volte penso che non resti altro agli sconfitti - ai nemici della scienza, alle intelligenze offuscate dalle fedi - che fare il verso di «studiare i propri errori». (A. Castronuovo).
Torno spesso a questa lugubre storia, mediante un magnifico volume che nasce "da dentro", dal Vaticano. Me ne chiedo la ragione, e a volte penso che non resti altro agli sconfitti - ai nemici della scienza, alle intelligenze offuscate dalle fedi - che fare il verso di «studiare i propri errori». (A. Castronuovo).
DUE NOTE:
a) #FISICA E #METAFISICA.#Patafisica-#mente, non si è ancora ascoltato il #suono del #nome e del #cognome di #GalileoGalilei, #Galileo, #Galilei; e, ancora, non si è visto che le radici della #Terra sono #Cosmicomiche (#ItaloCalvino), e, che è "l’amor che move il sole e le altre stelle"(#DanteAlighieri).
b) #STORIA #STORIOGRAFIA E #COSMOLOGIA: "#ECCE #HOMO" (#NIETZSCHE, 1888). BRILLANTISSIMA E OPPORTUNISSIMA SOLLECITAZIONE PER RIFLETTERE NON SOLO SU #GIORDANOBRUNO E #PAOLOSARPI, MA ANCHE SU #ITALOCALVINO E "#SIGISMONDO DI #VINDOBONA" (RILEGGERE "IL #CASTELLO DEI #DESTINI #INCROCIATI). SULLA IN-#CROCIATA DISCUSSIONE SU #RAGIONE E #FEDE (#CHIESACATTOLICA), FORSE, è tempo di cambiare decisamente #orizzonte e #logica della #ricercascientiffica e filosofica: la condanna di Gesù della #Galilea, come la condanna di #Galileo #Galilei, è di natura teologica e politica prima di tutto, e, poi scientifica e tecnica: la questione fondamentale è quella antropologica (cristologica), come aveva ben capito #Kant (e già #Orazio di #Venosa): "#sàpere aude!". Ricordare anche #Feuerbach, #naturalmente!
- I documenti vaticani del processo di Galileo Galilei
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- SVEGLIARSI DA UN SOGNO DEMIURGICO DI LUNGA DURATA. "Il parto maschio del tempo ovvero la grande instaurazione del dominio dell’uomo sull’universo" di "Bacone" è ormai a "buon" punto.19 settembre 2023, di Federico La Sala
FILOSOFIA, FILOLOGIA, ANTROPOLOGIA, POLITICA, E RELIGIONE E STORIA E LETTERATURA.
LA DIAGNOSI HAMLETICA DI SHAKESPEARE E LA DIALETTICA "NAPOLEONICA" DELLO SPIRITO DI HEGEL:
- "[...] Io mi attengo a quest’idea, che lo Spirito del mondo ha dato al tempo l’ordine di avanzare. Tale comando è stato eseguito; questa essenza s’avanza come una compatta falange corazzata, irresistibilmente, ovunque, con un movimento impercettibile come quello del sole. Le muovono contro, l’affiancano, da tutte le parti, innumerevoli truppe leggere, la maggior parte delle quali non sa affatto di che si tratti, e non fa che ricevere colpi sulla testa, come da una mano invisibile. Tutte le millanterie temporeggiatrici o i colpi a vuoto pur tanto celebrati non servono a niente contro di essa. [...] La cosa più sicura (dal punto di vista interno ed esterno) è di non perdere di vista l’avanzata del gigante"[...]" (cfr. G. W. F. Hegel, "Lettere": a Niethammer, 5 luglio 1816; con prefazione di E. Garin - Laterza).
Nonostante Hegel sapesse che "The time is out of joint" (Shakespeare, "Hamlet", I.2), la visione COSMOTEANDRICA di Napoleone a cavallo a Jena (1806) in parte lo accecò e non poté più portarsi fuori dalla DIALETTICA della "strada di Damasco" (e "protestante" e "cattolica"). Con Amleto (e Marx), tuttavia non si può non ripetere: "Ben detto, vecchia talpa!" (I.5).
ANTROPOLOGIA, FILOLOGIA, TECNOCRAZIA, E COSMOTEANDRIA: IL"NOVUM ORGANUM" (BACONE). L’ AVANZATA DEL GIGANTE, ormai, con i suoi stivali dalle sette leghe, è diventata inarrestabile: è un "golem-antico" progresso sulla strada aperta dal demiurgico sogno tragico dell’Accademia platonico-socratica, paolina, baconiana-hobbesiana, e schmittiana. "Il parto maschio del tempo ovvero la grande instaurazione del dominio dell’uomo sull’universo" è ormai a "buon" punto.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- ELOGIO DELLA FOLLIA E DELLA GUERRA. UNA NOTA STORIOGRAFICA SULLA STORIA E LA "VITA MODERNA"29 agosto 2023, di Federico La Sala
ELOGIO DELLA FOLLIA E DELLA GUERRA (degli "uomini") , UN’ANTROPOLOGIA "ANDROCENTRICA", STORIOGRAFIA, E RINASCIMENTO MERIDIONALE.
- Una nota a margine di una citazione di Erasmo da Rotterdam (*) e un omaggio alla memoria del prof. Romeo De Maio (Università degli Studi di Salerno):
- Chiarissimo Ernesto Scelza ... ottima sollecitazione a riprendere il discorso e la riflessione sul "Perché la guerra?" (Carteggio di Freud e Einstein, 1933) dall’opera di Erasmo da Rotterdam:
- LA GUERRA E’ IMPRESA DELLA FOLLIA. "Ora dovrei aggiungere che nulla di grande si può intraprendere senza la mia spinta, perché è a me che si deve l’invenzione di ogni nobile arte. Forse che non sia la guerra la fonte e il coronamento di ogni celebrata impresa? E che c’è di più pazzesco dell’impegnarsi, per non so quali cause, in un confronto da cui, immancabilmente, ognuna delle due parti trae più danno che guadagno? Dei caduti, poi, neanche si parla [...]" (Erasmo, "Elogio della follia", [pf. 23])
"Cum grano salis", e con tutte le differenze implicite ed esplicite.... se si tira un filo, dagli inizi del Cinquecento (l’ "Elogio della Follia" è degli anni 1509-1511) al "29 agosto 2023" e alla dimensione talebanica della "vita moderna", diffusa su tutto il pianeta, io proporrei di ripercorrere questo "tratto di storia", rileggendo un bel lavoro dal titolo "Donna e Rinascimento: l’inizio della rivoluzione-" (Romeo De Maio, il Saggiatore, 1987), da cui riprendo la seguente citazione: "La potestas maritalis aveva per fondamento che la moglie fosse sempre educanda, per legge. Lo credeva pure Erasmo". Questa la "question" radicata nell’orizzonte del "tempo fuori dai cardini" (Shakespeare, "Amleto", I.2).
Sul tema, come si sa, non la pensava affatto allo stesso modo, se non ricordo male, il Principe di Salerno, Ferrante Sanseverino.
*
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- CRITICA DELLO "STATO NASCENTE" E DELLO "STATO PUTRESCENTE". DUE NOTE IN MEMORIA DI ELVIO fACHINELLI E fRANCESCO ALBERONI.16 agosto 2023, di Federico La Sala
SOCIOLOGIA, PSICOANALISI, E CRITICA DELLO "STATO NASCENTE" E DELLO "STATO PUTRESCENTE":
"MOVIMENTO E ISTITUZIONE" (1977) E "INNAMORAMENTO E AMORE" (1979) .... E "LA FRECCIA FERMA. TRE TENTATIVI DI ANNULLARE IL TEMPO" (1979).
Due appunti sulle ricerche di Elvio Fachinelli e di Francesco Alberoni:
A) - "Alberoni, ’Innamoramento e amore’ bestseller internazionale (Adnkronos):
"Era il 1979 quando dall’editore Garzanti usciva il saggio che lo rese il sociologo più famoso d’Italia [...] Dopo un lungo periodo di #ideologie che avevano negato ogni valore alla coppia, all’#innamoramento e ridicolizzato l’esclusività e la gelosia, "Innamoramento e amore" fu come un lampo che fece improvvisamente vedere una realtà nascosta. Ed ebbe un immediato successo con traduzioni in 25 lingue. Criticando le correnti filosofiche e psicologiche dominanti che riducevano l’innamoramento a una #rimozione sessuale o a una #regressione infantile, il libro lo colloca nel #campo dei processi collettivi in cui #due individui si ribellano ai loro legami precedenti e danno origine, attraverso l’entusiasmo dello stato nascente, a una nuova comunità: la coppia innamorata, proiettata sul futuro." (AdnKronos).
B) - STATO "PUTRESCENTE": SOCIETA’ ARCAICA, NEVROSI OSSESSIVA, E FASCISMO. Sul tema, e sul percorso "sociologico" di Francesco Alberoni, forse, è opportuno richiamare anche il contesto storico e riconsiderare il lavoro critico della rivista "L’erba voglio" e il "soprendente" saggio del 1979 dello psicoanalista Elvio Fachinelli, dal filosofico titolo "LA FRECCIA FERMA. Tre tentativi di annullare il tempo" (cfr. la mia recensione su BELFAGOR, 3, 1980, pp. 363-365).
Individuo e società... questione antropologica e paradosso del mentitore:
 Sociologia, filosofia, psicoanalisi e critica della ragione "pura", troppo "pura"!
Sociologia, filosofia, psicoanalisi e critica della ragione "pura", troppo "pura"!Una nota in ricordo e in omaggio al lavoro del sociologo Francesco Alberoni... *
Nonostante Alberoni abbia scritto un lavoro molto interessante e creativo, a partire dal suo celebre "Movimento e istituzione" (1977), intitolato "Genesi" (1989), l’ambiguità del suo orizzonte sociologico è rimasto per così dire intrappolato nella logica dell’individualismo (e non solo metodologico), ha chiuso un occhio (ricordare anche Freud) e non ha saputo sciogliere il nodo della nascita dell’ in_divi_duo, (dal e) del "due in uno" (da non dividere).
Il problema antropologico epocale è ancora quello evangelico giovanneo (e cristologico) di Nicodemo (Enzo Paci, 1944): "come si ri-nasce", "come nascono i bambini".
 Buon ferragosto (15 agosto 2023).
Buon ferragosto (15 agosto 2023). -
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- PIANETA TERRA: ANTROPOLOGIA FILOSOFICA E "APOCALISSE". L’eredità del nostro tempo.14 agosto 2023, di Federico La Sala
PIANETA TERRA: ANTROPOLOGIA FILOSOFICA E "APOCALISSE". "SAPERE AUDE!" (KANT): UNA "RIVELATIVA" QUESTIONE DI "CRITICA DELL’ ECONOMIA POLITICA" *
L’eredità del nostro tempo
di Giorgio Agamben (Quodlibet, 31 luglio 2023)
La meditazione sulla storia e la tradizione che Hannah Arendt pubblica nel 1954 porta il titolo, certo non casuale, Tra passato e futuro. Si trattava, per la filosofa ebreo-tedesca da un quindicennio rifugiata a New York, di interrogarsi sul vuoto tra passato e futuro che si era prodotto nella cultura dell’Occidente, cioè sulla rottura ormai irrevocabile della continuità di ogni tradizione. È per questo che la prefazione al libro si apre con l’aforisma di René Char Notre héritage n’est précédé d’aucun testament. In questione era, cioè, il problema storico cruciale della ricezione di un’eredità che non è più in alcun modo possibile trasmettere.
Circa venti anni prima, Ernst Bloch in esilio a Zurigo aveva pubblicato col titolo L’eredità del nostro tempo una riflessione sull’eredità che egli cercava di recuperare frugando nei sotterranei e nei depositi nella cultura borghese ormai in disfacimento («l’epoca è in putrefazione e al tempo stesso ha le doglie» è l’insegna che apre la prefazione al libro). È possibile che il problema di un’eredità inaccessibile o praticabile solo per vie scabrose e spiragli seminascosti che i due autori, ciascuno a suo modo, sollevano non sia per nulla obsoleto e ci riguardi, anzi, da vicino - così intimamente che a volte sembriamo dimenticarcene. Anche noi facciamo esperienza di un vuoto e di una rottura fra passato e futuro, anche noi in una cultura in agonia dobbiamo cercare se non una doglia del parto, almeno qualcosa come una parcella di bene sopravvissuta allo sfacelo.
Un’indagine preliminare su questo concetto squisitamente giuridico - l’eredità - che, come spesso avviene nella nostra cultura, si espande al di là dei suoi limiti disciplinari fino a coinvolgere il destino stesso dell’Occidente, non sarà pertanto inutile. Come gli studi di un grande storico del diritto - Yan Thomas - mostrano con chiarezza, la funzione dell’eredità è quella di assicurare la continuatio dominii, cioè la continuità della proprietà dei beni che passano dal morto al vivo. Tutti i dispositivi che il diritto escogita per sopperire al vuoto che rischia di prodursi alla morte del proprietario non hanno altro scopo che garantire senza interruzioni la successione nella proprietà.
Eredità non è forse allora il termine adatto per pensare il problema che tanto Arendt che Bloch avevano in mente. Dal momento che nella tradizione spirituale di un popolo qualcosa come una proprietà non ha semplicemente senso, in questo ambito un’eredità come continuatio dominii non esiste né può in alcun modo interessarci. Accedere al passato, conversare coi morti è anzi possibile solo spezzando la continuità della proprietà ed è nell’intervallo fra passato e futuro che ogni singolo deve necessariamente situarsi. Non siamo eredi di nulla e da nessuna parte abbiamo eredi ed è solo a questo patto che possiamo riallacciare la conversazione col passato e coi morti. Il bene è, infatti, per definizione adespota e inappropriabile e l’ostinato tentativo di accaparrarsi la proprietà della tradizione definisce il potere che rifiutiamo in ogni ambito, nella politica come nella poesia, nella filosofia come nella religione, nelle scuole come nei templi e nei tribunali.
* Nota:
PIANETA TERRA, 13 AGOSTO 2023.
DOPO MILLENNI DI "RECINZIONI" E DI DIRITTO ALLA "SUCCESSIONE DELLA PROPRIETA’, L’ APOCALITTICA RIVELAZIONE DI RINO GAETANO: "MIO FRATELLO E’ FIGLIO UNICO" (1976) COMINCIA AD ESSERE ACCOLTA: "FRATELLI TUTTI", E SORELLE TUTTE.
SEMBRA CHE SIA GIUNTA L’ORA DI USCIRE DAL "LETARGO" (DANTE ALIGHIERI), DI SVEGLIARSI DAL "SONNO DOGMATICO" (KANT), E LASCIARSI ALLE SPALLE LA "TERRA" DEL PLATONISMO E DEL PAOLINISMO: SEMBRA CHE SIA GIUNTA L’ORA DI USCIRE DAL "LETARGO" (DANTE ALIGHIERI), DI SVEGLIARSI DAL "SONNO DOGMATICO" (KANT), E DI LASCIARSI ALLE SPALLE LA "RICAPITOLAZIONE" DEL PLATONISMO, DEL PAOLINISMO, E DELL’HEGELISMO:
- "La meditazione sulla storia e la tradizione che Hannah Arendt pubblica nel 1954 porta il titolo, certo non casuale, Tra passato e futuro. [...] Accedere al passato, conversare coi morti è anzi possibile solo spezzando la continuità della proprietà ed è nell’intervallo fra passato e futuro che ogni singolo deve necessariamente situarsi. Non siamo eredi di nulla e da nessuna parte abbiamo eredi ed è solo a questo patto che possiamo riallacciare la conversazione col passato e coi morti. Il bene è, infatti, per definizione adespota e inappropriabile e l’ostinato tentativo di accaparrarsi la proprietà della tradizione definisce il potere che rifiutiamo in ogni ambito, nella politica come nella poesia, nella filosofia come nella religione, nelle scuole come nei templi e nei tribunali" (G. Agamben, 31 luglio 2023).
IN PRINCIPIO ERA IL LOGOS (NON UN LOGO): "IO SONO L’ ALFA E L’OMEGA".
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- STORIA E STORIOGRAFIA: PENSARE L’ALDI LA’ DELLA TRADIZIONE TEOLOGICO-POLITICA DI SAN PAOLO.12 agosto 2023, di Federico La Sala
MARXISMO, PAOLINISMO E LENINISMO: STORIA E STORIOGRAFIA. UNA NOTA A MARGINE DELL’INTRODUZIONE A "IL POLITICO. Da Machiavelli a Cromwell" (Mario Tronti, 1979).
In memoria di Mario Tronti... credo che non sia proprio il caso di lasciar cadere l’importanza dei suoi studi sul tema del "politico" :
"INTRODUZIONE: 1. Il politico ha una storia. E’ la storia moderna del rapporto di potere [...] Il passato ha una storia borghese. Non si può saltare. non si può arrivare subito a un politico "altro", senza aver attraversato e sperimentato e conosciuto quello che già c’è. Il passato pesa. Il capitalismo ha prodotto fin qui potere, ma anche il potere ha prodotto capitalismo. Quest’ultima cosa è difficile da accettare. [...] Il politico ha una storia borghese moderna. Molte delle cose che facciamo oggi male, sono state ben fatte qualche secolo fa. E’ impressionante quanto poco di nuovo ci sia sotto il sole della politica. No, non è la tesi banale che la politica è sempre quella. Non è sempre quella [...] La nascita del politico come problema è alle origini della scienza capitalistica. L’impatto, l’intreccio, lo scambio, il conflitto è tra soggetto statale e transizione al capitalismo. Senza Stato, fin dalle origini, niente capitalismo. Senza politica moderna, subito, fin dagli inizi, nessuna rivoluzione borghese. Rileggiamo il caso "marxiano" dell’Inghilterra [...].
 Con Hobbes, in epoca borghese, prende inizio una vera e propria età dello Stato. Da Machiavelli a Cromwell, - questa è l’età della politica moderna. Nasce un fare, un agire, che è di un individuo singolo, ma è per tutti gli altri, o su tutti gli altri. E’ l’azione pubblica della persona isolata, è l’attività politica. Nascono delle leggi per l’azione, delle regole per dirigere gli uomini, delle forme per dominarli. Nasce la razionalità della politica: dentro, c’è la reiterazione del comportqamnto umano e il disprezzo per la vocazione naturalmente subalterna dell’uomo, il cittadino come suddito; fuori, c’è il gusto dell’abilità e il senso della forza, la coltura della virtù e il comando sulla fortuna, "quelli principi sono deboli, che non stanno in su la guerra." Questo è l’orizzonte borghese della politica: l’unico che finora si sia dato." (cfr. "IL POLITICO. Antologia di testi" a cura di Mario Tronti. Vol. primo, Tomo primo, Feltrinelli 1979).
Con Hobbes, in epoca borghese, prende inizio una vera e propria età dello Stato. Da Machiavelli a Cromwell, - questa è l’età della politica moderna. Nasce un fare, un agire, che è di un individuo singolo, ma è per tutti gli altri, o su tutti gli altri. E’ l’azione pubblica della persona isolata, è l’attività politica. Nascono delle leggi per l’azione, delle regole per dirigere gli uomini, delle forme per dominarli. Nasce la razionalità della politica: dentro, c’è la reiterazione del comportqamnto umano e il disprezzo per la vocazione naturalmente subalterna dell’uomo, il cittadino come suddito; fuori, c’è il gusto dell’abilità e il senso della forza, la coltura della virtù e il comando sulla fortuna, "quelli principi sono deboli, che non stanno in su la guerra." Questo è l’orizzonte borghese della politica: l’unico che finora si sia dato." (cfr. "IL POLITICO. Antologia di testi" a cura di Mario Tronti. Vol. primo, Tomo primo, Feltrinelli 1979).MARX- LENIN, CRISTO - SAN PAOLO: A. GRAMSCI, "POSIZIONE DEL PROBLEMA: [...] Marx inizia intellettualmente un’età storica che durerà probabilmente dei secoli, cioè fino alla sparizione della Società politica e all’avvento della Società regolata. Solo allora la sua concezione del mondo sarà superata (concezione della necessità, 〈superata〉 da concezione della libertà). Fare un parallelo tra Marx e Ilici per giungere a una gerarchia è stolto e ozioso: esprimono due fasi: scienza-azione, che 〈sono〉 omogenee ed eterogenee nello stesso tempo. Così, storicamente, sarebbe assurdo un parallelo tra Cristo e S. Paolo: Cristo-Weltanschauung, S. Paolo organizzazione, azione, espansione della Weltanschauung: essi sono ambedue necessarii nella stessa misura e però sono della stessa statura storica. Il Cristianesimo potrebbe chiamarsi, storicamente, cristianesimo-paolinismo e sarebbe l’espressione più esatta (solo la credenza nella divinità di Cristo ha impedito un caso di questo genere, ma questa credenza è anch’essa solo un elemento storico, non teorico)." (A. Gramsci, "Quaderno 7 (VII) § (33)").
PENSARE L’ALDI LA’ DELLA TRADIZIONE TEOLOGICO-POLITICA DI SAN PAOLO. Riaprire l’orizzonte storiografico stretto nei limiti "da Machiavelli a Cromwell" e ripartire, recuperando il filo della lezione di Dante Alighieri ("Monarchia") presente nel lavoro di Mercurino da Gattinara (con Carlo V) e la critica tensione teologico-politica alla base dell elisabettiano "Amleto" di Shakespeare.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- TEATRO E METATEATRO, "HAMLETICA-MENTE": SHAKESPEARE E IL DRAMMA STORICO SU "IL LIBRO DI TOMMASO MORO".21 luglio 2023, di Federico La Sala
TEATRO, METATEATRO, E CRITICA DELLA TEOLOGIA-POLITICA CATTOLICO-SPAGNOLA:
SHAKESPEARE, CON "AMLETO" (E DANTE), CERCA LA VIA D’USCITA PER PORTARSI OLTRE LUTERO E OLTRE ERASMO E TOMMASO MORO.
SOVRANITA’ E OBBEDIENZA. iN "The Book of Sir Thomas More", Shakespeare prende le distanze dalle posizioni teologiche di Tommaso Moro (ed Erasmo) e chiarisce le ragioni antropologiche, politiche e teologiche della Riforma anglicana.
- LEZIONE DELL’APOSTOLO PAOLO:
 1 Ogni persona stia sottomessa alle autorità superiori; perché non vi è autorità se non da Dio; e quelle che esistono sono stabilite da Dio.
1 Ogni persona stia sottomessa alle autorità superiori; perché non vi è autorità se non da Dio; e quelle che esistono sono stabilite da Dio.
 2 Perciò chi resiste all’autorità si oppone all’ordine di Dio; quelli che vi si oppongono si attireranno addosso una condanna; -3 infatti i magistrati non sono da temere per le opere buone, ma per le cattive. Tu, non vuoi temere l’autorità? Fa’ il bene e avrai la sua approvazione,
2 Perciò chi resiste all’autorità si oppone all’ordine di Dio; quelli che vi si oppongono si attireranno addosso una condanna; -3 infatti i magistrati non sono da temere per le opere buone, ma per le cattive. Tu, non vuoi temere l’autorità? Fa’ il bene e avrai la sua approvazione,
 4 perché il magistrato è un ministro di Dio per il tuo bene; ma se fai il male, temi, perché egli non porta la spada invano; infatti è un ministro di Dio per infliggere una giusta punizione a chi fa il male.
4 perché il magistrato è un ministro di Dio per il tuo bene; ma se fai il male, temi, perché egli non porta la spada invano; infatti è un ministro di Dio per infliggere una giusta punizione a chi fa il male.
 5 Perciò è necessario stare sottomessi, non soltanto per timore della punizione, ma anche per motivo di coscienza.
5 Perciò è necessario stare sottomessi, non soltanto per timore della punizione, ma anche per motivo di coscienza.
 6 È anche per questa ragione che voi pagate le imposte, perché essi, che sono costantemente dediti a questa funzione, sono ministri di Dio.
6 È anche per questa ragione che voi pagate le imposte, perché essi, che sono costantemente dediti a questa funzione, sono ministri di Dio.
 7 Rendete a ciascuno quel che gli è dovuto: l’imposta a chi è dovuta l’imposta, la tassa a chi la tassa; il timore a chi il timore; l’onore a chi l’onore."(ROMANI: 13, 1-7).
7 Rendete a ciascuno quel che gli è dovuto: l’imposta a chi è dovuta l’imposta, la tassa a chi la tassa; il timore a chi il timore; l’onore a chi l’onore."(ROMANI: 13, 1-7).
Sir Thomas Moore
da Maria Borio (Nuovi Argomenti, 18 Dic. 2017) *
 The Booke of Sir Thomas Moore è un’opera a più mani pervenutaci in manoscritto in una stesura non definitiva che racconta l’ascesa, il trionfo e la caduta del grande statista e umanista inglese attraverso una serie di episodi secondari o immaginari della sua carriera. Con le sue correzioni e revisioni, il testo ci permette di osservare come lavoravano i drammaturghi del Rinascimento inglese. Il manoscritto contiene le uniche pagine vergate di suo pugno da Shakespeare, il cui contributo è limitato a poche scene del dramma. Una di esse (una parte della Scena 6) è quella qui riprodotta.
The Booke of Sir Thomas Moore è un’opera a più mani pervenutaci in manoscritto in una stesura non definitiva che racconta l’ascesa, il trionfo e la caduta del grande statista e umanista inglese attraverso una serie di episodi secondari o immaginari della sua carriera. Con le sue correzioni e revisioni, il testo ci permette di osservare come lavoravano i drammaturghi del Rinascimento inglese. Il manoscritto contiene le uniche pagine vergate di suo pugno da Shakespeare, il cui contributo è limitato a poche scene del dramma. Una di esse (una parte della Scena 6) è quella qui riprodotta.
 Il contesto della vicenda è il cosiddetto Ill May Day (1517), una rivolta del popolino contro i Lombardi, i potenti mercanti e banchieri stranieri attivi a Londra in quell’epoca. Per placare il delirio xenofobo irrompono alcuni nobili e poi Moro, il quale persuade i ribelli ad arrendersi (il fatto è un’invenzione dei drammaturghi). Come ricompensa, viene nominato cavaliere e membro del Privy Council, mentre i rivoltosi vengono imprigionati.
Il contesto della vicenda è il cosiddetto Ill May Day (1517), una rivolta del popolino contro i Lombardi, i potenti mercanti e banchieri stranieri attivi a Londra in quell’epoca. Per placare il delirio xenofobo irrompono alcuni nobili e poi Moro, il quale persuade i ribelli ad arrendersi (il fatto è un’invenzione dei drammaturghi). Come ricompensa, viene nominato cavaliere e membro del Privy Council, mentre i rivoltosi vengono imprigionati.
 Le parti del testo sottolineate sono quelle cancellate dal censore di stato, Edmund Tilney. In carattere speciale (tipo grassetto) sono invece indicate le annotazioni di una mano diversa da quella dell’autore.
Le parti del testo sottolineate sono quelle cancellate dal censore di stato, Edmund Tilney. In carattere speciale (tipo grassetto) sono invece indicate le annotazioni di una mano diversa da quella dell’autore.- Il testo è tratto da William Shakespeare, Tutte le opere, coordinamento generale di Franco Marenco, Volume terzo, I drammi storici, Bompiani, Milano, 2017.
- Edoardo Zuccato
Il libro di Sir Tommaso Moro
di Anthony Munday e Henry Chettle,
 con revisioni e aggiunte di Thomas Dekker, William Shakespeare e Thomas Heywood
con revisioni e aggiunte di Thomas Dekker, William Shakespeare e Thomas Heywood- Scena 6 Entrano Lincoln, Doll, Clown [Betts], George Betts, Williamson, [Sherwin] e altri: [Cittadini, armati][i]
- [Aggiunta II (Shakespeare)]
LINCOLN
 Silenzio, ascoltatemi! Chi non vuol vedere un’aringa affumicata a quattro centesimi[ii], il burro a undici centesimi alla libbra, la farina a nove scellini allo staio[iii] e il manzo a quattro nobili[iv] per sei chili, mi ascolti[v].
Silenzio, ascoltatemi! Chi non vuol vedere un’aringa affumicata a quattro centesimi[ii], il burro a undici centesimi alla libbra, la farina a nove scellini allo staio[iii] e il manzo a quattro nobili[iv] per sei chili, mi ascolti[v].UN ALTRO GEORGE BETTS
 Arriveremo a tanto se continuiamo a tollerare gli stranieri. Dategli retta.
Arriveremo a tanto se continuiamo a tollerare gli stranieri. Dategli retta.LINCOLN
 Per il cibo il nostro è un grande paese; argo[vi], questi mangiano più da noi che in patria.
Per il cibo il nostro è un grande paese; argo[vi], questi mangiano più da noi che in patria.UN ALTRO CLOWN BETTS
 Almeno una pagnotta da mezzo centesimo al giorno, pesata alla francese[vii].
Almeno una pagnotta da mezzo centesimo al giorno, pesata alla francese[vii].LINCOLN
 Loro importano qui verdure straniere giusto per rovinare i poveri apprendisti: cos’è mai una misera pastinaca rispetto al nostro buon cuore?
Loro importano qui verdure straniere giusto per rovinare i poveri apprendisti: cos’è mai una misera pastinaca rispetto al nostro buon cuore?UN ALTRO WILLIAMSON Schifezze, schifezze! Infiammano gli occhi, e questo basta per impestare la città con un’ondata di paralisi cerebrale[viii].
LINCOLN
 Con quella l’hanno già impestata: queste bastarde piante del letame (lo sapete, no? che crescono nel letame!) ci hanno impestato, e la nostra infezione farà tremare tutta la città, cosa che in parte succede a mangiar pastinache.
Con quella l’hanno già impestata: queste bastarde piante del letame (lo sapete, no? che crescono nel letame!) ci hanno impestato, e la nostra infezione farà tremare tutta la città, cosa che in parte succede a mangiar pastinache.UN ALTRO CLOWN BETTS
 È vero, e anche le zucche.
È vero, e anche le zucche.- Entra [una guardia del corpo del re]
GUARDIA
 Che cosa rispondete alla clemenza del re? La rifiutate?
Che cosa rispondete alla clemenza del re? La rifiutate?LINCOLN
 Vorreste prenderci in contropiede, non è vero? Niente affatto, non la rifiutiamo. Accettiamo la clemenza del re, ma non avremo compassione degli stranieri.
Vorreste prenderci in contropiede, non è vero? Niente affatto, non la rifiutiamo. Accettiamo la clemenza del re, ma non avremo compassione degli stranieri.GUARDIA
 Siete gli esseri più ingenui che si siano mai infilati in un pasticcio del genere.
Siete gli esseri più ingenui che si siano mai infilati in un pasticcio del genere.LINCOLN
 Che ne dite adesso, apprendisti? Apprendisti ingenui? Diamogli una lezione.
Che ne dite adesso, apprendisti? Apprendisti ingenui? Diamogli una lezione.TUTTI
 Apprendisti ingenui? Ingenui noi?
Apprendisti ingenui? Ingenui noi?- Entrano il sindaco, Surrey, Shrewsbury, [Moro, Palmer]
SHREWSBURY SINDACO
 Fermi, in nome del re, fermi!
Fermi, in nome del re, fermi!SURREY
 Amici, maestri, compatrioti...
Amici, maestri, compatrioti...SINDACO
 Silenzio, oh, silenzio! Vi ordino di stare calmi!
Silenzio, oh, silenzio! Vi ordino di stare calmi!SHREWSBURY
 Maestri miei, compatrioti...
Maestri miei, compatrioti...SHERWIN WILLIAMSON
 Il nobile conte di Shrewsbury! Ascoltiamolo!
Il nobile conte di Shrewsbury! Ascoltiamolo!GEORGE BETTS
 Vogliamo sentire il conte di Surrey!
Vogliamo sentire il conte di Surrey!LINCOLN
 Il conte di Shrewsbury!
Il conte di Shrewsbury!GEORGE BETTS
 Vogliamo sentirli tutti e due!
Vogliamo sentirli tutti e due!TUTTI I CITTADINI
 Tutti e due, tutti e due, tutti e due, tutti e due!
Tutti e due, tutti e due, tutti e due, tutti e due!LINCOLN
 Silenzio, vi dico, silenzio! Siete persone assennate o che cosa?
Silenzio, vi dico, silenzio! Siete persone assennate o che cosa?SURREY
 Tutto quel che volete, tranne che persone di buon senso.
Tutto quel che volete, tranne che persone di buon senso.ALCUNI CITTADINI
 Non vogliamo sentire lord Surrey!
Non vogliamo sentire lord Surrey!ALTRI CITTADINI
 No, no, no, no, no! Shrewsbury, Shrewsbury!
No, no, no, no, no! Shrewsbury, Shrewsbury!MORO
 Hanno oltrepassato l’argine dell’obbedienza, e così travolgeranno ogni cosa.
Hanno oltrepassato l’argine dell’obbedienza, e così travolgeranno ogni cosa.LINCOLN
 Parla lo sceriffo[ix] Moro! Vogliamo sentirlo, lo sceriffo Moro?
Parla lo sceriffo[ix] Moro! Vogliamo sentirlo, lo sceriffo Moro?DOLL
 Sentiamolo! Il suo è uno sceriffato[x] generoso, e ha fatto diventare mio fratello, Arthur Watchins, attendente del sergente Safe. Sentiamo lo sceriffo Moro!
Sentiamolo! Il suo è uno sceriffato[x] generoso, e ha fatto diventare mio fratello, Arthur Watchins, attendente del sergente Safe. Sentiamo lo sceriffo Moro!TUTTI I CITTADINI
 Sceriffo Moro, Moro, Moro, sceriffo Moro!
Sceriffo Moro, Moro, Moro, sceriffo Moro!MORO
 Secondo l’autorità in vigore fra di voi, ordinategli di ascoltare in silenzio.
Secondo l’autorità in vigore fra di voi, ordinategli di ascoltare in silenzio.ALCUNI CITTADINI
 Surrey, Surrey!
Surrey, Surrey!ALTRI CITTADINI
 Moro, Moro!
Moro, Moro!LINCOLN e GEORGE BETTS
 Zitti, zitti, silenzio, zitti!
Zitti, zitti, silenzio, zitti!MORO
 Voi che avete autorità e credito presso la folla, ordinategli di fare silenzio.
Voi che avete autorità e credito presso la folla, ordinategli di fare silenzio.LINCOLN
 Gli venga un accidente, non vogliono star zitti. Neanche il diavolo può governarli.
Gli venga un accidente, non vogliono star zitti. Neanche il diavolo può governarli.MORO
 Che incarico spinoso e difficile avete, guidare gente che neanche il diavolo è in grado di governare. Cari maestri, ascoltate le mie parole.
Che incarico spinoso e difficile avete, guidare gente che neanche il diavolo è in grado di governare. Cari maestri, ascoltate le mie parole.DOLL
 Sì, corpo di Cristo, vi ascolteremo, Moro. Siete un buon padrone di casa, e ringrazio vostra altezza per mio fratello Arthur Watchins.
Sì, corpo di Cristo, vi ascolteremo, Moro. Siete un buon padrone di casa, e ringrazio vostra altezza per mio fratello Arthur Watchins.TUTTI GLI ALTRI CITTADINI
 Zitti, pace!
Zitti, pace!MORO
 Attenti, voi offendete proprio quello che invocate, cioè la pace. Nessuno di voi sarebbe qui presente, se quando eravate bambini fossero vissuti dei vostri simili che avessero travolto[xi] la pace come voi volete fare adesso; quella pace in cui finora siete cresciuti vi sarebbe stata tolta, e i tempi sanguinari non vi avrebbero permesso di diventare adulti. Poveri voi! Che cosa otterrete se anche vi concediamo quello che cercate?
Attenti, voi offendete proprio quello che invocate, cioè la pace. Nessuno di voi sarebbe qui presente, se quando eravate bambini fossero vissuti dei vostri simili che avessero travolto[xi] la pace come voi volete fare adesso; quella pace in cui finora siete cresciuti vi sarebbe stata tolta, e i tempi sanguinari non vi avrebbero permesso di diventare adulti. Poveri voi! Che cosa otterrete se anche vi concediamo quello che cercate?GEORGE BETTS
 Per la Madonna, mandar via gli stranieri, cosa che senz’altro porterà grandissimo vantaggio ai poveri artigiani della città.
Per la Madonna, mandar via gli stranieri, cosa che senz’altro porterà grandissimo vantaggio ai poveri artigiani della città.MORO
 Mettiamo che vengano allontanati, e mettiamo che la vostra baraonda abbia soffocato[xii] tutta l’autorità reale dell’Inghilterra. Immaginate di vedere i disgraziati stranieri trascinarsi verso la costa e i porti per imbarcarsi, con i loro miseri bagagli e i bambini dietro[xiii], mentre voi ve ne state a soddisfare i vostri desideri come sovrani, con le autorità ammutolite dal vostro berciare e voi tronfi nella gorgiera della vostra arroganza: che cosa avrete ottenuto? Ve lo dico io: avrete mostrato come la superbia e la forza possono prevalere e come l’ordine può essere distrutto. Ma in questo schema di cose non uno di voi giungerebbe alla vecchiaia, poiché altri furfanti, seguendo le loro ubbie, con identiche mani, identiche ragioni e identico diritto, vi spolperebbero, e gli uomini si divorerebbero fra loro come pesci voraci.
Mettiamo che vengano allontanati, e mettiamo che la vostra baraonda abbia soffocato[xii] tutta l’autorità reale dell’Inghilterra. Immaginate di vedere i disgraziati stranieri trascinarsi verso la costa e i porti per imbarcarsi, con i loro miseri bagagli e i bambini dietro[xiii], mentre voi ve ne state a soddisfare i vostri desideri come sovrani, con le autorità ammutolite dal vostro berciare e voi tronfi nella gorgiera della vostra arroganza: che cosa avrete ottenuto? Ve lo dico io: avrete mostrato come la superbia e la forza possono prevalere e come l’ordine può essere distrutto. Ma in questo schema di cose non uno di voi giungerebbe alla vecchiaia, poiché altri furfanti, seguendo le loro ubbie, con identiche mani, identiche ragioni e identico diritto, vi spolperebbero, e gli uomini si divorerebbero fra loro come pesci voraci.DOLL
 Dio mi sia testimone, questo è vero come il vangelo.
Dio mi sia testimone, questo è vero come il vangelo.GEORGE BETTS LINCOLN
 Sì, questo è uno pieno di buon senso, parola mia. Stiamo attenti a quello che dice.
Sì, questo è uno pieno di buon senso, parola mia. Stiamo attenti a quello che dice.MORO
 Miei cari amici, lasciate che sottoponga un’ipotesi alla vostra riflessione. Se ci pensate bene, vi accorgerete quale forma orribile hanno in sé le vostre novità rivoluzionarie. Anzitutto, è un peccato verso il quale l’Apostolo ci ha ammonito spesso di stare in guardia, raccomandandoci di obbedire alle autorità [xiv: Si riferisce al noto passo di S. Paolo, Romani 13.1-2]; e non sbaglierei se vi dicessi che voi siete insorti contro Dio.
Miei cari amici, lasciate che sottoponga un’ipotesi alla vostra riflessione. Se ci pensate bene, vi accorgerete quale forma orribile hanno in sé le vostre novità rivoluzionarie. Anzitutto, è un peccato verso il quale l’Apostolo ci ha ammonito spesso di stare in guardia, raccomandandoci di obbedire alle autorità [xiv: Si riferisce al noto passo di S. Paolo, Romani 13.1-2]; e non sbaglierei se vi dicessi che voi siete insorti contro Dio.TUTTI I CITTADINI
 Santa Vergine, che Dio non voglia!
Santa Vergine, che Dio non voglia!MORO
 Eppure è così, perché al re Dio prestò il proprio ufficio di terrore, giustizia, potere e comando. A lui ingiunse di governare e volle che voi obbediste. E per aggiungere a questo una più ampia maestà, prestò al re non soltanto la sua figura, il trono e la spada, ma gli diede il suo stesso nome, chiamandolo dio in terra. Che cosa fate dunque voi, ribellandovi contro un uomo insediato da Dio in persona, se non ribellarvi contro Dio? Facendo così, che cosa fate alle vostre anime? Oh sconsiderati, lavate di lacrime le vostre menti corrotte; e le stesse mani che da ribelli levate contro la pace, a favore della pace alzatele, e le vostre ginocchia sacrileghe trasformatele in piedi. Inginocchiarsi per il perdono è la guerra [xv] più sicura che potete fare voi, la cui tattica[xvi] è la ribellione. Su, su, tornate a obbedire! Perfino questa sommossa può proseguire solo con l’obbedienza. Ditemi soltanto: quando una rivolta sta per scoppiare, quale capopopolo è in grado di sedare la turba nel proprio nome? Chi vuole obbedire a un traditore? O quanto bene suonerà l’elezione di qualcuno che come titolo abbia solo quello di ‘ribelle’ per definire un ribelle?
Eppure è così, perché al re Dio prestò il proprio ufficio di terrore, giustizia, potere e comando. A lui ingiunse di governare e volle che voi obbediste. E per aggiungere a questo una più ampia maestà, prestò al re non soltanto la sua figura, il trono e la spada, ma gli diede il suo stesso nome, chiamandolo dio in terra. Che cosa fate dunque voi, ribellandovi contro un uomo insediato da Dio in persona, se non ribellarvi contro Dio? Facendo così, che cosa fate alle vostre anime? Oh sconsiderati, lavate di lacrime le vostre menti corrotte; e le stesse mani che da ribelli levate contro la pace, a favore della pace alzatele, e le vostre ginocchia sacrileghe trasformatele in piedi. Inginocchiarsi per il perdono è la guerra [xv] più sicura che potete fare voi, la cui tattica[xvi] è la ribellione. Su, su, tornate a obbedire! Perfino questa sommossa può proseguire solo con l’obbedienza. Ditemi soltanto: quando una rivolta sta per scoppiare, quale capopopolo è in grado di sedare la turba nel proprio nome? Chi vuole obbedire a un traditore? O quanto bene suonerà l’elezione di qualcuno che come titolo abbia solo quello di ‘ribelle’ per definire un ribelle?
 Voi volete schiacciare gli stranieri, ucciderli, tagliargli la gola, impadronirvi delle loro case e condurre al guinzaglio[xvii] la maestà della legge, per aizzarla come un segugio. Ahimè, ahimè! Supponiamo adesso che il re, nella sua clemenza verso i trasgressori pentiti, giudicasse il vostro grave reato limitandosi a punirvi con l’esilio: dove andreste, allora? Quale paese vi accoglierebbe vedendo la natura del vostro errore? Che andiate in Francia o nelle Fiandre, in qualsiasi provincia della Germania, in Spagna o in Portogallo, anzi no, un luogo qualunque diverso dall’Inghilterra, vi ritroverete inevitabilmente stranieri.
Voi volete schiacciare gli stranieri, ucciderli, tagliargli la gola, impadronirvi delle loro case e condurre al guinzaglio[xvii] la maestà della legge, per aizzarla come un segugio. Ahimè, ahimè! Supponiamo adesso che il re, nella sua clemenza verso i trasgressori pentiti, giudicasse il vostro grave reato limitandosi a punirvi con l’esilio: dove andreste, allora? Quale paese vi accoglierebbe vedendo la natura del vostro errore? Che andiate in Francia o nelle Fiandre, in qualsiasi provincia della Germania, in Spagna o in Portogallo, anzi no, un luogo qualunque diverso dall’Inghilterra, vi ritroverete inevitabilmente stranieri.
 Vi farebbe piacere trovare una nazione dal carattere così barbaro che, in un’esplosione di odiosa violenza, non vi offrisse dimora sulla terra, affilasse i suoi detestabili coltelli sulle vostre gole, vi cacciasse via come cani, quasi che Dio non vi avesse creati né vi riconoscesse come suoi figli, o che gli elementi naturali non fossero stati fatti per il vostro benessere ma riservati per legge esclusivamente a loro? Che cosa pensereste se vi trattassero così? Questa è la condizione degli stranieri, e questa la vostra barbara disumanità.
Vi farebbe piacere trovare una nazione dal carattere così barbaro che, in un’esplosione di odiosa violenza, non vi offrisse dimora sulla terra, affilasse i suoi detestabili coltelli sulle vostre gole, vi cacciasse via come cani, quasi che Dio non vi avesse creati né vi riconoscesse come suoi figli, o che gli elementi naturali non fossero stati fatti per il vostro benessere ma riservati per legge esclusivamente a loro? Che cosa pensereste se vi trattassero così? Questa è la condizione degli stranieri, e questa la vostra barbara disumanità.TUTTI I CITTADINI
 In fede, dice la verità. Facciamo agli altri ciò che vorremmo fosse fatto a noi stessi.
In fede, dice la verità. Facciamo agli altri ciò che vorremmo fosse fatto a noi stessi.TUTTI I CITTADINI LlNCOLN
 Ci faremo governare da voi, mastro Moro, se ci sarete amico e ci procurerete il perdono.
Ci faremo governare da voi, mastro Moro, se ci sarete amico e ci procurerete il perdono.MORO
 Sottomettetevi a questi nobili signori[xviii], implorate la loro mediazione presso il Re, assumete un comportamento ortodosso, obbedite al magistrato, e senza dubbio troverete misericordia, se la cercate in questo modo.
Sottomettetevi a questi nobili signori[xviii], implorate la loro mediazione presso il Re, assumete un comportamento ortodosso, obbedite al magistrato, e senza dubbio troverete misericordia, se la cercate in questo modo.* Fonte: Nuovi Argomenti, Dic 18, 2017 (ripresa parziale, senza le note).
- LEZIONE DELL’APOSTOLO PAOLO:
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- SCOMPENSI EPOCALI DI CUORE, PARADISO PERDUTO, E QUESTIONE ANTROPOLOGICA: "SÀPERE AUDE!" (ORAZIO-KANT)16 giugno 2023, di Federico La Sala
FILOLOGIA, ANTROPOLOGIA (CRISTOLOGIA), COSMOTEANDRIA, E STORIOGRAFIA.
- A Gioacchino da Fiore, al "calavrese abate Giovacchino / di spirito profetico dotato" (Pd., XII, 140), un omaggio.
"PARADISO PERDUTO" E SCOMPENSI EPOCALI DI CUORE: "SÀPERE AUDE!" (ORAZIO -> #KANT).
- Una nota a margine della ricorrenza del "SACRO CUORE DI GESU" *
CARDIOCENTRISMO, CARDIOPATIE, E MEDICINA. Forse, oggi, è proprio giunto il tempo di riprendere il filo e rievocare la memoria del giardino (paradiso perduto) e sollecitare un ripensamento della questione antropologica (della cristologia e del "corpus domini", del "corpo del signore" - ateo e/o devoto).
Se è vero. come è vero da sempre, che il cuore è l’organo dell’intelligenza spirituale, dell’intelligenza-che-ama o intelletto d’amore e, come ha chiarito Dante, è l’amore ("CHARITAS") che muove il sole e le altre #stelle, non è ora di uscire dal letargo (Pd. XXXIII, 94), e rendere praticabile il cammino ad ogni essere umano (cristo- logica-mente, non "paolinamente") sì che ognuno e ognuna, "dal suo proprio grembo [ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ]", possa far sgorgare "fiumi di acqua viva" (Gv 7, 38-39)?! E, finalmente, ammirare il sorgere della Terra , "della Terra, il brillante colore"?
P. S. - DANTE, MILTON, E FREUD. Alla fidanzata Martha, il 7 agosto 1882, Sigmund Freud scrive che, nel "Paradiso perduto" (John Milton, 1667), «ancora di recente, in un momento in cui non mi sono sentito sicuro del tuo amore, ho trovato consolazione e conforto».
Federico La Sala
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE --- CAMBIARE PARADIGMA: GIORNATA DELLA TERRA, MESSAGGIO EVANGELICO E CONCILIO DI NICEA (325-2025)24 aprile 2023, di Federico La Sala
GIORNATA DELLA TERRA (2023), MESSAGGIO EVANGELICO E #CONCILIO DI #NICEA (325-2025): #ANTROPOLOGIA, #TEOLOGIA, E #STORIA. Una nota a margine del documento del Centro Orientamento Pastorale (*)
- LA PASTORALE GENERATIVA (INTRODUZIONE AL DOSSIER N. 3/2023 DI ORIENTAMENTI PASTORALI):
- "Nelle nostre prassi pastorali spesso sperimentiamo - non senza sofferenza - il paradosso di una Chiesa che, nata per annunciare e preparare la venuta del Regno, protesa per essenza verso il futuro, venga percepita da molti come relitto malinconico del passato. Vale a dire una realtà che sembra incapace di offrire una parola per l’uomo moderno che vive in ambienti profondamente secolarizzati, in cui è difficile poter incrociare risposte religiose alle proprie domande. Talvolta si ha l’impressione che si stia predicando un vangelo che non è più quello di Gesù, che era capace di penetrare i cuori e toccare l’orizzonte affettivo e progettuale della gente che incontrava. Le sue erano risposte concrete a problemi reali e non preconfezionate o scontate. Le risposte di Gesù erano di un sapore particolare, sapevano di futuro, di un domani sorprendente, capace d’indicare possibilità insperabili. È il «grigio pragmatismo della vita quotidiana della Chiesa - afferma il papa nella Evangelii gaudium - nel quale tutto apparentemente procede nella normalità, mentre in realtà la fede si va logorando e degenerando nella meschinità. Si sviluppa la psicologia della tomba, che a poco a poco trasforma i cristiani in mummie da museo» (EG, n. 83)." [...]" ("Orientamenti pastorali", 14.04.2023).
- Pastorale: urge un cambio di paradigma: «Occorre un cambiamento di paradigma: dalla trasmissione della fede “a senso unico” alla comune scoperta, in piena sintonia con uno stile sinodale di Chiesa. A ben guardare, non si tratta di un’innovazione, bensì di un ripartire dallo stile di Gesù e dall’esperienza degli inizi del cristianesimo». Pubblichiamo di seguito l’introduzione al Dossier del numero di Orientamenti Pastorali 3/2023 (sommario. La rivista Orientamenti Pastorali è espressione del «Centro di orientamento pastorale» (COP), un’associazione che fedele alla eredità del Concilio Vaticano II contribuisce allo sviluppo della ricerca e dello studio pastorale nella Chiesa italiana, offrendo strumenti di aggiornamento e formazione per le parrocchie e gli operatori pastorali [...]" (cfr. SETTIMANA News, 20.04.2023).
(*)
GIORNATA DELLA TERRA (2023) E MESSAGGIO EVANGELICO (2025).
Pastorale “generativa”? Certissimamente un paradigma interessante per la missione della Chiesa... Ma ad esso, unitamente allo spirito dei profeti, non manca anche e ancora lo spirito delle profetesse, delle sibille!? Non è bene, forse, ri-andare nella Cappella Sistina, guardare in alto, ri-meditare le indicazioni di Michelangelo, e ri-vedere e ri-pensare il “Tondo Doni”, con la sua cornice? Non è bene, dopo 1700 anni da Nicea 325, arrivare al 2025 rinnovando il paradigma e ri-diventare finalmente “bambini”, semplicemente esseri umani, cristiani adulti? Se non ora, quando? (Federico La Sala)
P. S. #COMENASCONOIBAMBINI E #FILOSOFIA (ENZO PACI, "SCUOLA DI MILANO") : "TONDO DONI". #Attenzione - Nella #cornice, è detto che sono"raffigurate la testa di Cristo e quelle di #quattro profeti" (Galleria degli Uffizi), ma, per Michelangelo, non sono due profeti e due sibille?!
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- IL PRINCIPE AMLETO, IL PRINCIPIO DI INDIVIDUAZIONE, E IL NODO DA SCIOGLIERE: COME NASCONO I BAMBINI22 febbraio 2023, di Federico La Sala
PSICOANALISI E FILOSOFIA:
- SENZA SHAKESPEARE E SENZA FREUD, NON SI ESCE DAL LABIRINTO DEL "CORPO MISTICO" DEL RE DI TEBE. .***IL PRINCIPE AMLETO, IL PRINCIPIO DI INDIVIDUAZIONE, E IL NODO DA SCIOGLIERE: COME NASCONO I BAMBINI...
METAPHYSICS ANTHROPOLOGY PSYCHOANALITIC. Shakespeare, dopo Lutero e prima di Nietzsche e Freud, con Amleto s’interroga sul come sia possibile andare oltre la vecchia "imitazione di Cristo". Una nota a margine di un programma di ricerca intitolato “Hamlet’s Bible”... *
TEATRO E METATEATRO. La straordinaria ricchezza di #Hamlet, a mio parere, sta proprio in questo doppio movimento: "The tension or dissonance between these similarities and differences is an important source of irony" (Paul Adrian Fried). Con questo "gioco" il meta-obiettivo di Shakespeare appare essere proprio quello di indicare una direzione di riflessione che possa portare oltre il proprio #tempo e rendere praticabile l’idea di rimettere i suoi cardini in sesto!
Europa e "Globe Theatre": "Ecce Homo". Dato che la posta (storicamente e teologicamente) è epocale, il "gioco" è ancora più importante: qui, nell’Hamlet, il tema è "ripensare" lo #specchio dell’intera "Danimarca".
P. S.
"ECCE HOMO": NIETZSCHE E LA VOLONTA’ DI POTENZA DI JUNG. Carl Gustav Jung ha fatto un brillantissimo lavoro su «Lo Zarathustra di Nietzsche. Seminario 1934-39» , ma alla fine la sua stessa ombra gli ha impedito di giungere a fondo e a capo dell’enigma di Edipo, della domanda (la "question") di Amleto, della "visione e l’enigma di Zarathustra e, infine, di accogliere il bambino nato dalla metamorfosi del cammello e del leone (cfr. Federico La Sala, "La mente accogliente. Tracce per una svolta antropologica", Antonio Pellicani Editore, Roma 1991).
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- "IL PRONIPOTE DI CESARE MUSATTI": UNA LEZIONE (TEOLOGICO-POLITICA) ITALIANA DI CESARE MUSATTI (1979).17 febbraio 2023, di Federico La Sala
ARCHEOLOGIA, #INTERPRETAZIONE DEI SOGNI" (1899), E "#COSTRUZIONI NELL’#ANALISI" (1937): A ONORE E GLORIA DI #SIGMUND #FREUD (1856-1939).
- In omaggio al Freud Museum London e alla Sigmund Freud University Vienna,
- una nota in #memoria del lavoro di #SigmunFreud e di #CesareMusatti...
LA "#PSICOLOGIA DELLE MASSE E ANALISI DELL’IO" (S. #FREUD, 1921) E UNA LEZIONE (TEOLOGICO-POLITICA) ITALIANA. Data la interminabile lotta e #analisi portata coraggiosamente avanti da #Freud (con il suo #Mosè) fino all’arrivo a #Londra, nella città di #Shakespeare (#Amleto), e, al contempo, di #HowardCarter (1874-1939), lo scopritore della #tomba di #Tutankhamon (1922), per imparare ed insegnare a #distinguere tra l’idea della famiglia del #Faraone (secondo la #Legge) e l’idea della "famiglia" del "Faraone" (secondo la #logica zoppa e cieca dell’#incesto), forse, è utile e importante rilegger(si) l’autobiografia di un grande interprete italiano del lavoro di #Freud: Cesare #Musatti, "Il pronipote di Giulio Cesare" (#Milano 1979) e, possibilmente, anche l’#Hamlet di William Shakespeare.
#Oggi, 17 febbraio 2023, a ricordo di #GiordanoBruno (#17febbraio 1600).
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- ANTROPOLOGIA CULTURALE E PSICOANALISI: LA FILOLOGIA AL SERVIZIO DELLA COSMOTEANDRIA PLANETARIA.28 dicembre 2022, di Federico La Sala
STORIA, STORIOGRAFIA, E FILOSOFIA:
PONZIOPILATO, CHRISTINEDEPIZAN, E LA FILOLOGIA AL SERVIZIO DELLA COSMOTEANDRIA TERRESTRE.
Alcune note in #memoria di #Franca Ongaro Basaglia. *
A) LA DIGNITÀ DELL’UOMO: «ECCE HOMO». PONZIO PILATO «disse loro: "Ecco, ve lo conduco fuori, affinché sappiate che non trovo in lui alcuna colpa". Uscì dunque Gesù, portando la corona di spine e il mantello di porpora. Pilato disse loro: "«Ecco l’uomo» (gr. ««ἰδοὺ ὁ ἄνθρωπος - idou ho anthropos», vulg. «ecce homo»)". Vedendolo, i sommi sacerdoti e i loro inservienti gridarono: "Crocifiggi! Crocifiggi!" Disse loro Pilato: "Prendetelo voi e crocifiggetelo; io non trovo in lui colpa". Gli risposero gli Ebrei: "Noi abbiamo una legge e secondo questa legge deve morire, perché si è fatto figlio di Dio"» (Gv. 19, 4-7).
B) UNA QUESTIONE DI #LANA "CAPRINA" (NON DI "#AGNELLO", NON DI "#ARIETE"). ALLA LUCE DELL’ATTENZIONE ALLE PAROLE DI PONZIO PILATO, si comprende meglio anche il significato delle parole di CHRISTINE DE PIZAN, l’autrice della “Città delle dame”: «Or fus jee vrais homs, n’est pa fable,/De nefs mener entremettable » (« Allora diventai un vero uomo, non è una favola,/capace di condurre le navi» - cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Christine_de_Pizan), che dicono ovviamente non della “#metamorfosi” in “vir” - uomo, ma della “#metanoia” in “homo” - essere umano (su questo, in particolare, si cfr. Michele Feo, “#HOMO - Metanoia non Metamorfosi”, Dalla parte del torto, Parma, autunno 2019, numero 86, pp. 12-13).
C) MATEMATICA E #ANTROPOLOGIA: "UN UOMO PIU’ UNA DONNA HA PRODOTTO, PER SECOLI, UN UOMO" (Franca Ongaro Basaglia, #Donna, in Enciclopedia, 5, Torino, Einaudi editore, 1978, p. 89).
N. B. - RENE’ GIRARD , L’#AGNELLO DI #DIO, E L’#INTERPRETAZIONEDEISOGNI (S. #FREUD, 1899): la"Menzogna romantica e verità romanzesca" (1961), il "Delle cose nascoste sin dalla fondazione del mondo" (1978), e "Il capro espiatorio" ( "Le bouc émissaire", 1982).
Parola di Girard: "Qualche lettore potrà obiettare che il Nuovo Testamento non ricorre mai all’espressione «capro espiatorio» per indicare Gesù come la vittima innocente di una frenesia mimetica collettiva; questo è vero, ma ciò avviene solo perché le Scritture cristiane dispongono di un’espressione equivalente, e anzi superiore a «capro espiatorio», vale a dire #agnello di #Dio. Questa immagine elimina gli attributi negativi e sgradevoli del capro, e pertanto corrisponde meglio all’idea della vittima innocente ingiustamente sacrificata" (cfr. René Girard, "Vedo cadere Satana come la folgore". Adelphi, Milano 2001, p. 203).
Girard accoglie la tradizionale interpretazione del messaggio evangelico e non tiene conto né di Marx, né di Nietzsche, né di Freud. Sulla lunga durata della tradizione #critica dimentica quanto ha scritto Freud nel #Disagiodellaciviltà (1929) sulla #fondazione del cattolicesimo da parte di san Paolo e, infine, fa dell’agnello un bel #caproespiatorio!
*
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- IL TRAGICO ALGORITMO DELL’ ANDROCENTRISMO COME “UOMO SUPREMO”, "SUPERUOMO".26 dicembre 2022, di Federico La Sala
COSMOLOGIA ("MONDO"), TEOLOGIA ("DIO"),
ANTROPOLOGIA ("UOMO")
E
"DISAGIO DELLACIVILTÀ" (S. FREUD, 1929):
The Stages of Man (1510), by Charles de Bouelles (c. 1470-1553).
USCIRE DAL LABIRINTO O DALLA CAVERNA,
E
NON RICADERE NELL’ILLUSIONE DI
“DIO”
CONCEPITO
SECONDO IL TRAGICO ALGORITMO DELL’
ANDROCENTRISMO
COME “UOMO SUPREMO”, "SUPERUOMO"
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE --- L’ITALIA, IL NOME DELLA MADRE, E L’ART. 3 DELLA COSTITUZIONE. "Nella mia ingenuità di madre di famiglia, ma anche secondo un mio fermo convincimento" (Discorso di Liliana Segre).14 ottobre 2022, di Federico La Sala
Il discorso della senatrice a vita Liliana Segre
L’apertura della seduta a Palazzo Madama per il voto del presidente
di Redazione Ansa*
***
Ecco il testo del discorso della senatrice a vita Liliana Segre che ha aperto a Palazzo Madama la seduta per il voto del presidente
Colleghe Senatrici, Colleghi Senatori,
rivolgo il più caloroso saluto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e a quest’Aula. Con rispetto, rivolgo il mio pensiero a Papa Francesco.
Certa di interpretare i sentimenti di tutta l’Assemblea, desidero indirizzare al Presidente Emerito Giorgio Napolitano, che non ha potuto presiedere la seduta odierna, i più fervidi auguri e la speranza di vederlo ritornare presto ristabilito in Senato.
Il Presidente Napolitano mi incarica di condividere con voi queste sue parole: “Desidero esprimere a tutte le senatrici ed i senatori, di vecchia e nuova nomina, i migliori auguri di buon lavoro, al servizio esclusivo del nostro Paese e dell’istituzione parlamentare ai quali ho dedicato larga parte della mia vita”.
Rivolgo ovviamente anch’io un saluto particolarmente caloroso a tutte le nuove Colleghe e a tutti i nuovi Colleghi, che immagino sopraffatti dal pensiero della responsabilità che li attende e dalla austera solennità di quest’aula, così come fu per me quando vi entrai per la prima volta in punta di piedi.
Come da consuetudine vorrei però anche esprimere alcune brevi considerazioni personali.
Incombe su tutti noi in queste settimane l’atmosfera agghiacciante della guerra tornata nella nostra Europa, vicino a noi, con tutto il suo carico di morte, distruzione, crudeltà, terrore...una follia senza fine.
Mi unisco alle parole puntuali del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “la pace è urgente e necessaria. La via per ricostruirla passa da un ristabilimento della verità, del diritto internazionale, della libertà del popolo ucraino”.
Oggi sono particolarmente emozionata di fronte al ruolo che in questa giornata la sorte mi riserva.
In questo mese di ottobre nel quale cade il centenario della Marcia su Roma, che dette inizio alla dittatura fascista, tocca proprio ad una come me assumere momentaneamente la presidenza di questo tempio della democrazia che è il Senato della Repubblica.
Ed il valore simbolico di questa circostanza casuale si amplifica nella mia mente perché, vedete, ai miei tempi la scuola iniziava in ottobre; ed è impossibile per me non provare una sorta di vertigine ricordando che quella stessa bambina che in un giorno come questo del 1938, sconsolata e smarrita, fu costretta dalle leggi razziste a lasciare vuoto il suo banco delle scuole elementari, oggi si trova per uno strano destino addirittura sul banco più prestigioso del Senato!
Il Senato della diciannovesima legislatura è un’istituzione profondamente rinnovata, non solo negli equilibri politici e nelle persone degli eletti, non solo perché per la prima volta hanno potuto votare anche per questa Camera i giovani dai 18 ai 25 anni, ma soprattutto perché per la prima volta gli eletti sono ridotti a 200.
L’appartenenza ad un così rarefatto consesso non può che accrescere in tutti noi la consapevolezza che il Paese ci guarda, che grandi sono le nostre responsabilità ma al tempo stesso grandi le opportunità di dare l’esempio.
Dare l’esempio non vuol dire solo fare il nostro semplice dovere, cioè adempiere al nostro ufficio con “disciplina e onore”, impegnarsi per servire le istituzioni e non per servirsi di esse.
Potremmo anche concederci il piacere di lasciare fuori da questa assemblea la politica urlata, che tanto ha contribuito a far crescere la disaffezione dal voto, interpretando invece una politica “alta” e nobile, che senza nulla togliere alla fermezza dei diversi convincimenti, dia prova di rispetto per gli avversari, si apra sinceramente all’ascolto, si esprima con gentilezza, perfino con mitezza.
Le elezioni del 25 settembre hanno visto, come è giusto che sia, una vivace competizione tra i diversi schieramenti che hanno presentato al Paese programmi alternativi e visioni spesso contrapposte. E il popolo ha deciso.
È l’essenza della democrazia.
La maggioranza uscita dalle urne ha il diritto-dovere di governare; le minoranze hanno il compito altrettanto fondamentale di fare opposizione. Comune a tutti deve essere l’imperativo di preservare le Istituzioni della Repubblica, che sono di tutti, che non sono proprietà di nessuno, che devono operare nell’interesse del Paese, che devono garantire tutte le parti.
Le grandi democrazie mature dimostrano di essere tali se, al di sopra delle divisioni partitiche e dell’esercizio dei diversi ruoli, sanno ritrovarsi unite in un nucleo essenziale di valori condivisi, di istituzioni rispettate, di emblemi riconosciuti.
In Italia il principale ancoraggio attorno al quale deve manifestarsi l’unità del nostro popolo è la Costituzione Repubblicana, che come disse Piero Calamandrei non è un pezzo di carta, ma è il testamento di 100.000 morti caduti nella lunga lotta per la libertà; una lotta che non inizia nel settembre del 1943 ma che vede idealmente come capofila Giacomo Matteotti.
Il popolo italiano ha sempre dimostrato un grande attaccamento alla sua Costituzione, l’ha sempre sentita amica.
In ogni occasione in cui sono stati interpellati, i cittadini hanno sempre scelto di difenderla, perché da essa si sono sentiti difesi.
E anche quando il Parlamento non ha saputo rispondere alla richiesta di intervenire su normative non conformi ai principi costituzionali - e purtroppo questo è accaduto spesso - la nostra Carta fondamentale ha consentito comunque alla Corte Costituzionale ed alla magistratura di svolgere un prezioso lavoro di applicazione giurisprudenziale, facendo sempre evolvere il diritto.
Naturalmente anche la Costituzione è perfettibile e può essere emendata (come essa stessa prevede all’art. 138), ma consentitemi di osservare che se le energie che da decenni vengono spese per cambiare la Costituzione - peraltro con risultati modesti e talora peggiorativi - fossero state invece impiegate per attuarla, il nostro sarebbe un Paese più giusto e anche più felice.
Il pensiero corre inevitabilmente all’art. 3, nel quale i padri e le madri costituenti non si accontentarono di bandire quelle discriminazioni basate su “sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali”, che erano state l’essenza dell’ancien regime.
Essi vollero anche lasciare un compito perpetuo alla “Repubblica”: “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
Non è poesia e non è utopia: è la stella polare che dovrebbe guidarci tutti, anche se abbiamo programmi diversi per seguirla: rimuovere quegli ostacoli !
Le grandi nazioni, poi, dimostrano di essere tali anche riconoscendosi coralmente nelle festività civili, ritrovandosi affratellate attorno alle ricorrenze scolpite nel grande libro della storia patria.
Perché non dovrebbe essere così anche per il popolo italiano? Perché mai dovrebbero essere vissute come date “divisive”, anziché con autentico spirito repubblicano, il 25 Aprile festa della Liberazione, il 1° Maggio festa del lavoro, il 2 Giugno festa della Repubblica?
Anche su questo tema della piena condivisione delle feste nazionali, delle date che scandiscono un patto tra le generazioni, tra memoria e futuro, grande potrebbe essere il valore dell’esempio, di gesti nuovi e magari inattesi.
Altro terreno sul quale è auspicabile il superamento degli steccati e l’assunzione di una comune responsabilità è quello della lotta contro la diffusione del linguaggio dell’odio, contro l’imbarbarimento del dibattito pubblico, contro la violenza dei pregiudizi e delle discriminazioni.
Permettetemi di ricordare un precedente virtuoso: nella passata legislatura i lavori della “Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza” si sono conclusi con l’approvazione all’unanimità di un documento di indirizzo. Segno di una consapevolezza e di una volontà trasversali agli schieramenti politici, che è essenziale permangano.
Concludo con due auspici.
Mi auguro che la nuova legislatura veda un impegno concorde di tutti i membri di questa assemblea per tenere alto il prestigio del Senato, tutelare in modo sostanziale le sue prerogative, riaffermare nei fatti e non a parole la centralità del Parlamento.
Da molto tempo viene lamentata da più parti una deriva, una mortificazione del ruolo del potere legislativo a causa dell’abuso della decretazione d’urgenza e del ricorso al voto di fiducia. E le gravi emergenze che hanno caratterizzato gli ultimi anni non potevano che aggravare la tendenza.
Nella mia ingenuità di madre di famiglia, ma anche secondo un mio fermo convincimento, credo che occorra interrompere la lunga serie di errori del passato e per questo basterebbe che la maggioranza si ricordasse degli abusi che denunciava da parte dei governi quando era minoranza, e che le minoranze si ricordassero degli eccessi che imputavano alle opposizioni quando erano loro a governare.
Una sana e leale collaborazione istituzionale, senza nulla togliere alla fisiologica distinzione dei ruoli, consentirebbe di riportare la gran parte della produzione legislativa nel suo alveo naturale, garantendo al tempo stesso tempi certi per le votazioni.
Auspico, infine, che tutto il Parlamento, con unità di intenti, sappia mettere in campo in collaborazione col Governo un impegno straordinario e urgentissimo per rispondere al grido di dolore che giunge da tante famiglie e da tante imprese che si dibattono sotto i colpi dell’inflazione e dell’eccezionale impennata dei costi dell’energia, che vedono un futuro nero, che temono che diseguaglianze e ingiustizie si dilatino ulteriormente anziché ridursi. In questo senso avremo sempre al nostro fianco l’Unione Europea con i suoi valori e la concreta solidarietà di cui si è mostrata capace negli ultimi anni di grave crisi sanitaria e sociale.
Non c’è un momento da perdere: dalle istituzioni democratiche deve venire il segnale chiaro che nessuno verrà lasciato solo, prima che la paura e la rabbia possano raggiungere i livelli di guardia e tracimare.
Senatrici e Senatori, cari Colleghi, buon lavoro!
* Fonte: ANSA, 13 ottobre 2022 (ripresa parziale, senza immagini).
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE --- «Il presidenziasmo? Sarebbe uno stravolgimento della Costituzione. In nome del populismo si seppellisce la nostra democrazia parlamentare, e potrebbe diventare l’avvio di una svolta autoritaria» (Gerardo Bianco).2 agosto 2022, di Federico La Sala
Intervista. Gerardo Bianco: elezione del capo dello Stato? Rischio svolta autoritaria
L’ex ministro Dc sulla proposta del centrodestra: presidenzialismo stravolge la Costituzione. Serve un risveglio dei cattolici, le parole del Papa in Canada erano rivolte a noi
di Angelo Picariello (Avvenire, martedì 2 agosto 2022)
«Il presidenziasmo? Sarebbe uno stravolgimento della Costituzione. In nome del populismo si seppellisce la nostra democrazia parlamentare, e potrebbe diventare l’avvio di una svolta autoritaria». Gerardo Bianco, passati i 90 anni, dedica la sua vita alla lettura e a tenersi informato. Nella gloriosa Dc è stato tante cose (capogruppo alla Camera più volte, ministro della Pubblica istruzione) e poi è stato segretario del Partito popolare.
 Considerato uno degli storiografi più autorevoli di questa cultura politica, oggi ai margini dalle proposte politiche che vanno per la maggiore, si dice preoccupato per una «carenza di consapevolezza » che registra fra i cattolici, una sorta di mix di delusione e diserzione. -Il suo ragionamento parte da lontano. Da quello che il Papa ha inteso dirci con la sua visita in Canada: «Al di là della rappresentazione mediatica poco più che folkloristica, essa è stata un rivolgersi a noi, come San Paolo ai Colossesi, un invito a tutto l’Occidente a non smarrire sé stesso. Proprio la nostra crisi di identità ha consentito a Putin di scatenare la sua offensiva, un tentativo di disgregazione in atto che è di carattere culturale prima che bellico».
Considerato uno degli storiografi più autorevoli di questa cultura politica, oggi ai margini dalle proposte politiche che vanno per la maggiore, si dice preoccupato per una «carenza di consapevolezza » che registra fra i cattolici, una sorta di mix di delusione e diserzione. -Il suo ragionamento parte da lontano. Da quello che il Papa ha inteso dirci con la sua visita in Canada: «Al di là della rappresentazione mediatica poco più che folkloristica, essa è stata un rivolgersi a noi, come San Paolo ai Colossesi, un invito a tutto l’Occidente a non smarrire sé stesso. Proprio la nostra crisi di identità ha consentito a Putin di scatenare la sua offensiva, un tentativo di disgregazione in atto che è di carattere culturale prima che bellico».E questo c’entra con la campagna elettorale?
C’entra eccome, perché nei confronti di un popolo che sembra aver smarrito la sua identità la politica rispolvera il vecchio motto latino panem et cicencences, con proposte prive di una visione solidale, d’insieme, volte solo a catturare fasce di consenso sociale. La tradizione politica dei cattolici è un’altra cosa, non può nemmeno rifugiarsi in un’acritica idolatria del Pil, mentre ancora una volta il Papa ci sollecita a superare un consumismo sfrenato, indifferente al futuro del pianeta.
Che cosa occorre invece?
Serve un risveglio dei cattolici. Una nuova presa di coscienza. I grandi assenti sono i temi delle ultime Settimane sociali, delle grandi encicliche. Manca una vera consapevolezza del ruolo svolto dai cattolici nell’unità d’Italia, e nella promozione del progetto europeo.
Forse un momento così difficile lo si può paragonare solo al primo dopoguerra e agli anni di piombo.
Quella uscita dalla guerra era un’Italia poverissima, che seppe aprire una prospettiva di crescita, non basata su un’idea di benessere per il benessere, ma sulla sua forza morale. Penso al ruolo, umile ma dignitoso, svolto sul piano internazionale da De Gasperi nell’opera di ricostruzione; penso al sacrificio di Moro e al suo insegnamento negli anni di piombo, ma penso soprattutto al ruolo svolto da grandi costituenti come Dossetti, La Pira, Mortati, Fanfani, lo stesso Moro. Che seppero imprimere alla nostra Carta costituzionale il principio della centralità della persona umana. E ai movimenti anti-sistema seppero opporre la centralità dei corpi intermedi, un concetto di cui vedo scarsa consapevolezza, anche fra i cattolici.
Ma il problema della governabilità richiede, e non da oggi, una riforma delle istituzioni.
Se l’obiettivo fosse davvero questo sono altre le proposte da prendere in esame: ad esempio il modello del cancel-lierato, molto più compatibile con il nostro impianto costituzionale, e la sfiducia costruttiva, che imporrebbe a chi mette in crisi un governo di indicare contemporaneamente una soluzione alternativa.
E il presidenzialismo?
Si muove in tutt’altra direzione, mira proprio al superamento dei corpi intermedi su cui si basa il nostro assetto istituzionale. Un concetto mutuato dalla Dottrina sociale cristiana, richiamato già dalla Rerum novarum, di cui pochi si ricordano, in diretto collegamento alla centralità della persona umana che in questi organismi sviluppa la sua libertà, anche in nome del principio di sussidiarietà inserito nella nostra Carta costituzionale. Si vorrebbe ora passare a un modello, il presidenzialismo, che ha mostrato ovunque i suoi limiti: lo si è visto negli Usa, ma nell’America del Sud è stata la strada che ha aperto a una deriva istituzionale gravissima, che pari pari rischia di ripetersi in Italia.
Il centrodestra ha vinto già altre volte, in Italia.
Stavolta a vincere non sarebbe il centrodestra, ma la destra. E il vero rischio che vedo è lo stravolgimento della Costituzione, se avesse i numeri per poterlo fare da sola.
A sinistra quali rischi vede, invece?
Vedo il rischio del riproposi di modelli ormai superati, che hanno poco a che vedere con un’impostazione come la nostra. Mentre trovo giusto, invece, che essa porti alla luce le istanze dei ceti più deboli, come è naturale che altre forze portino avanti soprattutto quelle dei ceti produttivi. Poi toccherebbe a noi, come cattolici, il favorire - in nome del bene comune - che si tenga conto di tutti i fattori in gioco, senza idolatrare nessuna ideologia o classe sociale. Ma perché ciò avvenga c’è bisogno di una nuova presenza, e di un nuovo protagonismo, da mettere in campo.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- USCIRE DAL LETARGO. PARMENIDE, IL PONTE DI ELEA, E LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA.17 luglio 2022, di Federico La Sala
IL PROBLEMA DELL’UNO (DELL’ONU) E DEI MOLTI: USCIRE DAL LETARGO.
PARMENIDE, IL PONTE DI ELEA, E LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA.
"IN PRINCIPIO ERA IL LOGOS": UNA QUESTIONE LOGICA EPOCALE...
Costituzione e Società. Se in una Repubblica democratica (dove "tutti i giornali sono uguali" o "tutti i partiti sono uguali") viene fondato e registrato un giornale (o un partito) con un Nome più "uguale degli altri giornali" o, anche, "più uguale degli altri partiti" (es. "La Repubblica", "La Nazione", "La Verità", ecc.), già #solo il Nome non dice qualcosa di ermetico del programma comunicativo o politico di un tale giornale o di un tale partito?
Filosofia e ... Archeologia. "Cum grano salis", una domanda: ma non c’è un vizio logico-politico e psicoanalitico nel mettersi dietro lo scudo di un giornale battezzato "la Repubblica" (!) e raccontare a chi legge la storiella che la propria porta (in senso spaziale e figurato), attraverso cui passa l’acqua di un fiume di opinioni, sia il ponte repubblicano e costituzionale che permette di attraversarlo?
 Non è meglio ritornare a Elea-Velia (da Parmenide e Zenone), seguire le inDICazioni della Giustizia (DIKe). e riprendere il cammino sul viadotto, sul ponte della cosiddetta "Porta Rosa" (https://it.wikipedia.org/wiki/Porta_Rosa)?
Non è meglio ritornare a Elea-Velia (da Parmenide e Zenone), seguire le inDICazioni della Giustizia (DIKe). e riprendere il cammino sul viadotto, sul ponte della cosiddetta "Porta Rosa" (https://it.wikipedia.org/wiki/Porta_Rosa)?Federico La Sala
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- RISALIRE LA CORRENTE. Presente storico e storia di lunga durata: il Giubileo di Platino della regina Elisabetta II e la domanda di Amleto (Shakespeare).3 giugno 2022, di Federico La Sala
RISALIRE LA CORRENTE. Storia Filosofia, Antropologia, Psicoanalisi, e Costituzione (2giugno 2022).
Europa e Giubileo di Platino di Elisabetta II d’Inghilterra. Presente storico e storia di lunga durata...
Per riflettere sull’idea di sovranità (e l’individualità dello Stato), oggi, associare (come ha fatto qualcuno) la figura della regina Elisabetta II con il testo della "Filosofia del diritto" (& 279) di Hegel è un ottimo invito a svegliarsi dal sonno dogmatico (Kant) e a riaprire la questione antropologica (e teologico-politica)!
Sollecita a ripensare la storia dell’Europa quanto meno dalla disfatta della Invincibile Armada, da Elisabetta I e da Shakespeare e, ancora, da Trafalgar e da Napoleone e, infine, dal successo di Hegel di proporsi (illuminato da Napoleone a Jena, 1806) come interprete della storia dell’ "anima del mondo", come figura del "Re del mondo"!
EDIPO, TEBE, E "DISAGIO DELLA CIVILTÀ" (Freud, 1929). La questione antropologica e politica su cui si arrovella Shakespeare con il suo "Amleto" è ancora l’enigma della sfinge: "Che cos’è mai un uomo se del suo tempo non sa far altr’uso che per mangiare e dormire?" (Amleto, Atto IV, Sc. 4).
Federico La Sala
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. -- IL TARLO DELLA COSCIENZA. "Dostoevskij legge Hegel in Siberia e scoppia a piangere" (László Földényi). Due recensioni.19 marzo 2022, di Federico La Sala
La rivolta di Dostoevskij. Quel gesto disperato contro la filosofia di Hegel
di Alberto Manguel (la Repubblica, 25 luglio 2012)
- [Foto] copertina libro
- Dostoevskij legge Hegel in Siberia e scoppia a piangere
- László Földényi
- Editore: Il Nuovo Melangolo
- Prezzo: EUR 8,00
Lo scrittore dei “Demoni” rifiutò con orrore la concezione della Storia formulata dal padre dell’idealismo: l’idea che passi inosservata l’esistenza dei singoli. Il principio perseguito dall’autore russo, secondo l’ungherese László Földényi, è che nessuno può essere estromesso dal corso delle vicende umane.
Devo la scoperta di László Földényi a Cees Nooteboom, che in uno dei suoi assalti epistolari insistette perché lo leggessi e mi inviò uno dei suoi saggi, Dostoevskij legge Hegel in Siberia e scoppia a piangere, pubblicato in italiano dal Melangolo qualche anno fa. Tra le tante vie che ci portano a leggere un libro (che hanno tutte qualcosa di misterioso) c’è quella del titolo. Magari non ci sentiamo immediatamente attratti verso un testo intitolato la Divina Commedia o Le contemplazioni, ma solo un cuore di pietra può resistere a Dostoevskij legge Hegel in Siberia e scoppia a piangere.
Io lo lessi immediatamente, tutto di un fiato, e poi lo lessi una seconda volta, e poi una terza: il contenuto non faceva assolutamente torto allo splendido titolo. La mia ignoranza dell’ungherese è assoluta e mi dovetti limitare perciò a leggere qualcuna delle opere di Földényi tradotte in spagnolo e in tedesco: sufficienti per giudicarlo un pensatore brillante, originale, lucido; ho seguito con piacere le sue illuminanti considerazioni filosofiche, storiche ed estetiche. I suoi libri sulla malinconia, l’arte e la critica sono dei capolavori.
Molto tempo fa, le scoperte di Copernico spostarono la visione autocentrata del nostro mondo su un’angolazione che da allora si è spostata sempre più in là, verso i margini dell’universo. La presa di coscienza che noi esseri umani siamo aleatori, minimali, un’apparecchiatura casuale per molecole autoreplicanti, non induce ad alte speranze o grandi ambizioni. Eppure, quello che Nicola Chiaromonte ha chiamato «il tarlo della coscienza» fa anch’esso parte del nostro essere, e pertanto, noi, queste particelle di pulviscolo cosmico, per quanto effimere e distanti siamo anche uno specchio in cui tutte le cose, noi stessi inclusi, ci riflettiamo. Questa modesta gloria dovrebbe bastarci. Il nostro passaggio (e, su una scala minuscola, il passaggio dell’universo insieme a noi) sta a noi registrarlo: un paziente e vano sforzo cominciato quando per la prima volta abbiamo iniziato a leggere il mondo. Chiamiamo Storia quella storia in svolgimento che pretendiamo di decifrare mentre la fabbrichiamo. Dostoevskij aveva capito tutto quando diceva che se la nostra fede nell’immortalità venisse distrutta, «tutto sarebbe permesso ». Così come la Storia, non abbiamo bisogno che l’immortalità sia vera per credere in essa.
Fin dall’inizio, la Storia è la storia raccontata dai suoi testimoni, vera o falsa che sia. Nell’VIII libro dell’Odissea, Ulisse elogia l’aedo che canta le sventure dei greci: «Tu narri quello che i Danai patirono e quanto patirono; uno tu sembri che era presente o che abbia udito da loro». Quel «sembri» è essenziale. La Storia quindi è la storia di quello che noi diciamo che è successo, anche se le giustificazioni che diamo per la nostra testimonianza non possono, per quanto ci sforziamo, essere giustificate.
 Secoli dopo, in una polverosa aula di università in Germania, Hegel avrebbe diviso questa «invenzione di ciò che è avvenuto» in tre categorie: la prima è la Storia scritta dai presunti testimoni diretti (ursprünglische Geschichte); la seconda è la Storia come meditazione su se stessa (reflektierende Geschichte); la terza è la Storia come
filosofia (philosophische Geschichte), che alla fine si trasforma in quella che tutti chiamiamo Storia mondiale (Welt-Geschichte), la storia infinita che include se stessa nel racconto.
Secoli dopo, in una polverosa aula di università in Germania, Hegel avrebbe diviso questa «invenzione di ciò che è avvenuto» in tre categorie: la prima è la Storia scritta dai presunti testimoni diretti (ursprünglische Geschichte); la seconda è la Storia come meditazione su se stessa (reflektierende Geschichte); la terza è la Storia come
filosofia (philosophische Geschichte), che alla fine si trasforma in quella che tutti chiamiamo Storia mondiale (Welt-Geschichte), la storia infinita che include se stessa nel racconto.Immanuel Kant, in precedenza, aveva immaginato due diverse concezioni della nostra evoluzione collettiva: la Historie, che indicava il mero resoconto dei fatti, e la Geschichte, un’elaborazione ragionata di quei fatti, perfino un’a-priori Geschichte, la cronaca di un corso annunciato di eventi a venire. Per Hegel, quello che importava era la comprensione (o l’illusione della comprensione) dell’intero flusso degli eventi, compreso il letto del fiume e gli osservatori sulla riva, e per potersi meglio concentrare sul corso principale escludeva i margini, le pozze laterali e gli estuari.
Földény immagina che questo sia l’orrore scoperto da Dostoevskij: che la Storia, di cui sa di essere la vittima, ignora la sua esistenza, che la sua sofferenza passa inosservata o, ancora peggio, non assolve a nessuno scopo nel flusso generale della specie umana. Quello che Hegel propone, agli occhi di Dostoevskij (e di Földényi) è quello che Kafka dirà poi a Max Brod: «C’è speranza, ma non per noi». Il caveat di Hegel è ancora più terribile dell’esistenza illusoria proposta dagli idealisti: veniamo percepiti, ma non veniamo visti.
Un presupposto del genere, per Földényi, (e altrettanto dovette sembrare a Dostoevskij) è inammissibile. Non solo la Storia non può estromettere nessuno dal suo corso, ma è vero anche l’inverso: è necessario il riconoscimento di tutti perché la Storia possa essere. La mia esistenza, l’esistenza di qualsiasi uomo, è condizionata al vostro essere, all’essere di qualsiasi altro uomo, ed entrambi dobbiamo esistere perché Hegel, Dostoevskij e Földényi esistano, dato che noi (gli anonimi altri) siamo la loro convalida e la loro zavorra, noi li portiamo in vita leggendoli. È questo il significato di quell’antica intuizione che siamo tutti parte di un insieme ineffabile in cui ogni singola morte e ogni sofferenza specifica influenza l’intera collettività umana, un insieme che non è limitato da ciascun io materiale.
 Il tarlo della coscienza mina la nostra esistenza, ma allo stesso tempo la convalida; non serve a nulla negarla, nemmeno come atto di fede. «Il mito che nega se stesso», dice Földényi saggiamente, «la fede che pretende di sapere: questo è l’inferno grigio, questa è la schizofrenia universale su cui è inciampato Dostoevskij».
Il tarlo della coscienza mina la nostra esistenza, ma allo stesso tempo la convalida; non serve a nulla negarla, nemmeno come atto di fede. «Il mito che nega se stesso», dice Földényi saggiamente, «la fede che pretende di sapere: questo è l’inferno grigio, questa è la schizofrenia universale su cui è inciampato Dostoevskij».La nostra immaginazione ci consente sempre una speranza in più, al di là della speranza spezzata o realizzata, una frontiera finora apparentemente irraggiungibile, che alla fine raggiungeremo solo per proporne un’altra ancora più in là. Dimenticare questa illimitatezza (come cercava di fare Hegel «potando» la sua concezione di quello che conta in quanto Storia) può riuscire a garantirci la piacevole illusione che ciò che avviene nel mondo e nella nostra vita sia pienamente comprensibile, ma riduce la contestazione dell’universo al catechismo e quella della nostra esistenza al dogma. Come sostiene Földényi, quello che vogliamo non è la consolazione di ciò che appare ragionevole e probabile, ma le inesplorate terre siberiane dell’impossibile.
 (Traduzione di Fabio Galimberti)
(Traduzione di Fabio Galimberti)
Dostoevskij vs. Hegel
di Andrea Monda (BombaCarta, 24 Marzo 2009) *
- [Foto] Fëdor Dostoevskij
Nel febbraio del 1854 Dostoevskij si trova ad essere condannato a servire l’esercito come soldato nella città siberiana di Semipalatinsk vicino al confine cinese. Cinque anni prima era stato condannato a morte, poi la pena era stata commutata, all’ultimo minuto, ai lavori forzati a vita; infine anche questa pena, dopo quattro anni durissimi, era stata trasformata nel servizio militare in Siberia. In questo periodo gli furono di grande supporto morale i libri inviatigli clandestinamente dal fratello Michail, tra cui i romanzi di Dumas e la Critica della ragion pura di Kant nonché Hegel.
 E proprio dalla lettura di Hegel prende le mosse questo strano libretto, a metà tra il racconto biografico e il saggio filosofico, scritto due anni fa dal professore ungherese di letteratura comparata Laszlo Foldèny che oggi arriva in Italia grazie all’edizioni de Il Melangolo.
E proprio dalla lettura di Hegel prende le mosse questo strano libretto, a metà tra il racconto biografico e il saggio filosofico, scritto due anni fa dal professore ungherese di letteratura comparata Laszlo Foldèny che oggi arriva in Italia grazie all’edizioni de Il Melangolo.Foldèny si concentra in quei cinque anni della biografia del grande scrittore russo passati nell’inferno bianco della Siberia (potrà tornare nella Russia europea solo il 18 marzo 1859) ed in particolare sull’effetto che ebbe su di lui la lettura di un brano delle Lezioni sulla filosofia della storia di Hegel in cui il filosofo tedesco, parlando dell’Asia, scrive di non essere interessato alla Siberia “in nessun modo, perché la zona nordica giace fuori dalla storia“. Il più grande filosofo e il più grande romanziere discutono “a distanza” (Hegel in realtà è già morto da oltre vent’anni) e il primo rivela al secondo, in modo secco e arrogante, di non far parte della storia.
Il breve saggio di Foldèny può essere visto come un tardivo tentativo di “risarcimento”, un prendere parte nel senso proprio di “parteggiare” per Dostoevskij, duramente colpito dalla lettura hegeliana: “E’ facilmente immaginabile che proprio allora, quando capì di non far parte della storia, per la quale aveva accettato tutte le disavventure” scrive Foldèny, “nacque in lui la convinzione che la vita potesse avere delle dimensioni che non possono essere inquadrate nella storia [...] Che è necessario uscire dalla storia per poter vedere i confini e i limiti dell’esistenza della storia“.
Il saggio è diviso in due parti, la prima si concentra su Hegel e la sua riflessione, perfettamente lucida quanto arida, sulla storia, e la seconda invece dedicata al tumultuosa condizione in cui si trova l’animo del romanziere russo che trova nella Siberia nello stesso tempo l’Inferno per cui disperare ma anche le ragioni per una riconquista più matura della fede e della speranza.
Sul filo del paradosso l’autore conduce al lettore alla conclusione che, proprio perché sconfitto dalla storia e sbattuto nel luogo più sperduto della terra, Dostoevskij riesce a osservare il mondo e l’uomo più in profondità di quanto faccia Hegel, cogliendo che nella storia c’è qualcosa di più, qualcosa di irriducibile e che sfugge anche alla più perfetta “architettura filosofica” realizzata dall’uomo occidentale.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI.
Federico La Sala
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- IL CORPO POLITICO (E LA TESTA). Trattativa Stato-mafia: assolti carabinieri e Dell’Utri. In primo grado erano stati tutti condannati a pene severissime.24 settembre 2021, di Federico La Sala
Trattativa Stato-mafia: assolti carabinieri e Dell’Utri
Pena ridotta al boss Bagarella, condannato il capomafia Cinà *
La corte d’assise d’appello di Palermo ha assolto al processo sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia gli ex ufficiali del Ros Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno e il senatore Marcello Dell’Utri, accusati di minaccia a Corpo politico dello Stato. In primo grado erano stati tutti condannati a pene severissime.
Dichiarate prescritte le accuse al pentito Giovanni Brusca. Pena ridotta al boss Leoluca Bagarella. Confermata la condanna del capomafia Nino Cinà.
Per Bagarella i giudici hanno riqualificato il reato in tentata minaccia a Corpo politico dello Stato, dichiarando le accuse parzialmente prescritte. Ciò ha comportato una lieve riduzione della pena passata da 28 a 27 anni. Confermati i 12 anni a Cinà. Gli ex ufficiali del Ros Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno sono stati assolti con la formula perché il "fatto non costituisce reato", mentre Dell’Utri "per non aver commesso il fatto". Confermata la prescrizione delle accuse al pentito Giovanni Brusca. L’appello, nel corso del quale è stata riaperta l’istruttoria dibattimentale, è cominciato il 29 aprile del 2019. Nel corso del processo è uscito di scena, per la prescrizione dei reati, un altro imputato, Massimo Ciancimino, figlio dell’ex sindaco mafioso di Palermo Vito, che rispondeva di calunnia aggravata all’ex capo della polizia Gianni De Gennaro e concorso in associazione mafiosa.
A rappresentare l’accusa in aula sono stati i sostituti procuratori generali Giuseppe Fici e Sergio Barbiera che hanno chiesto la conferma della sentenza di primo grado. Al termine del primo dibattimento, la Corte d’Assise aveva inflitto 28 anni a Bagarella, 12 a Dell’Utri, Mori, Subranni e Cinà e 8 a De Donno e Ciancimino. Vennero poi dichiarate prescritte le accuse rivolte al pentito Giovanni Brusca. Sotto processo, ma per il reato di falsa testimonianza, era finito anche l’ex ministro dell’interno Nicola Mancino che venne assolto. La Procura non presentò appello e quindi l’assoluzione diventò definitiva. Per la cosiddetta trattativa è stato, infine, processato separatamente e assolto, in abbreviato, l’ex ministro Dc Calogero Mannino. "Uomini delle istituzioni, apparati istituzionali deviati dello Stato, hanno intavolato una illecita e illegittima interlocuzione con esponenti di vertice di Cosa nostra per interrompere la strategia stragista.
La celebrazione del presente giudizio ha ulteriormente comprovato l’esistenza di una verità inconfessabile, di una verità che è dentro lo Stato, della trattativa Stato-mafia che, tuttavia, non scrimina mandanti ed esecutori istituzionali perché o si sta contro la mafia o si è complici. Non ci sono alternative", aveva detto l’accusa durante la requisitoria del processo d’appello, al termine della quale aveva chiesto la conferma di tutte le condanne del primo grado. Secondo i pm, il dialogo che gli ufficiali del Ros, tramite i Ciancimino e godendo di coperture istituzionali, avviarono con Cosa nostra durante gli anni delle stragi per interrompere la stagione degli attentati, avrebbe rafforzato i clan spingendoli a ulteriori azioni violente contro lo Stato. Sul piatto della trattativa, in cambio della cessazione delle stragi, sarebbero state messe concessioni carcerarie ai mafiosi detenuti al 41 bis e un alleggerimento nell’azione di contrasto alla mafia. Il ruolo di Mori e i suoi, dopo il ’93, sempre nella ricostruzione dell’accusa, sarebbe stato assunto da Dell’Utri che nella sentenza di primo grado venne definito "cinghia di trasmissione" tra i clan e gli interlocutori istituzionali.
"E’ un film, una cosa inventata totalmente - dice Marcello Dell’Utri, in una telefonata con Bruno Vespa a Porta a Porta -. Io questo processo non l’ho neanche seguito. Mi sono sentito quando sono andato a Palermo all’udienza come un turco alla predica, non capivo di cosa stessero parlando. Questa cosa era inesistente però purtroppo avevo paura che potessero avallare queste cose inventate servendosi dei soliti pentiti che hanno bisogno di dire cose per avere vantaggi, e di molta stampa che affianca le procure e soprattutto la procura di Palermo. Questo mi preoccupava, ma speravo intimamente nell’assoluzione".
"Non abbiamo mai dubitato dell’estraneità del Generale Mario Mori e degli ex ufficiali del Ros Antonio Subranni e Giuseppe De Donno alla vicenda per la quale per anni sono stati inchiodati e additati come traditori dello Stato. Questa sentenza ci obbliga ad una lettura radicale della narrazione di questi anni. La riforma della giustizia e in particolare la responsabilità civile sono una impellente necessità". Lo dichiarano Maurizio Turco e Irene Testa, Segretario e Tesoriere del Partito Radicale.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- IL CORPO POLITICO (E LA TESTA). Stato-mafia, se trattativa c’è stata «non è un reato».24 settembre 2021, di Federico La Sala
Politica
Stato-mafia, se trattativa c’è stata «non è un reato»
Ribaltando la sentenza di primo grado la Corte d’Assise d’appello di Palermo assolve l’ex senatore dell’Utri e gli ex ufficiali dei Ros
di Red. Int. (il manifesto, 24.09.2021)
ROMA. Se c’è stata una trattativa tra lo Stato e la mafia per mettere fine alle stragi dei primi anni ’90, non è un reato. Tre anni dopo la decisione con cui la Corte d’Assise di Palermo aveva accolto le richieste dell’accusa riconoscendo l’esistenza di un «patto scellerato» tra una parte delle istituzioni e i boss mafiosi, la Corte d’Assise d’appello del capoluogo siciliano capovolge quella sentenza e assolve gli uomini delle istituzioni. A partire dagli ex ufficiali dei Ros Mario Mori, Antonio Subranni, condannati in primo grado a 12 anni, e Giuseppe De Donno (8 anni), assolti con la formula perché il «fatto non costituisce reato» e dall’ex senatore di Forza Italia Marcello dell’Utri (12 anni in primo grado) «per non aver commesso il fatto». Confermate, invece, le condanne per il boss Leoluca Bagarella (27 anni invece dei 28 del primo grado) e del capomafia Nino Cinà (12 anni). Confermata anche la prescrizione delle accuse al pentito Giovanni Brusca.
«Sono soddisfatto e commosso. E’ un peso che ci togliamo. Il sistema giudiziario funziona», è stato il commento di Dell’Utri dopo la lettura della sentenza. Per l’avvocato Basilio Milo, che difende il generale Mori, «la sentenza stabilisce che la trattativa non esiste. E’ una bufala, un falso storico». Secco, invece, il commento del procuratore generale Giuseppe Fici: «Aspettiamo le motivazioni e leggeremo il dispositivo».
Per la procura di Palermo tra il 1992 e il 1993 gli uomini dello Stato avrebbero trattato con i vertici di Cosa nostra al fine di mettere fine alla stagione delle stragi cominciata con l’attentato ai giudici Falcone e Borsellino e proseguita poi con le bombe a Roma, Milano e Firenze. Sempre secondo l’accusa, rappresentata nel processo di primo grado dai pm Nino Di Matteo, Francesco Del Bene, Roberto Tartaglia e Vittorio Teresi, «i carabinieri dei Ros avevano avviato una prima trattativa con l’ex sindaco mafioso di Palermo Vito Ciancimino, che avrebbe consegnato un ’papello’ con le richieste di Totò Riina per fermare le stragi». Accusa sempre respinta dagli imputati.
Diversa la posizione di Marcello Dell’Utri. Le accuse all’ex senatore di Forza Italia facevano riferimento al periodo del governo Berlusconi, ovvero il 1994. Secondo i pm, inoltre, il dialogo che gli ufficiali dei Ros, tramite Ciancimino e godendo di coperture istituzionali, avviarono con Cosa nostra avrebbe rafforzato i clan spingendoli a ulteriori azioni violente contro lo Stato. Sul piatto della trattativa, in cambio della cessazione delle stragi sarebbero state messe concessioni carcerarie ai mafiosi detenuti al 41 bis e un alleggerimento dell’azione di contrasto alla mafia.
Diverse, e di segno opposto, le reazioni. «Rispetto il giudizio dei magistrati - ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando - , tuttavia questa sentenza rischia di non diradare, anche in virtù di una sentenza di primo grado che ha messo in fila fatti inquietanti, le tante zone d’ombra su uno dei periodi più oscuri della nostra Repubblica e sul rapporto perverso tra mafia, politica e istituzioni che ha scandito a suon di bombe la storia italiana».
Soddisfazione per l’esito del processo d’appello è stata espressa invece sia da Matteo Renzi che da Matteo Salvini. Per il leader di Italia viva «oggi si scrive una pagina di storia giudiziaria decisiva. Viene condannato il mafioso e assolti i rappresentanti delle istituzioni. Ciò che i giustizialisti hanno fatto credere in talk show e giornali era falso: non c’è reato. Ha vinto la giustizia, ha perso il giustizialismo». Amaro, infine, il commento di Salvatore Borsellino: «In Italia non c’è giustizia», ha detto il fratello del giudice assassinato dalla mafia.
-
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- "DIREZIONE SBAGLIATA": "UNA PALLA DI NEVE ALL’INFERNO". Fine della Storia o della Preistoria?!22 settembre 2021, di Federico La Sala
PIANETA TERRA: "UNA PALLA DI NEVE ALL’INFERNO". Fine della Storia o della Preistoria?!
- "Il mondo non è mai stato più minacciato o più diviso, siamo sull’orlo di un abisso e ci muoviamo nella direzione sbagliata" (A. Guterres, segretario generale dell’Onu, 21 settembre 2021)
QUAL è questa "direzione sbagliata"?! IN UNA CONFERENZA DEL 9 GENNAIO 1970, GREGORY BATESON, in una brillante sintesi, così riassume la visione del nostro rapporto storico con la natura:
"[...] Se mettete Dio all’esterno e lo ponete di fronte alla sua creazione, e avete l’idea di essere stati creati a sua immagine, voi vi vedrete logicamente e naturalmente come fuori e contro le cose che vi circondano. E nel momento in cui vi arrogherete tutta la mente, tutto il mondo circostante vi apparirà senza mente e quindi senza diritto a considerazione morale o etica. L’ambiente vi sembrerà da sfruttare a vostro vantaggio. La vostra unità di sopravvivenza sarete voi e la vostra gente o gli individui della vostra specie, in antitesi con l’ambiente formato da altre unità sociali, da altre razze e dagli animali e dalle piante.
 Se questa è l’opinione che avete sul vostro rapporto con la natura e se possedete una #tecnica progredita, la probabilità che avete di sopravvivere sarà quella di una palla di neve all’inferno.
Voi morrete a causa dei sottoprodotti tossici del vostro stesso odio o, semplicemente, per il sovrappopolamento e l’esagerato sfruttamento delle riserve. Le materie prime del mondo sono limitate.
Se questa è l’opinione che avete sul vostro rapporto con la natura e se possedete una #tecnica progredita, la probabilità che avete di sopravvivere sarà quella di una palla di neve all’inferno.
Voi morrete a causa dei sottoprodotti tossici del vostro stesso odio o, semplicemente, per il sovrappopolamento e l’esagerato sfruttamento delle riserve. Le materie prime del mondo sono limitate.
 Se io sono nel giusto, allora il nostro atteggiamento mentale rispetto a ciò che siamo e a ciò che sono gli altri dev’essere ristrutturato. Non si tratta di uno scherzo, e non so quanto tempo abbiamo ancora prima della fine"
Se io sono nel giusto, allora il nostro atteggiamento mentale rispetto a ciò che siamo e a ciò che sono gli altri dev’essere ristrutturato. Non si tratta di uno scherzo, e non so quanto tempo abbiamo ancora prima della fine"
 (cfr. G. Bateson, "Verso un’ecologia della mente", Adelphi, Milano 976, p. 480).
(cfr. G. Bateson, "Verso un’ecologia della mente", Adelphi, Milano 976, p. 480). -
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- IL DDL ZAN E LO STATO-CHIESA."Quell’animale mitologico metà Stato e metà ente religioso che, quando la lotta si fa dura, tira fuori l’asso nella manica sparigliando le carte" (Cinzia Sciuto).23 giugno 2021, di Federico La Sala
Il Vaticano, il ddl Zan e il Concordato da abolire
L’entrata a gamba tesa del Vaticano nella discussione sul ddl Zan non sorprende e mostra come lo statuto privilegiato che lo Stato italiano accorda alla Chiesa può seriamente minarne l’indipendenza e la laicità.
di Cinzia Sciuto (MicroMega, 23 Giugno 2021)
Lo stracciarsi di vesti in seguito alla nota verbale del Vaticano sul Ddl Zan è francamente incomprensibile. Dal 1929 (pieno regime fascista), grazie ai Patti lateranensi, la Chiesa cattolica - una sorta di monstrum metà Stato (con tanto di governo, ministri, ambasciatori, leggi, giudici ecc.) e metà ente religioso (con tanto di testo sacro, dogmi, riti e una rete di parrocchie e diocesi e preti e suore estesa su tutto il globo terracqueo) - gode di uno statuto privilegiato nei rapporti con lo Stato italiano, che francamente non si capisce perché non dovrebbe sfruttare (se non per suo opportunismo).
La Repubblica nata nel 1946 ha confermato in tutto e per tutto questo statuto privilegiato, parzialmente modificato solo con la revisione del Concordato del 1984 che ha fatto un passo importante, senza però tirarne le dovute e logiche conseguenze: dal momento in cui infatti, la religione cattolica non è più religione di Stato (come invece stabiliva il Concordato in vigore fino a quel momento), viene meno il fondamento su cui questo statuto privilegiato si fondava. -Uno Stato laico non può infatti per definizione avere rapporti privilegiati con una religione (tanto più che questa si presenta come quel monstrum metà Stato e metà ente religioso di cui sopra). (Per inciso: uno Stato davvero laico non può avere rapporti privilegiati con le religioni in generale, ma questo è un altro tema).
Antonio Gramsci osservava che il Concordato rappresenta di fatto una limitazione unilaterale della sovranità dello Stato italiano nel proprio stesso territorio: “Mentre il concordato limita l’autorità statale di una parte contraente, nel suo proprio territorio, e influisce e determina la sua legislazione e la sua amministrazione, nessuna limitazione è accennata per il territorio dall’altra parte. [...] Il concordato è dunque il riconoscimento esplicito di una doppia sovranità in uno stesso territorio statale”[1]. Altro che libera Chiesa in libero Stato.
Prendiamo per esempio l’insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica italiana. Come stabilisce il protocollo addizionale all’accordo di modifica del Concordato del 1984, questo insegnamento ha per legge carattere confessionale, in quanto impartito da insegnanti indicati dall’autorità religiosa e con contenuti non storico-critici ma dogmatici: “L’insegnamento della religione cattolica [...] è impartito - in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni - da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall’autorità ecclesiastica, nominati, d’intesa con essa, dall’autorità scolastica” (corsivi miei).
Se le cose stanno così, dunque, è del tutto inutile, e anche francamente un po’ penoso, frignare e implorare la Chiesa di essere un po’ meno invadente. La Chiesa fa la Chiesa, e a seconda delle contingenze storico-politiche sceglie gli strumenti che più le sono utili per raggiungere i suoi scopi, apparendo talvolta più conciliante ma sapendo tirar fuori gli artigli quando si sente seriamente minacciata. Artigli che però le abbiamo affilato noi.
Purtroppo non possiamo neanche lontanamente sperare che questa occasione venga colta per recidere finalmente l’unico legame della nostra Repubblica con il regime fascista e completare il percorso per rendere questo Paese compiutamente laico. Stando alle anticipazioni della stampa Draghi oggi dirà che «dovranno essere valutati gli aspetti segnalati da uno Stato con cui abbiamo rapporti diplomatici», mentre Letta - il segretario di quello che dovrebbe essere il partito erede di Gramsci - si è già messo sull’attenti, dichiarando di essere “pronto al dialogo sui nodi giuridici”. Nodi giuridici che sono stati sollevati già da diverse realtà non reazionarie e non cattoliche, le quali però non hanno goduto dell’attenzione invece riservata al Vaticano.
Il ddl Zan è, come tutte le proposte di legge in un Paese laico e democratico, aperto alla discussione e agli apporti critici di tutta la cittadinanza. Solo che ci sono cittadini che a disposizione hanno solo gli strumenti della libera discussione politica, attraverso i partiti e la società civile. E poi ci sono cittadini più uguali degli altri che possono contare su quell’animale mitologico metà Stato e metà ente religioso che, quando la lotta si fa dura, tira fuori l’asso nella manica sparigliando le carte.
- FOTO: Alessandro Zan (s) e il Segretario della Santa Sede per i Rapporti con gli Stati, Richard Paul Gallagher (d), 22 giugno 2021. ANSA/CIMAGLIA - CARCONI
[1] A. Gramsci, Quaderni del carcere [1932-1935], edizione critica a cura di V. Gerratana, 4 voll., Einaudi, Torino 2007, vol. III, quaderno 16 (XXII), p. 1866.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- Ascensione «per uno», «per molti» o «per tutti»?! Dante Alighieri non narra come stato è possibile uscire dall’inferno?!16 maggio 2021, di Federico La Sala
#Antropologia
#filologia «(gr. «idou ho #anthropos»)
e
#principiodicarità:
#Ascensione «per uno», «per molti» o «per tutti»?!
#DanteAlighieri non narra come stato è possibile uscire dall’#inferno
e
#giungere in #purgatorio e in #paradiso?!
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- USCIRE DALL’INFERNO (DANTE 2021). The Doomsday Book: Can the World Survive? (Gordon Rattray Taylor).15 maggio 2021, di Federico La Sala
Scheda sul libro di Gordon Rattray Taylor *
***
La Società Suicida - Requiem per un Pianeta Infetto?
Titolo originale: The Doomsday book [The Doomsday Book: Can the World Survive? (1st ed. : 1970 / ed.1972)]
Autore/i: Taylor Gordon Rattray
Editore: Arnoldo Mondadori Editore
terza edizione, traduzione di Angelo Francesco Lucchesi.
pp. 384, Milano [I ed., 1971]
Gordon Rattray Taylor è l’autore di La bomba biologica (Mondadori, 1968), best-seller della saggistica in tutto il mondo. Nato nel 1911, ha studiato scienze naturali al Trinity College di Cambridge. Si è specializzato negli studi degli orientamenti scientifici e delle loro implicazioni sociopsicologiche. Fra le altre sue opere: Economics for Exasperated, Conditions for Happiness, Are Workers Human?, Sex in History.
Pochi batteri in una provetta, con nutrimento e ossigeno, prolificano rapidamente. Raddoppiano di numero ogni venti minuti circa, fino a diventare una massa visibile e solida. La proliferazione si ferma quando i microbi cominciano a venire avvelenati dai loro stessi prodotti di rifiuto: al centro della massa si forma un nucleo di batteri morti o morenti, tagliati fuori dal nutrimento e dall’ossigeno dell’ambiente dalla compatta barriera dei loro vicini. Il numero dei microbi viventi si riduce pressoché a zero se le materie di rifiuto non vengono eliminate.
L’umanità si trova oggi in una situazione simile. Gli abitanti del pianeta Terra, che nel 1850 erano un miliardo, nel 1975 saranno quattro volte tanto e nel 2000 raggiungeranno i sette miliardi. La specie umana aumenta, per ora, alla velocità di 100 individui al minuto. La nuova tecnologia favorisce la moltiplicazione degli esseri umani, ma i suoi residui inquinanti, che avvelenano il suolo, l’aria e l’acqua, minacciano direttamente l’esistenza stessa di tutte le creature viventi.
La società suicida è una documentatissima, allucinante messa a punto dei problemi della sovrappopolazione, dell’inquinamento, dell’alterazione della natura in rapporto con le sempre più diffuse applicazioni della tecnologia.
Gli uomini vanno preparando la morte del pianeta. Il mondo possiede risorse che possono esaurirsi. Molti hanno lanciato messaggi di avvertimento che preannunciano un disastro di proporzioni immani: il pianeta Terra sta raggiungendo il limite delle sue capacità. Gordon Rattray Taylor ha riunito e ordinato in un unico mosaico i dati statistici, le indagini, le opinioni isolate e i rapporti ufficiali sull’argomento. Che fare? Grande numero, inquinamento, radioattività, mutamenti già in atto e a lungo termine che l’uomo provoca su geografia, atmosfera e clima, sono conseguenze di un’irreversibile spinta tecnologica.
L’umanità è giunta a una svolta decisiva della sua storia: l’utopia di una futura e perfetta civiltà delle macchine diventa un pauroso incubo tecnologico che nel giro di trent’anni può rendere inabitabile il mondo: La società suicida è un grido d’allarme contro l’ottimismo dei tecnocrati, un richiamo alla responsabilità dei politici, un invito all’uomo della strada affinché prenda coscienza dei pericoli che lo minacciano.
Sorridere sulle «profezie apocalittiche» è un grosso rischio: il futuro è già cominciato, il mondo desolato in cui la flora e la fauna sono morte per avvelenamento non è una profezia: è la realtà che circonda le nostre metropoli industriali. È già concreta la prospettiva di un pianeta infetto sul quale la vita diventa impossibile per i figli della razza umana d’oggi.
- Indice:
L’uomo, questo microbo
 Parole di ammonimento
Parole di ammonimento
 La «nave spaziale» terra
La «nave spaziale» terra
 Inquinamento e super-inquinamento
Inquinamento e super-inquinamento
 Il problema demografico
Il problema demografico
 Una vittoria di Pirro
Una vittoria di PirroGli ingegneri planetari
 Opere idriche
Opere idriche
 Gli artefici di terremoti
Gli artefici di terremoti
 I bulldozer nucleari
I bulldozer nucleari
 Lo scioglimento delle calotte polari
Lo scioglimento delle calotte polari
 Risparmiate quell’albero!
Risparmiate quell’albero!Era glaciale o morte da calore?
 Acqua sul fuoco
Acqua sul fuoco
 Prospettive nuvolose
Prospettive nuvolose
 Sbalzi di clima
Sbalzi di clima
 La morte da calore
La morte da caloreLa natura replica
 Esplosioni demografiche
Esplosioni demografiche
 Il controllo dei parassiti delle piante e suoi rischi
Il controllo dei parassiti delle piante e suoi rischi
 Animali in via d’estinzione
Animali in via d’estinzione
 Bacini idrici e relativi errori
Bacini idrici e relativi errori
 I grandi cicli
I grandi cicli
 Il nitrato che corrode
Il nitrato che corrode
 I gas tossici
I gas tossiciL’ultimo anelito
 Corona di spine
Corona di spine
 Le maree rosse
Le maree rosse
 Il mare, uno scarico che ha i suoi limiti
Il mare, uno scarico che ha i suoi limiti
 Una zaffata di nafta
Una zaffata di nafta
 La crisi dell’ossigeno
La crisi dell’ossigenoSostanze inquinanti all’ultima moda
 L’amianto come sostanza inquinante - DDT - DDT, sesso e cancro
L’amianto come sostanza inquinante - DDT - DDT, sesso e cancro
 Controlli biologici
Controlli biologici
 Che cosa è successo alle aquile?
Che cosa è successo alle aquile?Limitatevi a espirare
 La minaccia del piombo
La minaccia del piombo
 Il piombo che respiriamo
Il piombo che respiriamo
 Il più letale dei metalli
Il più letale dei metalli
 Vita breve e allegra?
Vita breve e allegra?Il quinto fattore
 Il problema dei rifiuti radioattivi
Il problema dei rifiuti radioattivi
 Cripto e tritio
Cripto e tritio
 Esistono i livelli di sicurezza?
Esistono i livelli di sicurezza?
 La concentrazione biologica
La concentrazione biologica
 Le dosi accettabili
Le dosi accettabili
 Il cancro e la dose accettabile
Il cancro e la dose accettabile
 Il rischio di incidenti
Il rischio di incidenti
 Darla a bere o menar per il naso
Darla a bere o menar per il naso
 Conclusione
ConclusioneIl limite della popolazione
 L’energia solare in-deficit
L’energia solare in-deficit
 Carestia e sovrabbondanza?
Carestia e sovrabbondanza?
 È lecito credere alle previsioni di espansione demografica?
È lecito credere alle previsioni di espansione demografica?
 Le proteine
Le proteine
 L’erosione
L’erosione
 I problemi che ci attendono
I problemi che ci attendonoLo sfacelo demografico: quando?
 La congestione dell’abitato umano
La congestione dell’abitato umano
 Le condizioni nelle grandi città
Le condizioni nelle grandi città
 Il sovraffollamento negli animali
Il sovraffollamento negli animali
 Natura e sobborghi
Natura e sobborghi
 L’optimum demografico
L’optimum demograficoNon fate male alla terra!
 WEW e GEO?
WEW e GEO?
 Sforzi personali
Sforzi personali
 Già si paga
Già si paga
 Che cosa si é fatto finora?
Che cosa si é fatto finora?
 Quelli che hanno l’autorità
Quelli che hanno l’autorità
 Punti oscuri
Punti oscuriL’incubo tecnologico
 Sotterfugi tecnici
Sotterfugi tecnici
 La crisi dei comuni
La crisi dei comuni
 La bancarotta dell’economia
La bancarotta dell’economia
 Le schiavitù tecnologiche
Le schiavitù tecnologiche
 I paladini della tecnologia
I paladini della tecnologia
 L’amore per la natura
L’amore per la natura
 Triplice crisi
Triplice crisi Ringraziamenti
Ringraziamenti
 Note bibliografiche
Note bibliografiche
 Indice analitico
Indice analitico
* FONTE: Libreria Editrice Ossidiane
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- STORIA, FILOLOGIA E TRADUZIONE: VULGATA E NEOVULGATA. Quando tradurre diventa creatività semantica (di A. Fraccacreta).14 aprile 2021, di Federico La Sala
TRADUZIONE E DISTRUTTIVITA’ SEMANTICA. UNA LEZIONE DI GIANNI RODARI. L’Acca in fuga ... *
- NEOVULGATA."Sulla scia di Cicerone, Girolamo traduce agape in caritas e attua così un’importante svolta nella conformazione del pensiero occidentale: nasce «qualcosa di nuovo che è stato creato dal movimento del linguaggio»" (A. Fraccacreta, Quando tradurre diventa creatività semantica, Avvenire, 14.04.2021).
- VULGATA."Charissimi, nolite omni spiritui credere [...] quoniam Deus charitas est" ["Carissimi, non prestate fede a ogni ispirazione [...] perché Dio è amore" (1 Gv. 4, 1-8).
- NEOVULGATA. "Carissimi, nolite omni spiritui credere (...) quoniam Deus caritas est" (1 Gv. 4.1-8).
- CHARIDAD (1729).
Letteratura.
Quando tradurre diventa creatività semantica
In un saggio Arduini interviene su una polemica antica relativa alla trasposizione dei libri in altra lingua. Dalle Scritture al caso Amanda Gorman
di Alberto Fraccacreta (Avvenire, martedì 13 aprile 2021)
La traduzione è un problema? Lo sono i traduttori. È quello che sta succedendo in Europa particolarmente, in Paesi Bassi e Spagna - per la versione del nuovo libro (in uscita a fine marzo) di Amanda Gorman, la ventitrenne poetessa afroamericana resa celebre dalla lettura di The Hill We Climb durante la cerimonia di insediamento del presidente Biden. La polemica si può sintetizzare in questi termini: i bianchi non possono comprendere a fondo (e quindi tradurre) testi afroamericani specificamente dedicati a questioni razziali. Al di là di accese diatribe, certo è che il processo di traduzione non coincide soltanto con un trasferimento di figure e immagini in una lingua differente, ma ha la capacità di entrare nel cuore delle idee e modificarle.
È l’ipotesi affascinante che emerge dal saggio di Stefano Arduini, Con gli occhi dell’altro. Tradurre ( Jaca Book, pagine 216, euro 18), ruotante attorno a dieci nuclei tematici (tra cui ’verità’, ’bellezza’, ’intraducibile’) intessuti di citazioni e rimandi dall’Antico e Nuovo Testamento, con uno sguardo ai Padri della Chiesa e alle versioni dei primi secoli del cristianesimo. «Se la traduzione riscrive le nostre configurazioni di conoscenze - commenta Arduini, ordinario di Linguistica all’università Lcu di Roma -, non può essere intesa come qualcosa che ripete il già detto in modo diverso, ma come un’operazione cognitiva che crea nuovi concetti ». Il tradurre diviene così un’«esperienza intellettuale » a livello estremamente creativo. Esempio lampante è il concetto di altro, transitato attraverso un estenuante tourbillon di variazioni semantiche: i termini greci hèteros e allos, i latini alter e alius, ma anche le nozioni di ospitalità nell’indoeuropeo segnalate da Benveniste e poi riformulate alla luce della filosofia di Ricoeur (la reciprocità e la sollecitudine), Lévinas (l’invocazione), Florenskij (la sophia e la costruzione del soggetto fuori da sé) e Meschonnic (la signifiance).
Tradurre vuol dire mettere in gioco costantemente l’identità e l’alterità, instaurare un’amicizia che pervade l’io nel rapporto col tu. Evitando di annettere a sé una cultura diversa, Arduini scrive: «Dobbiamo stare in silenziosa attesa di fronte all’alterità e in qualche modo rispettarla, accettare quello spazio vuoto». Solo così il traduttore, «figura emblematica della nostra contemporaneità multiculturale», può assolvere al compito di cogliere le diversità e accoglierle. Qui ci soccorre di nuovo Ricoeur col mirag- gio dell’«ospitalità linguistica »: «abitare la lingua dell’altro», guardare le cose con i suoi occhi, nel solco di quell’incontro a cui la traduzione ci educa.
 L’indagine si sposta sul Prologo del Vangelo di Giovanni e in particolare su logos, divenuto verbum nella Vulgata. La sostanziale polisemia del sostantivo greco rende ardua un’adeguata trasposizione, ma ciò che più importa è che, sul piano linguistico e teologico, le speculazioni sorte attorno all’incipit giovanneo hanno modificato di fatto il corso della ricezione storica, configurandosi come «nuovi concetti per nuovi mondi».
L’indagine si sposta sul Prologo del Vangelo di Giovanni e in particolare su logos, divenuto verbum nella Vulgata. La sostanziale polisemia del sostantivo greco rende ardua un’adeguata trasposizione, ma ciò che più importa è che, sul piano linguistico e teologico, le speculazioni sorte attorno all’incipit giovanneo hanno modificato di fatto il corso della ricezione storica, configurandosi come «nuovi concetti per nuovi mondi».Lo stesso accade in Esodo 3,14 con la notissima espressione «Io sono colui che sono» (dall’ebraico ehyeh asher ehyeh). Siamo di fronte a un passo nei limiti del traducibile perché la posizione aspettuale del predicato nella lingua d’origine tecnicamente si tratta di un imperfettivo - pone alcune insanabili ambiguità. Ecco le possibili traduzioni: «Io ero quello che ero, Io sarò quello che sarò, Io ero quello che sarò, Io sarò quello che ero». (E tuttavia non ne esce scalfita l’immutabilità di Dio.) Aquila, Filone, Origene e poi Agostino, Girolamo e Tommaso: l’innesto del pensiero greco e latino nel sostrato ebraico fa scintille e la catena di rivolgimenti aggiunge e perde qualcosa, generando però un’identità completamente inedita. Gli slittamenti semantici del termine parresia (dire tutto) sembrano invece riscrivere un’intera ’enciclopedia culturale’: dibattito e libertà di parola nel greco precristiano, apertura del cuore e trasparenza dell’anima in Dio sul versante veterotestamentario, rivelazione di Gesù e presenza dello Spirito in ambito neotestamentario. Ma nei primi secoli dopo Cristo - come suggerisce Michel Foucault - parresia diviene coraggio della verità, coraggio dei martiri nel testimoniare la fede.
Universi concettuali affini o distanti sorgono anche nelle traduzioni dei presocratici e nelle variazioni dell’amore dall’ebraico ’ahavahfino alla diade inconciliabile di eros e agape, quest’ultimo forse non voce indoeuropea ma più probabilmente prestito di area semitica. Sulla scia di Cicerone, Girolamo traduce agape in caritas e attua così un’importante svolta nella conformazione del pensiero occidentale: nasce «qualcosa di nuovo che è stato creato dal movimento del linguaggio». Cognitivista di lunga data, esponente di spicco della traduzione biblica e dei Translation Studies, Arduini ci conduce nelle arcane radici delle lingue antiche (si pensi ai termini che in ebraico indicano bellezza, Jafeh, bello esteriore, e Tôb, lo spazio del bene della Genesi) lasciandoci, con la ’moltiplicazione degli sguardi’ data dal mito di Babele, alle soglie dell’Intraducibile. Il traducibile all’infinito.
* Sul tema, nel sito, si cfr.:
PER RATZINGER, PER IL PAPA E I CARDINALI, UNA LEZIONE DI GIANNI RODARI. L’Acca in fuga
Federico La Sala
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- ANTROPOLOGIA, FILOLOGIA, E SPIRITO FARISAICO: MARIO DRAGHI E UNA SOLLECITAZIONE COSTITUZIONALE.4 aprile 2021, di Federico La Sala
PER UN "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") COSTITUZIONALE ....
- Una nota a margine dell’art. di Sara Nocent e Davide Amato, "Draghi, un messia “tecnico”?", Sinistrainrete, 02 April 2021.
SE E’ VERO CHE, "ANCORA UNA VOLTA, chi trova soluzioni alternative al neoliberismo è bandito dalla stanza dei bottoni", è ALTRETTANTO VERO CHE RIPETERE CON Adorno e Horkheimer, che “la terra interamente illuminata splende all’insegna di trionfale sventura”, porta tutti e tutte ancor di più nel buio dell’inferno.
Si è mai chiarito perché il Marx del "Capitale. Critica dell’economia politica", come il Marx della "Prefazione" a "Per la critica dell’economia politica", richiami Dante (è solo l’eco mnemonico di letture giovanili?) o, ancora, in un "banale" ritornello nei suoi lavori associ alla parola "economia politica" sempre la parola "critica"?! Non è perché il suo discorso ha qualche legame con il lavoro del Kant della "Critica della Ragion Pura", "Critica della Ragion Pratica", "Critica del Giudizio"!?
Se "Oggi tutti sono pazzi per Draghi", forse, c’è qualche motivo - per esempio, un motivo storico-costituzionale di lunga durata: "Una vera parità di genere non significa un farisaico rispetto di quote rosa richieste dalla legge: richiede che siano garantite parità di condizioni competitive tra generi. Intendiamo lavorare in questo senso, puntando a un riequilibrio del gap salariale e un sistema di welfare che permetta alle donne di dedicare alla loro carriera le stesse energie dei loro colleghi uomini, superando la scelta tra famiglia o lavoro" (Mario Draghi, discorso al Senato, 17.02.2021)!
DRAGHI, UN MESSIA "TECNICO"?! NON è TEMPO, FORSE, DI CHIARIRSI LE IDEE SU "CHI SIAMO IN REALTà" e, finalmente, riprendere con Marx la via della CRITICA DELL’ECONOMIA POLITICA" DELLA RAGIONE ATEA E DEVOTA. O no?!
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- LA QUESTIONE ANTROPOLOGICA. "La difficile eredità di Marx" (di Riccardo Bellofiore).29 marzo 2021, di Federico La Sala
MARX, IL "LAVORO - IN GENERALE", E IL "RAPPORTO SOCIALE DI PRODUZIONE - IN GENERALE".... *
- Una nota a margine del testo di Riccardo Bellofiore, La difficile eredità di Marx, Sinistra in rete, 24 marzo 2021.
"CRITICA DELL’ECONOMIA POLITICA" , "CRITICA DELLA RAGION PRATICA" (E MEMORIA DI DANTE ALIGHIERI - ANNO 2021) . Alla luce del fatto che si è persa ogni cognizione dello "stato di cose presente", forse, è opportuno - come voleva Marx - riprendere il filo dalla indicazione delle note "Per la critica della filosofia del diritto di Hegel. Introduzione"): "La teoria è capace di impadronirsi delle masse non appena dimostra ad hominem, ed essa dimostra ad hominem non appena diviene radicale. Essere radicale vuol dire cogliere le cose alla radice. Ma la radice, per l’uomo, è l’uomo stesso".
Si dice:
- "[...] Vi sono delle lacune nella riflessione originaria di Marx che vanno superate. Marx vede bene un punto: che sotto il capitale il lavoro è prestazione erogata dalla forza-lavoro di ‘soggetti’ apparentemente liberi ed eguali. È di lì, da questi lavoratori che sono un ‘altro’ dal capitale che deve essere reso interno, ‘incorporato’ nella fabbrica produttiva, che viene estratto il lavoro vivo, dunque il nuovo valore di cui il plusvalore è parte: è per questo che le lotte sul lavoro sono centrali. Non presta però attenzione alla riproduzione sociale degli esseri umani che sono portatori viventi della forza-lavoro, dunque al lavoro domestico e al lavoro di cura. È questo uno dei fuochi del discorso del femminismo. C’è poi un ‘altro’ che è esterno al capitale, che è la natura, che viene anch’essa sfruttata e depredata nel suo corpo come gli esseri umani. Anche questo Marx lo vede, ma in qualche misura ne sottostima la gravità, che non può più sfuggirci" (R. Bellofiore, cit).
CONCORDO. Ma per ripartire bisogna riprendere il filo dalla "Logica" di Kant (non di Hegel, come si recita ancora oggi: http://www.leparoleelecose.it/?p=41116#comment-439785), dalla sua "quarta" (e prima!) domanda: "che cosa è l’uomo?", dalla sua "Critica della ragion pratica", e dal suo "imperativo categorico" (http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=5635)! La questione è antropologica (non andrologica né ginecologica)! O no?!
* Sul tema, mi sia lecito, si cfr. la "Lettera da ‘Johannesburg’ a Primo Moroni (in memoriam)": "CHI" SIAMO NOI, IN REALTÀ. RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE (http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=4198); su COME NASCONO I BAMBINI? E COME ‘NASCONO’ I GENITORI?!, rileggere la lettera di Sigmund Freud (http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=2923).
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- LA COSTITUZIONE, LA "BIBBIA CIVILE", E LA "SOLLECITAZIONE" DI MARIO DRAGHI:15 marzo 2021, di Federico La Sala
La #Costituzione è la nostra #Bibbiacivile.
Ricordiamo i nostri #Padri e le nostre #Madri #Costituenti:
"Una vera #paritàdigenere non significa un farisaico rispetto di #quoterosa richieste dalla #legge"
(#MarioDraghi).
***
#USCIAMO DAL #LETARGO
e
dall’#immaginario
di una zoppa e cieca #antropologia.
A #ContursiTerme (#Salerno), almeno del 1989 è ripreso
il dibattito sulla #paritadigenere
grazie alla #memoria
di #Michelangelo e di #TeresadAvila
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- IL CAPITOLO DI UN TESTO DI "ANATOMIA" DEL 1560 E IL COMMENTO DEL PROF. LUIGI CANCRINI DEL 2005.10 marzo 2021, di Federico La Sala
MATEMATICA, ANATOMIA, E BAMBINI E BAMBINE. UNA QUESTIONE DI CIVILTÀ..
- LA MATEMATICA È LA COSTITUZIONE, “È una disciplina che non ammette principio di autorità giacché nessuno possiede la verità da solo, le verità sono asserzioni verificabili da chiunque, o se non da chiunque (alcune volte è difficile) almeno da un certo numero di persone. Inoltre, la matematica è un linguaggio, una grammatica. Per discutere di matematica bisogna accettarne le regole. Sicché uno studioso, ma anche uno studente di matematica, è abituato a operare in un mondo di regole comuni, per ridiscutere le quali non si può essere in uno, bisogna essere almeno in due.
 Ovviamente la matematica non procede per voto o alzata di mano, ma per ipotesi e verifiche. Se i nostri politici avessero studiato matematica, e se studiandola l’avessero capita, si comporterebbero diversamente rispetto alle cariche dello Stato che ricoprono perché non agirebbero come singoli, ma come funzioni di un sistema più ampio del loro ego, e soprattutto non si preoccuperebbero delle cose ma delle relazioni tra le cose, dunque sarebbero più cauti nel dare una notizia falsa o non verificata, perché consci di quanto la notizia falsifichi il resto, talvolta il contesto.” (Chiara Valerio, La matematica è politica, Einaudi, Torino, 2020, p. 53).
Ovviamente la matematica non procede per voto o alzata di mano, ma per ipotesi e verifiche. Se i nostri politici avessero studiato matematica, e se studiandola l’avessero capita, si comporterebbero diversamente rispetto alle cariche dello Stato che ricoprono perché non agirebbero come singoli, ma come funzioni di un sistema più ampio del loro ego, e soprattutto non si preoccuperebbero delle cose ma delle relazioni tra le cose, dunque sarebbero più cauti nel dare una notizia falsa o non verificata, perché consci di quanto la notizia falsifichi il resto, talvolta il contesto.” (Chiara Valerio, La matematica è politica, Einaudi, Torino, 2020, p. 53).
Parlare dell’embrione per dimenticare il mondo
risponde Luigi Cancrini (l’Unità, 28.02.2005, p. 27)
«Avrei voluto con mio honore poter lasciar questo capitolo, accioche non diventassero le Donne più superbe di quel che sono, sapendo, che elleno hanno anchora i testicoli, come gli uomini; e che non solo sopportano il travaglio di nutrire la creatura dentro suoi corpi, come si mantiene qual si voglia altro seme nella terra, ma che anche vi pongono la sua parte; pure sforzato dall’historia medesima non ho potuto far altro. Dico adunque che le Donne non meno hanno testicoli, che gli huomini, benche non si veggiano per esser posti dentro del corpo».
Così inizia il capitolo 15 dell’Anatomia di Giovanni Valverde, stampata a Roma nel 1560, intitolato «De Testicoli delle donne» (p. 91). Dopo queste timide e tuttavia coraggiose ammissioni, ci vorranno altri secoli di ricerche e di lotte: «(...) fino al 1906, data in cui l’insegnamento adotta la tesi della fecondazione dell’ovulo con un solo spermatozoo e della collaborazione di entrambi i sessi alla riproduzione e la Facoltà di Parigi proclama questa verità ex cathedra, i medici si dividevano ancora in due partiti, quelli che credevano, come Claude Bernard, che solo la donna detenesse il principio della vita, proprio come i nostri avi delle società prepatriarcali (teoria ovista), e quelli che ritenevano (...) che l’uomo emettesse con l’eiaculazione un minuscolo omuncolo perfettamente formato che il ventre della donna accoglieva, nutriva e sviluppava come l’humus fa crescere il seme» (Françoise D’Eaubonne). Oggi, all’inizio del terzo millennio dopo Cristo, nello scompaginamento della procreazione, favorito dalle biotecnologie, corriamo il rischio di ricadere nel pieno di una nuova preistoria: «l’esistenza autonoma dell’embrione, indipendente dall’uomo e dalla donna che hanno messo a disposizione i gameti e dalla donna che può portarne a termine lo sviluppo» spinge lo Stato (con la Chiesa cattolico-romana - e il Mercato, in una vecchia e diabolica alleanza) ad avanzare la pretesa di padre surrogato che si garantisce il controllo sui figli a venire. Se tuttavia le donne e gli uomini e le coppie che si sentono responsabili degli embrioni residui dichiarassero quale destino pare loro preferibile, se un’improbabile adozione, la distruzione o la donazione alla ricerca scientifica, con la clausola che in nessun modo siano scambiati per denaro o ne derivi un profitto, la vita tornerebbe rivendicata alle relazioni umane piuttosto che al controllo delle leggi, ne avrebbe slancio la presa di coscienza dei vincoli che le tecnologie riproduttive impongono e più consenso la difesa della “libertà” di generare.
 Federico La Sala
Federico La SalaHo molto apprezzato la citazione di Valverde soprattutto per un motivo: perché dimostra, con grande chiarezza il modo timido e spaventato con cui da sempre gli uomini di scienza si sono accostati al tema della procreazione. Il problema di quello che era un tempo “l’anima” dell’essere umano, la sua parte più preziosa e più peculiare, quella cui le religioni affidavano il senso della memoria e dell’immortalità è stata sempre monopolio, infatti, dei filosofi e dei teologi che hanno difeso accanitamente le loro teorie (i loro “pregiudizi”: nel senso letterale del termine, di giudizi dati prima, cioè, del momento in cui si sa come stanno le cose) dalle conquiste della scienza. Arrendendosi solo nel momento in cui le verità scientifiche erano troppo evidenti per essere ancora negate e dimenticando in fretta, terribilmente in fretta, i giudizi morali e gli anatemi lanciati fino ad un momento prima della loro resa. Proponendo uno spaccato estremamente interessante del modo in cui il bisogno di credere in una certa verità può spingere, per un certo tempo, a non vedere i fatti che la contraddicono. Come per primo ha dimostrato, scientificamente, Freud.
Ragionevolmente tutto questo si applica, mi pare, alle teorie fra il filosofico e il teologico (come origine: i filosofi e teologi “seri” non entrano in polemiche di questo livello) per cui l’essere umano è tale, e tale compiutamente, dal momento del concepimento. Parlando di diritti dell’embrione tutta una catena ormai di personaggi più o meno qualificati per farlo (da Buttiglione a Schifani, da Ruini a La Russa) si riempiono ormai la bocca di proclami (sulla loro, esibita, profonda, celestiale moralità) e di anatemi (nei confronti dei materialistici biechi di una sinistra senza Dio e senza anima).
In nome dell’embrione sentito come una creatura umana, la cui vita va tutelata, con costi non trascurabili, anche se nessuno accetterà mai di impiantarli in un utero. Mentre milioni di bambini continuano amorire nel mondo e intorno a loro senza destare nessun tipo di preoccupazione in chi, come loro, dovendo predisporre e votare leggi di bilancio, si preoccupa di diminuire la spesa sociale del proprio paese (condannando all’indigenza e alla mancanza di cure i bambini poveri che nascono e/o vivono in Italia) e le spese di sostegno ai piani dell’Onu (mantenendo, con freddezza e cinismo, le posizioni che la destra ha avuto da sempre sui problemi del terzo mondo e dei bambini che in esso hanno la fortuna di nascere).
Si apprende a non stupirsi di nulla, in effetti, facendo il mestiere che faccio io. Quando un paziente di quelli che si lavano continuamente e compulsivamente le mani fino a rovinarle, per esempio, ci dice (e ci dimostra con i suoi vestiti e con i suoi odori) che lava il resto del suo corpo solo quando vi è costretto da cause di forza maggiore, ci si potrebbe stupire, se non si è psichiatri, di questa evidente contraddizione. Quello che capita di capire essendolo, tuttavia, è che i due sintomi obbediscono ad una stessa logica (che è insieme aggressiva e autopunitiva) e che il primo serve di facciata, di schermo all’altro che è il più grave e il più serio. E accade a me di pensare, sentendo Buttiglione e La Russa che parlano di diritti dell’embrione e ignorando nei fatti quelli di tanti bambini già nati, che il problema sia, in fondo, lo stesso. Quello di un sintomo che ne copre un altro. Aiutando a evitare il confronto con la realtà e con i sensi di colpa. All’interno di ragionamenti che dovrebbero essere portati e discussi sul lettino dell’analista, non nelle aule parlamentari.
Così va, tuttavia, il mondo in cui viviamo. Perché quello che accomuna la Chiesa di ieri e tanta destra di oggi, in effetti, è la capacità di far germogliare il potere proprio dalle radici confuse della superficialità e del pregiudizio. Perché essere riconosciuti importanti ed essere votati, spesso, è il risultato di uno sforzo, anch’esso a suo modo assai faticoso, “di volare basso”, di accarezzare le tendenze più povere, le emozioni e i pensieri più confusi di chi non ama pensare. Parlando della necessità di uno Stato che pensi per lui, che decida al suo posto quello che è giusto e quello che non lo è. Liberandolo dal peso della ragione e del libero arbitrio. Come insegnava a Gesù, nella favola immaginata da Dostojevskji, il Grande Inquisitore quando Gesù aveva avuto l’ardire di tornare in terra per dire di nuovo agli uomini che erano uguali e liberi e rischiava di mettere in crisi, facendolo, l’autorità di una Chiesa che per 16 secoli aveva lavorato per lui e agito nel suo nome.
Del tutto inimmaginabile, sulla base di queste riflessioni, mi sembra l’idea che Buttiglione e Ruini, Schifani e La Russa possano accettare oggi l’idea da te riproposta nell’ultima parte della tua lettera per cui «le donne, gli uomini e le coppie che si sentono responsabili degli embrioni» potrebbero/ dovrebbero essere loro a decidere quale destino pare loro preferibile.
Ragionando sui fatti con persone scelte liberamente da loro perché sentite come capaci di dare loro gli elementi necessari per la decisione più corretta. Affermando l’idea per cui gli uomini, le donne e le coppie possono e debbono essere i veri protagonisti di quella procreazione responsabile che è il passaggio più alto, più difficile, più esaltante e più faticoso della vita di tutti gli esseri umani. Quella che più fa paura a tanta parte della Chiesa e della destra, in fondo, è soprattutto la libertà della coscienza critica. Per ragioni, io torno qui sul mio ragionamento iniziale, che andrebbero discusse sul lettino dell’analista, però, non nelle aule parlamentari, sui manifesti o sulle pagine di un giornale.
- LA MATEMATICA È LA COSTITUZIONE, “È una disciplina che non ammette principio di autorità giacché nessuno possiede la verità da solo, le verità sono asserzioni verificabili da chiunque, o se non da chiunque (alcune volte è difficile) almeno da un certo numero di persone. Inoltre, la matematica è un linguaggio, una grammatica. Per discutere di matematica bisogna accettarne le regole. Sicché uno studioso, ma anche uno studente di matematica, è abituato a operare in un mondo di regole comuni, per ridiscutere le quali non si può essere in uno, bisogna essere almeno in due.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- Nessun cambiamento di paradigma all’orizzonte: tutte le cose, urgentissime, che ci sarebbero da fare, non sono in programma (di Antonella Cilento).7 marzo 2021, di Federico La Sala
La lente azzurra
Contro la pandemia bisogna cambiare il rapporto col mondo
di Antonella Cilento (la Repubblica/Napoli, 07 Marzo 2021).
Nessun cambiamento di paradigma all’orizzonte: tutte le cose, urgentissime, che ci sarebbero da fare, non sono in programma.
Chiudere gli allevamenti intensivi che sono causa e humus della pandemia in corso e di quelle future (lo ha raccontato molto bene una puntata di "Indovina chi viene a cena" su Rai Tre), dare istruzione sulle abitudini alimentari, interrompere l’abuso farmacologico umano, agricolo e animale, fermare l’inquinamento chimico ed elettromagnetico (che ha già provocato danni a un’intera fascia di popolazione e che in questi giorni ha visto una condanna storia del professor Alexander Lerchl, docente di Biologia ed Etica della Scienza all’Università di Brema, da parte della Corte d’Appello Anseatica di Brema per aver supportato la diffusione massiva del 5 G: "tesi false che negano il potenziale genotossico della radiazioni elettromagnetiche"), introdurre abitudini mediche integrate e naturali: niente di tutto questo sta accadendo.
Non è accaduto per i numeri del cancro, non accade per il clima oltre la soglia di non ritorno, non accade neppure per la pandemia eterna che ci siamo, con le nostre stesse mani, organizzati. Nessuno guarda la luna, tutti il dito: il vaccino.
Certo: meglio usare i soldi pubblici europei per i laboratori farmaceutici, meglio sprecare energie per fare propaganda, per spingere una parte della popolazione ad accusarne un’altra.
Manon Aubry, eurodeputata di 31 anni, ha accusato in questi giorni Ursula Von Der Leyen di aver abdicato ogni potere ai laboratori farmaceutici privati, costruendo un gigantesco giro d’affari che rende i vaccini la leva con cui si può sollevare il mondo. I capi d’imputazione sono molti: contratti non chiari, consensi informati pieni di buchi, mancanza di garanzie. Ha chiesto di togliere la proprietà intellettuale sui brevetti, proprio in un momento in cui ci sarebbe necessità di produrre grandi quantità di vaccini su scala mondiale per uscire dalla crisi.
Ci sono segnalazioni di morti improvvise post vaccino (in Campania, in Alto Adige, in Norvegia, in Portogallo, in Francia): indagini in corso. Crescono i casi di effetti collaterali (l’Italia ha il primato europeo). Nessuna risposta per gli effetti su chi ha comunissime malattie autoimmuni (basta avere la diffusissima tiroidite di Hashimoto, regalino di Chernobyl per intere generazioni), nessuna risposta ai dubbi di una larga parte di popolazione, che è composta da persone che leggono e studiano, da medici, oncologi e scienziati di fama mondiale. Dopo il vaccino c’è chi non ha nessun effetto collaterale immediato. Le verifiche finali si faranno nel 2023: però questo non si fa a spese dei contribuenti.
Né si può parlare di obbligo vaccinale o passaporti vaccinali: la salute è un bene comune e sull’impossibilità di stabilire l’obbligo nelle scorse settimane si è espresso chiaramente il Consiglio Europeo.
Ci siamo fatti togliere molte libertà, in un anno, perché la paura conduce nel buio, ma non riusciamo con altrettanta forza a chiedere che vengano messe in opera politiche ambientali alternative che cambino il nostro rapporto col pianeta ma, è chiaro, queste politiche non sono un affare.
E allora affidiamoci alla letteratura: chissà che a leggere il bellissimo libro di Benjamín Labatut, "Quando abbiamo smesso di capire il mondo" (Adelphi) qualche dubbio sui comportamenti etici degli scienziati non venga. Romanzo della Storia, il genere che accomuna Sebald a una messe di scrittori contemporanei, i racconti intrecciati di Labatut narrano di come lo stesso elemento chimico può produrre il colore del manto delle madonne e il famigerato Zyklon B, di come i padri della fisica moderna abbiano alzato il velo della morte, di come siamo tutti esposti e abbiamo bisogno di etica e non di religioni della percezione.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- LA NASCITA DELLA TRAGEDIA, LA STORIA DELL’ARTE, E LA DIVINA COMMEDIA.1 marzo 2021, di Federico La Sala
STORIA DELL’ARTE E TEOLOGIA: LA PRIMA "CENA" DI "CAINO" (DOPO AVER UCCISO IL PASTORE "ABELE") E L’INIZIO DELLA "BUONA-CARESTIA"("EU-CARESTIA")! *
NELL’OSSERVARE "L’Ultima Cena raffigurata sulla parete di fondo del refettorio dell’ex convento dei francescani di Veglie" (sec. XVI/XVII ca.) E NEL RIFLETTERE SUL FATTO CHE "è tra le più canoniche rappresentazioni del momento in cui Cristo istituì la santissima Eucarestia" (Riccardo Viganò, L’Ultima Cena nel refettorio della Madonna della Favana di Veglie, Fondazione Terra d’Otranto, 07.06,2020), c’è da interrogarsi bene e a fondo su chi (teologi ed artisti) abbia potuto concepire e dare forma con straodinaria chiarezza e potenza a questa "cena"(vedere la figura: "Portata centrale, saliere e frutti", cit.) e, insieme, riflettere ancora e meglio sui tempi lunghi e sui tempi brevi della storia di questa interpretazione tragica del messaggio evangelico - a tutti i livelli, dal punto di vista filosofico, teologico, filologico, artistico, sociologico. O no?
NOTARE BENE E RICORDARE. Siamo a 700 anni dalla morte dell’autore della "COMMEDIA", della "DIVINA COMMEDIA", e della sua "MONARCHIA"!
SAPERE AUDE! (I. KANT). Sul tema, per svegliarsi dal famoso "sonno dogmatico", mi sia lecito, si cfr. l’intervento di Armando Polito, "Ubi maior minor cessat"(Fondazione Terra d’Otranto, 24.02.2021) e, ancora, una mia ipotesi di ri-lettura della vita e dell’opera di Dante Alighieri.
*
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE --- SPIRITO DELLA COSTITUZIONE E TRANSIZIONE CULTURALE: "PARITA’ DI GENERE" (Mario Draghi).18 febbraio 2021, di Federico La Sala
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. -- IMPARARE A CONTARE: UNA QUESTIONE DI ANALFABETISMO ANTROPOLOGICO E MATEMATICO.18 febbraio 2021, di Federico La Sala
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- TRACCIA PER UNA SVOLTA ANTROPOLOGICA: DUE SOLI (Dante 2021) E TRE CORONE (Giordano Bruno, 2021)!17 febbraio 2021, di Federico La Sala#STORIA #FILOSOFIA #STORIOGRAFIA e #Memoria - #17febbraio: #DUESOLI (#Dante2021) E #TRECORONE (#GiordanoBruno, 2021)! Un #paradigma e un legame da ripensare... http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=2647
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. IMPARARE A CONTARE E A PENSARE, COME DA ANTROPOLOGIA (NON DA ANDROLOGIA).9 febbraio 2021, di Federico La Sala
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- APPELLO. Una grave preoccupazione alla notizia che l’acqua, come una qualsiasi altra merce, nel mercato dei «futures» della Borsa di Wall Street.8 febbraio 2021, di Federico La Sala
ITALIA
Quotazione in Borsa dell’acqua: NO grazie *
Noi sottoscritte/i ci uniamo alla denuncia del Relatore Speciale delle Nazioni unite sul diritto all’acqua Pedro Arrojo-Agudo che l’11 dicembre scorso ha espresso grave preoccupazione alla notizia che l’acqua, come una qualsiasi altra merce, verrà scambiata nel mercato dei «futures» della Borsa di Wall Street.
L’inizio della quotazione dell’acqua segna un prima e un dopo per questo bene indispensabile per la vita sulla Terra.
Si tratta di un passaggio epocale che apre alla speculazione dei grandi capitali e alla emarginazione di territori, popolazioni, piccoli agricoltori e piccole imprese ed è una grave minaccia ai diritti umani fondamentali.
L’acqua è già minacciata dall’incremento demografico, dal crescente consumo ed inquinamento dell’agricoltura su larga scala e della grande industria, dal surriscaldamento globale e dai relativi cambiamenti climatici.
È una notizia scioccante per noi, criminale perché ucciderà soprattutto gli impoveriti nel mondo.
Secondo le Nazioni unite già oggi un miliardo di persone non ha accesso all’acqua potabile e dai tre ai quattro miliardi ne dispongono in quantità insufficiente.
Per questo già oggi ben otto milioni di esseri umani all’anno muoiono per malattie legate alla carenza di questo bene così prezioso.
Questa operazione speculativa renderà vana, nei fatti, la fondamentale risoluzione dell’Assemblea Generale dell’Onu del 2010 sul diritto universale all’acqua e, nel nostro paese, rappresenterà un ulteriore schiaffo al voto di 27 milioni di cittadine/i italiane/i che nel 2011 si espressero nel referendum dicendo che l’acqua doveva uscire dal mercato e che non si poteva fare profitto su questo bene.
Se oggi l’acqua può essere quotata in Borsa è perché da tempo è stata considerata merce, sottoposta ad una logica di profitto e la sua gestione privatizzata.
Per invertire una volta per tutte la rotta, per mettere in sicurezza la risorsa acqua e difendere i diritti fondamentali delle cittadine/i
CHIEDIAMO
Al Governo italiano che si sta delineando nel nostro paese chiediamo di:
prendere posizione ufficialmente contro la quotazione dell’acqua in borsa; approvare la proposta di legge Disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque» (A. C. n. 52) in discussione presso la Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati; sottrarre ad Arera le competenze sul Servizio Idrico e di riportarle al Ministero dell’Ambiente; di investire per la riduzione drastica delle perdite nelle reti idriche; di salvaguardare il territorio attraverso investimenti contro il dissesto idrogeologico; impedire l’accaparramento delle fonti attraverso l’approvazione di concessioni di derivazione che garantiscano il principio di solidarietà e la tutela degli equilibri degli ecosistemi fluviali.
* * * primi firmatari
Alex Zanotelli, Dacia Maraini, Moni Ovadia, Luciana Castellina, Emilio Molinari, Nando Dalla Chiesa, Don Virginio Colmegna, Gino Strada, Mimmo Lucano..
Info: www.acquabenecomune.org
* Fonte: il manifesto, 09.02.2021
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- UNA "QUESTIONE OMERICA": "PERICLE IL POPULISTA" E LA LEZIONE DI GIAMBATTISTA VICO.2 febbraio 2021, di Federico La Sala
AL DI LA’ DELL’ORIZZONTE DI "PERICLE IL POPULISTA" E DI PLATONE...
- TUCIDIDE E LA GUERRA CONTRO I "POETI": "[...] non abbiamo bisogno di alcun Omero che canti la nostra gloria né di chi con le sue parole procurerà un diletto immediato, dando però un’interpretazione dei fatti che non potrà reggere quando la verità si affermerà: con la nostra audacia abbiamo costretto il mare e la terra interi ad aprirci le loro vie, e ovunque abbiamo innalzato alle nostre imprese, siano state esse sfortunate o coronate da successo, monumenti che non periranno. Ed è per una tale città che questi uomini hanno affrontato amabilmente la morte in combattimento [...]" (Tucidide, La guerra del Peloponneso, II, 41, Bari, Laterza 1986).
PER NON CADERE (di nuovo e ancora, dopo millenni) NELLA TRAPPOLA DELLA TRACOTANZA E DELLA MALAFEDE DI "PERICLE", E NON DIMENTICARE CHE LA SUA LINEA POLITICA SEGNA L’INIZIO DELLA FINE DELLA GLORIA E DEL PROGETTO POLITICO DI ATENE, forse, è opportuno - ricordando la messa al bando di Omero e dei "poeti" dalla "Repubblica" di Platone - riprendere e rivedere (non solo i lavori di Eric A. Havelock, ma anche) la brillante analisi del cosiddetto "Elogio di Atene" da parte di Umberto Eco nella sua nota sul "Pericle il populista" di ieri e di oggi (la Repubblica, 14 gennaio 2012):
- "Il discorso di Pericle (riportato da Tucidide, in Guerra del Peloponneso) è stato inteso nei secoli come un elogio della democrazia, e in prima istanza è una descrizione superba di come una nazione possa vivere garantendo la felicità dei propri concittadini, lo scambio delle idee, la libera deliberazione delle leggi, il rispetto delle arti e dell’educazione, la tensione verso l’uguaglianza. Ma che dice in realtà Pericle?";
e, al contempo, volendo, rimeditare la storica lezione di Giambattista Vico sulla questione "Omero" e riflettere sulla sua proposta di una "Scienza Nuova", al di là dell’imbalsamazione crociana.
Federico La Sala
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- Condannato l’ex presidente dello Ior, Caloia. Si è concluso con tre condanne il processo in Vaticano a carico dell’ex presidente dello Ior (di M. Mu. - "Avvenire").22 gennaio 2021, di Federico La Sala
Vaticano. Condannato l’ex presidente dello Ior, Caloia
Dal Tribunale vaticano presieduto da Pignatone una pena di 8 anni e 11 mesi. Analoga condanna per l’avv. Gabriele Liuzzo. Al figlio Lamberto 5 anni e 2 mesi. Riciclaggio e appropriazione indebita
di M. Mu. (Avvenire, giovedì 21 gennaio 2021)
- [Foto] Angelo Caloia - Archivio Ansa
Si è concluso con tre condanne il processo in Vaticano a carico dell’ex presidente dello Ior Angelo Caloia e degli avvocati Gabriele e Lamberto Liuzzo, padre e figlio, riconosciuti colpevoli di peculato in danno dello Ior e di appropriazione indebita aggravata in danno della Sgir s.r.l., oltre che di autoriciclaggio i primi due; e di riciclaggio il terzo. La sentenza di primo grado ha comminato 8 anni e 11 mesi a Caloia e Gabriele Liuzzo, gravati anche di una multa di 12.500 euro cadauno e cinque anni e due mesi a Lamberto Liuzzo, oltre a una multa di 8mila euro. A pronunciarla è stato oggi il presidente del Tribunale della Città del Vaticano, Giuseppe Pignatone, affiancato dai due giudici a latere, Venerando Marano e Carlo Bonzano.
La vicenda riguarda la vendita di 29 immobili di proprietà dell’Ior e di una società controllata, la Sgir s.r.l. Secondo l’accusa, basata principalmente sulle indagini fatte nel 2014 dal gruppo Promontory, Caloia e Liuzzo, d’intesa con l’allora direttore generale dello Ior Lelio Scaletti, poi deceduto, avrebbero venduto - tra il 2002 e il 2007 - gli immobili ad un prezzo di gran lunga inferiore al valore di mercato; essi si sarebbero poi appropriati della differenza, stimata in circa 59 milioni di euro, che in parte avrebbero riciclato in Svizzera, anche con l’aiuto del figlio del Liuzzo, Lamberto Liuzzo.
«L’istruttoria dibattimentale - precisa un comunicato della Sala Stampa della Santa Sede -, durata circa due anni, ha consentito di chiarire, grazie al contributo di tutte le parti, nel pieno rispetto del contraddittorio, i principali aspetti della vicenda; tra l’altro, i periti hanno stimato nella misura di circa 34 milioni di euro la differenza tra quanto incassato dallo Ior e dalla Sgir ed il valore di mercato degli immobili. Il Tribunale ha ritenuto provato che in alcuni casi gli imputati si sono effettivamente appropriati di parte del denaro pagato dai compratori, o comunque di denaro dello Ior e della Sgir, per un importo complessivo di circa 19 milioni di euro. I tre imputati sono stati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici ed è stata altresì disposta a loro carico la confisca di somme complessivamente pari a circa 38 milioni di euro. Infine, Caloia e i due Liuzzo sono stati condannati al risarcimento dei danni nei confronti dello Ior e della sua controllata Sgir, costituiti parte civile, per una somma superiore a 20 milioni di euro. Gli imputati sono stati invece assolti dalle accuse relative alla vendita di quegli immobili per cui non è stata provata l’appropriazione -da parte loro- di denaro, anche se il prezzo di acquisto è risultato inferiore al valore di mercato dell’epoca. I 29 immobili si trovano a Roma (in zone di pregio), a Frascati, Fara Sabina, Milano (Porta Nuova) e Genova (piazza della Vittoria).
Sempre oggi il Tribunale ha confermato in sede di appello l’applicazione della misura di prevenzione nei confronti di Liuzzo Gabriele, ordinando la confisca di circa 14 milioni di euro depositati presso lo IOR e già da tempo in sequestro, nonché di altri 11 milioni di euro circa, depositati presso banche svizzere. Caloia è stato presidente dello Ior dal 1989 al 2009 e ha 81 anni. Gabriele Liuzzo 97 anni e Lamberto Liuzzo 55. I tre erano assenti ieri. Gli avvocati di Caloia hanno preannunciato appello.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
VITA E DENARO. COME RICICLARE LO STERCO DEL DIAVOLO. Intervista di Francesco Anfossi di "Famiglia Cristiana" al "banchiere del Papa", Angelo Caloia, presidente dello IOR
FLS
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- "E’ pazzesco": "E’ inaudito che imprenditori privati possano controllare e decidere loro chi possa parlare alla gente e chi no" (M. Cacciari).).9 gennaio 2021, di Federico La Sala
Trump sospeso dai social, Cacciari: "E’ pazzesco"
di Redazione Adnkronos *
"C’è un problema di fondo, che è al di là e al di fuori di Trump. E’ inaudito che imprenditori privati possano controllare e decidere loro chi possa parlare alla gente e chi no. Doveva esserci un’autorità ovviamente terza, di carattere politico che decide se qualche messaggio che circola in rete è osceno, come certamente sono quelli di Trump". E’ l’opinione di Massimo Cacciari, filosofo, professore ed ex sindaco di Venezia, che interviene con l’Adnkronos sulle polemiche che ha suscitato l’eliminazione dei post di Trump da parte di Twitter e la sospensione dell’account da parte di Facebook, Instagram e altri social in seguito all’assalto al Congresso.
"Che sia l’imprenditore a farlo, che è il padrone di queste reti, è una cosa semplicemente pazzesca. E’ uno dei sintomi più inauditi del crollo delle nostre democrazie. Non c’è dubbio alcuno. Perché come oggi è Trump, domani potrebbe essere chiunque altro, e lo decide Zuckerberg. E’ una cosa semplicemente pazzesca", incalza Cacciari.
Che spiega meglio nel merito: "Dovrebbe esserci una forma di autorità politica che decide. Esattamente così come c’è l’Autorità per concorrenza, per la privacy, che decide ’questi messaggi in rete sono razzisti, sono sessisti, incitano alla violenza’ e cosi via. E tu, Zuckerberg, li devi cancellare. Cioè deve essere l’autorità che dice a Zuckerberg cosa cancellare, invece qui è lui che decide. E’ una cosa dell’altro mondo".
* Fonte: Adnkronos, 08/01/2021 10:31 (ripresa parziale).
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- CHARITÉ: SOCIALISMO O BARBARIE. La realtà è più importante delle idee.5 gennaio 2021, di Federico La Sala
CHARITÉ: SOCIALISMO O BARBARIE ....
La realtà è più importante delle ideeRiccardo Cristiano. Bergoglio o barbarie *
Riccardo Cristiano racconta il suo saggio Bergoglio o barbarie, pubblicato da Castelvecchi nel 2020. L’idea di scrivere questo libro è venuta a Cristiano dopo l’incontro con un teologo che lo invitava ad andare negli Stati Uniti d’America per verificare di persona che l’alternativa a Bergoglio è la barbarie. Un’alternativa che ricordava quella famosa di Rosa Luxemburg tra socialismo o barbarie. Sostituire l’ideologia socialista con una persona come Bergoglio ha mostrato che il problema non era l’idea ma la realtà, perché la realtà è più importante delle nostre idee e il sole è quello che brilla oggi non quello dell’avvenire.
- I comportamenti di Bergoglio si accompagnano alle proposte, anzi sono la traduzione fisica delle sue proposte, perché il Papa considera la forma meno importante della sostanza del messaggio.
I suoi atti pontificali principali sono stati, secondo Cristiano, il documento di Abu Dhabi sulla fratellanza, che è l’antefatto dell’enciclica Fratelli tutti, l’accordo provvisorio con la Cina e il Sinodo per l’Amazzonia che è un po’ la sintesi del suo pontificato:
- lo sviluppo umano integrale, la difesa degli ecosistemi, della casa comune e la valorizzazione delle nostre diversità intese come dimostrazione del fatto che proprio perché siamo diversi siamo fratelli, cioè uguali, uguali nelle nostre diversità che sono parti del tutto che costruiamo insieme. Oggi solo Bergoglio può essere il punto di incontro tra universalismo e localismo.
Riccardo Cristiano, particolarmente attento al dialogo interreligioso, a lungo coordinatore dell’informazione religiosa di Radio Rai, è fondatore dell’Associazione Giornalisti amici di padre Dall’Oglio e collabora come vaticanista con «Reset» e «La Stampa». Ha pubblicato con Castelvecchi Medio Oriente senza cristiani? (2014), Bergoglio, sfida globale (2015), Siria. L’ultimo genocidio (2017) e ha curato il volume Solo l’inquietudine dà pace. Così Bergoglio rilancia il vivere insieme (2018).
* FONTE: RAI CULTURA/FILOSOFIA
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- CHARITÉ: BERLINO RICORDA A PAPA RATZINGER IL NOME ESATTO DELL’ OSPEDALE E DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA.
VICO E MARX CONTRO LA PRASSI (ATEA E DEVOTA) DELLA CARITÀ POMPOSA.
FLS
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- Una grande occasione per convertirsi e recuperare autenticità. La grazia della crisi della Chiesa (di Marcello Neri - Il Mulino).23 dicembre 2020, di Federico La Sala
La grazia della crisi della Chiesa
di Marcello Neri (Il Mulino, 23 dicembre 2020)
Il discorso di papa Francesco alla Curia romana per la presentazione degli auguri di Natale ha avuto quest’anno un clamore relativamente più basso sulla stampa e sui mezzi di informazione rispetto a quelli di anni precedenti. Niente di appetibile per confezionare notizie ad effetto - come nel 2014 quando Francesco elencò una per una le malattie curiali; o nel 2018 dove affrontò di petto la questione dell’abuso del potere; oppure l’anno scorso sulle linee portanti di una riforma della Curia stessa. Lo scarso potenziale polemico del discorso non ne sminuisce però l’importanza per la vita della Chiesa cattolica e la sua solidale presenza in un mondo che nel giro di pochi mesi sembra aver perso la sua tracotante sicurezza, per ritrovarsi vulnerabile e ferito.
Si procede a tentoni e in ordine sparso davanti alla crisi del nostro tempo, forse proprio perché ci ostiniamo a non voler cogliere nella crisi “una grande occasione per convertirci e recuperare autenticità”. Pensare di uscire da una crisi tornando alle condizioni quo ante vuol dire abdicare a ogni possibilità di futuro, indice questo di una condizione umana che non sa più declinare un lessico, anche solo minimale, della speranza.
Invece, la crisi è “una tappa obbligata della storia personale e della storia sociale (...) che causa sempre un senso di trepidazione, angoscia, squilibrio e incertezza nelle scelte da fare (...). La crisi è quel setacciamento che pulisce il chicco di grano dopo la mietitura”. Setacciamento che mette al vaglio la stessa Chiesa, che non è esente da questa doverosa fedeltà alla storia in cui vive.
Proprio per la Chiesa, davanti alla Curia, Francesco rilancia il senso evangelico della crisi. E lo fa senza tacere una disfunzionalità oramai conclamata dell’apparato, giunta al punto tale da mortificare impietosamente anche i tanti slanci di sincera generosità e di buon servizio professionale che pur sempre vi sono al suo interno. Perché oramai l’apparato ecclesiastico sembra essersi asservito a quella che Francesco chiama la logica del conflitto: “vorrei esortarvi a non confondere la crisi con il conflitto: sono due cose diverse. La crisi generalmente ha un esito positivo, mentre il conflitto crea sempre un contrasto, una competizione, un antagonismo apparentemente senza soluzione fra soggetti divisi in amici da amare e nemici da combattere, con la conseguente vittoria di una delle due parti (...). La Chiesa, letta con le categorie del conflitto - destra e sinistra, progressisti e tradizionalisti - frammenta, polarizza, perverte, tradisce la sua vera natura: essa è un corpo perennemente in crisi proprio perché è vivo (...)”.
L’apparato che gioca col conflitto, schierandosi sul fronte delle tante scomposizioni del nostro tempo, impedisce alla Chiesa di fare il suo lavoro - che è quello di immettere un orizzonte di speranza nel tempo della crisi e dei suoi drammi. Tra tutte le istituzioni, proprio la Chiesa dovrebbe avere una famigliarità connaturale con la crisi, perché da sempre essa è “messa in crisi dal Vangelo” che la origina. La logica del conflitto impedisce oggi alla Chiesa di attingere alla sapienza di questo attraversamento millenario della crisi, mettendo invece in campo tutto un armamentario difensivo mediante il quale viene stoltamente ostacolata “l’opera della Grazia”.
Dopo otto anni di pontificato, giunto oramai al suo 84º compleanno, Francesco continua imperterrito a cercare di allineare la Chiesa cattolica sull’asse portante del Vangelo, scontentando a destra e manca - che è poi il prezzo che la liberalità evangelica paga da sempre nel cristianesimo.
 Smarcandosi così da quella conflittualità che scuote il corpo della comunità ecclesiale fin dai suoi primi giorni: ogni volta che si dice “io sono di Paolo; io invece sono di Apollo; e io di Cefa; e io di Cristo” (1Cor 1,12) si è sicuramente fuori dal Vangelo di Gesù, e la Chiesa si trasforma in un apparato insopportabilmente scandaloso al cospetto di Dio e degli uomini.
Smarcandosi così da quella conflittualità che scuote il corpo della comunità ecclesiale fin dai suoi primi giorni: ogni volta che si dice “io sono di Paolo; io invece sono di Apollo; e io di Cefa; e io di Cristo” (1Cor 1,12) si è sicuramente fuori dal Vangelo di Gesù, e la Chiesa si trasforma in un apparato insopportabilmente scandaloso al cospetto di Dio e degli uomini. -
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE, E LA RICEZIONE DI DANTE NEL MAGISTERO PONTIFICIO CONTEMPORANEO17 dicembre 2020, di Federico La Sala
LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE, E IL VATICANO ... *
- «Qui sarai tu poco tempo silvano; /e sarai meco sanza fine cive /di quella Roma onde Cristo è romano.
- Però, in pro del mondo che mal vive, /al carro tieni or li occhi, e quel che vedi, /ritornato di là, fa che tu scrive».
- Così Beatrice; e io, che tutto ai piedi /d’i suoi comandamenti era divoto, /la mente e li occhi ov’ella volle diedi. (Purg. XXXII, 100-109).
«QUELLA ROMA ONDE CRISTO È ROMANO»: LA RICEZIONE DI DANTE NEL MAGISTERO PONTIFICIO CONTEMPORANEO
di VALENTINA MERLA *
In un clima di polemica tra cattolici e non cattolici, negli anni dell’Unità d’Italia, in cui i patrioti italiani avevano studiato la concezione politica dell’Alighieri incasellandola sotto l’egida del ghibellinismo anticlericale, Leone XIII sceglie la strada del dialogo con la società, progettando una riforma della cultura cattolica sulla base del tomismo. La sua ricezione di Dante è possibile proprio alla luce del tomismo: Leone XIII è, in effetti, secondo una definizione di padre Semeria, un’«anima dantesca», soprattutto per la significativa consonanza tra il suo pensiero sociale e la Monarchia (era stato proprio il suo intervento ad assolvere il trattato dantesco dall’accusa di eterodossia, escludendolo dall’indice dei Libri Proibiti). Infatti, come Dante, anche papa Pecci partecipa al dibattito sui rapporti tra Stato e Chiesa, riflettendo “laicamente” sul potere politico e sostenendo la reciproca indipendenza delle due istituzioni.
Alla morte dell’anziano pontefice sale al soglio pontificio Pio X, attento riorganizzatore del Catechismo della Chiesa Cattolica e sostenitore di una nuova concezione pastorale, che considera ogni strumento culturale, anche il testo dantesco, funzionale all’esigenza catechetica. Il pontefice incentiva, dunque, le iniziative in preparazione alla commemorazione del VI centenario dantesco, tra le quali una è particolarmente vicina ai suoi orientamenti pastorali. Si tratta di un lavoro di sinossi e comparazione tra il testo del catechismo del pontefice e la scrittura dantesca, che, in questo modo, viene frammentata al duplice scopo di supportare le affermazioni del catechismo e di dimostrare la perfetta aderenza del poeta al cattolicesimo. L’opera, firmata con lo pseudonimo d Minimo Sacerdote in Cristo, si intitola Il più bel ricordo del VI centenario di Dante, ossia Catechismo della Dottrina Cristiana pubblicato per ordine di sua Santità Pio X, meditato e studiato con Dante.
Una linea spartiacque nella rivalutazione dell’Alighieri da parte del magistero pontificio si ha con l’enciclica In praeclara summorum (1921), scritta da Benedetto XV per commemorare il VI centenario della morte del sommo poeta, che viene per la prima volta apostrofato come figlio prediletto della fede cattolica. Sulla scia del predecessore, sebbene in modi differenti, si colloca il riuso che dell’opera dantesca fa Pio XI, riportando nei suoi documenti ufficiali un ricco corredo di citazioni.
 Ciò emerge maggiormente quando riflette sulla romanità della Chiesa, poiché papa Ratti risolve definitivamente la “questione romana”, affermando la necessità della reciproca collaborazione tra potere spirituale e potere politico.
Ciò emerge maggiormente quando riflette sulla romanità della Chiesa, poiché papa Ratti risolve definitivamente la “questione romana”, affermando la necessità della reciproca collaborazione tra potere spirituale e potere politico.
 Di questa collaborazione si fa simbolo la città di Roma (residenza del Papato e antica capitale dell’Impero di Roma), che assurge a figura della città di Dio, secondo la più canonica esegesi di Pg XXXII 102, verso prediletto dal pontefice e più volte citato. Con Pio XI Dante si presta per la prima volta, in modo significativo, ad essere rispolverato e letto criticamente. In effetti papa Ratti consacra la Commedia come un’opera di fede e se ne avvale come auctoritas a supporto delle argomentazioni dei suoi discorsi.
Di questa collaborazione si fa simbolo la città di Roma (residenza del Papato e antica capitale dell’Impero di Roma), che assurge a figura della città di Dio, secondo la più canonica esegesi di Pg XXXII 102, verso prediletto dal pontefice e più volte citato. Con Pio XI Dante si presta per la prima volta, in modo significativo, ad essere rispolverato e letto criticamente. In effetti papa Ratti consacra la Commedia come un’opera di fede e se ne avvale come auctoritas a supporto delle argomentazioni dei suoi discorsi.Ad imitare il suo esempio è Pio XII, in cui si nota una fitta trama di allusioni desunte dall’Alighieri soprattutto nei discorsi rivolti alla Pontificia Accademia delle Scienze (di cui era membro onorario). Queste prolusioni finiscono inevitabilmente per riflettere sulla vastità dell’universo, sede e immagine di Dio attraverso l’utilizzo della fonte dantesca.
Diversa è la fruizione di Dante da parte di Angelo Roncalli, il cui nome si lega inequivocabilmente al Concilio Vaticano II e all’esigenza di un rinnovato dialogo con il mondo intero, sicché anche la sua ricezione del poeta di Firenze si può ascrivere a questo desiderio di un più agevole confronto con la contemporaneità. Anche se in realtà, nel corpus degli scritti del pontefice, sia in quelli ufficiali che in quelli destinati alla scrittura privata, non se ne conserva una memoria significativa.
Vero e proprio punto di svolta nella lunga vicenda della ricezione dantesca è la lettera apostolica Altissimi cantus, che Paolo VI divulga il 7 dicembre 1965 in occasione del VII centenario della nascita di Dante. In essa il pontefice non esita ad appellare il sommo poeta con l’epiteto di teologo perché ha saputo comunicare le verità di fede servendosi della bellezza del verso. È, quella di papa Montini, una forte presa di posizione che innalza l’Alighieri al ruolo di maestro delle cose di Dio. Non a caso le citazioni del poema abbondano quando affronta temi particolarmente rilevanti, come l’amore di Dio; oppure quando parla del giubileo; numerosi sono poi i documenti che riflettono sul significato simbolico della città di Roma (in cui, a sostegno delle argomentazioni, viene citato If II 22-24 e Pg XXXII 102, evidenziando il significato provvidenziale che il poeta attribuisce all’Urbe).
Albino Luciani è ricordato dalla storia per il suo brevissimo pontificato, ma pur nella esiguità dei documenti del suo magistero, la fonte dantesca non passa sotto silenzio: l’Alighieri, infatti, è uno degli autori più citati dal papa bellunese. La prima interessante presenza si nota nella raccolta, pubblicata nel 1976, sotto il titolo di Illustrissimi. Lettere del Patriarca, in cui non mancano riferimenti danteschi espliciti, tra i quali i più interessanti si ravvisano nella lettera indirizzata a Casella, amico di Dante e personaggio della Commedia. -Tra i documenti che precedono l’elezione al soglio di Pietro, il più interessante è il messaggio quaresimale del 31 gennaio 1978, che risulta essere un vero e proprio microsaggio sul Purgatorio, perché il suo esordio trae spunto proprio da questa cantica.
 Durante il periodo del pontificato, Giovanni Paolo I, sceglie di citare Dante nell’udienza generale del 20 settembre 1978, richiamando alla memoria l’esame teologico sulla speranza che il poeta affronta nel paradiso (Pd XXV).
Durante il periodo del pontificato, Giovanni Paolo I, sceglie di citare Dante nell’udienza generale del 20 settembre 1978, richiamando alla memoria l’esame teologico sulla speranza che il poeta affronta nel paradiso (Pd XXV).Se per Paolo VI e per i suoi predecessori la scrittura dantesca assume una notevole rilevanza come auctoritas, nei discorsi di Giovanni Paolo II la vastissima gamma di citazioni, oltre che emergere nelle più svariate occasioni, predomina nelle riflessioni che hanno per argomento l’arte e il ruolo dell’artista. Nel caso del pontefice polacco tale preponderanza assume un particolare rilievo perché, prima dell’elezione papale, Wojtyla è stato drammaturgo e poeta.
 Il riuso di Dante si intravede non solo nei documenti ufficiali del magistero wojtyliano, ma anche nella sua produzione letteraria, in cui, al di là delle tracce intertestuali (irrisorie a mio parere), è possibile un accostamento a Dante, considerando non solo la concezione del ruolo del poeta e della poesia, ma anche lo sviluppo di alcuni nuclei tematici, ad esempio: il legame con le terra natia; la ricerca problematica di Dio; l’attenzione alla storia contemporanea considerata nella prospettiva escatologica; l’incontro con l’uomo, la concezione dell’io autoriale come “poeta visionario”. Si possono notare anche confluenze dal punto di vista stilistico come, ad esempio, l’insistenza sulle sfere semantiche dell’acqua, del fuoco, della luce, del viaggio, e ciò soprattutto nell’ultimo lavoro poetico, risalente al 2003: il Trittico romano.
Il riuso di Dante si intravede non solo nei documenti ufficiali del magistero wojtyliano, ma anche nella sua produzione letteraria, in cui, al di là delle tracce intertestuali (irrisorie a mio parere), è possibile un accostamento a Dante, considerando non solo la concezione del ruolo del poeta e della poesia, ma anche lo sviluppo di alcuni nuclei tematici, ad esempio: il legame con le terra natia; la ricerca problematica di Dio; l’attenzione alla storia contemporanea considerata nella prospettiva escatologica; l’incontro con l’uomo, la concezione dell’io autoriale come “poeta visionario”. Si possono notare anche confluenze dal punto di vista stilistico come, ad esempio, l’insistenza sulle sfere semantiche dell’acqua, del fuoco, della luce, del viaggio, e ciò soprattutto nell’ultimo lavoro poetico, risalente al 2003: il Trittico romano.
 Interessanti sono anche i documenti ad argomento prettamente dantesco. Tra questi, molto significativa è la lettera indirizzata a Mieczyslaw Kotlarczyk, datata 27 maggio 1964 e risalente al periodo in cui Karol Wojtyla era vescovo di Cracovia. Come già nel magistero dei suoi predecessori, anche nei documenti di Giovanni Paolo II le presenze dantesche non sono sporadiche e casuali: numerosissime sono quelle mariane, (desunte essenzialmente da Pd XXIII 73-74, Pd XXIII 88-89 e Pd XXXII 85-87, da Pd XXXIII 1-18). Tra le citazioni ricorrenti si annovera quella riferita all’Ulisse dantesco (If XXVI 118-120) e quella che descrive la scelta ascetica di san Pier Damiani (Pd XXI 117).
Interessanti sono anche i documenti ad argomento prettamente dantesco. Tra questi, molto significativa è la lettera indirizzata a Mieczyslaw Kotlarczyk, datata 27 maggio 1964 e risalente al periodo in cui Karol Wojtyla era vescovo di Cracovia. Come già nel magistero dei suoi predecessori, anche nei documenti di Giovanni Paolo II le presenze dantesche non sono sporadiche e casuali: numerosissime sono quelle mariane, (desunte essenzialmente da Pd XXIII 73-74, Pd XXIII 88-89 e Pd XXXII 85-87, da Pd XXXIII 1-18). Tra le citazioni ricorrenti si annovera quella riferita all’Ulisse dantesco (If XXVI 118-120) e quella che descrive la scelta ascetica di san Pier Damiani (Pd XXI 117).La Commedia non è ignorata neanche da papa Ratzinger. È esemplare in tal senso il messaggio per l’incontro promosso dal Pontificio Consiglio Cor Unum, il 23 gennaio 2003 in cui il pontefice, sin dall’esordio, afferma di aver attinto da Dante lo stimolo per elaborare l’intera prolusione. La fonte dantesca è, inoltre, ridondante nei discorsi mariani: è come se i luoghi topici della mariologia dantesca avessero delineato in modo talmente ineguagliabile il profilo di santità della Madre divina, da pretendere di essere richiamati alla memoria, proprio per la loro ineguagliabile bellezza.
* Scheda: Cineca Iris (Università di Foggia, Tesi di dottorato - 24-giugno-2014).
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- "ERODE" E LE GERARCHIE CATTOLICO-ROMANE CONTRO CRISTO E "CONTRO CESARE. Cristianesimo e totalitarismo nell’epoca dei fascismi".
DANTE ALIGHIERI (1265-1321)!!! LA LINGUA D’AMORE: UNA NUOVA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO.
VIVA L’ITALIA!!! LA QUESTIONE "CATTOLICA" E LO SPIRITO DEI NOSTRI PADRI E DELLE NOSTRE MADRI COSTITUENTI. Per un ri-orientamento antropologico e teologico-politico.
FLS
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- Speranze e delusioni in un tornante decisivo del Novecento italiano. L’Orologio di Carlo Levi (di Andrea Mariuzzo).7 dicembre 2020, di Federico La Sala
LA PRASSI (ATEA E DEVOTA) DELLA CARITÀ POMPOSA.... *
- « L’Italia è il paese classico dell’ospitalità (...). Ma lo spirito evangelico non ha saputo trasformarsi nella forma moderna della solidarietà e dell’organizzazione disinteressata e civile (...). L’assistenza, che è un diritto, diventa un regalo, una umiliante carità, che si può e non si può fare » (A. Gramsci, Odio gli indifferenti, pp.13 e 14).
- "Si usa dire che ci sono due sole strade, due soli principi su cui costruire lo Stato e la Società : quello russo e quello americano. Ebbene, ce n’è un terzo, del tutto diverso e ugualmente importante, ed è quello italiano. La via americana sarebbe, dicono, quella della Libertà, la via russa quella della Giustizia : ma la via italiana è un’altra, è quella della Carità. - Naturalmente, questa carità statale, ha certi suoi caratteri speciali : è una carità che si rivolge a se stessa, che riguarda anzitutto e unicamente i componenti dello Stato che su di essa si fonda. Lo Stato è l’incarnazione della Carità, e il suo dispensatore : e la sparge sui propri membri, sui funzionari, sui parenti, sugli amici, su coloro che direttamente o indirettamente ne vivono". (Carlo Levi, L’Orologio, Einaudi, 1950)
Speranze e delusioni in un tornante decisivo del Novecento italiano
L’Orologio di Carlo Levi
di Andrea Mariuzzo (Il Mulino, 02 dicembre 2020])
Il 29 novembre del 1902 nasceva a Torino uno degli intellettuali più brillanti e sottovalutati del Novecento italiano: Carlo Levi. Esponente di quella generazione di figli della buona borghesia del capoluogo piemontese che in tanti casi si sarebbe impegnata nel gruppo cittadino di Giustizia e Libertà sgominato dalla polizia politica fascista nel 1935 a causa della delazione di Dino “Pitigrilli” Segre, Levi fu per tutta la vita attivista politico della sinistra antifascista, ma anche scrittore e giornalista, osservatore con occhio quasi antropologico delle dinamiche sociali piccole e grandi di un Paese, del suo Mezzogiorno più profondo e di una classe politica, e soprattutto pittore molto apprezzato dai suoi contemporanei.
Tuttora, Levi deve la sua fama alle riflessioni nate nel periodo del confino in un villaggio della Lucania, e raccolte in Cristo si è fermato a Eboli, pubblicato da Einaudi subito dopo la fine della Seconda guerra mondiale e tradotto in tutto il mondo. Ormai quasi dimenticata è, invece, la sua opera letteraria forse più matura, L’Orologio, pubblicato sempre con la casa editrice torinese nel 1950. Eppure, esso rappresenta forse l’unico esempio riuscito, quantomeno tra i pochi applicati a materia relativa all’età repubblicana italiana, di un genere assai raramente praticato nella letteratura italiana, quello del “romanzo politico”.
Riletto oggi, di certo, il libro presenta al pubblico una difficoltà non da poco che pure deve essere affrontata per apprezzarlo, cioè la necessità di immaginarsi come all’epoca e nel contesto della sua stesura un protagonista degli eventi narrati, risalenti a cinque anni prima, potesse rileggerli e guardare criticamente al modo in cui li visse. Vale tuttavia la pena di provarci, per poter godere di una riflessione che ha ancora molto da dirci sull’attualità e sulle sue radici storiche.
L’Orologio, dunque, prende esplicitamente le mosse dalle conclusioni del Cristo si è fermato a Eboli, in alcune pagine citando esplicitamente il libro precedente. Nell’Italia fossilizzata su illusori contrasti all’interno della propria classe dirigente che in realtà celavano la realtà profonda della dialettica di sopraffazione sui “contadini” dei “donluigini”, occorreva ricostruire da zero una comunità nazionale realmente coesa, strutturata attorno a istituzioni davvero al servizio dei cittadini e capaci di accompagnarli nel loro sforzo di elevazione sociale, ma prima di tutto occorreva smantellare fino in fondo gli apparati amministrativi e burocratici dal precedente assetto strutturalmente ineguale. A quegli apparati burocratici i privilegiati di ogni livello, dai grandi imprenditori monopolisti ai piccoli titolari della concessione di una farmacia, erano avvinghiati per ottenere ciò che sanciva in modo inequivocabile la propria condizione di privilegio: una sinecura pubblica, una sovvenzione, una deroga, una norma spudoratamente favorevole.
Su questi rapporti istituzionali e politici malati, che pure lo precedevano di decenni negli interstizi della società italiana, si era retto per vent’anni il regime fascista, e allo smantellamento di questa patologia che era stata una delle basi portanti della dittatura doveva dedicarsi, per completare la sua opera, l’antifascismo vittorioso nel 1945. Era del resto questo l’obiettivo di quella che il Partito d’Azione, allora soggetto politico di riferimento di Carlo Levi nonché interprete più convinto dell’epopea resistenziale, intendeva raggiungere con quella che con un certo understatement era presentata come “riforma della pubblica amministrazione”, ma che in realtà doveva essere una rivoluzione culturale, un lavacro purificatore di tutti i germi socio-culturali alla radice del fascismo. Lavacro purificatore forse utopistico, ragione fondamentale per cui tanta parte delle culture politiche italiane, da quelle raccolte nei partiti di massa della sinistra marxista a quella del cattolicesimo organizzato di governo fino agli opinionisti liberal-conservatori a la Montanelli, avrebbe ricordato il Pda come un partito di anime belle, di illusi sospesi tra il desiderio di crogiolarsi nei loro sogni e la volontà di realizzarli con un colpo di mano giacobino, in definitiva figure storicamente inutili o peggio ancora (per chi guardava da destra) mosche cocchiere per utopie assai meglio armate.
Scrivendo L’Orologio nel 1950, Levi non rinnegava affatto quell’obiettivo ideale, ma in una certa misura ammetteva la necessità di riflettere su quanto esso fosse effettivamente realizzabile, poiché chiariva che esso poteva essere spiegato, e “fatto passare” al pubblico, solo nella forma del romanzo, della scrittura di finzione. Il canovaccio del racconto era però intessuto di fatti reali, poiché l’azione si svolgeva effettivamente tra il 22 e il 24 novembre del 1945, nelle convulse giornate in cui si consumò la crisi del governo guidato da Ferruccio Parri, l’esecutivo in cui gli azionisti avevano riposto le speranze di vedere realizzate le loro istanze di rinnovamento al soffio del “vento del Nord” dell’esperienza resistenziale. Allo stesso modo aveva radici nella realtà anche il ruolo del protagonista e voce narrante, direttore del quotidiano del partito che esprimeva “il Presidente”, proprio come nel novembre 1945 Levi era direttore dell’organo azionista “L’Italia libera”.
In fondo tutto il romanzo è la riflessione su quanto la compagine azionista ed ex-partigiana alla guida del governo chiede troppo a quel “vento del Nord”, per il quale era impossibile soffiare così forte da abbattere abitudini e necessità radicate troppo in profondità nel sentire del Paese, soprattutto delle sue zone più problematiche.
Questa riflessione si dipana, sul piano narrativo, nella forma di due viaggi.
Dapprima il protagonista-narratore si trova a compiere un giro per Roma alla ricerca di esponenti politici più o meno importanti, ma soprattutto alla scoperta di funzionari e impiegati passati dal pre-fascismo al post-fascismo senza mutare di una virgola il loro atteggiamento e il modo di interpretare il loro ruolo. Essi, ai suoi occhi, rappresentavano la vera forza materiale della conservazione, in quanto legati in maniera irremovibile a quei piccoli privilegi che di fatto non permettevano loro null’altro che di galleggiare appena sopra la miseria, ma senza i quali essi non sapevano neppure immaginarsi.
Al protagonista toccò poi compiere un viaggio di andata e ritorno per Napoli che assunse i caratteri di un’odissea tra strade bombardate e paesi ridotti all’inesistenza. Il viaggio di ritorno, in particolare, avverrà in automobile, privilegio che il direttore di un giornale di partito non si sarebbe mai potuto concedere se nel capoluogo campano non avesse ricevuto un passaggio da due esponenti di spicco dei due grandi partiti che si apprestavano a gestire in proprio il governo e il potere: Colombi (figura sotto cui si cela il democratico-cristiano Attilio Piccioni) e Tempesti (il comunista Emilio Sereni).
Proprio nel corso del viaggio due rappresentanti dei grandi partiti di massa, a cui simbolicamente sarebbe passata la responsabilità di guidare il Paese pochi giorni dopo con l’incarico di formare il governo affidato direttamente al leader della Dc Alcide De Gasperi, si rendono protagonisti di un dialogo di cui il protagonista è muto testimone, forse profetico per il dibattito pubblico degli anni successivi: un dialogo in cui moderati e sinistra si confrontano da posizioni opposte, ma portandolo avanti utilizzando le stesse parole e riconoscendo reciprocamente il ruolo l’uno dell’altro. Si manifestava insomma come inevitabile la conclusione che avrebbe condotto all’esito delle elezioni per la Costituente nel giugno 1946, ovvero quella per cui per avere successo nella politica italiana si doveva finire per accettare, e quasi per incorporare e rappresentare, ciò che nel Paese non funzionava, costruendo su tale comune accettazione la collaborazione e il conflitto.
Si chiudeva così la riflessione sul recente passato di Levi, che aveva accompagnato parole e pensieri del protagonista col pensiero ricorrente di un vecchio orologio di famiglia che aveva portato a riparare, ma che non avrebbe più ritirato anche perché nel frattempo gli eventi gliene avevano regalato uno nuovo, come a simboleggiare anche sul piano materiale una netta cesura nel suo percorso esistenziale di attivista politico antifascista che però si stagliava sulla continuità della verità destinata a uscire in modo più evidente dalle pagine del volume: «il nostro [Stato] è una grande organizzazione caritatevole per coloro che ne fanno parte [...]. Qualcuno deve pagare le spese della pubblica carità, le spese di Stato: e questi sono coloro che dello Stato non fanno parte».
Dopo settant’anni queste parole restano allo stesso modo suggestive, anche se l’effettiva partecipazione o meno alla “carità di Stato” si è fatta sempre meno facilmente intuibile.
*
Sul tema, nel sito, si cfr.:
VICO E MARX CONTRO LA PRASSI (ATEA E DEVOTA) DELLA CARITÀ POMPOSA. Alcune note su un testo del Muratori
LA STORIA DEL FASCISMO E RENZO DE FELICE: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO" !
LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE.
Federico La Sala
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- TRAGEDIA E COMMEDIA. Una nota "sulle fallacie comiche in letteratura".4 dicembre 2020, di Federico La Sala
LOGICA E REALTÀ: LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE, E IL VATICANO CON IL SUO TRADIZIONALE SOFISMA DELLA "FALLACIA ACCIDENTIS".... *
Quando la logica va in vacanza
di Edoardo Camassa **
- [Esce oggi per Quodlibet Quando la logica va in vacanza. Sulle fallacie comiche in letteratura di Edoardo Camassa. Ne pubblichiamo un estratto per gentile concessione dell’autore]
Il termine “fallacia” può essere inteso in almeno due modi. In senso lato designa una qualsiasi idea, opinione o credenza sbagliata; per esempio che le donne non sappiano guidare o che rompere uno specchio porti sette anni di disgrazie. Come si vede, stando a questa prima accezione del termine, le fallacie si fondano sugli stereotipi, sulla superstizione o comunque su detti e proverbi popolari, e perciò non ambiscono in nessun modo a risultare convincenti. Ma le cose cambiano se ci spostiamo dal linguaggio comune al linguaggio filosofico-scientifico. In senso stretto, infatti, “fallacia” indica un’argomentazione o un ragionamento che sono logicamente viziati ma psicologicamente persuasivi; ciò può avvenire in modo consapevole e deliberato, quando vengono prodotti con l’intenzione di ingannare, e allora parleremo di sofismi, o inconsapevolmente, quando vengono prodotti senza volontà di inganno, e allora parleremo di paralogismi. In estrema sintesi, nella prospettiva della logica dell’argomentazione la fallacia è un ragionamento che ricorda un qualche tipo d’inferenza, ma che se sottoposto a un esame rigoroso si rivela scorretto[1].
Tra gli innumerevoli esempi possibili di fallacie intese in questa seconda accezione ce n’è uno su cui vale la pena di soffermarsi, se non altro perché compare in quello che è in assoluto il primo trattato sistematico sui ragionamenti viziati - il De sophisticis elenchis di Aristotele - e ha il pregio di essere estremamente chiaro[2]. Si tratta della fallacia d’accidente converso, un tipo di generalizzazione indebita che nasce dal considerare ciò che vale sotto un determinato aspetto (παρὰ τὸ πῄ, traducibile nei termini della logica medievale con secundum quid) come se valesse in assoluto, in sé e per sé (ἁπλῶς, corrispondente al latino simpliciter). In base a questo indebito procedimento generalizzante, dal fatto che un indiano è nero ma ha i denti bianchi si passa a concludere, erroneamente, che questo indiano è al contempo bianco e nero (Soph. el., 167a 7-9)[3]. Nel presente lavoro mi occuperò di fallacie intendendole in questo secondo senso, ossia nell’accezione ristretta; mi occuperò cioè di “fallacie logiche”. Più nel dettaglio, mi concentrerò su una particolare classe di ragionamenti scorretti: quella delle argomentazioni viziate che realizzano il loro potenziale comico.
[...]
Per sgombrare il campo da ogni possibile equivoco, occorre però aggiungere subito che qui mi soffermerò sulle fallacie comiche per come appaiono nella letteratura.
[...]
Per provare a esplicitare gli scopi delle fallacie comiche nella letteratura conviene rifarsi ancora una volta a Freud, e nello specifico all’analisi di ciò che egli chiama «storielle con una facciata logica» (o «motti concettuali sofistici»). Secondo Freud, se questo tipo di barzellette mostra una parvenza logica così robusta da rivelarsi come tale solo in seguito a un esame più attento è appunto perché lo scherzo tradisce qualcosa di serio, cela una logica ancor più profonda[4]. Orlando, che dal libro freudiano sul Witz ha tentato di estrapolare una teoria generale del comico letterario, scrive a ragione che i motti con una facciata logica sono «di una logica sofistica, esagerata, che dissimula anziché ostentarla l’erroneità dei propri ragionamenti secondo il livello della coscienza, e con ciò stesso ostenta fingendo di dissimularla la validità dei ragionamenti stessi secondo un’altra logica di fondo»[5].
È proprio questa dialettica di erroneità e validità, di illogicità e logicità che caratterizza le fallacie comiche rinvenibili nelle opere letterarie. Vale perciò la pena di approfondirne l’esame e di articolarne i momenti costitutivi. In prima battuta il lettore (mi riferisco al lettore modello) prende per buono il ragionamento incongruo; in altre parole si lascia persuadere dalla sua coerenza apparente. Il pensiero critico e la valutazione razionale subentrano in lui solo in un secondo momento, così da rendergli la fallacia palese, riconoscibile, e con ciò stesso da muoverlo al riso. Ma non è tutto: il lettore è infine portato a riconsiderare l’argomentazione comica e a intuire che quel che gli pareva erroneo così erroneo non è, dal momento che fa luce su verità paradossali ma profonde a cui la logica ordinaria non può né vuole accedere[6]. Da questa angolatura, assurdo non è più tanto e solo il ragionamento fallace, ma anche e soprattutto qualcos’altro di più generale. Se si vuole, il sistema di pensiero corrente e le sue leggi ritenute inattaccabili.
Un esempio chiarirà meglio cosa intendo: «L’unico modo per liberarsi di una tentazione è quello di cedervi»[7]. Tra tutte le massime che in The Picture of Dorian Gray (1890) Wilde mette in bocca a Lord Henry Wotton, irresistibile campione di freddure, questa è forse la più celebre. Essa di primo acchito sembra sensata, convincente. Tuttavia, a un esame più approfondito, l’aforisma rivela tutta la sua inconsistenza argomentativa. A rigor di logica, oltre a quella suggerita da Lord Wotton, vi sarebbe infatti un’altra e ben più valida soluzione per liberarsi di una tentazione: quella di metterla a tacere, di ignorarla e in definitiva di reprimerla. Come si vede, ci troviamo qui a ridere di una fallacia facilmente individuabile, che è nota come evidenza soppressa (o unilateralità) e che consiste nel dimenticare per strada alcune informazioni in grado di invalidare la tesi proposta. Benché tutto questo sia esatto, va pur detto che la massima sopra citata non si esaurisce nell’errore logico e nel comico puro. Nonostante l’incongruenza, e anzi proprio in virtù di questa, Wilde mira a farci intravedere qualcosa di serio: che tutto sommato non c’è davvero altro modo per liberarsi di una tentazione se non quello di cedervi. Per convincersene, basta leggere come il discorso di Lord Wotton continua: «Resistetele, e la vostra anima si ammalerà di bramosia per le cose che si è proibite da sola, di desiderio per ciò che le sue leggi mostruose (monstrous laws) hanno reso mostruoso e illegittimo (monstrous and unlawful)»[8]. Qui Wilde vagamente anticipa una idea che da lì a poco la psicanalisi cercherà di fondare su basi scientifiche. Per quanto proviamo a domarlo, il desiderio - mostruoso e proibito, sì, ma solo nell’ottica della ragione dispiegata - non si lascerà mai ammansire e combatterà con tutte le proprie forze per emergere. Con buona pace della mentalità borghese-puritana, additata come il “vero” bersaglio comico del ragionamento.
Quanto detto può essere riformulato e arricchito combinando la terminologia di Freud con quella del suo erede cileno Matte Blanco: le fallacie comiche della letteratura sono - un po’ come i sogni, i lapsus e i sintomi psiconevrotici, benché calcolate e coscienti - «formazioni intermedie e di compromesso»[9], frutti di un «sistema logico-antilogico»[10]. Esse ci spingono da un lato a ridere con superiore distacco di assurdità che a tutta prima paiono il risultato di una disattenzione, di un disimpegno mentale, e dall’altro a sentire in modo partecipe che il pensiero consueto in fondo non è altro che uno tra i molti tipi di pensiero possibili e immaginabili. Credo che D’Angeli e Paduano vogliano suggerire qualcosa del genere quando scrivono che nel riso diretto ai danni di chi pronuncia ragionamenti aberranti si maschera il timore che la sua logica altrettanto strutturata e resistente costituisca un grave rischio per la presunta inattaccabilità del sistema di pensiero corrente: le sue leggi, date senza verifica per completamente affidabili, se messe sotto la lente di un simile sguardo straniante, si rivelano discutibili e quindi incerte, e coinvolgono nel dubbio l’intero sistema logico[11].
Ricapitolando, le fallacie comiche in letteratura hanno un intento duplice e ambiguo: punire col riso le argomentazioni che si discostano dalla logica ordinaria e, contemporaneamente, rimarcare i limiti e i vincoli delle certezze comuni. Da ciò si ricava che nella finzione letteraria i ragionamenti ridicoli si presentano come un salvacondotto grazie a cui formidabili deviazioni dalla logica e dal pensiero razionale riescono a trapelare in modo socialmente fruibile. Lo scopo di questo lavoro è appunto mettere in luce, attraverso un congruo numero di esempi, in quali modi la letteratura può trasgredire la logica consueta e dare risalto alle verità paradossali e profonde che emergono proprio in virtù del sovvertimento della logica.
** Fonte: Le parole e le cose, 3 dicembre 2020 (ripresa parziale - senza note)
*
NOTA
LOGICA E REALTÀ: LE FALLACIE “COMICHE” NELLA LETTERATURA DELLA TRAGEDIA.
 E le fallacie tragiche nella letteratura della “Commedia” e della “Monarchia” di Dante Alighieri...
E le fallacie tragiche nella letteratura della “Commedia” e della “Monarchia” di Dante Alighieri... SE “le fallacie comiche in letteratura hanno un intento duplice e ambiguo: punire col riso le argomentazioni che si discostano dalla logica ordinaria e, contemporaneamente, rimarcare i limiti e i vincoli delle certezze comuni [....]”, alla fin fine, confermano il sentimento tragico della vita in cui si collocano. O no?
Se è così, non è meglio capovolgere il senso del cammino e mettere in luce le fallacie “tragiche” nella “Commedia”, e nella “Monarchia”, come da lezione di Dante?! O no?!
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- DUE POTERI E UN DOPPIO "GRAN RIFIUTO"! L’indicazione dei " due soli" di Dante e l’invito di Papa Francesco a pagare il tributo a Cesare.18 ottobre 2020, di Federico La Sala
DUE SOLI.
La Costituzione, la "Monarchia" di Dante, e la indicazione di Papa Francesco...
- PROPOSTA DI INTERPRETAZIONE. Per Dante, Roma aveva "due soli" (Purg. XVI, v. 107): Ponzio Pilato, "che fece per viltade il gran rifiuto" (Inf. III, v. 60), ruppe la bilancia dei due poteri e aprì la strada a Costantino prima e al "novo Pilato" che porta "nel Tempio le cupide vele” poi (Purg. XX, vv. 91-93).
Pagare il tributo a Cesare «è un dovere»! Con la precisazione evangelica sulla necessità di pagare le tasse allo Stato (secondo la Costituzione della Repubblica italiana), Papa Francesco apre la strada a Dante -2021 e, insieme, a una comprensione più precisa e contestualizzata della "misteriosa" figura che "fece per viltade il gran rifiuto".
Federico La Sala
-
> L’indicazione dei " due soli" di Dante e l’invito di Papa Francesco a pagare il tributo a Cesare. --- Lettera all’Europa. Papa Francesco: "Sogno un’Europa sanamente laica}}, in cui Dio e Cesare siano distinti ma non contrapposti" (di red. "Avvenire").27 ottobre 2020, di Federico La Sala
Lettera all’Europa.
Il Papa: ruolo dell’Europa ancor più rilevante al tempo del Covid
Nella lettera al cardinale Parolin sulla Unione Europea: “Sogno un’Europa sanamente laica, in cui Dio e Cesare siano distinti ma non contrapposti”
di Redazione Internet (Avvenire, martedì 27 ottobre 2020)
L’Europa ha avuto e deve ancora avere "un ruolo centrale": lo sottolinea papa Francesco in una lettera al cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, in occasione di alcuni anniversari: il 40° anniversario della Commissione degli Episcopati dell’Unione Europea, il 50° anniversario delle relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e l’Unione Europea e il 50° anniversario della presenza della Santa Sede come Osservatore Permanente al Consiglio d’Europa.
"Tale ruolo - sottolinea il Pontefice parlando dell’Europa - diventa ancor più rilevante nel contesto di pandemia che stiamo attraversando. Il progetto europeo sorge, infatti, come volontà di porre fine alle divisioni del passato. Nasce dalla consapevolezza che insieme ed uniti si è più forti, che l’unità è superiore al conflitto e che la solidarietà può essere uno stile di costruzione della storia, un ambito vitale dove i conflitti, le tensioni e gli opposti possono raggiungere una pluriforme unità che genera nuova vita".
"Nel nostro tempo che sta dando segno di ritorno indietro, in cui sempre più prevale l’idea di fare da sé, la pandemia - dice il Papa - costituisce come uno spartiacque che costringe a operare una scelta: o si procede sulla via intrapresa nell’ultimo decennio, animata dalla tentazione all’autonomia, andando incontro a crescenti incomprensioni, contrapposizioni e conflitti; oppure si riscopre quella strada della fraternità, che ha indubbiamente ispirato e animato i Padri fondatori dell’Europa moderna, a partire proprio da Robert Schuman".
Il Papa lancia, quindi, un appello all’Europa affinché ritrovi sé stessa. "All’Europa allora vorrei dire: tu, che sei stata nei secoli fucina di ideali e ora sembri perdere il tuo slancio, non fermarti - scrive il Papa nel messaggio al Segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, per condividere con lui delle riflessioni in occasione delle celebrazioni di alcuni anniversari - a guardare al tuo passato come ad un album dei ricordi. Nel tempo, anche le memorie più belle si sbiadiscono e si finisce per non ricordare più. Presto o tardi ci si accorge che i contorni del proprio volto sfumano, ci si ritrova stanchi e affaticati nel vivere il tempo presente e con poca speranza nel guardare al futuro. Senza slancio ideale ci si riscopre poi fragili e divisi e più inclini a dare sfogo al lamento e lasciarsi attrarre da chi fa del lamento e della divisione uno stile di vita personale, sociale e politico".
"Europa, ritrova te stessa! Ritrova dunque i tuoi ideali - prosegue il Papa - che hanno radici profonde. Sii te stessa!"
"Non avere paura della tua storia millenaria che è una finestra sul futuro più che sul passato. Non avere paura del tuo bisogno di verità che dall’antica Grecia ha abbracciato la terra, mettendo in luce gli interrogativi più profondi di ogni essere umano; del tuo bisogno di giustizia che si è sviluppato dal diritto romano ed è divenuto nel tempo rispetto per ogni essere umano e per i suoi diritti; del tuo bisogno di eternità, arricchito dall’incontro con la tradizione giudeo-cristiana, che si rispecchia nel tuo patrimonio di fede, di arte e di cultura".
"Sogno un’Europa sanamente laica, in cui Dio e Cesare siano distinti ma non contrapposti. Una terra aperta alla trascendenza, in cui chi è credente sia libero di professare pubblicamente la fede e di proporre il proprio punto di vista nella società" scrive ancora papa Francesco nella Lettera al cardinale Parolin.
"Sono finiti i tempi dei confessionalismi, ma - si spera - anche quello di un certo laicismo che chiude le porte verso gli altri e soprattutto verso Dio, poiché è evidente che una cultura o un sistema politico che non rispetti l’apertura alla trascendenza, non rispetta adeguatamente la persona umana. I cristiani hanno oggi una grande responsabilità: come il lievito nella pasta, sono chiamati a ridestare la coscienza dell’Europa, per animare processi che generino nuovi dinamismi nella società. Li esorto dunque ad impegnarsi con coraggio e determinazione a offrire il loro contributo in ogni ambito in cui vivono e operano".
-
> L’indicazione dei " due soli" di Dante e l’invito di Papa Francesco a pagare il tributo a Cesare. --- La Costituzione e una controversia infinita. Crocifisso nelle aule scolastiche senza pace, questa volta va in Cassazione.31 ottobre 2020, di Federico La Sala
DANTE 2021: DUE SOLI. "Sogno un’Europa sanamente laica" (papa Francesco, Lettera all’Europa) *
Laicismo.
Crocifisso nelle aule scolastiche senza pace, questa volta va in Cassazione
Rimessa alla decisione delle Sezioni unite la questione sollevata dalla battaglia legale di un insegnante di lettere toscano che chiede di rimuovere il simbolo cristiano durante le sue lezioni
di Marcello Palmieri (Avvenire, sabato 31 ottobre 2020)
Crocifisso sì o crocifisso no? Il simbolo cristiano divenuto nei secoli anche immagine di "laicissimi" e condivisi valori universali, torna di nuovo nelle aule giudiziarie. Ma non sul muro: sul banco degli imputati.
A portarcelo, stavolta, è un insegnante di lettere toscano, che ha ingaggiato da anni una battaglia legale contro il proprio dirigente scolastico - e pure contro l’assemblea dei suoi studenti - per vedersi riconoscere il diritto di staccare dal muro delle aule il crocifisso durante le ore delle proprie lezioni.
La vicenda, ora, è arrivata in Cassazione. Dove la Sezione lavoro, ritenendo la causa di particolare importanza, ha deciso di rimetterla al primo presidente della Corte, perché la devolva alle Sezioni unite. Così facendo, la pronuncia avrà un grande valore: difficilmente, infatti, i giudici territoriali potranno decidere in modo difforme eventuali casi analoghi che dovessero presentarsi successivamente in Italia.
Ma, già ora, sorge una perplessità di fondo: solitamente la Cassazione decide a Sezioni unite le questioni sulle quali si era formato un contrasto giurisprudenziale. Spesso, infatti, situazioni quasi uguali vengono risolte dai giudici in modo diverso, e lo stesso accade anche tra le diverse sezioni della medesima Cassazione.
Sulla presenza del crocifisso nei luoghi pubblici, però, sembrava non esserci più alcun dubbio. Il Consiglio di Stato nel 2006 aveva stabilito che «è un simbolo idoneo a esprimere l’elevato fondamento di valori civili (tolleranza, rispetto reciproco, valorizzazione della persona, affermazione dei suoi diritti, etc...)», che hanno sì un’origine religiosa, ma che pure «delineano la laicità nell’attuale ordinamento dello Stato». Da qui, dunque, l’idea che «il crocifisso potrà svolgere, anche in un orizzonte laico, diverso da quello religioso che gli è proprio, una funzione simbolica, altamente educativa, a prescindere dalla religione professata dagli alunni».
E che il crocifisso potesse rimanere nelle scuole l’ha detto più di recente, nel 2011, anche la Grande Chambre della Corte europea dei diritti dell’uomo, massima istanza della Cedu: «È un simbolo essenzialmente passivo - hanno scritto i giudici di Strasburgo, decidendo la causa intentata da Soile Lautsi, un’italiana di origini finlandesi, contro il nostro Pese - che non contrasta né con il diritto dei genitori alla libera educazione dei figli né con la libertà di pensiero, coscienza e religione. E se è vero che questa icona «dà alla religione maggioritaria del Paese una visibilità preponderante nell’ambiente scolastico», è pur sempre una discrezionalità dello Stato - insindacabile dalla Corte europea - quello di decidere dove esporlo.
Ma ecco che l’ordinanza di remissione alle Sezioni unite della Cassazione mette in dubbio proprio questa "passività" riconosciuta dalla Cedu: «Si potrebbe dubitare dell’asserito ruolo passivo - hanno scritto i giudici della Sezione lavoro - qualora all’esposizione del simbolo si attribuisse il significato di evidenziare uno stretto collegamento fra la funzione esercitata e i valori fondanti il credo religioso che quel simbolo richiama».
Ma per Angelo Salvi, giurista del Centro Studi Livatino, questa perplessità «non sembra valorizzare l’eredità più importante del causo Lautsi, che consiste nell’individuazione del perimetro nel quale va delimitato il concetto di neutralità religiosa».
In parole povere: secondo la Cedu, lo Stato non deve astenersi da qualsiasi richiamo religioso. Semplicemente, gli viene chiesto di non offendere i diritti di ognuno in relazione al proprio credo. Cosa che, ovviamente, un crocifisso appeso al muro non può fare. Ma attenzione: diversamente - è sempre Salvi a notarlo - si rischierebbe di «virare verso un modello di laicità "rigida" alla francese, che si declina in termini di incompatibilità con la religione».
L’Italia e il crocifisso, una controversia infinita
Dall’Europa l’ultimo sì, ’la sua esposizione non lede la libertà religiosa’
di Redazione ANSA 01 ottobre 2019
ROMA L’esposizione del crocifisso nei luoghi pubblici - in particolare nelle scuole, nelle aule di giustizia e nei seggi elettorali - è legittima o è in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza dei cittadini, di libertà di religione e di laicità dello Stato? La controversa questione - che contrappone da decenni cattolici e laici - si ripropone periodicamente e torna ora di nuovo di attualità alla luce delle ultime affermazioni del ministro dell’istruzione Lorenzo Fioramonti, il quale ha detto di ritenere l’esposizione della croce nelle aule scolastiche "una questione divisiva" e di preferire una "scuola laica", suscitando reazioni di disapprovazione da parte del mondo cattolico, favorevoli da parte degli atei e degli agnostici. Sull’argomento, l’ultima pronuncia giurisdizionale di rilievo si è avuta nel 2011 ed è stata della Grande Camera della Corte europea per i diritti dell’uomo, che, accogliendo un ricorso dell’Italia, ha definitivamente ritenuto legittima l’esposizione del crocifisso, ribaltando una sentenza di segno opposto della stessa Corte europea.
 La vicenda giudiziaria, durata quasi nove anni, ebbe origine in una scuola di Abano Terme e seguì un iter complesso: IL FATTO - Il 27 maggio 2002 il Consiglio di Istituto della scuola Vittorino da Feltre di Abano Terme (Padova) respinge il ricorso della famiglia di due alunne e decide che possono essere lasciati esposti negli ambienti scolastici i simboli religiosi, ed in particolare il crocifisso, unico simbolo esposto.
La vicenda giudiziaria, durata quasi nove anni, ebbe origine in una scuola di Abano Terme e seguì un iter complesso: IL FATTO - Il 27 maggio 2002 il Consiglio di Istituto della scuola Vittorino da Feltre di Abano Terme (Padova) respinge il ricorso della famiglia di due alunne e decide che possono essere lasciati esposti negli ambienti scolastici i simboli religiosi, ed in particolare il crocifisso, unico simbolo esposto.IL RICORSO - La decisione del Consiglio di Istituto viene impugnata dalla madre delle due alunne davanti al Tar del Veneto. Nel ricorso si sostiene che la decisione del Consiglio di Istituto sarebbe in violazione del principio supremo di laicità dello Stato, che impedirebbe l’esposizione del crocifisso e di altri simboli religiosi nelle aule scolastiche, perche’ violerebbe la "parità che deve essere garantita a tutte le religioni e a tutte le credenze, anche a-religiose".
LA POSIZIONE DEL MINISTERO - Il Ministero dell’Istruzione, costituitosi nel giudizio, sottolinea che l’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche è prevista da disposizioni regolamentari contenute in due regi decreti: uno del 1924, n. 965; l’altro del 1928, n. 1297 Tali norme, per quanto lontane nel tempo, sarebbero tuttora in vigore, come confermato dal parere reso dal Consiglio di Stato n.63 del 1988.
LA PRIMA DECISIONE DEL TAR, ATTI ALLA CONSULTA - Il Tar compie un esame delle norme regolamentari sull’esposizione del crocifisso a scuola e conclude che esse sono tuttora in vigore. Rimette, tuttavia, gli atti alla Corte costituzionale. La norma che prescrive l’obbligo di esposizione del crocifisso - scrivono i giudici - sembra delineare "una disciplina di favore per la religione cristiana, rispetto alle altre confessioni, attribuendole una posizione di privilegio", che apparirebbe in contrasto con il principio di laicità dello Stato.
LA CORTE COSTITUZIONALE, RICORSO INAMMISSIBILE - La Consulta dichiara inammissibile il ricorso: le norme sull’esposizione del crocifisso a scuola sono "norme regolamentari", prive "di forza di legge" e su di esse "non può essere invocato un sindacato di legittimità costituzionale". Gli atti tornano al Tar.
SECONDA DECISIONE TAR, CROCE NON CONTRASTA CON LAICITA’ - Il crocifisso, "inteso come simbolo di una particolare storia, cultura ed identità nazionale (...), oltre che espressione di alcuni principi laici della comunità (...), può essere legittimamente collocato nelle aule della scuola pubblica, in quanto non solo non contrastante ma addirittura affermativo e confermativo del principio della laicità dello Stato". Si conclude con queste parole la sentenza del 2005 con la quale il Tar rigetta il ricorso della madre della due alunne di Abano.
IL CONSIGLIO DI STATO, CROCIFISSO HA FUNZIONE EDUCATIVA - Il Consiglio di Stato chiude la parte italiana della vicenda, con il rigetto definitivo del ricorso della madre delle due alunne.
 Il crocifisso - scrivono i giudici - non va rimosso dalle aule scolastiche perché ha "una funzione simbolica altamente educativa, a prescindere dalla religione professata dagli alunni"; non è né solo "un oggetto di culto", ma un simbolo "idoneo ad esprimere l’elevato fondamento dei valori civili" - tolleranza, rispetto reciproco, valorizzazione della persona, affermazione dei suoi diritti, riguardo alla sua liberta’, solidarietà umana, rifiuto di ogni discriminazione - che hanno un’origine religiosa, ma "che sono poi i valori che delineano la laicità nell’attuale ordinamento dello Stato".
Il crocifisso - scrivono i giudici - non va rimosso dalle aule scolastiche perché ha "una funzione simbolica altamente educativa, a prescindere dalla religione professata dagli alunni"; non è né solo "un oggetto di culto", ma un simbolo "idoneo ad esprimere l’elevato fondamento dei valori civili" - tolleranza, rispetto reciproco, valorizzazione della persona, affermazione dei suoi diritti, riguardo alla sua liberta’, solidarietà umana, rifiuto di ogni discriminazione - che hanno un’origine religiosa, ma "che sono poi i valori che delineano la laicità nell’attuale ordinamento dello Stato".CORTE EUROPEA BOCCIA ITALIA, POI RIMETTE A GRANDE CAMERA - Il 3 novembre 2009 la Corte europea per i diritti dell’uomo boccia l’Italia: il crocifisso appeso nelle aule scolastiche - rileva la Corte - è violazione della liberta’ dei genitori ad educare i figli secondo le loro convinzioni e della libertà di religione degli alunni. Il governo italiano ricorre e la Corte europea decide di affidare la soluzione del caso alla Grande Camera.
GRANDE CAMERA STRASBURGO ASSOLVE L’ITALIA. Con la sentenza del 18 marzo 2011 la Grande Camera ribalta il verdetto della Corte e dice definitivamente sì all’Italia, ritenendo che l’ esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche e negli altri luoghi pubblici non possa essere considerato un elemento di "indottrinamento" e dunque non comporta una violazione dei diritti umani. "Le autorità - dice la Grande Camera - hanno agito nei limiti della discrezionalità di cui dispone l’Italia nel quadro dei suoi obblighi di rispettare, nell’esercizio delle funzioni che assume nell’ambito dell’educazione e dell’insegnamento, il diritto dei genitori di garantire l’istruzione conformemente alle loro convinzioni religiose e filosofiche".
FLS
-
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- Becciu è il malfattore e il Papa l’innocente tradito? La realtà è un po’ diversa (di Marco Marzano).14 ottobre 2020, di Federico La Sala
Becciu è il malfattore e il Papa l’innocente tradito? La realtà è un po’ diversa
di Marco Marzano (da ilfattoquotidiano.it)*
Gigantesche e oscure speculazioni finanziarie spesso finite malissimo, violentissime rivalità interne tra gerarchi in tonaca disposti a tutto pur di far del male al proprio rivale, imprenditori e finanzieri di dubbia reputazione e in qualche caso in odor di mafia divenuti negli ultimi anni abituali frequentatori delle stanze vaticane e lì ricoperti di denaro. Se giudicata dai fatti che emergono dalle cronache di questi giorni e non dalle parole delle encicliche o dei documenti pontifici, la chiesa “povera e per i poveri” annunciata da Francesco appare poco di più di una felice immagine retorica, di una formula buona forse per ottenere il plauso di qualche “ateo devoto” in cerca di identità, ma certo inadatta a descrivere il modo in cui la Chiesa agisce concretamente nel mondo.
Insomma, la Chiesa di Roma predica bene e razzola malissimo e usa molti dei denari che i poveri, direttamente o indirettamente, le donano per arricchire prelati di corte, faccendieri vari e le famiglie di tutti costoro.
Quello che non convince nelle ricostruzioni giornalistiche di queste vicende è però l’individuazione delle catene di responsabilità. Sempre in casi come questo l’attenzione della pubblica opinione viene giustamente puntata in alto, in direzione del vertice dell’organizzazione, verso i capi, che non potevano non sapere. Qui invece è bastato che papa Francesco, guarda caso proprio pochi giorni prima della pubblicazione della prima inchiesta giornalistica, licenziasse brutalmente e degradasse il cardinal Becciu, implicitamente additandolo al pubblico ludibrio come traditore, perché tutta la stampa che conta si precipitasse sul cadavere politico dell’alto gerarca per sbranarne quel che resta, per dipingerlo come il più sordido dei criminali, come un infido malfattore fattosi strada con l’astuzia nelle segrete stanze per appropriarsi dei suoi tesori.
Non manca giorno che non si apprenda di qualche nuova pista, invero mai approfondita e mai corredata da solide prove di colpevolezza, che porta ad arricchire il catalogo dei crimini di costui. Il fatto che il papa lo abbia solo due anni fa promosso prefetto (cioè capo) della congregazione dei santi e soprattutto nominato cardinale non ha, per la stampa, nessun rilievo. Becciu è diventato ormai il sinonimo di Giuda, capace, per qualche denaro, di vendere l’immacolato e purissimo successore argentino di Pietro. Giorno dopo giorno cadono con lui nella polvere altre figure, ma la loro disgrazia non fa che esaltare, nelle cronache, il candore della veste papale, l’innocenza tradita del Santo Padre. Più costoro sono meschini più lui appare diverso da tutti, unico e puro.
E’ lo schema usato in altre circostanze storiche per descrivere il rapporto tra i sovrani e la loro corte, tra i dittatori e il loro seguito. “Il re e è puro e ama il suo popolo - questo è l’adagio - ma i perfidi cortigiani tramano alle sue spalle e approfittano della sua immensa bontà per compiere il male”. Oppure “il duce è onesto, sono i suoi collaboratori ad essere corrotti”. E’ questo anche lo schema adoperato all’inizio di Tangentopoli da quei leader politici che cercavano disperatamente di scaricare tutte le responsabilità degli affari illeciti dei loro partiti sui “mariuoli”, sui segretari amministrativi, su chi gestiva i cordoni della borsa.
Ho il sospetto che la realtà sia un po’ diversa. La Chiesa Cattolica è la più centralizzata e gerarchica delle istituzioni esistenti. Il monarca che la guida è dotato di poteri immensi e assoluti e la curia è il principale apparato organizzativo al suo diretto servizio.
Se così stanno le cose, i casi sono due: o Bergoglio si trova nella stessa posizione che fu di Ratzinger e ha perso completamente il controllo della situazione e allora siamo di fronte ad un vuoto di potere che immaginiamo sarà colmato al più presto (casomai grazie a un gesto di responsabilità, un autopensionamento del monarca) oppure il papa regna e governa a tutti gli effetti e allora qualche responsabilità l’avrà anche lui nelle vicende di cui sopra.
Quel che in ogni caso sarebbe bello sentirgli dire è che, per risolvere il problema alla radice, andrebbe direttamente soppressa la curia romana, che la struttura di governo accentrata e autoritaria ereditata dall’impero romano non funziona più, che non ha senso che un’organizzazione religiosa amministri una tale quantità di denaro e che lo investa cercandone di fare profitti, che è venuto il momento per delegare poteri, risorse e responsabilità alle periferie, facendo seguire una volta tanto alle parole i fatti. Sarebbe bello. Ma temiamo di dover aspettare ancora qualche secolo.
* MicroMega, 14 ottobre 2020 (ripresa parziale, senza immagine).
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- L’enciclica «Fratelli Tutti» non è ancora uscita che è già oggetto di feroci critiche. Stavolta da parte di donne (di Franca Giansoldati).27 settembre 2020, di Federico La Sala
Papa Francesco, la nuova enciclica discrimina le donne già dal titolo «Fratelli Tutti». Critiche violentissime
di Franca Giansoldati *
Città del Vaticano - L’enciclica «Fratelli Tutti» non è ancora uscita che è già oggetto di feroci critiche. Stavolta da parte di donne che si battono per un linguaggio meno discriminatorio e per la parità di diritti, dentro e fuori la Chiesa. Il titolo scelto da Papa Francesco - secondo diverse teologhe, opinioniste, accademiche - sembra essere ben poco inclusivo visto che non tiene conto - esplicitamente - del mondo femminile. Praticamente la «spina dorsale della Chiesa».
Che il linguaggio racchiuda in sé anche un germe sessista non è una novità. Gli studi accademici in materia sono numerosissimi. Il linguaggio del resto serve a collegare, unire, relazionare ma può benissimo diventare strumento per discriminare, escludere, segregare. E così - anche nella Chiesa - modificare il linguaggio significa incidere sulla realtà con la consapevolezza che la questione non sia tanto grammaticale, ma culturale e che la lingua sia uno strumento utile per produrre i cambiamenti.
Ad essere al centro del dibattito è il titolo della imminente lettera enciclica che Papa Francesco firmerà ad Assisi il 3 ottobre dedicata alla pandemia. Un tempo difficile e doloroso per tutti, marcato da una condizione di fragilità e al tempo stesso dal bisogno di creare una fratellanza universale, una rete super partes capace di far superare il gap tra poveri e ricchi, tra giovani e vecchi, tra uomini e donne e ridisegnare i contorni di un mondo nuovo.
Il titolo scelto - tratto da uno scritto di San Francesco - uguale per tutte le lingue - Fratelli tutti - non è passato inosservato. Teologhe, accademiche e gruppi femminili che si battono per i diritti paritari a cominciare anche dal linguaggio hanno manifestato forti perplessità.
Naturalmente il termine “fratelli” - negli intenti del Papa - va inteso in senso estensivo, a chi è legato ad altri da un vincolo di affetto, di carità, da comunanza di patria. Un po’ come l’inno «Fratelli d’Italia» di Mameli o la celebre frase di Manzoni, «I fratelli hanno ucciso i fratelli». Il mancato riferimento alle sorelle ha però aperto il dibattito sui social e non sono mancati giudizi negativi e critiche.
Non è la prima volta che nei documenti magisteriali alle donne viene riservato una posizione marginale. Per esempio nella esortazione apostolica Evangelii Gaudium - praticamente il manifesto del pontificato di Bergoglio - alla enorme questione della donna vengono riservati solo 4 punti su un totale di quasi 300. Il tema della violenza viene poi liquidato in sette righe. Inoltre non si dice nulla sul fatto che la Santa Sede non ha finora mai voluto né firmare né ratificare la Convenzione di Istanbul - praticamente la magna charta per contrastare le radici culturali della violenza tra i sessi.
Fratelli Tutti di conseguenza non poteva non sollevare obiezioni. La teologa inglese Tina Beattie lamenta il solito linguaggio non inclusivo e così ha fatto Paola Lazzarini presidente di Donne Per La chiesa una associazione che appartiene alla Catholic Women’s Council, una realtà globale che lavora per il pieno riconoscimento della dignità e dell’uguaglianza tra i sessi nella Chiesa cattolica. «Chissà se qualcuno farà notare al Papa che le donne non possono essere fratelli e che questo linguaggio ci esclude» ha chiosato su Twitter. Lazzarini ha riportato un parere della Crusca sul termine di fratellanza, specificando che forse, in certi casi, sarebbe stato meglio parlare di sorellanza, perché «più appropriat»”.
Sul Tablet in un editoriale Lizz Dodd ha manifestato sconcerto. «Papa Francesco potrebbe rompere con la tradizione e chiamare l’enciclica con qualcosa di diverso dalla sua frase di apertura (...) Il fatto che questo titolo sia riuscito a superare ilproceso di editing mi suggerisce che nessuna donna sia stata consultata o che le donne hanno sollevato preoccupazioni che sono state trascurate». L’idea suggerita è di inserire la parola ’sorelle’ a quella di fratelli. «Sarebbe un gesto verso le donne che sono la spina dorsale della Chiesa da millenni, sebbene esclusa. Significherebbe sentirci dire che il nostro bisogno di sentirci incluse nella casa viene prima dei giochi linguistici. Cambiare titolo sarebbe come se Francesco dicesse: vi vedo».
Naturalmente in Vaticano la questione è finità già sotto il tappeto. Vatican News attraverso il direttore editoriale Andrea Tornielli è sceso in campo per spegnere gli incendi scrivendo in un editoriale: «Fraternità e amicizia sociale, i temi indicati nel sottotitolo, indicano ciò che unisce uomini e donne, un affetto che si instaura tra persone che non sono consanguinee e si esprime attraverso atti benevoli, con forme di aiuto e con azioni generose nel momento del bisogno. Un affetto disinteressato verso gli altri esseri umani, a prescindere da ogni differenza e appartenenza. Per questo motivo non sono possibili fraintendimenti o letture parziali del messaggio universale e inclusivo delle parole “Fratelli tutti”».
Nel frattempo sono partite anche appelli al Papa di cambiare il titolo della nuova enciclica. Sui social, per esempio, spicca quello dell’economista cattolico Luigi Bruni, editorialista di Avvenire. «Caro papa Francesco finchè è ancora in tempo per favore cambi il titolo della nuova enciclica. Quel Fratelli (senza sorelle) non si può usare nel 2020. Lei ci ha insegnato il peso delle parole. Il titolo si mangerà il contenuto e sarebbe un grande peccato. L’altro nome di Francesco è Chiara».
* Il Messaggero, Lunedì 21 Settembre 2020 Ultimo aggiornamento: 23 Settembre (ripresa parziale).
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- Per una “teologia della liberazione” dalle mafie. Studiare le cause delle deviazioni.20 agosto 2020, di Federico La Sala
Religiosità e criminalità.
Liberare la Madonna dalle mafie. Messaggio di papa Francesco
di Filippo Rizzi ed Enrico Lenzi (Avvenire, giovedì 20 agosto 2020)
La devozione mariana va salvaguardata da una religiosità fuorviata. Nel mirino «gli inchini» delle statue ai boss nelle processioni e la presenza dei clan nelle feste patronali
Liberare la Madonna dalla mafia. È il senso del nuovo intervento che papa Francesco ha voluto fare inviando un messaggio al francescano minore padre Stefano Cecchin presidente della Pontificia accademia mariana internazionale (Pami), che ha deciso di porre il tema «religiosità e criminalità» al centro del proprio lavoro, dando vita a un Dipartimento di analisi, studio e monitoraggio, a cui sono stati chiamati anche esperti esterni, rappresentati da magistrati, esponenti delle forze dell’ordine e della società civile. È a loro che si rivolge il Papa nel messaggio inviato in vista del convegno che la Pami realizzerà il 18 settembre prossimo.
«La devozione mariana è un patrimonio religioso-culturale da salvaguardare nella sua originaria purezza - scrive Francesco nel suo messaggio datato significativamente 15 agosto, festa dell’Assunzione -, liberandolo da sovrastrutture, poteri o condizionamenti che non rispondono ai criteri evangelici di giustizia, libertà, onestà e solidarietà».
Il riferimento, neppure troppo velato, è all’uso che le varie mafie fanno degli eventi religiosi - processioni e feste patronali in particolare - per mostrare la propria presenza sul territorio e anche per creare consenso facendo proprio leva attraverso la fede popolare. Negli anni passati accadeva spesso di leggere degli “inchini” che le statue della Madonna o del santo patrono, facevano verso la casa del boss locale, segno di omaggio e, nello stesso tempo, di riaffermazione del potere in quel territorio. Leggi anche
- Pami. Culto mariano, un laboratorio per difendere la devozione dalla criminalità
E il Pontefice, che già in passato ha fatto sentire la propria voce contro il crimine organizzato e le varie mafie, ribadisce con forza come sia «necessario che lo stile delle manifestazioni mariane sia conforme al messaggio del Vangelo e agli insegnamenti della Chiesa».
Ecco allora che uno «dei criteri per verificare ciò, è l’esempio di vita dei partecipanti a tali manifestazioni, i quali sono chiamati a rendere dappertutto una valida testimonianza cristiana mediante una sempre più salda adesione a Cristo e una generosa donazione ai fratelli, specialmente i più poveri». Insomma le comunità locali vigilino sulle feste patronali e soprattutto su coloro che in quelle occasioni si presentano come devoti, nascondendo intenti tutt’altro che devozionali. E ai fedeli, quelli veri, papa Francesco chiede di «assumere atteggiamenti che escludono una religiosità fuorviata e rispondano invece a una religiosità rettamente intesa e vissuta».
Invito che il Pontefice estende anche ai Santuari mariani, affinché «diventino sempre più cittadelle della preghiera, centri di azione del Vangelo, luoghi di conversioni, caposaldi di pietà mariana, a cui guardano con fede quanti sono alla ricerca della verità che salva». Dunque, conclude il Papa, ben venga questo lavoro che la Pontificia accademia mariana internazionale (Pami) intende avviare con la creazione del Dipartimento.
Un passo nuovo, che coinvolge anche le realtà del territorio non solo legate alle parrocchie o alle diocesi. Del resto queste ultime, in particolare nelle regioni con la maggior presenza delle organizzazioni di stampo mafioso, già da tempo sono intervenute con documenti e anche decisioni che hanno portato alla rottura con il passato.
Lo stesso papa Francesco, come abbiamo detto, ha espresso con forza l’impossibilità di far convivere una fede religiosa autentica e l’appartenenza alla mafia. Nella spianata di Sibari, durante la sua visita alla diocesi di Cassano all’Jonio il 21 giugno 2014, papa Bergoglio nell’omelia della Messa arrivò a dire che «coloro che seguono nella loro vita questa strada del male, come sono i mafiosi, non sono in comunione con Dio: sono scomunicati».
Concetto ribadito nell’omelia della Messa celebrata poco più di quattro anni dopo (il 15 settembre 2018) a Palermo in ricordo del beato don Pino Puglisi, sacerdote ucciso dalla mafia: «Non si può credere in Dio ed essere mafiosi. Chi è mafioso non vive da cristiano, perché bestemmia con la vita il nome di Dio-amore».
Per questo «ai mafiosi dico: cambiate fratelli e sorelle. Smettete di pensare a voi stessi e ai vostri soldi. Convertitevi al vero Dio di Gesù Cristo, cari fratelli e sorelle. Io dico a voi mafiosi: se non fate questo, la vostra stessa vita andrà persa e sarà la peggiore delle sconfitte».
E se, come disse nella visita a Napoli il 21 marzo 2015, «un cristiano che lascia entrare dentro di sé la corruzione non è cristiano, puzza», papa Francesco richiama tutti i credenti a essere vigilanti contro le distorsioni che della devozione mariana viene fatta. Un compito che richiama le coscienze di tutti all’impegno. E a non voltare le spalle quando si manifestano lungo i borghi della nostra Penisola queste deviate devozioni religiose.
Pami.
Culto mariano, un laboratorio per difendere la devozione dalla criminalità
Teologi, ma anche magistrati e giudici, nel Dipartimento creato nella Pontificia accademia Padre Roggio: studiare le cause delle deviazioni. Il criminologo Iadeluca: riti per odio e omertà
di Filippo Rizzi (Avvenire, giovedì 20 agosto 2020)
- Una processione in Calabria. La Chiesa vuole proteggere la devozione popolare da infiltrazioni criminali - Ansa, foto d’archivio.
Un dipartimento ad hoc all’interno della Pontificia accademia mariana internazionale (Pami) per studiare i fenomeni criminali e mafiosi e così «liberare la figura della Madonna dall’influsso delle organizzazioni malavitose». È quanto è allo studio di questa Istituzione pontificia per evitare di strumentalizzare la figura della Vergine da parte dei boss e dei clan criminali presenti nel nostro Paese: dalla Lombardia alla Calabria. Un centro studi sorto soprattutto sulla scorta dei recenti interventi di papa Francesco a questo riguardo: tra questi in particolare quello pronunciato, il 21 giugno del 2014, dove il Vescovo di Roma nella piana di Sibari in Calabria pronunciò parole inequivocabili: «La Chiesa deve dire di no alla ‘ndrangheta. I mafiosi sono scomunicati».
E il prossimo 18 settembre a Roma la Pami nel corso di un convegno traccerà le linee guida di questo nuovo Dipartimento che coinvolge (una trentina di persone): non solo teologi e mariologi ma anche magistrati (molto di loro della Dda, Direzione distrettuale antimafia), criminologi, avvocati, membri delle Forze dell’Ordine e sindaci di importanti città.
«Persone che ogni giorno - spiega il mariologo padre Gian Matteo Roggio, appartenente alla Congregazione dei missionari di Nostra Signora della Salette e tra i principali ispiratori di questa nuova sezione della Pami - si confrontano con il fenomeno mafioso, lo contrastano all’insegna della cultura della legalità. In un certo senso come recita il documento programmatico di questo nuovo dipartimento siamo chiamati tutti a un autentica “teologia della liberazione” dalle mafie».
Un evento assicurano gli organizzatori che ha anche il sostegno di papa Francesco. «Per il Convegno - racconta padre Roggio - il Papa ha inviato un messaggio chiaro e forte che porta la data del 15 agosto scorso. E caso singolare il documento reca la firma di Francesco dal palazzo del Laterano il luogo adiacente alla Cattedrale di Roma. In questo testo Francesco chiede a chi si professa autenticamente cristiano di salvaguardare la devozione mariana nella sua originaria purezza».
L’auspicio di questa task force di esperti è proprio quella di liberare anche idealmente luoghi simbolo come alcuni Santuari mariani del nostro Meridione - basti pensare - a quello della “Madonna di Polsi” nel cuore dell’Aspromonte dall’uso distorto di devozioni che ne fanno oggi le mafie odierne. «Il rito dell’iniziazione è la liturgia che accompagna l’ingresso del neofita nell’organizzazione.
È simile al “Battesimo” e deve essere considerata una “sorta di rinascita”, ovvero la nascita a nuova vita - spiega il criminologo Fabio Iadeluca -. Nella ’ndrangheta, in modo particolare rispetto a cosa nostra, alla camorra, alla sacra corona unita ed altre forme associative mafiose pugliesi, le forme rituali rappresentano l’essenza stessa dell’organizzazione e ne disciplina la vita dei suoi affiliati».
E aggiunge un dettaglio: «Monitorando questi episodi e intercettazioni ambientali a preoccuparci è stata l’adulterazione delle tradizionali venerazioni alla Madonna o ad importanti santi del Sud, penso in particolare a san Michele Arcangelo che con queste pratiche si trasformano in figure vendicatrici e cariche di odio; si tratta di usanze che servono a tutelare tutta una rete di omertà su cui si reggono queste realtà. Sono quasi sempre riti di iniziazione violenti con l’uso di santini e immagini sacre provenienti dal nostro patrimonio di fede cattolica».
Agli occhi di padre Roggio l’appuntamento di settembre servirà a fare chiarezza su quanto il magistero ecclesiale dice a riguardo. «Non è in discussione quanto da tempi non sospetti la Chiesa - è l’osservazione - si sia pronunciata per dire no a questi fenomeni e ribadire che tutto questo non appartiene alla corretta dottrina e spiritualità. Ma lo sforzo ulteriore che il nostro osservatorio vuole offrire è di andare alle radici culturali e antropologiche che fanno scaturire queste deviazioni religiose». Una sfida dunque di lungo termine.
«Penso che gli esempi di don Diana e don Puglisi e di come la Chiesa abbia mostrato proprio ai boss - è la riflessione finale - che questi miti sacerdoti erano dei modelli da imitare e non il contrario. Spesso viene usata dalla “cultura mafiosa” la figura della Vergine come un modello di obbedienza passiva di fronte al potere dominante. Essa viene raffigurata come una donna capace “oleograficamente” solo di piangere per la morte di un figlio. Bisogna dire basta a questo uso distorto dell’immagine della Madonna e ricordare attraverso la voce di tutti che ogni atto compiuto nella sua vita terrena e celeste è stato quello di essere in ascolto di tutti e in comunione fraterna con tutti gli uomini di buona volontà proprio come ci mostra il Vangelo quando ci parla di Lei a cominciare dal suo “fiat” all’arcangelo Gabriele».
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- NATURA, TECNICA, CIVILTÀ: QUALE “SUGGERIMENTO E’ FECONDO”?2 agosto 2020, di Federico La Sala
NATURA, TECNICA, CIVILTÀ: QUALE “SUGGERIMENTO E’ FECONDO”? La mossa di Kant spiazza tutti... *
- "Quando il fondamento della civiltà è in discussione, è il momento di tornare alle ragioni del patto sociale e al “pensiero” di cui La Ginestra ci parla" (Romano Luperini, "Natura e civiltà : Leopardi e il corona virus", 11 aprile 2020)
A). NO GARDEN: “[...] per usare le parole di Donna Haraway, there is no garden and never has been. Il discorso sulla natura è un discorso avvelenato, e, per sua stessa “natura”, un nostro discorso. Invocare la natura, oltre che terribilmente insidioso, rischia di suonare ingenuo, quando non reazionario. Statuire delle nette dicotomie a partire da ciò che è “naturale” ancor peggio [...] Cultura e natura, soggetti e oggetti, persone e cose: noi immaginiamo un mondo di binarismi che non esistono. Ciò che rimane profondamente impensato è la relazione, l’ibrido, che il diritto non riesce a cogliere, fondato com’è sull’individuale. Su questo si sofferma Michele Spanò, curatore del testo e autore del prezioso saggio che tira le fila dei due che lo precedono, proponendo una innovativa terzietà: le azioni. Le procedure, le azioni collettive, sono il terreno di intersezione fra diritti e interessi, banco di prova per diritti soggettivi, del tutto inservibili alla causa della natura, e potenziale terreno fertile per assemblaggi di cose e persone, diretti destinatari entrambi dei danni ecologici. Il suggerimento è fecondo: al posto della vetusta soggettività, implicita nei “diritti della natura”, non dovremmo, forse, ripartire dalla tecnica?” ( cfr. Xenia Chiaramonte, “Fare la natura con le parole del diritto. Note su “L’istituzione della natura” di Y. Thomas e J. Chiffoleau” - Le parole e le cose, 1 Agosto 2020);
B). NO PARTY (“STERMINATOR VESEVO”): “[...] I più grandi pensatori pessimisti sono spesso portatori di una speranza utopica. È così per Leopardi (e per Machiavelli). Farla finita con la retorica dell’“usciremo migliori”, del “tutto andrà a finire bene” (che sembra presa di peso da un film americano di avventure), considerare che la tendenza all’egoismo e alla violenza fa parte della natura animale dell’uomo e nello stesso tempo impegnarsi perché quella alla solidarietà (insita, insieme alla spinta alla sopraffazione, in alcune specie animali, compresa quella umana) prevalga sulle pulsioni di morte, questo ci insegna Leopardi. Quando il fondamento della civiltà è in discussione, è il momento di tornare alle ragioni del patto sociale e al “pensiero” di cui La Ginestra ci parla ” (cfr. Romano Luperini, “Natura e civiltà: Leopardi e il corona virus “, La letteratura e noi, 27 luglio 2020);
C). “GENIO MALIGNO”, “RAGION PURA”, E “RIVOLUZIONE COPERNICANA”: “Con l’interpretazione de “i sogni di un visionario chiariti con i sogni della metafisica” (1766), Kant traccia le linee epistemologiche del suo programma di ricerca: egli ha trovato la sua “bilancia” e, come già il Galilei del “Saggiatore”, comincia a usarla ! Non a caso, l’atmosfera che traspare - nel breve testo (un vero e proprio ‘discorso sul metodo’ del lavoro critico da portare avanti) - è quello delle grandi occasioni storiche. Fin dall’inizio (“Parte prima dogmatica. Capitolo 1. Un intricato nodo metafisico che si può a piacere sciogliere o tagliare”), egli mostra di essere ben consapevole di quale sia la posta in gioco, a quali reazioni va incontro (considerate le idee dominanti dell’epoca - sul piano metafisico, teologico-politico, e scientifico), e di quanto dura e lunga sarà la lotta. L’attacco ai “grandi sapienti” è fortissimo e richiama la lezione di Galilei e del “Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo” (quarta giornata) : “Le chiacchiere metodiche delle alte scuole sono spesso soltanto un accordo per sfuggire con parole ambigue ad una domanda difficile a risolversi, perché il comodo e il più delle volte ragionevole “non so” non si ode facilmente nelle accademie” (I. Kant, I sogni di un visionario spiegati con i sogni della metafisica, Rizzoli, Milano 1982, p. 102). Quasi a dire, leggere bene - con attenzione : qui la questione non è più e solo astronomica, è metafisica in senso stretto e i due sistemi del mondo di cui si parla non sono più il “tolemaico” e il “copernicano”, ma il materialismo e il dogmatismo (l’idealismo e lo spiritualismo). La mossa di Kant spiazza tutti [...]” (cfr. Note per una rilettura di “I sogni di un visionario chiariti con i sogni della metafisica”).
* Sul tema, mi sia lecito, si cfr.: Federico La Sala, “Kant, Freud, e la banalità del male” (Academia-edu, 2010).
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. -- QUANTE "NUVOLE" ALL’ORIZZONTE DEL PIANETA!!! ANCORA E DI NUOVO A SCUOLA DEL "VECCHIO" SOCRATE DI ARISTOFANE?!2 luglio 2020, di Federico La Sala
Le nuvole (Aristofane) *
Le nuvole (in greco antico Νεφέλαι, Nephèlai) è una commedia di Aristofane, andata in scena per la prima volta ad Atene, alle Grandi Dionisie del 423 a.C. [...]
Trama
Il contadino Strepsìade è perseguitato dai creditori a causa dei soldi che suo figlio Fidippide ha dilapidato alle corse dei cavalli; pensa allora di mandare il figlio alla scuola di Socrate, filosofo che, aggrappandosi ad ogni sofisma, insegna come prevalere negli scontri dialettici, anche se in posizione di evidente torto. In questo modo, pensa Strepsiade, il figlio sarà in grado di vincere qualsiasi causa che i creditori gli intenteranno.
In un primo momento Fidippide non vuole andare al Pensatoio (phrontistérion) del filosofo e così il padre, disperato e perseguitato dagli strozzini, decide di recarvisi lui stesso, seppur vecchio. Appena giunto, incontra un discepolo che gli dà un assaggio delle cose su cui si ragiona in quel luogo: una nuova unità di misura per calcolare la lunghezza del salto di una pulce, oppure la scoperta del modo in cui le zanzare emettono il loro suono. In seguito, finalmente Strepsiade vede Socrate sedere su una cesta sospesa a mezz’aria, in modo da studiare più da vicino i fenomeni celesti.
Il filosofo, dopo un breve dialogo, decide di impegnarsi ad istruirlo: gli mette indosso un mantello e una corona ed invoca l’arrivo delle Nuvole, le divinità da lui adorate, che si presentano puntuali sulla scena. Strepsiade però non riesce a capire nulla dei discorsi pseudo-filosofici che gli vengono fatti (parodia della filosofia socratica e sofistica) e viene quindi cacciato. Fidippide, incuriosito dai racconti del padre, decide infine di andare a visitare il pensatoio e quando arriva assiste al dibattito tra il Discorso Migliore e il Discorso Peggiore.
Nonostante i buoni propositi e i sani valori proposti dal Discorso Migliore (personificazione delle virtù della tradizione), alla fine prevale il Discorso Peggiore (personificazione delle nuove filosofie) attraverso ragionamenti cavillosi. Fidippide impara la lezione ed insieme al padre Strepsiade riesce a mandare via due creditori; il padre è contento, ma la situazione gli sfugge subito di mano: Fidippide comincia infatti a picchiarlo, e di fronte alle sue proteste il figlio gli dimostra di avere tutto il diritto di farlo. Esasperato e furioso, Strepsiade dà allora alle fiamme il Pensatoio di Socrate, tra le grida spaventate dei discepoli.
[...]
* LE NUVOLE: Wikipedia - ripresa parziale; testo completo, su filosofico.net.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- POLITICA E NUVOLE (V SEC. A. C.).Trasformare il bianco in nero e rendere i quadrati uguali ai cerchi2 luglio 2020, di Federico La Sala
La potenza mediatica contro la sentenza Mediaset
Berlusconi. La prova della falsità dell’insinuazione: il fascicolo è stato iscritto alla cancelleria della Corte di Cassazione dopo l’arrivo del carteggio dalla Corte di appello
di Domenico Gallo (il manifesto, 02.07.2020)
- [Foto] Corte di cassazione © LaPresse
Il giudicato, secondo un antico brocardo del diritto romano, facit de albo nigro, aequat quadrata rotundis. Cioè il giudicato ha una forza tale che può trasformare il bianco in nero e rendere i quadrati uguali ai cerchi. In tempi in cui l’autorevolezza delle sentenze passate in giudicato appare piuttosto gracile, dobbiamo constatare che la funzione iperbolica che i romani attribuivano al giudicato è passata di mano. Oggi è la potenza di un sistema mediatico che può rovesciare una realtà e il nero in bianco.
Solo così si può spiegare l’attacco temerario contro la sentenza della Cassazione che, nell’agosto del 2013, ha reso definitiva la condanna di Berlusconi per frode fiscale. Il cosiddetto “audio shock” trasmesso da una Tv di Berlusconi, poi rilanciato con commenti al vetriolo contro la magistratura dalla galassia dei media del Cavaliere ed utilizzato dai politici di Forza Italia per avanzare le richieste più strampalate (come la nomina di Berlusconi senatore a vita), è un documento che testimonia l’esatto contrario di quanto vorrebbero fargli dire coloro che l’hanno diffuso.
Il tenore del colloquio esprime chiaramente l’esigenza del giudice Amedeo Franco di dissociarsi dalla decisione assunta dal Collegio giudicante. Se poi guardiamo il contenuto delle “rivelazioni” del giudice Franco, vediamo che l’unico appiglio utilizzato come prova di disegno di pilotare il processo a danno di Berlusconi, è la questione dell’affidamento del processo alla Sezione feriale. Il comunicato emesso ieri dalla Corte di Cassazione ha dimostrato la falsità dell’insinuazione. Il fascicolo è stato iscritto presso la cancelleria centrale della Corte il 9.7.2013, dopo l’arrivo del relativo carteggio dalla Corte di appello di Milano.
“In ragione della rilevata urgenza dovuta all’imminente scadenza del termine di prescrizione dei reati durante il periodo feriale, il processo, (..) venne assegnato alla Sezione feriale, e quindi ad un collegio già costituito in data anteriore all’arrivo del fascicolo alla Corte di cassazione, dunque nel pieno rispetto del giudice naturale precostituito per legge.”
Quanto all’insinuazione sulla “malafede” del Presidente del Collegio giudicante, che, a detta di Franco, avrebbe ricevuto pressioni dalla Procura di Milano per il fatto che il figlio, anch’egli magistrato, era indagato dalla stessa Procura per... “essere stato beccato con droga a casa di...”, anche in questo caso la circostanza della droga evocata è completamente falsa.
Essendo del tutto false l’insinuazione sull’attribuzione del processo ad un Collegio ad hoc e quella su presunte pressioni della Procura di Milano sul Presidente del Collegio, tutto il resto non è altro che una giaculatoria volta a dimostrare all’illustre imputato che lo stesso Franco non condivideva la decisione. Anche l’espressione “plotone di esecuzione”, riferita al Collegio giudicante, seppur riprende un linguaggio comune delle difese mediatiche, caro all’orecchio del Commendatore, non arreca alcun elemento fattuale di conoscenza, esprimendo una mera opinione. D’altra parte la cosa più significativa che emerge nel corso del colloquio è il fatto che Amedeo Franco confessa la sua fedeltà a Berlusconi: “Dall’inizio sono sempre stato un suo ammiratore (..) non dell’ultima ora”.
Dobbiamo allora chiederci: per quale motivo un giudice, violando il segreto della Camera di Consiglio, sente l’esigenza di discolparsi con l’imputato per l’esito a lui non favorevole del processo?
Una risposta a questa domanda avrebbe potuto darla soltanto il procedimento penale (e disciplinare) che inevitabilmente sarebbe stato aperto se il protagonista non fosse deceduto. Non è un caso, pertanto, che questa “prova” della iniquità del processo sia stata diffusa dopo la morte dell’interessato. Indubbiamente un comportamento così inusitato per un giudice, costituisce indizio di un rapporto non trasparente con l’imputato e quindi di una perdita di imparzialità.
In definitiva questo colloquio registrato lungi dall’essere un elemento significativo di una persecuzione giudiziaria in danno di Berlusconi, costituisce una prova del rapporto opaco che Berlusconi intratteneva con taluni magistrati. Forse qualcuno dovrebbe spiegare al cittadino comune che questa sensazionale rivelazione, non rivela nulla se non il fascino che il sistema di potere berlusconiano esercitava, e forse esercita ancora, nei confronti di una frangia di magistrati, ma rivela anche che, fin qui, il sistema indipendenza della magistratura, ha sostanzialmente retto assicurando il controllo di legalità nei confronti dei potentati economici e politici, a garanzia dei diritti dei cittadini. Ma domani è un altro giorno.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- «Che cosa è l’uomo?», «Il cielo stellato sopra di me, la legge morale dentro di me» (Kant).. È nostra la libertà più grande (di Luigino Bruni).7 giugno 2020, di Federico La Sala
L’anima e la cetra /11.
È nostra la libertà più grande
di Luigino Bruni (Avvenire, sabato 6 giugno 2020)
- Chi sa se il deserto che lasceremo, un giorno, non avrà questa voce, questo lamento umano del vento, infinitamente ripetuto: mah-’enòsh? Che cos’è un uomo? Che cosa fu l’uomo? Che cosa è stato essere uomo?
- Guido Ceronetti, Il libro dei salmi.
«I cieli narrano la gloria di Dio, l’opera delle sue mani annuncia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il racconto e la notte alla notte ne trasmette notizia. Senza linguaggio, senza parole, senza che si oda la loro voce, per tutta la terra si diffonde il loro annuncio e ai confini del mondo il loro messaggio» (Salmo 19,2-5). I cieli narrano. La Bibbia è tutta parola, è tutta narrazione; è custode della parola di Dio detta in parole umane. È gelosa sentinella di racconti straordinari e diversi, dove le parole sono state capaci di dire l’indicibile, farci sognare Dio fino a quasi vederlo.
La Bibbia ha amato e venerato la parola, al punto di rischiare di farla diventare un idolo, violando il divieto d’immagine e di idolatria contenuto tra le sue pagine. Uno dei dispositivi teologici e poetici che le ha consentito di non diventare l’idolo più grande e perfetto è la presenza in essa di linguaggi di Dio non verbali. Della gloria di Elohim parlano, infatti, anche i cieli, il firmamento, il sole, la notte. Non siamo solo noi umani a parlare di Dio, non siamo i soli affidatari e trasmettitori di messaggi divini. La Bibbia ci dice che ci sono meravigliosi racconti di Dio scritti senza parole umane. Dio ci parla con la bocca e con le parole dei profeti, ci ha scritto lettere d’amore con lo stilo dello scrittore sacro, ha composto canti stupendi con la poesia e la cetra di Davide. La Bibbia però sa che il linguaggio umano non è l’unica lingua usata nei colloqui tra Elohim e noi - -«Senza linguaggio, senza parole, senza che si oda la loro voce». Narrazioni più antiche di quelle umane, che hanno risuonato attraverso l’universo prima che vi arrivasse l’uomo, e che continuano oggi a risuonare nelle galassie infinite; a dirci che quelle narrazioni sono anche per noi, ma non sono soltanto per noi: non siamo l’unico senso della creazione. I loro racconti gli astri non li scrivono soltanto per noi. Qui l’umiltà e la grandezza dell’Adam si incontrano e si armonizzano.
Ma nel momento in cui la Bibbia testimonia le narrazioni delle stelle e le riconosce come linguaggio di Dio, anche quel linguaggio non-verbale diventa parola di uomo che narra la non-parola di Dio. E il Salmo diventa un incontro di narrazioni: i cieli narrano all’uomo la gloria senza usare parole umane, e le parole umane, nel narrare queste narrazioni non-verbali, tramutano in parola ciò che parola non è. Stupendo. Allora quando leggiamo la sua parola più folle - «la parola si è fatta carne» - in quella parola dobbiamo includere anche le non-parole del sole, delle stelle, del cosmo - il verbo nella Bibbia sono tutte le parole della terra e tutte le "parole" del cielo.
Forse i primi racconti scritti dagli uomini sono stati tentativi di narrare i racconti della natura scritti senza parole. Come il bambino impara a parlare ripetendo le parole della madre, noi abbiamo imparato a parlare ripetendo le "parole" dei racconti delle stelle. Molti popoli antichi erano così affascinati da questo linguaggio cosmico da chiamare dèi il sole e le stelle. La Bibbia, invece, pone il suo Dio al di sopra degli altissimi astri. Gli astri non sono Dio, ma sue creature - i cieli narrano la gloria di Dio. Non sono portatori di un messaggio proprio, ma significanti di altri significati, anch’essi "parole" pronunciate. Sta qui la differenza tra questo Salmo e i canti cosmici che ritroviamo nella letteratura babilonese o egiziana. Il sole non è Dio, ma è ospite di Dio: «Là pose la tenda per il sole, uno sposo che esce dall’alcova, un prode contento di slanciarsi per la sua via» (19,5-6). È il suo atleta migliore, che corre ogni giorno da oriente a occidente, andando incontro alla notte per passarle il suo messaggio, per dirle, ogni mattina, parole teofore: «Parte dal lontano dei cieli, all’altro estremo termina il suo arco» (19,7). C’è tutta la Bibbia nel Cantico di Frate sole.
Non abbiamo ancora ripreso fiato per questa visione cosmica del verbo, detta con una poesia che qui cogliamo in uno dei suoi momenti sorgivi all’aurora delle civiltà, ed ecco che il Salmo ci sorprende con un secondo colpo di scena: «La legge del Signore è perfetta, rinfranca l’anima» (19,8). Come mai questo salto dalla sinfonia cosmica alla Torah, dal cielo alla Legge? Un salto talmente inatteso che non pochi esegeti hanno ipotizzato che i salmi all’origine del Salmo 19 fossero in realtà (almeno) due, fusi poi insieme da un redattore finale.
In realtà, l’unità del Salmo ce la svela la Bibbia stessa. Per l’uomo biblico il firmamento e la Torah sono entrambi capolavori di YHWH. Quando quell’antico salmista alzava gli occhi verso l’alto era incantato dall’armonia e dalla bellezza del cielo; ma poi provava lo stesso incanto quando guardava la terra e vi trovava la Torah. L’ordine cosmico è garantito da leggi intrinseche impresse dal Creatore nel creato, e l’ordine morale nasce dall’obbedire alle leggi e ai precetti della Torah. Lo scopo è lo stesso, l’identica provvidenza: «I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore;... sono più preziosi dell’oro, di molto oro fino, più dolci del miele e di un favo stillante» (19, 9-11).
 Il salmista provava la stessa "gioia del cuore" quando vedeva, in ogni aurora, risorgere il sole e quando leggeva "onora il padre e la madre"; restava tramortito dal firmamento e dal "non uccidere". Perché sapeva che le stelle e la Torah erano dono per lui, erano solo e tutta gratuità. Senza questa doppia bellezza non entriamo nell’umanesimo biblico, non comprendiamo il suo più grande profitto: «Per chi li osserva è grande il profitto» (19,12).
Il salmista provava la stessa "gioia del cuore" quando vedeva, in ogni aurora, risorgere il sole e quando leggeva "onora il padre e la madre"; restava tramortito dal firmamento e dal "non uccidere". Perché sapeva che le stelle e la Torah erano dono per lui, erano solo e tutta gratuità. Senza questa doppia bellezza non entriamo nell’umanesimo biblico, non comprendiamo il suo più grande profitto: «Per chi li osserva è grande il profitto» (19,12).
 «Il cielo stellato sopra di me, la legge morale dentro di me»: solo con il Salmo 19 davanti agli occhi si coglie il senso dell’ultima pagina della Critica della ragion pratica di Kant, una pagina tra le più bibliche di tutta la filosofia.
«Il cielo stellato sopra di me, la legge morale dentro di me»: solo con il Salmo 19 davanti agli occhi si coglie il senso dell’ultima pagina della Critica della ragion pratica di Kant, una pagina tra le più bibliche di tutta la filosofia.Quell’antico poeta sapeva poi un’altra cosa: «Le inavvertenze, chi le discerne? Assolvimi dai peccati inconsapevoli. Anche dall’orgoglio salva il tuo servo perché su di me non abbia potere» (19,13-14). Sopra il sole, gli astri obbediscono, docili e mansueti, alle leggi che YHWH ha scritto per loro; trasmettono il loro messaggio, non trasgrediscono, non peccano. Sotto il sole no, perché sulla terra l’Adam è stato creato con una libertà morale unica che lo rende il grande mistero dell’universo. Solo l’uomo e la donna possono decidere di non seguire le leggi d’amore pensate per loro da Dio. E in questo sono superiori al sole e alle stelle. Sta qui il grande mistero dell’uomo biblico: l’immagine di Dio lo rende libero al punto di poter negare le leggi pensate per la sua felicità (le nostre infelicità più importanti sono quelle che scegliamo sapendo che sono infelicità). Siamo più liberi del sole, e quindi meno ubbidienti. E torna il nostro destino tremendo e stupendo custodito dal Salmo 8: «Che cosa è l’uomo? Eppure...».
Tra i peccati umani troviamo qui sottolineati quelli fatti per inavvertenza e quelli inconsapevoli. Anche se il Novecento ci ha mostrato un inconscio non innocente, la categoria dei peccati inconsci è distante dalla nostra sensibilità moderna, molto centrata sulle intenzioni.
 La Bibbia non è un’etica, anche se nei suoi libri ci sono molte etiche. L’umanesimo biblico non può essere inquadrato in una o l’altra delle teorie etiche moderne (responsabilità, intenzioni, virtù...), ma è certamente più interessato di noi alle conseguenze degli atti. Perché ciò che più gli interessava era l’equilibrio del corpo sociale e la cura dell’Alleanza con Dio. Se allora qualcuno commetteva un peccato e provocava un danno, era a questo squilibrio nei rapporti sociali che la Bibbia soprattutto guardava.
La Bibbia non è un’etica, anche se nei suoi libri ci sono molte etiche. L’umanesimo biblico non può essere inquadrato in una o l’altra delle teorie etiche moderne (responsabilità, intenzioni, virtù...), ma è certamente più interessato di noi alle conseguenze degli atti. Perché ciò che più gli interessava era l’equilibrio del corpo sociale e la cura dell’Alleanza con Dio. Se allora qualcuno commetteva un peccato e provocava un danno, era a questo squilibrio nei rapporti sociali che la Bibbia soprattutto guardava.
 Il Decalogo inizia con il ricordo della liberazione dall’Egitto: non con un principio etico astratto, ma con un fatto. La dimensione storica della fede biblica si manifesta anche nel grande valore che attribuisce ai comportamenti, alle azioni, ai fatti, alle parole. Basti pensare, per un esempio, al vecchio Isacco che dona per errore/inganno la sua benedizione a Giacobbe; quando si accorge del suo errore non può più revocare quella benedizione sbagliata, perché quelle parole avevano generato la realtà mentre la dicevano, e avevano operato indipendentemente dalle condizioni soggettive di Isacco e dei suoi parenti (Gen 27).
Il Decalogo inizia con il ricordo della liberazione dall’Egitto: non con un principio etico astratto, ma con un fatto. La dimensione storica della fede biblica si manifesta anche nel grande valore che attribuisce ai comportamenti, alle azioni, ai fatti, alle parole. Basti pensare, per un esempio, al vecchio Isacco che dona per errore/inganno la sua benedizione a Giacobbe; quando si accorge del suo errore non può più revocare quella benedizione sbagliata, perché quelle parole avevano generato la realtà mentre la dicevano, e avevano operato indipendentemente dalle condizioni soggettive di Isacco e dei suoi parenti (Gen 27).
 I peccati sono fatti che agiscono e cambiano il mondo, con una vita propria distinta dalle intenzioni che li hanno generati. Se oggi ti dico una parola brutta e domani ti chiedo scusa, quelle scuse potranno agire sul futuro, ma non potranno cancellare la realtà di dolore che quella parola ha generato nel cuore dell’altro in quelle ore trascorse tra il peccato e il pentimento. Nella Bibbia poi la parola è talmente seria che produce effetti da sé medesima, anche quando non ne siamo coscienti, anche in quelle "ore" che passano e noi non chiediamo scusa perché non siamo consapevoli dei danni che stiamo procurando - i danni inconsci possono essere maggiori proprio perché non arrivano mai il pentimento né le scuse.
I peccati sono fatti che agiscono e cambiano il mondo, con una vita propria distinta dalle intenzioni che li hanno generati. Se oggi ti dico una parola brutta e domani ti chiedo scusa, quelle scuse potranno agire sul futuro, ma non potranno cancellare la realtà di dolore che quella parola ha generato nel cuore dell’altro in quelle ore trascorse tra il peccato e il pentimento. Nella Bibbia poi la parola è talmente seria che produce effetti da sé medesima, anche quando non ne siamo coscienti, anche in quelle "ore" che passano e noi non chiediamo scusa perché non siamo consapevoli dei danni che stiamo procurando - i danni inconsci possono essere maggiori proprio perché non arrivano mai il pentimento né le scuse.Chiedere allora a Dio (e alla comunità) di essere assolti per i peccati inconsci nasceva dalla consapevolezza che i danni che procuriamo sono maggiori delle nostre cattive intenzioni. L’uomo biblico lo sapeva, e ristabiliva l’equilibrio. Noi ne abbiamo perso coscienza, non chiediamo perdono a nessuno, ci copriamo dietro la buona fede, e accresciamo gli squilibri. Il Salmo 15 aveva lodato la sincerità. Il Salmo 19 ci dice che la sincerità qualche volta non basta. Perché nella vita c’è anche il valore delle conseguenze di azioni sbagliate compiute in buona fede. La Bibbia è un continuo e prezioso esercizio di auto-sovversione, che è la cura più efficace contro ogni ideologia. Incluse le molte piccole ideologie del nostro secolo nate sulla morte delle grandi ideologie del secolo scorso.
Il Salmo 19 ci ha rapiti al settimo cielo e poi ci ha riportato sulla terra, alle nostre inavvertenze e colpe inconsce, per dirci qualcosa di importante che non dovremmo più dimenticare: un rapporto sanato ha lo stesso valore di una galassia.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- CORONA VIRTUS O CORONA VIRUS?! #iorestoacasa, Forza Italia! (di Italo Mastrolia)29 maggio 2020, di Federico La Sala
#iorestoacasa, Forza Italia!
di Italo Mastrolia (Linkedin, 9 aprile 2020)
Storia di un marchio pubblico
In questi giorni di forzata permanenza in casa sto imparando a prestare attenzione alle cose; specialmente a quelle che, nella vita “ordinaria”, avrebbero meritato maggiore considerazione e tutela, ma che - nella distrazione generale - abbiamo tutti accettato e “subìto” nel tempo senza alcuna resistenza. Mi è capitato di leggere un commento su FB; si trattava di una considerazione relativa ad un programma televisivo: «Ma è proprio necessario che lo spot di Rai Sport finisca con “Forza Italia”»? L’interrogativo, che voleva essere soltanto ironico, è di un eccellente e famoso giornalista, il quale sollecitava una sorta di ’par condicio’, auspicando una analoga versione della sigla televisiva utilizzando la denominazione “Italia Viva”.
Ho ripensato a quando, in gioventù, lo slogan più diffuso (condiviso ed universale - specialmente nello sport -) era appunto “Forza Italia”: era il grido di tutti gli italiani che sostenevano le nostre squadre nelle competizioni internazionali (specialmente la nazionale di calcio); e ho pensato che, da quando è stato fondato quel partito politico che ha assunto proprio questa esatta denominazione, non abbiamo più potuto gridare o scrivere questa “esclamazione” in modo spontaneo . Ovviamente nessuno ce lo avrebbe impedito, ma ... insomma, abbiamo tutti avvertito un senso di imbarazzo (o addirittura di contrarietà); oppure - più semplicemente - abbiamo preferito non correre il rischio di essere fraintesi.
Insomma, all’improvviso quello storico ed universale slogan non è stato più utilizzato, ed è scomparso dal vocabolario della tifoseria sportivo. Nulla era più come prima.
Ho svolto una rapida ricerca: il nome si ispirava allo slogan Forza Italia! utilizzato nella campagna elettorale della Democrazia Cristiana del 1987, curata dal pubblicitario e accademico Marco Mignani. Ma il nuovo partito pensò di registrare il marchio presso l’Ufficio Marchi e Brevetti: i primi due depositi risalgono al 24 giugno 1993 - attraverso una società di Milano -; assicuravano la tutela dei marchio d’impresa per ben 13 classi di merci e servizi. Sono seguiti ulteriori 11 depositi integrativi, fino al 2008, attraverso i quali le classi merceologiche sono arrivate fino a 21.
Mi sono chiesto se la registrazione di quel marchio con l’indicazione geografica (Italia) potesse essere vietata (secondo l’art. 13 Codice Proprietà Industriale). Niente da fare; non sarebbe stato possibile impedirlo: tale divieto, infatti, non è assoluto. È consentito registrare un nome geografico che, in relazione al servizio o al prodotto, non si presenti come indicazione di provenienza, ma come nome di fantasia. Quindi, sulla base di questa disposizione normativa, “Forza Italia” (con il quale il partito non intendeva indicare la provenienza geografica dei proprio “prodotti”) venne considerato come denominazione di fantasia, e - in quanto tale - legittimo ed utilizzabile.
Però (ho obiettato) quelle due parole costituiscono uno “slogan” collettivo, un modo di dire, una locuzione condivisa da tutto il popolo... niente da fare un’altra volta: secondo la giurisprudenza dell’Unione Europea il ‘marchio-slogan’ è sempre registrabile purché abbia carattere distintivo: a prescindere dal suo significato promozionale, infatti, deve avere qualcosa che permetta al pubblico di percepirlo come indicatore dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi che lo stesso contraddistingue. In effetti, l’articolo 4 del Regolamento sul marchio UE prevede che “Possono costituire marchi UE tutti i segni, come le parole, compresi i nomi di persone o i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma dei prodotti o del loro imballaggio e i suoni”.
Quindi nulla vieta di registrare come marchio uno slogan pubblicitario.
Insomma, sembra proprio che la registrazione del marchio-slogan “Forza Italia” sia stata del tutto legittima, frutto di un’abile e geniale operazione giuridica con la quale, profittando del rigore formale della normativa vigente, si è trovato il modo (legittimo) per sottrarre alla collettività una frase appartenente a tutti, e attribuirla ad un partito politico per contraddistinguere i propri beni e servizi su cui poter ‘apporre’ il marchio (ripeto ... per ben 21 classi merceologiche!).
Però è innegabile che quelle due parole messe insieme hanno sempre costituito uno slogan collettivo, una storica esortazione popolare che - richiamando la nostra nazione - può essere ricondotta al concetto di res publica e - senza esagerare - a quello di patrimonio culturale immateriale. La questione merita un ben diverso approfondimento.
Nonostante tutto questo, è bello vedere che le persone - attraverso varie forme espressive - iniziano spontaneamente a “riappropriarsi” di quella storica esortazione sportiva; c’è un ritrovato orgoglio nazionale che, facendo vincere gli imbarazzi, mostra una tardiva reazione di sdegno a quella (seppur legittima) “sottrazione” del nostro grido più amato. A partire dal quella sigla del programma RAI, fino al web e agli striscioni sui balconi, finalmente ricompare senza imbarazzi la scritta “Forza Italia”!
A nessuno viene in mente, però, di usare la frase “Italia Viva”. In sincerità, la scelta di assegnare ad un partito questa locuzione è stata molto meno astuta e del tutto ’innocua’ per la collettività; vedremo se la registrazione di quel marchio verrà autorizzata dall’Ufficio Marchi e Brevetti (la domanda è stata depositata il 26.9.2019 ed è ancora in fase di esame).
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- COSTITUZIONE E PENSIERO CRITICO: IL "CASO CORDERO".14 maggio 2020, di Federico La Sala
IL PENSIERO DELLA COSTITUZIONE E LA COSTITUZIONE DEL PENSIERO....
Addio al giurista e polemista. Franco Cordero, il più scomodo di tutti gli eclettici
A 91 anni scomparso il giurista e polemista, capace di spaziare dal diritto al romanzo, con forte inclinazione anticlericale
di Francesco D’Agostino (Avvenire, domenica 10 maggio 2020)
Personalità fuori dal comune, quella di Franco Cordero (scomparso due giorni fa a Roma a 91 anni): uomo poliedrico, capace di spaziare con sicurezza dalla giurisprudenza alla storia, dalla filosofia alla teologia, dall’antropologia alla politica; polemista memorabile, romanziere di notevole originalità, anche se di ardua leggibilità, inventore di stilemi linguistici suggestivi. Se su queste sue doti non c’è da dubitare, su altre probabilmente è difficile che si trovi un accordo tra i suoi colleghi, i suoi studiosi ed i suoi lettori.
È stato davvero, come alcuni sostengono, uno dei massimi giuristi italiani del Novecento? Sicuramente è stato un giurista fuori dal comune, che ha nobilitato la sua disciplina (il diritto processuale penale) oltre ogni aspettativa. Ma è stato anche vittima della sua intelligenza labirintica, della sua rigidità ideologica, della sua carenza di flessibilità. Ordinario da anni nell’Università Cattolica di Milano, entrò in tensione con il paradigma culturale che la governava e di cui egli aveva perfetta consapevolezza: non ebbe il buon senso (di cui ad esempio diede prova il filosofo Emanuele Severino) di chiedere il trasferimento ad altro Ateneo, che pure avrebbe immediatamente ottenuto; privato tra mille polemiche del necessario nulla-osta all’insegnamento, attivò un duro braccio di ferro con le autorità accademiche, che volle portare fino al giudizio della Corte Costituzionale.
Era ovviamente un suo diritto ricorrere alle vie legali, ma fu molto sgradevole vedere come il suo ricorso si saldasse con un anticlericalismo sempre più aspro, polemico e in definitiva sterile, che egli cercò faticosamente di nobilitare arrivando perfino a scrivere un fitto commento all’Epistola ai Romani di San Paolo.
È difficile dire se il suo anticlericalismo giunse infine a trasformarsi in un vero e proprio anticattolicesimo; è certo però che alla fine logorò anche la pubblica opinione, al punto che, per mantenere comunque un contatto col “suo” pubblico, Cordero trovò uno sfogo cominciando a scrivere numerosi romanzi, dedicando a Savonarola una sterminata biografia, e insinuandosi abilmente nel dibattito politico del tempo (fu lui a forgiare il soprannome di “caimano” per Berlusconi , soprannome che ebbe un certo successo, anche perché ripreso da Nanni Moretti in un suo film omonimo).
Gira la notizia che una nuova e brillante casa editrice starebbe per pubblicare un suo ultimo romanzo e che sarebbe anche in progettazione una nuova edizione di un suo importante testo di molti decenni fa, Gli Osservanti, del 1967, l’opera con la quale Cordero intendeva radicare definitivamente il suo pensiero nella filosofia del diritto. Gli Osservanti è un libro, pieno di riferimenti, provocazioni, citazioni, allusioni, polemiche; un libro col quale l’Autore voleva presentare ai suoi lettori nuovi e rivoluzionari paradigmi dottrinali. Ma si trattava anche di un libro troppo difficile e troppo costoso per divenire popolare tra gli studenti sessantottini e contestatori e troppo farraginoso per conquistare la platea dei giuristi di professione. Se esso, nella sua nuova edizione, avrà successo, ne sarò lieto, perché è pieno di intelligenza. Ma non si tratta di intelligenza né giuridica, né filosofica, ma di intelligenza polemica: ammirevole, ma sterile.
- Sul tema, nel sito, si cfr.:
- L’ITALIA AD PERSONAM E IL PROF. CORDERO CHE SI LAMENTA. MA E’ ELEMENTARE (1994-2010)!!! "L’ITALIA SONO IO" E IL DIRITTO E’ "UN DIRITTO AD PERSONAM": "FORZA ITALIA" !!!
Morto Franco Cordero, il giurista che inventò il "Caimano"
Raffinato uomo di legge, anticlericale, intellettuale militante si è spento a 92 anni. Indimenticabili le sue polemiche contro Berlusconi al quale dedicò il soprannome
di ROBERTO ESPOSITO (la Repubblica, 08 maggio 2020)
Con Franco Cordero scompare una delle figure più raffinate e poliedriche della cultura italiana contemporanea. Ma anche un intellettuale militante, impegnato in battaglie civili contro il lato oscuro del potere politico ed ecclesiastico italiano. Nato a Cuneo nel 1928, ha attraversato l’ultimo secolo, lasciando una traccia indelebile non solo nel campo del diritto di cui è stato riconosciuto maestro, ma anche in quelli della riflessione filosofica, teologica, antropologica. E infine nella letteratura con una serie di romanzi - tra i quali Opus, Bellum civile, L’armatura - di lettura non semplice, ma scritti con uno stile personalissimo che gli assegna un ruolo non secondario nella letteratura degli ultimi decenni.
Allievo di Giuseppe Greco, ha insegnato in diverse Università italiane, tra cui Trieste, Torino, Roma, dove ha chiuso nel 2002 la propria brillante carriera accademica. Ma certamente l’esperienza che più lo ha segnato, diffondendo il suo nome anche all’estero, è stato l’insegnamento alla Cattolica di Milano, allora diretta da Agostino Gemelli, iniziato nel 1960. Entrato in conflitto per la sua posizione di intransigente polemica nei confronti della parte più retriva della gerarchia ecclesiastica, è stato espulso dalla Cattolica, scatenando quello che, sulle pagine dei quotidiani italiani e stranieri, ha assunto il nome di "caso Cordero". L’occasione dello scontro, non cercato ma neanche evitato da Cordero, è stata la pubblicazione del testo intitolato Gli osservanti (1967) ma soprattutto il successivo romanzo Genus che nel 1969 gli costerà l’allontanamento dalla cattedra. Accusato di eterodossia e attaccato frontalmente dalla destra cattolica, Cordero ha risposto con altrettanta nettezza, scatenando una polemica arrivata perfino alla Corte Costituzionale.
Da allora la sua persona è diventata occasione di continue controversie. Attaccato dagli ambienti confessionali, è diventato per altri una bandiera di indipendenza e di libero pensiero. I suoi scritti, alcuni memorabili, vanno dalla tecnica giuridica - il suo manuale di procedura penale, ristampato più volte, costituisce ancora riferimento essenziale per gli studi di diritto - alla filosofia, alla teologia, all’antropologia. Ciò che di essi colpisce è la straordinaria miscela di erudizione e originalità, di filologia e di spregiudicatezza ermeneutica.
Se la sua monumentale biografia di Savonarola in quattro volumi contiene ancora una miniera di informazioni per gli studiosi, il suo Commento alla Lettera ai Romani di Paolo di Tarso continua a sorprenderci per la radicalità della sua interpretazione, allo stesso tempo fedele ed estrema. Oggi, in una cultura accademica sempre più proclive a uno specialismo senza nerbo, la vastità e la poliedricità del suo sapere restano una sorta di unicum con cui è difficile stabilire confronti.
Ma questa molteplicità di interessi e di linguaggi non sfocia mai in una sorta di vacuo eclettismo, tanto meno in divulgazione. Al contrario il suo stile di scrittura, a volte denso fino all’ermetismo, costituisce per il lettore una sfida che non può lasciare indifferenti. Si può anzi dire che, nonostante l’ampiezza di orizzonti della sua cultura, tutti i suoi testi sembrano convergere verso un fuoco centrale, al contempo teoretico ed etico-politico.
La forza - nel senso pieno del termine - di Cordero stava nel rifiutare ogni compromesso, ogni risposta troppo facile a questioni complesse, come quella del rapporto tra sacro e profano, teologia e politica, eternità e tempo. Tra di essi, per Cordero, non c’è possibilità di sintesi dialettica. Ma continua tensione tra poli irriducibili, necessari l’uno ad illuminare l’altro non per analogia, ma per contrasto. Egli c’insegna che le grandi contraddizioni, nella vita e nel pensiero, non hanno mai soluzioni facili.
Il suo - potremmo dire - è un pensiero teologico-politico consapevole del rischio di ogni sovrapposizione tra teologia e politica. Come è impossibile fondare razionalmente il sacro, così va evitato ogni sacralizzazione del potere. Che anzi è ciò che Cordero ha combattuto per tutta la vita.
Alla fine dell’insegnamento universitario Cordero ha potenziato il proprio impegno politico attraverso una serie di interventi, articoli, polemiche rimaste insuperate per la loro radicalità e anche fantasia semantica. Come dimenticare le vere e proprie invenzioni lessicali, come quelle indirizzate contro Berlusconi, identificato ora con il "Caimano", ora con un Mackie Messer contemporaneo? Le sue polemiche nei confronti del collasso della cultura politica italiana dei due ultimi decenni hanno avuto un tono aspro e duro, come era il suo carattere.
Oggi forse non sono più di moda. Ma basta rileggere alcuni suoi titoli - da Nere lune d’Italia a Morbo italico - per accorgersi che quei libri parlano ancora di noi. La sua etica, lucida e disperata, è una luce della quale c’è ancora bisogno. Il suo discorso, leopardiano, sopra lo stato presente dei costumi italiani non ha smesso di interpellarci. Esso attende ancora una risposta e una promessa di riscatto all’altezza delle sue domande
Sul tema, nel sito, si cfr.:
KANT E SAN PAOLO. COME IL BUON GIUDIZIO ("SECUNDA PETRI") VIENE (E VENNE) RIDOTTO IN STATO DI MINORITA’ DAL GIUDIZIO FALSO E BUGIARDO ("SECUNDA PAULI")
KANT E GRAMSCI. PER LA CRITICA DELL’IDEOLOGIA DELL’UOMO SUPREMO E DEL SUPERUOMO D’APPENDICE.
MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI ?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA E A PENSARE BENE "DIO", "IO" E "L’ITALIA", CHI PIÙ CHI MENO, TUTTI VIVONO DENTRO LA PIÙ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA E POLITICA ITALIANA, NEL REGNO DI "FORZA ITALIA" !!!
Federico La Sala
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. -- STORIA, FILOLOGIA. E LETTERATURA: APULEIO E "CHARITE DULCISSIMA", UNA FANCIULLA RAPITA DA UNA CRICCA DI BRIGANTI PER OTTENERE UN BUON RISCATTO!11 maggio 2020, di Federico La Sala
UNA FANCIULLA, "CHARITE DULCISSIMA", RAPITA DA UNA CRICCA DI BRIGANTI PER OTTENERE UN BUON RISCATTO!
- "Bono animo es," inquit, "Charite dulcissima; nam totis istos hostes tuos statim captivos habebis"
- "Sta tranquilla," disse, "dolcissima Chàrite: tra poco tutti questi tuoi nemici saranno tuoi prigionieri"
- Apuleio, Le Metamorfosi, VII, 12.
Il racconto di Apuleio sul destino dell’anima
Amore e Psiche: mistero, magia e passione
di Franco Manzoni *
Un autore dalla personalità polimorfa, complessa e contraddittoria. Le fonti lo tramandano mago, alchimista, avvocato, scienziato. E ancora filosofo platonico, sacerdote del dio Asclepio e di culti misterici, appassionato di occulto, esoterismo e riti iniziatici come quelli di Eleusi, Mitra, Iside.
 Nato verso il 125 d.C. a Madauro, nell’odierna Algeria, da famiglia benestante, Apuleio studiò a Cartagine e ad Atene. Si vantava di conoscere a fondo ogni artificio retorico e di padroneggiare con virtuosismo il greco e il latino. Per il resto poche e incerte sono le notizie sulla vita di uno scrittore che fu il personaggio più poliedrico dell’età degli Antonini. Di lui più nulla sappiamo dopo il 170.
Nato verso il 125 d.C. a Madauro, nell’odierna Algeria, da famiglia benestante, Apuleio studiò a Cartagine e ad Atene. Si vantava di conoscere a fondo ogni artificio retorico e di padroneggiare con virtuosismo il greco e il latino. Per il resto poche e incerte sono le notizie sulla vita di uno scrittore che fu il personaggio più poliedrico dell’età degli Antonini. Di lui più nulla sappiamo dopo il 170.Apuleio esercitò un naturale fascino sull’ultimo paganesimo e sulla cultura medievale. La sua opera maggiore, le Metamorfosi, divisa in undici libri, è l’unica testimonianza pervenuta intera di un romanzo antico in lingua latina, la cui diffusione si deve a Boccaccio, che ritrovò il codice e ne fece una trascrizione.
 Il titolo nei manoscritti è Metamorphoseon libri XI, ma l’opera è conosciuta anche come Asinus aureus, così indicata da sant’Agostino nel De civitate Dei (XVIII 18). La storia delle eccezionali avventure di un uomo trasformatosi in asino non è un’invenzione di Apuleio. La trama deriva da un modello greco di Lucio di Patre, opera che non ci è giunta, ripresa in modo sintetico da Luciano di Samòsata, poligrafo coevo di Apuleio, che scrisse in greco Lucio o l’asino.
Il titolo nei manoscritti è Metamorphoseon libri XI, ma l’opera è conosciuta anche come Asinus aureus, così indicata da sant’Agostino nel De civitate Dei (XVIII 18). La storia delle eccezionali avventure di un uomo trasformatosi in asino non è un’invenzione di Apuleio. La trama deriva da un modello greco di Lucio di Patre, opera che non ci è giunta, ripresa in modo sintetico da Luciano di Samòsata, poligrafo coevo di Apuleio, che scrisse in greco Lucio o l’asino.L’originalità dell’autore latino consiste nel fatto di essere riuscito a rielaborare materiali preesistenti, assegnando significati mistici, metafisici e simbolici autoctoni, che cambiano radicalmente la struttura e gli intenti della narrazione. Non solo puro intrattenimento. Vi è sottesa una progettualità geniale, che riesce a unificare una folla di racconti popolareschi, passionali, erotici, iniziatici.
 Sullo sfondo dell’odissea di un uomo-asino, Apuleio crea il libro nel libro, mettendo al centro dell’opera la celebre Favola di Amore e Psiche, una narrazione interna in forma di apologo, che occupa i libri IV, V e VI e rispecchia fedelmente l’andamento del romanzo. È il testo in edicola con il «Corriere» ed è la chiave di lettura che permette di comprendere la trama generale in un gioco di parallelismi a specchio.
Sullo sfondo dell’odissea di un uomo-asino, Apuleio crea il libro nel libro, mettendo al centro dell’opera la celebre Favola di Amore e Psiche, una narrazione interna in forma di apologo, che occupa i libri IV, V e VI e rispecchia fedelmente l’andamento del romanzo. È il testo in edicola con il «Corriere» ed è la chiave di lettura che permette di comprendere la trama generale in un gioco di parallelismi a specchio.Il mito, che unisce l’amore e l’anima, viene ascoltato dall’uomo-asino in una caverna di banditi. Qui è trattenuta una fanciulla di nome Càrite, rapita per ottenere un buon riscatto. Per consolarla, la vecchia che la custodisce narra una storia a lieto fine. Figlia di re, Psiche è così bella da suscitare la reazione di Venere, che chiede al dio Amore di ispirare alla fanciulla una passione per l’uomo più brutto della terra.
Ma Amore s’innamora di Psiche. La trasporta nel suo palazzo, dove ogni notte il dio, invisibile al buio, a lei si unisce. Vedere il viso del misterioso amante, però, romperebbe l’incantesimo. Spinta dalla curiositas, la stessa che nella trama generale delle Metamorfosi «costringe» Lucio a provare l’unguento magico che invece lo trasforma in asino, Psiche decide di conoscere Amore, illuminandolo con una lucerna. Si punge con una saetta presa dalla faretra del dio e, perciò, s’innamora perdutamente. Tuttavia, una stilla d’olio cade sul corpo di Amore, svegliandolo. L’incantesimo è finito, il dio fugge e Psiche, disperata, si mette alla sua ricerca. Seguono peripezie e terribili prove da superare, congeniate dalla gelosissima Venere. Alla fine Amore sposa Psiche, ottenendo per lei da Giove l’immortalità. Dalla loro unione nasce la figlia Voluttà.
La storia dell’interpretazione allegorica è plurisecolare. Il racconto ha un iter travagliato: una sequela di cadute, riscatti, dolori, piaceri spirituali dell’Anima umana. Giace sotto ogni evento il pensiero platonico, nella favola come nell’intero romanzo. -La vicenda di Amore e Psiche, così ben colta nel capolavoro scultoreo neoclassico di Canova, è incentrata sul destino dell’Anima, che, per aver commesso il peccato di hybris, vale a dire «tracotanza», tentando di penetrare un mistero che non le era consentito svelare, è costretta a scontare la propria colpa con umiliazioni e affanni di ogni genere, prima di essere degna di ricongiungersi al dio. Lo stile di Apuleio è denso di frequenti neologismi, rarità lessicali, giochi di parole, arcaismi, di toni ironici, patetici, delicati, di estrema tenerezza come nell’episodio della deflorazione di Psiche.
* Corriere della Sera, 14.06.2012
Sul tema, nel sito, si cfr.:
CANOVA E IL VATICANO: LE GRAZIE, AMORE E PSICHE. Una gerarchia senza Grazie (greco: Χάριτες - Charites) e un papa che scambia la Grazia ("Charis") di Dio ("Charitas") con il "caro-prezzo" del Dio Mammona ("Caritas"). Materiali per riflettere
Federico La Sala
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. -- ANTROPOLOGIA (NON "ANDROPOLOGIA"!) E TEOLOGIA: DAL CONCILIO DI NICEA DEL 325 AL CONCILIO DI NICEA DEL 2025. Materiali sul tema.3 maggio 2020, di Federico La Sala
COSTANTINO, IL CONCILIO DI NICEA, E LA DICHIARAZIONE DELL’HOMOOUSIOS. *
- CONCILIO DI NICEA I (325) -
BENEDETTO XVI
Il ritorno di Ratzinger: «Nozze gay e aborto segni dell’Anticristo»
L’anticipazione del nuovo libro del papa emerito
di Redazione Online (Corriere della Sera, 3 maggio 2020).
Il Papa emerito Ratzinger parla di crisi della società contemporanea paragonando al «matrimonio omosessuale» e l’«aborto» al «potere spirituale dell’Anticristo», in una nuova biografia scritta dal suo amico giornalista Peter Seewald, «Ein Leben» che esce lunedì, mentre per la versione italiana e inglese occorrerà aspettare l’autunno, con una intervista dal titolo «Le ultime domande a Benedetto XVI» e che, come nel libro di Sarah, propone ai lettori un verbo che scalda gli animi dell’ala conservatrice della Chiesa, quella parte che gli è rimasta fedele anche dopo la rinuncia dell’11 febbraio 2013. Lo anticipa il sito americano conservatore LifeSiteNews, lo stesso che in questi mesi ha diffuso le uscite anti-Francesco dell’ex nunzio a Washington Carlo Maria Viganò, attacca a testa bassa l’’ideologia dominante’ nella società e opponendosi alla quale, spiega, si è scomunicati. Si percepisce, nel suo dire, l’eco del testo di un anno fa dedicato alla pedofilia, con quella condanna delle aperture iniziate nel ‘68, l’incipit a detta sua del decadimento morale della società e di una crisi irreversibile della Chiesa.
Il nemico è sempre il medesimo: la rivoluzione degli anni Sessanta-Settanta. «Cento anni fa - afferma Benedetto - tutti avrebbero considerato assurdo parlare di un matrimonio omosessuale». Mentre oggi, dice, si è scomunicati dalla società se ci si oppone. E lo stesso vale per «l’aborto e la creazione di esseri umani in laboratorio». E ancora: «La società moderna è nel mezzo della formulazione di un credo anticristiano e se uno si oppone viene punito dalla società con la scomunica. La paura di questo potere spirituale dell’Anticristo è più che naturale e ha bisogno dell’aiuto delle preghiere da parte della Chiesa universale per resistere».
*
Sul tema, nel sito, si cfr.:
COSTANTINO, SANT’ELENA, E NAPOLEONE. L’immaginario del cattolicesimo romano.
"NUOVA ALLEANZA" ?!: A CONDIZIONE CHE ACCANTO A "MARIA" CI SIA "GIUSEPPE"!!!
- IL PROBLEMA GIAMBATTISTA VICO E IL PROBLEMA DELLA COSTITUZIONE. CROCE “CRISTIANO” , VICO “ATEO”, E L’UOMO DELLA PROVVIDENZA.
- FILIAZIONE DIVINA E "PRATICA DELLA SCIENZA NUOVA". VICO: "LA MENTE EROICA". Il testo dell’orazione inaugurale del 1732
DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE.
GUARIRE LA NOSTRA TERRA : VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- LA CADUTA DELL’IMPERO ROMANO E LA "FILOLOGIA". "Il destino di Roma". Un libro dello storico statunitense Kyle Harper16 aprile 2020, di Federico La Sala
L’impero romano tra cambiamenti climatici e pestilenze
In un libro dello storico statunitense Kyle Harper
di Gabriele Nicolò (L’Osservatore Romano, 15 aprile 2020)
Si racconta che uno storico tedesco abbia addotto duecentodieci motivi per spiegare il crollo dell’impero romano. Molto più parco è lo storico statunitense Kyle Harper che nel libro Il destino di Roma. Clima, epidemie e la fine di un impero (Torino, Einaudi, 2019, pagine 520, euro 34) di cause - a parte quelle “istituzionali” legate sia alle farraginose dinamiche della ormai fatiscente struttura governativa che al logorio dell’esercito e delle forze di combattimento in generale - ne individua due: i cambiamenti climatici e le pestilenze. Vale a dire, due cause che rivestono, evidentemente, un valore di attualità sorprendente e disarmante.
È vero che Giulio Cesare si vantava che i suoi soldati erano così vigorosi nel fisico che potevano resistere sia ai rigori dell’inverno che ai torridi raggi del sole d’estate, ma è altrettanto vero - rileva lo storico statunitense in un’intervista al settimanale francese «Nouvelle Observateur» - che i bruschi cambiamenti del clima, attestati tra l’altro da numerosi documenti d’epoca, con graduale e non arginata pressione finirono per incidere profondamente sulla popolazione dell’impero, e in particolare sulla psiche dei soldati, resi più vulnerabili dalle continue privazioni, inevitabile prezzo da pagare in una vita spesa sui campi di battaglia. E a dare il colpo di grazia al già fatiscente impero - sottolinea Harper - furono le pestilenze, la cui propagazione fu alimentata dalla vertiginosa crescita del numero della popolazione, non solo a Roma, ma anche nelle zone limitrofe, ovvero nelle campagne che, col declinare dell’impero, non vennero più adeguatamente bonificate come invece accadeva nei giorni di gloria.
In particolare - sostiene lo storico - a sbaragliare ogni forma di resistenza fu lo Yersinia pestis, che corrisponde alla moderna accezione di peste bubbonica. Un inquietante intreccio di morbi e di germi invase vaste regioni dell’impero mietendo, senza pietà, lutti e devastazione. I romani - ricorda Kyle Harper - avevano saputo come sconfiggere i nemici, anche perché aveva saputo imparare dalle lezioni derivanti dalle sconfitte subite. Ma non avevano le conoscenze e i mezzi adeguati per fronteggiare le ricorrenti pestilenze che certo potevano “approfittare”, per attecchire e poi infuriare, anche della mancanza di social distancing, misura certo non praticabile visto che i romani solevano vivere in ambienti molto ristretti e in accampamenti sovraffollati.
NOTA:
L’Impero romano e la ragione nascosta della sua caduta: una questione "filologica", epocale! L’ "In principio era il logos" (e sulla testa di tutti e di tutte, c’era la corona-virtus) diventa piano-piano l’ "In principio era il Logo" (e sul capo c’era il coronavirus)!!!
Federico La Sala
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- CRITICA DELL’ECONOMIA POLITICA."Il capitalismo ha racchiuso il Messia nella merce (come aveva capito Marx), e così lo ha cancellato" (di Luigino Bruni).5 aprile 2020, di Federico La Sala
L’anima e la cetra /2.
La mano che abbassa il ponte
di Luigino Bruni (Avvenire, sabato 4 aprile 2020)
- C’è qualcosa di grandioso nel vivere nella speranza, ma allo stesso tempo c’è in esso qualcosa di profondamente irreale. Diminuisce il valore specifico dell’individuo, che non può mai realizzarsi pienamente, perché l’incompletezza segna le sue imprese
- Gershom Scholem, L’idea messianica nell’ebraismo
«Perché le genti sono in tumulto e i popoli cospirano invano?». Con questa domanda inizia il Salmo 2. Una domanda tremenda che i profeti e i sapienti ripetono da millenni: perché nonostante la vocazione alla pace e al benessere iscritta nel cuore di ogni persona e delle comunità, gli uomini continuano a esercitarsi nell’arte della guerra, a seminare e coltivare discordia e inimicizia? Le civiltà restano vive finché non si stancano di ripetere questa domanda.
Siamo trasportati dal salmo dentro un ambiente di ribellione, in una congiura di popoli nei confronti di un re - «Spezziamo le catene, gettiamo via da noi il giogo» (2,2). Questo re non è un sovrano qualunque: «E i prìncipi congiurano insieme contro il Signore e il suo unto» (2). Il protagonista del salmo è il Messia, l’unto di YHWH, mistero e anelito di tutta la Bibbia. Il salmo dice che i popoli cospirano «invano», e che di queste congiure «ride Colui che sta nei cieli, il Signore si fa beffe di loro» (4). È molto probabile che il Salmo 2 sia stato scritto dopo l’Esilio, quando la monarchia in Israele non c’era più e il popolo aveva sperimentato la distruzione, la sconfitta, la deportazione. Aveva sentito sulla propria pelle la forza tremenda delle trame di potere e di conquista dei popoli, e lì aveva capito che la verità del loro Dio non coincideva con la vittoria sui nemici. L’esilio fu infatti il grande tempo in cui gli ebrei impararono che un Dio sconfitto può restare un Dio vero.
Perché allora quell’«invano»? Nonostante l’esperienza della sconfitta e della violenza che prevale sulla pace, la Bibbia qui e altrove annuncia l’avvento di un Messia, e quindi di un tempo nuovo finalmente diverso, giusto e buono. Più la realtà si allontana dal tempo messianico, più occorre annunciarlo. Credere e affermare una verità quando la storia e il presente dicono tutt’altro: è questo il vero ruolo della grande spiritualità, che è sempre incarnata, che parla della nostra vita soprattutto nei tempi nei quali l’evidenza dice l’opposto delle sue parole. È negli esili che si fanno i sogni più grandi.
L’attesa del Messia è un’anima profonda dell’intera Bibbia. La troviamo nei profeti, nei libri storici, e ora nei salmi. È una forma concreta che assume in essa la speranza. Questa attesa ha tenuto vivo il futuro e lo ha custodito come giudizio sul presente e come possibilità di liberazione.
Se si perde la dimensione messianica della storia, la vita individuale e sociale accorcia il suo orizzonte, si schiaccia tutta sul presente, si spegne la gioia e si abbuia la libertà. Ci riempiamo di piccole attese perché abbiamo ucciso quella più grande.
 Il capitalismo ha racchiuso il Messia nella merce (come aveva capito Marx), e così lo ha cancellato. Il messianesimo biblico è l’anno giubilare della storia, quel tempo diverso che diventa criterio morale per giudicare le prassi di tutti gli altri tempi. Il Messia resta tale finché non è ancora venuto. È il sovrano del non-ancora, il suo tempo è l’ideale che misura il tempo reale, un ideale che è profezia della storia. C’è un rapporto profondo tra profezia e messianesimo: entrambi sono dentro e fuori la storia, reale e ideale, già e non ancora. E quando si perde questa tensione vitale e paradossale, il messianesimo si identifica in questo o in quel leader politico e la profezia diventa profezia di corte - sta anche qui il senso di quell’anima critica nei confronti della monarchia che è ben presente e operante nei libri storici della Bibbia.
Il capitalismo ha racchiuso il Messia nella merce (come aveva capito Marx), e così lo ha cancellato. Il messianesimo biblico è l’anno giubilare della storia, quel tempo diverso che diventa criterio morale per giudicare le prassi di tutti gli altri tempi. Il Messia resta tale finché non è ancora venuto. È il sovrano del non-ancora, il suo tempo è l’ideale che misura il tempo reale, un ideale che è profezia della storia. C’è un rapporto profondo tra profezia e messianesimo: entrambi sono dentro e fuori la storia, reale e ideale, già e non ancora. E quando si perde questa tensione vitale e paradossale, il messianesimo si identifica in questo o in quel leader politico e la profezia diventa profezia di corte - sta anche qui il senso di quell’anima critica nei confronti della monarchia che è ben presente e operante nei libri storici della Bibbia.Per usare le parole di Jacob Taubes, il messianesimo biblico ci ricorda che «il ponte levatoio si trova sull’altra sponda ed è dall’altra sponda che devono comunicarci che siamo liberi». Ci dice quindi che se esiste una dimensione fondamentale della libertà che è auto-liberazione, in altre sue dimensioni decisive la libertà è invece liberazione per mano di qualcuno che abbassa per noi il ponte levatoio. La Bibbia ha custodito nei secoli questa dimensione della libertà come liberazione, l’ha scritta come suo primo comandamento, e così ci ha protetti dall’auto-inganno frequentissimo di immaginare libertà senza avvertire più il bisogno di una voce diversa dalla nostra che ci chiama e ci salva. Sta qui uno dei sensi di quella che chiamiamo salvezza. Grazie a questa attesa tenace del Messia, nella Bibbia il futuro non diventò «un tempo omogeneo e vuoto: perché ogni secondo era la porta da cui poteva passare il Messia» (Walter Benjamin).
Un errore grave e frequente dei cristiani è allora pensare che l’attesa del Messia sia finita con la venuta di Cristo, dimenticando che egli deve venire ogni giorno e deve ritornare. La liturgia è il grande luogo dove ciò che è stato si incontra con ciò che è e che sarà: in ogni Sabato Santo preghiamo che il sepolcro torni ancora vuoto e ogni resurrezione accade oggi. Nella Bibbia ricordare è verbo al futuro.
Molto noto e forte è il versetto 7 del Salmo: «Voglio annunciare il decreto del Signore. Egli mi ha detto: "Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato"». Una frase splendida, molto amata anche nel Nuovo Testamento e nel cristianesimo, dove la categoria di "Figlio di Dio" è divenuta un pilastro teologico. In questo salmo (e altrove nella Bibbia ebraica) scopriamo, tra l’altro, che chiamare Dio con l’appellativo di Padre e concepire la condizione umana come figliolanza non è una invenzione del cristianesimo ma eredità biblica.
Ma è quell’oggi che ci conquista - «oggi ti ho generato». Qui non c’è solo, forse, un’antica traccia di un canto composto per la consacrazione di un nuovo re in Israele; in questo "oggi" ci possiamo leggere anche qualcosa di diverso e di più. C’è il paradigma di ogni vocazione spirituale, che è una figliolanza che si manifesta dentro un primo oggi che si ripete in tutti gli oggi dell’esistenza, perché una vocazione è viva solo nel presente, e in questo presente continuo si incontra l’eternità.
Ogni paternità e ogni maternità umana è poi una generazione declinata al presente. È ripetere per tutta la vita: «Oggi ti ho generato» - «Ma ora che sei morta, o madre, io so le volte che mi hai generato. In silenzio, non vista d’alcuno» (David Maria Turoldo). Ogni generazione è ri-generazione, e ciò che è vivo se non si rigenera degenera. La paternità-maternità ci dice, simbolicamente (quindi realmente), che siamo vivi e capaci di generare perché oggi siamo rigenerati. Il giorno che tutti smetteranno di generarci inizieremo a morire. Per la Bibbia il principio, l’origine di questa generazione-rigenerazione sempre attuale è Dio, che quindi diventa il garante di quella mutua generazione che scandisce il ritmo della vita. Fino alla fine, quando nell’ultimo oggi ci sorprenderemo di vedere scendere il ponte levatoio e passeremo, indenni, sopra i coccodrilli.
Dopo aver udito pronunciare la promessa del Messia-figlio, eccoci precipitati in un altro paesaggio ampio e profondo: «Chiedimi e ti darò in eredità le genti e in possesso i confini della terra» (8). Questo «chiedimi» ricorda l’invito rivolto da Dio a Salomone nell’oggi della sua chiamata: «Chiedimi ciò che vuoi» (1 Re 3,4). Salomone chiese la cosa più bella («Un cuore che sa ascoltare»: 9). Non sappiamo invece cosa chiese quel re dell’antico salmo; sappiamo però la promessa ivi contenuta, che se è diventata salmo allora, è promessa universale: le genti e la terra sono anche nostra eredità e nostro possesso. Sono l’eredità e il possesso di chi prega i salmi, che oggi, mentre li canta si deve riscoprire erede di tutte le genti e possessore dell’intera terra. Nell’umanesimo biblico, però, tutta la terra è di YHWH, e gli uomini sono soltanto utilizzatori e amministratori (economi). E dunque ogni proprietà è seconda e ogni possesso è imperfetto. La promessa è vera perché è imperfetta, o perché la completezza sta nella sua incompletezza.
Ogni figlio è erede, e quindi i figli di Dio sono eredi di tutto il cielo e di tutta la terra. Lo abbiamo intuito, e ci siamo sentiti eredi. Ma ci siamo dimenticati dell’incompiutezza, siamo diventati padroni della terra, l’abbiamo profanata, siamo diventati, molte volte, mercenari.
Dentro la stessa tradizione e promessa, un giorno Gesù di Nazareth ci disse qualcos’altro di nuovo e di importante su questa speciale eredità: «Beati i miti, perché erediteranno la terra». La mitezza è anche il riconoscimento dell’incompiutezza e della provvisorietà dell’esistenza e dei nostri possessi. Il mite abita il mondo senza diventarne predatore, possiede senza concupiscenza, usa i beni con castità. Il mite è custode della terra e del fratello. È l’anti-Caino. Solo una custodia mite può amministrare l’eredità della terra e far sì che i figli siano eredi di un patrimonio non sperperato.
La mitezza è virtù delle mani - mansueto, cioè "abituato alla mano", docile alla mano del pastore, come sa fare l’agnello. La custodia mite non è stata quella della nostra generazione. Ma oggi ci siamo improvvisamente ritrovati dentro una inondazione di mitezza, in un oceano di mansuetudine. Questo tempo tremendo sta diventando il tempo dei miti. Quello di chi sa restare a casa, di chi sa stare, docile, sotto le mani di medici e infermieri. Stiamo vedendo molte mani abbassare ponti su sponde che prima sembravano irraggiungibili.
«E ora siate saggi, o sovrani; lasciatevi correggere, o giudici della terra; servite il Signore con timore e rallegratevi con tremore» (Salmo 2,10-12). Le ultime parole del salmo ci donano una nuova beatitudine per questo tempo: «Beato chi in lui si rifugia».
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. -- FILOSOFIA E SCIENZA AL TEMPO DELLA SOVRANITA’ ( “CORONA”) DEL “VIRUS” .4 aprile 2020, di Federico La Sala
SCIENZA, STORIA E MEMORIA. PORTARSI DOPO DEWEY ....
***
ALLA LUCE DEL GRANDE “SUCCESSO” NELLA CAPACITA’ DI ANALISI DELLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS mostrato dal CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (“Coronavirus. Rischio basso, capire condizioni vittime”, 22/02/2020), e della condivisione dei suoi “risultati” da parte di Giorgio AGAMBEN (”Lo stato d’eccezione provocato da un’emergenza immotivata”, il manifesto, 26/02/2020) , CONDIVIDENDO l’urgenza di accogliere “La sfida del Covid-19 alle scienze umane”, mi sia lecito rinviare ad alcune note dell’anno scorso (2019) proprio sul tema del “processo di apprendimento nelle due culture”. Forse, è proprio ora di uscire dal letargo e riprendere la navigazione “sotto coverta” e “il dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo” con Galileo Galilei. O no?!
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- MUSICA, POLITICA, E PIFFERAIO MAGICO.3 aprile 2020, di Federico La Sala
MUSICA, POLITICA, E PIFFERAIO MAGICO...
- “In questo senso, lo stato della musica (includendo in questo termine tutta la sfera che imprecisamente definiamo con il termine ‘arte’) definisce la condizione politica di una determinata società meglio e prima di qualsiasi altro indice e, se si vuole mutare veramente l’ordinamento di una città, è innanzitutto necessario riformarne la musica. La cattiva musica che invade oggi in ogni istante e in ogni luogo le nostre città è inseparabile dalla cattiva politica che la governa.” (Giorgio Agamben, Che cos’è la filosofia?, Quodlibet, Macerata, 2016 p. 140)
PER CARITÀ...
MUSICA, POLITICA, E PIFFERAIO MAGICO: RIATTIVARE LA MEMORIA della TEOLOGIA DELLA LIBERAZIONE, della “Wohl-tätigkeit”, della carità! “THE SHAWSHANK REDEMPTION” : LA “MOS-ART” (“arte di Mosé”)! Una breve sequenza dal film “Le Ali della Libertà”.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. -- LA SOVRANITA’ (LA “CORONA”) DEL “VIRUS”, LA “PACE PERPETUA”, E LA RISATA DI KANT.31 marzo 2020, di Federico La Sala
LA SOVRANITA’ (LA “CORONA”) DEL “VIRUS”, LA “PACE PERPETUA”, E LA RISATA DI KANT. Nota ... *
- Riflessioni sulla peste
- di Giorgio Agamben Quodlibet,27 marzo 2020
- Le riflessioni che seguono non riguardano l’epidemia, ma ciò che possiamo capire dalle reazioni degli uomini ad essa. Si tratta, cioè, di riflettere sulla facilità con cui un’intera società ha accettato di sentirsi appestata, di isolarsi in casa e di sospendere le sue normali condizioni di vita, i suoi rapporti di lavoro, di amicizia, di amore e perfino le sue convinzioni religiose e politiche. Perché non ci sono state, come pure era possibile immaginare e come di solito avviene in questi casi, proteste e opposizioni? L’ipotesi che vorrei suggerire è che in qualche modo, sia pure inconsapevolmente, la peste c’era già, che, evidentemente, le condizioni di vita della gente erano diventate tali, che è bastato un segno improvviso perché esse apparissero per quello che erano - cioè intollerabili, come una peste appunto. E questo, in un certo senso, è il solo dato positivo che si possa trarre dalla situazione presente: è possibile che, più tardi, la gente cominci a chiedersi se il modo in cui viveva era giusto.
- E ciò su cui occorre non meno riflettere è il bisogno di religione che la situazione fa apparire. Ne è indizio, nel discorso martellante dei media, la terminologia presa in prestito dal vocabolario escatologico che, per descrivere il fenomeno, ricorre ossessivamente, soprattutto sulla stampa americana, alla parola «apocalisse» e evoca, spesso esplicitamente, la fine del mondo. È come se il bisogno religioso, che la Chiesa non è più in grado di soddisfare, cercasse a tastoni un altro luogo in cui consistere e lo trovasse in quella che è ormai di fatto diventata la religione del nostro tempo: la scienza. Questa, come ogni religione, può produrre superstizione e paura o, comunque, essere usata per diffonderle. Mai come oggi si è assistito allo spettacolo, tipico delle religioni nei momenti di crisi, di pareri e prescrizioni diversi e contraddittori, che vanno dalla posizione eretica minoritaria (pure rappresentata da scienziati prestigiosi) di chi nega la gravità del fenomeno al discorso ortodosso dominante che l’afferma e, tuttavia, diverge spesso radicalmente quanto alle modalità di affrontarlo. E, come sempre in questi casi, alcuni esperti o sedicenti tali riescono ad assicurarsi il favore del monarca, che, come ai tempi delle dispute religiose che dividevano la cristianità, prende partito secondo i propri interessi per una corrente o per l’altra e impone le sue misure.
- Un’altra cosa che dà da pensare è l’evidente crollo di ogni convinzione e fede comune. Si direbbe che gli uomini non credono più a nulla - tranne che alla nuda esistenza biologica che occorre a qualunque costo salvare. Ma sulla paura di perdere la vita si può fondare solo una tirannia, solo il mostruoso Leviatano con la sua spada sguainata.
- Per questo - una volta che l’emergenza, la peste, sarà dichiarata finita, se lo sarà - non credo che, almeno per chi ha conservato un minimo di lucidità, sarà possibile tornare a vivere come prima. E questa è forse oggi la cosa più disperante - anche se, com’è stato detto, «solo per chi non ha più speranza è stata data la speranza».
* Nota:
LA SOVRANITA’ (LA “CORONA”) DEL “VIRUS”, LA “PACE PERPETUA”, E LA RISATA DI KANT...
CONSIDERATO, PURTROPPO, CHE ” Le riflessioni” di Agamben non riguardano l’epidemia del CORONAVIRUS, “ma ciò che possiamo capire dalle reazioni degli uomini ad essa”, ACCOLTA “L’ipotesi [...] che in qualche modo, sia pure inconsapevolmente, la peste c’era già [...]”
 E CONDIVISA L’IDEA CHE BISOGNA RIFLETTERE SUL “[...] bisogno di religione che la situazione fa apparire. Ne è indizio, nel discorso martellante dei media, la terminologia presa in prestito dal vocabolario escatologico che, per descrivere il fenomeno, ricorre ossessivamente, soprattutto sulla stampa americana, alla parola «apocalisse» e evoca, spesso esplicitamente, la fine del mondo [...]”
E CONDIVISA L’IDEA CHE BISOGNA RIFLETTERE SUL “[...] bisogno di religione che la situazione fa apparire. Ne è indizio, nel discorso martellante dei media, la terminologia presa in prestito dal vocabolario escatologico che, per descrivere il fenomeno, ricorre ossessivamente, soprattutto sulla stampa americana, alla parola «apocalisse» e evoca, spesso esplicitamente, la fine del mondo [...]”
 E, ANCORA, CHE “come sempre in questi casi, alcuni esperti o sedicenti tali riescono ad assicurarsi il favore del monarca, che, come ai tempi delle dispute religiose che dividevano la cristianità, prende partito secondo i propri interessi per una corrente o per l’altra e impone le sue misure. [....] sulla paura di perdere la vita si può fondare solo una tirannia, solo il mostruoso Leviatano con la sua spada sguainata” (cf. G. Agamben, “Riflessioni...” : https://www.quodlibet.it/giorgio-agamben-riflessioni-sulla-peste),
E, ANCORA, CHE “come sempre in questi casi, alcuni esperti o sedicenti tali riescono ad assicurarsi il favore del monarca, che, come ai tempi delle dispute religiose che dividevano la cristianità, prende partito secondo i propri interessi per una corrente o per l’altra e impone le sue misure. [....] sulla paura di perdere la vita si può fondare solo una tirannia, solo il mostruoso Leviatano con la sua spada sguainata” (cf. G. Agamben, “Riflessioni...” : https://www.quodlibet.it/giorgio-agamben-riflessioni-sulla-peste),
 PER NON PERDERE IL “FILO” DI “SOFIA” E, CON ESSA, ANCHE LA VITA E LA “SOVRANITA’ (LA “CORONA”) DEL SUO “SAPERE AUDE!”, IO RIPRENDEREI IL DISCORSO dalla citazione evangelica, utilizzata anche dallo stesso Agamben in “Pilato e Gesù” (nottetempo 2013), relativa al problema dell’ ECCE HOMO (cfr. RITORNARE A SCUOLA DA PONZIO PILATO ... http://www.leparoleelecose.it/?p=37854#comment-426632) e dalla LEZIONE DI KANT sull’UOMO SUPREMO DI EMANUEL SWEDENBORG (http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=5028) E SULLA “fine di tutte le cose” (http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=5026). O no?! Boh e bah?!
PER NON PERDERE IL “FILO” DI “SOFIA” E, CON ESSA, ANCHE LA VITA E LA “SOVRANITA’ (LA “CORONA”) DEL SUO “SAPERE AUDE!”, IO RIPRENDEREI IL DISCORSO dalla citazione evangelica, utilizzata anche dallo stesso Agamben in “Pilato e Gesù” (nottetempo 2013), relativa al problema dell’ ECCE HOMO (cfr. RITORNARE A SCUOLA DA PONZIO PILATO ... http://www.leparoleelecose.it/?p=37854#comment-426632) e dalla LEZIONE DI KANT sull’UOMO SUPREMO DI EMANUEL SWEDENBORG (http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=5028) E SULLA “fine di tutte le cose” (http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=5026). O no?! Boh e bah?!Federico La Sala
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- CORSI E RICORSI STORICI: VICO E LA STORIA DEI LEMURI (LEMURUM FABULA), OGGI.28 marzo 2020, di Federico La Sala
PIANETA TERRA. Fine della Storia o della "Preistoria" ?
CORSI E RICORSI STORICI: CIVILTA’ AL COLLASSO.
Uno studio della Nasa : l’Occidente è destinato a crollare come Roma antica e gli altri grandi imperi del passato.
PER UN’ALTRA EUROPA E PER UN’ALTRA ITALIA. Al di là dei "corsi e ricorsi", il filo della tradizione critica. Contro la cecità e la boria dei dotti e delle nazioni ... L’ITALIA AL BIVIO : VICO E LA STORIA DEI LEMURI (LEMURUM FABULA), OGGI. Un invito alla (ri)lettura della "Scienza Nuova"
Federico La Sala
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- EPIDEMIA E TEOLOGIA: "CORONAVIRTUS"! Un fatto “apocalittico”, nel senso etimologico del termine: non un evento da fine del mondo, ma di una rivelazione (un ebook di Lorenzo Fazzini). .26 marzo 2020, di Federico La Sala
Coronavirus. Epidemia e teologia, l’ebook di Fazzini
Un istant ebook che individua nella pandemia in cui siamo emersi un fatto “apocalittico”, nel senso etimologico del termine: non un evento da fine del mondo, ma di una rivelazione
di Redazione Agorà (Avvenire, mercoledì 25 marzo 2020)
“Si può fare una teologia del Covid-19? È possibile pensare teologicamente il coronavirus? Che cos’ha da dire la parola umana su Dio di fronte alla pandemia che da alcune settimane stravolge la nostra vita e la storia del mondo?”.
Esordisce con queste domande l’istant ebook Dio in quarantena. Una teologia del coronavirus (Emi, 2020, scaricabile gratuitamente su https://www.emi.it/dio-in-quarantena-un-ebook-gratuito) firmato da Lorenzo Fazzini, giornalista e saggista, direttore dell’Editrice missionaria italiana, disponibile da oggi. Una breve e densa riflessione in cui Fazzini individua nella pandemia in cui siamo immersi un fatto “apocalittico”, nel senso etimologico del termine: non un evento da fine del mondo, ma di una rivelazione che “ci dirà il senso. Il perché. La ragione. Ovvero: eschaton come il tempo ultimo che ci dice il significato. Di noi, degli altri, del mondo, di Dio”.
L’analisi di Fazzini inanella una serie di eventi, da lui appunti interpretati in chiave apocalittica, che hanno segnato l’inizio di terzo millennio: l’11 settembre, lo tsunami asiatico, la crisi finanziaria, l’ecatombe del terremoto di Haiti, il dramma delle migrazioni, l’elezione di papa Francesco dopo le dimissioni di un pontefice. Fino a due segnali convergenti: simbolicamente, la fine della cristianità nel rogo di Notre Dame; la recente certificazione di papa Bergoglio - “non siamo più in un regime di cristianità” - rispetto al cambio di epoca che stiamo vivendo.
Fazzini arricchisce il suo ragionamento di vari spunti letterati, da Cormac McCarthy a Marilynne Robinson, filosofici (Hans Jonas, Paul Ricoeur) e teologici (Dietrich Bonhoeffer e il gesuita australiano Richard Leonard), per concludere che la forza della solidarietà e l’eroismo umano che questi eventi “da fine del mondo” ci offrono, e che il coronavirus sta mettendo sotto i nostri occhi nel sacrificio di medici, infermieri e operatori sanitari, dicono molto della “salvezza ancora possibile” che ci sta davanti.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- VITA E FILOSOFIA: USCIRE DAL LETARGO. Quando il dito indica la luna, lo stolto guarda il dito21 marzo 2020, di Federico La Sala
QUESTIONE EPOCALE. Quando il dito indica la luna, lo stolto guarda il dito....
Nota a margine “Su Agamben e il contagio. Il ruolo della filosofia e la comune umanità” *
E’ DA DIRE che, nonostante “La veglia per Finnegan” (James Joyce), la “Storia notturna” (Carlo Ginzburg) continua: “Ulisse” prosegue il suo “folle volo” ancora nel mare eracliteo (“la stessa cosa sono Ade e Dioniso”)! E, nell’orizzonte cartesiano-heideggeriano, la traccia della “fanciulla straniera” è perduta e, con essa, ogni possibilità di distinguere tra “charitas” e “caritas” (“virus” e “virtus”, “Forza, Italia” e “Forza Italia”, ecc.)!!! Il tempo scorre ... e Dante Alighieri è già oltre!
Non è forse ora di svegliar-si e uscire fuori dall’ inferno epistemologico paolino-hegeliano e dallo “stato di eccezione” schmittico-agambeniano?! Non si è ancora capita la “battuta” di Ponzio Pilato (“Ecce Homo”), di Giuliano l’Apostata e di Keplero (“Vicisti, Galilaee”, 1610)?! Ennio Flaiano , nella sua “Autobiografia del Blu di Prussia”, così scrive: “L’ Amor che muove il sole e le altre stelle. Ecco un verso di Dante che vede oltre il telescopio di Galileo”! Che dire?! In tempi di “peste”, non è male ricordare Manzoni, i “Promessi sposi”, e la sua “ardua sentenza” su Napoleone. Credo che sia meglio, ora e subito, uscire dal let-argo! O no?!
*
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- Intellettuali (di Ivano Dionigi).17 marzo 2020, di Federico La Sala
Tu quis es?
Intellettuali
di Ivano Dionigi (Avvenire, martedì 17 marzo 2020)
Dove sono finiti gli intellettuali, figure che mettano il loro sapere a confronto col potere e a frutto del bene comune ? Per i quali la virtù sia per se ipsa praemium ? Che abbiano nel sangue il senso del destino delle persone ? Missing, scomparsi. Sostituiti da intrattenitori, giornalisti, velinari, rappresentanti politici, tecnici delle singole discipline. Dovunque ti giri, stesso spettacolo : loquaces, muti sunt, « blaterano, ma sono muti », direbbe Agostino.
Tra le diverse cause di questa scomparsa, direi anzitutto il primato indiscusso della comunicazione, questo rinnovato impero della retorica, che impone messaggi semplice e semplificati, e che ai pensieri lunghi preferisce gli slogan.
 E poi loro, gli intellettuali, i quali, non si fanno scrupolo di scodinzolare attorno al principe o principino di turno e di asservirsi al potere, tradendo quella “convinzione” e quella “responsabilità” che dovrebbero caratterizzarli.
E poi loro, gli intellettuali, i quali, non si fanno scrupolo di scodinzolare attorno al principe o principino di turno e di asservirsi al potere, tradendo quella “convinzione” e quella “responsabilità” che dovrebbero caratterizzarli.Infine i partiti, che, tra miopia e istinto di sopravvivenza, hanno ridotto la politica a pratica amministrativa oppure a pura spartizione di potere, estranea al pensiero e al progetto.
 Fanno riflettere le parole di Socrate, lontano dalle cariche pubbliche e condannato dalle leggi della città : «Io credo di essere tra quei pochi Ateniesi, per non dire il solo, che tenti la vera arte politica, e il solo tra i contemporanei che la eserciti » (Gorgia 521 d).
Fanno riflettere le parole di Socrate, lontano dalle cariche pubbliche e condannato dalle leggi della città : «Io credo di essere tra quei pochi Ateniesi, per non dire il solo, che tenti la vera arte politica, e il solo tra i contemporanei che la eserciti » (Gorgia 521 d). -
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- IL SIGNIFICATO DEL SACRIFICIO, L’ETICA CATTOLICA E DELLO SPIRITO DEL CAPITALISMO.16 marzo 2020, di Federico La Sala
LA RELIGIONE CATTOLICA NELLA TRAPPOLA DEL "PADRE NOSTRO", DEL "DEUS CARITAS"... *
Oikonomia /10.
Ambiguo è il sacrificio
di Luigino Bruni (Avvenire, sabato 14 marzo 2020)
- Uno dei motivi dell’uccisione del dio è preservarlo dall’invecchiamento
- R. Money-Kyrle, Il significato del sacrificio
Sacrificio è parola della religione, dell’economia, di ogni crisi. I sacrifici sono nati o si sono sviluppati durante le grandi crisi collettive - le guerre, le carestie, le pestilenze. Nel mondo antico, quando la vita diventava dura e un male minacciava le comunità, i nostri progenitori iniziarono a pensare che offrire qualcosa di valore alla divinità potesse essere l’essenziale strumento di management delle catastrofi e delle crisi. Il sacrificio agli dèi di animali e, in certi casi, di bambini e di vergini divenne un linguaggio per legare cielo e terra, la speranza collettiva di poter agire sui nemici invisibili. I sacrifici si nutrono di speranza e di paura, di vita e di morte. È una esperienza radicalmente comunitaria, che cura, ricrea e nutre i legami dentro la comunità e tra la comunità e i suoi dèi.
Il sacrificio è luce e buio insieme. Le luci sono chiare. Le comunità non nascono, non durano né crescono senza sacrifici - continuiamo a scoprirlo, e mai abbastanza. Abbiamo imparato a praticare il dono e la generosità in millenni di offerte sacrificali. Ogni dono vero porta intrinseco una dimensione di sacrificio (nel senso più comune della parola). Quei doni che non ci costano nulla non valgono nulla - una delle leggi sociali più antiche -, perché il dono vero è sempre dono della vita. Amiamo molto i doni, soprattutto da parte delle persone più care, perché sono sacramenti del loro amore per noi. Per i nostri ragazzi i giorni della pandemia che stiamo vivendo tra l’inverno e la primavera di questo anno 2020 possono essere anche un tempo meraviglioso per imparare il misterioso e decisivo rapporto tra sacrificio, dono, vita.
Venendo al suo lato oscuro, il sacrificio ha una intrinseca dimensione verticale e asimmetrica. Non si offre qualcosa a un pari grado, ma a una entità sentita superiore. Le comunità sacrificali sono sempre gerarchiche, perché il rapporto uomo-dio diventa immediatamente il paradigma dei rapporti politici e sociali, quindi del potere. La comunità che offre sacrifici e doni agli dèi deve anche offrire sacrifici e doni ai potenti e al re - che in certe religioni è di natura divina. Il dono fatto al re è il regalo (da rex: re), che si fa perché non lo si può non fare.
Se poi guardiamo le stesse parole che abbiamo appena usato per descrivere la luce del sacrificio (“costano”, “valgono”, “care”), ci ritroviamo subito dentro un’altra sua dimensione buia, legata ancor più direttamente all’economia. Il sacrificio non è un atto isolato, è un processo che si svolge nel tempo. All’inizio c’è in genere una aspettativa di ritorno che troppo facilmente diventa pretesa. La grazia desiderata nei sacrifici è oggetto di commercio. In genere il sacrificio si trova prima della grazia. E anche quando il sacrificio arriva dopo, quando torneremo al tempio per fare un’altra offerta sacrificale saremo già dentro un rapporto commerciale con il dio.
 È possibile che molte comunità abbiano iniziato la pratica del sacrificio di oggi come riconoscenza per un dono ricevuto ieri dagli dèi, e che dal secondo sacrificio in poi sia prevalso il registro commerciale, e il sacrificio sia diventato il prezzo pagato in anticipo per lucrare una nuova grazia. Ciò che manca (o che è fortemente sfidata) nei sacrifici è proprio la gratuità.
È possibile che molte comunità abbiano iniziato la pratica del sacrificio di oggi come riconoscenza per un dono ricevuto ieri dagli dèi, e che dal secondo sacrificio in poi sia prevalso il registro commerciale, e il sacrificio sia diventato il prezzo pagato in anticipo per lucrare una nuova grazia. Ciò che manca (o che è fortemente sfidata) nei sacrifici è proprio la gratuità.Attraverso la mediazione del cristianesimo il sacrificio è entrato direttamente nell’economia medioevale e poi nel capitalismo, diventandone uno dei pilastri etici. Economia e sacrificio hanno entrambi a che fare con la dimensione materiale della vita. Nei sacrifici non basta offrire preghiere e salmi di lode: occorre offrire qualcosa di materiale, sacrificare cose o vite alla cose assimilate. I primi beni economici della storia umana sono stati gli animali offerti, i primi mercati quelli con gli dèi, i primi commerci quelli tra cielo e terra, i primi mercanti i sacerdoti dei templi.
Il sacrificio lo incontriamo oggi in molti luoghi del capitalismo. E non solo nei fenomeni più evidenti, quali i crescenti sacrifici chiesti dalle grandi imprese ai dipendenti, che oggi prendono spesso la forma di veri olocausti (distruzione totale dell’offerta) della vita intera, perché spesso inutili alla produttività dell’azienda, ma puri segnali di devozione totale e incondizionata.
La presenza più interessante del sacrificio nel capitalismo è però quella meno evidente. Nelle religioni il sacrificio non vuole solo cose: vuole cose vive che muoiono mentre le offriamo. Il sacrificio consiste proprio nel trasformare ciò che vive in qualcosa che muore perché vivo (solo le cose vive possono morire: gli oggetti non muoiono perché non sono vivi). Le monete, ad esempio, si trovano nei santuari di tutto il mondo, ma non sono usate come materia del sacrificio - servono per comprare animali da offrire, o si lasciano come accessori complementari al sacrificio vivo. Nei sacrifici quegli animali o quelle libagioni (vegetali), che come tutte le cose vive sarebbero destinate necessariamente e naturalmente alla morte, grazie al sacrificio riescono, paradossalmente, a sconfiggere la morte, ad acquistare una dimensione che le sottrae al ritmo naturale della vita. Perché se da una parte l’agnello muore prematuramente perché sacrificato quando è ancora vivo, mentre muore sull’altare diventa qualcosa di diverso che vince le leggi naturali. Entra in un altro ordine, acquista un altro valore. Non morendo naturalmente diventa, in un certo modo, immortale.
Anche l’economia vive e cresce trasformando cose destinate alla morte in beni che acquistano valore proprio in questa trasformazione. Ogni giorno le imprese prendono cose vive (materie prime, animali, grano, cotone, le nostre energie...), destinate in quanto vive alla morte, e creano valore aggiunto facendole “morire” trasformandole in merci. Quel valore che si aggiunge alle cose nel trasformarle somiglia molto al valore che gli animali e le piante prendevano mentre venivano offerte sull’altare.
La lettura della morte e risurrezione di Gesù è stata anche letta da questa prospettiva: il suo “sacrificio” sconfigge l’ordine naturale della morte e lo rende, con la risurrezione, immortale. Anche il martirio, o più tardi la verginità, furono lette nel cristianesimo come un’alchimia della morte in una vita diversa e superiore.
Il rapporto tra cristianesimo e sacrificio è però pieno di equivoci. Anche se la vita e le parole di Gesù si muovono dentro una logica anti-sacrificale («Misericordia voglio, non sacrifici»), il cristianesimo da subito ha interpretato la passione e morte di Gesù come un sacrificio, come l’«agnello di Dio» che con la sua morte toglie, definitivamente, il peccato dal mondo. Un nuovo e ultimo sacrificio (Ebrei 10), che sostituisce gli antichi e reiterati sacrifici nel tempio. Il sacrificio di Gesù, del Figlio, sarebbe stato il prezzo pagato a Dio Padre per estinguere l’enorme debito che l’umanità aveva contratto. Gesù il nuovo sommo sacerdote che offre in sacrificio non animali ma se stesso (Ebrei 7).
Questa teologia sacrificale ha attraversato e segnato l’intero Medioevo, ribadita dalla Controriforma, e ancora oggi molto radicata nella prassi cristiana. L’idea sacrificale informa molta liturgia cristiana, e ha trasmesso al cristianesimo anche la visione gerarchica tipica del sacrificio. Per tutto il Medioevo (e oltre) la cultura del sacrificio si è espressa infatti in pratiche sociali di sacrificio dove erano i sudditi, i figli, le donne, i servi, i poveri a doversi sacrificare per i padroni, per i capi, per i preti, per i padri e per i mariti. Il sacrificare a Dio divenne facilmente sacrificarsi per altri uomini che, come Dio, si trovano sopra e più in alto dei sacrificanti.
 Il contesto teologico sacrificale ha offerto a rapporti di potere asimmetrici e feudali una giustificazione spirituale, chiamando sacrificio ciò che era, semplicemente, sfruttamento.
Il contesto teologico sacrificale ha offerto a rapporti di potere asimmetrici e feudali una giustificazione spirituale, chiamando sacrificio ciò che era, semplicemente, sfruttamento.Il sacrificio sta finalmente uscendo dalla teologia più recente (grazie a una comprensione più biblica del mistero della Passione), ma sta entrando sempre più nella nuova religione capitalista. Infatti, il processo creativo delle cose vive che muoiono, e “morendo” aumentano il loro valore, è diventato particolarmente forte e centrale nel capitalismo del XXI secolo, dove, diversamente da quanto avveniva nel passato, le prime cose vive che acquistano valore morendo sono diventati i lavoratori.
 Marx ci aveva spiegato che solo le persone sono capaci di creare valore aggiunto in economia - non bastano le macchine. Questa antica verità ha subìto recentemente una importante trasformazione. Fino a qualche decennio fa, il “sacrificio” richiesto dalle fabbriche non era eccessivo, tantomeno totale: era soltanto quello inquadrato nel contratto di lavoro e custodito dai sindacati.
Marx ci aveva spiegato che solo le persone sono capaci di creare valore aggiunto in economia - non bastano le macchine. Questa antica verità ha subìto recentemente una importante trasformazione. Fino a qualche decennio fa, il “sacrificio” richiesto dalle fabbriche non era eccessivo, tantomeno totale: era soltanto quello inquadrato nel contratto di lavoro e custodito dai sindacati.
 Il sacrificio della vita lo si riservava solo alla fede, alla famiglia, alla patria. La mutazione in senso religioso del capitalismo e l’eclissi degli altri ambiti “sacrificali”, ha fatto sì che le grandi imprese siano diventate i nuovi luoghi del sacrificio totale. A questo capitalismo non basta più né interessa consumare la nostra forza-lavoro. Sono i lavoratori che devono offrirsi, spontaneamente, sull’altare. Il loro culto ha bisogno delle persone intere - in ogni religione l’offerta più gradita è quella intera, giovane e senza macchia -, che valgono tanto più quanto più grande è il loro sacrificio. È crescente e impressionante, ad esempio, il numero di manager single o senza figli nelle posizioni apicali delle grandi imprese, un numero che aumenta molto nelle capitali del capitalismo (da Singapore a Milano). Una nuova forma di celibato e di voto di castità, essenziali alla nuova religione. E, come nel Medioevo, la bella parola sacrificio copre la brutta parola sfruttamento. Questo capitalismo sta manipolando troppe parole.
Il sacrificio della vita lo si riservava solo alla fede, alla famiglia, alla patria. La mutazione in senso religioso del capitalismo e l’eclissi degli altri ambiti “sacrificali”, ha fatto sì che le grandi imprese siano diventate i nuovi luoghi del sacrificio totale. A questo capitalismo non basta più né interessa consumare la nostra forza-lavoro. Sono i lavoratori che devono offrirsi, spontaneamente, sull’altare. Il loro culto ha bisogno delle persone intere - in ogni religione l’offerta più gradita è quella intera, giovane e senza macchia -, che valgono tanto più quanto più grande è il loro sacrificio. È crescente e impressionante, ad esempio, il numero di manager single o senza figli nelle posizioni apicali delle grandi imprese, un numero che aumenta molto nelle capitali del capitalismo (da Singapore a Milano). Una nuova forma di celibato e di voto di castità, essenziali alla nuova religione. E, come nel Medioevo, la bella parola sacrificio copre la brutta parola sfruttamento. Questo capitalismo sta manipolando troppe parole.
* SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
IL VANGELO DI PAPA RATZINGER E DI TUTTI I VESCOVI E IL "PANE QUOTIDIANO" DEL "PADRE NOSTRO", VENDUTO A "CARO PREZZO".
GUARIRE LA NOSTRA TERRA : VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- SIGNIFICATO DELLE PAROLE DI PONZIO PILATO, LA MEMORIA DI CHRISTINE DE PIZAN, E DI ASTREA (LA GIUSTIZIA)10 marzo 2020, di Federico La Sala
L’ECCE HOMO, L’8 MARZO AL TEMPO DEL “CORONA VIRUS”, E LA MEMORIA DI CHRISTINE DE PIZAN ...
ALLA LUCE DEL CHIARIMENTO DEL SIGNIFICATO DELLE PAROLE DI PONZIO PILATO: “ECCE HOMO”(cfr. sopra : https://www.fondazioneterradotranto.it/2020/02/26/dialetti-salentini-piticinu/#comment-269838), si comprende meglio anche il significato delle parole di Christine de Pizan, l’autrice della “Città delle dame” : «Or fus jee vrais homs, n’est pa fable,/De nefs mener entremettable » (« Allora diventai un vero uomo, non è una favola,/capace di condurre le navi» - cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Christine_de_Pizan), che dicono ovviamente non della “metamorfosi” in “vir” - uomo, ma della “metanoia” in “homo” - essere umano (su questo, in particolare, si cfr. Michele Feo, “HOMO - Metanoia non Metamorfosi”, “dalla parte del torto”, Parma, autunno 2019, numero 86, pp. 12-13).
***
ASTREA ! “IAM REDIT ET VIRGO” ...
CARO ARMANDO... RICORDANDO DI NUOVO E ANCORA IL TUO PREGEVOLISSIMO LAVORO SU- GLI ARCADI DI TERRA D’OTRANTO, VIRGILIO, E IL “VECCHIO DI CORICO”. A SOLLECITAZIONE E CONFORTO DELL’IMPRESA (si cfr. https://www.fondazioneterradotranto.it/2019/07/08/gli-arcadi-di-terra-dotranto-premessa-1-x/#comment-238474), E LA TUA CONNESSIONE TRA LA “PIZANA” CAPACE DI “CONDURRE LE NAVI” CON LA FIERA E NOBILE Carola Rackete, A SUO E TUO OMAGGIO, riprendo qui una breve scheda su:
- ASTREA - L’Astraea Virgo, ” vergine delle stelle “, simbolo della giustizia, abitò la terra nell’età dell’oro e la lasciò per ultima nell’età del ferro, cedendo all’iniquità ormai dominante. Il ‛ritorno di A.‘ si identifica in Virgilio con il ritorno dell’età di Saturno (” magnus ab integro saeclorum nascitur ordo. / iam redit et Virgo, redeunt Saturnia regna, / iam nova progenies caelo demittitur alto “, Buc. IV 5-7). L’intero passo virgiliano è parafrasato in Pg XXII 70-72 Secol si rinova ; / torna giustizia e primo tempo umano, / e progenïe scende da ciel nova ; in Mn I XI 1 è riportato il v. 6 (cui segue la chiosa ‛ Virgo ‘... vocabatur iustitia, quam etiam ‛Astraeam‘ vocabant), ricordato anche in Ep VII 6 ; in Ep XI 15 il nome di A. è usato come metonimico di giustizia (http://www.treccani.it/enciclopedia/astrea_%28Enciclopedia-Dantesca%29/).
Buon 8 marzo 2020 - e buon lavoro...
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- Etica & Società. L’imago Dei non abita più in noi? (di Vittorio Possenti).1 marzo 2020, di Federico La Sala
USCIRE DAL SONNAMBULISMO E DALL’INFERNO EPISTEMOLOGICO.... *
Etica & Società. L’imago Dei non abita più in noi?
Che ne è della persona in questo scorcio del nuovo secolo? Possiamo ancora riferici a essa, al concetto variegato che la esprime, oppure è divenuta una parola senza senso?
di Vittorio Possenti (Avvenire, sabato 29 febbraio 2020)
- [Foto] La creazione di Adamo, Paolo Uccello
Che ne è della persona in questo scorcio del nuovo secolo? Possiamo ancora fare ricorso a essa, e al concetto ricchissimo che la esprime, oppure è divenuta un richiamo usurato e da lasciare da parte, perché non possiede più un senso? È un evento su cui meditare che nel corso dell’ultimo secolo il riferimento alla persona sia diventato universale, “ecumenico”, nella cultura filosofica, teologica e nelle scienze umane e sociali in Occidente, e poi in contesti assai più ampi. -Sempre più si ricorre, spesso solo in modo retorico, all’idea di persona, ma con il risultato che i suoi contorni sono diventati plurimi, sfuggenti, irriconoscibili, e quella che non pochi hanno considerato un passepartout universale o una chiave d’oro che apre tutte le porte, solleva invece immensi problemi che toccano in profondità la condizione umana. -L’esser-persona concerne tutti indistintamente, e secondo l’idea che ne viene formata vita e civiltà prendono cammini molto diversi, e anche il nostro destino singolo ne è segnato.
Per un certo tempo la poderosa diffusione dell’idea di persona ha potuto costituire un elemento di cui rallegrarsi per coloro che l’avevano adottata e coltivata assiduamente, senza però perdere la capacità di un attento discernimento che diventa ogni giorno più necessario. In effetti il diffondersi del termine “persona” e del lessico personalistico è andato di pari passo con una preoccupante vaghezza del loro contenuto; discorso analogo vale per l’idea di “dignità della persona” cui si fa un richiamo tanto inflazionato quanto confuso.
 Ma l’orecchio esperto riesce a udire nel frastuono sulla persona un’altra musica: l’intento di decostruirne la nozione, intendendola quasi solo come una finzione giuridica, oppure più radicalmente di dissolverne la sua stessa realtà, riportando la persona a una maschera dell’impersonale. Decostruzione che prende origine in Francia dove, secondo l’antiumanesimo di Michel Foucault, l’uomo è solo un’invenzione delle scienze umane, destinato a sparire molto presto. E da lì si è diffusa in vari contesti, Italia compresa: nell’assunto si annida quella che spesso ho chiamato “filosofia del Neutro”, una delle massime espressioni del nichilismo moderno-contemporaneo.
Ma l’orecchio esperto riesce a udire nel frastuono sulla persona un’altra musica: l’intento di decostruirne la nozione, intendendola quasi solo come una finzione giuridica, oppure più radicalmente di dissolverne la sua stessa realtà, riportando la persona a una maschera dell’impersonale. Decostruzione che prende origine in Francia dove, secondo l’antiumanesimo di Michel Foucault, l’uomo è solo un’invenzione delle scienze umane, destinato a sparire molto presto. E da lì si è diffusa in vari contesti, Italia compresa: nell’assunto si annida quella che spesso ho chiamato “filosofia del Neutro”, una delle massime espressioni del nichilismo moderno-contemporaneo.La dialettica in corso tra umanesimo e antiumanesimo comporta l’esplosione della “questione antropologica” che si è prepotentemente affiancata alle questioni pubbliche che prendono il nome di “questione istituzionale democratica” e “questione sociale”: esse hanno dato almeno in Occidente il tono a due secoli di storia. Rispetto a queste problematiche la questione antropologica presenta caratteri più radicali ed è destinata a diventare sempre più pervasiva.
 L’uomo è messo in questione tanto nella sua base biologica e corporea quanto nella coscienza che forma di se stesso. E ciò non soltanto astrattamente, ma praticamente, perché le nuove tecnologie, e non solo quelle della vita, incidono sul soggetto, lo trasformano, tendono a operare un mutamento nel modo di intendere nozioni centrali dell’esperienza di ognuno: essere generato oppure prodotto, nascere, vivere, procreare, cercare la salute, invecchiare, morire ecc.
L’uomo è messo in questione tanto nella sua base biologica e corporea quanto nella coscienza che forma di se stesso. E ciò non soltanto astrattamente, ma praticamente, perché le nuove tecnologie, e non solo quelle della vita, incidono sul soggetto, lo trasformano, tendono a operare un mutamento nel modo di intendere nozioni centrali dell’esperienza di ognuno: essere generato oppure prodotto, nascere, vivere, procreare, cercare la salute, invecchiare, morire ecc.
 Si tratta di trasformazioni di nuclei sensibilissimi che hanno interessato migliaia di generazioni e che costituiscono il tessuto fondamentale dell’esperienza umana in tutti i luoghi e tempi. La generazione umana rischia di passare dal procreare al fare, andando verso un soggetto progettato in serie, fabbricato, col rischio di non avere volto proprio.
Si tratta di trasformazioni di nuclei sensibilissimi che hanno interessato migliaia di generazioni e che costituiscono il tessuto fondamentale dell’esperienza umana in tutti i luoghi e tempi. La generazione umana rischia di passare dal procreare al fare, andando verso un soggetto progettato in serie, fabbricato, col rischio di non avere volto proprio.
 La controversia sull’humanum è incandescente e onnipresente. Oltre quarant’anni fa Giovanni Paolo II sosteneva qualcosa che vale tuttora: «La verità che dobbiamo all’uomo è innanzi tutto una verità sull’uomo stesso» (Puebla, 28 gennaio 1979). La verità sull’uomo non può essere soggetta a votazione ma pazientemente rimeditata e fatta circolare nella cultura.
La controversia sull’humanum è incandescente e onnipresente. Oltre quarant’anni fa Giovanni Paolo II sosteneva qualcosa che vale tuttora: «La verità che dobbiamo all’uomo è innanzi tutto una verità sull’uomo stesso» (Puebla, 28 gennaio 1979). La verità sull’uomo non può essere soggetta a votazione ma pazientemente rimeditata e fatta circolare nella cultura.Oggi gli orizzonti prevalenti nella cultura in ordine alla persona sono sopratutto il funzionalismo e il riduzionismo. Nel primo essa è vista e ricondotta a un insieme di funzioni e/o di capacità, di cui ci si contenta di stendere vari elenchi senza andare al nucleo intimo che fa la persona. Nel riduzionismo essa è intesa come una parte, sia pure rilevante ma sempre parte, della madre-natura, secondo una posizione di esplicito naturalismo in cui l’essere umano non sporge oltre il suo grembo. Bisogna certo fare pace con la natura, senza però pensarci solo come risolti nella madre-terra, ma come esseri che abitano il mondo simbolico: linguaggio, mito, religione, arte. Ma anche l’antropocentrismo moderno, che aveva alzato l’uomo al di sopra del cielo, conserva posizioni.
 In questo incandescente crocevia storico-spirituale a condurre il gioco è la rivoluzione tecnologica che domina il mondo: robotica, mediatica, digitale e informatica, biopolitica, intelligenza artificiale, potenziamento umano. Essa impone i suoi ritmi forsennati che non consentono momenti meditativi. Siamo trascinati senza requie da un vento che spira da ogni luogo e trascina ogni contesto, senza pause e moratorie, e coinvolti in processi giganteschi, mentre diversi sostengono che occorre abbattere le barriere tra l’umano, l’animale, la macchina.
In questo incandescente crocevia storico-spirituale a condurre il gioco è la rivoluzione tecnologica che domina il mondo: robotica, mediatica, digitale e informatica, biopolitica, intelligenza artificiale, potenziamento umano. Essa impone i suoi ritmi forsennati che non consentono momenti meditativi. Siamo trascinati senza requie da un vento che spira da ogni luogo e trascina ogni contesto, senza pause e moratorie, e coinvolti in processi giganteschi, mentre diversi sostengono che occorre abbattere le barriere tra l’umano, l’animale, la macchina.A mio avviso il settore in cui la situazione risulta maggiormente compromessa è quello bioetico-biopolitico dove il tecnicamente possibile tende a diventare moralmente lecito a priori: si può pensare alla nuova legge bioetica in discussione in Francia, di cui è appariscente il carattere fortemente libertario e centrato sulle pretese degli adulti. Tutto ciò accade proprio quando vi è più alto bisogno di una nozione non mistificata di persona, della verità sulla persona cui non si può rinunciare. Per non essere trascinati passivamente dalla tempesta del “progresso” e dalle insidie del nichilismo è necessario riprendere contatto con una visione integra dell’esser-persona, che può provenire dal pensiero ontologico e dalla religione. In merito si ergono come irti ostacoli la pregiudiziale postmetafisica e la progressiva cancellazione dell’imago Dei dal perimetro dell’umano: essa nega all’essere umano la sua costitutiva apertura verso l’alto. Si avverte dolorosamente la carenza di un atteggiamento contemplativo, particolarmente arduo in un’epoca dominata dalla fretta e da un’ansia (ansia di prestazione e ansia di consumo) che colpisce tutti, e che annienta lo spazio meditativo e contemplativo, da cui può sorgere un orientamento sapiente. Non rinunciamo alla persona, rimettiamola al centro secondo tutta la verità che essa include.
*
Sul tema, nel sito, si cfr.:
L’”ECCE HOMO” (E LA “CORONA DI SPINE”)! IN MEMORIA DI LEONZIO PILATO E DI PONZIO PILATO.
IL MESSAGGIO EVANGELICO, LA COSTITUZIONE, E IL PARADOSSO ISTITUZIONALE DEL MENTITORE, ATEO E DEVOTO. LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE.
DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE.
Federico La Sala
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- "EST MODUS IN REBUS". San Remo e un "desiderio di resilienza umana".5 febbraio 2020, di Federico La Sala
L’AMORE ("CHARITAS") NON E’ LO ZIMBELLO NE’ DEL TEMPO NE’ DELLA FILOLOGIA. ESISTE UNA MISURA NELLE COSE ("Est modus in rebus") ... *
L’analisi.
Sanremo, il camaleonte tatuato e il bene non più negoziabile
Basta un rapido sguardo ai testi delle canzoni del Festival e si nota un bisogno profondo di senso, la voglia di imparare resistendo al degrado, di resilienza umana
di Antonio Staglianò (Avvenire, mercoledì 5 febbraio 2020)
Codice etico cercasi, anche in musica: valore educativo (e no) delle canzoni popolari. Uno sguardo veloce ai testi delle nuove canzoni di Sanremo e si nota subito un bisogno profondo di senso, la voglia di imparare resistendo al degrado, desiderio di resilienza umana, come in 8 Marzo della giovanissima Tecla: «Ci vuole forza e coraggio, lo sto imparando vivendo ogni giorno questa vita; comunque dal dolore si può trarre una lezione; e la violenza non ha giustificazione». E la bella canzone sul bullismo di Marco Sentieri, Billy blu che dice al bullo - salvandogli la vita - no ma quale odio, no nessun odio, eri tu quello più debole, tu dentro stavi male». Si giunge perfino a punte mistiche, con Matteo Faustini in Nel bene e nel male: «perché dentro quel rancore si può ancora perdonare ».
 Frasi estrapolate? No, testi con una certa coerenza, alla ricerca di un codice etico capace di rilanciare i giovani in un futuro in cui l’essere umano cresca con l’uomo - «nonostante che a volte uomo non vuol dire essere umano per tutto il sangue che è stato versato» (Tecla). Tante proposte e tanti messaggi positivi sull’amore universale che pur essendo tale non è aleatorio, ma sempre incarnato dentro drammi umani ed esperienze di persone speciali, magari ai margini o sopra le righe: «Ti prego insisto, fatti il segno della croce e poi rinuncia a Mefisto siamo chiese aperte a tarda sera, siamo noi; siamo l’amen di una preghiera, siamo noi» (Levante).
Frasi estrapolate? No, testi con una certa coerenza, alla ricerca di un codice etico capace di rilanciare i giovani in un futuro in cui l’essere umano cresca con l’uomo - «nonostante che a volte uomo non vuol dire essere umano per tutto il sangue che è stato versato» (Tecla). Tante proposte e tanti messaggi positivi sull’amore universale che pur essendo tale non è aleatorio, ma sempre incarnato dentro drammi umani ed esperienze di persone speciali, magari ai margini o sopra le righe: «Ti prego insisto, fatti il segno della croce e poi rinuncia a Mefisto siamo chiese aperte a tarda sera, siamo noi; siamo l’amen di una preghiera, siamo noi» (Levante).E poi c’è Junior Cally (rapper noto al pubblico per il suo linguaggio sessista e violento contro le donne). Ed è subito polemica. Di mezzo c’è un diffuso senso di scandalo: questa volta non è la frangia ’religiosa’ della popolazione (facilmente criticata di ’beghinismo’ e bigotteria), ma quella espressione di organizzazioni sociali e di istituzioni politiche. Gruppi organizzati a chiedere l’esclusione dal palco di Sanremo di Junior Cally: un giovane che, anche nella foto-immagine di ’Sorrisi e canzoni’ in prima fila è ritratto con la sua maschera. Il suo volto è la sua maschera o le tante maschera che indossa. Perché, a quanto pare, vuole presentarsi ’fuori da ogni identità’, senza una riconoscibilità che lo inquadri.
 Con il brano che presenterà a Sanremo - No grazie - intende essere un «antipopulista e folle », dice: «sono un ragazzo semplicissimo che ha un sogno nel cassetto e va a prenderselo ». Una identità ce l’ha: Antonio Signore ha 28 anni. Tanto basta per capire che non è un ragazzino e sa bene quello che fa e che scrive. Non ci sta e dice ’no grazie’ a quanto lo possa omologare a destra o a sinistra o al centro: politicamente corretto? No grazie; puntare il dito contro e fare il populista? No grazie; «non fare niente tutto il giorno e proclamarmi artista? No no no-no grazie». È fuori da tutto, dalle righe e dalle rime e se la gente ’fa buon viso a cattivo gioco’, Junior il mascherato fa l’opposto: »faccio cattivo viso a buon gioco». Al suo rap (forse troppo violento, per lui «parlare di eccesso non è eccessivo») non vuole ri- nunciare e dice «no grazie» anche a chi gli consiglia di smetterla con questa storia del rap per incanalare la sua creativa fantasia a scrivere canzoni d’amore per la sua ex, oppure «trovarmi un lavoro serio e diventare yes man, insultare tutti sì, ma solo nel web».
Con il brano che presenterà a Sanremo - No grazie - intende essere un «antipopulista e folle », dice: «sono un ragazzo semplicissimo che ha un sogno nel cassetto e va a prenderselo ». Una identità ce l’ha: Antonio Signore ha 28 anni. Tanto basta per capire che non è un ragazzino e sa bene quello che fa e che scrive. Non ci sta e dice ’no grazie’ a quanto lo possa omologare a destra o a sinistra o al centro: politicamente corretto? No grazie; puntare il dito contro e fare il populista? No grazie; «non fare niente tutto il giorno e proclamarmi artista? No no no-no grazie». È fuori da tutto, dalle righe e dalle rime e se la gente ’fa buon viso a cattivo gioco’, Junior il mascherato fa l’opposto: »faccio cattivo viso a buon gioco». Al suo rap (forse troppo violento, per lui «parlare di eccesso non è eccessivo») non vuole ri- nunciare e dice «no grazie» anche a chi gli consiglia di smetterla con questa storia del rap per incanalare la sua creativa fantasia a scrivere canzoni d’amore per la sua ex, oppure «trovarmi un lavoro serio e diventare yes man, insultare tutti sì, ma solo nel web».No grazie è una canzone di un mascherato che vuole comunque dire qualcosa di sé, farsi conoscere, presentarsi: «sono il fuori programma televisivo». Addirittura «spero che si capisca che odio il razzista » e nel passaggio è possibile intravedere un affondo ’politico’, perché non sta con Salvini (e la sua Lega) - che sarebbe «il raz- zista che pensa al paese ma è meglio il mojito », come anche l’altro Matteo, «il liberista di centro sinistra che perde partite e rifonda il partito». E se qualcuno si chiedesse - ’questo da dov’è uscito?’ - la risposta è semplice: «dal terzo millennio col terzo dito ».
 Si, Junior Cally appartiene alla generazione dei ’nati liquidi’, di quelli che per quanto ’fuori’ vivono una certa smania affannosa di «notorizzare la propria individualità ». Con l’abbigliamento manifesta la propria disponibilità a rinunciare ai simboli dell’identità comune e la voglia di incarnare identità diverse e plurali in ogni cangiante istante. Il camaleonte è la metafora giusta per capire la direzione. Eppure, la contraddizione emerge lampante nei segni del corpo, stracarico di tatuaggi, magari indelebili e quindi portatori di un impegno duraturo e serio della propria identità (non solo di un momentaneo capriccio): «il tatuaggio, miracolo dei miracoli, segnala al contempo l’intenzionale stabilità (forse anche irreversibilità) dell’impegno e la libertà di scelta che contraddistingue l’idea di diritto all’autodefinizione e al suo esercizio » (Zygmunt Bauman, in Nati liquidi).
Si, Junior Cally appartiene alla generazione dei ’nati liquidi’, di quelli che per quanto ’fuori’ vivono una certa smania affannosa di «notorizzare la propria individualità ». Con l’abbigliamento manifesta la propria disponibilità a rinunciare ai simboli dell’identità comune e la voglia di incarnare identità diverse e plurali in ogni cangiante istante. Il camaleonte è la metafora giusta per capire la direzione. Eppure, la contraddizione emerge lampante nei segni del corpo, stracarico di tatuaggi, magari indelebili e quindi portatori di un impegno duraturo e serio della propria identità (non solo di un momentaneo capriccio): «il tatuaggio, miracolo dei miracoli, segnala al contempo l’intenzionale stabilità (forse anche irreversibilità) dell’impegno e la libertà di scelta che contraddistingue l’idea di diritto all’autodefinizione e al suo esercizio » (Zygmunt Bauman, in Nati liquidi).Nella condizione liquida giovanile delle società liquide e del pensiero liquido e gassoso, è difficile stabilire, però, cosa va bene e cosa non va. Chi stabilisce i ’limiti’, i ’paletti’ del buon gusto, del pudore? Est modus in rebus , si diceva in un latino che tutti capiscono. Un tempo la censura era una sorta di competenza della religione (e della Chiesa cattolica in Italia). Ora è tutto cambiato, ovviamente. La democrazia - ma in verità è la democrazia ridotta a procedure e vuota di ogni riferimento valoriale, a tal punto che democraticamente non si può nemmeno giungere a stabilire cosa sia un valore condivisibile per tutti, nell’attuale dittatura del relativismo e del (non) pensiero unico - sembra incapace di garantire una protezione valoriale agli stessi simboli religiosi, spesso vilipesi e ridicolizzati in nome della liberà di pensiero, di espressione e del diritto all’ironia. Le libertà individuali - si fa per dire che siano poi davvero ’libertà’ - sono esaltate senza ’limiti’, mentre è ormai perduto il riferimento all’appartenenza comunitaria e a un quadro valoriale di riferimento che debba imporsi a chiunque voglia condurre una convivenza pacificata tra esseri umani.
Ora, però, la cosa è diversa, perché nonostante il trend liquido della cultura, un quadro normativo tende a emergere come l’araba fenice dalle ceneri della distruzione libertaria dei processi culturali degli ultimi trent’anni. Così, il cambiamento climatico porta i nostri giovani sulle piazze a gridare la loro volontà di vivere respirando ’aria pura’ e questo diventa un ’valore non più negoziabile’, come anche i diritti delle donne a non essere violentate dalle tante forme di bullismo sociale e di femminicidio.
 In verità, è doveroso anche riferire la giustificazione del rapper il quale ha precisato - ovviamente da grande intellettuale ed ermeneuta contemporaneo (!) - che il rap, come genere letterario e stile musicale, «fa grande uso di elementi narrativi di finzione e immaginazione che non rappresentano il pensiero dell’artista» e, pertanto, non sarebbe possibile ascrivergli l’idea della violenza contro le donne: idea che egli stesso troverebbe insopportabile. Forse ci troviamo davanti a un filosofo incompreso! A un nuovo Nietzsche che diagnostica dove sta andando la cultura e l’umanità? Tuttavia, il punto dolente riguarda ciò che è stato da molti sottolineato: il potere di grande influenza che un musicista ha sulle nuove generazioni (specie sulle giovanissime). Quale messaggio arriverà ai più piccoli? Quale insegnamento si darà ai nostri figli se passasse l’idea (già oltremodo sdoganata e diffusa) che gli atteggiamenti più sono turpi e più portano al successo.
In verità, è doveroso anche riferire la giustificazione del rapper il quale ha precisato - ovviamente da grande intellettuale ed ermeneuta contemporaneo (!) - che il rap, come genere letterario e stile musicale, «fa grande uso di elementi narrativi di finzione e immaginazione che non rappresentano il pensiero dell’artista» e, pertanto, non sarebbe possibile ascrivergli l’idea della violenza contro le donne: idea che egli stesso troverebbe insopportabile. Forse ci troviamo davanti a un filosofo incompreso! A un nuovo Nietzsche che diagnostica dove sta andando la cultura e l’umanità? Tuttavia, il punto dolente riguarda ciò che è stato da molti sottolineato: il potere di grande influenza che un musicista ha sulle nuove generazioni (specie sulle giovanissime). Quale messaggio arriverà ai più piccoli? Quale insegnamento si darà ai nostri figli se passasse l’idea (già oltremodo sdoganata e diffusa) che gli atteggiamenti più sono turpi e più portano al successo.Resta comunque una sintesi che deve dare a pensare. Le canzoni pop non sono innocue. Hanno un valore educativo o diseducativo potente e performante che non può essere disatteso nell’annuncio del Vangelo ai giovani. Perciò, una buona teologia popolare - una pop-Theology - è attesa come servizio alla ’carità intellettuale’ (Antonio Rosmini) di cui oggi c’è bisogno più del pane nelle nostre comunità parrocchiali. Allora, al lavoro, al lavoro, per risorgere!
*Sul tema, in rete e nel sito, si cfr.:
- "Misericordia et Veritas in Caritate" (Stemma del vescovo Antonio Staglianò).
SANT’AGOSTINO, DOTTORE DELLA GRAZIA ("CHARIS"): "ECCO DA DOVE COMINCIA L’AMORE" ("ECCE UNDE INCIPIT CHARITAS").
L’AMORE NON E’ LO ZIMBELLO DEL TEMPO: "AMORE E’ PIU’ FORTE DI MORTE" (Cantico dei cantici: 8.6).
Federico La Sala
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. AL GOVERNO DELLA CHIESA UN PAPA CHE PREDICA CHE GESU’ E’ IL FIGLIO DEL DIO "MAMMONA" ("Deus caritas est") E AL GOVERNO DELL’ **ITALIA** UN PRESIDENTE DI UN PARTITO (che si camuffa da "Presidente della Repubblica"), che canta "Forza Italia" con il suo "Popolo della libertà" (1994-2012). Questo è il nodo da sciogliere. Materiali sul tema - di Federico La Sala15 dicembre 2019, di Federico La Sala
BENEDETTO XVI/ Per fare politica occorre il “cuore” di Salomone
31.01.2014 - Andrea Simoncini
Ieri, presso la Biblioteca del Quirinale, è stato presentato il volume “La legge di Salomone. Ragione e diritto nei discorsi di Benedetto XVI”.
Ne parla ANDREA SIMONCINI *
- Ieri, presso la Biblioteca del Quirinale, è stato presentato il volume “La legge di Salomone. Ragione e diritto nei discorsi di Benedetto XVI” curato da Marta Cartabia, giudice della Corte costituzionale e da Andrea Simoncini dell’Università di Firenze. A discutere del libro, coordinati dal giornalista Andrea Tornielli, erano presenti Gaetano Silvestri, presidente della Corte costitutzionale, mons. Georg Gaenswein, Prefetto della Casa Pontificia, i professori Francesco Viola e Francesco D’Agostino.
L’idea di questo libro nasce da una constatazione: oggi la Chiesa è accusata spesso di entrare “a gamba tesa” nei dibattiti politici ovvero nelle discussioni di tipo giuridico; da più parti si ritiene che le gerarchie cattoliche pretendano di dettare ex cathedra i contenuti del dibattito democratico, distorcendo, così, tale dibattito. Un’accusa del genere è fondata? Questa obiezione nasce dalla vera posizione della Chiesa sulle questioni politiche e giuridiche? Davvero il Papa e la Chiesa intendono entrare in questi dibattiti “dettando” ai politici ed alle istituzioni cosa dovrebbero dire o fare?
Cosí è nato il progetto che Marta Cartabia ed io abbiamo curato, quello cioè di raccogliere assieme e ripubblicare cinque grandi discorsi pubblici che il Papa emerito Benedetto XVI ha tenuto dinanzi ad istituzioni civili, politiche o accademiche (Regensburg, Westminster, Collège des Bernardins, Nazioni Unite e Bundestag); chiedendo poi ad un gruppo di autorevoli esperti nel campo delle scienze giuridiche e politiche, espressivi delle più diverse sensibilità religiose, geografiche, culturali, accademiche e istituzionali, di proporne un commento.
Il risultato è andato al di là delle più ottimistiche previsioni. I nomi che hanno accettato di partecipare sono davvero tra gli studiosi più autorevoli e chi vorrà acquistare il libro potrà scorrerne l’elenco completo.
Cattolici, ebrei, protestanti, musulmani, agnostici, tutti hanno accettato di paragonarsi con questo pensiero. Alcuni hanno posto domande o sollevato interrogativi, altri hanno sottolineato la fecondità della posizione della Chiesa soprattutto dinanzi alle sfide che vive la società umana contemporanea. Tutti, comunque, hanno accettato questo dialogo con il Papa emerito come un interlocutore all’altezza delle sfide e dei valori in gioco, rifiutando così la riduzione caricaturale cui molto spesso viene sottoposta la posizione del magistero cattolico.
Ma il punto più interessante è che questo dialogo sta proseguendo oltre le pagine del libro.
La giornata di ieri lo dimostra: un panel d’eccezione ha accettato di proseguire la discussione lanciata dal volume, riprendendo le tesi di fondo del pontefice emerito e sviluppandone ulteriormente le potenzialità. Il dibattito è stato ricchissimo di contributi interessanti; un punto tra gli altri è emerso sinteticamente: le idee riguardanti il pensiero politico-giuridico della dottrina cattolica molto spesso sono stereotipi.
Per dimostrare questa conclusione proviamo un esperimento mentale: se oggi invitassimo un campione casuale di uomini politici o di responsabili di istituzioni pubbliche a stilare una lista dei temi toccati dal Papa emerito in questi suoi discorsi pubblici, prima di leggerli, è molto probabile che nell’elenco troveremmo: difesa della vita, eutanasia, contraccezione, divorzio, fecondazione assistita e così via. Rimarremmo, perciò, molto sorpresi nel non trovare nessuno di questi argomenti nei testi. Attenzione! Non che al Papa o alla Chiesa non interessino quei temi, anzi! Ma in questi discorsi, in cui il tema è il fondamento dell’ordine giuridico, il punto di attacco è molto più profondo e radicale. La preoccupazione non è dire alla politica cosa deve fare, ma − più alla radice − riconoscere da cosa nasce la politica.
«Nella storia, gli ordinamenti giuridici sono stati quasi sempre motivati in modo religioso: sulla base di un riferimento alla Divinità si decide ciò che tra gli uomini è giusto. Contrariamente ad altre grandi religioni, il cristianesimo non ha mai imposto allo Stato e alla società un diritto rivelato, maiun ordinamento giuridico derivante da una rivelazione. Ha invece rimandato alla natura e alla ragione quali vere fonti del diritto - ha rimandato all’armonia tra ragione oggettiva e soggettiva, un’armonia che però presuppone l’essere ambedue le sfere fondate nella Ragione creatrice di Dio».
In questo passaggio del discorso pronunciato al Bundestag di Berlino è racchiuso il cuore del pensiero di Benedetto XVI: non la rivelazione, ma «la ragione e la natura nella loro correlazione» costituiscono «la fonte giuridica valida per tutti».
Dunque, il problema non è dire ai governanti cosa debbono fare, ma come far sì che essi usino correttamente la propria ragione nelle scelte che debbono fare.
In questo senso è davvero sorprendente l’unitarietà della traiettoria che lega il Papa emerito a Papa Francesco. Questa battaglia per un’idea non ridotta di ragione e di verità che costituisce il più grande contributo civile e laico della Chiesa.
Come ha detto Papa Francesco nella lettera inviata ad Eugenio Scalfari, “Ora, la verità, secondo la fede cristiana, è l’amore di Dio per noi in Gesù Cristo. Dunque, la verità è una relazione! Tant’è vero che anche ciascuno di noi la accoglie, la verità, e la esprime a partire da sé: dalla sua storia e cultura, dalla situazione in cui vive, ecc. Ciò non significa che la verità sia variabile e soggettiva, tutt’altro. Ma significa che essa si dà a noi sempre e solo come un cammino e una vita. Non ha detto forse Gesù stesso: «Io sono la via, la verità, la vita»? In altri termini, la verità essendo in definitiva tutt’uno con l’amore, richiede l’umiltà e l’apertura per essere cercata, accolta ed espressa”.
La verità, quindi, chiede umiltà e apertura e qui non possiamo non riconoscere la eco di quel “cuore docile, che sappia rendere giustizia al suo popolo e sappia distinguere il bene dal male” che chiede Salomone a Dio e che il papa emerito ha additato a modello per i politici di qualsiasi credo.
* Fonte: Il Sussidiario.net, 31.01.2014
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- COSTITUZIONE, CORTE COSTITUZIONALE, E CONTI PUBBLICI ("FISCAL COMPACT").10 novembre 2019, di Federico La Sala
COSTITUZIONE, CORTE COSTITUZIONALE, E CONTI PUBBLICI ("FISCAL COMPACT"): DEUS CARITAS EST ... *
- C’è un fatto contraddittorio ed emblematico, però, che tanti non sanno o non ricordano. Il disegno di legge per l’introduzione del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale - che, malgrado l’“avvertimento” contenuto nella (sempre dimenticata) sentenza numero 275/2016 della Consulta, ha subordinato i diritti fondamentali, tra cui quello alla salute, alla disumanità dei conti pubblici - fu intanto d’iniziativa dei deputati dell’Idv Cambursano, Donadi, Borghesi, Cimadoro, Di Giuseppe, Di Stanislao, Messina, Mura, Paladini, Palagiano, Palomba e Piffari. E va rammentato che all’epoca, a mia memoria, soltanto il giurista Giuseppe Guarino, più volte ministro, tuonò contro il Fiscal compact, che costituì la base di quell’operazione disastrosa, bollandolo come «illegale» (Cfr. E. Morrone, Sul dogma dell’infallibilità della magistratura, cit.)
Sul dogma dell’infallibilità della magistratura
Al di là della solita sfida giustizialismo contro garantismo
Rieccoci, spunta il complotto universale ogni volta che si parla di Why not e De Magistris in termini articolati, obiettivi e con lo sguardo al rapporto inquieto tra politica e magistrati, anche non più in servizio.
di Emiliano Morrone ("il coraggio della verità" - 10.11.2019)
Lo confermano reazioni scomposte a un mio articolo apparso di recente su Iacchitè, piene di congetture - non nuove - sul mio conto, spinte sino al sospetto di interessi personali dietro le mie scuse a Tonino Saladino, arrivate a 12 anni dal suo coinvolgimento in Why not, capitolo che la giustizia ha chiuso con una pronuncia della Cassazione che rimanda al verdetto del primo grado, per cui «il fatto non sussiste». Di fronte a questa formula possono sussistere ancora dubbi e “correttivi epistemologici”? È lecita la dietrologia permanente sulla non colpevolezza - Leonardo Sciascia avrebbe detto «in senso proprio tecnico» - di Agazio Loiero e degli altri ex accusati? Ed è corretto sostenere a oltranza il dogma dell’infallibilità dei magistrati, senza distinzione alcuna sull’operato dei singoli e senza un sussulto interiore se fra di loro c’è per giunta chi ha cenato con propri indagati?
Tra i commenti contro quella mia riflessione su Iacchitè ne ho letti di suggestivi; in uno vengo perfino accostato al governatore della Regione Calabria, Mario Oliverio, come suo vecchio amico per la comune provenienza da San Giovanni in Fiore. Collegarmi a Oliverio è come ritenere Sacchi e Trapattoni apparentati dallo schema a zona.
Tangentopoli fu in Italia uno spartiacque: segnò l’inizio della delegittimazione della classe politica nel suo complesso: tutta sporca, tutta marcia, tutta castale, con la conseguenza di trasformare il motto di Heidegger, «ormai solo un dio può salvarci», in «ormai solo un Monti, solo un Draghi può salvarci». La morte della politica risale al ’92, l’anno di Maastricht. Ora abbiamo i rubinetti chiusi, i parlamenti ratificanti e i bilanci vincolati assieme ai leader del momento, a obsolescenza programmata come tv, cellulari e lavatrici.
Allora galoppò la spettacolarizzazione mediatica di Tangentopoli, in nome dell’audience e dunque della pubblicità commerciale. Perciò si radicò e diffuse l’idea della magistratura come potere buono, sano, giusto, provvidenziale, l’unico affidabile cui letteralmente votarsi e abbandonarsi. Dominò il pensiero che davanti alle connivenze e complicità politiche generali le Procure esercitassero una funzione suppletiva, di intervento e di bonifica delle sale di comando. Poi questo pensiero si consolidò: nacque il partito dei magistrati capitanato da Antonio Di Pietro e concentrato sulle denunce, spesso fondate, di abusi, violazioni, trattative di potere per il potere. L’Italia dei Valori diventò il riferimento politico dei movimenti per la verità sulle stragi degli anni ’90, sugli omicidi di mafia, sui silenzi permanenti dello Stato. Di Pietro, con cui lavorai fianco a fianco, era impeccabile: onnipresente, carismatico, attento, bersagliato dal mainstream, dall’intero arco parlamentare e addirittura colpito in “casa” propria. Penso, per esempio, alla sua (op)posizione nei confronti del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, da molti definita come estrema. E penso alla scelta dell’ex magistrato di piazzarsi a sinistra della sinistra, prima che Idv, perduta la partita del rovesciamento di Berlusconi tramite il “pentito” Fini, si squagliasse a stretto giro dal discusso servizio di Report sulle proprietà dello stesso Di Pietro.
C’è un fatto contraddittorio ed emblematico, però, che tanti non sanno o non ricordano. Il disegno di legge per l’introduzione del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale - che, malgrado l’“avvertimento” contenuto nella (sempre dimenticata) sentenza numero 275/2016 della Consulta, ha subordinato i diritti fondamentali, tra cui quello alla salute, alla disumanità dei conti pubblici - fu intanto d’iniziativa dei deputati dell’Idv Cambursano, Donadi, Borghesi, Cimadoro, Di Giuseppe, Di Stanislao, Messina, Mura, Paladini, Palagiano, Palomba e Piffari. E va rammentato che all’epoca, a mia memoria, soltanto il giurista Giuseppe Guarino, più volte ministro, tuonò contro il Fiscal compact, che costituì la base di quell’operazione disastrosa, bollandolo come «illegale».
Ora, questi pochi ma significativi elementi non sono sufficienti a farci rivedere l’assunto dell’insindacabilità assoluta della magistratura, generato e alimentato da un intero sistema che ha confinato il dissenso critico, la ricerca della verità oggettiva e storica e il ruolo precipuo della politica, la quale - per richiamare il filosofo Salvatore Natoli - ha da fare con il progetto per il bene comune e non con il mero governo della contingenza?
* Sul tema, nel sito, si cfr.:
- Nuovo ordine mondiale: "Dio è valore", "Dio è ricchezza" ("Deus caritas est"). Il teologo Ratzinger scrive da papa l’enciclica "Deus caritas est" (2006) e, ancora oggi, nessuno ne sollecita la correzione del titolo. Che lapsus!!! O, meglio, che progetto!!!
LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE.
ITALIA!!! TUTTI. MOLTI. POCHI: E NESSUNA COGNIZIONE DELL’UNO, DELL’UNITA’!!! L’Italia e le classi dirigenti senza senso nazionale. Uno dei problemi della storia italiana dell’ultimo secolo e mezzo è segnato da élites che non hanno saputo andare oltre gli interessi particolari.
Federico La Sala
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- IL "LETARGO" DI "VENTICINQUE SECOLI" DI DANTE, E NOI, OGGI.2 novembre 2019, di Federico La Sala
PIANETA TERRA: LA NAVE D’ARGO, IL LETARGO DI "VENTICINQUE SECOLI" DI DANTE, E NOI, OGGI .... *
La nave dei folli
di Pietro Barbetta *
Una gita a Clusone e una a Pinzolo non guastano. La danza macabra di Borlone de Buschis di Clusone (1485) e quella di Simone Baschenis di Pinzolo (1539) segnano forse l’inizio e la fine di un periodo di comunità inconfessabile (Blanchot, 1983). Inconfessabile perché composta di trapassati, che, in quanto tali, già sono passati in giudicato, ingiudicabili. In molti accomunano questa comunità a un’altra, che potrebbe essere anche la medesima, chissà. Si tratta della Stultifera Navis. -Cos’hanno in comune gli stolti e i morti? Il semplice fatto di non essere confessabili. Gli uni per il regno dei cieli, gli altri per la terra, sono inguaribili. Bosch e le illustrazioni a Brant di Dürer ne danno rappresentazione figurativa. Ecco una figura chiave, il centro del primo capitolo, della prima parte della Storia della follia di Foucault: Sebastian Brant (1458-1521). Vissuto tra l’opera del de Buschis e quella del Baschenis. Nel giugno 1984 Francesco Saba Sardi (1922-2012) ci regalò, in versi endecasillabi, la traduzione di Das Narrenschiff.
- [Foto] Borlone de Buschis di Clusone
Narrenschiff uscì per la prima volta nel 1494, due anni dopo la scoperta dell’America. Prima di Brant abbiamo alcune opere importanti sull’argomento a partire dal 1360. Si immagina una sorta di confraternita delle persone strambe - le sole che possano esservi ammesse. Corporazione non chiusa per via di censo, particolari privilegi o saperi occulti. Bisognava essere, per esempio, un vescovo che aveva ipotecato il reddito per comprare il titolo religioso, un alchimista che aveva sciolto nel crogiolo le sue ricchezze.
La follia è ingiudicabile altrettanto quanto la morte, inguaribile. Questa caratteristica segna una linea di confine comunitaria, la nave è uno dei suoi contenitori. A quel tempo - successivo alla lebbra e alla peste, coevo di una nuova malattia giunta dalle Americhe, la sifilide - i folli venivano allontanati dalle città, imbarcati su navi per essere abbandonati altrove, ma il navigatore spesso le gettava a mare o le sbarcava in qualche landa desolata, dove morivano. Molti annegavano. Non è difficile immaginarlo oggi che abbiamo sotto gli occhi le immagini di uomini e donne morti alla deriva delle coste italiane. Unica differenza: allora giungevano dove nessuno stava, oggi invece si torce il collo altrove.
Gran satira grottesca o poema moralista? L’opera di Sabstian Brant ci lascia ancora nel dubbio. Quando Foucault ci parla della Stultifera Navis, qualunque opera scritta o figurativa ci venga in mente, dà un senso a quell’insieme indistinto di uomini e donne che ci entravano. Foucault distingue questo ammasso indifferenziato dalla follia così come viene identificata a partire dal secolo XVIII. Dal Settecento la follia diventerà regno del dominio medico, verrà diagnosticata e sistematicamente curata.
La nave dei folli non è che l’inizio di un processo che vedrà successive partizioni, da Erasmo fino a Pinel; è un crogiolo umano, un pleroma. Per alcuni Brant si confronta con l’avvento del Nuovo Mondo. La nave dei folli richiama le navi che iniziano a salpare verso le Americhe, fino al Seicento con la Mayflower, carica di puritani. Nave che navigò la luna, secondo i versi di Paul Simon. Anche loro inconfessabili, in quanto protestanti, spirito del capitalismo.
- [Foto] Simone Baschenis di Pinzolo
Brant sarebbe il primo progressista dell’epoca moderna, sguardo disincantato verso il futuro imminente e immanente, fiducia nella città come luogo dell’innovazione e, per via dei commerci, luogo d’incontro multiculturale. La città è il centro dove ogni superstizione, credenza, invidia, odio saranno eliminati. Brant progressista. Invero sulla nave - destinata a Narragonia, che si dirige verso Cuccagna - non ci sono solo i folli contemporanei, bensì usurai, giocatori d’azzardo, adulteri, viziosi, prodighi, invidiosi, voluttuosi, ingrati, spergiuri, bestemmiatori. Tutta la follia premoderna raccolta dentro questa nave autorganizzata, autosufficiente, autopoietica. Brant moralista.
A voler ben guardare, la maggioranza del testo elenca, tra l’altro, la cupidigia, le nuove mode, il retto Catechismo, gli istigatori di discordia, le male costumanze, il dispregio delle Scritture, i galanti, la crapula e la gozzoviglia, le ciarle, i desideri superflui, gli studi inutili, le procrastinazioni, l’adulterio, la presunzione, la voluttà, l’ingratitudine, la bestemmia, l’usura.
- [Foto] Albrecht Dürer
Come scritto, Albrecht Dürer illustra l’opera di Brant e Bosch crea una sua opera, sempre nel 1494. Nel frattempo altre comunità inconfessabili si muovono per via terrena, gli Ebrei, cacciati da Spagna e Portogallo, i Valdesi perseguitati ed erranti tra le valli montane fino alla Riforma.
Quanto l’opera si adatti all’ultimo ventennio, quanto sia attuale, quanto si stia trasformando nella Nemesi, lo vediamo dal momento in cui l’Europa è essa stessa, oggi, una nave di folli. Ci si aspetta solo un grande evento naturale, il distacco dagli Urali.
- [Foto] Hieronymus Bosch
* Doppiozero, 27.02.2013 - ripresa parziale, senza immagini.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
DANTE, ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. Note per una riflessione storiografica
GIOACCHINO, DANTE, E LA "CASTA ITALIANA" DELLO "STATO HEGELIANO" - DELLO STATO MENTITORE, ATEO E DEVOTO ("Io che è Noi, Noi che è Io").
RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". Per la rinascita dell’EUROPA, e dell’ITALIA. La buona-esortazione del BRASILE. Una "memoria"
Federico La Sala
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---PER UN NUOVO PATTO EDUCATIVO. il Papa convoca a Roma per il 14 maggio 2020 personalità di tutto il mondo insieme ai giovani per una serie di iniziative.12 settembre 2019, di Federico La Sala
Messaggio.
Umanità più fraterna, il Papa invita i Grandi per un nuovo patto educativo *
L’appuntamento il 20 maggio nell’Aula Paolo VI per una "società più accogliente". L’annuncio della Congregazione per l’educazione cattolica. Francesco: dialoghiamo su come costruire il futuro
Il Papa convoca a Roma per il 14 maggio personalità di tutto il mondo insieme ai giovani per una serie di iniziative, dibattiti, tavole rotonde per una "società più accogliente". La Congregazione per l’Educazione Cattolica spiega il motivo di questo evento mondiale che si svolgerà in Vaticano nell’Aula Paolo VI: "Sono invitate a prendere parte all’iniziativa proposta le personalità più significative del mondo politico, culturale e religioso, ed in particolare i giovani ai quali appartiene il futuro. L’obiettivo è di suscitare una presa di coscienza e un’ondata di responsabilità per il bene comune dell’umanità, partendo dai giovani e raggiungendo tutti gli uomini di buona volontà".
"L’iniziativa - spiega ancora la Congregazione per l’Educazione Cattolica in una nota - è la risposta ad una richiesta. In occasione di incontri con alcune personalità di varie culture e appartenenze religiose è stata manifestata la precisa volontà di realizzare una iniziativa speciale con il Santo Padre, considerato una delle più influenti personalità a livello mondiale e, tra i temi più rilevanti, è stato da subito individuato quello del Patto educativo, richiamato più volte dal Papa nei suoi documenti e discorsi. Il quinto anniversario dell’enciclica Laudato sì, con il richiamo all’ecologia integrale e culturale, si offre come piattaforma ideale per tale evento".
In un messaggio il Pontefice rinnova "l’invito a dialogare sul modo in cui stiamo costruendo il futuro del pianeta e sulla necessità di investire i talenti di tutti, perché ogni cambiamento ha bisogno di un cammino educativo per far maturare una nuova solidarietà universale e una società più accogliente". Ricorda ancora Bergoglio che "in un percorso di ecologia integrale, viene messo al centro il valore proprio di ogni creatura, in relazione con le persone e con la realtà che la circonda, e si propone uno stile di vita che respinga la cultura dello scarto. Un altro passo è il coraggio di investire le migliori energie con creatività e responsabilità".
Sul tema, bel sito, si cfr.:
Cattolicesimo, fascismo, nazismo, stalinismo: il sogno del "regno di ‘dio’" in un solo ‘paese’ è finito.
- "AVREMMO BISOGNO DI DIECI FRANCESCO DI ASSISI". LA RIVOLUZIONE EVANGELICA, LA RIVOLUZIONE RUSSA, E L’ "AVVENIRE" DELL’UNIONE SOVIETICA E DELLA CHIESA CATTOLICA. Le ultime riflessioni di Lenin raccolte da Viktor Bede
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- Una nuova scommessa per la Chiesa di oggi (di Chiara Giaccardi e Mauro Magatti).25 agosto 2019, di Federico La Sala
Riflessione.
Una nuova scommessa per la Chiesa di oggi
di Chiara Giaccardi e Mauro Magatti (Avvenire, giovedì 22 agosto 2019)
- Duemila anni di storia, un miliardo e 300 milioni di fedeli in continua crescita nei paesi del Sud del mondo. Eppure la Chiesa cattolica appare invecchiata e impacciata, soprattutto in Europa dove per la maggior parte dei trentenni la «questione Dio» ha scarsa rilevanza, e gli scandali finanziari e sessuali hanno nuociuto alla sua reputazione. Partendo da questo stato delle cose Chiara Giaccardi e Mauro Magatti hanno scritto un saggio - La scommessa cattolica (il Mulino, pagine 200, euro 15, da oggi in libreria, dal quale anticipiamo alcuni stralci dell’introduzione). Quale scommessa? I due autori si chiedono - come recita il sottotitolo - se «c’è ancora un nesso tra il destino delle nostre società e le vicende del cristianesimo?». Che futuro per un mondo che recide completamente il dialogo con la religione?
Duemila anni di storia, un miliardo e trecento milioni di fedeli in continua crescita grazie alla spinta demografica dei paesi del Sud del mondo. Da un certo punto di vista, la Chiesa cattolica gode di ottima salute. Eppure, dietro la facciata rassicurante dei numeri, si odono scricchiolii allarmanti che non possono essere sottovalutati. Crollo della partecipazione religiosa nelle società più avanzate; difficoltà particolarmente forti tra i giovani e i ceti più istruiti; sensibile riduzione delle vocazioni. Sintomi eloquenti, ai quali si aggiunge la perdita di reputazione causata dagli scandali finanziari e dagli abusi sessuali.
Lo spostamento del baricentro in aree economicamente, politicamente e socialmente più arretrate è dunque una buona notizia solo a metà. In quei paesi - dove il livello istituzionale è meno evoluto e il rapporto con le persone più diretto - la Chiesa gioca su un terreno che le è più congeniale. Ma il timore è che le cose siano destinate a cambiare rapidamente anche in quei contesti. Difficile immaginare un futuro se la Chiesa rinuncia a dialogare con la parte più avanzata del mondo.
Almeno in Europa la Chiesa si trova di fronte a uno snodo generazionale senza precedenti: nella popolazione che ha meno di 30 anni, coloro che non credono semplicemente perché si sentono del tutto indifferenti e apatici rispetto alla «questione Dio» (i cosiddetti nones) sono netta maggioranza. Come se la cosa non li riguardasse, come se non riuscissero neppure a cogliere il senso della domanda: credi tu? Di Dio sembra proprio non sentirsi la necessità.
Oggetto di un discorso ormai superato, residuo di tradizioni che sconfinano nella superstizione o bandiera di fondamentalismi che sfociano nella violenza: è questo il registro in cui la questione della fede viene oggi rubricata in Europa da buona parte della popolazione, specie giovanile. Quando la generazione di chi oggi ha 70 anni e più passerà, la Chiesa europea, già assottigliata, si ritroverà con un numero assai esiguo di fedeli. C’è una questione organizzativa: la struttura della Chiesa - burocratizzata e gerarchica - appare inadatta a stare al passo con un mondo diventato veloce e plurale. Manca la consapevolezza che non è più possibile parlare dell’esperienza religiosa oggi usando lo stesso discorso di quando la fede era un’evidenza sociale.
Occorrerebbero, piuttosto, parole in cammino, che cerchino di dare voce e forma al diffuso senso di precarietà. Parole capaci di trasmettere l’esperienza della fede dove, con Michel de Certeau, «la sola stabilità è spingere il pellegrinaggio più in là», alla ricerca di nuove vie di presenza e narrazione. Ma sembra difficile, quasi impossibile, trovarle. C’è ancora spazio per la «buona novella» cristiana nel mondo di oggi? Ci può essere ancora una domanda che non trova risposta in ciò che già c’è, o nelle promesse di un progresso della scienza, della tecnica, dell’economia nel quale si ripongono ormai tutte le speranze di salvezza?
Facciamo un passo indietro. Se il messaggio del Vangelo, la buona notizia dell’amore che salva e vince la morte, è arrivato fino a noi è perché ha saputo parlare al profondo del cuore degli uomini e delle donne lungo i venti secoli che ci hanno preceduti. Riuscendo così a ispirare il modo di pensare e di vivere di intere società. Questa forza che ha attraversato la storia si è fondata su almeno tre pilastri, che sono però oggi tutti soggetti a una profonda erosione, sotto la spinta di cambiamenti storico-culturali di enorme portata.
Il primo pilastro ha a che fare con lo spinosissimo nodo dell’onnipotenza. Prendendo le distanze dalle religioni che l’avevano preceduta - nelle quali la potenza del sacro si manifestava al di là di qualunque limite -, quella cristiana è sempre stata molto attenta a evitare di farsi schiacciare dall’onnipotenza di Dio. In questo modo, essa ha potuto garantire una scansione tra ordine religioso e ordine politico, aprendo una dialettica che nel corso della storia si è rivelata straordinariamente fruttuosa. È per il fatto impensabile di essere una religione in cui è Dio che si sacrifica per l’uomo - e non viceversa - che quella cristiana ha potuto essere grembo per l’affermazione della soggettività moderna. Persino Nietzsche ha riconosciuto che proprio «grazie al cristianesimo l’individuo acquistò un’importanza così grande, fu posto in modo così assoluto, che non lo si poté più sacrificare».
E tuttavia, come in altre epoche, anche oggi - dentro e fuori la Chiesa - questo «scandalo» evangelico fatica a trovare ascolto: come far capire all’uomo contemporaneo - affascinato dai miti dell’efficienza, della performance, della (onni) potenza tecnica o all’opposto attratto da una divinità a cui semplicemente sottomettersi - il significato liberatorio di un Dio che, con le parole di Hölderlin, «crea l’uomo come il mare la terra: ritirandosi»?
E che mostra la propria «potenza» incarnandosi in un bambino e facendosi appendere a una croce? Il secondo pilastro riguarda la salvezza personale, tema essenziale per ogni grande religione. Dio salva la vita di ciascuno. Nella storia del cristianesimo ci sono state, come è naturale, molte oscillazioni attorno a questo tema, in una continua tensione fra terra e cielo, corpo e anima. Con la modernità, come sappiamo, sul piano culturale il baricentro si è spostato dalla salvezza eterna al successo mondano, dalla cura dell’anima al benessere materiale. Di quale salvezza si può dunque parlare oggi, quando la tecnica arriva addirittura a immaginare di poter promettere l’«immortalità»? Il terzo pilastro tocca il tema della universalità.
La Chiesa ha sempre riconosciuto e coltivato la propria vocazione universale, consapevole della necessità di parlare a tutti. Condizione per essere chiesa, appunto, anziché setta, piccolo gruppo di duri e puri ripiegati su sé stessi e separati dal resto del mondo. Sappiamo che la relazione tra fede e ragione, ereditata dalla tradizione greca e latina, è stata di enorme importanza. Sin dall’inizio la Chiesa ha intuito che il proprio destino sarebbe stato legato a quello della ragione. Ma il problema è che nel corso degli ultimi secoli si sono modificati i termini stessi della questione. Da una parte, il restringimento alla sola dimensione strumentale (vero è ciò che è certo, e dunque ciò che funziona e realizza rapidamente le promesse) ha di molto diminuito la capacità della ragione di essere guida sicura all’agire umano. Diventata tecnica, l’ambito principio in cui la ragione sembra applicarsi è il problem solving e il suo obiettivo il superamento del limite, di ogni limite.
Così, ciò che oggi sembra unificare il mondo è il grande sistema tecno/economico che, con la sua neutralità etica e le sue pretese di controllo, vorrebbe rendere superflua la stessa questione religiosa. Ma è realistico un tale progetto? Dall’altra parte, se oggi, come dicono le stime dell’autorevole Pew Research Institute, su dieci abitanti della terra tre sono cristiani, cosa vuol dire pensarsi come «universali »? In un pianeta diventato piccolo, senza più terre da esplorare, ma dove le diverse tradizioni religiose - che pure si delocalizzano e si innestano un po’ dappertutto - hanno sedimenti ormai consolidati, come sviluppare il dialogo interreligioso?
Questione che a maggior ragione investe l’ecumenismo: quale ruolo il cattolicesimo romano può e deve giocare rispetto alle altre confessioni cristiane, numericamente più deboli ma custodi di ricchezze da rimettere in gioco, a vantaggio dei cattolici stessi e del mondo intero? In questa cornice, all’inizio del XXI secolo, la scommessa cattolica non è allora né quella di rincorrere qualcosa che starebbe davanti - la piena affermazione della modernità, con tutti i suoi successi - né di inseguire un sogno di restaurazione e rinnovata centralità - cullandosi nella nostalgia di un passato ormai perduto. Si tratta, piuttosto, di muovere i primi passi di una via nuova, recuperando la consapevolezza di avere qualcosa di inaudito da dire. Qualcosa che manca a questo tempo. Qualcosa di prezioso per il nostro futuro comune.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- L’ORA. QUASI UN MINIMO PROGRAMMA DI GOVERNO (UN DISCORSO QUESTA MATTINA IN PIAZZA, RIASSUNTO IN POCHE PAROLE).22 agosto 2019, di Federico La Sala
L’ORA. QUASI UN MINIMO PROGRAMMA DI GOVERNO (UN DISCORSO QUESTA MATTINA IN PIAZZA, RIASSUNTO IN POCHE PAROLE)
I. Finisca il tempo dell’odio
Finisca il tempo dell’odio e della follia
 non mangino piu’ carne umana i ministri della repubblica
non mangino piu’ carne umana i ministri della repubblicasiano soccorsi tutti i naufraghi
 siano liberati e portati in salvo tutti i prigionieri dei lager libici
siano liberati e portati in salvo tutti i prigionieri dei lager libici
 sia dato aiuto e asilo a chi fugge dalle guerre e dalla fame
sia dato aiuto e asilo a chi fugge dalle guerre e dalla fame
 sia dato aiuto e asilo a chi fugge da dittature e schiavitu’
sia dato aiuto e asilo a chi fugge da dittature e schiavitu’torni l’Italia alla civilta’
 siano abrogate tutte le antileggi hitleriane
siano abrogate tutte le antileggi hitleriane
 sia ripristinato il dovere di soccorrere chi e’ in pericolo
sia ripristinato il dovere di soccorrere chi e’ in pericolo
 si condivida il pane tra sorelle e fratelli
si condivida il pane tra sorelle e fratelliogni essere umano ha diritto alla vita
 salvare le vite e’ il primo dovere
salvare le vite e’ il primo dovereII. Rinuncino a commettere ulteriori crimini
Rinuncino a commettere ulteriori crimini altri ebbri abominii
 i ministri gia’ decaduti
i ministri gia’ decadutiin questi pochi giorni d’interregno
 s’attengano finalmente al rispetto della Costituzione
s’attengano finalmente al rispetto della Costituzionegia’ tanti delitti hanno commesso per cui saranno giudicati in tribunale
 non aggiungano in guisa di colpo di coda finale altri orrori
non aggiungano in guisa di colpo di coda finale altri orrorisi ricordino almeno ora
 della loro umanita’
della loro umanita’
 dell’umanita’ di tutti gli esseri umani
dell’umanita’ di tutti gli esseri umaniogni essere umano ha diritto alla vita
 salvare le vite e’ il primo dovere
salvare le vite e’ il primo dovereIII. Con la forza della verita’
Con la forza della verita’ con la scelta della nonviolenza
 si riconquista il bene comune
si riconquista il bene comunecon la forza della verita’ con la scelta della nonviolenza
 l’umanita’ intera torna interamente umana
l’umanita’ intera torna interamente umanacon la forza della verita’ con la scelta della nonviolenza
 si abbattono i regimi totalitari
si abbattono i regimi totalitaricon la forza della verita’ con la scelta della nonviolenza
 si salvano tutte le vite
si salvano tutte le viteogni essere umano ha diritto alla vita
 salvare le vite e’ il primo dovere
salvare le vite e’ il primo dovereIV. Qui e adesso
Qui e adesso occorre che ogni persona di volonta’ buona
 insorga per salvare tutte le vite
insorga per salvare tutte le vitequi e adesso occorre che la repubblica
 torni ad essere una repubblica
torni ad essere una repubblicaqui e adesso valga finalmente
 la legge che salva tutte le vite
la legge che salva tutte le vitequi e adesso
 si riconoscano uguali io e tu
si riconoscano uguali io e tu
 si facciano noi
si facciano noi
 vale per tutti dinanzi a ogni ingiustizia
vale per tutti dinanzi a ogni ingiustizia
 il motto del resistente je me revolte donc nous sommes
il motto del resistente je me revolte donc nous sommesogni essere umano ha diritto alla vita
 salvare le vite e’ il primo dovere
salvare le vite e’ il primo dovereV. E quasi un minimo programma di governo
1. abrogare immediatamente tutte le misure razziste e persecutorie imposte dal governo razzista teste’ caduto (ma anche le altre imposte dai governi precedenti che hanno aperto la strada all’inabissamento nella brutalita’ di quest’ultimo anno);
 2. ripristinare l’adempimento del dovere di soccorrere chi e’ in pericolo;
2. ripristinare l’adempimento del dovere di soccorrere chi e’ in pericolo;
 3. escludere da ogni incarico di governo chi e’ stato complice dell’esecutivo razzista ora caduto;
3. escludere da ogni incarico di governo chi e’ stato complice dell’esecutivo razzista ora caduto;
 4. ripristinare la legalita’ costituzionale che il governo della disumanita’ ha infranto;
4. ripristinare la legalita’ costituzionale che il governo della disumanita’ ha infranto;
 5. riconoscere il diritto di voto e tutti gli altri diritti sociali, civili e politici a tutte le persone che vivono in Italia, facendo cessare l’effettuale regime di apartheid e di schiavitu’ di cui sono vittima milioni di nostri effettivi conterranei.
5. riconoscere il diritto di voto e tutti gli altri diritti sociali, civili e politici a tutte le persone che vivono in Italia, facendo cessare l’effettuale regime di apartheid e di schiavitu’ di cui sono vittima milioni di nostri effettivi conterranei.Ogni essere umano ha diritto alla vita alla dignita’ alla solidarieta’
 siamo una sola umanita’ in quest’unico mondo vivente casa comune dell’umanita’ intera
siamo una sola umanita’ in quest’unico mondo vivente casa comune dell’umanita’ intera
 il razzismo e’ un crimine contro l’umanita’
il razzismo e’ un crimine contro l’umanita’
 ogni vittima ha il volto di Abele
ogni vittima ha il volto di Abele
 salvare le vite e’ il primo dovere
salvare le vite e’ il primo doveresalvare le vite e’ il primo dovere
 chi salva una vita salva il mondo
chi salva una vita salva il mondo
 sii tu il buon samaritano
sii tu il buon samaritano
 sii tu l’umanita’ come dovrebbe essere
sii tu l’umanita’ come dovrebbe essereogni essere umano ha diritto alla vita
 salvare le vite e’ il primo dovere
salvare le vite e’ il primo dovere* FONTE: "LA NONVIOLENZA CONTRO IL RAZZISMO. Supplemento de "La nonviolenza e’ in cammino" (anno XX). Numero 303 del 22 agosto 2019.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- ’Interessi di parte compromettono interesse Italia’. Il premier Conte si è dimesso.21 agosto 2019, di Federico La Sala
Conte si è dimesso, furia contro Salvini: "Irresponsabile". Al via le consultazioni
Il premier a palazzo Madama: ’Interessi di parte compromettono interesse Italia’.
di Redazione Ansa (21.08.2019)*
"L’azione del governo si arresta qui". E’ quasi a metà del suo intervento nell’aula di palazzo Madama che ieri il premier Giuseppe Conte ha messo la parola fine ai 14 mesi di governo gialloverde aprendo ufficialmente la crisi, con le dimissioni rassegnate al presidente Mattarella che ha avviato le consultazioni a partire dalle 16. Un intervento in cui il presidente del Consiglio difende quanto fatto - "abbiamo lavorato fino all’ultimo giorno" -, ricorda ancora il lavoro da fare, ma soprattutto ne approfitta per lanciare un duro affondo contro Matteo Salvini. Il premier è una furia e non usa giri di parole nel bollare Salvini come "irresponsabile" per aver aperto una crisi solo per "interessi personali e di partito". Un crescendo di accuse che arriva dopo mesi passati a dosare e mediare ogni parola.
Conte ora è senza filtri. Ripercorre i mesi del governo elencando tutti i problemi creati dal leader della Lega, ultimo appunto la decisione di aprire una crisi con il rischio, ricorda Conte, che senza un nuovo esecutivo il Paese andrà in esercizio provvisorio e ci sarà l’aumento dell’Iva: "I comportamenti del ministro dell’Interno rivelano scarsa sensibilità istituzionale e una grave carenza di cultura costituzionale". Il capo del governo che in diverse occasioni si rivolge a Salvini chiamandolo Matteo (Conte è seduto in mezzo ai due vicepremier) lo accusa di aver oscurato quanto fatto dall’esecutivo: "hai macchiato 14 mesi di attività mettendo in dubbio anche quanto fatto dai tuoi ministri". Ma ad un certo punto, il capo del governo arriva a definirsi "preoccupato" da chi "invoca piazze e pieni poteri". L’affondo non si ferma solo alla decisione di mettere fine all’esperienza gialloverde ma tocca anche dossier delicati come il Russiagate.
- Conte: "Al Colle per dimissioni"
Conte gli imputa di non essere andato in Aula e di aver creato problemi allo stesso presidente del Consiglio. Il capo del governo non tiene fuori nulla dal suo intervento nemmeno il ricorso che Salvini all’uso di simboli religiosi. Si tratta per Conte di "uso incosciente di simboli religiosi".
- Salvini bacia il rosario in aula mentre Conte parla
L’INTERVENTO DI SALVINI - "Grazie e finalmente: rifarei tutto quello che ho fatto", ha detto il vicepremier, Matteo Salvini, intervenendo nell’Aula del Senato. "Non ho paura del giudizio degli italiani". Sono qua "con la grande forza di essere un uomo libero, quindi vuol dire che non ho paura del giudizio degli italiani, in questa aula ci sono donne e uomini liberi e donne e uomini un po’ meno liberi. Chi ha paura del giudizio del popolo italiano non è una donna o un uomo libero". "Se qualcuno da settimane, se non da mesi, pensava a un cambio di alleanza, molliamo quei rompipalle della Lega e ingoiamo il Pd, non aveva che da dirlo. Noi non abbiamo paura", ha detto ancora Salvini.
"La libertà non consiste nell’avere il padrone giusto ma nel non avere nessun padrone", ha detto Matteo Salvini citando Cicerone. "Non voglio una Italia schiava di nessuno, non voglio catene, non la catena lunga. Siamo il Paese più bello e potenzialmente più ricco del mondo e sono stufo che ogni decisione debba dipendere dalla firma di qualche funzionario eruopeo, siamo o non siamo liberi?". "Gli italiani non votano in base a un rosario, ma con la testa e con il cuore. La protezione del cuore immacolato di Maria per l’Italia la chiedo finchè campo, non me ne vergogno, anzi sono ultimo e umile testimone". "Voi citate Saviano, noi San Giovanni Paolo II.., lui diceva e scriveva che la fiducia non si ottiene con la sole dichiarazioni o con la forza ma con gesti e fatti concreti se volete completare le riforme noi ci siamo. Se volete governare con Renzi auguri...".
L’INTERVENTO DI RENZI - "Sarebbe facile assistere allo spettacolo sorridendo ma la situazione impone un surplus di responsabilità. Lei oggi presidente del consiglio si dimette ed il governo che lei ha definito populista ha fallito e tutta l’Ue ci dice che l’esperimento populista funziona in campagna elettorale ma meno bene quando si tratta di governare". "No si è mai votato in autunno, c’è da evitare l’aumento dell’Iva e serve un governo non perchè noi ci vogliamo tornare ma perchè l’aumento dell’Iva porta crisi dei consumi non è un colpo di Stato cambiare il governo ma un colpo di sole aprire la crisi ora ora, questo è il Parlamento non il Papeete". Le parole di Conte sono "da apprezzare" ma c’è il "rischio di una autoassoluzione", ha detto in una nota il Segretario del Pd Nicola Zingaretti. Per questo "qualsiasi nuova fase politica non può non partire dal riconoscimento di questi limiti strutturali di quanto avvenuto in questi mesi".
- Governo, Salvini: "Adesso mi spiego i tanti ’no’"
* http://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2019/08/20/governo-in-senato-e-il-giorno-di-conte_57d1a36a-11ff-48b7-ba74-d2380fb14a93.html (ripresa parziale - sena immagini e allegati).
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. -- A un’Europa vecchia e sterile serve il fertilizzante della Chiesa. Intervista a Massimo Cacciari (di andrea Monda).19 luglio 2019, di Federico La Sala
Intervista a Massimo Cacciari
A un’Europa vecchia e sterile serve il fertilizzante della Chiesa
· La crisi della società italiana e il ruolo della Chiesa ·
di Andrea Monda (L’Osservatore Romano, 18 luglio 2019)
Il cambiamento d’epoca di cui parla Papa Francesco è tale che ha colto impreparato l’Occidente. Da qui parte la riflessione di Massimo Cacciari che riprende la suggestione di Giuseppe De Rita sulle due autorità, civile e spirituale, e si concentra sulla prima, quella «che fa acqua un po’ da tutte le parti». Lo abbiamo incontrato in un caldo pomeriggio di luglio, è arrivato a piedi e se n’è andato a piedi, una sorta di Giovanni Battista inquieto e sempre pronto ad accendersi di una santa ira che non risparmia nessuno.
Qual è l’elemento più preoccupante della crisi attuale?
Il problema è che la parte laica, civile, è proprio quella che fa acqua, per una complessa serie di cause. Le grandi culture che hanno formato l’Europa del dopoguerra e che hanno dato consistenza alla politica italiana si sono mostrate inapte a comprendere e a dar forma alla nuova età. Sono cose che succedono nella storia, quando un mondo finisce. Il mondo del dopoguerra si è chiuso con la caduta del muro, con la fine dell’impero socialista, con le trasformazioni globali negli equilibri economici e politici, la nascita della nuova Cina e il decollo indiano. Siamo di fronte a una nuova età, come quella che segna la fine delle polis greche, come quella che segna la fine dell’età dell’impero romano. Barbari che compaiono, gente di cui non capisci la lingua, e le grandi famiglie culturali e politiche europee, che sono sostanzialmente quella socialdemocratica, quella cristiano-popolare e quella liberale, non comprendono la situazione, rimangono abbarbicate inerzialmente a determinati valori e giudizi, che sono diventati pregiudizi, dato il mutare della situazione. Questo vale in particolare per le culture liberali e socialdemocratiche: i primi diventano dei puri conservatori, mentre la socialdemocrazia rimane aggrappata a un modello di stato sociale e di idea di uguaglianza che non può più reggere rispetto ai fenomeni di globalizzazione. È tutto da reimpostare, da rivedere, in particolare in Italia, dove accanto a questa trasformazione globale c’è anche la catastrofe specifica che passa sotto il nome di tangentopoli, che invece è il crollo anche di tenuta etica e morale dei partiti del patto antifascista.
Qui De Rita direbbe che la mia lettura è tutta politicistica (io credo cultural-politicistica): secondo me non sono mai le trasformazioni semplicemente economiche che possano motivare quello che è successo in questo paese e in Europa. Accade dunque che le componenti fondamentali che hanno dato vita all’Unione europea entrano in un cono d’ombra totalmente subalterno ai modelli neoliberisti; anche l’euro nasce in questo clima: il mercato, la libera concorrenza... non c’è più il pilastro della solidarietà, della sussidiarietà, punti fondamentali per la cultura di uno Sturzo, di un De Gasperi. Tutti questi pilastri vengono meno. Rimane l’affannosa rincorsa a quelle che si presume essere le nuove forme di potere. E quando con la crisi vengono meno le possibilità di promettere ancora ulteriormente «magnifiche sorti e progressive», queste forze si spappolano.
Lo scenario che sta illustrando non è dei migliori...
Lo so, ma nel mio discorso non c’è niente di nostalgico. Il problema non è il venir meno di determinati valori, ma il fatto che questa Europa è vecchia, forse decrepita, e non si può chiedere a un vecchio di non aver paura, di essere audace. La domanda allora è: c’è la stoffa per ritessere un discorso politico, per riformare una élite politica in Italia, in Europa? Perché questi nazionalismi, i sovranismi sono nient’altro che l’effetto del disgregarsi di queste precedenti culture, che non sono state al passo con la trasformazione. Sono il segno che l’Europa è vecchia, che non produce più, che è un terreno sterile; bisogna quindi trovare nuovi fertilizzanti. E penso, da non credente (ma è da qui che nasce la mia attenzione al mondo cattolico) che forse il fertilizzante può venire proprio dalla Chiesa: discutendo, dialogando, dibattendo, polemizzando... È il mondo cattolico che può essere il segno di contraddizione, che può rimettere in movimento qualcosa. Se non da lì, da dove può venire? Certo, frange socialdemocratiche possono anche tentare un discorso sui temi economici, sui temi sociali... ma è da lì che può venire la spinta maggiore.
Eppure oggi quel mondo cattolico sembra silente o, il che forse è peggio, diviso al suo interno...
Ha ragione. Un esempio molto banale, visto da fuori. Io ero convintissimo che l’agitazione del crocifisso, del rosario in un comizio sarebbe costata cara in termini di consenso. Pensavo che era impossibile che passasse inosservata la blasfemia di gesti simili e invece mi dicono i miei amici sondaggisti e analisti che il gesto ha fatto guadagnare consenso, proprio dal mondo cattolico. Qui c’è un problema colossale e mi riferisco al problema educativo, alla formazione della classe dirigente, un ambito che oggi appare sterile. Gli intellettuali non esercitano più alcuna influenza. Le università hanno sempre esercitato in Europa un’egemonia culturale, ma tutto questo oggi sembra finito. E si fa fatica a pensare un’Europa senza cristianità.
Secondo l’espressione del Papa, non è un’epoca di cambiamenti, ma un cambiamento d’epoca, che però ha trovato tutti impreparati.
Il modello è proprio quello del libro di Karl Polanyi, La grande trasformazione. Dove la trasformazione economica diventa trasformazione della testa della gente. Dobbiamo diventare consapevoli che abbiamo a che fare con un uomo diverso; il mutamento è culturale e antropologico, basta vedere i giovani, i ragazzi. Questo mutamento ha colto impreparate le culture che sono uscite dalla grande prova della guerra, che hanno avviato l’Unione europea e che hanno fatto le costituzioni, quelle costituzioni che avevano quel carattere tipicamente democratico, progressivo, come ad esempio la costituzione italiana. Il fatto è che sull’Europa ci sono stati e permangono molti equivoci. Ad esempio si cita il modello di Spinelli ma ho la sensazione che i tanti che lo citano non l’hanno mai letto. Quello era un modello totalmente neo-illuministico e sostanzialmente autoritario per cui è l’élite che fa l’Europa in barba alle diverse sovranità nazionali. Quindi quando parliamo di identità nazionale di cosa parliamo? Una identità liberale? Cosmopolita? Illuminista? Per come si sono sviluppate le vicende dell’Europa è evidente che si è perduto di vista l’elemento della sussidiarietà, che era fondamentale nel modello federalista autentico. In quel modello con la creazione dell’unione europea politica si superava, ma al tempo stesso si difendeva, l’identità nazionale, la si garantiva, dando peso politico al singolo stato membro, in un’unione che faceva la forza di ognuno. Non si è riuscito a spiegarlo, a comunicarlo in nessun modo. E ora è facile comunicare il messaggio opposto: Italy first e così via. Non si è riuscito a comunicarlo perché si è trasmessa sempre e costantemente l’impressione che l’obiettivo fosse il mero superamento dell’identità nazionale all’interno di un modello illuministico. Così come non si è compreso che la battaglia sull’Europa è decisiva per la cristianità. Si può certo dire “l’Europa vada come va, tanto noi, la Chiesa, siamo il mondo”. È giusto da una parte, dall’altra è sempre vero che urbs et orbis, la città e il mondo, come a dire che non può esserci un mondo senza centro, e qual è il centro? Washington? Pechino? Buenos Aires? Roma? Gerusalemme? Certo, il Mediterraneo, il centro è quello. Non si è ancora capito in nessun modo che il centro, bene o male, continua a essere questo. E invece assistiamo in Europa all’assenza e al fallimento totale di politiche mediterranee, perché non si ha questa visione storica, e agli errori tattico-politici che dipendono dall’incomprensione della dimensione di lungo periodo. Il Mediterraneo non era cruciale soltanto per evitare che diventasse il fossato, il muro che è diventato, ma lo era in quanto è esso stesso l’Europa che si gioca lì, in quelle acque che uniscono Atene e Gerusalemme con la prima e la seconda Roma.
La crisi assume i contorni di una mutazione antropologica. Penso all’impatto delle tecnologie, al grande innalzamento dell’età della vita e penso all’elemento che oggi sembra giocare un ruolo fondamentale anche a livello politico, quasi elettorale: la paura, che si trasforma in rancore.
Ritengo che la paura sia strettamente collegata all’invecchiamento. Organismi vecchi difficilmente affrontano le sfide con coraggio. Un organismo vecchio tende a difendersi, quando l’ambiente muta si chiude, questa è fisica. Questi fenomeni che avvertiamo ovunque in Europa derivano, secondo me, sostanzialmente da questo. Come nei secoli dell’Impero romano, mutatis mutandi, l’Europa ha bisogno di accogliere. Ma bisognava farlo per tempo. Perché era evidente che l’Europa avesse bisogno di sangue nuovo, e anche di intelligenza nuova, e che dovesse quindi affrontare questo meticciamento, come dice il cardinale Scola che lo aveva capito perfettamente e predicato in modo incessante. Ricordo quando era Patriarca a Venezia: non c’era manifestazione religiosa dove lui non ricordasse questo aspetto del meticciato. Per tempo era necessario che l’integrazione avvenisse attraverso politiche di cittadinanza, politiche economiche rivolte anche ai paesi da cui veniva questa gente, stringendo accordi commerciali, culturali, scambi con più paesi. Avremmo dovuto fare noi europei quello che in termini neocoloniali assoluti sta facendo la Cina. Questo è compito degli europei, come si fa a non capire? È lo stesso discorso del Mediterraneo di cui sopra: l’Europa è Euro-Africa. Qual è il tuo destino, Europa? A chi devi guardare se non ai due miliardi e mezzo che saranno tra un po’ gli africani, a chi altri devi guardare?
Se svolto per tempo e organizzato bene, quel lavoro politico di integrazione avrebbe dato vita a quel positivo meticciamento di cui parlava Scola. È certo che se non lo organizzi in alcun modo e improvvisamente, in base alla spinta delle guerre, dei cambiamenti climatici, della miseria, cominciano a precipitarti addosso enormi masse di rifugiati, esuli, poveretti, è chiaro che quei vecchi di cui sopra, soprattutto durante una crisi economica, diventano inevitabilmente la più facile preda di una propaganda di destra classica.
Hitler, che non c’entra niente con questo discorso, nel 1929, prima della crisi, prende il solo 2,8 per cento dei voti, e Stresemann e Briand, pochi giorni prima del crollo di Wall Street, s’incontrano, dicono ogni problema tra loro è risolto, che si metteranno d’accordo su tutto, fratelli per sempre, e che insieme Germania e Francia lavoreranno da domani per dar vita all’unione europea. Sei mesi dopo c’è la crisi e tre anni dopo c’è l’avvento di Hitler. Crisi non gestite, trasformazioni epocali non governate, possono produrre di tutto, come abbiamo visto quando sono crollati gli stati socialisti e c’è stata la guerra in Bosnia. Questa è la grande responsabilità che devono capire gli eredi di quelle culture, devono capirla, mettersi insieme e dire: cosa facciamo insieme?
Parliamo degli eredi di quella cultura che è quella cattolica, che lei, da laico, non credente, definisce un potenziale fertilizzante di una società vecchia.
La Chiesa è fondamentale, la forma politica della Chiesa ha dimostrato di essere quella forse più valida per affrontare problemi di questo genere. Però la domanda che io mi pongo sempre di più è: si capisce che la battaglia decisiva è qui in Europa?
Sono stato io a suggerire a monsignor Ravasi il motto episcopale quando fu ordinato: Praedica Verbum. Proprio come dovevano fare i professori di religione nelle scuole: evidenziare senza chiacchiere, senza spiegazioni. Semplicemente praedica Verbum, che però si rivela un segno di contraddizione, perché non sarai mai capace di seguire quel Verbo. Però - è questo è il punto - vedi che distanza c’è rispetto alla realtà. Misura la distanza, inquieta l’intelligenza dei tuoi interlocutori facendoli riflettere su questa distanza, senza tante chiacchiere, senza voler fare il maestro di nessuno. Questa parola indubitabilmente ha formato da due millenni l’Europa. Predicare il Verbo può avere, secondo me, effetti politici enormi ancora oggi come li ha avuti in passato.
Che cosa sono i movimenti di riforma se non tornare a quel breviloquio? Quel Verbo ha formato la testa della gente, proprio in momenti di crisi. Si tratta allora pascalianamente di scommettere di nuovo su questa forza.
- CONTINUAZIONE NEL POST SUCCESSIVO
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. -- A un’Europa vecchia e sterile serve il fertilizzante della Chiesa. Intervista a Massimo Cacciari (di andrea Monda).19 luglio 2019, di Federico La Sala
Intervista a Massimo Cacciari...
 di Andrea Monda (L’Osservatore Romano, 18 luglio 2019)
di Andrea Monda (L’Osservatore Romano, 18 luglio 2019)- CONTINUAZIONE E FINE
E i laici? Qual è il loro ruolo?
I laici devono riprendere un grande discorso di riforma dell’Unione, delle sue istituzioni con coraggio, con radicalità. Sono trent’anni che si insegue invece la moderazione, ma come vuoi risolvere moderatamente una situazione di grande trasformazione? Puoi essere benissimo un moderato, se si tratta di barcamenarsi, ma se affronti una tempesta devi abbandonare la moderazione. La Tempesta di Shakespeare si apre appunto con una tempesta per cui tutti i personaggi sono come annichiliti, ci sono pure i re, ma non contano niente adesso, il re non serve ora, ci vuole invece il nocchiere, ci vuole uno che governi nella tempesta: tu caro re non sei più sulla terraferma come prima. Questa è la sfida per i laici che devono provarsi per capire se sono in grado di governare nella tempesta. Allora potrebbero combinarsi, accordarsi con la dimensione spirituale. Se c’è una grande forza spirituale questo ha effetti civili, politici, sociali, ma ci vuole radicalità, in entrambi i campi, nel capire che qui in Europa si gioca una battaglia forse decisiva per la stessa cristianità.
Sul versante cattolico: da una parte c’è questo predicare il Verbo, anche in maniera molto essenziale, di Papa Francesco, dall’altra c’è quel dato preoccupante che lei prima citava, c’è qualcuno che sventola i simboli religiosi e accresce il suo consenso, magari incitando la folla a fischiare contro il Papa. Uno scollamento a dir poco inquietante.
Secondo me in questo momento difficile d’invecchiamento europeo, di crisi delle culture politiche di cui ho parlato, è stata coinvolta anche l’immagine della Chiesa, ridotta all’interno di un discorso di astratto cosmopolitismo: la Chiesa che s’interessa del mondo, s’interessa dei migranti, il Papa che va a Lampedusa... è stata data una lettura superficiale, complice anche il modo in cui il Papa è stato letto da laici e non credenti, in una chiave alla partito d’azione, alla Spinelli... Si è data questa immagine: un cosmopolitismo degli intellettuali.
Il che contrasta frontalmente con la realtà, se pensiamo, ad esempio, alla predicazione di Francesco che è il massimo della concretezza, della prossimità.
Sì, ma c’è stata questa lettura. E bisogna fare attenzione, perché appunto uno furbo come Salvini ha capito questo e si è inserito in questa situazione cercando in modo sottile di spaccare, mettendo i Papi uno contro l’altro, venerando per esempio la figura di Giovanni Paolo II, il Papa dell’identità cristiana, della lotta al comunismo....
L’identità è una parola che adesso è rispuntata fuori prepotentemente.
Questa è un’altra battaglia culturale formidabile da fare. Perché l’identità cristiana è l’identità che acquisisci facendoti prossimo, non esiste un’identità a sé. L’identità è pros eteron, per l’altro, la tua identità diviene nella misura in cui ti fai altro, diviene nella misura in cui ti approssimi, ti fai prossimo all’altro. Questo è fondamentale, non si tratta di un’identità astratta. Un’identità “suolo e sangue” semmai è quella del polites greco, l’identità cristiana non ha niente a che vedere con questo. Questa è una battaglia culturale grande, complessa e urgente. Potrebbe aiutare il recupero di un’etica classica di un certo tipo per questa battaglia da condurre insieme laici e cattolici. Sfida difficilissima in una condizione in cui l’Europa è in una situazione di estrema debolezza economica e demografica. Ci vorrebbe davvero una grande iniziativa, credibile sul piano delle riforme da attuare, delle riforme da svolgere, sul piano anche del ceto politico, della classe dirigente che la porta avanti, perché anche quello ha la sua importanza. L’autorevolezza del ceto politico è un elemento importante nell’azione politica e invece oggi è ai minimi storici.
Il suo libro su Maria, «Generare Dio», mi è venuto in mente perché prima parlava dell’Europa decrepita, che ha bisogno di un fertilizzante, che è in crisi di generatività.
In crisi come tutto l’Occidente che ha avuto il suo grande boom dalla metà del Settecento alla prima guerra mondiale, un grande boom demografico, e poi questo boom demografico si è spostato in Asia e Africa. Dipende da vari fattori, ma certo è un segno caratteristico del declino di un paese, di una stirpe. In questo contesto il tema di Maria è importantissimo, se s’intende in questa chiave. C’è stato un modo del tutto sbagliato con cui si sono affrontati in questi anni temi di questo genere come famiglia e procreazione. Con una posizione da parte della Chiesa non di attacco, ma di difesa. Errore devastante.
 Penso al tema della dignità della donna: io nel libro dico che quando la donna genera, genera Dio. E invece si è scelta la linea della difesa su vecchie frontiere riguardanti i diritti della donna, il diritto di famiglia... Il risultato è che oggi in regioni cattoliche come il Veneto nessuno più segue quello che gli dice Santa Romana Chiesa. Una forza politica può dare un’immagine di sé conservatrice, ma se la dà la Chiesa è spacciata. Alla riforma devi rispondere con la tua riforma, alla crisi rispondi con i santi, rispondi con San Francesco, con Sant’Ignazio, non puoi rispondere difendendo etiche e basta. L’idea di Maria per me è fondamentale, è l’idea di una donna che consapevolmente, liberamente, accoglie, malgrado il dubbio, malgrado il dolore, malgrado la sofferenza, accoglie e segue fino alla Croce.
Penso al tema della dignità della donna: io nel libro dico che quando la donna genera, genera Dio. E invece si è scelta la linea della difesa su vecchie frontiere riguardanti i diritti della donna, il diritto di famiglia... Il risultato è che oggi in regioni cattoliche come il Veneto nessuno più segue quello che gli dice Santa Romana Chiesa. Una forza politica può dare un’immagine di sé conservatrice, ma se la dà la Chiesa è spacciata. Alla riforma devi rispondere con la tua riforma, alla crisi rispondi con i santi, rispondi con San Francesco, con Sant’Ignazio, non puoi rispondere difendendo etiche e basta. L’idea di Maria per me è fondamentale, è l’idea di una donna che consapevolmente, liberamente, accoglie, malgrado il dubbio, malgrado il dolore, malgrado la sofferenza, accoglie e segue fino alla Croce.Ritorno sul tema del rancore, da dove nasce questo risentimento?
Ci sono dei vizi nella nostra natura. Il realismo cristiano ce lo dice, chiamalo peccato originale, chiamalo come vuoi, ma la nostra natura è prigioniera. Ed ecco allora gli animali danteschi, i vizi capitali che oggi vengono esaltati in un sistema individualistico, penso all’invidia, all’avarizia. L’invidia è l’opposto della prossimità. Il cristiano dice di farsi prossimo, l’individualismo dice “io invidio”, sono due posizioni inconciliabili, drammaticamente contrapposte. L’avarizia, pleonexia dicevano i classici, è volere avere di più, tenere il mio e avere di più. Il risentimento allora può diventare odio, perché se io ho e voglio avere di più, se comincio ad avere di meno, c’è l’invidia, e l’invidia può diventare odio. Una dinamica opposta alla dinamica che i cristiani indicano nel termine caritas e che Aristotele diceva giustizia, dikaiosyne: il giusto non è soltanto colui che dà a ciascuno il suo, ma che vuole il bene dell’altro. Quindi già per Aristotele la giustizia è un atteggiamento per l’altro, pros eteron. Sono temi che poi la Chiesa eticamente recupera: San Tommaso quando parla di etica recupera questi elementi propri, che poi, nell’itinerario in Deum, vengono tutti valorizzati ancora di più, esaltati ancora di più e trasposti su un piano ancora più alto. Ora di nuovo siamo lì, siamo forse nella fase estrema del sistema individualistico. Sono venuti meno quegli organismi, quelle organizzazioni, quelle forme che metabolizzavano queste dinamiche proprie dell’individualismo. I partiti politici facevano una cosa di questo genere, le assumevano e le trasformavano, le metabolizzavano, le accordavano, e facevano venire fuori una specie di sintesi, ognuno per la sua parte sociale. La crisi dei partiti politici ha provocato anche questo. Nessuno dei partiti, anche l’unico che c’è che è la Lega, compie più questo lavoro, assolutamente. Mette insieme, fa un mucchio di tutte le istanze degli individui e le mette lì ma senza mediazione, senza sintesi. L’attuale governo è esemplare da questo punto di vista: ce n’è per tutti, meno tasse per chi vuole meno tasse, il reddito di cittadinanza per chi vuole il reddito di cittadinanza...
I partiti politici come i corpi intermedi sono entrati in crisi, anche perché, bisogna riconoscerlo, si sono “dimissionati”. Se i corpi intermedi per anni e anni sono andati avanti facendo clienti, non possono più avere credibilità.
La tecnologia come contribuisce a questo cambiamento d’epoca?
È chiaro che è fondamentale. Di per sé non è niente di nuovo, perché dalla rivoluzione industriale e ancora prima, scienza e tecnica sono elementi strettamente connessi. Ma ci sono grandi trasformazioni con dei veri “salti”, come quello dell’Ottocento. E così oggi assistiamo a un grande salto tecnologico, che però oggi può intervenire nella vita, nel determinarne le forme. La vita, questo è il punto. Secondo me, il tratto più spaventoso, più tremendo, più terribile proprio nel senso greco di meraviglioso e tremendo, cioè stupefacente, è che questo individuo è tutto fuorché l’individuo nascosto, è tutto esposto, tutto sulla scena, tutto a disposizione, tutto calcolabile; non è il singolo, è esattamente l’opposto del “singolo” di Kierkegaard. No, questo è proprio l’individuo, è un numero, ma sul palco, sulla scena. Esposto. È l’oscenità di quest’epoca, e sarà sempre peggio; con i big data che ci possono essere adesso tu individuo sei perfettamente quello che risulti in base a quello che acquisti: i libri che acquisti, i vestiti che acquisti, le telefonate che fai, i treni che prendi, quante volte usi il bancomat. Tutto questo è totalmente schedato, il data è la combinazione di tutte queste informazioni dalle quali viene fuori come risultato chi sei tu. E un domani potrebbe accadere benissimo che tu vai a chiedere lavoro a qualcuno: “il nome scusi? Vediamo, ah lei è questo”. Vede dove siamo arrivati? A una inquietante forma di uguaglianza, ciò che alcuni teorici della democrazia temevano, che l’uguaglianza potesse portare a questo, non a caso ci avevano aggiunto la fratellanza.
Che però è stata la grande dimenticata, a favore di libertà e uguaglianza.
Anche perché, come ricordava un vero grande sociologo e filosofo come Georg Simmel, libertà e uguaglianza per conto loro sono in assoluto opposizione e contrasto, sono la contraddizione logica, perché se sono libero non sono uguale a te. Quindi libertà e uguaglianza di per sé fanno l’individuo, ognuno libero contro l’altro. E dunque ci vuole la fratellanza. Come si produce questa fratellanza, questa amicizia? Come si produce? Chi la produce? E allora, di nuovo, organismi, corpi intermedi, partiti, sindacati, da “sin-ducere”, mettere insieme. Ci abbiamo provato in passato e in parte ci siamo riusciti. Ma ora se tutto questo si spappola non c’è niente da fare, ci sono i big data, c’è chi ne dispone, e a sua disposizione sono anche gli individui.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. -- LA COSTITUZIONE DOGMATICA DELL’IMPERO SU CUI NON TRAMONTA MAI IL SOLE.21 giugno 2019, di Federico La Sala
IL PRIMOGENITO TRA MOLTI FRATELLI E LA COSTITUZIONE DOGMATICA DELL’IMPERO SU CUI NON TRAMONTA MAI IL SOLE...*
1. La gioia della verità (Veritatis gaudium) esprime il desiderio struggente che rende inquieto il cuore di ogni uomo fin quando non incontra, non abita e non condivide con tutti la Luce di Dio[1]. La verità, infatti, non è un’idea astratta, ma è Gesù, il Verbo di Dio in cui è la Vita che è la Luce degli uomini (cfr. Gv 1,4), il Figlio di Dio che è insieme il Figlio dell’uomo. Egli soltanto, «rivelando il mistero del Padre e del suo amore, rivela l’uomo all’uomo e gli fa nota la sua altissima vocazione»[2].
Nell’incontro con Lui, il Vivente (cfr Ap 1,18) e il Primogenito tra molti fratelli (cfr Rm 8,29), il cuore dell’uomo sperimenta già sin d’ora, nel chiaroscuro della storia, la luce e la festa senza più tramonto dell’unione con Dio e dell’unità coi fratelli e le sorelle nella casa comune del creato di cui godrà senza fine nella piena comunione con Dio. Nella preghiera di Gesù al Padre: «perché tutti siano uno, come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi» (Gv 17,21) è racchiuso il segreto della gioia che Gesù ci vuole comunicare in pienezza (cfr 15,11) da parte del Padre col dono dello Spirito Santo: Spirito di verità e di amore, di libertà, di giustizia e di unità. [:::] "(Costituzione Apostolica «Veritatis gaudium» di Papa Francesco circa le Università e le Facoltà ecclesiastiche, 29.01.2018. Proemio)
*
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- Costituzione dogmatica della chiesa "cattolica"... e costituzione dell’Impero del Sol Levante. Un nota sul “disagio della civiltà”
L’EREDE: IL PESO DEI PADRI (ATEI E DEVOTI). UN’EREDITA’ ANCORA PENSATA ALL’OMBRA DELL’"UOMO SUPREMO" E DEL "MAGGIORASCATO".
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. -- L’ ITALIA, LE “ROBINSON-NATE”, E LA “POESIA” DEL PRESENTE.20 giugno 2019, di Federico La Sala
L’ ITALIA, LE “ROBINSON-NATE”, E LA “POESIA” DEL PRESENTE ... *
- “Oggi assistiamo a una sorta di crisi di intelligibilità, che in diverse diagnosi sembra avere a che fare con la fine di un mondo e delle sue pratiche, di una forma di vita leggibile: fine della società letteraria, fine della politica nella sua concezione novecentesca... (...) Che cosa sarebbe della poesia, e anche del suo rapporto critico con la società, se questo nostro tempo, come spesso diagnosticato, costituisse davvero l’epoca della sua fine, della fine del modo in cui ne abbiamo inteso il senso sino a ora? ” (Italo Testa, “Autorizzare la speranza. Poesia e futuro radicale” , "Le parole e le cose", 21 marzo 2019).
“OGGETTO: Per la nostra sana e robusta Costituzione.... ” (Mail, 2002): “[...] Tempo fa una ragazza, a cui da poco era morta la madre e altrettanto da poco cominciava ad affermarsi il partito denominato “Forza Italia”, discutendo con le sue amiche e i suoi amici, disse: “Prima potevo gridare “forza Italia” e ne ero felice. Ora non più, e non solo perché è morta mia madre e sono spesso triste. Non posso gridarlo più, perché quando sto per farlo la gola mi si stringe - la mia coscienza subito la blocca e ricaccia indietro tutto. Sono stata derubata: il mio grido per tutti gli italiani e per tutte le italiane è diventato il grido per un solo uomo e per un solo partito. No, non è possibile, non può essere. E’ una tragedia!”. Un signore poco distante, che aveva ascoltato le parole della ragazza, si fece più vicino al gruppo e disse alla ragazza: “Eh, sì, purtroppo siamo alla fine, hanno rubato l’anima, il nome della Nazionale e della Patria. E noi, cittadini e cittadine, abbiamo lasciato fare: non solo un vilipendio, ma un furto - il furto dell’anima di tutti e di tutte. Nessuno ha parlato, nessuno. Nemmeno la Magistratura!” (Si cfr. RESTITUITEMI IL MIO URLO! ... DALLA CINA UNA GRANDE LEZIONE!).
ITALIA, 2 GIUGNO 2019. A pag. 2 dell’inserto “ROBINSON” (n. 130) di “la Repubblica” del 1° Giugno 2019, in un testo con il titolo “Mia madre, il Re e la cosa di tutti “, e il sottotitolo “Il 2 giugno 1946 l’Italia scelse di non essere più una monarchia. Lessico familiare del Paese che puntò su se stesso”. L’autore - dopo aver premesso che “una persona sola che incarna lo Stato e incarna il popolo intero non può che essere, essere, simbolicamente, una persona «sacra»“, e chiarito che “è per definizione, per ruolo un signore al di sopra delle parti, non rappresenta una frazione, rappresenta l’intero. L’unità. La comunità. (...) la sua carica è elettiva. Non è un raggio divino, e nemmeno il raggio della Storia attraverso l’espediente dinastico, a fargli incarnare «la cosa di tutti»” (...) La repubblica è anti-assolutista anche in questo suo sapiente scegliere gli uomini che la incarnano a seconda dei sommovimenti della politica e della società (...) così si avvia alla conclusione: “Dunque si è repubblicani - o almeno lo sono io - se si ama e si accetta ciò che non è assoluto, NON SIMULA L’ETERNO, ACCETTA IL LIMITE, lo traduce in politica”.
E, INFINE, l’autore così CHIUDE: “Mi rimane da dire che quando Eugenio Scalfari fondò un giornale che si chiamava «la Repubblica» andavo all’università e subito pensai: che bel nome! Che nome giusto per un giornale! Ma come è possibile che a nessuno prima di lui, sia venuto in mente di chiamare così un pezzo di carta che si occupa soprattutto della «res publica», della cosa di tutti, e lo fa tutti i giorni? E’ al tempo stesso un nome umile e alto. Peggio per chi non se ne è accorto prima” (Michele Serra).
POESIA, COSTITUZIONE, E FUTURO RADICALE...: “Come certi capi indiani che si trovarono di fronte al fatto che, una volta entrati nelle riserve, non risultasse più comprensibile cosa fosse un atto coraggioso, quale attività potesse esemplificarlo, visto che le pratiche che sino ad allora avevano dato senso a tali attività erano venute meno - i bisonti scomparsi, le guerre con altre tribù proibite” (Italo Testa - sopra).
ITALIA: “ESAME DI MATURITA’ 2019”. - PER UN CONVEGNO E UNA RIFLESSIONE SUL CONCETTO DI UNITÀ E DI SOVRANITÀ (SOVRA-UNITÀ). Materiali sul tema .
Federico La Sala (20 giugno 2019)
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- CON DANTE (2021), VERSO IL "PARADISO TERRESTRE". Al di là della Trinità adamitica (edipica).13 giugno 2019, di Federico La Sala
VERSO IL "PARADISO TERRESTRE" (DANTE, 2021):
DALLA TRINITA’ DI ADAMO ED EVA ALLA TRINITA’ DI GIUSEPPE E MARIA. Al di là della Trintà edipica....*
Il Vangelo.Trinità, il mistero che abita dentro noi
di Ermes Ronchi (Avvenire, giovedì 13 giugno 2019)
- Santissima Trinità
- Anno C
- In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà».
Memoria emozionante della Trinità, dove il racconto di Dio diventa racconto dell’uomo. Dio non è in se stesso solitudine: esistere è coesistere, per Dio prima, e poi anche per l’essere umano. Vivere è convivere, nei cieli prima, e poi sulla terra. I dogmi allora fioriscono in un concentrato d’indicazioni vitali, di sapienza del vivere. Quando Gesù ha raccontato il mistero di Dio, ha scelto nomi di casa, di famiglia: abbà, padre... figlio, nomi che abbracciano, che si abbracciano. Spirito, ruhà, è un termine che avvolge e lega insieme ogni cosa come libero respiro di Dio, e mi assicura che ogni vita prende a respirare bene, allarga le sue ali, vive quando si sa accolta, presa in carico, abbracciata da altre vite. Abbà, Figlio e Spirito ci consegnano il segreto per ritornare pienamente umani: in principio a tutto c’è un legame, ed è un legame d’amore.
Allora capisco che il grande progetto della Genesi: «facciamo l’uomo a nostra immagine e somiglianza», significa «facciamolo a immagine della Trinità», a immagine di un legame d’amore, a somiglianza della comunione. La Trinità non è una dottrina esterna, è al di qua, è dentro, non al di là di me. Allora spirituale e reale coincidono, verità ed esistenza corrispondono. E questo mi regala un senso di armoniosa pace, di radice santa che unifica e fa respirare tutto ciò che vive.
In principio c’è la relazione (G. Bachelard). «Quando verrà lo Spirito di verità, vi guiderà... parlerà... dirà... prenderà... annunzierà». Gesù impiega tutti verbi al futuro, a indicare l’energia di una strada che si apre, orizzonti inesplorati, un trascinamento in avanti della storia. Vi guiderà alla verità tutta intera: la verità è in-finita, «interminati spazi» (Leopardi), l’interezza della vita. E allora su questo sterminato esercito umano di incompiuti, di fragili, di incompresi, di innamorati delusi, di licenziati all’improvviso, di migranti in fuga, di sognatori che siamo noi, di questa immensa carovana, incamminata verso la vita, fa parte Uno che ci guida e che conosce la strada. Conosce anche le ferite interiori, che esistono in tutti e per sempre, e insegna a costruirci sopra anziché a nasconderle, perché possono marcire o fiorire, seppellire la persona o spingerla in avanti.
La verità tutta intera di cui parla Gesù non consiste in concetti più precisi, ma in una sapienza del vivere custodita nell’umanità di Gesù, volto del Padre, respiro dello Spirito: una sapienza sulla nascita e sulla morte, sulla vita e sugli affetti, su me e sugli altri, sul dolore e sulla infinita pazienza di ricominciare, che ci viene consegnata come un presente, inciso di fessure, di feritoie di futuro.
 (Letture: Proverbi 8,22-31; Salmo 8; Romani 5,1-5; Giovanni 16,12-15)
(Letture: Proverbi 8,22-31; Salmo 8; Romani 5,1-5; Giovanni 16,12-15)
* SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
UOMINI E DONNE. LA NUOVA ALLEANZA di "Maria" e di "Giuseppe"!!! AL DI LA’ DELL’ "EDIPO", L’ "AMORE CONOSCITIVO". SULL’USCITA DALLO STATO DI MINORITA’, OGGI. In memoria di Kurt H. Wolff.
"NUOVA ALLEANZA"?!: A CONDIZIONE CHE ACCANTO A "MARIA" CI SIA "GIUSEPPE"!!!
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- MARGINI DELLA FILOSOFIA - E DELLA COSTITUZIONE! Tracce per una svolta antropologica.13 giugno 2019, di Federico La Sala
MARGINI della filosofia. Intervento libero. In memoria di Jacques Derrida...
Siccome orientarsi nell’infinito è un problema meta-fisico e costituzionale, e - dopo Kant e la sua "rivoluzione copernicana" - non sappiamo ancora distinguere "dewey"anamente tra "prima di Cristo" e "dopo Cristo", tra Tolomeo e Copernico, tra il tutto e la parte, tra antropologia e andrologia - e ginecologia, tra Italia e "Italia", tra Costituzione e Partito, tra forza Italia e "Forza Italia", mi è sembrato opportuno fornire un piccolo banale (comune!) elemento per uscire dal sonnambulismo e dalla confusione! Siamo o non siamo "Dopo Dewey" !? O no?!
P. S. - SUL TEMA, MI SIA CONSENTITO, SI CFR.:
FILOSOFIA. IL PENSIERO DELLA COSTITUZIONE E LA COSTITUZIONE DEL PENSIERO
 MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?!
MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?!Federico La Sala
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. -- UNA CORRENTE DI GRAZIA NELLA CHIESA. Santa Sede: nasce "Charis" per il Rinnovamento Carismatico Cattolico. Ce lo chiede il Papa (di Emanuela Campanile).7 giugno 2019, di Federico La Sala
Santa Sede: nasce Charis per il Rinnovamento Carismatico Cattolico
CHARIS in Vaticano. Il nostro sogno è fare comunione. Ce lo chiede il Papa
I responsabili del Rinnovamento Carismatico Cattolico si incontrano in Vaticano da oggi fino a sabato 8 giugno per pregare insieme in attesa dell’apertura ufficiale di Charis
di Emanuela Campanile (Vatican News, 06 giugno 2019)
Città del Vaticano Si sono dati appuntamento in Vaticano - Aula Paolo VI - e arrivano da tutto il mondo. Sono più di 550 e sono i responsabili del Rinnovamento Carismatico Cattolico. Vogliono pregare insieme e mettersi all’ascolto dello Spirito Santo in attesa dell’inizio ufficiale di Charis previsto proprio domenica 9 giugno: solennità di Pentecoste. Voluto espressamente da Papa Francesco, Charis (Catholic Charismatic Renewal International Service) segna una nuova tappa per il Rinnovamento Carismatico Cattolico come corrente di grazia nel cuore della Chiesa.
Il Charis
Si tratta di un servizio di comunione tra tutte le realtà del Rinnovamento Carismatico Cattolico che, nel mondo, conta attualmente più di 120 milioni di cattolici che vivono l’esperienza del battesimo nello Spirito in gruppi di preghiera, comunità, scuole di evangelizzazione, reti di comunicazioni e ministeri vari. Quando nella solennità di Pentecoste prenderà ufficialmente il via, l’Iccrs e il Catholic Fraternity cesseranno di esistere.
Rinnovamento come corrente di grazia
"Il nostro sogno è fare ciò che il Papa ci ha chiesto", spiega nell’intervista Jean-Luc Moens, il professore belga nominato moderatore di Charis. "Lui parla del Rinnovamento carismatico come di una corrente di grazia nella Chiesa, riprendendo l’espressione dal cardinale Suenens, il quale voleva sottolineare che il Rinnovamento Carismatico non è un movimento, perché - prosegue il professore - in un movimento c’è un’appartenenza; le persone sono o dentro o fuori. Dunque, c’è una separazione. Una corrente di grazia è un’altra cosa. Il cardinale faceva il paragone con la corrente del Golfo nell’Atlantico che riscalda tutto l’oceano e poi sparisce. Allora, forse posso dire qualcosa di abbastanza strano, ma - conclude - il nostro sogno è quello di sparire quando tutta la Chiesa avrà scoperto il battesimo nello Spirito Santo".
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- FILOSOFIA, SCIENZA, E STORIA: COSTITUZIONE E RICERCA SCIENTIFICA.7 giugno 2019, di Federico La Sala
FILOSOFIA, SCIENZA, E STORIA. PER UN NUOVO CNR ....
NOTE A MARGINE DELLA LETTERA "Al CNR la storia è una scienza? Una risposta all’intervento di Gilberto Corbellini"
- Recensendo un volume dell’epistemologo statunitense Alex Rosenberg, in un articolo dal titolo Questa storia è davvero molto falsa apparso sul supplemento domenicale del “Sole - 24 ore” il 12 maggio scorso, il professor Gilberto Corbellini ne ha preso spunto per asserire, in polemica con un recente appello in difesa dell’insegnamento della storia, l’assenza di scientificità e di utilità sociale della disciplina stessa. [...] (ALFABETA-2, 26 MAGGIO 2019)
1. PER LA STORIA DELLLA SCIENZA E PER LA SCIENZA DELLA STORIA, FORSE, E’ MEGLIO RI-DISCENDERE “SOTTO COVERTA DI ALCUN GRAN NAVILIO” E RIPRENDERE IL LAVORO GALILEANO DELLA CONVERSAZIONE E DELLA CONOSCENZA 29 Maggio 2019 :
- «Rinserratevi con qualche amico nella maggiore stanza che sia sotto coverta di alcun gran navilio, e quivi fate d’aver mosche, farfalle e simili animaletti volanti: siavi anco un gran vaso d’acqua, e dentrovi de’ pescetti; sospendasi anco in alto qualche secchiello, che a goccia a goccia vada versando dell’acqua in un altro vaso di angusta bocca che sia posto a basso; e stando ferma la nave, osservate diligentemente come quelli animaletti volanti con pari velocità vanno verso tutte le parti della stanza. (..)
 Osservate che avrete diligentemente tutte queste cose, benché niun dubbio ci sia mentre il vascello sta fermo non debbano succedere così: fate muovere la nave con quanta si voglia velocità; ché (pur di moto uniforme e non fluttuante in qua e in là) voi non riconoscerete una minima mutazione in tutti li nominati effetti; né da alcuno di quelli potrete comprendere se la nave cammina, o pure sta ferma.» (Galileo Galilei, “Dialogo sopra i due massimi sistemi tolemaico e copernicano”, 1632 - Salviati, giornata II)
Osservate che avrete diligentemente tutte queste cose, benché niun dubbio ci sia mentre il vascello sta fermo non debbano succedere così: fate muovere la nave con quanta si voglia velocità; ché (pur di moto uniforme e non fluttuante in qua e in là) voi non riconoscerete una minima mutazione in tutti li nominati effetti; né da alcuno di quelli potrete comprendere se la nave cammina, o pure sta ferma.» (Galileo Galilei, “Dialogo sopra i due massimi sistemi tolemaico e copernicano”, 1632 - Salviati, giornata II)
2. STORIA, SCIENZA, ED ECLISSI. Da Galileo Galilei ad Albert Einstein 30 maggio 2019...
Al di là delle pretese “mitideologiche” (atee e devote) del “post-positivismo” contemporaneo (Paolo Fabbri) di dare il via a un’ epoca in cui la storia del mondo dev’essere riscritta secondo l’indicazione rosenberghiana!), ricordiamo che il 29 maggio 1919 Arthur Eddington provò sperimentalmente la teoria della relatività (cfr. : Franco Gabici, “Cento anni fa l’eclissi che diede ragione a Einstein” - https://www.avvenire.it/agora/pagine/cento-anni-fa-leclissi-che-diede-ragione-a-einstein). Buon lavoro!
3. COSTITUZIONE E CNR. UN PROBLEMA STORIOGRAFICO (SCIENTIFICO) DI LUNGA DURATA 31 Maggio 2019...
CONDIVIDO LA PREOCCUPAZIONE E, AL CONTEMPO, LA CONSAPEVOLEZZA dei firmatari della lettera. La “provocazione” - da parte di chi dirige il Dipartimento del CNR, “al cui interno operano decine di storici, storici della filosofia, giuristi e altri ricercatori nel campo delle scienze umane e sociali” - evidenzia il sintomo non tanto e non solo “di un profondo problema culturale e scientifico”, ma anche e soprattutto di un problema politico-filosofico (metafisico), costituzionale, di CRITICA della “ragion pura” (di questo parla il “principio della relatività galileiana”, condensato nel “Rinserratevi” del “Dialogo sopra i due massimi sistemi tolemaico e copernicano”)!,
DOPO GALILEI, DOPO KANT, DOPO EINSTEIN, DOPO LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA... UNA “PROVOCAZIONE” al CNR DA ACCOGLIERE!
Strana “coincidenza”, oggi!:
- A) Il 9 Aprile 2019, in una nota (dal titolo
“CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. A che gioco giochiamo?!: https://www.alfabeta2.it/2019/03/31/marcel-detienne-memorie-felici-e-concetti-indelebili/#comment-639227), così scrivevo:
 “La totale incomprensione del “relazionismo” proposto da Karl Mannheim in “Ideologia e Utopia” (1929), esaminato e rigettato nel capitolo quarto dello “Spirito tedesco in pericolo”, impedisce a Curtius (e non solo!) di aprire gli occhi su stesso e sul mondo, di uscire dal relativismo-assolutismo dogmatico in cui naviga, e di smetterla di sognare il “sogno dei visionari” (sul tema, mi sia lecito, cfr.: “Heidegger, Kant, e la miseria della filosofia - oggi”: http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=4790)”.
“La totale incomprensione del “relazionismo” proposto da Karl Mannheim in “Ideologia e Utopia” (1929), esaminato e rigettato nel capitolo quarto dello “Spirito tedesco in pericolo”, impedisce a Curtius (e non solo!) di aprire gli occhi su stesso e sul mondo, di uscire dal relativismo-assolutismo dogmatico in cui naviga, e di smetterla di sognare il “sogno dei visionari” (sul tema, mi sia lecito, cfr.: “Heidegger, Kant, e la miseria della filosofia - oggi”: http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=4790)”.
- B) Il 12 maggio 2019, “recensendo un volume - come scrivono gli studiosi e le studiose del CNR - dell’epistemologo statunitense Alex Rosenberg, in un articolo dal titolo Questa storia è davvero molto falsa apparso sul supplemento domenicale del “Sole - 24 ore” il 12 maggio scorso, il professor Gilberto Corbellini ne ha preso spunto per asserire, in polemica con un recente appello in difesa dell’insegnamento della storia, l’assenza di scientificità e di utilità sociale della disciplina stessa”.
Prima che sia troppo tardi, che fare?! Alle studiose e alle studiose di scienze umane e sociali (del CNR e non solo), consiglierei (mi sia permesso) la ri-lettura del “Dialogo sopra i due massimi sistemi iolemaico e copernicano” di Galileo Galilei, la ri-lettura dei “Sogni di un visionario chiariti con i sogni della metafisica” di Immanuel Kant, e, infine, la rilettura dei “Principi” della Costituzione della Repubblica Italiana - e, alla luce della “ferocissima” provocazione, ri-prendere il lavoro storiografico-scientifico con più grande entusiamo e responsabilità di prima!
VIVA IL CNR,
VIVA L’ITALIA!
4. PER UN NUOVO CNR! ALL’INSEGNA DI ERMES: “IO VORREI PENSARE CON IL CERVELLO INTERO”. IN MEMORIA DI ENRICO FILIPPINI E DI MICHEL SERRES 3 Giugno 2019 ...
“[...] all’insegna di Ermes, che per me è il simbolo della scienza contemporanea”.
 In che senso? “Nel senso che Mercurio, a cui ho dedicato ben cinque libri, è il dio della comunicazione. A differenza di quanto pensavano i marxisti, io ritenevo che il problema della comunicazione fosse più importante di quello della produzione, e che l’ economia stessa fosse più una questione di comunicazione che di produzione. Sono fiero di quell’ assunto, mi scusi la superbia: infatti, i paesi che hanno scommesso in questo senso, per esempio il Giappone, hanno evitato la crisi”.
In che senso? “Nel senso che Mercurio, a cui ho dedicato ben cinque libri, è il dio della comunicazione. A differenza di quanto pensavano i marxisti, io ritenevo che il problema della comunicazione fosse più importante di quello della produzione, e che l’ economia stessa fosse più una questione di comunicazione che di produzione. Sono fiero di quell’ assunto, mi scusi la superbia: infatti, i paesi che hanno scommesso in questo senso, per esempio il Giappone, hanno evitato la crisi”.
 Ma comunicazione che vuol dire? “All’ inizio, all’ epoca dello strutturalismo, davo del termine “struttura” un’ interpretazione algebrica, esatta. Poi, studiando il XIX secolo, la fisica ottocentesca, e cioè essenzialmente la termodinamica, finii per attribuire un ruolo centrale alla teoria dell’ informazione. In fondo, se del mio lavoro dovessi tracciare un profilo, ecco: per tutta la vita ho cercato di tenermi al corrente, da filosofo, del sapere scientifico (il che in Francia ø raro), e insieme di non dimenticare la tradizione letteraria: ho scritto su Zola e su Jules Verne. Ecco, ho cercato di tenere unite, con le due mani, la scienza e la letteratura, di passare dall’ una all’ altra. E’ quello che chiamo, nel quinto volume dedicato a Mercurio, il Passaggio a Nord-Ovest: passaggio difficile, pericoloso, tempestoso, ma passaggio. Per me la filosofia è questa alleanza. In Italia ciò dovrebbe essere comprensibile”.
Ma comunicazione che vuol dire? “All’ inizio, all’ epoca dello strutturalismo, davo del termine “struttura” un’ interpretazione algebrica, esatta. Poi, studiando il XIX secolo, la fisica ottocentesca, e cioè essenzialmente la termodinamica, finii per attribuire un ruolo centrale alla teoria dell’ informazione. In fondo, se del mio lavoro dovessi tracciare un profilo, ecco: per tutta la vita ho cercato di tenermi al corrente, da filosofo, del sapere scientifico (il che in Francia ø raro), e insieme di non dimenticare la tradizione letteraria: ho scritto su Zola e su Jules Verne. Ecco, ho cercato di tenere unite, con le due mani, la scienza e la letteratura, di passare dall’ una all’ altra. E’ quello che chiamo, nel quinto volume dedicato a Mercurio, il Passaggio a Nord-Ovest: passaggio difficile, pericoloso, tempestoso, ma passaggio. Per me la filosofia è questa alleanza. In Italia ciò dovrebbe essere comprensibile”.
 In Italia c’ è stata una forte tradizione idealista e marxista. L’ interesse per la scienza tende a diventare scientismo. “Come nel mondo anglosassone. Ma il fatto è che nella letteratura c’ è spesso più rigore che nella scienza. In Tito Livio c’ è più epistemologia che in Popper. Il mio sogno è di scrivere un’ opera che compia la riconciliazione enciclopedica, proprio alla maniera di Diderot e di D’ Alembert, ma non solo nel senso storico (per cui si pensa sempre soltanto nel solco della propria tradizione), anche nel senso del concetto: quello è il campo che si percorre e che si deve percorrere. La filosofia ha perduto troppo non sapendo nulla di scienza, ma oggi che ne sa qualcosa, ha perduto la dimensione culturale. E’ come un cervello tagliato in due. Io vorrei pensare col cervello intero”.
In Italia c’ è stata una forte tradizione idealista e marxista. L’ interesse per la scienza tende a diventare scientismo. “Come nel mondo anglosassone. Ma il fatto è che nella letteratura c’ è spesso più rigore che nella scienza. In Tito Livio c’ è più epistemologia che in Popper. Il mio sogno è di scrivere un’ opera che compia la riconciliazione enciclopedica, proprio alla maniera di Diderot e di D’ Alembert, ma non solo nel senso storico (per cui si pensa sempre soltanto nel solco della propria tradizione), anche nel senso del concetto: quello è il campo che si percorre e che si deve percorrere. La filosofia ha perduto troppo non sapendo nulla di scienza, ma oggi che ne sa qualcosa, ha perduto la dimensione culturale. E’ come un cervello tagliato in due. Io vorrei pensare col cervello intero”.
 Ora sta scrivendo qualche cosa? “Un libro sui cinque sensi, e, appunto, in una forma letteraria, anche se sono partito da un sistema rigorosamente formale. E’ un tentativo di alleanza tra le due forme di sapere, è anche il tentativo di ritrovare, come diceva Edmund Husserl, le radici profonde della cultura europea. Lei conosce La crisi delle scienze europee?”.
Ora sta scrivendo qualche cosa? “Un libro sui cinque sensi, e, appunto, in una forma letteraria, anche se sono partito da un sistema rigorosamente formale. E’ un tentativo di alleanza tra le due forme di sapere, è anche il tentativo di ritrovare, come diceva Edmund Husserl, le radici profonde della cultura europea. Lei conosce La crisi delle scienze europee?”.
 L’ ho tradotta in italiano da studente. Ma Husserl parlava appunto di “crisi” di quell’ idea e di quella tradizione. C’ è il problema della tecnicizzazione della scienza. E poi c’ è la difficoltà della estrema specializzazione dei settori scientifici [...]
L’ ho tradotta in italiano da studente. Ma Husserl parlava appunto di “crisi” di quell’ idea e di quella tradizione. C’ è il problema della tecnicizzazione della scienza. E poi c’ è la difficoltà della estrema specializzazione dei settori scientifici [...]
 (cfr. ENRICO FILIPPINI, “Il mio amico Mercurio”, “la Repubblica”, 15 giugno 1984: https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1984/06/15/il-mio-amico-mercurio.html).
(cfr. ENRICO FILIPPINI, “Il mio amico Mercurio”, “la Repubblica”, 15 giugno 1984: https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1984/06/15/il-mio-amico-mercurio.html).5. STORIA E SCIENZA: “VICISTI, GALILAEE” (KEPLERO, 1611) 5 Giugno 2019.
La rotazione della Terra rimescola le acque del lago di Garda ... http://www.ansa.it/canale_scienza_tecnica/notizie/terra_poli/2019/06/05/la-rotazione-della-terra-rimescola-le-acque-del-lago-di-garda-_8cbe9d78-1459-4088-a0a4-12016cd675b9.html.
6. PER UNA "RIVOLUZIONE KEPLERICANA": "IL LINGUAGGIO DEL CAMBIAMENTO. ELEMENTI DI COMUNICAZIONE TERAPEUTICA". Note per orientarsi nel pensiero [7 giugno 2019]...
Dal momento che (a quanto pare) è stata persa la "bussola", è opportuno, forse, riprendere il "cervello in una vasca" (Hilary Putnam: https://it.wikipedia.org/wiki/Cervello_in_una_vasca), riportarlo nella "nave" di Galilei ("Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo tolemaico e copernicano"), e rileggere (sia consentito) la mia nota sul lavoro di Paul Watzlawick ("Il linguaggio del cambiamento. Elementi di comunicazione terapeutica", Milano, Feltrinelli, 1980), dal titolo "LE DUE META’ DEL CERVELLO" ("Alfabeta", n. 17, settembre 1980, p. 11: http://www.lavocedifiore.org/SPIP/IMG/pdf/LE_DUE_META_DEL_CERVELLO_0001-2.pdf); e, infine, rimeditare ancora e di nuovo la lezione di Kant su “Che cosa significa orientarsi nel pensiero” (http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=4837).
Federico La Sala
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- Riflesssioni su tre parole-chiave: carità, sviluppo integrale e comunione - attenti a non cadere nella tentazione di vivere una carità ipocrita o ingannatrice (papa Francesco).28 maggio 2019, di Federico La Sala
DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
AI PARTECIPANTI ALL’INCONTRO PROMOSSO DA CARITAS INTERNATIONALIS
 Sala Clementina
Sala Clementina
 Lunedì, 27 maggio 2019
Lunedì, 27 maggio 2019Signori Cardinali,
venerati Fratelli nell’Episcopato e nel Sacerdozio,
cari fratelli e sorelle,
sono lieto di avere questa opportunità di incontrarvi in occasione della vostra XXI Assemblea Generale. Ringrazio il Cardinale Tagle per le parole che mi ha indirizzato e rivolgo un cordiale saluto a tutti voi, alla grande famiglia della Caritas e a quanti nei vostri rispettivi Paesi si impegnano nel servizio della carità.
In questi giorni, provenendo da ogni parte del mondo, avete vissuto un momento significativo nella vita della Confederazione, finalizzato non solo ad adempiere ai doveri statutari, ma anche a rafforzare i vincoli di comunione reciproca nell’adesione al Successore di Pietro, a motivo dello speciale legame esistente tra la vostra organizzazione e la Sede Apostolica. Infatti, San Giovanni Paolo II volle conferire a Caritas Internationalis la personalità giuridica canonica pubblica, chiamandovi a condividere la missione stessa della Chiesa nel servizio della carità.
Oggi vorrei soffermarmi a riflettere brevemente con voi su tre parole-chiave: carità, sviluppo integrale e comunione.
Considerata la missione che la Caritas è chiamata a svolgere nella Chiesa, è importante tornare sempre a riflettere assieme sul significato della stessa parola carità. La carità non è una sterile prestazione oppure un semplice obolo da devolvere per mettere a tacere la nostra coscienza. Quello che non dobbiamo mai dimenticare è che la carità ha la sua origine e la sua essenza in Dio stesso (cfr Gv 4,8); la carità è l’abbraccio di Dio nostro Padre ad ogni uomo, in modo particolare agli ultimi e ai sofferenti, i quali occupano nel suo cuore un posto preferenziale. Se guardassimo alla carità come a una prestazione, la Chiesa diventerebbe un’agenzia umanitaria e il servizio della carità un suo “reparto logistico”. Ma la Chiesa non è nulla di tutto questo, è qualcosa di diverso e di molto più grande: è, in Cristo, il segno e lo strumento dell’amore di Dio per l’umanità e per tutto il creato, nostra casa comune.
La seconda parola è sviluppo integrale. Nel servizio della carità è in gioco la visione dell’uomo, la quale non può ridursi a un solo aspetto ma coinvolge tutto l’essere umano in quanto figlio di Dio, creato a sua immagine. I poveri sono anzitutto persone,e nei loro volti si cela quello di Cristo stesso. Essi sono sua carne, segni del suo corpo crocifisso, e noi abbiamo il dovere di raggiungerli anche nelle periferie più estreme e nei sotterranei della storia con la delicatezza e la tenerezza della Madre Chiesa. Dobbiamo puntare alla promozione di tutto l’uomo e di tutti gli uomini affinché siano autori e protagonisti del proprio progresso (cfr S. Paolo VI, Enc. Populorum progressio, 34).
 Il servizio della carità deve, pertanto, scegliere la logica dello sviluppo integrale come antidoto alla cultura dello scarto e dell’indifferenza. E rivolgendomi a voi, che siete la Caritas, voglio ribadire che «la peggiore discriminazione di cui soffrono i poveri è la mancanza di attenzione spirituale» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 200). Voi lo sapete bene: la grandissima parte dei poveri «possiede una speciale apertura alla fede; hanno bisogno di Dio e non possiamo tralasciare di offrire loro la sua amicizia, la sua benedizione, la sua Parola, la celebrazione dei Sacramenti e la proposta di un cammino di crescita e di maturazione nella fede» (ibid.). Pertanto, come ci insegna anche l’esempio dei Santi e delle Sante della carità, «l’opzione preferenziale per i poveri deve tradursi principalmente in un’attenzione religiosa privilegiata e prioritaria» (ibid.).
Il servizio della carità deve, pertanto, scegliere la logica dello sviluppo integrale come antidoto alla cultura dello scarto e dell’indifferenza. E rivolgendomi a voi, che siete la Caritas, voglio ribadire che «la peggiore discriminazione di cui soffrono i poveri è la mancanza di attenzione spirituale» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 200). Voi lo sapete bene: la grandissima parte dei poveri «possiede una speciale apertura alla fede; hanno bisogno di Dio e non possiamo tralasciare di offrire loro la sua amicizia, la sua benedizione, la sua Parola, la celebrazione dei Sacramenti e la proposta di un cammino di crescita e di maturazione nella fede» (ibid.). Pertanto, come ci insegna anche l’esempio dei Santi e delle Sante della carità, «l’opzione preferenziale per i poveri deve tradursi principalmente in un’attenzione religiosa privilegiata e prioritaria» (ibid.).La terza parola è comunione, che è centrale nella Chiesa, definisce la sua essenza. La comunione ecclesiale nasce dall’incontro con il Figlio di Dio, Gesù Cristo, che, mediante l’annuncio della Chiesa, raggiunge gli uomini e crea comunione con Lui stesso e con il Padre e lo Spirito Santo (cfr 1 Gv 1,3). È la comunione in Cristo e nella Chiesa che anima, accompagna, sostiene il servizio della carità sia nelle comunità stesse sia nelle situazioni di emergenza in tutto il mondo. In questo modo, la diakonia della carità diventa strumento visibile di comunione nella Chiesa (cfr Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, 4). Per questo, come Confederazione siete accompagnati dal Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, che ringrazio per il lavoro che svolge ordinariamente e, in particolare, per il sostegno alla missione ecclesiale di Caritas Internationalis. Ho detto che siete accompagnati: non siete “sotto”.
Riprendendo questi tre aspetti fondamentali per vivere nella Caritas, ossia la carità, lo sviluppo integrale e la comunione, vorrei esortarvi a viverli con stile di povertà, di gratuità e di umiltà.
Non si può vivere la carità senza avere relazioni interpersonali con i poveri: vivere con i poveri e per i poveri. I poveri non sono numeri ma persone. Perché vivendo con i poveri impariamo a praticare la carità con lo spirito di povertà, impariamo che la carità è condivisione. In realtà, non solo la carità che non arriva alla tasca risulta una falsa carità, ma la carità che non coinvolge il cuore, l’anima e tutto il nostro essere è un’idea di carità ancora non realizzata.
Occorre essere sempre attenti a non cadere nella tentazione di vivere una carità ipocrita o ingannatrice, una carità identificata con l’elemosina, con la beneficienza, oppure come “pillola calmante” per le nostre inquiete coscienze. Ecco perché si deve evitare di assimilare l’operato della carità con l’efficacia filantropica o con l’efficienza pianificatrice oppure con l’esagerata ed effervescente organizzazione.
Essendo la carità la più ambita delle virtù alla quale l’uomo possa aspirare per poter imitare Dio, risulta scandaloso vedere operatori di carità che la trasformano in business: parlano tanto della carità ma vivono nel lusso o nella dissipazione oppure organizzano Forum sulla carità sprecando inutilmente tanto denaro. Fa molto male constatare che alcuni operatori di carità si trasformano in funzionari e burocrati.
Ecco perché vorrei ribadire che la carità non è un’idea o un pio sentimento, ma è l’incontro esperienziale con Cristo; è il voler vivere con il cuore di Dio che non ci chiede di avere verso i poveri un generico amore, affetto, solidarietà, ecc., ma di incontrare in loro Lui stesso (cfr Mt 25,31-46), con lo stile di povertà.
Cari amici, vi ringrazio, a nome di tutta la Chiesa, per quello che fate con e per tanti fratelli e sorelle che fanno fatica, che sono lasciati ai margini, che sono oppressi dalle schiavitù dei nostri giorni, e vi incoraggio ad andare avanti! Possiate tutti voi, in comunione con le comunità ecclesiali a cui appartenete e di cui siete espressione, continuare a dare con gioia il vostro contributo perché cresca nel mondo il Regno di Dio, Regno di giustizia, di amore e di pace. Vi nutra e vi illumini sempre il Vangelo, e vi guidi l’insegnamento e la cura pastorale della madre Chiesa.
Che il Signore vi benedica e la Madonna vi custodisca. E, per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Grazie.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. -- DALLA FIABA, UNA LEZIONE. I seduttori e i maestri: due voci ben diverse.9 maggio 2019, di Federico La Sala
DALLA FIABA, UNA LEZIONE DI PENSIERO COSTITUZIONALE ... *
I seduttori e i maestri: due voci ben diverse
di Ermes Ronchi (Avvenire, giovedì 9 maggio 2019)
IV Domenica di Pasqua
 Anno C
Anno C- In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola».
Le mie pecore ascoltano la mia voce. Non i comandi, la voce. Quella che attraversa le distanze, inconfondibile; che racconta una relazione, rivela una intimità, fa emergere una presenza in te. La voce giunge all’orecchio del cuore prima delle cose che dice. È l’esperienza con cui il bambino piccolo, quando sente la voce della madre, la riconosce, si emoziona, tende le braccia e il cuore verso di lei, ed è già felice ben prima di arrivare a comprendere il significato delle parole.
La voce è il canto amoroso dell’essere: «Una voce! L’amato mio! Eccolo, viene saltando per i monti, balzando per le colline» (Ct 2,8). E prima ancora di giungere, l’amato chiede a sua volta il canto della voce dell’amata: «La tua voce fammi sentire» (Ct 2,14)... Quando Maria, entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta, la sua voce fa danzare il grembo: «Ecco appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo» (Lc 1,44). Tra la voce del pastore buono e i suoi agnelli corre questa relazione fidente, amorevole, feconda. Infatti perché le pecore dovrebbero ascoltare la sua voce?
Due generi di persone si disputano il nostro ascolto: i seduttori, quelli che promettono piaceri, e i maestri veri, quelli che danno ali e fecondità alla vita. Gesù risponde offrendo la più grande delle motivazioni: perché io do loro la vita eterna. Ascolterò la sua voce non per ossequio od obbedienza, non per seduzione o paura, ma perché come una madre, lui mi fa vivere. Io do loro la vita.
Il pastore buono mette al centro della religione non quello che io faccio per lui, ma quello che lui fa per me. Al cuore del cristianesimo non è posto il mio comportamento o la mia etica, ma l’azione di Dio. La vita cristiana non si fonda sul dovere, ma sul dono: vita autentica, vita per sempre, vita di Dio riversata dentro di me, prima ancora che io faccia niente. Prima ancora che io dica sì, lui ha seminato germi vitali, semi di luce che possono guidare me, disorientato nella vita, al paese della vita. La mia fede cristiana è incremento, accrescimento, intensificazione d’umano e di cose che meritano di non morire.
Gesù lo dice con una immagine di lotta, di combattiva tenerezza: Nessuno le strapperà dalla mia mano. Una parola assoluta: nessuno. Subito raddoppiata, come se avessimo dei dubbi: nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io sono vita indissolubile dalle mani di Dio. Legame che non si strappa, nodo che non si scioglie. L’eternità è un posto fra le mani di Dio. Siamo passeri che hanno il nido nelle sue mani. E nella sua voce, che scalda il freddo della solitudine.
 (Letture: Atti 13,14.43-52; Salmo 99; Apocalisse 7,9.14-17; Giovanni 10,27-30)
(Letture: Atti 13,14.43-52; Salmo 99; Apocalisse 7,9.14-17; Giovanni 10,27-30)
*
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- DUE PAPI IN PREGHIERA: MA CHI PREGANO?! Bergoglio incontra Ratzinger: "Siamo fratelli". Ma di quale famiglia?!
L’ASTUZIA DEL LUPO E I SETTE CAPRETTI. "APRITE, APRITE": SONO IL VOSTRO "PAPI"!!! LA PAROLA "ITALIA", LA "PASSWORD", CONSEGNATA A UN PARTITO (1994-2011).
LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE.
Federico La Sala
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- AL DI LA’ DELLA "MENTE ASTUTA". PER UNA NUOVA "BUSSOLA TEOLOGICA". La lezione di Dante.19 febbraio 2019, di Federico La Sala
AL DI LA’ DELLA "MENTE ASTUTA". PER UNA NUOVA "BUSSOLA TEOLOGICA". "DUE SOLI" .... *
Classici.
Più fede nella politica, la lezione di Dante
La vicenda biografica e intellettuale del grande fiorentino si rivela di grande attualità ancora oggi, specie per quanto riguarda l’impegno dei credenti a favore del bene comune
di Gabriella M.Di Paola Dollorenzo (Avvenire, 17 febbraio 2019)
- [Foto] La visione del «Paradiso» dantesco in un’incisione di Gustave Doré
L’intervista al cardinale Gualtiero Bassetti (Avvenire, 9 dicembre 2018) ha riportato la nostra attenzione «sull’impegno concreto e responsabile dei cattolici in politica». Già nell’inchiesta del mensile Jesus sul «tempo del rammendo » (ottobre 2018), il presidente della Cei aveva rimarcato l’urgenza di ricostruire una presenza laicale che guardasse alla politica come a un’avventura positiva, nella necessità di una classe dirigente in grado di opporre alla sfiducia popolare un forte senso di concretezza e di responsabilità. Queste virtù o, per meglio dire, questi talenti ci permettono di richiamare la coerenza del pensiero politico di Dante così come ebbe a svilupparsi, sia negli anni di politica attiva sia dopo l’esilio e parallelamente allo svolgersi del suo pensiero teologico nella Commedia. Considerare l’architettura del suo pensiero, il rapporto tra teoria e prassi, l’utilizzo anzi l’interazione delle fonti (Sacre Scritture, autori grecolatini, testi arabi) può essere utile per individuare l’archetipo del cristiano impegnato nella realtà politica del proprio tempo, con l’ambizione di tradurre l’imitatio Christi nel concreto operare all’interno della res publica.
La vicenda umana del Poeta incardinato nella realtà politica del suo tempo, specialmente negli anni che vanno dalla morte di Beatrice (1290) alla condanna all’esilio (1302), ci permette di riflettere sul rapporto teologia- politica, così come fu duramente ma appassionatamente vissuto, in «un crescendo di temerarietà e di coerenza» (Giorgio Petrocchi, Vita di Dante, 1993) e, nello stesso tempo, avendo ben salda la «coscienza della storia», quell’habitus morale in base al quale «gli avvenimenti non si confondono caoticamente nella memoria, ma sono collegati dalla coscienza della causa e dell’effetto, dell’iniziativa e della responsabilità» (Romano Guardini, Dante, 2008). Se accogliamo l’approccio euristico di Jürgen Moltmann (si veda in particolare Dio nel progetto del mondo moderno, edito da Queriniana nel 1999), possiamo capire in che senso la teologia può “binarizzarsi” con la politica determinando le scelte tra il bene e il male, nel concreto avvicendarsi della storia di una città, di una nazione, di un popolo. Non è un caso che la formazione filosofico-teologica di Dante preceda cronologicamente l’attività politica, anzi ne sia quasi il trampolino di lancio: «Io che cercava di consolarme, trovai non solamente a le mie lagrime rimedio, ma vocaboli d’autori e di scienze e di libri: li quali considerando, giudicava bene che la filosofia, che era donna di questi autori, di queste scienze e di questi libri, fosse somma cosa. E da questo imaginare cominciai ad andare là dov’ella si dimostrava veracemente, cioè ne le scuole de li religiosi e a le disputazioni de li filosofanti » ( Convivio, II, xii, 5-7).
Dopo aver approfondito l’Etica Nicomachea e la Politica di Aristotele (nella traduzione latina di Guglielmo di Moerbeke e col commento di Tommaso d’Aquino), nel libro II del Convivio si rivendica il primato della morale. Dante va oltre Tommaso d’Aquino: se la metafisica è la scienza di Dio, l’uomo potrà cercare lo status felicitatis in questa vita e, dato che l’uomo è un animale sociale, in una politica regolata dalla morale. Pertanto non è conforme alla morale rinchiudersi nella contemplazione dell’intelligibile, quando l’odio e la violenza di parte sconvolgono la comunità in cui si vive.
Nel 1294, anno dell’elezione e successiva abdicazione di Celestino V, nonché dell’ascesa al papato di Bonifacio VIII, Dante ha un ruolo diplomatico- culturale di primo piano nella delegazione dei cavalieri destinati dal Comune al seguito dell’imperatore Carlo Martello. In seguito, con la stesura del Paradiso, Dante potrà immaginare un incontro con Carlo al cospetto di Dio; il dialogo tra i due, con esplicito richiamo alla Politica di Aristotele, ma anche al De Anima, ha una precisa connotazione teologica: «“Vuo’ tu che questo ver più ti s’imbianchi?”. /E io: “Non già; ché impossibil veggio / che la natura, in quel ch’è uopo, stanchi”. / Ond’ elli ancora: “Or dì: sarebbe il peggio /per l’omo in terra, se non fosse cive?”. / “Sì”, rispuos’ io; “e qui ragion non cheggio”. / “E puot’ elli esser, se giù non si vive /diversamente per diversi offici? / Non, se ’l maestro vostro ben vi scrive”» ( Paradiso, VIII, 113-120).
Sarebbe un male per l’uomo sulla terra se non facesse parte di un ordine civile, di un organismo sociale? E può esistere un’organizzazione civile se i suoi membri non siano ordinati a vivere esercitando diverse funzioni? E Dante risponde “sì” alla prima domanda e “no” alla seconda. La naturale politicità dell’uomo si accompagna alla necessità di distinguere gli offici poiché Nihil frustra natura facit (Politica I, 2).
Il quinquennio successivo al 1294 segnerà intensamente la vita e l’opera di Dante proprio perché continuo sarà lo scambio tra teoria e prassi, una prassi in toga candida: dalla riflessione filosofica riguardo al primato della morale alla traduzione di ciò nella vita della polis, una sorta di ragion pratica kantiana ante litteram: impegno civile, riflessione morale, tenace inseguimento della giustizia.
Proprio quando Firenze è dilaniata da lotte sociali interne e lo stesso papato non è immune dalla brama di potere che assale i partiti politici, Dante tiene ben ferma la barra del suo operare cristiano, perché è fermamente convinto di agire nella direzione indicata dalla bussola teologica. In questo atteggiamento riconosciamo l’attualità del suo pensiero politico e del suo agire politico. Dopo la condanna, negli anni dell’esilio, Dante consegnerà alle pagine del Convivio, della Commedia, ma soprattutto del trattato Monarchia, la riflessione teorica frutto della sua esperienza politica. È un progetto in fieri perché dovrà fare i conti col divenire della storia, è un progetto politico voluto da Dio per il bene dell’umanità.
Dopo la fine del potere temporale dei Papi, la Chiesa, a partire dall’enciclica In praeclara summorum (1921) di Benedetto XV, fino al Messaggio al presidente del Pontificio Consiglio della cultura in occasione del 750° anniversario della nascita di Dante Alighieri (2015) di papa Francesco, ha pienamente rivendicato, si pensi alla mirabile Altissimi cantus, la lettera apostolica di Paolo VI, l’appartenenza di Dante alla Chiesa cattolica e alla fede di Cristo, proprio considerando la sua battaglia di cristiano impegnato nella vita politica del suo tempo e nella sua somma opera teologica.
Oggi l’umanesimo cristiano di Dante può essere una traccia da seguire nella comunicazione religiosa e laica che stiamo vivendo. Per la preparazione del laicato cattolico alla vita politica, il pensiero di Dante può diventare una “bussola teologica”. Il rapporto tra fede, morale e politica, vissuto alla luce dei valori cristiani, che fece di Dante il segno di contraddizione della sua epoca, oggi fa di lui un nostro contemporaneo.
*
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- Come troppo spesso accade anche con la religione. La Costituzione, il sacro dovere e la sua torsione populista (Francesco Palermo).).5 febbraio 2019, di Federico La Sala
Il “sacro dovere” e l’erosione della costituzione
di Francesco Palermo *
La costituzione è il perimetro entro il quale si può muovere la politica con le sue scelte discrezionali. È il ring nel quale il legittimo conflitto di idee deve svolgersi secondo regole prestabilite, la cui interpretazione è affidata a degli arbitri, i più importanti dei quali sono la Corte costituzionale e il Presidente della Repubblica. È pertanto non solo legittimo ma anzi doveroso che la politica ricorra ad argomentazioni costituzionali per giustificare le proprie azioni e le proprie tesi, perché solo dentro la costituzione può svolgersi la politica. La costituzione è, per certi aspetti, la versione laica del principio di esclusività tipico della religione: non avrai altro Dio all’infuori di me. E non può esserci politica al di fuori della costituzione.
Come troppo spesso accade anche con la religione, però, non è raro che i precetti vengano piegati ad interpretazioni funzionali alla preferenza politica del momento. E che tale torsione venga compiuta non già dagli arbitri, bensì dai giocatori.
Un esempio di particolare interesse si è registrato in questi giorni, quando il ministro dell’interno ha invocato l’articolo 52 della costituzione per giustificare la propria politica in materia di sbarchi. Nelle due pur diverse vicende della nave Diciotti da un lato e della nave Sea Watch dall’altro, il ministro Salvini ha rivendicato la scelta di negare l’accesso ai porti italiani come un obbligo costituzionale, fondato sul “sacro dovere” di ciascun cittadino alla “difesa della patria”, previsto appunto dall’articolo 52 della costituzione.
La disposizione non ha naturalmente nulla a che vedere con le questioni di cui si tratta. Il suo ambito di riferimento è esclusivamente la difesa militare, come si evince dai lavori preparatori e dagli altri commi dell’articolo, che prevedono rispettivamente l’obbligatorietà del servizio militare, nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge, e la natura democratica dell’ordinamento delle forze armate. È per questo che l’articolo 52 non fu oggetto di particolare dibattito in assemblea costituente, impegnata a sottolineare il carattere pacifista della costituzione. Non a caso il testo definitivo è praticamente identico a quello della prima bozza, caso rarissimo nei lavori della costituente. Erano tutti d’accordo su una previsione che doveva dare copertura costituzionale al servizio militare e alle forze armate.
Il ministro dell’interno trasforma invece quella previsione - estrapolandola dal contesto - in una sorta di diritto di resistenza. Peraltro ponendolo in capo al governo, ossia all’organo contro il quale il diritto di resistenza si esercita, nei pochi ordinamenti in cui è previsto. Non solo. Il richiamo al “sacro dovere” della “difesa della Patria” ha una forte portata simbolica. In primo luogo, la formulazione è nota anche ai cittadini meno familiari con la costituzione, quindi suona plausibile. In secondo luogo, richiama il gergo militare, anche grazie all’espressione ottocentesca della disposizione (“sacro dovere”), figlia di un’epoca in cui la guerra era ancora drammaticamente presente negli occhi e nelle menti dei costituenti. Soprattutto, l’invocazione di quel segmento dell’art. 52 è un abile gioco retorico: prima lo stacca dal contesto militare in cui è collocato, poi lo ricollega a tale contesto, facendo intuire che “l’invasione” dei profughi sia un atto di guerra nei confronti del Paese, contro cui occorre difendersi. Anche militarmente. Dunque senza essere soggetti alla costituzione, ma al diritto eccezionale del tempo di guerra, in cui vale quasi tutto.
Il rischio di una simile operazione, per quanto scaltra sotto il profilo politico e mediatico, è quello di depotenziare il carattere normativo della costituzione, di eroderne il ruolo di limite e di parametro dell’attività politica. Un’erosione che continua da tempo, trasversalmente alle forze politiche, e di cui questo caso è solo l’esempio più recente. Così facendo si arriva però a cancellare la funzione di garanzia della politica che è il compito principale della costituzione. Non può sfuggire la pericolosità di questo crinale. O forse sì. E infatti l’operazione funziona proprio in quanto alla gran parte degli elettori questo ruolo della costituzione - il più importante - sfugga. Si continua così a ballare sulla nave che affonda. Dimenticando che non è “solo” quella dei migranti, ma quella della costituzione. Su cui siamo imbarcati tutti...
* 31.01.2019 - "Il sacro dovere e la sua torsione populista" (Il Mulino)
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. -- Il segno di Belzebù indelebile sul Paese. Come le mani disegnate in rosso sulle parete delle caverne.7 gennaio 2019, di Federico La Sala
Il Divo che commise il reato di associazione con la mafia
di Gian Carlo Caselli ( Il Fatto, 07.01.2019)
Subito dopo la morte di Falcone e Borsellino ho chiesto il trasferimento a Palermo. Ho avuto l’onore di guidare la procura di questa città per quasi sette anni. Nel contrasto all’ala militare di Cosa nostra i risultati sono stati imponenti: basti ricordare gli innumerevoli processi contro mafiosi “doc” conclusi con condanne per 650 ergastoli e un’infinità di anni di reclusione. Ma la mafia (tutti son bravi a dirlo, pochi a trarne le conseguenze sul piano investigativo) non è solo “coppola e lupara”. È anche complicità e collusioni assicurate da “colletti bianchi”. Ecco quindi vari processi contro imputati “eccellenti”. Fra gli altri Marcello Dell’Utri e Giulio Andreotti. Del primo (condannato in via definitiva a sette anni di reclusione) non si parla, se non quando vengon fuori i suoi problemi di salute. Del secondo è stata calpestata e fatta a pezzi la verità che emerge chiara dagli atti.
In primo grado c’è stata assoluzione, sia pure per insufficienza di prove. In Appello (mentre per i fatti successivi è stata confermata tale assoluzione) fino alla primavera del 1980 l’imputato è stato dichiarato colpevole, per aver commesso (sic!) il reato di associazione a delinquere con Cosa nostra. Il reato commesso è stato dichiarato prescritto, ma resta ovviamente commesso. La Cassazione ha confermato la sentenza d’appello e quindi anche la penale responsabilità dell’imputato fino al 1980. Processualmente è questa la verità definitiva ed irrevocabile. Ed è evidente che chi parla di “assoluzione” è fuori della realtà. Non esiste in natura, è una bestemmia la formula “assolto per aver commesso il reato”.
La corte d’Appello si è basata su prove sicure e riscontrate. Ad esempio, ha ritenuto provati due incontri del senatore con il “capo dei capi” di allora , Stefano Bontade, per discutere il caso di Pier Santi Mattarella, integerrimo capo della Dc siciliana, che pagò con la vita il coraggio di essersi opposto a Cosa nostra. La corte sottolinea tra l’altro che l’imputato ha “omesso di denunziare elementi utili a far luce [sull’omicidio] di cui era venuto a conoscenza in dipendenza dei suoi diretti contatti con i mafiosi”. Secondo la corte d’Appello, Andreotti ha contribuito “al rafforzamento della organizzazione criminale , inducendo negli affiliati, anche per la sua autorevolezza politica, il sentimento di essere protetti al più alto livello del potere legale. Così realizzando “una vera e propria partecipazione all’associazione mafiosa apprezzabilmente protrattasi nel tempo”.
Chi ha nascosto o stravolto la verità - oltre a truffare il popolo italiano in nome del quale si pronunziano le sentenze - non ha voluto elaborare la memoria di ciò che è stato, perché teme il giudizio storico su come in una certa fase, almeno parzialmente, si è formato il consenso nel nostro Paese. Ma in questo modo si rende un pessimo servizio alla qualità della democrazia. Perché si finisce per legittimare (ieri, oggi e domani) la politica che ha rapporti con la mafia.
Il segno di Belzebù indelebile sul Paese
Imperitura memoria - L’impronta lasciata sul seggio di Palazzo Madama da Giulio Andreotti, in Senato dal ‘91 al 2013 dopo 45 anni passati alla Camera
di Pino Corrias (Il Fatto, 07.01.2019)
Come le mani disegnate in rosso sulle parete delle caverne ci dicono che l’uomo del Pleistocene passò da lì, così la gobba di Giulio Andreotti incisa sul cuoio della sua sedia al Senato ci ricorda che in un tempo remoto della Repubblica siamo stati tutti democristiani - volenti o nolenti, eretti o quadrumani - lungo un’era che gli archeologi del nostro tempo chiamano per l’appunto Andreottiana.
Il capostipite era più alto di quanto oggi si possa immaginare. Aveva un pallore da sagrestia su un volto senza labbra, le orecchie aguzze, il passo veloce e scivoloso. Dormiva poco. Usciva ogni mattina all’alba per la Messa. Faceva l’elemosina ai mendicanti raccolti sul sagrato. Mangiava in bianco. Vestiva oscuri completi Caraceni col panciotto. Soffriva di emicrania e di persistente disincanto. Nel raro tempo libero giocava a gin-rummy e collezionava campanelli. Nell’ampio tempo del lavoro accumulava nemici e segreti.
I nemici li ha seppelliti quasi tutti. I segreti invece sono diventati la nostra storia e il suo leggendario archivio, nutrito per molto più di mezzo secolo, da quando la sua giovinezza fu rinvenuta tra le mura vaticane da Alcide De Gasperi, futuro plenipotenziario della Democrazia Cristiana, più o meno mentre le bombe degli angloamericani violavano il sacro suolo di Roma città aperta, estate 1943, impolverando la stola di papa Pio XII.
A 24 anni Giulio stava già nel posto giusto, tra gli inchiostri dell’eterno potere e al cospetto della grande Storia, intraprendendone da allora i cospicui labirinti che lo condussero, tra maldicenze e applausi, a indossare 27 volte i panni di ministro, 7 volte la corona di presidente del Consiglio.
Per poi passare, a intermittenza, dalle luci dello statista alle ombre del grande vecchio, 27 volte inquisito dalla magistratura e 27 volte salvato dalle Camere che a maggioranza negavano l’autorizzazione a procedere. Salvo soffriggere, udienza dopo udienza, sul banco degli imputati del tribunale di Palermo, anno 1995, per il celebre bacio a Totò Riina, e poi su quello di Perugia, dove era accusato di essere il mandante dei quattro colpi di pistola con cui venne cancellato il giornalista romano Mino Pecorelli, suo acerrimo nemico, le sue imminenti rivelazioni sul caso Moro e su certi assegni finiti tra i velluti e i sughi della sua corrente, detta anche lei andreottiana.
Inciampi giudiziari mai davvero prescritti e che hanno nutrito la sua leggenda nera - passata per Piazza Fontana, i Servizi deviati, lo scandalo petroli, il Banco Ambrosiano, Gladio, la morte solitaria del generale Dalla Chiesa sull’asfalto di Palermo - ma anche il suo fatalismo romanesco di eterno sopravvissuto al suo stesso danno: “Preferisco tirare a campare che tirare le cuoia” come recitava la sua massima preferita, che poi era anche il cuore della sua politica, talmente malleabile da rendersi disponibile a destra e a sinistra, purché immobile sotto l’ombrello angloamericano e in cambio di un costante incasso elettorale che gli garantivano, guarda caso, i collegi del Lazio e della Sicilia. Oltre naturalmente alla benevolenza della Chiesa, i sette papi che conobbe in vita, lasciandosi ispirare da una fede mai troppo intransigente, disponibile all’umano peccato purché con l’Avemaria sempre incorporata. “Quando andavano insieme in chiesa - scrisse Montanelli - De Gasperi parlava con Dio, Andreotti con il prete”.
La zia, i libri, la chiesa e la proposta al cimitero
A dispetto del molto che avrebbe intrapreso, Giulio nasce fragile il 14 gennaio del 1919. Orfano di padre, cresce cagionevole aiutato da una vecchia zia e dalla piccola pensione della madre. Fa il chierichetto e lo studente modello. Si laurea in Giurisprudenza. Alla visita militare il medico lo scarta e gli pronostica sei mesi di vita. Racconterà: “Quando diventai la prima volta ministro gli telefonai per dirgli che ero ancora vivo, ma era morto lui”.
Diventa sottosegretario con De Gasperi nel 1947, entra in Parlamento l’anno dopo. Ci rimarrà per sempre. Sotto ai suoi governi è nata la Riforma sanitaria, è stato legalizzato l’aborto, firmato il Trattato di Maastricht. E dentro alla sua ombra l’Italia è diventata un Paese industriale, alfabetizzato, un po’ più europeo, un po’ meno cialtrone, al netto del clamoroso debito pubblico e delle quattro mafie.
A trent’anni si sposa, dichiarandosi a Donna Livia “mentre passeggiavamo in un cimitero”. Avrà quattro figli. Una sola segretaria, la mitica Enea. Una sola vocazione: “Non ama le vacanze - dirà la figlia Serena - non ama il mare, non ama le passeggiate. La verità è che se non fa politica si annoia”.
Amici scomodi e nemici uccisi sempre col sorriso
Diventandone il prototipo incorpora tutti i pregi e i difetti dei democristiani. Conosce la pazienza e la prudenza. Uccide gli avversari con estrema gentilezza e sorride per buona educazione. È in confidenza con Kissinger e ammira Arafat. Si commuove alla morte di Paolo VI e a quella di Alberto Sordi, che poi sarebbero il sacro e il profano della sua esistenza. Maneggia il potere in silenzio, come un gioco di prestigio. E i cattivi come fossero i buoni. Tra i banchieri d’avventura predilige il piduista Michele Sindona, quello del crack della Banca Privata, a cui aveva appena conferito il titolo di “salvatore della lira”, per poi guardarne imperturbabile il naufragio dentro a un caffè avvelenato, nella cella singola di San Vittore, detenuto per l’omicidio di Giorgio Ambrosoli.
Non ha amici, ma soci momentanei di cordata, mai Fanfani e De Mita, qualche volta Forlani, più spesso Cossiga che lo nominerà senatore a vita. Educa Gianni Letta a fargli da scudiero per poi affidargli il giovane pupillo piduista Luigi Bisignani. Tutti i suoi sottocapi sono tipi da prendere con le molle: Vittorio Sbardella, detto “lo squalo” mastica per lui il Lazio. Ciarrapico è il re del saluto romano, delle acque minerali e degli impicci da sbrogliare. Franco Evangelisti è il faccendiere di “A Fra’ chette serve?”. Cirino Pomicino, detto “’O ministro” digerirà a suo nome 42 processi e 40 assoluzioni. E naturalmente Salvo Lima, il suo alter ego in Sicilia, morto sparato tra i cassonetti di Mondello per ordine dei corleonesi, la mattina del 12 marzo 1992, alba della stagione delle stragi.
Esecuzione che cancellò il suo unico sogno inconcluso, quello di salire al Quirinale, indossare finalmente i panni di presidente della Repubblica e (forse) sistemare gli scheletri del suo notevole armadio. Cominciando dallo scandalo fondante, anno 1963, il tentato golpe di un certo generale De Lorenzo, capo dei servizi segreti, e la scomparsa dei fascicoli che aveva accumulato sui protagonisti della vita pubblica italiana. Archivio quanto mai avvelenato e formidabile arma di ricatto che proprio Andreotti, all’epoca ministro della Difesa, era incaricato di distruggere. E che invece sarebbe riemerso nelle molte nebbie future e persino nei dossier di Licio Gelli, il finto o vero titolare della loggia massonica P2, forse a fondamento di un suo potere sussidiario esercitato per conto (proprio) di chi li aveva maneggiati per primo.
Da Moro agli anni di B.: è lui il capo dei diavoli
“Livido, assente, chiuso nel suo cupo sogno di gloria”, gli avrebbe scritto Aldo Moro dalla prigione brigatista, colmo di rancore e di rassegnazione per il nulla che il governo di solidarietà nazionale riuscì a fabbricare nei 55 giorni impiegati da Mario Moretti a eseguire la sentenza.
Bettino Craxi lo battezzo Belzebù, il capo dei diavoli. Lo temeva e forse lo ammirava, ma non imparò nulla dalla sua quieta imperturbabilità nelle aule di Giustizia e una volta inquisito da Mani pulite, strillò così tanto, da dichiararsi colpevole, pretendere l’impunità e finire latitante.
A differenza di quasi tutti, Andreotti non si lasciò sfiorare dalla volgarità delle tangenti, che lasciò volentieri alle mandibole dei suoi. Né dall’incantesimo delle notti romane. Una sola volta una nobildonna provò a trascinarlo sulla pista da ballo: “Non ho mai danzato con un presidente del Consiglio”, gli disse lei leziosa. “Neanch’io” rispose lui secco, allontanandosi. Non capì il bianco e nero di Berlinguer e non prese mai sul serio i troppi colori di Berlusconi. Sopravvisse alla morte della Dc e di due repubbliche. Scrisse migliaia di pagine senza mai rivelare un segreto. Sembrava eterno. Sembrava un destino. Invece anche lui, uscendo di scena a 94 anni, incollato alla sedia e in piena luce, è diventato un altro anniversario del nostro buio.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- Un discorso «all’Italia che ricuce». Le parole-chiave del messaggio di Mattarella1 gennaio 2019, di Federico La Sala
Il messaggio di Mattarella.
Un discorso «all’Italia che ricuce»
Ecco le parole-chiave di Mattarella, che considera gli altri un valore e recupera il senso della comunità. Oltre l’invito a riportare il Parlamento al centro
di Angelo Picariello (Avvenire, martedì 1 gennaio 2019)
Un discorso all’«Italia che ricuce», che considera gli altri un valore e recupera il senso della comunità. Un tema, quest’ultimo, che Mattarella richiama sovente nei suoi interventi e che il presidente della Repubblica mette al centro anche di questo delicatissimo discorso di fine anno, che arriva all’indomani di una approvazione in tempo limite della legge di Bilancio, appena in tempo per evitare l’esercizio provvisorio. E proprio citando i social, i luoghi di una politica spesso incattivita e aggregata per rivalità, Mattarella parte: «Siamo - dice - nel tempo in cui molti vivono connessi in rete e comunicano di continuo ciò che pensano e anche quel che fanno nella vita quotidiana...». E proprio i social sono la più grande novità nei dati di ascolto. Sono stati oltre 10 milioni e mezzo i telespettatori in Tv, a fronte dei 9 milioni e 700mila dello scorso anno, per il messaggio del capo dello Stato, ma la vera notizia è il pieno raggiunto dal discorso sul Web, con un dato - in continua evoluzione - di circa 2 milioni e mezzo di visualizzazioni, praticamente triplicate rispetto allo scorso anno.
L’ITALIA CHE RICUCE. Un «augurio, caloroso», lo rivolge a papa Francesco: «Lo ringrazio, ancora una volta, per il suo magistero volto costantemente a promuovere la pace, la coesione sociale, il dialogo, l’impegno per il bene comune». Quello di Mattarella è soprattutto un grazie all’Italia impegnata a costruire, a unire, e non ad alimentare odi e paure, come una recente ricerca del Censis ha portato alla luce.
Un grazie a quell’«“Italia che ricuce” e che dà fiducia», lo rivolge, in chiara sintonia con le parole più volte usate dal presidente della Cei, il cardinale Gualtierio Bassetti. «Spesso - spiega - la società civile è arrivata, con più efficacia e con più calore umano, in luoghi remoti non raggiunti dalle pubbliche istituzioni». Ricorda chi «negli ospedali o nelle periferie e in tanti luoghi di solitudine e di sofferenza dona conforto e serenità».
IL SENSO DELLA COMUNITA’. Inaugurato da Luigi Einaudi «non è un rito formale», ricorda Mattarella, il messaggio di fine anno. E replica così in modo garbato e indiretto ai vari tentativi di contro-messaggi in atto. Sottolinea «l’esigenza di sentirsi e di riconoscersi come una comunità di vita», il «bisogno di unità, raffigurata da chi rappresenta la Repubblica che è il nostro comune destino», perché «“comunità” significa condividere valori, prospettive, diritti e doveri. Significa “pensarsi” dentro un futuro comune, da costruire insieme. Significa responsabilità».
SICUREZZA COME RISPETTO. Ma è sulla sicurezza che batte maggiormente, Mattarella. Per mettere in risalto che è proprio un ritrovato senso della comunità l’antidoto più efficace ai rischi che si manifestano per la tranquilla convivenza. «Battersi, come è giusto, per le proprie idee», rimarca. Ma, auspica, occorre «rifiutare l’astio, l’insulto, l’intolleranza, che creano ostilità e timore». E, sottolinea, non è «retorica dei buoni sentimenti», non si può sostenere che «la realtà è purtroppo un’altra; che vi sono tanti problemi e che bisogna pensare soprattutto alla sicurezza». La sicurezza, insiste, non consiste in un difendersi dagli altri, ma si fonda proprio su questo sentirsi parte di un’unica comunità, di «un ambiente in cui tutti si sentano rispettati e rispettino le regole del vivere comune».
MAFIA: NO A ZONE FRANCHE. E, a pochi giorni da un inquietante segnale venuto da Pesaro con l’uccisione di uno stretto congiunto di un pentito di ‘ndrangheta, Mattarella torna su un altro tema a lui caro da sempre anche per ragioni di tragica biografia familiare: la lotta alla mafia. La vera insidia alla nostra sicurezza, ricorda, non viene da un elemento esterno al nostro Paese, ma dal male irrisolto della criminalità organizzata: «La domanda di sicurezza è particolarmente forte in alcune aree del Paese, dove la prepotenza delle mafie si fa sentire più pesantemente. E in molte periferie urbane dove il degrado favorisce il diffondersi della criminalità». E scandisce: «Non sono ammissibili zone franche dove la legge non è osservata e si ha talvolta l’impressione di istituzioni inadeguate, con cittadini che si sentono soli e indifesi».
NO A TASSE SULLA BONTA’. Poi, con nettezza, entra nel merito di una brutta polemica che ha caratterizzato il dibattito “strozzato” sulla Manovra: l’odioso raddoppio dell’Ires per gli enti Non profit. Il ripensamento che ne è venuto, anche dopo le prese di posizione chiare da parte della Chiesa italiana, per ora è solo un impegno. La misura è stata infatti inserita nella legge approvata dal Parlamento. «Vanno evitate “tasse sulla bontà”», avverte Mattarella. «Le realtà del Terzo Settore, del No profit rappresentano una rete preziosa di solidarietà», ricorda il presidente. «Realtà che hanno ben chiara la pari dignità di ogni persona e che meritano maggiore sostegno da parte delle istituzioni, anche perché, sovente, suppliscono a lacune o a ritardi dello Stato negli interventi in aiuto dei più deboli».
RIPORTARE IL PARLAMENTO AL CENTRO. Non c’era tempo di intervenire, per evitare l’esercizio provvisorio, ma è un impegno di tutti, ora, quello di riportare il Parlamento al centro, proprio a partire dal varo delle misure previste in Manovra. «Ieri sera - ricorda Mattarella - ho promulgato la legge di Bilancio nei termini utili a evitare l’esercizio provvisorio, pur se approvata in via definitiva dal Parlamento soltanto da poche ore». Bene il faticoso risultato raggiunto: «Avere scongiurato la apertura di una procedura di infrazione da parte dell’Unione Europea per il mancato rispetto di norme liberamente sottoscritte è un elemento che rafforza la fiducia e conferisce stabilità». Ma segnala «la grande compressione dell’esame parlamentare e la mancanza di un opportuno confronto con i corpi sociali». E formula un augurio, che è anche un monito, «che il Parlamento, il Governo, i gruppi politici trovino il modo di discutere costruttivamente su quanto avvenuto; e assicurino per il futuro condizioni adeguate di esame e di confronto».
LA VERA CITTADINANZA. Fra le piaghe da debellare, invece, quella degli «ultras violenti degli stadi di calcio, estremisti travestiti da tifosi». E «l’alto debito pubblico che penalizza lo Stato e i cittadini e pone una pesante ipoteca sul futuro dei giovani». Problemi complessi per risolvere i quali «non ci sono ricette miracolistiche», avverte, ma solo «il lavoro tenace, coerente, lungimirante produce risultati concreti», senza mettere a rischio i traguardi raggiunti dalle precedenti generazioni. Ricorda i quarant’anni del Servizio sanitario nazionale, «grande motore di giustizia, un vanto del sistema Italia. Che ha consentito di aumentare le aspettative di vita degli italiani, ai più alti livelli mondiali». E ricorda che «l’universalità e la effettiva realizzazione dei diritti di cittadinanza» su scuola, salute, assistenza, sono state «grandi conquiste della Repubblica».
UN’EUROPA SENZA CONFINI. Si rivolge ai familiari di Antonio Megalizzi, il giornalista morto nell’attentato di Strasburgo, per richiamare il senso di un’Europa amica, non ostile, che veda di nuovo l’Italia - Paese fondatore - come protagonista. «Come molti giovani si impegnava per un’Europa con meno confini e più giustizia. Un’Europa dei diritti, dei cittadini e dei popoli, della convivenza, della lotta all’odio, della pace». E il pensiero va all’imminente competizione europea: «Mi auguro che la campagna elettorale si svolga con serenità e sia l’occasione di un serio confronto sul futuro dell’Europa».
LE DIVISE SONO DI TUTTI. Quando poi ricorda il toccante episodio di Anna, la signora 90enne che la notte di Natale ha telefonato ai Carabinieri per chiedere compagnia, lo fa per richiamare il significato collettivo, sentito da tutti e non di parte, di quelle divise. «La loro divisa, come quella di tutte le Forze dell’ordine e quella dei Vigili del fuoco, è il simbolo di istituzioni al servizio della comunità. Si tratta di un patrimonio da salvaguardare perché appartiene a tutti i cittadini». Un grazie va a loro anche per l’aiuto fornito nelle recenti calamità naturali. Nel ricordare poi il grande contributo che i militari danno alla pace, si schiera, con un chiaro riferimento, con il ministro della Difesa Elisabetta Trenta, contro l’ipotesi di un loro arruolamento per porre rimedio alle buche di Roma: «La loro funzione non può essere snaturata, destinandoli a compiti non compatibili con la loro elevata specializzazione», avverte.
IMMIGRATI “AMICI”. Nell’Italia-comunità gli immigrati, per Mattarella, sono una componente, non una realtà contrapposta. Un saluto finale Mattarella lo rivolge «ai cinque milioni che vivono, lavorano, vanno a scuola, praticano sport, nel nostro Paese». Chiude come aveva aperto, parlando di solidarietà e senso della comunità. E ricorda, citando i volontari del Centro di cura per l’autismo, di Verona i tanti «luoghi straordinari dove il rapporto con gli altri non è avvertito come un limite, ma come quello che dà senso alla vita».
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- IL PADRE NOSTRO: BIBBIA, INTERPRETAZIONE, E "LATINORUM".15 novembre 2018, di Federico La Sala
IL PADRE NOSTRO: BIBBIA, INTERPRETAZIONE, E "LATINORUM" ...
Assemblea dei vescovi.
La Cei approva la nuova traduzione di Padre nostro e Gloria
Il documento finale dell’Assemblea generale straordinaria. Lotta alla pedofilia, nasce un Servizio nazionale per la tutela dei minori
di Redazione Internet (Avvenire, giovedì 15 novembre 2018)
L’Assemblea generale della Cei ha approvato la traduzione italiana della terza edizione del Messale Romano, a conclusione di un percorso durato oltre 16 anni. In tale arco di tempo, si legge nel comunicato finale dell’Assemblea generale straordinaria della Cei (12-15 novembre), vescovi ed esperti hanno lavorato al miglioramento del testo sotto il profilo teologico, pastorale e stilistico, nonché alla messa a punto della Presentazione del Messale, che aiuterà non solo a una sua proficua recezione, ma anche a sostenere la pastorale liturgica nel suo insieme.
Il testo della nuova edizione sarà ora sottoposto alla Santa Sede per i provvedimenti di competenza, ottenuti i quali andrà in vigore anche la nuova versione del Padre nostro («non abbandonarci alla tentazione») e dell’inizio del Gloria («pace in terra agli uomini, amati dal Signore»).
Riconsegnare ai fedeli il Messale Romano con un sussidio
Nell’intento dei vescovi, la pubblicazione della nuova edizione costituisce l’occasione per contribuire al rinnovamento della comunità ecclesiale nel solco della riforma liturgica. Di qui la sottolineatura, emersa nei lavori assembleari, relativa alla necessità di un grande impegno formativo. In quest’ottica «si coglie la stonatura di ogni protagonismo individuale, di una creatività che sconfina nell’improvvisazione, come pure di un freddo ritualismo, improntato a un estetismo fine a se stesso». La liturgia, hanno evidenziato i vescovi, coinvolge l’intera assemblea nell’atto di rivolgersi al Signore: «Richiede un’arte celebrativa capace di far emergere il valore sacramentale della Parola di Dio, attingere e alimentare il senso della comunità, promuovendo anche la realtà dei ministeri. Tutta la vita, con i suoi linguaggi, è coinvolta nell’incontro con il Mistero: in modo particolare, si suggerisce di curare la qualità del canto e della musica per le liturgie». Per dare sostanza a questi temi, si è evidenziata l’opportunità di preparare una sorta di «riconsegna al popolo di Dio del Messale Romano» con un sussidio che rilanci l’impegno della pastorale liturgica.
Nasce un Servizio nazionale per la tutela dei minori
Riguardo alla lotta alla pedofilia, dall’Assemblea generale emerge che le Linee guida che la Commissione della Cei per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili sta formulando «chiederanno di rafforzare la promozione della trasparenza e anche una comunicazione attenta a rispondere alle legittime domande di informazioni». La Commissione - che sottoporrà il risultato del suo lavoro alla valutazione della Commissione per la Tutela dei minori della Santa Sede e soprattutto della Congregazione per la dottrina della fede - ha l’impegno di portare le Linee guida all’approvazione del Consiglio permanente, per arrivare a presentarle alla prossima Assemblea generale.
 Si intende, quindi, portarle sul territorio, anche negli incontri delle Conferenze episcopali regionali per facilitare un’assimilazione diffusa di una mentalità nuova, nonché di un pensiero e una prassi comuni.
Si intende, quindi, portarle sul territorio, anche negli incontri delle Conferenze episcopali regionali per facilitare un’assimilazione diffusa di una mentalità nuova, nonché di un pensiero e una prassi comuni.I vescovi hanno approvato due proposte, che consentono di dare concretezza al cammino. È stata condivisa, innanzitutto, la creazione presso la Cei di un Servizio nazionale per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili, con un proprio Statuto, un regolamento e una segreteria stabile, in cui laiche e laici, presbiteri e religiosi esperti saranno a disposizione dei vescovi diocesani. Il Servizio sosterrà nel compito di avviare i percorsi e le realtà diocesani - o inter-diocesani o regionali - di formazione e prevenzione. Inoltre, «potrà offrire consulenza alle diocesi, supportandole nei procedimenti processuali canonici e civili, secondo lo spirito delle norme e degli orientamenti che saranno contenuti nelle nuove Linee guida».
La seconda proposta approvata riguarda le Conferenze episcopali regionali. Si tratta di individuare, diocesi per diocesi, uno o più referenti, da avviare a un percorso di formazione specifica a livello regionale o interregionale, con l’aiuto del Centro per la tutela dei minori dell’Università Gregoriana.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
LA CHIESA DEL SILENZIO E DEL "LATINORUM". Il teologo Ratzinger scrive da papa l’enciclica "Deus caritas est" (2006) e, ancora oggi, nessuno - nemmeno papa Francesco - ne sollecita la correzione del titolo. Che lapsus!!! O, meglio, che progetto!!!
IL PADRE NOSTRO: BIBBIA, INTERPRETAZIONE, E DUEMILA ANNI DI "LATINORUM" CATTOLICO-ROMANO.
STORIA E (FENOMENOLOGIA DELLO) SPIRITO. Il cristianesimo non è un "cattolicismo": il ’cattolicesimo’ è finito...
 IL DRAMMA DEL CATTOLICESIMO ATEO E DEVOTO, HENRI DE LUBAC, E LA POSTERITÀ SPIRITUALE DI GIOACCHINO DA FIORE.
IL DRAMMA DEL CATTOLICESIMO ATEO E DEVOTO, HENRI DE LUBAC, E LA POSTERITÀ SPIRITUALE DI GIOACCHINO DA FIORE.GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. -- "La filologia al servizio delle nazioni. Storia, crisi e prospettive della filologia romanza" (Stefano Rapisarda).25 ottobre 2018, di Federico La Sala
La filologia al servizio delle nazioni. Storia, crisi e prospettive della filologia romanza
di Stefano Rapisarda *
Se un giorno la filologia morisse, la critica morirebbe con lei, la barbarie rinascerebbe, la credulità sarebbe di nuovo padrona del mondo». Così Ernest Renan ne "L’avenir de la science" (1890) tesseva un altissimo elogio della filologia, una delle scienze regine del XIX secolo.
Oggi, al tempo delle fake news e della post-verità, quelle parole ci ricordano che la filologia può essere ancora argine alla barbarie. E ci ricordano che la filologia, quella con aggettivi e quella senza, è intrinsecamente politica. Non è utile o interessante in sé: lo è quando è schierata, militante, "calda", quando tocca interessi, quando serve interessi. Quando è "al servizio" di un Principe o di un partito o di uno Stato o di una visione del mondo.
Ci ricordano insomma che la filologia è anche politica, come sapevano Lorenzo Valla e Baruch Spinoza, Ernest Renan e Ulrich Wilamowitz-Möllendorff, Gaston Paris e Paul Meyer, Eduard Koschwitz e Joseph Bédier, Ernst Robert Curtius e Erich Auerbach, Cesare Segre e Edward Said.
Eppure la filologia, con o senza aggettivi, oggi sa di polvere e di noia. Ciò sollecita varie domande: perché questa antica "scienza del testo" si è ridotta al margine della cultura di oggi? Può tornare al centro dei bisogni intellettuali dell’uomo contemporaneo? Quale tipo di filologia può ancora servire il mondo e servire al mondo?
*
SCHEDA - Academia.Edu
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. -- Nel nome della croce. La distruzione cristiana del mondo classico (Catherine Nixey). No, la violenza non è soltanto dei cristiani (di Mauro Bonazzi).30 settembre 2018, di Federico La Sala
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE.... *
No, la violenza non è soltanto dei cristiani
Catherine Nixey ha scritto un saggio piacevole, scorrevole e inutilmente unilaterale. Che segue sempre lo stesso schema di un’opposizione tra pagani tolleranti e illuminati e seguaci del Vangelo fanatici e ignoranti. Il fatto è che, se non ci liberiamo di queste ricostruzioni arbitrarie e di questi luoghi comuni, non saremo mai capaci di costruire una società su valori condivisi
di Mauro Bonazzi (Corriere della Sera, La Lettura, 30.09.2018)
- Catherine Nixey, Nel nome della croce. La distruzione cristiana del mondo classico, Traduzione di Leonardo Ambasciano, Bollati Boringhieri, Pagine 364, e. 24
«Sono venuto a portare la spada, non la pace!», tuonava Gesù nel Vangelo di Matteo. Nella tarda antichità al posto delle spade venivano usate delle mazze, provvidenzialmente ribattezzate «Israele». Vestiti di nero, con lunghe barbe nere, le brandivano orde di monaci, anonimi e irrintracciabili: arrivavano, colpivano e sparivano, in missione per far sentire la voce del Signore. Altre volte ci si accontentava di bastoni e pietre. Tra i tanti che assaporarono questa forma molto concreta di giustizia divina fu Ipazia, la celebre filosofa e matematica: trascinata in una chiesa, fu scorticata viva; morta, fu fatta a pezzi e le sue membra gettate nel fuoco. Non erano solo gli esseri umani a essere investiti da questa furia. A Palmira, la perla del deserto, fu ad esempio raso al suolo il tempio di Atena e la sua statua tirata giù dal piedistallo, con le braccia mozzate e la testa decapitata. Così, nel volgere di un paio di secoli fu spazzata via una cultura millenaria, quella greca e romana, fatta di terme (dove succedeva di tutto, ma proprio di tutto) e teatri, di poesie erotiche e discussioni filosofiche. C’era stato una volta un mondo capace di godersi la vita, dove ora regnava il terrore di Dio.
Ricordano qualcosa di attuale queste storie di fanatici barbuti e statue abbattute (a Palmira!)? Di sicuro sono vicende che non mancano di una discreta ironia per quanti ricordano il celeberrimo (o famigerato) discorso che Joseph Ratzinger tenne a Ratisbona nel settembre del 2006: negava la legittimità di qualsivoglia legame tra fede e violenza (un legame, suggeriva il Papa maldestramente, forse caratteristico del mondo islamico), rivendicando con chiarezza la necessità di un confronto proficuo con la ragione (il logos dei greci, più precisamente). Chissà che cosa avrebbero risposto Scenute di Atripe, oggi santo della chiesa copta (cristiana), allora instancabile bastonatore (ma non mancava mai di piangere per i nostri peccati, dopo le sue spedizioni) o Tertulliano, uno dei grandi padri della chiesa romana, quello del credo quia absurdum, con tanti saluti ai ragionamenti dei filosofi.
Scritto con grande verve, piacevole e scorrevole, il libro di Catherine Nixey ricostruisce con dovizia di dettagli questi e numerosi altri episodi analoghi, sempre secondo lo stesso schema di un’opposizione tra pagani tolleranti e illuminati contro cristiani fanatici e ignoranti. La tradizione in cui s’inserisce è gloriosa, da Voltaire a Edward Gibbon (passando per esempi meno nobili di scrittori nostrani che campano grazie a un pubblico ristretto ma sempre contento di sentirsi ripetere quanto stupidi siano i cristiani o più in generale i credenti). È però anche inutilmente unilaterale. Il problema non è solo quello dell’attendibilità storica - davvero la tarda antichità è stato questo bagno di sangue e roteare di mazze? In gioco c’è il problema dell’identità europea e occidentale, e del difficile rapporto che essa intrattiene con la tradizione cristiana. Era il tema che stava sullo sfondo del discorso di Ratzinger a Ratisbona. Ne stiamo ancora discutendo.
In una prospettiva strettamente storica il mito di un’opposizione tra pagani illuminati e cristiani fanatici è appunto nient’altro che un mito. Cirillo, il vescovo di Alessandria e il mandante morale dell’assassinio di Ipazia, fu anche un raffinato teologo: brutale e disumano quanto si vuole nelle battaglie politiche, ma non certamente un ignorante. Ancora di meno lo era Origene, di cui si ricorda solo che si era evirato in ossequio a un passo del Vangelo (ma si eviravano anche i sacerdoti di diversi culti misterici pagani, pare, e Ipazia aveva sbattuto in faccia a uno spasimante un assorbente sporco di sangue perché si rendesse conto di cosa fosse l’amore: non era un’epoca particolarmente sensibile alle sirene del corpo, senza troppe distinzioni tra cristiani o pagani); o tanti altri padri della Chiesa, impegnati in dibattiti infiniti e sottilissimi. Raramente si è discusso tanto come in questi secoli. Le mani e la testa di Cicerone appesi ai Rostri per far contento Marco Antonio o la fila infinita di schiavi crocifissi sulla via Appia dopo la rivolta di Spartaco ci ricordano in compenso che la violenza, pubblica o privata, non era certo prerogativa dei soli cristiani. Il punto decisivo è piuttosto che cristiani e pagani con il passare del tempo divennero due comunità compiutamente integrate. Fronteggiandosi da campi ideologici opposti, queste due fazioni hanno finito per rendersi simili l’una all’altra, ritrovandosi in una eredità culturale comune. Ed è questo su cui bisognerebbe riflettere.
Lontana e poco conosciuta, questa storia, fatta di scontri violentissimi e amanuensi che copiavano pazienti pagine e pagine di testi, è infatti molto più attuale di quanto non si creda. Ai tanti che oggi inneggiano al cristianesimo come ultimo baluardo in difesa della nostra civilità andrebbe ricordato che il cristianesimo non è nato qui: è un prodotto orientale, che ha lentamente e inesorabilmente invaso tutte le coste del Mediterraneo. Perché così è stato e così sempre sarà: le persone e le idee si muovono. Ma ai tanti altri che nel cristianesimo vedono solo una lunga e interminabile teoria di errori e violenze andrebbe fatto osservare che lo spazio riservato da questa religione alla ragione, a quello che i Greci chiamavano logos, è davvero significativo. Quando Paolo predicò sull’Areopago, gli Ateniesi lo irrisero per l’assurdità della sua fede. Ma i suoi successori hanno progressivamente sviluppato una teologia, un modo di guardare al mondo e all’uomo, che non aveva niente da invidiare alla filosofia greca. Pur con tutti gli episodi violenti che si possono rievocare, la battaglia tra Gerusalemme e Atene è stata anche, e forse soprattutto, un confronto di idee, che si è conclusa non con la distruzione del nemico, ma con la conservazione (parziale, sia ben chiaro) del suo patrimonio. E con la comprensione dell’importanza dell’intelligenza e delle parole nella vita degli uomini. Era una delle idee che stava alla base del discorso di Ratzinger. Non c’è bisogno di essere credenti per riconoscere che non aveva tutti i torti.
Naturalmente, non si vuole con questo affermare che tutti i problemi siano stati risolti. «Io», aveva risposto Gesù Cristo, quando Ponzio Pilato gli aveva chiesto che cosa fosse la verità. Non è evidentemente una risposta che può soddisfare il non credente. Ma intanto si sono poste le basi per un terreno comune (quello della verità o dell’accordo) su cui ritrovarsi, in cui le istanze opposte possano esprimersi. È il problema della tolleranza, in altre parole, un principio fondamentale oggi che appare difficilmente compatibile con le idee di questi primi cristiani. Ma proprio il confronto con questa tradizione dovrebbe aiutarci a fare chiarezza, impedendo di fare della tolleranza un idolo vuoto: perché una tolleranza illimitata non può che scadere in un relativismo morale per cui ognuno si sente libero di fare quello che vuole a casa sua, disinteressandosi di quello che succede altrove.
Una società ha piuttosto bisogno di una serie di valori condivisi per potersi orientare tra i tanti conflitti potenziali che l’attraversano. E uno dei principi che più hanno contribuito al successo della tradizione cristiana è stato quello di una comunanza di tutti gli esseri umani - «senza distinzioni di genti e classi, liberi e schiavi», scriveva Benedetto Croce.
L’appartenenza degli esseri umani a un’unica famiglia. È un’idea che era stata abbozzata nel mondo greco (dagli stoici) e che sarà ripresa in tutt’altro modo dall’Illuminismo con lo sviluppo dell’idea dei diritti umani. È un’idea che sta alla base della civiltà europea. E di cui andare tanto più orgogliosi proprio oggi che viene criticata da più parti, vuoi perché sentita come una forma sottile di imperialismo vuoi perché incapace di difendere la nostra specificità rispetto alle altre civiltà. Senza negare le violenze che indubbiamente ci sono state, ma consapevoli della nostra storia.
*
Sul tema, nel sito, si cfr.:
-
IL MESSAGGIO EVANGELICO, IL PARADOSSO ISTITUZIONALE DEL MENTITORE, E LA CATASTROFE DELL’EUROPA. “Come fu possibile la hitlerizzazione dell’Imperativo Categorico di Kant? E perché è ancora attuale oggi?” (Emil L. Fackenheim, Tiqqun. Riparare il mondo).
 DISTRUGGERE IL CRISTIANESIMO: IL PROGRAMMA "ANTICRISTO" DEL CATTOLICESIMO-ROMANO. LA LEZIONE CRITICA DI KANT.
DISTRUGGERE IL CRISTIANESIMO: IL PROGRAMMA "ANTICRISTO" DEL CATTOLICESIMO-ROMANO. LA LEZIONE CRITICA DI KANT.
L’EUROPA, IL CRISTIANESIMO ("DEUS CHARITAS EST"), E IL CATTOLICESIMO COSTANTINIANO ("DEUS CARITAS EST"). Una storia di lunga durata...
LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE.
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. -- “Siamo sotto attacco di Satana”. Con un appello che non ha precedenti Papa Francesco chiede ai fedeli di tutto il mondo di pregare il rosario nel mese di ottobre per «proteggere la Chiesa dal diavolo, che sempre mira a dividerci da Dio e tra di noi» (andrea Tornielli).30 settembre 2018, di Federico La Sala
“Siamo sotto attacco di Satana”
L’appello del Papa
di Andrea Tornielli (La Stampa, 30.09.2018)
Con un appello che non ha precedenti Papa Francesco chiede ai fedeli di tutto il mondo di pregare il rosario nel mese di ottobre per «proteggere la Chiesa dal diavolo, che sempre mira a dividerci da Dio e tra di noi». Lo fa rimettendo in auge due antiche preghiere, una alla Madonna e una allo stesso San Michele.
È un’iniziativa che indica quanta sia la preoccupazione del Vescovo di Roma per la piaga degli abusi sui minori, ma anche per l’innalzarsi del livello degli attacchi contro lo stesso Papa e i vescovi, usando in modo strumentale lo scandalo pedofilia per combattere battaglie di potere nella Chiesa e mettere in stato d’accusa il Pontefice, come ha fatto un mese fa, con la sua clamorosa richiesta delle dimissioni papali, l’arcivescovo Carlo Maria Viganò, ex nunzio apostolico negli Stati Uniti.
«Il Santo Padre - ha scritto la Sala Stampa vaticana in un comunicato diffuso a mezzogiorno di ieri - ha deciso di invitare tutti i fedeli, di tutto il mondo, a pregare il Santo Rosario ogni giorno, durante l’intero mese mariano di ottobre; e a unirsi così in comunione e in penitenza, come popolo di Dio, nel chiedere alla Santa Madre di Dio e a San Michele Arcangelo di proteggere la Chiesa dal diavolo, che sempre mira a dividerci da Dio e tra di noi».
Papa Francesco invita tutti i fedeli «a concludere la recita del Rosario con l’antica invocazione “Sub Tuum Praesidium”, e con la preghiera a San Michele Arcangelo che ci protegge e aiuta nella lotta contro il male». La preghiera - aveva affermato Bergoglio lo scorso 11 settembre, in un’omelia a Santa Marta - «è l’arma contro il Grande accusatore che gira per il mondo cercando come accusare».
«Con questa richiesta di intercessione - spiega ancora la Sala Stampa - il Santo Padre chiede ai fedeli di tutto il mondo di pregare perché la Santa Madre di Dio, ponga la Chiesa sotto il suo manto protettivo: per preservarla dagli attacchi del maligno, il grande accusatore, e renderla allo stesso tempo sempre più consapevole delle colpe, degli errori, degli abusi commessi nel presente e nel passato e impegnata a combattere senza nessuna esitazione perché il male non prevalga». Il Papa ha chiesto anche che la recita del rosario durante il mese di ottobre si concluda con la preghiera scritta da Leone XIII: «San Michele Arcangelo, difendici nella lotta: sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio».
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- "LA CHIESA, CORPO DI CRISTO", LA PAROLA DEL PAPA, E LA NECESSITA’ DI UNA "UMILTA’ NUOVA"..16 settembre 2018, di Federico La Sala
"LA CHIESA, CORPO DI CRISTO", LA PAROLA DEL PAPA, E LA NECESSITA’ DI UNA "UMILTA’ NUOVA". IL DRAMMA DEL CATTOLICESIMO ATEO E DEVOTO.... *
- "L’immagine del corpo mistico di Cristo è molto seducente, ma l’importanza che si annette oggi a questa immagine mi pare uno dei sintomi più gravi della nostra decadenza. La nostra vera dignità infatti non sta nell’essere membra di un corpo, anche se mistico, anche se quello di Cristo, ma in questo: nello stato di perfezione, al quale tutti aspiriamo, noi non viviamo più in noi stessi, ma è Cristo che vive in noi; in questa condizione, Cristo nella sua integrità, nella sua unità indivisibile, diviene, in certo senso, ognu no di noi, come è tutto intero nell’ostia. Le ostie non sono frammenti del suo corpo. L’importanza attuale dell’immagine del corpo mistico dimostra quanto i cristiani siano miseramente esposti alle influenze esterne. certo inebriante sentirsi membro del co rpo mistico del Cristo: ma oggi molti altri corpi mistici, che non hanno Cristo come capo, procurino alle proprie membra un’ebbrezza, a mio parere, della stessa natura" (Simone Weil, 1942.)
Pedofilia: la parola profonda e tagliente del Papa.
Se nella Chiesa c’è chi fa muto Dio
di Marina Corradi (Avvenire, sabato 15 settembre 2018)
C’è fra alcuni di noi una stanchezza. Gli episodi di pedofilia nella Chiesa emergono dal passato molto più numerosi di quanto li avremmo mai creduti. Si delinea un male sotterraneo, taciuto, e quasi, in certi ambienti, tollerato. È un’onda fangosa quella che si solleva dall’Irlanda, dagli Usa, dall’Australia e da altrove. Fa scandalo, come è giusto, e fa molto rumore. E appunto alcuni credenti, pure avviliti e addolorati, cominciano a avere una reazione tuttavia di insofferenza: non si sente parlare che di pedofilia, obiettano, non c’è solo questo, la Chiesa è ben altro. La Chiesa, dicono, è piena uomini e donne che fanno del bene senza fare rumore, è fatta anche di missionarie e missionari coraggiosi, di bravi parroci, di suore che curano i figli dei poveri, di laici generosi. È fatta la Chiesa, anche di sconosciuti santi, e di martiri.
Ed è tutto assolutamente vero. Eppure, il Papa giovedì scorso a dei vescovi di recente nomina, tornando sul dramma della pedofilia fra consacrati, ha detto parole drammatiche. Ha detto che le nostre risposte «saranno prive di futuro se non raggiungeranno la voragine spirituale che, in non pochi casi, ha permesso scandalose debolezze, se non metteranno a nudo il vuoto esistenziale che esse hanno alimentato. Se non riveleranno - ha proseguito - perché mai Dio è stato così reso muto, così messo a tacere, così rimosso da un certo modo di vivere, come se non ci fosse».
Dio reso muto. Dio messo a tacere, come se non esistesse. Etsi non daretur. E hanno vissuto, e vivono, così persone consacrate. Taglia come un rasoio questa parola del Papa. Come il bisturi del chirurgo che, aprendo il petto di un paziente, scopre che è ampio, il male da asportare. Non minimizza il Papa, non si consola pensando a tutto il bene fatto dalla Chiesa. Sembra dirci che occorre prendere coscienza del male, tutto intero, di quanto profondo sia stato - tanto da ammutolire Dio.
Francesco ci fa stare davanti al peccato che ha intaccato la Chiesa, senza scappatoie. Un peccato che, nel dolore delle vittime, nel loro scandalo, riguarda anche noi. Coloro che parlavano a dei bambini di Dio erano gli stessi che ne abusavano: ingenerando in loro il pensiero che né degli uomini, né di Dio ci si può fidare. Pensiero che annienta, colpo di scure su giovani piante.
Dio reso muto, Dio rimosso, proprio da chi doveva insegnare ad amarlo. Il dito del Papa non smette di indicarci ciò che è stato. Noi, forse, avremmo la tentazione di dimenticarcene. D’accordo, lo sappiamo, basta adesso. Perché abbiamo il vizio di pensare che gli uomini e le istituzioni siano "buoni", oppure "cattivi". La Chiesa è "buona", e dunque non tolleriamo di constatare quanti abbiano potuto tradire, e nel modo peggiore, con dei bambini. Ci umilia troppo il ricordarlo.
Ma la Chiesa, corpo di Cristo, è fatta da uomini. Contiene in sé, come il cuore di ogni uomo, possibilità di luce e di buio, di generosità fedele e silenziosa, di eroismo, ma anche di diserzione vigliacca, sotto a ordinate apparenze. E chi conosce il labirinto del suo cuore, e a una certa età almeno bisognerebbe conoscerlo, può guadare allo scandalo che il Papa continua a indicarci, senza domandare che si parli d’altro.
Si può stare a viso aperto davanti a tanto male compiuto in mezzo a noi, solo se non ci si sente orgogliosamente "buoni", "onesti", intoccabili dalla miseria umana. Nessuno è buono, ci ha insegnato Gesù Cristo. Siamo tutti poveri, dei miserabili che mendicano la grazia di Dio. È quella grazia, domandata ogni mattina, che ci permette di fare del bene, che ci allontana dalla attrazione del male. Non un nostro essere "bravi".
«Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me peccatore» era la litania dei monaci della tradizione greco-bizantina, ripetuta come un respiro, come una domanda inesausta. In questa coscienza di mendicanti possiamo stare di fronte alle parole del Papa, al tragico Dio muto che ha evocato, e non perdere il coraggio. In un travaglio che potrebbe portarci a una umiltà nuova.
 Nessuno è buono, e c’è in ciascuno di noi la possibilità del male. Bisogna ostinatamente domandare. Il peccato dentro la Chiesa che si leva alto come un’onda non ci travolge, se non lo censuriamo; ma, più coscienti del nostro e altrui male, ci ricordiamo che l’autentica santità, come ha concluso l’altro giorno Francesco, «è quella che Dio compie in noi».
Nessuno è buono, e c’è in ciascuno di noi la possibilità del male. Bisogna ostinatamente domandare. Il peccato dentro la Chiesa che si leva alto come un’onda non ci travolge, se non lo censuriamo; ma, più coscienti del nostro e altrui male, ci ricordiamo che l’autentica santità, come ha concluso l’altro giorno Francesco, «è quella che Dio compie in noi».
Sul tema, nel sito, si cfr.:
"TEBE": IN VATICANO NON C’E’ SOLO LA "SFINGE" - C’E’ LA "PESTE"!!! Caro Benedetto XVI ... DIFENDIAMO LA FAMIGLIA!? MA QUALE FAMIGLIA - QUELLA DI GESU’ (Maria - e Giuseppe!!!) O QUELLA DI EDIPO (Laio e Giocasta)?!
- IL DRAMMA DEL CATTOLICESIMO ATEO E DEVOTO. L’EUROPA, IL CRISTIANESIMO ("DEUS CHARITAS EST"), E IL CATTOLICESIMO COSTANTINIANO ("DEUS CARITAS EST").Una storia di lunga durata...
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
Federico La Sala
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- "LA CHIESA, CORPO DI CRISTO", LA PAROLA DEL PAPA, E -- La Chiesa a scuola di Bannon per creare una fronda anti-Papa Francesco (di Paolo Rodari).17 settembre 2018, di Federico La Sala
In campo l’ex stratega di Trump
La Chiesa a scuola di Bannon per creare una fronda anti-Papa
Al via un corso presso l’Istituto Dignitatis Humanae, presieduto dal cardinale Burke
di Paolo Rodari (la Repubblica, 17.09.2018)
CITTÀ DEL VATICANO Piomba sul Vaticano alle prese con la stesura di una risposta al dossier dell’ex nunzio a Washington Carlo Maria Viganò la notizia che l’ex stratega di Trump, Steve Bannon, sta organizzando in collaborazione con l’Istituto " Dignitatis Humanae" di Roma un corso di leadership per "politici cattolici conservatori", una vera e propria fazione populista, nazionalista e conservatrice che dall’intero del mondo cattolico va nella sostanza a contrastare il magistero di papa Bergoglio.
Bannon, cattolico su posizioni oltranziste e contrastanti al papato, legato al cardinale statunitense ultraconservatore Raymond Burke e al mondo che ha prodotto il dossier Viganò. E anche se apparentemente prende le distanze da Viganò dicendo che Francesco «non dovrebbe assolutamente dimettersi» perché «è il vicario di Cristo sulla terra», in realtà l’azione dei conservatori americani in opposizione a Francesco appare studiata e frontale e assume sempre più i contorni di una strategia studiata a tavolino. La volontà di Bannon di lasciare il Papa al suo posto sembra motivata più che altro dal fatto che così la leadership del vescovo di Roma si logora meglio. Bannon, non a caso, dice senza remore che la risposta del Papa sulla pedofilia è insufficiente e che «la gente deve capire la portata del danno inferto dalla e alla Chiesa cattolica » . Per questo invoca « un Tribunale indipendente dalla Chiesa» sulla pedofilia. Anche perché, dice, la convocazione a Roma a febbraio dei capi dell’episcopato mondiale «è troppo tardi».
L’Istituto " Dignitatis Humanae" non è fondazione neutrale. Compagine religiosa di orientamento conservatore, ha scelto come sua base di lavoro l’abazia di Trisulti, passata all’ala tradizionalista dopo che gli ultimi tre monaci ormai anziani sono rientrati a Casamari. L’antico convento, a un centinaio di chilometri a Sudest di Roma, potrà ospitare anche 250- 300 studenti alla volta e, secondo quanto ha dichiarato il direttore Benjamin Harnwell, porterà avanti i lavori di quello che è a tutti gli effetti un think tank di stampo catto- tradizionalista che vuole proteggere e promuovere la dignità umana sulla base della « verità antropologica » che l’uomo sia nato a immagine e somiglianza di Dio. L’obiettivo è di favorire questa visione sostenendo i cristiani nella vita pubblica «aiutandoli a presentare risposte efficaci e coerenti a sforzi crescenti per zittire la voce cristiana nella pubblica piazza » . Un’attività che viene svolta coordinando anche i gruppi di lavoro parlamentari «affiliati sulla dignità umana in tutto il mondo».
E forse non è un caso che una settimana fa il cardinale di riferimento Burke (presiederà il think tank) abbia scelto il Senato per presentare il suo ultimo libro «Chiesa Cattolica, dove vai? Una dichiarazione di fedeltà». Come a dire: è da qui che certi valori debbono essere annunciati. A soffiare contro il magistero di Bergoglio c’è anche quell’ala cattolica italiana che non ha remore a guardare a Salvini e al suo mondo. Bannon, lanciando a Roma " The Movement", ha dichiarato: « Salvini è un leader mondiale».
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- LOTTA AGLI ABUSI. Papa Francesco sentito il Consiglio di cardinali, ha deciso di convocare una riunione con i presidenti delle Conferenze episcopali della Chiesa cattolica sul tema della protezione dei minori e degli adulti vulnerabili.13 settembre 2018, di Federico La Sala
Santa Sede.
Lotta agli abusi, il Papa convoca i capi dei vescovi di tutto il mondo
L’annuncio al termine della riunione dei 9 Cardinali. L’incontro sarà in Vaticano dal 21 al 24 febbraio 2019. Sul tavolo il tema della protezione dei minori e della prevenzione degli abusi
di Riccardo Maccioni (Avvenire, mercoledì 12 settembre 2018)
- [Foto] Il Sinodo dei vescovi del maggio 2018 (Ansa)
Una decisione forte, che esprime la volontà fermissima di fare verità su una piaga che va sanata al più presto. Papa Francesco sentito il Consiglio di cardinali, ha deciso di convocare una riunione con i presidenti delle Conferenze episcopali della Chiesa cattolica sul tema della protezione dei minori e degli adulti vulnerabili.
 L’annuncio è contenuto nel comunicato che conclude la XXVI riunione del cosiddetto C9, il gruppo di porporati cui lo stesso Pontefice ha affidato il compito di aiutarlo nella riforma della Curia e nel governo della Chiesa universale. Un tema quello degli abusi, rilanciato dal recente dossier sulla diocesi della Pennsylvania e dal caso McCarrick, ampiamente trattato, come recita la nota finale, nella riunione di cardinali, iniziata lunedì per concludersi stamani.
L’annuncio è contenuto nel comunicato che conclude la XXVI riunione del cosiddetto C9, il gruppo di porporati cui lo stesso Pontefice ha affidato il compito di aiutarlo nella riforma della Curia e nel governo della Chiesa universale. Un tema quello degli abusi, rilanciato dal recente dossier sulla diocesi della Pennsylvania e dal caso McCarrick, ampiamente trattato, come recita la nota finale, nella riunione di cardinali, iniziata lunedì per concludersi stamani.- [Foto] Una riunione del C9 (Foto Osservatore Romano)
Il vertice con i tutti i leader degli episcopati rilancia una volta di più la volontà di adottare misure idonee alla prevenzione e alla tutela delle vittime e, allo stesso tempo rappresenta una presa d’atto di come il problema si ancora drammaticamente caldo. Il tutto si svolgerà nella linea della tolleranza zero, che Bergoglio ha adottato sin dall’inizio del suo pontificato, proseguendo la rotta indicata da papa Ratzinger.
Domani l’incontro con i vertici dell’Episcopato Usa
Un anticipo dell’appuntamento di febbraio si avrà comunque già domani, giovedì. quando saranno ricevuti in Vaticano i vertici della Conferenza episcopale statunitense. In particolare il Papa incontrerà il cardinale Daniel DiNardo, arcivescovo di Galveston-Houston e presidente dei vescovi Usa, il cardinale Sean Patrick O’Malley, arcivescovo di Boston e presidente della Pontificia Commissione per la tutela dei minori, monsignor José Horacio Gomez arcivescovo di Los Angeles, vicepresidente dell’episcopato e il segretario generale monsignor Brian Bransfield.
Non imminente un ricambio nel C9
Naturalmente il C9 ha affrontato ha anche gli argomenti per cui è nato. Come ha sottolineato la vicedirettrice della Sala Stampa vaticana, Paloma Garcia Ovejero, «gran parte dei lavori del Consiglio e stata dedicata agli ultimi aggiustamenti della bozza della nuova Costituzione Apostolica della Curia romana, il cui titolo provvisorio e “Praedicate evangelium”. Il Consiglio di cardinali ha già consegnato, in proposito, il testo provvisorio che, comunque, e destinato ad una revisione stilistica e ad una rilettura canonistica».
Inoltre come comunicato lunedì scorso, durante la prima sessione di questa XXVI riunione, il C9 «ha chiesto al Papa una riflessione sul lavoro, la struttura e la composizione dello stesso Consiglio, tenendo anche conto dell’età avanzata di alcuni membri». In proposito la vicedirettrice della Sala Stampa ha detto che «per dicembre non ci saranno nuovi membri del C9» aggiungendo che «se ci saranno cambiamenti, vedremo». Procedendo nei lavori per la riforma della Curia romana infine il Consiglio che «ancora una volta ha espresso piena solidarietà a papa Francesco per quando accaduto nelle ultime settimane», vedi dossier Viganò, «si è concluso con la rilettura dei testi già preparati facendo motivo di attenzione la cura pastorale per il personale che vi lavora». Dei 9 porporati che costituiscono il C9 mancavano il cardinale australiano George Pell, l’85 enne cardinale cileno Francisco Javier Errazuriz e il quasi 79enne cardinale africano Laurent Monsengwo Pasinya.
«Il Santo Padre, come di consueto, informa il comunicato finale del C9, ha partecipato ai lavori, anche se e stato assente in tre momenti: lunedì in fine mattinata, per l’udienza al cardinale Beniamino Stella; martedì mattina, per la visita ad limina apostolorum della Conferenza episcopale Venezuela e questa mattina per l’Udienza generale».
La Cei: non per fermarsi all’abuso
E sempre in tema di abusi, il sottosegretario della Cei e direttore dell’Ufficio nazionale per la comunicazioni sociali della Conferenza episcopale italiana cita l’incontro, annunciato nei giorni scorsi dal C9 e svoltosi ieri. «Ascolto delle vittime, impegno di educazione, formazione e comunicazione, stesura di Linee guida e di norme per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili. Sono questi - scrive don Ivan Maffeis - i temi approfonditi nell’incontro che ieri - martedì 11 settembre - ha visto insieme la Pontificia Commissione per la tutela dei minori con la corrispondente Commissione della Cei. Una collaborazione fattiva, che mira soprattutto all’elaborazione di proposte, iniziative e strumenti di prevenzione da offrire alle diocesi. Per non fermarsi a condannare l’abuso e promuovere una cultura della persona e della sua dignità».
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- SULLA PEDOFILIA, L’ALLARME DELLA RIVISTA "CONCILIUM" (3/2004) E IL COLPEVOLE SILENZIO DEL VATICANO.
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
STORIA E (FENOMENOLOGIA DELLO) SPIRITO. Il cristianesimo non è un "cattolicismo": il ’cattolicesimo’ è finito...
 IL DRAMMA DEL CATTOLICESIMO ATEO E DEVOTO
IL DRAMMA DEL CATTOLICESIMO ATEO E DEVOTOUN NUOVO CONCILIO, SUBITO. 95 TESI? NE BASTA UNA SOLA! Cattolicesimo, fascismo, nazismo, stalinismo: il sogno del "regno di ‘dio’" in un solo ‘paese’ è finito.
Federico La Sala
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- LOTTA AGLI ABUSI. Papa Francesco: più attenti nella selezione dei preti, per prevenire nuove "scandalose debolezze".13 settembre 2018, di Federico La Sala
L’incontro.
Il Papa: più attenti nella selezione dei preti
Nel discorso ai vescovi di recente nomina il forte richiamo di Francesco a una particolare attenzione al clero e ai Seminari per prevenire nuove "scandalose debolezze".
di Riccardo Maccioni (Avvenire, giovedì 13 settembre 2018)
- [Foto] Papa Francesco con un gruppo di vescovi
Occorre «una particolare attenzione al clero e ai Seminari». È la raccomandazione che il Papa rivolge ai presuli di recente nomina dipendenti dalla Congregazione per i vescovi e da quella per le Chiese Orientali. L’occasione è il Corso promosso dal dicastero vaticano che si occupa della loro nomina e formazione.
Il compito urgente della santità
Nel suo discorso, ampio e articolato Francesco sottolinea come il compito più urgente affidato ai vescovi sia quello della santità. Un itinerario che chiede di restare vigili anche quando sparisce la luce, che non può alimentarsi di «una dedizione intermittente, di una fedeltà a fasi alterne, di una obbedienza selettiva» ma chiama a «consumarsi giorno e notte». Per riuscirsi occorre «mettere Dio al centro». Si tratta di «rimanere fedeli anche quando, nel calore del giorno, vengono meno le forze della perseveranza e il risultato della fatica più non dipende delle risorse che abbiamo» E tutto questo - prosegue il Papa - «non per alimentare la narcisistica pretesa di essere essenziali, ma per rendere il Padre propizio al vostro popolo. Dio» infatti, «è già a favore dell’uomo».
L’invito quindi è a tenere «fisso lo sguardo sul Signore Gesù in modo» che «abituandosi alla sua luce» si riesca «incessantemente anche dove essa si rifrange, sia pure attraverso umili bagliori».
«So bene - aggiunge il Pontefice - quanto nel nostro tempo imperversano solitudine e abbandono, dilaga l’individualismo e cresce l’indifferenza al destino degli altri. Milioni di uomini e donne, bambini, giovani sono smarriti in una realtà che ha oscurato i punti di riferimento, sono destabilizzati dall’angoscia di appartenere a nulla. La loro sorte non interpella la coscienza di tutti e spesso, purtroppo, coloro che avrebbero le maggiori responsabilità, colpevolmente si scansano. Ma a noi non è consentito ignorare la carne di Cristo, che ci è stata affidata non soltanto nel Sacramento che spezziamo, ma anche nel Popolo che abbiamo ereditato».
Aggiornare la selezione e l’accompagnamento
Mai dunque dimenticare la vicinanza a chi ha bisogno, ma trascurare quello che è il primo obiettivo della Chiesa: «distribuire nel mondo il vino nuovo che è Cristo. Niente ci può distogliere da questa missione». Al tempo stesso mai «vergognarsi della carne delle vostre Chiese - chiede il Papa ai vescovi -. Entrate in dialogo con le loro domande. Vi raccomando una particolare attenzione al clero e ai seminari. Non possiamo rispondere alle sfide che abbiamo nei loro confronti senza aggiornare i nostri processi di selezione, accompagnamento, valutazione. Ma le nostre risposte saranno prive di futuro se non raggiungeranno la voragine spirituale che, in non pochi casi, ha permesso scandalose debolezze, se non metteranno a nudo il vuoto esistenziale che esse hanno alimentato, se non riveleranno perché mai Dio è stato così reso muto, così messo a tacere, così rimosso da un certo modo di vivere, come se non ci fosse».
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. -- L’Europa - L’Italia è ora in un punto di passaggio critico. La democrazia svanisce se diventa illiberale (di Sabino Cassese)29 agosto 2018, di Federico La Sala
La democrazia svanisce se diventa illiberale
di Sabino Cassese (Corriere della Sera, 29.0820.18)
Il vicepresidente del Consiglio dei ministri italiano ha incontrato a Milano il primo ministro ungherese Viktor Mihály Orbán. Quest’ultimo ha dichiarato già da tempo che «i valori liberali occidentali oggi includono la corruzione, il sesso, la violenza» e che «i valori conservatori della patria e dell’identità culturale prendono il sopravvento sull’identità della persona». Ispirato da questi orientamenti, ha poi trasformato la televisione pubblica in un mezzo di propaganda governativa, limitato la libertà di stampa, l’autonomia universitaria e l’indipendenza dell’ordine giudiziario.
Ha inoltre ridisegnato i collegi elettorali, fatto approvare una legge elettorale che gli consente di avere la maggioranza di due terzi dei seggi in Parlamento, con il 45 per cento dei voti, dato una svolta nazionalistica e anti-immigrazione al governo. Il maggiore esperto dei problemi ungheresi, la professoressa Kim Lane Scheppele, dell’Università di Princeton, ritiene che oggi l’Ungheria abbia una «costituzione incostituzionale» e il «Washington Post» qualche mese fa ha intitolato una sua analisi della situazione ungherese «la democrazia sta morendo in Ungheria e il resto del mondo dovrebbe preoccuparsi». Orbán, tuttavia, è stato eletto e rieletto, e gode quindi di un consenso popolare. Perché allora tante voci preoccupate? Basta il voto popolare per legittimare limitazioni delle libertà?
Il primo ministro ungherese ha dichiarato più volte di voler realizzare una «democrazia illiberale». Questo è un disegno impossibile perché la democrazia non può non essere liberale.
La democrazia non può fare a meno delle libertà perché essa non si esaurisce, come ritengono molti, nelle elezioni. Se non c’è libertà di parola, o i mezzi di comunicazione sono nelle mani del governo, non ci si può esprimere liberamente, e quindi non si può far parte di quello spazio pubblico nel quale si formano gli orientamenti collettivi. Se la libertà di associazione e quella di riunione sono impedite o limitate, non ci si può organizzare in partiti o movimenti, e la società civile può votare, ma non organizzare consenso o dissenso. Se i mezzi di produzione sono concentrati nelle mani dello Stato, non c’è libertà di impresa, e le risorse economiche possono prendere soltanto la strada che sarà indicata dal governo.
 Se l’ordine giudiziario non è indipendente, non c’è uno scudo per le libertà. Se la libertà personale può essere limitata per ordine del ministro dell’Interno (come è accaduto nei giorni scorsi in Italia), i diritti dei cittadini sono in pericolo. Insomma, come ha osservato già nel 1925 un grande studioso, Guido De Ruggiero, nella sua «Storia del liberalismo europeo», i principi democratici sono «la logica esplicazione delle premesse ideali del liberalismo»: estensione dei diritti individuali a tutti i membri della comunità e diritto del popolo di governarsi. Quindi, «una divisione di province tra liberalismo e democrazia non è possibile». Una «democrazia illiberale» non è una democrazia.
Se l’ordine giudiziario non è indipendente, non c’è uno scudo per le libertà. Se la libertà personale può essere limitata per ordine del ministro dell’Interno (come è accaduto nei giorni scorsi in Italia), i diritti dei cittadini sono in pericolo. Insomma, come ha osservato già nel 1925 un grande studioso, Guido De Ruggiero, nella sua «Storia del liberalismo europeo», i principi democratici sono «la logica esplicazione delle premesse ideali del liberalismo»: estensione dei diritti individuali a tutti i membri della comunità e diritto del popolo di governarsi. Quindi, «una divisione di province tra liberalismo e democrazia non è possibile». Una «democrazia illiberale» non è una democrazia.Tutto il patrimonio del liberalismo è parte essenziale della democrazia, così come oggi lo è quello del socialismo. Queste tre grandi istanze che si sono succedute negli ultimi due secoli in Europa e nel mondo, fanno ormai corpo. Il liberalismo con le libertà degli uomini e l’indipendenza dei giudici. L’ideale democratico, con l’eguaglianza e il diritto di tutti di partecipare alla vita collettiva (suffragio universale). Il socialismo con lo Stato del benessere e la libertà dal bisogno (sanità, istruzione, lavoro, protezione sociale). Questi tre grandi movimenti, pur essendosi affermati in età diverse, e pur essendo stati inizialmente in conflitto tra loro (come ha spiegato magistralmente, nel 1932, Benedetto Croce nella sua “Storia d’Europa nel secolo decimonono”) fanno ora parte di un patrimonio unitario e inalienabile come è dimostrato da due importanti documenti internazionali, il Trattato sull’Unione europea e la Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite. Il primo dispone che l’Unione “si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto”. Il secondo che le Nazioni Unite si impegnano a «promuovere la democrazia e a rafforzare il rispetto per tutti i diritti umani e le libertà fondamentali».
L’Italia è ora in un punto di passaggio critico, nel quale si decide il futuro delle sue libertà e la sua collocazione internazionale, tra quelli che sono stati per secoli i nostri «compagni di strada» ed esempi (Francia, Germania, Regno Unito) o nuovi alleati. Che significato possiamo attribuire a un «incontro esclusivamente politico e non istituzionale o governativo», ma tenuto in Prefettura, tra il primo ministro ungherese e un vicepresidente del Consiglio dei ministri italiano?
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. -- EICHMANN A GERUSALEMME (1961). Come fu possibile la hitlerizzazione dell’Imperativo Categorico di Kant? E perché è ancora attuale oggi (Emil L. Fackenheim).28 agosto 2018, di Federico La Sala
EICHMANN A GERUSALEMME (1961). “come fu possibile la hitlerizzazione dell’Imperativo Categorico di Kant? E perché è ancora attuale oggi?” (Emil L. Fackenheim, Tiqqun. Riparare il mondo). *
Così Hannah Arendt descrisse (nel ’51) i populismi del Terzo millennio
L’inquietante attualità di “Le origini del totalitarismo”
- [Foto] Adolf Hitler e Joseph Goebbels al Teatro di Charlottenburg, a Berlino, in un’immagine scattata nel 1939 da Hugo Jaeger, fotografo personale del Führer fin dagli anni della sua ascesa al potere, uno dei pochi, all’epoca, a utilizzare il colore. Negli ultimi giorni della guerra seppellì le sue foto in 12 vasi di vetro nei dintorni di Monaco. Le recuperò dieci anni dopo e nel ’65 le vendette alla rivista Life
di Christian Rocca (La Stampa, 23.08.18)
Le origini del totalitarismo, il saggio scritto nel 1951 dalla politologa Hannah Arendt, è considerato uno dei libri più importanti del XX Secolo per l’analisi dei movimenti politici totalitari d’inizio ’900, in particolare del nazismo e dello stalinismo (secondo Arendt, il fascismo era invece un movimento nazionalista e autoritario). All’indomani dell’elezione di Donald Trump, i giornali internazionali segnalarono la ritrovata popolarità del saggio di Arendt, assieme a 1984 di George Orwell, e rileggendo l’ultima parte del saggio, quella dedicata alla trasformazione delle classi in masse, al ruolo della propaganda e all’organizzazione dei movimenti, si capisce bene perché.
Arendt descriveva il nuovo soggetto politico come «la folta schiera di persone politicamente neutrali che non aderiscono mai a un partito e fanno fatica a recarsi alle urne».
Fuori e contro il sistema dei partiti, indifferenti agli argomenti degli avversari
Secondo Arendt, i movimenti totalitari europei «reclutarono i loro membri da questa massa di gente manifestamente indifferente, che tutti gli altri partiti avevano lasciato da parte perché troppo apatica o troppo stupida. Il risultato fu che in maggioranza furono composti da persone che non erano mai apparse prima sulla scena politica. Ciò consentì l’introduzione di metodi interamente nuovi nella propaganda e un atteggiamento d’indifferenza per gli argomenti degli avversari; oltre a porsi al di fuori e contro il sistema dei partiti nel suo insieme, tali movimenti trovarono un seguito in settori che non erano mai stati raggiunti, o “guastati”, da quel sistema».
Se l’analisi è familiare, è proprio perché ricorda il reclutamento popolare e di classe dirigente dei nuovi partiti populisti occidentali di questo scorcio di secolo. Allora come adesso, prendendo a prestito le parole di Arendt, questi movimenti «misero in luce quel che nessun organo dell’opinione pubblica aveva saputo rilevare, che la costituzione democratica si basava sulla tacita approvazione e tolleranza dei settori della popolazione politicamente grigi e inattivi non meno che sulle istituzioni pubbliche articolate e organizzate».
Arendt elenca gli errori dei partiti politici tradizionali e la complicità delle élite borghesi tra le concause del successo dei movimenti totalitari ma, di nuovo, è impressionante quanto la fotografia del risveglio delle masse di allora rimandi a quella attuale: «Il crollo della muraglia protettiva classista trasformò le maggioranze addormentate, fino allora a rimorchio dei partiti, in una grande massa, disorganizzata e amorfa, di individui pieni d’odio che non avevano nulla in comune tranne la vaga idea che (...) i rappresentanti della comunità rispettati come i suoi membri più preparati e perspicaci fossero in realtà dei folli, alleatisi con le potenze dominanti per portare, nella loro stupidità o bassezza fraudolenta, tutti gli altri alla rovina».
Una profezia sulle conseguenze politiche di un dibattito pubblico guidato dalla postverità
Anche le pagine dedicate all’organizzazione dei movimenti totalitari degli Anni Trenta sembrano cronaca dei nostri giorni: «Sono organizzazioni di massa di individui atomizzati e isolati, da cui, in confronto degli altri partiti e movimenti, esigono una dedizione e fedeltà incondizionata e illimitata; ciò da prima della conquista del potere, in base all’affermazione, ideologicamente giustificata, che essi abbracceranno a tempo debito l’intera razza umana» e, per questo, «sono stati definiti società segrete operanti alla chiara luce del giorno» perché, come queste, «adottano una strategia di coerenti menzogne per ingannare le masse esterne di profani, esigono obbedienza cieca dai loro seguaci, uniti dalla fedeltà a un capo spesso sconosciuto e sempre misterioso».
E se non fosse chiaro, anche in tempi di fake news e post verità, Arendt continua così: «Forse il massimo servizio reso alle società segrete come modello ai movimenti totalitari è l’introduzione della menzogna coerente come mezzo per salvaguardare il loro mondo fittizio. L’intera gerarchia dei movimenti, dall’ingenuo simpatizzante al membro del partito, alle formazioni d’élite, all’intima cerchia intorno al capo, e al capo stesso, può essere descritta dal punto di vista del curioso miscuglio di credulità e cinismo in varie proporzioni con cui ciascun militante, secondo il suo rango, deve reagire alle mutevoli affermazioni menzognere dei dirigenti e all’immutabile finzione ideologica centrale».
In un passaggio, citato anche dal recente libro di Michiko Kakutani, The Death of Truth, Arendt scrive: «In un mondo in continuo mutamento, e sempre più incomprensibile, le masse erano giunte al punto di credere tutto e niente, da pensare che tutto era possibile e niente era vero».
La grande novità degli Anni 30, che pare non sia servita da lezione al mondo contemporaneo, era che «la propaganda di massa scoprì che il suo pubblico era pronto in ogni momento a credere al peggio, per quanto assurdo, senza ribellarsi se lo si ingannava, convinto com’era che qualsiasi affermazione fosse in ogni caso una menzogna. I capi totalitari basarono quindi la loro agitazione sul presupposto psicologicamente esatto che in tali condizioni la gente poteva essere indotta ad accettare le frottole più fantastiche e il giorno dopo, di fronte alla prova inconfutabile della loro falsità, dichiarare di aver sempre saputo che si trattava di una menzogna e di ammirare chi aveva mentito per la sua superiore abilità tattica».
Pensando al nazismo e al comunismo, Arendt ha spiegato perché sono falliti i tentativi di neutralizzarli, e la spiegazione è più che mai attuale: «Uno dei principali svantaggi del mondo esterno nei rapporti coi regimi totalitari è stato costituito dal fatto che, ignorando tale sistema, esso confidava che la stessa enormità delle menzogne ne avrebbe causato la rovina o che, prendendo in parola il capo, sarebbe stato possibile costringerlo a rispettare gli impegni, a dispetto delle intenzioni ordinarie. -Il sistema totalitario è purtroppo al sicuro da queste conseguenze normali; la sua ingegnosità sta appunto nell’eliminazione di quella realtà che smaschera il bugiardo o lo obbliga ad adeguarsi alla sua simulazione». Quella di Arendt, insomma, è l’analisi storica sulle origini del totalitarismo, ma riletta oggi suona anche come una profezia sulle conseguenze politiche di un dibattito pubblico che non si basa più sui dati di fatto e che si lascia guidare dalla post-verità.
*
Sul tema, nel sito, si cfr.:
"LEZIONE SU KANT" A GERUSALEMME: PARLA EICHMANN "PILATO", IL SUDDITO DELL’"IMPERATORE-DIO". Il ’sonnambulismo’ di Hannah Arendt prima e di Emil Fackenheim dopo.
HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI.
- LA "PROFEZIA" DI MARSHALL MCLUHAN: NARCISO E LA MORTE DELL’ITALIA. Il "rimorso di incoscienza" di Marshall McLuhan
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
Federico La Sala
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. -- VATICANO. Lo scandalo che il papa non riesce ad arginare. Per la chiesa, una scossa tellurica capace di fare tremare le fondamenta.27 agosto 2018, di Federico La Sala
VATICANO
Lo scandalo che il papa non riesce ad arginare
di Francesco Peloso, giornalista (Internazionale, 21 agosto 2018)
Un colpo durissimo per la chiesa, una scossa tellurica capace di fare tremare le fondamenta dell’istituzione. È questo l’effetto del rapporto di circa 900 pagine messo a punto da un grand giurì della Pennsylvania al termine di due anni di indagini sugli abusi sessuali commessi da rappresentanti del clero in sei delle otto diocesi dello stato negli ultimi settant’anni. Il quadro - così come presentato alla stampa da Josh Shapiro, procuratore generale dello stato - è devastante: più di trecento preti hanno commesso violenze sessuali, mille le vittime fra bambini e minori. L’ipotesi però è che siano molte di più: in tanti hanno avuto paura di denunciare i fatti mentre numerosi documenti sono stati distrutti o sono spariti dagli archivi segreti delle diocesi.
Proprio quest’ultimo è un punto chiave dell’indagine, la più ampia e completa mai condotta negli Stati Uniti. Dalle 500mila pagine di documenti analizzati sono emersi gli elementi che consentono di descrivere una strategia dell’insabbiamento messa in atto dalle gerarchie ecclesiastiche per nascondere gli abusi all’opinione pubblica ed evitare il carcere ai sacerdoti predatori (come vengono definiti). All’inchiesta ha contribuito anche l’Fbi. Alcuni agenti del Center for the analysis of violent crime hanno fatto venire alla luce i metodi di insabbiamento.
Tra le opzioni più frequenti spiccano quelle sul linguaggio, come l’indicazione di non usare mai il termine “stupro” ma la più asettica definizione di “comportamento inappropriato”. Soprattutto, è delineata una pianificazione del depistaggio con alcuni elementi ricorrenti: lo svolgimento di indagini incerte e superficiali, evitando che a condurle fosse un personale “adeguatamente formato”; il provvedimento, tutto di facciata, di mandare per qualche tempo il prete colpevole in una clinica psichiatrica o in un istituito specializzato per una opportuna “valutazione”; lo spostamento in un’altra diocesi del sacerdote di cui è certa la responsabilità. Per giustificare questi spostamenti, tutte le diocesi negavano le ragioni vere e parlavano invece di “esaurimento nervoso” o “congedo per malattia”. Un sistema di coperture che si fondava sul ruolo decisivo dei vescovi, cioè delle massime autorità della chiesa locale.
Evitare lo scandalo
Si tratta di uno scenario in parte noto, venuto alla luce a pezzi in varie inchieste e indagini negli ultimi anni, ma che ora trova una sua organicità e precisione tale da ridisegnare in modo definitivo il livello di responsabilità delle persone coinvolte nell’azione di copertura. La documentazione trovata negli archivi segreti delle diocesi riafferma un principio base che ritorna nelle indagini sugli abusi da parte del clero in varie parti del mondo: “evitare lo scandalo”, piuttosto che proteggere le vittime.
Le chiavi dell’archivio segreto, per altro, secondo quanto stabilito dal codice di diritto canonico, devono essere in possesso “del solo vescovo”. Lo stesso codice stabilisce altresì che “ogni anno si distruggano i documenti che riguardano le cause criminali in materia di costumi, se i rei sono morti oppure se tali cause si sono concluse da un decennio con una sentenza di condanna, conservando però un breve sommario del fatto con il testo della sentenza definitiva”; una norma che, evidentemente, è stata variamente interpretata.
I casi specifici messi in evidenza dall’ufficio del procuratore sono raccapriccianti. Nella diocesi di Pittsburgh un gruppo di almeno quattro sacerdoti ha abusato di vari ragazzi. Uno di loro, non ancora diciottenne, è stato costretto a restare in piedi nudo sul letto di una canonica, posando come Cristo sulla croce per i sacerdoti abusatori. Questi ultimi hanno scattato fotografie alla vittima, inserendole poi in una più ampia raccolta di materiale pedopornografico condivisa con altri sacerdoti. Comportamenti sadomasochisti, uso di fruste, torture, violenze su bambini e bambine di pochi anni, penetrazioni anali, sesso orale e poi violenze psicologiche sulle stesse vittime, ragazze messe incinte e poi costrette ad abortire. È un catalogo sconvolgente di brutalità e comportamenti sadici, feticismi - come quello del prete che raccoglieva urine e mestruo delle ragazze violentate - conditi da paternalismo e da minacce, da una cultura del segreto, complicità morbosa, protezioni.
La gran parte di questi reati è caduta in prescrizione, mentre per gli anni più recenti l’accesso alla documentazione è stato complicato. Il procuratore Shapiro ha fatto proprie alcune raccomandazioni del gran giurì, tra cui la richiesta di eliminare i limiti di età alle denunce per i crimini contro i minori, la possibilità per le vittime più grandi di fare causa per danni, una legislazione adeguata che sanzioni l’omissione delle denunce di abusi sui minori e soprattutto un chiarimento circa il fatto che gli accordi di riservatezza non hanno valore rispetto a quanto una vittima possa riferire alla polizia.
In un paio di casi la giustizia è riuscita a indagare i preti abusatori, mentre nell’occhio del ciclone è finto il cardinale Donald Wuerl, oggi arcivescovo di Washington, accusato di aver coperto gravi abusi in passato, quando era vescovo di Pittsburgh. Va detto che da parte di alcuni esponenti della chiesa c’è stata collaborazione all’indagine: è il caso del vescovo della diocesi di Erie, Lawrence Persico, che ha spinto per la pubblicazione del rapporto e, da parte sua, ha reso noti i nomi dei responsabili degli abusi sul sito della diocesi, creandosi non pochi nemici .
Ritorno al punto di partenza
Tuttavia l’episcopato americano nel suo insieme appare tramortito. Dopo quasi vent’anni di normative in favore della “tolleranza zero”, il susseguirsi di nuovi scandali, i risarcimenti miliardari alle vittime, le centinaia di processi canonici e riduzioni allo stato laicale di preti pedofili, le collaborazioni con la giustizia civile, l’istituzione di comitati di esperti, sembra di essere tornati al punto di partenza. Anche perché solo poche settimane fa, monsignor Theodore McCarrick, ex arcivescovo di Washington, è stato costretto a rinunciare al titolo di cardinale, accusato anche lui di abusi su minori; e però a destare scalpore, anche in questo caso, è stato il fatto che in Vaticano segnalazioni sul caso McCarrick erano arrivate anni fa. Del resto, contatti e scambi d’informazioni fra le diocesi e il Vaticano in merito a certi casi emergono anche nell’indagine in Pennsylvania, ulteriore conferma che Roma era informata del problema.
All’indagine del gran giurì, la Santa Sede ha reagito con una lunga dichiarazione del direttore della sala stampa vaticana, Greg Burke, nella quale si spiega che “davanti al rapporto reso pubblico in Pennsylvania questa settimana, due sono le parole che possono esprimere quanto si prova di fronte a questi orribili crimini: vergogna e dolore”.
Allo stesso tempo si precisa che le nuove pratiche messe in campo dalla chiesa cattolica hanno ridotto drasticamente il numero di episodi di abusi negli ultimi anni. Resta il fatto che solo nei giorni scorsi la sede dell’episcopato cileno è stata perquisita dalla magistratura in cerca di ulteriori prove su una cinquantina di denunce di abusi avvenuti nelle scuole rette dalla congregazione marista. Il paese andino è stato travolto negli ultimi mesi dallo scandalo e sotto indagine è finito anche Ricardo Ezzati Andrello, cardinale e arcivescovo di Santiago del Cile, accusato anch’egli di aver insabbiato e coperto violenze e abusi.
- Siamo di fronte a uno scandalo oggettivamente sconvolgente per durata nel tempo e per dimensioni
Il papa di certo ha contribuito ad aprire il vaso di Pandora degli abusi sui minori con l’intento di fare pulizia. Le mosse di Francesco - in particolare l’allontanamento di sacerdoti e vescovi coinvolti in episodi di pedofilia - sembrano tuttavia un po’ tardive e si dimostrano ormai insufficienti. Anche per questo, lunedì 20 agosto, il papa ha sentito il bisogno di rivolgere un lungo messaggio “a tutto il popolo di Dio”, nel quale oltre a riconoscere che “che non abbiamo saputo stare dove dovevamo stare, che non abbiamo agito in tempo riconoscendo la dimensione e la gravità del danno che si stava causando in tante vite” ha individuato nel clericalismo una delle cause di fondo del problema. “Il clericalismo - ha scritto Bergoglio - favorito sia dagli stessi sacerdoti sia dai laici, genera una scissione nel corpo ecclesiale che fomenta e aiuta a perpetuare molti dei mali che oggi denunciamo. Dire no all’abuso significa dire con forza no a qualsiasi forma di clericalismo”. Un messaggio apprezzato fra l’altro anche dal procuratore Josh Shapiro, probabilmente anche perché il papa chiede alla chiesa di appoggiare “tutte le mediazioni giudiziarie che siano necessarie”.
Il rapporto mai semplice tra sessualità, esercizio del potere, celibato obbligatorio, segretezza e buon nome dell’istituzione, ha prodotto danni che perdurano nel tempo e, per quanti passi avanti siano stati compiuti dalla chiesa nell’ultimo decennio, la realtà che continua a emergere delinea una quantità di crimini sessuali forse nemmeno ipotizzabile fino a qualche anno fa.
Siamo di fronte a uno scandalo oggettivamente sconvolgente per durata nel tempo e per dimensioni (in Australia i rapporti governativi parlano di 4.500 casi di abusi commessi da sacerdoti fino al 2015) tanto più se si tiene conto che solo una parte di questo tipo di reati è denunciata.
Tra pochi giorni il papa andrà in Irlanda, un paese che, anche in ragione dell’enormità degli abusi sui minori emersi negli anni scorsi, ha visto una caduta clamorosa dell’egemonia culturale cattolica tra la popolazione. Bergoglio incontrerà anche alcune vittime.
In passato Francesco ha più volte descritto il clericalismo come un male da combattere, ma forse è arrivato il momento che il papa apra definitivamente le porte della chiesa ai laici per uscire da una crisi che nessuna commissione vaticana sembra in grado di arginare.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. -- Col senno di poi. Tutti i disastri «irreparabili» e il senno di prima (di Maurizio Fiasca).20 agosto 2018, di Federico La Sala
IL SENNO DI PRIMA ("PROMETEO"), IL SENNO DI POI ("EPIMETEO"), I DISASTRI E IL "DISPOSITIVO DI DERIVAZIONE KANTIANA" ...*
- "È significativo che l’espressione di Tertulliano: "Il cristiano è un altro Cristo", sia diventata: "Il prete è un altro Cristo"." (Albert Rouet, arcivescovo di Poitiers, 2010).
- (...) il superiore guarda al consenso e alle conferme di chi siede ancora più in alto di lui. E quest’ultimo rivolge la sua mente al mandato di chi è il supremo detentore di quel bene, di quella situazione, di quel dato potere. E tutto questo complesso di fattori cambia la prospettiva, perché il conformismo è più potente della psicologia della responsabilità.
 A meno che nella persona responsabile in situazione trovino nutrimento valori morali assoluti: che spingono ad assumersi il rischio personale di andare controcorrente, e di superare derisioni e ostracismo, di non farsi influenzare dal dispositivo di derivazione kantiana, «faccio quel che devo, accada quel che può» (Maurizio Fiasco, "Tutti i disastri «irreparabili» e il senno di prima", Avvenire, 18.08.2018)).
A meno che nella persona responsabile in situazione trovino nutrimento valori morali assoluti: che spingono ad assumersi il rischio personale di andare controcorrente, e di superare derisioni e ostracismo, di non farsi influenzare dal dispositivo di derivazione kantiana, «faccio quel che devo, accada quel che può» (Maurizio Fiasco, "Tutti i disastri «irreparabili» e il senno di prima", Avvenire, 18.08.2018)).
- Avere il coraggio di dire ai giovani che essi sono tutti sovrani, per cui l’obbedienza non è ormai più una virtù, ma la più subdola delle tentazioni, che non credano di potersene far scudo né davanti agli uomini né davanti a Dio, che bisogna che si sentano ognuno l’unico responsabile di tutto (don Lorenzo Milani),
Il sociologo.
Tutti i disastri «irreparabili» e il senno di prima
Dopo il ragionamento è il solito, col senno di poi: come è stato possibile che nessuno vedesse e capisse prima dell’irreparabile fatto?
di Maurizio Fiasco (Avvenire, sabato 18 agosto 2018)
- Il balletto delle responsabilità inizia sempre dopo, col senno di poi. Il senno di prima è ignoto (Fotogramma)
Come accadono i disastri? C’è un’espressione, all’apparenza banale ma ricorrente, quando siamo sconcertati per un evento dai costi umani incalcolabili. «Col senno di poi». Che equivale: come è stato possibile che nessuno vedesse e capisse prima dell’irreparabile fatto? Quel che ha condotto al precipitare di una situazione - fisica, come un ponte, oppure comportamentale come una battaglia, un volo, il funzionamento di uno stabilimento industriale - aveva già emesso dei segnali.
 I disastri - risulta quasi sempre agli investigatori ex post - hanno avuto una incubazione, più o meno lunga. Incubazione tutt’altro che muta, o col bavaglio, anzi spesso visibile per un complesso di segnali. Come ha insegnato, quarant’anni fa un illuminato e inascoltato Barry Turner, non sono prevenuti - ovvero fermati da decisioni pragmatiche - per le patologie della comunicazione tra gli attori di un sistema. Industriale, amministrativo, finanziario, politico: non importa la scala di grandezza. Le incompetenze si strutturano e agiscono come un sistema.
I disastri - risulta quasi sempre agli investigatori ex post - hanno avuto una incubazione, più o meno lunga. Incubazione tutt’altro che muta, o col bavaglio, anzi spesso visibile per un complesso di segnali. Come ha insegnato, quarant’anni fa un illuminato e inascoltato Barry Turner, non sono prevenuti - ovvero fermati da decisioni pragmatiche - per le patologie della comunicazione tra gli attori di un sistema. Industriale, amministrativo, finanziario, politico: non importa la scala di grandezza. Le incompetenze si strutturano e agiscono come un sistema.I segnali sono sfuggiti a un apparato cognitivo, a una mente capace di connetterli e perciò di abbattere le barriere che inibiscono il giudizio. È mancata la responsabilità di contrastare la universale ottusità dei sistemi, di tutti i sistemi organizzativi. Che squalificano la coscienziosità di chi abbia colto il segnale e si sia posto in modo attivo per spingere al provvedere.
 Egli finisce per scontrarsi con la gerarchia, con i muri levati su dai rituali dell’organizzazione, per impattare con la squalificazione che si replica davanti all’umile operatore che sta sul terreno e lì ’vede’ qualcosa che non va. Oppure c’è il feticcio della responsabilità di vertice. Chi è in alto - pensa il testimone dei segnali che il disastro sta inviando - lo capirà più e meglio di me.
Egli finisce per scontrarsi con la gerarchia, con i muri levati su dai rituali dell’organizzazione, per impattare con la squalificazione che si replica davanti all’umile operatore che sta sul terreno e lì ’vede’ qualcosa che non va. Oppure c’è il feticcio della responsabilità di vertice. Chi è in alto - pensa il testimone dei segnali che il disastro sta inviando - lo capirà più e meglio di me.Ma il superiore guarda al consenso e alle conferme di chi siede ancora più in alto di lui. E quest’ultimo rivolge la sua mente al mandato di chi è il supremo detentore di quel bene, di quella situazione, di quel dato potere. E tutto questo complesso di fattori cambia la prospettiva, perché il conformismo è più potente della psicologia della responsabilità.
 A meno che nella persona responsabile in situazione trovino nutrimento valori morali assoluti: che spingono ad assumersi il rischio personale di andare controcorrente, e di superare derisioni e ostracismo, di non farsi influenzare dal dispositivo di derivazione kantiana, «faccio quel che devo, accada quel che può».
A meno che nella persona responsabile in situazione trovino nutrimento valori morali assoluti: che spingono ad assumersi il rischio personale di andare controcorrente, e di superare derisioni e ostracismo, di non farsi influenzare dal dispositivo di derivazione kantiana, «faccio quel che devo, accada quel che può».Insomma, la responsabilità, invece di essere ispirata a valori trascendenti, si attesta alla procedura, al ’di fronte’, a quel che le regole gerarchiche - per esempio il mandato degli azionisti - hanno assegnato. E così si scambia la diversa posizione ricoperta nella piramide organizzativa con la diversità di valori etici e professionali di quanti operano in una struttura complessa: che invece, a rigore, sono unici e universali. Cioè per tutti. Nelle forze armate, dal piantone al generale; nelle autostrade, dall’operaio che passa il bitume all’amministratore delegato della infrastruttura. Unitarietà dei valori e trasparenza della comunicazione sono la speranza del «senno di prima». Potremmo dire l’intelligenza del Buon Samaritano che si prende carico della complessità della situazione e non trascura alcuna variabile.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
IL NOME DI DIO, SENZA GRAZIA ("CHARIS")! L’ERRORE FILOLOGICO E TEOLOGICO DI PAPA BENEDETTO XVI, NEL TITOLO DELLA SUA PRIMA ENCICLICA. Nel nome della "Tradizione"
IL NATALE DI GESU’: L’INCARNAZIONE SECONDO L’ IMMAGINAZIONE "TEANDRICA" DEL CATTOLICESIMO-COSTANTINIANO. Gianfranco Ravasi ne ripropone una sintesi e la presenta come "il realismo del nascere nella storia"!!!
LO STATO DEL FARAONE, LO STATO DI MINORITA’, E IMMANUEL KANT "ALLA BERLINA" - DOPO AUSCHWITZ
 "LEZIONE SU KANT" A GERUSALEMME: PARLA EICHMANN "PILATO", IL SUDDITO DELL’"IMPERATORE-DIO".
"LEZIONE SU KANT" A GERUSALEMME: PARLA EICHMANN "PILATO", IL SUDDITO DELL’"IMPERATORE-DIO".LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE.
PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!
 FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.Federico La Sala
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. - GENOVA 2018. AUTOSTRADE PER IL CIELO: CARTE TRUCCATE E "PONTE PERICOLANTE".18 agosto 2018, di Federico La Sala
AUTOSTRADE PER IL CIELO: CARTE TRUCCATE E "PONTE PERICOLANTE". L’*AMORE* Di MARIA E GIUSEPPE E LA "PREGHIERA UFFICIALE PER L’INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE 2018" :
- Preghiera dei bambini (1870): “Cristo lo voglio io per Padre/ la Madonna la voglio per Madre/ S. Giuseppe lo voglio per fratello,/ I Santi tutti li voglio per parenti / Affinché mi scampino da tutti i cimenti” (http://www.fondazioneterradotranto.it/2018/07/06/ggimentu-gimmientu-e-ggimintare/#comment-96032)
- Dichiarazione del Cardinale Dario Castrillon Hoyos alla XV conferenza internazionale del Pontificio consiglio: "Duemila anni fa, un ovulo fu miracolosamente fecondato dall’azione soprannaturale di Dio, da questa meravigliosa unione risultò uno zigote con un patrimonio cromosomico proprio. Però in quello zigote stava il Verbo di Dio"(la Repubblica del 17 novembre 2000, p. 35).
- "CHARISSIMI, NOLITE OMNI SPIRITUI CREDERE... DEUS CHARITAS EST" (1Gv., 4. 1-16).
PREGHIERA UFFICIALE PER L’INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE 2018 *
 Dio, nostro Padre,
Dio, nostro Padre,
 Siamo fratelli e sorelle in Gesù, tuo Figlio,
Siamo fratelli e sorelle in Gesù, tuo Figlio,
 Una famiglia unita dallo Spirito del tuo amore.
Una famiglia unita dallo Spirito del tuo amore.
 Benedici ognuno di noi con la gioia dell’amore.
Benedici ognuno di noi con la gioia dell’amore.
 Rendici pazienti e gentili,
Rendici pazienti e gentili,
 Amorevoli e generosi,
Amorevoli e generosi,
 Accoglienti con i bisognosi.
Accoglienti con i bisognosi.
 Aiutaci a vivere il tuo perdono e la tua pace.
Aiutaci a vivere il tuo perdono e la tua pace.
 Proteggi tutte le nostre famiglie con il tuo amore,
Proteggi tutte le nostre famiglie con il tuo amore,
 Specialmente coloro che ti affidiamo ora con la nostra preghiera:
Specialmente coloro che ti affidiamo ora con la nostra preghiera:
 [facciamo un momento di silenzio per pregare per i membri della famiglia e altre
[facciamo un momento di silenzio per pregare per i membri della famiglia e altre
 persone che ci stanno a cuore, ricordandoli per nome].
persone che ci stanno a cuore, ricordandoli per nome].
 Aumenta la nostra fede,
Aumenta la nostra fede,
 Rendi forte la nostra speranza,
Rendi forte la nostra speranza,
 Conservaci nel tuo amore,
Conservaci nel tuo amore,
 Aiutaci ad essere sempre grati del dono della vita che condividiamo.
Aiutaci ad essere sempre grati del dono della vita che condividiamo.
 Ti chiediamo questo nel nome di Cristo, nostro Signore,
Ti chiediamo questo nel nome di Cristo, nostro Signore, Amen
Amen Maria, madre e guida nostra, prega per noi.
Maria, madre e guida nostra, prega per noi.
 San Giuseppe, padre e protettore nostro, prega per noi.
San Giuseppe, padre e protettore nostro, prega per noi.
 Santi Gioacchino e Anna, pregate per noi.
Santi Gioacchino e Anna, pregate per noi.
 San Luigi e Zelia Martin, pregate per noi.
San Luigi e Zelia Martin, pregate per noi.*Fonte: https://www.worldmeeting2018.ie/WMOF/media/downloads/prayerA4-IT.pdf
* L’Incontro mondiale. «Famiglia, sfida globale». Ecco il senso dell’incontro di Dublino. L’arcivescovo Martin, primate della Chiesa d’Irlanda: Amoris Laetitia, messaggio di misericordia nella complessità. Uno spazio dedicato anche al soloroso tema degli abusi (di Luciano Moia, Avvenire, venerdì 17 agosto 2018: https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/famiglia-sfida-globale-ecco-il-senso-di-dublino).
SUL TEMA, IN RETE, SI CFR.:
GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA!!! NON IL FIGLIO DEL "DIO" ("CARITAS") DELLA CHIESA AF-FARAONICA E COSTANTINIANA !!!
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo".
Federico La Sala (18.08.2018)
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. - Abusi, la "Lettera di papa Francesco (testo integrale). Tutta la Chiesa se ne faccia carico21 agosto 2018, di Federico La Sala
Lettera.
Abusi, il Papa: vergogna e pentimento. Tutta la Chiesa se ne faccia carico
Francesco ribadisce l’impegno contro il crimine degli abusi. Nella Lettera al popolo di Dio: «Chiediamo perdono per i peccati propri e altrui»
_***«È imprescindibile che come Chiesa possiamo riconoscere e condannare con dolore e vergogna le atrocità commesse da persone consacrate, chierici, e anche d--a tutti coloro che avevano la missione di vigilare e proteggere i più vulnerabili. Chiediamo perdono per i peccati propri e altrui. La coscienza del peccato ci aiuta a riconoscere gli errori, i delitti e le ferite procurate nel passato e ci permette di aprirci e impegnarci maggiormente nel presente in un cammino di rinnovata conversione».
 Questo uno dei passaggi chiave della “Lettera di Papa Francesco al popolo di Dio” diffusa questa mattina dalla Sala Stampa vaticana. Un testo in cui il Pontefice, all’indomani della pubblicazione del rapporto sui casi di pedofilia nelle diocesi della Pennsylvania (Stati Uniti), esprime a nome dell’intero popolo di Dio «vergogna e pentimento». E sottolinea la necessità della conversione da parte dell’intera comunità ecclesiale.
Questo uno dei passaggi chiave della “Lettera di Papa Francesco al popolo di Dio” diffusa questa mattina dalla Sala Stampa vaticana. Un testo in cui il Pontefice, all’indomani della pubblicazione del rapporto sui casi di pedofilia nelle diocesi della Pennsylvania (Stati Uniti), esprime a nome dell’intero popolo di Dio «vergogna e pentimento». E sottolinea la necessità della conversione da parte dell’intera comunità ecclesiale.Di seguito il testo integrale della lettera.
LETTERA DEL SANTO PADRE FRANCESCO AL POPOLO DI DIO
«Se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme» (1 Cor 12,26). Queste parole di San Paolo risuonano con forza nel mio cuore constatando ancora una volta la sofferenza vissuta da molti minori a causa di abusi sessuali, di potere e di coscienza commessi da un numero notevole di chierici e persone consacrate. Un crimine che genera profonde ferite di dolore e di impotenza, anzitutto nelle vittime, ma anche nei loro familiari e nell’intera comunità, siano credenti o non credenti. Guardando al passato, non sarà mai abbastanza ciò che si fa per chiedere perdono e cercare di riparare il danno causato. Guardando al futuro, non sarà mai poco tutto ciò che si fa per dar vita a una cultura capace di evitare che tali situazioni non solo non si ripetano, ma non trovino spazio per essere coperte e perpetuarsi. Il dolore delle vittime e delle loro famiglie è anche il nostro dolore, perciò urge ribadire ancora una volta il nostro impegno per garantire la protezione dei minori e degli adulti in situazione di vulnerabilità.
1. Se un membro soffre
Negli ultimi giorni è stato pubblicato un rapporto in cui si descrive l’esperienza di almeno mille persone che sono state vittime di abusi sessuali, di potere e di coscienza per mano di sacerdoti, in un arco di circa settant’anni. Benché si possa dire che la maggior parte dei casi riguarda il passato, tuttavia, col passare del tempo abbiamo conosciuto il dolore di molte delle vittime e constatiamo che le ferite non spariscono mai e ci obbligano a condannare con forza queste atrocità, come pure a concentrare gli sforzi per sradicare questa cultura di morte; le ferite “non vanno mai prescritte”. Il dolore di queste vittime è un lamento che sale al cielo, che tocca l’anima e che per molto tempo è stato ignorato, nascosto o messo a tacere. Ma il suo grido è stato più forte di tutte le misure che hanno cercato di farlo tacere o, anche, hanno preteso di risolverlo con decisioni che ne hanno accresciuto la gravità cadendo nella complicità. Grido che il Signore ha ascoltato facendoci vedere, ancora una volta, da che parte vuole stare. Il cantico di Maria non si sbaglia e, come un sottofondo, continua a percorrere la storia perché il Signore si ricorda della promessa che ha fatto ai nostri padri: «Ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote» (Lc 1,51-53), e proviamo vergogna quando ci accorgiamo che il nostro stile di vita ha smentito e smentisce ciò che recitiamo con la nostra voce.
Con vergogna e pentimento, come comunità ecclesiale, ammettiamo che non abbiamo saputo stare dove dovevamo stare, che non abbiamo agito in tempo riconoscendo la dimensione e la gravità del danno che si stava causando in tante vite. Abbiamo trascurato e abbandonato i piccoli. Faccio mie le parole dell’allora Cardinale Ratzinger quando, nella Via Crucis scritta per il Venerdì Santo del 2005, si unì al grido di dolore di tante vittime e con forza disse: «Quanta sporcizia c’è nella Chiesa, e proprio anche tra coloro che, nel sacerdozio, dovrebbero appartenere completamente a Lui! Quanta superbia, quanta autosufficienza! [...] Il tradimento dei discepoli, la ricezione indegna del suo Corpo e del suo Sangue è certamente il più grande dolore del Redentore, quello che gli trafigge il cuore. Non ci rimane altro che rivolgergli, dal più profondo dell’animo, il grido: Kyrie, eleison - Signore, salvaci (cfr Mt 8,25)» (Nona Stazione).
2. Tutte le membra soffrono insieme
La dimensione e la grandezza degli avvenimenti esige di farsi carico di questo fatto in maniera globale e comunitaria. Benché sia importante e necessario in ogni cammino di conversione prendere conoscenza dell’accaduto, questo da sé non basta. Oggi siamo interpellati come Popolo di Dio a farci carico del dolore dei nostri fratelli feriti nella carne e nello spirito. Se in passato l’omissione ha potuto diventare una forma di risposta, oggi vogliamo che la solidarietà, intesa nel suo significato più profondo ed esigente, diventi il nostro modo di fare la storia presente e futura, in un ambito dove i conflitti, le tensioni e specialmente le vittime di ogni tipo di abuso possano trovare una mano tesa che le protegga e le riscatti dal loro dolore (cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 228). Tale solidarietà ci chiede, a sua volta, di denunciare tutto ciò che possa mettere in pericolo l’integrità di qualsiasi persona. Solidarietà che reclama la lotta contro ogni tipo di corruzione, specialmente quella spirituale, «perché si tratta di una cecità comoda e autosufficiente dove alla fine tutto sembra lecito: l’inganno, la calunnia, l’egoismo e tante sottili forme di autoreferenzialità, poiché “anche Satana si maschera da angelo della luce” (2 Cor 11,14)» (Esort. ap. Gaudete et exsultate, 165). L’appello di San Paolo a soffrire con chi soffre è il miglior antidoto contro ogni volontà di continuare a riprodurre tra di noi le parole di Caino: «Sono forse io il custode di mio fratello?» (Gen 4,9).
Sono consapevole dello sforzo e del lavoro che si compie in diverse parti del mondo per garantire e realizzare le mediazioni necessarie, che diano sicurezza e proteggano l’integrità dei bambini e degli adulti in stato di vulnerabilità, come pure della diffusione della “tolleranza zero” e dei modi di rendere conto da parte di tutti coloro che compiono o coprono questi delitti. Abbiamo tardato ad applicare queste azioni e sanzioni così necessarie, ma sono fiducioso che esse aiuteranno a garantire una maggiore cultura della protezione nel presente e nel futuro.
Unitamente a questi sforzi, è necessario che ciascun battezzato si senta coinvolto nella trasformazione ecclesiale e sociale di cui tanto abbiamo bisogno. Tale trasformazione esige la conversione personale e comunitaria e ci porta a guardare nella stessa direzione dove guarda il Signore. Così amava dire San Giovanni Paolo II: «Se siamo ripartiti davvero dalla contemplazione di Cristo, dovremo saperlo scorgere soprattutto nel volto di coloro con i quali egli stesso ha voluto identificarsi» (Lett. ap. Novo millennio ineunte, 49). Imparare a guardare dove guarda il Signore, a stare dove il Signore vuole che stiamo, a convertire il cuore stando alla sua presenza. Per questo scopo saranno di aiuto la preghiera e la penitenza. Invito tutto il santo Popolo fedele di Dio all’esercizio penitenziale della preghiera e del digiuno secondo il comando del Signore,[1] che risveglia la nostra coscienza, la nostra solidarietà e il nostro impegno per una cultura della protezione e del “mai più” verso ogni tipo e forma di abuso.
E’ impossibile immaginare una conversione dell’agire ecclesiale senza la partecipazione attiva di tutte le componenti del Popolo di Dio. Di più: ogni volta che abbiamo cercato di soppiantare, mettere a tacere, ignorare, ridurre a piccole élites il Popolo di Dio abbiamo costruito comunità, programmi, scelte teologiche, spiritualità e strutture senza radici, senza memoria, senza volto, senza corpo, in definitiva senza vita.[2] Ciò si manifesta con chiarezza in un modo anomalo di intendere l’autorità nella Chiesa - molto comune in numerose comunità nelle quali si sono verificati comportamenti di abuso sessuale, di potere e di coscienza - quale è il clericalismo, quell’atteggiamento che «non solo annulla la personalità dei cristiani, ma tende anche a sminuire e a sottovalutare la grazia battesimale che lo Spirito Santo ha posto nel cuore della nostra gente»[3]. Il clericalismo, favorito sia dagli stessi sacerdoti sia dai laici, genera una scissione nel corpo ecclesiale che fomenta e aiuta a perpetuare molti dei mali che oggi denunciamo. Dire no all’abuso significa dire con forza no a qualsiasi forma di clericalismo.
E’ sempre bene ricordare che il Signore, «nella storia della salvezza, ha salvato un popolo. Non esiste piena identità senza appartenenza a un popolo. Perciò nessuno si salva da solo, come individuo isolato, ma Dio ci attrae tenendo conto della complessa trama di relazioni interpersonali che si stabiliscono nella comunità umana: Dio ha voluto entrare in una dinamica popolare, nella dinamica di un popolo» (Esort. ap. Gaudete et exsultate, 6). Pertanto, l’unico modo che abbiamo per rispondere a questo male che si è preso tante vite è viverlo come un compito che ci coinvolge e ci riguarda tutti come Popolo di Dio. Questa consapevolezza di sentirci parte di un popolo e di una storia comune ci consentirà di riconoscere i nostri peccati e gli errori del passato con un’apertura penitenziale capace di lasciarsi rinnovare da dentro. Tutto ciò che si fa per sradicare la cultura dell’abuso dalle nostre comunità senza una partecipazione attiva di tutti i membri della Chiesa non riuscirà a generare le dinamiche necessarie per una sana ed effettiva trasformazione. La dimensione penitenziale di digiuno e preghiera ci aiuterà come Popolo di Dio a metterci davanti al Signore e ai nostri fratelli feriti, come peccatori che implorano il perdono e la grazia della vergogna e della conversione, e così a elaborare azioni che producano dinamismi in sintonia col Vangelo. Perché «ogni volta che cerchiamo di tornare alla fonte e recuperare la freschezza originale del Vangelo spuntano nuove strade, metodi creativi, altre forme di espressione, segni più eloquenti, parole cariche di rinnovato significato per il mondo attuale» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 11).
E’ imprescindibile che come Chiesa possiamo riconoscere e condannare con dolore e vergogna le atrocità commesse da persone consacrate, chierici, e anche da tutti coloro che avevano la missione di vigilare e proteggere i più vulnerabili. Chiediamo perdono per i peccati propri e altrui. La coscienza del peccato ci aiuta a riconoscere gli errori, i delitti e le ferite procurate nel passato e ci permette di aprirci e impegnarci maggiormente nel presente in un cammino di rinnovata conversione.
Al tempo stesso, la penitenza e la preghiera ci aiuteranno a sensibilizzare i nostri occhi e il nostro cuore dinanzi alla sofferenza degli altri e a vincere la bramosia di dominio e di possesso che tante volte diventa radice di questi mali. Che il digiuno e la preghiera aprano le nostre orecchie al dolore silenzioso dei bambini, dei giovani e dei disabili. Digiuno che ci procuri fame e sete di giustizia e ci spinga a camminare nella verità appoggiando tutte le mediazioni giudiziarie che siano necessarie. Un digiuno che ci scuota e ci porti a impegnarci nella verità e nella carità con tutti gli uomini di buona volontà e con la società in generale per lottare contro qualsiasi tipo di abuso sessuale, di potere e di coscienza.
In tal modo potremo manifestare la vocazione a cui siamo stati chiamati di essere «segno e strumento dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il genere umano» (Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 1).
«Se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme», ci diceva San Paolo. Mediante l’atteggiamento orante e penitenziale potremo entrare in sintonia personale e comunitaria con questa esortazione, perché crescano tra di noi i doni della compassione, della giustizia, della prevenzione e della riparazione. Maria ha saputo stare ai piedi della croce del suo Figlio. Non l’ha fatto in un modo qualunque, ma è stata saldamente in piedi e accanto ad essa. Con questa posizione esprime il suo modo di stare nella vita. Quando sperimentiamo la desolazione che ci procurano queste piaghe ecclesiali, con Maria ci farà bene “insistere di più nella preghiera” (cfr S. Ignazio di Loyola, Esercizi spirituali, 319), cercando di crescere nell’amore e nella fedeltà alla Chiesa. Lei, la prima discepola, insegna a tutti noi discepoli come dobbiamo comportarci di fronte alla sofferenza dell’innocente, senza evasioni e pusillanimità. Guardare a Maria vuol dire imparare a scoprire dove e come deve stare il discepolo di Cristo.
Lo Spirito Santo ci dia la grazia della conversione e l’unzione interiore per poter esprimere, davanti a questi crimini di abuso, il nostro pentimento e la nostra decisione di lottare con coraggio.
* Fonte: Avvenire, 20.08.2018
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- Lo scenario d’apocalisse del Polcevera. Genova: un banco di prova per tutti17 agosto 2018, di Federico La Sala
LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE... *
- AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA L’INVITO A RIPRENDERSI LA "PAROLA" E A RIDARE ORGOGLIO E DIGNITA’ A TUTTO IL PAESE: VIVA , VIVA L’ ITALIA!!!
Un banco di prova per tutti.
Genova e adesso fatti e stile
di Francesco Ognibene (Avvenire, venerdì 17 agosto 2018)
Non è faccenda che si archivia in fretta, questa di Genova, e non solo per la vastissima impressione suscitata dal crollo del ponte Morandi in un Paese appena entrato nella pacificante quiete ferragostana. Rimuovere le immani macerie, ricostruire la complicata trama delle possibili responsabilità, ipotizzare e mettere in opera un manufatto durevole che possa rimpiazzare il viadotto sventrato richiederà tempo, e per una ferita di questa portata è il caso di chiedere soluzioni certo solerti, ma non spicciative. Va dunque risolutamente accantonata l’illusione di poter archiviare nel giro di qualche giorno la tragedia di martedì relegando alla svelta la notizia nella categoria dei traumi violenti ma momentanei, o delle grane locali. Prendiamo bene le misure dell’accaduto. Quello che si è consumato non è un incidente casuale o naturale, è una sciagura scatenata da un manufatto umano, che oltre a mietere decine di vite in modo crudele ha travolto una struttura che pompa ossigeno da e verso un’area produttiva del Paese, col rischio di stringere il collo di uno dei porti più grandi del Mediterraneo, di una straordinaria città e di una buona metà della Liguria.
Ma c’è anche dell’altro che va colto dentro e attorno lo scenario d’apocalisse del Polcevera. È proprio ascoltando la profonda emozione diffusa tra gli italiani - un misto di cordoglio, angoscia, indignazione e interrogativi non liquidabili con risposte a buon mercato - che va cercato l’atteggiamento doveroso in questa situazione tanto aspra. Avvertiamo tutti il dovere - nostro, di chi ci rappresenta, di quanti sono più direttamente coinvolti nei molti snodi della vicenda - di essere all’altezza di giorni duri nei quali si sente gravare su tutti il peso di una tragedia che come altre volte nella nostra storia recente ci fa sentire più che mai comunità nazionale, solidali nel dolore con chi patisce una perdita, una ferita, la lacerazione di dover lasciare casa propria forse per sempre, l’incertezza sul lavoro e il domani. Genova soffre e l’Italia soffre con lei, la abbraccia e insieme ne scruta la reazione, come sempre sobria e operativa.
Le parole misurate degli sfollati e della gente, mai sopra le righe o genericamente recriminatorie, ma neppure rassegnate o irose, sembrano indicare al Paese in ogni sua componente che davanti all’inimmaginabile la sola risposta proporzionata è badare all’essenziale, tenendo alla larga le polemiche frontali e le dichiarazioni roboanti in cerca di fugace consenso (ancora troppe, però, e suonano offensive quando parenti in angoscia attendono che sia trovato il corpo di un loro caro).
Silenzio, ci vuole, e misura e condivisione di un dolore che è di tutti. Chi rumoreggia in un campo e nell’altro (se ha un senso dividersi in ore come queste) pare rimuovere un dato che invece vorremmo vedere chiaramente compreso e interiorizzato, trasparente nei gesti e nelle parole, nelle strategie operative e nelle decisioni che ci attendono. La modernità di un Paese è giustamente evocata come il parametro che rende intollerabile il collasso di un’infrastruttura strategica costruita appena mezzo secolo fa, ma si misura non solo in trafori o ferrovie.
Altro serve per dirsi evoluti che la padronanza di tecnologie costruttive che peraltro da tempo vedono le nostre imprese spuntare in tutto il mondo appalti di opere ben più vertiginose. A Genova si tratta di affrontare un nuovo esame di maturità che è per tutti, ognuno in proporzione al proprio ruolo. E per superarlo è uno stile che ora serve, e che proviamo a riassumere in tre parole. Ci vuole anzitutto compostezza nel modo di accostarsi alla dimensione di un fatto che è insieme umano e materiale, sapendo unire comprensione delle ferite da sanare e capacità di vedere tutti gli aspetti di un problema che coinvolge vita quotidiana, mobilità, lavoro, economia, turismo. Impegnarsi a vedere oltre le macerie il futuro e ciò che occorre a costruirlo conferisce la serietà e il rigore adesso imprescindibili, e che mettono in fuori gioco protagonismi e recriminazioni.
Ci vuole anche concretezza nel saper cogliere ciò che va fatto davvero, un passo dopo l’altro, senza la furia di mostrarsi a conoscenza di soluzioni che tutti sappiamo complesse quanto l’immenso guaio che si è prodotto. È solo così che si sarà in grado di agire nei tempi giusti, con una visione progettuale, senza improvvisare e sapendo mettere insieme competenze e risorse di tutti quelli che possono contribuire, evitando esclusioni pregiudiziali, processi sommari e la caccia a scalpi da esibire sulla piazza.
Ci vuole, infine, consapevolezza della terra che abitiamo, frastagliata e vulnerabile come poche al mondo, e le scosse in Molise poche ore dopo il dramma di Genova e di nuovo ieri sera ce lo hanno bruscamente ricordato. Un territorio così, con una morfologia sofferta e una presenza umana diffusa e laboriosa pressoché ovunque, richiede una cura assoluta delle opere pubbliche soggette a degrado elevato e talora improvviso. È un posto fragile, l’Italia, possibile che siano i morti a dovercelo rammentare? Il Paese maturo che vogliamo abitare non può prescindere da questo stile. La tragedia di Genova può diventare uno di quei momenti in cui abbiamo dimostrato di saper girare al largo dallo sfiancante dedalo delle polemiche faziose per mostrarci capaci di quella forza che di una espressione geografica e politica fa una comunità.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
L’ITALIA , TRE PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA SENZA "PAROLA", E I FURBASTRI CHE SANNO (COSA SIGNIFICA) GRIDARE "FORZA ITALIA". In memoria di Sandro Pertini e di Gioacchino da Fiore, alcuni appunti per i posteri
LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE.
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE.
Federico La Sala
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. -- "PERCHE’ NON POSSIAMO NON DIRCI CRISTIANI", 0GGI.14 agosto 2018, di Federico La Sala
IL MESSAGGIO EVANGELICO, IL PARADOSSO ISTITUZIONALE DEL MENTITORE, E LA CATASTROFE DELL’EUROPA.
 "PERCHE’ NON POSSIAMO NON DIRCI CRISTIANI", 0GGI.. In memoria di (Benedetto Croce), alcune note a margine del discorso di Papa Francesco, all’Angelus del 12 agosto 2018 d. C. ... *
"PERCHE’ NON POSSIAMO NON DIRCI CRISTIANI", 0GGI.. In memoria di (Benedetto Croce), alcune note a margine del discorso di Papa Francesco, all’Angelus del 12 agosto 2018 d. C. ... *- “(...) noi non siamo più sotto un pedagogo. Non c’è più giudeo né greco; non c’è più schiavo né libero; non c’è più uomo né donna, poiché tutti voi siete uno in Cristo Gesù” (Paolo, Galati 3, 25-28).
- "(...) non dimenticatevi di questo. Il cristiano non può essere ipocrita: deve vivere in maniera coerente" (Papa Francesco).
PAPA FRANCESCO
ANGELUS
 Piazza San Pietro
Piazza San Pietro
 Domenica, 12 agosto 2018
Domenica, 12 agosto 2018Cari fratelli e sorelle e cari giovani italiani,
buongiorno!
Nella seconda Lettura di oggi, San Paolo ci rivolge un pressante invito: «Non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, con il quale foste segnati per il giorno della redenzione» (Ef 4,30).
Ma io mi domando: come si rattrista lo Spirito Santo? Tutti lo abbiamo ricevuto nel Battesimo e nella Cresima, quindi, per non rattristare lo Spirito Santo, è necessario vivere in maniera coerente con le promesse del Battesimo, rinnovate nella Cresima. In maniera coerente, non con ipocrisia: non dimenticatevi di questo. Il cristiano non può essere ipocrita: deve vivere in maniera coerente. Le promesse del Battesimo hanno due aspetti: rinuncia al male e adesione al bene.
Rinunciare al male significa dire «no» alle tentazioni, al peccato, a satana. Più in concreto significa dire “no” a una cultura della morte, che si manifesta nella fuga dal reale verso una felicità falsa che si esprime nella menzogna, nella truffa, nell’ingiustizia, nel disprezzo dell’altro. A tutto questo, “no”. La vita nuova che ci è stata data nel Battesimo, e che ha lo Spirito come sorgente, respinge una condotta dominata da sentimenti di divisione e di discordia. Per questo l’Apostolo Paolo esorta a togliere dal proprio cuore «ogni asprezza, sdegno, ira, grida e maldicenza con ogni sorta di malignità» (v. 31). Così dice Paolo. Questi sei elementi o vizi, che turbano la gioia dello Spirito Santo, avvelenano il cuore e conducono ad imprecazioni contro Dio e contro il prossimo.
Ma non basta non fare il male per essere un buon cristiano; è necessario aderire al bene e fare il bene. Ecco allora che San Paolo continua: «Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo» (v. 32). Tante volte capita di sentire alcuni che dicono: “Io non faccio del male a nessuno”. E si crede di essere un santo. D’accordo, ma il bene lo fai? Quante persone non fanno il male, ma nemmeno il bene, e la loro vita scorre nell’indifferenza, nell’apatia, nella tiepidezza. Questo atteggiamento è contrario al Vangelo, ed è contrario anche all’indole di voi giovani, che per natura siete dinamici, appassionati e coraggiosi. Ricordate questo - se lo ricordate, possiamo ripeterlo insieme: “E’ buono non fare il male, ma è male non fare il bene”. Questo lo diceva Sant’Alberto Hurtado.
Oggi vi esorto ad essere protagonisti nel bene! Protagonisti nel bene. Non sentitevi a posto quando non fate il male; ognuno è colpevole del bene che poteva fare e non ha fatto. Non basta non odiare, bisogna perdonare; non basta non avere rancore, bisogna pregare per i nemici; non basta non essere causa di divisione, bisogna portare pace dove non c’è; non basta non parlare male degli altri, bisogna interrompere quando sentiamo parlar male di qualcuno: fermare il chiacchiericcio: questo è fare il bene. Se non ci opponiamo al male, lo alimentiamo in modo tacito. È necessario intervenire dove il male si diffonde; perché il male si diffonde dove mancano cristiani audaci che si oppongono con il bene, “camminando nella carità” (cfr 5,2), secondo il monito di San Paolo.
Cari giovani, in questi giorni avete camminato molto! Perciò siete allenati e posso dirvi: camminate nella carità, camminate nell’amore! E camminiamo insieme verso il prossimo Sinodo dei Vescovi. La Vergine Maria ci sostenga con la sua materna intercessione, perché ciascuno di noi, ogni giorno, con i fatti, possa dire “no” al male e “sì” al bene.
Dopo l’Angelus
Cari fratelli e sorelle,
rivolgo il mio saluto a tutti voi, romani e pellegrini provenienti da tante parti del mondo.
In particolare saluto i giovani delle diocesi italiane, accompagnati dai rispettivi Vescovi, dai loro sacerdoti ed educatori. In questi giorni, avete riversato per le strade di Roma il vostro entusiasmo e la vostra fede. Vi ringrazio per la vostra presenza e per la vostra testimonianza cristiana! E ieri, nel ringraziare, ho dimenticato di dire una parola ai sacerdoti, che sono quelli che vi sono più vicini: ringrazio tanto i sacerdoti, ringrazio per quel lavoro che fanno giorno per giorno, ringrazio per quella pazienza - perché ci vuole pazienza per lavorare con voi! La pazienza dei sacerdoti ... - ringrazio tanto, tanto, tanto. E ho visto anche tante suore che lavorano con voi: anche alle suore, grazie tante.
E la mia gratitudine si estende alla Conferenza Episcopale Italiana - qui rappresentata dal Presidente Cardinale Gualtiero Bassetti - che ha promosso questo incontro dei giovani in vista del prossimo Sinodo dei Vescovi.
Cari giovani, facendo ritorno nella vostre comunità, testimoniate ai vostri coetanei, e a quanti incontrerete, la gioia della fraternità e della comunione che avete sperimentato in queste giornate di pellegrinaggio e di preghiera.
A tutti auguro una buona domenica. Un buon rientro a casa. E per favore, non dimenticate di pregare per me! Buon pranzo e arrivederci!
* Appunti di commento sul tema, si cfr.:
- PAOLO COME "CRISTO": “(...) noi non siamo più sotto un pedagogo. Non c’è più giudeo né greco; non c’è più schiavo né libero; non c’è più uomo né donna, poiché tutti voi siete uno in Cristo Gesù” (Galati: 3, 25-28).
- CAPO E CORPO "MISTICO" - FORZA "CRISTO"!: "(...) vivendo secondo la verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa verso di lui, che è il capo, Cristo, dal quale tutto il corpo, ben compaginato e connesso, mediante la collaborazione di ogni giuntura, secondo l’energia propria di ogni membro, riceve forza per crescere in modo da edificare se stesso nella carità" (Paolo, Ef. 4,15-16)
- "CRISTO", ORDINE SACERDOTALE, E CHIESA: "È significativo che l’espressione di Tertulliano: "Il cristiano è un altro Cristo", sia diventata: "Il prete è un altro Cristo"" (Albert Rouet, arcivescovo di Poitiers, 2010.)
- SIMONE WEIL: "L’immagine del
corpo mistico di Cristo è molto seducente, ma l’importanza
che si annette oggi a questa immagine mi pare uno dei sintomi più gravi della
nostra decadenza. La nostra vera dignità infatti non sta nell’essere membra di
un corpo, anche se mistico, anche se quello di Cristo, ma in questo: nello stato
di perfezione, al quale tutti aspiriamo, noi non viviamo più in noi stessi, ma è
Cristo che vive in noi; in questa condizione, Cristo nella sua integrità, nella sua
unità indivisibile, diviene, in certo senso, ognuno di noi, come è tutto intero
nell’ostia. Le ostie non sono frammenti del suo corpo.
 L’importanza attuale dell’immagine del corpo mistico dimostra quanto i
cristiani siano miseramente esposti alle influenze esterne. certo inebriante
sentirsi membro del corpo mistico del Cristo: ma oggi molti altri corpi mistici,
che non hanno Cristo come capo, procurino alle proprie membra un’ebbrezza, a
mio parere, della stessa natura" (Simone Weil, 1942.)
L’importanza attuale dell’immagine del corpo mistico dimostra quanto i
cristiani siano miseramente esposti alle influenze esterne. certo inebriante
sentirsi membro del corpo mistico del Cristo: ma oggi molti altri corpi mistici,
che non hanno Cristo come capo, procurino alle proprie membra un’ebbrezza, a
mio parere, della stessa natura" (Simone Weil, 1942.)
KANT E SAN PAOLO. COME IL BUON GIUDIZIO ("SECUNDA PETRI") VIENE (E VENNE) RIDOTTO IN STATO DI MINORITA’ DAL GIUDIZIO FALSO E BUGIARDO ("SECUNDA PAULI").
IL MESSAGGIO EVANGELICO, IL PARADOSSO ISTITUZIONALE DEL MENTITORE, E LA CATASTROFE DELL’EUROPA. “Come fu possibile la hitlerizzazione dell’Imperativo Categorico di Kant? E perché è ancora attuale oggi?” (Emil L. Fackenheim, Tiqqun. Riparare il mondo).
 LA LEZIONE CRITICA DI KANT. Alcune luminose pagine da "La fine di tutte le cose"
LA LEZIONE CRITICA DI KANT. Alcune luminose pagine da "La fine di tutte le cose"GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. -- IL TRADIMENTO STRUTTURALE DELLA FIDUCIA. Negli Stati Uniti, 70 anni di abusi in Pennsylvania coperti dalla Chiesa.16 agosto 2018, di Federico La Sala
SULLA PEDOFILIA, L’ALLARME DELLA RIVISTA "CONCILIUM" (3/2004) E IL COLPEVOLE SILENZIO DEL VATICANO.
- Poscritto di "Concilium", 3/2004: "La chiesa deve affrontare la questione di come (ri-)creare l’autorità del sacerdote. Tale questione non può essere intesa unicamente come questione dell’identità individuale di coloro che hanno scelto e continuano a scegliere il sacerdozio. È anche un interrogativo rivolto all’istituzione: la preparazione, la guida e il controllo dei sacerdoti nell’adempimento del loro ufficio sono una cosa, la conformazione strutturale delle interazioni tra sacerdoti e credenti un’altra, la questione teologico-ecclesiologica relativa alla forma della chiesa una terza. Noi, le curatrici di questo fascicolo, siamo teologhe. Siamo donne. Siamo madri. Non di rado, nella prospettiva delle strutture tradizionali della chiesa, stiamo “dall’altra parte”, per cui non siamo noi a decidere dove, di volta in volta, vadano tracciatii confini" (dal Poscrittum di "Concilium").
Preti pedofili, 70 anni di abusi in Pennsylvania coperti dalla ChiesaUn Grand giurì ha riconosciuto la colpa di 300 sacerdoti su oltre mille bambini *
Più di 300 sacerdoti sono accusati in Pennsylvania di aver commesso abusi sessuali su oltre mille bambini nel corso di settant’anni, coperti "sistematicamente" dai vertici della Chiesa cattolica. Un Gran giurì americano ha diffuso un rapporto di oltre 1.400 pagine, ritenuto il più articolato e globale pubblicato sinora sulla pedofilia nella Chiesa americana da quando il Boston Globe per la prima volta denunciò il problema in Massachusetts nel 2002, vincendo un premio Pulitzer e ispirando il film ’Spotlight’. Il dossier ha portato all’incriminazione di due preti, ma la maggioranza dei presunti responsabili è ormai morta e la gran parte dei fatti è prescritta.
L’indagine del Gran giurì è durata due anni ed è stata condotta in tutte le diocesi della Pennsylvania, fatta eccezione per due. Cita decine di testimoni e mezzo milione di pagine di informazioni della Chiesa, contenenti "accuse credibili contro oltre 300 preti predatori". Più di mille bambine e bambini che furono vittime di abusi sono identificabili, ma "il vero numero" è in realtà "nell’ordine delle migliaia", secondo il Grand giurì, perché molti bambini hanno avuto paura di denunciare o i loro dati sono andati perduti. Le vittime, afferma il dossier, sono state speso traumatizzate per la vita, finendo per abusare di droga e alcol, o per suicidarsi.
Tra i casi elencati c’è quello di un religioso che ha stuprato una bambina di 7 anni in ospedale, dopo che la piccola aveva subito una tonsillectomia. Un altro bambino bevve un succo di frutta e si svegliò il mattino dopo sanguinante dal retto, senza poter ricordare che cosa gli fosse accaduto. Un prete costrinse un bambino di 9 anni a praticargli sesso orale, poi gli lavò la bocca con l’acqua santa per "purificarlo". Un altro sacerdote abusò di cinque sorelle della stessa famiglia, tra cui una da quando aveva 18 mesi ai 12 anni. Quando una delle bambine lo disse ai genitori nel 1992, la polizia trovò nella casa del prete slip, bustine di plastica contenenti peli pubici, fiale d’urina e fotografie a sfondo sessuale di bambine. La Chiesa ignorò per anni le accuse e il sacerdote morì in attesa di processo, ha dichiarato il procuratore generale della Pennsylvania, Josh Shapiro.
"Lo schema era abuso, negazione e copertura", ha spiegato Shapiro, aggiungendo: "Come diretta conseguenza della sistematica copertura da parte delle alte autorità ecclesiastiche, quasi ogni caso di pedofilia che abbiamo rilevato è troppo datato per un processo". Sinora solo due preti sono stati incriminati per accuse che sono al di fuori della prescrizione: uno è accusato di aver eiaculato nella bocca di un bambino di sette anni e si è dichiarato colpevole, secondo la procura; l’altro ha aggredito due bambini, uno dei quali da quando aveva 8 anni per un periodo di otto anni, sino al 2010.
Il Gran giurì ha chiesto che la prescrizione per i reati di pedofilia sia cancellata, che le vittime abbiano più tempo per presentare denuncia e che sia rafforzata la legge che obbliga a denunciare gli abusi sessuali di cui si viene a conoscenza. "I preti stupravano bambine e bambini piccoli e gli uomini di Dio che erano responsabili per loro non solo non facevano nulla, ma nascondevano tutto. Per decenni", si legge nel rapporto. I religiosi anziani, al contrario, furono promossi e i preti pedofili poterono amministrare per 10, 20 e persino 40 anni dopo che i vertici erano venuti a conoscenza degli abusi e mentre la lista delle vittime si allungava sempre di più, ha detto Shapiro.
Negli Stati Uniti, sono tra 5.700 e 10mila i preti cattolici accusati di abusi sessuali, ma poche centinaia sono stati processati, dichiarati colpevoli e condannati, secondo Bishop Accountability. Da quando il problema della pedofilia nella Chiesa cattolica è diventato noto all’inizio degli anni 2000, la Chiesa americana ha speso più di 3 miliardi di dollari in patteggiamenti, secondo l’osservatorio. Questo ha documentato accordi con 5.679 presunte vittime del clero cattolico, solo un terzo delle 15.235 denunce che i vescovi hanno detto di aver ricevuto fino al 2009. Una stima ipotizza che le vittime negli Usa siano 100mila. Sotto la pressione dell’aumento di denunce nel mondo e delle continue critiche per la insufficiente risposta della Chiesa, papa Francesco nel 2013 ha promesso una nuova legge sulla pedofilia e pedopornografia. Anche in Cile la Chiesa è stata di recente travolta da accuse di vasta copertura di casi di pedofilia durante gli anni Ottanta e Novanta.
* Fonte: La Presse, Martedì 14 Agosto 2018
SULLA PEDOFILIA, L’ALLARME DELLA RIVISTA "CONCILIUM" (3/2004) E IL COLPEVOLE SILENZIO DEL VATICANO.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- I DUE CRISTIANESIMI, I DUE PAPI, E LA PENA DI MORTE. Fede definita e pena capitale: insieme, ma «con moderazione»?7 agosto 2018, di Federico La Sala
I DUE CRISTIANESIMI, I DUE PAPI, E LA PENA DI MORTE.....
Lupus in pagina
Fede definita e pena capitale: insieme, ma «con moderazione»?
di Gianni Gennari (Avvenire, 07.0 8.2018)
"Life Site News" 3/8: «La liceità della pena di morte è una verità di fede cattolica... de fide tenenda, definita dal Magistero ordinario e universale della Chiesa... Chi afferma che la pena capitale è in se stessa un male cade nell’eresia». Così Roberto De Mattei, con testo dal latino: «Si può esercitare la pena di morte senza peccato mortale, a condizione che la vendetta sia esercitata non per odio ma per giudizio, non in maniera imprudente ma con moderazione».
Ormai contiamo anche «sette accuse» esplicite di «eresia» a papa Francesco, ma qui fa pensare quell’uccidere «con moderazione»: si prenderà esempio dai briganti che nel Vangelo lasciano al Samaritano quel poveraccio «emithanè», solo «mezzo morto»? Quindi, in rete, esemplare chiarezza non solo evangelica ma anche storica con rimando al «Concilio di Trento» parte III, al «Catechismo maggiore di San Pio X», sempre «parte III» e, oltre queste "modernità" esibite, anche alla «lettera del 18 dicembre 1208» di Innocenzo III contro i Valdesi. Se la fede cattolica continua a sopravvivere, insomma, lo dobbiamo a questi professori integerrimi, infrangibili, che sfidano Chiesa e mondo senza tema del ridicolo.
Altri tempi, se avessero incontrato un Galileo Galilei lo avrebbero condannato, e in coerenza con tanto passato, anche "bruciato" - cosa che quei "lassisti" e "modernisti" del 1600 non hanno fatto! - ma con moderazione, accendendo il fuoco a poco a poco, magari con una sigaretta elettronica, perché la loro vera modernità è aperta e immediata.
A proposito, in questi giorni si parla del 50° della Humanae vitae di un Papa che loro non hanno mai gradito del tutto, ma stavolta lo hanno approvato in pieno, con una sola condizione, esplicita e firmata dallo stesso di cui sopra: non va letta alla luce del Concilio e del Vangelo, ma «alla luce della Casti connubii» di Pio XI, del 1930! Sempre in anticipo: la classe non si smentisce mai!
Sul tema, nel sito, si cfr.:
DUE PAPI IN PREGHIERA: MA CHI PREGANO?! Bergoglio incontra Ratzinger: "Siamo fratelli". Ma di quale famiglia?!
OBBEDIENZA CIECA: TUTTI, PRETI, VESCOVI, E CARDINALI AGGIOGATI ALLA "PAROLA" DI PAPA RATZINGER ("DEUS CARITAS EST", 2006). Materiali per riflettere
- NOMADELFIA: IN NOME DELLA FRATERNITA’ EVANGELICA ("CHARITAS"), NON "MAMMONICA" (Benedetto XVI: "Deus caritas est", 2006)! PER LA CHIESA CATTOLICA, LA SOLLECITAZIONE E L’ORA DI UN PROFONDO ESAME DI COSCIENZA!!! "FE’ DU MUCC". FATE DUE MUCCHI": LA LEZIONE DON ZENO SALTINI.
I "DUE CRISTIANESIMI" E LA PROPRIA FACOLTA’ DI GIUDIZIO. "Perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto?".
Federico La Sala
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. -- L’Europa è sull’orlo di una drammatica disgregazione , alla quale l’Italia sta dando un pesante contributo. Prepariamoci alle Europee (di Massimo Cacciari).3 agosto 2018, di Federico La Sala
POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. Non è mai troppo tardi .... *
L’ appello
Prepariamoci alle Europee
di Massimo Cacciari (la Repubblica, 03.08.2018)
La situazione dell’Italia si sta avvitando in una spirale distruttiva. L’alleanza di governo diffonde linguaggi e valori lontani dalla cultura - europea e occidentale - dell’Italia. Le politiche progettate sono lontane da qualsivoglia realismo e gravemente demagogiche. Nella mancanza di una seria opposizione, i linguaggi e le pratiche dei partiti di governo stanno configurando una sorta di pensiero unico, intriso di rancore e risentimento. Il popolo è contrapposto alla casta, con una apologia della Rete e della democrazia diretta che si risolve, come è sempre accaduto, nel potere incontrollato dei pochi, dei capi. L’ossessione per il problema dei migranti, ingigantito oltre ogni limite, gestito con inaccettabile disumanità, acuisce in modi drammatici una crisi dell’Unione europea che potrebbe essere senza ritorno.
L’Europa è sull’orlo di una drammatica disgregazione, alla quale l’Italia sta dando un pesante contributo, contrario ai suoi stessi interessi. Visegrad nel cuore del Mediterraneo: ogni uomo è un’isola, ed è ormai una drammatica prospettiva la fine della libera circolazione delle persone e la crisi del mercato comune. È diventata perciò urgentissima e indispensabile un’iniziativa che contribuisca a una discussione su questi nodi strategici. In Italia esiste ancora un ampio spettro di opinione pubblica, di interessi sociali, di aree culturali disponibile a discutere questi problemi e a prendere iniziative ormai necessarie.
Perché ciò accada è indispensabile individuare, tempestivamente, nuovi strumenti in grado di ridare la parola ai cittadini che la crisi dei partiti e la virulenza del nuovo discorso pubblico ha confinato nella zona grigia del disincanto e della sfiducia, ammutolendoli.
 Per avviare questo lavoro - né semplice né breve - è indispensabile chiudere con il passato ed aprire nuove strade all’altezza della nuova situazione, con una netta ed evidente discontinuità: rovesciando l’ideologia della società liquida, ponendo al centro la necessità di una nuova strategia per l’Europa, denunciando il pericolo mortale per tutti i paesi di una deriva sovranista, che, in parte, è anche il risultato delle politiche europee fin qui condotte.
Per avviare questo lavoro - né semplice né breve - è indispensabile chiudere con il passato ed aprire nuove strade all’altezza della nuova situazione, con una netta ed evidente discontinuità: rovesciando l’ideologia della società liquida, ponendo al centro la necessità di una nuova strategia per l’Europa, denunciando il pericolo mortale per tutti i paesi di una deriva sovranista, che, in parte, è anche il risultato delle politiche europee fin qui condotte.C’è una prossima scadenza, estremamente importante, che spinge a mettersi subito in cammino: sono ormai alle porte le elezioni europee. C’è il rischio che si formi il più vasto schieramento di destra dalla fine della Seconda guerra mondiale. La responsabilità di chi ha un’altra idea di Europa è assai grande. Non c’è un momento da perdere. Tutti coloro che intendono contribuire all’apertura di una discussione pubblica su questi temi, attraverso iniziative e confronti in tutte le sedi possibili, sono invitati ad aderire.
Gli altri firmatari: Enrico Berti Michele Ciliberto Biagio de Giovanni Vittorio Gregotti Paolo Macrì Giacomo Manzoni Giacomo Marramao Mimmo Paladino
Sul tema, nel sito, si cfr.:
FILOSOFIA. IL PENSIERO DELLA COSTITUZIONE E LA COSTITUZIONE DEL PENSIERO
 MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA E A PENSARE BENE "DIO", "IO" E "L’ITALIA", CHI PIÙ CHI MENO, TUTTI VIVONO DENTRO LA PIÙ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA E POLITICA ITALIANA, NEL REGNO DI "FORZA ITALIA"!!!
MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA E A PENSARE BENE "DIO", "IO" E "L’ITALIA", CHI PIÙ CHI MENO, TUTTI VIVONO DENTRO LA PIÙ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA E POLITICA ITALIANA, NEL REGNO DI "FORZA ITALIA"!!!UNITÀ D’ITALIA E FOLLIA: EMERGENZA LOGICO-POLITICA EPOCALE. PER UN CONVEGNO E UNA RIFLESSIONE SUL CONCETTO DI ’UNITÀ E DI SOVRANITÀ (SOVRA-UNITÀ). Materiali sul tema
Federico La Sala
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. -- POPULISMO E PRINCIPI COSTITUZIONALI. Serve con urgenza una “operazione verità” condotta da un vasto movimento di opinione.28 luglio 2018, di Federico La Sala
IL SONNO DELLA RAGIONE COSTITUZIONALE GENERA MOSTRI.... *
Un dialogo difficile ma necessario per capire l’Unione europea
Europeisti, euro-critici, euro-scettici, euro-ostili
di Pier Virgilio Dastoli (Il Mulino, 24 luglio 2018)
L’editoriale di Ernesto Galli della Loggia, uscito qualche giorno fa sul “Corriere della Sera”, si inscrive in quella corrente di pensiero che è stata troppo genericamente definita “euroscettica” - espressione coniata nel 1985 dal “Times” per definire l’ostilità del Partito laburista britannico contro le politiche liberiste della Comunità economica europea. Da allora il termine “euroscettico” viene applicato indistintamente ai (pochi) partiti che si battono per l’uscita del loro Paese dall’Unione europea (come l’Ukip di Neil Farage), ai (sempre più numerosi) movimenti contrari alla cessione o alla perdita dell’apparente sovranità nazionale nella dimensione sopranazionale, a alcuni partiti della sinistra radicale e alle forze politiche di estrema destra xenofobe e antisemite.
Come avviene per la corrente di pensiero europeista, nella quale occorre distinguere gli orientamenti moderati o conservatori di chi difende l’Ue nel suo stato attuale - con le istituzioni consolidate nel Trattato di Lisbona (2009) e le politiche di austerità rappresentate dal Fiscal Compact (2013) - dalla cultura federalista che sostiene la necessità di sovranità condivise nel quadro di una democrazia europea multilivello, così fra gli euroscettici occorre distinguere fra chi sostiene l’idea di un’Europa intergovernativa, nella quale prevalga la difesa degli interessi nazionali e la posizione di chi è contrario in se al progetto di integrazione europea, che ne propugna la fine e che potremmo definire più correttamente “euro-ostile”. Dalla nascita della Comunità economica europea nel 1957, i cittadini e le cittadine di ventidue Paesi europei sono stati chiamati quaranta volte a esprimersi per referendum sul processo di integrazione europea dando il loro consenso ventinove volte (a cominciare dal primo referendum “europeo” nel Regno Unito del 1975) e il loro voto contrario undici, ivi compreso il doppio “no” dei norvegesi all’adesione. Si è concluso un ciclo durato oltre vent’anni, segnato da una globalizzazione caratterizzata da politiche liberiste senza regole, da una crisi economica che è stata la più lunga e profonda che abbia mai attraversato il mondo. La crisi ha prodotto disuguaglianze tra i ceti sociali in conseguenza di un processo redistributivo della ricchezza a scapito del lavoro, del ceto medio, dei giovani e tra i popoli, in cui con la stessa logica non i ceti, ma le economie più forti hanno prodotto un ulteriore impoverimento all’interno dell’Ue dove vivono oggi 120 milioni di persone che rischiano la povertà e l’esclusione sociale.
L’intero pianeta è interessato da processi che, in maniera sempre più interdipendente e con velocità crescente, ne mettono in discussione l’assetto geopolitico e ne accrescono gli squilibri sociali: da quelli concernenti la finanza e le monete alla loro ricaduta sull’economia e sull’assetto sociale, dalla crescita della popolazione mondiale alla disperata migrazione delle parti più deboli di essa che rende sempre più aleatoria la distinzione fra richiedenti asilo e migranti economici, dal consumo eccessivo delle risorse naturali non rinnovabili alla compromissione irreversibile dell’ambiente, dal miglioramento delle condizioni di benessere di una parte minoritaria della popolazione del pianeta al precipitare in condizioni di crescente povertà, fame e malattia di un’altra parte notevole della stessa popolazione. Questi processi interdipendenti, se non governati da autorità sopranazionali, provocheranno devastazioni degli assetti istituzionali anche nelle democrazie più progredite del pianeta.
Le conquiste di civiltà, in particolare quelle che caratterizzano l’Europa, conseguenti a contraddittorie e controverse secolari azioni di dominio mondiale, rischiano di essere messe in discussione. L’illusione degli Stati europei che ritengono di attraversare, immuni, gli sconvolgimenti planetari ai quali assistiamo, rinchiudendosi nell’ottocentesca dimensione nazionalista, sarà spazzata via non solo dai flussi migratori africani e asiatici, ma anche dal progredire degli Stati continentali.
Alle problematiche sopra accennate si aggiungono, tra le altre, quelle dell’energia e dell’ambiente che continuano a essere affrontate dagli Stati nazionali, singolarmente e nelle sedi internazionali, con scarse possibilità di successo, in assenza di soggetti di governo e di politiche che consentano di fronteggiare e governare i processi interdipendenti che le caratterizzano.
Per rispondere al neo-protezionismo degli Stati Uniti, al nazionalismo russo, alla trasformazione nella rete dei poteri globali e al neocolonialismo economico cinese, l’Ue dovrebbe essere dotata degli strumenti necessari a svolgere un ruolo autonomo di attore politico a livello planetario per contribuire ad avviare un nuovo ciclo nel governo dell’interdipendenza, segnato da uno sviluppo equilibrato e sostenibile, dalla distensione e dal rispetto della dignità umana.
Se la globalizzazione ha cambiato, nel bene e nel male, il mondo in rapidissima sequenza, l’Ue è così apparsa incapace di reagire velocemente e in modo adeguato, prigioniera del potere multi cefalo dei governi nazionali in settori chiave per la gestione di problemi di carattere nazionale. Al contrario di un Leviatano o di un Impero europeo che dà ordini a stati e sudditi satelliti dall’alto del Berlaymont (la sede della Commissione europea a Bruxelles), il potere europeo è passato progressivamente nelle mani dei governi nazionali e, per essi, dei capi di Stato e di governo riuniti nel Consiglio europeo all’interno di un’inedita “Santa Alleanza”, che costituisce quello che Habermas chiama il “federalismo degli esecutivi”. Amplificata dalla rivoluzione tecnologica e digitale, la globalizzazione ha sconvolto in questi anni gli equilibri più di quanto si immaginasse, causando una rapida redistribuzione internazionale del lavoro, delle ricchezze e degli investimenti. Se la portata inedita di tali fenomeni e il loro manifestarsi in veloce sequenza hanno cambiato il mondo, rendendo precari gli equilibri, l’Ue è apparsa vittima del suo gradualismo, delle risibili risorse finanziarie del bilancio Ue pari all’1% del Pil europeo e gestito da un’euro-burocrazia che costa a ogni cittadino 1,40 euro al mese.
L’analisi di Galli della Loggia non mi pare, dunque, fondata. Non vi è stata una vera eliminazione delle differenze fra gli Stati nazionali e le nazioni non sono scomparse. I Parlamenti nazionali sono stati in grado di recuperare parte dei loro poteri con il Trattato di Lisbona. Il pluralismo non è stato negato e gli indirizzi comuni nella sanità, nell’istruzione, nella cultura e nella ricerca sono passati dai tentativi (falliti) di armonizzazione al mutuo riconoscimento. La cittadinanza europea, infine, non ha sostituito le cittadinanze nazionali, ma ha aggiunto a esse diritti comuni che sono stati consolidati nella Carta europea dei diritti fondamentali.
Ogni giorno di più la realtà mostra, drammaticamente, che non ci può essere alternativa all’unità europea nella prospettiva di rinsaldare la secessione secolare con l’Oriente e con il Mediterraneo.
 Per costruire quest’alternativa serve con urgenza una “operazione verità” condotta da un vasto movimento di opinione ben al di là dell’associazionismo europeista, una alleanza di innovatori che nasca dal mondo dell’economia e del lavoro, della cultura e della ricerca, delle organizzazioni giovanili e del volontariato coinvolgendo tutti coloro che vivono l’utilità dell’integrazione europea e pagano le conseguenze dei costi della non-Europa.
Per costruire quest’alternativa serve con urgenza una “operazione verità” condotta da un vasto movimento di opinione ben al di là dell’associazionismo europeista, una alleanza di innovatori che nasca dal mondo dell’economia e del lavoro, della cultura e della ricerca, delle organizzazioni giovanili e del volontariato coinvolgendo tutti coloro che vivono l’utilità dell’integrazione europea e pagano le conseguenze dei costi della non-Europa.
*
POPULISMO E PRINCIPI COSTITUZIONALI
Perché la nazione ha ancora un senso
Il tema della patria è stato regalato a chi manipolandolo lo ha utilizzato per i propri scopi: è un inganno al quale non basta opporre il progetto europeista
di Ernesto Galli della Loggia *
L’Unione europea è visibilmente in crisi, non riesce a fare alcun passo avanti in quanto soggetto politico (anzi negli ultimi tempi ne ha fatto parecchi indietro), ma l’ideologia europeista almeno un successo importante può continuare comunque a vantarlo. Essere riuscita a delegittimare alla radice la dimensione della nazione in generale. Essere riuscita a farla passare come responsabile di tutte le sciagure novecentesche e come il ricettacolo delle più inquietanti ambiguità ideologiche, tipo quelle messe in circolazione da Matteo Salvini con il suo sciovinismo xenofobo a base di «prima gli italiani» e «padroni in casa nostra». Il risultato è che in pochi Paesi come l’Italia ogni riferimento alla nazione appare, ormai, come il potenziale preludio di una deriva sovranista, di una dichiarazione di guerra antieuropea, come sinonimo di sopraffazione nazionalistica. Non abbiamo forse sentito ripetere fino alla nausea, ad esempio, e dalle cattedre più alte, che gli Stati nazionali significano inevitabilmente la guerra? Come se gli esseri umani avessero dovuto aspettare la Marsigliese, il Kaiser o Mussolini per trovare il motivo di scannarsi. Come se prima dell’esistenza dei suddetti Stati nazionali di guerre non ce ne fossero mai state, e come se i Romani, l’impero turco, gli Aztechi, gli Arabi dell’epoca di Maometto o mille altri non avessero tutti coperto di stragi e di morti ammazzati il proprio cammino nella storia.
Naturalmente l’ostracismo comminato alla nazione ha avuto effetto non tanto sulla gente qualunque, sulla maggioranza dell’opinione pubblica quanto nei confronti delle élites, della classe dirigente. Anche perché l’Italia, si sa, non è la Francia. Da noi la cultura della nazione era già stata messa abbastanza nell’angolo dalla storia: non per nulla la Repubblica, nata e vissuta con l’obbligo di differenziarsi dal fascismo specialmente su questo punto, ha intrattenuto a lungo un rapporto per così dire minimalista con la nazione. Come del resto le sue maggiori culture politiche fondatrici (quella cattolica e quella comunista), il cui sfondo ideologico non aveva certo molto a che fare con la nazione.
Cresciuto per decenni in questa atmosfera, l’establishment italiano - in prima fila l’establishment culturale - si è dunque trovato prontissimo, dopo la fine della Dc e del Pci, a gettarsi nell’infatuazione europeistica più acritica. Trovandovi nuovo alimento non solo alla propria antica indifferenza, al suo disinteresse nei confronti di una dimensione nazionale giudicata ormai una sorta di inutile ectoplasma, ma per spingersi addirittura fino alla rinuncia della sovranità in ambiti delicatissimi come la formazione delle leggi. Mi domando ad esempio quante altre Costituzioni europee siano state modificate come lo è stata quella italiana nel 2001 con la nuova versione dell’articolo 117, che sottomette la potestà legislativa al rispetto, oltre che come ovvio della Costituzione stessa, anche «dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario». (Sulla stessa linea, pur nella sua evidente vacuità prescrittiva, anche il primo comma aggiunto nel 2012 all’art. 97, secondo il quale «le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione Europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico»).
È accaduto così, attraverso queste vie e mille altre, che il tema della nazione sia stato pian piano regalato a chi, manipolandolo ed estremizzandolo, combinandolo con i cascami del populismo, se ne è sempre più servito per i propri scopi agitatori. Espulsa dalla cultura ufficiale del Paese, tenuta in non cale dal circuito della formazione scolastica, non più elemento vivo costitutivo del modo d’essere e di pensare della classe dirigente, la nazione (o meglio la sua caricatura) è fatalmente divenuta patrimonio e strumento di una parte. La quale non ci ha messo molto ad accorgersi della sua capacità di aggregare, di commuovere, e anche di illudere, d’ingannare, se del caso di trascinare alla più vile prepotenza.
Cioè di trasformarsi in nazionalismo, appunto. Ma di chi la colpa principale mi chiedo, se non di coloro che, pur potendo e sapendo, per cecità ideologica hanno omesso di ricordare che cosa ha veramente rappresentato l’idea di nazione? Di illustrare e di far valere nella discussione pubblica la reale portata storica, le innumerevoli conseguenze positive di quell’idea?
Senza la quale, tanto per dirne qualcuna, non ci sarebbero stati il liberalismo e la democrazia moderna, la libertà religiosa, le folle di esclusi e di miserabili trasformate in cittadini, le elezioni a suffragio universale. Senza la quale non ci sarebbe stata la scuola obbligatoria e l’alfabetizzazione di massa, il Welfare e la sanità pubblica, e poi la rottura di mille gerarchie pietrificate, di tante esclusioni corporative. Senza la quale infine - scusate se è poco - non ci sarebbe stata neppure l’Italia. Cioè questo Stato scalcagnato e pieno di magagne grazie al quale, bene o male, però, nel giro di tre o quattro generazioni (una goccia nel mare della storia) un popolo di decine di milioni di persone ha visto la propria vita migliorare, cambiare come dalla notte al giorno, in una misura che non avrebbe mai osato sperare prima.
All’inganno nazionalistico che incalza e che cresce non vale opporre la speranza sbiadita e senza voce, il disegno dai contorni tuttora imprecisi e imprecisabili, del progetto europeistico. Va opposta prima di ogni altra cosa, in tutta la sua forza storica, la cultura della nazione democratica. Che più volte - ricordiamo anche questo - ha dimostrato anche di sapere aprirsi al mondo superando i confini della propria patria con la sua carica emancipatrice volta all’umanità.
* Corriere della Sera, 19 luglio 2018 (modifica il 19 luglio 2018 | 20:30) (ripresa parziale, senza immagini).
Sul tema, nel sito, si cfr.:
IL SONNO DELLA RAGIONE COSTITUZIONALE GENERA MOSTRI ATEI E DEVOTI. Un invito e un appello a fare luce, a fare giorno
RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". Per la rinascita dell’EUROPA, e dell’ITALIA. La buona-esortazione del BRASILE. Una "memoria"
Federico La Sala
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. - COSTITUZIONE ED EDUCAZIONE CIVICA. SENZA INDUGIO (Aldo Moro, 1947). La legge proposta dai Sindaci.26 luglio 2018, di Federico La Sala
MEMORIA E STORIA. COSTITUZIONE ED EDUCAZIONE CIVICA....*
La legge proposta dai Sindaci. Educazione civica ora tocca ai cittadini
di Luciano Corradini (Avvenire, domenica 22 luglio 2018)
Caro direttore,
il termine indugio indica il ritardo, più o meno motivato, rispetto alla tempestività di un inizio o la regolarità di uno svolgimento. Si tratta di un termine illustre, indicato da un ordine del giorno votato all’unanimità dall’Assemblea Costituente l’11 dicembre 1947, primo firmatario Aldo Moro, per dire che la nuova Carta costituzionale doveva trovare «senza indugio adeguato posto nel quadro didattico della scuola di ogni ordine e grado».
 Ora i Sindaci invitano i cittadini a chiedere a Parlamentari e Ministri, in nome e con metodi previsti dalla Costituzione di rompere quegli indugi che hanno afflitto l’ultimo decennio. Il 20 luglio in diverse sedi comunali è stato dato avvio alla raccolta di firme per la ’proposta di legge di iniziativa popolare’, promossa dal sindaco Nardella di Firenze e fatta propria dall’Anci, presieduta dal sindaco Decaro di Bari, «sull’introduzione dell’educazione alla cittadinanza nei curricoli scolastici di ogni ordine e grado».
Ora i Sindaci invitano i cittadini a chiedere a Parlamentari e Ministri, in nome e con metodi previsti dalla Costituzione di rompere quegli indugi che hanno afflitto l’ultimo decennio. Il 20 luglio in diverse sedi comunali è stato dato avvio alla raccolta di firme per la ’proposta di legge di iniziativa popolare’, promossa dal sindaco Nardella di Firenze e fatta propria dall’Anci, presieduta dal sindaco Decaro di Bari, «sull’introduzione dell’educazione alla cittadinanza nei curricoli scolastici di ogni ordine e grado».Entro sei mesi, si dovranno raccogliere le prescritte 50mila firme, con le modalità ricordate dal comunicato dell’Anci. Si chiede cioè che il Parlamento vari una legge in cui si dice, all’art. 2: «È istituita un’ora settimanale di educazione alla cittadinanza come disciplina autonoma con propria valutazione, nei curricoli e nei piani di studio di entrambi i cicli di istruzione. Sono conseguentemente da ritenersi modificati, in armonia con quanto disposto dal comma precedente, tutti gli articoli di legge che disciplinano i curricoli, i piani di studio e la loro articolazione. Il monte ore necessario (non inferiore alle 33 ore annuali) - ove non si preveda una modifica dei quadri orario che aggiunga l’ora di educazione alla cittadinanza - dovrà essere ricavato rimodulando gli orari delle discipline storicofilosofico- giuridiche».
Gli autori di questa proposta di legge non si nascondono la complessità dell’operazione e prevedono che il Parlamento dialoghi in certo senso con organi tecnici del Ministero dell’Istruzione. Si dice infatti all’art. 3: «È istituita presso il Miur una commissione ad hoc, che, sentito il comitato scientifico per le indicazioni nazionali e il Cspi, assuma: 1) il compito di elaborare entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, gli obiettivi specifici di apprendimento per i diversi cicli di istruzione, e di provvedere, entro il medesimo termine, alla corretta collocazione dell’insegnamento in seno ai curricula e ai piani di studio dei diversi cicli di istruzione, nonché di optare per l’aggiunta di un’ora ai curricula o per la sua individuazione nell’ambito degli orari di italiano, storia, filosofia, diritto, tenendo conto dei quadri orari e del numero di materie per ciascun tipo di scuola; 2) la decisione se optare per un’ora di nuova istituzione che si aggiunga in tutti o in alcuni cicli di istruzione e tipologie di indirizzo scolastico, o per un’ora da ricavare nell’ambito dei quadri orari esistenti».
Sotto il termine generale ’cittadinanza’, si precisa che «Gli obiettivi specifici di apprendimento dovranno necessariamente comprendere nel corso degli anni: lo studio della Costituzione, elementi di educazione civica, lo studio delle istituzioni dello Stato italiano e dell’Unione Europea, diritti umani, educazione digitale, educazione ambientale, elementi fondamentali del diritto e del diritto del lavoro, educazione alla legalità, oltre ai fondamentali princìpi e valori della società democratica, come i diritti e i doveri, la libertà e i suoi limiti, il senso civico, la giustizia». Nell’art. 4 si dice che «L’insegnamento potrà essere affidato ai docenti abilitati nelle classi di concorso che abilitano per l’italiano, la storia, la filosofia, il diritto, l’economia».
L’art. 5 aggiunge: «Sono istituiti percorsi di formazione dei docenti e azioni di sensibilizzazione sull’educazione digitale, ai sensi del comma 124 dell’art.1 legge 13.7.2015, n.107». A conclusione dell’art. 6 si dice: «Nell’ipotesi in cui si opti per l’aggiunta di un’ora agli orari delle discipline storicofilosofico- giuridiche, i maggiori oneri saranno a carico dei Fondi di riserva e speciali del bilancio dello Stato». A parere di chi scrive l’iniziativa, nonostante alcuni limiti che saranno affrontati in seguito, presenta caratteri di trasversalità, di necessità e urgenza, e non merita né ulteriori indugi né frettolose conclusioni. Intanto i ’cittadini praticanti’ dovrebbero impegnarsi a firmare entro i sei mesi previsti.
Professore emerito di Pedagogia generale nell’Università di Roma Tre,
 già presidente del Consiglio superiore della Pubblica istruzione
già presidente del Consiglio superiore della Pubblica istruzione
Sul tema, nel sito, si cfr.:
VIVA L’ITALIA!!! LA QUESTIONE "CATTOLICA" E LO SPIRITO DEI NOSTRI PADRI E E DELLE NOSTRE MADRI COSTITUENTI. Per un ri-orientamento antropologico e teologico-politico.
TRE PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA SENZA "PAROLA", E I FURBASTRI CHE SANNO (COSA SIGNIFICA) GRIDARE "FORZA ITALIA". In memoria di Sandro Pertini e di Gioacchino da Fiore, alcuni appunti per i posteri
Federico La Sala
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. -- FEDE E RAGIONE: LA LEZIONE DI GALILEO, L’ACCADEMIA DEL CIMENTO, E UNA "VECCHIA" PREGHIERA DI BAMBINI.12 luglio 2018, di Federico La Sala
Jesus. Chi era costui? Antropologia filologia archeologia filosofia teologia cristologia pedagogia ...
- Dopo il "VICISTI, GALILAEE" di Keplero a GALILEO, l’Accademia del Cimento, e l’Unità d’Italia, una preghiera per "bambini" del 1870... *
IL "CIMENTO" DELL’ACCADEMIA GALILEIANA E LA "PIETRA” DEI FILOSOFI: "PROVANDO E RIPROVANDO"!
A riorganizzare le idee, a sollecitare ulteriori riflessioni e approfondimenti sugli importanti e vitali "rapporti tra cemento, cimento e cimentare" ("Ggimentu, gimmientu e ggimintare"), e a non cadere nel delirio di onnipotenza della preghiera nient’affatto evangelica e nient’affatto infantile, troppo “infantile” (“Cristo lo voglio io per Padre/ la Madonna la voglio per Madre/ S. Giuseppe lo voglio per fratello,/ I Santi tutti li voglio per parenti / Affinché mi scampino da tutti i cimenti” - vale a dire, i serpenti-parenti), tenendo conto delle precisazioni del prof. Polito e delle mie "vecchie" note relative al suo articolo "Serpente? Presente",
RICORDO
che il motto della ACCADEMIA DEL CIMENTO ("Accademia dell’esperimento"), nel solco del "Saggiatore" di Galileo Galilei, è
"PROVANDO E RIPROVANDO".
Solo su questa strada, valendosi "del proprio intelletto senza la guida di un altro", con l’uso della propria "bilancetta", è possibile trovare all’interno dalla caverna la "pietra da costruzione" ("lapis philosophorum") e al contempo l’uscita dallo Stato di minorità (Kant).
*
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. -- "La farfalla e la crisalide" di Edoardo Boncinelli. E la scienza divenne sperimentale (di Stefano Gattei).26 ottobre 2018, di Federico La Sala
Conoscenza. Il saggio di Edoardo Boncinelli
E la scienza divenne sperimentale
L’approccio soltanto speculativo ha grossi limiti che molti filosofi non riconoscono
La ricostruzione dello scienziato nel saggio «La farfalla e la crisalide» (Raffaello Cortina)
di Stefano Gattei (Corriere della Sera, 26.10.2018)
Che cos’è la scienza? E che cosa la distingue dalle altre discipline? La domanda ha impegnato i filosofi per secoli. Se la pone ora, nel libro La farfalla e la crisalide (Raffaello Cortina), un grande scienziato, Edoardo Boncinelli, autore di importanti scoperte in campo genetico.
Il saggio ripercorre per importanti snodi concettuali la storia della scienza, dalla sua nascita nella Grecia di 2.500 anni fa, quando l’indagine della realtà era ancora difficilmente distinguibile dalla riflessione filosofica, al presente, nel quale scienza e filosofia appaiono del tutto separate, incommensurabili per capacità di analisi e significatività dei risultati. La farfalla - questa la metafora scelta dall’autore - è la scienza così come la conosciamo oggi: nasce dalla crisalide della filosofia, un intreccio di modi di pensare spesso in competizione fra loro, ma capaci di influenzare profondamente la nostra vita. Poco più di quattro secoli fa, la scienza si svincola dal ruolo ancillare nei confronti della filosofia, sviluppandosi autonomamente e ramificandosi gradualmente in una serie di discipline che, dalla fisica alla biologia all’intelligenza artificiale, hanno sostituito la filosofia come strumento di conoscenza del mondo. Con Galileo, tra scienza e filosofia si apre un baratro che oggi forse non vale neppure la pena di provare a colmare.
All’inizio, con i Presocratici, la filosofia avanza ipotesi sul mondo. Nasce libera, svincolata da ogni verità rivelata. La messa a morte di Socrate, «corruttore» dei giovani ateniesi con la critica implacabile della religiosità che la società si attende da loro, inaugura paradossalmente la grande stagione del pensiero greco. Consapevole dell’importanza della tecnica, la riflessione classica accompagna l’osservazione del mondo (culminata nei trattati naturalistici di Aristotele) all’indagine ipotetico-deduttiva, che si sviluppa senza bisogno di conferme sperimentali. Gli enormi successi della geometria euclidea e dell’astronomia matematica convincono però i filosofi che la verità sia raggiungibile per via puramente speculativa. Così, pur rimanendo sostanzialmente indistinguibili, scienza e filosofia iniziano a perdere contatto. Un ruolo non secondario nella separazione è svolto da Platone, sostenitore di una teoria della conoscenza «innatista» dall’indiscutibile sapore biologico, che Boncinelli apprezza, ma che inchioda l’uomo alla sterile fissità di un mondo delle idee sempre uguale a sé stesso. Se però Platone non poteva conoscere l’evoluzione, non così i molti filosofi che oggi a lui direttamente si rifanno, e che ignorano l’impatto rivoluzionario del cambiamento che si impone di continuo in biologia.
Una discussione serrata e tranchant, che non risparmia neppure Cartesio, porta il lettore al Seicento, quando dalla crisalide della filosofia occidentale si libera finalmente la farfalla della scienza sperimentale. Se, fino ad allora, scienziati e filosofi si erano limitati a porsi domande e a tentare di dare risposte attraverso l’osservazione, con la possibilità e l’opportunità di condurre esperimenti, lo scienziato «costringe» la natura a rispondere a domande specifiche. Mentre l’osservazione si limita a registrare ciò che accade, lo sperimentatore svolge un ruolo attivo, preparando le condizioni per portare la natura stessa su un terreno a noi favorevole. L’adozione del metodo sperimentale, spesso accompagnato da un’analisi quantitativa, è per Boncinelli un rivoluzionario atto di umiltà: segna il riconoscimento che per certi problemi l’approccio speculativo non è sufficiente - riconoscimento, questo, che l’autore non manca di contestare come estraneo a molti filosofi di ieri e di oggi.
Con l’Accademia del Cimento e il suo motto, «provando e riprovando», inizia la stagione della grande scienza, che giunge fino a noi. Ma non si chiude la stagione della filosofia, che pure arriva fino a noi, ignorando però (o fingendo di ignorare) l’abisso che la separa dalla scienza. Né, forse, può essere altrimenti: la crisalide è fondamentale per la nascita della farfalla, ma appena questa nasce le due strutture biologiche si devono separare una volta per tutte, perché la presenza della crisalide si rivelerebbe ora tossica per l’insetto alato. Fuor di metafora, la filosofia è stata fondamentale per la nascita del pensiero scientifico, ma col passare del tempo ha avuto un’influenza sempre più negativa, come una sorta di a priori indiscusso che ha finito per ostacolare il progresso scientifico.
L’analisi di Boncinelli è spietata. E senza dubbio corretta, anche se a volte scivola in qualche semplificazione eccessiva. Ma questo nulla toglie alla tesi generale di La farfalla e la crisalide, che interroga e sfida gli studiosi: un libro utile agli scienziati, che dalla riflessione dell’autore possono trarre spunti per meditare sul significato e sulla portata della propria disciplina, e necessario ai filosofi, per considerare i limiti della propria attività e i modi per ripensarla.
SUL TEMA, IN RETE, SI CFR.:
IL “CIMENTO” DELL’ACCADEMIA GALILEIANA E LA “PIETRA” DEI FILOSOFI: “PROVANDO E RIPROVANDO”!
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. -- CON DECENZA PARLANDO: LA PRIVATIZZAZIONE DEL NOME "ITALIA" E IL POPULISMO. "Ghe Pensi Mi"!9 luglio 2018, di Federico La Sala
CON DECENZA PARLANDO: LA PRIVATIZZAZIONE DEL NOME "ITALIA" E IL POPULISMO. "Ghe Pensi Mi"!
Una nota*
SICCOME QUI SI TOCCANO TEMI di tranquillizzazione politica (con tutti i suoi risvolti teologici e costituzionali) e di "superomismo" populistico ("stai sereno!" - "scuscitatu" vale come "senza pensieri, senza preoccupazioni": cioè, "Ghe Pensi Mi"), e c’è da svegliarsi e riappropriarsi della propria *dignità* (politica e *costituzionale*, e non solo economica) di cittadini e di cittadine, è bene ricordare che per "stare sereni" troppo e troppo a lungo, come cittadini italiani e cittadine italiane, abbiamo perso la stessa possibilità di "tifare" per noi stessi e stesse, per se stessi e per se stesse, sia sul piano sportivo sia sul piano *costituzionale*: non solo perché la nostra NAZIONALE è fuori dai MONDIALI DI CALCIO ma, anche e soprattutto, perché il NOME della NAZIONE (di tutti e di tutte) è diventato il "Logo" della "squadra" di un Partito e di un’Azienda.
IL LUNGO SONNO DELLA RAGIONE COSTITUZIONALE CONTINUA ...
*
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. -- Storie di testi e tradizione classica. Filologia e libertà: filologia e "verità". Note30 giugno 2018, di Federico La Sala
Canfora, la filologia è libertà
Il volume curato da Rosa Otranto e Massimo Pinto (Edizioni di Storia e Letteratura)
di Livia Capponi (Corriere della Sera, 29.06.2018)
Come lavoravano gli autori greci e latini? Nel suo lungo e intenso magistero, Luciano Canfora, a cui gli allievi Rosa Otranto e Massimo Pinto dedicano il volume collettivo Storie di testi e tradizione classica, ha insegnato ad affrontare ogni testo a partire dalla sua storia, reinventando la filologia come disciplina in grado di leggere non solo i testi giunti fino a noi, ma anche le cicatrici, i tagli, i contorni invisibili di ciò che è stato modellato da un censore, da un copista, dal gusto di un’epoca.
Diversamente da Isocrate, famoso per la sua lentezza nel comporre, e da Pitagora, che preferiva depositare la sua dottrina nei libri più sicuri, cioè nella memoria degli alunni, Canfora, la cui bibliografia conta 843 opere, è più simile a Demostene, che cesellava ogni rigo o a Fozio, patriarca bizantino che salvò il patrimonio letterario antico, aiutato da un’affezionata cerchia di studenti.
Nei contributi qui raccolti, l’erudizione è messa al servizio di una coinvolgente ricerca della verità, intesa come integrità testuale, storica ed etica. Sono toccati i temi prediletti, come l’analisi critica della democrazia, la storia della tolleranza e della libertà di parola, la schiavitù e i perseguitati politici e religiosi da Atene ai giorni nostri, attraverso lo studio di storiografia, archivi, biblioteche e pubblicistica d’ogni epoca. Il tutto condito da empatia e indipendenza di giudizio, in grado di far rivivere gli antichi con grande vivacità: Cesare è ritratto mentre elabora il primo sistema crittografico per l’intelligence romana; Fozio nell’atto di divorare romanzi d’amore greci (per poi censurarli). Coerentemente con la lezione canforiana, lo studio dei classici diventa motivo di apertura mentale perché aiuta a capire il presente e noi stessi.
Filologia e “verità”
di Daniele Ruini (Nazione Indiana, 01 marzo 2009)
Quale importanza abbia avuto, nella storia dell’umanità, la parola scritta è un fatto difficilmente sottostimabile. Per quanto riguarda, più in particolare, la storia delle religioni, ciò è chiaramente evidente in tutti quei culti che riconoscono autorità sacra a uno o più testi, ritenuti frutto della diretta ispirazione divina, ovvero “parola di Dio”. Dato lo speciale statuto assegnato a tali scritture, ogni operazione volta a definirne con esattezza il dettato testuale acquista un valore particolare; se, da un lato, avvicinarsi il più possibile allo stadio originario di un Testo Sacro significa ridurre la distanza che separa dalla supposta Verità in esso contenuta, dall’altro lato, rimettere ogni volta in discussione la lezione di un’opera di tal fatta non può non avere conseguenze delicate per la comunità religiosa che di essa ha fatto il proprio testo di riferimento. Il rapporto tra Sacre Scritture e filologia (la disciplina finalizzata a ricostruire la veste originaria di un testo attraverso lo studio delle varie fasi della sua trasmissione) è infatti necessariamente contraddittorio: il carattere dogmatico della “parola di Dio” può sopportare il libero esercizio critico della filologia? E soprattutto: fino a che punto saranno disposti ad accettarlo i rappresentanti delle gerarchie ecclesiastiche?
È questo il tema al centro di Filologia e Libertà di Luciano Canfora (Mondadori 2008), nel quale si ripercorre la storia delle resistenze del Vaticano dinnanzi all’applicazione della critica testuale alla Bibbia, dando risalto alle figure dei pochi studiosi che quei divieti tentarono di infrangere. Come sottolinea Canfora, riannodare le fila di questo racconto equivale a narrare la storia «della libertà di pensiero attraverso il faticoso e contrastato dispiegarsi della libertà di critica sui testi che l’autorità e la tradizione hanno preservato».
Benché sia sempre esistita una filologia biblica, le cui origini affondano nel giudaismo ellenistico, la Chiesa Cattolica è venuta progressivamente irrigidendosi, assumendo, di fronte alle possibilità di studiare le Sacre Scritture secondo i principi della critica testuale, un atteggiamento di totale chiusura, cui si accompagnò un’azione di repressione nei confronti dei disobbedienti. Tale fu la posizione espressa nelle disposizioni del Concilio di Trento (1545-1563), colle quali fu sancito il primato della Vulgata, ovvero della versione latina della Bibbia tradotta da San Gerolamo nel IV secolo d.C.
In maniera del tutto illogica e fondandosi sulla supposta ispirazione divina del traduttore, veniva riconosciuta la superiorità di una traduzione rispetto al testo originale (ebraico per l’Antico Testamento, greco per il Nuovo). Si trattava di una risposta alle iniziative dei luterani, che rivendicavano invece l’originale biblico e che quello traducevano per la massa dei fedeli. Tali norme rimasero valide fino al Concilio Vaticano II (1965), quando fu finalmente ammessa, anche da parte cattolica, la possibilità di tradurre le Sacre Scritture nelle lingue moderne, favorendone l’accesso al popolo dei credenti.
E nondimeno, la filologia moderna, sviluppatasi storicamente nel XIX secolo sui classici greci e latini, ebbe le sue prime applicazioni proprio in ambito biblico e, più in particolare, neotestamentario. Alla netta chiusura della Chiesa Cattolica - ma atteggiamento non dissimile ebbero le Chiese riformate - si contrappose l’attività di singoli eruditi che, raccogliendo l’eredità di Erasmo da Rotterdam (1466-1536), si prodigarono nello studio della formazione dell’Antico e del Nuovo Testamento, subendo spesso l’ostracismo delle comunità religiose di appartenenza.
 Tra le figure ricordate da Canfora vi sono l’ebreo Baruch Spinoza (1632-1677), il giansenista Richard Simon (1627-1704), i protestanti Pierre Bayle (1647-1706), Johann Jacob Wetstein (1694-1745) e Jean Leclerc (1657-1736). Il loro lavoro fu la principale fonte d’ispirazione della critica illuministica delle religioni, della cui efficacia ed attualità rende conto il fatto che «la condanna dell’illuminismo si replica, di papa in papa, di enciclica in enciclica, fino alla recentissima Spe salvi (par. 19) dell’attuale pontefice».
Tra le figure ricordate da Canfora vi sono l’ebreo Baruch Spinoza (1632-1677), il giansenista Richard Simon (1627-1704), i protestanti Pierre Bayle (1647-1706), Johann Jacob Wetstein (1694-1745) e Jean Leclerc (1657-1736). Il loro lavoro fu la principale fonte d’ispirazione della critica illuministica delle religioni, della cui efficacia ed attualità rende conto il fatto che «la condanna dell’illuminismo si replica, di papa in papa, di enciclica in enciclica, fino alla recentissima Spe salvi (par. 19) dell’attuale pontefice».Le infrazioni ai divieti cattolici in materia di filologia biblica proseguirono nel XIX secolo per merito di alcuni esponenti dell’Institut Catholique di Parigi, ai quali il Vaticano affibbiò l’etichetta di “modernisti”. Tra di essi, Ernest Renan (1823-1892) - autore di una celebre Vita di Gesù in cui si negava la divinità del Cristo -, Louis Duchesne (1843-1922) e Alfred Loisy (1857-1940), cui si devono due volumi sulla Storia del canone dell’Antico e del Nuovo Testamento.
 La durissima presa di posizione del cattolicesimo romano fu affidata alle encicliche Providentissum Deus di papa Leone XIII (1893) e Pascendi dominici gregis di papa Pio X (1907). In quest’ultima, in particolare, il pontefice espresse in termini retrogradi l’allarme risentito verso la critica testuale, il cui carattere eversivo risalirebbe alla pretesa di introdurre nell’ambito dei Testi Sacri il concetto di “evoluzione”, «quasi che la stessa religione fosse opera non di Dio ma degli uomini o un qualche ritrovato filosofico che con mezzi umani possa essere perfezionato» (sic).
La durissima presa di posizione del cattolicesimo romano fu affidata alle encicliche Providentissum Deus di papa Leone XIII (1893) e Pascendi dominici gregis di papa Pio X (1907). In quest’ultima, in particolare, il pontefice espresse in termini retrogradi l’allarme risentito verso la critica testuale, il cui carattere eversivo risalirebbe alla pretesa di introdurre nell’ambito dei Testi Sacri il concetto di “evoluzione”, «quasi che la stessa religione fosse opera non di Dio ma degli uomini o un qualche ritrovato filosofico che con mezzi umani possa essere perfezionato» (sic).Nessuna posizione ufficiale venne più espressa fino al 1943, quando papa Pio XII compì una svolta inaspettata, ammettendo la legittimità della critica testuale in ambito biblico (enciclica Divino afflante spiritu). Non si trattava, tuttavia, di una netta presa di distanza dalle chiusure del passato; l’enciclica pretende anzi di stabilire una continuità colle dichiarazioni dei pontefici precedenti, disegnando una prospettiva distorta secondo cui la Chiesa avrebbe sempre favorito e appoggiato la critica testuale, ed affermando che il riconoscimento della legittimità dell’indagine filologica sui testi sacri non è in contraddizione coi deliberati tridentini.
 L’apertura di papa Pacelli era in realtà la conseguenza della presa d’atto che alcune significative esperienze filologiche recenti avevano reso del tutto obsoleta e non più sostenibile la condanna vaticana verso la critica testuale; capolavori come l’edizione critica dell’Historia Ecclesiastica di Eusebio di Cesarea realizzata da Eduard Schwartz (1905-1909), o quella della Bibbia dei Settanta prodotta nel 1935 in ambiente protestante, costituivano una smentita concreta delle preclusioni cattoliche nei confronti della filologia. D’altra parte, pur nella sua apertura di fondo, Pio XII si appella alla cautela degli studiosi; l’enciclica contiene infatti l’invito a produrre nuove edizioni scientifiche del Testo Sacro pur mantenendo nei suoi confronti «somma riverenza».
L’apertura di papa Pacelli era in realtà la conseguenza della presa d’atto che alcune significative esperienze filologiche recenti avevano reso del tutto obsoleta e non più sostenibile la condanna vaticana verso la critica testuale; capolavori come l’edizione critica dell’Historia Ecclesiastica di Eusebio di Cesarea realizzata da Eduard Schwartz (1905-1909), o quella della Bibbia dei Settanta prodotta nel 1935 in ambiente protestante, costituivano una smentita concreta delle preclusioni cattoliche nei confronti della filologia. D’altra parte, pur nella sua apertura di fondo, Pio XII si appella alla cautela degli studiosi; l’enciclica contiene infatti l’invito a produrre nuove edizioni scientifiche del Testo Sacro pur mantenendo nei suoi confronti «somma riverenza».
 Si tratta, come evidenzia Canfora, di una posizione assurda e insensata, dacché inconciliabile colla pur invocata «rigorosa osservanza di tutte le leggi della critica». Ciò equivarrebbe infatti ad ammettere che “un testo affidabile di Platone possano darlo soltanto dei platonici puri e graniticamente fedeli al “verbo” del maestro (ammesso comunque che tale verbo esista già preconfezionato, prima del necessario, lunghissimo, imprevedibile, lavorio critico)”.
Si tratta, come evidenzia Canfora, di una posizione assurda e insensata, dacché inconciliabile colla pur invocata «rigorosa osservanza di tutte le leggi della critica». Ciò equivarrebbe infatti ad ammettere che “un testo affidabile di Platone possano darlo soltanto dei platonici puri e graniticamente fedeli al “verbo” del maestro (ammesso comunque che tale verbo esista già preconfezionato, prima del necessario, lunghissimo, imprevedibile, lavorio critico)”.
 Questo non-senso nasce dalla convinzione, mai messa in discussione, che i testi inclusi nel canone cattolico - e solo quelli - contengano la verità, una verità «precostituita e testualmente compiuta prima della ricostruzione del testo». L’apparente apertura rivoluzionaria del Vaticano tradisce, quindi, un certo conservatorismo, nell’incapacità di accettare fino in fondo l’idea che «il testo della Scrittura va letto (e criticato) per quello che letteralmente dice, mentre la sua difesa di principio può condursi solo sul piano della “fede”».
Questo non-senso nasce dalla convinzione, mai messa in discussione, che i testi inclusi nel canone cattolico - e solo quelli - contengano la verità, una verità «precostituita e testualmente compiuta prima della ricostruzione del testo». L’apparente apertura rivoluzionaria del Vaticano tradisce, quindi, un certo conservatorismo, nell’incapacità di accettare fino in fondo l’idea che «il testo della Scrittura va letto (e criticato) per quello che letteralmente dice, mentre la sua difesa di principio può condursi solo sul piano della “fede”».Il volume di Canfora costituisce, in conclusione, un elogio della filologia, considerata come un antidoto al dogmatismo e all’oscurantismo e come fondamento della libertà di pensiero.
Per materiali sul tema, nel sito, si cfr.:
LA SAPIENZA E IL MESSAGGIO EVANGELICO. FRANCESCO BACONE E SAN PAOLO PRENDONO LE DISTANZE DALLE ENCICLICHE DI PAPA BENEDETTO XVI. Una "preghiera comune" firmata da Bacone
LA CHIESA DEL SILENZIO E DEL "LATINORUM". Il teologo Ratzinger scrive da papa l’enciclica "Deus caritas est" (2006) e, ancora oggi, nessuno - nemmeno papa Francesco - ne sollecita la correzione del titolo. Che lapsus!!! O, meglio, che progetto!!!
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. -- La civiltà dell’uomo a una dimensione. "Aquarius: se io fossi Papa (di Paolo Farinella).14 giugno 2018, di Federico La Sala
"ADAMO", "ABRAMO", I TRE MONOTEISMI, L’ONU, E LA STORIA DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE ... *
Aquarius: se io fossi Papa, scomunicherei Matteo Salvini
di Paolo Farinella, sacerdoye (Il Fatto quotidiano, 12 giugno 2018)
Finita la civiltà occidentale, è iniziata l’inciviltà di Salvini Matteo, segretario della Lega non più secessionista ma a vocazione planetaria, (vice)Presidente del Consiglio dei ministri in atto e cattolico «coerente» (l’ha detto lui medesimo in persona!), in risposta al cardinal Gianfranco Ravasi che twittava il Vangelo di Matteo al capitolo 25,43: «Ero straniero e non mi avete accolto». La motivazione della coerenza cristiana di Matteo Salvini: «Ho il rosario in tasca, io coerente con gl’insegnamenti del Vangelo».
 È il capovolgimento di ogni ordine e principio. Se avere un oggetto in tasca è segno di coerenza, chi porta le «Madonne ripiene» di Lourdes, le immagini dei Padri Pii e armamentari di questo genere, cosa è? Un padre/madre eterno in terra?
È il capovolgimento di ogni ordine e principio. Se avere un oggetto in tasca è segno di coerenza, chi porta le «Madonne ripiene» di Lourdes, le immagini dei Padri Pii e armamentari di questo genere, cosa è? Un padre/madre eterno in terra?Se io fossi Papa, lo scomunicherei in forza delle sue stesse parole che sono un insulto a tutto l’insegnamento evangelico, tenuto conto che per un ministro della Repubblica Italiana, fresco di giuramento «di servire con disciplina e onore», dovrebbe essere ininfluente l’aspetto, finto o vero che sia, della religione perché bastano e avanzano i principi della Costituzione che anche Salvini difese nel referendum del 2016, le leggi e i trattati internazionali, sottoscritti dall’Italia e la legge della coscienza che su tutto fa prevalere l’umanità e il pericolo imminente di vita.
Nella creazione, «Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno, mentre chiamò le tenebre notte» (Gen 1,4-5), ora le tenebre prendono il posto del giorno come se niente fosse.
Mi ribello a questa ignominia che, come scrive Lucia Annunziata su Huffington Post, ci riporta indietro di 72 anni minimo alla vergogna della nave ebraica «Exodus». In questi giorni, nella mia parrocchia, abbiamo pubblicato tutti i bilanci e gli aiuti che diamo a oltre un centinaio di persone/famiglie (50% italiani e 50% di origine non italiana), provengono unicamente da contribuzioni volontarie di circa 150 persone.
 Non un soldo pubblico, non un contributo politico che non vogliamo perché abbiamo un senso di dignità che esige la compartecipazione e il sentimento umano. La «pacchia» la rimandiamo indietro al mittente perché è lui che lucra elettoralmente e politicamente dalla disgrazia dei migranti.
Non un soldo pubblico, non un contributo politico che non vogliamo perché abbiamo un senso di dignità che esige la compartecipazione e il sentimento umano. La «pacchia» la rimandiamo indietro al mittente perché è lui che lucra elettoralmente e politicamente dalla disgrazia dei migranti.A Salvini e a Di Maio che ho votato per scardinare l’immondo sodalizio «Renzi/Berlusconi» e non per trovarmi i fascisti al governo, nonostante la Costituzione, dedico queste parole nelle quali mi riconosco io e il meglio del popolo italiano:
- «Tutti i figli di Adamo formano un solo corpo, sono della stessa essenza. Quando il tempo affligge con il dolore una parte del corpo (anche) le altre parti soffrono. Se tu non senti la pena degli altri, non meriti di essere chiamato uomo».
Queste parole sono scolpite nell’atrio del Palazzo dell’Onu. Parole antiche, di Poeta e di Mistico, Saādi di Shiraz, Iran1203-1291. Nove secoli fa un persiano musulmano esprimeva un pensiero che è ebraico e cristiano. Nella Bibbia, «Adamo» non è nome proprio di persona, ma nome collettivo e significa «Umanità - Genere Umano», senza aggettivi perché non è occidentale, orientale, del nord o del sud, ma solo universale.
 L’Onu ha scolpito le parole sul suo ingresso perché le nazioni possano leggerla prima di deliberare per richiamarsi l’orizzonte delle decisioni. Europa, Italia e Occidente fan parte dell’Onu al punto che spiriti poveri osano parlare di «civiltà occidentale», identificandola, sacrilegamente, con il Crocifisso, senza memoria di storia, di geografia e di civiltà.
L’Onu ha scolpito le parole sul suo ingresso perché le nazioni possano leggerla prima di deliberare per richiamarsi l’orizzonte delle decisioni. Europa, Italia e Occidente fan parte dell’Onu al punto che spiriti poveri osano parlare di «civiltà occidentale», identificandola, sacrilegamente, con il Crocifisso, senza memoria di storia, di geografia e di civiltà.La nostra civiltà sta regredendo verso la preistoria, verso il nulla. Come insegna il secolo XX, secolo di orrori, la barbarie porta all’abisso e inghiotte la Storia in un buco nero senza ritorno. Guardando le immagini di umanità crocifissa nella miseria dell’opulenza attorno al Grattacielo della Regione Liguria, ho pensato istintivamente alle parole del pastore protestante tedesco, Martin Möller, pronunciate nel 1946 in un sermone liturgico: -***«Prima di tutto vennero a prendere gli zingari e fui contento, perché rubacchiavano. Poi vennero a prendere gli ebrei e stetti zitto, perché mi stavano antipatici. Poi vennero a prendere gli omosessuali, e fui sollevato, perché mi erano fastidiosi. Poi vennero a prendere i comunisti, e io non dissi niente, perché non ero comunista. Un giorno vennero a prendere me, e non c’era rimasto nessuno a protestare».
A Genova il Comune ha deciso di restaurare la Lanterna, simbolo della città, faro di luce nel buio e segnale per rotte sicure; a Genova, in Italia, in Europa e nel Mondo si perseguitano i poveri, i senza dimora, gli sbandati, figli di una società impazzita che crede di potersi chiudere in sé, erigendo muri e fili spinati, mentre si difendono Istituzioni ed Europa, gusci vuoti d’ideali, ma pieni di interessi miopi. Chi costruisce muri distrugge l’Europa e il proprio Paese, chi perseguita il povero si attira la collera di Dio che è «il Dio degli umili, il soccorritore dei piccoli, il rifugio dei deboli, il protettore degli sfiduciati, il salvatore dei disperati» (Gdt 14,11).
 La civiltà e il suo cammino lo avevano indicato nei millenni antichi le Scritture degli Ebrei, dei Cristiani e dei Musulmani, recepiti dalla modernità nell’esistenza stessa dello spirito delle Nazioni Unite, che si riconoscono in Saādi di Shiraz.
La civiltà e il suo cammino lo avevano indicato nei millenni antichi le Scritture degli Ebrei, dei Cristiani e dei Musulmani, recepiti dalla modernità nell’esistenza stessa dello spirito delle Nazioni Unite, che si riconoscono in Saādi di Shiraz.Se oggi, cittadini, uomini e donne, politici e amministratori, vescovi e preti, politici e governanti, sindaci e assessori, credenti e non credenti, docenti e studenti, non si riconoscono laicamente nelle parole che vengono dal lontano Medio Evo, noi abbiamo messo mano alla scure per recidere l’albero su cui siamo seduti. Se non ci si chiede la ragione per cui i poveri aumentano, i senza casa aumentano, gli sbandati crescono esponenzialmente e i migranti africani chiedono il conto, siamo colpevoli di assassinio della civiltà, non salveremo noi, ma ci votiamo destiniamo alla distruzione.
Berthold Brecht (1898-1956), poeta e drammaturgo, nelle Poesie di Svendborg (1933-1938), 1937 (traduzione di E. Castellani-R. Fertonani) ne ha una col titolo «Germania», atto di accusa al sopruso del forte sul debole, all’arroganza del sistema sulla persona. A sessant’anni della sua morte, Germania è nome simbolico, sostituibile con Italia, Ungheria, Polonia, Austria, Olanda, Genova, Torino Milano, Roma, Io, Tu, Egli, Noi, Voi e Loro: -***«Parlino altri della propria vergogna, / io parlo della mia. /O Germania, pallida madre! / come insozzata siedi / fra i popoli! / Fra i segnati d’infamia /tu spicchi. / Dai tuoi figli il più povero/ è ucciso. / Quando la fame sua fu grande / gli altri tuoi figli / hanno levato la mano su lui. / ... Perché ti pregiano gli oppressori, tutt’intorno, ma / ti accusano gli oppressi? / Gli sfruttati / ti mostrano a dito, ma / gli sfruttatori lodano il sistema / che in casa tua è stato escogitato! / E invece tutti ti vedono / celare l’orlo della veste, insanguinato / dal sangue del migliore / dei tuoi figli. / O Germania, pallida madre! / Come t’hanno ridotta i tuoi figli, / che tu in mezzo ai popoli sia / o derisione o spavento!» (Berthold Brecht).
Possano la Poesia e la Memoria rinsavire Ragione e Dignità. Salvini, la Lega, Di Maio e l’illusione passeranno, l’umanità sopravvivrà e i poveri porteranno fiori sulle loro tombe. È la Storia, bellezza! È la Storia!
*
SUL TEMA NEL SITO, SI CFR.:
SAN PAOLO, COSTANTINO, E LA NASCITA DEL CATTOLICESIMO. La "donazione di Pietro", la "donazione di Costantino" e noi, oggi.
- FORZA "CRISTO RE"!!! (Paolo di Tarso): "vivendo secondo la verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa verso di lui, che è il capo, Cristo, dal quale tutto il corpo, ben compaginato e connesso, mediante la collaborazione di ogni giuntura, secondo l’energia propria di ogni membro, riceve forza per crescere in modo da edificare se stesso nella carità" (Ef. 4,15-16)
- "È significativo che l’espressione di Tertulliano: "Il cristiano è un altro Cristo", sia diventata: "Il prete è un altro Cristo"" ([Albert Rouet, arcivescovo di Poitiers, 2010).
"ERODE" E LE GERARCHIE CATTOLICO-ROMANE CONTRO CRISTO E "CONTRO CESARE. Cristianesimo e totalitarismo nell’epoca dei fascismi". Il lavoro di Emilio Gentile
CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico
GUARIRE LA NOSTRA TERRA. "Potrei, per me, pensare un altro Abramo" (F. Kafka).
Federico La Sala
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE - «Oeconomicae et Pecuniariae Quaestiones». Verso una nuova finanza: il cammino ora è segnato.12 giugno 2018, di Federico La Sala
TEOLOGIA, ECONOMIA, E STORIA ..... *
Il documento vaticano.
Verso una nuova finanza: il cammino ora è segnato
Il testo della Congregazione per la Dottrina della Fede «Oeconomicae et Pecuniariae Quaestiones» offre spunti per un discernimento etico sul sistema attuale e offre soluzioni per il bene comune
di Stefano Zamagni (Avvenire, martedì 12 giugno 2018)
«Oeconomicae et Pecuniariae Quaestiones» (Opq) è un documento - reso di dominio pubblico il 17 maggio 2018 - originale e intrigante.
Originale per il taglio espositivo e soprattutto perché è la prima volta che la Congregazione per la Dottrina della Fede - la cui competenza copre anche le questioni di natura morale - interviene su una materia di Dottrina Sociale della Chiesa. Il lavoro congiunto tra Congregazione e Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale è già di per sé qualcosa che non può passare inosservato e che lascerà il segno.
Opq è poi un contributo intrigante per il modo e per lo spessore con cui affronta una tematica che, come quella della nuova finanza, è oggi al centro delle preoccupazioni della Chiesa e della società in generale. (Papa Francesco ha approvato il Documento che entra pertanto nel Magistero ordinario). Come recita il sottotitolo («considerazioni per un discernimento etico circa alcuni aspetti dell’attuale sistema economico-finanziario» - corsivo aggiunto), non ci troviamo di fronte ad una sorta di esortazione apostolica o ad un testo di taglio pastorale. Piuttosto, vi si legge un’analisi, scientificamente fondata, delle cause remote dei disordini e dei guasti che l’architettura dell’attuale sistema finanziario va determinando.
Si legge al n. 5: «La recente crisi finanziaria poteva essere l’occasione per una nuova regolamentazione dell’attività finanziaria, neutralizzandone gli aspetti predatori e speculativi (sic!) e valorizzandone il servizio all’economia reale. Sebbene siano stati intrapresi molti sforzi positivi... non c’è stata però una reazione che abbia portato a ripensare quei criteri obsoleti che continuano a governare il mondo».
 A scanso di equivoci, è bene precisare che il documento non parla affatto contro la finanza, di cui riconosce la rilevanza e anzi la necessità (e non potrebbe essere diversamente, se si considera che la finanza moderna nasce entro l’alveo del pensiero economico francescano). Esso prende piuttosto posizione nei confronti di una realtà efficacemente descritta dal seguente dato: nel 1980, l’insieme degli attivi finanziari a livello mondiale era pressoché eguale al Pil sempre mondiale; nel 2015 la prima variabile era diventata dodici volte superiore alla seconda.
A scanso di equivoci, è bene precisare che il documento non parla affatto contro la finanza, di cui riconosce la rilevanza e anzi la necessità (e non potrebbe essere diversamente, se si considera che la finanza moderna nasce entro l’alveo del pensiero economico francescano). Esso prende piuttosto posizione nei confronti di una realtà efficacemente descritta dal seguente dato: nel 1980, l’insieme degli attivi finanziari a livello mondiale era pressoché eguale al Pil sempre mondiale; nel 2015 la prima variabile era diventata dodici volte superiore alla seconda.Il punto centrale dell’argomento sviluppato nel Documento è l’affermazione del principio secondo cui etica e finanza non possano continuare a vivere in sfere separate. Ciò implica il rigetto della tesi del Noma (Non Overlapping Magisteria) per primo formulata in economia nel 1829 da Richard Whateley, cattedratico all’Università di Oxford e vescovo della Chiesa Anglicana.
 Secondo questa tesi, la sfera dell’economia va tenuta separata sia dalla sfera dell’etica sia da quella della politica, se si vuole che l’economia ambisca a vedersi riconosciuto lo statuto di disciplina scientifica. E così è stato, almeno fino a tempi recenti, quando si è cominciato a parlare con Amartya Sen e altri, di economia e etica.
Secondo questa tesi, la sfera dell’economia va tenuta separata sia dalla sfera dell’etica sia da quella della politica, se si vuole che l’economia ambisca a vedersi riconosciuto lo statuto di disciplina scientifica. E così è stato, almeno fino a tempi recenti, quando si è cominciato a parlare con Amartya Sen e altri, di economia e etica.
 I paragrafi 7-12 di Opq si soffermano con grande incisività a descrivere come dall’accettazione del principio del Noma sia derivato l’accoglimento dell’assunto antropologico (di ascendenza Hobbesiana) dell’homo homini lupus, posto a fondamento della figura dell’homo oeconomicus.
I paragrafi 7-12 di Opq si soffermano con grande incisività a descrivere come dall’accettazione del principio del Noma sia derivato l’accoglimento dell’assunto antropologico (di ascendenza Hobbesiana) dell’homo homini lupus, posto a fondamento della figura dell’homo oeconomicus.Ben diverso è l’assunto antropologico da cui parte il paradigma dell’economia civile - fondato da Antonio Genovesi nel 1753 a Napoli - che, rifiutando esplicitamente il Noma, riconosce che homo homini natura amicus. («L’uomo è per natura amico dell’altro uomo»).
Seconda novità di rilievo del Documento è la rilevanza attribuita al principio della responsabilità adiaforica, di cui quasi mai si fa cenno. Il par. 14 recita: «Ad li là del fatto che molti operatori siano singolarmente animati da buone e rette intenzioni, non è possibile ignorare che oggi l’industria finanziaria, a causa della sua pervasività e della sua inevitabile capacità di condizionare e di dominare l’economia reale, è un luogo dove gli egoismi e le sopraffazioni hanno un potenziale di dannosità della collettività che ha pochi eguali».
È questo un esempio notevole di struttura di peccato, come la chiamò, per primo nella Dottrina Sociale della Chiesa, Giovanni Paolo II nella sua Sollecitudo Rei Socialis (1987). Non è il solo operatore di borsa, o banchiere o uomo d’affari ad essere responsabile delle conseguenze delle azioni che pone in atto. Anche le istituzioni economiche, se costruite su premesse di valore contrarie ad un’etica amica dell’uomo, possono generare danni enormi a prescindere dalle intenzioni di coloro che in esse operano. Per meglio comprendere la ragione di ciò, conviene fissare l’attenzione su tre caratteristiche specifiche della nuova finanza.
La prima è l’impersonalità dei contesti di mercato, la quale oscura il fatto che da qualche parte vi è sempre un qualcuno sull’altro lato dell’affare. La seconda caratteristica è la complessità della nuova finanza che fa sorgere problemi di agentività indiretta: il principale si riconosce moralmente disimpegnato nei confronti delle azioni poste in essere dal suo ’ingegnere finanziario’, cioè dall’esperto cui affida il compito di disegnare un certo prodotto, il quale a sua volta si mette il cuore in pace perché convinto di eseguire un ordine.
Accade così che ognuno svolge il suo ruolo separando la propria azione dal contesto generale, rifiutandosi di accettare che, anche se solo amministrativamente, era parte dell’ingranaggio. Infine, la nuova finanza tende ad attrarre le persone meno attrezzate dal punto di vista etico, persone cioè che non hanno scrupoli morali e soprattutto molto avide. Riusciamo così a comprendere perché il problema non risiede unicamente nella presenza di poche o tante mele marce; ma è sulla stessa cesta delle mele che si deve intervenire.
Il Documento in questione, infine, prende definitiva ed esplicita posizione contro la tesi della doppia moralità - purtroppo diffusa anche tra alcune organizzazioni di tipo finanziario che dichiarano di ispirarsi alla Dottrina Sociale della Chiesa. Per capire di che si tratta conviene partire dal saggio di Albert Carr, ’Is business bluffing ethical?’ pubblicato sulla prestigiosa Harvard Business Review nel 1968. È questo il saggio che, più di ogni altro, ha guidato fino ad oggi la riflessione etica nel mondo degli affari. Vi si legge che l’uomo d’affari di successo deve essere guidato da «un diverso insieme di standars etici», poiché «l’etica degli affari è l’etica del gioco [d’azzardo], diversa dall’etica religiosa». Assimilando il business al gioco del poker, il noto economista americano conclude che «gli unici vincoli di ogni mossa nel business sono la legalità e il profitto.
Se qualcosa non è illegale in senso stretto (sic!) ed è profittevole allora è eticamente obbligante che l’uomo d’affari lo realizzi». I paragrafi dal 22 al 34 di Opq si soffermano sul faciendum: che fare per cercare di invertire la situazione? Parecchie le proposte - tutte realizzabili - che vengono avanzate. Dal sostegno a istituti che praticano la finanza non speculativa, come le Banche di Credito Cooperativo, il microcredito, l’investimento socialmente responsabile, alle tante forme di finanza etica. Dalla chiusura della finanza offshore e dalle forme di cannibalismo economico di chi, con i credit default swaps, specula sul fallimento altrui, alla regolamentazione dello shadow-banking, soggetti finanziari non bancari che agiscono come banche ma operando al di fuori di ogni quadro normativo ufficiale.
L’obiettivo da perseguire è quello di assicurare una effettiva biodiversità bancaria e finanziaria. Di speciale interesse è inoltre la proposta di affiancare ai Cda delle grandi banche Comitati Etici costituiti da persone moralmente integre oltre che competenti - così come già accade nei grandi policlinici. Nell’aprile 2015 la ’Dutch Banking Association’ (l’Associazione di tutte le banche olandesi) stabilì di esigere dai dipendenti delle banche (circa 87.000 persone) il ’Giuramento del Banchiere’, stilato sulla falsariga del giuramento ippocratico per i medici.
Il giuramento consta di otto impegni specifici. Ne indico solamente un paio: «Prometto e giuro di mai abusare delle mia conoscenze»; «Prometto e giuro di svolgere le mie funzioni in modo etico e con cura, adoperandomi di conciliare gli interessi di tutte le parti coinvolte: clienti, azionisti; occupati; società». Si opera dunque a favore di tutte le classi di stakeholder e non solamente di quella degli azionisti. Sarebbe bello se sull’esempio dell’Olanda - un Paese non certo sprovveduto né arretrato in materia finanziaria - anche l’Italia volesse seguirne la traccia.
Delle tre principali strategie con le quale si può cercare di uscire da una crisi di tipo entropico - quale è l’attuale - e cioè quella rivoluzionaria, quella riformista, quella trasformazionale, il Documento Opq sposa, in linea con il Magistero di papa Francesco, la terza. Si tratta di trasformare - non basta riformare - interi blocchi del sistema finanziario che si è venuto formando nell’ultimo quarantennio per riportare la finanza alla sua vocazione originaria: quella di servire il bene comune della civitas che, come ci ricorda Cicerone, è la «città delle anime», a differenza dell’urbs che è la «città delle pietre». È questa la strategia che vale, ad un tempo, a scongiurare il rischio sia di utopiche palingenesi sia del misoneismo, che è l’atteggiamento tipico di chi detesta la novità e osteggia l’emergenza del nuovo.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
SAN PAOLO, COSTANTINO, E LA NASCITA DEL CATTOLICESIMO. La "donazione di Pietro", la "donazione di Costantino" e noi, oggi.
LA CHIESA DI COSTANTINO, L’AMORE ("CHARITAS") E LA NASCITA DELLA DEMOCRAZIA DEI MODERNI. LA "CHARTA CHARITATIS" (1115), LA "MAGNA CHARTA" (1215) E LA FALSA "CARTA" DELLA "DEUS CARITAS EST" (2006).
LA CATTEDRA DI SAN PIETRO UNA CATTEDRA DI ECONOMIA POLITICA. Tutti a scuola in Vaticano, per aggiornamenti. Materiali per approfondire
STORIA D’ITALIA. INTELLETTUALI E SOCIETA’....
 VICO, LA «SCUOLA» DEL GENOVESI, E IL FILO SPEZZATO DEL SETTECENTO RIFORMATORE. Una ’Introduzione’ di Franco Venturi, tutta da rileggere
VICO, LA «SCUOLA» DEL GENOVESI, E IL FILO SPEZZATO DEL SETTECENTO RIFORMATORE. Una ’Introduzione’ di Franco Venturi, tutta da rileggereGUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. -- LA DEMOCRAZIA DEL NARCISISMO. Declino e (possibile) Caduta della Democrazia.7 giugno 2018, di Federico La Sala
POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. Il Narcisismo e l’uso lucidissimo come arma politica dell’"antinomia del mentitore" ... *
Narcisismo e democrazia
di Sergio Benvenuto (Doppiozero, 06 giugno 2018)
Il libro di Giovanni Orsina, La democrazia del narcisismo. Breve storia dell’antipolitica (Marsilio) si inserisce in un filone di studi che chiamerei, parafrasando Gibbon: Declino e (possibile) Caduta della Democrazia. Insomma, Orsina tematizza uno dei maggiori problemi della nostra epoca: la crisi della democrazia pluralista e liberale.
Una crisi che non a tutti appare evidente. Perché è vero che 25 paesi negli ultimi 18 anni sono retrocessi, per dir così, dalla democrazia al dispotismo - compresi Russia, Turchia e Venezuela - ma in Occidente la democrazia può sembrare ben salda. In effetti, le tre grandi catastrofi degli ultimi due anni - Brexit, elezione di Trump, vincita dei partiti anti-politica in Italia - si sono prodotte rispettando in tutto i meccanismi democratici. Non è un caso, però, che molti commentatori, anche in Italia, abbiano deprecato la decisione di Cameron di indire un referendum sull’appartenenza del Regno Unito all’Europa: “non è materia su cui ha da decidere il popolo”, hanno detto. -Insomma, molti democratici cominciano ad aver seriamente paura della democrazia. E ne hanno le ragioni, perché sappiamo che talvolta le democrazie uccidono democraticamente se stesse: fu questo il caso del fascismo italiano nel 1923, del nazismo in Germania nel 1933, delle elezioni algerine del 1991, e più di recente delle elezioni russe (Putin), turche (Erdogan) e venezuelane (Maduro). Il presupposto di onniscienza politica della democrazia è smentito storicamente. Un popolo può liberamente decidere di rovinarsi, come accade a certi individui, che decidono liberamente di rovinarsi; ne conosciamo tanti.
Ma per Orsina come per altri (incluso il sottoscritto) il sintomo della crisi della democrazia in Occidente è l’avanzare dei cosiddetti partiti populisti, ovvero “anti-politici”. Partiti o movimenti ossimorici, perché attaccano il potere politico proponendo se stessi come potere politico. Ma il merito di Orsina è di situare questo retreat della liberal-democrazia non come evento nuovo, congiunturale, ma come il manifestarsi di una contraddizione fondamentale nel genoma stesso della democrazia. Così, Orsina si appella all’analisi, così ambivalente, di Tocqueville della democrazia americana nell’800.
 Potremmo dire che questo filone di studi cerca di fare nei confronti della democrazia quel che Karl Marx fece nei confronti del capitalismo. Per Marx il capitalismo non sarebbe caduto per la rivolta indignata delle classi oppresse, ma per un’implosione interna, per il venire al pettine dei nodi di una contraddizione fondamentale del capitalismo stesso. Analogamente, la democrazia comporta una contraddizione fondamentale che sta per venire al pettine. Siccome la profezia marxiana del crollo del capitalismo non si è (finora) verificata, c’è solo da augurarsi che, analogamente, il crollo della democrazia non si verifichi. Ce lo auguriamo perché dopo tutto pensiamo come Churchill, che la democrazia è il peggiore dei sistemi politici, a esclusione di tutti gli altri.
Potremmo dire che questo filone di studi cerca di fare nei confronti della democrazia quel che Karl Marx fece nei confronti del capitalismo. Per Marx il capitalismo non sarebbe caduto per la rivolta indignata delle classi oppresse, ma per un’implosione interna, per il venire al pettine dei nodi di una contraddizione fondamentale del capitalismo stesso. Analogamente, la democrazia comporta una contraddizione fondamentale che sta per venire al pettine. Siccome la profezia marxiana del crollo del capitalismo non si è (finora) verificata, c’è solo da augurarsi che, analogamente, il crollo della democrazia non si verifichi. Ce lo auguriamo perché dopo tutto pensiamo come Churchill, che la democrazia è il peggiore dei sistemi politici, a esclusione di tutti gli altri.Va detto che Orsina, professore di Storia contemporanea alla LUISS, non si rifà tanto a sociologi e politologi accademici, quanto piuttosto a testi e ad autori del mondo filosofico e poetico: a La rivolta delle masse di José Ortega y Gasset, a Nelle ombre del domani di Johan Huizinga, a Massa e potere di Elias Canetti, a Montale, a Marcel Gauchet. È tra quelli che pensano che non bastino fatti e statistiche per capire il mondo in cui viviamo: occorrono anche le intuizioni, le folgorazioni intellettuali, di scrittori e filosofi.
Del resto, sin dal titolo - che riecheggia il bestseller anni 70 La cultura del narcisismo di Christopher Lasch - Orsina usa un concetto non ‘sociologico’, quello di narcisismo. Concetto freudiano più che mai, anche se l’autore non cita Freud ma i sociologi e i pensatori che, oltre Lasch, hanno sdoganato il concetto di narcisismo nella cittadella sociologica (Tom Wolfe, Richard Sennett, Gilles Lipovetski).
 Ora, per narcisismo Orsina non intende egoismo e nemmeno individualismo. Quest’ultimo, diceva Tocqueville, “è un sentimento ponderato e tranquillo”, è il valutare oculatamente i costi e benefici, e difatti tutte le teorie liberali si basano sull’individuo come homo rationalis, come buon calcolatore dei propri personali vantaggi. Il narcisista invece è una personalità fondamentalmente irrazionale (ho cercato di descrivere il narcisismo secondo Freud qui). Non è tranquillo, anzi, tende all’ira e alla protesta perenne, divorato da una frustrazione che lo assilla. In modo stringato, possiamo dire che il narcisista è chi si crede. Chi crede solo nella propria opinione, e che crede soprattutto nei propri desideri. Ma siccome nella vita sociale ci sarà sempre qualcuno al di sopra di lui, sentirà conficcate nella sua pelle “le spine del comando” (dice Orsina citando Canetti) ogni volta che ubbidirà a qualche ordine, e tutte queste spine costituiranno “un duro cristallo di rancore”. Perciò le democrazie sono caratterizzate da un cumulo di rabbia contro chi “comanda”, come ha visto il filosofo Peter Sloterdijk in Ira e tempo, dove parla di partiti e movimenti politici come “banche dell’ira”.
Ora, per narcisismo Orsina non intende egoismo e nemmeno individualismo. Quest’ultimo, diceva Tocqueville, “è un sentimento ponderato e tranquillo”, è il valutare oculatamente i costi e benefici, e difatti tutte le teorie liberali si basano sull’individuo come homo rationalis, come buon calcolatore dei propri personali vantaggi. Il narcisista invece è una personalità fondamentalmente irrazionale (ho cercato di descrivere il narcisismo secondo Freud qui). Non è tranquillo, anzi, tende all’ira e alla protesta perenne, divorato da una frustrazione che lo assilla. In modo stringato, possiamo dire che il narcisista è chi si crede. Chi crede solo nella propria opinione, e che crede soprattutto nei propri desideri. Ma siccome nella vita sociale ci sarà sempre qualcuno al di sopra di lui, sentirà conficcate nella sua pelle “le spine del comando” (dice Orsina citando Canetti) ogni volta che ubbidirà a qualche ordine, e tutte queste spine costituiranno “un duro cristallo di rancore”. Perciò le democrazie sono caratterizzate da un cumulo di rabbia contro chi “comanda”, come ha visto il filosofo Peter Sloterdijk in Ira e tempo, dove parla di partiti e movimenti politici come “banche dell’ira”.In effetti la democrazia non è solo un sistema per scegliere chi deve governare, essa si basa su una Promessa fondamentale, implicita o esplicita che sia: l’auto-determinazione di ciascun uomo e di ciascuna donna. Ovvero, non c’è alcun criterio che trascenda la volontà di ciascuno, sia esso la religione, la patria, il re, la classe sociale... “Il popolo è sovrano”, quindi ciascuno si sente sovrano nel pensare e nell’odiare. Ormai contano le opinioni dei singoli, ovvero la loro somma, non l’autorevolezza delle opinioni: se un’opinione è diffusa, diventa ipso facto autorevole. Se un libro si vende bene, allora è un capolavoro. Se un leader cialtrone prende una barca di voti, diventa ipso facto un grande uomo politico. Da qui l’esplosione dei sondaggi d’opinione: essi servono non solo a sapere quel che la gente pensa, ma a stabilire, appunto, che cosa vale e che cosa no. Ora, ciascuno è convinto che la propria opinione sia quella giusta, anche se in realtà non sa nulla di ciò di cui ha un’opinione. In democrazia, dicevano gli antichi greci, prevale la doxa, l’opinione, non l’epistheme (il sapere). Dico qui a parole mie quel che mi sembra il succo del libro di Orsina.
Decenni fa le persone semplici, non colte, mi chiedevano spesso “Professore, ma per chi devo votare?” Non rispondevo, ligio all’ideale democratico per cui il “professore” non deve esercitare un’autorità intimidente sull’elettore. Oggi invece le persone senza cultura non sanno che farsene non solo delle mie idee politiche, ma di quelle di tutti i professori. Del resto, per ogni opinione, per quanto becera, si riesce a trovare sempre qualche “esperto” che la puntelli o la legittimi. Si scoprono “specialisti” i quali dicono che vaccinare i bambini fa male, per esempio, quando si spande il rumor secondo cui vaccinare fa male. Il narcisismo è insomma l’arroganza dei propri desideri e delle proprie opinioni; non conta più il percorso - di studio, riflessione, informazione, confronto con esperti - che porta ad avere un’opinione che pesi.
Così, scrive Michel Crozier (citato da Orsina):
- I cittadini avanzano richieste incompatibili fra di loro. Insistono perché i loro problemi siano affrontati in maniera più efficace, e perciò chiedono più controllo sociale. Allo stesso tempo, si oppongono a qualsiasi forma di controllo sociale si associ ai valori gerarchici che hanno imparato a scartare e rigettare.
- Emerge qui la contraddizione fondamentale della democrazia, grazie al narcisismo che essa genera: ci si aspetta che loro (i politici) risolvano i problemi, ma per risolverli costoro devono esercitare un’autorità, devono infliggere “le spine del comando” e limitare l’autodeterminazione su cui la democrazia si fonda, eppure questa limitazione è costantemente rigettata. Scrive Orsina:
- Cacciati dalla porta, i vincoli della piena autodeterminazione soggettiva rientrano dalla finestra. È vero che il narcisista non è più tenuto a osservare alcun codice etico, ma deve comunque sottostare alle regole che disciplinano la convivenza civile. È vero che nessuno può più imporgli dall’esterno alcun obiettivo esistenziale, ma è soltanto dall’esterno che possono venire la stima altrui e il successo sociale dei quali ha disperato bisogno - anche perché osserva con invidia i molti che, attorno a lui, riescono a raccoglierli (p. 60).
Insomma, il principio di autodeterminazione di ciascuno porta a un indebolimento progressivo della politica. Da qui il crescente discredito dei politici: essi fanno da capro espiatorio di questa contraddizione fondamentale. Vengono applauditi solo i politici che si dichiarano anti-politici... Il narcisista moderno esige dalla politica che risolva i propri problemi, ma siccome la politica deve cercare di risolvere anche i problemi degli altri, qualunque cosa un politico farà sarà sempre insoddisfacente. Ogni misura politica pesta sempre i piedi a qualcuno. Ogniqualvolta un politico agirà politicamente, tenendo conto quindi dei vari interessi tra loro spesso contrapposti, sarà sempre considerato fallimentare, anzi un corrotto.
Si prenda il caso esemplare della lotta all’evasione fiscale: questa dovrebbe essere popolare perché permette allo stato di avere più fondi per i servizi pubblici, per il sistema sanitario..., ma essa comporta una decurtazione del reddito di chi prima evadeva. Solo questa decurtazione viene vista, e biasimata.
Il paradosso è che la credibilità dei politici si abbassa sempre più man mano che essi si convertono alla demagogia, diventando “cantastorie” come dice Orsina, ovvero aizzano richieste specifiche anche se irrealistiche al fine di guadagnare voti e potere. Sempre più abdicano a una funzione che i politici di vecchio stampo esercitavano: quella di presentare agli elettori anche gli oneri che un sistema politico-economico esige, i vincoli che vengono dall’economia, dal sistema internazionale delle alleanze. Oggi i politici promettono sempre di più a tutti, non mettono mai gli elettori di fronte alla complessità e alla durezza dei problemi sociali. Ma la demagogia dà un vantaggio effimero: prima o poi, l’elettore capisce che le promesse non vengono mantenute. E si volgerà a un altro demagogo...
Si è denunciato il fatto che il nuovo governo della Lega e del M5S in Italia si basi su due progetti praticamente contraddittori: da una parte la flat tax, che di fatto regala soldi ai più ricchi; dall’altra il reddito di cittadinanza, che dovrebbe andare ai più poveri. Ma se lo stato rinuncia a una parte cospicua delle tasse, gli sarà impossibile dare un reddito a chi non lavora.
 Il fatto che questi due progetti abbiano trovato una sorta di affinità elettiva è un’allegoria della contraddizione della democrazia narcisista: dallo stato, ovvero dalla politica, si chiede che da una parte esso dia sempre più, ma dall’altra gli si vuole dare sempre meno. Esigo che lo stato spenda sempre più per me, ma mi rifiuto sempre più di dargli questi soldi da spendere. Il segreto dell’esplosione del debito pubblico in Italia, che ha raggiunto il 130% del PIL nazionale, è tutto qui (esso è il frutto di decenni di politiche che hanno comprato consenso di massa indebitando però i nostri figli fino al collo).
Il fatto che questi due progetti abbiano trovato una sorta di affinità elettiva è un’allegoria della contraddizione della democrazia narcisista: dallo stato, ovvero dalla politica, si chiede che da una parte esso dia sempre più, ma dall’altra gli si vuole dare sempre meno. Esigo che lo stato spenda sempre più per me, ma mi rifiuto sempre più di dargli questi soldi da spendere. Il segreto dell’esplosione del debito pubblico in Italia, che ha raggiunto il 130% del PIL nazionale, è tutto qui (esso è il frutto di decenni di politiche che hanno comprato consenso di massa indebitando però i nostri figli fino al collo).Da qui il paradosso: lo stato italiano è fortemente indebitato, mentre i patrimoni e i risparmi personali sono altissimi. In Italia abbiamo uno stato quasi alla bancarotta, e una ricchezza privata cospicua.
Come nota Orsina, i pericoli della democrazia del narcisismo hanno portato gli stati, nel corso degli ultimi decenni, a sottrarre spazi al controllo democratico (cosa che viene denunciata dai populisti). Le banche centrali si sono autonomizzate sempre più dal potere politico, difendono la moneta del paese senza subire le pressioni dei governi, i quali esprimono le esigenze confuse di chi li ha eletti. Orsina legge il distacco crescente della magistratura dal potere politico come un altro segno di questa secessione di parti dello stato dal controllo democratico (sempre più, in quasi tutti i paesi, i magistrati fanno la loro politica; come abbiamo visto in Brasile oggi con Lula, la magistratura può opporsi fermamente alla volontà popolare). Egli nota, ad esempio, che tra il 1969 e il 1976 la quota di budget federale americano sul quale la politica conservava un controllo discrezionale si è dimezzato, scendendo dal 50 al 24%. Le istituzioni europee, di fatto, tolgono spazi all’autodeterminazione dei singoli paesi, imponendo a ciascuno parametri entro cui operare. Va detto che questo controllo della tecnocrazia europea sui destini nazionali non ha funzionato sempre. Non ha impedito il crack della Grecia nel 2016 né l’esplosione del debito pubblico italiano e portoghese fino a oggi.
Molti denunciano questo crescente potere tecnocratico e rivendicano più democrazia, ma non si rendono conto del fatto che la secessione di molte funzioni dalla “politica” - banche centrali, magistratura, FMI, WTO, ecc. - è proprio un ammortizzatore della democrazia frutto della democrazia stessa: rispetto all’autodeterminazione di tutti contro tutti, le istituzioni non elette, “tecniche”, pongono dei paletti fondamentali che impediscano le derive. Così, le costrizioni esterne imposte dai trattati internazionali, che il narcisista delle democrazie rigetta rivendicando la propria autodeterminazione nazionale (o regionale), rientrano.
“Il basso continuo” (è l’espressione di Orsina) dei populismi, rivendicando la propria sovranità nazionale di contro ai vincoli che pone a una nazione il tessuto europeo (o, per gli Stati Uniti, il NAFTA e altri trattati internazionali), titilla il desiderio di autodeterminazione di ciascuno. Si dice “Se noi italiani potessimo decidere tutto quello che vogliamo, senza tener conto dell’Europa, saremmo più liberi...” Si tratta ovviamente di un’illusione, perché rinunciare ai vincoli volontari non evita affatto i vincoli involontari, quelli imposti dai mercati internazionali, ad esempio. Rinunciare ai vincoli con altri stati ci mette in balia di forze economiche e politiche internazionali per noi ancor più incontrollabili.
Vent’anni fa ci fu una forte reazione alla globalizzazione “da sinistra”. Ma la sinistra, soprattutto marxista, è globalista per vocazione. Il vero grande attacco alla globalizzazione - di cui Trump e la Brexit sono gli episodi più salienti - viene però oggi da destra, o dai “populismi”. Dilaga la tendenza a negare l’evidenza di un mondo globalmente interconnesso, tornando alle vecchie identità, nazionali o regionali.
Ora, questa esigenza di autodeterminazione va sempre più spezzettandosi: ogni regione potrà pensare che sia meglio decidere da sola, senza avere i lacci nazionali che la legano ad altre regioni, magari più povere, ecc.
Lo abbiamo visto con la Lega Nord, prima che svoltasse verso un nazionalismo neo-fascista. Accade così che da una parte la Gran Bretagna decide di separarsi dall’Europa, ma dall’altra questo spingerà scozzesi e nord-irlandesi a volersi separare a loro volta dalla Gran Bretagna, ecc. ecc. Alla fine di questo processo ricorsivo di separazioni, nel quale ci si illuderà di diventare sempre più liberi... c’è solo l’individuo solo, narcisista. Che non vuole legami né costrizioni. Ma non si può vivere da soli. A meno di non fare come il protagonista del film Into the Wild di Sean Penn: se ne va a vivere completamente isolato, autarchico, sovrano, in Alaska, per morirvi. Anche la prospettiva delle nostre società potrebbe essere la morte, quella della democrazia.
Questo di Orsina è un libro che evade dal recinto di molto dibattito politico di oggi, diviso tra neo-marxisti, neo-liberisti e neo-populisti. Un dibattito ormai stereotipato, dove già si sa prima che cosa ciascuno dirà.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- TEORIA E PRATICA DEL BAAL-LISMO. COME UN CITTADINO RUBA IL NOME DI TUTTO UN POPOLO, NE FA LA BANDIERA DEL PROPRIO PARTITO PERSONALE, E GETTA LE BASI DELLA PIU’ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA D’ITALIA...
 POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. Materiali sul tema
POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. Materiali sul tema
RIPENSARE L’EUROPA. PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!
 FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.Federico La Sala
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. -- Bob Kennedy, la faccia morale dell’America finita nel sangue (di Furio Colombo)..6 giugno 2018, di Federico La Sala
Bob Kennedy, la faccia morale dell’America finita nel sangue
Le lotte contro la segregazione razziale e le marce per i diritti dei latinos
di Furio Colombo (Il Fatto, 06.06.2018)
Quando cominci a parlare - nel mio caso, a riparlare - di Robert Kennedy, ti accorgi che qualcosa di diverso, di insolito e anche di difficile da spiegare, segna il ricordo e la riflessione, rispetto a ogni altro politico. Per esempio, con Robert Kennedy sei entrato nella segregazione razziale che conosceva ancora il linciaggio, e sei uscito in un mondo di diritti ottenuto con una sfida che è stata insieme di popolo e di governo, di grandi manifestazioni di massa combattute contro una polizia accanitamente ostile (cani lupo, bastoni e pompe d’acqua), ma con a fianco un ministro della Giustizia disposto, con le truppe federali, a tener testa a un governatore che aveva già schierato la sua guardia nazionale intorno alla sua università segregata. Il governatore Wallace, a gambe divaricate, davanti al portone da non valicare, ha spiegato: “Sono stato eletto per questo”. Il ministro della Giustizia, Robert Kennedy, ha risposto. “Sei stato eletto giurando sulla Costituzione”. Kennedy ha precisato che un’Alabama fuori dalla Costituzione sarebbe stato anche fuori dagli Strati Uniti. Quella stessa sera il primo afroamericano ha fatto il suo ingresso nell’università fino ad allora segregata.
Questo episodio, come tanti durante la lotta per i diritti civili, ci dice molto della tenacia e della forza morale di Robert Kennedy. Ma voglio far notare che ho detto forza morale, non forza politica. Politicamente Kennedy non era né più grande né più forte dei suoi elettori democratici al Congresso e nel Paese.
Tutti sapevano tutto dell’esclusione e umiliazione dei neri, e non avevano, fino a quel momento, mosso un dito. Ma durante la lotta per i diritti civili, che ha visto il governo americano (in prima fila il ministro della Giustizia) schierato dalla parte degli umiliati e offesi, è emerso un aspetto nuovo, unico e breve nella politica americana: la forza morale. Comincia qui la presenza di un fatto nuovo di cui è rappresentante e portatore Robert Kennedy. Non è la politica che affronta il problema della spaccatura razziale del Paese, non saprebbe come e non può perché.
Il conflitto nasce completamente fuori dalla politica, e - attraverso la voce di Martin Luther King -, diventa la grande questione morale. Robert Kennedy la raccoglie e capisce che quella è la strada che va al di là del razzismo, al di là della vita dei poveri, al di là delle disuguaglianze mortali. E, poco dopo, al di là e contro la guerra nel Vietnam.
Robert Kennedy si rende conto di essere entrato (fin dall’uccisione di suo fratello) nell’area della non convenienza, che dissuade ogni politico, nell’area del pericolo, perché ti opponi troppo a troppe cose che hanno un peso (e un costo) troppo grande. La sua immagine, sempre più amata e seguita da masse di giovani, si contrappone a volti e poteri non visibili.
Il fenomeno strano, che resta unico nella nostra memoria, è che “la sua strada sbagliata” (cito il senatore Humphrey, democratico e amico di famiglia che rimproverava a Robert Kennedy) gli porta un successo popolare immenso che, subito prima di essere ucciso, ha travolto l’America.
Ho vissuto giorno per giorno quell’ultimo periodo di febbre affettuosa ed entusiasta, una febbre sempre più grande. Ho partecipato, giorno per giorno, all’ultima campagna elettorale di Robert Kennedy e ricordo, ogni sera, le mani piagate da decine di migliaia di strette di mano.
Ma adesso, mentre ne scrivo nel giorno dell’anniversario del suo assassinio, non riesco a non ricordare un altro evento di cui Robert Kennedy è stato protagonista. È accaduto due anni prima. L’ex ministro della Giustizia si era messo alla testa di una lunga marcia dei raccoglitori di uva messicani, portati in California come clandestini, per raccogliere l’uva di immense coltivazioni per paghe inesistenti. La marcia a piedi partiva da El Centro e arrivava a Sacramento, e accanto a Robert Kennedy c’era Cesar Chavez, improvvisato sindacalista dei contadini senza paga, uomo intelligente e analfabeta, capace di tener testa alle televisioni in modo da coinvolgere l’intera America in un famoso “sciopero dell’uva”.
Ecco, ripensando e rivedendo la testa del giovane leader assassinato, mentre viene scrutata dai flash e dalle telecamere, sul pavimento dell’Hotel Ambassador, mi ricordo di quella marcia in cui Robert Kennedy e Cesar Chavez parlavano insieme alla folla, l’uno nello spagnolo dei campi, l’altro nel suo inglese di Harvard. E mi domando: può esistere una santità laica? E come mai, adesso, il luogo in cui viviamo (dall’America di Kennedy all’Italia di Spinelli e Colorni) sia diventato un mondo carogna, con le frontiere di filo spinato a lama di rasoio, in modo che i bambini con la faccia sfregiata siano i primi a imparare che le frontiere non si attraversano?
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. - Un dio Chiamato Capitale. La quintessenziale volontà di potenza dell’uomo europeo ispira perciò in tutto anche Marx e la sua violenza rivoluzionaria.2 maggio 2018, di Federico La Sala
Due secoli di Marx
Un dio chiamato Capitale
Non è stata l’economia politica il cuore della rivoluzione del grande pensatore. Ma l’Economico come categoria dello spirito. La vera potenza che mette all’opera il mondo
di Massimo Cacciari (l’espresso, 29.04.2018)
Tacete economisti e sociologi in munere alieno. Marx non è affare vostro, o soltanto di quelli di voi che ne comprendano la grandezza filosofica, anzi: teologico-filosofica. Marx sta tra i pensatori che riflettono sul destino dell’Occidente, tra gli ultimi a osare di affrontarne il senso della storia. In questo è paragonabile forse soltanto a Nietzsche. Ma “Il Capitale”, si dirà? Non è l’economia politica al centro della sua opera? No; è la critica dell’economia politica. Che vuol dire? Che l’Economico vale per Marx come figura dello Spirito, come espressione della nuova potenza che lo incarna nel mondo contemporaneo. L’Economico è per Marx ciò che sarà la Tecnica per Heidegger: l’energia che informa di sé ogni forma di vita, che determina il Sistema complessivo delle relazioni sociali e politiche, che fa nascere un nuovo tipo di uomo. Nessuna struttura cui si aggiungerebbe una sovra-struttura a mo’ di inessenziale complemento - l’Economico è immanente in tutte le forme in cui l’agire e il pensare si determinano; ognuna di esse è parte necessaria dell’intero.
Marx è pensatore del Tutto, perfettamente fedele in questo al suo maestro Hegel. Il Sistema è più delle parti, irriducibile alla loro somma. Chi intende l’Economico come una struttura a sé, autonoma, che determinerebbe meccanicisticamente le altre, non ha capito nulla di Marx. Marx non è pensatore astratto, e cioè non astrae mai l’Economico dall’intero sistema delle relazioni sociali, culturali, politiche.
La sua domanda è: quale potenza oggi governa l’Intero e come concretamente essa si esprime in ogni elemento dell’Intero? L’Economico è infinitamente più che Economico. Esso rappresenta nel contemporaneo la potenza che mette all’opera il mondo.
 Il mondo della “morte di Dio”. Ogni opera deve essere valutata sul metro del lavoro produttivo di ricchezza e ogni uomo messo al lavoro per questo fine. Non è concesso “ozio”; nessuno può essere “lasciato in pace”. Il processo stesso di specializzazione del lavoro viene compreso in questo grandioso processo: più avanza la forma specialistica del lavoro, più l’Opera appare complessiva e distende il proprio spirito sull’intero pianeta; più il lavoro appare diviso, più in realtà esso funziona come un unico Sistema, dove ogni membro coopera, ne sia o meno consapevole, al fine universale dell’accumulazione e riproduzione. Fine che si realizza soltanto se al lavoro è posto prioritariamente il cervello umano. La vera forza del lavoro sta infatti nell’intelligenza che scopre, inventa, innova. La differenza tra teoretico e pratico si annulla nella potenza del cervello sociale, Intelletto Agente dell’intero genere, che si articola in lavori speciali soltanto per accrescere sempre più la propria universale potenza.
Il mondo della “morte di Dio”. Ogni opera deve essere valutata sul metro del lavoro produttivo di ricchezza e ogni uomo messo al lavoro per questo fine. Non è concesso “ozio”; nessuno può essere “lasciato in pace”. Il processo stesso di specializzazione del lavoro viene compreso in questo grandioso processo: più avanza la forma specialistica del lavoro, più l’Opera appare complessiva e distende il proprio spirito sull’intero pianeta; più il lavoro appare diviso, più in realtà esso funziona come un unico Sistema, dove ogni membro coopera, ne sia o meno consapevole, al fine universale dell’accumulazione e riproduzione. Fine che si realizza soltanto se al lavoro è posto prioritariamente il cervello umano. La vera forza del lavoro sta infatti nell’intelligenza che scopre, inventa, innova. La differenza tra teoretico e pratico si annulla nella potenza del cervello sociale, Intelletto Agente dell’intero genere, che si articola in lavori speciali soltanto per accrescere sempre più la propria universale potenza.Per Marx è questo il “nuovo mondo” che il sistema di produzione capitalistico crea, non certo dal nulla, ma certo sconvolgendo dalle radici forme di vita e relazioni sociali, insomma: l’ethos dell’Occidente, la “sede” in cui l’Occidente aveva ino ad allora abitato È il mondo dove il Logos della forma-merce si incarna in ogni aspetto della vita, per diventarne la religione stessa. E Marx ne esalta l’impeto rivoluzionario. È questo impeto che per lui va seguito, al suo interno è necessario collocarsi per comprenderne le contraddizioni e prevederne scientificamente l’aporia, e cioè dove la strada che esso ha aperto è destinata a interrompersi - per il salto a un altro mondo. Qui bisogna intendere bene: la contraddizione non viene da fuori, da qualcosa che sia “straniero” al Sistema.
Contraddittorio in sé è il capitalismo stesso. Il capitalismo è crisi, è fatto di crisi. Funziona per salti, che ogni volta mettono inevitabilmente in discussione gli equilibri raggiunti. Non vi è riproduzione senza innovazione. Questo è noto anche agli economisti.
 Ma Marx aggiunge: il capitalismo è crisi perché si costituisce nella lotta tra soggetti antagonisti. Il capitale è la lotta tra capitalisti e classe operaia. In quanto forza-lavoro la classe operaia è elemento essenziale del capitale stesso - ma quell’elemento che ha la possibilità di assumere coscienza di sé e lottare contro la classe che detiene l’egemonia sull’intero processo, che lo governa per il proprio profitto, metro del proprio stesso potere.
Ma Marx aggiunge: il capitalismo è crisi perché si costituisce nella lotta tra soggetti antagonisti. Il capitale è la lotta tra capitalisti e classe operaia. In quanto forza-lavoro la classe operaia è elemento essenziale del capitale stesso - ma quell’elemento che ha la possibilità di assumere coscienza di sé e lottare contro la classe che detiene l’egemonia sull’intero processo, che lo governa per il proprio profitto, metro del proprio stesso potere.
 È anche e soprattutto in forza di questa intrinseca contraddizione che il capitalismo è innovazione continua, produzione di merci sempre nuove e produzione del loro stesso consumo (la produzione più importante, quest’ultima, dice Marx). Tuttavia, ecco la metamorfosi: proprio diventando cosciente di questa sua funzione la forza-lavoro si fa soggetto autonomo rispetto al capitale, autonomo rispetto al carattere rivoluzionario di quest’ultimo. La lotta di classe di cui parla Marx è lotta tra rivoluzionari. Vera guerra civile.
È anche e soprattutto in forza di questa intrinseca contraddizione che il capitalismo è innovazione continua, produzione di merci sempre nuove e produzione del loro stesso consumo (la produzione più importante, quest’ultima, dice Marx). Tuttavia, ecco la metamorfosi: proprio diventando cosciente di questa sua funzione la forza-lavoro si fa soggetto autonomo rispetto al capitale, autonomo rispetto al carattere rivoluzionario di quest’ultimo. La lotta di classe di cui parla Marx è lotta tra rivoluzionari. Vera guerra civile.Questa contraddizione muove tutto. E ognuno è imbarcato in essa. L’idea di poterne giudicare “dall’alto” costituisce per l’appunto quella ideologia, che Marx sottopone a critica in dalle prime opere. Se la realtà dell’epoca è contraddizione inscindibilmente economica e politica, ogni interpretazione che la riduca a fatti naturalisticamente analizzabili la mistifica. Non è possibile cogliere la realtà del Sistema che collocandosi in esso, e dunque collocandosi nella contraddizione. Soltanto in questa prospettiva l’Intero è afferrabile. Non si comprende la realtà del presente se non in prospettiva e perciò a partire da un punto di vista determinato. Impossibile oggi un sapere astrattamente neutrale. La pretesa all’avalutatività è falsamente scientifica; l’epoca costringe a prender-parte, all’aut-aut. A porsi in gioco, alla scommessa anche. Il momento, o il kairòs, della decisione politica viene cosi a far parte della stessa potenza dell’Economico, resta immanente in essa.
 È l’ideologia propria del pensiero liberale, per Marx, che cerca di convincere a una visione de-politicizzante dell’Economico, a separare Economico e Politico, conferendo appunto all’Economico l’aspetto di un sistema naturale di relazioni.
È l’ideologia propria del pensiero liberale, per Marx, che cerca di convincere a una visione de-politicizzante dell’Economico, a separare Economico e Politico, conferendo appunto all’Economico l’aspetto di un sistema naturale di relazioni.Poiché concepisce la storia dell’Occidente come conflitto, e conflitto determinato dal suo carattere di classe, e poiché intende il presente alla luce dell’intrinseca contraddittorietà della stessa potenza rivoluzionaria del Sistema tecnico-economico, Marx pensa di aver posto saldamente sui piedi il pensiero dialettico dell’idealismo. Le epoche della Fenomenologia hegeliana dello Spirito non trovano conclusione in un Sapere assoluto che tutte accoglie e accorda, in una suprema Conciliazione, ma nella insuperabile contraddizione tra la potenza universale del Lavoro produttivo divenuto cosciente di sé e la sua appropriazione capitalistica. Si tratta di ben altro che di calcoli su valore e plusvalore.
 L’analisi del meccanismo dello sfruttamento, tanto bombardata dagli economisti e da filosofi dilettanti, sarà pure la parte caduca della grande opera di Marx. Ciò che conta in essa è la questione: il prodotto di questa umanità al lavoro (e questo significa “classe operaia”, altro che semplice “operaismo”!), di questo cervello sociale che inventa e innova, appartiene a chi? Come se ne determina la distribuzione? Chi la comanda? Può la sua potenza rinunciare a esigere potere? E se essa funziona riducendo sempre più il lavoro necessario per unità di prodotto o di prestazione, non si dovrebbe pensare nella prospettiva di una liberazione tout-court da ogni forma di lavoro comandato?
L’analisi del meccanismo dello sfruttamento, tanto bombardata dagli economisti e da filosofi dilettanti, sarà pure la parte caduca della grande opera di Marx. Ciò che conta in essa è la questione: il prodotto di questa umanità al lavoro (e questo significa “classe operaia”, altro che semplice “operaismo”!), di questo cervello sociale che inventa e innova, appartiene a chi? Come se ne determina la distribuzione? Chi la comanda? Può la sua potenza rinunciare a esigere potere? E se essa funziona riducendo sempre più il lavoro necessario per unità di prodotto o di prestazione, non si dovrebbe pensare nella prospettiva di una liberazione tout-court da ogni forma di lavoro comandato?
 Il comunismo risponde per Marx a queste domande. È l’idea della suprema conciliazione del soggetto col suo prodotto; il compito di superare nella prassi ogni estraneità. Comunismo significa la stessa “missione dell’uomo”. In questo senso, il capitalismo opera per il suo stesso superamento, poiché il suo sistema si fonda su quel cervello sociale-classe operaia che per “natura” è destinato a non sottostare ad alcun comando. Che deve diventare libero. Il comunismo è il Sistema della libertà.
Il comunismo risponde per Marx a queste domande. È l’idea della suprema conciliazione del soggetto col suo prodotto; il compito di superare nella prassi ogni estraneità. Comunismo significa la stessa “missione dell’uomo”. In questo senso, il capitalismo opera per il suo stesso superamento, poiché il suo sistema si fonda su quel cervello sociale-classe operaia che per “natura” è destinato a non sottostare ad alcun comando. Che deve diventare libero. Il comunismo è il Sistema della libertà.
 Marx sembra non avvedersi che tale “risoluzione” dell’aporia del capitalismo riproduce esattamente la conclusione della Fenomenologia hegeliana e, forse ancor più, del Sistema della scienza di Fichte. Ed è l’idea di un potere assoluto sulla natura, in cui la “comunità degli Io” sottopone al proprio dominio tutto ciò che le appaia “privo di ragione”.
Marx sembra non avvedersi che tale “risoluzione” dell’aporia del capitalismo riproduce esattamente la conclusione della Fenomenologia hegeliana e, forse ancor più, del Sistema della scienza di Fichte. Ed è l’idea di un potere assoluto sulla natura, in cui la “comunità degli Io” sottopone al proprio dominio tutto ciò che le appaia “privo di ragione”.
 La quintessenziale volontà di potenza dell’uomo europeo ispira perciò in tutto anche Marx e la sua violenza rivoluzionaria. Marx appartiene all’Europa “rivoluzione permanente”, all’Europa “leone affamato” (Hegel). Il suicidio di questa Europa lungo il tragico Novecento spiega lo spegnersi dell’energia politica scaturita dal marxismo assai più di quelle colossali trasformazioni sociali e economiche che hanno segnato il declino del soggetto “classe operaia”.
La quintessenziale volontà di potenza dell’uomo europeo ispira perciò in tutto anche Marx e la sua violenza rivoluzionaria. Marx appartiene all’Europa “rivoluzione permanente”, all’Europa “leone affamato” (Hegel). Il suicidio di questa Europa lungo il tragico Novecento spiega lo spegnersi dell’energia politica scaturita dal marxismo assai più di quelle colossali trasformazioni sociali e economiche che hanno segnato il declino del soggetto “classe operaia”.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
"CHI" SIAMO NOI, IN REALTÀ. RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.
RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". Per la rinascita dell’EUROPA, e dell’ITALIA. La buona-esortazione del BRASILE. Una "memoria"
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
Federico La Sala
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. -- STATO-MAFIA. Pm Di Matteo: silenzio assordante.23 aprile 2018, di Federico La Sala
Stato-Mafia: Pm Di Matteo: ’Dell’Utri tramite dopo il ’92’
’Da Anm e Csm nessuna difesa. Silenzio assordante, chi speravamo ci difendesse ha taciuto’
- Stato-mafia: pm Di Matteo, da Anm e Csm nessuna difesa © ANSA FOTO
di Redazione ANSA *
"La sentenza è precisa e ritiene che Dell’Utri abbia fatto da cinghia di trasmissione nella minaccia mafiosa al governo anche nel periodo successivo all’avvento alla Presidenza del Consiglio di Berlusconi. In questo c’è un elemento di novità. C’era una sentenza definitiva che condannava Dell’Utri per il suo ruolo di tramite tra la mafia e Berlusconi fino al ’92. Ora questo verdetto sposta in avanti il ruolo di tramite esercitato da Dell’Utri tra ’Cosa nostra’ e Berlusconi". Lo ha detto il pm della Dna Nino Di Matteo, a proposito della sentenza sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia, intervenendo alla trasmissione "1/2 ora in più" di Lucia Annunziata, in onda sui Rai tre.
La replica dell’Anm, sempre difeso magistrati attaccati - "L’Associazione Nazionale Magistrati ha sempre difeso dagli attacchi l’autonomia e l’indipendenza dei magistrati". Lo dice il presidente dell’Anm Francesco Minisci. "Lo ha fatto - prosegue - a favore dei colleghi di Palermo e continuerà sempre a difendere tutti i magistrati attaccati, pur non entrando mai nel merito delle vicende giudiziarie".
"Né Silvio Berlusconi, né altri hanno denunciato le minacce mafiose, né prima né dopo" ha anche detto il pm Di Matteo, a proposito della sentenza sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia, intervenendo alla trasmissione "1/2 ora in più" di Lucia Annunziata, su Rai tre. "Nel nostro sistema costituzionale le sentenze vengono pronunciate nel nome del popolo italiano e possono essere criticate e impugnate. Il problema è che quando le sentenze riguardano uomini che esercitano il potere devono essere conosciute", ha aggiunto. "C’è una sentenza definitiva - ha spiegato - che afferma che dal ’74 al ’92 Dell’Utri si fece garante di un patto tra Berlusconi e le famiglie mafiose palermitane. Ora questa sentenza dice che quella intermediazione non si ferma al ’92, ma si estende al primo governo Berlusconi, questi sono fatti che devono essere conosciuti"
"I carabinieri che hanno trattato sono stati incoraggiati da qualcuno. Noi non riteniamo che il livello politico non fosse a conoscenza di quel che accadeva. Ci vorrebbe ’un pentito di Stato’, uno delle istituzioni che faccia chiarezza e disegni in modo ancora più completo cosa avvenne negli anni delle stragi". Lo ha detto il pm della dna Nino Di Matteo, a proposito della sentenza sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia, intervenendo alla trasmissione "1/2 ora in più" di Lucia Annunziata, in onda sui Rai tre.
"Quello che mi ha fatto più male è che rispetto alle accuse di usare strumentalmente il lavoro abbiamo avvertito un silenzio assordante e chi speravamo ci dovesse difendere è stato zitto. A partire dall’ Anm e il Csm". Lo ha detto il pm della Dna Nino Di Matteo, dopo la sentenza sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia, intervenendo alla trasmissione "1/2 ora in più" di Lucia Annunziata, in onda sui Rai tre a proposito delle critiche subite, negli anni, dal pool che ha coordinato l’inchiesta.
* ANSA,23 aprile 2018 (ripresa parziale, senza immagine).
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. -- Il destino ambiguo del Concordato. Nella Costituzione senza esserlo (di Roberto Finzi).30 marzo 2018, di Federico La Sala
MITO E STORIA, POLITICA E TEOLOGIA: "LUCIFERO!" E LA STELLA DEL DESTINO. Storiografia in crisi d’identità ... *
Diritto
Nel saggio di Daniele Menozzi (Carocci) la storia di come la Carta regolò i rapporti tra Stato e Chiesa
Nella Costituzione senza esserlo. Il destino ambiguo del Concordato
I tessitori. Dossetti e Togliatti con il liberale Lucifero trovarono la soluzione sancita nell’articolo 7
di Roberto Finzi (Corriere della Sera, 30.03.2018)
Non c’è dubbio che tra i «principi fondamentali» che reggono la nostra Repubblica racchiusi nei primi dodici articoli della Carta del 1948 (cui Carocci dedica una serie diretta da Pietro Costa e Mariuccia Salvati) il più controverso sia stato (in parte continui a essere) l’articolo 7 o meglio, e soprattutto, il primo asserto del suo secondo comma. Se, al di là delle sfumature, ogni forza politica e ogni cittadino, poteva ammettere che «lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani» perplessità e opposizioni nascevano e continuarono dalla affermazione che seguiva: «I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi», firmati, come si sa, da Benito Mussolini e dal cardinale segretario di Stato Pietro Gasparri l’11 febbraio 1929, regnante Achille Ratti, Papa Pio XI. Sanavano la «questione romana» apertasi con la presa di Roma. Con accordi e norme complicate tra cui due particolarmente odiose per un Paese che - dopo un decennio di guerre e la doppia occupazione nazista e alleata - si era scrollato di dosso la dittatura anche attraverso la Resistenza e stava lavorando non solo al ritorno delle civili libertà ma a una democrazia nuova, repubblicana come aveva decretato il voto del 2 giugno 1946.
Si trattava dell’asserto che quella cattolica era la religione «di Stato» e, per la sua pervasività, dell’attribuzione degli effetti civili al matrimonio religioso. Con il paradosso che chi riteneva il matrimonio un sacramento poteva, per le norme del diritto canonico, ottenerne la nullità, riconosciuta poi dallo Stato e chi invece aveva del matrimonio una concezione puramente civile era destinato a essere legato a vita, indissolubilmente, non per diretta conseguenza dei Patti, ma per la coincidenza nella visione della famiglia tra Chiesa e fascismo. Nel quadro per di più di un diritto di famiglia in cui era sancita una netta subordinazione della donna.
Nella sua ricostruzione del formarsi del dettame costituzionale e poi dei suoi effetti nella vita democratica italiana ( Art.7. Costituzione italiana ), Daniele Menozzi non nega le conseguenze negative del permanere di quelle norme specie nel quindicennio successivo alla emanazione della Carta Costituzionale. Ci offre però una chiave di lettura della formazione e del senso della norma più articolata, che affonda le sue radici nella complessità del problema cattolico nella storia dell’Italia unita e soprattutto a quel punto della vicenda del nostro Paese.
La Chiesa, lo dimostreranno le successive elezioni del 18 aprile 1948, aveva ancora un forte ascendente sulla popolazione ed era una Chiesa che, seppure - si vedrà di lì a poco - intimamente percorsa da interne pulsioni verso il nuovo, era ancora fortemente contraria al mondo moderno e alle sue forme politiche. In particolare a quelle di matrice socialista e comunista. Ora, si trattava, in sostanza - spiega Menozzi con precisione e acribia filologica - di attirare, per così dire, la Chiesa verso la accettazione piena di quella democrazia che si andava delineando nel lavoro della Costituente, cedendo in via formale alle sue richieste anche se nell’immediato contraddittorie con quella visione.
Protagonista di questa operazione complicata e sottile fu in primis Giuseppe Dossetti che univa alla sua profonda fede cristiana una visione non ierocratica della Chiesa, la competenza giuridica del canonista di vaglia, cristalline convinzioni democratiche, saldi legami con le altre culture politiche formatisi nella Resistenza. Dossetti trovò una sponda in Palmiro Togliatti, a lungo, e tutt’oggi, accusato di avere, in qualche modo permesso un inquinamento della Costituzione con il riconoscimento nel suo testo dei famigerati Patti Lateranensi.
L’atteggiamento del leader del Pci derivava dal convincimento che nella Repubblica dovessero riconoscersi per davvero tutti gli italiani e pure, dice Menozzi, da considerazioni più immediatamente politiche. Mentre stava costruendo il «partito nuovo» guardava alla possibilità di una adesione al Pci di cattolici. Così temuta dalla Chiesa pacelliana che nel 1949 il Papa scomunicherà i comunisti.
Io aggiungerei due aspetti. Togliatti era ben consapevole di quanto Milovan Gilas nelle sue Conversazioni con Stalin ricorda avergli detto il dittatore sovietico: «Questa guerra (...) è diversa da tutte quelle del passato; chiunque occupa un territorio gli impone anche il suo sistema sociale». E infine la lotta per l’egemonia all’interno della sinistra. In quel campo i socialisti, allora sotto la sigla Psiup, erano ancora, seppure non di molto, maggioritari rispetto al Pci.
Per ben intendere la vicenda al quadro manca un tassello. Decisivo. Si tratta della seconda parte del secondo comma dell’articolo 7 che recita: «Le modificazioni dei Patti (Lateranensi), accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale». In tal modo si eliminava una delle più forti obiezioni all’inserimento dei Patti in Costituzione. Per tale via infatti non venivano «costituzionalizzati» ché la loro modifica poteva avvenire per legge ordinaria. L’artefice di questo accorgimento essenziale fu Roberto Lucifero, liberale e monarchico.
Così l’articolo, nota Menozzi, «appariva formulato con il concorso di tre diverse famiglie politiche: la democristiana, la comunista e la liberale».
La «non costituzionalizzazione» dei Patti - in un modo profondamente cambiato all’interno e soprattutto all’esterno della Chiesa - sarà uno degli elementi che permetterà all’Italia l’adozione formale, prima sul terreno parlamentare e quindi - con i referendum del 1974 e del 1981 - attraverso la conferma popolare di decisive riforme come il divorzio e l’interruzione volontaria di gravidanza. E del nuovo diritto di famiglia.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
MITO E STORIA, POLITICA E TEOLOGIA: "LUCIFERO!" E LA STELLA DEL DESTINO. Storiografia in crisi d’identità ...
 LA STORIA DEL FASCISMO E RENZO DE FELICE: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"!
LA STORIA DEL FASCISMO E RENZO DE FELICE: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"!
 I. BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI - II. ARNALDO MUSSOLINI E MADDALENA SANTORO.
I. BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI - II. ARNALDO MUSSOLINI E MADDALENA SANTORO.- TEORIA E STORIA DELLA STORIOGRAFIA. IL PROBLEMA GIAMBATTISTA VICO E IL PROBLEMA DELLA COSTITUZIONE
 CROCE “CRISTIANO” , VICO “ATEO”, E L’UOMO DELLA PROVVIDENZA.
CROCE “CRISTIANO” , VICO “ATEO”, E L’UOMO DELLA PROVVIDENZA.
- VENI, CREATOR SPIRITUS: LO SPIRITO DELLA VERITA’. Lo Spirito "costituzionale" di Benedetto Croce, lo spirito cattolico-romano di Giacomo Biffi, e la testimonianza di venti cristiani danesi
LA QUESTIONE "CATTOLICA" E LO SPIRITO DEI NOSTRI PADRI E E DELLE NOSTRE MADRI COSTITUENTI. Per un ri-orientamento antropologico e teologico-politico. Una nota (del 2006)
KANT E SAN PAOLO. COME IL BUON GIUDIZIO ("SECUNDA PETRI") VIENE (E VENNE) RIDOTTO IN STATO DI MINORITA’ DAL GIUDIZIO FALSO E BUGIARDO ("SECUNDA PAULI").
Federico La Sala
- TEORIA E STORIA DELLA STORIOGRAFIA. IL PROBLEMA GIAMBATTISTA VICO E IL PROBLEMA DELLA COSTITUZIONE
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. - LA CRISI DELL’ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE E LA NECESSITA’ DI RIPRENDFERE IL FILO DI UN ALTRO DISCORSO.8 marzo 2018, di Federico La Sala
IL MAGGIORASCATO (NON "PATRIARCATO"!). La crisi epocale dell’ordine simbolico di "mammasantissima" (alleanza Madre-Figlio) ...*
Del femminismo liquido
di Rossella Ghigi (Il Mulino, 08 marzo 2018)
Le vicende elettorali offuscheranno solo parzialmente lo spazio mediatico ogni anno occupato dalla Giornata della donna. Anche quest’anno, infatti, alcuni must non potranno mancare all’appuntamento dell’otto marzo: chi celebrerà le virtù delle donne, ricordando quanto esse “sappiano farcela” anche in condizioni difficili perché “hanno una marcia in più” (per non dire, con le solite espressioni, quanto siano mirabili se hanno “gli attributi” maschili anche propriamente detti, il che è tutto dire sul sessismo di questa figura retorica).
 Chi vorrà ricordare l’importanza di una giornata nata con un martirio, quello di operaie americane bruciate vive in un incendio perché il proprietario della fabbrica newyorkese dove questo avvenne (la Triangle? La Cotton? Le versioni non combaciano mai) le teneva lì rinchiuse. E chi osserverà come sono cambiati i tempi, quanto lontani fossero i cortei delle donne sulle strade a rivendicare diritti e libertà e come oggi sembri svuotata questa ricorrenza dalle allegre cene tra amiche, magari corredate dalla artificiosa ironia dello spogliarello maschile (perché “le giovani generazioni non sanno, hanno trovato tutto già pronto”).
Chi vorrà ricordare l’importanza di una giornata nata con un martirio, quello di operaie americane bruciate vive in un incendio perché il proprietario della fabbrica newyorkese dove questo avvenne (la Triangle? La Cotton? Le versioni non combaciano mai) le teneva lì rinchiuse. E chi osserverà come sono cambiati i tempi, quanto lontani fossero i cortei delle donne sulle strade a rivendicare diritti e libertà e come oggi sembri svuotata questa ricorrenza dalle allegre cene tra amiche, magari corredate dalla artificiosa ironia dello spogliarello maschile (perché “le giovani generazioni non sanno, hanno trovato tutto già pronto”).Il riferimento agli scandali sessuali e a forme più o meno glamourizzate o addomesticate del femminismo d’oltreoceano probabilmente sarà la novità mediatica di quest’anno, con riferimenti spesso immemori di una riflessione quasi secolare su questi temi. Sono tutti discorsi a cui siamo ormai assuefatti. E non si tratta, in fondo, semplicemente di decostruirne le basi - osservando, per esempio, che il mantra per cui le donne “ce la fanno” può finire per giustificare le lacune del welfare, o che il mito dell’incendio è stato contestato dalla storiografia (si veda il lavoro di Tilde Capomazza e Marisa Ombra a questo riguardo) ed è un’origine che “non impegna”, o che contraddizioni proprie di un contesto di circolazione di merci, informazioni e di persone globale, di catene transnazionali della cura e di digitalizzazione del dissenso vedono sì l’articolazione dei temi di genere in modalità nuove, intersezionali, attente alle istanze del Sud del mondo, ma anche il rifiorire di forme più tradizionali di contestazione di piazza (a cominciare dallo sciopero globale di oggi).
 Si tratta di capire, piuttosto, quanto del femminismo sia oggi effettivamente patrimonio comune, superando le facili critiche all’emancipazionismo da tastiera, al commercialismo del femvertising o alla spettacolarizzazione hollywoodiana, per aprirsi a una riflessione sulle potenzialità di forme inedite di condivisione delle esperienze come il #metoo o il movimento Non una di meno. Quanto di esso sia invece sdoganato - purché lo si annacqui un po’ e non lo si chiami con questo nome - e quanto sia invece tradito, laddove ormai nessuno, a destra come a sinistra, sembra sottrarsi all’elogio dell’uguaglianza nella differenza, della parità nella meritocrazia, della libertà nell’autoaffermazione individuale.
Si tratta di capire, piuttosto, quanto del femminismo sia oggi effettivamente patrimonio comune, superando le facili critiche all’emancipazionismo da tastiera, al commercialismo del femvertising o alla spettacolarizzazione hollywoodiana, per aprirsi a una riflessione sulle potenzialità di forme inedite di condivisione delle esperienze come il #metoo o il movimento Non una di meno. Quanto di esso sia invece sdoganato - purché lo si annacqui un po’ e non lo si chiami con questo nome - e quanto sia invece tradito, laddove ormai nessuno, a destra come a sinistra, sembra sottrarsi all’elogio dell’uguaglianza nella differenza, della parità nella meritocrazia, della libertà nell’autoaffermazione individuale.
 La filosofa Nancy Fraser si è pronunciata in proposito con una lettura molto chiara: i temi del femminismo sono stati fagocitati dal neoliberismo, allo stesso modo in cui, secondo Slavoj Žižek o Luc Boltanski, l’ambientalismo o la critica sociale del 68 lo sono stati dal capitalismo, trasformando cioè istanze di autenticità e giustizia in merci da consumare e in sistemi da riprodurre. Tuttavia, aggiunge Fraser, alcune condizioni strutturali emergenti possono permettere di non rimanere vittime delle seduzioni individualiste del capitalismo e di riprendere il filo di un altro discorso del femminismo di seconda ondata per molti versi abbandonato: quello della solidarietà sociale, della politicizzazione del personale e del rifiuto dell’economicismo.
La filosofa Nancy Fraser si è pronunciata in proposito con una lettura molto chiara: i temi del femminismo sono stati fagocitati dal neoliberismo, allo stesso modo in cui, secondo Slavoj Žižek o Luc Boltanski, l’ambientalismo o la critica sociale del 68 lo sono stati dal capitalismo, trasformando cioè istanze di autenticità e giustizia in merci da consumare e in sistemi da riprodurre. Tuttavia, aggiunge Fraser, alcune condizioni strutturali emergenti possono permettere di non rimanere vittime delle seduzioni individualiste del capitalismo e di riprendere il filo di un altro discorso del femminismo di seconda ondata per molti versi abbandonato: quello della solidarietà sociale, della politicizzazione del personale e del rifiuto dell’economicismo.Riprendere quel filo significa ripartire dalla struttura, dal tessuto economico e sociale, tralasciando affermazioni di principio più o meno liquide, ma osservando la materialità delle asimmetrie nel loro farsi quotidiano. Le dimensioni in cui questo avviene sono molte. Rielaborando la proposta di un classico testo degli anni Settanta, La condizione della donna di Juliet Mitchell (Einaudi, 1972), Raewyn Connell (2011) propone ad esempio di analizzare la asimmetria tra uomini e donne secondo quattro dimensioni.
 La prima, quella della produzione, del consumo e della accumulazione. La divisione sessuale del lavoro, la segregazione occupazionale, la discriminazione, i vari soffitti e labirinti di cristallo che separano uomini e donne lungo assi verticali e orizzontali della gerarchia lavorativa rappresentano la principale dimensione delle asimmetrie di genere riconosciuta nelle scienze sociali.
La prima, quella della produzione, del consumo e della accumulazione. La divisione sessuale del lavoro, la segregazione occupazionale, la discriminazione, i vari soffitti e labirinti di cristallo che separano uomini e donne lungo assi verticali e orizzontali della gerarchia lavorativa rappresentano la principale dimensione delle asimmetrie di genere riconosciuta nelle scienze sociali.
 La seconda, quella del potere, è stata un elemento cruciale nella analisi del funzionamento del sistema patriarcale elaborata dal femminismo radicale. Il potere dei mariti sulle mogli e dei padri sulle figlie è stato al centro di una riflessione critica dell’esperienza di sopraffazioni e violenze vissuta entro le mura di casa, riflessione che si è poi estesa ad ambiti extradomestici e forme più tacite di subordinazione, anche simbolica.
La seconda, quella del potere, è stata un elemento cruciale nella analisi del funzionamento del sistema patriarcale elaborata dal femminismo radicale. Il potere dei mariti sulle mogli e dei padri sulle figlie è stato al centro di una riflessione critica dell’esperienza di sopraffazioni e violenze vissuta entro le mura di casa, riflessione che si è poi estesa ad ambiti extradomestici e forme più tacite di subordinazione, anche simbolica.
 La terza, la dimensione emotiva, comprende le asimmetrie nelle aspettative che una società costruisce intorno all’espressione e alla gestione delle emozioni sulla base del genere, da cui discendono anche le attribuzioni di una diversa attitudine alla cura e alla dipendenza dagli altri: a seconda che siamo uomini o donne veniamo socializzati non soltanto a comportamenti e stati emotivi diversi, ma a una diseguale considerazione in termini di controllo di sé, degli altri e dell’ambiente.
La terza, la dimensione emotiva, comprende le asimmetrie nelle aspettative che una società costruisce intorno all’espressione e alla gestione delle emozioni sulla base del genere, da cui discendono anche le attribuzioni di una diversa attitudine alla cura e alla dipendenza dagli altri: a seconda che siamo uomini o donne veniamo socializzati non soltanto a comportamenti e stati emotivi diversi, ma a una diseguale considerazione in termini di controllo di sé, degli altri e dell’ambiente.
 La quarta, infine, è la dimensione culturale e discorsiva: in contesti che vanno dal linguaggio alle rappresentazioni visive, dal diritto alla religione, maschilità e femminilità vengono continuamente evocate e riprodotte, ribaltate e contestate, in condizioni di visibilità e accesso alle risorse che sono però asimmetriche e discriminanti (basti spesso invertire mentalmente i ruoli di donne e uomini per far emergere elevazioni e degradazioni simboliche degli uni e delle altre).
La quarta, infine, è la dimensione culturale e discorsiva: in contesti che vanno dal linguaggio alle rappresentazioni visive, dal diritto alla religione, maschilità e femminilità vengono continuamente evocate e riprodotte, ribaltate e contestate, in condizioni di visibilità e accesso alle risorse che sono però asimmetriche e discriminanti (basti spesso invertire mentalmente i ruoli di donne e uomini per far emergere elevazioni e degradazioni simboliche degli uni e delle altre).Liberamente ispirandoci a questa classificazione, proviamo qui a ricordare alcuni elementi che possano far riflettere sul senso di una Giornata della Donna in un Paese come il nostro, in cui molti indicatori suggeriscono che molta strada c’è ancora da fare. Per la prima dimensione, tratteremo delle diseguaglianze nel mercato del lavoro. Abbiamo già avuto modo, in questa rivista, di conoscere le difficoltà della conciliazione dovute alle carenze nei servizi (si veda Naldini e Santero); si tratta di osservare qui quali difficoltà le donne incontrino in termini di entrata e permanenza nel mercato del lavoro, specie quando decidono di essere madri.
 Per la seconda dimensione, ricorderemo i dati sulla violenza di genere e sulle forme che essa sta prendendo in un Paese dove una donna ogni due giorni viene uccisa per mano del partner o dell’ex partner (e il contrario non accade, è bene ricordarlo) e dove c’è ancora una forte carenza e disomogeneità nelle strutture di accoglienza e rifugio contro la violenza.
Per la seconda dimensione, ricorderemo i dati sulla violenza di genere e sulle forme che essa sta prendendo in un Paese dove una donna ogni due giorni viene uccisa per mano del partner o dell’ex partner (e il contrario non accade, è bene ricordarlo) e dove c’è ancora una forte carenza e disomogeneità nelle strutture di accoglienza e rifugio contro la violenza.
 Per la terza, si vedranno i dati riguardanti il permanere delle asimmetrie nella cura e nel lavoro domestico anche in epoca di “nuove paternità” e di “padri affettivi”, all’interno di un quadro della divisione del lavoro domestico particolarmente disequilibrato rispetto ad altri Paesi europei.
Per la terza, si vedranno i dati riguardanti il permanere delle asimmetrie nella cura e nel lavoro domestico anche in epoca di “nuove paternità” e di “padri affettivi”, all’interno di un quadro della divisione del lavoro domestico particolarmente disequilibrato rispetto ad altri Paesi europei.
 Per la quarta, infine, proporremo i dati di una recente indagine internazionale sulle donne nell’informazione di tv, radio e giornali, dalla quale emerge come l’Italia sia ancora lontana da una rappresentazione di genere fedele alla distribuzione delle competenze riconosciute in seno alla società.
Per la quarta, infine, proporremo i dati di una recente indagine internazionale sulle donne nell’informazione di tv, radio e giornali, dalla quale emerge come l’Italia sia ancora lontana da una rappresentazione di genere fedele alla distribuzione delle competenze riconosciute in seno alla società.Tutti i dati, naturalmente, risentono sempre dei limiti del contesto per cui sono prodotti e gli elementi che qui si mettono sul piatto non sono esenti dalle ambivalenze su cui ci allertava Fraser. Ma rappresentano dei tasselli per una presa d’atto del modo in cui, in questo paese, la differenza si fa disuguaglianza. Una consapevolezza da cui partire il nove marzo, liquidando facili enunciazioni di principio.
* Sul tema nel sito, si cfr.:
UNA CATTOLICA, UNIVERSALE, ALLEANZA "EDIPICA"!!! IL MAGGIORASCATO: L’ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE, L’ALLEANZA DELLA MADRE CON IL FIGLIO, REGNA ANCORA COME IN TERRA COSI’ IN CIELO DONNE, UOMINI E VIOLENZA: "Parliamo di FEMMINICIDIO".
COSTANTINO, SANT’ELENA, E NAPOLEONE. L’immaginario del cattolicesimo romano.
L’EREDE: IL PESO DEI PADRI (ATEI E DEVOTI). UN’EREDITA’ ANCORA PENSATA ALL’OMBRA DELL’"UOMO SUPREMO" E DEL "MAGGIORASCATO". Una riflessione di Massimo Cacciari su "cosa significa ereditare il passato"
LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89).
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. -- I LIBRI DI STORIA CON LE LORO STORIE: "PURGATORIO DE L’INFERNO" (E. Sanguineti).7 marzo 2018, di Federico La Sala
IL DIO MAMMONA ("CARITAS"), IL DENARO, E "IL GATTO CON GLI STIVALI". LA LEZIONE DI EDOARDO SANGUINETI ... *
PURGATORIO DE L’INFERNO, 10. "Questo è il gatto con gli stivali" *
- Mentre con il figlio osserva un libro illustrato, il poeta sollecita con amore e affetto a guardare le immagini con attenzione e spirito critico, dietro a ogni cosa in esso rappresentata, e a ogni manifestazione della vita, si nasconde l’onnipotenza del ’dio’ denaro.
Questo è il gatto con gli stivali, questa è la pace di Barcellona
fra Carlo V e Clemente VII, è la locomotiva, è il pesco
fiorito, è il cavalluccio marino: ma se volti pagina, Alessandro,
ci vedi il denaro:
questi sono i satelliti di Giove, questa è l’autostrada
del Sole, è la lavagna quadrettata, è il primo volume dei Poetae
Latini Aevi Carolini, sono le scarpe, sono le bugie, è la scuola di Atene, è il burro,
è una cartolina che mi è arrivata oggi dalla Finlandia, è il muscolo massetere,
è il parto: ma se volti foglio, Alessandro, ci vedi
il denaro:
e questo è il denaro,
e questi sono i generali con le loro mitragliatrici, e sono i cimiteri
con le loro tombe, e sono le casse di risparmio con le loro cassette
di sicurezza, e sono i libri di storia con le loro storie:
ma se volti il foglio, Alessandro, non ci vedi niente
*
Edoardo Sanguineti
 La poesia è tratta dalla raccolta Triperuno, dalla sezione Purgatorio de l’Inferno,1964.
La poesia è tratta dalla raccolta Triperuno, dalla sezione Purgatorio de l’Inferno,1964.
*
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- REALTA’ E RAPPRESENTAZIONE. STORIA ("RES GESTAE") E STORIOGRAFIA ("HISTORIA RERUM GESTARUM") ... E INTELLETTUALI.
 I LIBRI DI "STORIA" E LE "DOMANDE DI UN LETTORE OPERAIO" - DI BERTOLT BRECHT
I LIBRI DI "STORIA" E LE "DOMANDE DI UN LETTORE OPERAIO" - DI BERTOLT BRECHT
- PER RATZINGER, PER IL PAPA E I CARDINALI, UNA LEZIONE DI GIANNI RODARI. L’Acca in fuga
- GATTO MAMMONE/(MAMMONA).
- SINODO DEI VESCOVI. L’ANNO DELLA PAROLA DI DIO: AMORE ("CHARITAS") O MAMMONA ("CARITAS")?! Fatto sta che la prima enciclica di Papa Benedetto XVI (Deus caritas est, 2006) è per Mammona.
- LA CHIESA DEL SILENZIO E DEL "LATINORUM". Il teologo Ratzinger scrive da papa l’enciclica "Deus caritas est" (2006) e, ancora oggi, nessuno - nemmeno papa Francesco - ne sollecita la correzione del titolo. Che lapsus!!! O, meglio, che progetto!!!
Edoardo Sanguineti
Ritratto critico di Edoardo Sanguineti. Prima parte - Seconda parte - Terza parte (di Angelo Petrella, "Belfagor", 2005 - "Nazione Indiana", 2017).
Federico La Sala
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. -- GIOACCHINO DA FIORE, LA SORPRENDENTE “CARITÀ”, E IL DRAMMA DEL CATTOLICESIMO ATEO E DEVOTO..6 marzo 2018, di Federico La SalaMEMORIA, STORIA, E FILOLOGIA. L’AMORE NON E’ LO ZIMBELLO DEL TEMPO...
 GIOACCHINO DA FIORE, LA SORPRENDENTE “CARITÀ”, E IL DRAMMA DEL CATTOLICESIMO ATEO E DEVOTO.
GIOACCHINO DA FIORE, LA SORPRENDENTE “CARITÀ”, E IL DRAMMA DEL CATTOLICESIMO ATEO E DEVOTO.
 Di Gioacchino se si è conservato memoria del suo lavoro come del suo messaggio, lo si deve sicuramente alla sua "posterità spirituale" - è da dire con H. De Lubac, ma contro lo stesso De Lubac (...)
Di Gioacchino se si è conservato memoria del suo lavoro come del suo messaggio, lo si deve sicuramente alla sua "posterità spirituale" - è da dire con H. De Lubac, ma contro lo stesso De Lubac (...)
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. -- LA SOVRANITÀ, LA DIGNITÀ DI OGNI CITTADINO E DI OGNI CITTADINA, E "I DUE CORPI DEL RE". La lezione di Kantorowicz (Barbara Spinelli).28 febbraio 2018, di Federico La SalaLA SOVRANITÀ, LA DIGNITÀ DI OGNI CITTADINO E DI OGNI CITTADINA, E "I DUE CORPI DEL RE". La lezione di Kantorowicz...
 LA COSTITUZIONE, I "DUE CORPI DEL RE", E I DUE PATTI DEL CITTADINO. L’ analisi di Barbara Spinelli (2006)
LA COSTITUZIONE, I "DUE CORPI DEL RE", E I DUE PATTI DEL CITTADINO. L’ analisi di Barbara Spinelli (2006)
 I due corpi del re vanno tenuti disgiunti, perché resti vivo l’inaugurale patto che dissuade dalla guerra di tutti contro tutti, e che fonda un rapporto non effimero, non continuamente modificabile, fra i cittadini e chi li comanda.
I due corpi del re vanno tenuti disgiunti, perché resti vivo l’inaugurale patto che dissuade dalla guerra di tutti contro tutti, e che fonda un rapporto non effimero, non continuamente modificabile, fra i cittadini e chi li comanda.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. -- La sinistra che c’era è andata a destra (di Furio Colombo).26 febbraio 2018, di Federico La Sala
La sinistra che c’era è andata a destra
di Furio Colombo (Il Fatto, 25.02.2018)
La destra e la sinistra non esistono più. La frase, che circola anche nei migliori partiti, è come una benda gettata all’improvviso sugli occhi dei cittadini per costringerli a un gioco a mosca cieca. Dovunque cerchi, non trovi. L’epoca, affollata di computer e robot, non ha ricordi. Che senso ha cercare la destra del mercato e del capitale, se non esiste più (non conta niente) il sindacato della lotta di classe? Se sei italiano, però, prima di rispondere alla domanda su destra e sinistra, devi tener conto di un fatto.
L’Italia ha due destre, una di interessi economici e di difesa dei capitali, con la sua visione conservatrice. L’altra destra è ideologica, è fondata sulla violenza e sul potere, che trucca, tradisce, condanna, reprime, se ha il potere. -Qual è la destra che non esiste più, al punto che vi dicono: la parola non ha più senso? Evidentemente la prima, che partecipava al gioco con la sinistra sapendo di avere sempre delle buone carte in mano, ma anche interessata (la pace sociale costa meno) a non rompere i ponti. Il fatto strano, almeno per l’Italia, è che è stata la sinistra ad alzarsi dal tavolo e ad abbandonare il gioco, imperfetto ma funzionante, delle due parti con interessi diversi e la comune convenienza.
 Mille convegni non hanno spiegato perché la sinistra se ne è andata o si è sempre più travestita da destra, arrivando a spingere più in là di quel che le imprese volevano. Qui è accaduto un effetto collaterale che forse la sinistra non aveva calcolato: il suo popolo, sentendosi non più rappresentato se n’è andato alla spicciolata, lasciando un largo spazio vuoto. Perché quello spazio vuoto sia tuttora celebrato come “il popolo della sinistra” non si sa.
Mille convegni non hanno spiegato perché la sinistra se ne è andata o si è sempre più travestita da destra, arrivando a spingere più in là di quel che le imprese volevano. Qui è accaduto un effetto collaterale che forse la sinistra non aveva calcolato: il suo popolo, sentendosi non più rappresentato se n’è andato alla spicciolata, lasciando un largo spazio vuoto. Perché quello spazio vuoto sia tuttora celebrato come “il popolo della sinistra” non si sa.
 Certo che se c’è stato un tempo in cui la destra erano Agnelli e Pirelli e la sinistra erano Pertini e Berlinguer, stiamo parlando di un universo perduto. Ora c’è la sala vuota della Confindustria, ci sono i circoli chiusi del Pd e qualcuno ha la faccia tosta di organizzare la Festa dell’Unità dopo avere fatto morire, deliberatamente, il giornale di Gramsci.
Certo che se c’è stato un tempo in cui la destra erano Agnelli e Pirelli e la sinistra erano Pertini e Berlinguer, stiamo parlando di un universo perduto. Ora c’è la sala vuota della Confindustria, ci sono i circoli chiusi del Pd e qualcuno ha la faccia tosta di organizzare la Festa dell’Unità dopo avere fatto morire, deliberatamente, il giornale di Gramsci.
 Il fenomeno però non è così simmetrico come sembra. Impossibile negare che la sinistra non c’è più, nel Paese in cui domina l’anelito di tagliare le pensioni e diminuire i salari (vedi Fornero e Whirpool).
Il fenomeno però non è così simmetrico come sembra. Impossibile negare che la sinistra non c’è più, nel Paese in cui domina l’anelito di tagliare le pensioni e diminuire i salari (vedi Fornero e Whirpool).Ma, delle due destre, ne è rimasta una, quella ideologica e del potere, quella fascista. È viva negli Usa, con il suo presidente che vuole armare gli insegnanti, con il capo dell’estrema destra (alt right) Steven Bannon che è appena un passo dalla Casa Bianca, con i misteriosi contatti con Putin. È viva nei Balcani e nell’Europa dell’Est (dall’Ungheria all’Austria alla Polonia). E dove sembra che non ci sia fascismo compare un Breivik niente affatto povero e marginalizzato, un fascista abbiente e bene armato, che uccide in un paio d’ore cento giovani socialisti di una scuola di partito.
 Se pensate che il fascismo, per tornare a crescere, abbia bisogno di un popolo abbandonato dalla sinistra, ecco l’idea: dedicarsi a diffondere e far crescere la paura dell’immigrazione. Gli stranieri sono gente impura, non cristiana, sconosciuta, diversa, con cui vorrebbero obbligarti a dividere la vita fino a sottometterti. Poiché questo è ciò di cui bisogna occuparsi, anche con la forza, se necessario: qualcuno sta organizzando l’invasione di una immensa quantità di stranieri in Italia e dunque sta creando un grave pericolo per la pura razza italiana.
Se pensate che il fascismo, per tornare a crescere, abbia bisogno di un popolo abbandonato dalla sinistra, ecco l’idea: dedicarsi a diffondere e far crescere la paura dell’immigrazione. Gli stranieri sono gente impura, non cristiana, sconosciuta, diversa, con cui vorrebbero obbligarti a dividere la vita fino a sottometterti. Poiché questo è ciò di cui bisogna occuparsi, anche con la forza, se necessario: qualcuno sta organizzando l’invasione di una immensa quantità di stranieri in Italia e dunque sta creando un grave pericolo per la pura razza italiana.Se pensate di non aver notato nulla di così sconvolgente, ma solo povera gente terrorizzata da fame, guerra e dal pericolo di annegare in mare, se temete che ci sia una falsificazione o una esagerazione dei dati, ecco la vera notizia, il complotto. Come aveva previsto Umberto Eco ne Il pendolo di Foucoult, ne Il cimitero di Praga e nel bellissimo testo Il fascismo eterno, arriva la notizia del complotto.
 Qualcuno trama per la sostituzione dei popoli, i neri (i neri!) prenderanno, qui, nel nostro Paese di pura razza italiana, il posto dei bianchi. Naturale che i popoli non si sostituiscono da soli. Ci vuole il miliardario canaglia che, come è naturale in un mondo fascista, è ebreo. Si tratta di un certo Soros, e anche se persino Minniti o Salvini o Meloni o Lombardi (il cuore d’oro del M5S) non hanno ancora rivelato la causa di questo complotto (ci impongono di accettare nuovi schiavi o nuovi padroni?), il complotto c’è e vi partecipano persino (quando non sono in Siria a salvare bambini o in mare a salvare naufraghi) le Ong, compresi i “Medici senza frontiere” onorati dal presidente della Repubblica. E l’invasione continua. Non dite vanamente che l’invasione non c’è. Nessun partito importante in queste elezioni vi starebbe a sentire.
Qualcuno trama per la sostituzione dei popoli, i neri (i neri!) prenderanno, qui, nel nostro Paese di pura razza italiana, il posto dei bianchi. Naturale che i popoli non si sostituiscono da soli. Ci vuole il miliardario canaglia che, come è naturale in un mondo fascista, è ebreo. Si tratta di un certo Soros, e anche se persino Minniti o Salvini o Meloni o Lombardi (il cuore d’oro del M5S) non hanno ancora rivelato la causa di questo complotto (ci impongono di accettare nuovi schiavi o nuovi padroni?), il complotto c’è e vi partecipano persino (quando non sono in Siria a salvare bambini o in mare a salvare naufraghi) le Ong, compresi i “Medici senza frontiere” onorati dal presidente della Repubblica. E l’invasione continua. Non dite vanamente che l’invasione non c’è. Nessun partito importante in queste elezioni vi starebbe a sentire.
 Abbiamo dunque alcune certezze. La sinistra non c’è. Ma la destra, con il coraggio di dirsi fascista, c’è e conta.
Abbiamo dunque alcune certezze. La sinistra non c’è. Ma la destra, con il coraggio di dirsi fascista, c’è e conta.
La frase finale di Berlusconi
risponde Furio Colombo (il Fatto, 14.05.2013)
- CARO FURIO COLOMBO, mi domando se il comizio di Brescia non si possa definire, in termini legali, “adunata sediziosa”, un comizio di false informazioni da parte di una falsa autorità al fine di provocare sollevazione. Perché tanta tolleranza? Patrizio
CERTO, IL COMIZIO di Brescia in difesa di un imputato di reati gravi, condannato per reati gravi, in attesa di imminente sentenza per reati gravi, appena raggiunto da un rinvio a giudizio per reati gravi, non era né una festa né un evento politico. Il fine era chiaro e indiscutibile: creare una barriera insormontabile, tra un imputato e i suoi giudici. Lo ha fatto il capo di quello che, al momento, risulta il partito più grande.
E quel capo ha mobilitato per l’occorrenza il ministro dell’Interno e vice primo ministro, mentre sta governando in una presunta “grande coalizione” con un partito che dovrebbe essere il principale antagonista. Purtroppo non ci sono segnali dal governo di coalizione, non ci sono segnali dal partito antagonista, e i media trattano la materia come una notizia interessante, ma non meritevole di allarme, di denuncia e di condanna. Così i cittadini sono autorizzati a pensare che forse è normale che tutta la forza di un esecutivo (uno dei tre poteri della democrazia) venga lanciato contro la magistratura, ovvero un altro potere indipendente, nel silenzio del terzo potere, il Parlamento.
Per capire il rischio che stiamo correndo, si riveda la frase conclusiva del monologo di Berlusconi, nel suo comizio a due piazze (una gremita di sostenitori più o meno spontanei, l’altra di disciplinati obiettori).
La frase era: “Nessuna sentenza e nessuna prepotenza della magistratura potrà impedirmi di essere capo di un popolo che mi elegge con milioni di voti”. Non parlava di legame ideale o affettivo. Dichiarava la superiorità dei voti sulle sentenze, come se ci fossero democrazie in cui il votato non è più come tutti gli altri, ma qualcuno esente da ogni giurisdizione e giudizio. Ovvio che Berlusconi non parlava di democrazia, parlava di sé e del suo progetto di rivolta, in caso di altre condanne. E ci ha ricordato che non gli si può rimproverare il sotterfugio.
Berlusconi si comporta da fuorilegge e lo dice prima. Eppure, non vi sono risposte politiche o risposte istituzionali. E i segnali non sono buoni. La giudice Fiorillo ha visto segnato il fascicolo della sua carriera da una censura del Csm per avere smentito quanto detto da Berlusconi e quanto dai complici sulla vicenda Ruby. Berlusconi ha potuto tenere il suo comizio di minaccia alla Repubblica senza che seguisse, per decenza, almeno un “pacato” cenno di dissenso.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. - LA LEZIONE DI KANT: "SAPERE AUDE!". ORIENTARSI NEL PENSIERO, CON CORAGGIO.24 febbraio 2018, di Federico La Sala
ORIENTARSI NEL PENSIERO:"SAPERE AUDE!". KANT, NIETZSHE, E " UN GRANDE GENIO SENZA CORAGGIO" ... *
Il metodo di Heidegger per imparare a pensare
di Armando Torno (Il Sole-24 Ore, 23.02.2018)
Adelphi ha ristampato in una “nuova edizione ampliata” il saggio che Martin Heidegger intitolò “Nietzsche” (pp. 1040, euro 28). La prima traduzione italiana risale al 1994 [pp. 1034], l’edizione originale è del 1961.
A dire il vero, questo libro non è una monografia del più grande filosofo del Novecento sul pensatore-chiave del mondo contemporaneo. L’opera, composta da testi scritti tra il 1936 e il 1946, utilizza come titolo il nome di Nietzsche ma indica - usiamo le parole dello stesso Heidegger - “la cosa in questione nel suo pensiero”. Dove “cosa” va intesa come la metafisica dell’Occidente, la gabbia speculativa che è stata adoperata per secoli e che in Nietzsche si manifesta in una sua ultima espressione. O, meglio, in una forma esasperata.
Queste pagine non contengono quindi l’analisi di un particolare sistema utilizzando uno schema tradizionale ma, pur esaminando parti del lascito di Nietzsche (e anche di altri, quali Platone, Protagora, Descartes, Schelling o Kierkegaard), intraprendono una sorta di lotta per svincolarsi dalla ricordata metafisica. Heidegger, insomma, combatte una battaglia ricorrendo al filosofo che per primo l’aveva tentata.
In una nota Roberto Calasso pone in evidenza il fatto che Heidegger, che non ha nulla da condividere con i manipoli dei critici di Nietzsche, sia l’unico che gli “risponda”.
Del resto, come scriveva nella postfazione Franco Volpi, nel secolo scorso Nietzsche ha suscitato al tempo stesso “entusiasmi e attirato anatemi”; ha inoltre ispirato “atteggiamenti, mode culturali e stili di pensiero, ma al tempo stesso provocato reazioni e rifiuti altrettanto risoluti”.
Heidegger, è il caso di aggiungere, non è stato da meno. Se si consultano le tante storie della filosofia che circolano, in ciascuna di esse si può trovare una definizione che lo riguardi; ma tutte, ci si accorge ben presto, gli stanno strette.
Anche la recente polemica, che si fondava su un presunto antisemitismo di Heidegger, non ha tenuto conto del fatto che tra i suoi allievi vi sono stati alcuni tra i migliori intellettuali ebrei del secolo scorso, come prova il caso di Karl Löwith; o, guardando oltre, basterà ricordare Leo Strauss, anch’egli esule dalla Germania per le leggi razziali, che applicò il metodo heideggeriano di decostruzione storica in alcuni suoi importanti scritti. Entrambi, insieme a molti altri, tra cui il cattolico Romano Guardini, furono affascinati da Heidegger.
E anche chi leggerà, meditandolo, il suo “Nietzsche” difficilmente potrà restare indifferente. Vi troverà non la descrizione di un pensiero (anche se non manca) ma un metodo per imparare a pensare. Cosa che non si nota in molti filosofi dei nostri talk show.
*
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- ORIENTARSI, OGGI - E SEMPRE. LA LEZIONE IMMORTALE DI KANT, DALLA STIVA DELLA "NAVE" DI GALILEI. Invito alla rilettura dell’opera del 1786, "Che cosa significa orientarsi nel pensiero" - e della "Critica della ragion pura" (1781/1787).
HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI.
L’APOLOGIA DEL MENTITORE ISTITUZIONALIZZATO E LA FILOSOFIA ITALIANA. Nella scia di Constant, Kant, Hobbes e Mendiola. Una nota di Armando Torno su "una questione oziosa e irrisolta"
ULTIMA CENA ED ECONOMIA VATICANA: LA CARESTIA AVANZA!!! Benedetto XVI "cambia la formula dell’Eucarestia"! «Il calice fu versato per molti», non «per tutti»!!! Note di Gian Guido Vecchi e di Armando Torno
MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA E A PENSARE BENE "DIO", "IO" E "L’ITALIA", CHI PIU’ CHI MENO, TUTTI VIVONO DENTRO LA PIU’ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA E POLITICA ITALIANA
Federico La Sala
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. -- "L’ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE": "GENERARE DIO". Narciso e l’arte di restare a galla.30 gennaio 2018, di Federico La Sala
FILOSOFIA DELLA RIVELAZIONE. "L’ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE": "GENERARE DIO". L’immaginario del cattolicesimo romano....
Narciso e l’arte di restare a galla: una lezione di Massimo Cacciari
di Luisa Muraro *
Narciso non sapeva niente di narcisismo. Il pastorello vanitoso si sporge per specchiarsi, casca nello stagno e annega. Doveva venire in Italia a imparare dai nostri uomini di spicco. Specchiarsi e, soprattutto, restare a galla, è un’arte. Per esempio, come fa il narciso italiano quando succedono cose notevoli che lo mettono ai margini? Aspetta un po’ che passino ma se non passano, come sta succedendo con il femminismo?
Massimo Cacciari, intervistato sul suo ultimo libro risponde con una lezione esemplare.
Il suo libro è di argomento teologico ed è il giorno di Natale. Il Professore si vanta di aver fatto una scoperta filosofica, teologica e politica su Maria di Nazareth. L’intervistatore, Nicola Mirenzi, è ammirato ma mostra incredulità. L’intervistato ammette di non essere stato il primo e fa il nome di un grande teologo del passato. L’intervistatore chiede: come mai neanche le femministe si sono dedicate a pensare la grandezza di Maria? Neanche loro, conferma il professore. Dice il falso ma lui non teme che la verità gli secchi la lingua perché non la sa, lui di femminismo non ha mai voluto saper niente con un minimo di precisione. L’ignoranza, però, non basta più con i tempi che corrono, ci vuole un tampone e Cacciari l’ha pronto. Ripete un elogio del femminismo fatto da altri (sempre lo stesso, “ultima vera rivoluzione” ecc.). Intanto pensa: nessuno può lontanamente aver visto quello che ho visto io! E a voce alta dice: le femministe “sono rimaste vittime della lettura maschilista dell’incarnazione, hanno guardato Maria come una figura servile, totalmente oscurata dal rapporto tra padre e figlio, non riuscendo a scorgere quello che c’è oltre”. Questa è la mossa classica dell’intellettuale italiano: s’inventa una posizione “femminista” fasulla, che gli pare verosimile e che trova facile da eliminare.
Termina così l’intervista; la trovate su Huffington Post, che in seguito ha pubblicato l’intervento di Nadia Lucchesi su questo argomento; lo trovate anche qui.
Inventarsi un femminismo finto, dopo quasi mezzo secolo di un movimento che sta modificando i tratti di una civiltà, e uno studioso di chiara fama che crede di poterlo fare impunemente, tutto questo non sarebbe possibile senza la complicità dei suoi pari e dei mass-media che vanno per la maggiore. È questo un andazzo che è durato troppo e danneggia il nostro paese. Da notare però anche, in questo caso, un certo desiderio maschile di mettersi alla luce della differenza femminile. Nadia Lucchesi e le sue amiche sono intervenute a smentire il Professore con molta serenità, come se, sotto le sue arie da grande pensatore, riconoscessero uno dei pastori che andarono alla grotta di Betlemme. (Luisa Muraro)
Il commento di Nadia Lucchesi e amiche all’intervista di Massimo Cacciari
Se i filosofi hanno ignorato Maria, le filosofe ne hanno invece valorizzata la figura, liberandola dagli stereotipi e dalle incomprensioni della tradizione. Penso, per nominarne alcune, a María Zambrano, a Simone Weil e a Edith Stein. Le femministe hanno guardato ben oltre la lettura maschilista dell’incarnazione: come scriveva Luisa Muraro nel 2011 «Data la scarsa conoscenza del femminismo, dovuta più alla novità delle idee che all’ignoranza delle persone, vi capiterà di leggere che noi femministe eravamo contro la figura di Maria. No, non solo la mariologia fu un terreno di coltura del femminismo cattolico, ma anche le agnostiche si sono dedicate a strappare Maria alla devozione di tipo patriarcale. Penso al Magnificat di Rosetta Stella (Marietti)... Di Maria si è enfatizzato il protagonismo, la mobilità, l’autonomia. La sua verginità è stata interpretata in termini d’indipendenza simbolica dagli uomini. Fondamentale è stato l’apporto di Luce Irigaray, che, dagli anni Ottanta, ha contribuito a diffondere un nuovo linguaggio religioso...» (Maria. Il latte della Vergine, Madre di Dio e Dio lei stessa, Il manifesto - Alias, 24 dicembre 2011).
Infatti, Luce Irigaray ha pubblicato nel 2010 «Il mistero di Maria» (Edizioni Paoline, 2010), mentre nel 2002 Nadia Lucchesi aveva dato alle stampe «Frutto del ventre, frutto della mente: Maria, madre del Cristianesimo» (Luciana Tufani, Ferrara 2002).
Nel 2014 si è svolto a Venezia il convegno «Rivisitazione di Maria. Per una teologia in lingua materna», a cura di Laura Guadagnin e Grazia Sterlocchi delle associazioni Settima Stanza e Waves in collaborazione col Centro Donna, mentre a Roma, all’interno del progetto speciale culturale Biblioteche di Roma 2014 «Presenza e mistero di Maria», Annarosa Buttarelli e Suor Michela Porcellato sono intervenute sul tema: «La sovranità di Maria di Nazareth».
Raffaella Molinari e Monica Palma, relatrici di un intervento dal titolo «Maria della Sororità, Nostra Signora Nostra Sorella» continuano il lavoro straordinario di Ivana Ceresa, fondatrice della Sororità, un ordine religioso posto sotto l’autorità di Maria, concepita come figura di donna potente.
Da più di cinquant’anni, inoltre, Angela Volpini diffonde un’immagine di Maria che rappresenta l’umanità realizzata e ci insegna la “via della felicità sulla terra”.
Non parlo dei tantissimi contributi delle teologhe cattoliche e non, che hanno interpretato in modo non tradizionale la figura della Vergine, della Maestra di Sapienza: cito, per nominarne solo una, Elisabeth Schüssler-Fiorenza, teologa statunitense, femminista cattolica, autrice di due opere fondamentali: «In memoria di Lei» (Claudiana, Torino 1990) e «Gesù, figlio di Myriam, profeta della Sophia» (Claudiana, Torino 1996).
* www.libreriadelledonne.it, 19 gennaio 2018
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- PER LA NUOVA ALLEANZA, UN ALTRO SOGGETTO: LA LUCE DI IRIGARAY SUL "MISTERO DI MARIA" (E DI GIUSEPPE!?). Alcune pagine sul "silenzio di Maria", con alcune note
L’EREDE: IL PESO DEI PADRI (ATEI E DEVOTI). UN’EREDITA’ ANCORA PENSATA ALL’OMBRA DELL’"UOMO SUPREMO" E DEL "MAGGIORASCATO". Una riflessione di Massimo Cacciari su "cosa significa ereditare il passato"
UOMINI E DONNE. LA NUOVA ALLEANZA di "Maria" e di "Giuseppe"!!! AL DI LA’ DELL’ "EDIPO", L’ "AMORE CONOSCITIVO". SULL’USCITA DALLO STATO DI MINORITA’, OGGI. In memoria di Kurt H. Wolff.
Federico La Sala
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. - L’Ur-Fascismo può ancora tornare sotto le spoglie più innocenti: “Il fascismo eterno” (di Umberto Eco)11 gennaio 2018, di Federico La Sala
“Il fascismo è eterno: ecco come lo si può riconoscere”
Non pensiero ma azione
- Esce oggi per La Nave di Teseo “Il fascismo eterno”, la lectio inedita pronunciata da Umberto Eco alla Columbia University il 25 aprile 1995. Ne pubblichiamo uno stralcio.
di Umberto Eco (Il Fatto, 11.01.2018)
Il termine “fascismo” si adatta a tutto perché è possibile eliminare da un regime fascista uno o più aspetti, e lo si potrà sempre riconoscere per fascista. [...] Ritengo sia possibile indicare una lista di caratteristiche tipiche di quello che vorrei chiamare l’“Ur-Fascismo”, o il “fascismo eterno”. che non possono venire irreggimentate in un sistema; molte si contraddicono reciprocamente, e sono tipiche di altre forme di dispotismo o di fanatismo. Ma è sufficiente che una di loro sia presente per far coagulare una nebulosa fascista.
1. [...] Il culto della tradizione. Il tradizionalismo è più vecchio del fascismo. Non fu solo tipico del pensiero controrivoluzionario cattolico dopo la Rivoluzione francese, ma nacque nella tarda età ellenistica come una reazione al razionalismo greco classico. Nel bacino del Mediterraneo, i popoli di religioni diverse (tutte accettate con indulgenza dal Pantheon romano) cominciarono a sognare una rivelazione ricevuta all’alba della storia umana. Questa rivelazione era rimasta a lungo nascosta sotto il velo di lingue ormai dimenticate. Era affidata ai geroglifici egiziani, alle rune dei celti, ai testi sacri, ancora sconosciuti, delle religioni asiatiche. Questa nuova cultura doveva essere sincretistica. [...] tollerare le contraddizioni. Come conseguenza, non ci può essere avanzamento del sapere. La verità è stata già annunciata una volte per tutte [...] È sufficiente guardare il sillabo di ogni movimento fascista per trovare i principali pensatore tradizionalisti. [...]
2. Il tradizionalismo implica il rifiuto del modernismo. [...] Tuttavia, sebbene il nazismo fosse fiero dei suoi successi industriali, la sua lode della modernità era solo l’aspetto superficiale di una ideologia basata sul “sangue” e la “terra” (Blut und Boden). [...] L’illuminismo, l’età della ragione vengono visti come l’inizio della depravazione moderna. In questo senso, l’Ur-Fascismo può venire definito come “irrazionalismo”.
3. L’irrazionalismo dipende anche dal culto dell’azione per l’azione. [...] Pensare è una forma di evirazione. Perciò la cultura è sospetta nella misura in cui viene identificata con atteggiamenti critici. [...]
4. Nessuna forma di sincretismo può accettare la critica. Lo spirito critico opera distinzioni, e distinguere è un segno di modernità. Nella cultura moderna, la comunità scientifica intende il disaccordo come strumento di avanzamento delle conoscenze. Per l’Ur-Fascismo, il disaccordo è tradimento.
5. Il disaccordo è inoltre un segno di diversità. L’Ur-Fascismo cresce e cerca il consenso sfruttando ed esacerbando la naturale paura della differenza. [...] è dunque razzista per definizione.
6. L’Ur-Fascismo scaturisce dalla frustrazione individuale o sociale. Il che spiega perché una delle caratteristiche tipiche dei fascismi storici è stato l’appello alle classi medie frustrate, a disagio per qualche crisi economica o umiliazione politica, spaventate dalla pressione dei gruppi sociali subalterni.
7. A coloro che sono privi di una qualunque identità sociale, l’Ur-Fascismo dice che il loro unico privilegio è il più comune di tutti, quello di essere nati nello stesso paese. È questa l’origine del “nazionalismo”. Inoltre, gli unici che possono fornire una identità alla nazione sono i nemici. Così, alla radice della psicologia Ur-Fascista vi è l’ossessione del complotto, possibilmente internazionale. I seguaci debbono sentirsi assediati. Il modo più facile per far emergere un complotto è quello di fare appello alla xenofobia. [...]
8. I seguaci debbono sentirsi umiliati dalla ricchezza ostentata e dalla forza dei nemici. [...]
9. Per l’Ur-Fascismo non c’è lotta per la vita, ma piuttosto “vita per la lotta”. Il pacifismo è allora collusione col nemico[...].
10. L’elitismo è un aspetto tipico di ogni ideologia reazionaria, in quanto fondamentalmente aristocratico. Nel corso della storia, tutti gli elitismi aristocratici e militaristici hanno implicato il disprezzo per i deboli. L’Ur-Fascismo non può fare a meno di predicare un “elitismo popolare”. Ogni cittadino appartiene al popolo migliore del mondo, i membri del partito sono i cittadini migliori, ogni cittadino può (o dovrebbe) diventare un membro del partito. Ma non possono esserci patrizi senza plebei. Il leader, che sa bene come il suo potere non sia stato ottenuto per delega, ma conquistato con la forza, sa anche che la sua forza si basa sulla debolezza delle masse, così deboli da aver bisogno e da meritare un “dominatore”. [...]
 L’Ur-Fascismo può ancora tornare sotto le spoglie più innocenti. Il nostro dovere è di smascherarlo e di puntare l’indice su ognuna delle sue nuove forme - ogni giorno, in ogni parte del mondo.
L’Ur-Fascismo può ancora tornare sotto le spoglie più innocenti. Il nostro dovere è di smascherarlo e di puntare l’indice su ognuna delle sue nuove forme - ogni giorno, in ogni parte del mondo.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- La democrazia, l’antinomia istituzionale del mentitore e la catastrofe culturale italiana.... UMBERTO ECO E IL POPULISMO DI "FORZA ITALIA". Un’intervista di Marcelle Padovani (2002) e un’intervista di Deborah Solomon (2007)
"PUBBLICITA’ PROGRESSO": L’ITALIA E LA FORZA DI UN MARCHIO REGISTRATO!!! NEL 1994 UN CITTADINO REGISTRA IL NOME DEL SUO PARTITO E COMINCIA A FARE IL "PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA" DEL "POPOLO DELLA LIBERTA’"
UNA DOMANDA ALL’ITALIA: MA COME AVETE FATTO A RIDURVI COSI’?! UN "BORDELLO STATE": UN PAESE BORDELLO. Una nota di Maurizio Viroli (dagli Usa) - e una risposta (agli americani, dall’Italia)
KANT E SAN PAOLO. COME IL BUON GIUDIZIO ("SECUNDA PETRI") VIENE (E VENNE) RIDOTTO IN STATO DI MINORITA’ DAL GIUDIZIO FALSO E BUGIARDO ("SECUNDA PAULI").
Federico La Sala
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. - Il caso italiano. Rischio autoritarismo: rappresentare non basta più. Rinforzare la democrazia.8 gennaio 2018, di Federico La Sala
Il caso italiano
Rischio autoritarismo: rappresentare non basta più, la democrazia sia più efficace
Rinforzare la democrazia
di Romano Prodi (Il Mulino, 08 gennaio 2018) *
Per molti anni, soprattutto dopo la caduta del muro di Berlino, ci siamo illusi che l’espansione della democrazia fosse irresistibile. Una speranza alimentata da numerosi rapporti di organismi internazionali dedicati a sottolineare come il numero delle nazioni che affidavano il proprio futuro alle sfide elettorali fosse in continuo aumento. La convinzione di un “fatale” progresso della democrazia veniva rafforzata dalla generale condivisione delle dottrine che sono sempre state i pilastri della democrazia stessa, cioè il liberalismo e il socialismo che, alternandosi al potere, avrebbero sempre garantito la sopravvivenza ed il rafforzamento del sistema democratico. Tanto era forte questa convinzione che divenne dottrina condivisa il diritto (o addirittura il dovere) di imporre il sistema democratico con ogni mezzo, incluse le armi.
La guerra in Iraq e in Libia, almeno a parole, si sono entrambe fondate sulla motivazione di abbattere un tiranno per proteggere, in nome della democrazia, i sacrosanti diritti dei cittadini in modo da arrivare, con la maggiore velocità possibile, a libere elezioni.
La realtà ci ha obbligato invece a conclusioni ben diverse. Le guerre “democratiche” hanno mostrato l’ambiguità delle loro motivazioni e si sono trasformate in tragedie senza fine, mentre le elezioni imposte dall’esterno, soprattutto nei Paesi africani, sono state sempre più spesso utilizzate per attribuire al vincitore un potere assoluto, quasi patrimoniale, sul Paese. Colui che è stato eletto democraticamente si trasforma in proprietario dei cittadini e dei loro beni e la tornata elettorale successiva viene trasformata in una lotta impari se non addirittura in una farsa perché il leader democratico si è nel frattempo trasformato in un dittatore. Guardiamoci quindi dal ritenere che il progresso democratico sia fatale e inevitabile perché la democrazia non si esaurisce nel giorno delle elezioni. Essa si regge non sulle sue regole astratte ma sul rispetto di queste regole e, crollata l’influenza delle ideologie che ne stavano alla base, sui comportamenti e sui risultati delle azioni dei governanti.
Non dobbiamo quindi sorprenderci se, a quasi trent’anni dalla caduta del muro di Berlino, ci troviamo invece in un mondo in cui il desiderio e la richiesta di autorità crescono a discapito del progresso della democrazia. Lo vediamo a tutte le latitudini: non solo in molti Paesi africani ma in Russia, in Cina, in Vietnam, nelle Filippine, in Turchia, in Egitto, in India, nei Paesi dell’Est Europeo e perfino in Giappone. Un desiderio di autorità che si estende alle democrazie più mature e che lievita perfino negli Stati Uniti pur essendo, in questo grande Paese democratico, temperato dagli infiniti pesi e contrappesi della società americana.
Tutti questi eventi ci hanno portato ad un punto di svolta: la democrazia sta cessando di essere il modello di riferimento della politica mondiale e non si esporta più.
Possiamo simbolicamente collocare il riconoscimento ufficiale di questa svolta nel XIX Congresso del Partito Comunista Cinese dello scorso ottobre. Il presidente Xi, forte dei suoi successi, ha indicato nel sistema cinese lo strumento più adatto per promuovere lo sviluppo ed il progresso non solo della Cina ma anche a livello globale. La proposta della via della seta intende sostituire nell’immaginazione popolare il piano Marshall come modello di riferimento per la crescita globale e, in particolare, dei Paesi in via di sviluppo.
Un compito facilitato dalle fratture fra i Paesi democratici e dalla moltiplicazione dei partiti politici all’interno di questi Paesi, evoluzioni che rendono sempre più complessa la formazione di governi democratici robusti e capaci di durare nel tempo. Il susseguirsi degli appuntamenti elettorali (locali, nazionali ed europei) e le analisi demoscopiche, che rendono di importanza vitale ogni pur piccolo appello alle urne, abbreviano l’orizzonte dei governi che, invece di affrontare i grandi problemi del futuro, si concentrano solo sulle decisioni idonee a vincere le sempre vicine elezioni.
A rendere più difficile e precaria la vita dei governi democratici si aggiunge la moltiplicazione dei partiti, figlia della maggiore complessità della società moderna e della crisi delle grandi ideologie del passato. Ci sono voluti sette mesi di trattative per formare un governo in Olanda e, dopo oltre tre mesi dalle elezioni, non vi è ancora alcun accordo per un governo tedesco.
Di fronte a tutti questi eventi il favore degli elettori si allontana sempre più da una democrazia che “rappresenta” e si sposta verso una democrazia che “consegna”, che opera cioè in modo efficace.
Se non vogliamo vedere crescere in modo irresistibile anche nei nostri Paesi il desiderio di autoritarismo dobbiamo rendere forte la nostra democrazia: è nostro dovere primario rinnovarla e irrobustirla per metterla in grado di “consegnare”.
Quest’obiettivo può essere raggiunto solo adottando sistemi elettorali sempre meno proporzionali e sempre più maggioritari.
Il sistema elettorale non è fatto per fotografare un Paese ma per renderne possibile il governo.
Di queste necessarie trasformazioni l’Italia se ne sarebbe dovuta rendere conto da gran tempo e invece le ha volute ignorare: speriamo che possa metterle in atto fin dall’inizio della prossima legislatura.
* Questo articolo è uscito su «Il Messaggero» del 7 gennaio 2018.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. - Australia, migliaia di bambini abusati. Conclusa l’inchiesta della Royal commission. Il premier Turnbull: «Tragedia nazionale».16 dicembre 2017, di Federico La Sala
Australia, migliaia di bambini abusati da sacerdoti e insegnanti cattolici
Minori. Conclusa l’inchiesta della Royal commission. Il premier Turnbull: «Tragedia nazionale»*
«Decine di migliaia di bambini sono stati abusati sessualmente in molte istituzioni australiane, non sapremo mai il vero numero. Non si tratta di poche mele marce, le principali istituzioni della società hanno seriamente fallito». È la terribile conclusione a cui è giunta la Royal commission, istituita nel 2013 dal governo laburista di Julia Gillard per fare luce sugli abusi sessuali in Australia, dopo un’inchiesta quinquennale, articolata in 8.013 sessioni private e 57 udienze pubbliche, durante la quale sono state raccolte le testimonianze di oltre 8000 vittime, con più di 1200 testimoni ascoltati in 440 giorni. «La più alta forma di inchiesta pubblica australiana», la definisce la Bbc.
In 17 volumi che ha aggiunto 189 raccomandazioni alle 220 che erano già state rese pubbliche e che saranno ora esaminate dai legislatori, la relazione invita la Chiesa cattolica a rivedere le sue regole sul celibato. Perché secondo il rapporto la maggior parte degli abusi sono stati commessi - tra il 1950 e il 2015 - da ministri religiosi e insegnanti scolastici delle istituzioni cristiane: 4.400 abusi verificati solo nella chiesa cattolica, 1.115 denunce raccolte da quella anglicana, 1000 presunti molestatori nascosti dalla chiesa dei Testimoni di Geova.
Ma «non è un problema del passato», ha avvisato il presidente della commissione McClellan, perché dai sistemi di protezione dell’infanzia alla giustizia civile e la polizia, «molte istituzioni hanno tradito i nostri bambini». Il premier australiano, Malcolm Turnbull, ringraziando «i membri della commissione e coloro che hanno avuto il coraggio di raccontare le loro storie», ha parlato di «tragedia nazionale».
Mentre Denis Hart, l’arcivescovo di Melbourne, ha dichiarato di aver preso «molto seriamente» i risultati dell’inchiesta, ha ribadito le «scuse incondizionate per questa sofferenza e il nostro impegno a garantire giustizia per le persone colpite», ma ha respinto la raccomandazione della commissione di rendere obbligatorie le denunce di molestie raccolte durante le confessioni religiose: «Voglio osservare la legge della terra - ha detto - ma la pena per ogni sacerdote che spezza il sigillo della confessione è la scomunica». Il Papa tace.
*il manifesto, 16.12.2017
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
VERITA’ E RICONCILIAZIONE. PAPA RATZINGER A SYDNEY, PER LA GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’: "IL RE E’ NUDO"!!! NON SOLO DEVE CHIEDERE PERDONO ALL’AUSTRALIA E ALL’ITALIA E AL "PADRE NOSTRO", MA CAMBIARE STILE DI VITA!!! Gesù, che non era schizofrenico, non si travestiva da imperatore.
"AVREMMO BISOGNO DI DIECI FRANCESCO DI ASSISI". LA RIVOLUZIONE EVANGELICA, LA RIVOLUZIONE RUSSA, E L’ "AVVENIRE" DELL’UNIONE SOVIETICA E DELLA CHIESA CATTOLICA. Le ultime riflessioni di Lenin raccolte da Viktor Bede
UN NUOVO CONCILIO, SUBITO. 95 TESI? NE BASTA UNA SOLA! Cattolicesimo, fascismo, nazismo, stalinismo: il sogno del "regno di ‘dio’" in un solo ‘paese’ è finito.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. - L’ISTITUZIONALIZZAZIONE DELLA FIGURA DEL MENTITORE. Così la vergogna è ufficialmente scomparsa dall’orizzonte dei valori e dei sentimenti individuali e collettivi.16 dicembre 2017, di Federico La Sala
VERGOGNA E "LATINORUM": UNA GOGNA PER L’ITALIA INTERA... *
____________________________________________________________________
Le idee
La vergogna è morta
Da Berlusconi a Trump: così un sentimento è scomparso dall’orizzonte dei valori individuali e collettivi
di Marco Belpoliti (l’Espresso, 15 dicembre 2017)
Quando nel 1995 Christopher Lasch, l’autore del celebre volume “La cultura del narcisismo”, diede alle stampe un altro capitolo della sua indagine sulla società americana, “La rivolta delle élite” (ora ristampato opportunamente da Neri Pozza), pensò bene di dedicare un capitolo alla abolizione della vergogna.
Lasch esaminava gli scritti di psicoanalisti e psicologi americani che avevano lavorato per eliminare quella che sembrava un deficit delle singole personalità individuali: la vergogna quale origine della scarsa stima di sé. La pubblicistica delle scienze dell’anima vedeva in questo sentimento una delle ultime forme di patologia sociale, tanto da suggerire delle vere e proprie campagne per ridurre la vergogna, cosa che è avvenuta in California, ad esempio («programma cognitivo-affettivo finalizzato a ridurre la vergogna»). Lasch non ha fatto in tempo a vedere come questo sentimento sia stato abolito dalla classe dirigente che è apparsa sulla scena della politica mondiale all’indomani del 1994, anno in cui lo studioso della cultura è scomparso.
* * *
Con il debutto di Silvio Berlusconi in politica la vergogna è ufficialmente scomparsa dall’orizzonte dei valori e dei sentimenti individuali e collettivi. Le élite che hanno scorrazzato nel paesaggio italiano nel ventennio successivo alla “discesa in campo” sono state totalmente prive di questo. In un certo senso Berlusconi è stato l’avanguardia di una classe politico-affaristica che ha il suo culmine nella figura dell’attuale inquilino della Casa Bianca, Donald Trump. Nessuno dei due uomini d’affari trasformati in leader politici conosce né il senso di colpa né la vergogna propriamente detta.
La vergogna, come sostengono gli psicologi, costituisce un’emozione intrinsecamente sociale e relazionale. Per provarla occorre immedesimarsi in un pubblico che biasima e condanna. Ma questo pubblico non esiste più. Ci sono innumerevoli figure dello spettacolo, della politica, della economia e del giornalismo, per cui la sfrontatezza, l’esibizione del cinismo, la menzogna fanno parte della serie di espressioni consuete esibite davanti alle telecamere televisive e nel web. Nessuno prova più vergogna. Anzi, proprio questi aspetti negativi servono a creare un’immagine personale riconoscibile e, se non proprio stimata, almeno rispettata o temuta. Come ha detto una volta Berlusconi, genio del rovesciamento semantico di quasi tutto: «Ci metto la faccia». È l’esatto contrario del “perdere la faccia”, sentimento che prova chi sente gravare dentro di sé la vergogna. Metterci la faccia significa apparire rimuovendo ogni senso di colpa, di perdita del senso dell’onore, della rispettabilità.
* * *
L’esibizione dell’autostima è al centro del libro più celebre di Lasch, quello dedicato al narcisismo. «Meglio essere temuti che amati», recita un proverbio; nel rovesciamento avvenuto negli ultimi quarant’anni, cui non è estranea la televisione commerciale inventata da Silvio Berlusconi, è molto meglio che gli altri ti vedano come sei: cattivo, spietato, senza vergogna. L’assenza del senso di vergogna è generata dall’assenza di standard pubblici legati a violazioni o trasgressioni. Nella vergogna s’esperimenta l’immagine negativa di sé stessi, si prova il senso di un’impotenza. Questa emozione rientra in quel novero di quelle esperienze che sono definite dagli psicologi “morali”. Ciò che sembra scomparso in questi ultimi decenni è proprio un sistema di valori morali condivisi.
* * *
Non è lontano dal vero immaginare che la deriva populista nasca anche da questa crisi verticale di valori, dall’assenza di un codice etico collettivo. Nell’età del narcisismo di massa ognuno fa per sé, stabilendo regole e comportamenti che prescindono dagli altri o dalla società come entità concreta, entro cui si misura la propria esistenza individuale. La vergogna è senza dubbio un sentimento distruttivo, probabilmente molto di più del senso di colpa, come certificano gli psicoanalisti. Sovente porta a derive estreme, a reazioni autodistruttive, e tuttavia è probabilmente uno dei sentimenti più umani che esistano.
Per capire come funzioni la vergogna basta leggere uno dei libri più terribili e insieme alti del XX secolo, “I sommersi e i salvati” (Einaudi) di Primo Levi nel capitolo intitolato Vergogna. Lo scrittore vi riprende una pagina di un suo libro, l’inizio de “La tregua”, dove si racconta l’arrivo dei soldati russi ad Auschwitz. Sono dei giovani militari a cavallo che assistono alla deposizione del corpo di uno dei compagni di Levi gettato in una fossa comune. Il cumulo dei cadaveri li ha come pietrificati. Levi riconosce nei soldati russi il medesimo sentimento che lo assaliva nel Lager dopo le selezioni: la vergogna, scrive, che i tedeschi non avevano provato. La scrittore spiega che non è solo un sentimento che si prova per aver compiuto qualcosa di male, di scorretto o di errato. Nasce piuttosto dalla “colpa commessa da altrui”: la vergogna dei deportati scaturisce proprio da quello che hanno fatto i carnefici. Una vergogna assoluta, che rimorde alla coscienza delle vittime per la colpa commessa dai carnefici: «gli rimorde che esista, che sia stata introdotta irrevocabilmente nel mondo delle cose che esistono, e che la sua volontà sia stata nulla o scarsa, e non abbia valso a difesa». Levi parla di una vergogna radicale, che svela la profonda umanità di questo sentimento.
* * *
Gli psicologi affermano che la vergogna è molto più distruttiva del senso di colpa. Proprio per questo è lì che si comprende quale sia la vera radice dell’umano. Si tratta della «vergogna del mondo», come la definisce Levi, vergogna assoluta per ciò che gli uomini hanno fatto agli altri uomini, e non solo ad Auschwitz, ma anche in Cambogia, nella ex Jugoslavia, in Ruanda, nel Mar Mediterraneo e in altri mille posti ancora.
Che la vergogna ci faccia umani non lo dice solo Levi in modo estremo, ma lo evidenzia l’ultima frase di uno dei più straordinari testi letterari mai scritti, “Il processo” di Franz Kafka. Libro che quasi tutti hanno letto almeno una volta da giovani. Il romanzo dello scrittore praghese termina con una frase emblematica: «E la vergogna gli sopravvisse». K. è stato ucciso dai due scherani che l’hanno perseguitato nel corso dell’intera storia. L’hanno barbaramente accoltellato al cuore, dopo avere tentato inutilmente di convincerlo a farlo lui stesso. Il libro di Kafka si chiude con questa frase che, come ha segnalato Giorgio Agamben, significa esattamente questo: la vergogna ci rende umani. Chissà se Silvio Berlusconi e la sua corte hanno mai avuto in mano questo racconto, se l’hanno letto. Probabilmente no. Ma anche se lo avessero fatto, dubito che ne avrebbero tratto qualche ammaestramento, com’è evidente da quello che è seguito dal 1994: senza vergogna.
* SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
VERGOGNA E "LATINORUM": UNA GOGNA PER L’ITALIA INTERA. Sul filo di una nota di Tullio De Mauro
L’OCCUPAZIONE DELLA LEGGE E DELLA LINGUA ITALIANA: L’ITALIA E LA VERGOGNA.
LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE.
Federico La Sala
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. -- Ora Scalfari vota Berlusconi: “Populista sì, ma di sostanza”. Dalla battaglia per la Mondadori con le sentenze comprate dal Cavaliere agli ultimi tentavi di fare impresa assieme23 novembre 2017, di Federico La Sala
Conversioni - Il fondatore di “Repubblica” va in tv e si rimangia 20 anni di “guerra al puzzone”: “Preferisco lui a Di Maio”. È la scelta dell’establishment per il 2018
Ora Scalfari vota Berlusconi: “Populista sì, ma di sostanza”
di Daniela Ranieri (Il Fatto, 23.11.2017)
Nelle ore in cui si scaldano le rotative che sforneranno la nuova Repubblica, interamente scritta col carattere tipografico sobriamente ribattezzato “Eugenio”, Eugenio Scalfari, fondatore di Repubblica e autorità morale, è a La7, ospite di Giovanni Floris.
Esordisce dicendo che se il Pd “sta esaurendo il suo ruolo”, nondimeno Renzi è il suo “nipotino” e non si sente “il nonno di nessun altro”. La frecciata è per quelli di Mdp (in particolare per Bersani che, macchiandosi d’ignominia, “fece la corte ai 5Stelle”), colpevoli di aver abbandonato il tontolone neoliberista al suo destino invece di farsi carico della sua prossima, ennesima sconfitta.
I diseredati per Scalfari prenderanno tra l’8 e il 10%, che “è niente” rispetto a quanto prenderà Renzi, peraltro alleandosi con tutte le frattaglie della Repubblica. “Io sono perché si rinnovi il Pd”, dice Scalfari ieraticamente: in questo senso gli pare “notevole il colloquio che Renzi ha avuto con Macron”, due “pilastri dell’europeismo” (Scalfari pensa che Renzi sia Bismarck, ogni tanto lo critica e lo indirizza ma come Machiavelli farebbe col Valentino). Il Fondatore sa bene che Renzi è europeista solo quando gli fa comodo, che in lui convivono lo statista kitsch della portaerei al largo di Ventotene e il bamboccione capriccioso delle bandiere europee tolte dal set di Palazzo Chigi per fare una delle sue gradassate; ciò nondimeno, del figaccio in Scervino apprezza il cinismo, e la tempra per fondare l’unica cosa che per Scalfari conta più della democrazia: l’oligarchia.
A questo punto viene fatto entrare Bruno Vespa, che come tutti sanno è venuto a promuovere il nuovo libro che ancora deve uscire ma è già in classifica (è come la Apple, ogni anno sforna un aggiornamento): si intitola Soli al comando. Da Stalin a Renzi, da Mussolini a Berlusconi, da Hitler a Grillo; titolo che farebbe sorridere se non venisse dallo stesso autore di Donne d’Italia. Da Cleopatra a Maria Elena Boschi (come se uno storico del cinema scrivesse Latin lover. Da Rodolfo Valentino a Er Mutanda).
La serata prosegue con geriatrica lentezza, rassicurante come un documentario di Geo & Geo: l’incontro con B. “quando lui non si occupava di politica ma di televisioni” (“era una delizia”), il giardino con le tombe, il materasso a cuore... Ma l’aneddotica sui mausolei e i bordelli di B. (che peraltro dopo la sfilata delle ragazze a Un giorno in pretura non può più emozionarci) è destinata a interrompersi. La bomba è grossa e Floris sa come innescarla: accertato il decesso del Pd, “tra B. e Di Maio, chi sceglierebbe?”. Scalfari incide su pietra: “Sono tutti populisti tranne il Pd, però il populismo di B. ha una sua sostanza”. Basti pensare alle dentiere e alle am-lire. Soprattutto, “B. è europeista, non sfegatato; mentre Salvini no” (riecco B. argine contro i populisti), ergo “in caso di estrema necessità può allearsi col Pd”, senza Salvini. Senza dimenticare che B. “è un attore-autore, sceglie il tema e lo interpreta, recita il suo testo”. E quindi? Qui Scalfari confessa: “Sceglierei B.”
Ma come? E i 20 anni di antiberlusconismo di Repubblica? E la distanza antropologica? E le 10 domande? E le Se non ora quando?
A noi disillusi, la confessione di Scalfari pare coerente. Logicamente: se non può vincere Renzi, che ha distrutto il Pd e in tre anni di governo ha attuato un programma neoliberista di destra, perché non votare B., che può allearsi con Renzi facendo argine contro gli odiati populisti?
Storicamente: fu lo stesso Scalfari, in occasione degli 80 anni di Berlusconi, a rivelare un retroscena “divertente” della “guerra di Segrate” tra il gruppo Espresso di De Benedetti e il magnate della Tv. Il quale, sconfitto, si rifiutò di pagare le spese legali (si sa come sono fatti questi ricchi quando c’è da pagare). Scalfari: “Dopo molti suoi rifiuti riuscii a persuaderlo promettendogli e dandogli la mia parola d’onore che se lui accettava di pagare le spese legali io l’avrei trattato d’ora in avanti come un socio cioè eventuali notizie che lo riguardassero sarebbero state anzitutto rese note a lui che ne dava la sua interpretazione dopodiché l’inchiesta sarebbe andata avanti”.
Non stupisce che oggi Scalfari difenda l’establishment, rassicurato solo da un’alleanza tra i due migliori, si fa per dire, lazzaroni su piazza. E tutto nel giorno del varo del nuovo font Eugenio! (che a questo punto poteva pure chiamarsi Silvio).
Affari e grandi guerre, il triangolo fra Silvio, il fondatore e l’editore
Dalla battaglia per la Mondadori con le sentenze comprate dal Cavaliere agli ultimi tentavi di fare impresa assieme
di Gianni Barbacetto (Il Fatto, 23.11.2017)
Il triangolo no, Berlusconi non l’aveva considerato. Eppure Eugenio Scalfari è riuscito a fare in tv l’elogio dell’ex Cavaliere. “Il populismo di Berlusconi ha una sua sostanza”, ha detto il Fondatore. E alla domanda di Giovanni Floris, “se dovesse scegliere tra Di Maio e Berlusconi, chi sceglierebbe?”, ha risposto senza esitazioni: “Berlusconi”. Il terzo del triangolo è l’Editore, Carlo De Benedetti, che completa un ménage à trois burrascoso ma intenso, che si dipana in quarant’anni di scontri e incontri e scontri. Grandi guerre e improvvise alleanze. In cui, più che il giornalismo, pesano gli affari.
All’inizio - era il 1979 - ci fu un incarico commerciale affidato a Scalfari dalla famiglia Mondadori: vendere a Berlusconi Rete 4, che stava trascinando nel baratro la casa editrice di Segrate. “Berlusconi ci invitò a cena ad Arcore”, raccontò poi il Fondatore, “e fu quello l’inizio non dico di un’amicizia ma di una conoscenza che col passare dei giorni e dei mesi diventò molto cordiale”.
L’agente commerciale Scalfari portò a compimento il suo mandato: “I contatti durarono a lungo, l’affare Rete 4 fu concluso. Ci vedevamo spesso finché lui cominciò ad occuparsi di politica. Per metà diventò socialista (craxiano ovviamente)... Per l’altra metà diventò democratico cristiano, vicino ad Andreotti e a Forlani”. E allora la quasi-amicizia si interruppe, perché Eugenio preferiva De Mita. Scalfari sparò contro Silvio - era il 1990 - articoli in cui lo paragonò a Mackie Messer, il bandito inventato da Bertolt Brecht. Anche De Benedetti, intanto, aveva incrociato Silvio sulla sua strada. Nel 1985 aveva cercato di portare a casa a buon prezzo la Sme, industria alimentare di Stato. Bettino Craxi chiese a Berlusconi di bloccare a ogni costo l’operazione. Silvio eseguì: gli preparò una cordata concorrente (Barilla, Ferrero, Fininvest) e l’affare sfumò. I due si ritrovarono a fare i duellanti nella “guerra di Segrate”. La Mondadori era diventata di De Benedetti e Repubblica si era integrata nel gruppo. Ma Silvio si era mangiato tutto, anche comprandosi giudici e sentenza. Poi però aveva accettato di spartire il bottino, lasciando Repubblica e L’Espresso a Scalfari e De Benedetti. Ci fu uno strascico: 50 milioni di lire di spese legali.
Non le voleva pagare nessuno, né Berlusconi, né De Benedetti, né Carlo Caracciolo, il principe editore del vecchio Espresso. “A quel punto dovetti intervenire io”, racconta Scalfari, che propose a Berlusconi un baratto. “Riuscii a persuaderlo promettendogli e dandogli la mia parola d’onore che se lui accettava di pagare le spese legali io l’avrei trattato d’ora in avanti come un socio cioè eventuali notizie che lo riguardassero sarebbero state anzitutto rese note a lui che ne dava la sua interpretazione dopodiché l’inchiesta sarebbe andata avanti come sempre accade in tutti i giornali... Il mio impegno durò fino a quando divenne presidente del Consiglio”. Allora sparò un’altra delle sue definizioni: non più Mackie Messer, ma “ragazzo coccodé”, prendendola a prestito da Renzo Arbore.
Nel bel mezzo del ventennio berlusconiano - e dunque anche antiberlusconiano - i duellanti della Sme e della “guerra di Segrate”, De Benedetti e Berlusconi, nemici accerrimi, anche antropologicamente inconciliabili, diventano improvvisamente soci. Nel 2005 De Benedetti fonda la società di investimenti M&C. Mission: salvare imprese in difficoltà. Si diffonde la notizia che vi entrerà, con una quota consistente, anche la Fininvest. La Borsa s’infiamma, il titolo s’impenna, la Consob s’insospettisce e De Benedetti, accusato di insider trading, paga una sanzione di 30 mila euro.
Ma la pubblica opinione, di cui i lettori di Repubblica sono parte, s’indigna: ma come, l’Editore, dopo guerre sanguinose per Sme e Mondadori, fa affari insieme al suo arcinemico? Alla fine Berlusconi si sfila: troppe polemiche, troppe insinuazioni (e forse pochi affari). I duellanti riprendono a duellare. Dopo che una sentenza definitiva stabilisce, nel 2007, che la Mondadori era andata a Berlusconi grazie a una sentenza comprata, De Benedetti avvia una causa civile, chiedendo che Fininvest risarcisca la sua Cir per avergli scippato la casa di Segrate. Porta a casa in primo grado, nel 2009, 745 milioni di euro come “danno patrimoniale da perdita di opportunità di un giudizio imparziale”: a scriverlo è il giudice Raimondo Mesiano, subito messo in ridicolo dalle tv di Berlusconi per via dei suoi imperdonabili calzini azzurri. Nel 2011 il risarcimento a De Benedetti è ridotto a 540 milioni, che diventano 560 con gli interessi. Nel 2013, nuovo ritocco: 494 milioni.
Quando il 29 settembre 2016 Silvio compie 80 anni, Eugenio unisce agli auguri un’autocritica: “Sbagliai, non era affatto il ragazzo coccodé e ce lo ritrovammo sul gobbo per vent’anni. E ancora non è finito”. E allora: “Oggi dovrei fargli gli auguri e infatti glieli faccio anche se non ci parliamo più dal 1994”. Del resto, “debbo dire che invecchiando è migliorato, l’età porta guai ma anche qualche prestigio”. Sarà la comune senescenza a farli tornare più vicini? Ora Eugenio recupera Silvio come populista “di sostanza” contro il populismo senza qualità dei 5stelle. Si chiude il cerchio. Anzi il triangolo.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. -- COSTITUZIONE E POPULISMI "DI SOSTANZA". L’inganno sul mio voto a Berlusconi (di Eugenio Scalfari)24 novembre 2017, di Federico La Sala
Costituzione e populismi (ateo-devoto) "di sostanza": W "la Repubblica", W "Forza Italia"!!! ... *
Il commentoL’inganno sul mio voto a Berlusconi
di Eugenio Scalfari (la Repubblica, 24.11.2017)
Cari Lettori, non cadete nell’inganno di chi sfrutta una domanda paradossale («Chi voterebbe tra Di Maio e Berlusconi?») per sostenere che avrei cambiato posizione su Berlusconi: non l’ho mai votato e ovviamente non lo voterò mai. Martedì scorso ho partecipato alla trasmissione televisiva guidata da Giovanni Floris, dove tornerò martedì prossimo. Rispondendo a una domanda sul tema dell’ingovernabilità, ho detto che in caso di estrema necessità per superare una situazione paralizzante per il Paese il Pd (per il quale io ho sempre votato dai tempi di Berlinguer, dell’Ulivo prodiano e infine di quello costruito da Walter Veltroni) potrebbe essere costretto, come già successo in passato, a un’intesa non di natura politica con Forza Italia, sempreché si separasse da Salvini.
Ipotesi a me sgradita, che è emersa parlando del rischio di ingovernabilità del Paese, tema approfondito ieri sul nostro giornale con molta lucidità da Gustavo Zagrebelsky. Ho poi detto che ai miei occhi sia Di Maio che Berlusconi sono populisti, ma che il populismo del secondo ha perlomeno una sua sostanza. Ma veniamo allo stato attuale dei satti e dei sondaggi, i partiti in corsa sono soprattutto tre: il Pd, i Cinquestelle, la destra di Berlusconi e della Lega di Salvini.
Nelle recenti elezioni siciliane la destra ha largamente vinto, seguita dai grillini e a buona distanza dal Pd, con la sinistra dissidente che aveva presentato una propria lista con risultati lillipuziani. Questa situazione si ripeterà probabilmente nelle prossime elezioni di sine Legislatura che avverranno a marzo o aprile del 2018? Probabilmente sì. Il Pd si rassorzerebbe se la sinistra dissidente e Pisapia e Bonino consluissero sin d’ora nel partito: una sinistra unita probabilmente recupererebbe anche una parte degli astenuti che hanno sentimenti di sinistra lacerati dall’attuale dissidenza. Fassino, incaricato da Renzi, ha tentato in tutti i modi di recuperare la dissidenza, ma non è riuscito. Forse Pisapia, ma è ancora molto incerto.
Il tema dell’ingovernabilità è dunque ancora dominante, se nessuno dei tre maggiori partiti assronterà le elezioni della prossima primavera nella situazione attuale, il Paese non avrà un governo legittimato dal voto. Il Centro si orienterà verso la destra ma anche in quel caso un governo Berlusconi- Salvini non avrà la maggioranza, durerà qualche mese dopodiché le elezioni dovranno ripetersi. Ci troviamo purtroppo nella stessa situazione della Germania di Angela Merkel.
Ma c’è un’altra evidenza da sottolineare: così come sta accadendo per la Germania, anche un’Italia sballottata dall’ingovernabilità non conterebbe più nulla in Europa con tutte le conseguenze del caso. La mia risposta nella trasmissione televisiva a Floris era chiaramente motivata da quanto sta accadendo: se l’ingovernabilità prosegue così come le previsioni e i sondaggi attuali consermano, la maggioranza relativa sarà certamente del centrodestra, Salvini compreso ed anzi preponderante.
Ovviamente io non voterò mai Berlusconi, ma con quel tanto di esperienza che gli anni hanno largamente ampliato, la situazione è quella che ho qui esposto.
Come c’era da aspettarsi sono stato ricoperto di insulti dai grillini rappresentati nel Fatto quotidiano diretto da Marco Travaglio, ma considero quegli insulti come una sorta di Legion d’onore. Quanto alla sinistra dissidente, ci pensi bene prima di risiutare le aperture di Renzi nei suoi consronti. Da parte loro è un litigio di comari, come si diceva un tempo. La politica è la prima delle attività dello spirito. Lo dimostrarono Platone e soprattutto Aristotele. Sarebbe opportuno leggerli. L’ho consigliato a Renzi e spero l’abbia satto. A Berlusconi è inutile suggerirlo, la lettura non sa parte della sua attività. Gli consiglio soltanto di piantare Salvini: meglio soli che in pessima compagnia.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
GLI APPRENDISTI STREGONI E L’EFFETTO "ITALIA". LA CLASSE DIRIGENTE (INCLUSI I GRANDI INTELLETTUALI) CEDE (1994) IL "NOME" DEL PAESE AL PARTITO DI UN IMPRENDITORE. Che male c’è?! - Materiali sul tema
FILOSOFIA. IL PENSIERO DELLA COSTITUZIONE E LA COSTITUZIONE DEL PENSIERO
 MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?!
MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?!COSTITUZIONE E PENSIERO. ITALIA: LA MISERIA DELLA FILOSOFIA ITALIANA E LA RICCHEZZA DEL MENTITORE ISTITUZIONALIZZATO ...
 BERTRAND RUSSELL: LA LEZIONE SUL MENTITORE (IGNORATA E ’SNOBBATA’), E "L’ALFABETO DEL BUON CITTADINO".
BERTRAND RUSSELL: LA LEZIONE SUL MENTITORE (IGNORATA E ’SNOBBATA’), E "L’ALFABETO DEL BUON CITTADINO".Federico La Sala
-
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. -- La miseria dei giorni della politica contemporanea e le celebrazioni del decennale del "Vaffa day".16 settembre 2017, di Federico La Sala
LA QUESTIONE MORALE.
LA COSTITUZIONE, LA NOSTRA “BIBBIA CIVILE” ...*
Il Vaffa di Grillo ha origini nel situazionismo di Debord e Gallizio
Non tutti sanno che il nucleo fondativo di quel pensiero trovò accoglienza nel 1957 in un paesino dell’entroterra ligure
di Pino Pisicchio *
Nella miseria dei giorni della politica contemporanea si sono dovute ascoltare anche le celebrazioni per il decennale del "Vaffa day". Potrebbe essere una parabola tutta italiana, un segno dei tempi macilenti che ci toccano in dote. Eppure, forse con qualche preterintenzionalità, quelle celebrazioni hanno un senso. Anche dal punto di vista culturale.
Infatti, ciò che la base elettorale, il vertice dei dirigenti, il sinedrio degli eletti dei Cinquestelle ma anche l’universo dei giornalisti laureati e dei maître à penser usi a invadere Tv, testate ed editrici blasonate, non sanno, è che i grillini, contrariamente a quanto si possa immaginare, un pensiero nobile ce l’hanno, eccome.
E quel Vaffa day lo interpreta perfettamente. Il pensiero nobile grillino, però, non è quella minestra- brodo primordiale lanciata col nome di Gaia da Casaleggio senior nella rete qualche anno fa, con sembianze oniriche stile new age. No. O meglio: la storia dell’agorà virtuale è la fissa aziendale che ha mostrato di funzionare egregiamente sulla base del principio: "urla, offendi, cavalca il mostro che si muove nelle viscere della rete e farai tanti adepti".
La vera grande ispirazione culturale discende, invece, dai rami del Situazionismo di Pinot Gallizio e di Debord, rielaborazione dada della filosofia trozkista, nella convinzione che la borghesia crassa e decadente soggiogata dalla società dello spettacolo, sarebbe stata abbattuta con le stesse armi ma rivolte contro.
Insomma un pensiero spiazzante, indecente e arrabbiato. Ora non tutti sanno che il nucleo fondativo di quel pensiero trovò accoglienza nel 1957 in un paesino dell’entroterra ligure, Cosio di Arroscia, in provincia di Imperia, con un grappolo di stralunati pensatori, pittori, artisti a vario titolo, provenienti da mezza Europa, una sorta di comunità beatnik avanti lettera.
In Italia, dunque, anzi, in quella striscia un po’ nordica, un po’ mediterranea che è la Liguria. A Genova e dintorni, infatti, si insediò un nucleo di resistenti, discepoli sulla scia dell’insegnamento di Debord, tutti apprendisti stregoni della tv, sperimentatori, mischiatori di generi, ritagliatori di suggestioni e di irriverenze.
Marco Giusti, Antonio Ricci, Carlo Freccero, Enrico Ghezzi. E Beppe Grillo. Sì, proprio lui. Che ha sublimato l’idea primigenia del situazionismo offrendo il suo corpo e la sua cacofonia alla causa. Con Grillo, infatti, Debord ha visto compiuta la sua utopia dello sberleffo al potere con i voti di quella che una volta si sarebbe chiamata borghesia e che oggi invece somiglia all’informe ventre di un popolo celibe. E nubile (per parità di genere).
Cos’è, allora, il "Vaffa day" se non il gesto situazionista per antonomasia? Cos’è lo stesso Grillo, con la sua faccia, il suo mestiere di comico, la sua perenne coprolalia brandita come arma contundente? Ma è chiaro: è la vittoria politica di Debord nell’unico consorzio umano al mondo dove poteva attecchire il suo pensiero: la società italiana. Non a caso la Bibbia dei Situazionisti fu il suo libro: "La società dello Spettacolo ".
* Il blog Pino Pisicchio, Presidente gruppo Misto Camera Deputati, The Huffingtonpost, 11.09.2017.
*
- SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
 LA COSTITUZIONE, LA NOSTRA “BIBBIA CIVILE” ....
LA COSTITUZIONE, LA NOSTRA “BIBBIA CIVILE” ....
 L’ITALIA, LA CARTA D’IDENTITA’ TRUCCATA, E GLI SFORZI FALLITI DEL PRESIDENTE CIAMPI DI ROMPERE L’INCANTESIMO DI "FORZA ITALIA"!!! Una nota di Arrigo Levi
L’ITALIA, LA CARTA D’IDENTITA’ TRUCCATA, E GLI SFORZI FALLITI DEL PRESIDENTE CIAMPI DI ROMPERE L’INCANTESIMO DI "FORZA ITALIA"!!! Una nota di Arrigo Levi Per la Costituzione - e il dialogo, quello vero ...
Per la Costituzione - e il dialogo, quello vero ...
 "ITALIA". AMARE L’ITALIA: RIPRENDIAMOCI LA PAROLA. VAFFA-DAY?! ONORE A BEPPE GRILLO. Contro la vergognosa confusione dell’ "antipolitica" in Parlamento e della "politica" in Piazza, l’invito ad uscire dalla "logica" del "mentitore". Una lettera (2002), con un intervento di Beppe Grillo (la Repubblica, 2004).
"ITALIA". AMARE L’ITALIA: RIPRENDIAMOCI LA PAROLA. VAFFA-DAY?! ONORE A BEPPE GRILLO. Contro la vergognosa confusione dell’ "antipolitica" in Parlamento e della "politica" in Piazza, l’invito ad uscire dalla "logica" del "mentitore". Una lettera (2002), con un intervento di Beppe Grillo (la Repubblica, 2004).Federico La Sala
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. -- USCIRE DALLO STATO DI MINORITA’. "Personalizing Politics and Realizing Democracy".29 agosto 2017, di Federico La Sala
INDIVIDUO, SOCIETA’, E COSTITUZIONE. IERI COME OGGI: USCIRE DALLO STATO DI MINORITA’, APRIRE GLI OCCHI!!! C’E’ DIO E "DIO", PATRIA E "PATRIA", E FAMIGLIA E "FAMIGLIA" ...
Scienze psicosociali
Democrazie personalizzate
 Per Platone, politica e morale sono due facce della stessa medaglia e il governo giusto è solo quello dei filosofi, che sanno cosa è la giustizia.
Per Platone, politica e morale sono due facce della stessa medaglia e il governo giusto è solo quello dei filosofi, che sanno cosa è la giustizia.
 Aristotele, invece, preferisce discutere la politica come dimensione dell’esperienza sociale indipendente dall’etica
Aristotele, invece, preferisce discutere la politica come dimensione dell’esperienza sociale indipendente dall’eticadi Gilberto Corbellini (Il Sole-24 Ore, Domenica, 27.8.2017)
- Gian Vittorio Caprara, Michele Vecchione, Personalizing Politics and Realizing Democracy , Oxford University Press, New York, pagg. 420, $ 58
Per Platone, politica e morale sono due facce della stessa medaglia e il governo giusto è solo quello dei filosofi, che sanno cosa è la giustizia. Aristotele, invece, preferisce discutere la politica come dimensione dell’esperienza sociale indipendente dall’etica. Non tanto perché le forme della virtù siano irrilevanti, ma in quanto, se si ha di mira il bene generale, è disfunzionale decidere una forma di governo partendo da doti etiche personali. Meglio chiedersi sotto quale tipo di legge (costituzione) sarebbe preferibile vivere.
Sono dovuti trascorrere quasi due millenni, ed è occorsa la provocazione di Macchiavelli (ma quale etica, è tutto lecito in politica!), per rendersi conto che i valori della convivenza civile si possono stabilire concordemente, per vie democratiche, attraverso leggi nelle quali tutti si riconoscono e che sono uguali per tutti; piuttosto che lasciarli decidere, i valori, dai politici che di volta in volta per le loro personalità/capacità intercettano i favori popolari. La selezione naturale non poteva prevedere che per la convivenza civile nelle innaturali società moderne si dovessero inventare lo stato di diritto, il libero mercato, l’epistemologia scientifica, il rispetto degli estranei, i diritti umani, etc. Le sensibilità per questi valori non sono innate, come provano le scienze cognitive. Scaturiscono da processi storico-sociali che hanno manipolato, provvisoriamente, predisposizioni psicologiche individuali polimorfiche, dando luogo a repertori e combinazioni di profili comportamentali, quindi preferenze valoriali e infine orientamenti politico-ideologici, che si combinano e ricombinano nei gruppi umani per rispondere a continue e diverse sfide o instabilità dettate da dinamiche ecologiche in senso lato.
La psicologia della personalità è un terreno fertile per studiare e ragionare delle basi comportamentali della politica e per capire quali forme di organizzazione della convivenza umana sono più congeniali alle disposizioni individuali e sociali umane.
 In un denso e lucido libro, Gian Vittorio Caprara e Michele Vecchione argomentano che la democrazia è un’«impresa morale che si fonda ampiamente sulla moralità pubblica dei suoi cittadini», e che la divaricazione ideologica tra destra e sinistra o tra liberali e conservatori intercetta tratti fondamentali della personalità, che nell’evoluzione della cultura politica occidentale si strutturano preferibilmente attraverso questa tipologia di identificazione politica, in ragione dei valori morali e politici associati a questi piani.
In un denso e lucido libro, Gian Vittorio Caprara e Michele Vecchione argomentano che la democrazia è un’«impresa morale che si fonda ampiamente sulla moralità pubblica dei suoi cittadini», e che la divaricazione ideologica tra destra e sinistra o tra liberali e conservatori intercetta tratti fondamentali della personalità, che nell’evoluzione della cultura politica occidentale si strutturano preferibilmente attraverso questa tipologia di identificazione politica, in ragione dei valori morali e politici associati a questi piani.Non è di personalizzazione della politica nel senso tradizionale che parla il libro, cioè delle caratteristiche psicologiche dei leader votati dagli elettori e che sembrano contare sempre più, ma di come i tratti e i valori delle personalità dei cittadini concorrono al funzionamento di un sistema politico. Nondimeno si parla anche del fatto, corroborato da studi empirici, che le somiglianze di personalità tra politici ed elettori giocano un ruolo nelle scelte di voto.
Il libro espone dati, analisi e proposte fondate su due influenti paradigmi della psicologia della personalità e della psicologia sociale umana: il modello dei Big Five e la tassonomia dei valori umani fondamentali di Shalom H. Schwartz.
 I cinque “grandi” tratti selezionati nei primi decenni del secondo dopoguerra sulla base di studi lessicali e analisi fattoriali, come noto, sono: apertura mentale (quanto una persona è inventiva e curiosa piuttosto che cauta e conservatrice), amicalità (quanto una persona è fiduciosa, altruista e cordiale, piuttosto che egoista e sospettosa) coscienziosità (quanto è efficiente e scrupolosa, piuttosto che superficiale e disattenta), estroversione (quanto è energica e socievole, piuttosto che solitaria e chiusa) e, infine, stabilità emotiva (quanto è vulnerabile alle emozioni negative come l’ansia o l’angoscia, o tende alla depressione, piuttosto che sicura di sé e fiduciosa).
I cinque “grandi” tratti selezionati nei primi decenni del secondo dopoguerra sulla base di studi lessicali e analisi fattoriali, come noto, sono: apertura mentale (quanto una persona è inventiva e curiosa piuttosto che cauta e conservatrice), amicalità (quanto una persona è fiduciosa, altruista e cordiale, piuttosto che egoista e sospettosa) coscienziosità (quanto è efficiente e scrupolosa, piuttosto che superficiale e disattenta), estroversione (quanto è energica e socievole, piuttosto che solitaria e chiusa) e, infine, stabilità emotiva (quanto è vulnerabile alle emozioni negative come l’ansia o l’angoscia, o tende alla depressione, piuttosto che sicura di sé e fiduciosa).
 Numerosi studi dicono che le personalità caratterizzate da apertura e socievolezza tendono a essere progressiste, mentre quelle coscienziose, sono conservatrici. Qualche ricerca trova che le persone che spiccano come amicali tendono a essere di sinistra in economia e di destra nelle politiche sociali, mentre vale il contrario per gli emotivamente instabili. L’estroversione non produce effetti preferenziali. Esiste anche una letteratura che usa i Big Five per mappare geograficamente i tratti di personalità prevalenti in diverse aree degli Stati Uniti, spiegando in questo modo, cioè come concentrazione di persone con tratti simili, gli orientamenti ideologici e i comportamenti di voto costanti, per i repubblicani o per i democratici, in diversi stati.
Numerosi studi dicono che le personalità caratterizzate da apertura e socievolezza tendono a essere progressiste, mentre quelle coscienziose, sono conservatrici. Qualche ricerca trova che le persone che spiccano come amicali tendono a essere di sinistra in economia e di destra nelle politiche sociali, mentre vale il contrario per gli emotivamente instabili. L’estroversione non produce effetti preferenziali. Esiste anche una letteratura che usa i Big Five per mappare geograficamente i tratti di personalità prevalenti in diverse aree degli Stati Uniti, spiegando in questo modo, cioè come concentrazione di persone con tratti simili, gli orientamenti ideologici e i comportamenti di voto costanti, per i repubblicani o per i democratici, in diversi stati.Non è questa la sede per discutere i limiti del fortunatissimo modello dei Big Five, che non ha una base teorica e trova però alcune conferme a livello neurobiologico, ma non genetico. Ora, i tratti non danno informazioni a livello motivazionale: sono differenze individuali dimensionabili per quanto riguarda delle tendenze a mostrare schemi di azioni, affetti e pensiero coerenti.
L’israeliano Schwartz ha quindi costruito, partendo dalle ricerche dell’olandese Geert Hofstede sulle dimensioni delle differenze culturali e valoriali transnazionali, una tassonomia di dieci valori riscontrabili nelle principali culture, i quali funzionano come credenze, desideri o scopi che hanno effetti motivazionali per la persona: autodirettività, stimolazione, edonismo, realizzazione, potere, sicurezza, conformità, tradizione, benevolenza, universalismo.
 Questi valori strutturano in quattro gruppi che definiscono l’apertura al cambiamento (primi due), l’autoaffermazione (successivi tre), la conservazione (successivi tre) e l’auto-trascendenza (ultimi due), e sono tra loro interconnessi e sovrapposti. In che misura le dinamiche relazioni tra i valori correlano con o predicono orientamenti ideologici e scelte elettorali?
Questi valori strutturano in quattro gruppi che definiscono l’apertura al cambiamento (primi due), l’autoaffermazione (successivi tre), la conservazione (successivi tre) e l’auto-trascendenza (ultimi due), e sono tra loro interconnessi e sovrapposti. In che misura le dinamiche relazioni tra i valori correlano con o predicono orientamenti ideologici e scelte elettorali?Schwartz, Caprara e Vecchioni hanno suggerito otto “nuclei valoriali politici” che definiscono preferenze socio-economiche e culturali che contano per le persone in quanto espressione sul piano ideologico della loro visione morale: equità, libera concorrenza, morale tradizionale, legge e ordine, patriottismo fanatico, libertà civili, accettazione degli immigrati, interventismo militare.
 Esaminando prima due elezioni politiche italiane, 2006 e 2008, e quindi testando le preferenze valoriali e politiche in altri paesi europei, anche post-comunisti, gli autori hanno trovato che le ideologie tradizionali sono ancora i migliori predittori di voto, anche se i dati consigliano di guardare oltre la divisione destra-sinistra e progressisti-conservatori, per cogliere complessivamente i determinanti valoriali delle scelte politiche. Infatti, al di là di chiare differenze si notano comunanze tra i votanti. Per esempio, autodirettività e universalismo sono apprezzati più che potere e realizzazione nella maggior parte dei Paesi studiati, non solo come prevedibile da chi è di sinistra/progressista, ma anche per chi è di destra/conservatore.
Esaminando prima due elezioni politiche italiane, 2006 e 2008, e quindi testando le preferenze valoriali e politiche in altri paesi europei, anche post-comunisti, gli autori hanno trovato che le ideologie tradizionali sono ancora i migliori predittori di voto, anche se i dati consigliano di guardare oltre la divisione destra-sinistra e progressisti-conservatori, per cogliere complessivamente i determinanti valoriali delle scelte politiche. Infatti, al di là di chiare differenze si notano comunanze tra i votanti. Per esempio, autodirettività e universalismo sono apprezzati più che potere e realizzazione nella maggior parte dei Paesi studiati, non solo come prevedibile da chi è di sinistra/progressista, ma anche per chi è di destra/conservatore.Per quanto riguarda gli atteggiamenti politici, gli elettori di sinistra/progressisti sono per politiche di equa distribuzione delle risorse e delle opportunità e per le libertà civili (di agire e pensare), mentre quelli di destra/conservatori preferiscono politiche attente ai valori familiari e religiosi tradizionali, all’applicazione della legge e liberiste in economia. Ma questi ultimi danno un’importanza a eguaglianza e libertà civili non molto distante da chi è dell’ideologia opposta.
Per gli autori «i dati suggeriscono che gli atteggiamenti e le scelte politiche degli elettori dipendono meno che in passato dal menu offerto loro dai partiti e dai politici. Oggi i cittadini sono agenti proattivi, le cui priorità largamente dettano il tipo di menu che i partiti politici e i politici dovrebbero servire. Di fatto, più i cittadini sono consapevoli dei loro diritti, specialmente della libertà di esprimere le loro opinioni, più le rappresentazioni mentali di sé e le visioni del mondo personali dettano le loro scelte individuali». Il che dovrebbe suscitare ottimismo per il futuro della democrazia nella misura in cui un buon sviluppo della personalità si trasferisce nel buon funzionamento della democrazia. Ma nonostante le messe di dati e modelli utili che offre alla riflessione, il libro non spiega perché si dovrebbe essere ottimisti.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
CRISI POLITICA E "SACRA FAMIGLIA" [UNITA]!!! NON SOLO LA TEOLOGIA (E LA FILOSOFIA), MA NEMMENO LA SOCIOLOGIA SA DISTINGUERE TRA FAMIGLIA DEMOCRATICA E FAMIGLIA DI "MAMMASANTISSIMA" E DI "MAMMONA"...
 "FAMILISMO AMORALE" E SOCIETA’. LA FAMIGLIA CHE UCCIDE: IL LATO OSCURO DELLA FAMIGLIA.
"FAMILISMO AMORALE" E SOCIETA’. LA FAMIGLIA CHE UCCIDE: IL LATO OSCURO DELLA FAMIGLIA.ITALIA: STORIA E POLITICA (1513-2013). MACHIAVELLI CONTRO OGNI TIRANNIA E CONTRO OGNI POPULISMO: C’E’ CAPO E "CAPO" E STATO E "STATO"!!!
 LA QUESTIONE DELLO STATO: "IL PRINCIPE" O MEGLIO "DE PRINCIPATIBUS" (1513).
LA QUESTIONE DELLO STATO: "IL PRINCIPE" O MEGLIO "DE PRINCIPATIBUS" (1513).INDIVIDUO E SOCIETA’ E COSTITUZIONE, IERI COME OGGI. USCIRE DALLO STATO DI MINORITA’, APRIRE GLI OCCHI: C’E’ DIO E "DIO", PATRIA E "PATRIA", E FAMIGLIA E "FAMIGLIA" ...
 C’E’ CAPO E "CAPO" E STATO E "STATO"
C’E’ CAPO E "CAPO" E STATO E "STATO" -
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. -- FILOLOGIA E FILOSOFIA/TEOLOGIA. L’affresco di sant’Agostino nella cattedrale di Nardò.28 agosto 2017, di Federico La Sala
IN MEMORIA DI SANT’AGOSTINO (E IN ONORE DEL LAVORO DELLA FONDAZIONE "TERRA D’OTRANTO").
"ECCO DA DOVE COMINCIA L’AMORE" ("ECCE UNDE INCIPIT CHARITAS"), DALLA GRAZIA ("gr.: "XAPIS", lat.: "CHARIS") DI DIO AMORE ("CHARITAS"), NON DI DIO MAMMONA ("CARITAS") ...
Lode a Marcello Gaballo per questa bellissima e preziosa nota su "L’affresco di sant’Agostino nella cattedrale di Nardò" (cfr.: http://www.fondazioneterradotranto.it/2017/08/28/laffresco-di-santagostino-nella-cattedrale-di-nardo/#_ftn1) - e il lavoro di De Giorgi: la sua trascrizione della scritta sul cartiglio (ormai scomparsa) "iuste/et cas/te viv/ere et/ xarita(te)" - contrariamente alla protervia che ha portato allo "sproposito maiuscolo" e alla brutta abitudine instauratasi almeno a partire da Ludovico A, Muratori di una "caritas" latina! - conserva ancora la memoria del legame della tradizione dell’evangelo (non: "vangelo"!) con la lingua greca ("charis", "charites"... "charitas").
FILOLOGIA E FILOSOFIA/TEOLOGIA. Giambattista Vico ("De constantia iurisprudentis", 1721) giustamente e correttamente e onestamente così pensava e scriveva: "Solo la carità cristiana insegna la prassi del Bene metafisico"("Boni metaphysici praxim una charitas christiana docet"). Sapeva che Gesù ("Christo") aveva cacciato i mercanti FUORI dal tempio, e non aveva autorizzato i sacerdoti a vendere a "caro-prezzo" (lat.: "caritas") la "grazia" (gr.: "Xapis", lat.: "Charis") di Dio (lat.: "Charitas")!!!
Due padroni: Dio "Charitas" o dio "Caritas"?!, Dio Amore o dio Mammona?! In questo bivio ("X") ancora siamo, oggi - e ancora non sappiamo sciogliere l’incognita (""x")!
Sul tema, mi sia consentito, si cfr. la seguente nota:
L’EUROPA, IL CRISTIANESIMO ("DEUS CHARITAS EST"), E IL CATTOLICESIMO COSTANTINIANO ("DEUS CARITAS EST").Una storia di lunga durata...
 MURATORI, BENEDETTO XVI, E "UNO SPROPOSITO MAIUSCOLO": LA LEZIONE DI VICO. Un breve testo dalla "Prefazione ai lettori" del "Trattato sulla carità cristiana" di Ludovico A. Muratori
MURATORI, BENEDETTO XVI, E "UNO SPROPOSITO MAIUSCOLO": LA LEZIONE DI VICO. Un breve testo dalla "Prefazione ai lettori" del "Trattato sulla carità cristiana" di Ludovico A. Muratori
 MURATORI E RATZINGER. "DEUS CARITAS EST": FINE DEL CRISTIANESIMO. TOLTA AL PESCE ("I.CH.TH.U.S.") L’ ACCA ("H"), IL COLPO ("ICTUS") E’ DEFINITIVO!!!
MURATORI E RATZINGER. "DEUS CARITAS EST": FINE DEL CRISTIANESIMO. TOLTA AL PESCE ("I.CH.TH.U.S.") L’ ACCA ("H"), IL COLPO ("ICTUS") E’ DEFINITIVO!!!Federico La Sala
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
SULL’USCITA DALLO STATO DI MINORITÀ E SULLO SPIRITO CRITICO, OGGI. "X"- FILOSOFIA. LA FIGURA DEL "CHI": IL NUOVO PARADIGMA.
 DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE.
DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. -- EUROPA, ITALIA, ONG. Migranti, chi infligge colpi mortali al codice morale.8 agosto 2017, di Federico La Sala
LA QUESTIONE MORALE ...*
Migranti, chi infligge colpi mortali al codice morale
Ong. Non era ancora accaduto, nel lungo dopoguerra almeno, in Europa e nel mondo cosiddetto «civile», che la solidarietà, il salvataggio di vite umane, l’«umanità» come pratica individuale e collettiva, fossero stigmatizzati, circondati di diffidenza, scoraggiati e puniti
di Marco Revelli (il manifesto, 08.08.2017)
Negli ultimi giorni qualcosa di spaventosamente grave è accaduto, nella calura di mezza estate. Senza trovare quasi resistenza, con la forza inerte dell’apparente normalità, la dimensione dell’«inumano» è entrata nel nostro orizzonte, l’ha contaminato e occupato facendosi logica politica e linguaggio mediatico. E per questa via ha inferto un colpo mortale al nostro senso morale.
L’«inumano», è bene chiarirlo, non è la mera dimensione ferina della natura contrapposta all’acculturata condizione umana.
Non è il «mostruoso» che appare a prima vista estraneo all’uomo. Al contrario è un atteggiamento propriamente umano: l’«inumano» - come ha scritto Carlo Galli - «è piuttosto il presentarsi attuale della possibilità che l’uomo sia nulla per l’altro uomo».
Che l’Altro sia ridotto a Cosa, indifferente, sacrificabile, o semplicemente ignorabile. Che la vita dell’altro sia destituita di valore primario e ridotta a oggetto di calcolo. Ed è esattamente quanto, sotto gli occhi di tutti, hanno fatto il nostro governo - in primis il suo ministro di polizia Marco Minniti - e la maggior parte dei nostri commentatori politici, in prima pagina e a reti unificate.
Cos’è se non questo - se non, appunto, trionfo dell’inumano - la campagna di ostilità e diffidenza mossa contro le Ong, unici soggetti all’opera nel tentativo prioritario di salvare vite umane, e per questo messe sotto accusa da un’occhiuta «ragion di stato».
O la sconnessa, improvvisata, azione diplomatica e militare dispiegata nel caos libico con l’obiettivo di mobilitare ogni forza, anche le peggiori, per tentare di arrestare la fiumana disperata della nuda vita, anche a costo di consegnarla agli stupratori, ai torturatori, ai miliziani senza scrupoli che non si differenziano in nulla dagli scafisti e dai mercanti di uomini, o di respingerla a morire nel deserto.
Qui non c’è, come suggeriscono le finte anime belle dei media mainstream (e non solo, penso all’ultimo Travaglio) e dei Gabinetti governativi o d’opposizione, la volontà di ricondurre sotto la sovranità della Legge l’anarchismo incontrollato delle organizzazioni umanitarie.
Non è questo lo spirito del famigerato «Codice Minniti» imposto come condizione di operatività in violazione delle antiche, tradizionali Leggi del mare (il trasbordo) e della più genuina etica umanitaria (si pensi al rifiuto di presenze armate a bordo). O il senso dell’invio nel porto di Tripoli delle nostre navi militari.
Qui c’è la volontà, neppur tanto nascosta, di fermare il flusso, costi quel che costi. Di chiudere quei fragili «corridoi umanitari» che in qualche modo le navi di Medici senza frontiere e delle altre organizzazioni tenevano aperti. Di imporre a tutti la logica di Frontex, che non è quella della ricerca e soccorso, ma del respingimento (e il nome dice tutto).
Di fare, con gli strumenti degli Stati e dell’informazione scorretta, quanto fanno gli estremisti di destra di Defend Europe, non a caso proposti come i migliori alleati dei nuovi inquisitori. Di spostare più a sud, nella sabbia del deserto anziché nelle acque del Mare nostrum, lo spettacolo perturbante della morte di massa e il simbolo corporeo dell’Umanità sacrificata.
Non era ancora accaduto, nel lungo dopoguerra almeno, in Europa e nel mondo cosiddetto «civile», che la solidarietà, il salvataggio di vite umane, l’«umanità» come pratica individuale e collettiva, fossero stigmatizzati, circondati di diffidenza, scoraggiati e puniti.
Non si era mai sentita finora un’espressione come «estremismo umanitario», usata in senso spregiativo, come arma contundente. O la formula «crimine umanitario». E nessuno avrebbe probabilmente osato irridere a chi «ideologicamente persegue il solo scopo di salvare vite», quasi fosse al contrario encomiabile chi «pragmaticamente» sacrifica quello scopo ad altre ragioni, più o meno confessabili (un pugno di voti? un effimero consenso? il mantenimento del potere nelle proprie mani?)
A caldo, quando le prime avvisaglie della campagna politica e mediatica si erano manifestate, mi ero annotato una frase di George Steiner, scritta nel ’66. Diceva: «Noi veniamo dopo. Adesso sappiamo che un uomo può leggere Goethe o Rilke la sera, può suonare Bach e Schubert, e quindi, il mattino dopo, recarsi al proprio lavoro ad Auschwitz». Aggiungevo: Anche noi «veniamo dopo».
Dopo quel dopo. Noi oggi sappiamo che un uomo può aver letto Marx e Primo Levi, orecchiato Marcuse e i Francofortesi, militato nel partito che faceva dell’emancipazione dell’Umanità la propria bandiera, esserne diventato un alto dirigente, e tuttavia, in un ufficio climatizzato del proprio ministero firmare la condanna a morte per migliaia di poveri del mondo, senza fare una piega. La cosa può essere sembrata eccessiva a qualcuno. E il paragone fuori luogo. Ma non mi pento di averlo pensato e di averlo scritto.
Consapevole o meno di ciò che fa, chi si fa tramite dell’irrompere del disumano nel nostro mondo è giusto che sia consapevole della gravità di ciò che compie. Della lacerazione etica prima che politica che produce. Se l’inumano - è ancora Galli a scriverlo - «è il lacerarsi catastrofico della trama etica e logica dell’umano», allora chi a quella rottura contribuisce, quale che sia l’intenzione che lo muove, quale che sia la bandiera politica sotto cui si pone, ne deve portare, appieno, la responsabilità. Così come chi a quella lacerazione intende opporsi non può non schierarsi, e dire da che parte sta. Io sto con chi salva.
*
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.
IL SONNO MORTIFERO DELL’ITALIA. In Parlamento (ancora!) il Partito al di sopra di tutti i partiti.
IL MESSAGGIO EVANGELICO, LA COSTITUZIONE, E IL PARADOSSO ISTITUZIONALE DEL MENTITORE, ATEO E DEVOTO. COME LA "SACRA FAMIGLIA" DIVENNE ZOPPA E CIECA E IL FIGLIO PRESE IL POSTO DEL PADRE DI GESU’ E DEL "PADRE NOSTRO" E DIVENNE IL SANTO "PADRINO".... CON E ACCANTO A "MAMMASANTISSIMA".
 LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA
LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA L’INDICAZIONE DI NELSON MANDELA: GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. -- IL TEMPO PRESENTE DEL FASCISMO. Ricostituire una linea di separazione tra lecito e illegittimo (di Claudio Vercelli)4 agosto 2017, di Federico La Sala
- LA STORIA DEL FASCISMO E RENZO DE FELICE: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"!
 I. BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI - II. ARNALDO MUSSOLINI E MADDALENA SANTORO.
I. BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI - II. ARNALDO MUSSOLINI E MADDALENA SANTORO.
Il tempo presente del fascismo
di Claudio Vercelli (Patria Indipendente, 20 luglio 2017)
Le ragioni del fuoco di sbarramento al ddl Fiano. Lo «sdoganamento» del fascismo iniziato più di trent’anni fa, e il tentativo di affossamento dell’antifascismo. Non oscene nostalgie, ma la volontà di una dittatura presentata come visione alternativa della società. L’urgenza di ricostituire una linea di separazione tra lecito e illegittimo
- L’accesso al lido di Chioggia pieno di riferimenti celebrativi del fascismo (da http://www.giornalettismo.com/wp-content/uploads/2017/07/Chioggia-950×450.jpg
Non può sorprendere il fuoco di sbarramento che si sta opponendo all’introduzione, nel nostro ordinamento penale, dell’articolo 239-bis, concernente il reato di propaganda «attiva» (attraverso il ricorso a gesti palesi, come il saluto romano; la distribuzione di oggettistica e la diffusione di immagini; il ricorso a strumenti informatici e di comunicazione di massa) «del regime fascista e nazifascista». Il primo firmatario della proposta di legge, che nella sua originaria stesura risale già a due anni fa, è Emanuele Fiano.
La discussione in Commissione Giustizia e gli echi nelle aule parlamentari hanno scatenato la furia di quanti si sono appellati a un’improbabile «libertà di pensiero», rimandando, in maniera volutamente distorta, alla lettera dello stesso articolo 21 della nostra Costituzione. Tra di essi, spiccano coloro che si sono espressi contro una norma che hanno bollato da subito come «liberticida». Immediatamente dietro costoro, si articola il vasto coro di quei pallidi liberali variamente assortiti e motivati nel loro comune rifiuto: da quanti hanno invocato la necessità di imporre una pari condanna contro il «comunismo», poiché anch’esso manifestazione di «totalitarismo», a coloro che nel tentativo di dimostrare quanto il rimando ai simboli del fascismo sia solo una sorta di ragazzata, hanno quindi colto l’occasione per ridimensionare ancora una volta il tragico lascito di quell’esperienza storica. Anche nel suo riproporsi nel corso del tempo, fino ai rigurgiti dei diversi gruppi che esplicitamente, e con raccapricciante orgoglio, ad oggi rivendicano apertamente la loro identità fascista. Ciliegina sulla torta rancida delle polemiche è il ripetere, da parte di polemisti perlopiù dello stesso colore politico, ossia tra un grigio e un nero sbianchettato all’occorrenza, di quello che si sta cercando di affermare come luogo comune, ovvero che l’antifascismo sarebbe un falso valore. Anzi, semmai un ostacolo alla «libertà» dei moderni, che dovrebbe quindi prescindere da «anacronistici divieti», nel nome di un’inverosimile parificazione e un’inaccettabile «pacificazione» tra le parti contrapposte. In quanto - sentenziano costoro - il fascismo non fece troppo male; semmai, esagerò un po’, ma non molto di più.
Detto questo, poiché ciò che è in corso è una battaglia politica, l’ennesima di una storia lunga quanto quella della nostra Repubblica, alcune considerazioni vanno richiamate. Occorre quindi fissare pochi ma netti punti nella discussione.
- Un’istantanea del blitz squadrista di Casapound contro gli stranieri venditori ambulanti al lido di Ostia (da http://images.roma.corriereobjects.it/methode_image /Video/2017/07/10/Roma/Foto% 20Roma%20-%20Trattate/casa_apound_spiagge_ostia_640_ori_crop_master __0x0_640x360.jpg)
Il primo rimanda al fatto che la sostanza del rifiuto della norma che Fiano e altri parlamentari vorrebbero invece introdurre nella nostra giurisprudenza non ha a oggetto la tutela della libertà di giudizio, come della sua manifestazione in pubblico. Il vero obiettivo è semmai l’antifascismo organizzato, nel suo costituire ancora una delle ossature della democrazia. Le polemiche astiose e le invettive contro la proposta di legge, infatti, irridono in coro a esso, indicandolo come un ingombro da sotterrare una volta per sempre. Su questo passaggio è bene avere le idee molto chiare.
Lo «sdoganamento» del fascismo, che non data a questi ultimi tempi ma, di fatto, è iniziato più di trent’anni fa, corre su un binario parallelo all’affossamento dell’antifascismo, in tutte le sue manifestazioni. Si sia consapevoli di ciò: i neofascisti, e i loro amici, parlano di pacificazione per poi procedere all’azzeramento dei fondamenti antifascisti della nostra Costituzione.
Se si cede su un punto (legittimando il lascito storico del fascismo attraverso la sua relativizzazione morale, qualcosa del tipo “non era così male come invece lo si è dipinto”) ci si dovrà ben presto confrontare con l’inutilità dell’antifascismo.
Dopo di che, e si tratta del secondo passaggio, non è lo spettro del fascismo a dare corpo alle angosce del presente, ma sono le incongruenze del tempo corrente a dare nuovo fiato a un fascismo mai venuto meno in settant’anni e più di storia repubblicana, democratica e costituzionale. Nel corpo del nostro Paese così come anche in Europa. Poiché il problema è continentale e come tale va ragionato e affrontato. Partendo quindi dalla propria realtà nazionale, per poi estendere lo sguardo oltre se stessi. Se il regime mussoliniano è stato cancellato dalla storia, ovvero da coloro che vi si sono opposti a rischio della propria vita, non senza che una lunga e tragica guerra dilacerasse le nazioni, il fascismo come ideologia della sopraffazione, del primato razzista di Stato, della società di caste, dell’aristocraticismo dei potenti e della inibizione dei subalterni, del rifiuto della diversità e della varietà umana, dell’uso politico della paura per tacitare qualsiasi dissenso (insieme a molto altro) è invece più che mai presente. Non costituisce una ideologia politica tra le tante, anestetizzata e tacitata una volta per sempre dalla clamorosa sconfitta del 1945, bensì il concentrato del rifiuto della democrazia sociale. Una questione di nuovo urgente, dal momento in cui quest’ultima sta vivendo una crisi pericolosissima, dovuta soprattutto ai mutamenti che la globalizzazione ha introdotto nelle nostre società. Gli individui, all’atto in cui smarriscono l’orizzonte del futuro e la fiducia nel tempo che stanno vivendo, rischiano di cadere nelle trappole delle peggiori illusioni. Non per caso, quindi, il neofascismo si ripresenta con i falsi tratti, in sé purtroppo seducenti, di una visione alternativa della società. Dinanzi alla crisi degli ordinamenti liberali, dettata soprattutto dal dirompente ritorno delle diseguaglianze economiche - enfatizzate come un fatto tanto ovvio quanto naturale, quindi in sé “legittimo” perché immodificabile - il neofascismo afferma che la risposta ai problemi sta in un ordinamento non solo autoritario, ma basato sulla cancellazione della cittadinanza democratica.
- L’oltraggio razzista dell’On. Corsaro all’On. Fiano, in quanto ebreo. (http://www.lettera35.it/wp-content/uploads/2017/07/corsaro-fiano.jpg)
A dovere impensierire - ed è il terzo punto - non sono quindi solo le oscene “nostalgie” di un qualche vecchio apologeta o le adunate degli irriducibili che non si sono convertiti alla democrazia, né tanto meno lo sgradevole “folclore” di certi personaggi, bensì il fatto che la galassia neofascista sia la punta di un iceberg dove, alla paccottiglia del Ventennio si accompagnano, si legano e si riordinano i miasmi antidemocratici che attraversano la nostra società. Il passato fascista, da questo punto di vista serve al presente delle cosiddette «post-democrazie»: sancisce che la partecipazione consapevole non serve più; dichiara che si deve dare a una ristretta élite la delega totale rispetto alle decisioni; stabilisce un nesso di dipendenza tra la vita dei più e il volere insindacabile di pochi, a partire da un capo carismatico; enfatizza l’imposizione come strumento di indirizzo nell’esistenza delle nostre società; semplifica e banalizza problemi complessi per poi offrire soluzioni di forza. L’elenco sarebbe molto lungo. Non abbiamo quindi a che fare con un’assenza di memoria e, men che meno, con l’eventuale “non conoscenza” della storia. Risparmiamoci le retoriche di circostanza.
Chi si rifà al fascismo in quanto modello non solo politico ma anche sociale e culturale, intendendolo come attuale e quindi riproponibile, ha una precisa idea del passato ma anche e soprattutto chiare intenzioni verso il futuro. Vuole una dittatura. Un tempo ciò sarebbe stato denunciato come inaccettabile mentre oggi rischia di entrare nel circuito dei giudizi di senso comune. Anzi, sarebbe il caso di dire, “nei pregiudizi” diffusi: la democrazia è un orpello, una zavorra di cui liberarsi.
- Charlie Chaplin ne “Il grande dittatore”
Non è un caso, al riguardo, se esiste un doppio livello. Da una parte lo zoccolo duro delle organizzazioni neofasciste, che rivendicano per sé, apertamente, una tale identità. Non sono mai venute meno, dal 1945 in poi, adattandosi, di volta in volta, alle situazioni date. Sembrano periferiche, quasi marginali, consegnate al loro squallido radicalismo. Ma sono soprattutto un bacino di idee, di volti e anche di voti attraverso il quale introdurre nella discussione politica ciò che fino a non molto tempo fa sarebbe invece risultato impensabile poiché inaccettabile. Dall’altra parte, infatti, si collocano quei movimenti e partiti politici che, pur nella loro legittimità costituzionale, tuttavia ammiccano ai temi che il neofascismo rivendica esplicitamente per sé: a partire dallo svuotamento della rappresentanza democratica, passando attraverso il leaderismo esasperato per poi giungere al razzismo.
Punire il saluto romano non implica il solo osteggiare quei tragici pagliacci che lo ostentano provocatoriamente. Implica semmai il ricostituire una linea di separazione tra lecito e illegittimo, tra accettabile e inaccettabile. I simbolismi non sono mai delle ritualità fini a se stesse. Piuttosto sono dei precisi segnali attraverso i quali si comunicano volontà più ampie, poiché rivolte alla collettività. L’antifascismo, da questo punto di vista, è a un bivio. Dopo anni e anni di erosioni del suo patrimonio condiviso, deve riprendere l’iniziativa politica. Ne va non solo del suo destino ma di quello della democrazia. Laddove le due cose sono facce della medesima medaglia.
Claudio Vercelli, storico - Università cattolica del Sacro Cuore
- LA STORIA DEL FASCISMO E RENZO DE FELICE: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"!
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. -- IN RICORDO DI GIOVANNI FRANZONI (di Mons. Luigi Bettazzi).14 luglio 2017, di Federico La Sala
In ricordo di Giovanni Franzoni
di Mons. Luigi Bettazzi (Già presidente di Pax Christi) *
Pax Christi Italia e Mosaico di Pace mi chiedono di esprimere la loro partecipazione al lutto della famiglia e della Comunità cristiana di S. Paolo a Roma per la morte di Giovanni Franzoni.
Personalmente lo ricordo, quando era Abate di S. Paolo, alle Assemblee della CEI e agli ultimi due Periodi del Concilio Vaticano II. Penso alla sua attività negli anni caldi dopo il 1968; il suo libro “La terra è di Dio” (cui seguì poi “Anche il cielo è di Dio. Il credito dei poveri”) anticipava i problemi ecologici oggi sul tavolo della politica internazionale. Le sue prese di posizione sulla Chiesa dei poveri e sul dialogo con i comunisti sembrano appartenenti al passato, ma la sua dichiarazione di aver votato comunista lo portò alla “riduzione allo stato laicale”.
Il suo temperamento ardente, ma soprattutto il legame con la Comunità di S. Paolo, che aveva fondato e diretto fino ai nostri giorni, lo portarono a prese di posizioni di critica e di contestazione molto forti al di là di ogni compromesso (ad esempio di prendere domicilio nella mia Diocesi, pur restando a Roma), che indussero poi la Chiesa a decisioni drastiche.
Era rimasto, anche vivendo da laico (e sposandosi) uomo di fede. L’avevo incontrato il mese scorso, presentando insieme, in una parrocchia piemontese, il Concilio Vaticano II, di cui eravamo rimasti gli ultimi membri viventi italiani, ed era stato molto pacifico e fraterno.
Forse i suoi atteggiamenti di contrasto non permetteranno lo si ponga tra i profeti, accanto a don Mazzolari e don Milani, ma non gli tolgono il merito di una profezia - sulla Chiesa dei poveri, sull’ecologia, sulla nonviolenza e la pace - perseguita con sincerità e con coraggio e con la coscienza di una fede sincera. Gliene restiamo grati.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. -- STORIA E MEMORIA: GIOVANNI FALCONE, A 25 ANNI DALLA STRAGE DI CAPACI.23 maggio 2017, di Federico La Sala
Giovanni Falcone, chi lo chiamava “cretino” e chi non lo votò al Csm: ecco i nemici del giudice ucciso nella strage di Capaci
Dalle offese di Carnevale agli attacchi in diretta televisiva fino all’ultima provocazione di Berlusconi. A 25 anni dalla strage di Capaci ecco i nomi di chi ha provato in tutti i modi a rendere difficile l’esistenza del magistrato palermitano. Come Lino Jannuzzi che ai tempi della Superprocura definiva lui e De Gennaro "i maggiori responsabili della débâcle dello Stato di fronte alla mafia. Una coppia la cui strategia ha approdato al più completo fallimento"
di Giuseppe Pipitone *
C’è chi non si è pentito delle offese lanciate persino quando l’avevano già assassinato, ma anche chi ha chiesto scusa. Chi ha fatto delle scelte poi rivelatesi errate e adesso porta in tribunale i giornali che le ricordano, chi non ha mai più commentato certe critiche lanciate a favor di telecamera e chi invece nega persino le sue stesse parole. Sono i nemici di Giovanni Falcone, quelli che lo hanno osteggiato in vita rendendogli impossibile l’esistenza. Una categoria che non viene mai - o quasi mai - citata nelle decine di eventi organizzati ogni anno per commemorare il giudice palermitano.
“I nemici principali di Giovanni furono proprio i suoi amici magistrati. Tanti furono gli attacchi e le sconfitte tanto che fu chiamato il giudice più trombato d’Italia e purtroppo lo è stato ed è stato lasciato solo”, ha ricordato la sorella Maria alla vigilia dell’anniversario numero 25 della strage di Capaci. Un quarto di secolo dopo quel maledetto 23 maggio del 1992, tante, tantissime cose sono cambiate: a cominciare dalla stessa Cosa nostra e dall’Antimafia, fenomeni che negli anni sono addirittura arrivati a confondersi e compenetrarsi. Un gioco di specchi di cui sono piene le cronache degli ultimi anni e che soltanto nell’isola dei paradossi poteva andare in scena.
I nemici di Falcone - Confusa tra mille riflessi è stata anche la figura stessa di Falcone: la storia del giudice più trombato d’Italia, per citare la sorella Maria, è stata trasformata - spesso dai suoi stessi detrattori - in quella perfetta del magistrato sempre appoggiato da superiori e opinionisti lungo la sua intera esistenza. Venticinque anni dopo la sua morte, il ricordo del giudice siciliano è finito annacquato da fiumi di retorica: oggi sembra quasi che Falcone sia stato in vita un uomo amato da tutti, mai attaccato o ostacolato da nessuno. E pazienza se i fatti siano andati in maniera diversa. D’altra parte la figura del magistrato palermitano viene usata oggi come una sorta di santino: un nome da citare per dare solidità a qualsiasi tipo di ragionamento o di ragionatore.
Solo per fare un esempio, rivendica di aver conosciuto Falcone persino quello che è considerato il capo dei capi di Mafia capitale. “Una volta mi accollarono un reato in Sicilia (il delitto di Piersanti Mattarella ndr), presi l’avvocato e andai da Falcone, il giudice Falcone a Palermo”, dice in un’intercettazione Massimo Carminati. “Ma Falcone lo hai conosciuto di persona te?”, gli chiedono i suoi compari, come racconta il giornalista Lirio Abbate. “Mi ha interrogato. Persona intelligentissima, si vedeva proprio, aveva l’intelligenza che che gli sprizzava dagli occhi. Era anche una persona amabile nei modi”, risponde il Cecato dando vita a un dialogo grottesco.
Sono al limite dell’imbarazzo, invece, le ultime dichiarazioni di Silvio Berlusconi.”Falcone è il simbolo di come dovrebbe essere un magistrato”, ha detto l’ex cavaliere, intervistato dal Foglio. Chi magari pensava che il magistrato simbolo per Berlusconi dovesse somigliare al corrotto Vittorio Metta è dunque rimasto deluso. Ma l’ex premier ha addirittura rilanciato: “Al pensiero di Falcone si ispirano molte delle nostre idee sulla giustizia”. Il magistrato siciliano purtroppo non può replicare. In alternativa avrebbe respinto al mittente qualsiasi connessione con la ex Cirielli, il lodo Alfano, e la depenalizzazione del falso in bilancio, solo per citare qualche “idea sulla giustizia” di Forza Italia, partito fondato da Marcello Dell’Utri, detenuto a Rebibbia dopo la condanna in via definitiva per concorso esterno. Vale la pena di ricordare che Berlusconi - tra le altre cose - è stato lungamente indagato come mandante a volto coperto delle stragi del 1992 e 1993. “So che ci sono fermenti di procure che ricominciano a guardare a fatti del ’92, ’93, ’94: follia pura. Quello che mi fa male è che c’è chi sta cospirando contro di noi“, disse invece il leader di Forza Italia da presidente del consiglio in carica, quando la procura di Caltanissetta riaprì le indagini sulla strage di via d’Amelio, depistate dal falso pentito Vincenzo Scarantino.
D’altra parte è sempre uno dei governi di Berlusconi che nel 2003 inserì un comma in Finanziaria per concedere al giudice Corrado Carnevale di essere reintegrato, recuperando gli anni di contributi pensionistici persi a causa delle inchieste a suo carico. Carnevale era stato lo storico presidente della prima corte di Cassazione che nel 1992 avrebbe dovuto giudicare le sentenze del primo Maxi processo a Cosa nostra. Per il gran numero di annullamenti decisi negli anni precedenti si era guadagnato un soprannome evocativo: l’Ammazzasentenze. Ed è per evitare di ammazzare pure gli ergastoli del primo Maxi processo che Falcone - nel frattempo approdato alla direzione degli Affari Penali del ministero della Giustizia - ottenne l’applicazione di un criterio di rotazione per i casi di mafia approdati alla Suprema corte. Carnevale non la prese bene. “I motivi per cui me ne sono andato non sono quelli di pressione di quel cretino di Falcone: perché i morti li rispetto, ma certi morti no“, diceva in una conversazione l’8 marzo del 1994, a meno di due anni dalla strage di Capaci. Un’intercettazione in cui il giudice non risparmia neanche la moglie di Falcone, Francesca Morvillo. “Io sono convinto che la mafia abbia voluto uccidere anche la moglie di Falcone che stava alla prima sezione penale della Corte d’Appello di Palermo per farle fare i processi che gli interessavano per fregare qualche mafioso“, dirà senza un minimo di compassione per la coppia appena assassinata da Cosa nostra.
Il risentimento dell’Ammazzasentenze - Quando il 10 novembre dello stesso anno gli investigatori gli danno lettura di quelle conversazioni, l’Ammazzasentenze confida: “Devo ammettere che io ho avuto del risentimento nei confronti del dottor Falcone”. Gli chiedono: “Neppure dopo la morte di Falcone si è placato quel suo grave risentimento?”. “No, devo ammettere di no”. Processato per concorso esterno, Carnevale è stato assolto in primo grado, condannato in appello a sei anni, prosciolto definitivamente in Cassazione. Dopo l’assoluzione torna a fare il giudice della corte di Cassazione, pensa di ricandidarsi come presidente della prima sezione ma lascia perdere. Poteva rimanere in servizio fino al 2015, ma decide di andare in pensione nel 2013 quando ha ormai 83 anni. Alcuni mesi dopo va a testimoniare al processo Capaci bis - quello nato dalle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza - e dice incredibilmente: “Non ho mai parlato di Falcone, non avevo motivo per farlo”. Ai giornalisti del Foglio e del Giornale che lo vanno a trovare a casa per intervistarlo invece racconta: “La casta a cui appartengo fin dal primo momento non mi ha visto di buon occhio. Temevano che potessi salire tanto in alto da influire sul loro lassismo. È la logica dell’invidia“.
Ha azzerato praticamente gli interventi mediatici Vincenzo Geraci, altro nome che ha un ruolo nella carriera di Giovanni Falcone, perché insieme al magistrato siciliano era presente ai primi interrogatori di Tommaso Buscetta. Anni dopo Geraci è tra i consiglieri del Csm che la sera del 19 gennaio del 1988 bocciano la nomina di Falcone a capo dell’ufficio istruzione di Palermo. Era lo stesso posto ricoperto da Antonino Caponnetto, l’inventore del pool antimafia: sembrava scontato che la successione toccasse a Falcone. “Se da un lato, infatti, le notorie doti di Falcone e i rapporti personali e professionali che coltivo con lui mi indurrebbero a preferirlo nella scelta, a ciò mi è però dì ostacolo la personalità di Meli, cui l’altissimo e silenzioso senso del dovere, costò in tempi drammatici la deportazione nei campi di concentramento della Polonia e della Germania, dove egli rimase prigioniero per due anni. In tali condizioni vi chiedo pertanto di comprendere con quanta sofferenza e umiltà mi sento portato ad esprimere il mio voto di favore”, dirà Geraci annunciando il suo sostegno alla candidatura dell’anziano Antonino Meli: di mafia sapeva poco o nulla ma era stato internato dai tedeschi. Venne nominato consigliere istruttore con 14 voti a favore, 10 contrari (tra i quali Gian Carlo Caselli) e 5 astenuti.
“Un giuda ci ha traditi” - “Quando Giovanni Falcone, solo per continuare il suo lavoro, propose la sua aspirazione a succedere ad Antonino Caponnetto, il Csm, con motivazioni risibili gli preferì il consigliere Antonino Meli. Falcone concorse, qualche Giuda si impegnò subito a prenderlo in giro, e il giorno del mio compleanno il Csm ci fece questo regalo. Gli preferì Antonino Meli”, si sfogherà Paolo Borsellino, nel suo ultimo intervento pubblico il 25 giugno del 1992. Borsellino non indicherà mai chi fosse quel Giuda: venne ucciso, infatti, meno di tre settimane dopo quell’intervento. Molti anni dopo, quindi, quando il giornalista Rino Giacalone tirerà in ballo Geraci, quest’ultimo lo querelerà per diffamazione. Oggi Geraci è procuratore generale aggiunto della Cassazione: in pratica è il vice di Pasquale Ciccolo, titolare dell’azione disciplinare nei confronti dei magistrati.
Il Corvo senza nome - Sempre per rimanere nel campo delle toghe non si può non citare il famoso caso del Corvo di Palermo, l’anonimo autore di lettere in cui si accusava Falcone di avere gestito illegalmente il pentito Totuccio Contorno: addirittura di averlo chiamato a Palermo per mandarlo a caccia dei boss del clan dei corleonesi. Accusato di essere il Corvo fu il giudice Alberto Di Pisa, condannato in primo grado a un anno a sei mesi e poi assolto definitivamente nel 1993. L’identità del Corvo non sarà mai individuata mentre tra i detrattori di Falcone si possono annoverare anche personaggi estranei alla magistratura. A cominciare magari da semplici e normali privati cittadini.
“Spostate i magistrati in periferia” - La Palermo in cui ha vissuto Giovanni Falcone era molto diversa dalla Palermo che si è svegliata dopo quello che i mafiosi battezzarono come l’Attentatuni. Un esempio? Una lettera pubblicata dal Giornale di Sicilia negli anni ’80. A scriverla è una donna che abita nelle vicinanze del condominio in cui Falcone fa ritorno ogni sera, blindato dalle auto della scorta. Il motivo della missiva? “Regolarmente tutti i giorni, al mattino, nel primissimo pomeriggio e la sera, vengo letteralmente assillata da continue e assordanti sirene di auto della polizia che scortano i vari giudici. Ora mi domando: è mai possibile che non si possa eventualmente riposare un poco nell’intervallo del lavoro? O quanto meno seguire un programma televisivo in pace?”; scriveva la vicina di casa del giudice che poi lanciava un invito: “Perché i magistrati non si trasferiscono in villette alla periferia della città, in modo tale che sia tutelata la tranquillità di noi cittadini lavoratori e l’incolumità di noi tutti, che nel caso di un attentato siamo regolarmente coinvolti senza ragione”. Parole che fanno un certo effetto. Soprattutto oggi che l’albero Falcone - nei pressi dell’abitazione del magistrato - sarà invaso da persone arrivate a Palermo da tutta Italia.
L’attacco in diretta tv - Le cose per Falcone non andavano meglio quando accettava di partecipare a qualche trasmissione televisiva. Nota, anzi notissima, è la puntata che Michele Santoro e Maurizio Costanzo dedicano in tandem alla memoria dell’imprenditore Libero Grassi, ucciso nell’agosto del 1991. In studio tra gli ospiti c’è il giudice palermitano, attaccato più volte in quell’occasione da personaggi che avranno storie future completamente diverse. “Falcone ha dichiarato che è notorio che l’onorevole Salvo Lima utilizzava la macchina degli esattori Salvo”, è l’intervento - in collegamento da Palermo - di Leoluca Orlando. “C’era bisogno che lo dicessi io perché si sapesse dei rapporti tra i Salvo e i Lima”, risponde Falcone, raccogliendo la replica dell’allora leader della Rete. “Ecco un’ulteriore conferma“, dice in diretta televisiva Orlando, che in pratica accusava Falcone di non aver perseguito volontariamente l’europarlamentare della Dc. Quelle accuse a Falcone saranno rinfacciata per anni al primo cittadino palermitano, il quale chiederà poi scusa per le sue parole.
 Quella trasmissione, però, è passata alla storia anche per l’intervento di Totò Cuffaro. “Ho assistito ad una volgare aggressione alla classe migliore che abbia la Democrazia Cristiana in Sicilia. Il giornalismo mafioso che è stato fatto stasera fa più male di dieci anni delitti”, è una parte dello sfogo del futuro governatore della Sicilia, poi condannato in via definitiva per favoreggiamento alla mafia. Per il video di
quell’intervento - intitolato su youtube “Totò Cuffaro aggredisce Giovanni Falcone” - l’ex presidente siciliano ha querelato Antonio Di Pietro, che lo aveva postato sul suo blog: il tribunale gli ha dato ragione.
Quella trasmissione, però, è passata alla storia anche per l’intervento di Totò Cuffaro. “Ho assistito ad una volgare aggressione alla classe migliore che abbia la Democrazia Cristiana in Sicilia. Il giornalismo mafioso che è stato fatto stasera fa più male di dieci anni delitti”, è una parte dello sfogo del futuro governatore della Sicilia, poi condannato in via definitiva per favoreggiamento alla mafia. Per il video di
quell’intervento - intitolato su youtube “Totò Cuffaro aggredisce Giovanni Falcone” - l’ex presidente siciliano ha querelato Antonio Di Pietro, che lo aveva postato sul suo blog: il tribunale gli ha dato ragione.“Giovanni vattene da Roma” - E se oggi tutti concordano nel valutare come un salto di qualità nella lotta alla mafia il passaggio di Falcone a Roma per dirigere gli Affari Penali del ministero di Grazia e Giustizia, così non era in quel 1992. “Secondo me Falcone farebbe bene ad andarsene il più presto possibile dai palazzi ministeriali, perché l’aria non gli fa bene proprio“, disse l’avvocato Alfredo Galasso nella stessa puntata del Maurizio Costanzo Show, nota per l’esordio televisivo di Cuffaro. “Questo mi sembra scarso senso dello Stato. Al ministero di Grazia e Giustizia ci sono posti espressamente previsti per i magistrati”, fu la replica di Falcone, attaccato spesso per il suo trasferimento a Roma anche in altre salotti televisivi. “Noi abbiamo imparato a conoscerla quando viveva barricato laggiù e forse l’abbiamo un po’ mitizzata. Adesso che sta al ministero e che scrive editoriali sulla Stampa, le sue posizioni sembrano più morbide, più sfumate. Non vorrei dire che ci ha un po’ deluso negli ultimi tempi ma sicuramente è cambiato: lei lo sa? Ne è consapevole?”, gli chiede il 12 gennaio del 1992 Corrado Augias durante una puntata di Telefono Giallo. Una trasmissione che passa alla storia soprattutto per la domanda posta da una componente del pubblico. “Lei - chiederà una donna a Falcone - dice nel suo libro che in Sicilia si muore perché si è soli. Giacché lei fortunatamente è ancora con noi: chi la protegge?” La reazione del magistrato è amara: “Questo vuol dire che per essere credibili bisogna essere ammazzati?”
Critiche asprissime arriveranno a Falcone nello stesso periodo anche sulla stampa. È il momento in cui il magistrato siciliano è candidato a dirigere la cosiddetta Superprocura (cioè la procura nazionale antimafia) e il poliziotto Gianni De Gennaro la Dia. Lino Jannuzzi, però, sul Giornale di Napoli li indicherà come i “maggiori responsabili della debacle dello Stato di fronte alla mafia... una coppia la cui strategia, passati i primi momenti di ubriacatura per il pentitismo e i maxi-processi, ha approdato al più completo fallimento. Da oggi, o da domani, dovremo guardarci da due Cosa Nostra, quella che ha la Cupola a Palermo e quella che sta per insediarsi a Roma. E sarà prudente tenere a portata di mano il passaporto”.
Jannuzzi in seguito sarà senatore di Forza Italia per ben due legislature. In precedenza, tra l’altro - lo ricorda Caselli sul Fatto Quotidiano di qualche giorno fa - erano stati altri due futuri parlamentari di centrodestra ad attaccare Falcone dalle colonne del Giornale e del Giornale di Sicilia: Ombretta Fumagalli Carulli e Guido Lo Porto. Nei loro articoli il maxi-processo viene definito un “un processo-contenitore abnorme, un meccanismo spacciato come giuridico”, mentre i procedimenti genericamente contro Cosa nostra vengono bollati come “messinscene dimostrative, destinate a polverizzarsi sotto i colpi di quel po’ che è rimasto dello Stato di diritto”, “montature” allestite dai “registi del grande spettacolo della lotta alla mafia”.
“Un mediocre pubblicista” - Gli opinionisti non saranno teneri neanche quando Falcone darà alle stampe un libro - Cose di Cosa nostra - scritto alla fine del 1991 insieme a Marcelle Padovani. “Scorrendo il libro-intervista di Falcone, “Cose di cosa nostra”, s’avverte (anche per il concorso di una intervistatrice adorante) proprio questo: l’eruzione di una vanità, d’una spinta a descriversi, a celebrarsi, come se ne colgono nelle interviste del ministro De Michelis o dei guitti televisivi”, scriverà Sandro Viola in un’editoriale durissimo pubblicato da Repubblica il 9 gennaio del 1992. “A Falcone non saranno necessarie, ma a me servirebbero, invece, due o tre particolari illuminazioni: così da capire, o avvicinarmi a capire, come mai un valoroso magistrato desideri essere un mediocre pubblicista“, sarà la chiusa di quell’articolo, che oggi è quasi introvabile online. Come i nemici di Falcone: attivissimi quando il giudice era vivo, evaporati dopo il botto di Capaci. E in qualche caso diventati amici intimi del magistrato assassinato. Ma - ovviamente - soltanto post mortem.
*Il Fatto Quotidiano, 23 maggio 2017 (ripresa parziale - senza immagini).
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. -- PROVARE PER CREDERE: RILEGGERE "I PROMESSI SPOSI" E "IL FONDAMENTALISTA RILUTTANTE"!!!23 maggio 2017, di Federico La Sala
I "PROMESSI SPOSI": DON RODRIGO, DON ABBONDIO, E QUEL "RAMO D’ORO" DEL LAGO DI COMO! Liberare gli studenti dalla "boria" dei "sapientissimi" proff. e dalle sapientissime proff.!!!
- Già ai suoi tempi, Collodi aveva capito che gli italiani e le italiane non sapevano più di cosa parla una *fiaba* (Vladimir Ja. Propp) e non sapevano più nemmeno raccontarla... E CE LO GRIDAVA IN FACCIA!!!
 Italo Calvino aveva capito la lezione di Collodi e perciò cercò di mettere in salvo le "Fiabe italiane"! Nella *fiaba*, infatti, è nascosta la chiave stessa della nostra dignità di esseri umani, della nostra sovranità, della sovranità di cittadini e di cittadine di una sana e robusta Costituzione (art. 3)!!! (Federico La Sala)
Italo Calvino aveva capito la lezione di Collodi e perciò cercò di mettere in salvo le "Fiabe italiane"! Nella *fiaba*, infatti, è nascosta la chiave stessa della nostra dignità di esseri umani, della nostra sovranità, della sovranità di cittadini e di cittadine di una sana e robusta Costituzione (art. 3)!!! (Federico La Sala)
- DONNE, UOMINI E VIOLENZA. L’importanza della lezione dei "PROMESSI SPOSI", oggi.
- "ERODE" E LE GERARCHIE CATTOLICO-ROMANE CONTRO CRISTO E "CONTRO CESARE. Cristianesimo e totalitarismo nell’epoca dei fascismi". Il lavoro di Emilio Gentile, recensito da Riccardo Chiaberge
“Liberiamo gli studenti dai Promessi sposi”
La noia di leggere Manzoni a quindici anni
I "Promessi sposi" sono testo obbligatorio dal 1870. Ora docenti come Giunta e Gardini, e scrittori come Camilleri, Terranova e Trevi chiedono di cambiare. Per salvare le prossime generazioni di lettori
di Marco Filoni ("pagina 99", 19 maggio 2017)
Facciamo un esperimento. Provate a immaginare una sensazione, un’immagine che vi torna alla mente dei Promessi sposi. D’accordo, a tutti più o meno risuona il famoso incipit Quel ramo del Lago di Como... Ma provate a far emergere dai vostri ricordi qualcosa che più che a mezzogiorno “volge” alle vostre emozioni. -Siate sinceri: pensate a un misto di noia e fastidio? Bene, la cosa non deve preoccuparvi. Fatti salvi gli studiosi, rientrate nella quasi totalità della popolazione italiana che, a scuola, ha letto le pagine dei Promessi sposi. Lo chiamano “effetto-Manzoni” e, secondo molti, sarebbe alla base di una successiva ripulsa verso la letteratura di molti giovani.
C’è però una considerazione che forse è arrivato il momento di fare. Ovvero: quanto questo romanzo ottocentesco (la prima versione è del 1827, la sua edizione definitiva uscì fra il 1840 e il 1842) è davvero costitutivo del carattere nazionale dell’Italia?
La domanda non suoni peregrina. Se la sono posta allo scoccar d’ogni decennio funzionari ministeriali, scrittori e insegnanti dal 1870 in poi - alternando elogi delle pagine manzoniane a severi giudizi sulla loro utilità, proponendo alternative (le Confessioni di un ottuagenario di Ippolito Nievo nel 1922, fra gli altri) e netti rifiuti (come Giosuè Carducci «perché dalla lingua dei Promessi sposi a certa broda di fagioli non c’è traghetto e dall’ammagliamento logico dello stile e discorso manzoniani alle sfilacciature di calza sfatta di cotesti piccoli bracaloni c’è di mezzo un abisso di ridicolo»).
Sul nuovo numero di pagina99, in edicola e in versione digitale, pubblichiamo una lista dei libri che sono le letture obbligatorie in differenti Paesi del mondo (compilata da Daryl Chen e Laura McClure per il sito dei Ted Talks). Perché sapere cosa un Paese fa leggere ai suoi giovani ci dice qualcosa di quel Paese. Prendiamo la Germania, dove si legge Il diario di Anna Frank (scritto in olandese, non in tedesco). Per non dire dei molti Paesi che fanno leggere romanzi scritti negli ultimi decenni: per esempio il Pakistan che propone Il fondamentalista riluttante di Mohsin Hamid (2007).
Verrebbe da chiedersi, con Italo Calvino, cos’è oggi un classico... E nel rispondere a questa domanda ci vorrebbe forse un po’ di coraggio per superare un certo familismo culturale che investe la nostra società: i nostri padri vogliono che studiamo le stesse cose che hanno studiato loro, così come noi vogliamo che i nostri figli studino quello su cui siamo incappati noi stessi. Una sorta di immobilismo che ritroviamo esplicitato nelle così dette riforme della scuola italiana, alla cui crisi si accompagna una mancanza di coraggio (ricordate don Abbondio?) forse insita nel nostro patrimonio culturale...
- LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). Un omaggio a Kurt H. Wolff e a Barrington Moore Jr.
(federico la sala)
- Già ai suoi tempi, Collodi aveva capito che gli italiani e le italiane non sapevano più di cosa parla una *fiaba* (Vladimir Ja. Propp) e non sapevano più nemmeno raccontarla... E CE LO GRIDAVA IN FACCIA!!!
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. -- Storiografia in crisi d’identità. Cattolicismi e totalitalitarismi nell’epoca dei fascismi.22 maggio 2017, di Federico La Sala
Storiografia in crisi d’identità ...
- "ERODE" E LE GERARCHIE CATTOLICO-ROMANE CONTRO CRISTO E "CONTRO CESARE. Cristianesimo e totalitarismo nell’epoca dei fascismi". Il lavoro di Emilio Gentile, recensito da Riccardo Chiaberge
RENZO DE FELICE E LA STORIA DEL FASCISMO: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"!
 I. BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI - II. ARNALDO MUSSOLINI E MADDALENA SANTORO.
I. BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI - II. ARNALDO MUSSOLINI E MADDALENA SANTORO. -
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- IMPARARE A CONTARE! "Realismo Metafisica Modernità" - oggi.20 febbraio 2017, di Federico La Sala
MATEMATICA E REALTÀ. "Realismo Metafisica Modernità" *
FILOSOFIA, MATEMATICA E REALTA’: IMPARARE A CONTARE!!! Una nota in memoria di PRIMO MORONI ...
PLAUDENDO AL VOSTRO "SPECIALE MATEMATICA E REALTÀ", in ottima corrispondenza con l’incontro filosofico del 22 pv (“Realismo Metafisica Modernità”, Aula Biblioteca Guglielmo Marconi - Piazzale Aldo Moro 7, Roma),
PREMESSO CHE il “LOGOS” non è un “NUMERO” (cfr. CONTARE E PENSARE... http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=4963) e, convinto che occorra legare insieme FILOSOFIA E ANTROPOLOGIA (cfr. ATENE/EUROPA ... https://www.alfabeta2.it/2017/02/16/ateneeuropa-volare-sullabisso/#comment-625400),
COME CONTRIBUTO al lavoro della Redazione di ALFABETA2 e del SUO CANTIERE, ripropongo qui UNA DOMANDA AI MATEMATICI: COME MAI “UN UOMO PIU’ UNA DONNA HA PRODOTTO, PER SECOLI, UN UOMO”?! Non è il caso di ripensare i fondamenti?! (http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=3995)
 e un mio breve lavoro
e un mio breve lavoroin memoria di PRIMO MORONI:
CHI SIAMO NOI, IN REALTÀ?! RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE (http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=4198).
BUON-LAVORO!!!
Federico La Sala (18.02.2017)
2)
MATEMATICA, REALTÀ, E CREATIVITÀ. Un omaggio ad “Alfabeta - 1”, “Alfabeta - 2“, e un contributo ai lavori del Cantiere ...
Realismo e Metafisica. A voler rendere meno sintetico ed ellittico il discorso, e a raccordare l’ieri con l’oggi, “ALFABETA 1” con “ALFABETA 2” e il CANTIERE, mi sia consentito richiamare, due miei interventi: il primo sugli atti di un convegno eccezionale sugli “stati generali” del realismo scientifico e filosofico - LIVELLI DI REALTÀ (“Alfabeta”, 66, 1984) e, insieme, il secondo sul “grande scontro” tra razionalismo fondazionalistico e razionalità antifondazionalistica - FILOSOFI CATTOLICI IN POLEMICA (“Alfabeta”, 108, 1988), intorno al lavoro del filosofo cattolico Dario Antiseri, vicino al “pensiero debole” ieri e vicino a studiosi e ricercatori (cfr. il suo contributo “L’universo incerto della ragione umana”, nel volume collettaneo “I modi della razionalità”, Mimesis Edizioni, 2016, pp. 29-45) di questi anni recenti, sino ad oggi.
REALISMO E MODERNITÀ. RIPRENDENDO A “CONTARE”, e portando alla luce del sole (dalla caverna o, se si vuole, da “interi millenni” di labirinto) il legame profondo tra filosofia, matematica, e antropologia, si arriva a comprendere di nuovo e meglio che della razionalità, come dell’essere, si può parlare “in molti modi” - non in un solo modo (quello mono-logico ed ego-latrico, con le sue platonizzanti pretese: “Io, Platone, sono la Verità”). E, altrettanto, come sia possibile riportare - FILOSOFICAMENTE E ANTROPOLOGICAMENTE - la vita e la ricerca sulla strada aperta da ARISTOTELE (al di là di ogni tomistica e neotomistica illusione: http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=3617#forum3121791) e illuminata da KANT (oltre ogni scetticismo e ogni idealismo-materialismo: http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=4829), definitivamente, fuori dall’orizzonte della creatività “andropologica” dell’ “uomo supremo”, del “superuomo” e della sua società a “una” dimensione.
 N.B. - L’uscita dallo “stato di minorità” è all’ordine del giorno già dal 1784...
N.B. - L’uscita dallo “stato di minorità” è all’ordine del giorno già dal 1784...BUON-LAVORO!!!
Federico La Sala (19.02.2017)
* DUE NOTE A MARGINE DELLO "SPECIALE MATEMATICA E REALTÀ" DI ALFABETA2.
-
> IMPARARE A CONTARE! "Realismo Metafisica Modernità" - oggi -- La critica dell’economia politica capitalistica e l’economia di comunione di papa Bergoglio.20 febbraio 2017, di Federico La Sala
- GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
L’altra economia di Bergoglio
di Paolo Cacciari (eddyburg, 10 febbraio 2017)
- A commento del clamoroso (e silenziato) discorso di Jorge Mario Bergoglio del 4 febbraio scorso ecco una valutazione dell’assoluta e dirompente novità delle affermazioni del Papa e delle indicazioni che offre a chi si propone di costruire un’altra economia.
Papa Bergoglio con un discorso pronunciato in Vaticano il 4 febbraio scorso ha compiuto un passo decisivo nella definizione del suo pensiero in materia di economia. L’occasione è stata un’udienza con il movimento dell’Economia di Comunione che si ispira a Chiara Lubich, un’imprenditrice che negli anni ’70 in Brasile dette vita ad esperimenti di imprese organizzate in “cittadelle” industriali che si sono date la regola di ripartire i profitti a beneficio dei dipendenti e di “coloro che sono nel bisogno”. Anche in Italia, a Loppiano in Toscana, esiste un Polo produttivo di imprese che seguono i principi dell’Economia di comunione e una Scuola di Economia civile coordinata dall’economista Luigino Bruni.
La novità del discorso di Bergoglio, rispetto alla stessa enciclica Laudato si’ (Papa Francesco, Laudato si’. Enciclica sulla cura della casa comune, Edizioni San Paolo, 2015) e a tutta la Dottrina sociale della Chiesa (Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, Compendio della Dottrina sociale della Chiesa, Libreria Editrice Vaticana, 2004), è che questa volta il Papa non si è limitato a denunciare i peccati (gli eccessi, gli effetti collaterali indesiderati) dell’economia, ma ha chiamato il peccatore per nome: il capitalismo. “Quando il capitalismo fa della ricerca del profitto l’unico suo scopo, rischia di diventare una struttura idolatrica, una forma di culto”. E ancora: “Il capitalismo continua a produrre scarti”, cioè poveri, emarginati, esclusi dalla società. Non mi pare che dalla Chiesa romana sia mai giunta una condanna così esplicita del capitalismo.
Vediamo alcuni passaggi dell’impegnativo discorso pubblicato sull’Avvenire di domenica 5 febbraio con il significativo titolo di prima pagina a 4 colonne: “Altra economia, ora”. Gli imprenditori che applicano i principi e le regole dell’“economia di comunione” operano un “profondo cambiamento del modo di vedere e di vivere l’impresa. L’impresa non solo può non distruggere la comunione tra le persone, ma può edificarla, può promuoverla”. Tre i temi scelti: il denaro, la povertà e il futuro.
Sul denaro Bergoglio ricorda il Gesù di Giovanni della cacciata dei mercanti dal tempio e prosegue con un bagno di realismo: “Il denaro è importante, soprattutto quando non c’è e da esso dipende il cibo, la scuola, il futuro dei figli. Ma diventa idolo quando diventa il fine (...) [quando] l’accumulo di denaro per sé diventa il fine del proprio agire”.
La soluzione: “Il modo migliore e più concreto per non fare del denaro un idolo è condividerlo con altri”. Per Bergoglio la lotta alla povertà (“curare, sfamare, istruire i poveri”) ha bisogno di istituzioni pubbliche efficaci fondate sulla solidarietà e il reciproco soccorso. Qui sta “la ragione delle tasse” come forma di solidarietà e la condanna morale all’“elusione e alla evasione fiscale”.
Ma attenzione, l’assistenza ai bisognosi non deve servire a nascondere le cause della povertà: “questo non lo si dirà mai abbastanza - il capitalismo continua a produrre gli scarti che poi vorrebbe curare. Il principale problema etico di questo capitalismo è la creazione di scarti per poi cercare di nasconderli o curarli per non farli più vedere”.
Il ragionamento di Bergoglio riguarda il funzionamento dell’economia in senso generale e ridicolizza i puerili tentativi con cui un certo capitalismo tenta di riparare i danni arrecati alle persone e all’ambiente naturale. Lo scritto è davvero magistrale: “Gli aerei inquinano l’atmosfera, ma con una piccola parte dei soldi del biglietto piantano alberi, per compensare parte del danno arrecato. Le società dell’azzardo finanziano campagne per curare i giocatori patologici che esse creano. E il giorno in cui le imprese di armi finanzieranno ospedali per curare i bambini mutilati dalle loro bombe, il sistema avrà raggiunto il suo culmine. Questa è ipocrisia!”.
Più avanti precisa: “Il capitalismo conosce la filantropia non la comunione”. Leggendo queste parole a me sono venute in mente tanta parte della cooperazione internazionale, la fondazione Bill&Melinda Gates che pretende di insegnare agli africani come vivere, ma anche le illusioni distribuite a piene mani dalle industrie della green economy, dai “fondi di investimento etici”, dei certificati di Responsabilità sociale delle imprese e così via, tentando di umanizzare il capitalismo.
Prosegue quindi Bergoglio più chiaro che mai, quasi a voler richiamare i suoi bravi interlocutori imprenditori dell’economia di comunione ad un impegno ancora più profondo: “Bisogna allora puntare a cambiare le regole del gioco del sistema economico-sociale. Imitare il buon Sammaritano non è sufficiente”. E ancora: “Occorre agire soprattutto prima che l’uomo si imbatta nei briganti, combattendo le strutture del peccato che producono briganti e vittime”. Verso la fine torna sul concetto: è necessario “cambiare le strutture per prevenire la creazione delle vittime e degli scarti”.
Infine il tema del futuro; come comportarsi per apportare cambiamenti.“Non occorre essere in molti per cambiare la nostra vita”, dice Bergoglio. “Piccoli gruppi” possono funzionare da seme, sale ed enzima per il lievito. “Tutte le volte che le persone, i popoli e persino la Chiesa hanno pensato di salvare il mondo crescendo nei numeri, hanno prodotto strutture di potere, dimenticando i poveri”. Dono e amore, reciprocità e condivisione sono le leve del cambiamento. “Il ‘no’ ad un’economia che uccide diventi un ‘sì’ ad un’economia che fa vivere”, conclude. Per quanti si occupano in vario modo e in varie forme di economia solidale questo discorso del Papa appare molto incoraggiante.
Papa: capitalismo scarta i più deboli, no a evasione e gioco d’azzardo
di Jorge Maria Bergoglio (eddyburg, 08.02.2017)
- Papa Francesco osa adoperare parole e condannare ideologie che neppure la "sinistra" adopera più. Radiovaticana online, 7 febbraio 2017
«Sconfiggere l’idolatria del denaro alimentata da un’economia centrata solo sul profitto. E’ il monito lanciato da Francesco nell’udienza ai partecipanti all’Incontro "Economia di Comunione", promosso dal Movimento dei Focolari. Il Papa ha messo in guardia dal “sistema dell’azzardo” che sta distruggendo milioni di famiglie. Ancora ha affermato che l’evasione fiscale viola la legge “basilare della vita”: “il reciproco soccorso”. Infine, ha esortato a mettere sempre la persona, soprattutto se debole o povera, al centro del sistema economico. Il servizio di Alessandro Gisotti:
Unire “economia e comunione”, raccogliendo l’invito di Chiara Lubich. Papa Francesco ha sottolineato l’importanza dell’esperienza promossa dal Movimento dei Focolari, 25 anni fa in Brasile. E subito ha constatato con amarezza che la cultura attuale tende a separare l’economia e la comunione con conseguenze disastrose.
No al capitalismo che fa del denaro un idolo, contrastare sistema dell’azzardo
Innanzitutto, ha avvertito, bisogna guardarsi dal fare del denaro un idolo. “Il denaro - ha tenuto a precisare - è importante, soprattutto quando non c’è e da esso dipende il cibo, la scuola, il futuro dei figli. Ma diventa idolo quando diventa il fine”:
“Quando il capitalismo fa della ricerca del profitto l’unico suo scopo, rischia di diventare una struttura idolatrica, una forma di culto. La ’dea fortuna’ è sempre più la nuova divinità di una certa finanza e di tutto quel sistema dell’azzardo che sta distruggendo milioni di famiglie del mondo, e che voi giustamente contrastate. Questo culto idolatrico è un surrogato della vita eterna. I singoli prodotti (le auto, i telefoni...) invecchiano e si consumano, ma se ho il denaro o il credito posso acquistarne immediatamente altri, illudendomi di vincere la morte”.
Ecco perché, ha soggiunto, è di grande “valore etico e spirituale” la “scelta di mettere i profitti in comune”. E ha soggiunto che “il modo migliore e più concreto per non fare del denaro un idolo è condividerlo con altri, soprattutto con i poveri”. Ricordarsi sempre, ha soggiunto, che non si possono servire due signori, due padroni e che “il diavolo entra dalle tasche”.
L’evasione delle tasse viola la legge basilare del reciproco soccorso
Ha così rivolto il pensiero al tema della povertà. Il Papa ha rilevato che ci sono sempre state forme di aiuto verso i poveri ma nonostante gli aiuti, gli scarti della società “restavano molti”:
“Oggi abbiamo inventato altri modi per curare, sfamare, istruire i poveri, e alcuni dei semi della Bibbia sono fioriti in istituzioni più efficaci di quelle antiche. La ragione delle tasse sta anche in questa solidarietà, che viene negata dall’evasione ed elusione fiscale, che, prima di essere atti illegali sono atti che negano la legge basilare della vita: il reciproco soccorso”.
Il capitalismo crea scarti e non riesce più a vedere i suoi poveri
Francesco ha così denunciato che il capitalismo “continua a produrre gli scarti che poi vorrebbe curare”. “Il principale problema etico di questo capitalismo - ha ripreso - è la creazione di scarti per poi cercare di nasconderli o curarli per non farli più vedere. Una grave forma di povertà di una civiltà è non riuscire a vedere più i suoi poveri, che prima vengono scartati e poi nascosti”:
“Gli aerei inquinano l’atmosfera, ma con una piccola parte dei soldi del biglietto pianteranno alberi, per compensare parte del danno creato. Le società dell’azzardo finanziano campagne per curare i giocatori patologici che esse creano. E il giorno in cui le imprese di armi finanzieranno ospedali per curare i bambini mutilati dalle loro bombe, il sistema avrà raggiunto il suo culmine. Questa è l’ipocrisia!”.
A tutto questo, ha affermato, si contrappone l’economia di comunione che non scarta mai la persona. Per il Papa, “bisogna allora puntare a cambiare le regole del gioco del sistema economico-sociale”, non basta comportarsi come buoni samaritani. E ha sottolineato che il grande lavoro da svolgere è “cercare di non perdere il principio attivo” che anima l’economia di comunione, puntando sulla qualità, non sulla quantità:
“Tutte le volte che le persone, i popoli e persino la Chiesa hanno pensato di salvare il mondo crescendo nei numeri, hanno prodotto strutture di potere, dimenticando i poveri. Salviamo la nostra economia, restando semplicemente sale e lievito: un lavoro difficile, perché tutto decade con il passare del tempo”.
Mettere al centro la comunione, il capitalismo conosce solo la filantropia
“L’economia di comunione - ha ripreso - avrà futuro se la donerete a tutti e non resterà solo dentro la vostra ‘casa’. Donatela a tutti, e prima ai poveri e ai giovani, che sono quelli che più ne hanno bisogno”, perché “il denaro non salva se non è accompagnato dal dono della persona”:
“Il capitalismo conosce la filantropia, non la comunione. È semplice donare una parte dei profitti, senza abbracciare e toccare le persone che ricevono quelle ’briciole’. Invece, anche solo cinque pani e due pesci possono sfamare le folle se sono la condivisione di tutta la nostra vita. Nella logica del Vangelo, se non si dona tutto non si dona mai abbastanza”.
“Il ’no’ ad un’economia che uccide - ha concluso Francesco - diventi un ’sì’ ad una economia che fa vivere, perché condivide, include i poveri, usa i profitti per creare comunione”.
-
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. -- I PATTI LATERANENSI E LA POLITICA E LA TEOLOGIA, OGGI.12 febbraio 2017, di Federico La Sala
I PATTI LATERANENSI, MADDALENA SANTORO, E LA PROVVIDENZA. Una nota sul Nicola Fanizza, "Maddalena Santoro e Arnaldo Mussolini. La storia d’amore che il duce voleva cancellare"
I POLITICI SI SONO FATTI TEOLOGI E LA TEOLOGIA, IN SENSO PROPRIO, NON PARLA PIU’. Una riflessione di Paolo Prodi.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. - Il Comma 22 del sistema politico italiano - e la psefologia (di Paolo Pombeni).6 febbraio 2017, di Federico La Sala
COSTITUZIONE E PENSIERO. ITALIA: LA MISERIA DELLA FILOSOFIA ITALIANA E LA RICCHEZZA DEL MENTITORE ISTITUZIONALIZZATO ...
Il Comma 22 del sistema politico italiano
di Paolo Pombeni (Il Mulino, 06 febbraio 2017)
Vista dall’esterno la attuale situazione politica sembra descrivibile come il famoso Comma 22. Infatti da un lato ci sono quelli che invocano elezioni nel più breve tempo possibile, perché c’è una situazione in cui senza un saldo governo sono scarse le prospettive di avere reazioni efficaci per affrontare i molti problemi che ci affliggono. Dal lato opposto ci sono quelli che ci avvertono che il risultato di un ricorso rapido alle urne sarebbe un parlamento incapace di produrre qualsiasi governo dotato della necessaria saldezza. Il Comma 22 sta, come da tradizione, nel fatto che hanno ragione entrambi.
Come se ne esce? Questa sarebbe la vera domanda da porsi. Al momento si assiste solo a un estenuante gioco di tattica in cui i contendenti fanno più che altro delle «finte», giusto per ingannare gli avversari e per trarre profitto da questo.
Sul fatto che la situazione sia difficile, se non difficilissima, c’è un certo consenso. Del resto basta guardare all’economia, fra disoccupazione, crisi bancarie, conflitto sul bilancio con la Commissione europea. Come se tutto ciò non bastasse, c’è un ricco contorno di preoccupazioni, tanto sul fronte nazionale quanto su quello internazionale. Dunque che serva un governo in grado di farsene carico è pacifico.
L’attuale esecutivo può rispondere a queste sfide? Già qui la risposta si complica: in parte sì, in parte no. Sì, perché non mancano i ministri capaci, perché il presidente del Consiglio è persona equilibrata, perché ci sono in atto interventi che possono andare nella giusta direzione. No, perché non tutti i ministri sono capaci (prezzo pagato al continuismo con il governo Renzi), perché al presidente del Consiglio sembra mancare il guizzo di leadership necessario a dominare una platea indisciplinata, ma soprattutto perché non ha un sostegno convinto da parte di una maggioranza che è più impegnata a farsi una guerra intestina senza quartiere che a dare linfa all’azione riformatrice necessaria (e tacciamo di una opposizione che pensa solo allo sfascio, o a quello sfrontato alla Salvini-Grillo & Co., o a quello soft del tramonto berlusconiano).
Veniamo all’alternativa elettorale. I fari sono puntati su stucchevoli dibattiti circa le tecnicalità che potrebbero produrre una legge elettorale che facesse il miracolo di assestare la distribuzione del consenso. Sono piuttosto rari quelli che ricordano alla pletora dei nostri psefologi, professionisti o dilettanti che siano, che i sistemi elettorali possono organizzare la realtà, ma non sono in grado di crearne una diversa. Il problema infatti è, come si suol dire, nel manico. Infatti il sistema che produce opinione (parlare di cultura politica è eccessivo) è tutto preso nel vortice delle lotte di fazione e delle «narrazioni», o, se volete un termine più à la page, delle «post verità» che queste producono.
Che la diatriba fra renziani e antirenziani sia davvero un dibattito fra destra e sinistra fa sorridere e in ogni caso nessuno dei due campi spiega quale sarebbe il progetto di risoluzione dei nostri problemi che ha in mente. Quelle che sentiamo sono tautologie: noi siamo i buoni e di conseguenza diamo buone ricette che porteranno buoni frutti. Amen.
E che dire dei vari dibattiti dei grillini, dei cosiddetti «sovranisti», e via elencando? Ogni tanto vediamo che esibiscono qualche tecnico che fa calcoli economici. Noi siamo digiuni della materia, ma ci permettiamo di ricordare che non si fanno i calcoli senza l’oste, cioè che sono tutte argomentazioni che non tengono conto del fatto che intorno a noi c’è un mondo complicato che non ci lascerà agire come sarebbe meglio, ma che è molto intenzionato a farcela pagare (e qualche indizio ci sembra di coglierlo).
In queste condizioni il ricorso alle urne è ovviamente rischioso perché abbiamo davanti due scenari. Il primo è che continui il trend per cui il Paese si dividerà dietro tutte le varie narrazioni e post verità che gli stanno propinando, dando vita a un sistema corporativizzato e feudalizzato in perenne, endemico conflitto, dove decidere diventerà molto difficile se non impossibile. Il secondo è che i cittadini, stanchi o inorriditi da questa prospettiva, scelgano di mettersi nelle mani di qualcuno che abbia il potere per creare un unico punto di riferimento. È possibile. E in genere non viene scelto il migliore e il più saggio.
Per assurdo che possa sembrare, l’unica via d’uscita razionale, per quanto estremamente difficile sarebbe poter contare su un responsabile movimento di rigetto dell’universo di faide tra tribù politiche e populismi d’accatto che sembra in procinto, quello sì, di stabilizzarsi. Non si tratta astrattamente di contrapporre società civile e società politica, perché posta così la questione è evanescente. Si tratta di operare perché i ceti dirigenti di questo Paese riprendano in mano la formazione della coscienza collettiva costringendo la componente politica che hanno dentro a uscire dall’autoreferenzialità dei propri scontri e a produrre nuovi quadri capaci di mettersi su questa lunghezza d’onda (chi non è capace di farlo merita di essere rottamato).
Se non ci si riuscirà, non facciamoci illusioni: torneremo ad essere, come all’inizio del XVI secolo, il Paese che ha tante cose belle, ma che cadrà preda del mondo che ci circonda, con buona pace di tutti, dei sovranisti e di quelli che sono rimasti alla sinistra luddista.
COME ALL’INIZIO DEL XVI SECOLO ....
MICHELANGELO E LA SISTINA (1512-2012). I PROFETI INSIEME ALLE SIBILLE PER LA CHIESA UN GROSSO PROBLEMA ....
 DOPO 500 ANNI, PER IL CARDINALE RAVASI LA PRESENZA DELLE SIBILLE NELLA SISTINA E’ ANCORA L’ELEMENTO PIU’ CURIOSO. Materiali sul tema, per approfondimenti
DOPO 500 ANNI, PER IL CARDINALE RAVASI LA PRESENZA DELLE SIBILLE NELLA SISTINA E’ ANCORA L’ELEMENTO PIU’ CURIOSO. Materiali sul tema, per approfondimenti -
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. -- IL POPULISMO DELLA POST-VERITA’, EPIMENIDE, E LA LEZIONE ITALO-AMERICANA28 gennaio 2017, di Federico La Sala
UNA RISPOSTA A "SPECIALE C17":
IL POPULISMO DELLA POST-VERITA’, EPIMENIDE, E LA LEZIONE ITALO-AMERICANA. In memoria di Italo Calvino *
Siamo nella post-verità da sempre, a quanto pare!
SIAMO PROPRIO CONCIATI MALE, MALISSIMO!
Dopo ventanni di berlusconismo stiamo ancora a commentare i giochini di mentitori istituzionalizzati. E a riflettere sulle "spine del C17 - spine nel fianco di un pingue potere" (https://www.alfabeta2.it/2017/01/21/c17-spine-nel-fianco-un-pingue-potere/).
DOPO IL 1917, E DOPO IL 1922, ANCORA NON SAPPIAMO NULLA DELLA "MORTE NERA" (cfr.: Massimo Palma,"Waler Benjamin, l’inquilino in nero", cfr.: https://www.alfabeta2.it/2017/01/11/walter-benjamin-linquilino-nero/) E DELLA MISTICA FASCISTA (cfr.: mia nota a "Infanzia salentina", pagine del lavoro di Nicola Fanizza, "Maddalena Santoro e Arnaldo Mussolini" - https://www.nazioneindiana.com/2017/01/21/infanzia-salentina/).
Tanto tempo fa, in un’isola del Mediterraneo, un tale chiamato EPIMENIDE (con questo nome è rimasto nella storia, come persona degna di essere ricordata per la sopravvivenza della stessa isola), indignato contro i suoi stessi concittadini (che evidentemente lo accusavano di chissà quali malefatte), fece il primo passo nella terra della post-verità, gridò infuriato: "Tutti i cretesi mentono"! Se molti risero, altrettanto molti lo applaudirono.
Qualche anno dopo, sempre in quell’isola, ci furono le elezioni: tra i partiti (quello che la storia non ci ha tramandato) comparve uno strano partito, con il nome "Forza Creta", e il leader era proprio il vecchio EPIMENIDE!
CONQUISTATO IL POTERE LEGALMENTE, IL SUO GRIDO AI CRETESI CHE AVEVANO RISO DELLA SUA "BATTUTA" FU QUASI SIMILE A QUELLO DI BRENNO CONTRO I ROMANI SORPRESI NEL SONNO, ANZI, NEL SONNAMBULISMO: "GUAI AI VINTI"!
SOLO CHE A ROMA CI FURONO LE OCHE CHE SVEGLIARONO UN POCO TUTTI E I GALLI FURONO CACCIATI, MA A CRETA ALLA FINE NESSUNO PIU’ OSO’ RIDERE E ... "TUTTI I CRETESI MENTONO" ANCORA!!! A MEMORIA (E A VERGOGNA) ETERNA.
Federico La Sala
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. -- AUSCHWITZ, DOPO AUSCHWITZ. Viktor Frankl, L’amore per la vita, nonostante tutto3 febbraio 2017, di Federico La Sala
- AUSCHWITZ, QUEL GIORNO (di Luigina D’Emilio): Primo Levi, La tregua: "La prima pattuglia russa giunse in vista del campo verso il mezzogiorno del 27 gennaio 1945. Fummo Charles ed io i primi a scorgerla (...)"
DOPO AUSCHWITZ. Dialogo tra un teologo e uno psicologo: Pinchas Lapide e Viktor Frankl. "Entrambi ebrei, entrambi sopravvissuti ai lager: e l’Olocausto sempre lì, con i suoi interrogativi" (Marco Roncalli)
- Auschwitz: Drone video of Nazi concentration camp Nella Giornata della memoria vale davvero la pena condividere queste straordinarie immagini girate dalla BBC nel 2015, in occasione del 70esimo anniversario della liberazione del campo di concentramento di Birkenau, ad Auschwitz in Polonia. Il sito oggi è patrimonio dell’Unesco e viene visitato ogni anno da migliaia di persone, tra cui sopravvissuti all’eccidio nazista. Più di un milione di prigionieri - di cui la maggior parte ebrei - persero la vita in questo campo di sterminio tra il 1940 e il 1945 (Pisa Pier Luigi Pisa, 27 gennaio 2016).
Viktor Frankl, L’amore per la vita, nonostante tutto. Si riproduce l’introduzione a Viktor E. Frankl, L’uomo alla ricerca di senso. Uno psicologo nei Lager e altri scritti inediti (Daniele Bruzzone - Alfabeta2, 27.01.2017)
-
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- LA VERGOGNA DI PARLARE SENZA VERGOGNA (di Tullio De Mauro)6 gennaio 2017, di Federico La Sala
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. -- Una vera e ineludibile questione “politica” (di Stefano Rodotà).18 dicembre 2016, di Federico La Sala
- Costituzione, art. 54 - Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
L’etica perduta della politica
di STEFANO RODOTÀ (la Repubblica, 17 Dicembre 2016)
TRA una politica che fatica a presentarsi in forme accettabili dai cittadini e un populismo che di essa vuole liberarsi, bisogna riaffermare una “moralità” delle regole attinta a quella cultura costituzionale diffusa la cui emersione costituisce una rilevantissima novità.
Mai nella storia della Repubblica vi era stata pari attenzione dei cittadini per la Costituzione, per la sua funzione, per il modo in cui incide sul confronto politico e le dinamiche sociali. I cittadini ne erano stati lontani, non l’avevano sentita come cosa propria. Nell’ultimo periodo, invece, si sono moltiplicate le occasioni in cui proprio il riferimento forte alla Costituzione è stato utilizzato per determinare la prevalenza tra gli interessi in conflitto.
Dobbiamo ricordare che nell’articolo 54 della Costituzione sono scritte le parole “disciplina e onore”, vincolando ad esse il comportamento dei «cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche». I costituenti erano consapevoli del fatto che il ricorso al diritto non consente di economizzare l’etica. Non si affidarono soltanto al rigore delle regole formali, ma alla costruzione di un ambiente civile all’interno del quale potessero essere esercitate le “virtù repubblicane”. Colti e lungimiranti, guardavano alla storia e al futuro. Non avevano solo memoria del fascismo. Rivolgevano lo sguardo ad un passato più lontano, anch’esso inquietante: agli anni del “mostruoso connubio” tra politica e amministrazione denunciato da Silvio Spaventa.
Così la questione “morale” si presenta come vera e ineludibile questione “politica”. Lo aveva messo in evidenza in passato Enrico Berlinguer. L’intransigenza morale può non piacere, ma la sua ripulsa non può divenire la via che conduce a girare la testa di fronte a fatti di corruzione anche gravi. Altrimenti la caduta dell’etica pubblica diviene un potente incentivo al diffondersi dell’illegalità e a una sua legittimazione sociale.
In questi anni il degrado politico e civile è aumentato. È cresciuto il livello della corruzione, in troppi casi la reazione ai comportamenti devianti non è stata adeguata alla loro gravità. Tra i diversi soggetti che istituzionalmente dovrebbero esercitare forme di controllo, questa attività si è venuta concentrando quasi solo nella magistratura. Ma la scelta del ceto politico di legare ad una sentenza definitiva qualsiasi forma di sanzione può produrre due conseguenze negative. Non solo la sanzione si allontana nel tempo, ma rischia di non arrivare mai, perché non tutti comportamenti censurabili politicamente o moralmente costituiscono reato.
Non ci si è accorti dell’ampliamento del ruolo che da ciò derivava per la magistratura, eletta a unico e definitivo “tribunale della politica”. E questo non è un segno di buona salute, perché i sistemi politici riescono a mantenere equilibri democratici solo quando vi è il concorso di tutti i soggetti istituzionali ai quali questi equilibri sono affidati.
È stata dunque la politica stessa ad affidarsi ai giudici come “decisori finali”, azzerando in questo modo per se stessa i vincoli di moralità e di responsabilità propriamente politica. Ma questa constatazione porta ad un interrogativo: come restituire alla politica l’etica perduta?
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- Il sogno del "regno di ‘dio’" in un solo ‘paese’ è finito.17 dicembre 2016, di Federico La Sala
LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. Cattolicesimo, fascismo, nazismo, stalinismo: il sogno del "regno di ‘dio’" in un solo ‘paese’ è finito. *:
Gli 80 anni del papa
Papa Francesco che cammina sulle tracce di Agostino
di EUGENIO SCALFARI (la Repubblica, 17 dicembre 2016)
COMPIE ottant’anni papa Francesco e li porta molto bene, sia fisicamente e sia spiritualmente. Viaggia continuamente nel mondo intero e nelle parrocchie romane. Di Roma è vescovo e questa qualifica la rivendica spesso perché gli consente di definirsi come “primus inter pares” e lui è consapevole di quanto sia utile a quella Chiesa missionaria da lui realizzata.
Personalmente ho avuto la fortuna di diventargli amico ancorché io non sia un credente. Papa Francesco aveva bisogno di un non credente che approvasse la predicazione di quello che lui chiama Gesù Cristo ed io chiamo Gesù di Nazareth figlio di Maria e di Giuseppe della tribù di David, cioè era figlio dell’uomo e non di Dio. Ma su questo modo di considerare Cristo papa Francesco è d’accordo: il Figlio di Dio quando decide di incarnarsi diventa realmente un uomo con tutte le passioni, le debolezze, le virtù d’un uomo. Francesco racconta spesso la settimana della Passione che ha il suo inizio con l’ingresso quasi trionfale di Gesù a Gerusalemme, seguito da molti dei suoi fedeli e naturalmente dei suoi apostoli. Ma a Gerusalemme trova anche quelli che lo temono e lo odiano. Soprattutto la gerarchia ebraica del Tempio che si sente minacciata nei suoi privilegi.
A quell’epoca Israele era sotto la "protezione" dell’impero di Roma e l’imperatore era Tiberio che nulla sapeva di quanto avvenisse in province assai lontane. Papa Francesco ricorda gli ultimi giorni di quella che poi fu chiamata la "Via Crucis", l’ultima cena e poi quel che avvenne nell’orto di Getsemani. Gli apostoli a quella cena erano tredici ma uno di loro, Giuda Iscariota, lo aveva già tradito e quando Gesù cominciò a parlare abbandonò quel tavolo e andò via. Restarono in dodici e fu lì che Gesù condivise il pane e il vino identificandoli con il suo corpo e il suo sangue. Il Signore era già stato battezzato da Giovanni nelle acque del Giordano e battesimo ed eucarestia furono i soli due Sacramenti; gli altri vennero dopo. La natura umana del Cristo si ha nei racconti dei Vangeli, nel Getsemani e poi sulla Croce. Nell’orto, dove sarà poi arrestato dai soldati romani guidati dall’Iscariota, Gesù entra in contatto con il Padre e dice: «Se tu puoi allontana da me questo amaro calice ma se non vuoi lo berrò fino in fondo». Sulla Croce, negli ultimi istanti prima della morte dice: «Padre, perché mi hai abbandonato?». Quindi era un uomo, l’incarnazione era stata reale.
- Scalfari: "Gli 80 anni del mio Papa rivoluzionario"
Papa Francesco è affascinato da questi racconti. Mi sono chiesto e gli ho chiesto il perché del fascino che esercitano su di lui e la risposta è stata che nel mistero trinitario Cristo rappresenta l’amore in tutte le sue manifestazioni. L’amore verso Dio che si trasforma in amore verso il prossimo. «Ama il prossimo tuo come te stesso» è una legittimazione dell’amore all’individuo e alla comunità, in cerchi concentrici: la famiglia, il luogo dove vive e soprattutto la specie cui appartiene.
Francesco indica i poveri, i bisognosi, gli ammalati, i migranti. Francesco sa bene quello che dice la Bibbia: «I ricchi e i potenti debbono passare per la cruna d’un ago per guadagnare il Paradiso». Occorre dunque che i popoli si integrino con gli altri popoli. Si va verso un meticciato universale che sarà un beneficio, avvicinerà i costumi, le religioni. Il Dio unico sarà finalmente una realtà. È questo che Francesco auspica. «È ovvio che sia unico, ma finora non è stato così. Ciascuno ha il suo Dio e questo alimenta il fondamentalismo, le guerre, il terrorismo. Perfino i cristiani si sono differenziati, gli Ortodossi sono diversi dai Luterani, i protestanti si dividono in migliaia di diverse confessioni, gli scismi hanno accresciuto queste divisioni. Del resto noi cattolici siamo stati invasi dal temporalismo, a cominciare dalle Crociate e dalle guerre di religione che hanno insanguinato l’Europa e l’America del Nord e del Sud. Il fenomeno della schiavitù e la tratta degli schiavi, la loro vendita alle aste. Questa è stata la realtà che ha deturpato la storia del mondo».
Quando papa Francesco ha partecipato alla celebrazione di Martin Lutero e della sua Riforma ha colto l’essenza delle tesi luterane: l’identificazione dei fedeli con Dio non ha bisogno dell’intermediazione del clero ma avviene direttamente. Questo ci conduce al Dio unico e assegna al sacerdozio un ruolo secondario. Così avveniva nei primi secoli del cristianesimo, quando i Sacramenti erano direttamente celebrati dai fedeli e i presbiteri facevano soltanto il servizio. Francesco è d’accordo su queste tesi luterane che coincidono con quanto avvenne nei primi secoli.
- Bergoglio racconta Bergoglio: gli 80 anni del Papa
Ma quali sono i Santi che il nostro Papa predilige? Gliel’ho chiesto e lui mi ha risposto così: «Il primo è naturalmente Paolo. È lui ad aver costruito la nostra religione. La Comunità di Gerusalemme guidata da Pietro si definiva ebraico-cristiana, ma Paolo consigliò che bisognava abbandonare l’ebraismo e dedicarsi alla diffusione del cristianesimo tra i Gentili, cioè ai pagani. Pietro lo seguì in questa sua concezione anche se Paolo non aveva mai visto Gesù. Non era un apostolo, eppure si considerò tale e Pietro lo riconobbe. Il secondo è San Giovanni Evangelista, che scrisse il quarto Vangelo, il più bello di tutti. Il terzo è Gregorio, l’esponente della Patristica e della liturgia.
 Il quarto è Agostino, vescovo di Ippona, educato adeguatamente da Ambrogio vescovo di Milano. Agostino parlò della Grazia, che tocca tutte le anime e le predispone al bene compatibilmente con il libero arbitrio. La libertà accresce il valore del bene e condiziona il suo eventuale abbandono.
Il quarto è Agostino, vescovo di Ippona, educato adeguatamente da Ambrogio vescovo di Milano. Agostino parlò della Grazia, che tocca tutte le anime e le predispone al bene compatibilmente con il libero arbitrio. La libertà accresce il valore del bene e condiziona il suo eventuale abbandono.Ebbene, sembrerà che io esageri ma ne sono fermamente convinto: dopo Agostino viene papa Francesco. L’intervallo temporale è enorme, ma la sostanza è quella. L’ho definito, quando l’ho conosciuto, rivoluzionario e profetico ma anche modernissimo.
In uno dei nostri incontri gli chiesi se pensava di convocare un nuovo Concilio e lui rispose: «Un Concilio no: il Vaticano II, avvenuto cinquant’anni fa, ha lasciato una precettistica che in buona parte è stata applicata da Giovanni Paolo II, da Paolo VI e da Benedetto XVI. Ma c’è un punto che non ha fatto passi avanti ed è quello che riguarda il confronto con la modernità. Spetta a me colmare questa lacuna. La Chiesa deve modernizzarsi profondamente nelle sue strutture ed anche nella sua cultura».
Santità - ho obiettato io - la modernità non crede nell’Assoluto. Non esiste la verità assoluta. Lei dovrà dunque confrontarsi con il relativismo. «Infatti. Per me esiste l’Assoluto, la nostra fede ci porta a credere nel Dio trascendente, creatore dell’Universo. Tuttavia ciascuno di noi ha un relativismo personale, i cloni non esistono. Ognuno di noi ha una propria visione dell’Assoluto da questo punto di vista il relativismo c’è e si colloca a fianco della nostra fede».
Buoni ottant’anni, caro Francesco. Continuo a pensare che dopo Agostino viene Lei. È una ricchezza spirituale per tutti, credenti o non credenti che siano.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE:
KANT E SAN PAOLO. COME IL BUON GIUDIZIO ("SECUNDA PETRI") VIENE (E VENNE) RIDOTTO IN STATO DI MINORITA’ DAL GIUDIZIO FALSO E BUGIARDO ("SECUNDA PAULI").
UN NUOVO CONCILIO, SUBITO. 95 TESI? NE BASTA UNA SOLA! Cattolicesimo, fascismo, nazismo, stalinismo: il sogno del "regno di ‘dio’" in un solo ‘paese’ è finito.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.
Federico La Sala
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. -- La moneta sonante delle promesse. Una bussola ler leggere la crisi (di Christian Marazzi)16 dicembre 2016, di Federico La Sala
"Deus caritas est" (2006).
Sul Vaticano, in Piazza san Pietro, il "Logo" del Grande Mercante!!!
Cultura
La moneta sonante delle promesse
Saggi. La filosofia del linguaggio usata per leggere la crisi. Un sentiero di lettura a partire dal rapporto tra la teoria degli atti enunciativi e i prodotti derivati messo a fuoco ne «Scommettere sulle parole» di Arjun Appadurai (Raffaello Cortina). Mentre la natura linguistica del denaro analizzata da Ferruccio Rossi-Landi è vista come una bussola per orientarsi nel capitalismo postfordista
di Christian Marazzi (il manifesto, 15.12.2016)
Ancora non si è insediato alla Casa Bianca e già le parole di Donald Trump su come intende make America great again stanno modificando radicalmente gli equilibri monetari e finanziari globali che in qualche modo si erano venuti normalizzando nel corso degli ultimi anni. Parole enunciate in forma di promessa, come in qualsiasi campagna elettorale, ma parole basate sul nulla che, nel momento stesso in cui Trump ha vinto le elezioni, hanno assunto legittimità e potere, a tal punto da invertire le scelte degli investitori, modificando la grammatica finanziaria che d’ora in poi plasmerà il mondo.
Per rilanciare la crescita economica americana,Trump ha promesso un forte stimolo fiscale con la riduzione delle imposte sugli alti redditi e sul capitale e con l’aumento della spesa pubblica per investimenti infrastrutturali. Queste due misure portano diritti all’aumento dei deficit pubblici e di conseguenza all’aumento dei tassi di interesse. In tale prospettiva, gli investitori si precipitano a vendere i titoli a reddito fisso, in particolare i Buoni del Tesoro, i cui tassi d’interesse, cioè i rendimenti, sono inversamente proporzionali al loro prezzo. E infatti i rendimenti dei bonds, dei titoli obbligazionari americani, inglesi e giapponesi, sono subito aumentati.
IN PROSPETTIVA di una crescita più robusta e di politiche monetarie restrittive, il dollaro si sta rivalutando rispetto a tulle le altre monete, a quelle dei paesi emergenti in particolare. Se così sarà, saranno i settori industriali orientati all’esportazione che verranno penalizzati. La pressione per aumentare le tariffe alle importazioni, promesse da Trump, non mancherà di farsi sentire.
E non è detto che a trarne vantaggio saranno i ceti medi e bassi, dato che il potere d’acquisto dei loro redditi è aumentato in questi anni proprio grazie ai beni low cost importati da paesi come la Cina. Il settore più esposto alla globalizzazione, quello tecnologico, è quello che più rischia dalla rivalutazione del dollaro. I profitti statunitensi realizzati all’estero diminuirebbero, vanificando i vantaggi derivanti dagli sgravi fiscali.
Molti vedono una ripetizione di quel che accadde nel corso dei primi quattro anni di presidenza di Ronald Reagan, dato che allora l’aumento del debito federale e gli alti tassi d’interesse provocarono una tale rivalutazione del dollaro e una tale pressione per erigere barriere tariffarie, che solo il Plaza Accord del 1985 per indebolire il dollaro riuscì a bloccare.
Nell’economia globalizzata di oggi, con le tensioni geopolitiche che l’attraversano, è poco probabile che una rivalutazione del dollaro potrà essere domata con la stipulazione di accordi internazionali. Porterà, piuttosto, all’acuirsi dei conflitti tra la pluralità di aree economiche che in questi decenni si sono consolidate.
IL DENARO torna così ad essere la spia di cambiamenti economici e sociali destinati a durare nel tempo, un campo di battaglia in cui si gioca la possibilità stessa di costruire lotte e resistenze contro gli effetti del ripiegamento sulla sovranità monetaria nazionale. Ma si tratta di un denaro che in questi decenni è mutato nella sua stessa natura, un denaro in cui la dimensione linguistica ha assunto una centralità inedita.
Del divenire linguistico del denaro, del fatto, come ebbe a dire Ben Bernanke, già presidente della Federal Reserve, che «La politica monetaria è per il 98% parole e per il 2% azione», parlano due libri recenti: Gli oracoli della moneta. L’arte della parola nel linguaggio dei banchieri centrali, di Alberto Orioli (il Mulino, pp. 248, euro 16) e Scommettere sulle parole. Il cedimento del linguaggio nell’epoca della finanza, di Arjun Appadurai (Raffaello Cortina Editore, pp. 197, euro 21).
Per Orioli, nelle politiche monetarie degli ultimi due decenni gli «atti di parole», gli speech acts, riflettono un cambiamento radicale nella gestione delle informazioni, il fatto che la parola è ormai diventata azione. Quando denaro e linguaggio coincidono si ha a che fare con la teoria degli enunciati performativi del filosofo del linguaggio John Austin, di cui il titolo dell’opera fondamentale, Fare cose con le parole, è di per sé alquanto significativo. Si tratta di enunciati in cui il solo dire qualcosa rende vero questo qualcosa. Esemplare a questo proposito è il whatever it takes, quel «qualunque cosa necessaria» pronunciato da Mario Draghi nel 2012 per rassicurare i mercati finanziari e, come di fatto accadde, salvare l’Euro dal tracollo.
PIÙ IN GENERALE, con le politiche di quantitative easing e, prima ancora, di forward guidance, le Banche centrali dichiarano quel che si farà e si continuerà a fare, aggiustando in corso d’opera la durata e l’entità delle politiche di emissione monetaria per stimolare la domanda aggregata e la crescita in generale, come sta facendo in questi giorni la Bce. Col rischio, come nel caso della trappola della liquidità quando si inceppano i meccanismi di trasmissione della politica monetaria, che si incorra nell’altra trappola, quella verbale. La qual cosa è pericolosa, perché le spalle dei banchieri centrali «possono sopportare solo ciò che la fiducia concede alle loro parole».
ANCHE APPADURAI - figura intellettuale rilevante nel campo dei postcolonial studies e autore dei rilevanti Modernità in polvere e Il futuro come fatto culturale, entrambi riproposta da Raffello Cortina - parte dal ruolo nuovo che il linguaggio ha assunto nei mercati monetari e finanziari. La sua analisi si concentra però sui prodotti derivati: «Un prodotto derivato si può definire come un asset il cui valore dipende da quello di un altro asset sottostante, il quale può essere a sua volta un prodotto derivato. In questa catena di collaterali che la finanza dei nostri giorni ha prolungato all’infinito un prodotto derivato finisce per costituire fondamentalmente un fenomeno di tipo linguistico».
La catena degli scambi di questi prodotti finanziari, e i contratti che sulla loro base vengono stipulati, si basano sulla promessa relativa a valori futuri fondamentalmente ignoti. E’ così che «La dispersione e disseminazione all’infinito delle promesse, unita alla monetizzazione dell’intera serie, ha indotto una clamorosa incongruenza tra l’idea e la realtà del sistema di compravendita di derivati». Da cui la tesi di Appadurai: il crollo finanziario del 2007-2008, a partire dall’esplosione dei derivati legati all’evoluzione del mercato immobiliare statunitense, va inteso in primo luogo come un «crollo linguistico».
BENCHÉ SUGGESTIVA, l’interpretazione della natura linguistica del denaro e dello sviluppo dei prodotti derivati lascia in ombra il fatto che, all’origine degli atti di parole monetari, risiede in primo luogo la svolta linguistica del lavoro, il fatto che nel capitalismo postfordista si lavora comunicando, si producono merci a mezzo di linguaggio. Il denaro è, in altre parole, forma del valore di merci linguisticamente prodotte.
L’insegnamento di Ferruccio Rossi-Landi, oggi riproposto con la pubblicazione di Linguistica ed economia (Mimesis, Milano-Udine), andrebbe tenuto presente per cogliere appieno le implicazioni della crisi monetaria e finanziaria odierna.
Con una precisazione, e cioè che le merci e le parole sono sì entrambi artefatti secondo la teoria del valore-lavoro, come dimostrato da Rossi-Landi, ma non sono ormai più distinguibili in due sfere separate, quella della produzione e quella della circolazione.
La crisi linguistica e monetaria rimandano ad una nuova fase dello scontro sociale in cui ogni promessa non mantenuta sarà pagata cara.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. -- Il paradosso della Costituzione (di Giovanni De Luna)9 dicembre 2016, di Federico La Sala
IL PARADOSSO DELLA COSTITUZIONE:
LA ’NAZIONALIZZAZIONE’ DEL MENTITORE
- UNITÀ D’ITALIA E FOLLIA: EMERGENZA LOGICO-POLITICA EPOCALE. PER UN CONVEGNO E UNA RIFLESSIONE SUL CONCETTO DI ’UNITA’ E DI SOVRANITÀ (SOVRA-UNITÀ). Materiali sul tema
- L’ITALIA (1994-2016), TRE PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA SENZA "PAROLA", E I FURBASTRI CHE SANNO (COSA SIGNIFICA) GRIDARE "FORZA ITALIA". In memoria di Sandro Pertini e di Gioacchino da Fiore, alcuni appunti per i posteri
Il paradosso della Costituzione
Difesa oggi dagli antipartito, 70 anni fa nel mirino degli “apolitici” dell’Uomo Qualunque. Bobbio li definiva il “pantano in cui finirà per impaludarsi il rinnovamento democratico”
di Giovanni De Luna (La Stampa, 09.12.2016)
Il paradosso del referendum del 4 dicembre è questo: la Costituzione del 1948 è stata vittoriosamente difesa dalle forze politiche che ne hanno sempre criticato il carattere «comunista» (Berlusconi e la Lega) o denunciato la fissità «talmudica» (così Grillo, nel 2011 sul suo blog). Il paradosso è anche più evidente se lo si confronta con le polemiche che - tra il 1945 e il 1947 - accompagnarono il varo della Carta Costituzionale.
Allora, il passaggio dalla dittatura alla democrazia fu accolto con sospetto e diffidenza da una larga fetta dell’opinione pubblica, abituata da venti anni di fascismo a considerare la politica una pratica «inconcludente» e incline a guardare agli uomini dei partiti con la diJffidenza dovuta a chi svolgeva «non un’attività disinteressata al servizio della collettività e della nazione, cercando invece di procurare potere, ricchezza, privilegi a sé stesso, alla propria famiglia, fazione, clientela elettorale». Queste frasi - tratte da uno dei tanti rapporti dei carabinieri che allora funzionavano come oggi i sondaggi di opinione - fotografavano un diffuso sentimento «antipartito» che si tradusse negli impetuosi successi elettorali dell’Uomo Qualunque.
La nuova Repubblica
Anche tra le file del Partito d’Azione - al quale oggi viene attribuita la paternità della Costituzione - all’inizio la forma partito era vista con sospetto. La nuova Repubblica che nasceva dalla Resistenza avrebbe dovuto puntare direttamente sugli uomini (con un rinnovamento della classe dirigente) e sulle istituzioni (con un allargamento della partecipazione politica fondata sulle autonomie e sull’autogoverno). Lo scriveva un giovane Norberto Bobbio (non aveva ancora 40 anni): «Una responsabilità pubblica ciascuno può assumerla dentro o fuori dei partiti, secondo le sue capacità e le sue tendenze, e magari meglio fuori che dentro».
Ma proprio i suoi articoli di allora sul quotidiano Giustizia e Libertà ci consentono oggi di capire che intorno alla Costituzione la partita si giocò essenzialmente tra la politica e l’antipolitica, meglio - come si diceva a quel tempo - tra gli «apolitici» e gli uomini dei partiti. Il qualunquismo nascondeva dietro la maschera della «apoliticità» e dell’«indipendenza» una lotta senza quartiere ai partiti del Cln, giudicati come il lascito più significativo e più pericoloso della Resistenza. BJobbio lo diceva esplicitamente: «gli indipendenti [...] non sono né indipendenti, né apolitici. Sono politici, ecco tutto, di una politica che non è quella dei comitati di liberazione o del fronte della Resistenza».
«Vizi tradizionali» italiani
L’«apoliticismo» (per Bobbio «l’indifferenza o addirittura l’irrisione per ogni pubblica attività in nome dell’imperioso dovere di lavorare senza ambizioni né distrazioni per la famiglia, per i figli e soprattutto per sé») si traduceva in una critica alla «politica di partito» che, scriveva, «lusinga e quindi rafforza inveterate abitudini, vizi tradizionali del popolo italiano, incoraggia gli ignavi, fa insuperbire gli ottusi e gli inerti [...], offre infine a tutti gli apolitici un motivo per allearsi, facendo di una folla di isolati una massa organica, se non organizzata, di persone che la pensano allo stesso modo e hanno di fronte lo stesso nemico [...] generando di nuovo quel pantano in cui finirà per impaludarsi lo sforzo di rinnovamento democratico dello Stato italiano».
Per gli uomini della Resistenza il nemico era quindi diventato quella «sorta di alleanza dei senza partito», «scettica di quello scetticismo che è proprio delle classi medie italiane», alimentata «da un dissenso di gusti, un disaccordo di stati d’animo, uno scontro di umori, una gara di orgogli, dai quali null’altro può derivare che invelenimento di passioni, impacci all’azione ricostruttrice».
La Carta strumentalizzata
Sembra che Bobbio parli proprio di quell’estremismo di centro che caratterizza oggi una parte della società italiana e un movimento come quello di Grillo. Allora fu un passaggio decisivo per l’approdo a una sua convinta adesione alla «democrazia dei partiti», frutto di una riflessione approfondita su un «modello», quello inglese, che, partendo dai capisaldi fondamentali delle origini (la divisione dei tre poteri, la monarchia costituzionale e il governo parlamentare), era stato in grado di rinnovarsi, spostando progressivamente verso il basso, verso il corpo elettorale, rappresentato e diretto dai partiti, il baricentro del sistema politico.
Le cifre del referendum del 4 dicembre ci dicono come l’elettorato dei movimenti più tipicamente antipartito (Cinque Stelle e Lega) abbia votato massicciamente per il No (l’80%), affiancato da una ristretta fascia di elettori appartenenti al Pd (23%) o alle varie sigle accampate alla sua sinistra. Essere salvata da quelli che volevano affossarla, adesso come nel 1948: da questo duplice paradosso cronologico la Costituzione esce come schiantata, degradata a puro pretesto, con una torsione innaturale che la espone, in futuro, a ogni tipo di uso strumentale.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. -- REFERENDUM COSTITUZIONALE: IERI E OGGI. Una lezione attuale (di Salvatore Settis): stare sempre in guardia (di Carlo Smuraglia - Anpi).7 dicembre 2016, di Federico La Sala
- DONNE E UOMINI, CITTADINE E CITTADINI. Per un ri-orientamento antropologico e teologico-politico ....
- 25 Giugno 2006: salviamo la Costituzione e la Repubblica che è in noi
- UNITÀ D’ITALIA E FOLLIA: EMERGENZA LOGICO-POLITICA EPOCALE. PER UN CONVEGNO E UNA RIFLESSIONE SUL CONCETTO DI ’UNITA’ E DI SOVRANITÀ (SOVRA-UNITÀ). Materiali sul tema
- IL SONNO MORTIFERO DELL’ITALIA. In Parlamento (ancora!) il Partito al di sopra di tutti i partiti.
Una lezione attualeIl confronto con l’esito del referendum costituzionale del 2006
di Salvatore Settis (la Repubblica, 07.12.2016)
IL DATO più rilevante nei risultati del 4 dicembre emerge dal confronto con l’esito del referendum costituzionale del 2006. In ambo i casi il voto popolare ha respinto una riforma costituzionale assai invasiva (54 articoli modificati nel 2006, 47 nel 2016), approvata a maggioranza semplice da una coalizione di governo che ostentava sicurezza per bocca di un premier (allora Berlusconi, ora Renzi) in cerca di un’investitura plebiscitaria.
Le due riforme abortite non sono identiche, ma vicine in aspetti cruciali (la fiducia riservata alla sola Camera e il nebbioso ruolo del Senato). Se guardiamo ai numeri, il confronto è impressionante: nel 2006 i No furono il 61,29%, nel 2016 il 59,25; quanto ai Sì, si passa dal 38,71% (2006) al 40,05 (2016). Un rapporto di forze simile, che diventa più significativo se pensiamo che l’affluenza 2016 (68,48%) è molto superiore a quella del 2006 (52,46%): allora votarono 26 milioni di elettori, oggi ben 32 milioni, in controtendenza rispetto al crescente astensionismo delle Europee 2014 e delle Regionali dello stesso anno.
Eppure, dal 2006 ad oggi il paesaggio politico è completamente cambiato, per l’ascesa dei 5Stelle, la frammentazione della destra berlusconiana, le fratture di quella che fu la sinistra. Più affluenza oggi di dieci anni fa, un cambio di generazioni, con milioni di giovani che votavano per la prima volta a un referendum costituzionale: eppure, nonostante i mutamenti di scenario, un risultato sostanzialmente identico, con un No intorno al 60%.
Una notevole prova di stabilità di quel “partito della Costituzione” che rifiuta modifiche così estese e confuse. Esso è per sua natura un “partito” trasversale, come lo fu la maggioranza che varò la Costituzione, e che andava da Croce a De Gasperi, Nenni, Calamandrei, Togliatti. Il messaggio per i professionisti della politica è chiaro: non si possono, non si devono fare mai più riforme così estese e con il piccolo margine di una maggioranza di parte.
Nel 2006 e nel 2016, due governi diversissimi hanno cercato di ripetere il discutibile “miracolo” del referendum 2001, quando la riforma del Titolo V (17 articoli) fu approvata con il 64% di Sì contro un No al 36%: ma allora l’affluenza si era fermata al 34% (16 milioni di elettori). Si è visto in seguito che quella riforma, varata dalle Camere con esiguo margine, era mal fatta; e si è capito che astenersi in un referendum costituzionale vuol dire rinunciare alla sovranità popolare, principio supremo dell’articolo 1 della Costituzione.
Per evitare il ripetersi (sarebbe la terza volta) di ogni tentativo di forzare la mano cambiando la Costituzione con esigue maggioranze, la miglior medicina è tornare a un disegno di riforma costituzionale (nr. 2115), firmato nel 1995 da Sergio Mattarella, Giorgio Napolitano, Leopoldo Elia, Franco Bassanini. Esso prevedeva di modificare l’art. 138 Cost. nel senso che ogni riforma della Costituzione debba sempre essere «approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti», e ciò senza rinunciare alla possibilità di ricorrere al referendum popolare.
Questo l’art. 4; ma anche gli altri di quella proposta troppo frettolosamente archiviata sarebbero da rilanciare. L’art. 2 prevedeva che la maggioranza necessaria per eleggere il Presidente della Repubblica debba sempre essere dei due terzi dell’assemblea (l’opposto della defunta proposta Renzi-Boschi, che avrebbe reso possibile l’elezione da parte dei tre quinti dei votanti, senza computare assenti e astenuti); e che qualora l’assemblea non riesca ad eleggere il Capo dello Stato «le funzioni di Presidente della Repubblica sono provvisoriamente assunte dal Presidente della Corte Costituzionale». L’art. 3, prevedendo situazioni di stallo nell’elezione da parte del Parlamento dei membri della Consulta di sua spettanza, prevedeva che dopo tre mesi dalla cessazione di un giudice, se il Parlamento non riesce a eleggere il successore «vi provvede la Corte Costituzionale stessa, a maggioranza assoluta dei suoi componenti». Previsione lungimirante: è fresco il ricordo del lungo stallo delle nomine alla Corte, finché nel dicembre 2015 si riuscì a nominare tre giudici dopo ben 30 tentativi falliti.
In quelle proposte, come si vede, la Corte Costituzionale aveva un ruolo centrale, e il rafforzamento delle istituzioni passava attraverso un innalzamento delle maggioranze necessarie per passaggi istituzionali cruciali, come le riforme costituzionali o l’elezione del Capo dello Stato. In un momento di incertezza come quello che attraversiamo, quella lezione dovrebbe tornare di attualità, anche se molti firmatari di quella legge sembrano essersene dimenticati.
La riforma Renzi-Boschi è stata bocciata, ma fra le sue pesanti eredità resta una cattiva legge elettorale, l’Italicum, che la Consulta potrebbe condannare tra poche settimane, e che comunque vale solo per la Camera. Compito urgente del nuovo governo, chiunque lo presieda, sarà dunque produrre al più presto una legge elettorale finalmente decorosa, e compatibile (si spera) con riforme costituzionali come quelle sopra citate. Le prossime elezioni politiche, anticipate o no, dovranno portare alle Camere deputati e senatori liberamente eletti dai cittadini e non nominati nel retrobottega dei partiti.
Il referendum da cui veniamo è stato un grande banco di prova per la democrazia: ma ora è il momento di mostrare, per i cittadini del No e per quelli del Sì, che sappiamo essere “popolo” senza essere “populisti”. Che per la maggioranza degli italiani la definizione di “popolo”, della sua sovranità e dei suoi (dei nostri) diritti coincide con quella della Costituzione, la sola che abbiamo. Il “ritorno alla Costituzione” che ha segnato i mesi scorsi e che ha portato all’esito del referendum mostra che è possibile.
Smuraglia: è un No per attuare la Costituzione
"Al referendum non hanno vinto i partiti", dice il presidente dell’Anpi. "Leggere la vittoria referendaria del 4 dicembre solo sul terreno del confronto politico è un modo per ridimensionare il risultato popolare"
intervista di Andrea Fabozzi (il manifesto, 7.12.2016)
Carlo Smuraglia, presidente dell’Associazione nazionale partigiani, si aspettava questo successo del No?
Onestamente no. Immaginavo il paese spaccato a metà e speravo in una vittoria con il minimo distacco. Avevo indicazioni molto positive dalle nostre manifestazioni, in particolare l’ultima a Roma al teatro Brancaccio. Ma l’esperienza mi insegna a non fidarmi di quello che si vede nelle piazze e nei teatri, perché è la gente silenziosa che decide il risultato. E c’era da temere la propaganda del governo, le promesse, le proposte e le minacce del presidente del Consiglio, la complicità della stampa con il Sì...
E invece.
Mi ha sorpreso felicemente la grande partecipazione. Avevamo captato questo desiderio di capire e di partecipare, ma forse l’abbiamo persino sottovalutato. Evidentemente i cittadini che si sono informati sulla riforma, l’hanno compresa bene e giudicata male, sono stati la maggioranza. Anche se questa parte ragionata del No, adesso, mi pare messa del tutto tra parentesi, rimossa.
Non le piace come viene raccontata la vittoria del No?
Mi sorprende che tra le tante ragioni della sconfitta del Sì, la più elementare - e cioè che la riforma è stata bocciata nel merito - sia finita nell’ombra. Tutte le analisi sono sul terreno politico, tornano a farsi sentire come vincitori partiti che in campagna elettorale avevamo visto poco. Io credo che leggere il 4 dicembre esclusivamente sul terreno del confronto tra partiti sia un modo per ridimensionare lo straordinario risultato popolare.
Lei invece ci legge il segnale di una speranza? Si può ricominciare a parlare di attuazione della Costituzione?
Noi ne parliamo da sempre e lo abbiamo fatto anche in questa campagna elettorale. Alla fine dei miei incontri c’era sempre chi mi chiedeva “ma se vince il No cosa facciamo?”. E io rispondevo “Prima brindiamo, poi diciamo che invece di cambiarla la Costituzione bisogna attuarla”. A quel punto arrivava l’applauso più forte. Perché tutti vedono l’enorme contrasto che c’è tra i principi fondamentali della Carta e la realtà. Non voglio illudermi, ma credo che dentro questo 60% di No ci sia anche questa richiesta di attuazione.
Insieme a un voto contro il governo, non le pare?
Non per quanto ci ha riguardato. L’ho detto anche a Renzi nel nostro confronto di settembre a Bologna. Non ci è mai interessata la sorte del governo, volevamo solo difendere la Costituzione da uno strappo. Mi pare che lei non sia rimasto contento del modo in cui è stato raccontato quel confronto alla festa dell’Unità. Non sono rimasto contento che sia stato oscurato. Evidentemente non si era concluso come giornali e tv si auguravano, con la vittoria di Renzi.
Secondo lei, adesso, come si viene fuori dalle dimissioni del presidente del Consiglio?
La richiesta di votare presto mi pare infondata. Mancano molti presupposti, innanzitutto la legge elettorale: ne abbiamo due diverse per camera e senato e la prima è attesa al giudizio della Consulta. In più tutti i partiti dicono di volerla cambiare. La corsa alle urne è ingiustificata, il presidente della Repubblica, anche di fronte alle dimissioni di Renzi, ha molti strumenti prima di accettare le elezioni anticipate, provvederà con saggezza.
Questo No mette fine ai tentativi di riscrivere la Costituzione, almeno per un po’?
La Costituzione non è mai messa sufficientemente al riparo e bisogna stare sempre in guardia. Ma un No di questa entità ha anche un valore di ammonimento molto forte, si è capito che la Costituzione non è una legge ordinaria e non si può modificarla a cuor leggero, ma solo quando ce n’è effettivamente bisogno. E con il massimo di consenso.
In campagna elettorale si è parlato molto delle divisioni dell’Anpi. Vicenda chiusa? Lascerà qualche segno tra voi?
I segni sono stati più esterni che interni. Ogni piccola cosa è stata ingigantita e presa per buona, noi non abbiamo mai allontanato né sanzionato nessuno. Abbiamo solo chiesto ai nostri iscritti di non fare campagna per il Sì nel nome dell’Anpi, visto che la nostra posizione era opposta. La verità è che ha dato molto fastidio che l’Anpi si fosse schierata per il No. La nostra associazione è portatrice di valori in cui tutti devono riconoscersi, e dunque a molti abbiamo fatto fare almeno un pensierino.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. -- IL SONNO MORTIFERO DELL’ITALIA E IL REFERENDUM: ZAGREBELSKY, SCALFARI, E LA COSTITUZIONE.3 dicembre 2016, di Federico La Sala
- IL SONNO MORTIFERO DELL’ITALIA. In Parlamento (ancora!) il Partito al di sopra di tutti i partiti.
- SE VADO A CASA DI ZAGREBELSKY E ... COMINCIO A FARE IL MIO COMODO DICENDO DI ESSERE DEL PARTITO "FORZA ZAGREBELSKY", CHE COSA HO FATTO E CHE COSA SONO?! L’ITALIA NON S’E’ DESTATA ED E’ STATA UCCISA!!!
Caro Scalfari, con il Sì passa un’espropriazione di sovranità
di Gustavo Zagrebelsky *
Caro Eugenio Scalfari, ieri mi hai chiamato in causa due volte a proposito del mio orientamento pro-No sul referendum prossimo venturo e, la seconda volta, invitandomi a ripensarci e a passare dalla parte del Sì. La "pessima compagnia", in cui tu dici ch’io mi trovo, dovrebbe indurmi a farlo, anche se, aggiungi, sai che non lo farò. Non dici: "non so se lo farà", ma "so che non lo farà", con il che sottintendi di avere a che fare con uno dalla dura cervice.
I discorsi "sul merito" della riforma, negli ultimi giorni, hanno lasciato il posto a quelli sulla "pessima compagnia". Il merito della riforma, anche a molti di coloro che diconono di votare Sì, ultimo Romano Prodi, appare alquanto disgustoso. Sarebbero piuttosto i cattivi compagni l’argomento principale, argomento che ciascuno dei due fronti ritiene di avere buoni motivi per ritorcere contro l’altro.
Un topos machiavellico è che in politica il fine giustifica i mezzi, cioè che per un buon proposito si può stare anche dalla stessa parte del diavolo. Non è questo. Quel che a me pare è che l’argomento della cattiva compagnia avrebbe valore solo se si credesse che i due schieramenti referendari debbano essere la prefigurazione d’una futura formula di governo del nostro Paese. Non è così. La Costituzione è una cosa, la politica d’ogni giorno un’altra. Si può concordare costituzionalmente e poi confliggere politicamente. Se un larghissimo schieramento di forze politiche eterogenee concorda sulla Costituzione, come avvenne nel ’46-’47, è buona cosa. La lotta politica, poi, è altra cosa e la Costituzione così largamente condivisa alla sua origine valse ad addomesticarla, cioè per l’appunto a costituzionalizzarla. In breve: l’argomento delle cattive compagnie, quale che sia la parte che lo usa, si basa sull’equivoco di confondere la Costituzione con la politica d’ogni giorno.
Vengo, caro Scalfari, a quella che tu vedi come un’ostinazione. Mi aiuta il riferimento che tu stesso fai a Ventotene e al suo "Manifesto", così spesso celebrati a parole e perfino strumentalizzati, come in quella recente grottesca rappresentazione dei tre capi di governo sulla tolda della nave da guerra al largo dell’isola che si scambiano vuote parole e inutili abbracci, lo scorso 22 agosto. C’è nella nostra Costituzione, nella sua prima parte che tutti omaggiano e dicono di non voler toccare, un articolo che, forse, tra tutti è il più ignorato ed è uno dei più importanti, l’articolo 11. Dice che l’Italia consente limitazioni alla propria sovranità quando - solo quando - siano necessarie ad assicurare la pace e la giustizia tra le Nazioni. Lo spirito di Ventotene soffia in queste parole. Guardiamo che cosa è successo. Ci pare che pace e giustizia siano i caratteri del nostro tempo? Io vedo il contrario. Per promuovere l’una e l’altra occorre la politica, e a me pare di vedere che la rete dei condizionamenti in cui anche l’Italia è caduta impedisce proprio questo, a vantaggio d’interessi finanziario-speculativi che tutto hanno in mente, meno che la pace e la giustizia. Guardo certi sostegni alla riforma che provengono da soggetti che non sanno nemmeno che cosa sia il bicameralismo perfetto, il senato delle autonomie, la legislazione a data certa, ecc. eppure si sbracciano a favore della "stabilità". Che cosa significhi stabilità, lo vediamo tutti i giorni: perdurante conformità alle loro aspettative, a pena delle "destabilizzazioni" - chiamiamoli ricatti - che proprio da loro provengono.
Proprio questo è il punto essenziale, al di là del pessimo tessuto normativo che ci viene proposto che, per me, sarebbe di per sé più che sufficiente per votare No. La posta in gioco è grande, molto più grande dei 47 articoli da modificare, e ciò spiega l’enorme, altrimenti sproporzionato spiegamento propagandistico messo in campo da mesi da parte dei fautori del Sì. L’alternativa, per me, è tra subire un’imposizione e un’espropriazione di sovranità a favore d’un governo che ne uscirebbe come il pulcino sotto le ali della chioccia, e affermare l’autonomia del nostro Paese, non per contestare l’apertura all’Europa e alle altre forme di cooperazione internazionale, ma al contrario per ricominciare con le nostre forze, secondo lo spirito della Costituzione. Si dirà: ma ciò esigerebbe una politica conforme e la politica ha bisogno di forze politiche. E dove sono? Sono da costruire, lo ammetto. Ma il No al referendum aprirà una sfida e in ogni sfida c’è un rischio; ma il Sì non l’aprirà nemmeno. Consoliderà soltanto uno stato di subalternità.
Questa, in sintesi, è la ragione per cui io preferisco il No al Sì e perché considero il No innovativo e il Sì conservativo.
Ti ringrazio dell’attenzione. A cose fatte avremo tempo e modo
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- Per dizionario Oxford ’post-verità’ (’post-truth’) è parola del 2016. Scelta fatta sullo sfondo di elezioni Usa e referendum Brexit17 novembre 2016, di Federico La Sala
Per dizionario Oxford ’post-verità’ è parola del 2016
Scelta fatta sullo sfondo di elezioni Usa e referendum Brexit
di Redazione Ansa *
LONDRA E’ ’post verità’, in inglese ’post-truth’, il neologismo dell’anno secondo gli esperti di Oxford Dictionaries. La scelta e’ quella di un’espressione che secondo un comitato di esperti ha segnato profondamente la scena politica internazionale durante il 2016, con riferimento in particolare alle polemiche legate alla campagna referendaria britannica sfociata a giugno nella vittoria della Brexit (il divorzio dall’Ue) e a quella americana per le presidenziali appena culminata nel trionfo di Donald Trump.
L’annuncio è arrivato in queste ore, riporta la Bbc: ’post-truth’ ha prevalso in una short list finale che comprendeva anche termini come ’Brexiteer’ (sostenitore della Brexit). Si tratta, ha sentenziato Casper Grathwohl, fra i curatori dei prestigiosi dizionari editi a Oxford, "di una di quelle parole che definiscono il nostro tempo".
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- È MEGLIO SAPERLO. Siamo in trappola. L’inimicizia tra sconfitti (e lo siamo tutti, in ogni caso) è la peggiore delle cretinate.29 novembre 2016, di Federico La Sala
- COSTITUZIONE, EVANGELO, e NOTTE DELLA REPUBBLICA (1994-2016): PERDERE LA COSCIENZA DELLA LINGUA ("LOGOS") COSTITUZIONALE ED EVANGELICA GENERA MOSTRI ATEI E DEVOTI ...
- COSTITUZIONE E PENSIERO. ITALIA: LA MISERIA DELLA FILOSOFIA ITALIANA E LA RICCHEZZA DEL MENTITORE ISTITUZIONALIZZATO ...
Siamo in trappola. Cosa possiamo fare?
di Franco Berardi Bifo*
Non so a voi ma a me questo referendum mi dà un po’ di angoscia senza esagerare, intendiamoci. La vita mi sorride abbastanza, ma un po’ di angoscia questo referendum me la dà. Le ragioni sono molteplici e cerco di raccontar(me)le. I miei amici litigano fra loro astiosamente, si arriva al punto che qualcuno cancella da Facebook quelli che votano sì, o quelli che votano no. Potrei anche sopportarlo, se si trattasse di una disputa che davvero ci riguarda. Che ne so, se qualcuno votasse a favore del licenziamento degli operai dissenzienti di Pomigliano, se qualcuno votasse a favore della guerra di George Bush e Dick Cheney, beh allora d’accordo, io con un tipo così non ci voglio aver nulla a che fare, che vada a farsi fottere.
Ma qui mi pare che siamo tanto rissosi per la semplice ragione che siamo insicuri, non crediamo davvero a questo referendum a questo sì e a questo no, perciò alziamo tanto la voce, e ci ripetiamo che la costituzione non si tocca oppure che bisogna toccarla eccome.
Chi (come me) vota No non può non sapere che sta votando come Gianfranco Fini, e che se il No è maggioritario si va presto a nuove elezioni in un clima drammatico di collasso finanziario in cui vincitori probabili saranno razzisti ininterrotti come Salvini o razzisti a giorni alterni come Grillo. Chi vota Si non può non sapere che sta rafforzando il potere di un ammiratore di Tony Blair, criminale di guerra, e sta rafforzando il governo del voucher, non può non sapere che una riforma della costituzione non dovrebbe assolutamente essere varata da un governo che non è stato eletto da nessuno, e non può essere imposta alla metà del corpo elettorale.
Chi vota sì non può non sapere che una riforma costituzionale di questo genere spacca per sempre il paese, senza speranza di tornare indietro.
Il fatto è che questo referendum è una trappola costruita da un furbetto che era convinto di stravincere e avere poi tutto il potere con cui asfaltare del tutto i diritti dei lavoratori. Ma siccome il furbetto non è poi così intelligente come fa finta di essere ha fatto male i conti e a un certo punto si è reso conto che non siamo tutti come Letta a cui si può dire “Enrico stai sereno” che ti frego il posto appena ti volti. Una buona parte della popolazione ha deciso di non aspettare serenamente, e di votare no.
I contenuti di questa riforma sono risibili dal punto di vista specificamente costituzionale: nessuno può pensare davvero che il bicameralismo è il problema principale di un paese in cui gli studenti che vogliono studiare vanno all’estero, nessuno può credere che il risparmio di qualche spicciolo per i senatori sarà decisivo per le sorti economiche di un paese che ha perduto un quarto del sistema industriale negli ultimi dieci anni a causa del Fiscal compact e del debito che più lo paghi e più cresce. Questa riforma costituzionale miserella serviva nelle intenzioni del furbetto a sbaragliare ogni opposizione alla riforma vera, che è la riforma interminabile del mercato del lavoro, la privatizzazione infinita l’impoverimento illimitato della società (su questo tema vale la pena rileggere Come pensa la classe dominante di Raúl Zibechi, ndr).
Purtroppo il referendum è una trappola che scatterà in ogni caso. Se vince il sì la società è sbaragliata, e Marchionne ha vinto per sempre. Se vince il No si spalanca un abisso di instabilità finanziaria e politica. Ma se ci penso meglio poi mi rendo conto del fatto che se invece vince il sì l’abisso è solo rimandato di qualche mese, e in qualche mese lo spostamento a destra dell’elettorato è destinato ad accentuarsi.
È meglio saperlo, è meglio dirlo, invece di alzare la voce e cancellare gli amici. Siamo in una trappola, e la sola cosa che possiamo fare è impedire la (provvisoria) stabilizzazione del governo di un tizio che ammira il criminale di guerra Tony Blair e lo schiavista Marchionne.
Siamo in una trappola, e la sola cosa che possiamo fare è prepararci in ogni caso al peggio, e lavorare a un lungo periodo di ricostruzione della prospettiva europeista e anti-finanzista.
Siamo in una trappola, e la sola cosa che possiamo fare è non comportarci come i polli di Renzo Tramaglino, evitare di rompere amicizie in nome di una sconfitta in ogni caso assicurata.
L’inimicizia tra sconfitti (e lo siamo tutti, in ogni caso) è la peggiore delle cretinate.
-
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. -- ELEZIONI USA. Per la Santa Sede, una sconfitta bruciante. Quei cardinali che tifano per Donald (Massimo Franco).11 novembre 2016, di Federico La Sala
- GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Quei cardinali che tifano per Donalddi Massimo Franco (Corriere della Sera, 11.11.2016)
Il Vaticano aveva scelto la strategia del «male minore». E alla fine sembrava così rassegnato alla vittoria di Hillary Rodham Clinton da pensare a lei come alla candidata meno sgradita: sebbene forse non ci credesse fino in fondo. Donald Trump era considerato «non votabile» per le rivelazioni sul suo maschilismo aggressivo, che si aggiungevano alle minacce di deportare oltre il confine sud undici milioni di messicani, di impedire l’entrata negli Usa agli islamici: cose ormai archiviate.
E invece, il presunto «male maggiore» Trump è emerso a furor di popolo come nuovo inquilino della Casa Bianca, a conferma di un’America arrabbiata e radicalizzata.
 E per la Santa Sede si tratta di una sconfitta bruciante: culturale prima che politica. Tra l’altro, è il segno che la Chiesa cattolica non aveva captato i sommovimenti più profondi in atto nel maggiore Paese occidentale.
E per la Santa Sede si tratta di una sconfitta bruciante: culturale prima che politica. Tra l’altro, è il segno che la Chiesa cattolica non aveva captato i sommovimenti più profondi in atto nel maggiore Paese occidentale.La cautela ufficiale e le parole di augurio rivolte al neopresidente dal segretario di Stato vaticano, cardinale Piero Parolin, sono state doverose e ineccepibili. Ma si affiancano a una preoccupazione palpabile. Va detto che sarebbe stata una sconfitta anche se avesse vinto la Clinton, considerata un bastione del laicismo più ideologico e indigesto alle gerarchie ecclesiastiche. Ma Trump è simbolicamente «l’uomo del muro» col Messico. È il cantore della sbrigativa associazione Islam-terrorismo. Ancora, ha vinto dopo essersi presentato come argine «bianco» contro l’invasione demografica degli immigrati latino-americani, di cui l’argentino papa Francesco è il sommo protettore.
Così, a Roma è stato percepito e raffigurato come una sorta di anti Papa, al di là dei suoi meriti e demeriti. Lui stesso, d’altronde, scelse questo ruolo quando il 18 febbraio scorso accusò Jorge Mario Bergoglio di essere «un agente del governo messicano per l’immigrazione». Il Papa tornava da un viaggio al confine tra Messico e Usa, dove aveva celebrato una messa proprio sul versante «povero» . E reagì con una durezza insolita. «Chi pensa che bisogna costruire muri e non ponti», scolpì, «non è cristiano».
«Nessuno sa cosa è rimasto nell’anima di Trump dopo le parole del Santo Padre...», ammette un influente cardinale italiano. Allora, il candidato repubblicano replicò a brutto muso. Oggi, quella domanda rimbalza nella Roma papale, perché il «cristiano non cristiano» Trump dal 20 gennaio sarà alla Casa Bianca. La sua «cultura dei muri» e l’islamofobia minacciano di legittimare tutti i populismi; e soprattutto di fare breccia nei circoli cattolici più conservatori, che diffidano dei toni inclusivi di Bergoglio verso i divorziati e gli omosessuali e della difesa dei migranti.
Non è un caso che il 22 settembre scorso Trump, protestante presbiteriano, abbia diramato una lista di «trentatré cattolici conservatori» come consiglieri elettorali: era un amo elettorale.
L’arcivescovo di New York, Timothy Dolan, ha definito la campagna per le presidenziali «disgustosa», pur invitando i cattolici a non astenersi. E l’episcopato americano si è tenuto su una posizione di formale equidistanza che è suonata come presa di distanza da entrambi i candidati; ma alla fine è apparso disorientato.
Nelle pieghe buie dei sondaggi è cresciuto silenziosamente un «partito di Trump» affezionato al motto «Dio, patria, famiglia e armi», caro all’America profonda; e appoggiato da pezzi di organizzazioni cattoliche potenti come i Cavalieri di Colombo, in quanto contrario all’aborto e alle unioni gay.
Ultimamente, anche in Vaticano si parlava sottovoce dell’esistenza di frange della Curia affascinate da Trump in opposizione alla «laicista Hillary», e come nemico di un establishment logorato dal potere. Si tratta di settori minoritari che però adesso si sentono rafforzati. Capofila è il cardinale Raymond Leo Burke, critico coriaceo delle aperture di Bergoglio: Burke ha già benedetto il neopresidente come «difensore dei valori della Chiesa». Ma dietro di lui si indovinano invisibili benedizioni di cardinali e vescovi di peso, schierati da sempre per la «sacralità della vita»: «guerrieri culturali» contro il Partito democratico di Barack Obama e dei Clinton.
La lotta all’aborto è uno dei punti di incontro fra Trump e l’episcopato cattolico nordamericano, che teme una Corte Suprema e una legislazione troppo progressiste. In più, potrebbe emergere una sintonia con Francesco se fosse confermata una politica più conciliante con la Russia di Putin, che il Vaticano considera un alleato in Medio Oriente e nei rapporti col mondo ortodosso. Al fondo, tuttavia, la vera incognita per Bergoglio rimangono l’Occidente e la sua metamorfosi culturale. «Crediamo che a votare per Trump siano stati pochi vescovi», spiega un profondo conoscitore degli Usa dentro la Santa Sede. «Il problema è che lo hanno votato molti cattolici».
Significa evocare un’opinione pubblica percorsa da pulsioni che vanno in direzione opposta a quella indicata da Francesco: in America e in Europa, dove la categoria del populismo va declinata con meno sufficienza, perché coinvolge anche persone che populiste non sono. C’è chi prevede che, se Bergoglio non ricalibra la strategia, dal prossimo Conclave potrebbe spuntare un Papa ultraconservatore. Il texano col cappello da cowboy e il crocifisso al collo, felice per l’elezione di Trump, che mercoledì 8 novembre è stato intervistato dai media statunitensi all’udienza in piazza San Pietro, non era un’anomalia. Era l’emblema di un paradosso destinato a scuotere la Chiesa di Francesco.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. -- LA PATOLOGIA AUTODISTRUTTIVA DELLE CLASSI DIRIGENTI.10 novembre 2016, di Federico La Sala
- CRISI COSTITUZIONALE DI LUNGA DURATA. DUE PRESIDENTI GRIDANO: FORZA ITALIA!!! .... E IL LUNGO SONNO DELLA RAGIONE COSTITUZIONALE DELLE ISTITUZIONI E DEGLI INTELLETTUALI.
 BERLUSCONI E LA "MEZZA" DIAGNOSI DEL PROF. CANCRINI. Il Narcisismo e l’uso lucidissimo come arma politica dell’"antinomia del mentitore" - "L’Italia è il mio Partito": "Forza Italia"!!!
BERLUSCONI E LA "MEZZA" DIAGNOSI DEL PROF. CANCRINI. Il Narcisismo e l’uso lucidissimo come arma politica dell’"antinomia del mentitore" - "L’Italia è il mio Partito": "Forza Italia"!!!
Referendum Costituzionale Riforme
sì/no: un voto decisivo
Dalla psicopatologia delle élite alla pedagogia costituzionale
di Luca Verzichelli (il Mulino, 09.11.2016)
Può piacere o meno, ma che la discussione attorno al referendum abbia assunto fin dalla sua fase iniziale i toni di un confronto, in qualche modo autodistruttivo, tra i vari segmenti delle élite, è sotto gli occhi di tutti. Se molti politici tendono a litigare agitando con fare non sempre avveduto concetti importanti ma assai delicati come governabilità e responsabilità, gli opinion maker fanno eco con toni anche più grevi. I protagonisti dei social media, e anche il residuo manipolo di praticanti dell’antico ma ancora in auge wrestling televisivo completano il quadro, alimentando di fatto la patologia autodistruttiva della nostra classe dirigente.
Tale azione si appoggia all’uso di strumenti distribuiti in egual misura tra i competitori, sia pure con dosaggi diversi: chi insiste sulla contrapposizione tra vecchio e nuovo, chi continua a puntare sull’irrisione sistematica o sulla presunta inadeguatezza culturale degli avversari, chi ricorre a espressioni popolari per solleticare gli istinti più tipici della mentalità populista, come la connaturata sfiducia nella capacità riformatrice dei «politici di professione».
Che le élite politiche italiane siano un disastro lo diciamo da un po’. E non è neppure una novità che le campagne elettorali siano spesso un disastro. Se pensiamo a una campagna come quella appena chiusa per l’elezione del presidente negli Stati Uniti, incentrata a lungo sugli scandali e sulle inadeguatezze dei candidati, se non sulle pratiche loro, dei loro parenti e dei loro amici, non sembriamo messi poi troppo male: grazie al buon senso di molti - inclusi molti amici del Mulino - una parte della discussione rimane sul merito della riforma e comunque su valutazioni politiche complessive informate e ponderate.
Tuttavia, si può e si deve fare di più quando parliamo di Costituzione. La classe politica, intanto, deve smettere di guardarsi allo specchio e uscire dalla palude delle bassezze, per non fare la figura di un insieme di free rider che restituiscono al cittadino la responsabilità di scelte complesse e tecniche senza nemmeno informarlo doverosamente sulle proposte.
Ma ancor più dannosa è l’auto-celebrazione degli esponenti dell’élite socio-culturale i quali, pur nel tentativo lodevole di dare un contributo alla scelta pubblica, finiscono per mettere in ridicolo con le proprie approssimazioni anche i progetti della propria parte politica. Roberto Escobar ha evidenziato la contraddizione di una comunicazione basata sul ticket politica-società civile, dove la società civile, rappresentata dal difensore del brand costituzionale in tempi berlusconiani, ruba la scena anche al riformatore, paventando gli scenari più foschi in caso di fallimento della riforma. Mi chiedo se Benigni non avesse dovuto prefigurare alcune delle implicazioni che discendono da questo operato. Così come mi chiedo se alla fine non sia imbarazzante per uno storico dell’arte autorevole come Montanari costruire uno spot elettorale leggendo in un’opera d’arte l’immagine della ribellione nei confronti di una leadership telecomandata dalla finanza internazionale.
Insomma, quando la comunicazione scivola su questo piano, viene il sospetto che anche l’autonomia di giudizio dell’intellettuale sia entrata in riserva. Invece di una «visione» da prestare alla propria parte politica ne esce fuori un ulteriore messaggio personalizzato al proprio piccolo popolo di follower.
Mi si dirà che in tempi di democrazia senza partiti è di questo che si ciba l’opinione pubblica. Ok. Tuttavia, parlando di Costituzione e di referendum, un lavoro intellettuale che reitera la mera partigianeria, senza dare agli elettori un minimo elemento per fugare i loro dubbi, non mi pare un grande aiuto.
Non sarebbe meglio spendere queste ultime settimane di campagna ad ascoltare chi ha davvero qualcosa da dire nel merito? Sarebbe possibile inserire negli spiegoni televisivi gli elementi descrittivi alla base delle decisioni sulle quali dobbiamo esprimerci, magari partendo dal funzionamento attuale del bicameralismo, oppure introducendo qualche elemento oggettivo di analisi comparata? Inoltre, sarebbe auspicabile rinunciare alla logica del «ring» e ai contradditori più inutili, per lasciare posto a illustrazioni sinottiche sui pro e i contro, commentate ovviamente dai politici e da esperti con capacità dissertative adeguate.
Con una tale strumentazione, e con la certezza che si tratta di un voto su una proposta di manutenzione costituzionale (che possiamo naturalmente valutare nei modi più diversi), forse focalizzeremo meglio la vera partita che stiamo giocando. A seconda del livello di interesse e delle competenze, potremo valutare in coscienza il merito politico della riforma, e produrre un qualche «spacchettamento», necessario per calcolare la somma algebrica di migliorie e peggioramenti. Ci sentiremo forse un po’ meno decisivi per le sorti del Paese, rispetto a quanto ci hanno detto molti assertori del «sì» e del «no», ma alleggeriti nel nostro stato d’animo e coscienti che a noi adesso spetta fare questo e solo questo. Saremo inoltre meno sensibili al ciarpame mediatico e più interessati a imparare qualcosa sulla nostra costituzione, apprezzando le analisi approfondite come quelli ospitate dal «Mulino». Nel contempo, ci impratichiremo con un esercizio, davvero utile, di coinvolgimento civico.
Spostare il dibattito dalla psicopatologia delle élite alla pedagogia costituzionale sarebbe un primo risultato importante del referendum.
- CRISI COSTITUZIONALE DI LUNGA DURATA. DUE PRESIDENTI GRIDANO: FORZA ITALIA!!! .... E IL LUNGO SONNO DELLA RAGIONE COSTITUZIONALE DELLE ISTITUZIONI E DEGLI INTELLETTUALI.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- USA 2016. Cerchiamo di capire cosa è successo: "Nazional-Operaismo e guerra razziale".10 novembre 2016, di Federico La Sala
- LA STATUA DELLA LIBERTA’ DEGLI U.S.A. - CON LA SPADA SGUAINATA: "GUAI AI VINTI"!!! LA LEZIONE DI FRANZ KAFKA, IL MAESTRO DELLA LEGGE: RIPENSARE L’AMERICA. E il sogno del "nuovo mondo"!!!
- UNA DOMANDA ALL’ITALIA: MA COME AVETE FATTO A RIDURVI COSI’?! UN "BORDELLO STATE": UN PAESE BORDELLO. Una nota di Maurizio Viroli (dagli Usa) - e una risposta (agli americani, dall’Italia) di Federico La Sala
- POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. Materiali sul tema
Nazional-Operaismo e guerra razziale
di Franco Berardi Bifo*
Cerchiamo di capire cosa è successo. Come fece nel 1933, la classe operaia si vendica di chi l’ha presa per il culo negli ultimi trent’anni. Uno schiavista che per sua stessa ammissione non ha mai pagato le tasse, un violentatore seriale è diventato Presidente degli Stati Uniti d’America. Hanno votato per lui coloro che sono stati traditi dalla sinistra, in America come in Europa.
La più urgente azione da compiere ora sarebbe linciarli, coloro che hanno aperto la strada al fascismo mettendosi al servizio del capitale finanziario e della riforma neo-liberale: Bill Clinton e Tony Blair, Massimo d’Alema e Matteo Renzi, Giorgio Napolitano, François Hollande, Manuel Valls e Sigmar Gabriel. Chiamiamoli per nome i mascalzoni che per cinismo e per imbecillità hanno consegnato alle grandi corporation finanziarie il governo sulla nostra vita, e hanno aperto la porta al fascismo che ora dilaga, alla guerra civile globale alla quale ora non c’è più modo di porre argini.
Nel Regno Unito e in Polonia, in Ungheria e in Russia e ora negli Stati Uniti, ha vinto il Nazional-Operaismo. La classe operaia bianca, umiliata negli ultimi trent’anni, ingannata dalle promesse riformiste dei suoi rappresentanti, impoverita dall’aggressione finanziaria, porta uno schiavista violentatore alla Casa Bianca.
Dato che la sinistra ha tolto dalle mani dei lavoratori le armi per difendersi, ecco la versione fascista e razzista della lotta di classe: Wall Street è riuscita a sconfiggere Bernie Sanders alle primarie, e ora un uomo del Ku Klux Klan sconfigge la rappresentante di Wall Street.
I prossimi dieci anni saranno tremendi, è bene saperlo. Il crollo della globalizzazione capitalista è l’inizio di una guerra nella quale poco di ciò che chiamammo civiltà è destinato a sopravvivere. «Zero Hedge», il giornale online in cui scrivono gli intellettuali trumpisti ha pubblicato qualche giorno fa un articolo che sintetizza benissimo quello che sta accadendo e anticipa quello che accadrà:
È la classe media demoralizzata e disillusa che ha perduto di più, depredata dalla Federal Reserve, con salari che languiscono dagli anni Ottanta. Gli interessi a zero hanno punito lavoratori pensionati e risparmiatori mentre hanno beneficiato i milionari della finanza. Il prossimo collasso finanziario, che è dietro l’angolo provocherà una guerra di classe nelle strade.
Trump ha vinto perché rappresenta un’arma nelle mani dei lavoratori impoveriti, dato che la sinistra li ha consegnati disarmati nelle mani del capitale finanziario. Purtroppo si tratta di un’arma che si rivolgerà presto contro i lavoratori stessi, e li porterà a una guerra razziale. L’altra faccia dell’Operaismo trumpista è infatti il Nazionalismo bianco. Scrive ancora «Zero Hedge»: «Alle elezioni le persone bianche, sposate, rurali e religiose si scontrano contro le persone nere, senza padre, e non religiose».
La minaccia di guerra razziale è del tutto esplicita nelle posizioni del Nazional-Operaismo americano. Sconfitti sul piano sociale dal capitalismo finanziario, gli operai bianchi si riconoscono come razza degli sterminatori e degli schiavisti.
Il movimento Black Lives Matter sponsorizzato da Soros ha creato il caos nelle città americane, spingendo giovani neri a uccidere ufficiali di polizia, e portando all’estremo il programma di riparazioni ispirato da Obama. Ma se provano a uscire dai loro ghetti urbani creati dai democratici e se provano a venire nelle zone dell’America rurale incontreranno i possessori legali di armi che gli spareranno addosso. La guerra razziale si concluder presto e non c’è dubbio su chi sarà il vincitore. I bianchi moderati e conservatori sono stufi marci del programma liberal e del vittimismo nero. La risposta che daremo è: fatela finita di fare figli fuori dal matrimoni, andate a lavorare, educatevi. La vita è dura. Imparatelo. Nessuno vi deve nulla.
Aspettando la seconda guerra civile americana, in questi giorni mi trovo a Mosca per una conferenza. Mentre parlavo in una galleria d’arte ai fighetti come me e come i lettori di Operaviva, fuori, nel gelido nevischio della metropoli il popolo russo festeggiava. Cosa? Cosa si celebra, e si ricorda all’inizio del mese di Novembre in Russia? Non la rivoluzione sovietica del 1917 ma la cacciata dei polacchi nel 1612. Il fascismo russo ha salutato l’erezione della statua di Vladimiro il savio, cristianizzatore della patria 18 metri di altezza. Molte donne e molti bambini vestono con uniformi militari e inneggiano ai peggiori assassini che la storia ricordi, da Ivan il Terribile a Stalin il massacratore di comunisti.
La razza bianca in armi prepara un finale spaventoso per la storia spaventosa del colonialismo moderno. Riusciremo a sfuggire a questo finale già scritto nei libri dell’Armageddon che il capitalismo finanziario ha preparato e cui la sinistra riformista ha aperto la strada?
* Ha aderito alla campagna Facciamo Comune insieme. Questo articolo è stato pubblicato su operaviva.info
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. -- PERCHÉ IL SINDACO MARINO È SOTTO ATTACCO E PERCHÉ BISOGNA ASSOLUTAMENTE DIFENDERLO (don Aldo Antonelli, 2015).8 ottobre 2016, di Federico La Sala
- Da: Aldo Antonelli
 Inviato: venerdì 2 ottobre 2015 07:54
Inviato: venerdì 2 ottobre 2015 07:54
 Oggetto: Viva Ignazio Marino
Oggetto: Viva Ignazio Marino
- Fossi stato un cittadino romano, alle comunali di due anni fa, molto probabilmente non avrei votato Ignazio Marino. Oggi, però, lo difendo!
 Lo difendo contro tutti coloro che lo stanno calpestando a morte.
Lo difendo contro tutti coloro che lo stanno calpestando a morte.
 Lo difendo anche dal Papa che, vergognosamente è stato trascinato in questa vergognosa campagna denigratoria!
Lo difendo anche dal Papa che, vergognosamente è stato trascinato in questa vergognosa campagna denigratoria!
 Volete sapere perché?
Volete sapere perché?
 Vi chiedo cinque minuti del vostro tempo.
Vi chiedo cinque minuti del vostro tempo.
 Calma: cinque minuti.
Calma: cinque minuti.
 Leggete l’allegato e poi ditemi pure la vostra.....
Leggete l’allegato e poi ditemi pure la vostra.....
 Buon fine settimana, nonostante!
Buon fine settimana, nonostante!
 Aldo
Aldo
***
PERCHÉ IL SINDACO MARINO È SOTTO ATTACCO E PERCHÉ BISOGNA ASSOLUTAMENTE DIFENDERLO
di Aldo Antonelli (29 SETTEMBRE 2015 - senza le foto)
- Il sindaco di Roma, Ignazio Marino
Perché sparano tutti contro il sindaco di Roma? Come mai da qualche mese a questa parte lo sport preferito di intere bande di editorialisti e twittaroli è prendere a pallate incatenate Ignazio Marino? Come mai a queste masse agitate ha fornito una sponda, assestando lui stesso fendenti micidiali, persino il “misericordioso” papa Francesco? Se provi a chiedere a qualcuno dei vessatori quotidiani di Marino, siano essi editorialisti o gestori di potenti siti internet, ti rispondono che la colpa è del sindaco, che non sa comunicare. Il che è abbastanza prevedibile: ogni aggressore giustifica le proprie azioni accusando la vittima: è lei che le botte “se le va a cercare”. Oppure indicano un cassonetto pieno o un autobus in ritardo e dicono: “Vedi? Marino se ne deve andare”.
In realtà i motivi dell’aggressione quotidiana contro Marino sono altri. Il motivo principale, quello che muove le grandi masse urlanti, è che picchiare Marino è facile. Marino è un “soft target”, uno che si può massacrare tranquillamente. Marino è la cuccagna dei vigliacchi da scrivania: lo possono sbertucciare sui giornali senza paura, perché nessuno telefonerà il giorno dopo per minacciare il loro editore. Anzi: saranno in molti a brandire i loro editoriali come scimitarre per chiedere la rimozione del sindaco. E i cittadini di Twitter, che dei giornali leggono solo i titoli si uniscono volentieri al pestaggio, così, perché lo fanno tutti.
- L’ex sindaco Gianni Alemanno
Il secondo motivo per cui Marino si può picchiare è che si è fatto molti nemici. E ai vigliacchi piace far parte del branco, specie se del branco fanno parte personaggi non particolarmente belli a vedersi. Chi detesta Marino è per esempio l’ex sindaco Gianni Alemanno, quello che gli ha lasciato in eredità una città sull’orlo del collasso, quello che rimpinzò l’Atac, l’azienda comunale dei trasporti, di parenti e amici, portandola quasi alla bancarotta. Fra chi vorrebbe cacciare Marino ci sono poi i Casamonica, quelli del funerale coatto che ha sputtanato la città davanti al mondo, per colpa di gravi omissioni da parte delle forze dell’ordine, che sapevano e non fecero nulla. Le forze dell’ordine, sia detto per inciso, fanno capo al prefetto Franco Gabrielli, è lui il responsabile del disastro dei Casamonica, come ha del resto ammesso lui stesso. Ma Gabrielli non si tocca: lui i protettori ce li ha.
- I funerali di Vincenzo Casamonica
A proposito di “mondo di mezzo”, Marino è certamente visto come il fumo negli occhi dai mafiosi di Mafia Capitale. Da quando c’è lui, per i criminali gli affari vanno a rotoli. Non riescono più a piazzare nessuno dei loro in Campidoglio, non riescono a condizionare gli appalti, hanno grosse difficoltà ad entrare nelle stanze dei dirigenti comunali, come facevano un tempo, e a far capire chi è che comanda. Insomma: non comandano più e quelli sono personaggi con i quali è meglio non scherzare. Infatti a Marino, che aveva cominciato a fare il sindaco girando in bicicletta, da molti mesi è stata assegnata dal Ministero dell’Interno una scorta.
Fra gli altri nemici di Marino ci sono alcune fra le famiglie più potenti di Roma, come la famiglia Tredicine, quella che gestisce gli orribili camion bar che Marino ha fatto sgomberare dal Colosseo e da altre fra le più belle attrazioni turistiche di Roma. Mettrersi contro questi signori, fra l’altro ampiamente rappresentati in Campidoglio, è un gesto di grande coraggio, che nessuno fra i predecessori di Marino aveva mai compiuto, a cominciare dai due recenti sindaci più famosi e acclamati: Veltroni e Rutelli. Adesso il Colosseo lo si può finalmente ammirare in tutto il suo splendore, non più impallato dai camion bar. Una gioia da assaporare magari dopo una passeggiata sull’ultimo tratto di via dei Fori Imperiali, resitituita finalmente sempre di più al traffico pedonale (altra coraggiosa iniziativa che ha mandato su tutte le furie i commercianti e i residenti, molto potenti, della zona).
- Camion bar davanti al Colosseo
L’elenco dei nemici di Marino potrebbe continuare a lungo: ci sono le potenti famiglie di Ostia che avevano cementificato abusivamente il lungomare e che si sono trovate una mattina le ruspe mandate da Marino a restituire la spiaggia ai romani. O coloro che lucravano sulla discarica di Malagrotta, un orribile monumento all’inquinamento e al degrado, che Marino, dopo anni di sindaci indecisi, ha chiuso, raddoppiando allo stesso tempo la raccolta differenziata. O le potenti ditte abusive che infestavano la città con enormi cartelloni pubblicitari. Marino ha persino messo mano agli affitti degli alloggi comunali, rimettendo in discussione casi di gente che pagava poche decine di euro al mese per appartamenti in pieno centro e mettendo in vendita ben 600 appartamenti. E ha deciso di far lavorare di più i macchinisti della metro, costringendoli a “strisciare” il badge a inizio e fine turno, come nei paesi civili.
Contro Marino c’è poi ovviamente il PD romano, infiltrato da personaggi inquietanti e contingui alle opache pratiche del malaffare di Mafia Capitale e dunque sciolto da Matteo Renzi e commissariato con Matteo Orfini. Con la vittoria di Marino, i potentati del PD romano si erano già messi il tovagliolo ed erano pronti a sedersi a tavola. Ma il sindaco li ha sbattuti fuori, forte del mandato popolare diretto. Chi sperava di fare l’assessore si è dovuto accontentare di un seggio in consiglio comunale, chi sognava la poltrona di amministratore di una municipalizzata è rimasto a casa. Qualcun altro, nel frattempo, è finito in galera. Tutte persone con amicizie molto in alto, tutte persone che gliel’hanno giurata.
- Marino e Renzi, quando andavano d’accordo
Fra i nemici più illustri di Marino c’è poi lui, il più potente di tutti: Matteo Renzi. Il presidente del Consiglio non ama Marino, e non capiamo perché. Il sindaco di Roma è in realtà il più renziano dei primi cittadini. Da quando è stato eletto ha preso le sue decisioni senza guardare in faccia nessuno, ha sbaragliato i centri di potere, ha avviato politiche di lungo termine, ha preso decisioni impopolari. Ha “cambiato verso” e ne sta raccogliendo i frutti, se è vero che solo la scorsa settimana Fitch ha detto che finalmente, dopo tre anni, i conti di Roma stanno tornando in ordine. Ma a Renzi Marino non piace, e questo facilita ovviamente il compito dei picchiatori mediatici. Se l’imperatore mostra il pollice verso, i leoni (che in realtà sono conigli) possono partire all’attacco.
E veniamo all’ultimo dei nemici che Marino si è fatto, che poi è il più grosso: il Vaticano. E qui il piccolo sindaco di Roma si è messo contro un gigante contro il quale nessuno aveva mai osato mettersi. Come mai Marino è inviso a Papa Francesco? Qui Filadelfia non c’entra nulla. Marino è malvisto dalla Curia per la sua storia, passata e presente. Da politico, Marino si batté con coraggio a favore del referendum sulla procreazione medicalmente assistita eterologa. Pochi se lo ricordano, ma quella di Marino e altri fu una battaglia di civiltà osteggiata con forza dal Vaticano e purtroppo persa per il non raggiungimento del quorum al referendum del 2005.
Ma non finisce qui. Poco dopo il suo insediamento, Marino istituì il registro comunale per le unioni civili, accogliendo anche coppie dello stesso sesso, proprio mentre si concludeva in Vaticano il sinodo sulla famiglia. Un’iniziativa simbolica, che provocò anche aspri contrasti con l’attuale ministro dell’Interno, Alfano, ma che fu uno dei pochissimi riconoscimenti della dignità delle coppie gay. Non contento, Marino ha poi nel giugno scorso apertamente patrocinato il Gay Pride a Roma. Va ricordato in proposito che, nel 2000, l’allora sindaco Rutelli patrocinò dapprima il Gay Pride, ma fu costretto poco prima della giornata a ritirare il patrocinio. Marino non solo non ha ritirato il patrocinio, ma si è persino messo in testa al corteo, il 13 giugno scorso. E vedere quella fascia tricolore sfilare a pochi metri dal Cupolone insieme alle bandiere arcobaleno deve aver provocato più di un travaso di bile nelle segrete stanze del Vaticano e più di una preoccupazione per la “cattolicità” dell’imminente Giubileo.
- Marino al Gay Pride, il 13 giugno scorso
Si arriva così alla trasferta di Filadelfia. I fatti sono noti: in giugno il sindaco di Filadelfia, Michael Nutter, e l’arcivescovo, Charles Chaput, volano a Roma per preparare la visita del Papa di settembre. Vogliono capire dagli esperti comunali come organizzarsi. Marino li riceve e Nutter lo invita a Filadelfia per una serie di iniziative in concomitanza con la visita del Papa. Marino annuncia la trasferta, specificando che i costi non saranno a carico dell’Amministrazione capitolina e che l’invito viene dal suo collega sindaco. Pochi giorni fa, come annunciato, Marino vola prima a New York, poi a Filadelfia, dove partecipa a diverse riunioni ed eventi, fra cui la messa del Papa in occasione del World Meeting of Families.
E siamo al redde rationem. Durante il viaggio di ritorno del Papa, a nome dei giornalisti italiani al seguito, il giornalista di SkyNews24, Stefano Maria Paci, gli rivolge una domanda molto scorretta. Eccola: “Ci tolga una curiosità. Il sindaco Marino, sindaco di Roma, città del Giubileo, ha dichiarato che è venuto all’incontro conviviale delle famiglie, alla messa, perché è stato invitato da lei. Ci dice com’è andata?”.
Notate come il giornalista inserisca nella sua domanda al Papa una vera e propria menzogna, quando afferma: “Il sindaco Marino ha dichiarato che è stato invitato da lei”. Mai, in nessuna occasione, Marino ha detto di essere stato invitato dal Papa. Anzi: ha sempre specificato che l’invito a Filadelfia gli era stato rivolto dal sindaco di quella città. E’ abbastanza incredibile che giornalisti professionisti compiano una scorrettezza simile, fra l’altro rivolgendosi ad una delle persone più influenti della Terra. Il Papa non può ovviamente sapere cosa abbia detto o non detto Marino, ma non sembra dispiaciuto dalla domanda. Ecco cosa risponde:
- Papa Francesco in volo.
“Io non ho invitato il sindaco Marino, chiaro? Ho chiesto agli organizzatori e neanche loro lo hanno invitato. Chiaro? È venuto... lui si professa cattolico: è venuto spontaneamente”
Il colpo è micidiale e l’effetto politico che ne segue devastante. I siti internet (a parte La Stampa) mettono in rete solo la risposta del Papa, non la domanda, facendo credere surrettiziamente che la precisazione sia un’iniziativa di Bergoglio. Il video del Pontefice in aereo col microfono che dileggia Marino, in un colpo solo, fa contenti: i Casamonica, Gianni Alemanno, Matteo Salvini, Giorgia Meloni, la famiglia Tredicine, la lobby dei commercianti dei Fori Imperiali, il PD romano commissariato e ciò che resta di Mafia Capitale. Si stappa lo champagne. Partono i tweet e partono le paginate sui siti, ma soprattutto si mettono in moto le tastiere dei picchiatori. Il Papa tiene fermo Marino e loro possono pestarlo a sangue: dài ché ci divertiamo. Si impaginano i pezzi dei vari Merlo, Tucci, per non parlare di Giordano e Tramontano. E’ una festa: la character assassination impazza. Tutti a scrivere che il Papa smentisce e sbugiarda Marino, quando è ovvio che il Papa non ha smentito nulla, perché Marino mai aveva detto di aver ricevuto inviti dal Papa. La replica di Marino viene nascosta in poche righe, nessuno la vede. La gogna è scattata, chi vuole può avvicinarsi a scagliare la sua pedata.
Pochissimi scelgono di ragionare con la propria testa. Fra questi, Massimo Gramellini, sulla Stampa, e Francesco Oggiano, su Vanity Fair. Intervengono per ristabilire la verità opinionisti noti come Stefano Menichini e Chiara Geloni. Ma le loro voci, per quanto forti, sono surclassate dalle grida sguaiate dei pecoroni da tastiera.
Il colpo è assestato, Oltretevere qualcuno forse sta brindando. O forse no, sta di fatto che il Papa è ormai ufficialmente collocato fra quanti vogliono togliere di mezzo il sindaco di Roma.
Resisterà Marino, sindaco da poco più di due anni, all’attacco concentrico dei suoi tanti nemici, con l’appoggio di fatto di chi a Roma regna da una ventina di secoli? Non lo so. So che questo sindaco è stato eletto con il 60% dei voti dei romani, che hanno diritto di vedere rispettato il proprio voto. So anche che Marino ha difetti, come tutti, ma nonostante la stampa e la tv facciano finta di non vedere, sta portando avanti riforme coraggiose e provvedimenti importanti e che la città, lasciata dalla destra in condizioni drammatiche, sta migliorando. Marino è un argine fragile all’arroganza e alla protervia di chi, da varie angolazioni, vorrebbe tornare a decidere cosa deve e non deve essere fatto a Roma, infischiandosene dei romani e di quello che essi stessi hanno scelto. Per questo Marino ha il dovere di resistere e andare avanti, se ce la fa. E chi se la sente ha il dovere di difenderlo.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. -- IL SINDACO MARINO. Sbagliato a dimettermi, ma ho subito enorme pressione e minacce.8 ottobre 2016, di Federico La Sala
Marino, ora girerò l’Italia per dire No al referendum
Sbagliato a dimettermi, ma ho subito enorme pressione e minacce
di Redazione *
ROMA "Ho inviti in oltre 20 città italiane. Dirò quel che penso sulla riforma: che il Senato va totalmente abolito e che la revisione non è stata studiata e votata come avevano fatto all’assemblea costituente". Lo dice a la Stampa l’ex sindaco di Roma, Ignazio Marino, intervistato da diversi quotidiani dopo l’assoluzione sul caso scontrini. Non farà un suo movimento né si candiderà alla segreteria Pd: "Io non sono proprio, di indole, un capopartito. Non lo sarò mai - afferma a Repubblica -. Posso produrre idee e studiare".
"Forse non mi sarei dovuto dimettere - si rimprovera -. Ma è vero che io subivo un’enorme pressione. Non solo io, ma anche la mia famiglia. Mi arrivarono due buste con dei proiettili, in una c’erano le cartucce di una P38 special con questo messaggio: ’I prossimi proiettili serviranno per bucare te, tua moglie e tua figlia. E sappiamo dove vive tua figlia’. Poi, certo, ci fu l’assedio politico e l’aggressione mediatica...". A Raggi che ha chiesto i danni d’immagine per la città replica: "Mi aspetto che la sindaca si impegni con la stessa determinazione con cui io ho trovato 13 milioni di euro di finanziamenti, grazie ai quali lei ha potuto inaugurare con la fascia tricolore la scalinata di piazza di Spagna restaurata". Raggi dice di esser sotto attacco dei poteri forti.
Condivide? "Non lo so - risponde Marino intervistato anche dal Fatto Quotidiano -. Certo che dicendo brutalmente no alle Olimpiadi deve essersi fatta dei nemici molto potenti".
- Da: Aldo Antonelli
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. -- LA DEA ATENA, MINERVA E IL "LOGO" DELLA "SAPIENZA" DI ROMA. Università: Cantone, collegamento fuga cervelli-corruzione24 settembre 2016, di Federico La Sala
- IL "LOGO" DELLA "SAPIENZA": MAMMASANTISSIMA. Il grande ordine simbolico del "Che_rùbino" ... tutti e tutto!!!
- IL PUTTANESIMO DELLO SPIRITO: LA DIPINTURA TUTTA CONTRARIA. LA LEZIONE IGNORATA DI GIAMBATTISTA VICO.
Università: Cantone, subissati da segnalazioni, collegamento fuga cervelli-corruzione
’Soprattutto sui concorsi. Riforma Gelmini ha creato problemi’ ha spiegato il responsabile dell’Autorità nazionale anticorruzione
di Redazione ANSA *
"C’è un grande collegamento, enorme, tra fuga di cervelli e corruzione". Lo ha sottolineato il responsabile dell’Anac Raffaele Cantone oggi a Firenze, intervenendo al convegno nazionale dei responsabili amministrativi delle università. Cantone lo ha detto dopo aver riferito che l’’Anac è "subissata" di segnalazioni di presunti casi di corruzione negli atenei italiani.
"Siamo subissati di segnalazioni su questioni universitarie, spesso soprattutto segnalazioni sui concorsi" ha spiegato il responsabile dell’Anac. "Non voglio entrare nel merito, non ho la struttura né la competenza - ha aggiunto - ma la riforma Gelmini secondo me ha finito per creare più problemi di quanti ne abbia risolti. Per esempio, ha istituzionalizzato il sospetto: l’idea che non ci possano essere rapporti di parentela all’interno dello stesso dipartimento, il che ha portato a situazioni paradossali".
 "In una università del Sud è stato istituzionalizzato uno ’scambio’: in una facoltà giuridica è stata istituita una cattedra di storia greca e in una facoltà letteraria una cattedra di istituzioni di diritto pubblico. Entrambi i titolari erano i figli di due professori delle altre università. Credo che questo sia uno scandalo e che lo sia il fatto che si sia stati costretti a fare questa operazione; se tutto avvenisse in trasparenza, la legge che nasce dalla logica del sospetto è una legge sbagliata".
"In una università del Sud è stato istituzionalizzato uno ’scambio’: in una facoltà giuridica è stata istituita una cattedra di storia greca e in una facoltà letteraria una cattedra di istituzioni di diritto pubblico. Entrambi i titolari erano i figli di due professori delle altre università. Credo che questo sia uno scandalo e che lo sia il fatto che si sia stati costretti a fare questa operazione; se tutto avvenisse in trasparenza, la legge che nasce dalla logica del sospetto è una legge sbagliata".Faremo linee guida per garantire la discrezionalità - Sull’università "proveremo a fare linee guida ad hoc, che non vogliono burocratizzare ma provare a consentire l’esercizio della discrezionalità in una logica in cui la discrezionalità però non diventi arbitrio, in cui discrezionalità significhi dare conto ai cittadini, non solo gli studenti ma tutti i cittadini perché l’università è il nostro futuro" ha spiegato Cantone.
 "L’università - ha aggiunto - dovrebbe essere l’esempio, per rilanciare il nostro Paese. Le classifiche internazionali, purtroppo, in questo senso, e se non ci premiano una delle cause sta anche in una serie di vischiosità del sistema universitario. Non concordo che le università italiane sono baracconi burocratici; ma all’estero tutti credono che lo siano, e sappiamo bene quanto conti non solo il fatto di essere ma anche di apparire. E questo apparire costituisce un danno enorme per il nostro Paese".
"L’università - ha aggiunto - dovrebbe essere l’esempio, per rilanciare il nostro Paese. Le classifiche internazionali, purtroppo, in questo senso, e se non ci premiano una delle cause sta anche in una serie di vischiosità del sistema universitario. Non concordo che le università italiane sono baracconi burocratici; ma all’estero tutti credono che lo siano, e sappiamo bene quanto conti non solo il fatto di essere ma anche di apparire. E questo apparire costituisce un danno enorme per il nostro Paese". -
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. - TERREMOTO: AMATRICE. Così il Comune mentì sui lavori nella scuola: «Ora è antisismica» (di Giovanni Bianconi).31 agosto 2016, di Federico La Sala
il rapporto della finanza all’anac
Così il Comune mentì sui lavori nella scuola: «Ora è antisismica»
La scuola di Amatrice è crollata nonostante i lavori di «miglioramento sismico»: vennero assegnati e spesi 700 mila euro tra il 2011 e il 2012. Due le gare d’appalto, entrambe vinte dal Consorzio Stabile Valore, un cartello che riunisce 79 aziende
di Giovanni Bianconi *
La scuola di Amatrice crollata nonostante i recenti lavori di ristrutturazione e «miglioramento sismico», che non ha provocato vittime solo perché la scossa assassina è arrivata in una notte d’estate, rischia di diventare il simbolo dell’intreccio tra i danni provocati dal terremoto e quelli derivanti da appalti mal gestiti. Dietro i quali potrebbe annidarsi non solo l’incuria, ma pure la corruzione. Per questo motivo l’Autorità nazionale guidata da Raffaele Cantone ha incaricato l’apposito Nucleo speciale della Guardia di finanza di analizzare il caso dell’Istituto omnicomprensivo «Romolo Capranica», e il primo rapporto consegnato lunedì sera dal generale Gaetano Scazzeri, comandante del Nucleo, alimenta diversi interrogativi su come sono stati assegnati e utilizzati i quasi 700.000 euro spesi tra il 2011 e il 2012.
Il primo intervento nel 2011
Si tratta di due diverse gare, entrambe vinte dal Consorzio Stabile Valore, un cartello che riunisce 79 aziende e fa capo, attraverso un’altra società, agli imprenditori siciliani Mollica. Al Consorzio aderisce per una quota piccolissima (lo 0,32 per cento) la società Edilqualità, che ha materialmente effettuato i lavori nella scuola. Divisi anch’essi in due tronconi. Il primo finanziato con 511.000 euro, deliberato il 29 settembre 2011, nel quale non c’è alcun richiamo a opere di prevenzione in vista di un terremoto. Si parla esclusivamente di «miglioramento termico, migliorie della pavimentazione, efficienza dell’impianto elettrico, sistemazione del piazzale e del cortile esterno» e altri lavori.
Il secondo intervento nel 2012
Il secondo contratto risale all’anno successivo, 25 settembre 2012, e deriva da una clausola contenuta nel primo: il Comune di Amatrice poteva, «a suo insindacabile giudizio», affidare alla stessa impresa (la Edilqualità) un ulteriore incarico per il «miglioramento sismico del Polo scolastico verticalizzato». Valore dell’appalto: 157.500 euro, sebbene in origine fossero 163.000. La legge prevedeva che questo tipo di procedura potesse applicarsi per spese inferiori a 100.000 euro, e questa sarebbe già una violazione. Ma c’è un altro particolare che inquieta: la gara è stata assegnata a fine settembre 2012 e registrata il successivo 11 ottobre. Cioè un mese dopo l’inaugurazione della struttura, avvenuta in pompa magna il 13 settembre.
Dubbi sui lavori
Dunque per gli investigatori anticorruzione «non è chiaro» se i lavori anti-terremoto siano stati effettivamente eseguiti quando la scuola era già aperta e funzionante. Di qui la necessità di verifiche, attraverso nuove acquisizioni presso gli Enti locali e le imprese coinvolte, già disposte da Cantone. Anche perché nella banca dati di monitoraggio utilizzata dall’Anac, sono stati trovati solo dati e documenti relativi al primo appalto, quello da 511.000 euro, e i finanzieri denunciano il mancato adempimento dei «previsti obblighi informativi». Le maggiori ombre, in attesa di ulteriori approfondimenti, si addensano al momento sul Comune di Amatrice. Perché gran parte del finanziamento è stato utilizzato per opere che nulla avevano a che vedere con la messa in sicurezza della scuola in previsione di eventuali scosse, come risulta dal bando di gara e dai documenti allegati. Ciò nonostante, fuori dalla scuola era stato affisso un avviso pubblico in cui si enfatizzava la «sontuosa opera di ristutturazione dell’intero edificio realizzata in poco più di tre mesi» proprio con quella somma (511.297,68 euro Iva esclusa, per la precisione), «consistente soprattutto nell’adeguamento della vulnerabilità sismica».
Una bugia, stando al rapporto delle Fiamme gialle. E il «tempo record» per il completamento dei lavori viene indicato come ulteriore elemento sospetto. Le ricerche sul sito Internet dell’Amministrazione di Amatrice, inoltre, hanno portato alla luce due delibere approvate rispettivamente il 13 luglio 2012 e il 9 settembre 2013.
Delibere dimenticate
La prima, votata durante lo svolgimento dei lavori assegnati col primo contratto, riguardava un accordo con la Provincia di Rieti per un piano di «miglioramento sismico dell’edificio scolastico Romolo Capranica»; la seconda, arrivata a lavori conclusi, doveva servire a chiedere un finanziamento di 131.521 euro alla Regione Lazio per il «completamento del miglioramento sismico strutturale in cemento armato» dell’edificio. Ma «di tali delibere non si sono rinvenuti eventuali sviluppi o esiti».
Le verifiche in corso riguardano anche la ditta Edilqualità, su cui sono affiorate alcune anomalie che l’Anticorruzione intende approfondire. Amministratore unico è il geometra Gianfranco Truffarelli, detentore del 90 per cento del capitale sociale, il quale ha già dichiarato ai giornalisti che nessuno gli chiese «l’adeguamento sismico», bensì il semplice «miglioramento».
Ma a parte la disparità con quanto scritto nell’avviso comunale, ora si dovrà accertare se e come sono stati svolti quei lavori. La società fu costituita nel dicembre 2010 e ottenne l’attestazione necessaria per concorrere all’appalto nel maggio 2011, grazie all’acquisizione di una società in liquidazione e di una «ditta individuale». Il bando per i lavori nella scuola fu pubblicato tre mesi più tradi, ad agosto 2011, il Consorzio Stabile Valori se lo aggiudicò il 29 settembre e solo dopo, il 12 ottobre, la Edilqualità entrò nel cartello. Ne derivano, secondo i detectivedell’Anticorruzione, «forti dubbi» sulla «capacità tecnico-operativa» della ditta a effettuare il lavori nella «Romolo Caprarica». Il seguito dell’indagine dirà se sono destinati a crescere o diradarsi.
* Corriere della Sera, 31 agosto 2016 (ripresa parziale - senza immagini).
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- FILANTROPIA. Tra carità e giustizia (di Renato Piccini).26 luglio 2016, di Federico La Sala
La “moneta falsa” del filantrocapitalismo.
Una riflessione sulla «carità dei ricchi» *
- doc-2801. brescia-adisTa. (...) Di seguito ampi stralci dell’articolo di Piccini (rimandando per la sua versione integrale al sito della Fondazione (http://www.fondazionegpiccini.org/Filantropia_tra_carita_e_giustizia.asp). (claudia fanti)
FILANTROPIA
Tra cariTà e giusTizia
Renato Piccini
La filantropia è diventata di moda nel sistema neoliberista. Per capire, quindi, cos’è, la sua vera natura, il peso che ha nei rapporti economico-sociali, quali sono i suoi meriti e demeriti, è necessario guardare dentro il sistema economico capitalista. Oggi, infatti, vi è una nuova concezione, definita filantrocapitalismo.
La filantropia vuol essere la faccia buona del capitalismo, il suo volto pulito, che giustifica le sue scelte fondamentali, anche quelle della più assurda sperequazione sociale, l’impressionante ingiustizia che genera. (...). Non per niente, infatti, il Paese in cui è più diffusa la filantropia, gli USA, è anche quello in cui la sperequazione sociale raggiunge livelli tra i più alti del mondo.
La filantropia, nella concezione capitalista, esclude ogni senso di giustizia. (...). Chi “fa” filantropia non si sente legato ad alcun obbligo né legge e la esercita in piena libertà, secondo i propri “sentimenti” ma, soprattutto, secondo calcoli economico-politici. Chi la riceve sa che non ha alcun diritto e quindi raccoglie quella “moneta” con un duplice obbligo morale: non calcolare il dono secondo le proprie necessità; accoglierlo, soprattutto, con la massima gratitudine per aver ricevuto ciò cui non aveva diritto.
La giustizia è un obbligo di coscienza (e di legge) per chi deve praticarla e, per il destinatario, è un diritto da rivendicare. (...). Linsey McGoey (...) si interroga sull’efficacia ed efficienza dell’attuale filantropia (non molto diversa da quella del passato), soprattutto nell’ottica del filantrocapitalismo, rendendo evidente che la filantropia non viene esercitata secondo i bisogni e le necessità dell’uguaglianza - un diritto che è di tutti, al di là di ogni cultura, fede, geografia... - ma solo secondo la “bontà” (leggi “interessi”) dei padroni del denaro.
È DAVVERO EFFICIENTE LA FILANTROPIA?
In uno dei suoi racconti brevi, La moneta falsa, Charles Baudelaire descrive un incontro immaginario tra due amici che incrociano per strada un mendicante. Entrambi danno l’elemosina, però la moneta che lascia cadere uno di essi è molto più preziosa. Il narratore elogia la sua generosità e il suo compagno gradisce il complimento, però poi, lontano dal mendicante, aggiunge: «Era una moneta falsa».
Il narratore rimane sbalordito. Non soltanto perché il suo amico ha ingannato il mendicante, ma per la sua soddisfazione di apparire generoso. La soddisfazione deriva dal fatto che il mendicante non si rende conto di essere stato ingannato. Il narratore considera che «aveva voluto fare, a un tempo, la carità e un buon affare; guadagnarsi quaranta soldi e il cuore di Dio; pigliarsi senza spesa la fama d’uomo caritatevole».
Baudelaire scrisse questa storia nella seconda metà del XIX secolo, quando industriali come Andrew Carnegie e John Rockefeller cominciavano a investire le loro grandi fortune nelle maggiori azioni di filantropia mai viste prima. Dalle donazioni di Carnegie a biblioteche pubbliche sino agli investimenti di Rockefeller in ricerche biomediche, entrambi cambiarono il modo di fare carità, che passò da donazioni poco sistematiche a una forma di affare in se stesso, controllato da consulenti pagati.
Molti, tuttavia, non si sentivano riconoscenti per la generosità di questi robber barons (baroni ladri). Nel suo saggio L’anima dell’uomo sotto il socialismo, Oscar Wilde criticò la tendenza dei benefattori di usare la carità come copertura dinanzi alle richieste di una giusta redistribuzione della ricchezza. «I migliori tra i poveri - scrisse Wilde - non sono mai riconoscenti [ai benefattori]. Sono scontenti, ingrati, disobbedienti e ribelli, e hanno ragione di esserlo. [...]. Perché dovrebbero essere grati delle briciole che cadono dalla mensa del ricco? Dovrebbero essere seduti intorno al tavolo con gli altri commensali condividendo la festa!».
Ora che la filantropia entra in una seconda epoca d’oro, con donazioni di benefattori come Bill Gates e Warren Buffett (...), gli scettici cominciano a chiedersi se le preoccupazioni di Wilde e Baudelaire siano ancora attuali. I filantropi di oggi stanno coscientemente distribuendo “monete false”? Stanno cercando di “conquistarsi senza sforzi la fama d’uomo caritatevole”?
Nella maggior parte dei casi non è così. Le donazioni vengono realizzate in buona fede, con empatia verso vicini o lontani sconosciuti. Sta però affermandosi una nuova tendenza: il filantrocapitalismo, che cerca di combinare il guadagno con la riduzione della povertà. Dietro a questa nuova filantropia c’è il tentativo di fare una buona azione e, allo stesso tempo, realizzare un buon affare. È ancora valido l’interrogativo che si pose Baudelaire: chi trae più vantaggio dagli aiuti di carità, il donatore o il destinatario?
MISURAZIONE DEI RISULTATI
Nell’avanguardia della nuova filantropia si trova il movimento dell’“altruismo efficiente”, che (...) pone l’accento sulla misurazione dei risultati. Un pioniere è Peter Singer, discusso bioetico che ha elogiato Buffett e Gates come “gli altruisti più efficienti della storia”. (...).
L’organizzatore di una recente conferenza sull’altruismo efficiente, svoltasi nel campus di Google in Mountain View, arrivò al punto di affermare che «l’altruismo efficiente potrebbe essere l’ultimo movimento sociale di cui abbiamo bisogno ». Tuttavia è evidente che l’aumento globale delle donazioni negli ultimi dieci anni non è riuscito a ridurre le disuguaglianze economiche. (...).
Carnagie pubblicò il suo primo saggio sulla ricchezza, nel quale esortava i ricchi a condividere il loro bottino, solo pochi anni prima dello sciopero di Homestead del 1892, una delle più sanguinose rivolte di lavoratori della storia degli USA. Carnagie, nel momento in cui combatteva e annientava i grandi sforzi sindacali in espansione, dispensava anche “generosi aiuti” ai suoi lavoratori.
«Paradossalmente - ha segnalato David Nasaw, biografo del filantropo - Carnagie divenne sempre più spietato nella ricerca di guadagni una volta che decise di distribuirne i benefici». «Nel sostenere che il milionario è l’unico a poter decidere dove destinare i suoi milioni e che quanto egli considera migliore è il meglio - aggiunge Nasaw - Carnagie promulgava una verità profondamente antidemocratica, quasi feudale, del suo paternalismo».
Gli altruisti efficienti insistono sul fatto che la filantropia privata è la via più adatta per migliorare la vita. «I filantrocapitalisti di oggi vedono un mondo pieno di grandi problemi che loro, e forse soltanto loro, possono e debbono risolvere », scrivono Matthew Bishop e Michael Green in Filantrocapitalismo: come i ricchi possono cambiare il mondo, la Bibbia dei nuovi filantropi. (...).
Come ai tempi di Carnegie, la filantropia in molte occasioni viene utilizzata come giustificazione per decisioni lesive per la maggioranza della popolazione. «Ho donato 5 milioni di dollari per diverse cause. E ho una grande voglia di farlo sapere», scriveva su Twitter, a metà settembre del 2015, Martin Shkreli, consigliere delegato dell’impresa farmaceutica Turing, criticata duramente per aver aumentato il prezzo del Darapi (un medicinale di prima necessità usato contro gravi malattie infettive che colpiscono il sistema immunitario, ndt) di oltre il 5.000%. Questo è un eccellente esempio di filantrocapitalismo in azione: l’uso della filantropia per sviare l’attenzione da pratiche commerciali che impediscono l’accesso a medicinali salvavita. (...).
LE CONTRADDIZIONI DELLA FILANTROPIA: OPPORTUNITÀ DI PROGRESSO O AMMORTIZZATORE SOCIALE?
La filantropia viene ritenuta in diversi settori della società essenziale nel contesto del XXI secolo. I fautori ne difendono l’importanza e la necessità come argine agli effetti dell’attuale sistema capitalista “selvaggio”. Molte, però, sono le voci contrarie. (...).
«La filantropia - scrive Slavoj Zizek - è il modo in cui il sistema conserva lo status quo. La sua funzione è nascondere l’origine del problema. Grazie alla beneficienza il capitalismo si può auto-assolvere. La beneficienza diviene parte integrante del sistema, la carità fa parte dell’ideologia generale di oggi». Invece di porsi interrogativi seri su cosa sta succedendo e cercare vie d’uscita che garantiscano il bene comune, si delegano le soluzioni al “buon cuore” di chi ha denaro. (...). «La carità - continua Slavoj Zizek - è la maschera comunitaria che si nasconde dietro lo sfruttamento
economico. Per me il modello insuperabile di ciò che io considero “carità falsa” continua a essere Carnegie. Va bene, fece di tutto, costruì anche spazi culturali, per concerti, ecc... però assunse anche centinaia di detective Pinkerton in Texas per piegare i lavoratori in sciopero e liquidare i sindacati. Questo è per me il modello: prima colpisce brutalmente i lavoratori e poi... offre loro un concerto».
Peter Buffett, figlio di Warren Buffett e, come lui, uno dei più grandi filantropi statunitensi - quindi non “sospettabile” di sentimenti antifilantropici - fa un’analisi interessante: «La carità dei ricchi ha creato una macchina di povertà eterna. [...]. Nelle riunioni dei grandi filantropi si possono vedere capi di Stato, operatori economici, direttori di grandi imprese, capi di corporation transnazionali... che con la mano destra cercano soluzioni per risolvere problemi che i presenti nella sala hanno creato con la mano sinistra. [...]. Nella misura in cui la vita di un numero sempre più alto di individui e comunità viene distrutta da un sistema che crea enormi volumi di ricchezza per poche persone, si rafforza la filantropia come sistema per lavarsi la coscienza con la donazione di qualche briciola». (...).
La carità non arriva mai al nucleo del problema, nei casi migliori lo sfiora soltanto. Non si tratta di essere contro la carità, ma è necessario riconoscere l’ipocrisia di un sistema che, con una mano, “accumula e centralizza il capitale” e, con l’altra, “fa la carità per ridistribuire qualcosa”. (...).
José Ignacio Fernández scrive: «Nel capitalismo carità e ipocrisia sono due pilastri essenziali per la sua sopravvivenza: permettono ai ricchi di nascondere l’esistenza di meccanismi sistemici che generano disuguaglianza e ingiustizia sociale. È un po’ il gioco delle maschere per nascondere il comportamento egoista e il furto sistematico».
I sostenitori della filantropia la difendono come garanzia della vera “sostenibilità” che consiste non nel limitarsi “a dare un pesce a chi ha fame, ma nell’insegnargli a pescare”. La “legge della foresta” che “regola” i mercati, affermano, continuerà a creare bolle speculative che apriranno crisi ricorrenti... e il capitalismo produrrà sempre vincitori e vinti, lasciando molta gente vulnerabile e in grandi difficoltà. Se non si corregge qualcosa di queste disuguaglianze, i “vinti”, anche grazie alle nuove tecnologie di comunicazione, hanno la possibilità di “rovinare la festa” ai vincitori. La filantropia è essenziale per la sopravvivenza dell’umanità perché i grandi filantropi sono gli unici che possono “pensare in grande”. (...).
Il filantrocapitalismo non è altro che applicare alla solidarietà e alla carità i meccanismi imprenditoriali che hanno permesso di accumulare ricchezze multimilionarie. Harry Browne scrive: «L’idea è geniale: fatti ricco nello stesso tempo in cui salvi il mondo!».
Stephan Ernest Schmidheiny è un imprenditore svizzero condannato a 18 anni di carcere dalla Corte d’Appello di Torino per il disastro ambientale provocato dall’amianto negli stabilimenti Eternit in Italia e nei territori limitrofi, poi prosciolto in via definitiva per intervenuta prescrizione di reato e rimasto unico imputato nel processo Eternit-bis per l’ipotesi di reato di omicidio volontario di 258 persone.
In giro per il mondo, Schmidheiny è ben conosciuto e rispettato in quanto filantropo. Non solo, un’università americana gli ha dato una laurea honoris causa per il suo presunto impegno a favore dell’ambiente. In Italia l’hanno giudicato colpevole di disastro ambientale.
Slavoj Zizek (e molti altri) afferma che l’economia capitalistica attuale ingloba l’etica filantropica assumendola come proprio fondamento, un fondamento contraddetto dalle stesse logiche del capitale. Questo meccanismo perverso fa sì che, di fatto, si verifichi «una sovrapposizione tra etica e consumo: chi consuma può comprare, allo stesso tempo, un’azione etica. La redenzione del consumismo è nel consumo stesso».
La pubblicità che si fa delle grandi donazioni filantropiche aiuta a migliorare l’immagine della marca del donatore, associandola a una percezione di impegno sociale. (...). La filantropia diventa così un’ottima arma di concorrenza, un ottimo strumento di pubblicità e marketing.
La filantropia serve al cambiamento sociale? (...). Il giornalista Pere Rusiñol scrive: «L’età d’oro della filantropia è indiscutibile, però le maggiori quote storiche di fondi della filantropia coincidono con le maggiori quote di disuguaglianza della storia contemporanea. L’aumento delle elargizioni della filantropia e della disuguaglianza percorrono strade parallele». Le donazioni filantropiche negli USA si sono triplicate nello stesso periodo in cui gli ultraricchi hanno triplicato anche la loro parte di torta.
Naturalmente ci sono ragioni precise ed evidenti (...). Secondo i calcoli dell’economista francese Thomas Piketty, negli ultimi trent’anni il tasso effettivo delle imposte del 99% dei cittadini statunitensi è stato, praticamente, costante, mentre per i super-ricchi, in seguito alle detrazioni per “opere benefiche”, è passato dal 72 al 35%.
Lo stesso avviene per le grandi corporazioni con la diminuzione delle imposte per l’aumento della Responsabilità Sociale d’Impresa (CSR - Corporate Social Responsability). (...). L’economista francese Gabriel Zucman mette in guardia sul fatto che questa nuova età d’oro della filantropia, basata sulla riduzione delle imposte pagate dai ricchi e dalle imprese, «mina le fondamenta stesse del controllo sociale. Una società nella quale i ricchi decidono per proprio conto quante imposte pagare e a quali servizi pubblici sono disposti a contribuire non è una società civile. Questo è ciò che succedeva nella società vittoriana del XIX secolo e non dovrebbe succedere nel XXI. Se i multimilionari sono liberi di contribuire alla società, perché debbono pagare imposte? L’atteggiamento di molti, in particolare in Silicon Valley, si riassume in: smetti di farmi pagare imposte e darò la mia ricchezza alle cause che ritengo valgano la pena».
Molte “cause che valgono la pena” hanno quasi sempre a che vedere con la fede assoluta nella tecnologia in grado di risolvere, per se stessa, i problemi dell’umanità. Le fondazioni dei filantrocapitalisti sono lo strumento più importante usato dal capitale per penetrare in settori strategici dove fare affari (salute, educazione, ambiente, comunicazione...).
Ricercatori inglesi e tedeschi sono molto critici circa il potere decisionale dei grandi filantropi in grado di imporre a entità pubbliche e organizzazioni internazionali (Organizzazione Mondiale della Sanità, Organizzazione Mondiale del Commercio, ONU, ecc...) sia l’agenda - i problemi che debbono essere presi in considerazione - sia la metodologia per affrontarli e gli obiettivi che ci si pongono, privilegiando le “soluzioni” idonee e congeniali alle transnazionali. Questi milionari rappresentano un pericolo poiché possono imporre le loro priorità nel mondo, al margine di governi e del sistema democratico: la democrazia diventa una mera facciata al servizio del potere economico-finanziario.
La Fondazione Gates, ad esempio, finanzia campagne in campo sanitario, ma, attraverso intense campagne di lobby, difende anche la validità della proprietà intellettuale per assicurare ampi benefici ai suoi brevetti di software. I brevetti, però, colpiscono anche medicinali e sementi, condizionando pesantemente il diritto alla salute e all’alimentazione di centinaia di milioni di persone in tutto il mondo, soprattutto nei Paesi più poveri.
La filantropia, infatti, è anche espressione delle lobby più potenti, in grado di condizionare ogni aspetto della vita, della politica, dell’economia. (...). Per il mondo della filantropia l’accesso ai mezzi di comunicazione di massa è abituale: è indispensabile poter contare sull’informazione per far passare il proprio messaggio e portare a casa grandi profitti. (...). Naturalmente, anche in questo campo c’è un uso perverso del linguaggio: cancellati termini riconducibili a diritti sociali, si parla di “necessità” a cui rispondere con azioni filantropiche. (...).
Slavoj Zizek afferma: «La filantropia ha sostituito la politica ». La politica non è più un “affare comune”, è affidata a “professionisti” e rappresentanti, mentre il semplice cittadino deve limitarsi a preoccuparsi/occuparsi dei propri “affari privati”.
Nella privatizzazione “selvaggia”, a tutto campo, del sistema neoliberale, il “cittadino” diviene “insignificante”, non ha voce né spazio, non è ritenuto in grado di decidere cosa sia bene per lui - e tanto meno per la società - per cui ha l’obbligo di “scegliere” ciò che è stato scelto da altri per lui. (...).
Rhodes Diaves, responsabile del programma Giving Thought, della Charities Aid Foundation, chiede: «Come è possibile affrontare ingiustizia e disuguaglianze, quando la filantropia è possibile proprio come risultato della mancanza di equità?». (...).
Andando al di là di ideologie ed emozioni, se analizziamo a grandi linee il ruolo storico della filantropia, le sue conseguenze sociali, economiche e culturali, sembra che questa sia stata più una nemica che un’alleata nella trasformazione dell’attuale sistema economico verso uno più giusto ed equilibrato: una società veramente sana, retta da un modello basato su giustizia ed equità, non avrebbe alcun bisogno di gesti filantropici. Oscar Wilde diceva: «Il vero obiettivo deve esser quello di ricostruire la società in modo tale che la povertà sia impossibile ».
La filantropia rientra nella logica di privatizzare gli interventi su effetti, sintomi, conseguenze che non colpiscono mai le cause, perché queste sono originate dal sistema e ne perpetuano la priorità, prima tra tutto la demolizione del Welfare.
Di certo lo Stato attuale si allontana sempre più da un reale Stato di diritto, rappresentativo dei diritti e degli interessi delle maggioranze, preso com’è tra le spire soffocanti dell’economia e del potere finanziario internazionale, però il futuro della storia non può essere affidato a chi del sistema vive e che tale sistema ha creato e perpetuato: pure questo è un campo aperto da affrontare e per cui lottare.
* Adista/Documenti, 30 LUGLIO 2016 • N. 28
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- Nuzzi e Fittipaldi sono accusati del reato di «associazione criminale». Il processo ai giornalisti in Vaticano ricorda i tribunali sovietici (di Ezio Mauro)6 luglio 2016, di Federico La Sala
- W o ITALY !!! Evangelo, Costituzione, e fine del cattolicismo costantiniano ....
 DEMOCRAZIA, TEOCRAZIA (LA MONARCHIA "EDIPICA" VATICANA), E RISPETTO PER LA REPUBBLICA ITALIANA!!! Il Papa è un personaggio molto autorevole, ma è il Capo di un altro Stato - e non democratico!!! Una nota di Furio Colombo
DEMOCRAZIA, TEOCRAZIA (LA MONARCHIA "EDIPICA" VATICANA), E RISPETTO PER LA REPUBBLICA ITALIANA!!! Il Papa è un personaggio molto autorevole, ma è il Capo di un altro Stato - e non democratico!!! Una nota di Furio Colombo
Quei due libri in attesa di una sacra sentenza
Il processo ai giornalisti in Vaticano ricorda i tribunali sovietici
di Ezio Mauro (la Repubblica, 06.07.2016)
- L’indagine condotta dal comandante della gendarmeria vaticana Domenico Giani attraverso perquisizioni e intercettazioni aveva preso il via dopo la pubblicazione di documenti riservati inerenti la Prefettura per gli Affari economici vaticana
 Il 31 ottobre 2015, pochi giorni prima della pubblicazione dei due libri sugli sprechi e i lussi in Vaticano - uno di Gianluigi Nuzzi, l’altro di Emiliano Fittipaldi - la gendarmeria arresta monsignor Lucio Ángel Vallejo Balda e Francesca Chaouqui, accusati di aver diffuso documenti riservati
Il 31 ottobre 2015, pochi giorni prima della pubblicazione dei due libri sugli sprechi e i lussi in Vaticano - uno di Gianluigi Nuzzi, l’altro di Emiliano Fittipaldi - la gendarmeria arresta monsignor Lucio Ángel Vallejo Balda e Francesca Chaouqui, accusati di aver diffuso documenti riservati
 Il 24 novembre 2015 si è aperto il processo. Con Chaouqui e Balda sono imputati il segretario Nicola Maio, e i giornalisti Nuzzi e Fittipaldi. Il Tribunale vaticano ha chiesto 3 anni e 1 mese per Balda, 3 anni e 9 mesi per Chaouqui, 1 anno e 9 mesi per Maio, 1 anno per Nuzzi e l’assoluzione di Fittipaldi
Il 24 novembre 2015 si è aperto il processo. Con Chaouqui e Balda sono imputati il segretario Nicola Maio, e i giornalisti Nuzzi e Fittipaldi. Il Tribunale vaticano ha chiesto 3 anni e 1 mese per Balda, 3 anni e 9 mesi per Chaouqui, 1 anno e 9 mesi per Maio, 1 anno per Nuzzi e l’assoluzione di Fittipaldi
 Francesca Chaouqui, 33 anni, nel 2013 entra, unica donna, nella Commissione di studio sull’organizzazione delle strutture economiche e amministrative della Santa Sede. È accusata di aver passato a Nuzzi documenti riservati
Francesca Chaouqui, 33 anni, nel 2013 entra, unica donna, nella Commissione di studio sull’organizzazione delle strutture economiche e amministrative della Santa Sede. È accusata di aver passato a Nuzzi documenti riservati
DA una parte la croce, incastonata nel legno che regge gli scranni della Corte. Dall’altra il busto severo di Pio XI, “professore di sacra eloquenza”, che sorveglia l’aula. Sul soffitto, il simbolo sacro delle chiavi di Pietro che normalmente aprono il regno dei cieli, ma oggi possono rinserrare anche la porta del carcere vaticano, perché qui, nel Tribunale della Santa Sede, si stanno celebrando gli ultimi atti del processo Vatileaks per la fuga di notizie riservate dai sacri palazzi.
Sulla panca degli imputati che ha sullo schienale un cordolo in rilievo, in modo che nessuno possa appoggiarsi ma tutti rimangano protesi verso la Corte, siedono due funzionari vaticani (monsignor Lucio Vallejo Balda, segretario della commissione nominata da Papa Francesco per l’indagine sulle finanze vaticane, il suo collaboratore Nicola Maio) e una donna, Francesca Immacolata Chaouqui, membro anche lei della commissione.
Nuzzi e Fittipaldi sono accusati del reato di «associazione criminale» per la rivelazione di notizie e documenti che riguardano interessi fondamentali dello Stato. Con loro, imputati di «concorso» nella divulgazione di documenti, due giornalisti, Emiliano Fittipaldi dell’Espresso e Gianluigi Nuzzi, conduttore televisivo. Ma sarebbe più giusto dire che sul banco degli imputati, nella grande sala al pianterreno del Tribunale, ci sono due libri, portati alla sbarra in mezzo all’Europa malandata e all’Occidente distratto del 2016, anno terzo dell’era Bergoglio.
Quei due libri, frutto di due separate inchieste giornalistiche, hanno in realtà molto poco a che fare con quelli che nelle democrazie vengono comunemente considerati gli «interessi fondamentali» dello Stato. Sia Via Crucis di Nuzzi che Avarizia di Fittipaldi riguardano invece la gestione disinvolta e per nulla trasparente dei fondi del Vaticano e degli istituti collegati alla Santa Sede, dai 70-80 milioni annui dell’obolo di San Pietro che finiscono ai poveri solo in minima parte, secondo la Commissione europea, alla fondazione Bambin Gesù che spende quasi mezzo milione di euro non per l’ospedale infantile ma per ristrutturare l’attico del cardinal Bertone, allo Ior che non dichiara a chi appartenevano quei quattromila conti che sono stati chiusi, e ha ancora oggi misteriosi laici intestatari dei suoi conti, al mercato delle case dei cardinali e all’immensa proprietà immobiliare della Santa Sede, al prezzo della cause di beatificazione dei santi, che arriva anche a 500mila euro per ogni anima venerabile canonizzata. Uno scandalo? Certo. Una materia che per la Curia doveva rimanere coperta, secondo quel culto del segreto avviato in Vaticano da Bonifacio VIII? Probabile. Ma cosa c’entrano la Patria e l’interesse nazionale con la denuncia del malgoverno delle sacre finanze?
In realtà due terrori congiunti pesano su San Pietro da quando sulla cupola della basilica, dove una volta nei mosaici s’innalzava immacolata la fenice, vola alto il corvo. La prima paura riguarda la dimensione dei guai economici della Santa Sede, strettamente legati alla gestione oscura di troppi interessi. La seconda paura è che la mancanza di trasparenza su questa materia favorisca un gioco incrociato di ricatti, vendette e avvertimenti, diventando strumento di lotte di potere interne, amplificate dal clamore profano che gonfia ogni rivelazione all’esterno, rimandandola ingigantita dentro i sacri palazzi: soprattutto in un momento in cui l’opera di rinnovamento di Papa Francesco incontra forti resistenze nella Chiesa. Quando La Curia al completo gli si è presentata davanti per gli auguri di Natale, il 23 dicembre di due anni fa, Francesco ha dato un posto d’onore a queste due “malattie” nelle 15 piaghe che affliggono la Chiesa: il «terrorismo delle chiacchiere, delle mormorazioni e dei pettegolezzi» che trasforma gli uomini in «seminatori di zizzania, simili a Satana» e l’accumulo di beni materiali per profitto mondano, «perché il sudario non ha tasche».
Bergoglio sa che nel suo mandato in conclave c’è il recupero del ruolo della Chiesa consumato attraverso gli scandali, i peccati contro il sesto e il settimo comandamento, la rete di ricatti che da tutto questo è cresciuta avviluppando il visibile e insidiando l’invisibile della sacralità vaticana fino a deturparne il volto, come ha denunciato lo stesso Ratzinger. Anche la rinuncia di Benedetto XVI è infatti un obbligo testamentario, perché denuncia la fragilità papale davanti al peso di una responsabilità di governo diventata intollerabile, quando manca «il vigore del corpo e dell’animo ».
Il nuovo Papa è dunque consapevole fin dall’apparizione sulla Loggia di essere stato eletto in un rovesciamento geografico del potere curiale, quasi a dire basta agli intrighi e ai ricatti italiani del Palazzo, tanto che appena quattro mesi dopo la sua elezione cerca di frenare il volo dei corvi e i piani dei loro addestratori. Lo fa mettendo mano al codice penale vaticano, in particolare al paragrafo sui “Delitti contro la Patria”, aggiungendo un nuovo articolo, il 116 bis. «Chiunque si procura illegittimamente o rivela notizie o documenti di cui è vietata la divulgazione, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni - dice la norma - Se la condotta ha avuto a oggetto notizie o documenti concernenti gli interessi fondamentali o i rapporti diplomatici della Santa Sede o dello Stato, si applica la pena della reclusione da quattro a otto anni».
Quando escono i due libri, l’indagine della Gendarmeria scopre una «squadra operativa» che si è formata proprio nella Prefettura per gli Affari Economici, con l’obiettivo di raccogliere materiali riservati e diffonderli all’estero. Il Promotore di Giustizia, cioè il Pubblico Ministero Vaticano, individua in Balda, Chaouqui e Maio il «sodalizio criminale organizzato col presupposto di una missione da seguire per realizzare la vera volontà del Papa», attraverso la raccolta e la diffusione di notizie e documenti sensibili. Con loro, finiscono a giudizio i due giornalisti, prima con l’ipotesi di minacce sui funzionari vaticani per avere i materiali, poi col sospetto di pressioni, infine semplicemente - e incredibilmente - soltanto per aver manifestato un interesse professionale alle notizie che dal Vaticano venivano fatte filtrare. Non potendo bloccare i libri (che hanno autori ed editori italiani, e sono tutelati e soggetti alle leggi italiane) si accusano i loro due autori di «concorso» con i tre principali imputati, accusati di «associazione criminale».
Poiché in Vaticano soffia lo Spirito santo, ma non esiste la Costituzione, non c’è nemmeno l’articolo 21 che nella nostra Carta tutela la libertà di espressione dei cittadini, in quanto «tutti hanno diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero con parole, scritti e ogni altro mezzo di diffusione», mentre «la stampa non può essere oggetto di autorizzazione o censura ». Nel tribunale vaticano, così, lunedì i Promotori di Giustizia Gian Pietro Milano e Roberto Zannotti hanno potuto accusare Nuzzi e Fittipaldi di concorso morale nella divulgazione per «l’impulso psicologico » che con la loro «presenza e disponibilità » ha «contribuito a rafforzare il proposito della rivelazione delle notizie» nei funzionari vaticani. I Promotori hanno precisato che «chi riceve notizie normalmente non è punibile». Ma hanno aggiunto: «Lo diventa se rafforza il proposito di chi le rivela. I giornalisti sono stati una ragione essenziale per divulgare le notizie». Quindi siamo davanti a questo paradosso: due giornalisti sono portati in Tribunale perché con la loro semplice «presenza e disponibilità » hanno rafforzato la decisione di divulgare le carte da parte di un «sodalizio criminale» già organizzato a tal fine in Vaticano; la pura presenza diventa una colpa; la disponibilità a raccogliere notizie un comportamento da censurare. E il mestiere di giornalista finisce sotto accusa.
Quasi una vendetta per il passato, e un monito per il futuro: qui la libertà di stampa non esiste, fare giornalismo secondo le regole e i comandamenti di ogni democrazia dietro le mura leonine può diventare un reato. E infatti mentre per Fittipaldi il Promotore ha proposto l’assoluzione per insufficienza di prove, per Nuzzi ha chiesto la condanna a un anno, con sospensione condizionale. Per Chaouqui 3 anni e nove mesi, per Balda tre anni e un mese, per Maio un anno e nove mesi.
Così finisce lo strano processo in cui gli imputati non hanno potuto avere copia del fascicolo che li riguarda, per la difesa hanno dovuto obbligatoriamente scegliere due nomi nell’elenco presso la Santa Sede degli avvocati rotali, mentre monsignor Balda ha negato in aula di aver ricevuto qualsiasi minaccia dai giornalisti, nessuno ha presentato una querela per affermazioni non veritiere nei due libri, le fonti erano istituzionali. È l’ultimo paradosso di un processo in uno Stato straniero che vede coinvolti tutti cittadini italiani (giudici, Promotori e avvocati compresi) salvo il monsignore segretario della Prefettura per gli Affari Economici. Tanto che Nuzzi ha chiesto al premier Renzi «perché il governo italiano tace, visto che sono intervenute organizzazioni internazionali a tutela della libertà di stampa».
Resta una domanda: e il Papa? Francesco ha parlato due volte di Vatileaks. La prima all’Angelus dell’8 novembre 2015, festa di San Goffredo: «So che molti di voi sono turbati dalle notizie che riguardano documenti riservati della Santa Sede sottratti e pubblicati. Voglio dirvi che rubare questi documenti è un reato, è un atto deplorevole che non aiuta. E voglio assicurarvi che questo fatto non mi distoglie dal lavoro di riforma che sto portando avanti». La seconda il 30 novembre 2015, Sant’Andrea, rispondendo ai giornalisti: «La stampa libera laica e confessionale ma professionale (perché le notizie non devono essere manipolate) per me è importante, perché la denuncia delle ingiustizie e della corruzione è un bel lavoro. Ma la stampa deve dire tutto, senza cadere nei tre peccati più comuni: la disinformazione, la calunnia e la diffamazione».
In questo caso non c’è calunnia, non c’è diffamazione, non c’è disinformazione. C’è una verità scomoda, che qualcuno dal Vaticano ha voluto far conoscere all’esterno, e che i giornalisti hanno ovviamente pubblicato, verificata la fonte. C’è la fattispecie surreale dell’«impulso psicologico », trasformata in un atto d’accusa. È bastato questo al direttore di Radio Maria, Padre Livio Fanzaga, per condannare con grande anticipo Nuzzi e Fittipaldi, il 6 novembre 2015: «Quelli che mi scandalizzano sono i giuda, i giornalisti dalla lingua e dalla penna biforcuta mi fanno nauseare. Mi fa fatica pregare per loro, perché io li impiccherei, quasi quasi».
Alla fine, restano due libri sugli scranni di un Tribunale, come nel processo sovietico ai romanzi di Sinjavsky e Daniel nel 1966, quando gli imputati provarono invano a spiegare in aula che a un libro non si possono applicare categorie giuridiche. Due libri, che aspettano ormai la sacra sentenza.
I volumi di Fittipaldi e Nuzzi sono frutto di inchieste giornalistiche: nessuno ha presentato querela per affermazioni non veritiere Poiché in Vaticano soffia lo Spirito santo ma non esiste la Costituzione non c’è nemmeno l’articolo 21 che tutela la libertà di espressione dei cittadini.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- «in nome del Papa»: Vatileaks, condannati Chaouqui e Balda. Prosciolti i giornalisti Nuzzi e Fittipaldi (di Virginia Piccolilllo)8 luglio 2016, di Federico La Sala
Vatileaks, condannati Chaouqui e Balda.
Prosciolti i giornalisti Nuzzi e Fittipaldi
Dieci mesi alla pr (pena sospesa), 18 per il monsignore.
Applicato il motu proprio del Pontefice
di Virginia Piccolillo (Corriere della Sera, 08.07.2016)
ROMA È rimasto immobile, con il suo aspetto dimesso e rassegnato, anche mentre «in nome del Papa», il presidente del Tribunale pronunciava la sua condanna. La più dura. Un anno e mezzo. A meno di un ricorso in appello che, da indiscrezioni, non è intenzionato a proporre, monsignor Angel Lucio Vallejo Balda è uscito di scena così. Curvo sotto il peso di un processo che ha causato più clamore e amarezze che conseguenze giudiziarie.
Prosciolti i due giornalisti, Gianluigi Nuzzi ed Emiliano Fittipaldi. E non solo per difetto di giurisdizione. «Rilevata la sussistenza, radicata e garantita dal diritto divino, della libertà di manifestazione del pensiero e della libertà della stampa nell’ordinamento giuridico vaticano» si legge nella sentenza, che cita il motu proprio del Papa. Ridimensionata, rispetto alle richieste, la condanna di Francesca Immacolata Chaouqui: dieci mesi di reclusione con pena sospesa per cinque anni. Solo per concorso in divulgazione. Niente più associazione a delinquere. Prosciolto anche Nicola Maio.
Una sentenza, quella firmata dal presidente Giuseppe Dalla Torre, e dai giudici Piero Antonio Bonnet, Paolo Papanti-Pelletier e Raffaele Ottaviano, accolta da molti commenti positivi. Incluso quello della Federazione della Stampa. Ma che porta con sé anche un dubbio: c’era davvero bisogno di questo processo?
In attesa delle motivazioni dell a sentenza, alle ragioni del «sì» ha dato voce Padre Lombardi. «Si doveva fare perché c’è una legge, per di più recente (2013), promulgata per contrastare le fughe di notizie. Non si possono dichiarare intenzioni e stabilire norme e non essere coerenti nel metterle in pratica» ha spiegato. Ricordando come sia stato smentito più volte che fosse un processo alla libertà di stampa ha aggiunto che si doveva «dimostrare la volontà di combattere con decisione le manifestazioni e le conseguenze scorrette delle tensioni e polemiche interne vaticane» che da un po’ di tempo si riflettono all’esterno con «indiscrezioni» o «documenti ai media» creando «un contesto ambiguo e conseguenze negative anche nell’opinione pubblica, che ha diritto a una informazione obiettiva e serena».
«Questa è una “malattia”, come direbbe Papa Francesco, da combattere con determinazione», rimarca padre Lombardi. E aggiunge: «Anche Benedetto XVI, pur non essendovi ancora la legge attuale, aveva ritenuto giusto che la giustizia “umana” facesse il suo corso nei confronti del suo maggiordomo fino alla sentenza».
Una precisazione che sembra fugare l’ipotesi, circolata ieri, che tra le richieste di condanna (quasi 4 anni per Chaouqui, 3 e un mese per Balda e 1 per Nuzzi) e la sentenza ci sia stato un intervento dall’alto.
Infine l’auspicio che «nonostante la tristezza che ogni reato e la conseguente vicenda processuale necessariamente causano, se ne possano trarre le conclusioni e le riflessioni utili per prevenire in futuro il ripetersi di situazioni e vicende simili». L’avviso ai «corvi» è stato dato. Ora basta.
- W o ITALY !!! Evangelo, Costituzione, e fine del cattolicismo costantiniano ....
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- Riforma costituzionale: sì della Chiesa, sì della Confindustria. Se la democrazia è incompatibile con il Dio.Mercato. Note,27 maggio 2016, di Federico La Sala
- IL SONNO MORTIFERO DELL’ITALIA. In Parlamento (ancora!) il Partito al di sopra di tutti i partiti.
- IL SONNO MORTIFERO DELLA CHIESA: DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ?("Caritas")
Se la democrazia è incompatibile con il mercato
di Andrea Colombo (il manifesto, 27.05.2016)
Il pronunciamento netto a favore della riforma istituzionale col quale ieri Vincenzo Boccia ha inaugurato il mandato alla guida di Confindustria non è uno dei tanti pareri che piovono in questi giorni, in seguito alla scelta renziana di aprire la campagna referendaria con mesi di anticipo.
Sul sì degli industriali, che verrà ufficializzato il 23 giugno dal Consiglio generale dell’associazione, non c’erano dubbi. Le motivazioni dell’entusiasta sostegno degli industriali alla riforma meritano tuttavia di essere considerate con attenzione. Boccia infatti non le manda a dire: le riforme sono benvenute e benemerite perché devono «liberare il Paese dai veti delle minoranze e dai particolarismi», il cui perverso esito è stato «l’immobilismo».
Immobilismo? In un Paese in cui, nel 2011, un governo da nessuno eletto ma imposto dall’Europa e da un capo dello Stato che travalicava di molto i confini del proprio ruolo istituzionale ha stracciato in quattro e quattr’otto diritti e garanzie del lavoro conquistate in decenni, senza che quasi nessuno proferisse verbo? Con un governo che nella sua marcia ha incontrato un solo serio ostacolo, costituito non dalle minoranze e dai particolarismi ma da una parte integrante della truppa del premier, i cosiddetti catto-dem? Dal giorno dell’ascesa a palazzo Chigi di Renzi, anche lui senza alcun voto popolare, il loro è stato l’unico no che il governo ha dovuto ingoiare ma è improbabile che a questo alludesse Boccia. Per il resto nessuna minoranza e nessun particolarismo hanno trovato ascolto alle orecchie del gran capo.
Il problema è che gli industriali, proprio come la grande finanza e le centrali del potere europeo, stanno mettendo le mani avanti. Non hanno bisogno di intervenire sul presente, che dal 2011 gli va benone così com’è, ma sul futuro. Devono impedire che la democrazia, dissanguata in nome della crisi dei debiti e del voto del 2013, reclami domani diritti che sulla carta ancora avrebbe. Si tratta, non certo per la prima volta nella storia italiana, di rendere un’emergenza permanente.
Quello degli industriali non è un endorsement tra i tanti: è la vera chiave della riforma, la sua ragion d’essere. Per smontare la retorica sui guasti del bicameralismo che costringerebbe le leggi a transitare come anime in pena tra Montecitorio e Palazzo Madama basterebbero i dati sui tempi di approvazione delle leggi in Europa. L’Italia è nella media.
Da quel punto di vista il bicameralismo non desta preoccupazioni. I tempi diventano biblici solo quando leggi spinose vengono chiuse nel cassetto e lì dimenticate. Nulla, nel nuovo assetto disegnato dalla riforma, impedirebbe di farlo ancora, sia pure in una sola camera.
I poteri economico-finanziari, però, si sono convinti che produzione ed economia possano prosperare solo in una situazione di democrazia decurtata e in virtù di governi autoritari, tali cioè da non doversi misurare con «le minoranze e con i particolarismi», in concreto, con un libero Parlamento.
Come quasi tutti gli orientamenti imposti dall’Europa e dai poteri economico-finanziari si tratta di un dogma. Anche a voler accettare il prezzo salatissimo dello scambio tra democrazia e produttività, nulla garantisce che i risultati arriverebbero, anche solo in termini di efficienza produttiva. Proprio il caso dell’Italia, dove la democrazia parlamentare è soffocata da ormai cinque anni senza risultati apprezzabili, dovrebbe dimostrarlo, ma tant’è. Questa è la strada decisa da chi deve decidere per tutti.
Questo ha detto nel suo primo discorso il presidente di Confindustria. Scusate se è poco.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- Riforma costituzionale: sì di Cacciari. “Riforma maldestra ma è una svolta, l’attacca chi ha fallito per 40 anni” (Interv. di Ezio Mauro)27 maggio 2016, di Federico La Sala
Massimo Cacciari. Il filosofo, ex deputato e sindaco, fa autocritica “Anche noi volevamo dare più potere decisionale alla democrazia, il Pci frenò”. “Ora Renzi però fa un errore capitale se personalizza il confronto”
“Riforma maldestra ma è una svolta, l’attacca chi ha fallito per 40 anni”
Intervista di Ezio Mauro (la Repubblica, 27.05.2016)
PROFESSOR Cacciari, lei è una coscienza inquieta della sinistra italiana che ha visto anche all’opera da vicino, quando è stato parlamentare. Si aspettava questa battaglia all’ultimo sangue sul referendum?
«Devo essere sincero? C’erano tutti i segnali. Abbiamo provato a riformare le istituzioni per quarant’anni, e non ci siamo riusciti. La strada della grande riforma sembra un cimitero pieno di croci, i nostri fallimenti. Adesso Renzi forza, e vuole passare. Chi ha fallito si ribella».
Fuori i nomi, professore: chi ha fallito?
«Noi, la mia generazione, a destra come a sinistra. Sia i politici che noi intellettuali. Ci sono anch’io, infatti, insieme con Marramao, Barbera, Barcellona, Bolaffi, Flores, si ricorda? E dall’altra parte, a destra, il professor Miglio alla Cattolica, le idee di Urbani. Eravamo nella fase finale degli anni di piombo, la democrazia faticava. Ragionavamo sulla necessità e sulla possibilità di riformare una Costituzione senza scettro, come dicevamo allora, perché necessariamente era nata con la paura del tiranno. Di fronte alla crisi sociale di quegli anni, pensavamo fosse venuto il momento di rafforzare le capacità di decisione del sistema democratico ».
Di cosa avevate timore?
«Si parlava molto del fantasma di Weimar. Ragionavamo su basi storiche, scientifiche, costituzionali. La crisi ci faceva capire come una Costituzione che ostacola un meccanismo di governo forte e sicuro sia debole, perché quando la politica e le istituzioni sono incerte decidono altri, da fuori».
Oggi diremmo la finanziarizzazione, la globalizzazione?
«Certo. Ma non dobbiamo pensare solo alle lobby e all’economia finanziaria o ai grandi monopoli, bensì anche alle tecnocrazie create democraticamente, come le strutture dell’Unione europea, che rischiano in certi momenti di soverchiare la politica».
Come mai quell’idea non ha funzionato?
«Per un ritardo culturale complessivo del sistema, evidentemente. Ma devo dire in particolare per il conservatorismo esasperato del Pci e del suo gruppo dirigente, che parlavano di riforme di struttura per il mondo economico-industriale, ma sulle istituzioni erano bloccati. Dibattiti tanti, convegni dell’istituto Gramsci, qualche apertura di interesse da Ingrao e Napolitano. Ma niente, rispetto alla nostra discussione sul potere e la democrazia».
Per la paura comunista, dall’opposizione, di rafforzare l’esecutivo?
«Un riflesso automatico. Ma vede, noi non parlavamo solo di rafforzare l’esecutivo, è una semplificazione banale. Il potere non è una torta di cui chi vince prende la fetta più grande e chi perde la più piccola, la somma non è zero. Noi volevamo rafforzare tutti i soggetti del sistema democratico. Più potere al governo, dunque, ma con un vero impianto federalista che articola il meccanismo decisionale, e un autentico Senato della Regioni con i rappresentanti più autorevoli eletti direttamente, e non scelti tra i gruppi dirigenti più sputtanati d’Italia, come oggi».
Ma un governo più forte significa un parlamento più debole?
«Non se lo dotiamo di strumenti di controllo e d’inchiesta all’americana, e se è capace di agire autonomamente, senza succhiare le notizie dai giornalisti o dai giudici: un’autorità quasi da tribunato».
Quindi un nuovo bilanciamento, tra poteri tutti più forti? E’ questa la riforma che vorrebbe?
«Un potere rafforzato e ben suddiviso. Il potere non si indebolisce se è articolato razionalmente e democraticamente tra i soggetti giusti. E’ quando si concentra in poche mani e si irrigidisce che diventa debole».
Non è quello che denuncia Zagrebelsky?
«E’ quello che capisce chiunque, salvo chi è digiuno culturalmente. Il potere per funzionare deve essere efficace ma anche articolato come ogni organizzazione moderna. Chi può pensare in questo millennio che si ha più potere se lo si riassume in un pugno di uomini invece di regolarlo con una diffusione partecipata e democratica? ».
E’ esattamente l’accusa che viene rivolta dal fronte del “no” alla riforma del Senato, non le pare?
«Esattamente proprio no. Manca l’autocritica che sta dietro tutto il mio discorso: la presa d’atto che non siamo mai riusciti a riformare il sistema, pur sapendo che ce n’era bisogno. Diciamola tutta: la nostra idea di rispondere al bisogno di modernizzazione dell’Italia riformando le istituzioni ha contato in questi quarant’anni come il due di coppe quando si va a bastoni. Bisognerà pur prendere atto di questo, e trarne le conseguenze politiche».
Quali?
«Non abbiamo la faccia per dire no a una riforma dopo aver buttato via tutte le occasioni di questi quattro decenni. Non siamo riusciti a costruire nulla di positivo dal punto di vista della modernizzazione del sistema: niente di niente».
E dunque per questo - mi ci metto anch’io - dovremmo stare zitti?
«Dovremmo misurare i concetti, le parole, le proporzioni tra ciò che accade e come lo rappresentiamo. La riforma crea danni ed è autoritaria? Balle: è vero che punta sulla concentrazione del potere, ma la realtà è che si tratta di una riforma modesta e maldestra. La montagna ha partorito un brutto topolino. Erano meglio persino quei progetti delle varie Bicamerali guidate da Bozzi, De Mita e D’Alema, più organici e articolati, anche se centralisti e nient’affatto federalisti ».
Ma la critica sulla concentrazione oligarchica del potere è la stessa di Zagrebelsky, no?
«Certo ma, ripeto, non condivido certi toni da golpe in arrivo, che non sono di Zagrebelsky. Il vero problema, secondo me, non è una riforma concepita male e scritta peggio, ma la legge elettorale. Qui sì che si punta a dare tutti i poteri al Capo. Anzi, le faccio una facile previsione: se si cambiasse la legge elettorale, correggendola, tutto filerebbe liscio, si abbasserebbe il clamore e la riforma passerebbe tranquillamente ».
Lo chiede la minoranza Pd, lo propone Scalfari, ma Renzi finora ha risposto di no: dunque?
«La posta è stata alzata troppo, da una parte e dall’altra, anche se in verità ha cominciato Renzi, personalizzando il referendum e legandolo alla sua sorte. Un errore capitale. Penso che lo abbia capito ma ormai non possiamo far finta di non vedere che la partita si è spostata, e si gioca tutta su di lui, da una parte e dall’altra: se mandarlo a casa oppure no. Ci siamo chiesti cosa succede dopo? ».
Anche lei prigioniero del “non c’è alternativa”?
«No, io so cosa c’è, è evidente. Renzi va da Mattarella, chiede le elezioni anticipate e le ottiene. Poi resetta il partito purgandolo e lancia una campagna all’insegna del sì o no al cambiamento, con quello che potremmo chiamare un populismo di governo. Votiamo col proporzionale, con questo Senato, e non otteniamo nulla, se non una lacerazione ancora più forte del campo: è davvero quello che vogliamo? ».
Ma non le sembra che così lei si stia autoricattando?
«Perché quante volte lei e tante persone di sinistra non hanno fatto la stessa cosa in questi anni? Vuole fingere che non abbiamo votato spesso turandoci il naso? C’è una teoria della cosa, si chiama il “male minore”. D’altra parte stiamo parlando della povera politica italiana, non di Aristotele».
E se si trovasse in emergenza una maggioranza per una diversa legge elettorale?
«Illusioni. Se mai, non escludo il contrario. E cioè che Renzi come extrema ratio punti lui a una rottura verticale per ottenere il voto anticipato. E in ogni caso, pensiamo all’effetto che avrebbe sull’opinione pubblica un nuovo fallimento, dopo i tanti che noi abbiamo collezionato. Significherebbe certificare che in Italia il sistema non è riformabile, per due ragioni opposte unite nel “no”: chi vede un pericolo autoritario, chi solo dei dilettanti allo sbaraglio».
Sta dicendo che rifiuta il “no”?
«Come ho cercato di spiegare capisco molte delle ragioni del fronte del “no”, non il tono e l’impianto generale. Dopo aver detto tutto quel che penso della riforma, considero che realizza per vie traverse e balzane alcuni cambiamenti che volevamo da anni».
Dunque?
«Voterò sì, per uno spirito di responsabilità nei confronti del sistema. Penso che si possa essere apertamente critici e sentire questa responsabilità repubblicana ».
Lei è stato tre volte sindaco di una città come Venezia. Pensa che il voto amministrativo potrà modificare il quadro o i rapporti di forza?
«E’ inutile girarci intorno, è Milano che decide l’intera partita. Se il Pd perde a Milano, il centrodestra capisce come deve muoversi, ricostruisce un campo, prova a sfondare sul referendum sfruttando la ferita aperta di Renzi».
E a sinistra?
«Nessun segno di vita pervenuto, dunque poche speranze».
Professore, non rischiamo così di incoraggiare un cinismo distruttivo che la sinistra già produce in abbondanza? E proprio mentre una nuova destra al quadrato bussa ai confini con l’Austria e con tutta l’Europa di mezzo?
«Di più. Stiamo coltivando una cultura della sconfitta, guardi com’è ridotta la socialdemocrazia che poco tempo fa governava l’Europa. Oggi è schiacciata da derive di sinistra, come Tsipras, e di destra magari anche al cubo, come Hofer ».
E’ colpa della crisi o della lettura che la sinistra fa della crisi?
«E’ colpa della sua incertezza identitaria. Anche in politica l’identità è tutto, non ci sono solo gli interessi, sia pure legittimi. La sinistra perde perché è identificata col sistema vigente, anzi con la sua élite, a cui viene imputata la crisi. Ma così perde la sua ragione di stare al mondo che è ancora e sempre una sola: cercare di cambiare lo stato di cose esistente».
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- Riforma costituzionale. Caro Cacciari, perché su Renzi sbagli tutto (di Piero Bevilacqua)1 giugno 2016, di Federico La Sala
- LO "STATO HEGELIANO" - DELLO STATO MENTITORE, ATEO E DEVOTO ("Io che è Noi, Noi che è Io"). --- Destra e Sinistra: "Al cuore delle cose. Scritti politici" (di E. Fachinelli - Dario Borso)
Caro Cacciari, perché su Renzi sbagli tutto
Riforme. Il neo-centralismo della riforma costituzionale e il dispositivo autoritario contenuto nell’Italicum non sono una cattiveria di Renzi. È un passaggio obbligato, nel contesto del capitalismo globale, di una strategia ineludibile per il ceto politico. Se non hai il consenso hai bisogno del potere
di Piero Bevilacqua (il manifesto, 31.05.2016)
L’intervista che Massimo Cacciari ha rilasciato a Ezio Mauro (Repubblica, 27.5.2016) per motivare il suo SI al referendum confermativo della riforma del Senato, offre al lettore, io credo, un buon campionario di motivi per indurlo al comportamento contrario a quello perorato dal filosofo: cioé a votare decisamente NO.
Nel merito Cacciari arriva a definire l’oggetto del referendum «una riforma modesta e maldestra. La montagna ha partorito un brutto topolino». Poco prima, incalzato da Mauro, aveva ricordato che da decenni era nelle sue aspirazioni e nella parte più illuminata della sinistra, la creazione di «un autentico Senato delle Regioni con i rappresentanti più autorevoli eletti direttamente, e non scelti tra i gruppi dirigenti più sputtanati d’Italia, come oggi». Come dissentire?
Poco prima, incalzato da Mauro, aveva ricordato che da decenni era nelle sue aspirazioni e nella parte più illuminata della sinistra, la creazione di «un autentico Senato delle Regioni con i rappresentanti più autorevoli eletti direttamente, e non scelti tra i gruppi dirigenti più sputtanati d’Italia, come oggi». E tuttavia egli dichiara che la riforma è da approvare comunque, perché finalmente si arriverebbe a decidere un cambiamento. Quel che importa è che si faccia qualcosa.
Un ragionamento - mi perdonerà l’amico Cacciari - che non si discosta molto da quello del padre della fanciulla che ha visto sfumare tante occasioni di matrimonio e alla fine si acconcia a farla sposare allo sciancato del paese. Perché almeno non resti zitella. Ma non son queste le pecche peggiori del suo argomentare.
Egli fa una ricostruzione storica troppo sommaria e indistinta della sinistra in lotta per le riforme istituzionali. Finisce con lo stabilire un nesso di continuità, diciamo tra la fondazione del Centro per la riforma dello Stato, voluta dal Pci nel 1972, con l’efficace direzione di Ingrao per tutti gli anni ’80, e il «brutto topolino» dei nostri giorni. Finisce col dare ragione a tanti giovanotti e fanciulle del Pd, che negli ultimi tempi sono andati in forze in Tv («la riforma che l’Italia aspettava da 30 anni»). Come dimenticare, infatti le grandi manifestazioni popolari, nelle piazze di tutto il Paese, per invocare l’abolizione del Senato? Ma questo è il folklore... La sostanza storica è che Cacciari mette insieme cose diverse.
Intanto ricordiamo che l’esigenza di una riforma dello Stato, nata dentro alcuni settori del Pci, non era ispirata solo da ragioni di efficienza della macchina decisionale, ma soprattutto dalla volontà di un allargamento della democrazia. Per la verità, ricordando le battaglie federaliste degli ultimi decenni, Cacciari non dimentica le ragioni di una maggiore vicinanza delle istituzioni ai cittadini, ma proprio questo rende ancora più paradossale e insostenibile la sua posizione. A essere tradito oggi è esattamente l’ordito federalista da lui auspicato, a favore di un neocentralismo che sta sottraendo materie importanti alle regioni, soprattutto per quanto riguarda il governo dei propri territori.
Il nuovo Senato toglierà ancor più potere alle aree periferiche del Paese - com’è stato persuasivamente argomentato da tanti costituzionalisti di rango - non solo perché non tutti i territori saranno parimenti rappresentati. Ma anche per una ragione più grave e per certi versi drammatica. Ma si ha idea delle lotte che esploderanno all’interno dei consigli regionali per accaparrarsi il posto di consigliere-senatore? Quanti mesi sottrarranno al lavoro dei nostri governi regionali?
C’è nel ragionamento di Cacciari, ma soprattutto di tanti altri commentatori, una impropria sopravvalutazione del fattore efficienza della macchina amministrativa. Fattore certo importante, ma spesso secondario. Attribuire al bicameralismo perfetto l’inefficienza dei nostri governi è una lettura semplicemente superficiale della storia politica italiana.
Negli anni ’70 vigeva il bicameralismo eppure in quel decennio sono state realizzate le riforme più importanti per la modernizzazione dell’Italia. E il ragionamento vale anche in periferia. Davvero si crede che le nostre regioni, soprattutto quelle meridionali, non siano capaci di utilizzare a pieno i fondi strutturali europei per pura inefficienza? In realtà sono lentissime nel decidere a causa delle lotte intestine tra i vari gruppi che si contendono le risorse e sono in perenne litigio sulle forme, i modi, i luoghi del loro utilizzo. Il guasto è nel corpo del ceto politico e lo si cerca nelle istituzioni.
Ancora più paradossale è però il “Si” di Cacciaci al referendum accompagnato da un giudizio severo sulla riforma elettorale dell’Italicum. Ma dov’è, innanzi tutto, il senso tattico di questa posizione? Già Renzi ha fatto sapere, con la consueta mitezza di modi, che «l’Italicum non si tocca». Figuriamoci quanto sarà disponibile a modificarlo nel caso dovesse vincere il referendum d’autunno. Ma questa distinzione tra legge elettorale e riforma del Senato, che è di tanti attori politici e commentatori, tradisce una grave incomprensione storica di quel che è avvenuto nei paesi capitalistici.
E a Cacciari, a tal proposito, dovrei ricordare, allorché usa il termine sinistra, che negli ultimi 15 anni, un arcipelago di intellettuali si è messo a studiare il capitalismo attuale e riesce a leggere in profondità e con capacità di anticipazione i fenomeni sociali e politici del nostro tempo. Quella capacità che la sinistra storica sembra avere ormai definitivamente perduto.
Il dispositivo autoritario contenuto nell’Italicum non è una cattiveria di Renzi. E’ un passaggio obbligato, nel contesto del capitalismo globalizzato, di una strategia che oggi appare ineludibile per il ceto politico. Non lo ripeterò mai abbastanza: ceto politico vuol dire una classe professionale, con sempre meno legami con le masse popolari, che vive di politica, cioè di mediazione tra i poteri industrial-finanziari e la società. Tale ceto politico, sia per la sempre minore autonomia d’azione dello Stato-nazione, sia perché necessitato a ridurre sempre di più diritti e welfare non riesce a governare con il consenso dei cittadini. C’è bisogno di prove?
Osservate le statistiche della diserzione delle urne, in Italia come altrove. Se manca il consenso, per governare occorre il potere. L’Italicum è il completamento di un disegno già in atto. Il governo Renzi ha abolito l’articolo 18, combatte apertamente il sindacato, ha elevato a simbolo della sua nuova narrazione un capitalista internazionale come Marchionne, ha insediato la figura del preside-capo nelle scuole, controlla e presidia quotidianamente le Tv pubbliche. Forse che non ha dato sufficienti prove di spregiudicatezza e irresponsabilità nel manomettere la Costituzione e spaccare ora il Paese? Che cosa devono desiderare di più e di meglio i gruppi capitalistici nazionali e transnazionali? Giusto un governo dominato da un capo che comanda un Parlamento di nominati. Eccolo in arrivo...
L’Italia ha già conosciuto su scala ridotta lo squallido servilismo, il conformismo asfissiante generato in tutti gli ambiti della società dal potere assunto, a metà anni ’80, da Bettino Craxi e dal suo Psi. Oggi incombe su di noi un ben più grave pericolo, perché allora, benché mal messi, esistevano ancora i partiti di massa. Oggi non più. Allarmante è che un intellettuale della statura di Cacciari non l’abbia ancora capito.
-
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- CACCIARI E IL "SENATICCHIO" INCONGRUO. Ma perché dici sì a una riforma costituzionale sulla quale sputi? (di Roberta De Monticelli)17 maggio 2016, di Federico La Sala
CACCIARI E IL "SENATICCHIO" INCONGRUO... Non è di questione morale che si dovrebbe parlare ma di sistema. Non di gente che ruba, ma dell’assenza di un sistema funzionante, di un meccanismo, di un automatismo - hai insistito - che renda irrilevante la gente che ruba (non il rubare, spero).
- RICERCA E MERAVIGLIA: AL SAN RAFFAELE, UNA GRANDE FESTA FILOSOFICA! IL "VECCHIO" PROBLEMA DEL PENSIERO DELLA COSTITUZIONE E DELLA COSTITUZIONE DEL PENSIERO E’ STATO RISOLTO !!!
Ma perché dici sì a una riforma costituzionale sulla quale sputi?
Lettera aperta a Massimo Cacciari
di DI ROBERTA DE MONTICELLI (libertàegiustizia, 11 MAGGIO 2016)
Caro Massimo, non è la prima questa lettera e non sarà l’ultima, nel corso della nostra ormai lunga, benché molto intermittente, conversazione “filosofica”. E lo scrivo fra virgolette, perché lo è, filosofica, e non lo è, la questione che pongo. Lo è per noi che concepiamo la filosofia come “pensiero concreto”, per usare un’espressione tua. E non come una fabbrica di abracadabra e calembour più o meno brillanti. Comunque la questione che ti pongo la chiamo “filosofica” anche per darmi coraggio e superare la distanza, tutta a tuo favore, di autorevolezza e presenza sulla scena pubblica, oltre che quella abissale, ancora a tuo favore, di effettiva conoscenza ed esperienza della politica.
Vengo alla questione che vorrei porti questa sera, 9 maggio, dopo averti ascoltato, ospite di “Otto e mezzo”, sviscerare - anzi, eviscerare, a rapidi colpi di spada, con espressività e vigore assolutamente eloquenti - l’“assurdità” e la sgangherata incongruenza della riforma costituzionale che sarà sottoposta a referendum. Quel ridicolo senato fatto di consiglieri regionali e sindaci non solo non risolverebbe il problema del bicameralismo perfetto, che tu ed altri, dicevi, avevate rivoltato in tutti i suoi aspetti (con ben altra attenzione e competenza, si evinceva dal contesto) prima che gli autori della riforma attuale “fossero al mondo”, ma complicherebbe a dismisura - lo hai ben chiarito - il più profondo errore di sistema della democrazia italiana, al quale tornerò fra poco.
Ecco la domanda: perché allora voterai “sì” al referendum, come hai detto? E’ una domanda sincera e smarrita. E se la faccio, è perché credo che molti se la facciano con il mio stesso smarrimento. Molti di quei non molti che della nostra vita civile si preoccupano, che credono o tentano di credere, con la loro fatica quotidiana, che la Repubblica siamo noi, e che se accettiamo una riforma “assurda”, incongrua, incoerente e inefficiente dei suoi fondamenti, della democrazia sfigurata e monca che ne risulterà noi saremo non passivi, ma attivi complici, dunque colpevoli. E quanti di quelli che ti hanno ascoltato continueranno a credere, come Socrate insegnava ai suoi concittadini, che sia doveroso chiedere ragione di ogni decisione che ci riguarda? Che abbia senso applicare la volontà di evidenza, la logica, il buon senso, alle cose che pure sommamente ci riguardano, della politica?
Se anche il più noto filosofo italiano scorna la logica e l’evidenza in politica, e getta il peso di tutto il suo prestigio nel dire sì a una riforma costituzionale sopra la quale sputa? Quanti che ancora non avevano del tutto perduto la voglia di partecipare, cioè di discutere e deliberare nello spazio delle ragioni, dove le parole hanno un senso e le decisioni una coerenza, perderanno la loro residua fiducia nella democrazia? Perché la democrazia non è solo una forma di governo. E’ una civiltà fondata in ragione, il che vuol dire, sulla fragile forza dei nostri interrogativi, sulla fatica dei buoni argomenti. Una Repubblica democratica è fondata su lavoro - sul nostro lavoro di cittadini, così faticoso, così disprezzato. Anche e soprattutto da chi, “nel paese di Machiavelli”, come hai detto, trova come te che si parli troppo di “questione morale”. Cioè di interesse pubblico!
Vengo al paese di Machiavelli, perché qui hai detto una cosa illuminante, che il politico di turno ha subito ripreso a suo vantaggio. Non è di questione morale che si dovrebbe parlare ma di sistema. Non di gente che ruba, ma dell’assenza di un sistema funzionante, di un meccanismo, di un automatismo - hai insistito - che renda irrilevante la gente che ruba (non il rubare, spero). Evviva, qui riconosco a ciascuno il suo e a te maggior sapienza: io non chiamerei automatismo un’amministrazione impermeabile alla corruzione, ma riconosco che qui sì, ha più da dire un filosofo che conosce o riconosce l’elemento sistemico della politica e della società - più di uno che, come chi scrive, non ha in politica altro orizzonte che quella dell’etica pubblica e non vede altri attori che gli individui responsabili.
Bene: ma proprio qui tu hai detto la cosa giusta. Il più profondo errore di sistema della democrazia italiana è non disporre di un dispositivo che disinneschi la corruzione, lasciando operare come devono le pressioni degli interessi particolari, ma senza farsene travolgere. E proprio questo senaticchio incongruo, fatto dei pezzi finora più corrotti di meccanismo mal funzionante, ci hai fatto capire, aggraverebbe ancora di più l’errore di sistema. Questo sarebbe l’esito della riforma.
E allora perché, perché dirle di sì?
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. -- QUESTIONE IMMORALE. Conflitto di interessi, familismo amorale, cronica carenza di senso civico (di Norma Rangeri).5 maggio 2016, di Federico La Sala
Questione immorale
di Norma Rangeri
(il manifesto, 05.05.2016)
Almeno il fatto che in Italia c’è una questione morale, che poi, profanamente, potrebbe essere la traduzione del settimo comandamento (non rubare), è una banale constatazione. La diagnosi di una malattia grave sulla quale è difficile non convenire anche se poi si può chiamare in tanti modi.
Buttarsi in politica per fare affari, è, purtroppo un malcostume nazionale. Lo ha spiegato bene Stefano Rodotà scrivendo di «una proterva controetica esibita senza pudore anche in sedi governative e parlamentari». Lo ripete il presidente dell’Autorità anticorruzione, Raffaele Cantone, in un’intervista all’Unità quando sostiene che «va evitata la commistione, specie a livello locale, tra attività economiche e attività politiche». Forse sarà per questo che in Italia non si riesce a fare una legge sul conflitto di interessi mentre si piazzano imprenditori al ministero dello Sviluppo. E dire che abbiamo avuto al governo, per vent’anni, il conflitto di interessi in persona (altra semplice constatazione, difficilmente confutabile).
Conflitto di interessi, familismo amorale, cronica carenza di senso civico disegnano un quadro d’insieme disastroso. Specialmente se il politico ricopre un ruolo istituzionale, alla periferia come al centro del potere. Lo stiamo verificando nella vicenda delle recenti nomine del governo, con gli amici del premier candidati a ruoli di governo delicati e importanti.
Una volta diagnosticato il pessimo stato di salute dell’articolo 54 della Costituzione a proposito delle funzioni pubbliche da adempiere con «disciplina e onore», di tutto il resto si può discutere. Si può discutere se finire in galera perché si è un po’ taroccato un appalto per una piscina comunale sia eccessivo. Sicuramente lo sembra, probabilmente anche perché siamo un paese dove su una popolazione carceraria in crescita i detenuti per reati fiscali o finanziari nessuno li ha visti.
Sull’arresto del sindaco di Lodi è anche arrivato puntuale l’autogol del Pd con la richiesta dell’apertura di una pratica contro le magistrate che hanno mandato in carcere il sindaco piddino. Non stupisce che a chiedere un provvedimento disciplinare sia stato un componente del Csm iscritto al Pd, Giuseppe Fanfani, esponente di un blasonato casato politico aretino (salvo poi, scaricato da Renzi, fare marcia indietro). Tutta acqua al mulino dei 5Stelle.
Con un fenomeno di corruzione strutturale che investe la politica come la società, è difficile non arrivare ai ferri corti tra politici e magistrati. Ai rappresentanti del popolo non fa piacere ricevere l’accusa di essere i protagonisti del brutto film sul vasto mondo di corrotti e corruttori. Ed è vero che, fatalmente, i magistrati incontrando sulla loro strada professionale così tanti politici, finanzieri e imprenditori difficilmente riescono ad evitare collisioni di interessi e di poteri.
Il fatto è che tra un mese gli italiani di molte città saranno chiamati alle urne per decidere chi le deve amministrare. E il buon senso consiglia a Renzi di tenersi lontano dagli zelanti alleati del gruppo di Verdini. Che parlano di “complotto dei magistrati” mentre si coprono di ridicolo nel vano tentativo di smentire la loro partecipazione alla riunione di ieri con il ministro Orlando per definire la linea del governo sulla prescrizione. Renzi getta acqua sul fuoco («il complotto? ma de’ che»), ma se il Pd non si cura della qualità della sua classe dirigente (come ha fatto a Roma dopo Mafia-Capitale) rischia l’autocomplotto.
Il presidente-segretario, che già annuncia di schierare diecimila renziani per i porta a porta referendari, sa che ben prima, solo tra qualche settimana, deve affrontare le insidiose urne del 5 giugno. E l’unico boato che si ascolta per strada di questi tempi è l’intenzione di andare al mare.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- La corruzione dominante nel nostro paese non è quella dei ladruncoli di strada, ma delle classi dirigenti e tra queste mafia, camorra e ’ndrangheta (di Piero Bevilacqua)28 aprile 2016, di Federico La Sala
Se delinque un politico il danno è doppio
Legalità. La corruzione dominante nel nostro paese non è quella dei ladruncoli di strada, ma delle classi dirigenti e tra queste mafia, camorra e ’ndrangheta, per i capitali e il territorio che controllano
di Piero Bevilacqua (il manifesto, 28.04.2016)
Credo che sulla polemica esplosa in seguito alla dichiarazioni di Pier Camillo Davigo occorra un di più di riflessione politica, rispetto alle schermaglie formali, alle difese e alle accuse che abbiamo letto in questi giorni. Sotto la densa polvere che si è alzata occorre cogliere una sostanza politica di primissimo rilievo.
Sono in disaccordo con quanto sostiene Anna Canepa, segretaria di Magistratura Democratica, a proposito delle posizioni di Davigo, nell’intervista ad Andrea Fabozzi (il manifesto, 24 aprile). Sono in disaccordo non tanto per i contenuti in sé, che rientrano in logiche e schermaglie di corrente (interessano a pochi). « Noi pensiamo che la corruzione non possa essere affrontata esclusivamente in termini repressivi», afferma Canepa nell’intervista, usando un motivo retorico per ridurre Davigo al rango del Grande Repressore.
Ma come si può attribuire una convinzione del genere non dico a un magistrato dell’intelligenza di Davigo, ma una qualsiasi persona di media cultura? Chi può non essere d’accordo su questo punto? Ma il fatto è che se manca la repressione, il resto (l’ amministrazione efficiente, un giustizia più rapida, la cultura della legalità, ecc) non tiene.
 Senza la certezza della sanzione, la tendenza a delinquere appare incomprimibile. Soprattutto, per svariatissime ragioni storiche, in Italia.
Senza la certezza della sanzione, la tendenza a delinquere appare incomprimibile. Soprattutto, per svariatissime ragioni storiche, in Italia.
 Non dimentichiamo che nel nostro paese sono ancora vive e vegete due forme di criminalità organizzate che risalgono a prima dell’unificazione nazionale, la mafia e la camorra, mentre una terza, meno antica, la ‘ndrangheta, ha un raggio d’azione a scala mondiale.
Non dimentichiamo che nel nostro paese sono ancora vive e vegete due forme di criminalità organizzate che risalgono a prima dell’unificazione nazionale, la mafia e la camorra, mentre una terza, meno antica, la ‘ndrangheta, ha un raggio d’azione a scala mondiale.Capisco bene quanto ha dichiarato Raffaele Cantone, in un’intervista sul Corriere della Sera (23 aprile): «Mani Pulite ha fallito perché le manette non bastano». Certamente, non sono bastate e non bastano, in nessun caso. Ma chi doveva far seguire alla repressione i fatti di una profonda trasformazione della macchina amministrativa, delle procedure giudiziarie, delle strutture della vigilanza e dei controlli? Chi se non i governi e il ceto politico? Chi non ha fatto seguire alla galera i fatti positivi di un profondo rinnovamento anche dello spirito pubblico nazionale? Chi, se non il potere legislativo e gli esecutivi? Sono costoro che sono mancati alla prova. Ai magistrati spettano altri compiti, altrimenti in questo modo, per difendere il governo Renzi capovolgiamo la verità dei fatti e con una capriola retorica gettiamo la croce su Mani Pulite.
Un po’ di storia non tanto per Cantone - magistrato prezioso per l’ opera che svolge nel nostro paese - ma soprattutto per il presidente del Consiglio. Le parole polemiche di Davigo sui politici che continuano a rubare, come in passato, ma ora non se ne vergognano - che certo non sono formalmente ineccepibili in chi rappresenta un sindacato - nascono nell’atmosfera tossica creata dalla dichiarazione di Renzi al Senato il 20 di questo mese.
In quella occasione ha detto testualmente che negli ultimi 25 anni sono state scritte «pagine di autentica barbarie legate al giustizialismo». 25 anni? Ora lasciamo da parte Mani Pulite, che di sicuro eccessi ne ha commessi, ma senza i quali non avrebbe scoperchiato un sistema di corruttela così pervasivo e onnipotente. Chi ha governato in Italia dopo quel terremoto giudiziario?
Abbiamo già dimenticato? Noi siamo appena usciti da una fase storica in cui un avvocato, Cesare Previti, che faceva vincere le cause al suo padrone comprando i magistrati che lo giudicavano, è diventato ministro della Repubblica. Vigeva allora la barbarie giustizialista?
 Erano gli anni in cui il presidente del Consiglio, Berlusconi, con i suoi avvocati fatti eleggere in Parlamento, si faceva emanare le leggi che dovevano salvarlo dalla cause pendenti. L’intero parlamento della Repubblica asservito ai voleri, ai capricci, perfino alle bugie ridicole di un magnate. A questo giustizialismo allude Renzi?
Erano gli anni in cui il presidente del Consiglio, Berlusconi, con i suoi avvocati fatti eleggere in Parlamento, si faceva emanare le leggi che dovevano salvarlo dalla cause pendenti. L’intero parlamento della Repubblica asservito ai voleri, ai capricci, perfino alle bugie ridicole di un magnate. A questo giustizialismo allude Renzi?
 Sono anni di giustizialismo i nostri, in cui il parlamentare Denis Verdini, amico del presidente del Consiglio Renzi, e suo importante sostegno politico, con ben 6 rinvii a giudizio, è tranquillamente al suo posto e continua a onorare della sua presenza il nostro Parlamento? Ma perché Renzi scopre oggi l’urgenza del garantismo? Non è per caso che, avendo fondato il suo potere su una costellazione di appoggi, dal mondo imprenditoriale a quello finanziario - come ha ben scritto A.Floridia (il manifesto, 14 aprile) - teme che qualche inchiesta giudiziaria possa mandare in aria il suo traballante castello?
Sono anni di giustizialismo i nostri, in cui il parlamentare Denis Verdini, amico del presidente del Consiglio Renzi, e suo importante sostegno politico, con ben 6 rinvii a giudizio, è tranquillamente al suo posto e continua a onorare della sua presenza il nostro Parlamento? Ma perché Renzi scopre oggi l’urgenza del garantismo? Non è per caso che, avendo fondato il suo potere su una costellazione di appoggi, dal mondo imprenditoriale a quello finanziario - come ha ben scritto A.Floridia (il manifesto, 14 aprile) - teme che qualche inchiesta giudiziaria possa mandare in aria il suo traballante castello?Ora, nel paese in cui si tende a guardare solo al dito e a non scorgere la luna, bisogna ricordare che Davigo ha anche fatto un’altra affermazione: «La classe dirigente, quando delinque, fa un numero di vittime incomparabilmente più elevato di qualunque delinquente da strada, e fa danni più gravi».
 Ed è questo il punto, il vero punto da discutere.
Ed è questo il punto, il vero punto da discutere.Perché la corruzione dominante nel nostro paese, non è quella dei ladruncoli di strada, ma delle classi dirigenti. E tra queste, lo si voglia o no, occorre metterci mafia, ‘ndrangheta e camorra, sia per l’imponenza dei capitali che muovono, che per l’ampiezza dei territori che controllano. Tale corruzione non è solo rilevante per il danno economico che infligge al paese, com’è universalmente riconosciuto. Essa rivela in realtà una questione politica di prima grandezza, a cui la sinistra dovrebbe guardare con più attenzione.
Più di quanto non si creda essa è legata strettamente alla dissoluzione dei grandi partiti di massa, i quali formavano e selezionavano i quadri politici destinati alle amministrazioni locali, al Parlamento, alla loro stessa gestione in centro e in periferia.
Erano questi che operavano i primi filtri e controlli sulla qualità, innanzi tutto morale, dei propri esponenti. Oggi tale lavoro di selezione e filtro non esiste più. I presidi politici della legalità sono stati sciolti. E chi decide di fare politica lo fa per pura ambizione personale, entrando in un agone competitivo interpersonale, anche con i propri compagni e in cui tutto è permesso.
Ma la scomparsa dei grandi partiti popolari, nel nostro caso del Pci, e l’emarginazione crescente del sindacato, hanno anche un altro esito rilevantissimo per il dilagare della corruzione. Perché in mancanza di un grande antagonista organizzato, capace di opposizione, vigilanza e controllo, le classi dirigenti italiane, i nostri ceti dominanti e quei politici che li rappresentano, sono da 20 anni impegnati in un’azione predatoria del bene pubblico di un’ampiezza senza precedenti.
 Un’opera imponente di manomissione che solo il vigore delle leggi riesce in parte a contenere e limitare. Oltre all’azione generosa di pochi movimenti. La predazione, tramite soprattutto le Grandi opere, riguarda il territorio, l’acqua, il patrimonio urbano, i beni artistici , le città, il paesaggio. Anche spesso i nostri diritti.
Un’opera imponente di manomissione che solo il vigore delle leggi riesce in parte a contenere e limitare. Oltre all’azione generosa di pochi movimenti. La predazione, tramite soprattutto le Grandi opere, riguarda il territorio, l’acqua, il patrimonio urbano, i beni artistici , le città, il paesaggio. Anche spesso i nostri diritti.Allora, caro Cantone, è evidente che «le manette non bastano». La legge e la vigilanza dei magistrati servono solo a contenere parte di quella predazione di classe che scivola nell’illegalità, la punta dell’ iceberg. Non il resto. Perciò non solo non è giusto, ma è un grave danno criticare i magistrati intransigenti. Perché oggi, quanto meno, costituiscono l’ insufficiente argine in difesa del bene pubblico.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE -- "I politici non hanno smesso di rubare, hanno smesso di vergognarsi" (Piercamillo Davigo).22 aprile 2016, di Federico La Sala
- POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. Materiali sul tema
Piercamillo Davigo: "I politici non hanno smesso di rubare, hanno smesso di vergognarsi"
Ansa *
I politici "non hanno smesso di rubare; hanno smesso di vergognarsi. Rivendicano con sfrontatezza quel che prima facevano di nascosto. Dicono cose tipo: "Con i nostri soldi facciamo quello che ci pare". Ma non sono soldi loro; sono dei contribuenti".
Lo afferma al Corriere della Sera, Piercamillo Davigo, presidente dell’Anm, spiegando che "prendere i corrotti è difficilissimo. Nessuno li denuncia, perché tutti hanno interesse al silenzio: per questo sarei favorevole alla non punibilità del primo che parla. Il punto non è aumentare le pene; è scoprire i reati. Anche con operazioni sotto copertura".
Alla domanda se quindi si ruba più di prima, Davigo spiega: "Si ruba in modo meno organizzato. Tutto è lasciato all’iniziativa individuale o a gruppi temporanei. La corruzione è un reato seriale e diffusivo: chi lo commette, tende a ripeterlo, e a coinvolgere altri. Questo dà vita a un mercato illegale, che tende ad autoregolamentarsi: se il corruttore non paga, nessuno si fiderà più di lui. Ma se l’autoregolamentazione non funziona più, allora interviene un soggetto esterno a regolare il mercato: la criminalità organizzata".
Dopo Mani Pulite, prosegue Davigo, "hanno vinto i corrotti, abbiamo migliorato la specie predata: abbiamo preso le zebre lente, le altre sono diventate più veloci".
A fermare quel pool "cominciò Berlusconi, con il decreto Biondi; ma nell’alternanza tra i due schieramenti, l’unica differenza fu che la destra le fece così grosse e così male che non hanno funzionato; la sinistra le fece in modo mirato. Non dico che ci abbiano messi in ginocchio; ma un pò genuflessi sì".
Il governo Renzi? "Fa le stesse cose - dice Davigo -. Aumenta le soglie di rilevanza penale. Aumenta la circolazione dei contanti, con la scusa risibile che i pensionati non hanno dimestichezza con le carte di credito".
Sulla responsabilità civile dei magistrati, il presidente dell’Anm parla di norme ridicole: "L’unica conseguenza è che ora pago 30 euro l’anno in più per la mia polizza: questo la dice lunga sulla ridicolaggine delle norme. Tutti abbiamo un’assicurazione. Non siamo preoccupati per la responsabilità civile, ma per la mancanza di un filtro. Se contro un magistrato viene intentata una causa, anche manifestamente infondata, gli verrà la tentazione di difendersi; ma così non farà più il processo, e potrà essere ricusato. È il modo sbagliato per affrontare un problema serio: perché anche i magistrati sbagliano". Sul rapporto tra toghe e Palazzo, Davigo osserva: "I magistrati avendo guarentigie non sono abituati al criterio di rappresentanza: per questo sovente sono pessimi politici".
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- Un padre di famiglia7 aprile 2016, di Federico La Sala
Un padre di famiglia
di Giuseppe Di Lello (il manifesto, 07.04.2016)
Un padre e una madre, sposati in chiesa con rito concordatario e poi la prole: quella di Totò Riina è una vera famiglia italiana secondo gli stringenti canoni formali dei partecipanti al family day. Come tale si comporta anche nella sostanza, con il marito attento all’educazione dei figli, premuroso e sempre presente, specialmente la sera a cena quando la famigliola si ritrova intorno al desco, non sappiamo quanto frugale.
Poi, come in ogni famiglia normale, tutti insieme si guarda anche la Tv e ci si aggiorna col telegiornale.
Scorrono le immagini delle stragi di Capaci o di Via D’Amelio e il patriarca, forse tra sé e sé, o forse ad alta voce, perché nelle famiglie normali non ci debbono essere segreti, pensa che sarebbe stato molto più gratificante essere sui luoghi al momento di quelle esplosioni, dato che era stato lui a deciderle, programmarle e farle eseguire: poi però, per qualche contrattempo, avrebbe potuto far tardi per la cena familiare e questo non se lo poteva permettere.
La mia è una ricostruzione fantasiosa del menage familiare dei Riina, ma non troppo azzardata, posto che il rampollo ospitato dalla Tv di stato a «Porta a porta» ne ha propagandato più o meno una immagine abbastanza simile. Il suddetto ha ovviamente escluso ogni riferimento a Cosa nostra che senza dubbio nelle conversazioni familiari doveva ricorrere spesso, viste le dure condanne per mafia collezionate da tutti i maschi e, certo, non a loro insaputa.
Ogni anno non vi è scuola che non organizzi un corso sulla legalità e contro le mafie, giornate del ricordo, messe di suffragio, cortei e chi più ne ha, ne metta: poi la Tv di stato ci regala una patetica performance per dirci che i valori della famiglia, quella normale secondo concordato, possono essere coltivati anche in quella di un mafioso come Totò Riina, che si prende somma cura dei suoi figli, anche se poi, fuori dalle sue mura domestiche, ha fatto ammazzare decine di figli degli altri: questo purtroppo è il messaggio che passa.
Non c’è dubbio che non è «informazione», anche se censurarla sarebbe arduo perché solo nei regimi autoritari ci sono canoni standard ai quali adeguare le «opere dell’ingegno».
La Tv di stato, però, pur essendo libera di mandare in onda il Riina junior show, avrebbe dovuto spiegare che era una fiction, dato che nella realtà si trattava non di una famiglia normale, ma di una famiglia mafiosa.
Scandalo Vespa? Ma no, Vespa è il padrone della televisione e fa quello che vuole, anche perché tutto il mondo politico, trasversale quanto mai, sbava per sprofondarsi nelle poltrone del suo salotto consapevole che chi non è invitato non conta granché.
Per una sera questa massa di ipocriti si strapperà le vesti per l’offesa al sentimento antimafioso degli italiani e alle vittime di Totò Riina, ma poi, da domani, tornerà a chiedersi ansiosa quando arriverà il sospirato invito.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- Quella a Riina è l’intervista più pregna di messaggi mafiosi degli ultimi anni. E Bruno Vespa non se n’è accorto" (Roberto Saviano).9 aprile 2016, di Federico La Sala
Roberto Saviano decifra Salvo Riina: "Ha mandato un messaggio alla nuova mafia. Bruno Vespa non se n’è accorto"
di Redazione (L’Huffington Post, 09/04/2016)
Non la promozione di un libro bensì un messaggio chiaro dalla vecchia mafia ai nuovi dirigenti di Cosa Nostra. Per Roberto Saviano l’intervista di Salvo Riina a "Porta a Porta" è stata soprattutto una occasione storica della "vecchia guardia mafiosa" per parlare agli esponenti della criminalità organizzata che davvero oggi detengono il potere.
"Quella a Riina è l’intervista più pregna di messaggi mafiosi degli ultimi anni. E Bruno Vespa non se n’è accorto", commenta Saviano durante la trasmissione "TvTalk", Rai3. "Se un mafioso accetta una intervista televisiva è soltanto perché vuole lanciare degli avvertimenti", prosegue l’autore di Gomorra, che non contesta la scelta di dialogare con il figlio di Totò Riina: "Se parli con il male devi riuscire a codificarlo, senza diventare un megafono". Ed è ciò che secondo lo scrittore è successo durante la puntata di "Porta a Porta" che ha sollevato un enorme polverone sulla Rai.
Saviano ritiene che la scelta di Salvo Riina di apparire in televisione non è legata al libro che ha scritto sulla propria famiglia. "Non è vero, come ha introdotto Vespa, che i Riina sono la famiglia più potente della mafia. Lo sono stati, ormai appartengono alla vecchia guardia mafiosa che parla alla nuova mafia come Matteo Messina Denaro".
Il messaggio: "Salvo Riina ha fatto capire che la vecchia mafia, con i codici e le regole di una volta, non esiste più. Ma rivendica che la loro era la vera mafia", spiega Saviano, riferendosi alla parte dell’intervista nella quale il giovane Riina ha parlato di una famiglia unita, con valori tradizionali.
"La vecchia mafia non poteva sopportare relazioni extra-coniugali, l’omosessualità, il divorzio. Atteggiamenti e scelte che invece ora appartengono ai nuovi esponenti mafiosi". Inoltre, continua Saviano, Salvo Riina "non ha mai fatto riferimento a nessun avvenimento legato alla mafia, tranne poi dare un giudizio molto negativo sui pentiti": anche questo, dice lo scrittore, è un avvertimento a coloro che in questi anni nelle carceri stanno cominciando a collaborare: "Non pagheremo le vostre colpe, mio padre non sarà mai un pentito".
-
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- Il figlio di Riina a Porta a Porta (di Salvatore Frequente)7 aprile 2016, di Federico La Sala
- CRISI POLITICA E SACRA FAMIGLIA [UNITA]!!! NON SOLO LA TEOLOGIA (E LA FILOSOFIA), MA NEMMENO LA SOCIOLOGIA SA DISTINGUERE TRA FAMIGLIA DEMOCRATICA E FAMIGLIA DI "MAMMASANTISSIMA" E DI "MAMMONA"...
 "FAMILISMO AMORALE" E SOCIETA’. LA FAMIGLIA CHE UCCIDE: IL LATO OSCURO DELLA FAMIGLIA. Una nota di Chiara Saraceno
"FAMILISMO AMORALE" E SOCIETA’. LA FAMIGLIA CHE UCCIDE: IL LATO OSCURO DELLA FAMIGLIA. Una nota di Chiara Saraceno
SALVO RIINA DA BRUNO VESPA
Il figlio di Riina a Porta a Porta
«Amo mio padre e non lo giudico»
La mafia cos’è? «Non me lo sono mai chiesto, non so cosa sia. Oggi la mafia può essere tutto e nulla. Omicidi e traffico di droga non sono soltanto della mafia»
di Salvatore Frequente (Corriere della Sera, 06.04.2016) *
«Sono figlio di Totò e non del capo dei capi». Si presenta così Salvo Riina, 38enne e una condanna per mafia (già scontata) alle spalle, nella contestata puntata di Porta a Porta. Da Bruno Vespa il figlio di Totò, capo di Cosa Nostra, racconta la vita della famiglia del padre-boss in occasione dell’uscita del suo libro «Riina, family life».
Falcone e Borsellino? «Ho rispetto per tutti i morti»
«Io ho sempre rispetto per i morti, per tutti i morti», dice Salvo quando parla dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Riina Junior osserva con sguardo impassibile le immagini storiche di quelle stragi ordinate dal padre. «Io non giudico Falcone e Borsellino, qualsiasi cosa io dico sarebbe strumentalizzata», dice da Bruno Vespa il figlio di Totò Riina che ricorda così il 23 maggio del 1992 giorno dell’attentato a Falcone: «Ricordo il fatto, avevo 15 anni, eravamo a Palermo e sentivamo tante ambulanze e sirene - aggiunge Riina Jr. - abbiamo cominciato a chiederci il perché e il titolare del bar ci disse che avevano ammazzato Falcone, eravamo tutti ammutoliti. La sera tornai a casa, c’era mio padre e non mi venne mai il sospetto che lui potesse essere dietro quell’attentato».
«La mafia non so cosa sia»
Lui che la condanna per associazione mafiosa a 8 anni e 10 mesi l’ha interamente scontata, con un papà e un fratello condannati all’ergastolo (e al «41 bis») alla domanda «La mafia cos’è?» risponde così: «Non me lo sono mai chiesto, non so cosa sia. Oggi la mafia può essere tutto e nulla. Omicidi e traffico di droga non sono soltanto della mafia». Nato mentre il padre era ricercato, ha vissuto anche lui cambiando sempre abitazione ma quando parla della sua famiglia la descrive solamente come «diversa»: «A casa nostra - dice Riina Jr. a Porta a Porta - abbiamo vissuto sempre nella massima tranquillità. Non ci siamo mai chiesti perché non andavamo a scuola. Mai fatto queste domande, la nostra era una sorta di famiglia diversa». «C’era - prosegue - una sorta di tacito accordo familiare, noi eravamo bambini particolari, il nostro contesto era diverso, abbiamo vissuto anche in maniera piacevole, nella sua complessità è stato come dire un gioco».
«Amo mio padre». L’arresto? «Non lo condivido»
Quel Totò Riina che, per la sua ferocia sanguinaria, è stato soprannominato «la belva», dal figlio viene descritto come un padre affettuoso: «Amo mio padre e la mia famiglia, al di fuori di ciò che gli viene contestato, giudico ciò che mi hanno trasmesso: il bene e il rispetto, se oggi sono quello che sono - dice Salvo da Bruno Vespa - lo devo ai miei genitori. Perché devo dire che mio padre ha sbagliato? Per questo c’è lo Stato, non tocca a me». E lo Stato? «È l’entità in cui vivo» di cui «magari non condivido determinate leggi o determinate sentenze»,dice il figlio di Totò Riina, rispondendo ad una domanda di Bruno Vespa. «Rispetta la condanna contro suo padre?», gli chiede il conduttore: «No, perché è mio padre. A me ha tolto mio padre». Nessun riferimento ai crimini commessi dal padre, nessuna condanna da parte del figlio: «Il quarto comandamento dice: "onora e rispetta sempre i tuoi genitori", e io così faccio», ha detto Salvo. Ma quando Bruno Vespa ribatte citando il quindi comandamento «Non uccidere», Riina ribadisce: «Non devo essere io a giudicare».
L’attacco ai pentiti
Ma il figlio di Totò Riina si spinge anche a parlare dei collaboratori di giustizia. «Negli altri Paesi democratici non accade. Solo in Italia un pentito, che dice di aver commesso centinaia di omicidi, non fa neppure un giorno di carcere, mandano gli altri in carcere e poi loro tornano in giro a fare quello che facevano». I pentiti di mafia, aggiunge Riina Jr., «sono stati sicuramente usati dallo Stato. Non si accusano le persone solo per un tornaconto, ci sarà sempre un giorno in cui dovrai pentirti davanti a Dio».
Le polemiche
Un’intervista che ha fatto discutere prima della messa in onda. A sollevare le polemiche per la presenza di Riina jr. era stata proprio Rosy Bindi, presidente della Commissione Antimafia. «Mi auguro che in Rai ci sia un ripensamento. Ma se questa sera andrà in onda l’intervista al figlio di Totò Riina, avremo la conferma che Porta a Porta si presta ad essere il salotto del negazionismo della mafia e chiederò all’Ufficio di Presidenza di convocare in Commissione la presidente e il direttore generale della Rai», aveva detto Bindi. Poco dopo, l’annuncio di Pier Luigi Bersani di non partecipare alla trasmissione. E dopo ore di polemiche incalzanti arriva la conferma: la puntata andrà in onda. «Tra poco trasmetteremo l’intervista a un mafioso. È Salvo Riina, il figlio di Totò Riina, il capo dei capi della mafia», dice Bruno Vespa lanciando all’inizio del programma Porta a Porta l’intervista del figlio di Totò Riina e sottolineando: «Un ritratto sconcertante, certo, ma per combattere la mafia bisogna conoscerla. E per conoscerla meglio c’è bisogno a nostro avviso anche di interviste come questa».
Maria Falcone: «Fatto indegno»
«La Rai ha deciso di andare avanti e di mandare in onda il figlio di Totò Riina? Vuol dire che non ha avuto la forza di tornare indietro. La sua presenza nel servizio pubblico è un’offesa per tutti, un fatto indegno», ha commentato Maria Falcone, sorella del magistrato ucciso dalla mafia. E la Commissione parlamentare Antimafia ha convocato per domani, giovedì 7 aprile, alle ore 16, la presidente della Rai, Monica Maggioni e di direttore generale Antonio Campo Dall’Orto, per un’audizione urgente sulla vicenda.
- SALVATORE BORSELLINO.
 Avrei preferito non dovere scrivere queste righe, avrei preferito non essere costretto ad essere assalito dal senso di nausea che ho provato nel momento in cui ho dovuto leggere che il figlio di un criminale, criminale a sua volta, comparirà questa sera nel corso di una trasmissione della RAI, un servizio pubblico, per presentare il suo libro, scritto, come dichiarerà lui,"per difendere la dignità della sua famiglia".
Avrei preferito non dovere scrivere queste righe, avrei preferito non essere costretto ad essere assalito dal senso di nausea che ho provato nel momento in cui ho dovuto leggere che il figlio di un criminale, criminale a sua volta, comparirà questa sera nel corso di una trasmissione della RAI, un servizio pubblico, per presentare il suo libro, scritto, come dichiarerà lui,"per difendere la dignità della sua famiglia".
 Di quale dignità si tratti ce lo spiegherà raccontandoci come, insieme a suo padre, seduto in poltrona davanti alla televisione, abbia assistito il 23 maggio e il 19 luglio del ’92 allo spettacolo dei risultati degli attentati ordinati da suo padre per eliminare Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.
Di quale dignità si tratti ce lo spiegherà raccontandoci come, insieme a suo padre, seduto in poltrona davanti alla televisione, abbia assistito il 23 maggio e il 19 luglio del ’92 allo spettacolo dei risultati degli attentati ordinati da suo padre per eliminare Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.
 Non ci racconterà forse le esclamazioni di gioia di quello stesso padre che descriverà, come da copione, come un padre affettuoso, ma quelle possiamo immaginarle dalle espressioni usate da quello stesso padre quando, nelle intercettazioni nel carcere di Opera, progettava di far fare la "fine del tonno, del primo tonno" anche al magistrato Nino Di Matteo.
Non ci racconterà forse le esclamazioni di gioia di quello stesso padre che descriverà, come da copione, come un padre affettuoso, ma quelle possiamo immaginarle dalle espressioni usate da quello stesso padre quando, nelle intercettazioni nel carcere di Opera, progettava di far fare la "fine del tonno, del primo tonno" anche al magistrato Nino Di Matteo.
 Non ha voluto rispondere, Salvo Riina, alle domande su Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Non me ne rammarico, quei nomi si sarebbero sporcati soltanto ad essere pronunciate da una bocca come la sua.
Non ha voluto rispondere, Salvo Riina, alle domande su Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Non me ne rammarico, quei nomi si sarebbero sporcati soltanto ad essere pronunciate da una bocca come la sua.
 In quanto al conduttore Bruno Vespa avrà il merito di fare diventare un best-seller il libro che qualcuno ha scritto per il figlio di questo criminale e che alimenterà la curiosità morbosa di tante menti sprovvedute. Si sarà così guadagnato le somme spropositate che gli vengono passate per gestire un servizio pubblico di servile ossequio ai potenti, di qualsiasi colore essi siano.
In quanto al conduttore Bruno Vespa avrà il merito di fare diventare un best-seller il libro che qualcuno ha scritto per il figlio di questo criminale e che alimenterà la curiosità morbosa di tante menti sprovvedute. Si sarà così guadagnato le somme spropositate che gli vengono passate per gestire un servizio pubblico di servile ossequio ai potenti, di qualsiasi colore essi siano.
 Qualcuno ha chiamato la trasmissione "Porta a Porta", la terza Camera, dopo la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica, questo significa infangare le istituzioni, infangare la nostra Costituzione, sport che sembra ormai molto praticato nel nostro paese. In quanto a noi familiari delle vittime di mafia eventi di questo tipo significano ancora una volta una riapertura delle nostre ferite, ove mai queste si fossero chiuse, ma ormai purtroppo questo, dopo 24 anni un cui non c’è stata ancora ne Verità ne Giustizia, è una cosa a cui ci siamo abituati, ma mai rassegnati.
Qualcuno ha chiamato la trasmissione "Porta a Porta", la terza Camera, dopo la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica, questo significa infangare le istituzioni, infangare la nostra Costituzione, sport che sembra ormai molto praticato nel nostro paese. In quanto a noi familiari delle vittime di mafia eventi di questo tipo significano ancora una volta una riapertura delle nostre ferite, ove mai queste si fossero chiuse, ma ormai purtroppo questo, dopo 24 anni un cui non c’è stata ancora ne Verità ne Giustizia, è una cosa a cui ci siamo abituati, ma mai rassegnati.
 La nostra RESISTENZA continuerà fino all’ultimo giorno della nostra vita
La nostra RESISTENZA continuerà fino all’ultimo giorno della nostra vita
Salvatore Borsellino
Salvatore Borsellino, fratello del magistrato ucciso dalla mafia guidata da Totò Riina, affida a un post di Facebook il suo sfogo: «Noi familiari delle vittime di mafia eventi di questo tipo significano ancora una volta - scrive - una riapertura delle nostre ferite, ove mai queste si fossero chiuse, ma ormai purtroppo questo, dopo 24 anni un cui non c’è stata ancora né Verità né Giustizia, è una cosa a cui ci siamo abituati, ma mai rassegnati».
Il no di Fnsi e Usigrai
Anche l’Usigrai, il sindacato dei giornalisti di Viale Mazzini, e la Federazione nazionale della stampa sono contrari alla messa in onda dell’intervista: «Dopo i Casamonica, stasera a Porta a Porta la famiglia Riina. La Rai Servizio Pubblico non può diventare il salotto di famiglie criminali. Chi strumentalmente vuole invocare presunte volontà censorie, ci dica perché non si dedica almeno lo stesso spazio alle giornaliste e ai giornalisti minacciati». Scrivono così il segretario generale e il presidente della Fnsi, Raffaele Lorusso e Giuseppe Giulietti, e il segretario dell’Usigrai, Vittorio Di Trapani.
I familiari delle vittime della strage di via dei Georgofili
Interviene nella polemica anche l’Associazione tra i familiari delle vittime della strage di via dei Georgofili: «Possibile che siamo costretti a subire una offesa così grave, senza poter far nulla? Ma che Paese è quello che consente a conduttori televisivi di emittenti di Stato di insultare le vittime di Cosa nostra per mere ragioni che ci rifiutiamo di prendere in considerazione?», chiede la presidente Giovanna Maggiani Chelli.
Grasso: «Non guarderò Porta a Porta»
Sulla questione è intervenuto anche Pietro Grasso. Il presidente del Senato commenta su Twitter: «Non mi interessa se le mani di #Riina accarezzavano i figli, sono le stesse macchiate di sangue innocente. Non guarderò @RaiPortaaPorta».
«In 20 anni di Porta a Porta Vespa non si è mai occupato del delitto di Piersanti Mattarella e non ha mai invitato in studio il fratello, oggi presidente della Repubblica. Adesso invita il figlio del carnefice. È questo il nuovo servizio pubblico?», si chiede il deputato del Pd e segretario della commissione di Vigilanza Rai Michele Anzaldi. Interviene anche Ernesto Magorno, deputato Pd e componente dell’Antimafia: «La Rai ascolti l’appello della presidente Bindi e ci ripensi. La presidente e il direttore generale della Rai intervengano. C’è il rischio che proprio dalla prima rete del servizio pubblico il figlio del boss mandi messaggi e segnali di natura inquietante e inaccettabile. Siamo sicuri che sia questo il tipo di giornalismo di cui ha bisogno il servizio pubblico?».
* Corriere della Sera, 6 aprile 2016 (modifica il 7 aprile 2016 | 07:50) (ripresa parziale - senza video).
- CRISI POLITICA E SACRA FAMIGLIA [UNITA]!!! NON SOLO LA TEOLOGIA (E LA FILOSOFIA), MA NEMMENO LA SOCIOLOGIA SA DISTINGUERE TRA FAMIGLIA DEMOCRATICA E FAMIGLIA DI "MAMMASANTISSIMA" E DI "MAMMONA"...
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. -- Panama Papers: spunta il tesoro di Marine e Jean-Marie Le Pen. Si dimette premier Islanda.5 aprile 2016, di Federico La Sala
Panama Papers: spunta il tesoro di Marine e Jean-Marie Le Pen. Si dimette premier Islanda Milioni di documenti trapelati, ci sarebbero persone vicine a Putin, Xi e Poroshenko. Le accuse ai leader del mondo
di Redazione ANSA *
LONDRA. Si è dimesso il premier islandese Sigmundur Gunnlaugsson, coinvolto nel caso dei Panama Papers. E la notizia è rimbalzata sui principali media internazionali. La Bbc online scrive che "il primo ministro islandese si è dimesso sull’onda dello scandalo. E’ la prima ’vittima’ dei Panama Papers". L’attuale ministro dell’Agricoltura potrebbe prendere il suo posto, aggiunge la Bbc online. Gunnlaugsson poco prima aveva chiesto lo scioglimento del Parlamento, ma il presidente Olafur Ragnar Grimsson l’aveva respinto.
Intanto in Francia, stretti collaboratori di Marine Le Pen, il "cerchio magico" della presidente del Front National, sono accusati di aver messo in piedi "un sistema offshore sofisticato" nell’ambito di Panama Papers. Ma non solo Marine, anche Jean-Marie Le Pen è direttamente coinvolto nello scandalo finanziario rivelato dai Panama Papers. Secondo Le Monde, una parte della ricchezza nota come "il tesoro" del fondatore del Front National è stata dissimulata attraverso la società offshore Balerton Marketing Limited, creata nei Caraibi nel 2000. Banconote, lingotti, monete d’oro, ci sarebbe di tutto nel "tesoro", intestato al prestanome Gerald Gerin, ex maggiordomo di Jean-Marie e della moglie Jany Le Pen.
Primo ministro Islanda offre dimissioni - Sigmundur Gunnlaugsson, coinvolto nel caso dei Panama Papers, ha offerto le sue dimissioni. La notizia delle dimissioni di Sigmundur Gunnlaugsson è rimbalzata sui principali media internazionali. La Bbc online scrive che "il primo ministro islandese si è dimesso sull’onda dello scandalo. E’ la prima ’vittima’ dei Panama Papers". L’attuale ministro dell’Agricoltura potrebbe prendere il suo posto, aggiunge la Bbc online. Gunnlaugsson poco prima aveva chiesto lo scioglimento del Parlamento, ma il presidente Olafur Ragnar Grimsson l’aveva respinto.
Mentre si aggrava la posizione di David Cameron. Nuovi dettagli sullo schema attraverso il quale il padre Ian avrebbe nascosto per decenni al fisco britannico le sue fortune di broker della finanza conquistano l’apertura di alcuni giornali di Londra. La stampa rivela che Ian Cameron, morto nel 2010, avrebbe dirottato fin dal 1982 ingenti somme di denaro in Centro America, facendo ruotare in seno al board della sua societa’ - la Blairmore Holdings - decine di prestanome caraibici. David Cameron ha affermato "Non ho azioni, né conti offshore, ne fondi offshore", replicando oggi per la prima volta David Cameron, durante un incontro pubblico a Birmingham, alle accuse contenute nei Panama Papers sul ’tesoro’ di famiglia che suo padre Ian avrebbe occultato in un paradiso fiscale e alle contestazioni dell’opposizione laburista. Il primo ministro britannico ha tuttavia glissato sulla domanda di Sky News se abbia beneficiato delle fortune paterne d’oltremare.
Uno scandalo di proporzioni planetarie fa tremare i leader e i vip di mezzo mondo. I Panama Papers, milioni di documenti che hanno origine in uno studio legale internazionale specializzato in paradisi fiscali, gettano l’ombra del sospetto su fortune riconducibili - pare - all’entourage di Vladimir Putin e del suo arcinemico ucraino Petro Poroshhenko; a familiari del leader cinese Xi Jinping e al re saudita, ma anche a Luca Cordero di Montezemolo, a banche italiane, a primi ministri e loro parenti, a criminali, personaggi dello spettacolo e dello sport come Leo Messi, a funzionari d’intelligence.
I 307 reporter dell’International Consortium of Investigative Journalists, impegnati per mesi a spulciare le carte, allargano la cerchia dei sospetti a personaggi dei Paesi di appartenenza: e cosi’ l’Espresso evoca Montezemolo, l’imprenditore Giuseppe Donaldo Nicosia, latitante e coinvolto in un’inchiesta per truffa con Marcello dell’Utri, l’ex pilota di Formula 1 Jarno Trulli oltre a Ubi e Unicredit; mentre Haaretz cita ad esempio alcuni dei piu’ ricchi e influenti uomini d’affari di Israele.
Nei documenti anche societa’ che sarebbero riconducibili a 33 sigle o individui inseriti nella lista nera degli Usa, per connessioni con i signori della droga messicani, con organizzazioni definite terroristiche come gli Hezbollah sciiti libanesi e con Stati come Corea del Nord o Iran.
L’Agenzia delle Entrate richiederà i dati relativi ai Panama Papers
Ieri l’ira del Cremlino: "Autori dello scoop sono agenti Usa"
Australia è il primo Paese ad aprire indagine. 800 i casi, alcuni saranno affidati a task-force speciale
Appello Oxfam, subito riforme per trasparenza totale LEGGI
Nella lunga lista di nomi coinvolti nello scandalo dei paradisi off-shore ci sono parenti e persone vicine al presidente siriano Bashar Al Assad, ma anche il defunto Muammar Gheddafi e l’ex presidente egiziano Hosni Mubarak. L’elenco continua ad allungarsi di ora in ora e spazia dalla politica, allo spettacolo, allo sport. Tra gli altri ci sono i nomi del presidente dell’Argentina Mauricio Macri, di parenti del presidente dell’Azerbaigian Ilham Aliyev.
Nella lista Montezemolo, Ubi e Unicredit LEGGI
Le rivelazioni, fatte trapelare da uno studio legale non molto noto, Mossack Fonseca, ma con sedi a Miami, Hong Kong, Zurigo e 35 altre localita’. Documenti passati al giornale tedesco Suddeutsche Zeitung e da questo condivisi poi con un pool di reporter investigativi di vari media internazionali fra cui i britannici Guardian e Bbc. Per l’Italia l’esclusiva è de L’Espresso. Il Guardian si concentra in apertura della sua edizione online solo su Putin, che viene ritenuto coinvolto indirettamente attraverso la figura di Sergei Roldugin: un musicista, indicati fra i migliori amici del presidente russo e padrino di una delle sue figlie, che sarebbe il terminale almeno nominale di uno spostamento di due miliardi di dollari partiti da Bank Rossya, un istituto di credito guidato da Yuri Kovalciuk, che gli Usa sostengono essere una sorta di banchiere del Cremlino, indirizzati verso Cipro e il paradiso off-shore delle Isole Vergini Britanniche.
Nelle carte anche Messi, Platini e Jackie Chan LEGGI
Sospetti che peraltro il Cremlino respinge come una montatura, assicurando che la Mosca ha i mezzi per difendere in sede legale la reputazione di Putin. Altri media coinvolti nella rivelazione di questi leaks allargano da parte loro il campo delle personalita’ al centro dei sospetti. Personalita’ fra cui figurano esponenti dello spettacolo e dello show business, accanto a criminali e trafficanti, ma anche altri leader politici o persone a loro vicine. Haaretz, oltre a soffermarsi su businessman e personaggi pubblici israeliani, cita ad esempio aziende che secondo le carte dello scandalo farebbero riferimento ai capi di governo di Islanda e Pakistan.
SCHEDA/ ’Panama Papers’, i numeri della mega fuga di notizie
E inoltre somme sottratte al fisco da familiari di Xi Jinping, dal re dell’Arabia Saudita o da suoi figli, dalla famiglia del presidente filo-occidentale ucraino Poroshenko. Nei documenti anche societa’ che sarebbero riconducibili a 33 sigle o individui inseriti nella lista nera degli Usa, per connessioni con i signori della droga messicani, con organizzazioni definite terroristiche come gli Hezbollah sciiti libanesi e con Stati come Corea del Nord o Iran.
* ANSA, 05 aprile 2016 (ripresa parziale).
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. -- Dossier Panama Papers: miliardi nei paradisi, le accuse ai leader del mondo.3 aprile 2016, di Federico La Sala
Dossier Panama Papers: miliardi nei paradisi, le accuse ai leader del mondo
Milioni di documenti trapelati, ci sono di Putin, Xi e Poroshenko
di Redazione ANSA LONDRA *
Un nuovo caso Wikileaks suote il mondo politico e finanziario ma non solo. I numeri arrivno da una enorme fuga di notizie, chiamata ’Panama Papers’. Si tratta di informazioni di una gigantesca massa di denaro dirottata da studi legali internazionali e banche verso paradisi fiscali per conto di criminali, leader politici e funzionari d’intelligence. Lo denunciano milioni di documenti fatti trapelare sui media internazionali. Fra i beneficiari di questi schemi ci sarebbero persone indicate come vicine al presidente russo Vladimir Putin, familiari del leader cinese Xi Jinping, del presidente ucraino Poroshenko, del re saudita, dei premier di Islanda e Pakistan.
Nella lista Montezemolo, Ubi e Unicredit LEGGI
Le rivelazioni sono contenute in milioni di documenti (denominati Panama Papers) fatti trapelare da uno studio legale non molto noto, Mossack Fonseca, ma con sedi a Miami, Hong Kong, Zurigo e 35 altre localita’. Documenti passati al giornale tedesco Suddeutsche Zeitung e da questo condivisi poi con un pool di reporter investigativi di vari media internazionali fra cui i britannici Guardian e Bbc. Per l’Italia l’esclusiva è de L’Espresso. Il Guardian si concentra in apertura della sua edizione online solo su Putin, che viene ritenuto coinvolto indirettamente attraverso la figura di Sergei Roldugin: un musicista, indicati fra i migliori amici del presidente russo e padrino di una delle sue figlie, che sarebbe il terminale almeno nominale di uno spostamento di due miliardi di dollari partiti da Bank Rossya, un istituto di credito guidato da Yuri Kovalciuk, che gli Usa sostengono essere una sorta di banchiere del Cremlino, indirizzati verso Cipro e il paradiso off-shore delle Isole Vergini Britanniche.
Nelle carte anche Messi e Jackie Chan LEGGI
Sospetti che peraltro il Cremlino respinge come una montatura, assicurando che la Mosca ha i mezzi per difendere in sede legale la reputazione di Putin. Altri media coinvolti nella rivelazione di questi leaks allargano da parte loro il campo delle personalita’ al centro dei sospetti. Personalita’ fra cui figurano esponenti dello spettacolo e dello show business, accanto a criminali e trafficanti, ma anche altri leader politici o persone a loro vicine. Haaretz, oltre a soffermarsi su businessman e personaggi pubblici israeliani, cita ad esempio aziende che secondo le carte dello scandalo farebbero riferimento ai capi di governo di Islanda e Pakistan.
SCHEDA/ ’Panama Papers’, i numeri della mega fuga di notizie
E inoltre somme sottratte al fisco da familiari di Xi Jinping, dal re dell’Arabia Saudita o da suoi figli, dalla famiglia del presidente filo-occidentale ucraino Poroshenko. Nei documenti anche societa’ che sarebbero riconducibili a 33 sigle o individui inseriti nella lista nera degli Usa, per connessioni con i signori della droga messicani, con organizzazioni definite terroristiche come gli Hezbollah sciiti libanesi e con Stati come Corea del Nord o Iran.
* ANSA, 03.04.20116 (ripresa parziale).
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- LA GLOBALITA’ DELLA CORRUZIONE: L’IDOLATRIA (di Roberto Toscano)3 aprile 2016, di Federico La Sala
- GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITA’ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
- RIPENSARE L’EUROPA. PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!
La globalità della corruzionedi Roberto Toscano (la Repubblica, 03.04.2016)
- DA qualche tempo a questa parte il tema della corruzione occupa le prime pagine dei nostri giornali e attira l’attenzione, e lo sdegno, dell’opinione pubblica. Non mancano i cinici che, autodefinendosi realisti, fanno notare che la corruzione è sempre esistita.
DEPLORANO quello che definiscono moralismo e denunciano le campagne anti-corruzione come sempre tendenti a squalificare l’avversario politico. Invece occuparsi, e preoccuparsi della corruzione, oggi convertita in una perversa normalità, non è moralismo, ma una oggettiva necessità sia politica che culturale.
Come punto di partenza dovremmo cercare di liberarci da molti luoghi comuni. Il primo è quello che la corruzione sia un inevitabile corollario della democrazia, mentre le dittature sarebbero in grado di stroncarla grazie alla loro spietata inflessibilità repressiva. Falso. Si sapeva di certo che Pinochet era un assassino, ma è poi risultato che era anche un ladro e che aveva trasferito su un conto di Washington denaro pubblico di cui si era illegalmente appropriato. E che dire della Cina, dove i corrotti sono arrivati a un “fatturato” di miliardi di dollari a dispetto dei ricorrenti processi che si concludono anche con condanne a morte?
L’altro luogo comune è che la corruzione sia esclusivamente legata al capitalismo, sistema che si basa sulla legittimazione anche culturale dell’avidità («L’avidità è buona. L’avidità funziona» - come dice Gordon Gekko nel film Wall Street), e che l’unico antidoto sia quello di un’etica rivoluzionaria basata sui doveri sociali e sull’austerità. Falso. La Corea del Nord, il meno democratico e il meno capitalista fra i sistemi politici esistenti, è elencata da Transparency International in testa alla classifica della corruzione a pari merito con la Somalia, lo stato fallito più anarchico del mondo.
Prendiamo alcune fra le grandi cause rivoluzionarie del secolo scorso. Il successore di Mandela, il presidente sudafricano Zuma, è appena stato incriminato per uso privato di fondi pubblici, e la classe dirigente del glorioso African National Congress è coinvolta in una serie di scandali. Daniel Ortega, l’eroe della rivoluzione sandinista in Nicaragua, ha impiantato un regime in cui la retorica rivoluzionaria è ormai solo una consunta copertura di un sistematico andazzo corruttivo. In Angola, ancora governata da quel Mpla che aveva resistito, con l’aiuto cubano, all’attacco combinato di Sudafrica e Cia, la figlia del presidente dos Santos è diventata la prima miliardaria africana. È vero che il tema della corruzione viene usato contro gli avversari politici. Sta avvenendo in Brasile, contro Dilma Rousseff e Lula, ma il problema è che la corruzione c’è davvero, e a livelli colossali.
Altro luogo comune è quello che la corruzione sia un fenomeno del settore pubblico. Come se le frodi che hanno innescato la crisi finanziaria globale non fossero attribuibili a Wall Street - anche se con la complicità dei “cani da guardia” federali che non hanno abbaiato. In Italia tutti danno addosso alla pubblica amministrazione e ai suoi funzionari, definiti come una manica di disonesti parassiti. Pubblico cattivo/ privato buono. Viene in mente La fattoria degli animali di Orwell: “due gambe cattivo, quattro gambe buono”. Come se potesse esistere un funzionario pubblico corrotto senza un privato corruttore - come se ci potesse essere la prostituzione senza i clienti. Basterebbe ascoltare con attenzione i linguaggi, oltre che i contenuti, delle intercettazioni per capire con quanta protervia, quanta arroganza, i corruttori privati sentono di poter dominare i loro prezzolati manutengoli nella pubblica amministrazione.
Ma cosa spiega il fatto che la corruzione sia passata da trasgressione a sistema? Non certo che l’umanità sia diventata più criminale. E nemmeno che siano venuti meno i freni derivanti dai precetti religiosi: che la fede religiosa non sia incompatibile con la corruzione e in genere la criminalità lo dimostrano fatti come i santini nel covo di Provenzano e l’appartamento del cardinale Bertone, finanziato con i soldi dell’ospedale Bambin Gesù. Senza parlare dei corrotti ayatollah iraniani e degli iper-religiosi/iper-corrotti sauditi.
Qualcosa di profondo è però avvenuto. Si tratta del restringersi degli orizzonti culturali all’interno di una comunità che non è globale né nelle norme né nella solidarietà, ma è unificata rispetto a quello che è ormai il criterio singolo del valore, del successo, della stessa identità: il denaro.
Ha ragione il Papa quando parla di idolatria. Si tratta della perdita di rilevanza della molteplicità di valori e obiettivi che dovrebbero dare un senso alla vita umana, ma che oggi risultano accantonati per lasciare tutto il campo a uno spirito acquisitivo in termini di denaro e del benessere e potere che dal denaro si possono ricavare. Un tempo il denaro serviva ad acquisire potere, oggi il potere viene usato per conseguire il denaro.
Sarebbe assurdo manifestare nostalgia per il tempo delle ideologie totalitaria e dei loro crimini, dalla Shoah al Gulag, ma non dovremmo cadere nell’errore di non vedere la totalità idolatrica di quella che è oggi l’ideologia dominante. Non avrebbe senso a questo punto ripercorrere le fallite strade della lotta contro Mammona e contro il Capitale e riproporre pauperismo o collettivismo. Dobbiamo lottare non contro, ma per.
Riconoscendo il giusto spazio che l’aspirazione al benessere occupa nel quadro di un sano equilibrio etico-antropologico, dovremmo ridare diritto di cittadinanza a tutto quello che il denaro e il “pensiero unico” che lo accompagna hanno accantonato, negato, squalificato, strumentalizzato: arte, cultura, religione, etica, politica.
Si deve certo combattere la corruzione con gli strumenti della legge, ma la vera battaglia dovrà essere quella, di natura culturale ed etico-politica, anti-totalitaria e anti-idolatrica. Altrimenti non servirebbe nemmeno - né in Italia né altrove - mettere un poliziotto dietro ogni cittadino e sottoporlo a intercettazioni costanti.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- UNIVERSITÀ DI MESSINA Copia ma non perde il concorso. Il caso del prof, figlio del potentissimo ex rettore. (di Gian A. Stella)1 febbraio 2016, di Federico La Sala
- MAMMASANTISSIMA. Il grande ordine simbolico del "Che-rùbino" ... tutti e tutto!!!
 lL "LOGO" DELLA SAPIENZA, L’UMANITA’, E L’ACQUA. PAESE IMPAZZITO: FORZA "CHE RùBINO" TUTTO E TUTTI !!!
lL "LOGO" DELLA SAPIENZA, L’UMANITA’, E L’ACQUA. PAESE IMPAZZITO: FORZA "CHE RùBINO" TUTTO E TUTTI !!!
UNIVERSITÀ DI MESSINACopia ma non perde il concorso
Il caso del prof ordinario Dario Tomasello, figlio del potentissimo ex rettore.
Nei suoi saggi brani identici a quelli del suo maestro
di Gian Antonio Stella (Corriere della Sera, 01.02.2016)
Aguzzate la vista», invita la Settimana Enigmistica su vignette identiche dove occorre scoprire dettagli diversi. Qui non occorre manco aguzzarla. Per andare in cattedra un docente messinese ha portato al concorso per l’abilitazione in Letteratura italiana contemporanea testi qua e là platealmente copiati di sana pianta. Fin qui, capita. Non è la prima volta, difficile sia l’ultima. Molto più grave è risposta del ministero. Dove si spiega che la commissione, messa davanti alle prove del plagio, ha deciso di non «modificare il giudizio». Chi ha dato ha dato, chi ha avuto ha avuto...
I protagonisti della storia sono due. Di qua Dario Tomasello, dal 2006 «associato» di letteratura italiana contemporanea all’Università di Messina dove il padre Francesco era allora il potentissimo rettore, destinato a rimanere in carica tra mille polemiche fino al 2013. Di là Giuseppe Fontanelli, lui pure associato nello stesso Ateneo. Punti in comune: l’essere stati entrambi allievi di Giuseppe Amoroso, storico luminare della materia. Destini diversi: al concorsone del 2013 il giovane Tomasello passa, il più anziano Fontanelli no.
«Possibile?», mastica amaro il bocciato. Non si dà pace. Finché, come racconterà alla rivista «centonove», viene «colto da una folgorazione, una chiaroveggenza del caso, uno strappo nel cielo di carta». In pratica, spiega oggi, «ho riconosciuto qua e là nei lavori del Tomasello non solo i pensieri ma le parole stesse di Amoroso e sono andato a controllare: c’erano pagine e pagine non ispirate ma riprese da questo o quel libro con il “copia incolla”. Senza virgolette e citazione dei testi originali».
Un esempio? Primo testo: «La vitalità di osservatore accanito del ciclo della natura spinge Pascoli a cogliere il flusso di un divenire sempre diverso, una trama di suggestioni che si allacciano alla natura umana, facendosi, nell’istante in cui sono isolate, parafrasi della vita quotidiana ed eroica, brulicante di apparizioni, di tentazioni e allegorie...». Secondo testo: «La vitalità di osservatore accanito dell’esistenza spinge Quasimodo a cogliere il flusso di un divenire sempre diverso, una trama di suggestioni che si allacciano alla natura umana, facendosi, nell’istante in cui sono isolate, parafrasi della vita quotidiana ed eroica, brulicante di apparizioni, di tentazioni e allegorie...»
Uguali. Virgola per virgola, tranne due parole (di qua «ciclo della natura», di là «esistenza») ma soprattutto il poeta di cui si parla. Nel primo caso Pascoli nel libro La realtà per il suo verso e altri studi su Pascoli prosatore di Tomasello, nel secondo Quasimodo nel lavoro di Amoroso nel libro collettivo Salvatore Quasimodo, la poesia nel mito e oltre a cura di Finzi.
Cocciutamente deciso a smascherare il plagio, Fontanelli dice di avere per cinque mesi «letto tutto, confrontato tutto, scoperto tutto. O almeno quasi tutto». Messe insieme delle cartelle, mostra pagine e pagine a confronto. Saggio sul futurismo (Bisogno furioso di liberare le parole) di Tomasello: «Il chiuso di un laboratorio talora finisce per avere più brio della felicità plausibile e appagante dell’avventura in pieno sole». Saggio sulla narrativa italiana (Forse un assedio) di Amoroso: «Il chiuso di un laboratorio talora finisce per avere più brio della felicità plausibile e appagante dell’avventura in pieno sole». Ancora Tomasello: «Fra segmentazioni dialogiche, mimesi del parlato, spazi di pura narrazione, l’aggancio ai nodi del reale dispone frattanto i testi nella misura di una cronaca ricca e criticamente più centrata nel cardine dei fatti, nella mostra vitale del tempo». Amoroso: «Fra segmentazioni dialogiche, mimesi del parlato, spazi di pura narrazione, l’aggancio ai nodi del reale dispone frattanto le pagine sulla regola di una cronaca ricca e criticamente più centrata nel cardine dei fatti, nella mostra vitale del tempo».
Ancora Tomasello in L’isola oscena: «L’inventario di questo universo appare un catalogo di sbigottimenti grazie alla posizione inconsueta delle tessere nel quadro, allo sbandato riflesso delle tinte, all’atmosfera di incantamento suggerita dalle angolature, dai coefficienti instabili dell’impianto, dal nervoso punto di vista». Amoroso in Raccontare l’assenza: «L’inventario di questo universo appare un catalogo di sbigottimenti grazie alla posizione inconsueta delle tessere nel quadro, allo sbandato riflesso delle tinte, all’atmosfera di incantamento suggerita dalle angolature, dai coefficienti instabili dell’impianto, dal nervoso punto di vista». E potremmo andare avanti...
«Ho una produzione sterminata e, confesso, non mi ero proprio accorto del presunto “saccheggio”», disse dopo la denuncia Amoroso, «Ad aprirmi gli occhi è stato Fontanelli». Di più: «Non sono Proust, non pretendo che venissero riconosciuti la mia mano, il mio tratto. Questo mai. Non mi permetterei. Ma...». «Ho sempre agito con correttezza e professionalità», rispose Tomasello, minacciando sventagliate di querele.
Fatto sta che, davanti allo scandalo, la «chiamata» dell’accusato come ordinario a Messina fu sospesa e il nuovo rettore Pietro Navarra girò i documenti al Ministero e alla procura di Milano, competente perché lì si era riunita la commissione. Mesi e mesi di attesa, dubbi, polemiche e infine, giorni fa, al rettore messinese è arrivata una lettera del direttore generale del Miur Daniele Livon. La frase che conta è questa: «Visionata la documentazione» la commissione (che lodava il vincitore anche per i «contributi originali») ritiene di «non dover modificare il giudizio di abilitazione già reso nei riguardi del prof. Tomasello». Proprio educativo, per insegnare agli studenti a non copiare...
- MAMMASANTISSIMA. Il grande ordine simbolico del "Che-rùbino" ... tutti e tutto!!!
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- La compagnia di caffè israeliana, lIsraeli Espresso Club, Clooney e Nespresso.22 gennaio 2016, di Federico La Sala
Nespresso fa causa per uno spot di una concorrente con il sosia di Clooney
Chiesti 50mila dollari di risarcimento e rimozione spot
 di Redazione ANSA ROMA 22 gennaio 2016
di Redazione ANSA ROMA 22 gennaio 2016Clooney e Nespresso, binomio inconfondibile. Non per la compagnia di caffè israeliana, la Israeli Espresso Club, che ha cercato invece di confondere le idee a suo vantaggio ricorrendo ad un sosia della star hollywodiana per un suo spot. Mossa che che gli è subito costata una citazione in giudizio da parte della Nespresso che rivendica l’unicità del suo volto-immagine.
Durante la pubblicità della compagnia israeliana compare una scritta sullo schermo che avverte che l’attore, dai capelli argento e con in mano quello che sembra essere un sacchetto di Nespresso, "non è George Clooney. La Nespresso chiede 50,000 dollari di danni e la rimozione dell’annuncio pubblicitario.
Lo spot della società concorrente con il sosia di Clooney (da Youtube)
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. -- LA "PAROLA" A PAGAMENTO! VATICANO, COPYRIGHT, E CARO-PREZZO ("CARITAS").19 gennaio 2016, di Federico La Sala
VATICANO, COPYRIGHT, E CARO-PREZZO ("CARITAS"): "IN PRINCIPIO ERA LA PAROLA" A PAGAMENTO!!!
Enciclica "mammonica"!!!
 «DEUS CARITAS EST», LA PRIMA ENCICLICA DI RATZINGER E’ A PAGAMENTO !!!
«DEUS CARITAS EST», LA PRIMA ENCICLICA DI RATZINGER E’ A PAGAMENTO !!!LA "LUCE DEL MONDO" SONO "IO"!!! CHE SUCCESSO, QUANTI SOLDI CON I DIRITTI DI AUTORE!!! --- IL NOME DI DIO E’ MISERICORDIA. Il titolo del libro-intervista di Papa Francesco con il vaticanista Andrea Tornielli (EDIZIONI PIEMME - GRUPPO MONDADORI)
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- "QUO VADO?": LA LUNGA MARCIA DELLA CIVILIZZAZIONE VIDEO-CATTOLICA.17 gennaio 2016, di Federico La Sala
DAL ’MONDO’ DEL "QUO VADIS?" AL ’MONDO’ DEL "QUO VADO?". PER UNA CRITICA DELLA LUNGA MARCIA DELLA CIVILIZZAZIONE VIDEO-CATTOLICA:
"QUO VADIS, DOMINE? - SIGNORE, DOVE VAI?): "LA FIABA E’ LA FIABA, LA FAVOLA E’ LA FAVOLA, IL ROMANZO DI FORMAZIONE E’ IL ROMANZO DI FORMAZIONE - E IL MESSAGGIO EVANGELICO E’ IL MESSAGGIO EVANGELICO
 Note su "Quo vadis? (romanzo storico e film" e su "Quo vado?" (il film diretto da Gennaro Nunziante, interpretato da Luca Pasquale Medici, nei panni di Checco Zalone)":
Note su "Quo vadis? (romanzo storico e film" e su "Quo vado?" (il film diretto da Gennaro Nunziante, interpretato da Luca Pasquale Medici, nei panni di Checco Zalone)":A.
- Gesù - nel messaggio evangelico ...
 Marco 7,31-37:
Marco 7,31-37:
 Di ritorno dalla regione di Tiro, passò per Sidone, dirigendosi verso il mare di Galilea in pieno territorio della Decàpoli.
Di ritorno dalla regione di Tiro, passò per Sidone, dirigendosi verso il mare di Galilea in pieno territorio della Decàpoli.
 E gli condussero un sordomuto, pregandolo di imporgli la mano.
E gli condussero un sordomuto, pregandolo di imporgli la mano.
 E portandolo in disparte lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua;
guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e disse: «Effatà» cioè: «Apriti!».
E portandolo in disparte lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua;
guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e disse: «Effatà» cioè: «Apriti!».
 E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente.
E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente.
 E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo raccomandava, più essi ne parlavano
e, pieni di stupore, dicevano: «Ha fatto bene ogni cosa; fa udire i sordi e fa parlare i muti!».
E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo raccomandava, più essi ne parlavano
e, pieni di stupore, dicevano: «Ha fatto bene ogni cosa; fa udire i sordi e fa parlare i muti!».- ... e "Gesù" - nella tradizione del cattolicesimo-romano
 James Joyce, Finnegans Wake (Libro Primo V-VIII):
James Joyce, Finnegans Wake (Libro Primo V-VIII):
- "He lifts the lifewand and the dumb speak
 Quoiquoiquoiquoiquoiquoiquoiq"
Quoiquoiquoiquoiquoiquoiquoiq"
- "Egli brandisce la bacchetta della vita e i muti parlano
 Quoiquoiquoiquoiquoiquoiquoiq"
Quoiquoiquoiquoiquoiquoiquoiq"
- Vale a dire (fls):
 Quoì-quoì-quoì-quoì-quoì-quoì-quoì...
Quoì-quoì-quoì-quoì-quoì-quoì-quoì...
 Quà-quà-quà-quà-quà-quà-quà-quà-quà...
Quà-quà-quà-quà-quà-quà-quà-quà-quà...
B.
INTERVISTA A Luca Pasquale Medici
Checco Zalone, dagli sms con Matteo Renzi al pranzo con Silvio Berlusconi: "Zalone starebbe sulle palle anche a me"
di Redazione (L’Huffington Post, 15/01/2016 - ripresa parziale)
Un successo trasversale, senza colori politici. Lo dimostrano gli sms con il premier Renzi e il pranzo a casa Berlusconi.
 Forse, come racconta lui stesso in un’intervista a "Sette", Checco Zalone ha un solo difetto, un’eccessiva indulgenza verso gli italiani e i loro vizi. "È vero - dice a Vittorio Zincone - Di questo schifo che siamo noi italiani, penso che qualcosa vada salvato. È il motivo per cui ho successo. Non mi piace puntare il ditino dall’alto di un piedistallo".
Forse, come racconta lui stesso in un’intervista a "Sette", Checco Zalone ha un solo difetto, un’eccessiva indulgenza verso gli italiani e i loro vizi. "È vero - dice a Vittorio Zincone - Di questo schifo che siamo noi italiani, penso che qualcosa vada salvato. È il motivo per cui ho successo. Non mi piace puntare il ditino dall’alto di un piedistallo".Eppure, ormai, Zalone con Quo Vado?, è entrato prepotentemente nell’Olimpo del cinema italiano, quantomeno per i numeri strabilianti registrati ai botteghini, numeri che fanno da cassa di risonanza a un talento ormai appurato, attirando anche l’interesse del premier, che non nasconde di essere un suo fan.
- "Mi ha scritto per farmi in bocca al lupo e per dirmi che sarebbe stato in prima fila con tutta la famiglia. Ha aggiunto anche un post scriptum per commentare la parte che lo riguarda della canzone La Prima Repubblica, ’Ma il Presidente è toscano/ell’è un gran burlone/ ha detto “eh, scherzavo” /piuttosto che il Senato mi taglio un coglione’. Ecco il suo sms: ’Prima di tagliarmi un coglione taglio Senato, Camera e Palazzo Chigi. Ai coglioni tengo molto’. Poi mi ha chiamato e mi ha fatto la classifica delle gag preferite dai figli". Poi insinua scherzosamente che forse il presidente del Consiglio volesse cavalcare l’onda del successo zaloniano: "Il sospetto? La certezza! Ahahah. Scherzo, eh".
Ma nella vita di Zalone non ci sono solo sms da Palazzo Chigi, ma anche un pranzo ad Arcore.
- "Qualche mese fa sono stato ad Arcore. Un pranzo. Mi ha invitato Piersilvio". "Lui - riferendosi al Cavaliere - è stato con noi solo una mezz’oretta. Sono capitato il giorno in cui si è materializzata l’ipotesi di una scissione dentro Forza Italia. Stava a tavola con questo foglietto in mano. Sopra c’era il piccolo elenco degli scissionisti. Era piuttosto incazzato".
Poi il racconto della sua "storia" con Gennaro Nunziante, il regista con cui hai realizzato i suoi film.
- "Siamo una coppia di fatto. Lui era un autore leggendario di Telenorba. Un giorno mi dissero che stava cercando un finto cantante neo-melodico per lo show Sottano’s, la parodia dei Soprano’s. Mi presentai col pezzo La globalizzazione. Dopo avermi ascoltato, mi chiese: “Ma ci sei o ci fai?”. Mi prese".
Inevitabile un rapido passaggio sugli incassi delle pellicole: 14 milioni con Cado dalle nubi, 43 con Che bella giornata, 52 con Sole a catinelle, con Quo vado? più di 60.
- "Mica vorrai parlare di soldi. Non posso. Ma calcola che io non monetizzo questo successo. Quando ero a Zelig accettavo serate e comparsate alle convention, ora ho smesso e, a differenza di molti colleghi, non faccio pubblicità, nonostante ci sia la fila. Compagnie telefoniche, case automobilistiche. Ti fanno offerte tali che ti senti un po’ coglione a rifiutare". Ma lui rifiuta comunque perché per Zalone sarebbe come un tradimento. "La gente ti viene a vedere, si diverte, ti vuole bene... e tu prendi la tua faccia da cazzo e la metti a disposizione di un prodotto? Non si fa. E non per afflato idealistico, ma per educazione. Poi c’è anche un problema di convenienza: se ti vedono tutti i giorni in tv negli spot, quattro volte il pomeriggio e sei la sera, perché poi dovrebbero venirti a vedere al cinema?". "Comunque, alla fine prenderò quanto un discreto giocatore di serie A. Anzi no, quanto uno scarso".
Infine i complimenti da parte del ministro della Cultura Dario Franceschini e del regista Gabriele Muccino, entrambi concordi sul fatto che Zalone serviva al cinema italiano perché i soldi degli incassi possono essere spesi per finanziare film belli. Il pugliese si diverte.
- "In realtà se io fossi un altro attore comico o un regista oggi rosicherei un po’. Checco Zalone starebbe sulle palle anche a me. Pensa a Carlo Verdone: tra poco esce il suo film. Sono cavoli, eh. Dopodiché tra cinque/sei anni spunterà un nuovo comico e toccherà a me rosicare".
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- FIABA, COSTITUZIONE, E SOCIETA’. NON SAPPIAMO PIU’ RACCONTARE LE "FAVOLE"! L’ALLARME DI COLLODI E LA "PROVOCAZIONE" DI GRAMELLINI. AL DI LA’ DEL MITO E DELLA LOGICA TRAGICA.... L’INDICAZIONE DI MANDELA E DON MILANI.
- CHI INSEGNA A CHI CHE COSA COME?! QUESTIONE PEDAGOGICA E FILOSOFICA, TEOLOGICA E POLITICA INSEGNAMENTO E COSTITUZIONE: CHI INSEGNA AI MAESTRI E ALLE MAESTRE A INSEGNARE?!
- QUI, QUA, Quo e il MANUALE DELLE GIOVANI MARMOTTE. L’immaginario dell’impero disneyano
LA "PROFEZIA" DI MARSHALL MCLUHAN. Cedere occhi, orecchie e nervi a interessi commerciali è come consegnare il linguaggio comune a un’azienda privata o dare in monopolio a una società l’atmosfera terrestre.
LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE.
IL "ROMANZO DI FORMAZIONE" EUROPEO: LA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO DEI "DUE SOLI".
- Gesù - nel messaggio evangelico ...
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- "Corrotti perdono pudore e dignità, provino vergogna". "Il nome di Dio è misericordia": il libro-intervista di papa Francesco (di F. Gasparroni)13 gennaio 2016, di Federico La Sala
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITA’ E RICONCILIAZIONE.....
"Corrotti perdono pudore e dignità, provino vergogna"
Esce libro. "Mai emarginare i gay, ogni creatura è amata da Dio"
di Fausto Gasparroni (Ansa, 12 gennaio 2016)
ROMA "Sì, io credo che questo sia il tempo della misericordia". E’ quasi un vademecum per il Giubileo il libro-intervista di papa Francesco con Andrea Tornielli, "Il nome di Dio è misericordia" (Piemme, pp. 120, 15.00 euro), uscito oggi in 86 Paesi e presentato a Roma con ospiti come Roberto Benigni e il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin. "La Chiesa mostra il suo volto materno, il suo volto di mamma, all’umanità ferita - vi afferma Bergoglio -. Non aspetta che i feriti bussino alla sua porta, li va a cercare per strada, li raccoglie, li abbraccia, li cura, li fa sentire amati".
Nell’agile volume c’è tutta la visione di Francesco sulla misericordia, vero balsamo per "l’umanità ferita" del terzo millennio, cui ha voluto dedicare l’Anno Santo straordinario ponendola al centro della stessa idea di cristianesimo: "la misericordia è la carta d’identità del nostro Dio. Dio di misericordia. Dio misericordioso. Per me questa è davvero la carta d’identità del nostro Dio". Rivelando tra l’altro come una prima idea dell’Anno giubilare l’ebbe in embrione in una tavola rotonda tra teologi ai tempi di Buenos Aires: "si discuteva su che cosa il Papa potesse fare per avvicinare la gente, di fronte a tanti problemi che sembravano senza soluzione. Uno di loro disse: ’Un giubileo del perdono’. Questo mi è rimasto in mente". Forte l’accento posto dal Papa sul valore del sacramento della penitenza, sui confessori che devono avere "tenerezza" e "non allontanare" la gente che "soffre". E se, da una parte, "andare a confessarsi non è come andare a portare il vestito in tintoria", dall’altra i confessionali "non devono mai essere stanze di tortura". "A volte desidererei poter entrare in una chiesa e sedermi ancora in confessionale", confida Francesco. La stessa giustizia terrena "è più giusta, realizza davvero se stessa", se attuata "con la misericordia". Ecco quindi la crescita nella coscienza mondiale del "rifiuto della pena di morte". Bene anche "quanto si sta cercando di fare per il reinserimento sociale dei carcerati". La misericordia divina, insomma, "contagia l’umanità".
Tuttavia le parole più forti del Pontefice sono ancora sulla piaga della corruzione, un peccato che "viene elevato a sistema, diventa un abito mentale, un modo di vivere". "Il corrotto - denuncia Francesco - è così chiuso e appagato nella soddisfazione della sua autosufficienza che non si lascia mettere in discussione da niente e da nessuno. Ha costruito un’autostima che si fonda su atteggiamenti fraudolenti: passa la vita in mezzo alle scorciatoie dell’opportunismo, a prezzo della sua stessa dignità e di quella degli altri". Per il Papa, "il corrotto ha sempre la faccia di chi dice: ’Non sono stato io!’. Quella che mia nonna chiamava ’faccia da santarellino’". Il corrotto, in altre parole, "è quello che s’indigna perché gli rubano il portafoglio e si lamenta per la scarsità di sicurezza che c’è nelle strade, ma poi truffa lo Stato evadendo le tasse e magari licenzia i suoi impiegati ogni tre mesi per evitare si assumerli a tempo indeterminato oppure sfrutta il lavoro in nero. E poi si vanta pure con gli amici di queste sue furbizie". E’ quello "che magari va a messa ogni domenica, ma non si fa alcun problema nello sfruttare la sua posizione di potere pretendendo il pagamento di tangenti". La corruzione, insomma, "fa perdere il pudore", mentre "il corrotto spesso non si accorge del suo stato, proprio come chi ha l’alito pesante e non se ne rende conto". Il Papa lo ripete più volte: "peccatori sì, corrotti no!", perché nell’animo dei secondi non c’è il pentimento e la richiesta di perdono. "Dobbiamo pregare in modo speciale, durante questo Giubileo - aggiunge -, perché Dio faccia breccia anche nei cuori dei corrotti donando loro la grazia della vergogna, la grazia di riconoscersi peccatori bisognosi del Suo perdono".
Bergoglio torna con chiarezza anche sul tema dei gay: "persone omosessuali", vuole che le si chiami, perché "prima c’è la persona, nella sua interezza e dignità. E la persona non è definita soltanto dalla sua tendenza sessuale: non dimentichiamoci che siamo tutti creature amate da Dio, destinatarie del suo infinito amore". "Puoi consigliare loro la preghiera, la buona volontà, indicare la strada, accompagnandole", risponde a una domanda sulla sua esperienza di confessore. E a proposito della sua celebre frase "Chi sono io per giudicare?" afferma: "Avevo detto in quella occasione: se una persona è gay, cerca il Signore e ha buona volontà, chi sono io per giudicarla? Avevo parafrasato a memoria il Catechismo della Chiesa cattolica, dove si spiega che queste persone vanno trattate con delicatezza e non si devono emarginare".
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- Vaticano: a proposito della finta donazione del cardinal Bertone (di Paolo Farinella)21 dicembre 2015, di Federico La Sala
Vaticano: a proposito della finta donazione del cardinal Bertone
di Paolo Farinella (il Fatto, 20 dicembre 2015)
Sig. cardinale Tarcisio Pietro Evasio Bertone,
che lei sia inadeguato ai ruoli e compiti che ha svolto è davanti agli occhi di tutti: a Genova dove non lasciò alcuna traccia significativa, ma scelse come plenipotenziario del Galliera, il prof. Giuseppe Profiti, al centro di ogni ben di Dio; da segretario di Stato dove ha distrutto la credibilità della Chiesa universale con la sua incapacità di governo, privo di qualsiasi discernimento, ma dedito a costruire una rete di fedelissimi per perpetuare il suo potere anche da pensionato e da morto; infine da cardinale in pensione con il miserevole attico di 296 mq dove vive con tre suore e magari si rilassa, giocando a golf negli appropriati corridoi.
Leggo sui giornali che lei ha deciso «ex abundantia cordis» di donare all’ospedale Bambin Gesù un contributo di 150mila euro, attinti come da lei dichiarato, dai «miei risparmi e dai vari contributi di beneficenza ricevuti negli anni per finalità caritative». Mi faccia capire perché c’è qualcosa che non quadra. Non sto a questionare sul fatto che la ristrutturazione è costata € 300mila, di cui 200mila pagati dalla fondazione Bambin Gesù.
Mi lascia esterrefatto la notizia che lei ha preso questi soldi «dai vari contributi di beneficenza ricevuti negli anni per finalità caritative», cioè non per lei, ma perché lei li desse per gli scopi per cui li ha ricevuti o, genericamente, per opere di carità. Invece lei dice che attinge da questi «vari contributi di beneficenza ricevuti negli anni» per pagare il suo appartamento. Non solo, ma lei parla di «vari anni», lasciando intendere un solo senso: lei ha trattenuto per anni contributi ricevuti per beneficenza. Mi perdoni, quando pensava di darli in beneficenza, alla sua morte per testamento?
Il buco che lei vuol coprire risulta più grande della toppa che cerca disperatamente di metterci su senza riuscirci perché la sua maldestra difesa aggrava ancora di più la sua posizione che l’espone, per le sue stesse parole, al ludibrio della gente perbene che vede nei suoi comportamenti una miserabile attitudine alla superficialità che è colpa ancora più grande della delinquenza di persone come lei che dicono di volere rappresentare quel Dio che accusa chi veste di porpora di essere soci della casta del potere. Non solo lei ha trattenuto nel suo conto personale denari ricevuti per beneficenza, ma li ha anche trattenuti per «vari anni», lucrando magari sugli interessi che dalle parti dello Ior, gestito da suoi uomini e da lei stesso, potrebbero essere stati più che generosi.
Lei ha rubato due volte ai poveri: la prima volta trattenendo questi denari non suoi e la seconda volta facendosi bello con l’ospedale «Bambin Gesù» dando soldi non suoi, ma quelli della beneficenza che non ha donato negli anni passati. In ultima analisi, poiché è il totale che fa la somma (copyright Totò), lei non sborsa nulla di tasca sua, ma paga tutto sempre con denaro di beneficenza. Complimenti, esimio cardinale!
La rovina dei preti sono sempre i soldi. Per questo sproloquiate di celibato perché così siete più liberi di amare «mammona iniquitatis», fornicando giorno e notte senza essere visti da alcuno. Se il tempo che dedicate a difendere il celibato dei preti, che solo pochi rispettano (e lei lo sa perfettamente!) o a condannare i gay laici - visto che preti, vescovi, monsignori e cardinali lo sono ad abundantiam - o a sproloquiare di separati e divorziati, di cui non sapete nulla, lo dedicaste a proibire ai preti di gestire denaro, fareste una cosa preziosa per il mondo e per la Chiesa. Sicuramente due terzi del clero lascerebbe la Chiesa, ma con il terzo che resta e con l’aiuto dei preti ridotti allo stato laicale perché sposati, ripresi in servizio, saremmo capaci di rivoluzionare il mondo, oltre che il Vaticano, covo di malaffare e di depravazione senza misura.
Tanti anni fa, quando era potente, io la ripudiai pubblicamente insieme al suo amico e sodale Berlusconi, da cui lei - o lui da lei? - «prese lo bello stile che le ha fatto (dis)onore» e oggi sono contento di avere visto lungo e giusto. Lei mente dicendo di essere salesiano; se lo fosse veramente, avrebbe agito come il cardinale Carlo Maria Martini, il quale, date le dimissioni, si è ritirato in una casa di gesuiti abitando in una stanza 6×4 con letto, tavolo, armadio, servizi e un assistente personale perché malato, partecipando alla vita comunitaria da cui proveniva.
Scegliendo di accorpare due appartamenti con i soldi della beneficenza, lei ha dimostrato non solo di non credere in Dio, ma di dare un pugno nello stomaco a Papa Francesco che sta provando a dire ai cardinali, ai vescovi e ai preti che c’è anche un piccolo libretto che si chiama Vangelo. A lei, di sicuro non interessa, perché come i fatti dimostrano, lei legge solo «Gli Attici degli Apostoli».
Con profonda disistima perché la conosco dai tempi di Genova, senza rimpianti.
prete - Genova.
-
> LA QUESTIONE MORALE --- «Il ministro Boschi deve dimettersi». Roberto Saviano giudica «abnorme» il conflitto di interessi rappresentato da un membro dell’esecutivo che decide sul destino di una banca, la Popolare dell’Etruria, di cui il padre è stato dirigente e il fratello dipendente.12 dicembre 2015, di Federico La Sala
Saviano: “La Boschi deve dimettersi”
“Abnorme conflitto di interessi”.
Guerini (Pd): “Interventi così non aiutano”
di F. S. (la Repubblica 12.12.15
ROMA. «Il ministro Boschi deve dimettersi». Roberto Saviano chiede al ministro per le Riforme di lasciare, in un video messaggio pubblicato da Repubblica Tv. Lo scrittore giudica «abnorme» il conflitto di interessi rappresentato da un membro dell’esecutivo che decide sul destino di una banca, la Popolare dell’Etruria, di cui il padre è stato dirigente e il fratello dipendente. «Il governo non doveva occuparsi della banca, oppure deve chiedere al ministro di dimettersi», sostiene Saviano. Il fatto che Boschi non abbia partecipato al voto sul “salva-banche” è solo una «dissimulazione»: «Una struttura politica ha compiuto l’ennesimo atto autoritario».
Dalla Leopolda sono arrivate le reazioni di diversi esponenti del Pd. «Il governo ha fatto quello che era necessario, non capisco la richiesta di dimissioni», ha detto il sottosegretario Scalfarotto. «Servono equilibrio e attenzione, non credo che questo aiuti», ha aggiunto il vice segretario Guerini. E per il sindaco di Firenze Nardella, Saviano è «fuori dal mondo».
Due giorni fa Boschi ha preso le difese del padre Pier Luigi, vice presidente della Popolare fino a febbraio del 2015, data del commissariamento: «È una persona perbene, non sento nessun disagio».
Un gesto nobile, secondo Saviano, ma che ricorda le frasi di Marina Berlusconi sul padre. «Questo governo deve essere criticato con lo stesso rigore con cui abbiamo criticato il governo Berlusconi», continua lo scrittore. «Per molto meno siamo scesi in piazza. Non possiamo introiettare l’accusa di disfattismo con cui Renzi reagisce alle critiche».
Secondo Saviano sulla vicenda restano «troppe opacità» a cui Boschi deve rispondere: «Se resterà al suo posto è solo perché questo è il Paese del conflitto di interessi».
La moglie di Cesare e il padre di Maria Elena Boschi
di Roberto Saviano (il post, 11.12.2015)
- Per Roberto Saviano il ministro dovrebbe dimettersi, e c’è un problema con le critiche al governo Renzi Boschi
Molti si sono preoccupati di dare ampia pubblicità agli impegni del Ministro Boschi nella giornata in cui il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto che ha salvato dal fallimento anche la Banca della quale il padre è vicepresidente. Molti hanno sentito la necessità di dare ampio spazio all’alibi del Ministro che, salvata la forma, ritiene di aver risolto la questione sul piano politico. Ma non è così.
Perché la Banca sia fallita - dopo essere stata oggetto nei mesi scorsi di sospette speculazioni - è compito degli organi competenti accertarlo (sempre che non si applichino al caso moratorie altrove felicemente utilizzate). Ma il conflitto di interessi del Ministro Boschi è un problema politico enorme, dal quale un esponente di primissimo piano del governo del cambiamento non può sfuggire. In epoca passata abbiamo assistito a crociate sui media per molto meno, contro esponenti di terza fila del sottobosco politico di centrodestra: oggi invece pare che di certe cose non si debba o addirittura non si possa parlare. È probabile che il Ministro Boschi non risponda come se il silenzio fosse la soluzione del problema. Ma questo è un comportamento autoritario di chi si sente sicuro nel proprio ruolo poiché (per ora) le alternative non lo impensieriscono. E se il Ministro resterà al suo posto, senza chiarire, la colpa sarà principalmente nostra e di chi, temendo di dare munizioni a Grillo o a Salvini, sta tacendo o avallando scelte politiche inaccettabili.
Quando è iniziata la paura di aprire un serio dibattito su questo governo? Quando è accaduto che a un primo ministro fosse consentito di prendere un impegno serio sul Sud ad agosto per dimenticarlo del tutto il mese successivo?
Proviamo a immaginare per un attimo che la tragedia che ha colpito Luigino D’Angelo, il pensionato che si è suicidato dopo aver perso tutti i risparmi depositati alla Banca Etruria, fosse accaduta sotto il governo Berlusconi. Tutto questo avrebbe avuto un effetto deflagrante. Quelli che ora gridano allo scandalo, gli organi di stampa vicini a Berlusconi forse avrebbero taciuto, ma per tutti gli altri non ci sarebbe stato dubbio: si sarebbero invocate le dimissioni. Dunque, cosa è successo? Come siamo passati dai politici tutti marci ai politici tutti intoccabili? Cosa ci sta accadendo?
All’alba della Terza Repubblica un ministro del governo Letta, la campionessa Josefa Idem, sfiorata da una vicenda senza alcuna rilevanza penale (aveva indicato come abitazione principale ai fini della tassazione un immobile che non lo era), decise di dimettersi. Era iniziato un nuovo corso e alle elezioni politiche il Movimento 5 Stelle, con la carica moralizzatrice che gli è propria, aveva ottenuto un risultato impensabile: c’era la necessità di marcare la differenza con il passato. Il passato era la Seconda Repubblica e la sua impostazione liberale, non nel senso classico, ma in quello icasticamente definito da Corrado Guzzanti per il quale la Casa della Libertà era solo un luogo dove ognuno - e i potenti ancor di più - facevano quello che volevano, contro la legge o con l’ausilio di leggi ad hoc.
Si torna sempre a Berlusconi, ma del resto non è vero che senza conoscere il passato non può comprendersi il presente? O si tratta di una massima di portata generale e mai particolare? I nemici di Berlusconi, tra i quali mi onoro di essere annoverato, sono una folta, foltissima schiera di scrittori, giornalisti, intellettuali, privati cittadini che nel tempo si sono sentiti investiti del compito di monitorare cosa stesse accadendo alla politica italiana, alla sua economia. Di comprendere e se possibile rendere pubblici certi meccanismi. I tentativi di censurare, di impedire il racconto della realtà e infine di diffamare chi osasse farlo, sono stati innumerevoli. Ma l’Italia non è mai diventata la Turchia di Erdoğan o la Russia di Putin - amici dichiarati del nostro ex Presidente - perché non eravamo soli. Ognuno di noi sapeva di poter contare sul supporto di altri che come noi spendevano tempo, energie e intelligenza per raccontare quanto succedeva ogni giorno, tra cronaca parlamentare e giudiziaria. Sulle pagine del quotidiano Repubblica un maestro indimenticabile del giornalismo di inchiesta, Peppe D’Avanzo, inchiodò il berlusconismo a dieci domande che non hanno mai ricevuto risposta, poiché è bene ricordare che il compito del giornalista è chiedere, il dovere del potere è rispondere. Quel potere era legittimo e democratico e quei governi frutto di libere elezioni: i media facevano il proprio dovere, tutelando quelle regole democratiche alle quali il signore di Arcore e il suo codazzo si richiamavano costantemente per fare quello che gli pareva e conveniva. Cosa è successo da allora? Cosa è cambiato nel nostro modo di leggere ciò che accade? Cosa è cambiato nella nostra capacità di indignarci? Cosa ne è di quel fronte unito contro un metodo di governo?
Perché era giusto sotto Berlusconi chiedere le dimissioni, urlare allo scandalo e all’indecenza ogni volta che qualcosa, a ragione, ci sembrava andare nel verso sbagliato e tracimare nell’autoritarismo? Perché sotto Berlusconi non ci si limitava a distinguere tra responsabilità giuridica e opportunità politica, ma si era giustizialisti sempre? E perché invece oggi noi stessi ieri zelanti siamo indulgenti anche dinanzi a una contraddizione cosi importante e oggettiva?
Se Berlusconi, che per anni abbiamo considerato causa dei mali dell’Italia, era in realtà la logica conseguenza della ingloriosa bancarotta della Prima Repubblica, così la stagione politica che stiamo vivendo adesso non ha nessuna caratteristica peculiare, nessun pregio o difetto autonomo, ma nasce dalle ceneri di quella esperienza. Il che non vuole dire in continuità, ma neanche ci si può ingannare (o ingannare gli altri) raccontandoci l’incredibile approdo sul suolo italico di una nuova generazione di politici senza passato. Banalmente - questa la narrazione dei media di centrodestra - potremmo dire che quando al potere ci sono le sinistre, si è più indulgenti. L’opinione pubblica è più indulgente. I media sono più indulgenti. È come se, a prescindere, si fidassero. Anche se ho seri dubbi che al governo ci sia la sinistra, o anche solo il centro-sinistra, e nemmeno, a dire il vero, una politica moderna: dato il ridicolo (per non dire peggio) ritardo sul tema dei diritti civili.
O forse le ragioni della attuale timidezza risiedono nell’iperattivismo del Renzi I (dato che tutti prevedono un nuovo ventennio per mancanza di alternative, forse dobbiamo prepararci alle numerazioni di epoca andreottiana) che lascia spiazzati, poiché il timore è di sembrare conservatori (con un uso improprio degli hashtag) o peggio nostalgici.
Del resto come si comunica contro gli hashtag del premier senza passare per gufi o nemici del travolgente cambiamento? Ormai si è giunti ad un passo dall’accusa di disfattismo. Imporre la furba dicotomia che criticare il governo o mostrare le sue forti mancanze sia un modo per fermare le riforme, che invece vogliamo, e per armare il populismo, verso cui nutriamo sempiterna diffidenza, è un modo per anestetizzare tutto, per portare all’autocensura.
Ma non cadiamo nella trappola: la felicità di Stato non esiste, è argomento che riguarda gli individui, non si impone, si raggiunge e noi ne siamo lontani. E la critica non è insoddisfazione malinconica, non è mal di vivere, non è spleen: e considerarla tale è quanto di peggio possa fare un capo di governo. Che il ministro Boschi risponda e subito della contraddizione che ha visto il governo salvare la banca di suo padre con un’operazione veloce e ambigua. Lo chiederò fino a quando non avrò risposta.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- "AVARIZIA" - E "CARESTIA", SENZA GRAZIA! Il Vaticano manda a processo Fittipaldi e Nuzzi e tre presunte fonti interne24 novembre 2015, di Federico La Sala
Il Vaticano manda a processo i giornalisti Fittipaldi e Nuzzi e tre presunte fonti interne
Il tribunale della Santa Sede, a sorpresa, ha rinviato a giudizio l’autore di "Avarizia", il libro-scoop sugli scandali finanziari della curia. La sua colpa: aver «divulgato notizie riservate». Rischia dai 4 agli 8 anni. Alla sbarra anche monsignor Vallejo Balda, Francesca Chaoqui e Nicola Maio, accusati di associazione per delinquere. La prima udienza oggi
di R.I. (L’Espresso, 24 novembre 2015)
Il Vaticano manda a processo i giornalisti Fittipaldi e Nuzzi e tre presunte fonti interne Emiliano Fittipaldi, giornalista de l’Espresso e autore del libro "Avarizia" Il Vaticano manda alla sbarra il nostro giornalista Emiliano Fittipaldi, l’autore del bestseller "Avarizia", l’inchiesta che ha svelato scandali e ricchezze della Santa Sede grazie alla pubblicazione di carte segrete e inchieste esclusive sullo Ior, sugli investimenti all’estero dei monsignori e sugli affari dei cardinali. È la prima volta nella storia del Vaticano che un giornalista è messo sotto accusa davanti ai giudici del papa.
La prima udienza è in programma martedì 24 novembre.
I magistrati d’Oltretevere hanno concluso le indagini preliminari, e hanno deciso - a sorpresa - di usare le maniere forti e mandare a processo sia Fittipaldi sia il collega Gianluigi Nuzzi, autore di "Via Crucis", per aver divulgato «notizie riservate». Si tratta, per il codice penale vaticano, di un reato grave: nel paragrafo sui «Delitti contro la Patria» nel luglio del 2013 è stato infatti inserito un nuovo articolo, il 116 bis.
«Chiunque si procura illegittimamente o rivela notizie o documenti di cui è vietata la divulgazione, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni o con la multa da euro mille ad euro cinquemila» recita la norma. «Se la condotta ha avuto ad oggetto notizie o documenti concernenti gli interessi fondamentali o i rapporti diplomatici della Santa Sede o dello Stato, si applica la pena della reclusione da quattro a otto anni».
Fittipaldi e Nuzzi non sono gli unici rinviati a giudizio. Davanti al giudice sono stati mandati anche due presunte fonti dei giornalisti: Lucio Vallejo Balda, monsignore spagnolo nominato da papa Francesco e segretario della Cosea, la commissione referente che ha condotto l’indagine sulle finanze vaticane, e Francesca Immacolata Chaouqui, membro della stessa commissione. Sarà processato anche il quinto indagato: Nicola Maio, ex collaboratore della commissione referente sulle strutture economiche e amministrative della Santa Sede (Cosea).
Nei confronti di questi tre imputati la magistratura vaticana contesta anche il reato di associazione per delinquere.
«Sono incredulo. Non è un processo contro di me, ma contro la libertà d’informazione» spiega Fittipaldi a "L’Espresso". «In tutto il mondo i giornalisti hanno il dovere di pubblicare notizie e segreti che il potere, qualunque esso sia, vuole tenere nascosti all’opinione pubblica. Mostrare documenti confidenziali e informare la gente delle malefatte dei potenti è l’essenza del nostro lavoro. Capisco che in Vaticano siano in grave imbarazzo per quello che ho raccontato, anche perché non hanno potuto smentire nulla di quanto ho denunciato. Però non mi aspettavo che aprissero un processo penale contro me e Nuzzi». Il dibattimento potrebbe iniziare già la prossima settimana, e concludersi in tempi record, prima dell’inizio del Giubileo della Misericordia previsto per l’8 dicembre.
«Forse sono ingenuo, ma credevo che indagassero su chi ha commesso gli illeciti che ho denunciato, non su chi li ha svelati» prosegue Fittipaldi «Cosa farò adesso? Non lo so. Parlerò stasera con i miei avvocati. Ma è un fatto che in Vaticano la libertà di stampa non sia sufficientemente tutelata. Nel loro ordinamento non esiste nulla di simile all’articolo 21 della nostra Costituzione. Il promotore di giustizia e gli uomini della gendarmeria mi avevano ventilato la possibilità di finire a processo? No. All’interrogatorio di lunedì scorso sono stati rispettosi e cortesi, ma alle domande ho opposto il segreto professionale. Non ce l’ho con loro, ma con una legge che considero illiberale e inaccettabile. Come ci si può difendere in quel tribunale se in Vaticano
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. - ABBAZIA DI MONTECASSINO. Sequestro di beni della Guardia di Finanza nei confronti di Pietro Vittorelli, ex abate.11 novembre 2015
Rubava soldi della carità, sequestrati beni per 500mila euro all’ex abate di Montecassino
Pietro Vittorelli, durante il suo mandato, si sarebbe impossessato insieme al fratello della stessa somma dai conti destinati a finalità di culto e aiuto ai poveri *
Sequestro di beni della Guardia di Finanza nei confronti di Pietro Vittorelli, ex abate di Montecassino, e del fratello Massimo, per un valore di oltre 500 mila euro, somma della quale l’alto prelato si sarebbe impossessato prelevandola, durante il suo mandato, dai conti dell’Abbazia.
La misura è stata disposta dal gip Vilma Passamonti del Tribunale di Roma, su richiesta del pm Francesco Marinaro della Procura capitolina. L’alto prelato è indagato perché durante il suo mandato, abusando del suo ruolo e avendo illimitato accesso ai conti dell’abbazia, si sarebbe appropriato indebitamente di oltre 500 mila euro.
Secondo la Procura il denaro sottratto, che doveva essere destinato a finalità di culto e a opere caritatevoli, è stato invece riciclato in varie tranche attraverso vorticosi passaggi da conti correnti vari gestiti dal fratello, per poi tornare nella disponibilità del prelato per usi privati.
Vittorelli, romano, 53 anni, laureato in Medicina, ha rinunciato al governo dell’abbazia nel giugno del 2013 per motivi di salute. Ne era diventato abate nell’ottobre del 2007. Nel 2012 venne colpito da una grave crisi cardiaca a cui seguì una lunga degenza e una terapia riabilitativa. Nel 2003 è stato membro del comitato provinciale di bioetica dell’azienda sanitaria locale di Frosinone. Nel settembre scorso l’ex abate ha partecipato alla convention di Forza Italia a Fiuggi
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- UNA SOLA CATENA, "UNA CATENA DI GRAZIA"!4 novembre 2015
DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?!
FRANCESCO, ALL’OMBRA DEL "TRADIZIONALE" MAGISTERO DI BENEDETTO XVI ("DEUS CARITAS EST")!
DUE PAPI E UNA SOLA CATENA, "UNA CATENA DI GRAZIA":
 IL BATTESIMO NELLA CATECHESI DI PAPA FRANCESCO.
IL BATTESIMO NELLA CATECHESI DI PAPA FRANCESCO.-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- Via Crucis, l’inchiesta di Nuzzi sul Vaticano segreto. Il Papa sa (di Francesco A. Grana)5 novembre 2015, di Federico La Sala
Via Crucis, l’inchiesta di Nuzzi sul Vaticano segreto. “Il Papa sa di investimenti della Chiesa usati per fabbricare armi”
"Santo Padre, c’è una totale assenza di trasparenza nella contabilità sia della Santa Sede, sia del Governatorato". Inizia così il documento più importante del libro del giornalista di Mediaset. L’intervento del Pontefice sulla gestione finanziaria, i suoi rapporti con la Curia e con il cardinale Bertone
di Francesco Antonio Grana *
Investimenti della Chiesa cattolica in aziende per la fabbricazione di armi e società proprietarie di televisioni porno. È quanto emerge dal nuovo libro di Gianluigi Nuzzi Via Crucis (Chiarelettere) che svela la difficile lotta di Papa Francesco per cambiare la Chiesa. Il giornalista di Mediaset racconta che il 3 luglio 2013, a pochi mesi dal suo insediamento, Bergoglio incontra i cardinali della Curia dicendo che i costi sono fuori controllo e che bisogna stare attenti perché gli è stato riferito che in Svizzera la Santa Sede aveva perso 10 milioni di euro per un investimento sbagliato. Il Papa ricorda con dolore cosa gli confidò l’economo generale della diocesi di Buenos Aires quando era ancora provinciale dei gesuiti in merito ad alcuni investimenti fatti “in una banca seria e onesta. Poi, col cambiamento dell’economo, quello nuovo è andato alla banca per fare un controllo. Aveva chiesto come erano stati scelti gli investimenti: venne a sapere che più del 60 per cento erano andati per la fabbricazione di armi!”.
In 314 pagine Nuzzi pubblica anche le trascrizioni di registrazioni audio di Bergoglio in riunioni riservate e documenti inediti principalmente usciti dalla Commissione referente di studio e di indirizzo sull’organizzazione delle strutture economico-amministrative della Santa Sede. Organismo creato ad hoc da Francesco subito dopo l’elezione al pontificato di cui facevamo parte monsignor Lucio Angel Vallejo Balda e Francesca Chaouqui, arrestati dalla Gendarmeria vaticana con l’accusa di essere loro i corvi di Bergoglio. Nel volume di Nuzzi monsignor Vallejo Balda viene citato 27 volte, mentre il nome della Chaouqui ricorre solo 3 volte.
“Santo Padre, c’è una totale assenza di trasparenza nella contabilità sia della Santa Sede, sia del Governatorato”. Inizia così il documento più importante del libro del giornalista di Mediaset. Si tratta di una lettera riservata indirizzata al Papa scritta dai revisori finanziari di Bergoglio. “Questa mancanza di trasparenza - si legge nel documento - rende impossibile fornire una chiara stima dell’attuale stato finanziario del Vaticano nel suo complesso e delle singole entità che la compongono. Questo significa anche che nessuna persona può essere considerata effettivamente responsabile per la gestione finanziaria. Sappiamo soltanto che i dati esaminati mostrano una tendenza al ribasso e davvero sospettiamo fortemente che il Vaticano nel suo complesso ha un grave deficit strutturale. Il management finanziario generale all’interno del Vaticano può essere definito, nel migliore dei casi, come inadeguato”. Play 0:00 / 2:06 Fullscreen Mute
Per i revisori di Bergoglio “il bilancio e il processo decisionale sia della Santa Sede che del Governatorato sono senza senso, nonostante l’esistenza di chiari orientamenti definiti dal regolamento corrente. Questa realtà sembra suggerire che, come minimo, l’atteggiamento prevalente del Vaticano è meglio catturato dall’espressione ‘le regole non si applicano a noi’. I costi sono fuori controllo. Ciò vale in particolare per i costi del personale, ma si estende anche altrove. Ci sono vari casi di attività duplicate, dove il consolidamento dovrebbe invece garantire risparmi significativi e migliorare la gestione dei problemi. Non siamo stati in grado di identificare chiare linee guida da seguire per investimenti di capitale finanziario. Questo è un limite grave e lascia troppa discrezionalità ai gestori e aumenta il livello complessivo di rischio. La situazione - si legge ancora nel rapporto riservato al Papa - che è applicabile per gli investimenti della Santa Sede, del Governatorato, del Fondo Pensioni, del Fondo di assistenza sanitaria, e di altri fondi gestiti da enti autonomi dovrebbe essere immediatamente migliorata. I dirigenti dovrebbero assumersi chiaramente le loro responsabilità per preparare i budget e realizzarli in un modo più realistico ed efficace. Noi siamo consapevoli che abbiamo presentato forti e talvolta gravi consigli e suggerimenti. Ci auguriamo vivamente che Vostra Santità comprenda che le nostre azioni sono ispirate dal nostro amore per la Chiesa e al nostro sincero desiderio di aiutare e migliorare l’aspetto temporale del Vaticano”.
Parole che suonano come un macigno sul pontificato di Papa Francesco e sulla sua difficile opera di affermare finalmente la trasparenza finanziaria e contrastare definitivamente il riciclaggio di denaro sporco all’interno dello Ior. L’immagine che esce dal libro di Nuzzi è di una Santa Sede afflitta da una cattiva gestione economica, dall’avidità, dal clientelismo e dalla corruzione, dove Bergoglio deve ancora lottare contro una dura resistenza della vecchia guardia curiale per le sue riforme. Il giornalista racconta anche di irregolarità nel finanziamento delle cause dei santi e sottolinea che la gestione dell’Obolo di San Pietro, un fondo per la carità del Papa, “è un enigma ammantato nel segreto più impenetrabile”. Nuzzi scrive di contratti di manutenzione e restauro con prezzi gonfiati; immobili del Vaticano che valgono sette volte quello che sono quotati nei libri contabili. Il giornalista si sofferma anche sul lusso dei cardinali. Mentre Francesco vive in un appartamento di 50 metri quadri, nella suite 201 di Casa Santa Marta, Nuzzi riporta le metrature delle residenze più fastose dei porporati della Curia romana. L’appartamento più grande nei sacri palazzi è quello del cardinale Velasio de Paolis: 445 metri quadrati. Seguono i porporati Sergio Sebastini con 424 mq, Raymond Leo Burke con 417 mq, Franc Rodé con 409 mq e Zenon Grocholewski con 405 mq.
Nuzzi, per la prima volta nella storia, fa perfino ascoltare la voce del Papa in una trascrizione di una registrazione audio di una riunione riservata: “Bisogna chiarire meglio le finanze della Santa sede e renderle più trasparenti. Quello che io dirò adesso è per aiutare, vorrei individuare alcuni elementi che sicuramente vi aiuteranno nella vostra riflessione. Primo. È stato universalmente accertato nelle congregazioni generali che in Vaticano si è allargato troppo il numero dei dipendenti. Questo fatto crea un forte dispendio di soldi che può essere evitato. Il cardinal Calcagno mi ha detto che negli ultimi cinque anni c’è stato il 30 per cento di aumento nelle spese per i dipendenti. Lì qualcosa non va! Dobbiamo prendere in mano questo problema”.
Il giornalista racconta, inoltre, che, in un incontro con i vertici della Curia romana, il Papa si rivolge a quei cardinali che presiedono dicasteri che negli anni non hanno gestito il denaro della Chiesa con oculatezza, a tutti i responsabili che non hanno controllato come dovevano. Per Nuzzi si tratta di “un palese atto di accusa, durissimo, diretto e senza sconti, persino umiliante per i porporati: sottolinea aspetti che qualunque amministratore che opera anche nelle più modeste realtà imprenditoriali conosce e capisce benissimo. Francesco - aggiunge ancora il giornalista - fissa negli occhi Tarcisio Bertone. Uno scambio di sguardi intenso. Chi è seduto vicino al Papa non vi scorge certo l’amicizia e l’indulgenza che legavano Ratzinger al cardinale italiano, tanto da portarlo con sé fino al vertice del potere in Vaticano. Quello sguardo - conclude Nuzzi - esprime il monito glaciale del gesuita arrivato a Roma dalla ‘fine del mondo’”.
* Il Fatto, 4 novembre 2015 (ripresa parziale).
-
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- La Capitale immorale. Defenestrazione dall’alto di un sindaco. Senza misericordia.3 novembre 2015, di Federico La Sala
La capitale immorale
Defenestrazione dall’alto di un sindaco inviso al potere. Marino, ostacolo democraticamente rappresentativo, viene sostituito con la figura del commissario
E il Vaticano scarica sulla città la sua forza. Senza misericordia
di Alberto Asor Rosa (il manifesto, 3.11.2015)
Adesso basta. Roma ha più del doppio degli abitanti di Milano (2.869.169 contro 1.342.385). Quanto ad estensione, il confronto non è neanche pensabile (1.287,36 kmq contro 181,67; se si parla delle due città metropolitane, il divario si allarga a dismisura: 5.363,28 kmq, contro 1.575). Se caliamo la mappa di Milano su quella di Roma, Milano parte dal Quarticciolo e arriva a Porta San Giovanni: non entra neanche nella porzione storica e monumentale della Capitale. Non si capisce quale senso abbia la vana chiacchiera di trasferire il modello dell’una (se c’è) sull’altra.
Naturalmente, si può governare bene una città di medie dimensioni (come Milano) e male una metropoli (come Roma), come anche viceversa. Le dimensioni e i rapporti, però, sono incommensurabili. Roma è al quarto posto fra le grandi città europee, dopo Londra, Berlino e Madrid, non a caso tutte capitali dei rispettivi Stati. Milano si colloca nel campo delle città di medie dimensioni (al tredicesimo posto al livello europeo, credo). Se si deve ipotizzare un rapporto a livello mondiale, l’unica città italiana degna d’esser presa in considerazione è Roma (per questi, e soprattutto per altri motivi, sui quali tornerò più avanti).
Milano “capitale morale”? Qualche anno fa apparve un bel libro, Il mito della capitale morale, forse recentemente ristampato, di Giovanna Rosa (non ci sono parentele, neanche a metà, fra me e l’autrice): libro che nessuno cita, e nessuno mostra di aver letto. Il “mito”, appunto: non “la capitale morale”. Un lungo percorso dal Risorgimento a oggi, fatto di fatti, illusioni e disillusioni, cadute e riprese, riprese e cadute.
Del resto, se prendessimo alla lettera per Milano la definizione di “capitale morale”, dovremmo chiederci sul piano storico come sia stato possibile che da siffatta realtà politico-urbanistico-civile siano precipitate sull’Italia le due sciagure politico-istituzionali ed etico-politiche più terrificanti dell’ultimo secolo e mezzo, Benito Mussolini e Silvio Berlusconi. Che Torino, culla della nostra unità nazionale, per questo e per altri motivi, sia più degna di tale definizione?
Su Roma, la Capitale, l’unica città italiana in grado di entrare in una competizione e classificazione internazionale, sono precipitate nel tempo tutte le contraddizioni e tutto il degrado di cui è stato capace (o incapace) questo disgraziato paese, - l’Italia.
Roma è, ahimè, il luogo del potere e dei Palazzi: la Presidenza della Repubblica, la Presidenza del Consiglio e il Governo, il Senato, la Camera dei Deputati, i Ministeri, gli organismi dirigenti della Magistratura, della scuola, dell’Università, dei corpi separati dello Stato, ecc. ecc. Tutti, ovviamente, gestiti al novanta per cento da non romani: tutti orientati a difendere interessi che con Roma non avevano niente a che fare.
Roma, per quanto mi concerne, è se mai vittima, non carnefice.
Quando ha preso democraticamente la parola, lo ha fatto poco e male. Con Alemanno ha dato il peggio di sé, sul piano etico, civile e amministrativo. Anche questo oggi è ampiamente e vistosamente dimenticato e accantonato, per non interferire neanche mentalmente con le procedure di esecuzione sommaria dell’ultimo Sindaco.
A Roma, poi (anche questo avete dimenticato?), c’è il Vaticano. Il Vaticano è al tempo stesso una grande potenza religiosa e una grande potenza temporale, terrena. E, - lo dico con assoluta persuasione, - non può essere che così. Non può essere che così, nessuno, né dal basso né dall’alto, potrebbe impedirlo (Gesù, unico, per volerlo fare, è finito nell’orto di Getsemani e poi sulla croce).
La proclamazione del presente Giubileo ne è la più vicina e lampante testimonianza.
Esprimo il mio stupore: non c’è commentatore di qualche portata che si sia soffermato come meritava su questo passaggio. Un bel giorno Papa Francesco proclama un Giubileo straordinario della Misericordia. E’ l’ultima mazzata: trenta milioni di pellegrini e migliaia di cerimonie nella Capitale, molto immorale forse, ma di certo molto, molto strapazzata. Siccome è improbabile che il Giubileo si svolga dentro le mura dello Stato Vaticano, che del resto non accoglie quasi nulla di quanto lo riguarda, la città intiera ne sarà travolta.
Ci sono state consultazioni preventive in proposito? Qualcuno, al di qua del Tevere, ha risposto che andava tutto bene? Improbabile.
Dunque, il Vaticano dispone di Roma come fosse cosa sua (è già accaduto altre volte nella storia, anche dopo il 1870). I poteri democratico-rappresentativi a quel punto sono spinti inevitabilmente in un angolo. Cosa potrebbe dire o fare di fronte a un messaggio universalistico-religioso di tale portata? Ma il messaggio universalistico-religioso si trasforma rapidamente in una serie di Ukase politico-temporali sempre più assillanti e persino da un certo momento in poi anche violenti: avete chiuso le buche? Avete rattoppato le metropolitane? A che punto siete con l’accoglienza? Siete in grado di garantire il ristoro? E la sicurezza, la sicurezza, come va?
Il grande evento di Misericordia vale dunque per tutto il mondo (così almeno si dice): ma non vale per Roma, né per i suoi cittadini, né per i suoi amministratori, che infatti, in tutte le occasioni possibili, sono trattati a pesci in faccia, cooperando inevitabilmente (e diciamo consapevolmente) alla distruzione della loro credibilità e del loro prestigio.
A Roma non ci sono gli “anticorpi”? Sì, questo è un po’ vero. Infatti, a Roma, nelle scorse settimane, e con accelerazione crescente negli ultimi giorni, si è consumata la più imponente e capillare distruzione di anticorpi che si sia mai vista in Italia dalla Liberazione a oggi.
Anche qui esprimo il mio stupore: osservatori, avete colto davvero quel che è accaduto a Roma nelle scorse settimane e con accelerazione crescente negli ultimi giorni? Il giudizio sul comportamento e le attitudini dirigenziali del sindaco Marino, - un “marziano”, un inetto, un incapace, un supponente, da un certo momento in poi anche uno poco corretto, - non ha niente a che fare con lo svolgimento e la conclusione della faccenda.
Se si dovessero rimuovere dai loro incarichi Sindaci, Presidenti delle Regioni, Ministri, Direttori Generali, Rettori, ecc. ecc., - perché “marziani”, inetti, incapaci, supponenti, poco corretti, ecc. ecc, - assisteremmo in poco tempo al crollo verticale dell’intera macchina politico-istituzionale italiana (sarebbe comunque affare della magistratura, come talvolta già accade, non dei politici).
Quel che invece è accaduto a Roma è la defenestrazione dall’alto, - per vie politiche, non legali, intendo, - di un uomo politico che non era in grado (e probabilmente non voleva) garantire le attese dei principali poteri interessati alla vicenda: la nuova forma della politica oggi dominante in Italia, il Vaticano, i poteri economici all’arrembaggio della nuova torta.
Il risultato di tutta la vicenda è che esiste oggi in Italia un Potere Supremo il quale è in grado di sbarazzarsi di qualsiasi ostacolo democraticamente rappresentativo, sostituendolo con la figura fin qui anomala ed eccezionale del Commissario, il quale ovviamente è, e non potrebbe non essere, un delegato al servizio di quel medesimo Potere Superiore. Il quale, essendo anch’esso non determinato dal voto popolare ma, diciamo, da una sorta di autocommissariamento del medesimo (com’è noto, il nostro Presidente del Consiglio non ha goduto di tale investitura), tende a riprodursi per geminazione secondo le medesime modalità.
Roma, se è e resta la Capitale d’Italia, la quarta città europea, una delle più importanti del mondo, dal punto di vista del patrimonio artistico e culturale è senza ombra di dubbio la prima.
Questo suscita da un bel po’ di tempo una corrente d’invidia e di gelosia, nazionale e internazionale, da far spavento. Essa si collega, e strettamente si congiunge, al progetto dell’attuale potere politico italiano di farne da tutti i punti di sta una cosa propria.
A Roma, più che in qualsiasi altra città italiana, abbiamo a che fare con una massa di potere inimmaginabile altrove: Vaticano, poteri economici forti, potere politico di tipo nuovo, incline al commissariamento della Nazione ovunque sia possibile e a suo avviso necessario, procedono affiancati, e nella medesima direzione (non c’è bisogno di pensare a incontri segreti a Via dei Penitenzieri o a Largo Chigi o magari a Palazzo Vecchio a Firenze: basta pensarla nello stesso modo).
Ce la faranno Roma, e i romani, a rovesciare questa mostruosa tendenza? I romani, senza i quali anche il mito di Roma rischia di diventare un’astrazione, sono delusi, confusi, smarriti. Come volete che siano? Avevano votato trionfalmente per Marino esattamente per dare una svoltata alla storia. Ora forze potenti della politica e dell’informazione si affannano quotidianamente a spiegar loro che Marino era semplicemente un “marziano”, un inetto, un incapace, un supponente, uno poco corretto, ecc. ecc., e a spiegarglielo sono esattamente innanzitutto quelli del suo proprio partito, quelli che avevano chiesto loro di votarlo (neanche uno dei consiglieri comunali “dem” che abbia resistito alla sferza del capo, che vergogna!). Però, al tempo stesso, monta l’indignazione, anzi, una rabbia cupa e violenta, contro tutti quelli che hanno realmente combinato tutto questo, il Potere Superiore e i suoi molteplici alleati.
La Capitale immorale giace così sotto il peso degli errori commessi, quelli suoi, certo, ma soprattutto, soprattutto quelli degli altri.
Come ultimo schiaffo viene inviato a governarla un Prefetto dal nome beneaugurante di Tronca. All’Expo, - per sue dichiarazioni, - si è occupato dell’ordine pubblico; in precedenza, dei Vigili del fuoco. Competenze, queste, indubitabilmente adeguate a governare la metropoli Roma, le sue contraddizioni e lacerazioni, e a suscitare in lei i nuovi anticorpi. Nel frattempo il Potere Superiore garantisce che il Giubileo sarà un successo come l’Expo.
Tutto è money, d’accordo, ma forse qui siamo andati un po’ troppo oltre. Il Vaticano soddisfatto annuisce.
Per sottrarsi a questa nefasta spirale, ed evitare altre cantonate, ci vorrà un lavoro lungo e in profondità, razionale, sì, ma anche rabbioso. Il tempo delle mediazioni è finito, ne comincia un altro, meno disponibile alle prese in giro. Se ci sono voci disposte a parlare in questo senso, si facciano sentire presto.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- “I soldi della carità spesi dai monsignori e quelli dei bambini per l’attico di Bertone” (di Emiliano Fittipaldi)3 novembre 2015
Nel libro del giornalista de L’Espresso Emiliano Fittipaldi, i documenti che raccontano gli ultimi scandali finanziari vaticani
“I soldi della carità spesi dai monsignori e quelli dei bambini per l’attico di Bertone”
di Emiliano Fittipaldi (la Repubblica, 03.11.2015)
RICCHEZZE sterminate, proprietà immobiliari per quattro miliardi di euro, offerte per la beneficenza che non vengono spese per i più poveri ma ammucchiate in conti e investimenti, o per esigenze dei monsignori di curia.
E ancora: fondazioni vaticane dedicate ai bambini malati che investono centinaia di migliaia di euro per ristrutturare la casa di cardinali importanti, imprenditori indagati in Italia che - nonostante l’annunciata pulizia della banca vaticana - ancora nascondono i loro soldi allo Ior, investimenti milionari (da parte del Bambin Gesù, ospedale finanziato dallo Stato italiano e che ha in cassaforte un fondo segreto da 427 milioni di euro) su aziende petrolifere e chimiche Usa come la Exxon e la Dow Chemical.
Nel libro “Avarizia” del giornalista de “L’Espresso” Emiliano Fittipaldi, in uscita per Feltrinelli giovedì 5 novembre, si raccontano decine di scandali finanziari vaticani, grazie allo studio di una documentazione riservatissima e a un lungo lavoro di inchiesta giornalistica. Ecco alcuni stralci.
LAVORI NEL MEGA ATTICO
Partiamo dal Bambin Gesù. O meglio da una fondazione controllata, nata nel 2008 per raccogliere denaro per i piccoli pazienti. Gli investigatori della società di revisione PricewaterhouseCoopers (PwC) nella bozza del rapporto consegnata al Vaticano il 21 marzo 2014 dedicano alla onlus italiana con sede in Vaticano alcuni passaggi della loro due diligence. Nel focus si evidenzia l’affitto di un elicottero, nel febbraio 2012, per la bellezza di 23 mila e 800 euro. Pagati sull’unghia dalla fondazione Bambin Gesù «a una società di charter per trasportare monsignor Bertone dal Vaticano alla Basilicata per alcune attività di marketing svolte per conto dell’ospedale». Ma c’è un’altra spesa della fondazione non pubblicata sul rapporto PwC che rischia di imbarazzare il Papa e il Vaticano.
Quella che riguarda il pagamento dei lavori della nuova casa di Bertone a palazzo San Carlo. La fondazione, definita da PwC come «un veicolo per la raccolta di fondi volti a sostenere l’assistenza, la ricerca e le attività umanitarie del Bambin Gesù» ha saldato le fatture dei lavori per un totale di circa 200mila euro, pagati all’azienda Castelli Real Estate dell’imprenditore Gianantonio Bandera. «Gentile dottor Fittipaldi, alle sue domande» precisa Bertone, «rispondo che il sottoscritto ha versato al medesimo governatorato la somma richiesta come mio contributo ai lavori di ristrutturazione. Non ho nulla a che vedere con altre vicende ».
Profiti, fino al 2015 presidente sia del Bambin Gesù che del consiglio direttivo dell’omonima fondazione conferma invece la spesa autorizzata a favore dell’appartamento di Bertone, già finito nella bufera per la sua ampia metratura. La parcella, spiega Profiti, sarebbe stata giustificata dal fatto che la casa del cardinale sarebbe stata poi messa a disposizione della fondazione stessa per finalità “istituzionali”: «È vero: con i soldi stanziati da noi è stata ristrutturata una parte della casa di Bertone. Cercando di ottenere in cambio la disponibilità di potere mettere a disposizione l’appartamento ».
BENEFICENZA ZERO
Se analisi della Ernst e Young evidenziano che vendendo benzina, sigarette e vestiti a costi ribassati rispetto all’Italia il Vaticano guadagna ogni anno 60 milioni (i clienti dei negozi dovrebbero essere circa 5mila, ossia residenti e dipendenti della Santa Sede, ma a Roma sono state distribuite ben 41mila tessere a vip, raccomandati e amici degli amici), leggendo le carte è evidente che i denari in Vaticano si trovano dappertutto. E, quando ce ne sono tanti, è facile che non manchino nemmeno gli sprechi. Un cruccio, per Francesco, che vorrebbe limitarli il più possibile, bloccando rigagnoli infruttuosi per deviarli su attività evangeliche.
Una delle voci più interessanti analizzate dai revisori di Kpmg è quella relativa all’Obolo di San Pietro. Il Vaticano lo definisce, letteralmente, un «aiuto economico che i fedeli offrono al Santo Padre, come segno di adesione alla sollecitudine del successore di Pietro per le molteplici necessità della Chiesa universale e per le opere di carità in favore dei più bisognosi». La carità dei fedeli (esiste anche un conto Iban dedicato) è andata a gonfiare un fondo che non compare nel bilancio della Santa Sede, e che nel 2013 ha toccato i 378 milioni di euro.
«Tutte le entità menzionate nella Pastor Bonus sono incluse nel perimetro di consolidamento», riassumono i commissari della dissolta commissione pontificia commentando le analisi di Kpmg, «ma non tutti i fondi esistenti in queste entità, prevalentemente denaro liquido e titoli, sono riportati nel bilancio di esercizio. Tra gli attivi non consolidati i fondi esclusi dal bilancio consolidato ammontano a nonmeno di 471 milioni di euro; di questi, 378 corrispondono all’Obolo di San Pietro.
Questi fondi sono depositati su conti bancari presso lo Ior, l’Apsa e altre banche». Un paragrafo del rapporto Moneyval fa luce anche sulla reale destinazione finale dei denari raccolti: «Nel 2010 gli esborsi erano costituiti principalmente da spese ordinarie e straordinarie dei dicasteri e delle istituzioni della curia romana» e non in opere di carità. Stesse evidenze nella gestione dell’8 per 1000.
CASE E AFFARI
Un documento della Commissione referente, scritto in inglese e in italiano e destinato a George Pell, capo della nuova segreteria per l’Economia voluta da Francesco, sintetizza per la prima volta il valore reale di tutti i beni immobiliari di proprietà di istituzioni vaticane.
Leggiamolo: «Sulla base delle informazioni messe a disposizione di Cosea, ci sono 26 istituzioni relazionate alla Santa Sede che possiedono beni immobiliari per un valore contabile totale di un miliardo di euro al 31.12.2012. Una valutazione di mercato indicativa dimostra una stima del valore totale dei beni di quattro volte più grande rispetto al valore contabile, o quattro miliardi di euro».
Già: quattro miliardi tondi tondi. Nel report sono indicate anche le istituzioni papali «con le proprietà più importanti a valore di mercato». Cioè l’Apsa (con un patrimonio da 2,7 miliardi), la congregazione Propaganda Fide (450 milioni di euro, in passato libri e giornali hanno sempre dato stime ancora più alte), la Casa sollievo della sofferenza (grazie alle donazioni l’ospedale di Padre Pio ha un portafoglio di 37 palazzi valutato 190 milioni) e il Fondo pensioni dei dipendenti, che possiede immobili per 160 milioni di euro.
Non è tutto. In un altro report confidenziale della Cosea datato 7 gennaio 2014 si specifica che quasi sempre «gli immobili sono registrati o al costo di acquisizione o al costo di donazione, e molti edifici istituzionali sono valutati a 1 euro. Dunque c’è da aspettarsi che il valore di mercato del real estate vaticano sia molto più grande».
I DEPOSITI DI NOMI ECCELLENTI
Mentre “Avarizia” va in stampa allo Ior galleggiano poco più di cento conti sospetti, tra cui una decina intestati a nomi eccellenti che potrebbero creare più di un disagio a Santa Romana Chiesa. In qualche caso si tratta di eredità di clienti laici ancora da liquidare (a bilancio la somma è messa a 17 milioni), ma altri depositi appartengono a professionisti e imprenditori. «Questi depositi sono stati bloccati», ha giurato il capo dell’Aif Brülhart.
A Bankitalia, che ha firmato un accordo di collaborazione con l’Uif, sono però rimasti di sasso quando la procura di Roma ha spedito oltre le mura un’altra rogatoria internazionale, chiedendo conto e ragione di eventuali beni posseduti da Angelo Proietti.
Un costruttore titolare della società Edil Ars, diventato celebre perché la sua ditta ha ristrutturato gratis la casa in cui ha abitato per anni l’ex ministro dell’Economia Giulio Tremonti. Ebbene, Proietti è uno dei fornitori storici del Vaticano e della curia romana per cui ha eseguito decine di lavori e interventi, e i pm - da mesi alla ricerca del suo patrimonio - sono certi che parte dei suoi guadagni siano nascosti ancora oggi allo Ior.
Anche questa vicenda, se le ipotesi investigative dei magistrati italiani si rivelassero corrette, dimostrerebbe che la Santa Sede scambia informazioni con procure e autorità antiriciclaggio di Roma solo col contagocce. Lo Ior non conferma e non smentisce l’esistenza del conto di Proietti. «Non è possibile parlare di casi concreti, si violerebbero il segreto di ufficio e il segreto istruttorio, ma se Proietti aveva un conto presso lo Ior, e questo conto è “non conforme” alla legislazione antiriciclaggio vaticana e alle nuove politiche Ior, ciò che si può affermare è che esso è stato sottoposto alla procedura».
Lussi, sprechi e case da 500 metri quadrati
In due libri i documenti imbarazzanti
di Gia. Gal. (La Stampa
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- L’abbondanza e il capitale. Oggi possiamo far sentire a tutti, anche agli scoraggiati e ai perplessi, che nelle nostre vele può tornare a soffiare il vento della storia (di Piero Bevilacqua)5 ottobre 2015, di Federico La Sala
L’abbondanza e il capitale. Oggi possiamo far sentire a tutti, anche agli scoraggiati e ai perplessi, che nelle nostre vele può tornare a soffiare il vento della storia:
L’abbondanza e il capitaledi Piero Bevilacqua ( Eddyburg, 30 Settembre 2015) *
Il capitalismo ha un grande e tenace nemico, una malattia che produce esso stesso incessantemente: l’abbondanza. Oggi l’abbondanza che lo minaccia è, come sempre, quella delle merci, ma in una misura che non ha precedenti. Ad essa, negli ultimi decenni, se ne è aggiunta un’altra, assolutamente inedita, che coinvolge un vasto e crescente ambito di servizi. Per alcuni beni la saturazione del mercato capitalistico è visibile a occhio nudo ormai da tempo. I capi d’abbigliamento si comprano ancora nei negozi, a prezzi che generano un certo profitto a chi li produce e a chi li vende. Ma per il vestiario esiste un mercato parallelo così esteso e abbondante che ormai sfiora la gratuità. Si può dire che nelle nostre società più nessuno ormai, nemmeno il più misero degli individui, ha il problema di vestirsi. Non dissimile fenomeno possiamo osservare nell’ambito dei servizi più avanzati: l’accesso all’informazione, alla cultura, all’arte, alla musica.
Certo, occorre almeno possedere un cellulare, pagare un contratto a un gestore. Ma è evidente che siamo invasi anche qui - insieme, certo, al ciarpame - da un’abbondanza di offerta, a prezzi decrescenti che tendono a creare uno spazio di fruizione fuori mercato. Sappiamo che il capitale anche da tali beni riesce a trarre ancora profitti, ma oggi è sotto i nostri occhi uno scenario di abbondanza di servizi e beni culturali, di umana emancipazione, potenziale e di fatto, che non ha precedenti. Solo cinquant’anni fa tutto questo era lontano dalla nostra immaginazione. Occorre sempre gettare un occhio al passato, per evitare di scorgere nel presente solo un cumulo di sconfitte.
Com’è noto, il capitale combatte la caduta tendenziale del saggio di profitto inventando nuovi beni e nuovi bisogni, dilatando il suo dominio sulla natura per trasformare il vivente in merci brevettabili, strappando al controllo pubblico servizi che un tempo erano dei comuni e dello stato. Ma il capitale, aiutato da circostanze storiche fortunatissime - la crisi e poi il crollo del blocco comunista, la burocratizzazione dei partiti democratici di massa e dei sindacati, la rivoluzione informatica - ha sventato la più grande minaccia da abbondanza che gli sia parata dinnanzi nella sua storia: quella degli ultimi decenni del XX secolo. Un oceano di beni stava per riversarsi nel mercato dei Paesi avanzati, un sovrappiù di merci che avrebbe costretto imprenditori e governi a innalzare i salari e soprattutto a ridurre drasticamente l’orario di lavoro. Si sarebbe arrivati a quel passaggio epocale previsto da Keynes nel saggio Possibilità economiche per i nostri nipoti (1928-30), che, con la crescita della produttività a «a un ritmo superiore all’1% annuo» avrebbe spinto le società industriali, nel giro di un secolo, a istituire una durata del lavoro a 15 ore settimanali.
In realtà, la crescita della produttività mondiale è stata superiore alle stesse previsioni di Keynes, con risultati però opposti rispetto alle sue aspettative. In un saggio prezioso per rilevanza documentaria e nitore espositivo, Abbondanza, per tutti (Donzelli, 2014) Nicola Costantino ha ricordato che il tasso di crescita annuo della produttività a livello mondiale, nel corso del XX secolo, ha oscillato tra il 2 e il 3%. Negli Usa, tra il 1950 e il 2000 è stato in media, del 2,5%, in Francia, nel solo settore industriale, tra il 1978 e il 1998, del 3,7%. Il che ha significato che la produttività oraria del singolo lavoratore, a un tasso di crescita del 2% annuo, è aumentata di ben 7 volte, molto di più delle 2,7 volte ipotizzate da Keynes e su cui egli fondava la previsione delle 15 ore settimanali.
Ma la giornata lavorativa non è stata accorciata, se non in Francia, in maniera contrastata e oggi rimessa in discussione. Ovunque, specie negli ultimi anni, la durata del lavoro quotidiano è cresciuta a dismisura. Negli USA, già prima della crisi era diventato generale il fenomeno del workaholic, l’alcolismo del lavoro, mentre oggi sempre di più gli americani lamentano la mancanza di tempo, il time squeeze, time pressure, time poverty (S.Bartolini, Manifesto per la felicità, Donzelli 2010). Lavorano tutto il giorno come dannati: ma almeno guadagnano bene? Niente affatto, essi sono in grandissimo numero poveri e indebitati. Come ha ricordato Maxime Robin su Le Monde diplomatique-Il Manifesto (Stati Uniti, l’arte di ricattare i poveri, settembre 2015) oggi in Usa i check casher, piccole banche per prestiti veloci, dilagano nei quartieri poveri più dei McDonald’s. Ma in genere tutti gli americani della middle class sono indebitati. «Uno statunitense nella norma è un cittadino indebitato che paga le rate in tempo». E le cose non son certo migliorate con la ripresa santificata dai media. Il 95% dei redditi aggiuntivi che si sono creati dopo la crisi - ricordava The Economist nel settembre 2013 - è andato all’1% delle persone più ricche. Al restante 99% sono andate le briciole del 5%. Tutto come prima, peggio di prima.
Che cosa dunque è accaduto? Perché dal mondo dell’abbondanza a portata di mano siamo precipitati nel regno della scarsità? La risposta essenziale è molto semplice. Perché il capitalismo dei paesi dominanti (Usa e Europa in primis), ricercando nuovi mercati e occasioni di profitto nei paesi poveri (la cosiddetta globalizzazione), innalzando la produttività del lavoro, ristrutturando e innovando le imprese, non incontrando resistenze in sindacati e partiti avversi, ha generato un’arma strategica formidabile: la Grande Scarsità, la scarsità del lavoro. Il lavoro inteso come occupazione, come job. I dati recenti sono impressionanti.Tra il 1991 e il 2011 - ricorda Costantino - mentre il Pil reale planetario è cresciuto del 66%, il tasso globale di occupazione è diminuito dell’1,1%. In 20 anni un quarto di beni in più con meno lavoro.
Ma una vasta e ben controllata disoccupazione è oggi un arma politica, non solo un effetto delle trasformazioni economiche. Tale scarsità, diventata permanente e sistematica, ha reso i rapporti tra capitale e lavoro, economia e politica, poteri finanziari e cittadini, drammaticamente asimmetrici e sbilanciati. Tutti invocano lavoro come gli affamati un tempo chiedevano il pane, fornendo al capitale una legittimazione mai goduta in tutta la sua storia. L’intera struttura dello stato di diritto ne risente, gli istituti della democrazia vengono progressivamente svuotati. Sindacati e partiti, funzionari del presente, invocano la “ripresa” come se il futuro possa “riprendere” le fattezze del passato.
E tuttavia tale artificiale scarsità non può durare a lungo. Non solo perché le innovazioni produttive in arrivo (stampanti 3D, intelligenza artificiale,ecc) stanno per rovesciarci interi continenti di merci e servizi, sostituendo perfino lavoro intellettuale con macchine. Ma anche perché l’abbondanza del capitale che la Grande Scarsità del lavoro oggi genera è una forma di obesità, una malattia sistemica. C’è troppo danaro in giro, masse smisurate di risorse finanziarie, rispetto alle necessità della produzione. Patrimoni concentrati in gruppi ristretti che non corrono il rischio dell’investimento produttivo in società ormai sature di beni e con una domanda debole, mentre la grande massa dei lavoratori è tenuta a basso salario perché i loro padroni devono poter competere a livello globale. Tutti i capitalismi nazionali comprimono i salari, allungano gli orari di lavoro, sperando nelle esportazioni e tutti, o quasi, languono nella generale stagnazione. Mentre i soldi si accumulano, generano altri soldi, muovono speculazioni nei mercati finanziari e preparano altre crisi.
Questo quadro che non teme smentite - poggia su una vasta e solida letteratura - ha una grande importanza per la sinistra. In esso è possibile scorgere che una vita di gran lunga migliore sarebbe possibile per tutti e che solo i rapporti di forza dominanti la ostacolano, facendo regredire la società nel suo insieme. Non c’è una crisi, intesa come un evento naturale. È stato il cedimento storico dei partiti della sinistra, dei sindacati, dei governi a favorire la vittoria della scarsità sull’abbondanza. Una grande battaglia perduta, ma da cui ci si può riprendere. Da questa lezione si può comprendere come niente di naturale è rinvenibile nella situazione presente: è tutto dipendente da scelte politiche, da puri rapporti di forza.
Si può così smascherare l’idea di una scarsità a cui occorre piegarsi come all’antico Fato. Così come l’idea di una “ripresa” affidata alle riforme del mercato del lavoro, alla flessibilità dei lavoratori, senza toccare la piramide delle ricchezze accumulate. Non ci sono i soldi, recita la litania dei politici, di gran parte degli economisti main stream, gli aguzzini intellettuali più attivi sulla scena pubblica, con il loro seguito di giornalisti orecchianti. È la più grande menzogna della nostra epoca. I soldi non ci sono per pensioni dignitose, per il reddito di cittadinanza, non ci sono per le borse di studio agli studenti, che disertano gli studi universitari, non ci sono per i nostri ricercatori e per la gioventù intellettuale, costretta a migrare all’estero. Ma ci sono in misura crescente e cumulativa nei patrimoni privati: in un solo anno, tra il 2011 e 2012, mentre infuriava la crisi, il numero degli individui con un patrimonio superiore a un milione di dollari è cresciuto nel mondo del 6%, in Italia del 10% . I soldi ci sono in quantità senza precedenti per le banche. E le centinaia di miliardi di euro che la BCE sta profondendo a piene mani, semplicemente stampandoli?
Dunque, una grande abbondanza (auspichiamo, di beni e servizi avanzati, frutto di una generale riconversione ecologica, di riduzione del lavoro ) è alla nostra portata. E bisogna infondere non solo nel nostro popolo, ma nella società italiana tutta intera questa grande pretesa. La pretesa della prosperità e del ben vivere per tutti. È una prospettiva di nuovi bisogni, che non solo è possibile soddisfare, ma coincide con una tendenza storica inarrestabile e che capitale e ceto politico possono solo ritardare, con danno generale. La redistribuzione dei redditi e del lavoro e la lotta alle disuguaglianze incarnano come mai nel passato l’interesse generale, una necessità indifferibile e universale. Oggi possiamo far sentire a tutti, anche agli scoraggiati e ai perplessi, che nelle nostre vele può tornare a soffiare il vento della storia.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- La questione “(im)morale” e la questione “politica” (di Carlo Smuraglia).1 luglio 2015, di Federico La Sala
La questione “(im)morale” e la questione “politica”
di Carlo Smuraglia (Presidente - A.N.P.I., 30 giugno 2015)
Nel numero scorso della Newsletter Anpi (quello del 16 giugno), ho scritto una nota intitolata “Basta!”, dedicata alla questione morale. Di fronte agli scandali, alla corruzione sempre più diffusa, alle altrettanto diffuse manifestazioni di illegalità, ponevo un problema (per me) fondamentale, quello cioè di cambiare non tanto le leggi, che ci sono e basterebbe rispettarle, quanto i comportamenti di tutti, a cominciare dai partiti, da coloro che rivestono cariche elettive pubbliche o funzioni di governo, fino ai comuni cittadini. E sostenevo che bisognava ripartire dalla “tolleranza zero”, cioè non solo dall’assoluto rispetto della legge (art. 54 della Costituzione), ma anche dall’osservanza di tutto ciò che è imposto dalla morale corrente e dal comune sentire di un Paese civile. Per questo, il “Basta!” del titolo.
Sono stato subito “accontentato”: basta fare qualche esempio. Partiamo dall’incredibile pasticcio creato dall’elezione di De Luca a “Governatore” della Campania. Un pasticcio previsto e prevedibile perché la condizione di De Luca era nota ed altrettanto lo era la Legge Severino. Candidarlo e sostenerlo significava affrontare un garbuglio indecoroso ed inaccettabile, come ora si sta dimostrando. Tentennamenti e incertezze anche da parte del Governo: alla fine si decide per il decreto di sospensione; ma lo stesso Presidente del Consiglio si affretta a dire che De Luca potrà ricorrere e potrà compiere gli atti che riterrà possibili e leciti. E De Luca, che si è candidato e non si è mai arreso, non si arrenderà neppure questa volta; intendeva presentarsi in Consiglio regionale, e chissà quali atti pensava di compiere: poi ci ha ripensato, pare (sto scrivendo di sabato e la seduta sarà lunedì). Certo è che tutto questo era annunciato e si conosceva. Perché allora sostenere un candidato in queste condizioni? Per fare una prova di forza? Per arroganza? Per la teoria già diffusa e pubblicizzata da Berlusconi che il popolo ha sempre ragione e se ha eletto una persona, questa diventa intoccabile, anche dalla legge? Difficile pronunciarsi su ciò che induce a certi comportamenti anche organi di Governo e dirigenti di partito; ma è lecito dire che tutto questo è scandaloso; il cittadino “comune” sa che c’è una legge Severino, approvata da tutti i maggiori partiti e pensa che non ci sia altro da fare che applicarla.
Sbaglia per semplicismo, ma attenzione (!), se si accorge del suo errore, finisce per pensare che la legge c’è solo per alcuni, e per altri non vale, e utilizza lo strumento di cui dispone nel modo più negativo: non va a votare. È questo che vogliamo? È questo che occorre alla democrazia di un Paese, che richiederebbe rispetto della legge da parte di tutti e partecipazione convinta dei cittadini alla cosa pubblica? Proseguiamo: scoppia a Roma uno scandalo colossale (si parla ormai comunemente di “Mafia Capitale”). Bisogna far pulizia e non deve essere solo la Magistratura a farlo, ma devono essere i partiti, il Parlamento, il Governo. Bene: c’è un sottosegretario, “coinvolto” in qualche modo nello scandalo. Mi auguro sinceramente che risulti innocente, ma considero doveroso che si dimetta dalla carica pubblica, oppure che venga invitato a dimettersi. Non si dimette; c’è una mozione di sfiducia per indurlo a dimettersi; dovrebbe approvarla tutto il Parlamento; e invece no, il sottosegretario viene “salvato” da una maggioranza anomala, che va da Forza Italia fino al Partito Democratico.
Il cittadino non ha di che essere soddisfatto, soprattutto se rilegge l’art. 54 della Costituzione, in tutte le sue parti. Ma non è finita. Alla guida del Comune di Roma c’è un Sindaco le cui qualità, come tale, in una città difficile e complessa, non sta a noi giudicare; ma è pacificamente e da tutti ritenuto onesto ed estraneo a tutte queste scandalose e vergognose vicende che hanno avviluppato Roma e il suo Comune in un abbraccio spaventoso, fatto di un misto di delinquenza, corruzione, arroganza, mafia. Ma è lui, la persona perbene che se ne deve andare, secondo alcuni, pochi o molti che siano. Che lo pretendano i partiti che pensano di guadagnare qualche posto per eventuali elezioni è possibile e comprensibile; che lo pensi il Partito che lo ha indicato, lo ha appoggiato, in qualche modo lo ha fatto vincere, è stupefacente. Naturalmente non si tratta di tutto il Partito, perché ad esempio, il Commissario che il PD ha nominato per gestire la vicenda romana, soprattutto per ciò che attiene -appunto- alla sua organizzazione politica, sostiene Marino e pensa che debba restare al suo posto, magari aiutato e consolidato con una Giunta più autorevole e più qualificata, per governare questo immenso pasticcio che è la città metropolitana, Capitale d’Italia. Ma non sembra pensarla così il Capo di quel partito, che parla quasi con “distacco” del Sindaco, lasciando a lui ogni responsabilità di decisione, tanto da far pensare a tutta la stampa che se ne voglia sbarazzare appena possibile (dopo l’estate?); intanto, già due o tre consiglieri (del PD) si autosospendono, quasi a suggerire un percorso.
Così il cittadino - che ragiona in modo semplice, con una logica elementare - conclude: resta al suo posto il “coinvolto” (ripeto, spero che lo sia solo formalmente e risulti poi innocente) e deve avviarsi verso l’uscita il Sindaco, più o meno capace di amministrare, ma perbene. Dal punto di vista dell’etica politica e della morale comune, non c’è davvero male. Ma andiamo ancora avanti: il Governo vuole “rivoluzionare” per ragioni sue, che io non ho capito (ma solo perché sono ignorante nella materia specifica) la governance della Cassa Depositi e Prestiti. Fa fuori la vecchia dirigenza, con la quale discute solo dopo aver già nominato i nuovi “capi”, e non si accorge che per uno dei due c’è un problema di “onorabilità” che secondo lo Statuto dell’Ente, lo renderebbe improponibile (una pendenza giudiziaria, in sostanza). Si rinuncia, quando ci se ne accorge, a quel dirigente? No, neanche per sogno, si progetta la modifica dello Statuto, per rendere più “morbida” la clausola di “onorabilità”, in modo che il progetto possa avere il suo corso, con tutti i “nuovi governanti” al loro posto. Questo fatto è così lineare e semplice da non richiedere commenti; anche un bambino, ignaro di Costituzione e Statuto, capirebbe che non è così che si inculca nel cittadino il concetto di “legalità”, inteso nel senso molto ampio a cui solitamente mi attengo nelle mie note, concordando con molti autorevolissimi giuristi e costituzionalisti.
È proprio in questo contesto, che include nel concetto di legalità anche la morale e la correttezza dei comportamenti politici, che può inserirsi un altro paio di esempi, con i quali chiuderò l’argomento, anche se ci sarebbe ancora materia per continuare. È stata approvata la legge elettorale, la “migliore possibile”, tanto che per averla si è ricorsi anche alla fiducia, perché bisognava ottenere il risultato, e al più presto. Tutto questo dopo un anno di palleggio tra le due Camere, ripensamenti, modifiche, innovazioni. Adesso, la legge elettorale c’è, anche se - ulteriore distorsione - entrerà in vigore tra un anno circa.
Ci sono state le elezioni amministrative, sia pure parziali, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Non è più sicuro che ci sia un partito che può vincere tutto; si intravvedono pericoli se si va ai ballottaggi, pur essendo in testa nella prima tornata (Venezia insegna!); e che cosa accade? Si ricomincia a parlare della Legge elettorale, pensando seriamente di metterci mano ancora, non già per togliere di mezzo le parti più criticate e più sospette di incostituzionalità, ma per affrontare un paio di punti che parevano risolti in modo definitivo: l’assegnazione del premio di maggioranza alla “lista” che ha raggiunto un determinato quorum; il ballottaggio nel caso che nessuno raggiunga, nel primo turno , il quorum necessario per il premio di maggioranza. E qui si prospetta già la prima anomalia. L’Italicum è sbagliato, dannoso, pericoloso. Sarebbe da cambiare, con qualunque mezzo, perché non è ciò che serve ai cittadini e alla democrazia. E invece, si parla di cambiarlo per ragioni di convenienza politica, che sembrano suggerire che fosse migliore la prima idea, quella del premio di coalizione e che si debba rimettere mano al “secondo turno” che era stato presentato come una garanzia.
Naturalmente, non c’è ancora nulla di scritto o di dichiarato pubblicamente; ma la stampa (che è attenta a ciò che si pensa dietro le quinte), comincia a parlare di questi propositi; e nessuno la smentisce. Anzi, mi è capitato di leggere una significativa intervista con un illustre Professore, considerato (anche se lui smentisce) come un padre dell’Italicum e certamente molto vicino al Presidente del Consiglio e Segretario del partito di maggioranza relativa. Basta leggere il titolo (che può anche non essere del tutto esatto, ma esprime l’opinione che si è fatta l’autore dell’intervista): “D’Alimonte: un baby Nazareno, sul premio di coalizione”. La lettura dell’articolo non smentisce affatto la possibilità (e forse già l’intenzione) di rimettere le mani sulla legge elettorale, per ragioni - checché se ne dica - di pura convenienza politica, al punto che si arriva ad ipotizzare una sorta di intesa tra la maggioranza di governo e una parte delle opposizioni.
Tutto questo è serio, accettabile e ammissibile? Io penso di no, perché se una legge è pessima, come lo è l’Italicum, essa va cambiata nelle parti in cui nega la rappresentanza, impedisce ai cittadini di scegliere, assegna premi che distorcono la volontà popolare. E invece no. Si pensa di ricostituire un vecchio e, per fortuna, superato patto con Berlusconi, per tutt’altre ragioni, che nulla hanno a che fare con la rappresentanza, la democrazia e la sovranità popolare. Non è così che si riconquista la fiducia dei cittadini, né - tantomeno - si incoraggia la partecipazione. Anzi, così si convincono più che mai i cittadini che i fini perseguiti sono corrispondenti ad interessi e convenienze di parte, anziché all’interesse generale.
Concludo con l’ultimo esempio. È passata la riforma della Scuola, al Senato, con la fiducia, ancora una volta. La fiducia su una riforma importante dovrebbe essere un’eccezione rarissima; ma tant’è: si è ricorsi alla fiducia e si è chiusa la partita in quattro e quattr’otto. Non era stato detto che a luglio ci sarebbe stata una “giornata della scuola” per discutere, tutti insieme e in tutto il Paese, della riforma di uno degli Istituti più importanti per la convivenza, il senso civico e la formazione del cittadino? Semplicemente non se ne è parlato più. Tutto questo, perché c’era la necessità di inserire nei ruoli 120.000 insegnanti ancora precari; esigenza giustissima, cui si sarebbe potuto far fronte stralciando questo punto, facendo un Decreto Legge, data l’urgenza, riservando quindi alla riforma della Scuola tutto il tempo necessario, senza ricatti di sorta.
Anche in questo caso, c’è un modo di intendere la politica, il governo della cosa pubblica, il prestigio del Parlamento, che non ci convince e non può convincere il cittadino che questa sia la “buona politica” di cui tutti parlano da molto tempo come di una necessità assoluta, proprio per “moralizzare “ la convivenza civile del Paese. Si noti che non ho parlato affatto dei contenuti della riforma della Scuola, sui quali mi sono già espresso più volte; ma ho fatto solo questioni di metodo, ponendo un problema di “moralità” e di “legalità” (in senso ampio) di una scelta politica.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- «Mafia Capitale»: Lo Stato vittima e complice (di A. Mingardi) - Il fiume di denaro verso Ostia (di Toberto Galullo)6 giugno 2015, di Federico La Sala
Lo Stato vittima e complice
di Alberto Mingardi (La Stampa, 06.06.2015)
«Mafia Capitale» sta tutta in un’intercettazione di Salvatore Buzzi. «La mucca tu la devi mungere, però gli devi dà da mangià». Metafora leggermente imperfetta: a mangiare, più che la mucca (lo Stato), sono i pastori (la classe politica). Ma ci siamo capiti.
Parlando ai Giovani Industriali, il presidente dell’autorità anti-corruzione Raffaele Cantone ha detto che «la classe imprenditoriale italiana si nasconde dietro la corruzione per creare un sistema anti concorrenziale». Per fortuna la classe imprenditoriale italiana è anche e soprattutto altro: una galassia di aziende (piccole, medie, grandi) che giorno dopo giorno si guadagnano la fiducia dei consumatori. E tuttavia, non c’è dubbio che se a qualcuno viene garantita una rendita di posizione, farà quanto possibile per «mungerla» fino in fondo. La concorrenza è faticosa, dura, perennemente incerta. Dedicarsi alla mucca è tanto più facile.
Torniamo a un’altra intercettazione di Salvatore Buzzi, formidabile teorico del sistema, uscita sui giornali qualche mese fa. «Con gli immigrati si guadagna più che con la droga». Sottinteso: la droga è un mercato concorrenziale. Esistono multinazionali della droga e artigiani dello spaccio. I clienti sono fedeli fino a un certo punto. Prezzi più bassi o prodotti nuovi possono convincerli a cambiare fornitore. Che fatica.
Il «mondo di mezzo» funziona in un’altra maniera, una maniera che conosciamo sin troppo bene. E’ un mondo più semplice. La classe politica ha a disposizione risorse (che ha prelevato dai nostri redditi con le tasse) per svolgere tutta una serie di funzioni. Le può svolgere attraverso organizzazioni sottoposte direttamente al suo controllo: la burocrazia, nelle sue diverse articolazioni. O le può svolgere facendo ricorso ai privati. Questo accade non perché la pubblica amministrazione abbia sperimentato negli ultimi anni una svolta «liberista». Almeno in Italia, lo Stato non ha «esternalizzato» per sudditanza psicologica nei confronti del privato. Semmai è vero il contrario. La classe politica ha stabilito di essere il miglior fornitore possibile di tutta una serie di servizi. Ha dovuto coinvolgere i privati semplicemente per stare al passo delle sue promesse.
Questi privati stabiliscono col pubblico un rapporto perverso. Non vendono «prodotti» che il consumatore può portarsi a casa o lasciare sugli scaffali. La vita o la morte delle loro imprese è appesa alle decisioni discrezionali di pochissime persone, che peraltro spendono denaro non loro. La loro priorità diventa allora convincere quelle persone a spendere a loro vantaggio i quattrini del contribuente.
Di soluzioni semplici non ne esistono. Non è immaginabile che lo Stato faccia, «in house», tutti i servizi che è andato monopolizzando con gli anni. E nemmeno si può pensare che bastino più controlli e più controllori. E’ difficile sostenere che l’Italia sia un Paese in cui mancano le norme per sanzionare certi comportamenti.
Si può cercare, certamente, di automatizzare quanto più possibile i processi. Se un’autorizzazione me la dà un essere umano in carne ed ossa, gli posso allungare una bustarella. I computer pare siano impermeabili a queste lusinghe. Riducendo gli spazi di discrezionalità dei decisori, le regole somigliano di più ai computer: non ammettono eccezioni. Bisognerebbe soprattutto far dimagrire la mucca: che dia latte solo quando assolutamente necessario. L’accoglienza agli immigrati è probabilmente una funzione pubblica insopprimibile. Si può però provare a ridurre l’intermediazione. Anziché dare i soldi a chi poi da da mangiare agli immigrati, tanto varrebbe darli all’immigrato che poi provveda a nutrirsi come vuole. Piuttosto che affittare le case per i richiedenti asilo, si potrebbe dar loro un voucher per scegliersi il padrone di casa che preferiscono.
Tante altre funzioni pubbliche non è affatto detto debbano essere tali. Il «mondo di mezzo» si è abituato a rifornirsi alla mangiatoia in cinquant’anni di para-Stato. Per fargli passare l’abitudine, bisogna restringere il perimetro pubblico: lo spazio in cui quel «sistema anticoncorrenziale» di cui parla Cantone mette radici, si sviluppa, prospera.
Il fiume di denaro verso Ostia
di Roberto Galullo (Il Sole-24 Ore, 06.06.2015)
Un fiume di denaro verso Ostia ha arricchito politica e mafie. Questa è la convinzione dei pm di Roma con il secondo atto di Mafia Capitale. E questa è anche la preoccupazione del Comune che il 29 aprile ha nominato l’ex pm Alfonso Sabella commissario del litorale laziale.
I soldi erano principalmente quelli destinati alle gare pubbliche, a partire dalla manutenzione del verde pubblico e della pulizia nelle spiagge (nell’ordinanza si legge di un bando per 1,2 milioni), intercettati dalla rete di cooperative riconducibili agli indagati Salvatore Buzzi e Massimo Carminati. Nel corso della perquisizione effettuata nei confronti di un altro indagato il 2 dicembre 2014 è stata individuata la “gara di Ostia” relativa all’alberatura nei “Lavori a somma urgenza per indagini sulla stabilità delle alberature stradali e conseguenti interventi di potatura. Via di Castel Fusano - via del Mare (tratto Ostia Lido) - Cineland”.
Nell’ordinanza firmata il 29 maggio dal Gip Flavia Costantini si legge di un accordo per convogliare fondi regionali assegnati al Comune verso il X Municipio «presidiato da amministratori compiacenti con Buzzi, perché da lui remunerati» e perché proprio lì, secondo l’accusa, Buzzi «era sicuro di potersi appropriare di tali risorse con l’aiuto del presidente da lui corrotto». Per far capire quanto Ostia sia diventata un crocevia di traffici politico/criminali, i pm della procura capitolina si soffermano sulle difficoltà incontrate sul litorale dall’organizzazione riferibile a Buzzi e al presunto boss Carminati. L’operazione per piegare la discrezionalità degli amministratori si scontrava, infatti, con gli appetiti economici di altri rappresentanti del consiglio comunale che rivendicavano un potere d’interdizione sull’assegnazione dei lavori, il cui mancato esercizio andava remunerato, cosa, secondo Buzzi, avvenuta.
Il primo, secondo la ricostruzione, a cadere nella catena corruttiva è Andrea Tassone che, dimettendosi dalla carica di presidente del X Municipio il 18 marzo, quando l’onda lunga del primo atto dell’indagine “Mondo di mezzo” stava già travolgendo Ostia, dirà «non ci dimettiamo per lotte intestine o perché abbiamo ricevuto avvisi di garanzia o altro, ma io azzero oggi la mia esperienza amministrativa e rimetto il mio mandato per lanciare un appello al sindaco Ignazio Marino, quello di avere la consapevolezza che Ostia non è come tutti gli altri Municipi». Per la procura, Tassone ricorreva «ad un faccendiere che agiva e operava in nome e per suo conto».
Anche nel secondo atto delle indagini su Mafia Capitale, Carminati entra a pieno titolo nelle vicende del litorale. Una mano alla Procura per ricostruire il profilo del “cecato” e il suo «legame con il clan Fasciani di Ostia» la dà il collaboratore di giustizia Roberto Grilli nell’interrogatorio del 17 dicembre 2014.
Grilli ha riferito ai pm di essere rimasto «un attimino sconcertato» dal fatto che sin dal 2008 Massimo Carminati, con il quale «al tempo» non aveva rapporti diretti, si mostrasse al corrente («ah, so che hai incontrato un nostro comune amico, quello che sta al mare») di un tentativo fatto da Carmine Fasciani di coinvolgere lo skipper in un’importazione di stupefacente dalla Spagna (e del rifiuto che quest’ultimo aveva opposto).
L’interpretazione data all’episodio da Grilli («come se Fasciani si fosse rivolto ad altri, cioè avesse fatto sapere a Carminati la sua non contentezza») gli rinsaldava la convinzione dei legami che Carminati vantava nell’ambiente criminale e gli instillava il dubbio di poter essere identificato come «uomo a disposizione» del gruppo da questi rappresentato, privandolo così della sua autonomia («il fatto che alle mie spalle quello (Fasciani. ndr) avverte Carminati...è come se io fossi in dovere di dovere qualcosa a qualcuno che sinceramente non dovevo dà niente a nessuno») e magari rischiare di essere oggetto di interferenze da parte di quel gruppo nell’organizzazione del trasporto di stupefacente.
Grilli - arrestato ad Alghero il 26 settembre 2011 - nell’interrogatorio ha fornito alla Procura ulteriori elementi sul coinvolgimento di Carminati, come intermediario, nell’organizzazione, nell’estate del 2011, dell’importazione di 503 chilogrammi di cocaina dal Sudamerica con l’imbarcazione Kololo II.
La capacità di interlocuzione di Carminati con la criminalità organizzata insediata a Ostia ha trovato nelle parole di Salvatore Buzzi una conferma. Il 6 ottobre 2014, a partire dalle 18.14, gli investigatori captano un dialogo presso la Coop 29 giugno, nel corso del quale Buzzi - nel riepilogare le gare che si erano aggiudicati - parla della possibilità di prendere in concessione uno stabilimento di Ostia ed evidenzia la necessità di parlare con Carminati allo scopo di evitare problemi con la criminalità locale: «Ne devo parlare con Massimo per stà assicurato contro la malavita».
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- La difesa “contro” le regole, uscendo dal circuito delle regole stesse. Così seppelliscono la questione morale (di Gian Carlo caselli).30 maggio 2015, di Federico La Sala
Così seppelliscono la questione morale
di Gian Carlo Caselli (il Fatto, 30.05.2015)
Una grave anomalia del nostro Paese consiste nel valutare gli interventi sul versante dell’osservanza delle regole non in base a criteri di correttezza e rigore, ma in base al parametro di utilità. In sostanza il messaggio è: se applicando le regole si fa qualcosa che danneggia me o qualcuno della mia cordata, metti in conto che tu che applichi le regole dovrai subire attacchi, aggressioni e denunce. È la solita difesa “contro” le regole, uscendo dal circuito delle regole stesse.
Un classico è accusare chi fa il suo dovere di uso distorto della funzione per fini politici di parte, appioppando etichette fasulle di appartenenza a questa o quell’altra fazione. Sta succedendo anche alla presidente della Commissione Antimafia Rosi Bindi, accusata ingiustamente di voler favorire una componente del suo gruppo politico a scapito di altre.
Lo scopo è quello di sempre: denigrare e svalutare il lavoro che si sta facendo, parlando di altro rispetto al merito. È successo a Falcone e Borsellino quando si occupavano di Vito Ciancimino e dei fratelli Salvo, è successo alla Procura di Palermo quando si occupava del dopo stragi, di Andreotti e Dell’Utri. Succede oggi a Rosi Bindi, quando si occupa, non di un insieme di parole vuote, ma di rompere la cortina di silenzio che sta cancellando la questione morale.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- Regionali: Antimafia, 16 ’impresentabili’. Quattro sono candidati in Puglia, il resto in Campania.29 maggio 2015, di Federico La Sala
Regionali:Antimafia, 16 ’impresentabili’
Quattro sono candidati in Puglia, il resto in Campania
di Redazione ANSA, 29 maggio 2015 - 20:44
(ANSA) - ROMA, 29 MAG - E’ formata da 16 nomi la lista dei candidati "impresentabili" alle prossime regionali resa nota oggi dalla Commissione parlamentare Antimafia presieduta da Rosy Bindi, al termine dell’Ufficio di presidenza e della seduta plenaria della Commissione.
 I nomi appartengono a candidati nelle regioni Puglia (4) e Campania. Nella lista c’è anche il candidato presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.
I nomi appartengono a candidati nelle regioni Puglia (4) e Campania. Nella lista c’è anche il candidato presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.Ecco i nomi segnalati come impresentabili dalla Commissione parlamentare Antimafia.
 Casi di giudizio pendente in primo grado per reati rientranti nel codice di autoregolamentazione: Ambrosio Antonio, Passariello Luciano, Ladisa Fabio, Nappi Sergio, De Luca Vincenzo, Errico Fernando, Lonardo Alessandrina, Plaitano Francesco, Scalzone Antonio, Viscardi Raffaele.
Casi di giudizio pendente in primo grado per reati rientranti nel codice di autoregolamentazione: Ambrosio Antonio, Passariello Luciano, Ladisa Fabio, Nappi Sergio, De Luca Vincenzo, Errico Fernando, Lonardo Alessandrina, Plaitano Francesco, Scalzone Antonio, Viscardi Raffaele.
 Casi di prescrizione per reati rientranti nel codice con giudizio definitivo: Elefante Domenico, Palmisano Enzo, Copertino Giovanni.
Casi di prescrizione per reati rientranti nel codice con giudizio definitivo: Elefante Domenico, Palmisano Enzo, Copertino Giovanni.
 Casi di assoluzione per reati rientranti nel codice con giudizio ancora pendente: Oggiano Massimiliano, Grimaldi Carmela. -Casi di condanna per reati rientranti nel codice con giudizio ancora pendente: Gambino Alberico.
Casi di assoluzione per reati rientranti nel codice con giudizio ancora pendente: Oggiano Massimiliano, Grimaldi Carmela. -Casi di condanna per reati rientranti nel codice con giudizio ancora pendente: Gambino Alberico. -
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- IL GOLPE INVISIBILE. Giorgio Galli Sbloccare il Paese da speculatori e parassiti (di Giuseppe Oddo)12 aprile 2015, di Federico La Sala
Giorgio Galli
Sbloccare il Paese da speculatori e parassiti
di Giuseppe Oddo (Il Sole-24 Ore, Domenica, 12.04.2015)
- Giorgio Galli, Il golpe invisibile, Kaos edizioni, Milano, pagg. 256, € 18,00
Il malgoverno, l’illegalità, il saccheggio delle risorse pubbliche sono divenuti in Italia una condizione permanente realizzatasi a partire dagli anni ’70 con un “golpe invisibile” che ha segnato la storia della prima repubblica, condizionato lo svolgersi della seconda e che lascia appese a un filo di speranza le sorti della terza. Gli artefici di questo degrado materiale, morale e civile del Paese, che hanno reso la democrazia un “simulacro”, sono, a giudizio di Giorgio Galli, la borghesia finanzario-speculativa e i ceti burocratico-parassitari che già quarantinque anni fa si erano impadroniti della Dc.
Il politologo ottantasettenne autore di una produzione saggistica tra le più vaste ed originali osserva come a metà degli anni ’70 si fossero create le condizioni per una svolta che sbarrasse la strada alla finanza d’assalto dei Sindona e dei Calvi e all’avanzata della borghesia di Stato allora rappresentata da Eugenio Cefis. Alle politiche del 20 giugno 1976 il Pci aveva raggiunto il massimo storico del 34,4 per cento. La Dc, al 38,7%, non disponeva più di una maggioranza. Il responso delle urne rendeva attuale una svolta riformista.
I ceti produttivi e la borghesia industriale erano pervasi da una corrente di cambiamento che aveva contagiato la parte di elettorato cattolico che due anni prima si era espressa per il divorzio. Si sarebbe potuto costituire, dice Galli, un governo di programma presieduto da Ugo La Malfa, sostenuto da una robusta rappresentanza comunista, insieme a socialisti, repubblicani e socialdemocratici e con qualche ministro Dc ancora presentabile.
Purtroppo mancarono gli interpreti di quella stagione. Il Pci «consentì il formarsi di un governo monocolore democristiano presieduto da Andreotti, per la cui maggioranza fu inventata la formula della “non sfiducia”»; e lo consentì «gratuitamente», annota lo studioso, «condizionato da una campagna mediatica che indicava nel “terrorismo” (comprendente ogni forma di contestazione) il maggior problema da fronteggiare».
Fu così che il partito guidato da Enrico Berlinguer cominciò a perdere consensi, replicando le politiche di austerità dei governi democristiani proprio mentre l’alta inflazione erodeva i salari dei lavoratori che lo avevano votato in massa.
La finestra di opportunità per un ricambio, che s’era aperta nell’estate 1976, si chiuse diciotto mesi più tardi, quando lo scudocrociato «ritenne giunto il momento di ricollocare all’opposizione un Pci che perdeva voti in parziali elezioni amministrative..., mentre ne riguadagnava la...Dc».
Negli anni ’70 e ’80, i fenomeni di arricchimento si ingigantirono. La corruzione divenne epidemica. Ai Michele Sindona e ai Nino Rovelli, che avevano il loro garante in Giulio Andreotti, subentrò la P2 di Licio Gelli, «stanza di compensazione dell’economia della corruzione di matrice politico-affaristica». Emersero imprenditori dalle «rapide fortune personali» come Silvio Berlusconi, «espressione della continuità del sistema». L’intreccio mafia-politica assunse carattere strutturale. La spesa pubblica lievitò. I ceti improduttivi e parassitari che avevano conquistato la Dc catturarono il Psi di Bettino Craxi per poi trovare rappresentanza, nel 1994, nel partito-azienda di Berlusconi. Il berlusconismo diede vita, secondo Galli, a «un regime politico-affaristico-mediatico» che «un’opposizione di centro-sinistra evanescente e condiscendente» evitò di riconoscere e di definire tale.
La sinistra geneticamente modificata, divenuta ormai maggiornza in Parlamento, sventolò trionfante la bandiera delle privatizzazioni. Ma la vendita delle imprese di Stato, attuata prima da Romano Prodi e poi da Massimo D’Alema, ebbe l’effetto di rendere ancora più famelico il ceto speculativo-parassitario e di consegnare a una “razza” non più “padrona”, ma predona, società strategiche come Telecom. Il Pds-Ds, oggi Pd, «aveva l’occasione di stabilizzare il sistema, affrontando l’oligarchia finanziario-speculativa a partire da uno dei suoi baluardi: l’impero mediatico berlusconiano basato sull’illecito monopolio della tv privata».
 D’Alema, invece, accantonò il conflitto d’interesse e con una ottusità «tanto spregiudicata quanto miope, aprì la strada a quella involuzione del partito ex comunista della quale l’avventurista Matteo Renzi sarà l’approdo terminale».
D’Alema, invece, accantonò il conflitto d’interesse e con una ottusità «tanto spregiudicata quanto miope, aprì la strada a quella involuzione del partito ex comunista della quale l’avventurista Matteo Renzi sarà l’approdo terminale».Galli si rifà in conclusione alle teorie del politologo Usa Robert Dahl, secondo il quale la democrazia dei nostri successori sarà diversa da quella dei nostri predecessori: «O si restringerà in una oligarchia...; oppure evolverà verso una democrazia più partecipata». E anche se vede l’Italia incamminata verso una «postdemocrazia autoritaria», l’ottimismo della ragione lo induce a non escludere la possibilità di un moto di indignazione che modifichi il corso degli eventi: un’ondata di sdegno con forti ricadute elettorali che spinga Renzi ad abbandonare il sentiero dell’«involuzione oligarchica» per rimettere al centro della sua iniziativa politica «lo Stato di diritto e l’economia produttiva».
-
> La questione morale e la zona grigia del premier. Il caso Lupi potrebbe trasformarsi in tempi rapidi nel caso Renzi se il governo non esce dall’ambiguità19 marzo 2015
La questione morale e la zona grigia del premier
Il caso Lupi potrebbe trasformarsi in tempi rapidi nel caso Renzi se il governo non esce dall’ambiguità
di Stefano Folli (la Repubblica, 19.03.2015)
IL CASO Lupi rischia di finire in una zona grigia, o meglio opaca, senza apparenti vie d’uscita. Né chiarimenti né dimissioni. Dubbi e sospetti a volontà, nonché il solito discredito che plana sulla politica romana. È questo che vuole il presidente del Consiglio? In tal caso si prepari a pagarne le conseguenze sul terreno che più gli sta a cuore, quello mediatico. Perché il caso Lupi potrebbe trasformarsi in tempi rapidi nel caso Renzi.
È facile capire le ragioni. Ieri il ministro delle Infrastrutture ha detto in Parlamento di sentirsi del tutto tranquillo e di godere della fiducia e dell’appoggio del governo. Se questo è vero, la questione si chiude, almeno fino a quando l’inchiesta giudiziaria dovesse riservare altre sorprese. Nessun ministro che sente la fiducia del suo presidente ha motivo di dimettersi.
Ma vale anche il contrario: un ministro a cui è stata ritirato il sostegno di chi guida il governo, non può restare al suo posto. E non si parla delle mozioni di sfiducia presentate alle Camere dai Cinque Stelle e dal Sel per un’ovvia operazione politica. Ci si riferisce a quel patrimonio prezioso e insondabile che è il rapporto fiduciario fra il presidente del Consiglio e il responsabile di uno dei maggiori dicasteri.
Esiste ancora quel rapporto oppure no? Ieri Lupi ha fatto capire che sì, esiste. Lo ha fatto intendere con le parole e anche con gesti inequivocabili, quasi di esultanza, dal banco del governo. Forse aveva ragione, perché nell’arco del pomeriggio Matteo Renzi non lo ha smentito. Da Palazzo Chigi non è venuto alcun segno, alcun distinguo. Eppure il giorno prima il presidente del Consiglio aveva lasciato filtrare tutto il suo disappunto per gli sviluppi dell’inchiesta che ha riempito le pagine dei giornali (anche in questo caso senza smentite di sorta).
L’irritazione del premier era palese, come evidente era la volontà di indurre il ministro alle dimissioni nel più breve tempo possibile. Del resto, il «garantismo» renziano non è mai stato assoluto, bensì legato alle convenienze politiche. Tutti ricordano il caso di Anna Maria Cancellieri, difesa da Enrico Letta, allora premier, e attaccata impetuosamente, con richiesta perentoria di dimissioni, dal sindaco di Firenze che andava in cerca di occasioni per indebolire il rivale.
Da presidente del Consiglio l’impeto si è attenuato, ma Renzi ha sempre alzato la bandiera della questione morale, anche per sottrarla a Grillo e Salvini. L’uomo che vuol cambiare verso all’Italia non meno che all’Europa ha sempre curato - lo sappiamo - l’immagine del rinnovatore a tutto campo, capace di rifiutare i compromessi al ribasso. E il rinnovatore non può tollerare le zone opache.
Questo sulla carta. In pratica le contraddizioni del caso Lupi raccontano un’altra storia. Può darsi che il premier si sia convinto che il ministro merita il suo appoggio, ma allora ha il dovere di dirlo con chiarezza uscendo dall’ambiguità. Non possono coesistere due opposte interpretazioni dei fatti a distanza di ventiquattro ore. Anche perché la vicenda Lupi dovrà chiudersi in un modo o nell’altro entro pochi giorni, a meno di non voler creare altro sconcerto in una pubblica opinione a cui il presidente del Consiglio è sempre molto attento. E il recente caso De Luca in Campania dimostra quanto sia grande la distanza fra la retorica e la realtà.
Certo, esiste una spiegazione politica per i tentennamenti e forse è la più autentica. Lupi è stato difeso con vigore dal suo partito, l’Ncd. L’asse con Alfano si è rivelato ancora una volta la struttura portante dei centristi: se si spezza e il ministro viene abbandonato al suo destino, il cortocircuito rischia di diventare incontrollabile. Una crisi distruttiva per il gruppo Ncd-Udc, uscito molto male dalle polemiche sull’elezione di Mattarella.
Non stupisce che Renzi si preoccupi della stabilità del suo governo, messa in pericolo dalle convulsioni centriste. Ma senza dubbio egli si rende conto che il renzismo intriso di «realpolitik »è assai meno suggestivo per gli italiani dei sogni che il premier evoca ogni giorno nei suoi «twitter».
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- Questione immorale, corruzione legalizzata. Ora la corruzione è a norma di legge (di Roberta De Monticelli)21 gennaio 2015, di Federico La Sala
Il parricidio della civiltà, come predisse Socrate, è vicino.:
Questione immorale, corruzione legalizzata
Ora la corruzione è a norma di legge
di Roberta De Monticelli (il Fatto, 21.01.2015)
La questione morale ha cambiato taglia. Ma non è la “mappa della corruzione” nella Pubblica amministrazione, con le sue percentuali di illeciti che sembrano aver impressionato il ministro della Giustizia Orlando (Fatto Quotidiano19/01/2015) a fare la differenza. Per la semplice ragione che si tratta di “illeciti”. Cioè di violazioni della legge. Almeno dai tempi di Tacito è ben noto che la peggiore corruzione è quella “a norma di legge”, per far eco al bel titolo di un recente libro di Rizzo e Giavazzi.
Ma ancora peggiore è la corruzione della legge stessa. Qui per illustrare il fenomeno vien buona un’altra immagine di sartoria. Secondo una famosa ricetta cinica di Giolitti, “Un sarto che deve tagliare un abito per un gobbo deve fare la gobba anche all’abito”. La corruzione delle leggi è appunto questo: una legge non serve a prevenire, impedire o raddrizzare una deformità, ma ad adattarcisi al meglio.
Se proprio serve un esempio, oltre alla reiterata depenalizzazione del falso in bilancio, che non ha invece impensierito il ministro, può valere l’ormai ben noto 19-bis del Decreto-legge sulla delega fiscale. La cosa più sorprendente di questo vestito tagliato a misura di gobba è che il clamore che ha finito per suscitare si sia limitato nella maggior parte dei casi a censurare il carattere ad personam di questo mostriciattolo partorito probabilmente da un accordo sordido: come se il suo effetto “riabilitante” nei confronti di un noto pregiudicato ne esaurisse la mostruosità. Come se non ci fossero due altri aspetti mostruosi.
Il primo è l’atto con cui l’articolo è improvvisamente comparso nel testo di un decreto del Consiglio dei ministri. Questo, stando alle autorevoli dichiarazioni di due costituzionalisti, è semplicemente un falso in atto pubblico. Per il Prof. Sorrentino si tratta di un “reato commesso nell’esercizio delle funzioni del ministro o del presidente del Consiglio... un fatto di una gravità straordinaria, passato sotto silenzio” (FQ 18/01/15).
Per il Prof. Pace chi se ne è assunto la responsabilità “ha usato un sotterfugio per far sì che una sua ‘volizione individuale’ assumesse le sembianze di una disposizione legislativa approvata con tutti i crismi dal Consiglio dei ministri, contro la verità dei fatti” (FQ 17/01/15). E il contenuto di questa “volizione”? Ecco, dall’intervista di F. Forquet al ministro Padoan (Sole 24 Ore 17/01/2015). Domanda: “Quella franchigia del 3% sarà riproposta? ”. Risposta: “Bisogna ragionare su un sistema di percentuali e di margini, dall’intreccio di questi due parametri può uscire un sistema equo”.
Traduzione: dall’intreccio di una frode che non viene più trattata come frode e di una legge che calcola gli sconti per le frodi invece di sanzionarle, “può uscire un sistema equo”. Domanda: “Ma qual è la sua versione sulla famosa manina che ha introdotto la norma del 3%? ”. Risposta: “... è il metodo di lavoro abituale di questo governo: l’interazione tra ministeri e presidenza e quindi il Consiglio”. Cioè: un falso in atto pubblico come lo chiama, un ministro della Repubblica? Un metodo di lavoro!
Ecco: per capire la gravità di questi due aspetti, l’atto e il suo contenuto, occorre allargare la visuale al più vasto fenomeno cui il colpaccio che si sperava passasse inosservato appartiene. È un fenomeno di proporzioni apocalittiche, la cui profondità e vastità ci impedisce forse di prenderne veramente coscienza: perché ci nuotiamo dentro, come pesci nell’acqua.
Questo fenomeno è l’appiattimento del dover essere sull’essere, del valore sul fatto, della norma sulla pratica comune anche se abnorme, e in definitiva del diritto sulla forza. “Tutto quel che è reale è razionale”, dice il filosofo che dà ragione alla forza, purché vinca. “Tutto quello che è reale è normale”, dice il cinismo che ha permeato il linguaggio popolare.
AL FONDO, è la dissoluzione dei vincoli di senso, i vincoli all’interno dei quali soltanto le parole umane dicono qualcosa di definito, i comportamenti umani hanno un significato e un valore definito. Sciogliete una lingua dalle sue norme logiche e nessuno potrà più affermare o negare nulla. Si dirà insieme tutto e il contrario di tutto.
Sciogliete i comportamenti umani dai vincoli pur minimi dell’etica, da quelle norme implicite che sono i mores o da quelle ponderate che sono le leggi, e non potrete più valutare se la mano che vi si tende offre morte o amicizia.
Leggiamola a questa profondità, la piccola porcheria del 19-bis. Ci consente di farlo il comportamento degli individui che con atti, parole e omissioni contribuiscono, come tutti ormai facciamo senza accorgercene neppure più, ad appiattire la norma sul fatto e il diritto sul potere. Perché l’erosione dell’idealità non avviene da sola, e neppure da soli i vestiti si attagliano alle gobbe, ci vuole chi dispone, chi scrive, chi tace, chi usa le leggi corrotte.
E cosa c’è di terribile in questo? Quasi niente: l’auto-destituzione del soggetto morale in noi, vale a dire la semplice impossibilità di dissentire anche nel foro interiore da ciò che non è come dovrebbe essere, perché la distinzione non c’è più: la realtà ha vinto completamente, ovunque. Chi si ribella a uno Stato totalitario, come fecero i coniugi Solgenitsin quando decisero di non mentire più qualunque conseguenza potesse seguirne, ha una chance di uscire libero dalla sofferta “prigionia della mente”. Nel caso totalitario resta la potenziale coscienza della libertà perduta: la costrizione, il dolore di subirla, la vergogna di piegarsi... mentre lo Stato impunitario è una distruzione irreversibile di risorse di senso.
Chi ha sciolto il suo pensiero dal vincolo della legge ha destituito in se stesso per sempre l’autonomia, la libertà di resistere all’arbitrio, dentro e fuori di sé.
Il parricidio della civiltà, come predisse Socrate, è vicino. E questo è il vero ultimo senso della parola “corruzione”: dissoluzione e morte di un intero vivente. Ecco perché la questione morale ha cambiato taglia.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- “Capitale corrotta, nazione infetta”. La Capitale da rifondare. Giuseppe Pignatone ha svelato il mistero dell’ingovernabilità di Roma.3 dicembre 2014, di Federico La Sala
La Capitale da rifondare
Un calderone maleodorante nel quale si mescolavano criminalità mafiosa, estremismo neofascista, imprenditoria malata e politica corrotta
di Sebastiano Messina (la Repubblica, 03.12.2014)
SCOPERCHIANDOLO il procuratore della Repubblica Giuseppe Pignatone ha svelato il mistero dell’ingovernabilità di Roma. La capitale era in realtà governata benissimo - naturalmente ai propri fini - da questa banda di criminali che sapeva usare la prepotenza della pistola, l’odore dei soldi, la solidarietà tra camerati e la forza del clan per mettere le mani sugli affari che passavano per il Comune di Roma e per le sue controllate, a cominciare dall’Ama, l’azienda dei rifiuti.
Quella che faceva capo a Massimo Carminati - l’ex terrorista nero dei Nuclei Armati Rivoluzionari legato alla banda della Magliana, l’uomo che come hanno accertato i magistrati «manteneva i rapporti con gli esponenti delle altre organizzazioni criminali, con pezzi della politica e del mondo istituzionale e finanziario e con appartenenti alle forze dell’ordine e ai servizi segreti» - era una creatura mai vista, un intreccio perverso e spietato tra la malavita mafiosa e il governo della capitale, legati da un filo nero - è il caso di dirlo - che passava per l’ entourage dell’ex sindaco Gianni Alemanno, il primo sindaco postfascista dalla caduta del duce.
Si capiscono molte cose, leggendo le 1.200 pagine dell’ordinanza che ha mandato in carcere 37 persone e chiamato in causa più di cento indagati - il più importante dei quali è lo stesso Alemanno. E si scopre che questa banda battezzata da Pignatone “Mafia capitale” gestiva senza problemi non solo i fondi per la manutenzione del verde o quelli per la raccolta differenziata, arrivando a partecipare alla stesura dei bandi per le gare d’appalto, ma aveva messo stabilmente le mani sul flusso di denaro pubblico destinato ai campi nomadi e alle strutture per gli immigrati richiedenti asilo.
Rifiuti, nomadi, immigrati: quelli che per la città di Roma erano in cima alla lista dei problemi, per la destra neofascista erano contemporaneamente il facile bersaglio delle sue proteste populiste e la ricca miniera d’oro che alimentava una rete sotterranea di corruzione, quella invisibile ma potentissima cerniera che in questi anni ha tenuto insieme mafiosi, ex terroristi, politici corrotti e imprenditori senza scrupoli.
“Capitale corrotta, nazione infetta” fu il celebre articolo di una grande inchiesta dell’ Espresso del 1956 sul sacco di Roma, ma quello che abbiamo scoperto ieri ci dice che la corruzione è penetrata in profondità, e mescolandosi con la forza eversiva dell’estremismo neofascista e con la potenza criminale della mafia ha avvelenato il Campidoglio.
Sarebbe sbagliato identificare la capitolazione della politica alla mafia con la stagione di Alemanno, e non solo perché sarà l’inchiesta a chiarire fin dove arrivavano le complicità politiche, ma perché questa struttura spietata e diabolica agiva anche prima che Alemanno arrivasse ed ha continuato a operare anche dopo che lui se n’è andato.
Eppure questo rende ancora più grave la diagnosi: il virus è penetrato in profondità, e ha imparato a resistere agli anticorpi dell’alternanza. Perciò da un sindaco chirurgo come Ignazio Marino oggi i romani, e non solo loro, si aspettano un gesto forte, non una cura ma un taglio netto, un colpo di bisturi sul malgoverno infetto della Capitale.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- IO RUBO, MA LO FACCIO PER IL BENE DEL MIO PAESE.7 giugno 2014
Confessioni politiche. Corrotti e contenti
Io rubo, ma lo faccio per far del bene al Paese
di Pino Corrias (il Fatto, 07.06.2014)
Io rubo. Pago tangenti, sigillo buste, movimento contante. Lo faccio ovunque, dove serve: nelle aree di servizio, per strada, in discoteca, al ristorante. Mi tengo la mia cresta, diciamo il 10 per cento più le spese per il disturbo, abbastanza per tirarci fuori una casa, un attico al mare, una seconda moglie, la governante, due auto, una barca, una ragazza di prima classe per le serate che mi sento solo, un po’ di bambagia esentasse in Lussemburgo per la vecchiaia e un cane. Il cane è l’unico che mi vuole bene.
IO RUBO E HO LA COSCIENZA A POSTO. Muovo l’economia. Compro terreni che non valgono un cazzo, do la sveglia agli uffici tecnici, ai geometri indolenti, agli assessori in fregola. Ingaggio due imprese di malavita per semplificare i permessi e un’azienda buona che fa il lavoro in nero, al ribasso, ed ecco che saltano fuori cento villini vista pioppi e autostrada. E se poi nessuno li compra prendetevela con i dilettanti delle agenzie e con questa maledetta recessione. Io cosa c’entro?
Scavo dighe in fondo al mare, un portento di ingegneria che il mondo ci invidia, lubrifico in dollari, euro, cene, escort, cocaina, vacanze, fondi pensione. Combatto le maree e finanzio il Carnevale, salvo Venezia da tutti i metalli pesanti che scarica in laguna quell’altro capolavoro di Petrolchimico che astuti ingegneri hanno costruito nel posto più bello del mondo, piantando ciminiere d’altiforni sulla schiena delle sogliole e sulle rime di Lord Byron. È colpa mia se poi ai cristiani e alle vongole gli viene il cancro?
Io rubo e innalzo pale eoliche in cima a delle stupide colline d’Appennino dove volano stupidi uccelli e mosche. Le pale fanno schifo, lo so, ma un architetto scemo che dice che invece sono belle si trova sempre. E anche un artista controcorrente. Muoiono le api? Chissenefrega, apriamo il dibattito, facciamo sei convegni pieni di hostess bionde sulle energie rinnovabili, foraggiamo il ministro e la sua corrente di arrapati, adottiamo una coppia di lontre sul Trebbia, due ecologisti in Amazzonia e vedrete che prima o poi il vento arriva.
Io rubo e fabbrico corsie d’ospedali in linoleum ad aria condizionata, sale operatorie in acciaio inox, non è colpa mia se poi l’energia elettrica non arriva, piove dal tetto, gli zingari si fregano il rame e il polmone per la ventilazione meccanica va in malora. Nella Sanità bisogna stare attenti, c’è così tanta malavita che neanche nell’infermeria ad alta sicurezza di Poggioreale: sottosegretari che allattano primari, primari che si scopano le infermiere, infermiere che si vendono i letti, tutto sovrinteso dalla politica, benedetto dal vescovo, ci mancherebbe, purché le infermiere, i primari e i sottosegretari siano dei buoni obiettori di coscienza.
Io rubo e faccio pil. Dicono 60 miliardi di euro l’anno, che poi sarebbe la metà della corruzione di tutta l’Unione europea messa insieme, una bella soddisfazione per il Made in Italy, la professionalità paga. La creatività pure. Se poi la cifra sia vera o falsa non lo so. Se è tutto nero, tutto sommerso, come si fa a vedere? Con le cimici dentro i piatti di astice e spigola da Assunta Madre? Pedinando i commercialisti? Perquisendo le fondazioni bancarie? Oppure mettendoci a contare le mignotte su via del Babbuino?
Io rubo e non capisco tutto questo scandalo. Scandalo a orologeria, dico io. Uso politico dello scandalo, dico io. Gogna mediatica. Che a essere dei veri garantisti ogni scandalo andrebbe considerato innocente fino al terzo grado di giudizio di un giusto processo, diminuito di ogni attenuante. E per quel che ne so con Ilva, Malagrotta, Montepaschi, Expo, Carige, Mose, non siamo neanche ai preliminari. Quindi calma e gesso.
CHE POI DOVREMMO avere un po’ più di orgoglio patriottico, visto che gli scandali li abbiamo pure esportati - come l’olio, la pasta, il concentrato di salsa - specie ai tempi d’oro del socialismo riformista e altruista, con le bananiere dirette in Somalia, le autostrade dirette a Tripoli, gli ospedali nel deserto. Io rubo e la chiamo economia reale, condivisione, socialità. La chiamo adrenalina, dinamismo, gioia di vivere. Guarda la faccia triste di un sindaco finlandese senza tangente e quella allegra di uno dei nostri che incassa mozzarelle e cozze pelose a ogni ordinanza. Guarda le pance e le mandibole dei nostri consiglieri regionali, che sposano figlie, festeggiano amanti, volano in business, visitano Padre Pio e i Caraibi. Ascolta le risate. Lasciati andare, ce n’è per tutti. Io rubo e ruberò fino alla morte. Pensa che noia senza.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- L’«affare» del Mose è esemplare. Eppure è tutto chiaro: per vent’anni ... (di Gian Antonio Stella).5 giugno 2014, di Federico La Sala
Ma quando dichiariamo guerra alle mazzette?
Per il Mose ci sono voluti nove volte i tempi del colossale ponte di Donghai
di Gian Antonio Stella (Corriere della Sera, 05.06.2014)
«Votatelo, pesatelo, se sbaglia impiccatelo», diceva un antico adagio veneziano. Certo, se anche le accuse contro Giorgio Orsoni, Giancarlo Galan e gli altri politici e affaristi coinvolti nell’inchiesta trovassero conferma nei processi e nelle sentenze, nessuno pretende corda e sapone. Il quadro di corruzione disegnato dai giudici, però, è così vasto da imporre finalmente una guerra vera, non a chiacchiere, contro la mazzetta.
L’«affare» del Mose è esemplare. Perché c’è dentro tutto. C’è dentro lo spaccio dell’«emergenza», dei lavori da fare a tutti i costi in tempi così drammaticamente rapidi da non consentire percorsi lineari nei progetti, nella scelta degli esecutori, nelle gare d’appalto, nelle commesse. Risultato: di fretta in fretta sono passati 31 anni, nove volte di più di quelli bastati alla Cina per fare il ponte di Donghai, che coi suoi 32 chilometri a 8 corsie sul mare collega Shanghai alle isole Yangshan.
C’è dentro l’idea della scorciatoia per aggirare (non cambiare: aggirare) le regole troppo complicate con la creazione d’un concessionario unico, il Consorzio Venezia Nuova che, dopo tre decenni passati senza lo straccio di una concorrenza e dopo essere stato così pesantemente coinvolto negli scandali coi suoi massimi dirigenti, giura oggi d’essere estraneo alle brutte cose e pretende di presentarsi come una verginella al primo appuntamento.
C’è dentro quel rapporto insano tra la cattiva politica e il cattivo business così stretto da chiudere ogni spazio ai controlli veri sui costi, sui materiali, sugli uomini, sui tempi. Basti ricordare l’impegno preso dall’allora vicepresidente del consiglio Gianni De Michelis il 4 novembre 1988, quando dopo anni di tormentoni fu presentato il prototipo del Mose: «La scadenza? Resta quella del 1995. Certo, potrebbe esserci un piccolo slittamento...». Sono passati quasi vent’anni, da quella scadenza: ci saranno anche stati degli intoppi, ma cosa succederebbe, in Germania o in Olanda, se lo Stato si sentisse preso per i fondelli sui tempi in modo così sfacciato? E cosa direbbero i leghisti da tre lustri al governo del Veneto se un cantiere interminabile come quello del Mose fosse ancora aperto dopo tanti anni a Reggio Calabria o a Napoli?
C’è dentro il disprezzo per i pareri discordanti e più ancora, alla faccia del chiacchiericcio federalista, per le opinioni del Comune, tagliato fuori da decisioni prese altrove: «Sinistra e destra, sul Mose, erano d’accordo, e io sono rimasto inascoltato», ha accusato più volte, negli anni, Massimo Cacciari. Ieri l’ha ripetuto: «Le procedure erano tali che da sindaco io non potevo toccare palla». Una linea verticistica che la Serenissima non avrebbe accettato mai. Al punto di pretendere, se c’erano di mezzo opere idrauliche, che oltre a quello degli ingegneri si sentisse il parere di «otto pescadori» e cioè «due da S. Nicolò, uno da Sant’Agnese, uno da Muran, due da Buran e due da Chiozza».
E poi c’è dentro, in questa brutta storia, il continuo rincaro delle spese, la peste bubbonica delle nostre opere pubbliche: doveva costare un miliardo e trecento milioni di euro attuali, il Mose. E di anno in anno, di perizia in perizia, di furbizia in furbizia, ha sfondato i cinque miliardi e non è detto che ne basteranno sei.
C’è dentro la blandizia verso i possibili «amici» e insieme l’insofferenza arrogante verso ogni critica, come nel caso della stupefacente querela per «accanimento mediatico» (avevano dato battaglia sui giornali) contro Vincenzo Di Tella, Paolo Vielmo e Giovanni Sebastiani, tre ingegneri rei di avere criticato il costosissimo progetto delle paratie mobili, la gallina dalle uova d’oro del consorzio.
C’è dentro la ripartizione di incredibili privilegi, come ad esempio, per citare le Fiamme Gialle, «il compenso di un milione di euro riconosciuto nel 2009» all’allora presidente Giovanni Mazzacurati «a titolo di “una tantum”, nonché i periodici rimborsi spese privi di giustificazione contabile», per non dire delle case affittate in California, delle consulenze distribuite ad amici e parenti o della liquidazione finale di 7 milioni di euro incassata dopo l’arresto: l’equivalente di trentuno anni di stipendio del presidente della Repubblica. Una buonuscita stratosferica, per un uomo finito in manette.
E tutti soldi pubblici. Sia chiaro. Tutti soldi privatamente gestiti come in una combriccola di società private ma tirati fuori dalle tasche degli italiani. Per amore di Venezia. Per salvare Venezia dall’acqua alta dovuta non solo ai capricci della Natura e del Fato ma anche a interventi come la cosiddetta «sussidenza», cioè lo sprofondamento del suolo dovuta al pompaggio dell’acqua dolce nel sottosuolo o la creazione del canale dei petroli, un canyon lungo 14 chilometri, largo 200 metri e profondo fino a 17, scavato nel ventre di una laguna delicata la cui profondità media era di 110 centimetri.
E torniamo al rispetto per l’acqua, la terra, le barene della Serenissima Repubblica. «Tre condition de homeni ruinano la Laguna: li Signori, li Inzegneri e li Particulari», cioè i proprietari, scriveva nel ‘500 il Magistrato alle acque Cristoforo Sabbadino. Scordava gli affaristi dell’appalto facile. Quelli della spartizione fra sodali. Che non guardano alla destra o alla sinistra ma al business. O, per dirla alla veneta, ai «schei». Montagne di «schei».
Certo è che quest’ultima ondata di arresti colpisce i cittadini italiani, proprio mentre mostravano di voler credere in un riscatto e in una nuova speranza, come una frustata in faccia. E dimostra che, nella scia dei moniti di papa Francesco che batte e ribatte contro il «pane sporco» del «dio tangente», è indispensabile una svolta vera. Nei fatti.
L’Expo 2015, i restauri a Pompei, il G8 alla Maddalena e poi all’Aquila, i primi interventi e poi la ricostruzione in Abruzzo, i Mondiali di nuoto, il Mose... Non c’è Grande Evento, da anni, che non sia infettato dalla corruzione. E dopo ogni arresto, lagne su lagne. E tutti a chiedersi come sia possibile, come mai non cambi mai niente, perché proprio qui e bla bla bla... Poi, passata la tempesta di sabbia, appena si posa la polvere, le leggi che parevano ur-gen-tis-si-me vengono rinviate dal lunedì al martedì, poi alla settimana dopo, poi al mese seguente, poi all’autunno e da lì all’estate successiva...
Eppure è tutto chiaro: per vent’anni, come denunciano don Luigi Ciotti, Piercamillo Davigo e tanti altri, ogni sforzo della cattiva politica (troppo comodo dare tutta la colpa ai berlusconiani) è stato dedicato a smontare le leggi che c’erano e a buttare bastoni tra le ruote dei giudici. Pochi numeri: nel decennio dopo la stagione di Mani Pulite, 1996-2006, secondo l’Alto Commissariato, le condanne per corruzione precipitarono dell’83,9%, quelle per concussione del 90,4%, quelle per abuso d’ufficio del 96,5%. Come mai? Perché l’Italia è più pulita? Magari!
L’abbiamo scritto ma vale la pena di ripeterlo: dice il rapporto 2013 dell’Institut de criminologie et de droit pénal curato dall’Universita di Losanna, che nelle nostre carceri solo 156 detenuti, lo 0,4% del totale, sono lì per reati economici e fiscali, tra cui la corruzione e la concussione. Una percentuale ridicola. Dieci volte più bassa rispetto alla media europea del 4,1%. È una coincidenza se la Germania, il Paese di traino del Continente, ha le galere più affollate di «colletti bianchi»? Ed è solo una coincidenza se noi, che arranchiamo faticosamente in coda, ne abbiamo 55 volte di meno?
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- La mostruosa normalità di un sistema corruttivo (di Paolo Favilli)25 aprile 2014, di Federico La Sala
La mostruosa normalità di un sistema corruttivo
di Paolo Favilli (il manifesto, 25 aprile 2014)
L’uso senza limiti del linguaggio iperbolico in un dibattito politico quasi sempre privo di spessore analitico ci sta privando della possibilità di orientarci. Se la politica finanziaria connessa all’attuale gestione dell’euro diventa "Auschwitz". Se ogni approvazione di leggi da parte della maggioranza (spesso davvero ingiuste e intrise di conflitti d’interessi) diventa "colpo di stato". Se la reale tendenza al progressivo concentrarsi del potere in ristrette oligarchie diventa "ritorno al fascismo", ebbene la specificità e il peso di ogni fenomeno scompaiono ed orientarsi in «"una notte in cui tutte la vacche sono nere" è impresa assai difficile. In un articolo apparso su questo giornale qualche giorno fa (15 aprile,Berlusconi-Napolitano «gli esiti criminali della politica separata») ho usato anch’io tinte molto forti. Si tratta, però, e credo che questa affermazione possa reggere l’onere della prova, di un linguaggio con alto grado di mimesi nei confronti della realtà. Il problema è che il fenomeno al centro di quello scritto, se analizzato davvero, è in grado di produrre disvelamenti, tanto sull’oggi che su un itinerario storico ventennale, che i facitori di opinione sembrano impossibilitati a sopportare. Meglio la rimozione.
Luigi Pintor diceva che dopo mezzogiorno con il quotidiano si potevano incartare le patate. Visto con quanta facilità si dimentica, mi si scuserà se faccio riferimento all’articolo citato. I dati di fatto non sono controvertibili. Dall’insieme delle sentenze relative a Berlusconi, Previti, Dell’Utri (su quest’ultimo si attende ancora quella definitiva della Cassazione che, come ricordiamo, non è giudice di merito) emerge un quadro criminale impressionante. Il centro del quadro è rappresentato da un enorme e ramificato sistema corruttivo espanso in tutte le possibili varianti. Il sistema corruttivo è necessità funzionale come uscita di sicurezza per una molteplicità di comportamenti delinquenziali. La politica è una delle varianti più importanti tanto come uscita di sicurezza che come luogo privilegiato del circuito potere-denaro.
La triade suddetta è stata il fulcro, il soggetto agente della costruzione di un soggetto politico che per lunghi anni ha esercitato il potere ad ogni livello della vita pubblica. Ancora oggi il soggetto creato vent’anni fa è tutt’altro che marginale e le sue prospettive non sono necessariamente perdenti.
Naturalmente sarebbe una sciocchezza pensare che il successo di quella forza politica sia derivato da una logica criminale, ma quella logica, tenuto conto del ruolo centrale della triade, ha informato di sé aspetti importantissimi delle pratiche di governo. Inoltre è stato punto di riferimento legittimante di analoghe pratiche locali: il paradigma Cosentino si comprende meglio nell’ambito di tale insieme strutturale.
Per la prima volta nella storia dell’Italia repubblicana i gangli fondamentali della vita politica si trovano ad essere intrinsecamente legati a una operazione criminale. Di fronte a tutto ciò ci troviamo a vivere in una situazione di "normalità mostruosa", come potremmo definirla con un ossimoro. Mostruosa: sia come fenomeno straordinario, che suscita stupore, sia come fenomeno orribile. Normalità: in quanto lo svolgimento della vita politica non è assolutamente toccato dalla mostruosità.
Si pensi solo alla leggerezza con cui autorevoli editorialisti di autorevoli quotidiani hanno trattato questo enorme peso che grava su tutta la nostra vita etico-civile. Commentando la sentenza che ha fissato la pena (si fa per dire) rieducativa per il delinquente, ci viene data l’immagine di un uomo "dolorante dietro l’eterno sorriso (...) un uomo che merita rispetto", un uomo i cui errori sono quelli di non aver fatto le riforme promesse, un uomo che però ha definitivamente superato una "guerra giudiziaria" finita da tempo (Massimo Franco, Corriere della sera, 16 aprile). E anche dal fronte pervicacemente antiberlusconiano (la Repubblica), dopo aver messo giustamente in rilievo lo "status particolare" che spiega l’agibilità politica concessa al delinquente, non si fa una piega di fronte alla "necessità" di farne un padre della patria, visto che Renzi avrebbe avuto una via "quasi obbligata" (Massimo Giannini, 16 aprile).
L’espressione "non ci sono alternative", non casualmente una delle preferite da Margaret Thatcher per giustificare la durissima repressione sociale, è, in genere, causa delle maggiori nefandezze. Nel nostro caso non si tratta di "necessità» bensì di una conclamata «sintonia» per una prospettiva di bipartitismo forzoso su cui Renzi e Berlusconi giocano il futuro delle loro fortune politiche. Ma la questione centrale su cui gli autorevoli opinionisti svolazzano entrambi, l’uno auspicando il superamento definitivo di «una guerra finita da tempo», l’altro facendo appello allo stato di necessità, è la compatibilità del quadro che esce dalle sentenze Berlusconi, Dell’Utri, Previti, con qualsiasi ruolo di rilevanza politica, figuriamoci con quello di «padre della patria». In realtà, su questo, la guerra non c’è mai stata.
Il dilemma, in fondo, è piuttosto semplice: le sentenze dicono il vero o sono il frutto della falsificazione di una magistratura politicizzata? La seconda ipotesi è sostenuta, con forza, non solo dai condannati, ma da aree politiche e d’opinione relativamente ampie. Gli autorevoli devono dirci se la condividono o meno. Penso di sì, perché è l’unica ipotesi in perfetta coerenza con i loro svolazzamenti. Diranno che Berlusconi ha i voti e il loro è semplicemente realismo politico. Non di realismo si tratta, invece, ma dell’accettazione, della condivisione di quello stato di necrosi che caratterizza il tessuto connettivo civile in Italia. Ovviamente è del tutto inutile chiedere ai molti «autorevoli» di uscire dal recinto in cui stanno comodi e protetti, ma forse non è inutile chiedere a chi sta fuori il recinto, in vari e articolati modi, di assumere il quadro che emerge dalle sentenze come uno dei problemi essenziali delle iniziative politiche in corso. Il berlusconismo non è il fascismo, certo, ma il solo modo di uscirne davvero è quello della cesura netta, sia pure in forme diverse, con la quale l’Italia è uscita dal fascismo. Sappiamo bene che nemmeno le cesure sono in grado di tagliare davvero la vischiosità profonda dei processi storici, pur tuttavia sono i soli momenti che possono segnare una, seppur parziale, discontinuità radicale.
I compagni, i professoroni, i professori qualsiasi (come chi scrive), devono prendere coscienza che anche questa via d’uscita dal berlusconismo, e da tutti gli affinismi col berlusconismo, è una «via maestra». La battaglia difficile per l’affermazione della lista L’altra Europa con Tsipras non può ignorare il problema. L’Italia deve presentarsi in Europa anche con una forza che rappresenti davvero l’antitesi a un volto del paese sfigurato dal morbo criminal-politico. Frutto di quella «passata di peste» che Paolo Volponi, profeticamente, aveva visto sopraggiungere più di vent’anni fa.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. -- “Ali Babà e i Quaranta Ladroni”. Corruzione, la parola che manca alla politica (di Furio Colombo)20 aprile 2014
Corruzione, la parola che manca alla politica
di Furio Colombo (il Fatto, 20.04.2014)
Il giorno 15 aprile il New York Times, edizione internazionale, ha aperto il giornale (due colonne a destra, impaginazione rara e drammatica) con un articolo datato da Roma, che ha questo titolo: “La mafia allunga i tentacoli e cresce”.
Il paesaggio è l’Europa, dove la mafia pianta sempre più bandierine. Ma i nomi, i luoghi dei quartieri generali, le organizzazioni da cui partono sempre nuove e anche fantasiose iniziative, sono tutte italiane.
L’articolo continua occupando gran parte di pag. 4 di uno dei grandi quotidiani del mondo e sembra inviare un messaggio ai simpatici alleati italiani: niente da dichiarare? Erano i giorni in cui in Italia si stava facendo un grande discutere di reati di mafia, ma come materia di scontro politico in Parlamento, non come presa d’atto di una realtà tragica che chiede una lotta senza quartiere.
Erano le stesse ore in cui, tramite passaggio in Libano, si stava preparando uno scivolo per consentire al noto senatore Dell’Utri di saltare fuori dal rischio della prigione (sette anni per una questione di mafia). Gli stessi giorni in cui veniva consentito a Silvio Berlusconi di scontare un anno residuo di prigione in comode rate da quattro ore alla settimana. È lo stesso Berlusconi che mentre era a capo del governo italiano, da un palco elettorale, abbracciato a Dell’Utri, ha dichiarato “eroe italiano” un assassino di mafia condannato a vari ergastoli. Può farlo perché va e viene, come statista (definizione sua, ma evidentemente accolta nelle istituzioni italiane), tra i vertici del potere.
I CITTADINI, ormai si sono arresi e - quelli non caduti in depressione o nella chiusura della fabbrica - pensano: “Si vede che adesso in Italia si fa così”. Sperano che Renzi ce la faccia (non si sa esattamente che cosa vuol dire, ma funziona come ultima speranza), sperano che i poliziotti non picchino troppo forte i loro figli, in caso di corteo esasperato. E si sono persuasi, ormai, che Silvio Berlusconi sia il padre di questo governo e anche il padre delle riforme che il governo ha fatto (per ora solo mezza legge elettorale e mezza chiusura del Senato) e di quelle che certamente si faranno, tanto ci sono anni di tempo.
Il New York Times però ha insistito per dare una mano a questa Italia stremata, tenuta sveglia da un animatore di giochi. Attenzione, alla vostra politica manca una parola. Infatti, qualunque sia la crisi che viviamo, manca la parola corruzione. È come se, di fronte alla roccia impenetrabile di Ali Babà, nessuno avesse potuto dire “abracadabra”, la parola magica che smuove l’ostacolo e apre magicamente il passaggio verso il tesoro rubato.
Le fiabe, si sa, sono un modo per narrare la realtà. In questo caso si tratta di una fiaba di potere, tanto che il suo titolo è “Ali Babà e i Quaranta Ladroni”. Si trattava di batterli in astuzia e bravura. L’idea, invece è stata di fare un governo insieme. E una disorientata folla mista continua a sostare davanti alla caverna cercando non come entrare ma come tenere a bada coloro che avrebbero potuto pronunciare la parola magica, per iniziare il grande inventario.
Si poteva avviare il discorso sui tagli alla Sanità senza confrontarsi con il problema dell’immenso assalto e del continuo, accurato depredare della Sanità da fuori e da dentro, con un attivismo senza tregua? Si poteva affrontare il dibattito sul lavoro e sul “cuneo fiscale” senza tentare di calcolare la vasta quantità di tasse occulte che la malavita impone a quasi ogni attività produttiva in Italia e, adesso apprendiamo, anche in Europa ma a beneficio dell’Italia ricca e clandestina?
Si poteva esaltare e sostenere un programma di grandi opere (quelle che “danno lavoro” e “muovono l’economia”) senza domandarsi (ci sono fonti serie, accurate, informatissime a partire da Roberto Saviano) come affrontare l’infezione “tangenti politiche” che gravano fin dalla radice su ogni progetto, e durano fino alla consegna, che spesso (per la grande opera) non arriva mai, ma è pronta cassa per gli strani gruppi misti di politica e imprese che credono di usare la mafia e ne sono sempre usate?
Tutto ciò, come racconta il lungo articolo del New York Times, e come molto prima aveva avvertito Saviano, è zona infetta, dunque coltura adatta alla mafia, adatta a sostenerla e a moltiplicarla. Per questo la mafia cresce e cresce la malavita. Cresce dentro i luoghi e le istituzioni che dovrebbero combatterla.
FINO A BERLUSCONI, Dell’Utri, Previti e classe dirigente della “rivoluzione liberale” con cui Berlusconi ha ingannato l’Italia e chi gli ha creduto (un po’ anche, i governi amici) qualcuno poteva dire che non era così chiaro il rapporto fra corruzione, diffusa e mafia, in Italia. Adesso lo è, al punto di dubitare sulla sequenza causa-effetto. Tre poteri ormai si riversano (e allo stesso tempo si nutrono) in un mare di corruzione: la politica, il potere privato e la mafia. La mafia conduce sempre, e questo è il grido d’allarme del giornale americano. Sullo schermo del nuovo, auto-elogiatissimo governo scorrono in continuazione cifre di misure in cui si toglie ai poveri per dare ai poveri o si fanno acrobazie per racimolare pochi soldi per colmare (invano) una immensa diseguaglianza.
Su un altro schermo, che la maggioranza di noi non vede, scorrono le immense cifre della corruzione che non è conosciuta, non è intercettata, non è nei programmi di nessuno. Un grande vuoto fa da contenitore al male che impedisce ogni ritorno dell’Italia alla normalità e la rende pericolosa e infetta. Per ora, avrete notato, non si levano voci. Anzi, di solito cambiamo discorso.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- L’ONU ALLA SANTA SEDE: HAI PROTETTO I PEDOFILI, NON I BAMBINI.10 febbraio 2014, di Federico La Sala
L’ONU ALLA SANTA SEDE: HAI PROTETTO I PEDOFILI, NON I BAMBINI *
37504. ROMA-ADISTA. Bocciata la Santa Sede sull’applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti del fanciullo (Crc), che ha sottoscritto nel 1990. L’apposito Comitato Onu di vigilanza, con sede a Ginevra, ha emesso il 5 febbraio un rapporto di sedici pagine, al termine di un lungo percorso di interlocuzione fra le parti (v. Adista Notizie nn. 28/13 e 3/14), in cui condanna il comportamento della sede apostolica in particolare riguardo agli abusi perpetrati da preti su bambini. E, pur prendendo nota dell’impegno espresso dalla delegazione della Santa Sede sulla inviolabilità della dignità e dell’integrità personale di ogni bambino, detta una serie di misure che la Santa Sede dovrà rispettare per superare l’esame in futuro. «La Santa Sede - ha detto, esponendo il rapporto, la presidente del Comitato, Kristen Sandberg - ha sistematicamente posto la preservazione della reputazione della Chiesa e la protezione degli autori degli abusi al di sopra dell’interesse per i minori».
La Santa Sede nega ogni responsabilità, dato il suo quadro giuridico. Il portavoce, p. Federico Lombardi, aveva già precisato a metà gennaio (v. ancora Adista Notizie n. 3/14) «la natura particolare della Santa Sede come soggetto di diritto internazionale che aderisce alla Convenzione, in particolare nella sua distinzione e nel suo rapporto con lo Stato della Città del Vaticano (che è “parte” anch’esso della Crc) e in rapporto alla Chiesa cattolica, come comunità dei fedeli cattolici sparsi nel mondo (che invece non è in alcun modo “parte” della Crc, ed i cui membri sono sottoposti alle leggi degli Stati dove vivono ed operano)».
Il Rapporto cita però direttive e prassi della Santa Sede che rendono poco credibile fin quì la tesi difensiva del Vaticano.
I crimini riconducibili alla Santa Sede
«Il Comitato è gravemente preoccupato -sintetizza il Rapporto - del fatto che la Santa Sede non abbia riconosciuto la portata dei crimini commessi, non abbia intrapreso le misure necessarie per affrontare i casi di abusi sessuali sui minori e per proteggere i bambini e abbia adottato politiche e prassi che hanno condotto alla continuazione dell’abuso con impunità dei responsabili». Poi entra nello specifico: «Pedofili ben noti sono stati trasferiti di parrocchia in parrocchia o in altri Paesi nel tentativo di coprire tali crimini, pratica questa documentata da numerose Commissioni nazionali di inchiesta» e permettendo «a molti preti di restare a contatto con i bambini e di continuare ad abusarne»; «la Santa Sede ha stabilito la sua piena giurisdizione sui casi di abusi sessuali su minori nel 1962 e li ha posti nel 2001 [v. Adista n. 87/01] sotto l’esclusiva competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede», e tuttavia «ha declinato di fornire al Comitato i dati relativi a tutti i casi di abusi sessuali sui minori portati alla sua attenzione nel periodo delle denunce e come risultato dei processi interni»; «l’abuso sessuale sui minori» è stato trattato come «grave delitto contro la morale» tramite «procedure confidenziali»; «a causa di un codice del silenzio, imposto a tutti i membri del clero sotto pena di scomunica, i casi di abuso sessuale non sono quasi mai stati denunciati alle autorità giudiziarie dei Paesi dove questi crimini erano avvenuti» e si è dato il caso «di preti e suore rimossi e licenziati per non aver rispettato l’obbligo del silenzio», mentre altri «sono stati gratificati per aver rifiutato di denunciare i responsabili degli abusi come dimostra la lettera rivolta dal card. Darío Castrillón Hoyos al vescovo Pierre Pican nel 2001» (v. Adista n. 63/01); e ancora, la «denuncia alle autorità giudiziarie non è mai stata obbligatoria ed è stata esplicitamente rifiutata in una lettera ufficiale destinata ai membri della Conferenza episcopale irlandese dal vescovo Moreno e dal nunzio Storero nel 1997 [v. Adista n. 5/11]. In molti casi le autorità ecclesiastiche anche ai livelli più alti della Santa Sede hanno mostrato riluttanza e in alcuni casi hanno rifiutato di cooperare con le autorità giudiziarie e con le commissioni nazionali di inchiesta».
Fra le misure per ovviare a queste gravi pecche, il Comitato «sollecita» la Santa Sede, fra l’altro, ad «assicurarsi che la Commissione sulla protezione dei fanciulli creata nel dicembre 2013 investighi in modo indipendente tutti i casi di abuso sessuale su minori così come la condotta della gerarchia cattolica nell’affrontarli»; a rimuovere tutti i sacerdoti colpevoli o sospettati di pedofilia dai loro incarichi e il loro deferimento alle autorità giudiziarie; a «rivedere il Diritto Canonico allo scopo di considerare l’abuso sessuale sui minori come crimine e non come delitti contro la morale».
La reazione della Santa Sede
«La prima reazione è di sorpresa perché - ha detto ai microfoni della Radio Vaticana il 5/2 mons. Silvano Maria Tomasi, osservatore permanente vaticano presso gli Uffici Onu a Ginevra - l’aspetto negativo del documento che hanno prodotto sembra quasi che fosse già stato preparato prima dell’incontro del Comitato con la delegazione della Santa Sede, che ha dato in dettaglio risposte precise su vari punti, che non sono state poi riportate in questo documento conclusivo o almeno non sembrano essere state prese in seria considerazione. Di fatto il documento sembra quasi non essere aggiornato, tenendo conto di quello che in questi ultimi anni è stato fatto a livello di Santa Sede, con le misure prese direttamente dall’autorità dello Stato della Città del Vaticano e poi nei vari Paesi dalle singole Conferenze episcopali». «La Santa Sede risponderà», assicura, ha ratificato la Convenzione e intende osservarla nello spirito e nella lettera», ma «senza aggiunte ideologiche o imposizioni che esulano dalla Convenzione stessa», aggiunge. «La Convenzione sulla protezione dei bambini - specifica a seguire, in qualche modo, sottraendo legittimità alla Crc - nel suo preambolo parla della difesa della vita e della protezione dei bambini prima e dopo la nascita; mentre la raccomandazione che viene fatta alla Santa Sede è quella di cambiare la sua posizione sulla questione dell’aborto! [v. più avanti] Certo, quando un bambino è ucciso non ha più diritti! Allora questa mi pare una vera contraddizione con gli obiettivi fondamentali della Convenzione».
Se viene riconosciuto alla Santa Sede, come si sostiene nell’introduzione del rapporto conclusivo, che ha risposto esaustivamente a tutte le domande rivoltele dal Comitato, afferma mons. Tomasi, allora tanta negatività del Rapporto fa sorgere un sospetto: «Probabilmente, delle Organizzazioni non governative, che hanno interessi sull’omosessualità, sul matrimonio gay e su altre questioni, hanno certamente avuto le loro osservazioni da presentare e in qualche modo hanno rafforzato una linea ideologica».
Dal canto suo, la Sala Stampa vaticana ha emesso un comunicato nel quale tra l’altro si legge: «Alla Santa Sede rincresce di vedere in alcuni punti delle Osservazioni Conclusive un tentativo di interferire nell’insegnamento della Chiesa Cattolica sulla dignità della persona umana e nell’esercizio della libertà religiosa. La Santa Sede reitera il suo impegno a difesa e protezione dei diritti del fanciullo, in linea con i principi promossi dalla Convenzione sui Diritti del Fanciullo e secondo i valori morali e religiosi offerti dalla dottrina cattolica».
E c’è dell’altro
A cosa si riferisca il comunicato della Sala Stampa quando parla di «tentativo di interferire nell’insegnamento della Chiesa» è presto detto: il Rapporto steso dal Comitato dell’Onu individua una violazione dei diritti del bambino anche nelle conseguenze della dottrina cattolica su famiglia, contraccezione, aborto, protezione dall’Aids. Il Comitato infatti snocciola una serie di ulteriori preoccupazioni, fra le quali: la Santa Sede «non riconosce l’esistenza di una pluriformità di famiglie con la conseguenza di una discriminazione dei bambini sulla base della loro situazione familiare»; nega agli adolescenti «l’accesso alla contraccezione» e all’informazione sulla «salute sessuale e riproduttiva» con il corollario di alta mortalità e morbilità a causa di «premature e indesiderate gravidanze, aborti clandestini» e infezioni da Hiv.
Fra le svariate raccomandazioni riscontrabili nel Rapporto, poi, anche quella di «trasmettere queste conclusioni al papa, alla Curia, alla Congregazione per la Dottrina della Fede, a quella per l’Educazione cattolica e al Pontifico Consiglio per la Pastorale della Salute e di quello per la Famiglia». E che non rimangano senza né vescovi, né «individui e istituzioni che ricadono sotto l’autorità della Santa Sede». Sono tutti responsabili. (eletta cucuzza)
* Adista Notizie n. 6 del 15/02/2014
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- Rapporto dell’Onu processa la Santa Sede. Il sistema pedofilo vaticano - Una catena di comando ha occultato tutto.6 febbraio 2014, di Federico La Sala
Il sistema pedofilo vaticano
Rapporto dell’Onu processa la Santa Sede: rimuovete e fate processare tutti i preti colpevoli
di Giampiero Gramaglia (il Fatto, 06.02.2014)
Nel giorno in cui 25.000 persone ascoltano l’esortazione di Papa Francesco nell’udienza generale, “che i bambini si preparino bene alla Prima Comunione e che tutti la facciano”, ultima versione dell’evangelico “lasciate che i bambini vengano a me”, le Nazioni Unite pubblicano un atto d’accusa durissimo contro il Vaticano per i preti pedofili e per le posizioni sull’omosessualità (e pure per l’aborto e la contraccezione). L’attacco frontale è in un rapporto del Comitato dell’Onu sui diritti dell’infanzia diffuso a Ginevra.
Non è la prima volta che il fiume carsico della pedofilia, che ha traversato invisibile e silente quasi cinque secoli di storia della Chiesa, prima di emergere alla superficie con violenza negli ultimi tre papati, crea tensioni tra la gerarchia cattolica e la società civile. Ma forse mai in passato l’atto d’accusa era stato così radicale. Kirsten Sandberg, norvegese, presidente del Comitato, afferma che il Vaticano ha violato, e tuttora viola, la Convenzione dell’Onu sui diritti dell’infanzia: “La Chiesa viola la Convenzione perché non ha fatto tutte le cose che doveva fare”.
IL RAPPORTO non ha riguardi per la Santa Sede, trattata alla stregua d’uno Stato qualsiasi (senza distinguo e senza favori). La reazione del Vaticano è pronta. Ma monsignor Silvano Tomasi, capo delegazione della Santa Sede presso il Comitato, peggiora - se possibile situazione, denunciando a Radio Vaticana l’ingerenza nella stesura del rapporto di lobbies omosessuali.
L’arcivescovo è sorpreso: “Pare che il testo fosse già stato preparato prima dell’incontro tra il Comitato e la nostra delegazione”, il mese scorso. “Abbiamo dato risposte precise su vari punti, che non sono state né riportate né prese in considerazione... Il documento muove da tesi ideologiche”.
Il rapporto chiede che vengano “immediatamente rimossi” e consegnati alle autorità civili i prelati coinvolti in abusi su minori o sospettati di esserlo; e pretende che la Santa Sede renda accessibili i propri archivi in modo che chi ha abusato e “quanti ne hanno coperto i crimini” possano essere chiamati a risponderne davanti alla giustizia. Fra le richieste, quelle di scoprire quanti siano “i figli di sacerdoti”.
“Il Comitato - si legge nel rapporto - è gravemente preoccupato dal fatto che la Santa Sede non abbia riconosciuto l’ampiezza dei crimini commessi, non abbia preso le misure necessarie per affrontare i casi di abusi sessuali e per proteggere i bambini e abbia anzi adottato politiche e pratiche che hanno portato a una continuazione degli abusi e all’impunità dei responsabili”.
IL VATICANO è tra i firmatari della Convenzione dell’Onu sui diritti dell’infanzia, approvata dall’Assemblea generale nel 1989. Il testo definisce i diritti fondamentali da riconoscere e garantire ai minori e prevede un controllo sull’operato degli Stati, che devono stilare un rapporto periodico sul rispetto dei diritti dei bambini nel proprio ambito. La Santa Sede ratificò la convenzione nel ’94, ma fino al 2012 non ha consegnato nessun rapporto, neanche dopo le rivelazioni sui casi di abusi, le migliaia di denunce e l’allontanamento dal sacerdozio di centinaia di preti.
Il documento dell’Onu esorta, inoltre, il Vaticano a rivedere le posizioni su aborto, contraccezione e omosessualità. Sull’aborto, quando “è a rischio la vita e la salute delle donne incinte, modificando il canone 1398 in materia” - il rapporto cita un caso del 2009 in Brasile, in cui madre e medico fecero abortire una bambina di 9 anni rimasta incinta dopo la violenza del patrigno -. Sulla contraccezione, per tutelare le adolescenti e prevenire l’Aids.
Per l’omosessualità, il Comitato dell’Onu sollecita la Chiesa a sostenere gli sforzi per depenalizzarla e “fare pieno uso della sua autorità morale per condannare tutte le forme di molestie, discriminazione e violenza contro i minori sulla base del loro orientamento sessuale e/o di quello dei loro genitori”.
Nel rapporto, infine, il Comitato esprime “preoccupazione” per “la sorte degli adolescenti reclutati dalla Legione di Cristo e da altre istituzioni cattoliche, separandoli dalle loro famiglie e isolandoli dal mondo esterno”. E chiede di assicurare “canali accessibili, confidenziali ed efficaci” ai bambini “vittime o testimoni di abusi”, assistendo le famiglie e prevenendo qualsiasi altra forma successiva di violenza.
Una catena di comando ha occultato tutto
di Marco Politi (il Fatto, 06.02.2014)
Città del Vaticano La folgore dell’Onu cade sul Vaticano e illumina violentemente colpe, omissioni, ritardi nel contrastare gli abusi sessuali del clero. Al tempo stesso costringe la Santa Sede a rendere conto di quanto ancora non sta facendo per portare alla luce i crimini commessi e assicurare alla giustizia i preti delinquenti.
Ci sono passaggi nel rapporto del Comitato per i diritti dell’infanzia, che sembrano scritti prima del 2010 quando Benedetto XVI fece pubblicamente mea culpa (nella sua lettera ai cattolici d’Irlanda) per i silenzi della Chiesa, il mancato ascolto delle vittime, la disapplicazione delle norme canoniche che punivano il crimine, l’assenza di intervento dei vescovi e - testualmente - la “preoccupazione fuori luogo per il buon nome della Chiesa e per evitare gli scandali”.
Allora e in seguito Benedetto XVI ribadì più volte che i preti colpevoli dovevano sottoporsi alla giustizia civile. Sia Ratzinger che Bergoglio hanno inasprito la normativa del codice canonico e - a differenza della giustizia civile - i delitti cadono ora in prescrizione solo vent’anni dopo il raggiungimento della maggiore età della vittima. C’è quindi un prima e un dopo.
DELLA STAGIONE precedente fa parte una catena di comando che non ha funzionato. La gran massa dei vescovi ha trattato il problema proteggendo generalmente i colpevoli. Esemplare il caso del cardinale Bernard Francis Law, arcivescovo di Boston, trasferito a Roma alla basilica di Santa Maria Maggiore da Giovanni Paolo II per evitargli disavventure con la giustizia americana.
Non ha funzionato il controllo della Congregazione del Clero. Vergognosa la lettera che il prefetto della congregazione, cardinale Castrillon Hoyos, scrive nel 2001 al vescovo francese Pican per complimentarsi di non aver denunciato alla magistratura un prete, poi condannato per abuso di undici minori.
Non ha funzionato, negli anni del pontificato di Giovanni Paolo II, la Congregazione per la dottrina della fede guidata dall’allora cardinale Ratzinger: congregazione troppo lenta, troppo legalistica nel reagire ad una serie di casi gravissimi venuti poi alla luce sulla stampa internazionale, troppo silenziosa sui crimini del fondatore dei Legionari di Cristo.
Non ha funzionato la segreteria di Stato, retta dal cardinale Sodano, proprio nel caso eclatante di Marcial Maciel Degollado: il governo centrale della Chiesa non ha dato nessun seguito a lettere ufficiali pervenute tramite i nunzi e a denunce pubbliche sulla stampa.
Papa Francesco nel suo primo incontro con l’attuale prefetto della Congregazione per la dottrina della fede ha ribadito l’impegno della Chiesa a combattere la pedofilia nelle proprie file.
Il rapporto Onu, rifacendo tutta la storia, mette però in luce tutto ciò che oggi ancora non funziona. Vale poco l’obiezione di parte ecclesiastica che la Chiesa non è una multinazionale e il Vaticano non ne sarebbe il quartiere generale. Perchè certo il pontefice non può sapere cosa fa cosa fa un prete in Amazzonia, tocca al vescovo vigilare. Ma spetta ai papi e al loro governo vigilare che tutto l’organismo rispetti e applichi le leggi, che la Chiesa stessa si è data. Tanto più che il cattolicesimo gode - unico fra le religioni - di una fisionomia statuale. E allora il centro deve rendere conto del funzionamento delle sue norme in periferia.
C’è da fare moltissimo. Benedetto XVI incaricò le conferenze episcopali di dotarsi di Linee-guida per contrastare il fenomeno. Ci sono conferenze episcopali, che si sono dotate di strutture nazionali e diocesane serie, e ci sono conferenze episcopali - fra cui brilla la Cei - che finora si sono rifiutate in tutti i modi di assumersi responsabilità nel fare applicare le norme ecclesiastiche. È un atteggiamento di fuga, che non può continuare.
Dopo il rapporto del comitato Onu per i diritti dell’infanzia è evidente che dal Vaticano devono arrivare indicazioni cogenti per tutti - con la creazione di strutture ecclesiali locali e nazionali per scoprire i crimini - se la Santa Sede non vorrà trovarsi di nuovo fra tre anni sul banco degli accusati.
INOLTRE non è tollerabile restare a metà del guado rispetto al dovere di denuncia alla magistratura. In coerenza con gli auspici di Benedetto XVI, il Vaticano la deve dichiarare obbligatoria. Se la pedofilia è un crimine, come ha ricordato papa Francesco ai giornalisti tornando dal Brasile, l’omertà di un vescovo non è sostenibile.
Dire ad esempio, come fa la Cei, che in Italia il vescovo non è un pubblico ufficiale, è ridicolo. Perché? Se io privato cittadino vedo che per strada massacrano una vecchietta, che faccio? Tiro avanti zitto perché non sono un pubblico ufficiale?
Il lavoro del comitato di Ginevra si sta rivelando prezioso. Grazie alle audizioni, cui sono stati chiamati i rappresentanti vaticani, è emerso che Benedetto XVI in due anni ha espulso 384 preti indegni. Bene. Il rispetto delle vittime esige che siano aperte inchieste in tutti i Paesi perché vengano alla luce i crimini nascosti e avvolti nel silenzio. Papa Francesco lo sa dall’esperienza che hanno fatto i suoi connazionali in Argentina.
Quando è in gioco la violazione dei diritti umani non esiste una trasparenza a metà. Non si fa pace con il passato, se prima non si porta alla luce tutta la verità. Chiarendo chi è stato colpevole e chi complice. Il comitato ha toccato anche un punto delicato, che finora era stato sempre rimosso: il destino dei figli dei preti. Non c’è dubbio che tutto ciò rappresenti una sfida per il pontificato di Francesco. Ma la Chiesa non può eluderla.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- Una «deriva etica». Dov’è l’etica pubblica? Con il condannato non si discute.20 gennaio 2014, di Federico La Sala
Rodotà: dov’è l’etica pubblica?
Stefano Rodotà, ospite ieri sera di Fabio Fazio a Che tempo che fa, è stato molto critico sull’incontro Renzi-Berlusconi, accusando una «deriva etica»: «Per chi è cittadino del Paese e ritiene che ci sia da ricostruire un’etica pubblica e civile, abbiamo perduto tutta la memoria se non ricordiamo che Silvio Berlusconi è stato condannato a agosto e che solo da poche settimane è stata dichiarato decaduto da senatore».
Rodotà fa notare che solo «uno solo tra i commentatori ha detto che Berlusconi a breve sarà o ai domiciliari o ai servizi sociali e allora c’è un’anomalia se abbiamo bisogno di rilegittimare chi si trova in questa condizione». Anche perché a quel punto l’ex premier dirà, «guardate oggi che sono un padre della patria che modifica la Costituzione, come mi tratta questa giustizia».
Dubbioso anche sulla legge elettorale: il sistema spagnolo «favorisce i grandi partiti» e le liste bloccate sono state bocciate dalla Consulta e hanno fatto «allontanare i cittadini dalla politica». Rodotà, inoltre, non è sicuro che con una legge elettorale proporzionale (se non si approvasse una nuova legge) si avrebbe lo stesso risultato alle urne. Dubbi anche sul Senato delle autonomie: «Se resta alla Camera il voto di fiducia, su leggi importanti anche la seconda Camera deve poter dire la sua».
* l’Unità 20.1.14
Con il condannato non si discute
di Marco Politi (il Fatto, 18.01.2014)
Si può fare una riunione del consiglio scolastico con il professore pedofilo per discutere di programmi educativi dell’anno 2013/2014? Non si può. Non c’è da spiegare molto. Non si può. In Italia sta accadendo di peggio. Tra poche ore saremo informati che un aspirante premier, leader del maggiore partito politico italiano, ha incontrato un pregiudicato per discutere di affari di Stato: una legge elettorale, l’abolizione del Senato elettivo. Stiamo parlando di elementi cardine del sistema costituzionale. I media italiani - t elevisione e carta stampata - stanno banalizzando l’evento in maniera imbarazzante. Quasi si trattasse della normale prosecuzione dell’uso del potere, che Berlusconi ha accumulato negli anni, e delle inevitabili (o evitabili) trattative politiche che si fanno con chi detiene una fetta di potere. Non è così.
Come diceva un diplomatico francese, “le forme non sono importanti, salvo quando vengono meno”. In certi quartieri di Palermo, se ti occupano abusivamente la casa, puoi andare dalla polizia e dai giudici - e l’esito sarà lungo, forse incerto - oppure ti rechi dal capomafia di quartiere. Entro ventiquattr’ore l’abusivo sparisce. Ma non è gratis. Non perché lo ‘zu ti chiede soldi, non è mica un poveraccio... quando sarà ti presenterà il conto.
Berlusconi è un personaggio condannato e interdetto. C’è un prima e un dopo, sebbene un’insistente ondata propagandistica tenti di confondere le acque. Prima della condanna definitiva era una personalità che a buon ragione risultava repellente a molti e - in nome del libero arbitrio - poteva piacere ad altri. Dopo la sentenza della Cassazione il suo status è mutato per una sentenza emessa in nome del “popolo italiano”, che ha - dovrebbe avere - una valenza nazionale. È una persona caratterizzata da una “naturale capacità a delinquere mostrata nella persecuzione del (proprio) disegno criminoso”, come hanno sancito i giudici del processo Mediaset.
CON LA FRESCA arroganza di chi è pervenuto a un posticino di potere per grazia del sovrano, l’economista Filippo Taddei membro della segreteria del Pd ha dichiarato l’altra mattina a Omnibus a chi gli chiedeva dei dubbi sull’incontro Renzi-Berlusconi: “Francamente non capisco il senso della questione”. Peccato, perché è ipotizzabile che abbia viaggiato in Europa e si sa per certo che ha vissuto negli Stati Uniti.
L’incontro tra un politico incensurato e un pregiudicato è inconcepibile in qualsiasi capitale democratica dell’Occidente. Un evento del genere è escluso a Washington come a Berlino, a Parigi come a Londra. Nixon era stato eletto nel 1972 con 47 milioni di voti. Nel momento in cui fu riconosciuto responsabile dei reati connessi allo scandalo Watergate, non fu più un interlocutore per nessuno. Punto. I democratici americani hanno continuato ovviamente a trattare e fare politica con i repubblicani, ma il colpevole di reati era pubblicamente fuori gioco. Perché c’è un confine invalicabile tra l’onorabilità pubblica prima e dopo una condanna.
Anzi nei paesi anglosassoni e a democrazia matura c’è anche un secondo confine, quello della condotta “appropriata” o “inappropriata”, che riguarda la correttezza del comportamento pubblico e prescinde dai procedimenti penali. Per cui il politico, beccato con lo scontrino delle mutande messo in conto al contribuente, sparisce subito dalla circolazione e nessuno dei suoi sodali di partito grida al complotto. Semplicemente perché “non si può”.
In Italia la classe politica rimuove costantemente questo discrimine di etica pubblica per cui i più grandi cialtroni possono gridare che non sono indagati, facendoci ridere dietro all’estero. Ma pazienza. La maggioranza paziente si accontentava di aspettare le sentenze definitive della magistratura, augurandosi che avessero un senso erga omnes.
Il fatto che da noi si voglia ora platealmente varcare il limite tra chi ha la titolarità di buona fede per stare sulla scena pubblica è chi è interdetto per gravi reati costituisce un ulteriore allontanamento dell’Italia dallo standard dei paesi europei e occidentali. Dove “ulteriore” significa ammettere con tristezza che l’ultimo ventennio ha visto il nostro paese scendere sempre più in basso, ma c’era la speranza piccola, flebile, che il novembre 2011 e l’accertata criminalità con sentenza definitiva dell’agosto 2013 potesse segnare un piccolo, graduale passo verso il ritorno all’Europa.
DICIAMO, a scanso di equivoci, che a milioni di cittadini delle beghe interne del Pd non interessa niente. E meno che mai interessa il politichese con cui il vertice imminente (o avvenuto) viene ammantato. Ci sono invece milioni di cittadini, che pagano le tasse, e tanti milioni che a destra, centro e sinistra sentono il valore della legalità e vorrebbero uscire dal degrado istituzionale. E c’è quell’umanità pulita vista due anni fa in Piazza del Popolo nel giorno di “Se non ora, quando? ” .
Questa Italia capisce perfettamente il “segno” di questo vertice voluto da Renzi, che cancella il confine tra ciò che è sostenibile nel costume democratico e ciò che non lo è. Che mette sullo stesso piano della presentabilità l’evasore e chi non lo è.
Raccontava Piercamillo Davigo che nei dibattiti, quando il discorso scivolava sul “tanto rubano tutti”, lui si fermava e domandava: “Lei ruba? Io no. Allora siamo già in due”. Tanto per rimarcare la frontiera. Da oggi, nella società di comunicazione visiva in cui siamo immersi, il messaggio è chiarissimo. Tra Davigo e Berlusconi non c’è nessuna differenza.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- LA NUOVA "BANALITA’ DEL MALE" (di Bruno Forte)..5 gennaio 2014, di Federico La Sala
A 50 anni dal libro di Hannah Arendt
LA NUOVA "BANALITA’ DEL MALE"
di Bruno Forte (Il Sole-24 Ore, 05.01.2014) *
Esattamente cinquant’anni fa Hannah Arendt, la filosofa ebrea tedesca allieva di Martin Heidegger e di Karl Jaspers, pubblicava l’edizione definitiva del suo libro "La banalità del male", frutto del lavoro svolto a Gerusalemme come inviata del "New Yorker" per seguire lo storico processo ad Adolf Eichmann. Il criminale nazista responsabile dello sterminio di milioni di Ebrei era stato catturato l’anno prima a Buenos Aires dove aveva vissuto indisturbato per anni.
Il "reportage" della Arendt si sviluppava in una serie preziosa di considerazioni morali, che furono poi raccolte e ampliate nel libro. La tesi che emerge dalle straordinarie pagine di questo testo è per molti aspetti sconcertante: «Il guaio del caso Eichmann era che di uomini come lui ce n’erano tanti e che questi tanti non erano né perversi né sadici, bensì erano, e sono tuttora, terribilmente normali. Dal punto di vista delle nostre istituzioni giuridiche e dei nostri canoni etici, questa normalità è più spaventosa di tutte le atrocità messe insieme» (282). Il messaggio che scaturiva dal caso Eichmann, quello «che il suo lungo viaggio nella malvagità umana ci aveva insegnato», era per la Arendt «la lezione della spaventosa, indicibile e inimmaginabile banalità del male» (259).
Su questa lezione mi sembra importante ritornare perché, fatte salve le ovvie differenze fra quello che fu "il male assoluto" e quelli che sono i mali del nostro presente, non c’è dubbio che molti di essi derivino dalla mentalità del "così fan tutti", giustificata dai cattivi maestri della scena pubblica, in particolare di quella politica. Provo ad articolare questa riflessione sull’insinuante presenza della "banalità del male" su tre fronti, che convergono nel male endemico e distruttivo della corruzione: la perdita diffusa del senso del dovere; il rimando alle altrui responsabilità per scaricare le proprie; la disaffezione nei confronti del bene comune, a favore di quello personale o della propria "lobby".
Il senso del dovere è a fondamento della coscienza morale e del comportamento che ad essa si ispira. Nella sua essenza esso consiste nella disposizione ferma a compiere il bene perché è bene e a fuggire il male per l’unica ragione che è male. Applicato all’etica del lavoro questo principio comporta la cura rigorosa da mantenere nell’assolvimento dei propri compiti, a prescindere dal riconoscimento altrui e dalla ricerca pur così naturale di gratificazioni.
Fare bene ciò di cui si è incaricati - purché ovviamente non contrasti con la legge morale inscritta in ciascuno di noi, com’è riassunta nei precetti del Decalogo - vuol dire contribuire alla qualità della vita di tutti, fino a poter avvertire il senso del giusto orgoglio di aver fatto la propria parte per migliorare l’esistenza collettiva. Essere paghi del bene compiuto non è egoismo: esattamente al contrario è uno dei volti dell’amore per gli altri, che è alla base della legge morale.
Un servitore dello Stato che rimandasse colpevolmente a domani ciò che può fare oggi nel dare risposte a chi richiede i suoi servizi, specialmente nell’ambito delle necessità dello stato sociale, cadrebbe in una mancanza etica, che dovrebbe pesargli a prescindere da qualsivoglia sanzione (peraltro spesso inesistente o ignorata).
Si pensi, per fare due esempi ben noti, ai tanti casi di esasperante lentezza della giustizia o ai continui rimandi della politica nell’affrontare questioni urgenti e necessarie, come la riforma dell’attuale, pessima legge elettorale. Se questa sensibilità morale è richiesta specialmente a chi deve assolvere a un servizio pubblico, essa mi sembra sia doverosa per tutti, perché indispensabile al bene di tutti.
La perdita del senso del dovere viene per lo più giustificata dal rimando alle responsabilità altrui: se sono i capi a dare il cattivo esempio, si comprende come il meccanismo di deresponsabilizzazione si diffonda a macchia d’olio.
I cattivi maestri si possono trovare tuttavia in molti ambiti della scena pubblica: si tenga conto dell’influenza che hanno specialmente sui giovani alcuni comportamenti o stili di vita immorali di protagonisti dello spettacolo e dello sport; o si pensi alle autogiustificazioni o addirittura alla semplice negazione della responsabilità giuridica o morale che figure di rilievo della politica danno di propri comportamenti scorretti, perfino quando essi siano stati accertati e condannati a più livelli di azione giudiziaria. Questo modo di fare corrompe le scelte e le motivazioni di tanti: i corrotti diventano a loro volta corruttori, e questi si giustificano con la logica perversa del "così fan tutti".
È un veleno che dilaga facilmente: «Si comincia con una piccola bustarella, ed è come una droga», afferma Papa Francesco, stigmatizzando una prassi che porta tanti a dar da mangiare ai loro figli "pane sporco". In tal senso, la corruzione è peggio del peccato, perché erode in profondità la coscienza morale e induce a sguazzare nella "banalità del male".
La diffusione di comportamenti corrotti va poi di pari passo con la crescita della disaffezione al bene comune, che è forse oggi la malattia dell’anima più insidiosa per la nostra società: la sola logica che sembra debba giustificare le scelte diventa quella del "che me ne viene?". La preoccupazione del benessere proprio e della propria lobby prevale su ogni considerazione che finalizzi l’agire al maggior bene di tutti. Si perde così il senso dell’impresa collettiva, del sogno e della speranza di una giustizia più grande; si spegne nei cuori la passione per ciò che è possibile, da fare al servizio degli altri per la costruzione di un domani migliore per tutti.
Non sorprende in questo clima avvelenato che i giovani provino disgusto per l’impegno sociale e politico e preferiscano rintanarsi nel privato della propria ricerca di vantaggi e di sicurezze per il futuro. A questa mentalità che riduce il male a banalità si può reagire in un solo modo, ritrovando il senso della serietà della vita, del suo spessore morale, della dignità unica e irripetibile dell’esistenza personale.
L’indignazione, su cui insiste il fortunato pamphlet di Stéphane Hessel, il grande vecchio della resistenza francese, recentemente scomparso ("Indignez-vous!", Paris 2010, in traduzione italiana: "Indignatevi!", Torino 2011), può essere il primo passo, l’appello a un risveglio. Ciò di cui, però, c’è assoluto bisogno è l’impegno serio e perseverante al servizio del bene comune, vissuto nella fedeltà rigorosa e continua alle esigenze morali. La domanda di Gesù riassume l’antidoto necessario alla banalità del male: «Quale vantaggio ha un uomo che guadagna il mondo intero, ma perde o rovina se stesso?» (Luca 9,25).
Misurarsi sulle esigenze di un giudizio assoluto non è rifugio consolatorio, ma fondamento di un’esistenza che valga la pena di essere vissuta e di una tensione etica e spirituale in grado di dare dignità e bellezza alla fatica dei giorni, rendendo serio e grande ciò che appare o si vorrebbe ridurre a semplicemente banale. Tendere a questa serietà, amarla, custodirla ed essere pronti a pagare di persona per non rinunciarvi è l’augurio migliore che si possa fare a se stessi e agli altri in questo inizio di un anno nuovo.
* Bruno Forte è arcivescovo di Chieti-Vasto
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- La danza dei sordi (di Piero Stefani)8 dicembre 2013, di Federico La Sala
La danza dei sordi
di Piero Stefani (“Il pensiero della settimana” - http://pierostefani.myblog.it, 7 dicembre 2013)
Una leggenda ebraica attribuita al fondatore del moderno chassidismo, il Ba’al Shem Tov, racconta che c’era una volta un musicista di straordinaria bravura; quando suonava, la gente era obbligata a danzare estasiata in qualunque posto fosse. Passò di lì un sordo e vedendo i presenti agitarsi in quel modo li prese per matti. Era però lui a essere in torto, se fosse stato saggio avrebbe intuito la loro gioia e, pur non udendo, si sarebbe unito al ballo collettivo.
A prescindere dagli scopi originari per cui è stato inventato, il racconto pecca di un eccesso di ottimismo. Lo fa perché, stando alla sua versione, il sordo è l’eccezione mentre coloro che si agitano per nobili motivi sono la regola.
Se si dovesse adattare la parabola alla situazione politica del nostro Paese essa dovrebbe venir capovolta. Chi si agita in modo ditirambico sono coloro che non ascoltano, mentre chi ode se ne sta quasi impietrito di fronte a quello sconfortante spettacolo.
Il quadro sociale italiano è di inaudita (è il caso di dirlo) gravità. I dati reali parlano di nove milioni di poveri e tra essi i miserabili sono una quota rilevante. Il rapporto sulla situazione sociale del Paese 2013 del Censis - scritto peraltro in un linguaggio astruso, già di per sé spia inquietante - pur prendendo atto che non è avvenuto il paventato crollo, fornisce un quadro scoraggiante: « Una società sciapa e infelice. Quale realtà sociale abbiamo di fronte dopo la sopravvivenza? Oggi siamo una società più “sciapa”: senza fermento, circola troppa accidia, furbizia generalizzata, disabitudine al lavoro, immoralismo diffuso, crescente evasione fiscale, disinteresse per le tematiche di governo del sistema, passiva accettazione della impressiva comunicazione di massa. E siamo “malcontenti”, quasi infelici, perché viviamo un grande, inatteso ampliamento delle diseguaglianze sociali. Si è rotto il “grande lago della cetomedizzazione”, storico perno della agiatezza e della coesione sociale. Troppa gente non cresce, ma declina nella scala sociale. Da ciò nasce uno scontento rancoroso, che non viene da motivi identitari, ma dalla crisi delle precedenti collocazioni sociali di individui e ceti».
Da vent’anni, vale a dire dall’epoca di “Mani pulite” fino alla sentenza della Corte costituzionale di giovedì scorso, una serie impressionante di mutamenti nel sistema politico e in quello dei partiti lo si deve all’azione della magistratura. Si tratta di un’anomalia oggettiva. Essa da un lato ha, de facto, assegnato alla magistratura dei compiti che non le spetterebbero, mentre, dall’altro, ha evidenziato in maniera macroscopica l’inadeguatezza tanto della classe politica quanto di quella antipolitica (di passaggio la parola “antipolitica”, fino a qualche tempo fa pronunciata a ogni piè sospinto come gravissimo campanello di allarme, oggi è quasi del tutto accantonata - in ciò è paragonabile a Mario Monti - senza che, nella sostanza, nulla sia mutato).
La vicenda legata all’ultima legge elettorale approvata dal Parlamento italiano ne è una prova lampante. Dopo aver, in pratica, legittimato a 360° un nome che di per sé dovrebbe far vergognare ogni persona eletta con quel sistema, da qualche anno si è iniziato a denunciare l’urgenza prioritaria di modificarla. Ma, stando ai dati di fatto, a essere urgente era solo il dirlo - atto ormai entrato nel lessico obbligatorio - non il farlo, atto perennemente rimandato. Un escamotage per non attuare la riforma elettorale è stato, val la pena di ricordarlo, quello di legare la legge elettorale a velleitarie, e non ancora tramontate, volontà di realizzare radicali riforme costituzionali (chi si ricorda più dei “saggi”? Forse neppure Napolitano). Non occorre essere maestri del sospetto per capire che la scelta di subordinare l’ingresso nelle mura domestiche di un gatto a quelle di un elefante, significa, in pratica, che in casa non si vuole neppure il gatto.
La nostra classe politica si è dimostrata ben capace di creare e disfare raggruppamenti parlamentar- partitici o di presentare e ripresentare le primarie per la segreteria del partito o per un premierato non previsto né dalla costituzione né dai fatti (ci governa Letta non Bersani) come ultima spiaggia della democrazia. Essa però si è mostrata incapace non dico di dar un autentico ascolto al «grido di dolore» che viene dal paese, ma persino di modificare con le proprie forze un sistema elettorale indecente. Ora dovrà farlo per un imput che le viene dall’esterno a opera di un Parlamento moralmente, anche se non giuridicamente, delegittimato; a meno che non si accetti, per paralisi interna, di andare alle elezioni con la legge indirettamente stabilita dalla Corte costituzionale.
Guardato nel suo insieme, il quadro resta quello di un’ agitata danza di sordi fatta, ben s’intende, a detta dei ballerini, per il bene del Paese. Va dichiarato però che non mancano i sordi neppure tra gli spettatori. In questo gruppo rientra, per esempio, l’episcopato italiano incapace ormai da anni, salvo rare eccezioni, di dire parole davvero capaci di orientare una popolazione sempre più smarrita.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- E LA "BANDIERA DI UN’ITALIA CHE DEVE RICONQUISTARE IL (SUO) PRIMATO" (di Roberto Napoletano - "il Sole-24 ore") -1 dicembre 2013, di Federico La Sala
NOTE DI PREMESSA SUL TEMA:
- FILOSOFIA. IL PENSIERO DELLA COSTITUZIONE E LA COSTITUZIONE DEL PENSIERO
 MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA E A PENSARE BENE "DIO", "IO" E "L’ITALIA", CHI PIU’ CHI MENO, TUTTI VIVONO DENTRO LA PIU’ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA E POLITICA ITALIANA, NEL REGNO DI "FORZA ITALIA"!!! Un’inchiesta e una mappa
MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA E A PENSARE BENE "DIO", "IO" E "L’ITALIA", CHI PIU’ CHI MENO, TUTTI VIVONO DENTRO LA PIU’ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA E POLITICA ITALIANA, NEL REGNO DI "FORZA ITALIA"!!! Un’inchiesta e una mappa
BANDIERA DI UN’ITALIA CHE DEVE RICONQUISTARE IL (SUO) PRIMATOdi Roberto Napoletano (Il Sole-24 Ore, 01.12.2013)
A portare Platone in prima pagina sulla Domenica del Sole è il genio didascalico di Giovanni Reale. Il giorno dopo il suo allievo e successore, Roberto Radice, in un’aula della Cattolica di Milano, si rivolge a un gruppo di studenti e formula la seguente domanda: «Chi ha letto il pezzo di filosofia sul Domenicale?». Radice non attende risposte e chiosa: «Chi non legge il Domenicale è un pirla». Per capire fino in fondo che cos’è la Domenica del Sole, ribattezzata dai suoi affezionati lettori Domenicale, bisogna partire da qui. L’Accademia italiana e i giovani. Vittore Branca e un quarantenne prefetto della Biblioteca Ambrosiana che risponde al nome di Gianfranco Ravasi. Ludovico Geymonat, filosofo della scienza e marxista, che dice a Cossutta di avere trovato sulle pagine della cultura del Sole «il mio luogo di libertà», una giovanissima Elena Loewenthal che scrive di cose ebraiche, e un Federico Zeri che attribuisce alcuni dipinti di Assisi alla mano di Cavallini e non di Giotto.
I pesi massimi Eugenio Garin, Giovanni Pettinato, Alvar González-Palacios e le "giovani scoperte" dell’epoca Massimo Firpo, Carlo Ossola e Angela Vettese, critici teatrali e cinematografici del calibro di Renato Palazzi e Roberto Escobar. L’ironia amara di Peppo Pontiggia: «I narratori dovrebbero realizzare l’unica etica che appartiene a loro, l’etica del racconto. Potrà apparire cinica, tragica, disperata. Ma l’occhio che guarda il male è più prezioso di quello che si chiude» (18 aprile 1999). Tutto ciò, e molto altro, festeggia questa settimana il suo trentesimo compleanno. Un patrimonio che si riconosce nelle sue firme storiche e in tante altre che individua e alleva di settimana in settimana. Noi ci siamo portati avanti e abbiamo cominciato a festeggiare poco più di due anni fa quando abbiamo caparbiamente voluto restituire alla Domenica del Sole la forza espressiva del suo certificato di nascita, fatto di un formato tradizionale che combina in un unicum inscindibile testi, foto e disegni che appartengono alla storia della cultura italiana.
Un unicum, concepito e realizzato da un giornale finanziario, che è diventato materia di studio per tante tesi di laurea. Ne avvertiamo il peso e la responsabilità, c’è da custodire qualcosa che merita rispetto e unisce antico e nuovo. La mescolanza tra lettere e scienza, ma ancora di più tra i mille saperi della cultura, nessuno escluso, resta il principio guida, la base su cui poggiare la sfida culturale per eccellenza: aiutare questo Paese a riconciliarsi con il suo (grande) capitale dimenticato. Prima il Manifesto, poi due edizioni degli Stati generali della cultura, un nuovo indice elaborato dagli esperti del Sole 24 Ore che misura come il brand Italia perda terreno nel mondo. Non ci stancheremo mai di ripetere che la cultura, per come la intendiamo noi, arte, musei, lettere, ma anche ricerca scientifica e tecnica, innovazione e università, moda e design, talento della manifattura e dell’artigianato, deve essere collocata al centro della politica economica di sviluppo e di internazionalizzazione.
Sappiamo che la consapevolezza nella coscienza del Paese è aumentata e crediamo, in questo, di poter rivendicare un piccolo merito. Faremo la nostra parte selezionando e formando con una primaria banca i progetti giovanili di innovazione culturale che riterremo più convincenti e con un sito bilingue che si propone di ricordare al mondo il patrimonio italiano, i suoi talenti spesso abbandonati a se stessi, la forza e la suggestione di una bellezza e di un’identità uniche. Non ci rassegniamo all’idea che a tutto ciò si debbano negare non solo le risorse pubbliche (non ci sono) ma anche quegli stimoli fiscali (detraibilità e credito d’imposta per chi investe in cultura) che permetterebbero di attrarre risorse private, italiane e estere, necessarie per valorizzare un grande capitale dimenticato. Per non parlare dei vincoli che rischiano di soffocare istituzioni di qualità che ci si ostina a considerare come un ufficio dell’anagrafe e non per quello che sono: aziende culturali che reclamano (pensate) la libertà di muoversi sul mercato degli investitori.
Ricordo l’entusiasmo degli occhi e il sorriso sornione con cui Vincenzo Cerami accoglie la mia proposta di inventarsi critico cinematografico della Domenica e di regalarci un elzeviro al mese. Gli piace (tanto) l’idea di entrare nell’Accademia italiana e ci scherza su, a modo suo, con l’umiltà del grande cronista autore di Un borghese piccolo piccolo e sceneggiatore de La vita è bella, senza mai perdere la capacità di cogliere i segreti di uomini e donne e di restituirti luoghi, fatti e persone mai in posa. Anche per uomini come lui che non ci sono più (quanto ci manchi Vincenzo) vale la pena di impegnarsi perché la Domenica del Sole resti la bandiera di un’Italia che vuole (deve) riconquistare il suo primato culturale nel mondo chiedendo solo di non essere ostacolata e di potere contare su una parità di incentivazione fiscale con Paesi (molto) meno ricchi culturalmente e (molto) più lungimiranti.
- FILOSOFIA. IL PENSIERO DELLA COSTITUZIONE E LA COSTITUZIONE DEL PENSIERO
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- E ORA SI FACCIA CHIAREZZA (di Vitaliano Della Sala)4 ottobre 2013, di Federico La Sala
E ora si faccia chiarezza
di Vitaliano Della Sala ("Adista")
«Non aspettatevi cambiamenti del prodotto, aspettatevi cambiamenti della pubblicità». A sei mesi dall’elezione di papa Francesco la risposta del cardinale di New York, Timothy Dolan, ad una domanda sul nuovo papa, sembra racchiudere l’essenza di questo pontificato. Non so se sono l’unico, ma di fronte a questo papa mi sento combattuto tra due sentimenti: sta solo cambiando la forma o anche la sostanza della gerarchia cattolica? Bergoglio è solo un papa che guarda ottimisticamente il bicchiere mezzo pieno, mentre finora quasi tutti i papi hanno fatto il contrario? Fa gesti straordinari o appaiono tali solo perché nessun altro papa ne ha mai fatti di tanto normali? E quello che dice è scontato e già detto da altri o è la banalità che diventa eccezionalità solo per il contesto azzeccato in cui lo si pronuncia?
Insomma, papa Francesco rappresenta quella Chiesa-altra che in molti abbiamo sognato e ci siamo sforzati di costruire o è la solita musica suonata diversamente? Certo è che c’è credibilità e coerenza nelle sue parole chiare, semplici, incisive, che si accompagnano ai gesti “nuovi”. E c’è da sperare che non sia soltanto una squallida - e riuscita - operazione di marketing a favore di una gerarchia della quale, fino a sei mesi fa, si parlava quasi esclusivamente in relazione agli scandali sessuali e finanziari.«Non possiamo insistere solo sulle questioni legate ad aborto, matrimonio omosessuale e metodi contraccettivi», dice, tra l’altro papa Bergoglio nell’intervista a Civiltà Cattolica. Parole chiare e gesti concreti: questo papa sembra aver spiazzato e sorpassato anche quella parte di Chiesa “progressista” e di base.
Ma la storia della Chiesa ci insegna che per una volta che si sceglie un papa buono “che puzza di pecora” e di Spirito Santo, ne possono poi venir fuori altri che invece “puzzano” di interessi personali o di cordata, di troppa teologia e di poca pastoralità, di più o meno autoritarismo, di più o meno democraticità. E il volto della Chiesa, la percezione che fedeli e non fedeli laici hanno di essa, non può cambiare dopo ogni Conclave come se la Chiesa fosse l’espressione di questa o quella cordata e non la sposa di Cristo.
Lo confesso, sono anche arrabbiato perché troppa parte di Chiesa “progressista” sembra subire e acriticamente applaudire le parole e i gesti del papa, senza ricordarsi quanto sia preoccupante, se non pericoloso, quando gli annunci di cambiamento vengono dal vertice: il Francesco poverello d’Assisi che restaura la Chiesa cadente, può veramente coincidere con un papa, solo perché si chiama anch’egli Francesco, o non si rischia di creare un inevitabile corto circuito?
Qualche fedele meno plaudente e più attento, mi ha ricordato che «tante cose di quelle che oggi dice e fa il papa, le hai dette e fatte anche tu anni fa». È vero, ovviamente con le dovute proporzioni, e sono stato solo l’ultimo tra tanti che, per parole e gesti che oggi sembrerebbero scontati, è stato pesantemente punito e ancora vive gli strascichi di assurdi e ingiusti provvedimenti canonici. Come me e molto peggio di me, altri hanno subìto la moderna inquisizione, e non nel Medioevo, ma solo pochi anni fa, sotto il pontificato mediatico e reazionario di Woityla/Ratzinger, mentre Bergoglio era già cardinale, senza che abbia speso una parola di giustizia. Forse che nella Chiesa bisogna aspirare o brigare per diventare papa prima di poter parlare liberamente?
Invece oggi papa Bergoglio dice: «Ci vuole audacia e coraggio. Trovare strade nuove per chi se ne è andato», e spero che intenda anche dire: per chi è stato cacciato, e per chi è rimasto, punito, calpestato, ridotto al silenzio, umiliato, senza un briciolo di quella tenerezza di Dio, che i vertici della Chiesa avrebbero dovuto incarnare. Se il clima sembra realmente cambiato, chi restituirà il tempo perso a doversi difendere, l’insegnamento tolto ingiustamente a bravi docenti, la serenità a comunità punite e sconvolte, la salute compromessa? Chi dirà al mio vecchio ed ex vescovo che aveva torto lui, e alla mia ex comunità parrocchiale che avevamo ragione noi?
Alle sue parole chiare, ai suoi gesti coerenti, papa Francesco dovrebbe far corrispondere scelte e fatti concreti. Si potrebbe iniziare dal dire apertamente se ha ragione o torto, chi ipocritamente e per intraprendere una carriera senza meriti, si è accodato al pensiero dominante di una gerarchia tesa solo ad accontentare un papa polacco e un inquisitore tedesco, divenuto a sua volta pontefice, che hanno portato avanti un’idea di Chiesa autoritaria, immischiata nella peggiore politica, invischiata nei peggiori scandali, senza un briciolo di misericordia, che ha sguazzato nella contraddizione per cui si pretende il rispetto dei diritti umani all’esterno della Chiesa, mentre li si nega al proprio interno.
Sì, è indispensabile iniziare con un chiarimento, senza meschine vendette o ritorsioni, ma per «fare la verità nella carità».Sono certo che è comunque saggio e lungimirante vivere questo momento come una grande opportunità storica per la Chiesa. E per non ridurre le parole e i gesti di papa Francesco a qualcosa di stravagante; e per non arrivare ancora una volta tardi all’appuntamento con la Storia, non bastano più le parole e i gesti di “Pietro”, occorre che si coinvolga tutta la Chiesa in questo cammino. Forse è veramente giunto il tempo di un nuovo Concilio, da celebrare in una delle tante periferie del mondo, con vescovi e cardinali invitati come periti, esperti o osservatori. E con protagonisti questa volta donne e uomini fedeli laici.
*Amministratore parrocchiale a Mercogliano (Av)
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- Bisogna resistere alla tentazione di chiudere gli occhi, di accettare gli italici compromessi.(di Mons. Giuseppe Casale - Berlusconi, uno e due, virtuale e reale)28 settembre 2013, di Federico La Sala
Berlusconi, uno e due, virtuale e reale
di Mons. Giuseppe Casale
in “Adista” - Segni nuovi - n. 30 del 7 settembre 2013
Ma chi è il personaggio Berlusconi, che tiene in agitazione un intero Paese, che suscita accesi contrasti, che mette a rischio la tenuta stessa del governo, mentre ben altri e gravi problemi (crisi economica, disoccupazione giovanile, criminalità organizzata, immigrazione) esigono interventi urgenti e indilazionabili?Non è una domanda retorica. Perché il caso Berlusconi va ben al di là del fatto di cronaca riguardante una persona. È il termometro che segna una grave anomalia nella vita della democrazia italiana.
Si fa presto a descrivere il Berlusconi reale: un imprenditore che ha accumulato un’enorme ricchezza, non si sa con quali metodi; un uomo politico che ha suscitato forti critiche e riserve da parte di tanti onesti cittadini e numerosi interventi della magistratura per una condotta che è apparsa a coloro che indagavano su di lui riprovevole, in contrasto con le leggi dello Stato e l’etica pubblica, sia quando Berlusconi vestiva i panni di uomo di governo sia quando dirigeva, direttamente o indirettamente, le sue aziende. Alla fine di uno dei tanti procedimenti giudiziari che lo hanno visto indagato o imputato è stato condannato in maniera definitiva dalla Cassazione. Non è un perseguitato. È, tecnicamente, un condannato. La sentenza della Cassazione doveva perciò bastare per chiudere questo triste e avvilente capitolo della storia italiana recente.
Non è così. Perché se cade Berlusconi, cade tutta una costruzione pseudo-politica che ha in lui sostegno e spinta propulsiva. Ecco quindi che a fianco del Berlusconi reale c’è il Berlusconi virtuale, quello che ha fatto dimenticare ad un’intera generazione il rispetto delle leggi, della Costituzione e dei poteri dello Stato, assieme alle stesse norme minime di comportamento che vigono in una società organizzata. E che continua ad alimentare suggestioni collettive e un fitto reticolo di interessi. Ci sono ancora milioni di persone che vedono in Berlusconi il “salvatore della patria”, il politico che fa sognare e dispensa dal pensare. Vi sono, inoltre, altre centinaia di persone alle quali Berlusconi assicura potere, posti di lavoro, carriera politica, posizioni di rilievo nell’apparato dello Stato.
E allora la condanna? Per tutte queste persone non conta. È solo il frutto di una magistratura di sinistra che perseguita "l’unto del Signore. Gli insuccessi nel governo della cosa pubblica? Solo la conseguenza di una democrazia che impedisce al “capo” di governare con rapidità e decisione. Bisogna quindi salvare Berlusconi - si dice - perché è stato eletto da milioni di italiani. Come se l’essere eletti comporti non la responsabilità, ma l’impunità. Bisogna salvare Berlusconi, perché - si insiste - altrimenti tutto crolla. È vero. Però crolla una costruzione che non si basa sull’apporto responsabile dei cittadini, ma sulla verbosità, spesso menzognera, di chi pensa e decide per tutti.
Bisogna resistere alla tentazione di chiudere gli occhi, di accettare gli italici compromessi. Il bene comune non esige l’acquiescenza, il salvacondotto, la tortuosità di pseudo giustificazioni. La condanna di Berlusconi è l’uscita di sicurezza da un populismo mistificatore verso una democrazia sana, costruita ogni giorno con l’apporto intelligente e responsabile di tutti i cittadini. Che ne pensano i tanti cattolici “berluscones”? Non è giunto il momento per fare un serio esame di coscienza e... convertirsi?
* Arcivescovo emerito della diocesi di Foggia-Bovino
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- Ici alla Chiesa, biotestamento e Rai la trattativa segreta tra Pdl e Vaticano (di Carlo Bonini)5 settembre 2013
Ici alla Chiesa, biotestamento e Rai la trattativa segreta tra Pdl e Vaticano
di Carlo Bonini (la Repubblica, 5 settembre 2013)
Migliaia di mail. Centinaia di note riservate. Annotava e catalogava tutto con metodo e pazienza l’ex presidente dello Ior Ettore Gotti Tedeschi. E la corrispondenza del suo immenso archivio - che gli interlocutori fossero cardinali, ministri della Repubblica, banchieri, parlamentari, lo stesso Pontefice - non aveva a che fare con il governo delle anime, ma con il Potere degli uomini. Con la solerzia “papista” di deputati che pure hanno giurato sulla Costituzione. Con le urgenze della diplomazia tra le due sponde del Tevere di cui Gotti era diventato snodo cruciale. L’Ici, piuttosto che il disegno di legge sul testamento biologico, la nomina del direttore generale della Rai, il governo tecnico di Monti, le linee di credito del san Raffaele. Ebbene, il segreto che ha protetto quell’archivio, sequestrato nel 2012 dalla Procura di Napoli e trasmesso alla Procura di Roma (dove Gotti è stato a lungo indagato per violazione delle norme antiriciclaggio prima che ne venisse chiesta nel luglio scorso l’archiviazione), ora non è più tale. E queste sono alcune delle storie che quel segreto ha protetto.
il testamento biologico
Domenica 6 febbraio 2011, Alfredo Mantovano, già viceministro del Pdl, scrive al Presidente dello Ior: «Caro Ettore, perdonami, ma sulla questione del testamento biologico vi è necessità che dalla Cei vi sia qualche segnale». Mantovano ha intenzione di coinvolgere direttamente il Presidente della Conferenza Episcopale, il cardinale Angelo Bagnasco, sottoponendogli una lunga nota che consenta alla maggioranza, sulla base delle indicazioni della Santa Sede, di intervenire su alcune delle norme cruciali del disegno di legge sul “testamento biologico”. Nonché di risolvere un problema interno alle due anime del Pdl. Per questo motivo, chiede a Gotti di aiutarlo. «Ettore, perdonami se ti tormento. Ho abbozzato la nota per il cardinal Bagnasco. Ti chiedo una valutazione non tanto sulle considerazioni tecniche, di cui sono abbastanza sicuro, e che sono molto simili a quelle che a suo tempo lasciai al cardinal Bertone e da lui poi ritenute fondate, quanto sulla lettera che le precede. Un caro saluto in Domino».
La lettera e la nota per Bagnasco (un articolato normativo del disegno di legge con indicate in grassetto le norme da correggere) vengono inviate da Mantovano con il placet dell’allora Presidente dello Ior. Si legge nella missiva: «Eminenza reverendissima, il testo sul testamento biologico approvato dalla Commissione Affari sociali della Camera ha subito incisivi cambiamenti in pejus. Nell’appunto che segue accenno alle ragioni per le quali tali cambiamenti sono a mio avviso fortemente negativi e rischiano di trasformare una debole legge a tutela del fine vita in una legge sostanzialmente eutanasica». Ma c’è di più. «Ho provato a porre le obiezioni che seguono al capogruppo del mio partito alla Camera. Mi è stato detto però che quelle modifiche sono state concordate con soggetto autorevole delegato dalla Conferenza Episcopale e che, poiché le ragioni per le quali si sta provando ad approvare la legge è di venire incontro alle esigenze del mondo cattolico italiano, è strano che io critichi le modifiche stesse, quasi a voler essere pretestuosamente “più papista del Papa”. Sono convinto che ci si trovi di fronte a un equivoco che è necessario risolvere ».
così risolviamo l’ici
Seria quanto e più del testamento biologico, appare dalla corrispondenza dell’archivio Gotti la questione del pagamento dell’Ici da parte degli Enti ecclesiastici. Ma, anche in questo caso, come documenta una nota riservata trasmessa nell’ottobre 2011 dall’allora Presidente dello Ior sia a Papa Benedetto per il tramite di monsignor Georg Ganswein, sia all’allora Segretario di Stato Tarcisio Bertone, un aiuto importante arriva dall’allora ministro del Tesoro Tremonti. Gotti lo indica quale “suggeritore” delle alternative che si pongono alla Santa Sede. «Nel 2010 - scrive Gotti - la Commissione Europea ha avviato una procedura contro l’Italia per aiuti di Stato non accettabili alla Chiesa Cattolica. Detta procedura evidenzia oggi un rischio di condanna per l’Italia e una conseguente imposizione di recupero delle imposte non pagate (dal Vaticano, ndr) dal 2005. Dette imposte deve pagarle lo Stato Italiano che si rivarrà sulla Cei (si suppone). Ci sono tre strade percorribili: 1) Abolire le agevolazioni Ici (Tremonti non lo farà mai); 2) Difendere la normativa passata e calcolare l’aiuto di Stato dato (non è sostenibile); 3) Modificare la vecchia norma contestata dalla Commissione Europea, con una nuova norma che definisca una categoria per gli edifici religiosi e crei un criterio di classificazione della natura commerciale. La Cei accetta la nuova procedura e questo fa decadere le richieste pregresse (2005-2011) della Comunità Europea. Il tempo è limitato. Ci viene suggerito di accelerare un tavolo di discussione. L’interlocutore all’interno del Ministero delle Finanze è Enrico Martino (nipote del card. Martino)».
Alfano, Passera, Lei
Gli interlocutori di Gotti sono regolarmente figure di vertice e di Potere. Come le questioni che con loro affronta. In una mail del 16 dicembre 2011 il Presidente dello Ior rassegna ad Angelino Alfano le tre raccomandazioni che devono accompagnare la riflessione sull’appoggio del Pdl al governo Monti: «1. Cosa deve preoccuparci. 2 Come mettere sotto osservazione in modo politico e logico l’azione del governo tecnico. 3) Anticipare al governo tecnico quale modello è stato loro conferito». Qualche mese prima, il 24 settembre, sollecita invece Corrado Passera di Banca Intesa per la questione del dissesto del san Raffaele, cui la banca ha sospeso gli affidamenti. «Tu sai quanto ci teniamo al rilancio del san Raffaele - lo rassicura il banchiere - Siamo più che disponibili a supportare un piano serio come quello che sicuramente ci presenterete». Mentre l’11 marzo di quello stesso anno, una mail all’allora Segretario di Stato Bertone invita il cardinale ad occuparsi della nomina di Lorenza Lei a direttore generale della Rai. «Mi risulta che la nomina possa trovare ostacoli. Per due ragioni. 1) La dottoressa Lei avrebbe sussurrato di aver ricevuto assicurazioni che il cardinal Bertone ha ricevuto assicurazioni da Berlusconi sulla sua nomina e questo avrebbe provocato una certa opposizione interna ed esterna. 2) Risulta che la Lega voglia contare e avere un proprio direttore generale. Mi parrebbe dunque che per sostenere detta candidatura sia indispensabile interloquire con la Lega. Sono a sua disposizione».
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- Chiesa cattolica italiana e Berlusconi: a quando un esame di coscienza? (di Aldo Maria Valli)4 agosto 2013
Chiesa cattolica italiana e Berlusconi: a quando un esame di coscienza?
di Aldo Maria Valli
in “Vino Nuovo” (www.vinonuovo.it) del 3 agosto 2013
La condanna è arrivata, e irresponsabili non sono i giudici, ma coloro che la mettono in discussione.
Non accettarla, o dipingerla come sintomo di un disegno politico, vuol dire minare lo stato di diritto alle fondamenta.
Il guitto Berlusconi, ormai vecchio e gonfio, con la sua faccia da bambolotto di plastica, continua la recita, stancamente, come per inerzia, ma la cosa più triste è che un paese intero questa recita la segue e la subisce da un ventennio. E senza neppure la consolazione di poter dire di aver vissuto una pagina drammatica. Perché qui prevale la farsa, come nella peggior tradizione italica.
Ora però una domanda che riguarda i cattolici e le gerarchie. Come è stato possibile che per tanti, troppi anni la Chiesa istituzionale e un largo numero di sedicenti cattolici abbiano appoggiato quest’uomo?
Com’è stato possibile che tanti cattolici, a tutti i livelli, abbiano votato e chiesto di votare per lui, che gli abbiano concesso credito, che lo abbiano visto come l’uomo della provvidenza?
Com’è stato possibile che una parte, una larga parte del mondo cattolico non abbia provato un moto di spontanea ripulsa verso il guitto impegnato a usare la politica e gli italiani per il proprio tornaconto?
E’ una vecchia domanda che tuttavia non ha mai trovato risposta. Forse perché rispondere, per i cattolici italiani, vorrebbe dire fare un profondissimo e doloroso esame di coscienza, non solo e non tanto in termini politici, ma sotto il profilo culturale. Equivarrebbe a mostrare il vuoto culturale di un soggetto, il cattolico medio italiano, che sia sotto la Dc sia, e a maggior ragione, sotto l’ombrello berlusconiano non è mai stato abituato a pensare con la propria testa, a usare lo spirito critico, a distinguere tra senso dello Stato e opportunismo, ma si è lasciato guidare da una categoria tanto generica quanto comoda, l’anticomunismo, accontentandosi di parole d’ordine vuote.
Fare questo esame di coscienza equivarrebbe inoltre a togliere il velo steso sopra una classe dirigente ecclesiale in gran parte modesta e tremebonda, incline a non disturbare il manovratore e anzi a ingraziarselo, per ottenere vantaggi immediati.
Fare questo esame di coscienza equivarrebbe a mostrare come la religione, separata dalla fede, diventi facilmente alibi per giustificare il non giustificabile, per chiudere gli occhi davanti all’arroganza del potere, per trasformare la stessa appartenenza di fede in strumento di potere e di sottopotere. Procedere con questo esame di coscienza equivarrebbe alla fin fine a mostrare il tradimento del Vangelo operato da tanti, sia chierici sia laici cattolici, che il berlusconismo o l’hanno sposato in pieno o l’hanno tollerato in silenzio o hanno cercato di utilizzarlo.
Fare questo esame di coscienza vorrebbe dire scrivere una pagina triste del cattolicesimo italiano, quasi del tutto incapace di sottrarsi alle lusinghe del guitto e pronto anzi a sponsorizzarlo in maniera più o meno aperta.
Fare un simile esame di coscienza vorrebbe dire mostrare come i cattolici italiani, a tutti i livelli, si siano lasciati incantare dalla sottocultura televisiva dispensata a piene mani dal guitto e non abbiano opposto resistenza alcuna, preferendo anzi crogiolarsi in essa come sotto l’effetto di un narcotico. Fare questo esame di coscienza equivarrebbe a chiedersi come e perché politici molto solerti nello sbandierare la loro cattolicità abbiano deciso di militare sotto le insegne truffaldine del guitto.
Fare questo esame di coscienza equivarrebbe a constatare che perfino gli oppositori ormai hanno nel proprio dna dosi massicce di berlusconismo. Fare un tale esame di coscienza equivarrebbe a dimostrare che gran parte dei cattolici non sanno nemmeno che cosa sia la parresia, la libertà e la capacità di dire tutto, senza reticenze e senza sotterfugi interessati.
Dov’erano i cattolici quando il guitto destabilizzava lo Stato con le sue battaglie ad personam?
Dov’erano quando inebetiva gli italiani con i suoi circenses televisivi? Dov’erano quando separava la morale privata da quella pubblica infrangendo così uno dei pilastri della dottrina sociale della Chiesa?
Dov’erano quando, palesemente e senza vergogna, divulgava con il proprio comportamento l’idea che con la ricchezza sia possibile guadagnarsi l’impunità?
La verità è che la Chiesa italiana e gran parte dei cattolici, se si studia il loro rapporto con il guitto di Arcore, hanno sulla coscienza gravi peccati, sia di connivenza sia di omissione. Quando ne hanno preso le distanze lo hanno fatto timidamente e in ritardo, a scempio ormai compiuto, e comunque è difficile dimenticare certe immagini, come la folla del meeting di Rimini osannante nei confronti del guitto, accolto come un salvatore e riverito, incredibile dictu, come un vero statista.
Per tutte queste ragioni l’esame di coscienza non ci sarà e chi proverà a farlo, dentro il mondo cattolico, sarà guardato per lo più con fastidio e messo ai margini, come del resto è già avvenuto durante il regno del guitto.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- CIO’ CHE I GOVERNI (COMPRESO IL VATICANO) HANNO TACIUTO.9 luglio 2013, di Federico La Sala
Ciò che i governi hanno taciuto
di Furio Colombo (il Fatto Quotidiano, 9 luglio 2013)
“Ha gettato fiori sul mare per ricordare i morti fantasma”, hanno scritto molti giornali per parlare della visita di papa Francesco a Lampedusa. Nessuno ha voluto dire senza ipocrisia che nel Mediterraneo non si muore per la violenza della natura o per la crudeltà del destino, ma a causa di un accurato piano elaborato con coscienza di causa (pena di morte) di un governo italiano. Lo ha detto il Papa dall’altare costruito alla buona, con legno di barche affondate, rivolto a chi comanda, a qualunque grado di responsabilità: “Per favore, non fatelo più”.
Non c’era aria da cerimonia o l’astuzia di dire cose buone. C’era verità e dolore del primo Papa che ha scelto di accorgersi che i profughi, i rifugiati, i migranti morti in mare non sono le dolorose vittime di una disgrazia. Sono morti ammazzati.
Ricordate? C’erano, in base a un trattato, veloci e armate motovedette italiane, con marinai italiani e ufficiali o poliziotti libici con il compito di “respingere”, negando non solo le leggi umanitarie, ma i doveri del mare. Finalmente si è saputo con chiarezza il numero: “almeno” 20 mila morti. Che vuol dire uomini e donne giovani, mamme incinte, adolescenti, bambini, che stavano fuggendo da guerre, persecuzioni e fame credendo che l’Italia fosse un Paese civile. Ma l’Italia era un Paese governato da Maroni e da Berlusconi, firmatari del tragico patto con la Libia.
Sapevamo, prima del Papa, che gli annegati a causa del nostro governo leghista, affarista, indifferente, crudele e stupido, erano “almeno” 20 mila? Lo sapevamo. Lo aveva detto Laura Boldrini, allora coraggiosa portavoce dell’Onu, al Comitato per i diritti umani della Camera dei deputati che io presiedevo. Lo aveva detto e testimoniato il solo deputato del Pd che era venuto con me a Lampedusa, Andrea Sarubbi (prontamente non più ricandidato). Lo avevano detto i sei deputati Radicali che non avevano smesso mai di denunciare con allarme ciò che stava accadendo.
Purtroppo i media hanno taciuto temendo il potere vendicativo Maroni-Berlusconi. Per questo dobbiamo dire grazie al Papa. Con un calice e una croce di legno e un timone ripescato dal mare accanto, ha detto, lui capo di un altro Stato, ciò che nessun italiano, inclusi i presunti buoni, aveva mai detto: “Per favore, per favore, non fatelo più”.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- Le riforme e il denaro un intreccio secolare nella storia del papato (di Agostino Paravicini Bagliani)4 luglio 2013, di Federico La Sala
Le riforme e il denaro un intreccio secolare nella storia del papato
di Agostino Paravicini Bagliani (la Repubblica, 4 luglio 2013)
Le cronache di questi giorni ci parlano di un nuovo scandalo che coinvolge l’Istituto per le opere di religione (Ior), sulla cui esistenza papa Francesco espresse pubblicamente dubbi, affermando: «Lo Ior è necessario fino a un certo punto»; e «San Pietro non aveva un conto in banca». Sono affermazioni che nascono da una profonda riflessione sul rapporto tra Chiesa e denaro e preannunciano una radicale riforma della Curia.
Anche nel corso della lunga storia del papato, le riforme della Curia (peraltro frequenti) sono state sovente motivate da problemi di natura finanziaria. E in momenti particolarmente importanti non mancarono decisioni radicali.
Nel pieno della cosiddetta Riforma gregoriana, un papa francese, Urbano II (1088-1099), già monaco di Cluny, decise persino di affidare l’intera amministrazione papale. Lo fece perché Cluny era allora forse l’istituzione europea più efficiente in termini di amministrazione finanziaria. Ma Urbano II voleva anche proseguire nel programma della Riforma, e rendere il papato sempre più autonomo dall’aristocrazia romana. Questo legame tra Cluny e il papato introdusse a Roma due termini - quello di Camera e di Camerlengo - che sono ancor oggi in uso. Il cardinale Camerlengo è responsabile dell’amministrazione papale durante la Vacanza della Sede apostolica.
Quando Benedetto Caetani fu eletto papa Bonifacio VIII (1294), la Curia non era in buone condizioni. La debolezza, in termini amministrativi, del pontificato di Celestino V, il papa del “gran rifiuto”, aveva provocato gravi disfunzioni, permettendo persino a prelati di curia di disporre di bolle papali in bianco... Che cosa fece Bonifacio VIII? Congedò - lo dice un cronista inglese bene informato - tutti «i banchieri della Camera apostolica, conservando ai propri servizi solo tre società, quelle dei Mori, degli Spini e dei Chiarenti». A questi banchieri “esterni” alla Curia, assegnò l’intera amministrazione papale, sottoponendoli ad uno stretto controllo. Tutti i venerdì dovevano far verificare i loro registri dal Camerlengo.
Bonifacio VIII fu uno dei primi papi ad essere stato eletto da cardinali “chiusi in conclave”. Ora, anche il conclave fu introdotto (nel 1274 da Gregorio X) per risolvere problemi di natura finanziaria. I cardinali avevano infatti preso l’abitudine di prolungare le Vacanze della Sede apostolica perché così potevano fruire dei proventi della Camera apostolica. Proprio Gregorio X era stato eletto al termine di una Vacanza durata quasi tre anni...
Innumerevoli parodie e testi satirici di quei secoli mettono in evidenza l’avidità della Curia. Per i Carmina Burana, «Roma è la capitale del mondo ma non conserva nulla di pulito». Il poema si serviva del gioco di parole tra mundi (del mondo) e mundum (pulito). Non si trattava di retorica.
Il 16 giugno 1281, il vescovo di Hereford Tommaso di Cantilupo sapeva che «gli affari in curia non possono progredire se non si organizzano “visite” generali e individuali», ossia offrendo doni. Anche in natura. Il maestro generale dei Serviti (un ordine mendicante) regalò sovente libbre di zafferano, di un altissimo valore economico, a diversi cardinali, tra i quali il futuro Bonifacio VIII. Il giorno dell’elezione di questo papa, il procuratore della città di Bruges gli fece pervenire tessuti del valore di 220 fiorini per «ringraziarlo dei servizi resi alla sua città quando era avvocato di curia». A questo generale “sistema di doni”- certo non circoscritto allora alla sola curia romana - alcuni papi cercarono di porre rimedio.
Per tagliare alla radice “ogni occasione di cupidità”, Innocenzo IV (1243-1254) decretò che coloro che avrebbero offerto ad un curiale una somma superiore a 20 soldi (una cifra relativamente alta) dovevano farsi rilasciare una quietanza, il che significa che tale dono non era di per sé illecito.
Non mancarono nemmeno tentativi per imporre più austerità in termini di vita di corte. Soltanto due settimane dopo la sua elezione, il terzo papa avignonese, Giovanni XXII (1314), decretò che i cardinali avrebbero dovuto accontentarsi di due sole portate, o di solo pesce o di pesce e carne. La selvaggina (caprioli, cervi, pavoni, fagiani, cigni) poteva essere aggiunta alle due portate di base, ad esclusione di lepri, conigli, pernici (molto abbondanti in Provenza).
Malgrado queste restrizioni, la mensa dei cardinali continuò però ad essere eccezionalmente ricca e varia. Ed anche la circolazione di doni in Curia continuò a imperversare ben al di là del Medioevo, diventando persino una delle principali polemiche, nei primi decenni del Cinquecento, da parte dei protagonisti della Riforma protestante.
Insomma, il legame tra riforma della Curia e denaro attraversa i secoli. Tentativi di riforma, anche radicali, non mancarono, né nel Medioevo né in epoca moderna, ma il loro successo fu relativo. La riforma medievale più duratura fu l’introduzione del conclave, che riuscì ad eliminare le lunghe Sedi vacanti, togliendo ai cardinali la possibilità di interessanti proventi.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- RESISTERE E CAMBIARE. Francesco in trincea contro i conservatori (di Marco Politi).13 giugno 2013, di Federico La Sala
Francesco in trincea contro i conservatori: resistere e cambiare
di Marco Politi (il Fatto Quotidiano, 13 giugno 2013)
Le critiche sono già cominciate. Sotterranee e micidiali. “È ripetitivo... demagogico... imprudente... pauperista... non è all’altezza del pensiero di Ratzinger... non decide... troppo folclore latino-americano... speriamo che la smetta di fare il parroco”.
Passati i primi tre mesi, papa Bergoglio si sta accorgendo che esiste in Vaticano la grande palude di quelli che non vogliono cambiare e spargono veleni contro chi intende dar la vuelta a la tortilla (copyright Bergoglio): noi diremmo ‘rivoltare il calzino’.
Poi ci sono i timorosi come l’ Avvenire , che riferisce della corruzione in Vaticano, ma nasconde in fondo all’articolo il tema dei carrieristi gay in tonaca.
Papa Francesco incassa. Ieri ha criticato i conservatori con la testa rivolta all’indietro e i progressisti frettolosi. Prima del conclave diceva che il futuro pontefice doveva “ripulire la Curia”.
Adesso , dal suo colloquio a ruota libera con i vertici dei religiosi sudamericani (CLAR), avvenuto il 6 giugno scorso, affiora un certo affanno. Affrontare i problemi della Curia, ha confessato, “è difficile... dobbiamo vedere cosa fare... non posso fare la riforma da solo... pregate che faccia meno errori possibile!”. Dice un vip curiale che Francesco intende “cambiare con l’esempio”. Certo non basterà.
Lo zoccolo conservatore della Curia resiste. C’è da cambiare strutture e quadri in Vaticano e nella Chiesa universale, se la rivoluzione di Francesco non intende arenarsi nei segnali personali lanciati dal pontefice.
Perciò ha rinunciato alle vacanze, tranne due giorni a Ferragosto. Bergoglio si alza alle 5 del mattino, prega e medita sulle Scritture fino alle 6, poi prepara l’omelia per la messa in Santa Marta, alle 10 si sposta negli appartamenti del Palazzo apostolico per udienze rese note e per incontri tenuti riservati.
Nel pomeriggio lavora nella sua suite alberghiera. Resta ad abitare lì, non vuole sentirsi isolato, ha spiegato. Nella sala mensa si siede a tavola con chi vuole o lascia che venga a mangiare con lui chi ha bisogno di scambiare due parole con il pontefice.
Quando interrompe il lavoro, esce dalla sua stanza a Santa Marta e va tranquillamente nel corridoio alla macchinetta del caffè, cava di tasca la monetina e si serve un espresso. Rifiutando l’appartamento papale, ha smitizzato di colpo l’Appartamento che in gergo vaticano ha sempre significato la suprema stanza dei bottoni, accessibile solo a pochi eletti.
La sua attività in questi primi mesi è tutta concentrata in una ricognizione a tappeto degli uffici vaticani (le Congregazioni e i Consigli), i loro dirigenti, il modo di lavorare. “Riflettere, pregare, dialogare” ha dichiarato ai cardinali come metodologia del suo lavoro. “È un uomo che rumina e ascolta molto”, lo descrive un veterano di Curia. Settimana dopo settimana Francesco riceve i capi dicastero, si intrattiene con loro anche un’ora di seguito. Confronti “concreti e senza formalismi”.
Il Papa analizza ciò che si fa e chiede ciò che si può cambiare. Bergoglio progetta una Curia più snella, meno burocratica, più collegata con l’episcopato mondiale e che - spiega un monsignore - “sia attenta alla condizione degli uomini di oggi”.
Questo implica anche un nuovo sguardo sulla sessualità nel mondo odierno come richiesto sottovoce da parecchi cardinali e vescovi nell’ultima fase del pontificato ratzingeriano. Senza annacquare la dottrina (fa notare chi lo frequenta), ma con una sensibilità reale ai problemi quotidiani dei divorziati, delle coppie di fatto e persino delle convivenze gay. Matrimonio omosessuale escluso. Citando i libretti d’opera, un uomo di Curia ha esclamato riferendosi ai fondamenti dottrinali di Ratzinger e Bergoglio: “Il testo è uguale, la musica è diversa”.
Più volte Bergoglio ha già incontrato il cardinale Maradiaga, coordinatore dello speciale gruppo di lavoro consultivo di otto cardinali di tutto il mondo, che farà una sua proposta organica di riforma della Curia ai primi di ottobre.
Si attendono novità in primo luogo nel settore economico della Santa Sede. Governatorato vaticano e Amministrazione del Patrimonio apostolico (Apsa) potrebbero essere unificati sotto una direzione comune. Non si pensa all’abolizione dello Ior, ma ad una accelerazione in direzione di una piena trasparenza e rispondenza alle regole del comitato europeo Moneyval.
Alla Frankfurter Allgemeine Zeitung il nuovo presidente dello Ior, von Freyberg, ha dichiarato “tolleranza zero” sulle operazioni opache e garantito una verifica totale dei conti correnti: “Nei prossimi mesi faremo controllare ogni singolo rapporto dei clienti (i correntisti dello Ior, ndr) da un’agenzia esterna, la Promontory, internazionalmente riconosciuta”. D’altronde sono già partite nel 2012 le prime indagini interne su sospetto riciclaggio.
I più accesi fautori della riforma della Curia - e ce ne sono all’interno del Vaticano - lamentano che papa Francesco non abbia ancora sostituito il Segretario di Stato cardinale Bertone. C’è chi spera in un annuncio per il 29 giugno, ‘festa del papato’ dedicata ai santi Pietro e Paolo, ma Bertone ha annunciato ufficialmente che andrà in vacanza dal 1 al 13 agosto e dunque lascia intendere che dopo sarà ancora al suo posto. Forse spera in una proroga di un anno come fu per Sodano all’avvento sul trono papale di Benedetto XVI, però in Curia la maggioranza pensa che al massimo il 2 dicembre, quando compirà 79 anni, dovrà ritirarsi. Per molti trascinare la scelta del nuovo Segretario di Stato è un errore.
Come successore circola il nome del cardinale Bertello, attuale Governatore della Città del Vaticano. Fa parte del “consiglio della corona” di Bergoglio, il gruppo di otto porporati chiamati a dargli consigli per il governo. Eppure c’è suggerisce altri nomi: i nunzi Ventura di Parigi e Mennini di Londra. In Francia hanno anche preconizzato un Segretario di Stato francese: il nunzio vaticano in Messico, Christophe Pierre. Per gli Esteri è in pole position mons. Parolin, già viceministro per le relazioni internazionali.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- IL PRESIDENZIALISMO. Il colpo di Stato permanente (di Barbara Spinelli - L’escamotage presidenzialista).5 giugno 2013, di Federico La Sala
L’escamotage presidenzialista
di Barbara Spinelli (la Repubblica, 5 giugno 2013)
Come se fosse l’architettura dei poteri e una Costituzione difettosa, a impedire alla politica e ai partiti di ritrovare la decenza perduta, o a darsene una ex novo. Come se un capo di Stato eletto direttamente dal popolo, e più dominatore - è il farmaco offerto in questi giorni - servisse a curare mali che non vengono da fuori, ma tutti da dentro, dentro la coscienza dei partiti, dentro il loro rapporto con la cosa pubblica, con l’elettore, con la verità delle parole dette.
De Gaulle in Francia concepì la Repubblica presidenziale per sormontare la guerra d’Algeria: aveva di fronte a sé un compito immane - la decolonizzazione - e alle spalle una classe politica incapace di decidere. Non aveva tuttavia uno Stato intimamente corroso come il nostro, in cui i cittadini credono sempre meno. La costituzione semi-monarchica nacque per adattarsi a lui - l’uomo che da solo era entrato in Resistenza, nel 1940 - non per servire un capopopolo stile Berlusconi, che non sopporta il laccio di leggi e costituzioni. La politica francese prima del 1958 era inservibile, ma la corruzione morale e mentale non l’aveva sgretolata sino a farla svanire.
La nostra guerra d’Algeria l’abbiamo in casa: è la nostra casa, squassata, che va decolonizzata. Sono qui dentro i golpisti, non lontani nelle colonie. Piazzare all’ingresso dell’edificio un padre-padrone, con poteri più vasti ancora di quelli che già possiede, non preserva la casa dalla rovina.
E poi non dimentichiamolo. Non fu facile far nascere la Quinta Repubblica. L’accentramento dei poteri all’Eliseo rese il Paese più efficiente, ma moltiplicò opache derive e non lo democratizzò. Avvenne piuttosto il contrario: un Presidente autocrate e decisamente di parte; un Parlamento in gran parte esautorato; un governo sempre sacrificabile dal Capo supremo, e non a caso chiamato fusibile: la Quinta Repubblica è anche questo, e venne confutata da politici e costituzionalisti di rilievo.
Non si oppose solo il socialista Mitterrand, che nel ’64 scrisse Il colpo di Stato permanente, denunciando antiche vocazioni bonapartiste e la perdita - grave - della funzione di arbitro del Presidente. Pur esecrando il precedente regno dei partiti, pur approvando l’elezione diretta, si sollevarono anche costituzionalisti come Maurice Duverger: nella nuova Costituzione, egli scorse fin dal ’59 «spirito di rivincita» e partigianeria: “Ogni costituzione è un’arma politica, attraverso la quale un partito vincitore cerca di consolidare la propria vittoria e trasformare gli avversari in vinti”.
Né la rivolta fu solo di sinistra. L’attacco finale venne da Jean-François Revel che, osservando l’uso socialista della Carta gollista, scrisse un pamphlet feroce: L’assolutismo inefficace. Mitterrand fu accusato di indossare il detestato manto presidenzialista per spezzare la dialettica democratica: “Le costituzioni sono cattive quando il controllo può divenire invadente al punto di paralizzare l’esecutivo, oppure quando l’esecutivo diventa onnipotente al punto di annientare il controllo”.
Testi simili aiutano a capire. Una costituzione è buona se consente controlli: “Senza contropoteri costituzionali - così Revel - il Presidente reagisce solo a forze esterne alle istituzioni: ai media e alle piazze”. Né si può dire che il presidenzialismo sia, almeno, più efficace: “Una buona costituzione non solo associa controllo ed efficacia senza sacrificarli l’un l’altro, ma garantisce l’efficacia perché esiste il controllo”.
Bisogna comunque avere uno Stato e virtù pubbliche ben solidi, per schivare questi pericoli. E l’Italia di oggi, dopo la Prima repubblica degradata in Tangentopoli, nella P2, nei patti Stato-mafia, dopo il ventennio dominato da uno scardinatore di istituzioni come Berlusconi, faticherà a salvaguardare la democrazia se cincischia la Carta proprio ora: è come se De Gaulle l’avesse negoziata con l’Organizzazione dell’armata segreta Oas.
E non perché possediamo “la Costituzione più bella del mondo”, ma perché il vero check and balance, il reciproco controllo fra poteri indipendenti, non è compiuto. Più che bellissima, la nostra Carta è finalmente da realizzare. Credere di raddrizzarla con il presidenzialismo vuol dire aggiungere un potere, lasciandola storta. Dicono che il popolo tornerebbe a esser sovrano, votando il Presidente. Non è detto affatto, rammentano i detrattori della V Repubblica.
Mitterrand descrive rischi che saranno anche i nostri: una volta svuotati Parlamento, politica, governi, “si installa una tecnocrazia rampante, una sfera di amministratori indifferenti al popolo” che “confiscano il potere della Rappresentanza nazionale”.
Citiamo ancora Revel: “La logica della V Repubblica deresponsabilizza, perché il potere è attribuito da un onnipotente irresponsabile a creature che sono solo emanazioni della sua essenza, e che dunque partecipano del suo privilegio di irresponsabilità”. De Gaulle non era temuto come tiranno. Ma i suoi successori?
Altro scenario in Italia. Primo, perché non c’è un De Gaulle fra noi. Secondo, perché il contesto conta quando si disfa la Carta e il contesto nostro è quello di uno Stato diviso in bande, che ha patteggiato finanche con le mafie. Un male come il nostro nemmeno sappiamo più bene nominarlo, e proprio quest’afonia trasforma le discussioni sul presidenzialismo in furbo escamotage. In doppia fuga: fuga dai fondamenti (quale bene pubblico è difeso da partiti o sindacati?) e fuga da noi, dalla nostra storia di colpe e misfatti. Una storia in cui si bagnano ormai destra e sinistra.
Se evochiamo parole morali come colpe e misfatti è perché qui è il nostro guaio, dilatatosi a dismisura: l’aggiramento voluto delle volontà cittadine, la parola sistematicamente non tenuta, il tradimento. Il governo Letta è visto come inciucio perché nato da intese tutte fuoriscena, ob-scaena. È strano come i politici, perfino gli innovatori, evitino di menzionare una tema che resta cruciale: la morale pubblica. Giacché è per immoralità che si rinviano le cose prioritarie, anteponendo l’escamotage.
Mai come adesso invece, la questione posta da Berlinguer nei primi ’80 è stata così attuale. Oggi come allora, è obbligo etico il «corretto ripristino del dettato costituzionale», il divieto ai partiti di occupare lo Stato. Nulla è cambiato rispetto a quando Berlinguer diceva a Scalfari che la questione morale «è il centro del nostro problema»: quell’«occupazione » produce sprechi, debito, ingiustizia. È questione morale allontanarsene subito. È urgente, fattibile, e però intollerato dalle oligarchie. Per questo pesa il contesto delle riforme istituzionali, e inane è mimare Parigi.
Questo è un paese dove non è stata mai fatta una legge sul conflitto di interessi. Dove un magnate tv ha governato nonostante una legge del ’57 proibisca l’elezione di titolari di concessioni pubbliche (frequenze tv). E restano le leggi ad personam, grazie a cui quest’ultimo elude processi e condanne. Questo è il paese dove si ha l’impressione che niente sia vero, di quanto detto in politica. Che tutto sia fumo o diversivo.
Il Pd aveva promesso di non governare con Berlusconi, e ora Berlusconi comanda. Aveva promesso di cambiare subito la legge elettorale, restituendo all’elettore la scelta dei suoi rappresentanti, e neppure questo fa. Quel che è accaduto giorni fa è una pagina nera, simile alla pugnalata di Prodi.
La mattina del 29 maggio il deputato Pd Giachetti raccoglie adesioni contro il Porcellum per tornare automaticamente alla legge Mattarella (1 milione 210.000 italiani hanno chiesto un referendum per ottenere proprio questo, il 30-9-11). Circa 100 firmano: di Pd, Sel e 5 Stelle. Ma arriva l’altolà di Enrico Letta e Finocchiaro («È intempestivo, prepotente!») e dei Pd resta solo Giachetti. Se ne parlerà, sì, ma se vorrà Berlusconi.
Questo è un paese dove si mente al popolo, annunciando pompose abolizioni del finanziamento pubblico ai partiti, e poi ecco una proposta che obbliga i contribuenti a sovvenzionarli col 2 per mille, anche quando non lo dichiarano (le cosiddette somme “inoptate”) Questo è un paese dove il presidente della Repubblica esercita poteri imprevisti. Con che diritto, sabato, ha definito «eccezionale» il governo: «a termine»? Il Quirinale già ha pesato molto, influenzando il voto presidenziale e favorendo le grandi intese.
Formidabile è la coazione a ripetere inganni, tradimenti. La chiamano addirittura pace, responsabilità. In realtà nessuno risponde di quel che fa o non fa. Deridono Grillo, che chiama portavoce i rappresentanti. Ma loro non sono affatto rappresentanti, essendo nominati. Nessuno è imputabile, e che altro è la non-imputabilità se non la fine d’ogni etica pubblica.
MATERIALI PER RIFLETTERE:
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- COSTITUZIONE E FINANZIAMENTI ALLE SCUOLE PRIVATE.21 maggio 2013, di Federico La Sala
 COSTITUZIONE E SCUOLA PUBBLICA: REFERENDUM CONSULTIVO. Alle urne questo 26 maggio i cittadini e le cittadine di Bologna voteranno per difendere la scuola pubblica e la Costituzione. Ogni altra interpretazione è pretestuosa e fallace.
COSTITUZIONE E SCUOLA PUBBLICA: REFERENDUM CONSULTIVO. Alle urne questo 26 maggio i cittadini e le cittadine di Bologna voteranno per difendere la scuola pubblica e la Costituzione. Ogni altra interpretazione è pretestuosa e fallace.
 BOLOGNA-REFERENDUM. COSTITUZIONE E FINANZIAMENTI ALLE SCUOLE PRIVATE. Materiali: note di Stefano Rodotà, Emiliano Liuzzi, Francesca Coin
BOLOGNA-REFERENDUM. COSTITUZIONE E FINANZIAMENTI ALLE SCUOLE PRIVATE. Materiali: note di Stefano Rodotà, Emiliano Liuzzi, Francesca Coin
 FRANCESCO GUCCINI. “Entrare nella scuola pubblica è il primo passo di ogni individuo che voglia imparare l’alterità e la condivisione. Ed è il primo passo di ogni essere umano per diventare uomo, per diventare donna”.
FRANCESCO GUCCINI. “Entrare nella scuola pubblica è il primo passo di ogni individuo che voglia imparare l’alterità e la condivisione. Ed è il primo passo di ogni essere umano per diventare uomo, per diventare donna”.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- LA "SCIENZA NUOVA" E LA CRITICA DEL PUTTANESIMO- RILEGGERE VICO.13 maggio 2013, di Federico La Sala
 RILEGGERE VICO. Teoria e pratica della "Scienza Nuova". Un breve lavoro (pdf, scaricabile)
RILEGGERE VICO. Teoria e pratica della "Scienza Nuova". Un breve lavoro (pdf, scaricabile)
 Se pochi filosofi e letterati sanno dell’omaggio di Ugo Foscolo al filosofo delle “nozze e tribunali ed are” ( “Dei sepolcri”, v. 91), moltissimi “addottrinati” ignorano ancora e del tutto che (...)
Se pochi filosofi e letterati sanno dell’omaggio di Ugo Foscolo al filosofo delle “nozze e tribunali ed are” ( “Dei sepolcri”, v. 91), moltissimi “addottrinati” ignorano ancora e del tutto che (...)
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- “IL SISTEMA PROSTITUTIVO”. Ruby, chiesti 6 anni per Berlusconi (di Paolo Colonnello)13 maggio 2013
 Ruby, chiesti 6 anni per Berlusconi
Ruby, chiesti 6 anni per Berlusconi
 “Ad Arcore un contesto prostitutivo”
“Ad Arcore un contesto prostitutivo” «Nipote di Mubarak? Balla colossale
«Nipote di Mubarak? Balla colossale
 E lo sapevano anche in Questura»
E lo sapevano anche in Questura» di Paolo Colonnello (La Stampa, 13/05/2013)
di Paolo Colonnello (La Stampa, 13/05/2013)Milano.
Ilda Boccassini, al termine della requisitoria del processo Ruby, ha chiesto sei anni di reclusione per Silvio Berlusconi, imputato di concussione e prostituzione minorile nel processo Ruby. Il pm ha inoltre chiesto l’interdizione perpetua dai pubblici uffici per l’ex premier neppure «meritevole» delle attenuanti generiche.
SENTENZA PREVISTA IL 24 GIUGNO
Per il rappresentante dell’accusa l’ex premier è responsabile dei due reati contestati. Pertanto la procura nell’illustrare la richiesta di pena ha spiegato che 5 anni riguardano il primo reato, aumentati a 6 per il secondo reato. Tra le pene accessorie oltre all’interdizione perpetua dai pubblici uffici, il pm ha chiesto, tra l’altro, l’interdizione legale per 6 anni. Ora la difesa di Berlusconi parlerà il 3 giugno mentre un’altra udienza, probabilmente per eventuali repliche e sentenza, è stata fissata per il 24 giugno.
LA POLEMICA CON IL PDL
Ruby «mente e nega di avere avuto rapporti sessuali» con Berlusconi, perché ha avuto «un tornaconto personale» quantificato in cinque milioni di euro, ha spiegato il procuratore aggiunto di Milano in uno dei passaggi della requisitoria. Secondo la Boccassini, «l’interesse» dell’ex premier per il rilascio della giovane marocchina dalla Questura nel maggio del 2010 si basava sul suo «timore» che «si potesse disvelare che quella minorenne avesse fatto sesso con lui» e ciò che «accadeva ad Arcore». Poi un passaggi più politico: «Mi sono sentita smarrita per il fatto che rappresentanti delle Istituzioni abbiano invaso il Palazzo di Giustizia lo scorso 11 marzo», ha dichiarato il pm al termine della requisitoria facendo riferimento alla manifestazione dei parlamentari del Pdl avvenuta nel corso di un’udienza del medesimo processo.
“LA BALLA COLOSSALE”
Ruby nipote di Mubarak? «Fu una balla colossale», aveva affermato questa mattina la Boccassini in un passaggio della requisitoria. «Silvio Berlusconi temeva che Ruby, rimanendo in Questura, potesse disvelare di avere fatto sesso con il Presidente del Consiglio ad Arcore. Perchè sapeva che era minorenne: lo sapeva Emilio Fede, lo sapeva la Minetti, la De Coinceicao, la Pasquino, lo sapeva Mora». Poco prima delle conclusioni, il pm aveva tirato i suoi colpi finali. È un contesto «prostitutivo», di interessi economici, di arrembaggio per una particina in tivù, di mancanza di valori culturali, quello in cui arriva la minorenne Ruby Rubacuori il giorno in cui mette piede ad Arcore per la prima volta: 14 febbraio 2010. «Non ci sono dubbi» che Ruby «si prostituisse» né che «avesse fatto sesso con l’imputato e ne aveva ricevuto benefici», ha affermato in aula Boccassini.
“IL SISTEMA PROSTITUTIVO”
Nell’introduzione della sua attesissima requisitoria il magistrato aveva ricordato che l’inasprimento delle leggi sulla prostituzione minorile furono volute proprio dal governo Berlusconi. Una premessa necessaria per spiegare anche perché di questa vicenda si è occupata lei stessa, responsabile della Procura distrettuale antimafia, proprio grazie alle competenze attribuite da queste nuove leggi. Quindi, il pm era passata ad illustrare la storia del processo e di Karima El Mahroug, in arte Ruby Rubacuori. «Il collega Sangermano vi ha dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio, che presso l’abitazione di Arcore del presidente del consiglio, le ragazze invitate facevano parte di un sistema prostitutivo organizzato per compiacere il piacere di silvio Berlusconi». Un “piacere” che, nonostante l’assenza di inchieste, era noto già a tutti in quell’epoca, maggio 2010, quando Ruby venne fermata e portata in Questura. «Anche i funzionari della questura erano consapevoli del pericolo che poteva rappresentare l’emergere delle frequentazioni di una minorenne con l’allora Premier, che temeva lo scandalo».
FEDE, MINETTI E MORA
Ruby, aveva spiegato il pm, non ha una casa, vive di espedienti e si prostituisce: «E in questo contesto che arriva ad Arcore, ovvero in quel sistema prostitutivo organizzato per compiacere Silvio Berlusconi e organizzato da Fede, Minetti e Mora. È quando Ruby il 14 febbraio 2010 arriva ad Arcore, queste tre persone ci sono. E quando viene portata alla villa da Emilio Fede, il direttore del Tg4 è consapevole della sua minore età, avendo partecipato come presidente di giuria al concorso di bellezza svolto si appena qualche mese prima a Taormina». «Possiamo veramente immaginare che in quel contesto una persona che ha quel rapporto di amicizia e fedeltà assoluta con il Premier non abbia avvertito il presidente che stava introducendo nella serata di Arcore anche una minorenne?». Il pm era poi passata ad illustrare il reato di concussione, relativo alla “liberazione”di Ruby dalla questura la sera del 28 maggio 2010. Dopo aver ripercorso le conversazioni della funzionaria in servizio Giorgia Iafrate con il pm dei minori Fiorillo e ricostruito minuziosamente le telefonate di Silvio Berlusconi al capo di Gabinetto della Questura Pietro Ostuni da mezzanotte in avanti (le chiamate, attraverso il cellulare del capo scorta furono almeno 7), ha definito una “scusa grossolana” aver definito Ruby “nipote di Mubarak”, meglio, «una balla colossale».
“TUTTI SAPEVANO”
«Ora mi sembra evidente di aver potuto dimostrare ogni oltre ragionevole dubbio che quella notte i vertici Questura di Milano, a seguito dell’interferenza del Presidente del consiglio rilasciarono la minore e la consegnarono a una prostituta tramite la Minetti». Tutti sapevano, ha detto Boccassini, che Karima era una minorenne, «lo dimostra il semplice fatto che subito ne venne chiesto l’affido e l’affido si può chiedere solo per i minori».
-
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- BATTIPAGLIA (Salerno), il Comune dove i Casalesi sono entrati dalla porta principale mentre il sindaco faceva il playboy (di Roberto Galullo)12 maggio 2013
Battipaglia, il Comune dove i Casalesi sono entrati dalla porta principale mentre il sindaco faceva il playboy
di Roberto Galullo *
«Una città solidale ed efficiente ti cambia la vita». Con questo slogan Giovanni Santomauro è diventato sindaco di Battipaglia (Salerno) alle ultime elezioni amministrative. Evidentemente piace. Piace così tanto che il suo profilo facebook tre giorni fa aveva 5.414 "fedeli" (ora 5.409 e i commenti sono diventati aspri).
Piace così tanto, questo sindaco nato ad Albanella (Salerno) nel 1948 - ha dunque 65 anni suonati - che secondo le intercettazioni e gli interrogatori raccolti da investigatori e inquirenti, nel suo ufficio copulava con ardore a destra e manca con due concittadine che riceveva (entrambe separate, con figli e in difficoltà economica).
Dispiace invece alla Giustizia: è infatti finito agli arresti domiciliari. Le sue copule infuocate non sono passate inosservate nel corso dell’indagine Alma (che ora descriverò), visto che gli investigatori della Dia di Napoli e Salerno hanno appurato (anche) alcuni episodi di concussione sessuale. Secondo l’accusa le due cittadine sono state indotte a sottostare alle sue «concupiscenze sessuali», in cambio di un interessamento a trovarle un lavoro o a garantirle contributi comunali.
Ma l’operazione Alma è molto di più perché la Dia di Napoli e Salerno (oltre che di Firenze e Bologna), con l’Arma dei Carabinieri dei rispettivi comandi provinciali, hanno eseguito cinque ordinanze di custodia cautelare e il sequestro di un’azienda, emessi dal Gip Dolores Zanone su richiesta della Dda di Salerno, nei confronti di persone indagate, a vario titolo, per corruzione aggravata, abuso d’ufficio, turbativa d’asta, concussione ed intestazione fittizia di beni.
In particolare, le indagini dei pm Rosa Volpe e Rocco Alfano (che hanno atteso dal 23 luglio 2012 che la propria richiesta fosse firmata da un Gip!), sotto la guida del capo della Procura di Salerno, Franco Roberti, hanno portato alla luce gli interessi del clan dei Casalesi negli appalti indetti dal Comune di Battipaglia tra il 2009 e il 2011. Due imprenditori dell’area casertana, Nicola Madonna e Attilio Guida, secondo l’accusa hanno tenuto strettissimi contatti con il sindaco e tecnici comunali impegnati nel completamento della Casa Municipale (opere edili ed impianti tecnologici) e nella messa in sicurezza di un incrocio, aggiudicandosi irregolarmente appalti per oltre 5 milioni e favorendo così il clan dei "Casalesi". «Per i due imprenditori - ha detto in conferenza stampa il Procuratore di Salerno, Franco Roberti - è contestata l’aggravante mafiosa che non sussiste per il sindaco e i due tecnici comunali».
LE TAPPE
Il primo passaggio del progetto è stato, secondo la ricostruzione investigativa, l’accaparramento della commessa pubblica grazie ad un’offerta presentata con il ribasso d’asta di oltre il 34% rispetto al prezzo di gara da una società edile che di lì a poco sarebbe fallita ed il successivo subentro nell’appalto, attraverso sub appalti non autorizzati e una cessione di ramo d’azienda, di due società diverse ma sempre controllate dai casalesi attraverso la famiglia Madonna.
A fronte dell’ottenimento pilotato dei lavori, il sindaco di Battipaglia, sempre secondo l’accusa, chiedeva ed otteneva dall’imprenditore di Casal di Principe, l’assunzione di alcuni operai sui cantieri, paventando persino di non autorizzare i pagamenti delle commesse fino ad allora eseguite. Tutto ciò avveniva - secondo la ricostruzione della Procura - anche con l’aiuto ed il contributo di due tecnici, che richiedevano ed ottenevano dagli imprenditori tangenti per sbloccare i pagamenti e/o condizionare ulteriori procedure di gara.
LA FAMIGLIA MADDONA Nelle 178 pagine dell’ordinanza firmata dal gip Zanone si legge un profilo non edificante di quella che in vero - all’opinione pubblica nazionale - è nota solo per essere la patria della mozzarella di bufala campana.
E invece...Invece si scopre il ruolo “adesivo” a parti dell’amministrazione pubblica battipagliese di Nicola Madonna, parente di camorristi casalesi, che sa di non poter partecipare un prima persona alle gare di appalto pubbliche e per questo motivo fa ricorso a società intestate formalmente a terzi.
Il fratello è Michelangelo Madonna, di cui alcune società a lui riconducibili, sottoscrive il Gip, hanno ricevuto nel passato interdittiva antimafia dal prefetto di Caserta. Presso la Procura di Napoli, inoltre, pende anche un processo la cui indagine è rivolta all’individuazione d’imprese di riferimento del clan e del loro inserimento degli appalti pubblici. Nel procedimento è indagato un ex socio di Nicola Madonna che, avendo saputo dell’indagine, ha effettuato una serie di cessioni e acquisizioni di quote societarie per distinguere la sua posizione da quella del socio.
Nicola e Michelangelo Madonna, inoltre, sono cugini di secondo grado di Carlo Madonna, condannato per associazione a delinquere di stampo camorristico.
Tutti sono appassionatamente cugini di Pasquale Giovanni Vargas (di Armando), pregiudicato, latitante per diversi anni, arrestato il 20 febbraio 2010.
«Madonna Nicola e anche Guida Attilio che Madonna considera come vero e proprio amico - si legge a pagina 108 dell’ordinanza - rappresentano dunque due volti “apparentemente” puliti della criminalità organizzata casalese attraverso i quali quest’ultima investe i proventi illeciti in attività imprenditoriali, soprattutto di tipo pubblicistico, riuscendo a vincere, attraverso rapporti collusivi con funzionari e politici locali, gare di appalto presso pubbliche amministrazioni. Madonna Nicola non vi partecipa ancora in prima persona perché sa che “non è ancora il momento di farlo”, che bisogna attendere che il collegamento economico con la realtà criminale da cui proviene si affievolisca ma, soprattutto, che il legame collusivo con l’amministrazione pubblica si consolidi in maniera tale da non richiedere ulteriori intermediazioni illecite».
LA STRANA DISPONIBILITA’
I funzionari del Comune di Battipaglia - si legge a pagina 22 dell’ordinanza - consapevoli che dietro tutte le imprese appaltatrici dei lavori del Municipio ci fosse sempre e solo Nicola Madonna, si prestavano a favorirne l’aggiudicazione dell’appalto, ad incrementarne i costi per accrescerne i guadagni. «Queste condotte sono ben strane - si legge nel provvedimento - se si tiene conto del fatto che sono rivolte a favorire un soggetto che non può formalmente apparire nei lavori appaltati e che li gestisce, come “capo occulto”, presente di fatto nel cantiere, referente fondamentale di tutti i problemi ma formalmente inesistente in un pubblico appalto di rilevante interesse economico».
CONCUSSIONE PER INDUZIONE
Al sindaco vengono addebitati quattro episodi sostanzialmente “per induzione”. In due episodi - si legge a pagina 158 dell’ordinanza - «...al fine di rilevare come la pressione esercitata dal sindaco Santomauro sul Nicola Madonna al fine di indurlo ad assumere personale segnalato non costituisca una condotta isolata del Santomauro bensì un tipico modus agendi del primo cittadino, si riporta una conversazione intercorsa....Anche in questo caso la conversazione è esplicita. Il sindaco chiede a...omissis...l’assunzione di personale da lui indicato, a tale richiesta l’imprenditore risponde che sarebbe preferibile che gli indicasse le ditte alle quali rivolgersi per le forniture e non di assumere i lavoratori temendo che possano essere “gentaglia” che lo costringe a chiamare i Carabinieri e ciò avrebbe ricadute negative anche per la realizzazione dell’opera.
...Omissis...è una persona intelligente e, capendo la “forzatura” che sta subendo, peraltro alla presenza di...omissis..., si appella alla conoscenza del Santomauro come “persona per bene” il che pone il sindaco nell’imbarazzo di imporgli il nominativo di qualche operaio e così indica, con l’aiuto di una donna appena entrata, probabilmente la segretaria, i nominativi generali di...Di fatto la richiesta di assunzione formulata dal sindaco Santomauro non ha seguito con...omissis...in quanto gli accertamenti svolti dalla pg e mezzo interrogazioni al sistema informativo Inps, non ne hanno consentito l’individuazione tra i dipendenti della società...omissis...
Con il Madonna il sindaco ha potuto agire illecitamente in più modi e in più occasioni operando il medesimo Madonna in una condizione di illeceità. Con...omissis..., onesto imprenditore i sindaco ha temuto reazioni da parte di costui e pertanto ha preferito non calcare ulteriormente la mano e non ha insistito ulteriormente nell’imposizione di operai».
LA VITA E IL SESSO
Quanto ai reati di concussione sessuale iscritti al sindaco è meglio sorvolare perché la lettura delle intercettazioni - che se riportate su un articolo richiamerebbero pruriginosità - è davvero poco edificante.
Per capire gli “appetiti” del sessantacinquenne sindaco -già segretario e direttore generale dello stesso Comune oltre che commissario nel Comune di Casal di Principe - basti riportare un passo secondo il quale per gli investigatori e gli inquirenti quello «con...omissis...è particolarmente allarmante nel contenuto delle richieste oscene che le vengono esternate dal sindaco, ossia quella di partecipare a un “rapporto a tre”, unitamente alla sua amante, richieste che il sindaco le ripete anche più volte contattandola per telefono...».
Con l’augurio - come sempre - che tutti gli indagati riescano a dimostrare la propria innocenza e che la Giustizia faccia il suo corso, vi saluto.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- Potere e affari, il patto segreto tra Vaticano e Massoneria (di Alberto Statera)10 maggio 2013
La croce e il compasso
Potere e affari, il patto segreto tra Vaticano e Massoneria
di Alberto Statera (la Repubblica, 10 maggio 2013)
Il “fumo di Satana” evocato da Papa Paolo VI quarant’anni fa è filtrato da qualche fessura pure nell’ultimo conclave, che ha eletto il gesuita Francesco a capo di una Chiesa ridotta come quella profetizzata dal vescovo Malachia, percorsa da lotte di potere e guerre per bande. Quel fumo ha l’odore acre della massoneria, una parola che fa tremare da secoli persino le foglie dei giardini vaticani. Eppure, logge ufficiali, logge segrete e logge spurie sono avvinghiate nel cuore di San Pietro.
Questa, almeno, è la tesi di un libro-inchiesta di oltre 500 pagine che stanno per mandare in libreria Giacomo Galeazzi e Ferruccio Pinotti ( Vaticano Massone. Logge, denaro e poteri occulti: il lato segreto della Chiesa di Papa Francesco
 Edizioni Piemme).
Edizioni Piemme).Il tema, naturalmente, si presta di per sé all’accusa di complottismo, di insana volontà di vedere ovunque trame segrete e cospirazioni. L’ha messa in burla il Segretario di Stato uscente Cardinal Bertone quando ha irriso ai giornalisti che si improvvisano Dan Brown. Ma il libro è talmente documentato, ricco di testimonianze e di documenti inediti che una confutazione con questo argomento non reggerebbe.
Tra l’altro, contiene la copia anastatica di una lettera scritta da Virgilio Gaito, ex Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia, insieme al Cardinale Silvio Oddi, a Papa Giovanni Paolo II per chiedere un “grande patto” di pacificazione tra Chiesa e massoneria, il riconoscimento ufficiale da parte del Vaticano della conciliabilità tra fede cattolica e appartenenza alla libera muratoria. «Pienamente consapevoli delle finalità perseguite dalla Massoneria universale, da sempre votata al miglioramento dell’individuo per il miglioramento ed il progresso dell’Umanità raggiungibili solo attraverso l’Amore e la tolleranza - scrivono il Gran Maestro e il Cardinale - riteniamo giunto il momento di lanciare un doveroso appello alla riconciliazione che ponga fine a quella secolare incomprensione tra Chiesa Cattolica e Massoneria».
Oddi, morto nel 2011, è stato considerato un grande protettore dell’Opus Dei, ma anche sponsor della discesa in campo nel 1994 di Silvio Berlusconi, tessera 1816 della Loggia P2 di Licio Gelli e, secondo il massone dissidente Gioele Magaldi, fondatore di una sua obbedienza denominata “Loggia del Dragone”.
Wojtyla, del resto, si servì in Polonia a favore di Solidarnosc e contro il comunismo del bancarottiere piduista Roberto Calvi, finito ucciso con rito massonico a Londra sotto il Ponte dei Frati neri. Come il suo predecessore Paolo VI, che fece realizzare simboli esoterici sulla tomba della madre, si era servito dell’altro bancarottiere mafioso e piduista Michele Sindona.
Ma sotto il papato di Wojtyla, nel 1983, vide la luce la “Dichiarazione sulla Massoneria” elaborata dal prefetto della Congregazione per la dottrina della fede Joseph Ratzinger, che dichiarava inalterato il divieto di appartenenza alla libera muratoria. Divieto disatteso durante il suo papato, secondo la messe di documenti e testimonianze raccolta da Galeazzi e Pinotti, tanto da aver probabilmente contribuito a provocare le dimissioni di Benedetto XVI e forse l’elezione di Francesco, primo Papa gesuita della storia, dopo che la Compagnia di Gesù, considerata uno dei canali dell’infiltrazione massonica in Vaticano, era stata commissariata da Wojtyla nel 1981.
Durante il pontificato di Ratzinger è cresciuto in Vaticano il potere dei gruppi integralisti in lotta tra loro, come Opus Dei, Comunione e Liberazione, Focolarini, Legionari di Cristo, che si sono contesi il controllo delle finanza e dello Ior.
Ma l’ex banchiere Cesare Geronzi, intimo del cardinal Bertone, il quale raramente parla a caso, ha rivelato di recente di aver trovato simboli massonici in evidenza nello studio di un cardinale e che nella finanza cattolica l’Opus Dei non conta molto perché a contare è la massoneria. E dentro le Mura Leonine?
Di certo la massoneria è entrata con prepotenza nel processo al maggiordomo-corvo di Ratzinger che sottraeva documenti nella scrivania di uno degli uomini più potenti del mondo. «Mi sono messo al servizio di una loggia massonica che opera dentro il Vaticano - ha testimoniato tra le lacrime un dipendente laico della Segreteria di Stato - della quale fanno parte anche dei cardinali. Scopo della nostra azione portata avanti nella convinzione di fare il bene della Chiesa, è quello di mettere fine all’attuale situazione di anarchia che mette a rischio la cristianità».
Tra le migliaia di documenti sequestrati il 23 maggio 2012 nell’abitazione del maggiordomo “moltissime riguardavano la massoneria e i servizi segreti”, come hanno dichiarato gli agenti della gendarmeria che fecero le perquisizioni. Con un’attenzione quasi ossessiva per la figura del piduista Luigi Bisignani, che era di casa allo Ior fin dai tempi del riciclaggio della tangente Enimont.
La rete di confidenti dell’ex maggiordomo comprendeva il vicario papale per la città del Vaticano monsignor Angelo Comastri e l’ex vicecamerlengo Paolo Sardi, indicati come appartenenti a una loggia massonica interna; il vescovo Francesco Cavina, ora alla diocesi di Carpi, ma in precedenza alla Segreteria di Stato, e l’ex segretaria di Ratzinger, Ingrid Stampa.
Bergoglio cresce e si forma in Argentina, una repubblica fondata su squadra e compasso, dove la massoneria e la Chiesa sono molto forti. È sostenibile la tesi che lo strapotere dei gruppi integralisti abbia originato come reazione la sua elezione al trono di Pietro? O che sia invece frutto di un patto tra massoneria e gruppi della destra cattolica?
Nel libro di Galeazzi e Pinotti non troverete una risposta certa, ma la non peregrina ipotesi che la decisione di Ratzinger di dimettersi possa essere stata presa nella previsione dell’elezione del gesuita su un trono che lui non riusciva più a governare tra scandali e guerre intestine tra fazioni contrapposte per il potere e il denaro. Nella prima fase del conclave del 2005, del resto, il cardinale Bergoglio aveva raccolto il maggior numero di voti, ma poi rinunciò per convogliarli su Ratzinger.
Che fosse fumo di Satana o aria salubre quella respirata in conclave, i Gran Maestri delle tante massonerie italiane sembrano concordi nell’entusiasmo per l’avvento di Francesco. Uno per tutti: «Con Papa Francesco nulla sarà più come prima. Chiara la scelta di fraternità per una Chiesa del dialogo, non contaminata dalle logiche e dalle tentazioni del potere temporale». Firmato: Gustavo Raffi, Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- A MARGINE DEI DISASTRI: LA QUESTIONE LAICI E CATTOLICI}} (di Giancarla Codrignani)10 maggio 2013, di Federico La Sala
- VIVA L’ITALIA!!! LA QUESTIONE "CATTOLICA" E LO SPIRITO DEI NOSTRI PADRI E E DELLE NOSTRE MADRI COSTITUENTI. Per un ri-orientamento antropologico e teologico-politico. Una nota (del 2006) - di Federico La Sala
A MARGINE DEI DISASTRI: LA QUESTIONE LAICI E CATTOLICI
di Giancarla Codrignani *
È tornata a galla in questi giorni, ma la questione ha un’origine lontana: quando io andavo ancora a scuola e rifiutavo l’esistenza di un "partito dei cattolici", a mio avviso "eretico".
Il neotemporalismo preparava frutti amari anche per i tempi in cui sarebbe diventato un fantasma. Perciò fu per me un momento cruciale quando Enrico Berlinguer parlò di "incontro" tra culture comunista, socialista e cattolica: programma serio reso vano dalla prassi del "compromesso" amato dai burocrati di tutti i partiti e inteso opportunisticamente come accordo ai vertici.
Proprio come Togliatti volle i Patti lateranensi nella Costituzione per quella cosa orrenda, anche linguisticamente, che oggi si chiama inciucio, così il Pci degli anni Ottanta (del secolo scorso) cercava l’intesa di governo con la Dc. Il che era perfino politicamente ovvio, soprattutto in un paese come l’Italia destinato a non avere mai avuto alternanza di governo; ma senza fare leva sulla crescita culturale della gente, già il Pci doveva sapere che sarebbe rimasto, anche se avesse raggiunto l’intento, prigioniero come il Psi nella stanza dei bottoni. All’inizio degli anni Novanta avvenne l’impensabile: un processo di corruzione - in un paese che quarant’anni prima chiamava i democristiani "i forchettoni" e chi aspirava ad un sussidio gli si raccomandava per ottenere, anche sano, una pensione di invalidità - dissolse in pochi mesi cinque partiti storici: Dc, Psi, Psdi, Pri, Pli.
Non avvenne certo per lo scandalo della corruzione scoperto da "Mani pulite", anche se la gente si arrabbiò di brutto, ma perché i partiti (la stessa forma-partito) erano intollerabilmente vecchi, rispetto ad un mondo divenuto complesso che imponeva ai politici di ripensare (magari studiando) il loro ruolo e le loro competenze.
La destra non ha mai avuto una forma partitica seria, dopo il Pli, ed è finita nel berlusconismo; mentre la sinistra non si è mai messa in analisi e ha dovuto aspettare che Bertinotti andasse in pensione per chiudere una delle sue vetrine. Invece la società italiana era pronta, dopo la caduta del muro di Berlino e Mani pulite, per quel Partito Democratico che si è inventato dopo le dissolvenze Pds, Ds e le tensioni D’Alema/Veltroni. Insieme si inventava purtroppo la Margherita e Casini vagheggiava il Centro.
Ritornavano, sostenuti da Ruini, i cattolici che, dopo il Concilio Vaticano II, dovevano essere diventati attenti a quel bene comune che è laico, anche se lo Ior era da sempre inquietante e gli elettori già democristiani stavano per votare compatti Berlusconi.
Senza elaborare risposte all’esigenza di cambiare pelle - di fronte ad un futuro sempre più urgente - con idee nuove da condividere con il paese, i diesse si sono accordati con una "Margherita" rassicurante, come se i cromosomi identitari fossero eliminabili con qualche spartizione; tanto più che il peso numerico del Pd non era confrontabile con quello dei cattolici che mantenevano le loro pretese, non solo di idee. L’elezione di Prodi fu un momento alto anche per il recupero di senso: l’uomo era un cristiano adulto, un personaggio di livello internazionale estraneo ai tatticismi (anche perché non ne aveva bisogno): peccato che sia stato fatto fuori, senza neppure un tentativo credibile a giustificazione dell’incidente. Adesso non solo è stato proposto Marini, uno che neppure i cattolici volevano (per un paese che ha bisogno di recupero di credibilità internazionale), ma è stato fatto uscire da una trattativa indecente con il PdL
Quando, poi, a rimediare l’errore, il cilindro manda fuori il coniglio Prodi, i soliti gli hanno tolto il voto. Alla base del popolo sovrano (che non ha idea di come si configuri la sua sovranità) tutto questo sembra (ed è) incomprensibile.
Certamente bisogna che il Pd vada a Congresso, ricominci a tessere relazioni interne ed esterne e riorienti la dirigenza. Intanto, come ai tempi di Ingrao e Amendola, ci ritroviamo - mutati i tempi! - a fare i conti fra Bersani (o, al suo posto, Barca) e Renzi. Non ci sono altri nomi, né altre tendenze per la solita "linea" che non può più calare dall’alto... Ma intanto sono andati avanti i grillini, in corsa dietro un comico che li pilota dalla rete e dal cellulare, proprio come i loro genitori si fidavano di uno che gli firmava in tv il patto con gli italiani e che adesso gli ha promesso l’abolizione dell’ Imu. Con problemi istituzionali gravi che vanno affrontati, a partire dalla regolamentazione della rappresentatività via internet.
Chiunque voglia curarsi del paese, laico o cattolico che sia, deve fare il cittadino responsabile e il Pd bisogna che si rimetta in gioco e faccia cultura, cultura, cultura, anche se non si sa che cosa proporre, che certezze offrire: è più vincente farsi aiutare da chi forse ne sa meno di te, ma è vivo in questo mondo e vuole sapere (oltre ad averne diritto) che senso ha viverci. I cattolici dicevano "il bene comune"....
N.B. La rabbia non è una mia passione. Mi viene tardiva, di testa. Quindi aggiungo qualche chiarimento al testo. Ma, a distanza di qualche giorno, proseguo un ragionamento che diventa giudizio.
Severo, anche perché vedo che ci si accontenta di due o tre dichiarazioni di ignari che hanno votato la loro stima per Rodotà. L’indagine - figurarsi la censura - sui 101 ha poco senso; e, giustamente, la si pone per finta. Invece si accettano, senza far verbo, accuse dell’informazione su divisioni e lotte interne, poco preoccupanti se non si aggiungesse "per bande".
Qualche politico insinua a quattr’occhi - e mai vorrebbe essere nominato - la catena di intrighi apertasi con l’incontro Bersani/Berlusconi. Marini non era bene accetto nemmeno ai cattolici: perché non è stata traumatica la sua caduta e gli si è trovato subito un successore? È stato prontamente sostituito da Prodi, che più candidato del centro-sinistra non poteva essere, ma era anche il massimo nemico di Berlusconi (che avrebbe forse accettato perfino Rodotà, ma mai Prodi). E nasce la bocciatura. Le elezioni del Presidente della Repubblica non sono sempre state lineari: Pertini l’abbiamo eletto in sedici tornate, ancor di più per Scalfaro.
Come mai il dramma ha bloccato la ripresentazione di Prodi o una nuova "sorpresa", come la chiamava Bersani? Solo per il rumore del M5S interno all’aula ed esterno? La piazza ha sempre fatto rumore e in aula dall’antico Pci o i radicali fino - oddio lo stile - ai mangiatori di mortadella i richiami all’ordine si sprecavano. In questo caso il capolinea per Prodi e il dramma fino al ricorso a Napolitano hanno impedito di capire chi mai fosse stato previsto come terzo candidato.
Questo è il vizio oggi intollerabile dei "vecchi" partiti: era necessario che il Pd dicesse pubblicamente quali erano le carte su cui puntava. Non averlo fatto autorizza a pensare che il nome prestigioso di Rodotà (che M5S ha venduto come merce propria e poi svenduto al conteggio tardivo di nemmeno 5.000 preferenze) insieme con Prodi abbia affossato un gioco che avrebbe portato alla terza proposta, nemmeno tanto misteriosa, che l’autodifesa tesissima di un D’Alema di solito controllato e irridente ha fatto sparire.
Certo Bersani ha le responsabilità formali degli errori, ma, proprio perché un segretario non è né un autocrate né un martire, non deve permettere la favola italica di storie che non si saprà mai come sono veramente andate.
Giancarla Codrignani
Articolo tratto da:
FORUM Koinonia 345 (9 maggio 2013)
http://www.koinonia-online.it
Convento S.Domenico - Piazza S.Domenico, 1 - Pistoia - Tel. 0573/22046
* Il Dialogo, Giovedì 09 Maggio,2013
- VIVA L’ITALIA!!! LA QUESTIONE "CATTOLICA" E LO SPIRITO DEI NOSTRI PADRI E E DELLE NOSTRE MADRI COSTITUENTI. Per un ri-orientamento antropologico e teologico-politico. Una nota (del 2006) - di Federico La Sala
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- «Meglio essere peccatori che corrotti». "Guarire dalal corruzione". La lezione semplice del vescovo Bergoglio (di Gian Guido Vecchi)24 marzo 2013
«Meglio essere peccatori che corrotti» La lezione semplice del vescovo Bergoglio
di Gian Guido Vecchi (Corriere della Sera, 24 marzo 2013)
«Potremmo dire che il peccato si perdona, la corruzione non può essere perdonata. Semplicemente per il fatto che alla radice di qualunque atteggiamento corrotto c’è una stanchezza della trascendenza: di fronte al Dio che non si stanca di perdonare, il corrotto si erge come autosufficiente nell’espressione della sua salvezza: si stanca di chiedere perdono».
La corruzione corrode la politica, l’economia, la società, arriva a minacciare la stessa Chiesa. E le parole di Jorge Mario Bergoglio sono severe e semplici: meglio peccatori che corrotti. Perché dal peccato si può essere perdonati, dalla corruzione no: se ne deve guarire, proprio come da un male.
Il libro, Guarire dalla corruzione , riprende una meditazione pronunciata dall’allora arcivescovo di Buenos Aires nel 2005 e viene pubblicato per la prima volta in italiano (Editrice missionaria italiana, che fa uscire anche un altro testo: Umiltà, la strada verso Dio ) con la postfazione di Pietro Grasso: «I giorni dell’elezione di papa Francesco hanno portato in Italia una calda brezza di rinnovamento», scrive il neopresidente del Senato. «Proprio in quelle ore, mentre l’uomo vestito di bianco venuto dalla "fine del mondo" parlava di "tenerezza" e "povertà", il nostro Paese tentava di trovare una via d’uscita dall’ennesima impasse politica, accompagnata da una drammatica crisi sociale e dal degrado morale che divora ormai le nostre istituzioni...».
Sono parole molto attuali per ogni Paese e istituzione, quelle di Bergoglio. Che inizia subito a distinguere: «Non bisogna confondere peccato con corruzione. Il peccato, soprattutto se reiterato, conduce alla corruzione, non però quantitativamente (tanti peccati fanno un corrotto), ma piuttosto qualitativamente, con il generarsi di abitudini che vanno deteriorando e limitando la capacità di amare, ripiegando ogni volta di più i riferimenti del cuore su orizzonti più vicini alla sua immanenza, al suo egoismo».
Così il futuro Papa, a proposito degli «uomini ingiusti», cita San Paolo: «Essi sono dunque inescusabili, perché, pur conoscendo Dio, non gli hanno dato gloria né gli hanno reso grazie come Dio, ma hanno vaneggiato nei loro ragionamenti e si è ottenebrata la loro mente ottusa».
Ma la corruzione «non può rimanere nascosta», considera caustico Bergoglio: «Lo sbilanciamento tra la convinzione di bastare a se stessi e la realtà di essere schiavi di quel tesoro non può essere arginato. È uno squilibrio che esce fuori e, come succede con tutte le cose chiuse su se stesse, bolle per sfuggire alla propria pressione... E, al fuoriuscire, sparge l’odore di questa chiusura su se stessi: puzza. Sì, la corruzione odora di putrefazione».
Il corrotto però, «come succede con l’alito cattivo», non se ne accorge. Non resta che guarirne: «Generalmente il Signore lo salva attraverso prove che gli arrivano da situazioni che non può evitare (malattie, perdita di ricchezze, di persone care eccetera) e sono queste che spaccano l’ossatura corrotta e permettono l’accesso della grazia. Adesso potrà essere curato».
La riflessione di Pietro Grasso al termine del libro parte da qui, dal «dovere di iniziare un nuovo cammino» attraverso «la ricostruzione morale del Paese».
Scrive il presidente del Senato: «Il percorso è impervio, ma ci accompagnano ora quelle profonde riflessioni dell’allora cardinale Bergoglio che fa della corruzione non solo la somma "quantitativa" dei peccati, ma una mala pianta che minaccia le fondamenta su cui sono costruiti gli Stati democratici e la Chiesa stessa».
La «scossa morale» di papa Francesco si oppone all’«egoismo della corruttela», conclude Grasso: «Il suo messaggio è così chiaro che nessuno potrà più giustificarsi dicendo "non avevo capito" o "così fanno tutti"». G. G. V.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- LA CHIESA E L’ITALIA AL BIVIO: IL PUTTANESIMO UNIVERSALE (Dante e Vico).3 marzo 2013, di Federico La Sala
Dante Alighieri, Inferno (Canto XIX, vv.103-117)
 Di voi pastor s’accorse il Vangelista,
Di voi pastor s’accorse il Vangelista,
 quando colei che siede sopra l’acque
quando colei che siede sopra l’acque
 puttaneggiar coi regi a lui fu vista;
puttaneggiar coi regi a lui fu vista; quella che con le sette teste nacque,
quella che con le sette teste nacque,
 e da le diece corna ebbe argomento, fin che virtute al suo marito piacque.
e da le diece corna ebbe argomento, fin che virtute al suo marito piacque. Fatto v’avete dio d’oro e d’argento;
Fatto v’avete dio d’oro e d’argento;
 e che altro è da voi a l’idolatre,
e che altro è da voi a l’idolatre,
 se non ch’elli uno, e voi ne orate cento?
se non ch’elli uno, e voi ne orate cento? Ahi, Costantin, di quanto mal fu matre,
Ahi, Costantin, di quanto mal fu matre,
 non la tua conversion, ma quella dote
non la tua conversion, ma quella dote
 che da te prese il primo ricco patre!».
che da te prese il primo ricco patre!».IL PUTTANESIMO UNIVERSALE:
LA CHIESA E L’ITALIA AL BIVIO: VICO E LA STORIA DEI LEMURI (LEMURUM FABULA), OGGI. Un invito alla (ri)lettura della "Scienza Nuova"
 Potrai facilmente, o Leggitore, intendere la bellezza di questa divina Dipintura dall’orrore, che certamente dee farti la bruttezza di quest’altra, ch’ora ti dò a vedere tutta contraria.
Potrai facilmente, o Leggitore, intendere la bellezza di questa divina Dipintura dall’orrore, che certamente dee farti la bruttezza di quest’altra, ch’ora ti dò a vedere tutta contraria.-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- GUARIRE DALLA CORRUZIONE ( di Mario Jorge Bergoglio/Papa Francesco - La corruzione, male del cuore)24 marzo 2013, di Federico La Sala
La corruzione, male del cuore
di Jorge Mario Bergoglio (la Repubblica, 24 marzo 2013)
- Il testo è tratto dal libro “Guarire dalla corruzione” di Mario Jorge Bergoglio/Papa Francesco edito da Emi, in uscita domani.
Oggi si parla spesso di corruzione, soprattutto per ciò che riguarda l’attività politica. Viene denunciata in diversi ambienti sociali. Vari vescovi hanno segnalato la “crisi morale” che attraversa molte istituzioni. Intanto la reazione generale di fronte a certi fatti che sono indice di corruzione è andata crescendo.
[...] E, tuttavia, ogni corruzione sociale non è altro che la conseguenza di un cuore corrotto... Non ci sarebbe corruzione sociale senza cuori corrotti: «Ciò che esce dall’uomo, questo sì contamina l’uomo. Dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono le intenzioni cattive: fornicazioni, furti, omicidi, adultèri, cupidigie, malvagità, inganno, impudicizia, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dal di dentro e contaminano l’uomo» (Mc 7,20- 23).
Un cuore corrotto: qui sta il punto. Perché un cuore si corrompe? [...] Il cuore umano è cuore nella misura in cui è in grado di riferirsi a un’altra cosa: nella misura in cui è capace di aderire, nella misura in cui è capace di amare o di negare l’amore (odiare). Per questo Gesù, quando invita a conoscere il cuore come fonte delle nostre azioni, richiama la nostra attenzione su questa adesione finalistica del nostro cuore inquieto: «Là dov’è il tuo tesoro, sarà anche il tuo cuore» (Mt 6,21).
Conoscere il cuore dell’uomo, il suo stato, comporta necessariamente conoscere il tesoro al quale questo cuore si riferisce, il tesoro che lo libera e lo riempie o che lo distrugge e lo riduce in schiavitù; in quest’ultimo caso, il tesoro che corrompe. Di modo che dal fatto della corruzione (personale o sociale) si passa al cuore come autore e preservatore di questa corruzione, e dal cuore si passa al tesoro al quale è attaccato questo cuore. [...]
In primo luogo, può essere utile addentrarsi nella struttura interna dello stato di corruzione «soppesando la disonestà e malizia che... porta in sé»; sapendo che, sebbene la corruzione sia una condizione intrinsecamente legata al peccato, si distingue in alcuni punti di esso.
In secondo luogo, è pur utile descrivere il modo di procedere di una persona, di un cuore corrotto (che è diverso da quello di un peccatore). In terzo luogo, considerare alcune delle forme di corruzione con le quali Gesù ebbe a scontrarsi nel suo tempo.
Infine, sarà utile interrogarsi sulla forma di corruzione che potrebbe essere più tipica di una persona religiosa. È chiaro che può portare in sé una corruzione simile a quella del resto dei mortali, però qui mi interessa indagare ciò che io chiamerei corruzione minore, cioè la possibilità che un religioso abbia il cuore corrotto ma (mi si permetta l’espressione) venialmente, cioè che la sua lealtà nei confronti di Gesù Cristo sia indolenzita da un certo grado di paralisi. Può essere che un religioso partecipi di un ambiente corrotto? È possibile che un religioso sia - in qualche modo - parzialmente o venialmente corrotto? [...]
Corruptio optimi, pessima. Questo motto può applicarsi ai religiosi corrotti. E ce ne sono, eccome. Per saperlo, basta leggere la storia. Nei diversi ordini che hanno richiesto una riforma o che l’hanno fatta, c’era un maggiore o minore grado di corruzione. Non voglio riferirmi qui ai casi ovvi di corruzione, ma piuttosto a stati di corruzione quotidiana, che io chiamerei veniale, ma che fanno arenare la vita religiosa. Come si produce ciò?
Il beato Fabro utilizzava una regola d’oro per individuare lo stato di un’anima che viveva tranquillamente e in pace: proporle qualcosa in più ( magis ). Se un’anima era chiusa alla generosità, avrebbe reagito male. L’anima si abitua al cattivo odore della corruzione. Come succede in un ambiente chiuso: solo chi viene dall’esterno si accorge dell’aria viziata. E quando si vuole aiutare una persona così, il cumulo di resistenze è enorme.
Gli israeliti erano schiavi in Egitto, ma si erano abituati alla perdita della libertà, avevano adeguato la forma della loro anima a quella condizione, non immaginavano un’altra maniera di vivere. La loro coscienza era addormentata e, in questo senso, possiamo affermare che era una sorta di corruzione. Quando Mosè annuncia loro il progetto di Dio, «essi non ascoltarono Mosè, perché erano all’estremo della sopportazione per la dura servitù». (Es 6,9).
[...] Sotto la minaccia della potenza assira, gli anziani d’Israele, stanchi e impauriti, vorrebbero scendere a patti con il nemico; deve farsi avanti Giuditta a rileggere loro la storia affinché non accettino come pecore situazioni che Dio non vuole. [...] E gli apostoli preferivano non credere a ciò che i loro occhi vedevano quella mattina nel cenacolo: dice il Vangelo che «per la grande gioia ancora non credevano» (Lc 24,41).
Ecco qui il nodo del problema: un percorso doloroso demoralizza sempre, avere sperimentato delle sconfitte conduce il cuore umano ad abituarvisi, per non doversi sorprendere né tornare a soffrire se ne arrivassero altre. O semplicemente uno è soddisfatto dello stato in cui si trova e non vuole altri problemi.
In tutte queste citazioni bibliche incontriamo reticenza. Il cuore non vuole problemi. Esiste il timore che Dio ci imbarchi in viaggi che non possiamo controllare. Esiste un timore della visita di Dio, un timore della consolazione. In questo modo si matura una disposizione fatalista; gli orizzonti si rimpiccioliscono a misura della propria desolazione o del proprio quietismo. Si teme l’illusione e si preferisce il realismo del meno alla promessa del più [...]
Invece, nella preferenza per il meno che sembrerebbe più realista c’è già un sottile processo di corruzione: si arriva alla mediocrità e alla tiepidezza (due forme di corruzione spirituale), si arriva alla trattativa con Dio secondo il modello del primo o del secondo binario. Nella preghiera penitenziale del sacramento della riconciliazione si chiede il perdono per altri peccati... ma non si mostra al Signore questo dato di scoraggiamento dell’anima. È la lenta, ma definitiva, sclerosi del cuore.
L’anima inizia allora ad accontentarsi dei prodotti che le offre il supermercato del consumismo religioso. Più che mai vivrà la vita consacrata come una realizzazione immanente della sua personalità. Per molti tale realizzazione consisterà nella soddisfazione professionale, per altri nell’esito delle opere, per altri nel compiacersi di sé per la stima di cui sono fatti oggetto.
Altri ancora cercheranno nella perfezione degli strumenti moderni di riempire quel vuoto che la loro anima sente rispetto al fine che un tempo cercò e dal quale si lasciò cercare. Altri faranno un’intensa vita sociale: si godranno uscite, vacanze con gli «amici», grandi mangiate e feste; cercheranno di essere tenuti in considerazione in tutte le occasioni che comportano la loro presenza.
Potrei continuare citando casi di corruzione, ma - semplificando - tutto questo non è nient’altro che qualcosa di più profondo: ciò che ho già chiamato «mondanità spirituale».
La mondanità spirituale come paganesimo in vesti ecclesiastiche. Davanti a questi uomini e donne corrotti nella loro vita consacrata, la Chiesa mostra la grandezza dei suoi santi... che hanno saputo trascendere ogni apparenza fino a contemplare il volto di Cristo, e questo li ha resi «pazzi per Cristo».
Chissà, uno sogna ad occhi aperti e vorrebbe ravvivare questa parte morta del cuore, avverte l’invito del Signore... Ma no, quanto lavoro, troppa fatica! La nostra indigenza deve sforzarsi un poco per aprire uno spazio alla trascendenza, ma la malattia della corruzione ce lo impedisce. E il Signore non si stanca di chiamarci: «Non avere paura... ». Non temere che cosa? Non temere la speranza... e la speranza non delude.
-
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- FINE DEL PONTIFICATO: 28 FEBBRAIO 2013, DIMISSIONI DI BENEDETTO XVI. L’ANELLO DEL PESCATORE (PIRATA) DISTRUTTO E UNA BUONA OCCASIONE PER LA CHIESA.28 febbraio 2013, di Federico La Sala
MESSAGGIO DELL’EVANGELO ("DEUS CHARITAS EST": 1 Gv. 4.8), MESSAGGIO DEL POSSESSORE DELL’"ANELLO DEL PESCATORE" ("DEUS CARITAS EST": BENEDETTO XVI, 2006), E TEOLOGIA POLITICA DELL’"UOMO SUPREMO" ("DOMINUS IESUS", 2000):
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- Appello per la riforma della Chiesa ... prima che sia troppo tardi! (di Leonardo Boff)3 marzo 2013, di Federico La Sala
Appello per la riforma della Chiesa ... prima che sia troppo tardi!
di Leonardo Boff *
- Allora Gesù, chiamatili a sé, disse loro: «Voi sapete che coloro che sono ritenuti capi delle nazioni le dominano, e i loro grandi esercitano su di esse il potere.
 Fra voi però non è così; ma chi vuol essere grande tra voi si farà vostro servitore, e chi vuol essere il primo tra voi sarà il servo di tutti. (Mc 10, 42-44)
Fra voi però non è così; ma chi vuol essere grande tra voi si farà vostro servitore, e chi vuol essere il primo tra voi sarà il servo di tutti. (Mc 10, 42-44)
La Chiesa-istituzione come “casta meretrix”
di Leonardo Boff 27/02/2013
Chi ha seguito le notizie degli ultimi giorni sugli scandali dentro al Vaticano, portati a conoscenza dai giornali italiani “La Repubblica” e “La Stampa”, che parlano di una relazione di 300 pagine e elaborata da tre cardinali provetti sullo stato della curia vaticana, deve naturalmente, essere rimasto sbalordito. Immagino i nostri fratelli e sorelle devoti, frutto di un tipo di catechesi che celebra il Papa come “il dolce Cristo in Terra”. Devono star soffrendo molto, perché amano il giusto, il vero e il trasparente e mai vorrebbero legare la sua immagine a notorie malefatte di assistenti e cooperatori.
Il contenuto gravissimo di queste relazioni rafforza, a mio parere, la volontà del papa di rinunciare. E’ la riprova di un’atmosfera di promiscuità, di lotta per il potere tra “monsignori”, di una rete di omosessuali gay dentro al Vaticano e disvio di denaro attraverso la banca del Vaticano come se non bastassero i delitti di pedofilia in tante diocesi, delitti che hanno profondamente intaccato il buon nome della Chiesa-istituzione.
Chi conosce un poco la storia della Chiesa - e noi professionisti dell’area dobbiamo studiarla dettagliatamente - non si scandalizza. Ci sono state epoche di vera rovina del Pontificato con Papi adulteri, assassini e trafficanti di immoralità. A partire da Papa Formoso (891-896) sino a Papa Silvestro (999-1003) si instaurò, secondo il grande storico cardinale Baronio, l’“era pornocratica” dell’alta gerarchia della Chiesa. Pochi papi la passavano liscia senza essere deposti o assassinati. Sergio III (904-911), assassinò i suoi 2 predecessori, il Papa Cristoforo e Leone V.
La grande rivoluzione nella Chiesa come un tutto è avvenuta, con conseguenze per tutta la storia ulteriore, col papa Gregorio VII, nel 1077. Per difendere i suoi diritti e la libertà della istituzione-Chiesa contro re e principi che la manipolavano, pubblicò un documento che porta questo significativo titolo “Dictatus Papae” che tradotto alla lettera significa “la dittatura del Papa”. Con questo documento, lui assunse tutti poteri, potendo giudicare tutti senza essere giudicato da nessuno. Il grande storico delle idee ecclesiali Jean-Yves Congar, domenicano, la considera la maggior rivoluzione avvenuta nella chiesa. Da una chiesa-comunità è passata a essere una istituzione-società monarchica e assolutista, organizzata in forma piramidale e che arriva fino ai nostri giorni.
Effettivamente il canone 331 dell’attuale Diritto Canonico si connette a questa lettura, con l’attribuzione al Papa di poteri che in verità non spetterebbero a nessun mortale se non al solo Dio: “in virtù del suo Ufficio, il Papa ha il potere ordinario, supremo, pieno, immediato, universale” e in alcuni casi precisi, “infallibile”.
Questo eminente teologo, Congar, prendendo la mia difesa davanti al processo dottrinario mosso dal cardinale Joseph Ratzinger in ragione del libro “Chiesa: carisma e potere” ha scritto un articolo su “La Croix” 08.09.1984) su “Il carisma del potere centrale”. Scrive: “il carisma del potere centrale è non aver nessun dubbio. Ora, non aver nessun dubbio su se stessi è, nello stesso tempo, magnifico e terribile. È magnifico perché il carisma del centro consiste precisamente nel rimanere saldi quando tutto intorno vacilla. E è terribile perché a Roma ci sono uomini che hanno limiti, limiti nella loro intelligenza, limiti del loro vocabolario, limiti delle loro preferenze, limiti nei loro punti di vista”. E io aggiungerei ancora limiti nella loro etica e morale.
Si dice sempre che la Chiesa è “Santa e peccatrice” e deve essere “riformata in continuazione”. Ma questo non è successo durante secoli e neppure dopo l’esplicito suggerimento del concilio Vaticano II e dell’attuale papa Benedetto XVI. L’istituzione più vecchia dell’Occidente ha incorporato privilegi, abitudini, costumi politici di palazzo e principeschi, di resistenza e di opposizione che praticamente impediscono o distorcono tutti i tentativi di riforma.
Solo che questa volta si è arrivati a un punto di altissimo degrado morale, con pratiche persino criminali che non possono più essere negate e che richiedono mutamenti fondamentali nella struttura di governo della Chiesa. Caso contrario, questo tipo di istituzionalità tristemente invecchiata e crepuscolare languirà fino a entrare nel suo tramonto. Scandali come quelli attuali sempre ci sono stati nella curia vaticana, soltanto non c’era quel provvidenziale Vatileaks per renderli di pubblico dominio e far indignare il Papa e la maggioranza dei cristiani.
La mia percezione del mondo mi dice che queste perversità nello spazio sacro e nel centro di riferimento di tutta la cristianità - il papato - (dove dovrebbe primeggiare la virtù e persino la santità) sono conseguenze di questa centralizzazione assolutista del potere papale. Questo rende tutti vassalli, sottomessi e avidi perché stanno fisicamente vicino al portatore del supremo potere, il Papa. Un potere assoluto, per sua natura, limita e perfino nega la libertà degli altri, favorisce la creazione di gruppi di anti-potere, fazioni di burocrati del sacro contro altre, pratica largamente la simonia che è compravendita di favori, promuove adulazioni e distrugge i meccanismi di trasparenza. In fondo tutti diffidano di tutti. E ognuno cerca la soddisfazione personale nella forma migliore che può. Per questo è sempre stata problematica l’osservanza del celibato all’interno della curia vaticana, come si sta rivelando adesso con l’esistenza di una vera rete di prostituzione gay. Fino a quando questo potere non sarà decentralizzato e non permetterà maggior partecipazione di tutti gli strati del popolo di Dio, uomini e donne, alla conduzione dei cammini della Chiesa, il tumore che sta all’origine di questa infermità continuerà a durare. Si dice che Benedetto XVI consegnerà a tutti i cardinali la suddetta relazione perché ciascuno sappia che problemi dovrà affrontare nel caso che sia eletto papa. E l’urgenza che avrà di introdurre radicali trasformazioni. Dal tempo della Riforma che si sente il grido: “Riforma nel capo e nelle membra”. E siccome mai è avvenuta, è nata la Riforma come gesto disperato dei riformatori di compiere tale impresa per conto proprio.
Per spiegare meglio ai cristiani e a tutti gl’interessati di problemi di Chiesa, torniamo alla questione degli scandali. L’intenzione è di sdrammatizzarli, permettere che se n’abbia una nozione meno idealista e a volte idolatrica della gerarchia e della figura del Papa e liberare la libertà a cui il Cristo ci ha chiamati (Gal 5,1). In questo non c’è nessun cattivo gusto per le cose negative né volontà di aumentare sempre di più il degrado morale. Il cristiano deve essere adulto, non può lasciarsi infantilizzare né permettere che gli neghino conoscenze teologiche e storiche per rendersi conto di quanto umana ed smodatamente umana può essere l’istituzione che ci viene dagli apostoli.
Esiste una lunga tradizione teologica che si riferisce alla Chiesa come casta meretrix, tema abbordato dettagliatamente da un grande teologo, amico dell’attuale Papa, Hans Urs von Balthasar (vedere in Sponsa Verbi, Einsiedeln 1971, 203-305). In varie occasioni il teologo Joseph Ratzinger è ritornato su questa denominazione.
La chiesa è una meretrice che tutte le notti si abbandona alla prostituzione; è casta perché Cristo, ogni mattina ne ha compassione, la lava è la ama.
L’habitus meretricius, il vizio del meretricio, è stato duramente criticato dai santi padri della Chiesa come Sant’Ambrogio, Sant’Agostino, San Gerolamo e altri. San Pier Damiani arriva chiamare il suddetto Gregorio VII “Santo satanasso” (D. Roma, compendio di storia della Chiesa, volume secondo, Petropolis, 1950, p. 112). Questa denominazione dura ci rimanda a quella di Cristo diretta Pietro. Per causa della sua professione di fede lo chiama “pietra”, ma per causa della sua poca fede e di non capire i disegni di Dio lo qualifica come “satanasso” (Vangelo di Matteo 16,23). San Paolo pare un moderno quando parla ai suoi oppositori con furia: “magari si castrassero tutti quelli che vi danno fastidio” (Galati, 5,12).
C’è pertanto un luogo per la profezia nella Chiesa e per le denunce delle malefatte che possono capitare in mezzo agli ecclesiastici e persino in mezzo ai fedeli.
Vi riporto un altro esempio tratto dagli scritti di un santo amato dalla maggioranza dei cattolici per il suo candore e bontà: Sant’Antonio da Padova. Nei suoi sermoni, famosi all’epoca, non appare niente affatto dolce e gentile. Fa una vigorosa critica ai prelati corrotti del suo tempo. Dice: “i vescovi sono cani senza nessuna vergogna perché il loro aspetto ha della meretrice e per questo stesso non vogliono vergognarsi” (uso l’edizione critica in latino pubblicata a Lisbona in due volumi nel 1895). Questo fu pronunciato nel sermone della quarta domenica dopo Pentecoste (pagina 278). Un’altra volta chiama i prelati “ scimmie sul tetto, da lì presiedono alle necessità del popolo di Dio”. (Op. cit p. 348). È continua: “Il vescovo della Chiesa è uno schiavo che pretende regnare, principe iniquo, leone che ruggisce, orso affamato di rapina che depreda il popolo povero” (p.348). Infine nella festa di San Pietro alza la voce e denuncia: “Attenzione che Cristo disse tre volte: pasci e neanche una volta tosa e mungi... Guai a quello che non pasce neanche una volta e tosa e munge tre o quattro volte...lui è un drago a fianco dell’arca del Signore che non possiede altro che apparenza e non verità” (volume secondo, 918).
Il teologo Joseph Ratzinger spiega il senso di questo tipo di denunce profetiche: “il senso della profezia risiede in verità meno in alcune previsioni che nella protesta profetica: protesta contro l’autosoddisfazione delle istituzioni, l’autosoddisfazione che sostituisce la morale con il rito e la conversione con le cerimonie” (Das neue volk Gottes, Düsseldorf 1969,250, esiste traduzione italiana Il nuovo popolo di Dio, Brescia 1971).
Ratzinger critica con enfasi la separazione che abbiamo fatto in riferimento alla figura di Pietro: prima della Pasqua, il traditore; dopo la Pentecoste, il fedele. “Pietro continua a vivere questa tensione del prima e del dopo; lui continua ad essere tutte due le cose: la pietra e lo scandalo...Non è successo lungo tutta la storia della Chiesa che il Papa era simultaneamente il successore di Pietro e la pietra dello scandalo” (p.259)?
Dove vogliamo arrivare con tutto questo? Vogliamo arrivare a riconoscere che la Chiesa-istituzione di papi, vescovi e preti è fatta di uomini che possono tradire negare e fare del potere religioso un affare e uno strumento di auto soddisfazione. Tale riconoscimento è terapeutico dato che ci cura di ogni ideologia idolatrica intorno alla figura del Papa, ritenuto come praticamente infallibile. Questo è visibile nei settori conservatori e fondamentalisti del movimento cattolico laici e anche di gruppi di preti. In alcuni è ancora viva una vera papolatria, che Benedetto XVI ha sempre cercato di evitare.
La crisi attuale della Chiesa provocato la rinuncia di un Papa che si è reso conto che non aveva più il vigore necessario per sanare scandali di tale portata. Ha buttato la spugna con umiltà. Che un altro più giovane venga e assuma il compito arduo e duro di pulire la corruzione nella curia romana e dell’universo dei pedofili, eventualmente punisca, deponga e invii i più renitenti in qualche convento per far penitenza e emendare la propria vita .
Soltanto chi ama la Chiesa può farle le critiche che gli abbiamo fatto noi citando testi di autorità classiche del passato. Se tu hai smesso di amare una persona un tempo amata, ti diventano indifferenti la sua vita e il suo destino. Noi ci interessiamo come fa l’amico e fratello di tribolazione Hans Kung (è stato condannato dalla ex inquisizione), forse uno dei teologi che più ama la Chiesa e per questo la critica.
Non vogliamo che i cristiani coltivino questo sentimento di poca stima e di indifferenza. Per quanto gravi siano stati gli errori e gli equivoci storici, l’istituzione-Chiesa custodisce la memoria sacra di Gesù e la grammatica dei Vangeli. Essa predica la libertà, sapendo che generalmente sono altri che liberano e non lei.
Anche così vale stare dentro la chiesa, come ci stavano S. Francesco, dom Helder Camara, Giovanni XXIII e noti teologi che hanno aiutato a fare il concilio Vaticano II e che prima erano stati tutti condannati dall’ex inquisizione, come de Lubac, Chenu, Congar, Rahner e altri. Dobbiamo aiutarla a uscire da quest’imbarazzo, alimentandosi di più col sogno di Gesù di un regno di giustizia, di pace e di riconciliazione con Dio e di sequela della sua causa e destino, piuttosto che di semplice giustificata indignazione che può scadere facilmente nel fariseismo e nel moralismo.
Altre riflessioni del genere si trovano nel mio libro Chiesa: carisma e potere, ed. Record, 2005, specialmente in appendice con tutte gli atti del processo celebrato all’interno dell’ex inquisizione nel 1984.
Traduzione: Romano Baraglia - romanobaraglia@gmail.com
- Allora Gesù, chiamatili a sé, disse loro: «Voi sapete che coloro che sono ritenuti capi delle nazioni le dominano, e i loro grandi esercitano su di esse il potere.
-
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- IL PUTTANESIMO: VICO E LA STORIA DEI LEMURI (LEMURUM FABULA), OGGI.27 febbraio 2013, di Federico La Sala
 L’ITALIA AL BIVIO: VICO E LA STORIA DEI LEMURI (LEMURUM FABULA), OGGI. Un invito alla (ri)lettura della "Scienza Nuova"
L’ITALIA AL BIVIO: VICO E LA STORIA DEI LEMURI (LEMURUM FABULA), OGGI. Un invito alla (ri)lettura della "Scienza Nuova"
 Potrai facilmente, o Leggitore, intendere la bellezza di questa divina Dipintura dall’orrore, che certamente dee farti la bruttezza di quest’altra, ch’ora ti dò a vedere tutta contraria.
Potrai facilmente, o Leggitore, intendere la bellezza di questa divina Dipintura dall’orrore, che certamente dee farti la bruttezza di quest’altra, ch’ora ti dò a vedere tutta contraria.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- SENZA PIU’ NE’ LEGALITA’ NE’ LEGITTIMITA’. Cosa insegna alla politica la rinuncia di Ratzinger (di G. Agamben).20 febbraio 2013, di Federico La Sala
Cosa insegna alla politica la rinuncia di Ratzinger
di Giorgio Agamben (la Repubblica, 16 febbraio 2013)
La decisione di Benedetto XVI deve essere considerata con estrema attenzione da chiunque abbia a cuore le sorti politiche dell’umanità.
Compiendo il “gran rifiuto”, egli ha dato prova non di viltà, come Dante scrisse forse ingiustamente di Celestino V, ma di un coraggio, che acquista oggi un senso e un valore esemplari. Deve essere evidente per tutti, infatti, che le ragioni invocate dal pontefice per motivare la sua decisione, certamente in parte veritiere, non possono in alcun modo spiegare un gesto che nella storia della Chiesa ha un significato del tutto particolare.
E questo gesto acquista tutto il suo peso, se si ricorda che il 4 luglio 2009, Benedetto XVI aveva deposto proprio sulla tomba di Celestino V a Sulmona il pallio che aveva ricevuto al momento dell’investitura, a prova che la decisione era stata meditata.
Perché questa decisione ci appare oggi esemplare? Perché essa richiama con forza l’attenzione sulla distinzione fra due principi essenziali della nostra tradizione etico-politica, di cui le nostre società sembrano aver perduto ogni consapevolezza: la legittimità e la legalità.
Se la crisi che la nostra società sta attraversando è così profonda e grave, è perché essa non mette in questione soltanto la legalità delle istituzioni, ma anche la loro legittimità; non soltanto, come si ripete troppo spesso, le regole e le modalità dell’esercizio del potere, ma il principio stesso che lo fonda e legittima.
I poteri e le istituzioni non sono oggi delegittimati, perché sono caduti nell’illegalità; è vero piuttosto il contrario, e cioè che l’illegalità è così diffusa e generalizzata, perché i poteri hanno smarrito ogni coscienza della loro legittimità.
Per questo è vano credere di potere affrontare la crisi delle nostre società attraverso l’azione - certamente necessaria - del potere giudiziario: una crisi che investe la legittimità, non può essere risolta soltanto sul piano del diritto. L’ipertrofia del diritto, che pretende di legiferare su tutto, tradisce anzi, attraverso un eccesso di legalità formale, la perdita di ogni legittimità sostanziale.
Il tentativo della modernità di far coincidere legalità e legittimità, cercando di assicurare attraverso il diritto positivo la legittimità di un potere, è, come risulta dall’inarrestabile processo di decadenza in cui sono entrate le nostre istituzioni democratiche, del tutto insufficiente.
Le istituzioni di una società restano vive solo se entrambi i principi (che, nella nostra tradizione, hanno anche ricevuto il nome di diritto naturale e diritto positivo, di potere spirituale e potere temporale) restano presenti e agiscono in essa senza mai pretendere di coincidere.
Per questo il gesto di Benedetto XVI è così importante. Quest’uomo, che era a capo dell’istituzione che vanta il più antico e pregnante titolo di legittimità, ha revocato in questione col suo gesto il senso stesso di questo titolo. Di fronte a una curia che, del tutto dimentica della propria legittimità, insegue ostinatamente le ragioni dell’economia e del potere temporale, Benedetto XVI ha scelto di usare soltanto il potere spirituale, nel solo modo che gli è sembrato possibile: cioè rinunciando all’esercizio del vicariato di Cristo. In questo modo, la Chiesa stessa è stata messa in questione fin dalla sua radice.
Non sappiamo se la Chiesa sarà capace di trarre profitto da questa lezione: ma sarebbe certamente importante che i poteri laici vi trovassero occasione per interrogarsi nuovamente sulla propria legittimità.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- Sesso e carriera i ricatti in Vaticano dietro la rinuncia di Benedetto XVI (di Concita De Gregorio)21 febbraio 2013, di Federico La Sala
Sesso e carriera i ricatti in Vaticano dietro la rinuncia di Benedetto XVI
di Concita De Gregorio (la Repubblica, 21 febbraio 2013)
"In questi 50 anni abbiamo imparato ed esperito che il peccato originale esiste, si traduce sempre in peccati personali che possono divenire strutture del peccato. Abbiamo visto che nel campo del Signore c’è sempre la zizzania. Che nella rete di Pietro si trovano i pesci cattivi".
La zizzania. I pesci cattivi. Le "strutture del peccato". È giovedì 11 ottobre, Santa Maria Desolata. È il giorno in cui la Chiesa fa memoria di papa Giovanni XXIII, cinquant’anni dal principio del Concilio. Benedetto XVI si affaccia al balcone e ai ragazzi dell’Azione cattolica raccolti in piazza dice così: «Cinquant’anni fa ero come voi in questa piazza, con gli occhi rivolti verso l’alto a guardare e ascoltare le parole piene di poesia e di bontà del Papa. Eravamo, allora, felici. Pieni di entusiasmo, eravamo sicuri che doveva venire una nuova primavera della Chiesa». Breve pausa. Eravamo felici, al passato. «Oggi la gioia è più sobria, è umile. In cinquant’anni abbiamo imparato che la fragilità umana è presente anche nella Chiesa». Che c’è la zizzania, ci sono i pesci cattivi.
Nessuno ha capito, in quel pomeriggio di ottobre. I ragazzi in piazza hanno applaudito e pianto il ricordo di papa Giovanni. Nessuno sapeva che due giorni prima Benedetto XVI aveva di nuovo incontrato il cardinale Julian Herranz, 83 anni, lo spagnolo dell’Opus Dei da lui incaricato di presiedere la commissione d’indagine su quello che i giornali chiamano Vatileaks. Il corvo, la fuga di notizie, le carte rubate dall’appartamento del Papa.
Herranz ha aggiornato Ratzinger con regolarità. Ogni settimana, in colloquio riservato, da aprile a dicembre. Il Papa ha appreso con crescente apprensione gli sviluppi dell’inchiesta: decine e decine di interviste a prelati, porporati, laici. In Italia e all’estero. Decine e decine di verbali riletti e sottoscritti dagli intervistati. Le stesse domande per tutti, dapprima, poi interviste libere. Controlli incrociati. Verifiche. Un quadro da cui veniva emergendo una rete di lobby che i tre cardinali hanno diviso per provenienza di congregazione religiosa, per origine geografica. I salesiani, i gesuiti. I liguri, i lombardi.
Infine, quel giorno di ottobre, il passaggio più scabroso. Una rete trasversale accomunata dall’orientamento sessuale. Per la prima volta la parola omosessualità è stata pronunciata, letta a voce alta da un testo scritto, nell’appartamento di Ratzinger. Per la prima volta è stata scandita, sebbene in latino, la parola ricatto: «influentiam», Sua Santità. Impropriam influentiam.
17 dicembre 2012, San Lazzaro. I tre cardinali consegnano nelle mani del Pontefice il risultato del loro lavoro. Sono due tomi di quasi 300 pagine. Due cartelle rigide rilegate in rosso, senza intestazione. Sotto "segreto pontificio", sono custodite nella cassaforte dell’appartamento di Ratzinger. Le conosce soltanto, oltre a Lui, chi le ha scritte. Contengono una mappa esatta della zizzania e dei pesci cattivi. Le «divisioni nel corpo ecclesiale che deturpano il volto della Chiesa», dirà il Papa quasi due mesi dopo nell’Omelia delle Ceneri.
È quel giorno, con quelle carte sul tavolo, che Benedetto XVl prende la decisione tanto a lungo meditata. È in quella settimana che incontra il suo biografo, Peter Seewald, e poche ore dopo aver ricevuto i tre cardinali gli dice «sono anziano, basta ciò che ho fatto». Quasi le stesse parole, in quell’intervista poi pubblicata su Focus, che dirà a febbraio al concistoro per i martiri di Otranto: «Ingravescente aetate». «Noi siamo un Papa anziano», aveva già allargato le braccia molte volte, negli ultimi mesi, in colloqui riservati.
Dunque nella settimana prima di Natale il Papa prende la sua decisione. Con queste parole la commenta il cardinale Salvatore De Giorgi, un altro dei tre inquisitori che redigono la "Relationem", presente al momento della rinuncia: «Ha fatto un gesto di fortezza, non di debolezza.
Lo ha fatto per il bene della Chiesa. Ha dato un messaggio forte a tutti quanti nell’esercizio dell’autorità o del potere si ritengono insostituibili. La Chiesa è fatta di uomini. Il Pontefice ha visto i problemi e li ha affrontati con un’iniziativa tanto inedita quanto lungimirante». Ha assunto su di sé la croce, insomma. Non ne è sceso, al contrario. Ma chi sono «coloro che si ritengono insostituibili?». Riecheggiano le parole dell’Angelus di domenica scorsa: bisogna «smascherare le tentazioni del potere che strumentalizzano Dio per i propri interessi».
La "Relationem" ora è lì. Benedetto XVI la consegnerà nelle mani del prossimo Papa, che dovrà essere abbastanza forte, e giovane, e «santo» - ha auspicato - per affrontare l’immane lavoro che lo attende. È disegnata, in quelle pagine, una geografia di «improprie influenze» che un uomo molto vicino a chi le ha redatte descrive così: «Tutto ruota attorno alla non osservanza del sesto e del settimo comandamento». Non commettere atti impuri. Non rubare. La credibilità della Chiesa uscirebbe distrutta dall’evidenza che i suoi stessi membri violano il dettato originario. Questi due punti, in specie. Vediamo il sesto comandamento, atti impuri. La Relazione è esplicita. Alcuni alti prelati subiscono «l’influenza esterna» - noi diremmo il ricatto - di laici a cui sono legati da vincoli di "natura mondana".
Sono quasi le stesse parole che aveva utilizzato monsignor Attilio Nicora, allora ai vertici dello Ior, nella lettera rubata dalle segrete stanze al principio del 2012: quella lettera poi pubblicata colma di omissis a coprire nomi. Molti di quei nomi e di quelle circostanze riaffiorano nella Relazione. Da vicende remote, come quella di monsignor Tommaso Stenico sospeso dopo un’intervista andata in onda su La 7 in cui raccontava di incontri sessuali avvenuti in Vaticano.
Riemerge la vicenda dei coristi di cui amava circondarsi il Gentiluomo di sua Santità Angelo Balducci, agli atti di un’inchiesta giudiziaria. I luoghi degli incontri. Una villa fuori Roma. Una sauna al Quarto Miglio. Un centro estetico in centro. Le stanze vaticane stesse. Una residenza universitaria in via di Trasone data in affitto ad un ente privato e reclamata indietro dal Segretario di Stato Bertone, residenza abitualmente utilizzata come domicilio romano da un arcivescovo veronese.
Si fa menzione del centro "Priscilla", che persino da ritagli di stampa risulta essere riconducibile a Marco Simeon, il giovane sanremese oggi ai vertici della Rai e già indicato da monsignor Viganò come l’autore delle note anonime a suo carico. Circostanze smentite dai protagonisti sui giornali, ma approfondite e riprese dalla Relazione con dovizia di dettagli.
I tre cardinali hanno continuato a lavorare anche oltre il 17 dicembre scorso. Sono arrivati fino alle ultime vicende che riguardano lo Ior - qui si passa al settimo comandamento - ascoltando gli uomini su cui confida Tarcisio Bertone a partire dal suo braccio destro, il potentissimo monsignor Ettore Balestrero, genovese, classe 1966. Sono arrivati fino alla nomina del giovane René Bruelhart alla direzione dell’Aif, l’autorità finanziaria dell’Istituto.
Il terzo dei cardinali inquirenti, Josef Tomko, è il più anziano e dunque il più influente della triade. Ratzinger lo ha richiamato in servizio a 88 anni. Slovacco, era stato con Woijtyla a capo del controspionaggio vaticano. Aveva seguito di persona la spinosa questione dei contributi anche economici alla causa polacca come delegato ai rapporti con l’Europa orientale. Dopo monsignor Luigi Poggi, scomparso nel 2010, è l’ultimo custode di quella che ancora oggi si chiama l’Entità, il "Sodalitium pianum" di antica memoria, il servizio segreto vaticano formalmente smantellato da Benedetto XV, nel nome predecessore di Ratzinger.
Poiché i simboli e i gesti, a San Pietro, contano assai più delle parole chi è molto addentro alle liturgie vaticane fa notare questo. Nell’ultimo giorno del suo pontificato, Benedetto XVI riceverà i tre cardinali estensori della Relationem in udienza privata. Subito dopo, al fianco di Tomko, vedrà i vescovi e i fedeli slovacchi in Santa Maria Maggiore. La sua ultima udienza pubblica. 27 febbraio, San Procopio il Decapolita, confessore. Poi il conclave.
-
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- DIMISSIONI DI STATO. Note in memoria di Elsa Morante e Giuseppe Dossetti.18 febbraio 2013, di Federico La Sala
DIMISSIONI DI STATO E LOTTA DI LIBERAZIONE, IERI (E OGGI)
- 25 LUGLIO 1943: DIMISSIONI DI MUSSOLINI (Cfr.:Ordine del giorno Grandi).
Elsa Morante scrisse nel suo "Diario":
Roma 1° maggio 1945 *
Mussolini e la sua amante Clara Petacci sono stati fucilati insieme, dai partigiani del Nord Italia. Non si hanno sulla loro morte e sulle circostanze antecedenti dei particolari di cui si possa essere sicuri. Così pure non si conoscono con precisione le colpe, violenze e delitti di cui Mussolini può essere ritenuto responsabile diretto o indiretto nell’alta Italia come capo della sua Repubblica di Sociale. Per queste ragioni è difficile dare un giudizio imparziale su quest’ultimo evento con cui la vita del Duce ha fine.
Alcuni punti però sono sicuri e cioè: durante la sua carriera, Mussolini si macchiò più volte di delitti che, al cospetto di un popolo onesto e libero, gli avrebbe meritato, se non la morte, la vergogna, la condanna e la privazione di ogni autorità di governo (ma un popolo onesto e libero non avrebbe mai posto al governo un Mussolini). Fra tali delitti ricordiamo, per esempio: la soppressione della libertà, della giustizia e dei diritti costituzionali del popolo (1925), la uccisione di Matteotti (1924), l’aggressione all’Abissinia, riconosciuta dallo stesso Mussolini come consocia alla Società delle Nazioni, società cui l’Italia era legata da patti (1935), la privazione dei diritti civili degli Ebrei, cittadini italiani assolutamente pari a tutti gli altri fino a quel giorno (1938).
Tutti questi delitti di Mussolini furono o tollerati, o addirittura favoriti e applauditi. Ora, un popolo che tollera i delitti del suo capo, si fa complice di questi delitti. Se poi li favorisce e applaude, peggio che complice, si fa mandante di questi delitti. Perché il popolo tollerò favorì e applaudì questi delitti? Una parte per viltà, una parte per insensibilità morale, una parte per astuzia, una parte per interesse o per machiavellismo.
Vi fu pure una minoranza che si oppose; ma fu così esigua che non mette conto di parlarne. Finché Mussolini era vittorioso in pieno, il popolo guardava i componenti di questa minoranza come nemici del popolo e della nazione, o nel miglior dei casi come dei fessi (parola nazionale assai pregiata dagli italiani). Si rendeva conto la maggioranza del popolo italiano che questi atti erano delitti? Quasi sempre, se ne rese conto, ma il popolo italiano è cosìffatto da dare i suoi voti piuttosto al forte che al giusto; e se lo si fa scegliere fra il tornaconto e il dovere, anche conoscendo quale sarebbe il suo dovere, esso sceglie il suo tornaconto.
Mussolini, uomo mediocre, grossolano, fuori dalla cultura, di eloquenza alquanto volgare, ma di facile effetto, era ed è un perfetto esemplare e specchio del popolo italiano contemporaneo. Presso un popolo onesto e libero, Mussolini sarebbe stato tutto al più il leader di un partito con un modesto seguito e l’autore non troppo brillante di articoli verbosi sul giornale del suo partito. Sarebbe rimasto un personaggio provinciale, un po’ ridicolo a causa delle sue maniere e atteggiamenti, e offensivo per il buon gusto della gente educata a causa del suo stile enfatico, impudico e goffo. Ma forse, non essendo stupido, in un paese libero e onesto, si sarebbe meglio educato e istruito e moderato e avrebbe fatto migliore figura, alla fine. In Italia, fu il Duce. Perché è difficile trovare un migliore e più completo esempio di Italiano.
Debole in fondo, ma ammiratore della forza, e deciso ad apparire forte contro la sua natura. Venale, corruttibile. Adulatore. Cattolico senza credere in Dio. Corruttore. Presuntuoso: Vanitoso. Bonario. Sensualità facile, e regolare. Buon padre di famiglia, ma con amanti. Scettico e sentimentale. Violento a parole, rifugge dalla ferocia e dalla violenza, alla quale preferisce il compromesso, la corruzione e il ricatto. Facile a commuoversi in superficie, ma non in profondità, se fa della beneficenza è per questo motivo, oltre che per vanità e per misurare il proprio potere. Si proclama popolano, per adulare la maggioranza, ma è snob e rispetta il denaro. Disprezza sufficientemente gli uomini, ma la loro ammirazione lo sollecita.
Come la cocotte che si vende al vecchio e ne parla male con l’amante più valido, così Mussolini predica contro i borghesi; accarezzando impudicamente le masse. Come la cocotte crede di essere amata dal bel giovane, ma è soltanto sfruttata da lui che la abbandonerà quando non potrà più servirsene, così Mussolini con le masse. Lo abbaglia il prestigio di certe parole: Storia, Chiesa, Famiglia, Popolo, Patria, ecc., ma ignora la sostanza delle cose; pur ignorandole le disprezza o non cura, in fondo, per egoismo e grossolanità. Superficiale. Dà più valore alla mimica dei sentimenti , anche se falsa, che ai sentimenti stessi. Mimo abile, e tale da far effetto su un pubblico volgare.
Gli si confà la letteratura amena (tipo ungherese), e la musica patetica (tipo Puccini). Della poesia non gli importa nulla, ma si commuove a quella mediocre (Ada Negri) e bramerebbe forte che un poeta lo adulasse. Al tempo delle aristocrazie sarebbe stato forse un Mecenate, per vanità; ma in tempi di masse, preferisce essere un demagogo. Non capisce nulla di arte, ma, alla guisa di certa gente del popolo, e incolta, ne subisce un poco il mito, e cerca di corrompere gli artisti. Si serve anche di coloro che disprezza. Disprezzando (e talvolta temendo) gli onesti, i sinceri, gli intelligenti poiché costoro non gli servono a nulla, li deride, li mette al bando.
Si circonda di disonesti, di bugiardi, di inetti, e quando essi lo portano alla rovina o lo tradiscono (com’è nella loro natura), si proclama tradito, e innocente, e nel dir ciò è in buona fede, almeno in parte; giacché, come ogni abile mimo, non ha un carattere ben definito, e s’immagina di essere il personaggio che vuole rappresentare.
* Cfr.: Elsa Morante, Opere, Mondadori (Meridiani), Milano 1988, vol. I, pp. L-LII.
- Una riflessione da "Aracoeli"*:
E allora mi sono guardato negli occhi. Raramente ci si guarda, con se stessi, negli occhi, e pare che in certi casi questo valga per un esercizio estremo. Dicono che, immergendosi allo specchio nei propri occhi - con attenzione cruciale e al tempo stesso con abbandono - si arrivi a distinguere finalmente in fondo alla pupilla l’ultimo Altro, anzi l’unico e vero Se stesso, il centro di ogni esistenza e della nostra, insomma quel punto che avrebbe nome Dio. Invece, nello stagno acquoso dei miei occhi, io non ho scorto altro che la piccola ombra diluita (quasi naufraga) di quel solito niño tardivo che vegeta segregato dentro di me. Sempre il medesimo, con la sua domanda d’amore ormai scaduta e inservibile, ma ostinata fino all’indecenza. È strano come l’eternità si lasci captare piuttosto in un segmento effimero che in una continuità estesa.
* Cfr.: Elsa Morante, Aracoeli, Einaudi, Torino, 1982.
***
REGGIO EMILIA, 31 luglio 1945: TRIPLICE VITTORIA (don Giuseppe Dossetti, su "Reggio democratica")
Perché non possiamo non dirci laburisti
di Giuseppe Dossetti (l’Unità, 10 febbraio 2013)
- L’articolo fu scritto per «Reggio democratica» all’indomani della vittoria elettorale del Labour. Era il luglio del ’45, un anno prima della Costituente. «Triplice vittoria»: questo il titolo dello scritto dossettiano, che suscitò scandalo nella destra
Trascorse le primissime ore di sorpresa, di fervore, di entusiasmo, l’esito delle elezioni inglesi appare sempre meglio come la vittoria di un mondo nuovo in via di faticosa emersione. Vittoria innanzi tutto del lavoro più che, come alcuni hanno detto, vittoria del socialismo; vittoria cioè di una effettiva, concreta e universale realtà umana, meglio che di una particolare dottrina e prassi politica concernente l’affermazione sociale di quella realtà.
Certo il Partito laburista ha contrastato e vinto i conservatori opponendo alla loro caparbia cristallizzazione di interessi e di metodi, un vasto programma di trasformazioni sociali; ma si tratta di tali socializzazioni che, per i principi teorici cui si richiamano (e che non hanno a che vedere con le dottrine classiche del socialismo, né di quello utopico, né di quello marxista), per il campo di applicazione (le industrie chiave e i grandi gruppi finanziari) e soprattutto per il metodo di realizzazione (proprietà sociale e non statale) non consentono, se non per approssimazione giornalistica o propagandistica, di parlare di socialismo, almeno come da decenni lo si intende nell’Europa continentale, e come da mesi lo si intende nella ripresa italiana.
Ben più propriamente invece dobbiamo parlare di un programma di concreta e realistica inserzione, al vertice della gerarchia sociale e politica, del lavoro, inteso come la prima e fondamentale esplicazione della personalità umana, come il genuino e non fallace metro delle capacità, dei meriti, dei diritti di ognuno: programma che non è logicamente né praticamente connesso con la teoria socialista e che può essere condiviso, come di fatto lo è, da altri partiti non socialisti.
In secondo luogo la «vittoria della solidarietà», più e meglio che come qualcuno si limita a dire vittoria della pace. Gli elettori inglesi rifiutando con così grande maggioranza a Churchill, vincitore della guerra, il compito di organizzare il dopo-guerra, non hanno semplicemente voluto esprimere la loro volontà di pace e il proposito di allontanare gli uomini, gli interessi, gli atteggiamenti che hanno portato alla guerra e potrebbero perpetuarla in potenza o in atto, ma ben più essi hanno voluto mostrare la loro preferenza per quelle forze e quegli uomini che, appunto per la loro qualità e il loro spirito di lavoratori e di edificatori, hanno dato prova di avere una volontà positiva e attiva per l’edificazione di una nuova struttura sociale e internazionale in cui, nei rapporti tra singoli, tra classi e tra nazioni, non solo siano psicologicamente superate, ma persino oggettivamente rimosse, le possibilità concrete di egoismi, di privilegi, di sopraffazioni e in cui siano poste garanzie effettive di solidarietà e di uguaglianza.
Infine, «vittoria della democrazia»: non solo per l’aspetto dai giornali e dai commentatori più rilevato, cioè per il fatto che, con l’avvento del laburismo al potere, la democrazia inglese entra finalmente nella linea della sua coerenza plenaria e la democrazia quasi esclusivamente formale (cioè di forme costituzionali e parlamentari di fatto accessibili solo a una minoranza di privilegiati) quale sinora è stata, si avvia a essere democrazia sostanziale, cioè vero accesso del popolo e di tutto il popolo al potere e a tutto il potere, non solo a quello politico, ma anche a quello economico e sociale; ma vittoria della democrazia in un senso ancor più profondo e definitivo che molti non considerano e forse alcuni vogliono ignorare, cioè per il fatto che per la prima volta nella storia dell’Europa contemporanea si è potuto effettuare, nonostante le difficoltà dell’ambiente (la «Vecchia Inghilterra» conservatrice per eccellenza) e le difficoltà del momento (l’indomani della più grandiosa storia militare), una trasformazione così grave, decisa e inaspettata, che tutti consentono nel qualificarla «rivoluzione» e che tuttavia questa rivoluzione è avvenuta proprio per le vie della legalità e attraverso i metodi della democrazia tipica e gli istituti del sistema parlamentare.
Questo fatto è quello che riassume e corona, è quello che consacra nel presente e garantisce per l’avvenire la definitività delle altre vittorie. Ma è soprattutto quello che veramente conclude la storia dell’Europa moderna e apre non un nuovo capitolo, ma un nuovo volume, ponendo fine all’età del liberalismo europeo e preannunziando insieme la fine del grande antagonista storico della concezione liberale; cioè il socialismo cosiddetto scientifico. Non sembri un’affermazione paradossale: essa è veramente il frutto di una meditazione storica.
La vittoria del Partito laburista, che non è partito di classe, ma partito interclassista (in quanto accoglie il filatore di Manchester, Mac Farlane, il proletario del Galles e il maresciallo Alexander), del Partito laburista che non ha vinto solo con i voti dei distretti operai, ma anche con quelli dei centri rurali più legati alle concezioni tradizionali della Vecchia Inghilterra, del Partito laburista che ha vinto con una elezione popolate e veramente libera, tale vittoria, diciamo, ha non solo concluso il periodo delle dittature o delle aristocrazie conservatrici, ma ha smentito per la prima volta con la prova dei fatti le dottrine e le prassi (già da tempo confutare in teoria) che solo nel ricorso alla forza, nella dittatura di una classe sulle altre e nella metodologia dell’attivismo sopraffattore vedono una possibilità di ascesa per i lavoratori e di instaurazione di una vera democrazia.
Da oggi i lavoratori di tutto il mondo finalmente sanno di potere con fiducia rispondere ad un grido che li invita all’unità, ma non nel nome di un mito di classe e di lotta, ma nel nome di una volontà di solidarietà con tutti e di libertà e giustizia per tutti. Volontà che, come ha riconosciuto Clemente Attlee, è veramente cristiana.
Reggio Emilia, 31 luglio
***
- 12 novembre 2011: Le dimissioni di Berlusconi sui giornali internazionali
 COSTANTINO, SANT’ELENA, E NAPOLEONE. L’immaginario del cattolicesimo romano.
COSTANTINO, SANT’ELENA, E NAPOLEONE. L’immaginario del cattolicesimo romano.Federico La Sala (18.02.2013)
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- L’ANNIVERARIO DEI PATTI LATERANENSI E LE DIMISSIONI DI BENEDETTO XVI.Lo strappo definitivo tra la Chiesa e il Pdl11 febbraio 2013, di Federico La Sala
- BENEDETTO XVI SI DIMETTE. Lascerà il pontificato dal prossimo 28 febbraio. Lo ha annunciato personalmente, in latino "Ben consapevole della gravità di questo atto, con piena libertà, dichiaro di rinunciare al ministero di Vescovo di Roma, Successore di San Pietro, a me affidato per mano dei Cardinali il 19 aprile2005"
Lo strappo definitivo tra la Chiesa e il Pdldi Claudio Tito (la Repubblica, 11 febbraio 2013)
L’ultimo strappo tra i vertici della Chiesa italiana e il Pdl si è consumato proprio in queste ore. Con uno sgarbo che Segreteria di Stato e presidenza della Cei considerano poco digeribile. Il segretario del Pdl, Angelino Alfano, infatti, dopo aver disertato il concerto con il Papa, non prenderà parte nemmeno al tradizionale ricevimento che celebra l’anniversario dei Patti Lateranensi. Ci sarà Mario Monti, in qualità di presidente del consiglio, e il leader Udc, Pier Ferdinando Casini. Pierluigi Bersani, invece, presente al concerto con Benedetto XVI ha fatto sapere per tempo di non poter partecipare all’appuntamento.
A meno di un cambio di programma dell’ultima ora da parte di Alfano (che comunque verrebbe considerato tardivo dal punto di vista dei rapporti “politici”), domani pomeriggio nella sede dell’Ambasciata italiana presso la Santa Sede non ci sarà quindi nessuno dei “big” del Pdl. Non essendo previsto neanche Silvio Berlusconi. Non mancherà l’“ambasciatore” del Cavaliere, Gianni Letta, ma si tratta comunque di una lesione nei contatti tra Chiesa e centrodestra mai così evidente. Anzi, la “fotografia” nei saloni di Palazzo Borromeo dei cosiddetti “colloqui in piedi” senza una “presenza berlusconiana” non ha di fatto precedenti dal 1994. Del resto l’allontanamento delle attuali gerarchie ecclesiastiche dai rappresentanti pidiellini negli ultimi due anni è stato progressivo.
Eppure la “foto” di domani è anche il frutto di un ultimo scontro che si sta consumando all’interno della Conferenza episcopale italiana e con la Segreteria di Stato. Una battaglia che in questo caso vede alleati Tarcisio Bertone, numero uno della Curia, il presidente della Cei Angelo Bagnasco e l’Appartamento papale. Sull’altro fronte la “destra curiale” che sul versante della Cei si basa sull’asse cosrtuito da Ruini con il Patriarca di Venezia Moraglia e all’interno del Vaticano sulla convergenza tra il prefetto della Congregazione per il Clero Mauro Piacenza e monsignor Balestrero.
L’ultimo affondo della “corrente” ruiniana, infatti, c’è stato in occasione delle formazione delle liste elettorali. Secondo Don Camillo, il Cavaliere resta il «male minore» e lo strumento per conseguire un «risultato utile», al punto di benedire nel Lazio il patto tra Francesco Storace e Eugenia Roccella. «Berlusconi - va ripetendo da settimane - i voti ancora ce li ha». L’ipotesi di un’intesa tra il centrosinistra e la lista di Monti viene considerata «inappropriata». Non a caso, proprio i “bracci armati” di Ruini - a cominciare da Monsignor Fisichella - avevano chiesto a gennaio ai rappresentanti di Scelta Civica e al leader centrista Casini di mettersi alla guida di un nuovo centrodestra cercando di replicare una sorta di “Operazione Sturzo”. Con l’obiettivo, appunto, di rendere impossibile la successiva alleanza con lo schieramento di Bersani in virtù dei «valori non negoziabili».
Una linea contestata dall’asse Bertone-Bagnasco. Entrambi, infatti, considerano la presenza del Cavaliere nella corsa elettorale un ostacolo insormontabile sia a causa delle vicende Noemi e Ruby, sia per l’immagine internazionale dell’ex premier. Dopo le tensioni piuttosto vistose dei mesi scorsi, quindi, tra Segreteria di Stato e Cei è stata siglata una sorta di «tregua operosa». Resa plasticamente visibile alla presentazione alcune settimane fa del libro “La porta stretta” che raccoglie le prolusioni del presidente della Cei.
Un patto che, secondo gli uomini più vicini ai vertici episcopali e della Curia, si basa anche sui nuovi orientamenti dei credenti praticanti. L’attivismo “ruiniano”, infatti, non sembra aver preso piede tra i cattolici di base se si considera il recente sondaggio pubblicato dal mensile Jesus: Pd e Scelta Civica sono in cima alle loro preferenze e il centrodestra scivola sempre più dietro. Anzi, tra quelli che un tempo votavano per il Cavaliere emerge la tentazione-Grillo. Per di più i «valori non negoziabili» non vengono considerati un criterio fondamentale per le scelte politiche.
La disposizione verso il superamento del “rapporto esclusivo” con il centrodestra sta diventando quindi il perno di quella ricucitura di rapporti tra Bertone, Bagnasco e l’Appartamento papale. Basti pensare all’appello lanciato pochi giorni fa proprio dal capo della Cei che tutti hanno interpretato come un ulteriore stop al Cavaliere: «Gli italiani hanno bisogno della verità delle cose, senza sconti, senza tragedie ma anche senza illusioni. La gente non si fa più abbindolare da niente e da nessuno».
Ma questa scelta viene appunto criticata dalla componente “ruiniana” e dai conservatori. Al punto di tentare un accordo con l’ala più conservatrice della Chiesa. Non è un caso che di recente sia partita un’offensiva diplomatica con il Cardinale Piacenza (che aspirava alla successione di Bertone in Segreteria di Stato), con Moraglia (Patriarca di Venezia), e con l’arcivescovo di Ferrara Luigi Negri (vicino a Cl) e monsignor Balestrero (Sottosegretario per i Rapporti con gli Stati). A loro è offerta una sponda per creare un nuovo rapporto di forze. Si tratta di uno scontro che dentro la Curia richiama alla memoria il vecchio duello tra Papa Montini, Paolo VI, e l’arcivescovo Roberto Ronca, esponente della destra romana e della corrente più tradizionalista di Coetus Internationalis Patrum.
Ma soprattutto ha aperto con un certo anticipo la scacchiera per il futuro Conclave. Sta di fatto che in questa fase Bertone e Bagnasco non intendono accettare l’idea di una nuova concessione a Berlusconi né giustificare alcune sue gaffe con il pricipio della “contestualizzazione”.
I vertici della Cei, prima di optare per l’addio definitivo, avevano chiesto proprio ad Alfano - ottenendole - garanzie sulla necessità che Berlusconi non sarebbe ricandidato come guida. Assicurazioni che poi sono state smentite. Le differenze tra il Segretario di Stato e il presidente della Cei riguarderanno semmai la gestione delle scelte per il dopo voto. Ma al momento c’è un anello che li unisce: guardare al dopo-Berlusconi.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- "La nave è ormai in mano al cuoco di bordo", scrive Kierkegaard. (Teologia e) Politica senza visione, è rimasto il vuoto.1 febbraio 2013, di Federico La Sala
«Politica senza visione, è rimasto il vuoto»
di intervista a Gianfranco Ravasi,
a cura di Gian Guido Vecchi (Corriere della Sera, 01.02.2013)
«Vede, c’è una frase dal Diario di Søren Kierkegaard che amo citare: "La nave è ormai in mano al cuoco di bordo", scrive il filosofo danese, "e ciò che trasmette il megafono del comandante non è più la rotta, ma ciò che mangeremo domani"». Il cardinale Gianfranco Ravasi abbozza un sorriso un po’ mesto, il presidente del Pontificio consiglio per la cultura ha appena presentato l’assemblea che il dicastero vaticano dedicherà dal 6 al 9 febbraio ai giovani, aperta da un’udienza con Benedetto XVI, e risposto pure alle domande dei ragazzi che gli arrivavano via Twitter, un senso diffuso di estraneità e desolazione, la «tristezza» dei tagli alla cultura, una campagna elettorale che esclude i giovani.
Già il livello del dibattito spesso non aiuta, ma il fatto è che «non possiamo avere una politica che sia esclusivamente di tipo economico, per quanto importanti siano quei temi», sospira il cardinale. «La pólis greca aveva anche la presenza di sapienti. Perché una società ha bisogno di questo respiro, delle grandi prospettive. C’è anche un Pil del benessere, della felicità. E invece ciò che manca alla politica - come peraltro, penso, qualche volta anche alla Chiesa - è proprio la capacità di presentare visioni globali vere e proprie: visioni globali della persona, della società e del mondo».
Manca la classica Weltanschauung, si direbbe, una visione del mondo, e meno male che ci si era rallegrati della morte delle ideologie... «Sì, è vero, ne hanno celebrato i funerali ed erano tutti contenti perché erano state sepolte, le ideologie. Risultato: è rimasta una piattaforma sabbiosa e arida, certe volte il vuoto. Non c’è neppure più l’assenza di qualcosa».
In che senso, eminenza? «Lo scrittore Georges Bernanos distingueva tra vuoto e assenza. Perché parlare di assenza significa almeno avvertire che qualcosa manca. Ma il momento peggiore è questo: quando non ne avverti più neppure il bisogno. L’indifferenza. Tutto uguale, tutto irrilevante».
Il grande biblista ricorda che «otto secoli prima di Cristo, quando vuole esprimere che siamo arrivati al disastro, Isaia dice: "Guardai in giro e non c’era più nessuno da interrogare per avere una risposta". Si dovrà tornare a dare quelle risposte che ormai non risuonano più, nella cultura contemporanea».
Mentre presentava l’assemblea sulle «Culture giovanili emergenti», il cardinale Ravasi ha citato le parole di San Paolo a Timoteo: «Nessuno disprezzi la tua giovane età, ma sii tu di esempio...». Bisognerebbe «prestare più attenzione ai giovani anche nella Chiesa, dove dovrebbero poter accedere anche a incarichi di responsabilità», ha spiegato. E ora sorride: «E Timoteo era un vescovo!». Ma il discorso, chiaro, è più ampio e riguarda la società in generale, «la classe dirigente», la politica. Che fa, sostiene la cosiddetta rottamazione? Il «ministro» vaticano della Cultura scuote la testa divertito: «Immaginavo saltasse fuori ma no, la cosa è più complessa.
È necessario dire a quelli che si sono insediati brutalmente che è ora di fare intervenire anche i giovani, aprire a un nuovo vento. E i giovani devono cominciare a prendersi le loro responsabilità e a entrare in scena, tenendo conto però del fatto che non si comincia mai da zero.
La rottamazione, se considerata come demolizione, è pericolosa. È vero quello che Giovanni di Salisbury attribuisce a Bernardo di Chartres, nel XII secolo: "Siamo nani sulle spalle dei giganti". Significa che riusciamo a vedere più lontano perché facciamo tesoro del passato».
Qui sta l’«ingenuità della rottamazione», riflette: «È la pretesa di dire: alziamoci, tocca a noi. Ma per vedere più lontano bisogna avere un passato. E una delle crisi della società contemporanea è di essere smemorata, o di non voler memoria. Chi non ricorda, però, non vive».
Così Ravasi si rivolge ai giovani e alle loro domande, consapevole dello scarto. «Mi sono persino esposto all’ascolto di un cd di Amy Winehouse per averne la prova immediata», ha scherzato.
«Eppure in quei testi così lacerati musicalmente e tematicamente emerge una domanda di senso comune a tutti». Quei ragazzi che sono consapevoli «della media, del grigio, della mucillagine». Ha ragione Pascal, conclude il cardinale: «"L’uomo supera infinitamente l’uomo". Non si accontenta. Lascialo pure così, fallo stupido, consideralo stupido, però alla fine, soprattutto se giovane, andrà oltre».
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- PATTI LATERANENSI. La struttura segreta del Vaticano. Immobili a Londra con i soldi che Mussolini diede al papato (di Enrico Franceschini)22 gennaio 2013, di Federico La Sala
 La struttura segreta del Vaticano
La struttura segreta del Vaticano
 Immobili a Londra con i soldi di Mussolini
Immobili a Londra con i soldi di Mussolini Una società off-shore custodisce un patrimonio da circa 650 milioni di euro. Per conto della Santa Sede, che ha raggranellato prestigiosi locali ed edifici nella capitale britannica. Grazie ai soldi che Mussolini diede al papato con i Patti Lateranensi
Una società off-shore custodisce un patrimonio da circa 650 milioni di euro. Per conto della Santa Sede, che ha raggranellato prestigiosi locali ed edifici nella capitale britannica. Grazie ai soldi che Mussolini diede al papato con i Patti Lateranensi dal nostro corrispondente ENRICO FRANCESCHINI *
dal nostro corrispondente ENRICO FRANCESCHINI *LONDRA - A chi appartiene il locale che ospita la gioielleria Bulgari a Bond street, più esclusiva via dello shopping nella capitale britannica? E di chi è l’edificio in cui ha sede la Altium Capital, una delle più ricche banche di investimenti di Londra, all’angolo super chic tra St. James Square e Pall Mall, la strada dei club per gentiluomini?
La risposta alle due domande è la stessa: il proprietario è il Vaticano. Ma nessuno lo sa, perché i due investimenti fanno parte di un segretissimo impero immobiliare costruito nel corso del tempo dalla Santa Sede, attualmente nascosto dietro un’anonima società off-shore che rifiuta di identificare il vero possessore di un portfolio da 500 milioni di sterline, circa 650 milioni di euro. E come è nata questa attività commerciale dello Stato della Chiesa? Con i soldi che Benito Mussolini diede in contanti al papato, in cambio del riconoscimento del suo regime fascista, nel 1929, con i Patti Lateranensi.
A rivelare questo storia è il Guardian, con uno scoop che oggi occupa l’intera terza pagina. Il quotidiano londinese ha messo tre reporter sulle tracce di questo tesoro immobiliare del Vaticano ed è rimasto sorpreso, nel corso della sua inchiesta, dallo sforzo fatto dalla Santa Sede per mantenere l’assoluta segretezza sui suoi legami con la British Grolux Investment Ltd, la società formalmente titolare di tale cospicuo investimento internazionale. Due autorevoli banchieri inglesi, entrambi cattolici, John Varley e Robin Herbert, hanno rifiutato di divulgare alcunché e di rispondere alle domande del giornale in merito al vero intestatario della società.
Ma il Guardian è riuscito a scoprirlo lo stesso attraverso ricerche negli archivi di Stato, da cui è emerso non solo il legame con il Vaticano ma anche una storia più torbida che affonda nel passato. Il controllo della società inglese è di un’altra società, chiamata Profima, con sede presso la banca JP Morgan a New York e formata in Svizzera.
I documenti d’archivio rivelano che la Profima appartiene al Vaticano sin dalla seconda guerra mondiale, quando i servizi segreti britannici la accusarono di "attività contrarie agli interessi degli Alleati". In particolare le accuse erano rivolte al finanziere del papa, Bernardino Nogara, l’uomo che aveva preso il controllo di un capitale di 65 milioni di euro (al valore attuale) ottenuto dalla Santa Sede in contanti, da parte di Mussolini, come contraccambio per il riconoscimento dello stato fascista, fin dai primi anni Trenta. Il Guardian ha chiesto commenti sulle sue rivelazioni all’ufficio del Nunzio Apostolico a Londra, ma ha ottenuto soltanto un "no comment" da un portavoce.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- Vaticano: cercasi bancomat extracomunitario (di Marco Lillo)19 gennaio 2013, di Federico La Sala
Vaticano: cercasi bancomat extracomunitario
di Marco Lillo (il Fatto Quotidiano, 19 gennaio 2013)
La lettera che ha decretato la chiusura del bancomat in Vaticano porta la data del 6 dicembre 2012, ma da più di due anni la Santa Sede era informata dei problemi legali del bancomat della Deutsche Bank Spa. E almeno dal novembre 2011 la filiale della banca tedesca (soggetta alla vigilanza di Bankitala) sapeva di non essere in regola.
Eppure nessuno aveva segnalato in tempo il pericolo al Segretario di Stato Tarcisio Bertone che non l’ha presa bene. Il direttore generale dello Ior, Paolo Cipriani, è stato chiamato nei giorni scorsi a spiegare perché non siano state approntate valide alternative ai pos di Deutsche Bank.
L’impossibilità di accettare pagamenti con il bancomat ai musei vaticani e nella farmacia si sta rivelando un problema serio e in tutta fretta si sta correndo ai ripari. Giovedì scorso il direttore dell’Aif, l’Autorità di Informazione Finanziaria del Vaticano, René Brulhart, ha incontrato in via Nazionale i vertici dell’Area vigilanza della Banca d’Italia.
La riunione istituzionale era fissata da tempo ma ovviamente buona parte dell’incontro è stato dedicato all’emergenza bancomat. Brulhart giocava fuori casa: l’esperto antiriciclaggio a novembre ha soppiantato la vecchia guardia dell’Aif, capeggiata dall’ex funzionario di Bankitalia Marcello Condemi, ispiratore della linea più rigorosa poi sconfessata da Bertone.
Brulhart in Vaticano non è passato inosservato, sia per l’aspetto da attore di fiction che per la sua indubbia competenza. Nato in Svizzera a Friburgo 40 anni fa è stato descritto generosamente sui giornali italiani come un cacciatore di patrimoni dei dittatori, a partire da Saddam Hussein. Il suo bell’aspetto e l’abilità nei rapporti con la stampa (si è fatto fotografare abbronzato con le sue Alpi sullo sfondo) ha fatto dimenticare che l’Autorità da lui diretta per anni non è quella di un paese come l’Italia ma quella di un paradiso fiscale come il Liechtenstein.
Il suo sponsor in Vaticano è stato monsignor Ettore Balestrero, il 46enne sottosegretario ai rapporti con gli stati esteri. Nonostante le sue arti diplomatiche, Brulhart non ha smosso i vertici dell’Area Vigilanza di via Nazionale dalle posizioni sostenute nel provvedimento del 16 dicembre. Leggendolo si scopre che il blocco dei pagamenti pos ha poco a che vedere con l’indagine della Procura di Roma, come sostenuto dalla stampa italiana.
Il provvedimento ripercorre la storia dall’inizio: “A conclusione dell’ispezione di vigilanza condotta fra il 24 maggio e il 10 ottobre 2010 è stato contestato a Deutsche Bank Spa di prestare servizi di pagamento mediante apparecchiature Pos installate nello Stato della Città del Vaticano in assenza dell’autorizzazione ex articolo 16, comma 2, Testo Unico”.
Dopo un carteggio con Deutsche, Bankitalia ha confermato all’istituto tedesco il 15 novembre del 2011 che “l’offerta di servizi di pagamento tramite Pos nello stato extra-comunitario (il Vaticano, ndr) costituisce una prestazione di servizi senza stabilimento all’estero”. Quindi soggetta ad autorizzazione, che però non era mai stata chiesta.
In pratica da venti anni la Deutsche bank aveva un bancomat senza permesso. “La banca”, prosegue il provvedimento , “ha presentato il 18 maggio 2012, istanza di autorizzazione a sanatoria per lo svolgimento dell’attività di ‘convenzionamento’ degli esercizi commerciali”. E la risposta è stata picche. “Con lettera del 10 settembre 2012 Banca d’Italia ha comunicato all’intermediario che l’istanza relativa allo svolgimento di servizi di pagamento tramite Pos nello Stato della Città del Vaticano non era suscettibile di accoglimento”.
LA MOTIVAZIONE è una bocciatura del sistema antiriciclaggio e di vigilanza del Vaticano: “Mancando dei presupposti per il rilascio dell’autorizzazione relativamente all’adeguatezza della legislazione e del sistema di vigilanza, anche in materia di antiriciclaggio dello stato extracomunitario”. Ora il Vaticano può impugnare il provvedimento al Tar ma intanto deve risolvere il problema operativo subito.
La soluzione è stata individuata in una banca extra Ue, quindi non soggetta alla vigilanza di Bankitalia. La Segreteria di Stato sta esaminando le offerte. In lizza ci sono una banca svizzera e un istituto americano. Presto i bancomat del Vaticano ricominceranno a strisciare lontano dagli occhi della Banca d’Italia.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- FEMMINICIDIO. Tacere sarebbe un po’ come avallare (di don Renato Sacco - Mosaico di pace)).28 dicembre 2012, di Federico La Sala
Femminicidiodi don Renato Sacco (“Mosaico di pace”, 27 dicembre 2012)
No. Tacere sarebbe un po’ come avallare. Ci ho pensato molto quando ho letto la notizia di un prete, parroco in Liguria, che ha affisso alla porta della sua chiesa un articolo preso da internet dal titolo: “Le donne e il femminicidio, facciano sana autocritica. Quante volte provocano?” Mi ha molto colpito, come prete e come uomo, tutta questa vicenda con le successive affermazioni, smentite ecc.
Ho pensato che non era giusto stare in silenzio. Credo, di fronte alla morte, all’uccisione, al ‘femmnicidio’ non ci sia spazio per i se e per i ma... Siamo di fronte a persone uccise in quanto donne, quasi sempre da uomini del proprio ambito familiare.
Far finta di non vedere o puntare i riflettori su altro (es. modo di vestire ecc.) credo sia molto grave. E penso che come uomo e come prete, anch’io sono parroco, non si debba spostare l’attenzione dalle vittime, che hanno un nome, un volto e una storia.
Ancora ieri, 26 dicembre, in Liguria, un marito, già denunciato per violenze e minacce, uccide la moglie Olga e la sorella Francesca. No, sulla morte non si scherza, e non si scrivono cose dicendo che servono ‘a far riflettere’. Oppure cercando una qualche colpa nelle vittime.
Credo che una seria autocritica la debba fare io - noi in quanto uomini. E io - noi in quanto preti, che spesso parliamo del valore della vita, della famiglia, ecc.
Molti omicidi avvengono proprio in ambito familiare. Stiamo attenti a non arrivare a dire, com’è già successo in passato, che ‘bisogna contestualizzare’. Di fronte al genocidio degli Ebrei, dobbiamo dire che anche gli Ebrei se la sono un po’ cercata? Di fronte ai bambini uccisi a Sarajevo durante la guerra perché giocavano sulla neve, dobbiamo dire che è anche colpa loro e delle mamme che li hanno lasciati uscire dalle cantine?
E di fronte alla vittime di tante guerre passate e attuali, qualche colpa la troviamo per giustificare le bombe e i massacri? E di fronte a questi cristiani uccisi in una chiesa in Nigeria, dobbiamo dire che se la sono cercata, che era meglio se stavano a casa e non andavano in chiesa a pregare? No, credo proprio che sia importante non perdere la bussola e stare dalla parte delle vittime.
Sempre. Don Tonino Bello, profeta dei nostri tempi, morto 20 anni fa, ci ricordava che "delle nostre parole dobbiamo rendere conto agli uomini. Ma dei nostri silenzi dobbiamo rendere conto a Dio!".
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- FEMMINICIDIO. Tacere sarebbe un po’ come avallare (di don Renato Sacco - Mosaico di pace)).12 gennaio 2013, di paperegirasolegrazie, Padre, per aver deciso di che non fosse giusto stare in silenzio. Grazie per il Suo contributo critico, equilibrato ma deciso. Grazie per aver riconosciuto che questo fenomeno non consente di essere "banalizzato" da contestualizzazioni che rischiano di apparire amorali più di quanto esso stesso sia immorale.
-
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- La singolare amnesia dei vessilliferi del cattolicesimo istituzionale.22 dicembre 2012, di Federico La Sala
Amnesie vaticane per brutti alleati
di Marco Politi (il Fatto Quotidiano, 22 dicembre 2012)
Ora che Berlusconi è diventato ufficialmente cattivo, perché i vertici ecclesiastici hanno trovato il Monty-Party da caldeggiare, una singolare amnesia coglie i vessilliferi del cattolicesimo istituzionale. Con la minacciosa impudenza di sempre Berlusconi ricordava l’altro giorno le sue benemerenze nei confronti di Chiesa e Vaticano. Non aveva bisogno di elencarle.
Sono tante, sono agli atti: le norme imbroglione per non fare pagare l’Ici agli enti ecclesiastici con attività commerciale, i finanziamenti alle scuole, i finanziamenti a pioggia a opere confessionali varie anche prelevando le somme che i cittadini con l’8 per mille avevano destinato espressamente a “iniziative umanitarie statali”, l’appoggio alla campagna astensionistica del cardinal Ruini per sabotare il referendum sulla procreazione artificiale, il blocco ad una legge sull’omofobia, l’adesione al Family Day per impedire una legge sulle coppie di fatto, il catenaccio contro una legge sul testamento biologico che garantisca l’autodeterminazione del paziente, il tentativo di sovvertire con un decreto legge la sentenza del tribunale che autorizzava il padre di Eluana a lasciarla spegnersi in pace, la pressione in Europa per rovesciare la sentenza della corte di Strasburgo che sanciva la non sostenibilità di una presenza monopolistica di un simbolo religioso (vedi crocifisso) nelle aule scolastiche.
“AUSPICO - ha detto il Caimano - che i si ricordi tutto quello che abbiamo fatto per la Chiesa”. I cittadini ricordano... Ma l’Avvenire, stizzito, ha reagito con un corsivetto del direttore, in cui si accusa B. di muoversi “con poco garbo e nessuna eleganza” e di ignorare che i cattolici sono “gente che è piuttosto difficile incantare con stentoree o suadenti propagande”.
Dice il giornale dei vescovi che l’elettorato sa valutare con “saldi criteri civili e morali.... (sia i programmi che) i profili politici e personali” di chi vuole governare l’Italia. Un tono davvero sferzante, sintomo del nuovo corso chiesastico.
Giorni fa l’Avvenire rimarcava anche il “fallimento” del governo Berlusconi e la Tv dei vescovi gli accreditava un comportamento politico “miope e meschino”. Peccato soltanto che una grande amnesia avvolga il fervido appoggio a Berlusconi di Chiesa e Vaticano per un intero ventennio. Sì, si possono ripescare dagli archivi singoli interventi critici, che di quando in quando hanno rotto i grandi silenzi di complicità con il governo del Caimano. Si possono anche citare gli ultimi duri interventi (cinque) dell’era Boffo, poi lasciato massacrare dal Giornale di Feltri. “Lasciato” massacrare, perché poche settimane dopo all’aeroporto di Ciampino (26 settembre 2009) il Papa salutava cordialmente il patrono della decapitazione dell’allora direttore di Avvenire, esclamando: “Che piacere rivederla”. C’è stata anche qualche bacchettata della Cei nel corso post-ruiniano.
Piccoli lampi nella grande nube di silente sostegno alle follie rovinose del governo berlusconiano. Non si è sentita la voce della Chiesa tra gli oppositori, quando il Caimano anno dopo anno ha scardinato il sistema giuridico. Non si è sentita quando ha falsato la legge sul bilancio e si è aggiustato i processi a colpi di deformazioni di legge. Non si è sentita quando la magistratura è stata sistematicamente delegittimata. Anzi, il ruinismo allora ha rispolverato una comoda versione degli opposti estremismi, evocando un’inesistente guerra tra giudici e politica che in nessun Paese occidentale è mai stata citata (tra gli ultimi casi, l’esemplare atteggiamento di Israele dove è possibile processare senza turbative e senza “legittimi impedimenti” un capo di stato o un ministro degli esteri). Non si è sentita, peraltro, nemmeno la voce laica di molti odierni rinnovatori.
GLI ITALIANI ricordano invece le esortazioni di mons. Fisichella a “contestualizzare” le bestemmie. Gli italiani ricordano la volonterosa partecipazione del Segretario di Stato vaticano cardinale Bertone ad una cena organizzata in casa di Vespa per sponsorizzare il riavvicinamento tra Casini e Berlusconi. Ricordano le pressioni del cardinal Ruini perché continuasse l’alleanza tra l’Udc e il Pdl dell’allora premier, oggi diventato improvvisamente impresentabile.
Gli italiani ricordano anche il grande assist della Chiesa a B. alla vigilia del voto di sfiducia del 14 dicembre 2010 (quando Fini e il neonato Fli, si ribellarono). La scena si svolse ad un ricevimento nell’ambasciata d’Italia presso la Santa Sede. “Da parte mia non verrà mai nulla contro il Vaticano”, scandì Berlusconi. Il suo governo, replicò Bertone perché il messaggio fosse sentito ben bene su tutti i media, “va ringraziato per aver svolto un’azione che ha tenuto in gran conto le istanze della Chiesa, in un contesto di relazioni pacificate”.
“Memoria ottima”, titolava l’Avvenire ieri. Si vede che i saldi criteri di giudizio funzionano a intermittenza. Facile oggi dire che Monti ha salvato l’Italia dal “baratro”. Tra gli oppositori di chi trascinava l’Italia verso la rovina, in quegli anni i grandi prelati non c’erano. Signori, capaci di indignarsi al momento giusto, si nasce (direbbe Totò). Certe pensose figure, adesso veloci a ripudiare il Caimano, non lo nacquero
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- LA SOLIDARIETA’-PANETTONE DI BENEDETTO XVI E IL "FINANCIAL TIMES".21 dicembre 2012, di Federico La Sala
 Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio ... e un cattolicesimo che ha sempre confuso "Erode" con Cesare e Dio ("Charitas") con Mammona ("Caritas")!!!
Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio ... e un cattolicesimo che ha sempre confuso "Erode" con Cesare e Dio ("Charitas") con Mammona ("Caritas")!!!
 NATALE A LONDRA: LA SOLIDARIETA’-PANETTONE DI BENEDETTO XVI E IL "FINANCIAL TIMES". Il testo di Benedetto XVI e una nota di Sergio Cesaratto
NATALE A LONDRA: LA SOLIDARIETA’-PANETTONE DI BENEDETTO XVI E IL "FINANCIAL TIMES". Il testo di Benedetto XVI e una nota di Sergio Cesaratto
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- I CAPISALDI DI IERI (2010) E I CAPISALDI DI OGGI (2012)!!!12 dicembre 2012, di Federico La SalaCAPISALDI?! LA BUSSOLA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UN PAESE, SENZA "NOME" E SENZA "PAROLA"!!! Una nota di Mario Monti - con appunti
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- IL PAPATO DI BENEDETTO XVI: SETTE ANNI DI OFFESE ALLA CHIESA E ALL’ITALIA.21 novembre 2012, di Federico La Sala
CEDIMENTO STRUTTURALE DEL CATTOLICESIMO-ROMANO. Benedetto XVI, il papa teologo, ha gettato via la "pietra" ("charitas") su cui posava l’intera Costruzione... e anche la maschera
 IL PAPATO DI BENEDETTO XVI: SETTE ANNI DI OFFESE ALLA CHIESA E ALL’ITALIA. Una nota su un incontro del 2005 e sugli eventi successivi, fino ad oggi
IL PAPATO DI BENEDETTO XVI: SETTE ANNI DI OFFESE ALLA CHIESA E ALL’ITALIA. Una nota su un incontro del 2005 e sugli eventi successivi, fino ad oggiCOSTANTINO, SANT’ELENA, E NAPOLEONE. L’immaginario del cattolicesimo romano.
IL SOGNO DI UNA "COSA" DI BENEDETTO XVI: UNA CHIESA "PER MOLTI", NON "PER TUTTI".
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- MARXISTI RATZINGERIANI: QUANDO LA “SINISTRA” CELEBRA IL PAPA TEOLOGO (di Emilio Carnevali)3 dicembre 2012, di Federico La Sala
MARXISTI RATZINGERIANI: QUANDO LA “SINISTRA” CELEBRA IL PAPA TEOLOGO
36949. ROMA-ADISTA. Sono stati in molti a sorprendersi per i nomi del “Pantheon” indicati dai vari candidati alle primarie del centrosinistra la sera del loro primo dibattito televisivo. In particolare per le scelte di Nichi Vendola e Pierluigi Bersani - entrambi provenienti dal Partito Comunista Italiano - che hanno citato come propri punti di riferimento due importanti uomini di Chiesa: rispettivamente il card. Carlo Maria Martini e Giovanni XXIII.
Lo stupore potrebbe venire meno scavando un po’ più a fondo nelle biografie dei due uomini politici. Vendola, che non ha mai nascosto la sua fede cattolica, è stato allievo di don Tonino Bello, vescovo della diocesi di Molfetta e successore di mons. Luigi Bettazzi alla presidenza di Pax Christi. E anche la passione di Bersani per i papi non è affatto una novità, dato che il segretario del Pd si è laureato in filosofia, all’Università di Bologna, con una tesi in storia del cristianesimo dedicata a papa Gregorio Magno ed è sempre stato molto attento, da presidente della Regione Emilia Romagna prima, e da ministro dell’Industria poi, agli interessi ecclesiastici.
Al di là degli aspetti frivoli della “questione Pantheon” - non sono mancate, in Rete, feroci ironie sulle scelte compiute dai due esponenti della sinistra -, è vero che il dialogo fra eredi della tradizione comunista italiana e mondo cattolico ha recentemente conosciuto originali momenti di incontro ed interlocuzione di grande profondità.
Il 16 ottobre del 2011 il quotidiano dei vescovi Avvenire pubblicava con molto risalto un manifesto di quattro intellettuali di formazione marxista - Giuseppe Vacca, Pietro Barcellona, Mario Tronti e Paolo Sorbi - intitolato “L’emergenza antropologica: per una nuova alleanza” (v. Adista n. 78/11). Nel testo emergeva uno sguardo assai interessato al magistero di Benedetto XVI, in modo particolare alla critica delle culture individualistiche ed edoniste sviluppata dal papa in molte riflessioni pubbliche: «La condanna del “relativismo etico”», scrivevano i quattro, «non travolge il pluralismo culturale, ma riguarda solo le visioni nichilistiche della modernità che, seppur praticate da minoranze intellettuali significative, non si ritrovano a fondamento dell’agire democratico in nessun tipo di comunità: locale, nazionale e sovranazionale. Il “relativismo etico” permea, invece, profondamente, i processi di secolarizzazione, nella misura in cui siano dominati dalla mercificazione. Ma non è chi non veda come la lotta contro questa deriva della modernità costituisca l’assillo fondamentale della politica democratica, comunque se ne declinino i principi, da credenti o da non credenti». Ecco quindi le basi per un’alleanza, o quantomeno un dialogo, fra critici della modernizzazione capitalistica intesa come dissoluzione di ogni legame comunitario - con conseguente sussunzione di ogni sfera della vita agli imperativi del profitto - e spiritualismo cattolico diffidente verso le potenzialità nichiliste della modernità stessa, o meglio della sua volontà di autosufficienza rispetto alle domande ultime di senso. È nella condivisione di una cultura del limite che può essere rintracciato anche il comune terreno di confronto per quei temi “eticamente sensibili” che nel passato recente hanno tanto diviso l’opinione pubblica del nostro Paese.
Alla pubblicazione del manifesto seguì un acceso dibattito, i cui contributi sono stati raccolti nel volume Emergenza antropologica: per una nuova alleanza tra credenti e non credenti (Guerini e Associati, 2012) che ospita interventi di personalità di diversa provenienza culturale e politica come Vittorio Possenti, Franco Totaro, Emma Fattorini, Pierangelo Sequeri, Massimo De Angelis, Roberto Ronza, Luigi Amicone, Pasquale Serra, Claudio Sardo, Andrea Olivero, Paolo e Luca Tanduo, e Gabriella Cotta.
Inoltre, il quotidiano dei vescovi ha promosso un ciclo di incontri con i firmatari del manifesto. Il 1 novembre 2012 è stata pubblicata una conversazione fra Vittorio Possenti e Mario Tronti. La settimana successiva quella fra Paolo Sorbi e Mauro Magatti, poi quella fra Pietro Barcellona e Paola Ricci Sindoni. Il ciclo si è concluso lo scorso 21 novembre con il dibattito fra il direttore dell’Istituto Gramsci, Giuseppe Vacca, e il giurista cattolico, ed ex presidente del Comitato nazionale di bioetica, Francesco D’Agostino.
D’altra parte la rinnovata attenzione degli ambienti intellettuali post-comunisti verso questi temi - e verso il mondo cattolico più “ortodosso” - non è confinata solo entro le pagine di Avvenire. Ne è un significativo esempio il libro di uno degli uomini politicamente più vicini a Bersani, il responsabile economia e lavoro del Pd Stefano Fassina. Nel suo libro Il lavoro prima di tutto (Donzelli, 2012) Fassina ha scritto che «nello smarrimento post-Lehman Brothers, la Chiesa di Benedetto XVI, sulla scia di un pensiero secolare, è stata un punto di riferimento. Ha messo a nudo le radici etiche, culturali, e politiche dell’equilibrio saltato: l’individualismo utilitaristico e il primato dell’economia sulla politica». E non sorprende che al keynesiano Fassina sia piaciuta un’enciclica cui ha ampiamente collaborato un economista per certi aspetti distante dall’ortodossia neoclassica come Stefano Zamagni. «La sfida per segnare in senso progressivo la “grande transizione” in corso», aggiungeva infatti il responsabile economia del Pd nel capitolo finale del suo libro, «investe il “senso del lavoro”, prima ancora che il piano programmatico. È la sfida che la Caritas in veritate di Benedetto XVI, l’analisi più lucida della fase, pone alla politica. È la sfida sulla quale siamo impegnati: ridefinire il senso del lavoro per affermare, nel quadro di una economia oggi senza regole democratiche, un “neo-umanesimo laburista”». (emilio carnevali)
* Adista Notizie n. 44 del 08/12/2012
-
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- VITA E PARADOSSI: TOPOLINO E RUSSELL LIBERI PENSATORI, MA NON I FILOSOFI ITALIANI. Una nota di Giulio Giorello.10 novembre 2012, di Federico La Sala
 DEMOCRAZIA, SCIENZA E RELIGIONE: TOPOLINO E RUSSELL LIBERI PENSATORI, MA NON I FILOSOFI ITALIANI. Una nota di Giulio Giorello
DEMOCRAZIA, SCIENZA E RELIGIONE: TOPOLINO E RUSSELL LIBERI PENSATORI, MA NON I FILOSOFI ITALIANI. Una nota di Giulio Giorello
 VITA E PARADOSSI "(...) riportando una sua «intervista con lo spettro» Pippo afferma che per una persona sensata fantasmi e anime disincarnate non esistono, e ribadisce che «questo è proprio quel che dice anche lui», lo spettro medesimo! "
VITA E PARADOSSI "(...) riportando una sua «intervista con lo spettro» Pippo afferma che per una persona sensata fantasmi e anime disincarnate non esistono, e ribadisce che «questo è proprio quel che dice anche lui», lo spettro medesimo! "
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- CULTURA, EMERGENZA DEL PAESE -- Con Napolitano per la Costituente. Stati Generali della Cultura: a Roma al Teatro Eliseo, il 15 novembre, alle 11.12 novembre 2012, di Federico La Sala
ITALIA (1994-2012): CULTURA, EMERGENZA DEL PAESE.
LA MISERIA DELLA CULTURA ITALIANA E LA RICCHEZZA DEL MENTITORE ISTITUZIONALIZZATO. Note di premessa sul tema:
 PER L’ITALIA E PER LA COSTITUZIONE. CARO PRESIDENTE NAPOLITANO, CREDO CHE SIA ORA DI FARE CHIAREZZA. PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI ... (Federico La Sala)
PER L’ITALIA E PER LA COSTITUZIONE. CARO PRESIDENTE NAPOLITANO, CREDO CHE SIA ORA DI FARE CHIAREZZA. PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI ... (Federico La Sala)
Con Napolitano per la Costituente *
È il momento degli Stati Generali della Cultura per tirare le fila, con l’intervento del Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, del Manifesto lanciato dal Sole 24 Ore il 19 febbraio scorso «per una Costituente della cultura». Sotto l’alto patronato della Presidenza della Repubblica, sono organizzati da Sole 24 Ore, Accademia dei Lincei e Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani, e si terranno a Roma al Teatro Eliseo, il 15 novembre, alle 11. Introdurrà i lavori Giuliano Amato.
Seguiranno un cortometraggio di Vincenzo Cerami («Appunti per un film sulla rinascita italiana») e la tavola rotonda «Cultura, l’emergenza dimenticata del Paese», introdotta e moderata dal direttore del Sole 24 Ore Roberto Napoletano, che presenterà l’«Indice24» della cultura (di cui Pier Luigi Sacco in questa pagina e Fabrizio Galimberti all’interno anticipano i contenuti), con le indicazioni economiche sul quadro competitivo globale e sulle possibilità concrete di sviluppo senza fondi pubblici dell’industria culturale italiana. Intervengono i ministri Fabrizio Barca, Lorenzo Ornaghi e Francesco Profumo, e Ilaria Borletti Buitoni, Ilaria Capua, Andrea Carandini, Lamberto Maffei, Carlo Ossola.
L’intervento del presidente della Repubblica chiuderà la mattinata. Nella sessione pomeridiana, «Fare economia della cultura. Idee e proposte», moderata dal responsabile della «Domenica» Armando Massarenti, intervengono Alessandro Laterza, Emmanuele Emanuele, Pier Luigi Sacco, Roberto Grossi, Antonio Cognata, Paolo Galluzzi, Gabriella Belli, Walter Santagata, Massimo Monaci, Guido Guerzoni, Alberto Melloni. Le conclusioni sono affidate al ministro Corrado Passera.
 Per partecipare è necessario registrarsi online entro le ore 12 del 14 novembre nel sito
Per partecipare è necessario registrarsi online entro le ore 12 del 14 novembre nel sito
 L’evento verrà trasmesso
in diretta streaming
L’evento verrà trasmesso
in diretta streaming
 e potrà essere seguito su twitter:
#SGCultura12
e potrà essere seguito su twitter:
#SGCultura12
La “Costituente” per la cultura * *
1 Una costituente per la cultura
Cultura e ricerca sono capisaldi della nostra Carta fondamentale. L’articolo 9 della Costituzione «promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione». Sono temi intrecciati tra loro. Perché ciò sia chiaro, il discorso deve farsi economico. Niente cultura, niente sviluppo. "Cultura" significa educazione, ricerca, conoscenza; "sviluppo" anche tutela del paesaggio.
2 Strategie di lungo periodo
Se vogliamo ritornare a crescere, se vogliamo ricominciare a costruire un’idea di cultura sopra le macerie che somigliano a quelle su cui è nato il risveglio dell’Italia nel dopoguerra, dobbiamo pensare a un’ottica di medio-lungo periodo in cui lo sviluppo passi obbligatoriamente per la valorizzazione delle culture, puntando sulla capacità di guidare il cambiamento. Cultura e ricerca innescano l’innovazione, e creano occupazione, producono progresso e sviluppo.
3 Cooperazione tra i ministeri
Oggi si impone un radicale cambiamento di marcia. Porre la reale funzione di sviluppo della cultura al centro delle scelte del Governo, significa che strategia e scelte operative devono essere condivise dal ministro dei Beni Culturali con quello dello Sviluppo, del Welfare, della Istruzione e ricerca, degli Esteri e con il premier. Il ministero dei Beni Culturali e del paesaggio dovrebbe agire in coordinazione con quelli dell’Ambiente e del Turismo.
4 L’arte a scuola e la cultura scientifica
L’azione pubblica contribuisca a radicare a tutti i livelli educativi, dalle elementari all’Università, lo studio dell’arte e della storia per rendere i giovani i custodi del nostro patrimonio, e per poter fare in modo che essi ne traggano alimento per il futuro. Per studio dell’arte si intende l’acquisizione di pratiche creative e non solo lo studio della storia dell’arte. Ciò non significa rinunciare alla cultura scientifica, ma anche assecondare la creatività.
5 Pubblico-privato, sgravi ed equità fiscale
Una cultura del merito deve attraversare tutte le fasi educative, formando i cittadini all’accettazione di regole per la valutazione di ricercatori e progetti di studio. La complementarità pubblico/privato, che implica l’intervento dei privati nella gestione del patrimonio pubblico, deve divenire cultura diffusa. Provvedimenti legislativi a sostegno dei privati vanno sostenuti con sgravi fiscali: queste misure presentano anche equità fiscale.
* Il Sole 24 Ore, 25 febbraio 2012
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- Con Napolitano per la Costituente. --- Un dubbio manifesto (di Tomaso Montanari).12 novembre 2012, di Federico La Sala
Un dubbio manifesto: la cultura della Domenica
di Tomaso Montanari (Il Fatto Quotidiano, 09.03.2012)
Ci sarebbero molte ragioni per non prendere sul serio il manifesto «per una costituente della cultura» lanciato dal giornale di Confindustria: prima tra tutte «una determinata opacità, oscillante tra convenzionale deferenza per le competenze umanistiche e indifferenza o fatale estraneità al tema» (così, perfettamente, Michele Dantini sul “Manifesto”).
Tra gli stessi firmatari molti confessano (ovviamente in privato) di trovare il testo irrilevante («Me l’hanno chiesto, son cose che passano come acqua»), mentre altri raccontano di esser stati inclusi a loro insaputa, o addirittura dopo un diniego. Ma la solenne adesione dei ministri Passera, Profumo e Ornaghi e il successo che il “manifesto” sta riscuotendo nel paese più conformista del mondo, significano che esso ha interpretato nel modo più rassicurante un’opinione diffusa. Al famoso “la cultura non si mangia” di Giulio Tremonti, il giornale di Confindustria oppone un discorso che vuol essere «strettamente economico»: “la cultura si mangia eccome”.
Niente di nuovo: è questo il dogma fondante del trentennale pensiero unico sul patrimonio culturale, per cui «le risorse non si avranno mai semplicemente sulla base del valore etico-estetico della conservazione, [ma] solo nella misura in cui il bene culturale viene concepito come convenienza economica» (Gianni De Michelis, 1985). Su questo dogma si fonda l’industria culturale che sta trasformando il patrimonio storico e artistico della nazione italiana in una disneyland che forma non cittadini consapevoli, ma spettatori passivi e clienti fedeli.
È a questo dogma che dobbiamo la privatizzazione progressiva delle città storiche (Venezia su tutte), e un’economia dei beni culturali che si riduce al parassitario drenaggio di risorse pubbliche in tasche private, socializzando le perdite (l’usura materiale e morale dei pochi “capolavori” redditizi) e privatizzando gli utili, senza creare posti di lavoro, ma sfruttando un vasto precariato intellettuale.
È grazie a questo dogma che prosperano le strapotenti società di servizi museali, che lavorano grazie a un opaco sistema di concessioni e che stanno fagocitando antiche istituzioni culturali e cambiando in senso commerciale la stessa politica del Ministero per i Beni culturali.
È in omaggio a questo dogma che la storia dell’arte è mutata da disciplina umanistica in “scienza dei beni culturali” (e infine in una sorta di escort intellettuale), e che le terze pagine dei quotidiani si sono convertite in inserzioni a pagamento. Appare, insomma, realizzata la profezia di Bernard Berenson, che già nel 1941 intravide un mondo «retto da biologi ed economisti dai quali non verrebbe tollerata attività o vita alcuna che non collaborasse a un fine strettamente biologico ed economico». Di tutto ciò il manifesto confindustriale non si occupa, preferendo affermare genericamente che «la cultura e la ricerca innescano l’innovazione, e dunque creano occupazione, producono progresso e sviluppo».
Naturalmente questo è vero, ed è giusto dire che anche dal punto di vista strettamente economico investire in cultura “paga”. Ma il pericolo principale di questa stagione è la debolezza dello Stato e la voracità con cui i privati declinano la valorizzazione (leggi monetizzazione) del patrimonio. E che il manifesto del Sole non intenda per nulla smarcarsi da questa linea dominante, induce a crederlo il nome del primo firmatario, quell’Andrea Carandini che è un guru del rapporto pubblico-privato nei beni culturali, visto che è riuscito ad autoerogarsi fondi pubblici per restaurare il castello di famiglia chiuso al pubblico.
Né tranquillizza il fatto che il “manifesto” fosse accompagnato da un articolo di fondo del sottosegretario Roberto Cecchi, artefice del più smaccato trionfo degli interessi privati in seno al Mibac (dal caso clamoroso del finto Michelangelo alla svendita del Colosseo a Diego della Valle). Induce, infine, a più di un dubbio la sede stessa in cui il “manifesto” è comparso, quel Domenicale che da anni pratica (almeno nelle pagine di storia dell’arte) un elegante cedimento delle ragioni culturali a quelle economiche, con lo sdoganamento di “eventi” impresentabili e di “scoperte” improbabili.
Un meccanismo approdato a una filiera completa: 24 Ore Cultura produce le mostre (per esempio l’ennesima su Artemisia Gentileschi), Motta (dello stesso gruppo) ne stampa i cataloghi, il «Domenicale» le vende con una pubblicità martellante. Dopo il pirotecnico lancio iniziale, il «Domenicale» ha dedicato ad Artemisia altre quattro pagine, con foto di Piero Chiambretti che visita la mostra e con l’immancabile sfruttamento intensivo della condizione femminile di Artemisia (stupro incluso). Così, una mostra mediocre che si apre con la commercialissima trovata di un letto sfatto che si tinge del rosso della verginità violata di Artemisia si trova a essere la mostra più pompata della storia italiana recente.
È forse pensando a questo tipo di esiti che il “manifesto” consiglia l’«acquisizione di pratiche creative, e non solo lo studio della storia dell’arte»? Più che un programma per il futuro, la santificazione del presente. La risposta vera a quanti affermano che la “cultura non si mangia” è, innanzitutto, che «non di solo pane vive l’uomo»: la nostra civiltà non si è mai basata solo su un «discorso strettamente economico», e la cultura è una delle pochissime possibilità di orientare le nostre vite fuori del dominio del mercato e del denaro. Il punto non è «niente cultura, niente sviluppo», ma: lo sviluppo non ci servirà a nulla, se non rimaniamo esseri umani. Perché è a questo che serve la cultura.
Sarebbe stato assai meglio se, invece del fumoso e conformista “manifesto” confindustriale, gli intellettuali italiani avessero sottoscritto una dichiarazione antiretorica e pragmatica come quella pronunciata, qualche anno fa, da uno dei massimi storici dell’arte del Novecento, Ernst Gombrich: «Se crediamo in un’istruzione per l’umanità, allora dobbiamo rivedere le nostre priorità e occuparci di quei giovani che, oltre a giovarsene personalmente, possono far progredire le discipline umanistiche e le scienze, le quali dovranno vivere più a lungo di noi se vogliamo che la nostra civiltà si tramandi. Sarebbe pura follia dare per scontata una cosa simile. Si sa che le civiltà muoiono.
Coloro che tengono i cordoni della borsa amano ripetere che “chi paga il pifferaio sceglie la musica”. Non dimentichiamo che in una società tutta volta alla tecnica non c’è posto per i pifferai, e che quando chiederanno musica si scontreranno con un silenzio ottuso. E se i pifferai spariscono, può darsi che non li risentiremo mai».
-
-
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- LA PAROLA TRUCCATA E LA MENTE ASTUTA.5 novembre 2012, di Federico La Sala
 SINODO DEI VESCOVI PER LA "NUOVA" EVANGELIZZAZIONE, SECONDO IL DETTATO DELLA "NUOVA" TEOLOGIA DI PAPA RATZIGNGER: "DOMINUS IESUS"(2000), "DEUS CARITAS"(2006). "DIO E’ RICCHEZZA" E I NOSTRI VALORI ... SONO "VERI VALORI"!
SINODO DEI VESCOVI PER LA "NUOVA" EVANGELIZZAZIONE, SECONDO IL DETTATO DELLA "NUOVA" TEOLOGIA DI PAPA RATZIGNGER: "DOMINUS IESUS"(2000), "DEUS CARITAS"(2006). "DIO E’ RICCHEZZA" E I NOSTRI VALORI ... SONO "VERI VALORI"!
 PAROLA TRUCCATA, MENTE ASTUTA E "COMANDAMENTO NUOVO". Una riflessione di Bruno Forte sulla sua partecipazione al Sinodo dei Vescovi - con alcune note
PAROLA TRUCCATA, MENTE ASTUTA E "COMANDAMENTO NUOVO". Una riflessione di Bruno Forte sulla sua partecipazione al Sinodo dei Vescovi - con alcune note
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- L’ERA DELLA COMPIACENZA. L’inganno della cultura al servizio del potere (di Gustavo Zagrebelsky)3 novembre 2012, di Federico La Sala
L’era della compiacenzaL’inganno della cultura al servizio del potere
di Gustavo Zagrebelsky (la Repubblica, 03.11.2012)
NELLE società libere, la cultura è una funzione sociale, per così dire, democratica. Giustamente si dice che la cultura ha una funzione politica, ma questo vale in senso ampio, come servizio alla vita della pòlis, non nel senso stretto di “politica dei politici”. La cultura è una delle tre “funzioni sociali” sulle quali si reggono le nostre società: economia, politica e, per l’appunto, cultura.
Tutti i bisogni sociali sono ascrivibili a uno degli elementi di quella triade, elementi che, variamente configurati, intrecciati, coordinati o messi in gerarchia connotano il modo d’essere e di reggersi delle nostre società. La dottrina delle tre funzioni, che ha radici antichissime, deve tener conto degli odierni postulati della libertà e dell’uguaglianza. Libertà significa mobilità sociale, dunque la possibilità di passare da una funzione all’altra. L’uguaglianza, a sua volta, esclude che alle tre funzioni possano corrispondere categorie sociali separate, com’era invece nelle società antiche. Il cittadino è potenzialmente attivo nel campo economico, politico e culturale; può passare dall’uno all’altro, all’altro ancora, e può perfino svolgerne più d’una contemporaneamente.
La caduta delle barriere rigide, non esclude affatto, tuttavia, che ciascuna funzione mantenga il suo profilo differenziato; che chi si dedica e quando si dedica a una di esse, operando negli ambiti e nelle istituzioni corrispondenti, sia tenuto a un codice di comportamento specifico, vincolato ai dettami di una vocazione particolare. La confusione dei comportamenti determina situazioni percepite come improprie, inammissibili, corrotte.
Le commistioni sono la spia della perdurante vitalità nella nostra coscienza civile di quell’antichissima visione tripartita delle funzioni sociali, in quanto non siano accettate ma siano squalificate come incompatibilità o conflitti d’interesse dagli effetti inquinanti. Non è forse questo uno dei temi politici dominanti nel nostro Paese, dove le connivenze tra finanza e politica, nel silenzio, nei balbettamenti o con la copertura e la connivenza della cultura, hanno avvelenato i pozzi da cui ciascuna di esse dovrebbe attingere le proprie specifiche, non contaminate, risorse?
La cultura, i suoi attori, i beni di cui essi dispongono, vivono, per così dire, assediati. La loro forza materiale è nulla, ma la forza spirituale può essere grande. Si comprende allora che le altre funzioni sociali, l’economia e la politica, la lusinghino per ottenerne i favori, la insidino. Dall’altra parte, poiché la cultura non produce né ricchezza né potere, si spiega la forza d’attrazione che economia e politica esercitano su chi opera nel campo della cultura. Qui, nascono i tradimenti.
C’è un’evidente asimmetria: le seduzioni sono a senso unico. Non si è mai visto che la cultura abbia seriamente tratto a sé uomini dell’economia e della politica, distraendoli dalla ricchezza e dal potere. Non esistono “stati di cultura”, se non nell’immaginario regno platonico dei filosofi. Invece, esistono “Stati di politica”, dove il momento politico pretende il monopolio della legittimità; ed esistono Stati di economia, dove è il momento economico, travestito da tecnico, a pretendere il monopolio della legittimità.
Né l’uno né l’altro, tuttavia, potrebbero esistere senza la legittimazione, la copertura, offerta dalla cultura. Ma, quale cultura? Poiché la ricerca del potere e della ricchezza, come prodotti della libertà e dell’uguaglianza, ha di per sé effetti distruttivi della compagine sociale, la cultura che si limita a seguire pedissequamente gli interessi di chi opera in quegli altri ambiti moltiplica la distruzione e contraddice il suo compito di “terzo” unificatore.
Il mondo della cultura ha il diritto al rispetto della sua autonomia e gli uomini di cultura hanno il dovere di difenderla. Esempi? Non c’è rispetto, quando i beni culturali e i beni ambientali, che sono “culturali” anch’essi, sono usati e abusati, ceduti, cementificati, per ottenere consenso da spendere nella competizione per il potere. I “beni culturali”, conformemente alla loro natura e funzione, hanno da essere collocati in una sfera immunizzata dalla politica.
Se esiste un ministero che si occupa di cultura, questo non dovrebbe essere concepito come appannaggio di partiti in funzione di non si sa quali “politiche culturali”, che non spetta loro progettare e mettere in opera. Ma, devono anche essere immuni dagli interessi commerciali. Non c’è rispetto quando sono sfruttati in campagne commerciali, per promuovere marchi e pubblicizzare prodotti. Possono, certamente, procurare e produrre denaro.
La cultura - per parafrasare un’espressione triviale - non si mangia, ma può dare da mangiare a molti e in molti modi, soprattutto quando, com’è auspicabile, si rivolge al pubblico dei grandi numeri. Ma, deve trattarsi, per così dire, di una conseguenza, o di un effetto collaterale e indotto, non dell’obiettivo primario, prevalente sul rispetto della cultura. La quale non esiste per dar da mangiare ai corpi, ma per alimentare le forze spirituali dell’auto-coscienza individuale e collettiva.
Non c’è rispetto per la cultura quando il Ministero, questa volta dell’istruzione, formula programmi scolastici come quello noto “delle tre I” (inglese, internet, impresa) che esprimono un’idea puramente aziendalistico- esecutiva della scuola, idea resa concreta nella programmazione degli studi nei dove una volta si studiava il diritto costituzionale e pubblico e ora si studiano i contratti con la pubblica amministrazione, le opportunità di finanziamento delle imprese, la disciplina degli investimenti finanziari, e altre cose di questa natura (Gazz. Uff. 30.3. 2012, Supplemento), cose utili ma in ambito diverso. Dall’altra parte, non c’è rispetto per la cultura da parte di chi, per primo, dovrebbe difenderne l’autonomia.
Come ho già detto la nostra epoca è sempre più ricca di consiglieri e consulenti e sempre meno d’intellettuali. Quella del consigliere sarebbe una sorta di versione odierna “dell’intellettuale organico” gramsciano che si collegava alle forze storiche della società per conquistare “l’egemonia” e per svolgere così un compito certo ambiguo, ma indubbiamente grandioso. Il consigliere di oggi vive tra ministeri, enti, istituti, fondazioni, aziende, e si lega al piccolo o grande potente, offrendo i suoi servigi intellettuali e ottenendo in cambio protezione e favori.
La stessa cosa può ripetersi per i consulenti che offrono le proprie conoscenze alle imprese, per testarne, certificarne, magnificarne e pubblicizzarne i prodotti; per testimoniare la qualità del ciclo produttivo, la sua non-nocività, la sostenibilità dell’impatto ambientale, e altre prestazioni di questo genere. Naturalmente, consiglieri e consulenti non sono affatto cosa cattiva, ma solo quando non sono spinti dalla smania di “proporsi” e per questo, inevitabilmente, accettano d’essere reclutati e d’entrare “nell’organico” di questo o quel potente. L’uomo di cultura diventa allora uomo di compiacenza, sebbene spesso voglia illudere se stesso d’essere lui a usare il potente come mezzo per realizzacorsi re le proprie idee, mentre è sempre il contrario: sono le sue idee a essere usate come mezzo per gli interessi del potente.
La società del nostro tempo, dove le conoscenze sono sempre più approfondite e settorializzate; dove nessuno padroneggia anche solo la minima parte dei problemi dalla cui soluzione dipende la vita collettiva; dove il più sapiente nel suo campo è perfettamente ignorante nei campi altrui; dove quindi è inevitabile delegare ad altri la conoscenza che ciascuno di noi, da solo, non può avere: in questa società, massimo è il bisogno di fiducia reciproca. Se non ci si potesse fidare gli uni degli altri e, in primo luogo, di coloro che per professione si dedicano a professioni intellettuali, se l’integrità delle loro “prestazioni” fosse inficiata dal sospetto di compromissione con interessi politici o economici, la cultura, come indispensabile luogo “terzo” di convergenza e convivenza, sarebbe un corpo morto. Il dileggio degli intellettuali non sarebbe immotivato.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- L’anticorruzione è legge. L’incandidabilità è «finta» (di Claudia Fusani)1 novembre 2012, di Federico La Sala
 L’anticorruzione è legge. L’incandidabilità è «finta»
L’anticorruzione è legge. L’incandidabilità è «finta»
 Ok definitivo alle norme anti tangenti
Ok definitivo alle norme anti tangenti
 Severino ora punta a prescrizione e voto di scambio
Severino ora punta a prescrizione e voto di scambio
 Dell’Utri potrà essere candidato
Dell’Utri potrà essere candidato di Claudia Fusani (l’Unità, 01.11.2012)
di Claudia Fusani (l’Unità, 01.11.2012)Missione compiuta. Ma non c’è voglia di esultare. L’anticorruzione è legge e intorno al testo alla fine si è contata una maggioranza altissima (460 sì per la fiducia, 480 per il voto finale), cosa che dopo l’intemerata conferenza stampa post sentenza di Berlusconi non era da considerare scontata. E questi sono, in questo momento, elementi sicuramente positivi.
Ma esultare è un’altra cosa. E la prima ad esserne consapevole è il ministro Paola Severino: «Sono soddisfatta perché i numeri delle votazioni dimostrano che alla fine c’è stata un’ampia condivisione politica» dice calcando il Transatlantico dopo il voto finale e l’ennesimo tour de force smorzato dal color albicocca della giacca. È chiaro però che poteva essere fatto di più e meglio. E dietro l’affermazione del ministro «nessun compromesso al ribasso» c’è esattamente il contrario e la scelta di portare a casa comunque qualcosa. Ci sono nuovi reati (corruzione tra privati, traffico di influenze illecite, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, corruzione per l’esercizio della funzione, concussione per induzione), talvolta le pene sono state alzate e con loro i tempi della prescrizione. C’è il complesso delle nuove regole e relative sanzioni negli uffici pubblici per prevenire la corruzione. E alcuni divieti pesanti come quello per i dipendenti pubblici di ricevere regali e, per la magistratura amministrativa e l’avvocatura pubblica, di dirimere arbitrati. Sono sacche antiche di privilegi spazzati via con la legge.
Ma manca ancora molto: nuove regole sul voto di scambio, sulla prescrizione (che ammazza 200 mila processi ogni anno), e poi il falso in bilancio e l’autoriciclaggio. «Nulla è perfetto e tutto è perfettibile» ha detto il ministro citando Esopo e impegnandosi per i mesi che restano della legislatura. Quelle del ministro sono una lista di buone intenzioni che dipendono però solo in piccola parte dai suoi uffici. Sulla non candidabilità dei condannati, ad esempio, Severino ha quasi un moto di stizza quando le si ricorda che la norma, così com’è, è inutile. Uno specchietto per le allodole che non distrae più nessuno. L’aula ha approvato anche ieri una serie di ordini del giorno. Dicono tutti che bisogna fare presto per avere norme chiare prima del voto politico, in Lazio e Lombardia.
SPECCHIO PER LE ALLODOLE
Il Parlamento ha dato la delega al governo su questo punto. Il legislativo dell’Interno, il prefetto Bruno Frattasi, è pronto. Ma restano problemi di tempo. E di contenuto. Frattasi spiega quelli di tempo: «Gli uffici hanno già scritto lo schema del decreto delegato. Solo che la procedura prevede che il testo ripassi dal Parlamento, cioè sia sottoposto al vaglio delle commissioni per un parere obbligato ma non vincolante». Parere che le commissioni di Camera e Senato possono dare in 60 giorni, ma anche in una settimana.
Su quelli relativi al contenuto della delega, il prefetto auspica («è soprattutto la mia aspirazione da cittadino») che quando i partiti compileranno le liste e dovranno scegliere i candidati «prevalgano più i motivi di opportunità che non quelli del diritto».
Quello del prefetto è un modo gentile per dire che le maglie della non candidabilità sono amplissime. Così tanto che tra 21 condannati definitivi che stanno in Parlamento e dei 125 indagati o condannati in primo e secondo grado, si potranno candidare praticamente tutti tranne uno: Giuseppe Ciarrapico. I paletti della delega, messi dal Parlamento e non dal governo, vietano la candidatura a chi ha condanne definitive superiori ai due anni per reati di grave allarme sociale e contro la pubblica amministrazione. Il senatore Marcello Dell’Utri, stando così le cose, potrà essere ricandidato. Ha una sola condanna definitiva (2 anni e 3 mesi) patteggiata e per frode fiscale. «Nel nostro schema di decreto il patteggiamento è paragonato alla condanna definitiva» spiega Frattasi.
La frode fiscale però non è tra i reati previsti. «A meno che aggiungenon si decida di inserire anche i reati fiscali tra quelli di grave allarme sociale su cui il governo può ancora intervenire per allargare le fattispecie». Anche coloro che hanno avuto la riabilitazione, seppure per reati gravi come il terrorismo, possono essere candidati.
Mancano 4 mesi e mezzo alla fine della legislatura. Dovendo scegliere, dopo le misure per un carcere più vivibile, il ministro Severino punta a lavorare sul prescrizione e voto di scambio. Ma è solo un sogno.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- IL CORRUTTORE DIFESO DALLA POLITICA. Corruzione, sì della Camera alla fiducia, domani il voto finale sul provvedimento31 ottobre 2012, di Federico La Sala
Il corruttore difeso dalla politicadi Giuseppe D’Avanzo (la Repubblica, 05.10.2009)
 La "discesa in campo" del ’94 è servita al Cavaliere per difendere il proprio interesse, come i partiti della prima repubblica lo avevano aiutato a sviluppare il suo business
La "discesa in campo" del ’94 è servita al Cavaliere per difendere il proprio interesse, come i partiti della prima repubblica lo avevano aiutato a sviluppare il suo business
 Paradossalmente metà del Paese è chiamata a difendere un episodio di corruzione che ha assicurato al presidente del Consiglio il dominio nel campo pubblicitario
Paradossalmente metà del Paese è chiamata a difendere un episodio di corruzione che ha assicurato al presidente del Consiglio il dominio nel campo pubblicitarioLa politica, per Silvio Berlusconi, è nient’altro che il modo più efficace per accrescere e proteggere il suo business. È sempre stato così fin da quando, neolaureato fuori corso in giurisprudenza, si dà agli affari. Forte di legami politici con le amministrazioni locali e regionali - e qualche «assegno in bocca» - diventa promotore immobiliare. La politica gli consente di tenere a battesimo, fuori della legge, il primo network televisivo nazionale.
La collusione con la politica - la corruzione d’un capo di governo e il controllo di ottanta parlamentari - gli permette di ottenere, dal presidente del consiglio corrotto, due decreti d’urgenza e, dal parlamento, una legge che impone il duopolio Rai-Fininvest. Non proprio un prometeo dell’economia, nel 1994 è in rotta e fallito (gli oneri del debito della Fininvest - 4000 miliardi di lire - superano l’utile operativo del gruppo). Ha perso però i protettori travolti dal malaffare tangentocratico e s’inventa "imprenditore della politica" convertendo l’azienda in partito.
E’ ancora la politica che gli consente di manomettere, con diciassette leggi ad personam, codici e procedure per evitare condanne penali per un variopinto numero di reati (falso in bilancio, frode fiscale, appropriazione indebita, corruzione) fino all’impunità totale della «legge Alfano» che gli assicura un parlamento diventato bottega sua (domani la Consulta ne vaglierà la costituzionalità).
Non c’è da sorprendersi allora se, condannato oggi al pagamento di un risarcimento di 750 milioni di euro per aver trafugato la Mondadori corrompendo un giudice, Silvio Berlusconi si nasconda ancora una volta dietro il paravento della politica. E’ sempre la sua carta jolly per confondere le acque, cancellare i fatti, rendere incomprensibile quel che è accaduto, difendere - dietro le insegne dell’interesse pubblico - il suo interesse personale. Secondo un copione collaudato nel tempo, il premier anche oggi è lì a cantare la favola dell’«aggressione politica al suo patrimonio», dell’«assedio ad orologeria». Evoca, con le parole della figlia Marina (presidente di Mondadori), il «momento politico molto particolare». Piagnucola: «Se è così, chiudo». Minaccia (gli capita sempre quando è a mal partito) che chiamerà alle urne gli elettori, se sarà contrariato.
Bisogna dunque dire se c’entra la politica, in questa storia della Mondadori. La risposta è sì, c’entra ma (non è un paradosso) soltanto perché salva Berlusconi dai guai (e non è una novità).
Ricapitoliamo. E’ il giugno 2000. Berlusconi è accusato di aver comprato la sentenza che gli ha permesso di mettere le mani sul più grande impero editoriale del Paese scippandolo a Carlo De Benedetti (editore di questo giornale). Per suo conto e nel suo interesse, gliela compra l’avvocato e socius Cesare Previti (poi suo ministro). L’udienza preliminare del "caso Mondadori" ha un esito sorprendente: non luogo a procedere. E’ salvo. Il pubblico ministero Ilda Boccassini si appella. La Corte le dà ragione, ma Previti e Berlusconi hanno destini opposti. Per una svista, i legislatori nel 1990 si sono dimenticati del «privato corruttore» aumentando la pena della corruzione nei processi soltanto per il «magistrato corrotto». Correggono l’errore nel 1992, ma i fatti della Mondadori sono anteriori a quell’anno e dunque Berlusconi è passibile della pena meno grave, da due a cinque anni (corruzione semplice), anziché da tre a otto (corruzione in atti giudiziari). Se ottiene le attenuanti cosiddette generiche, può farla franca perché il reato sarebbe estinto. La sentenza del 25 giugno 2001 le concede a Berlusconi, non a Previti che va a processo.
Stravagante la motivazione che libera il premier: è vero, Berlusconi ha corrotto il giudice, ma si è adeguato a una prassi d’un ambiente giudiziario infetto e poi l’attuale suo stato «individuale e sociale» (si è appena insediato di nuovo a Palazzo Chigi) merita riguardi. Diciamolo in altro modo. Per i giudici non si possono negare le attenuanti, e quindi la prescrizione, a quell’uomo che - è vero - è un «privato corruttore» perché è «ragionevole» e «logico» che il mandante della tangente al giudice sia lui, ma santiddio oggi governa l’Italia, è ricco, potente, conduce la sua vita in modo corretto, come si fa a mandarlo a processo? Berlusconi potrebbe rinunciare alla prescrizione, affrontare il giudizio, dimostrare la sua estraneità, pretendere un’assoluzione piena o almeno testimoniare e dire perché ha offerto a Previti i milioni da cui attinge per pagare il mercimonio del giudice. Non lo fa, tace, si avvale della facoltà di non rispondere e il titolo indecoroso di «privato corruttore» gli resta appiccicato alla pelle.
Dunque, prima conclusione. La politica di ieri e di oggi non c’entra nulla se si esclude il salvataggio del premier, «privato corruttore». Bisogna riprendere il racconto da qui perché la favola dell’«aggressione politica al patrimonio» di Berlusconi si nutre di un sorprendente argomento: «Il processo non ha mai riguardato la Fininvest che si limitò a pagare compensi professionali a Previti».
Occorre allora mettere mano alle sentenze. C’è un giudice, Vittorio Metta, che già è stato corrotto da Previti per un altro affare (Imi-Sir). Viene designato come relatore dell’affare Mondadori. La designazione è pilotata con sapienza. Scrive le 167 pagine della sentenza in un solo giorno, ventiquattro ore, «record assoluto nella storia della magistratura italiana». In realtà, la sentenza è scritta altrove e da chi lo sa chi: «Da un terzo estraneo all’ambiente istituzionale», si legge nella sentenza di primo e secondo grado. Venti giorni dopo il deposito del verdetto (14 febbraio 1991), la Fininvest (attraverso All Iberian, il «gruppo B very discreet») bonifica a Cesare Previti quasi 2 milioni e 800 mila dollari (3 miliardi di lire). Su mandato di chi? Nell’interesse di chi? «La retribuzione del giudice corrotto è fatta nell’interesse e su incarico del corruttore» scrivono i giudici dell’Appello che condannano Cesare Previti non perché concorre al reato di Vittorio Metta (il giudice), ma perché complice del «privato corruttore» (Berlusconi). «E’ la Fininvest - conclude infine la Corte di Cassazione - la fonte della corruzione e pagatrice del pretium sceleris», del baratto che consente a Berlusconi da diciotto anni di avere nella sua disponibilità la Mondadori.
Rimettiamo allora in ordine quel si sa e ha avuto conferma nel lungo percorso processuale, in primo grado, in appello, in Cassazione. Berlusconi è un «privato corruttore». Incarica il socius Previti di corrompere il giudice che decide la sorte e la proprietà della casa editrice. Previti ha «stabilmente a libro paga» Vittorio Metta. Il giudice si fa addirittura scrivere la sentenza. Ottiene «almeno quattrocento milioni» da una "provvista" messa a disposizione dalla Fininvest che "incassa" in cambio la Mondadori.
Questi i nudi fatti che parlano soltanto di malaffare, corruzione, baratterie, di convenienze privatissime e non di politica e mai di interesse pubblico. Di politica parla oggi Berlusconi per salvare se stesso. Come sempre, vuole che sia la politica a tutelare business e patrimonio privati. Per farlo, non rinuncia - da capo del governo e «privato corruttore» - a lanciare una "campagna" che spaccherà in due - ancora una volta - un’opinione pubblica frastornata e disinformata. Berlusconi chiede un’altra offensiva di plagio mediatico con il canone orientale delle tv e dei giornali che controlla e influenza: non convincere, non confutare, screditare. Il premier giunge a minacciare le elezioni anticipate, come se il suo destino fosse il destino di tutti e l’opacità della sua fortuna una responsabilità collettiva.
Ripete la solita filastrocca che si vuole «manipolare con manovre di palazzo la vittoria elettorale del 2008 ed è ora che si cominci a esaminare l’opportunità di una grande manifestazione popolare». In piazza, metà del Paese. In difesa di che cosa? Si deve rispondere: in difesa della corruzione che ha consentito a Berlusconi la posizione dominante nell’informazione e nella pubblicità. E perché poi dovremmo tornare a votare? In difesa del suo portafoglio. L’Italia esiste, nelle intenzioni del capo del governo, soltanto se si mobilita a protezione delle fortune dell’uomo che la governa.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- Questa Italia la sprezzante "Scheisse" non la meritava proprio (di Fulvio Papi - Minima Immoralia).28 ottobre 2012, di Federico La Sala
MINIMA IMMORALIA
di Fulvio Papi *
Stresa. Ho passato una parte dell’estate in un luogo lacustre a me carissimo per pubbliche e segrete ragioni, un tempo luogo di vacanze anche per gli italiani (Gadda vi veniva a trovare la zia, vi passò Piovene), ma oggi soprattutto richiamo pieno di seduzioni per stranieri.
Ogni mattina mi recavo all’edicola della stazione e così, dopo aver ritirato il quotidiano d’abitudine, mi fermavo a dare un’occhiata ai giornali stranieri che, per lo meno nella mostra, subissavano le nostre prestigiose (?) testate.
Non voglio far credere a nessuno che potessi passare da una lingua all’altra come se tutte me le avesse insegnate mia madre (che del resto sapeva male anche l’italiano). Ma una cognizione a un foglio e poi ad un altro per riuscire a capire l’essenziale non era impossibile.
Erano i tempi in cui si preparava la cosiddetta manovra economica poi votata con la fiducia da parte dei parlamentari che, salvo le eccezioni che ci sono sempre, o usurpano quel titolo, o lo onorano parlando da assoluti incompetenti.
Ma allora erano i tempi della cosa da fare. E sui fogli stranieri l’impressione comune non era quella di un incontro-scontro di ipotesi che avessero uno sguardo al complicatissimo avvenire del nostro paese nell’Europa e nel mondo, ma piuttosto che si trattasse di una sfilata su un palcoscenico di varietà nel quale ogni attore aveva il problema di far sentire la sua voce, eco di sgangherati ma solidissimi interessi di qualche corporazione piena di soldi che, di fronte al possibile naufragio, si accaparrava più salvagente possibili per non essere toccata nei propri privilegi. Che cosa ne è venuto fuori lo capisce chiunque sappia leggere i documenti. Tuttavia la cosa più interessante è più personale.
La frequentazione quotidiana dell’edicola mi fece conoscere un professore tedesco che parlava anche un ottimo francese. Egli elogiava il luogo, le sue sponde, i suoi colori, i suoi boschi e soprattutto l’isola Bella.
Allora per un gusto antipatico e un poco maligno (che di solito non credo di avere) gli dissi che tutti i grandi elogi fatti dagli scrittori tedeschi all’isola Bella, Goethe compreso, non derivavano affatto da proprie visite (come fu invece quella di Stendhal) ma da una ripetizione di una guida di viaggio tedesca che andava per la maggiore nell’ultimo Settecento.
Non era sapere mio ma un apprendimento da un valentissimo filologo italiano che ne aveva scritto nel 1923. Il mio interlocutore rimase tra l’incredulo e il perplesso. In ogni modo mi restituì la malignità dicendomi, nella sua lingua ma lentamente e in modo comprensibile: «lo sa che il suo è un paese di merda?».
Avesse detto un paese cui spettava qualche altra qualità, avrei potuto anche non capire e fingere di aver capito. Ma la parola tedesca Scheisse apparteneva al mio antico sapere filosofico poiché appariva nella Ideologia tedesca di Marx-Engels laddove il testo affermava che se il proletariato non avesse colto l’occasione rivoluzionaria, tutto sarebbe tornato nella alte Scheisse (vecchia m....).
Poiché la mia informazione quotidiana non è buona, rimasi quasi un po’ offeso. Il mio paese è pieno di ladri, di parassiti, di ignoranti (che comandano), di imbroglioni, di evasori fiscali (ai quali riserverei pene ottocentesche), di servi nell’anima prima che altrove, ma è anche un paese di gente che fa una vita d’inferno per lavorare, di giovani che, senza nessuna garanzia, si adattano a lavori differenti e precari, di persone colte che leggono anche libri difficili, di forze dell’ordine che (tolte le inevitabili mele marce) sono un esempio di efficienza e di senso del dovere, di scienziati che i centri di ricerca stranieri desiderano rapirci, di madri che fanno tre lavori per farcela ecc. ecc.
Questa Italia la sprezzante Scheisse non la meritava proprio. Poi con un minimo di pazienza ci siamo spiegati, e soprattutto il professore mi ha messo sotto il naso un giornale tedesco. Allora tutto rientrava in una nota autobiografia.
Fulvio Papi
* Odissea, Novembre-Dicembre 2011, n. 2, p. 4
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- ALL’ITALIA, «A L’AQUILA LA VERITÀ NON SI DICE». CON QUESTE POCHE PAROLE PRONUNCIATE DA BERTOLASO A BOSCHI È STATO SEGNATO IL DESTINO CRUDELE DI UNA CITTÀ (di Stefania Pezzopane - L’Aquila, le verità che ci hanno nascosto).29 ottobre 2012, di Federico La Sala
L’Aquila, le verità che ci hanno nascosto
di Stefania Pezzopane, Assessore al Comune dell’Aquila
«A L’AQUILA LA VERITÀ NON SI DICE». CON QUESTE POCHE PAROLE PRONUNCIATE DA BERTOLASO A BOSCHI È STATO SEGNATO IL DESTINO CRUDELE DI UNA CITTÀ. Oggi più che mai sento tutto il dolore per l’inganno che abbiamo subito. L’ennesima ulteriore dimostrazione che prima del terremoto gli aquilani non sono stati messi in condizione di essere informati su quello che stava accadendo.
Sfido chiunque ora a difendere la commissione Grandi Rischi in nome di una ideologica difesa della scienza. Queste persone erano venute all’Aquila con il proposito predeterminato di rassicurarci. I giudici sono stati non solo coraggiosi ma veri difensori dello Stato. Uno Stato che in quei giorni ci ha scientificamente ignorati. Gli scienziati infatti, invece di fare il loro mestiere, hanno piegato la loro scienza e la loro coscienza ad una logica allucinante.
Una pagina vergognosa. Nel mio libro «La politica con il cuore», che ho scritto nel 2009, avevo apertamente denunciato l’inganno e la superficialità dei quali si era resa colpevole la commissione. Nessuno, neanche il Comune dell’Aquila che si è costituito parte civile fin dal 2010, ha mai avuto intenzione di processare la scienza.
Piuttosto ci interessa accertare atti e responsabilità di quei componenti della commissione che a L’Aquila è venuta, non purtroppo per indagare il fenomeno che da mesi colpiva il territorio, bensì per obbedire al comando del capo della Protezione civile Bertolaso che in una intercettazione telefonica con l’assessore Stati affidava agli scienziati il solo scopo di fare esclusivamente «un’operazione mediatica» e «tranquillizzare la gente».
La comunità scientifica e quei politici che insorgono contro questa sentenza, nulla sanno degli atti processuali e non aspettano, come sarebbe giusto, di vedere le motivazioni della sentenza, ma più comodamente usano la metafora ideologica e davvero poco razionale del «processo alla scienza». Il ministro Clini con le sue affermazioni di difesa della commissione fa veramente rigirare nella tomba Galileo Galilei.
Mi sarei aspettata dalla comunità scientifica una presa di distanza dai comportamenti di quei «cosiddetti scienziati» che, invece di comportarsi da tali, hanno piuttosto assecondato il bisogno politico della rassicurazione, invece del bisogno scientifico dell’informazione. Quando un giudice condanna un medico che per negligenza o imperizia ha prodotto menomazioni o morte ad un paziente, è forse un processo alla medicina? O non è molto più semplicemente il processo a quel medico negligente e incapace? Quando si processa un politico che ruba e lo si condanna giustamente, non è semplicemente il processo a quel politico e alle sue ruberie e non un processo alla politica? I medici competenti e i politici onesti ringraziano i giudici che condannano incapaci e disonesti.
Questa coraggiosa sentenza rende un po’ di giustizia agli aquilani truffati prima e dopo il terremoto ed ingannati in maniera vergognosa. Il terremoto dell’Aquila non poteva essere previsto, ma a noi aquilani non è stato detto questo, è stato detto esattamente il contrario, ovvero che non era prevedibile in quel dato momento un terremoto grave e che lo sciame sismico era un fenomeno di scaricamento dell’energia, cioè un elemento positivo e tranquillizzante.
Come può allora una comunità scientifica preferire una difesa ad oltranza di chi è condannato, invece di difendere la scienza dall’oltraggio delle interferenze della brutta politica che in quella circostanza e forse anche in altre ha usato commissioni, comitati per fini che nulla c’entrano con l’informazione scientifica.
La commissione in occasione del terremoto dell’Emilia Romagna e del Pollino si è comportata molto diversamente, così come la Protezione Cilvile in più di un’occasione dopo il 6 aprile ha lanciato allarmi meteo, addirittura invitando la popolazione a non uscire di casa. Non mi sembra che quegli allarmi abbiano prodotto se non qualche disagio, gravi ripercussioni. A L’Aquila sarebbe bastato non negare l’evidenza. Mentre nella città ferita, dopo le rassicurazioni, si sono contati 309 morti e migliaia di feriti. Ma l’Aquila pur truffata ed ingannata non si arrende.
* l’Unità, 29.10.2012
-
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- Altro che processo a Galileo! La protezione incivile.27 ottobre 2012, di Federico La Sala
La protezione incivile
di Francesco Merlo (la Repubblica, 27.10.2012)
La spavalderia è la stessa che Bertolaso esibiva sulle macerie quando si vestiva da guerrigliero geologico, da capitano coraggioso, gloria e vanto del berlusconismo, con certificati ammiratori a sinistra. Ma i testi delle telefonate che, in rete su repubblica. it, ora tutti vedono e tutti giudicano, lo inchiodano al ruolo del mandante morale. Quel «nascondiamo la verità», quel «mi serve un’operazione mediatica», quel trattare gli scienziati, i massimi esperti italiani di terremoti, come fossero suoi famigli, «ho mandato i tecnici, non mi importa cosa dicono, l’importante è che tranquillizzino », e poi i verbali falsificati...: altro che processo a Galileo! E’ Bertolaso che ha reso serva la scienza italiana.
Più passano i giorni e più diventa chiara la natura della condanna dell’Aquila. Non è stato un processo alla scienza ma alla propaganda maligna e agli scienziati che ad essa si sono prestati. E innanzitutto perché dipendono dal governo. Sono infatti nominati dal presidente del Consiglio come i direttori del Tg1 e come gli asserviti comitati scientifici dell’Unione sovietica. In Italia la scienza si è addirittura piegata al sottopotere, al sottosegretario Bertolaso nientemeno, la scienza come parastato, come l’Atac, come la gestione dei cimiteri. Dunque è solo per compiacere Guido Bertolaso, anzi per obbedirgli, che quei sette servizievoli scienziati sono corsi all’Aquila e hanno improvvisato una riunione, fatta apposta per narcotizzare.
Chiunque ha vissuto un terremoto sa che la prima precauzione è uscire di casa. Il sisma infatti terremota anche le nostre certezze. E dunque la casa diventa un agguato, è una trappola, può trasformarsi in una tomba fatta di macerie. In piazza invece sopra la nostra testa c’è il cielo che ci protegge. Ebbene all’Aquila, su più di trecento morti, ventinove, secondo il processo, rimasero in casa perché tranquillizzati dagli scienziati di Bertolaso. E morirono buggerati non dalla scienza ma dalla menzogna politica, dalla bugia rassicurante.
Purtroppo il nostro codice penale non prevede il mandante di un omicidio colposo plurimo e Bertolaso non era imputato perché le telefonate più compromettenti sono venute fuori solo adesso. E però noi non siamo giudici e non dobbiamo attenerci al codice. Secondo buon senso Bertolaso è moralmente l’istigatore dei condannati, è lui che li ha costretti a sporcarsi con la menzogna.
Tanto più perché noi ora sappiamo che questi stessi scienziati avevano previsto l’arrivo di un’altra scossa mortale, nei limiti ovviamente in cui la scienza può prevedere le catastrofi. Ebbene, il dovere di Franco Barberi, Bernardo De Bernardinis, Enzo Boschi, Mauro Dolce, Giulio Selvaggi, Gian Michele Calvi, Claudio Eva era quello di dare l’allarme. Gli scienziati del sisma sono infatti le sentinelle nelle torri di avvistamento, sono addestrati a decifrare i movimenti sotterranei, sono come i pellerossa quando si accucciano sui binari. Nessuno si sogna di rimproverarli se non “sentono” arrivare il terremoto. Ma sono dei mascalzoni se, credendo di sentirlo, lo nascondono.
Il processo dell’Aquila dunque è stato parodiato. E quell’idea scema che i giudici dell’Aquila sono dei persecutori che si sono accaniti sulla scienza è stata usata addirittura dalla corporazione degli scienziati. Alcuni di loro, per solidarizzare con i colleghi, si sono dimessi, lasciando la Protezione Civile nel caos, proprio come Schettino ha lasciato la Concordia. Il terremoto in Italia è infatti una continua emergenza: giovedì notte ne abbiamo avuto uno in Calabria e ieri pomeriggio un altro più modesto a Siracusa.
Ebbene gli scienziati che sguarniscono le difese per comparaggio con i colleghi sono come i chirurghi che scioperano quando devono ricucire la ferita.
Ma diciamo la verità: è triste che gli scienziati italiani si comportino come i tassisti a Roma, forze d’urto, interessi organizzati, cecità davanti a una colpevolezza giudiziaria che può essere ovviamente rimessa in discussione, ma che non è però priva di senso, sicuramente non è robaccia intrusiva da inquisizione medievale. Insomma la sentenza di primo grado può essere riformata, ma non certo perché il giudice oscurantista ha condannato i limiti della scienza nel fare previsioni e persino nel dare spiegazioni.
E il giudice dell’Aquila è stato sobrio. E’ raro in Italia trovare un magistrato che non ceda alla rabbia, alla vanità, al protagonismo. Ha letto il dispositivo della sentenza, ha inflitto le condanne e se n’è andato a casa sua come dovrebbero fare tutti i magistrati, a Palermo come all’Aquila. Pochi sanno che si chiama Marco Billi. Non è neppure andato a Porta a Porta per difendersi dall’irresponsabile travisamento che ai commentatori frettolosi può essere forse perdonato, ma che è invece imperdonabile al ministro dell’Ambiente Corrado Clini, il quale ha tirato in ballo Galileo e ci ha tutti coperti di ridicolo facendo credere che in Italia condanniamo i sismologi perché non prevedono i terremoti, che mettiamo in galera la scienza, che continuiamo a bruciare Giordano Bruno e neghiamo che la Terra gira intorno al Sole.
Il ministro dell’Ambiente è lo stesso che appena eletto si mostrò subito inadeguato annunziando che l’Italia del referendum antinucleare doveva comunque tornare al nucleare. Poi pensammo che aveva dato il peggio di sé minimizzando i terribili guasti ambientali causati dall’Ilva di Taranto. Non lo avevamo ancora visto nell’opera brechtiana ridotta a battuta orecchiata, roba da conversazione al Rotary, da sciocchezzaio da caffè. E sono inadeguatezze praticate sempre con supponenza, a riprova che c’è differenza tra un tecnico e un burocrate. In Italia puoi scoprire che anche il direttore generale di un ministero non è un grand commis di Stato ma un impiegato di mezza manica.
So purtroppo che è inutile invitare personaggi e comparse di questa tragica farsa ad un atto di decenza intellettuale, a restituire l’onore alla ricerca, alla scienza e alla giustizia, e a risalire su quelle torri sguarnite della Protezione Civile senza mai più umiliarsi con la politica. A ciascuno di loro, tranne appunto al dimenticabile Bertolaso che intanto si è rintanato nel suo buco, bisognerebbe gridare come a Schettino: «Torni a bordo...».
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- LA COPPIA INCESTUOSA DELLA GERARCHIA CATTOLICO-ROMANA NON HA NIENTE A CHE FARE CON GIUSEPPE E MARIA!!!26 ottobre 2012, di Federico La SalaPSICOANALISI E CRISTIANESIMO:IN MEMORIA DI SIGMUND FREUD. LA "SACRA FAMIGLIA" DELLA GERARCHIA CATTOLICO-ROMANA NON HA NIENTE A CHE FARE CON LA FAMIGLIA DI GESU’, DI GIUSEPPE E MARIA ...
 UNA COPPIA UN PO’ INCESTUOSA: LA MADRE ELENA E L’IMPERATORE COSTANTINO, IL "SIGNORE DEL MONDO" E LA MADRE DI "DIO". Tre donne «forti» dietro tre padri della fede. Una nota di Marco Garzonio - con appunti
UNA COPPIA UN PO’ INCESTUOSA: LA MADRE ELENA E L’IMPERATORE COSTANTINO, IL "SIGNORE DEL MONDO" E LA MADRE DI "DIO". Tre donne «forti» dietro tre padri della fede. Una nota di Marco Garzonio - con appunti
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- EVANGELO, COSTITUZIONE, E STORIA DEI "PAPI".20 ottobre 2012, di Federico La Sala
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- BENEDETTO XVI RIPETE AL BALCONE LA STESSA FRASE DI PAPA GIOVANNI (di Marco Ansaldo - “Nella Chiesa arroganza e ipocrisia”).12 ottobre 2012, di Federico La Sala
 Sinodo, i mea culpa dei vescovi
Sinodo, i mea culpa dei vescovi
 “Nella Chiesa arroganza e ipocrisia”
“Nella Chiesa arroganza e ipocrisia” di Marco Ansaldo (la Repubblica, 12 ottobre 2012)
di Marco Ansaldo (la Repubblica, 12 ottobre 2012)L’ultimo mea culpa in ordine di tempo è venuto dal cosiddetto “papa nero”, il superiore dei gesuiti. «La nuova evangelizzazione - ha detto padre Adolfo Nicolas - deve imparare dagli aspetti buoni e meno buoni della prima evangelizzazione. Mi sembra che noi missionari non l’abbiamo fatto con la profondità richiesta. Abbiamo cercato le manifestazioni occidentali della fede, e non abbiamo scoperto in che maniera Dio ha operato presso altri popoli. E tutti ne siamo impoveriti». Il Sinodo sulla nuova evangelizzazione si è aperto domenica e in Vaticano la discussione è in pieno sviluppo.
Tra i vescovi prevalgono accenti autocritici. Monsignor Rino Fisichella, che del Pontificio consiglio per la nuova evangelizzazione è il presidente, nel suo intervento ha detto: «Ci siamo rinchiusi in noi stessi. Mostriamo un’autosufficienza che impedisce di accostarci come una comunità viva e feconda che genera vocazioni, tanto abbiamo burocratizzato la vita di fede e sacramentale ».
Ancora più duro è l’arcivescovo filippino Socrates Villegas: «Perché in alcune parti del mondo c’è una forte ondata di secolarizzazione, una tempesta di antipatia o pura e semplice indifferenza verso la Chiesa? La nuova evangelizzazione richiede nuova umiltà. Il Vangelo non può prosperare nell’orgoglio. L’evangelizzazione è stata ferita e continua ad essere ostacolata dall’arroganza dei suoi agenti. La gerarchia deve evitare l’arroganza, l’ipocrisia e il settarismo. Dobbiamo punire quanti tra noi sbagliano, invece di nascondere gli errori».
Un altro big come il cardinale Timothy Dolan, arcivescovo di New York e presidente della Conferenza episcopale Usa, rilancia l’importanza della confessione. «La risposta alla domanda “cosa c’è di sbagliato nel mondo?” non è la politica, l’economia, il secolarismo, l’inquinamento, il riscaldamento globale... No. Come scrisse Chesterton, “la risposta alla domanda cosa c’è di sbagliato nel mondo sono due parole: sono io».
Ieri i lavori del Sinodo si sono sospesi per la celebrazione dei 50 anni del Concilio Vaticano II. E alla sera Benedetto XVI ha sorpreso tutti, affacciandosi al balcone e pronunciando la stessa frase detta da Giovanni XXIII l’11 ottobre 1962 in quello che è passato alla storia come il “discorso alla luna”. «Alla fine oso fare mie - ha detto Joseph Ratzinger - le parole indimenticabili di Papa Giovanni: andate a casa e date una carezza ai bambini e dite che è del Papa».
«Anch’io sono stato in questa piazza 50 anni fa - ha poi dichiarato, anch’egli con parole suonate di critica alla Chiesa - quella sera eravamo felici, pieni di entusiasmo. In questi 50 anni abbiamo imparato che il peccato originale esiste e si traduce in peccati personali. Abbiamo visto che nel campo del Signore c’è sempre la zizzania, che nella rete di Pietro ci sono anche pesci cattivi, che la fragilità umana è presente anche nella Chiesa. Qualche volta abbiamo pensato che il Signore dorme e ci ha dimenticato». Nella messa al mattino, all’apertura solenne dell’Anno della fede, Ratzinger aveva detto che «nei decenni che ci separano dal Concilio è avanzata una desertificazione spirituale».
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- Il deserto è davanti a noi. Vent’anni di berlusconismo ed ecco il risultato: il Lazio, la Lombardia, la Calabria, il Molise e a continuare (di don Paolo FArinella - Laziogate, le colpe del Vaticano).27 settembre 2012, di Federico La Sala
DON PAOLO FARINELLA - Laziogate, le colpe del Vaticano *
Come ho scritto tante volte, negli anni scorsi e a ridosso del cambio di guardia del governo italiano, imposto dall’Europa, il fallimento su tutta la linea dell’usurpatore Berlusconi non ha significato la fine delle disgrazie italiane. Anzi, adesso vengono allo scoperto con più veemenza perché è l’inizio di una fine tragica che durerà a lungo. Ho scritto, in epoca non sospetta, cioè anni addietro su questi «pacchetti» che il «berlusconismo» come virus infettivo ha inficiato il tessuto vitale del nostro Paese e saranno necessari decenni (dicevo 70 anni) di disintossicazione per cominciare a respirare aria salubre.
I fatti sono davanti a noi. Quando c’erano Pci e Dc, c’erano anche processi di selezione politica, aberranti se si vuole, come la supremazia del partito e il clericalismo raccomandatizio, che fungeva da deterrenza e c’erano «scuole di formazione politica» che preparavano alla responsabilità pubblica. Da quando Berlusconi ha sdoganato l’indecenza e i fascisti, facendo accettare il suo conflitto d’interessi come «sacrificio personale per la patria», la politica è stata invasa dalle cavallette senza testa e senza anima: predoni e prostitute, ladri e corrotti, mafiosi e malavitosi ... tutti hanno avuto accesso indiscriminato alla tavola della politica, trasformata in una mangiatoia a prescindere.
Il deserto è davanti a noi. Vent’anni di berlusconismo ed ecco il risultato: il Lazio, la Lombardia, la Calabria, il Molise e a continuare. Certo, quelli del Pd non scherzano nemmeno e pare che ce la mettano tutta per fare a gara nel tentativo di superare la destra, ma nonostante si sforzino non ci riescono perché la base è onesta, sana, lavoratrice, vive del proprio stipendio, onora gli impegni. La destra no, non può per essenza propria: la base è profittatrice, raccomandata, tendente al furto costitutivo, vuole essere furba, ricca e anche cattolica con l’imprimatur vaticano.
Avvenire, il giornale dei vescovi italiani, sabato 22 settembre 2012 riporta: «Oggi anche il presidente della Conferenza episcopale italiana, Angelo Bagnasco, è intervenuto sulla vicenda. Gli sprechi di cui si sente parlare in questi giorni “sono una cosa vergognosa”, ha detto l’arcivescovo di Genova. “Le ristrettezze devono farci stringere gli uni agli altri con maggiore bontà”, ha aggiunto: “pensare solo a noi stessi sarebbe egoista e miope”». L’Avvenire ha la memoria corta e non può fermarsi ad un cenno senza dire il dritto e il rovescio di come stanno le cose, perché se lo fa diventa immoralmente complice. Proviamo a chiarire per noi, che di solito seppelliamo la memoria passata e dimentichiamo, quasi fossimo affetti da alzheimer politico.
Aprendo i lavori del consiglio di presidenza della Cei, il giorno 22 settembre 2012, il cardinale di Genova e presidente della stessa Cei, Angelo Bagnasco, ha parlato di «un reticolo di corruttele e di scandali» per cui «è l’ora di una lotta penetrante e inesorabile alla corruzione». Ottima risposta in tempo reale. In verità mi sarei anche aspettato un vero atto di contrizione e di pentimento, le scuse dei vescovi a tutto il popolo italiano per avere sostenuto per 18 anni la fucina della corruzione, Silvio Berlusconi e il suo sistema di ladrocinio. Alle elezioni regionali laziali, la Cei appoggiò a spada tratta la candidatura di Renata Polverini alla presidenza della regione Lazio con tutte le forze «cattoliche». Bisogna ricordare cosa avvenne, altrimenti non si capisce cosa stia succedendo oggi.
Alle elezioni regionali del Lazio (28-29 marzo 2010), nel deserto della politica decaduta come un piombo nel vuoto, si candidò Emma Bonino, sostenuta dai radicali e dopo un po’ di torcicollo, anche da quella che eufemisticamente veniva chiamata «sinistra» (dal Pd a Sel). Emma Bonino, che era stata Commissario europeo stimatissima ed era vice presidente del Senato, aveva ufficialmente due handicap: era radicale e abortista. La sua vera colpa, però, fu l’impegno, se fosse stata eletta, a mettere drasticamente mano alla riforma della sanità regionale totalmente in mano privata: cliniche e servizi di istituti religiosi e privati affaristi. Se ciò si fosse realizzato, sarebbe finita la cuccagna dell’allegra compagnia.
Per evitare l’affronto di questa prospettiva che avrebbe visto una «abortista» e laica a capo della Regione Lazio, la «regione del papa» (!!!), l’ex presidente della Cei, il cardinale Camillo Ruini, il 10 gennaio 2010, nella sede del Seminario Romano, dove risiedeva, invitò a colazione il presidente del consiglio dei ministri, Silvio Berlusconi e il suo reggi-oscenità e ombra complice, il nobiluomo di S. Santità Giovanni Letta, sottosegretario alla presidenza del consiglio, per mettere a punto insieme una strategia per scongiurare la vittoria di Emma Bonino che tutti i sondaggi davano per scontata.
I tre moschettieri si coalizzarono sulla candidatura di Renata Polverini, voluta da Berlusconi e Fini, donna insignificante, fascista e segretaria dello sparuto sindacato destrorso Ugl, da contrapporre all’altra donna con tutta la potenza di fuoco di una vera macchina da guerra agguerrita: l’influenza della gerarchia cattolica, le tv, i giornali e i rotocalchi di proprietà del capo banda e l’arte sottile del nobiluomo si mise in moto per convincere l’Udc di Pierferdinando Casini a fare parte della compagnia massonica. Non andarono tanto per il sottile, mettendo in moto ogni strumento lecito e illecito, sturando senza remore la fogna della corruzione, pur di fare vincere la destra. Era questione di vita o di morte per Berlusconi a livello governativo e per la Cei e il Vaticano a livello d’immagine e d’influenza. Il Vaticano era terrorizzato dalla vittoria di Emma Bonino perché, in caso di vittoria, il papa avrebbe dovuto riceverla e certamente non poteva prevedere i discorsi che avrebbe fatto «davanti al papa».
Per farla breve vennero eletti «i rappresentanti del malaffare» come Fiorito e compagni di merenda, Er Batman de Anagni. Quando nel V secolo in Italia scesero i vandali, furono più generosi e non si papparono tutto. Questi famelici e idrovore non hanno avuto rispetto per alcuno. La Polverini ha tagliato i sussidi ai disabili, ha ridotto alla fame la povera gente, ma ha approvato con la sua giunta e il suo consiglio leggi per distribuire soldi pubblici ai gruppi regionali e ai singoli consiglieri: 100.000,00 euro (diconsi cen-to-mi-la-eu-ro). Senza l’appoggio dei sedicenti cattolici e della gerarchia cattolica Polverini & C. non sarebbero stati eletti, ai disabili non sarebbero stati tolti 150 milioni di aiuti e oggi il presidente della Cei non si scandalizzerebbe a buon mercato.
Il 25 giugno 2012 parlando agli assistenti delle associazioni cattoliche, fu lo stesso segretario del cardinale Angelo Bagnasco, mons. Mariano Crociata a dire con disarmante ingenuità: «E’ impressionante come tanta nostra gente (leggi: cattolici che appoggiamo e di cui ci serviamo, ndr) sia parte integrante di quella folla ... di corrotti e corruttori, di evasori e parassiti, di profittatori e fautori di illegalità diffusa, difensori sistematici della rivendicazione dei diritti nell’ignoranza, se non nella denigrazione, dei doveri».
Tutti costoro fanno a gara per farsi fotografare col papa e con i cardinali, i quali non disdegnano, anzi «posano» beati e beoti con poco e nulla discernimento. Da mesi non si parla che dell’abisso in cui è caduta Comunione e Liberazione, rappresentata dal «povero, vergine e ubbidente» Roberto Formigoni che di corruttela ha intessuto la gestione della Regione lombarda, vendendo morale e religiosità a chi pagava meglio a suon di milioni, a spese della collettività. Non dovevano essere i custodi gelosi del bene comune e della dignità della persona? Il Celeste melmoso ha avuto anche il coraggio di dire al Meeting di Rimini che il papa gli ha fatto sapere che «prega per lui», con ciò volendo dire che stava sotto l’ascella papalina. Se ci stava comodo, lui! Da parte vaticana non c’è stata alcuna smentita, quindi? L’inferno esiste e si è spalancato davanti a noi. Purtroppo non fa distinzione e sta inghiottendo tutto e tutti.
* Leggi tutto da micromega.blogautore.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- LA LEZIONE DEL PERSONALISMO CRISTIANO E LA ... PREDICA "CATTOLICA" DI BRUNO FORTE SULLA LEGGE ELETTORALE ITALIANA (MA NON ANCHE VATICANA!).23 settembre 2012, di Federico La Sala
MEDICO, CURA TE STESSO! O, ALTRIMENTI, IL LUPO PERDE IL PELO, MA NON IL VIZIO. Note sul tema:
La riforma elettorale guardi all’uomo
di Bruno Forte * (Il Sole 24 Ore, 23 settembre 2012)
Si parla molto di legge elettorale. Lo fa con autorevolezza il Capo dello Stato, pungolando parlamentari e partiti a procedere con sollecitudine alla riforma della legge che dalla fine del 2005 ha modificato il sistema elettorale italiano. L’accordo sulla necessità e l’urgenza di questa riforma è - a parole - quasi generale. Eppure, finora non si è ottenuto nulla.
L’impressione che molti hanno è che le forze politiche stiano considerando più i vantaggi e gli svantaggi che a esse verrebbero dalle possibili modifiche del l’attuale normativa che non l’interesse del Paese e quello della gente comune. Ecco perché, senza entrare in merito a proposte tecniche per le quali non ho competenza, vorrei provare a considerare la questione sotto il profilo etico, partendo da ciò che mi pare di cogliere fra la gente, accanto alla quale il mio impegno quotidiano di pastore continuamente mi pone.
Visto dal basso, il difetto principale che si avverte nel sistema in vigore è che l’elettore può votare solo per liste bloccate, senza possibilità di scegliere fra i candidati. L’elezione dei parlamentari dipende quindi completamente dalle decisioni e dalle graduatorie stabilite dai partiti, con il risultato che spesso gli eletti non hanno e non avranno alcun rapporto vero con il territorio di cui sarebbero espressione.
Con una certa durezza, qualcuno osserva che così la "casta" semplicemente clona se stessa. E poiché non è detto che i cloni siano migliori dell’originale, si profilerebbe lo scenario imbarazzante di un inevitabile, progressivo peggioramento della qualità della classe politica. C’è perfino chi osserva maliziosamente che, su questa strada, la sola speranza per il Paese potrebbe essere quella di arrivare a una qualità dei suoi rappresentanti talmente scadente, da impedire ad essi stessi di rendersi conto di un’eventuale miglioramento che li metterebbe da parte così da non saper attuare strategie per difendersi da esso!
Al di là di questi scenari preoccupanti, non mi pare difficile constatare che l’attuale rappresentanza politica non gode di quella rappresentatività dei problemi reali della gente e del territorio, che aveva caratterizzato la grande stagione della nascita della Repubblica e l’esercizio ritrovato della democrazia parlamentare nel dopo guerra. Il Paese ufficiale sembra essersi insomma scollato dal Paese reale. Se prima l’uomo della strada generalmente sapeva più o meno chi fosse il referente politico da cui sentirsi rappresentato e a cui rivolgersi per avere attenzione, direttamente o attraverso i canali dei partiti e delle organizzazioni socio-politiche, oggi la gente si sente priva di riferimenti affidabili, come se non ci fosse a livello politico chi possa dar voce a quanti non hanno voce.
I più deboli sono ovviamente i più svantaggiati da una tale situazione: chi potrà rappresentare i loro interessi? Chi potrà provvedere ai loro bisogni? Chi sarà in grado di dare loro speranza e di lavorare al loro fianco perché questa speranza prenda corpo nella vita reale? Il parlamentare imposto dai partiti, spesso scelto in base a meriti che non paiono andare oltre a quello dell’ossequio ai capi, potrà mai essere voce dei poveri e operatore di giustizia per essi?
Se si considera poi il processo di personalizzazione della politica, che ha portato sempre più a sostituire i bagagli ideali delle forze politiche con la figura del leader di turno, fino a legare il nome stesso delle parti in gioco a quello del personaggio carismatico più o meno forte, si comprende fino a che punto sia giunta la spoliazione di reale rappresentatività dei rappresentanti del popolo.
L’"eletto" carismatico prende voti da tutte le parti del Paese per la sua sola faccia o per il fascino del suo nome, senza di fatto rappresentare i mondi reali da cui gli sono stati espressi i consensi. In termini morali, questo processo rischia di essere una sorta di furto perpetrato ai danni della democrazia reale, con il conseguente drammatico slittamento del compito del politico dal rappresentare i bisogni della gente al tutelare e promuovere interessi personali o di gruppo più o meno influenti.
Che cosa allora chiedere ai nostri parlamentari impegnati a riformare la legge elettorale? Alcuni punti mi sembrano chiari: che si faccia di tutto perché i poveri abbiano voce. Che l’eletto sia uno vicino alla gente, in ascolto della vita reale, delle sofferenze e delle inadeguatezze del mondo del lavoro e della scuola, della vita familiare e delle forme di servizio proprie dello stato sociale. Che come fu per molti dei rappresentanti dell’Italia del dopoguerra e del boom economico, il parlamentare si getti in politica per servire il popolo e non per servirsi del potere acquisito a vantaggio proprio o della casta.
Tutto questo richiede che agli elettori venga restituita la possibilità di scegliere non solo fra bandiere diverse, ma anche fra donne e uomini differenti, fra programmi legati a impegni personali e di gruppo che siano affidabili e verificabili attraverso il rapporto costante e diretto fra la base e gli eletti. Se da una parte ciò esige la presenza di candidati competenti, generosi, onesti, animati da forti tensioni ideali e da virtù non comuni, dall’altra domanda che il legislatore dia fiducia alla maturità del nostro popolo di saper discernere fra possibilità diverse e di sapersi affidare a chi è sentito più vicino alla gente per storia, passione, vocazione e missione.
Andrebbe poi garantito un effettivo e costante rapporto fra il parlamentare e il territorio di cui è espressione. Solo così la politica, restituita al Paese reale, potrà assumere connotati nuovi: certamente non quelli di un affare su cui investire, quanto piuttosto quelli di una vocazione cui rispondere e di una missione da svolgere.
Scriveva una delle voci più autorevoli del personalismo d’ispirazione cristiana, Emmanuel Mounier: «L’essere personale è generosità; per questo esso fonda un ordine che è opposto a quello dell’adattamento e della sicurezza... La persona rischia e si prodiga senza badare al prezzo... Tutto ciò assomiglia piuttosto a un richiamo silenzioso, in una lingua che richiederebbe tutta la nostra vita per essere tradotta: per questo il termine di vocazione gli conviene meglio di qualunque altro» (Il personalismo, 97 e 68).
Politici per vocazione, non per affari, per missione, non per guadagno: riusciremo a trovare una legge elettorale che dia spazio a persone del genere, vicine alla gente, capaci di farsi voce dei più deboli e dei più poveri e di servire la causa del bene comune al di sopra di tutto?
*Arcivescovo di Chieti-Vasto
PER LA RIFORMA DELLA CHIESA, NEL SITO, SI CFR.:
RINUNCIARE AI FASTI, RICOMINCIARE A PARLARE AL TEMPO PRESENTE. MONS. CASALE DÀ LA SCOSSA AL SINODO
36838. ROMA-ADISTA. La sonnacchiosa vigilia che precede la celebrazione, in Vaticano, dal 7 al 28 ottobre prossimi, della XIII Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi è rotta dalla accorata lettera aperta che un anziano vescovo, mons. Giuseppe Casale, ha voluto indirizzare ai padri sinodali per esortarli a mettere mano ad alcune urgenti questioni che premono alle porte di una Chiesa ancora ciecamente arroccata a difesa della propria gerarchia e di assetti legati ad un anacronistico passato. Si tratta, scrive Casale, di riforme ancora inevase, appuntamenti mancati con i bisogni spirituali profondi di questo tempo: povertà, collegialità, ministero ordinato, parrocchie, nuova evangelizzazione, comunità di base. Ma Casale, arcivescovo emerito di Foggia, tra i pochi esponenti dell’episcopato italiano ancora saldamente legati alla Chiesa conciliare, richiama anche alla sempre più urgente necessità di dare testimonianza al popolo di Dio della propria radicale sequela del Vangelo: «Dobbiamo cominciare noi vescovi insieme al papa a dare l’esempio. Al termine del Concilio, molti vescovi chiesero che la Chiesa riscoprisse la gioia della povertà evangelica. La rinuncia al fasto esteriore e ai titoli onorifici, la scelta della vita semplice e senza lusso, la condivisione della povertà di tanta gente sono ancora un traguardo lontano».
Dei temi di questa lettera, appena pubblicata dalla casa editrice la Meridiana con il titolo Guai a me se non annuncio il Vangelo. Riformare la Chiesa. Lettera aperta al Sinodo dei Vescovi (euro 12: il libro può essere richiesto ad Adista, tel. 06/68801924, e-mail: abbonamenti@adista.it, oppure acquistato online sul sito www.adista.it), abbiamo parlato con l’autore, il vescovo Casale. (valerio gigante)
La collegialità fu uno degli argomenti più dibattuti al Concilio. Alla fine della Lumen Gentium, la Costituzione che trattava della funzione e dell’organizzazione della Chiesa, il papa decise di inserire la celebre “nota esplicativa previa” che riduceva di molto la portata della deliberazioni dell’assemblea in tema di collegialità. Poi venne il Sinodo, che per molti costituisce una risposta non adeguata alle richieste che venivano dall’assemblea conciliare. Lei ai partecipanti al prossimo Sinodo scrive oggi una lettera aperta: crede che il Sinodo possa ancora rispondere all’esigenza di una maggiore partecipazione dell’episcopato al governo della Chiesa?
Il limite fondamentale dell’istituto del Sinodo è il suo valore esclusivamente consultivo. Le sue conclusioni sono infatti sottoposte all’approvazione del papa, che arriva di solito parecchi mesi dopo la conclusione del Sinodo, quando ormai i temi portati alla sua attenzione dall’episcopato hanno perso gran parte della loro “urgenza” pastorale.
Grazie anche alla sua composizione, il Sinodo, che vede la presenza di delegati scelti direttamente dal papa oppure di delegati episcopali, che sono però spesso espressione del ceto dominante all’interno delle conferenze episcopali, non sempre esprime esigenze realmente avvertite dal popolo di Dio. Non riesce così, al di là delle sue intenzioni, a fotografare la vera realtà delle Chiese locali, le istanze che da esse vengono, le difficoltà pastorali che esse vivono. L’assemblea sinodale finisce quindi per ridursi ad una lunga maratona oratoria che tiene i delegati impegnati per giorni, dalla mattina alla sera, in discussioni articolate e complesse, con interventi che si susseguono in modo praticamente ininterrotto, nella lingua ufficiale della Chiesa, cioè il latino. Dibattiti che alla fine si stemperano nel riesame che viene fatto a livello di Curia di ciò che è emerso dal confronto tra i padri sinodali e che rende ancora più inefficaci i tentativi di sintesi fatti in assemblea. Per questo, anche se di Sinodi se ne sono tenuti tanti, generali e continentali, non si sono mai visti risultati apprezzabili. Del resto, se non è possibile una risposta immediata ad un problema teologico o pastorale urgente, i documenti prodotti, che dovrebbero incarnarsi nelle realtà diocesane, in realtà restano quasi sempre nient’altro che sulla carta.
La sua, quindi, più che una lettera al Sinodo, per i problemi scottanti che tocca, è piuttosto una lettera ad gentes...
È una lettera aperta al papa, ai partecipanti al Sinodo e, certo, soprattutto al popolo di Dio, perché si risvegli tra i credenti la coscienza della necessità di una partecipazione corale alla vita della Chiesa, attraverso i rappresentanti delle comunità ecclesiali locali, che vivono giorno per giorno i problemi che riguardano i fedeli. Per questo pongo sul tavolo, sin dall’apertura della mia lettera, le questioni cui mi sembra più urgente dare risposta oggi nella Chiesa. Anzitutto il tema della Chiesa povera, cioè come effettivamente rinunciare ai fasti, ai titoli ed ai privilegi che caratterizzano tanti uomini e strutture della Chiesa ed interrompere relazioni, talvolta anche discutibili, con potenze economiche che gravitano attorno alla Chiesa e che riescono talvolta a condizionarne l’azione ed il governo. Poi chiedo una effettiva collegialità: il papa deve esercitare il suo primato in maniera sinodale. Ritengo che con un coinvolgimento maggiore delle Chiese locali il primato del papa non venga intaccato; semmai arricchito. Oggi invece il papa condivide le sue scelte con i soli membri della Curia romana, composta da persone magari ottime, ma oggettivamente lontane dalla concreta realtà delle comunità locali, dalle ansie e dalle attese del popolo di Dio. C’è poi la questione della ricerca della “verità” che la Chiesa deve pensare in una prospettiva storica, non in quella di cui spesso parla e discetta, che è astratta, metafisica. La verità per la Chiesa deve diventare sempre più quella dei popoli sofferenti che attendono da lei risposte concrete ed immediate. Ancora, nella mia lettera chiedo di dare un assetto nuovo alle parrocchie: piccole chiese “di condominio”, costituite da gruppi di famiglie, strettamente legate al territorio in cui sono inserite, in maniera da divenire segni effettivi ed efficaci strumenti di azione pastorale. Infine, chiedo con urgenza la riapertura del dialogo con le comunità ecclesiali di base. Mi stupisce tanta premura nei confronti dei seguaci di Lefebvre e tanta disattenzionese, quando non rifiuto e diniego, per chi vive un impegno quotidiano ed incarnato nelle contraddizioni della Chiesa e della società come fanno le comunità di base, pur tra alcune esagerazioni e posizioni radicali che vanno attentamente vagliate.
Una parte importante della sua lettera è dedicata ai viri probati...
Io credo che sia maturo il tempo di introdurre questa novità nella Chiesa, e che ne sia forte l’esigenza; ma nella gerarchia resta la paura che i viri probati portino con sé la fine del celibato. Non è così! Il celibato rimane come dono, come carisma. Quella dei viri probati è invece una risposta alle attuali contraddizioni delle unità pastorali, che sono solo un espediente amministrativo per far fronte alla carenza di preti, ma che non assicurano una reale ed assidua cura pastorale delle comunità, specie di quelle più piccole, con le loro ricchezze e tradizioni. A loro serve una guida che non sia un prete di passaggio, un “pendolare” dei sacramenti, talmente impegnato nella cura di tante parrocchie e di tante anime da riuscire solo a consacrare o a confessare, a celebrare funerali o matrimoni. Serve qualcuno che venga dall’interno delle comunità di fede, uomini sposati che per autorevolezza umana e spirituale siano ritenuti idonei ad assumere il compito di “anziano” e che alimentino la vitalità spirituale dei loro fratelli e delle loro sorelle.
I diversi temi che abbiamo toccato richiamano alla mente le parole dell’ultima intervista del card. Martini sulla povertà nella Chiesa e sulla Chiesa povera, come anche quelle sulla Chiesa in ritardo di 200 anni. La sua visione sembra però più fiduciosa rispetto a quella dell’ex arcivescovo di Milano...
Ho voluto molto bene a Martini, mi sono ritrovato con lui su tante delle posizioni che ha espresso durante gli anni del suo ministero episcopale. Lui ha concluso la sua esperienza terrena con molta sofferenza e con un po’ di pessimismo nei confronti della Chiesa. Nel suo libro Colloqui notturni a Gerusalemme diceva di aver fatto molti sogni di una Chiesa che «procede per la sua strada in povertà e umiltà», «che non dipende dai poteri di questo mondo», «che dà spazio alle persone capaci di pensare in modo più aperto», «che infonde coraggio, soprattutto a coloro che si sentono piccoli o peccatori». «Sognavo una Chiesa giovane. Oggi non ho più di questi sogni», concludeva. E anche la sua ultima intervista è piena di una amarezza che ci deve profondamente interrogare. Ma io, nonostante tutto, resto fiducioso: credo che lo Spirito irromperà in questa nostra Chiesa e ci mostrerà una realtà diversa. Certo, ci vorrà tempo. E pazienza. E in questa attesa succederà che qualcuno sarà forse costretto a pagare per il coraggio delle sue posizioni. È successo a Martini, capiterà ad altri vescovi. Bisogna essere pronti. Io lo sono e ho cercato - vendendo quel poco che avevo e tornando a vivere nella mia prima diocesi, a Vallo della Lucania - di dare attuazione alla testimonianza di una Chiesa che riscopre Gesù povero tra i poveri e i semplici.
A cinquanta anni di distanza dalla sua indizione, quale delle istanze conciliari le pare più disattesa, se non tradita?
La povertà è senz’altro l’aspetto più disatteso. Oggi, invece che di una Chiesa povera tra i poveri facciamo piuttosto quotidianamente esperienza di una Chiesa che ha bisogno dei paramenti di Armani per celebrare le proprie pompose liturgie. Stiamo tornando indietro, altro che riscoprire la semplicità evangelica! Ma se non facciamo presto a liberarci dalla schiavitù del denaro e dalla collusione con il capitalismo finanziario globalizzato, il demonio, invece che limitarsi a diffondere il suo fumo, darà zampate laceranti sul tessuto “griffato” di questa Chiesa. Noi vescovi denunciamo spesso gli assalti che giungerebbero da fuori della Chiesa, dal laicismo e dalla secolarizzazione. Ma i pericoli veri vengono dall’interno, da una Chiesa che continua a perdere la lucentezza e la genuinità del messaggio evangelico. (v. g.)
* FONTE: Adista Notizie, n. 33, 22/09/2012
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- DECALOGO PER I POLITICI. Bendetto XVI ammonisce i politici cattolici, mentre la Santa Sede tuona contro scandali e abusi nella vita pubblica italiana (di Giacomo Galeazzi)23 settembre 2012, di Federico La Sala
Decalogo per politici
Il Papa ammonisce i politici cattolici, mentre la Santa Sede tuona contro scandali e abusi nella vita pubblica italiana
di Giacomo Galeazzi *
Decalogo papale ai politici cattolici, mentre la Santa Sede tuona contro scandali e abusi nella vita pubblica italiana. Il Papa indica i «precetti irrinunciabili» ai leader dell’Internazionale democristiana, ricevuti in udienza a Castel Gandolfo con il presidente Pier Ferdinando Casini. Prima bacchetta i partiti cattolici («vanno difesi la vita e il matrimonio tra uomo e donna»), poi esorta i politici a recuperare credibilità: «Il giudizio è severo per chi sta in alto, non seguite il mercato ma il bene comune». La crisi economica globale nasce dall’assenza di «un fondamento etico» in campo economico e la risposta dei governanti non deve basarsi sulla difesa della dignità umana. Perciò Benedetto XVI invoca un nuovo impegno pubblico senza «ripiegamenti», mentre «false tesi sui temi etici ingannano gli uomini di oggi». L’umanità si circonda di «maestri secondo i propri capricci, rifiutando di dare ascolto alla verità per perdersi dietro alle favole».
In particolare il Pontefice ribadisce il no della Chiesa all’aborto e all’eutanasia. Il rispetto della vita in tutte le sue fasi, dal concepimento fino al suo esito naturale (con conseguente rifiuto dell’aborto procurato, dell’eutanasia e di ogni pratica eugenetica) è un impegno che si intreccia con quello del rispetto del matrimonio, come unione indissolubile tra un uomo e una donna e come fondamento a sua volta della comunità di vita familiare, raccomanda il Papa. È nella famiglia, fondata sul matrimonio e aperta alla vita, che la persona sperimenta la condivisione, il rispetto e l’amore gratuito, ricevendo (dal bambino al malato, all’anziano) la solidarietà che gli occorre. E’ la famiglia a costituire il «principale e più incisivo» luogo educativo della persona, attraverso i genitori che si mettono al servizio dei figli per «aiutarli a trarre fuori il meglio di sè». La cellula originaria della società è la radice che «alimenta non solo la singola persona, ma anche le stesse basi della convivenza sociale».«Vergogna» per lo spreco di danaro pubblico. «Intollerabili» gli abusi sulla gestione dei fondi ai partiti.
Non assiste inerme la Chiesa italiana alle ultime vicende di scandali legati alla gestione dei soldi pubblici ed esplose in particolare con le spese pazze di consiglieri e assessori Pdl della Regione Lazio - ora al vaglio della magistratura -, e per bocca di due suoi esponenti di primo piano quali il presidente della Cei, cardinale Angelo Bagnasco, e il vicario del Papa per la diocesi di Roma, cardinale Agostino Vallini, emette una ferma condanna. A prendere la parola per primo è proprio il cardinale di Roma, città teatro delle cene a ostriche e champagne e delle sontuose feste in toga greco-romana che hanno fatto da cornice alle accuse di peculato mosse all’ex capogruppo Pdl al consiglio regionale laziale, Franco Fiorito, e da lui rilanciate ad altri membri del Pdl locale fino allo scontro con la governatrice Renata Polverini. Per il cardinale la misura è colma. «Non comprendo - spiega in un’intervista al settimanale diocesano Roma Sette - che i sacrifici non possano essere più equamente distribuiti con il sostegno del potere legislativo, mentre assistiamo al persistere di privilegi di corporazioni, a scandali ed abusi di denaro pubblico che sono intollerabili».
La gestione quantomeno allegra del denaro pubblico indigna Vallini che attraverso le strutture socio-caritative della sua diocesi conosce bene la difficile realtà delle famiglie che, incalzate dalla crisi, non arrivano a fine mese. Problemi a cui richiama fortemente la politica. «Se non c’è una ripresa di senso morale individuale e collettivo in termini di giustizia e di solidarietà sociale - afferma -, le leggi non bastano o non sono equilibrate». La priorità va data al dramma della disoccupazione. «Dove non c’è lavoro - osserva -, non c’è futuro, e le conseguenze le conosciamo tutti: delusione, scoraggiamento, non di rado depressione, rabbia, o peggio». «Non manco mai - aggiunge - di sollecitare i responsabili delle istituzioni, in forma rispettosa e chiara, di fare di tutto perchè vi sia una maggiore equità sociale. Comprendo che la grave crisi economica abbia richiesto alle famiglie sacrifici assolutamente straordinari; non comprendo - ribadisce - che i sacrifici non possano essere più equamente distribuiti con il sostegno del potere legislativo».
L’indignazione da Roma rimbalza a Genova, dove l’arcivescovo della Città della Lanterna e capo dei vescovi italiani, Bagnasco, rincara la dose. La sua è una condanna senza mezzi termini: lo spreco di danaro pubblico, tuona, «è una cosa vergognosa». «Le ristrettezze devono farci stringere gli uni agli altri con maggiore bontà», ha aggiunto: «pensare solo a noi stessi sarebbe egoista e miope». Intervengono poi anche i gesuiti che - con padre Michele Simone, vicedirettore della Rivista della Civiltà cattolica, intervistato dalla Radio Vaticana - allargano lo sguardo dagli scandali del Lazio alla più generale crisi che investe la politica. «È un momento difficile - afferma - perchè l’elemento molto negativo è, oltre il discredito nei confronti dei partiti, anche l’incapacità dei partiti di reagire in maniera significativamente incisiva». «Il discredito nei confronti dei partiti - aggiunge - sarà un elemento che peserà nelle prossime non lontane elezioni».
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. - LA CHIESA E’ SPOSA DI CRISTO: MA QUALE CRISTO?! Sempre sposata con "Uomini della Provvidenza"!22 settembre 2012, di Federico La Sala
 DIO E’ AMORE ("CHARITAS"), MA NON PER IL CATTOLICESIMO-ROMANO! Una gerarchia senza Grazie ( greco: Χάριτες - Charites) e un papa che scambia la Grazia ("Charis") di Dio ("Charitas") con il "caro-prezzo" del Dio Mammona ("Deus caritas est": Benedetto XVI, 2006).
DIO E’ AMORE ("CHARITAS"), MA NON PER IL CATTOLICESIMO-ROMANO! Una gerarchia senza Grazie ( greco: Χάριτες - Charites) e un papa che scambia la Grazia ("Charis") di Dio ("Charitas") con il "caro-prezzo" del Dio Mammona ("Deus caritas est": Benedetto XVI, 2006).
 GESU’ SPOSATO E LA CHIESA NUDA.
GESU’ SPOSATO E LA CHIESA NUDA.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- UN CIELO OSCURO SOPRA TUTTA LA TERRA: LA FINANZA MODELLO AL QAEDA.16 settembre 2012, di Federico La Sala
 CAPITALISMO FINANZIARIO E TEOLOGIA "MAMMONICA": UN CIELO OSCURO SOPRA TUTTA LA TERRA. E’ un cielo gravido di nuvole impenetrabili sopra tutto ciò che sappiamo, un cielo in cui occasionali schiarite non sono mai una promessa.
CAPITALISMO FINANZIARIO E TEOLOGIA "MAMMONICA": UN CIELO OSCURO SOPRA TUTTA LA TERRA. E’ un cielo gravido di nuvole impenetrabili sopra tutto ciò che sappiamo, un cielo in cui occasionali schiarite non sono mai una promessa.
 ECONOMIA E SOCIETA’: LA FINANZA MODELLO AL QAEDA. Un’analisi di Furio Colombo
ECONOMIA E SOCIETA’: LA FINANZA MODELLO AL QAEDA. Un’analisi di Furio Colombo
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- CAMBIARE STRADA. Il progresso è fallito: ora una nuova civiltà (di Edgar Morin e Mauro Ceruti)13 settembre 2012, di Federico La Sala
Il progresso è fallito: ora una nuova civiltà
di Edgar Morin e Mauro Ceruti (l’Unità, 13 settembre 2012)
La nostra crisi è una crisi di civiltà, dei suoi valori e delle sue credenze. Ma è soprattutto una transizione fra un mondo antico e un mondo nuovo. Le vecchie visioni della politica, dell’economia, della società ci hanno resi ciechi, e oggi dobbiamo costruire nuove visioni. Ogni riforma politica, economica e sociale è indissociabile da una riforma di civiltà, da una riforma di vita, da una riforma di pensiero, da una rinascita spirituale.
La riuscita materiale della nostra civiltà è stata formidabile, ma ha anche prodotto un drammatico insuccesso morale, nuove povertà, il degrado di antiche solidarietà, il dilagare degli egocentrismi, malesseri psichici diffusi e indefiniti. Oggi si impone una vigorosa reazione atta a ricercare nuove convivialità, a ricreare uno spirito di solidarietà, a intessere nuovi legami sociali, a fare affiorare dalla nostra e dalle altre civiltà quelle fonti spirituali che sono state soffocate. Questa sfida deve essere integrata nella politica, che deve porsi il compito di rigenerarsi in una politica di civiltà.
Le visioni della politica e dell’economia si sono basate sull’idea, che risale al settecento e all’ottocento, del progresso come legge ineluttabile della Storia. Questa idea è fallita. Soprattutto, è fallita l’idea che il progresso segua automaticamente la locomotiva tecno- economica. È fallita l’idea che il progresso sia assimilabile alla crescita, in una concezione puramente quantitativa delle realtà umane. Negli ultimi decenni la storia non va verso il progresso garantito, ma verso una straordinaria incertezza. Così oggi il progresso ci appare non come un fatto inevitabile, ma come una sfida e una conquista, come un prodotto delle nostre scelte, della nostra volontà e della nostra consapevolezza.
vedi alla voce sviluppo
Altrettanto discutibile è la nozione tradizionale di sviluppo, definita in una prospettiva unilateralmente tecno-economica, ritenuta quantitativamente misurabile con gli indicatori di crescita e di reddito. Ha assunto come modello universale la condizione dei Paesi detti appunto «sviluppati», in particolare occidentali, alla quale si dovrebbero ispirare tutti gli altri Paesi del mondo (detti perciò «sotto-sviluppati» o «in via di sviluppo »). Così si è arrivati a credere che lo stato attuale delle società occidentali costituisca lo sbocco e la finalità della storia umana stessa, trascurando i tanti problemi drammatici, le tante miserie, i tanti sotto-sviluppi, non solo materiali, provocati dal perseguimento degli obiettivi di una crescita tecno-economica fine a se stessa. Ma le soluzioni che volevamo proporre agli altri sono diventate problemi per noi stessi.
L’iperspecializzazione disciplinare ha frammentato il tessuto complesso dei fenomeni e ha modellato una scienza economica che non riesce a concepire e a comprendere tutto ciò che non è calcolabile e quantificabile: passioni, emozioni, gioie, infelicità, credenze, miserie, paure, speranze, che sono il corpo stesso dell’esperienza e dell’esistenza umana.
Oggi siamo chiamati a respingere quello che continua a essere in primo piano: la potenza della quantificazione contro la qualità, la dissoluzione della pluralità di dimensioni dell’esistenza umana a poche variabili, la razionalizzazione che è l’opposto della razionalità critica e che è il tentativo cieco di rifiutare tutto ciò che le sfugge e che non riesce a comprendere a prima vista. Uno dei tratti più nocivi di questi ultimi decenni è l’esasperazione della competitività, che conduce le imprese a sostituire i lavoratori con le macchine e, ove questo non accada, ad aumentare i vincoli sulla loro attività lavorativa. Allo sfruttamento economico, contro il quale hanno sempre lottato i sindacati, oggi si aggiunge un’ulteriore alienazione in nome della produttività e dell’efficienza. Abbiamo urgente bisogno di una politica di umanizzazione di quella che è ormai un’economia disumanizzata.
cambiare strada
Se si vogliono seriamente realizzare gli obiettivi di «sostenibilità» e di «umanizzazione », non basta spianare la via con qualche levigatura: bisogna cambiare via. La necessità di cambiare via, naturalmente, non ci impone di ripartire da zero. Anzi, ci spinge a integrare tutti gli aspetti positivi che sono stati acquisiti nel nostro difficile cammino, anche e soprattutto nei Paesi occidentali, a cui dobbiamo i diritti umani, le autonomie individuali, la cultura umanistica, la democrazia. E tuttavia la necessità di cambiare via diventa sempre più urgente, nel momento in cui il dogma della crescita all’infinito viene messo drasticamente in discussione dal perdurare della crisi economica europea e mondiale, dai pericoli prodotti di certo sviluppo tecnico e scientifico, dagli eccessi della civiltà dei consumi che rendono infelici gli individui e la collettività.
Certamente, la crescita deve essere misurata in termini diversi da quelli puramente quantitativi del Pil, mettendo in gioco gli indicatori dello sviluppo umano. Ma la cosa più importante è superare la stessa alternativa crescita/decrescita, che è del tutto sterile. Si deve promuovere la crescita dell’economia verde, dell’economia sociale e solidale. Un imperativo ineludibile dei prossimi decenni è l’accelerazione della transizione dal dominio quasi assoluto delle energie fossili a un sempre maggiore sviluppo delle energie rinnovabili. Anche questa transizione impone di cambiare via, paradigma: dall’attuale paradigma imperniato su un sostanziale monismo energetico (le fonti di energia fossile) a un paradigma imperniato su un pluralismo energetico, nella cui prospettiva si deve sostenere simultaneamente la crescita di molteplici fonti rinnovabili di energia (solare, eolico, biogas, idroelettrico, geotermico...), che possono avere un valore non solo additivo ma moltiplicativo, se messe in rete e se condivise da ambiti internazionali sempre più ampi.
In questo senso, la realizzazione di un pluralismo energetico è indissociabile dalla realizzazione di una democrazia energetica: la condivisione energetica risulta un valore fondante delle politiche internazionali, su scala continentale come su scala globale. Nello stesso tempo si deve sostenere la decrescita dei prodotti inutili dagli effetti illusori tanto decantati dalla pubblicità, la decrescita dei prodotti che generano rifiuti ingombranti e non riciclabili, la decrescita dei prodotti di corta durata e a obsolescenza programmata. Si deve promuovere la crescita di un’economia basata sulla filiera corta, e promuovere la decrescita delle predazioni di tutti quegli intermediari che impongono prezzi bassi ai produttori e prezzi alti ai consumatori. E per imboccare una via nuova bisogna concepire una nuova politica economica che possa contrastare l’onnipotenza della finanza speculativa e mantenere nello stesso tempo il carattere concorrenziale del mercato.
Nello stesso tempo, si rivela sterile anche l’alternativa globalizzazione/deglobalizzazione. Dobbiamo globalizzare e deglobalizzare in uno stesso tempo. Dobbiamo valorizzare tutti gli aspetti della globalizzazione che producono cooperazioni, scambi fecondi, intreccio di culture, presa di coscienza di un destino comune. Ma dobbiamo anche salvare le specificità territoriali, salvaguardare le loro conoscenze e i loro prodotti, rivitalizzare i legami fra agricoltura e cultura. Questo andrebbe di pari passo con una nuova politica nei confronti delle aree rurali, volta a contrastare l’agricoltura e l’allevamento iperindustrializzati, ormai divenuti nocivi per i suoli, per le acque, per gli stessi consumatori, e a favorire invece l’agricoltura biologica basata su stretti legami con il territorio.
Certo, quando parliamo dell’attuale fase della globalizzazione, non possiamo certo sottovalutare il fatto che Paesi solo poco tempo fa definiti sottosviluppati abbiano decisamente migliorato i loro livelli di vita: sotto questo aspetto le delocalizzazioni della produzione hanno sicuramente svolto un ruolo importante. Ma dinanzi all’eccesso di queste delocalizzazioni, e di conseguenza all’annientamento dell’industria europea, dobbiamo certamente prevedere interventi protettivi.
Per quanto riguarda il destino particolare dell’Europa nell’età della globalizzazione, è decisivo il fatto che tutte le nazioni siano oggi diventate multiculturali. L’Italia stessa è entrata appieno in questo processo, anche se con un certo ritardo rispetto ad altre nazioni storicamente più ricche di legami con il mondo intero: Francia, Gran Bretagna, Olanda, Germania... Le nuove diversità conseguenti alla globalizzazione si sono aggiunte alle diversità etniche e regionali tradizionalmente costitutive dei nostri paesi.
Oggi non basta dire che la Repubblica è una e indivisibile, bisogna anche dire che è multiculturale. Concepire insieme unità, indivisibilità e multiculturalità significa far sì che l’unità eviti il ripiegamento delle singole culture su se stesse e nello stesso tempo riconoscere la diversità feconda di tutte le culture. Anche in questo caso dobbiamo superare le alternative rigide.
Dobbiamo superare l’alternativa fra l’omologazione che ignora le diversità, che è stata la politica prevalente negli stati nazionali europei degli ultimi due secoli, e una visione del multiculturalismo come semplice giustapposizione delle culture. Per evitare la disgregazione delle nostre società abbiamo bisogno di riconoscere nell’altro sia la sua differenza sia la sua somiglianza con noi stessi. Rendere le diversità interne non un ostacolo, ma una ricchezza per la nazione: questo è un compito essenziale per la ricostruzione civile dell’Italia e di tutte le nazioni europee, nel momento in cui le sfide globali possono essere affrontate solo da società che siano nello stesso tempo aperte e coese.
un nuovo pensiero
Oggi il pensiero politico deve riformularsi sulla base di una diagnosi pertinente del momento storico dell’era planetaria che stiamo vivendo, deve concepire una via di civiltà, e deve di conseguenza trovare un percorso coerente sul piano nazionale, europeo, mondiale. Attualmente, siamo in una situazione contraddittoria: c’è un mondo che vuole nascere e che non riesce a nascere, e nel contempo questa nascita incipiente è accompagnata da uno scatenamento di forze di distruzione.
Questa situazione contradditoria ci impone di superare anche un’altra falsa alternativa classica, basata sulla contrapposizione fra conservazione e rivoluzione. Dobbiamo fare nostra l’idea di metamorfosi, combinando insieme conservazione e rivoluzione. Questa metamorfosi ci appare ancora improbabile, anzi quasi inconcepibile. Ma questa constatazione a prima vista disperante comporta un principio di speranza, motivato dalla consapevolezza che ci viene dalla conoscenza delle grandi soglie della storia e dell’evoluzione umana. Sappiamo che le grandi mutazioni sono invisibili e logicamente impossibili prima della loro attuazione; sappiamo anche che esse compaiono quando i mezzi dei quali un sistema dispone sono divenuti incapaci di risolvere i suoi problemi all’interno del sistema stesso. Così siamo inclini a sperare che, pur ancora improbabile e inconcepibile, la metamorfosi non sia impossibile.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- STATO E CHIESA: UN’ EMERGENZA TEOLOGICO-POLITICA TOTALE10 settembre 2012A 50 ANNI DAL VATICANO II, EMERGENZA TEOLOGICO-POLITICA TOTALE. UN AUT-AUT EPOCALE: RETTIFICARE I NOMI E BONIFICARE LA CHIESA DALLO SPIRITO DI "MAMMONA ("CARITAS") E DI "MAMMASANTISSIMA" O PORTARE AL SUICIDIO LA CHIESA CATTOLICO-ROMANA?! Che la "Luce delle Genti", il "Lumen Gentium", La illumini ...
 AL VICARIO DEL SIGNORE, IL PADRONE GESU’ ("DOMINUS IESUS"), UN GIURAMENTO DI OBBEDIENZA CIECA E ASSOLUTA. UNICA RILEVANTE ECCEZIONE: CARLO MARIA MARTINI. A partire dal funerale, cominciata l’operazione "anestesia". Una nota di Vito Mancuso - con appunti
AL VICARIO DEL SIGNORE, IL PADRONE GESU’ ("DOMINUS IESUS"), UN GIURAMENTO DI OBBEDIENZA CIECA E ASSOLUTA. UNICA RILEVANTE ECCEZIONE: CARLO MARIA MARTINI. A partire dal funerale, cominciata l’operazione "anestesia". Una nota di Vito Mancuso - con appunti
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- RATZINGERISMO E BERLUSCONISMO. "Dio è al di là delle frontiere che vengono erette". Così come l’Italia è al di là di tutti i partiti.2 settembre 2012, di Federico La Sala
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- IL MAGISTERO EQUIVOCO DI BENEDETTO XVI OGGI (2006-2012).28 agosto 2012, di Federico La Sala
SE DIO SI E’ FATTO PAROLA, IO NON POSSO GIOCARE CON LE PAROLE ... IL CATECHISTA NON USA MAI PAROLE EQUIVOCHE: PARLARE DI CARITÀ SIGNIFICA PARLARE DI GRAZIA
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- LA GERARCHIA CHE RUSSA E LA CHIESA CHE NON DORME. Lettera di don Aldo Antonelli a don Giuseppe Costa, direttore della Libreria Editrice Vaticana.3 agosto 2012, di Federico La Sala
LETTERA DI DON ALDO ANTONELLI A:- Don Giuseppe Costa
 Direttore Libreria Editrice Vaticana
Direttore Libreria Editrice Vaticana
 00120 CITTA’ DEL VATICANO
00120 CITTA’ DEL VATICANO
Ricevo la Vs. del 31 Luglio 2012, nella quale vi pregiate di presentare in offerta le Vostre pubblicazioni. Il sottoscritto fa presente la sua piena riluttanza ad accettare offerte di pubblicazioni nelle quali figura anche solo la firma di mons. Rino Fisichella, fosse anche la Bibbia.
Non vogliamo avere niente a che fare con colui che frequenta ambienti depravati ed è amico di ladri, spergiuri, mendaci e corruttori di minorenni.
 Aldo Antonelli
Aldo Antonelli
 (Parroco della Parrocchia Santa Croce Antrosano - AQ)
(Parroco della Parrocchia Santa Croce Antrosano - AQ) - Don Giuseppe Costa
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- IL CASO ARGENTINA. L’ex dittatore Jorge Videla confessa i crimini della Chiesa (di Horacio Verbitsky)3 agosto 2012, di Federico La Sala
Videla confessa i crimini della Chiesa
di Horacio Verbitsky (il Fatto Quotidiano, 2 agosto 2012)
La valanga di dichiarazioni dell’ex dittatore Jorge Videla ha messo fine a un lungo dibattito sui modelli di transizione. Quanti criticavano la riapertura dei processi per crimini contro l’umanità sostenevano che l’obiettivo di giungere a una condanna penale rischiava di ostacolare il raggiungimento della verità ed esaltavano, invece, il modello sudafricano consistente nell’ottenere informazioni in cambio dell’impunità. Durante una visita in Sudafrica nel 2005, i familiari delle vittime della violenza razzista mi parlarono del senso di frustrazione provato nel vedere i loro aguzzini raccontare con particolari sadici come avevano massacrato i loro figli o coniugi per poi andarsene liberi.
In Argentina, al contrario, sono già state pronunciate oltre 250 sentenze di condanna al termine di processi che hanno garantito tutti i diritti alla difesa tanto che vi sono state anche due dozzine di sentenze di assoluzione. E il flusso di informazioni non solo non si è arrestato, ma è aumentato. Il presunto contrasto insanabile tra Verità e Giustizia si è rivelato falso. Le successive confessioni del condannato Videla a diversi giornalisti che lo hanno intervistato in carcere hanno fatto luce sulla complicità con il regime dei grandi imprenditori, dei principali partiti politici e della Chiesa cattolica. Nell’ultima intervista ha detto che il nunzio apostolico Pio Laghi, l’ex presidente della Conferenza episcopale Raul Primatesta e altri vescovi hanno fornito al suo governo consigli su come gestire la situazione dei detenuti-desaparecidos.
SECONDO VIDELA la Chiesa si spinse addirittura a “offrire i suoi buoni uffici” affinché il governo informasse della morte dei figli tutte le famiglie che si fossero impegnate a non rendere pubblica la notizia e a smettere di protestare. È la prova che la Chiesa era a conoscenza dei crimini della dittatura militare, come risulta dai documenti segreti pubblicati in libri e articoli e la cui autenticità l’Episcopato è stato costretto a riconoscere dinanzi alla giustizia.
Ma è altresì la prova di un coinvolgimento attivo dell’Episcopato per garantire il silenzio dei familiari delle vittime, silenzio di cui la Chiesa era garante. Videla ha detto che non fornirono informazioni sui desaparecidos affinché nessuna madre chiedesse “dove è sepolto mio figlio per portargli un fiore? Chi l’ha ucciso? Perché? Come l’hanno ucciso? A nessuna di queste domande fu data risposta”. Il ragionamento è il medesimo che Videla fece il 10 aprile 1978 nel corso di un cordiale pranzo alla presenza della commissione esecutiva dell’Episcopato.
Secondo la nota informativa inviata dai vescovi al Vaticano, Videla aveva detto loro che “sarebbe ovvio” affermare che nessuno è desaparecido, che “sono morti”, ma che una tale affermazione avrebbe “alimentato una serie di domande sul luogo della sepoltura. Era forse una fossa comune? E in tal caso: chi li ha messi in questa fossa? Insomma una serie di domande alle quali il governo non poteva rispondere sinceramente per le conseguenze a carico di alcune persone”, vale a dire per proteggere i sequestratori e gli assassini.
I CONSIGLI delle autorità ecclesiastiche ammessi da Videla confermano altresì i dati frammentati che già erano noti. Il primo ufficiale che ha confessato la partecipazione personale al massacro, il capitano della Marina Adolfo Scilingo, mi raccontò che quando il comandante delle Operazioni Navali lo aveva informato che i prigionieri sarebbero stati gettati in mare dagli aerei, gli aveva anche detto che si erano consultati con le autorità ecclesiastiche per trovare la soluzione “più cristiana e meno violenta”. Quando tornò turbato dal primo volo e si rivolse al cappellano della sua unità militare, il sacerdote lo tranquillizzò raccontandogli alcune parabole bibliche.
Disse che era una morte cristiana perché non avevano sofferto. Nel corso del primo processo contro esponenti della giunta militare, il giornalista Jacobo Timerman raccontò che quando aveva chiesto per quale ragione non avevano applicato apertamente la pena di morte, uno degli ufficiali più alti in grado della Marina gli aveva risposto: “In questo caso sarebbe intervenuto il Papa e sarebbe stato difficile fucilare i detenuti se il Pontefice avesse fatto pressione”.
Il generale Ramon Diaz Bessone diede la medesima spiegazione alla giornalista francese Marie-Monique Robin: “Pensate alle pesanti critiche rivolte dal Papa a Franco nel 1975 per la fucilazione di appena tre persone. A noi ci sarebbe saltato addosso tutto il mondo. Non sarebbe stato possibile fucilare 7000 persone”. Questo spiega perché, fino a oggi, la Chiesa non ha scomunicato Videla e nessuno degli altri condannati, tra i quali il sacerdote cattolico Christian von Wernich. Ha deciso invece di essere complice, da qui all’eternità.
Traduzione di Carlo Antonio Biscotto
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- LA CRISI ECONOMICA E TEOLOGICO-POLITCA, LA GRATUITA’ EVANGELICA, E LA SUBDOLA APOLOGIA DELLA DOTTRINA DI RATZINGER-BENEDETTO XVI.28 luglio 2012
 LA GRAZIA ("CHARIS"), L’AMORE ("CHARITAS"), O LA RICCHEZZA ("CARITAS") DELLA GERARCHIA CATTOLICO-ROMANA?! IL ’VANGELO’ DI PAPA RATZINGER ("Deus caritas est", 2006) E’ QUELLO DI VENDERE A "CARO PREZZO" (= "CARITAS")IL "PANE QUOTIDIANO" DEL "PADRE NOSTRO" ...
LA GRAZIA ("CHARIS"), L’AMORE ("CHARITAS"), O LA RICCHEZZA ("CARITAS") DELLA GERARCHIA CATTOLICO-ROMANA?! IL ’VANGELO’ DI PAPA RATZINGER ("Deus caritas est", 2006) E’ QUELLO DI VENDERE A "CARO PREZZO" (= "CARITAS")IL "PANE QUOTIDIANO" DEL "PADRE NOSTRO" ...
 LA CRISI ECONOMICA E TEOLOGICO-POLITCA, LA GRATUITA’ EVANGELICA, E LA SUBDOLA APOLOGIA DELLA DOTTRINA DI RATZINGER-BENEDETTO XVI. Una riflessione di Enzo Bianchi - con note
LA CRISI ECONOMICA E TEOLOGICO-POLITCA, LA GRATUITA’ EVANGELICA, E LA SUBDOLA APOLOGIA DELLA DOTTRINA DI RATZINGER-BENEDETTO XVI. Una riflessione di Enzo Bianchi - con note
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE.---- LA "SANTA ALLEANZA" CONTINUA. Ior, la banca più amata da Mario Monti (di Marco Politi)7 luglio 2012, di Federico La Sala
Ior, la banca più amata da Monti
di Marco Politi (il Fatto Quotidiano, 6 luglio 2012)
Lo Ior non passa ancora l’esame delle autorità finanziarie europee. Dietro gli annunci ottimisti del Vaticano, secondo cui si è “sulla buona strada”, rimane il fatto che su 16 requisiti cruciali elencati lo Ior rimane inadempiente per 7.
Dice il viceministro degli Esteri vaticano, mons. Ettore Ballestrero, recatosi personalmente a Strasburgo a dimostrazione del bruciante interesse della Santa Sede a far parte della “Lista bianca” degli Stati affidabili in tema di riciclaggio, che entrare nel sistema Moneyval richiede la necessità di “apprendere in breve tempo il linguaggio, le regole, le tecniche di un sistema complesso”.
Un prelato qual è mons. Ballestrero non ha bisogno per la sua missione di padroneggiare le sottigliezze del sistema bancario. Sarebbe ridicolo, invece, affermare che il direttore dello Ior, Paolo Cipriani, si sia trovato improvvisamente impreparato, come Alice nel paese delle meraviglie, dinanzi alle regole di trasparenza, che Moneyval esige. Cipriani proviene dal Banco di Santo Spirito e dalla Banca di Roma, è stato rappresentante di questi istituti a New York e a Londra: il massimo della finanza mondiale.
PUÒ SPIEGARE allora perché a un anno e mezzo dal decreto di Benedetto XVI - che impegnava lo Ior a una totale trasparenza - la banca vaticana non si è messa ancora al passo con le regole internazionali? Una settimana fa, il direttore della Sala Stampa vaticana, padre Lombardi, si era sforzato di aprire una breccia nei misteri dello Ior, organizzando un briefing nella sede dell’istituto. Cipriani non ha avuto il coraggio di accettare il gioco delle libere domande dei giornalisti e fino a quando non lo farà, i discorsi più belli rimarranno a metà strada. Perché nelle democrazie occidentali funziona così: si risponde senza rete all’opinione pubblica.
La cosa più sconcertante nelle ultime vicende riguardanti lo Ior riguarda tuttavia la notizia - pubblicata ieri dal solo Fatto Quotidiano - che il governo italiano ha imbavagliato la delegazione dei funzionari della squadra antiriciclaggio della Banca d’Italia, impedendo loro di esprimere le proprie valutazioni professionali sulla condotta tenuta sinora dalla banca vaticana.
Va detto in proposito che a tutt’oggi, i dirigenti dello Ior non hanno ancora fornito dati precisi su che fine abbiano fatto i celebri (e spesso opachi) conti correnti presso l’istituto dei cosiddetti “laici esterni”, cioè di quelle persone che non appartengono assolutamente alla lista rigorosa di persone abilitate ad averne uno. Conti esterni di cui il faccendiere Bisignani è figura simbolica, ma non l’unica.
Non importa qui indagare attraverso quali canali contorti si sia espresso il veto. Contano i fatti. Il direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria (Uif) della Banca d’Italia, Giovanni Castaldi, ha ritirato i suoi due delegati dalla riunione di Strasburgo perché impossibilitato a fare il proprio dovere. È evidente che in un consesso internazionale - a una scadenza cruciale per Oltretevere - il governo Monti ha voluto fare un favore macroscopico alla Santa Sede, privo di qualsiasi motivazione (diciamo così) professionale. È un episodio che fa cadere le braccia specialmente a coloro che hanno sempre provato stima per il “tecnico” Monti e il suo stile da gentiluomo.
All’assemblea Moneyval di Strasburgo proprio il governo tecnico italiano si è comportato da politicante, impedendo ai “tecnici” della Banca d’Italia di dare il proprio giudizio su ciò che manca allo Ior per presentarsi pulito sulla scena europea. Da chi è stato commissario Ue per il mercato interno e per la concorrenza, da un liberale per il quale la pulizia e le regole del sistema finanziario dovrebbero essere la stella polare, questo “sopire... troncare... sopire” era lecito non aspettarselo. L’INCIDENTE non è peraltro isolato. È la terza volta che il governo Monti, abituato a usare il guanto ruvido con i ceti popolari, i pensionati e gli operai, fa dei favori incomprensibili e inaccettabili al Vaticano nel momento in cui tutti sono chiamati - e tanti cittadini ci credono anche - a stringere la cinghia per risollevare le sorti dell’Italia.
Implacabile nel chiedere a ogni padre di famiglia di pagare gli aumenti Imu sull’unghia nel 2012, Monti ha disposto che gli enti ecclesiastici (evasori da anni) la paghino soltanto nel 2013. Non esiste uno straccio di ragione economica che giustifichi questo privilegio. Ancora: mentre gli italiani redigevano la loro dichiarazione dei redditi, Monti si è rifiutato di indicare la destinazione della quota dell’8 per mille, che va allo Stato per “iniziative umanitarie”. Avrebbe potuto dire che andava ai terremotati dell’Emilia. Non lo ha fatto. Il governo ha taciuto, perché è noto che il Vaticano esige che non vi sia pubblicità “concorrente” quando si tratta dell’8 per mille.
Lo scandalo di Strasburgo si inserisce in una linea di per sé inquietante. Laicità non significa denigrare la religione. Laicità significa che nessuna confessione può imporre i propri interessi alla comunità nazionale. Laicità significa la regola aurea del costituzionalismo americano: nessun comportamento dello Stato per “ostacolare o favorire una religione”. Questa laicità gli italiani hanno il diritto di pretenderla dal liberale cattolico Monti
E visto che si parla di spending review, gli italiani hanno il diritto di pretendere anche dal premier di attivare la commissione bilaterale italo-vaticana per rivedere il gettito dell’8 per mille, molto ma molto superiore a quelli che sono i bisogni reali della struttura della Chiesa in rapporto agli anni Ottanta (quando c’erano assai più preti).
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- I vertici dello Stato sapevano. “Alcuni potenti non hanno salvato neppure la dignità”. Intervista ad Agnese Borsellino.(di Sandra Amurri)17 giugno 2012, di Federico La Sala
 I vertici dello Stato sapevano
I vertici dello Stato sapevano
 “Paolo aveva capito tutto”
“Paolo aveva capito tutto”Agnese Borsellino. “Alcuni potenti non hanno salvato neppure la dignità”
intervista di Sandra Amurri (il Fatto, 17.06.2012)
Agnese Piraino Borsellino non è donna dalla parola leggera. È abituata a pesarle le parole prima di pronunciarle, ma non a calcolarne la convenienza. È una donna attraversata dal dolore che il dolore non ha avvizzito. I suoi occhi brillano ancora. E ancora hanno la forza per guardare in faccia una verità aberrante che non sfiora la politica e le istituzioni. Una donna che trascorre il suo tempo con i tre figli e i nipotini, uno dei quali si chiama Paolo Borsellino. Le siamo grati di aver accettato di incontrarci all’indomani delle ultime notizie sulla trattativa Stato-mafia iniziata nel 1992, che ha portato alla strage di via D’Amelio, di cui ricorre il ventennale il 19 luglio, e alle altre bombe. In un’intervista al Fatto l’11 ottobre 2009, Agnese disse: “Sono una vedova di guerra e non una vedova di mafia” e alla domanda: “Una guerra terminata con la strage di via D’Amelio? ”, rispose: “No. Non è finita. Si è trasformata in guerra fredda che finirà quando sarà scritta la verità”.
A distanza di tre anni quella verità, al di là degli esiti processuali, è divenuta patrimonio collettivo: la trattativa Stato-mafia c’è stata. Sono indagati, a vario titolo, ex ministri come Conso e Mancino, deputati in carica come Mannino e Dell’Utri. Lei che ha vissuto accanto a un uomo animato da un senso dello Stato così profondo da anteporlo alla sua stessa vita, cosa prova oggi?
Le rispondo cosa non provo: non provo meraviglia in quanto moglie di chi, da sempre, metteva in guardia dal rischio di una contiguità tra poteri criminali e pezzi dello Stato, contiguità della quale Cosa Nostra, ieri come oggi, non poteva fare a meno per esistere.
Non la meraviglia neppure che probabilmente anche alte cariche dello Stato sapessero della trattativa Stato-mafia, come si evince dalla telefonata di Nicola Mancino al consigliere giuridico del presidente della Repubblica, Loris D’Ambrosio, in cui chiede di parlare con Giorgio Napolitano e dice: “Non lasciatemi solo, possono uscire altri nomi” (tra cui Scalfaro)? Come dire: le persone sole parlano di altre persone?
Questo mi addolora profondamente, perché uno Stato popolato da ricattatori e ricattati non potrà mai avere e dare né pace né libertà ai suoi figli. Ma ripeto, non provo meraviglia: mio marito aveva capito tutto.
Lei descrive i cosiddetti smemorati istituzionali, coloro che hanno taciuto o che hanno ricordato a metà, come “uomini che tacciono perché la loro vita scorre ancora tutta dentro le maglie di un potere senza il quale sarebbero nudi” e disse di provare per loro “una certa tenerezza”. La prova ancora, o ritiene che abbiano responsabilità così grandi da non poter essere né compianti né perdonati?
Non perdono quei rappresentanti delle istituzioni che non hanno il senso della vergogna, ma sanno solo difendersi professandosi innocenti come normalmente si professa il criminale che si è macchiato di orrendi crimini. Alcuni cosiddetti “potenti”, ritenuti in passato intoccabili, hanno secondo me perso in questa storia un’occasione importante per salvare almeno la loro dignità e non mi meraviglierei se qualche comico li ridicolizzasse.
 Paolo Borsellino ai figli ripeteva spesso: imparate a fare la differenza umanamente, non è il ruolo che fa grandi gli uomini, è la grandezza degli uomini che fa grande il ruolo. Mai parole appaiono più vere alla luce dell’oggi.
Paolo Borsellino ai figli ripeteva spesso: imparate a fare la differenza umanamente, non è il ruolo che fa grandi gli uomini, è la grandezza degli uomini che fa grande il ruolo. Mai parole appaiono più vere alla luce dell’oggi.
 Il posto, il ruolo, non è importante, lo diventa secondo l’autorevolezza di chi lo ricopre. Oggi mio marito ripeterebbe la stessa espressione con il sorriso ironico che lo caratterizzava.
Il posto, il ruolo, non è importante, lo diventa secondo l’autorevolezza di chi lo ricopre. Oggi mio marito ripeterebbe la stessa espressione con il sorriso ironico che lo caratterizzava.Signora, perché ha raccontato ai magistrati di Caltanissetta solo nel 2010, dopo 18 anni, che suo marito le aveva confidato che l’ex comandante del Ros, il generale Antonio Subranni, era in rapporto con ambienti mafiosi e che era stato “punciutu”?
Potrebbe apparire un silenzio anomalo, ma non lo è. I tempi sono maturati successivamente e gli attuali magistrati di Caltanissetta, cui ancora una volta desidero manifestare la mia stima e il mio affetto, sanno le ragioni per le quali ho riferito alcune confidenze di mio marito a loro e soltanto a loro.
Sta dicendo che ha ritenuto di non poter affidare quella confidenza così sconvolgente alla Procura di Caltanissetta fino a che è stata diretta da Giovanni Tinebra?
Il primo problema che mi sono posta all’indomani della strage è stato di proteggere i miei figli, le mie condotte e le mie decisioni sono state prevalentemente dettate, in tutti questi lunghi anni, da questa preoccupazione.
Il pm Nico Gozzo all’indomani della dichiarazione del generale Subranni, che l’ha definita non credibile con parole che per pudore non riportiamo, ha fondato su Facebook il gruppo: ”Fraterno sostegno ad Agnese Borsellino”. Un fiume di adesioni, lettere commoventi, fotografie, dediche struggenti. Come lo racconterebbe a suo marito in un dialogo ideale?
Caro Paolo, l’amore che hai sparso si è tradotto anche in tantissime lettere affettuose, prive di retorica e grondanti di profondi sentimenti, che ho avuto l’onore di ricevere perché moglie di un grande uomo buono.
Dove trova la forza una donna che ha toccato il dolore per la perdita del suo più grande amore e ora deve sopportare anche il dolore per una verità che fa rabbrividire?
Nel far convivere i sentimenti emotivi e la ragione, ho fatto prevalere quest’ultima in quanto mi ha dato la forza di sopportare il dolore per la perdita di un marito meraviglioso ed esemplare e per accettare una verità complessa, frutto di una società e di una politica in pieno degrado etico e istituzionale.
 Indagine sulla trattativa Stato-Mafia
Indagine sulla trattativa Stato-Mafia
 Il Quirinale è intervenuto
Il Quirinale è intervenuto
Il Colle definisce “risibili” e “irresponsabili illazioni” le rivelazioni del Fatto sulle pressioni di Mancino contro i pm di Palermo Ma poi tira fuori la lettera della Presidenza della Repubblica al Pg della Cassazione: la prova dell’interferenza
di Giuseppe Lo Bianco e Sandra Rizza (il Fatto, 17.06.2012)
Palermo E alla fine la lettera è saltata fuori. È firmata da Donato Marra, segretario generale della Presidenza della Repubblica, ed è datata 4 aprile 2012. Destinatario: il Procuratore generale della Cassazione, nella fase di passaggio di consegne tra Vitaliano Esposito e Gianfranco Ciani. La rende pubblica il Quirinale in una nota emessa poco prima delle 19 di ieri: “Per stroncare ogni irresponsabile illazione sul seguito dato dal capo dello Stato a delle telefonate e a una lettera del senatore Mancino in merito alle indagini che lo coinvolgono”. A nome di Napolitano, Marra “gira” al pg della Suprema Corte le lamentele di Mancino, indagato a Palermo per la trattativa che “si duole del fatto che non siano state fin qui adottate forme di coordinamento delle attività svolte da più uffici giudiziari sulla cosiddetta trattativa”.
Ma il Quirinale non si limita a una semplice trasmissione: Marra informa il pg che le preoccupazioni di Mancino, ex presidente del Senato e tuttora rispettabile cittadino italiano, sono condivise da Napolitano. “Conformemente a quanto da ultimo sostenuto nell’Adunanza plenaria del Csm del 15 febbraio scorso, il capo dello Stato - scrive Marra - auspica possano essere prontamente adottate iniziative che assicurino la conformità di indirizzo delle procedure ai sensi degli strumenti che il nostro ordinamento prevede, e quindi anche ai sensi delle attribuzioni del procuratore generale della Cassazione”. Spiega Marra alla fine della missiva che l’intervento del capo dello Stato è finalizzato a “dissipare le perplessità che derivano dalla percezione di gestioni non unitarie delle indagini collegate, i cui esiti possono anche incidere sulla coerenza dei successivi percorsi processuali”.
NAPOLITANO in prima persona, dunque, scavalca il capo della Dna Pietro Grasso cui compete il coordinamento tra le procure e su una materia delicata e scottante come l’indagine sulla trattativa Stato-mafia investe, in modo irrituale e insolito, direttamente il pg della Cassazione. Che non ha poteri di coordinamento tra procure, ma solo quello di decidere sui conflitti di competenza eventualmente sollevati sulle inchieste in corso. Le preoccupazioni di Mancino e Napolitano sono legate alle indagini parallele delle Procure di Caltanissetta e Firenze che, fino a questo momento, hanno ritenuto “penalmente non rilevanti” le condotte dei protagonisti di quella stagione di dialogo dello Stato con Cosa Nostra. E convergono nel senso di indirizzarle verso un unico sbocco: quello “minimalista” che salvi i politici da ogni coinvolgimento penale. La lettera di Marra si conclude con il capo dello Stato che resta in attesa di informazioni (“il presidente Napolitano le sarà grato di ogni consentita notizia”) dal Pg della Cassazione, per - spiega la nota del Quirinale - “pervenire tempestivamente all’accertamento della verità su questioni rilevanti, nel caso specifico ai fini della lotta contro la mafia e di un’obiettiva ricostruzione della condotta effettivamente tenuta, in tale ambito, da qualsiasi rappresentante dello Stato’’.
E se l’inchiesta di Palermo genera fibrillazioni sul Colle più alto, isolando di fatto i pm palermitani, lo stato maggiore di Magistratura democratica giura “a scatola chiusa” sull’innocenza dell’ex guardasigilli Giovanni Conso, spaccando la corrente: il procuratore aggiunto di Roma Nello Rossi si dice “incredulo e profondamente preoccupato”. L’ex segretario dell’Anm Giuseppe Cascini esterna il suo “sentimento di stima a Conso che a 90 anni si trova inquisito”. Giovanni Palombarini, tra i fondatori della corrente, “senza bisogno di conoscere il fascicolo” è pronto a giurare sulla sua innocenza. Come fa a saperlo? “Lo so”. Parole che scatenano il dibattito nella mailing list della corrente, con una stragrande maggioranza di interventi di segno opposto: cioè a favore dei pm di palermo.
Lo Stato, diceva Leonardo Sciascia, non può processare se stesso. Ma se proprio è costretto a farlo, perché i suoi più autorevoli esponenti sono accusati di avere dialogato con i boss stragisti Riina e Provenzano, il corto circuito istituzionale è assicurato.
Se a parole tutti condannarono Pietro Lunardi per il suo “con la mafia si deve convivere”, ora che un’inchiesta prospetta una vera trattativa con Cosa Nostra, tutti si chiedono: è legittimo considerare personalità come Mannino, Mancino, Conso, alla stregua di criminali comuni? Ma anche: è legittimo un comportamento sanzionato dal codice penale solo perché giustificato dalla ragion di Stato? “Ragion di Stato e ragioni di giustizia dovrebbero essere in sintonia - ha sempre sostenuto il pm Ingroia - ma spesso non lo sono. In caso di divorzio tra le due succede che la ragion di Stato può costituire movente di un reato’’. La levata di scudi che determina l’isolamento politico, giuridico e interno alle toghe di un pugno di pm illusi di poter scandagliare con un’indagine giudiziaria la cattiva coscienza della politica italiana ripropone la domanda centrale, scomoda e imbarazzante: la magistratura ha il diritto-dovere di far salire sul banco degli imputati la scelta politica di unoopiùgoverni, quandoquesta è suggerita dalla gravità del momento?
È LECITO, insomma, trattare sottotraccia con la mafia se l’intento è quello di salvare la vita di esponenti politici minacciati anche a costo di sacrificare Borsellino e la sua scorta, e poi tanti innocenti a Firenze e Milano)? Dal mondo accademico arrivano le prime soluzioni: il docente Giovanni Fiandaca, già capo della commissione di riforma del codice antimafia, è scettico sull’efficacia dell’azione penale. E propone un’exit strategyextra-giudiziale, ricordando le commissioni di verità istituite in Sudafrica per riconciliare le parti e chiudere i conti con il passato al di fuori delle aule giudiziarie: “I protagonisti direbbero la verità in un clima più sereno, non punitivo”. Ma Cosa Nostra può esser trattata alla stregua dell’apartheid? “Fino a che - è il parere di Ingroia - ciascuno non farà di tutto perché la verità venga a galla, la democrazia non potrà mai diventare matura perché resterà ostaggio dei poteri criminali che ne hanno condizionato le origini e la storia”.
Da via D’Amelio alle stragi del ’93 fino all’indagine di Palermo
 il Fatto 17.6.12
il Fatto 17.6.12L’omicidio del magistrato antimafia Giovanni Falcone, il 23 maggio 1992, cambia per sempre la storia di Palermo e fa saltare tutti gli equilibri politici in Italia. Pochi giorni dopo la strage di Capaci, sarebbe partita la trattativa tra i vertici dello Stato e Cosa Nostra per far cessare la “strategia stragista”, in cambio di un’attenuazione dell’articolo 41 bis, che prevedeva misure carcerarie durissime contro i mafiosi. Due giorni dopo la strage, il Parlamento elegge Oscar Luigi Scalfaro presidente della Repubblica al sedicesimo scrutinio. Un’elezione a sorpresa, visto che prima di Capaci la partita al Quirinale era giocata da Giulio Andreotti e Arnaldo Forlani. E la conferma che la strage aveva mutato per sempre anche la politica italiana. A portare avanti il dialogo segreto fra Stato e mafia sarebbero stati i carabinieri del Ros, tramite l’ex sindaco di Palermo Vito Ciancimino. Secondo il figlio di questi, Massimo, al padre fu consegnato un “papello”, ovvero il documento in cui venivano espresse le dodici “volontà” di Cosa Nostra, con una lunga serie di richieste allo Stato. La prima era appunto l’attenuazione del 41 bis, rafforzato l’8 giugno 1992 con un decreto dal ministro dell’Interno Vincenzo Scotti e dal Guardasigilli, Claudio Martelli.
A inizio luglio, proprio Scotti viene “dirottato” alla Farnesina. Al suo posto viene nominato Nicola Mancino. Il 19 luglio, la strage di via D’Amelio, a Palermo. Una 126 imbottita di esplosivo salta per aria, uccidendo il magistrato Paolo Borsellino e i cinque agenti della sua scorta. Pochi giorni prima, Borsellino aveva interrogato Mutolo, poi aveva incontrato Nicola Mancino. La trattativa segreta, intanto, sarebbe proseguita.
Dopo il ‘93 i boss avrebbero avuto un altro referente nelle istituzioni, l’attuale senatore del Pdl Marcello Dell’Utri. La trattativa avrebbe avuto il suo culmine nel 1994: lo sostengono il procuratore aggiunto di Palermo, Antonio Ingroia, e i sostituti Nino Di Matteo, Lia Sava e Francesco Del Bene. Fu proprio allora che i capimafia Leoluca Bagarella e Giovanni Brusca, secondo gli inquirenti, “prospettarono al capo del governo in carica, Silvio Berlusconi, per il tramite del suo stalliere Vittorio Mangano e di Dell’Utri, una serie di richieste finalizzate a ottenere benefici di varia natura”.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ----- LA TEOLOGIA POLITICA DEL "MENTITORE". Quella che vediamo è La crisi del papato in quanto forma istituzionale (di Aldo M. Valli - I corvi, il papa e la posta in gioco)9 giugno 2012, di Federico La Sala
I corvi, il papa e la posta in gioco
di Aldo Maria Valli (Europa, 9 giugno 2012)
A questo punto occorre pur dirlo. La vicenda dei corvi è anche la forma espressiva, sotto molti aspetti sciagurata ma efficace, trovata dalle tensioni interne in Vaticano in vista del nuovo conclave. Senza voler mancare di rispetto al papa regnante, sul piano storico non si può ignorare che siamo entrati nella fase fibrillatoria che contraddistingue la fine dei pontificati, quando le forze in campo si muovono per guadagnare le posizioni migliori e raggiungere equilibri e accordi da far contare nel momento della scelta del nuovo papa.
La posta in gioco è il papato che sarà, e il terreno di scontro è la politica attuata da Ratzinger, specie per quanto riguarda la sua lettura del Concilio Vaticano II. In modo felpato, com’è nel suo stile, ma anche molto chiaro nei contenuti, Benedetto XVI ha di fatto riletto il Concilio in senso anti-innovativo. Basandosi sull’idea, incontestabile, che la Chiesa non ha né può avere una carta costituzionale, perché la sua sola “costituzione” è la sacra scrittura, Ratzinger ha però depotenziato l’eredità conciliare per quanto riguarda almeno quattro contenuti fondamentali del Concilio stesso: la collegialità, la liturgia, l’ecclesiologia, l’ecumenismo.
Circa la collegialità, la prassi dei sinodi fa capire di che tipo sia lo svuotamento attuato. Il sinodo, creatura conciliare, nasce per dare voce al confronto fra i vescovi e per far giungere le loro istanze al papa, ma oggi questa è una finzione, perché al posto di un confronto aperto c’è solo un accostamento di voci sotto il controllo del potere centrale della curia, senza un autentico dibattito e senza la possibilità, per ogni vescovo, di interloquire con il papa e di avere da lui qualche risposta concreta.
Quanto alla liturgia, le simpatie di Benedetto XVI per il rito antico sono note, e da queste derivano le sue scelte. Il concilio, su questo piano, non è mai stato apertamente criticato, ma con l’andare del pontificato sono state ripristinate forme liturgiche decisamente preconciliari e la preoccupazione di Ratzinger per il recupero dei lefebvriani, con tutte le energie spese in proposito, è di per sé eloquente.
Sul piano dell’ecclesiologia, abbiamo un rinnovato centralismo, con il papa e la curia romana in posizione di preminenza, i vescovi nel ruolo di meri esecutori, senza possibilità di vero confronto, e i laici totalmente subordinati, chiamati in causa in funzione di supplenza e solo se del tutto in linea con le indicazioni centrali. La nozione di Chiesa come “popolo di Dio” sembra lontana, persa nelle nebbie di un clericalismo di ritorno.
Infine l’ecumenismo. Anche in questo caso, nessuna sconfessione aperta del concilio, ma se poi si vanno a vedere i comportamenti concreti si nota la regressione. Significativa la giornata di Assisi di un anno fa, dove la preoccupazione di evitare il sincretismo ha svuotato l’incontro di contenuto ecumenico per farlo diventare un pellegrinaggio fatto in comune ma senza reali segni di fraternità, e dove si è preferito accentuare il ruolo dei non credenti, trasportando così il confronto dal piano della preghiera a quello del confronto culturale.
Stando così le cose, mentre la Chiesa (per ammissione dello stesso Benedetto XVI) sta vivendo una pagina “drammatica”, segnata anche dalla disubbidienza di alcuni preti europei che, non trovando altre forme per manifestare le proprie richieste e il proprio disagio, hanno deciso di dire no al magistero su questioni come il celibato, la consacrazione ministeriale delle donne e il divieto di comunione per i divorziati risposati, dentro le sacre mura si confrontano e si scontrano le fazioni: continuare su questa strada che è di sostanziale ridimensionamento dell’eredità conciliare oppure aprire una pagina diversa, all’insegna del confronto tra i punti fermi del concilio, che devono restare tali, e le nuove realtà? Il fatto che il confronto sia emerso secondo le modalità che abbiamo sotto gli occhi, attraverso fughe di documenti, è di per sé significativo.
Quella che vediamo non è soltanto la crisi di questo papato. E una crisi del papato in quanto forma istituzionale. La concentrazione di potere, senza eguali, nelle mani di uno solo, l’influenza inevitabile che il ruolo di capo di stato ha su quello di capo spirituale e la mancanza di veri luoghi di dibattito all’interno della curia stanno determinando una situazione che, specialmente nel confronto con la società della comunicazione, si è fatta insostenibile. Un modello che ha retto per secoli sta mostrando ora crepe sempre più evidenti.
Ma fino a quando la Chiesa, nella sua espressione gerarchica, potrà fingere di non accorgersene? Fino a quando la linea della segretezza potrà essere privilegiata rispetto a quella della trasparenza e la forma dell’assolutismo (che alimenta inevitabilmente manovre oscure e maldicenze) rispetto a un confronto aperto, magari anche duro ma istituzionalizzato? Fino a quando la paura dovrà prevalere sulla fiducia? Questa è la posta in gioco. Questi i veri problemi che i corvi e le conseguenti battaglie fra guardie e ladri hanno portato alla luce.
Queste le vere tensioni che stanno sotto e dietro i fatti di cronaca. Se nella Chiesa cattolica ci fosse un’opinione pubblica sarebbero motivo di dibattito. Ma nella Chiesa una vera opinione pubblica non c’è, perché chi cerca di alimentarla viene costantemente mortificato ed emarginato. Ed anche su questo aspetto, a cinquant’anni dal concilio, bisognerebbe riflettere.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ----- Vatileaks, l’ira del Papa contro la stampa e la Curia (di Marco Ansaldo).12 giugno 2012, di Federico La Sala
Benedetto XVI parla di “menzogna sotto veste di informazione”, e pensa a cambiamenti tra i suoi collaboratori più stretti. In tempi brevi
Vatileaks, l’ira del Papa contro la stampa e la Curia
di Marco Ansaldo (la Repubblica, 12.6.12
CITTÀ DEL VATICANO - Un Papa arrabbiato: con la stampa, ma anche con alcuni dei suoi collaboratori, e soprattutto con la situazione creatasi in Vaticano per la vicenda delle lettere interne diffuse sui media. «È nero dall’ira», lo descrivono all’interno con qualche timore. E così, venuta la sera, il Pontefice si scatena quando a Roma parla nella Basilica di San Giovanni in Laterano: «No a un tipo di cultura dove non conta la verità, dove conta solo la sensazione, lo spirito di calunnia e di distruzione», e «dove la menzogna si presenta nella veste della verità e dell’informazione».
Sceglie bene le parole Joseph Ratzinger. E le scandisce forte, quando lancia all’esterno il suo attacco per le rivelazioni sui giornali. Parla, è chiaro, pur senza nominarlo, del caso Vatileaks. «Lascio a ognuno di voi riflettere sulla pompa del Diavolo e su questa cultura a cui diciamo no, per emanciparci e liberarci». Si sofferma sull’espressione inusuale, sull’origine del termine «pompa del diavolo». E spiega che l’immagine è rivolta al passato, a «grandi spettacoli cruenti» in cui il diavolo si presentava «con apparente bellezza» ma «con tutta sua crudeltà». E’ più duro Benedetto XVI rispetto al mattino quando, con un discorso alla Pontificia accademia ecclesiastica aveva parlato con gratitudine della «lealtà che si vive nella Chiesa e nella Santa Sede», lealtà che non è mai «cieca». Riferimenti, questi riguardanti i collaboratori e la loro fedeltà, al suo braccio destro, il cardinale Tarcisio Bertone, accusato di guidare con un’eccessiva disinvoltura la Segreteria di Stato, e al suo segretario particolare, monsignor Georg Gaenswein.
All’esterno Ratzinger li difende a spada tratta. Ma poi c’è il fronte interno. E qui il Papa appare determinato, in pochi giorni, a cambiare qualche assetto. È così concentrato, Benedetto, che sembra voler fare questa volta tutto da sé, senza parlarne nemmeno con padre Georg. L’altro giorno, poi, il Pontefice ha avuto parole piuttosto ferme con altri collaboratori, che sul fronte della stampa hanno permesso dichiarazioni e interviste sui problemi interni allo Ior, rivelatesi al dunque dei boomerang. Ma è molto preoccupato, Ratzinger, sull’attività della Segreteria di Stato. Il braccio operativo della Santa Sede appare troppo preso dal caso Vatileaks. «Ad esempio - si spiega - c’è stata una strage orribile in Nigeria, con i cristiani letteralmente massacrati. E non si fa niente, al di là delle dichiarazioni ufficiali di dolore».
Sul fronte delle indagini, ieri il portavoce vaticano, padre Federico Lombardi, ha detto che Paolo Gabriele, il maggiordomo del Papa per ora unico arrestato, non è un «capro espiatorio». E ha commentato come «non piacevole» il parere psichiatrico stilato da un medico su Ettore Gotti Tedeschi, presidente sfiduciato dal board della banca vaticana, come rivelato da Il Fatto.
-
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- VITA E FILOSOFIA: LETTERE DI PIERO MARTINETTI. Se dopo Kant «nessun filosofo serio può non essere in Etica "kantiano", dopo il Cristianesimo non è possibile non essere in qualche modo cristiano» (di Adriano Prosperi - Vita da filosofo contro il regime)7 giugno 2012, di Federico La Sala
 Le lettere di Martinetti che non prestò giuramento al fascismo
Le lettere di Martinetti che non prestò giuramento al fascismo
 Vita da filosofo contro il regime
Vita da filosofo contro il regime
 Mussolini chiese il suo esonero e lo definì un "filosofante"
Mussolini chiese il suo esonero e lo definì un "filosofante" di Adriano Prosperi (la Repubblica, 07.06.2012)
di Adriano Prosperi (la Repubblica, 07.06.2012)Documento di un’epoca e di un protagonista della cultura e della vita civile italiana, queste Lettere 1919-1942 di Piero Martinetti raccolte e curate da Pier Giorgio Zunino con la collaborazione di Giulia Beltrametti (Olschki) offrono un’occasione importante di accostarci a un personaggio straordinario, uno dei più rari e preziosi maestri italiani di vita e di pensiero che il ’900 ci abbia regalato.
Di Piero Martinetti pochi sanno qualcosa di più oltre al fatto dell’essere stato l’unico filosofo universitario italiano che si sia rifiutato di prestare giuramento di fedeltà al fascismo. Quella scelta che lo fece decadere dalla cattedra dell’università di Milano fu l’esito naturale di un percorso di ferrea coerenza morale e intellettuale. Per Piero Martinetti l’insegnamento di filosofia teoretica e morale fu l’impegno di una vita. Le lettere permettono di ritrovarne la cifra umana più profonda, quella che si rivelava nei contatti personali: si pensi per esempio al senso doloroso dell’inadeguatezza della propria opera che ogni elogio e apprezzamento stimolava in lui.
Qui i curatori ricompongono quello che rimane delle sue lettere, pubblicandone molte tuttora inedite, integrando e correggendo sugli originali quelle già note, indicando le lacune per ora non colmate, precisandone e contestualizzandone le circostanze.
Citiamo a titolo d’esempio la lettera del dicembre 1937 a Guido Cagnola, dove Piero Martinetti ragiona sul suo appartarsi dal mondo e prepararsi alla morte come ad un passaggio, una metamorfosi del "principio che vive in noi". Quanto ingiusta risulta così la polemica clericale sulle sue esequie laiche e sulla scelta di far cremare le sue spoglie, condannata allora come segno di ateismo. Ma quello fu l’epilogo postumo della guerra senza quartiere che oppose Martinetti alle autorità del regime clericofascista e che conobbe episodi clamorosi. Agli scontri pubblici il filosofo non si sottrasse: non per un protagonismo che gli fu del tutto estraneo, ma per la convinzione che difendendo la sua indipendenza intellettuale, come ebbe a scrivere a Bernardino Varisco, si difendeva in realtà «uno degli interessi più vitali e più gelosi dello Stato».
Lo dimostrò nella battaglia intellettuale che lo vide impegnato nella Milano degli anni Venti contro il protervo caposcuola della neoscolastica, il convertito Padre Agostino Gemelli. Nello scontro allora in atto che aveva per posta la religione degli italiani, Gemelli capeggiava la restaurazione di un cattolicesimo di Stato e si confrontava con la religione dello Spirito di Croce e di Gentile ma più ancora con quel solitario professore piemontese formatosi sullo studio di filosofie indiane e che andava pubblicando volumi e saggi su argomenti che il battagliero francescano riteneva monopolio cattolico: la metafisica, le dottrine cristiane, i rapporti fra morale e teologia.
Il conflitto esplose in occasione del congresso di filosofia organizzato da Martinetti a Milano nel 1926: un congresso preceduto dalla denunzia di un sicario al rettore e seguito dall’intervento pubblico ostile di Giovanni Gentile e da un telegramma di Mussolini che chiese l’esonero immediato dall’insegnamento del "filosofante".
L’esonero non ci fu. Ma il regime regolò poi i conti con l’imposizione del giuramento di fedeltà a cui Martinetti si rifiutò: la Chiesa mise all’indice le opere nel 1937. Martinetti reagì alla condanna con una lettera inviata alla Congregazione dell’Indice, un’istituzione che a quella data non esisteva più, poi con una seconda versione della stessa mandata alla direzione dell’Osservatore Romano: questa seconda versione, rintracciata nell’Archivio Vaticano della Congregazione per la dottrina della fede, compare qui per la prima volta e offre a Zunino l’occasione di una precisa messa a punto dei dati documentari e del contesto di tutta la questione. E si può così con migliore conoscenza di causa rileggere questa testimonianza dello stile e dei convincimenti profondi di Martinetti.
L’uomo aveva presentato le sue credenziali filosofiche dichiarando fin dal 1909 che, se dopo Kant «nessun filosofo serio può non essere in Etica "kantiano", dopo il Cristianesimo non è possibile non essere in qualche modo cristiano» (un suggerimento che Croce non dimenticò).
Ora, giunto all’appuntamento finale con un’autorità ecclesiastica vittoriosa e vendicativa, dichiarava di aver scritto contro la Chiesa con un «segreto senso di dolore». In quella Chiesa - così Martinetti - «vi sono tante cose che ammiro e che amo». E si dichiarava pronto a ritrattare le sue accuse se e quando avesse visto il capo di quella Chiesa non benedire più le bandiere di guerre fratricide e vietare «a tutti i fedeli di seguire i comandamenti del demonio». Questo non gli fu dato. Ma la sua testimonianza era destinata a restare. Essa si stacca dal grigiore del chiacchiericcio di religione allora diffuso come la cima solitaria di una grande pianta.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- Al di là della "doppia egemonia" crociana e gentiliana - e del cattolicesimo (romano-fascista), la solitudine di Piero Martinetti.4 novembre 2018, di Federico La Sala
La solitudine del FILOSOFO
di Massimo Cacciari (la Repubblica, 24 aprile 2013)
Piero Martinetti appartiene ai pochi, ma grandi "solitari" del pensiero italiano della prima metà del Novecento, capaci di opporsi drasticamente alla "doppia egemonia" crociana e gentiliana. Un altro nome mi viene subito in mente, quello di Giuseppe Rensi. Pensatori entrambi di statura europea, "in presa diretta" con le correnti della "grande crisi" che investiva i fondamenti di ogni disciplina scientifica e filosofica, e di quegli stessi sistemi dell’ idealismo classico tedesco, che, invece, Croce e Gentile intendevano "riformare".
Entrambi, pur sulla base di diversissime ragioni, oppositori a viso aperto del regime fascista, fin dalla sua nascita, e perciò privati della cattedra nel ’ 31. Martinetti, che allora aveva quasi sessant’ anni, insegnava da tempo a Milano, dove ebbe, tra gli altri, allievi come Antonio Banfi. Da quel momento fino alla morte, nell’ anno orribile 1943, visse ritirato nella sua casa nel Canavese. L’ opera fondamentale di quest’ ultimo, drammatico periodo è Gesù Cristo e il cristianesimo (ora ristampata da Castelvecchi), pubblicata nel ’ 34, immediatamente sequestrata dalle autorità fasciste, messa all’ indice dalla Chiesa.
La riflessione sulla esperienza religiosa e sul cristianesimo era già centrale nella filosofia di Martinetti. La religione è una forma che assume il processo di liberazione dello spirito verso quell’ unità suprema del «sapere nostro... col logos eterno, che è il fondamento assoluto della nostra natura». La religione è una forma per la quale, spinozianamente, giungiamo a concepire la vita sub specie aeternitatis. Questo è il nostro Fine, ovvero il Regno dei Fini, che ci si impone come compito necessario: «Nella conquista graduale della libertà l’ uomo realizza un ordine, una legge che, nella sua perfezione, resta sempre per lui un ideale; ma che tuttavia, poiché è la sorgente dell’ attività umana che la realizza, deve già essere ab initio, come un mondo ideale, in Dio ».
Il valore insuperabile dell’ esperienza religiosa consisterebbe, dunque, nel condurre il processo di liberazione fino al "contatto" più intimo, profondo, radicale dell’ anima con quel suo Inizio, con quella Unità suprema di soggetto e oggetto, di sapere e natura, che essa postula continuamente nella sua ricerca, nel suo inesausto interrogare. Religione, insomma, come esattamente l’ opposto di ciò che lega, che vincola, che riduce lo spirito alla lettera. Il cristianesimo è religione spirituale, poiché il suo Fine non è un "paradiso in terra", ma lo stesso, ininterrotto processo di liberazione da ogni terrena condizionatezza, da ogni contingente norma che voglia imporsi alla nostra interiorità. «La religione vive nelle anime, non nel mondo», e ancora: un fondamento storico «è sempre questione di imbarazzo per un pensiero religioso vivo». Gesù Cristo e il cristianesimo è la storia o il destino di un tale cristianesimo spirituale, che si fonda sulla drastica separazione tra Regno di Dio e il reame di questo mondo, che appartiene sempre alle potenze demoniache.
Non si potrebbe immaginare sfida più esplicita, coraggiosa, polemica nei confronti del cristianesimo delle Chiese, e di quella cattolica in particolare. Esse sono tutte marchiate da radicali aut-aut, da scelte e decisioni inappellabili. La vastità delle conoscenze, i fondamenti anche eruditi di questo libro-testamento sono tutti volti a dimostrare quest’ assunto: che il cristianesimo storico, a partire da Paolo, ma, ancor più, dal Vangelo di Giovanni, il teologo, si costituisce come una "tradizione" che essenzialmente tradisce l’ annuncio di Gesù. Paolo e Giovanni divinizzano Gesù. Le Chiese ne continuano l’opera, facendone un idolo, che, alla fine, «relega completamente nell’ ombra il Dio di Gesù, il Padre celeste».
Sulla base di questa idea Martinetti può svolgere una storia del cristianesimo dove la patristica orientale è assente, Anselmo, Alberto, Tommaso non vengono neppure citati, e il pensiero di Agostino viene ritenuto «insignificante»!
Esiste tuttavia una Chiesa spirituale, formata da tutti coloro che hanno continuato a trasmettere la «saggezza» di Gesù, successione di spiriti che hanno «attraversato il mondo umilie miserabili come luie i suoi discepolo». Il primo nome di questa successione è quello di Marcione, l’ ultimo quello di Kant. Marcione costituì, nel Secondo secolo, l’alternativa radicale alla Chiesa cattolica. Gesù è per lui il Maestro che annuncia il vero Regno dei Cieli, nascosto dal Dio creatore di questo mondo e legislatore della Bibbia ebraica.
Al di là degli aspetti mitologici o dell’ estremo dualismo del "vangelo" marcionita, è evidente che ciò che di esso a Martinetti interessa è il netto rifiuto di qualsiasi elaborazione teologica fondata sul quarto Vangelo. Qui è il perno del Gesù: la dottrina del Logos contenuta del prologo di Giovanni sta alla base del progressivo abbandono dell’ Annuncio. La purezza dell’ esperienza religiosa consiste nell’ intuire in sé, in interiore, il Dio al di là di ogni predicazione o immagine, verso il quale trascendersi, liberandosi da tutti gli idoli che pretenderebbero di incarnarlo. Perciò il Logos-theos che si fa carne di Giovanni contraddice, per Martinetti, ab imis fundamentis l’ insegnamento gesuano. Ed è altrettanto evidente quale sia il grande filosofo che, alla fine di questo processo, dovremo trovare: Hegel. Marcione sta a Kant, come Giovanni a Hegel! È la "dialettica" del Deus-Trinitas l’ avversario di Martinetti. Una simile prospettiva solleva infiniti problemi.
È certo che Martinetti pensa alla sua come a un’ autentica esegesi della parola di Gesù. È infondata questa pretesa? Non lo penso. Il testo cui anche Martinetti si appella richiede costantemente di essere interrogato: veritas indaganda. Ma, allora, l’ esegesi ne è parte immanente e costitutiva.
Come il Logos, in Giovanni, fa esegesi del Padre, così i suoi discepoli dovranno fare esegesi di Lui. Martinetti muove ovunque l’ istanza della originarietà autentica, che era, appunto, tipica di Marcione. Ma proprio la novitas di questo Annuncio consiste nell’ esigenza di farne sempre esegesi. L’ origine non è qualcosa che stia "alle spalle" come un fondamento, ma si trasforma nella tradizione, che è sempre anche possibilità di fraintendimento-tradimento. Nel dualismo di Martinetti le due dimensioni si contraddicono. Per Martinetti il Logos si rivolge al Padre nei cieli, ma non si incarna nella storia, non accoglie in sé il proprio stesso smarrimento nella storia, ignora il "grande grido" dell’ Abbandonato sulla Croce. Martinetti non vede come, accanto alla sua esegesi, sia necessario pensare anchea quella che darà vita alla teologia trinitaria - e proprio a partire dalla drammatica dello stesso Annuncio. Aut-aut, certo, ma questo aut-aut è sistole e diastole della nostra civiltà. E proprio il non saperlo sopportare ne segnerà forse la fine.
La "linea" marcionita (analogamente a quella delle più grandi eresie) è volta alla "razionalizzazione" dell’ Annuncio, a mostrare il significato tutto spirituale dei temi dell’ immortalità, della resurrezione, del "comandamento nuovo" dell’ amore per tutti, anche per il nemico. La paradossalità della parola di Gesù viene costantemente spiegata "nei limiti della sola ragione". Kierkegaard e Barth sono lontani quanto Hegel dal cuore e dalla mente di Martinetti.
Ma se nel grande dibattito intorno al Cristo dei secoli III e IV avessero prevalso le correnti marcionite o gnostiche o manichee quale cristianesimo sarebbe sopravvissuto? Forse appena una memoria erudita. La stessa possibilità che un Harnack o un Martinetti parlino della Chiesa spirituale in contraddizione con le Chiese dipende dal fatto che queste si sono storicamente affermate, permixtae, compromesse in ogni modo con la civitas hominis, peccatrici come quel Pietro su cui testimoniamo di fondarsi. Eppure mai del tutto dimentiche che possa darsi anche la Chiesa spirituale, mai semplicemente o astrattamente inimiche dello "spirito profetico". È il paradosso dell’ incarnazione che ne informa la storia, nel bene e nel male. Ma proprio da ogni male dovrebbe, invece, restare libera la Chiesa spirituale, in cui la legge morale kantiana si è fatta natura interiore, espressione dell’ ideale religioso supremo per Martinetti, e tutt’ uno, ovviamente, con la sua etica.
Potremmo ancora chiederci se questa assimilazione di cristianesimo e ideale etico, che respinge, alla fine, ogni elemento di irriducibile paradossalità dell’ esperienza religiosa, costituisca il solo mezzo per mantenere vivo oggi l’ ascolto dell’ Annuncio - o non rappresenti piuttosto proprio il suo estremo "tradimento", la sua "traduzione" in religiosità etico-filosofica o, peggio, in "cultura".
Ma soprattutto dovremmo interrogarci se oggi la "lotta" sia davvero ancora all’ interno dello spazio complesso e contraddittorio disegnato dalla Europa o cristianità, spazio formato da Chiese e eresie, istituzionie forze spirituali, potenze politiche e religiose cristiche e anti-cristiche, tutte consapevolmente appartenenti a un unico Evo, oppure proprio questa comunanza di opposti sia tramontata o volga inesorabilmente al tramonto. Chiese e chiesa spirituale sono in procinto, forse, di ritirarsi insieme in deserto, scoprendo così, nella comune sconfitta, la loro comune matrice.
-
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- Emanuela Orlandi, Mirella Gregori e la pista dei preti pedofili a Boston (di di Fabrizio Peronaci)4 giugno 2012
 Emanuela Orlandi, Mirella Gregori e la pista dei preti pedofili a Boston
Emanuela Orlandi, Mirella Gregori e la pista dei preti pedofili a Boston
 I legami con la città dello scandalo pedofili: un timbro postale e le telefonate dell’«Amerikano»
I legami con la città dello scandalo pedofili: un timbro postale e le telefonate dell’«Amerikano» di Fabrizio Peronaci (Corriere della Sera, 04.06.2012)
di Fabrizio Peronaci (Corriere della Sera, 04.06.2012)Emanuela Orlandi e Mirella Gregori: un filo robusto lega la loro scomparsa allo scandalo dei preti pedofili a Boston. Una vicenda che nel 2002 sconvolse la Chiesa cattolica, lasciò sgomenti milioni di fedeli americani per i sistematici abusi su minori coperti dai vertici ecclesiastici e portò alle dimissioni dell’arcivescovo Bernard Law, poi tornato a Roma nel 2005.
ROMA - C’è un filo robusto - rimasto sottotraccia nelle decine di faldoni dell’inchiesta aperta da 29 anni presso la Procura di Roma - che lega la scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori allo scandalo dei preti pedofili a Boston. Una vicenda che nel 2002 sconvolse la Chiesa cattolica, lasciò sgomenti milioni di fedeli americani per i sistematici abusi su minori coperti dai vertici ecclesiastici e portò alle dimissioni dell’arcivescovo Bernard Francis Law, poi tornato a Roma nel 2005 in qualità di arciprete della basilica di Santa Maria Maggiore.
Mirella, Emanuela. Due ragazzine quindicenni accomunate da un atroce destino: la prima sparì nel piazzale di Porta Pia il 7 maggio 1983, dopo aver detto alla mamma che doveva incontrarsi con gli amici, e la seconda (figlia del messo pontificio di Wojtyla) il successivo 22 giugno, all’uscita della lezione di flauto a Sant’Apollinare. Un duplice mistero che da tre decenni fa perdere il sonno agli investigatori. E che - considerata l’ipotesi di una mai chiarita Vatican connection - solletica fantasie, ambizioni e congetture di stuoli di giallisti, detective, giornalisti, persino veggenti. L’ultimo colpo di scena, il 14 maggio, ha portato all’apertura della tomba del boss Enrico De Pedis, sepolto nella basilica a ridosso della scuola di musica della «ragazza con la fascetta».
Ma ora c’è di più. Un timbro, un fermo posta: entrambi localizzati in Kenmore Station, nel centro di Boston. L’uno agli atti, l’altro no. Il primo risale alle prime rivendicazioni dell’affaire Orlandi-Gregori, il secondo fu usato dall’associazione pedofila Nambla (North American Man Boy Lover Association) ed è emerso 19 anni dopo. Vale la pena spiegarlo, questo indizio principe. Metterlo a fuoco, contestualizzarlo.
Macchina indietro di 29 anni: luglio 1983. Il Papa è da poco rientrato dai bagni di folla nella sua Polonia, le elezioni in Italia hanno appena spianato la strada a Bettino Craxi ma, sul doppio sequestro, è buio totale. Quello di Mirella è «silente» ormai da due mesi e lascia attoniti i genitori, gestori di un bar vicino alla stazione Termini, mentre quello di Emanuela, inaspettatamente, deflagra: è Giovanni Paolo II, con l’appello del 3 luglio all’Angelus («Sono vicino alla famiglia Orlandi, la quale è in afflizione per la figlia...»), a proiettare uno dei tanti casi di missing people in una dimensione planetaria. L’effetto è immediato. Il 5 luglio a casa del «postino» papale arriva la prima telefonata del cosiddetto «Amerikano», italiano incerto e poche battute in inglese, che getta sul piatto una richiesta secca: libereremo «tua figliola», dice, in cambio della scarcerazione di Ali Agca.
Vincenzo Parisi, del Sisde, traccerà il seguente profilo dell’inquietante personaggio: «Straniero, verosimilmente anglosassone, livello culturale elevatissimo, appartenente (o inserito) nel mondo ecclesiale, formalista, ironico, calcolatore...». Trattativa vera o di facciata, quella sull’attentatore di Wojtyla? Un dato è certo: di contatti con la Santa Sede, attraverso il famoso codice «158», il dominus dell’intera vicenda ne ebbe più d’uno.
Il giallo infiamma l’estate. A luglio l’«Amerikano» telefona ancora, lancia ultimatum sulla vita di Emanuela. Ma all’improvviso smette, tace. Agosto viene così «riempito» da un altro soggetto, il Fronte Turkesh, i cui messaggi (scoprirà l’ex giudice Ferdinando Imposimato) altro non sono che depistaggi della Stasi e del Kgb per tenere sotto scacco l’odiato Papa anticomunista e filo-Solidarnosc. Settembre, mese chiave dell’intrigo. Il 4 l’«Amerikano» riappare e fa trovare una busta dentro un furgone Rai, contenente un messaggio a penna e uno spartito di Emanuela. Ancora: al bar dei Gregori, il 12, giunge una telefonata choc. Un anonimo elenca i vestiti indossati e la marca della biancheria intima di Mirella, che solo la madre conosce. È un complice dell’«Amerikano»? Entrambe le ragazze sono in suo pugno?
Ed eccoci al 27 settembre 1983, all’ulteriore rivendicazione (o messinscena?) che, riletta oggi, fa correre brividi lungo la schiena. Richard Roth, corrispondente da Roma della Cbs, riceve una lettera che preannuncia «un episodio tecnico che rimorde la nostra coscienza». Gli investigatori, scrive l’Ansa il giorno dopo, sono sicuri: si tratta dei «veri rapitori di Emanuela» o di «quelli che l’hanno tenuta prigioniera». Sulla busta c’è il timbro di partenza: Kenmore.
Ma a quale episodio «tecnico» si allude? «L’imminente uccisione dell’ostaggio». Non basta: una perizia grafologica accerta che il messaggio del 4 settembre e questo del 27 sono opera della stessa mano. L’«Amerikano» si è spostato sulla East coast? O ha trasmesso i suoi scritti a qualcuno, forse per continuare i depistaggi?
Tale pista all’epoca non fu percorsa ma adesso, alla luce dei nuovi indizi, potrebbe riprendere quota. Gennaio 2002, Boston: scoppia lo scandalo. Il cardinale Law è accusato di aver coperto per molti anni sacerdoti pedofili della diocesi. Maggio 2002, si apre il processo davanti alla Corte di Suffolk: Law nella deposizione risponde a monosillabi, si scusa per aver controllato poco i «collaboratori». 7 giugno 2002: fuori dal tribunale le mamme delle vittime (per lo più maschietti, ma non solo) protestano. E, dentro, l’interrogatorio è incalzante: «È emerso in una precedente deposizione - attacca il rappresentante dell’accusa - che 32 uomini e due ragazzi hanno formato il gruppo Nambla. Per contattarlo si può scrivere presso il Fag Rag, Box 331, Kenmore Station, Boston... Cardinale Law, ha inteso?». Pausa. Nell’aula risuona una frase sibilata, poco più di un soffio.
«I do», risponde l’arcivescovo. Sì, è vero. Il Fag Rag, che sta per «Giornalaccio omosessuale», faceva quindi proseliti per conto del temutissimo sodalizio pedofilo degli States, proprio dalla stazione da cui partì la lettera su Emanuela. Nella sequenza di omissioni e depistaggi che da sempre alimenta il giallo della «ragazza con la fascetta», la pista di Boston, 29 anni dopo, fa balenare il più spaventoso e sconvolgente degli scenari.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- IL DOPPIO DRAMMA DELL’ITALIA E DEL VATICANO: UNA GALLERIA DI FINZIONI E INGANNI4 giugno 2012, di Federico La Sala
Vaticano e Italia, mali comuni
di Furio Colombo (il Fatto, 03.06.2012)
La domanda è questa: la turbolenta spaccatura che sta attraversando il Vaticano e - come in un film dell’orrore - arriva fino alle stanze del Papa, è la stessa spaccatura di profondità sconosciuta, che tormenta l’Italia? La risposta è sì. È una brutta risposta, perché dice che il Vaticano - il papa, il governo della Chiesa, la Istituzione - dovranno confrontarsi con uno sforzo immane per uscire dalla palude. Dovranno, soprattutto, dimostrare una decisa volontà di farlo, senza sotterfugi, autocelebrazioni e finzioni. Qualcosa che in Italia non è ancora accaduto.
Che cosa hanno in comune la storia italiana contemporanea e quella del Vaticano, che cosa può dimostrare la stessa natura del male (corvi, complotti, spionaggi, agguati, tradimenti e misteriosi tornaconti, in cui spesso restano ignoti mandante e beneficiario)? Prima di produrre le prove di quello che sto scrivendo, devo tentare di definire questo "male comune" che mette in pericolo l’equilibrio e persino la continuità di due Stati.
Lo descriverei così. È la decisione, abile e pericolosa di affidare immagine e auto-definizione a principi e programmi alti e nobili sempre più lontani dalla realtà che invece peggiora sotto gli occhi di tutti. In questo modo si evita ogni spietata e coraggiosa verifica dei fatti, accusando più o meno oscuri nemici di essere l’unica causa del male (malareligione o malapolitica).
Proverò a produrre alcune prove della situazione inaffidabile che scuote e tormenta tanto l’Italia quanto il Vaticano e la Chiesa, precisando che di questi due ultimi protagonisti parlerò a partire da ciò che vede e constata un osservatore estraneo, dunque dalle manifestazioni sociali, organizzative, di governo, non di fede e di religione, che in questa riflessione non entrano mai.
COMINCIO da uno spunto che mi pare molto utile perché fa da ponte fra politica vaticana e politica italiana (istituzioni e leggi) e dunque chiama apertamente in causa quei cittadini che sono allo stesso tempo attivi nelle istituzioni italiane e vincolati all’ubbidienza di Vaticano-Stato e di Vaticano-Chiesa. Intendo riferirmi al finto culto della famiglia, che viene visto come strumento di aggregazione (ma anche di espulsione, se non si tratta della famiglia giusta) e come fondamento dell’edificio politico conservatore (di nuovo inteso come argine e frontiera contro ogni mutamento di aggregazione sociale, visto come turbamento della conservazione politica).
Ho appena scritto "finto culto della famiglia" perché nessun gruppo sociale è più solo, abbandonato, privo di sostegno morale e sociale, da parte di entrambi i celebranti di questo culto, la Chiesa e la politica. È vero, non tutta la Chiesa e non tutta la politica. Ma qui interessa individuare i percorsi da cui entra con impeto il disordine, il distacco, l’apparente sottomissione e il profondo cinismo di cui stiamo parlando.
Quando si spengono le luci su eventi e giornate organizzate per celebrare la famiglia, non resta né un asilo né una scuola né un sostegno per le madri che lavorano, né un progetto, per quanto austero, per le famiglie troppo povere, per esempio Rom e immigrati, dove la presenza di mamme e bambini non ha mai fatto differenza.
Pensate alla distruzione di un campo nomadi (e agli animaletti di peluche che restano fra i denti delle ruspe). Pensate ai pasti scolastici negati ai bambini se le famiglie non possono pagare. O all’internamento delle donne dette “clandestine” nei “Centri di identificazione”, improvvisamente e brutalmente separate dai loro bambini a causa di un arresto arbitrario (parlo di eventi vissuti e constatati).
E, come se non bastasse, aggiungete la risoluta e congiunta condanna (Stato-Chiesa) delle famiglie “diverse”, definite “una minaccia”. Ecco, in questa finzione, che è forse la madre di tutte le finzioni di atti e fatti che hanno solo un fine politico (impedire che esistano altri tipi di famiglia, di amore, di figli), sta il deposito di cinismo, tradimento, rincorsa del potere, distacco da ogni valore, di patria o di fede, che constatiamo nel doppio dramma, dell’Italia e del Vaticano. Appartengono alla galleria delle finzioni (che si trasformano in veri inganni) le folle di autorevoli finti credenti, pronti a ricevere i sacramenti, purché in presenza di telecamere e di pubblico, o alla gara dei medici che si dichiarano obiettori di coscienza negli ospedali dove essere obiettori “fa curriculum” per i medici, qualunque sia la condizione della donna che chiede aiuto.
IL FINTO credente, che trova Dio solo se la cerimonia è ben frequentata e notata da chi deve notare, corrisponde al finto amor di patria di chi - specialmente fra i politici - cerca la benevolenza delle Forze Armate e “dei nostri ragazzi in armi”, ma si infastidisce se quei ragazzi sono in tuta da operaio, magari iscritti a un sindacato, specialmente se quei ragazzi insistono nel pretendere i diritti che legge e Costituzione garantiscono. Intorno, nell’una e nell’altra chiesa, c’è un deserto di solidarietà.
In Europa nessuno è più solo e più abbandonato dei disabili italiani. In quel vuoto entrano i rapitori di Emanuela Orlandi, i maggiordomi con doppio e misterioso lavoro, i banchieri improvvisamente cacciati per ragioni non dette, i tesorieri di partito, gestori di ricchezze comunque illecite che dividono diamanti e spese indecenti con strani infiltrati nella vita pubblica, tutti molto simili, per coraggio e mancanza di scrupoli, a certi cardinali.
La Repubblica italiana come istituzione politica, e il Vaticano come governo dell’omonimo Stato e della Chiesa, sono contenitori di società segrete, intente a un sommerso, ininterrotto lavorìo di promozione (il mio uomo contro il tuo) e di eliminazione reciproca, in una infinita variazione di casi Boffo. I maggiordomi, con o senza la severa uniforme vaticana, avranno ancora molto da fare. Ai credenti nella fede e nella patria toccano tempi duri
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- Il Papa a Milano: una visita da 13 milioni (di Luigi Franco)1 giugno 2012, di Federico La Sala
Il Papa a Milano: una visita da 13 milioni
di Luigi Franco (il Fatto Quotidiano, 1 giugno 2012)
Un milione e duecentomila pellegrini. Tradotto: tre giorni di popolazione raddoppiata. Ruota tutta attorno a questa cifra da record la macchina organizzativa che sta preparando Milano all’arrivo del Papa. La visita più lunga in una città italiana nella storia dei pontefici. Benedetto XVI atterrerà a Linate questo pomeriggio alle 17. Alle spalle i contrasti dei palazzi vaticani e le rivelazioni dei ‘corvi’. Ad attenderlo le polemica sul ruolo della famiglia, proprio il tema al centro di questo incontro mondiale.
Due giorni fa lo scontro a distanza tra Giuliano Pisapia e Roberto Formigoni. “Se entro la fine dell’anno il Consiglio comunale non deciderà, assumerò io personalmente con la mia giunta la decisione sul registro delle unioni civili”, ha promesso il sindaco di Milano. “Di famiglia ne conosco una sola, fatta di un uomo, una donna e dei bambini”, ha replicato il presidente della Lombardia. Battibecchi che si aggiungono ai mal di pancia all’interno della stessa maggioranza arancione per “il deficit preoccupante di laicità” che accompagna la visita del Papa. Queste le parole della capogruppo di Fds in Consiglio comunale, Anita Sonego, che ha anche messo nel mirino i soldi pubblici stanziati per l’evento “in un periodo di crisi come questo”.
Il Comune ha previsto una spesa di 3,1 milioni di euro per potenziare i servizi in questi tre giorni: trasporti, sicurezza, pulizia delle strade. Soldi che secondo la giunta andranno a favore di tutta la città, dei milanesi oltre che dei pellegrini. In ogni caso, è saltato il milione di euro che Letizia Moratti aveva promesso alla Curia, senza mai però metterlo a bilancio.
CI SONO poi i due milioni elargiti da regione Lombardia e il 27esimo piano del Pirellone messo per nove mesi a disposizione della Fondazione Milano Famiglie 2012, che ha iniziato a organizzare l’evento quasi due anni fa. Spesa complessiva 10 milioni di euro, finanziati oltre che dalla Regione, dall’arcidiocesi di Milano, dalla Cei e da numerosi sponsor, come Intesa San Paolo, Eni ed Enel. Investimenti che saranno ben ripagati, fa sapere la fondazione, visto che l’indotto previsto è di 55 milioni di euro. Soldi portati dal milione di pellegrini che sono già iniziati ad arrivare. Ieri qualcuno si aggirava incuriosito per piazza Duomo, mentre gli operai spostavano transenne e preparavano il palco sul sagrato .
Se Milano reggerà, però, lo si inizierà a capire oggi. Una città sotto assedio, un assedio ‘gentile’, dicono le autorità. Allerta massima, le bonifiche delle strade dove passerà il papa sono già partite nei giorni scorsi: tolti i cestini, controllati i tombini. Per l’evento più delicato, la messa di domenica mattina a Bresso, sono state addirittura visionate le mappe militari per studiare al meglio come difendere il perimetro del parco Nord. Nei tre giorni saranno impiegati 15mila uomini, tra forze dell’ordine, vigili del fuoco e protezione civile. Ci sarà poi un esercito di 6mila volontari. A seguire il corteo papale un apparato di sicurezza imponente, tiratori scelti sui tetti, quattro elicotteri di polizia e carabinieri in volo. Primo trasferimento quello di oggi tra l’aeroporto di Linate e piazza Duomo, dove alle 17.30 Benedetto XVI terrà un discorso alla cittadinanza.
SULLA papamobile non salirà, come altre volte, il suo ex maggiordomo Paolo Gabriele, finito in una cella del Vaticano con l’accusa di essere uno dei responsabili della fuoriuscita di documenti riservati. Tre giorni di mezzi potenziati, metro tutta la notte, bus già in strada alle 4 di mattino, la zona a nord di Milano vicino a Bresso chiusa a quasi tutto il traffico. Misure eccezionali per un programma che dopo la presenza di Benedetto XVI in Duomo prevede il concerto alla Scala stasera.
Domani la festa dei cresimandi alle 11 allo stadio San Siro e alle 16 l’incontro nell’area allestita all’aeroporto di Bresso, dove in serata il pontefice salirà per la prima volta sul palco da 50 metri. Meglio di una rockstar. Alle 10 di domenica la messa, sempre a Bresso, da dove il Papa partirà dopo aver recitato l’Angelus. Direzione Linate. Poi, alle 17.30, in volo per Roma.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- In Vaticano non hanno ancora capito (di Aldo Maria Valli - I corvi e i gendarmi)29 maggio 2012, di Federico La Sala
I corvi e i gendarmi
di Aldo Maria Valli (Europa, 29 maggio 2012)
Chi frequenta i palazzi vaticani sa che là dentro ci sono tante persone stanche del misto di affarismo, carrierismo e ipocrisia dominante in quel mondo a causa di gruppi di potere.
Sono persone che non accettano più questo andazzo, e se fino a ieri esprimevano delusione in colloqui privati, ora alcune di loro hanno deciso di agire, consegnando alla stampa le prove di ciò che sostengono: documenti attraverso i quali si può vedere che la curia romana, proprio ai suoi vertici, si occupa di questioni di potere, piccolo o grande che sia, quasi ventiquattro ore su ventiquattro. Non solo. Chi si occupa di questi problemi molto spesso, all’esterno, si presenta come moralizzatore e fustigatore di costumi altrui. Una situazione che provoca grande disagio in coloro che ancora hanno un briciolo di onestà intellettuale e di amore per la Chiesa.
L’idea di far uscire le carte si presenta come un’extrema ratio. Non essendo riusciti altri tentativi di cambiamento, si cerca così di forzare l’istituzione. A mali estremi, estremi rimedi. I corvi sanno che l’operazione è pericolosa, perché il rischio di essere screditati è alto, così come notevole è la possibilità che l’istituzione risponda facendo passare i cospiratori per avversari della Chiesa. Ma i corvi hanno deciso di rischiare. Nell’epoca della comunicazione, sono le notizie le vere armi. Ciò che per secoli non è riuscito con altri sistemi può riuscire oggi attraverso l’informazione.
L’operato dei corvi può essere criticato sotto diversi aspetti. Quando si agisce nell’ombra, senza mostrare il volto, è molto facile vanificare tutto il proprio operato. Ma chi ha deciso di passare all’azione ha calcolato anche questo pericolo. Era necessario scatenare una bufera mediatica.
Gli obiettivi dei corvi sono di ordine morale e organizzativo, e le due questioni sono strettamente collegate. Il Vaticano si è sporcato le mani, e con le mani anche la coscienza, perché fa troppa politica nel senso più ampio e meno nobile del termine: si dedica a questioni che nulla hanno a che vedere con l’annuncio del Vangelo.
Come si può ben vedere dalla carte pubblicate nel libro del giornalista Nuzzi, i vertici della curia romana trascorrono gran parte del loro tempo immersi in problemi del tutto estranei al mandato che Gesù ha affidato a Pietro e ai suoi. Si parla di tutto, soprattutto di soldi, meno che del Vangelo. Qualcuno dice: ma è così in tutti i centri di potere e non si vede perché solo la curia romana debba essere attaccata per questo.
È un ragionamento che non regge. Perché la curia romana, anche se lo è da secoli, non deve essere un centro di potere. Al di là del nodo più immediato, come la successione al cardinale Bertone o allo stesso pontefice, la questione ha una portata ben più ampia. Si tratta di decidere cosa dev’essere la Santa Sede (e definirla “santa” oggi più che mai provoca un amaro sorriso) e cosa dev’essere quella struttura al suo servizio che è lo stato della Città del Vaticano.
La linea dei corvi, o per lo meno dei più lungimiranti fra loro, è chiara: Santa sede e Città del Vaticano hanno bisogno di una radicale cura dimagrante all’insegna della sobrietà e dell’essenzialità. Meno uffici e meno strutture vuol dire meno tentazioni e meno occasioni di compromissione con gli affari economici e il potere politico. Il papa è un sovrano assoluto e può tutto. Potrebbe denunciare tutto ciò che vede e sa, ma è anche un pastore e ha il dovere di tenere unito il gregge. Il suo timore è che lo scandalo sarebbe troppo grande e che il gregge potrebbe subirne conseguenze devastanti. I corvi pensano invece che non ci sia più spazio per attese e compromessi: occorre una radicale operazione di pulizia e di trasparenza, e si deve incominciare dalla segreteria di Stato, ganglio vitale di tutta la macchina.
Le domande sono di portata radicale. Perché il papa deve essere capo di stato? Perché il Vaticano deve avere una banca? Perché il successore del pescatore Pietro deve essere al centro di un sistema di potere? In Vaticano sono ore drammatiche. Mentre il povero Paoletto è in carcere, pesce piccolo catturato senza troppe difficoltà, diversi schieramenti si affrontano e si osservano. Perché anche tra i corvi non tutti sono puri di cuore e c’è chi vuole utilizzare la situazione per altre trame di potere. Finora la Santa sede sta reagendo nel modo più sbagliato. Con i gendarmi e il silenzio.
Lo si è visto domenica in piazza San Pietro. Quando è arrivata la marcia per Emanuela Orlandi, persone insospettabili si aggiravano per osservare e fotografare. Come se i partecipanti alla manifestazione fossero malfattori da schedare. E il papa, che avrebbe potuto dire una parola come padre su una sua giovane cittadina scomparsa nel nulla e una famiglia distrutta dal dolore, è rimasto zitto nel giorno dedicato allo Spirito santo. Quando dalla folla si è levato qualche fischio e qualcuno ha gridato “vergogna” abbiamo misurato l’intensità del dramma in corso.
In Vaticano non hanno ancora capito che nell’era dell’informazione non possono continuare ad agire in base all’ideologia del segreto e dell’opportunità. La credibilità sta venendo meno, ed è questo il bene più importante che la curia dovrebbe coltivare. I corvi saranno utilizzati, lo stiamo già vedendo, anche da chi vuole il male e non il bene della Chiesa. Questo è forse il pericolo più grande. Ecco perché la curia è folle se pensa di poter continuare a reagire utilizzando da un lato i gendarmi e dall’altro il segreto. Non è bastata la lezione della pedofilia? Non si è visto che il discredito aumenta a dismisura se non si è primi a denunciare e a sollevare il velo dell’ipocrisia?
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- A San Pietro un popolo disorientato. “Alla deriva come l’Italia laica” (di Federico Geremicca)28 maggio 2012, di Federico La Sala
A San Pietro un popolo disorientato
In piazza San Pietro lo scandalo che scuote il Vaticano preoccupa i fedeli
I fedeli traditi e disorientati “Alla deriva come l’Italia laica”
E in piazza San Pietro le sacre mura non riescono a contenere la “crisi parallela”
di Federico Geremicca (La Stampa, 28.05.2012)
Ver-go-gna, ver-gogna, ver-go-gna». Le urla cattive si alzano dalla piazza assieme ai palloncini bianchi ai quali è legata la solita foto - foto di trent’anni fa - di Emanuela Orlandi. Il Papa è lassù, in alto, come al solito troppo in alto per poter sentire il coro che si leva, ora che è mezzogiorno. Protesta e gesticola Pietro, il fratello di Emanuela. E protestano e urlano i cittadini arrivati per l’ennesima volta fin qui a chiedere verità e giustizia. E’ vero, ci sono giornate che sarebbe meglio non cominciassero mai. Per Papa Ratzinger e la sua cittadella assediata, questa è una di quelle: e al di là delle mura, anzi, cancellerebbero con un amen l’intera settimana, se solo si potesse.
Ci sono giornate che sarebbe meglio non cominciassero mai. E fatti che si vorrebbe scolorissero in fretta. I fatti, solo gli ultimi fatti, sono questi: il presidente del potentissimo Ior rimosso dal suo incarico come un fannullone qualunque, sepolto da accuse infamanti, infedele e sfaccendato; il maggiordomo del Papa spiato, perquisito e arrestato per aver «passato ai media» documenti riservati e personali del Santo Padre: alla stregua di un cancelliere infedele che distribuisca intercettazioni e verbali a questo o a quel cronista.
Guerra tra bande Verrebbe voglia di non crederci: e la voglia riguarda tutti, atei e fedeli. E invece, purtroppo, in questa piazza San Pietro inondata di sole, non solo ci credono, ma ricordano quando la Chiesa si divideva - è vero - ma su ben altro: se sostenere e come Solidarnosc, oppure cosa fare con quei «ribelli» della teologia della liberazione. Oggi, in quelle stesse stanze drappeggiate di scuro, si trama per il controllo di una banca, tutto è ridotto a una guerra per bande bande sante, naturalmente - e si corrompono e utilizzano funzionari infedeli e (pare) senza scrupoli. Come in un film. E proprio come al di là delle mura benedette.
Che è pur sempre una spiegazione, oltre che una inevitabile constatazione. E che magari può aiutare a capire l’incredulità, lo smarrimento e la rabbia - la rabbia anche, certo di un altro popolo che si sente tradito, e che quasi non ci crede. E’ una suggestione che si insinua ascoltando una signora anziana, nonna Luigina, arrivata fin qui da un paesino vicino Como: «E’ che al Papa - dice sicura - lo vogliono fregare come hanno fregato su da noi l’Umberto. Guai a fidarsi dei figli, dei maggiordomi e ascolti me: anche delle mogli le dico... ». Un popolo disorientato, quello di Piazza San Pietro, come disorientato è il «popolo di Pontida», una fede tradita, due fedi tradite, e non capisci ancora né come nè perché.
Senso di vergogna La lotta - presunta - tra il cardinal Bertone e il Papa, come la lotta - accertata - tra il «cerchio magico» e il resto della Lega. E la delusione del popolo di San Pietro un senso di vergogna - che fa tornare in mente lo smarrimento rabbioso del fu popolo berlusconiano, di fronte all’inefficienza e ai bunga bunga, un Paese che tira la cinghia e gli altri che ballano, cantano e si travestono. Può sembrare un paradosso unire così il sacro e il profano: ma le mura sante del Vaticano sembrano non bastar più ad arginare la «crisi parallela» della più antica istituzione del mondo.
«La fede non basta» E’ quel che teme Marco, che ha i capelli scuri, è giusto al centro della piazza e veste una maglietta nera con la scritta «Viareggio Marineria». E’ preoccupato, e guarda con timore un angolo di folla che rumoreggia: «E’ terribile. Se diventiamo come gli altri è finita ed è terribile. La fede da sola non basta, perché non può camminare sulle gambe di gente cattiva e di uomini infedeli». Il Papa, intanto, è lassù e parla. Prima, dentro San Pietro, aveva celebrato la Pentecoste con parole amare: «Sembra che gli uomini stiano diventando più aggressivi e più scontrosi... C’è un senso di diffidenza, di sospetto e di timore reciproco che ci fa diventare pericolosi gli uni per gli altri».
E’ quel senso di diffidenza - quella mancanza di orizzonti certi e di fiducia, insomma - che l’Italia laica conosce già. Ora, questa maledetta crisi di credibilità sembra investire - autoinvestire - anche la cittadella circondata da mura sante. Come se la Chiesa fosse un partito e il Papa il suo segretario, ombre tetre si allungano sugli uomini a lui più vicini: che siano leader anch’essi, che siano tecnici arrivati dal mondo dell’economia e delle banche, che siano amici e servitori del cerchio stretto che vigila sul Santo Padre. Non è che ci si debba soprendere chissà quanto, dopo la sconfinata bibliografia (e filmografia) sui misteri, gli scandali ed i segreti del Vaticano: però sia lecito e sia lecito soprattutto al popolo che riempie questa piazza - dirsi sconcertato e ferito dall’idea che corvi neri abbiano preso (ripreso) a volteggiare dentro le mura sante, come fossero un tribunale, una Procura o perfino la sede di un partito.
Il viaggio a Milano Lassù - intanto - il Papa parla, annuncia un viaggio a Milano, saluta i fedeli in più lingue, ringrazia e rende omaggio alle forze di polizia per il loro «compleanno» e perfino alla Federazione di tiro con l’arco. I palloncini con la foto di Emanuela Orlandi gli passano quasi davanti e salgono al cielo, segno di un passato che continua a inseguire un incerto presente. Il fratello Pietro aspettava dal Papa un segno, una parola. Ma il vento impiega un attimo a portar via la foto. E’ mezzogiorno e un quarto, la messa è finita: e chi riesce, allora, vada in pace..
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- L’URGENZA DI FARE PULIZIA26 maggio 2012, di Federico La Sala
L’urgenza di fare pulizia
di Francesco Paolo Casavola (Il Messaggero, 26 maggio 2012)
Le notizie delle dimissioni di Gotti Tedeschi da presidente della Banca Vaticana e dell’arresto di un dipendente dei Sacri palazzi, trovato in possesso di documenti riservati, sembrano destinate ad arricchire quel genere letterario alla Dan Brown in cui sacro e profano si mescolano nella trama di un romanzo poliziesco. I lettori comuni ne restano affascinati, come dimostra il successo editoriale di simili scritture. Ma nel caso particolare bisogna contrastare ogni velleità speculativa sulla curiosità del pubblico ad opera dei media. La prima ragione è che non si rinfocolino pregiudizi antireligiosi e antichiesastici, e conseguenti reazioni di autotutela. La posta in gioco è troppo alta perché si ricorra a modelli di comportamento usuali tra chi ha paura della verità.
La Chiesa cattolica non è lo Stato Vaticano, non è la sola gerarchia fino alla sua vetta, non è Roma: è l’intera famiglia umana raggiunta dal Vangelo. È questa universale platea in ascolto che deve poter ricevere parole di verità. La verità non abita soltanto i dogmi della fede, ma tutta la storia degli uomini, e soprattutto quella in cui agiscono i credenti e i loro pastori. Se avessimo forte il sentimento della coestensione di fede e storia, non avremmo cautele di riservatezza, quando non di segretezza rispetto a tante vicende interne alla grande casa comune. I rapporti tra le persone non si sottraggono alla legittima diversità di convinzioni e di scelte dinanzi a modi di adempimento dei rispettivi compiti, ma perché lasciare che di queste diversità si parli come di contrasti, rivalità, conflitti?
Non sarebbe più conforme alla sincerità evangelica dichiarare le ragioni di una linea piuttosto che di un’altra? Spesso la discrezione crea un cono d’ombra, in cui solo interessate fantasie intravedono contese inesistenti. Opporre ad esempio Segreteria di Stato e Conferenza episcopale italiana, per chi conosce i loro massimi responsabili, è ignorare la loro fedeltà al Papa, da cui ripetono le rispettive missioni. È possibile che a livelli minori si sottolineino peculiarità di comportamenti che si giustificherebbero se ne fossero conosciute le cause e le finalità. È un costume che va mutato, oltre le tradizioni, che il Concilio Vaticano II avrebbe dovuto lasciare alle sue spalle? La Chiesa deve essere sempre riformata. Ma i riformatori devono non solo guardare ai suoi dogmi e alle sue leggi, ma ai propri cuori, che abbiano sentimenti quali li rivelò e insegnò il Signore. E questo vale per i pastori e per ogni umile e anonimo credente. Perché la Chiesa è una comunione di spiriti senza distinzione di gradi.
Anzi, quelli più alti debbono servire gli ultimi. E tanto maggiore sarà la loro responsabilità quanto più gli ultimi saranno da essi confusi e turbati. È auspicabile che la verità si stia facendo strada in queste ore su tutti i due versanti, distinti e distanti, delle notizie sullo Ior e sul cameriere del Papa.
Farà bene alla Chiesa e alla cattolicità universale. Ma farà bene anche alla società italiana e a qualunque società civile. Il marcio in Danimarca denunciato dall’Amleto di Shakespeare manda in putrefazione il mondo. Dovunque misteri taciuti, contro cui lottano gli Stati, i loro apparati, i cittadini onesti. Un esempio alto, di una comunità di fede che da sempre e in tutto si affida alla verità, può giovare a quel mondo, che dimentica il suo marciume quando può indirizzare il giudizio moralistico fuori e altrove.
La Chiesa dimostri di essere nel mondo ma di non appartenervi, specie rifiutando i suoi principi ipocriti. Una vicenda amara, se vissuta nella fierezza della verità, può essere esemplare anche per chi è fuori della Chiesa. E la Chiesa continuerà la missione di convertire il mondo se saprà confessare sviamenti ed errori con una coscienza più esigente di qualunque giustizia umana.
I fatti, i nudi e veri fatti, San Raffaele, lo Ior, la legge della trasparenza nella gestione bancaria, i comportamenti degli amministratori, da una parte, e da un’altra, ripetiamo distinta e distante, i documenti sulle divisioni tra le gerarchie, le infedeltà nell’appartamento stesso del Pontefice, lasciamoli a chi ha il dovere e la competenza per accertarli. Non facciamone materia di emozioni e di insinuazioni. Senza cessare di attendere, anche a nostra edificazione, il racconto della verità
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- UN DISORDINE SISTEMICO. Mai lo smarrimento era arrivato a questi livelli nella Chiesa cattolica (di Alberto Melloni)).26 maggio 2012, di Federico La Sala
Strategia della tensione in Vaticano. Tocca ai vescovi reagire
I timori della Chiesa nella partita nascosta (e appena iniziata)
Mai lo smarrimento era arrivato a questi livelli nella Chiesa cattolica. Ma stavolta c’è qualcosa di più: il senso di un disordine sistemico.
di Alberto Melloni (Corriere della Sera, 26.05.2012)
Mai lo smarrimento era arrivato a questi livelli nella Chiesa cattolica. Certo nel Novecento non erano mancate lotte di potere condotte senza esclusione di colpi. Dal veto dell’imperatore d’Austria nel 1903 contro l’elezione al papato del cardinal Rampolla a quel novembre 1962 nel quale il Sant’Ufficio passò a Indro Montanelli accuse di modernismo per macchiare la giovinezza di Giovanni XXIII, dalla cacciata di Montini da Roma orchestrata dalla corte pacelliana nel 1954 alla lotta del torrido conclave del 1978 che convinse tutti a votare il Papa straniero, su su fino alla vicenda dell’Ambrosiano e di Marcinkus, nella quale toccò a un cattolico pulito come Nino Andreatta salvare la Chiesa dalle sue sozzure.
Ma stavolta c’è qualcosa di più. Ed è il senso di un disordine sistemico: la sensazione che ci sia ancora altro che debba deflagrare in tutta la sua catastroficità. Quelle che ci sono state negli ultimi anni, negli ultimi mesi e negli ultimi giorni non sono state solo fughe di notizie e non si possono rubricare come tradimenti. Sono pezzi di una strategia della tensione. Un’orgia di vendette e di vendette preventive che è ormai sfuggita di mano a chi s’illudeva di orchestrarla o di giovarsene. L’origine di tutto ciò non è misteriosa ed è - il Papa lo sa - tutta italiana. Per anni s’è pensato che alla Chiesa non servisse il confronto libero e duro delle idee (si vedano i duelli Kasper-Ratzinger, per dire): ma che invece le giovasse un meccanismo denigratorio fatto di blog, di corsivi, di aggettivi allusivi coi quali colpire nella fedeltà alla Chiesa e al Papa altri cattolici - se mai recuperando qualche documentino, gratis o a pagamento. Questa tela di illazioni, pettegolezzi e calunnie ha prodotto liste di proscrizione recepite da autorità sempre più anemiche, ha legittimato ai massimi livelli un para-magistero fatto di risentimenti oltraggiosi (come quelli sparati dal sito dell’Espresso sull’invulnerabile priore di Bose, Enzo Bianchi) e ha alimentato la bacata morale dell’anonimato (come quella in cui finì il mandato di Boffo al Toniolo). Da qui ai dossier completi, come quello stampato in «Vaticano spa», il passo è stato breve: e poi è venuto tutto il resto, con una sequenza di colpi e contraccolpi sempre più desolanti.
È evidente che la Chiesa cattolica (e non solo lei) ha patito del calo del livello intellettuale delle classi dirigenti che chiamiamo crisi: ma forse la Chiesa ne porta perfino qualche responsabilità. Lungo gli anni tremendi fra il 1914 e il 1945 (all’Est fino al 1989), la congiuntura politica o l’ingenua attesa di una cristianità restaurata hanno spinto la Chiesa a confidare in un lavoro di formazione intensa delle coscienze. Un capitale umano senza pari, fabbricato nelle canoniche e sulle riviste, è stato immesso senza troppe distinzioni dentro culture intransigenti, clericali, democratiche, confessionali, progressiste. Una riserva talora minoritaria (si pensi alle correnti Dc), ma sufficiente a tenere in equilibrio le cose o addirittura a sanarle con la propria limpidità interiore.
Negli ultimi trent’anni, invece, s’è vissuto consumando quel capitale: lo si è speso per coprire politiche «contestuali» o per illudersi che giocare a scacchi col potere rendesse potenti. E quando tutto era ormai consumato è arrivato Benedetto XVI: la cui distanza ontologica da questi modi d’essere ha finito paradossalmente per agevolarli. E il mood conservatore del suo pontificato ha finito per eccitare quei suoi sostenitori reazionari delusi dal suo stile. La durezza dei passaggi di questi due giorni - Gotti Tedeschi ha avuto un trattamento peggiore di Marcinkus, il maggiordomo del Papa è stato preso come Agca - potrebbe dunque essere il segnale che l’investigazione tanto attesa s’è avviata o sviata, che voleranno stracci di diversi colori, che la «gente attuffata in uno sterco che da li uman privadi parea mosso» dovrà cambiar lavoro.
Ma è certo che se non ci sarà una reazione spirituale il disastro sarà completo: anziché giocare all’amletico gioco dell’anno (crescita o rigore?) i vescovi su questo dovrebbero concentrarsi. Ne ha bisogno la Chiesa, se ne gioverebbe l’Europa.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. AL GOVERNO DELLA CHIESA --- Diffusione carte segrete, ’corvo’ è il maggiordomo del Papa. Paolo Gabriele si trova ora in stato di arresto.(di Fausto Gsparroni)26 maggio 2012
 Diffusione carte segrete, ’corvo’ è il maggiordomo del Papa
Diffusione carte segrete, ’corvo’ è il maggiordomo del Papa
 Paolo Gabriele si trova ora in stato di arresto. Fonte vicina al Pontefice: ’E’ rattristato e colpito’
Paolo Gabriele si trova ora in stato di arresto. Fonte vicina al Pontefice: ’E’ rattristato e colpito’(di Fausto Gasparroni) *
L’indagine aperta in Vaticano contro le fughe di documenti conosce sviluppi clamorosi, e porta direttamente nell’appartamento del Papa. E’ stato infatti messo in stato di arresto, perché trovato "in possesso illecito di documenti riservati", niente meno che "l’aiutante di camera" di Benedetto XVI, il maggiordomo del Papa, in assoluto una delle figure più vicine al Pontefice insieme ai segretari personali. Paolo Gabriele - questo il suo nome - è sospettato di essere uno dei "corvi", coloro che hanno portato all’esterno carte segrete del Vaticano e persino lettere private di papa Ratzinger. Informato dell’arresto dell’aiutante di camera, Benedetto XVI é rimasto particolarmente "addolorato", ha detto all’ANSA una fonte vicina al Papa, sottolineando come "si tratti di vicende dolorose" e come il Pontefice, "consapevole della situazione" mostri "partecipazione" e sia "rattristato e colpito".
Paolo Gabriele, soprannominato "Paoletto", romano, 46 anni, sposato con tre figli, è l’aiutante di camera di Benedetto XVI dal 2006, quando ha preso il posto dello "storico" maggiordomo di Giovanni Paolo II, Angelo Gugel. E’ entrato a far parte del ristrettissimo cerchio della "famiglia pontificia", dopo essere stato a servizio dal prefetto della Casa pontificia, monsignor James Harvey. Ieri pomeriggio Gabriele è stato prima fermato dagli agenti della Gendarmeria, al comando dell’ispettore generale Domenico Giani, per il possesso del materiale riservato e quindi interrogato stamane dal promotore di giustizia, Nicola Picardi, il pm del Vaticano, che lo fatto porre agli arresti.
L’uomo è trattenuto in stato di detenzione e sorvegliato e "si trova ora - ha spiegato il portavoce vaticano padre Federico Lombardi - a disposizione della magistratura vaticana per ulteriori approfondimenti". La Gendarmeria, nei suoi accertamenti, ha seguito anche le indicazioni della Commissione cardinalizia d’inchiesta nominata dal Benedetto XVI per indagare sui cosiddetti ’Vatileaks’ degli ultimi mesi, guidata dal cardinale Julian Herranz e composta dagli altri porporati Jozef Tomko e Salvatore De Giorgi. In Vaticano, comunque, circolano già dubbi sulla possibilità che Gabriele sia effettivamente il "corvo". E in ogni caso ciò che si presume è che eventualmente non sia il solo. Si fa fatica a pensare, comunque, che nella città leonina si sia voluto sacrificare come semplice "capro espiatorio" una persona così vicina al Papa, l’uomo, per dire, che gli serve il pranzo a tavola o gli prepara il letto la sera.
Già ieri, quando il ’board’ dello Ior ha sfiduciato il presidente Ettore Gotti Tedeschi, uno degli addebiti che gli venivano mossi, oltre alle carenze nella governance dell’Istituto, era di aver fatto filtrare all’esterno informazioni riservate del Vaticano. Sono due, quindi, i laici finora chiamati in causa per le fughe di notizie vaticane. Tuttavia anche su una ipotetica responsabilità dell’ormai ex presidente dello Ior circola più di un dubbio Oltretevere. Una fonte ben informata addirittura tratteggia in uno scontro tra Gotti Tedeschi e il direttore dello Ior, Paolo Cipriani, l’origine di possibili fughe di notizie. Il ’giallo’, insomma, assume sempre più contorni di una vicenda senza precedenti.
E le teste, anche qui con modalità e tempi mai visti, sono cominciate a cadere. Le indagini, inoltre, vanno avanti alla ricerca di altri presunti responsabili. Dopo mesi di stillicidio dei ’Vatileaks’, di "veleni", di sotterranei scontri di potere, il giro di vite sui presunti "corvi" ha avuto una stretta improvvisa negli ultimi giorni dopo la pubblicazione del libro di Gianluigi Nuzzi "Sua Santità", che contiene una mole di documenti riservati e carte private del Papa, su vicende di cui si è molto discusso, dal caso Boffo al caso Viganò, dalle polemiche sull’Ici e la Chiesa (ci sono carte sui contatti tra lo stesso Gotti Tedeschi e il ministro Tremonti sull’argomento) e sulle leggi italiane che il Vaticano avrebbe voluto fossero cambiate, in particolare su temi etici (se ne parla nella nota che il "ministro degli esteri" mons. Dominique Mamberti stilò in occasione di una cena tra il Papa e il presidente Napolitano).
Oltre all’indagine interna condotta dalla Gendarmeria e supervisionata dalla Commissione cardinalizia, la Santa Sede ha annunciato che ricorrerà alla giustizia contro il furto, la ricettazione e la divulgazione di "notizie segrete", descrivendo la pubblicazione dei documenti come "un atto criminoso". Per questo chiederà anche la "collaborazione internazionale". Intanto, sullo scenario delle manovre di Curia dipinto dalla pubblicazione dei documenti top secret trapela anche un commento dello stesso Benedetto XVI in un colloquio di due giorni fa in Vaticano: "’’Gli italiani, conosciamo gli italiani. Perché disturbare il Papa con queste cose di italiani?", riferendosi naturalmente ai porporati italiani apparentemente implicati.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- Vaticano: "Individuato il ’corvo’ Si trova in stato d’arresto". L’uomo, di cui non vengono fornite le generalità, è ora a disposizione del promotore di giustizia vaticano.25 maggio 2012
IL CASO
 Vaticano: "Individuato il ’corvo’
Vaticano: "Individuato il ’corvo’
 Si trova in stato d’arresto"
Si trova in stato d’arresto"Il portavoce vaticano: "Gendarmeria ha individuato persona in possesso illecito di documenti riservati che ora è a disposizione della magistratura vaticana". Voci vicine alla Santa Sede confermano che si tratta di Paolo Gabriele, "aiutante di camera" della famiglia pontificia *
CITTA’ DEL VATICANO - È in stato di arresto l’uomo operante in Vaticano individuato dalla Gendarmeria come in possesso di documenti riservati. L’uomo, di cui non vengono fornite le generalità, è ora a disposizione del promotore di giustizia vaticano, Nicola Picardi. Lo ha reso noto il vice direttore della Sala Stampa della Santa Sede, padre Ciro Bendettini. Era stato padre Federico Lombardi ad annunciare che l’indagine della Gendarmeria vaticana sulla diffusione di documenti segreti "ha permesso di individuare una persona in possesso illecito di documenti riservati".
Secondo Il Foglio, il sospettato a disposizione dei magistrati vaticani sarebbe Paolo Gabriele, "aiutante di camera" della famiglia pontificia. Questa l’indicazione che sarebbe arrivata dalla Curia. Ma secondo alcune fonti in Vaticano si tratta di una pista inverosimile: l’uomo viene descritto come assolutamente devoto e affezionato al Papa. Padre Ciro Bendettini non ha voluto confermare che il nome del fermato è quello che circola, ma fonti ben informate confermano che il presunto corvo individuato è proprio Paolo Gabriele. Questa mattina Gabriele è stato ascoltato in un interrogatorio da Nicola Picardi.
Il giorno dopo la decisione del Consiglio di sovrintendenza dello Ior di sfiduciare il presidente della Banca della Santa Sede, Ettore Gotti Tedeschi, 1 con l’accusa di non aver svolto funzioni di primaria importanza per il suo ufficio, Lombardi, in evidente riferimento a ’Vatileaks’ e al libro di Gianluigi Nuzzi ’Sua Santità’, ha annunciato: "Questa persona - ha aggiunto il gesuita - si trova ora a disposizione della magistratura vaticana per ulteriori approfondimenti". Ieri peraltro, sempre da ambienti vaticani, era filtrata anche l’ipotesi che il ’corvo’ fosse proprio Gotti Tedeschi.
Le indagini della Gendarmeria vaticana, ha precisato il portavoce della Santa Sede, padre Federico Lombardi, sono state svolte "secondo istruzioni ricevute dalla Commissione cardinalizia e sotto la direzione del promotore di Giustizia". La Commissione cardinalizia è composta dai cardinali julian Herranz, Josef Tomko e Salvatore de Giorgi.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- LA RICETTA del Conte zio poteva forse andar bene ai tempi del Manzoni (di Marco Lillo - Sopire, troncare e denunciare)22 maggio 2012
Sopire, troncare e denunciare
di Marco Lillo (il Fatto, 22.05.2012)
"Veda vostra paternità; son cose, come io le dicevo, da finirsi tra di noi, da seppellirsi qui, cose che a rimestarle troppo... si fa peggio”. Il Conte zio di manzoniana memoria, ha ispirato la Santa Sede nella sua reazione alla pubblicazione di documenti inediti da parte del Fatto Quotidiano e del libro Sua Santità di Gianluigi Nuzzi. Certe cose, spiegava il Conte zio al Padre provinciale, vanno seppellite ed è stato esattamente quello che la Santa Sede, sotto la guida del Segretario di Stato Tarcisio Bertone, ha deciso di fare con gli scandali documentati articolo dopo articolo, documento su documento, su queste pagine negli ultimi mesi.
Il mestiere del giornalista è evidentemente diverso da quello del cardinale e forse non si può pretendere che in Curia si osservino le regole di trasparenza e responsabilità che vigono nelle società democratiche. Eppure, la reazione delle gerarchie ecclesiastiche di fronte ai fatti gravi che siamo riusciti a documentare è davvero inadeguata.
LA RICETTA del Conte zio poteva forse andar bene ai tempi del Manzoni, ma non è più sostenibile nell’era della comunicazione globale. Proviamo a ricapitolare: sul Fatto Quotidiano abbiamo pubblicato per la prima volta i seguenti documenti:
 1) la nota in tedesco sulle presunte rivelazioni dell’arcivescovo di Palermo, Paolo Romeo, consegnata dal cardinale colombiano Dario Castrillon Hoyos al segretario del Papa (vedi Il Fatto del 10 febbraio 2012) nella quale veniva ipotizzato un complotto omicidiario ai danni di Ratzinger;
1) la nota in tedesco sulle presunte rivelazioni dell’arcivescovo di Palermo, Paolo Romeo, consegnata dal cardinale colombiano Dario Castrillon Hoyos al segretario del Papa (vedi Il Fatto del 10 febbraio 2012) nella quale veniva ipotizzato un complotto omicidiario ai danni di Ratzinger;
 2) la lettera (vedi Il Fatto del 27 gennaio 2012) nella quale l’ex segretario del Governatorato, monsignor Carlo Maria Viganò, denunciava furti nelle ville pontificie coperti dal direttore dei Musei Vaticani, monsignor Paolo Nicolini. E poi fatture contraffatte all’Università Lateranense a conoscenza addirittura dell’arcivescovo Rino Fisichella;
2) la lettera (vedi Il Fatto del 27 gennaio 2012) nella quale l’ex segretario del Governatorato, monsignor Carlo Maria Viganò, denunciava furti nelle ville pontificie coperti dal direttore dei Musei Vaticani, monsignor Paolo Nicolini. E poi fatture contraffatte all’Università Lateranense a conoscenza addirittura dell’arcivescovo Rino Fisichella;
 3) la lettera di fuoco sulla lotta per la poltrona dell’Istituto Toniolo di Milano, nella quale il cardinale Dionigi Tettamanzi veniva sfrattato da Bertone con un ultimatum che sarebbe stato benedetto, a suo dire, dal Papa. Lettera seguita da una replica di fuoco al Papa di Tettamanzi;
3) la lettera di fuoco sulla lotta per la poltrona dell’Istituto Toniolo di Milano, nella quale il cardinale Dionigi Tettamanzi veniva sfrattato da Bertone con un ultimatum che sarebbe stato benedetto, a suo dire, dal Papa. Lettera seguita da una replica di fuoco al Papa di Tettamanzi;
 4) la raccomandazione del capo di Comunione e Liberazione don Julian Carrón (vedi Il Fatto del 5 maggio 2012) a favore del cardinale ciellino Angelo Scola per sponsorizzare la sua nomina ad arcivescovo di Milano anche per la vicinanza al centro-destra. Lettera seguita da quella in cui Bertone garantisce la presenza del Papa al meeting di CL a Rimini;
4) la raccomandazione del capo di Comunione e Liberazione don Julian Carrón (vedi Il Fatto del 5 maggio 2012) a favore del cardinale ciellino Angelo Scola per sponsorizzare la sua nomina ad arcivescovo di Milano anche per la vicinanza al centro-destra. Lettera seguita da quella in cui Bertone garantisce la presenza del Papa al meeting di CL a Rimini;
 5) le mail del cardinale Attilio Nicora, presidente dell’AIF, l’autorità anti-riciclaggio vaticana, nella quale si descriveva il dietrofront del Vaticano sulla legge anti-riciclaggio;
5) le mail del cardinale Attilio Nicora, presidente dell’AIF, l’autorità anti-riciclaggio vaticana, nella quale si descriveva il dietrofront del Vaticano sulla legge anti-riciclaggio;
 6) il memo concordato dal presidente dello Ior Ettore Gotti Tedeschi con il ministro di allora, Giulio Tremonti, per attutire gli effetti sulle casse vaticane dell’offensiva europea per abolire le agevolazioni Ici (Il Fatto del 20 febbraio 2012) ;
6) il memo concordato dal presidente dello Ior Ettore Gotti Tedeschi con il ministro di allora, Giulio Tremonti, per attutire gli effetti sulle casse vaticane dell’offensiva europea per abolire le agevolazioni Ici (Il Fatto del 20 febbraio 2012) ;
 7) la lettera dell’ex direttore dell’Avvenire Dino Boffo al presidente della Cei Angelo Bagnasco nella quale l’ex direttore dell’Avvenire minacciava di rivelare il ruolo svolto dal direttore dell’Osservatore Romano Gian Maria Vian nella pubblicazione degli articoli diffamatori sulla presunta omosessualità di Boffo da parte del Giornale di Feltri.
7) la lettera dell’ex direttore dell’Avvenire Dino Boffo al presidente della Cei Angelo Bagnasco nella quale l’ex direttore dell’Avvenire minacciava di rivelare il ruolo svolto dal direttore dell’Osservatore Romano Gian Maria Vian nella pubblicazione degli articoli diffamatori sulla presunta omosessualità di Boffo da parte del Giornale di Feltri.Questi documenti sono riproposti con l’aggiunta di altre carte riservate nel libro di Gianluigi Nuzzi, la cui pubblicazione da parte di Chiarelettere, ha indotto la Santa Sede a emanare un comunicato nel quale si annuncia una denuncia penale: “La nuova pubblicazione di documenti della Santa Sede e di documenti privati del Santo Padre non si presenta più come una discutibile e obiettivamente diffamatoria iniziativa giornalistica, ma assume chiaramente i caratteri di un atto criminoso”.
IL VATICANO nel suo comunicato non esclude persino il ricorso alla “cooperazione internazionale”. A prima vista l’inchiesta della gendarmeria vaticana e forse, mediante la “cooperazione internazionale” anche della Polizia italiana per perseguire i giornalisti e le loro fonti potrebbe sembrare eccessiva. In realtà è la necessaria e logica conseguenza della scelta della Santa Sede di lasciare le cose come stanno.
Quando Dino Boffo accusa Gian Maria Vian di avere passato al Giornale la velina falsa contro di lui, quando il segretario del Governatorato accusa il direttore dei Musei Vaticani di coprire i ladri, quando il presidente del Toniolo sospetta il segretario di Stato di millantare il mandato del Papa, non si può far finta di nulla. Oggi gli accusatori (Viganò e Boffo) dopo avere scritto cose gravissime su Vian e monsignor Nicolini, sono stati promossi rispettivamente nunzio a New York e direttore della tv del Vaticano. Gli accusati sono al loro posto, come l’arcivescovo Romeo. Per il Vaticano, semplicemente, non è successo nulla, nonostante tutti i segreti siano stati svelati.
Ecco perché la denuncia è in fondo la logica conseguenza della politica dello struzzo. Il Conte zio poteva permettersi di suggerire: “Sopire, troncare, padre molto reverendo: troncare, sopire”. Ma allora nessuno pubblicava le lettere del padre provinciale. Ora che invece tutto è uscito alla luce del sole, grazie anche al Fatto, il Vaticano, è stato costretto ad aggiornare la strategia: “Sopire troncare e denunciare”.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- CASO ORLANDI. Per la scomparsa di Emanuela c’è un quinto inquisito: don Piero Vergari, ai tempi del rapimento rettore della basilica dove fu sepolto il boss De Pedis. E dove la ragazza fu vista per l’ultima volta (di Rita Di Giovacchino)19 maggio 2012, di Federico La Sala
 Orlandi: indagato per sequestro il prete di Sant’Apollinare
Orlandi: indagato per sequestro il prete di Sant’Apollinare
 Per la scomparsa di Emanuela c’è un quinto inquisito: don Piero Vergari, ai tempi del rapimento rettore della basilica dove fu sepolto il boss De Pedis. E dove la ragazza fu vista per l’ultima volta
Per la scomparsa di Emanuela c’è un quinto inquisito: don Piero Vergari, ai tempi del rapimento rettore della basilica dove fu sepolto il boss De Pedis. E dove la ragazza fu vista per l’ultima voltadi Rita Di Giovacchino (il Fatto, 19.05.2012)
Per la scomparsa di Emanuela Orlandi c’è ora un quinto indagato. Un prete, l’unico in grado di chiudere il cerchio di un’inchiesta “corsara” che indaga sul mistero della tomba di Renatino De Pedis nella cripta di Sant’Apollinare. Sotto la riga blu, che copre l’omissis, c’è il nome di don Piero Vergari, in quegli anni rettore della basilica minore, dal 1992 passata all’Opus Dei, all’epoca dipendente dal Vicariato di Roma e cioè dal cardinale Ugo Poletti.
Atto dovuto, liquida rapidamente la “fonte”. Ma, la recente iscrizione del parroco, precede di pochi giorni la decisione della Procura di Roma di varcare la soglia del sagrato, tra piazza Navona e il Senato, scendere nei sotterranei inviolati e aprire quel sarcofago tempestato di zaffiri attorno al quale, in un delirio di curiosità e legittimi interrogativi, è andata crescendo la convinzione che soltanto lì è racchiusa la verità. Non soltanto sulla scomparsa di Emanuela, ma su inaccessibili segreti vaticani a fronte dei quali gli intrighi romanzeschi di Dan Brown impallidiscono.
Unico dato certo è che fu Vergari a sollecitare il trasferimento a Sant’Apollinare della salma di De Pedis, ucciso il 2 febbraio in via del Pellegrino, con una lettera al cardinal Poletti che vergò il nulla osta in tempi rapidissimi. I resti del boss, riemersi quasi intatti dall’umido abitacolo, sono lì dal 20 marzo 1990. Ma Sant’Apollinare è anche la chiesa dove per l’ultima volta fu vista Emanuela, il 22 giugno 1983, prima che sparisse nel nulla. “Quell’indegna sepoltura rappresenta lo snodo del patto tra Stato, Chiesa e criminalità”, ha detto lunedì scorso Pietro Orlandi, sul piazzale della chiesa dove è tornato dopo 29 anni per assistere alla riapertura della tomba. Da anni il procuratore aggiunto Giancarlo Capaldo e il pm Simona Maisto indagano su una strana pista che lega la scomparsa della ragazzina a un “ricatto” nei confronti di Wojtyla.
MAFIA e malavita romana beffati dal Vaticano e pronti a tutto per rientrare di 250 miliardi di vecchie lire che i boss avevano riciclato nelle casse dello Ior. Soldi che il papa avrebbe utilizzato per finanziare Solidarnosc, il sindacato polacco di Walesa. Atto dovuto l’iscrizione di don Vergari, ma conferma della pista Ior. A indicarla era stata nel 2009 Sabrina Minardi, l’ex amante di Rena-tino. “La ragazza è morta, ho visto Sergio gettare due sacchi nella betoniera in un cantiere a Torvaianica... quando siamo tornati a casa gli ho chiesto chi era. Che te lo devo dì io, mi rispose”.
Quello di Emanuela era un rapimento “indicato” da qualcuno molto in alto, dice la donna. Da chi?“ Da Marcinkus... doveva creare scalpore, come la morte di Calvi, così chi doveva capi’ capiva”. Frasi apparentemente sconclusionate, ma non del tutto: l’anno prima la mafia aveva ucciso Roberto Calvi. Ora gli imputati di quel processo sono stati tutti assolti, ma agli atti restano i legami incrociati tra siciliani e romani: Calò era amico di De Pedis, considerato “l’uomo del Vaticano” come l’augusta sepoltura conferma.
Ora non è più soltanto Sabrina ad affermare che Emanuela era stata rapita da De Pedis. Molti personaggi legati alla banda della Magliana lo hanno confermato: da Maurizio Abbatino, a Fabiola Moretti, fino a Nino Mancini, l’Accattone che nell’intervista di martedì scorso al Fatto Quotidiano ha detto: “Bisognava decidere se far ritrovare qualche cardinale in una pozza di sangue o mandare un segnale forte, abbiamo scelto la seconda strada”. Un segnale che Marcinkus deve aver recepito: forse il cardinale da far ritrovare “nella pozza di sangue” era lui. Anche Sabrina è indagata, ha ammesso di averla tenuto in ostaggio Emanuela in un appartamento a Torvaianica.
CON LEI ci sono altri tre pregiudicati iscritti con l’accusa di sequestro di persona aggravato dallo scopo di estorsione, dalla conseguente morte dell’ostaggio e dalla minore età della vittima. Tutti a piede libero, tranne Sergio Virtù, in carcere per altro reato, l’uomo che avrebbe occultato il cadavere a Torvaianica. L’uomo ha sempre negato, ma ad accusarlo c’è anche la testimonianza di una donna polacca un tempo legata a lui. Ci sono poi due fedelissimi di De Pedis, Ci-letto e Giggetto, alias Angelo Cassani e Gianfranco Cerboni. Sospettato di aver avuto un ruolo marginale è anche Giuseppe De Tomasi, l’ex commercialista di Renatino che ha aggredito Federica Sciarelli, nell’ultima punta di Chi l’ha visto. Una perizia afferma che sarebbe Mario “il barista”, il telefonista anonimo. Se non fosse morto nel 2006 la Procura di Roma avrebbe iscritto anche Marcinkus per concorso in sequestro? Sospetto fondato, ma la prescrizione è dietro l’angolo. Il prossimo anno saranno 30 anni che Emanuela è scomparsa.
 L’incontro con De Pedis, l’amicizia e la sepoltura del boss
L’incontro con De Pedis, l’amicizia e la sepoltura del boss
 Il sacerdote è tornato a vivere nel suo paesino natale in Umbria
Il sacerdote è tornato a vivere nel suo paesino natale in Umbria
 La sua storia è parallela a quella del potente Marcinkus
La sua storia è parallela a quella del potente Marcinkus
 il Fatto 19.5.12
il Fatto 19.5.12Don Piero Vergari da anni è tornato a Sigillo, il paesino dell’Umbria che 72 anni fa gli diede i natali. Ogni tanto i giornalisti suonano alla sua porta per intervistarlo, ma lui si affaccia al balcone, saluta e lascia tutti a bocca asciutta. Un esilio che un po’ ricorda quello subito dal vescovo Marcinkus, tornato a Cicero nell’Illinois (che come tutti sanno è patria di Al Capone), nel 1989. Se non fosse per la scomparsa di Emanuela nulla legherebbe il destino di un vescovo che per 27 anni è stato tra gli uomini più potenti della Chiesa, che si muoveva come un capo di Stato o almeno come un ministro degli esteri, con quello di un umile parroco di cui mai avremmo sentito parlare se non fosse per questa strana storia della tomba di De Pedis.
A SEGNARE il suo destino, dicono, furono i primi anni Ottanta quando assisteva i detenuti nel carcere di Regina Coeli, in quegli anni affollato dai boss della Banda della Magliana. Lì conobbe Renatino e ne fu conquistato: “Parlavamo di cose religiose e di attualità”. Ma anche il boss lo amava. Tanto che nessuno sa dire se sia stato lui a introdurlo nelle sacrestie che contano e non invece sia stato De Pedis, importante crinale della “trattativa” tra Vaticano e boss, amico di tanti pezzi grossi della Santa Sede, a raccomandare il prete amico suo.
Nel 1989, proprio mentre Marcinkus lasciava la Roma che tanto amava a causa di quell’ordine di cattura spiccato dalla procura di Milano per il crac del banco Ambrosiano, don Vergari ormai rettore della basilica di Sant’Apollinare officiò le nozze di De Pedis con Carla Di Giovanni, ragazza seria e di buona famiglia. La pecorella smarrita era tornata all’ovile. Fu dopo, mentre si stappavano le bottiglie di champagne, che Renatino scherzando disse: “Quanno me tocca, me piacerebbe esse sepolto qui”. La profezia si avverò in tempi rapidi, appena tre mesi dopo in via del Pellegrino. Il resto è noto.
Quando lo scorso anno fu convocata in procura, Carla Di Giovanni diede questa spiegazione: “Mio marito era legato a quella chiesa, lì andavamo a messa la domenica e lì ci siamo sposati, so che aveva fatto offerte importanti a don Vergari, io stessa consegnai nelle sue mani 500 milioni”. Il parroco confermò: “Era un gran benefattore, ha fatto tanto del bene a giovani e persone bisognose”.
GIULIO ANDREOTTI, chiamato in causa dalla Minardi per un paio di cene, commentò caustico: “Forse non era un benefattore dell’umanità, ma di Sant’Apollinare sì”. A guastare la festa c’è il fatto che Emanuela Orlandi frequentava quella chiesa, anzi la scuola di musica Tommaso Ludovica de Victoria, dove studiava flauto traverso. La scuola si trova all’interno dell’imponente complesso di Sant’Apollinare. Tre volte a settimana, dalle 15 alle 18, entrava in quel cortile, quella primavera era improvvisamente sbocciata, ormai era un’adolescente e non passava inosservata.
Potevano rapirla ovunque, invece l’hanno rapita lì. Inutile girarci intorno, la famiglia sospetta l’esistenza di un basista. “Mia sorella è stata rapita soltanto perché era una cittadina vaticana”, ribadisce il fratello Pietro. Il segnale forte, di cui parla l’Accattone è passato sulla sua testa. Don Vergari è indagato anche se, quando i magistrati sono scesi nella Cripta, non era lì ad aprire la porta. Ma nel 1983 era lui il padrone di casa. Atto dovuto. Il nuovo rettore è don Pedro Huidobro, dell’Opus Dei, che per uno strano segno del destino è medico patologo e in questa veste ha assistito ai passaggi più delicati della riesumazione della salma. “Noi ci auguriamo che l’apertura della tomba aiuti a far ritrovare serenità e rispetto nei confronti di un luogo sacro, da parte nostra la collaborazione con le autorità competenti è totale”. A San-t’Apollinare si volta pagina, qualcuno dice: solo perché non è più la Curia romana a comandare in queste mura.
 Rdg
Rdg
Il caso gemello di Mirella Gregori sparita 47 giorni prima
 il Fatto, 19.05.2012
il Fatto, 19.05.2012Emanuela Orlandi, cittadina vaticana, figlia di un commesso della Prefettura della Casa Pontificia scompare il 22 giugno 1983 all’età di 15 anni. Alla sparizione di Emanuela fu collegata anche quella di un’altra adolescente romana, Mirella Gregori, scomparsa il 7 maggio 1983. La vicenda della Gregori viene collegata a Emanuela quando la madre di Mirella riconosce i volti di due uomini collegati all’Orlandi, mostrati negli identikit. Dopo 29 anni dalla scomparsa della Orlandi, la vicenda è ancora aperta. Dal 1983 ad oggi moltissime piste sono state seguite: dalle telefonate dell’Amerikano, secondo alcuni Paul Markinus, presidente dello Ior, che tiravano in ballo Ali Agca, l’uomo che un paio d’anni prima aveva sparato a Papa Giovanni II, fino alla banda della Magliana. Pista seguita dopo la telefonata anonima che suggeriva di controllare chi fosse sepolto nella chiesa di Sant’Apollinare, ovvero Enrico De Pedis, uno dei capi della banda.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- CASO ORLANDI. Padre Amorth: “Orlandi, fu un delitto a sfondo sessuale” Il capo degli escorcisti: “Attirata in una trappola” (di Giacomo Galeazzi)22 maggio 2012
 Padre Amorth: “Orlandi, fu un delitto a sfondo sessuale”
Padre Amorth: “Orlandi, fu un delitto a sfondo sessuale”
 Il capo degli escorcisti: “Attirata in una trappola”
Il capo degli escorcisti: “Attirata in una trappola” «Coinvolto anche personale di un’ambasciata straniera presso la Santa Sede»
«Coinvolto anche personale di un’ambasciata straniera presso la Santa Sede»
 «Anche un archivista del Vaticano parla di un reclutatore di ragazze»
«Anche un archivista del Vaticano parla di un reclutatore di ragazze»di Giacomo Galeazzi (La Stampa, 22.05.2012)
CITTÀ DEL VATICANO «E’ un delitto a sfondo sessuale», sostiene il capo mondiale degli esorcisti, padre Gabriele Amorth. L’anziano sacerdote, molto stimato da Benedetto XVI, rivela a La Stampa una pista interna per la scomparsa nel 1983 della cittadina vaticana davanti alla chiesa di Sant’Apollinare, da poco riferita riservatamente ai familiari della ragazza.
«Come dichiarato anche da monsignor Simeone Duca, archivista vaticano, venivano organizzati festini nei quali era coinvolto come “reclutatore di ragazze” anche un gendarme della Santa Sede. Ritengo che Emanuela sia finita vittima di quel giro - spiega padre Amorth - Non ho mai creduto alla pista internazionale, ho motivo di credere che si sia trattato di un caso di sfruttamento sessuale con conseguente omicidio poco dopo la scomparsa e occultamento del cadavere». E ancora: «Nel giro era coinvolto anche personale diplomatico di un’ambasciata straniera presso la Santa Sede».
Una testimonianza che padre Amorth ha reso pubblica ora nel suo libro «L’ultimo esorcista» e che presenta tratti in comune con la lettera anonima arrivata alla madre di Emanuela Orlandi nella quale si riferisce di una trappola nella quale fu attirata la quindicenne nella sacrestia di Sant’Apollinare. Monsignor Pietro Vergari, parroco della basilica negli Anni 80, continua a protestare la sua estraneità ai fatti («Sono tranquillo, non ho nulla da nascondere»), ma è considerato dagli inquirenti un elemento centrale nella sparizione. «Nell’ispezione nella cripta non hanno trovatonulla se non appunto il corpo di De Pedis - afferma don Vergari -. Tutte quelle ossa ritrovate non sono altro che ossa antichissime, risalenti a secoli fa quando anche i laici venivano sepolti nelle chiese. Ora dicono che faranno indagini approfondite ma non vedo proprio che cosa possano trovare».
Il prelato è finito nel registro degli indagati della procura di Roma, per concorso nel sequestro della ragazza, in concomitanza di una perquisizione presso il suo domicilio nel corso della quale è stato sequestrato un computer. Vergari, già sentito nel 2009 come testimone a proposito del seppellimento del capo della banda della Magliana, De Pedis nella cripta di Sant’Apollinare, sarà presto convocato in procura per essere interrogato, questa volta nella veste di indagato, dai pm Capaldo Maisto. Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, ricorda che suor Dolores, la direttrice della scuola di musica frequentata dalla sorella nel palazzo di Sant’Apollinare, raccomandava alle studentesse di stare alla larga dal rettore della basilica.
Nell’inchiesta sulla scomparsa della figlia di un commesso pontificio, un gendarme vaticano è stato sentito in procura come persona informata dei fatti, mentre su una decina di ossa ritrovate a Sant’Apollinare sarà effettuato il test del Dna per compararlo con quelli della Orlandi e di Mirella Gregori, l’altra ragazza scomparsa 29 anni fa a Roma. I resti saranno analizzati a Milano dagli esperti del Labanof, il Laboratorio di antropologia e odontologia forense. Il coinvolgimento di don Vergari apre scenari inquietanti.
Osserva Pietro Orlandi: «Emanuela scomparve alla sette di sera. Mai sarebbe salita su una macchina con un sconosciuto. Se l’avessero presa con la forza, a quell’ora in pieno centro qualcuno se ne sarebbe accorto. L’ipotesi della basilica ha un senso. Se a Emanuela qualcuno avesse detto di seguirlo a Sant’Apollinare non si sarebbe insospettita. Un luogo sacro non dovrebbe spaventare nessuno». Dunque potrebbe essere caduta in un tranello teso da qualcuno che era in rapporti con l’allora rettore della basilica.
«Che a Sant’Apollinare ci fossero giri strani e gravitasse un pezzo di malavita romana, non solo De Pedis con cui don Vergari era in confidenza, è purtroppo qualcosa di risaputo», precisa Pietro Orlandi: «Le amiche della scuola di musica di Emanuela mi dissero che suor Dolores, la direttrice, non le faceva andare a messa o cantare nel coro a Sant’Apollinare ma preferiva che andassero in altre chiese proprio perché diffidava, aveva una brutta opinione di monsignor Vergari».
Per il momento gli indagati restano cinque: don Vergari, Angelo Cassani, Gianfranco Cerboni, Sergio Virtù e Sabrina Minardi.
-
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- Monti e Papa ad Arezzo : contestazioni in arrivo, contro il Caropapa e il Caromonti (di Franca Corradini)4 maggio 2012, di Federico La Sala
Monti e Papa ad Arezzo : contestazioni in arrivo.
Il Pontefice Ratzinger e il Premier Monti si troveranno ad Arezzo per una visita formale.
di Franca Corradini *
- Ad Arezzo il 13 Maggio 2012 ci sarà un SIT IN dalle 9 alle 21 in Piazza Zucchi. CONTRO..... il Caropapa e il Caromonti.
Per questa visita si stima (a parere di chi scrive in difetto.. ) un costo totale di :500.000 Euro dei cittadini italiani,di cui 120.000 dei cittadini della Regione Toscana e 90.000 dei cittadini di Arezzo. Un gruppo di cittadini si sta organizzando raccogliendo adesioni attraverso un appello di cui riportiamo una parte : "...siamo cittadini delle città di Arezzo e Firenze, studenti e lavoratori. Apprendiamo da poco tempo che il Pontefice Ratzinger e il Premier Monti si troveranno ad Arezzo per visite formali il 13 maggio p.v. Chiediamo la vostra partecipazione all’organizzazione di un presidio unitario di protesta contro le loro politiche e per una società più laica, giusta, civile e vivibile e per dimostrare che esiste un’Arezzo, una Toscana molto diversa da quanto vogliono farci credere che sia....".
In tempo di crisi economica questo spreco di denaro pubblico pare un’insulto ai giovani e non disoccupati, ai precari, ai tanti cassaintegrati che popolano la cittadina toscana.
* A SCUOLA DI BUGIE. Viaggio tra gli errori e gli orrori della scuola italiana, 3 maggio 2012
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- Gli enormi limiti di una transizione al dopo-Berlusconi affidata al neoliberismo più tedesco che americano di Monti (di Ida Dominjanni - Voto italiano, vento europeo. Fine di un’egemonia)9 maggio 2012, di Federico La Sala
Voto italiano, vento europeo. Fine di un’egemonia
di Ida Dominijanni (il manifesto, 9 maggio 2012)
Non archiviano solo il Pdl, le prime elezioni del dopo-Berlusconi, ma l’intero polo dell’allora "nuova" destra che Berlusconi mise al mondo nel ’94 e che ha tenuto il campo della politica italiana per quasi un ventennio. Già lesionato dalla separazione di Fini di due anni fa, quel polo è oggi palesemente in frantumi, colpito al cuore dell’asse Berlusconi-Bossi che ne è stato il nerbo. Non aiuta la comprensione di quello che sta accadendo riportare questo crollo solo alle cause scatenanti più recenti: come sempre, nel momento della fine conviene piuttosto allungare lo sguardo sull’inizio.
Sul crollo della destra incidono infatti di sicuro la fine della leadership di Berlusconi - certificata ormai da un lungo declino, iniziato alle Europee del 2009 e mai più arrestatosi - e la devastante sequenza dei cosiddetti "scandali" - dal sexgate al Belsito-gate -, potenti rivelatori del funzionamento di un sistema di potere ancor più che eloquenti spie di una "questione morale" delegittimante. Giova però ricordare, per spiegarne la tenuta prima e adesso il disfarsi, di quali ingredienti fosse fatta la creatura berlusconiana del ’94, una creatura tricipite che teneva insieme tre destre diverse fra loro: quella neoliberista di Forza Italia, quella comunitarista-xenofoba della Lega e quella statalista-sociale di An. Il "miracolo" del Cavaliere consistette precisamente nella capacità di unificare e cementificare sotto il proprio "carisma" queste tre anime diverse, talvolta perfino incompatibili, dando vita a un campo neolib-neocon più simile al suo omologo americano marcato Bush che alle destre europee. E consistette altresì nella capacità di incardinare su questa destra tricipite il bipolarismo della cosiddetta seconda repubblica, ridefinendo al contempo un’agenda di lotta e di governo tagliata sul blocco sociale e sugli interessi del Nord postfordista e "autoimprenditoriale", con il Sud "assistenzialista" in posizione periferica e ancillare.
Quel miracolo non è più ripetibile, e non solo perché è finita, o comunque sfinita, la leadership di Berlusconi senza la quale esso non si dà, ma perché la ricetta neolib-neocon che esso predicava non funziona (ammesso che abbia mai funzionato) e non seduce più. Il crollo, prima che politico, è di blocco sociale, nonché ideologico (al di là delle sue sopravvivenze residuali, paradossalmente più tenaci, a giudicare dal voto di domenica, al Sud che al Nord). Si tratta, in altri termini, della fine di una egemonia. Se e come una destra, e quale destra, riemergerà dalle macerie di questo blocco egemonico, ha probabilmente a che fare con la forma che prenderanno le sue tre componenti originarie. Ed è facile ipotizzare fin d’ora, dalle divisioni che le separano, che non si profila una loro ricomposizione bensì una loro scomposizione, dominata, più che dallo scenario nazionale, dall’evoluzione di quello europeo.
Qui entra in campo il secondo fattore decisivo del terremoto elettorale. Che non serve a nulla interpretare esclusivamente, o prevalentemente, nei termini triti dell’opposizione politica-antipolitica, rimuovendo il dato eclatante della contestazione antirigorista che dal voto (e dal non voto) emerge nettamente, in perfetta consonanza con i segnali che vengono dalla Francia e dalla Grecia. E qui si vedono anche gli enormi limiti di una transizione al dopo-Berlusconi tutta affidata alla sostituzione del neoliberismo più americano che europeo del Cavaliere con il neoliberismo più tedesco che americano di Monti.
Alla prima verifica elettorale, il risultato di questa transizione dall’alto è che alla sepoltura del ventennio del Cavaliere si somma la contestazione del governo dei tecnici e dell’Europa ostile e vessatoria che esso rappresenta. E questo mentre, crollato con la destra di Berlusconi il bipolarismo sperimentato fin qui, l’intero sistema politico deve ridefinirsi, e si sta già ridefinendo, in relazione al quadro europeo, alla crisi europea e alle politiche sociali europee. Non ne dipende infatti solo la configurazione che prenderà la destra, o le destre, orfana del Cavaliere, e allo stato prive di possibilità di riparo in un "terzo polo" che il voto di domenica ha dichiarato inesistente. Ne dipende altrettanto la configurazione che prenderà la sinistra, o le sinistre, nonché la curvatura che assumeranno i movimenti antisistema fin qui troppo genericamente etichettati come "antipolitici", e fin qui nella loro stessa autorappresentazione né di destra né di sinistra.
A proposito di questi ultimi, lo spettro europeo è assai vasto, va dalla sperimentazione delle pratiche di democrazia telematica dei "Pirati" tedeschi alla inquietante riesumazione del binomio socialnazista dell’"Alba dorata" greca, e oscilla dalla critica dell’Unione europea fin qui conosciuta al rifiuto tout court della costruzione europea. Sono movimenti che non garantiscono di per sé niente di buono, ma niente può piegarli al peggio quanto una pregiuziale sordità al disagio sociale di cui sono portatori.
Quanto ai destini della sinistra italiana, il voto francese, peraltro insistemente invocato dai suoi leader come condizione necessaria di un cambio di stagione su scala continentale, le indica limpidamente la strada. Non è affatto detto però che su quella strada essa possa portarsi l’appoggio al governo tecnico, né che basti mettere Monti nella posizione del mediatore fra Merkel e Hollande per far quadrare i conti dell’Euro e delle prossime elezioni politiche. Il Pd non è stato punito per le sue oscillazioni dal voto amministrativo, ma non è stato nemmeno granché premiato; e queste non sono circostanze in cui la rendita dell’ "unico partito che tiene" possa durare a lungo. Ci sono situazioni in cui i tempi stringono, e le oscillazioni non pagano. La nettezza, manda a dire il caso Hollande, paga di più.
La fine dell’egemonia neoliberista berlusconiana e il cambiamento del vento europeo domandano e comandano una manovra controegemonica in grande stile, di segno opposto all’introiezione temperata del rigore montiano. E la stessa contabilità del voto obbliga a distogliere finalmente lo sguardo da un centro desaparecido e a volgerlo con più convinzione verso sinistra. Diversamente, ci saranno nell’immediato una sinistra senza popolo e un populismo senza sinistra, e all’orizzonte più la disgregazione greca che l’alternativa francese.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- Monti e Papa ad Arezzo. Il Papa: l’Italia reagisca. Un governo tecnico in cerca di «supplementi d’anima» (di massimo Adinolfi)14 maggio 2012, di Federico La Sala
 Il Papa: l’Italia reagisca
Il Papa: l’Italia reagisca
 Un governo tecnico in cerca di «supplementi d’anima»
Un governo tecnico in cerca di «supplementi d’anima»di Massimo Adinolfi (l’Unità, 14.05.2012)
C’È UN PASSAGGIO, NELLE PAROLE PRONUNCIATE IERI DA MONTI, CHE CONVIENE OSSERVARE DA VICINO: non per impugnare la matita rossa e blu, ma solo per capire bene. «La crisi economica - ha detto il premier - se non è affrontata con convinzione e coraggio può diventare culturale e di valore». Il contesto in cui cadevano queste assennate parole - l’incontro con Benedetto XVI - giustifica l’attenzione rivolta alle condizioni morali e spirituali del Paese.
Il Papa ha invitato l’Italia a non scoraggiarsi di fronte alle difficoltà, e ha indicato nella grande tradizione umanistica del nostro paese i fondamenti culturali a cui attingere per invertire la rotta. Un grande «rinnovamento spirituale ed etico» deve collegarsi alla tradizione storica dell’Italia, per riprenderla, rielaborarla, riproporla su basi nuove.
Ed è vero: la nostra eredità culturale e civile è dote preziosa per tenere unito il Paese, e rimetterlo sul sentiero della crescita. Si può naturalmente discutere su cosa diventino i valori, anche i più “etici” e “spirituali”, quando siano separati dalle condizioni effettive in cui furono pensati e posti in essere, e se una sorta di philosophia perennis possa mai accompagnare un Paese attraverso le sue tante e diverse stagioni storiche e politiche. Ma queste son domande di filosofi.
Nel momento in cui i timori di uno sfilacciamento del tessuto sociale si fanno sempre più grandi, è comprensibile e anzi auspicabile che forti si intendano le parole che infondono fiducia, che donano speranza, che richiamano tutti al comune senso di appartenenza e alla più coraggiosa assunzione di responsabilità. E fa bene il presidente del Consiglio ad accoglierle e rilanciarle, specialmente di fronte a segnali di malessere sociale che vanno acuendosi sempre più.
Ancor più è apprezzabile che Monti abbia sentito ieri l’esigenza di riprendere la parola che fin dal giorno del suo insediamento aveva accompagnato la proposta programmatica del suo governo: la parola equità. Ci vuole equità, aveva detto, e ancora ieri ha ripetuto. E dentro la tradizione umanistica si trovano davvero le risorse per ripensare il valore non solo morale ma anche politico dell’equità: quella dimensione in cui il rigore della giustizia non può andar disgiunto da un ricco senso di umanità, e le proposizioni di principio non vengono mai fatte valere in astratto, nell’ignoranza delle circostanze concrete in cui gli uomini vivono.
Ma resta il passaggio che citavamo in apertura. Perché non può sfuggire che, a rigor di logica, se il premier teme che l’acuirsi della crisi economica possa comportare conseguenze più ampie, sul piano culturale ed etico, allora per lui l’elemento «culturale» ed «etico» si trova in posizione di effetto, mentre la crisi economica, recessione e disoccupazione si trovano in posizione di causa. Ma questo significa che ben difficilmente il rapporto può rovesciarsi, e d’improvviso la fiducia e la speranza, il coraggio e i forti auspici morali possono essere la causa, e la ripresa economica l’effetto. Sempre a rigor di logica si dovrebbe piuttosto pensare il contrario, e che un clima di aspettative favorevoli si stabilirà solo grazie a nuovi investimenti: non solo di fiducia.
Certo, abbiamo bisogno di supplementi d’anima. Forse ne ha ancora più bisogno il governo in carica, che non ha l’etichetta di governo tecnico perché analisti cocciuti si ostinano a ricordare le competenze del premier, ma perché Monti stesso parla alla politica come a un mondo ben distinto e a volte anche distante dal governo. La politica viene individuata come una sfera diversa, con la quale si discute, ma della quale tuttavia non si fa parte e non si intende far parte.
Forse c’è la convinzione che la popolarità dell’esecutivo ne trarrà guadagno, o forse si ritiene che sia così più facile trovare nel governo il punto di mediazione fra interessi contrapposti. Può darsi. Ma sta il fatto che è proprio questo distacco a volte ostentato che rende comprensibile che il premier cerchi supplementi morali a sostegno della sua azione, pur con qualche bisticcio fra la causa e l’effetto. Perché a pensarci il vero supplemento dell’azione di governo c’è, e non può avere altro nome che, per l’appunto, politica. E in tutta Europa, sembra proprio che ne stia di nuovo venendo il tempo.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- I tempi in cui i ladri erano appesi alle croci (di Mario Pirani)30 aprile 2012, di Federico La Sala
I tempi in cui i ladri erano appesi alle croci
di Mario Pirani (la Repubblica. 30.04.2012)
Negli ultimi tempi le tangenti non soddisfano più. Vi si aggiunge la richiesta di lingotti d’oro, pietre preziose, qualche appartamento d’incerta origine, o anche beni "minori" ma egualmente fruibili per parenti di scarsa volontà, figli svogliati e altro, aspiranti a tesi di laurea rilasciate da università fasulle, meglio se fornite di qualche timbro internazionale. È così accaduto che un giudice dell’Alta Corte, nel corso del recente provvedimento sull’illecito appalto del palazzo dei Marescialli di Firenze, si sia imbattuto in una subdola richiesta di un funzionario che ambiva ricevere una croce di cavalierato quale riconoscimento aggiuntivo per i suoi servigi sottobanco. Il magistrato, colto e spiritoso, ne fu molto divertito, ricordando una sarcastica quartina ottocentesca dello sfortunato giornalista Felice Cavallotti che, polemizzando con gli artefici del fallimento della Banca Romana, scrisse:
 In tempi men leggiadri e più feroci,
In tempi men leggiadri e più feroci,
 i ladri li appendevano alle croci,
i ladri li appendevano alle croci,
 in tempi men feroci e più leggiadri,
in tempi men feroci e più leggiadri,
 si appendono le croci in petto ai ladri.
si appendono le croci in petto ai ladri.Le battute di spirito non furono però di buon auspicio. Qualche tempo dopo Cavallotti, infatti, cadde trafitto al 33° duello della sua vita. Peccato. Se questi scontri cavallereschi, ancorché perigliosi, fossero ancora in uso tutt’oggi, potrebbe anche darsi che molti inutili processi ci sarebbero risparmiati a vantaggio di qualche sentenza eseguita di mano propria e più rapidamente.
Allontanandoci dal paradosso per affrontare le caratteristiche proprie della corruzione, val la pena ripercorrere le vicende in proposito degli Stati americani, ristampate sovente in questo periodo. Lo storico C.Hove scrive in proposito: «Il Wisconsin era un vassallo degli interessi ferroviari, forestali ed elettorali che attraverso il complesso dei funzionari federali nominava ed eleggeva governatori, senatori e rappresentanti al Congresso, questi a loro volta usavano il potere per arricchire i loro sostenitori».
Una visione meno drastica della lotta alla criminalità la si evince dall’andamento da questa assunto negli Stati Uniti dell’ultimo decennio dell’Ottocento e del primo decennio del Novecento. L’argomento è stato ampiamente trattato in un convegno dell’Ambrosianeum, dove è stato approfondito il tema delle grandi ricchezze accumulate (poderosi trust, ferrovie, petrolio, ma anche grandi ineguaglianze, grandi miserie, grandi abusi di potere). Su tutto questo dominava una enorme rete corruttiva (v. Storia degli Stati Uniti di Nevisi e Comminger, Einaudi, Torino 1961). «È difficile stabilire se fossero più corrotte le amministrazioni statali o quelle municipali. Parlamenti statali e Consigli municipali potevano concedere preziose franchigie in servizi di pubblica autorità, aggiudicare ricchi contratti, il pagamento non sempre prendeva la forma di corruzione esplicita, esso poteva manifestarsi sotto veste di carriera nel campo politico».
Gli interventi al convegno a cura di M.Vitale ed M. Garzonio sono avvincenti come uno sceneggiato televisivo, sia che affrontino le sconfitte che le vittorie: «La politica era un commercio per privilegiati, pochi stimavano possibile un altro sistema e nessuno sfidava il governo dell’oligarchia che distribuiva le cariche, la stampa era indifferente e controllata». Un vigoroso movimento riformista divenne finalmente efficace quando si saldò con l’azione politica di giovani e brillanti leader, da Wilson a T. Roosevelt, che puntarono sul piano locale prima che occuparsi di Washington. Molte azioni si riferivano alla democratizzazione della macchina politica, (voto segreto, referendum, leggi contro la corruzione e per il suffragio femminile.) Fu un periodo di riforme e rivolte in quasi tutti i domini della vita americana.
Il discorso può essere non del tutto lontano dal caso italiano. In proposito vorremmo concludere queste osservazioni sulla corruzione citando un recente discorso di Piero Grasso, Procuratore generale antimafia: «Il metodo mafioso, anche quando non c’è la mafia, è diventato purtroppo un metodo diffuso nella nostra società. C’è un sistema basato su un principio di amicizie strumentali, relazioni informali che lasciano poco spazio a forme democratiche di libero mercato. Alla luce di rapporti amicali si prendono decisioni, si fanno affari, s’intrecciano conoscenze che sono funzionali a questo sistema».
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- Dopo un ventennio triste e nefasto che ha reso irrespirabile l’aria della convivenza civile (di don Giorgio Morlin - Un parroco e il ventennio B.B.). .24 aprile 2012, di Federico La Sala
Un parroco e il ventennio B.B.
di don Giorgio Morlin (“settimana”, n. 15, 15 aprile 2012)
Stendo in libertà alcune riflessioni personali sull’onda mediatica delle miserande vicende d’interesse privato che toccano un personaggio politico di primissimo piano come Umberto Bossi e il partito della Lega Nord. Innanzitutto lui, un personaggio carismatico che, nell’immaginario collettivo, rappresenta da circa 25 anni una specie di totem tribale intoccabile, a cui si deve obbedienza cieca e a cui è permessa ogni forma di turpiloquio e d’insulto, di pernacchie e di minacce, E poi il movimento leghista, una folla sempre plaudente verso il capo e perennemente arrabbiata con l’intero mondo, partecipe di grotteschi riti pagani come le ampolle d’acqua del Po dentro un ridicolo campionario d’innumerevoli scemenze celtiche.
Il crollo del leader padano arriva puntuale dopo alcuni mesi dal crollo di un altro suo compare nazionale, quel Silvio Berlusconi che è riuscito a catturare per quasi due decenni il consenso di masse d’italiani osannanti. Cos’è successo all’Italia di fine ’900 e inizio 2000? Sembra impossibile, eppure è successo che, nel giro di nemmeno un ventennio, si sono tra loro miscelati due filoni culturali dirompenti, il leghismo e il berlusconismo. Due fenomeni, autonomi ma tra loro interdipendenti, che, dopo aver inoculato un virus eticamente letale, hanno plasmato un’opinione pubblica addomesticata, ad immagine e somiglianza dei due capi che godevano effettivamente di un largo consenso di massa.
Mentre cala squallidamente il sipario sulla scena politica dei due succitati leaders, la terribile miscela culturale-etica da loro innescata sembra ormai stabilmente metabolizzata dentro un tessuto civile senza anticorpi, determinando l’assimilazione di nuovi modelli collettivi di vita e di pensiero. Abbiamo visto un’Italia umiliata e mortificata da una molteplicità di truci slogans, contro i magistrati, contro inesistenti comunisti, contro Roma ladrona, contro gli immigrati, che infiammavano istericamente le masse ma impoverivano l’anima e l’identità del popolo italiano.
Fino a poco più di un anno fa, non solo la maggioranza del mondo cattolico ma anche una parte dell’istituzione ecclesiastica apparivano ammaliate dalla seducente sirena berlusconiano-leghista.
L’incantamento di una parte della Chiesa italiana probabilmente nasceva da una tacita e reciproca intesa in cui, sempre e comunque, gli uni lucravano qualcosa dagli altri. Dalla parte politica, si lucrava il consenso elettorale dei cattolici e, dalla parte ecclesiastica, si lucrava la difesa dei valori cosiddetti non negoziabili (famiglia, bioetica, scuola) ed eventuali altre prebende, magari anche di tipo economico.
In un’intervista al Corriere della Sera, mons. Fisichella, esponente ecclesiastico di rilievo, il 30 marzo 2010, dichiarava che la Lega Nord, «per quanto riguarda i problemi etici, manifesta una piena condivisione con il pensiero della Chiesa».
Poco dopo, alla suddetta intervista rispondeva lo scrittore Claudio Magris con una lettera aperta in cui, riportando solo qualche stralcio, si poteva leggere: «Caro mons. Fisichella, mi permetto di scriverle per esprimerle lo sconcerto che ho provato leggendo la sua recente intervista in cui lei dichiarava che il partito politico Lega Nord si fonda su valori cristiani. Non intendo esprimere alcun giudizio politico sul suddetto partito. Ma, tutto l’atteggiamento del medesimo partito nei con fronti degli immigrati costituisce la negazione dello spirito cristiano. La Lega spesso fomenta un volgare rifiuto razziale, che è la perfetta antitesi dell’amore cristiano del prossimo e del principio paolino secondo il quale "non ha più importanza essere greci o ebrei, circoncisi o no, barbari o selvaggi, schiavi o liberi; ciò che importa è Cristo e la sua presenza in tutti noi!" (cf. Col 3,11).
Questa lettera non è indirizzata alla Chiesa, ma ad uno dei tanti - ancorché autorevoli - suoi rappresentanti, le cui opinioni non possono essere addebitate alla Chiesa, ma possono destare sconcerto e scandalizzare non pochi fedeli» (Corriere dello Sera, 11 aprile 2010).
Come avrei desiderato leggere quest’inequivocabile presa di posizione dell’illustre intellettuale italiano, forse credente o forse agnostico, magari in uno dei tanti documenti magisteriali della Cei negli ultimi due decenni! È vero - dirà qualcuno -, basta leggere il Vangelo e la dottrina sociale della Chiesa. Appunto! Però, queste due primarie fonti dell’annuncio cristiano vanno riscoperte, attualizzate e storicizzate dentro le emergenze culturali ed etiche che segnano il nostro tempo, proclamando a voce alta, senza se e senza ma, valori quali la dignità umana, il rispetto per lo straniero, la giustizia, la legalità, il bene comune, l’etica pubblica... Questi, oltre naturalmente a quelli tradizionali predicati dalla Chiesa, sono o no da riconoscere come valori non negoziabili sui quali non si può e non si deve transigere?
In quest’ultimo ventennio italiano si è collettivamente dissolto quel nucleo portante di valori civili che, ad esempio, aveva efficacemente retto durante la gravissima emergenza del terrorismo negli anni 70. E proprio la Chiesa postconciliare dell’epoca, assieme a tante altre istituzioni, si era direttamente messa in gioco e a servizio della società italiana con l’obiettivo di ricostruire il tessuto sociale che rischiava la degenerazione della convivenza (cf. il profetico documento Cei La Chiesa italiana e le prospettive del paese del 1981!).
Nella prolusione del card. Ruini al Consiglio permanente della Cei (19 settembre 1994) veniva ufficialmente proclamato che il Progetto culturale della Chiesa italiana rappresentava «un terreno d’incontro tra la missione della Chiesa e le esigenze più urgenti della nazione!». Sante parole!
Invece, proprio a partire dal 1994, con la micidiale miscela berlusconiano-leghista, paradossalmente iniziava per l’Italia una lenta ma progressiva deriva etica che ha portato al disastro attuale. Certamente i tradizionali valori cari alla Chiesa (vita, scuola, famiglia) sono salvi! Però, rimane il forte disagio per una deriva antropologica già raggiunta in tanti ambiti, evidente soprattutto negli immorali e amorali modelli di vita, indotti anche da una certa politica che mette l’interesse privato al centro. Lo ha detto, finalmente con chiarezza, il card. Bagnasco, proprio negli squallidi giorni del bunga bunga berlusconiano: «La collettività guarda sgomenta gli attori della scena pubblica e respira un evidente disagio morale» (Consiglio permanente, 24 gennaio 2011).
Come cittadini e come credenti, è proprio da questo disagio morale che bisogna ripartire per farsi carico delle sorti della società e delle generazioni che verranno, dopo un ventennio triste e nefasto che ha reso irrespirabile l’aria della convivenza civile.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- Caso Orlandi, il Vaticano non può cavarsela con un appello A quasi 30 anni dalla scomparsa la verità fa ancora paura (di Roberto Faenza)9 aprile 2012
 Caso Orlandi, il Vaticano non può cavarsela con un appello
Caso Orlandi, il Vaticano non può cavarsela con un appello
 A quasi 30 anni dalla scomparsa la verità fa ancora paura
A quasi 30 anni dalla scomparsa la verità fa ancora pauradi Roberto Faenza (il Fatto, 08.04.2012)
“Non portate segreti nella tomba”. Con queste parole di padre Raniero Cantalamessa si riapre il caso Orlandi. É un mistero che seguo da anni perché da tempo vorrei farne un film. Sinora non sono riuscito nell’impresa: nessuno lo vuole finanziare per paura di dispiacere a “qualcuno molto in alto”. Facile immaginare chi, visto il terrore che in questo Paese si ha del Vaticano, quasi non meritasse la stessa trasparenza che invochiamo per tutte le istituzioni, Chiesa inclusa.
Come disse santa Caterina da Siena: “La corte del Padre Santo Nostro sembrami talora un nido d’angeli, tal altra un covo di vipere”. Ora le parole di padre Cantalamessa, conclusive dell’omelia del Venerdì Santo, davanti al Papa, suonano come un terribile atto d’accusa nei confronti dell’omertà che tinge di nero il mistero di Emanuela.
A scoperchiare il caso è stato il fratello Pietro: lui e molti seguaci si sono recati in piazza San Pietro con striscioni e manifesti durante l’Angelus, per chiedere al Papa e a chi sa in Vaticano di parlare. Sono stati cacciati, vergognosa-mente, dalla nostra polizia. Walter Veltroni ha lodato la riapertura del caso: “Le dichiarazioni del procuratore aggiunto Capaldo sul caso Orlandi sono importanti e coraggiose”. E ha rivolto una interrogazione al ministro dell’Interno Cancellieri per chiarire una volta per tutte la sepoltura del boss della Magliana, “Renatino” De Pedis, nella basilica di Sant’Apollinare.
INTANTO sarebbe bello sapere cosa sta succedendo alla Procura di Roma. Giancarlo Capaldo ha detto o non ha detto che il Vaticano sa? É vero che il nuovo procuratore Giuseppe Pignatone ha avocato a sé il fascicolo, togliendolo all’aggiunto convinto del coinvolgimento del Vaticano?
Si parla di imminenti rogatorie in Vaticano per sentire alcuni religiosi “informati dei fatti”. Sin dai primi giorni della scomparsa di Emanuela, le piste si sono alternate senza tregua. A partire dai lupi grigi e dal feritore di Papa Wojtyla, quell’Alì Agca che aveva chiamato in causa il cardinale Giovanni Battista Re. Si parlò allora di un possibile scambio tra l’attentatore ed Emanuela, sotto la regia occulta del cardinal Marcinkus, capo dello Ior e responsabile della sicurezza del Papa. Da allora l’intrigo, altro che Codice Da Vinci, si è arricchito di continui colpi di scena.
Come l’auto con cui sarebbe stata rapita la ragazza, parcheggiata per anni a Villa Borghese, intestata al boss della Magliana e prima al faccendiere Flavio Carboni, l’eterno affarista coinvolto nei torbidumi di Calvi, P2 e P3.
Sul ruolo della banda della Magliana, le rivelazioni han cominciato a fioccare quando Sabrina Minardi, l’amante di “Renatino”, ha spifferato la sua verità. Indicando persino il luogo dove sarebbe sepolta Emanuela, a suo dire assassinata su mandato di un alto prelato. Stando alle sue parole, per premio “Renatino” sarebbe stato sepolto nella basilica, grazie a uno speciale nullaosta del card. Ugo Po-letti. Per ambire a tanto privilegio occorre avere ucciso almeno una decina di persone? O essersi prestati a ripulire i bottini della banda attraverso la banca del Vaticano, foraggiata dalla stessa come emerge dalle carte? Né possiamo dimenticare la mattina del 14 maggio 2001, allorché il parroco di San Gregorio VII, nei pressi del Vaticano, scopre in un confessionale un piccolo teschio umano senza mandibola, proprio nel 20° anniversario dell’attentato al Papa.
LA SCOMPARSA della ragazza è stata più volte associata a quella di Mirella Gregori, sua coetanea, nello stesso periodo. La madre di Mirella, durante una visita del Papa in una parrocchia del Nomentano, pare abbia riconosciuto in un uomo della scorta pontificia la persona che andava a prendere ogni tanto la figlia a casa. Per portarla da chi? É lo stesso uomo visto al bar con Emanuela poco prima della scomparsa? Ora che il caso è riesploso, riaffiorano le piste che portano a prelati pedofili, pare invaghiti sia di Mirella sia di Emanuela. Il mistero continua. In attesa della prossima puntata.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ----- Fu il cardinal Ugo Poletti, il 10 marzo 1990, a rilasciare il nulla osta della Santa Sede alla tumulazione di Renatino De Pedis nella Cripta di Sant’Apollinare (di Rita Di Giovacchino - De Pedis. “La tomba non è del Vaticano”).1 aprile 2012, di Federico La Sala
De Pedis. “La tomba non è del Vaticano”
di Rita Di Giovacchino (il Fatto, 01.04.2012)
Fu il cardinal Ugo Poletti, il 10 marzo 1990, a rilasciare il nulla osta della Santa Sede alla tumulazione di De Pedis nella Cripta di Sant’Apollinare. La cosa era nota, ma il ministro dell’Interno Annamaria Cancellieri, pressata da Walter Veltroni, lo ha scoperto soltanto ora. In ogni caso la sua risposta all’interpellanza del vicepresidente dell’Antimafia offre un crisma di ufficialità a questa strana storia di vescovi e gangster.
Sulla questione “dell’extraterritorialità” il ministro, pur asserendo che l’ormai famosa chiesa “non è territorio dello Stato Vaticano”, rimanda a una norma del Concordato (l’articolo 16 della legge n. 810/29) in base alla quale San-t’Apollinare, come tutte le basiliche anche minori “gode di un particolare regime giuridico, definito dalla Corte Costituzionale privilegio di extraterritorialità”. Privilegiata è anche la tumulazione di Renatino nella cappella accanto a quella di Roesler Franz, il pittore di Roma Sparita, ma la Santa Sede può dare “all’immobile l’assetto che crede, senza bisogno di autorizzazioni di autorità governative, provinciali e comunali”. Anche la sepoltura di Renatino è affar suo.
L’unico delegato a dare l’autorizzazione era il Cardinale vicario di Roma, per l’appunto Poletti che, a quanto racconta Sabrina Minardi, di Renatino era amico. La soluzione fu rapidissima: De Pedis fu ucciso il 20 febbraio e tumulato al Verano. Il parroco Don Vergari si rivolse a Poletti che si mobilitò: “La famiglia De Pedis il 23 marzo 1990 ottenne dall’autorità comunale l’autorizzazione all’estumulazione della salma del congiunto (...) per il successivo trasferimento alla Basilica di S. Apollinare in Roma e il 24 aprile ottenne l’autorizzazione al trasporto della salma alla chiesa di Sant’Apollinare, Stato Città del Vaticano”. Il cerchio si chiude, resta il caustico commento di Andreotti: “Forse De Pedis non era un benefattore dell’umanità, ma di Sant’Apollinare si”.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- Siamo oltre il "mostruoso connubio" tra politica e amministrazione. Questione morale ultimo atto (di Stefano Rodotà)12 marzo 2012, di Federico La Sala
Questione morale ultimo atto
di Stefano Rodotà (la Repubblica, 12 marzo 2012)
Lo stillicidio delle informazioni sui fatti di corruzione, quasi un quotidiano bollettino di guerra, rende sempre più insopportabile l’attesa di qualche nuova norma che consenta di opporsi in modo un po’ più efficace ad un fenomeno dilagante. Le cronache confermano che la corruzione è ormai una struttura della società italiana, è penetrata ovunque, come testimonia la presenza tra i corrotti di politici e amministratori, imprenditori e primari medici, poliziotti e vigili urbani. Ogni ritardo del Parlamento diventa un aiuto a questo nuovo ceto sociale. E proprio la "disattenzione" politica spiega perché, a vent’anni da Mani pulite e dalle speranze allora suscitate, la corruzione sia divenuta sempre più diffusa.
Ricordiamo quel che disse il cardinale Tettamanzi, lasciando la diocesi di Milano: "Gli anni della cosiddetta Tangentopoli pare che qui non abbiano insegnato nulla, visto che purtroppo la questione morale è sempre d’attualità". Ma vi è un documento recentissimo che descrive con spudoratezza una condizione della politica. È la memoria difensiva di un politico calabrese accusato di rapporti con ambienti criminali, dov’è scritto: "La mentalità elettoralistico-clientelare è diventata cultura, costume e inevitabilmente anche modo di governare" e quindi, per il politico che "vive ed opera in questo difficilissimo ambiente, mettersi a disposizione è quasi d’obbligo, senza grandi possibilità di crearsi una difesa che lo garantisca da immorali e infedeli strumentalizzazioni. Il mettersi a disposizione è condizione quali fisiologica dell’attività politica svolta in Calabria, con la conseguenza di affidarsi supinamente alla lealtà dell’interlocutore". Questa richiesta di una "assoluzione sociologica" riguarda i rapporti con ambienti criminali, ma descrive una più generale regola di comportamento dove il "mettersi a disposizione" s’intreccia con le pratiche corruttive alle quali, peraltro, proprio i poteri criminali ricorrono sempre più ampiamente.
Siamo oltre il "mostruoso connubio" tra politica e amministrazione denunciato nell’Ottocento da Silvio Spaventa. Conosciamo altri connubi: tra politica e affari, tra politica e criminalità, che tutti insieme hanno provocato un connubio obbligato tra politica e malapolitica, con quest’ultima che corrode l’intera società. Proprio per questo è necessario guardare alla dimensione politica, pur sapendo, ovviamente, che non è soltanto questa ad essere il luogo della corruzione e che i politici corrotti sono una minoranza. Ma quando la corruzione si insedia nel ceto politico, e da questo non è adeguatamente contrastata, essa finisce con l’assumere una particolare natura, diventa fatto istituzionale, modo di governo della cosa pubblica. Proprio per questo è grandissima la responsabilità dei politici onesti, che non possono chiamarsi fuori in nome della loro personale integrità, poiché hanno l’obbligo di ricostruire le condizioni anche istituzionali per il ritorno dell’etica pubblica.
Finora non è avvenuto. Si è ceduto al patriottismo di partito, si sono cercate misere scorciatoie, si sono coltivate illusioni politico-istituzionali. Spicca, tra queste ultime, la tesi secondo la quale la corruzione era figlia di un sistema bloccato sì che, una volta approdati ad una democrazia dell’alternanza, la corruzione si sarebbe automaticamente ridotta. Non è andata così. L’alternanza tra diverse forze politiche nel governo centrale e in quelli locali ha coinciso con l’espansione della corruzione. Questa, da modalità di esercizio del potere, si è fatta potere essa stessa, ha prodotto le sue istituzioni, le sue reti formali e informali, le sue aree di influenza, una sua economia. Non più fenomeno selvaggio, ma forte e autonomo potere corruttivo.
Non lo scopriamo oggi, nessun politico può invocare l’attenuante della mancanza di informazione. Da anni in Italia sono state prodotte eccellenti ricerche sul tema, sono state fatte proposte dettagliate. Se questa buona cultura è rimasta senza echi, è perché era stata imboccata una diversa via istituzionale.
Discutendo delle differenze tra il tempo di Mani pulite e il tempo nostro, bisogna ricordare le diverse linee istituzionali che proprio in Tangentopoli trovarono il loro spartiacque. Per anni la politica difese le pratiche corruttive senza toccare sostanzialmente il sistema generale delle regole, alle quali ci si sottraeva attraverso una robusta rete di protezione. Si negava la messa in stato d’accusa di ministri (unica eccezione il caso Lockheed, ma questa falla fu prontamente chiusa). Si negavano le autorizzazioni a procedere contro i parlamentari sospetti di corruzione. Si portavano inchieste scottanti nel "porto delle nebbie" della Procura di Roma, che provvedeva ad insabbiarle. Si rifiutava di prendere atto di clamorose responsabilità politiche, con l’argomento che qualsiasi sanzione poteva scattare solo dopo una definitiva sentenza di condanna (e così si allontanava nel tempo ogni iniziativa).
Questa rete si smaglia con l’arrivo delle inchieste del febbraio 1992. Si cancella una immunità parlamentare di cui si era abusato. La magistratura, che aveva assicurato protezione, ritrova il suo ruolo di garante della legalità. Questo provoca sconcerto, e per qualche tempo si spera che un tempo nuovo sia davvero cominciato. Ma le vecchie resistenze erano tutt’altro che sconfitte, come subito dimostrarono le difficoltà nel riformare la legge sugli appalti.
Una nuova strategia era alle porte, e trovò nel berlusconismo il clima propizio. Una diversa rete di protezione è stata costruita, cambiando le stesse regole di base. È storia nota, quella delle leggi sulla prescrizione e sul falso in bilancio, delle norme sulla Protezione civile. Il mutamento è radicale. L’intero sistema istituzionale viene configurato come "contenitore" della corruzione.
Di fronte a questa reale emergenza è pura ipocrisia rifiutare interventi immediati dicendo che si tratta di materia estranea al programma di governo e che nuove norme sulla corruzione devono far parte di un più largo "pacchetto" di riforme della giustizia. La questione morale, evocata dal cardinale Tettamanzi e che richiama l’intuizione lungimirante di Enrico Berlinguer, è tema ineludibile della politica di oggi.
Ma non è solo affare di leggi. Bisogna tornare alla responsabilità politica, rifiutando la scappatoia del "non è un comportamento penalmente rilevante". L’etica pubblica non ha il suo fondamento solo nel codice penale. Lo dice bene l’articolo 54 della Costituzione, affermando che le funzioni pubbliche devono essere adempiute con "onore" e "disciplina". Questo significa che, anche se verranno nuove norme, la partita non è chiusa. Oltre le leggi vi è la ricostruzione della moralità pubblica, il dovere della politica d’essere inflessibile con se stessa, se vuole riconquistare la fiducia dei cittadini. Una domanda, per intenderci. Le frequentazioni mafiose possono essere considerate penalmente non rilevanti e consentire a Dell’Utri l’assoluzione. Ma sono compatibili con l’onore e la disciplina richiesti dalla Costituzione?
Per i candidati alle future elezioni dovrebbe essere obbligatoria la lettura del Viaggio elettorale raccontato da Francesco De Sanctis nel 1875, che così parlava ai cittadini: "Avete intorno al mio nome inalberata la bandiera della moralità. Siate benedetti!".
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- GIUSEPPE DOSSETTI (1913-1996). C’è una morale nella politica - sia della Chiesa sia dello Stato (di Sergio Zavoli)11 marzo 2012, di Federico La Sala
GIUSEPPE DOSSETTI (1913-1996)
C’è una morale nella politica
di Sergio Zavoli (Il Sole 24 Ore - Domenicale, 11 marzo 2012)
Avrebbe novantanove anni, nacque nel febbraio del 1913, è stato tra i personaggi centrali della democrazia repubblicana sorta sulle macerie del fascismo, il suo pensiero politico e la sua essenza civile e morale stanno ancora attraversando l’identità di un cattolicesimo che ha il suo esordio storico quando i cattolici, nella riconquistata libertà, consolidano laicamente la scelta democratica di Sturzo.
È appena il 1945 quando - mentre De Gasperi interpreta la necessità di dar vita a una economia di mercato - Dossetti propende per una libertà politica cui va affiancata un’economia anche statale in grado di garantire la tutela dei ceti subalterni, ovviamente deboli rispetto al potere condizionante delle grandi forze economiche. Dossetti scrive: «La Democrazia cristiana non vuole e non potrà essere un movimento conservatore», attirandosi qua e là addirittura il sospetto di voler far sua la distinzione di Maritain tra fascismo e comunismo. Mentre il primo, cioè, andava considerato una forza estranea agli ideali cristiani in quanto perseguiva un ideale di Stato-guida, che permea di sé tutto, dalla cultura agli ordinamenti, al cittadino sacrificato all’individuo; il secondo è visto come una sorta di "eresia cristiana", cioè un sistema che richiama lontanamente originarie ispirazioni comunitarie. D’altronde fu Berdjaef, il filosofo russo espulso dall’Urss nel 1922, a dire che il comunismo doveva intendersi come «la parte di dovere non compiuta dai cristiani».
Ma Dossetti tende alla qualità di una scelta ben più radicale e autentica, che ne farà un testimone scomodo, talvolta persino mal tollerato, di quanto si può dare alla politica senza farlo venir meno alla morale, al pragmatismo senza sottrarlo ai principi, al cittadino senza privarlo della persona.
Chi non ha in mente questa fedeltà laica e insieme religiosa al primato dell’uomo, quello della sua intrinseca e libera dignità personale, stenterà a farsi largo negli aspetti non di rado impervi - per esempio della dignità sacerdotale - di don Giuseppe Dossetti. Non a caso egli fa coincidere l’unicum cui si ispira affrontando la politica come il momento in cui si diventa responsabili personalmente di ciò che scegliamo per l’orientamento di noi stessi e nei confronti degli altri.
Ecco, allora, la base su cui poggiare il peso della scelta: la norma costituzionale dell’eguaglianza tra i cittadini, da perseguire attraverso la ricerca e la messa a punto di un modello di statualità sottratta, insieme, alla vischiosità della conservazione borghese e a una giustizia sociale i cui costi gravino sulle libertà personali; nell’assoluta preminenza dei diritti inalienabili di un uomo partecipe della speranza collettiva - laica, razionale, organizzata dalla politica dentro la storia - ma nella intangibile responsabilità della risposta individuale.
Si è detto di Dossetti che aveva i principali nemici, per paradosso, nelle sue idee. Certo, voler trarre da una vocazione originale e rigorosa un patrimonio di principi da comunicare a masse di cittadini comportava un’impresa virtuosa e pedagogica tale da scontrarsi con quel bisogno di duttilità e tolleranza che la gran parte di un popolo appena rinato alla democrazia coltivava nel limbo di una coscienza civile ancora confusa; in cui, per legittimarsi anche spiritualmente, bastava esibire l’alibi del «perché non possiamo non dirci cristiani», di crociana memoria, per indispettire chiunque intendesse la lotta politica come un esercizio fondato sulla pregiudiziale anti-comunista, e da tenere in sospetto una parte della stessa sinistra, la quale si sentiva insidiata nella sua dimensione più difficile, quella dell’autocritica filosofica e pragmatica.
Questi condizionamenti non giovarono all’immagine pubblica di Dossetti, ma al tempo stesso ne esaltarono la dimensione, per dir così, più sottesa e costosa. Tra gli uomini che hanno rifondato lo spirito democratico del nostro Paese è quello che ha reso più manifesto il significato morale del far politica, seppure alzandolo a un tale livello di esemplarità da essere, non di rado, irriconoscibile. Forse si fa torto al politico, ma quanto gli si toglie nella sfera pubblica alla sfera pubblica ritorna proprio attraverso quella privazione: è il paradosso-Dossetti, la sua storia e la sua coscienza. Pochi eletti, di quegli anni e dopo, hanno uniformato i propri gesti all’esigente esemplarità di quella lezione. Dossetti ne fu così consapevole che prese su di sé, assumendolo nel suo animo, il segno di contraddizione che egli stesso aveva finito per rappresentare. E quando cominciò a capire che la parola, passando per strade e piazze spesso votate alla facilità degli slogan, all’intelligenza pratica e quindi alla realtà del giorno per giorno non suscitava più le risposte che avrebbe voluto udire, la portò nel deserto e ne rimase paziente, incorruttibile custode.
Così aveva descritto il senso di quel viaggio fruttuoso: «Il mio sacerdozio è nato da uno sbocco credo coerente con la vita che già conducevo, una vita consacrata nell’intenzione e nella forma al dominio dell’orazione sull’azione tutta orientata a diffondere tra i laici cristiani una formazione che stesse a monte del pensiero socio-politico e che lo sanasse continuamente dai suoi pericoli: perché il pensiero politico è continuamente insidiato da grandi pericoli». E subito dopo, per ricomporre nella sua fondamentale unità il senso dell’altra scelta, aggiungerà: «Noi non siamo monaci, conduciamo una vita molto simile, o quasi integralmente eguale alla vita dei monaci, però negli istituti monastici tradizionali non mi riconosco».
Nasceva qui, non sentendosi espulso dalla politica, ma riconoscendone i legittimi limiti temporali, la necessità di radicare in un certo luogo - con una testimonianza tangibile anche per i significati di memoria e di lascito - la scelta definitiva di Monte Sole come riferimento e irradiazione verso la Palestina, l’Oriente, le cento terre, le cento patrie, le cento paci promesse. Monte Sole è una sorta di vulcano alla rovescia, dove si è compiuta una violenza senza tempo, in quanto consumata davanti al giudizio di Dio. È quindi il luogo della preghiera continua, per un perdono senza soste.
Qui Dossetti vuole un radicamento e si conforma a una regola. Egli è «uomo delle regole». Prima del presbiterio viene da una cultura giuridica, sa che la civiltà del diritto si fonda sul "contratto". Occorre regolare quel "contratto": nella Costituzione come nel Concilio, come nella stessa "piccola regola" che si darà il monastero di Monte Sole. Un "contratto" che rimetta insieme, anzitutto, storia ed etica, politica e morale, non per trasferire nella vita civile quello che ricavi dalla vita religiosa. Non è integralismo, né zelo, né mera virtù: si tratta di rivivere la dimensione pubblica secondo il principio della condivisione e della solidarietà.
C’è un fascino di Dossetti che sta anche in questo continuo contemplare e agire, nel mettere in crisi ciò a cui pensa per sottoporlo alla prova di ciò in cui crede. Egli vedeva, in lontananza, una grande crisi religiosa, anche di cristianità, forse per l’insorgere di culture pragmatiche, dispensatrici di straordinari sollievi terreni, spesso ingannevoli e persino alienanti. Anche di qui il suo sguardo all’Oriente, in cerca di una grande scaturigine di religiosità, da cui attingere per nutrire un grembo vasto, limpido, universale. C’è un enigma nell’aver visto queste distanze, e concepito quel viaggio, dal suo stare a Monteveglio, il piccolo centro della sua intoccabile, appartata totalità. «Non è possibile purificarsi da solo o da soli; purificarsi, sì, ma insieme; separarsi per non sporcarsi è la sporcizia più grande». Sono parole di Tolstoj e don Giuseppe le sa a memoria.
La parte finale della sua vita è stata giudicata una fuga dal mondo. Dossetti stesso annotava: «E qualcuno (anche tra cattolici e persino teologi) parla della vita monastica non solo come di "fuga dal mondo", ma persino dalla Chiesa». E qui è possibile cogliere una conclusione: «Al termine di ogni via c’è l’unico e definitivo mistero di Gesù di Nazareth, figlio di Dio e figlio di Maria, che con la sua croce e la sua morte volontaria, gloriosa e vivificante, è divenuto il primogenito dei morti aprendo per noi la via della Risurrezione».
Dossetti chiuderà il suo libro, lacerato e di nuovo riunito dalla sua totalità, il 15 dicembre del 1996. Credenti e non credenti parteciperanno alle esequie in gran numero. Intorno alla bara, per un tratto della cerimonia funebre, si alterneranno vecchi partigiani con i loro nipoti e pronipoti, i nuovi bambini della comunità; laicamente destinati a capire i valori anche civili che lo spirito, secondo Dossetti, sa mettere nella storia. La quale forse non si ripete, ma quanto disse e visse Dossetti somiglia ancora a non poche questioni che si presentano davanti alla Chiesa e ai cattolici nella dimensione globalizzata dei problemi. La centralità dell’uomo, l’etica associata allo sviluppo, la relazione tra uomo e ambiente, le connessioni tra diritti umani e civili, la lotta agli egoismi vecchi e nuovi, la salvaguardia delle diverse identità, il dialogo tra le culture religiose, la laicità dello Stato e della politica, sono temi che investono anche la teologia cattolica e la pratica dei credenti, la loro visione della società e delle relazioni umane. Tutto ciò nel segno della prima delle regole: la ricongiunzione del cittadino con la persona, della politica con la moralità, dello Stato con l’interesse del popolo.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- L’Italia a un bivio tra verità e vanità (di Bruno Forte)11 marzo 2012, di Federico La Sala
L’Italia a un bivio tra verità e vanità
di Bruno Forte (Il sole 24 Ore, 11 marzo 2012)
Singolare attualità del passato: definirei così l’impressione che lascia la lettura del passo De Civitate Dei in cui Agostino, meditando sul tempo drammatico che gli fu dato di vivere, quello del tramonto dell’impero romano, stigmatizza le ragioni della crisi: esse non si trovano nell’impatto esterno dei barbari, elemento solo concomitante, aperto anzi alla potenzialità positiva di immettere linfa nuova nel sangue malato di una civiltà in sfacelo. La profonda causa del declino è per il Vescovo d’Ippona di carattere morale: si tratta dell’attitudine - avallata dai vertici e divenuta mentalità comune - a preferire la vanitas alla veritas, la vanità alla verità.
Le due logiche si oppongono: la vanità dà il primato all’apparenza, a quella maschera rassicurante, che copre interessi egoistici e prospettive di corto metraggio dietro proclamazioni altisonanti, misurando ogni cosa sul gradimento dei più. La verità fonda invece le scelte sui valori permanenti, sulla dignità di ogni persona umana davanti al suo destino, temporale ed eterno. Eppure, nel mondo «che va dissolvendosi e sprofonda» («tabescenti ac labenti mundo»), Agostino riconosce l’opera di Dio, che nel rispetto delle libertà va radunandosi una famiglia per farne la sua città eterna e gloriosa, fondata «non sul plauso della vanità, ma sul giudizio della verità» («non plausu vanitatis, sed iudicio veritatis»: II,18,3).
Lo straordinario affresco di "teologia della storia", tracciato dal Pastore teologo, mi pare di un’impressionante contemporaneità: all’orgia della frivolezza, che ha celebrato i miti del consumismo esasperato e dell’edonismo rampante, vanno opposte scelte fondate sulla verità e sul primato dei valori, a cui a nessuno è lecito sottrarsi. Vorrei provare a indicare queste scelte confrontando vanitas e veritas in alcuni campi decisivi.
In primo luogo, la crisi della politica davanti a cui ci troviamo, evidente nel fatto che per salvare l’Italia i politici hanno dovuto lasciare il campo ai tecnici: è una crisi frutto anche del modo di agire che ha separato l’autorità dall’effettiva autorevolezza dei comportamenti e la rappresentanza democratica dalla reale rappresentatività dei bisogni e degli interessi dei cittadini. Dove l’amministratore o il politico perseguono unicamente il proprio interesse, puntando sull’immagine e sulla produzione del consenso, lì trionfa la vanitas a scapito della veritas.
Il primato della verità esige una politica ispirata alla ricerca disinteressata del bene comune, capace di ascoltare e coinvolgere i cittadini come portatori di bisogni e di diritti, di proposte e di potenzialità, e perciò in grado di dire anche dei "no" per fare ciò che è giusto: l’ideale della cosiddetta "good governance" è inseparabile dalla tensione etica che anteponga al proprio il bene comune.
Sul piano dei modelli culturali e delle risorse spirituali la vanitas trionfa lì dove si privilegia l’effimero a ciò che non lo è, sradicando l’agire dalla memoria collettiva, di cui sono tracce le opere dell’arte e dell’ingegno e le tradizioni spirituali e religiose. Una comunità privata di memoria perde l’identità e rischia di essere esposta a strumentalizzazioni perverse: il trionfo della veritas consiste qui nel rispetto e nella promozione del patrimonio culturale, artistico, religioso della collettività, come base per il riconoscimento dei bisogni e delle priorità cui tendere.
Un’azione educativa capillare, sostenuta da un sistema efficiente di didattica e di ricerca scientifica, è condizione indispensabile per la conservazione dei beni culturali, religiosi e ambientali, e ha un impatto positivo sull’economia, che va calcolato sia sincronicamente in rapporto alla fruibilità dei beni stessi, sia diacronicamente, misurandone gli effetti benefici sui tempi lunghi e i risparmi connessi a una sana azione di tutela e di prevenzione. Ne consegue che una società che non investa su scuola e università, formazione e cultura, è destinata a implodere.
L’ambito dell’economia è parimenti luogo della contrapposizione fra vanitas e veritas: se alla prima s’ispira un’azione economica orientata al solo profitto e all’interesse privato, alla seconda punta un’economia attenta non solo alla massimizzazione dell’utile, ma anche alla partecipazione di tutti ai beni, al rafforzamento dello stato sociale, alla promozione dei giovani, delle donne, degli anziani, delle minoranze. Un’economia di comunione, che miri alla messa in comune delle risorse, al rispetto della natura, alla partecipazione collettiva agli utili, al reinvestimento finalizzato a scopi sociali, al principio di "gratuità" e alla responsabilità verso le generazioni future, può essere il modello della svolta necessaria in questo campo (rilevanti in questa direzione sono le tesi dell’Enciclica di Benedetto XVI Caritas in veritate del 29 giugno 2009).
La città futura non potrà essere programmata e gestita secondo logiche esclusivamente utilitaristiche: o sarà frutto di un’economia integrata, che unisca l’interesse pubblico e quello privato secondo i principi di un’"economia civile" in grado di valorizzare tutti i soggetti in gioco e di promuoverne la crescita collettiva, o rischierà di accrescere le dinamiche di frammentazione, che producono la disumanizzazione della società. Processi di riconversione industriale e di ottimizzazione del capitale umano, legati anche all’investimento sulla qualità del prodotto, appaiono quanto mai urgenti, specie di fronte agli scenari di crisi che vanno profilandosi a motivo della concorrenza del mercato del lavoro. Qui la centralità della persona umana, la sua dignità, la sua salute, appaiono criteri decisivi, dove vanitas e veritas vengono a discriminarsi. Una società che non investa su lavoro e salute dei cittadini è destinata a inesorabile declino.
È, dunque, l’etica il campo di applicazione più profondo della dialettica proposta da Agostino: a una morale individualista e utilitaristica, finalizzata esclusivamente all’interesse dei pochi, occorre opporre un’etica della verità, aperta a valori fondati sulla comune umanità e sulla dignità trascendente della persona. Quest’etica si caratterizzerà per il primato della responsabilità verso gli altri, verso se stessi e verso l’ambiente, per l’urgenza della solidarietà, che pone in primo piano i diritti dei più deboli, e per l’apertura ai valori spirituali.
Ciò che appare urgente per uscire dalla crisi è preferire alla logica di corte vedute della vanitas la logica della condivisione e del servizio. Averlo chiaramente presente è dovere di tutti, nella misura in cui ci stia a cuore una città futura che sia meno dissimile dalla città di Dio, voluta e sperata per il bene dell’intera famiglia umana: quella che Agostino ebbe l’audacia di proporre come orizzonte di senso e di speranza per il futuro di un’umanità, che sembrava destinata a un inarrestabile destino di dissoluzione.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- "L’uomo resta dove sta, e basta!"- La lapidaria risposta, il Vaticano e la resa dei conti (di Marco Politi)-29 febbraio 2012, di Federico La Sala
Il Vaticano e la resa dei conti
di Marco Politi (il Fatto Quotidiano, 29 febbraio 2012)
Ha il sapore di un fine-regime la lotta di potere scatenatasi all’interno del Vaticano. Perché scontri e bracci di ferro sotterranei sono sempre avvenuti nel Palazzo apostolico. Ma l’asprezza degli attacchi rivolti al segretario di Stato, in un crescendo che pare inarrestabile, rivela che all’interno della Curia ci sono gruppi e persone che - con il pontefice ormai in età avanzata e l’evidente mancanza di direzione della barca di Pietro - ritengono necessario arrivare a un nuovo assetto ai vertici della Santa Sede. La novità assoluta è che non si procede, come in altre stagioni, per insinuazioni o messaggi tenuti rigorosamente segreti. Di fronte alla stagnazione, in cui si sta arenando il pontificato ratzingeriano, ci sono forze che hanno deciso di portare tutto alla luce del sole, di svolgere questa battaglia sul palcoscenico dei mass media, di rendere chiara anche la posta in gioco: una svolta nell’amministrazione delle finanze, nei rapporti tra Vaticano e Chiesa italiana, nelle relazioni tra il segretario di Stato e i cardinali. Non ci sono (più) “corvi” in questa storia. Ci sono combattenti clandestini.
Il carteggio Bertone-Tettamanzi pone sotto la luce dei riflettori i punti più vulnerabili del governo bertoniano.
Primo, un assolutismo che i suoi avversari denunciano come centralismo senza autentica managerialità: poiché procede per scatti di improvvisazione e crea opposizione laddove dovrebbe lavorare per la massima coesione dell’apparato su linee strategiche condivise.
Secondo, la tendenza a scavalcare sistematicamente i confini del proprio ambito. Il segretario di Stato ha in cura la strategia della Chiesa universale. Invece, sottolineano i suoi oppositori, lo si è visto occuparsi di un fantomatico polo ospedaliero ecclesiastico italiano (caso San Raffaele). E ancora, l’Istituto Toniolo riguarda la Chiesa italiana, idem l’Università Cattolica. Non erano certo in ballo questioni dottrinali di massimo rilievo, tali da provocare un intervento del Papa.
Assistere a un segretario di Stato, che pone e dispone a suo arbitrio, per puri disegni di potere è diventato allarmante in certi ambienti ecclesiastici e - per alcuni - talmente intollerabile da avere voluto informare l’opinione pubblica della sconfitta subita da Bertone dopo l’appello diretto del cardinale Tettamanzi al pontefice, come risulta dalle lettere pubblicate ieri dal Fatto.
D’altronde al momento del cambio della guardia alla presidenza della Cei tra Ruini e Bagnasco il cardinale Bertone si è arrogato per lettera l’alto comando delle relazioni con la politica italiana, scavalcando la dirigenza della conferenza episcopale. Ma viene il momento in cui qualcuno e più d’uno presenta il conto.
Già nel 2009, all’indomani del disastroso caso Williamson (il vescovo lefebvriano negazionista cui venne tolta la scomunica) e dell’altrettanto penoso caso Wagner (un prete reazionario austriaco nominato vescovo e poi costretto a rinunciare in seguito alla protesta dei cattolici e dell’episcopato d’Austria) alcuni porporati di rilievo avevano posto a Benedetto XVI la questione di un avvicendamento di Bertone.
Quando in aprile, nella residenza di Castelgandolfo, i cardinali Scola, Schoenborn di Vienna, Bagnasco e Ruini interpellarono il pontefice, la risposta lapidaria risposta fu, in tedesco: “Der Mann bleibt wo er ist, und basta”. L’uomo resta dove sta, e basta! Pochi mesi dopo Benedetto XVI fece pubblicare sull’Osservatore Romano uno sperticato elogio per il “grande impegno e la perizia” dimostrati dal segretario di Stato.
Ora il vento è cambiato. Il suo braccio destro, ricordano quotidianamente i suoi silenziosi, ma attivi antagonisti, ha commesso in pochi mesi due errori capitali su un terreno, che papa Ratzinger considera sensibilissimo per il prestigio internazionale della Santa Sede. Bertone ha cacciato Viganò dopo che questi aveva denunciato storie di corruzione riguardanti appalti in Vaticano. Bertone ha frenato la strategia di trasparenza finanziaria della banca vaticana perseguita dal cardinale Nicora e dal direttore dello Ior Gotti Tedeschi. Due autogol micidiali per la Santa Sede.
Sono errori che avvelenano l’atmosfera. La cosa più pericolosa per il segretario di Stato è che i favorevoli a un suo avvicendamento si trovano sia nel campo conservatore sia in quello riformista.Anche tra i ratzingeriani di ferro. Si avverte il senso di un silenzioso accerchiamento. Mentre qualche monsignore già si avvicina al “candidato-segretario” cardinale Piacenza. Anche perché la guerra dei documenti non è destinata a finire.
In un cassetto c’è un messaggio di Bertone al premier Monti - nelle ore frenetiche della formazione del governo a dicembre - per raccomandare a un posto di sottosegretario il suo pupillo Marco Simeon, già paracadutato come direttore di Rai Vaticano e responsabile delle relazioni istituzionali e internazionali. Un Segretario di Stato vaticano, che chiede un posto di sottosegretario per un suo protetto al presidente del Consiglio italiano? Che c’azzecca, direbbe Di Pietro.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- "L’uomo resta dove sta, e basta!" - Bertone si vantò con Tettamanzi: il papa vuole cacciarti (di Marco Lillo)29 febbraio 2012, di Federico La Sala
Bertone si vantò con Tettamanzi: il papa vuole cacciarti
di Marco Lillo (il Fatto Quotidiano, 28 febbraio 2012)
Le lettere che il Fatto pubblica oggi in esclusiva, descrivono una situazione inedita al vertice della Chiesa. Il braccio destro del Papa, il segretario di Stato Tarcisio Bertone, si arroga il diritto di parlare a nome di Benedetto XVI e, forte di questo mandato, nel marzo del 2011 arriva a licenziare su due piedi il presidente dell’Istituto Giuseppe Toniolo, un cardinale autorevole come Dionigi Tettamanzi, allora arcivescovo di Milano e accreditato dalla stampa nel 2005 come un possibile successore di Giovanni Paolo II.
Per tutta risposta Tettamanzi scrive a Benedetto XVI per chiedergli di sconfessare Bertone annullando la sua decisione. E, colpo di scena, la sconfessione di fatto si realizza. Nonostante il rinnovo dei vertici del Toniolo fosse stato già comunicato ufficialmente al successore in pectore, Giovanni Maria Flick, un anno fa. La vicenda era stata già narrata a grandi linee nella primavera scorsa, ma nessuno aveva mai letto le lettere dei due cardinali. L’oggetto della lettera di “licenziamento” per Tettamanzi non era il posto di arcivescovo di Milano, che nel giugno 2011 sarà poi assegnato ad Angelo Scola, ma la presidenza dell’Istituto Toniolo, uno dei maggiori centri di potere in Vaticano, che controlla il Policlinico Agostino Gemelli di Roma e l’Università Cattolica con gli atenei di Brescia, Cremona, Piacenza, Roma e Campobasso, oltre alla casa editrice Vita e pensiero e numerosi beni immobili in tutta Italia più altre proprietà intestate a società commerciali.
Il Toniolo è sempre stato uno snodo dei rapporti tra politica e Chiesa, dai tempi in cui il suo consiglio includeva Oscar Luigi Scalfaro ed era presieduto dall’ex presidente del Consiglio Emilio Colombo. Nel 2003 Dionigi Tettamanzi, da poco nominato arcivescovo di Milano, fu spedito da Giovanni Paolo II a presiedere l’istituto proprio per togliere dall’imbarazzo il Vaticano dopo il coinvolgimento di Colombo, come consumatore, in un’inchiesta sullo spaccio di cocaina a Roma.
Quando nel marzo 2011 Bertone intima brutalmente a Tettamanzi di levare le tende entro due settimane, nemmeno fosse la sua colf, il cardinale ha già i nervi tesi perché si sente nel mirino di una campagna diffamatoria partita con una serie di lettere velenose sui giornali che gli imputano la presunta mala-gestio familistica del direttore amministrativo della Cattolica, Antonio Cicchetti. E proprio nella lotta per il controllo del Toniolo molti iscrivono anche la pubblicazione, sempre nel 2010, della velina falsa e calunniosa contro l’ex direttore dell’Avvenire Dino Boffo, consigliere del Toniolo vicino al presidente della Cei Angelo Bagnasco e al suo predecessore Camillo Ruini.
Quando Tettamanzi, il 26 marzo del 2011, legge il fax con la lettera di licenziamento nella quale Bertone gli intima di lasciare il posto al professor Flick e di non fare nomine prima dell’arrivo del successore, l’arcivescovo reagisce come una belva ferita. Tettamanzi scrive al Papa una lettera nella quale sostanzialmente insinua che Bertone non avesse l’investitura papale, da lui millantata, per cacciarlo e chiede a “Sua Santità” di essere confermato. Detto fatto. Il Papa, dopo avere ricevuto Bertone il 31 marzo e Tettamanzi il 30 aprile, lascia quest’ultimo al suo posto (e lì si trova tuttora a distanza di quasi un anno). L’aperta sconfessione di Bertone non viene accolta bene dal segretario di Stato che da allora medita la rivincita.
Il primo scricchiolio dell’equilibrio precario raggiunto dopo il braccio di ferro si è avvertito qualche settimana fa quando nel consiglio del Toniolo è entrato il cardinale Angelo Scola. Probabilmente Bertone ha pensato di dare scacco matto a Tettamanzi mettendo in campo un uomo stimato dal Papa ma che non è considerato un suo fedelissimo. Il cardinale ciellino Angelo Scola però non è certo paragonabile al laico ed ex ministro prodiano Flick. La sostituzione del progressista Tettamanzi con un arcivescovo vicino alle posizioni del Pdl (anche se recentemente ha preso le distanze dai seguaci lombardi di don Giussani) sarebbe una piccola rivoluzione negli equilibri del potere Vaticano esarebbe vista come una presa da parte dei conservatori di un feudo dei moderati non berlusconiani. Per questo, nonostante risalgano a quasi un anno fa, le lettere (che pubblichiamo in parte sotto e integralmente sul sito www.ilfattoquotidiano.it ) conservano una grande attualità.
IL FAX del segretario di Stato del 26 marzo 2011 e la missiva di Tettamanzi al Papa del 28 marzo sono la prova migliore della situazione anomala in cui versa oggi il vertice della Chiesa. Il segretario di Stato si arroga sempre più spesso i poteri del Santo Padre e agisce con lo stile di un capo azienda. Dall’altro lato i cardinali più autorevoli, come Tettamanzi, e i monsignori più orgogliosi, come Carlo Maria Viganò, si ribellano ai diktat di Bertone. E il risultato è un governo schizofrenico che oscilla tra autarchia e anarchia. Mentre Benedetto XVI si isola negli studi e nella scrittura dei libri, alle sue spalle si svolge una lotta di potere senza esclusione di colpi che danneggia l’autorità morale della Chiesa dentro e fuori le mura leonine.
Ratzinger mi dice che devi lasciare (lettera di Bertone a Tettamanzi)
di Tarcisio Bertone
del 24 marzo 2011
Signor Cardinale, circa otto anni or sono Ella, accogliendo con encomiabile zelo e generosa disponibilità la richiesta che Le veniva fatta, accettò per un biennio la nomina a Presidente dell’Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori.(...). Di fatto, l’impegno di Vostra Eminenza a servizio dell’Istituto Toniolo si è protratto ben oltre il tempo originariamente previsto, e questo ovviamente a prezzo di ben immaginabili sacrifici (...) Ora, essendo scaduti alcuni Membri dei Comitato Permanente, il Santo Padre intende procedere a un rinnovamento, in connessione col quale Vostra Eminenza è sollevata da questo oneroso incarico. Adempiendo pertanto a tale Superiore intenzione, sono a chiederLe di fissare l’adunanza del Comitato Permanente entro il giorno 10 del prossimo mese di aprile. In tale circostanza. (...) Contestualmente indicherà il Prof. Giovanni Maria Flick, previa cooptazione nel Comitato Permanente, quale Suo successore alla Presidenza. Il Santo Padre dispone inoltre, che fino all’insediamento del nuovo Presidente, non si proceda all’adozione dì alcun provvedimento o decisione riguardanti nomine o incarichi o attività gestionali dell’Istituto Toniolo. Sarà poi compito del Prof. Flick proporre la cooptazione dei membri mancanti nell’Istituto Toniolo, indicando in particolare il prossimo Arcivescovo pro tempore di Milano e un Prelato suggerito dalla Santa Sede. In previsione dell’avvicendamento indicato, questa Segreteria di Stato ha già informato il Prof. Flick, ottenendone il consenso. Non c’è bisogno che mi soffermi ad illustrare le caratteristiche etiche e professionali che raccomandano questa illustre Personalità, ex allievo dell’Università Cattolica del Sacro. Cuore, oggi nelle migliori condizioni per assumere la nuova responsabilità in quanto libero da altri incarichi. (...)
Ma il cardinale parla a nome tuo? (Lettera di Tettamanzi a Ratzinger)
di Dionigi Tettamanzi
Beatissimo Padre, sabato 26 marzo mattina per fax è arrivata alla mia attenzione, in qualità di Presidente dell’Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori, una lettera “riservata - personale” del Segretario di Stato, che mi induce (...) a sottoporre direttamente alla Sua persona alcune spiacevoli considerazioni. La lettera in oggetto prende le mosse dalla mia nomina a Presidente dell’Istituto nel 2003, pochi mesi dopo il mio ingresso a Milano, sostituendo il Sen. Emilio Colombo, dimissionario non tanto a causa di modifiche statutarie, come affermato nello scritto, ma per più consistenti ragioni legate alla sua condotta personale e pubblica (...) L’accenno a un originario ’’biennio" di carica, anch’esso senza alcun riscontro, e a un tempo di governo prolungato è l’unico motivo che viene addotto per procedere immediatamente nella coazione al mio dimissionamento (...) Annoto a margine che il candidato (Giovanni Maria Flick Ndr), sul cui profilo gravano non poche perplessità, sorprendentemente è già stato avvisato della cosa da parte della Segreteria di Stato. Tutte queste sanzioni (...) sono direttamente ricondotte all’esplicito volere di Vostra Santità, cui lo scritto fa continuamente riferimento. Ben conoscendo la mitezza di carattere e delicatezza di tratto di Vostra Santità e avendo serena coscienza di avere sempre agito per il bene dell’Istituto e della Santa Chiesa, con trasparenza e responsabilità e senza avere nulla da rimproverarmi, sorgono in me motivi di profonda perplessità rispetto all’ultima missiva ricevuta e a quanto viene attribuito direttamente alla Sua persona (...) Nell’ultimo anno l’Istituto Toniolo è stato oggetto di attacchi calunniosi, anche mediatici, a causa di presunte e non dimostrate inefficienze amministrative e gestionali, apostrofate con l’espressione di mala gestio. Nulla di tutto questo! (...) (...) Ma lascio a Lei di confermarmi con una Sua parola
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- "L’uomo resta dove sta, e basta!" - Bertone contro Tettamanzi Università cattolica e Policlinico Gemelli: i giganti della guerra in Vaticano29 febbraio 2012, di Federico La Sala
Bertone contro Tettamanzi
Università cattolica e Policlinico Gemelli: i giganti della guerra in Vaticano
di Marco Lillo (il Fatto, 29.02.2012)
La partita del Toniolo non è affatto chiusa. L’ente conteso tra il cardinale Dionigi Tettamanzi, che lo presiede, e il segretario di Stato Tarcisio Bertone che vorrebbe metterlo sotto la sua ala, ieri è stato scosso dalla pubblicazione delle lettere nelle quali i due porporati se le davano di santa ragione al cospetto del Papa. A stupire non è stato tanto il contenuto delle missive, in parte rivelato dai migliori vaticanisti nella primavera scorsa, ma i toni.
NESSUNO si aspettava che il braccio destro del Papa, il cardinale Bertone, si permettesse di recapitare un simile “foglio di via” a un personaggio della caratura di Dionigi Tettamanzi, dato come probabile Papa nel 2005. Né era immaginabile che il Segretario di Stato si arrogasse il diritto di parlare a nome del pontefice o che arrivasse a licenziare il presidente dell’Istituto Toniolo addirittura con un fax. Allo stesso modo nessuno si aspettava di leggere la parte della lettera del cardinale Tettamanzi nella quale di fatto si dice che il senatore Emilio Colombo aveva perso la presidenza dell’Istituto per la sua spiacevole abitudine di consumare cocaina. Né che Tettamanzi giungesse a mettere in discussione la figura di Giovanni Maria Flick, ex ministro del Governo Prodi, vicino ai settori progressisti ai quali il cardinale si era appoggiato negli anni in cui aveva ricoperto il ruolo di arcivescovo prima a Genova e poi a Milano.
PROBABILMENTE dopo il braccio di ferro è arrivata l’epoca della tregua. Formalmente il Toniolo sarà guidato da Tettamanzi per tutto il 2012 di fatto però a uscire vincitrice è stata l’alleanza tra la Cei e la Curia milanese. Tra i due litiganti sono i due Angeli a godere. Dalla contesa epistolare tra Bertone e Tettamanzi sono usciti vincitori il cardinale Angelo Bagnasco e l’arcivescovo Angelo Scola. Non si comprende l’importanza della partita in corso se non si tengono a mente alcuni numeri. Dall’Istituto di Studi Superiori Giuseppe Toniolo, dipende l’università Cattolica del Sacro Cuore, il più grande ateneo privato d’Europa con 42 mila studenti, 1400 docenti, 14 facoltà, 54 istituti e 22 dipartimenti sparsi in quattro atenei con sedi a Milano, Brescia, Piacenza, Cremona, Roma e Campobasso. Il rettore, che proviene dal Toniolo è il ministro della cultura del Governo Monti, il professor Lorenzo Ornaghi, in aspettativa e sostituito solo “per il periodo dell’espletamento dell’incarico” dal professor Franco Anelli.
Fondato nel 1920 da padre Agostino Gemelli, il Toniolo controlla la casa editrice, fondata due anni prima, “Vita e pensiero”, che pubblica l’omonima rivista e un catalogo di 800 libri. Ma soprattutto il policlinico Agostino Gemelli, sorto nel 1964 a Roma su un’estensione di 37 ettari, per una superficie coperta che negli anni è aumentata fino a 30 mila metri quadrati, una cittadina di 20 mila abitanti (tra pazienti, medici e familiari) nella città. All’Istituto Toniolo fanno poi capo anche le (piccole) quote della SCAI Spa, Società di Chirurgia addominale italiana, e della Altipiani Val di Non Spa più la proprietà della Passo della Mendola Srl e della Monte Mario 2000 Srl, oltre che della Vita e Pensiero Srl.
IN PARTICOLARE la Monte Mario 2000 possiede un fabbricato in via degli Scolopi, sulla Trionfale e molti terreni nella zona Pineta Sacchetti, sui quali era stata tentata anche un’operazione immobiliare bloccata dagli enti locali e poi dalla giustizia amministrativa. Direttamente al Toniolo fanno capo interi palazzi a Milano, in viale Stelvio e in via San Vittore, oltre ovviamente ai fabbricati che ospitano le sedi degli atenei e del Policlinico Gemelli.
Ovviamente l’ospedale Gemelli e l’università Cattolica sono due grandi centri di spesa, imponenti stazioni appaltanti dai quali dipendono più di 1600 lavoratori e tante società fornitrici di beni e servizi.
Non a caso i primi annunci della lotta di potere che si sta disputando attorno al consiglio del Toniolo si riferivano proprio agli appalti. Nel settembre del 2010 furono pubblicati alcuni articoli sui grandi quotidiani nazionali nei quali si dava conto di alcune accuse, tutte da dimostrare, al direttore amministrativo della Cattolica, Antonio Cicchetti. In particolare uscirono sul Corriere della sera ampi stralci delle tre lettere scritte dal giurista Alberto Crespi. Il penalista che aveva insegnato per decenni diritto alla Cattolica prima di divenire anche preside della facoltà di giurisprudenza, dopo essere andato in pensione, prendeva carta e penna per segnalare “forti anomalie” nelle scelte dell’Istituto Toniolo.
Negli articoli, basati sulle lettere, fu così squadernato il reticolo di interessi, talvolta in società vicine alla Cattolica e al Gemelli, dei familiari di Cicchetti. Si ponevano dubbi sui conflitti di interesse.
MA QUALCUNO fa risalire il primo campanello di allarme di una sorda lotta di potere all’ombra dell’Istituto, mediante la pubblicazione di lettere e veline, alla campagna contro di Dino Boffo. L’allora direttore di Avvenire fu fatto fuori nell’estate 2009 per la pubblicazione sul Giornale di un documento falso e calunnioso che - secondo i bene informati - mirava a metterlo fuori gioco proprio dalla partita del Toniolo. Una partita che, dopo il mantenimento di Dionigi Tettamanzi alla presidenza e la nomina di Angelo Scola nel consiglio, però trova proprio in Dino Boffo e nella Cei il vero ago della bilancia.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- "L’uomo resta dove sta, e basta!". Bertone e il disagio tra gli episcopati dei Paesi europei (di Gian Guido Vecchi)1 marzo 2012, di Federico La Sala
Bertone e il disagio tra gli episcopati dei Paesi europei
di Gian Guido Vecchi (Corriere della Sera, 1 marzo 2012)
Il cardinale Tarcisio Bertone abbozza un sorriso ma ha l’aria un po’ tirata, «questi sono i documenti veri da vedere e da presentare!». Il Segretario di Stato è appena uscito dalla mostra Lux in arcana che presenta un centinaio di gioielli dell’Archivio segreto - dai processi a Galileo e Giordano Bruno agli interrogatori dei Templari - e non ha voglia di parlare dei «corvi» e delle fughe di documenti riservati, «di questi documenti in mostra, piuttosto, colpisce la verità storica». Nel senso, gli chiedono, che i testi usciti in questi giorni non sono veri? «Voi lo sapete. Voi siete bene informati», risponde secco ai giornalisti.
È un momento difficile, in Vaticano. E’ evidente che la diffusione col contagocce dei documenti riservati ha avuto ed ha l’obiettivo di colpire il cardinale Bertone. Ed è una strategia di logoramento che sta lasciando il segno, la pressione intorno al Segretario di Stato cresce. Tanto che circola la voce di un disagio crescente tra gli episcopati europei, dalla Germania alla Francia alla Spagna, i quali si preparerebbero a porre a Roma il problema della Segreteria di Stato.
Bertone il 2 dicembre compirà 78 anni, la stessa età del predecessore quando lasciò l’incarico, cosa alla quale puntano i suoi avversari. In ogni caso, non è questione di date: l’ufficio di Segretario di Stato si esercita ad nutum Summi Pontificis, il che significa che al Papa basta un cenno («nutum») per cambiare in qualsiasi momento, se vuole, il Segretario di Stato. Le previsioni di un cambio della guardia «imminente» si ripetono come i malumori da almeno tre anni ma nel frattempo Benedetto XVI ha sempre dimostrato la massima fiducia nell’uomo che è il suo più stretto collaboratore dai tempi della Congregazione per la dottrina della Fede.
Certo che la situazione non era mai stata così tesa. Oltretevere si arriva a dire che all’indagine della Gendarmeria alla caccia dei corvi si sia associata un’inchiesta «privata». Raccontano che la gente usi con timore computer e telefoni, mentre cresce il sospetto reciproco e con esso le voci velenose. Voci, veleni. Cui si aggiungono problemi più oggettivi. Ad esempio, il «compromesso» voluto da Bertone e raggiunto nella modifica alla legge di trasparenza finanziaria, approvata il 25 gennaio, non ha dissolto le perplessità.
Prima dell’approvazione finale, il cardinale Attilio Nicora, presidente dell’Autorità di informazione finanziaria, si era mostrato preoccupato perché «la nuova versione della legge riforma in toto l’assetto istituzionale del sistema antiriciclaggio vaticano, ridefinendo compiti e ruoli dell’Autorità e modificando l’impostazione». Con relativo timore che l’intervento «potrebbe essere visto dall’esterno, anche se erroneamente, come un "passo indietro"». Anche dopo il «compromesso» è un timore che resta, Oltretevere: in vista dell’attesissima risposta alla richiesta di ingresso della Santa Sede nella «white list» dell’Ocse. Tanto da alimentare altre voci - riprese ieri dal giornalista Gianluigi Nuzzi su Twitter - che vorrebbero Bertone incline a sostituire entro l’estate Ettore Gotti Tedeschi - tra gli artefici principali della prima versione della legge - alla presidenza dello Ior.
-
-
-
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- IL TRATTATO DELLA VERGOGNA (di Furio Colombo)-27 febbraio 2012, di Federico La Sala
Il Trattato della vergogna
La condanna di Strasburgo contro l’Italia, responsabile di violazione dei diritti umani per i respingimenti, pone un interrogativo: che ne è dell’accordo con la Libia, formalmente mai sospeso?
di Furio Colombo (il Fatto, 26.02.2012)
Signor Presidente, vorrei ricordare che il voto favorevole su questo Trattato sarà una pietra tombale sui diritti di umani di quei dannati della terra che sono in realtà la ragione del pagamento di centinaia di milioni di dollari alla Libia di Gheddafi. Il fatto è prorpio questo: si dice di voler combattere i mercanti di schiavi e si dà la caccia agli schiavi.
Signor Presidente, per fortuna abbiamo la testimonianza costante dei deputati radicali eletti nel Pd, per fortuna ci sono persone come l’On. Sarubbi che dicono queste cose, altrimenti da questa parte dell’aula ci sarebbe un silenzio che non riesco a spiegarmi. Signor Presidente, è già stato notato dai colleghi radicali il curioso silenzio dei media. Per le televisioni e i giornali questo dibattito non sta avvenendo. Se i media ne parlassero, la vicenda, così come si sta svolgendo, sarebbe clamorosa: dalla parte della Libia, vi sono il Popolo della Libertà e il Partito Democratico; dall’altra, contro il governo libico e contro il Trattato di amicizia con la Libia, i sei deputati radicali, due deputati del Pd, l’Italia dei Valori, l’Unione di Centro (su alcune posizioni) e alcuni deputati che usciranno dall’aula al momento del voto.
Signor Presidente, vorrei anticiparle che, in questo mondo globale, entro alcuni mesi cominceremo a sapere che cosa accade davvero nelle prigioni libiche e nella zona di mare sottoposta a pattugliamento misto, dunque a respingimento. Quando sapremo queste cose suggerisco ai colleghi del ‘corteo Gheddafi’ di preparare qualche risposta per gli italiani e per il mondo. Signor Presidente, questo Trattato è fuori dalla Costituzione perchè nega i diritti delle persone, è fuori dalla Convenzione di Ginevra perchè abbandona i profughi e non consente il diritto di asilo; è fuori dalla Carta dei Diritti dell’Uomo perché espone a persecuzione i migranti. È fuori dall’Europa perchè nessun Paese vuole avere un ruolo accanto all’Italia in questa storia terribile. Oggi questo Parlamento dovrà votare un trattato-ricatto con un ricattatore che non esisterà a rilanciare il gioco perché sa che i due fondamenti del Trattato sono il respingimento in mare o la cattura dei migranti e l’approvvigionamento del petrolio. Il senso di questo Trattato è che noi paghiamo i privilegi che ci garantisce con armi, somme enormi e vite umane”.
* * *
QUESTI CHE avete letto qui sopra sono frammenti del continuo, affannato intervenire alla Camera dei Deputati il giorno 20 gennaio 2009, quando ho tentato di oppormi all’approvazione quasi all’unanimità il Trattato di amicizia con la grande Jamahirrya (la Libia di Gheddafi). Quel Trattato adesso si aggiunge agli errori gravi e ai momenti oscuri della nostra Repubblica. Perché ancora oggi, con la selvaggia uccisione di Gheddafi, non sappiamo e non sapremo mai tutte le ragioni, e il vero senso di un ignobile atto diplomatico stranamente accettato in modo così silenzioso e concorde da quasi tutto il Parlamento.
Un evento di giovedì scorso mi riporta al ricordo di quel giorno, di quelle ore di estremo tentativo di sbarrare la strada al Trattato, sospetto di interessi privati, oltre che di clamorosa violazione di norme internazionali e di patti italiani pre-esistenti, oltre che di creazione di una folle alleanza militare con basi italiane a disposizione della Libia, oltre che alla istituzione, approvata e votata, del delitto di “respingimento in mare” per chi tentasse di trovare rifugio in Italia fuggendo guerre e persecuzioni.
Sto parlando della condanna definitiva della Corte di Strasburgo contro l’Italia per violazione dei diritti umani. Tale sentenza ripete, una per una, le ragioni e le tragiche previsioni degli oppositori di quella legge priva di senso umano e di senso giuridico. Nella Cancelleria della Corte il caso è rubricato come “Hirsi Jamaa contro l’Italia”, ed è fondato sul ricorso di 11 profughi somali e 10 eritrei, assistiti dal Consiglio Italiano per i Rifugiati (cito da La Repubblica, 24 febbraio) che nella notte tra il 6 e il 7 maggio 2009 furono intercettati a sud di Lampedusa e consegnati dalle motonavi italiane alle autorità libiche.
Un comportamento che, secondo il verdetto unanime dei giudici di Strasburgo, ha violato l’articolo 3 della Convenzione europea sui Diritti dell’Uomo. Infatti consegnando i profughi alla Libia, l’Italia li ha esposti a due rischi estremi: la morte nelle prigioni di un Paese che non ha firmato alcuna convenzione o trattato sui Diritti umani e ha goduto della triste celebrità di non rispettarli mai. E il rischio di morte, se rimpatriati, per i profughi consegnati ai libici. Inoltre l’Italia è stata riconosciuta colpevole del delitto di espulsione collettiva, per non aver concesso ai migranti la possibilità di richiedere il diritto d’asilo.
L’ITALIA è stata anche condannata per avere dichiarato che “La Libia era un posto sicuro e che Tripoli rispettava i propri impegni internazionali sull’accesso all’asilo”. Ora è bene chiarire: questo ricordare insieme l’opposizione accanita di pochi in un Parlamento stranamente succube a un Trattato disumano, ma anche assurdo, e la sentenza della Corte di Strasburgo non è una celebrazione perché ha troppe impronte di morte. Ma l’intenzione è di tenere vivo un altro allarme.
Misteriosamente il Trattato condannato da Strasburgo non è ufficialmente e formalmente cancellato. Per quanto ne sappiamo, i nuovi libici vorrebbero dimenticarlo. L’Italia, anche con il nuovo governo, sembra amare una finzione di sopravvivenza, benché i mondi di Gheddafi e di Berlusconi siano crollati per sempre. Il problema rimane. Qualcuno lo chieda, qualcuno lo dica: c’è ancora quel Trattato che ci condanna come un Paese barbaro e disumano secondo la squallida visione di Maroni, di Bossi, di Calderoli, di Borghezio, di Castelli e di ciò che resta della Lega Nord?
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- La Chiesa non «collusa» si ribella (Luca Kocci)26 febbraio 2012
La Chiesa non «collusa» si ribella
di Luca Kocci
in “il manifesto” del 26 febbraio 2012
La Chiesa è spesso alleata del potere, invece dovrebbe schierarsi sempre con gli ultimi e con i senza potere. Lo chiedono in una «Lettera aperta alla Chiesa italiana» - rilanciata ieri dall’agenzia di informazioni Adista - 7 parroci e religiosi, fra cui don Alessandro Santoro della Comunità delle Piagge di Firenze e la teologa domenicana Antonietta Potente, insieme ad oltre 250 cattolici che l’hanno sottoscritta. Il malessere e l’insofferenza verso le strutture gerarchiche e i comportamenti di un’istituzione ecclesiastica che sembra assai distante dal Vangelo sono evidenti: «L’esempio che abbiamo dalla Chiesa ufficiale è, la maggior parte delle volte, quello di pretendere riconoscimenti e difendere i propri interessi, immischiandosi in politica solo per salvaguardare i propri privilegi», si legge nella Lettera aperta .
Non vogliamo «essere collusi e complici», scrivono i religiosi che chiedono che la Chiesa «ripensi la propria struttura gerarchica e i rapporti con la società. Vorremmo che si rifiutasse ogni privilegio economico e soprattutto vorremmo che l’economia delle strutture ecclesiali non fosse complice della finanza e delle banche che speculano con il denaro a scapito del sudore e del sangue di individui e intere comunità, praticando un indebito sfruttamento, non solo delle risorse umane, ma anche di quelle naturali». Fardelli, ma per altri
I credenti, denunciano, non sono considerati e trattati nel rispetto della loro autonomia e libertà - quel «popolo di Dio in cammino» proclamato da un Concilio Vaticano II sempre più soffocato e riportato nel solco della tradizione, da papa Wojtyla prima e da Ratzinger adesso -, bensì gregge obbediente da condurre: «La struttura ecclesiale sembra più preoccupata a guidarci che a farci partecipare», si legge nella Lettera , «le comunità cristiane appaiono più tese a difendere una tradizione che a vivere una esperienza di fede», «ci sentiamo trattati come persone immature, come se non fossimo responsabili delle nostre comunità, ma solo destinatari chiamati a obbedire a ciò che pochi decidono ed esprimono per noi».
Infatti molto spesso la Chiesa interviene «attraverso analisi, sentenze e a volte giudizi, che non ascoltano e non rispettano le ricerche e i tentativi che comunque la società fa per essere più autentica e giusta. Ci sembrano sempre più vere le parole di Gesù nel Vangelo: legano pesanti fardelli e li impongono sulle spalle della gente, ma loro non vogliono muoverli neppure con un dito».
Quello espresso dalla Lettera aperta è un disagio che emerge sempre di più. Dall’interno della stessa Chiesa - assai meno monolitica di quanto viene proclamato dalle gerarchie e dai media istituzionali -, spesso si levano voci critiche non di isolati "battitori liberi" ma di gruppi consistenti di preti, religiosi e religiose che non possono essere etichettati con la categoria del «dissenso», in voga qualche decennio fa, ma che sono pienamente inseriti nel tessuto ecclesiale e che chiedono riforme, anche radicali.
Come quella di un gruppo di preti del Triveneto, fra i quali Albino Bizzotto dei Beati i costruttori di pace, che ad inizio anno fecero un elenco: la Chiesa rinunci ai patrimoni, elimini i cappellani militari e l’ora di religione cattolica, dia spazio alle donne e si apra alla democrazia. Insomma sia più evangelica.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ----STATO E CHIESA: FISCO. Il giorno dopo la gran decisione del governo Monti di far pagare l’Imu anche alla Chiesa è già controffensiva (di Francesco Grignetti).26 febbraio 2012, di Federico La Sala
FISCO RIFORME E POLEMICHE
Le scuole cattoliche all’offensiva anti-Imu
E Bertone sottolinea il ruolo della Chiesa per il welfare italiano
di FRANCESCO GRIGNETTI (La Stampa, 26/02/2012)
ROMA Il giorno dopo la gran decisione del governo Monti di far pagare l’Imu anche alla Chiesa con un emendamento ad hoc al decreto-liberlizzazioni, è già controffensiva su tutti i fronti: politico, mediatico, giuridico. In Campidoglio c’è il cardinale Tarcisio Bertone, segretario di Stato vaticano, che presiede un convegno sul «welfare cattolico» che sembra fatto apposta. Sono presenti tutte le congregazioni religiose, ovvero i terminali da cui dipendono scuole, cliniche, alberghi, case di riposo, ostelli. Si sciorinano dati: sono 14.246 i servizi sanitari, sociosanitari e socioassistenziali direttamente o indirettamente collegati con la Chiesa, i quali «contribuiscono alla costruzione del welfare». Sono oltre 420 mila tra laici e religiosi, i dipendenti e i volontari impiegati. Ricorda quindi a buon diritto, Bertone, quanto il welfare cattolico lavori «per la promozione e il riconoscimento della dignità di ogni uomo». E pur senza citare la questione delle tasse, il cardinale rivendica un ruolo storico per l’Italia: «Una presenza capillare di opere benefiche e caritative ha contribuito in modo significativo alla maturazione nella società di una nuova sensibilità rispetto all’adozione di politiche assistenziali».
Il sottinteso del discorso del cardinal Bertone è evidente: se la sente il governo di fare a meno di questo apparato cattolico che comunque esiste e supporta il welfare pubblico? Soltanto in risparmi sulle scuole si calcola che lo Stato risparmi 5 miliardi di euro. Giunge a questo proposito un sonoro messaggio dal Quirinale che non manca di sottolineare quanto il mondo cattolico abbia concorso «allo sviluppo economico-sociale del Paese ed alla maturazione di valori, quali quelli della mutualità, della solidarietà e della convivenza pacifica, che trovano oggi consacrazione nella nostra Carta costituzionale».
In Parlamento, intanto, si fa sentire l’area cattolica. Da Maurizio Gasparri («Sarebbe errato penalizzare chi si occupa di poveri o di educazione») a Pier Ferdinando Casini («Decisione ineccepibile. Diverso è il caso egli enti assistenziali e delle scuole») a Gianni Alemanno («Non può e non deve essere un attacco agli istituti religiosi, perché senza di loro saremmo molto più deboli e più poveri»), a Paola Binetti («Tassiamo senza chiederci se è possibile fare di tutta un’erba un fascio, senza chiederci quanto effettivo è il risparmio che la scuola paritaria consente di far fare allo Stato»), al democratico Giorgio Merlo («C’è solo da augurarsi che non riparta la solita, noiosa litania anticlericale»). E intanto il senatore Salvatore Piscitelli (Coesione Nazionale) propone di cancellare l’emendamento o almeno posporlo al 2016.
Fissato il principio, la battaglia ora si sposta sull’interpretazione delle norme. Entro due mesi l’Agenzia delle Entrate dovrà stabilire se, come e quanto le scuole private cattoliche debbano pagare l’Ici. Così le case di cura o di riposo. «L’emendamento è chiaro e risolutivo - commenta il senatore Stefano Ceccanti, Pd - nel determinare il regime fiscale esclusivamente sulla base delle modalità dell’attività e non sulla natura dell’ente». «Sulla delicata questione scolastica, andranno commisurati i contributi richiesti agli utenti con il costo effettivo del servizio per valutare se si tratti di attività commerciale o meno».
Caso per caso sarà da verificare se un’attività sia effettivamente no-profit. E però don Alberto Lorenzelli, presidente della Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori, è in grande apprensione: «Così rischiamo la chiusura perché solitamente le nostre scuole si trovano in complessi molto grandi e il contributo sarebbe proporzionale alla loro misura. Mi auguro che l’Imu riguardi solo gli spazi in cui ci sono vere realtà commerciali».
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- La "Costituente" della cultura, Cinque punti-25 febbraio 2012, di Federico La Sala
La “Costituente” per la cultura *
1 Una costituente per la cultura
Cultura e ricerca sono capisaldi della nostra Carta fondamentale. L’articolo 9 della Costituzione «promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione». Sono temi intrecciati tra loro. Perché ciò sia chiaro, il discorso deve farsi economico. Niente cultura, niente sviluppo. "Cultura" significa educazione, ricerca, conoscenza; "sviluppo" anche tutela del paesaggio.
2 Strategie di lungo periodo
Se vogliamo ritornare a crescere, se vogliamo ricominciare a costruire un’idea di cultura sopra le macerie che somigliano a quelle su cui è nato il risveglio dell’Italia nel dopoguerra, dobbiamo pensare a un’ottica di medio-lungo periodo in cui lo sviluppo passi obbligatoriamente per la valorizzazione delle culture, puntando sulla capacità di guidare il cambiamento. Cultura e ricerca innescano l’innovazione, e creano occupazione, producono progresso e sviluppo.
3 Cooperazione tra i ministeri
Oggi si impone un radicale cambiamento di marcia. Porre la reale funzione di sviluppo della cultura al centro delle scelte del Governo, significa che strategia e scelte operative devono essere condivise dal ministro dei Beni Culturali con quello dello Sviluppo, del Welfare, della Istruzione e ricerca, degli Esteri e con il premier. Il ministero dei Beni Culturali e del paesaggio dovrebbe agire in coordinazione con quelli dell’Ambiente e del Turismo.
4 L’arte a scuola e la cultura scientifica
L’azione pubblica contribuisca a radicare a tutti i livelli educativi, dalle elementari all’Università, lo studio dell’arte e della storia per rendere i giovani i custodi del nostro patrimonio, e per poter fare in modo che essi ne traggano alimento per il futuro. Per studio dell’arte si intende l’acquisizione di pratiche creative e non solo lo studio della storia dell’arte. Ciò non significa rinunciare alla cultura scientifica, ma anche assecondare la creatività.
5 Pubblico-privato, sgravi ed equità fiscale
Una cultura del merito deve attraversare tutte le fasi educative, formando i cittadini all’accettazione di regole per la valutazione di ricercatori e progetti di studio. La complementarità pubblico/privato, che implica l’intervento dei privati nella gestione del patrimonio pubblico, deve divenire cultura diffusa. Provvedimenti legislativi a sostegno dei privati vanno sostenuti con sgravi fiscali: queste misure presentano anche equità fiscale.
* Il Sole 24 Ore, 25 febbraio 2012
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- Senza fede o fiducia, non è possibile futuro, c’è futuro solo se possiamo sperare o credere in qualcosa (di Gorgio Agamben - Se la feroce religione del denaro divora il futuro)16 febbraio 2012, di Federico La Sala
Se la feroce religione del denaro divora il futuro
di Giorgio Agamben (la Repubblica, 16.02.2012)
Per capire che cosa significa la parola "futuro", bisogna prima capire che cosa significa un’altra parola, che non siamo più abituati a usare se non nella sfera religiosa: la parola "fede". Senza fede o fiducia, non è possibile futuro, c’è futuro solo se possiamo sperare o credere in qualcosa.
Già, ma che cos’è la fede? David Flüsser, un grande studioso di scienza delle religioni - esiste anche una disciplina con questo strano nome - stava appunto lavorando sulla parola pistis, che è il termine greco che Gesù e gli apostoli usavano per "fede". Quel giorno si trovava per caso in una piazza di Atene e a un certo punto, alzando gli occhi, vide scritto a caratteri cubitali davanti a sé Trapeza tes pisteos. Stupefatto per la coincidenza, guardò meglio e dopo pochi secondi si rese conto di trovarsi semplicemente davanti a una banca: trapeza tes pisteos significa in greco "banco di credito".
Ecco qual era il senso della parola pistis, che stava cercando da mesi di capire: pistis, " fede" è semplicemente il credito di cui godiamo presso Dio e di cui la parola di Dio gode presso di noi, dal momento che le crediamo. Per questi Paolo può dire in una famosa definizione che "la fede è sostanza di cose sperate": essa è ciò che dà realtà a ciò che non esiste ancora, ma in cui crediamo e abbiamo fiducia, in cui abbiamo messo in gioco il nostro credito e la nostra parola. Qualcosa come un futuro esiste nella misura in cui la nostra fede riesce a dare sostanza, cioè realtà alle nostre speranze.
Ma la nostra, si sa, è un’epoca di scarsa fede o, come diceva Nicola Chiaromonte, di malafede, cioè di fede mantenuta a forza e senza convinzione. Quindi un’epoca senza futuro e senza speranze - o di futuri vuoti e di false speranze. Ma, in quest’epoca troppo vecchia per credere veramente in qualcosa e troppo furba per essere veramente disperata, che ne è del nostro credito, che ne è del nostro futuro?
Perché, a ben guardare, c’è ancora una sfera che gira tutta intorno al perno del credito, una sfera in cui è andata a finire tutta la nostra pistis, tutta la nostra fede. Questa sfera è il denaro e la banca - la trapeza tes pisteos - è il suo tempio. Il denaro non è che un credito e su molte banconote (sulla sterlina, sul dollaro, anche se non - chissà perché, forse questo avrebbe dovuto insospettirci - sull’euro), c’è ancora scritto che la banca centrale promette di garantire in qualche modo quel credito.
La cosiddetta "crisi" che stiamo attraversando - ma ciò che si chiama "crisi", questo è ormai chiaro, non è che il modo normale in cui funziona il capitalismo del nostro tempo - è cominciata con una serie sconsiderata di operazioni sul credito, su crediti che venivano scontati e rivenduti decine di volte prima di poter essere realizzati. Ciò significa, in altre parole, che il capitalismo finanziario - e le banche che ne sono l’organo principale - funziona giocando sul credito - cioè sulla fede - degli uomini.
Ma ciò significa, anche, che l’ipotesi di Walter Benjamin, secondo la quale il capitalismo è, in verità, una religione e la più feroce e implacabile che sia mai esistita, perché non conosce redenzione né tregua, va presa alla lettera. La Banca - coi suoi grigi funzionari ed esperti - ha preso il posto della Chiesa e dei suoi preti e, governando il credito, manipola e gestisce la fede - la scarsa, incerta fiducia - che il nostro tempo ha ancora in se stesso. E lo fa nel modo più irresponsabile e privo di scrupoli, cercando di lucrare denaro dalla fiducia e dalle speranze degli esseri umani, stabilendo il credito di cui ciascuno può godere e il prezzo che deve pagare per esso (persino il credito degli Stati, che hanno docilmente abdicato alla loro sovranità).
In questo modo, governando il credito, governa non solo il mondo, ma anche il futuro degli uomini, un futuro che la crisi fa sempre più corto e a scadenza. E se oggi la politica non sembra più possibile, ciò è perché il potere finanziario ha di fatto sequestrato tutta la fede e tutto il futuro, tutto il tempo e tutte le attese.
Finché dura questa situazione, finché la nostra società che si crede laica resterà asservita alla più oscura e irrazionale delle religioni, sarà bene che ciascuno si riprenda il suo credito e il suo futuro dalle mani di questi tetri, screditati pseudosacerdoti, banchieri, professori e funzionari delle varie agenzie di rating.
E forse la prima cosa da fare è di smettere di guardare soltanto al futuro, come essi esortano a fare, per rivolgere invece lo sguardo al passato. Soltanto comprendendo che cosa è avvenuto e soprattutto cercando di capire come è potuto avvenire sarà possibile, forse, ritrovare la propria libertà. L’archeologia - non la futurologia - è la sola via di accesso al presente.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- IL VATICANO DELLE LAVANDAIE.14 febbraio 2012, di Federico La Sala
Il Vaticano delle lavandaie
di Aldo Maria Valli *
Che il Vaticano sia (anche) un villaggio di lavandaie si sapeva da tempo. Il pettegolezzo, nei sacri palazzi, è pane quotidiano, un grande gioco al quale giocano in tanti, con molteplici obiettivi. Mondo piccolo e chiuso, lo staterello del papa è anche un concentrato di poteri e di interessi: miscela esplosiva.
Inoltre è una monarchia assoluta, il che impedisce al dibattito interno di trovare sfogo attraverso vie istituzionali. Man mano che il sovrano, per età, per condizioni di salute o per entrambe le circostanze, si inoltra nella fase finale del regno, o in quella che i più ritengono tale, il villaggio entra in fibrillazione, le lavandaie danno il peggio di sé e il grande gioco si fa più duro. Alcuni esponenti del piccolo mondo, per ragioni diverse, si mettono a difendere posizioni, a tentare scalate, a cercare di guadagnare terreno.
Ad alcuni fa gola il potere, ad altri il denaro, a molti l’uno e l’altro. Poi ci sono le cordate, i gruppi di pressione, le amicizie e le inimicizie. A volte la linea che separa un vincente da un perdente è sottilissima. La curia vaticana è una corte, e nelle corti basta poco perché gli equilibri siano messi in discussione. Basta una parola avventata, un commento fuori posto, un inchino poco convinto o esagerato, ed ecco che ci si ritrova al centro di voci, di insinuazioni, di malignità o di vere e proprie calunnie. Una palla di neve, così, può diventare rapidamente una valanga. La lingua batte dove il dente duole. Per questo il terreno di gioco molto spesso è quello economico o quello sessuale. E anche sotto questo aspetto niente di nuovo da segnalare.
Gli elementi veramente nuovi, che emergono dalle ultime vicende, sono due: la spiccata propensione delle lavandaie a gettare i panni sporchi in pasto ai mass media e il basso, bassissimo livello denunciato dai giocatori. Un tempo le lavandaie arrivavano a scannarsi, esattamente come ora, per i più diversi motivi, ma il tutto restava all’interno delle sacre mura. Ora invece, nell’epoca dell’informazione, alcuni dei giocatori anno preso gusto a rovesciare i loro veleni nel grande imbuto dei mass media. In questo modo, pensano alcune lavandaie, la potenza dei proiettili è moltiplicata. Un’insinuazione o una calunnia, finché restano dentro le mura, hanno una certa forza: se ne fuoriescono, acquistano molta più incisività. E così i giornalisti vengono sempre più coinvolti nel grande gioco, con la funzione di megafoni.
Le lavandaie tuttavia sembrano non rendersi conto dell’effetto assuefazione e della distrazione del pubblico. Se una lettera anonima fa notizia, una seconda lettera anonima passa quasi inosservata e una terza provoca soltanto noia. Idem per complotti e cospirazioni varie, sia pure targate Vaticano. Circa il basso livello dei giocatori, basta passare in rassegna le ultime vicende (almeno dal caso Boffo in poi) per verificare che il materiale umano è davvero deludente. C’è modo e modo di ordire trame e architettare complotti.
Per dirla con Sciascia, anche nel campo delle macchinazioni ci sono uomini, mezzi uomini, ominicchi e quaquaraqua. Puoi essere un Borgia o un Castrillon Hoyos. E se una vecchia volpe come il cardinale Re ha soprannominato quest’ultimo “Pasticcion Hoyos”, un motivo ci dev’essere.
Da secoli il Vaticano si porta appresso la fama (più o meno meritata) di luogo incline alla congiura. Ma se una volta, dicendo “congiura”, si pensava a qualcosa di grande e raffinato, adesso si pensa più che altro a liti da comari bisbetiche. Sic transit gloria mundi, verrebbe da dire, ammesso che nello scandalo ci possa essere qualcosa di glorioso. Resta da capire come stia vivendo tutto questo un uomo intelligente, e ottimo conoscitore della curia, come Joseph Ratzinger.
Fu lui, quando era cardinale, a parlare di riforma paragonandola a un‘opera di ablatio (lo disse in latino, perché una volta gli uomini di Chiesa ancora lo parlavano), ovvero di eliminazione di tutte le cose e le persone inutili. Fu sempre lui a usare una parola inequivocabile, “sporcizia”, per dipingere certe degenerazioni all’interno della Chiesa, ed è stato ancora lui a mettere in guardia a più riprese dal carrierismo degli ecclesiastici. Dunque, i problemi li conosce bene, e non potrebbe essere altrimenti visti i decenni trascorsi nella stanza dei bottoni.
Eppure, proprio il pontificato del fine teologo Ratzinger rischia di chiudersi in mezzo agli schiamazzi di lavandaie sempre più sguaiate e alle liti da cortile di eminenze e illustrissimi che non meriterebbero di gestire nemmeno il più infimo degli ordini religiosi. Triste destino per lui e triste situazione per la gerarchia cattolica. Anche perché le voci coraggiose e limpide, dotate di profezia (guardare lontano) e di parresia (libertà di dire tutto) sembrano scomparse.
Aldo Maria Valli
* Europa, 14 febbraio 2012
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ----- La città del Vaticano “un nido di vipere”. Ora come allora... (di Roberto Faenza)12 febbraio 2012, di Federico La Sala
Al di là del Tevere “un nido di vipere”
di Roberto Faenza (il Fatto Quotidiano, 12 febbraio 2012)
Bisognerebbe interrogarsi da cosa derivi il potere del Vaticano sui media italiani. Ne sa qualcosa questo giornale, che sfidando l’ira dei colleghi quotidiani, ha appena pubblicato un documento sconcertante. Documento minimizzato dagli altri giornali. Per non concedere al Fatto l’onore delle armi di fronte a uno scoop giustamente definito una bomba da Santoro in trasmissione? Non credo sia questa la ragione. Il motivo risiede nel timore reverenziale di urtare la “sensibilità” d’oltre Tevere. Ringraziamo Internet e la stampa internazionale, se lo scoop del Fatto ha ricevuto la giusta attenzione.
A mio avviso la parte più drammatica del documento inviato al Papa non è nella rivelazione di un possibile attentato (ora grazie alla pubblicazione di sicuro allontanato; almeno di questo si renderà merito).
L’elemento più inquietante è nelle righe che sottintendono una faida interna in seno alle segrete stanze. Il New York Times, che se c’è da dare una notizia dell’ira del Vaticano se ne frega, ha cominciato a frugare in quei segreti, a partire dalla trasmissione di Gianluigi Nuzzi su La7 a proposito della lettera dell’attuale Nunzio apostolico a Washington (pare ancora per poco) sulla presunta corruzione all’interno del Governatorato di Città del Vaticano.
Questo silenzio omertoso che costringe gran parte dei media italiani a tenere la schiena poco dritta ha radici antiche. Quando negli anni Settanta insegnavo a Washington, ebbi l’avventura di “liberare” per la prima volta una serie di documenti segreti della amministrazione americana che riguardavano l’Italia e il Vaticano.
Si trattava di rivelazioni scottanti, antesignane del lavoro che fa oggi Julian Assange, incluse le fotocopie degli assegni pagati ai politici nostrani e ad alcuni prelati. Questi documenti li ho pubblicati in un primo libro circolato indenne grazie alla Feltrinelli, Gli americani in Italia, e poi in un secondo, Il Malaffare, subito tolto dal mercato dalla Mondadori.
Alla vigilia della Liberazione, un documento Top secret dell’ambasciata americana a Roma informa Washington che sono stati “agganciati” due alti prelati, Monsignor Perrone e Monsignor Dadaglio, i quali spifferano agli yankee quanto sta avvenendo in Vaticano, ovvero i timori di Pio XII per un possibile governo con dentro i comunisti. I due prelati rivelano che in Vaticano non tutti sono d’accordo con il Papa, tra questi Monsignor Tardini, che è a capo di una corrente “non ostile” al Pci.
La documentazione relativa a questi “intrighi del Vaticano”, così li definisce la stessa amministrazione americana, viene inviata ad alcuni giornalisti italiani perché ne scrivano, favorendo così il deflagrare di alcune posizioni troppo progressiste. Come si vede, quando si vuole scrivere si scrive.
Ancora più scottante la documentazione che concerne Monsignor Giovambattista Montini. Prima di diventare Segretario di stato e poi Papa Paolo VI, Montini viene “agganciato” da James Angleton, capo del controspionaggio di stanza a Roma. È convinto delle capacità del prelato, ma preoccupato del suo orientamento “poco conservatore”. Lo farà intercettare e monitorare tramite cimici piazzate nei suoi uffici da alcuni prelati compiacenti.
Le “trame in Vaticano”, così le qualificano i documenti, si fanno particolarmente accese, quando negli anni Sessanta si prepara il Concilio Vaticano II e la DC sta per aprire al partito socialista. Giovanni XXIII appare favorevole, ma non sono pochi i cardinali che la pensano diversamente e vorrebbero metterlo “sotto tutela”.
SI AGITANO come in un balletto il Sottosegretario di stato Monsignor Dell’Acqua e i monsignori Berloco e Iginio Cardinale, capo protocollo della Segreteria. Monsignor Vagnozzi, il delegato apostolico nella capitale americana, fa addirittura la spia di nascosto al Papa. Si presenta in gran segreto ai dirigenti del Dipartimento di stato per comunicare che “Giovanni XXIII ha un cancro inoperabile. Gli restano da vivere dai 6 ai 12 mesi. Monsignor Vagnozzi ha pregato di non fare il suo nome”. Lo stesso monsignore diventerà Presidente della Prefettura per gli Affari economici.
Ai tempi del breve e misterioso pontificato di Papa Luciani il cardinale Palazzini gli contesterà la sua reticenza sugli “immorali affari dello IOR” di Monsignor Marcinkus, “in combutta con Calvi eSindona”. Tutto questo cicaleccio preoccupa la stampa americana, che comincia a filtrare notizie. Silenzio invece sui nostri quotidiani.
Spiegano bene all’Italian desk del Dipartimento di stato: il Vaticano e la Chiesa sono due entità diverse: il primo è un vero e proprio stato con un suo governo. E come tutti i governi è attraversato da correnti e conflitti interni. La Chiesa invece, scrivono a Washington, si occupa delle anime dei fedeli, in quanto vera erede di Cristo. Il Vaticano, aggiungono, talvolta appare in dissidio con la Chiesa. È sicuramente il “partito” italiano più influente, temuto dalla stampa, riverito e omaggiato persino dal partito comunista. Poi in una nota definiscono la città del Vaticano “un nido di vipere”. Ora come allora?
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ----- DIREZIONE SPIRITUALE E MAGISTERO MAMMONICO (di Marco Pollliti - Abusi d’Oltretevere).9 febbraio 2012, di Federico La Sala
ABUSI D’OLTRETEVERE
“Volevo farmi suora, un prete si è fatto me”
di Marco Politi (il Fatto Quotidiano, 9 febbraio 2012)
- Don Virginio Colmegna, che a Milano dirige la Casa della Carità, afferma di aver letto il diario di Emanuela con “fatica, disgusto e conati di vomito”, augurandosi che il violentatore “ammantato di potere religioso” si assuma le sue responsabilità e decida di “rompere la copertura ipocrita del silenzio”. Nel diario, Emanuela scrive di un incidente. A me ha confessato di essersi gettata da un ponte.
Ho iniziato a fare direzione spirituale quando avevo 18 anni e la storia è iniziata quasi subito. Il don aveva capito il mio punto debole, la carenza d’affetto e, piano piano, lavorando sulla mia psiche fragile, è riuscito a mettermi in testa che l’amore, l’affetto, è un bene che si può vendere e comprare. La nostra frase era “Cinque minuti di quello che vuoi tu in cambio di cinque minuti di quello che voglio io”. Io volevo solamente sfogarmi, parlare dei miei problemi ed essere abbracciata, volevo essere messa al centro dell’attenzione, cosa che non accadeva mai nella mia famiglia.
La prima volta è stato così. “Ti porto in camera, ci sdraiamo sul letto così ti abbraccio meglio”. Ero talmente inesperta che non avevo mai visto un pene in vita mia, non sapevo come si facevano certe cose, ma poi ho dovuto imparare per forza. Stavamo su quel letto, c’erano volte in cui io dovevo semplicemente stare ferma e lui mi ravanava dappertutto e volte in cui si sedeva sul mio collo e io avevo paura di soffocare.
In camera sua c’era un crocifisso di legno pesante, proprio sopra il letto. Io avevo il terrore che quel crocifisso potesse cadermi in testa. Poi lui si rivestiva in fretta, mi buttava i vestiti e mi diceva di andarmene, aveva fretta di liberarsi di me.
Adesso Emanuela Violani (lo pseudonimo che ha scelto) ha più di ventisei anni. Il diario le è servito per rielaborare il trauma. Per cinque anni, in un paesino di campagna, è stata abusata da un prete. Aveva più di diciott’anni. Non era una minore. “Soltanto” una ragazza fragilissima, dedita all’alcol, manipolata come oggetto sessuale.
Era prete da poco. Ogni tanto andavamo al parcheggio del cimitero ed era sempre la solita storia: ho dovuto pagare tutto quello che mi ha dato. Ogni tanto mi portava al cinema o a mangiare una pizza. Io ero contenta perché non uscivo mai, solo che poi al ritorno andavamo a finire sempre in qualche parcheggio isolato e lì non mi doveva abbracciare per cinque minuti, dovevo subito iniziare. Per due anni mi sono ubriacata quasi tutti i fine settimana e quando non bevevo, andavo dal don perché avevo bisogno di riempire il vuoto della mia anima. Capivo che lui mi stava usando, ma io volevo stare con qualcuno. Ho anche avuto disturbi alimentari, mi nutrivo quasi esclusivamente di latte e nell’estate 2003 sono arrivata a pesare 41 chili. Era agosto, faceva caldo, stavo talmente male che non mi interessava della mia verginità, avrei dato tutto pur di essere presa in braccio e coccolata per qualche minuto, ma quando mi sono accorta che faceva sul serio, mi sono spaventata, ho iniziato a sentire male e gli ho detto di fermarsi. Lui (cento e più chili contro i miei quarantuno) con una mano mi teneva ferma e con l’altra mi tappava la bocca, poi ricordo il sangue, un “vaffanculo” detto da me e un “lo volevi anche tu” detto da lui. Ci ho messo un anno a capire che cosa mi era successo veramente, ho capito che razza d’uomo era solo quando ci siamo rivisti dopo diversi mesi e mi ha sbattuta fuori casa perché non volevo fare porcate con lui.
Da giovane Emanuela, molto credente, voleva diventare suora missionaria. Ora dice: “Volevo farmi suora e il prete si è fatto me”. Mi sono confessata da don D. Ho detto che avevo commesso un solo grande peccato: “Atti impuri con un prete” e lui mi ha detto cose orribili, mi ha detto che io ero il demonio sulla terra, che se quel prete dava la comunione dopo essere stato con me rovinava la sua comunità. Ero lì in ginocchio in quella chiesa scura con un pretino anziano che mi faceva cadere addosso dei massi enormi e non sapevo come difendermi. Non voleva darmi l’assoluzione, ma poi si è convinto e mi ha detto di non rifare più certe cose. Io sono uscita dal confessionale di corsa perché lui voleva vedermi, facevo fatica a stare in piedi, facevo fatica a parlare, ero sbiancata. Emanuela per chiedere aiuto si confida, mandando lettere a un altro sacerdote.
Don B. le leggeva ma un giorno le ha buttate via perché quando facevo le cose con don G. io descrivevo nei minimi dettagli le porcate che facevamo. Don B. ha buttato via questi miei “resoconti” perché ha detto che potrebbero finire nelle mani sbagliate. Quando a don B. in una lettera ho descritto per filo e per segno della violenza e ho chiesto: “È stata violenza?”, lui mi ha presa in un angolo della chiesa e, sottovoce per non farsi sentire, mi ha detto: “Se le cose sono andate come le hai descritte, sì, è stata violenza”, poi ssst, silenzio e se n’è andato”.
Don Virginio Colmegna, che a Milano dirige la Casa della Carità, afferma di aver letto il diario di Emanuela con “fatica, disgusto e conati di vomito”, augurandosi che il violentatore “ammantato di potere religioso” si assuma le sue responsabilità e decida di “rompere la copertura ipocrita del silenzio”. Nel diario, Emanuela scrive di un incidente. A me ha confessato di essersi gettata da un ponte.
Venti giorni dopo l’operazione, venti giorni soltanto dopo che mi hanno aperto la testa, mi hanno ricostruita con il metallo e con le viti, mi hanno tirato fuori le ossa della faccia che erano entrate... venti giorni dopo don G. mi ha detto che non ero più buona neanche a fare pompini.
Ho voluto rompere la cortina dello pseudonimo. Ho rintracciato Emanuela per sapere cosa è accaduto dopo. Mi ha detto al telefono che per anni, dopo che si rifiutava di vedere il suo violentatore, il prete l’ha perseguitata con messaggini. Finalmente lo ha denunciato per violenza. In Questura le hanno risposto che era passato troppo tempo. È andata dal vescovo. Il tribunale ecclesiastico doveva intervenire, ma nulla è successo. Il prete ha confessato di avere compiuto un “atto di debolezza”, ora è parroco. Le hanno proposto di versare una somma di denaro a un’associazione benefica da lei indicata. Così, per non dovere ammettere pubblicamente responsabilità, Emanuela ha rifiutato.
In Vaticano l’altro giorno hanno organizzato una veglia per le vittime, ma discutono ancora se rendere obbligatorio o no che il vescovo denunci i preti criminali.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ----- Si cambia passo, ma sulle denunce restano tanti «se» (di Luca Kocci)10 febbraio 2012, di Federico La Sala
Si cambia passo, ma sulle denunce restano tanti «se»
di Luca Kocci (il manifesto, 10 febbraio 2012)
Negli ultimi dieci anni oltre quattromila casi di abusi sessuali commessi da preti e religiosi su bambini, ragazze e ragazzi minorenni sono stati segnalati alla Congregazione vaticana per la dottrina della fede. Lo rivela il cardinale statunitense William Levada, prefetto dell’ex Sant’uffizio, a cui, secondo una disposizione del 2001 di papa Wojtyla, i vescovi dovrebbero comunicare tutti i casi di abuso e di violenza da parte di sacerdoti contro minori di cui sono a conoscenza.
Benché alto - quattromila in dieci anni significa più di un caso al giorno - il numero sembra assai inferiore alla realtà: Michael Bemi e Patricia Neal (del National catholic risk retention group e del National catholic services) parlano di «almeno centomila vittime solo negli Usa» dal 1950 ad oggi. Cifre degne di una guerra in cui lo stupro viene utilizzato come arma.
In questo caso, però, si parla di pedofilia ecclesiastica, al centro dei lavori del simposio internazionale sull’abuso sessuale Verso la guarigione e il rinnovamento che si è chiuso ieri sera alla Pontificia università gregoriana di Roma, con vescovi e preti in rappresentanza di 110 conferenze episcopali.
Un incontro senza precedenti, che segna un evidente cambio di passo rispetto al passato in cui la parola d’ordine era negare il fenomeno. Ma non ancora una svolta: su un punto, quello dell’obbligo da parte dei vescovi di denunciare alle autorità civili l’autore delle violenza, le parole dei rappresentanti del Vaticano non sono chiare.
Come non è chiara la Lettera circolare della Congregazione per la dottrina della fede del maggio 2011 inviata alle Conferenze episcopali di tutto il mondo per aiutarle a preparare le «linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici»: si invita ad «ascoltare le vittime» e a «proteggere i minori», a garantire «un’adeguata formazione a sacerdoti e religiosi» e a «vigilare» sui loro comportamenti, fino a «limitare l’esercizio del ministero da parte di un chierico » o a dimetterlo se riconosciuto colpevole. Si chiede anche di «collaborare» con le autorità statali, perché l’abuso sessuale dei minori «rappresenta anche un crimine perseguibile dal diritto civile», sebbene «i rapporti con le autorità possano variare da Paese a Paese», precisa mons. Charles Scicluna, promotore di giustizia - una sorta di pm - della Congregazione per la dottrina della fede. E comunque mai se la notizia dell’abuso fosse stata appresa in confessione.
Una collaborazione con tanti "se" e "ma". Eppure, spiega Marier Collins - una donna irlandese di 66 anni violentata da un prete quando ne aveva 13 ed era ricoverata in ospedale - «avevo 47 anni quando parlai del mio abuso per la prima volta» ma «l’inizio della guarigione per me è stato il giorno in cui il mio aggressore in tribunale ha ammesso la sua colpa».
In Italia, per ammissione dello stesso Bagnasco, la Cei riconosce oltre cento casi di abusi compiuti negli ultimi dieci anni. A maggio verranno presentate le «linee guida» per «affrontare la questione in spirito di giustizia, avendo premura - spiega - in primo luogo per le vittime degli abusi e curando in particolare la formazione dei futuri sacerdoti». E chissà se si farà cenno anche alla giustizia terrena.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- Il Vaticano sta prendendo per il naso da mesi la giustizia e la Banca d’Italia. Lo Ior si fa beffe dell’Italia (di Marco Lillo)31 gennaio 2012, di Federico La Sala
Lo Ior si fa beffe dell’Italia
di Marco Lillo (il Fatto Quotidiano, 31 gennaio 2012)
Il Vaticano sta prendendo per il naso da mesi la giustizia e la Banca d’Italia. Il Governo Monti dovrebbe fare la voce grossa e ottenere il rispetto degli impegni assunti in materia di antiriciclaggio ma c’è un piccolo particolare: il ministro della giustizia che dovrebbe essere in prima linea in questa battaglia, è stato l’avvocato del presidente della banca vaticana, lo IOR, Ettore Gotti Tedeschi.
La linea del Vaticano in questa materia non corrisponde affatto alle promesse di trasparenza contrabbandate in pubblico. Lo dimostra un documento che Il Fatto pubblica in esclusiva.
Si intitola “Memo sui rapporti IOR-AIF” ed è un documento “confidenziale” e “riservato” circolato negli uffici del Papa e della Segreteria di Stato e annotato a penna da una mano che - secondo gli esperti di cose Vaticane - potrebbe essere quella di monsignor Georg Ganswein, il segretario di Benedetto XVI. E’ stato scritto da un personaggio molto in alto che si può permettere di sottoporre la sua analisi ai vertici del Vaticano.
Al di là di chi sia l’autore, il “memo” dimostra che il Papa, il segretario di Stato Tarcisio Bertone, il presidente dello AIF, l’autorità di controllo antiriciclaggio Attilio Nicora e i vertici dello IOR sono tutti a conoscenza della linea sul fronte antiriciclaggio che si può sintetizzare così: non si deve collaborare con la giustizia italiana per tutto quello che è successo allo IOR fino all’aprile 2011.
Il “Memo”, come dimostrano le note appuntate a penna dalla segreteria del Santo Padre, è stato “Discusso con SER (Sua Eminenza Reverendissima) il Cardinale Bertone il 3 novembre” 2011. L’autore della nota, favorevole a una maggiore apertura verso Bankitalia e le Procure, aggiunge: Bertone “Si è trovato d’accordo sulle mie considerazioni! Incontrerà SER il cardinale Attilio Nicora (Presidente dell’AIF) e il direttore AIF (Francesco Ndr) De Pasquale”. Il memo, così annotato, è stato poi girato, al presidente dello IOR e al direttore dell’AIF.
Basta scorrere il testo per capire la rilevanza della partita in gioco: “Dall’entrata in vigore della legge vaticana anti-riciclaggio, avvenuta il primo aprile 2011, si sono tenuti numerosi incontri tra lo IOR e l’AIF (Autorità creata dalla nuova legge del Vaticano Ndr), rivolti da una parte a dimostrare alla nuova Autorità le iniziative intraprese per l’adeguamento delle procedure interne alle misure introdotte dalla legge....”
IN QUESTA prima parte il memo ripercorre la vicenda del mutamento della normativa antiriciclaggio, intervenuto sotto la spinta dell’indagine della Procura di Roma. Il pm Stefano Rocco Fava e il procuratore aggiunto Nello Rossi - a settembre del 2010 - avevano sequestrato 23 milioni di euro che stavano per essere trasferiti dal conto dello IOR presso il Credito Artigiano alla Jp Morgan di Francoforte (20 milioni di euro) e alla Banca del Fucino (3 milioni) e aveva indagato il presidente IOR, Ettore Gotti Tedeschi e il direttore Cipriani. Secondo i pm, lo IOR si era rifiutato di dire “le generalità dei soggetti per conto dei quali eventualmente davano esecuzioni alle operazioni”. Cioé chi era il reale proprietario dei soldi. Dalle indagini della Guardia di Finanza emergeva un quadro inquietante: lo IOR mescolava sul suo conto al Credito Artigiano i 15 milioni di euro provenienti dalla CEI, e frutto dell’8 per mille dei contribuenti italiani, con fondi di soggetti diversi.
Non solo: da altre operazioni emergeva che lo IOR funzionava come una fiduciaria e i suoi conti erano stati usati per schermare persino i proventi di una presunta truffa allo Stato italiano realizzata dal padre e dallo zio (condannato per fatti di mafia) di don Orazio Bonaccorsi.
DI FRONTE a un simile scenario i pm romani si erano opposti al dissequestro dei 23 milioni di euro nonostante le dotte motivazioni dell’avvocato del presidente dello IOR, il professor Paola Severino. Il ministro ora ha lasciato lo studio e si è cancellato dall’Albo anche se non ha comunicato alla Procura chi la sostituirà nella difesa di Gotti Tedeschi.
A sbloccare la situazione comunque non fu l’avvocato Severino ma il Papa in persona. Con una Lettera Apostolica per la prevenzione e il contrasto delle attività illegali in campo finanziario il 30 dicembre 2010, Benedetto XVI ha istituito l’Autorità di informazione finanziaria (AIF), per il contrasto del riciclaggio.
I pm romani motivarono così il loro parere favorevole al dissequestro nel maggio 2011: “l’AIF ha già iniziato una collaborazione con l’UIF fornendo informazioni adeguate su di un’operazione intercorsa tra IOR e istituti italiani e oggetto di attenzione”.
Peccato che, un minuto dopo essere rientrato in possesso dei suoi 23 milioni, lo IOR ha cambiato completamente atteggiamento. Tanto che in Procura non si nasconde il disappunto per quel dissequestro “sulla fiducia”. Ora si scopre che la giravolta vaticana è una scelta consapevole delle gerarchie, come spiega lo stesso “memo” discusso dai cardinali Nicora e Bertone e dallo stesso Gotti Tedeschi. “L’AIF (.... ) ha inoltrato allo IOR alcune richieste di informazioni relative a fondi aperti presso l’Istituto, cui quest’ultimo ha corrisposto, consentendo tra l’altro lo sblocco dei fondi sequestrati dalla Procura di Roma (....)
Ultimamente, tuttavia la Direzione dell’Istituto ha ritenuto di riscontrare le richieste dell’ AIF - relative ad operazioni sospette o per le quali sono in corso procedimenti giudiziari - fornendo informazioni soltanto su operazioni effettuate dal primo aprile 2011 in avanti.
Nel corso dell’ultimo incontro tra IOR e AlF del 19 ottobre u.s. tale posizione è stata sostenuta dall’Avv. Michele Briamonte (dello studio Grande Stevens Ndr), sulla base di un generale principio di irretroattività della legge, per il quale le misure introdotte dalla legge antiriciclaggio, (....) non possono valere che per l’avvenire”.
Questa linea interpretativa, ovviamente, ostacola enormemente il lavoro degli investigatori italiani e l’Aif ne è consapevole tanto che, come si evince dal memo ha ribadito “il proprio diritto/dovere ad accedere a tutti i dati e le informazioni in possesso dello IOR (...) motivando tale posizione con argomentazioni attinenti alla lettera e alla ratio della legge, al rispetto degli standard internazionali cui la Santa Sede ha aderito, allo svuotamento dell’effettività della disciplina appena introdotta, al rischio di una valutazione negativa dell’organismo internazionale chiamato a esaminare il sistema Vaticano di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”.
PURTROPPO l’operazione trasparenza era solo uno specchietto per le allodole. Nel frattempo il Vaticano ha spostato la sua operatività dalle banche italiane alla JP Morgan, soprattutto a Francoforte. La banca americana ha però un solo sportello (non accessibile alla clientela comune) a Milano, che è già finito, da quello che risulta al Fatto, nel mirino dell’attività ispettiva della Banca d’Italia. E così il 25 gennaio è stato pubblicato un decreto pontificio che ha ratificato tre convenzioni contro il riciclaggio. Sembra ci sia anche un articolo sull’obbligo di “adeguata verifica” prima del fatidico primo aprile. In Procura però stavolta non si fidano.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- «Corruzione». Malaffare e degrado morale. I misteri della finanza in Vaticano: le rivelazioni di monsignor Carlo Maria Viganò (di Sergio Rizzo).25 gennaio 2012, di Federico La Sala
I misteri della finanza in Vaticano: le rivelazioni di monsignor Viganò
di Sergio Rizzo (Corriere della Sera, 25 gennaio 2012)
«Corruzione». La parola è sinonimo di malaffare e degrado morale. Ma se a pronunciarla è un altissimo prelato vicino al Papa, come rivela questa sera «Gli intoccabili», il programma d’inchiesta del giornalista Gian Luigi Nuzzi che va in onda su La7, allora vengono i brividi. Il suo nome: Carlo Maria Viganò, fino a qualche mese fa segretario generale del governatorato del Vaticano, la struttura che gestisce gli appalti e le forniture del più piccolo e potente Stato della Terra.
«Corruzione» è proprio il termine che quel monsignore usa per descrivere in una clamorosa lettera a Benedetto XVI l’incredibile situazione che si è trovato davanti dopo aver assunto nel luglio del 2009 il delicatissimo incarico. Una bomba sganciata nelle stanze del potere vaticano il 27 marzo del 2011, nell’estremo tentativo di sventare una manovra di corridoio che culminerà con la sua rimozione.
«Un mio trasferimento provocherebbe smarrimento in quanti hanno creduto fosse possibile risanare tante situazioni di corruzione e prevaricazione», scrive Viganò al Papa. Facendo capire a Joseph Ratzinger di non essere affatto isolato: «I cardinali Velasio De Paolis, Paolo Sardi e Angelo Comastri conoscono bene la situazione».
La storia ricostruita da «Gli intoccabili» ha tutti gli ingredienti di un noir di prim’ordine. Trame misteriose, colpi di scena, testimonianze sconvolgenti. È un terremoto senza precedenti, che fa tremare i vertici delle gerarchie ecclesiastiche. Tutto comincia nel maggio del 2009, quando il Papa decide di affidare la gestione degli appalti al cardinale Giovanni Layolo e a monsignor Viganò, che sostituiscono rispettivamente il cardinale Edmund Casimir Szoka e monsignor Renato Boccardo nei ruoli di presidente e segretario generale del governatorato. Quella struttura è un buco nero: nel 2009 perde 8 milioni di euro. Cifra apparentemente modesta, ma estremamente significativa se rapportata alle dimensioni dello Stato Vaticano.
«Non avrei mai pensato di trovarmi davanti a una situazione così disastrosa», rivela Viganò in un altro scioccante appunto inviato a Ratzinger nella scorsa primavera. Definendola «inimmaginabile», e per giunta «a tutti nota in Curia». Dal pentolone che ha scoperchiato salta fuori l’inverosimile. I servizi tecnici sono un regno diviso in piccoli feudi. In Vaticano opera una cordata di fornitori che non fanno praticamente gare: dentro le mura dello Stato della Chiesa lavorano sempre le stesse ditte, a costi doppi rispetto all’esterno anche perché non esiste alcuna trasparenza nella gestione degli appalti di edilizia e impiantistica. Insomma, una moderna fabbrica di San Pietro che ingoia denaro a ritmi ingiustificati, come dimostra il conto astronomico che viene presentato per il presepe montato nel Natale 2009 a piazza San Pietro: 550 mila euro.
Non bastasse, c’è una situazione finanziaria allucinante: le casse del governatorato subiscono perdite del 50-60%. Per tamponarla, spiega Viganò, la gestione dei fondi è stata affidata a un «comitato finanza e gestione composto da alcuni grandi banchieri, i quali sono risultati fare più il loro interesse che i nostri». Racconta il monsignore che una sola operazione finanziaria nel dicembre 2009 ha mandato in fumo due milioni e mezzo di dollari.
Ma chi fa parte di questo comitato? Nuzzi fa i nomi di quattro pezzi da novanta della finanza italiana. Quelli di Pellegrino Capaldo, Carlo Fratta Pasini, Ettore Gotti Tedeschi e Massimo Ponzellini. Capaldo è l’ex presidente della Banca di Roma: banchiere cattolico apprezzatissimo anche al di fuori degli ambienti ecclesiastici, è attualmente il proprietario della casa vinicola Feudi di San Gregorio.
Fratta Pasini è il presidente del Banco popolare. Gotti Tedeschi, consigliere di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, la banca del Tesoro italiano, nonché consigliere della Fondazione San Raffaele di don Luigi Verzé, è il banchiere poi scelto da Ratzinger per guidare lo Ior. Ponzellini è l’ex presidente della Banca popolare di Milano, ma ha ricoperto in passato anche molti incarichi in società del Tesoro, come il Poligrafico dello Stato.
Viganò prende l’incarico maledettamente sul serio. La sua scure colpisce dappertutto: non risparmianemmeno il conto del famoso presepe, tagliato d’emblée di 200 mila euro, né la gestione dei giardini, uno dei capitoli più problematici. Il risultato è che il bilancio del governatorato passa da un deficit di 8 milioni a un utile di 34,4 milioni nel giro di un anno. Ma tanto rigore non gli vale un encomio. Anzi, per lui cominciano i guai. «Viganò si è fatto un sacco di nemici e quei nemici si stanno muovendo nell’ombra per fargliela pagare», è il commento de «Gli intoccabili».
Fatto sta che sul Giornale escono alcuni articoli non firmati, nei quali è contenuto un segnale preciso: il segretario generale del governatorato ha praticamente le ore contate. Ed è proprio quello che accade. Il segretario di Stato Tarcisio Bertone lo solleva dall’incarico, e la decisione fa saltare anche la nomina a cardinale che gli sarebbe stata promessa. Tanto per cambiare la rimozione avviene con il solito meccanismo del promoveatur ut amoveatur. Viganò viene nominato Nunzio apostolico della Santa sede negli Stati Uniti e spedito a Washington. Incarico prestigiosissimo, anche se a 7.228 chilometri di distanza.
A nulla serve l’appello disperato e diretto a Ratzinger. Che anzi si rivela un errore, perché scavalcando Bertone ottiene semmai l’effetto contrario. Ma Viganò non digerisce affatto la decisione e inizia una corrispondenza infuocata con il segretario di Stato. Lettere nelle quali rivendica il risanamento ottenuto «eliminando la corruzione ampiamente diffusa», e chiede di essere messo a confronto con i suoi accusatori in un processo «ai sensi del canone 220 del codice di diritto canonico».
Senza limitarsi alle generiche affermazioni, riferisce il servizio de «Gli intoccabili», punta pure il dito su un personaggio che ritiene abbia avuto un ruolo nella vicenda che lo riguarda: Marco Simeon. Figlio di un benzinaio di Sanremo, è uno degli animatori della cooperativa sociale «Il Cammino», fornitrice di fiori del Papa. Considerato molto vicino a Bertone, è autore di una carriera fulminea, per gli standard italiani. Prima a Capitalia, la ex Banca di Roma di Cesare Geronzi, banchiere con altissime aderenze vaticane. Quindi a Mediobanca, come capo delle relazioni istituzionali, sempre al seguito di Geronzi. Infine alla Rai, dove a quello stesso incarico aggiunge la direzione di Rai Vaticano. Interpellato da Nuzzi, risponde con una risata: «Non ne so assolutamente niente». E forse questo è solo l’inizio.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- "Benedetta corruzione". Lettera di Carlo Maria Viganò e una nota di Marco Lillo.27 gennaio 2012, di Federico La Sala
Benedetta corruzione
di Marco Lillo (il Fatto Quotidiano, 27 gennaio 2012)
Furti nelle ville pontificie coperti dal direttore dei Musei Vaticani, monsignor Paolo Nicolini. E poi fatture contraffatte all’Università Lateranense a conoscenza addirittura dell’arcivescovo Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per l’evangelizzazione. E ancora: interessi del monsignore in una società che fa affari con il Vaticano ed è inadempiente per 2,2 milioni di euro. Ammanchi per centinaia di migliaia di euro all’Apsa - rivelati dal suo stesso presidente - e frodi all’Osservatore, rivelate da don Elio Torregiani, ex direttore generale del giornale.
C’è tutto questo nella lettera che Il Fatto pubblica oggi. I toni e i contenuti sono sconvolgenti per i credenti che hanno apprezzato gli appelli del Papa. “Maria ci dia il coraggio di dire no alla corruzione, ai guadagni disonesti e all’egoismo” aveva detto nel giorno dell’Immacolata del 2006 Ratzinger. Eppure il Papa non ha esitato a sacrificare l’uomo che aveva preso alla lettera quelle parole: Carlo Maria Viganò, l’arcivescovo ingenuo ma onesto, approdato alla guida dell’ente che controlla le gare e gli appalti del Vaticano. La lettera di Viganò è diretta a “Sua Eminenza Reverendissima il cardinale Tarcisio Bertone, Segretario di Stato della Città del Vaticano”, praticamente al primo ministro del Vaticano.
Quando scrive a Bertone l’8 maggio del 2011, Viganò è ancora il segretario generale del Governatorato. Ed è proprio dopo questa lettera inedita, e non dopo quella del 27 marzo già mostrata in tv da Gli intoccabili, che Viganò viene fatto fuori. La7 si è occupata mercoledì scorso della lotta di potere che ha portato alla promozione-rimozione di Viganò a Nunzio apostolico negli Usa. L’arcivescovo-rinnovatore aveva trovato nel 2009 una perdita di 8 milioni di euro e aveva lasciato al Governatorato nel 2010 un guadagno di 22 milioni (34 milioni secondo altri calcoli). Nonostante ciò è stato fatto fuori da Bertone grazie all’appoggio del Papa e del Giornale di Berlusconi. A questa faida vaticana è stata dedicata buona parte della trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi che, nonostante lo scoop, si è fermata al 3,4% di ascolto. In due ore sono sfilati anche il direttore del Giornale Alessandro Sallusti, un uomo del Vaticano in Rai, Marco Simeon e il vice di Viganò al Governatorato, monsignor Corbellini. Sono state poste molte domande sulle lettere scritte prima e dopo ma non su quella dell’8 maggio che è sfuggita agli Intoccabili. Peccato perché proprio in questa lettera si trovano storie inedite che coinvolgono nella parte di testimoni o vittime di accuse anche diffamanti, gli ospiti di Nuzzi.
E peccato anche perché nella lettera ci sono molte risposte (di Viganò ovviamente) ai quesiti posti da Nuzzi. Tipo: chi è la fonte del Giornale che ha scatenato la polemica tra Viganò e i suoi detrattori? Oppure: perché Viganò è stato cacciato? Probabilmente dopo la lettera che pubblichiamo sotto era impossibile per il Papa mantenere Viganò al suo posto.
Il segretario del Governatorato non scriveva solo di false fatture e ammanchi milionari. Non lanciava solo accuse diffamatorie sulle tendenze sessuali dei suoi nemici ma soprattutto metteva nero su bianco i risultati di una vera e propria inchiesta di controspionaggio dentro le mura leonine. E non solo spiattellava i risultati, (tipo: la fonte del Giornale è monsignore Nicolini che vuole prendere il mio posto. O peggio: Monsignor Nicolini ha contraffatto fatture e defraudato il Vaticano) ma sosteneva che le sue fonti erano personaggi di primissimo livello come don Torregiani, monsignor Fisichella e monsignor Calcagno.
Infine minacciava : “I comportamenti di Nicolini oltre a rappresentare una grave violazione della giustizia e della carità sono perseguibili come reati, sia nell’ordinamento canonico che civile, qualora nei suoi confronti non si dovesse procedere per via amministrativa, riterrò mio dovere procedere per via giudiziale”. Una minaccia ancora valida nonostante l’oceano separi l’arcivescovo dalla Procura. Anche perché il telefonino di Viganò continua a squillare a vuoto.
Carte di credito, fatture false, traffici e complotti
di Carlo Maria Viganò (il Fatto Quotidiano, 27 gennaio 2012)
Domenica, 8 maggio 2011 Sua Eminenza Reverendissima Il Sig. Card. Tarcisio Bertone, Segretario di Stato Città del Vaticano. Nella lettera riservata che Le avevo indirizzato il 27 marzo 2011, che affidai personalmente al Santo Padre attesa la delicatezza del suo contenuto, affermavo di ritenere che il cambiamento cosi radicale di giudizio sulla mia persona che Vostra Eminenza mi aveva mostrato nell’Udienza del 22 marzo scorso non poteva essere frutto se non di gravi calunnie contro di me ed il mio operato (....) ed ora, dopo le informazioni di cui sono venuto in possesso, anche in sincero e fedele sostegno all’opera di Vostra Eminenza, a Cui è affidato un incarico così oneroso ed esposto a pressioni di persone non necessariamente ben intenzionate (....) con tale spirito di lealtà e fedeltà che reputo mio dovere riferire a Vostra Eminenza fatti e iniziative di cui sono totalmente certo, emerse in queste ultime settimane, ordite espressamente al fine di indurre Vostra Eminenza a cambiare radicalmente giudizio sul mio conto, con l’intento di impedire che il sottoscritto subentrasse al Card. Lajolo come Presidente del Governatorato, cosa in Curia da tempo a tutti ben nota. Persone degne di fede hanno infatti spontaneamente offerto a me e S.E. Mons. Corbellini, Vice Segretario Generale del Governatorato, prove e testimonianze dei fatti seguenti:
1. Con l’avvicinarsi della scadenza di detto passaggio di incarichi al Governatorato, nella strategia messa in atto per distruggermi agli occhi di Vostra Eminenza, vi è stata anche la pubblicazione di alcuni articoli, pubblicati su Il Giornale, contenenti calunniosi giudizi e malevole insinuazioni contro di me. Già nel marzo scorso, fonti indipendenti, tutte particolarmente qualificate - il Dott. Giani (Domenico Giani, ex finanziere ed ex agente dei servizi segreti italiani nel Sisde poi nominato direttore dei servizi di sicurezza e Ispettore Capo della Gendarmeria del Vaticano Ndr) il Prof. Gotti Tedeschi (Ettore Gotti Tedeschi, presidente dello IOR, l’istituto finanziario del Vaticano, Ndr) il Prof. Vian (Gian Maria Vian, direttore dell’Osservatore Romano Ndr) e il Dott. Andrea Tornielli, all’epoca Vaticanista di Il Giornale, - avevano accertato con evidenza uno stretto rapporto della pubblicazione di detti articoli con il Dott. Marco Simeon, almeno come tramite di veline provenienti dall’interno del Vaticano. A conferma, ma soprattutto a complemento di tale notizia, è giunta a S.E. Mons. Corbellini e a me la testimonianza, verbale e scritta, del Dott. Egidio Maggioni (ex presidente della società pubblicitaria SRI, Socially Responsible Italia Spa in rapporti di affari con il Vaticano Ndr), persona ben introdotta nel mondo dei media, ben conosciuta e stimata in Curia, fra gli altri, dal Dott. Gasbarri (direttore amministrativo di Radio Vaticana, Ndr), da S.E. Mons. Corbellini e da Mons. Zagnoli, già responsabile del Museo Etnologico-Missionario dei Musei Vaticani. Il Dott. Maggioni ha testimoniato che autore delle veline provenienti dall’interno del Vaticano è Mons. Paolo Nicolini, Delegato per i Settori amministrativo-gestionali dei Musei Vaticani. La testimonianza del Dott. Maggioni assume un valore determinante in quanto egli ha ricevuto detta informazione dallo stesso Direttore de Il Giornale, Sig. Alessandro Sallusti, con il quale il Maggioni ha una stretta amicizia da lunga data. 2. L’implicazione di Mons. Nicolini, particolarmente deplorevole in quanto sacerdote e dipendente dei Musei Vaticani, è confermata dal fatto che il medesimo Monsignore, il 31 marzo scorso, in occasione di un pranzo, ha confidato al Dott. Sabatino Napolitano, Direttore dei Servizi Economici del Governatorato, nel contesto di una conversazione fra appassionati di calcio, che prossimamente oltre che per la vittoria del campionato da parte dell’lnter (previsione errata purtroppo, Ndr), si sarebbe festeggiata una cosa ben più importante, cioè la mia rimozione dal Governatorato. (...)
3. Sul medesimo Mons. Nicolini sono poi emersi comportamenti gravemente riprovevoli per quantosi riferisce alla correttezza della sua amministrazione, a partire dal periodo presso la Pontificia Università Lateranense, dove, a testimonianza di S.E. Mons. Rino Fisichella (presidente del Pontificio consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione Ndr) furono riscontrate a suo carico: contraffazioni di fatture e un ammanco di almeno settantamila euro. Cosi pure risulta una partecipazione di interessi del medesimo Monsignore nella Società SRI Group, del Dott. Giulio Gallazzi, società questa attualmente inadempiente verso il Governatorato per almeno due milioni duecentomila euro e che, antecedentemente aveva già defraudato L’Osservatore Romano, come confermatomi da Don Elio Torreggiani (direttore generale della Tipografia Vaticana Ndr) per oltre novantasettemila Euro e I’A.P.S.A., per altri ottantacinquemila, come assicuratomi da S.E. Mons. Calcagno (presidente dell’Apsa, l’Amministrazione del Patrimonio della Santa Sede, Ndr). Tabulati e documenti in mio possesso dimostrano tali affermazioni e il fatto che Mons. Nicolini è risultato titolare di una carta di credito a carico della suddetta SRI Group, per un massimale di duemila e cinquecento euro al mese.
4. Altro capitolo che riguarderebbe sempre Mons. Nicolini concerne la sua gestione ai Musei Vaticani. (...) volgarità di comportamenti e di linguaggio, arroganza e prepotenza nei confronti dei collaboratori che non mostrano servilismo assoluto nei suoi confronti, preferenze, promozioni e assunzioni arbitrarie fatte a fini personali; innumerevoli sono le lamentele pervenute ai Superiori del Governatorato da parte dei dipendenti dei Musei (...).
5. Poiché i comportamenti sopra descritti di Mons. Nicolini, oltre a rappresentare una grave violazione della giustizia e della carità, sono perseguibili come reati, sia nell’ordinamento canonico che civile, qualora nei suoi confronti non si dovesse procedere per via amministrativa, riterrò mio dovere procedere per via giudiziale.
6. Per quanto riguarda il Dott. Simeon, pur essendo per me più delicato parlarne atteso che dai media risulta essere persona particolarmente vicina a Vostra Eminenza, non posso tuttavia esimermi dal testimoniare che, da quanto personalmente sono venuto a conoscenza in qualità di Delegato per le Rappresentanze Pontificie, il Dott. Simeon risulta essere un calunniatore (nel caso a mia precisa conoscenza, di un sacerdote) e che lui stesso è OMISSIS Ndr. Tale sua OMISSIS, Ndr mi è stata confermata da Prelati di Curia e del Servizio Diplomatico. Su questa grave affermazione che faccio nei confronti del Dott. Simeon sono in grado di fornire i nomi di chi è a conoscenza di questo fatto, compresi Vescovi e sacerdoti.
7. A tale azione di denigrazione e di calunnie nei miei confronti ha contribuito anche il Dott. Saverio Petrillo, che si è sentito ferito nel suo orgoglio per un’inchiesta condotta dalla Gendarmeria Pontificia - atto questo dovuto a seguito di un furto avvenuto l’anno scorso nelle Ville Pontificie di cui il medesimo Dott. Petrillo non aveva informato né i Superiori del Governatorato né la Gendarmeria. A provocare poi una sua ulteriore reazione contro di me, è stata la decisione presa dal Presidente Cardinale Lajolo (e non da me), di affidare la gestione delle serre delle Ville al Sig. Luciano Cecchetti, Responsabile dei Giardini Vaticani, con l’intento di creare una sinergia fra le esigenze di questi ultimi e lerisorsedisponibilinelleVillePontificie, il cui debito di gestione annuale raggiunge i 3 milioni e mezzo di euro.
8. Non stupirebbe poi nessuno se anche qualche altro Direttore del Governatorato avesse voluto formulare delle critiche nei miei confronti, attesa l’azione incisiva di ristrutturazione, di contenimento degli sprechi e delle spese, da me operata secondo i criteri di una buona amministrazione, le indicazioni datemi dal Cardinale Presidente e i consigli gestionali della società consulente McKinsey. Non ho tuttavia prove in tale senso (...) Ritengo quanto sopra esposto sufficiente per dissipare le menzogne di quanti hanno inteso capovolgere il giudizio di Vostra Eminenza sulla mia persona, sull’idoneità a che abbia a continuare la mia opera al Governatorato (....) Ho ritenuto mio dovere farlo, animato dallo stesso sentimento di fedeltà che nutro verso il Santo Padre.
-
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- USA. Nella fase cruciale delle primarie, Benedetto XVI ha rivolto un discorso ai vescovi statunitensi in visita ad limina. Il Papa vota repubblicano (di Massimo Faggioli).20 gennaio 2012, di Federico La Sala
Il papa vota repubblicano?
di Massimo Faggioli (Europa, 20 gennaio 2012)
Nella fase cruciale delle primarie, con il front-runner mormone Romney tallonato dai social conservatives spaccati tra i due candidati cattolici Gingrich e Santorum, papa Benedetto XVI ha rivolto un discorso di rara durezza ai vescovi statunitensi in visita ad limina. Il papa ha ricordato la specificità del ruolo della religione e della libertà religiosa in America, fondato su un «consenso morale» attorno al riconoscimento del valore della «legge naturale». Questa legge naturale ha sempre garantito in America non solo la libertà religiosa, ma anche la libertà di coscienza, in un ambiente storico-culturale che si muoveva nel quadro di quelli che il papa definisce «i valori ebraico-cristiani».
Tutto questo è sotto attacco, afferma il papa, a causa di forze culturali che mirano a seppellire non solo quel consenso morale e i valori ebraico-cristiani, ma anche la stessa libertà religiosa e la libertà di coscienza. «Il secolarismo radicale» e «l’individualismo estremo» tendono a stravolgere quel consenso sulla legge naturale tentando di avvocare nuovi diritti, come quelli all’aborto e al matrimonio omosessuale, che il papa contrappone agli «autentici diritti umani».
Il discorso del papa è stato scritto da chi conosce molto bene la situazione del cattolicesimo statunitense, tanto da usare parole-chiave che risalgono al vocabolario del “costituzionalismo cattolico americano” del gesuita John Courtney Murray (quello che contribuì a sdoganare politicamente il cattolicesimo americano, a far eleggere John F. Kennedy, e che per questo si guadagnò la celebre foto sulla copertina di Time del 12 dicembre 1960).
Le questioni di fondo che agitano il rapporto tra chiesa americana e cultura politica all’inizio del secolo XXI sono più ampie e complesse dell’eterna questione del diritto all’aborto. La chiesa americana si sente sotto attacco - tanto da aver creato recentemente una task force episcopale per la difesa della libertà religiosa - per nuovi problemi come quello del matrimonio omosessuale, che è ormai accettato dalla gran parte degli americani, anche dai cattolici delle giovani generazioni. Ma altre questioni sono più intricate, come la recente decisione dell’amministrazione federale americana e di alcuni stati di negare alle carità cattoliche fondi statali fino a quando le carità cattoliche non accettino di mettere in pratica integralmente le linee-guida del governo, che comprendono anche le pratiche contraccettive e abortive.
Su questo si inserisce la messa in pratica della riforma del sistema sanitario, che metterebbe fine ad alcune esenzioni di cui finora i datori di lavoro cattolici potevano godere: ad esempio, escludere dalle polizze di assicurazione sanitaria per i lavoratori delle università cattoliche i rimborsi per pratiche mediche «contrarie alla morale cattolica» ufficiale.
Nei recenti dibattiti i candidati repubblicani religiosi e social-conservatori (Gingrich, Santorum, e Perry) hanno accusato l’amministrazione Obama di aver «dichiarato guerra alla religione» in America e alla chiesa cattolica in particolare. Propaganda a parte, i cattolici liberal che votarono Obama e appoggiarono la sua riforma sanitaria ora chiedono alla Casa Bianca di ripristinare quelle tutele per la libertà di coscienza. Ma i cattolici americani sanno che l’idea del carattere “ebraicocristiano” dell’America nacque nella guerra fredda e che oggi è diventata, nel paese culturalmente e religiosamente più pluralista del mondo, una reliquia.
Gli americani non esiteranno a vedere nel discorso del papa un attacco all’amministrazione Obama, all’inizio di un anno elettorale in cui i cattolici saranno ancora una volta il voto in bilico tra repubblicani e democratici.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE .--- Il Professore Mario Monti, la Chiesa e l’Ici dimenticata (di Miguel Gotor)19 gennaio 2012, di Federico La Sala
Il Professore, la Chiesa e l’Ici dimenticata
di Miguel Gotor (la Repubblica, 19.01.2012)
MARIO Monti ha rilasciato ieri un’intervista a L’Osservatore Romano: un gesto di attenzione significativo da parte della Santa Sede poiché avviene di rado che l’organo ufficiale della Città del Vaticano intervisti il presidente del Consiglio in carica. Tanto più che il colloquio cade all’indomani dell’udienza ufficiale di Monti con papa Benedetto XVI, in una qualche misura a suggellare il felice esito di quell’incontro. L’intervista sottolinea il fondamentale contributo dei cattolici alla vita sociale italiana e tocca i principali problemi all’ordine del giorno: dalla crisi economica globale al futuro della moneta unica, dai destini del progetto di integrazione europea alla questione della cittadinanza italiana per i minori stranieri, dai programmi del governo in materia di liberalizzazioni alla politica fiscale.
Monti mette in risalto che proprio in quanto "tecnico" «può liberamente affermare che l’antipolitica e l’antiparlamentarismo causano danni che nel tempo possono dimostrarsi insidiosi». Da questa considerazione deriva la necessità che «ogni soggetto, individuale e collettivo, privato e pubblico, è chiamato a essere "migliore", in ogni ruolo - piccolo o grande - che assuma». Inoltre, evidenzia l’importanza dei "beni comuni" come orizzonte della politica nazionale e comunitaria e riconosce che sia la Santa Sede sia la Conferenza episcopale italiana possono svolgere un ruolo critico e propulsivo di rilievo perché «di fronte al bene comune non si può sfuggire». Per quanto riguarda gli interventi fiscali il presidente del Consiglio ribadisce il massimo rigore nella lotta all’evasione.
E tuttavia manca una questione: sia le domande relative alla politica fiscale, sia le risposte di Monti eludono il nodo del pagamento dell’Ici da parte della Chiesa cattolica per quei luoghi di carattere "parzialmente" commerciale che oggi sono esenti. Come è noto, tali immobili entrano in contraddizione sia con le previsioni della legge "concordataria" 222/1985, richiamate dalla Corte suprema di Cassazione nel luglio 2010 (in cui è stato condannato un ente ecclesiastico di Assisi) sia con la normativa europea che vieta gli aiuti di Stato e l’indebita concorrenza.
Tempo fa il cardinale Angelo Bagnasco, presidente della Conferenza episcopale italiana, ha dichiarato che «se ci sono punti della legge da rivedere o da discutere, non ci sono pregiudiziali da parte nostra». Si tratta di una disponibilità importante che il governo italiano, tanto più perché non strettamente legato da vincoli di carattere elettorale, dovrebbe verificare e raccogliere: sarebbe imperdonabile lasciarla cadere nel vuoto. In un periodo di crisi come questo è giusto che tutte le istituzioni, Chiesa cattolica compresa, si mostrino disposte all’impegno, al sacrificio, all’esempio e facciano seguire ai pronunciamenti i fatti: unicuique suum, ossia "a ciascuno il suo", come recita per l’appunto il motto de L’Osservatore Romano
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- Giovanni Paolo II: “Dio sembra quasi disgustato dalle azioni dell’umanità”.17 gennaio 2012, di Federico La Sala
- E si continua a dormire: una lettera del 2002
DEPONIAMO LE ARMI, APRIAMO UN DIBATTITO
di Federico La Sala*
Bisogna cominciare a vaccinarsi: il conto alla rovescia è partito. L’allineamento dei “pianeti” si fa sempre più stretto e minaccioso (Usa, Uk, Spagna, Italia, Grecia, Turchia, Israele..) e il papa - accerchiato e costretto alla rassegnazione - lo ha detto con decisione e rassegnazione: “Dio sembra quasi disgustato dalle azioni dell’umanità”.
Io credo che non si riferisse solo e tanto all’umanità degli altri, ma anche e soprattutto delle sue stesse “truppe” che lavorano dietro le quinte e alacremente a tale progetto.
Come è già apparso chiaro in varie occasioni (ultima, plateale, nel Kazakistan nel 2001) la gerarchia della Chiesa Cattolico-Romana ha il cuore duro come quello dei consiglieri del faraone. Si è mantenuta a connivente distanza da Hitler, ha appoggiato Mussolini, sta appoggiando il governo Berlusconi, e non finirà per appoggiare Bush? Figuriamoci.
Lo sforzo di memoria e riconciliazione non è stato fatto per riprendere la strada della verità, ma per proseguire imperterrita sulla via della volontà di potenza... Non ha sentito e non vuole sentire ragioni - nemmeno quelle del cuore: la “risata” di Giuseppe (cfr. Luigi Pirandello, Un goj, 1918, “Novelle per un anno”) contro il suo modello-presepe di famiglia (e di società) continua e cresce sempre di più, ma fanno sempre e più orecchi da mercanti! Cosa vogliono che tutti e tutte puntino le armi non solo contro Betlemme (come già si è fatto) ma anche contro il Vaticano?
Credo con Zanotelli che "stiamo attraversando la più grave crisi che l’homo sapiens abbia mai vissuto: il genio della violenza è fuggito dalla bottiglia e non esiste più alcun potere che potrà rimettervelo dentro"; e credo - antropologicamente - che sia l’ora di smetterla con l’interpretazione greco-romana del messaggio evangelico!Bisogna invertire la rotta e lavorare a guarire le ferite, e proporre il modello-presepe correttamente.
Lo abbiamo sempre saputo, ma ora nessuno lo ignora più! Chi lo sa lo sa, chi non lo sa non lo sa, ma lo sanno tutti e tutte sulla terra, nessuno e nessuna è senza padre e senza madre! Dio “è amore” (1Gv.: 4,8) e Gesù (non Edipo, né tanto meno Romolo!) è figlio dell’amore di un uomo (Giuseppe, non Laio né tanto meno Marte, ma un nuovo Adamo) e una Donna (Maria) e non Giocasta né tanto meno Rea Silvia, ma una nuova Eva. Cerchiamo di sentire la “risata”. Deponiamo le armi: tutti e tutte siamo “terroni” - nativi del pianeta Terra, cittadini e cittadine d’Italia, d’Europa, degli Stati Uniti d’America, di Asia, di Africa ecc., come di Betlemme, come di Assisi e di Greccio... E non si può continuare con le menzogne e la violenza!
Non siamo più nella “fattoria degli animali”: fermiamo il gioco, facciamo tutti e tutte un passo indietro se vogliamo saltare innanzi e liberarci dalla volontà di potenza che ha segnato la storia dell’Occidente da duemila anni e più! Si tratta di avere il coraggio - quello di don Milani - di dire ai nostri e alle nostre giovani che sono tutti e tutte sovrani e sovrane o, che è lo stesso, figli e figlie dell’amore di D(ue)IO... dell’amore di "due Soli" esseri umani, come anche Dante aveva già intuito, sul piano politico ma anche sul piano antropologico.
Cerchiamo finalmente di guardarci in faccia e intorno: apriamo il dibattito - o, perché no, un Concilio Vaticano III (come voleva già il cardinale Martini) tra credenti e non credenti - e teniamo presente che Amore non è forte come la morte, ma è più forte di Morte (Cantico dei cantici: 8,6, trad. di G. Garbini, non degli interpreti greco-romani della Chiesa Cattolica).
* Pubblicata su l’Unità del 29 dicembre 2002, p. 30.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- SULL’INCONTRO DI MONTI CON BENEDETTO XVI. Perché, secondo il pontefice, la soluzione della crisi sarebbe “quasi” insolubile? (diRosario Amico Roxas)15 gennaio 2012, di Federico La Sala
Perché, secondo il pontefice, la soluzione della crisi sarebbe “quasi” insolubile ?
di Rosario Amico Roxas
Il Papa al premier: avete cominciato bene in una situazione quasi insolubile
(Il Messaggero del 14 gen.2012
****
Cominciato bene... senza dubbio, perché a essere toccati dalle esigenze di “fare” cassa” sono stati i cittadini di serie B, quelli che non evadono anche perché non possono evadere, stante il fatto di dover subire il prelievo fiscale alla fonte; cominciato bene... perché non si è parlato di patrimoniale per i grandi capitali, perché c’è un tentennamento per indire l’asta per le frequenze TV tanto care all’ex premier Berlusconi, tanto attentamente sostenuto dall’attuale pontefice; cominciato bene perché ancora nessuno ha deciso di far pagare le tasse, sotto qualunque forma, anche al Vaticano.
La situazione diventa così insostenibile, almeno, nell’ottica di Benedetto XVI, che è la medesima ottica berlusconiana ancorata al capitalismo liberista, sì da formare una indegna miscela tra religione, fede, politica ed economia . Diventa insolubile quando sarà necessario “fare cassa” presso quelle caste da troppo tempo aduse ad evadere i doveri per avanzare solamente diritti
Non si riesce nemmeno a capire adeguatamente quale sia la gerarchia dei valori nell’attuale pontefice, e meno che meno lo si capisce attraverso i suoi scritti, a cominciare da quel “Senza radici” scritto a quattro mani con l’ateo razzista Pera, nel quale il cristianesimo viene ridotto ad un elemento distintivo antropologico che riserva un primato agli occidentali europei, in quanto provenienti dalle radici cristiane dell’Europa; un adeguamento ai tempi delle “radici ariane della razza pura”.
L’esaltazione del liberismo si evidenzia nella lettera di presentazione al libercolo di Marcello Pera “Perché dobbiamo dirci cristiani”, firmata Benedetto XVI, come se il pontefice volesse trasferire al suo scritto l’autorevolezza della carica; leggiamo infatti:
«all’essenza del liberalismo appartiene il suo radicamento nell’immagine cristiana di Dio».
Allora il fallimento del liberismo, sancito dall’attuale crisi, che diventerebbe irreversibile se non dovesse arrivare un nuovo modo di intendere e attuare le regole dell’economia, riportando l’economia del lavoro al centro dei rapporti umani, sia politici che economici, sociali e religiosi, porterebbe come diretta conseguenza il fallimento di Cristo; è stato il liberismo che ha stimolato le peggiori evoluzioni del capitalismo, ma il pontefice aggiunge che senza questo radicamento il liberalismo “distrugge se stesso”. Ne deriverebbe che l’antica promessa “non praevalebunt” sarebbe legata e connessa alle sorti dell’economia liberista, fallita l’economia liberista fallirebbe il cristianesimo; Cristo e il cristianesimo trattati, così, come una banca zeppa di titoli-spazzatura.
Allora se l’ateo razzista Pera scrive “Perché dobbiamo dirci cristiani” dobbiamo aspettarci che un prossimo scritto del pontefice esibisca il titolo “Perché dobbiamo dirci liberisti”.
Rosario Amico Roxas
N.B.
Per facilitare il riscontro con il testo originale della lettera-presentazione al libercolo di Pera “Perché dobbiamo dirci cristiani”, ne accludo copia.
*****
Caro Senatore Pera,
in questi giorni ho potuto leggere il Suo nuovo libro “Perché dobbiamo dirci cristiani”.
Era per me una lettura affascinante. Con una conoscenza stupenda delle fonti e con una logica cogente Ella analizza l’essenza del liberalismo a partire dai suoi fondamenti, mostrando che all’essenza del liberalismo appartiene il suo radicamento nell’immagine cristiana di Dio: la sua relazione con Dio di cui l’uomo è immagine e da cui abbiamo ricevuto il dono della libertà.
Con una logica inconfutabile Ella fa vedere che il liberalismo perde la sua base e distrugge se stesso se abbandona questo suo fondamento.
Non meno impressionato sono stato dalla Sua analisi della libertà e dall’analisi della multiculturalità in cui Ella mostra la contraddittorietà interna di questo concetto e quindi la sua impossibilità politica e culturale. Di importanza fondamentale è la Sua analisi di ciò che possono essere l’Europa e una Costituzione europea in cui l’Europa non si trasformi in una realtà cosmopolita, ma trovi, a partire dal suo fondamento cristiano-liberale, la sua propria identità. Particolarmente significativa è per me anche la Sua analisi dei concetti di dialogo interreligioso e interculturale.
Ella spiega con grande chiarezza che un dialogo interreligioso nel senso stretto della parola non è possibile, mentre urge tanto più il dialogo interculturale che approfondisce le conseguenze culturali della decisione religiosa di fondo. Mentre su quest’ultima un vero dialogo non è possibile senza mettere fra parentesi la propria fede, occorre affrontare nel confronto pubblico le conseguenze culturali delle decisioni religiose di fondo. Qui il dialogo e una mutua correzione e un arricchimento vicendevole sono possibili e necessari.
Del contributo circa il significato di tutto questo per la crisi contemporanea dell’etica trovo importante ciò che Ella dice sulla parabola dell’etica liberale. Ella mostra che il liberalismo, senza cessare di essere liberalismoma, al contrario, per essere fedele a se stesso, può collegarsi con una dottrina del bene, in particolare quella cristiana che gli è congenere, offrendo così veramente un contributo al superamento della crisi. Con la sua sobria razionalità, la sua ampia informazione filosofica e la forza della sua argomentazione, il presente libro è, a mio parere, di fondamentale importanza in quest’ora dell’Europa e del mondo. Spero che trovi larga accoglienza e aiuti a dare al dibattito politico, al di là dei problemi urgenti, quella profondità senza la quale non possiamo superare la sfida del nostro momento storico. Grato per la Sua opera Le auguro di cuore la benedizione di Dio.
Benedetto XVI
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- È ora di restituire lo Stato ai cittadini. Commento ai dati dell’indagine di Demos - la Repubblica (di Ilvo Diamanti).9 gennaio 2012, di Federico La Sala
È ora di restituire lo Stato ai cittadini
di Ilvo Diamanti (la Repubblica, 09.01.2012)
Come sono cambiati gli atteggiamenti degli italiani verso lo Stato e le istituzioni? Per rispondere possiamo utilizzare i dati dell’indagine di Demos - la Repubblica, giunta alla 14a edizione. Suggeriscono un’immagine nota, quanto consumata: il declino. Oggi è considerato un "fatto" indiscutibile, sotto il profilo economico. Ma lo è anche sul piano del civismo e del rapporto con lo Stato e le istituzioni.
 1) La fiducia nelle istituzioni e nelle organizzazioni sociali, infatti, scende in modo generalizzato, nell’ultimo anno, con poche eccezioni (fra cui la "scuola", che però perde credito rispetto a dieci anni fa).
1) La fiducia nelle istituzioni e nelle organizzazioni sociali, infatti, scende in modo generalizzato, nell’ultimo anno, con poche eccezioni (fra cui la "scuola", che però perde credito rispetto a dieci anni fa). 2) In particolare, colpisce il livello - davvero basso - raggiunto dai principali attori su cui si fonda la democrazia rappresentativa. Per primi, i partiti, a cui crede meno del 4% dei cittadini. Mentre la fiducia nel Parlamento viene espressa da circa il 9% degli intervistati. Oltre quattro punti meno di un anno fa.
2) In particolare, colpisce il livello - davvero basso - raggiunto dai principali attori su cui si fonda la democrazia rappresentativa. Per primi, i partiti, a cui crede meno del 4% dei cittadini. Mentre la fiducia nel Parlamento viene espressa da circa il 9% degli intervistati. Oltre quattro punti meno di un anno fa. 3) Si tratta di una tendenza simile a quella che coinvolge - e travolge - gli organismi del sistema economico e finanziario. Per prime le banche, verso cui manifesta "stima" il 15% dei cittadini; 7 punti meno di un anno fa. Ma la metà rispetto al 2001. Non molto più alta - intorno al 20% - risulta la considerazione verso le istituzioni economiche europee e internazionali: la Bce e il Fmi.
Appare basso anche il grado di consenso verso le rappresentanze delle categorie socioeconomiche: associazioni imprenditoriali (24%) e sindacato. Soprattutto la Cisl e la Uil, ben sotto il 20%.
3) Si tratta di una tendenza simile a quella che coinvolge - e travolge - gli organismi del sistema economico e finanziario. Per prime le banche, verso cui manifesta "stima" il 15% dei cittadini; 7 punti meno di un anno fa. Ma la metà rispetto al 2001. Non molto più alta - intorno al 20% - risulta la considerazione verso le istituzioni economiche europee e internazionali: la Bce e il Fmi.
Appare basso anche il grado di consenso verso le rappresentanze delle categorie socioeconomiche: associazioni imprenditoriali (24%) e sindacato. Soprattutto la Cisl e la Uil, ben sotto il 20%. 4) Il sistema politico e quello economico appaiono, dunque, privi di riferimenti credibili fra i cittadini. Perfino le istituzioni di garanzia mostrano segni di debolezza. La "Magistratura", soprattutto, perde 8 punti di fiducia, nell’ultimo anno. Un altro segno della fine di un ciclo. Visto che il "consenso" verso i magistrati è sempre stato in stretta relazione con il "dissenso" verso Berlusconi.
4) Il sistema politico e quello economico appaiono, dunque, privi di riferimenti credibili fra i cittadini. Perfino le istituzioni di garanzia mostrano segni di debolezza. La "Magistratura", soprattutto, perde 8 punti di fiducia, nell’ultimo anno. Un altro segno della fine di un ciclo. Visto che il "consenso" verso i magistrati è sempre stato in stretta relazione con il "dissenso" verso Berlusconi. 5) Fra gli orientamenti che emergono da questa indagine, il più netto e appariscente è, forse, il crollo di fiducia nei confronti della Ue. Verso cui esprime (molta-moltissima) fiducia il 37% dei cittadini: oltre 13 punti meno di un anno fa, ma 16 rispetto al 2001. All’indomani dell’introduzione dell’euro. Quando la maggioranza assoluta degli italiani si diceva euro-convinta.
5) Fra gli orientamenti che emergono da questa indagine, il più netto e appariscente è, forse, il crollo di fiducia nei confronti della Ue. Verso cui esprime (molta-moltissima) fiducia il 37% dei cittadini: oltre 13 punti meno di un anno fa, ma 16 rispetto al 2001. All’indomani dell’introduzione dell’euro. Quando la maggioranza assoluta degli italiani si diceva euro-convinta. 6) Ciò sottolinea la crisi di governabilità di cui soffre la società italiana. Che - da sempre - non crede nello Stato (di cui si fida meno del 30% dei cittadini), tanto meno nei partiti (quasi metà degli italiani ritiene che non siano necessari alla democrazia) e, quindi, nel Parlamento ("presidiato" dai partiti). Ma oggi diffida - molto - anche dell’Unione Europea. Mentre, in passato, i due orientamenti procedevano in modo simmetrico. Perché gli italiani compensavano la (e reagivano alla) sfiducia nello Stato e nel governo italiano con la fiducia nella Ue. E con una crescente identità locale Ma la speranza nei governi locali e nel federalismo appare, anch’essa, molto raffreddata, rispetto al passato.
6) Ciò sottolinea la crisi di governabilità di cui soffre la società italiana. Che - da sempre - non crede nello Stato (di cui si fida meno del 30% dei cittadini), tanto meno nei partiti (quasi metà degli italiani ritiene che non siano necessari alla democrazia) e, quindi, nel Parlamento ("presidiato" dai partiti). Ma oggi diffida - molto - anche dell’Unione Europea. Mentre, in passato, i due orientamenti procedevano in modo simmetrico. Perché gli italiani compensavano la (e reagivano alla) sfiducia nello Stato e nel governo italiano con la fiducia nella Ue. E con una crescente identità locale Ma la speranza nei governi locali e nel federalismo appare, anch’essa, molto raffreddata, rispetto al passato. 7) Alla Bussola pubblica degli italiani restano, così, pochi punti cardinali. Le "forze dell’ordine", che riflettono il senso di insicurezza sociale. Oltre al Presidente della Repubblica, che è divenuto - negli ultimi dieci anni - il principale appiglio della domanda di identità nazionale degli italiani. Un sentimento rafforzato, nel 2011, dalle celebrazioni del 150enario. In questa indagine, il Presidente conferma la credibilità conquistata in questi anni. Ottiene, infatti, (molta-moltissima) fiducia da parte del 65% della popolazione. Eppure anch’egli arretra in misura sensibile rispetto al 2010: quasi 6 punti. Risente, probabilmente, dell’insoddisfazione sollevata presso alcuni settori sociali dalla manovra finanziaria del governo Monti. Un sentimento che si "scarica", in qualche misura, anche sul Presidente. Percepito, a ragione, come il principale sostegno (politico) a favore del governo (tecnico). Tanto più di fronte alla debolezza che affligge i partiti e il Parlamento. Ma anche le organizzazioni di mobilitazione e di integrazione sociale.
7) Alla Bussola pubblica degli italiani restano, così, pochi punti cardinali. Le "forze dell’ordine", che riflettono il senso di insicurezza sociale. Oltre al Presidente della Repubblica, che è divenuto - negli ultimi dieci anni - il principale appiglio della domanda di identità nazionale degli italiani. Un sentimento rafforzato, nel 2011, dalle celebrazioni del 150enario. In questa indagine, il Presidente conferma la credibilità conquistata in questi anni. Ottiene, infatti, (molta-moltissima) fiducia da parte del 65% della popolazione. Eppure anch’egli arretra in misura sensibile rispetto al 2010: quasi 6 punti. Risente, probabilmente, dell’insoddisfazione sollevata presso alcuni settori sociali dalla manovra finanziaria del governo Monti. Un sentimento che si "scarica", in qualche misura, anche sul Presidente. Percepito, a ragione, come il principale sostegno (politico) a favore del governo (tecnico). Tanto più di fronte alla debolezza che affligge i partiti e il Parlamento. Ma anche le organizzazioni di mobilitazione e di integrazione sociale. 8) D’altronde, anche la fiducia verso la più importante istituzione religiosa, la Chiesa, appare in sensibile calo. Oggi si attesta al 45%: 2 punti meno di un anno fa, ma 14 rispetto al 2001.
Tutto ciò ripropone l’immagine del "declino" che ha coinvolto i principali riferimenti istituzionali e dell’identità sociale degli italiani. Non solo lo Stato, ma anche l’Europa, la Chiesa; e ancora, il mercato e le organizzazioni di rappresentanza.
L’indice di fiducia complessivo nelle istituzioni politiche e di governo, dal 2005 ad oggi, è sceso infatti, dal 42% al 33%. Mentre, nello stesso periodo, la fiducia nelle istituzioni sociali ed economiche, nell’insieme, cala dal 35% al 26%.
Più che di declino, forse, converrebbe parlare di "recessione".
8) D’altronde, anche la fiducia verso la più importante istituzione religiosa, la Chiesa, appare in sensibile calo. Oggi si attesta al 45%: 2 punti meno di un anno fa, ma 14 rispetto al 2001.
Tutto ciò ripropone l’immagine del "declino" che ha coinvolto i principali riferimenti istituzionali e dell’identità sociale degli italiani. Non solo lo Stato, ma anche l’Europa, la Chiesa; e ancora, il mercato e le organizzazioni di rappresentanza.
L’indice di fiducia complessivo nelle istituzioni politiche e di governo, dal 2005 ad oggi, è sceso infatti, dal 42% al 33%. Mentre, nello stesso periodo, la fiducia nelle istituzioni sociali ed economiche, nell’insieme, cala dal 35% al 26%.
Più che di declino, forse, converrebbe parlare di "recessione". 9) Ciò marca una differenza profonda rispetto agli anni Novanta, quando la sfiducia nello Stato e nelle forme di partecipazione collettiva si accompagnò all’affermarsi del mito del mercato, del privato, dell’individuo, della concorrenza, dell’imprenditore. Oggi, al contrario, l’insoddisfazione verso i servizi privati è cresciuta molto più di quella verso i servizi pubblici. E la domanda di ridurre la presenza dello Stato nei servizi - scuola e sanità - si è ridotta al punto di apparire ormai residuale. Mentre il grado di partecipazione sociale non è "declinato", ma, negli ultimi anni, si è, anzi, allargato sensibilmente. In particolare, hanno conquistato ampio spazio le nuove forme di partecipazione sociale: il consumo critico, i movimenti di protesta, le mobilitazioni che si sviluppano, sempre più, attraverso la rete.
Comportamenti particolarmente diffusi fra i giovani e fra gli studenti. I più colpiti dalla crisi, ma anche dalla sfiducia.
9) Ciò marca una differenza profonda rispetto agli anni Novanta, quando la sfiducia nello Stato e nelle forme di partecipazione collettiva si accompagnò all’affermarsi del mito del mercato, del privato, dell’individuo, della concorrenza, dell’imprenditore. Oggi, al contrario, l’insoddisfazione verso i servizi privati è cresciuta molto più di quella verso i servizi pubblici. E la domanda di ridurre la presenza dello Stato nei servizi - scuola e sanità - si è ridotta al punto di apparire ormai residuale. Mentre il grado di partecipazione sociale non è "declinato", ma, negli ultimi anni, si è, anzi, allargato sensibilmente. In particolare, hanno conquistato ampio spazio le nuove forme di partecipazione sociale: il consumo critico, i movimenti di protesta, le mobilitazioni che si sviluppano, sempre più, attraverso la rete.
Comportamenti particolarmente diffusi fra i giovani e fra gli studenti. I più colpiti dalla crisi, ma anche dalla sfiducia. 10) Da ciò l’immagine di una "società senza Stato", (come recita il titolo di un libretto pubblicato di recente dal "Mulino"). Che, però, ha paura di restare senza Stato. E reagisce. Seguendo molte diverse vie. E vie molto diverse. La "sfiducia" - ma anche la "protesta" e la mobilitazione. Emerge, nel complesso, una diffusa resistenza alla "privatizzazione" dei servizi, all’individualizzazione dei riferimenti di valore e degli stili di comportamento, all’affermarsi delle logiche finanziarie e di mercato in ogni sfera della vita: a livello pubblico e privato. Sfiducia politica e partecipazione, dunque, coesistono presso le componenti sociali più vulnerabili. I ceti periferici, ma soprattutto i giovani, che manifestano incertezza e paura verso il presente, oltre che verso il futuro. E reagiscono insieme. Non solo per cercare soluzioni e per cambiare le cose. Ma per superare la solitudine e la frustrazione che li affliggono La partecipazione e la protesta agiscono, quindi, come una sorta di terapia. Contro la sfiducia e contro l’isolamento.
10) Da ciò l’immagine di una "società senza Stato", (come recita il titolo di un libretto pubblicato di recente dal "Mulino"). Che, però, ha paura di restare senza Stato. E reagisce. Seguendo molte diverse vie. E vie molto diverse. La "sfiducia" - ma anche la "protesta" e la mobilitazione. Emerge, nel complesso, una diffusa resistenza alla "privatizzazione" dei servizi, all’individualizzazione dei riferimenti di valore e degli stili di comportamento, all’affermarsi delle logiche finanziarie e di mercato in ogni sfera della vita: a livello pubblico e privato. Sfiducia politica e partecipazione, dunque, coesistono presso le componenti sociali più vulnerabili. I ceti periferici, ma soprattutto i giovani, che manifestano incertezza e paura verso il presente, oltre che verso il futuro. E reagiscono insieme. Non solo per cercare soluzioni e per cambiare le cose. Ma per superare la solitudine e la frustrazione che li affliggono La partecipazione e la protesta agiscono, quindi, come una sorta di terapia. Contro la sfiducia e contro l’isolamento.Si delinea, così, una stagione incerta. Un ciclo politico si è chiuso, dopo quasi vent’anni. Lasciandoci spaesati. Privi di riferimenti istituzionali e politici. Insoddisfatti del pubblico e delusi dal privato. Senza fiducia. Ma quel che verrà dopo non è chiaro - e un nuovo ciclo ancora non si vede. Tuttavia, la scelta di Monti di investire nel "civismo" - attraverso la centralità "mediatica" attribuita alla lotta all’evasione fiscale - appare una risposta poco "tecnica" e, invece, molto "politica" al problema sollevato da questa indagine. Restituire i cittadini allo Stato. Per restituire lo Stato ai cittadini.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ----- Teologia della crisi italiana (di Furio Colombo)8 gennaio 2012, di Federico La Sala
Teologia della crisi italiana
di Furio Colombo (il Fatto, 08.01.2012)
Scende e si deposita su articoli e discorsi, su prese di posizione e proteste un alone di magistero religioso. È il momento fondativo di una fede o del rigetto di una fede. Lo vedi, lo constati: una parte si avvia a credere con devozione. Una parte è composta di miscredenti o di atei. Scende e si deposita su articoli e discorsi, su prese di posizione e proteste un alone di magistero religioso. È il momento fondativo di una fede o del rigetto di una fede. Lo vedi, lo constati: una parte si avvia a credere con devozione. Una parte è composta di miscredenti o di atei.
I due gruppi però ora sono tutt’altro che omogenei, fatti di gente molto diversa, fra imposizione e fiducia da una parte, fra scetticismo e rivolta (qualcuno teme rivolta violenta) dall’altra. Sia i leader delle nuove tavole della legge, sia coloro che sono decisi (non tutti decisi allo stesso modo) a restare fuori dal tempio, sono consapevoli che l’evento è unico, che il momento è decisivo. Vibra intorno a tutti (anche i miscredenti) la percezione di una eccezionalità che dà un peso enorme a ogni frase, a ogni gesto, trasforma tutto in simbolo.
Salvezza e perdizione sono i due modi per definire lo spazio e i limiti dello spazio. “Adesso, subito” oppure “prima parliamone” sono i due modi di qualificare la percezione del tempo. Come sempre, la grazia non può aspettare. Il rifiuto della grazia, intesa come salvezza, è il peccato. Il peccato si annuncia col trascinamento nel tempo. “Discutiamone” è la tipica via d’uscita di chi non ha fede. Di che cosa sto parlando? Il lettore ha capito che sto parlando di Europa in questi giorni, che sto parlando dell’Italia. Ho detto della contrapposizione tra salvezza e perdizione, ma la parola giusta è esclusione. Esclusione dalla comunità dei salvati. È la vera sanzione del peccato: fuori dal benessere, fuori dalla crescita, fuori dal futuro, fuori dall’euro, fuori dal-l’Europa. Il peccato è rifiutare il sacrificio. È vero che il sacrificio non è uguale per tutti, ma questo avviene in tutte le religioni, dove alcuni, per la stessa fede, pagano prezzi immensi e altri no.
NELLE RELIGIONI classiche si dice che Qualcuno o Qualcosa provvederà, in un’altra ambientazione di fatti e di tempi, a rimborsare chi ha dovuto eccedere nel-l’offerta (“beati i poveri”). In questa, che stiamo vivendo e discutendo, il rimborso è affidato a una speranza che prudentemente rimane inespressa. Al massimo ti dicono che, se il sistema tornerà a produrre ricchezza, non potrà che distribuirla. Tranne che in casi di guerra o di estrema calamità naturale, nessuna autorità ha mai preteso, nei sistemi democratici, una così rigorosa accettazione indiscussa di regole tanto dure che però non assicurano alcuna certezza, solo una chance. Esigono, ma non promettono. “Forse” è già un articolo di fede. Cerco di essere preciso. Tutto ciò di cui sto parlando non è il capitalismo. Del capitalismo ci sono, e vengono ripetute, regole e comportamenti che costituivano buona parte di quel disegno di costruzione sociale basata, come si ama dire, sul merito, e fondata, nella vita reale, su occasioni, ben raccolte e bene usate, di privilegio. Non sto parlando - lo vedete - di corruzione. Perché i corrotti non sono mai fra i miscredenti, non si contrappongono mai a un sistema religioso. La corruzione - così come aveva visto per tempo Martin Lutero per il cattolicesimo - si nasconde nelle migliori pratiche di fede. E perciò, in attesa di una “riforma”, sulla corruzione sospendiamo il discorso.
Mi premeva dire che la strana, mistica avventura che stiamo vivendo non è un ritorno o una rivincita del capitalismo. Il capitalismo è freddo e pragmatico e non perde tempo con le sue vittime. Spiana dove deve costruire, e costruisce, se deve, anche murando la tua finestra. Per giunta il capitalismo è privo di preoccupazioni che non siano “l’affare”, non si volta indietro, dialoga solo con soci e con partner.
Qui siamo in un tempio. Le lacrime non sono finzione, la preoccupazione anche grave non è una messa in scena, la parola deve essere ascoltata non per sottomissione alla autorità ma perché in essa chi partecipa al nuovo rito riconosce la verità. Da quella verità non si sfugge perché è l’unica possibilità di salvezza. Non fornisce tutti i dati del “come” si arriverà alla salvezza, ma una cosa è certa: questa è l’unica strada. Una religione prevale quando anche i miscredenti gravitano su di essa, nel senso che discutono, anche accanitamente, ma voltati verso l’altare, ovvero il punto sacro e caldo del tempio, quello in cui deve avvenire il miracolo. I più non stanno dicendo che la strada è un’altra. I più stanno invocando un cambiamento o attenuazione o dilazione di regole per me, o per te o per loro. In inglese la parola è advocacy. Significa che la nuova fede è più forte dei miscredenti e li sta portando, con tutte le differenze e le eresie, a un unico punto caldo? Di sicuro dimostra che non stiamo parlando di rivincita e ritorno del capitalismo puro, che non si è mai proposto come salvezza ma come naturale espressione tecnica ed economica della democrazia liberale. E non stiamo parlando di un battibecco tra destra e sinistra, fra conservatori e liberal.
No, signori, qui c’è fede, dunque vita, morte, salvezza o dannazione (nella forma della esclusione), via d’uscita o precipizio (il baratro viene continuamente invocato, e anche il baratro non è una figura del capitalismo, se non come fallimento di una impresa, e danno grave per qualcuno, quasi sempre a beneficio di qualcun altro). La strada della salvezza invece la imbocchi per fede, non perchè ti forniscono le prove.
A essere sinceri non siamo sicuri neppure del peccato originale che ci ha portato così vicini alla perdizione. Ogni paese ha il suo, in Europa. Ma la passione religiosa si estende all’America, dove il candidato repubblicano (uno di loro, Romney, ma a nome di tutti) dichiara: “Non un dollaro per salvare l’Europa”. Che vuol dire: mai finanziare il peccato. Tutto ciò porta a non notare che - proprio in America - una solida e pericolosa congrega di atei, guidata dai premi Nobel per l’economia Krugman, Stieglitz e Amartya Sen, sostiene che la nuova chiesa si fonda sull’errore. Alle dovute condizioni e con le dovute regole, si deve spendere per salvarsi, non risparmiare. E cominciare con il salvare i poveri (molti) e ridare speranza ai quasi poveri (moltissimi).
È tollerabile una simile eresia? È tollerabile se la si isola in un ghetto universitario-giornalistico, lontano dai governi. I governi tagliano, in Europa e in America, per non essere esclusi dal tempio. Dunque la decisione è terribile e semplice: abbracciare o no la fede. Tanto più che si diffonde l’inquietante sensazione che fuori dal tempio e sopra e lontano, abiti un dio potente che non ha ancora svelato il suo volto.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- Pax Christi contro gli F-35: «Sono come Erode» (di Luca Kocci).7 gennaio 2012, di Federico La Sala
Pax Christi contro gli F-35: «Sono come Erode»
di Luca Kocci (il manifesto, 7 gennaio 2012)
I cacciabombardieri di Erode: anche loro, come il re della giudea che secondo il racconto del Vangelo ordinò il massacro dei neonati per tentare di uccidere Gesù appena nato, compiono «stragi di innocenti», magari mascherate da «danni collaterali». Vanno fermati. Usa una metafora biblica e parole estremamente dure monsignor Giovanni Giudici, vescovo di Pavia e presidente nazionale di Pax Christi, per attaccare governo e parlamento che non sembrano voler recedere dall’intenzione di acquistare 131 cacciabombardieri f-35 per una spesa di oltre 15 miliardi di euro. «Finalmente la notizia è arrivata nei titoli di giornale - dice monsignor Giudici -, nel panorama drammatico di questa crisi economica che esige sacrifici e tagli per il bene del paese e per il futuro di tutti: anche le spesemilitari devono essere drasticamente tagliate», e in particolare va cancellato - senza dover pagare alcuna esorbitante penale, come le lobby militari sostenevano e come un’inchiesta di altreconomia, confermata anche dall’ex capo di statomaggiore il generale Vincenzo Camporini ha smento - il programma di acquisto degli F-35, «aerei di attacco che costano quasi 150 milioni di euro ciascuno».
«L’assordante silenzio che copriva questo progetto è stato rotto», denuncia il presidente di Pax Christi, una delle poche associazioni cattoliche da sempre in prima linea contro gli F-35. «Sempre più palese è l’assurdità di produrre armi investendo enormi capitali mentre il grido dei poveri, interi popoli, ci raggiunge sempre più disperato». Bisogna cambiare radicalmente strada, dice il vescovo: abbandonare quella «di Erode, fatta di violenza e sopruso», e - non a caso le parole vengono pronunciate proprio in occasione della festa dell’Epifania - seguire invece quella «dei Magi e di chiunque, singoli e popoli, discerne le opere di pace per garantire il futuro di tutti» e per orientare «ogni scelta alla via esigente e necessaria della pace».
Per questo, chiede il presidente di Pax Christi anche ai tanti cattolici, per lo meno a parole, che fanno parte del governo - dal «ministro di sant’Egidio » Riccardi, al rettore dell’università cattolica Ornaghi, all’ex presidente del movimento dei laureati dell’azione cattolica Balduzzi - «esigiamo un ripensamento di queste spese militari con un serio dibattito in parlamento. I popoli che camminano nella tenebra di questa follia chiedono di cancellare questo progetto, e ciò è ancora più necessario in un tempo di crisi che è già molto pesante soprattutto per le famiglie e per i più poveri e che non sembra invece toccare i grandi investimenti per le armi». Chi si proclama cattolico, aggiunge monsignor giudici, «non può familiarizzare con progetti di violenza, neppure in chiave di pseudo-sicurezza internazionale».
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- La Chiesa non fa sacrifici Esenzione dell’Ici, otto per mille, insegnanti di Religione diventati statali, fondi alle scuole cattoliche e altri privilegi (di Marco Politi)7 dicembre 2011, di Federico La Sala
La Chiesa non fa sacrifici
Esenzione dell’Ici, otto per mille, insegnanti di Religione diventati statali, fondi alle scuole cattoliche e altri privilegi che il Vaticano non vuole toccare: dov’è la sobrietà uinvocata dal cardinale Scola?
di Marco Politi (il Fatto, 07.12.2011)
La Chiesa si autoesenta, sacrifici mai. Resta attaccata ai suoi privilegi, ma è prodiga di consigli sull’equità della manovra. È da agosto che l’opinione pubblica aspetta dalla Cei un segnale di disponibilità ad aiutare lo Stato a ripianare il suo debito colossale. In tempi passati i vescovi fondevano l’oro dei sacri calici per sostenere la difesa di un regno invaso. Ora che il nemico finanziario è molto più subdolo e spietato, non succede nulla. Dalla gerarchia non è giunto il più piccolo segnale di “rinuncia”. Solo la dichiarazione del Segretario di Stato Vaticano, Tarcisio Bertone, che ha affermato: “Il problema dell’Ici è un problema particolare, da studiare e approfondire”. Eppure quello che pensano gli italiani è chiarissimo. Sono contrari all’esenzione dell’I-ci, sono contrari a spolpare le casse dello Stato ai danni della scuola pubblica, perché credono al principio costituzionale che chi fonda una scuola privata la paga con i propri soldi. Soprattutto gli italiani sono convinti a grande maggioranza che la Chiesa predica bene e razzola male. Vedere per credere l’indagine del professor Garelli sulla “Religione all’italiana”.
QUANDO si parla di soldi, la gerarchia ecclesiastica si rifugia subito nel vittimismo, accusa complotti da parte dei nemici della Chiesa, si attacca a errori di conteggio sbagliati per qualche dettaglio o di chi mette sullo stesso piano la Cei (organismo nazionale) e il Vaticano, realtà internazionale. Nessuno trascura l’aiuto sistematico che è venuto in questi anni alle fasce più povere da parrocchie, episcopato e organizzazioni come la Caritas o Sant’Egidio. Ma ora è il momento di gesti straordinari e di uno sfoltimento di privilegi come avviene in tutto il Paese. Ci sono fatti molto precisi su cui la gerarchia non ha mai dato risposta e che costituiscono privilegi inaccettabili specialmente nella drammatica situazione economica attraversata dal Paese.
Ne elenchiamo alcuni, che indignano egualmente credenti e diversamente credenti. Non limitare l’esenzione Ici agli edifici strettamente di culto è un’evasione fiscale legalizzata. L’attuale sistema di conteggio dell’8 per mille è truffaldino perché non tiene conto del fatto che quasi due terzi dei contribuenti - non mettendo la crocetta sulla dichiarazione delle tasse - intendono lasciare i soldi allo Stato. In Spagna, dove è stato a suo tempo copiato il sistema italiano, si conteggiano giustamente soltanto i “voti espressi”. In Germania il finanziamento alle chiese luterana e cattolica avviene con una “tassa ecclesiastica” che grava direttamente sul cittadino. Se il contribuente non vuole, si cancella. L’attuale sistema dell’8 per mille è uscito fuori controllo. Doveva garantire una somma più o meno equivalente alla vecchia congrua data dallo Stato ai sacerdoti, ma essendo agganciata all’Irpef la somma che il bilancio statale passa alla Cei è cresciuta a dismisura. Nel 1989 la Chiesa prendeva 406 miliardi di lire all’anno, oggi il miliardo di euro che incassa equivale a quasi 2.000 miliardi di lire. Cinque volte di più!
L’8 per mille è stato pensato (ed è approvato come principio dalla maggioranza degli italiani) per finanziare il clero in cura d’anime e l’edilizia di culto in primo luogo. Ciò nonostante la Chiesa si fa pagare ancora una volta a parte i cappellani nelle forze armate, nella polizia, negli ospedali, nelle carceri, persino nei cimiteri. Si tratta di decine di milioni di euro. Nessuno ignora quanti splendidi preti siano impegnati specialmente nelle prigioni, ma è il sistema del pagamento aggiuntivo che non è accettabile. Lo stesso vale per le decine di milioni aggiuntivi versati dallo Stato, dalle regioni e dai comuni per l’edilizia di culto, che è già coperta dall’8 per mille.
PER NON PARLARE dei milioni di euro elargiti ogni anno attraverso la famigerata “Legge mancia”. Invitando a uno stile di vita più sobrio per la festa di san-t’Ambrogio in Milano, il cardinale Scola afferma che con gli anni si è stravolto il concetto di “diritti”. In un clima di benessere e “senza fare i conti con le risorse veramente disponibili si sono avanzate pretese eccessive in termini di diritti nei confronti dello Stato”. Verissimo. C’è da aggiungere che anche la Chiesa ha partecipato alla gara. Non è bastato che gli insegnanti di Religione venissero stipendiati dallo Stato, si è preteso che da personale extra-ruolo venissero anche statalizzati. Contemporaneamente si è iniziato a mungere le casse statali per finanziare le scuole cattoliche. Altrove in Europa lo fanno, ma non c’è l’8 per mille. È l’ingordigia nel ricorso ai fondi statali che spaventa.
Quanto al Vaticano, i Trattati lateranensi garantiscono ad esempio un adeguato fornimento d’acqua al territorio papale. Non è prepotenza il rifiuto di contribuire allo smaltimento delle acque sporche? Costa all’Italia 4 milioni di euro l’anno. Cifra su cifra ci sono centinaia di milioni che possono essere risparmiati. Il premier Monti può fare tre cose subito. Decretare che, come accade in Germania e altri Paesi, i finanziamenti statali vanno solo a enti che pubblicano il bilancio integrale di patrimoni e redditi: così gli italiani e lo Stato conosceranno il patrimonio delle diocesi. Limitare l’esenzione dell’I-ci esclusivamente agli edifici di culto. Attivare la commissione paritetica prevista dall’art. 49 della legge istitutiva dell’8 per mille per rivedere la somma del gettito. Sarebbe molto europeo.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- Il capitalismo divino e la mistica del capitalismo (di Roberto Esposito)6 dicembre 2011, di Federico La Sala
LA MISTICA DEL CAPITALISMOdi Roberto Esposito (la Repubblica, 06.12.2011)
«Nel capitalismo può ravvisarsi una religione, vale a dire, il capitalismo serve essenzialmente alla soddisfazione delle medesime ansie, sofferenze, inquietudini, cui un tempo davano risposta le cosiddette religioni». Queste fulminanti parole di Walter Benjamin - tratte da un frammento del 1921, pubblicato adesso nei suoi Scritti politici, a cura di M. Palma e G. Pedullà per gli Editori Internazionali Riuniti - esprimono la situazione spirituale del nostro tempo meglio di interi trattati di macroeconomia. Il passaggio decisivo che esso segna, rispetto alle note analisi di Weber sull’etica protestante e lo spirito del capitalismo, è che questo non deriva semplicemente da una religione, ma è esso stesso una forma di religione. Con un solo colpo Benjamin sembra lasciarsi alle spalle sia la classica tesi di Marx che l’economia è sempre politica sia quella, negli stessi anni teorizzata da Carl Schmitt, che la politica è la vera erede moderna della teologia.
Del resto quel che chiamiamo "credito" non viene dal latino "credo"? Il che spiega il doppio significato , di "creditore" e "fedele", del termine tedesco Gläubiger. E la "conversione’’ non riguarda insieme l’ambito della fede e quello della moneta? Ma Benjamin non si ferma qui. Il capitalismo non è una religione come le altre, nel senso che risulta caratterizzato da tre tratti specifici: il primo è che non produce una dogmatica, ma un culto; il secondo che tale culto è permanente, non prevede giorni festivi; e il terzo che, lungi dal salvare o redimere, condanna coloro che lo venerano a una colpa infinita. Se si tiene d’occhio il nesso semantico tra colpa e debito, l’attualità delle parole di Benjamin appare addirittura inquietante. Non soltanto il capitalismo è divenuto la nostra religione secolare, ma, imponendoci il suo culto, ci destina ad un indebitamento senza tregua che finisce per distruggere la nostra vita quotidiana.
Già Lacan aveva identificato in questa potenza autodistruttiva la cifra peculiare del discorso del Capitalista. Ma lo sguardo di Benjamin penetra talmente a fondo nel nostro presente da suscitare una domanda cui la riflessione filosofica contemporanea non può sottrarsi. Se il capitalismo è la religione del nostro tempo, vuol dire che oltre di esso non è possibile sporgersi? Che qualsiasi alternativa gli si possa contrapporre rientra inevitabilmente nei suoi confini - al punto che il mondo stesso è "dentro il capitale", come suona il titolo di un libro di Peter Sloterdijk (II mondo dentro il capitale, Meltemi 2006)?
Oppure, al di la di esso, si può pensare qualcosa di diverso - come si sforzano di fare i numerosi teorici del postcapitalismo? Intorno a questo plesso di questioni ruota un intrigante libro, originato da un dibattito tra filosofi tedeschi, ora tradotto a cura di Stefano Franchini e Paolo Perticari, da Mimesis, col titolo Il capitalismo divino. Colloquio su denaro, consumo, arte e distruzione.
Da un lato esso spinge l’analisi di Benjamin più avanti, per esempio in merito all’inesorabilità del nuovo culto del brand. Tale è la sua forza di attrazione che, anche se vi è scritto in caratteri cubitali che il fumo fa morire, compriamo lo stesso il pacchetto di sigarette. Come in ogni religione, la fede è più forte della evidenza. Dior, Prada o Lufthansa garantiscono per noi più di ogni nostra valutazione. Le azioni cultuali sono provvedimenti generatori di fiducia cui non possibile sfuggire. Non a caso anche i partiti politici dichiarano "Fiduia nella Germania" a prescindere, non diversamente da come sul dollaro è scritto "In God we trust". Ma, allora, se il destino non è, come credeva Napoleone, la politica, ma piuttosto l’economia; se il capitale, come tutte le fedi, ha i suoi luoghi di culto, i suoi sacerdoti, la sua liturgia - oltre che i suoi eretici, apostati e martiri quale futuro ci attende?
Su questo punto i filosofi cominciano a dividersi. Secondo Sloterdijk, con l’ingresso in campo del modello orientale - nato a Singapore e di lì dilagato in Cina e in India - si va rompendo la triade occidentale di capitalismo, razionalismo e liberaldemocrazia in nome di un nuovo capitalismo autoritario. In effetti oggi si assiste a un curioso scambio di consegne tra Europa e Asia. Nel momento stesso in cui, a livello strutturale, la tecnologia europea, e poi americana, trionfa su scala planetaria, su quello culturale il buddismo e i diversi "tao" invadono l’Occidente. La tesi di Zizek è che tra i due versanti si sia determinato un perfetto (e perverso) gioco delle parti. In un saggio intitolato Guerre stellari III. Sull’etica taoista e lo spirito del capitalismo virtuale (ora incluso nello stesso volume), egli individua nel buddismo in salsa occidentale l’ideologia paradigmatica del tardo capitalismo. Nulla più di esso corrisponde al carattere virtuale dei flussi finanziari globali, privi di contatto con la realtà oggettiva, eppure capaci di influenzarla pesantemente. Da questo parallelismo si può trarre una conseguenza apologetica o anche una più critica, se riusciamo a non identificarci interiormente col giuoco di specchi, o di ombre cinesi, in cui pure ci muoviamo. Ma in ciascuno dei casi restiamo prigionieri di esso.
E’ questa l’ultima parola della filosofia? Diverremo tutti, prima o poi, officianti devoti del culto capitalistico, in qualsiasi versione, liberale o autoritaria, esso si presenti? Personalmente non tirerei questa desolata conclusione. Senza necessariamente accedere all’utopia avveniristica del Movimento Zeitgeist o del Venus Project - entrambi orientati a sostituire l’attuale economia finanziaria con un’organizzazione sociale basata sulle risorse naturali -, credo che l’unico grimaldello capace di forzare la nuova reli¬gione del capitale finanziario sia costituito dalla politica. A patto che anch’essa si liberi della sua, mai del tutto dismessa, maschera teologica. Prima ancora che sul terreno pratico, la battaglia si gioca sul piano della comprensione della realtà. Nel suo ultimo libro, Alla mia sinistra (Mondadori, 2011), Federico Rampini percorre lo stesso itinerario - da Occidente a Oriente e ritorno - ma traendone una diversa lezione. All’idea di "mondo dentro il capitale" di Sloterdijk è possibile opporre una prospettiva rovesciata, che situi il capitale dentro il mondo, vale a dire che lo cali dentro le differenze della storia e della politica. Solo quest’ultima può sottrarre l’economia alla deriva autodissolutiva cui appare avviata, governandone i processi ed invertendone la direzione.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- GOVERNO MONTI. Ma perché il Vaticano non paga l’Ici? (di Pino Corrias) - Oggi solo il 10 per cento circa delle proprietà della Chiesa paga l’imposta. Il mancato gettito annuale è stimato in 400-600 milioni di euro (di Gianmaria Pica - Ma per la Chiesa è sempre esenzione).6 dicembre 2011, di Federico La Sala
Ma perché il Vaticano non paga l’Ici?
di Pino Corrias (il Fatto, 12.06.2011)
NON AVENDO Ruby da farsi perdonare, né lo spergiuro sulla testa dei figli, né tanto meno le vacanze con Previti, Gheddafi e Putin, ci chiedevamo cosa diavolo avesse Mario Monti da farsi perdonare per avere messo in salvo anche questa volta il Vaticano dalla nuova fucilazione di tasse che a quanto pare dovrebbe salvarci la pelle, bucherellandocela. Tra le ragioni azzardavamo pure la santità di Corrado Passera che per di più risulta un poco ottenebrata dal recente divorzio e perciò ancora più sensibile ai soffici ammonimenti della virtuosa gerarchia.
Ci chiedevamo (dunque) come mai venisse di nuovo tassata la prima casa di tutti i cristiani, tranne quella dei padri della cristianità. E insomma, perché mai le grasse casse di Ratzinger che già ci aspirano l’8 per mille non dovessero almeno restituirci i 600 milioni di Ici non versati ogni anno. È a quel punto della giornata che si è fatto vivo monsignor Giancarlo Bregantini, responsabile della Cei per i problemi sociali, che ha detto: “La manovra poteva essere più equa. Specialmente coi redditi alti”. Tipo i patrimoni Vaticani? Ma questo monsignor Bregantini che oggi parla di corda in casa dell’impiccato, ci è o cristianamente ci fa?
LA CEI non paga l’Ici e critica la manovra *
Per i Vescovi la manovra di Monti doveva essere più equa. Secondo monsignor Bregantini, dalla presentazione della manovra si ricava l’impressione che “si poteva fare di più sui redditi alti con l’Irpef” mentre, aggiunge, “bisogna essere molto attenti sulle pensioni e forse le misure andavano presentate in contemporanea con quelle per la ripresa. Sarebbe stato forse più opportuno mettere tutte e due le mani insieme, la mano sul fisco e sulla crescita”. “A questo punto - prosegue il responsabile Cei - si deve puntare sulla seconda fase organizzando molto bene l’aspetto della ripresa”, essendo “propositivi”. “Il mondo sindacale guarda con preoccupazione” alle mosse del governo, osserva ancora l’arcivescovo, “ma sarebbe opportuno dialogare per poter arrivare a delle proposte precise soprattutto nel settore dove tutti facciamo fatica, quello della precarietà giovanile”.
Bregantini auspica inoltre nuove misure a favore della famiglia e il sostegno della politica al governo Monti. Ma i Radicali protestano perché la Chiesa, ancora una volta, pur protestando, resta immune dai sacrifici degli italiani. ’’Ha davvero una gran faccia tosta la Cei a obiettare che la manovra avrebbe potuto essere più equa - dice Mario Staderini, segretario nazionale - Purché a pagare siano gli altri e non la Chiesa, evidentemente . Tanto per cominciare, infatti, sarebbe stata più equa se avesse abolito l’esenzione dell’Ici anche per le attività commerciali degli enti ecclesiastici e similari, piuttosto che fare cassa sulle prime case degli italiani”. “Da un primo esame delle misure risulta ancora troppo timido il ridimensionamento della spesa pubblica, che - conclude Staderini - avrebbe dovuto costituire il nucleo centrale dell’intervento di emergenza e che invece vede ancora prevalere le nuove tassazioni”.
* il Fatto, 12.06.2011
CARO CASA. Il viceministro Grilli afferma che l’imposta immobiliare la dovranno pagare tutti, anche le imprese. Intanto, sui beni gestiti dal Vaticano, il premier glissa: «È una questione che non ci siamo posti ancora».
Sarà Ici anche per le società di comodo
Ma per la Chiesa è sempre esenzione
Oggi solo il 10 per cento circa delle proprietà della Chiesa paga l’imposta. Il mancato gettito annuale è stimato in 400-600 milioni di euro.
di Gianmaria Pica (il Riformista, 06.12.2011)
Basta trucchetti fiscali. Se la villa, l’appartamento, o il capannone industriale sono intestati a società, il titolare dell’impresa non potrà più sfuggire e dovrà versare all’erario l’imposta Ici (oggi super-Imu) anche su questi beni immobiliari. Così, come ha spiegato il viceministro Grilli, saranno chiamate a pagare tutte le imprese, anche le società di comodo e i trust. Il trust è un istituto giuridico attraverso cui è possibile creare in maniera piuttosto flessibile un rapporto fiduciario tra un primo soggetto che mette a disposizione i beni e un secondo soggetto che gestirà il patrimonio conferito nel trust.
La società di comodo (o società non operativa), invece, si costituisce al solo fine di amministrare i patrimoni personali dei soci, anziché esercitare un’effettiva attività commerciale. Un esempio concreto? Il patrimonio di Silvio Berlusconi non è costituito solo di televisioni ed editoria. Anche le case sono nel cuore del Cavaliere-imprenditore. Così, anche Berlusconi custodisce i suoi gioielli immobiliari in una cassaforte del mattone: si tratta della Immobiliare Idra (controllata dalla Dolcedrago che appartiere al 99,5 per cento allo stesso Berlusconi).
L’Immobiliare Idra ha in pancia una settantina di proprietà, tra cui le rimanenze di Milano 2, alcune case e ville a Roma e i beni più preziosi: Villa La Certosa (residenza estiva dell’ex premier), Villa San Martino (la dimora berlusconiana ad Arcore), e Villa Belvedere Visconti di Modrone a Macherio (castello ottocentesco, residenza dell’ex moglie Veronica Lario). Insomma, adesso anche Berlusconi sarà chiamato a pagare la super-Ici sui beni custoditi nell’Immobiliare Idra-Dolcedrago, un impero che vale centinaia di milioni di euro.
Ma a quale sacrificio economico saranno chiamati gli italiani? La manovra correttiva approvata domenica dal Consiglio dei ministri prevede che l’Imu sostituisca la vecchia Ici. Dunque, l’Imu si pagherà anche sulla prima casa con un’aliquota dello 0,4 percento (con una detrazione di 200 euro), rispetto allo 0,76 per cento dell’aliquota ordinaria per la seconda casa. È prevista anche una rivalutazione degli estimi catastali del 60 per cento, che toccherà anche gli uffici.
In sostanza, il decreto Monti prevede una rivalutazione dei valori catastali che passa da 50 a 80 per gli uffici (più 60 per cento), mentre non è ancora chiaro quale sarà l’incremento per gli immobili commerciali. Al di là dei tecnicismi, il Tesoro quantifica in 10-12 miliardi le entrate da Imu. Naturalmente, l’impatto del ritorno dell’Ici (previsto dal primo gennaio 2012) sarà molto forte sulle famiglie, il cui costo medio sarà pari a 1.680 euro l’anno. Equivalente all’8 per cento del reddito medio di una famiglia del Mezzogiorno e al 4 per cento del reddito annuo di una famiglia del Centro-Nord.
Ma ci sono sempre i soliti noti che non pagheranno un euro di Imu. Ieri, il presidente del Consiglio Mario Monti sulla questione Ici-Chiesa ha glissato: «È una questione che non ci siamo posti ancora». Per comprendere meglio il paradosso di quest’esenzione dobbiamo fare un salto indietro nel tempo. Nel 1992 il governo Amato stabilisce alcune esenzioni per le proprietà della Chiesa. La questione su quale tipo di edifici e proprietà dovessero essere esentati ha portato negli anni a diversi procedimenti giudiziari, fino al 2004 quando la norma viene in parte bocciata dalla Consulta che elimina le agevolazioni fiscali per gli immobili a scopo di lucro. L’esenzione, però, viene reintrodotta nel 2005 dal governo Berlusconi III che cambia la vecchia normativa, includendo gli immobili destinati ad attività commerciali tra quelli compresi nel diritto all’esenzione. Nel 2006, l’allora governo Prodi, modifica nuovamente la legislazione. Tuttavia un emendamento alla legge permise di mantenere l’esenzione per le sedi di attività che abbiano fini «non esclusivamente commerciali».
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- In quale punto dell’universo si proclama l’ideale del greed is good, ovvero l’avidità è un bene? (di Leonard Boff - La grande perversione).5 dicembre 2011, di Federico La Sala
La grande perversione
di Leonardo Boff *
Per risolvere la crisi economico-finanziaria della Grecia e dell’Italia è stato costituito, per esigenza della Banca Centrale Europea, un governo di soli tecnici senza la presenza di politici, nell’illusione che si tratti di un problema economico che deve essere risolto economicamente. Chi capisce solo di economia finisce col non capire neppure l’economia. La crisi non è di economia mal gestita, ma di etica e di umanità. E queste hanno a che vedere con la politica. Per questo, la prima lezione di un marxismo minimo è capire che l’economia non è parte della matematica e della statistica, ma un capitolo della politica. Gran parte del lavoro di Marx è dedicato alla destrutturazione dell’economia politica del capitale. Quando in Inghilterra si visse una crisi simile all’attuale e si creò un governo di tecnici, Marx espresse con ironia e derisione dure critiche perché prevedeva un totale fallimento, come effettivamente successe. Non si può usare il veleno che ha creato la crisi come rimedio per curare la crisi.
Per guidare i rispettivi governi di Grecia e Italia hanno chiamato gente che apparteneva agli alti livelli dirigenziali delle banche. Sono state le banche e le borse a provocare l’attuale crisi che ha affondato tutto il sistema economico. Questi signori sono come talebani fondamentalisti: credono in buona fede nei dogmi del mercato libero e nel gioco delle borse. In quale punto dell’universo si proclama l’ideale del greed is good, ovvero l’avidità è un bene? Come fare di un vizio (e diciamo subito, di un peccato) una virtù? Questi signori sono seduti a Wall Street e alla City di Londra. Sono volpi che non si limitano a guardare le galline, ma le divorano. Con le loro manipolazioni trasferiscono grandi fortune nelle mani di pochi. E quando è scoppiata la crisi sono stati soccorsi con miliardi di dollari sottratti ai lavoratori e ai pensionati. Barack Obama si è dimostrato debole, inchinandosi più a loro che alla società civile. Con i soldi ricevuti hanno continuato la baldoria, giacché la promessa regolazione dei mercati è rimasta lettera morta. Milioni di persone vivono nella disoccupazione e nel precariato, soprattutto i giovani che stanno riempiendo le piazze, indignati contro l’avidità, la disuguaglianza sociale e la crudeltà del capitale.
Persone formate al catechismo del pensiero unico neolibersita tireranno fuori la Grecia e l’Italia dal pantano? Quello che sta succedendo è il sacrificio di tutta una società sull’altare delle banche e del sistema finanziario.
Visto che la maggioranza degli economisti dell’estabilishment non pensa (né ha bisogno), tentiamo di comprendere la crisi alla luce di due pensatori che nello stesso anno, il 1944, negli Stati Uniti, ci hanno fornito una illuminante chiave di lettura. Il primo è il filosofo ed economista ungaro-canadese Karl Polanyi con il suo La grande trasformazione (1944; Einaudi, 1974), un In che consiste? Consiste nella dittatura dell’economia. Dopo la Seconda Guerra Mondiale che ha aiutato a superare la grande Depressione del 1929, il capitalismo ha messo a segno un colpo da maestro: ha annullato la politica, mandato in esilio l’etica e imposto la dittatura dell’economia. A partire dalla quale non si ha più, come si era sempre avuta, una società con mercato, ma una società di solo mercato. L’ambito economico struttura tutto e fa di tutto commercio, sorretto da una crudele concorrenza e da una sfacciata avidità. Questa trasformazione ha lacerato i legami sociali e ha approfondito il fossato fra ricchi e poveri in ogni Paese e a livello internazionale.
L’altro pensatore è un filosofo della scuola di Francoforte, esiliato negli Usa, Max Horkheimer, autore de L’eclissi della ragione (1947; Einaudi 1969). Qui si danno i motivi per la Grande Trasformazione di cui parla Polanyi che consistono fondamentalmente in questo: la ragione non è più orientata dalla verità e dal senso delle cose, ma è stata sequestrata dal processo produttivo e ridotta ad una funzione strumentale «trasformata in un semplice meccanismo molesto di registrazione dei fatti». Deplora che concetti come «giustizia, uguaglianza, felicità, tolleranza, per secoli giudicati inerenti alla ragione, abbiano perso le loro radici intellettuali». Quando la società eclissa la ragione, diventa cieca, perde significato lo stare insieme, rimane impaludata nel pantano degli interessi individuali o corporativi. È quello che abbiamo visto nell’attuale crisi. I premi Nobel dell’Economia, i più umanisti, Paul Krugman e Joseph Stiglitz hanno scritto ripetutamente che i “giocatori” di Wall Street dovrebbero stare in carcere come ladri e banditi.
Ora, in Grecia e in Italia, la Grande Trasformazione si è guadagnata un altro nome: si chiama la Grande Perversione.
* Teologo e filosofo
* Adista/Segni Nuovi, n. 92 del 10/12/2011
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- Il codice di Don Verzè boss con la tonaca (di Francesco Merlo)3 dicembre 2011, di Federico La Sala
Il codice di Don Verzè boss con la tonaca
di Francesco Merlo
* la Repubblica, 02 dicembre 2011
ORDINA: «Bruciate!» e il picciotto va e appicca il fuoco. Don Luigi Verzé è il primo prete capomafia della storia d’Italia e il silenzio del Vaticano o è rassegnato o è omertoso, decidete voi. Ma per noi siciliani è un sollievo che almeno sia padano questo ’don’ che è due volte ’don’, per il turibolo e per la coppola storta. Attenzione: non un prete mafioso, non un prete al servizio della mafia, che ce ne sono stati tanti, ma un boss che amministra i sacramenti, un don Calogero Vizzini con il crocifisso portato - fateci caso - all’occhiello, lì dove si mettono gli stemmi dei Lyons e del Rotary, e i massoni vi appuntano il ramo d’acacia e i gagà la mitica pansé. Anche don Calogero non pagava mai con le mazzette tipiche della corruzione diciamo così normale, ma con bigliettoni ’impilati’. «Le buste di don Verzé - raccontano i testimoni oculari - erano alte tre o quattro centimetri con biglietti da 500 euro». Don Calogero Vizzini le chiamava appunto ’pile’. E don Verzé non comunica con i pizzini come i più rozzi tra i corleonesi, ma si attiene ai classici che affidavano le sentenze ’allo sguardo e al silenzio ’.
E SE proprio deve farsi intendere don Verzé «manda l’autista - tutte le citazioni sono prese dai verbali - anche all’estero». Trasmette gli ordini «attraverso messaggeri umani». Il pizzino infatti è mafia stravagante, deviazione sbruffona, «niente di scritto e niente al telefono» raccomanda Marlon Brando Vito Corleone: «La polizia registra, poi taglia e cuce le parole per farvi dire quello che vuole».
Il codice di don Verzé non è quello classico del danaro cattolico, neppure nella variante diabolica della simonia. Don Verzé non è uno di quei generosi mostri italiani che hanno messo insieme mammona e il Padreterno, come direbbero gli evangelisti Matteo e Luca, l’ingordigia e la bontà. È invece un don Luciano Liggio per la gloria di Dio. Anche don Luciano bruciava una campagna e poi si presentava al proprietario: «Non rende, vendetemela». Sono gli stessi metodi criminali di don Verzé che aveva deciso di comprare i terreni confinanti con il suo ospedale, ma il proprietario non voleva vendere perché vi aveva costruito campi da tennis, da calcio e da calcetto, spogliatoi e bar... Ebbene nel 2005 e nel 2006 quegli impianti subirono due incendi dolosi. Poi don Verzé convocò Pollari, capo del Sismi e gli disse: «Mandaci la Finanza».
In quel periodo il prete fondatore dell’ospedale San Raffaele pubblicava con Bompiani "Io e Cristo" per spiegare come «la Fede si fa opera». E infatti la Finanza andò, controllòe multò. Ma il proprietario resisteva. E allora «sabotate» ordinò letteralmente don Verzé prendendosi una pausa dalla pia esegesi neotestamentaria (pag. 123 sgg) del famoso «verbum caro factum est», il verbo si è fatto carne. E specificò: «Sabotate, ma state attenti all’asilo e ai cavalli che sono nostri». Il picciotto, che stavoltaè un ingegnere, lo rassicura: «Sarà sabotato il quadro elettrico, quindi i campi non potranno essere illuminati e quando gli "amici" andranno a fargli la proposta di acquisto, lui sarà in ginocchio...». "Gli amici", "in ginocchio"...: il linguaggio cristologico qui diventa cosco- massonico.
Qualche giorno dopo "l’ingegnere", che sembra il personaggio misterioso dei romanzi di Le Carrè, titolo nobile e funzione ignobile, spiega a un don Verzé in partenza: «Quando lei sarà in Brasile ci sarà del fuoco». Come si vede, è un dialogo in argot, allusivo al crimine e alla mafia. E infatti don Verzé indossa i gessati dei mafiosi di una volta, ha la faccia anonima dei veri malacarne, con il cappello che richiama la coppola ma la nega, e forse perché un prete capomafia poteva nascere solo nel Lombardo Veneto, nella terra dei "buli" e dei "bravi", la terra sì del cardinale Borromeo e di Manzoni ma anche della Colonna Infame, delle opere benedette da don Giussani, dell’investimento economico come pietas, del capitalismo dell’Opus dei.
E infatti il titolo del dialogo tra Carlo Maria Martini e don Verzé è ’Siamo tutti nella stessa barca’ (non banca): «Eminenza, posso chiamarla eminente padre?» . E il cardinale: «Chiamami padre Carlo Maria Martini». Don Verzé recita la parte del piccolo uomo davanti al santo: «Amore, verità, libertà di scelta». È un libro tutto compunzione e incenso. Il cardinale lo lodae lo legittima: «Nessuno meglio di lei...», «capisco la sua posizione, don Luigi», «comprendo i suoi sentimenti», «trovo bella questa sua espressione». A quel tempo don Verzé è già chiacchierato ma molto potente, nessuno immagina che organizza attentati e distribuisce mazzette e che i suoi ospedali sono fondati su una corruzione enorme, ma certo i suoi lussi sono già evidenti, le sue spese folli non passano inosservate, i suoi uomini gestiscono misteriose società in mezzo mondo, dal Sudamerica alla Svizzera, hanno conti correnti i dappertutto, e don Verzé ha comprato un aereo e ne prenota un altro e tratta una intera flotta perché non vuole perdere tempo negli aeroporti, e tutti sanno che l’aereo è l’arma principe dei malavitosi e dei guerrieri.
Inoltre don Verzé non parla come un Marcinkus alle prese con la volatilità della finanza ma come un capobastone, un campiere che controlla il territorio: «La Moratti, l’ho convinta io a fare il sindaco», «il cardinale Tettamanzi l’ho fatto venire io a Milano» e Formigoni, che il faccendiere di don Verzé ospita nel suo yacht, è sotto controllo perché «l’abbiamo salvato noi». E Berlusconi «dono di Dio» è «legatissimo alla famiglia», anche se, «ha fatto qualche giro di valzer». Ecco: Dio non s i cura del sesso quando si fanno affari. Perché appunto il verbo si è fatto carne.
Ma non bisogna credere che don Verzé sia un ateo mascherato e che tutto quei suoi libri di dottrina siano solo copertura. È al contrario un devoto in missione mafiosa per conto di Dio perché le vie della provvidenza sono infinite e se c’è la necessità di un attentato, beh, Dio non è certo un moralista.
Don Verzé è come quei preti medievali che, convinti di essere illuminati dalla grazia, commettevano in nome di Dio ogni nefandezza, vivevano a statuto speciale, in sospensione dei peccati, in deroga. Del resto don Verzé non ha sedotto solo il cardinale Martini e tutta la credula Milano cattolica.
Come ogni rispettabile padrino aveva bisogno della copertura laica e dunque l’ha ingaggiata. Massimo Cacciari ed Ernesto Galli della Loggia sono due intelligenze di prima grandezza nella cultura italiana, di quelli che braccano e scovano e mettono alla gogna i vizi del paese, uno come grande vedetta lombarda e l’altro come doge dei mari del sapere, callido Ulisse di Venezia: «mio carissimo amico dell’anima» dice don Verzé. Eppure anche loro sono stati impaniati, sono caduti nella panie dell’imprenditore in Cristo, del Christusunternehmer, avrebbe detto Cacciari se non fosse stato professore e rettore della sua università. Anche il facondo Vendola, quello che scioglie in bocca le parole come caramelle ideologiche, non ha mai avvertito nel comparaggio per l’ospedale a Taranto il sentore dell’imbroglione in Cristo, e gli ha invece fornito la legittimazione della sua pregiata griffe di sinistra.
Vaticano, cultura laica e sinistra comunista: nessun mafioso siciliano era riuscito a superare tutti questi livelli. Con don Verzé siamo ben oltre i colletti bianchi.
E certo la Chiesa se fosse coerente dovrebbe scomunicarlo come scomunicò quei quattro frati di Mazzarino che, unico caso nella storia della mafia, taglieggiavano i contadini, facevano caporalato, decidevano vita e morte, controllavano il territorio: trasformarono il loro convento in un covo di prepotenza. E quando, era il 1960, furono processati, turbarono gli animi degli italiani al punto che gli stessi giudici ebbero soggezione e si misero a somministrare gli ergastoli come fossero sacramenti. Ma la Chiesa - pensate, la Chiesa complice di allora - non ebbe pietà per quei sai sporcati e per quella mania di fra bruciare i terreni, proprio come ha fatto don Verzé, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito santo.
 FRANCESCO MERLO
FRANCESCO MERLO* la Repubblica, 02 dicembre 2011
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- ’NDRANGHETA. Il boss Giulio Lampada ha ricevuto l’onoreficenza vaticana di Cavaliere di San Silvestro.1 dicembre 2011, di Federico La Sala
’NDRANGHETA: BOCCASSINI, RICONOSCIMENTO A BOSS DA VATICANO *
(AGI) - Milano, 1 dic. - Giulio Lampada, uno dei componenti del clan al centro dell’operazione anti ’ndrangheta di ieri, "ha ricevuto un importante e prestigiosa riconoscenza dal Vaticano". Lo ha sottolineato il procuratore aggiunto di Milano Ilda Boccassini durante una conferenza stampa. La famiglia Lampada "ha cominciato a vendere panini ed e’ finita a fatturare miliardi", ha aggiunto. Dalla lettura del provvedimento di custodia cautelare firmata da Giuseppe Gennari e’ emerso come il boss Giulio Lampada ha ricevuto l’onoreficenza vaticana di Cavaliere di San Silvestro.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- ’NDRANGHETA. La maschera caduta (di Roberto Saviano)2 dicembre 2011, di Federico La Sala
La maschera caduta
di Roberto Saviano (la Repubblica, 01.12.2011).
È una rivoluzione per chi si occupa di mafie. La sentenza del Tribunale di Milano del 19 novembre, con le 110 condanne al processo sulla ‘ndrangheta al Nord, e l’inchiesta che ha portato all’arresto di un giudice cambiano la storia del potere - non solo criminale - del nostro Paese.
La sentenza e questa inchiesta sono di carattere epocale perché mostrano una volta per tutte che le mafie comandano anche e soprattutto nell’economia del Nord Italia. Al Sud agiscono nelle modalità più violente, sia militari sia di accaparramento degli appalti. Considerano il Mezzogiorno come un territorio a loro completa disposizione. Il Nord, invece, è il luogo del silenzio facile, degli affari redditizi, dell’inesistente cultura dell’antimafia nelle istituzioni e di una robusta omertà da parte di tutti. Un luogo perfetto.
Il meccanismo di insediamento è capillare. L’imprenditoria del Nord Italia ha un canale di approvvigionamento di capitali attraverso il narcotraffico. L’economia italiana che già da anni subisce una progressiva crisi ha trovato nel territorio dell’illegalità capitali freschi. Soprattutto liquidi. L’insegnamento che emerge dalle carte dell’inchiesta porta a questa certezza: in economia vince chi riesce a usare ogni possibilità per sbaragliare la concorrenza. Chi segue le regole o non esiste o è già uno sconfitto.
Questa indagine che vede coinvolti personaggi delle istituzioni descrive la società civile mafiosa. Non affiliata: non ci sono pungiture, non ci sono battesimi, non ci sono pistole in faccia. I personaggi di questa inchiesta entrano in rapporto con i boss come se fossero normali interlocutori, senza dar troppo peso morale al proprio comportamento. Sembrano non avere neanche piena coscienza di quello che fanno. Forse hanno la sensazione, molto italiana, che così fan tutti, anzi che qualcuno starà facendo sicuramente peggio di loro.
E così scopriamo (se le indagini venissero confermate) un giudice che sarebbe stato corrotto favorendo la carriera della moglie, dirigente della provincia diventata commissario straordinario della Asl di Vibo Valentia e poi a sua volta inquisita per mafia. Scopriamo un altro magistrato, Giancarlo Giusti, di Palmi, che sarebbe stato corrotto con una serie di viaggi e soggiorni a Milano pagati dall’associazione con l’utilizzo di una ventina di escort diverse. La frase di Giusti emersa dalle intercettazioni "io dovevo fare il mafioso, non il giudice" è indice di una connivenza gravissima quanto cialtrona. Neanche il più corrotto dei magistrati si è mai relazionato così direttamente ad un affiliato: anche perché il suo ruolo, la sua professione è la "merce" che vende al mafioso, e non può svilirla. In questo caso invece c’è superficialità, connivenza, complicità assoluta: la corruzione viene percepita come un diritto naturale e acquisito.
Usando un concetto di Guy Debord, definito per comprendere la società dello spettacolo "il vero è un momento del falso" si può affermare che dopo queste inchieste pare evidente che l’illegale sta diventando un momento del legale. In passato l’attività criminale si contraddistingueva per l’efferatezza delle azioni, per i "lavori sporchi", per le operazioni evidentemente e platealmente fuorilegge. Era un mondo a parte. Oggi, e da molto tempo, non più. Sempre di più il coinvolgimento di settori di società con il mondo criminale avviene seguendo un percorso imprenditoriale e politico almeno all’apparenza lineare, in cui i momenti di illegalità sono appunto "momento". Fasi che servono per guadagnare di più, per ottenere favori, per emergere nel proprio campo. E in quanto "fasi" le persone che le vivono si perdonano facilmente, non si sentono nè traditrici né corrotti.
Sembra delirante ma è ciò che emerge dall’inchiesta condotta dal pool del pm Boccassini. Il metodo Boccassini, erede del metodo Falcone, si contraddistingue per la ricerca capillare delle prove e un prudente rigore nella comunicazione delle indagini ai media: nulla parte da sensazioni o solo dalle intercettazioni o dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Ilda Boccassini è stata spesso attaccata, isolata, stressata dal fango e dalle accuse di politicizzazione. Tutto questo è accaduto anche dentro l’ambiente della magistratura stessa. Queste inchieste e queste sentenze dimostrano, invece, che il suo metodo è rigoroso, ed è grazie al suo lavoro che possiamo gettare luce su una realtà del Nord che tanti non vogliono vedere.
Esattamente un anno fa La Lega e l’ex ministro Maroni rimasero scandalizzati quando denunciai in tv che le mafie al Nord interloquivano con i poteri, con tutti i poteri, nessuno escluso. Domandavo cosa facesse la Lega mentre dilagavano, e dilagano, i capitali criminali. Cosa facesse mentre gli imprenditori lombardi messi a dura prova dalla crisi economica entravano in rete con le ‘ndrine. Il quotidiano della famiglia Berlusconi lanciò addirittura una campagna e una raccolta di firme contro di me, reo di "dare del mafioso al Nord".
Io non ho mai detto né pensato che "il Nord è mafioso", naturalmente. Ma bisogna riconoscere che, oltre le fiaccolate contro il soggiorno obbligato e qualche iniziativa simbolica tesa ad aumentare la repressione, gran parte della politica e della cultura del settentrione italiano (con alcune coraggiose eccezioni, per fortuna) è stata silente sul potere delle cosche. E ora vorrei vedere i visi, ascoltare le parole di chi per decenni ha nascosto la testa nella sabbia, ha fatto finta di niente, ha permesso che il Nord diventasse parte fondamentale dell’economia mafiosa. E chiedere: perché?
-
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- Economia ed ecologia. Buon vivere e buon convivere (di Vittorio Cristelli).25 novembre 2011, di Federico La Sala
Buon vivere e buon convivere
di Vittorio Cristelli (vita trentina, 27 novembre 2011)
Non so se vi siete mai resi conto, ma il primo elementare segno che abbiamo tradito visioni fondamentali è nell’uso stesso delle parole. Gli esempi sarebbero molteplici ma mi limito a considerarne due: economia ed ecologia. E’ interessante e salutarmente provocatorio per i credenti in Cristo l’“Agenda latinoamericana” del 2012 che prende a petto il nostro argomento. E’ intitolata “Buen Vivìr” - Buon vivere, e tende a descrivere una buona, umana convivenza che noi potremmo anche chiamare buona cittadinanza e buona comunità.
Di per sé ed etimologicamente economia vuol dire regolamento della casa (dal greco oikos - casa e nomos - legge). Ma se andate a vedere sui vocabolari o attingete anche alla scienza accademica, vi dicono che economia è il complesso di attività che producono beni e accumulano ricchezza, anche quando questo è a scapito o relega all’ultimo posto la “casa dell’uomo”.
Analoga sorte subisce il termine ecologia. Etimologicamente significa “discorso sulla casa” (dal greco oikos - casa e logos - discorso). Ma ordinariamente ecologia vuol dire studio dei rapporti tra specie ed ambiente o territorio. Evidente in ambedue i casi che ad essere trascurato o relegato all’ultimo posto è l’uomo.
Eppure esistono economie che non si propongono l’accumulo di ricchezza o di beni, bensì il servizio all’uomo. Basti pensare all’economia municipale, all’economia familiare e all’economia del volontariato. Non economie queste solo perché introducono anche il servizio alla “casa” cioè all’uomo? E se questa invece fosse la strada per uscire dalla crisi?
Domenico Rosati, pensatore cattolico e già presidente delle Acli nazionali, osserva che finora le misure per uscire dalla crisi sono state indicate solo nella direzione di riattivare i mercati, mentre è necessario un pensiero nuovo che vada nella direzione di un’economia a servizio dell’uomo. “Un passaggio - dice - dal selvatico all’umano”. Il nuovo governo instauratosi in Italia sotto la guida dell’economista Mario Monti e composto di professori ed esperti di economia e finanza fa ben sperare. C’è però chi vorrebbe legarlo a realizzare soltanto il contenuto dell’emendamento collegato alla legge sulla stabilità, e cioè della lettera che il governo italiano ha spedito all’Europa in risposta a quella della Banca Centrale Europea pervenuta l’agosto scorso. Anche qui l’economista Tito Boeri ha rilevato che quella lettera è frutto di “ingegneria finanziaria”. Una gabbia del liberismo la chiama Rosati che mostra di non offrire rimedi, ma piuttosto problemi aggiuntivi. C’è da augurarsi che proprio la competenza dei nuovi ministri li faccia uscire dalla gabbia. Per fare un esempio, io avrei visto benissimo l’inserimento nel governo dell’economista Stefano Zamagni, che da anni teorizza, motiva e sostiene l’“economia civile” e la vorrebbe più ascoltata e incisiva nel contesto sia nazionale che internazionale.
E’ interessante e salutarmente provocatorio per i credenti in Cristo l’“Agenda latinoamericana” del 2012 che prende a petto il nostro argomento. E’ intitolata “Buen Vivìr” - Buon vivere, e tende a descrivere una buona, umana convivenza che noi potremmo anche chiamare buona cittadinanza e buona comunità. Come dice nell’introduzione il vescovo profeta dom Pedro Casaldaliga, l’Agenda vuole rispondere alle domande “che umanità possiamo e vogliamo essere, che vita possiamo e vogliamo vivere e a quale tipo di convivenza tendiamo?”. Queste domande si impongono di fronte alle scandalose diseguaglianze che ci sono anche da noi. Di fronte a quello che Casaldaliga chiama “mal vivere dell’immensa maggioranza delle persone mentre la bella vita insultante e blasfema di una minoranza cerca di starsene sola nella casa comune dell’umanità”.
Un buon vivere dunque che è anche buon convivere, perché non è immaginabile una buona vita che non sia anche una buona umana convivenza. Per i cristiani questo si chiama addirittura costruire il Regno di Dio.
Più laicamente, ma non meno incisivamente, il movimento “Sbilanciamoci” di fronte alla crisiauspica la nascita di una “Comunità europea dei beni comuni”. Una Comunità dotata di poteri sovranazionali per quanto riguarda la terra, il lavoro, l’energia, l’acqua, l’ambiente e la sicurezza. Tutte risposte alla crisi, ma alternative al neoliberismo mercantile che Casaldaliga chiama “mal vivere”.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- Ormai parliamo solo di eco-nomia, regola della casa, regola per vivere, regola per non imbrogliare (di Enrico Peyretti).24 novembre 2011, di Federico La Sala
Ormai parliamo solo di eco-nomia, regola della casa, regola per vivere, regola per non imbrogliare
di Enrico Peyretti *
Da qualche mese dobbiamo tutti studiare economia, anche di malavoglia. L’uomo è un animale etico. Sì, è bipede, scimmia nuda, animale razionale, politico, ha miseria e grandezza, è bestia e angelo, è lavoratore, faber fortunae suae, è ciò che mangia, è ciò che sogna. E in tutto ciò, se non si è preventivamente stordito, si chiede cosa è giusto.
Ha diritto ad avere il necessario per vivere. Ha il dovere di assicurarlo ai suoi simili. Nel dare regole alla vita della unica casa umana (eco-nomia), e all’uso delle cose, si stabiliscono diritti e doveri: non rubare, non prendere ciò che non è dato, non frodare (tanto meno sfruttare fino a far morire). Regola d’oro di tutte le civiltà umane è non fare ciò che non vorresti fosse fatto a te, fai ciò che desideri per te, perciò considera il valore degli altri uguale al tuo.
C’è un raggio di relazioni prossime, dove più facilmente si possiede e si distribuisce senza difficoltà a ciascuno ciò che è necessario e utile, secondo la regola scritta negli Atti degli apostoli e in Karl Marx: «Da ciascuno secondo le sua capacità, a ciascuno secondo i suoi bisogni». Se tutti fanno e danno quanto possono, tutti hanno quanto occorre. È l’economia del dono senza calcolo, vigente in realtà umane concrete, col solo limite delle risorse, del non spreco o dell’inutile.
Poi c’è una rete ampia di relazioni, estesa al popolo di appartenenza, all’umanità intera, sempre più prossima. Occorrono regole generali e astratte. Il diritto è la tutela del terzo sconosciuto. Mentre garantisco la persona che non vedrò mai, io sono garantito nei suoi confronti. Qui occorre più calcolo mentre diminuisce la logica del dono diretto, ma guai se il calcolo eliminasse il dono. Proprio questo è accaduto quasi totalmente nella macroeconomia contemporanea. L’impero del calcolo porta facilmente alla logica della rapina.
«Crisi del debito, crisi del debito!». Distinguiamo bene! Chi ruba per non morire di fame non è un ladro. Ladra è quella società che mette qualcuno in questa necessità. Chi fa debiti per non morire e non ha poi la possibilità di pagarli, non è tenuto a pagarli. La società che non ha provveduto a lui è gravemente debitrice verso di lui. Se si esige il pagamento del debito dal povero, torniamo alla prigione per debiti, al debitore venduto schiavo con la sua prole (l’unica cosa che ha), per compensare il creditore.
Tutt’altra cosa è il debito del consumismo, lo spreco, il comprare troppo senza soldi, per pagare domani o dopodomani. Dovevi pensarci prima. Ma neppure lo stupido va messo alla fame. E peggio fa chi lo corrompe col mito della quantità di nuovi possessi. In una società umana che sia umana, ognuno ha diritto al necessario per vivere. Come una società si organizza per distribuire e bilanciare i poteri, per organizzare l’economia politica e le funzioni sociali, e i mezzi di difesa, e l’informazione, eccetera, altrettanto deve provvedere a che ciascuno possa vivere, anche l’incapace, anche il pigro, anche lo stupido. Non c’è la pena di morte per i pigri e gli incapaci (il nazismo ci stava arrivando), ma li si condanna con l’abbandono: espulsi dalla competizione per primeggiare, mangiano le briciole, come i cagnolini, se le trovano. Altrimenti muoiono sotto i ponti, sulle panchine fredde. Il merito di chi più può e più dà è un bel titolo per lui, ma non può stabilire una gerarchia meritocratica, una graduatoria esclusiva più che inclusiva.
Una società che sia umana, in via di umanizzazione, assicura a tutti i nati un salario vitale. Con le attuali immense spese militari (inutili e pericolose), con gli sprechi dei privilegiati, ogni società mediamente sviluppata può assicurare un salario vitale a tutti. Certo, tolta la necessità personale del lavoro, si creerebbero altri problemi: non si produrrebbe più il necessario? Il padre ozio genererebbe tutti gli altri vizi (che tuttavia oggi nascono e prosperano anche dal padre super-lavoro accanito e frenetico)? Ma se il lavoro fosse espressione libera, creativa, soddisfacente, invece che necessità e condanna, l’umanità crescerebbe in umanità. Quei problemi si potrebbero gestire, e sarebbero meno feroci dei problemi attuali di una società che frusta i cittadini come cavalli da corsa, o li usa come macchine a produrre tanti profitti per pochi.
L’obiettivo di una società umanizzata è lo scambio gratuito: ti do il pane e le rose che mi chiedi non per averne un profitto, ma per rispondere al tuo bisogno e desiderio. E così vicendevolmente. Se questa un giorno sarà l’etica e la cultura diffusa, ci saranno furberie e violazioni, ma lo sfruttamento attuale del bisogno altrui sarà l’eccezione e non la regola. Oggi ci sono omicidi, ma non la regola degli omicidi, come c’è nel bellum omnium contra omnes.
Quello è un orizzonte, e non può ancora essere il programma immediato o prossimo: non ci sono le condizioni spirituali, culturali, materiali. Ma ogni visione dell’orizzonte, dei valori, del polo della bussola, orienta e qualifica il più piccolo passo immediato. Si passa dove si può, ma sapendo dove si va. Ecco: dove intendiamo andare? Ricadere nel mito falso della crescita quantitativa dei prodotti, ora che il pianeta è al limite dei prelievi possibili, e quella crescita è definitivamente impossibile? Vogliamo sviluppare ciò che abbiamo e siamo, cioè la custodia e il piacere della natura, la distribuzione dei frutti e dei prodotti, per ridurre disparità, conflitti, vittime? «Vivere semplicemente perché ognuno possa semplicemente vivere», diceva Gandhi. Vivere e lasciar vivere è più piacevole che arraffare comunque, per paura di morire.
La crisi generata dal “mal-di-troppo” (proprio come è il cancro), del generale modello consumistico impazzito e della rapina indiscriminata da parte di alcuni, può essere una opportunità nella storia umana. La terra grida il suo limite e le sue ferite. L’accumulo dei possessi, che consegna alcuni nelle mani di altri, che degrada l’umanità dei privilegiati, non saziati e non sviluppati, che lascia nella fame alcuni miliardi di umani, può essere l’occasione per un radicale ripensamento.
Naturalmente, chi ha cultura e capacità di concretezza, cercherà gli artifici giusti ed efficaci per riparare e modificare la macchina economica, locale e mondiale, se sarà possibile mandarla avanti. Ma la macchina non ha anima e scopi, che sono quelli di chi la guida, e dei popoli che sperano di viaggiare con essa. Lavorare ad una cultura umanistica, dunque etica, dell’economia, e progettare un sistema più umano della economia politica classica, ha valore e necessità uguale al lavoro dei tecnici bravi inventori di soluzioni pratiche. È l’utopia (la realtà che non-ha-ancora-luogo) che promuove il cammino sul terreno, perché il cammino da solo (muoversi per muoversi, fare per fare) non sa se va all’altopiano o al burrone. Sale una protesta indignata, in tutto il mondo. Sembra che abbia vasto consenso (dal quale la politica democratica sempre dipende, nel bene e nel male).
Le chiese cristiane, le religioni, l’antropologia filosofica, hanno molto da dire. Un po’ lo fanno, con contraddizioni. Possono farlo predicando bene, ma anche operando, col deporre privilegi, col costruire azioni e istituzioni con fine di dono solidale e non di cattura di profitti. «Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori», non riguarda solo i peccati personali e non è solo invocazione per la salvezza eterna, ma norma saggia (come il giubileo ebraico, l’elemosina islamica, la compassione buddhista, il dovere disinteressato nell’induismo) per riequilibrare sempre le nostre cattive o inevitabili diseguaglianze umilianti e offensive. Vale anche in economia la verità che «senza perdono non c’è futuro» (Desmond Tutu).
Chi può pensare davvero, a mente sgombra, che rende solo il prendere e non il dare, il mietere senza di più seminare? Se l’economia non è etica, cioè umana, a favore della vita umana di tutti gli umani, allora, mancando la regola che la tiene in piedi e in funzione, la comune casa umana crolla sugli abitanti. Vogliamo una economia di appropriazione, o di condivisione? Né l’illusione del buon selvaggio, né il sofisma machiavellico dell’uomo “tristo” per natura dicono l’intero vero sulla nostra condizione: non è vero che siamo solo avidi; non è vero che siamo solo solidali. Una regola di vita giusta traccia il cammino tra questi poli, favorendo ciò che unisce, cioè il vivere, su ciò che divide, cioè il farsi guerra.
* http://domani.arcoiris.tv/ormai-parliamo-solo-di-eco-nomia/ - 24-11-2011
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- Per riprendere a crescere serve lo spirito dello sviluppo (di Mauro Magatti).23 novembre 2011, di Federico La Sala
Per riprendere a crescere serve lo spirito dello sviluppo
di Mauro Magatti (Avvenire, 23 novembre 2011)
L a storia è sempre sorprendente. Lunghe e tormentate fasi gestatorie generano poi cambiamenti improvvisi. Spesso irreversibili. Così accade, per l’ennesima volta, in Italia in questi giorni, dove l’intero sistema politico, impantanato nelle proprie alchimie, si è ritrovato in qualche modo ’commissariato’ nel giro di 48 ore. Se saprà uscire dal pantano, la politica dimostrerà che non è così. Ma per intanto e soprattutto è il nuovo governo, composto da ’tecnici’, a tenere la scena. Un governo al quale si chiedono misure capaci di portarci fuori dall’occhio del ciclone. Cioè al riparo dalla speculazione, in modo che il vero valore del Paese - ben superiore a quello che ’i mercati’ hanno decretato in queste settimane - torni in auge. E tuttavia, non ci può illudere che la questione finisca qui.
Il Paese, infatti, ha bisogno di ristabilire non solo la propria economia, ma anche le condizioni stesse della propria convivenza, sociale e politica. Si potrebbe dire così: in quella che è stata chiamata Seconda Repubblica, il sistema politico nel suo insieme è stato il mediatore di un ’equilibrio di marginalità’: raggiunto il benessere e lo status di potenza economica, è come se l’Italia avesse smesso di pensare al suo futuro. Come se avesse smesso di interrogarsi sul proprio ruolo nel mondo e nella storia. Il debito pubblico è stato il galleggiante di tale ’equilibrio di marginalità’.
L’insostenibilità di tale modello ha cominciato ad affiorate con la nascita dell’euro. Come sappiamo, sono dieci anni che il Paese ha smesso di crescere. Il che è come dire che l’Italia non è stata capace di fare quel salto che le nuove condizioni richiedevano. E si è invece accartocciata su se stessa, facendo esplodere la conflittualità verbale, le chiusure corporative, le paure isteriche.
Chiudendo, così, la porta del futuro alle nuove generazioni. A poco a poco, la barca ha cominciato a imbarcare acqua. E oggi, sotto l’impulso delle autorità monetarie europee, siamo costretti a intervenire sulle falle che si sono aperte. L’urgenza dell’intervento è innegabile.
Ma mentre questo intervento si svolgerà è ugualmente necessario lavorare per ritracciare la rotta della nave che verrà riparata. E su questo punto occorre essere decisi: al di là degli interventi necessari, l’Italia potrà uscire dall’equilibrio di marginalità in cui è caduta solo a condizione di ritrovare uno spirito. Contrariamente a quanto pensa il neo-materialismo contemporaneo, lo sviluppo o è spirituale o non è.
Per chiarire di che cosa si tratta, vale la pena ricordare la radice del termine ’spirito’: spas-spus, che significa soffiare, esalare, alitare. In italiano - appunto - spirare. Il vento, infatti, spira. Per questo, lo spirito è strettamente associato alla parola speranza, che viene anch’essa dalla medesima radice nel senso di a-spirare e di spingere verso. Dunque, la speranza - come atto spirituale - indica la capacità dell’essere umano di desiderare qualche cosa di buono, di bello, di vero. Qualche cosa di qualitativamente differente dall’esistente. La speranza è esattamente l’eccedenza che troppo manca all’Italia di oggi, che per questo rischia di non avere futuro. La crisi italiana viene da lontano.
L’inadeguatezza ’tecnica’, che questo governo è chiamato ad affrontare, deriva prima di tutto e fondamentalmente da uno smarrimento spirituale. L’Italia ha oggi urgentemente bisogno del farmaco tecnico. Ma nessuno sviluppo potrà darsi se non tornerà a soffiare uno spirito. Cioè una speranza, un’energia, un desiderio.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!! E INSEGNIAMO AD INSEGNARE FILOSOFIA COME RIMOZIONE DELLA FACOLTA’ DI GIUDIZIO.23 novembre 2011, di Federico La Sala
RIPENSARE L’ITALIA
RIPENSARE L’EUROPA.
PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO.
ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!
- FILOSOFIA, ANTROPOLOGIA E POLITICA. IL PENSIERO DELLA COSTITUZIONE E LA COSTITUZIONE DEL PENSIERO ....
 STATO DI MINORITA’ E FILOSOFIA COME RIMOZIONE DELLA FACOLTA’ DI GIUDIZIO. Una ’lezione’ di un Enrico Berti, che non ha ancora il coraggio di dire ai nostri giovani che sono cittadini sovrani. Una sua riflessione
STATO DI MINORITA’ E FILOSOFIA COME RIMOZIONE DELLA FACOLTA’ DI GIUDIZIO. Una ’lezione’ di un Enrico Berti, che non ha ancora il coraggio di dire ai nostri giovani che sono cittadini sovrani. Una sua riflessione
(Federico La Sala).
- FILOSOFIA, ANTROPOLOGIA E POLITICA. IL PENSIERO DELLA COSTITUZIONE E LA COSTITUZIONE DEL PENSIERO ....
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- VATICANO: BERTONE SCONFESSA LA NOTA DI GIUSTIZIA E PACE SULLA CRISI. E "BLINDA" LA CURIA (di Valerio Gigante - Adista).22 novembre 2011
BERTONE SCONFESSA LA NOTA DI GIUSTIZIA E PACE SULLA CRISI. E "BLINDA" LA CURIA
di Agenzia Adista n. 86 - 26 Novembre 2011 *
36403. CITTÀ DEL VATICANO-ADISTA. Un’ulteriore accelerazione del processo di accentramento del potere avviato negli ultimi anni. Un sistema per riportare sotto controllo ogni eventuale spinta centrifuga da parte dei dicasteri vaticani. Ma anche un sistema per evitare gaffes ed imbarazzi, che negli ultimi anni non sono mancati Oltretevere, per disorganizzazione, mancanza di comunicazione e forse anche per qualche volontaria “omessa vigilanza” da parte di qualche ecclesiastico o responsabile di Curia che intendeva mettere in cattiva luce l’operato del Segretario di Stato.
Una di queste ragioni, o tutte insieme, sono probabilmente all’origine della decisione del Segretario di Stato vaticano, il card. Tarcisio Bertone, di non permettere più a nessun ufficio della Curia romana di pubblicare o diffondere documenti prima che essi abbiano ricevuto il preventivo controllo e autorizzazione da parte della Segreteria di Stato.
La decisione, resa nota da Sandro Magister (chiesa.espressonline.it, 10/11), è arrivata alla fine di un piccolo summit convocato in segreteria di Stato nei giorni scorsi. Casus belli, il documento sulla crisi finanziaria mondiale di cui il segretario di Stato ha lamentato di non essere stato informato fino all’ultimo momento.
Il 24 ottobre scorso, infatti, in Vaticano, nell’Aula Giovanni Paolo II della Sala Stampa della Santa Sede, si era tenuta una conferenza stampa di presentazione di una Nota del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace intitolata: “Per una riforma del sistema finanziario internazionale nella prospettiva di un’autorità pubblica a competenza universale” (v. Adista n. 82/11). Nel documento, che voleva costituire un contributo di idee e proposte per il vertice del G20 di Cannes, che si sarebbe svolto il successivo 3 e 4 novembre, il Pontificio Consiglio chiede l’istituzione di un’autorità pubblica mondiale che svolga le funzioni di una sorta di “Banca Centrale Mondiale” per regolare «il flusso e il sistema degli scambi monetari»; «la tassazione delle transazioni finanziarie, mediante aliquote eque»; la ricapitalizzare delle banche «anche con fondi pubblici condizionando il sostegno a comportamenti “virtuosi” e finalizzati a sviluppare l’economia reale». Inoltre, il documento individua le cause della crisi in «un liberismo economico senza regole e senza controlli», e in tre ideologie che hanno «un effetto devastante»: l’utilitarismo, l’individualismo e la tecnocrazia.
Insomma, a leggere la Nota, poteva apparire che il Vaticano chiedesse misure di tassazione delle transazioni finanziarie sul modello della “Tobin Tax”, che è stata evocata anche durante il G20 (ne hanno fatto cenno Obama e Sarkozy), ma senza alcun seguito. Come nessun seguito hanno avuto le altre proposte contenute nel documento, sostanzialmente smentite dall’esito del vertice di Cannes. Una circostanza, unita al sostanziale approccio “progressista” del documento, che deve aver indotto Bertone a correre ai ripari. Attraverso la decisione di filtrare più attentamente i documenti in “uscita” dalle Congregazioni, dai dicasteri e dagli uffici di Curia. Ma anche attraverso un articolo che Ettore Gotti Tedeschi (presidente dello Ior, ed economista cattolico di destra molto vicino al Segretario di Stato) ha firmato sull’Osservatore Romano del 7/11, dando della crisi, e della sua possibile soluzione, una interpretazione assai diversa dal documento del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, che non viene peraltro mai citato.
Ma dietro la decisione di Bertone potrebbe esserci anche l’esigenza di smentire un documento in cui si critica esplicitamente l’approccio tecnocratico delle istituzioni monetarie e degli organismi internazionali, che poteva suonare come una implicita critica a Mario Monti ed al nuovo esecutivo da lui varato, in cui la Chiesa cattolica è riuscita a inserire molti suoi uomini in ruoli di primissimo piano (v. notizie su questo stesso numero).
Del resto, appare difficile immaginare che in Segreteria di Stato non sapessero nulla della genesi della Nota del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace. Segretario di quel dicastero è infatti mons. Mario Toso, salesiano come Bertone, che lo ha prima portato in Vaticano e poi consacrato vescovo. È Toso ad aver organizzato ed animato, per conto di Bertone, una serie di incontri, durante l’estate, per la nascita di una nuova aggregazione di ispirazione cristiana. Sempre Toso, tra gli uomini di fiducia collocati da Bertone nei posti chiave della Curia e degli organismi di controllo della Santa Sede (v. Adista n. 65/11). Difficile quindi che egli non abbia avuto modo di informare Bertone della stesura di un documento così importante. La smentita ex post del documento, è invece funzionale a smarcare la Segreteria di Stato da contenuti che stridono con gli scenari che si stanno delineando nelle ultime settimane. E costituisce un ottimo pretesto per un ulteriore giro di vite sull’autonomia dei singoli dicasteri e uffici di Curia. Accelerando un processo di centralizzazione in atto da mesi. (valerio gigante)
 Articolo tratto da
Articolo tratto da
 ADISTA
ADISTA
 La redazione di ADISTA si trova in via Acciaioli n.7 - 00186 Roma Telefono
La redazione di ADISTA si trova in via Acciaioli n.7 - 00186 Roma Telefono
 +39 06 686.86.92
+39 06 686.86.92
 +39 06 688.019.24
+39 06 688.019.24
 Fax +39 06 686.58.98
Fax +39 06 686.58.98
 E-mail info@adista.it
E-mail info@adista.it
 Sito www.adista.it
Sito www.adista.it* Il Dialogo, Martedì 22 Novembre 2011
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- La scelta di Vittorio Bachelet22 novembre 2011, di Federico La Sala
La scelta di Vittorio Bachelet
di Angelo Paoluzi (Europa, 22 novembre 2011)
Un discorso del cardinale Martini del 1995 contestava il ruolo di un moderatismo cattolico come stampella di regime e si rifaceva alla «vocazione ad una società avanzata» della dottrina sociale della Chiesa; una «socialità di tipo relazionale, che punta sui diritti delle persone, delle comunità, a cominciare dalla famiglia, e dei gruppi sociali e infine dello Stato di tutti...».
Non riguarda direttamente il protagonista della monografia dedicata da Angelo Bertani a Vittorio Bachelet, ma si iscrive in un contesto nel quale attorno al personaggio si snoda una riflessione più generale. A partire dal titolo: Bachelet. Testimoniare da cristiani nella vita e nella politica (La Scuola, Brescia 2011, 156 pagine, 9 euro). Il curatore - che già in altre occasioni si è interessato di Bachelet - aggiunge oggi alcune valutazioni su un momento storico, come l’attuale.
«Oggi - scrive Bertani - i cattolici si chiedono come fare ad essere più presenti nella società. L’interrogativo è complesso e persino ambiguo, ma una risposta c’è: fare come Bachelet. Educare, aiutare a crescere tanti cittadini credenti, laici cristiani come Vittorio Bachelet. Non è facile, ma forse non ci proviamo neppure perché troppo alta e disinteressata appare la loro testimonianza, troppo pericolosa la loro libertà, poco redditizia la loro militanza».
Ma nelle cinquanta pagine dell’introduzione, un terzo del volumetto, su alcuni testi illuminanti del «messaggio educativo» di Bachelet (esemplare nella sua «antropologia della mitezza») c’è la chiave di lettura di qualcuno che «ci ha aiutato a uscire dal cristianesimo di cristianità: quello che si affidava al conformismo e all’intimidazione, all’abitudine, alle strutture, alle leggi. E a camminare verso un cristianesimo della coscienza e dell’amore, di comunione e di carità, dell’evangelo e del Concilio».
Troviamo ancora, nell’introduzione, una ricchezza di riferimenti: ecco che spuntano Giuseppe Dossetti, Aldo Moro, padre Adolfo Bachelet, il gesuita fratello maggiore di Vittorio: non per il gusto della citazione appropriata ma con il criterio della perennità che quelle parole attribuiscono ai valori.
E se è un raffinato riferimento quello al testo di una lettera inviata dal cardinale Ercole Consalvi nell’anno di grazia 1800 all’allora ambasciatore del Vaticano (non si chiamavano ancora nunzi) a Parigi, monsignor Annibale della Genga - il futuro Leone XII -, e nella quale era avveniristicamente contenuta l’esortazione a rendersi conto che la rivoluzione francese c’era stata, è meritorio, come fa Bertani, ricordare, civicamente parlando, la trama di riconciliazione tessuta da Adolfo Bachelet con alcuni protagonisti delle sanguinose vicende degli anni settanta.
Il «nucleo incandescente del linguaggio evangelico » viene evocato nel rapporto Dossetti-Bachelet, anche se con esiti diversi. Bertani torna inoltre più volte sulla esemplare testimonianza espressa dalla famiglia di Vittorio Bachelet; e riporta alcuni passi di una intervista nella quale, a vent’anni dalla morte, il figlio Giovanni rifletteva sul significato di quel sacrificio che, ricorda, è stata « l’occasione, pur tristissima, di mettere alla prova quello che diceva papa Giovanni: anche se qualcuno dice di essere nostro nemico, e si comporta come tale, noi non ci sentiamo nemici di nessuno».
Si rammenteranno le parole di Giovanni che, il giorno delle esequie del padre, inducevano al perdono e nello stesso tempo alla giustizia in difesa della democrazia: «Vogliamo pregare per quelli che hanno colpito il mio papà perché, senza nulla togliere alla giustizia che deve trionfare, nelle nostre bocche ci sia sempre il perdono e mai la vendetta, sempre la vita e mai la richiesta della morte degli altri».
Con questo spirito si potranno leggere gli otto interventi contenuti nella seconda parte del libro, che disegnano un percorso culturale e spirituale. Del quale è stato un tornante la «scelta religiosa» impressa all’Azione cattolica in anni di grande tensione: «Scelta religiosa - affermava Bachelet che ne era stato il gestore - è anche, allora capacità di aiutare i cristiani a vivere la loro vita di fede in una concreta situazione storica, ad essere “anima del mondo”, cioè fermento, seme positivo per la salvezza ultima, ma anche servizio di carità non solo nei rapporti personali, ma nella costruzione di una città comune in cui si siano meno poveri, meno oppressi, meno gente che ha fame».
Angelo Paoluzi
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- ILLUSIONI E MANOVRE NEOTEMPORALISTE. Certamente Cei e Vaticano sono decisi a dettare a Monti la linea (di Marco Politi - Cattolici, ma un po’ più laici)22 novembre 2011, di Federico La Sala
Cattolici, ma un po’ più laici
di Marco Politi (il Fatto Quotidiano, 21 novembre 2011)
Dalla Spagna a Palazzo Chigi spira un vento di riscossa cattolica. A Madrid i democristiani spagnoli del Partito popolare riconquistano il potere. In Italia una nutrita pattuglia cattolica è approdata nei giorni scorsi al governo con grande visibilità. A prima vista sembra un effetto del revival della religione, manifestatosi già sul finire del Novecento durante il lungo pontificato wojtyliano, e non manca Oltretevere chi assapori l’illusione di un maggiore spazio di manovra neotemporalista.
Certamente Cei e Vaticano sono decisi a dettare a Monti la linea di maggiori finanziamenti alle scuole cattoliche e dell’adeguamento della legislazione in tema di testamento biologico, fecondazione e pillole contraccettive e abortive alla dottrina dei valori non negoziabili. Così come è avvenuto durante l’era Berlusconi. Pretese e sogni si mescolano. Il sentimento popolare va in realtà da un’altra parte. Già negli anni scorsi, analizzando i flussi elettorali in Italia, si è appurato concretamente che il cittadino compie la sua scelta nelle urne principalmente in base ai temi, che toccano più da vicino la sua esistenza quotidiana: il lavoro, la crisi economica, il welfare. I cosiddetti temi eticamente sensibili - sistematicamente agitati dalle gerarchie ecclesiastiche e dalle cerchie politiche più opportuniste - sono in fondo alla scala delle urgenze. Perché i fedeli cattolici qui e altrove sono convinti che certi problemi vadano affrontati e risolti nell’intimo della propria coscienza.
IN SPAGNA, dunque, il Partito popolare ha in cima all’agenda il deficit pubblico, lo spread a 470 e una disoccupazione giovanile al 20 per cento. Al di là di questo va, tuttavia, notato che già negli anni passati il partito di Mariano Rajoy ha mostrato spesso disagio per le furibonde campagne antigovernative scatenate dalla parte più conservatrice della gerarchia ecclesiastica in nome della “vita” e della tradizione cattolica. Meno che mai Rajoy, che negli anni scorsi si era già meritato i rimbrotti di Giuliano Ferrara per non essere abbastanza ratzingeriano, ha voluto portare in campagna elettorale temi come l’aborto e l’omosessualità.
È probabile che il nuovo governo interverrà contro alcune forzature di Zapatero come la concessione dell’aborto alle minori senza informare i genitori o l’indicazione di parlare di coniuge A e coniuge B invece che usare i termini “marito” e “moglie”. Molti ritengono certo anche un cambiamento della legge sui matrimoni omosessuali. Ma nel complesso l’impianto laico della legislazione è destinato a rimanere perché questo vuole la società spagnola nel suo complesso. Il governo democristiano non toccherà il diritto all’aborto e le coppie omosessuali potranno naturalmente usufruire di una normativa sulle unioni civili. La Madrid “bianca” sarà quindi più avanzata di Roma.
Anche in Italia la situazione è molto più fluida di quanto possa apparire a prima vista. Quasi nessuno ha notato che, intervenendo giorni fa al convegno del movimento “Scienza e Vita” su bioetica e politica, il segretario del Pd Bersani - nonostante la presenza del cardinale Bagnasco, che aveva ripresentato le tavole dei principi non negoziabili - ha indicato una linea diversa: basata sul dovere delle democrazie di negoziare le “soluzioni” dei problemi, lasciando ad ognuno di credere nei principi generali cui sente di ispirarsi. Bersani ha anche respinto fermamente l’idea che essere non credente o diversamente credente significhi mancare di etica. “Ci sono persone che sono morte per un’etica (non trascendente), non dimentichiamolo”, ha sottolineato con orgoglio. Sul piano politico immediato il segretario del Pd ha chiesto di cambiare l’attuale legge sulle “Dichiarazioni anticipate di trattamento” e praticamente di fare una legge diversa sul testamento biologico.
LA COSA interessante è che, parlando subito dopo di lui e dopo il segretario Pdl Alfano (steso sulla linea del Vaticano), il leader dell’Udc Casini - pur dando per scontato l’approvazione della legge sul fine vita - ha bollato di “miopia totale” quanti usano la bioetica “per dividere”. Rispetto alla linea degli atei devoti o rinati alla fede, trionfante nel regime berlusconiano e guardata con compiacimento dalla gerarchia ecclesiastica, Casini ha lanciato un allarme: “Stiamo molto attenti al legislatore che forzando si espone al cambiamento in ogni legislatura”.
Casini guarda lontano. Il “partito nazionale” ispirato al popolarismo europeo, che ha in mente, non può ridursi a essere mera cinghia di trasmissione dell’ideologia dei valori non negoziabili. Non c’è alcun dubbio, infatti, sulla constatazione (confermata da ricerche svolte a più riprese) che in caso di referendum sul testamento biologico i cittadini messi dinanzi al quesito secco - “volete la norma che esautora il paziente e affida ogni potere al medico o volete che siano rispettate le decisioni del paziente e dei suoi familiari per evitare l’accanimento di trattamenti medici non voluti”? - sceglierebbero la seconda. In altre parole la dottrina dei valori non negoziabili, imposta in politica, si rivela una gabbia non praticabile per le società contemporanee. Tocca ai cattolici a Palazzo Chigi praticare autonomia per soluzioni adatte alla realtà sociale italiana. Utile sarebbe stato che nella formazione del governo si fosse tenuto conto anche di un’area di pensiero laica rappresentata, esemplificando, da personalità come Rodotà e Zagrebelsky. È un peccato non averlo fatto.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- La Chiesa nel dopo Berlusconi (di Massimo Faggioli)18 novembre 2011, di Federico La Sala
La Chiesa nel dopo Berlusconi
di Massimo Faggioli
 “The Tablet” del 19 novembre 2011 (traduzione: www.finesettimana.org)
“The Tablet” del 19 novembre 2011 (traduzione: www.finesettimana.org)La Chiesa in Italia è arrivata alla fine di un periodo critico delle sue relazioni con i politici italiani con le dimissioni di colui che è stato per tre volte primo ministro, Silvio Berlusconi. Quando il magnate dei media andò al potere per la prima volta, ereditò la maggior parte dei voti e degli elettori della Democrazia Cristiana, dissoltasi all’inizio degli anni ’90, presentando se stesso come l’erede del suo fondatore, Alcide De Gasperi, che fu Primo Ministro di otto successive coalizioni di governo tra il 1945 e il 1953.
Ma Berlusconi, che è stato premier dal 1994 al 1995, poi di nuovo dal 2001 al 2006, ed infine dal 2008 fino alle dimissioni della scorsa settimana, ha offerto alla Chiesa cattolica qualcosa di più del nostalgico appello all’anticomunismo, promettendo di usare il suo potere di veto contro provvedimenti riguardanti “valori non negoziabili” come quelli relativi alle coppie di fatto, etero sessuali ed omosessuali, provvedimenti relativi al fine vita riguardanti le “dichiarazioni anticipate di trattamento” e il suicidio assistito.
La Chiesa cattolica ed il Vaticano trovarono impossibile resistere a questa offerta durante il lungo incarico del Cardinale Camillo Ruini (1986-2007) come segretario generale e poi come presidente della Conferenza episcopale italiana. Il cattolicesimo italiano divenne un prigioniero volontario di un’imbarazzante alleanza con Berlusconi fino all’inizio del 2011, finché i vescovi sotto la guida del Cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova, diedero voce alle loro preoccupazioni nei confronti dei comportamenti del Primo ministro, in particolare dei suoi incontri con ragazze più giovani della più giovane delle sue figlie.
Berlusconi creò il suo partito, Forza Italia, in poche settimane prima delle elezioni del 1994 grazie alle ingenti disponibilità economiche. Riuscì nel miracolo di unire il volto rassicurante del Partito popolare europeo al suo più importante alleato, la Lega Nord, con il suo progetto xenofobo per il futuro dell’Italia.
Berlusconi si mostrò capace di mantenere le sue vecchie abitudini di donnaiolo e di uomo d’affari volgare e senza scrupoli, con la sua cinica alleanza al cattolicesimo, come entità puramente politica. La mancanza di coerenza tra il suo affermato cattolicesimo e la sua ideologia materialistica - “berlusconismo” - divenne un problema per la grande maggioranza dei cattolici italiani solo negli ultimi due anni del suo “premierato”.
Per lungo tempo i cosiddetti atei devoti - un gruppo di intellettuali conservatori con forti legami con il Vaticano - furono i maggiori difensori delle credenziali cattoliche di Berlusconi, presentandolo come un uomo capace di difendere l’Italia e la Chiesa dalla secolarizzazione e l’Europa dall’islam. Essi comprendono l’ex comunista ed ora direttore del quotidiano Il Foglio, Giuliano Ferrara, e l’ex presidente del Senato, il filosofo Marcello Pera, coautore con il cardinal Joseph Ratzinger nel 2004 di Senza radici, sul futuro della cristianità in Europa.
Il volto cattolico del dominio di Berlusconi sull’Italia era quello dei membri di “Comunione e Liberazione” che detenevano posizioni chiave a livello nazionale e locale del movimento laicale ecclesiale. La stessa Curia romana di Benedetto XVI si dimostrò più permeabile di quella di Giovanni Paolo II, specialmente grazie a certi monsignori come Rino Fisichella, per molti anni cappellano al parlamento italiano ed ora arcivescovo e presidente del recentemente creato Pontificio Consiglio per la nuova evangelizzazione.
Inoltre, Berlusconi potè sfruttare a proprio favore la situazione nella Chiesa in Italia e nel Vaticano fin dall’elezione di Benedetto XVI. Funzionari curiali politicamente esperti furono sostituiti dagli uomini del nuovo papa, uomini che erano meno esperti ed interessati di politica in generale e della ingarbugliata politica italiana in particolare. Ad esempio, benché il nuovo segretario di stato di Benedetto XVI, cardinale Tarcisio Bertone, reclamasse l’agenda politica italiana come affare della Curia, non mostrò mai l’abilità politica necessaria per trattare con Berlusconi, mentre la Conferenza episcopale italiana non accettò mai i diktat del segretario di stato.
Berlusconi capitalizzò su queste divisioni interne alla Chiesa e ancor di più sul disagio dei vescovi italiani e della curia romana nel trattare con un “cattolico del Vaticano II” come Romano Prodi (Primo ministro dal 1996 al 1998 e di nuovo dal 2006 al 2008), l’ex leader della coalizione di contro-sinistra ed unico candidato in grado di battere Berlusconi alle elezioni.
La Chiesa e i vescovi italiani temevano Prodi, che si autodefiniva “cattolico adulto” e preferivano trattare con Berlusconi. Benché fosse notoriamente corrotto, si inginocchiava di fronte alle richieste della chiesa in termini di “valori non negoziabili” e sovvenzioni di stato alle scuole cattoliche. D’altro canto, la coalizione di centro sinistra non si mostrò mai capace di entrare in un reale dialogo con il cattolicesimo italiano e tentò di risolvere la “questione cattolica” unicamente dando a politici cattolici una sovrarappresentazione nel Partito Democratico fondato nel 2007.
La reputazione di Berlusconi tra i cattolici cominciò a soffrire solo grazie al disgusto dei fedeli delle parrocchie, e i vescovi sembrarono seguire l’umore di cattolici laici, preti e suore. L’assordante silenzio delle associazioni cattoliche e dei movimenti di laici durante il governo Berlusconi tra il 1994 e il 2011 sta ancora aspettando una spiegazione. La parte che il cattolicesimo svolgerà nel futuro dell’Italia è uno dei maggiori problemi che deve affrontare la Chiesa, che sembra sentire molto la mancanza del “bel tempo passato” della Democrazia Cristiana.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- E IL GOVERNO MONTI. I cattolici di Todi vanno al governo (di Marco Politi - Da Todi a Palazzo Chigi) - Il Vaticano benedice. I «professori cattolici» nella squadra del governo Monti rassicurano la Chiesa (di Roberto Monteforte)..17 novembre 2011, di Federico La Sala
Da Todi a Palazzo Chigi
di Marco Politi (il Fatto, 17.11.2011)
I cattolici di Todi vanno al governo. Prima ancora che la carovana umbra riesca a darsi un’organizzazione, l’area bianca assume il volto della consistente pattuglia di personalità cattoliche che faranno parte del Consiglio dei ministri guidato dal cattolico Monti. È una squadra di tutto rispetto: Andrea Riccardi, leader della Comunità di Sant’Egidio alla Cooperazione internazionale, il banchiere Corrado Passera allo Sviluppo, Lorenzo Ornaghi rettore dell’Università Cattolica ai Beni culturali, Renato Balduzzi già presidente dei Laureati cattolici (Meic) alla Salute. Al di là delle differenti caratteristiche, la loro presenza testimonia l’avvento di una cultura politica radicalmente diversa da quella del governo di centro-destra. Al posto di una compagnia di ventura ispirata a faziosità, aggressività, ideologismo e nutrita di un’incosciente disattenzione al Paese reale, salgono sulla scena personaggi riunitisi a Todi sulla base del “Manifesto per la buona politica e il bene comune”.
“SIAMO ORGOGLIOSI di essere italiani, portatori di valori, di cultura, di tradizioni, apprezzati nel mondo e consapevoli di avere un destino comune... (impegnati ad) avviare una nuova stagione di sviluppo e per dare risposte positive alle giovani generazioni, ai territori meno sviluppati, alle persone bisognose”. Così recita il manifesto, su questo si misureranno e saranno misurati.
Il solo fatto di vedere persone che non alzeranno il dito medio (marchio Bossi), non manderanno ‘affanculo oppositori (Romano), non parleranno di élite di merda (Brunetta) o elettori coglioni (Berlusconi) è antropologicamente un sollievo. Il loro stesso modo di esprimersi rappresenta un ritorno a un linguaggio basato sul pensiero e non ispirato a spot pubblici-tari o furbizie da comizio.
La foto di Monti e dei suoi boys di parte bianca (al di là delle specifiche esperienze di ognuno) rappresenta plasticamente l’immagine del contributo di risorse cattoliche che si è sempre manifestato nei tornanti decisivi delle vicende italiane. Persino durante il Risorgimento, nel quale - nonostante la scatenata opposizione papalina e clericale - il cattolicesimo liberale è stato ben presente. Sul piano della cronaca politica più recente, il loro arrivo marca la sconfitta definitiva del tentativo di Berlusconi di costruire il suo governo del 2008 rifiutando superbamente il rapporto con forze cattoliche autonome. Tutti si accorsero, quando fu presentato l’ultimo governo di centrodestra, che i cattolici erano stati esclusi dai ministeri che contano. (Letta, uomo vaticano, è un caso a parte). La ricreazione del partito padronale, ateo devoto e intrinsecamente cinico, ora è finita. La benedizione di Ruini e di Bertone - è bene ricordarlo - ha portato al disastro attuale.
I conciliaboli antecedenti alla formazione del governo hanno lasciato tuttavia uno strascico avvelenato. Il veto prepotente pronunciato da parte della Chiesa nei confronti dell’ipotesi che uno scienziato come Veronesi andasse al ministero della Salute. Vera o no l’ipotesi, rimane reale il veto. Sintomo preoccupante di una visione ideologica dei problemi della sanità (e della famiglia, possiamo aggiungere) che con un governo di stampo “europeo” non è assolutamente in sintonia.
È bene riflettere subito su problemi che toccano la vita quotidiana di milioni di uomini e donne. Un governo liberalizzatore di stampo europeo non può e non dovrà permettere che un farmacista si arroghi il diritto - contro la legge - di vendere o meno la pillola del giorno dopo. Non può tollerare ostruzionismi capziosi, che nulla hanno a che fare con la cura delle persone, nei confronti della pillola del giorno dopo o della Ru486. Dovrà riformulare urgentemente le assurde linee guida, varate come ultima raffica, per impedire la diagnosi preimpianto degli embrioni mortalmente malati. Soltanto il cinismo di una radicale pentita come Eugenia Roccella può dichiarare che l’assistenza alla procreazione è per le coppie sterili e non riguarda padri e madri che hanno la responsabilità di non mettere al mondo bimbi condannati a morire per talassemia o fibrosa cistica.
QUESTA VERGOGNA ideologica deve finire. Sarebbe poco logico predicare la libera concorrenza e ampliare la libertà di gestione delle imprese ad esempio nel campo dei licenziamenti, sarebbe poco comprensibile voler spezzare i lacci delle caste e delle corporazioni, e poi mortificare la libertà di responsabile decisione di uomini e donne nello spazio vitale della propria esistenza. Il profilo stesso delle personalità cattoliche arrivate nel governo Monti dimostra che questo governo è tutt’altro che tecnico. Al contrario, è altamente politico perché portatore di una visione generale di riorganizzazione sociale all’insegna di sviluppo, modernizzazione, equità e coesione. Dai cattolici, che siederanno ai banchi del governo, ci si aspetta che sappiano misurarsi con i problemi della modernità con l’indipendenza di un De Gasperi e della migliore tradizione di autonomia della Dc, trovando soluzioni concrete orientate al bene comune. Con l’accento su “comune”.
 Il cardinale Bertone: «Una bella squadra». Dalle Acli all’Azione Cattolica reazioni soddisfatte
Il cardinale Bertone: «Una bella squadra». Dalle Acli all’Azione Cattolica reazioni soddisfatte
 Casini si spinge a dire: «È la fine della diaspora della Dc». Replica Bindi: «Ti sbagli»
Casini si spinge a dire: «È la fine della diaspora della Dc». Replica Bindi: «Ti sbagli»
 Il Vaticano benedice
Il Vaticano benedice
 Per i cattolici è l’«effetto Todi»
Per i cattolici è l’«effetto Todi» I «professori cattolici» nella squadra del governo Monti rassicurano la Chiesa.
I «professori cattolici» nella squadra del governo Monti rassicurano la Chiesa.
 La novità dell’esecutivo «tecnico» risponde allo spirito di Todi. Apprezzamenti dal cardinale Bertone, dal Sir, dall’Azione cattolica e dalle Acli.
La novità dell’esecutivo «tecnico» risponde allo spirito di Todi. Apprezzamenti dal cardinale Bertone, dal Sir, dall’Azione cattolica e dalle Acli. di Roberto Monteforte (l’Unità 17.11.11
di Roberto Monteforte (l’Unità 17.11.11«Una bella squadra alla quale auguro buon lavoro. Si tratta di un lavoro difficile, ma penso che la squadra sia attrezzata per affrontare questo lavoro». È stata questa l’autorevolissima «benedizione» del segretario di Stato vaticano, cardinale Bertone al «governo tecnico» presentato ieri dal professore Mario Monti che ha giurato ieri al Quirinale. Un governo forte. Con personalità «tecniche» di grande competenza che con si mettono al servizio del Paese per favorire il superamento della crisi con un’imprevista accelerazione, almeno stando ai commenti e ai messaggi di augurio rivolti dal mondo dell’associazionismo cattolico al governo. Dal settimanale Famiglia Cristiana all’agenzia dei vescovi Sir, dalle Acli all’Azione cattolica è comune il sostegno convinto a Monti.
«Un governo tecnico» lo descrive il Sirnato da un passo indietro delle forze politiche che «tuttavia, fin d’ora sono chiamate ad accompagnare con serietà e senso di responsabilità il lavoro dei tecnici». «Coniugare rigore ed equità, sacrifici e crescita conclude il Sir comporta da parte di tutti uno spirito di coesione e di collaborazione. Plaudono anche il Terzo Settore e il presidente delle Acli, Andrea Olivero che lo definisce «un esecutivo convincente», con «figure di alto profilo» che «non nasce contro la politica, ma al servizi della buona politica».
Quello che si sottolinea è la sintonia con le indicazioni «politiche» avanzate dal laicato cattolico al seminario di Todi. Rafforzata dalla presenza di «ministri» di area. Il leader dell’Udc, Pierferdinando Casini si spinge a parlare di «fine della diaspora della Dc», visto che ora i cattolici si ritrovano uniti nello stesso al gover no. Gli risponde Rosy Bindi (Pd). Non vi è stata «alcuna riunificazione» dei cattolici. «Questo governo puntualizza -non è sostenuto da una coalizione, ma da forze politiche che lavorano in autonomia, ciascuna con le proprie caratteristiche».
QUELLI DELL’«INCONTRO»
Una cosa è certa. Tra i ministri che hanno giurato al Quirinale, vi sono protagonisti dell’«incontro di Todi» che hanno accolto l’invito delle gerarchie e dello stesso pontefice a mettersi al servizio del paese e del «bene comune». Vi è il banchiere Corrado Passera, neo-ministro allo sviluppo economico. Il professore Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di sant’Egidio, a cui il presidente Monti ha affidato la responsabilità di un nuovo dicastero che comprende la «cooperazione interna e internazionale», due emergenze che hanno contraddistinto l’«azione sociale» della comunità di Trastevere. «L’impegno per la coesione sociale, per l’integrazione nazionale e per la cooperazione internazionale ha spiegato Riccardi fanno parte della mia cultura e dell’esperienza da me maturata in questi anni. Credo siano elementi decisivi per un Paese che ritrova la forza per uscire dalla crisi».
Alla guida dei Beni culturali vi è il rettore della università Cattolica professore Ornaghi, l’uomo chiave del «progetto culturale» della Cei voluto dal cardinale Ruini, intellettuale apprezzato anche dal presidente dei vescovi, Bagnasco. Del governo fa parte anche Piero Giarda, formatosi alla Cattolica di Milano: sarà il ministro per i rapporti con il Parlamento. Espressione autorevole dell’associazionismo cattolico è il professore di diritto costituzionale, Renato Balduzzi già presidente del Meic, il movimento di impegno culturale legato all’Azione cattolica. Sarà a capo di un ministero strategico per la Chiesa: la Salute. Non gli manca l’esperienza. È stato esperto giuridico della Bindi alla Sanità e alle Politiche per la famiglia.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- “Rischio protettorato Usa per il Vaticano”. Andreotti scoperchia l’archivio della Dc. “Lo scongiurammo inserendo i Patti Lateranensi in Costituzione”.16 novembre 2011, di Federico La Sala
 “Rischio protettorato Usa per il Vaticano”
“Rischio protettorato Usa per il Vaticano”
 Andreotti scoperchia l’archivio della Dc
Andreotti scoperchia l’archivio della Dc
 Il senatore: “Lo scongiurammo inserendo i Patti Lateranensi in Costituzione”
Il senatore: “Lo scongiurammo inserendo i Patti Lateranensi in Costituzione” di Fabio Martini (La Stampa, 16.11.2011)
di Fabio Martini (La Stampa, 16.11.2011)ROMA. Dopo il Pci, ora è la volta della Dc. Il declino della Seconda Repubblica sta accelerando la riscoperta dei partiti della prima stagione della Repubblica e così, dopo la ricca mostra itinerante dedicata alcuni mesi fa alla storia del Partito comunista italiano (e preparata dai «legittimi eredi» di quella storia, gli ex Ds), da oggi al Tempio di Adriano di Roma si apre una analoga iniziativa che in questo caso ripercorre, per immagini e documenti, la storia della Democrazia cristiana. Promossa dalla Associazione «I Popolari», la mostra intende «valorizzare il ruolo dei cattolici impegnati in politica - spiega l’ideatore della iniziativa Pier Luigi Castagnetti - che, dopo non aver partecipato alla stagione risorgimentale, nel secondo dopoguerra furono i protagonisti della rinascita del Paese e della sua unificazione, anche grazie alla scolarizzazione di massa, all’Ina-casa di Fanfani, all’autostrada in sei anni, all’effetto unificante sul linguaggio realizzato dalla prima Rai».
Un soprassalto di orgoglio democristiano che, più o meno consapevolmente, trae alimento anche da una piccola maledizione che perseguita il buon nome della Dc: nell’immaginario collettivo il termine democristiano oramai è diventato sinonimo di compromesso al ribasso, di sottogoverno deteriore. Un’immagine che finisce per associare in un unico «calderone» la stagione del declino - l’ultimo ventennio, dal 1974 al 1993 - con l’intera storia del partito, che copre un cinquantennio e che comprende tutta la prima fase della Repubblica, la ricostruzione e il boom economico.
Nel lavoro di preparazione della mostra, gli organizzatori hanno avuto la fortuna di acquisire una testimonianza storicamente assai interessante sulle ingerenze straniere sull’Italia, tema in questi giorni assai dibattuto, sia per motivi molto diversi. Richiesto di ricordare la stagione della Assemblea costituente, Giulio Andreotti, rivela un dettaglio che lui stesso riconosce essere stato finora «mai considerato». Racconta Andreotti, in quegli anni molto vicino al presidente del Consiglio Alcide De Gasperi: «Inserendo nella Costituzione i Patti lateranensi, si allontanò definitivamente l’ipotesi di una garanzia internazionale alla Santa Sede, per la quale avevano fatto sondaggi in Segreteria di Stato tanto il governo americano che quello irlandese, con esito per loro non incoraggiante da parte di monsignor Montini».
In parole povere, uno dei passaggi più importanti nella storia del dopoguerra, l’inserimento dei Patti lateranensi in Costituzione col voto congiunto della Dc e del Pci e quello contrario dei socialisti e degli azionisti, sarebbe stato preceduto e accelerato anche dall’opzione di una sorta di «protettorato» straniero, con una esplicita candidatura non solo dell’Irlanda cattolica, ma soprattutto di una delle due superpotenze uscite vittoriose dalla guerra mondiale, gli Stati Uniti d’America. In sostanza, la Chiesa attraverso il futuro Paolo VI, la Dc di De Gasperi e il Pci filosovietico di Palmiro Togliatti si ritrovarono d’accordo nel concedere alla Chiesa la «protezione» nazionale piuttosto che affidare il Vaticano alle cure degli Stati Uniti d’America. Nella mostra che si apre oggi sono esposti 170 documenti, tra manifesti, volantini, audiovisivi e alcune lettere di speciale valore storico.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---AL DI LA’ DEL SACRO E DEL DEVOTO, PENSARE UN ALTRO ABRAMO16 novembre 2011, di Federico La Sala
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- IL BERLUSCONISMO COME CATEGORIA DELLO SPIRITO (ATEO E DEVOTO) E COME AUTOBIOGRAFIA DELLA NAZIONE (di Francesco Merlo - Quei pozzi avvelenati, dalla giustizia alla Rai).13 novembre 2011, di Federico La Sala
Quei pozzi avvelenati, dalla giustizia alla Rai
di Francesco Merlo (la Repubblica, 13.11.2011)
È certo che anche se Berlusconi andasse via, per molto tempo rimarrà tra noi come categoria dello spirito. Durante questo ventennio ha terremotato l’apparato statale infilandovi dentro la Lega antistatale e secessionista. Dalle abitudini al linguaggio, ha "smontato" lo Stato È la normalità, la tanto attesa normalità, che ha reso storica la lunga giornata di ieri anche se ci vorrebbe un governo Monti delle anime e dei sentimenti e dei valori per liberare l’Italia dal berlusconismo. Nessuno dunque si illuda che sia davvero scaduto il tempo. Certo, alla Camera lo hanno giubilato, gli hanno fatto un applauso da sipario: è così che si chiude e si dimentica, con l’applauso più forte e più fragoroso che è sempre il definitivo.
Poi Napolitano è riuscito a dare solennità anche all’addio di Berlusconi che sino all’altro ieri si era comportato da genio dell’impunità inventando le dimissioni a rate. Che lui nascondesse una fregatura sotto forma di sorpresa è stato il brivido di ieri, e difatti, inconsapevolmente, nessuno si è lasciato troppo andare e la festa, sino all’annuncio ufficiale delle dimissioni, più che sobria è stata cauta. Di sicuro Berlusconi non ha avuto il lieto fine. Entrato in scena cantando My Way ne è uscito con lo Zarathustra che premia "il folgorante destino di chi tramonta".
Dunque non c’è stato il 25 luglio, non la fuga dei Savoia né la fine della Dc, né tanto meno la tragedia craxiana, nessuno ha mangiato mortadella in Parlamento come avvenne quando cadde Prodi, non c’è stato neppure l’addio ai monti di Renzo anche se nessuno sa cosa farà Berlusconi, se rimarrà in Italia o invece andrà in uno dei degli ospedali che dice di avere regalato nei luoghi del Terzo Mondo. Tutti parlano, probabilmente a vanvera, di una trattativa parallela e coperta sui processi, di un salvacondotto e di un’amnistia che non hanno mai riguardato in Italia reati come la corruzione e lo sfruttamento della prostituzione. In un Paese normale la rimozione di un capo non produce mai sconquassi e siamo sicuri che il pedaggio che paghiamo alla normalità non sarà l’enorme anormalità di un pasticcio giuridico.
È comunque certo che, anche se Berlusconi si rifugiasse ad Antigua, per molto tempo rimarrà tra noi come categoria dello spirito. Ecco perché ci vorrebbe una banca centrale della civiltà per commissariare il Paese dove Berlusconi "ha tolto l’aureola a tutte le attività fino a quel momento rispettate e piamente considerate. Ha trasformato il medico, il giurista, il prete, il poeta, l’uomo di scienza in salariati da lui dipendenti".
Dunque neppure nello storico giorno in cui è stato accompagnato fuori con il suo grumo di rancore invincibile e lo sguardo per sempre livido, è stato possibile accorarsi e simpatizzare. Non c’è da intonare il requiem di Mozart o di Brahms per l’uomo più ricco d’Italia che ha comprato metà del Parlamento e ha ordinato di approvare almeno 25 leggi ad personam. E ha terremotato lo Stato infilandovi dentro la Lega antistatale e secessionista. E mentre i suoi ministri leghisti attaccavano la bandiera e l’unità dello Stato, Berlusconi organizzava la piazza contro i tribunali di Stato, la Corte costituzionale, il capo dello Stato. Anche il federalismo non ha preso, come negli Usa e in Germania, la forma dello Stato ma dell’attacco al cuore dello Stato. Avevamo avuto di tutto nella storia: mai lo statista che lavorava per demolire lo Stato. Quanto tempo ci vorrà per rilegittimare i servitori dello Stato, dai magistrati ai partiti politici, dagli insegnanti ai bidelli ai poliziotti senza soldi e con le volanti a secco?
E quante generazioni ci vorranno per restituire un po’ di valore all’università, alla scuola e alla cultura che Berlusconi ha depresso e umiliato: contro i maestri, contro gli insegnanti, contro tutti i dipendenti pubblici considerati la base elettorale del centrosinistra, e contro la scuola pubblica, contro il liceo classico visto come fucina di comunisti. E ha degradato la più grande casa editrice del Paese a strumento di propaganda (escono in questi giorni i saggi di Alfano, Sacconi, Bondi, Lupi....). Ha corrotto una grande quantità di giornalisti come mai era avvenuto. Ha definitivamente distrutto la Rai affidata ad una gang di male intenzionati che hanno manipolato, cacciato via i dissidenti, lavorando in combutta con i concorrenti di Mediaset. E con i suoi giornali e le sue televisioni ha sfigurato il giornalismo di destra che aveva avuto campioni del calibro di Longanesi e Montanelli. Con lui la faziosità militante è diventata macchina del fango. Testate storiche sono state ridotte a rotocalchi agiografici. E ha smoderato i moderati, ha liberato i mascalzoni dando dignità allo spavaldo malandrino, ai Previti e ai Verdini, ai pregiudicati, e c’è un po’ di Lavitola, di Lele Mora e di Tarantini in tutti quelli che gli stanno intorno, anche se ora li chiama traditori.
Berlusconi, che fu il primo a circondarsi di creativi, di geniacci come Freccero e Gori ha umiliato la modernità dei nuovi mestieri, della sua stessa comitiva, l’idea di squadra che all’esordio schierava a simbolo Lucio Colletti e alla fine ha schierato a capibranco Tarantini, Ponzellini, Anemone, Bisgnani, Papa, Scajola, Bertolaso, Dell’Utri, Verdini, Romani, Cosentino. Eroi dei giornali di destra sono stati Igor Marini e Pio Pompa. I campioni dell’informazione berlusconiana in tv sono Vespa, Fede e Minzolini. Persino il lessico è diventato molto più volgare, il berlusconismo ha introdotto nelle istituzioni lo slang lavitoilese, malavitoso e sbruffone. E’stato il governo del dito medio e del turpiloquio, è aumentato lo ’spread’tra la lingua italiana e la buona educazione.
E la corruzione è diventata sacco di Stato e basta pensare agli appalti per la ricostruzione dell’Aquila, assegnati tra le risate della cricca. Berlusconi ha dissolto "tutti i tradizionali e irrigiditi rapporti sociali, con il loro corollario di credenze e venerati pregiudizi. E tutto ciò che era solido e stabile è stato scosso, tutto ciò che era sacro è stato profanato". Persino la bestemmia è diventata simonia spicciola, ufficialmente perdonata dalla Chiesa in cambio di privilegi, scuole e mense. Toccò, nientemeno, a monsignor Rino Fisichella spiegare che, sì, la legge di Dio è legge di Dio, ma "in alcuni casi, occorre "contestualizzare" anche la bestemmia". E quanto ci vorrà per far dimenticare la diplomazia del cucù e delle corna, lo slittamento dal tradizionale atlantismo verso i paesi dell’ex Unione Sovietica, la speciale amicizia con i peggiori satrapi del mondo?
E mai c’era stata una classe dirigente maschile così in arretrato di femmina verrebbe da dire con il linguaggio dell’ex premier: femmina d’alcova, esibita e valutata come una giumenta, con il Tricolore sostituito con quella grottesca statuetta di Priapo in erezione che circolava - ricordate? - nelle notti di Arcore. Persino il mito maschile della donna perduta e nella quale perdersi, persino la malafemmina italiana è stata guastata da Berlusconi, ridotta a ragazza squillo della politica: l’utilitaria, il mutuo, seimila euro, l’appartamentino, un posto di deputato e forse di ministro per lucrare il compenso - "il regalino" - agli italiani.
Lo scandalo del berlusconismo non è stato comprare sesso in un mondo dove tutto è in vendita ma nel pagare con pezzi di Stato, nell’uso della prostituzione per formare il personale politico e selezionare la classe dirigente. E non è finita: se la prostituzione ha cambiato la politica, anche la politica ha cambiato la prostituzione. La Maddalena ha perso la densità morale che fu una forza della nostra civiltà, è diventata la scialba ragazzotta rifatta dal chirurgo ed educata dalla mamma-maitresse a darla via a tariffa.
Il berlusconismo è stato l’autobiografia della nazione per dirla con Croce, non un accidente della storia. Non basta certo una giornata solennemente normale per liberarcene. C’è bisogno di anni di giornate normali. E per la prima volta non saranno gli storici a mettere in ordine gli archivi di un’epoca. Ci vorranno gli antropologi per classificare il berlusconismo come involuzione della specie italiana, perché anche noi, che siamo stati contro, l’abbiamo avuto addosso: "Non temo il Berlusconi in sé - cantava Gaber - ma il Berlusconi in me".
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- "Fuori dal Tempio. La Chiesa al servizio dell’umanità"!!! Un libro di Pierluigi Di Piazza, prete e parroco di Udine (di Aldo M. Valli).,13 novembre 2011
 MESSAGGIO EVANGELICO E ...SANTO PADRE?! ABUSO DEL TITOLO E TRADIMENTO STRUTTURALE DELLA FIDUCIA
MESSAGGIO EVANGELICO E ...SANTO PADRE?! ABUSO DEL TITOLO E TRADIMENTO STRUTTURALE DELLA FIDUCIA
 LA CHIESA AL SERVIZIO DEI POTENTI?! "Fuori dal Tempio. La Chiesa al servizio dell’umanità"!!! Un libro di Pierluigi Di Piazza, prete e parroco di Udine, recensito da Aldo M. Valli -
LA CHIESA AL SERVIZIO DEI POTENTI?! "Fuori dal Tempio. La Chiesa al servizio dell’umanità"!!! Un libro di Pierluigi Di Piazza, prete e parroco di Udine, recensito da Aldo M. Valli -
 «Mi chiedo spesso - scrive Di Piazza - dove sia Gesù di Nazaret, cosa c’entri lui non solo con l’apparato del potere (...) Cosa c’entri lui con i titoli di Sua Santità, Eminenza, Eccellenza, Monsignore (...)
«Mi chiedo spesso - scrive Di Piazza - dove sia Gesù di Nazaret, cosa c’entri lui non solo con l’apparato del potere (...) Cosa c’entri lui con i titoli di Sua Santità, Eminenza, Eccellenza, Monsignore (...)
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- LA RICOSTRUZIONE ETICA (di Guido Crainz - Così tramonta un regime).11 novembre 2011, di Federico La Sala
Così tramonta un regime
di Guido Crainz (la Repubblica, 11.11.2011)
Negli anni trionfali di Berlusconi era possibile sostenere con molti argomenti che non si trattava comunque di un regime: ma come definire il crollare per disfacimento che è sotto i nostri occhi, l’assenza totale di ricambio all’interno del centrodestra, le fughe accelerate e talora sorprendenti, dopo gli "irresponsabili" afflussi dei mesi scorsi (talora con protagonisti non dissimili)? "Muore ignominiosamente la Repubblica" scriveva il poeta Mario Luzi alla fine degli anni settanta: allora la tragedia investiva per intero il Paese e il ceto politico, oggi il centrodestra è in gran parte approdato alla farsa. Ad una dissoluzione senza nobiltà.
All’indomani del 25 luglio del 1943 fra i tanti fedelissimi di Mussolini vi fu un solo caso drammatico, il suicidio per coerenza estrema di Manlio Morgagni, presidente dell’agenzia giornalistica di regime: "Il Duce non c’è più, la mia vita non ha più scopo", lasciò scritto. Le cronache di questi giorni ci danno, fortunatamente, una tranquilla sicurezza: Morgagni non corre proprio il rischio di avere degli imitatori, neppure incruenti, anche se la paura del suicidio (con riferimento solo alla carriera, naturalmente) è stato l’argomento più evocato nelle dichiarazioni. E con buona pace della giovane deputata del Pdl che ha assunto come suo modello Claretta Petacci.
Non si leggano però solo come farsa le cronache dei giorni scorsi, il ricomparire di transfughi o ex transfughi. C’è in realtà poco da sorridere: ci sono i sintomi di una tragedia nelle private disinvolture e vergogne che molte microscopiche vicende ci raccontano (o ci hanno raccontato nei mesi passati, con segno rovesciato). E che Cirino Pomicino sia fra gli affossatori della "seconda repubblica" è il più malinconico epitaffio sia della "prima" che della "seconda".
Sono una cosa terribilmente seria le crisi di regime. Coinvolgono nel loro insieme le istituzioni e il Paese, e conviene prender avvio dalle domande più immediate: perché questo ceto politico è riuscito a imporsi sin qui, a occupare così a lungo la scena? La legge elettorale lo spiega solo in parte, e ripropone in altre forme la stessa domanda: perché il centrodestra ha potuto riempire le sue liste di figure di questo tipo senza pagare dazio? Perché nel crollo della "prima Repubblica" è stata solo o prevalentemente questa "società incivile" ad invadere le istituzioni e non hanno trovato spazio voci diverse, espressione di un opposto modo di intendere la politica e il rapporto fra privato e pubblico?
Non ci si fermi però a queste prime e più immediate domande: quando tramonta un regime è necessario un esame di coscienza più profondo. Nel crollo della "prima repubblica" esso fu eluso addossando ogni colpa a un ceto politico corrotto, contrapposto a una società civile incontaminata: le conseguenze dell’abbaglio si videro presto ed oggi nessuno può affidarsi a quel mito. Nel dicembre del 1994, nell’imminente crisi del primo governo del Cavaliere, Sandro Viola scriveva su questo giornale: "quando Berlusconi prima o poi cadrà, sul Paese non sorgerà un’alba radiosa. Vi stagneranno invece i fumi tossici, i miasmi del degrado politico di questi mesi". I mesi sono diventati anni, quasi un ventennio, e il degrado ha superato da tempo i livelli di guardia. Con una sfiducia nella democrazia ormai dilagante, e con conseguenze pesantissime nell’insieme della società.
Poco meno di un anno fa il rapporto del Censis sul 2010 ha disegnato il quadro di un’Italia sfiduciata, percorsa da una diffusa sensazione di fragilità individuale e collettiva. Incapace di vedere un approdo, una direzione di marcia. Un’Italia "senza più legge né desiderio": ma tornare a "desiderare", a sperare, è la virtù civile necessaria per rimetter in moto la società. E per andare in questa direzione, concludeva il Censis, è necessario ridare centralità e prestigio alle leggi e alle regole. Quel rapporto segnalava anche un dato drammatico, che fu colpevolmente rimosso dall’agenda politica: gli oltre due milioni di giovani che non studiavano e non avevano lavoro né lo cercavano. Resi sempre più sfiduciati e apatici dal diffuso trionfare dei "furbetti" e delle corporazioni. Tramontate da tempo le disastrose illusioni del berlusconismo, affermava allora Giuseppe De Rita, un leader vero dovrebbe ridare in primo luogo agli italiani il senso delle loro responsabilità.
Da qui occorre ripartire, da quella "ricostruzione etica" evocata domenica da Eugenio Scalfari: una più generale ricostruzione che riguarda l’intero Paese ma che nella politica deve trovare riferimento e incentivo. Anche per questo un governo di civil servants sarebbe oggi fortemente auspicabile, segno di un’inversione di tendenza cui chiamare il Paese.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- ANDARE A NOI STESSI. NOTE SULLA VIA DELLA VITA, NON DELLA GUERRA E DELLA MORTE..9 novembre 2011, di Federico La Sala
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- VATICANO SENZA VERGOGNA. Anno dopo anno i vertici vaticani hanno sostenuto il Cavaliere nonostante la sua indecenza e la sua incapacità e soltanto il 22 settembre scorso, recandosi in Germania, papa Ratzinger ha segnalato al presidente Napolitano l’esigenza di un “sempre più intenso rinnovamento etico” per il bene dell’Italia (di Marco Politi - Senza parole, fino alla fine).8 novembre 2011, di Federico La Sala
Senza parole, fino alla fine
di Marco Politi (il Fatto Quotidiano, 8 novembre 2011)
Alla crisi del berlusconismo il Vaticano arriva smarrito e disorientato. E muto. Anno dopo anno i vertici vaticani hanno sostenuto il Cavaliere nonostante la sua indecenza e la sua incapacità e soltanto il 22 settembre scorso, recandosi in Germania, papa Ratzinger ha segnalato al presidente Napolitano l’esigenza di un “sempre più intenso rinnovamento etico” per il bene dell’Italia. Poi Oltretevere non ha più disturbato il premier, lasciando che la situazione degenerasse. Le foto della Minetti e altre pupe vestite da suore, pubblicate dal Fatto, stanno lì a testimoniare a chi il Vaticano stagione dopo stagione, a forza di contestualizzare, ha rinnovato la fiducia. Si è dovuto aspettare il 26 settembre perché il cardinale Bagnasco denunciasse a nome dell’episcopato l’“aria ammorbata” dal regime berlusconiano e chiedesse discontinuità. Subito dopo, però, il segretario della Cei monsignor Crociata si è affrettato a comunicare che la Chiesa non fa i governi “e non li manda a casa”. Ennesimo aiutino mediatico alla tattica dilazionatrice di Berlusconi, disastrosa per il Paese.
E COSÌ ANCORA per settimane, mentre l’Italia rotolava verso la rovina, le gerarchie ecclesiastiche
 a differenza della Confindustria che finalmente aveva imboccato la strada della pressione
crescente per voltare pagina - hanno scelto di stare zitte invece di chiarire ulteriormente che il bene
comune dell’Italia richiedeva l’allontanamento urgente di Berlusconi. Nemmeno la constatazione
che tre quarti degli italiani bocciano B. (come da sondaggio di Famiglia Cristiana) ha spinto i
vescovi a farsi sentire. Paradossalmente è stato il Financial Times a lanciare l’esclamazione, che
avrebbe potuto venire dai pulpiti: “In nome di Dio, dell’Italia e dell’Europa, Berlusconi vattene!”.
a differenza della Confindustria che finalmente aveva imboccato la strada della pressione
crescente per voltare pagina - hanno scelto di stare zitte invece di chiarire ulteriormente che il bene
comune dell’Italia richiedeva l’allontanamento urgente di Berlusconi. Nemmeno la constatazione
che tre quarti degli italiani bocciano B. (come da sondaggio di Famiglia Cristiana) ha spinto i
vescovi a farsi sentire. Paradossalmente è stato il Financial Times a lanciare l’esclamazione, che
avrebbe potuto venire dai pulpiti: “In nome di Dio, dell’Italia e dell’Europa, Berlusconi vattene!”.In realtà, esaurita la stagione di Ruini che non a caso ha premuto finché ha potuto per far tornare Casini ad allearsi con Berlusconi, la Chiesa italiana non ha più una linea strategica su come affrontare la perigliosa e complicata transizione a quella che sarà la Terza Repubblica. Non ha una sua visione dell’Italia post-berlusconiana, ma non ha nemmeno il coraggio di affidare decisamente il timone ai cattolici impegnati in politica. A Todi il cardinale Bagnasco, pressato dal Vaticano, dagli atei devoti e dai conservatori ecclesiali, ha dovuto risfoderare la dottrina dei principi non negoziabili, Un diktat inadatto per qualsiasi moderno governo europeo, di destra o di sinistra. In queste settimane cruciali si è liquefatta anche l’ambizione della carovana di Todi di rappresentare quel “soggetto culturale e sociale” cattolico in grado di “interloquire con la politica”. È nel vivo della battaglia che si affermano i protagonisti. A cose fatte sono bravi tutti a chiedere rappresentanza. Nella crisi attuale un singolo democristiano come Pisanu ha rappresentato di più e meglio la tradizione del cattolicesimo politico moroteo di quanto non siano riusciti a fare i grandi oratori di Todi.
Naturalmente la rete, messa in piedi con il convegno umbro, continuerà ad agire, ma per l’oggi - nelle ore drammatiche che l’Italia sta vivendo - si registra nuovamente la generale afasia dell’associazionismo cattolico. Unica eccezione le Acli, che dopo aver chiesto il mese scorso le dimissioni di Berlusconi sono tornate a ribadire fermamente la necessità del suo allontanamento. E la Cisl, che ha insistito sull’esigenza di un governo di larghe intese.
LA GERARCHIA ecclesiastica, nella tempesta in corso, è rimasta come acquattata sotto la bufera. Non si esprime. Sul piano sociale ha dalla sua una posizione più volte rimarcata di attenzione ai problemi del precariato giovanile e di denuncia dell’intollerabile evasione fiscale. Nonché l’aiuto economico prestato in questi anni da organizzazioni ecclesiali a tante famiglie in difficoltà. Questione del lavoro e tutela della famiglia sono temi sistematicamente toccati. L’immagine di Bagnasco con l’ombrello tra i disastrati di Genova mostra una Chiesa vicina alle angosce della gente. Ma sul piano politico la gerarchia ecclesiastica naviga a vista. Avrebbe visto di buon occhio un governo post-berlusconiano basato sull’alleanza Pdl-Lega-Udc. Ma anche in Vaticano hannocapito che è un’utopia. Adesso la Cei e i vertici vaticani sembrano affidarsi - loro malgrado - alla strategia di Casini per la creazione di un governo d’emergenza trasversale che vada dal Pdl ai Democratici.
Più di ogni cosa il Vaticano teme nuove elezioni, che sancirebbero lo sfaldamento del partito berlusconiano, il ridimensionamento della Lega (con la sua ambigua difesa dei principi non negoziabili ratzingeriani) e l’emergere di un forte blocco di centrosinistra. Ancora una volta la stella polare sembra essere la tutela delle posizioni di privilegio economico-istituzionale conquistate. E soprattutto Oltretevere hanno il terrore di una maggioranza che sblocchi in Parlamento quelle leggi sulle coppie di fatto e il testamento biologico, che Berlusconi e i suoi alleati hanno sempre affossato.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- LA LEZIONE DI PIERO CALAMANDREI. “Lo Stato siamo noi” (Chiarelletere; 7 euro, 136 pagine) raccolta di scritti e discorsi (di Silvia Truzzi - Calamandrei, educazione italiana).)6 novembre 2011, di Federico La Sala
Calamandrei, educazione italiana
di Silvia Truzzi (il Fatto, 5.11.2011)
A chi si domanda perché riprendere in mano gli scritti dei vecchi, dei morti - invece che tenerli come santini in improbabili pantheon - sarà utile dare più di un’occhiata a “Lo Stato siamo noi” (Chiarelletere; 7 euro, 136 pagine) raccolta di scritti e discorsi di Piero Calamandrei. Giurista, azionista, padre costituente: perché Calamandrei oggi lo spiega Giovanni De Luna nella sua introduzione al volumetto, a proposito della fascistizzazione degli italiani. “Si era trattato, diceva Calamandrei, di un arido ventennio di diseducazione, passato sulle menti come una carestia morale’. Bisognava impedire che gli elementi essenziali di questa carestia transitassero intatti nella nuova Italia repubblicana”. Dice qualcosa? “Le macerie lasciate dal fascismo sono state quelle che ci hanno obbligato a riedeficare lo spazio pubblico con una religione civile”, spiega ancora De Luna. E tutti i comandamenti sono nella Costituzione. “La Carta è una cosa bellissima, però vive nella mente e nel cuore delle persone. Si deve incarnare nella concretezza di movimenti collettivi. Non è una conquista data una volta per tutte: va rinnovata in continuazione, attraverso la partecipazione politica”. Ma per sentirsi partecipi dello spazio pubblico della cittadinanza c’è bisogno di valori. Ci si domanda se alla bufera delle cricche, del potere e dell’individualismo, qualche forma di etica sia sopravvissuta. “Quello che è accaduto con la Seconda Repubblica”, conclude De Luna, “è stata una desertificazione dello spazio pubblico. Gli unici elementi di continuità sono stati gli interessi. Come se quella italiana fosse una sorta di cittadinanza bancomat. Una carta per accedere a beni, ricchezze, consumi, merci”. Bisogna ripartire. E bisogna ripartire da un’idea di democrazia che non è se non è inclusiva.
NEL LIBRO C’È un celebre discorso fatto da Calamandrei ai giovani. Parte dall’articolo 34 e dice: “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana: quindi dare lavoro a tutti, dare una giusta retribuzione a tutti, dare una scuola a tutti, dare a tutti gli uomini dignità di uomo. Soltanto quando questo sarà raggiunto, si potrà veramente dire che la formula contenuta nel-l’art. primo - «L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro» - corrisponderà alla realtà. Perché fino a che non c’è questa possibilità per ogni uomo di lavorare e di studiare e di trarre con sicurezza dal proprio lavoro i mezzi per vivere da uomo, non solo la nostra Repubblica non si potrà chiamare fondata sul lavoro, ma non si potrà chiamare neanche democratica perché una democrazia in cui non ci sia questa uguaglianza di fatto, in cui ci sia soltanto una uguaglianza di diritto, è una democrazia puramente formale”.
Il testo è del 1955 eppure sembra scritto per i ragazzi della generazione mille euro che chiedono il diritto di essere, pienamente e non precariamente, persone. L’istruzione, il lavoro, l’uguaglianza sostanziale: ecco come avrete un’esistenza degna. Tutti: Calamandrei non dimentica mai gli ultimi. Come nel discorso in difesa - è proprio il testo di un’arringa difensiva pronunciata davanti al Tribunale di Palermo nel ’56 - di Danilo Dolci, accusato di manifestazione sediziosa e turbamento dell’ordine pubblico. Dolci aveva (addirittura) incitato al digiuno una comunità di pescatori, rimasti senza pesci nelle reti a causa del contrabbando. Digiunare vuol dire disturbare l’ordine pubblico. Ma l’ordine pubblico di chi? chiede Calamandrei ai giudici. E risponde: “L’ordine pubblico di chi ha da mangiare. Non bisogna disturbare con spettacoli di miseria e di fame la mensa imbandita di chi mangia bene”. Chissà che avrebbe detto dei “respingimenti”. Naturalmente nelle parole di questo libro ci sono anche il regime e la guerra civile. Quella frase diventata così famosa - “ora e sempre Resistenza” - è l’ultimo verso di un’epigrafe datata 4 dicembre 1952, scritta da Calamandrei per una lapide collocata nell’atrio del palazzo comunale di Cuneo, in protesta per la liberazione di Albert Kesselring, comandante delle forze di occupazione tedesche in Italia, condannato all’ergastolo nel 1947 ma liberato nel 1952 per “gravi” condizioni di salute. E ci sono anche i morti.
IN UN DISCORSO all’Assemblea Costituente, l’avvocato che elogiava i magistrati fa una domanda sui cittadini di domani: “Mi chiedo come i nostri posteri giudicheranno questa nostra Assemblea costituente. Se la sentiranno alta e solenne come noi sentiamo oggi alta e solenne la Costituente romana, dove un secolo fa sedeva e parlava Giuseppe Mazzini. Io credo di sì: credo che i nostri posteri sentiranno più di noi (...) che in questa nostra Assemblea, seduti su questi scranni non siamo stati noi, uomini effimeri di cui i nomi saranno cancellati e dimenticati, ma sia stato tutto un popolo di morti. Essi sono morti senza retorica, senza grandi frasi, con semplicità, come se si trattasse di un lavoro quotidiano da compiere: il grande lavoro che occorreva per restituire all’Italia libertà e dignità. Di questo lavoro si sono riservata la parte più dura e più difficile; quella di morire, di testimoniare con la resistenza e la morte la fede nella giustizia. A noi è rimasto un compito cento volte più agevole; quello di tradurre in leggi chiare, stabili e oneste il loro sogno: di una società più giusta e più umana, di una solidarietà di tutti gli uomini, alleati a debellare il dolore. Non dobbiamo tradirli”. Siamo in tempo?
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- L’IMPORTANZA DELLA VERITA’.5 novembre 2011, di Federico La Sala
L’importanza della verità
di Adriano Prosperi (la Repubblica, 5.11.2011)
L’autunno italiano è triste, luttuoso, incerto. Gravano su di noi la maledizione della natura e l’irrisione del mondo intero. La lingua stessa sembra diventata di legno, equivoca, inservibile. Ma quando la usa il presidente della Repubblica tutti la capiscono. «Parliamoci chiaro, dice oggi Giorgio Napolitano nei confronti dell’Italia è insorta in Europa, e non solo in Europa, una grave crisi di fiducia. Dobbiamo esserne consapevoli e sentircene, più che feriti, spronati nel nostro orgoglio e nella nostra volontà di recupero». Dire la verità, dirla con chiarezza, con nettezza, in limpido italiano è il dovere d’ufficio che il capo dello Stato si è assunto. Oggi ne abbiamo avuto una nuova prova, tanto più importante quanto più amara è questa verità e più urgente la necessità che il Paese intero ne prenda coscienza. Da giorni, da anni, un altro uomo, uno che dice di governare l’Italia ma che è considerato da tutto il mondo un ostacolo alla credibilità di tutti noi come individui e come Paese, tenta di venderci la sua capacità di illusionista, mentre coi più meschini calcoli di potere personale rinvia le scelte necessarie e trascina sempre più in basso la credibilità del Paese avvolgendo nelle nebbie di messaggi vaghi la comunicazione con le istituzioni europee.
La parola di Napolitano giunge ancora una volta tempestiva in risposta alle incredibili dichiarazioni di un premier che cerca di raccontarci la sua favola preferita: quella dell’Italia paese ricco, dove abbondano i soldi e i consumi, dove i ristoranti e gli hotel traboccano di clienti, gli aerei di passeggeri. Dove se c’è qualche problema è per colpa dell’euro. A queste menzogne il Paese ha il torto di avere creduto nella sua maggioranza per troppi anni. Oggi scopre a carissimo prezzo di avere sbagliato: la voce dei pentiti non potrebbe essere più corale. E la verità è la medicina amara che deve prendere per guarire, per cessare di essere un burattino nelle mani di un manipolatore professionale dell’informazione.
Enorme è il conto che viene presentato all’Italia al risveglio dal suo lungo sonno. Ci vorranno generazioni intere per saldarlo - le generazioni dei nostri figli. Il nostro è oggi un Paese che va letteralmente in pezzi, giorno dopo giorno: qui se sono fatiscenti e abbandonati i ruderi del mondo antico, ancor più fragili sono le costruzioni recenti. Mai come oggi l’idea che ci sia qualcuno che governa l’Italia appare surreale. È per questo che è necessario dire agli italiani che c’è una grave crisi di fiducia nel mondo che ci riguarda e che dunque tutti gli italiani debbono sentirsi chiamati a risalire questa china. Il Paese Italia resterà inaffidabile finché parlerà al mondo con la voce dell’attuale presidente del Consiglio. Dunque deve esserci un’altra voce che si faccia ascoltare e che parli a nome di noi tutti. Poi ci divideremo nella divisione dei debiti e nel conteggio di chi deve pagare. Ma non oggi.
Riconciliare le parole con la verità è il primo passo della ricostruzione che ci aspetta. Sarà una lunga fatica ma senza questo primo passo non si può nemmeno cominciare a rimboccarsi le maniche. Dunque è fondamentale che ci sia chi dice parole di verità: tanto meglio se lo fa con la garanzia di una credibilità che gli deriva non dalla sua pur altissima posizione istituzionale ma dal fatto di non avere mai mentito agli italiani e di avere saputo interpretare sentimenti e bisogni profondi del Paese. "La verità vi renderà liberi", si legge nel Vangelo di Matteo. "La verità è rivoluzionaria", scriveva Gramsci.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- COLPEVOLE DI ALTO TRADIMENTO. Raccolgo la poca speranza residua che un riscatto morale e civile degli italiani sia ancora possibile (di Roberta De Monticelli).20 ottobre 2011, di Federico La Sala
Colpevole di alto tradimento
di Roberta De Monticelli (“il Fatto Quotidiano”, 20 ottobre 2011)
Raccolgo la poca speranza residua che un riscatto morale e civile degli italiani sia ancora possibile, per scrivere questa lettera aperta agli esperti di Diritto costituzionale. Mi rivolgo a tutti loro e a chiunque, nelle istituzioni di questa Repubblica, abbia titolo a suggerire una via per sanare le profondissime ferite che sono in questi giorni inferte alla nostra coscienza civile. O sia, almeno, in grado di dare risposta allo sconcerto di molti semplici cittadini come me, dei quali mi faccio portavoce. Siamo noi che abbiamo perduto il senso della misura, o è l’opinione pubblica che ha perduto, per abitudine e rassegnazione, la capacità di percepire quando la misura è colma?
IO CREDO che il voto di scambio sia un reato, e che se non si procede a denunciarlo e a esigere che chi se ne è reso colpevole ne paghi le conseguenze, sia in generale perché è difficile trovare le prove che il mercato abbia avuto luogo. Ma nel caso che abbiamo sotto gli occhi, le prove ci sono. Il presidente del Consiglio ha ripetuto di aver "dovuto" ripagare con un posto di viceministro la signora Polidori per via di promesse già fatte, in cambio di favori pregressi, ha anche aggiunto che precedeva altri nella lista, e che c’era un documento scritto a provarlo. Lo ha detto, ed è stato riportato dai giornali di ieri e di sabato. In quelli di oggi, con le intercettazioni delle telefonate con Lavitola, emergono numerosi altri casi del genere, con personaggi che dicono "io sono prima di lui nella lista", eccetera.
Io credo che un capo di governo che dica "facciamo la rivoluzione vera... facciamo fuori il Palazzo di Giustizia di Milano" si renda semplicemente colpevole di tradimento nei confronti della Repubblica, e della sua Costituzione, sulla quale ha giurato. Credevo che, se fino ad ora non si è proceduto a denunciarlo e a procedere con una qualche - immagino prevista - forma di impeachment per alto tradimento, fosse perché non era dimostrabile che questo fosse il pensiero del capo del governo. Ora è dimostrato. Nero su bianco, voce e sua riproduzione scritta, comparsa sui giornali del 17 ottobre. Io credo che quando un presidente del Consiglio dichiara che nessuno che non sia un suo "pari" - cioè, immagino, un parlamentare, o un ministro - non ha il diritto di giudicarlo, fa una dichiarazione eversiva, in quanto lesiva dell’articolo 3 della Costituzione. E questa dichiarazione il suddetto presidente l’ha fatta in numerose occasioni, già molti anni fa. È oggi uno dei temi ricorrenti delle conversazioni con Lavitola, anche queste oggi di pubblico dominio .
IO CREDO che se un presidente del Consiglio dimostra di avere ogni genere di rapporti, che lo rendono ricattabile, con un indagato per reati di vario genere, peraltro dichiaratosi latitante; se addirittura ha istigato il suddetto latitante a restare tale; se infine pare all’origine del fatto che costui non viene arrestato, nonostante sia perfettamente reperibile, avendo concesso a una televisione nazionale una pubblica intervista: ebbene questo presidente del Consiglio si rende come sopra colpevole di eversione e tradimento della Costituzione su cui ha giurato, nonché di insulto alla coscienza morale e civile di tutti i suoi concittadini.
Se queste mie credenze sono fondate, allora mi chiedo e vi chiedo se le migliori intelligenze delle discipline giuridiche pertinenti non possano e non debbano farsi autrici di un documento di pubblica accusa, che se anche fosse destinato all’inefficacia pratica, avrebbe comunque una forte efficacia morale, come specchio e riferimento ideale di tutti i cittadini italiani che nella Costituzione si riconoscono, e che l’occupazione del potere da parte di chi la spregia ferisce nel fondamento stesso della loro coscienza e fedeltà alla Repubblica.
NON CI si obietti che questo capo di governo e la sua maggioranza sono al tramonto. Qualunque sia la maggioranza che gli succederà, considerare semplicemente “politica” la differenza fra la fedeltà alla Costituzione e il suo disprezzo, è rendersi complici del massacro, che si sta svolgendo sotto i nostri occhi, della nostra dignità di cittadini, oltre che di quella delle istituzioni di questaRepubblica. Ed è soffocare per sempre la speranza di quel riscatto a partire dal quale soltanto una civiltà nazionale e politica può ricominciare a esistere.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- IL POTERE IN MASCHERA (di Barbara Spinelli).18 ottobre 2011, di Federico La Sala
Il potere in maschera
di Barbara Spinelli (la Repubblica, 18 ottobre 2011)
Che l’Italia fosse un campione anomalo nel novero delle democrazie lo si sapeva già. Ce ne accorgiamo ogni volta che qualche straniero, di sinistra o destra, ci guarda sbigottito - o meglio ci squadra - e dice: "Non è Berlusconi, il rebus. Il rebus siete voi che non sapete metterlo da parte". Tutto questo è noto, e spesso capita di pensare che il fondo sia davvero stato raggiunto, che più giù non si possa scendere.
Invece si può, tutti sappiamo che il fondo, per definizione, può esser senza fondo. C’è sempre ancora un precipizio in agguato, e incessanti sono i bassifondi se con le tue forze non ne esci, magari tirandoti su per i capelli. L’ultimo precipizio lo abbiamo vissuto tra sabato e lunedì. Una manifestazione organizzata in più di 900 città del mondo, indignata contro i governi che non sanno dominare la crisi economica senza distruggere le società, degenera a Roma, solo a Roma, per colpa di qualche centinaio di black bloc che in tutta calma hanno potuto preparare un attacco bellico congegnato alla perfezione, condurlo impunemente per ore, ottenere infine quel che volevano: rovinare una protesta importante, e fare in modo che l’attenzione di tutti - telegiornali, stampa, politici - si concentrasse sulla città messa a ferro e fuoco, sul cosiddetto inferno, anziché su quel che il movimento voleva dire a proposito della crisi e delle abnormi diseguaglianze che produce fra classi e generazioni. Il primo precipizio è questo: torna la questione sociale, e subito è declassata a questione militare, di ordine pubblico.
Il secondo precipizio è la pubblicazione, ieri su Repubblica, di un colloquio telefonico avvenuto nell’ottobre 2009 fra Berlusconi e tale signor Valter Lavitola, detto anche faccendiere o giornalista: un opaco personaggio che il capo del governo tratta come confidente, che la segretaria del premier tranquillizza con deferenza. Nessuno può dirgli di no, perché sempre dice: "Mi manda il Capo". Lo si tocca con mano, il potere - malavitosamente sommerso - che ha sul premier e dunque sulla Politica. È a lui che Berlusconi dice la frase, inaudita: "Siamo in una situazione per cui o io lascio oppure facciamo la rivoluzione, ma vera... Portiamo in piazza milioni di persone, cacciamo fuori il palazzo di giustizia di Milano, assediamo Repubblica e cose di questo genere". E riferendosi alla sentenza della Consulta che gli ha appena negato l’impunità: "Hai visto la Corte costituzionale? ha detto che io conto esattamente come i ministri".
Lavitola non è un eletto, né (suppongo) una gran mente. Ma un’autorità la possiede, se è a lui che il premier confida il proposito di ricorrere al golpe che disarticola lo Stato. È una vecchia tentazione che da sempre apparenta il suo dire a quello dei brigatisti, e per questo la parola prediletta è rivoluzione: contro i magistrati che indagano su possibili suoi reati (già prima che entrasse in politica) o contro i giornali da accerchiare, con forze di polizia o magari usando le ronde inventate dai leghisti. Sono due precipizi - il sequestro di una manifestazione ad opera dei black bloc, l’appello berlusconiano al golpe rivoluzionario - che hanno in comune non poche cose: il linguaggio bellico, le questioni sociali prima ignorate poi dirottate. E non l’esercizio ma la presa del potere; non la piazza democratica ascoltata come a Madrid o New York ma distrutta. Anche l’attacco dei Nerovestiti era inteso ad assediare i giornali su cui scriviamo. A storcere i titoli di prima pagina del giorno dopo, a imporci bavagli. La guerra fa precisamente questo, specie se rivoluzionaria. Nazionalizza le esistenze, le frantuma separandole in due tronconi: da una parte gli individui spaventati che si rifugiano nel chiuso casalingo; dall’altra la società declassata, chiamata a compattarsi contro il nemico. Scompare la vita civile, e con essa lo spazio di discussione democratica, l’agorà. Tra il Capo militare e la folla: il nulla. È la morte della politica.
Dovremmo aprire gli occhi su queste cateratte; su questo alveo fiumano che digrada da anni ininterrottamente. Dovremmo non stancarci mai di vedere nel conflitto d’interessi il male che ci guasta interiormente, e non accettarlo mai più: quale che sia il manager che con la scusa della politica annientata si farà forte della propria estraneità alla politica. Dovremmo dirla meglio, la melmosa contiguità fra i due atti di guerra: le telefonate in cui Berlusconi si affida a un buio trafficante aggirando tutti i poteri visibili, e i black bloc che sequestrano i manifestanti ferendone le esasperate speranze. Tra le somiglianze ce n’è una, che più di tutte colpisce: ambedue i poteri sono occulti. Ambedue sono incappucciati.
È dagli inizi degli anni ’80 che andiamo avanti così, con uno Stato parallelo, subacqueo, che decide sull’Italia. Peggio: è dalla fine degli anni ’70, quando i 967 affiliati-incappucciati della loggia massonica P2 idearono il "Piano di Rinascita". Il Paese che oggi abitiamo è frutto di quel Piano, è la rivoluzione berlusconiana pronta a far fuori palazzi di giustizia e giornali. Sono anni che il capo di Fininvest promette la democrazia sostanziale anziché legale (parlavano così le destre pre-fasciste nell’Europa del primo dopoguerra) e sostiene che la sovranità del popolo prevale su tutto. Non è vero: la res publica non è stata in mano al popolo elettore, neanche quando il leader era forte. Sin da principio era in mano a poteri mascherati, a personaggi che il Capo andava a scovare all’incrocio con mafie che di nascosto ricattano, minacciano, non si conoscono l’un l’altra, come nei Piani della P2. Non a caso è sotto il suo regno che nasce una legge elettorale che esautora l’elettore, polverizzando la sovranità del popolo. Non spetta a quest’ultimo scegliere i propri rappresentanti - lo ha ricordato anche il capo dello Stato, il 30 settembre - ma ai cacicchi dei partiti e a clan invisibili. Se ne è avuta la prova nei giorni scorsi, quando Berlusconi ha chiamato i suoi parlamentari a dargli la fiducia: "Senza di me - ha detto - nessuno di voi ha un futuro". Singolare dichiarazione: non era il popolo sovrano a determinare il futuro, nella sua vulgata? Basta una frase così, non tanto egolatrica quanto clanicamente allusiva, per screditare un politico a vita.
La sensazione di piombare sempre più in basso aumenta anche a causa dell’opposizione: del suo attonito silenzio - anche - di fronte alla manifestazione democratica deturpata. D’improvviso non c’è stato più nessuno a difendere gli indignati italiani, e gli incappucciati hanno vinto. Non è rimasto che Mario Draghi, a mostrare passione politica e a dire le parole che aiutano: "I giovani hanno ragione a essere indignati (...) Se la prendono con la finanza come capro espiatorio, li capisco, hanno aspettato tanto: noi all’età loro non l’abbiamo fatto". E proprio perché ha capito, ha commentato amaramente ("È un gran peccato") la manifestazione truffata. Nessun politico italiano ha parlato con tanta chiarezza.
La minaccia alla nostra democrazia viene dagli incappucciati: d’ogni tipo. Vale la pena riascoltare quel che disse Norberto Bobbio, poco dopo la conclusione dell’inchiesta presieduta da Tina Anselmi sulle attività della P2. Il testo s’intitolava significativamente "Il potere in maschera": lo stesso potere che oggi pare circondarci d’ogni parte. Ecco quel che diceva, che tuttora ci dice: "Molte sono le promesse non mantenute dalla democrazia reale rispetto alla democrazia ideale. E la graduale sostituzione della rappresentanza degli interessi alla rappresentanza politica è una di queste. Ma rientra insieme con altre nel capitolo generale delle cosiddette trasformazioni della Democrazia. Il potere occulto no. Non trasforma la Democrazia, la perverte. Non la colpisce più o meno gravemente in uno dei suoi organi vitali, la uccide. Lo Stato invisibile è l’antitesi radicale della Democrazia".
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- Ancora soldi al Vaticano. Con la legge di stabilità che sarà varata oggi il governo rifinanzia scuole private e autotrasporto (di Giorgio Meletti).13 ottobre 2011, di Federico La Sala
 Ancora soldi al Vaticano
Ancora soldi al Vaticano
 Con la legge di stabilità che sarà varata oggi il governo rifinanzia scuole private e autotrasporto
Con la legge di stabilità che sarà varata oggi il governo rifinanzia scuole private e autotrasporto di Giorgio Meletti (il Fatto, 13.10.2011)
di Giorgio Meletti (il Fatto, 13.10.2011)Per le scuole private ci sono 242 milioni di euro. Poi 20 milioni, meglio di niente, per le Università non statali legalmente riconosciute.Per l’autotrasporto 400 milioni. Le rispettive lobby (Vaticano nel primo caso, Confcommercio a nome degli altri nel secondo) festeggiano. La legge di stabilità che questa mattina va all’approvazione del Consiglio dei ministri rispetta alcuni debiti d’onore, con il governo impegnato, nonostante il convulso clima politico, a pagare alcune cambiali irrevocabili.
I contenuti del disegno di legge sono stati in parte anticipati in serata dall’agenzia Ansa, verosimilmente ispirata dai ministri competenti ansiosi di cantare vittoria, Maria Stella Gelmini dell’Istruzione per le scuole private e Altero Matteoli per i Trasporti. Complessivamente si parla di un’allocazione di risorse per 4.183 milioni di euro, a cui corrisponderanno tagli di spesa di eguale misura, le cui vittime saranno scoperte nei prossimi giorni. Il provvedimento, quello che una volta era la Finanziaria, è snello, di appena 9 articoli, dei quali il primo sul saldo netto da finanziare e l’ultimo sull’entrata in vigore.
NEL DOCUMENTO si fa riferimento alle due manovre estive, e per questo con la legge di Stabilità non ci sono “effetti correttivi sui saldi di finanza pubblica”, si legge nella Relazione Illustrativa. La politica del Tesoro non cambia: “L’azione del governo non può che essere rigorosamente vincolata al mantenimento della stabilità dei conti pubblici”, si legge nella bozza. Tra gli impegni di spesa contenuti nelle bozze anticipate dall’Ansa c’è un miliardo di euro per rifinanziare gli ammortizzatori sociali nel 2012.
Le risorse sono però destinate solo alla cassa integrazione “in deroga”, quella per chi non ne avrebbe diritto stando alla legislazione vigente: ma si tratta proprio delle categorie che in questo momento ne hanno più bisogno.
Le missioni militari internazionali vengono rifinanziate per 700 milioni di euro. Viene prorogato per il 2012 il cosiddetto “bonus produttività”, la tassazione agevolata al 10 per cento per premi, lavoro straordinario e lavoro notturno. La regola vale solo per i redditi fino a 40 mila euro. Viene confermata la dotazione di 400 milioni per il 5 per mille, la parte di tasse che ciascun contribuente può devolvere in favore delle onlus.
Confermato il pugno di ferro sulle spese dei ministeri. Per chi non raggiunge “gli obiettivi” di riduzione della spesa è prevista “una riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni e dei programmi di spesa di ciascun ministero interessato”. Aumenta la cosiddetta flessibilità gestionale della spesa, cioè la possibilità di spostare i fondi da un capitolo di spesa all’altro: “Le rimodulazioni potranno riguardare anche le spese classificate tra quelle non rimodulabili”.
La Gelmini può cantare vittoria anche per l’Università, che otterrebbe secondo la bozza 150 milioni per il diritto allo studio e 400 milioni per aumentare il fondo ordinario di funzionamento dell’Università.
DELUSIONE per il ministro dello Sviluppo economico, Paolo Romani: il fondo aggiuntivo di 1,6 miliardi di euro proveniente dall’asta per le frequenze messe in vendita alle società telefoniche non andrà allo sviluppo della banda larga, ma verrà interamente incamerato per altri scopi: precisamente andrà per metà al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato (cioè alla riduzione del debito pubblico) e l’altra metà a un fondo con diverse finanzlità, tra le quali aiuti all’istruzione e nuove risorse per eventi internazionali.
La relazione tecnica, stando alle bozze, giudica imprescindibile la destinazione di “risorse aggiuntive” ai fondi Fas, quelli per il sostegno allo sviluppo del Mezziogiorno, ma chiarisce che tutto ciò sarà possibile solo a partire dal 2015.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- E’ UNA QUESTIONE COGNITIVA. Una riflessione di Angela Giuffrida.2 ottobre 2011, di Federico La Sala
RIFLESSIONE. ANGELA GIUFFRIDA: LA QUESTIONE MORALE E’ UNA QUESTIONE COGNITIVA *
La questione morale torna d’attualita’ a ondate successive senza mai trovare spiegazioni soddisfacenti e possibili vie d’uscita.
La separazione millenaria fra affettivita’ e ragione ha finora impedito di scorgere la sua derivazione dal sistema di pensiero dominante. Basato sull’assunzione di dati singoli scorporati dal contesto e opposti fra loro, esso da’ origine ad una rappresentazione del mondo popolata da atomi irrelati, in eterno conflitto. Accade cosi’ che la ragione e la morale, assolutizzate ed entizzate perche’ prive di riferimento al corpo che le produce, diventino simili a monadi senza porte ne’ finestre.
Allo stesso modo il singolo si percepisce come un atomo isolato che ricava da se stesso forza e potenza, ignorando il fatto allo stesso tempo elementare e macroscopico che, come tutti i viventi, deve la sua esistenza ad una intricata rete di nessi inscindibili che lo legano alla sua come alle altre specie. L’individuo che scambia le persone per cose ed ha l’infantile convinzione che tutto cio’ che il mondo ospita esiste unicamente per soddisfare i suoi desideri - il furbo per intenderci, a cui nelle societa’ androcentriche si attribuisce una intelligenza acuta e penetrante -, si muove in un orizzonte mentale ristretto e alla lunga il suo sguardo limitante finira’ per nuocere anche a lui.
La questione morale altro non e’ che l’estrinsecazione di categorie mentali parziali e riduttive. L’evidente diffusione capillare del binomio irrazionalita’-disumanizzazione nelle comunita’ in cui viviamo, ne costituisce la prova provata. D’altronde il fondamento di tutte le societa’ patrifocali, senza eccezioni, e’ l’immorale sfruttamento del lavoro di cura, irrazionale perche’ imprescindibile per la nostra sopravvivenza e perche’ si situa alla base dell’evoluzione cerebrale di noi mammiferi, come autorevoli ricerche in tutto il mondo confermano. La sua collocazione in un mondo a parte - privato, inferiore e di pertinenza esclusivamente femminile - ha precluso agli uomini quelle esperienze affettivo-cognitive adatte a sviluppare una mente aperta e contenitiva, in grado di cogliere la ricchezza e la complessita’ del reale.
*
[Ringraziamo Angela Giuffrida (per contatti: frida43@inwind.it) per questo intervento.
"Angela Giuffrida, gia’ docente di filosofia, ha avviato una riflessione critica sul sistema concettuale dominante che ha portato all’elaborazione di una nuova teoria della conoscenza, contenuta nel saggio Il corpo pensa. Umanita’ o femminita’?, pubblicato nel 2002 da Prospettiva Edizioni, e applicata nel saggio La razionalita’ femminile unico antidoto alla guerra, pubblicato a marzo del corrente anno da Bonaccorso editore. ’E’ in atto nel panorama culturale internazionale uno slittamento verso un diverso paradigma interpretativo che non ha trovato adeguata definizione. La teoria del corpo pensante risponde a tale necessita’. Non si arresta alla denuncia dei limiti e delle lacune del sapere convenzionale ma, evidenziando i meccanismi mentali sottesi, indica la via del loro superamento. Per promuovere la transizione da una impostazione mentale che coarta la vitale creativita’ della specie ad una che la favorisce, Angela Giuffrida ha promosso corsi di studio e seminari, ha partecipato a convegni e ha scritto numerosi articoli’"]
*
LA DOMENICA DELLA NONVIOLENZA
Supplemento domenicale de "La nonviolenza e’ in cammino"
Direttore responsabile: Peppe Sini. Redazione: strada S. Barbara 9/E, 01100
Viterbo, tel. 0761353532, e-mail: nbawac@tin.it
Numero 267 del 2 ottobre 2011
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. AL GOVERNO DELLA CHIESA ---- Ratzinger ha fallito. Un brano del nuovo libro di Hans Küng “Salviamo la Chiesa” (Rizzoli). Il saggio del teologo Küng affronta gli abusi sessuali e la crisi del cattolicesimo.1 ottobre 2011, di Federico La Sala
 Il manifesto di Küng per una nuova Chiesa.
Il manifesto di Küng per una nuova Chiesa.
 "Ratzinger ha fallito"
"Ratzinger ha fallito" Anticipiamo un brano del nuovo libro di Hans Küng “Salviamo la Chiesa” (Rizzoli) Il saggio del
teologo Küng affronta gli abusi sessuali e la crisi del cattolicesimo.
Anticipiamo un brano del nuovo libro di Hans Küng “Salviamo la Chiesa” (Rizzoli) Il saggio del
teologo Küng affronta gli abusi sessuali e la crisi del cattolicesimo.
 Quello che rende malata la
situazione attuale è il monopolio del potere e della verità, il clericalismo, la sessuofobia e la
misoginia. Il papato deve essere rinnovato, ai sacerdoti non si può negare il calore di una famiglia
ed è necessaria l’ordinazione femminile.
Quello che rende malata la
situazione attuale è il monopolio del potere e della verità, il clericalismo, la sessuofobia e la
misoginia. Il papato deve essere rinnovato, ai sacerdoti non si può negare il calore di una famiglia
ed è necessaria l’ordinazione femminile.di Hans Küng (La Repubblica, 01.10.2011)
Nella situazione attuale non posso assumermi la responsabilità di tacere: da decenni, con successo alterno e, nell’ambito della gerarchia cattolica, modesto, richiamo l’attenzione sulla grande crisi che si è sviluppata all’interno della Chiesa, di fatto una crisi di leadership. È stato necessario che emergessero i numerosi casi di abusi sessuali in seno al clero cattolico.
Abusi occultati per decenni da Roma e dai vescovi in tutto il mondo, perché questa crisi si palesasse agli occhi di tutti come una crisi sistemica che richiede una risposta su basi teologiche. La straordinaria messinscena delle grandi manifestazioni e dei viaggi papali (organizzati di volta in volta come "pellegrinaggi" o "visite di Stato"), tutte le circolari e le offensive mediatiche non riescono a creare l’illusione che non si tratti di una crisi durevole. Lo rivelano le centinaia di migliaia di persone che solo in Germania nel corso degli ultimi tre anni hanno abbandonato la Chiesa cattolica, e in genere la distanza sempre maggiore della popolazione rispetto all’istituzione ecclesiastica.
Lo ripeto: avrei preferito non scrivere questo testo.
E non l’avrei scritto:
 1) se si fosse avverata la speranza che papa Benedetto avrebbe indicato alla Chiesa e a tutti i
cristiani la strada per proseguire nello spirito del concilio Vaticano. L’idea era nata in me durante
l’amichevole colloquio di quattro ore avuto con il mio ex collega di Tubinga a Castel Gandolfo, nel
2005. Ma Benedetto XVI ha continuato con testardaggine sulla via della restaurazione tracciata dal
suo predecessore, prendendo le distanze dal concilio e dalla maggioranza del popolo della Chiesa in
punti importanti e ha fallito riguardo agli abusi sessuali dei membri del clero in tutto il mondo;
1) se si fosse avverata la speranza che papa Benedetto avrebbe indicato alla Chiesa e a tutti i
cristiani la strada per proseguire nello spirito del concilio Vaticano. L’idea era nata in me durante
l’amichevole colloquio di quattro ore avuto con il mio ex collega di Tubinga a Castel Gandolfo, nel
2005. Ma Benedetto XVI ha continuato con testardaggine sulla via della restaurazione tracciata dal
suo predecessore, prendendo le distanze dal concilio e dalla maggioranza del popolo della Chiesa in
punti importanti e ha fallito riguardo agli abusi sessuali dei membri del clero in tutto il mondo;
 2) se i vescovi si fossero davvero fatti carico della responsabilità collegiale nei confronti dell’intera
Chiesa conferita loro dal concilio e si fossero espressi in questo senso con le parole e con i fatti. Ma
sotto il pontificato di Wojtyla e Ratzinger la maggior parte di loro è tornata al ruolo di funzionari,
semplici destinatari degli ordini vaticani, senza dimostrare un profilo autonomo e un’assunzione di
responsabilità: anche le loro risposte ai recenti sviluppi all’interno della Chiesa sono state titubanti e
poco convincenti;
2) se i vescovi si fossero davvero fatti carico della responsabilità collegiale nei confronti dell’intera
Chiesa conferita loro dal concilio e si fossero espressi in questo senso con le parole e con i fatti. Ma
sotto il pontificato di Wojtyla e Ratzinger la maggior parte di loro è tornata al ruolo di funzionari,
semplici destinatari degli ordini vaticani, senza dimostrare un profilo autonomo e un’assunzione di
responsabilità: anche le loro risposte ai recenti sviluppi all’interno della Chiesa sono state titubanti e
poco convincenti;
 3) se la categoria dei teologi si fosse opposta con forza, pubblicamente e facendo fronte comune,
come accadeva un tempo, alla nuova repressione e all’influsso romano sulla scelta delle nuove
generazioni di studiosi nelle facoltà universitarie e nei seminari. Ma la maggior parte dei teologi
cattolici nutre il fondato timore che, a trattare criticamente in modo imparziale i temi divenuti tabù
nell’ambito della dogmatica e della morale, si venga censurati e marginalizzati. Solo pochi osano
sostenere la KirchenVolksBewegung, il Movimento popolare per la riforma della Chiesa cattolica
diffuso a livello internazionale. E non ricevono sufficiente sostegno nemmeno dai teologi luterani e
dai capi di quella Chiesa perché molti di loro liquidano le domande di riforma come problemi
interni al cattolicesimo e nella prassi qualcuno talvolta antepone i buoni rapporti con Roma alla
libertà del cristiano.
3) se la categoria dei teologi si fosse opposta con forza, pubblicamente e facendo fronte comune,
come accadeva un tempo, alla nuova repressione e all’influsso romano sulla scelta delle nuove
generazioni di studiosi nelle facoltà universitarie e nei seminari. Ma la maggior parte dei teologi
cattolici nutre il fondato timore che, a trattare criticamente in modo imparziale i temi divenuti tabù
nell’ambito della dogmatica e della morale, si venga censurati e marginalizzati. Solo pochi osano
sostenere la KirchenVolksBewegung, il Movimento popolare per la riforma della Chiesa cattolica
diffuso a livello internazionale. E non ricevono sufficiente sostegno nemmeno dai teologi luterani e
dai capi di quella Chiesa perché molti di loro liquidano le domande di riforma come problemi
interni al cattolicesimo e nella prassi qualcuno talvolta antepone i buoni rapporti con Roma alla
libertà del cristiano.Come in altre discussioni pubbliche, anche nei più recenti dibattiti sulla Chiesa cattolica e le altre Chiese la teologia ha avuto un ruolo ridotto e si è lasciata sfuggire la possibilità di reclamare in modo deciso le necessarie riforme.
Da più parti mi pregano e mi incoraggiano di continuo a prendere una posizione chiara sul presentee il futuro della Chiesa cattolica. Così, alla fine, invece di pubblicare articoli sparsi sulla stampa, mi sono deciso a redigere uno scritto coeso ed esauriente per illustrare e motivare ciò che, dopo un’attenta analisi, considero il nocciolo della crisi: la Chiesa cattolica, questa grande comunità di credenti, è seriamente malata e la causa della sua malattia è il sistema di governo romano che si è affermato nel corso del secondo millennio superando tutte le opposizioni e regge ancora oggi. I suoi tratti salienti sono, come sarà dimostrato, il monopolio del potere e della verità, il giuridismo e il clericalismo, la sessuofobia e la misoginia e un uso della forza religioso e anche profano. Il papato non deve essere abolito, bensì rinnovato nel senso di un servizio petrino orientato alla Bibbia.
Quello che deve essere abolito, invece, è il sistema di governo medievale romano. La mia "distruzione" critica è perciò al servizio della "costruzione", della riforma e del rinnovamento, nella speranza che la Chiesa cattolica, contro ogni apparenza, si mantenga vitale nel terzo millennio.
[* * *]
Certamente alcuni sacerdoti vivono la loro condizione di celibato apparentemente senza grossi problemi e molti, a causa dell’enorme carico di lavoro che grava su di loro, non sarebbero quasi in grado di preoccuparsi di una vita di coppia o di una famiglia. Viceversa, il celibato obbligatorio porta anche a vivere situazioni insostenibili: parecchi sacerdoti desiderano ardentemente l’amore e il calore di una famiglia, ma nel migliore dei casi possono solo tenere nascosta un’eventuale relazione, che in molti luoghi diventa un "segreto" più o meno pubblico. Se poi da una relazione nascono dei figli, le pressioni provenienti dall’alto inducono a tenerli nascosti con conseguenze devastanti sulla vita degli interessati.
La correlazione tra gli abusi sessuali dei membri del clero a danno di minori e la legge sul celibato è continuamente negata, ma non si può fare a meno di notarla: la Chiesa monosessuale che ha imposto l’obbligo del celibato ha potuto allontanare le donne da tutti i ministeri, ma non può bandire la sessualità dalle persone accettando così, come spiega il sociologo cattolico della religione FranzXaver Kaufmann, il rischio della pedofilia. Le sue parole sono confermate da numerosi psicoterapeuti e psicanalisti.
È auspicabile che sia reintrodotto il diaconato femminile, ma tale misura, da sola, è insufficiente: se non viene accompagnata dal permesso di accedere al presbiterato (sacerdozio), non condurrebbe a una equiparazione dei ruoli bensì a un differimento dell’ordinazione femminile. Un servizio che dà loro la stessa dignità degli uomini, completamente diverso dalla posizione e dalla funzione subalterna che recentemente ricoprono numerose donne dei "movimenti" nell’ambito della curia romana. Che in seno alla Chiesa cattolica la resistenza, e in determinate circostanze anche la disobbedienza, possano pagare, è dimostrato dall’esempio delle chierichette. Anni fa, il Vaticano vietò a bambine e ragazze di servir messa. L’indignazione del clero e del popolo cattolico fu grande e in molte parrocchie si continuò semplicemente a tenerle. A Roma la situazione venne da principio tollerata, infine accettata. Così cambiano i tempi. Anzi, un articolo uscito il 7 agosto 2010 sull’Osservatore Romano ha elogiato questa evoluzione come il superamento di un’importante frontiera poiché oggi non si può più ascrivere alla donna alcuna "impurità" e in questo modo è stata eliminata una "disuguaglianza profonda". Quanto tempo ci vorrà ancora perché in Vaticano capiscano che lo stesso argomento vale per la consacrazione sacerdotale, meglio l’ordinazione femminile? Molto dipende dalla posizione e dall’impegno dei vescovi.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- PURIFICARE L’ARIA. La Chiesa boccia Berlusconi. Al Consiglio permanente della Cei il cardinale Bagnasco attacca senza mezzi termini le sue indecorose esibizioni, che “ammorbano l’aria”.(di Marco Politi)27 settembre 2011, di Federico La Sala
Purificare l’aria
di Marco Politi (il Fatto Quotidiano, 27 settembre 2011)
La Chiesa boccia Berlusconi. Al Consiglio permanente della Cei il cardinale Bagnasco attacca senza mezzi termini le sue indecorose esibizioni, che “ammorbano l’aria”. I suoi comportamenti “licenziosi” sono contrari al pubblico decoro e danneggiano il Paese all’interno e all’estero. Il Cavaliere non è mai chiamato per nome, ma ogni epiteto, ogni aggettivo si attaglia all’uomo che si è definito premier a tempo perso e il cui programma conclamato è: “la patonza deve girare”.
Stili di vita contro il decoro
DI FRONTE al malumore crescente della base cattolica, dinanzi alla rabbia dei fedeli pressati dalla crisi il vertice della Cei non ha potuto tacere. Il telegramma papale a Napolitano giovedì scorso, in cui Benedetto XVI auspicava un deciso “rinnovamento etico per il bene della diletta Italia”, era già un segnale diallarmecheperlagerarchiaecclesiastica la misura era colma. Bagnasco nella sua relazione al direttivo dell’episcopato lo ha riempito di contenuti. Il presidente della Cei è partito denunciando il clima di insicurezza sociale, causato da una crisi iniziata ben tre anni fa e che non si era voluta capire. Ciò che si sta facendo (leggi: da parte del governo) non è sufficiente, per non parlare del “metodo scombinato con cui si procede”. Poi è stato un crescendo.
Mortifica, ha detto, il deteriorarsi del costume e del linguaggio pubblico. Mortifica il dover prendere atto di “comportamenti non solo contrari al pubblico decoro, ma intrinsecamente tristi e vacui”. Bagnasco ha ricordato che ricoprire una carica pubblicarichiede,comevuolela Costituzione,“misuraesobrietà, disciplina e onore”. Si rincorrono racconti, ha proseguito, che se comprovati “rilevano stili di vita difficilmente compatibili con la dignità delle persone e il decoro delle istituzioni e della vita pubblica”. Colpisce, ha incalzato, l’esibizione.
Comportamenti licenziosi
E BENCHÉ il cardinale non sfuggaallatentazionedicriticare le troppe intercettazioni e le troppe cronache dedicate al tema, in ultima analisi scandisce: “Nessun equivoco...la responsabilità morale ha una gerarchia interna che si evidenzia da sé, a prescindere dalle strumentalizzazioni... I comportamenti licenziosi e le relazioni improprie sono in se stessi negativi e producono un danno sociale a prescindere dalla loro notorietà. Ammorbano l’aria e appesantiscono il cammino comune”. Da una “situazione abnorme”, insiste, si genera una spirale che deteriora l’equilibrio della società. Sotto il peso della crisi, che grava sulle famiglie, non si possono “assecondare scelte dissipatorie e banalizzanti”. La collettività guarda “con sgomento” a quanto avviene sulla scena politica e l’immagine del Paese all’esterno ne viene “pericolosamente fiaccata”.
La questione morale non è un’invenzione
URGONO , martella Bagnasco, comportamenti esemplari. La “questione morale - rimarca è un’invenzione mediatica: nella dimensione politica, come in ciascun altro ambito privato o pubblico, essa è un’evenienza grave”, che suscita un senso di urgenza. Non si può propagare l’immagine di un’ “esistenza facile e gaudente” nel momento in cui servono serietà e sacrificio. “C’è da purificare l’aria - esclama il presidente della Cei - perché nuove generazioni non restino avvelenate”. Servono trasparenza ed equità.
Per non restare solamente nel-l’ambito della denuncia politico-morale Bagnasco entra anche nei particolari più penosi dell’azione o inazione del governo Berlusconi. “Non si capisce - accusa - che legittimazione possano avere in un consorzio democratico i comitati d’affari, che si autoimpongono attraverso il reticolo clientelare” e generano costi maggiorati per la collettività
Due anni di ritardo
di Marco Politi (il Fatto Quotidiano, 27 settembre 2011)
La Chiesa molla Berlusconi. Dopo la Confindustria anche la gerarchia ecclesiastica si accorge che il Paese non può andare avanti così. Il carico di accuse che il cardinale Bagnasco nuove al premier è infamante soltanto a elencarle. Comportamenti indecorosi, licenziosi, tristi, vacui. Incompatibili con la dignità delle persone e delle istituzioni. Relazioni improprie che fanno danno a prescindere dalla notorietà. Esibizioni che danneggiano la società e il credito dell’Italia all’estero. Una situazione che “ammorba l’aria”.
Dunque avevano ragione i cittadini di ogni credo e il popolo delle parrocchie, quando denunciavano il prolungato silenzio della Chiesa. Avevano ragione a porre la questione morale, che oggi Bagnasco riconosce non essere un’invenzione mediatica. Non erano faziosi dell’antiberlusconismo quanti da anni denunciavano il profondo danno causato da un premier, vergogna dell’Italia, colpevolmente inerte nel combattere corruzione, comitati d’affari ed evasione fiscale.
È troppo chiedere ai vertici ecclesiastici perché hanno tardato tanti anni a dire basta? È, al più tardi, dall’anno 2009 - l’anno di Noemi e dell’ignobile decapitazione di Boffo - che ognuna delle parole impiegate nella relazione del presidente della Cei potevano essere scandite. Anche i vertici ecclesiastici portano la loro responsabilità nell’aver puntellato per troppo tempo chi portava l’Italia al baratro.
Nella sua relazione il cardinale Bagnasco si distacca prudentemente dai progetti vaticani di una nuova Dc. La Cei sembra puntare su un “soggetto culturale e sociale” che si confronta con la politica. Per rinascere l’Italia ha bisogno delle migliori energie di credenti e diversamente credenti. Meglio se convergenti. Un modesto suggerimento: i vertici ecclesiastici lascino liberi i cattolici nel loro impegno politico. Non pretendano di teleguidarli o intrupparli. Sono adulti. Faranno le scelte che credono giuste.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- Accuso papa Benedetto per il suo micidiale raggiro dell’umanità. Intervista a Uta Ranke-Heinemann (di Elisabeth Lind)23 settembre 2011, di Federico La Sala
“Tutti i pastori sono uomini, tutte le donne sono pecore”
intervista a Uta Ranke-Heinemann, a cura di Elisabeth Lind
in “dersstandard.at” del 22 settembre 2011 (traduzione: www.finesettimana.org)
Papa Benedetto visita la Germania, suo paese natale. Sei anni fa i tedeschi esultavano per il “loro” papa, ora gli viene preparata solo una “tiepida” accoglienza. Perché i tedeschi hanno perso il loro entusiasmo?
Non è solo “tiepida accoglienza”, c’è piuttosto una vivace protesta. Credo che la cosa peggiore che questo papa si sia permesso, è la faccenda dei casi di abuso. Infatti dal 2001 ad oggi non ha ancora ritirato il suo scritto “De Delictis gravioribus” (Sui delitti più gravi).
 In quello scritto, a cui lei ha appena fatto riferimento, si parla di una lettera che Ratzinger
nelle sue funzioni come prefetto della congregazione per la dottrina della fede (ex inquisizione)
ha inviato a tutti i vescovi.
In quello scritto, a cui lei ha appena fatto riferimento, si parla di una lettera che Ratzinger
nelle sue funzioni come prefetto della congregazione per la dottrina della fede (ex inquisizione)
ha inviato a tutti i vescovi.Esattamente. Non una parola per le vittime. A tutti i vescovi si intima, pena la scomunica, di trasmettere tutti i casi di abuso esclusivamente al Vaticano come corte di giustizia apostolica, il che ha come conseguenza la totale impossibilità di attivare procedimenti giudiziari per i tribunali degli Stati, e porta ad un continuo trasferimento dei preti e dei religiosi pedofili, che dopo una “terapia” continuano a perpetrare per decenni i loro crimini. Tale scritto non lo ha finora ritirato. Solo, di tanto in tanto, versa lacrime di coccodrillo, quando incontra in vari paesi vittime di abusi.
 Tuttavia, un anno fa, Joseph Ratzinger ha presentato per la prima volta come papa le sue
scuse alle vittime e ha promesso che sarebbe stato fatto di tutto per evitare che gli abusi si
ripetessero. Lei crede a questo cambiamento?
Tuttavia, un anno fa, Joseph Ratzinger ha presentato per la prima volta come papa le sue
scuse alle vittime e ha promesso che sarebbe stato fatto di tutto per evitare che gli abusi si
ripetessero. Lei crede a questo cambiamento?No, questo papa cambia solo di male in peggio. Gli sono stata fedele per più di cinquant’anni, da quando nel 1953/54 abbiamo studiato insieme per un anno a Monaco e ci siamo aiutati reciprocamente a tradurre in latino le nostre rispettive tesi di dottorato. Lo ritenevo un teologo intelligente e riservato. Solo nel 2005, quando è diventato papa, mi si sono aperti gli occhi.
 Allora, crede che la critica attuale dei tedeschi a papa Benedetto XVI dipenda principalmente
dal modo in cui il papa si è occupato dei casi di abuso?
Allora, crede che la critica attuale dei tedeschi a papa Benedetto XVI dipenda principalmente
dal modo in cui il papa si è occupato dei casi di abuso?Certamente. Ma c’è anche una seconda cosa che fa orrore. Per Benedetto XVI i preservativi sono permessi solo “per prostituti maschi”, come dice nel libro del 2010 “Luce del mondo”. Perché pensa a “prostituti maschi”, consegnando invece al fuoco eterno dell’inferno le mogli che usano il preservativo per difendersi dal contagio dell’AIDS? Papa Benedetto coglie ogni occasione per - se non annullare - almeno “ascetizzare”, “eunuchizzare”, “monacheizzare” e “celibatizzare” il matrimonio. Perché non si allontana alla fine dalle camere matrimoniali, che sono diventate nel frattempo il luogo del suo massimo soggiorno per il controllo dei rapporti? Con la sua teologia del preservativo ha pervertito l’annuncio evangelico di Gesù in un annuncio di bordello per prostituti maschi. Al resto della popolazione che non si prostituisce predica il fuoco eterno dell’inferno. Accuso papa Benedetto per il suo micidiale raggiro dell’umanità.
 Perché pensa che così tante persone in tutto il mondo si allontanano dalla Chiesa cattolica?
Perché pensa che così tante persone in tutto il mondo si allontanano dalla Chiesa cattolica?Per 26 anni ho avuto da ridire su papa Giovanni Paolo II. Poi, quando Benedetto è diventato papa, mi è stato chiaro nel giro di un paio di mesi, che tutta la politica del Vaticano già dal 1981 (quando Ratzinger è diventato prefetto della congregazione per la dottrina della fede) dipendeva da Joseph Ratzinger. È stata la più grande delusione della mia vita. Non mi sono mai sbagliata così tanto.
 In Austria c’è una iniziativa, che invita alla rivoluzione dei fedeli e alla disobbedienza al papa.
Tra le altre cose, si chiede l’ammissione delle donne e delle persone sposate al presbiterato, la
comunione per i divorziati risposati ed un cambiamento per il celibato. Anche in Germania c’è
un ampio dialogo a favore di riforme nella Chiesa. Quali opportunità vede per queste
iniziative?
In Austria c’è una iniziativa, che invita alla rivoluzione dei fedeli e alla disobbedienza al papa.
Tra le altre cose, si chiede l’ammissione delle donne e delle persone sposate al presbiterato, la
comunione per i divorziati risposati ed un cambiamento per il celibato. Anche in Germania c’è
un ampio dialogo a favore di riforme nella Chiesa. Quali opportunità vede per queste
iniziative?C’è il rischio di una spaccatura tra chi è in alto e chi è in basso. Tutti quelli che si mettono in testa cappelli da carnevale, dal vescovo al cardinale fino al papa, non vengono più accettati. Ma i semplici preti, che sono sempre pronti ad annunciare la buona notizia di Gesù: “non cercare ricompense, fare del bene ai nemici”, e ad aiutare, e comunque tutte le donne, a poco a poco si staccheranno dai pastori di grado superiore. Da 2000 anni, tutti i pastori sono uomini, tutte le donne pecore. L’allontanamento delle donne sotto gli ultimi due papi ha raggiunto il punto massimo, e anche il punto finale. Una spaccatura tra la gerarchia e il popolo è possibile. (...)
 Uta Ranke-Heinemann è stata la prima donna al mondo ad aver ottenuto una cattedra di teologia
cattolica (1970), che poi ha perso (1987) per i suoi dubbi sull’immacolata concezione. Nel 1953/54
è stata compagna di studi di Joseph Ratzinger a Monaco. I suoi due libri “Eunuchi per il Regno dei
cieli. Chiesa cattolica e Sessualità” e “No! e così sia” sono bestseller internazionali.
Uta Ranke-Heinemann è stata la prima donna al mondo ad aver ottenuto una cattedra di teologia
cattolica (1970), che poi ha perso (1987) per i suoi dubbi sull’immacolata concezione. Nel 1953/54
è stata compagna di studi di Joseph Ratzinger a Monaco. I suoi due libri “Eunuchi per il Regno dei
cieli. Chiesa cattolica e Sessualità” e “No! e così sia” sono bestseller internazionali. -
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- Hans Küng, intervista a “Spiegel”: “La Chiesa è malata del sistema romano”.22 settembre 2011, di Federico La Sala
“La Chiesa è malata del sistema romano”
 di suc/dpa
di suc/dpa
 in “www.spiegel.de” del 18 settembre 2011 (traduzione: www.finesettimana.org)
in “www.spiegel.de” del 18 settembre 2011 (traduzione: www.finesettimana.org)In occasione della visita in Germania del papa, secondo il famoso teologo svizzero ottantatreenne Hans Küng, esiste “una enorme discrepanza tra la facciata che viene costruita e la realtà” della Chiesa. “La vita della Chiesa” a livello di comunità è decisamente crollata in molti paesi, ha detto Küng nell’intervista a “Spiegel”.
Ma “la gerarchia ecclesiastica non ha finora trovato il coraggio, di ammettere onestamente e chiaramente quale sia veramente la situazione.” Di fronte all’ “occultamento dello stato di emergenza”, la diagnosi di Küng è “che la Chiesa è malata del sistema romano”. Le immagini dell’evento papale ingannano, a suo avviso, presentando una Chiesa potente.
“Si sa invece che questi eventi non portano quasi niente alle comunità”, avverte l’ex compagno di Joseph Ratzinger, oggi Papa Benedetto XVI. “Non abbiamo quasi più persone che vengono alle celebrazioni, non abbiamo praticamente più candidati al presbiterato, abbiamo non pochi abbandoni.”
Benedeto XVI visiterà la Germania la prossima settimana. La cancelliera Angela Merkel spera che la visita unisca maggiormente cristiani cattolici ed evangelici. L’ecumenismo è un momento centrale nella visita, ha detto sabato nel suo videomessaggio settimanale la signora Merkel, che è anche capo della CDU. Secondo quanto riferito dal Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, il papa dovrebbe incontrare anche alcune vittime di abusi. A tale incontro dovrebbero partecipare anche persone che si sono prese a cuore il dolore delle vittime, scrive il giornale. Nel frattempo si discute molto sul previsto intervento del papa al Bundestag. Alcuni politici della CDU definivano vergognoso l’annunciato boicottaggio del discorso da parte di deputati dell’opposizione.
Küng critica nell’intervista a “Spiegel” un tale “culto della persona, che è in contrasto con tutto ciò che si legge nel Nuovo Testamento”. “Oggi mi chiedo se non stiamo vivendo in una fase di ’putinizzazione’ della Chiesa cattolica”, dice Küng, perché a suo parere esistono analogie strutturali e politiche tra il presidente russo Vladimir Putin e la politica di restaurazione dei papi in Vaticano dopo il Concilio Ecumenico Vaticano II, che parlava invece di rinnovamento e di dialogo ecumenico.
“Praticamente, sia Ratzinger che Putin hanno messo i loro vecchi collaboratori in posizioni di guida ed allontanato invece altri meno amati”. E “in questo sistema i delatori tornano a crescere”. Ogni parroco favorevole alle riforme, e anche ogni vescovo, deve temere di essere denunciato a Roma. Secondo Küng, la conseguenza è che sotto il papa tedesco alle leve del potere ha potuto mettersi una cricca di “yes-men” prevalentemente italiana, che non ha alcuna considerazione per le esigenze di riforma.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- "FORZA ITALIA"!!! Il monito del Papa per l’Italia:"Serve un rinnovamento etico"22 settembre 2011, di Federico La Sala
 VATICANO
VATICANO Il monito del Papa per l’Italia
Il monito del Papa per l’Italia
 "Serve un rinnovamento etico"
"Serve un rinnovamento etico"ROMA - ’L’auspicio di un sempre più intenso rinnovamento etico per il bene della diletta Italia" è espresso dal Papa nel telegramma al presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, inviato come è tradizione di ogni viaggio internazionale al momento di partire per il viaggio in Germania, il 21esimo del pontificato. Benedetto XVI indirizza "l’auspicio" al Presidente e "all’intero popolo italiano", insieme con un "cordiale saluto".
* la Repubblica, 22 settembre 2011)
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. AL GOVERNO DELLA CHIESA UN PAPA CHE .... ’Non e’ grande filosofo’. Eco contro Ratzinger (Ansa).21 settembre 2011, di Federico La Sala
Eco contro Ratzinger: ’Non e’ grande filosofo’
’Posizioni contro il relativismo grossolane, formazione filosofica debole’ *
BERLINO - "Non credo che Ratzinger sia un grande filosofo, né un grande teologo, anche se generalmente viene rappresentato come tale". Lo ha detto l’intellettuale, linguista e scrittore Umberto Eco in un’intervista al quotidiano tedesco Berliner Zeitung.
"Le sue polemiche, la sua lotta contro il relativismo sono, a mio avviso, semplicemente molto grossolane - ha commentato Eco riferendosi ancora a Benedetto XVI -, nemmeno uno studente della scuola dell’obbligo le formulerebbe come lui. La sua formazione filosofica è estremamente debole".
Per argomentare il suo giudizio Eco fa riferimento proprio alla questione del relativismo in una risposta diretta al suo intervistatore: "In sei mesi potrei organizzarle un seminario sul tema. E può starne certo: alla fine presenterei almeno 20 posizioni filosofiche differenti sul relativismo.
Metterle tutte insieme come fa papa Benedetto, come se ci fosse una posizione unitaria è, per me, estremamente naif".
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- Lo strano silenzio della Chiesa (di Barbara Spinelli)..21 settembre 2011, di Federico La Sala
Lo strano silenzio della Chiesa
di Barbara Spinelli (la Repubblica, 21 settembre 2011)
Il sostegno che i vertici della Chiesa continuano a dare a Berlusconi è non solo uno scandalo, ma sta sfiorando l’incomprensibile. Che altro deve fare il capo di governo, perché i custodi del cattolicesimo dicano la nuda parola: «Ora basta»? Qualcosa succede nel loro animo quando leggono le telefonate di un Premier che traffica favori, nomine, affari, con canaglie e strozzini? Non sono sufficienti le accuse di aver prostituito minorenni, di svilire la carica dimenticando la disciplina e l’onore cui la Costituzione obbliga gli uomini di Stato? Non basta il plauso a Dell’Utri, quando questi chiamò eroe un mafioso, Vittorio Mangano? Cosa occorre ancora alla Chiesa, perché si erga e proclami che questa persona, proprio perché imperterrita si millanta cristiana, è pietra di scandalo e arreca danno immenso ai fedeli, e allo Stato democratico unitario che tanti laici cattolici hanno contribuito a costruire?
Un tempo si usava la scomunica: neanche molto tempo fa, nel ’49, fu scomunicato il comunismo (il fascismo no, eppure gli italiani soffrirono il secondo, non il primo). Se Berlusconi non è uomo di buona volontà, e tutto fa supporre che non lo sia, la Chiesa usi il verbo. Ha a suo fianco la lettera di Paolo ai Corinzi: «Vi ho scritto di non mescolarvi con chi si dice fratello, ed è immorale o avaro o idolatra o maldicente o ubriacone o ladro; con questi tali non dovete neanche mangiare insieme. Spetta forse a me giudicare quelli di fuori? Non sono quelli di dentro che voi giudicate? Quelli di fuori li giudicherà Dio. Togliete il malvagio di mezzo a voi!».
Anche l’omissione è complicità. Sta accadendo l’intollerabile dal punto di vista morale, in politica, e i vertici della Chiesa tacciono: dunque consentono. Si può scegliere l’afonia, certo, o il grido inarticolato di disgusto: sono moti umani, ma che bisogno c’è allora di essere papa o vescovo? (avete visto, in Vaticano, Habemus Papam?). Dicono che parole inequivocabili son state dette: «desertificazione valoriale», «società dei forti e dei furbi», «cultura della seduzione». Ma sono analisi: manca la sintesi, e le analisi stesse son fiacche. D’un sol fiato vengono condannati gli eccessi dei magistrati, pareggiando ignominiosamente le condanne. Da troppo tempo questo è, per tanti laici cattolici scandalizzati ma non uditi, incomprensibile. Quasi che il ritardo nella presa di coscienza fosse ormai connaturato nella Chiesa. Quasi che l’espiazione (penso ai mea culpa di Giovanni Paolo II, nobili ma pur sempre tardivi) fosse più pura e santa che semplicemente non fare il male: qui, nell’ora che ci si spalanca davanti.
Un gesto simile a quello di Cristo nel tempio, un no inconfondibile, allontanerebbe Berlusconi dal potere in un attimo. Alcuni veramente prezzolati resterebbero nel clan. Ma la maggior parte non potrebbero mangiare insieme a lui, senza doversi ogni minuto giustificare. Non è necessario che l’espulsione sia resa subito pubblica, anche se lo sapete, uomini di Chiesa: c’è un contagio, del male e del malaffare. Forse basterebbe che un alto prelato vada da Berlusconi, minacci l’arma ultima, la renda nota a tutti. Questa è l’ora della parresia, del parlar chiaro: la raccomanda il Vangelo, nelle ore cruciali.
Sarebbe un’interferenza non promettente per il futuro, lo so. Ma l’interferenza è una prassi non disdegnata in Vaticano, e poi non dimentichiamolo: già l’Italia è governata da podestà stranieri in questa crisi (Mario Monti l’ha scritto sul Corriere: «Le decisioni principali sono prese da un «governo tecnico sopranazionale»), e Berlusconi d’altronde vuole che sia così per non assumersi responsabilità.
Resta che gli alleati europei possono poco. E una maggioranza che destituisca Berlusconi ancora non c’è in Parlamento. Lo stesso Napolitano può poco, ma la sua calma è d’aiuto, nel mezzo del fragore di chi teme chissà quali marasmi quando il Premier cadrà. Il marasma postberlusconiano è fantasia cupa e furba, piace a chi Berlusconi ce l’ha ormai nelle vene. Il marasma, quello vero, è Berlusconi che non governa la crisi ma si occupa di come evitare i propri processi: tanti processi, sì, perché di tanti reati è sospettato. L’Italia è un battello ebbro, il capitano è un simulacro. Non ci sonocongiure di magistrati, per indebolire la carica. Il trono è già vuoto. Il pubblico ministero, organo dello Stato che rappresenta l’interesse pubblico, deve per legge esercitare l’azione penale, ogni qualvolta abbia notizia di un reato, e in molte indagini Berlusconi è centrale: come corruttore o vittima-complice di ricatti. Gli italiani non possono permettersi un timoniere così. Se sono economicamente declassati, la colpa è essenzialmente sua.
Berlusconi non farà passi indietro, gli oppositori si ridicolizzano implorandolo senza mai cambiare copione. Oppure vuole qualcosa in cambio, e anche questo sarebbe vituperio dell’Italia. Il salvacondotto proposto da Buttiglione oltraggia la Costituzione. Casini lo ha smentito: «Sarebbe tecnicamente e giuridicamente impossibile perché siamo in uno Stato di diritto». Perché la Chiesa non dice basta? Si dice «impressionata» dalle cifre dell’evasione fiscale, ma la vecchia domanda di Prodi resta intatta: «Perché, quando vado a messa, questo tema non è mai toccato nelle omelie? Eppure ha una forte carica etica» (Famiglia cristiana, 5-8-07). E come si spiega tanta indulgenza verso Berlusconi, mentre Prodi fu accusato di voler essere cristiano adulto?
Pare che sia la paura, ad attanagliare i vertici ecclesiastici: paura di perdere esenzioni fiscali, sovvenzioni. Berlusconi garantisce tutto questo ma da mercante, e mercanti sono quelli che con lui mercanteggiano, di quelli che Cristo cacciò dal tempio rovesciandone i banchi. E siete proprio sicuri di perdere privilegi? Tra gli oppositori vi sono persone a sufficienza, purtroppo, che non ve li toglieranno. Paura di un cristianesimo che in Italia sarebbe saldamente ancorato a destra? Non è vero. Non posso credere che lo spauracchio agitato da Berlusconi (un regime ateo-comunista) abbia ancora presa. Oppure sì? Penso che la Chiesa sia alle prese con la terza e più grande tentazione.
Alcuni la chiamano satanica, perché di essa narra il Vangelo, quando enumera le prove cui Cristo fu sottoposto: la prova della ricchezza, del regno sui mondi: «Tutte queste cose ti darò, se prostrandoti mi adorerai». La Chiesa sa la replica di Gesù.
Il Papa ha detto cose importanti sulla crisi. Che agli uomini vengon date pietre al posto del pane (Ancona, 11 settembre). La soluzione spetta a politici che arginino i mercati con la loro autorevolezza. Non saranno mai autorevoli, se ignorano la quintessenza della decenza umana che è il Decalogo. Ma neanche la Chiesa lo sarà. Diceva Ilario di Poitiers all’imperatore Costanzo, nel IV secolo dC: «Noi non abbiamo più un imperatore anticristiano che ci perseguita, ma dobbiamo lottare contro un persecutore ancora più insidioso, un nemico che lusinga; non ci flagella la schiena ma ci accarezza il ventre; non ci confisca i beni (dandoci così la vita), ma ci arricchisce per darci la morte; non ci spinge verso la libertà mettendoci in carcere, ma verso la schiavitù invitandoci e onorandoci nel palazzo; non ci colpisce il corpo, ma prende possesso del cuore; non ci taglia la testa con la spada, ma ci uccide l’anima con il denaro».
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. AL GOVERNO DELLA CHIESA UN PAPA CHE PREDICA CHE GESU’ E’ IL FIGLIO DEL DIO "MAMMONA" ("Deus caritas est") E AL GOVERNO DELL’ **ITALIA** UN PRESIDENTE DI UN PARTITO (che si camuffa da "Presidente della Repubblica"), che canta "Forza Italia" con il suo "Popolo della libertà" (1994-2011). Questo è il nodo da sciogliere. Materiali sul tema - di Federico La Sala21 settembre 2011, di John Mazzei
Il prezzo del celibato obbligatorio dei sacerdoti “porta ad azioni legali per l’accertamento della paternità, amanti, maggiore attività omosessuale fra ecclesiastici e seminaristi, solitudine e in alcuni casi pedofilia”. Questa, secondo il National Catholic Reporter, è la sostanza dell’allarme dato da Joe Sternak, ex sacerdote cattolico dell’arcidiocesi di Chicago (Stati Uniti), a proposito del celibato durante una recente conferenza annuale. Sternak, che sta scrivendo un libro sulla pedofilia, afferma che le diocesi di oltre 20 stati usano le donazioni fatte alla chiesa per pagare i procedimenti penali e le transazioni amichevoli per casi di abusi sessuali da parte di sacerdoti ai danni di bambini.
In meno di 300 anni, il campo di grano del cristianesimo era stato infestato dalle zizzanie, anticristi apostati, finché, con l’entrata in scena di Costantino il Grande (colpevole dell’assassinio di almeno sette intimi amici e familiari), si arrivò all’istituzione di una religione di stato mascherata da “cristianesimo”.
“Gli uomini hanno scoperto che è molto più conveniente adulterare la verità che raffinare se stessi”. Charles Caleb Colton, ecclesiastico inglese del XIX secolo quando una religione diventa oggetto di complicata erudizione metafisica, la sua vera vitalità come fede si va perdendo”. - World Encyclopedia (giapponese).
Le persone che in Europa vanno ancora in chiesa di solito non ci vanno per scoprire cosa Dio richiede da loro. Un articolo dall’Italia dice: “Gli italiani si costruiscono una religione su misura che sia adatta al loro stile di vita”. E un sociologo italiano afferma: “Dal papa prendiamo qualunque cosa ci sia congeniale”. Lo stesso si può dire dei cattolici in Spagna, dove la religiosità ha lasciato il posto al consumismo e alla ricerca di un paradiso da ottenere subito, quello economico! Queste tendenze sono in netto contrasto con il cristianesimo insegnato e praticato da Cristo e dai suoi seguaci. Gesù non offrì una religione “self-service” o “a buffet”, in cui ognuno prende ciò che più gli aggrada e scarta quello che non è di suo gradimento. Egli disse: “Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda di giorno in giorno il suo palo di tortura e mi segua di continuo”. Gesù insegnò che il modo di vivere cristiano richiedeva sacrificio e sforzo a livello personale.
Con tutto il rispetto e la stima del mondo; accompagnato, con tanto bene...fino a quando servira’! Dall’Emigrato Integrato da quasi 50 anni.
Mi chiedo! molto spesso...dopo una ponderata e proficua meditazione....SE! La Politica e’ come e’!!! La Religione continua a fare quello che ha’ sempre fatto!!! e il calcio l’hanno smesso di giocarlo!!! ( Chissa’ se la NUTELLA continueranno a farla e venderla!!! (PER COMPRERLA AL MIO NIPOTINO?)
-
> AL GOVERNO DELLA CHIESA ---- «Non credo che Ratzinger sia un grande filosofo, né un grande teologo, anche se generalmente viene rappresentato come tale» (Umberto Eco).20 settembre 2011, di Federico La Sala
Dura critica di Eco al Papa: non è un grande teologo
di Maria Antonietta Calabrò (Corriere della Sera, 20 settembre 2011)
«Non credo che Ratzinger sia un grande filosofo, né un grande teologo, anche se generalmente viene rappresentato come tale». Lo ha affermato, a due giorni dall’inizio del viaggio in Germania di Benedetto XVI, Umberto Eco intervistato dal quotidiano tedesco «Berliner Zeitung» in edicola ieri. «Le sue polemiche, la sua lotta contro il relativismo sono, a mio avviso, semplicemente molto grossolane - ha commentato Eco riferendosi ancora a papa Ratzinger - nemmeno uno studente della scuola dell’obbligo le formulerebbe come lui. La sua formazione filosofica è estremamente debole».
Per argomentare il suo giudizio Eco fa riferimento proprio alla questione del relativismo, che è stata il cuore dell’approccio di Ratzinger al declino della cultura occidentale e in particolare europea. In una risposta diretta al suo intervistatore Eco ha detto: «In sei mesi potrei organizzarle un seminario sul tema. E può starne certo: alla fine presenterei almeno venti posizioni filosofiche differenti sul relativismo. Metterle tutte insieme come fa papa Benedetto, come se ci fosse una posizione unitaria è, per me, estremamente naïf». Eco, infine, ha fatto anche un paragone con Giovanni Paolo II, sostenendo che dopo papa Wojtyla era difficile per Ratzinger essere una «big star».
«Naturalmente Eco è un grande filosofo ed un grande teologo!», commenta con una punta d’ironia Jorg Bremer, vaticanista della «Frankfurter Allgemeine Zeitung», che pochi giorni fa ha intervistato il Papa a Castelgandolfo. «Sono stato da Sua Santità e ho visto in anteprima insieme all’editore Manuel Herder la mostra che, organizzata con la Libreria editrice Vaticana, per la prima volta mette insieme le copertine di 600 diverse edizioni di opere pubblicate in 25 paesi nei 50 anni di attività scientifica dal teologo Joseph Ratzinger, un’esposizione che si sposterà presso la sede della casa editrice a Friburgo, in occasione della visita che il Papa compirà in Germania da giovedì a domenica. Mi chiedo: è questo il teologo e il filosofo con un’educazione troppo debole?». Bremer, che pure è di religione protestante, sostiene «che i due pilastri del pensiero di Ratzinger sono da una parte la teologia del dogma cattolico, dall’altro il metodo e la ratio di Platone» (il quale combatté tutta la vita per demolire l’edificio relativista dei sofisti e sostituirlo con un sistema che rendesse possibile una conoscenza certa).
La lotta contro il relativismo e le sue conseguenze che rendono «senza radici» la costruzione dell’Europa è stato il leitmotiv di tutto il pontificato di Ratzinger che già il 18 aprile 2005 nell’omelia della Missa pro eligendo Pontifice affermava: «Avere una fede chiara, secondo il Credo della Chiesa, viene spesso etichettato come fondamentalismo. Mentre il relativismo, cioè il lasciarsi portare "qua e là da qualsiasi vento di dottrina", appare come l’unico atteggiamento all’altezza dei tempi odierni. Si va costituendo una dittatura del relativismo che non riconosce nulla come definitivo e che lascia come ultima misura solo il proprio io e le sue voglie».
-
> AL GOVERNO DELLA CHIESA ---- Tutti zitti sul porno-sacrilegio. Tra Dio e Mammona la Chiesa cattolica gerarchica sceglie inequivocabilmente Mammona (di Paolo Flores d’Arcais)20 settembre 2011, di Federico La Sala
Tutti zitti sul porno-sacrilegio di Paolo Flores d’Arcais (il Fatto Quotidiano, 20 settembre 2011)
Davvero enigmatico il prolungato silenzio di monsignor Rino Fisichella, da tempo in odore di porpora cardinalizia, dati i suoi trascorsi di cappellano di Montecitorio e dunque direttore spirituale e confessore di tanti “eccellenti”. Sono passati ormai 4 giorni dalla clamorosa intervista a questo giornale in cui una partecipante ai festini/mercimonio di Berlusconi ha raccontato il pornosacrilegio che ha visto la consigliera regionale Nicole Minetti (eletta nel listino bloccato personale di Formigoni, guru storico di Comunione e Liberazione) vestita da monaca esibirsi in uno spogliarello sexy al palo della lap dance, molto efficace, sembra (“un bellissimo spettacolo, davvero”), e - una volta che la consigliera di Formigoni è completamente nuda - concluso dal premier che smaneggia un crocifisso piazzandoglielo prima tra le tette e poi tra le cosce mentre biascica una personalissima variante della benedizione canonica (“ha detto ‘Dio santo ti benedica’; poi le ha appoggiato il crocifisso sulla testa, tra le gambe e sui seni”).
CI ASPETTAVAMO che monsignor Fisichella intervenisse prontamente, come già in passato a proposito di un exploit del premier bestemmiatore, per invitare i fedeli troppo facili a scandalizzarsi (facendo il gioco dei comunisti, ça va sans dire) a contestualizzare il comportamento dell’ex compagno di merende di Gheddafi, relativizzandolo ad esuberanza ludica. Invece nulla. Evidentemente quel comportamento non esige neppure una cattolica contestualizzazione: va bene così. Del resto nessun altro giornale l’ha ripreso, e nessuna delle tante trasmissioni di approfondimento che, in assenza di Annozero, confermano così di essere civilmente e giornalisticamente superflue (civismo e giornalismo dovrebbero fare una cosa sola, secondo “leggende” come Joseph Pulitzer, e ancor prima come il grande storico dell’Ottocento Jules Michelet).
Evidentemente, tanto la Chiesa gerarchica quanto il giornalismo embedded considerano che l’episodio sia irrilevante sul piano pubblico. Sia chiaro, noi siamo tra i pochissimi a credere davvero che la vita sessuale e privata di ciascuno vada rigorosamente rispettata (gli “attenzionamenti” di Pio Pompa hanno avuto sanzioni? Anche solo morali? I nostri “garantisti” un tanto al chilo farebbero meglio a tacere), e che ogni incursione in esse vada severamente repressa. Con le eccezioni e i limiti che ciascuna persona pubblica stabilisce ella stessa.
Nei giorni scorsi, dopo il tragico esito di un gioco sadomasochista in un garage di Roma, uno dei guru in fatto di “bondage” ha raccontato (cronaca di Roma di Repubblica) come gli adepti siano tantissimi, di ogni ceto sociale, e nella “comunità” fosse presente un notissimo politico da poco promosso ai vertici di un importante partito. Giustamente nessuno ha approfondito, e anzi quella stessa dichiarazione, forse non sufficientemente criptica, era censurabile.
Ma l’onorevole che propone una legge contro l’omosessualità non può lamentarsi se un cronista svela una sua relazione gay, il ministro che tuona contro la prostituzione ha già stabilito la legittimità (anzi doverosità) di uno scoop che lo colga in meretricio sollazzo, il candidato tutto casa e chiesa e indissolubilità del matrimonio non può obiettare se una o più famiglie parallele finiscono in pasto a lettori e telespettatori. Per non parlare delle campagne contro l’aborto.
Perciò, i porno-sacrilegi con crocifisso tette e cosce cui si dedica il succube di Tarantini nella sua villa di Arcore (strappata per un tozzo di pane a un’orfana minorenne grazie alle cure dell’avvocato Previti, non dimentichiamolo) sarebbero vicenda privata, se il puttaniere-premier avesse condotto le campagne elettorali sventolando l’opera omnia del marchese de Sade come personalissimo “Mein Kampf”.
Ma il Berlusconi porno-sacrilego è lo stesso che come capo del governo ha sostenuto con grande dovizia di mezzi pubblici un contenzioso di fronte ai tribunali europei, il cui oggetto era l’irrinunciabilità del crocifisso in tutte le aule scolastiche dello Stivale, perché simbolo altissimo di civiltà, sacralità, identità e chi più ne ha più ne metta.
PERCIÒ L’USO che Berlusconi fa del crocifisso, il suo teatrino di “messe rosa”, di propiziazione e supporto a una virilità idraulico-artificiale evidentemente indigente, è questione di rilevanza pubblica. Il silenzio dei media in proposito si chiama censura e viltà, fino all’omertà. Quello della Chiesa gerarchica rientra invece piuttosto tra gli effetti collaterali di una vocazione simoniaca che con Ruini, Bertone e Bagnasco è di nuovo prepotentemente riaffiorata.
Se Bertone cita domenica un richiamo di Benedetto XVI ai laici (del settembre 2008), secondo cui devono essere “testimoni di coerenza tra i principi, la vita spirituale che praticano, e i comportamenti” e fa il pesce in barile per quanto riguarda nomi e cognomi, rifiutando anche la più obliqua, “gesuitica” o sibillina allusione al puttaniere di Arcore, è perché non c’è sacrilegio ne spudorata infamia morale che prevalga per il Vaticano rispetto al sontuoso piatto della bilancia dove pesano l’8 per mille, le esenzioni Ici, le anticostituzionali munificenze alla scuola privata, il bacio della pantofola allo Ior, la tortura di Stato per i moribondi, e le altre infinite delizie mondane e spirituali che la Cei ha ottenuto in questi anni dal regime.
Una volta di più, tra Dio e Mammona la Chiesa cattolica gerarchica sceglie inequivocabilmente Mammona.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- La Chiesa il cavaliere e il suo doppio (di Gian Antonio Stella)18 settembre 2011, di Federico La Sala
La Chiesa il cavaliere e il suo doppio
di Gian Antonio Stella (Corriere della Sera, 18 settembre 2011)
Il Cavaliere, oltre che il premier, fa anche il cattolico «a tempo perso»? Le autorità vaticane sembrano aver scelto di tacere, per ora, su quel pollaio di finte infermiere e squillo russe e ballerine sudamericane che emerge dalle intercettazioni e che una delle ragazze coinvolte ha definito «un gran troiaio». Un silenzio assoluto. Lo stesso Silvio Berlusconi, però, sa che il quadro delle sue notti brave con Gianpi Tarantini («Tu porta le tue, io le mie. Poi ce le prestiamo. La patonza deve girare...») rischia di guastare irrimediabilmente un rapporto con la Chiesa che aveva coltivato accuratamente. Giorno dopo giorno. Per anni.
Tutta la sua storia politica, coerentemente con la tesi di Don Gianni Baget Bozzo («ho sempre creduto nello Spirito Santo e considero Berlusconi come un evento spirituale») ha traboccato fin dall’inizio di messaggi, parole, rimandi religiosi. Nelle omelie elettorali: «Tutti dobbiamo diventare missionari, dobbiamo farci apostoli... Spiegheremo il vangelo di Forza Italia, il Vangelo secondo Silvio!». Nelle professioni di fede: «Sono religioso, cattolico praticante. Ho cinque zie suore e la domenica un mio cugino sacerdote viene ad Arcore a celebrare Messa nella mia cappella privata. Sì, mi comunico spesso. Anche perché se non lo faccio, mia madre mi chiama in disparte e mi rimprovera: "Cos’hai fatto a Dio, che oggi non hai preso l’ostia?"». Nelle interviste in cui spiegava gli incontri con Giovanni Paolo II: «Mi ha dato la sua benedizione. Ma con l’aria di pensare che non ne avessi un bisogno particolare». Negli annunci: «Il programma verrà presentato in dodici disegni di legge come le dodici tavole».
E via così, per anni. «Ho anche Sgarbi, nella funzione di San Giovanni Battista». «Ho detto: vade retro Satana a tutti i pastrocchi della Prima Repubblica». «Sui referendum mi rimetto serenamente al giudizio di Dio». «Berrò l’amaro calice di tornare a Palazzo Chigi». «Noi e Buttiglione abbiamo gli stessi ideali, la famiglia, il cattolicesimo, una posizione che si riflette nel magistero di Giovanni Paolo II». «Il male di questo Paese è che tutti guardano alle loro parrocchie, invece bisognerebbe stare attenti alla diocesi». A un certo punto confidò: «Io sono in collegamento continuo con lassù, mi aiuta il circuito delle zie suore». E rivelò: «L’altro giorno nella cappella di Arcore ho visto mia madre in colloquio diretto col mio angelo custode, con mio padre e anche con le zie che sono dall’altra parte: con accenti accorati li rimproverava di non aiutarmi abbastanza».
E qualche giorno dopo a Maria Latella che gli aveva chiesto con un pizzico di irridente incredulità quali richieste facesse lui all’impalpabile protettore, rispose con un sospiro addolorato: «L’idea dell’angelo custode suscita la sua ironia, forse le sembra una cosa fanciullesca... E io sorrido con qualche amarezza per il disprezzo così poco laico per questa elementare dimensione della fede, per questo amore che noi cattolici portiamo agli agenti della Divina Provvidenza».
Quando andò a trovarlo l’inviato di Famiglia Cristiana, volle dunque trascinarlo a tutti i costi, di stanza in stanza, fino alla cappella. «Presidente, non serve, la mia è un’intervista politica». «I suoi lettori devono sapere». «Quando faccio la Messa ad Arcore», raccontò a un settimanale, «la chiesa si riempie di giovani. La religione spinge tutti noi a migliorarci, a tendere verso l’alto».
Fino alla sortita più famosa: «Uno che arriva come me alla guida dell’Italia è come se fosse stato unto dal Signore». Di più: «Quando si assume un ruolo come questo, la vita cambia. I cattolici la chiamano la Grazia dello status. È una cosa che ti fa diventare una persona diversa senza che tu te ne accorga. Già stanotte ho dormito da persona diversa, anche se con lo stesso pigiama». E mano a mano che Don Luigi Verzé lo confortava nella convinzione d’essere stato scelto da lassù («l’ho sempre detto, Silvio è stato mandato dalla Divina Provvidenza per salvare questo Paese») il Cavaliere si lanciava nel racconto di parabole: «All’Ospedale San Raffaele una madre mi pregò di convincere il figlio bloccato provvisoriamente su una sedie a rotelle a riprendere a camminare. Mi presentai dal ragazzo e gli dissi: "Giacomo, fatti forza. Alzati e cammina". Lui, dopo alcuni giorni, si alzò». Un prodigio.
Come tanti altri. Che gli avrebbero strappato battute come quella con cui annunciò di aver trovatoun punto d’accordo su Bankitalia: «San Silvio da Arcore ha fatto un altro miracolo». Fino alla sublimazione del celebre gesto nel salotto di Bruno Vespa, quando porse la mano all’incerto giornalista: «Annusi, annusi!». «Cosa devo annusare?». «È odore di santità». E tanto deve essersi convinto, nel tempo, di questa sua dimensione al di là dei due divorzi e di una vita, diciamo così, sessualmente spericolata, che un giorno dell’estate 2008, alla Messa per il nuovo campanile di Porto Rotondo, chiese al vescovo di Tempio Pausania: «Eccellenza, perché non cambiate le regole per noi separati e ci permettete di fare la comunione?». «Lei che ha potere, si rivolga a chi è più in alto di me», gli disse quello sorridendo. Il Papa, in qualche modo, gli rispose dal Quebec: «Coloro che non possono ricevere la comunione a motivo della loro situazione, troveranno comunque nel desiderio di comunione e nella partecipazione all’Eucaristia una forza e una efficacia salvatrice». Parole che avrebbe interpretato come un via libera. Facendo la comunione in pubblico almeno un paio di volte, ai funerali dell’alpino Matteo Miotto e a quelli di Raimondo Vianello.
E adesso? Cosa faranno i vertici della Chiesa dopo aver letto quei dialoghi («Ieri sera avevo la fila fuori dalla porta della camera... Erano in undici... Io me ne son fatte solo otto perché non potevo fare di più») finiti su tutti i giornali del pianeta? Lo vedremo nei prossimi giorni. Ma certo, stavolta, se venissero confermate certe testimonianze, sarà difficile per lui spiegare che anche Nicole Minetti vestita in una notte brava con «una tunica scura da suora, compreso il copricapo ed una croce rossa sul velo» facesse parte del «circuito» delle zie monachelle.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- COSTITUZIONE E PROSTITUZIONE (di Antonio Padellaro).17 settembre 2011, di Federico La Sala
Costituzione e prostituzione
di Antonio Padellaro (il Fatto, 17.09.2011)
A chi ancora domanda (gli sbalorditi giornalisti stranieri e tanti comuni cittadini) come sia possibile che un tipo accusato di essere un puttaniere patentato e ricattato resti inamovibile e protervo a Palazzo Chigi, e cosa si possa fare per lavare questa vergogna nazionale non si può che rispondere: troppo tardi, bisognava pensarci prima. Chi è infatti il personaggio che, parlando di ragazze come se fossero agnelli da scuoiare, dice a Gianpi “chi mi porti stasera?” e che versa centinaia di migliaia di euro a Tarantini e ai suoi degni compari perché tengano la bocca chiusa? È lo stesso che più di tre lustri fa ribaltò, grazie a una montagna di quattrini, il già poco virtuoso tavolo della politica italiana e che ora, disponendo di un patrimonio di quasi 6 miliardi di euro, si è comprato un governo, una maggioranza e tutte le leggi di cui ha bisogno. E dunque può fare solo rabbia il fatto che ora, nell’opposizione guidata dal Pd, si levino alti i lamenti sul “Berlusconi che ci porta alla rovina” quando per ben due volte (1996 e 2006) la sinistra di lotta e di governo si guardò bene dal varare una seria norma sul conflitto d’interessi per impedire che un miliardario senza scrupoli facesse banco, come poi ha fatto. E che dire della grande stampa d’informazione? Siamo convinti che il galantuomo Ferruccio de Bortoli prima o poi darà voce sulla prima pagina del Corriere della Sera allo sdegno della grande borghesia produttiva, che quel grande giornale rappresenta, per lo spettacolo vergognoso di un premier che vuole trasformare la Costituzione in prostituzione. Mentre i giornali di Arcore si coprono di ridicolo sostenendo che il padrone non paga le ragazze, ma fa beneficenza (non sposarono festosamente anche la balla suprema di Ruby nipote di Mubarak?), ciò che resta della libera informazione, con poche eccezioni, si limita a commentare il “troiaio” con timide giaculatorie che lasciano il tempo che trovano. Del resto i loro editori, palazzinari, banchieri o industriali dell’auto, hanno un maledetto bisogno del governo di Papi e si adeguano. Una prece infine sui silenzi vaticani. Sì, quelle purpuree gerarchie che insorgono appena si osi parlare di coppie di fatto, tacciono imperturbabili di fronte allo scempio morale: decine di giovani donne vendute e comprate per il sollazzo di un vecchio. Il quale sa di non temere nulla, finché i mercanti continueranno a bivaccare nel tempio in cambio di un’esenzione Ici.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- Vaticano. Chi predica e chi razzola. La Chiesa non stacca la spina a Berlusconi.La benedizione in nome dell’Ici17 settembre 2011, di Federico La Sala
 Vaticano. Chi predica e chi razzola
Vaticano. Chi predica e chi razzola
 La benedizione in nome dell’Ici
La benedizione in nome dell’Ici di Marco Politi (il Fatto, 17.09.2011)
di Marco Politi (il Fatto, 17.09.2011)La Chiesa non stacca la spina a Berlusconi. Nel degrado in cui l’uomo di Arcore ha gettato la credibilità del premierato e della stessa Italia a livello internazionale, le massime gerarchie ecclesiastiche continuano a fornirgli l’appoggio politico. Un sostegno vitale per lui e incomprensibile per la maggioranza dei credenti e dei cittadini. L’80% degli italiani (secondo il recente rilevamento di Mannheimer) non ha fiducia in lui. I cattolici hanno partecipato in massa al referendum che ha sconfessato clamorosamente i suoi trucchi per sottrarsi ai giudici. Cos’altro deve succedere perché dalle più alte cupole venga la semplice, evangelica dichiarazione: “Quest’uomo non pretenda di rappresentarsi come amico e difensore della Chiesa”?
Non basta la macchina del fango contro il direttore di “Avvenire” Dino Boffo, non bastano i crocifissi che ballonzolano sulle tette delle ninfette del bunga bunga, non bastano le menzogne istituzionali sulle minorenni, non bastano i commenti osceni su esponenti politici internazionali che spingono il premier a mendicare e minacciare un decreto bavaglio contro giudici e informazione.
Sembra che niente sia abbastanza per smuovere le gerarchie ecclesiastiche. “Piovono guai su Berlusconi”, titola l’“Avvenire” come se si trattasse di improvvise disavventure e non dell’ennesima riprova di indegnità di un capo del governo che si circonda di lestofanti, parla come nemmeno i mitici scaricatori, consuma il tempo tacitando olgettine e consultando avvocati invece di occuparsi del Paese in maniera meno ridicola di quanto sia dimostrato dalle sue cinque manovre. Eppure la Chiesa sa. Proprio sul giornale dei vescovi l’anno è cominciato con il monito che il presidente della conferenza episcopale cardinale Bagnasco aveva ricordato già nel 2010 che l’articolo 54 della Costituzione impone “decoro” a chi occupa le supreme cariche e che per loro risulta inammissibile scindere “ruolo e contegno”. Dunque il metro c’è. È ben presente nei palazzi ecclesiastici. Non è un’invenzione di anti-berlusconiani arrabbiati. È il semplice metro del buon senso, dell’etica civile, dell’attenzione al bene comune.
Ma quando è il momento di misurare definitivamente Silvio Berlusconi, l’istituzione ecclesiastica si rimette il metro in tasca, esprime un rimbrottino e poi volta la testa dall’altra parte e tace. Giunti al dunque, non conta l’etica civile, non conta il bene comune, non conta che questo governo nulla stia facendo contro quei mali che pure la gerarchia ecclesiastica denuncia: la corruzione, l’evasione fiscale, il precariato, la disattenzione permanente ai problemi vitali delle famiglie. Quasi si trattasse di un dogma, i vertici supremi ecclesiastici continuano a fare da sostegno a Berlusconi. Incuranti del fatto che il 70% dei vescovi la pensi diversamente. Tra i presuli, in effetti, il 40% è filo-centrista e il 30 ha una sensibilità sociale di centro-sinistra. Anche tra i vescovi Berlusconi è ormai in minoranza. E più che mai in minoranza è tra il popolo delle parrocchie indignato, arrabbiato, rattristato per i “baccanali” di Arcore e la trascuratezza con cui (non) viene seguita la situazione economica delle normali famiglie.
Oltretevere, però, ci si gingilla con l’ipotesi di rifondare un nuovo partito cattolico. Ci si accontenta dei privilegi fiscali, dei soldi alle scuole confessionali, delle leggi civili bloccate da una maggioranza prona. L’Italia va a rotoli? Sopire, troncare...
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- Comunicato stampa su denuncia papa a corte dell’Aja.14 settembre 2011, di Federico La Sala
 Comunicato stampa su denuncia papa a corte dell’Aja
Comunicato stampa su denuncia papa a corte dell’Aja
 COMUNITÀ CRISTIANE DI BASE
COMUNITÀ CRISTIANE DI BASE Segreteria Tecnica Nazionale
Segreteria Tecnica Nazionale
 c/o CdB San Paolo - Roma
c/o CdB San Paolo - Roma
 Via Ostiense, 152/B - 00154 - Roma
Via Ostiense, 152/B - 00154 - Roma
 328.4366864
328.4366864 ufficiostampa@cdbitalia.it - segreteria@cdbitalia.it - www.cdbitalia.it
ufficiostampa@cdbitalia.it - segreteria@cdbitalia.it - www.cdbitalia.itL’iniziativa dell’Associazione delle vittime della pedofilia del clero di rivolgere alla Corte internazionale di giustizia dell’Aja una denuncia del papa e di altri alti prelati vaticani per crimini contro l’umanità è un evento storico. Evitiamo di dare giudizi di merito sulla competenza della Corte e sull’opportunità della denuncia. Non possiamo però non rilevare che è un segno dei tempi il fatto stesso che tale denuncia possa essere effettuata. La chiamata in causa presso un tribunale terreno del papa, sovrano assoluto, che si proclama vicario di Cristo, che tutti giudica ma da nessun può essere giudicato rappresenta una vera svolta nella storia della Chiesa. E’ un altro pezzo di medioevo che viene abbattuto. E’ un nuovo orizzonte che si apre e rende ineludibile ormai un serio e aperto dibattito sulla piena responsabilizzazione del Popolo di Dio nella Chiesa. Non si può continuare nella Chiesa ad affrontare le sfide positive della secolarizzazione e dell’ecumenismo con gli ammodernamenti di superficie che lasciano intatta la struttura gerarchica dell’istituzione.
Il Popolo di Dio non è più gregge genuflesso. La democrazia è stata considerata parola impronunciabile nella Chiesa. E’ l’ora invece di farci i conti se non si vuole che l’apparato ecclesiastico continui a soffocare la vitalità della Comunità ecclesiale.
 Le comunità cristiane di base italiane
Le comunità cristiane di base italiane
 Roma, 14 settembre 2011
Roma, 14 settembre 2011* Il Dialogo, Mercoledì 14 Settembre,2011 Ore: 17:00
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- Il Papa in tribunale (di Marco Politi)14 settembre 2011, di Federico La Sala
Il Papa in tribunale
di Marco Politi (il Fatto Quotidiano, 14 settembre 2011)
Trascinare il papa dinanzi alla Corte penale internazionale dell’Aja. È l’obiettivo dell’associazione di vittime di pedofilia clericale statunitense (Snap), che ha inoltrato ieri al Tribunale internazionale una denuncia di 85 pagine, in cui viene richiesta l’incriminazione di Benedetto XVI per “crimini contro l’umanità”. La parola d’ordine, riecheggiata spesso l’anno scorso - anche a Roma in una manifestazione di delegazioni di 13 nazioni svoltasi il 31 ottobre 2010 - si è tradotta a sorpresa in un atto giuridico per mettere in moto un processo internazionale contro i vertici vaticani, accusati di decenni di insabbiamento.
Lo SNAP (la cui sigla significa Rete dei sopravvissuti agli abusi dei preti) è la più potente organizzazioni di vittime americana, impegnata da anni nel contestare i silenzi vaticani. Il suo obiettivo è di portare sul banco degli accusati anche il successore di Ratzinger alla Congregazione per la dottrina della fede e due segretari di Stato. Quello in carica, cardinale Tarcisio Bertone, e il suo predecessore Angelo Sodano. La denuncia è accompagnata da un corposo dossier di 20.000 pagine contenente rapporti ufficiali, documentazione di polizia, testimonianze di vario tipo. Lo Snap motiva la sua iniziativa con il fatto che le “azioni legali condotte a livello nazionale non sono state sufficienti a impedire che gli abusi contro i minori continuassero”. L’accusa rivolta ai vertici vaticani al pontefice è di "diretta e superiore responsabilità per i crimini contro l’umanità degli stupri e altre violenze sessuali” commessi dal clero in tutto il mondo.
La linea vaticana è stata finora di opporre un gelido e sdegnato silenzio a un’azione considerata meramente propagandistica. “Non sta in cielo né in terra”, è il commento di un esponente di Oltretevere. “Vogliono farsi solo pubblicità”.
Intanto, però, una procedura giuridica è stata messa in modo e il procuratore generale delle Corte penale internazionale Louis Moreno-Ocampo dovrà nelle prossime settimane fornire un responso ufficiale, spiegando se il ricorso sarà accolto o no. In via immediata lo Snap punta almeno all’avvio di un’indagine preliminare per esaminare se il caso rientra sotto la sua giurisdizione. Anche soltanto l’ipotesi che il nome di Benedetto XVI venga inserito tra quelli di criminali come Gheddafi o Milosevic provoca orrore nelle altre gerarchie vaticane e viene ritenuto impensabile da molte parti.
Assistita dagli esperti giuridici del Centre for Constitutional Rights di Washington, l’associazione delle vittime statunitensi punta contemporaneamente a una vasta campagna di mobilitazione della pubblica opinione. Barbara Blain, presidente dello Snap, ha un obiettivo preciso: costringere la Santa Sede ad aprire gli archivi dove si cela la documentazione dei passati decenni e dove sono conservate le amare testimonianze di tanti insabbiamenti. E’ bastato che a Monaco di Baviera l’arcivescovo cardinale Reinhard Marx decidesse coraggiosamente di incaricare l’avvocata Marion Westphal di esaminare quanto avvenuto nei decenni dal 1945 al 2009 e sono avvenuti alla luce 365 casi di abusi. Il rapporto di duecentocinquanta pagine è tuttora secretato. Il giudizio ufficiale della Westphal, espresso in sede diocesana: “Regnava la totale mancanza di considerazione per le vittime”.
Papa Ratzinger, con la sua Lettera agli Irlandesi del 2010 e le nuove misure della Congregazione per la dottrina della fede, ha inaugurato un netto cambio di linea che vale per il futuro. Ma il punto debole resta la chiusura degli archivi vaticani. Perciò lo Snap inizierà un tour europeo, che porterà a dibattiti pubblici ad Amsterdam, Berlino, Bruxelles, Parigi, Vienna, Londra, Dublino, Varsavia, Madrid. Il 20 settembre l’appuntamento è a Roma.
In realtà da tempo erano partiti dall’interno del mondo cattolico suggerimenti per avviareun’inchiesta ecclesiastica internazionale sui casi di pedofilia. I conservatori in Curia si sono sempre opposti. Ora le vittime presenteranno il conto.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- Con l’Italia sull’orlo del baratro la Chiesa resta aggrappata al dogma che Berlusconi non va messo di fronte alle sue responsabilità (di Marco Politi - Chiesa, la svolta non c’è stata).9 settembre 2011, di Federico La Sala
Chiesa, la svolta non c’è stata
di Marco Politi (il Fatto Quotidiano, 9 settembre 2011)
Con l’Italia sull’orlo del baratro la Chiesa resta aggrappata al dogma che Berlusconi non va messo di fronte alle sue responsabilità. Invece di fare capire al più indegno premier della Repubblica che l’Italia ha bisogno di altro, la gerarchia ecclesiastica continua ad attestarsi su esortazioni generiche. Non fa l’unica cosa che dovrebbe: ritirargli la cambiale in bianco concessagli per diciassette anni. Il varo della manovra al Senato spinge l’Avvenire a un editoriale costellato di auspici. È “necessario cambiare registro e passo”. I giovani sono “sempre più in fondo alla lista delle priorità dell’azione politica”. Non c’è ancora un “fisco amico della famiglia”, le nuove generazioni sono ingabbiate nel precariato e “continuiamo a chiedere una svolta nella lotta all’economia sommersa e all’evasione fiscale”. No, la svolta non c’è stata. Il boss dei boss, come le amichette chiamano il premier, non ha nessuna intenzione di fare sul serio.
La norma delle manette a chi evade tre milioni di euro soltanto se rappresentano il 30 per cento del fatturato del contribuente infedele, fa sbellicare dalle risa tutti gli uffici fiscali dell’Occidente. E fa vomitare. Non c’è stata nemmeno la svolta nelle politiche familiari da parte di un premier, che con l’occhio umido da coccodrillo afferma di aiutare con ventimila euro al mese la “famiglia in difficoltà” del real fornitore di cortigiane Tarantini. “Caro Direttore”, chiede un lettore di Avvenire, un uomo che ha rubato allo Stato può cavarsela donando una sommetta di beneficenza al prete? No, risponde il direttore: “La via diritta per un evasore fiscale pentito è una soltanto: fare il proprio dovere verso la comunità civile di cui è parte”.
E allora cosa ancora deve avvenire perché le gerarchie ecclesiastiche affermino con chiarezza evangelica che questa leadership corrotta, laida e totalmente inefficiente non gode più della loro fiducia? Per molto meno, una leggina farraginosa sulle coppie di fatto o un finanziamento in più alle scuole confessionali dai sacri palazzi sono partite in passato direttive per organizzare manifestazioni di massa! Il mondo cattolico, al cui interno esistono tante energie che aspettano solo di concorrere assieme agli altri cittadini alla rinascita dell’Italia, è come immobilizzato dal diktat delle alte sfere per cui non si deve attaccare Berlusconi. Qualche critichina sì. Ma guai a dire ciò che pensa l’Europa intera. L’incapace se ne vada. A luglio l’associazionismo cattolico è sembrato alzare la testa. Alcune associazioni hanno varato un manifesto “per la Buona politica”. Nel momento cruciale del balletto indegno sulle manovre due-tre-quattro-cinque la cappa del silenzio è nuovamente calata. È indubbio che il disagio, il malumore, l’inquietudine e l’angoscia per il futuro siano largamente diffusi nel mondo cattolico. Ne sono un segno anche le pagine che il giornale dei vescovi dedica da settimane all’evasione fiscale, al quoziente familiare, ai problemi dei giovani.
La gravità del momento traspare anche da singole frasi di alti esponenti della Chiesa. Il cardinale Tettamanzi, che in queste ore lascia ufficialmente la guida della diocesi di Milano, ha lanciato l’allarme che quasi nulla è cambiato nella vita politica italiana dopo Tangentopoli. Il cardinale Re, al congresso eucaristico di Ancona, ha evocato il dramma della disoccupazione. Il cardinale Bagnasco ha denunciato le “cifre impressionanti” dell’evasione fiscale e ha sottolineato la pressione che grava sulle famiglie. Il cardinale Bertone in un intervento alle Acli ha scandito che i “diritti sociali sono parte integrante della democrazia sostanziale e l’impegno a rispettarli non può dipendere meramente dall’andamento delle borse e del mercato”. Poi, però, scena muta quando il governo vara l’articolo 8 della manovra, che rottama lo Statuto dei lavoratori e colpisce direttamente le famiglie italiane. Perché sono i padri e le madri di famiglia, che domani saranno gettati sul lastrico (La Stampa ha dedicato una pagina intera alle ampie possibilità di licenziare), a sostenere economicamente centinaia di migliaia di giovani immersi nel precariato.
Rispetto all’urgenza di pronunciare una parola chiara e definitiva sul malgoverno di Berlusconi (sulprofilo di etico le parole ormai sono insufficienti), le massime autorità ecclesiastiche preferiscono muoversi, restando al coperto. Sperando nella nascita di un partito di centrodestra postberlusconiano “quando sarà”. Non è un caso che l’unico - in campo Pdl - a mettere pubblicamente la faccia per chiedere la rimozione urgente di Berlusconi sia Giuseppe Pisanu, uomo di solida formazione cattolico-democratica. L’ala ciellina dei Lupi e Formigoni non ha avuto lo stesso coraggio.
Certamente una parte consistente dell’episcopato non ne può più del Cavaliere, delle sue ninfette e della totale mancanza di una visione di governo.
Pisanu non avrebbe fatto la sua sortita se non percepisse di godere del silenzioso sostegno di settori importanti della gerarchia ecclesiastica. Buttiglione nell’Udc rilancia con tempismo sulle pagine di Avvenire la proposta di un ritiro del premier accompagnato da un salvacondotto giudiziario (altra aberrazione inconcepibile per un paese occidentale). Ma l’Italia merita molto più che ordinarie manovre da congiurati. E i cattolici meritano una parola chiara verso chi ha portato il paese alla catastrofe. La partenza di Berlusconi dovrà essere un atto di pulizia e di liberazione, non il frutto di una piccola cospirazione.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- GIUDICARE E VALUTARE: LA FACOLTA’ DI GIUDIZIO E IL MAGISTERO DEI SANTI PADRI DELLA CHIESA CATTOLICA DI OGGI.7 luglio 2011, di Federico La Sala
 SONNO DOGMATICO, STATO DI MINORITA’, E INCAPACITA’ DI GIUDIZIO. DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! CARDINAL RAVASI, NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? SI TRATTA DELLA PAROLA FONDANTE E DISTINTIVA DELLA FEDE CRISTIANA!!! Ha dimenticato l’esortazione di Papa Wojtyla ("Se mi sbalio, mi coriggerete")?!
SONNO DOGMATICO, STATO DI MINORITA’, E INCAPACITA’ DI GIUDIZIO. DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! CARDINAL RAVASI, NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? SI TRATTA DELLA PAROLA FONDANTE E DISTINTIVA DELLA FEDE CRISTIANA!!! Ha dimenticato l’esortazione di Papa Wojtyla ("Se mi sbalio, mi coriggerete")?!
 LA FACOLTA’ DI GIUDIZIO E IL MAGISTERO DEI SANTI PADRI DELLA CHIESA CATTOLICA DI OGGI. Il cardinale Ravasi si rende conto che "è grave atrofizzare la facoltà, di cui è dotata la nostra mente, di sceverare tra vero e falso", ma continua a fare "sogni d’oro"! Un suo "mattutino" - con alcune note, a c. di Federico La Sala
LA FACOLTA’ DI GIUDIZIO E IL MAGISTERO DEI SANTI PADRI DELLA CHIESA CATTOLICA DI OGGI. Il cardinale Ravasi si rende conto che "è grave atrofizzare la facoltà, di cui è dotata la nostra mente, di sceverare tra vero e falso", ma continua a fare "sogni d’oro"! Un suo "mattutino" - con alcune note, a c. di Federico La Sala
 GIUDICARE E VALUTARE. (...) Montaigne, nei suoi Saggi non esitava ad affermare che «la cura e la spesa dei nostri padri mirano solo a riempirci la testa di sapere; di giudizio e di virtù, non se ne parla nemmeno!»
GIUDICARE E VALUTARE. (...) Montaigne, nei suoi Saggi non esitava ad affermare che «la cura e la spesa dei nostri padri mirano solo a riempirci la testa di sapere; di giudizio e di virtù, non se ne parla nemmeno!»
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- Ma la questione morale - sia per Berlinguer sia per Napolitano - prima che un problema giuridico, era uno stile di vita (di Luca Telese - La fine dell’innocenza)..10 luglio 2011, di Federico La Sala
La fine dell’innocenza
di Luca Telese (il Fatto Quotidiano, 7 luglio 2011
L’intervista rilasciata da Enrico Berlinguer a Eugenio Scalfari contiene una scudisciata che il giorno dopo farà sobbalzare i lettori di La Repubblica e metà della classe politica italiana: “I partiti di oggi sono soprattutto macchine di potere e di clientela”. Nessun leader, nel tempo della prima repubblica, con l’esclusione dell’antisistema Marco Pannella - aveva mai osato tanto. Sono passati trent’anni da quel giorno. Trent’anni di questione morale. Trent’anni di rabbia e di oblio.
È stato esattamente trent’anni fa, che in una estate calda come questa Enrico Berlinguer ha coniato - in una intervista che sarebbe entrata in tutti gli archivi - una locuzione destinata a raccontare l’Italia di allora, quella di Mani pulite (che sarebbe arrivata undici anni più tardi) e - purtroppo - anche quella che stiamo vivendo, nel tempo dei pizzini, degli appalti facili, delle p3 e della P4, dei contributi spontanei alle fondazioni “amiche”. Intervista “profetica”, si disse. Ma in realtà nata con un processo di elaborazione che in Berlinguer fu tutt’altro che rapido.
Oggi Scalfari ricorda quel giorno con una nitidezza cristallina: “Parlammo ore. Segnai pochi appunti e poi ricostruii di getto tutta l’architettura del discorso. Berlinguer era uno dei pochi politici che mi considerava e di cui mi consideravo amico. Poteva capitare che cenassimo insieme, a casa mia o a casa sua. Ancora più frequentemente a casa di Tonino Tatò. Ma quando poi l’intervista era scritta, con lo stesso Tatò iniziava un lavoro minuzioso di limatura. Di quell’intervista - aggiunge il fondatore di La Repubblica - toccammo poco o nulla. E mi accorsi subito che la sua portata avrebbe trasceso quella della cronaca politica”.
ERA L’ITALIA che esce faticosamente dagli anni di piombo. L’Italia del terremoto, di Vermicino, delle lacrime di Sandro Pertini. Ed è il Pci che sta abbandonando la Solidarietà Nazionale e l’accordo con la Dc per passare all’opposizione. Ma lo strappo che questa svolta produce nel partito non è, e non può essere, indolore.
Lo scontro che è già nell’aria prende corpo quasi improvvisamente, anche perché, il grande critico della svolta ha il nome del dirigente più pesante nel gruppo dirigente di quel Pci: Giorgio Napolitano. Sono curiosi i paradossi della storia, quando passano trent’anni. Oggi forse Napolitano, che fu il fiero oppositore di quella svolta, limerebbe molte delle sue critiche del 1981 a Berlinguer, e condividerebbe molte delle sue affermazioni. E probabilmente Massimo D’Alema, che allora era un sostenitore del segretario, oggi lo criticherebbe.
Si disse che quel dialogo del segretario del Pci con Scalfari era stato l’atto fondativo dell’antipolitica: oggi, dopo tutto quello che la politica ci ha regalato, possiamo forse dire che quella critica drastica era (ed è) l’unica possibilità di salvezza della politica pulita. “I partiti - diceva Berlinguer - sono soprattutto macchine di potere e di clientela: scarsa o mistificata conoscenza della vita e dei problemi della società e della gente, idee, ideali, programmi pochi o vaghi, sentimenti e passione civile, zero. Gestiscono interessi, i più disparati, i più contraddittori, talvolta anche loschi - sosteneva - comunque senza alcun rapporto con le esigenze e i bisogni umani emergenti, oppure distorcendoli, senza perseguire il bene comune”. In quei giorni, secondo la migliore tradizione del gruppo dirigente comunista, le ragioni della politica contingente vennero dissimulate dietro la disputa di dottrina. Napolitano aveva scelto di attaccare Berlinguer, partendo da lontano. Ovvero dall’editoriale che doveva scrivere per commemorare l’anniversario della morte di Togliatti, ma usando Togliatti per criticare Berlinguer su tre punti: il giudizio sul degrado dei partiti, la denuncia inappellabile che Berlinguer faceva sulla questione morale, la chiusura netta che il segretario del Pci opponeva a Craxi, il rifiuto della via socialdemocratica in nome della cosiddetta “terza via” fra socialismo reale e capitalismo.
Ma il giudizio più duro era quello sulla società italiana e sul suo degrado: “I partiti - diceva il segretario del Pci - hanno occupato lo Stato e tutte le sue istituzioni, a partire dal governo. Hanno occupato gli enti locali, gli enti di previdenza, le banche, le aziende pubbliche, gli istituti culturali,gli ospedali, le università, la Rai, alcuni grandi giornali”. Parole che sarebbero passate alla storia come il manifesto della “Diversità”.
“Io - diceva il segretario - credo di sapere a che cosa lei pensa: poiché noi dichiariamo di essere un partito “diverso” dagli altri, lei pensa che gli italiani abbiano timore di questa diversità”. E Scalfari: “Sì, è così, penso proprio a questa vostra conclamata diversità. A volte ne parlate come se foste dei marziani, oppure dei missionari in terra d’infedeli: e la gente diffida. Vuole spiegarmi con chiarezza in che consiste la vostra diversità? C’è da averne paura?”. Berlinguer ovviamente negava: “Qualcuno, sì, ha ragione di temerne, e lei capisce subito chi intendo. Per una risposta chiara alla sua domanda, elencherò per punti molto semplici in che consiste il nostro essere diversi, così spero non ci sarà più margine all’equivoco. Ma noi vogliamo che i partiti cessino di occupare lo Stato”.
Per Napolitano era troppo. Racconterà di aver telefonato a Gerardo Chiaromonte: “Eravamo entrambi sbigottiti: in quella clamorosa esternazione coglievamo un’esasperazione pericolosa come non mai, una sorta di rinuncia a fare politica, visto che non riconoscevamo più nessun interlocutore valido, e negavamo che gli altri partiti, ridotti a macchine di potere e di clientela esprimessero posizioni e programmi con cui confrontarci”.
Insomma, lo spettro della cosiddetta “antipolitica”, e l‘esaltazione del primato dei partiti, il dilemma su cui ancora oggi si dibatte a sinistra, (a partire dal celebre discorso di D’Alema a Gargonza che preconizzò la fine dell’Ulivo nel 1996). Il primo segnale premonitore della Questione morale a sinistra, era arrivato da Torino, con lo scandalo Zampini. Un imprenditore era andato dal sindaco comunista Diego Novelli dicendo di aver pagato una tangente. Novelli (berlingueriano di ferro) anziché insabbiare disse: “Lei deve andare dal magistrato”.
Nel 1992-93, nel ciclone di Tangentopoli, emersero le confessioni di un segretario di federazione milanese, Cappellini, che ammetteva di aver preso tangenti e di “averle buttate nel calderone dei bilanci delle feste dell’Unità”. Parole che sconvolsero i militanti di base, insieme alle rivelazioni successive che riguardavano pagamenti per la metropolitana di Milano, e poi l’epopea del compagno “G”, alias primo Greganti, e quella della tangente “scomparsa” alle soglie di Botteghe Oscure su cui indagò (senza trovare prove definitive) il pm Di Pietro. Achille Occhetto arrivò a proclamare, contro la corruzione, “una seconda Bolognina”.
Poi i piccoli smottamenti di costume come l’entusiastico grido di Piero Fassino al telefono con Giovanni Consorte: “Abbiamo una banca?”. Proprio Fassino, nel suo Per passione, aveva ricostruito l’ultima parte della vita di Berlinguer come un partita a scacchi bergmaniana con Craxi, dove il segretario muore un attimo prima che l’altro gli faccia scacco matto. Parole di pessimo gusto, in ogni caso. Soprattutto alla luce degli scandali “sinistri” di questi giorni. Ha detto Pierluigi Bersani al Messaggero: “Nel nostro partito non c’è nessuna questione morale”. Ma la questione morale - sia per Berlinguer sia per Napolitano - prima che un problema giuridico, era uno stile di vita.
-
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- IL RAGIONAMENTO DI TOCQUEVILLE. Quando manca la coscienza (di Barbara Spinelli).6 luglio 2011, di Federico La Sala
Quando manca la coscienza
di Barbara Spinelli (la Repubblica, 06.07.2011)
Vale la pena meditare su cosa significhi precisamente partito degli onesti, visto che a proporlo è stato il nuovo segretario del Pdl. ossia della formazione che sin qui non aveva la rettitudine come stella polare. Può darsi che Alfano abbia emesso un mero suono, un flatus vocis senza rapporto alcuno con la realtà, ma i realisti che credono nella consistenza delle parole hanno tutto l’interesse a ripensare vocaboli come onestà, morale pubblica, virtù politica. A meno di non essere incosciente, il ministro della Giustizia non può infatti ignorarlo: i passati diciassette anni non sono stati propriamente intrisi di probità (lui stesso ne è la prova vivente, avendo aiutato Berlusconi a inserire nella manovra economica un codicillo ad personam, che tutelando il premier dalla sentenza sul Lodo Mondadori nobilita a tutti gli effetti il concetto di insolvenza nel privato). Alle spalle abbiamo un’epoca corrotta, molto simile al periodo dei torbidi che Mosca conobbe fra il XVI e il XVII secolo, prima che i Romanov salissero al trono e mettessero fine all’usurpazione di Boris Godunov.
Meditare sull’onestà dei politici significa che da quest’epoca usciremo - se ne usciremo - a condizione di capire in concreto cosa sia la morale pubblica, e come la sua cronica violazione abbia prodotto una propensione al vizio quasi naturale, che va ben oltre la disubbidienza alle leggi. Soprattutto, significa guardare al fenomeno Berlusconi come a qualcosa che è dentro, non fuori di noi: la cultura dell’illegalità, i conflitti d’interesse vissuti non come imbarazzo ma come risorsa, non sono qualcosa che nasce con lui ma hanno radici più profonde, non ancora estirpate. Sono un male italiano di cui il premier è il sintomo acutizzato: chiusa la parentesi non l’avremo curato ma solo preteso d’averlo fatto. L’inferno non sono gli altri, ogni giorno lo constatiamo: dal dramma dei rifiuti a Napoli alle vicende che scuotono il partito di Bersani e D’Alema.
Il fatto è che ci stiamo abituando a restringere la nozione di morale pubblica. L’assimiliamo a una condotta certamente cruciale - l’osservanza delle leggi, sorvegliata dai tribunali - ma del tutto insufficiente. Perché esistano partiti onesti, altri ingredienti sono indispensabili: più personali, meno palpabili, non sempre scritti. Attinenti alle virtù politiche, più che a un dover-essere codificato in norme scritte. Precedenti le stesse Costituzioni.
Di che c’è bisogno dunque, per metter fine alla leggerezza del vizio che riproduce sempre nuovi boiardi e nuovi disastri trasversali come la monnezza napoletana e la corruttela? Gli ingredienti mancanti sono sostanzialmente due: una memoria lunga della storia italiana, e un’idea chiara di quelle che devono essere le virtù politiche a prescindere dalle norme scritte nel codice penale.
La memoria, in primo luogo. Non si parla qui di un semplice rammemorare. Le celebrazioni ci inondano e forse anche ci svuotano; esistono date che evochi continuamente proprio perché sono stelle morte. Per memoria intendo la correlazione stretta, e vincolante, tra ieri e oggi: ogni atto passato (come ogni omissione) ha effetti sul presente e come tale andrebbe analizzato. Diveniamo responsabili verso il futuro perché lo siamo del passato, di come abbiamo o non abbiamo agito.
 Il ragionamento di Tocqueville sull’individuo democratico vale anche per le sue azioni, specialmente politiche: la «catena aristocratica delle generazioni» viene spezzata, e lascia ogni anello per conto suo. Così come avviene per l’individuo, l’atto - sconnesso dalla vasta trama dei tempi - «non deve più nulla a nessuno, si abitua a considerarsi sempre isolatamente (...) Ciascuno smarrisce le tracce delle idee dei suoi antenati o non se ne preoccupa affatto. Ogni nuova generazione è un nuovo popolo (...) La democrazia non solo fa dimenticare a ogni uomo (a ogni azione) i suoi avi, ma gli nasconde i suoi discendenti e lo separa dai suoi contemporanei: lo riconduce incessantemente a se stesso e minaccia di rinchiuderlo per intero nella solitudine del suo cuore».
Il ragionamento di Tocqueville sull’individuo democratico vale anche per le sue azioni, specialmente politiche: la «catena aristocratica delle generazioni» viene spezzata, e lascia ogni anello per conto suo. Così come avviene per l’individuo, l’atto - sconnesso dalla vasta trama dei tempi - «non deve più nulla a nessuno, si abitua a considerarsi sempre isolatamente (...) Ciascuno smarrisce le tracce delle idee dei suoi antenati o non se ne preoccupa affatto. Ogni nuova generazione è un nuovo popolo (...) La democrazia non solo fa dimenticare a ogni uomo (a ogni azione) i suoi avi, ma gli nasconde i suoi discendenti e lo separa dai suoi contemporanei: lo riconduce incessantemente a se stesso e minaccia di rinchiuderlo per intero nella solitudine del suo cuore».La citazione si applica perfettamente alla calamità napoletana. Sono settimane che i leghisti sbraitano, negando la solidarietà con una città che precipita. Se la memoria funzionasse, non potrebbero. Dovrebbero dire, a se stessi e agli italiani, la verità: se Napoli e la Campania sono diventate un’immensa mefitica discarica di rifiuti tossici e non tossici, è perché il Nord da vent’anni ha perpetuato quello che Tommaso Sodano, ex senatore e oggi vice di de Magistris, chiama lo «stupro del Sud»: una «specie di guerra etnica, giocata con l’arma del rifiuto, alimentata dalla camorra, ma anche da una catena di falsificazione e di enti di controllo assenti». Il Nord è responsabile di quanto avviene a Sud, quali che siano le colpe delle amministrazioni campane. La sua industrializzazione ha prodotto rifiuti tossici smaltiti senza trattamento nel Sud, sancendo con la connivenza di clan camorristi la morte del Mezzogiorno, e avvelenando uomini, animali, fiumi, piantagioni (Tommaso Sodano, «La Peste«, Rizzoli 2010).
Il secondo ingrediente, essenziale, è la virtù personale del politico. Indipendentemente dal codice penale, essa dovrebbe escludere frequentazioni di mafiosi, connivenze con personaggi come Cosentino, assuefazione infine alla droga che è il conflitto d’interessi. Piano piano cominciamo a capire come mai, sul conflitto d’interessi berlusconiano, la sinistra non ha mai fatto nulla, anche quando governava: il conflitto era droga anche per lei. Come definire altrimenti il caso Franco Pronzato? Ecco infatti un uomo, vicinissimo ai vertici Pd, che nello stesso momento in cui agiva nel consiglio d’amministrazione dell’Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile), era coordinatore nazionale del trasporto aereo nel Pd. Pronzato ha percepito tangenti sulla rotta Roma-Isola d’Elba e il suo corruttore, Morichini, ha fatto favori finanziari a D’Alema. «L’incarico pubblico assegnato senza neppure mascherare la sua finalità lottizzatoria viene notato ora solo perché Pronzato va in carcere», ha scritto Gad Lerner su «Repubblica« (30 giugno).
Lo scandalo esiste solo quando la magistratura interviene: qui è il male italiano che precede Berlusconi, e per questo è urgente pensare la morale pubblica. Il mondo si rimette nei cardini così: individuando il punto dove la legge non arriva, e però cominciano le indecenze, le cattive frequentazioni, la triviale leggerezza del politico. Non tutte le condotte sono perseguibili penalmente (il doppio incarico di Pronzato non è illegale) ma politicamente non denotano né probità né prudenza: due virtù fra loro legate. Si parla di giustizialismo, del potere dei giudici sulla politica. Se questo accade, è perché la morale pubblica ha come unico recinto la magistratura, e non anche la coscienza.
Borsellino ha detto, in proposito, cose che restano una bussola: «La magistratura può fare solo un accertamento giudiziale. Può dire: ci sono sospetti, anche gravi, ma io non ho la certezza giuridica (...) Però siccome dalle indagini sono emersi fatti del genere, altri organi, altri poteri, cioè i politici, cioè le organizzazioni disciplinari delle varie amministrazioni, cioè i consigli comunali o quello che sia, dovevano trarre le dovute conseguenze da certe vicinanze tra politici e mafiosi». Se le conseguenze non sono state tratte, «è perché ci si è nascosti dietro lo schermo della sentenza». (La presenza di grossi sospetti) «dovrebbe quantomeno indurre, soprattutto i partiti politici, non soltanto a essere onesti ma a apparire onesti, facendo pulizia al loro interno di tutti coloro che sono raggiunti comunque da episodi o da fatti inquietanti anche non costituenti reati». Era questo il fresco profumo di libertà che augurava all’Italia, prima d’esser ammazzato. Non era flatus vocis, il suo, anche se è stato preso per tale da un’intera classe politica.
Dopo Berlusconi, la morale pubblica sarà da reinventare: non uscirà come Afrodite dalle acque. S’imporranno farmaci forti, perché gli italiani osino fidarsi del Politico. Oggi non si fidano: i No-Tav pacifisti di Val di Susa dicono questo. Possiamo sprezzarli, possiamo denunciare la sindrome Nimby (Not In My Backyard, «non nel mio cortile»). Ma non senza dire, prima, che tutti soffrono la stessa sindrome, a cominciare dal Nord di Bossi.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- FAME NEL MONDO?! CIBO MATERIALE E CIBO SPIRITUALE: UNA SOLA GRANDE SPECULAZIONE TEOLOGICO-POLITICA ED ECONOMICA! La Conferenza della Fao e l’intervento di Benedetto XVI.1 luglio 2011, di Federico La Sala
 L’EUCHARISTIA E IL "DEUS CARITAS" DI BENEDETTO XVI. LA GRAZIA DEL DIO DI GESU’ E’ *BENE COMUNE* DELL’INTERA UMANITA’, MA IL VATICANO LA GESTISCE COME SE FOSSE UNA SUA PROPRIETA’. Una miseria senza fine dell’intera gerarchia vaticana ...
L’EUCHARISTIA E IL "DEUS CARITAS" DI BENEDETTO XVI. LA GRAZIA DEL DIO DI GESU’ E’ *BENE COMUNE* DELL’INTERA UMANITA’, MA IL VATICANO LA GESTISCE COME SE FOSSE UNA SUA PROPRIETA’. Una miseria senza fine dell’intera gerarchia vaticana ...
 FAME NEL MONDO?! CIBO MATERIALE E CIBO SPIRITUALE: UNA SOLA GRANDE SPECULAZIONE TEOLOGICO-POLITICA ED ECONOMICA! La Conferenza della Fao e l’intervento di Benedetto XVI. Una nota sull’evento - con appunti sul tema
FAME NEL MONDO?! CIBO MATERIALE E CIBO SPIRITUALE: UNA SOLA GRANDE SPECULAZIONE TEOLOGICO-POLITICA ED ECONOMICA! La Conferenza della Fao e l’intervento di Benedetto XVI. Una nota sull’evento - con appunti sul tema
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- PD E AMALGAMA. ARRIVA UN CATTOLICO A CASA GRAMSCI. Claudio Sardo, il primo cattolico, che dirigerà, dall’8 luglio, il giornale fondato da Gramsci (di Daniela Preziosi).6 luglio 2011, di Federico La Sala
 Pd e amalgama
Pd e amalgama
 Arriva un cattolico a casa Gramsci
Arriva un cattolico a casa Gramscidi Daniela Preziosi (il manifesto, 6 luglio 2011)
Non capita spesso che i primi «cordiali auguri» a un nuovo direttore dell’Unità arrivino dall’Osservatore Romano, organo ufficiale della Città del Vaticano. Anzi, fin qui non era nell’ordine delle cose, nonostante il crollo del Muro e via scendendo.
È capitato ieri a Claudio Sardo, il primo cattolico (dichiaratamente tale, non solo in interiore homine) che dirigerà, dall’8 luglio, il giornale fondato da Gramsci. Sostituisce Concita De Gregorio, contratto scaduto e non rinnovato con i ringraziamenti della casa, nonostante la riconsegna delle chiavi a quota 38mila, meno 10mila copie di quelle che le aveva lasciato Antonio Padellaro.
Formalmente il Pd non c’entra con la nomina decisa dalla Nie, e in persona dall’editore Renato Soru, arrivato nel 2008 da presidente della Sardegna con la nuova stagione veltroniana, poi disarcionato e fra le concause della successiva ’walterloo’. Ma il vento è cambiato e l’editore, che ora punta sul suo nuovo Sardegna 24, si vuole disimpegnare. E così chiama il notista del Messaggero (e segretario della Stampa parlamentare) che, insieme allo storico Miguel Gotor ha firmato il libro-intervista di Bersani, «Per una buona ragione». L’ottima ragione di Soru è che così il Pd non potrà tirarsi indietro nel ’facilitare’ la sua uscita. L’ottima ragione di Bersani è che oltretutto le ultime interviste di Sardo al giornale di Caltagirone sono state D’Alema, Casini, oltreché lo stesso segretario Pd: più che articoli, un’alleanza di governo.
«Ma no, quello a cui potrei contribuire piuttosto è alla costruzione di un’alleanza fra società, movimenti e politica», replica Sardo. Che è cattolico, «di sinistra» ma soprattutto persona prudente. E non dimentica che la sua predecessora rischiò il collo raccontando la linea editoriale a un periodico prima che alla redazione. «Rispetteremo le radici dell’Unità e cercheremo di dare un contributo alla nuova identità plurale del Pd. Sapendo che non tutte le antinomie sono componibili. Dando priorità alla questione sociale. Ma l’Unità è un giornale, faremo giornalismo».
Su Gramsci ovviamente non c’è discussione, «importantissimo per la cultura italiana, come decisivo è stato l’apporto del Pci». Quanto al suo essere cattolico, «la cultura religiosa è spesso un apporto decisivo alla partecipazione e a un tessuto sociale solidale». Tanto basta per zittire i Fioroni e i D’Ubaldo.
Sardo è un ex aclista dell’era di Domenico Rosati, ai tempi ne ha anche diretto il settimanale. Ha certo un’allure meno scapigliata della tuttavia pettinatissima De Gregorio, che è approdata all’unità da Repubblica con nel curriculum un po’ di cose di sinistra, persino un libro sul G8 di Genova.
Tutto congiurerebbe contro di lui, dalla gioia dell’Udc a un entusiasmo che D’Alema e i dalemiani hanno messo in circolo per la sua nomina. Ma che Sardo non abbia il profilo del normalizzatore lo dimostra il fatto che la redazione - stanca di fili rossi e direttrici in tv - ha accolto con un comunicato affettuoso il «professionista serio e autorevole» a cui offre «massima collaborazione».
Lui ha ricambiato con un gesto di quelli che dicono cose, una prima informale visita alla redazione già lunedì, stringendo la mano a colleghi e poligrafici. Dettagli: la direttrice a metà giugno ha preso le ferie, e fin qui di saluti non se n’è visti.
-
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- FILOSOFIA IN STATO COMATOSO. ENRICO BERTI E REMO BODEI IN COMA DOGMATICO PROFONDO, HANNO PERSO LA PROPRIA "FACOLTA’ DI GIUDIZIO"!!!24 giugno 2011
SAPERE AUDE! USCIRE DAL "CERCHIO DEI CERCHI" DELLA FILOSOFIA DI HEGEL.
PAROLA DI ENRICO BERTI: Più realista, e meno illuminista, di Kant è stato Hegel, il quale ha criticato i pedagogisti suoi contemporanei che volevano insegnare a «pensare con la propria testa».
E’ talmente vero quello che pensa Berti (e, con lui, la maggioranza dei suoi colleghi di filosofia e storia della filosofia) che qualsiasi studente e ogni studentessa per educarsi all’uso della sua propria intelligenza e alla sua "facoltà di giudizio" deve ricorrere non alle sue (e loro) letture di Kant, ma a qualche perito o a qualche manuale di estimo: l’estimo è la disciplina che ha la finalità di fornire gli strumenti metodologici per la valutazione dei beni per i quali non sussiste un apprezzamento univoco!!!
MATERIALI SUL TEMA, NEL SITO, IN:
Gioacchino - da Fiore!!!
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- IL REFERENDUM DEL 12 E 13 GIUGNO 2011 E IL LEGAME TRA CHIESA E SCOCIETA’ IN ITALIA, OGGI.14 giugno 2011, di Federico La SalaIL REFERENDUM DEL 12 E 13 GIUGNO 2011 E IL LEGAME TRA CHIESA E SCOCIETA’ IN ITALIA, OGGI: RITROVATA E RIPRESA LA MEMORIA DELLA LEGGE, DEL FUOCO, E DELL’ACQUA DELL’ALLEANZA ...
 ACQUA, FUOCO, LEGGE DELL’ALLEANZA! UN’ESPLOSIONE D’AMORE - LA PENTECOSTE, "LA DONAZIONE DI PIETRO", E IL CATTOLICESIMO ROMANO. Una riflessione di Jacques Noyer, con una nota di Federico La Sala
ACQUA, FUOCO, LEGGE DELL’ALLEANZA! UN’ESPLOSIONE D’AMORE - LA PENTECOSTE, "LA DONAZIONE DI PIETRO", E IL CATTOLICESIMO ROMANO. Una riflessione di Jacques Noyer, con una nota di Federico La Sala
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- Chiesa, in che mondo convivi? (di Marco Politi)7 giugno 2011, di Federico La Sala
Chiesa, in che mondo convivi?
di Marco Politi (il Fatto Quotidiano, 7 giugno 2011)
Dalle alte cattedre, i papi parlano di coppie e convivenza e il mondo vero si trova da un’altra parte. C’è una distanza siderale tra la Chiesa dottrinaria e la vita reale di uomini e donne, giovani e maturi, per come si svolge nel secolo XXI, tale da scoraggiare persino il dibattito.
In Croazia, ancora una volta Benedetto XVI - come prima di lui papa Wojtyla - ha condannato le convivenze associandole alla leggerezza incosciente di chi “riduce l’amore a emozione sentimentale e a soddisfazione di pulsioni istintive, senza impegnarsi a costruire legami duraturi di appartenenza reciproca e senza apertura alla vita”. Ha ragione Paola Concia a rispondere con una battuta: “Giusto, lasciamo che si sposino le coppie gay”.
PERCHÉ la famiglia che è descritta dai pulpiti non ha nessun contatto con quello che avviene nella società. Lasciamo stare gli atteggiamenti soggettivi e le ebbrezze passeggere. Il nodo di fondo è che è saltato il vecchio impianto della famiglia - come si è retta ancora fino alla II guerra mondiale - dei contadini, degli operai, dei borghesi grandi e piccoli che si sposavano tra i venti e i trent’anni. Che avevano di fronte a sé il binario di prospettive sostanzialmente stabili, consuetudinarie, senza grandi scosse culturali.
Questa famiglia non c’è più. Cos’è capace di dire la Chiesa-istituzione ai giovani uomini e alle giovani donne che riescono a crearsi una vita economicamente più o meno “sistemata” (e spesso meno che più) sul finire dei trent’anni se non intorno ai quaranta? Cosa dovrebbero fare nei due decenni di intervallo fra la pubertà e il matrimonio o la convivenza? “Peccare” solitariamente o in due, correndo poi al confessionale... attendere il principe azzurro e la regina dei sogni?
C’è un parlare astratto dai pulpiti che chiude gli occhi dinanzi alla realtà, niente affatto composta nella sua grande maggioranza da “peccatori” o edonisti, ma da uomini e donne che cercano la loro strada. E ritengono positivi i rapporti prematrimoniali, mettersi alla prova, sperimentare la vicinanza dei corpi e dei temperamenti perché non ha senso imbarcarsi in naufragi.
Il vecchio modello non si reggeva su anime più virtuose, ma sul mero fatto della subordinazione della donna, che una volta entrata nella struttura del matrimonio “lì stava”, mentre l’uomo proseguiva sentendosi garantita comunque una propria libertà. Non è più così. Il divorzio è stato assunto da centinaia di milioni di persone - del tutto pacate, equilibrate, non consumiste - come un dato di valore. Giustamente. Il disvalore è il fallimento di un legame, la fine di un progetto, il deteriorarsi di una vita insieme. Non la presa d’atto responsabile della fine. Sciogliere un rapporto quando non c’è più “comunione” e comunicazione è positivo, liberatorio, vivificante.
SI VIVE insieme in molti modi, oggi. Si formano coppie eterosessuali o gay fortemente solidali, che accettano anche la prospettiva che un domani le vie possano separarsi. Perché si è cresciuti con ritmi diversi, perché non si condivide più lo stesso progetto. Ci si sposa, ci si separa, si convive, si vive da soli, ci si risposa, si vive in case separate. Il modello Mulino Bianco non esiste più. Da tempo. Non è il segno di un arbitrio sfrenato. È il prodotto di una società che rende tutti più mono-nucleari. Una società segnata fortemente anche dall’incertezza economica. Una società più mobile, più liquida.
QUANDO IL cardinale Bagnasco descrive la gioventù italiana come “generazione inascoltata”, senza futuro - cogliendo l’angoscia derivante dalla perenne precarietà - bisogna poi capire (come fanno da decenni i parroci) che è tramontato il contesto in cui coppie speranzose si accostavano all’altare o andavano in municipio appena superati i vent’anni.
Vuol dire che la Chiesa non ha più spazio per trasmettere valori evangelici nei rapporti tra uomo edonna, tra persona e persona, tra genitori e figli? Niente affatto. Ha moltissimo da dire sul rispetto, la tenerezza, l’amore, il perdono, la cura, la pazienza, lo sforzo, la solidarietà, il sacrificio, la condivisione, la responsabilità. Tutto ciò che attiene al nocciolo di quel comandamento senza tempo che dice: “Ama il tuo prossimo come te stesso”. Perché, come spiegano gli esegeti, soltanto riconoscendo l’Altro simile a me, io e noi possiamo vivere in pace, in serenità.
E moltissimo, naturalmente, può venire da un messaggio religioso per la dimensione educativa, quel mondo complicato, affascinante, sempre da esplorare in cui i genitori fanno crescere i figli in modo che siano maturi e indipendenti.
Però per ritrovare l’ascolto delle nuove (e meno nuove) generazioni la Chiesa dovrebbe abbandonare l’ossessione di controllare il territorio della sessualità e dei rapporti interpersonali come è stato nei secoli passati. Quella stagione non tornerà più. I ragazzi che osannavano Wojtyla al giubileo di Tor Vergata, poi sotto le tende facevano felici all’amore.
Se poi l’uso delle parole papali deve servire per perpetuare il veto ad una legislazione sulle coppie di fatto, è ora che si dica basta a quei politici, che legittimamente vivono la propria vita e poi pretendono - tra una baciata di pila e l’altra - di ingabbiare di veti le esistenze altrui.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- Il cardinale Bertone e la sconfitta del terzo B. Affonda anche la politica di sostegno ad oltranza offerta dal Vaticano al sistema di potere berlusconiano (di Marco Politi)..1 giugno 2011
Il cardinale Bertone e la sconfitta del terzo B.
C’è un terzo “B” sconfitto nella primavera italiana. Si chiama Bertone. Cardinale Tarcisio Bertone, segretario di Stato vaticano. Nel rovescio inglorioso, che colpisce il premier e l’alleato Bossi, affonda anche la politica di sostegno ad oltranza offerta dal Vaticano al sistema di potere berlusconiano.
di Marco Politi (il Fatto Quotidiano, 1 giugno 2011)
CI SONO STATI , a tratti, moniti sui comportamenti di Berlusconi da parte della presidenza della Cei, a volte critiche più ruvide sono venute dal giornale dei vescovi Avvenire, ma niente ha smosso il segretario di Stato vaticano dalla linea di benevola copertura nei confronti del berlusconismo. Al cambio della guardia tra Ruini e Bagnasco alla presidenza della conferenza episcopale italiana nel marzo 2007, Bertone con lettera ufficiale avocò a sé i rapporti tra Chiesa e governo italiano. “Per quanto concerne i rapporti con le istituzioni politiche - mise nero su bianco rivolto a Bagnasco - assicuro fin d’ora a vostra eccellenza la cordiale collaborazione e la rispettosa guida della Santa Sede, nonché mia personale”. Compito della Segreteria di Stato, spiegò, è di “intessere e promuovere le relazioni con gli Stati e di attendere agli affari che, sempre per fini pastorali, debbono essere trattati con i Governi civili”.
In questi anni la “guida” di Bertone non ha mostrato una Chiesa super partes, impegnata nella sua missione pastorale. L’applicazione concreta si è tradotta in un sistematico puntello al Cavaliere qualunque cosa facesse. Da Letizia Noemi a Ruby niente - nonostante qualche lieve, episodica scossa - ha mutato il corso della linea Bertone. Il Vaticano ha chiuso gli occhi sulle violazioni più eclatanti dell’etica pubblica e ha assistito inerte ad una macelleria istituzionale, che continua a stupire le cancellerie delle democrazie occidentali.
PER IMPEDIRE ad un milione di cittadini italiani di stringere un patto di coppia solidale con diritti e doveri garantiti dalle istituzioni, per impedire una legge che desse diritto ai malati terminali di non restare attaccati ad un tubo ad ogni costo, tutto del sistema berlusconiano è stato tacitamente benedetto. E benevolenti sorrisi sono stati riservati ai proclami di fedeltà del premier, frenetico nel ricordare i suoi trascorsi salesiani. “Da parte mia non verrà mai nulla contro il Vaticano”, dichiarò il 10 dicembre scorso, quattro giorni prima del voto di fiducia , guardando negli occhi il salesiano Bertone ad un pranzo con altri nove neocardinali nell’ambasciata d’Italia presso la Santa Sede.
Nell’imbarazzo degli stati d’Europa e d’America una delle più antiche diplomazie del mondo è stata piegata ai disegni di potere berlusconiani. Lo si è avvertito con cruda chiarezza nell’agosto 2009, quando Il Giornale attaccò Boffo. Mentre Feltri massacrava il direttore del giornale dell’episcopato italiano, l’Osservatore Romano criticava pubblicamente la linea di Avvenire in tema di immigrazione, facendo sapere a tutti che i rapporti con il governo erano “eccellenti”. Per pudore Bertone aveva dovuto disdire il pranzo con Berlusconi all’Aquila in occasione della festa della Perdonanza, ma poche settimane dopo all’aeroporto di Ciampino il Cavaliere poteva presentarsi tranquillamente davanti a Benedetto XVI in partenza per Praga, che lo accoglieva con un “che piacere rivederla”.
È stato un collateralismo tenace, quello praticato dal cardinale Bertone in questi anni. Non ha certo giovato al prestigio della Chiesa. Quando l’8 luglio 2010 il segretario di Stato si presentò a casa Vespa per partecipare ad una “cena di compleanno”, organizzata per consentire a Berlusconi di persuadere Casini a rientrare nel suo governo - sotto l’ala protettiva di Santa Romana Chiesa - anche in Vaticano si sentirono diffusi mormorii di critica per l’infelice partecipazione. Alle elezioni i moderati e i cattolici hanno mostrato di andare da un’altra parte, tocca al Vaticano decidere se continuare con la linea Bertone o lasciare che l’Italia possa iniziare a rigenerarsi. Bene sarebbe che anche i vescovi venissero lasciati liberi di captare l’umore dei fedeli.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- LA CADUTA DA CAVALLO. La Chiesa istituzionale ha seguito Comunione e Liberazione e i suoi uomini al servizio di Berlusconi a occhi chiusi, con una assenza di discernimento semplicemente sconvolgente (di Mirella Camera) .31 maggio 2011, di Federico La Sala
La caduta da cavallo
di Mirella Camera
 in “a latere...” (http://alatere.myblog.it/) del 31 maggio 2011 *
in “a latere...” (http://alatere.myblog.it/) del 31 maggio 2011 *E ora si moltiplicano le analisi per capire cosa è successo nell’elettorato alle elezioni amministrative che hanno messo ko Berlusconi. Eppure è di una semplicità elementare: il troppo stroppia. C’è un punto di rottura in tutte le cose, persino dopo il costante lavoro di anestesia delle coscienze che il berlusconismo ha compiuto in 20 anni.
Lo svelamento avviene per gradi. All’inizio una deformazione può essere celata, e quando emerge la si può persino considerare come qualcosa di nuovo e originale, una caratteristica che fa personaggio. Poi però la deformazione cresce e prende il sopravvento, così come si esaltano certi tratti in una caricatura. Se nessuno la ferma, si nutre di se stessa e diventa abnorme, paradossale, grottesca. E’ quello che è successo allo stile politico di Berlusconi e dei suoi fedelissimi nell’ultimo anno, compiendo questa metamofosi; o meglio, svelando la sua profonda natura e rendendola visibile attraverso una sempre crescente deformità che solo i ciechi e i disonesti intellettuali hanno continuato a sostenere come se fosse "normale".
I ciellini di corte, supportati da gerarchie completamente accecate, in questi anni hanno aiutato il berlusconismo ad avvelenare la convivenza in cambio del biblico piatto di lenticchie, e sono arrivati a capovolgere i più elementari principi del buon senso, prima ancora che dell’etica cristiana.
Una volta Giorgio Vittadini ha detto: "Berlusconi è un puttaniere, ma dobbiamo voltarlo per difendere i valori della famiglia". Se la logica è questa possiamo continuare: B, è un bugiardo, ma dobbiamo votarlo per difendere la verità; è un corruttore, ma dobbiamo votarlo per difendere la giustizia; è uno che pensa solo ai suoi interessi, ma dobbiamo votalo per difendere il bene comune; ha come dio il potere e il denaro, ma dobbiamo votarlo per difendere la religione cattolica. E così hanno fatto.
Persino dopo la disfatta di Milano, a urne ancora calde, Formigoni ha rilasciato un’intervista nella quale vagheggiava di portare Berlusconi al Colle, mettendo là, dove dovrebbe stare la più alta figura di garanzia istituzionale, colui che ha fatto strame delle istituzioni e dichiarato guerra alla stessa Costituzione.
In questi anni solo poche voci di cattolici si sono levate, ed erano quelle di singoli commentatori, di comunità di base, di gruppi legati al volontariato, di piccole chiese locali, di stampa minore, se si esclude la voce sempre chiara e inequivocabile di Famiglia Cristiana. La Chiesa istituzionale ha seguito Comunione e Liberazione e i suoi uomini al servizio di Berlusconi a occhi chiusi, con una assenza di discernimento semplicemente sconvolgente. Solo nell’ultima prolusione il cardinal Bagnasco ha preso le distanze, pur con quella sua prosa tutta "prudenza" che dice e non dice. Ma c’è voluta tutta la forza straniante del grottesco per insinuare qualche disagio in una Chiesa che dovrebbe invece coltivare come un tesoro il dono della profezia.
Il berlusconismo sta tramondando. Probabilmente non sarà un processo rapido e indolore. I cocci resteranno a lungo nella convivenza civile. E soprattutto rimarrà la costernazione, lo stupore, il dolore di moltissimi cattolici nell’aver visto in tutti questi anni la Chiesa italiana affiancare con la sua autorevolezza proprio chi inoculava nel Paese un’anticultura fatta di menzogne, corruzione, prepotenza, disprezzo delle regole, ingiustizia, egoismo, slealtà, amoralità, idolatria del potere. Lontana anni luce dallo stile evangelico.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- LA MUMMIA TELEVISIVA (di Norma Rangeri).21 maggio 2011, di Federico La Sala
La Mummia televisiva
di Norma Rangeri, (il manifesto, 21.05.2011)
Non più la libreria del leader giovane che seduce gli italiani con il sogno ceronato. Al suo posto un politico lento nel parlare, lo sguardo fisso, i capelli dipinti e il volto colorato come una mummia della nomenklatura sovietica. Dopo una settimana di silenzio, colpito dal flop delle preferenze nel forziere del suo elettorato, il premier si è presentato sulle reti televisive e radiofoniche (controllate o di proprietà) per un appello al voto di quattro minuti.
Il conflitto di interessi entra nelle case degli italiani seguendo gli orari delle edizioni di sei telegiornali. Pesante e asfissiante nella normalità dei palinsesti, si ripresenta con Berlusconi che parla come capo del governo e come candidato al comune di Milano, con il simbolo del Pdl formato gigante dietro le spalle e la didascalia che lo indica come presidente del consiglio. Una manifestazione di arroganza nel mezzo di una corsa elettorale che sta perdendo, una prova di forza di un leader dimezzato nel consenso e nella presa sulla maggioranza di governo.
Il presidente-candidato si appella ai moderati con l’estremismo del linguaggio leghista, visibile ostaggio degli umori dell’alleato, appeso agli interessi delle camicie verdi che hanno impostato la musica del secondo tempo della campagna elettorale coprendo i muri di Milano con lo slogan «la zingaropoli di Pisapia». Al quale lo spot di Berlusconi aggiunge una nota sul tema (l«Pisapia vuole baracca libera») nella finta intervista che inonda il piccolo schermo, accompagnata dalle faccette patetiche dei caporali dei telegiornali travestiti da giornalisti.
E’ un Berlusconi imbalsamato nella parodia del berlusconismo («con noi meno tasse per tutti, toglieremo anche l’ecopass a Milano») quello che chiama i milanesi e i napoletani al voto contro la sinistra. Tenta la rincorsa del centrodestra verso i ballottaggi evocando i fantasmi della sua realtà parallela, sventolando l’immagine di Milano trasformata nella «Stalingrado d’Italia», prigioniero di un mondo che non c’è più, impantanato in un’ideologia sempre meno capace di egemonia. Conosce la manipolazione demagogica e la proclamazione dell’emergenza, il vecchio armamentario che ricicla per rivolgersi a un elettorato che sarà moderato ma ha dimostrato di non essere così sprovveduto.
Berlusconi non ha scelto il comizio di piazza o la platea di qualche palazzetto, troppo pericoloso affrontare lo scontento delle città che gli hanno voltato le spalle. Meglio mettere la faccia nel territorio protetto del feudo mediatico, dove le telecamere si muovono sotto il suo controllo, e i telespettatori non hanno diritto di replica.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- BIOTESTAMENTO: UNA PAGA PER IL VATICANO (di Marco Politi)28 aprile 2011, di Federico La Sala
Una paga per il Vaticano
di Marco Politi (il Fatto Quotidiano, 28 aprile 2011)
Berlusconi paga sull’unghia. Uno strapuntino nel governo ai responsabili-pronti-a-tutto. Una legge sul biotestamento, che espropria il paziente di qualsiasi decisione, per tacitare la Chiesa e garantirsi il suo appoggio.
Le gerarchie ecclesiastiche si adombrano, quando si accenna al do ut des. Ma è sotto gli occhi di tutti. In cambio delle concessioni sui principi “non negoziabili”, la Chiesa italiana chiude gli occhi sullo sfascio inflitto dal premier al Paese.
Il testamento biologico non spacca gli italiani, non divide credenti e sinistre - come continua caparbiamente a sostenere la stampa ecclesiastica - non separa cattolici da laici. Il diritto del paziente di non essere sottoposto a trattamenti medici contro la propria volontà, sancito dalla Costituzione, è un concetto radicato nella stragrande maggioranza degli italiani. Se i media ecclesiastici vogliono conoscere la voce del Paese, possono facilmente rintracciare i sondaggi che da anni confermano la stessa tendenza. Dai due terzi ai quattro quinti degli italiani vogliono decidere personalmente se rimanere attaccati a un tubo o dipendere a oltranza da trattamenti artificiali. Non c’entra l’eutanasia, non c’entra la voglia di darsi la morte. È in gioco - lo ribadiscono da sempre coscienze cattoliche come il filosofo Giovanni Reale - la scelta se lasciare che la morte arrivi naturalmente o accanirsi a rimandarla tecnologicamente.
L’ultimo sondaggio all’interno del collegio dei chirurgi italiani certifica che il 73 per cento di loro considera “trattamento medico” la nutrizione e l’alimentazione artificiale e quindi un argomento su cui il paziente ha diritto di decidere. Anche all’interno del Pdl già nel 2009 il 70 per cento era per il biotestamento (dati Crespi). I cattolici quotidiani hanno già scelto.
La cinica manovra di Berlusconi nasce dalla paura che il Terzo polo lo possa scavalcare nei rapporti con la Chiesa e dal desiderio di demonizzare le sinistre come partito anti-vita. Al di là di queste miserie, resta che la legge anti-paziente, che il premier e la gerarchia vogliono varare, è imposta contro la volontà degli italiani: credenti e diversamente credenti.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- LA MENZOGNA COME BANDIERA (di Barbara Spinelli).19 aprile 2011, di Federico La Sala
La menzogna come bandiera
di BARBARA SPINELLI *
DUE mesi prima della marcia su Roma, l’8 agosto 1922, Luigi Einaudi prese la penna e disse quel che andava detto nelle ultime ore della democrazia. Disse alcune cose semplici, profetiche: che "è più facile sperare di risolvere con mezzi rapidi ed energici un problema complesso, che risolverlo in effetto". Che l’idea di sostituire il politico con uomini provenienti dalle industrie, dalla "vita vissuta", è favola perniciosa.
Nella favola i non-politici "trasporteranno al governo i metodi di azione che sono loro familiari; faranno marciare le ferrovie; licenzieranno gli inetti; incuteranno un sano terrore agli altri". Ma è una chimera, e la macchina s’incepperà: "Il problema da risolvere non è già di trovare dei grandi industriali disposti a governare la cosa pubblica con la mentalità industriale. Essi non potranno fare che del male. Saranno degli straordinari improvvisatori". Saranno audaci, ma il primo impulso di simili audaci è di semplificare quel che è complesso: "di tagliare i nodi gordiani, di mandare a spasso il giudice che non decide un processo in ventiquattro ore, di ordinare ai direttori delle banche di emissione di far scendere il cambio del dollaro a 10 lire e così via".
Gli italiani tuttavia erano attratti dalla chimera, allora come oggi. Il fatto è che si sentivano abbattuti, tristi: erano "come malati che non trovano tregua alle loro sofferenze da qualunque lato si voltino". La via della dittatura pareva così rapida, e brillante, mentre com’era "noiosa, fastidiosa, minuta, la via della legalità costituzionale, sotto il maligno sguardo di giornali avversari e infidi"! È a questo punto che Einaudi, che nel ’48 sarà il secondo Presidente della Repubblica, ricorda come esista una sola salvezza dall’errore e il disastro che è la dittatura: la discussione, essenza della democrazia. Al cittadino triste e malato ci si rivolge con fiducia, non trattandolo come un triste, un malato. Meglio informarlo bene e aiutarlo a discutere sul vero e il falso, piuttosto che dargli verità preconfezionate per sedarlo. Meglio una pluralità di poteri, che il potere apparentemente efficace di uno solo.
Sono saggezze che tanti italiani hanno difeso lungo il tempo, ma che si sfaldano quando viene meno la discussione libera. Si sfaldano da quasi un ventennio e spesso vien da pensare che siamo nella stasi più totale, ma non è così: ultimamente qualcosa si è incrinato ancor più vistosamente. Accusato di reati commessi prima e dopo essere entrato in politica, il premier ha smesso di presentare le leggi che si fa cucire sulla propria persona come utili per l’intero Paese. I suoi seguaci, politici o giornalisti, hanno cominciato a dire apertamente, senza remore, che sì, il Parlamento deve mobilitarsi per mettere il capo sopra la legge e le corti. Il capo è quel conta, e i suoi eventuali reati sono bazzecole, da non evocare. Di bene pubblico nessuno parla più, l’inganno si disfa e tutto ruota attorno a un privato che governando gode di meritati privilegi.
È cosa sana e buona, rispondere a un attacco giudiziario ad personam con leggi ad personam. Lo stesso Berlusconi ha citato il mitico mugnaio prussiano che nel ’700 decise di veder riconosciute le proprie ragioni, e ai soprusi di Federico il Grande replicò: "C’è pur sempre un giudice a Berlino". Solo che Berlusconi non è un mugnaio, diffida d’ogni giudice, ed essendo Re assoluto pensa di non dover rispondere dei propri soprusi, di potersi fare giustizia da sé. Perfino l’apologo sulla giustizia del mugnaio è riuscito a riscrivere, trasformandolo in apologo dell’impunità.
Altra incrinatura visibile, da settimane, è nel linguaggio dei potenti. I giudici che indagano sui reati sono chiamati ufficialmente brigatisti (Berlusconi davanti alla stampa estera, 13 aprile). Il loro scopo è sovvertire lo Stato, violare la sovranità del popolo elettore. Egualmente eversore è chiunque dissenta: giornalisti, intellettuali, coi quali non si discute. È lunga la lista dei neo-terroristi, e in cima a tutti sta ora Asor Rosa. Probabilmente anche il cardinale Tettamanzi disarticola lo Stato, avendo detto domenica scorsa al Duomo che davvero paradossali sono questi giorni in cui tocca domandarsi: "Perché ci sono uomini che fanno la guerra, ma non vogliono si definiscano come "guerra" le loro azioni violente? Perché molti agiscono con ingiustizia, ma non vogliono che la giustizia giudichi le loro azioni?". Siamo, insomma, davanti a un salto di qualità importante, a qualcosa che somiglia a una vigilia: tanto esibiti, innalzati come stendardi, sono inganni e paradossi.
Il colmo, a mio parere, è stato raggiunto con l’elogio, da parte di un giornale del potere berlusconiano, del Grande Inquisitore di Dostoevskij (Il Foglio, 16-4). Nelle Lamentazioni che si recitano alla vigilia della Croce e della Resurrezione, Geremia parla di abominio, di panno immondo, e c’è un elemento di abominio nell’allegra difesa di una delle più nere leggende della letteratura. Come pretesto si è scelto il libro di Franco Cassano, L’Umiltà del Male (Laterza). La leggenda narra di Gesù che torna sulla Terra - con la sua mitezza, con i suoi messaggi di libertà - e per la seconda volta, quindici secoli dopo la sua morte, è giustiziato.
Ma il libro è stravolto, usato in difesa del nostro premier. L’Inquisitore non è forse santo ma di certo è più attento alle umane debolezze di quanto lo sia stato Cristo, perché sa quanto il male sia radicato nell’uomo e come difficile sia estirparlo e dare pace ai mortali infelici invece che tormento e angoscia. Sa che l’uomo non sopporta la libertà che Cristo gli ha dato: che la salvezza la troverà inginocchiandosi davanti all’autorità, commettendo le colpe che vuole ma col consenso delle gerarchie ecclesiastiche, le quali prenderanno su di sé il castigo patteggiando con Satana. Le parole che ho letto sabato sul quotidiano berlusconiano sono stupefacenti.
È scritto che il cardinale gesuita di Siviglia (l’Inquisitore), "impartisce (a Gesù) una lezione appassionata e tragica di umiltà del male e di teologia della storia e nella storia, spiegandogli che il suo aristocratismo etico, la sua bontà naturale e santa, non riesce a fare i conti, come riesce invece e bene la sua chiesa gerarchica, con la natura radicale del peccato umano". Gesù non ha la boria e la iattanza dei neopuritani che oggi avversano Berlusconi, ma in fondo appartiene anch’egli a una minoranza etica, che non ama gli uomini come li ama e li aiuta la Chiesa. Solo la Chiesa e l’Inquisitore amano davvero, perché tengono conto dei "bisogni umili delle maggioranze relativamente indifferenti, di coloro che non sono tra gli eletti, che per insicurezza chiedono protezione e sogni, magari anche rivolgendosi ad agenti del male, e che praticano la tutela del proprio interesse legittimo nelle forme e nei modi possibili alla creatura umana sofferente".
Se Gesù non diventa un brigatista, è solo perché nel momento decisivo (un momento musicale, vien definito) tace e bacia l’Inquisitore, a suo modo assoggettandosi. Così vengono distorti sia Gesù sia Dostoevskij: con il suo bacio, infatti, Gesù non s’assoggetta affatto; non accetta il parere dell’Inquisitore e i consigli di Satana. Il bacio è dato perché l’Inquisitore ha detto la verità, su se stesso e la Chiesa (la Chiesa gerarchica, non la Chiesa-popolo di Dio). Perché ancora una volta, come sempre ha fatto, Gesù restituisce all’uomo, compreso il malvagio, la piena libertà di scegliere, ragionando, tra il bene e il male. Dostoevskij almeno lo racconta così: il vecchio Inquisitore sussulta, "il bacio gli arde nel cuore" anche se resiste nella sua idea.
Non ho mai letto elogi simili del Grande Inquisitore, e mi domando cosa li renda possibili: oggi, qui in Italia. Forse perché siamo oltre la constatazione che l’umanità è fatta di un legno storto. La stortura non è constatata, ma incensata, addirittura cavalcata. Una sfiducia radicale negli uomini permette agli inquisitori odierni di trasformare il male e l’ingiustizia in vanti personali messi trionfalmente in mostra. L’uomo è malvagio. Inutile, assurdo, scommettere sulla sua libertà come fece Cristo, perché questa libertà la creatura umana vuole consegnarla, in cambio di protezione e sogni (di "felici canzoni infantili e cori e danze innocenti", scrive Dostoevskij) a chi usa le tre grandi forze necessarie al controllo delle coscienze: il miracolo, il mistero, l’autorità.
Per questo si giunge sino a sfoderare la menzogna come bandiera. Si dice senza temere smentite che Berlusconi è stato sempre assolto nei processi. È un falso: su 16 processi, solo 3 lo hanno assolto, gli altri o sono stati prescritti o è stato abolito il reato con leggi ad hoc. Si dice che i suoi processi iniziarono appena entrò in politica. È un falso: cominciarono prima, e fu colpa di tutta la classe politica accogliere chi era gravemente indagato. Da allora mentire è divenuto possibile, fino alle escrescenze odierne. Da allora la democrazia ha smesso di essere discussione e separazione dei poteri, intrisa com’è di paure, ricatti, silenzi inauditi. La macchina non ha funzionato, ma resta l’illusoria speranza in un audace, che infranga le leggi e permetta agli uomini deboli, inermi, di consegnargli la loro libertà in cambio di favole e favori.
* la Repubblica, 19 aprile 2011
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- L’AVVIO DEL FEROCE ATTACCO DELLA CHIESA ALL’ITALIA. Due discorsi al Quirinale: Benedetto XVI e Carlo Azeglio Ciampi (2005).10 aprile 2011, di Federico La Sala
Data di pubblicazione: 27.06.2005 *
"Se fossi Papa..."
di Federico La Sala *
Se fossi nei panni di Papa Benedetto XVI e ... avessi ancora un po’ di dignità di uomo, di studioso, di politico, e di cristiano - oltre che di cattolico, dopo l’incontro di ieri con il Presidente della Repubblica Italiana, di fronte all’elevato ed ecumenico discorso di Carlo Azeglio Ciampi (lodevolmente, L’Unità di oggi, 25.06.2005, a p. 25, riporta sia il discorso del Presidente Ciampi sia di Papa Benedetto XVI), considerato il vicolo cieco in cui ho portato tutta la ’cristianità’ (e rischio di portare la stessa Italia), prenderei atto dei miei errori e della mia totale incapacità ad essere all’altezza del compito di "Vescovo di Roma e Pastore della Chiesa universale", chiederei onorevolmente scusa Urbe et Orbi, e ....convocherei immediatamente un nuovo Concilio!!!
Non me la sento di insegnare ad altri come fare un mestiere che non è il mio, ma credo che tutti abbiano apprezzato la difesa della laicità dello Stato italiano compiuta da Ciampi. La ringrazio dei documenti, che allego.
 Due discorsi al Quirinale (Benedetto XVI e Carlo Azeglio Ciampi.pdf 25.29 KB )
Due discorsi al Quirinale (Benedetto XVI e Carlo Azeglio Ciampi.pdf 25.29 KB )* EDDYBURG
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE.--- L’ILLUSIONE DI UN VATICANO SENZA MEMORIA: L’ITALIA RIDOTTA A SUO CORTILE! Come se il Galileo della Galilea e Galileo Galilei non fossero mai esistiti! La lettera scritta da Benedetto XVI al presidente Napolitano in occasione del 150° dell’Unità d’Italia commentata da Piero Stefani8 aprile 2011, di Federico La Sala
Cliccare sul rosso, per leggere l’articolo:
 SCIENZA, FEDE, E "SIDEREUS NUNCIUS": "VICISTI, GALILAEE"! PER KEPLERO (1611), GALILEO HA VINTO NON SOLO SUL PIANO SCIENTIFICO, MA ANCHE TEOLOGICO E POLITICO!!! COSI’ PER KANT ....
SCIENZA, FEDE, E "SIDEREUS NUNCIUS": "VICISTI, GALILAEE"! PER KEPLERO (1611), GALILEO HA VINTO NON SOLO SUL PIANO SCIENTIFICO, MA ANCHE TEOLOGICO E POLITICO!!! COSI’ PER KANT ....
 L’ILLUSIONE DI UN VATICANO SENZA MEMORIA: L’ITALIA RIDOTTA A SUO CORTILE! Come se il Galileo della Galilea e Galileo Galilei non fossero mai esistiti! La lettera scritta da Benedetto XVI al presidente Napolitano in occasione del 150° dell’Unità d’Italia commentata da Piero Stefani
(...) L’omissis più macroscopico è però un altro. Si tratta di un nome studiato anche in sede di letteratura italiana. Parliamo, è scontato dirlo, di Galileo, colui che scrisse in italiano quanto fino ad allora era riservato al latino. Per una Chiesa non ipocrita sarebbe stato il primo nome da citare, anche al fine di confutare, attraverso la sincerità, l’uso strumentale fattone da altri. Ciò vale anche per Savonarola e Giordano Bruno (...)
L’ILLUSIONE DI UN VATICANO SENZA MEMORIA: L’ITALIA RIDOTTA A SUO CORTILE! Come se il Galileo della Galilea e Galileo Galilei non fossero mai esistiti! La lettera scritta da Benedetto XVI al presidente Napolitano in occasione del 150° dell’Unità d’Italia commentata da Piero Stefani
(...) L’omissis più macroscopico è però un altro. Si tratta di un nome studiato anche in sede di letteratura italiana. Parliamo, è scontato dirlo, di Galileo, colui che scrisse in italiano quanto fino ad allora era riservato al latino. Per una Chiesa non ipocrita sarebbe stato il primo nome da citare, anche al fine di confutare, attraverso la sincerità, l’uso strumentale fattone da altri. Ciò vale anche per Savonarola e Giordano Bruno (...)-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE.--- C’E’ DIO E "DIO", PATRIA E "PATRIA", FAMIGLIA E "FAMIGLIA" ... E CAPO E "CAPO": LENIN E MUSSOLINI. L’analisi di Gramsci, una bussola per non naufragare.8 aprile 2011, di Federico La Sala
 INDIVIDUO E SOCIETA’, OGGI. APRIRE GLI OCCHI: C’E’ DIO E "DIO", PATRIA E "PATRIA", E FAMIGLIA E "FAMIGLIA" .....
INDIVIDUO E SOCIETA’, OGGI. APRIRE GLI OCCHI: C’E’ DIO E "DIO", PATRIA E "PATRIA", E FAMIGLIA E "FAMIGLIA" .....
 ROMOLO AUGUSTOLO: L’ITALIA NON E’ NUOVA A QUESTI SCENARI. C’E’ CAPO E "CAPO" E STATO E "STATO": MUSSOLINI E LENIN A CONFRONTO. L’analisi di Gramsci, una bussola per non naufragare e una lezione di vita e di libertà
ROMOLO AUGUSTOLO: L’ITALIA NON E’ NUOVA A QUESTI SCENARI. C’E’ CAPO E "CAPO" E STATO E "STATO": MUSSOLINI E LENIN A CONFRONTO. L’analisi di Gramsci, una bussola per non naufragare e una lezione di vita e di libertà
 ANTONIO GRAMSCI (1924). "Roma non è nuova a questi scenari polverosi. Ha visto Romolo, ha visto Cesare Augusto e ha visto, al suo tramonto, Romolo Augustolo".
ANTONIO GRAMSCI (1924). "Roma non è nuova a questi scenari polverosi. Ha visto Romolo, ha visto Cesare Augusto e ha visto, al suo tramonto, Romolo Augustolo".
-
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- “Benedetto roi d’Italie. Chronique d’un pays à l’ombre du Vatican”. intervista a Martine Nouaille, a cura di Amanda Breuer Rivera.31 marzo 2011, di Federico La Sala
“Il Vaticano porta avanti una strategia di riconquista europea”
 intervista a Martine Nouaille, a cura di Amanda Breuer Rivera
intervista a Martine Nouaille, a cura di Amanda Breuer Rivera in “www.lemondedesreligions.fr” dell’11 marzo 2011
in “www.lemondedesreligions.fr” dell’11 marzo 2011
 (traduzione: www.finesettimana.org)
(traduzione: www.finesettimana.org)Secondo il suo libro “Benedetto roi d’Italie. Chronique d’un pays à l’ombre du Vatican”, il papa domina la politica italiana...
Sì, per una ragione molto semplice, Silvio Berlusconi ha bisogno del Vaticano per conquistare una parte dell’elettorato e non gli rifiuta niente. Per questo, la Chiesa influenza la vita politica italiana negli ambiti che le interessano prioritariamente, cioè sui temi della morale e della bioetica, in nome dei valori superiori del cristianesimo. Per il Vaticano, la vita politica deve ispirarsi ai suoi valori. Ad esempio, il parlamento italiano delibera attualmente una legge mirante a proibire alle persone malate in fin di vita di ricorrere all’eutanasia passiva. Questa legge fa riferimento al caso Eluana del 2008. In stato vegetativo da anni, suo padre voleva lasciarla morire tranquillamente. Ma la Chiesa cattolica vi si è fermamente opposta.
C’è un’influenza crescente della Chiesa cattolica sulla politica italiana?
È difficile dirlo, perché il suo potere è molto legato alla personalità del presidente del Consiglio. Pur essendo in maggioranza cattolica e legittimista con il papa, la società italiana ha un comportamento laico e molto secolarizzato. Niente dovrebbe impedire ai politici di prendere le distanze dall’influenza del Vaticano sulle istituzioni e sui partiti. Eppure, fino ad ora, Silvio Berlusconi ha avuto bisogno del sostegno del Vaticano e ha potuto riceverne un appoggio. Ma questo sostegno comincia a sbriciolarsi a causa della sua vita personale molto contestata.
In Francia esiste una relazione simile tra il potere e il Vaticano?
No, la Francia è un paese laico. Certo, il presidente Nicolas Sarkozy ha affermato che i valori cristiani fanno parte della nostra eredità e ha aggiunto che i preti sono superiore ai maestri. Nonostante tutto, tanto le istituzioni che le mentalità non sono affatto disposte a subire uno stretto rapporto con il Vaticano. L’Italia è un caso particolare per ragioni storiche. Per molto tempo i papi hanno avuto un potere temporale su Roma e si sono opposti fino all’ultimo all’unificazione italiana per conservare questo potere. Dato che l’unificazione è recente, il Vaticano conserva una forte influenza sul paese, ma in Francia non è così. Il Vaticano non ha qui una grande rete e non può imporre la sua legge. Tuttavia i poteri politici possono fargli delle concessioni, come ad esempio sulle leggi di bioetica.
Nel suo libro, lei sviluppa la tesi di una strumentalizzazione della religione da parte di certi regimi democratici. Può chiarire meglio?
Le nostre società liberali, come le conosciamo noi, attualmente non hanno più punti di riferimento culturali ed ideologici. Quindi certi politici, come Silvio Berlusconi o Nicolas Sarkozy, cercano di riempire questo vuoto con riferimenti al religioso. Ma in Francia il religioso non è più un patrimonio comune a tutti. Nicolas Sarkozy ha una concezione della laicità diversa da quella della Chiesa. Se la “sana laicità” del papa è una laicità che riconosce i valori cristiani come valori che devono guidare la società, la “laicità positiva” del presidente assegna alla religione un ruolo di legame sociale e di gendarme ideologico. Tuttavia, quando valorizza le “radici cristiane della Francia”, non si rende conto che questa rivendicazione indebolisce i legami sociali che erano basati sulla “laicità francese”, quella in cui le religioni sono un fatto privato e non devono intervenire nelle scelte politiche in quanto tali.
Quali sono le conseguenze?
Penso che con il dibattito attuale sulla laicità, promosso dall’UMP e da Nicolas Sarkozy, si finisce per offuscare dei riferimenti importanti della vita in società. Non si sa più esattamente che cosa sia la laicità, la separazione tra Chiesa e Stato o la differenza tra ambito privato e ambito pubblico. C’è un certo indebolimento della laicità che è la base della nostra Repubblica.
L’indebolimento della laicità in Francia può essere una porta aperta al Vaticano?
In ogni caso, è l’obiettivo del papa. Sotto la sua influenza, il Vaticano è partito nel tentativo di riconquista spirituale dell’Europa. Non perde la speranza di rimettere in discussione questa laicità alla francese per far avanzare una “sana laicità”. Su scala europea, non ha rinunciato a rimettere in discussione certe leggi adottate attualmente da tutti i paesi democratici sulla morale, sull’unione omosessuale, sul diritto all’aborto, sul diritto di scegliere la propria vita nella dimensione più intima... Quindi anche se il Vaticano ha perso molte anime, continua a voler controllare i corpi.
Con quali mezzi pensa di riconquistare spiritualmente l’Europa?
Secondo l’iniziativa di Benedetto XVI, la riconquista spirituale dell’Europa si farà in parte attraverso il “Cortile dei gentili”. Questo nome si riferisce ad un passo del Vangelo in cui Gesù evoca il cortile del Tempio, luogo di discussione tra gli ebrei e i non ebrei. Il Vaticano vuole dialogare con i non-credenti, ma non con tutti. Secondo loro, non si pone neanche la possibilità di discutere con Michel Onfray, ad esempio. Ma sono pronti a discutere con un certo tipo di non-credenti ad esempio quelli che si interrogano sul vuoto lasciato dalla perdita del religioso. L’iniziativa del “Cortile dei gentili” si svolgerà in Francia alla fine del mese di marzo in tre luoghi emblematici: la Sorbona, l’Unesco, l’Académie Française, il Collège des Bernardins e il sagrato di Notre-Dame. Esiste quindi una strategia di riconquista cattolica. Ma si scontra con una secolarizzazione sempre più importante delle società. Quindi i giochi sono ancora tutti aperti!
(traduzione: www.finesettimana.org)
 Martine Nouaille, Benedetto roi d’Italie. Chroniques d’un pays à l’ombre du Vatican (Stock, 2011)
Martine Nouaille, Benedetto roi d’Italie. Chroniques d’un pays à l’ombre du Vatican (Stock, 2011) -
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- SUL CROCIFISSO, LA CORTE EUROPEA HA DETTO LA SUA PAROLA DEFINITIVA: E’ "UN SIMBOLO ESSENZIALMENTE PASSIVO", IRRILEVANTE! Per la Santa Sede e il Ministro Gelmini, al contrario, è una grande vittoria - per tenere in piedi la loro alleanza "mammonica"!19 marzo 2011
 EUROPA, COSTITUZIONE, E MESSAGGIO EVANGELICO. LA ’CROCE’ (lettera alfabeto greco = X) DI CRISTO NON HA NIENTE A CHE FARE CON IL CROCIFISSO DELLA TRADIZIONE COSTANTINIANA E CATTOLICO-ROMANA ...
EUROPA, COSTITUZIONE, E MESSAGGIO EVANGELICO. LA ’CROCE’ (lettera alfabeto greco = X) DI CRISTO NON HA NIENTE A CHE FARE CON IL CROCIFISSO DELLA TRADIZIONE COSTANTINIANA E CATTOLICO-ROMANA ...
 CHE SCHIAFFO AL VATICANO E AL GOVERNO ITALIANO! SUL CROCIFISSO, LA CORTE EUROPEA HA DETTO LA SUA PAROLA DEFINITIVA: E’ "UN SIMBOLO ESSENZIALMENTE PASSIVO", IRRILEVANTE! Per la Santa Sede e il Ministro Gelmini, al contrario, è una grande vittoria - per tenere in piedi la loro alleanza "mammonica"! Rassegna stampa ...
CHE SCHIAFFO AL VATICANO E AL GOVERNO ITALIANO! SUL CROCIFISSO, LA CORTE EUROPEA HA DETTO LA SUA PAROLA DEFINITIVA: E’ "UN SIMBOLO ESSENZIALMENTE PASSIVO", IRRILEVANTE! Per la Santa Sede e il Ministro Gelmini, al contrario, è una grande vittoria - per tenere in piedi la loro alleanza "mammonica"! Rassegna stampa ...
 (...) Per il governo italiano e il fronte pro-crocefisso è una vittoria a tutto campo. Nel motivare la sua decisione la Corte afferma come il margine di manovra dello Stato in questioni che attengono alla religione e al mantenimento delle tradizioni sia molto ampio (...)
(...) Per il governo italiano e il fronte pro-crocefisso è una vittoria a tutto campo. Nel motivare la sua decisione la Corte afferma come il margine di manovra dello Stato in questioni che attengono alla religione e al mantenimento delle tradizioni sia molto ampio (...)
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- «I maturandi portati al Divino Amore». Per scegliere l’università giusta tutti in processione al santuario. 5000 ragazzi al Divino Amore.15 marzo 2011, di Federico La Sala
 «I maturandi portati al Divino Amore»
«I maturandi portati al Divino Amore» Cinquemila ragazzi del quinto anno delle superiori romane «ad orientarsi» sul futuro in un Santuario. Paga Gelmini
Cinquemila ragazzi del quinto anno delle superiori romane «ad orientarsi» sul futuro in un Santuario. Paga Gelmini di Gioia Salvatori (l’Unità, 15.03.2011)
di Gioia Salvatori (l’Unità, 15.03.2011)Chissà che ne penserebbe Socrate di un ministro dell’Istruzione che nell’anno domini 2011 manda i giovani delle superiori in un santuario per una giornata di orientamento universitario.
Coi soldi pubblici (l’ufficio scolastico regionale del Lazio ha organizzato i trasporti) e per conoscere una vasta gamma di atenei pubblici e, ovviamente, privati. Eh già, infatti l’ecumenico orientamento dell’era Gelmini nasce da una collaborazione dell’ufficio ministeriale regionale con la conferenza dei rettori delle università del Lazio (CRUL) e la Conferenza dei Rettori delle Università Pontificie Romane (CRUPR) che magari si sentono più a casa al santuario del Divino Amore, luogo di pellegrinaggi in mezzo ai campi di Roma Sud. D’altronde si sa, la scelta dell’università è cosa seria, si ripercuote «sul lavoro e sulla vita, richiede consapevolezza e serenità indispensabili per ridurre il rischio dell’errore e decidere con responsabilità», quindi meglio proporre ai giovani un’ampia scelta di atenei e corsi, tante brochure, tanti, depliant, workshop e una giornata di “festa dell’orientamento”. Animata anche da un musical: “Oggi scelgo io”, interpretato dalla Star Rose Academy fondata dalle suore orsoline della sacra famiglia e diretta da Claudia Koll.
Cosa può volere di più, a cento giorni dalla maturità, uno studente? Altro che pranzi dei cento giorni... Così ieri dopo aver ricevuto l’invito coi virgolettati qui riportati, i ragazzi sono stati in Chiesa a conoscere le università pubbliche e private del Lazio. A firmare l’invito inoltrato alle scuole qualche giorno fa è il direttore generale dell’ufficio scolastico regionale Lazio, Maria Maddalena Novelli. Nomen omen, la dirigente così giustifica la non casuale scelta del luogo: «il Santuario del Divino Amore è meta tradizionale di pellegrinaggi che si svolgono soprattutto di notte. Oggi come ieri, il Santuario si offre a tutti cattolici e di altra religione, credenti e non credenti, italiani e stranieri, tutti cittadini e pellegrini di Roma - come il traguardo di un viaggio notturno, passaggio umano denso di difficoltà ma che si conclude nella luce del mattino». Che il pellegrinaggio serva è certificato: si narra, infatti, che il candidato sindaco Gianni Alemanno lo fece a piedi nella notte elettorale...
 Per scegliere l’università giusta tutti in processione al santuario
Per scegliere l’università giusta tutti in processione al santuario
 5000 ragazzi al Divino Amore. I genitori: “Una vergogna”
5000 ragazzi al Divino Amore. I genitori: “Una vergogna”di Caterina Perniconi (il Fatto, 15.03.2011)
Un prato sterminato, un mare di fango, 5000 ragazzi. No, non è Woodstock, ma il santuario del Divino Amore, a Roma. Le note che accompagnano la giornata non sono quelle di Jimi Hendrix, ma del musical della Star Rose Accademy, fondata dalle suore orsoline e guidata da Claudia Koll, ormai lontanissima dalla versione “Tinto Brass”. Il tutto sotto l’occhio vigile di monsignor Lorenzo Leuzzi, direttore della pastorale e universitaria e neo cappellano di Montecitorio. Anche lui infangato fino ai polpacci. E no, non è nemmeno la giornata mondiale della gioventù promossa dal Vaticano, ma un appuntamento organizzato dall’ufficio scolastico regionale col vicariato di Roma per orientare i maturandi di tutte le scuole del Lazio (pubbliche e private) alla scelta universitaria.
IL LUOGO, aveva comunicato il ministero a tutti i dirigenti scolastici, non è scelto a caso, ma “sottolinea l’intento” del convegno. Perché “il santuario del Divino Amore è meta tradizionale di pellegrinaggi che si svolgono soprattutto di notte (...). Il pellegrinaggio, lungo cammino attraverso la notte, è evocativo di un messaggio simbolico per i nostri giovani: la vita che viviamo e che costruiamo incontra momenti di buio e sforzo, soprattutto quando si affrontano scelte importanti”. La circolare si concludeva prevedendo addirittura che “le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, valutino l’opportunità di riconoscere la partecipazione degli studenti come credito formativo”.
Ieri, sul prato del santuario, i ragazzi più che a un pellegrinaggio sembravano in gita. Gli stand allestiti erano sei. Il primo, riservato all’accoglienza, dove i presenti potevano ritirare il loro pacco “dono”: borsa, maglietta e cuscino. Infatti la struttura più grande, quella sotto la quale si sono rifugiati appena ha cominciato a piovigginare, non aveva sedie. Poi quattro gazebo, divisi per settore, dove gli studenti trovavano informazioni sull’ambito scientifico-tecnologico, artistico-letterario, giuridico-economico e bio-antropologico. Insieme alle università pubbliche (anche se i cartoni di depliant della Sapienza erano quasi tutti chiusi) quelle private. In prima fila, naturalmente, la Luiss. Poi l’università lateranense, la Cattolica, la pontificia salesiana, la pontificia auxilium, il campus bio-medico. Private battevano pubbliche almeno 6 a 3. Vicino un’altra sola struttura, per la pastorale universitaria. Nessuna informazione sull’ente per il diritto allo studio o su altre associazioni studentesche.
GLI ARTISTI dell’accademia della Koll si sono esibiti nel pomeriggio, ed erano ormai solo poche centinaia di ragazzi attenti allo spettacolo. Gli altri, sparsi nelle poche parti asciutte del prato. “La mia vita ha senso? - cantava una ragazza dal palco - credo che Dio abbia un progetto sulla mia vita”. Qualche gruppo si è allontanato. Subito dopo la celebrazione della messa, presieduta dal rettore dell’università lateranense, monsignor dal Covolo. Del resto, per romaset te.it , giornale on-line della diocesi di Roma, l’evento è promosso “dall’Ufficio scuola cattolica, pastorale scolastica, pastorale universitaria e pastorale giovanile del Vicariato di Roma”. Il ministero non è mai citato.
Impossibile, tramite l’ufficio scolastico regionale, ricevere una risposta per capire a quanto ammonta la spesa per un evento di queste proporzioni e in che parte lo Stato lo abbia finanziato. Quindi ci siamo rivolti a una società di organizzazione eventi, la Goodlink, per capire quale può essere la cifra in ballo. “Considerando che organizza lo Stato e non un privato, quindi ipotizzando numerose convenzioni - spiegano - possiamo stimare una spesa sicuramente superiore ai centomila euro. Ma se non ci fossero accordi, crescerebbe ancora”.
ECCO CHE, senza vedere con i propri occhi lo sviluppo dell’evento, molti genitori dopo aver letto le informazioni sulla giornata si sono opposti all’obbligo di far seguire ai propri figli l’orientamento. E in molti licei, come il Plauto per esempio, chi non è andato al Divino Amore oggi dovrà giustificare l’assenza. “A mia figlia - spiega la madre di un’alunna - hanno negato anche il diritto allo studio, perché è dovuta restare a casa. E ora avrà solo altre due ore per l’orientamento in una unica facoltà. É incerta ma non potrà vederne due”.
Un nutrito gruppo di genitori del liceo Tasso ha definito l’iniziativa “una vergogna”. “Ma vi rendete conto di quello che hanno avuto il coraggio di fare? - dice un genitore - si tratta di un evento con una forte impronta confessionale pagata con soldi pubblici. Esclude chi appartiene ad altre confessioni religiose o chi religioso non lo è. E vale anche come credito formativo. Uno scandalo”.
La regione Lazio, con l’assessore alla Formazione e Lavoro, Mariella Zezza, ha messo il cappello all’iniziativa spiegando che “l’orientamento per noi è un aspetto fondamentale del sistema dell’istruzione che forma per il mondo del lavoro”. A rispondergli la consigliera Idv, Giulia Rodano: “C’è sicuramente da chiedersi perché la Regione Lazio e il ministero abbiano promosso una giornata di orientamento scolastico con un taglio quasi confessionale o senz’altro non caratterizzato dalla laicità che dobbiamo esigere dall’istruzione pubblica. Chiederemo spiegazioni ufficiali agli assessori regionali competenti”.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- Per i 150 anni dell’Unità d’Italia, messaggio di Benedetto XVI al Presidente Napolitano.16 marzo 2011, di Federico La Sala
 Messaggio al Presidente Napolitano per 150 anni dell’Unità d’Italia
Messaggio al Presidente Napolitano per 150 anni dell’Unità d’Italia di BENEDICTUS PP. XVI (Avvenire, 16 marzo 2011)
di BENEDICTUS PP. XVI (Avvenire, 16 marzo 2011) Illustrissimo Signore On. GIORGIO NAPOLITANO
Illustrissimo Signore On. GIORGIO NAPOLITANO
 Presidente della Repubblica Italiana
Presidente della Repubblica ItalianaIl 150° anniversario dell’unificazione politica dell’Italia mi offre la felice occasione per riflettere sulla storia di questo amato Paese, la cui Capitale è Roma, città in cui la divina Provvidenza ha posto la Sede del Successore dell’Apostolo Pietro. Pertanto, nel formulare a Lei e all’intera Nazione i miei più fervidi voti augurali, sono lieto di parteciparLe, in segno dei profondi vincoli di amicizia e di collaborazione che legano l’Italia e la Santa Sede, queste mie considerazioni.
Il processo di unificazione avvenuto in Italia nel corso del XIX secolo e passato alla storia con il nome di Risorgimento, costituì il naturale sbocco di uno sviluppo identitario nazionale iniziato molto tempo prima. In effetti, la nazione italiana, come comunità di persone unite dalla lingua, dalla cultura, dai sentimenti di una medesima appartenenza, seppure nella pluralità di comunità politiche articolate sulla penisola, comincia a formarsi nell’età medievale.
Il Cristianesimo ha contribuito in maniera fondamentale alla costruzione dell’identità italiana attraverso l’opera della Chiesa, delle sue istituzioni educative ed assistenziali, fissando modelli di comportamento, configurazioni istituzionali, rapporti sociali; ma anche mediante una ricchissima attività artistica: la letteratura, la pittura, la scultura, l’architettura, la musica. Dante, Giotto, Petrarca, Michelangelo, Raffaello, Pierluigi da Palestrina, Caravaggio, Scarlatti, Bernini e Borromini sono solo alcuni nomi di una filiera di grandi artisti che, nei secoli, hanno dato un apporto fondamentale alla formazione dell’identità italiana. Anche le esperienze di santità, che numerose hanno costellato la storia dell’Italia, contribuirono fortemente a costruire tale identità, non solo sotto lo specifico profilo di una peculiare realizzazione del messaggio evangelico, che ha marcato nel tempo l’esperienza religiosa e la spiritualità degli italiani (si pensi alle grandi e molteplici espressioni della pietà popolare), ma pure sotto il profilo culturale e persino politico.
San Francesco di Assisi, ad esempio, si segnala anche per il contributo a forgiare la lingua nazionale; santa Caterina da Siena offre, seppure semplice popolana, uno stimolo formidabile alla elaborazione di un pensiero politico e giuridico italiano. L’apporto della Chiesa e dei credenti al processo di formazione e di consolidamento dell’identità nazionale continua nell’età moderna e contemporanea. Anche quando parti della penisola furono assoggettate alla sovranità di potenze straniere, fu proprio grazie a tale identità ormai netta e forte che, nonostante il perdurare nel tempo della frammentazione geopolitica, la nazione italiana poté continuare a sussistere e ad essere consapevole di sé. Perciò, l’unità d’Italia, realizzatasi nella seconda metà dell’Ottocento, ha potuto aver luogo non come artificiosa costruzione politica di identità diverse, ma come naturale sbocco politico di una identità nazionale forte e radicata, sussistente da tempo. La comunità politica unitaria nascente a conclusione del ciclo risorgimentale ha avuto, in definitiva, come collante che teneva unite le pur sussistenti diversità locali, proprio la preesistente identità nazionale, al cui modellamento il Cristianesimo e la Chiesa hanno dato un contributo fondamentale.
Per ragioni storiche, culturali e politiche complesse, il Risorgimento è passato come un moto contrario alla Chiesa, al Cattolicesimo, talora anche alla religione in generale. Senza negare il ruolo di tradizioni di pensiero diverse, alcune marcate da venature giurisdizionaliste o laiciste, non si può sottacere l’apporto di pensiero - e talora di azione - dei cattolici alla formazione dello Stato unitario. Dal punto di vista del pensiero politico basterebbe ricordare tutta la vicenda del neoguelfismo che conobbe in Vincenzo Gioberti un illustre rappresentante; ovvero pensare agli orientamenti cattolico-liberali di Cesare Balbo, Massimo d’Azeglio, Raffaele Lambruschini. Per il pensiero filosofico, politico ed anche giuridico risalta la grande figura di Antonio Rosmini, la cui influenza si è dispiegata nel tempo, fino ad informare punti significativi della vigente Costituzione italiana. E per quella letteratura che tanto ha contribuito a "fare gli italiani", cioè a dare loro il senso dell’appartenenza alla nuova comunità politica che il processo risorgimentale veniva plasmando, come non ricordare Alessandro Manzoni, fedele interprete della fede e della morale cattolica; o Silvio Pellico, che con la sua opera autobiografica sulle dolorose vicissitudini di un patriota seppe testimoniare la conciliabilità dell’amor di Patria con una fede adamantina. E di nuovo figure di santi, come san Giovanni Bosco, spinto dalla preoccupazione pedagogica a comporre manuali di storia Patria, che modellò l’appartenenza all’istituto da lui fondato su un paradigma coerente con una sana concezione liberale: "cittadini di fronte allo Stato e religiosi di fronte alla Chiesa".
La costruzione politico-istituzionale dello Stato unitario coinvolse diverse personalità del mondo politico, diplomatico e militare, tra cui anche esponenti del mondo cattolico. Questo processo, in quanto dovette inevitabilmente misurarsi col problema della sovranità temporale dei Papi (ma anche perché portava ad estendere ai territori via via acquisiti una legislazione in materia ecclesiastica di orientamento fortemente laicista), ebbe effetti dilaceranti nella coscienza individuale e collettiva dei cattolici italiani, divisi tra gli opposti sentimenti di fedeltà nascenti dalla cittadinanza da un lato e dall’appartenenza ecclesiale dall’altro.
Ma si deve riconoscere che, se fu il processo di unificazione politico-istituzionale a produrre quel conflitto tra Stato e Chiesa che è passato alla storia col nome di "Questione Romana", suscitando di conseguenza l’aspettativa di una formale "Conciliazione", nessun conflitto si verificò nel corpo sociale, segnato da una profonda amicizia tra comunità civile e comunità ecclesiale. L’identità nazionale degli italiani, così fortemente radicata nelle tradizioni cattoliche, costituì in verità la base più solida della conquistata unità politica. In definitiva, la Conciliazione doveva avvenire fra le Istituzioni, non nel corpo sociale, dove fede e cittadinanza non erano in conflitto.
Anche negli anni della dilacerazione i cattolici hanno lavorato all’unità del Paese. L’astensione dalla vita politica, seguente il "non expedit", rivolse le realtà del mondo cattolico verso una grande assunzione di responsabilità nel sociale: educazione, istruzione, assistenza, sanità, cooperazione, economia sociale, furono ambiti di impegno che fecero crescere una società solidale e fortemente coesa. La vertenza apertasi tra Stato e Chiesa con la proclamazione di Roma capitale d’Italia e con la fine dello Stato Pontificio, era particolarmente complessa.
Si trattava indubbiamente di un caso tutto italiano, nella misura in cui solo l’Italia ha la singolarità di ospitare la sede del Papato. D’altra parte, la questione aveva una indubbia rilevanza anche internazionale. Si deve notare che, finito il potere temporale, la Santa Sede, pur reclamando la più piena libertà e la sovranità che le spetta nell’ordine suo, ha sempre rifiutato la possibilità di una soluzione della "Questione Romana" attraverso imposizioni dall’esterno, confidando nei sentimenti del popolo italiano e nel senso di responsabilità e giustizia dello Stato italiano. La firma dei Patti lateranensi, l’11 febbraio 1929, segnò la definitiva soluzione del problema. A proposito della fine degli Stati pontifici, nel ricordo del beato Papa Pio IX e dei Successori, riprendo le parole del Cardinale Giovanni Battista Montini, nel suo discorso tenuto in Campidoglio il 10 ottobre 1962: "Il papato riprese con inusitato vigore le sue funzioni di maestro di vita e di testimonio del Vangelo, così da salire a tanta altezza nel governo spirituale della Chiesa e nell’irradiazione sul mondo, come prima non mai".
L’apporto fondamentale dei cattolici italiani alla elaborazione della Costituzione repubblicana del 1947 è ben noto. Se il testo costituzionale fu il positivo frutto di un incontro e di una collaborazione tra diverse tradizioni di pensiero, non c’è alcun dubbio che solo i costituenti cattolici si presentarono allo storico appuntamento con un preciso progetto sulla legge fondamentale del nuovo Stato italiano; un progetto maturato all’interno dell’Azione Cattolica, in particolare della FUCI e del Movimento Laureati, e dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, ed oggetto di riflessione e di elaborazione nel Codice di Camaldoli del 1945 e nella XIX Settimana Sociale dei Cattolici Italiani dello stesso anno, dedicata al tema "Costituzione e Costituente".
Da lì prese l’avvio un impegno molto significativo dei cattolici italiani nella politica, nell’attività sindacale, nelle istituzioni pubbliche, nelle realtà economiche, nelle espressioni della società civile, offrendo così un contributo assai rilevante alla crescita del Paese, con dimostrazione di assoluta fedeltà allo Stato e di dedizione al bene comune e collocando l’Italia in proiezione europea. Negli anni dolorosi ed oscuri del terrorismo, poi, i cattolici hanno dato la loro testimonianza di sangue: come non ricordare, tra le varie figure, quelle dell’On. Aldo Moro e del Prof. Vittorio Bachelet? Dal canto suo la Chiesa, grazie anche alla larga libertà assicuratale dal Concordato lateranense del 1929, ha continuato, con le proprie istituzioni ed attività, a fornire un fattivo contributo al bene comune, intervenendo in particolare a sostegno delle persone più emarginate e sofferenti, e soprattutto proseguendo ad alimentare il corpo sociale di quei valori morali che sono essenziali per la vita di una società democratica, giusta, ordinata. Il bene del Paese, integralmente inteso, è stato sempre perseguito e particolarmente espresso in momenti di alto significato, come nella "grande preghiera per l’Italia" indetta dal Venerabile Giovanni Paolo II il 10 gennaio 1994.
La conclusione dell’Accordo di revisione del Concordato lateranense, firmato il 18 febbraio 1984, ha segnato il passaggio ad una nuova fase dei rapporti tra Chiesa e Stato in Italia. Tale passaggio fu chiaramente avvertito dal mio Predecessore, il quale, nel discorso pronunciato il 3 giugno 1985, all’atto dello scambio degli strumenti di ratifica dell’Accordo, notava che, come "strumento di concordia e collaborazione, il Concordato si situa ora in una società caratterizzata dalla libera competizione delle idee e dalla pluralistica articolazione delle diverse componenti sociali: esso può e deve costituire un fattore di promozione e di crescita, favorendo la profonda unità di ideali e di sentimenti, per la quale tutti gli italiani si sentono fratelli in una stessa Patria".
Ed aggiungeva che nell’esercizio della sua diaconia per l’uomo "la Chiesa intende operare nel pieno rispetto dell’autonomia dell’ordine politico e della sovranità dello Stato. Parimenti, essa è attenta alla salvaguardia della libertà di tutti, condizione indispensabile alla costruzione di un mondo degno dell’uomo, che solo nella libertà può ricercare con pienezza la verità e aderirvi sinceramente, trovandovi motivo ed ispirazione per l’impegno solidale ed unitario al bene comune".
L’Accordo, che ha contribuito largamente alla delineazione di quella sana laicità che denota lo Stato italiano ed il suo ordinamento giuridico, ha evidenziato i due principi supremi che sono chiamati a presiedere alle relazioni fra Chiesa e comunità politica: quello della distinzione di ambiti e quello della collaborazione. Una collaborazione motivata dal fatto che, come ha insegnato il Concilio Vaticano Il, entrambe, cioè la Chiesa e la comunità politica, "anche se a titolo diverso, sono a servizio della vocazione personale e sociale delle stesse persone umane" (Cost. Gaudium et spes, 76).
L’esperienza maturata negli anni di vigenza delle nuove disposizioni pattizie ha visto, ancora una volta, la Chiesa ed i cattolici impegnati in vario modo a favore di quella "promozione dell’uomo e del bene del Paese" che, nel rispetto della reciproca indipendenza e sovranità, costituisce principio ispiratore ed orientante del Concordato in vigore (art. 1). La Chiesa è consapevole non solo del contributo che essa offre alla società civile per il bene comune, ma anche di ciò che riceve dalla società civile, come affrerma il Concilio Vaticano II: "chiunque promuove la comunità umana nel campo della famiglia, della cultura, della vita economica e sociale, come pure della politica, sia nazionale che internazionale, porta anche un non piccolo aiuto, secondo la volontà di Dio, alla comunità ecclesiale, nelle cose in cui essa dipende da fattori esterni" (Cost. Gaudium et spes, 44).
Nel guardare al lungo divenire della storia, bisogna riconoscere che la nazione italiana ha sempre avvertito l’onere ma al tempo stesso il singolare privilegio dato dalla situazione peculiare per la quale è in Italia, a Roma, la sede del successore di Pietro e quindi il centro della cattolicità. E la comunità nazionale ha sempre risposto a questa consapevolezza esprimendo vicinanza affettiva, solidarietà, aiuto alla Sede Apostolica per la sua libertà e per assecondare la realizzazione delle condizioni favorevoli all’esercizio del ministero spirituale nel mondo da parte del successore di Pietro, che è Vescovo di Roma e Primate d’Italia. Passate le turbolenze causate dalla "questione romana", giunti all’auspicata Conciliazione, anche lo Stato Italiano ha offerto e continua ad offrire una collaborazione preziosa, di cui la Santa Sede fruisce e di cui è consapevolmente grata.
Nel presentare a Lei, Signor Presidente, queste riflessioni, invoco di cuore sul popolo italiano l’abbondanza dei doni celesti, affinché sia sempre guidato dalla luce della fede, sorgente di speranza e di perseverante impegno per la libertà, la giustizia e la pace.
Dal Vaticano, 17 marzo 2011
BENEDICTUS PP. XVI
-
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- Papato, l’uso politico delle canonizzazioni (di Francesco Zanchini di Castiglionchio).14 marzo 2011, di Federico La Sala
Papato, l’uso politico delle canonizzazioni
di Francesco Zanchini di Castiglionchio* (Confronti, n. 2, febbraio 2011)
La questione che l’uso politico delle canonizzazioni propone sta acquistando con il tempo dimensioni scandalose. La tentazione della Curia romana di forzare i termini istruttori delle istanze provenienti dai postulatori viene da lontano: in germe, dall’accentramento deciso quasi un millennio fa da Gregorio VII [† 1085] che con la sua «riforma», gregoriana appunto, strappò alle chiese locali il diritto di prestare spontaneamente il debito onore ai defunti che avessero meritato, a loro insindacabile giudizio, una venerazione straordinaria.
E oggi, pur nelle mutate circostanze, la Curia sempre più esalta gli «amici», come il fondatore dell’Opus Dei, Josemaria Escrivà de Balaguer (un uomo di potere canonizzato lo stesso anno, il 2002, in cui lo fu Juan Diego, l’umile indio della vergine di Guadalupe!), per trovare poi ogni pretesto per sbarrare il passo a quelli che non considera tali - clamoroso il caso di Oscar Arnulfo Romero, vescovo-martire dei poveri del Salvador. Che però la tradizione gregoriana non possa mantenere a lungo la pretesa di identificarsi con la Tradizione tout court (come vorrebbero i lefebvriani) lo mostra il timido inizio di un decentramento che, dopo il Vaticano II, ha restituito all’episcopato locale poteri quanto meno istruttori e propositivi, almeno nella procedura di beatificazione.
Ma rimane il mito dell’infallibilità papale a presidio dell’esclusiva competenza pontificia per la decisione finale di beatificare e poi di canonizzare un servo di Dio. Perciò la Curia continuerà a tenersi ben stretta la sua competenza per la parte più solenne e pubblica del riconoscimento delle «virtù eroiche» dei fedeli. Anche se non è affatto certo che risoluzioni del genere rientrino nell’esercizio dell’autorità di magistero, l’apparato curiale continua a comportarsi come se la Santa Sede fosse dotata, in materia, di prerogative di diritto divino. Il che lascia a tale apparato mano libera per manovrare in senso populista, ma sempre con finalità di dominio, una leva potente di consensus fidelium: secondo una linea di condotta tracciata con maestria, nello stile autoritario della sua leadership, dal più populista dei papi del Novecento, Giovanni Paolo II.
In tale contesto, assistiamo a quella che lo storico Etienne Fouilloux ha definito la strategia curiale di «autogiustificazione del papato», che opera mediante l’omologazione manipolata dei suoi modelli (non di rado fortemente contraddittori) di incarnazione nel tempo. Così papa Wojtyla nel 2000 ha beatificato, lo stesso giorno, papa Mastai Ferretti e papa Roncalli, bilanciando la glorificazione di Pio IX, l’ideatore dell’architettura autoritaria del Vaticano I che nel 1870 proclamò i dogmi del primato pontificio e dell’infallibilità papale, con quella di colui che aveva voluto il Vaticano II per correggere l’unilateralità del Concilio precedente (dove l’antica idea del servizio petrino finiva per mettere ai margini l’autorità dei vescovi fratelli). E, adesso, Ratzinger beatifica Wojtyla e tiene viva la procedura in corso per portare sugli altari Pio XII. Insomma, un papa fa santo l’altro papa, in una catena che tende a rendere santa e indiscutibile, di diritto e di fatto, l’istituzione papale e le sue scelte.
Nella sostanza, non si vuole che resti traccia di una discontinuità conciliare - quella innescata dal Vaticano II - rispettosa fin troppo delle prerogative papali, ma in cammino verso un rinnovamento profondo della Chiesa; nella quale, secondo la Curia, non c’è invece nulla da innovare, essendo tutto già scritto nell’uniforme continuità del papato gregoriano, quello di sempre, e della sua storia. Di qui la cura ossessiva della Curia nel sottolineare (in implicita confutazione delle tesi opposte della scuola bolognese animata da Giuseppe Alberigo) la «continuità» perfetta tra il Vaticano II, il Vaticano I e il Tridentino. Senonché, con buona pace della Curia, i papi non sono tutti uguali (come non lo sono i Concili); ed a colui che volle il Vaticano II la dialettica della storia assegna un posto, il cui segno sta nell’ascolto primaziale di un bisogno profondo di riforma in capite [nella testa] della Chiesa, di riforma cioè dell’istituto papale nei suoi rapporti con la pluralità delle Chiese: una pluralità, di cui il Concilio è l’espressione esponenziale più ovvia ed eminente.
Il 6 dicembre 2006, un gruppo di intellettuali cattolici, di cui tredici teologi (per la metà spagnoli),aveva ritenuto opportuno far pervenire testimonianza contraria alla glorificazione di Karol Wojtyla, in risposta a conforme e pubblica sollecitazione diramata nella diocesi di Roma, sei mesi prima, dall’Ufficio di postulazione della causa. Le sette obiezioni, che i teologi muovevano alla procedura, erano tanto chiare in tesi, quanto fondate su fatti incontestabili, perché notori. Ma nessuna delle ponderate e articolate obiezioni presentate ha meritato attenzione alcuna in corso di procedimento, neppure per disporre un supplemento di istruttoria tramite interrogatorio dei firmatari, o per far sapere a questi ultimi i motivi per cui le si ritenevano infondate, o addirittura irrilevanti. L’unica risposta pervenuta al riguardo è: Wojtyla sarà beatificato il primo maggio. Ancora una volta, il silenzio serbato dalla Curia sull’opposizione dei teologi è un atto di cieca arroganza del sistema e di noncuranza per le sue stesse regole. Si leggono cioè solo gli atti che si vogliono leggere, non quelli che contraddirebbero una decisione già presa in sede politica, nei palazzi del potere.
Ma un tale autoritarismo, tanto paternalista quanto monolitico, incontra una crescente resistenza nel corpo complessivo della Chiesa cattolica e della sua opinione pubblica; soprattutto al di là delle Alpi e al di là dei mari ma, per fortuna, anche in Italia. L’assunzione di visibilità dei cattolici del «disagio», e perfino del «dissenso», in fondo non è dovuta ad altro, se non al macigno che intasa la corrente del movimento conciliare dai tempi del pontificato di Giovanni Paolo II; macigno che proprio costui ebbe a rafforzare in funzione di diga autoritaria, opposta, nel nome di un integralismo che sa di Pio IX, a qualsiasi seria possibilità di ripresa della parabola che il progressismo conciliare aveva appena attraversato nel Novecento. Malgrado perciò fortissime resistenze (la Curia manterrà il suo atteggiamento di tenace opposizione alla innovazione, e tenterà di giustificarla con argomenti ideologici: nessuno cede volentieri il potere!), si avvicina sempre più il momento inesorabile di una revisione critica del primato papale di giurisdizione, revisione che ne metta in luce aporie dottrinarie e manipolazioni ideologiche; momento che mi pare un kairòs di questo tempo della Chiesa, e sul fronte non solo dell’ecumenismo.
E a chi insiste sul «continuismo», sarebbe bene ricordare che, a quanti contrastavano la riforma, i gregoriani opponevano l’antico brocardo (massima giuridica) secondo il quale il divin Maestro non aveva affatto detto di sé Ego sum consuetudo (sono la consuetudine) ma, piuttosto, Ego sum Veritas.
La Chiesa romana, d’altronde, è ormai sempre più investita da un diffuso, crescente bisogno di profonda revisione dei rapporti tra responsabilità docente e libertà di una coscienza (dei fedeli e delle chiese) autonomamente formata alla luce della fede. Voglia il cielo che questo avvenga entro il 20 settembre 2020, centocinquantesimo anniversario della breccia di Porta Pia e dell’inizio di una stagione troppo lunga di opportunismo e di vittimismo guelfo nel nostro paese.
*Ordinario di Diritto Canonico all’Università di Teramo
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- Giovedì prossimo,17 marzo, i vertici istituzionali della Santa Sede celebreranno accanto alle massime autorità della Repubblica il 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Tra Stato e Chiesa chi ha vinto? (di Sergio Luzzatto).13 marzo 2011, di Federico La Sala
Tra Stato e Chiesa chi ha vinto?
di Sergio Luzzatto (Il Sole 24 Ore, 13 marzo 2011)
Giovedì prossimo,17 marzo, i vertici istituzionali della Santa Sede celebreranno accanto alle massime autorità della Repubblica il 150° anniversario dell’Unità d’Italia. E neppure il "laicista" più incallito avrà ragione di rimpiangerlo: sarà la prova di come sia definitivamente sanata, dopo un secolo e mezzo, la ferita di un Risorgimento culminato nella sfida militare al Papato e nella breccia di Porta Pia.
In compenso, si ha ragione di chiedersi se lo scrupolo vaticano nel celebrare l’anniversario non abbia a che fare - di là dal cerimoniale e dall’etichetta - con una sconfitta storica di quell’Italia laica che gli uomini del Risorgimento cercarono di fondare. Si ha ragione di chiedersi, cioè, se l’entusiasmo risorgimentista del Papa e delle gerarchie cattoliche non corrisponda alla (comprensibile) fierezza di chi, centocinquanta anni dopo la più bruciante delle sconfitte, capisce di avere vinto.
Che quanto resta dell’Italia laica abbia buoni motivi di preoccuparsi, è ciò che emerge dalle cronache stesse di questi giorni: attacco del premier alla scuola pubblica come luogo di formazione pluralistica delle coscienze, attacco del centrodestra alla libertà costituzionale di liberamente disporre - nel fine vita - della propria vita, eccetera.
Ma di là dal fosco spettacolo del presente, c’è oggi chi ricerca in un passato anche lontano, ancora più lontano del 1861, le circostanze originarie della sconfitta di un’Italia possibile, diversa, migliore. Questo ha fatto, in un "diario intimo" intitolato La fabbrica dell’obbedienza, quel grande vecchio delle nostre patrie lettere che è Ermanno Rea. Il quale ha finito per scrivere un libro molto politico, e non sempre condivisibile (non, per esempio, nell’elogio del separatismo meridionale). Un libro, comunque, che offre spunti preziosi di riflessione sulla "lunga durata" della Controriforma inaugurata dal Concilio di Trento.
Secondo Rea, il segreto dell’Italia presente è da ricercare là, lontano da noi, eppure vicinissimo. In un’unità d’Italia fatta - quattro secoli prima che da Cavour - dai tribunali della Santa Inquisizione. E fatta dentro quei confessionali dove la Chiesa cattolica ha inventato, insieme all’Italia del perdono, l’Italia del condono
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- L’UNITA’ DELLA CHIESA E L’UNITA’ D’ITALIA: MEMORIA DI GIOVANNI XXIII.Il Papa che ha «visto» il paese in Europa (di Bruno Forte).6 marzo 2011, di Federico La Sala
Il Papa che ha «visto» il paese in Europadi Bruno Forte (Il Sole 24 Ore, 6 marzo 2011)
Come la Chiesa vede l’unità d’Italia? Un episodio del pontificato di Giovanni XXIII, il "Papa buono", può aiutare a rispondere a questa domanda. È la primavera del 1961, precisamente l’11 aprile, quando il Pontefice riceve in visita ufficiale il Capo del governo italiano, Amintore Fanfani. Le parole pronunciate dal Papa in quell’occasione hanno grande eco sulla stampa, in un ventaglio di giudizi contrapposti. Il Pontefice fa, tra l’altro, due affermazioni. La prima riguarda i rapporti fra la Chiesa e l’Italia: «La singolare condizione della Chiesa cattolica e dello Stato italiano - due organismi di diversa struttura, fisionomia ed elevazione, quanto alle caratteristiche finalità dell’uno e dell’altro - suppone una distinzione e un tal quale riserbo di rapporti, pur fatti di garbo e di rispetto, che rendono tanto più gradite le occasioni dell’incontrarsi...».
Con quel suo fraseggiare a volte un po’ ridondante, il Papa dipinge in maniera precisa la distinzione e il genere dei rapporti fra le due sponde del Tevere: i termini usati, "riserbo", "garbo", "rispetto", mettono bene in luce la necessaria distanza e la comune appartenenza a una medesima storia e a uno stesso destino. Subito dopo Giovanni XXIII afferma: «La ricorrenza che in questi mesi è motivo di sincera esultanza per l’Italia, il centenario della sua unità, ci trova, sulle due rive del Tevere, partecipi di uno stesso sentimento di riconoscenza alla Provvidenza del Signore, che pur attraverso variazioni e contrasti, talora accesi, come accade in tutti i tempi, ha guidato questa porzione elettissima d’Europa verso una sistemazione di rispetto e di onore nel concetto delle nazioni grazie a Dio depositarie, sì, oggi ancora, della civiltà che da Cristo prende nome e vita».
Si sente in queste parole la competenza dello storico (tale era Angelo Giuseppe Roncalli, per formazione storico della Chiesa) e la finezza del diplomatico (a lungo rappresentante pontificio), pervase entrambe da una benignità pastorale, che priva la prima di ogni saccenteria e la seconda di ogni furbizia. Il "Papa buono" non nasconde nulla («pur attraverso variazioni e contrasti, talora accesi...») e mette l’accento su quanto gli sta veramente a cuore: l’Italia, nel suo rapporto costitutivo con il cristianesimo e con l’Europa.
Cinquant’anni dopo queste parole non hanno perso nulla del loro valore: prive di ogni retorica celebrativa, aiutano a far memoria onestamente dei momenti drammatici e delle tensioni attraverso cui si fece l’unità del paese. Nei confronti della causa italiana la posizione dei cattolici fu tutt’altro che unanime e concorde: le tesi dei fieri oppositori si affiancarono a quelle dei sostenitori entusiastici, mentre non pochi furono partigiani di un federalismo, che beneficiasse delle garanzie offerte dall’autorità morale del Papa.
Due mi sembrano gli orizzonti evocati da Giovanni XXIII, che val la pena di richiamare anche per l’imminente celebrazione del 150° anniversario dell’unità d’Italia: il cristianesimo e l’Europa. Sotto entrambi i profili l’Italia si è andata costruendo nel corso di questo secolo e mezzo e il da farsi resta ancora così tanto che la memoria si risolve in sfida e agenda per l’avvenire. Anzitutto, va sottolineata la rilevanza del cristianesimo per la nostra identità nazionale: senza di esso l’Italia sarebbe inconcepibile, con buona pace dei laicisti di turno e di quanti danno voce ai vari, possibili pregiudizi storiografici e culturali. Incontrandosi con l’eredità greco-romana e, più tardi, in un rapporto spesso dialettico con i processi emancipatori della modernità, l’anima cristiana ha plasmato il nostro paese. Una riprova altissima dell’importanza di questo contributo all’identità della nazione italiana viene da una delle pagine più significative della nostra storia: la promulgazione della Costituzione repubblicana. È in particolare al personalismo d’ispirazione cristiana che la nostra legge fondamentale deve la sua fonte più ricca in materia di valori.
Essa era stata compendiata nel cosiddetto Codice di Camaldoli, elaborato al termine di una settimana di studio tenutasi nel luglio del 1943 nel monastero camaldolese presso Arezzo, cui avevano partecipato una cinquantina di giovani dell’Azione cattolica e della Federazione universitaria cattolica italiana (Fuci), con l’intento d’individuare le linee dello sviluppo del paeseuna volta finita la guerra. Nel testo emergeva non solo l’idea della centralità della persona umana nella futura organizzazione dello Stato e della sua economia, ma anche la proposta di un sistema di partecipazione statale, che traduceva nella nostra realtà produttiva l’idea della corresponsabilità e della solidarietà nazionale.
Senza il rispetto della dignità della persona, e dunque di tutto l’uomo in ogni uomo, quale che siano la sua storia, la sua cultura e i mezzi di cui dispone, non ci sarà nazione italiana. E, parimenti, senza solidarietà l’idea d’Italia concepita dai padri costituenti rischia di essere totalmente svuotata: sottolinearlo è più che mai urgente, in un momento in cui il tanto parlare di federalismo potrebbe oscurare l’imprescindibile necessità che il nostro sia un federalismo solidale, e giammai un patto a vantaggio dei più forti, dannoso per i più deboli. In questo senso la memoria si fa dovere di vigile profezia per tutti.
L’altro orizzonte evocato da Giovanni XXIII e più che mai valido per le celebrazioni dell’unità italiana è quello dell’Europa: nello spirito dei padri fondatori - De Gasperi, Adenauer, Schuman - l’appartenenza alla casa comune europea vuol dire superamento degli egoismi nazionalistici e regionalistici, respiro aperto alla mondialità e all’interculturalità, senso profondo di responsabilità verso i valori costitutivi dell’identità europea. Accanto al rispetto dei diritti umani e delle libertà individuali, Europa vuol dire coniugazione sapiente di localismi e di solidarietà, di globalità e di attenzione alla ricchezza delle identità regionali e nazionali, di salvaguardia delle radici e di accoglienza dell’altro e del diverso. Per l’Italia questo significa rifiuto di logiche egoistiche e settarie e impegno perché la comune responsabilità europea si affermi negli scenari internazionali dove sono in gioco la costruzione della pace, il rispetto dei diritti umani, l’impegno per la giustizia.
Celebrare l’unità della nazione italiana nell’orizzonte dell’idea europea può aiutare a liberarci da ogni ripiegamento su noi stessi, o peggio ancora su una parte sola del paese, spingendoci a un’azione di stimolo e di supporto a politiche europee all’altezza delle radici culturali e spirituali che ci uniscono. Queste radici comprendono l’idea cristiana di persona e di storia orientata a un fine, l’idea di democrazia, contributo prezioso della grecità classica, cui si connette il dovere del rispetto delle ragioni altrui, e il diritto romano, con la sua esigenza di una giustizia giusta, rapida ed efficace nella tutela dei più deboli e dei diritti di tutti.
Celebrare l’unità è allora raccogliere il testimone di quanti hanno dato il meglio di sé, fino al sacrificio della vita, perché in questi 150 anni si andassero imponendo le urgenze dei diritti personali, l’idea di partecipazione democratica universale, e un senso del diritto e della legalità, che per troppi aspetti sembrano ancor lungi dall’essere realtà compiuta.
Al di là di ogni retorica, un esame di coscienza è richiesto in primo luogo a chi ha responsabilità pubbliche ed è tenuto a coltivare qualità morali che siano all’altezza del compito. Ricordare l’unità realizzata vuol dire rinnovare l’impegno a portarne a compimento i valori costitutivi. Ciò che iniziò ieri è appello per l’oggi e per il domani, un’occasione di salutare risveglio per tutti, la sfida di un "non ancora" che parte dal "già", iniziato 150 anni fa.
* Bruno Forte è arcivescovo di Chieti-Vasto
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- PROPAGANDA RATZINGERIANA A PARIGI: IL CORTILE DEL TEMPIO APERTO AL DIALOGO TRA MERCANTI ATEI E DEVOTI.3 marzo 2011, di Federico La Sala
 DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! PER IL CARDINALE RAVASI E’ LO STESSO!!! Ha dimenticato l’esortazione di Papa Wojtyla ("Se mi sbalio, mi corigerete")?!
DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! PER IL CARDINALE RAVASI E’ LO STESSO!!! Ha dimenticato l’esortazione di Papa Wojtyla ("Se mi sbalio, mi corigerete")?!
 PROPAGANDA RATZINGERIANA A PARIGI: IL CORTILE DEL TEMPIO APERTO AL DIALOGO TRA MERCANTI ATEI E DEVOTI. Dalla cattedra dei non credenti al cortile dei gentili. Una nota di Piero Stefani
PROPAGANDA RATZINGERIANA A PARIGI: IL CORTILE DEL TEMPIO APERTO AL DIALOGO TRA MERCANTI ATEI E DEVOTI. Dalla cattedra dei non credenti al cortile dei gentili. Una nota di Piero Stefani
 In luogo della «cattedra dei non credenti», la Chiesa universale ora lancia un’iniziativa chiamata «cortile dei gentili». Affidata al Pontificio Consiglio della Cultura (prefetto card. Ravasi), il «cortile» è stato preinaugurato un paio di settimane fa a Bologna; mentre l’avvio ufficiale avverrà a Parigi verso fine marzo.
In luogo della «cattedra dei non credenti», la Chiesa universale ora lancia un’iniziativa chiamata «cortile dei gentili». Affidata al Pontificio Consiglio della Cultura (prefetto card. Ravasi), il «cortile» è stato preinaugurato un paio di settimane fa a Bologna; mentre l’avvio ufficiale avverrà a Parigi verso fine marzo.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- NAPOLITANO LAVORA PER L’ITALIA, BERLUSCONI LAVORA PER "FORZA ITALIA" E IL SUO "POPOLO DELLA LIBERTA’"!!! Il Presidente del Consiglio all’attacco del Quirinale.1 marzo 2011
 STORIA D’ITALIA (1994-2011): SI PARLA, SI VEDE, E SI SENTE "DOPPIO"!!! "DUE PRESIDENTI" DELLA REPUBBLICA IN LOTTA TRA DI LORO ....
STORIA D’ITALIA (1994-2011): SI PARLA, SI VEDE, E SI SENTE "DOPPIO"!!! "DUE PRESIDENTI" DELLA REPUBBLICA IN LOTTA TRA DI LORO ....
 SE QUESTO E’ UN PAESE - SE QUESTA E’ L’ITALIA!!! NAPOLITANO LAVORA PER L’ITALIA, BERLUSCONI LAVORA PER "FORZA ITALIA" E IL SUO "POPOLO DELLA LIBERTA’"!!! Il Presidente del Consiglio all’attacco del Quirinale.
SE QUESTO E’ UN PAESE - SE QUESTA E’ L’ITALIA!!! NAPOLITANO LAVORA PER L’ITALIA, BERLUSCONI LAVORA PER "FORZA ITALIA" E IL SUO "POPOLO DELLA LIBERTA’"!!! Il Presidente del Consiglio all’attacco del Quirinale.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- Il silenzio del Papa dinanzi alle rovine d’Italia. È una cosa che fa impressione. Perché in Vaticano sanno. Quello che sta avvenendo in Italia con il suo premier non è comparabile a nessun paese dell’Occidente democratico. E in nessuna nazione verrebbe accettato (di marco Politi).27 febbraio 2011, di Federico La Sala
Il papa tuona contro l’aborto ma tace sulle rovine dell’Italia
di Marco Politi (il Fatto Quotidiano, 27 febbraio 2011)
Il silenzio del Papa dinanzi alle rovine d’Italia. È una cosa che fa impressione. Perché in Vaticano sanno. Quello che sta avvenendo in Italia con il suo premier non è comparabile a nessun paese dell’Occidente democratico. E in nessuna nazione verrebbe accettato.
Giorni fa ho varcato le mura vaticane e sono stato a trovare un cardinale. Si parlava della prossima beatificazione di Wojtyla e della situazione della Chiesa. Poi, da sé, l’eminenza abborda la situazione italiana. “Con questa storia delle donne - dice - Berlusconi ha superato ogni limite”. Pausa. “E ci mette in imbarazzo, perché non possiamo approvare”. Il cardinale sviluppa il suo pensiero. “Al di là delle cifre vere o presunte delle donazioni date a queste donne, in un momento di crisi come l’attuale ci vorrebbe più sobrietà, più onestà”.
Bene ha fatto il presidente della Cei Bagnasco, continua il porporato, a esigere più decoro. “Un altro
 seguita l’eminenza - lascerebbe il suo posto ad un politico diverso, magari per essere difeso
meglio. Lui no”. Un sospiro: “Non c’è alternativa. Tutti i ministri dipendono da lui. Ah la Dc ! Se
non andava bene l’uno, c’era sempre un altro pronto... Fanfani, Moro, Rumor, Colombo”. Il
cardinale guarda dinanzi a sé e conclude: “La situazione è difficile. Fini è finito. Nel simbolo ha
messo il Futuro, ma non ne ha. Chissà se riesce ad affermarsi un Terzo Polo?”.
Non è l’unico. Nel mini-stato del Papa molti comprendono la gravità della crisi italiana, avvitata in
un massacro di ogni regola per difendere l’indifendibile.
seguita l’eminenza - lascerebbe il suo posto ad un politico diverso, magari per essere difeso
meglio. Lui no”. Un sospiro: “Non c’è alternativa. Tutti i ministri dipendono da lui. Ah la Dc ! Se
non andava bene l’uno, c’era sempre un altro pronto... Fanfani, Moro, Rumor, Colombo”. Il
cardinale guarda dinanzi a sé e conclude: “La situazione è difficile. Fini è finito. Nel simbolo ha
messo il Futuro, ma non ne ha. Chissà se riesce ad affermarsi un Terzo Polo?”.
Non è l’unico. Nel mini-stato del Papa molti comprendono la gravità della crisi italiana, avvitata in
un massacro di ogni regola per difendere l’indifendibile.I cattolici chiedono di intervenire
NE SONO consapevoli anche alla Cei che l’insofferenza di Berlusconi ad ogni norma di equilibrio dei poteri e di controllo della legalità è sistematica e irrefrenabile. Il cardinale Bagnasco si è detto “sgomento” pubblicamente per i “comportamenti contrari al pubblico decoro” cui si sta assistendo. Poi su questa soglia la Chiesa si blocca. Benedetto XVI interviene sui temi etici generali: l’aborto, le staminali, il fine vita, le coppie di fatto, i finanziamenti alle scuole cattoliche. Ma non affronta il passaggio nodale di questo Paese, nella cui storia la Chiesa come realtà di popolo è profondamente coinvolta. Ancora ieri il Pontefice è intervenuto per condannare l’aborto terapeutico e ammonire che l’interruzione di gravidanza è una “ferita gravissima” alla coscienza morale. I medici, ha soggiunto, devono difendere la donna dall’“inganno” dell’aborto presentato come soluzione a difficoltà familiari, economiche, di salute.
Ma sulla malattia dell’Italia Benedetto XVI tace. Sostengono i clericali più arrabbiati (prevalentemente laici) che “quelli che protestano contro gli interventi del Papa sui temi etici, adesso chiedono che intervenga contro Berlusconi”. Posizioni del genere affiorano nelle lettera dei lettori di Avvenire. E’ una falsa obiezione. In uno stato democratico (lo ricordò il presidente francese Giscard a Papa Wojtyla) è il Parlamento che legifera. Liberi i deputati cattolici, i mass media cattolici, le associazioni cattoliche di fare le loro battaglie. Non tocca ai vertici ecclesiastici organizzare referendum o muovere parlamentari.
Ma qui non siamo in presenza di una delle tante battaglie politiche. Sui fallimenti di Berlusconi - uno zero nel rilancio dello sviluppo industriale, nella tutela economica delle famiglie, nel contrasto alla disoccupazione e al precariato, nella lotta alla corruzione, in politica estera dove è considerato “comico” - sono le forze politiche e sociali italiane a doversi misurare. Senza aiutini. Ma una questione più ampia, un nodo cruciale sta dinanzi agli occhi di tutti. Per salvare se stesso Berlusconi è pronto a scardinare il sistema costituzionale, stravolgere i processi, sanzionare l’informazione, attaccare la Consulta, insultare il lavoro del Parlamento. Tutto per affermare brutalmente la sua pretesa di immunità. E di immunità “personale” parla ora Bossi con gli abituali modi spicci.
Wojtyla e l’Unità d’Italia
QUESTO passaggio storico interpella anche la Chiesa. Venti anni fa, con l’esplodere del secessionismo leghista e i rischi di disgregazione dell’Italia, il Vaticano si trovò dinanzi ad un nodo storico di eguale rilevanza. Papa Wojtyla, sensibile come polacco al ruolo della nazione, intervenne incisivamente. Agì perché il cattolicesimo si schierasse per l’unità del Paese (e ne sono un riflesso le iniziative del cardinale Bagnasco e il preannunciato messaggio di Benedetto XVI per i 150 anni dell’Unità), lanciò la Preghiera per l’Italia, indirizzò l’Osservatore Romano su una linea rigorosa. Il giurista Carlo Cardia ricorda in una recente pubblicazione come nel 1996, in occasione del cosiddetto “Parlamento padano”, l’Osservatore elencasse ad una ad una le mosse disgregatrici leghiste: l’appello alla resistenza fiscale e alla disobbedienza civile, le formazioni paramilitari, la creazione di un “governo” secessionista. Fino alla conclusione del giornale del Papa: “Siamo ben oltre le provocazioni. Non si tratta più di questione settentrionale o meridionale... Qui si esiste ormai una questione Italia”.
È questa consapevolezza che non si riscontra oggi nella politica - in senso alto - del Pontificato ratzingeriano rispetto alla vicenda italiana. Certo se Benedetto XVI guarda soltanto il Tg1, se si affida unicamente alla rassegna stampa della Segreteria di Stato (che nel febbraio del 2010 censurò le polemiche di Feltri contro i presunti mandanti vaticani del falso documento su Boffo), se continua a non ricevere persone di varia estrazione a differenza di Wojtyla, che aveva ospiti a colazione e a pranzo, è difficile che possa avvertire il polso vibrante degli eventi, guardando all’Italia soltanto attraverso la lente dei suoi collaboratori ufficiali e dei rapporti che gli arrivano sul tavolo. Dovrebbe essere la Segreteria di Stato ad assisterlo. Ma da tempo affiora nella strategia politica della Santa Sede una carenza di sistematicità. Specie in campo internazionale. Interventi puntuali del Papa o documenti importanti come quello del Sinodo sul Medio Oriente si alternano a fasi in cui il Papato appare assente o marginale sulla scena internazionale.
Sta accadendo così anche in queste settimane con le rivolte nel Maghreb e il conflitto sanguinoso in Libia (benché l’Osservatore documenti ampiamente gli eventi). Il Papa, come leader di una delle tre grandi religioni monoteiste, avrebbe molto da dire su una sponda con cui il confronto è ineludibile, mentre gli arabi sono alla ricerca di una nuova statualità. Invece la sua voce non si sente. E se c’è una visione, non viene trasmessa.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- Il mondo sul baratro dell’irresponsabilità. La religione del libero mercato e i limiti profondi del capitalismo (di Hans Kung - Onestà).25 febbraio 2011, di Federico La Sala
Il mondo sul baratro dell’irresponsabilità
La religione del libero mercato e i limiti profondi del capitalismo
Il nuovo libro di Hans Küng si intitola Onestà. Perché l’economia ha bisogno di un’etica ed esce da Rizzoli il 2 marzo (traduzione di Chicca Galli, pp. 372, e 20). In questa pagina anticipiamo un brano dedicato all’ «economia responsabile» . Onestà è un saggio contro la religione del libero mercato, e per la riscoperta dei valori che potrebbero rendere l’economia più equa e più efficace. L’ultima crisi, sostiene Küng, lo ha confermato: il capitalismo non è una scienza e, come il socialismo, ha limiti profondi che rischiano di portare la società al collasso. Il teologo, a cui nel 1979 la Congregazione per la dottrina della fede ha revocato l’autorizzazione a insegnare la teologia cattolica, analizza da una parte la globalizzazione e l’evoluzione dei mercati, dall’altra si interroga su concetti chiave come giustizia, equità, remunerazione. Küng crede in un’etica mondiale, valida anche per l’economia, basata su due principi: la reciprocità (non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te) e l’umanità (ogni essere umano deve essere trattato umanamente). Con Rizzoli il teologo svizzero ha pubblicato vari libri, tra cui Ebraismo (1993), Cristianesimo (1997), Islam (2005), tutti disponibili nella Bur. L’anno scorso è uscito, sempre da Rizzoli, Ciò che credo.
di Hans Küng (Corriere della Sera, 25 febbraio 2011)
Responsabilità, nella sua accezione comune, indica l’impegno a rispondere di un evento e a valutare con coscienza doveri e conseguenze nelle decisioni conflittuali. Nel XX secolo il concetto di responsabilità divenne un concetto chiave dell’etica. Ai nostri giorni, il presidente Barack Obama, nel suo discorso d’insediamento - per prendere le distanze dall’era Bush - ha invocato «una nuova era della responsabilità». Poteva solo intuire che genere di fardelli sovrumani questa responsabilità avrebbe caricato su di lui come presidente: la guerra in Iraq, che offende il diritto internazionale, quella inutile dal punto di vista strategico in Afghanistan, l’opposizione interna alla riforma sanitaria, la crisi finanziaria ed economica mondiale, infine la «catastrofe naturale» senza precedenti della marea nera nel Golfo del Messico, provocata dagli uomini.
Tutto questo è accaduto anche in conseguenza della mancanza di responsabilità: proprio nel caso della fuoriuscita del petrolio in mare, l’irresponsabilità riguardava, da un lato, le aziende impegnate nell’estrazione, che hanno tralasciato diligenza e avvertimenti, dall’altro gli organi di sorveglianza corrotti, un’eredità di George W. Bush jr., l’ex presidente vicino all’industria petrolifera. Ma è già stato dimostrato: l’irresponsabilità in economia non paga; la responsabilità è richiesta anche per ragioni economiche.
Il sociologo Max Weber ha proposto un’etica della responsabilità. Anche una tale etica, secondo lui, non è «senza convinzione», ma s’interroga sempre in modo realistico sulle «conseguenze» prevedibili delle nostre azioni e se ne assume la responsabilità: «Pertanto l’etica della convinzione e quella della responsabilità non sono assolutamente antitetiche ma si completano a vicenda e solo congiunte formano il vero uomo, quello che può avere la "vocazione politica"». Senza l’etica della convinzione, l’etica della responsabilità degenererebbe in una mera etica del successo priva di princìpi morali, per la quale ogni mezzo è lecito per raggiungere lo scopo. Senza etica della responsabilità l’etica della convinzione degenererebbe nella mera cura di un’interiorità soddisfatta di sé. Nella Dichiarazione per un’etica mondiale del Parlamento delle religioni mondiali (Chicago 1993), al termine della parte dedicata al secondo principio fondamentale, si trova la seguente frase: «L’autodeterminazione e l’autorealizzazione sono perfettamente legittime - fin quando non sono disgiunte dalla responsabilità verso i propri simili e verso il pianeta Terra».
Prendendo le mosse da suddetta dichiarazione il filosofo Hans-Martin Schönherr-Mann spiega così la responsabilità: «Non solo volere il Bene, ma anche, nel giudizio etico, considerare razionalmente le conseguenze delle proprie azioni in relazione al loro scopo. L’individuo deve riflettere su cosa fa e sulle conseguenze di ciò che sta facendo. Non è sufficiente né rispettare le leggi né attenersi a determinate normemorali.
La responsabilità diventa la parola-chiave di un’etica della globalizzazione in un mondo pluralistico di sistemi di valori in concorrenza». Già alla fine degli anni Settanta il filosofo tedesco americano Hans Jonas ha analizzato a fondo il «principio di responsabilità» e lo ha riformulato per la nostra civiltà tecnologica, alla luce della situazione completamente mutata del mondo dopo la Seconda guerra mondiale, tenendo presente l’esistenza futura della specie umana, che oggi è messa seriamente in pericolo. L’uomo deve essere responsabile globalmente per bio-, lito-, idro-e atmosfera del pianeta. E tale responsabilità include - si pensi soltanto alla crisi energetica, all’esaurimento delle risorse naturali, alla crescita demografica - un’autolimitazione dell’essere umano e della sua libertà nel presente per amore della sua sopravvivenza nel futuro: si richiede così un’etica di nuovo tipo, un’etica della preoccupazione per il futuro (che rende avveduti) nel rispetto della natura.
Nel mio libro Progetto per un’etica mondiale (1990), ho fatto mia questa visione di Hans Jonas, con due modifiche. La prima è che con la responsabilità nei confronti del mondo si deve prendere in considerazione anche la responsabilità dell’uomo verso se stesso. Non si tratta solo di essere responsabili per l’ambiente, il prossimo, la posterità, bensì anche verso l’uomo stesso, che è un fine in sé e ha una responsabilità nei confronti della sua persona.
Detto con parole elementari, ciò significa: l’uomo deve diventare più umano! Per l’uomo è bene ciò che gli permette di conservare, promuovere, realizzare il suo essere uomo. L’uomo deve sfruttare il suo potenziale umano per realizzare una società il più possibile umana e un ambiente intatto, in modo diverso da com’è avvenuto finora. E può fare molto di più di quanto non stia facendo.
In questo senso il principio realistico di responsabilità e quello «utopico» di speranza (Ernst Bloch) vanno di pari passo. Al più tardi dalla Seconda guerra mondiale, ci troviamo a vivere un nuovo cambiamento di paradigma: dall’epoca moderna siamo passati a una postmodernità i cui contorni sono già delineati, ma a cui non è stato ancora dato un nome che la definisca.
Questo cambio di paradigma non ha come conseguenza una semplice decadenza di valori, come lamentano i pensatori conservatori, bensì un mutamento di valori: da una scienza eticamente libera a una eticamente responsabile; da una tecnocrazia dominante sull’uomo a una tecnologia al servizio dell’umanità dell’uomo. Una trasformazione della società, quindi, non contro la scienza, la tecnologia, l’industria e la democrazia, bensì in associazione con queste forze sociali a cui un tempo si attribuiva un valore assoluto e che invece oggi vengono relativizzate.
I valori specifici della modernità industriale - diligenza (in latino: industria!), razionalità, ordine, coscienziosità, puntualità, sobrietà, operosità, efficienza - non devono essere semplicemente aboliti, ma piuttosto reinterpretati in una nuova costellazione e combinati con i nuovi valori del postmoderno: con l’immaginazione, la sensibilità, l’emozionalità, il calore, la delicatezza, l’umanità. Non si tratta di rifiuti e condanne, ma di contrappesi e progetti alternativi.
In tale contesto - ed è questa la seconda modifica rispetto alla visione di Hans Jonas - le religioni e le ideologie mondiali non debbono essere ignorate bensì integrate. Un’analisi della situazione mondiale che non tenga conto delle religioni del mondo è deficitaria in partenza. Ne consegue che la parola d’ordine del terzo millennio, nel concreto, dovrebbe essere: responsabilità della società intera nei confronti del proprio futuro, responsabilità per la contemporaneità, l’ambiente e anche per l’uomo in sé, la posterità. I responsabili delle diverse regioni, religioni e ideologie del mondo sono invitati a pensare e ad agire nel contesto globale e a tener conto nello stesso tempo delle persone reali.
Ora, proprio l’economia mondiale spesso non è determinata dall’agire responsabile, ma dall’irresponsabilità. Desidero illustrarlo con due esempi concreti: l’avidità di guadagno, che si è estrinsecata in modo totalmente nuovo proprio in questi ultimi decenni, e la mendacità dilagante della politica.
Né l’avidità di guadagno né la mendacità sono una faccenda meramente privata, ma possono diventare un problema sistemico. Per questo bisogna parlarne espressamente sulla base di casi reali. «Passion to perform», la passione della prestazione: dev’essere stato un brillante consulente per la comunicazione quello che ha potuto convincere la più grande banca tedesca a presentare il complesso delle sue attività sotto questo slogan. Succedeva prima della crisi economica; fino a quel momento nessuno aveva collegato il concetto di «passione» con il settore bancario. Uno si domanda: passione di chi? Del gruppo o delle filiali locali, dei top manager o dei singoli consulenti? E passione per cosa?
«Passione» significa più di uno «stato di eccitazione» passeggero, indica uno stato d’animo emotivo che sovente la ragionefatica a governare. Esiste una passione creativa ma anche una passione cieca, distruttiva, esiste l’entusiasmo. Passione per cosa, allora? Ma è chiaro, risponderebbero alcuni impiegati di banca, è la passione di guadagnare il più possibile. E ciò non è un male in sé. È perfino qualcosa di positivo, nel caso di una banca che si è dimostrata capace di resistere alla crisi senza aiuti statali. Se però una banca, anche adesso che la crisi è ben lungi dall’essere superata, persegue di nuovo rendite del 25 per cento al netto della tassazione, molti si chiedono: come può farlo senza andare incontro a rischi troppo alti? A scapito di chi si ottengono simili utili? Perché non bastano un 12 o un 15 per cento come nell’economia reale? Per molti clienti, che hanno perduto parti considerevoli del loro patrimonio, comunque, un simile desiderio di guadagno lascia un retrogusto amaro.
Non è un caso che durante la crisi la parola avidità («greed») fosse sulla bocca di tutti. Ora, «desiderare ardentemente qualcosa» è una caratteristica profondamente umana, e anche un desiderio molto forte e sentito può avere una valenza positiva o una negativa. La «curiosità», il desiderio di imparare qualcosa di nuovo o la «brama di sapere», che è fondamentale per ogni studioso, sono costanti del comportamento umano. Come lo è, sotto un altro aspetto, aspirare a produrre utili, ad approfittare dell’incremento delle entrate e dei vantaggi a esse correlate. Ma questa non è l’avidità nel senso autentico del termine, che viene intesa quasi sempre in modo negativo: come desiderio incontrollato, smisurato, insaziabile. Non importa quale sia il suo oggetto, se si tratta di possesso, di guadagno, di potere, di sesso: il volerne avere sempre di più, senza riguardi per nessuno, è il contrario di una virtù cardinale, ed è in ogni caso un vizio diffuso a livello globale. E ciò non giova affatto alla stabilità finanziaria!
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- Quando finirà la notte (di Barbara Spinelli).23 febbraio 2011, di Federico La Sala
Quando finirà la notte
di Barbara Spinelli (la Repubblica, 23 febbraio 2011)
C’è qualcosa, nel successo strappato a Sanremo dalla canzone di Vecchioni, che intrecciandosi con altri episodi recenti ci consente di vedere con una certa chiarezza lo stato d’animo di tanti italiani: qualcosa che rivela una stanchezza diffusa nei confronti del regime che Berlusconi ha instaurato 17 anni fa, quando pretese di rappresentare la parte ottimista, fiduciosa del Paese. Una stanchezza che somiglia a un disgusto, una saturazione. Se immaginiamo i documentari futuri che riprodurranno l’oggi che viviamo, vedremo tutti questi episodi come inanellati in una collana: le manifestazioni che hanno difeso la dignità delle donne; la potenza che emana dalle recite di Benigni; il televoto che s’è riversato su una canzone non anodina, come non anodine erano le canzoni di Biermann nella Germania Est o di Lounes Matoub ucciso nel ’98 in Algeria. Può darsi che nei Palazzi politici tutto sia fermo, che il tema dell’etica pubblica non smuova né loro né la Chiesa. Ma fra i cittadini lo scuotimento sfocia in quest’ansia, esasperata, di mutamento.
A quest’Italia piace Benigni quando narra Fratelli d’Italia. Piace Vecchioni quando canta la «memoria gettata al vento da questi signori del dolore», e «tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro, un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendo il pensiero». Quando conclude: «Questa maledetta notte dovrà pur finire». Poiché si estende, il senso di abitare una notte: d’inganni, cattiveria, sfruttamento sessuale di minorenni. C’è voglia che inizi un risveglio. Che la politica e anche la Chiesa, cruciale nella nostra storia, vedano la realtà dei fatti dietro quella pubblicitaria. Massimo Bucchi aveva anticipato, in una vignetta del 19 gennaio 2010, questa rivolta contro il falso futuro promesso dai signori del dolore: «Ha da passà ‘o futuro!». Erano i giorni in cui il governo non s’occupava che di legittimo impedimento, di lodo Alfano costituzionale, di processo breve. Immobile, il tempo ci restituisce senza fine l’identico. Quel 19 gennaio, il Senato si riunì per commemorare Craxi. Colpito poco prima a Milano dalla famosa statuetta, Berlusconi annunciava «l’anno dell’amore».
Forse ricorderemo gli anni presenti per questa collana di eventi, che pian piano travolse giochi parlamentari, patti con un potere imperioso e tassativo con gli altri, mai con se stesso. Ricorderemo questa domanda di politica vera. Ricorderemo, infine, i tanti che non hanno visto montare la marea della nausea, che hanno consentito al peggio per noia, o rassegnazione, o calcolo di lobby. Cerchiamo di non dimenticarlo: ben 315 parlamentari hanno votato un testo, il 4 febbraio, in cui si sostiene che Berlusconi liberò Ruby perché, ritenendola nipote di Mubarak, voleva «evitare un incidente diplomatico».
Ma soprattutto, colpirà nei documentari futuri l’inerte ignavia dei vertici della Chiesa, l’orecchio aperto solo ai potenti, il rifiuto - così poco cristiano - di dire male del male solo perché da questo male sgorgano favori; perché i governanti concedono alla Chiesa il monopolio sui cosiddetti valori non negoziali (il dominio sulla vita e la morte, essenzialmente) purché siano lasciati in pace quando violano la Costituzione, fanno leggi per sottrarsi alla giustizia, mostrano di non sapere neppur lontanamente cosa sia la decenza pubblica. La canzone di Vecchioni, la recita di Benigni, sono punti di luce in una chiusa camera oscura; sono una forza che sta di fronte alla formidabile forza del regime. Una forza cocciuta, insistente, cui l’opposizione è estranea e ancor più la Chiesa. L’insurrezione interiore avviene anche dentro il mondo cattolico: si parla di un 30 per cento di refrattari, tra frequentatori della messa e presbiteri. Basta scorrere le innumerevoli lettere che parroci e preti scrivono contro i dirigenti in Vaticano, per rendersene conto. Sono lettere d’ira, contro la loro acquiescenza. Micromega dà ai dissidenti il nome di altra Chiesa e sul proprio sito li rende visibili. Le pagine dei lettori sulla rivista di attualità pastorale Settimana sono fitte di denunce del berlusconismo.
Quest’altra chiesa non ne può più dei compromessi ecclesiastici con una destra che nulla haereditato dalla destra storica che fece l’unità d’Italia. Ha riscoperto anch’essa il Risorgimento, la Costituzione del ’48. Condivide il dover-essere dei cattolici che Alberto Melloni riassume così: «Una dedizione alla grande disciplina spirituale, un primato vissuto del silenzio orante, un abito di umiltà, un’adesione alla democrazia costituzionale come ascesi politica» (Corriere della Sera 19-12- 10, il corsivo è mio).
Tra i criticati il cardinale Bagnasco, che critica il Premier ma per non sbilanciarsi vitupera non meno impetuosamente i magistrati. O che denuncia un disastro antropologico contro il quale però non pronuncia anatemi, preferendo alla chiarezza il torbido di alleanze tra Pdl e Casini che mettano fuori gioco Fini e le sinistre, troppo laici. Contro questo insorgono tanti preti: «Vedete quanto è pericoloso tacere?», chiedono citando Agostino. L’empio pecca, ma è la sentinella che ha mancato: «Chi ha trascurato di ammonirlo sarà giustamente condannato».
Nei paesi nordafricani vigeva simile spartizione di compiti: ai despoti il dominio politico, alle moschee la libertà di modellare l’intimo delle coscienze. L’accordo di scambio sta saltando ovunque, tanto che si parla di fallimento colossale di quella che gli Occidentali chiamavano stabilità. È in nome della stabilità che Berlusconi ha chiamato Mubarak un saggio, e ha detto non voler «disturbare» Gheddafi poco prima che questi bombardasse i libici facendo centinaia di morti. È la stabilità il valore che anima tanti responsabili in Vaticano, perché essa garantisce prebende varie, sconti fiscali per le case-albergo dei religiosi, finanziamenti per scuole.
In cambio si elargiscono indulgenze. Berlusconi dice parole blasfeme, e mons. Fisichella invita a «contestualizzare» la bestemmia. Il Premier è accusato di concussione e prostituzione minorile, e la Chiesa giudica «abnorme» la sua condotta come quella dei magistrati. Afferma Nogaro, vescovo emerito di Caserta: «Noi rimaniamo nello sgomento più doloroso vedendo i gesti farisaici delle autorità civili e religiose, che riescono ad approdare a tutti i giochi del male, dichiarando di usare una pratica delle virtù più moderna e liberatoria.» (Micromega 1/11).
Altri presbiteri ammoniscono contro leggi liberticide sul testamento biologico. Don Mario Piantelli, parroco di San Michele Arcangelo, si associa «alle richieste che da molte parti d’Italia sono indirizzate ai vertici ecclesiastici di alzare forte la voce e di compiere azioni profetiche nei confronti del governo Berlusconi. È necessario un supplemento di libertà evangelica per sganciarsi decisamente da un sistema di governo che, attraverso benefici e privilegi, sembra avvantaggiare il "mondo ecclesiastico", e in realtà aliena e impoverisce i credenti».
La Chiesa ebbe comportamenti non diversi nel fascismo. Sta macchiandosi di colpe simili, e nessuno sguardo profetico l’aiuta a vedere gli umori d’un paese che cambia, che magari non vota opposizione ma è stufo di quel che succede. Che comincia a guardare se stesso, oltre che l’avversario. Il cartello più nuovo, nella manifestazione delle donne, diceva: «Bastava non votarlo». Bastava la virtù dei primordi cristiani: la parresia, il parlar chiaro.
Nel filmato futuro che dirà il nostro oggi saranno convocati gli storici. Potranno imitare Benedetto Croce, quando nei Diari, il 2-12-’43, si mise nei panni di Mussolini e scrisse: «Chiamato a rispondere del danno e dell’onta in cui ha gettato l’Italia, con le sue parole e la sua azione e con tutte le sue arti di sopraffazione e di corruzione, potrebbe rispondere agli italiani come quello sciagurato capopopolo di Firenze (...) rispose ai suoi compagni di esilio che gli rinfacciavano di averli condotti al disastro di Montaperti: "E voi, perché mi avete creduto?"».
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- IL PROBLEMA DELL’UNO E DEI MOLTI - E DELL’UNIVERSALISMO (CATTOLICISMO) ATEO E DEVOTO DEL MENTITORE ISTITUZIONALE ATEO E DEVOTO.21 febbraio 2011, di Federico La Sala
In philosophos!, in theologos!, in tyrannos!: RIPENSARE L’UNO E I MOLTI ("UNO"), L’IDENTITA’ E LA DIFFERENZA!!! CONTIAMO ANCORA COME SE FOSSIMO NELLA CAVERNA DI PLATONE. NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN ....
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- Rosa Luxemburg: "Chiamare le cose con il loro nome". A Roma,in un convegno organizzato dalla Società Dante Alighieri, a confronto Zagrebelsky e Carofiglio (di Manuel Massimo)18 febbraio 2011, di Federico La Sala
 COSTITUZIONE, LINGUA E PAROLA..... E L’OCCUPAZIONE DELLA LEGGE E DELLA LINGUA IN ITALIA (1994-2011)!!!
COSTITUZIONE, LINGUA E PAROLA..... E L’OCCUPAZIONE DELLA LEGGE E DELLA LINGUA IN ITALIA (1994-2011)!!!
 A LORO (E NOSTRA) VERGOGNA: LA POLITICA CI RUBA LA PAROLA E CAROFIGLIO, ZAGREBELSKY E LA "DANTE ALIGHIERI" DORMONO ANCORA IN UN’ITALIA CON "DUE PRESIDENTI" DELLA REPUBBLICA (1994-2011)!!! Una nota di Manuel Massimo sul convegno di Roma - con alcuni appunti
A LORO (E NOSTRA) VERGOGNA: LA POLITICA CI RUBA LA PAROLA E CAROFIGLIO, ZAGREBELSKY E LA "DANTE ALIGHIERI" DORMONO ANCORA IN UN’ITALIA CON "DUE PRESIDENTI" DELLA REPUBBLICA (1994-2011)!!! Una nota di Manuel Massimo sul convegno di Roma - con alcuni appunti
 "Coltivare la varietà del linguaggio e fare un buon uso - accurato, consapevole e cosciente - delle parole". E compiere ogni giorno il gesto rivoluzionario di cui parlava Rosa Luxemburg: "Chiamare le cose con il loro nome".
"Coltivare la varietà del linguaggio e fare un buon uso - accurato, consapevole e cosciente - delle parole". E compiere ogni giorno il gesto rivoluzionario di cui parlava Rosa Luxemburg: "Chiamare le cose con il loro nome".
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- Suore e puttane (di Concita De Gregorio).9 febbraio 2011, di Federico La Sala
Suore e puttanedi Concita De Gregorio (l’Unità, 09.02.2011)
Nel disperato e spaventato tentativo di far sembrare la manifestazione di domenica prossima una piccola cosa, una cosa di donne, sono scese in campo le truppe da combattimento dei sostenitori e dei fiancheggiatori dell’Arcore style. Quelli che, a partire dall’anziano Ostellino, spiegano che ogni donna è seduta sulla sua fortuna dunque che male c’è, è sempre andata così, l’Italia in fondo è veramente un bordello abbiamo letto di nuovo ieri sul Corriere. I più raffinati, per così dire, schierano donne a denigrare altre donne nel tentativo di scatenare quella che, se solo si scatenasse, chiamerebbero entusiasti una rissa da pollaio.
Il sottotesto, il retropensiero divertito di chi manda in tv e mette in prima pagina le Santanchè da combattimento è il seguente: ecco, guardate, donne contro donne. Come se le donne non rispondessero alle categorie di ogni essere umano e non ce ne fossero di ladre e di oneste, di servili e di libere, di capaci e di inette. Gli argomenti più in voga, per denigrare chi crede che le donne siano capaci per prime di reagire al “sistema” piuttosto che adattarvisi, sono i seguenti: sono femministe, moraliste. Predicavano il libero amore ora si atteggiano a suore.
Le brave ragazze contro le prostitute, le madri contro le puttane, il mondo diviso in Maria e Maddalena così come i libri sacri ci insegnano, come gli uomini in fondo desiderano. Le puttane per strada offendono il decoro urbano, in villa sono accompagnate dagli autisti. Il femminismo e il moralismo non c’entrano: molte suore hanno firmato il nostro appello e parecchie prostitute, preti e libertini come se aveste la pazienza di leggerci capireste. Ammesso che l’obiettivo sia capire, naturalmente.
Carla Corso, una donna di 65 anni che è stata ed è leader del comitato per i diritti civili delle prostitute, ci racconta oggi perché aderisce alla manifestazione. Dice, a un certo punto: “Noi eravamo in lotta contro il mondo, volevamo rompere l’ipocrisia, queste ragazze non sono contro ma sono funzionali al sistema”. Il femminismo è stato un movimento politico portatore di diritti. Le ragazze che negli anni Settanta non erano nate, quelle che come me andavano alle elementari non hanno combattuto quella battaglia: ne hanno goduto i frutti. Ma i diritti non sono dati per sempre, vanno difesi: con la cultura, con la consapevolezza.
Scrivevo anni fa le storie vere di Dalia, la ragazzina dell’Est venduta dalla nonna a 12 anni, di Cristina, la studentessa che fiera di farlo rivendica il suo diritto a fare la puttana. La libertà consiste nel darsi il destino che si vuole. Credo che il “sistema” di cui parla Lele Mora e che da decenni è un modello di referimento per generazioni di ragazze - quelle sulle copertine dei rotocalchi, in tv - proponga come strada per la realizzazione di sé una libertà condizionata alla sottomissione. Un mondo di cortigiane, dice Carla Corso.
Il problema non è mai chi vende, è chi compra. L’amore è gratis, si può fare in quanti e come si vuole. Anche vendersi è lecito. E’ l’acquisto all’ingrosso, della società intera, che fa schifo. In specie se si comprano adolescenti: che siano consenzienti, e i loro padri con loro, non migliora. Peggiora piuttosto la responsabilità di chi dovrebbe indicare altri orizzonti e non lo fa. Di chi cavalca la sua privata debolezza spacciandola per legge di vita.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- ARCHEOLOGIA DELL’ALLLEANZA ATEO-DEVOTA: IL CORTILE DEI GENTILI, LUOGO D’INCONTRO DEI MERCANTI DELLA FEDE E I MERCANTI DELLA RAGIONE9 febbraio 2011, di Federico La Sala
MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? SI TRATTA DELLA PAROLA FONDANTE E DISTINTIVA DELLA FEDE CRISTIANA!!! DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! Ha dimenticato l’esortazione di Papa Wojtyla ("Se mi sbalio, mi coriggerete")?!:
 ARCHEOLOGIA FILOSOFICA E TEOLOGICA: "IN PRINCIPIO ERA IL LOGOS". ITALIA, NATALE 2010: AL GOVERNO DELLA CHIESA UN PAPA CHE PREDICA CHE GESU’ E’ IL FIGLIO DEL DIO "MAMMONA" ("Deus caritas est") E AL GOVERNO DELL’ **ITALIA** UN PRESIDENTE DI UN PARTITO (che si camuffa da "Presidente della Repubblica"), che canta "Forza Italia" con il suo "Popolo della libertà" (1994-2010).
ARCHEOLOGIA FILOSOFICA E TEOLOGICA: "IN PRINCIPIO ERA IL LOGOS". ITALIA, NATALE 2010: AL GOVERNO DELLA CHIESA UN PAPA CHE PREDICA CHE GESU’ E’ IL FIGLIO DEL DIO "MAMMONA" ("Deus caritas est") E AL GOVERNO DELL’ **ITALIA** UN PRESIDENTE DI UN PARTITO (che si camuffa da "Presidente della Repubblica"), che canta "Forza Italia" con il suo "Popolo della libertà" (1994-2010).
 ITALIA, NATALE 2010 d. C.: ARCHEOLOGIA EVANGELICA E COSTITUZIONALE. Il buon-messaggio di Giovanni e la preghiera insegnata da Gesù ai suoi discepoli.
ITALIA, NATALE 2010 d. C.: ARCHEOLOGIA EVANGELICA E COSTITUZIONALE. Il buon-messaggio di Giovanni e la preghiera insegnata da Gesù ai suoi discepoli.
Il «cortile» dove si incontrano fede e ragioneParte da Bologna il dialogo tra atei e credenti ispirato allo spazio per i «gentili» del Tempio di Gerusalemme
di Armando Torno (Corriere della Sera, 09.02.2011)
Nell’antico Tempio di Gerusalemme vi era uno spazio chiamato «Cortile dei Gentili» . Ad esso potevano accedere tutti, non soltanto gli israeliti. Non c’erano vincoli di cultura, lingua o religione. In tal modo, accanto al luogo nel quale Dio aveva fissato la sua presenza, si apriva un’area per i non ebrei, per gli «altri» , o meglio per i non credenti nel Dio unico di Abramo, Isacco e Giacobbe. Un atrio esterno, rappresentato appunto da questo cortile dei gojim, con porticato e colonne, sotto cui sostavano scribi e sacerdoti per dialogare con coloro che chiedevano di conoscere meglio la religione di Israele.
La sua esistenza è attestata a partire da Antioco III (223-187 a. C.) e ad esso si riferisce forse l’Apocalisse: «Ma l’atrio che è fuori del santuario, lascialo da parte e non lo misurare, perché è stato dato in balìa dei pagani» (11,2). Giuseppe Flavio nelle sue Antichità Giudaiche (XV, 417) parla dell’iscrizione che proibiva l’ingresso agli stranieri, sotto pena di morte, nella parte riservata al popolo ebraico. Qui si fermò anche Gesù.
Da questa consuetudine, dopo un invito di papa Benedetto XVI alla fine del 2009, è nata l’idea del cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, di dare vita a uno spazio di incontro e confronto sulla fede chiamato, appunto, «Cortile dei Gentili» . Un dialogo che non si terrà in un luogo fisso come un tempo usava ma percorrerà le città del mondo, incontrando le diverse culture. Cercherà risposte alle domande della fede, alimenterà una reciproca conoscenza tra credenti e non credenti.
Ravasi invita ogni uomo e punta sul dialogo: affida ad esso le speranze, gli approfondimenti, nonché la creazione di nuovi contesti per meglio comprendere i problemi attuali. Del resto, Platone consegnò ai dialoghi il suo pensiero; ora si guarda con spirito aperto a questa forma di comunicazione per scoprire idee e opinioni condivise, allargare le comuni consapevolezze. Il cardinale nota: «In ogni incontro c’è già un valore».
Non è possibile scrivere in questo momento un programma definitivo del progetto riguardante il «Cortile dei Gentili» , perché le richieste stanno giungendo da ogni parte del mondo. Possiamo soltanto ricordare che codesta odissea di ragione e fede comincerà a Bologna il prossimo 12 febbraio; il 24 e 25 marzo sarà la volta di Parigi, ma già si parla di Tirana, Praga, Stoccolma, Ginevra, Mosca, Chicago, senza contare le richieste che stanno giungendo dall’Asia e dal Sud America.
Perché Bologna? Ravasi chiarisce: «Cominceremo il nostro viaggio nella più antica università d’Europa, con una grande tradizione laica. Sabato prossimo sarà la vera e propria "prolusione"di un itinerario di dialogo e di ricerca dalle tappe molteplici. L’idea nasce quasi in connessione, in concorrenza con l’evento di Parigi, in particolare con la manifestazione della Sorbona» .
Il rettore, Ivano Dionigi, precisa che «un’università pubblica e laica che ospita il confronto tra il credere e l’intelligere non abdica alla propria autonomia, ma assolve la funzione di istituzione vocata, per natura e storia, alla formazione e alla ricerca» . Il suo intervento e quello del cardinale apriranno, poco dopo le 10, i discorsi dei primi quattro «relatori» del «Cortile» : lo scienziato Vincenzo Balzani, il costituzionalista Augusto Barbera, i filosofi Massimo Cacciari e Sergio Givone. Saranno intervallati da letture dell’attrice Anna Bonaiuto (tra l’altro, ha lavorato con Pupi Avati, Liliana Cavani e Nanni Moretti), che farà rivivere brani di Agostino (Confessioni), Pascal (dei Pensieri la parte sulla «Scommessa» ) e Nietzsche (Così parlò Zarathustra).
Sottolinea Ravasi: «L’iniziativa sarà aperta a tutti: studenti, docenti e anche a coloro che desiderano percorrere i sentieri di altura della ricerca sia filosofica sia teologica, sia razionale sia di fede. L’universitas torna a raccogliere ogni disciplina, compresa la teologia, e si rivolge all’agorà, alla comunità, a chi cerca e si interroga» . - per l’eminente uomo di Chiesa questo è il primo di due passi da intraprendere: «Mi sono ora rivolto all’orizzonte alto della cultura ed è auspicabile che sia l’inizio di un percorso di confronto nell’ambito accademico o, se si vuole, in quello del sapere più qualificato e specialistico; il secondo, invece, è delicato, decisamente arduo: sarà un confronto serrato, anche aspro, con la tipologia dominante della non credenza attuale che è quella nazional popolare dell’indifferenza, dell’amoralità, dello sberleffo ateistico» .
Inoltre Ravasi chiarisce i termini del primo incontro: «Il rettore e io non faremo, ovvero non daremo il là; vorrei ribadire che la tonalità del dibattito è lasciata completamente libera. Noi presenteremo soltanto la ragione di indole culturale che esige un simile confronto, perciò non sarà mai la finalità dell’incontro strettamente apologetica o volutamente laica, ma quello che si intende avviare è un dibattito aperto, un dialogo sulle letture differenti delle questioni umane fondamentali» .
Chiediamo degli esempi. In tal caso il cardinale mette in campo parole pesanti, che stanno al centro dell’attenzione di scienza e teologia, oltre che in secolari controversie filosofiche: «Vita, morte, oltrevita, bene e male, amore e dolore, verità e relativismo, trascendenza e immanenza» . Aggiunge: «Ovviamente ci sarà un’attenzione per le questioni bioetiche, in modo da essere sempre attenti ai progressi delle scienze ma al tempo stesso anche alla complessità del valore della vita e della persona, che restano il punto di riferimento sia per la teologia che per la filosofia» .
Il «Cortile dei Gentili» combatte la sonnolenza dello spirito, quel genere di torpore - per fare un esempio- alimentato da quell’editoria che fa notizia ma è inutile alla cultura, cara a coloro che confondono il messaggio con il massaggio. È iniziativa che ribadisce il valore della fede e ricorda con Dostoevskij l’impossibilità di vivere pienamente senza riflettere su Dio.
Ci accomiatiamo da Ravasi chiedendogli cosa si aspetta, come teologo, da questa iniziativa. «Con essa - risponde - attendo, oltre quel dialogo ricordato, un aiuto per coloro che desiderano uscire da una concezione povera del credere. Vorrei invitare il laico a non considerare la teologia un reperto archeologico o mitologico, perché ha una sua dignità "scientifica"; mentre il credente comprenda le ragioni profonde della teologia e non la veda come ostacolo: la intenda come un sussidio, una componente fondamentale per percorrere le strade della fede» .
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- Giorgio Agamben: Ripensare un’idea diversa del credere... chiave di una nuova politica. Agamben: "Provate a vivere secondo le vostre idee" (di Franco Marcoaldi - intervista).8 febbraio 2011, di Federico La Sala
Riscopriamo l’etica. Agamben: "Provate a vivere secondo le vostre idee"
intervista a Giorgio Agamben
a cura di Franco Marcoaldi (la Repubblica, 8 febbraio 2011)
In cosa crediamo? Quali sono le credenze civili, religiose, politiche, scientifiche, su cui si regge la società? La risposta si fa particolarmente difficile in un mondo come il nostro, che vede le credenze tradizionali - oggetto di una costante erosione - trasformarsi in surrogati, con il conseguente dilagare delle più diverse forme di superstizione. Oppure, per converso, il trionfo di uno scetticismo e di un’indifferenza che rasentano il nichilismo.
Proveremo a trattare la questione "credere, credenza", affrontandola da diversi punti di vista. E partiremo chiedendo l’aiuto di un filosofo italiano di fama internazionale: Giorgio Agamben. «Nella nostra cultura esistono due modelli di esperienza della parola. Il primo modello è di tipo assertivo: due più due fa quattro, Cristo è risorto il terzo giorno, i corpi cadono secondo la legge di gravità. Questo genere di proposizioni sono caratterizzate dal fatto che rimandano sempre a un valore di verità oggettivo, alla coppia vero-falso. E sono sottoponibili a verifica grazie a un’adeguazione tra parole e fatti, mentre il soggetto che le pronuncia è indifferente all’esito.
Esiste però un altro, immenso ambito di parola del quale sembriamo esserci dimenticati, che rimanda, per usare l’intuizione di Foucault, all’idea di "veridizione". Lì valgono altri criteri, che non rispondono alla separazione secca tra il vero e il falso. Lì il soggetto che pronuncia una data parola si mette in gioco in ciò che dice. Meglio ancora, il valore di verità è inseparabile dal suo personale coinvolgimento».
Il senso profondo del credere andrebbe dunque ricercato proprio qui?
«Certamente. Anche se, nel corso del tempo, il trionfo del primo modello, quello assertivo, ha di fatto cancellato il secondo. Mi fanno sorridere i confronti, oggi molto in voga, tra credenti e non credenti: veri e propri dialoghi tra sordi, visto che preti e scienziati condividono da versanti opposti lo stesso modello di verità. Poco importa che si discuta di leggi fisiche o teologiche, che naturalmente si elidono tra loro. Si tratta in ogni caso di proposizioni assertive. La confusione tra ciò che possiamo credere, sperare e amare e ciò che siamo tenuti a considerare vero, oggi ci paralizza».
Quando sarebbe stato cancellato il secondo tipo di esperienza con la parola?
«Nella tradizione dell’Occidente, è stato Aristotele ad affermare che la filosofia deve occuparsi soltanto delle proposizioni che possono risultare vere o false. Eppure esisteva ed esiste un’altra esperienza della parola: quella della promessa, della preghiera, del comando, dell’invocazione, che è stata esclusa dalla riflessione filosofica. Naturalmente, ciò non significa che essa non abbia continuato ad agire: il diritto e la religione si fondano su di essa».
Un esempio?
«Il più importante di tutti: San Paolo, che definendo la parola della fede, non fa riferimento a criteri di verità, ma parla di vicinanza tra cuore e labbra. È significativo che, tranne una volta, egli usi sempre l’espressione, da lui inventata, "credere in Gesù Cristo" e non, come sarebbe stato normale in greco, credere che Gesù è il figlio unigenito di Dio, eccetera. La differenza è sostanziale. La Chiesa, attraverso i suoi concili, ha cercato di fissare la fede in dogma, in un’esperienza di tipo assertivo. E così si è smarrito un tratto fondamentale della natura umana, che esige una fede estranea a una logica puramente fattuale. La vera fede non aderisce a un principio prestabilito ed è singolare che proprio la Chiesa, che doveva preservare questa idea, se ne sia dimenticata. Da qui la formula "Credo perché è assurdo"».
Quali sono i riflessi negativi di tale logica assertiva sulla nostra vita sociale?
«Infiniti. Pensi all’etica: si afferma che per agire bene bisogna disporre di un sistema di credenze prefissato. Dunque, agirebbe bene soltanto colui che ha una serie di principi a cui deve conformarsi.È il modello kantiano, ancora imperante, che definisce l’etica come dovere di obbedire a una legge. Quando lavoravo sull’idea di "testimonianza", mi colpì la storia di una ragazza che, sottoposta a tortura dalla Gestapo, aveva rifiutato di rivelare i nomi dei suoi compagni. A chi più tardi le chiese in nome di quali principi era riuscita a farlo, rispose soltanto "l’ho fatto perché così mi piaceva". L’etica non significa obbedire a un dovere, significa mettersi in gioco: in ciò che si pensa, si dice e si crede».
Anche perché, travolta la credenza nell’infallibilità di quella certa legge, rimane un campo di rovine.
«Prima o poi accade a tutte le credenze di tipo oggettivo. E difatti: le credenze politiche si sono letteralmente sbriciolate, quelle teologico-religiose si fossilizzano in dogmi contrapposti. Per quanto riguarda quelle scientifiche, esse risultano completamente irrelate rispetto alla vita etica dei singoli individui».
In Credere e non credere Nicola Chiaromonte formula una domanda secca: si può credere da soli?
«È una domanda pertinente. Che io riformulerei in questo modo: com’è possibile condividere una verità o una fede che non siano di tipo assertivo? Io penso che questo accada nei territori dell’esistenza in cui ci si mette in gioco personalmente. Se la veridizione è lasciata ai margini e il solo modello della verità e della fede diventano la scienza e il dogma, la vita diventa invivibile. Di qui l’indifferenza e lo scetticismo generalizzato, oltre che la tetraggine sociale dilagante. Soltanto procedendo a ritroso, ricercando quella diversa esperienza di parola, si può tornare al rapporto originario con la verità, irriducibile a qualunque sua istituzionalizzazione. Le faccio un esempio: la scienza guarda al passaggio dal primate all’uomo parlante unicamente in termini cognitivi, come se fosse soltanto una questione di intelligenza e di volume cerebrale. Ma non c’è solo questo aspetto. La trasformazione deve essere stata altrettanto gigantesca dal punto di vista etico, politico, sensibile. L’uomo non è solo homo sapiens. È un animale che, a differenza degli altri viventi, i quali non sembrano dare importanza al loro linguaggio, ha deciso di correre fino in fondo l’azzardo della parola. E da qui è nata la conoscenza, ma anche la promessa, la fede, l’amore, che esorbitano la dimensione puramente cognitiva».
È una strada ancora aperta?
«L’uomo non ha ancora finito di diventare umano, l’antropogenesi è sempre in corso. Menandro ha scritto: "com’è grazioso - cioè capace di gratuità - l’uomo quando è veramente umano". È questa gratuità che dobbiamo riscoprire. Tanto più che i modelli di credenza che ci vengono proposti non ci persuadono più. Sono, come diceva Chiaromonte, mantenuti a forza, in malafede».
Proviamo dunque a perimetrare il novero di queste credenze più genuine, anche se sotterranee, sommerse.
«Prendiamo la politica: perché non interroga finalmente la vita delle persone? Non la vita biologica, la nuda vita, che oggi è continuamente in questione nei dibattiti spesso vani sulla bioetica, ma le diverse forme di vita, il modo in cui ciascuno si lega a un uso, a un gesto, a una pratica. Ancora: perché l’arte, la poesia, la letteratura, sono museificate e relegate in un mondo a parte, come se fossero politicamente e esistenzialmente irrilevanti?».
Anche lo scrittore russo Alexandr Herzen lamentava a suo modo la cancellazione dell’esperienza vitale soggettiva. Affermando che crediamo in tutto, tranne che in noi stessi.
«Viviamo in società abitate da un Io ipertrofico, gigantesco, nel quale però nessuno, preso singolarmente, può riconoscersi. Bisognerebbe tornare all’ultimo Foucault, quando rifletteva sulla "cura di sé", sulla "pratica di sé". Oggi è rarissimo incontrare persone che sperimentino quella che Benjamin chiamava la droga che prendiamo in solitudine: l’incontro con sé stessi, con le proprie speranze, i propri ricordi e le proprie dimenticanze. In quei momenti si assiste a una sorta di congedo dall’Io, si accede a una forma di esperienza che è l’esatto contrario del solipsismo. Sì, penso che si potrebbe partire proprio da qui per ripensare un’idea diversa del credere: forme di vita, pratica di sé, intimità. Queste sono le parole chiave di una nuova politica».
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- CATTOLICI E ATEI, INSIEME PER CONTINUARE IL "DUETTO"!!! La proposta del cardinale Gianfranco Ravasi .4 febbraio 2011, di Federico La Sala
CATTOLICI E ATEI, INSIEME PER CONTINUARE IL "DUETTO"!!! La proposta del cardinale Gianfranco Ravasi ...
 CATTOLICI E ATEI, INSIEME PER UNA TEOLOGIA ATEA E DEVOTA!!! AL GOVERNO DELLA CHIESA UN PAPA CHE PREDICA CHE GESU’ E’ IL FIGLIO DEL DIO "MAMMONA" ("Deus caritas est") E AL GOVERNO DELL’ **ITALIA** UN PRESIDENTE DI UN PARTITO (che si camuffa da "Presidente della Repubblica") e canta "Forza Italia", con il suo "Popolo della libertà" (1994-2011).
CATTOLICI E ATEI, INSIEME PER UNA TEOLOGIA ATEA E DEVOTA!!! AL GOVERNO DELLA CHIESA UN PAPA CHE PREDICA CHE GESU’ E’ IL FIGLIO DEL DIO "MAMMONA" ("Deus caritas est") E AL GOVERNO DELL’ **ITALIA** UN PRESIDENTE DI UN PARTITO (che si camuffa da "Presidente della Repubblica") e canta "Forza Italia", con il suo "Popolo della libertà" (1994-2011).
 DAL DUELLO AL DUETTO, PER IL DIALOGO ATEI E DEVOTI! La proposta del cardinale Gianfranco Ravasi per promuovere il "Cortile dei Gentili".
DAL DUELLO AL DUETTO, PER IL DIALOGO ATEI E DEVOTI! La proposta del cardinale Gianfranco Ravasi per promuovere il "Cortile dei Gentili".
 (...) Quello che il progetto denominato "Cortile dei Gentili" vuole proporre è, invece, un duetto (dal latino duo) ove le voci possono appartenere anche agli antipodi sonori eppure riescono a creare armonia, senza per questo rinunciare alla propria identità, cioè, fuor di metafora, senza scolorirsi in un vago sincretismo ideologico (...)
(...) Quello che il progetto denominato "Cortile dei Gentili" vuole proporre è, invece, un duetto (dal latino duo) ove le voci possono appartenere anche agli antipodi sonori eppure riescono a creare armonia, senza per questo rinunciare alla propria identità, cioè, fuor di metafora, senza scolorirsi in un vago sincretismo ideologico (...)-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- L’ALLEANZA DEI MERCANTI DEL CIELO E DELLA TERRA. l cardinale Gianfranco Ravasi continua nella sua ’giusta’ pretesa di far dialogare l’amore insegnato da Benedetto XVI ("caritas") con l’amore dei mercanti ("caritas").8 febbraio 2011, di Federico La SalaDOPO CRISTO, DOPO DANTE, dopo Galilei, dopo Kant, E DOPO LA NOSTRA COSTITUZIONE, ANCORA IL RILANCIO DELLA VECCHIA ALLEANZA TRA I SACERDOTI DEL TEMPIO E IL RE ERODE?!
 LA VECCHIA E ASTUTA LAICITA’, VENDUTA COME NUOVA: "IL CORTILE DEI GENTILI" E L’APOLOGIA (E LA GENEALOGIA) DELLA LIBERTA’ DI COMMERCIO. Il cardinale Gianfranco Ravasi continua nella sua ’giusta’ pretesa di far dialogare l’amore insegnato da Benedetto XVI ("caritas") con l’amore dei mercanti ("caritas").
LA VECCHIA E ASTUTA LAICITA’, VENDUTA COME NUOVA: "IL CORTILE DEI GENTILI" E L’APOLOGIA (E LA GENEALOGIA) DELLA LIBERTA’ DI COMMERCIO. Il cardinale Gianfranco Ravasi continua nella sua ’giusta’ pretesa di far dialogare l’amore insegnato da Benedetto XVI ("caritas") con l’amore dei mercanti ("caritas").
-
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- DEMOCRAZIA E DECADENZA - IN ITALIA. È il problema della moralità pubblica come cemento della democrazia, o in altre parole della sostanza morale della democrazia (di Adriano Prosperi).3 febbraio 2011, di Federico La Sala
Democrazia e decadenza
di Adriano Prosperi (la Repubblica, 3 febbraio 2011)
Perché, nonostante le prove schiaccianti di ripetute e numerose illegalità e turpitudini morali, gli italiani continuano a sostenere Silvio Berlusconi? Questa è la domanda che ci si pone fuori d’Italia. Il New York Times ha aperto uno spazio di dibattito sull’Italia intitolandolo così: "Decadenza e democrazia in Italia". È un titolo che ci ricorda un punto importante: dal punto di vista di una tradizione come quella americana la moralità e la democrazia sono essenziali l’una all’altra. Dalla decadenza morale discende la crisi della democrazia. Il politico che mente, che giura il falso, che dà esempi di vita palesemente immorale, che attacca l’ordinamento costituzionale, vi è non solo messo in stato d’accusa ed espulso dal gioco del potere ma è anche immediatamente colpito dal verdetto inappellabile dell’opinione pubblica.
Il caso Berlusconi sembra fatto apposta per proiettare come in uno specchio rovesciato l’idea di democrazia agli occhi del paese che l’ha creata. Così gli argomenti hanno finito col battere sul tasto della diversità antropologica degli italiani: disposti a perdonare tutte le forme di corruzione, maschilisti e sessisti, portati a discriminare le donne più di ogni altro paese europeo e a consumare immagini di corpi femminili in una misura impensabile altrove. In quel dibattito sono intervenuti anche diversi italiani che hanno provato a rispondere e a fornire giustificazioni. Non hanno avuto un compito facile. E soprattutto non hanno centrato il nodo del rapporto tra moralità e democrazia. Si è andati dal piano politico - la presunta mancanza di alternative - a quello dell’imbonimento dei media asserviti in vario modo al padrone. Argomenti fragili, come ognun vede.
Non siamo in un regime dittatoriale di controllo dell’informazione. E quanto a possibili alternative, ce ne sono anche troppe: il problema è che non riscuotono consensi nella stessa misura del personaggio che fuori d’Italia appare così sconveniente e grottesco. Ma la speranza è dura a morire e c’è chi ha chiesto ai lettori americani di avere pazienza promettendo a breve scadenza una normalizzazione della situazione italiana: così Alexander Stille ha concluso il suo intervento affermando che il pubblico italiano non sopporterà più a lungo il fatto che Berlusconi si occupi dei propri affari trascurando del tutto l’attività di governo. Questo sarebbe secondo lui l’unico "peccato imperdonabile" per gli italiani. Vedremo se la previsione sarà confermata. Ma intanto si è affacciata la questione squisitamente teologica e religiosa del "sin that may not be forgiven", il "peccato imperdonabile".
Che cosa abbia significato nella cultura puritana questo problema lo abbiamo imparato dalla grande letteratura dell’800. Ma oggi è una domanda molto semplice quella che ci viene proposta dal paese di Melville e di Hawthorne: esiste almeno un peccato imperdonabile per gli italiani? La risposta negativa dei paesi di cultura non cattolica è a questo proposito antica e ben consolidata.
Un viaggiatore inglese del ’600 autore di un rapporto sullo stato della religione in Italia che fu postillato da Paolo Sarpi, Edwin Sandys, lo disse molto chiaramente: gli italiani gli sembrarono un popolo civile e accogliente, dotato di eccellenti qualità. Gli piacquero anche alcuni aspetti della loro religione. Ma trovò incomprensibile e del tutto esecrabile la pratica della confessione cattolica: il modo in cui nel segreto del confessionale i comportamenti più immorali e le infrazioni più gravi ai comandamenti cristiani venivano cancellati al prezzo di qualche orazioncella biascicata distrattamente gli sembrò una vera e propria licenza di immoralità, un modo per corrompere in radice la natura di un popolo.
Oggi quei tempi e quelle idee sono lontani ma il problema si ripropone. La questione teologica di allora ci si presenta come qualcosa che riguarda il paese intero e tocca la radice profonda della convivenza democratica e del funzionamento delle istituzioni. È il problema della moralità pubblica come cemento della democrazia, o in altre parole della sostanza morale della democrazia, come questione del rapporto che deve esserci tra il buon ordinamento della società e il patto stretto dal politico con gli elettori: l’impegno ad accettare le regole, quelle del fisco, della giustizia, dellalibertà d’informazione, incluso l’obbligo a sottostare alla legge come e più di ogni privato cittadino.
Ora, che questo problema sia stato ignorato clamorosamente dalla dirigenza della Chiesa cattolica italiana anche nei suoi recenti e imbarazzati pronunciamenti è qualcosa che rinvia ai caratteri profondi della religione italiana e non può essere spiegato soltanto dalla difesa del proprio potere e dalla ricerca dei favori governativi da parte di chi si arroga la funzione di maestro e censore della morale collettiva.
Ma è dal punto di vista della sopravvivenza della democrazia italiana che quello che ci viene proposto da Berlusconi in questo tardo autunno dell’ "egoarca" appare come un patto scellerato: si tratterebbe di affrontare i problemi del paese lasciando cadere come irrilevanti i capi d’accusa dei tanti reati che pendono sulla testa del premier. Se anche fosse vero che accettando questo patto i problemi di un paese ridotto nelle condizioni che ognuno vede sarebbero risolti, la questione è quella della natura del regime che noi italiani ci troveremmo ad avere inventato. E qui torna utile la domanda che fu posta da Benedetto Croce a proposito della natura del fascismo: rivoluzione o rivelazione, trasformazione violenta e radicale dell’assetto politico del paese o disvelamento di una verità profonda, di carenze antiche e radicali, tali da rendere il paese Italia diverso da tutti gli altri.
Oggi, al termine - speriamo, infine - di un’avventura individuale e collettiva che consegna una fetta consistente di storia del Paese alla figura di Berlusconi, gli italiani tutti e non solo la classe politica, sono giudicati nel mondo per ciò che hanno accettato e premiato con le loro scelte e di cui continuano a non volersi liberare. Come nel rapporto tra personaggio e ritratto descritto da Oscar Wilde ne "Il ritratto di Dorian Gray", oggi il nostro Paese e la qualità morale della nostra convivenza civile sono diventati il ritratto rivelatore della verità nascosta del personaggio Berlusconi: brutti, vecchi, laidi, corrotti. Così li giudica l’opinione pubblica democratica dei paesi civili.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- LA LEZIONE DI ALEX LANGER, OGGI. Piantare la carità nella politica (di Goffredo Fofi - Langer: fare ponti e «viaggiare leggeri»).28 gennaio 2011, di Federico La Sala
Langer: fare ponti e «viaggiare leggeri»
di Goffredo Fofi (Avvenire, 28 gennaio 2011)
Se si dovesse chiudere in una formula ciò che Alex Langer ci ha insegnato, essa non potrebbe che essere: piantare la carità nella politica. Proprio piantare, non inserire, trasferire, insediare. E cioè farle metter radici, farla crescere, difenderne la forza, la possibilità di ridare alla politica il valore della responsabilità di uno e di tutti verso «la cosa pubblica», il «bene comune», verso una solidarietà tra gli umani e tra loro e le altre creature secondo il progetto o sogno di chi «tutti in sé confederati estima/ gli uomini, e tutti abbraccia/ con vero amor, porgendo/ valida e pronta ed aspettando aita/ negli ultimi perigli e nelle angosce/ della guerra comun».
Dico carità nel preciso senso evangelico, poiché Alex era un cristiano, dei non molti che cercavano di attenersi agli insegnamenti evangelici che era possibile conoscere in quegli anni nel «movimento» (e oggi sono ancora di meno) e non, come tanti di noi che gli fummo contemporanei e amici, di fragilissime convinzioni «marxiste» oppure, al meglio, mossi confusamente da una visione solo etica del cristianesimo.
La «diversità» di Alex, la sua superiorità sui suoi amici e compagni, gli veniva anche da una storia famigliare più ricca, a cavallo tra lingue e culture, tra Germania e Italia e tra ebraismo e cattolicesimo, ma nessuno vide mai in questo il marchio del privilegio, poiché essa era caratterizzata in lui da una convinzione di umiltà reale e non esibita, non appariscente, dalla propensione all’ascolto degli altri, di tutti, dalla libertà dei collegamenti e dalla scelta di «far da ponte».
Quante volte Alex Langer non ha teorizzato nei suoi testi la funzione e l’imprescindibile necessità dei «ponti»? Ricordava tanti anni fa Piero Calamandrei fondando, a guerra appena conclusa, una rivista che si chiamava Il ponte, il significato metaforico ma anche concreto dei ponti, da riedificare dopo le distruzioni della guerra che si era accanita a distruggerli. Ponti veri, che gli uni o gli altri avevano fatto saltare, e che dovevano mettere di nuovo in comunicazione e in «commercio» persone e città, culture e territori.
Ponti ideali, che potessero permettere ai vinti e ai vincitori, tutti infine perdenti, sopravvissuti ai conflitti e alle stragi e cioè al dominio della morte, di ritrovare nell’incontro e nel dialogo la possibilità di un futuro migliore. (L’attaccamento di Alex alle sue radici regionali e la sua ambizione cosmopolita gli hanno permesso una concretezza precisa, mai parolaia, e una visione ampia, internazionale, nel filone di quell’utopia che era stata per un tempo di una parte del movement americano, quella che diceva di doversi preoccupare ostinatamente di due ambiti da tenere strettamente collegati tra loro: «Il mio villaggio e il mondo».)
Il progetto semplicissimo e immenso di far da ponte tra le parti in lotta, che ad Alex costò infine la vita, è fallito e continua a fallire in un mondo dove le incomprensioni permangono e prosperano gli odi, sollecitati dai diversi poteri e dal peso dei torti ricevuti e fatti, di una memoria di gruppo che, invece di rendere aperti, rende più chiusi alle ragioni degli altri. Poiché troppa memoria può uccidere alla pari della (nostra, italiana) assenza di memoria.
E tuttavia il messaggio di Langer è stato fino all’ultimo chiaro: se anche c’è chi cade, chi non regge più il peso della storia e della solitudine (forse ci si uccide perché ci si sente o si è rimasti soli - ma alcuni, come i vecchi e i malati, perché si è tagliati via dalla vita - più che per l’oggettiva debolezza e insicurezza del genere umano e per la fatica di dover continuamente ricominciare), bisogna imparare dall’esperienza quel che se ne può ricavare, e andare avanti. Non perché «si spera», ma perché «si ama»: e la «carità» è allora il centro di tutto, come voleva san Paolo - più della speranza e più della fede. Alex Langer ha svolto una funzione di ponte in due direzioni prioritarie: quella di accostare popoli e fazioni, di attutirne lo scontro e di promuoverne l’incontro, e quella dell’apertura a un rapporto nuovo tra l’uomo e il suo ambiente naturale.
E se nel primo caso, quello più determinato dalle pesanti contingenze della storia (per Alex, la guerra interna alla ex Jugoslavia), si trattava di far da ponte ma anche da intercapedine, da camera d’aria dove potesse esprimersi un dialogo assai difficile, nel secondo si trattava piuttosto di additare nuovi territori all’azione politica responsabile, allargandone il significato da città a contesto, da polis a natura. Se sul fronte della pace e della convivenza tra umani di diversa etnia o religione o parte politica Alex è stato un continuatore, egli è stato su quel secondo fronte un precursore, uno dei più persuasi pionieri dell’indispensabilità di una visione ecologica dell’agire politico.
Ha visto tra i primi l’arrivo della novità, come lo Zaccheo del Vangelo che si portò nel luogo più avanzato del suo villaggio e nel suo punto più alto per poter vedere per primo l’arrivo del Messia, e cioè della Novità, ed è stato confortato in questo dalla sua conoscenza e vicinanza a uno dei pochi veri profeti dello scorso secolo, il prete e filosofo che si faceva chiamare Ivan Illich. Tra l’antico e l’eterno del messaggio cristiano e la verde novità dell’ecologia, tra le esigenze della pace (gli uomini) e quelle dell’armonia (degli uomini con la natura) tra loro fittamente intrecciate, sempre più interdipendenti, Langer si è mosso quotidianamente, attento al presente ma cosciente del passato e straordinariamente aperto al futuro, al possibile e al doveroso dei compiti della politica (della militanza, della persuasione).
Contro il gioco chiuso del potere. E contro i ricatti paralleli di un’impazienza non meditata e di una lentezza non ipocrita: nell’avvicendarsi che appartiene alla storia delle fasi di stasi e di quelle di febbre, occorre prepararsi nella stasi per saper meglio muoversi nella furia che, prima o poi, si scatenerà.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- Ruby e l’uso politico dello sdegno (di Angelo Bersani).28 gennaio 2011, di Federico La Sala
Ruby e l’uso politico dello sdegno
di Angelo Bersani *
Un bravo vescovo, di quelli che non hanno fatto carriera perché conservano uno spirito libero ed evangelico, cercava di rispondere alla delusione suscitata dalle parole caute del presidente della Cei. Vedi, mi diceva, a questo punto non si tratta di usare parole forti che appaiono retoriche. Le invettive possono diventare un alibi per lavarsi la coscienza. Il problema non è tanto il comportamento, assolutamente deplorevole, di una persona; il dramma è l’indifferenza della grande maggioranza.
Certo chi è politicamente contrario al presidente esprime sdegno; chi è favorevole lo giustifica (e magari lo invidia). Ma è un uso politico. I vescovi e le persone di retta coscienza non sono interpellati tanto dal comportamento di qualche peccatore, quanto dalla catastrofe etica che sembra permeare tutta la società. Magari si grida allo scandalo, ma perché si tratta di un avversario politico. Pochi si indignano perché nelle storie che abbiamo ascoltato c’è disprezzo per la persona umana, c’è la prevaricazione del danaro, c’è il ricatto e la violenza, la menzogna elevata a sistema, la corruzione della politica che diventa clientela e mercimonio.
C’è, ancora più grave, la corruzione dei giovani, che partecipano e vedono l’esempio degli uomini “di successo”. Sono i giorni di un’apocalisse (che vuol dire “svelamento”) che ci rivela una società assai peggiore di quel che credevamo. E allora, spiega il vescovo, più che l’invettiva moralistica dobbiamo fare tutti un grande esame di coscienza; e le parole di Bagnasco vanno in questa direzione. Non è suo compito dire quali conseguenze politiche debba avere il comportamento indegno del capo della maggioranza. A ciò dovrebbe bastare il buon senso degli italiani; e se questo non c’è, significa che bisogna impegnarsi anzitutto a ricostruire una coscienza civile, morale e politica. È il tema della testimonianza e della educazione che torna in primo piano. Ma quale educazione? Il vescovo era d’accordo con vari commenti apparsi il 25 gennaio: Valli e Faggioli (Europa), Garelli (La Stampa) e Mancuso (Repubblica).
Certo anche la Chiesa italiana deve fare un esame di coscienza: per troppi anni alcuni prelati hanno voluto fare la politica in prima persona. Come dimenticare le elezioni regionali dell’aprile 2000, quando il vicariato di Roma fece campagna per Storace quando dall’altra parte c’era un cattolico esemplare come Piero Badaloni? Per cambiare strada servirà creare luoghi di dialogo e corresponsabilità nell’ambito ecclesiale e riconoscere ai laici cattolici autonomia e autorevolezza per affrontare la vita politica al servizio del bene comune e della speranza dei giovani.
* “Europa” del 28 gennaio 2011: http://www.finesettimana.org/pmwiki/uploads/Stampa201101/110128bertani.pdf
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- LINEA D’OMBRA (di Barbara Spinelli).26 gennaio 2011, di Federico La Sala
Linea d’ombra
di Barbara Spinelli (la Repubblica, 26 gennaio 2011)
Viviamo, da ormai quasi un ventennio, nella non-politica. Della politica abbiamo dimenticato la lingua, il prestigio, la vocazione. Dicono che a essa si sono sostituiti altri modi d’esercitare l ’autorità: il carisma personale, i sondaggi, il kit di frasi e gesti usati in tv. Ma la spiegazione è insufficiente, perché tutti questi modi non producono autorità e ancor meno autorevolezza.
Berlusconi ha potere, non autorevolezza. Non sono le piazze a affievolirla ma alcune istituzioni della Repubblica. evidentemente non persuase dalle sue ingiunzioni. Le vedono come ingiunzioni non di un rappresentante dello Stato, ma di un boss terribilmente somigliante al dr Mabuse, che nel film di Fritz Lang crea un suo stato nello Stato. Alle varie istituzioni viene intimato di ubbidire tacendo, e già questo è oltraggio alla politica e alla Costituzione.
Specialmente sotto tiro è la magistratura, che incarna il diritto. Un gran numero di magistrati si trova alle prese con un leader-non leader, sospettato di crimini di cui la giustizia indipendente non può non occuparsi. Le sue peripezie sessuali lo hanno minato ulteriormente, essendo forse connesse a reati, e hanno accresciuto la sua inaffidabilità. Questo è il dilemma. Il carisma che ha avuto e ha presso gli elettori non ha prodotto che subalternità o resistenza. Il potere gli dà una parvenza di autorità, ma l’autorevolezza, che è altra cosa, gli manca. Non incarna la legge, il servizio su cui la politica si fonda, perché questi ingredienti non sono per lui primari.
L’autorevolezza del leader è riconosciuta non solo dall’elettore ma dai pari grado e dai poteri chiamati per legge a controbilanciare il suo. Il conflitto tra il Premier e la giustizia non avviene fra due poteri irrispettosi dei propri limiti, come ha detto lunedì il cardinale Bagnasco. Avviene perché il premier indagato non va in tribunale, non accetta l’obbligatorietà dell’azione penale costituzionalmente affidata ai pm (art. 112). I pari grado esigono da chi comanda capacità di comunicare senza di continuo mentire e smentirsi. Esigono un equilibrio psichico che non sfoci in aggressività, in punizioni a tal punto fuori legge che sempre occorre scriverne di nuove.
A questo dovrebbe servire la politica non tirannica: a governare i conflitti nel loro sorgere, a non intimidire. Berlusconi disconosce tali virtù, per il semplice motivo che non sa - non vuol sapere - quel che significhino la politica e il comando. Non il merito e l’autonomia individuale sono stati da lui rafforzati, come tanti italiani s’attendevano, ma l’appartenenza ai giri di potere anti-Stato descritti da Gustavo Zagrebelsky (Repubblica 26-3-10). Non stupisce la contiguità fra i giri e le associazioni malavitose. Ambedue hanno potere di nuocere o favorire, non autorevolezza.
Anche il carisma non è politica alta. Il primo è personale e labile, la seconda essendo un impasto di regole s’innalza sopra il contingente, non si mimetizza nelle voglie della folla, guarda più lontano. La politica alta è distrutta quando i cittadini dimenticano che solo le istituzioni durano. Lo disse Jean Monnet dopo l’ultima guerra, vedendo i disastri commessi dagli Stati e progettando l’Europa sovranazionale: «Solo le istituzioni son capaci di divenire più sagge: esse accumulano l’esperienza collettiva, e da questa esperienza, da questa saggezza, gli uomini sottomessi alle stesse regole potranno vedere non già il cambiamento della propria natura, ma la graduale trasformazione del proprio comportamento». Solo l’istituzione ben guidata ha il carisma, il «dono» di operare per il bene comune indipendentemente da chi governa.
In Joseph Conrad, la scoperta delle capacità di comando è il momento in cui il capo della nave oltrepassa la linea d’ombra e apprende il compito come servizio (il compito di portare nave e passeggeri sani e salvi in porto). È scritto in Tifone: «Pareva si fossero spente tutte le luci nascoste del mondo. Jukes istintivamente si rallegrò di avere vicino il Capitano. Ne fu sollevato, come se quell’uomo, con la sola sua comparsa in coperta, si fosse preso sulle spalle il peso maggiore della tempesta. Tale è il prestigio, il privilegio e la gloria del comando. Ma da nessuno al mondo il capitano Mac Whirr avrebbe potuto attendere un simile sollievo. Tale è la solitudine del comando».
Berlusconi è rimasto al di qua della linea d’ombra. La prova che dall’adolescenza ci immette nella maturità, non l’ha superata.
Ma il problema non è solo Berlusconi. Al di qua della linea d’ombra è restata l’idea stessa che in Italia ci si fa della politica. La politica non è associata a competenza e disinteresse personale, e chi non entra nelle beghe di quella che in realtà è non-politica, viene chiamato un tecnico o un ingenuo. Non è associata alla verità, ritenuta quasi un attributo pre-politico. È dominio fine a se stesso, e così degenera. Lo Stato funziona se gli ordini vengono eseguiti, ma a condizione che sia custodito il bene comune. Che il potere si nutra di legalità, oltre che della legittimità data dalle urne. Che il privato non prevalga sul pubblico.
La vera corruzione italiana comincia qui: nelle teste, prima che nei portafogli. Non che sia scomparso il politico vero, ma spesso di lui si dice: «È uno straniero in patria». Sono i falsi politici a considerarlo estraneo ai giri, alla loro «patria». L’Italia ha conosciuto la politica alta: quella della destra storica nata dal Risorgimento; quella dei costituenti di destra e sinistra; quella di Luigi Einaudi. In uno scritto del 1956, il secondo Presidente della Repubblica invitò gli italiani a non illudersi: «Nessuno Stato può esistere e durare se non sono saldi i pilastri fondamentali» che sono la difesa, la sicurezza, il diritto, l’ordine pubblico. Senza tali pilastri «gli Stati sono cose fragili, che un colpo di vento fa cadere e frantuma». Al capo politico spetta salvaguardarli, poiché spetterà a lui «dire la parola risolutiva, dare l’ordine necessario».
Difficile dire la parola risolutiva, quando tutto traballa. Quando la linea d’ombra non è riconosciuta e il capo vive o cade nella pre-adolescenza. Uno dei motivi per cui da anni ci arrovelliamo sul potere berlusconiano - è un Regime? un autoritarismo nuovo? - è questa sua incapacità di dire parole credibili. L’ubbidienza al politico, scrive ancora Einaudi, è possibile solo se «gli uomini a cui è affidata l’osservanza della legge non mettono se stessi al di sopra della legge». Se i capi civili «sapranno di essere confortati dal consenso di cittadini, convinti che nessuno Stato dura, che nessuna proprietà, nessuna sicurezza di lavoro, nessuna certezza di avvenire sono pensabili, se tutti non siano decisi ad osservare i principii vigenti del diritto e dell’ordine pubblico».
La sinistra ha scoperto tardi la forza delle istituzioni, dello Stato. Anch’essa ha spesso considerato il sapere tecnico, la legalità, il parlar-vero, come non-politica. Politica era conquista di posti, più che servizio. Non era apprendere la prudenza insegnata nel ‘600 da Baltasar Gracián: la prudenza di chi non si scorda che «c’è chi onora il posto che occupa, e chi invece ne è onorato». Per questo l ’opposizione appare vuota, a volte perfino più incompetente di alcuni governanti, non meno indifferente ai meriti, non meno interessata a lottizzare poteri. Lo stesso Veltroni sfugge la politica quando invita a «viaggiare in mare aperto». C’è bisogno di porti, non fittizi. C’è bisogno di capire che non cresceremo più come prima. Che non è straniero in patria chi elogia l’invenzione delle tasse o del Welfare: questo strumento che crea comunità solidali strappandole alla legge del più forte.
È vero, l’Italia ha bisogno di una rivoluzione democratica. Dunque: di una rivalutazione della politica. È la politica che deve vagliare i dirigenti e impedire all’indegno di entrarvi, senz’aspettare la magistratura. Non è solo la sinistra a poter incarnare simile rivoluzione. Possono farla anche le destre, a lungo identificate con Berlusconi. Fini è il primo a riscoprire la politica, e anche la destra storica. C’è una tradizione riformatrice in quella destra, evocata su questo giornale da Eugenio Scalfari nell’88, nello stesso anno in cui denunciò l’ascesa del potere televisivo berlusconiano: la tradizione di Marco Minghetti, di Silvio Spaventa, che esalta la politica come servizio pubblico. Sinistra e destra debbono ritrovarla, come seppero fare dopo il ventennio fascista.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- Vergognatevi, così nasce l’etica (di Nadia Urbinati)22 gennaio 2011, di Federico La Sala
 Vergognatevi, così nasce l’etica
Vergognatevi, così nasce l’etica
 quelle riflessioni da Leopardi a Marx
quelle riflessioni da Leopardi a Marxdi Nadia Urbinati (la Repubblica, 22 gennaio 2011)
L’indignazione è un moto dell’animo nutrito dal senso di vergogna, un’emozione fondamentale nella fenomenologia dell’etica sociale. Come altre emozioni, la vergogna è "generativa di comportamento" in quanto mette in moto sentimenti, come l’indignazione e la colpa, che agiscono direttamente sulla volontà: per alleviarli si è portati a giustificare la proprie azioni e infine a reagire. Se l’emozione della vergogna è in se stessa non razionale, la serie di sentimenti e azioni che alimenta sono dunque di tipo strategico: le forme con le quali l’individuo che si vergogna agisce sono propositi razionali volti a rimediare il misfatto che ha generato vergogna. Per esempio Papa Benedetto XVI ha commentato i numerosi casi di pedofilia nel clero cattolico con queste parole: "Proviamo profonda vergogna e faremo tutto il possibile perché ciò non accada più in futuro".
Per questa sua capacità generativa di comportamento, l’emozione della vergogna è stata messa da Giambattista Vico alle origini della società: se "la natura di tutte le cose sta nel loro cominciamento", allora la natura della storia umana sta nella vergogna primaria, quella di Adamo ed Eva di fronte alla nudità che scoprirono di avere non appena violarono il patto di obbedienza con il loro creatore. Nella Genesi come nel Pentateuco, la vergogna e la colpa figurano alle origini della responsabilità morale. Il rossore che sale sulle guance di chi prova vergogna è il segno della socialità di questa emozione, del bisogno di riconoscimento da parte degli altri e nello stesso tempo del controllo che quel riconoscimento opera sulle nostre azioni: chi prova vergogna non riesce a sostenere lo sguardo altrui e abbassa gli occhi a terra. Questa dimostrazione di vergogna è correlata e complementare alla reazione di indignazione che la conoscenza di un comportamento vergognoso induce.
Pertanto, la vergogna ha una fenomenologia doppia: la persona colpevole può provare il desiderio di nascondersi (così nasce il senso di umiliazione); chi assiste può reagire con sdegno. È per questa doppia valenza che poeti e filosofi hanno attribuito alla vergogna un ruolo liberatorio, non solo per l’individuo ma anche per la collettività.
Non provare vergogna, e per converso non provare indignazione, sono da questo punto di vista il segno di una realtà impermeabile all’ethos perché indifferente, e di un atteggiamento di apatico realismo. Una persona che non si vergogna non sente di dover reagire o cambiare comportamento. Per questo scrittori e filosofi si sono spesi per svegliare le coscienze dormienti, educare il senso di indignazione, smuovere l’emozione della vergogna. E quest’opera della cultura dimostra come la vergogna sia segno della civiltà. La forza di questa emozione è naturale ma la forma che prende dipende dall’ethos di una società. Per esempio, ciò che il comportamento sessuale prescrive o censura non è identico in tutte le società, gli "oggetti" della vergogna e quindi dell’indignazione sono contestuali e socialmente situati; ma il meccanismo che li governa è universale nella sua fenomenologia. Universale nel senso che, per riprendere la Bibbia e Vico, le radici della responsabilità morale (e quindi della punibilità) stanno nella capacità che gli individui hanno di sentire la vergogna e la colpa. Su questa base si sviluppa l’azione educativa e culturale.
Nel 1823, Giacomo Leopardi annotava nello Zibaldone: "Niuna cosa nella società è giudicata, né infatti riesce più vergognosa, del vergognarsi". Convinto della funzione attiva ovvero pratica del "vergognarsi", Leopardi aveva immortalato la deprimente condizione dell’Italia nel Canto Sopra il monumento di Dante, come a voler muovere i lettori: "Volgiti indietro, e guarda, o patria mia/quella schiera infinita d’immortali/E piangi e di te stessa ti disdegna/Che senza sdegno omai la doglia è stolta/Volgiti e ti vergogna e ti riscuoti/E ti punga una volta/Pensier degli avi nostri e de’ nepoti ."(...)
Provare vergogna sembra quindi essere di sprone, sembra indurre a reagire, come ha scritto Silvana Patriarca. Quante volte si sente ripetere (e si dice) "mi vergogno di essere italiano/a"? Innumerevoli volte, soprattutto negli ultimi anni. Dirlo, ripeterlo instancabilmente segnala la speranza che dalla capacità di sentire vergogna nasca l’indignazione, e di qui la decisione di reagire, di cambiare.
Su questa catena di fenomeni lo stesso Marx - notoriamente contrario all’uso di emozioni e sentimenti nella spiegazione dei fenomeni sociali - vergò parole straordinarie a proposito delle politiche illiberali del governo prussiano, commentando che, senza cadere in un vuoto patriottismo, sarebbe stato auspicabile che i tedeschi avessero provato vergogna, e aggiungeva: "Non è la vergogna che fa le rivoluzioni", tuttavia "la vergogna è già una rivoluzione in qualche modo... se un’intera nazione esperimenta davvero il senso di vergogna è come un leone accovacciato pronto a balzare".
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- La Santa Sede rompe il silenzio sull’escalation. Il Vaticano chiede più moralità (di Carlo Marroni).21 gennaio 2011, di Federico La Sala
Il Vaticano chiede più moralità
di Carlo Marroni (Il Sole 24.Ore, 21 gennaio 2011)
CITTÀ DEL VATICANO La Santa Sede rompe il silenzio sull’escalation del caso Ruby. E lo fa al massimo livello. È infatti il segretario di stato, cardinale Tarcisio Bertone, a intervenire, sollecitando senza mezzi termini «moralità e legalità». I giornalisti gli chiedono se condivide il turbamento di Napolitano: «Avete visto la nota del Quirinale pubblicata dall’Osservatore romano», risponde Bertone, confermando la linea istituzionale di piena sintonia con il Colle, emersa già due giorni fa quando il giornale vaticano diretto da Gian Maria Vian aveva riportato integralmente e senza commenti la dura nota del presidente della Repubblica. «La Santa Sede segue con attenzione e in particolare con preoccupazione queste vicende italiane, alimentando la consapevolezza di una grande responsabilità soprattutto di fronte alle famiglie, alle nuove generazioni, di fronte alla domanda di esemplarità e ai problemi che pesano sulla società italiana», ha detto Bertone ai giornalisti che lo attendevano all’inaugurazione della casa di accoglienza Bellosguardo dell’Ospedale Bambino Gesù.
Una presa di posizione assunta con modalità a un livello intermedio di "ufficialità" ma che di certo non attenua la portata critica, già espressa qualche giorno fa in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario vaticano. «La Chiesa spinge e invita tutti, soprattutto coloro che hanno una responsabilità pubblica in qualunque settore amministrativo, politico e giudiziario, ad avere e ad assumere l’impegno di una più robusta moralità, di un senso di giustizia e di legalità» ha detto Bertone. Che ha aggiunto: «Credo che moralità, giustizia e legalità siano i cardini di una società che vuole crescere e che vuole dare delle risposte positive a tutti i problemi del nostro tempo».
Bertone ha voluto sottolineare che «la Santa Sede ha i suoi canali, le sue modalità di intervento e non fa dichiarazioni pubbliche». Umberto Bossi commenta così le parole di Bertone: «Il Vaticano non si commenta ma penso che per loro sia più facile parlare. Berlusconi si è trovato con la casa circondata, controllavano tutti quelli che entravano e che uscivano. Perché non hanno controllato anche là?». Poi l senatur chiarisce: «Mai criticato il Vaticano né tantomeno il cardinale Bertone che conosco da tempo e che considero amico e stimo molto». Per un altro ministro, Maurizio Sacconi, invece il messaggio del Vaticano «come al solito si rivolge alle coscienze in termini "alti" che vanno oltre la quotidianità»: «Come al solito - dice - sono proprio le persone più lontane dalla Chiesa e più ostili ai suoi valori a strumentalizzarne» le parole.
L’intervento del segretario di Stato rappresenta uno spartiacque della posizione della Chiesa verso il Cavaliere in questa fase particolarmente difficile e complessa della politica. Le prese di posizione erano arrivate da vescovi e organi di stampa della Cei (oltre che da «Famiglia cristiana») in attesa della prolusione del cardinale Angelo Bagnasco di lunedì al consiglio permanente: con le dichiarazioni di ieri Bertone, considerato l’interlocutore principale di Berlusconi di là dal Tevere, risponde alle sollecitazioni per un intervento e allo stesso tempo rivendica il suo primato dentro la Chiesa nei rapporti con la politica. Quando sottolinea che la Santa sede «ha i suoi canali» fa sapere che ci sono stati o ci saranno segnali attraversi i canali della diplomazia, ufficiale o parallela. Se non ci saranno incontri riservati prima l’appuntamento tra i due premier (presente anche il capo dello Stato) è fissato per il 18 febbraio a palazzo Borromeo, anniversario dei Patti lateranensi.
Ieri intanto è nuovamente intervenuto Avvenire. «È di questo che abbiamo bisogno tutti noi, in particolare i più giovani, e soprattutto oggi: buoni esempi». E questo perché «i risultati dei cattivi esempi, dei cattivi maestri, della cattiva politica e della cattiva informazione sono sotto gli occhi di tutti», ha scritto il direttore del quotidiano Cei, Marco Tarquinio, rispondendo alla lettera di un lettore. Domenico Delle Foglie, ex portavoce del Family day e vicino al cardinale Camillo Ruini, sul sito del laicato cattolico Piuvoce.net, ha scritto che «anche noi, con i media cattolici e con lo stesso presidente della Repubblica, ci associamo all’urgente necessità di restituire serenità, attraverso la chiarezza, ai cittadini italiani tutti. Credenti e non credenti».
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- Il Presidente del Consiglio, nonostante una notevole considerazione di sé, non si può paragonare a Sansone e gli italiani non possono fare la fine dei filistei (di Luigi La Spina - Il suo destino non è quello del paese).20 gennaio 2011
Il suo destino non è quello del paese
di Luigi La Spina (La Stampa, 20 gennaio 2011)
Il videomessaggio con il quale il presidente del Consiglio ha comunicato agli italiani la decisione di non presentarsi alla procura di Milano e la volontà di varare una legge per punire quei pm che lo accusano annuncia, purtroppo, una linea di difesa inquietante. Destinata ad aggravare sia lo stato di turbamento del Paese, sia l’immagine di discredito internazionale che, in questi giorni, si sta riversando sull’Italia.
Berlusconi ha lanciato un appello drammatico alla maggioranza che lo ha eletto perché, in maniera compatta, unisca il destino della nazione al suo destino personale. Senza comprendere che l’istituzione che presiede, il governo della Repubblica, deve rappresentare non solo coloro che l’hanno votato, ma tutti gli italiani. Ecco perché la sua sfida alla magistratura, in nome del consenso popolare, rischia di aver gravi conseguenze sull’ordinamento e sull’equilibrio dei poteri dello Stato, fondamenti della nostra democrazia.
Il presidente del Consiglio ha diritto, come tutti i cittadini, di veder rispettata la presunzione d’innocenza davanti alle infamanti accuse che la procura di Milano gli ha rivolto. Un principio costituzionale di elementare civiltà giuridica, ma che ha come corrispettivo naturale lo stesso rispetto sia verso il magistrato che lo indaga, sia verso i cittadini italiani che hanno diritto di conoscere la sua versione dei fatti contestati. Anche perché non sarà la procura di Milano a considerare la fondatezza della sua difesa, ma i giudici di un tribunale che, in passato, ha dimostrato indipendenza di valutazione rispetto alle richieste del pm. Né sarà la procura di Milano a decidere sulle questioni di competenza territorialee funzionale avanzate dai suoi avvocati. Fa parte, poi, di una strategia difensiva puramente mediatica, utile ad aumentare la confusione polemica, ma dalla logica avventurosa,l’invocazionealla cosiddetta privacy. Per due elementari ragioni: le indagini, innanzi tutto, sono nate dal sospetto di gravi reati e, quindi, la verifica di tali ipotesi non si può fermare davanti a quei limiti. La valutazione delle conseguenze, se questa obiezione venisse accolta, nelle inchieste sui comuni cittadini potrebbe equivalere alla dichiarazionedi una sostanziale impunità estesa a tutti gli italiani.
Ma la seconda ragione dell’insostenibilità della tesi che in questi giorni viene ripetuta dai fan di Berlusconi, senza un minimo di riflessione, riguarda proprio il fatto che il presidente del Consiglio non è, appunto, un comune cittadino italiano, ma rappresenta una delle più alte cariche dello Stato. La nostra Costituzione, come quelle di tutti i Paesi non retti da una dittatura, impone una trasparenza, una dignità di comportamenti, anche personali, che non sono richiesti a coloro che non hanno i doveri dell’uomo pubblico.
Al di là della fondatezza delle accuse, della solidità delle prove raccolte, delle competenze delle procure, il presidente del Consiglio dovrebbe rendersi conto che l’unico modo per arginare il mare, montante e inquietante, dei giudizi sprezzanti che si sta abbattendo, da parte dell’opinione pubblica internazionale, sul nostro Paese è fornire ai magistrati una versione, credibile e accettabile, di quanto avvenuto sia nelle sue ville private, sia nella famosa notte alla questura di Milano. Se davvero non ha nulla da farsi perdonare, né sul piano penale né su quello morale, non si capisce perché impedisca a se stesso, con formalismi giuridici discutibili, di convincere gli italiani, anche quelli che non sono suoi tifosi, di poter credere alla sua innocenza.
E’ arrivato il momento che anche Berlusconi, dopo quasi vent’anni, possa distinguere la sorte della sua fortuna di imprenditore, di politico, persino di uomo di grande successo mediatico e di sicurocarisma personale, da quella del suo Paese. Lui, nonostante una notevole considerazione di sé, non si può paragonare a Sansone e gli italiani non possono fare la fine dei filistei.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- IL SERMONE DELLA DECENZA (di Barbara Spinelli)19 gennaio 2011, di Federico La Sala
Il sermone della decenza
di Barbara Spinelli (la Repubblica, 19 gennaio 2011)
Dovrebbe esser ormai chiaro a tutti, anche a chi vorrebbe parlar d’altro e tapparsi le orecchie, anche a chi non vede l’enormità della vergogna che colpisce una delle massime cariche dello Stato, che una cosa è ormai del tutto improponibile: che il presidente del Consiglio resti dov’è senza neppure presentarsi al Tribunale, e che addirittura pretenda di candidarsi in future elezioni come premier. Molti lo pensano da tempo, da quando per evitare condanne il capo di Fininvest considerò la politica come un sotterfugio.
Non un piano nobile dove si sale ma uno scantinato in cui si «scende», si traffica, ci si acquatta meglio. La stessa ascesa al Colle resta, nei suoi sogni, una discesa in sotterranei sempre più inviolabili. Molti sono convinti che i suoi rapporti con la malavita, la stretta complicità con chi in due gradi di giudizio è stato condannato per concorso in associazione mafiosa (Dell’Utri), il contatto con un uomo - Mangano - che si faceva chiamare stalliere ed era il ricattatore distaccato da Cosa Nostra a Arcore - erano già motivi sufficienti per precludergli un luogo, il comando politico, che si suppone occupato da chi ha avuto una vita rispettosa della legge.
Ma adesso l’impegno a fermare quest’uomo infinitamente ricattabile perché incapace di controllare la sua sessualità deve esser esplicitamente preso dai responsabili politici tutti, dalla classe dirigente in senso lato, e non solo detto a mezza voce. È una specie di sermone che deve essere pronunciato, solenne come i giuramenti che costellano la vita dei popoli. Un sermone che non deleghi per l’ennesima volta il giudizio morale e civile alla magistratura. Che pur rispettando la presunzione d’innocenza, certifichi l’esistenza di un ceto politico determinato a considerare l’evidenza dello scandalo e a trarne le conseguenze prima ancora che i tribunali si pronuncino. Ci sono reati complessi da districare, per i giudici. Questo non vieta, anzi impone alla politica di delimitare in piena autonomia la dignità o non dignità dei potenti.
Non è più solo questione del conflitto di interessi, che grazie alla legge del 1957 avrebbe sin dall’inizio potuto vietare l’accesso a responsabilità politiche di un titolare di pubbliche concessioni (specie televisive). Chi è sospettato d’aver pagato prostitute o ragazze minorenni, d’aver indotto - sfruttando il proprio potere - un pubblico ufficiale a fare cose illecite, chi è talmente impaurito dall’arresto di Ruby dal presentarla in questura come nipote di Mubarak, chi ha avuto rapporti con mafiosi e corrotto testimoni o giudici, deve trovare chiuse le porte della politica, anche se i Tribunali ancora tacciono o se vi son state prescrizioni. Attorno a lui deve essere eretto una sorta di alto muro, che impersoni la legge, la riluttanza interiore d’un popolo a farsi rappresentare da un individuo dal losco passato e dal losco presente. Tra Berlusconi e la politica questo muro non è stato mai eretto, nemmeno dall’opposizione quando governava. Se non ora, quando? È così da millenni, nella nostra civiltà: una società ha anticorpi che espellono le cellule malate, o non li ha e decade. L’ostracismo fu un prodotto della democrazia ateniese, nel VI secolo a.C.
Eraclito scrive: «Combattere a difesa della legge è necessario, per il popolo, proprio come a difesa delle mura». Berlusconi non avrebbe dovuto divenire premier, e non perché si disprezzi il popolo che lo ha eletto: non avrebbe dovuto neanche potersi candidare. Comunque, oggi, non può restare o tornare in luoghi del comando che hanno una loro sacralità: non può, se la coerenza non è una quisquilia, nemmeno presentarsi come patrono del proprio successore. Non è un monarca che va in pensione.
Gli italiani più restii a vedere lo sanno, altrimenti non avrebbero acclamato in simultanea, da 16 anni, Berlusconi e tre capi dello Stato. È segno che in un angolo della coscienza, sognano quel decalogo che nelle parole di Thomas Mann «altro non è che la quintessenza dell’umana decenza»: il non rubare, il non pronunciare il nome di Dio invano, il non dire il falso, il non sbandierare valori senza rispettarli, il non adulterare ciò che è chiaro e puro confondendolo con il torbido e l’impuro. È come se i padri costituenti avessero presentito tutto questo, vietando plebisciti di capi di governo odi Stato: come se condividessero la diffidenza di Piero Calamandrei per l’inclinazione italiana alla «putrefazione morale, all’indifferenza, alla sistematica vigliaccheria».
La responsabilità del sermone è dunque per intero nelle mani dei parlamentari, liberi per legge da vincolo di mandato. Così come è in mano ai contro-poteri che costituzionalmente limitano il dominio d’uno solo (parlamento, magistratura, stampa). Contro-poteri su cui la sovranità popolare non ha il primato, se è vero che essa viene «esercitata nelle forme e nei limiti della Costituzione» (art 1).
Già una volta, nella «chiamata di correo» di Craxi, i politici caddero nel baratro, degradando se stessi. Fu il buco nero di Tangentopoli, e spiega come mai ancora abitiamo un girone dantesco fatto di menzogna e omertosi sortilegi. Il buco nero sono le parole di Craxi in Parlamento, il 3 luglio ’92: «Nessun partito è in grado di scagliare la prima pietra. (...) Ciò che bisogna dire, e che tutti del resto sanno, è che buona parte del finanziamento politico è irregolare o illegale.(...) Se gran parte di questa materia deve essere considerata materia (...) criminale, allora gran parte del sistema sarebbe un sistema criminale. Non credo che ci sia nessuno in quest’aula, responsabile politico di organizzazioni importanti, che possa alzarsi e pronunciare un giuramento in senso contrario a quanto affermo: presto o tardi, i fatti si incaricherebbero di dichiararlo spergiuro».
Difficile dimenticare il silenzio che seguì: nessun deputato si alzò, e ancor oggi la nostra storia stenta a non essere storia criminale. Ancor oggi si vorrebbe sapere perché i deputati che si ritenevano onesti rimasero appiccicati alla poltrona. Craxi pagò appropriatamente, perché le sentenze erano passate in giudicato e la legge è legge, ma pagò per molti: anche per Berlusconi, che con il suo aiuto costruì il proprio apparato di persuasione televisiva e profittò del crollo della Prima Repubblica sostituendola con un suo privato giro di corrotti e corruttori.
I deputati rischiano di restar seduti anche oggi, come allora: per schiavitù volontaria, o peggio. Il sermone oggi necessario deve essere un impegno a che simili ignominie non si ripetano. Proprio perché il conflitto d’interessi è sorpassato, e siamo di fronte a un conflitto fra decenza e oscenità, fra servizio dello Stato e servizio dei propri comodi, fra libertinaggio innocente e libertinaggio commisto a reati. Da molto tempo, c’è chi ha smesso di parlare di Palazzo Chigi: preferisce parlare di palazzo Grazioli come sede dell’esecutivo, e fa bene. Che si salvi, almeno, l’aura associata ai luoghi italiani del potere.
Domenica scorsa, Berlusconi ha fatto dichiarazioni singolari, oltre che ridicole. Definendo gravissima, inaccettabile, illegale, l’intromissione dei magistrati nella vita degli italiani ha detto: «Perché quello che i cittadini di una libera democrazia fanno nelle mura domestiche riguarda solo loro. Questo è un principio valido per tutti, e deve valere per tutti. Anche per me». L’uguaglianza fra cittadini equivale per lui alla libertà di fare quel che si vuole, in casa: anche un reato, magari. Non riguarda certo l’uguaglianza di fronte alla legge. L’antinomia stride, e offende. Siamo ben lontani dall’ingiunzione di Eraclito, se tutto diventa lecito nelle mura domestiche, e non appena succede qualcosa di criminoso l’uguaglianza cessa d’un colpo, e comincia l’età dei porci di Orwell, in cui tutti sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- IL SONNO DELLA RAGIONE E IL LETARGO DELLA RELIGIONE (di don Aldo Antonelli - Il letamaio).18 gennaio 2011
IL LETAMAIO
di don Aldo Antonelli
In questo letamaio in cui siamo affossati, non ci sono prudenze che tengano, né pazienze che si ammantino di virtù, né attese di dignità.
Lo scondalo è talmente acclarato e invasivo ed eversivo che solo dei gesti eclatanti e clamorosi possono destare il risveglio e riscattare la chiesa dal suo silenzio ibernale e, a questo punto anche, mafioso.
Sto maturando la decisione di non celebrare messa domenica prossima. Tenere le porte chiuse delle chiese con un comunicato in cui si denuncia il degrado della politica e la dittatura dell’economia il sonno della ragione e il letargo della religione.
Non mi dite che esagero.
Aldo
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- GERARCHIA COMPROMESSA... L’odierno catto-berlusconismo della gerarchia cattolica ricorda il catto-fascismo del ventennio violento, che fu il fallimento dei pastori e l’abbandono dei fedeli (di Enrico Peyretti)18 gennaio 2011
Gerarchia compromessa
di Enrico Peyretti (Adista - Segni nuovi, n. 4, 22 gennaio 2011)
Il “disagio” dei laici cattolici per le posizioni pubbliche della gerarchia ha nuovi gravi motivi. Ricevendo il nuovo ambasciatore d’Italia, a metà dicembre, il papa, come capo di Stato, ha ringraziato il governo italiano “per quanto ha fatto contro il tentativo di eliminare il crocifisso dai luoghi pubblici” dicendo che “si è mosso in conformità a una corretta visione della laicità e alla luce della sua storia, cultura e tradizione”. Il crocifisso nelle scuole - ipocrisia di origine fascista e usata dal padano-razzismo - compensa forse la crocifissione dei poveri del mondo, respinti dal governo italiano in mano a dittatori e predoni feroci? Con quale responsabilità si fa parlare così il papa?Con quale conoscenza della realtà e quale coscienza dei primari valori umani e civili? Ma sanno questi clero-burocrati a chi vendono la Chiesa?
E prima, il 9 dicembre, in una cena festosa in Vaticano, i nuovi cardinali si sono presentati al premier e ai maggiori ministri. C’è qualcosa da festeggiare nella crisi materiale, e soprattutto morale, dell’Italia di oggi?
Alcuni cattolici hanno scritto: “Perché i prìncipi della Chiesa dovrebbero essere presentati ai prìncipi di questo mondo? Evidentemente perché sono colleghi di principato. Ma non nel nostro nome di cittadini e di cristiani sgomenti di fronte a un premier e ad un governo che sono un concentrato di quanto di più antievangelico sia mai comparso nella storia della Repubblica e che è invece apprezzato e vezzeggiato dalle gerarchie ecclesiali” (fra i primi sottoscrittori del testo Maria Cristina Bartolomei, Claudio Ciancio, Beppe Elia, Miriam Franchella, Antonio Gorgellino, Virgilio Melchiorre, Salvatore Passari, Enrico Peyretti, Toni Revelli, Maria Adele Roggero, Ugo Gianni Rosenberg, Gabriele Scaramuzza, Stefano Sciuto, Riccardo Torta).
Più volte il card. Bertone ha dato esplicito appoggio a Berlusconi con cene e incontri semiclandestini, poi con grande pompa prima del voto sulla sfiducia; ed ha premuto perché un partito, l’Udc, si accordasse con Berlusconi: il pastore si fa trafficante di consensi politici e di giochi di potere.
Non si tratta di destra o sinistra, ma di un governo che è fuori da tutte le parti: fuori dalla Costituzione, fuori dalla giustizia verso i più poveri, fuori dalla legalità, fuori dalla parola veritiera e onesta.
La presentazione allegra, è scritto ancora in quel testo, “a un prìncipe corrotto e corruttore, che infanga il Vangelo mentre se ne appropria, è un’umiliazione per la Chiesa intera, fatta anche e soprattutto di tanti silenziosi, umili e coraggiosi credenti, e l’intervento squisitamente politico del segretario di Stato non può che portare divisioni nella Chiesa.
Chiediamo di pregare perché lo Spirito sostenga la Chiesa anche in questo momento difficile, perché sia preservata la sua unità, ma anche perché, a questo fine, sia liberata dei pastori indegni. Festa e festini stanno per finire, perché il Signore non abbandona i suoi fedeli e il male non avrà l’ultima parola”.
L’odierno catto-berlusconismo della gerarchia cattolica ricorda il catto-fascismo del ventennio violento, che fu il fallimento dei pastori e l’abbandono dei fedeli al potere malvagio e falso. Può accadere di peggio alla Chiesa? Questo è peggio della persecuzione.
Un tradizionale disprezzo-utilizzo del mondo porta il cattolicesimo a teorizzare una irresponsabile indifferenza morale tra monarchia e repubblica, tra dittatura e democrazia, tra Berlusconi e la Costituzione, chiedendo al potere solo la libertà di predicare il Vangelo, ma in una posizione di compromissione, privilegio e scambio di favori illeciti, che lo svuota e lo falsifica, perché non è più il Vangelo per i poveri e per la giustizia, annuncio storico del Regno promesso e iniziato nei cuori.
La libertà della Chiesa, la libertà religiosa, giustamente reclamata dal papa per i cristiani e per tutti, è inutile e sprecata se non è sfida evangelica ai potenti. Gesù è morto in croce perché ha esercitato “fino in fondo”, con amore coraggioso e fedele, questa sfida alle falsità potenti del mondo.
* Redattore de “Il foglio” di cristiani torinesi
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- LUTTO PER IL PAESE - LUTTO PER LA CHIESA. Un manifesto (di don Aldo Antonelli - Privacy).19 gennaio 2011, di Federico La Sala
PRIVACY
di don Aldo Antonelli
"Quello che i cittadini di una libera democrazia fanno nelle mura domestiche riguarda solo loro. Questo è un principio valido per tutti, e deve valere per tutti. Anche per me"! Così ha sentenziato domenica scorsa, a telecamere accese e a coscienza spenta.
 Cosicché, per questa analfabeta del diritto, per questo fattucchiero della morale casereccia, in casa si può anche stuprare la moglie e violentare i figli. In casa si possono ordire attentati e architettare colpi di stato. In casa si possono perpetrare assassini e qualsiasi ingerenza lederebbe l’unico sacro diritto del cittadino egotico: la "privacy"!
Mi si accappona la pelle al pensare che lo stesso è colui che da sempre ha istituzionalizzato i suoi privati interessi, ha reso pubblici, promuovendoli onorevoli, i suoi personali e privati contabili, commercialisti, avvocati, estetisti, entreneuses, prosseneti e puttane.
Cosicché, per questa analfabeta del diritto, per questo fattucchiero della morale casereccia, in casa si può anche stuprare la moglie e violentare i figli. In casa si possono ordire attentati e architettare colpi di stato. In casa si possono perpetrare assassini e qualsiasi ingerenza lederebbe l’unico sacro diritto del cittadino egotico: la "privacy"!
Mi si accappona la pelle al pensare che lo stesso è colui che da sempre ha istituzionalizzato i suoi privati interessi, ha reso pubblici, promuovendoli onorevoli, i suoi personali e privati contabili, commercialisti, avvocati, estetisti, entreneuses, prosseneti e puttane.
 Il popolo di lui ostaggio, galvanizzato dalle sue imprese, fa suo questo vangelo delle volgarità per cui l’uguaglianza dei cittadini equivale alla libertà di fare in casa quel che si vuole!
Riducendo la casa, da luogo di convivenza affettiva, a vandea di scorribande per le proprie bulimie inesauste.
Lui, il difensore della famiglia!
Mi sembra che sia stato Piero Calamandrei a denunciare già da tempo questa inclinazione del popolo italiano alla "putrefazione morale, all’indifferenza, alla sistematica vigliaccheria".
Il popolo di lui ostaggio, galvanizzato dalle sue imprese, fa suo questo vangelo delle volgarità per cui l’uguaglianza dei cittadini equivale alla libertà di fare in casa quel che si vuole!
Riducendo la casa, da luogo di convivenza affettiva, a vandea di scorribande per le proprie bulimie inesauste.
Lui, il difensore della famiglia!
Mi sembra che sia stato Piero Calamandrei a denunciare già da tempo questa inclinazione del popolo italiano alla "putrefazione morale, all’indifferenza, alla sistematica vigliaccheria".Nel suo libretto "Pio XII Il Vicario di Hochhuth Luigi Villa cita queste parole di Indro Montanelli: "In Italia, la "Verità" si può dire solo se si è in tanti. Perché in Italia aver torto non è pericoloso. Basta averlo in coro, cioè insieme a tutti gli altri. I pericoli grossi li corre solo chi nel coro fa stecca, anche se la fa per dire una verità, che poi i fatti convalidano. La legge di questo Paese è quella del gregge. Tutto si può fare, sia l’errore che il riconoscimento dell’errore, purché tutti in sieme. Per l’isolato non c’è scampo. In ogni epoca e sotto qualunque regime egli è e rimarrà sempre il nemico (delle pecore) numero uno"!
Per la cronaca, vi comunico che, incoraggiato da molti di voi, sono pervenuto a più miti consigli. Affiggerò sulla porta della Chiesa il manifesto che vi allego e, continuerò a celebrare messa, come sempre, con occhi ben aperti e con animo non rassegnato.
Aldo
 LUTTO
LUTTO
 PER IL PAESE
PER IL PAESE UMILIATO da un premier immondo, affarista e licenzioso
UMILIATO da un premier immondo, affarista e licenzioso
 SEQUESTRATO da un’economia corsara e forcaiola
SEQUESTRATO da un’economia corsara e forcaiola
 IMBAVAGLIATO da una TV servile e cortigiana
IMBAVAGLIATO da una TV servile e cortigiana***
 LUTTO
PER UNA CHIESA
LUTTO
PER UNA CHIESA
 CONNIVENTE E CONCUBINA
CONNIVENTE E CONCUBINA
 MUTA E IMBAVAGLIATA
MUTA E IMBAVAGLIATA
 SENSALE E MERCENARIA
SENSALE E MERCENARIA***
LUTTO
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- IL SONNO DELLA RAGIONE E IL LETARGO DELLA RELIGIONE (di don Aldo Antonelli - Il letamaio).20 gennaio 2011, di Giovanni Carullo
Don Antonelli,
ce ne vorrebbero 1000 come lei per riscattare la Chiesa da questo vergognoso silenzio.
Coraggio, vada avanti
Giovanni Carullo
-
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- CAMILLA CEDERNA, 1977: "Serve una città? Chiama il Berlusconi" (da "Il mio Novecento").15 gennaio 2011, di Federico La Sala
La prima intervista di mister B.
Alla vigilia della decisione della Consulta sul Legittimo impedimento, Ecco una chicca d’autore: l’incontro tra Camilla Cederna e il Cavaliere nel 1977. Dove c’è già tutto: dalle bugie alla corruzione, da don Verzé alla politica
 l’Espresso, 11 gennaio 2011*
l’Espresso, 11 gennaio 2011*Nel centenario della nascita di Camilla Cederna (21 gennaio 1911 - 5 novembre 1997) è in uscita per Rizzoli "Il mio Novecento", una raccolta della grande giornalista e scrittrice che per molti anni fu una prestigiosa firma de "L’espresso".
Tra gli articoli che compongono il volume ce n’è uno uscito sul nostro settimanale nell’aprile del 1977: un’intervista ritratto del giovane ed emergente imprenditore edile milanese Silvio Berlusconi. Come nota la stessa Cederna nel suo pezzo, è la prima intervista rilasciata da Berlusconi, che fino ad allora aveva deciso di tenere un profilo molto basso nei suoi rapporti con la stampa.
Il sito de "L’espresso" ripubblica qui di seguito l’articolo in questione, alla vigilia della decisione della Corte Costituzionale sul Legittimo impedimento. Come vedrete, nell’intervista-ritratto della Cederna c’era già quasi tutto di quello che sarebbe diventato, anni dopo, il fenomeno politico-mediatico Silvio Berlusconi.
Serve una città? Chiama il Berlusconi . di Camilla Cederna *
In un ambiente di lusso, saloni uno via l’altro, prati di moquette, sculture che si muovono, pelle, mogano e palissandro, continua a parlare un uomo non tanto alto, con un faccino tondo da bambino coi baffi, nemmeno una ruga, e un nasetto da bambola. Completo da grande sarto, leggero profumo maschio al limone. Mentre il suo aspetto curato, i suoi modini gentili, la sua continua esplosione di idee piacerebbero a un organizzatore di festini e congressi, il suo nome sarebbe piaciuto molto a Carlo Emilio Gadda. Si chiama infatti Silvio Berlusconi.
Un milanese che vale miliardi, costruttore di smisurati centri residenziali, ora proprietario della stupenda villa di Arcore dove vissero Gabrio Casati e Teresa Confalonieri (con collezione di pittori lombardi del Cinquecento, e mai nessun nudo per non offendere la moglie, religiosissima), quindi della villa ex Borletti ai margini del parco di Milano.
Allergico alle fotografie («magari anche per via dei rapimenti» spiega con un sorriso ironico solo a metà) è soddisfattissimo che nessuno lo riconosca né a Milano né in quella sua gemma che considera Milano 2. Siccome è la sua prima intervista, è contento di raccontarmi la sua vita felice. Media borghesia, il papà direttore di banca che, a liceo finito, non gli dà più la mancia settimanale; ma lui non si dispera, perché, mentre studia Legge, lavora in vari modi: suonando Gershwin o cantando le canzoni francesi alle feste studentesche. Non solo, ma fra un trenta e lode e l’altro, fa il venditore di elettrodomestici, e la sua strada è in salita: da venditore a venditore capo a direttore commerciale. Dopo la sua tesi di laurea sulla pubblicità (il massimo dei voti) inizia la sua vera attività entrando successivamente in due importanti imprese di costruzione.
A venticinque anni crea un complesso di case intorno a piazza Piemonte, ecco quindi la fortunatissima operazione di Brugherio, una lottizzazione destinata al ceto medio basso, mille appartamenti che van via subito; e preso dal piacere di raccontare, ogni tanto va nel difficile, dice «congesto», macrourbanistica, architettura corale, la connotazione del mio carattere è la positività, «natura non facit saltus». Il suo sogno sarebbe esser ricercato in tutto il mondo per fare città, e «chiamiamo il Berlusconi» dovrebbe essere l’invocazione di terre desiderose di espandersi. Di Milano 2, l’enorme quartiere residenziale nel comune di Segrate, parla come di una donna che ama, completo com’è di ogni bellezza e comfort, e centomila abitanti, che a dir che sono soddisfatti è dir poco. Lui legge tutte le novità di architettura e urbanistica, qualche best-seller ogni tanto, rilegge spesso l’Utopia di Tommaso Moro (infatti, lo ’scrisse’.. leggi l’articolo seguente-solleviamoci), sul quale vorrebbe scrivere un saggio. Si ritiene l’antitesi del palazzinaro, si ritiene un progressista, è cattolico e praticante, ha votato Dc; e «se l’urbanistica è quella che si contratta fra costruttori e potere politico, la mia allora non è urbanistica». Grazie, e vediamo cosa dicono gli altri di lui.
Lo considerano uno dei maggiori speculatori edilizi del nostro tempo che, valendosi di grosse protezioni vaticane e bancarie, vende le case e prende i soldi prima ancora di costruirle, lucrando in proprio miliardi di interessi. Si lega prima con la base Dc (Marcora e Bassetti), poi col centro, così che il segretario provinciale Mazzotta è il suo uomo. Altro suo punto di riferimento è il Psi, cioè Craxi, che vuol dire Tognoli, cioè il sindaco. E qui viene contraddetta la sua avversione verso l’urbanistica come compromesso tra politici e costruttori.
La società di Berlusconi è la Edilnord, fondata nel ’63 da lui e da Renzo Rezzonico, direttore di una società finanziaria con base a Lugano, liquidata nel ’71 per segrete ragioni. Viene fondata allora la Edilnord centri residenziali con le stesse condizioni della compagnia di prima: lo stesso capitale sociale (circa diecimila dollari), la stessa banca svizzera che fa i prestiti (la International Bank di Zurigo), ed ecco Berlusconi procuratore generale per l’Italia.
Nel ’71 il Consiglio dei Lavori Pubblici dichiara ufficialmente residenziale la terra di Berlusconi (comprata per 500 lire al metro quadrato nel ’63 e venduta all’Edilnord per 4250). Da Segrate (amministrazione di sinistra prima, poi socialista e Dc) vengono concesse all’Edilnord licenze edilizie in cambio di sostanziose somme di danaro. Umberto Dragone, allora capo del gruppo socialista nel consiglio comunale di Milano, pensa che l’Edilnord abbia pagato ai partiti coinvolti il cinque-dieci per cento dei profitti (diciottodiciannove miliardi) che si aspettava da Milano 2. (Qualche appartamento arredato pare sia stato dato gratis ad assessori e tecnici Dc e socialisti. Certo è che questo regalo lo ha avuto un tecnico socialista che vive lì con una fotomodella.)
«Il silenzio non ha prezzo, ecco il paradiso del silenzio» era scritto sulla pubblicità di questa residenza per alta e media borghesia. Ma il silenzio non c’è. L’aeroporto di Linate è lì a un passo, ogni novanta secondi decolla un aereo, intollerabili le onde sonore, superiori a 100 decibel. Così l’Edilnord si muove a Roma, manovrando i ministeri, per ottenere il cambio delle rotte degli aerei. (In quattro anni la Civilavia aveva già ordinato sei cambiamenti delle rotte degli apparecchi di Linate.) Approfittando della vicinanza di un ospedale, il San Raffaele, diretto da un prete trafficone e sospeso a divinis, don Luigi Maria Verzé, manda ai vari ministeri una piantina in cui la sua Milano 2 risulta zona ospedaliera e la cartina falsa verrà distribuita ai piloti (con su la croce, simbolo internazionale della zona di rispetto), così la Civilavia cambia rotte, ancora una volta.
Quanto a don Verzé, ottiene in cinque giorni, con decreto firmato dal ministro della Sanità Gui, la sostituzione del suo istituto privato e ancora in disarmo in istituto di ricerca a carattere scientifico (un titolo onorifico che viene dato solo in casi eccezionali), con annessa possibilità di avere finanziamenti. Lo Stato manda subito seicento milioni, mentre un miliardo e mezzo sarebbe stato versato dalla Regione. Di qui una polemica con Rivolta finché, due settimane fa, l’ex prete è stato condannato a un anno e quattro mesi per tentativo di corruzione ai danni dell’assessore Rivolta; l’istituto è ora frequentato da studenti e medici dell’università che lamentano la mancanza di strutture e strumenti validi.
Altre notizie. Berlusconi sta mettendo in cantiere la sua nuova Milano 3 nel comune di Basiglio a sud della città, con appartamenti di tipo «flessibile», cioè con pareti che si spostano secondo le esigenze familiari. In settembre comincerà a trasmettere dal grattacielo Pirelli la sua Telemilano, una televisione locale con dibattiti sui problemi della città, un’ora al giorno offerta ai giornali (egli possiede il quindici per cento del «Giornale» di Montanelli).
«Troppi sono oggi i fattori ansiogeni,» dice «la mia sarà una tv ottimista.» Staff di otto redattori, più tecnici e cameramen, quaranta persone in tutto. E pare che in questo suo progetto sia stato aiutato dall’amico Vittorino Colombo, ministro delle Poste e telecomunicazioni. Berlusconi aveva anche pensato di fondare un circolo di cultura diretto da Roberto Gervaso; la sua idea preferita però era quella di creare un movimento interpartitico puntato sui giovani emergenti, ma per adesso vi ha soprasseduto. Gli sarebbe piaciuto anche diventare presidente del Milan, ma la paura della pubblicità lo ha trattenuto. Massima sua aspirazione sarebbe infine quella di candidarsi al Parlamento europeo.
Ci tiene anche a coltivare al meglio la sua figura di padre, cercando di avere frequenti contatti coi suoi figlioletti. Quel che deplora è che dalle elementari di adesso sia stato esiliato il nozionismo: a lui le nozioni, in qualsiasi campo, hanno giovato moltissimo.
aprile 1977
fonte: http://espresso.repubblica.it/dettaglio/la-prima-intervista-di-mister-b/2142005
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- FOTO DI REGIME (di Ida Dominjanni)15 gennaio 2011, di Federico La Sala
Foto di regime
di Ida Dominijanni (il manifesto, 15.01.2011)
Uso della prostituzione minorile e concussione aggravata non sono due reati leggeri per nessuno, tantomeno per un presidente del consiglio. E la richiesta del rito immediato sta a significare che le prove in possesso della procura di Milano sono consistenti. Siamo di fronte all’atto giudiziario che sigla una sequenza di cosiddetti «scandali sessuali», meglio definita fin dall’inizio da Veronica Lario «ciarpame politico», che dura da ventuno mesi, e che contiene in sé tutti gli elementi necessari a un giudizio politico sul regime di Silvio Berlusconi, anche a prescindere dalla prova tecnica di un reato penale.
Chiunque, di fronte a tanta evidenza, cederebbe il passo, si imporrebbe cautela, abbasserebbe i toni. Berlusconi e la sua corte no. Quando, nell’autunno scorso, si seppe dai giornali che il premier aveva personalmente telefonato alla questura di Milano, la notte del 27 maggio scorso, perché Kharima el Marhouh, in arte Ruby, minorenne marocchina arrestata per furto, venisse rilasciata in quanto «nipote di Mubarak » e affidata a Nicole Minetti, il premier prima negò poi rivendicò: «l’ho fatto per bontà», «amo le donne» e «meglio amare le donne che essere gay». Oggi fa il gradasso e dice che non vede l’ora di difendersi dal reato inventato di «cena privata a casa del presidente». I suoi, intanto, organizzati in due armate, ripassano e ripetono il copione. L’armata politica grida alla giustizia a orologeria e al complotto destabilizzante; l’armata giuridica, Ghedini & co., prepara i cavilli per sfilare l’inchiesta dalla procura di Milano e le carte per usufruire di quel che resta del legittimo impedimento; Gaetano Quagliariello, testa di ponte fra i due battaglioni, sentendo parlare di prove «aspetta di vedere i preservativi» (parole sue). Non è da escludere che la seconda armata riesca nel suo intento di diluire nel nulla l’ennesima inchiesta a carico del premier. Ma qui non è, o non è solo, il seguito giudiziario della vicenda il punto.
Sempre nell’autunno scorso, fu di Carlo Freccero l’acuta osservazione che quel verbale della questura di Milano da cui risultava la telefonata notturna del premier rompeva improvvisamente e definitivamente, con un inoppugnabile dato di realtà, la fiction scritta, prodotta e interpretata con successo per vent’anni da Silvio Berlusconi.
A romperla in verità c’era già stata la parola di due donne, Veronica Lario e Patrizia D’Addario, la moglie e la prostituta uscite allo scoperto per denunciare di quanto ciarpame e di quanta corruzione fosse fatta quella fiction;Masi sa che nella misoginia imperante, non solo berlusconiana, la parola di due donne vale meno di un verbale. E dietro quel verbale ce n’erano altri, in procura, a resocontare un’inchiesta su un presunto giro di prostituzione organizzato a beneficio del premier dai suoi fidi, Mora, Fede, Minetti per le feste di Arcore nello stesso ruolo che fu di Tarantini per le feste di palazzo Grazioli e di villa Certosa. Questo è lo stato del principe e della corte. Questa è la fotografia del regime che va sotto il nome, ormai in tutto il mondo, di «berlusconismo».
Ora il punto è il seguente. Da ventuno mesi ci sentiamo ripetere, dalla maggioranza e dall’opposizione, la stessa solfa. Dalla maggioranza: sono «intrusioni indebite della vita privata»; a casa propria ognuno può fare quello che vuole, e la legge non ci può entrare; il premier è un simpatico libertino perseguitato da magistrati delinquenti e dalla stampa di sinistra talebana.
Dall’opposizione, fatte salve poche e meritevoli eccezioni: lo stile di vita del premier non è un esempio di moralità, ma non ci interessa, se non per le questioni di sicurezza e di decoro istituzionale che solleva; non è su questo che Berlusconi va combattuto e battuto, ma sulla politica «vera», l’economia, il malgoverno, i deputati comprati e venduti. Lasciamo perdere gli insuccessi strategici e tattici di cui è stata costellata, anche di recente, questa strada, e torniamo alla fotografia del regime.
Il fatto è che nella soap dei cosiddetti «scandali sessuali» che va avanti da ventuno mesi, derubricata da destra e da sinistra a fatto minore, c’è tutta, ma proprio tutta, la quintessenza del berlusconismo. Sconfinamento fra pubblico e privato, politicizzazione della biografia e privatizzazione della politica; contrabbando dell’arbitrio per libertà (tutto si può fare); riduzione a supermarket della vita pubblica e privata (tutto si può comprare, dalle donne ai parlamentari); uso della sessualità come protesi del potere; uso dei ruoli sessuali («veri uomini» e «vere donne») come maschere rassicuranti per identità, maschili e femminili, incerte;uso razzista della bellezza; imperativo del godimento come surrogato del desiderio; pratica dell’illegalità come risposta beffarda alla crisi dell’autorità e della legge; eccetera. Prima la politica di un’opposizione degna di questo nome si deciderà a occuparsi di questo fascio di questioni con una proposta culturale degna di questo nome, prima spunterà l’alba del dopo-regime. Diversamente la fiction scritta, prodotta e interpretata da Silvio Berlusconi continuerà a calamitare la sua audience, e i cavilli di Ghedini a occupare le cronache.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- "BUNGA BUNGA"? La cautela del Vaticano: “Non si cambia cavallo”. Resta isolata la voce critica di «Famiglia Cristiana» (di Giacomo Galeazzi)17 gennaio 2011, di Federico La Sala
La cautela del Vaticano: “Non si cambia cavallo”
di Giacomo Galeazzi (La Stampa, 17 gennaio 2011)
«Non ci sono novità sostanziali, per il momento le indagini dei magistrati milanesi non cambiano il quadro già conosciuto». In Segreteria di Stato, dove i vertici Bertone e Filoni sono molto attenti agli aspetti istituzionali, si invita alla prudenza nel valutare il caso-Berlusconi. La situazione è «fondamentalmente immutata», riflettono al Palazzo Apostolico. Inoltre «anche in altre circostanze», getta acqua sul fuoco la dirigenza vaticana, «le accuse al capo dell’esecutivo sono rimaste senza riscontri oggettivi».
Non è in discussione al momento l’asse tra Vaticano e governo. Il premier resta il principale interlocutore della Santa Sede, come si vede anche dalla nota «asettica e neutrale» con cui sabato Radio Vaticana ha dato conto dei guai giudiziari del capo del governo. In Curia «non si cambia cavallo» e si rispolvera il «principio di sussidiarietà» in base al quale sarà il leader dei vescovi, Angelo Bagnasco a pronunciarsi il 24 gennaio all’apertura del Consiglio permanente, «quando la vicenda avrà contorni più definiti e si conosceranno di più le carte in mano ai magistrati», spiegano in Segreteria di Stato.
L’Osservatore romano ha confermato il consueto «low profile» sugli scandali del presidente del Consiglio. Anche il solitamente più battagliero «Avvenire» stavolta si limita a ribadire che «nessun uomo di governo è al di sopra della legge». I quotidiani della Santa Sede e della Cei, dunque, mostrano ancora più cautela dell’emittente pontificia. Anche perchè ,evidenziano Oltretevere, «verba volant, scripta manent». E il pericolo-ingovernabilità espone il Paese all’attacco degli speculatori: «Troppo pericoloso un vuoto politico in piena turbolenza finanziaria».
In Cei non si vedono al momento sostanziali variazioni e, a «contesto meglio definito», toccherà a Bagnasco, titolare dei rapporti con la politica italiana, parlare per la Chiesa intera. Nel Sacro Collegio si mette in guardia dai «salti nel buio» sottolineando come il governo Berlusconi abbia garantito un argine alla legislazione laicista su vita, famiglia, istruzione, mentre nel centrosinistra il ruolo dei cattolici è «sempre più marginale». Il dopo-Berlusconi è ancora una nebulosa. L’esecutivo targato Ppe ipotizzato da Formigoni o una leadership di Tremonti sono «irrealistiche», si ragiona Oltretevere, «finché a detenere il consenso popolare è Berlusconi, al quale gli scandali non tolgono voti, come dimostrano le ultime Regionali precedute da polemiche simili a quelle attuali». Ferme restando le riserve morali, un equilibrio senza cedimenti o segnali di insofferenza.
Radio Vaticana puntualizza che «in Italia, il dibattito politico resta centrato sull’inchiesta della Procura di Milano» e che «il capo dell’esecutivo parla dell’ennesima macchinazione giudiziaria assicurando che la persecuzione dei giudici non fermerà la volontà di cambiare il Paese». Toni moderati, dunque sia nei mass media ecclesiastici sia nei discorsi in Curia. Che la Chiesa pref(er)isca mantenere una posizione mediana lo si era già visto sul legittimo impedimento. «Può un uomo di governo essere esentato dal rendere conto della sua condotta presente e passata per tutta la durata del servizio pubblico che svolge? Può per un tempo determinato essere al di sopra della legge? Credo di no», scrive il direttore di «Avvenire», Marco Tarquinio. «Si possono porre argini alle interferenze perniciose tra poteri dello Stato (e ne abbiamo viste in questi anni)», però «nessun uomo di governo dovrebbe essere posto o dovrebbe porsi al di sopra della legge. E nessun giudice. A questo si deve stare».
Resta isolata la voce critica di «Famiglia Cristiana», che giudica «incredibile che un uomo di simile livello non abbia il necessario autocontrollo» richiamando la «credibilità, meglio ancora la dignità, dell’uomo che governa il Paese, i riflessi sulla vita nazionale e sui rapporti con l’estero, l’esempio che dall’alto viene trasmesso ai normali cittadini, i quali non si sognano né trasgressioni né festini, ma dovranno abituarsi alle variazioni pecorecce sul “bunga bunga”».
E sul sito web del settimanale dei Paolini, il sondaggio sulla lite tra Berlusconi e le toghe ha un risultato bulgaro: 97% contro il premier. L’orientamente prevalente nelle gerarchie ecclesiastiche è diverso. In Segreteria di Stato si fa notare che ieri il presidente della Cei non ha fatto riferimenti alla situazione politica nell’omelia per la giornata del migrante.
-
-
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- «Bisogna andare al fondo del problema che non è politico, ma morale». Lo scrive il cardinale Agostino Vallini, già ausiliare di Napoli ed ora vicario di Roma (di Angelo Bertani - Il problema italiano? È morale)14 gennaio 2011, di Federico La Sala
Il problema italiano? È morale
di Angelo Bertani (Europa, 14 gennaio 2011)
Il momento del nostro paese è difficile e preoccupante: «Bisogna andare al fondo del problema che non è politico, ma morale». Lo scrive il cardinale Agostino Vallini, già ausiliare di Napoli ed ora vicario di Roma; insomma, il successore di Ugo Poletti e di Camillo Ruini. E spiega (nell’editoriale di Avvenire, 9 gennaio) che «la passione per il bene comune si affievolisce... dilaga la corruzione dalle forme più vistose... si evade tranquillamente il fisco...cresce la delinquenza organizzata...chi ha tutto non si contenta mai...la scaltrezza e la furbizia sembrano essere virtù...». Di più, cita il Vangelo: «Dal cuore degli uomini escono impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganni, dissolutezze, invidia, calunnie, superbia, stoltezza...” (Marco, 7).
Sembra la radiocronaca di queste settimane. E molti si domandano se l’immoralità consista nell’educazione sessuale a scuola oppure nel fatto che il capo del governo esibisca le sue escort e che un manager, mentre impone pesanti sacrifici agli operai, guadagni non il quadruplo o il centuplo...ma come migliaia di lavoratori: «Lui guadagna milioni di euro, un lavoratore poche migliaia: la differenza è questa» (Raffaele Bonanni, Asca già il 17 settembre 2010).
È da un tale disagio drammatico per le condizioni politiche e morali dell’Italia che nascono varie proposte anche dall’area cattolica. Raniero la Valle sottolinea che bisogna prendere atto di una nuovo pluralismo politico e chiede «una nuova legislatura di ricostruzione e dialogo». Sergio D’Antoni esorta all’«unità d’Italia contro la crisi» (Europa, 12 gennaio). Anche Casini auspica un «patto di pacificazione». Sono posizioni diverse, che convergono tuttavia nella esigenza di immaginare un «nuovo inizio». È sempre più necessario riscrivere regole e progetti comuni per il futuro del paese. Distinguendo la “tesi” (ognuno può immaginare e perseguire il suo ideale, la sua utopia religiosa o laica) e l’«ipotesi» (quello che appare concreto e possibile frutto di una intesa tra persone forze reali).
Perciò sarebbe necessario convenire su quel che scriveva Aldo Moro: «Non è importante che pensiamo le stesse cose, che immaginiamo e speriamo lo stesso identico destino; ma è invece straordinariamente importante che, ferma la fede di ciascuno nel proprio originale contributo per la salvezza dell’uomo e del mondo, tutti abbiano il proprio libero respiro, tutti il proprio spazio intangibile, nel quale vivere la propria esperienza di rinnovamento e di verità, tutti collegati l’uno all’altro nella comune accettazione di essenziali ragioni di libertà, di rispetto e di dialogo...». Al centro c’è un tema: la legge elettorale.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- L’educazione sessuale e civile impartita nelle scuole di alcuni Paesi europei costituisce una minaccia alla libertà religiosa. È questo il grave allarme lanciato lunedì da Benedetto XVI nel discorso tenuto di fronte al corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede.10 gennaio 2011, di Federico La Sala
BENEDETTO XVI DURANTE L’UDIENZA AL CORPO DIPLOMATICO ACCREDITATO PRESSO LA SANTA SEDE
«Nella Ue l’educazione sessuale e civile minaccia la libertà religiosa»
Poi l’appello: «Il Medio oriente garantisca la sicurezza dei cristiani, membri a pieno titolo delle società» *
CITTÀ DEL VATICANO - L’educazione sessuale e civile impartita nelle scuole di alcuni Paesi europei costituisce una minaccia alla libertà religiosa. È questo il grave allarme lanciato lunedì da Benedetto XVI nel discorso tenuto di fronte al corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede. «Proseguendo la mia riflessione - ha detto Ratzinger nella sua ampia disamina sulla libertà religiosa - non posso passare sotto silenzio un’altra minaccia alla libertà religiosa delle famiglie in alcuni Paesi europei, là dove è imposta la partecipazione a corsi di educazione sessuale o civile che trasmettono concezioni della persona e della vita presunte neutre, ma che in realtà riflettono un’antropologia contraria alla fede e alla retta ragione».
LE SCUOLE CATTOLICHE - «Esorto tutti i governi a promuovere sistemi educativi che rispettino il diritto primordiale delle famiglie a decidere circa l’educazione dei figli e che si ispirino al principio di sussidiarietà, fondamentale per organizzare una società giusta». Il papa ha chiesto di «garantire che le comunità religiose possano operare liberamente nella società, con iniziative nei settori sociale, caritativo od educativo». «In ogni parte del mondo si può constatare - ha osservato - la fecondità delle opere della Chiesa Cattolica in questi campi». Per questo, ha aggiunto, «è preoccupante che tale servizio che le comunità religiose offrono a tutta la società, in particolare per l’educazione delle giovani generazioni, sia compromesso o ostacolato da progetti di legge che rischiano di creare una sorta di monopolio statale in materia scolastica, come si constata ad esempio in certi Paesi dell’America Latina», proprio «mentre parecchi di essi celebrano il secondo centenario della loro indipendenza, occasione propizia per ricordarsi del contributo della Chiesa Cattolica alla formazione dell’identità nazionale».
BENE UE SU OBIEZIONE COSCIENZA - Nel suo discorso, lo sguardo verso Occidente e alle «minacce» che qui esistono «contro il pieno esercizio della libertà religiosa», il Papa ha fatto riferimento ai «Paesi nei quali si accorda una grande importanza al pluralismo e alla tolleranza, ma dove la religione subisce una crescente emarginazione. Si tende a considerare la religione - ha spiegato -, ogni religione, come un fattore senza importanza, estraneo alla società moderna o addirittura destabilizzante, e si cerca con diversi mezzi di impedirne ogni influenza nella vita sociale». «Si arriva così - ha aggiunto - a pretendere che i cristiani agiscano nell’esercizio della loro professione senza riferimento alle loro convinzioni religiose e morali, e persino in contraddizione con esse, come, per esempio, là dove sono in vigore leggi che limitano il diritto all’obiezione di coscienza degli operatori sanitari o di certi operatori del diritto». «Non si può che rallegrarsi dell’adozione da parte del Consiglio d’Europa, nello scorso mese di ottobre, di una Risoluzione che protegge il diritto del personale medico all’obiezione di coscienza di fronte a certi atti che ledono gravemente il diritto alla vita, come l’aborto» ha aggiunto.
L’APPELLO AL MEDIO ORIENTE - Poi Benedetto XVI ha lanciato un appello ai leader dei Paesi mediorientali: «Apprezzo l’attenzione per i diritti dei più deboli e la lungimiranza politica di cui hanno dato prova alcuni Paesi d’Europa negli ultimi giorni, domandando una risposta concertata dell’Unione europea affinché i cristiani siano difesi nel Medio oriente». «Guardando verso l’Oriente - ha detto il Papa -, gli attentati che hanno seminato morte, dolore e smarrimento tra i cristiani dell’Iraq, al punto da spingerli a lasciare la terra dove i loro padri hanno vissuto lungo i secoli, ci hanno profondamente addolorato». «Rinnovo alle Autorità di quel Paese e ai capi religiosi musulmani - ha proseguito - il mio preoccupato appello ad operare affinché i loro concittadini cristiani possano vivere in sicurezza e continuare ad apportare il loro contributo alla società di cui sono membri a pieno titolo». «Anche in Egitto, ad Alessandria - ha aggiunto il Pontefice -, il terrorismo ha colpito brutalmente dei fedeli in preghiera in una chiesa». Secondo papa Ratzinger, «questa successione di attacchi è un segno ulteriore dell’urgente necessità per i governi della regione di adottare, malgrado le difficoltà e le minacce, misure efficaci per la protezione delle minoranze religiose».
Redazione online
* Corriere della sera, 10 gennaio 2011
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- IL VANGELO SECONDO MARCHIONNE (di Marco Politi).11 gennaio 2011, di Federico La Sala
Il Vangelo secondo Marchionne
di Marco Politi (il Fatto Quotidiano, 11.01. 2011)
Quanto c’è di cristiano nelle nuove regole imposte da Marchionne a Mirafiori? L’interrogativo potrebbe suonare paradossale, ma si pone dal momento che il firmatario-guida del documento, Raffaele Bonanni, è il leader del sindacato che si richiama consapevolmente alla Dottrina sociale della Chiesa. Tanto più che la Cisl in anni passati si è spesa per portare gli altri sindacati confederali a festeggiare il 1º maggio in piazza San Pietro e, più recentemente, si è schierata con la Conferenza episcopale in quel Family Day, che sabotò la legge sulle coppie di fatto.
Nel crollo delle ideologie il sindacato di matrice cattolica ha sempre voluto attingere al patrimonio della dottrina sociale della Chiesa, arricchito da Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Giovanni Paolo II ha dedicato al tema lavoro molta parte del suo magistero. All’inizio - sul piano geopolitico - l’attenzione era focalizzata sul diritto dei lavoratori polacchi di organizzarsi in un sindacato “indipendente” (sebbene da subito, negli anni Ottanta, difendesse a São Paolo anche i diritti dei sindacati brasiliani, guidati dall’allora trotzkista Lula). Tuttavia, dopo il crollo dell’impero sovietico, Wojtyla ha continuato negli anni Novanta a occuparsi energicamente dell’argomento a fronte di un capitalismo che lui chiamava “radicale”, cioè tendente a sopraffare ogni regola.
Lontanissimo e anzi avverso ad ogni concezione di antagonismo di classe, Karol Wojtyla ha messo al centro della sua riflessione il carattere del lavoro come “dimensione fondamentale dell’esistenza”, rigettando quel tipo di prassi in cui “l’uomo viene trattato come strumento di produzione” e il lavoro come semplice “merce”. E usando questi termini - cattolici - sottolineava che il pericolo non andava relegato all’epoca dell’industrializzazione primitiva, ma appartiene al tempo presente laddove prevalga una “civiltà unilateralmente materialistica”.
IL PERICOLO di trattare l’uomo come mera “forza lavoro” - scriveva nella sua enciclica Laborem Exercens - “esiste sempre, e specialmente qualora tutta la visuale della problematica economica sia caratterizzata dalle premesse dell’economismo materialistico”. Ciò che colpisce nel documento Mirafiori, esaltato come innovativo, simbolo di modernità, spartiacque di una nuova era da coloro che quasi certamente non lo hanno nemmeno letto, è precisamente il fatto che non c’è nulla di innovativo. Non è una rivoluzione nell’organizzazione della produzione o nell’individuazione di nuovi metodi di valorizzazione della persona-operaio. Non è neanche una rivoluzione o, più modestamente, un passo in avanti sulla via della partecipazione dei prestatori d’opera alla gestione dell’azienda: nel senso della Mitbestimmung, la cogestione tedesca, letteralmente “codeterminazione”. La vera carta che la Cisl per la sua tradizione potrebbe giocare e di cui non c’è traccia nel documento Mirafiori.
Il punto non è dunque di schierarsi aprioristicamente per l’una o l’altra componente sindacale, il punto è di valutare le norme del contratto.
E qui, in tema di rappresentanza, la divaricazione con la dottrina sociale della Chiesa è totale. Sosteneva Giovanni Paolo II che il diritto di associarsi è fondamentale perché ha come scopo la “difesa degli interessi vitali degli uomini impiegati nelle varie professioni”. Cioè di assicurare la “tutela dei loro giusti diritti nei confronti degli imprenditori e dei proprietari dei mezzi di produzione”. Il corollario, nella vicenda Solidarnosc, era che non toccava al proprietario dell’azienda - lo Stato in questo caso - decidere chi potesse parlare o no a nome dei lavoratori.
Leggendo il testo Mirafiori (e sono gli articoli su cui Bonanni tiene un profilo bassissimo, perché sa che gridano vendetta al cospetto di Dio... per usare un linguaggio biblico) si vede che tutti i paragrafi sotto il titolo “Sistema di relazioni sindacali” sanciscono il radicale smantellamento della presenza in azienda di qualsiasi organizzazione sindacale, che dissenta dal contratto firmato. Chi ha il 51%, cancella gli altri.
ORA UN CONTO è accettare democraticamente i risultati di un referendum, un conto è imbavagliare totalmente un soggetto sindacale che la pensa diversamente. L’articolo 1 permette la costituzione di rappresentanti sindacali soltanto alle Organizzazioni firmatarie. Chi non è Organizzazione firmataria NON usufruisce di permessi sindacali (art. 2), NON può convocare un’assemblea (art. 3), NON ha diritto a un locale per esercitare le funzioni di rappresentanza sindacale (art. 5), NON fa più parte del sistema per cui l’azienda trattiene direttamente dallo stipendio i contributi sindacali versandoli alle rappresentanze. L’abolizione della legge 1993 sull’elezione dei delegati in azienda (festeggiata dai ministri berlusconiani Sacconi e Romani) e la clausola di umiliazione, per cui chi aderisce dopo deve ottenere il consenso di “tutti” i firmatari, completano un impianto che cozza contro la libera partecipazione dei prestatori d’opera e l’organizzazione sindacale dentro l’azienda come “indispensabile elemento della vita sociale, specialmente nelle moderne società industrializzate”. (Laborem Exercens)
Per chi ritenesse che gli anni passano, Benedetto XVI nella sua enciclica Caritas in Veritate del 2009 sottolinea come segno caratteristico dell’epoca contemporanea la diminuzione delle libertà sindacali e della capacità negoziale dei sindacati. Tuttavia che si arrivasse a dividere i “bianchi” dai “neri” neanche un papa poteva prevederlo.
-
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- IL PARADOSSO ISTITUZIONALE DEL MENTITORE E LA DISTRUZIONE DEL MESSAGGIO CRISTIANO. LA LEZIONE CRITICA DI KANT.16 dicembre 2010, di Federico La Sala
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- --- “Bagnasco, Bertone, Ruini. Liberaci, o Signore!” (di Paolo Flores d’Arcais - Se Bagnasco fa politica).17 dicembre 2010
Se Bagnasco fa politica
di Paolo Flores d’Arcais ( il Fatto Quotidiano, 17 dicembre 2010)
Moralmente parlando, siamo al governo Berlusconi-Scilipoti. Politicamente, siamo al governo dei tre B: Berlusconi, Bossi e Bagnasco. Sua Eminenza, infatti, qualche istante dopo il votomercimonio con cui a Montecitorio Berlusconi aveva evitato la sfiducia, già avvertiva l’impellente stimolo di incensarlo così: “Ripetutamente gli italiani si sono espressi con un desiderio di governabilità. Questa volontà, questo desiderio espresso in modo chiaro e democratico, deve essere da tutti rispettato e da tutti perseguito con buona volontà ed onestà”. Il più lurido mercato delle vacche cui sia stato dato assistere nel Parlamento italiano viene così santificato dal presidente della Conferenza episcopale, che parla evidentemente a nome di tutti i vescovi italiani.
Cosa c’entrino “buona volontà e onestà” con lo sfacciato acquisto “un tanto al chilo”, prolungato urbi et orbi lungo tutto un mese, di uomini e donne che dovrebbero rappresentare la nazione, lo sa solo Iddio. Con questo ultimo “endorsement” al caro amico di Putin e Gheddafi, la Chiesa gerarchica ha toccato lo zenit nel suo pellegrinaggio di ritorno al costantinismo, calpestando tutte le aperture di laicità del Concilio Vaticano II e del “Papa buono” Giovanni XXIII.
In uno dei passi più noti del Vangelo (Luca, 16,13), Gesù di Galilea condanna l’avidità di ricchezze con il definitivo “voi non potete servire Dio e Mammona”, e in Italia non c’è nessuno che - con decenni di tetragona coerenza nei comportamenti pubblici e privati-abbia dimostrato di rappresentare e incarnare i (dis)valori di Mammona meglio del signor Berlusconi da Arcore. Ma al capo dei vescovi italiani, la smisurata ed esibita corruzione del potere e del danaro, imposta dal malgoverno di regime come supremo criterio di valutazione morale, sembra invece rappresentare un giulebbe di onestà e buona volontà.
Non è possibile credere che tutta la Chiesa italiana condivida tanto oltranzismo filo-berlusconiano. Certo, ci sono i “preti in prima linea”, che hanno il coraggio di condannare il “pranzo dell’ignominia con Berlusconi” e lo “scandalo della gerarchia cattolica che si è inginocchiata alla mensa della corruzione, ha offerto corruttele e in cambio ha ricevuto soldi di peccato, leggi arraffa” per concludere con un “Bagnasco, Bertone, Ruini. Liberaci, o Signore!” (don Paolo Farinella). Ma anche nella Chiesa gerarchica, tra i vescovi, possibile che i tanti che in privato sussurrano gli stessi giudizi, abbiano deciso di ridursi a una volontaria “Chiesa del silenzio”?
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- Le amnesie dei cattolici in politica (di Gian Enrico Rusconi).28 dicembre 2010, di Federico La Sala
Le amnesie dei cattolici in politica
di Gian Enrico Rusconi (La Stampa, 28.12.2010)
I cattolici torneranno a condizionare direttamente la politica? Ma hanno forse mai smesso di contare nel berlusconismo in tutte le sue fasi: dal trionfo di ieri sino alla sua virtuale decomposizione? Dentro, fuori, contro. Grazie al berlusconismo hanno creato un consistente «pacchetto cattolico», con scritto sopra la perentoria frase «valori non negoziabili». Nel contempo hanno mantenuto aperti spazi giornalistici di franco dissenso.
Che cosa ci si aspetta ora da Pier Ferdinando Casini, che ha preso parte diretta e indiretta a tutte le fasi del berlusconismo? Anche quando se n’è tenuto lontano, è riuscito ad essere lo spauracchio della Lega e dei post-fascisti incorreggibili. Ma soprattutto a farsi rimpiangere dal Cavaliere.
E’ ovvio che ora, nella fase attuale di latente disarticolazione e disgregazione del berlusconismo, Casini riacquisti profilo. Si badi bene: non sto parlando affatto della fine del berlusconismo, tanto meno dell’esaurirsi dello stile politico-mediatico che ha prepotentemente segnato la vita politica italiana e ha deformato il modo di guardare e di giudicare la politica. Questo costume andrà avanti, sotto altre spoglie. Ma assistiamo alla disarticolazione dei pezzi della classe politica che il Cavaliere ha tenuto insieme sino ad ieri. Ma questa classe politica non sparirà affatto. Anche se sentimentalmente legata ancora a Berlusconi, è fermamente determinata a non finire con lui. In questo contesto, Casini si presenta come l’uomo politico in grado di ricompattare l’intero segmento dei cattolici in politica, cominciando con il mettere al sicuro «il pacchetto cattolico» da un’ipotetica ripresa laica. E’ questo ciò che sta a cuore alla gerarchia ecclesiastica.
Se questa operazione riesce, i cattolici continueranno a costituire una «lobby dei valori» (come se quegli degli altri fossero disvalori) senza riuscire ad essere una vera classe politica dirigente. Forse non se ne rendono neppure conto. Comincio a pensare che le ragioni di questa debolezza siano da ricercare anche nell’elaborazione religiosa di cui si sentono tanto sicuri. Cerco di spiegarmi - a costo di dire cose sgradevoli.
Non c’è bisogno di evocare «il ritorno della religione nell’età post-secolare» per constatare nel nostro Paese la forte presenza pubblica della religione-di-chiesa (cioè dell’espressione religiosa mediata esclusivamente dalle strutture della Chiesa cattolica). Ma la rilevanza pubblica della religione, forte sui temi «eticamente sensibili» (come si dice), è accompagnata da un sostanziale impaccio comunicativo nei contenuti teologici che tali temi dovrebbe fondare. O meglio, i contenuti teologici vengono citati solo se sono funzionali alle raccomandazioni morali.
Siamo davanti ad una religione deteologizzata, che cerca una compensazione in una nuova enfasi sulla «spiritualità». Ma questa si presenta con una fenomenologia molto fragile, che va dall’elaborazione tutta soggettiva di motivi religiosi tradizionali sino a terapie di benessere psichico. I contenuti di «verità» religiosa teologicamente forti e qualificanti - i concetti di rivelazione, salvezza, redenzione, peccato originale (per tacere di altri dogmi più complessi ) -, che nella loro formulazione dogmatica hanno condizionato intimamente lo sviluppo spirituale e intellettuale dell’Occidente cristiano, sono rimossi dal discorso pubblico. Per i credenti rimangono uno sfondo e un supporto «narrativo» e illustrativo, non già fondante della pratica rituale.
La Natività che abbiamo appena celebrato è fondata sul dogma teologico di Cristo «vero Dio e vero uomo». Si tratta di una «verità» che ha profondamente inciso e formato generazioni di credenti per secoli. Oggi è ripetuta - sommersa in un clima di superficiale sentimentalismo - senza più la comprensione del senso di una verità che non è più mediabile nei modi del discorso pubblico.
Ricordo il commento di un illustre prelato davanti alla capanna di Betlemme: lì dentro - disse - c’era «la vera famiglia», sottintendendo che tali non erano le coppie di fatto e peggio omosessuali. Si tratta naturalmente di un convincimento che un pastore d’anime ha il diritto di sostenere, ma che inquella circostanza suonava come una banalizzazione dell’evento dell’incarnazione, che avrebbe meritato ben altro commento.
Ma viene il dubbio che ciò che soprattutto preme oggi agli uomini di Chiesa nel loro discorso pubblico sia esclusivamente la difesa di quelli essi che chiamano «i valori» tout court, coincidenti con la tematica della «vita», della «famiglia naturale» e i problemi bioetici, quali sono intesi dalla dottrina ufficiale della Chiesa. Non altro. La crescita delle ineguaglianze sociali e della povertà, la fine della solidarietà in una società diventata brutale e cinica (nel momento in cui proclama enfaticamente le proprie «radici cristiane»), sollevano sempre meno scandalo e soprattutto non creano impegno militante paragonabile alla mobilitazione per i «valori non negoziabili».
Un altro esempio è dato dalla vigorosa battaglia pubblica condotta a favore del crocifisso nelle aule scolastiche e nei luoghi pubblici. Una battaglia fatta in nome del valore universale di un simbolo dell’Uomo giusto vittima dell’ingiustizia degli uomini. O icona della sofferenza umana. Di fatto però, a livello politico domestico il crocifisso è promosso soprattutto come segno dell’identità storico-culturale degli italiani. E presso molti leghisti diventa una minacciosa arma simbolica antiislamica. In ogni caso, l’autentico significato teologico - traumatico e salvifico del Figlio di Dio crocifisso, oggetto di una fede che non è condivisa da altre visioni religiose, tanto meno in uno spazio pubblico - è passato sotto silenzio. I professionisti della religione non riescono più a comunicarlo. E i nostri politici sono semplicemente ignoranti.
Se i cattolici hanno l’ambizione di ridiventare diretti protagonisti della politica, dovrebbero riflettere più seriamente sul loro ruolo. Il discorso politico, soprattutto quando porta alla deliberazione legislativa, rimane e deve rimanere rigorosamente laico, nel senso che non può trasmettere contenuti religiosi. Ma nello «spazio pubblico», che è molto più ampio e può ospitare discorsi di ogni tipo, si deve misurare la maturità di un movimento di ispirazione religiosa che sa essere davvero universalistico nell’interpretare e nel gestire l’etica pubblica. Non semplicemente una lobby in difesa di quelli che in esclusiva proclama i propri valori.
-
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- “La santa apparenza. Un teologo gay nella Chiesa cattolica”.“Omofobica e piena di gay”: Il teologo cattolico David Berger racconta l’ipocrisia della chiesa tedesca.14 dicembre 2010, di Federico La Sala
“Omofobica e piena di gay”: il teologo cattolico David Berger racconta l’ipocrisia della chiesa tedesca
da: Adista - Notizie (n. 97, 18 dicembre 2010)
 “Gran parte del clero cattolico e degli aspiranti preti in Europa e negli Stati Uniti è omosessuale”.
“Gran parte del clero cattolico e degli aspiranti preti in Europa e negli Stati Uniti è omosessuale”.
 “Nella Chiesa cattolica esiste una connessione tra la sessualità repressa e l’omofobia”.
“Nella Chiesa cattolica esiste una connessione tra la sessualità repressa e l’omofobia”.
 A
pronunciare queste parole è il teologo cattolico tedesco David Berger in un libro-confessione
appena uscito in Germania intitolato Der heilige Schein. Als schwuler Theologe in der katholischen
Kirche (“La santa apparenza. Un teologo gay nella Chiesa cattolica”).
A
pronunciare queste parole è il teologo cattolico tedesco David Berger in un libro-confessione
appena uscito in Germania intitolato Der heilige Schein. Als schwuler Theologe in der katholischen
Kirche (“La santa apparenza. Un teologo gay nella Chiesa cattolica”).Nel suo libro Berger, ex professore della Pontificia Accademia San Tommaso D’Aquino a Roma ed ex direttore della rivista di punta dei cattolici conservatori in lingua tedesca Theologisches, snocciola i numeri della “grande ipocrisia” della Chiesa cattolica sul tema omosessualità. “Secondo studi empirici nella Chiesa cattolica tedesca la percentuale di religiosi gay si aggira tra il 25% e il 40%. Alcuni teologi, come Wunibald Müller, stimano che nei seminari i docenti gay siano addirittura il 50%. Negli Usa la percentuale di preti gay è stimata tra il 25 e il 50%”. Berger racconta che lui stesso, da teologo cattolico convivente con un partner, per molti anni ha dovuto subire come un incubo l’atmosfera ostile ai gay della sua Chiesa, fino a quando, nell’aprile del 2010, ha deciso di fare outing, ricevendo dopo poche settimane la lettera di licenziamento dall’Accademia pontificia. Per spiegare la propria appartenenza agli ambienti più tradizionalisti della Chiesa cattolica, da cui ora prende le distanze, ma ai quali deve la sua carriera fulminante,
Berger si richiama alla sua precocissima “fascinazione per la liturgia latina e tridentina”. “Proprio l’estetica del culto tradizionalista - spiega - esercita una particolare attrazione sui gay”, anche se d’altra parte “è tra i difensori della liturgia tridentina che si trova l’omofobia più radicale”. Alla base di questo paradosso, ha spiegato in un’intervista rilasciata al settimanale Der Spiegel, c’è un meccanismo inquietante: “La sublimazione omosessuale è una radice e un nutrimento continuo del culto della Chiesa tradizionale, ma è anche un meccanismo di resistenza all’omosessualità, che spiega l’omofobia diffusa tra gli amici del rito classico e tra gli avversari della riforma liturgica”. Sulla confessione pubblica di Berger si era già espresso il teologo morale Eberard Schockenhoff.
In un’intervista rilasciata il 26 aprile 2010 alla Frankfurter Rundschau, Schockenhoff aveva dichiarato che la confessione di Berger accende i riflettori sui “pericoli mortali della doppia morale” della Chiesa cattolica sull’omosessualità. “Ci sono ambienti gay clericali - ha affermato - dove la sessualità viene vissuta esclusivamente in luoghi anonimi e con partner sessuali occasionali, per non incorrere nei pericoli di una relazione di lungo periodo che alla lunga non può essere nascosta. Le regole della dottrina morale del cattolicesimo finiscono per promuovere sesso poligamo, anonimo (spesso anche non protetto), con tutti i rischi connessi per la salute dell’anima e del corpo”.
C’è forse un implicito riferimento anche a questa realtà - si chiedono ora i giornali tedeschi - dietro le ultime dichiarazioni del papa, laddove come esempio di eccezione giustificabile nell’utilizzo del condom questi ha parlato espressamente di “uomini che si prostituiscono”?
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- «Alla base della logica c’è l’etica... alla base dell’etica c’è la logica» (di Vito Mancuso - La centralità della questione morale)13 dicembre 2010, di Federico La Sala
La centralità della questione morale
di Vito Mancuso (la Repubblica, 11 dicembre 2010)
La questione morale è la questione, argomenta Roberta De Monticelli, filosofa di statura europea con anni di insegnamento a Ginevra e ora a Milano al San Raffaele, nel suo nuovo libro (La questione morale, Raffaello Cortina). Sostenendo che la morale non è un’applicazione secondaria ma il punto da cui tutto dipende, l’autrice si pone in pieno contrasto col pensiero dominante in Italia, che concepisce la morale come traduzione pratica di un primato assegnato ad altro, a una dimensione vuoi politica, religiosa, economica, scientifica, teoretica.
Chi assegna il primato alla morale può stare sicuro oggi in Italia di ricevere l’antipatica etichetta di «moralista», sinonimo nel linguaggio comune di persona noiosa e pedante, incapace di fare i conti con la vita concreta. Contro questo cinismo che conosce solo la logica del potere, De Monticelli scrive pagine di vera passione intellettuale attaccando il potere politico («l’interesse affaristico che si fa partito e prostituisce il nome di libertà»), mediatico («facce patibolari»), ecclesiastico («nichilismo morale»), intellettuale («disprezzo ardente per tutto ciò che è comune»). Arriva anche alla piaga più dolorosa: «Una sorprendente maggioranza degli italiani che approva, sostiene e nutre» tale logica del potere. Alla denuncia segue però una proposta costruttiva («tornare a respirare»), dove lo scetticismo pratico viene confutato proprio in base al suo punto forte, cioè il freddo utilizzo della ragione, perché esercizio della ragione ed esperienza dei valori sono strettamente legati: «Alla base della logica c’è l’etica... alla base dell’etica c’è la logica».
Ritrovandomi pienamente d’accordo con la mia illustre collega, intendo onorare il suo pensiero approfondendo il nodo radicale del nostro Paese, cioè la «sorprendente maggioranza di italiani che approva, sostiene e nutre» lo scollamento tra etica e politica. Il problema è politico nel senso radicale del termine, riguarda cioè la raccolta del consenso. Come si raccoglie il consenso? Giocando sulle passioni e sugli interessi, quasi per nulla sul senso di giustizia (a meno di farlo diventare a sua volta una passione e un interesse, trasformando così però la giustizia in iniquo giustizialismo).
Da qui una sorta di primordiale conflitto di interessi: da un lato la morale che vive della solitudine della coscienza perché la vita ci mostra che sollevare problemi morali nel nome della coscienza significa spesso rimanere soli; dall’altro la politica che non può permettersi la solitudine. Da un lato la morale che si gioca in una impolitica solitudine, dall’altro la politica che si gioca nella capacità di raccogliere il consenso, operazione eminentemente sociale e quindi basata di necessità sugli interessi e le passioni (rimando d’obbligo il grosso animale della Repubblica di Platone e le indimenticabili pagine di Simone Weil al riguardo). La coscienza impone di essere giusti, ma l’essere giusti non paga in termini di fascino sociale e di raccolta del consenso. In particolare non paga in Italia, dove gli elettori da anni premiano un uomo che sanno bene non essere lo specchio della morale (ma è ricco, fortunato, abile, "tanto simpatico").
La questione morale quindi, politicamente intesa, è altamente drammatica. Il problema che essa pone si chiama traducibilità dell’etica a livello politico, o meglio non-traducibilità. Fate una campagna elettorale all’insegna della giustizia e del rispetto e sarete ricompensati con il minimo dei voti. È innegabile quanto scrive De Monticelli: «L’imbarbarimento morale e civile si combatte risvegliando le coscienze alla serietà dell’esperienza morale». Ma purtroppo è altrettanto innegabile che una raccolta del consenso politico oggi in Italia sulla base della serietà dell’esperienza morale è destinata a non oltrepassare la soglia di sbarramento: con quel programma lì si entra in monastero, non nel Parlamento italiano.
Il problema non è etico, è fisico, di quella fisica della politica che Simone Weil attribuiva a Machiavelli. Ovvero: perché l’aggregazione sociale non avviene nel nome della giustizia e della morale, ma degli interessi e delle passioni, e quindi molto spesso a scapito della giustizia e della morale?
Di fronte a questo immenso problema, qui mi limito a dire che a mio avviso lo si può affrontare solomediante i partiti e i professionisti della politica (la cui importanza vitale appare in particolare oggi, con le nostre classi dirigenti quasi del tutto prive di veri professionisti della politica). Il partito politico, nella misura in cui è veramente tale e non un semplice cartello elettorale, media gli interessi e le passioni della moltitudine attraverso un progetto più ampio, rivolto al bene comune. Il partito politico è il luogo in cui gli interessi e le passioni dei singoli vengono veicolati al servizio di un progetto più ampio, lo stato. Senza la mediazione dei partiti si ha il corto circuito tra leader e interessi e passioni della moltitudine, ovvero il populismo. Oppure l’altro estremo, il moralismo, che non vede l’inspiegabile ma reale distanza tra la morale e la politica e crea tra le due un impossibile passaggio diretto, finendo per generare costrizioni e violenza, il contrario della morale.
Occorre coltivare insieme il primato della morale e il richiamo della dura realtà. Una società (e prima ancora una persona) è matura quando ospita dentro di sé il gioco di queste due forze, quando sa porre il primato dell’etica e quando sa mediarlo con l’opacità del reale. E al riguardo il ruolo dei partiti e dei veri politici è insostituibile.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- Gli italiani e la sindrome della bandiera bianca (di Roberta De Monticelli).17 dicembre 2010, di Federico La Sala
 Gli italiani e la sindrome della bandiera bianca
Gli italiani e la sindrome della bandiera bianca Il teologo Vito Mancuso era intervenuto nei giorni scorsi sul tema della questione morale.
Il teologo Vito Mancuso era intervenuto nei giorni scorsi sul tema della questione morale.
 Quella
che segue è la risposta-riflessione della filosofa Roberta De Monticelli
Quella
che segue è la risposta-riflessione della filosofa Roberta De Monticelli di Roberta De Monticelli (l’Unità, 17 dicembre 2010)
di Roberta De Monticelli (l’Unità, 17 dicembre 2010)Caro Vito, in questi giorni in cui il disprezzo per le istituzioni repubblicane, l’etica e perfino la politica ha toccato il suo zenit, vorrei che cominciassero a riaprirsi le finestre almeno al vento fresco del pensiero. Prendo spunto dalla tua riflessione sulla questione morale (la Repubblica, 11 dicembre), e tento di tradurre in atto lo spirito di libertà, di ricerca e di critica che spero continuerà ad animare la nostra Università, anche con la tua presenza e il tuo aiuto. Nonostante l’ombra che la minaccia: il sospetto che brillanti centri di ricerca come il nostro siano accomunati con un imbroglio come l’università-Cepu, agli occhi del pubblico, dal fatto che attingano anche a risorse pubbliche.
Questo, io credo, tutti i docenti dovrebbero chiedere a gran voce, che fino all’ultimo centesimo l’erogazione di risorse pubbliche sia, in perfetta trasparenza, giustificata in proporzione al merito: ma l’abbiamo fatto? No, non l’abbiamo fatto, o non abbastanza fermamente e chiaramente, tutti, a una sola voce. E perché non l’abbiamo fatto? Per scetticismo. È solo un esempio, quello da cui riparto. Il saggio da cui ha preso spunto la tua riflessione cerca di identificare le radici dello scetticismo pratico che divora la vita civile del nostro Paese.
Lo scetticismo, cioè, che corrode non solo l’etica pubblica, ma ha invaso tutte le sfere dove il nostro agire è guidato dai nostri giudizi di valore. E soprattutto blocca ogni tentativo di ricostruire quella che ho chiamato l’unità della ragione pratica, vale a dire una fondazione nuova, e se possibile feconda di nuove scoperte, dei nessi fra etica, diritto e politica. Intese fra l’altro tutte come sfere aperte anche alla ricerca di conoscenza, cioè in ultima analisi di verità. So di trovarti su questo ultimo punto in sintonia con il mio tentativo.
Ma vorrei che si aprisse una discussione su quello che a me sembra continui a gravare, irrisolto equivoco, su questo tipo di ricerca. Perché da una parte le viene detto: l’etica è l’etica, la politica è la politica, e cercare il nesso fra le due già significa “criminalizzare l’avversario”, preparare lo Stato etico, Robespierre, la virtù e il terrore (interpreto così, magari nobilitandole un po’, le recenti obiezioni di Marcello Veneziani, il Giornale, 27 novembre e 4 dicembre). In altre parole, non c’è possibile radicalità etica, ma solo radicalismo politico, tanto più pericoloso in quanto giustizialista e moralista. Ma dall’altra parte le viene detto: c’è un enigma del male, cui è la politica che è chiamata a far fronte, e a volerlo combattere risvegliando le coscienze alla serietà dell’esperienza morale “si entra in monastero, non nel Parlamento italiano”.
Tu dici giusto: ma “serietà” è in primo luogo una proprietà che si riconosce all’esperienza morale, se la si considera vera esperienza del bene e del male, capace di nutrire vera conoscenza: e se non ricominciamo da qui, se non la prendiamo sul serio neppure noi filosofi, chi mai potrà farlo? A lasciar la mano ai cosiddetti realisti politici non si sta finendo per dire, ancora una volta, che nelle Città e nelle Istituzioni - tutte, comprese quelle del sapere e della ricerca, le nostre università, pubbliche e private, ferite ma anche colpevoli - che la ricerca di ragione e giustificazione là dove impera la forza è cosa da “anime belle”? Ma non è così che nel secolo scorso i filosofi hanno tradito il loro compito, e lasciato la civiltà in mano ai demagoghi?
Ecco: nell’insegnarci a chiedere “perché?” a noi stessi e agli altri, in ogni punto e in ogni momento del nostro dire, ma anche del nostro fare, è il cuore sempre pulsante della ragione e della filosofia. Socrate insegna a Eutifrone che non la tradizione, la religione o il mito sono risorsa normativa, ma lo è il fatto che vediamo il male. Dimenticarlo è una grande parte dell’equivoco, caro Vito: non hanno rimproverato anche a te una sorta di intellettualismo, di ignoranza del male di cui l’uomo è capace, contro il quale appunto nascono etica, diritto, politica? Come se Socrate, come se la filosofia o la ragione ignorassero il dato, il dato stesso che le risveglia: il male, appunto, che sappiamo fare. Torti, ineguaglianze, illibertà, ingiustizie e altre cose che gridano vendetta.Perché li ha visti, e non perché li ignora, la nostra ragione è in grado di spiegare a ciascuno il perché di una norma che questi torti impedisce, o limita. Lungo la via di Socrate è cresciuto, nell’anima d’Europa, quasi tutto ciò per cui vale la pena di vivere: la libera ricerca nelle scienze e nelle arti. Ma per molto tempo ancora l’etica, il diritto e la politica sono rimasti fuori da questa via. Non sarebbe ora di riprenderla, tutti insieme?
-
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- Il Vaticano puntella B. Ma Casini resiste a Ruini (di Marco Politi).10 dicembre 2010, di Federico La Sala
Il Vaticano puntella B. Ma Casini resiste a Ruini
di Marco Politi (il Fatto Quotidiano, 10.12.2010)
Berlusconi esibisce il puntello vaticano. E il Segretario di Stato, cardinale Bertone, partecipa volentieri. Il tradizionale ricevimento offerto ai dieci nuovi porporati italiani nell’ambasciata presso la Santa Sede, si è risolto in una rinnovata manovra per mostrare al pubblico che il sostegno vaticano al premier non è venuto meno. Due ore di pranzo, l’opportunità di una foto-spot, rinnovate garanzie al Vaticano. Il Cavaliere ha giocato le sue carte e Letta, che con vari ministri era presente al ricevimento, ha fatto la sua parte per convincere Bertone e il segretario della Cei mons. Crociata che l’unica soluzione è un rafforzamento dell’attuale compagine ministeriale, coinvolgendo anche l’Udc. Senza dimissioni, senza inoltrarsi nell’avventura di un reincarico.
Già dieci giorni fa, in occasione del vertice Osce nel Kazakhstan, Berlusconi aveva esibito l’immutato appoggio di Bertone (presente alla riunione internazionale) alla sua leadership. “Quando gli ho chiesto cosa ne pensasse del terzo polo, il cardinale mi ha risposto che non celebra matrimoni fra uomini, soprattutto se si tratta di Casini e di Fini”, ha riferito il Corriere della Sera.
BATTUTE A PARTE, resta la preferenza della Segreteria di Stato per l’uomo di Arcore. È questo il nodo del ruolo negativo che la Chiesa-istituzione sta giocando nella più grave crisi attraversata dal Paese negli ultimi decenni. Nulla smuove la gerarchia vaticana dalla sua posizione filoberlusconiana perinde ac cadaver. Non basta che il premier per due anni abbia inchiodato il Parlamento alla pasticciata elaborazione di leggi per evitare al Cavaliere i tribunali, dove è imputato di reati gravi che nulla c’entrano con le sue visioni politiche. Non basta che il suo collaboratore più stretto, Marcello Dell’Utri, sia stato riconosciuto colpevole - con sentenza di primo e secondo grado
 di avere stretto accordi con la mafia a suo vantaggio. Non basta che non abbia fatto nulla per
sostenere le famiglie in gravi difficoltà, per rilanciare l’occupazione, per contrastare un precariato
esiziale per un’intera generazione di giovani. Non bastano il bunga-bunga, le serate affollate di
puttane pagate o fattesi pagare, le frequentazioni con minorenni.
di avere stretto accordi con la mafia a suo vantaggio. Non basta che non abbia fatto nulla per
sostenere le famiglie in gravi difficoltà, per rilanciare l’occupazione, per contrastare un precariato
esiziale per un’intera generazione di giovani. Non bastano il bunga-bunga, le serate affollate di
puttane pagate o fattesi pagare, le frequentazioni con minorenni.I vertici ecclesiastici hanno deciso di volgere la faccia dall’altra parte. Non affrontando la questione morale, nel senso di etica istituzionale, costituita dai comportamenti del Caimano. Risale a quattordici mesi fa, settembre 2009, l’ultimo sussulto per chiamare direttamente alle sue responsabilità Silvio Berlusconi. Fu quando al Consiglio permanente della Cei il presidente cardinale Bagnasco dichiarò che “chiunque accetta di assumere un mandato politico sia consapevole della misura e della sobrietà, della disciplina e dell’onore che esso comporta, come anche la nostra Costituzione ricorda all’articolo 54”.
Da allora ci sono state solo critiche indirette, esclamazioni di allarme, manifestazioni di insoddisfazione per la mancanza di una seria politica sociale. Qualche protesta quando Berlusconi ha commesso l’imprudenza di raccontare barzellette-bestemmia. Ma mai la gerarchia ecclesiastica ha compiuto il gesto di ritirare apertamente il credito largamente concesso da decenni a Silvio Berlusconi. Nonostante il malessere di tanto mondo cattolico, nonostante le puntuali denunce di Famiglia Cristiana, nonostante l’aperta insofferenza dopo il caso Ruby di parecchi settimanali diocesani, nonostante il disagio crescente di molti vescovi.
Nei giorni passati le cronache hanno riferito di sotterranee pressioni del cardinale Ruini per convincere Casini a non tirare troppo la corda e trovare un accordo con Berlusconi. Per l’ex presidente della Cei - in sintonia con la Segreteria di Stato - conta solo la “ragion di Chiesa” della salvaguardia dei finanziamenti alle scuole confessionali (anche a scapito del 5 per mille provolontariato e di una scuola pubblica drammaticamente impoverita). Conta solo impedire che il “laicista” Fini - prontamente attaccato dall’Avvenire - possa osare di favorire nel nostro Paese l’introduzione di leggi normali come le unioni civili e il testamento biologico.
Un problema etico di Berlusconi-premier per Ruini non esiste. Basta leggere quanto dichiarato recentemente a Repubblica: “Quando si chiama in causa la morale non per scopi autenticamente morali ma per motivi diversi, ad esempio politici, si cade facilmente nel moralismo, che è a suavolta una forma di immoralità, negativa anzitutto per chi la pratica”. Un’affermazione gelida, che nella sua esposizione nega in radice qualsiasi dibattito sull’etica pubblica, che notoriamente - in tutto l’Occidente democratico - si svolge nelle sedi politiche e istituzionali, e non certo nei confessionali.
NON È UN CASO che in queste ore si stia consumando un silenzioso divorzio tra Casini e la linea Ruini. Da vecchio democristiano Casini ha intuito che nel profondo del Paese, Berlusconi ha perso l’alone del “salvatore” e perciò non ha più senso puntellare la sua anomalia. Se assieme a Fini riuscirà a reggere la strategia iniziata, il Vaticano resterà solo a puntellare il governo di un uomo definito dalla diplomazia americana “incapace, vanesio, inefficiente”.
Non è un caso nemmeno che “per impegni precedenti” il cardinale Bagnasco non sia venuto ieri da Genova a Roma per partecipare al pranzo-spot con Berlusconi. Non aveva problemi insormontabili. In mattinata una riunione con i vicari, in serata un appuntamento a Loreto. Il premier gli avrebbe certamente messo a disposizione un aereo.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- NEL NOME DEL "PAPI" (di di MARIA G. DI RIENZO).5 dicembre 2010, di Federico La Sala
NEL NOME DEL "PAPI"
di MARIA G. DI RIENZO *
Credo si debba dar credito di almeno una cosa alla Ministra Gelmini: pur facendo malissimo il suo lavoro, in una sola frase e’ riuscita a fotografare il "pensiero dominante" degli ultimi trent’anni italiani. Guardando dalla finestra, per cosi’ dire, la signora e’ sconcertata dal vedere pensionati e studenti protestare insieme. Che hanno a che fare gli uni con gli altri?, si chiede basita, Che interessi comuni possono avere?
Nel supermercato della giungla infatti, dove la Ministra vive e dove il suo governo pascola, tutti si vendono e/o comprano altri, ed ognuno e’ solo sino alla disperazione, perche’ chiunque si trovi accanto - se non e’ un oggetto da usare o un potente da agganciare - e’ un competitore, un ostacolo, un fastidio. Gli italiani non si sono tirati indietro: sulla base degli esempi e degli impulsi forniti dagli uomini e dalle donne "di successo", incoraggiati dalla propaganda ossessiva dei media, abbagliati dai premi forniti alla disonesta’ e alla cialtroneria, hanno contribuito ad alzare il livello di violenza nel paese senza pensare che sarebbe ricaduto su di loro. Hanno giustificato ogni iniquita’ propria e altrui esattamente sul fondamento di una solitudine egoista. Ma singolarizzati non si vive.
Se l’ambiente e’ un terreno di caccia e sfruttamento l’immondizia si accumula sulle tue strade, il tuo fiume straripa, le tue case crollano, le varie patologie da inquinamento fanno ammalare ed uccidono te e i tuoi figli. Se le scuole sono aziende che devono produrre profitto, e parcheggi per i ragazzi in attesa che trovino da fare gli idioti in tv, e’ perfettamente normale che il bullismo sia esploso come un fungo atomico. Quando le donne non possono essere viste e rappresentate se non come imprenditrici del sesso a pagamento, hostess da tavolo, cigni da cubo, vassoi viventi e "talenti futuri", ecco cosa aumenta: violenza domestica, violenza sessuale, disturbi dell’alimentazione nelle adolescenti, molestie sul lavoro (abbiamo il record europeo in quest’ultimo settore). Ed ecco cosa accade quotidianamente: bambine di quattro anni vestite come pornostar fanno balletti "sexy" nel giorno del loro compleanno o nel cortile dell’asilo, bambini delle elementari - tutti o quasi "fidanzati" con coetanee - cercano pornografia su internet, studenti delle medie molestano pesantamente le compagne in classe, quando non le stuprano nei bagni, sotto gli occhi indifferenti degli insegnanti. Questi sono tutti episodi di cui io ho conoscenza diretta. Soli, ipersessualizzati, violenti e senza orizzonte: dai quattro anni in poi gli italiani e le italiane sembrano avere quest’unica prospettiva.
Di recente se n’e’ accorto anche il Censis (44mo rapporto annuale sullo stato dell’Italia, dicembre 2010), definendo l’Italia "una societa’ senza regole e senza sogni" attraversata dal "gusto apatico di compiere delitti comuni". Il suo presidente De Rita ha rilasciato al proposito coltissime dichiarazioni piene di "auctoritas" e di "sregolazione pulsionale", ma di fronte alla richiesta di rimedi si e’ rivelato un po’ meno profondo. Cosa possiamo fare, dunque? Preoccuparci del "padre che evapora" (santo cielo, abbassate i termostati!), quindi "ridare senso alla figura paterna" e "alla dimensione sociale del peccato", ripartendo da un "desiderio" che nasca dalla "mancanza". Il rapporto rileva con giusta perplessita’ i bambini affogati in giocattoli che neppure hanno chiesto e la mezza dozzina di cellulari a cranio italico, ma provate a portarglieli via e vedremo come il desiderio nato dalla mancanza si esprimera’: non si tratta solo di quante cose si hanno, signor presidente, ma di a che servono, di chi le usa e come le usa e per quali motivi, perche’ di fatto esse hanno sostituito le relazioni sociali e definiscono il posto nel mondo - il "successo", il valore - di chi le possiede.
Giuseppe Roma, direttore del Censis, contribuisce: ripartiamo dal singolo, invoca, per ritrovare "impulsi vitali" ed "energie positive". No, grazie: al "singolo" (uno contro tutti nella competizione globale) ci siamo gia’. E’ la coscienza che il singolo esiste all’interno di un sistema di relazioni che manca, e’ la consapevolezza che ogni individuo umano e’ stato portato all’esistenza da una relazione che manca, e che il nostro stesso pianeta e’ una rete di relazioni viventi. E’ il riconoscere che viviamo grazie alla cooperazione, non grazie alla competizione, che manca. Quanto al desiderio di un "padre" che ci metta a posto fomentando in noi l’idea del peccato e strapazzandoci per farci rigare diritto lo rispedisco al mittente: cio’ che i signori del Censis hanno osservato con le lacrime agli occhi e’ esattamente il prodotto estremo e spettacolarizzato della "legge dei padri", il patriarcato.
Quando Mister "Ghe pensi mi" (l’attuale capo di governo) metteva in fila le cameriere nelle sue ville per dar loro lo sculaccione augurale, affinche’ quel giorno lavorassero bene e nessuna piega si formasse sulla tovaglia per gli ospiti, non stava facendo altro che il suo lavoro da padre-padrone e quasi nessuno - oltre a me - lo ha trovato ignobile; quando assieme ai suoi lacche’ ha sponsorizzato la pagliacciata del "Family Day", delegittimando ed insultando la mia, di famiglia, perche’ "sregolata" e "non tradizionale" (come non e’ "tradizionale" la maggioranza delle famiglie italiane), il padre-padrone si sentiva perfettamente in regola circondato da prelati, beghine, le sue due famiglie ed il corteggio di amanti a pagamento: e’ "tradizione", infatti, che il patriarca possa concedersi cio’ che ai comuni mortali e’ negato; quando le suddette dame di compagnia sessuale gli chiedevano favori (risolvimi l’abuso edilizio, prestami l’avvocato da talk show per i miei problemi legali, trovami un posto in tv o da parlamentare: e quelle che hanno sollevato i veli dell’ipocrisia lo hanno fatto solo perche’ non hanno ottenuto cio’ che volevano) stavano ridando pieno "senso alla figura paterna", quella del "tradizionale" padre onnipotente che da’ e toglie a suo capriccio, che ha piena potesta’ sulla figliolanza reale e simbolica, e che e’ autorizzato ad usarla per il proprio godimento: fra i figli, quindi, deve scatenarsi la lotta piu’ implacabile per ottenere i favori del padre, eliminare gli avversari, e infine prenderne il posto.
In questo quadro, lo stupore ministeriale che citavo all’inizio ("Che interessi comuni possono avere pensionati e studenti?") e’ perfettamente logico: ognun per se’ e dio per chi puo’ pagarlo con le regalie alle scuole private, mentre quella pubblica affonda. So che la Ministra non leggera’ mai la spiegazione che sto per fornirle, e che quand’anche cio’ accadesse probabilmente non riuscirebbe (ancora) a capirla, tuttavia eccola qua: pensionati e studenti, lavoratori e attivisti sociali, stanno cominciando a ricordare di essere umani, e che sono umani solo grazie al fatto che altri esseri umani li hanno messi al mondo, hanno avuto cura di loro, si preoccupano per loro, li amano. Se al Censis non hanno le fette di "papi" sugli occhi dovrebbero accorgersi che tutto questo ricorda molto di piu’ l’agire di una madre (o di un padre nient’affatto "tradizionale"). Una madre che non ti indica l’inferno piu’ o meno trascendente - il "senso sociale del peccato" - ma un quotidiano esistere fatto di buone relazioni, di negoziazioni, di condivisione di abilita’ e risorse, di responsabilita’ e rispetto, come sistema per vivere meglio, insieme, tutte e tutti. Se vogliono prove di quanto dico, e’ probabile che non debbano guardare piu’ lontano di casa propria.
* TELEGRAMMI DELLA NONVIOLENZA IN CAMMINO Numero 395 del 5 dicembre 2010 Telegrammi della nonviolenza in cammino proposti dal Centro di ricerca per la pace di Viterbo a tutte le persone amiche della nonviolenza Direttore responsabile: Peppe Sini. Redazione: strada S. Barbara 9/E, 01100 Viterbo, tel. 0761353532, e-mail: nbawac@tin.it, sito: http://lists.peacelink.it/nonviolenza/
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- E LA LEZIONE DI SAMUELE. Sulle piste di sabbia. Folate di vento negli occhi e nei capelli. Ovvero la paura della libertà (di Angelo casati - Mosaico di pace).9 ottobre 2010, di Federico La Sala
Sulle piste di sabbia. Folate di vento negli occhi e nei capelli. Ovvero la paura della libertà
di Angelo Casati ("mosaico di pace”, ottobre 2010)
Sento rinascermi in cuore di tanto in tanto e ancora non è spenta - eppure di anni se ne sono srotolati da allora, più di dieci - la nostalgia di un’estate in Giordania, nostalgia delle piste di sabbia del deserto. Piste infinite, inafferrabili, a smarrimento di occhi e folate di vento. Negli occhi e nei capelli. E fu desiderio una sera di fissare in righe quella straniante emozione, con gli occhi che già andavano ai giorni futuri:
Sulle piste di sabbia.
 E mi sveglierò
E mi sveglierò
 su strade grigie
su strade grigie
 e griderò inascoltato
e griderò inascoltato
 l’assenza.
l’assenza.
 Orfano
Orfano
 della magia del deserto
della magia del deserto
 delle sabbie rosate
delle sabbie rosate
 delle rocce
delle rocce
 ubriache di colore.
ubriache di colore. E sognerò
E sognerò
 folate di vento
folate di vento
 di libertà
di libertà
 e sabbia nei capelli
e sabbia nei capelli
 spazi senza recinti
spazi senza recinti
 e l’eco dopo millenni
e l’eco dopo millenni
 di messaggi segreti i-ncisi da beduini
di messaggi segreti i-ncisi da beduini
 su rocce di basalto.
su rocce di basalto. A segnalare
A segnalare
 ai nomadi del futuro
ai nomadi del futuro
 piste segrete
piste segrete
 d’indipendenza
d’indipendenza
 nell’infuocato deserto.
nell’infuocato deserto.Nostalgia di spazi e di libertà, che si fa ferita per restrizione, ora che le case, come fossero picchetti, fanno barriera da un lato e dall’altro della strada e negano sconfinamento alla sete degli occhi, cancellando l’oltre, impoverendo visioni. Mi odo camminare nel segno della restrizione e del contenimento. Quasi fosse scritto divieto, divieto a una sete che chiamo sete di libertà.
tra menzogna e verità
E sento, soffro sulla pelle a incisione la ferita della menzogna, la menzogna circa la libertà. Soffro lo svilimento, l’estenuazione, la sconsacrazione di una parola che è sacra, fatta oggetto di prostituzione. Scrivono libertà su ogni dove, perfino sul nome dei partiti, antichi e nuovi, proprio là dove è trasalimento di paura a ogni sussulto pur minimo di indipendenza, là dove è in sospetto il libero pensare e il libero comunicare.
C’è dunque nelle stanze alte del potere, anche se non confessata, una paura della libertà. Che non è solo di oggi. Chi di noi ha più anni sulle spalle ricorda come non raramente si giustificasse l’imposizione di regole dall’alto o una cieca obbedienza con il fatto che il popolo, la gente semplice - si diceva - è lontana dall’essere matura e dunque va indirizzata. Conseguenza fu la crescita di uomini e donne dipendenti, che pensavano di essere virtuosi, affidando la navigazione della coscienza e dell’intelligenza ad altri. La libertà fa paura a chi sogna un potere assoluto.
Meglio avere vassalli obbedienti, accoliti del nulla, esecutori plaudenti, meglio una massa pilotabile e acclamante che un popolo maturo di pensanti e resistenti. E, confessiamolo, non sempre abbiamo avuto e abbiamo occhi e vigilanza per questo esproprio strisciante della libertà. Le lusinghe del potere sono altamente seduttive. A tal punto la loro fascinazione che a volte neppure ci si accorge che per un pugno di vantaggi si è sul punto di vendere la libertà. Con esiti di raccapriccio, perché un popolo della dipendenza non può che prefigurare panorami di disgusto.
Non è forse vero che nei giorni di fame, di sete, di stanchezza nel deserto era accaduto agli israeliti, sfuggiti al giogo del faraone, di rimpiangere le pentole della carne e le cipolle d’Egitto? Come se vendere la libertà non costituisse baratto di cecità e di mostruosa insipienza.
La lusinga accompagnò nei secoli futuri il popolo di Dio, che si illuse, succede anche oggi, che rimedio ai problemi cruciali del tempo fosse l’entrata in scena dell’uomo forte, l’uomo della provvidenza. Così gli israeliti pretesero da Dio un re. Ma non erano forse usciti i loro padri dall’Egitto, per sfuggire a una sottomissione? Alla sottomissione a un re, il faraone, che si era fatto come Dio, Dio in terra?
Ebbene Dio rispettò la decisione, ma attraverso le parole del vecchio Samuele mostrò quali sarebbero stati i costi di questa scelta, svelando ciò che sarebbe avvenuto in futuro.
 Il futuro della concentrazione del potere in uno solo sarebbe stato l’abuso e lo sfruttamento. Li mise sull’avviso: il re, il capo assoluto, avrebbe preso i loro figli per l’esercito; avrebbe preso le loro figlie per il suo harem; avrebbe preso i loro campi, le loro vigne, i loro oliveti più belli, e li avrebbe dati ai suoi ministri, avrebbe preso mano d’opera e bestiame, li avrebbe adoperati per i lavori in casa sua e dei suoi cortigiani.
Il futuro della concentrazione del potere in uno solo sarebbe stato l’abuso e lo sfruttamento. Li mise sull’avviso: il re, il capo assoluto, avrebbe preso i loro figli per l’esercito; avrebbe preso le loro figlie per il suo harem; avrebbe preso i loro campi, le loro vigne, i loro oliveti più belli, e li avrebbe dati ai suoi ministri, avrebbe preso mano d’opera e bestiame, li avrebbe adoperati per i lavori in casa sua e dei suoi cortigiani.Sembra di leggere una pagina dei nostri tempi, una descrizione impietosa dei meccanismi e degli esiti di un potere che si arroga il diritto di essere assoluto, assoluto e insindacabile, e piega tutto e tutti ai suoi interessi. La Bibbia conosce questa facile perversione del potere, ed è estremamente critica. La lusinga, dobbiamo riconoscerlo, accompagnò e ancora oggi accompagna, il popolo dei credenti.
Voci di Padri antichi, voci di vigilanti, già nei primi secoli, mettevano in guardia dall’esproprio strisciante e sottile della libertà ad opera di atei devoti. Una delle voci lucide, quella di Ilario di Poitiers, scriveva:
 "Combattiamo contro un persecutore insidioso, un nemico che lusinga: non ci flagella la schiena, ma ci accarezza il ventre; non ci confisca i beni per la vita ma ci arricchisce per la morte; non ci sospinge col carcere verso la libertà ma ci riempie di incarichi nella sua reggia per la servitù: non spossa i nostri fianchi ma si impadronisce del cuore; non taglia la testacon la spada ma uccide l’anima con il denaro; non minaccia di bruciare pubblicamente, ma accende la geenna privatamente. Non combatte per non essere vinto, ma lusinga per dominare; confessa il Cristo per rinnegarlo; favorisce l’unità per impedire la pace; reprime le eresie per sopprimere i cristiani; carica di onori i sacerdoti [...] costruisce le chiese per distruggere la fede. Ti porta in giro a parole, con la bocca [...]".
"Combattiamo contro un persecutore insidioso, un nemico che lusinga: non ci flagella la schiena, ma ci accarezza il ventre; non ci confisca i beni per la vita ma ci arricchisce per la morte; non ci sospinge col carcere verso la libertà ma ci riempie di incarichi nella sua reggia per la servitù: non spossa i nostri fianchi ma si impadronisce del cuore; non taglia la testacon la spada ma uccide l’anima con il denaro; non minaccia di bruciare pubblicamente, ma accende la geenna privatamente. Non combatte per non essere vinto, ma lusinga per dominare; confessa il Cristo per rinnegarlo; favorisce l’unità per impedire la pace; reprime le eresie per sopprimere i cristiani; carica di onori i sacerdoti [...] costruisce le chiese per distruggere la fede. Ti porta in giro a parole, con la bocca [...]".Così Ilario di Poitiers, grande padre della Chiesa. Parole che ci chiamano con forza alla vigilanza, non solo fuori ma anche dentro le Chiese. Non è forse vero che troppo disinvoltamente e presuntuosamente ci definiamo donne e uomini liberi? Ricordate quel gruppo di dirigenti Giudei che a Gesù obiettano: "Come puoi dire: sarete liberi? Noi non siamo schiavi di nessuno".
Anni fa mi capitò di leggere, tra gli aforismi di Luigi Erba, uno che registrava con sottile disincanto la situazione della nostra libertà, scriveva: "Si parla di società permissiva e si inventa un’illusione. In realtà si vive in una selva di divieti e di costrizioni. Molte libertà si conquistano solo con i privilegi e i privilegi si ottengono con la violenza. I privilegi sono di pochi potenti e, a discendere, dei loro portatori d’acqua con le orecchie. Un gran numero di formiche, lavorano per pochi e le poche cicale pretendono che le formiche cantino per intrattenerle". Un pessimismo forse in eccesso, ma non totalmente ingiustificato.
Può succedere purtroppo che perfino all’interno degli spazi ecclesiali a volte la sensazione sia di vivere in un regime di libertà vigilata. Succede quando la libertà viene evocata più per mettere in guardia dalle sue possibili derive che per annunciarne la bellezza e la forza, bellezza e forza di un messaggio che trascina, fa alzare il capo e sprigiona vento di insurrezione, di indipendenza dai mille faraoni che pretendono sudditi devoti. Ci accomuna una vocazione, quella ad essere donne e uomini liberi. Sì, una vocazione. Di tutti. Come dirà Paolo nella lettera ai Galati: "Voi, fratelli, siete stati chiamati a libertà" (Gal 5,13).E ancora: "Cristo ci ha liberati per una vita di libertà" (Gal 5,1).
e la nostra immagine?
Mi chiedo se quando entriamo negli spazi del vivere quotidiano, nel confronto con le donne e gli uomini del nostro tempo, l’immagine che diamo sia quella della libertà dello Spirito o quella di coloro che sono preoccupati di porre paletti o di disegnare recinti. Diamo una notizia buona?
Mi suonano lontane, quanto lontane, le parole che Paolo VI - e volevano essere parole profetiche - pronunciò in un’udienza generale, il 9 luglio 19 69 . Diceva: -"Il nostro tempo di cui il Concilio si fa interprete e guida, reclama libertà. Avremo un periodo nella vita della Chiesa, perciò nella vita di ogni figlio della Chiesa, di maggiore libertà, cioè di minori obbligazioni legali e minori inibizioni interiori. Sarà ridotta la disciplina formale, abolita ogni arbitraria intolleranza, ogni assolutismo, sarà semplificata la legge positiva, temperato l’esercizio dell’autorità, sarà promosso il senso di quella libertà cristiana che tanto interessò la prima generazione cristiana, quando si seppe esonerata dalla legge mosaica e dalle sue complicate prescrizioni rituali".
Commentava Enzo Bianchi: "Sono parole di un Papa, del Papa che ha chiuso il Concilio. Oggi ci paiono distanti e quasi non più ripetibili senza destare sospetti, nella nuova situazione ecclesiale che si è delineata. Sono parole di cui occorre fare memoria". Da fissare a memoria con le parole di Paolo: "Cristo ci ha liberati perché restassimo liberi; state dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù" (Gal 5 ,1). Da niente e da nessuno. E sia vento di libertà sui nostri volti smunti
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- DENARO E PARADISO. I cattolici e l’economia globale. Il Papa riceve il presidente dello Ior.26 settembre 2010, di Federico La Sala
DENARO E PARADISO: AGLI INIZI DEL MODERNO - A BOLOGNA, NEL 1257, IL DENARO SERVIVA PER RESTITUIRE LA LIBERTA’ AI SERVI E ALLE SERVE DELLA GLEBA, OGGI A ROMA SERVE PER ASSERVIRE BAMBINI E BAMBINE, UOMINI E DONNE LIBERE. Cfr.:
 VATICANO
VATICANO
 Il Papa riceve il presidente dello Ior
Il Papa riceve il presidente dello Ior
 "Attestazione di stima e di fiducia"
"Attestazione di stima e di fiducia"Fonti della Santa Sede riferiscono di un "incontro al baciamano, davanti a molti testimoni", e lo definiscono "un modo per sottolineare pubblicamente la vicinanza e il sostegno del Pontefice". Gotti Tedeschi -insieme al direttore dello Io, Cipriani- è indagato dalla Procura di Roma per omissioni legate alla normativa anti-riciclaggio
CITTA’ DEL VATICANO - Viene interpretato dai più in Vaticano come una "evidente attestazione di stima e fiducia" da parte del Papa per il presidente dello Ior Ettore Gotti Tedeschi 1, in questi giorni sotto inchiesta 2, il breve incontro che i due hanno avuto questa mattina. "L’incontro al baciamano, davanti a molti testimoni - osservano fonti riservate - è stato chiaramente un modo per sottolineare pubblicamente, a soli cinque giorni dalla notizia dell’indagine avviata dalla Procura di Roma, la vicinanza e il sostegno da parte del Pontefice all’economista e banchiere scelto pochi mesi fa per guidare l’Istituto Opere religiose 3 in un percorso di totale e irreversibile trasparenza".
Benedetto XVI ha ricevuto Gotti Tedeschi dopo la preghiera dell’Angelus a Castelgandolfo. L’economista era accompagnato dalla moglie e ha presentato al Pontefice il libro Denaro e paradiso. I cattolici e l’economia globale, da lui scritto con Rino Cammilleri con una prefazione del segratario di Stato, cardinale Tarcisio Bertone.
Il presidente dello Ior e il direttore, Paolo Cipriani, massimi responsabili della banca vaticana, sono indagati dalla Procura di Roma per omissioni legate alla normativa antiriciclaggio. A loro si contesta di non aver fornito indicazione sulla tipologia di due movimentazioni di danaro, 20 milioni di euro destinati all’istituto di credito tedesco J.P. Morgan Frankfurt e 3 milioni alla Banca del Fucino, depositato in un conto presso la sede romana del Credito Agricolo.
In sostanza, lo Ior non avrebbe comunicato per conto di chi (ossia se in proprio o per terzi) avrebbe disposto il trasferimento di quelle somme. Ciò, in base ad una normativa antiriciclaggio del 2007, configura una violazione. Sulla vicenda, sono stati ascoltati alcuni esponenti del Credito Artigiano la cui segnalazione ha messo in moto l’Unità di informazione finanziaria (Uif), con la sospensione delle operazioni, definite "sospette", per cinque giorni, e successivamente la Procura della repubblica.
Gotti Tedeschi "è tranquillissimo", riferiscono le stesse fonti, e "attende serenamente di essere ascoltato in Procura", il che accadrà "entro la settimana".
* la Repubblica, 26 settembre 2010
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- Un paese in ginocchio (di Moni Ovadia)25 settembre 2010, di Federico La Sala
Un paese in ginocchio
di Moni Ovadia (l’Unità, 25.09.2010)
L’immagine dell’Italia trasmessa dai media, per una persona per bene di buon senso, è raccapricciante. Lo squallore della sua politica ha sfondato ogni soglia della decenza. Il governo si da con maniacale accanimento alla distruzione delle fondamenta dello stato democratico con lo strumento della demagogia populista più vieta, dell’intorbidamento delle acque per cancellare le differenze fra il giusto e l’ingiusto, fra la legalità e il crimine.
Con questa tecnica antica e oscena vengono demoliti a colpi di mazza i pilastri dell’intera società: i principi costituzionali, la scuola pubblica, la cultura, i fondamenti morali, i diritti civili e i diritti sociali. L’opposizione parlamentare, con rare eccezioni, sembra - anche ad ad un osservatore non particolarmente smaliziato - assistere allo scempio pavida, divisa, balbettante, capziosa, arrogante e stonata. È difficile non pensare che l’unica sua cura sia la propria autoconservazione.
Quanto alla «sinistra fuori dal parlamento» si è virtualizzata. Se non fosse per la coraggiosa Fiom, per un leader carismatico capace di guardare il futuro e per qualche sparuta testa pensante potrebbe bene figurare in un film di Moretti come associazione di reduci.
Spero con tutto il cuore di essere una cattiva Cassandra ma, sulla soglia dell’età della pensione, non riesco ad impedirmi di pensare che si tratti della bancarotta di quasi un’intera classe dirigente che ha sacrificato il benessere di un paese ai piedi di un grottesco omino, aspirante sovrano, truccato come un clown sinistro e sull’altare del cinismo e del conformismo. In questo sfacelo riesco a trarre conforto da quelle donne e quegli uomini dell’Italia reale che continuano a vivere, a lavorare e a lottare secondo i principi della dignità e della giustizia. Grazie a loro sento che essere italiano non è solo una iattura.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- STATO E CHIESA: L’ERRORE DI PROCEDURA DELLO IOR E LA MILLENARIA "FALLACIA ACCIDENTIS" DELLA MONARCHIA DI PAPA RATZINGER. Un’intevista a Gotti Tedeschi (di Andrea Tornielli) e una lezione dalla "Monarchia" di Dante Alighieri.24 settembre 2010, di Federico La Sala
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- STATO E CHIESA. Sconto Ici alla Chiesa la Ue processa l’Italia. Esenzioni fiscali per due miliardi l’anno. Bruxelles accelera: "Sono aiuti di Stato" (di Alberto D’Argenio).24 settembre 2010, di Federico La Sala
Sconto Ici alla Chiesa la Ue processa l’Italia
Esenzioni per due miliardi l’anno. Bruxelles accelera: "Sono aiuti di Stato". Se l’Italia sarà condannata, dovrà chiedere il rimborso delle tasse non pagate La Chiesa ha un patrimonio di circa 100mila fabbricati
dal nostro inviato ALBERTO D’ARGENIO *
BRUXELLES - Le esenzioni fiscali concesse alla Chiesa costano allo Stato italiano un’indagine formale dell’Ue per aiuti di Stato incompatibili con le norme sulla concorrenza. Dopo quattro anni di scambi di informazioni, due archiviazioni e una serie di controricorsi, Bruxelles mette in moto "un’indagine approfondita" sui privilegi fiscali attribuiti agli enti ecclesiastici in settori in cui "l’azienda Chiesa" (conta circa 100 mila fabbricati) è leader nazionale: ospedali, scuole private, alberghi e altre strutture commerciali che godono di un’esenzione totale dal pagamento dell’Ici e del 50% da quello sull’Ires. Con un risparmio annuo che si avvicina ai due miliardi di euro e conseguenti vantaggi competitivi rispetto ai concorrenti laici.
La procedura per aiuti di Stato sarà aperta a metà ottobre dalla Commissione europea. La decisione è già stata scritta e al momento è soggetta alle ultime limature. Nell’introduzione del documento redatto dal commissario alla Concorrenza Joaquin Almunia si legge: "Alla luce delle informazioni a disposizione la Commissione non può escludere che le misure costituiscano un aiuto di Stato e decide quindi di indagare oltre". In poche parole, da scambi di informazioni informali il dossier diventa ufficiale e fa scattare quella procedura di 18 mesi al termine della quale la Ue dovrà emettere un verdetto.
La procedura contro lo Stato italiano si articolerà su tre fronti: sotto accusa verranno subito messi il mancato pagamento dell’Ici e l’articolo 149 (4 comma) del Testo unico delle imposte sui redditi che conferisce a vita la qualifica di enti non commerciali a quelli ecclesiastici (non svolgete un’attività di impresa a prescindere e quindi pagate meno tasse). Il terzo filone riguarda lo sconto del 50% dell’Ires concesso agli enti della Chiesa che operano nella sanità e nell’istruzione: prenderà la forma di una richiesta di informazioni approfondita essendo risalente agli anni ’50, prima della nascita della Cee.
L’esenzione totale dall’Ici è stata introdotta nel dicembre 2005, in campagna elettorale, dal governo Berlusconi e quindi rivista da quello Prodi (2006) che messo sotto pressione dalla Ue aveva ristretto i privilegi solo alle attività "non esclusivamente commerciali". Intervento aggirato da ospedali o scuole che al loro interno hanno una piccola cappella. Le norme erano state portate a Bruxelles da una denuncia promossa dal radicale Maurizio Turco e del fiscalista Carlo Pontesilli (segretario di anticlericale. net) assistiti dall’avvocato Alessandro Nucara. L’allora commissaria Neelie Kroes aveva però archiviato due volte il caso e a Bruxelles in molti raccontano le fortissime pressioni ricevute da entrambe le sponde del Tevere. Di fronte all’ennesima archiviazione i denuncianti si sono rivolti alla Corte di giustizia e i legali di Bruxelles hanno convinto Almunia ad aprire la scomoda procedura (andare contro il Vaticano e un Paese fondatore non è mai consigliato) per evitare una condanna per inazione da parte dei giudici del Lussemburgo.
Condanna difficile da scampare leggendo le "conclusioni preliminari" contenute nel documento dello stesso Almunia: l’esistenza dell’aiuto di Stato è resa chiara dal "minor gettito per l’erario" e la norma viola la concorrenza in quanto i beneficiari degli sconti Ici "sembrano" essere in concorrenza con altri operatori nel settore turistico-alberghiero e della sanità. Insomma, le condizioni dell’esistenza dell’aiuto e della sua incompatibilità con le norme Ue "sembrano essere soddisfatte". Analisi curiosamente opposta a quella contenuta nelle due precedenti archiviazioni (2008 e 2010) quando non c’erano timori di una sconfessione da parte della Corte. Con l’apertura dell’indagine formale le parti avranno un mese per presentare le proprie ragioni. Quindi entro 18 mesi Bruxelles dovrà decidere se assolvere o condannare l’Italia, con conseguente fine dei privilegi e inevitabile rimborso all’erario delle tasse non pagate dagli enti ecclesiastici.
* la Repubblica, 24 settembre 2010
-
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- Da Porta Pia ai nuovi banchieri di Dio. Le vie dello Ior sono infinite.22 settembre 2010, di Federico La Sala
 Da Porta Pia ai nuovi banchieri di Dio
Da Porta Pia ai nuovi banchieri di Dio
 Le vie dello Ior sono infinite
Le vie dello Ior sono infinitedi Nicola Tranfaglia (l’Unità, 21.09.2010)
Lo Ior ritorna di attualità, e non a caso. Leggiamo la notizia battuta ieri dall’Ansa: «Ettore Gotti Tedeschi, presidente dell’Istituto Opere di Religione del Vaticano e un altro importante dirigente della stessa banca vaticana, sono indagati dalla Procura della Repubblica di Roma per violazione del decreto legislativo 231 del 2007 che è la normativa di attuazione della direttiva dell’Unione Europea sulla prevenzione del riciclaggio». È stato inoltre eseguito il sequestro preventivo di 23 milioni di euro (su 28 complessivi) dell’Istituto che si trovavano su un conto corrente aperto su un conto corrente aperto presso la sede romana del Credito Artigiano spa. Il sequestro, precisa la Procura di Roma, non è stato disposto perché esiste una prova di riciclaggio ma perché, secondo gli inquirenti, è stato già commesso il reato omissivo della norma antiriciclaggio.
Fin qui la cronaca. Ma se si va oltre si scopre subito che da due anni sono in corso accertamenti su una decina di istituti di credito che sono in rapporto con lo Ior e che scambiano operazioni tra loro e con l’Istituto di Religione Vaticano per centinaia di milioni di euro. E si apprende anche che controlli finanziari compiuti dalla Guardia di Finanza in questi ultimi anni si sono trovati di fronte alla difficoltà di identificare i beneficiari degli scambi o di verificare che quando la magistratura ha chiesto nomi e cognomi, ha verificato che quelli forniti non hanno retto alla verifica tanto da suscitare il sospetto che fossero fittizi e non corrispondenti alla realtà.
Ora, per chi ricorda i casi clamorosi che hanno portato alla luce della scena pubblica l’Istituto vaticano e hanno rivelato i rapporti che c’erano stati negli anni Ottanta con Michele Sindona, Roberto Calvi e con la P2 e che si erano conclusi con la messa fuori legge della loggia di Licio Gelli e l’inchiesta parlamentare voluta dal governo Spadolini terminata con relazioni di maggioranza e di minoranza, diverse tra loro ma tutte persuase dell’illiceità delle operazioni condotte dai “banchieri di Dio”, si guarda con un certo timore a quello che sta emergendo dalla nuova inchiesta giudiziaria.
Tutto questo avviene dopo la grottesca cerimonia di domenica per i 140 anni della breccia di Porta Pia che ha visto protagonista il cardinal Bertone, segretario di Stato vaticano e grande amico del presidente dello Ior Gotti Tedeschi. Una cerimonia grottesca perché, in nome di una ennesima riconciliazione tra lo Stato e la Chiesa, si è dimenticato il significato storico della conquista di Roma da parte dello Stato liberale per farne la capitale proprio in opposizione a quel potere temporale dei Papi che sembra proprio ora essere risorto nell’Italia governata da Silvio Berlusconi e dal suo populismo autoritario.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- STATO E CHIESA: PORTA PIA, FESTA GROTTESCA.21 settembre 2010, di Federico La Sala
Porta Pia, festa grottesca
La commistione tra autorità civili e religiose assomiglia al tentativo di far commemorare gli antifascisti da quelli che erano stati, negli anni ’30 e ’40, alleati con i loro nemici
di Nicola Tranfaglia (il Fatto, 21.09.2010)
Erano le cinque e un quarto del mattino quando il 20 settembre l’artiglieria italiana sparò i primi due colpi di cannone contro le mura di Roma all’altezza di Porta Maggiore e Porta Pia. La resa avvenne verso le undici del mattino dopo che Pio IX ha ordinato ai pontifici di presentare la bandiera bianca. I morti tra i bersaglieri sono 49, tra i pontifici 19. Pio IX, riuniti i diplomatici presso lo Stato Pontificio, definisce l’assalto “un attentato sacrilego” e dovranno passare altri cinquantanove anni prima che Mussolini e Pio XI firmino il Trattato del Laterano e i Patti annessi.
La pace tra Stato e Chiesa
DA QUEL MOMENTO regna, per così dire, la pace tra Stato e Chiesa ma la dittatura fascista lo ha fatto per avere la Chiesa dalla sua parte e non certo per realizzare la formula di Camillo Benso, conte di Cavour, che in anni lontani aveva detto: “Libera Chiesa in libero Stato.” E il Vaticano, a sua volta, ha ottenuto dallo Stato quel che non aveva mai avuto dalla classe dirigente liberale sul piano economico come su quello politico. Ed oggi, nel Ventunesimo secolo dopo che nel 1988 è stato rinnovato con qualche modifica il Concordato del 1929 e la Chiesa cattolica ha messo sull’attenti gran parte della classe politica, di governo e di opposizione, si può dire che la celebrazione del 1870 avviene nelle migliori condizioni possibili per la Santa Sede. Roma diventa Capitale con la legge appena approvata e il sindaco Alemanno che, da fascista che era è diventato un berlusconiano fervente, può celebrare oggi i centoquarant’anni della Breccia di Porta Pia non soltanto con il capo dello Stato ma anche con il cardinale segretario di Stato Tarcisio Bertone, come se la Chiesa fosse stata anch’essa dalla parte dell’Italia appena unificata piuttosto che contro a rispondere con le cannonate ai bersaglieri che premevano dal di fuori.
Ed è questo il centro della giornata di ieri e il significato che le autorità locali e centrali intendono fornire agli italiani, dimenticando quello che davvero l’arrivo dei bersaglieri aveva significato in quel mattino del 20 settembre 1870.
Non è un caso che oltre cinquanta tra associazioni, movimenti e forze politiche hanno deciso di festeggiare domenica la ricorrenza per non mischiarsi alle celebrazioni ufficiali. Ma se si guarda all’imponente serie di manifestazioni e di occasioni di visite e di mostre previste in questi giorni non si capisce davvero come Stato e Chiesa possano festeggiare insieme un avvenimento così limpido e chiaro.
L’Italia liberale del Risorgimento, dopo meno di dieci anni dall’unificazione nazionale, aveva deciso di scegliere Roma come sua Capitale e approfittando di un atteggiamento non negativo di due grandi potenze del tempo come la Francia e l’Inghilterra aveva mandato una spedizione ufficiale di soldati e di bersaglieri per entrare a Roma e far finire il Potere temporale dei Pontefici. E questo significato di fondo non si può rovesciare, celebrando la ricorrenza con la Santa Sede e con quel cardinale Bertone, segretario di Stato, che quando divenne vescovo di Genova si preoccupò immediatamente di chiudere gli archivi della diocesi per impedire che gli storici facessero luce sul ruolo del Vaticano nella fuga in Sudamerica dei criminali nazisti che si trovavano in Italia o che erano appena arrivati dalla Germania. Un amico mi ha detto, in questi giorni, che la commistione tra le autorità civili e religiose assomiglia al tentativo di far commemorare gli antifascisti da quelli che erano stati, negli anni Trenta e Quaranta, alleati con i loro nemici.
E si potrebbe dire ancora molto di peggio di fronte a questo spettacolo. A differenza dei francesi, noi non abbiamo nella nostra Costituzione all’inizio un articolo dedicato alla laicità dello Stato ma in vari punti del dettato costituzionale emerge con chiarezza il profilo laico della nostra democrazia parlamentare che riguarda i credenti come i non credenti e che dovrebbe spingere tutte le forze politiche, a cominciare da quelle di centrosinistra, a difendere il significato della Breccia di Porta Pia e la difesa della formula cavouriana. Nella cosiddetta “Prima Repubblica”, e soprattutto da parte di chi aveva partecipato ai lavori dell’Assemblea Costituente, anche tra cattolici come Aldo Moro era centrale la rivendicazione della laicità dello Stato come elemento fondamentale dell’attività politica e istituzionale.
Oggi, soprattutto dopo l’89 e la caduta delle grandi ideologie che avevano diviso il mondo negli anni della Guerra fredda, le classi dirigenti italiane e in particolare quelle più vicine e legate alla classe politica, sembrano aver perduto il senso delle distinzioni tra una sfera laica e una sfera religiosa. La destra berlusconiana, così priva di valori etici e politici, ha bisogno dell’appoggio del Vaticano e il papa attuale non ha avuto difficoltà fino a ieri ad appoggiarne l’azione di governo.
La sinistra e il Vaticano
QUANTO alla sinistra, la fine del comunismo ha favorito l’avvicinamento degli ex comunisti al Vaticano e ormai da anni essi si confondono con gli altri esponenti politici devoti alla Chiesa. Pochi di fatto - e noi dell’Italia dei Valori siamo tra questi - ritengono che, al di là della fede cattolica di ciascuno, che sia necessario sostenere con chiarezza una posizione che si riallacci a quella liberale e democratica dell’Ottocento ma anche del Novecento e del nuovo secolo: la parità di tutte le fedi religiose, la difesa della sfera politica dalle intromissioni della Chiesa e delle Chiese. E proprio questa incertezza della politica e il suo degrado evidente conducono alla situazione di oggi che è nello stesso tempo grottesca e paradossale: si vuol ricordare la Breccia di Porta Pia e lo si fa con il sindaco fascista berlusconiano e con il segretario di Stato del Vaticano.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- LEGGE ELETTORALE ("PORCELLUM") E PROSTITUZIONE: ANGELA NAPOLI LANCIA L’ALLARME.8 settembre 2010, di Federico La Sala
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- dal 2006 sventola sul Vaticano, il "logo" del grande mercante, e solo ora "Pax Christi Italia" - grazie a Gheddafi - comincia a dire "No all’idolatria del dio interesse3 settembre 2010, di Federico La Sala
No all’idolatria del dio interesse
di Pax Christi Italia
 in “www.peacelink.it/paxchristi/a/32309.html” del 2 settembre 2010
in “www.peacelink.it/paxchristi/a/32309.html” del 2 settembre 2010 Comunicato Stampa
Comunicato StampaPax Christi Italia esprime grande preoccupazione per quanto accaduto e ascoltato in questi giorni, in occasione della visita di Gheddafi a Roma: una celebrazione pagana colma di idolatria nei confronti di un dio che ha un nome che tutti hanno pronunciato: interessi. Un dio che non si cura della dignità delle persone e dei diritti fondamentali di ogni uomo o donna.
In nome dell’interesse economico, tutti hanno celebrato festosamente e trionfalmente una "liturgia di morte" respingendo con arroganza alcune critiche mosse da più parti. Presidente del Consiglio, rappresentanti del Governo, Ministri... tutti hanno voluto celebrare l’importanza della firma di accordi economici con il dittatore libico.
Anche la Lega, così orgogliosa nel difendere le radici cristiane dell’Italia, si è limitata a qualche borbottio, specificando però che “se si riesce a fare i nostri interessi, allora ci può stare tutto”.
Solo qualche parola di imbarazzo per le esternazioni del colonnello libico sull’invito alla conversione all’Islam, sulle sue prediche a centinaia di hostess. Quasi nulla sui diritti umani violati in Libia, sulla tragica sorte delle vittime dei respingimenti, su chi muore nel deserto o nelle prigioni libiche. Il dio interesse è un dio assoluto, totalitario, a cui tutto va immolato. Anche a costo di imprigionare innocenti, torturarli, privarli di ogni diritto, purché accada lontano da qui. In Libia.
Come cristiani dobbiamo però anche sottolineare un aspetto passato pericolosamente inosservato.
Abbiamo assistito a molti richiami religiosi, addirittura all’invito alla conversione da parte di un colonnello dittatore a fronte del richiamo costante ai "nostri" valori cristiani da parte di tutti i rappresentanti del Governo.
Da quando la fede delle persone viene decisa dai capi politici? Non è incredibile che debba essere un dittatore a decidere che l’Islam sia religione anche per l’Europa? O che debba essere un partito a proclamare l’Europa cristiana?
Per noi la fede può essere solo un cammino, una scelta libera, l’incontro con il Dio della vita, dell’amore, della pace. Frutto di una ricerca che parte dal cuore e dalla coscienza. Per noi cristiani, questo Dio si è fatto uomo e ci ricorda che ci verrà chiesto se lo abbiamo riconosciuto in chi ha fame, sete, in chi è malato o in carcere, in chi è straniero (Mt 25).
Non si può tornare ai secoli in cui si affermava “cuius regio eius religio?” (cioè l’obbligo del suddito di conformarsi alla confessione religiosa del principe del suo stato). Per noi la libertà religiosa, tema della prossima Giornata mondiale della pace, è strettamente collegata alle questioni della democrazia, della giustizia e della solidarietà per la cui realizzazione intendiamo operare.
In ogni caso, non è possibile tacere davanti allo spettacolo indecoroso dei giorni scorsi. Saremmo complici. Ricordiamo quanto don Tonino Bello amava dire: “delle nostre parole dobbiamo rendere conto agli uomini. Ma dei nostri silenzi dobbiamo rendere conto a Dio!”
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- Le bestie ci scrivono. Dura reazione degli animali all’accusa di essere i responsabili dell’omicidio del sindaco di Pollica (di Giovanni Sarubbi).12 settembre 2010, di Federico La Sala
Le bestie ci scrivonoDura reazione degli animali all’accusa di essere i responsabili dell’omicidio del sindaco di Pollica.
di Giovanni Sarubbi *
«Protestiamo, protestiamo vivamente per le parole di Rocco Favale, vescovo di Vallo della Lucania, al funerale di Angelo Vassallo sindaco di Pollica, in provincia di Salerno, ucciso la scorsa settimana. Noi animali, noi bestie, come ha detto il vescovo, non siamo responsabili di quell’omicidio.
E’ noto a tutti, infatti, che nessuna bestia usa automobili, tuttalpiù ne siamo uccisi quando, noi cani o gatti, veniamo abbandonati dai nostri padroni sulle autostrade. E’ noto ancora che nessuna bestia usa armi da fuoco che sono una invenzione tutta umana.
Quell’omicidio lo avete fatto voi umani. Lo avete fatto per soldi, freddamente, come se fosse una cosa del tutto normale. Solo voi siete capaci di uccidere a sangue freddo, senza provare alcuna emozione, e senza la necessità di dover soddisfare i morsi della fame come succede a quelle bestie che fra noi sono carnivore e lo sono non per propria scelta.
Nessuna bestia carnivora si sognerebbe mai di uccidere come uccidete voi umani. Nessuna bestia si sognerebbe di uccidere, per esempio, milioni di bisonti o di pinguini o di foche o di quelli che voi chiamate animali da pelliccia, solo per procurarsi la loro pelle per vestire quelle che voi umani chiamate “le nostre donne”, come se fosse possibile che qualcuno possa essere di proprietà di qualcun altro. Nessun animale predatore va a caccia per divertimento, come fate voi, a uccidere con armi potenti piccoli uccelletti indifesi che non fanno nulla di male ma che anzi allietano l’ambiente con i loro canti. Solo per voi la caccia è uno sport, solo fra voi umani c’è chi si inebria a vedere le persone combattere e uccidere.
Fra le nostre bestie carnivore non ci sono i serial killer come fra voi umani, che uccidono per il gusto di uccidere, si perché fra voi c’è chi prova gusto ad uccidere, chi si esalta nell’uccidere esseri indifesi. Gli animali che fra noi sono carnivori e uccidono altri animali lo fanno solo per sfamarsi e neppure tutti i giorni.
Fra voi umani i morti ammazzati ogni giorno e ad ogni ora non si contano. Secondo le vostre stesse statistiche ogni minuto nel mondo c’è qualcuno che viene ucciso da un’arma da fuoco. E chi produce quelle armi e quei proiettili non prova il minimo rimorso per quello che ha fatto e non si sente minimamente responsabile di quelle morti. Tranquilli padri e madri di famiglia producono armi durante la settimana e poi la domenica vanno a messa a sentire le prediche di vescovi come quello di Vallo della Lucania.
Siete così attivi nel campo degli omicidi che avete inventato persino un’attività redditizia, la guerra, attraverso la quale qualcuno di voi accumula ricchezze su ricchezze, tutte sporche di sangue umano, ma anche di quello di noi poveri animali o bestie, come preferisce chiamarci il vescovo di Vallo della Lucania, quando ci troviamo coinvolte nostro malgrado nei vostri combattimenti.
Avete costruito eserciti immensi, istruendo le persone a combattere e ad uccidere e armamenti di distruzione di massa, bombe atomiche a migliaia, armi chimiche e batteriologiche in migliaia di tonnellate, armi ad alta energia, armi all’uranio cosiddetto impoverito e le avete usate come si può usare un dentifricio per lavarsi i denti, incuranti delle distruzioni, dei morti e dell’inquinamento che esse provocavano. Avete bombardato Hiroshima e Nagasaki, avete usato i vostri agenti chimici nella guerra del Vietnam o nelle vostre guerre coloniali in Africa contro il popolo nero o in Asia contro quello giallo, avete compiuto qualche migliaio di esperimenti nucleari, giusto per provare le vostre bombe e per terrorizzare tutta la Terra o per dimostrare al vostro dio di essere pienamente liberi e padroni di voi stessi e della Terra. Avete fatto dell’uccidere un’arte con le sue regole che quasi sempre fra l’altro neppure rispettate.
E uccidete per soldi, per accumulare ricchezze, per poter avere ville lussuose, macchine di lusso, cibi succulenti, femmine o maschi a volontà per soddisfare la vostra libidine sessuale, per avere potere sulla vita e sulla morte di altri esseri umani come voi. A noi bestie neppure ci considerate. Ci usate solo per coprire i vostri crimini.
E per arricchirvi non esitate non solo ad uccidere altri essere umani come voi e anche animali, giusto per non perdere l’abitudine, ma anche la Terra che ci ospita. Non esitate a scaricare i veleni delle vostre industrie di prodotti inutili nei mari, nei fiumi, nei laghi, nell’atmosfera e tutto ciò lo chiamate progresso.
Vescovi come quello di Vallo della Lucania, che ci ha accusato di un omicidio che noi non possiamo avere commesso, hanno benedetto le armi, i soldati e le guerre che si sono combattute o che ancora si stanno combattendo in giro per il mondo. Siete arrivati persino a benedire, nel nome del vostro dio, le bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki che hanno fatto 200mila morti in un sol colpo.
Il vescovo di Vallo della Lucania ha definito bestie gli assassini di Angelo Vassallo. Ma si tratta di uomini che fra loro si chiamano “uomini d’onore”, che fanno parte di organizzazioni che voi stessi definite criminali e che vanno sotto il nome di mafia, camorra e ndrangheta.
Vescovi come quello di Vallo della Lucania hanno benedetto queste bande di delinquenti, hanno benedetto i loro matrimoni, hanno amministrato i loro battesimi, facendo finta di non vedere le pistole che il padrino regalava ai battezzandi, o di non sapere come egli si guadagnasse da vivere. Li avete accolti nelle vostre chiese in pompa magna e avete consentito loro di fregiarsi dei nomi di persone che voi avete definito santi e ora li chiamate bestie?
No, fanno parte del genere umano, quello che voi vi ostinate a chiamare “homo sapiens sapiens”. Nessuna bestia si sarebbe mai permesso di inquinare irrimediabilmente il Golfo del Messico, di far fondere i ghiacciai del polo nord e del polo sud a causa dell’uso sfrenato delle risorse della Terra che voi state mettendo in atto. Nessuna bestia si permetterebbe mai di bruciare migliaia di ettari di bosco solo per il gusto di vedere le fiamme o perché ci guadagna qualcosa o per mantenere il proprio posto di lavoro di addetto agli spegnimenti degli incendi boschivi. Nessuna bestia si permetterebbe di sfruttare altre bestie per conseguire vantaggi economici e politici come voi fate. Nessuna bestia guadagna quattro e più milioni di euro all’anno o al giorno ma è ancora insoddisfatto e ne vuole ancora di più e per ottenerlo non si fa scrupoli e chiede sacrifici su sacrifici a chi da lui dipende e che lui ritiene di possedere. Nessuna bestia produrrebbe droga, o utilizzerebbe mai la pubblicità per in stupidire milioni di esseri umani per indurle a comprare cose inutili e dannose e per spingerli alla guerra. Nessuna bestia utilizzerebbe mai alcun dio come fate voi per sostenere le vostre azioni criminali.
E noi saremmo le bestie? Ma perché, signor Vescovo, parlate così solo quando qualche persona onesta viene uccisa?»
Fin qui la lettera che mi ha dettato il cane che ho in casa a nome di tutti gli animali della Terra e che io ho semplicemente trascritto per farla conoscere a tutti gli esseri umani che non riescono a parlare più non solo con gli animali e tutti gli altri esseri viventi ma neppure fra di loro, impegnati come sono a fare soldi, a competere fra di loro, cioè a uccidersi a vicenda con le armi o con i guanti bianchi. Si perché anche quelli che stanno nei luoghi del potere politico economico uccidono. Non lo fanno direttamente, altri fanno il lavoro sporco per loro, ma uccidono.
Ho chiesto perdono al mio cane, l’ho abbracciato. Stanotte ho dormito vicino a lui sul divano. Ci ha poi raggiunto anche la nostra vecchia amica gatta. Ci ha fatto le fusa e poi si è addormentata vicino a noi. Poi all’alba ci siamo svegliati e abbiamo visto il sole sorgere di nuovo.
Un altro giorno è cominciato ma non è ancora l’alba di un giorno di pace per la Terra e per tutti gli esseri viventi che la abitano.
Giovanni Sarubbi
-
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- UN CIRCO CHE CI UMILIA (di Francesco Merlo).30 agosto 2010, di Federico La Sala
Gheddafi, un circo che ci umilia
Nessun’altra diplomazia occidentale tollera e incoraggia gli eccessi pittoreschi di un dittatorello e degrada la propria capitale a circo. Ci dispiace anche per il presidente del Consiglio, la cui maschera italiana si sovrappone ormai a quella libica, indistinguibili nel pittoresco, nell’eccesso, nella vanità, nel farsi soggiogare dalle donne che pensano di dominare
di FRANCESCO MERLO *
ANCHE ieri c’era il picchetto in alta uniforme ai piedi della scaletta dalla quale sono scese due amazzoni nerborute e in mezzo a loro, come nell’avanspettacolo, l’omino tozzo e inadeguato, la caricatura del feroce Saladino. Scortato appunto da massaie rurali nel ruolo di mammifere in assetto di guerra. E va bene che alla fine ci si abitua a tutto, anche alla pagliacciata islamico-beduina che Gheddafi mette in scena ogni volta che viene a Roma, ma ancora ci umilia e davvero ci fa soffrire vedere quel reparto d’onore e sentire quelle fanfare patriottiche e osservare il nostro povero ministro degli Esteri ridotto al ruolo del servo di scena che si aggira tra le quinte, pronto ad aggiustare i pennacchi ai cavalli berberi o a slacciare un bottone alle pettorute o a dare l’ultimo tocco di brillantina al primo attore.
È vero che ormai Roma, specie quella sonnolente di fine estate, accoglie Gheddafi come uno spettacolo del Sistina, con i trecento puledri che sembrano selezionati da Garinei e Giovannini, la tenda, la grottesca auto bianca, le divise che ricordano i vigili urbani azzimati a festa, e tutta la solita paccottiglia sempre uguale e sempre più noiosa ma, proprio perché ripetuta e consacrata, sempre più umiliante per il Paese, per i nostri carabinieri, per le istituzioni e per le grandi aziende, private e pubbliche, che pur legittimamente vogliono fare i loro affari con la Libia.
Nessun’altra diplomazia occidentale tollera e incoraggia gli eccessi pittoreschi di un dittatorello e degrada la propria capitale a circo. Ci dispiace - e lo diciamo sinceramente - anche per il presidente del Consiglio, la cui maschera italiana si sovrappone ormai a quella libica, indistinguibili nel pittoresco, nell’eccesso, nella vanità, nel vagheggiare l’epica dell’immortalità, nel farsi soggiogare dalle donne che pensano di dominare.
Di nuovo ieri Gheddafi si è esibito davanti a 500 ragazze, reclutate da un’agenzia di hostess, che hanno ascoltato i suoi gorgoglii gutturali tradotti da un interprete, le solite banalità sulla teologia e sulla libertà delle donne in Libia, il Corano regalato proprio come Berlusconi regala "L’amore vince sempre sull’odio", quel libro agiografico e sepolcrale edito da Mondadori. È fuffa senza interesse anche per gli islamici ma è roba confezionata per andare in onda nella televisione di Tripoli. Il capotribù vuol far credere alla sua gente di avere sedotto, nientemeno, le donne italiane e di averle folgorate recitando il messaggio del profeta. Addirittura, con la regia dell’amico Berlusconi, tre di queste donne ieri si sono subito convertite, a gloria della mascolinità petrolchimica libica: "Italiane, convertitevi. Venite a Tripoli e sposate i miei uomini". E di nuovo ci mortifica tutta questa organizzazione, il cerimoniale approntato dalla nostra diplomazia, con Gheddafi serio ed assorto che suggella la fulminea conversione di tre italiane libere e belle: un gesto di compunzione, gli occhi chiusi per un attimo, il capo piegato come un officiante sul calice. "L’Islam deve diventare la religione di tutta l’Europa" ha osato dire nella capitale del cattolicesimo, mentre l’Europa (con l’America) si mobilita per salvare la vita di una donna che rischia la lapidazione per avere fatto un figlio fuori dal matrimonio. Certo, l’Islam non è tutto fanatismo ma nello sguardo di Gheddafi c’è condensata la sua lunga vita di dittatore, di stratega del terrorismo, di tiranno che dal 1° settembre del 1969 opprime il suo popolo.
Ebbene, è a lui che oggi Berlusconi di nuovo bacerà la mano, come ha già fatto a Tripoli. Berlusconi, lasciandosi andare con i suoi amici fidati, ha più volte detto di invidiare Muammar perché comanda e non ha lacci, non combatte con il giornalismo del proprio paese, non ha bisogno di fare leggi ad personam ma gli basta un solo editto tribale, non ha né Fini né Napolitano, non ha neppure bisogno di pagare le donne... È vero che gli esperti di Orientalistica sostengono che la tribù in Libia è matriarcale e che dunque la moglie di Gheddafi sarebbe la generalessa del colonnello, ma questo Berlusconi non lo sa, la sua Orientalistica è ferma a quella dell’avanspettacolo, al revival di Petrolini: "Vieni con Abdul che ti faccio vedere il tukul".
E infatti ogni volta che Berlusconi va a Tripoli Gheddafi fa di tutto per stupirlo con gli effetti speciali del potere assoluto, gli fa indossare la galabìa e lo fa assistere alle parate militari delle amazzoni, organizza il caravanserraglio di Mercedes piene di farina, orzo e datteri da distribuire agli affamati recitando il ruolo del salvatore, proprio come Berlusconi all’Aquila... E ha pure imposto nei passaporti libici la foto di Berlusconi. Se lo porta nel deserto di notte per mostrargli la magia del freddo glaciale, tutti e due ad aspettare l’alba e il sole che torni ad arroventare la tenda. E ogni volta alla tv libica il viso di Berlusconi diventa in dissolvenza il viso di Gheddafi, e va in onda Berlusconi contrito nel museo degli orrori commessi dagli italiani, e c’è sempre il solito Frattini accovacciato fuori dalla tenda ad aspettare, aspettare, aspettare. E poi il tramonto, la luna...
Gheddafi a Roma fa quello che vuole non soltanto in cambio delle galere e dei campi di concentramento dove la polizia libica trattiene gli africani che vorrebbero fuggire verso l’Italia, e non solo perché i due fanno affari privati, come da tempo sospetta la stampa internazionale, e ora anche italiana. Il punto è che Berlusconi gli mette a disposizione tutto quello di cui ha bisogno l’eccentricità beduina perché con Gheddafi ha un patto antropologico. È una somiglianza tra capi che la storia conosce già, sono identità che finiscono con il confondersi: Trujllo e Franco, Pinochet e Videla, Ceausescu ed Enver Hoxha, Pol Pot e Kim il Sung... Non è l’ideologia a renderli somiglianti ma l’idea del potere, quello stesso che oggi lega Berlusconi e Gheddafi, Berlusconi e Chavez, Berlusconi e Putin. Ecco cosa offende e degrada l’Italia: l’Asse internazionale della Satrapia.
* la Repubblica, 30 agosto 2010
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- LA DEMOCRAZIA RECITATIVA (ATEO-DEVOTA). Oggi nessun progetto totalitario, piuttosto il totalitario disordine di uno Stato in disfacimento (di Emilio Gentile - Niente paragoni con il Fascismo).27 agosto 2010, di Federico La Sala
Il professor Gentile risponde a Chiaberge: dal premier oggi nessun progetto totalitario, piuttosto il totalitario disordine di uno Stato in disfacimentoNiente paragoni con il Fascismo
di Emilio Gentile (il Fatto, 27.08.2010)
Riccardo Chiaberge è turbato dall’incubo di un paragone storico inquietante fra la situazione italiana di oggi e la situazione italiana alla vigilia delle elezioni dell’aprile 1924, che aprirono la strada al regime fascista illiberale e totalitario, come lo definirono alcuni amanti della libertà, che nessuno ascoltò. Nel suo blog dell’11 agosto, Chiaberge ha chiesto agli italiani di liberarlo dall’incubo, convincendolo che ha torto oppure dimostrandogli, soprattutto, che hanno imparato la lezione della storia e non ricadranno di nuovo nella trappola del 1924.
La lezione inesistente
UN GRANDE storico disse due secoli fa che la storia dimostra che dalla storia gli uomini non imparano nulla. Un grande sociologo del secolo scorso scrisse che gli uomini fanno la storia ma non sanno che storia fanno. Nessuno ha finora dimostrato che gli italiani siano esseri umani speciali, perché sanno imparare la lezione della storia. Invece, è dimostrabile che in moltissimi italiani la capacità di oblio del passato è pari solo alla loro convinzione di essere sempre vittime di una storia fatta da istrioni ingannatori e da politicanti corrotti, piovuti da chissà quale pianeta maligno per traviare il Bel Paese. Dubito pertanto che Chiaberge possa avere dagli italiani la confortante promessa che non ripeteranno quello che, in maggioranza, i loro antenati fecero nelle elezioni del 1924.
Vorrei però tentare di liberare Chiaberge dall’incubo del suo inquietante paragone storico provando a convincerlo che ha torto, perché il paragone della situazione odierna con la vigilia delle elezioni dell’aprile 1924 non regge. Non regge neppure - e in questo Chiaberge ha ragione - il paragone che molti fanno fra la situazione attuale del governo in carica e quella del regime fascista alla vigilia del 25 luglio 1943. Come non regge, a mio modestissimo parere, nessun paragone fra la situazione italiana di oggi e il fascismo.
Prima di tutto, osservo che la riforma elettorale del 1924 non fu il suicidio del parlamento italiano: il suicidio, il Parlamento lo aveva già fatto nel novembre 1922 quando votò la fiducia ad un governo presieduto dal capo di un partito armato, nato appena tre anni prima (il partito armato, intendo), che si era aperto la via verso il potere con la violenza, dichiarando apertamente di voler creare uno Stato senza libertà per i suoi avversari, fortemente unitario e accentratore, fanaticamente nazionalista. E fu quello che il fascismo fece quando instaurò il regime a partito unico e impose agli italiani il primato assoluto dello Stato nazionale, trasfigurato in una divinità alla quale tutti dovevano dedizione totale, obbedendo ciecamente al Duce, adorato come un dio terreno in un culto collettivo. Inoltre, il regime fascista praticò un’etica spartana e bellicosa, esigendo da ogni uomo e donna di dedicare la sua vita alla patria, di sacrificare la ricerca della felicità, e persino la più modesta ricerca di un benessere personale, alla potenza dello Stato e alla conquista di un impero.
Oggi non vedo in Italia un partito armato, non vedo un fanatismo nazionalista, e non vedo neppure il progetto di uno Stato accentratore deificato. E non vedo neppure un culto del capo, che faccia rassomigliare l’attuale presidente del consiglio al Duce del fascismo. Anzi, sarà probabilmente il Duce del fascismo, nella nuova versione diaristica, che somiglierà all’immagine che l’attuale presidente del Consiglio vuole dare di sé. Infine, chi governa oggi in Italia non sogna, neppure nei più esaltati sogni di grandezza, di militarizzare gli italiani per trasformarli in asceti e guerrieri, dedicati per la vita e per la morte alla potenza della nazione e dello Stato. Sogna, invece, di renderli tutti consumatori felici di un benessere senza limiti.
Come un ghiacciaio che si scioglie
DUNQUE , Chiaberge si rassereni. Da eventuali elezioni politiche con il porcellum, con la maggioranza degli italiani cloroformizzati dall’apatia, dalla rassegnazione, dal disgusto per la politica o dalla presunzione di farla sempre franca coll’arte di arrangiarsi e col miracolo dello Stellone, non nascerà certamente uno regime totalitario. E’ più probabile invece che avremo il totalitario disordine di uno Stato nazionale in disfacimento, che sopravvivrà ancora per qualche tempo come espressione istituzionale, e poi, forse, se ne andrà alla deriva disgregandosi, come un ghiacciaio che si scioglie in mare.
Un’ultima osservazione, per tranquillizzare Chiaberge. Il totalitarismo fascista si fondava sul principio della subordinazione del privato al pubblico, rappresentato dallo Stato: dalle eventuali prossime elezioni, uscirà probabilmente consolidato il corso di una democrazia recitativa, che da decenni ha subordinato il pubblico al privato. Una democrazia recitativa, per sua stessa natura, è l’opposto di uno Stato totalitario. La loro diversità è geneticamente insuperabile. Da uno Stato totalitario ci si può, alla fine, liberare: la storia lo dimostra. Da una democrazia recitativa, è quasi impossibile.
(*) docente di Storia contemporanea all’Università La Sapienza di Roma
-
> LA DEMOCRAZIA RECITATIVA (ATEO-DEVOTA)... il totalitario disordine di uno Stato in disfacimento --- "Il capo e la folla": Emilio Gentile e le insidie dell’uomo forte (di Marco Gervasoni)29 maggio 2016, di Federico La Sala
Politica
Emilio Gentile e le insidie dell’uomo forte
La democrazia recitativa nasce dalla crisi dello Stato
di Marco Gervasoni (Corriere della Sera, La Lettura, 29.05.2016)
Mai come in questi ultimi tempi si è diffusa la trita metafora dell’«uomo solo al comando». E la convinzione che le democrazie, per essere tali, non debbano avere un capo o debbano averlo il più fragile possibile. Ma la filosofia politica, le scienze sociali e last but not least l’esperienza storica ci dicono che è vero esattamente il contrario: più una società è democratica e più ha bisogno di capi forti (o di leader, se si preferisce).
L’Italia liberale e la Repubblica di Weimar sono crollate di fronte ai totalitarismi perché non avevano capi in grado di far fronte ai processi di democratizzazione. Benché non convinti che Emilio Gentile sia totalmente d’accordo con la nostra conclusione, questa ci è sorta spontanea dopo la lettura del suo bel libro Il capo e la folla (Laterza). L’autore, uno dei massimi storici contemporanei, e non solo italiani, si assume qui una sfida temibile e avvincente, risalire fino all’antica Grecia per studiare il rapporto tra capo e folla. In particolare Aristotele si può dire avesse già capito tutto: il demos può condurre uno Stato solo se opportunamente selezionato e guidato, altrimenti si cade nella tirannide; e ad aprire le porte della polis al despota è proprio la folla, cioè il demos bruto, una questione che intriga la filosofia politica dell’età moderna, da Bodin a Machiavelli a Hobbes.
Se gli attori della rivoluzione americana temono la folla e plasmano un sistema che ne impedisca il sopravvento, in Europa i rivoluzionari parigini le folle invece le utilizzano, ora contro il cosiddetto ancien régime ora nelle lotte politiche interne, finendo, come mostrò a suo tempo Furet, per esserne schiacciati. C’è qui, nelle pagine dedicate da Gentile al XIX secolo, un continuo ricorso a Tocqueville, il più lucido analista delle derive dispotiche della democrazia rivoluzionaria e il teorico delle due democrazie, quelle americana che salva la libertà e quella europea che invece la distrugge.
Le pagine di Tocqueville non sono solo profetiche riguardo all’avvento del bonapartismo di Napoleone III, ma pure sull’evoluzione della democrazia del XX secolo. Qui il testimone passa a Gustave Le Bon, uno scienziato sociale oggi ingiustamente dimenticato che, osserva Gentile, coglie un elemento fondamentale: la folla desidera essere domata, è come un fiume in piena finché non trova la sua diga nel capo. Questi però deve disporsi di fronte alla folla come un attore e indossare una maschera. Siamo a quella che Gentile chiama «democrazia recitativa» incarnatasi soprattutto in Charles de Gaulle e in John Fitzgerald Kennedy.
Le previsioni di Gentile sul futuro sono pessimistiche: la democrazia recitativa si è ormai imposta ovunque e, con la sua «personalizzazione», la partecipazione dei cittadini sta diventando un’illusione. Se è così, tuttavia, occorre capire perché i fondamenti della democrazia partecipativa, il parlamento e i partiti, perdano potere e legittimità. Probabilmente perché non sanno rispondere alle spinte di quest’ultima fase della modernizzazione. E perché si fondono, l’uno e gli altri, sullo Stato nazione che, se non è in via di sparizione come molti credono, è un’entità sempre meno visibile: Stato-nazione di cui - è lezione di questi giorni - proprio il demos sembra volere il ritorno.
-
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- UNA VERITA’ BIMILLENARIA AL TRAMONTO (di Carlo Galli - Tra trono e altare alleanza al tramonto)..25 agosto 2010, di Federico La Sala
Tra trono e altare alleanza al tramonto
di Carlo Galli (la Repubblica, 25 agosto 2010)
Che "Famiglia Cristiana" attacchi Berlusconi e la sua politica con argomenti - fondatissimi e di per sé evidenti - che mescolano l’indignazione civile e lo sdegno religioso non ha nulla di "disgustoso". È semplicemente la dimostrazione di una verità quasi bimillenaria: che la Chiesa cattolica è capace di stringere compromessi con ogni potere, di allearsi con potenze mondane di ogni risma - da Costantino a Mussolini, solo per dare un’idea.
Ed è capace di agire con la spregiudicatezza che la politica richiede, trovando sempre (del resto non è troppo difficile) il modo di giustificare il proprio operato, davanti a se stessa e davanti al mondo. Ma che da questi abbracci la Chiesa sa anche sciogliersi per tempo, quando le diventano scomodi.
E questo perché la Chiesa non ha mai una politica soltanto, ma ne ha sempre altre di riserva. Ed è "con riserva" che sta nelle cose del mondo, senza sposare mai una causa una volta per tutte: del resto, è la Sposa di Cristo, non di questo o di quel potere.
Questa intrinseca duplicità deriva dal fatto che la radice religiosa del messaggio di cui la Chiesa è portatrice ha almeno due lati: quel messaggio è da una parte una volontà di organizzazione del mondo sul fondamento stabile del dogma e del magistero delle gerarchie. E per questo motivo la Chiesa è organismo politico, che si confronta con altri, secondo logiche di potenza. E’ la Chiesa costantiniana, che cerca il potere per essere in grado di esercitare in sicurezza la propria missione. Ma d’altra parte quel messaggio è anche la potenza profetica del Dio che libera dal peccato e dall’oppressione, del Dio che mobilita gli animi, muove le coscienze, e suscita gli scandali.
E’ anche questa una Chiesa politica, sia chiaro; ma di una politica caritatevole e battagliera, per nulla diplomatica o benpensante, che nel corso della storia si è sempre affiancata criticamente alla Chiesa gerarchica; e questa, per quanto l’abbia temuta e, per quanto possibile, normalizzata, non ne ha mai potuto prescindere. La Chiesa è entrambe le cose, contemporaneamente; fa coesistere in sé gli opposti. Non è un’azienda in cui regni la volontà unica del padrone, ma una realtà per sua natura complessa e plurima. Anche il rigido centralismo vaticano, il primato del Papa, si confronta con questa ricchezza inesauribile, a cui dà sì una direzione ma non un’uniformità totale.
Non c’è da stupirsi, quindi, se dentro la Chiesa cattolica le posizioni su Berlusconi sono differenziate: su queste differenze ha giocato, del resto, lo stesso premier, che, col caso Boffo, ha sfruttato a proprio vantaggio i contrasti fra la Cei e la Segreteria di Stato; mentre su altre differenze, ora, inciampa. "Famiglia Cristiana", da parte sua, non è nuova a questo esercizio di critica: e quindi non ci sarebbe da stupirsi.
Ma forse la destra sta fiutando - nell’asprezza, nella libertà, nella costanza degli attacchi del settimanale - un cambiamento di vento nelle stesse gerarchie, con le quali ha stipulato molti e vantaggiosi (per entrambi) compromessi, scambiando benefici fiscali e acquiescenze verso gli aspetti più chiusi del magistero (sulla bioetica e sulla biopolitica) con un appoggio politico di fatto. Un appoggio per nulla scontato poiché il modello d’uomo e di società proposto dalla destra di Berlusconi e Bossi - per non parlare del troppo laico Fini - non dovrebbe essere gradito alla sensibilità religiosa.
In ogni caso, la settimana scorsa, a un analogo attacco di "Famiglia Cristiana" era stato risposto, da parte della destra, con l’invito agli estensori - evidentemente ritenuti ignari - a ripassare i capisaldi della dottrina sociale della Chiesa, e, con un po’ più di verosimiglianza, a non dimenticare i tanti segni tangibili della vicinanza di questo governo alle richieste delle gerarchie.
Nelle risposte davvero sopra le righe a "Famiglia Cristiana" (rea di darsi alla "pornografia politica"), c’è forse solo l’esasperazione di una maggioranza in crisi per ben altri motivi. Ma potrebbe anche esserci la preoccupazione di Berlusconi di perdere, dopo Casini e Fini, e - chissà - Bossi e Tremonti, anche la benevolenza vaticana. Forse il fido Letta non è riuscito a far digerire Oltretevere le nuove minacciate leggi di ispirazione leghista contro immigrati e rom; o forse le gerarchie si rendono conto che dal Cavaliere hanno spremuto tutto quello che si poteva, e che la sua politica ormai di rottura, di lotta disperata per la sopravvivenza, non è più in grado di garantire quello spazio che la Chiesa chiede per sé e per le proprie istanze in Italia.
Forse la prospettiva di un clima di divisione permanente - che mette a rischio l’unità dello Stato (tema spesso sollevato ad altissimo livello, in queste settimane) e della società, e che spezza l’unità dei cattolici (come "Famiglia Cristiana" denuncia) - comincia a interessare meno i vertici della Chiesa. Che non vogliono e non possono legare il loro destino a quello di un’avventura politica ormai incerta, e mandano messaggi trasversali come sanno fare. Forse, un’alleanza fra trono e altare - un buon affare per entrambi, ma di solito più per il secondo che non per il primo - sta tramontando, e il trono comincia a temere per la propria stabilità.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- Cristianesimo la religione «monopolio di Stato» (rec. di "Il mercato di Dio" di Philippe Simonnot - di Tobia Zevi).23 agosto 2010, di Federico La Sala
Cristianesimo la religione «monopolio di Stato»
di Tobia Zevi (l’Unità, 22 agosto 2010)
È lecito parlare di Dio con le categorie della scienza economica? Secondo Adam Smith, il primo teorico del capitalismo moderno, sì. Nella Ricchezza delle nazioni (1776), il filosofo scozzese applica la teoria del mercato alla Chiesa, spingendosi a ritenere che questa si trovi in condizione di «monopolista». Ad un costo maggiore per i credenti e con una qualità peggiore del «prodotto». Smith considera la religione cristiana l’unica degna di fiducia, ma ritiene di poter compiere un’operazione che molti non esitano a definire blasfema.
Il terreno è evidentemente scivoloso, tanto che la pubblicazione de Il mercato di Dio - La matrice economica di ebraismo, cristianesimo ed islam (Fazi Editore, euro 18,50, pp. 338) di Philippe Simonnot ha provocato accese discussioni. L’autore chiarisce che «non si tratta affatto di pretendere di spiegare la religione attraverso l’economia» ma «più modestamente di mettere a disposizione della scienza religiosa gli strumenti dell’analisi economica», e tuttavia il suo approccio si attira necessariamente l’accusa del massimo relativismo culturale possibile. Il volume rilegge dunque i testi sacri delle tre religioni monoteistiche e interpreta i fatti con i principi della scienza economica.
Per l’Ebraismo, nella quasi totale assenza di fonti storiografiche, prevale la prima componente. Per il Cristianesimo e per l’Islam le fonti sono più numerose e ciò rende la teoria più chiara. Il punto di partenza è questo: le religioni sono un bene di «credenza» potenzialmente inesauribile.
L’utente non ne può verificare la correttezza, giacché la Verità si trova necessariamente al di fuori dell’esperienza umana, e pertanto la chiave del successo di una confessione è la sua credibilità, cioè la sua capacità di attrarre più fedeli possibile. Solo lo Stato può garantire il monopolio di una religione, contrattando con essa l’entità delle donazioni che può essere sottratta alla tassazione pubblica.
Abramo è il primo ebreo. Secondo Simonnot, la sua storia testimonia la necessità di controllare il bene più prezioso, la terra. La circoncisione, sugello del patto tra Dio ed Abramo, serve esattamente allo scopo: la proprietà fondiaria è limitata e l’accesso va dunque riservato ad un gruppo ben definito, il popolo eletto, così come la gran quantità di matrimoni tra membri della stessa famiglia riduce le contese territoriali. L’Ebraismo ha bisogno di accreditarsi di una tradizione precedente, e per questa ragione s’impadronisce dei santuari delle più antiche divinità cananee.
Quando il «prodotto» ebraico mostra segnali di crisi, ecco la comparsa del Cristianesimo che fa propria la figura di Abramo, mostrandosi contemporaneamente molto antico e molto nuovo. Inoltre i seguaci di Gesù mirano alla conquista di Roma, e per ottenerla rinunciano alla circoncisione e alle rigide normative alimentari ebraiche.
Se il Tempio di Gerusalemme era stato il centro religioso, statale ed economico della nazione ebraica, i cristiani impiegheranno tre secoli per conquistare la capitale dell’Impero. Grazie all’esaltazione della castità, del tutto inedita, la Chiesa si arricchisce di una gran quantità di patrimoni che perdono i loro eredi naturali.
L’Islam, infine, si richiama anch’esso ad Abramo, dichiarandosi discendente di Ismaele anziché di Isacco. L’identificazione tra la umma, la comunità dei fedeli, e lo Stato è assolutamente immediata, e a tutti coloro che non vogliono convertirsi viene imposto un tributo di protezione.
Pur non elaborando un sistema fiscale paragonabile alla decima ebraica poi mutuata dal Cristianesimo, l’Islam considera l’elemosina - essenziale per il suo sostentamento - una componente fondamentale della vita del fedele. Se la conquista di Gerusalemme, con l’edificazione della Moschea, fu la vittoria principale riportata dall’Islam nei confronti dei due contendenti, la mancata conquista di Costantinopoli prima del quindicesimo secolo costituì a lungo un punto di debolezza.
Un’analisi di questo tipo, lungi dall’esaurire il discorso sulla religione, ha però il merito di proporre una visione innovativa con un tono mai provocatorio, soffermandosi su aspetti in gran parte poco conosciuti.
-
> LA QUESTIONE ITALIANA --- L’ITALIA MERIDIONALE, L’ITALIA SETTENTRIONALE, E IL MAGISTERO ATEO-DEVOTO DI ROMA. --- Padroni in casa nostra? E’ la misura di Sodoma (di Piero Stefani).10 agosto 2010, di Federico La Sala
Padroni in casa nostra? E’ la misura di Sodoma
di Piero Stefani ("Jesus”, n. 8 dell’agosto 2010)
Leggo spesso giudizi molto duri nei confronti di chi dice «padroni in casa nostra». Ma cosa c’è di iniquo? In fin dei conti, chi viene da altre parti sarà padrone a casa sua. Detto in altro modo, si potrebbe dire che quel che è mio è mio e quel che è tuo è tuo. Cosa c’è di male? (Alessandro Tomasini di Verona)
Risponde il giudaista Piero Stefani:
«Ci sono quattro misure (vale a dire modi di comportamento) per l’uomo. Quel che dice il mio è il mio e il tuo è tuo. È la misura della spartizione. Ma c’è chi dice: è la misura di Sodoma. Il mio è tuo e il tuo è mio: è un ignorante. Il mio è tuo e il tuo è tuo: un pio. Il mio è mio e il tuo è mio: un empio», si legge nel capitolo 5, 10 dei Pirqè Avot (Capitoli dei padri), una raccolta di detti di maestri ebrei.
La struttura a quattro è propria dei detti raggruppati in quella sezione. Esso, come i punti cardinali, indica tutte le principali dimensioni di riferimento. Molti aspetti della nostra massima si comprendono al volo.
L’articolazione legata al possesso (o alla proprietà privata) è un principio ordinante. La confusione "comunistica" in cui non c’è distinzione tra mio e tuo è segno di ignoranza perché fa di ogni erba un fascio.
Un sigillo di malvagità contraddistingue chi tiene stretti i suoi possessi, mentre si accaparra quelli altrui.
Chi conosce la distinzione ma non la fa pesare a proprio favore, anzi la rende un servizio per gli altri senza chiedere il contraccambio, è un pio.
Quanto resta più difficile da comprendere è il giudizio pesante riservato alla prima alternativa, quella che afferma la netta separazione tra il «mio» e il «tuo»: cosa sta a fare il riferimento a Sodoma?
Fermo restando che - come avviene per una qualsiasi corretta lettura del testo biblico - l’omosessualità rispetto a Sodoma non gioca alcun ruolo, resta da capire perché un invalicabile muro di divisione posto tra il «mio» e il «tuo» - senza generosità, ma anche senza palese sopraffazione - meriti il paragone con la città simbolo per eccellenza di corruzione. Sembra, piuttosto, di essere di fronte a una convivenza ordinata in modo borghese, la stessa che si riflette nella massima stando alla quale «la mia libertà finisce là dove comincia la tua». Quando ognuno è padrone a casa propria, non nasce alcun conflitto.
L’aspetto ipocrita, però, è già presente nel riferimento alla libertà; infatti esso finge l’esistenza di un’uguaglianza inesistente sul piano reale: non tutti sono nelle condizioni di manifestare liberamente allo stesso modo le proprie potenzialità. L’ipocrisia diviene però ancora più scoperta nel caso dei possessi. Nulla sulla terra è spartito in modo così disuguale (bisognerebbe dire, iniquo) come la ricchezza (o la povertà, per guardarlo dall’altra parte).
Affermare perciò: quel che mio è mio e quel che tuo è tuo, comporta sancire perpetuamente la disparità. Ma cosa c’entra Sodoma?
Per rispondere a questa domanda occorre aver presente che la colpa autentica degli abitanti di Sodoma è stata quella contro l’ospitalità, vale a dire contro la modalità antichissima di rendere gli altri partecipi di quanto è proprio.
La «misura di Sodoma» sta nel rifiuto di accogliere gli altri e di considerare inviolabile la loro dignità umana. «Quel che è mio è mio e quel che è tuo è tuo», in questi casi significa dire: «Tornatevene a casa vostra» (senza chiedersi quale casa sia, ammesso che ce ne sia una). Un commento medievale ebraico, a proposito della «misura di Sodoma», evoca un passo del profeta Ezechiele: «Come i sodomiti, i quali non pretendevano nulla dagli altri uomini, ma non tolleravano che un povero potesse beneficiare delle loro ricchezze. Come sta scritto: "Ecco era questa l’iniquità di tua sorella Sodoma: orgoglio, sazietà di pane, prosperità tranquilla erano in lei e nelle sue figlie. Eppure non diede mai la mano al povero e all’indigente" (Ez 16,49)».
In questi ultimi anni, il nome biblico di Gomorra è divenuto un simbolo di alcuni aspetti aberranti dell’Italia meridionale; dal canto suo Sodoma potrebbe svolgere un ruolo analogo per indicare una forma mentis e un modo di comportarsi sempre più diffuso nell’Italia settentrionale.
-
> LA QUESTIONE ITALIANA --- L’egoismo e l’individualismo sono "gravi" e "devastanti" quando vengono da chi dovrebbe "dare un contributo decisivo alla costruzione del bene comune" (Tettamanzi - .Omelia Pontificale dell’Assunta in Duomo).15 agosto 2010
IL MONITO
Omelia Pontificale dell’Assunta in Duomo: "Imprigionati e rovinati dal nostro io"
Tettamanzi: "Grave e devastante l’egoismo di chi governa" *
L’egoismo e l’individualismo sono "gravi" e "devastanti" quando vengono da chi dovrebbe "dare un contributo decisivo alla costruzione del bene comune".
L’invito a guardare agli altri senza rinchiudersi nell’individualismo, nell’egoismo, nell’io diffuso nella politica come nella famiglia, nel sindacato, nell’impresa, nella società viene dall’arcivescovo di Milano, cardinale Dionigi Tettamanzi, che si è espresso così, stamani, durante l’omelia del Pontificale dell’Assunta in Duomo: "Il rischio che tutti corriamo - ha detto - è di guardare in basso, solo in basso, imprigionati e rovinati come siamo dal nostro io".
"Un io - ha proseguito - che ripiegandosi su se stesso tende ad assolutizzarsi, a configurarsi come un ’idolo da adorare e per il quale si è disposti a sacrificare tutto. Ma un io così inquina il rapporto essenziale che ciascuno di noi ha con gli altri: siamo fatti per l’incontro e la relazione. Quando però prevale l’affermazione del proprio io, la sensibilità verso l’altro diviene indifferenza, l’impegno verso l’altro non è più percepito e vissuto come responsabilità".
Tettamanzi ha parlato di "famiglie che vivono isolate tra le proprie mura" spiegando che "lo stesso purtroppo capita in alcuni gruppi, dove il bene dei singoli non è perseguito in relazione al bene comune dell’intera società, ma ricercato contrapponendosi ad altri, non di rado a scapito e a danno del bene altrui". Tanti sono gli esempi: "Non è questa la logica che anima le associazioni malavitose che operano nella nostra città e nel suo hinterland?".
"Questo atteggiamento - ha continuato l’arcivescovo - è altrettanto grave e dagli effetti altrettanto devastanti quando è realizzato da coloro dai quali invece ci si attenderebbe un contributo decisivo alla costruzione del bene comune". Si tratta di esponenti politici, del sindacato, dell’impresa fino "ad alcuni modi di vivere l’esperienza ecclesiale: in apparenza si dichiara di essere al servizio degli altri, in realtà si considerano gli altri funzionali ai propri interessi, per sfamare il bisogno di potere, notorietà, ricchezza. Così la città e il Paese non sono più guidati e sostenuti in un percorso ragionato e lungimirante di crescita complessivo, attento ai bisogni di tutti. Gli interessi dei singoli e dei singoli gruppi prevalgono violentemente, ferendo e disgregando le città".
Secondo il cardinale, ricostruire il rapporto con Dio "è la strada maestra da seguire per ricostruire il legame autentico con gli altri". E quindi, "paradossalmente, solo lo sguardo in alto rende possibile lo sguardo verso gli altri e verso il basso, verso la terra e i suoi problemi".
-
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- Breve storia del diavolo Il male nell’era delle tentazioni quotidiane (di MArino Niola - rec. del libro di Daniel Arasse).10 agosto 2010, di Federico La Sala
Breve storia del diavolo Il male nell’era delle tentazioni quotidiane
di Marino Nola (la Repubblica, 10 agosto 2010)
Uno nessuno centomila volti per l’inventore della tentazione. Il diavolo non è mai uguale eppure resta sempre lo stesso. Serpente infido, angelo caduto, caprone volante, dragone sulfureo. Ma anche eroe maledetto, libertino irredimibile, mercante d’anime. E ancora anormale, marginale, deviante. Bel tenebroso oppure brutto sporco e cattivo. E perfino terrorista e serial killer. Dalla Genesi ai nostri giorni il maligno ne ha cambiate di facce.
A dirlo è Daniel Arasse, storico dell’arte della Sorbona, in un libro appena uscito in Francia per le Edizioni Arke. Titolo Il ritratto del diavolo. Argomento, le mille sembianze con cui la nostra civiltà nel corso della storia ha cercato di rappresentare il principio attivo del male. Finendo per fare del signore delle tenebre il mutaforma per antonomasia. Proprio come quelli che oggi popolano il cinema e la letteratura fantasy. Ma in realtà ad essere veramente diabolico è proprio questo trasformismo gattopardiano. Cambiare tutto perché nulla cambi, mimetizzarsi per continuare ad indurci in tentazione.
Sin dai primi secoli del Cristianesimo la vera arma del diavolo è proprio la sua capacità di trucco e di travestimento. Tertulliano, uno dei padri della Chiesa, sosteneva che gli angeli ribelli scacciati dal paradiso rivelarono alle donne arti diaboliche come l’uso della “polvere nera con cui si prolungano gli occhi”. Quello che oggi non a caso si chiama mascara. Seduzione uguale tentazione. Come quella cui viene sottoposto sant’Antonio da un sexy-diavolo in sembianze femminili. Simile alla sensualissima Anita Eckberg che Fellini, in “Le tentazioni del dottor Antonio”, trasforma in una prorompente diavolessa bionda che sulle note di “bevete più latte” fa perdere la testa a Peppino De Filippo nelle vesti del bacchettone di turno. Di fatto Tertulliano, oltre a riaffermare che la tentazione è femmina, condanna la cosmetica in quanto mascheramento che snatura il modello divino di cui il volto umano è la copia rivelatrice. E in molte incisioni medievali il demonio viene riconosciuto proprio quando si toglie la maschera. Finendo letteralmente smascherato. Proprio come Diabolik. E come Arlecchino, la maschera per antonomasia, che in origine è anche lui un diavolo. Lo dice il nome stesso che viene dall’antico germanico hölle könig, che in inglese diventa hell king, ovvero re dell’inferno.
Ma questa capacità illusionistica non è solo uno strumento del mestiere, è anche la storica ragion d’essere del maligno. Che riesce, ieri come oggi, a rendere il male pensabile e soprattutto rappresentabile solo a condizione di restare un’icona a bassa risoluzione cui la Chiesa stessa non ha mai dato un volto definitivo. Ed è proprio grazie a questa indefinizione che il diavolo è rimasto un evergreen. Capace di un morphing perpetuo che ne fa sempre il profilo più aggiornato del male, la sua ultima versione.
Diceva Dostoevskij che in realtà l’uomo ha creato il diavolo a sua immagine e somiglianza. Come dire che ogni epoca ha il Lucifero che si merita. Lo mostra a chiare lettere la storia dell’arte occidentale che registra puntualmente le metamorfosi del grande nemico. Sin dalle prime raffigurazioni altomedievali dove Satana e Belzebù hanno facce da turchi, da mongoli, da africani. Tratti etnici per significare un male straniero, un pericolo che viene dall’esterno. Fino a quel tornante decisivo che sta fra medioevo ed età moderna quando il demonio perde le ali di pipistrello, la coda di dragone, gli zoccoli da satiro pagano, per lasciare il posto a un maligno dal volto umano.
Un diavolo politico, seppur cornuto, come quello che Ambrogio Lorenzetti mette al centro della celebre allegoria del cattivo governo, dipinta per il palazzo pubblico di Siena. Un tiranno, circondato da una squallida consorteria di vizi, che si mette sotto i piedi la giustizia, raffigurata con le mani legate (ogni riferimento al presente è puramente casuale). O addirittura un diavolocardinale, come quello del Michelangelo della Sistina che nel Giudizio universale dà al signore dell’inferno il volto del potentissimo Biagio da Cesena, maestro di cerimonie del pontefice Paolo III. Non più ibridi con gli occhi verdi di ramarro ma uomini dallo sguardo luciferino e dalla crudeltà mefistofelica.
Così il diavolo cede il posto al diabolico che è in ciascuno. Come diceva Paul Valéry, il diavolo diventa come Dio. Entrambi esistono, ma solo in noi e insieme formano una coppia inseparabile di divinità latenti. Come dire che la modernità lascia all’uomo la scelta tra bene e male. Tra resistere alle tentazioni del peccato o al contrario cedere deliberatamente cancellando così l’idea stessa di peccato. Una rivoluzione che finisce per fare del diavolo il simbolo della vittoria del piacere e della libertà. O, addirittura, della forza vindice della ragione, per dirla con Giosuè Carducci. Un eroe bello e impossibile. Come il Satana di William Blake del Victoria and Albert Museum di Londra, uno Spartaco venuto dagli inferi che guida gli angeli ribelli all’assalto del trono di Dio. E come il Satana di Milton che preferisce essere re all’inferno piuttosto che servo in paradiso.
Ma proprio perché si è fatto umano, troppo umano, il diavolo sparisce progressivamente dalla pittura e dall’iconografia. Che hanno bisogno di forconi, di artigli, di squame e di occhi fosforescenti da incubo. Se è facile dipingere dei mostri è difficile rappresentare la mostruosità. E così l’agente del caos esce dai manuali di storia dell’arte per entrare in quelli di criminologia e di psichiatria. E a dargli la caccia sono gli scienziati come Cesare Lombroso che fa dell’antropometria una demonologia positivista popolata di delinquenti, anormali, briganti, mattoidi e “pazzi morali”.
Uno zoo umano affollato di poveri diavoli come il “falsario piemontese”, il “ladro napoletano”, “l’anarchico lucano”. Più demonizzati che demoni in verità. Oggi, scacciato dalla morale religiosa Satana si delocalizza e si scioglie nel sociale. Entra nei moderni tribunali della coscienza laica con un look tutto nuovo. Un diavolo che veste Prada. Terziarizzato, immateriale, interiorizzato. E soprattutto medicalizzato. Un maligno da psicologi e dietologi più che da teologi. Un demonio interinale microfisicamente nebulizzato in mille piccole tentazioni e altrettanto piccole demonizzazioni che ci aiutano ad orientarci tra un bene e un male ad assetto variabile, più mutevoli degli indici della borsa. Dal colesterolo ai radicali liberi, dai grassi idrogenati ai raggi UVA. Dal sovrappeso agli inestetismi. Dalla mucca pazza all’effetto serra. E così il simbolo del male diventa sintomo di malessere. È tutto quel che resta del diavolo nell’era della flessibilità. Che ha tolto il posto fisso anche a Belzebù.
“Le portrait du diable”, un saggio di Daniel Arasse, ed. Arke
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- ETICA, LEGALITA’, E TEOLOGIA ATEO-DEVOTA.La sinistra non tiene il passo di Fini (di Barbara Spinelli).8 agosto 2010, di Federico La Sala
La sinistra non tiene il passo di Fini di BARBARA SPINELLI (La Stampa, 08.08.2010)
Alla fine, la rottura fra il presidente del Consiglio e il presidente della Camera è avvenuta sull’elemento che più caratterizza il regime autoritario di Berlusconi: il rapporto del leader con la legalità, quindi con l’etica pubblica. È ormai più di un decennio che il tema era divenuto quasi tabù, affrontato da pochi custodi della democrazia e della separazione dei poteri.
Agli italiani la legalità non interessa, ci si ostinava a dire, né interessano la giustizia violata, la corruzione più perniciosa che è quella dei magistrati, l’obbligo di obbedienza alle leggi, il patto tra cittadini che fonda tale obbedienza. Anche per la sinistra, nostalgica spesso di una democrazia sostanziale più che legale, tutti questi temi sono stati per lungo tempo sovrastruttura, così come sovrastruttura era il senso dello Stato e della sua autonomia.
Fini ha ignorato vecchie culture e nuovo spirito dei tempi e ha guardato più lontano. Ha intuito che uscire dalla crisi economica significa, ovunque nel mondo, uscita dal malgoverno, dai costi enormi della corruzione, dall’imbarbarimento del senso dello Stato. Ha visto che il presente governo e il partito che aveva fondato con Berlusconi erano colmi di personaggi indagati e spesso compromessi con la malavita. Ha visto che per difendere la sua visione privatistica della politica, Berlusconi moltiplicava le offese alla magistratura, alla stampa indipendente, alla Costituzione, all’idea di un bene comune non appropriabile da privati. E ha costretto il premier a uscire allo scoperto: lasciando che fosse quest’ultimo a rompere sulla legalità, sul senso dello Stato, sull’informazione libera, ha provocato un’ammissione indiretta delle volontà autoritarie che animano il capo del governo e i suoi amici più fedeli.
In qualche modo, Berlusconi ha chiesto a Fini e ad alcuni finiani particolarmente intransigenti (Fabio Granata) di scegliere la cultura dell’illegalità contro la cultura della legalità che il presidente della Camera andava difendendo con forza. Non solo: più sottilmente ed essenzialmente, ha chiesto loro di scegliere tra democrazia oligarchica e autoritaria e democrazia rappresentativa. Il capo del governo infatti non si limita a anteporre la sovranità del popolo elettore alla separazione dei poteri e a quello che chiama il «teatrino della politica politicante». La stessa sovranità popolare è distorta in maniera micidiale, a partire dal momento in cui essa si forgia su mezzi di informazione (la tv) che il capo-popolo controlla in toto. La dichiarazione contro Fini dell’ufficio di presidenza del Pdl, il 29 luglio, erge i disvalori come proprio non segreto emblema quando afferma: «Le sue posizioni (sulla legalità) sono assolutamente incompatibili con i principi ispiratori del Popolo della Libertà».
La sinistra non ha avuto né il coraggio né l’anticonformismo del presidente della Camera. Fino all’ultimo ha congelato la presa di coscienza italiana sulle questioni delle legge e della giustizia, ripetendo con pudibonda monotonia che «l’antiberlusconismo non giova al centrosinistra». E per antiberlusconismo intendeva proprio questo: combattere il Cavaliere sul terreno dell’etica pubblica, della legalità, della formazione dell’opinione pubblica attraverso i media. I problemi erano sempre altri: quasi mai erano la tenuta dello Stato di diritto, l’informazione televisiva manipolata, la corruzione stessa. C’erano sempre «questioni più gravi» da affrontare, più urgenti e più alte, prima di scendere nei piani bassi della legalità.
L’incapacità congenita della sinistra di vietare a chi fa politica un conflitto d’interessi, specie nell’informazione, nasce da qui ed è destinata a divenire il vecchio rimorso e il vizio assurdo della sua storia. In fondo, venendo anch’egli da una cultura totalitaria, Fini ha fatto in questo campo più passi avanti di quanti ne abbiano fatto tanti uomini dell’ex Pci (lo svantaggio di tempi così rapidi è che le sue truppe sono labili).
Questo parlar d’altro, di cose che si presumono più alte e nobili, è la stoffa di cui è fatto oggi lo spirito dei tempi, non solo in Italia. Uno spirito che contagia anche le gerarchie ecclesiastiche (non giornali come Famiglia Cristiana), oltre che molti moderati e uomini della sinistra operaista. È lo stesso Zeitgeist che in Francia, in pieno scandalo delle tangenti versate illegalmente da Liliane Bettencourt alla destra, spinge politici di rilievo a far propria l’indignazione dell’ex premier Raffarin contro la stampa troppo intemperante: «I francesi e i mezzi di comunicazione sono incapaci di appassionarsi per i grandi temi». Chi chiude gli occhi davanti al marcio che può manifestarsi nella politica sempre vorrebbe che i cittadini non vedessero la bestia, dietro l’angelo e i suoi grandi temi.
Invece l’imperio della legge fa proprio questo: rivela all’uomo la sua bestialità, gli toglie le prerogative dell’angelo. Nel descrivere il Decalogo mosaico, che della Legge è essenza e simbolo, Thomas Mann parla di «quintessenza della decenza umana» (La Legge, 1944). Alla stessa maniera, la quintessenza dell’esperienza berlusconiana è il rapporto distorto e irato con la legge e i poteri che la presidiano: un male italiano che non è nato con lui, ma che lui ha acutizzato. Un male che conviene finalmente guardare in faccia, perché è da qui che toccherà ricominciare se si vuol costruire meglio l’Italia. Se si vuol dar vita a un’opinione pubblica veramente informata, perché munita degli strumenti necessari alla formazione della propria sovranità democratica.
Per questo la dissociazione di Fini dai disvalori del Popolo della Libertà non è una frattura del bipolarismo, né tanto meno un ritorno a vecchi intrugli consociativi. È il primo atto di un’uscita dall’era di Berlusconi, da una seconda Repubblica che non ha riaggiustato la prima ma ne ha esasperato monumentalmente i vizi: ed è un atto che per forza di cose deve essere governato da un arco di partiti molto largo. Il termine giusto lo ha trovato Casini: si tratta di creare un’«area di responsabilità istituzionale», non diversamente dal modo di operare di chi predispose il congedo dal fascismo. Nell’inverno scorso, lo stesso Casini parlò di Cln, il Comitato di Liberazione Nazionale che nel 1943 associò tutti gli oppositori al regime mussoliniano. Spetta a quest’area preparare elezioni davvero libere, dunque creare le basi perché le principali infermità della repubblica berlusconiana siano sanate. In seguito, il bipolarismo potrà ricostituirsi su basi differenti.
In effetti, Berlusconi non è una persona che ha semplicemente abusato del potere. Le sue leggi, le nomine che ha fatto, il conflitto d’interessi di cui si è avvalso: tutto questo ha creato un’altra Italia, e quando si parla di regime è di essa che si parla. Un’Italia dove vigono speciali leggi che proteggono l’impunità. Un’Italia dove è colpito il braccio armato della malavita anziché il suo braccio politico, e dove i pentiti di mafia sono screditati e mal protetti come mai lo furono i pentiti di terrorismo. Un’Italia in cui la sovranità popolare non potendosi formare viene violata, perché un unico uomo controlla le informazioni televisive e perché il 70 per cento dei cittadini si fa un’opinione solo guardando la tv, non informandosi su giornali o Internet.
Un governo che non curasse in anticipo questi mali (informazione televisiva, legge elettorale che non premi sproporzionatamente un quarto dell’elettorato, soluzione del conflitto d’interessi) e che andasse alle urne sotto la guida di Berlusconi non ci darebbe elezioni libere, ma elezioni coerenti con questo regime e da esso contaminate.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- IL VESCOVO DI LOCRI CERCA DI DISTINGUERE TRA LA SUA "MAMMASANTISSIMA" E QUELLA DELLA ’NDRANGHETA (di Pierangelo Sapegno - Il vescovo scrive ai boss: “Non profanate i nostri santuari”).19 luglio 2010, di Federico La Sala
Il vescovo scrive ai boss: “Non profanate i nostri santuari”
di Pierangelo Sapegno (La Stampa, 19 luglio 2010)
Il vecchio boss lo diceva come se fosse in preghiera, sotto la Madonna: «Il crimine non è di nessuno. E’ di tutti». Magari dopo andavano a pregare davvero, lui e i suoi uomini, con le loro divise da lavoratori della terra, le giacchette celesti, i pantaloni a campana, le mani grosse e ruvide, quelle loro facce da niente che gestiscono miliardi e potere: il giorno della processione c’erano sempre tutti, in coda, dietro alla statua oscillante sopra le spalle dei fedeli, fra le mani protese, le lacrime e i segni della croce.
Ma a fare l’organigramma della ‘ndrangheta, poi, si trovavano ogni volta qua sotto, al Santuario della Madonna della Montagna di Polsi, nel cuore dell’Aspromonte, come devoti e padroni. Dispensavano morte e preghiera. «Facciamo le cariche per la Madonna», diceva il capo dei capi, Domenico Oppedisano, 80 anni portati assieme al potere, con i suoi capelli bianchi e le mani piene di calli. E’ per questo che il vescovo di Locri, monsignor Giuseppe Fiorini Morosini, ha scritto una lettera aperta a tutti i gregari e i comandanti della ‘ndrangheta per gridare il suo scandalo: «Perché dovete umiliare la nostra fede e la nostra religione?».
In tutto questo, alla fine, però, c’è qualcosa che stride. Non è la prima volta che un vescovo o un uomo di Chiesa si rivolge con durezza in Calabria agli uomini della ‘ndrangheta. Ma dall’altra parte, c’è anche - innegabile - questo abbraccio antico di un’organizzazione criminale che mostra ed esalta la sua fede come un paravento. Non deve stupire che gli uomini della ‘ndrangheta si riuniscano nel cuore di un santuario per disegnare strategie prendere decisioni. «Quello che abbiamo noi qua, se non era per me, non ci sarebbe stato», dice Oppedisano. Gli altri gli stanno attorno in religioso silenzio, come in preghiera, vestiti tutti come lui, con le stesse facce, la stessa durezza: sembrano braccianti che gestiscono miliardi, un’infinità di miliardi. Loro non hanno bisogno di sfoggiare ricchezza e potere.
Così, al confronto di questa immagine, suonano quasi ingenue le parole accorate di monsignor Morosini: «Il Vangelo di cui voi parlate non può essere il Vangelo di Gesù, che parla di amore, di perdono e di riconciliazione, di rispetto della persona e della legge, anche quella degli uomini. Che senso possono avere questi incontri all’ombra del Santuario della Madonna, dove, mentre i fedeli pregano e si riconciliano con Dio, voi decidete strutture e attività, che Dio e la Vergine Maria non possono benedire? Siamo profondamente rammaricati che ciò avvenga trasformando il Santuario di Polsi da luogo di fede in luogo di illegalità. A Polsi la gente viene per trovare nella fede e nella devozione alla Madonna motivi per vivere; i vostri incontri non sono affatto su questa linea, anzi spesso parlano di morte. La fede della gente va rispettata e non derisa e umiliata... Perché si deve ridere di noi, delle nostre tradizioni e delle nostre celebrazioni, quando poi le si vedono unite a questi incontri, i cui contenuti sono contro i valori della religione, che voi dite di professare?».
La realtà poi è un po’ diversa. Lo sanno benissimo i carabinieri che devono pedinare il nuovo capo. Domenico Oppedisano è di Rosarno, è il boss che ha voluto la cacciata dei lavoratori di colore, ed è diventato potente il 19 agosto del 2009 quando viene investito dello scettro di capocrimine al matrimonio di Elisa Pelle e Giuseppe Barbaro. La sua nomina però avviene in un santuario. E per seguirlo i militari devono andare a tutte le feste religiose di cui lui è devotissimo. Poi incontra i suoi, dopo le preghiere, tutti con le loro camicie da contadini, i calzoni larghi un po’ strascicati sulle scarpe, tutti in cerchio attorno a lui, con i capelli bianchi, il volto solcato da rughe profonde come le orme della terra e la voce dura, un po’ impastata, che ripete allargando le mani sotto la statua della Madonna: «tutto quello che avete lo dovete a me».
La camicia sgargiante con le punte del colletto così larghe che arrivano fin sulle spalle è la stessa che porta il giorno che i carabinieri lo portano via dietro a un cancello e davanti alle telecamere. Nessuno sapeva ancora il suo nome. Sapevano solo che era il Capo dei capi. Si chiama «Vangelo».
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- AL POTERE GLI AMICI DEL CESARE-PAPA E DEL PAPA-CESARE. L’eterno ritorno del cesarismo - e del populismo (di Gian Enrico Rusconi).18 luglio 2010, di Federico La Sala
L’eterno ritorno del cesarismo
di GIAN ENRICO RUSCONI (La Stampa, 18/7/2010)
Chi è il «Cesare» che compare nei discorsi dei faccendieri, degli affaristi e degli altri personaggi dell’ultimo scandalo politico? Secondo una prima dichiarazione dei carabinieri, si tratterebbe di Berlusconi. Quest’attribuzione è sembrata subito verosimile perché il nome di Cesare, con la sua reminiscenza di scuola, può esprimere anche una ingenua adulazione o una deferente ironia. Ora invece si dice che si riferisce a Previti. Ma trovo maldestro, anche da parte di dilettanti, mettere in circolazione un nome di persona reale. Poco importa. Quello che gli interessati non sospettano è che il riferimento a Cesare e il sostantivo che gli viene associato - cesarismo - hanno una lunga storia nell’interpretare un fenomeno politico che è antico ma che ritorna sempre. La domanda importante oggi quindi non è chi è il «Cesare» di cui si parla, ma se è in atto una forma di cesarismo politico e quali sono i suoi tratti caratterizzanti.
Il Giulio Cesare storico in questa storia conta, ma relativamente. Ciò che è davvero importante è il modello di comportamento che gli viene attribuito e che attraversa i secoli. Sinteticamente è il modello del «dittatore democratico». Cesare era amato dal popolo e affossatore di fatto, in suo nome, della antica repubblica che diceva di volere salvare. Ma i due termini «dittatore democratico» sono chiari soltanto in apparenza. Cambiano infatti profondamente di senso quando sono applicati al tempo della repubblica romana in via di transizione verso l’impero. O quando vengono ripresi sistematicamente nell’Ottocento in riferimento a Napoleone III, a Bismarck e persino, di riflesso, al nostro Cavour.
Nessuno di questi politici è stato propriamente un dittatore. Neppure l’imperatore dei francesi, che a metà dell’Ottocento è stato oggetto di una letteratura politica sterminata che ha rilanciato alla grande il tema del cesarismo (nel suo caso interscambiabile con bonapartismo). I tre nomi citati sono di uomini politici di grande statura. Hanno subito naturalmente stroncature feroci - come quella di «Cesare il piccolo» affibbiata al Bonaparte da Victor Hugo. Ma di Cesari grandi e piccoli ce ne sono stati tanti. Anche al tempo delle dittature novecentesche: basti ricordare i busti di Mussolini fisiognomicamente confusi con il profilo idealizzato di Cesare. In realtà però ha poco senso parlare di cesarismo fascista, perché in esso si perde l’elemento essenziale: il riferimento alla democrazia, che Mussolini certamente non voleva.
Questo è il punto: il cesarismo è uno stile di governo (non un regime) che, insediato in un sistema democratico preesistente, tende a forzare o a rifunzionalizzare le istituzioni esistenti in senso autoritario ma senza negarle, anzi volendo creare la «vera democrazia». Lo strumento centrale è un rapporto nuovo e diretto con il «popolo». Non a caso il concetto associato al fenomeno cesaristico è anche populismo.
Nei primi due decenni del Novecento Max Weber, facendo un bilancio della fine della democrazia liberale e spingendo lo sguardo in avanti, parlava di «tendenza cesaristica della democrazia di massa». Cesarismo e democrazia di massa sono dunque strettamente legati. Poi Weber ha insistito (forse troppo) sugli aspetti personali carismatici eccezionali della leadership cesaristica. Noi oggi più realisticamente riteniamo che il cesarismo del nostro tempo conti di più sulla potenza della comunicazione di massa e dei mezzi mass-mediatici che non sulle (presunte) doti carismatiche personali del leader. Si tratta di un mutamento di prospettiva decisivo.
Rimane essenziale il rapporto con il popolo. Ma chi è il popolo del Cesare storico? È la plebs acclamante ma anche un gruppo consistente di amici, collaboratori, mediatori, clientes e senatores del regime precedente. Il popolo del Cesare contemporaneo è il popolo-degli-elettori che lo votano, è il popolo mediatico monitorato con strumenti demoscopici. Ma anche una solida rete di «amici di Cesare», insediati non solo nella politica ma soprattutto nella «società civile». In questo senso il cesarismo è davvero popolare.
«Gli amici di Cesare» (compresi i leader di altri partiti che gli sono «amici» prima ancora che «alleati») surrogano di fatto il partito tradizionale. Il «partito del popolo» infatti ha la funzione esclusiva di mettergli a disposizione consenso e risorse. Offre personale esecutore, realizzatore, implementatore delle idee del leader. Non deve sollevare problemi, tanto meno competizioni o alternative interne. Il partito del leader cesaristico è, o meglio deve essere, assolutamente unitario. Deve attendere e sostenere le soluzioni dei problemi ipotizzate dal leader. Se queste non si realizzano la colpa è delle opposizioni che le ostacolano o degli ambiziosi disturbatori interni al partito che non sono più «amici». Ma soprattutto la colpa è del sistema istituzionale - in particolare giudiziario - che frena e boicotta. Da qui l’inderogabile necessità della riforma delle istituzioni che non si presenta come sovversiva (anche se retoricamente si sente «rivoluzionaria») ma come loro sistematica forzatura sempre al limite della legalità costituzionale.
Mentre scriviamo questo sistema sta entrando in una fase di turbolenza inedita. C’è chi da mesi ne prevede la fine. Personalmente - come analista - sarei cauto
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- L’ARCANGELO DELLA GIUSTIZIA, IL VATICANO, E UN BEL CARTELLO: "CHIUSO PER RESTAURO" (di Paolo Izzo).15 luglio 2010, di Federico La Sala
Vaticano, "chiuso per restauro"
di Paolo Izzo *
Cara “Liberazione”,
se un giorno si trovano le ossa di una donna nei loro lucernai, dove la luce non entra e nessuna chiarezza è possibile. Se un altro giorno si scopre che l’obbligo della loro astinenz riguarda soltanto i rapporti con l’altro sesso, ma non sono esclusi uomini e bambini; che le violenze su questi ultimi sono fisiche e morali, “annullanti” e distruttive...
Se un altro giorno ancora si stabilisce che, quando la loro parola non ti giunge attraverso campane, messe e politica, viaggia indisturbata su onde elettromagnetiche e cancerogene; vittime sempre i più deboli, i bambini.
Se l’ultimo giorno ci si rende conto che sono ancora tra i Paesi più ricchi del mondo, nonostante l’apparente carità mondiale: evangelizzazione mascherata da solidarietà.
Allora, c’è qualcosa che, ignominiosamente, non va.
Allora, diventa necessario e urgente che dalle loro porte lascino entrare e uscire soltanto... l’arcangelo della Giustizia. E che per tutti gli altri mettano un bel cartello: “chiusi per restauro”
Paolo Izzo
* Liberazione, Lettere - 15.07.2010
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- In pubblico e in un luogo sacro calabrese, stretti attorno al nuovo capo. Che dà le sue regole e i suoi codici d’onore (di Piero Colaprico - Nel Santuario la ’ndrangheta consacra il suo nuovo capo).14 luglio 2010, di Federico La Sala
 IMMAGINI INEDITE
IMMAGINI INEDITE Nel Santuario la ’ndrangheta
Nel Santuario la ’ndrangheta
 consacra il suo nuovo capo
consacra il suo nuovo capoAlcuni filmati registrati dai carabinieri nel corso delle indagini mostrano per la prima volta le immagini dei capi delle cosche che si riuniscono, in pubblico e in un luogo sacro calabrese, stretti attorno al nuovo capo. Che dà le sue regole e i suoi codici d’onore
di PIERO COLAPRICO *
La Madonna dei Polsi ha due devozioni: una popolare e cattolica, e un’altra elitaria e da setta, ed è quella della ’ndrangheta. Il filmato che è stato ripreso all’ombra del santuario mostra quel mix di simbologia sacra e di potere nero, occulto, invasivo, che ha reso i clan calabresi tra i più forti e temuti del mondo. Votare, dirsi chi è Il Crimine, e cioè il boss dei boss, mentre intorno si accendono candele sacre da parte dei fedeli serve a sgarristi e picciotti anche a sentirsi "parte di una comunità" più estesa, più vasta. Il rito pagano di mischia al rito religioso e c’è la sensazione, e la tentazione, di avvertire come "divino" un potere che ha a che fare con omicidi, con estorsioni, con sequestri di persona, con il traffico della droga, con l’ecomafia che avvelena la terra dove cammineranno anche i loro figli.
Nemmeno Francis Ford Coppola avrebbe potuto concepire per il suo "Padrino" la verità che emerge da queste riprese, fatte da un tecnico che ha lavorato insieme con i detective. Come ai "Polsi" si decidono i destini degli uomini, le carriere, chi è bravo e chi deve modificare il suo atteggiamento (la pena per chi esagera con l’indipendenza è la morte), così a Milano, nel circolo intitolato a Falcone e Borsellino, si sono visti i boss votare il loro Capo, quello che incarna per tutti al Nord il volere della ’ndrangheta. Quella che sembrava un gruppo di famiglie scollegate una dall’altra, dopo quest’inchiesta, è diventata qualcosa d’altro. I pm vogliono che la Cassazione riconosca che anche i clan calabresi hanno una cupola, che esiste un Totò Riina della ’ndrangheta, e che nessuno estraneo, prima della retata di lunedì notte, lo sapeva.
* la Repubblica, 14.07.2010
CRIMINALITA’ Maxi blitz contro la ’ndrangheta
Maxi blitz contro la ’ndrangheta
 trecento arresti in tutta Italia
trecento arresti in tutta ItaliaL’operazione svela una struttura simile a Cosa Nostra: tre mandamenti calabresi, c’è un organo di vertice e "la Lombardia", la struttura nordica, con una "Camera di controllo deputata al raccordo tra le strutture lombarde e calabresi". In manette anche Domenico Oppedisano, 80 anni, numero uno delle cosche calabresi *
ROMA - Chi litiga è un uomo morto. È stato un omicidio di due anni più che a rivelare, a certificare la "mutazione genetica" della ’ndrangheta. Si chiamava Carmelo Novella, detto compare Nuzzo, aveva sessant’anni e il 14 luglio del 2008 viene ammazzato in un bar di San Vittore Olona. Sembrava il risultato di una faida legata agli appalti nell’edilizia, invece Novella aveva detto in giro che "la Lombardia", e cioè tutti i gruppi di ’ndrangheta trapiantati al Nord, avrebbero potuto "fare da soli", senza la casa madre calabrese. Il desiderio di autonomia è stato stoppato con le pallottole, Novella non sarà più un problema e viene nominato un altro calabrese, Giuseppe Neri, come uomo del raccordo tra il Nord danaroso e il Sud antico e sanguinario.
È questo sangue che scorre al Nord un importante episodio nell’inchiesta ribattezzata "Il Crimine", che è in corso mentre scriviamo, sono in programma tra i duecento e i trecento arresti, tra Calabria e Lombardia. Nei fascicoli dei procuratori Ilda Boccassini e Giuseppe Pignatone sono entrati anche due filmati senza precedenti. Il più clamoroso è stato registrato a Paderno Dugnano, in un centro intitolato - incredibilmente - ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Per alzata di mano, e all’unanimità, è stato scelto, dai vertici dei clan calabresi del Nord tutti riuniti, il "mastro generale", e cioè Pasquale Zappia. Una scena degna del film "Il Padrino", ma senza smoking, una versione con abiti casual in stile provincia milanese.
L’altro filmato è avvenuto in Aspromonte, alla Madonna dei Polsi, dove si sono riuniti i boss calabresi. Senza l’aiuto di pentiti, sono stati documentati circa quaranta incontri. E da quanto raccontano i documenti redatti dai carabinieri e dalla polizia, è stata fatta una fondamentale scoperta. La ’ndrangheta sinora non era mai stata considerata come una struttura unitaria, cioè non sembrava "come" Cosa Nostra. E se allora, per stabilire le regole in Sicilia, ci volle il pentito Tommaso Buscetta, qua, oggi, per comprendere le regole calabresi è stato necessario un lavoro certosino. Ma, piano piano, sono emersi i tre mandamenti della ’ndrangheta in Calabria, poi un organo di vertice, che "ne governa gli assetti, assumendo o ratificando le decisioni più importanti".
E poi esiste - ed è sorprendente - "La Lombardia", cioè la federazione dei gruppi trapiantati al Nord, con una "Camera di controllo deputata al raccordo tra le strutture lombarde e calabresi". Una "struttura unitaria", accusano i pm, e hanno scoperto che, ovviamente, i clan al Nord avevano in mente di prendersi qualche buon appalto per l’Expo. Non ci sono riusciti "per il fallimento" della Perego general contractor srl: una ditta di rilievo dove Salvatore Strangio, espressione della famiglia Pelle, soprannominata "Gambazza", faceva il bello e cattivo tempo, per favorire "numerose imprese controllate dagli affiliati lombardi". Ne sono stati individuati ben 160, ma i boss si dicono "che hanno circa 500 unità".
I procuratori Boccassini e Pignatone, che hanno organizzato questa retata senza precedenti, si sono convinti che sia stato il sequestro di Alessandra Sgarella, portata via dalla sua casa bella zona di San Siro nel dicembre del 1997, l’ultima "azione" dei clan tradizionali. Dal Duemila la ’ndrangheta si è trasformata in "mafia imprenditrice".
Ci sono i criminali, ma accanto a loro affiliati lombardi, spesso senza problemi con la giustizia, com’è il caso di un alto funzionario della sanità lombarda: "In virtù del proprio ruolo istituzionale - viene detto di lui - assicura l’assistenza sanitaria, ma anche l’interessamento per investimenti immobiliari e coltiva e sfrutta per i "fini comuni" i legami con gli esponenti politici locali". L’inchiesta sembra riguardare anche il recente voto in Lombardia. Inoltre, da una lavanderia nel centro commerciale di Siderno, gestita dal boss Giuseppe Commisso, si è arrivati a nove locali individuati a Toronto e uno a Thunder Bay, controllati dalla provincia di Reggio. Un’intera rete di relazioni, affari, sembra venire allo scoperto e sono stati sequestrati beni per 60 milioni di euro.
Tra le persone arrestate a Milano, Carlo Antonio Chiriaco, classe 1959, nato a Reggio Calabria, direttore sanitario dell’Asl di Pavia, Francesco Bertucca, imprenditore edile del pavese e Rocco Coluccio, biologo e imprenditore residente a Novara. I tre sono ritenuti responsabili di aver fatto parte della ’ndrangheta attiva da anni sul territorio di Milano e nelle province vicine. Nel corso dell’operazione sono state fatte 55 perquisizioni e sequestri di beni immobili, quote societarie e conto correnti il cui valore è ancora da quantificare.
E in manette è finito anche Domenico Oppedisano, 80 anni, considerato dagli investigatori l’attuale numero uno delle cosche calabresi. La sua nomina a ’capocrimine’ - cioè colui che è al vertice dell’organismo che comanda su tutte le ’ndrine ed e’ denominato ’Provincia’ - sarebbe stata decisa il 19 agosto del 2009 nel corso del matrimonio tra Elisa Pelle e Giuseppe Barbaro, entrambi figli di boss. Un particolare significativo del personaggio: quando Oppedisano doveva parlare non usava il telefono. I suoi ordini arrivavano a Bollate attraverso Rocco Ascone, caposocietà e vicario della cosca locale comandata da Vincenzo Mandalari.
* la Repubblica, 13 luglio 2010
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- La cena di Vespa per sedurre Casini (di Eugenio Scalfari).11 luglio 2010, di Federico La Sala
L’EDITORIALE
La cena di Vespa per sedurre Casini
di EUGENIO SCALFARI *
LE DOMENICHE di afa e di solleone incitano al raccoglimento e a pensieri non degradati dall’attualità. Emerge per esempio - ed è inconsueta la fonte dalla quale provengono questi segnali - un sentimento d’infelicità, una noia di vivere tra immagini false e verità mascherate, il senso d’un declino inarrestabile, la necessità di ricominciare da zero abbandonando ogni retaggio lungo una strada erta di sassi e opaca per la polvere che la sommerge.
Le fonti che emettono questi segnali sono inconsuete perché fino a poco tempo fa essi erano del tutto diversi: si esaltavano conquiste di buon governo, prevalenza di spiriti liberali, dominanza d’un privato efficiente e sano e un lodevole ritrarsi d’un pubblico ancora inquinato da ideologie e impoverito da sprechi e ruberie.
Sembrava - e così veniva fatto credere - che fossimo finalmente entrati in una fase costruttiva della quale perfino una rinata fede religiosa contribuiva a rafforzare i lineamenti e gli obiettivi fornendo un plus di valori ad una buona laicità capace di coniugare la fede con la ragione.
Come mai, nel volger di pochi mesi e addirittura di poche settimane questo quadro positivo ha lasciato il posto allo sconforto? Perché le tinte rosee che lo illuminavano hanno di colpo assunto colori foschi dominati da nubi plumbee cariche di pioggia e di fulmini? Viene in mente che la causa possa essere di materia economica, la crisi che ha investito l’intero pianeta e in particolare le economie occidentali dei paesi opulenti.
Ma non è così, non è questa l’origine dei segnali di sconforto: la crisi infatti è cominciata da oltre due anni e secondo gli esperti ha superato la fase più acuta; anche se molte preoccupazioni persistono, esse non spiegano quel sentimento di frustrazione che si va diffondendo e che molti "laudatores" delle nuove libertà registrano con sconsolato scoramento.
Personalmente non mi stupisco di questo capovolgimento di atmosfera, di questa caduta di speranze e opacità di futuro. Ho scritto un libro in cui si racconta la storia di un’epoca che ha alle sue spalle quattro secoli ed ora dà segnali di estenuazione. Può darsi che non sia il solo ad aver colto il gran finale della modernità, che ha rappresentato il culmine della civiltà occidentale ed ora si decompone di fronte ad una sorta d’invasione barbarica che azzera i retaggi e inventa nuovi linguaggi e nuovi modelli.
La modernità ha dato ciò che poteva ma non si è ancora spenta: sta difendendo i suoi valori che i nuovi barbari imbrattano e insultano. Può darsi - me lo auguro - che alcuni intellettuali organici a quel nuovo e barbaro potere si siano resi conto della deriva in corso e siano diventati disorganici, secondo una felice definizione di Umberto Eco. Sarebbe un evento fausto. Spero che non sia un vago miraggio destinato rapidamente a dissipare.
* * *
L’attualità di queste ore ci riporta alle consuete banalità di un potere che si disarticola giorno dopo giorno: all’indomani d’uno sciopero di tutto il sistema dell’informazione che ha risposto massicciamente all’appello dei suoi sindacati e della propria coscienza professionale, il presidente del Consiglio non ha trovato di meglio che accusare i giornali di sinistra di menzogna e disfattismo perché racconterebbero un’immagine del paese che sarebbe secondo lui l’opposto di una realtà positiva, stabilizzata economicamente e socialmente equa.
Nelle stesse ore i sondaggi d’opinione hanno registrato - confrontando i dati della prima settimana di maggio con la prima di luglio - un calo di fiducia nel "premier" dal 50 al 41 per cento e un aumento della sfiducia dal 48 al 57.
I sondaggi sono una fotografia del presente e nulla ci dicono su come evolverà, ma non accadeva da anni uno smottamento così cospicuo del consenso berlusconiano. La caduta più vistosa si è verificata nel Nordest, nel Mezzogiorno continentale e nelle isole (specialmente in Sardegna). Il caso Brancher è stato l’elemento determinante insieme alla manovra economica e alla legge-bavaglio sull’informazione.
Lo scrittore Salman Rushdie, in un articolo di lunedì scorso sul nostro giornale, a proposito delle contraddizioni che costellano il nostro presente cita il romanzo "Gold!" di Joseph Heller e il personaggio dell’Assistente presidenziale che pronuncia frasi la cui fine contraddice sistematicamente l’inizio. Eccone una: "Il nostro Presidente non vuole dei leccapiedi. Ciò che vogliamo sono uomini indipendenti e integri che, una volta che avremo preso le nostre decisioni, concorderanno con ognuna di esse". Purtroppo siamo abituati a questa tecnica dell’imbonimento sotto la quale non c’è assolutamente nulla.
* * *
La manovra economica è stata un altro macroscopico esempio della disarticolazione del blocco di consenso berlusconiano. Fino all’ultimo il presidente del Consiglio ha cercato di disinnescare le mine che scuotevano il dissenso nelle sue file. Ha ottenuto poco o niente: briciole di piccoli miglioramenti lobbistici che hanno appagato piccole categorie (rinvio delle multe sul latte, compensazione tra debiti e crediti verso il fisco in favore di alcuni settori industriali) senza alcun piano coerente.
La coerenza è così rimasta quella di Tremonti che ha ormai portato in salvo la sua manovra da 25 miliardi invocando l’Europa come madre di queste restrizioni che tutti i paesi membri hanno adottato e che Berlusconi alla fine ha dovuto sottoscrivere.
Il problema non è se la manovra tremontiana dovesse farsi oppure no. Abbiamo più volte scritto e qui lo ripetiamo che la manovra che ha come obiettivo la stabilizzazione del debito pubblico era necessaria. I criteri possono essere controversi ma l’aggiustamento sui Ministeri e sulle Regioni era indispensabile.
Il problema riguarda la seconda parte della manovra, quella che non è mai stata scritta perché Tremonti, sostenuto dalla Commissione di Bruxelles e soprattutto da Bce e dal suo presidente Trichet, si è rifiutato di prenderla in considerazione: cioè gli stimoli alla crescita e il sostegno della domanda, dei redditi medio bassi e degli investimenti che ne conseguono.
Paul Krugman, premio Nobel per l’Economia, ha ricordato in una recente intervista al Sole 24 Ore che nel 1933 l’allora presidente degli Stati Uniti, Herbert Hoover, lanciava messaggi in tutto simili a quelli che oggi lanciano la Commissione di Bruxelles, la Banca centrale europea e il governo della Germania federale: rigore rigore rigore, è questa la sola ricetta che scoraggia la speculazione e farà aumentare la domanda quando gli effetti di stabilizzazione saranno consolidati.
Quando Franklin D. Roosevelt arrivò alla Casa Bianca pochi mesi dopo l’economia americana era alla canna del gas. Avesse tardato ancora a mettere in opera la reflazione, il sistema sarebbe crollato ancor più di quanto stava avvenendo, con una crisi che ancora non era stata domata nel 1937, cioè otto anni dopo il suo primo insorgere.
Tremonti si ripara dietro le spalle dell’Europa, Berlusconi non ha alcun piano alternativo da contrapporgli poiché ha le mani legate dal suo "mantra" di non toccare le tasse. Mantra già smentito dai fatti poiché per tacitare almeno i Comuni e le Province Tremonti ha concesso la "tassa di servizio", nuova imposta di cui gli enti locali si serviranno per sopravvivere e che gli procurerà 5 miliardi l’anno. Ecco il primo buco nelle tasche degli italiani, cui altri inevitabilmente seguiranno, purtroppo senza sortire effetto desiderabile di rilanciare la crescita. Ci vorrebbe infatti un programma coerente, non uno stillicidio lobbistico. L’opposizione ha promesso che lo sta studiando. Si sbrighi e poi lo ponga come base di una politica forte e innovativa. Il tempo non aspetta.
* * *
Nel frattempo c’è anche chi trova il tempo per festeggiare in pompa magna il cinquantenario giornalistico di Bruno Vespa. Cena giovedì scorso nell’abitazione del conduttore - padrone di "Porta a Porta" ospiti con le rispettive consorti: Gianni Letta, Mario Draghi, Cesare Geronzi e Pier Ferdinando Casini; Silvio Berlusconi con la figlia Marina e il cardinale segretario di Stato, Bertone, ovviamente celibe.
Sembra si sia parlato di tutto, manovra economica compresa. Forse anche dei Mondiali di calcio e della non brillante performance degli "azzurri". Forse di intercettazioni. Sicuramente dell’invito a "Pier" di tornare a casa, cioè nell’alleanza di centrodestra. Berlusconi gli avrebbe proposto di rifondare la Dc, gli avrebbe offerto il ministero dello Sviluppo, forse quello degli Esteri, sicuramente la vicepresidenza del Csm. Casini avrebbe ringraziato ma declinato, a meno che non si passi attraverso una formale crisi di governo. Letta ha concluso che tutto è rinviato ma qualche cosa è cominciato.
Mentre scrivo mi arriva sul tavolo un’Ansa con un comunicato ufficiale del ministro dell’Interno, Bobo Maroni. Con riferimento appunto alla cena di Vespa, Maroni accusa la classe politica d’esser tornata ai salotti del 1992, aggiunge che qualunque ritorno al governo dell’Udc provocherebbe l’immediata uscita dal medesimo della Lega e comunica che in caso di crisi ministeriale la Lega chiederebbe l’immediato ritorno del popolo sovrano alle urne. Una specie di convitato di pietra che si è fatto vivo con ventiquattr’ore di ritardo per stabilire chi è il padrone del vapore in questo momento.
Non si hanno altre notizie su quella cena, soprattutto sul ruolo di Draghi, Geronzi e Bertone nella conversazione. Si strologa. Che altro si può fare? Geronzi si è complimentato con Draghi per il suo lavoro allo Stability Financial Forum. Draghi con Bertone per l’efficienza del volontariato cattolico. Bertone con Marina per le opere di assistenza da lei finanziate.
Casini ha chiesto notizie a Marina sulla causa in corso con De Benedetti per il risarcimento del danno subito dalla Cir per il lodo Mondadori. Berlusconi ha pestato un piede alla figlia e le ha fatto gli occhiacci affinché lasciasse cadere la domanda. Marina non ha capito e ha fatto cadere in terra il tovagliolo. Bertone s’è inchinato per raccoglierlo ma ha dato una testata al bordo del tavolo.
Letta ha pregato la padrona di casa di portare ghiaccio e bende di lino per la fronte del porporato. Vespa ha versato champagne nei calici, il premier ha gridato Viva Vespa, ricordando il Viva Verdi che infiammava le riunioni dei cospiratori giacobini del Risorgimento. Vespa ha obiettato che i presenti non erano né cospiratori né tanto meno giacobini.
Alla fine sono tutti usciti da un portoncino laterale su piazza Mignanelli. Notte afosa. Nuvole di zanzare intorno alla fontana della Barcaccia. La macchina nera targata Vaticano ha sgommato verso il Babuino. Un ragazzotto in maglietta ha detto ad un altro che era con lui: "Aò, là drento c’era ’n cardinale. Chissà ’n do va a quest’ora". "Ma che te frega a te" ha risposto l’altro. "Annerà a pregà per i peccati der prossimo e pe li sua".
 [I fatti qui riferiti sono di pura fantasia. Ogni riferimento è puramente casuale].
[I fatti qui riferiti sono di pura fantasia. Ogni riferimento è puramente casuale].* la Repubblica, 11 luglio 2010
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- ai vertici della Segreteria di Stato e della Conferenza episcopale italiana serpeggia una certa preoccupazione per la "tenuta dell’intero sistema Paese" (di Orazio La Rocca e Carmelo Lopapa).11 luglio 2010, di Federico La Sala
 IL RETROSCENA
IL RETROSCENA Quei timori del Vaticano per l’Italia
Quei timori del Vaticano per l’Italia
 ma Bertone con il premier crea malumori
ma Bertone con il premier crea malumori La cena da Vespa preceduta da contatti di Letta con la Santa Sede. Monsignor Fisichella emissario per Casini.Oltretevere non si nasconde "la preoccupazione per la tenuta dell’intero sistema Paese"
La cena da Vespa preceduta da contatti di Letta con la Santa Sede. Monsignor Fisichella emissario per Casini.Oltretevere non si nasconde "la preoccupazione per la tenuta dell’intero sistema Paese" di ORAZIO LA ROCCA e CARMELO LOPAPA *
di ORAZIO LA ROCCA e CARMELO LOPAPA *CITTA’ DEL VATICANO - Apprensione e cautela. E il convincimento di fondo che il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, al cospetto di una crisi più grave del previsto, "rischia di non farcela". Il Segretario di Stato Tarcisio Bertone è figura di grande equilibrio, ha accettato l’invito di giovedì sera a casa Vespa, alla presenza tra gli altri del premier Berlusconi e del leader Udc Casini, "non certo per benedire una trattativa politica ma solo per amichevole cortesia", raccontano al Palazzo apostolico. Ma questa versione "diplomatica" non cancella un’altra verità: e cioè che ai vertici della Segreteria di Stato e della Conferenza episcopale italiana serpeggia una certa preoccupazione per la "tenuta dell’intero sistema Paese". Le mobilitazioni di piazza, la manovra finanziaria contestata dagli enti locali, la prospettiva di pesanti ricadute sociali sulle fasce più deboli, hanno alzato il livello di attenzione anche Oltretevere. La pagina di pesanti critiche ai tagli dell’assistenza ai disabili, pubblicata pochi giorni fa dall’Avvenire, è stato l’ultimo campanello di allarme. E perfino il "duro" Giulio Tremonti ne ha dovuto tenere conto.
L’incontro a casa Vespa - occasione per il faccia a faccia tra il capo del governo e l’ex alleato Casini, sotto lo sguardo di Bertone - è avvenuto dopo una serie di contatti telefonici e dialoghi tra emissari del governo e dei centristi ai quali gli ambienti della Curia non sono rimasti estranei. Al termine della messa per i 50 anni di sacerdozio del segretario di Stato, martedì scorso in San Pietro, alcuni dei politici invitati si sono trattenuti per sondare il terreno di un confronto. Erano Gianni Letta, Maurizio Lupi, Gianni Alemanno e Lorenzo Cesa. Amico di vecchia data di Pier Ferdinando Casini, monsignor Rino Fisichella, da poco presidente del dicastero della nuova evangelizzazione, raccontano abbia avuto un ruolo nella tessitura della trama per riavvicinare i centristi al governo. Nessun intervento diretto. "Il Vaticano non offre alcun genere di sponda" mettono le mani avanti dai Palazzi Apostolici. Allo stesso tempo, però, la gerarchia cattolica non è indifferente, si muove per dare un "contributo indiretto".
È una strategia che in Vaticano crea anche tensioni. La presenza di Bertone alla tavola di casa Vespa ha sconcertato più di un prelato. "Quando c’era il cardinale Agostino Casaroli cose del genere non sono mai successe. Ma nemmeno col suo successore Angelo Sodano" è uno dei commenti che si raccolgono Oltretevere. "Un segretario di Stato non deve esporsi in questo modo e tantomeno essere usato per andare in soccorso di questo o quell’uomo politico col pretesto di una cena tra amici" dicono altri vescovi e cardinali interpellati nei vari uffici della Segreteria di Stato e delle Congregazioni pontiticie. "Perché va bene incontrare i rappresentanti delle istituzioni, ma ritrovarsi a cena per parlare, magari, di crisi politiche italiane e di futuri scenari governativi, non è una buona cosa per il primo collaboratore del papa", commenta un cardinale esperto di diplomazia, che ha lavorato in istituzioni internazionali con Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, il quale rimprovera al segretario di Stato di "imbarazzare, con queste cene private, sia il Papa sia tutta la Chiesa".
"Cenare con un amico politico non ci sarebbe niente di male, ma qui la posta in gioco è ben altra", commenta un altro porporato, che vede nella cena da Vespa "un’altra tappa centrata da Gianni Letta nella lunga marcia di riavvicinamento tra Santa Sede e governo dopo lo strappo di un anno fa, quando il direttore dell’Avvenire Dino Boffo fu costretto alle dimissioni per gli ingiusti attacchi del giornale di casa Berlusconi". "E’ incomprensibile che il cardinale Bertone dia l’impressione di stare a questo gioco, facendosi usare da una figura come il premier con cui non prenderei nemmeno un caffè e tantomeno darei l’ostia consacrata", lamenta un arcivescovo impegnato nella pastorale dell’immigrazione.
* la Repubblica, 11 luglio 2010
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- Berlusconi chiede l’aiuto di Bertone. "E’ il momento che l’Udc torni da noi" (di Francesco Bei).10 luglio 2010, di Federico La Sala
IL RETROSCENA
 Berlusconi chiede l’aiuto di Bertone
Berlusconi chiede l’aiuto di Bertone
 "E’ il momento che l’Udc torni da noi"
"E’ il momento che l’Udc torni da noi" Il tentativo fallito del Cavaliere a cena da Vespa con Draghi e Geronzi. Il Cavaliere offre all’ex alleato il ministero degli Esteri e la vicepresidenza. Ma il centrista blocca le avances
Il tentativo fallito del Cavaliere a cena da Vespa con Draghi e Geronzi. Il Cavaliere offre all’ex alleato il ministero degli Esteri e la vicepresidenza. Ma il centrista blocca le avances di FRANCESCO BEI
di FRANCESCO BEIGIOVEDI’ SERA. Poco prima di mezzanotte, una mercedes nera targata Città del Vaticano s’allontana per la discesa di via Gregoriana, a due passi da piazza di Spagna. Seduto dietro, il cardinale Tarcisio Bertone, segretario di Stato. Poco dopo, dallo stesso portoncino, escono nella notte romana Cesare Geronzi e Mario Draghi. Cosa ci facevano alla stessa tavola il primo collaboratore del Papa, il governatore della Banca d’Italia e il presidente di Generali? Assistevano all’ultimo, caparbio, tentativo del Cavaliere di evitare lo sfarinamento della sua maggioranza, iniettando forze fresche - quelle dei centristi di Pier Ferdinando Casini - in un momento di grande difficoltà.
L’occasione la crea Bruno Vespa che, con l’idea di voler festeggiare "con qualche amico" i suoi 50 anni di giornalismo, offre la sua terrazza su Trinità de Monti per una spericolata (e per ora infruttuosa) operazione politica. Dunque Berlusconi. Accompagnato da Gianni Letta, il premier appare da subito deciso a tentare l’affondo finale. Anche la cornice - da Bertone, rappresentante del Vaticano a Geronzi, custode del nuovo assetto finanziario italiano - sembra creata apposta per accerchiare Casini. Almeno così spera Berlusconi, che stavolta è pronto a mettere tutto sul piatto pur di imbarcare "Pier Ferdinando" e lasciare a terra quel "traditore" di Fini. La presenza del segretario di Stato vaticano, agli occhi del premier, dovrebbe rendere più "ragionevole" il cattolico Casini. Una convinzione tratta dai contatti con i vertici d’Oltretevere, per i quali Letta aveva ricevuto un incarico preciso. Così, dopo un vago richiamo alle "comuni radici del Ppe", il Cavaliere mette i piedi nel piatto: "Pier, noi apparteniamo alla stessa famiglia, i nostri elettori sono gli stessi. Cosa ci fai in quella compagnia di giro? Il tuo posto è alla guida del paese accanto a me. Se solo volessi potresti fare il vicepresidente del Consiglio, saresti il numero due del governo. Sceglieresti tu il successore di Scajola e magari potreste avere anche la Farnesina". Un’offerta succulenta e del resto il premier ha assoluto bisogno di tamponare l’emorragia finiana, costi quel che costi. Di cedere alle richieste del presidente della Camera non lo prende nemmeno in considerazione. Anzi, sta provando a sfilare a Fini tutti gli interlocutori. Compreso Francesco Rutelli, che non a caso è stato invitato da Gaetano Quagliariello ad aprire gli incontri estivi della fondazione Magna Carta.
"Fini ti ha già fregato una volta - ricorda Berlusconi a Casini - ha detto che rompeva con me e poi è corso a fare il Pdl lasciandoti da solo. Se tornassi con noi nessuno potrebbe dirti niente". Ma il leader dell’Udc, nonostante molti dei suoi non aspettino altro, anche stavolta delude il suo interlocutore. E non è solo la volontà di non farsi utilizzare contro Fini, prestandosi all’accusa di trasformismo parlamentare. Casini i suoi 39 deputati sarebbe anche disposto a concederli, ma solo in cambio di un "forte segnale di discontinuità" rispetto all’attuale maggioranza. Un "cambio di passo" che non potrebbe che essere marcato da una "crisi di governo" e dalle conseguenti dimissioni del premier. "Non posso semplicemente aggiungermi a voi - spiega dunque al Cavaliere - perché vorrebbe dire rinnegare tutto quello che abbiamo detto e fatto finora. Non si può cambiare la base parlamentare del governo senza tornare al Quirinale e noi non facciamo la ruota di scorta, mi dispiace". Altra cosa sarebbe se si presentasse un nuovo governo: "Silvio, a guidarlo saresti sempre tu, ma sarebbe una nuova maggioranza per un nuovo programma. Riforme difficili, anche impopolari, da fare insieme per uscire dalla crisi. In questo caso potremmo anche valutare l’ipotesi". Bertone ascolta in silenzio e non si intromette. Berlusconi appare teso, protesta. "Io non posso aprire una crisi al buio, come puoi chiedermi questo? Dovrei ammettere che abbiamo fallito e invece stiamo facendo e abbiamo fatto tanto". C’è poi un’altra preoccupazione che agita il Cavaliere e gli impedisce di dar corpo alla richiesta di Casini. Alla cena da Vespa non ne fa cenno, ma ieri - riferendo della serata a più di un ministro - confessa il suo vero cruccio: "Se si apre una crisi di governo la palla passa al Quirinale. Come faccio a fidarmi?". È lo spettro di un nuovo Dini, di un governo di transizione come quello nato nel ’95 sotto l’ala protettrice di Scalfaro.
* la Repubblica, 10 luglio 2010
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- quarantasette pagine di omelia incondizionata a favore dell’energia dell’atomo, confezionate dalla MAB.q - agenzia che cura la comunicazione dell’Enel (di Paola Medde - {{«Benedetto nucleare» Spot atomico dalle diocesi)6 luglio 2010, di Federico La Sala
«Benedetto nucleare» Spot atomico dalle diocesi
di Paola Medde *
Il nucleare è cosa buona e giusta. L’undicesimo comandamento suonerebbe così, secondo l’opuscolo dal messianico titolo Energia per il futuro : quarantasette pagine di omelia incondizionata a favore dell’energia dell’atomo, confezionate dalla MAB.q - agenzia che cura la comunicazione dell’Enel - e distribuite urbi et orbi in allegato con i periodici ufficiali di diverse diocesi italiane, da Oristano a Trento, da Agrigento a Padova.
La benedizione atomica, si legge nell’opuscolo, arriverebbe proprio dal Pontefice il quale «ha auspicato l’uso pacifico della tecnologia nucleare». Nessun dubbio: qualche riga più in là emerge ancora più netto l’orientamento della Chiesa, «la cui posizione ufficiale in materia è stata espressa dal cardinale Renato Raffaele Martino, presidente emerito del Pontificio Consiglio Giustizia e Pace: “La Santa Sede è favorevole e sostiene l’uso pacifico dell’energia nucleare, mentre ne avversa l’utilizzo militare”».
Seguono quaranta e più pagine di spot cuciti addosso all’idea che l’atomo sia una scelta salvifica: pulita, sicura, poco costosa, capace di rinfilare l’Italia dentro i tetti fissati dal protocollo di Kyoto. Peccato che se e quando si metteranno in moto i reattori nucleari, l’Italia sarà già in ritardo per il rispetto degli accordi sul clima. Ma tant’è: quale sponsor migliore, per l’atomico made in Italy, di un viatico religioso? Scopri lo sponsor
I giornali delle diocesi prendono le distanze dai contenuti: non sono stati loro a redarre l’opuscolo, si sono limitati a ospitarlo come una pubblicità, anche se in nessuna pagina sta scritto che si tratta di un’inserzione a pagamento e men che meno da chi è finanziata. Per capire chi in realtà abbia firmato questa operazione di sdoganamento catto-nucleare, facendola passare per un’obiettiva e asettica informazione, bisogna scivolare fino all’ultima pagina. Qui, nel retrocopertina, si scopre che a curare la pubblicazione è stata tale MAB.q, ermetica sigla dietro cui si nasconde l’agenzia di comunicazione di Egidio Maggioni, responsabile del Centro Tv Vaticana, che nel suo portafoglio clienti vanta un intero filone religioso - Radio Vaticana, Fondazione Giovanni Paolo II per lo Sport, Teleradio Padre Pio, Azione Cattolica, Comune di Lourdes - ma anche nomi di peso come Fondazione Cariplo, Regione Lazio ed Enel. Enel, appunto, che della torta nucleare si accaparrerà una fetta consistente: suoi quattro degli otto reattori che sorgeranno in Italia.
L’Ente nazionale energia elettrica nell’opuscolo figura più o meno come una comparsa nei titoli di coda, sfuggente, pressoché invisibile: risulta aver messo a disposizione solo il suo archivio fotografico ed offerto la collaborazione di un suo esperto, ma è intuibile chi abbia ispirato il progetto, attraverso il suo braccio operativo Sviluppo Nucleare Italia. Ed è intuibile che MAB.q sia l’anello di congiunzione tra l’Enel e la Chiesa. Del resto, quando Radio Vaticana aprì le porte alla pubblicità, è stato proprio il gigante dell’energia elettrica l’inserzionista di punta.
Quanto abbia fruttato l’allegato ai periodici diocesani non è dato sapere: alcuni di loro, di fronte alle proteste dei lettori, si sono affrettati a prendere il largo dai contenuti e a giustificare la scelta con le difficoltà economiche causate dall’abolizione delle tariffe postali agevolate per la stampa. Nessuna smentita o distinguo sono arrivati invece dal Vaticano, a cui non potrebbe essere sfuggita una strumentalizzazione, se di questo si trattasse, delle parole del Papa, a cui viene attribuita una netta posizione pro-nucleare.
Singolare, e chissà quanto casuale, è poi notare che nella geografia scomposta della distribuzione del libretto compaiano alcuni fra i territori più accreditati per l’installazione delle centrali come Oristano, che si candida a ospitare un impianto nella piana di Cirras, e Agrigento, dove designato sarebbe il centro di Palma di Montechiaro. Qui, semmai dovessero sorgere, i reattori saranno avviati con tanto di aspersione dell’acqua santa.
* l’Unità, 06 luglio 2010
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- Adesso si capisce perché c’è tanto feeling tra B. e il Vaticano. Sono tutti e due convinti di essere al di sopra (di Bruno Tinti -Lui e il Vaticano, questione di feeling)4 luglio 2010, di Federico La Sala
Lui e il Vaticano, questione di feeling
di Bruno Tinti (il Fatto Quotidiano, 3 luglio 2010)
Adesso si capisce un po’ meglio perché Vaticano e B&C vanno così d’accordo. In effetti un cattolico praticante e, per la verità, anche un laico raziocinante, avevano qualche difficoltà a capire come le più alte gerarchie della chiesa cattolica continuassero a gratificare B. della loro affettuosa solidarietà nonostante la figura morale dell’uomo fosse certamente abbietta. Probabilmente nei cattolici destava minor stupore il fatto che B, colpevole di gravi reati e assolto per prescrizione a seguito di una legge costruita da lui e nel suo personale interesse, venisse ciò non di meno ricevuto in Vaticano; in fondo di reati fiscali, societari, contro la pubblica amministrazione si trattava, il loro tasso d’immoralità poteva essere giudicato modesto da chi si occupa di anime e non di soldi (?).
Meno comprensibile poteva sembrare che le gerarchie ecclesiastiche continuassero ad avere rapporti cordiali con persona amica di imputati e condannati per mafia, chi in primo grado, chi in secondo, chi in via definitiva, e che aveva addirittura ospitato in casa sua un riconosciuto mafioso: ma insomma, che mafia e religione costituiscano un binomio pressoché inscindibile (basta osservare l’esibita ma sincera devozione dei mafiosi frequentatori abituali delle messe) è noto a tutti. Certamente incomprensibile e incoerente era però il permanere di ottimi rapporti con persona che si scopava puttane previamente convocate in allegri festini presso la residenza di governo, che frequentava senza apparenti ragioni istituzionali o semplicemente amicali una minorenne, che era, ohibò, divorziato e risposato civilmente, ragione per la quale a milioni di fedeli è rifiutato il sacramento della comunione. Questo proprio non si riusciva a capire.
Fino ad oggi, veramente, quando abbiamo scoperto che anche le alte gerarchie ecclesiastiche sono convinte che gli unti dal signore meritino l’impunità giudiziaria. Magistratura e polizia belghe indagano su atti di pedofilia commessi da ecclesiastici? Cercano le prove di questi disgustosi delitti? Eseguono perquisizioni e, chissà, intercettazioni telefoniche (lì si può, pare che sia considerata una cosa intelligente da fare se si vogliono scoprire reati e colpevoli)? Addirittura trovano documentazione comprovante le violenze sessuali commesse da ecclesiastici in danno di bambini? Perfino sequestrano questa documentazione? E come reagisce la chiesa belga? La commissione nominata dalla conferenza episcopale si dimette per protesta: perché le indagini le dovevano fare loro per primi; poi, in piena trasparenza, ne avrebbero comunicato i risultati a polizia e magistratura. Da morir dal ridere, se non fosse drammatico.
Ma questa è la chiesa belga, si dirà, intemperanze alla periferia dell’Impero; che c’entra il Vaticano? Eh, non è stato il Vaticano a esprimere stupore e sdegno per le indagini della polizia belga? E non è stato tale padre Federico Lombardi, portavoce del Vaticano, a sostenere che le condotte tenute dalla Chiesa “non hanno inteso e non hanno favorito alcuna copertura di tali delitti, ma anzi hanno messo in atto un’intensa attività per affrontare, giudicare e punire adeguatamente tali delitti nel quadro dell’ordinamento ecclesiastico”? E alla fine non è stato il Vaticano che ha presentato un ricorso alla Corte Suprema degli Stati Uniti sostenendo la sua immunità a fronte delle denunce delle vittime di tale Andrew Ronan, un prete pedofilo, come tale noto alla sua gerarchia, che però si era limitata a trasferirlo di sede in sede ogni volta che veniva denunciato? E, alla fine, non sono stati lo stesso Papa e il cardinale Bertone ad incazzarsi con la polizia e la magistratura belghe?
Così adesso si capisce perché c’è tanto feeling tra B. e il Vaticano. Sono tutti e due convinti di essere al di sopra della legge. Il Vaticano perché è unto dal Signore; e B. perché è unto dal popolo. È quest’originale battesimo che rende inapplicabile ai preti pedofili la giustizia secolare: i loro delitti saranno puniti “adeguatamente nel quadro dell’ordinamento ecclesiastico”. Il che comunque sarebbe sempre meglio (se davvero avvenisse, ma la storia di padre Ronan non autorizza molta fiducia) di quanto avviene nell’entourage di B&C, dove non solo non si “punisce” nessuno ma chi commette delitti fa carriera politica. Sarà perché in Italia manca una figura (per dire, vista l’impresentabilità di B&C, magari il presidente della Repubblica) che possa convincentemente affermare, come ha fatto il premier belga Yves Leterme: “Ciò che mi interessa, come primo ministro di questo paese, è che il potere giudiziario possa esprimersi in modo autonomo ed è proprio questo che sta succedendo. Le perquisizioni sono la prova che in questo paese c’è una separazione di poteri tra Stato e Chiesa e che il potere giudiziario può agire in modo autonomo”?
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- POLITICA E SCUOLA. Per la scuola italiana travolta dai tagli, l’unico segno più è per gli insegnanti di Religione (di Salvo Intravaia).2 luglio 2010, di Federico La Sala
TAGLI
 In un anno 4% di insegnanti in meno
In un anno 4% di insegnanti in meno
 ma i prof di religione sono ancora in crescita
ma i prof di religione sono ancora in crescitaIn 12 mesi i bidelli e i tecnici del 6%. L’unico dato in controtendenza, tra quelli forniti dal ministero, riguarda i docenti dell’unica ora facoltativa. Per il resto meno cattedre e classi, e precari espulsi
di SALVO INTRAVAIA *
ROMA - Per la scuola italiana travolta dai tagli, l’unico segno più è per gli insegnanti di Religione. Il ministero dell’Istruzione ha appena pubblicato l’annuale dossier dal titolo "La scuola statale - sintesi dei dati, anno scolastico 2009/2010": il corposo volume di 342 pagine che contiene tutti i numeri dell’anno appena trascorso. Una pubblicazione di routine, che quest’anno però riserva una sorpresa: in mezzo a tanti segni meno, rispetto al 2008/2009 una delle poche voci che cresce è quella dei docenti di Religione. E’ lo stesso ministero a certificarlo.
Il confronto con un anno fa consegna un quadro della scuola italiana con sacrifici per tutti, dagli alunni disabili ai precari, tranne che per gli insegnanti di Religione. Un dato che appare in netta controtendenza col taglio delle classi e con il lento ma graduale spopolamento delle aule quando sale in cattedra il docente individuato dal vescovo. Quella dei docenti che impartiscono l’unica ora di lezione facoltativa prevista dall’ordinamento scolastico italiano è questione che ha destato sempre polemiche.
Quando nel 2004 l’allora ministro dell’Istruzione, Letizia Moratti, pensò di stabilizzarli attraverso due distinti concorsi il mondo politico-sindacale si spaccò in due. Anche perché tra i titoli necessari per accedere al concorso, riservato a coloro che avevano prestato servizio per almeno 4 anni negli ultimi dieci (dal 1993/1994 al 2002/2003), occorreva essere in possesso dell’idoneità rilasciata dall’ordinario diocesano. Ma il secondo governo Berlusconi non si curò troppo delle polemiche e bandì ugualmente il concorso, che nel settembre 2005 consentì per la prima volta nella storia dello Stato italiano l’immissione in ruolo dei primi 9167 docenti di Religione. Da allora il loro numero è sempre cresciuto, fino alla cifra record (26.326 unità) dell’anno scolastico appena archiviato. I quasi 14 mila prof di ruolo, in leggera flessione rispetto a 12 mesi fa, sono stati abbondantemente compensati dai colleghi precari: 12.446 in tutto.
Nel frattempo, la scuola italiana è stata oggetto di tagli senza precedenti. Nel triennio 2009/2012 spariranno 133 mila cattedre per un totale di 8 miliardi di euro. Ma non solo: l’incremento degli alunni disabili (da 175.778 a 181.177 unità) è stato fronteggiato con un taglio netto di oltre 300 cattedre di sostegno. Quasi 37 mila alunni in più sono stati stipati in 4 mila classi in meno. E sono diminuiti persino i plessi scolastici: 92 in meno. È toccato al personale della scuola pagare il prezzo più alto al risanamento dei conti pubblici. In un solo anno gli insegnanti di ruolo sono calati del 4%, senza nessun recupero da parte dei precari che hanno dovuto salutare quasi 14 mila incarichi con relativo stipendio. Per non parlare del personale di segreteria, dei bidelli e dei tecnici di laboratorio: meno 6% in 12 mesi.
L’anno appena trascorso ha visto anche il varo della riforma Gelmini per il primo ciclo (scuola elementare e media), col calo delle ore di lezione e del tempo prolungato alla scuola media. Ma è stato anche l’anno delle proteste dei dirigenti scolastici per il taglio ai fondi d’istituto e del congelamento per un triennio (dal 2011 al 2013) degli stipendi degli insegnanti.
* la Repubblica, 02 luglio 2010
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- LA TEOLOGIA DEL MENTITORE, LA CHIESA DI COSTANTINO, E LA SOVRANITA’ DEL PAPA. Perché il papa difende Sodano? Un’analisi di Vito Mancuso.1 luglio 2010, di Federico La Sala
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- L’indecenza istituzionale (di Massimo Giannini).1 luglio 2010, di Federico La Sala
L’indecenza istituzionale
di MASSIMO GIANNINI *
I GIURISTI inglesi dell’800 sostenevano che ci sono solo due modi per governare una società: l’opinione pubblica e la spada. Con l’affondo sulla legge che limita le intercettazioni Silvio Berlusconi li sta pericolosamente sperimentando tutti e due. Impone il bavaglio ai mass-media, per evitare che i cittadini sappiano ciò che si muove dentro e intorno al potere politico. Dispone il blitz in Parlamento, per costringerlo a votare questa legge-vergogna prima della pausa estiva.
Quanto accaduto alla Camera la dice lunga sullo stato di esaltazione e insieme di confusione che anima la maggioranza e il suo leader. C’è un presidente del Consiglio che alterna episodici momenti di ragionevolezza e drammatici sprazzi di dissennatezza. Ieri sono andati in scena i secondi: il premier ha voluto a tutti i costi che la conferenza dei capigruppo di Montecitorio calendarizzasse per il 29 luglio la discussione in aula del testo sulle intercettazioni. E ci è riuscito. Con il risultato, paradossale, che il dibattito sulla legge-bavaglio finirà per intrecciarsi a quello sulla manovra economica. Con buona pace degli appelli del presidente della Repubblica, che aveva invocato senso di responsabilità e aveva chiesto ai partiti di dare la priorità assoluta alla manovra, l’unico tema che sta realmente a cuore agli italiani, e di lasciar perdere le questioni che hanno come unico effetto quello di avvelenare i pozzi del confronto parlamentare e del discorso pubblico. Una mossa pericolosa, dunque. Benzina sul fuoco, alla vigilia della manifestazione contro la legge-bavaglio organizzata oggi in diverse piazze d’Italia.
In questa mossa del premier c’è un profilo di indecenza istituzionale, già ampiamente dimostrata dalle continue provocazioni contro il Quirinale. E c’è un profilo di arroganza politica, già ripetutamente esercitata attraverso i continui attacchi contro i nemici interni della maggioranza e quelli esterni dell’opposizione. Fa bene il Pd, insieme a tutte le forze che si oppongono a questo centrodestra, ad annunciare un Vietnam parlamentare, di fronte all’ennesima forzatura voluta dal capo del governo. Ma stavolta, occorre dirlo, ha fatto male il presidente della Camera ad accettare il diktat dei capigruppo della maggioranza, salvo poi far filtrare a giochi fatti la sua presa di distanza. "Una scelta irragionevole", l’ha definita Gianfranco Fini. Ma se davvero la considerava tale, avrebbe potuto e dovuto evitarla, invece che avallarla. A livello personale Fini incassa un vantaggio: smarcandosi dal Cavaliere nella forma lucra il massimo della rendita mediatica, dandogliela vinta nella sostanza non paga alcun prezzo politico. Ma a livello più generale il calcolo è ben diverso. Il giochino è a somma zero: stavolta non c’è stata alcuna "riduzione del danno" (che il co-fondatore del Pdl dice spesso di perseguire, per arginare i disastri imputabili al fondatore). Stavolta, in questa provocatoria accelerazione puntualmente benedetta da Bossi in nome del sacro federalismo, c’è solo il "danno". E rischiamo di pagarlo tutti.
C’è un profilo di tutela giurisdizionale delle indagini, irrinunciabili in qualunque Stato di diritto. Non c’è da aggiungere altro, rispetto a quanto hanno denunciato durante le audizioni in Commissione giustizia di Montecitorio non solo e non tanto dalle famigerate "toghe rosse" dell’Anm, quanto piuttosto dai magistrati in prima linea. Per esempio Pietro Grasso, procuratore nazionale antimafia: "Il disegno di legge, con le ultime modifiche, ha peggiorato la situazione per quanto riguarda la mafia e il terrorismo, con effetti devastanti sulle indagini... Le intercettazioni ambientali non si potranno più fare nei luoghi privati di dimora perché hanno bisogno, per essere autorizzate, della dimostrazione che in quel posto si sta commettendo un reato: agli inquirenti si chiede una ’prova diabolicà impossibile da fornire". Oppure Giovandomenico Lepore, procuratore capo di Napoli: "Le limitazioni alle intercettazioni danneggiano le indagini... Difficilmente, senza le intercettazioni, avremmo potuto capire come si svolgeva il traffico di droga che ci ha appena portato all’arresto di 28 persone nel quartiere San Giovanni a Teduccio". O ancora Rosario Cantelmo, procuratore aggiunto: "In 40 giorni di osservazione sono state documentate 870 azioni di spaccio. Tutto ciò non sarebbe stato possibile con la nuova legge". O infine Antonio Ingroia, procuratore antimafia a Palermo: "Le intercettazioni sono il principale strumento di indagine contro la criminalità mafiosa, economica e politica; oggi l’80% delle indagini si basa su questo strumento... Se il ddl passasse senza modifiche si tornerebbe indietro di 40 anni".
C’è un profilo di tutela costituzionale dei diritti, insopprimibili per qualunque democrazia. Lo sosteniano da settimane, anche attraverso la campagna dei post-it: la legge-bavaglio nega ai cittadini il diritto di essere informati. E l’informazione, in questo testo inemendabile, è violata in senso attivo e passivo: la legge-bavaglio nega ai mass media il diritto di informare. In nome di un’idea malintesa della privacy, e con il pretesto della difesa della riservatezza, il centrodestra opera un clamoroso sbilanciamento tra i diritti costituzionali meritevoli di tutela. Lo hanno detto e scritto i più autorevoli giuristi italiani, da Gustavo Zagrebelski a Valerio Onida. Ora lo ripete anche il Garante per la privacy Francesco Pizzetti, nella sua relazione annuale al Parlamento: "Nel ddl sulle intercettazioni si sposta oggettivamente il punto di equilibrio tra libertà di stampa e tutela della riservatezza, tutto a favore della riservatezza, e questo può giustificare che da molte parti si affermi che, così facendo, si pone in pericolo la libertà di stampa". È esattamente quello che pensiamo, al di là di tutte le risibili distorsioni ermeneutiche in cui si sono cimentati i cortigiani del Pdl. Ed è confortante che a ribadirlo sia il presidente di un’Authority, proprio nel momento in cui Berlusconi e il suo "cardinal Mazzarino" (l’immarcescibile Gianni Letta) usano queste istituzioni amministrative indipendenti come "succursali" governative in cui spartire e moltiplicare poltrone, a beneficio della solita "cricca" dei grand commis di regime.
Per tutte queste ragioni, la legge-bavaglio non può e non deve passare, nonostante i colpi di spada del presidente del Consiglio e i suoi dissennati appelli a scioperare contro i giornali. "Un giornalismo onesto e indipendente è la forza più possente che la civiltà moderna abbia sviluppato. Malgrado i suoi errori è indispensabile alla vita delle persone libere. Le frontiere del privilegio costituzionale della stampa sono tanto ampie quanto il pensiero umano...". Lo scrisse un secolo fa Alton Parker, giudice supremo della Corte d’Appello di New York. Un magistrato di enorme spessore, che contribuì a fare grande la democrazia americana. Una "toga" che Berlusconi, oggi, definirebbe senz’altro una "metastasi".
* la Repubblica, 01 luglio 2010
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- L’IMMUNITA’ UN’OFFESA AL BUON SENSO (di Michele Ainis).2 luglio 2010, di Federico La Sala
L’immunità un’offesa al buon senso
di MICHELE AINIS (La Stampa, 2/7/2010)
King cannot wrong»: il re non può sbagliare, recita un’antica massima della democrazia inglese. È dunque irresponsabile, se non infallibile tal quale il Papa, come stabilì Pio IX nel 1870.
Invece nella nuova democrazia italiana irresponsabili e infallibili sono i ministri, quale ne sia il numero, il sesso, la fedina penale. Così vuole il lodo Alfano nel suo abito costituzionale. Un abito peraltro continuamente allargato e ricucito nella sartoria del Senato; o dovremmo chiamarlo lodo Brancher?
L’ultima idea - quella di estendere lo scudo processuale alle iniziative giudiziarie inaugurate prima che l’imputato giurasse da ministro - sembra in effetti tagliata su misura per il neoministro a Non si sa che cosa. Significa che è un’idea incostituzionale? No di certo: ormai è vietato concludere i processi, figurarsi i processi alle intenzioni. E d’altronde già la Carta del 1947 elenca una serie d’immunità per le alte cariche; dunque l’immunità di per sé non viola il principio d’eguaglianza, altrimenti dovremmo reputare incostituzionale la Costituzione stessa. Purché ogni immunità venga introdotta attraverso il procedimento di revisione costituzionale, non con legge ordinaria: così ha sentenziato l’anno scorso la Consulta, così effettivamente sta operando la maggioranza di governo.
No, non c’è un attentato alla Costituzione in questo lodo redivivo. C’è piuttosto un’offesa al buon senso, oltre che al buon gusto. Perché mai, difatti, l’immunità dovrebbe estendersi ai reati commessi prima del giuramento da ministro? Se la risposta è il fumus persecutionis, ossia il sospetto che l’inchiesta giudiziaria risponda a una finalità politica, allora è come dire che i magistrati italiani hanno la palla di vetro. E perché il nuovo lodo protegge i ministri con una diga più alta di quella eretta nell’art. 96 della Costituzione? Quest’ultima norma concerne i reati funzionali, compiuti guidando un dicastero; il lodo tocca viceversa i delitti comuni. Insomma d’ora in poi ogni ministro sarà più tutelato se fa una rapina in banca anziché un abuso d’ufficio. E perché infine l’autorizzazione a procedere viene affidata alla maggioranza semplice delle assemblee legislative? Siccome tale maggioranza è lo sgabello su cui poggia il governo, siccome la sua sopravvivenza in Parlamento dipende dalla sopravvivenza del governo, è un po’ come consegnare un fucile a chi ha le manette ai polsi.
Eccolo infatti il vizio (logico, prima ancora che giuridico) di questo nuovo lodo. Non è illegittimo, è inopportuno. Peggiora la qualità delle nostre istituzioni, anziché innalzarla. Infine erode sotto traccia l’autorità del Capo dello Stato. Il presidente della commissione Giustizia del Senato ha dichiarato che sarebbe ingiusto negare al premier il medesimo scudo processuale per i reati pregressi di cui potrà avvalersi il Quirinale. Errore: lì abita la prima carica dello Stato, il presidente del Consiglio è soltanto la quarta. Ma il vero errore sta nel voto a maggioranza semplice con cui le Camere decideranno l’autorizzazione a procedere verso il Capo dello Stato: un improprio voto di fiducia, ha osservato Paolo Caretti. O altrimenti un’arma di ricatto. Meglio la maggioranza assoluta, come del resto vuole l’art. 90 della Costituzione per i reati presidenziali. O l’improcedibilità tout court, quale esiste in Francia, Israele, Grecia, Portogallo.
Ma l’opportunità è una categoria dello spirito, non della politica. A noi che non abbiamo scudi processuali sembrerà forse inopportuno tutto questo scalmanarsi attorno allo scudo dei potenti, prima con il lodo Schifani, poi con il lodo Alfano, poi con il legittimo impedimento, poi con il lodo Alfano bis. Suoneranno altrettanto inopportune le proclamazioni sui principi - la forma di governo, il federalismo, la libertà d’impresa nel nuovo art. 41 - quando le uniche riforme che poi approdano a riva sono quelle che hanno di mira la giustizia. Ci parrà infine inopportuno venire scomodati per il referendum costituzionale che giocoforza accompagnerà questo nuovo lodo. Ma ci scomoderemo.
michele.ainis@uniroma3.it
-
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- IL CROCIFISSO E IL TOTALITARISMO MASCHERATO. Da Bagnasco a Berlusconi, da Bertone a Napolitano ... (di Marco Politi - Laicità in croce).25 giugno 2010, di Federico La Sala
Laicità in croce
di Marco Politi (il Fatto Quotidiano, 25 giugno 2010)
Da Bagnasco a Berlusconi, da Bertone a Napolitano: in attesa della sentenza definitiva della Corte europea sul crocifisso si moltiplicano gli interventi. Sorge artificialmente lo spettro di giudici decisi a conculcare il sentimento religioso italiano. Ha detto il capo dello Stato che le sentenze europee “devono essere comunque accettate”. Ma ha soggiunto che la “laicità dell’Europa non può essere concepita e vissuta in termini tali da ferire sentimenti popolari e profondi”. In realtà la Corte di Strasburgo, a novembre scorso, ha sancito un principio pacifico in tanti altri Paesi: l’esposizione nelle aule scolastiche del simbolo religioso (per di più unico simbolo esposto) rappresenta una “violazione della libertà dei genitori di educare i figli secondo le loro convinzioni e della libertà di religione degli alunni”.
Da allora sono partite pressioni molteplici perché il secondo grado della Corte di Strasburgo sconfessi la prima sentenza. Si è mobilitata la Cei, si è mosso il governo, si sono allertato l’associazionismo cattolico, facendo un gran parlare di identità, tradizioni, libertà. Berlusconi proclama che la decisione “inaccettabile per la stragrande maggiorana degli italiani”, il cardinal Bagnasco chiede il “rispetto della libertà religiosa”, il cardinale Bertone definisce la croce “espressione identitaria, strettamente connessa con la storia e la tradizione dell’Italia come pure dei popoli europei”. In realtà non un solo argomento, portato in campo in questi mesi per difendere la presenza obbligatoria del crocifisso nelle aule e nei tribunali, ha un fondamento. L’Unione europea
 tranne la pattuglia isolata di Polonia, Irlanda, Italia e Malta - respinse a schiacciante maggioranza
dei suoi 27 stati la menzione delle “radici cristiane” nella propria costituzione. Non fu negazione del
ruolo del cristianesimo nella storia europea, bensì rifiuto che da un generico richiamo costituzionale
potessero scaturire, direttamente o indirettamente, situazioni di privilegio per una religione.
tranne la pattuglia isolata di Polonia, Irlanda, Italia e Malta - respinse a schiacciante maggioranza
dei suoi 27 stati la menzione delle “radici cristiane” nella propria costituzione. Non fu negazione del
ruolo del cristianesimo nella storia europea, bensì rifiuto che da un generico richiamo costituzionale
potessero scaturire, direttamente o indirettamente, situazioni di privilegio per una religione.Che l’Europa sovranazionale sia laicista o antireligiosa è falso: infatti il trattato costituzionale prevede un “dialogo permanente” con le varie Chiese. Falso è anche dire che la sentenza respingerebbe la fede nell’ambito angusto del “recinto privato”. Il cristianesimo, come ogni altra fede, è totalmente libero di esprimersi collettivamente e visibilmente nello spazio pubblico e sociale dei paesi Ue. Parlare in Italia di un cristianesimo che rischia di essere conculcato, è una gag.
Ciò che indica la prima sentenza della Corte europea è, correttamente, l’impossibilità che in uno spazio istituzionale come la scuola (o i tribunali) vi sia un simbolo religioso che visivamente rappresenti il supremo principio ispiratore dell’educazione (o della giustizia). Non ci può essere nella società pluralistica contemporanea il dito indice di una sola religione, che all’interno di un’istituzione segni la via da seguire. Perché non è vero che il crocifisso sia nelle aule o nei tribunali “per tradizione”. La croce nei luoghi istituzionali è il retaggio dei secoli in cui il cattolicesimo era religione di stato. E il tentativo di imporne la presenza, anche oggi che la Costituzione e il Concordato hanno eliminato qualsiasi riferimento ad una religione di stato, non ha più nessuna base giuridica. Meno che mai è giustificato il tentativo surrettizio delle gerarchie ecclesiastiche di creare e crearsi uno status privilegiato di “religione di maggioranza”. Peraltro i giovani italiani, come dimostra l’ultima indagine Iard riportata dall’Avvenire, si sentono “cattolici” soltanto al 52 per cento.
Neanche è vero che il cattolicesimo sia un tratto universale dell’identità italiana. Ogni cittadino ha la sua storia, la sua cultura, le sue credenze. Sul piano istituzionale è certo che un solo simbolo, il Tricolore, rappresenta tutti (con buona pace di Bossi) e una sola immagine rappresenta nei luoghi pubblici l’unità della nazione, quella del presidente della Repubblica (Berlusconi se ne faccia una ragione). Da questo punto di vista rimane insuperabile la chiarezza del principio costituzionale americano (nazione assai religiosa e spesso citata da Benedetto XVI come esempio di laicità positiva), secondo cui lo Stato non può “né favorire né contrastare una religione”. Nelle scuole americane c’è la bandiera a stelle e strisce, non il crocifisso.
C’è un accenno interessante nel recente intervento di Napolitano. Il richiamo ad una una laicità “inclusiva”, disponibile ad accogliere ed amalgamare le “tradizioni più diverse”. Se è così, si abbia il coraggio di lasciare scegliere gli alunni se nella propria classe vogliono una parete neutrale oppure tale da accogliere la pluralità dei simboli religiosi e filosofici, che ciascuno sente consono.
O si rispetta la libertà di coscienza come astensione volontaria da qualsiasi marchio o si lascia libera l’espressione di tutti. Decidere, invece, di imporre un simbolo dichiarato unilateralmente valido per tutti è totalitarismo mascherato.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- QUELL’ATTACCO POSTUMO A SARAMAGO (di Corrado Augias)22 giugno 2010, di Federico La Sala
Quell’attacco postumo a Saramago
risponde Corrado Augias (la Repubblica, 22.06.2010)
Caro Augias,
anche se viene sempre meno la voglia di scandalizzarsi, non posso fare a meno di provare vergogna per il tremendo attacco che l’Osservatore Romano ha dedicato a José Saramago dopo la morte. Un intervento pieno di livore. Un tempo la Chiesa sapeva distinguere tra peccato e peccatore affidava a Dio "misericordioso" anche l’anima di coloro che considerava irrecuperabili peccatori. La Chiesa di oggi, al centro di scandali di ogni genere, ha perso la tradizionale prudenza ed è diventata una protagonista attiva del penoso dibattito dei nostri giorni che consiste, sempre, nella demonizzazione dell’avversario, senza preoccuparsi per nulla, in particolare con Saramago, del fatto che, il pericoloso avversario, è passato a miglior (o peggior) vita, non avendo, perciò, possibilità di replica.
 Antonio Cammelli
Antonio Cammelli
 Firenze cammelli.a@tiscali.it
Firenze cammelli.a@tiscali.itHa molto colpito l’attacco post mortem ad uno scrittore premio Nobel che ha onorato l’arte sua, quali che fossero le sue idee in materia religiosa. Anche in altre materie, peraltro. Per esempio sulla politica dello Stato d’Israele, da lui condannata senza mezzi termini suscitando anche in questo caso aspre reazioni. Capisco il nervosismo di un paese in questo momento in forti difficoltà.
Ma l’organo ufficiale della Chiesa cattolica, che si vuole ispirata direttamente dal Cielo, avrebbe potuto argomentare con più misericordia verso un morto. Saramago vedeva nella diffusione del Male nel mondo una delle prove dell’inesistenza di Dio. Quanto meno del Dio della teologia cattolica. E’ un problema antico, più volte affrontato anche da grandi spiriti, mai risolto. Credo irrisolvibile.
Francesco Leporino (gransole@gransole.net) mi ricorda che: « L’uomo Saramago ha detto: "La bontà è una delle forme più alte di intelligenza!". Strappare al Cristianesimo il monopolio della bontà e iscriverlo in un pensiero illuminista, farne una categoria dell’intelligenza (e non del timor di dio) è stata una verità semplice e rivoluzionaria».
Francesco de Goyzueta da Napoli (fdegoyzueta@ extratel.it) scrive: « Saramago, grande voce civile che si è appena spenta, ha detto: "Dev’essere duro vivere quando il potere politico e quello imprenditoriale si riuniscono. Non invidio la sorte degli italiani, però alla fine è nella volontà degli elettori mantenere questo stato di cose o cambiarlo". Veemente dunque, ma anche rispettoso della democrazia».
Fulvio Bossino scrive: « Complimenti al Vaticano, tramite il suo organo di stampa introduce contro Saramago un nuovo genere letterario: dopo l’elogio funebre abbiamo finalmente l’insulto funebre».
Andrea Sillioni (Bolsena) è secco: «Fa rabbrividire una Chiesa che teme ancora, nel duemila, l’intellettualità atea e materialista».
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ... L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI ADOLF EICHMANN, IL SERVITORE DELLO STATO, E IL BUIO TOTALE!!! (di Federico La Sala18 giugno 2010, di Federico La Sala
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- L’IDEOLOGIA ATEO-DEVOTA DELLA "SOVRANITA’ PRIVATA" DEL PAPA-IMPRENDITORE E DELL’IMPRENDITORE-PAPA.15 giugno 2010, di Federico La Sala
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- LA COSTITUZIONE COME L’INFERNO: LA TEOLOGIA POLITICA DELLA "SOVRANITA’ PRIVATA" DELL’IMPRENDITORE E LA COSTITUZIONE (di Carlo Galli).12 giugno 2010, di Federico La Sala
 L’ALLEANZA "STATO -CHIESA" CONTRO L’ "INFERNO" ("Questa Costituzione è un inferno"): UNA QUESTIONE POLITICA E MORALE, EPOCALE!!!
L’ALLEANZA "STATO -CHIESA" CONTRO L’ "INFERNO" ("Questa Costituzione è un inferno"): UNA QUESTIONE POLITICA E MORALE, EPOCALE!!!
 LA TEOLOGIA POLITICA DELLA "SOVRANITA’ PRIVATA" DELL’IMPRENDITORE E LA COSTITUZIONE. Carlo Galli comincia a rendersi conto che nel 1994 è nato il presidente della "repubblica" del "popolo della liberta’". Una sua nota - a cura di Federico La Sala
LA TEOLOGIA POLITICA DELLA "SOVRANITA’ PRIVATA" DELL’IMPRENDITORE E LA COSTITUZIONE. Carlo Galli comincia a rendersi conto che nel 1994 è nato il presidente della "repubblica" del "popolo della liberta’". Una sua nota - a cura di Federico La Sala
 (...) Se Berlusconi afferma che agire secondo la Costituzione è un inferno, evidentemente pensa che il paradiso sia il potere senza limiti: il potere privato di un padrone (in greco, despòtes), reso onnipotente dall’investitura popolare.
(...) Se Berlusconi afferma che agire secondo la Costituzione è un inferno, evidentemente pensa che il paradiso sia il potere senza limiti: il potere privato di un padrone (in greco, despòtes), reso onnipotente dall’investitura popolare.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- Meditazione su una moneta da due euro... (di Jacques Noyer, vescovo emerito di Amiens).10 giugno 2010, di Federico La Sala
 Meditazione su una moneta da due euro...
Meditazione su una moneta da due euro... di Jacques Noyer, vescovo emerito di Amiens
di Jacques Noyer, vescovo emerito di Amiens in “Témoignage chrétien” n° 3398 del 27 maggio 2010 (traduzione: www.finesettimana.org)
in “Témoignage chrétien” n° 3398 del 27 maggio 2010 (traduzione: www.finesettimana.org)I miliardi di euro o di dollari volano a squadriglie sopra le nostre teste. Inquietanti come i bombardieri dell’ultima guerra. È per il nostro bene, si dice. Bisogna salvare l’Europa. Bisogna salvare la Francia. Da molto tempo hanno superato il muro del suono. Adesso vanno alla velocità della luce. Un clic, e sono qui. Un clic, e sono là. Chi li governa? Chi li conduce? Non si sa bene: è lui, sono io, sei tu... Tutt’a un tratto qui una fabbrica chiude, il cacao non vale più niente e il rame vale oro, una regione è senza lavoro, degli Stati minacciamo fallimento e i miliardari sono sempre più numerosi.
Ma chi mai ha inventato questo denaro che ci fa tanto male e di cui non possiamo fare a meno? Come la parola, come la scrittura, come la cultura, l’uomo ha inventato la moneta ed è la moneta che lo fa. Gli scambi necessari vi trovano la loro misura e vi cercano la loro giustizia. La moneta permette la scelta e apre alla libertà. Nel Vangelo, Gesù non chiede al giovane ricco di di dare i suoi beni ai poveri, ma di venderli e di darne ai poveri il ricavato. La moneta è incontestabilmente il passaggio in un mondo più umano. Si ha torto di parlare del materialismo del denaro. Esso appartiene all’ordine dello spirito.
Prima di essere chiamato Mammona da Gesù, il soldo che paga la giornata di lavoro, la dracma che viene perduta dalla donna, il talento che il servo riceve dal suo padrone, la doppia dracma che bisogna pagare al tempio o le monetine offerte dalla vedova ottengono la sua approvazione e il suo interesse.
Quando l’oro si mette a brillare per se stesso facendo dimenticare il sudore, la gioia, la fatica, la solidarietà, la riconoscenza, la sicurezza, la carità che gli danno il suo valore umano, comincia il suo ruolo di ingannatore. L’oro, diventando moneta, sfugge alla saturazione degli appetiti, al tempo necessario alla raccolta o alla produzione, al ritmo delle stagioni e alla diversità dei climi. Tende a diventare un al-di-là autonomo, paradiso e inferno, luogo di salvezza o di perdizione. Si divinizza.
Ecco allora il denaro nel suo orribile ruolo di Mammona, il divoratore di vita. È presente fin dall’inizio, nelle prime conchiglie che si sono scambiati gli uomini. È presente come Satana nelle prime parole pronunciate da Adamo ed Eva. Perché tale è la condizione dell’uomo che entra nell’universo dei segni: ciò che significa può ingannare, ciò che manifesta può nascondere, ciò che promette può deludere, colui che parla può essere un bugiardo. E grande è la tentazione di usare il denaro per comprare, per dominare, per spogliare, per possedere il concorrente a cui si fa credere di essere suoi amici. Diventa il nervo della guerra e spesso il suo movente. È il vitello d’oro delle nostre liturgie mondane. È il dio dai mille volti dei nostri panteon.
Prendiamo in mano una moneta. Come ha fatto Gesù per mostrarci ciò che dovevamo a Cesare. Se vi vediamo la fatica di una giornata di lavoro sotto il sole africano, il cibo quotidiano di un bambino bengalese o ciò che manca al nostro giovane vicino per arrivare alla fine del suo corso di studi, vedremo anche la fiducia collettiva che permette a quel gettone di metallo di acquisire valore, l’energia di tutto un popolo senza la quale la sua moneta sarebbe solo polvere, la solidarietà che distribuisce così a ciascuno un po’ della dignità umana. Il denaro è troppo prezioso per perderne il controllo.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- Resistenza e resa (Dietrich Bonhoeffer). Il problema degli stupidi (di Goffredo Fofi).6 giugno 2010, di Federico La Sala
Il problema degli stupidi
di Goffredo Fofi (l’Unità, 6 giugno 2010)
Dieci anni dopo è il titolo del testo che il pastore protestante Dietrich Bonhoeffer scrisse nella prigione dove era rinchiuso in attesa di venire impiccato per la sua partecipazione all’attentato a Hitler. Lo ebbero fortunosamente i suoi famigliari ed è compreso in un libro che è un classico, Resistenza e resa (Edizioni Paoline 1989, a cura di un amico prematuramente scomparso, Alberto Gallas), che documenta la traversata degli anni bui di una grande anima, dalla nonviolenza alla sofferta decisione di intervenire.
Un decennio dopo la vittoria elettorale del nazismo, il testo di Bonhoeffer è una riflessione che ha perfino di più che in passato molto da insegnarci. Il punto centrale ne è la riflessione sulla “stupidità”. «Per il bene la stupidità è un nemico più pericoloso della malvagità. Contro il male è possibile protestare, ci si può compromettere, in caso di necessità è possibile opporsi con la forza (...) ma contro la stupidità non abbiamo difese». Lo stupido è soddisfatto di sé e «non ascolta argomentazioni », ma parlandogli «ci si accorge che non si ha a che fare direttamente con lui personalmente, ma con slogan, motti ecc. da cui egli è dominato». Lo stupido è «ammaliato, accecato, vittima di un abuso e di un trattamento pervertito, (...) è uno strumento senza volontà» che proprio per questo può essere «capace di qualsiasi malvagità, essendo contemporaneamente incapace di riconoscerla come tale». Una sua «liberazione interiore è possibile, nella maggioranza dei casi», dice Bonhoeffer, «solo dopo esser stata preceduta dalla liberazione esteriore; fino a quel momento dovremo rinunciare ad ogni tentativo di convincere lo stupido».
Inutile cercar di capire cosa pensi “Il popolo” da parte di chi «pensa e agisce in modo responsabile». Utile è cercar di fare quanto è possibile perché reimpari a pensare, ma a partire da cosa se non dall’esempio di pochi, dall’attenzione che i non-stupidi potranno avere per loro, purché, aggiungo, siano davvero non-stupidi? Trent’anni dopo potrebbe essere il titolo di un saggio sul «problema degli stupidi» nell’Italia contemporanea, su una popolazione che è convinta di ragionare («io penso che», esordiamo tutti) e ragiona invece con la testa del potere e del mercato, «degli slogan, motti ecc.» che il potere ha pervicacemente instillato nella sua mente, sul modello nato sotto le dittature e tra Wall Street, Washington, e Hollywood.
L’Italia è un paese di stupidi, di un’immensa maggioranza di stupidi di cui facciamo in qualche modo parte tutti, catturati dal binomio diventato indissolubile, che ci ha drogati e pervertiti: il consumo-e-consenso. Non insisto su questo, ma è bene guardarsi allo specchio, stupidi siamo tutti, chi più chi meno (e di più chi pensa di non esserlo).
L’abbiamo dimostrato nei fatti, il nostro è un paese di un’immensa maggioranza omologata e conformista dove tutti si credono minoranza perché si aggrappano a tradizioni e identità di cui restano minime eco, o a differenze fasulle, di consumi. (Le più fastidiose, per me, le “minoranze narcise”, gruppi e associazioni che riempiono la penisola reagendo al fatto di non contar niente con l’invenzione di carità pelose e divertimenti alternativi, ovviamente “culturali”...).
Un problema forte si poneva a Bonhoeffer e si pone a noi: «il rischio di lasciarci spingere al disprezzo per gli uomini»; per gli stupidi che credono di pensare con la loro testa e oggi, mettiamo, pensano con quella di Berlusconi e dei giornalisti, dei pubblicitari e dei guru, o anche degli “indignati” di una sinistra tutta di chiacchiera. «Disprezzando gli uomini cadremmo esattamente nello stesso errore dei nostri avversari». È un’impresa titanica, di questi tempi, e tuttavia irrinunciabile. Il segreto per riuscirvi sta nell’«imparare a valutare gli uomini più per quello che soffrono che per quello che fanno o non fanno », e qui dovrebbe essere, credo, la chiave del nostro lavoro. Non tagliare i fili e anche se è una fatica di Sisifo, specialmente con i “vicini”, tentare sempre il dialogo, la comunicazione diretta essendo quella mediatica e istituzionale così fortemente corrotta. Per fortuna «è un’esperienza molto sorprendente, ma innegabile, che il male si riveli - e spesso in un arco di tempo inaspettatamente breve - stupido e incapace di raggiungere i suoi obiettivi ».
Per chi vuole essere meno stupido, nell’Italia stupidissima di fine trentennio, e per chi voglia aiutare gli altri a non esserlo, importa, per cominciare, riconoscere la propria parte di stupidità (complicità). Vale per tutti, ma soprattutto per coloro che si sono assunti o si sono trovati ad avere responsabilità minime o massime verso la collettività.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- LA GRANDE DISILLUSIONE (di Barbara Spinelli).30 maggio 2010, di Federico La Sala
La grande disillusione
di Barbara Spinelli (La Stampa, 30.05.2010)
A prima vista, si direbbe che due siano ormai le visioni della crisi divampata nel 2007, e dei modi di sormontarla in Italia. Da una parte c’è il film proiettato dal presidente del Consiglio per anni: la crisi è un fulmine, che non turba il cielo sereno sopra le nostre teste. La chiamano crisi, ma non è tale. Sono i giornali, le istituzioni internazionali, ad angosciarci con le loro aritmetiche cupe. Dovrebbero tacere, lasciar fare i governi. Ben diversa la visione di Tremonti, che usa metafore tutt’altro che confortanti: «La situazione non è bella. Siamo alpinisti aggrappati a una parete verticale, non possiamo traccheggiare».
Tremonti vede il disastro ma anch’egli proietta un suo film, quando paragona il marasma a un videogioco. Sullo schermo irrompe un mostro, dal nulla: o lo uccidi o perisci. Non c’è sguardo lungo. Abbatti l’orco, e passi al successivo. Non c’è tempo per traccheggiare ma neppure, molto, per pensare. Inoltre il videogame puoi spegnerlo. Così muore il reality show che Berlusconi manda in onda sin da principio: un mondo finto, chiuso. Una sorta di quartiere sigillato, inaccessibile alle ambasce delle metropoli, simile a Milano-2 costruita negli Anni 70.
In America i quartieri sono chiamati gated community, comunità corazzate da grossi cancelli, che proteggono da incursioni esterne e spesso sono dotate di circuiti televisivi stile Mediaset o Tg1, dispensatori di distrazioni. Il reality non dice il reale; lo fa. La negazione della crisi, fino all’allarme di Tremonti, è stata un ingrediente base del film berlusconiano. Anche la negazione dei mostri nascosti (mafia, suoi patti con l’anti-Stato) è ingrediente di rilievo.
Per questo non è appropriato parlare, a proposito della manovra, di sacrifici. Quello che urge da noi non sono sacrifici, ma un’autentica disintossicazione, unita a non meno urgenti operazioni verità sulla democrazia minacciata. Si tratta di uscire dallo show, di entrare nella realtà, di vederla. Si tratta di rompere con gli usi e costumi vigenti dietro le comunità transennate: il vivere alla giornata, il non guardare lontano, il non voler sapere la verità sullo Stato e su se stessi. Il compito affidatoci è una gigantesca disillusione, più che una rinuncia ai beni che avevamo. Il disilluso possedeva vizi, oltre che beni: volontariamente scelse d’illudersi. Anche Manovra è parola sciapa, che implica un guidatore e masse di guidati. Meglio parlare di un comune, benefico risvegliarsi.
In fondo l’esperienza è simile a quella traversata dal cattolicesimo, dopo lo scandalo della pedofilia. Il clero ha coperto reati atroci, e ora s’accinge a punirli. Ma il compito del risanamento spetta all’intera Chiesa, e la Chiesa non si riduce alla gerarchia: per definizione, è il popolo riunito dei fedeli. Lo spiega magistralmente, sul sito del Regno, il vicedirettore della rivista Gianfranco Brunelli. Perché l’istituzione riacquisti credibilità, deve pensarsi come parte del popolo di Dio, incorporare le vittime, parlare con loro più che a loro: non c’è esclusivamente il clero, da curare. Guarire significa concepire la Chiesa «non solo come istituzione ma come popolo di Dio»: giacché «Dio è delle vittime. Dio è nelle vittime. Là egli si è fatto sentire. Là la Chiesa lo può vedere in maniera privilegiata, poiché là sempre egli manifesta il suo Spirito (Matteo 25)».
Da secoli la Chiesa ispira regni e repubbliche, e oggi come ieri la teologia aiuta a capire, soprattutto in democrazia, il farsi della politica. Lo squasso economico mette quest’ultima a dura prova, e il rimedio anche qui non consiste nel salvare gerarchie e caste ma l’intero popolo della politica: composto di governati e governanti, fondato su sofisticati equilibri fra vari poteri che si bilanciano.
L’Italia economicamente sta meglio della Grecia (grazie al governo Prodi, essenzialmente), ma in molte cose i Paesi si somigliano. Atene è precipitata perché una classe di governanti, per anni, proiettò chimere: visse senza guardar lontano, fino a truccare - in casa, in Europa - le cifre del proprio bilancio. Lo fece per immunizzare caste, politici. Non pensò (qui è la somiglianza) che in custodia aveva tutto il popolo della politica, e in primis i poveri, le vittime, i contribuenti che pagano per gli evasori, i meno organizzati e garantiti. Epifani che annuncia scioperi anti-manovra ha comportamenti immodesti e suicidi: cos’ha dato il sindacato agli italiani, quando bocciò la vendita di Alitalia a Air France, se non più licenziati e fardelli più grevi sulle spalle dei contribuenti?
Degli aspetti tecnici della manovra si sa poco, ma ci sono elementi che fanno impressione: alcune misure sono spudoratamente copiate dal governo Prodi, abbattuto due anni fa. Restano memorabili gli insulti a Visco, stratega agguerrito dell’anti-evasione: fu dipinto come vampiro, nei videogame dell’attuale maggioranza. Ora le sue misure (tracciabilità dei redditi) sono riesumate, e Tremonti non può dar torto a quel che Visco scrive sul sito della Voce: «Se si ritiene che la riduzione dell’evasione sia utile, andrebbero reintrodotte integralmente le misure varate dal governo Prodi e subito abrogate dal governo Berlusconi».
Ma le similitudini tra Grecia e Italia sono innanzitutto politiche. In ambedue i casi, il rigore riesce a due condizioni: se la tecnica è buona, e se la democrazia ha le virtù raccomandate dall’Ocse alla finanza: correttezza, integrità, trasparenza. Per imporre rigore, infatti, i governi devono avere la legittimità etica di chi non tratta il «popolo della politica» come mezzo, ma come fine.
Sulla prima condizione si può sospendere il giudizio. Ma la seconda condizione di sicuro in Italia manca. Questo è un governo che ha passato più tempo a proteggere premier e politici dai processi, che a far politica per gli italiani. Questo è un governo cui l’ex presidente Ciampi chiede solennemente la verità sui pericoli corsi dalla democrazia nelle stragi inaugurate dall’eccidio di Falcone e Borsellino (Repubblica, 29 maggio). Questi sono giorni in cui il partito fondato da Berlusconi è sospettato di un patto con la mafia, che dopo Tangentopoli avrebbe convogliato su Forza Italia i voti di vaste aree del Sud in cambio di favori e promesse.
La crisi, come a Atene, disvela i trucchi ottimisti del film berlusconiano ma anche i suoi scantinati tenebrosi. L’evento fondamentale dei giorni scorsi è stato il discorso di Piero Grasso, mercoledì a Firenze nella commemorazione della strage dei Georgofili. Il procuratore nazionale antimafia non cita Berlusconi e Dell’Utri - non ha le prove - ma dice cose gravi: «Cosa nostra ebbe in subappalto una vera e propria strategia della tensione», e le stragi del ’92-93 volevano causare disordine per dare «la possibilità a un’entità esterna di proporsi come soluzione per poter riprendere in pugno l’intera situazione economica, politica, sociale che veniva dalle macerie di Tangentopoli. Certamente Cosa Nostra, attraverso questo programma di azioni criminali, che hanno cercato d’incidere gravemente e in profondità sull’ordine pubblico, ha inteso agevolare l’avvento di nuove realtà politiche che potessero poi esaudire le sue richieste». Grasso in genere è uomo prudente. Nel ’98, con altri magistrati, archiviò l’inchiesta su Berlusconi e Dell’Utri ritenuti mandanti occulti del terrore mafioso.
Il procuratore disse queste verità già allora. Per motivi non chiari, il verbale rimase però nascosto. Lo dissotterrano Lo Bianco e Sandra Rizza, in un libro che uscirà il 10 giugno per Chiarelettere («L’agenda nera»). Se Grasso torna a parlarne oggi è perché ha deciso di abbandonare le autocensure. In parte perché nuovi pentiti testimoniano. In parte perché, grazie alla crisi, il Truman Show berlusconiano si sfalda. Può darsi che la bolla sopravviva un po’, come nel film di Peter Weir. Ma il «popolo della politica» difficilmente si farà persuadere ancora da miraggi e occultamenti dell’incantatore di Palazzo Grazioli. Questo non è tempo di mostri che irrompono nel videogame. Ci sono mostri da stanare, non visibili perché non programmati per esserlo. È vero: «La situazione non è bella». Che diventi, almeno, vera.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- Cara Italia mai nata (di Ermanno Rea).29 maggio 2010, di Federico La Sala
Bertrando Spaventa (...) Sosteneva che la figura del cittadino responsabile era stata inventata dall’Italia, dalla cultura dell’Umanesimo e del Rinascimento, ma che essa era stata subito messa in ceppi dal Sant’Uffizio che non aveva tardato a trasformare il suddetto cittadino responsabile in suddito, perfetto figlio della Controriforma.
Cara Italia mai nata
di Ermanno Rea(il manifesto,29.05.2010)
Ho letto con grande attenzione l’intervento di Giorgio Ruffolo pubblicato dal manifesto (mercoledì 26 maggio) sotto il titolo «Federalismo, un patto tra Nord e Sud» e desidero, per quel poco che possano valere le mie parole, spenderne un po’ a favore dell’ipotesi avanzata dall’illustre economista e uomo politico a giudizio del quale il futuro dell’Italia potrebb’essere anche, o meglio forse, quello di suddividersi in alcune (poche) macro-regioni federate tra loro ma dotate di grande autonomia.
Ruffolo avanza la sua proposta senza alcuna iattanza o sicumera, non pretende affatto di avere in tasca la ricetta utile a salvare l’Italia dalle tempeste che la vanno squassando ormai da tempo immemorabile (fino a rendere fumosa ogni speranza di riassetto virtuoso soprattutto sotto il profilo economico, in un tempo ragionevolmente breve). No, egli si limita a richiamare l’attenzione generale su una possibilità che merita quanto meno di essere discussa, non fosse altro che per guardare meglio dentro noi stessi e per comprendere quanto gravi siano le ferite presenti sul corpo del paese e come sia impensabile che la disunità italiana possa continuare a produrre mostri, senza che vengano adottati rimedi radicali. Rimedi capaci di rivoluzionare lo stesso modo di pensare e di essere dei cittadini e soprattutto delle classi dirigenti sia al Nord che al Sud.
Imprevedibilmente, la sortita di Ruffolo (vedi il suo bel libro Un paese troppo lungo, pubblicato da Einaudi) ha ricevuto però un’accoglienza improntata a una certa sufficienza, nella convinzione che ogni discorso federalistico sarebbe nient’altro che un modo per consegnarsi nelle mani di Bossi .
Come Ruffolo, anch’io ritengo che le cose non stiano così, e non soltanto perché un pensiero federalista è presente in tutta la storia del Risorgimento, sostenuto con spirito patriottico da illustri intellettuali che non possono certamente essere annoverati tra i padri ispiratori dell’attuale leader leghista, tipico figlio di nessuno dal punto di vista politico e culturale. Ma perché non riesco a intravedere alternative diverse dal divorzio a un matrimonio così manifestamente andato in frantumi.
Inutile bendarsi gli occhi: dal punto di vista statuale l’Italia non esiste; non è mai nata. Il divario Nord/Sud, così come lo abbiamo costruito pazientemente, un po’ alla volta, in maniera deliberata e consapevole lungo centocinquant’anni di storia, non ha uguali in tutto il mondo, fa dell’Italia un caso unico nella sua anomalia socio-economica con riflessi perfino di natura neurologica (come negare che ormai la "faglia" attraversa la nostra stessa psicologia?).
Semmai c’è da apprezzare lo sforzo di Ruffolo nel formulare una proposta che, pur smontando l’idea di Stato, salva e rafforza quella di Nazione, secondo una distinzione che fu particolarmente coltivata a metà dell’Ottocento da Bertrando Spaventa, esponente di punta di quel neo-hegelismo napoletano (Bertrando e Silvio Spaventa, Francesco De Sanctis, Luigi Settembrini, Vittorio Imbriani...) che incarnò nel secolo XIX l’ideale unitario come organizzazione organica e rigidamente integrata di un popolo. Nello Stato, ebbe a dire Bertrando Spaventa, «la coscienza nazionale sale e si perfeziona a coscienza politica».
Non ricordo a caso la figura di questo pensatore ingiustamente depennato dai libri di scuola. Se lo faccio è soprattutto per ricordare da quale accademia e da quale milizia provengono tanti di noi in quanto meridionali convinti del valore salvifico dell’ideale unitario, di uno Stato italiano forte, coeso e soprattutto affrancato dalla tutela di santa romana Chiesa. Come predicava Bertrando Spaventa.
Per la verità il buon filosofo diceva di più. Sosteneva che la figura del cittadino responsabile era stata inventata dall’Italia, dalla cultura dell’Umanesimo e del Rinascimento, ma che essa era stata subito messa in ceppi dal Sant’Uffizio che non aveva tardato a trasformare il suddetto cittadino responsabile in suddito, perfetto figlio della Controriforma.
Tutto questo vuole dire che oggi, accettando di discutere di federalismo e di macro-regioni, stiamo smentendo noi stessi e i nostri maestri, stiamo facendo commercio dei nostri ideali? Non credo. Stiamo soltanto prendendo atto di un fallimento epocale, ci stiamo semplicemente interrogando se non sia possibile pervenire agli stessi risultati progettati un tempo attraverso una strada sicuramente più tortuosa e insidiosa, ma non per questo senza sbocchi e tassativamente perdente come l’ha dichiarata Eugenio Scalfari in un suo articolo (la Repubblica del 16 maggio scorso).
In ogni caso, coloro che si dichiarano indisponibili a ogni discorso sul federalismo e le macro-regioni dovrebbero quanto meno spiegarci quale possa essere oggi un rimedio credibile alla situazione di malessere, di sfascio e di spaccatura in cui versa l’Italia; soprattutto, dovrebbero spiegarci se siamo ancora in tempo a fare quello che non è stato fatto in passato, e cioè realizzare una unificazione del paese, oltre che di natura amministrativa, anche di tipo economico e sociale. Il marcio infatti è tutto qui. Personalmente ho il torto di pensare che ormai sia troppo tardi per correre ai ripari. Obbiettivamente e anche soggettivamente, nel senso che ritengo difficile orientare consolidati modi di pensare e di agire in direzioni opposte a quelle del passato.
L’Italia che si unisce lo fa infatti precostituendo il proprio fallimento di cui tutti oggi patiamo l’insopportabile peso. Tradizionalismo e arretratezza tarpano le ali a tutti: al Sud, dove prospera il latifondo e dove arcaici rapporti di proprietà e di produzione condannano le popolazioni agricole a una povertà senza scampo (a fronte dell’illimitata ricchezza dei proprietari terrieri assenteisti); al Nord, dove una miope borghesia produttiva non sa guardare oltre il proprio ombelico, senza riuscire a capire che l’unificazione l’ha investita di un grande ruolo: farsi promotrice dello sviluppo generale di tutta la nazione.
Sia concessa anche a me una illuminante citazione di Gramsci. «La egemonia del Nord sarebbe stata ’normale’ e storicamente benefica se avesse avuto la capacità di ampliare con un certo ritmo i suoi quadri per incorporare sempre nuove zone economiche assimilate. Sarebbe stata allora questa egemonia l’espressione di una lotta tra il vecchio e il nuovo, tra il progressivo e l’arretrato, tra il più produttivo e il meno produttivo; si sarebbe avuta una rivoluzione economica nazionale (...) e al contrasto sarebbe successa una superiore unità. Ma invece non fu così...».
La citazione è curiosa. Innanzi tutto per lo spirito che la ispira, squisitamente liberistico. Per Gramsci la borghesia produttiva del Nord va messa sotto accusa per la sua incapacità di guadagnare al capitalismo moderno nuove aree, si potrebbe dire per scarsa fiducia in se stessa e nel proprio verbo. La diresti l’opinione di un protestante.
Ma, detto questo, come negare che il passo è di rara lucidità e fa comprendere quanto l’unificazione italiana, così priva di progetti e ambizioni, appaia sin da principio destinata a produrre nient’altro che mostri? Che infatti non tardano ad arrivare, attraverso il congelamento della già debolissima economia meridionale , colpita negli anni Ottanta dell’800 da una grave crisi agricola internazionale che la mette completamente alla mercè del Nord.
A partire da quel momento, come spiega lo storico Francesco Barbagallo in un suo corposo studio intitolato Stato, Parlamento e lotte politico-sociali nel Mezzogiorno, il divario tra Nord e Sud «non cesserà più di accrescersi: allo sviluppo industriale del Nord si accompagnerà il sottosviluppo economico e sociale del Sud in un rapporto di stretta dipendenza destinato a perpetuarsi».
E’ tempo di concludere. Lo farò con una semplice domanda. E’ davvero impensabile che il Mezzogiorno non possa trovare dentro di sé quelle risorse di dignità, di energia e anche d’immaginazione in grado di salvarlo, sia pure in un tempo non breve e tra mille sacrifici, dal baratro nel quale è precipitato? In ogni caso, chi ha meglio da proporre si faccia avanti.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- IL VAMPIRISMO DEI "PAPI" (E DELLE "MAMI") SUI FIGLI. La macelleria sociale è già in atto, a prescindere dalla manovra. E riguarda una fascia di popolazione a cui questo Paese si ostina a non guardare: i giovani (di Irene Tinagli - Il buco nero del sistema Italia).27 maggio 2010, di Federico La Sala
Il buco nero del sistema Italia
di IRENE TINAGLI (La Stampa, 27/5/2010)
La macelleria sociale è già in atto, a prescindere dalla manovra. E riguarda una fascia di popolazione a cui questo Paese si ostina a non guardare: i giovani.
Idati appena resi noti dall’Istat lasciano poco spazio all’ottimismo. Il tasso di occupazione complessivo è calato dell’1,2% nell’ultimo anno, mentre quello dei giovani tra i 15 e i 29 anni dell’8,2%, scendendo al 44%. Ma il dato più preoccupante va oltre la mera disoccupazione e riguarda i cosiddetti «neet», ovvero i giovani che non sono né occupati in un lavoro né inseriti in percorsi di studio o formazione («neither in employment, nor in education or training»). In Italia sono il 21,2% dei giovani tra i 15 e i 29 anni, in larga parte diplomati e laureati: proprio quelli sui quali dovrebbe poter contare un Paese per rilanciare la propria economia. Si tratta in totale di oltre due milioni di giovani che, semplicemente, non fanno niente. Aspettano. Aspettano forse tempi migliori, mentre intanto le cose che hanno imparato a scuola vengono dimenticate o diventano obsolete, e assieme ai saperi svaniscono fiducia, entusiasmo, voglia di guardare avanti.
Questo è un dato drammatico, che avrà conseguenze pesantissime sul futuro di questi giovani e del nostro Paese. Stare lontani sia dal lavoro che dalla formazione aumenta le probabilità di essere disoccupati in futuro o di avere lavori stabili che consentono di crescere professionalmente. Diminuiscono le competenze e il bagaglio di esperienze, in altre parole: diminuisce il livello di capitale umano sia dell’individuo che del sistema socio-economico in cui questa persona vive e lavora. E’ anche alla luce di questi dati che una recente pubblicazione dell’Ocse ha previsto che il tasso di disoccupazione giovanile in Italia non diminuirà con il rallentare della crisi, ma continuerà piano piano a crescere.
Questo fenomeno non può essere imputato solo al crollo della produzione industriale. La crescita della disoccupazione complessiva in Italia è stata più bassa che in tutti gli altri Paesi, quindi il fatto che invece proprio in Italia i giovani siano così emarginati dal mondo del lavoro non può essere legato solo alla crisi. Un altro indicatore che ci mostra che il nostro problema va oltre la crisi economica emerge dal confronto con la Spagna. Infatti, persino in quel Paese, dove il tasso di disoccupazione giovanile è quasi il doppio del nostro, la percentuale di giovani «neet» che proprio non fanno niente è minore che da noi, segno che i giovani senza lavoro sono comunque inseriti in programmi di formazione, studio o apprendistato, un elemento che contribuisce a tenerli attivi e competitivi per il futuro.
Queste considerazioni ci fanno capire che il vero buco nero del nostro Paese non è solo e tanto la struttura economico-produttiva, ma il sistema della formazione e la transizione dal mondo dello studio a quello del lavoro. E’ questo il principale meccanismo di lotta all’inattività giovanile, come ci dicono ormai tutti i principali studi in materia. Basta guardare ai Paesi che fino ad oggi sono riusciti ad ottenere i migliori risultati su questo fronte: Olanda, Danimarca, e Germania per esempio, hanno tutti dei sistemi molto strutturati di formazione professionale, alternanza scuola-lavoro, e ammortizzatori sociali legati allo sviluppo di competenze e permanenza nel circuito della formazione.
Invece nel nostro Paese è proprio sul fronte della formazione e della transizione scuola-lavoro che manca un’offerta vera e di qualità. Abbiamo milioni di giovani abbandonati a loro stessi, che in molti casi non finiscono neppure gli studi superiori (non a caso abbiamo uno dei più bassi tassi di diplomati d’Europa), in altri restano emarginati dal mercato del lavoro o da una formazione che potrebbe aiutarli a restare comunque competitivi nel lungo periodo.
Una lacuna che non è stata colmata da nessun intervento o politica del governo. Di fronte ad una carenza di formazione e al dramma dei ragazzi che non finiscono le scuole, tutto quello che si è stati capaci di fare è stato abbassare l’obbligo scolastico, e schiacciare le ambizioni dei ragazzi incitandoli ad «accettare qualsiasi tipo di lavoro», rivalutando i lavori umili e manuali. Mentre la grande riforma del mercato del lavoro che il ministro annunciava già un anno fa si è limitata alla fine alla lotta sull’arbitrato. Un po’ pochino per risolvere un problema di questa portata.
Di fronte a un’emergenza del genere i ministri del Lavoro e dell’Istruzione e dello Sviluppo Economico dovrebbero lavorare insieme a ritmi serratissimi per pensare a misure strutturali che consentano al Paese di non perdere per strada queste nuove generazioni. Invece il ministero dell’Istruzione pare più in sintonia con quello del Turismo, il ministero dello Sviluppo Economico, dopo aver distribuito un po’ d’incentivi per l’acquisto di cucine e lavatrici, è adesso in cerca di identità dopo le dimissioni di Scajola, mentre quello del Lavoro pare ancora troppo impegnato nell’abolizione o riscrizione dell’articolo 18.
I milioni di giovani senza lavoro e senza formazione adeguata sono il vero dramma di questo Paese. Cercare di mortificare le loro ambizioni non è la soluzione. Ma d’altronde è difficile parlare di futuro e ambizioni in un Paese la cui unica ambizione, oggi, è «non fare come la Grecia».
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- L’INDIVIDUO, LA DEMOCRAZIA, E I TUTORI E GLI INQUISISTORI (di Gustavo Zagrebelsky - Quel che rende unico ogni individuo)27 maggio 2010, di Federico La Sala
 Quel che rende unico ogni individuo
Quel che rende unico ogni individuo
 Perché l’individuo è alle fondamenta della democrazia
Perché l’individuo è alle fondamenta della democrazia Sappiamo adattarci e adeguarci alle condizioni di vita più diverse
Sappiamo adattarci e adeguarci alle condizioni di vita più diverse
 La verità della nostra umanità non sta in una filosofia ma sta dentro ciascuno di noi
La verità della nostra umanità non sta in una filosofia ma sta dentro ciascuno di noi di Gustavo Zagrebelski
di Gustavo ZagrebelskiAnticipiamo una parte della lezione che il giurista terrà domani a Pistoia sul rapporto tra democrazia e identità personale
«Sull’uomo», sull’essere umano. Non so immaginare come altri, intervenendo in questi "dialoghi sull’uomo", interpreteranno l’espressione e intenderanno il loro compito. Da parte mia, non andrò di certo alla ricerca di qualcosa di essenziale, di ideale, di radicale circa l’essere-uomo. Nelle cose politiche e morali, è bene diffidare delle astrazioni e delle dottrine circa l’umanità autentica, vera, non corrotta, corrispondente all’ideale, un ideale che debba essere realizzato con ogni mezzo e a ogni costo. È prudente pensare che non esista "l’uomo" o che, se esiste, non l’abbiamo mai incontrato. Ci sono "gli uomini" e non uno è per natura uguale all’altro. Per nostra fortuna è così. Altrimenti saremmo pronti ad accettare l’uomo-massa, l’uomo-gregge, l’uomo in serie. La verità della nostra umanità non sta in una filosofia, in un’antropologia; sta dentro ciascuno di noi, in interiore homine, e tutti possiamo cercare di conoscerla seguendone le tracce profonde, senza mentire a noi stessi. Conosci te stesso! E non pensare che quello che hai trovato valga necessariamente nemmeno per chi ti sta più vicino.
La storia ci mostra però che questa realtà, tanto molteplice da non poter trovare un esemplare di per sé uguale a un altro, è tuttavia massimamente plastica, cioè capace di adattarsi, adeguarsi, combaciare alle condizioni nelle quali si trova a vivere. Nessun altro essere vivente ne è altrettanto capace. Per questo, gli esseri umani sopravvivono nelle condizioni ambientali, climatiche, sociali, politiche più diverse. Non solo gli individui, ma anche le loro società sono varie e sono capaci di cambiare, come nessun’altra società di esseri viventi. I viventi non umani ci appaiono programmati per vivere nella e solo nella struttura sociale che è loro propria.
Dalle società tribali arcaiche, studiate dagli etologi, alle odierne società della comunicazione, di cui si occupano gli informatici, quante varianti, quanti tipi umani diversi: cacciatori, agricoltori, nobili e plebei, liberi e servi, cittadini e contadini, corteggiani, cavalieri e borghesi, umanisti e tecnici, imprenditori ed esecutori, proprietari e proletari, uomini di religione e uomini di scienza, eccetera. Differenze, queste, che riguardano il lato esteriore degli esseri umani, quello che riguarda i rapporti sociali tra di loro. Ma che diremmo del lato interiore, quello che riguarda cose come le loro qualità morali, la loro sensibilità artistica, l’autocoscienza, la felicità e l’infelicità? Qui davvero ogni pretesa di generalizzare sarebbe ancora più arbitraria.
Forse però, potremmo già subito smentirci da noi stessi e dire che, allora, una natura dell’essere umano c’è, ed è la sua plasticità e irriducibilità ad unitatem. Ma è una smentita apparente, perché non ci permette di andare oltre, mentre è propriamente questo "oltre", o questo "altro" ciò che ci importerebbe di definire.
Orbene, è precisamente l’indefinibiltà di un’idea essenziale a priori che consente di dire qualcosa in modo indiretto, a partire dalle condizioni esterne che operano sugli esseri umani, conformandoli a determinati standard sociali e a determinate aspettative sociali. Ferma restando, peraltro, la sempre presente, residua e ribelle, loro irriducibilità integrale a tali standard.
Guardando alle condizioni odierne delle nostre società, troviamo impressionanti conferme di due profezie che risalgono, l’una, a Tocqueville e, l’altra, a Dostoevskij.
Tocqueville, osservando le condizioni della società americana orientata alla democrazia ugualitaria, previde «una folla innumerevole di uomini simili e uguali, che girano senza posa su se stessi per procurarsi piccoli, volgari piaceri, con cui soddisfare il proprio animo. Ciascuno di loro, tenendosi appartato, è come estraneo al destino degli altri: i suoi figli e i suoi amici più stretti formano per lui tutta la specie umana; quanto al rimanente dei suoi concittadini, è vicino a loro, ma non li vede; li tocca, ma non li sente; vive solo in se stesso e per se stesso, e se ancora gli rimane una famiglia, si può dire almeno che non abbia patria.
Al di sopra di costoro s’innalza un potere immenso e tutelare, che s’incarica da solo di assicurare il godimento dei loro beni e di vegliare sulla loro sorte. È assoluto, particolareggiato, regolare, previdente e mite. Assomiglierebbe al potere paterno, se, come questo, avesse per fine di preparare gli uomini all’età virile; ma al contrario, cerca soltanto di fissarli irrevocabilmente nell’infanzia» (La democrazia in America, 1840, libro II, parte IV, capitolo VI).
Dall’altra parte del mondo, qualche decennio dopo (1879-1880), Dostoevskij avrebbe scritto, presumibilmente senza conoscere il suo predecessore, quella che è stata definita la storia dei due secoli successivi, La leggenda del Grande inquisitore, capitolo centrale, somma del suo pensiero politico e vetta della sua arte, ne I fratelli Karamazov. Anche qui, l’umanità è vista divisa in due. I "tutori" di Tocqueville diventano gli "inquisitori" in Dostoevskij. La visione generale è la stessa: la massa addomesticata e i pochi che, al di sopra, l’addomesticano. Non tiranni feroci, ma benefattori che prendono sulle loro spalle il fardello di una libertà di cui, per lo più, gli esseri umani non sanno che farsi, anzi anelano di sbarazzarsi. La società dei grandi numeri, industrializzata, standardizzata, meccanizzata produrrebbe così una doppia, opposta umanità. La divisione ha a che fare con la distribuzione ineguale di tre risorse vitali, i beni materiali, le conoscenze, il potere: detto altrimenti, l’avere, il sapere, il potere, i tre pilastri d’ogni struttura sociale.
La democrazia in America è un testo che potremmo definire di sociologia politica; La Leggenda, di antropologia morale. Per questo, in un discorso sull’essere umano come è quello cui i "Dialoghi sull’uomo" ci invitano, è a Dostoevskij, innanzitutto, che ci rivolgiamo. Non con l’illusione di trovarvi tutto, ma almeno con la certezza di scorgervi qualcosa di ciò che cerchiamo, anzi forse non poco.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- "Il Rinoceronte" di Ionesco e i custodi della democrazia (di Barbara Spinelli).23 maggio 2010, di Federico La Sala
Chi azzoppa i custodi della democrazia
di BARBARA SPINELLI (La Stampa, 23/5/2010)
Contrariamente a quello che si tende a credere, non è il suffragio universale a sparire per primo, quando la democrazia si spezza. Per primi sono azzoppati i suoi guardiani, che non mutano col cambio delle maggioranze e che sono le leggi, i magistrati, le forze dell’ordine, la stampa che tiene sveglio il cittadino tra un voto e l’altro. Anche le costituzioni esistono per creare attorno alla democrazia un muro, che la protegge dalla degenerazione, dal discredito, soprattutto dal dominio assoluto del popolo elettore.
Quando quest’ultimo regna senza contrappesi, infatti, le virtù della democrazia diventano vizi mortiferi. Nella sua descrizione degli Stati Uniti, Tocqueville chiama i guardiani i «particolari potenti»: sono la stampa, le associazioni, i légistes ovvero i giuristi. In loro assenza «non c’è più nulla tra il sovrano e l’individuo»: sia quando il sovrano è un re, sia quando è il popolo.
Queste mura sono in via di dissoluzione in Italia, da anni. Ma nelle ultime settimane l’erosione ha preso la forma di un concitato giro di vite: un grande allarme s’è creato attorno alla corruzione dilagante, seguito da un grande tentativo di mettere corruzione e malavita al riparo dai custodi della democrazia. È un dramma in tre atti, che vorremmo sottoporre all’attenzione del lettore.
Il primo atto risale al 17 febbraio, quando la Corte dei Conti constata, in apertura dell’anno giudiziario 2010, l’enorme aumento del malaffare. La denuncia del presidente della Corte e del procuratore generale, Tullio Lazzaro e Mario Ristuccia, è grave: «Una sorta di ombra e nebbia sovrasta e avvolge il tessuto più vitale e operoso del Paese», opponendo una «pervicace resistenza a qualsiasi intervento volto ad assicurare la trasparenza e l’integrità» nelle amministrazioni pubbliche. I «necessari anticorpi interni non vengono attivati», ed è la ragione per cui la cura della patologia è «lasciata al solo contrasto giudiziale, per sua natura susseguente e repressivo». Le conseguenze, nefaste, indicate da Lazzaro: «Il Codice Penale non basta più, la denuncia non basta più. Ci vuole un ritorno all’etica da parte di tutti. Che io, purtroppo, non vedo».
Qui cominciano gli atti decisivi del dramma. Quel che va in scena è la controffensiva d’un governo che si sente asserragliato più che responsabilizzato: che a parole annuncia misure anti-corruzione, e nei fatti predispone un’autentica tenda protettiva, tale da coprire il crimine, sottraendolo agli occhi dei cittadini e della legge con tecniche di occultamento sempre più perverse, garantendo a chi lo commette impunità sempre più vaste. Nel secondo e terzo atto del dramma il crimine viene avvolto, ancora una volta, «nella nebbia e nell’ombra».
Il secondo atto fa seguito alla condanna in appello dei capi-poliziotti che la notte del 21 luglio 2001 assalirono la scuola Diaz a Genova, durante un vertice G8, massacrando 60 ragazzi inermi. «Nessuno sa che siamo qua, vi ammazziamo tutti», gridavano i picchiatori, quando invece i superiori sapevano. I fatti erano raccontati nella sentenza di primo grado, ma le condanne non coinvolsero gli alti gradi della polizia. In appello sono condannati anch’essi. Ebbene, cosa fa la politica? Assolve i condannati, li trafuga in una nuvola come gli dei omerici facevano con i propri eroi, e li lascia indisturbati al loro posto. Francesco Gratteri, capo della Direzione generale dell’anticrimine ed ex direttore del Servizio Centrale Operativo, è condannato a 4 anni e resta dov’è in attesa della Cassazione. Lo stesso succede a Giovanni Luperi, oggi capo del Dipartimento analisi dell’Aisi (ex Sisde), condannato a quattro anni. Vincenzo Canterini fu promosso questore nel 2005: aveva guidato la Celere contro la Diaz.
Il terzo e cruciale atto dell’operazione trafugamento del crimine è la legge sulle intercettazioni. Ancor oggi si spera che essa non passi, grazie alla resistenza congiunta di editori, stampa, magistrati, deputati finiani, Quirinale. Grazie anche all’intervento del sottosegretario americano alla Giustizia Breuer, che evocando la lotta antimafia di Falcone ha indirettamente smascherato la natura di una legge che sembra patteggiata con la malavita. Fino all’ultimo tuttavia, e per l’ennesima volta nell’ultimo quindicennio, Berlusconi tenterà di imbavagliare magistrati, mezzi d’informazione. Se la legge sarà approvata, i magistrati faticheranno sempre più a snidare reati, a istruire processi.
Potranno usare le intercettazioni solo in condizioni proibitive, e per una durata non superiore a 75 giorni (se stanno per accertare un reato al settantaquattresimo giorno, peggio per loro). Sarà proibito intercettare politici e preti senza avvisare le loro istituzioni: un privilegio incostituzionale, davanti alla legge. Non meno gravemente è colpita la stampa (quando riferisce su inchieste giudiziarie prima dei processi) per la sanzione che può colpire giornalisti e editori. Questi ultimi, intimiditi da alte multe, diverranno i veri direttori d’ogni cronista. Il direttore responsabile perderà prestigio, peso. Bersaglio dell’operazione è non solo la stampa ma il cittadino. Si dice che il suffragio universale è sacro e al tempo stesso si toglie, a chi vota, l’arma essenziale: la conoscenza, i Lumi indispensabili per capire la politica e dunque esercitare la propria vigile sovranità.
Ci sono eventi storici che solo la letteratura spiega fino in fondo e anche in Italia è così. Proviamo a leggere Il Rinoceronte di Eugène Ionesco e vedremo descritto, limpido, lo strano mondo in cui dai primi Anni 90 anni viviamo: un mondo che tutela il crimine, allontanandolo dalla scena e rendendolo sia invisibile, sia impunibile. Un mondo dove i custodi della democrazia sono neutralizzati e il popolo, bendato perché disinformato, vive e vota dopo esser mutato interiormente. Un regime simile ci trasforma ineluttabilmente nelle bestie a quattro zampe descritte dal drammaturgo. In principio passa un rinoceronte: è bizzarro, ma passa. Poi piano piano tutti si trasformano. Perfino il filosofo diventa prima un po’ verde, poi le mani raggrinziscono, poi sulla fronte gli cresce il corno.
La mutazione genetica di cui ha parlato Sergio Rizzo sul Corriere del 6 maggio avviene quando cadono le categorie umane classiche: il confine fra lecito e illecito, bene e male («il Male! Parola vuota!», dice Dudard a Berenger, nel Rinoceronte). In questione non resta che lo «stato d’animo». Come per Denis Verdini: indagato per concorso in corruzione, il coordinatore del Pdl non si dimette come Scajola perché, assicura, «non ho questa mentalità».
Chi ha desiderio di cedere, nel dramma di Ionesco, lo fa perché il rinoceronte gli appare più naturale dell’uomo, perché «possiede una specie di candore», perché emette un barrito incomprensibile ma sonoro, trascinante. Cedere è attraente, come spiega Dudard a Berenger. È questione di mentalità, appunto: «Io mi limito a constatare i fatti e a prenderne atto. E poi, dal momento che la cosa esiste, ci sarà bene una spiegazione (...) Se ce la prendessimo con tutto quello che succede, non vivremmo più. Dal momento che è così, non può essere altrimenti». E conclude, cercando di convincere l’amico ribelle: «Lei vede tutto nero... Dobbiamo imporci a priori un atteggiamento favorevole o, per lo meno, l’obiettività, l’ampiezza di vedute proprie di una mente scientifica. Tutto ha una logica: comprendere vuol dire giustificare». Chi guarda il notiziario del Tg1 in questi giorni avrà conferma della mutazione genetica. Niente sui capi-poliziotti della Diaz che mantengono la carica disonorando uno dei più importanti corpi dello Stato. Quasi niente sulle intercettazioni controverse. Fortuna che la ribellione non manca. Fortuna che al Tg1 c’è Maria Luisa Busi, che toglie la firma e non vuol essere rinoceronte.
Berenger è l’unico a resistere, a non avere la tollerante «ampiezza di vedute» consigliata dai falsi amici. Alla fine è solo, in una città di rinoceronti. Non ha ceduto alla forza che ti trasforma: la stanchezza infinita che ti può assalire, il «bisogno di lasciarsi andare», il fatale conformismo. Il pragmatismo di chi dice: meglio, se si vuol sopravviver quieti, tenere i due piedi ben piantati in terra. Anzi, i quattro piedi.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. AL GOVERNO DELLA CHIESA UN PAPA CHE PREDICA CHE GESU’ E’ IL FIGLIO DEL DIO "MAMMONA" ("Deus caritas est") E AL GOVERNO DELL’ **ITALIA** UN PRESIDENTE DI UN PARTITO (che si camuffa da "Presidente della Repubblica"), che canta "Forza Italia" con il suo "Popolo della libertà" (1994-2010). Questo è il nodo da sciogliere - di Federico La Sala20 maggio 2010, di John Mazzei
Questo è il nodo da sciogliere.......FACILE!
Le chiese: Dove sono dirette?
COSA sta succedendo alle chiese “cristiane”? Dalle vostre parti sono in declino o stanno prosperando? Forse avete sentito parlare di un risveglio spirituale, e di tanto in tanto da Africa, Europa orientale e Stati Uniti giungono notizie di congregazioni religiose che si espandono. Ma in altre parti del mondo, soprattutto nell’Europa occidentale, le notizie parlano di chiese che chiudono i battenti, di fedeli in diminuzione e di diffusa apatia nei confronti della religione. Di fronte al calo delle presenze, molte chiese hanno cambiato stile. Alcune dicono di non voler giudicare o criticare il comportamento della gente, lasciando così intendere che Dio accetti qualunque tipo di condotta. Sempre più spesso anziché impartire istruzione basata sulla Parola di Dio le chiese offrono intrattenimento e attività ricreative, nonché attrazioni che nulla hanno di religioso. Anche se alcuni praticanti considerano questi cambiamenti un necessario adattamento alla realtà del mondo attuale, molte persone sincere si chiedono se le chiese non stiano deviando dalla missione affidata loro da Gesù. Esaminiamo le tendenze che hanno caratterizzato le chiese negli ultimi decenni.
L’Europa volta le spalle alle chiese
Per oltre 1.600 anni gran parte dell’Europa è stata sotto il dominio di governi che si professavano cristiani. Che dire di oggi? Mentre ci addentriamo nel XXI secolo, la religione in Europa sta forse prosperando? Nel 2002, in un suo libro sulla secolarizzazione dell’Occidente, il sociologo Steve Bruce ha scritto riguardo alla Gran Bretagna: “Nel XIX secolo quasi tutti i matrimoni venivano celebrati con rito religioso”. (God is Dead-Secularization in the West) Tuttavia, nel 1971 solo il 60 per cento dei matrimoni inglesi era religioso. Nel 2000 lo era appena il 31 per cento. Nel commentare questa tendenza, un giornalista del Daily Telegraph che scrive in materia di religione ha detto: “Tutte le principali denominazioni, che si tratti di Chiesa d’Inghilterra o Chiesa Cattolica, oppure di Chiesa Metodista o Chiesa Riformata Unita, stanno subendo un graduale declino”. Riguardo a uno studio ha detto: “Entro il 2040 le Chiese britanniche saranno in via di estinzione con appena il due per cento della popolazione che frequenterà le funzioni domenicali”. Sono stati fatti commenti simili sulla condizione della religione nei Paesi Bassi. “Negli ultimi decenni sembra che il nostro paese sia diventato decisamente più secolarizzato”, ha osservato l’Ufficio di Pianificazione Socio-Culturale olandese. “Si prevede che entro il 2020 il 72% della popolazione non apparterrà ad alcuna confessione religiosa”. Un quotidiano on-line tedesco dice: “Sempre più tedeschi si rivolgono alla stregoneria e all’occulto per ricevere il conforto che una volta trovavano nella chiesa, nel lavoro e nella famiglia. . . . In tutto il paese le chiese sono costrette a chiudere i battenti per la mancanza di fedeli”.
Le persone che in Europa vanno ancora in chiesa di solito non ci vanno per scoprire cosa Dio richiede da loro. Un articolo dall’Italia dice: “Gli italiani si costruiscono una religione su misura che sia adatta al loro stile di vita”. E un sociologo italiano afferma: “Dal papa prendiamo qualunque cosa ci sia congeniale”. Lo stesso si può dire dei cattolici in Spagna, dove la religiosità ha lasciato il posto al consumismo e alla ricerca di un paradiso da ottenere subito, quello economico! Queste tendenze sono in netto contrasto con il cristianesimo insegnato e praticato da Cristo e dai suoi seguaci. Gesù non offrì una religione “self-service” o “a buffet”, in cui ognuno prende ciò che più gli aggrada e scarta quello che non è di suo gradimento. Egli disse: “Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda di giorno in giorno il suo palo di tortura e mi segua di continuo”. Gesù insegnò che il modo di vivere cristiano richiedeva sacrificio e sforzo a livello personale. - Luca 9:23.
(CON TUTTO IL RISPETTO E IL BENE DEL MONDO; CON SIMPATIA ED EMPATIA.)
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- LE ARMI DEL DOMINIO (di Danilo Zolo - rec. di "Le nostre guerre" di Alessandro Dal Lago).16 maggio 2010, di Federico La Sala
Le armi del dominio
di Danilo Zolo (il manifesto, 16.05.2010
Nel suo ultimo lavoro Alessandro dal Lago mette a fuoco il ruolo degli eserciti nella globalizzazione a partire dalla caduta del Muro di Berlino. A differenza del passato gli interventi militari riguardano solo in parte le controversie tra stati. Centrale è la costruzione di un nuovo ordine mondiale, la repressione dei migranti e la prevenzione dei conflitti sociali all’interno delle realtà nazionali
A partire dall’ultimo decennio del secolo scorso si è affermato in Occidente un processo di normalizzazione della guerra. L’industria della morte collettiva si è fatta più che mai fiorente e redditizia. La produzione e il traffico delle armi, inclusi gli ordigni nucleari, sono sottratti a qualsiasi controllo della cosiddetta «comunità internazionale». E l’uso delle armi dipende sempre più dalle decisioni che le grandi potenze occidentali prendono ad libitum, secondo le proprie convenienze strategiche.
In questi anni, sentenze di morte collettiva sono state emesse nella più assoluta impunità contro migliaia di persone non responsabili di alcun illecito penale, né di alcuna colpa morale. E nel mercato della morte il valore di scambio della vita umana si è sempre più diversificato: da una parte la vita delle persone ricche e civilizzate, e cioè in massima parte occidentali, e dall’altra parte la vita delle persone povere e non civilizzate, che vivono nel sottosuolo del mondo. La vita dei poveri e dei deboli vale sempre meno. Il loro diritto alla vita è una favola.
Alessandro Dal Lago dedica una sua recente raccolta di saggi - Le nostre guerre (manifestolibri pp. 262, euro 22) - ad una lucida riflessione filosofica e sociologica sulla natura delle nuove guerre e sulla normalizzazione della violenza anche nelle sue modalità più sanguinarie. Con poche eccezioni, sostiene Dal Lago, i sociologi, gli antropologi e i filosofi si disinteressano dei conflitti contemporanei e delle loro nuove modalità. La «guerra» è citata a malapena e ben pochi studiosi ricorrono a un minimo di immaginazione nel collegare i conflitti interni con quelli internazionali. E intanto aumenta la violenza, cresce l’insicurezza e si afferma il terrorismo sia nella forma delle guerre di aggressione occidentali, sia nelle repliche del global terrorism.
Il silenzio delle coscienze
Più in generale non si può negare che in Occidente si sta affermando un processo di «metabolizzazione» e di banalizzazione del fenomeno bellico che non conosce precedenti. La sensibilità nei confronti della tragedie umane e delle irreparabili devastazioni che le guerre comportano è inibita da una diffusa propensione individualistica. Un senso depressivo di insicurezza porta a ignorare tutto ciò che non riguarda l’incolumità individuale, e a pretendere che la propria sicurezza sia rigorosamente garantita dalle istituzioni repressive e penitenziarie. Il pacifismo - a partire da quello di ispirazione cattolica - è cosa di altri tempi.
Ai limitati rischi bellici che corre chi vive in Occidente si accompagna un ottundimento del senso delle sofferenze altrui, del martirio di intere popolazioni e una consapevolezza pressoché nulla nei confronti delle responsabilità politiche delle potenze occidentali che scatenano le guerre. In Italia, ad esempio, tutte le forze politiche presenti in parlamento sono concordi nel sostenere e finanziare la «missione di pace» che gli Stati Uniti e la Nato hanno deciso di condurre in Afghanistan, giustificando con false motivazioni la strage di decine di migliaia di cittadini afghani, in particolare dei membri dell’etnia Pashtun, cinicamente identificati con il movimento Taliban. L’opinione pubblica tace.
Da quando Massimo D’Alema, nel 1999, autorizzò personalmente il bombardamento della ex Jugoslavia - ricorda Dal Lago - i governi italiani non hanno mai parlato di guerra vera e propria, ed hanno del tutto ignorato l’articolo 11 della Costituzione italiana che vieta ogni guerra che non sia difensiva. Lo stato di guerra non è mai stato dichiarato - anche in questo caso in violazione della Costituzione -, né il parlamento è stato chiamato in causa, se non per finanziare le missioni militari all’estero, subdolamente qualificate come missioni di pace, finalizzate alla diffusione della libertà e della democrazia.
In questi anni le stragi hanno colpito quasi esclusivamente civili inermi e indifesi, come è ormai la caratteristica delle «nuove guerre», quelle che Dal Lago chiama «le nostre guerre». Si è trattato di guerre di aggressione «asimmetriche», nelle quali l’uso di armi di distruzione di massa sempre più sofisticate e potenti ha reso soverchiante il potere distruttivo degli aggressori e sottratto agli aggrediti ogni speranza di salvezza. E molto spesso gli aggressori si sono fatti forti del proprio strapotere economico arruolando truppe mercenarie di contractors, alle dipendenze di grandi corporations globali, talora in numero superiore a quello dei combattenti di ruolo. E si è trattato di guerre «privatizzate» nelle quali non esiste più un «nemico legittimo», definito come tale dalle norme del diritto internazionale, come un tempo accadeva.
La logica delle guerre di aggressione contemporanee è la stessa di qualsiasi «guerra civile», nella quale si lotta fino all’estremo e non si fanno prigionieri. Per di più, si tratta di guerre che non hanno la finalità di una conquista territoriale: si combatte su scala globale coinvolgendo potenzialmente il mondo intero. La finalità è un obiettivo strategico di dimensioni planetarie che coincide con la volontà egemonica degli Stati Uniti e che si esprime attraverso la costante minaccia dell’uso della forza.
La volontà egemonica degli Stati Uniti e dei loro alleati occidentali ha comportato la devastazione terroristica della vita, dei beni e dell’ambiente di interi paesi, mentre gli aggressori hanno subito un numero molto limitato di vittime, a volte addirittura nessuna. Questo è accaduto nell’arco di un ventennio in paesi come l’Iraq (1991), la ex Jugoslavia, l’Afghanistan, di nuovo l’Iraq (2003), il Libano, i territori palestinesi, per citare gli eventi bellici più rilevanti. In queste guerre, condotte in nome di valori universali, nessuna limitazione «umanitaria» degli strumenti bellici è stata praticata. Anzi, è vero il contrario: gli interventi «umanitari» sono serviti, soprattutto agli Stati Uniti e a Israele, per sperimentare nuovi sistemi d’arma, sempre più sofisticati e devastanti.
L’impero contro gli infedeli
Si può qui aggiungere, a commento conclusivo del testo di Dal Lago, che in tutti questi casi il terrorismo degli aggressori si è autogiustificato - ed è stato giustificato - in nome della pace globale, della lotta al global terrorism e soprattutto della tutela dei diritti umani. La guerra è stata esaltata come l’impresa di benefattori umanitari impegnati a proteggere e promuovere i diritti fondamentali delle persone in tutti gli angoli della terra. In realtà, la difesa dei diritti umani è stata mistificata e tradita dalla violenza omicida. E agli aggressori è stata riservata l’assoluta impunità. Questo vale anche per le aggressioni, le stragi, gli «omicidi mirati» compiuti dallo Stato di Israele contro il popolo palestinese, in particolare contro la popolazione di Gaza e il movimento Hamas, accusati di essere la culla del terrorismo globale.
In questi ultimi anni, in altre parole, si è sviluppato un processo di transizione dalla «guerra moderna» alla «guerra globale», con al centro il recupero da parte delle potenze occidentali della nozione di «guerra preventiva», concepita e praticata dagli Stati Uniti contro i cosiddetti rogue states e le organizzazioni, vere o presunte, del terrorismo globale. Questa transizione non riguarda soltanto la morfologia delle «nuove guerre», e cioè la loro dimensione strategica e la loro potenzialità distruttiva. Strettamente connessa è una vera e propria eversione del diritto internazionale vigente, dovuta all’incompatibilità della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale generale con la «guerra preventiva». E a questo si aggiunge la regressione alle retoriche antiche di giustificazione della guerra, inclusi importanti elementi della dottrina «imperiale» del bellum justum e del suo nocciolo teologico-sacrificale di ascendenza biblica: la «guerra santa» contro i barbari e gli infedeli. Queste retoriche sono diventate oggi, nel contesto della globalizzazione dei mezzi di comunicazione di massa, uno strumento bellico di eccezionale rilievo.
Ha fatto dunque molto bene Alessandro Dal Lago a richiamare l’attenzione e a denunciare la responsabilità dei filosofi e dei sociologi - oltre che, aggiungerei, dei giuristi accademici «al di sopra delle parti» - che dall’alto delle loro cattedre minimizzano la tragedia delle nuove guerre e talora la giustificano. Dulce bellum inexpertis, sosteneva Erasmo da Rotterdam.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- MONOTEISMO, MONOPOLIO ’CATTOLICO’, E INDUSTRIA CULTURALE. SOLLECITATI DALLA CRISI DEL "PARTITO DELL’AMORE" DEI PAPI ATEI E DEVOTI, FILOSOFI E TEOLOGI RIPROPONGONO "I DIECI COMANDAMENTI ANCHE PER CHI NON CREDE".15 maggio 2010, di Federico La Sala
 MONOTEISMO, MONOPOLIO ’CATTOLICO’, E INDUSTRIA CULTURALE. SOLLECITATI DALLA CRISI DEL "PARTITO DELL’AMORE" DEI PAPI ATEI E DEVOTI, FILOSOFI E TEOLOGI RIPROPONGONO "I DIECI COMANDAMENTI ANCHE PER CHI NON CREDE".
MONOTEISMO, MONOPOLIO ’CATTOLICO’, E INDUSTRIA CULTURALE. SOLLECITATI DALLA CRISI DEL "PARTITO DELL’AMORE" DEI PAPI ATEI E DEVOTI, FILOSOFI E TEOLOGI RIPROPONGONO "I DIECI COMANDAMENTI ANCHE PER CHI NON CREDE". Lodevole iniziativa quella assunta dalle edizioni il Mulino: far riflettere su «I comandamenti», aiutando a discernere se sono semplici «icone del passato» oppure se ad essi ci si può riferire come a «principi validi in ogni luogo e in ogni tempo». Interrogativo non così retorico, in una stagione in cui i principi immutabili non godono di grande fortuna (...)
Lodevole iniziativa quella assunta dalle edizioni il Mulino: far riflettere su «I comandamenti», aiutando a discernere se sono semplici «icone del passato» oppure se ad essi ci si può riferire come a «principi validi in ogni luogo e in ogni tempo». Interrogativo non così retorico, in una stagione in cui i principi immutabili non godono di grande fortuna (...) -
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- L’ITALIA, Il "MONOTEISMO" DELLA COSTITUZIONE, E IL "BAAL-LISMO" DEL MENTITORE (1994-2010). IL SONNO DELLA RAGIONE COSTITUZIONALE GENERA MOSTRI, ATEI E DEVOTI.12 maggio 2010, di Federico La Sala
L’ITALIA, Il "MONOTEISMO" DELLA COSTITUZIONE, E IL "BAAL-LISMO" DEL MENTITORE (1994-2010). IL SONNO DELLA RAGIONE COSTITUZIONALE GENERA MOSTRI, ATEI E DEVOTI ...
 L’UNITA’ INDIVISIBILE DELLA REPUBBLICA E L’UNITA’ DEI CITTADINI: QUALE RAPPORTO? QUALE "UNITA’" SI VUOLE COSTRUIRE E CUSTODIRE?! QUELLA DELL’"UNO" DELLA LEGGE E DEL DIRITTO O QUELLA DELL’"UNO" DEL FUORILEGGE E DELLA MENZOGNA? QUALE UNITA’ DA CUSTORIRE. Una nota di Michele Ainis
L’UNITA’ INDIVISIBILE DELLA REPUBBLICA E L’UNITA’ DEI CITTADINI: QUALE RAPPORTO? QUALE "UNITA’" SI VUOLE COSTRUIRE E CUSTODIRE?! QUELLA DELL’"UNO" DELLA LEGGE E DEL DIRITTO O QUELLA DELL’"UNO" DEL FUORILEGGE E DELLA MENZOGNA? QUALE UNITA’ DA CUSTORIRE. Una nota di Michele Ainis (...) l’esperienza insegna che i valori costituzionali possono venire erosi gradualmente, in forme oblique, attraverso una pioggia d’episodi minori che in conclusione ne faccia marcire le radici. E questo pericolo chiama in causa non solo il Capo dello Stato, bensì ciascuno di noi, la vigilanza di ogni cittadino (...)
(...) l’esperienza insegna che i valori costituzionali possono venire erosi gradualmente, in forme oblique, attraverso una pioggia d’episodi minori che in conclusione ne faccia marcire le radici. E questo pericolo chiama in causa non solo il Capo dello Stato, bensì ciascuno di noi, la vigilanza di ogni cittadino (...) -
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- Mai nella storia della Chiesa si è assistito a un tale cinico, lurido, paranoico sdoppiamento tra la pretesa di porsi come Grande Padre di un movimento per il Regno di Cristo e una pratica di vita immorale con un potere spirituale totalitario usato a fini predatori (di Mrco Politi - Le parole di Schönborn si rivolgono al “dopo Ratzinger”).11 maggio 2010, di Federico La Sala
Il cardinale attacca Sodano, ma l’obiettivo è il futuro conclave
Le parole di Schönborn si rivolgono al “dopo Ratzinger”
Da Vienna inizia la guerra ai “reazionari” e la difesa dell’azione del Papa contro gli abusi nel clero
di Marco Politi (il Fatto, 11.05.2010)
L’attacco al cardinale Sodano apre il tavolo del futuro Conclave. Con la sua mossa Schönborn pone il problema dell’organizzazione del potere ai vertici della Chiesa e sottolinea l’urgenza di una riforma.
La sortita straordinaria dell’arcivescovo di Vienna non è una rissa tra porporati. Triplice è la sua traiettoria: sostenere l’operazione pulizia di Benedetto XVI, salvaguardare la memoria di Wojtyla, porre le basi per il dopo-Ratzinger. Il cardinale di Vienna Schönborn, sollevando il caso del suo predecessore Groër costretto alle dimissioni per pedofilia, mira in realtà allo scandalo del fondatore dei Legionari di Cristo, Maciel, la cui condotta ignominiosa è stata certificata da un recente documento della Santa Sede.
Mai nella storia della Chiesa si è assistito a un tale cinico, lurido, paranoico sdoppiamento tra la pretesa di porsi come Grande Padre di un movimento per il Regno di Cristo e una pratica di vita immorale con un potere spirituale totalitario usato a fini predatori. Chi tocca i fili di una vicenda del genere, muore.
E le accuse di Schönborn al cardinale Sodano sono implacabili. Se l’ex segretario di Stato viene catalogato fra coloro che hanno impedito l’indagine sui crimini di Maciel, la sua credibilità crolla. In gioco viene messa automaticamente la posizione di Sodano quale decano del Sacro Collegio, cui tocca in caso di Conclave la presidenza delle riunioni preparatorie dei cardinali-elettori. Papa Wojtyla, benché malato di Parkinson, rimase lucido sino alla fine nel tracciare la sua strategia geopolitica. Ma per il resto ha sempre lasciato ai suoi più stretti collaboratori la gestione della macchina curiale, la nomina dei vescovi, gli affari correnti. Sodano - con il segretario papale Dziwisz e lo stesso Ratzinger - rappresentava la cerchia interna degli intimi collaboratori di Wojtyla.
Indicandolo tra gli oppositori delle inchieste volute da Ratzinger, Schönborn solleva una questione cruciale: come è stato informato o disinformato Giovanni Paolo II su Groër, Maciel e altri casi similari? Che tipo di disinformazione gli è stata fornita su altre vicende ecclesiali? Domanda esplosiva. Che rimanda all’uso del potere nelle stanze segrete della Curia. C’è anche un aspetto di allarme attuale.
Sotto la pressione degli eventi, che hanno toccato le sue convinzioni morali, Benedetto XVI è stato costretto negli ultimi mesi ad una perestrojka accelerata all’interno della Chiesa: decapitazioni di vescovi, pubbliche autocritiche, ammissione della necessità di affidare ai tribunali statali i preti colpevoli (in controtendenza alla pratica secolare di mantenere all’interno della propria giurisdizione i casi sporchi), sconfessione delle pratiche secolari di omertà, accettazione di responsabilità dinanzi alle vittime e all’opinione pubblica.
Non tutti nei ranghi ecclesiali sono d’accordo con questa eclatante tolleranza zero. La rivolta clamorosa del cardinale Castrillon Hoyos che a Murcia, in Spagna, poche settimane fa ha esibito tra tonanti applausi una sua lettera del 2001 al vescovo francese Pican, lodato perché non aveva “consegnato” alle autorità statali un prete pedofilo, ha rivelato in modo allarmante questa opposizione sotterranea. Specie perché tra gli entusiasti sostenitor i di Castr illon Hoyos, fattosi forte di un’autorizzazione di papa Wojtyla, c’era anche il cardinale di Curia Antonio Canizares, da poco chiamato a Roma dallo stesso Benedetto XVI per guidare la Congregazione per il Culto. L’intervento pasquale del cardinal Sodano, che ha derubricato a “chiacchiericcio” la documentazione dei mass media sugli abusi del clero, ha aggravato la situazione.
L’intervento del cardinale Schönborn mira a bloccare il sabotaggio anti-Ratzinger. Però con la sua mossa audace il cardinale di Vienna guarda - oltre lo scandalo pedofilia - al futuro della Chiesa. Il porporato, grande elettore di Ratzinger al conclave del 2005, sa che l’elezione di Benedetto XVI è avvenuta in uno “stato di emergenza”. Dinanzi alla necessità di riempire rapidamente il vuoto enorme lasciato dalla scomparsa del carismatico Wojtyla (e in assenza del candidato rifor matore Martini, fuori gioco per malattia) venne scelto Joseph Ratzinger come unica personalità di alto livello intellettuale e spirituale, dotata di prestigio internazionale. Fu portato da una maggioranza moderata e conservatrice, desiderosa di un pontificato “di pausa” e di garanzia dottrinale.
Ma all’interno di questo schieramento esiste un blocco reazionario, supercentralista, ottusamente anti-moderno, che Schönborn con la sua sortita senza precedenti vuole portare alla luce e isolare per impedirgli di pesare sul futuro Conclave. Perché quello che nel pensiero ratzingeriano è pessimistica meditazione di un monaco, che vede l’Europa cristiana desertificata dall’arrivo di nuovi barbari, nella visione del blocco reazionario è soltanto desiderio ossessivo di una rivincita sul moder no.
Schönborn , e con lui molti vescovi nei vari continenti, sono invece convinti che la Chiesa abbia bisogno di riforme e che dopo l’intervallo del pontificato ratzingeriano sia inevitabile sciogliere molti nodi. Nel 2005, per responsabilità di Ratzinger allora decano del Sacro Collegio, fu impedito ai cardinali elettori - nelle settimane antecedenti al Conclave - di discutere apertamente in interviste e riunioni pubbliche l’agenda dei problemi della Chiesa. Come invece era avvenuto nel 1978.
Questa volta Schönborn , e non è il solo, ritiene che vadano affrontate le sfide sul tappeto. A partire dall’organizzazione del potere nella Curia e dalla collaborazione tra papa ed episcopato mondiale. Non a caso, conversando con i giornalisti austriaci, ha definito “urgente” la riforma della Curia, ha evocato “considerazione” per le coppie omosessuali stabili, ha riparlato dei divorziati risposati. Di recente aveva anche proposto un riesame del celibato del clero. Come il cardinale Martini, del resto. La partita è appena iniziata. Sarà di lungo respiro e riserverà colpi di scena.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- L’inchiesta. Alcune compravendite di case passavano da «Propaganda fide». Gli incontri di Anemone con monsignor Camaldo. Il superteste racconta: portavo il costruttore dal cerimoniere del Papa.7 maggio 2010, di Federico La Sala
 L’inchiesta
L’inchiesta Alcune compravendite di case passavano da «Propaganda fide»
Alcune compravendite di case passavano da «Propaganda fide» Il superteste racconta: portavo
Il superteste racconta: portavo
 il costruttore dal cerimoniere del Papa
il costruttore dal cerimoniere del Papa Gli incontri di Anemone con monsignor Camaldo.
Gli incontri di Anemone con monsignor Camaldo.
 E Don Evaldo rivela: altri sacerdoti sapevano dei soldi
E Don Evaldo rivela: altri sacerdoti sapevano dei soldiAppartamenti trasformati in dimore di lusso grazie alle ristrutturazioni compiute dalle imprese di Diego Anemone. A beneficiarne erano «politici e prelati», così come ha raccontato Laid Ben Hidri Fathi, l’autista di Angelo Balducci, che del costruttore era diventato collaboratore. Di fronte ai magistrati di Perugia l’uomo ha cominciato a fornire dettagli e identità.
E ha svelato: «Ero io ad accompagnare Diego agli incontri con queste persone. Ricordo in particolare che era in rapporti con monsignor Francesco Camaldo». Si tratta del cerimoniere del Papa, per quindici anni segretario particolare del vicario di Roma cardinal Ugo Poletti. I legami con il Vaticano sono uno dei filoni principali dell’indagine sugli appalti dei Grandi eventi, soprattutto dopo la scoperta che una delle «casseforti» dell’imprenditore era gestita da don Evaldo Biasini, 83 anni. Ma anche perché alcune compravendite di case passavano proprio da enti religiosi come «Propaganda Fide», di cui Balducci era consigliere. Dimore che sarebbero state acquistate seguendo la procedura già scoperta nel caso del ministro Claudio Scajola. L’attenzione della Guardia di finanza si concentra su 15 operazioni sospette: trasferimenti di denaro dai conti di Anemone a quelli dei suoi prestanome- in particolare il geometra Zampolini e la segretaria Alida Lucci-e poi trasformati in assegni circolari da versare al momento del rogito.
Gli incontri
Il testimone-che aveva ricevuto il compito di gestire una serie di conti correnti di Anemone e per questo aveva ottenuto anche la delega ai prelevamenti per contanti-non fornisce dettagli sui contenuti dei colloqui. Ma è preciso nel riferire in quali occasioni portò Anemone da monsignor Camaldo. Sinora l’inchiesta aveva fatto emergere una buona conoscenza tra il prelato e Balducci. Tanto che quando il provveditore è stato arrestato, monsignor Camaldo ha commentato: «Sono molto addolorato, è una persona di assoluta limpidezza morale, conosciuta e stimata in Vaticano da tanti anni, sono certo che dimostrerà la sua completa estraneità alle accuse». Adesso si intravede una rete più ampia. Anche perché nel 2008 lo stesso prelato finì nell’inchiesta avviata dal pm Henry John Woodcock su Vittorio Emanuele di Savoia, sospettato di complicità con alcuni faccendieri inseriti nella massoneria. Per quale motivo incontrava Anemone? Tra gli interessi comuni c’erano soltanto acquisiti e ristrutturazioni di appartamenti, come racconta Hidri Fathi? È presumibile che monsignor Camaldo venga ascoltato dai magistrati di Perugia quando saranno terminati gli accertamenti sulle 15 operazioni sospette emerse nell’indagine.
Rogiti e assegni
Nell’elenco delle persone da interrogare c’è anche il notaio Gianluca Napoleone che ha stipulato tutti i rogiti delle operazioni immobiliari gestite dall’architetto Angelo Zampolini. E sono proprio quelle «anomale» movimentazioni di denaro scoperte sui suoi conti presso la Deutsche Bank e su quelli della Lucci a celare - secondo i pubblici ministeri Sergio Sottani e Alessia Tavarnesi- l’acquisto di case che Anemone avrebbe poi intestato ai politici, ai funzionari statali e a quei religiosi che lo avrebbero agevolato nella concessione degli appalti pubblici, ma anche nei lavori di ristrutturazione di interi stabili. Per questo, oltre alle verifiche effettuate presso istituti di credito e banche dati finanziarie, l’interesse degli investigatori si concentra sulle mappe catastali per rintracciare eventuali cambi di destinazione d’uso e verificare i proprietari degli appartamenti che spesso risultano intestati a società.
I sacerdoti
In questo vorticoso giro di case si inseriscono gli affari gestiti da Balducci e Anemone attraverso «Propaganda Fide» e soprattutto la Congregazione del preziosissimo sangue di cui era economo don Evaldo Biasini, che nella sua cassaforte conservava contanti messi a disposizione del costruttore in caso di emergenza. Il sacerdote, missionario in Africa, ha poi raccontato di aver messo a disposizione del costruttore i conti dell’Ente, di fatto utilizzati per depositare assegni e prelevare contanti.
Leggendo il verbale della perquisizione nella sede dell’Istituto dai Ros, si scopre che oltre a don Evaldo altri preti erano a conoscenza delle strane movimentazioni effettuate per favorire il costruttore. Afferma il sacerdote: «Sui depositi della Congregazione, intestati a me perché rivesto la carica di economo, sono autorizzati ad operare don Giuseppe Montenegro quale rappresentante legale e don Nicola Giampaolo, direttore di Primavera missionaria che ha sede ad Albano Laziale» cioè dove si trova anche la Congregazione.
 Fiorenza Sarzanini
Fiorenza Sarzanini* Corriere della Sera, 07 maggio 2010
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- Monsignor Camaldo l’amico «addolorato» per l’arresto di Balducci (di Roberto Monteforte).8 maggio 2010, di Federico La Sala
Monsignor Camaldo l’amico «addolorato» per l’arresto di Balducci
di Roberto Monteforte (l’Unità, 8 maggio 2010)
«Sono addolorato per l’arresto di Balducci. È una persona limpida, conosciuta e stimata in Vaticano da tanti anni». Era stato questo il commento di monsignor Francesco Camaldo, «decano dei cerimonieri pontifici», prelato vicinissimo a papa Ratzinger, al momento dell’arresto dell’ingegner Angelo Balducci.
È stata l’unica voce «vaticana» a rompere la cortina di silenzio e di prudente riserbo attorno al professionista inquisito. L’ingenere talmente ben introdotto nelle strutture della Santa Sede e apprezzato per le sue doti di «affidabilità ed efficienza» da essersi guadagnato il titolo di «gentiluomo di sua Santità» e quello ancora più significativo e non solo onorifico di «consultore di PropagandaFide», la potente struttura della Santa Sede che si occupa delle missioni all’estero.
L’unico dicastero vaticano con un bilancio proprio, che risponde direttamente al Papa e che amministra un imponente patrimonio immobiliare. Ora che emerge anche la frequentazione tra monsignor Camaldo e il costruttore-affarista Diego Anemone, socio e amico di Balducci, un’altra tessera viene collocata nel mosaico dei contatti avuta dalla «cricca» in Vaticano, fatta di amicizie, scambi di favori e interessi.
Non è la prima volta che monsignor Camaldo viene chiamato in causa in inchieste giudiziarie. Nel 2006 per alcune intercettazioni telefoniche è finito nell’inchiesta del pm di Potenza, John Woodcock sulle «macchinette informatiche» truccate che ha visto protagonista Vittorio Emanuele di Savoia. Sono molto stretti i rapporti tra il «cerimoniere» di sua santità e la famiglia Savoia: è stato grazie ai suoi uffici che Vittorio Emanuele, la moglie Marina Doria e il figlio Emanuele Filiberto sono stati ricevuti in udienza da Benedetto XVI.
È uomo di mondo e di mondanità trasversali monsignor Camaldo, che prima di arrivare in Curia dal 1984 al 1997 è stato il segretario particolare del cardinale vicario per la diocesi di Roma, Ugo Poletti. Nato a Lagonegro in provincia di Potenza nel 1952 è tutta romana la sua carriera «ecclesiastica». Frequenta il «seminario romano maggiore» ed è ordinato sacerdote nel 1976. Già da allora è spiccata la sua attenzione alle forme liturgiche. È stato «cerimoniere» del Vicariato dal 1984 al 1993. Un ruolo apprezzato, tanto che il 27 giugno 1984 Giovanni Paolo II lo nomina «Cerimoniere Pontificio e Prelato d’Onore di Sua Santità». Quando ha seguito il cardinale Poletti vicario «emerito» in Vaticano, ha assistito da cerimoniere anche l’allora cardinale Joseph Ratzinger.
Una carica prestigiosa quella di «cerimoniere». In questa veste ha partecipato a tutti i più grandi eventi della storia del Papato e della Santa Sede che si sono susseguiti negli anni, compresi il Grande Giubileo dell’anno 2000, i funerali di Giovanni Paolo II, il Conclave del 2005, l’incoronazione di Papa Benedetto XVI. Un percorso che gli ha consentito di tessere relazioni importanti con gli ambienti che contano e avere riconoscimenti prestigiosi. Ne dà testimonianza il sito del decano dei «Cerimonieri Pontifici».
Tra le tante «cariche» ricoperte quelle più significative sono cappellano de1la Cappella di Sant’Andrea Corsini nella Basilica di San Giovanni in Laterano, assistente ecclesiastico del Circolo San Pietro e rettore della Cappella di Santa Maria della Pietà al Colosseo. Ma l’elenco è lungo: cappellano Conventuale Gran Croce ad honorem del Sovrano Militare Ordine di Malta, Grand’Ufficiale dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro di CasaSavoia, Commendatore al merito della Repubblica Italiana. Titoli e onorificenze che paiono fuori tempo, ma che invece, sono indicativi degli ambienti, non solo ecclesiastici, che il monsignore frequenta. Dove ci si aiuta, dove si costruiscono carriere e favori. Come per Balducci e Anemone che il monsignore conosce da tempo, almeno dal 1998.
La svolta è con la preparazione del «Grande evento» per eccellenza: il Grande Giubileo del 2000. Dal 1997 per il Vaticano è segretario generale per il Giubileo monsignor Crescenzio Sepe. Angelo Balducci ha un ruolo strategico: è provveditore alle Opere Pubbliche del Lazio. Al tempo stesso è stimato «consulente» per la Santa Sede su tutti i problemi che riguardano l’urbanistica. Sono gli anni della realizzazione del «terminal» del Gianicolo su di un’area di pertinenza di «Propaganda Fide». Un «mega affare» per la congregazione vaticana che dal 2001 ha a capo come prefetto proprio il cardinale Sepe.
Si rafforza il rapporto con Balducci. Le sue capacità di gestione gli aprono le porte di «Propaganda Fide». Si ricorre a lui anche per la gestione del patrimonio immobiliare della congregazione vaticana. Si rafforza anche il suo rapporto di frequentazione con il sottosegretario di Stato, monsignor Leonardo Sandri, Le porte del Vaticano si aprono alle ditte amiche. Per Anemone è il grande salto. Anche in Vaticano.
-
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. .... DEBOLE O FORTE, LA TEOCRAZIA E’ SEMPRE PARENTE STRETTA DI FASCISMI, NAZISMI E BERLUSCONISMI (di Paolo Flores D’Arcais - La religione e la democrazia).4 maggio 2010, di Federico La Sala
La religione e la democrazia
di Paolo Flores D’Arcais (la Repubblica, 4 maggio 2010)
Joaquìn Navarro-Valls ha pubblicamente confessato il programma di "teocrazia debole" che la Chiesa gerarchica di Karol Wojtyla prima, e quella di Joseph Ratzinger oggi, stanno tenacemente perseguendo. Con esiti fin qui fallimentari nel mondo, ma di peculiare successo nella "eccezione" Italia. Non meraviglia perciò che l’articolo dell’ex portavoce di Giovanni Paolo II, ancora oggi autorevolissimo nell’esprimere umori e "desiderata" della Chiesa vaticana, prenda le mosse proprio dall’apologia del "caso italiano", osannato perché «è veramente considerevole il ruolo assunto dalla religione» nel dibattito (e soprattutto nella realtà del potere, ma su questo Navarro-Valls sorvola), per cui «l’enorme complessità e originalità di questo Paese» (cioè le macerie morali e materiali a cui l’ha ridotto il berlusconismo) «costituisce una ricchezza stimolante che altrove manca del tutto».
All’ex portavoce di Wojtyla l’Italia appare dunque il luogo provvidenziale in cui sperimentare l’obiettivo che il cattolicesimo gerarchico ha scelto come stella polare: «Una democrazia deve riconoscere il valore di verità, naturale e generale, della religiosità umana, considerandolo un diritto comune, indispensabile cioè per il bene di tutti». Papale papale.
Con questa logica, però, l’ateo, lo scettico, il miscredente, insomma il cittadino che non si riconosca in alcuna "religiosità umana", verrebbe irrimediabilmente colpito da ostracismo, e declassato a cittadino di serie B. Il suo ateismo, infatti, non solo non troverebbe posto in questo discriminatorio "diritto comune", ma verrebbe implicitamente tacciato di essere contrario al "bene di tutti".
Tanto perché non ci siano equivoci, infatti, Navarro-Valls aggiunge che «non è possibile, in effetti, escludere il valore politico e solidale della religione senza estromettere, al contempo, anche la giustizia dalle leggi dello Stato». E perché mai? Veramente Thomas Jefferson, eminente padre della democrazia americana - paese sempre citato come eden di libertà fondata su una religiosità onnipervasiva - , garantiva l’opposto: «Il manto della protezione [costituzionale] copre il giudeo e il gentile, il cristiano e il maomettano, l’indù e il miscredente di ogni genere» proprio perché la Costituzione «ha eretto un muro di separazione tra Chiesa e Stato».
Wojtyla e Ratzinger hanno invece sistematicamente gettato l’anatema su ogni versione di «libera Chiesa in libero Stato». Una legge che prescinda dalla religione avrebbe niente meno che «estromesso la giustizia», riassume con precisione Navarro-Valls, renderebbe illegittima la democrazia trasformandola in un vaso di iniquità. È esattamente quanto sostenne Papa Wojtyla di fronte al primo parlamento polacco democraticamente eletto, se la maggioranza parlamentare avesse promulgato una legge sull’aborto difforme dal diktat della morale vaticana. In perfetta sintonia papale la conclusione di Navarro-Valls: «La consapevolezza democratica di base» deve riconoscere che «la religione è un valore umano fondamentale e inevitabile, il quale deve essere valorizzato e garantito legalmente nella sua rilevanza pubblica» (sottolineatura mia). Con l’aggiunta finale di un criptico ma inquietante «a prescindere dal resto».
E invece no, dal "resto" non si può affatto prescindere. Perché il "resto" è che la democrazia si fonda sull’autos nomos di tutti i cittadini, singolarmente e collettivamente presi. Nella democrazia sono i cittadini che «si danno da sé la legge». E nessun altro prima o sopra di loro. Se i cittadini non potessero decidere la legge liberamente, ma obbedire a una legge già data (dall’Alto, dall’Altro), non sarebbero sovrani, «per la contraddizion che nol consente», secondo un padre Dante molto tomistico e che quindi dovrebbe andar bene anche a Navarro-Valls.
Che la giustizia secondo il dettame della religione diventi tassativa e vincolante per la democrazia significa espropriare il cittadino della sovranità e riconsegnarla a Dio. Tecnicamente si chiama alienazione: alienare i famosi diritti inalienabili. Alienazione che coincide con l’annientamento stesso della democrazia. Insomma e senza perifrasi: la sovranità di Dio è incompatibile con la sovranità dell’uomo, in cui consiste la democrazia. Dovrebbe essere una ovvietà, da oltre un paio di secoli. Ma nell’italica «ricchezza stimolante che altrove manca del tutto» tutto è invece permesso.
E sia. Quale Dio, però? Il Dio cristiano dei valdesi - compassionevole - riconosce ai suoi figli il diritto all’eutanasia, quello di Ratzinger - gelido - lo nega, quello di Küng (cristiano cattolico come Ratzinger) di nuovo lo consente, il Dio dei "Testimoni di Geova" proibisce ogni trasfusione di sangue anche a costo della vita, il Dio di altri (sempre lo stesso, perché l’Uno) esige invece mutilazioni sessuali per le bambine. E si potrebbe continuare. Quale di queste incompatibili verità dovrà assumere lo Stato nella sua legge, per ottemperare alla pretesa di Navarro-Valls di «concepire la religione come un valore assoluto»? Senza dimenticare che a pretendere che sia fatta la volontà di Dio, anziché quella democratica dei cittadini, c’è poi sempre in agguato un "Gott mit uns" che battezzerà di giustizia religiosa ogni terrena efferatezza.
Naturalmente, in una democrazia liberale i cittadini non possono stabilire per legge "qualsiasi cosa", neppure con maggioranze plebiscitarie. Ma il limite all’esercizio della loro autonomia è la loro autonomia stessa, non un’eteronoma volontà di Dio (magari agghindata da "legge naturale"). Che è poi la volontà di chi pretende di conoscere la volontà di Dio e parlare in suo nome (in psichiatria si chiama delirio di onnipotenza). Non si possono, a maggioranza, violare i diritti individuali sulla vita, la libertà, eccetera, di ciascuno, perché del ciascuno si distruggerebbe o amputerebbe la sovranità, dunque l’autonomia.
Dio e la religione, come si vede, non c’entrano un bel nulla. L’anti-relativismo della democrazia sta tutto e solo nel comune riconoscimento - interiorizzato come ethos repubblicano - delle inalienabili libertà di ciascuno (fino a che non violano identica libertà altrui: dalla vignetta blasfema all’eutanasia, esattamente come non si proibisce la superstizione della Sindone o la sofferenza terminale volontaria). "Religiosità" civile, se si vuole. Che la "teocrazia debole" di Ratzinger e Navarro-Valls pretende invece di sovvertire.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- L’ITALIA AL TEMPO DELLA CATTIVITA’ DEI DUE PAPI. La Chiesa del premier (di Antonio Padellaro)22 aprile 2010, di Federico La Sala
La Chiesa del premier
di Antonio Padellaro (il Fatto Quotidiano, 22 aprile 2010)
Il premier ha festeggiato la vittoria delle Regionali con un’accoglienza mai così calorosa da parte delle autorità ecclesiastiche”, si legge in un’attenta cronaca della Stampa dedicata al ricevimento di martedì alla Nunziatura per il 5° anniversario dell’elezione di Benedetto XVI. Seguono particolari sulle cordialità tra Berlusconi e il segretario di Stato Bertone che si sono reciprocamente congratulati per la sconfitta della Bonino nel Lazio. Salvate le cliniche private dall’anticristo, mancava solo che i due si battessero con la mano il cinque. Qualche interrogativo sorge spontaneo.
Quel signore accolto dai raggianti servi del Signore non è lo stesso su cui la scorsa estate piovvero strali e riprovazione a causa della sua “condotta morale” (vedi escort e minorenni)? Se di evangelico perdono si tratta, resta da capire quale penitenza avrà avuto la pecorella smarrita.
Se l’è cavata, forse, con tre pater, ave e gloria e un altro aiutino alle scuole cattoliche? Per il figliol prodigo è giusto cucinare il vitello grasso, soprattutto se è lo stesso capo di un governo che la Cei duramente condannò per la politica disumana dei respingimenti dei clandestini in mare. Non risulta però che quello stesso governo, dove siedono i cristianissimi esponenti padani, consideri adesso gli extracomunitari come fratelli da aiutare e non come “negri” da rispedire “fuori dalle balle”. Infine, quel devotissimo premier è lo stesso che sabato scorso al funerale di Vianello ha ricevuto la comunione benché divorziato e risposato? Se ha preso in giro anche Gesù Cristo, fatti suoi.
Ma come la mettiamo, eminenze reverendissime, con la severità ben altrimenti applicata a tutti quei semplici cittadini, credenti o no, ai quali non smettete un momento di elencare divieti e minacciare anatemi. Lo sappiamo che lassù c’è qualcuno superiore a tutto e a tutti. Non sapevamo però che si chiamasse Silvio.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- Cinque anni dopo il 19 aprile 2005, che segnò l’avvento di Benedetto XVI. Intervista a Franco Garelli (di Marco Politi).29 aprile 2010, di Federico La Sala
Se la Chiesa non coinvolge più. Un giovane su due non è cattolico
“La Chiesa di Benedetto XVI è troppo occidentale, si presta poca attenzione al resto del mondo”
Il sociologo Garelli: Ratzinger è distaccato e impolitico
di Marco Politi (il Fatto, 29.04.2010)
Cinque anni dopo il 19 aprile 2005, che segnò l’avvento di Benedetto XVI, un giovane italiano su due respinge la qualifica di cattolico. Segno di crescente disaffezione. Ancora nel 2004 si dichiaravano cristiano-cattolici i due terzi della gioventù. Certo, sono processi di lungo periodo, ma l’indagine realizzata dall’Istituto Iard rivela che il Pontificato di Ratzinger non è riuscito a contrastare l’allontanamento dei giovani dalla Chiesa. E proprio in quell’Italia, che è direttamente sottoposta alla sua giurisdizione pastorale. Anzi, c’è motivo di credere che l’abbia favorito.
Il quinquennio passato è quello di una “Chiesa del no” che, sull’onda dei cosiddetti principi non negoziabili stabiliti da Benedetto XVI, ha impedito la riforma delle legge sulla procreazione assistita per consentire ad una madre di non partorire un bimbo già condannato in partenza alla morte, ha combattuto una legge sulle coppie di fatto, ha vietato le unioni gay, ha bloccato l’autodeterminazione del paziente nel testamento biologico. Tematiche a cui le giovani generazioni sono sensibili.
Cosa non funziona nel Pontificato ratzingeriano? Franco Garelli, sociologo cattolico che per conto della Cei ha realizzato importanti inchieste sulla religiosità in Italia, preferisce partire da un dato positivo. “Nel caso degli abusi sessuali del clero Benedetto XVI - dice - sta proiettando l’immagine di un capo della Chiesa che vuole fare pulizia, non ha paura di tagli drastici, non demorde e caccia i colpevoli”.
Però questo è solo un aspetto. Nel suo svolgersi il quinquennio ratzingeriano ha mostrato di oscillare in diverse direzioni. Questo Papa, spiega, “genera ammirazione e preoccupazione, governa più con i dossier che attraverso uno spirito collegiale, è il Pontefice della chiarezza dottrinale, della ripresa della memoria e della tradizione, ma al tempo stesso - enfatizzando l’esclusività della fede cristiana - isola la Chiesa, poiché la propone come portatrice di un’unica verità e non la presenta come ponte verso le altre religioni e i non credenti”.
Non è per fare paragoni astratti con il predecessore, però chi osserva il procedere della Chiesa non può fare a meno di notare che “Wojtyla era un leader carismatico, Ratzinger è più teologo. Wojtyla creava movimento, Ratzinger crea riflessività. In Wojtyla il tradizionalismo era contemperato da segni affettivi, Benedetto XVI è più normativo, definitorio, distaccato. Non produce coinvolgimento o almeno non in maniera maggioritaria”.
Alla fine - a parte la battaglia determinata sulla pedofilia - l’impressione è quella di una Chiesa statica. Con una caratteristica specifica: “Si avverte una debolezza del governo istituzionale, spesso più del consenso prevale l’ossequio”. E soprattutto, questo “è un Papa impolitico”.
Se si chiede a Garelli quali siano i problemi insoluti del Pontificato, ne elenca alcuni: tutti legati al rapporto fra Chiesa e società. “La Chiesa - sostiene - deve affrontare finalmente la questione dei divorziati risposati. Dopo il concilio Vaticano II è impensabile non affrontare questo tema nel mondo contemporaneo”. E’ una cosa, d’altronde, che sanno tutti i parroci. Quelli che più soffrono della proibizione di non prendere la comunione, che vale tassativamente per ogni divorziato risposato (a parte le guasconate di Berlusconi, per il quale c’è sempre si trova sempre un prelato pronto a perdonarlo), sono proprio i cattolici più sinceri e più impegnati nella vita ecclesiale.
Seconda questione, il celibato dei preti. Garelli come tanti altri respinge totalmente ogni connessione tra abusi sessuali e castità richiesta al clero. Il problema non è questo. Si tratta, molto semplicemente, che “il celibato dei sacerdoti deve essere volontario”.
Su un piano più generale il sociologo mette il dito sul vero punto dolente del Pontificato. La mancata riforma dell’assolutismo monarchico della Chiesa cattolica. Riforma che già con Giovanni Paolo II era matura (e la cui assenza era appena mascherata dall’attivismo wojtyliano e dalle novità del suo pontificato) e che con Benedetto XVI si sta manifestando sempre più improcrastinabile. Garelli, non da oggi - e lo fa capire ogni volta che lo invitano a partecipare ai grandi convegni decennali della Chiesa italiana - è un convinto sostenitore della “collegialità”. Cioè della partecipazione dei vescovi al governo della Chiesa universale. E altrettanto convintamente ritiene che il “laicato nella Chiesa deve partecipare davvero alla progettazione della missione pastorale e non servire solo da supporto”.
“La collegialità - sottolinea - ha un valore teologico e sociale. Il cardinale Martini l’ha richiamata spesso come punto qualificante. E’ necessario creare le condizioni affinchè nella Chiesa vi sia circolarità di idee. Bisogna prestare attenzione alle situazioni diverse ed è importante accettare l’unità nella diversità. Così come è necessario spingere i vescovi a riflettere insieme”.
Di pari passo è urgente superare l’“afonia dei laici”, cioè la situazione per cui i fedeli non sono mai consultati e chiamati alla progettazione della nuova evangelizzazione. Colpa, certamente, anche di tanti esponenti cattolici che non aprono bocca, perché “hanno meno coraggio delle generazioni precedenti”, e quindi il laicato cattolico in Italia si presenta sempre “allineato e coperto”. Di fatto clero e alte gerarchie parlano solo loro e i media, a loro volta, prestano attenzione solo a loro.
Eppure dal corpo della Chiesa salgono richieste diverse. “I fedeli - racconta Garelli che tante volte è andato a misurare sul campo il polso del cattolicesimo italiano - chiedono più ascolto e confidenza. Vorrebbero una Chiesa che sappia parlare un linguaggio spirituale più attento alle condizioni di vita e alle ragioni umane. Una Chiesa più in ricerca, capace di accompagnarli nelle loro vicende umane piuttosto che pronunciare verità e definizioni”. E quando non accade? “Se non trovano risposte, si chiudono, tacciono o vanno altrove”.
Certo, non va sottovalutato il segno dei tempi di uno stile di vita dilagante che mira solo ai consumi, alla scalata sociale, all’edonismo. “La cultura televisiva del Grande Fratello - confessa Garelli - depotenzia qualsiasi impegno religioso, politico o culturale, depotenzia destra e sinistra!”.
Gli chiedo, ora che inizia l’anno sesto di Papa Ratzinger, quale sia un altro punto critico del pontificato. Risponde: “Porre il baricentro nell’Occidente e prestare poca attenzione al cattolicesimo mondiale, che si nutre di culture non occidentali”. Intanto dal 2000 al 2008 le vocazioni sacerdotali in Europa sono cadute di un altro 7 per cento.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- Se la Chiesa non coinvolge più. Intervista a Franco Garelli, sociologo cattolico, di Marco Politi.29 aprile 2010, di Federico La Sala
Se la Chiesa non coinvolge più. Un giovane su due non è cattolico
“La Chiesa di Benedetto XVI è troppo occidentale, si presta poca attenzione al resto del mondo”
Il sociologo Garelli: Ratzinger è distaccato e impolitico
di Marco Politi (il Fatto, 29.04.2010)
Cinque anni dopo il 19 aprile 2005, che segnò l’avvento di Benedetto XVI, un giovane italiano su due respinge la qualifica di cattolico. Segno di crescente disaffezione. Ancora nel 2004 si dichiaravano cristiano-cattolici i due terzi della gioventù. Certo, sono processi di lungo periodo, ma l’indagine realizzata dall’Istituto Iard rivela che il Pontificato di Ratzinger non è riuscito a contrastare l’allontanamento dei giovani dalla Chiesa. E proprio in quell’Italia, che è direttamente sottoposta alla sua giurisdizione pastorale. Anzi, c’è motivo di credere che l’abbia favorito.
Il quinquennio passato è quello di una “Chiesa del no” che, sull’onda dei cosiddetti principi non negoziabili stabiliti da Benedetto XVI, ha impedito la riforma delle legge sulla procreazione assistita per consentire ad una madre di non partorire un bimbo già condannato in partenza alla morte, ha combattuto una legge sulle coppie di fatto, ha vietato le unioni gay, ha bloccato l’autodeterminazione del paziente nel testamento biologico. Tematiche a cui le giovani generazioni sono sensibili.
Cosa non funziona nel Pontificato ratzingeriano? Franco Garelli, sociologo cattolico che per conto della Cei ha realizzato importanti inchieste sulla religiosità in Italia, preferisce partire da un dato positivo. “Nel caso degli abusi sessuali del clero Benedetto XVI - dice - sta proiettando l’immagine di un capo della Chiesa che vuole fare pulizia, non ha paura di tagli drastici, non demorde e caccia i colpevoli”.
Però questo è solo un aspetto. Nel suo svolgersi il quinquennio ratzingeriano ha mostrato di oscillare in diverse direzioni. Questo Papa, spiega, “genera ammirazione e preoccupazione, governa più con i dossier che attraverso uno spirito collegiale, è il Pontefice della chiarezza dottrinale, della ripresa della memoria e della tradizione, ma al tempo stesso - enfatizzando l’esclusività della fede cristiana - isola la Chiesa, poiché la propone come portatrice di un’unica verità e non la presenta come ponte verso le altre religioni e i non credenti”.
Non è per fare paragoni astratti con il predecessore, però chi osserva il procedere della Chiesa non può fare a meno di notare che “Wojtyla era un leader carismatico, Ratzinger è più teologo. Wojtyla creava movimento, Ratzinger crea riflessività. In Wojtyla il tradizionalismo era contemperato da segni affettivi, Benedetto XVI è più normativo, definitorio, distaccato. Non produce coinvolgimento o almeno non in maniera maggioritaria”.
Alla fine - a parte la battaglia determinata sulla pedofilia - l’impressione è quella di una Chiesa statica. Con una caratteristica specifica: “Si avverte una debolezza del governo istituzionale, spesso più del consenso prevale l’ossequio”. E soprattutto, questo “è un Papa impolitico”.
Se si chiede a Garelli quali siano i problemi insoluti del Pontificato, ne elenca alcuni: tutti legati al rapporto fra Chiesa e società. “La Chiesa - sostiene - deve affrontare finalmente la questione dei divorziati risposati. Dopo il concilio Vaticano II è impensabile non affrontare questo tema nel mondo contemporaneo”. E’ una cosa, d’altronde, che sanno tutti i parroci. Quelli che più soffrono della proibizione di non prendere la comunione, che vale tassativamente per ogni divorziato risposato (a parte le guasconate di Berlusconi, per il quale c’è sempre si trova sempre un prelato pronto a perdonarlo), sono proprio i cattolici più sinceri e più impegnati nella vita ecclesiale.
Seconda questione, il celibato dei preti. Garelli come tanti altri respinge totalmente ogni connessione tra abusi sessuali e castità richiesta al clero. Il problema non è questo. Si tratta, molto semplicemente, che “il celibato dei sacerdoti deve essere volontario”.
Su un piano più generale il sociologo mette il dito sul vero punto dolente del Pontificato. La mancata riforma dell’assolutismo monarchico della Chiesa cattolica. Riforma che già con Giovanni Paolo II era matura (e la cui assenza era appena mascherata dall’attivismo wojtyliano e dalle novità del suo pontificato) e che con Benedetto XVI si sta manifestando sempre più improcrastinabile. Garelli, non da oggi - e lo fa capire ogni volta che lo invitano a partecipare ai grandi convegni decennali della Chiesa italiana - è un convinto sostenitore della “collegialità”. Cioè della partecipazione dei vescovi al governo della Chiesa universale. E altrettanto convintamente ritiene che il “laicato nella Chiesa deve partecipare davvero alla progettazione della missione pastorale e non servire solo da supporto”.
“La collegialità - sottolinea - ha un valore teologico e sociale. Il cardinale Martini l’ha richiamata spesso come punto qualificante. E’ necessario creare le condizioni affinchè nella Chiesa vi sia circolarità di idee. Bisogna prestare attenzione alle situazioni diverse ed è importante accettare l’unità nella diversità. Così come è necessario spingere i vescovi a riflettere insieme”.
Di pari passo è urgente superare l’“afonia dei laici”, cioè la situazione per cui i fedeli non sono mai consultati e chiamati alla progettazione della nuova evangelizzazione. Colpa, certamente, anche di tanti esponenti cattolici che non aprono bocca, perché “hanno meno coraggio delle generazioni precedenti”, e quindi il laicato cattolico in Italia si presenta sempre “allineato e coperto”. Di fatto clero e alte gerarchie parlano solo loro e i media, a loro volta, prestano attenzione solo a loro.
Eppure dal corpo della Chiesa salgono richieste diverse. “I fedeli - racconta Garelli che tante volte è andato a misurare sul campo il polso del cattolicesimo italiano - chiedono più ascolto e confidenza. Vorrebbero una Chiesa che sappia parlare un linguaggio spirituale più attento alle condizioni di vita e alle ragioni umane. Una Chiesa più in ricerca, capace di accompagnarli nelle loro vicende umane piuttosto che pronunciare verità e definizioni”. E quando non accade? “Se non trovano risposte, si chiudono, tacciono o vanno altrove”.
Certo, non va sottovalutato il segno dei tempi di uno stile di vita dilagante che mira solo ai consumi, alla scalata sociale, all’edonismo. “La cultura televisiva del Grande Fratello - confessa Garelli - depotenzia qualsiasi impegno religioso, politico o culturale, depotenzia destra e sinistra!”.
Gli chiedo, ora che inizia l’anno sesto di Papa Ratzinger, quale sia un altro punto critico del pontificato. Risponde: “Porre il baricentro nell’Occidente e prestare poca attenzione al cattolicesimo mondiale, che si nutre di culture non occidentali”. Intanto dal 2000 al 2008 le vocazioni sacerdotali in Europa sono cadute di un altro 7 per cento.
-
> LA QUESTIONE MORALE ---- "TU DEVI": SOLLECITATI DALLA CRISI DEL "PARTITO DELL’AMORE" DEI PAPI ATEI E DEVOTI, FILOSOFI E TEOLOGI RIPROPONGONO "I DIECI COMANDAMENTI ANCHE PER CHI NON CREDE". Una presentazione di Armando Torno del programma di "Il Mulino", con due brevi testi di Massimo Cacciari e Piero Coda.1 maggio 2010, di Federico La Sala
I Dieci Comandamenti anche per chi non crede
di Armando Torno (Corriere della Sera, 1° maggio 2010)
Decalogo è un termine greco. Vuol dire dieci (déka) parole (lógos). In molti hanno scelto di tradurlo con «I Dieci Comandamenti», anche perché in ebraico «parola» (davar) è sinonimo di comandamento. La Bibbia riporta due versioni, sostanzialmente omogenee, delle frasi che Mosè ascoltò sul Sinai e che furono incise sulle Tavole della Legge. Si trovano in Esodo 20, 1-6 e in Deuteronomio 5, 6-10.
Nella tradizione cattolica - che si discosta da quella ebraica e, tra l’altro, anche dalla protestante, più aderenti al testo biblico - Agostino distinse i tre Comandamenti iniziali dai successivi sette, attribuendo ai primi i doveri verso Dio e agli altri quelli verso gli uomini. Ma la codificazione del Decalogo dei catechismi cattolici venne formulata, dopo diverse proposte scolastiche (Pietro Lombardo, Tommaso d’Aquino eccetera), da Alfonso Maria de’ Liguori nel Settecento. Il santo napoletano scelse i Comandamenti come sommario di tutta la teologia morale e cercò di riassumere in ogni proposizione un settore di vita. Per esempio il sesto, «non commettere adulterio», non figura nella sua sistemazione ma viene allargato con il «non commettere atti impuri», comprendendo in tal modo tutta la morale sessuale.
Rileggere il Decalogo e interpretarlo nell’epoca che si sta vivendo, è stato un bisogno continuo dell’Occidente; era naturale che lo si dovesse fare anche nel nuovo millennio. Per tal motivo il progetto de il Mulino, di rimeditare attraverso un duplice intervento i Comandamenti (compreso quello dell’amore per il prossimo, già enunciato in Levitico 19,18), merita la massima attenzione. Il primo volume, dedicato a Io sono il Signore Dio tuo, frase che non può essere equiparata alle successive e introduce le Tavole della Legge, è firmato da Piero Coda e Massimo Cacciari.
Il percorso offerto dai due autori in queste pagine parte dalla semantica originaria del Nome per giungere alle riflessioni sul Deus-Trinitas. Infinite le suggestioni e le riflessioni. Se da un lato ci si deve confrontare con l’autopresentazione di Dio di Esodo 3,14 «Io sono colui che sono» (’ehjeh asher ’ehjeh), e che Piero Coda mostra in innumerevoli interpretazioni compresa quella che nacque dalla versione greca dei Settanta (ego eimi o on: si potrebbe rendere sino a «Io sono l’Essente»), dall’altro lato ci si chiede chi sia «l’Uno dell’Esodo». E qui Massimo Cacciari sa dare il meglio di sé indicando le vie che consentono di avvicinarsi al «segreto del Nome divino», anche se resta «inafferrabile e ineffabile». Sottolinea: «Non interessa tanto il Nome ma ciò che l’Essere di Dio può. La sua natura è di essere, non di essere nominato, e di essere ponendo "fuori" di sé tutta la propria potenza».
Sulla frase «Non avere altri dei di fronte a me» (Esodo 20,3; Deuteronomio 5,7), il primo ordine di Dio del Decalogo, c’è una letteratura infinita. Coda ricorda tra l’altro che Jhwh irrompe nella storia attraverso Israele e si propone come «l’imprescindibile garanzia della libertà dell’uomo»; Cacciari comincia il suo saggio chiarendo gli equivoci dei possibili politeismi e notando che anche quello pagano «ci appare ormai testimonianza di un passato irripetibile, capace al più di esercitare un fascino antiquario-letterario privo di qualsiasi valore religioso o filosofico». C’è un’osservazione di Martin Buber che merita di essere ricordata: «La dottrina della unicità ha la sua ragione vitale non nel fatto che ci si formi un giudizio sul numero di dèi che ci sono e si cerchi magari di verificarlo, bensì nella esclusività che regge il rapporto di fede, come esso regge il vero amore tra uomo e uomo; più esattamente: nel valore e nella capacità totale insito nel carattere esclusivo... L’unicità nel "monoteismo" non è, dunque, quella di un "esemplare", ma è quella del partner nella relazione interpersonale, finché questa non viene rinnegata nell’insieme della vita vissuta» (Königtum Gottes, Opere II, München 1964). Coda, inoltre, verifica la frase di apertura dei Comandamenti nel Nuovo Testamento; Cacciari dedica due attente riflessioni all’ Uno Essere e a L’Uno Signore dell’Essere utilizzando una notevole conoscenza dei testi filosofici e teologici. Da Rosenzweig a Spinoza, da Nietzsche a Hegel, da Kant a Weber si muove indicando la lettura più vicina a noi.
Che aggiungere? Forse un’immagine che molti ricordano e che potrebbe essere una didascalia per questo primo volume. Nel film hollywoodiano I dieci comandamenti del 1956, diretto da Cecil B. De Mille, Ramesse (Yul Brynner) dice a Nefertari (Anne Baxter) al suo ritorno dal Mar Rosso, dopo aver inseguito gli ebrei e Mosè: «Il suo dio... è Dio». Coda e Cacciari ci aiutano a comprendere meglio queste parole.
Il progetto della casa editrice il Mulino dedicato a I Comandamenti sarà realizzato in 11 volumi. Si tratta di una scelta che tiene conto anche dell’invito ad amare il prossimo, non presente nel Decalogo del Sinai ricevuto da Mosé, ma raccomandato già nel libro del Levitico (19,18) e ribadito con forza da Gesù nel Nuovo Testamento. Oltre il libro che inaugura la serie di Massimo Cacciari e Piero Coda Io sono il Signore Dio tuo (pp. 164, € 12), che sarà in libreria il 6 maggio ed è presentato in questa pagina con un estratto dei due saggi (si intitolano rispettivamente Il pensiero più alto e Questo Dio per la libertà), sono previste le seguenti uscite: Non ti farai idolo né immaginecon Salvatore Natoli e Pierangelo Sequeri, Non nominare il nome di Dio invano con Carlo Galli e Piero Stefani, Santificare la Festa con Massimo Donà e Stefano Levi della Torre, Onora il padre e la madre con Giuseppe Laras e Chiara Saraceno, Non uccidere con Adriana Cavarero e Angelo Scola, Non commettere adulterio con Eva Cantarella e Paolo Ricca, Non rubare con Paolo Prodi e Guido Rossi, Non dire falsa testimonianza con Tullio Padovani e Vincenzo Vitiello, Non desiderare la donna e la roba d’altri con Gianfranco Ravasi e Andrea Tagliapietra. Chiuderà Ama il prossimo tuo con Enzo Bianchi e Massimo Cacciari.
Massimo Cacciari: Non un precetto ma un’affermazione
La prima Parola (il primo dei «deka logoi ») non si presenta nella forma di un precetto («miswa »), ma di un’affermazione, di una perentoria autoaffermazione: «Io sono Jhwh, tuo Elohim» (Esodo, 20,2). Non si tratta di un comandamento, ma del necessario presupposto di tutta la Legge. È infatti impossibile comandare di credere nell’esistenza di Jhwh. E che senso avrebbe obbedire a ciò che venisse ritenuto un puro nome, cui nulla di reale corrisponde? Lo stesso Maimonide, che pure fonda sui principi dell’esistenza di Dio e della sua unità l’insieme della Legge, non li concepisce affatto come oggetto di fede, ma, anzi, come il risultato cui perviene la sana ragione, oggetto cioè di dimostrazione. Questo «Io, proprio Io, Jhwh», creduto o riconosciuto che sia, non potrà mai essere il contenuto di un comando, e tuttavia la Legge, l’unica Legge (legge assolutamente universale, a tutti rivolta - tanto che l’antica tradizione rabbinica diceva essere stata dettata dal Signore in 76 lingue, così che ogni gente potesse comprenderla), divina tutta in quanto giusta in tutte le sue parti, nel suo stesso interno differenziarsi e articolarsi, la Legge che stabilisce le forme della relazione tra uomo e Dio, ne presuppone la Rivelazione. Se la forza di quell’Io venisse meno, il Decalogo si ridurrebbe a «legge morale in noi», la Legge divina perderebbe il significato che deve assumere anche per la perfezione del vivere civile. Le stesse norme che suonano semplicemente etiche o cultuali debbono sempre essere comprese alla luce della Rivelazione del Nome.
Piero Coda: Il nome rivelato è come la sua firma
Nella costruzione raddoppiata: «Io sono colui che Io sono», il predicato è identico al soggetto. Essa può sottolineare un rafforzamento dell’ auto presentazione di Jhwh: «Io sono proprio chi Io sono». Ma, più profondamente, insinua anche una riaffermazione della trascendenza e dell’incognito di Dio nel momento stesso del suo farsi presente: «Solo Io so chi Io sono». È un invito a non fermarsi al Nome così come suona e che pure esprime quanto detto, ma a passarvi attraverso per lasciare che sia Dio a stabilire, mediante la memoria verbale del suo Nome, un rapporto vivo e personale di sé con noi. Altrimenti si cade nella tentazione di volersi impadronire del Nome di Dio, e addirittura di farsene un idolo. Per questo Jhwh comanda di non pronunciare invano il suo Nome e di non farsi di Lui immagine alcuna. Dio si rivela - precisa Paul Beauchamp - mediante un significante che non fa parte dell’organizzazione interna al discorso, ma lo fonda come una firma. «Io sono chi Io sono»: firma esterna al testo, dunque, benché ricorrente nel testo stesso. Queste parole bucano la pagina, hanno cioè un risalto eccezionale. Il Nome rivelato a Mosè mette così tutta la Bibbia sotto un’istanza alla prima persona, quella di Dio come soggetto libero e incatturabile che viene graziosamente incontro all’uomo chiedendogli a sua volta affidamento e fedeltà.
-
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. AL GOVERNO DELLA CHIESA UN PAPA CHE PREDICA CHE GESU’ E’ IL FIGLIO DEL DIO "MAMMONA" ("Deus caritas est") E AL GOVERNO DELL’ **ITALIA** UN PRESIDENTE DI UN PARTITO (che si camuffa da "Presidente della Repubblica"), che canta "Forza Italia" con il suo "Popolo della libertà" (1994-2010). ---- Governo & Lega. Incontro segreto tra Tremonti e Ratzinger (di Giacomo Galeazzi).21 aprile 2010, di Federico La Sala
Governo & Lega. Incontro segreto tra Tremonti e Ratzinger
di Giacomo Galeazzi (La Stampa, 20 aprile 2010)
Il Papa ha «riservatamente ricevuto» Giulio Tremonti prima delle elezioni regionali. Secondo quanto si apprende in Curia, l’incontro tra Joseph Ratzinger e il ministro dell’Economia è stato organizzato al Palazzo Apostolico dal presidente dello Ior, Ettore Gotti Tedeschi, ascoltato consigliere economico di entrambi. Il «faccia a faccia» ha avuto luogo a fine marzo, in piena campagna elettorale e, com’è consuetudine in questo tipo di colloqui privati con esponenti di governi nazionali, è stato finora coperto da totale riserbo per evitare strumentalizzazioni o ombre di coinvolgimento del Papa in contingenze politiche. Tra i principali «sponsor» di Tremonti figurano il cardinale ciellino Scola (dal quale, subito dopo la vittoria elettorale di Zaia in Veneto, Tremonti ha portato in udienza Bossi) e il banchiere del Papa, Gotti Tedeschi.
Sono stati loro a intercedere per Tremonti il cui approdo nell’appartamento pontificio è anche il segno che il segretario di Stato, Bertone, individua nel Carroccio (con cui Tremonti ha saldi legami) una promettente sponda per la Santa Sede. Bertone ha pubblicamente riconosciuto ai leghisti un presidio di territorio paragonabile a quello della Chiesa negli Anni Cinquanta e il ministro vaticano della Bioetica, Fisichella, ha elogiato il «cattolico Cota» per le critiche alla pillola abortiva Ru486. Il colloquio «non politico» tra Benedetto XVI e Tremonti rientra comunque nell’apertura di credito della Santa Sede verso un crescente ruolo della Lega nella maggioranza.
Al consueto ponte tra le sponde del Tevere assicurato dal gentiluomo di Sua Santità, Letta, si affianca, quindi, un nuovo «ambasciatore» del governo nei Sacri Palazzi. Uomo-cerniera tra Pdl e Lega e possibile leader. A fare da «trait d’union» è stata la comune riflessione sulla globalizzazione che ha portato Benedetto XVI a scrivere l’enciclica sociale «Caritas in veritate» e Tremonti «La paura e la speranza».
Per quanto Oltretevere si enfatizzi il «carattere non politico» dell’incontro, l’udienza riservata costituisce un importante riconoscimento del ruolo di «interlocutore privilegiato» che il Pontefice riconosce al ministro dell’Economia. Joseph Ratzinger ci teneva ad approfondire la conoscenza intrecciata due anni fa a Bressanone durante le vacanze estive.
In quell’occasione il Papa accademico rimase ben impressionato dal «collega» economista le cui entrature nelle sacre stanze sono da allora costantemente aumentate. Al team di teologi coinvolti nella redazione dell’enciclica sociale i testi di Tremonti erano stati segnalati dal Papa in persona.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- IL DOVERE DEL VERBO (di Barbara Spinelli)18 aprile 2010, di Federico La Sala
Il dovere del verbo
di BARBARA SPINELLI (La Stampa, 18/4/2010)
Un filo neanche molto sottile lega l’offensiva del presidente del Consiglio contro La piovra e Gomorra, e il divario crescente che lo separa da Gianfranco Fini. Il filo è costituito dal parlar-vero, sui mali italiani: da quello che Melville chiama, meditando in Moby Dick sul ruolo profetico, il dovere del verbo. Non è la prima volta che Berlusconi attacca La piovra. Lo ha già fatto il 28 novembre («Se trovo quelli che hanno fatto 9 serie sulla Piovra, e quelli che scrivono libri sulla mafia che vanno in giro in tutto il mondo a farci fare così bella figura, giuro li strozzo»).
L’assalto non era impulsivo: venerdì s’è esteso al libro di Roberto Saviano Gomorra. Ha detto testualmente: «(Dalle statistiche) la mafia italiana risulterebbe la sesta al mondo. Ma guarda caso è quella più conosciuta, perché c’è stato un supporto promozionale a quest’organizzazione criminale, che l’ha portata a essere un elemento molto negativo di giudizio per il nostro Paese. Ricordiamoci le otto serie della Piovra, programmate dalle televisioni di 160 Paesi nel mondo, e tutto il resto, tutta la letteratura, il supporto culturale, Gomorra...». Se fuori casa appaiamo brutti, la colpa non è della mafia ma di chi fa vedere.
Allo stesso modo gli sono intollerabili le analisi negative sulla crisi economica mondiale, e infine il lavorio che Fini sta compiendo per costruire una destra conservatrice ma non populista, non xenofoba, con un forte senso della legge e soprattutto dello Stato: poiché è la sfiducia nello Stato che alimenta, a Sud come a Nord, la potenza mafiosa. I giornalisti narrano come alle critiche concrete del presidente della Camera, giovedì, Berlusconi rispondesse, macchinalmente, con slogan di piazza o frasi tipo: «Va tutto bene». Lo scisma della destra a Sud è disastroso e la Lega prevarica, osservava il primo, e lui replicava che a Sud la destra vince e che la Lega gli ubbidisce.
Vivo all’estero da tempo e posso certificarlo: se abbiamo ancora prestigio, presso i cittadini e i politici europei, è perché accanto al crimine esiste chi lo denuncia, a voce alta, rischiando la solitudine in patria e a volte la morte. Le sale si riempiono quando dall’Italia giungono Saviano, Travaglio, Tabucchi, descrivendo il regno d’un prepotente che controlla tutte le tv. Nei cinema, Gomorra e Il divo suscitano, oltre che spavento, ammirazione. Il giorno che Saviano visitò il Canada senza guardie del corpo, le giubbe rosse vollero scortarlo loro: per entusiasmo, e gratitudine. Non va dimenticato che la lotta antimafia di giudici e scrittori italiani aiuta molti Paesi ad arginare un crimine fattosi globale. Quando Falcone fu ucciso, nel maggio ’92, il giudice americano Richard Martin disse che mai sarebbe riuscito a smantellare Pizza Connection, senza Falcone. La mafia Usa fu combattuta da un trio composto da Falcone, Martin e Rudolph Giuliani, allora procuratore distrettuale di Manhattan. I metodi italiani antimafia sono un esempio mondiale. Non è con fiabe edificanti che correggiamo la storia. Fuori Italia, è a causa di Berlusconi che abbiamo problemi. Continuamente dobbiamo spiegare il suo successo, la sua malia, e non tanto lui quanto noi stessi.
Dice Saviano nella lettera al premier, pubblicata ieri da Repubblica, che «accusare chi racconta il potere della criminalità organizzata di fare cattiva pubblicità al Paese non è un modo per migliorare l’immagine italiana, quanto piuttosto per isolare» chi esplora tale potere. Senza narrazione veridica, niente riscatto: «È l’unica strada per dimostrare che siamo il Paese di Giovanni Falcone, di Don Peppe Diana, non il Paese di Totò Riina e di Schiavone Sandokan». Berlusconi non l’ignora: sa quel che dice, e non teme di dirlo in nome di tutti gli italiani. Quando proclamò eroe Vittorio Mangano (ergastolo per due omicidi, appartenenza alla mafia, traffico di droga) fu il silenzio omertoso che esaltò come modello di virtù. L’arma principe contro le mafie - i pentiti, che lo Stato deve tutelare - veniva spuntata.
Infatti è stata spuntata, come spiega il giudice Nicola Gratteri quando evoca la battaglia alla ’ndrangheta. Gian Carlo Caselli sostiene che il discredito gettato sui pentiti - quindi su chi parla - non esisteva nel contrasto al terrorismo, ragion per cui quest’ultimo fu vinto e la mafia no (Le due guerre, Melampo 2009). Sono arrestati molti latitanti, non c’è dubbio: un successo del ministro dell’Interno, ma anche di magistrati e poliziotti non intralciati. In futuro lo saranno. Dice ancora Gratteri che quella sulle intercettazioni è «una legge spaventosa, che costruirà attorno alle mafie una diga di silenzio con il pretesto della “privacy”» (il suo libro, La malapianta, è pubblicato come Saviano da Mondadori, editrice del premier). Il silenzio è un regalo enorme alle mafie.
Anche per questo, perché l’omertà trascolora in eroismo, la mafia non spara come prima. Ma dilaga, specie a Nord. La legge del silenzio e la legge che silenzia: probabilmente è questa la stoffa di cui è fatto il patto politica-mafia, sotto la cui tenda viviamo. Ci ha protetti da attentati. Non ci protegge da una condiscendenza dilatata all’illegalità, dai profitti colossali della ’ndrangheta. Parlando degli elettori berlusconiani, Saviano osserva: «Molti di loro saranno rimasti sbigottiti e indignati dalle sue parole». Gli italiani, non solo di sinistra, si sono appassionati a Gomorra e alla Piovra (il primo film che parli di rapporti fra mafia, politica, finanzieri, massoni). La piovra ha agito sulle coscienze come il serial televisivo Olocausto sui tedeschi, nel 1979, o come sui francesi il film di Resnais sulla collaborazione, Notte e nebbia. Scoprire i propri lati oscuri è parte d’ogni guarigione, individuale o collettiva. È raccontare il proprio Paese com’è, per migliorarlo. Matilde Serao fece vedere che Napoli non era una cuccagna: nel Ventre di Napoli s’aggrovigliavano crimine e povertà. Grazie a lei la medicazione ebbe inizio.
Parlare vero è anche una barriera contro la degradazione della politica, contro i suoi vocaboli edulcoranti, i suoi eufemismi. È qui che il richiamo al dovere del verbo si allaccia alle vicende di Fini. Dell’Utri afferma che la politica gli serve per i processi di complicità con la mafia. Lo ha detto in un’intervista a Beatrice Borromeo, il 10 febbraio sul Fatto: «A me della politica non frega niente, io mi sono candidato per non finire in galera». Lo ha ripetuto giovedì, al processo d’appello di Palermo. Ancora non si sa come finirà il conflitto Fini-Berlusconi, ma spegnersi del tutto non può: perché due visioni della destra si scontrano. Perché la contesa ha al proprio centro il dovere del verbo. Perché dall’antichità è con la parola che la politica comincia, o ricomincia. Perché l’attesa che si è creata non è piccola.
È vero: Fini ha inaugurato la sua diversità con il vocabolario e lo stile, prima che con le azioni; con discorsi sempre più affilati su temi decisivi come l’immigrazione, la legalità, la Costituzione. Dicono che qui è la sua debolezza, che mancano le politiche; che tutto è intellettualismo, maniera. «Fini dove va? Sono quattro gatti, sono dei fighetti», dice Berlusconi, e sa di poter contare su molti che la pensano così. Molti detrattori della parola, sospettata di non avere «radici nel territorio»: dunque radici nella paura, come la Lega. La retorica ha una fama cattiva, ma ha nobili tradizioni. Chi voglia riscoprirlo sfogli il periodico online di Farefuturo, la fondazione di Fini: spesso troverà i toni del j’accuse di Zola, che non è roba di fighetti. Il massimo politologo europeo è Machiavelli. È lui a smascherare l’opacità verbale, quando descrive riformatori religiosi come San Francesco: essi «lasciarono intendere che egli è male dir male del male», coprendo per questa via gli uomini della Chiesa. «Così quegli fanno il peggio che possono, perché non temono quella punizione che non veggono e non credono».
Il dovere del verbo non è altro che questo: dire male del male. Su mafia, crisi, sul parto così difficile di una destra non biliosa, equilibrata. Un male non imbellito da telegiornali che rincretiniscono con servizi sulla fine dei chewing-gum masticati, e che diventano - la formula è di Sabina Guzzanti - armi di distrazione di massa. Saremo apprezzati all’estero a queste condizioni. In Italia si dimenticano presto non solo i propri misfatti, ma anche le proprie grandezze e i propri uomini di valore.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- LA CHIESA DI RATZINGER E IL PECCATO CONTRO LA VERITA’ (di Adriano Prosperi) - IL GOVERNO BERLUSCONI E L’ATTACCO ALLA COSTITUZIONE E ALLA VITA DEMOCRATICA (di Stefano Rodotà)12 aprile 2010, di Federico La Sala
La Chiesa e il peccato contro la verità
 La scelta è tra la verità senza veli e la ragion di Stato, tra la tutela delle vittime e l’omertà
La scelta è tra la verità senza veli e la ragion di Stato, tra la tutela delle vittime e l’omertà
 La questione non sono le colpe dei singoli religiosi. A quelle penseranno i tribunali
La questione non sono le colpe dei singoli religiosi. A quelle penseranno i tribunalidi Adriano Prosperi (la Repubblica, 12.04.2010)
La Chiesa di Roma è oggi al centro di una grande tempesta, per le responsabilità di sacerdoti colpevoli di pedofilia e per quelle delle autorità centrali, accusate di averli coperti. Nell’alterco tra chi la difende e chi l’accusa c’è il rischio che la sostanza del problema passi in secondo piano. Anche se certe reazioni sono davvero allarmanti e a loro modo rivelatrici. Si pensi ai rigurgiti di antisemitismo e di filonazismo nelle incredibili dichiarazioni odierne di un qualsiasi monsignor Babini.
Sono episodi che mostrano quanto sia urgente una chiara presa di posizione del governo centrale della Chiesa sulla sostanza del problema. La scelta non riguarda la minuta casistica dei preti pedofili, per tanti che siano. Questo sarà materia di tribunali. La scelta davanti alla quale le autorità ecclesiastiche si trovano è quella tra la verità senza veli e la ragion di Chiesa, tra la tutela delle vittime e l’omertà verso gli aguzzini, tra la giustizia da rendere a chi ha patito offesa e una malintesa fedeltà all’istituzione. Solo abbracciando la verità e la giustizia senza riserve e senza infingimenti il governo della Chiesa potrà ancora parlare alla coscienza dei cristiani e potrà riaprire quel filo di comunicazione con l’umanità intera che oggi rischia di spezzarsi. Il prezzo da pagare è liquidare le residue incrostazioni di un passato che stenta a passare.
Quell’eredità la conosce meglio di chiunque altro l’attuale Pontefice: per esperienza che immaginiamo anche tormentosa e problematica, e comunque per precisa responsabilità istituzionale. Non dimentichiamo certo che è stato lui il primo a parlare pubblicamente di sporcizia nella Chiesa. Perciò quello che oggi si attende è un segno di discontinuità tra il prefetto della Congregazione vaticana per la dottrina della Fede e il pontefice della Chiesa universale.
Sappiamo come e perché nelle carte d’ufficio di quella congregazione la sporcizia si sia accumulata e perché chi sporcava sia stato coperto dal segreto. È stato l’esito del trascinamento nel nostro tempo degli esiti della lunga guerra di religione tra i cristianesimi europei. «Taci, il nemico ti ascolta». Quando c’è un nemico c’è una guerra: e la prima vittima della guerra è la verità. La paura che la conoscenza della verità incrinasse le basi del consenso popolare ha creato le condizioni perché il corpo ecclesiastico facesse quadrato intorno ai suoi membri. Così furono creati tribunali segreti e concessi privilegi speciali alla parte ecclesiastica della Chiesa. Quei tribunali nascosero le colpe del clero nel momento stesso e con gli stessi strumenti con cui lo obbligavano a un’immagine pubblica di alto profilo morale e culturale.
Alla Chiesa spetterebbe l’ufficio di rimettere i peccati, al potere dello Stato quello di punire i crimini. È un argomento che alcuni usano in chiave apologetica affermando che non spetta oggi alla Chiesa il compito di punire i criminali. Ma lo si può rovesciare: è compito della Chiesa ritrovare oggi una distinzione valida e adatta ai tempi fra peccato e reato. E c’è un peccato contro la verità che incombe sulla Chiesa. Non è in discussione l’impulso criminale dei pedofili, in quanto tale diffuso tra chierici e laici, ma il crimine creato da una legge speciale che ha fatto del sacramento dell’Ordine sacro e della licenza di confessore un privilegio corporativo.
Bisogna che le regole sbagliate siano cancellate. Sono le vittime che debbono tornare al primo posto, non i carnefici. Se la giustizia della Chiesa vuole rientrare in contatto con la giustizia degli uomini e con quella di Dio questa è la priorità. Non più coperture di segreto e licenze di libera circolazione a lupi coperti dall’abito talare. La legge della Chiesa deve saper rispondere all’idea di giustizia di una società che chiede trasparenza, che pone al vertice dei suoi valori la tutela dell’infanzia, che non capisce più la sopravvivenza di recinti arcaici, dalle barriere del diritto canonico al segreto speciale che ha celato finora i criminali del «crimine pessimo».
La questione che si è aperta è un segno dei tempi, fra tutti il più terribile e sconvolgente. Per questo tutti attendiamo di vedere come la Chiesa reagirà. La tentazione di minimizzare o di alzare il polverone difensivo dell’accusa di complotto può essere una reazione istintiva, ma come difesa non porta lontano. Insistere ancora su questa strada significherebbe ignorare la sostanza terribile del delitto nefando, il bisogno di verità e di giustizia che unisce credenti e non credenti. Dopo le avvisaglie di tanti episodi recenti in cui si è letto un ritorno di fiamma della Controriforma, questo caso mette oggi all’ordine del giorno un’emergenza suprema e assoluta. Essa riguarda il rapporto tra chiesa e secolo, papa e mondo, fede e democrazia.
Gli uomini di buona volontà, le culture democratiche e laiche hanno dimostrato di avere capito l’apertura confidente del Concilio Vaticano II ai fondamenti della coscienza moderna. E tutti sanno con quanto interesse sia stata accolta la decisione di papa Wojtyla di fare del giubileo del 2000 l’occasione per voltar pagina rispetto alle pesanti eredità dell’antisemitismo, dell’intolleranza e della violenza in materia di fede. Ma su quella strada come su ogni percorso della vita e della storia si può sempre scegliere se andare avanti o tornare indietro. E quali abissi si riaprano se si torna indietro, il caso del vescovo emerito mons. Babini basta a mostrarlo.
Una sfida sul destino della democrazia
di Stefano Rodotà (la Repubblica, 12.04.2010)
È mai possibile che si accetti senza reagire una politica che si manifesta con la distorsione dei fatti, l’aggressione alle istituzioni, l’esibizione di un potere ispirato da una logica autoritaria?
Questi sono i temi nitidamente posti da Eugenio Scalfari, e conviene seguire la strada da lui indicata tornando su alcune delle cose dette sabato dal presidente del Consiglio ad una platea di imprenditori. E tuttavia, prima di seguire Berlusconi lungo l’abituale suo itinerario di aggressioni e vanterie, bisogna sottolineare la novità rappresentata dai tre fatti gravissimi narrati da Scalfari, rivelatori non tanto di una inammissibile doppiezza, ma di un sistematico mentire al presidente della Repubblica, che configura un caso clamoroso di slealtà costituzionale. Mentre Giorgio Napolitano si adopera per creare un clima propizio per una riforma rispettosa della Costituzione, Silvio Berlusconi tiene comportamenti pubblici e privati che mettono in discussione la funzione esercitata dal presidente e gli lancia una sfida che può sfociare in un gravissimo conflitto al vertice delle istituzioni.
A Parma il presidente del Consiglio si è descritto come prigioniero di lacci e lacciuoli che gli impediscono un’azione efficace, come se non avesse una maggioranza parlamentare senza precedenti nella storia repubblicana e come se non avesse nei fatti mostrato che, quando le convenienze lo spingono, è in grado di far approvare rapidamente qualsiasi provvedimento. Ha imputato l’origine della crescita del debito pubblico ai "governi del compromesso storico", mentre proprio gli imprenditori dovrebbero sapere che quella vicenda comincia con il governo Craxi, un politico dal quale l’attuale presidente del Consiglio non era poi così lontano. Ha detto meraviglie di riforme che si sa bene che non saranno in grado di produrre i miracoli che ad esse vengono associate. Ma soprattutto ha descritto la Presidenza della Repubblica come un luogo che interferisce impropriamente nell’azione di governo, controllando «minuziosamente anche gli aggettivi» dei provvedimenti. E per l’ennesima volta ha definito la Corte costituzionale un "organo politico", che sta lì per smantellare la legislazione che non piace ai pubblici ministeri e ai giudici di Magistratura democratica. Un attacco frontale è stato così portato alle due istituzioni che in questo periodo hanno garantito la legalità costituzionale.
Quest’insieme di falsificazioni è il frutto di una strategia deliberata, basata sulla ripetizione degli stessi concetti e delle stesse parole, ispirata all’antica regola "calunniate, calunniate, qualcosa resterà". In questo modo si è già creato un perverso senso comune, al quale si fa appello nel momento in cui si deve raccogliere consenso. E ora, gonfiate le vele dal vento elettorale, si pensa di poter portare tutto all’incasso. Che cosa si sta facendo per contrastare questa che non è soltanto una strategia comunicativa, ma una sempre più pesante strategia politica?
L’obiettivo di Berlusconi è chiaro e ormai esplicitamente dichiarato. Spazzar via tutte le garanzie e i controlli che "disturbano il manovratore", concentrare il potere nelle mani di una sola persona, invocando quel che accade in altri paesi europei, ma ignorando del tutto i contrappesi che lì esistono. Così, quello che con approssimazione viene chiamato semipresidenzialismo si presenta come concentrazione di potere nelle mani di una sola persona. Non a caso si rifiuta ogni modifica della legge elettorale, che si è rivelata un docile strumento per avere parlamentari scelti dall’alto, vanificando proprio quella sovranità dei cittadini alla quale Berlusconi strumentalmente si richiama quando vuole avere le mani libere da qualsiasi controllo. Si scoprono le carte a proposito della riforma della magistratura.
Viene annunciata una antidemocratica riforma elettorale del Csm. La separazione delle carriere dovrebbe portare alla creazione di due consigli superiori, uno per i magistrati e l’altro per i pubblici ministeri, quest’ultimo presieduto dal ministro della Giustizia. Dalla proclamazione della volontà di cancellare la politicità della pubblica accusa si passerebbe così ad un controllo politico, anzi governativo, dei pubblici ministeri con l’evidente possibilità di distogliere il loro sguardo da indagini che potrebbero riguardare chi è vicino alla maggioranza e di indirizzare la loro azione verso chi si muova in modo sgradito al potere.
A Berlusconi la democrazia dà fastidio, e non a caso annuncia un plebiscito. Non vuole una riforma, vuole un referendum sulla "sua" riforma. Un referendum che inevitabilmente spaccherebbe il paese, e farebbe percepire la nuova architettura costituzionale come il progetto di una parte, nella quale gli altri non potrebbero riconoscersi. Dalle riforme condivise si passerebbe alle riforme "divisive".
Avendo deciso di imboccare questa strada, Berlusconi ha fatto una mossa che, per chi conosce la sua attenzione per il sistema della comunicazione, era prevedibile. Si è materializzato su Facebook. Da tempo, e non solo in Italia, si sottolinea che Internet non è di per sé uno strumento di democrazia e che, anzi, proprio l’insieme delle nuove tecnologie può dare sostegno al crescente populismo.
Si torna così all’interrogativo iniziale. Come contrastare questa pericolosa deriva? Contare solo sulla dialettica interna alle forze politiche, sperare nel dissenso dei finiani, cercare pontieri tra maggioranza e opposizione perché la minacciata eversione costituzionale venga ricondotta nel più ragionevole alveo della "buona manutenzione costituzionale"? Guardiamo pure in questa direzione, anche se la sconsolata ammissione del pontiere per eccellenza, Gianni Letta, riferita da Eugenio Scalfari, non autorizza alcun ottimismo.
Il compito dell’opposizione si è fatto più difficile, perché non basta contrapporre una bozza Violante ad una bozza Calderoli. Bisogna contrastare Berlusconi sul terreno che lui stesso ha scelto, quello della mobilitazione dell’opinione pubblica che dovrebbe sostenere l’impresa di riforma. Ma bisogna fare un passo oltre la registrazione di questa difficoltà, mostrando a tutti che cosa sia effettivamente diventata la questione della riforma costituzionale: una sfida sul destino della democrazia italiana.
Se così stanno le cose, vi è una responsabilità più ampia di quella che riguarda partiti e gruppi di opposizione. Vi è una responsabilità collettiva legata ad una cittadinanza attiva, alla necessità che tutti prendano la parola. La difesa della democrazia non è stata mai affidata a maggioranze o minoranze "silenziose". Proprio perché le tecnologie hanno fatto diventare "continua" la democrazia, continua dev’essere pure l’azione dei cittadini. E oggi il silenzio si rompe in molti modi, da quelli tradizionali a quelli che si affidano alla faccia democratica delle tecnologie, né plebiscitaria né populista. Di tutto questo bisogna parlare, per non lasciare solo il Presidente della Repubblica nella difesa della Costituzione, per scongiurare un cambiamento di regime, per non rassegnarsi al destino di spettatori. Esattamente quello che il Cavaliere vuole.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- LO SCANDALO DELLA PEDOFILIA E CREDIBILITA’ DELL’ISTITUZIONE. Ratzinger. Lo spettro delle dimissioni (di Marco Politi).11 aprile 2010, di Federico La Sala
 Lo scandalo pedofilia
Lo scandalo pedofilia
 Ratzinger
Ratzinger
 Lo spettro delle dimissioni
Lo spettro delle dimissioni
 Impensabili: ma il velo caduto sugli abusi ha rotto un dogma
Impensabili: ma il velo caduto sugli abusi ha rotto un dogmaDai Legionari di Cristo agli Stati Uniti: l’impunità garantita per anni ai sacerdoti ha minato le fondamenta del sistema
L’opinione pubblica è scossa, non si parla nemmeno più dei silenzi ma della credibilità dell’istituzione
di Marco Politi (il Fatto, 11.4.2010)
A lla fine la valanga degli scandali è piombata ai piedi del trono papale. La firma di Ratzinger su una lettera del 1985, che sconsiglia l’espulsione immediata di un prete pedofilo, è un colpo pesante al Papato. Negli Stati Uniti colgono la crisi gravissima e agitano lo spettro delle dimissioni. “Un Papa può dimettersi?”, si domandano a New York. E poi: “Qualcuno può spingerlo a ritirarsi?”. Perché la mentalità anglosassone è fatta di un’essenzialità dalle formulazioni brutali. L’Autorità colta in fallo, il Potere supremo inchiodato nell’attimo in cui dice o fa ciò che non doveva né dire né fare perde credibilità, prestigio, autorevolezza. E l’unica via d’uscita per il leader dopo l’errore fatale è l’abbandono di campo. Giorni fa la vescova tedesca Margot Kaesemann si è dimessa da presidente delle Chiese protestanti di Germania per il solo fatto di essersi trovata in macchina con un tasso alcolico superiore a quanto permesso. Non sarebbe stata più credibile, ha spiegato.
“(In)Fallibile”, titola in copertina il settimanale tedesco Spiegel, raffigurando Benedetto XVI. In Vaticano le dimissioni papali non sono in agenda, sono impensabili, sono inimmaginabili. Nessuno può chiederle, nessuno può costringerlo. Ma la paura sta invadendo i sacri palazzi. Si teme che la crisi - la più destabilizzante da quando i bersaglieri a Porta Pia cancellarono il millenario Stato pontificio - sia foriera di sviluppi impensabili, di contraccolpi imprevedibili, di sorprese sempre peggiori. Non cominciò così, dicono in America, il Watergate: un piccolo scasso effettuato da falsi idraulici? Sembrava un incidente facilmente circoscrivibile... Per la prima volta che il Papato si misura con un avversario più potente di qualsiasi stato, di qualsiasi movimento, di qualsiasi ideologia. L’opinione pubblica internazionale, che ha capito quanto la pressione dei media e dei processi abbia spinto la Chiesa a confessare le sue colpe, alzando il velo sugli insabbiamenti di crimini odiosi e ponendo la Suprema Autorità del cattolicesimo dinanzi ad una scelta cruciale: raccontare tutta la verità su ciò che è stato fatto o non fatto nel cuore stesso dell’apparato vaticano o lasciarsi travolgere da ondate di rivelazioni.
Se in America l’80 per cento dei cattolici non si riconosce nella linea tenuta da Ratzinger nelle ultime settimane, anche in Italia l’opinione pubblica non gli è favorevole. Il 62 per cento degli italiani “non approva l’operato della Chiesa e del Papa in questo frangente” (Istituto Piepoli). Perché Benedetto XVI non ha proseguito sulla via della denuncia e del pubblico mea culpa a Pasqua, quando il mondo intero guardava a lui. E perché arrivano nuovi materiali che lo chiamano direttamente in questione.
 I punti di vulnerabilità si stanno accumulando.
I punti di vulnerabilità si stanno accumulando. 1. A Monaco di Baviera un prete pedofilo, accolto in diocesi solo per una terapia, viene riassegnato nel 1980 ad un’altra parrocchia. Il vicario generale (che si è assunto ogni responsabilità) scrisse un memorandum in proposito all’arcivescovo Ratzinger. L’arcivescovo ha letto l’appunto? C’è un motivo, per cui in una realtà così attenta alle regole burocratiche come quella tedesca, non doveva essere letto?
1. A Monaco di Baviera un prete pedofilo, accolto in diocesi solo per una terapia, viene riassegnato nel 1980 ad un’altra parrocchia. Il vicario generale (che si è assunto ogni responsabilità) scrisse un memorandum in proposito all’arcivescovo Ratzinger. L’arcivescovo ha letto l’appunto? C’è un motivo, per cui in una realtà così attenta alle regole burocratiche come quella tedesca, non doveva essere letto? 2. Nel 1996 il vescovo di Milwaukee chiede alla Congregazione per la Dottrina della fede, guidata dal cardinale Ratzinger, di aprire un processo canonico contro il prete pedofilo Murphy, che ha abusato di duecento minori sordomuti. Nel 1997 mons. Bertone, vice di Ratzinger al Sant’Uffizio, autorizza l’apertura del procedimento. Nel 1998 il vescovo americano e un suo confratello vengono convocati in Vaticano da Bertone e il processo fermato, perché in Vaticano sono sorti improvvisamente “dubbi sulla fattibilità e opportunità”. Di fatto Murphy, vicino a morire, ha chiesto clemenza a Ratzinger.
2. Nel 1996 il vescovo di Milwaukee chiede alla Congregazione per la Dottrina della fede, guidata dal cardinale Ratzinger, di aprire un processo canonico contro il prete pedofilo Murphy, che ha abusato di duecento minori sordomuti. Nel 1997 mons. Bertone, vice di Ratzinger al Sant’Uffizio, autorizza l’apertura del procedimento. Nel 1998 il vescovo americano e un suo confratello vengono convocati in Vaticano da Bertone e il processo fermato, perché in Vaticano sono sorti improvvisamente “dubbi sulla fattibilità e opportunità”. Di fatto Murphy, vicino a morire, ha chiesto clemenza a Ratzinger. 3. Nel 2000 viene insabbiato il caso del fondatore dei Legionari di Cristo, padre Maciel, accusato di abusi plurimi. Ratzinger vorrebbe intervenire, ma resta aperto l’interrogativo su chi fra i collaboratori papali è riuscito a convincere Giovanni Paolo II a non aprire un’inchiesta.
3. Nel 2000 viene insabbiato il caso del fondatore dei Legionari di Cristo, padre Maciel, accusato di abusi plurimi. Ratzinger vorrebbe intervenire, ma resta aperto l’interrogativo su chi fra i collaboratori papali è riuscito a convincere Giovanni Paolo II a non aprire un’inchiesta.
 4. I fatti di Oakland sono esplosivi. Un vescovo chiede nel 1981 alla Congregazione per la Dottrina della fede di ridurre allo stato laicale un prete pedofilo, già condannato in tribunale e che ha chiesto personalmente di lasciare la tonaca. Il cardinale Ratzinger, nella risposta data solo nel 1985, non disconosce i gravi motivi “e tuttavia” (attamen, che in latino è un “ma” molto rafforzato) invita il vescovo a tenere conto del “bene della Chiesa universale” e dei “danni” che potrebbero venire alla comunità parrocchiale. (Quest’anno, nella sua lettera gli Irlandesi, Benedetto XVI parlerà di “preoccupazione malriposta per il buon nome della Chiesa”). Il vescovo sostiene che il pedofilo crea più scandalo ai fedeli rimanendo nelle fila del clero che andandosene. Però il Vaticano non gli dà retta ed esige un esame “più accurato”. Solo nel 1987 al prete verrà tolta la tonaca.
4. I fatti di Oakland sono esplosivi. Un vescovo chiede nel 1981 alla Congregazione per la Dottrina della fede di ridurre allo stato laicale un prete pedofilo, già condannato in tribunale e che ha chiesto personalmente di lasciare la tonaca. Il cardinale Ratzinger, nella risposta data solo nel 1985, non disconosce i gravi motivi “e tuttavia” (attamen, che in latino è un “ma” molto rafforzato) invita il vescovo a tenere conto del “bene della Chiesa universale” e dei “danni” che potrebbero venire alla comunità parrocchiale. (Quest’anno, nella sua lettera gli Irlandesi, Benedetto XVI parlerà di “preoccupazione malriposta per il buon nome della Chiesa”). Il vescovo sostiene che il pedofilo crea più scandalo ai fedeli rimanendo nelle fila del clero che andandosene. Però il Vaticano non gli dà retta ed esige un esame “più accurato”. Solo nel 1987 al prete verrà tolta la tonaca.La lettera riflette l’atmosfera nella Chiesa cattolica negli anni Ottanta: protagonisti sono le autorità ecclesiastiche, il prete accusato, il “bene della Chiesa”, l’eventuale scandalo per i fedeli. Le vittime non sono mai menzionate.
E’ un paradosso tragico che Joseph Ratzinger, il quale appena eletto pontefice si è battuto con grande fermezza e coerenza contro gli abusi sessuali del clero, venga oggi inseguito dai fantasmi di un passato in cui a tutti i livelli della Chiesa cattolica le “vittime non furono ascoltate” (come lui stesso ha scritto nel messaggio agli Irlandesi). Ma nel meccanismo delle rivelazioni c’è qualcosa di inarrestabile. E certamente si scaricano oggi su Benedetto XVI malumori, insofferenze e tensioni accumulate nell’opinione pubblica esterna e interna alla Chiesa nei confronti della sua linea tradizionalista, così chiusa alle riforme.
Nell’arco di poche settimane è mutato l’oggetto del contendere. Non si parla più dei silenzi della Chiesa, ma è in discussione l’inattaccabilità o meno del Romano Pontefice. La sua credibilità internazionale. A sua difesa si stanno muovendo i grossi calibri. Vescovi e cardinali, l’Opus Dei, i Cavalieri di Colombo che in America hanno indetto una “novena” di solidarietà al Papa. In Italia si sta progettando una manifestazione dei cattolici in appoggio del Papa.
Eppure, se non riuscirà a chiudere la vicenda con un atto di trasparenza totale, Benedetto XVI vedrà profilarsi sulla scena internazionale l’interrogativo bruciante: come potrà guidare la Chiesa cattolica? Con quale carisma?
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- ELEZIONI REGIONALI E INDICAZIONI DELLA CEI. L’arcivescovo Rino Fisichella: l’intervento dei vescovi era necessario (di Gian Guido Vecchi - Intervista).30 marzo 2010, di Federico La Sala
Fisichella: l’intervento dei vescovi era necessario
intervista a Rino Fisichella
a cura di Gian Guido Vecchi (Corriere della Sera, 30 marzo 2010)
L’indicazione della Cei per la difesa della vita, i principi «antropologici» che fondano quelli sociali e quindi sono una discriminante nel voto dei cattolici, l’aborto «crimine incommensurabile», le parole del cardinale Bagnasco riprese con evidenza dai media vaticani. E tutti a pensare a Emma Bonino.
Eccellenza, per la Chiesa non è stato rischioso esporsi così?
«Vede, noi siamo abituati a rispettare il consenso elettorale, sia che riguardi elezioni amministrative o politiche sia che si tratti di un referendum. Se fossero tutti abituati come noi al rispetto delle regole, potremmo vivere tempi migliori...».
A tarda sera l’arcivescovo Rino Fisichella, presidente della pontificia Accademia per la vita, considera sereno l’andamento dello spoglio. Quello che la Chiesa doveva dire, l’ha detto.
«Noi lavoriamo con un criterio che non si ferma alla politica, ai partiti: e richiede un impegno diretto nella società, secondo quel principio di sussidiarietà che ci sta particolarmente caro».
Che la Chiesa fosse preoccupata per Emma Bonino, non è un mistero.
«Qui non si tratta di esprimere un giudizio su questo o quel candidato. Ma se una candidatura è all’opposto di quelli che sono i valori fondamentali del Cristianesimo, anzitutto il rispetto della vita nascente e del suo termine naturale...».
Non sono temi astratti, rispetto al ruolo delle Regioni?
«Macché, non è vero: le Regioni hanno un’autonomia reale, legislativa, che determina anche la politica delle strutture sanitarie, oltre alla formazione scolastica».
Si può pensare a un’astensione di parte dei cattolici del Pd?
«Quando i numeri dell’astensionismo sono così rilevanti, è ovvio pensare che ci sia stata anche un’insoddisfazione dei cattolici: da una parte dipende dalla radicalizzazione bipolarista e dall’altra, certo, anche al fatto che i candidati scelti non sempre corrispondono ai valori fondamentali di un cristiano. Comunque, mi sembra importante far notare una cosa...».
Quale?
«I cattolici in queste elezioni hanno una presenza determinante, come nel caso di Formigoni o Cota, e questo vale anche quando non si presentano con gli schieramenti principali: penso ad esempio ai risultati qualificanti di Paola Binetti o di Magdi Cristiano Allam. Sono dati che fanno comprendere l’impegno costante del mondo cattolico».
Non avete messo in difficoltà una parte del mondo cattolico?
«Nel periodo elettorale c’è stata grande confusione, sia per motivi tecnico-amministrativi sia per ragioni valoriali. Per questo era ancor più necessario che i vescovi intervenissero. Siamo in una società libera e democratica. E quando sono in gioco valori fondamentali, non solo per i cattolici, è inevitabile che la voce dei vescovi si faccia sentire, come sempre chiara e convincente». Al Nord trionfa la Lega, in Veneto ha percentuali da Dc.
Per la Chiesa, ci possono essere problemi su temi come l’immigrazione?
«Anzitutto credo che dobbiamo prendere atto dell’affermarsi della Lega, della sua presenza ormai più che ventennale in Parlamento, di un radicamento nel territorio che le permette di sentire più direttamente alcuni problemi presenti nel tessuto sociale. Quanto ai problemi etici, mi pare che manifesti una piena condivisione con il pensiero della Chiesa. Sull’immigrazione, bisognerà essere capaci di saper coniugare le esigenze dei cittadini e quelle del mondo del lavoro: sapendo che non possiamo considerare gli immigrati come merce lavoro, che esiste un dignità della persona che va rispettata, e che la Chiesa d’altra parte non potrà mai non andare incontro a una richiesta di legalità. Il nostro criterio è dialogare e rispettare il voto dei cittadini».
Ma parlare di principi «non negoziabili», in politica, non è una contraddizione in termini?
«Noi non parliamo di principi non negoziabili in politica, ma a livello di istanza etica. La politica vive di una laicità propria, fatta di indipendenza dal mondo confessionale e religioso. Ma questo non significa indipendenza dai principi etici. Anche il legislatore deve richiamarsi a principi che hanno il loro fondamento nella legge naturale: che non è un’invenzione cattolica, ne parlava anche Cicerone e prima di lui i greci. Tutti siamo chiamati a rispettarla, per non permettere mai che prevalga l’arroganza del più forte sul più debole».
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- STATO E CHIESA: L’ALLEANZA A LUCI ROSSE DELLA CLASSE DIRIGENTE DEL SEMIOCAPITALISMO BAROCCO. Una nota di Marie-Thérèse Van Lunen Chenu, seguita da una riflessione di Franco (Bifo) Berardi.29 marzo 2010, di Federico La Sala
STATO E CHIESA: UN’ALLEANZA A LUCI ROSSE. LA CHIESA CATTOLICO-ROMANA, LA MISOGINIA, E LA MISURA DELLA ILLEGALITA’. Una nota di Marie-Thérèse Van Lunen Chenu, seguita da una riflessione di Franco (Bifo) Berardi sulla classe dirigente del semiocapitalismo barocco.
 La Chiesa e la misoginia
La Chiesa e la misoginia di Marie-Thérèse Van Lunen Chenu
di Marie-Thérèse Van Lunen Chenu in “www.temoignagechretien.fr” del 24 marzo 2010 (traduzione: www.finesettimana.org)
in “www.temoignagechretien.fr” del 24 marzo 2010 (traduzione: www.finesettimana.org)L’ondata di notizie su ripetuti casi di pedofilia nella Chiesa cattolica ha suscitato molti commenti che portano in ritorno delle valutazioni interessanti. Vi si legge che una prima messa in discussione del celibato obbligatorio per i preti trova ora degli ardenti oppositori, mentre restano stigmatizzate la frequente immaturità della scelta di vita da parte di persone troppo giovani, una formazione rimasta a lungo inadeguata nei seminari, la mancanza di relazioni con il mondo femminile, l’autoritarismo, la cultura del segreto e della negazione nell’istituzione ecclesiale.
Mi stupisco tuttavia che il dibattito non sia ancora stato allargato fino a prendere in considerazione il problema sempre più sensibile della marginalizzazione - se non dell’eliminazione - delle donne nelle strutture dell’istituzione romana. E che i commentatori neppure abbiano affrontato un problema di fondo: la natura della testardaggine con cui Roma si impegna nella difesa del primato del sesso maschile.
Quali sono allora le cause e gli effetti di questo attaccamento eccezionale dell’istituzione romana ad un primato del sesso maschile, fino a giungere alla sua vera “sacralizzazione” nel clericalismo? Una critica che potremmo definire “pastorale” (venuta proprio dall’interno della Chiesa) si è unita, almeno da un decennio, ad una prima analisi femminista che smaschera quel gioco semantico che si ostina a chiamare “servizio” ciò che, scelto ed esercitato spesso con la più grande generosità personale, resta tuttavia un monopolio ed un potere.
Ci si chiede allora come questo servizio ultimo della “rappresentazione di Cristo per compiere l’eucarestia”, quel potere-servire che si declina solo al maschile, non influenzi l’identità clericale e, per ciò stesso, l’idealizzazione e il carattere di rifugio che dei giovani possono investirvi? E sembra ingenuo stupirsi che alcuni di loro siano tentati di sfuggire, con questa scelta, ad una identificazione sessuata esigente.
La mia riflessione va quindi più in là rispetto al deplorare ciò che pudicamente viene chiamato “difficoltà a vivere la castità”. Parlo qui delle turbe del comportamento che possono essere legate ad una difficoltà non risolta dell’identificazione personale. Essere capaci di identificarsi come un essere maschile significa poter accettare il “di fronte” di una uguale partner femminile. E sostengo che l’idealizzazione del primato maschile, la sua canonizzazione in qualche modo, e la giustificazione permanente che ne viene fatta attraverso il rifiuto della competenza e dell’autorità delle donne, possono turbare il processo di identificazione maschile e arrivare talvolta ad influenzare una scelta per il presbiterato o la vita religiosa.
In fondo, le cause sarebbero ben più imbricate di quanto non si pensi tra la proibizione fatta alle donne di accedere al ministero sacerdotale e l’obbligo del celibato per il prete maschio. Sono radici profonde e tenebrose che si intrecciano tra denigrazione della sessualità, marginalizzazione delle donne, primato accordato al sesso maschile, sacralizzazione del sacerdozio, rapporto sclerotico alla tradizione e questo governo autoritario, clericale e monosessuato.
Così, che ci si ponga all’interno o all’esterno dell’istituzione, la crisi attuale designa come una sfida insieme ecclesiale e sociale la necessità di un vero dibattito e di cambiamenti la cui importanza non si limiterà al solo campo religioso. Infatti la Chiesa cattolica è in ritardo sulla società per mettere in atto questi cambiamenti che ormai vengono definiti “umani”: nell’identificare e curare le cause di una valutazione negativa della sessualità, le è necessario, al contempo, affrontare il suo rapporto con la sessuazione.
Chi dice “sessuazione” riconosce evidentemente la bi-sessuazione fondamentale dell’umanità. Con quali mezzi allora far comprendere che l’istituzione si è sclerotizzata e si esaurisce in un approccio maschile della femminilità, proprio al contrario rispetto a quello che fu l’atteggiamento di Cristo verso le donne? Non è “la questione delle donne nella Chiesa” che fa problema, come si sente dire con leggerezza..., è quella di una Chiesa autoritaria che difende il suo primato clericale maschile e rifiuta un confronto pieno con una buona metà dei suoi membri.
Si tratta qui di una mancanza strutturale legata, più di quanto non faccia pensare una prima apparenza, agli scandali attuali. Ci si chiede fino a quando Roma penserà di poter attenuare tali scandali con delle scuse pubbliche ed una vergogna manifestata “a nome di tutta la Chiesa”? E fino a quando le donne, che sono state più spesso cuoche che consigliere nei seminari, non esprimeranno pubblicamente il loro disaccordo?
Molte di loro sono già, di fatto, unitamente a degli uomini anch’essi consapevoli delle riforme necessarie, se non in rottura pastorale, almeno in rottura di coscienza con l’istituzione... Accettare in maniera riconoscente e responsabile la sessuazione, la sessualità, e quindi le donne di oggi come vere partner, suppone insieme un lavoro pluridisciplinare ed un ampio dibattito di società e di Chiesa.
Teologia ed ecclesiologia sono interpellate: che cosa abbiamo fatte per perdere la capacità profetica del messaggio cristiano, che testimoniava il principio del rispetto delle donne in un’epoca di misoginia sociale, ma che resta ridotto al silenzio dalla sua contro-testimonianza di sessismo ecclesiale nell’oggi di parità sociale?
La sfida è importante per il cattolicesimo, se vuole conservare il suo posto in seno al cristianesimo e la sua credibilità “umana”. Certi cristiani, e in maggior numero certe cristiane, sperano ancora che la gravità attuale delle accuse e delle messe in discussione possa diventare un punto a cui far riferimento per una conversione profonda del cattolicesimo romano.
*Marie-Thérèse van Lunen Chenu è membro di “Femmes et Hommes en Église” e di “Genre en christianisme”
La misura dell’illegalitàdi Franco (Bifo) Berardi (il manifesto, 27 marzo 2010)
Negli ultimi mesi la protesta contro il regime berlusconiano ha raggiunto toni quasi patetici. Si parla di crisi del berlusconismo come per esorcizzare la realtà di una perfetta corrispondenza tra la corruzione del ceto politico-imprenditoriale e il cinismo diffuso nella società. Ma la crisi dove sarebbe? L’escalation di arroganza non è segno di una crisi, direi, ma del suo contrario: è segno della stabilizzazione di un sistema che non ha più bisogno di legge perché basta la legge del più forte per regolare le relazioni di precarietà, sfruttamento e schiavismo nel campo del lavoro e della vita quotidiana.
Quanto più evidente è il disprezzo del ceto al potere per la legge e le regole, tanto più la protesta si concentra sulla difesa della legalità. Il problema è che la legge e le regole non valgono niente quando non esiste la forza per renderle operanti. E dove sta la forza, cos’è la forza in un sistema centrato sulla produzione mediatica della coscienza? Nel discorso corrente quel che accade in questo paese è visto come una bizzarra forma di corruzione dello spirito pubblico, come una singolare e isolata sospensione della democrazia. Allo stesso modo gli inglesi guardarono agli italiani dopo la prima guerra mondiale, e le democrazie occidentali interpretarono Mussolini: un fenomeno di marginale arretratezza culturale, o piuttosto un’anomalia culturale. Poi l’esempio di Mussolini produsse effetti su larga scala, fino a precipitare il mondo nella più grande carneficina della storia.
Tra riforma e controriforma
Forse occorrerebbe smetterla di considerare il caso italiano come un’anomalia: al contrario è l’esempio estremo degli effetti prodotti dalla deregulation, fenomeno mondiale che distrugge prima di tutto ogni regola nel rapporto tra lavoro e capitale. Vi è certamente una specificità culturale italiana che merita di essere studiata capita, approfondita. Ma grazie a Mussolini e a Berlusconi questa specificità ha finito per esprimersi come forma anticipatrice del destino del mondo.
Nel libro Vuelta de Siglo (Mexico city, Era editorial, 2006) il filosofo messicano Bolivar Echeverria parla di due modernità che configgono e si intrecciano fin dall’inizio del sedicesimo secolo. La prima è la modernità borghese fondata sulla morale protestante e sulla territorializzazione delle cose mondane e del dovere industriale. L’altra è modellata dalla Controriforma e dalla sensibilità del Barocco. Questa seconda modernità è stata rimossa e marginalizzata nello spirito pubblico dell’Occidente capitalista a partire dal momento in cui l’industrializzazione dell’ambiente umano ha richiesto una riduzione del sociale al processo di meccanizzazione. La vita della borghesia industriale è basata sulla severa dedizione al lavoro instancabile e sull’affezione proprietaria ai prodotti del lavoro. La borghesia è una classe territorializzata perché l’accumulazione di valore non può essere dissociata dall’espansione del mondo delle cose fisiche. Non esiste più la borghesia perché la produzione non si svolge più nel borgo, ma nella rete, e la ricchezza non si fonda più sulla proprietà di oggetti fisici, ma sulla deterritorializzazione finanziaria.
Echeverria osserva che fin dal sedicesimo secolo la Chiesa Cattolica ha creato un flusso alternativo di modernità, fondato sulle competenze immateriali dell’immaginazione e sulle potenze della deterritorializzazione linguistica e immaginativa. Il potere spirituale di Roma è sempre stato fondato sul controllo delle menti: questo è il suo capitale, fin quando la sua potenza venne marginalizzata dalla borghesia industriale.
La fonte dell’accumulazione
Ma quando le immagini, non più semplici rappresentazioni della realtà, divengono simulazione e stimolazione psico-fisica, i segni divengono la merce universale, oggetto principale della valorizzazione di capitale. Se l’economia borghese territorializzata era fondata sulla severità iconoclasta del ferro e dell’acciaio, la deterritorializzazione post-moderna è fondata invece sulla macchina caleidoscopica della produzione semiotica. Questa è la ragione per cui possiamo parlare di semiocapitalismo: perché le merci che circolano nel mondo economico - informazione, finanza, immaginario - sono segni, numeri, immagini, proiezioni, aspettative. Il linguaggio non è più uno strumento di rappresentazione del processo economico e vitale, ma diviene fonte principale di accumulazione, che continuamente deterritorializza il campo dello scambio.
La dinamica di progresso e crescita, nata dallo spazio fisico territoriale della fabbrica, ha obbligato le due classi fondamentali dell’epoca industriale, classe operaia e borghesia, al rispetto delle regole politiche e contrattuali. La morale protestante delle regole fonda la contrattazione collettiva e la funzione sociale dello stato.
A partire dagli anni ’70 la relazione tra capitale e lavoro è stata trasformata, grazie alla tecnologia digitale e alla deregulation del mercato del lavoro. Un effetto enorme di deterritorializzazione ne è seguita, e il modello borghese è stato spazzato via, insieme alla vecchia coscienza di classe operaia. La finanziarizzazione dell’economia globale ha eroso l’identificazione borghese di ricchezza proprietà fisica e lavoro territoriale. Quando il lavoro perde la sua forma meccanica e diviene immateriale, linguistico, affettivo, la relazione deterministica tra tempo e valore si rompe. La genesi del valore entra in una fase di indeterminazione e di incertezza. La via è aperta verso un prevalere di una visione neo barocca, e all’istaurazione di una logica aleatoria nel cuore stesso dell’economia. Quando il linguaggio diviene il campo generale della produzione quando la relazione matematica tra tempo-lavoro e valore è rotta, quando la deregulation distrugge tutte le garanzie, solo un comportamento di sopraffazione criminale può prevalere.
La violenza della deregulation
Questo è accaduto, in tutto il mondo non solo in Italia dal momento in cui le politiche neoliberiste hanno occupato la scena. Il principio della scuola neoliberale, la deregulation che ha distrutto i limiti legali e politici all’espansione capitalista non può intendersi come un mutamento puramente politico. Occorre vederlo nel contesto dell’evoluzione tecnologica e culturale che ha spostato il processo di valorizzazione dalla sfera della meccanica industriale al campo della produzione semiotica.
Il lavoro cognitivo non si può ridurre alla misura del tempo dato che il rapporto tra lavoro tempo e valorizzazione diviene incerto, indeterminabile. Il mercato del lavoro globale diviene il luogo della pura legge della violenza, della sopraffazione. Non si tratta più di semplice sfruttamento, ma di schiavismo, di violenza pura contro la nuda vita, contro il corpo indifeso dei lavoratori di tutto il mondo. La violenza è diventata la forza economica prevalente nell’epoca neoliberista. In Messico come in Italia come in Russia come in molti altri paesi il mercato finanziario, il mediascape e il potere politico sono nelle mani di persone che hanno ottenuto il loro potere con l’illegalità e con la violenza. Per non parlare del ruolo che corporation come Halliburton e Blackwater hanno svolto e svolgono nel provocare guerre e nel distruggere vite e città perché questo è il loro lavoro, perché il loro business ha bisogno della guerra per prosperare. La violenza è la forza regolatrice dell’economia semiocapitalista, perchiò non é contrastabile con i richiami alla legalità e alla moralità.
Come cento anni fa littlie è l’avanguardia del capitalismo non protestante e la seconda modernità di Echeverria, che si presentò per alcuni secoli come pura reazione antimoderna emerge oggi come principio fondativo del capitalismo mondiale. L’esperienza italiana durante gli ultimi cento anni è stato il teatro principale di questo ritorno dello spirito barocco. Le performance di Mussolini e di Berlusconi sono fondate entrambe sulla esibizione teatrale dell’energia maschile, ma anche sulla capacità di penetrare nei recessi del linguaggio nel campo profondo dell’autopercezione collettiva.
Curzio Malaparte, in un libro intitolato L’Europa vivente, ragionava su questo punto: il fascismo raccoglie l’eredità della Controriforma e dello spirito barocco, e la trasforma in un’energia che è al tempo stesso anti-moderna e neo-moderna. «Noi saremo grandi anche senza passare con un ritardo di tre secoli attraverso la Riforma: saremo grandi anzi unicamente contro la Riforma. La nuova potenza dello spirito italiano che già si manifesta per chiari segni non potrà essere se non antieuropea».
Sul corpo delle donne
Malaparte è ben consapevole - come lo erano stati i futuristi - del fatto che la modernità che il fascismo afferma è fondata sulla rimozione della femminilità. Il fascismo è sessualità che aborrisce e teme la sensualità. «Soffrire è necessario per vivere. La gloria e la libertà costano sangue, e soffrire bisogna per vivere con superbia e dignità fra superbi. Chi non riconosce questa verità fondamentale della vita umana si condanna alla bestialità. Chi predica l’odio alla sofferenza, chi predica alegge del paradiso e non quella dell’inferno (i socialisti) nega tutto ciò che di grande ha in sé un uomo, cioè tutto quello che un uomo ha in sé di umano. Un’umanità epicurea, paradisiaca, è anticristiana e antiumana» (Malaparte, L’Europa vivente).
La femminilità dell’autopercezione italiana è in gioco, nel caso di Mussolini come nel caso di Berlusconi. Mussolini e i giovani futuristi del 1909 volevano sottomettere disprezzandolo il corpo della donna (e il corpo sociale in quanto sottomesso e femminile). Berlusconi e la classe di lunpen che lo circonda vuole sporcare il corpo della donna, sottometterlo all’autodisprezzo cinico, sentimento prevalente e vincente della classe dirigente del semiocapitalismo barocco.
Le regole che i legalisti rivendicano sono decaduti nella cultura e nel lavoro. Occorre liberare la società dal legalismo, perché la società cominci a non rispettare le regole del semiocapitale, a essere autonoma nella post-legalità che il Semiocapitale ha istituito. Ciò che occorre alla società è la forza per non rispettare le regole non scritte che il capitalismo ha imposto, e per affermare un altro modo di vita, una nuova solidarietà del lavoro. Allora, nel campo senza regole del semiocapitalismo, la società potrà affermare i suoi bisogni e soprattutto le sue potenzialità. Difendere la legge diviene un lavoro risibile, quando il potere dichiara ogni giorno nei fatti che quelle regole non contano più niente. Solo a partire dall’abbandono di ogni illusione legalista sarà possible creare autonomia sociale, essere all’altezza (o se si preferisce alla bassezza) della sfida che il semiocapitale ha lanciato.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- Riuscirà la Repubblica Italiana a rientrare nella normalità democratica senza avere prima capito e detto e denunciato il grave stato di fuori gioco in cui si trovano ormai da tempo in questo Paese tutte le istituzioni? (di Furio Colombo - LA porta della libertà).28 marzo 2010, di Federico La Sala
La porta della libertà
di Furio Colombo (il Fatto, 28.03.2010)
Nessuno di noi finora ha tenuto conto di una domanda che pure dovrebbe apparire urgente e drammatica. La domanda è questa: riuscirà la Repubblica Italiana a rientrare nella normalità democratica senza avere prima capito e detto e denunciato il grave stato di fuori gioco in cui si trovano ormai da tempo in questo Paese tutte le istituzioni? Fino ad ora ha prevalso, se non altro per l’ autorevolezza di chi l’ ha espressa, la persuasione che alcuni episodi separati, non sempre denunciati, non sempre redarguiti, non formino di per sé un comportamento grave e costante e non debbano, quindi, essere affrontati in difesa della Repubblica e della sua Costituzione, come un grave pericolo in atto. Il più delle volte, a parte il silenzio, l’invito ha queste caratteristiche: ci sono due parti che debbono riconciliarsi. Offra ciascuna il suo “passo indietro” e “ i toni bassi” e “il rispetto delle istituzioni”, senza “delegittimare l’avversario”.
Questi ammonimenti sono saggi da un punto di vista molto importante: evitare il peggio. Chi li propone, a volte in modo ripetuto e con una preoccupazione che si percepisce molto intensa, questo “peggio” deve averlo intravisto o addirittura vissuto in alcune occasioni rimaste non pubbliche. Va dunque considerato e apprezzato lo sforzo di “evitare il peggio”, tenendo conto, però, che nelle vicende politiche sia nazionali che internazionali, tale intento di scartare un pericolo ha sempre portato a un pericolo più grave. Infatti lo spazio lasciato vuoto da fatti veri non riconosciuti e non descritti ai cittadini, viene invaso, ogni volta, da fatti più gravi e letali. Il lettore può pensare che mi sto tenendo un po’ alla larga. Perciò preciso. Vi prego di notare che dirò le stesse cose che molti di coloro che si oppongono vanno dicendo tutti i giorni, durante i quindici anni di Berlusconi.
Ma questa volta lo dico nel modo formulato dalla domanda: se si possa uscire da un pericolo ormai molto grave e imminente fingendo di non vedere, ed evitando di descrivere quel pericolo. Non è ciò che è accaduto a Monaco quando normali e prudenti statisti democratici hanno accettato e avvalorato la finzione di avere raggiunto un accordo con normali e democratici statisti di parte opposta che però erano Hitler e Mussolini? Purtroppo abbiamo imparato che prudenza e saggia cautela non diminuiscono il rischio contro la democrazia.
Il modo in cui avvengono le cose oggi in Italia lo conosciamo: un esecutivo, per sua natura pronto nell’ agire e nel reagire (per questo la Costituzione circonda ogni esecutivo di verifiche, contrappesi, controlli, garanzie per i cittadini) e per giunta reso fortissimo dal doppio potere, pubblico e privato, lancia attacchi violenti, con intenzione di piena rottura contro i centri costituzionali di verifica, controllo e garanzia. Alla fine di ogni attacco, complice quasi tutta la stampa (d’ altra parte comprata o succube o spaventata) manca la descrizione di quell’attacco, la portata distruttiva. Persino le intenzioni esplicite, proclamate dal capo di quell’esecutivo che attacca le altre istituzioni, vengono omesse. Qui il problema non è l’ arbitro (mi riferisco con tutto il rispetto al Capo dello Stato) perché il problema non è il rapporto fra maggioranza e opposizione e non è l’eventuale lamentela dell’opposizione.
Qui stiamo parlando di iniziative ripetute di tipo rivoluzionario contro la Costituzione, i suoi organi di controllo, i suoi giudici e le fondamentali leggi della Repubblica tuttora in vigore. In quel punto e in quel momento dell’ aggressione, che è ogni volta un colpo duro e forse finale al muro democratico, c’è l’ ultima, estrema possibilità di difesa della Repubblica. Vi sono consiglieri, in luoghi autorevoli, che insistono nel suggerire, come unica cura, come unico intervento risolutivo di questo momento grave, una ragionevole e ben visibile equidistanza.
Ma equidistanza da che cosa? La parte offesa di questo tremendo gioco non è l’ opposizione. Il suo mestiere comprende il dare e avere, argomenti duri e aggressivi (vedi la brutalità senza riguardi che i repubblicani americani riservano al loro Presidente, vedi l’impegno senza tregua con cui Barack Obama tiene testa a quell’ offensiva) .
La parte offesa, adesso, in Italia, sono le istituzioni dello Stato, sono i magistrati (tutti), sono le Corti, fino alla Cassazione e alla Corte Costituzionale, sono le authority di garanzia, come quella delle comunicazioni. Quando i giudici si comprano (nei pochi casi in cui si può) o si insultano con modalità di separazione definitiva dallo Stato di diritto, quando cade ogni finzione sull’ appartenenza comune alle leggi fondamentali, violandole e annunciandone la soppressione ogni volta che sono un ostacolo, la controparte è la Costituzione, sono le sue radici di libertà, la sua originaria e incancellabile natura antifascista. Questa è la descrizione di una grave e pericolosa situazione politica. Se continueremo a non riconoscerla fingendo di credere che due parti in contrapposizione debbano smettere di delegittimarsi e giungere a più miti consigli, si nega la realtà, si cancellano i fatti, si murano le porte di uscita.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- SCOSSE LE FONDAMENTA!!! L’obbligo della verità dopo troppi silenzi (di Adriano Prosperi).27 marzo 2010, di Federico La Sala
L’obbligo della verità dopo troppi silenzi
di Adriano Prosperi (la Repubblica, 27 marzo 2010)
Nel caso dei preti pedofili bisognerà evitare almeno che tutto si riduca alla solita diatriba fra clericali e laici. O che ci si metta addirittura a contare i numeri: quanti i pedofili tra i preti, quanti tra i non preti.
Sono cose che abbiamo già visto quando si discuteva su quanti eretici e quante streghe fossero stati mandati a morte dai tribunali della Chiesa cattolica e quanti da altre chiese e da altri poteri. E intanto passava in secondo piano la sofferenza delle vittime e la tenebra dell’intolleranza e si cancellava la responsabilità storica, giuridica, culturale degli assassini.
L’apologetica e la controversia uccidono la verità. E qui la questione della verità è fondamentale: e deve stare a cuore agli uomini di governo della Chiesa più che a chiunque altro se sono capaci di prendere sul serio il loro stesso ufficio e di capire quale sia la tremenda responsabilità che si sono assunti. Per candidarsi al governo delle coscienze bisogna dimostrare di saper rispettare la verità.
L’occultamento del vero, avvenga per trascuratezza burocratica o per malinteso spirito di corpo, uccide la fiducia. Tanto più quando si tratta di una verità orrenda che dovrebbe far tremare chi la viene e a conoscere e dovrebbe accendere di furore, di pena, di fame di giustizia chi ha il compito di governare e di giudicare.
Non per niente a tanti è venuto spontaneo citare la terribile parola del Gesù dei vangeli: bisogna che gli scandali avvengano ma guai a coloro che sono causa degli scandali. La macina al collo e il suicidio come la sola pena adeguata per chi scandalizza questi piccoli: questa la violenza estrema della parola evangelica. Gli echi di questa pagina hanno risuonato nei secoli: le abbiamo ritrovate in un grande capolavoro di Dostoevskij che tutti hanno letto o dovrebbero leggere.
E si ricorderà che Gesù di Nazareth non scendeva nei dettagli. Chissà cosa avrebbe detto delle attenuanti che sono state evocate in questi giorni: l’età del colpevole, il suo stato di salute, il silenzio delle vittime, di quelle creature piccole. Piccole e mute: non solo perché prive dell’uso della parola. Mute, perché per uscire dal buio e dal silenzio senza parole di quella lurida aggressione, al bambino e alla bambina che l’hanno subìta può non bastare una vita intera. Una vita compromessa, avvilita, oscurata per sempre da chi gode della fiducia dei fedeli in grazia del suo abito e della parola evangelica - quella frase, «lasciate che i pargoli vengano a me», si provi a immaginarla sulle labbra del prete pedofilo.
Per questo ci è parso singolarmente infelice il grido «Basta scandali!» che è risuonato in Piazza San Pietro e che ha unito per un attimo il capo della Chiesa cattolica al responsabile della protezione civile italiana. C’è chi davanti al brontolio di tuono della tempesta che ruggiva nel mondo intero e che bussava ormai alle porte dell’ovattato mondo della comunicazione italiana, sempre timoroso e pronto a inginocchiarsi davanti ai poteri consacrati e agli abiti talari ha evocato l’idea di una congiura anticristiana.
Ma simili bassi servigi hanno il torto di nascondere agli occhi degli italiani la gravità del problema. Non solo per la Chiesa: anche per il nostro paese che non può permettersi di subire tutta insieme la vergogna dell’ondata di discredito internazionale che si abbatte oggi sui due volti che lo rappresentano nel mondo: e passi pure che l’opinione pubblica rida di noi per le grottesche performances di un leader politico che dichiara guerra al cancro. Ma se la tempesta si abbatte sul papa di Roma e sulle autorità cattoliche, allora sì che le fondamenta storiche del Paese sono scosse.
E dunque guardiamo in faccia la verità: che è quella di una turpitudine storica e non solo episodica, giuridica e non solo morale. Questa vicenda è cominciata secoli fa: la inaugurò papa Paolo IV Carafa quando nel 1559 stabilì che i preti e i frati colpevoli di reati di natura sessuale nati nel contesto della confessione sacramentale dovessero essere sottoposti al Sant’Uffizio dell’Inquisizione. Era una misura in apparenza radicale, dura, minacciosa per i colpevoli: in realtà era la via d’uscita per chiudere la conoscenza di episodi scandalosi nello spazio giuridico di un tribunale ecclesiastico segretissimo. La ragione della scelta era ovvia: Lutero aveva bruciato non solo la bolla di scomunica ma anche l’intero corpus del diritto canonico, giudicato da lui una delle muraglie con cui il clero si era alzato al di sopra del popolo cristiano.
La Chiesa cattolica ribadì la superiorità sacrale del clero, mantenne il diritto canonico e il privilegio del foro per i chierici e, nel confermare l’obbligo del celibato ecclesiastico, preparò un comodo rifugio per chi lo infrangeva e per chi infangava il sacramento del perdono dei peccati attentando ai minori e alle donne che si affacciavano al confessionale. Da allora e per secoli i processi per i casi di «sollicitatio» sono stati nascosti dal segreto impenetrabile del Sant’Uffizio mentre i colpevoli venivano semplicemente trasferiti di sede per difendere il buon nome del clero: fino a oggi. E il segreto è diventato anche più fitto e ha coperto altre e più gravi turpitudini quando, per opera del cardinal Alfredo Ottaviani prefetto del Sant’Uffizio, fu approvata una istruzione per il «crimen sollicitationis» immediatamente sepolta nel segreto dei palazzi vaticani.
Quella istruzione imponeva un segreto assoluto sulle materie relative non solo al reato di «sollicitatio» ma anche a quello che veniva definito il «crimine pessimo»: cioè l’atto sessuale compiuto da un chierico con fanciulli impuberi dei due sessi o con animali. Chissà perché al cardinal Ottaviani venne in mente di includere anche questo nuovo versante del crimine sotto l’antico mantello protettivo.
Il Sant’Uffizio scomparve ufficialmente dalla nomenclatura istituzionale vaticana nel 1965 e Ottaviani uscì di scena, mentre il Concilio Vaticano II sembrava aprire scenari nuovi: scenari di fiducia verso il mondo moderno incluso il principio fondamentale fra tutti della trasparenza e della verità come obbligo dei governanti verso i governati. Ma concluso il concilio il vento cambiò. E la nuova Congregazione per la dottrina della fede fece sua l’istruzione del cardinal Ottaviani. Un documento ufficiale della Congregazione governata dal prefetto cardinal Joseph Ratzinger datata 18 maggio 2002 ne riprese la sostanza. Si intitola «De delictis gravioribus». Dunque il cardinal Ratzinger ha coperto con quel segreto specialissimo le vicende che per il suo ufficio doveva conoscere e governare.
Oggi non per sua scelta ma per la pressione di un mondo in rivolta gli si pone nella sua nuova veste il problema di decidere quale percorso proporre alla Chiesa cattolica. Ed è un singolare esempio dei corsi e ricorsi storici che tocchi di nuovo a un papa tedesco, il secondo dell’età moderna dopo quell’Adriano VI che dovette fare i conti con la Riforma luterana, affrontare un problema che ha trovato specialmente nella coscienza della Germania un’eco profonda: un problema che ripropone ancora una volta e su di una materia terribile la questione della capacità della Chiesa di interpretare i segni dei tempi. Si tratta di decidere se conservare o abbandonare quello che è stato fin dall’inizio uno strumento per difendere dalla verità e dalla giustizia i membri del clero.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- Usa, sacerdote abusò di 200 bambini. "Ratzinger e Bertone occultarono il caso".25 marzo 2010, di Federico La Sala
 Le violenze di un sacerdote del Wisconsin sui piccoli affetti da sordità
Le violenze di un sacerdote del Wisconsin sui piccoli affetti da sordità
 La rivelazione del New York Times: "La priorità era proteggere la Chiesa"
La rivelazione del New York Times: "La priorità era proteggere la Chiesa" Usa, sacerdote abusò di 200 bambini
Usa, sacerdote abusò di 200 bambini
 "Ratzinger e Bertone occultarono il caso" *
"Ratzinger e Bertone occultarono il caso" *ROMA - I vertici del Vaticano, tra cui il futuro Papa Benedetto XVI, occultarono gli abusi di un prete americano, sospettato di aver violentato circa 200 bambini sordi di una scuola del Wisconsin. Lo scrive il New York Times, sulla base di alcuni documenti ecclesiastici di cui è venuto in possesso. La corrispondenza interna tra vescovi del Wisconsin e l’allora cardinale Joseph Ratzinger, scrive il New York Times, mostra che la priorità era, a quel tempo, quella di proteggere la chiesa dallo scandalo.
La vicenda in questione riguarda un prete del Wisconsin, il reverendo Lawrence C. Murphy, che aveva lavorato nella scuola dal 1950 al 1977. Nel 1996, riferisce il quotidiano americano, l’allora cardinale Joseph Ratzinger non fornì alcuna risposta a due lettere che gli furono inviate dall’arcivescovo di Milwaukee, Rembert G. Weakland, mentre solo otto mesi più tardi il cardinale Tarcisio Bertone diede istruzioni, ai vescovi del Wisconsin, di avviare un processo canonico segreto che avrebbe potuto portare all’allontanamento di padre Murphy.
Ma Bertone, precisa il New York Times, fermò questo processo dopo che lo stesso padre Murphy scrisse al cardinale Ratzinger ricordando che il caso era sostanzialmente caduto in prescrizione. "Voglio solo vivere il tempo che mi resta nella dignità del mio sacerdozio. Chiedo il vostro aiuto in questa vicenda", chiese il sacerdote.
Nei documenti, ottenuti dal quotidiano dai legali di cinque uomini che hanno fatto causa alla diocesi di Milwaukee, non c’è traccia della risposta di Ratzinger a questa lettera. Ma secondo quanto si legge, padre Murphy non ricevette mai alcuna punizione o sanzione e fu trasferito in segreto in alcune parrocchie e scuole cattoliche, prima di morire nel 1998.
* la Repubblica, 25 marzo 2010
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- LA BANDIERA VATICANA (di Adriano Prosperi).23 marzo 2010, di Federico La Sala
La bandiera vaticana
di ADRIANO PROSPERI
Le elezioni sono alle porte e la Chiesa italiana ha parlato: o meglio, ha parlato la Cei per bocca del cardinal Bagnasco. La precisazione è d’obbligo: è possibile che una sola voce riesca ad esprimere la quantità e la qualità delle posizioni che si muovono nella realtà del mondo cattolico?
Ci si chiede anche se le elezioni amministrative siano un’occasione di tale importanza da imporre che si levi in modo speciale la voce di un’autorità morale e spirituale come la Chiesa nella sua espressione gerarchica, obbligata dalla sua stessa natura a essere al di sopra delle parti . E non intendiamo levare la pur sacrosanta protesta di chi chiede che le autorità ecclesiastiche si astengano dalla lotta politica: anche se si potrebbe - e forse si dovrebbe, visti i tempi - ricordare ai vescovi che ci sono tante occasioni di urgenze grosse e di scandali clamorosi davanti ai quali la loro voce dovrebbe trovare il coraggio di levarsi. Lo stato morale del Paese è disastroso. C’è una corruzione che ha invaso - partendo dall’alto - anche i più remoti angoli dove si dà esercizio del potere. È cosa recentissima la pubblicazione del rapporto annuale dell’agenzia internazionale per il monitoraggio dello stato dei diritti umani nel mondo: e lì abbiamo letto note ben poco confortanti per il nostro Paese. Che cosa può fare un vescovo in questa situazione?
I modelli di vescovi che hanno saputo affrontare senza paura i potenti per esercitare il loro compito di pastori di anime e di guide di coscienze non mancano certo nella millenaria storia della Chiesa: il gesto di ripulsa e di condanna di Sant’Ambrogio davanti all’imperatore Teodosio fondò il diritto del vescovo di Milano a guidare il suo popolo. Non sono più tempi così drammatici, penserà qualcuno. Eppure l’appello del cardinal Bagnasco ha un tono di una certa drammaticità. Anche se nel suo discorso sono stati toccati diversi problemi, nella sostanza uno domina su tutti gli altri. Gli elettori sono stati invitati a seguire nella scelta elettorale la bussola della questione dell’aborto.
Ora, la domanda che si pone è se questo è veramente il problema dei problemi, quello per cui sta o cade la società. Si dice che questa funzione è quella che prima di tutte le altre appartiene alla Chiesa: la difesa della vita. Bandiera nobile, se altre ce ne sono. La vita umana va difesa. Su questo siamo tutti d’accordo. Ma allora bisogna essere conseguenti e andare fino in fondo. Prendiamo un caso: sono passati appena pochi giorni da un episodio gravissimo: una madre ha partorito in una stazione di sport invernali dove lavorava, sulla neve dell’Abetone. Aveva un permesso di soggiorno legato al suo posto di lavoro. Ha nascosto il parto, il neonato è morto soffocato. Un’immigrata non può avere figli senza rischiare di perdere il lavoro: è l’effetto di una legge approvata da un governo di centrodestra che si vanta di avere il consenso degli italiani. E l’appoggio della Chiesa a questo governo produce ogni giorno effetti devastanti.
Noi non sappiamo quanti siano gli aborti clandestini che si praticano in Italia. Fu per affrontare la piaga dell’aborto clandestino che fu varata la legge 194. E l’effetto si è visto. Era un modo civile di affrontare una piaga antica, ben nota alle autorità ecclesiastiche. Per secoli l’arma della scomunica non ha impedito che nel segreto delle famiglie si eliminassero i figli indesiderati laddove le ferree catene del bisogno imponevano di non aumentare le bocche e di non avere figlie femmine. Allora la scomunica non colpiva i colpevoli della iniqua distribuzione delle risorse. E ancora oggi la condanna ecclesiastica non colpisce coloro che hanno varato quella legge che provoca lutti e dolori, che impedisce alle donne immigrate di avere figli. Né colpisce le forze politiche che non hanno a cuore la tutela della famiglia e che dedicano tutta la loro forza a sottrarre alla legge un presidente del Consiglio invece di varare una riforma fiscale che introduca il quoziente famiglia. Invece basta un normale appuntamento elettorale perché si ripeta ancora lo stanco spettacolo di un’autorità ecclesiastica che si schiera a favore di una parte politica contro un’altra. È un rito vecchio, logorato dall’uso, ripetitivo, facilmente decifrabile. Siamo a una scadenza elettorale resa inquieta dal silenzio della televisione di Stato, assurdamente determinata a lasciare i cittadini in una condizione di dubbio e di perplessità. Sono semplici elezioni amministrative. Non è in gioco la sorte del governo. Si tratta di scegliere i candidati più credibili per affidare loro l’amministrazione di regioni e città. Ci aspettavamo di essere messi in grado di scegliere serenamente sulla base dei profili dei candidati e del contenuto dei loro programmi. Ma di programmi è stato molto difficile parlare.
Il confronto è stato oscurato dall’episodio della clamorosa incapacità del più potente partito italiano di mettere insieme una lista di candidati e di farla pervenire alla scadenza dovuta davanti all’ufficio competente. Una manifestazione di piazza ha costruito lo spettacolo televisivo per raggiungere in un colpo solo tutti gli elettori. Ma forse anche questo spettacolo rischiava di non essere efficace. E allora, che altro si poteva fare per dare una mano al Pdl e combattere la candidatura di Emma Bonino nel Lazio?
© la Repubblica, 23 marzo 2010
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- DISOBBEDIRE E’ ORMAI UN DOVERE MORALE, URGENTE E IMPROCRASTINABILE (di Aldo antonelli, parroco - Assassini).22 marzo 2010, di Federico La Sala
ASSASSINI
di don Aldo Antonelli
Siamo sotto una grandinata di bombardamenti senza sosta e senza misura e senza ritegno. Dalle prediche blasfeme di don Berlusconi alle false esecrazioni morali del Papa, passando per i comizi fascisti dell’onorevole Bagnasco.
A ruoli invertiti il puttaniere pluridivorziato fa omelie sull’amore e il papa che da cardinale per 24 anni, dal 1981 al 2005, ha visto passare sotto le sue mani tutti i casi gravi di devianza sessuale commessi da sacerdoti senza che movesse un dito. E’ sua la lettera solenne del maggio 2001 (Epistula de delictis gravioribus) che poneva sotto segreto pontificio tali delitti.
Il Falso per antonomasia e il falsificatore di professione fonda il Movimento dei Missionari della Verità e il cardinale chiude gli occhi e allunga la mano per benedire. Anzi allunga tutte e due le mani: una per prendere e l’altra per benedire.
Da ladri professionisti ben si intendono: ambedue ladri di cosciena e di buona fede. Ladri di libertà e di dignità.
C’è un tribunale inte rnazionale cui deferirli?
L’uno con il suo sorriso a gremagliera e l’altro con il pastorale a mò di scimitarra!
Il primo che rifonda il Fascismo del nuovo millennio e il secondo che riscrive il Sillabo in lingua moderna.
Ambedue ladri e ambedue assassini: uccisori di democrazia e affossatori del Concilio.
Disobbedir loro è ormai un dovere morale, urgente e improcrastinabile.
Aldo Antonelli parroco
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- IL PATTO SCELLERATO (di Alessandro Portelli).23 marzo 2010, di Federico La Sala
Il patto scellerato
di Alessandro Portelli (il manifesto, 23 marzo 2010
Avevamo un Presidente Operaio, poi abbiamo avuto un Presidente Odontotecnico, e adesso abbiamo anche un Presidente facente funzioni di Papa. Dall’alto della sua ben nota autorità etica, Silvio Berlusconi benedice la lettera di Benedetto XVI sulla pedofilia; e immediatamente il presidente dei vescovi italiani ringrazia invitando a votare a destra alle regionali. Un’autorità politica che esprime un giudizio morale, un’autorità religiosa che lancia messaggi politici: in qualunque altro paese sarebbe il mondo alla rovescia. Ma le nostre classi dominanti non hanno mai accettato pienamente il principio democratico della separazione fra Chiesa e Stato. Così Berlusconi, nella sua infinita modestia, non potendo per il momento fare anche il Papa, si considera un’autorità più alta del Pontefice e lo conforta con la sua alta approvazione morale. E il cardinal Bagnasco, non potendo per il momento di fare il presidente del consiglio, dà la linea ai votanti riducendo la Chiesa Cattolica Apostolica Romana a comitato elettorale della signora Polverini.
Ma il fatto che ci siamo abituati non rende questa doppia invasione di campo meno ridicola da una parte, e meno pericolosa e offensiva dall’altra. Ridicolo: è roba da 1984, quando sono persone e istituzioni la cui autorità morale vacilla a erigersi a depositari della morale e dell’amore. «Perfino l’attacco alla sostanza stessa della religione cristiana» di cui straparla Berlusconi si materializza più negli abusi e nei silenzi, che in chi li denuncia. Se avesse un minimo di pudore, la Chiesa Cattolica in questi giorni dovrebbe usare toni come minimo un po’ più moderati nello sbandierare il tema della «dignità della persona umana», che è certamente offesa dagli impuniti abusi sui bambini commessi da sacerdoti assai più che dal «crimine incommensurabile dell’aborto». E se avesse un minimo di pudore, Silvio Berlusconi, utilizzatore finale di escort a pagamento, dovrebbe parlare di amore e di sessualità con un po’ più di umiltà e di attenzione.
Non c’è solo il ridicolo, c’è anche il pericolo. Contraddicendo Carlo Marx, farsa e possibile tragedia in questo caso coincidono. Perché quello che è in gioco in questa partita non sono l’amore, la dignità della persona umana, la vita. Siamo di fronte a due istituzioni carismatiche, che non accettano limiti, sentono erodere e sfuggir loro di mano almeno una parte del carisma e del potere, e si aggrappano l’una all’altra scambiandosi favori (anche assai più concreti e meno pubblici di una dichiarazione di sostegno) per rilanciarsi e darsi conforto. Potrebbe essere un buon segno, un auspicio di cambiamento. Ma è anche un segnale di rischio: né la Chiesa né Berlusconi hanno la minima idea di che cosa sia la democrazia, e non c’è limite a quello di cui sono capaci, pur di restare in sella.
Già il fatto di alzare così clamorosamente i toni è sia un segno di debolezza, sia un avvertimento: il potere si compatta, gli imperi sono sempre pronti a colpire ancora. Per questo mi pare assolutamente necessario che si vada tutti a votare in queste elezioni regionali. Se Berlusconi e il cardinal Bagnasco contano su uno zoccolo duro di obbedienza e consenso, nel voto abbiamo uno strumento, magari limitato ma reale, per esprimere disobbedienza e dissenso.
Candidati come Nichi Vendola o Emma Bonino, così diversi, sono comunque portatori di un’idea di vita, di amore, di sessualità, di dignità umana che è infinitamente più alto di quello mercanteggiato e svilito dal balletto politico-moralistico di questi potenti impauriti. Possiamo avere differenze e persino perplessità; ma l’entrata a gamba tesa di Bagnasco ci chiarisce che le scelte che siamo chiamati a fare non sono indifferenti, che i nomi nelle schede e nella vita non sono «tutti uguali». Se davvero abbiamo a cuore la vita (e la dignità, e anche l’amore), facciamoci sentire.
-
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- IL COLORE DELLA DEMOCRAZIA, IL GIOCO DELLA MORTE E IL BUFFONE (di Barbara Spinelli).21 marzo 2010, di Federico La Sala
Il colore della democrazia
di BARBARA SPINELLI (La Stampa, 21/3/2010)
L’8 marzo scorso, forse per rassicurare gli italiani, il Presidente della Repubblica ha fatto alcune considerazioni singolari, sul coraggio e la politica. Ha detto che «in un contesto degradato, di diffusa illegalità, essere ragazzi e ragazze perbene richiede talvolta sacrifici e coraggio»: in questi casi estremi sì, «è bello che ci sia» questa virtù. Ma in una democrazia rispettabile come la nostra, «per essere buoni cittadini non si deve esercitare nessun atto di coraggio». Profonda è infatti negli italiani «la condivisione di quel patrimonio di valori e principi che si racchiude nella Costituzione». Legge e senso dello Stato sono nostre doti naturali: il che esclude il degrado della legalità. I toni bassi sono lo spartito di sì armoniosa disposizione.
Il fatto è che non siamo in una democrazia rispettabile, e forse il Presidente pecca di ottimismo non solo sull’Italia ma in genere sullo stato di salute delle democrazie. Certo, non s’erge un totalitarismo sterminatore.
 Ma Napolitano avrà forse visto il terribile esperimento mostrato alla televisione francese, qualche giorno fa. Il documentario si intitola Il Gioco della morte, e mette in scena un gioco a premi in cui i candidati, per vincere, ricevono l’ingiunzione di infliggere all’avversario che sbaglia i quiz una scarica elettrica sempre più intensa, fino al massimo voltaggio che uccide.
Ma Napolitano avrà forse visto il terribile esperimento mostrato alla televisione francese, qualche giorno fa. Il documentario si intitola Il Gioco della morte, e mette in scena un gioco a premi in cui i candidati, per vincere, ricevono l’ingiunzione di infliggere all’avversario che sbaglia i quiz una scarica elettrica sempre più intensa, fino al massimo voltaggio che uccide.
 La vittima è un attore che grida per finta, ma i candidati non lo sanno. Il risultato è impaurente: l’81 per cento obbedisce, spostando la manopola sui 460 volt che danno la morte. Solo nove persone si fermano, udendo i primi gemiti del colpito. Sette rinunciano, poi svengono.
La vittima è un attore che grida per finta, ma i candidati non lo sanno. Il risultato è impaurente: l’81 per cento obbedisce, spostando la manopola sui 460 volt che danno la morte. Solo nove persone si fermano, udendo i primi gemiti del colpito. Sette rinunciano, poi svengono.Difficile dopo aver visto il Gioco dire che siamo democrazie rispettabili, dove legge e Costituzioni sono interiorizzate. Quel che nell’uomo è connaturato, in dittatura come in democrazia, non è la legge ma l’abitudine a «non pensarci», l’istinto di gregge, e in primis il conformismo. Il «contesto degradato» è nostro orizzonte permanente. È quello che Camus chiama l’assurdo: il mondo non solo non ha senso ma neppure sente bisogno di senso, ricorda Paolo Flores d’Arcais in un saggio sullo scrittore della rivolta (Albert Camus filosofo del futuro, Codice ed., 2010).
Coraggioso è chi invece «si dà pensiero», chi s’interroga sul male e per ciò stesso diventa, in patria, spaesato. Flores conclude: «Venire al mondo equivale a far nascere un dover essere». In effetti sono tanti e giornalieri, gli atti di coraggio di cui si può dire: vale la pena. È coraggioso chi in gran parte d’Italia non paga pizzi alle mafie. Sono coraggiosi il poliziotto o il giudice che resistono alle pressioni della malavita o della politica. Soprattutto il servitore dello Stato è chiamato al coraggio, in un’Italia unificata dalla lingua ma non dal senso dello Stato. Coraggioso è chiunque sia classe dirigente, e con il proprio agire, scrivere, fare informazione, influenza l’opinione con la verità. Non so se sia bello, dire no. È comunque necessario, specie in Italia dove paure e conformismo hanno radici possenti. Il coraggio, siamo avvezzi a vederlo come gesto di eccezionale purezza mentre è gesto di chi fu Borsellino a dirlo in cuor suo lo sa: «È normale che esista la paura. In ogni uomo, l’importante è che sia accompagnata dal coraggio». Così come c’è un male banale, esiste la banalità quotidiana del coraggio.
Forse bisogna tornare alle fonti antiche, per ritrovare questa virtù.
 Nella Repubblica, Platone spiega come il coraggio (andreia) sia necessario in ogni evenienza, estrema e non. Esso consiste nella capacità (dell’individuo, della città) di farsi un’opinione su ciò che è temibile o non lo è, e di «salvare tale opinione». L’opinione da preservare, sulla natura delle cose temibili, «è la legge e impiantarla in noi attraverso l’educazione», e il coraggio la conserva «in ogni circostanza: nel dolore, nel piacere, nel desiderio, nel timore» (429,c-d). La metafora usata da Platone è quella del colore. Immaginate una stoffa, dice: per darle un indelebile colore rosso dovrete partire dal bianco, e sapere che il colore più resistente si stinge, se viene a contatto con i detersivi delle passioni.
Nella Repubblica, Platone spiega come il coraggio (andreia) sia necessario in ogni evenienza, estrema e non. Esso consiste nella capacità (dell’individuo, della città) di farsi un’opinione su ciò che è temibile o non lo è, e di «salvare tale opinione». L’opinione da preservare, sulla natura delle cose temibili, «è la legge e impiantarla in noi attraverso l’educazione», e il coraggio la conserva «in ogni circostanza: nel dolore, nel piacere, nel desiderio, nel timore» (429,c-d). La metafora usata da Platone è quella del colore. Immaginate una stoffa, dice: per darle un indelebile colore rosso dovrete partire dal bianco, e sapere che il colore più resistente si stinge, se viene a contatto con i detersivi delle passioni.Il colore della democrazia è la resistenza a questo svanire di tinte, a questo loro espianto dal cuore (il cuore è la sede del coraggio). Compito dei cittadini e dei custodi della repubblica è «assorbire in sé, come una tintura, le leggi, affinché grazie all’educazione ricevuta e alla propria natura essi mantengano indelebile l’opinione sulle cose pericolose, senza permettere che la tintura sia cancellata da quei saponi così efficaci a cancellare: dal piacere, più efficace di qualsiasi soda; dal dolore, dal timore e dal desiderio, più forti di qualsiasi sapone» (430,a-b).
In Italia la democrazia è stinta più efficacemente perché le leggi e i custodi ci sono, ma l’innesto è meno scontato di quanto si creda. Berlusconi lavora a tale espianto da anni, e ora lo ammette senza più remore: alla legalità contrappone la legittimità che le urne conferiscono al capo. I custodi delle leggi li giudica usurpatori oltre che infidi. Legittimo è solo il capo, e questo gli consente di dire: «La legge è ciò che decido io». I contropoteri cesseranno di insidiarlo solo quando pesi e contrappesi si fonderanno: quando, eletto dal popolo, conquisterà il Quirinale.
Se la democrazia fosse rispettabile non ci sarebbe un capo che s’indigna perché scopre d’esser stato intercettato mentre ordina di censurare programmi televisivi sgraditi, e i cittadini, forti di indelebili tinture, gli direbbero: le tue telefonate non sono private come le nostre, le intercettazioni sono a volte eccessive ma chiamare l’autorità garante dell’informazione o il direttore di un telegiornale Rai, per imprimere loro una linea, è radicalmente diverso. Ognuno ha diritto alla privacy, e anche noi abbiamo criticato gli eccessi delle intercettazioni. Ma l’abuso di potere che esse rivelano è in genere ben più impaurente del cannocchiale che lo smaschera. Schifani dice: «È preoccupante la fuga di notizie» e di fatto lo riconosce: sono le notizie a inquietarlo. Anche dire questa semplice verità è coraggio quotidiano.
L’intervento sui programmi televisivi si fa specialmente sinistro alla luce di show come Il Gioco della morte. Non dimentichiamo che un esperimento simile si fece nel luglio 1961 all’università di Yale, guidato dallo psicologo Stanley Milgram. A ordinare gli elettroshock, allora, c’erano autorevoli biologi in camice grigio. Oggi l’autorità si fa giocosa, è una bella valletta a intimare, suadente: «Alzi il voltaggio!». Il pubblico applaude, ride. A opporsi è stato un misero 20 per cento, mentre il 35 s’oppose nel caso Milgram. Ne consegue che la televisione ha più potere di scienziati in camice, sulle menti: il coraggio diminuisce, il conformismo aumenta. Philip Zimbardo, organizzatore di test analoghi a Stanford nel 1971, racconta come nessuno di coloro che rifiutarono di infliggere i 460 volt chiese a Milgram di fermare l’esperimento, o di visitare l’urlante vittima degli elettroshock.
 Questo significa che la televisione non è più solo una caja tonta, una scatola tonta, come dicono in Spagna. È una cassa da morto, che trasforma lo studio televisivo in Colosseo di sangue: lugubri, le risate sono le stesse.
Questo significa che la televisione non è più solo una caja tonta, una scatola tonta, come dicono in Spagna. È una cassa da morto, che trasforma lo studio televisivo in Colosseo di sangue: lugubri, le risate sono le stesse.Ci sono sere a RaiUno in cui prima viene un notiziario menzognero (che dà per assolto Mills, che presenta il giurista Hans Kelsen come critico ante litteram della legalità), poi seguono programmi dai nomi ominosi: Affari Tuoi, I Raccomandati, in un crescendo di catodiche manipolazioni.
Presto vedremo, in Tv, la morte in diretta sotto forma di varietà. Kierkegaard dice in Aut-Aut che l’ultimo ad apparire, alla fine del mondo, sarà il Buffone: «Accadde in un teatro, che le quinte presero fuoco. Il Buffone uscì per avvisare il pubblico. Credettero che fosse uno scherzo e applaudirono; egli ripeté l’avviso: la gente esultò ancora di più. Così mi figuro che il mondo perirà fra l’esultanza generale degli spiritosi, che crederanno si tratti di uno scherzo».
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- SCAMBIARSI LA VESTE. STATO E CHIESA AL GOVERNO DELL’UOMO (rec. di Carlo Galli - Il dialogo delle verità)18 marzo 2010, di Federico La Sala
Il dialogo delle veritàZagrebelsky: potere, stato e chiesa
 L’ultimo libro del giurista affronta il rapporto fra politica e fede nel governo dell’uomo
L’ultimo libro del giurista affronta il rapporto fra politica e fede nel governo dell’uomo
 La ricostruzione storica mostra quando si spezza l’alleanza tra trono e altare
La ricostruzione storica mostra quando si spezza l’alleanza tra trono e altare
 Il saggio rivela l’esigenza di una riscoperta delle caratteristiche della laicità
Nelle democrazie moderne le due entità non possono venire sovrapposte e serve un pluralismo
Il saggio rivela l’esigenza di una riscoperta delle caratteristiche della laicità
Nelle democrazie moderne le due entità non possono venire sovrapposte e serve un pluralismodi Carlo Galli (la Repubblica, 18.03.2010)
Merito del libro di Gustavo Zagrebelsky (Scambiarsi la veste. Stato e Chiesa al governo dell’uomo, edito da Laterza, pagg. 160, euro 16) è di afferrare il bandolo di quella complicata matassa che è il ritorno politico della religione - in cui si intrecciano la crisi dello Stato democratico, l’emergere di una diffusa indifferenza verso la religione, ma al tempo stesso anche la ricerca di un supplemento d’anima per una politica sempre più spezzettata, irrazionale, instabile - , e di ricostruire in una sintesi agile, informata, incisiva, la tormentata vicenda del dualismo occidentale fra potere e religione, misurando così le ragioni strutturali del problema.
Quel dualismo fra Stato e Chiesa nacque con l’affermazione - risalente a papa Gelasio, alla fine del V secolo - che la Chiesa, originariamente capace di politica (Cristo ha salvato l’umanità intera nel mondo, non i singoli uomini nel chiuso delle loro coscienze), è altra e superiore rispetto al potere politico mondano: nel disegno della Chiesa il dualismo serviva a creare una gerarchia, a proprio favore; il cristianesimo era la precondizione dell’esistenza politica - essere cristiano e essere cittadino erano la medesima cosa - , e quindi anche della legittimità dei poteri civili. La laicità, quindi, nasce nel mondo cristiano, ma indirettamente; non è una concessione della Chiesa né un esito immediato della religione, ma il risultato di una lotta di lungo periodo contro la pretesa di supremazia che la caratterizza da sempre.
Una pretesa che Zagrebelsky ripercorre nelle sue varie forme - la ierocrazia medievale, e la teoria moderna di Bellarmino della potestas indirecta, ossia l’offerta di sostegno ai re e la parallela affermazione che i cattolici possono essere chiamati dal papa a disobbedire ai loro governanti - . La modernità politica spezza proprio questa alleanza fra trono e altare, e la Chiesa entra in conflitto frontale con il mondo moderno e la sua politica: l’Ottocento è così segnato dal rifiuto del liberalismo e della libertà che questo offriva alla religione (libera Chiesa in libero Stato). Ma nonostante questo arroccamento politico e dottrinario la Chiesa si aprì verso la società, per mobilitare masse cattoliche tendenzialmente antistatali, e per non lasciarle al socialismo; alla fede ormai non più coincidente con la cittadinanza sostituì, con la Rerum Novarum di Leone XIII, la propria dottrina sociale quale centro di una strategia di riappropriazione della politica. La Chiesa inizia così a proporsi come indispensabile non solo per la salvezza ma anche per tenere unita la società che l’insipienza e l’ingiustizia dei laici compromette alle radici.
La conciliazione, brevissima, col Moderno è vista da Zagrebelsky nel Concilio Vaticano II, in cui la Chiesa si rivolge a tutti gli uomini di buona volontà, e chiede di potere servire l’umanità, di difenderne la dignità e i diritti alla luce dell’insegnamento evangelico; il pluralismo delle opinioni politiche e sociali è accettato, e ci si apre anche all’idea della libertà religiosa. Ma, nota Zagrebelsky, il problema sta nel mai allentato rapporto della Chiesa con la Verità: un rapporto che la rende un ospite assai ingombrante nella democrazia, che può facilmente apparire alla Chiesa come nichilismo e instabilità, e destinata alla dissoluzione, se non interviene la Chiesa stessa, come una teologia civile o politica, a sostenerla.
Nell’ormai matura crisi dello Stato moderno, ecco quindi, da Giovanni Paolo II in poi, lo scambio di veste fra Chiesa e Stato - entrambi in gara per governare razionalmente gli uomini - , a cui allude il titolo del libro. Non più ostile in linea di principio alla politica della ragione, la Chiesa con Benedetto XVI (il discorso di Ratisbona) pretende di incarnare in sé la ragione umana al suo grado più alto, di essere l’erede della filosofia greca (intellettualmente preferita alla radice ebraica) e della riflessione filosofica non corrotta (cioè non protestante, non individualistica, non razionalistica): di essere insomma veramente razionale (non razionalistica), veramente laica (non laicista), veramente politica, oltre che veramente salvifica. Verità e ragione si unificano, nella teologia politica cattolica, contro la "dittatura del relativismo", a riaffermare un protettorato cattolico sulla società, della quale la Chiesa rivendica di essere l’origine e la sintesi, sempre operante e vigilante: ancora una volta, extra Ecclesiam nulla salus, fuori dalla Chiesa non c’è salvezza.
Questa struttura pedagogica agisce in nome della Verità (come anche l’ultima enciclica mostra già nel titolo), e quindi potenzialmente relega nell’errore chi non è d’accordo (costringendolo a vivere, appena tollerato, in un mondo dai cui principi è escluso, o nei quali è assimilato); il papa chiede che tutti si comportino come se Dio esistesse, e fosse il fondamento della società. Dopo la stagione conciliare di "credere senza appartenere", oggi i religiosi e anche parecchi laici (gli "atei devoti") vogliono che la politica si svolga all’insegna di un appartenere senza credere, che trasforma la cittadinanza democratica in una sorta di comunità a sfondo confessionale.
Zagrebelsky con forza non settaria pone in evidenza la difficoltà del dialogo fra laici e cattolici, su queste basi; la religione di cui la democrazia ha bisogno accetta infatti il relativismo, il pluralismo, mirando all’unica verità che la democrazia riconosce, l’umanistica affermazione della libertà, dell’uguaglianza, della responsabilità e dell’autonomia. Insomma, la democrazia chiede che gli uomini si comportino politicamente come se Dio non esistesse, e che trovino in se stessi - e non in fondamenti autoritari - la forza di essere liberi e giusti. La democrazia non ha paura di essere priva di fondazioni metafisiche; questo vuoto, infatti, è la condizione stessa della sua missione, che consiste nel far fiorire le contingenze particolari, i progetti di vita degli uomini e delle donne, in uguale dignità e libertà.
Dobbiamo quindi essere grati a Zagrebelsky per la chiarezza e la serenità con cui mostra la distanza - il non possumus laico, speculare ai diktat della Chiesa su tanti aspetti della vita sociale e politica - fra l’attuale posizione della Chiesa e la democrazia. Una distanza - il vero volto del dualismo occidentale - che, mentre indica l’esigenza di una radicale riscoperta delle caratteristiche imprescindibili della laicità, enfatizza la non sovrapponibilità fra politica e fede, fra sfera mondana e sacro, e mette in tensione libertà e obbedienza, rifiutando vecchi e nuovi fondamentalismi.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- CROLLO DEL REGIME, ATEO E DEVOTO: I PASTORI SI MANGIANO GLI AGNELLI E LE PECORE GIA’ PORTATE VIA.17 marzo 2010, di Federico La Sala
I PASTORI SI MANGIANO LE PECORE? E’ "UN FENOMENO RIDOTTO"!!!
SMS: “E’ vero che non si può accusare Berlusconi di abigeato (furto di bestiame) come titola Il Giornale. Ma è perché si è già portato via tutte le pecore”.
Regime, scene di un crollo
di Furio Colombo (il Fatto, 17.03.2010)
Un giorno qualcuno potrà dividere il regime Berlusconi (finora quindici anni ininterrotti) in tre periodi: quello del finto innocente, della negazione risoluta davanti ai fatti. Chi, io? ma io mi dimetterei immediatamente se fosse vero; quello in cui comincia lui e poi si guarda intorno smarrito come nel gioco “lo schiaffo del soldato”; quello della rivendicazione del fatto (o reato) compiuto come di un naturale e legittimo diritto. E la violenta denuncia: “Ci dobbiamo difendere”.
Ho detto “quindicennio ininterrotto” del regime Berlusconi nonostante due periodi (uno molto breve) di governo del centrosinistra a causa di due trovate di Berlusconi che spero gli storici non trascureranno. Il primo è di agire, in democrazia, con la trovata di sospendere la democrazia nel suo partito. Ciò gli dà uno spazio di libertà (a parte i soldi, a parte il conflitto di interessi) che i suoi avversari, appesantiti dalla necessità del consenso, non possono fronteggiare. Il secondo è di non governare mai e di fare opposizione, anzi campagna elettorale sempre. Per farlo deve arrecare danno - e lo fa - alla Repubblica. Il danno più grave è portarsi via - forse solo a causa del suo fascino leaderistico - potenti funzionari dello Stato, guardiani delle garanzie, verificatori e tutori della legalità, notai della vita istituzionale e della vita pubblica. Clamoroso è il caso dell’Autorità delle Comunicazioni.
Comincia il crollo del regime. Si vedono ovunque nel Pdl crepe, lacerazioni, perdite di rispetto. Le barzellette rimbalzano tra sms ed e-mail, tra l’Italia e il mondo. Quella che trovate oggi sul telefonino spiega: “E’ vero che non si può accusare Berlusconi di abigeato (furto di bestiame) come titola Il Giornale. Ma è perché si è già portato via tutte le pecore”.
Il fatto è che sta facendo crollare la Repubblica e con lui cadono nel vuoto i lavoratori senza fabbrica, i precari senza contratto, le aziende svendute senza padrone. Ma con lui cominciano a cadere anche pezzi importanti delle Istituzioni repubblicane. Per ogni regola è stato legiferato uno strappo. Per ogni strappo ci vuole un garante a rovescio. Un garante della illegalità. Sarà una lista lunga e un danno immenso.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- Da Locri ad Acerra, da Mazara del Vallo ad Agrigento: i vescovi di frontiera parlano: "Niente feste religiose nei comuni di mafia" (di Alessandra Ziniti).10 marzo 2010, di Federico La Sala
"Niente feste religiose nei comuni di mafia"
di Alessandra Ziniti (la Repubblica”, 10 marzo 2010)
Basta con la timidezza della Chiesa, basta con il sostegno ai politici che scendono a patti con la criminalità, basta con la falsa religiosità dei mafiosi. Dopo il documento della Cei sul Mezzogiorno, scendono in campo i presuli di trincea con due proposte forti: uno "sciopero elettorale" che sottolinei l’inadeguatezza della classe politica e l’abolizione delle feste religiose nei paesi in cui regna la criminalità mafiosa.
Da Locri ad Acerra, da Mazara del Vallo ad Agrigento: i vescovi di frontiera parlano dalle colonne di Famiglia cristiana e fanno autocritica per le timidezze del clero. Così Domenico Mogavero, vescovo di Mazara del Vallo e presidente del Consiglio per gli affari giuridici della Conferenza episcopale italiana, teme una Chiesa "icona dell’antimafia", che sollevi i singoli dalle proprie responsabilità e lancia il guanto di sfida per non lasciare lettera morta il recente documento della Cei sul Mezzogiorno. «Se dopo Pasqua nessuno ne parlerà, avremo fallito. Anche nelle nostre comunità - dice - occorre riflettere sul senso della parola terribile citata nel documento: collusione».
Monsignor Mogavero, che nei giorni scorsi era intervenuto con durezza sul decreto per la riammissione delle liste del Pdl per le Regionali e sulle leggi "ad personam", ora invita i fedeli ad azioni dimostrative: «Ogni comunità - propone - scelga un argomento in relazione alla situazione del proprio territorio e agisca: pizzo, usura, corruzione della politica, mafia devota che offre soldi per le feste popolari».
Invita invece ad uno sciopero elettorale don Riboldi. «Adesso tocca a noi - dice il vescovo di Acerra
 . Ai politici bisogna dire: o ascoltate la nostra voce, o non vi votiamo più. I cristiani al Sud devono
svegliarsi. Oggi sono continuamente assistiti. Il Mezzogiorno non è l’Italia, oggi si può dire che è
una zona annessa. Sarà brutto, ma è così. In 50 anni al Sud ho visto solo parole ed errori: fabbriche
nate e morte, terreni agricoli devastati, turismo in abbandono. Le mafie hanno avuto terreno fertile,
arato dallo Stato e da un sistema di corruzione e di collusione impostato con straordinaria efficacia.
E la gente ha subìto e si è rassegnata».
. Ai politici bisogna dire: o ascoltate la nostra voce, o non vi votiamo più. I cristiani al Sud devono
svegliarsi. Oggi sono continuamente assistiti. Il Mezzogiorno non è l’Italia, oggi si può dire che è
una zona annessa. Sarà brutto, ma è così. In 50 anni al Sud ho visto solo parole ed errori: fabbriche
nate e morte, terreni agricoli devastati, turismo in abbandono. Le mafie hanno avuto terreno fertile,
arato dallo Stato e da un sistema di corruzione e di collusione impostato con straordinaria efficacia.
E la gente ha subìto e si è rassegnata».Don Riboldi non risparmia dure critiche ai rappresentanti delle istituzioni: «La cultura dell’illegalità è stata diffusa dallo Stato. E non mi consola vedere che proprio chi ha contribuito alla logica della corruzione propone una legge contro di essa. La camorra domina i cuori e le menti. Impedisce ai ragazzini di andare a scuola, perché è lei che li vuole educare. Eppure tagliamo i fondi alla scuola. Bisogna tagliare i ponti, anche quelli tra le nostre chiese e la cultura mafiosa, che spesso dimostra di essere devota».
Un concetto che sta molto a cuore al vescovo di Agrigento, Francesco Montenegro, quello che a Natale tolse i Re Magi dal presepe lasciando la scritta: "respinti alla frontiera" come immigrati clandestini. Oggi dice: «Aboliamo ogni festa religiosa nei paesi dove si contano gli omicidi. Il sacro non basta per ritenersi a posto se poi nessuno denuncia e la cultura mafiosa è l’unica ammessa». E Giuseppe Morosini, vescovo di Locri, ammette le responsabilità: «Bisognava essere più chiari, anche nelle responsabilità di una Chiesa a volte troppo timida».
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- IN CERCA DELL’ANIMA (di Umberto Galimberti -Se gli italiani perdono l’anima)8 marzo 2010, di Federico La Sala
Se gli italiani perdono l’anima
di Umberto Galimberti (la Repubblica, 8 marzo 2010)
Anche i popoli hanno un’anima, o come dicono i tedeschi un Geist, uno "spirito" che li caratterizza e li rende riconoscibili. "Qual è l’anima degli italiani oggi?" chiede il saggista e romanziere Franco Scaglia al vescovo di Terni Vincenzo Paglia, presidente della Conferenza Episcopale Umbra, nonché consigliere spirituale della Comunità di Sant’Egidio.
La domanda percorre l’intero libro-intervista In cerca dell’anima (Piemme, pagg. 290, euro 19), che già nel titolo lascia intendere che gli italiani un’anima, in cui potersi riconoscere come nazione, società e stato, ancora non l’hanno trovata, perché, dopo l’unificazione di storie, culture, società, e soprattutto lingue diverse avvenuta 150 anni orsono, è mancato, come vuole l’espressione di Eugenio Scalfari (che spesso ritorna nelle pagine del libro come interlocutore laico ai discorsi che prendono le mosse da una visione religiosa del mondo), agli italiani è mancato un "federatore". Lo fu Mussolini in modo "approssimativo e superficiale in difesa di valori ingiusti", lo furono la Dc e il Pci "che lavorarono alla rinascita e alla ricostruzione dell’Italia". Dissolte queste due forze, oggi a federare gli italiani è l’"inerzia" quando non addirittura il cupio dissolvi "che ha afferrato le coscienze ancor prima delle menti".
L’inerzia infiacchisce l’anima, che più non si appassiona e non sogna. Non sognano i giovani a cui il futuro non appare più come una promessa ma come una minaccia, non sognano gli adulti che sembrano essersi consegnati a quell’unico generatore simbolico di tutti i valori che è il denaro, non sognano i vecchi a cui è stata allungata la vita solo per riempirla di vuoto. L’inerzia è come un fiume che tutto ingloba e che pigro scorre verso un mare lontano, senza più la spinta della sorgente, le cascate dei dislivelli, i vortici degli affluenti. A rallentare il suo cammino annoiato e triste è solo il suo ristagnare nelle anse sempre più inquinate, paludose e piatte.
Questo infiacchimento spirituale più non conosce ideali forti in grado di affrontare i problemi che la globalizzazione e la tecno-scienza ogni giorno ci propongono: dalla bioetica alla pace, dalla giustizia all’immigrazione, dalla conservazione dell’ambiente alla lealtà fiscale per la costruzione del bene comune. Immersi nel grigio della rassegnazione, gli italiani oggi sono più tristi che felici e, incapaci di guardare il futuro, vivono la "dittatura del presente" dove l’attenzione è rivolta più ai sondaggi che ai movimenti della storia, in un mondo che cambia rapidamente intorno a noi, anche senza la nostra collaborazione, e soprattutto senza che noi lo si sappia interpretare, col rischio che alla fine si cambi in un mondo senza di noi.
Per far emergere il nostro stato di inerzia il libro fa un frequente richiamo al ’68, ricordato dai media con una "sorta di pudore o di fastidio o di lontana e svagata memoria". Senza reticenze nel libro se ne fa una significativa rivalutazione, non tanto per i contenuti, quanto per la passione che esprimeva e che percorreva trasversalmente la società, anche quella ecclesiastica. Allora era difficile parlare di inerzia. C’era una grande voglia di futuro e soprattutto di futuro collettivo, perché a differenza di oggi non c’era chi stava accanto all’altro senza solide relazioni. C’era voglia di comunità e non quelle solitudini di massa, ciascuno col suo ipod nelle orecchie o col video del computer davanti agli occhi per comunicare, dietro una maschera, con altre maschere che nascondono la propria identità.
E tutto questo in un’Italia cattolica che ha il suo centro nella "comunione" che vuol dire comunità, soccorso al prossimo in quelle forme puntualmente elencate nel "Discorso della Montagna" pronunciato da Gesù. Ma già sappiamo che la chiesa del potere non coincide con la chiesa dell’amore, anche se la chiesa dell’amore probabilmente non sopravvivrebbe senza la chiesa del potere. Ma in quest’Italia tutta rifugiata nel privato, senza solidarietà, senza compassione, senza commozione per il proprio simile più svantaggiato, non sarebbe tempo di meno enunciazioni di principio e di più frequenti richiami all’amore del prossimo? Non è questo il grande comandamento del cristianesimo che chiede di scorgere il volto di Dio nel prossimo che non puoi evitare di incontrare lungo la via?
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- Siamo un Paese sull’orlo del Baratro (di Nadia Urbinati)5 marzo 2010, di Federico La Sala
Perché siamo un Paese sull’orlo del Baratro
di Nadia Urbinati (la Repubblica, Repubblica 5.3.10)
Il nostro paese è sul crinale di un baratro politico e criminale e non sarà questa maggioranza a ripristinare la fiducia nella politica e nei partiti. Come altre volte in passato, un’altra Italia sarà necessaria a rimediare al disastro di una violazione sistematica e proterva della legalità e del civismo, nella pubblica amministrazione come nella società civile (la quale non è per nulla innocente). Questa maggioranza non lo può fare per ragioni che sono politiche prima che giudiziarie, connaturate ad essa e al messaggio che ha in questi anni confezionato e propagandato per creare una sua solida base elettorale.
All’origine della difficoltà del premier e del suo governo di varare lo sbandierato provvedimento anti-corruzione c’è questa endogena incapacità (e impossibilità) di distinguere tra interesse e giustizia, di vedere la corruzione e soprattutto di rinunciare ai suoi sperimentati vantaggi elettorali. Questa incapacità e impossibilità è contenuta nel messaggio contraddittorio che viene da Palazzo Chigi. Infatti, se il sistema di malaffare che ci rende ancora una volta così vergognosamente popolari nel mondo è davvero opera dei proverbiali quattro gatti e di birbantelli, allora che bisogno c’è di un intervento urgente? Non ce n’è proprio. Ma allora, perché dar voce a questa nuova fanfara dell’emergenza quando nel frattempo si rappresenta lo stato delle cose in un modo che non giustifica alcuna impellenza?
Una spiegazione facile è che l’idea del fare pulizia è molto popolare; e quando si è a ridosso di elezioni e si vuole, si deve, incrementare la propria popolarità. La propaganda della pulizia può pagare, e soprattutto lo può per un tempo che si vuole limitato. Un anno e mezzo fa, per la precisione nell’autunno del 2008, il presidente del Consiglio aveva annunciato la creazione di una nuova unità speciale che avrebbe dovuto eliminare la corruzione nelle amministrazioni pubbliche e garantire più trasparenza. La task-force non doveva avere il compito di polizia, ma di "intelligence". Proponendo una politica dell’emergenza per fronteggiare l’emergenza corruzione, il capo del governo parlò allora della corruzione come di una antica patologia nel nostro paese.
Mai parole furono più vere, eppure chi si ricorda oggi di quella task-force? La propagandata fa rumore e passa, non si sedimenta nella memoria. E la nuova ondata propagandistica mira a fare proprio questo: mostrare che si vuol "fare"; usare una strategia moralizzante per creare una nebbia di malaffare nella previsione che, finita la campagna elettorale, l’oblio del circo mediatico che macina tutto così in fretta da non lasciare quasi traccia farà il suo corso. Proprio come la task-force di un anno e mezzo fa, tra qualche mese ci si ricorderà a mala pena di questo can can di nomi. Ma c’è una ragione ancora più radicale che suggerisce di diffidare di questi propositi di mettere in piedi un’impresa di pulizia morale, una ragione sintetizzabile in una domanda: come può un’oligarchia che con tempo e fatica si è consolidata in questi anni di politica berlusconiana fare leggi contro se stessa e per auto-liquidarsi? Ecco allora che si comprende l’uso dell’espressione "birbantelli": pochi ed esemplari agnelli sacrificali serviranno a chiudere presto il caso e a rimettere in moto la macchina senza troppe perdite collaterali. Entrambe queste ragioni - la propaganda della moralizzazione e l’esemplarità del fare - inducono a pensare che non siamo proprio a un ritorno al passato, ma semmai a una escalation e in effetti a un grande peggioramento rispetto a mani pulite atto primo. Poiché allora un’intera classe dirigente fu spazzata via, non solo alcuni birbanti (la tattica dei "mariuoli" di Bettino Craxi allora non funzionò); nessuno aveva il potere di creare salvagenti perché la fine della Guerra fredda aveva reso quella vecchia oligarchia arrugginita, vulnerabile e nuda. Ma questa nuova oligarchia ha costruito i suoi anti-corpi in un ambiente ben diverso, un ambiente non protetto da alleanze internazionali; essa è quindi più forte, più radicata e resistente di quella che vedemmo naufragare diciotto anni fa. Infatti, oggi esiste un’oligarchia che non è ancora sotto accusa da parte dell’opinione pubblica perché ha nel frattempo costruito una macchina per creare un’opinione pubblica addomesticata e recettiva ai disvalori pubblici, grazie in primo luogo all’uso monopolistico dei media e alla pratica sistematica di nascondimento del vero.
Propaganda ed esemplarità si alimentano a vicenda: dunque i proclami propagandistici sulle poche mele marce e la promessa di un decreto anti-corruzione affinché l’acqua torni presto nel proprio alveo e scorra come sempre. Ecco il paradosso: una politica che si presenta come moraleggiante e che è contemporaneamente sovvertitrice di ogni valore legale ed etico. Queste due dimensioni si sono per anni alimentate a vicenda generando quel mostruoso connubio di attenzione morbosa dei media e di altrettanto sconvolgente immutabilità delle cose, con la conseguenza di un peggioramento radicale della situazione legale e etica. È per queste ragioni che ci troviamo su un baratro dal quale questa maggioranza non può salvarci.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- «Non si smette mai di essere preti. Né mafiosi», ripeteva spesso Giovanni Falcone (di Massimiliano Amato - Mafia e preti, un libro di Isaia Sales racconta come siano «vicini»).4 marzo 2010, di Federico La Sala
Mafia e preti, un libro di Isaia Sales racconta come siano «vicini»
di Massimiliano Amato (l’Unità, 4 marzo 2010)
«Non si smette mai di essere preti. Né mafiosi», ripeteva spesso Giovanni Falcone, sottolineando come lo specifico criminale che da un secolo e mezzo marchia a fuoco la vita, l’economia e la società di quattro regioni italiane sia in realtà una religione, che dal cattolicesimo prende in prestito i riti, il linguaggio, l’espressività liturgica. E tuttavia, il legame non è fatto solo di simboli: Cosa Nostra si richiama ai Beati Paoli, la camorra alla Guarduna, confraternita esistente a Toledo sin dal XV secolo, la ‘ndrangheta ai tre arcangeli della tradizione. No, c’è di più, qualcosa che va oltre la sintassi dell’esteriorità, nel rapporto, mai investigato a sufficienza, tra Chiesa e grandi organizzazioni criminali.
Nel suo documentatissimo «I preti e i mafiosi», Isaia Sales, tra i più lucidi studiosi dei fenomeni mafiosi, docente di Storia della criminalità organizzata nel Mezzogiorno d’Italia al Suor Orsola Benincasa di Napoli, mette subito le cose in chiaro. Innanzitutto, sostiene Sales, c’è una gravissima condotta omissiva, addebitabile ad un «giusnaturalismo di sangue», che la cultura cattolica mutua da quella mafiosa (e viceversa: l’esistenza di altre Giustizie oltre a quella dei Tribunali) in opposizione al positivismo del diritto statuale. La Chiesa, è la tesi di fondo del libro, non ha mai alzato un argine - né dottrinale, né teologico, né morale - contro il proliferare delle mafie. Ne ha anzi tollerato (quando non fiancheggiato) il radicamento, concimandolo talvolta con una sconcertante sintonia valoriale: le comuni posizioni in materia di morale sessuale, o in politica, dove l’anticomunismo è consustanziale.
La carica antistatuale della Chiesa e quella delle organizzazioni criminali hanno finito spesso col convergere. Al punto che dal martirologio cristiano sono espunti gli eroismi, in nome della fede e di un credo fondato sull’anti-violenza (l’esatto opposto, in teoria, dell’ethos mafioso), di decine di preti uccisi dalle mafie, di cui poco o punto si sa. Solo recentemente, con i sacrifici di don Pino Puglisi, fatto ammazzare come un cane a Brancaccio dai fratelli Graviano, e di don Peppe Diana, eliminato a Casal di Principe dai sicari di Sandokan, è emersa una coscienza nuova, tuttavia confinata a pochi casi isolati di preti - coraggio. Le eccezioni. E così, nel paese degli atei devoti, l’archetipo mafioso è quello del fervido credente criminale efferato, che si fa il segno della croce prima di ordinare un omicidio o di premere il grilletto: i covi dei superlatitanti sono sempre zeppi di immagini e testi sacri, dalla Bibbia al Vangelo, i boss vengono maritati in chiesa, confessati, comunicati e, se muoiono nel loro letto, ricevono l’estrema unzione.
La parte più suggestiva del saggio è quella in cui Sales ipotizza, non senza riferimenti «alti», una sorta di «complementarietà» tra il fenomeno mafioso e l’affermazione di alcuni precetti cristiani: dalla teoria della Confessione di Sant’Alfonso, a quella del criminale pecorella smarrita, un filo sottile tiene insieme il comportamento deviante e l’esigenza cattolica della «redenzione», in cui il valore della dissociazione prevale su quello del pentimento. Anche in questo caso, i due antiStato s’incontrano.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- La corruzione soffoca la democrazia (di Aldo Schiavone)18 febbraio 2010, di Federico La Sala
IL SONNO DELLA RAGIONE COSTITUZIONALE GENERA MOSTRI.
La corruzione soffoca la democraziadi Aldo Schiavone (la Repubblica, 18 febbraio 2010)
Sembra che la percezione che gli italiani stanno sviluppando della corruzione esistente nel proprio Paese abbia raggiunto un’intensità mai prima toccata. Ed è l’irrimediabile buio di questa cupa autorappresentazione, quello che più colpisce nel rapporto del Procuratore Generale presso la Corte dei conti, ancor più delle cifre allarmanti da lui squadernate, che vedono la corruzione crescere del 229%.
Una nazione in via di dissolvimento morale, ormai in balia di una disastrosa deriva di comportamenti: questo dunque saremmo, veramente. Dobbiamo saper guardare negli occhi il pericolo che abbiamo di fronte. Se questa immagine fosse realistica - e molto lascia pensare purtroppo che lo sia - staremmo correndo, tutti, un incalcolabile rischio: la completa decomposizione del nostro tessuto civile.
Entro certi limiti, corruzione e democrazia possono coesistere: la storia ha moltiplicato di continuo esempi di questa precaria convivenza, dall’Atene o dalla Roma classiche all’America contemporanea. Le condizioni perché questo accada sono due, fra loro legate: una misura nella diffusione del male, e gli anticorpi che la sua presenza riesce ad attivare. In altri termini, che essa non arrivi a provocare, superata una soglia, l’abdicazione etica di un’intera società, quel generale oscuramento delle coscienze per cui la quantità di illegalismo circolante trasforma la qualità del giudizio morale su di esso, presentandolo come regola universale di condotta.
Se si verifica questa sorta di collasso generale, è la stessa democrazia a non reggere più: perché non esistono più interesse generale né bene comune - ma solo una somma feroce di arbitri individuali che non riconosce altro se non la sua immediata soddisfazione.
Siamo a questo punto? E qual è la causa di tutto ciò? E soprattutto, possiamo ancora porvi rimedio? Per cercare di capire dobbiamo rinunciare a qualunque retorica moralistica. La storia etica del Paese è quella che è: mentre altri, in Europa, costruivano lo Stato, noi abbiamo avuto la Controriforma, e questo ha provocato conseguenze che scontiamo ancora oggi. Ma dobbiamo tuttavia evitare di usare il nostro passato come un alibi: e di rifugiarci dietro i tratti più fragili e incompiuti della nostra slabbrata modernità per assolverci dalle nostre colpe.
C’è dell’altro nella notte in cui stiamo scivolando, e di molto più recente - su cui si può intervenire. E questo "altro" ci riporta alla politica. A me pare infatti che la crisi morale del Paese sia in primo luogo il frutto avvelenato della forma che ha assunto quella che ormai abbiamo convenuto di chiamare la "transizione italiana" - il quindicennio di trasformazioni sul quale ha messo il suo sigillo la leadership di Silvio Berlusconi.
In questi anni abbiamo assistito senza fiatare a una vera e propria orgia ideologica di antipolitica, in nome dell’efficienza, della deregolazione e dell’onnipotenza del mercato, che ha contribuito in modo determinante a recidere quei rapporti fra cultura e politica, fra politica e idee, e anche fra politica ed etica, che, bene o male, avevano alimentato per decenni la nostra vita pubblica, e avevano rappresentato il meglio della nostra storia repubblicana. Con la scusa di liberarci delle ideologie, abbiamo anche rinunciato ai pensieri, ai progetti, ai grandi disegni. E abbiamo ridotto così la funzione parlamentare e quella di governo a pure routine di potere, senza respiro, senza slancio morale, senza ricambio, senza più uno straccio di elaborazione intellettuale.
Ma una politica così rinsecchita - solo mestiere e potere - in un paese con le nostre storiche fragilità, privo di un’autentica eredità di etica pubblica, si offre disarmata alla corruzione, quando non addirittura la determina, in un gioco perverso di rimandi. E comunque non ha gli strumenti per combatterla, non suscita anticorpi, ma si rassegna, scambiando la resa per realismo. Senza dubbio, questo stato di cose non è solo l’esito del berlusconismo: ingigantiremmo l’ombra dell’avversario, se lo ritenessimo. Hanno pesato molti elementi nella caduta, anche ereditati dall’ultima stagione dell’epoca democristiana, e anche non specificamente italiani. L’onda ultraliberista dell’ultimo ventennio ha ridotto dovunque spazi e motivazioni dell’agire politico. Ma la nostra transizione vi ha aggiunto un che di protervo, di arrogante e insieme di meschino; starei per dire: di volgare, che è proprio l’aria del tempo.
È dunque dalla politica e dalla sua riforma che bisogna partire: questa è la più urgente delle scadenze, e anche la destra farebbe bene a capirlo. L’inevitabile gioco di specchi fra politica e società - a lungo andare, ogni corpo sociale ha la politica che si merita - può essere spezzato qualche volta: e può aprirsi una nuova stagione.
Io credo che una rinascita morale del Paese sia ancora possibile - non un’Italia improvvisamente di anime belle, ma un’Italia che riesca a capire che senza un salto di qualità nei suoi comportamenti individuali e collettivi siamo tutti perduti; non un’Italia "migliore", ma almeno più sicura e matura.
Credo per ò che senza una rigenerazione della politica, senza restituirle la sua vocazione propriamente moderna - che è quella di cambiare il mondo - non potremo mai farcela. Ed è intorno a questo nodo, che si apre per la sinistra un territorio sconfinato. La cosiddetta questione morale è oggi, per prima cosa, una questione di politica: i suoi contenuti ideali, il suo stile, il suo immedesimarsi nella democrazia. È da qui che si deve partire.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- IL PAPA, RUINI, LA RIVOLTA DEGLI ATEI DEVOTI - E IL SILENZIO DEI GRANDI PORPORATI (di Marco Politi).11 febbraio 2010, di Federico La Sala
Il Papa, Ruini e la rivolta degli atei devoti
di Marco Politi (il Fatto Quotidiano” , 11 febbraio 2010)
Sulla Curia attonita è calata la parola di Benedetto XVI in difesa di Bertone e di Vian. Ma ora è la rivolta degli atei devoti. Ferrara sbeffeggia il comunicato e il Giornale irride: “Il Papa fuori dalla grazia di Dio”.
Eccoli i rimasugli imprevisti e velenosi del lungo regno del cardinal Ruini, che dopo il crollo della Dc pensò di posizionare la Chiesa al centro del gioco politico. Scegliendosi alleati in campo cosiddetto “laico”, difensori improvvisati di un cristianesimo senza Cristo, araldi dell’identità cattolica d’Italia nel nome di un Vangelo agitato come libretto di Mao. Contro gli “uomini di Bertone” lancia frecciate sprezzanti Giuliano Ferrara, evangelista del pensiero ratzingeriano e infaticabile combattente a fianco delle gerarchie ecclesiastiche contro la 194 o i Dico o il testamento biologico.
La smentita vaticana, motteggia, è “squillante e molto tardiva”, di una “violenza verbale inconcludente”, stilata per “silenziare e mettere alla gogna l’informazione laica, libera, amica che denuncia il fattaccio”.
Doveva succedere prima o poi. Se la Chiesa, durante il ventennio ruiniano, è stata gestita come soggetto partitico, manovrata come un Comitato centrale per organizzare astensioni ai referendum, animare manifestazioni di piazza contro disegni di legge, intimidire governi... doveva finire che i mass media la considerassero alla stregua di un partito come gli altri, con le sue fazioni e i suoi intrighi, e che gli “alleati” di ieri si lanciassero a gettare benzina sulle divisioni interne come succede nel teatrino politico.
L’iperpoliticizzazione ruiniana ha condotto la Chiesa a perdere la sua “diversità”. Perché una cosa è combattersi nei ranghi ecclesiali su temi come il Concilio, il negazionismo, la sessualità, il rapporto con l’islam, altro è lasciare che venga proiettata l’immagine di corvi che portano pacchi maleodoranti di nido in nudo.
Un tale degrado d’immagine non si era mai visto in epoca contemporanea. E il verminaio è stato prodotto proprio da coloro che la strategia ruiniana aveva eletto come punta di diamante dell’inf luenza cattolica in partibus infidelium.
Gli elefantini allegramente neo-integralisti, “alla laica”, il cardinale Ruini, da presidente della Cei, se li era bene allevati. Facevano da pendant perfetto agli arditi ciellini. Gli ossequienti alla Ferrara tornavano utili per dare smalto al Comitato Scienza e Vita (sapiente mix di cattolici e agnostici), messo in piedi dietro le quinte dall’allora dirigenza Cei, per imporre la linea astensionista al referendum sulla fecondazione assistita.
Tornavano utili per predicare contro le “stragi” dell’aborto e buttare bombe intellettuali contro l’I l l u m i n ismo, nell’esaltazione delle perenni “radici cristiane” dell’Italia e dell’E u ro p a Nel 2006 al convegno nazionale della Chiesa italiana a Verona il cardinal Ruini incoraggiò Benedetto XVI all’e l ogio degli atei devoti, portati in palmo di mano perché erano testimoni dell’“insuf ficienza di una razionalità chiusa in se stessa e di un’e t ica troppo individualista”. Elogiati perché sensibili alla “gravità del rischio di staccarsi dalle radici cristiane della nostra civiltà”. Erano - s c a ndì Benedetto XVI - una “grande opportunità” che la Chiesa italiana doveva “cogliere”.
Si è visto. In queste settimane la “grande opportunità” ha armato la canizza assieme ai ciellini e ai falchi ruiniani contro l’Osservatore Romano per mettere al tappeto il cardinale Bertone. E adesso che il Papa (malvolentieri, peraltro) è dovuto intervenire di persona, Ferrara demolisce il comunicato, smontandone la “violenza verbale inconcludente ” e accusando nuovamente Vian di avere avvalorato la “cacciata di uno stimato giornalista cattolico” come Boffo. Mentre il G i o rnale, in passato estremamente rispettoso nei confronti della Chiesa, invita il Papa a informarsi “in tre minuti” della fondatezza della condanna per molestie di Boffo. In questo girotondo di bande il mondo dei fedeli cattolici appare ferito, disgustato e disorientato.
Alcuni punti fermi sono tuttavia acquisiti. La “velina”, che Feltri pubblicò l’agosto scorso, è nata in ambienti cattolici milanesi: avversari di Boffo per la concentrazione di potere avvenuta nelle sue mani come zar del sistema mediatico cattolico (Avvenire, la televisione della Cei, la rete delle radio cattoliche) e come portavoce politico di Ruini ormai in pensione. La “velina” è stata spedita in primavera, con buste e francobolli vaticani, all’indirizzo di circa duecento vescovi. Sarebbe morta nei cassetti se Feltri non l’avesse messa in pagina per punire Boffo, reo di avere criticato su Avvenire Berlusconi per l’affare escort. Il paradosso è che Boffo, solo premuto dalla base cattolica e con l’assenso del nuovo presidente della Cei Bagnasco, aveva attaccato il premier. Prima dello scandalo aveva sempre seguito la linea Ruini favorevole al centro-destra. Anche Bertone, il “nemico” di Ruini, è peraltro favorevole al centrodestra. Perciò fece intervenire ai primi di settembre Vian con un’intervista al Corriere della Sera per bacchettare l’Avvenire: proprio per salvaguardare i buoni rapporti istituzionali con Berlusconi. Un gioco degli specchi.
Emarginato Boffo, si sono mossi ora a gennaio gli atei devoti e manipoli ciellini e ruiniani per “ridare l’onore” all’ex direttore dell’Avvenire e mettere in difficoltà Bertone diventato troppo potente in Vaticano. Ma nel polverone del campo di battaglia si stagliano alcuni fatti precisi. Feltri dichiara chiuso il caso e annuncia che non “rivelerà” nomi. (E Berlusconi, con le elezioni incombenti, dichiara d’i mprovviso di essere tanto dispiaciuto per gli attacchi portati a Boffo a mezzo stampa).
Bagnasco continua in silenzio la sua “linea pastorale” né con Bertone né con Ruini. E lo scarno comunicato Cei testimonia la volontà di non mettere neanche un dito nel verminaio. I grandi porporati della Chiesa italiana - Scola, Sepe, Tettamanzi, futuri protagonisti del Conclave - tacciono, per mostrarsi superiori a queste miserie. E i cardinali di Curia stranieri sospirano: “Robe tutte italiane”.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- IL PAPA IL POTERE E IL VELENO DEI CARDINALI (di Vito Mancuso).4 febbraio 2010, di Federico La Sala
Il Papa il potere e il veleno dei cardinali
di Vito Mancuso (la Repubblica, 4 febbraio 2010)
Sarà vero che il documento calunnioso sul direttore di Avvenire è stato consegnato al direttore del Giornale niente di meno che da Giovanni Maria Vian, direttore dell’Osservatore Romano, dietro esplicito mandato del Segretario di Stato vaticano cardinale Bertone, numero due della gerarchia cattolica a livello mondiale? E che l’insigne porporato si è servito di Vian e di Feltri per colpire il direttore di Avvenire in quanto espressione di una Conferenza Episcopale Italiana a suo avviso troppo indipendente e troppo politicamente equidistante? E che quindi il vero bersaglio del cardinal Bertone era il collega e confratello cardinal Bagnasco? Sarà vera la notizia di questo complotto intraecclesiale degno di papa Borgia e di sua figlia Lucrezia?
Come cattolico spero di no, ma come conoscitore di un po’ di storia e di cronaca della Chiesa temo di sì. Del resto fu l’allora cardinal Ratzinger, poco prima di essere eletto papa, a parlare di "sporcizia" all’interno della Chiesa (25 marzo 2005). Qualcuno in questi cinque anni l’ha visto fare pulizia? Direi di no, e forse non a caso proprio ieri egli ha parlato di «tentazione della carriera, del potere, da cui non sono immuni neppure coloro che hanno un ruolo di governo nella Chiesa». Quindi è lecito pensare che la sporcizia denunciata dal Papa abbia potuto produrre l’abbondante dose di spazzatura morale di cui ora forse veniamo a conoscenza.
Naturalmente come siano andate davvero le cose è dovere morale dei diretti interessati chiarirlo. Con una precisa consapevolezza: che gli storici un giorno indagheranno e ricostruiranno la verità, la quale alla fine emerge sempre, chiara e splendente, perché non c’è nulla di più forte della verità. Le bugie hanno le gambe corte, dice il proverbio, e questo per fortuna vale anche per il foro ecclesiastico. Siamo in un mondo che è preda di una devastante crisi morale. Le anime dei giovani sono aggredite dalla nebbia del nichilismo. Parole come bene, verità, giustizia, amore, fedeltà, appaiono a un numero crescente di persone solo ingenue illusioni.
La missione morale e spirituale della Chiesa è più urgente che mai. E invece che cosa succede? Succede che la gerarchia della Chiesa pensa solo a se stessa come una qualunque altra lobby di potere, e come una qualunque altra lobby è dilaniata da lotte fratricide all’interno. Certo, nulla di nuovo alla luce dei duemila anni di storia e di certo nessun cattolico sta svenendo disilluso. Rimane però il problema principale, e cioè che oggi, molto più di ieri, il criterio decisivo per fare carriera all’interno della Chiesa non è la spiritualità e la nobiltà d’animo ma il servilismo, e che la dote principale richiesta al futuro dirigente ecclesiastico non è lo spirito di profezia e l’ardore della carità, ma l’obbedienza all’autorità sempre e comunque.
Eccoci dunque al tipo umano che emerge dalle cronache di questi giorni: il cosiddetto "uomo di Chiesa". È la presenza sempre più massiccia di persone così ai vertici della Chiesa che mi rende propenso a credere che le accuse alla coppia Bertone-Vian siano fondate. Impossibile però non vedere che nella storia ecclesiastica misfatti di questo genere contro gli elementari principi della morale ne sono avvenuti in quantità. Anzi, che cosa sarà mai un foglietto calunnioso passato al direttore di un giornale laico per far fuori il direttore del giornale cattolico, rispetto alle torture e ai morti dell’Inquisizione? È noto che il potere temporale dei papi si è basato per secoli su un documento falso quale la Donazione di Costantino, attribuito all’imperatore romano e invece redatto qualche secolo dopo dalla cancelleria papale.
Che cosa concludere allora? Che è tutto un imbroglio? No, il messaggio dell’amore universale per il quale Gesù ha dato la vita non è un imbroglio. L’imbroglio e gli imbroglioni sono coloro che lo sfruttano per la loro sete di potere, per la quale hanno costruito una teologia secondo cui credere in Gesù significa obbedire sempre e comunque alla Chiesa. Secondo l’impostazione cattolico-romana venutasi a creare soprattutto a partire dal concilio di Trento la mediazione della struttura ecclesiastica è il criterio decisivo del credere. Lo esemplificano al meglio queste parole di Ignazio di Loyola rivolte a chi «vuole essere un buon figlio della Chiesa»: «Per essere certi in tutto, dobbiamo sempre tenere questo criterio: quello che io vedo bianco lo credo nero, se lo stabilisce la Chiesa gerarchica». Ne viene che il baricentro spirituale dell’uomo di Chiesa non è nella propria coscienza, ma fuori di sé, nella gerarchia. I "principi non negoziabili" non sono dentro di lui ma nel volere dei superiori, e se gli si ordina di scrivere la falsa donazione di Costantino egli lo fa, e se gli si ordina di torturare gli eretici egli lo fa, e se gli si ordina di appiccare il fuoco alle fascine per il rogo egli lo fa, e se gli si ordina di passare un documento falso egli lo fa. Ecco l’uomo di Chiesa voluto e utilizzato da una certa gerarchia.
È questa la sporcizia a cui si riferiva il cardinal Ratzinger nel venerdì santo del 2005? È questo il carrierismo denunciato ieri da Benedetto XVI? Il messaggio di Gesù però è troppo importante per farselo rovinare da qualche personaggio assetato di potere della nomenklatura vaticana. Una fede matura sa distaccarsi dall’obbedienza incondizionata alla gerarchia e se vede bianco dirà sempre che è bianco, anche se è stato stabilito che è nero. Né si presterà mai a intrighi di sorta "per il bene della Chiesa". La vera Chiesa infatti è molto più grande del Vaticano e dei suoi dirigenti, è l’Ecclesia ab Abel, cioè esistente a partire da Abele in quanto comunità dei giusti. In questa Chiesa quello che conta è la purezza del cuore, mentre non serve a nulla portare sulla testa curiosi copricapo tondeggianti, viola, rossi o bianchi che siano.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. AL GOVERNO DELLA CHIESA UN PAPA CHE PREDICA CHE GESU’ E’ IL FIGLIO DEL DIO "MAMMONA" ("Deus caritas est") E AL GOVERNO DELL’ **ITALIA** UN PRESIDENTE DI UN PARTITO (che si camuffa da "Presidente della Repubblica") e canta "Forza Italia" (1994-2009). ---- Lo Ior e il Vaticano (di Luigi Cancrini).30 gennaio 2010, di Federico La Sala
Lo Ior e il Vaticano
risponde Luigi Cancrini (l’Unità, 30.01.10)
Non posso fare a meno di ringraziare Margherita Hack che a «Otto e mezzo» ci ha ricordato che in Italia oggi comanda un Vaticano che, francamente, non mi pare intenzionato a diffondere il messaggio evangelico sull’eguaglianza degli uomini, ma quello più redditizio del profitto economico.
Silvana Stefanelli
RISPOSTA
In «Qualunque cosa succeda» (Sironi editore), dedicato alla memoria di suo padre Giorgio, Umberto Ambrosoli ha lucidamente ricostruito l’imbroglio che Sindona aveva organizzato ai danni del nostro paese. C’erano, con lui, la Democrazia Cristiana di Andreotti e lo Ior, la banca del Vaticano legata alla P2 che tanta parte ha avuto nella vicenda politica italiana del secondo dopoguerra. Margherita Hack fa bene a ripeterlo, c’è una continuità impressionante fra quello che accadeva allora e quello che accade oggi che a capo del Governo c’è un uomo che nella P2 ha iniziato la sua carriera. Di lui infatti il Vaticano (che la rappresenta ma, per fortuna, non è la Chiesa) ha sfacciatamente auspicato e favorito (scendendo in capo col Family Day) il ritorno al potere. Continuando a godere senza problemi di coscienza i frutti di questo appoggio: la spregiudicatezza della finanza tanto cara agli uomini (o ai prelati) dello Ior, la tutela degli insegnanti di religione nominati dai Vescovi nella scuola pubblica e la difesa di leggi (l’ultima è il testamento biologico) ipocritamente confessionali. Come con la Dc di Sindona.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- EMERGENZA NAZIONALE (di Carlo Federico Grosso)30 gennaio 2010, di Federico La Sala
Emergenza nazionale
di CARLO FEDERICO GROSSO (La Stampa, 30/1/2010)
Fra politica e magistratura sono tempi di grande tensione. Ma ieri, all’inaugurazione solenne dell’anno giudiziario in Cassazione davanti al parterre delle alte cariche dello Stato, i toni sono stati misurati e composti. È bene che sia stato così, anche se i problemi esistono, sono profondi e non sono certamente le chiacchierate di un mattino a dissiparli.
Il Primo Presidente e il Procuratore Generale della Cassazione hanno pronunciato parole condivisibili. Sullo sfondo vi era, ovviamente, il tema del «processo breve» appena votato in Senato dalla maggioranza con l’intento di salvaguardare il premier dai processi in corso. Entrambi i due alti magistrati hanno sottolineato che un processo rapido costituisce, comunque, esigenza imprescindibile di ogni società civile. Ma hanno soggiunto che l’obiettivo non può essere conseguito tramite leggi di giornata, asfittiche e di corto raggio; deve essere invece perseguito attraverso riforme organiche di vasto respiro, accompagnate da un potenziamento delle risorse umane e materiali destinate all’esercizio della giurisdizione.
Parole ineccepibili, che il mondo del diritto pronuncia da anni, ma che, per anni, sono state ignorate dalla politica che, giorno dopo giorno, ha lasciato che la giustizia s’impoverisse. Ha ragione il Primo Presidente a denunciare l’intollerabilità di una situazione che, nella gerarchia mondiale in materia di giustizia, vede l’Italia solo al centocinquantesimo posto, al pari del Gabon, della Guinea e dell’Angola. Ma occorre ricordare che, se ciò è capitato, è soprattutto colpa di chi, al governo e in Parlamento, a tutto ha pensato tranne che a rendere efficiente la macchina giudiziaria dotandola, per legge, dei mezzi e degli strumenti necessari.
Ed occorre, ulteriormente, ricordare, ancora una volta con le parole del Primo Presidente, che senza un disegno riformatore di ampio respiro della legislazione penale e dell’organizzazione giudiziaria sarebbe vano pretendere di «imporre ex lege una risposta di giustizia che possa in concreto essere breve ed efficace a fronte di un crescente carico di domanda». In altre parole, prescrivere per legge un processo breve senza dotare gli addetti dei mezzi e degli strumenti idonei a rispettare i tempi stabiliti, significa introdurre, semplicemente, una mannaia destinata a cancellare processi, condanne, soluzioni giudiziarie. Un disastro ulteriore, e forse definitivo.
Il ministro della Giustizia, stando alle notizie di agenzia, ha cercato di abbozzare, riconoscendo che la condizione della giustizia italiana, specie di quella civile, costituisce «una vera e propria emergenza nazionale», ed annunciando «un piano straordinario di smaltimento delle pendenze». In realtà, sarebbe necessario un progetto complessivo di intervento sui codici civili e penali, sugli organici del personale giudiziario, sulla distribuzione delle sedi giudiziarie, sulla copertura dei posti vacanti. Non un intervento straordinario, ma un ordinario, serio, riassetto globale del sistema legislativo e giudiziario.
Un’ultima annotazione. Sempre il ministro, in un unico accenno leggermente polemico in una giornata «pacificante» ricca di composto equilibrio istituzionale, ha dichiarato di avere rispetto per l’indipendenza dell’ordine giudiziario, ma ha sottolineato che «i giudici sono soggetti alla legge» e che «la legge la fa il Parlamento libero, democratico, espressione del popolo italiano», quello stesso popolo italiano in nome del quale i giudici pronunciano le loro sentenze.
Anche questa è annotazione, di per sé, assolutamente condivisibile, costituendo, ciò che è stato detto, fotografia della divisione dei poteri propria dello Stato di diritto. Occorre tuttavia ricordare, al ministro e a noi tutti, che il Parlamento, nel legiferare, è sovrano, ma è, comunque, tenuto a rispettare la Costituzione (cosa sovente dimenticata in questi ultimi tempi). Nel dibattito di ieri in Cassazione è stato d’altronde ignorato un profilo di grande importanza. Si è parlato ampiamente della necessità di riformare con legge ordinaria la giustizia penale e civile per renderla efficiente (cosa sulla quale sono tutti, bene o male, a parole d’accordo); si è però taciuto sulle ventilate riforme costituzionali attraverso le quali una parte consistente del personale dei partiti intenderebbe rimodulare i rapporti di potere fra politica e magistratura.
È, questo, un profilo di grandissima delicatezza. Non si vorrebbe infatti che, con la scusa del riequilibrio fra i poteri dello Stato, si intendesse in realtà proteggere in modo abnorme il mondo politico intriso di malaffare. La speranza è che il clima con il quale il tema della giustizia ordinaria è stato affrontato ieri nell’inaugurazione dell’anno giudiziario in Cassazione consenta di affrontare con altrettanta distensione anche quello, assai meno pacifico, che concerne la ventilata riforma costituzionale. Per intanto si attende con una certa apprensione che cosa accadrà, oggi, nelle inaugurazioni dell’anno giudiziario in ciascuna sede di Corte d’Appello.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- IL VUOTO DELLA POLITICA (di Enzo Mazzi).15 gennaio 2010, di Federico La Sala
Il vuoto della politica
di Enzo Mazzi (il manifesto, 15 gennaio 2010)
Vale anche per i fatti di Rosarno l’affermazione di Luigi Pintor richiamata domenica da Valentino Parlato: la sinistra «non deve vincere domani, ma operare ogni giorno e invadere il campo. Il suo scopo è reinventare la vita in un’era che ce ne sta privando in forme mai viste». Non bastano le denunce e i fiumi di lacrime versate da politici, media, chiese e associazioni. Bisogna «reinventare la vita».
I fatti di Rosarno sono il sintomo di un malessere profondo che soffoca la società ormai a livello mondiale, sono quasi l’ecografia del cancro che divora la vita di tutti noi nell’intimo.
La moderna schiavitù senza regole, lo sfruttamento bestiale degli immigrati e le condizioni inumane di vita che sono loro riservate, il dominio sempre più invadente delle mafie, il nuovo squadrismo in salsa leghista, la politica dominate che fomenta le paure e le xenofobie degli autoctoni, sono realtà da denunciare e contrastare con tutte le poche forze che ci restano in questo sfascio della sinistra di rappresentanza. Ma non basta. Il tema che deve emergere con forza è la reinvenzione della vita, della politica, della economia, della cultura e perché no della religione.
Dall’inferno di Rosarno alla palingenesi? È un sogno impossibile che ci distoglie dalle cose possibili? E quali sono le cose possibili? Non avvertite tutta l’impotenza di denunce, manifestazioni e lacrime? E il vuoto della politica? Non c’è che ripartire dal quotidiano, dall’operare ogni giorno, dall’invasione di campo.
Ormai siamo tutti stranieri a noi stessi. Nella società fondata sul dominio assoluto del danaro siamo tutti neri. È il danaro, nuova divinità, che si è impossessato delle nostre anime e dei nostri corpi e ci ha privato della nostra vita e della stessa terra.
La società del benessere è ridotta a una fortezza assediata. Ma è una illusione alzar mura, installare body scanner, e rovesciar barconi. Il nemico che ci assedia non è l’immigrazione. Siamo noi nemici a noi stessi. La crisi è dentro la struttura stessa della città. Un nuovo umanesimo s’impone. Ma il suo centro non è più la città. Anzi presuppone il crollo delle mura e lo prepara. È la vendetta del sangue di Remo. Il fondamento di un nuovo patto non può che trovarsi nell’essere umano in quanto tale, indipendentemente dal luogo di nascita e dal colore della pelle. Il risveglio di una tale consapevolezza non è né facile né indolore. Ed è qui che si apre uno spazio significativo e caratterizzante non solo per la politica ma per il volontariato e più in generale per l’associazionismo. Purtroppo la strada più facile è quella dell’assistenzialismo. Ma è una strada scivolosa. L’assistenzialismo, comunque rivestito, non crea parità di diritti.
Chi ha a cuore l’obbiettivo dell’affermazione dei diritti di cittadinanza per tutti, come diritto pieno, comprensivo dei diritti sociali, e come diritto inalienabile della persona, non può fare a meno di impegnarsi sia sui tempi brevi della mediazione politica, per raggiungere il raggiungibile, qui e ora, sia sui tempi lunghi della trasformazione culturale, in mezzo alla gente, facendo cose concrete.
E direi che l’associazionismo più che tappar buchi e metter toppe, dovrebbe imboccare più decisamente proprio la strada della trasformazione culturale. Tendere a smontare i paradigmi culturali, ideologici e anche religiosi, che sono all’origine della discriminazione. Con pazienza infinita e con umiltà, senza tirare la pianticella per lo stelo. Ma anche con tanta coerenza e fermezza. Senza vendere mai tutto sul mercato dell’emergenza e senza sacrificare mai tutto sull’altare della mediazione politica. Ha ragione ancora una volta il nostro Pintor: l’utopia della palingenesi è l’unica realtà possibile e la stella polare di un cammino che abbia senso e che dia senso ad ogni più piccolo passo.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ----- NAPOLITANO RASSICURA BERLUSCONI. "La Costituzione garantisce il governo".21 dicembre 2009, di Federico La Sala
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. AL GOVERNO DELLA CHIESA UN PAPA CHE PREDICA CHE GESU’ E’ IL FIGLIO DEL DIO "MAMMONA" ("Deus caritas est") E AL GOVERNO DELL’ **ITALIA** UN PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (che si camuffa da "Presidente della Repubblica" e canta) "Forza Italia" (1994-2009). IL GRANDE INCIUCIO E IL GRANDE SILENZIO, PER UN PRESIDENZIALISMO ATEO-DEVOTO. Una nota di Eugenio Scalfari.20 dicembre 2009, di Federico La Sala
 L’inciucio
L’inciucio È cosa non buona e ingiusta
È cosa non buona e ingiusta di Eugenio Scalfari (la Repubblica, 20.12.2009)
di Eugenio Scalfari (la Repubblica, 20.12.2009)Ho letto con molto interesse l’articolo del nostro collaboratore Alexander Stille (figlio di tanto padre) pubblicato venerdì scorso su Repubblica. Spiega perché chi si opponga alla politica del Pdl non può che concentrare le sue critiche su Silvio Berlusconi. Non è questione di distinguere la parola "nemico" dalla parola "avversario", la parola "odio" dalla parola "opposizione". Su queste differenze lessicali potremmo (inutilmente) discutere per pagine e pagine senza cavarne alcun risultato, come pure potremmo discutere sulla personalizzazione degli scontri politici in altri paesi.
Negli Stati Uniti per esempio lo scontro personalizzato è una prassi durissima e assolutamente normale. Basta ricordare (ed è appena un anno fa) la polemica senza esclusione di colpi tra Obama e Hillary Clinton durante le primarie, quella tra Gore e Bush nella corsa alla Casa Bianca, la campagna dei giornali che portò alle dimissioni di Nixon e Bill Clinton ad un passo dall’"impeachment" all’epoca dello scandalo Lewinsky.
Eppure in nessuno di quei casi i protagonisti avevano mai personalizzato su di sé il partito o la parte politica che rappresentavano come è avvenuto per Silvio Berlusconi. Ma chi lo ha detto meglio di tutti e con maggiore attendibilità è stato Denis Verdini. Il suo non è un nome molto noto, eppure si tratta d’un personaggio di primissimo piano: è il segretario del Pdl, il numero uno dei tre coordinatori di quel partito e soprattutto il co-fondatore di Forza Italia.
Quando Berlusconi decise di scendere in campo nell’autunno del 1993, affidò la costruzione del partito ai due capi di Publitalia, la società che raccoglieva la pubblicità per il gruppo Fininvest, nelle persone di Dell’Utri e di Verdini. Il primo è da tempo distratto da altri affanni; Verdini è invece nel pieno del suo impegno politico.
Nell’articolo pubblicato dal Giornale il 18 dicembre Verdini elenca gli obiettivi che il Pdl si propone di realizzare nei prossimi mesi e descrive come meglio non si potrebbe il ruolo di Berlusconi. «Lui ha costruito la figura del leader moderno - scrive Verdini - anzi ha costruito la leadership come istituzione. Per affrontarlo anche gli altri partiti dovranno affidarsi ad una leadership e se non riusciranno a farlo saranno sempre sconfitti. Ma anche i "media" non potranno esimersi dal concentrare sul leader la loro attenzione se vorranno cogliere il vero significato di quanto accade».
Segue l’elenco degli obiettivi: smontare la Costituzione e adeguarla alla Costituzione materiale; cambiare il sistema di elezione del Csm e quello della Corte costituzionale; riformare la giustizia separando le carriere dei magistrati inquirenti da quelle dei giudicanti; concentrare nella figura del premier tutti i poteri dell’Esecutivo e sancire che tutti gli altri poteri siano tenuti a collaborare lealmente con lui perché lui solo è l’eletto del popolo e quindi investito della sovranità che dal popolo emana.
Quest’articolo è infinitamente più preoccupante delle esagitate denunce e liste di proscrizione lanciate da Cicchitto in Parlamento, da Feltri e da Belpietro sui loro giornali e dai vari "pasdaran" del berlusconismo di assalto. Verdini l’ha scritto il 18 dicembre quando già Berlusconi era tornato ad Arcore ed aveva avviato la politica del dialogo con l’opposizione. Esso contiene dunque con lodevole chiarezza le condizioni di quel dialogo, con l’ovvio preliminare che essi comportano e cioè il salvacondotto in piena regola riguardante i processi del premier. Da qui dunque bisogna partire, tutto il resto è pura chiacchiera.
* * *
I giornali di ieri hanno dato notevole risalto alla battuta di D’Alema sull’utilità ed anzi la necessità, in certi momenti della vita politica, di far ricorso agli "inciuci". La parola "inciucio" denomina un compromesso malandrino tra parti politiche avversarie, un compromesso sporco e seminascosto che contiene segrete pattuizioni e segreti benefici per i contraenti, nascosti al popolo-bue.
Per esemplificare la sua battuta sull’utilità dell’inciucio D’Alema ha citato la decisione di Togliatti di votare, nell’Assemblea costituente del 1947, per l’inclusione del Concordato nella Costituzione italiana. Ma l’esempio è stato scelto a sproposito: la costituzionalizzazione del Concordato tra lo Stato e la Chiesa non fu affatto un inciucio ma un trasparente atto politico con il quale il Pci, distinguendosi dal Partito socialista e dal Partito d’azione, dichiarò la sua contrarietà a mantenere viva una contrapposizione tra laici e cattolici.
Si può non concordare con quella posizione; del resto la sinistra ha sempre privilegiato le lotte sociali rispetto alle cosiddette libertà borghesi, iscrivendo tra queste anche la laicità che non fu mai un cavallo di battaglia del Pci. Si può non condividere ma, lo ripeto, l’inciucio è tutt’altra cosa e D’Alema lo sa benissimo.
Credo di sapere perché D’Alema ha scelto di usare quel termine così peggiorativo: vuole stupire, gli piace esser citato dai "media", è una civetteria di chi, essendo molto sicuro di sé, sfida e provoca e si diverte.
È fatto così Massimo D’Alema. I compromessi gli piace descriverli, teorizzarli, talvolta anche tentarne la realizzazione, annusarne il cattivo odore, sicuro che se gli riuscisse di farli sarebbe comunque lui a guidarli verso l’utilità generale perché lui è più bravo degli altri. In realtà non è riuscito a metterne in pista nessuno. Ma la sua provocazione ha suscitato preoccupazioni nel suo partito e parecchie reazioni. Si è dovuto parlare di lui per l’ennesima volta. Sarà contento perché era appunto ciò che voleva.
I suoi contraddittori hanno deciso che bisognerà spostare il tiro sui problemi economici ai quali il governo ha dedicato pochissima attenzione. Sarà su di essi che si svolgerà il grande confronto tra la sinistra e la destra.
È vero, il governo non ha fatto nulla, la nostra "exit strategy" dalla crisi è del tutto inesistente e farà bene l’opposizione e il Pd a darsene carico, ma il centro dello scontro non sarà questo. Il centro dello scontro l’ha indicato Verdini, sarà sullo smantellamento della Costituzione. Sul passaggio dallo Stato di diritto allo Stato autoritario.
* * *
Berlusconi vuole il dialogo. Che cosa vuol dire dialogo? Lo spiega quasi ogni giorno sul Foglio Giuliano Ferrara. Lo spiegano gli editorialisti terzisti "ad adiuvandum": dialogo vuol dire mettersi d’accordo sul percorso da seguire e poi attuarlo con leale fedeltà a quanto pattuito. Insomma un disarmo. Unilaterale o bilaterale? Vediamo.
Berlusconi chiede: la legge sul legittimo impedimento come strumento-ponte che lo metta al riparo fino al lodo Alfano attuato con legge costituzionale; rottura immediata tra Pd e Di Pietro; riforme costituzionali e istituzionali secondo lo schema Verdini. In contropartita Berlusconi promette di parcheggiare su un binario morto la legge sul processo breve e di "riconoscere" il Pd come la sola forma di opposizione. Va aggiunto che Berlusconi non pretende che il Pd voti a favore della legge sul legittimo impedimento; vuole soltanto che essa non sia considerata dal Pd come un ostacolo all’accordo sulle riforme.
Vi sembra un disarmo bilaterale? Chiaramente non lo è. Chiaramente sarebbe un inciucio di pessimo odore.
In una Repubblica parlamentare il dialogo si svolge quotidianamente in Parlamento. Le forze politiche presentano progetti di legge, il governo presenta i propri, il Capo dello Stato vigila sulla loro costituzionalità, i presidenti delle Camere sulla ricevibilità di procedure ed emendamenti nonché sul calendario dei lavori badando che anche i progetti di legge formulati dall’opposizione approdino all’esame parlamentare.
Non si tratta dunque di un dialogo al riparo di occhi indiscreti ma d’un confronto aperto e pubblico, con tanto di verbalizzazione.
Quanto alla richiesta politica di rompere con Di Pietro, non può essere una condizione in vista di una legittimazione di cui il Pd non ha alcun bisogno e che la maggioranza non ha alcun titolo ad offrire. Come risponderebbe Berlusconi se Bersani gli chiedesse di rompere con la Lega? Che non è meno indigesta di Di Pietro ad un palato democraticamente sensibile ed anzi lo è ancora di più?
La conclusione non può dunque essere che l’appuntamento in Parlamento. Il punto sensibile è l’assalto alla Costituzione repubblicana. Ci sarà un referendum confermativo poiché sembra molto difficile una riforma condivisa. A meno che il premier non receda dai suoi propositi che, nella versione Verdini, sono decisamente eversivi. Uso questa parola non per odio verso chicchessia ma per amore verso lo Stato di diritto che è condizione preliminare della democrazia.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. AL GOVERNO DELLA CHIESA UN PAPA CHE PREDICA CHE GESU’ E’ IL FIGLIO DEL DIO "MAMMONA" ("Deus caritas est") --- IL "DIO OGGI" DELLA CHIESA CATTOLICA E’ IL DIO -VALORE: "I NOSTRI VALORI NON SONO NEGOZIABILI".13 dicembre 2009, di Federico La Sala
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- - "Roma brucia". Il titolo dell’editoriale del Times di oggi si ferma a questo, ma è chiara l’allusione a un Nerone che suona la cetra mentre tutto crolla attorno a lui (di Ennio Franceschini).10 settembre 2009, di Federico La Sala
 Sui giornali internazionali impazzano gli articoli sul premier e le sue feste
Sui giornali internazionali impazzano gli articoli sul premier e le sue feste
 "Uno degli aspetti più deprimenti dello scondalo è che resti ancora al potere"
"Uno degli aspetti più deprimenti dello scondalo è che resti ancora al potere" La stampa estera e le "donne del Cavaliere"
La stampa estera e le "donne del Cavaliere"
 e il Times di Londra titola: "Roma brucia"
e il Times di Londra titola: "Roma brucia" dal corrispondente ENRICO FRANCESCHINI *
dal corrispondente ENRICO FRANCESCHINI *LONDRA - "Roma brucia". Il titolo dell’editoriale del Times di oggi si ferma a questo, ma è chiara l’allusione a un Nerone che suona la cetra mentre tutto crolla attorno a lui. "Uno degli aspetti più deprimenti dello scandalo che avvolge il primo ministro italiano è che egli, nonostante un calo di consensi nei sondaggi, rimanga ancora al potere", afferma il commento della direzione del quotidiano londinese.
Ci sono varie spiegazioni di questo, continua l’editoriale, "la più pertinente sembra essere la mancanza di un’alternativa credibile in un’opposizione divisa dopo la caduta del governo Prodi e tra gli stessi alleati del premier nel centro-destra". Ma anche se per il momento Berlusconi sopravvive, il presidente della Camera Gianfranco Fini, dopo il dissidio di questi giorni con il leader del Pdl, "sta sicuramente pensando al lungo termine" e "rappresenta il meglio della destra, valori familiari e conservatorismo tradizionale".
Tre cose rendono Berlusconi "vulnerabile", scrive il Times. La prima è "il danno che egli ha causato all’immagine dell’Italia all’estero". La seconda è "la mentalità da bunker in cui si è rinchiuso, le cause per diffamazione, le smentite, il voler far finta di credere che tutto va bene, nascondono una rabbia cocente per l’incapacità del suo mondo virtuale di proteggerlo". La terza è un "non detto timore di ricatti".
Varie delle giovani donne con cui il premier si è intrattenuto, osserva l’editoriale, sembrano essere straniere. "Cosa accadrebbe se una potenza straniera decidesse di strumentalizzare questa pacchiana faccenda? Non è una preoccupazione solo per Roma. L’Italia è un importante partner occidentale nella Nato, dai Balcani all’Afghanistan. Il comportamento del primo ministro preoccupa e imbarazza tutti gli amici del suo Paese".
Oltre all’editoriale, il Times dedica un’altra pagina intera al caso Berlusconi, con due articoli, nei quali osserva che le rivelazioni sulle deposizioni di Gianpaolo Tarantini a proposito delle "30 donne fornite a Berlusconi per i suoi party aumentano la pressione sul premier", la cui bonomia e i cui sorrisi "appaiono sempre meno convincenti, perché i problemi si accumulano, distraendolo in un momento in cui l’Italia ha bisogno di una mano ferma" che guidi l’economia. Il capo del governo, conclude il quotidiano di Londra condividendo l’opinione di un commentatore italiano, dà l’impressione di essere "un uomo arrabbiato, sconfitto e depresso, che litiga con tutti".
Titoli e servizi analoghi sugli altri principali quotidiani britannici. "Altre cinque donne pagate da Berlusconi", titola il Daily Telegraph, notando che gli ultimi sviluppo "aumentano la sensazione che la permanenza al potere del premier abbia i giorni contati" a causa dei suoi conflitti con i media, la Chiesa, gli alleati interni. Anche il Guardian, come il Times, osserva che il fatto che varie delle donne incontrate da Berlusconi siano straniere potrebbe avere "compromesso la sicurezza nazionale, come afferma l’opposizione". E il Daily Mail titola su "Silvio e la sua galleria di ragazze da party", pubblicando una serie di foto delle donne coinvolte nello scandalo.
Le nuove rivelazioni figurano nei titoli di tutta la stampa europea e internazionale. "Trenta accompagnatrici per allietare le serate del Cavaliere", titola il Figaro in Francia, dove Le Monde parla di una "strategia della tensione" lanciata da Berlusconi contro i suoi avversari, che però "potrebbe rivelarsi più pericolosa di quanto lui pensi". In Spagna, il Mundo titola: "Prostituzione e cocaina sono le chiavi del successo, un imprenditore ammette che pagava droga e ragazze per Berlusconi". La Voz de Galicia scrive che Tarantini ha organizzato "fiesta con 30 chicas" per Berlusconi. El Pais titola: "Un amico di Berlusconi gli organizzò 18 feste con prostitute", ricordando, in un altro servizio, che proprio in questo momento di crisi personale e di scandali il premier italiano si appresta a incontrarsi in Sardegna con il premier spagnolo Zapatero, con il quale "ha ben poco in comune, ideologicamente e personalmente", ma l’incontro era stabilito da tempo.
In Irlanda, un altro paese fortemente cattolico che segue con grande attenzione l’evolversi della Berlusconi story, l’Irish Times la definisce "una soap opera" in cui si aggiungono sempre nuovi colpi di scena e l’Irish Independent titola sulle "esplosive rivelazioni" riguardo a "trenta call girls" che "andavano ai party di Berlusconi".
E continuano a fare il giro del mondo, la vicenda arriva fino in Australia, dove Mx scrive sulla "string of hookers", la collana di prostitute, del premier; e in Argentina, dove il Clarin titola senza mezzi termini: 30 prostitute a 18 feste per "el capo".
* la Repubblica, 10 settembre 2009
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- Oggi il capo del governo italiano si prepara a pagare alla dirigenza vaticana della Chiesa un prezzo tanto più salato in termini di limitazione o erosione dei diritti costituzionali quanto più logora appare la sua rappresentatività allo sguardo non offuscato dalla propaganda mediatica: dichiarare - come ha fatto Berlusconi - che quelle relazioni sono «eccellenti» significa solo che il debitore si impegna a pagare qualunque prezzo. Oltre al testamento biologico avremo dunque sempre più uno Stato catechista, anzi uno Stato chierichetto (di Adriano Prosperi - Ora di religione, il Vaticano vuole lo Stato catechista)..10 settembre 2009, di Federico La Sala
Ora di religione il Vaticano vuole lo Stato catechista
di Adriano Prosperi (la Repubblica, 10.09.2009)
Che fra i tanti problemi dell’Italia di oggi si debba porre in evidenza - ancora una volta - quello dell’ora di religione potrà sembrare un lusso da laicisti incalliti. E invece è probabile che proprio in questo dettaglio si trovi un bandolo dell’imbrogliata matassa italiana. Vediamo. Nel testo della lettera inviata dal prefetto della Congregazione vaticana per l’educazione cattolica ai presidenti delle conferenze episcopali si affermano punti secchi e precisi:
1. l’insegnamento della religione non può essere «limitato ad un’esposizione delle diverse religioni, in modo comparativo o neutro», ma deve concentrarsi nell’insegnamento della religione cattolica.
2. Il potere civile «deve riconoscere la vita religiosa dei cittadini e favorirla»; ma uscirebbe dai suoi limiti se presumesse di «dirigere o di impedire gli atti religiosi». Dunque «spetta alla Chiesa stabilire i contenuti autentici dell’insegnamento della religione cattolica nella scuola» garantendo così genitori e alunni che quello che viene insegnato è proprio il cattolicesimo. Questa direttiva può essere letta da molti punti di vista: se ne ricava intanto un’idea di quanto scarsa sia l’autonomia dei vescovi e delle loro conferenze nazionali nel governo religioso dei fedeli cattolici. Il Concilio Vaticano II aveva segnato un momento di svolta rispetto all’avanzata del potere delle congregazioni vaticane, veri ministeri centralizzati capaci di ridurre i vescovi a obbedienti impiegati di concetto. Ma poi la Curia ha ripreso la sua marcia. Con qualche vittima e con evidenti conflitti tra figure dell’episcopato e mondo vaticano, come quelli intravisti nell’episodio dell’aggressione al direttore di «Avvenire» e delle sue dimissioni.
Oggi il capo del governo italiano si prepara a pagare alla dirigenza vaticana della Chiesa un prezzo tanto più salato in termini di limitazione o erosione dei diritti costituzionali quanto più logora appare la sua rappresentatività allo sguardo non offuscato dalla propaganda mediatica: dichiarare - come ha fatto Berlusconi - che quelle relazioni sono «eccellenti» significa solo che il debitore si impegna a pagare qualunque prezzo. Oltre al testamento biologico avremo dunque sempre più uno Stato catechista, anzi uno Stato chierichetto. Perché una cosa di cui il cardinale Grocholewski sembra non rendersi conto è questa: che quel pericolo di uno Stato che presuma di dirigere o di impedire atti religiosi è proprio ciò che la sua lettera tende a realizzare e che in Italia già esiste.
Non potremmo definire altrimenti lo Stato obbediente che a) impone nelle sue scuole pubbliche l’insegnamento di una sola e specifica religione; b) fa svolgere quell’insegnamento da persone scelte dall’autorità ecclesiastica; c) si prepara a garantire a quell’insegnamento la stessa autorevolezza delle altre discipline scolastiche e la stessa remunerazione in crediti, in barba alla sentenza del Tar del Lazio, assicurando che questa ora di religione ha «la stessa esigenza di sistematicità e di rigore che hanno le altre discipline».
Noi non vogliamo negare che lo studio delle dottrine cattoliche possa avere sistematicità e rigore. In popoli che il caso geografico e le svolte storiche hanno lasciato più lontani di noi da Piazza San Pietro ci sono eccellenti facoltà di teologia cattoliche sorte per emulazione accanto a quelle protestanti. Qui, come ben sa l’attuale pontefice che ne è stato un docente, le questioni dottrinali dell’intricato sistema di segni e di concetti elaborato nel corso di millenni vengono dottamente discusse seguendo le regole della ricerca intellettuale: conoscenza critica dei testi, rigore di analisi. Ma nell’insegnamento scolastico di cui qui si tratta abbiamo solo la distribuzione di verità in pillole per lottare contro i pericoli sommi evocati dalla lettera cardinalizia di cui sopra: «creare confusione o generare relativismo o indifferentismo religioso».
Tra l’esercizio dell’intelligenza aperta e ancora fresca delle menti giovanili e l’obbligo di inculcare certezze, tra la libera ricerca del vero e l’apologetica di una religione c’è un abisso. Quale sia poi l’effetto di questa dimensione catechistica sulla vita religiosa di un popolo è la storia a dircelo. Da secoli, in un modo o nell’altro, con una breve parentesi di scuola laica nell’Italia dello Statuto albertino, gli italiani imparano il catechismo cattolico, da quello di San Roberto Bellarmino in poi.
Ebbene, quale sia lo stato della religione degli italiani è sotto gli occhi di tutti. Non parliamo solo di conoscenza: ché qui l’abisso è grande come sanno i pochi volenterosi che tentano ogni tanto di diffondere la conoscenza della Bibbia. Parliamo di morale, quella dei Vangeli cristiani e del decalogo ebraico. Parliamo della capacità cristiana di testimoniare la fede in faccia al potere. L’Italia non ha conosciuto martiri se non quelli creati dal potere ecclesiastico. Ha conosciuto ipocriti, eredi di di ser Ciappelletto e di Tartufo. Nel paese dove un tempo fiorivano i marxisti immaginari, oggi pullulano i convertiti religiosi. «Franza o Spagna, purchè se magna», si diceva nel ‘600.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. AL GOVERNO DELLA CHIESA UN PAPA CHE PREDICA CHE GESU’ E’ IL FIGLIO DEL DIO "MAMMONA" ("Deus caritas est", 2006) E AL GOVERNO DELL’ITALIA UN PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEL PARTITO "Forza Italia" (1994-2008). Questo è il nodo da sciogliere ---- La riforma della giustia... il colpo finale (di Giuseppe D’Avanzo).9 dicembre 2008, di Federico La Sala
 La riforma della giustizia
La riforma della giustizia Il vero obiettivo
del Cavaliere
Il vero obiettivo
del Cavalieredi GIUSEPPE D’AVANZO *
Berlusconi non ha alcuna voglia di riformare subito la giustizia. Perché dovrebbe averne? Si è personalmente protetto con l’immunità (la "legge Alfano") e non teme più i giudici.
Può essere paziente, può non avere fretta, può attendere. C’è il tempo di una legislatura per preparare e realizzare il colpo finale (dipendenza del pubblico ministero dall’esecutivo). Con sapienza, è sufficiente al premier tenere alto il fuoco sotto la pentola e cuocere magistratura, riformisti democratici, opinione pubblica con sfide, provocazioni, affondi incrociati. Sempre inconciliabili. Tipo: "Nella sinistra c’è una questione morale", dice. Che ovviamente suggerito da un piduista, con un avvocato corruttore di giudici (Previti) e un braccio destro amico di mafiosi (Dell’Utri), fuori pericolo per amnistie e prescrizioni, scampato per un conflitto di interessi che gli ha permesso di approvarsi leggi ad personam, irrita gli animi e provoca un irrigidimento politico. Che subito dopo Berlusconi massaggia da "statista" con un invito a discutere insieme la riforma della giustizia.
Un’offerta politica che, presa in considerazione per qualche ora, provoca all’istante nell’opposizione divisioni e malanimo che l’egoarca aggrava lasciando dire, un attimo dopo, che "in ogni caso, il governo la riforma la farà per conto suo" alla pattuglia di sherpa più partisan che ha a disposizione - Alfano (suo segretario personale e ora ministro virtuale), Ghedini (suo avvocato personale e ministro di fatto), Cicchitto (fratello di loggia).
Bisogna mettersi nei panni di Berlusconi. L’unica forza che teme davvero è la Lega Nord e Bossi non vuole sentir parlare di giustizia prima di avere in tasca il federalismo e, se il premier s’azzarda a capovolgere l’ordine delle priorità, gli toccherà subire gran brutti scherzi in aula. E poi perché procurarsi delle rogne quando i suoi avversari si fabbricano guai da soli?
I magistrati si mangiano vivi come scorpioni in una bottiglia screditando irresponsabilmente la stessa funzione giudiziaria. Il Consiglio superiore della magistratura, costretto ad affrontare la crisi calabro-campana per la mossa inconsueta di Napolitano, è pronto già da oggi a ritornare ai tempi lunghi, al gioco di squadra correntizio, alla protezione corporativa incapace di trovare risposta al perché magistrati così palesemente inadeguati debbano ottenere un incarico direttivo. È questa la qualità della magistratura italiana o è questo il mediocre merito che piace ai "kingmaker" delle correnti? D’altronde, è anche vero che, per le toghe più spregiudicate, una buona visibilità mediatica rimedia a qualsiasi abbaglio professionale se si posa a vittima, se si strepita contro l’arroganza del potere e i baratti politici sotto banco: quel che non si è stati capaci di mettere insieme rispettando le regole del processo penale, lo si ottiene come condanna morale pubblica da un’opinione pubblica, disinformata con maestria, che attende l’Angelo vendicatore e l’inchiesta catartica.
Il quadro sarebbe però incompleto se si trascurasse quel che più conta, la moderna originalità del Berlusconi IV (novità che la miopia autoreferenziale di opposizione e magistratura neppure sembra scorgere). Oggi il bersaglio del signore di Arcore (impunito per legge) non concerne più la magistratura (avversario secondario), ma lo stesso sistema di legalità (obiettivo primario). Non l’ordine o il potere giudiziario, ma le leggi, quella "formulazione generale e astratta che distingue le leggi da ogni altra manifestazione di volontà dello Stato". Berlusconi rivendica la legittimità del suo comando e non vuole che esso sia determinato dalle norme, ma lo esige orientato dalla necessità concreta, dallo stato delle cose, dalla forza della situazione. Vuole dare un taglio netto alle "dispute avvocatesche" che accompagnano lo Stato dove i giudici interpretano la legge. Vuole liquidare "le discussioni senza fine" dello Stato legislativo-parlamentare. Vuole e pretende una decisione eseguita con prontezza senza che né i giudici né il Parlamento ci mettano il becco.
Questa è la "partita" che vede la magistratura e il riformismo democratico confusi nel difendere forme, identità e routine che le mosse di Berlusconi spingono costantemente in fuori gioco. Converrà allora abbandonare l’idea di discutere e dividersi per una riforma della giustizia che non ci sarà per il momento (ci saranno soltanto maligne e pericolose modifiche di procedure e codici). È più utile rendersi presto "presentabili" per difendere con qualche prestigio dinanzi all’opinione pubblica un’architettura dello Stato dove ""legittimo" e "autorità" valgono solo come espressione della legalità".
Il riformismo democratico ha molto lavoro, e doloroso, davanti a sé. È ferito, in qualche caso sfigurato, dalle collusioni con il malaffare, dal clientelismo, dall’avidità, da "sistemi di potere" chiusi e inaccessibili. Non riesce a prendere atto, anche nei sindaci più integri come Domenici e Iervolino, che la sconfitta dell’etica pubblica nelle loro amministrazioni è un fallimento politico e quindi una loro diretta, esclusiva responsabilità di cui devono dar conto. Prima che affare dei giudici, quella caduta è uno sfregio alla fiducia ottenuta dagli elettori. Le proteste per la propria, personale correttezza non gliela restituirà e non la restituirà al centro-sinistra. La discussione severa nel campo dei riformisti dovrà ricordare allora che non può esserci autorità al di fuori di legalità. Soltanto il rispetto della legalità può rendere legittimo e autorevole il comando a meno di non volersi incamminare lungo la strada aperta da Berlusconi.
La magistratura si muove nello stesso angolo stretto. Così ubriaca di se stessa da non accorgersi di ballare su un Titanic prossimo alla catastrofe, in alcune agguerrite falangi, inalbera le prerogative costituzionali di autonomia e indipendenza come se fossero un lasciapassare per l’irresponsabilità. La magistratura deve mostrare di essere in grado di rimuovere, con i propri poteri amministrativi, le toghe sporche, le toghe immature, le toghe oziose, le toghe incapaci, gli inetti volenterosi, i vanitosi cacciatori di titoli. "La ricreazione è finita", è stato detto sabato scorso al Csm durante le audizioni dei capi degli uffici di Salerno e Catanzaro. "La ricreazione" deve finire davvero, se la giustizia vuole essere ancora custode e garante del diritto in uno Stato giurisdizionale.
Soltanto questo doppio esame critico consentirà di affrontare, quando sarà, una riforma della giustizia che abbia non soltanto un uomo al comando, con i numeri insuperabili delle sue truppe, ma almeno un protagonista politico (il Pd) e un attore istituzionale (la magistratura) che possono far pesare nel Paese la loro credibilità, un indiscusso credito. Non è molto, ma è la sola moneta che si può spendere oggi.
* la Repubblica, 9 dicembre 2008.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- Una investitura medioevale. A proposito della “Lettera” autografa del Sovrano dello Stato Vaticano* al Presidente del Senato, e della "rivoluzione di Dio" (2005).7 dicembre 2008, di Maria Paola Falqui
A proposito della “Lettera” autografa del Sovrano dello Stato Vaticano* al Presidente del Senato, e della "rivoluzione di Dio".
UNA INVESTITURA “MEDIOEVALE”
di Federico La Sala
“Che l’Italia sia sempre stato un paese mammone e maschilista (la contraddizione è solo apparente)”, lo sottolinea e lo ricorda, con determinazione e chiarezza, Clara Sereni (cfr. O il rosa o il fango, l’Unità, 14.10.2005). “Non è mai stato un segreto per nessuno che l’Italia custodisse nelle proprie viscere un fondo limaccioso, fangoso, sporco”, ma oggi tutto questo è venuto a galla e sta inquinando tutto! Il buio e la peste (non solo aviaria) è all’ordine del giorno. Contro questa oscurità, che acceca sempre più i nostri occhi e i nostri pensieri, e devasta tutta la nostra Casa, non si può più stare zitti o zitte.
Io, cittadino italiano, ’figlio’ di ’Giuseppe’ e ’Maria’, consapevole di “avere profonde radici cristiane, intrecciate con quelle umanistiche” (come ha detto e ridetto il nostro Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, in molteplici occasioni e, in modo forte, nell’incontro al Quirinale con il Sovrano dello Stato del Vaticano, il 24.06.2005), sono assolutamente offeso per le continue interferenze e incursioni ’piratesche’ dei Politici dello Stato del Vaticano nella nostra società civile e politica!!!
La lettera inviata e firmata di suo pugno dal Sovrano dello Stato del Vaticano al Presidente del Senato, in occasione “Libertà e laicità” (in corso a Norcia) ha colmato la misura! Ha tutto il tono di un’investitura medioevale, degna di un Bonifacio VIII, e la volontà definitiva di distruggere la nostra Costituzione e la nostra stessa società, per soddisfare gli interessi del loro “Dio” Mammona, e Maschilista-Edipico!!!
La loro cecità e la loro volontà di potenza non ha confini - distruggere la Casa di tutti gli italiani e di tutte le italiane, figli e figlie dell’amore e del rispetto reciproco di ’Maria’ e ’Giuseppe’, è l’obbiettivo sempre più all’ordine del giorno dei figli del “Dio”di “Mammasantissima”. La loro campagna ’militare’ è iniziata: è stata chiamata“La rivoluzione di Dio”. E sulle loro insegne. ... già e di nuovo si cominciano a leggere le solite vecchie parole! Costantino è morto, Hitler è morto, Mussolini è morto, Stalin è morto ... e loro continuano a combattere - contro se stessi!!! Che il Dio - l’Amore - dei nostri padri e delle nostre madri li illumini, e giungano a se stessi e al loro prossimo, con gli occhi aperti e con la mano aperta - per stringere un patto nuovo, finalmente, degno di tutti gli esseri umani di tutto il pianeta Terra! (16.10.2005)
Federico La Sala
*
Lettera di Benedetto XVI a un convegno su "Libertà e laicità" che si tiene a Norcia, e a cui partecipano anche Pera e Formigoni
Il Papa: "I diritti fondamentali vengono da Dio, non dallo Stato"
Secondo il Pontefice, una nazione "sanamente laica" deve garantire la libera espressione della religiosità (www.repubblica.it, 15.10.2005)
NORCIA (Perugia) - Parole forti, con la firma di Benedetto XVI: "I diritti fondamentali non vengono creati dal legislatore, ma sono iscritti nella natura stessa della persona umana, e sono pertanto rinviabili ultimamente al creatore". Il passaggio è contenuto in una lettera che il papa ha inviato alla fondazione Magna Charta che tiene un convegno a Norcia sul tema "Libertà e laicità". E a cui partecipano, tra gli altri, Marcello Pera e di Roberto Formigoni.
Nella missiva, il Papa sostiene che uno Stato "sanamente laico" deve riconoscere nella sua legislazione quel "senso religioso in cui si esprime l’apertura dell’essere umano alla trascendenza". Solo questa, secondo Benedetto XVI, è una forma di "laicità positiva", che garantisce "a ogni cittadino il diritto di vivere la propria fede religiosa con autentica libertà, anche in ambito pubblico".
E dunque, secondo il papa, "per un rinnovamento culturale e spirituale dell’Italia e del continente europeo occorrerà lavorare affinchè la laicità non venga interpretata come ostilità alla religione, ma al contrario come impegno a garantire a tutti, singoli e gruppi, nel rispetto dell’esigenze del bene comune, la possibilità di vivere e manifestare le proprie convinzioni religiose" (15 ottobre 2005).
* www.ildialogo.org/filosofia, Lunedì, 17 ottobre 2005
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- Una investitura medioevale... "Resto convinto che la prefazione papale al testo di Pera sia un incidente, forse fraudolentemente provocato. Pera non è nuovo a questa pratica di assemblare abusivamente testi suoi e del Papa per fingere un dialogo diretto" (ALDO BODRATO).8 dicembre 2008, di Federico La Sala
Scienza e religione oltre Ratzinger e Odifreddi
di Aldo Bodrato
Comunicazione e intervento di Aldo Bodrato *
Caro Enrico (Peyretti),
non so come fare arrivare al Forum di Koinonia queste mie riflessioni. Se puoi, inoltragliele tu. In ogni caso possono interessare tutta la redazione.
Resto convinto che la prefazione papale al testo di Pera sia un incidente, forse fraudolentemente provocato. Pera non è nuovo a questa pratica di assemblare abusivamente testi suoi e del Papa per fingere un dialogo diretto sul tipo di quello instaurato dal teologo Ratzinger con Habermas.
Mi suona poi incredibile, che un’istituzione attenta alla forma come quella vaticana, abbia potuto consentire l’uso del titolo pontificale per sottoscrivere una presentazione-recensione, che solo come privato e singolo studioso il papa avrebbe potuto firmare. In sostanza, perché, quel testo è firmato Benedetto XVI e non Joseph Ratzinger, se non è un documento amministrativo interno della chiesa, un testo magisteriale a qualsivoglia titolo, se non perché qualcuno l’ha sottoposto alla firma del papa insieme ad altri di ufficio, così che questi firmasse con il nome di papa senza accorgersene?
Non dico questo certo per difendere il buon nome del pontefice, che sono tra i pochi teologi italiani che critico apertamente, denunciandone i limiti intellettuali e pastorali. Ma non credo possibile che neppure come Ratzinger, se non per senescenza grave, il noto teologo avrebbe scritto e firmato una introduzione-recensione tanto piena di piaggeria e di sciocchezze, del tipo l’Europa non può diventare un continente multiculturale, quando già lo è da secoli, fin da quando è nata. Sarebbe come dire che l’insalata russa non può essere fatta altro che con cetrioli romani.
Tutto in questa lettera-introduttiva coincide col pensiero di Pera e magari anche con quello privato di Ratzinger, ma che egli come papa si guarderebbe bene dall’esplicitare, pena la fine del dialogo con ogni confessione religiosa cristiana e con ogni religione, come vuole Baget-Bozzo e forse qualche leghista, ma non certo il papa, come capo di una Curia che in ogni modo cerca un dialogo religioso e culturale con Anglicani, Ortodossi, Ebrei, Islamici, anche se forse un po’ meno coi Protestanti non-integralisti alla Bush.
Attendo ancora una conferma vaticana sull’autenticità del testo, se mi è sfuggita fatemelo sapere e mi metterò il cuore in pace, cominciando a chiedere la destituzione per ragioni di chiesa e di fede di Benedetto XVI. Con simpatia
Aldo Bodrato
 [...]
[...] Articolo tratto da:
Articolo tratto da: FORUM (119) Koinonia
FORUM (119) Koinonia http://www.koinonia-online.it
http://www.koinonia-online.it
 Convento S.Domenico - Piazza S.Domenico, 1 - Pistoia - Tel. 0573/22046
Convento S.Domenico - Piazza S.Domenico, 1 - Pistoia - Tel. 0573/22046* Il Dialogo, Lunedì 08 Dicembre,2008 Ore: 16:32 - RIPRESA PARZIALE
-
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- Generazione "no limits" (di Luca Mercalli).7 dicembre 2008, di Federico La Sala
Generazione "no limits"
di Luca Mercalli (la Repubblica, 7 dicembre 2008)
Una nevicata tra dieci e trenta centimetri su gran parte della pianura Padana alla fine di novembre non è consueta. Ma nemmeno eccezionale, è già capitato in passato. Piogge abbondanti tra Toscana e Lazio in novembre sono ricorrenti, la grandinata su Roma un po’ meno, ma certo non è un evento nuovo. Vento forte, mare grosso, d’autunno sono di casa. La differenza rispetto al passato è semmai che le previsioni meteo oggi funzionano. Tutto era stato annunciato con un anticipo di un buon paio di giorni. E anche le modalità di comunicazione sono più capillari ed efficaci di un tempo: internet, telefonini, sistemi di navigazione gps, webcam. Perché allora tutto si blocca? Perché il traffico collassa, la gente impazzisce e qualcuno ci lascia pure la pelle?
Credo che i motivi siano tre.
Il primo è che viviamo in un paese sovraffollato e sovrasfruttato: quasi sessanta milioni di persone, circa trentacinque milioni di automobili, edilizia selvaggia, decine di migliaia di chilometri di strade, autostrade e ferrovie, antenne per cellulari, tralicci elettrici e pali telefonici, acquedotti, gasdotti, oleodotti, industrie, centri commerciali, poli logistici, impianti sportivi, villette e capannoni. Non c’è un francobollo di territorio che non abbia qualcosa che si può rompere, che può essere danneggiato dagli eventi meteorologici, sia pure ordinari. È tutto in equilibrio precario già quando c’è il sole, inevitabile che appena si supera una soglia minima di complicazione, il sistema ceda come un castello di carte.
Il secondo motivo è psicologico. Crediamo di essere onnipotenti. La pubblicità "no limits" continua a dirci che possiamo sfidare ogni rischio, ci istiga a trasgredire ogni regola, basta comprare quell’auto, indossare quell’abito, bere quel liquore. Quindi che sarà mai una nevicata annunciata dal telegiornale? Via, a capofitto dentro la tempesta, senza catene, senza precauzioni, senza cervello. Tanto tutto il mondo ruota intorno a me, sarà la neve a togliersi di torno, la pioggia e il vento si faranno di certo da parte quando vedranno la mia auto da duecento cavalli, dodici valvole, quattroperquattro, triplo airbag, abiesse, gipiesse. C’è poi chi ha visto queste cose solo nei film e su una macchina normale si getta di notte a guadare un fiume in piena come Indiana Jones. Non possiamo considerarle vittime del maltempo ma solo della loro imprudenza.
Terzo motivo: siamo sempre meno esercitati a rapportarci con l’ambiente esterno. Come scrivo nel mio saggio Filosofia delle nuvole uscito di recente per Rizzoli, viviamo ormai in un bozzolo a clima controllato che comincia in camera da letto e termina in ufficio, passando per garage, auto, ascensore, bar, ristorante, galleria commerciale. Sempre uguale, estate e inverno, regolato da un termostato e da un bel flusso di costosa energia. Così anche gli abiti sono sempre più omogenei, pochi aggiustamenti stagionali, scarpe con i tacchi che piova o faccia sole, ombelico scoperto a gennaio come a luglio. Il clima ideale lo si sogna sul salvaschermo che mostra le Maldive, ma non si vivono più sulla pelle quelle stagioni nostrane che, anche in città, il Marcovaldo di Calvino osservava con sguardo attento e curioso più di quarant’anni fa:
«Marcovaldo, a naso in su, assaporava l’odore della pioggia... Lo sguardo con cui egli ora scrutava in cielo l’addensarsi delle nuvole, non era più quello del cittadino che si domanda se deve prendere l’ombrello, ma quello dell’agricoltore che di giorno in giorno aspetta la fine della siccità».
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- Crisi è sottoporsi al giudizio, al processo. È ora che il processo cominci (di BARBARA SPINELLI - La crisi come occasione)..7 dicembre 2008, di Federico La Sala
La crisi come occasione
di BARBARA SPINELLI (La Stampa, 7/12/2008)
La parola crisi è tra le più tentacolari che esistano nel vocabolario: più che una parola, è albero dai rami incessanti. In greco antico significa un gran numero di cose tra cui: separazione, scelta, giudizio. Il verbo, krino, vuol dire anche decidere. In medicina si parla di giorno critico o di giorni critici: per Ippocrate (e per Galeno nel secondo secolo dC) è l’ora in cui la malattia si decide: o precipita nella morte o s’affaccia alla ripresa. È il punto di passaggio, di svolta.
Il termine riapparve nei sommovimenti enormi del ’700: nella rivoluzione francese, in quella industriale. La vera crisi, per Burckhardt, non cambia solo i regimi: scompone i fondamenti della società, come avvenne nelle migrazioni germaniche. Quel che la caratterizza è la straordinaria accelerazione del tempo: «Il processo mondiale d’un tratto cade in preda a una terribile rapidità: sviluppi che solitamente mettono secoli a crescere, passano in mesi e settimane come fantasmi in fuga» (Jacob Burckhardt, Considerazioni sulla storia universale).
Il concetto di crisi fu evocato con affanno sempre più frequente dopo il primo conflitto mondiale. Lo storico Reinhart Koselleck la chiama «cataratta degli eventi» e sottolinea il suo volto ambiguo: è una condanna, ma anche un’occasione che ci trasforma. Nel Vangelo di Giovanni (5, 24) Gesù la raffigura come temibile: «Chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita». Nella versione greca, andare incontro al giudizio è letteralmente «entrare nella krisis», nel processo. Al tempo stesso crisi è intelletto all’opera, che redime: «L’uomo che non ha alcuna krisis non è in grado di giudicare nulla», scrive Johann Heinrich Zedler nell’Universal-Lexikon del 1737.
Anche la crisi che traversiamo oggi è «vera crisi»: momento di decisione, climax d’un male, e se ne abbiamo coscienza, occasione. Uscirne è possibile, purché non manchi la diagnosi: secondo Galeno, i giorni critici sono valutabili solo se l’inizio del male è definito con precisione.
Gli economisti non bastano a tale scopo, e ancor meno i politici. Spesso vedono le cose più da vicino i letterati, i filosofi, gli storici, i teologi, i medici. Se la società è un corpo - dagli esordi è la tesi dei filosofi - questi sono i suoi giorni critici: può morire o guarire, mutando forma e maniere d’esistere.
Pietro Citati individua la radice del male nella passione dei consumi: frenesia che descrive con parole deliziose, ironiche, sgomente, evocando la telecamera americana che nel 1952 riprese una massaia che s’aggirava nel supermercato (Repubblica, 3 dicembre 2008). La camera registra i movimenti delle sue palpebre ed ecco d’un tratto i battiti crollano davanti agli scaffali, fino a raggiungere la media di quattordici al minuto, da trentadue che erano: «Una media subumana, come quella dei pesci; tutte le signore precipitavano in una forma di trance ipnoide. Molte erano così ipnotizzate, che a volte incontravano vecchi amici e conoscenti senza riconoscerli e salutarli». Sono decenni che nuotiamo come pesci, gli occhi sbarrati, consumando senza fiutare la crisi: scriteriati. Questo ci ha cambiati profondamente. In America ha distrutto il risparmio.
Ovunque, politici e responsabili finanziari sbigottiscono davanti all’incanto spezzato (alla bolla scoppiata). Vorrebbero che la stoffa di cui è fatto - l’illusione - non si strappasse mai: perché le campagne elettorali son cucite con quei fili, vivono della chimera d’un progresso ineluttabile, senza costi. L’America dopo il Vietnam respingeva le guerre: le voleva «a zero morti». Poi ricominciò a volerle, ma «a zero tasse». Importante nell’ipnosi è accaparrare sempre più, anche se mancano i mezzi: l’ipnosi, restringendo la coscienza, è il contrario della crisi. In America finanza e politica estera sono «entrate nella crisi» simultaneamente. Il 7 agosto inizia la guerra georgiana, e pure i ciechi scoprono che Washington non può alcunché: ha aizzato Saakashvili, ma senza mezzi per sostenerlo. Esattamente un mese dopo, fra il 7 e il 16 settembre, scoppia la bolla finanziaria (salvataggio di Fannie Mae e Freddie Mac, poi bancarotta di Lehman Brothers, poi salvataggio di Aig). Per decenni si è sentito dire: ci sono compagnie troppo grosse per fallire. Era menzogna: non erano troppo grandi né Lehman, né l’impero Usa. Le bolle esistono nella finanza, in politica, nelle teste. Sono i giorni critici della nostra mente.
La trance ipnoide ha stravolto modi di vivere, di convivere con l’altro in casa e nel mondo. Ci ha chiusi nella sfiducia. Lo storico Andrew Bacevich lega tutte queste esperienze, e racconta come dall’impero della produzione l’America sia passata, ancor prima di Reagan, all’impero dei consumi (The Limits of Power, Metropolitan Books 2008). Nel tragitto si son perse (specie in America) nozioni fondanti: la nozione del debito, che nella nostra cultura non è senza colpa ed è divenuto un fine positivo in sé, incondizionato. La nozione della fiducia, senza cui ogni debito degrada. La nozione del limite.
Il Padre nostro dice, in Luca 11, 2-4: «Perdona a noi i nostri peccati, anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore». In ebraico peccato e debito sono un’unica parola. La poetessa Margaret Atwood ricorda come il concetto di debito - essenziale nel romanzo dell’800: Emma Bovary si suicida perché un creditore non ripagato minaccia di rivelare il suo adulterio - sia oggi vanificato (Payback: Debt and the Shadow Side of Wealth, Toronto 2008). Soprattutto in America, le banche spingono all’indebitamento, più che a prudenza e risparmio. Scrive Zygmunt Bauman che un debitore che vuol restituire puntualmente (che «pensa al dopo») è sospetto: è «l’incubo dei prestatori». Non è «di alcuna utilità», perché il debito riciclato è fonte prima del loro profitto costante.
Ma il debito sconnesso da fiducia non è pungolato solo da banche o Wall Street. È un ottundersi generale dei cervelli, è l’ebete pensare positivo che il governante invoca con linguaggio sempre più pubblicitario, sempre meno politico. Main Street - che poi siamo noi, cittadini e consumatori - è vittima tutt’altro che innocente di Wall Street. Come nel Grande Crollo del ’29 descritto da John K. Galbraith, siamo affetti da una follia seminale (seminal lunacy) che accomuna potenti e milioni d’impotenti. Per questo è così vacuo il politico che incita a ricominciare i consumi come se niente fosse. Il suo dichiarare, i linguisti lo definiscono performativo: basta dire «la crisi non c’è», e la crisi smette di essere (le dichiarazioni performative sono predilette da Berlusconi). I politici sono responsabili, avendo ceduto a un mercato senza regole. Ora intervengono, ma senza curare la fonte del male. La crisi, cioè la svolta trasformatrice, è rinviata.
Naturalmente hanno le loro ragioni: il crollo dei consumi farà male. Stephen Roach, presidente di Morgan Stanley Asia, ricorda che comporterà disoccupazione dilatata, ulteriori cadute dei redditi e del valore delle case, aumento dei debiti, credito scarso. Ma qualcosa di non negativo può nascerne: un rapporto col debito più realistico e leale, una fiducia riscoperta, un consumo adattato alle possibilità (New York Times, 28 novembre).
Crisi vuol dire decidere, a occhi non sbarrati come la massaia del ’52 ma aperti: sul peggio sempre possibile, sulle bugie del pensare positivo, sulla duplice responsabilità verso la Terra che roviniamo, e verso i figli cui addossiamo i nostri debiti. Terra e figli sono i nostri discendenti: ignorarli perché i loro tempi son più lunghi dei nostri e perché non abiteremo il loro mondo (un mondo con meno petrolio, meno automobili) è senza dignità e chiude speranze altrui. Crisi è sottoporsi al giudizio, al processo. È ora che il processo cominci.
-
> LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. ---- Crisi è sottoporsi al giudizio, al processo. È ora che il processo cominci (di BARBARA SPINELLI - La crisi come occasione)..28 giugno 2010, di John Mazzei
11 E vidi un grande trono bianco e colui che vi sedeva sopra. Dalla sua presenza fuggirono la terra e il cielo, e non fu trovato luogo per loro. 12 E vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono, e dei rotoli furono aperti. Ma fu aperto un altro rotolo; è il rotolo della vita. E i morti furono giudicati dalle cose scritte nei rotoli secondo le loro opere. 13 E il mare diede i morti che erano in esso, e la morte e l’Ades diedero i morti che erano in essi, e furono giudicati individualmente secondo le loro opere. 14 E la morte e l’Ades furono scagliati nel lago di fuoco. Questo significa la seconda morte, il lago di fuoco. 15 Inoltre, chiunque non fu trovato scritto nel libro della vita fu scagliato nel lago di fuoco.
7 Secondo la visione, il Regno millenario di Cristo sarà un tempo di giudizio. L’apostolo Giovanni scrisse: “Vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono, e dei rotoli furono aperti. Ma fu aperto un altro rotolo; è il rotolo della vita. E i morti furono giudicati dalle cose scritte nei rotoli secondo le loro opere. . . . E furono giudicati individualmente secondo le loro opere”. (Rivelazione 20:12, 13) Si noti che la base di questo giudizio non è ciò che la persona ha fatto o non ha fatto prima di morire. (Romani 6:7) Ha relazione con dei “rotoli” che saranno aperti. Le azioni che la persona compirà dopo aver appreso il contenuto dei rotoli costituiranno la base per determinare se il suo nome sarà scritto nel “rotolo della vita”.
Con tutto il bene e rispetto del mondo...fino a quando! (NON E’ PIU’ NECESSARIO)
-