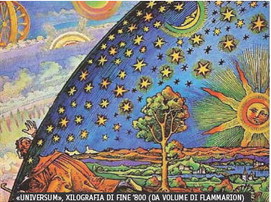
LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE, E IL VATICANO CON IL SUO TRADIZIONALE SOFISMA DELLA "FALLACIA ACCIDENTIS". Un invito alla lettura di due brevi estratti - a cura di Federico La Sala
 Introduzione.
Introduzione.
 Dante, alle origini del moderno!!! Pace, giustizia e libertà nell’aiuola dei mortali
Dante, alle origini del moderno!!! Pace, giustizia e libertà nell’aiuola dei mortali
Testi:
A. LA CARITA’ O IL RETTO AMORE
Monarchia, I. 11:
[...] ora il Monarca non ha più nulla da desiderare, poiché la sua giurisdizione è limitata soltanto dall’oceano (il che non si verifica per gli altri prìncipi i cui dominii confinano con altri dominii, come, per es., quello del re di Castiglia, che confina con quello del re di Aragona); quindi il Monarca, tra tutti gli uomini, è il soggetto di giustizia più esente da ogni cupidigia.
Inoltre, come la cupidigia, per quanto piccola sia, offusca l’abito della giustizia, così la carità, cioè il retto amore, lo rende più forte e più illuminato. Perciò, la persona che è capace di raggiungere il più alto grado di retto amore può attingere il massimo livello di giustizia; ora, questa persona è il monarca; quindi, con il monarca si instaura, o può instaurarsi, il massimo di giustizia. Che poi il retto amore produca tali effetti si può dedurre dal fatto che la cupidigia, spregiando il Bene supremo degli uomini, cerca altri beni, mentre la carità, spregiando tutti gli altri beni, cerca Dio e l’uomo, e di conseguenza il vero bene dell’uomo.
E siccome, fra tutti i beni dell’uomo, grandissimo è quello di vivere in pace, come si è detto sopra, e questo bene si raggiunge principalmente ed essenzialmente attraverso la giustizia, questa riceverà grandissimo vigore dalla carità, e tanto più quanto più quest’ultima sarà intensa. Che poi nel monarca debba trovarsi in sommo grado il retto amore degli uomini si dimostra nel modo seguente: ogni oggetto amabile è tanto più amato quanto più è vicino a chi l’ama; ora gli uomini sono più vicini al monarca che agli altri principi; quindi essi sono o debbono essere amati dal monarca più che da ogni altro.
La premessa maggiore è evidente se si considera la natura degli agenti e dei pazienti; la minore è dimostrata dal fatto che agli altri prìncipi gli uomini sono vicini solo in parte, al monarca invece nella loro totalità. Si aggiunga che gli uomini si avvicinano agli altri prìncipi attraverso il monarca e non viceversa, e quindi la cura del monarca verso tutti gli uomini è originaria ed immediata, mentre quella degli altri prìncipi passa attraverso la mediazione del monarca in quanto deriva dalla sua cura suprema. Inoltre, quanto più una causa è universale, tanto più è causa (la causa inferiore infatti non è causa se non in forza di quella superiore, come risulta dal libro «Delle cause»), e quanto più una causa è causa, tanto più ama il suo effetto, poiché tale amore è conseguenza diretta dell’essere causa; ora, il monarca è, tra gli uomini, la causa più universale del loro ben vivere (mentre gli altri prìncipi sono causa attraverso la mediazione del monarca, come si è detto); quindi il monarca ama il bene degli uomini più di ogni altro.
[Per il secondo punto], chi potrebbe mettere in dubbio che il monarca abbia il massimo potere per attuare la giustizia se non colui che non intende che cosa significhi quel nome? Se egli infatti è effettivamente monarca, non può avere nemici. E così è stata sufficientemente dimostrata la premessa minore del sillogismo principale, e pertanto è certa la conclusione che la monarchia è necessaria per un perfetto ordinamento del mondo. (trad. di Pio Gaja)
- - -
 [...] 12. Sed Monarcha non habet quod possit optare: sua nanque iurisdictio terminatur Occeano solum: quod non contingit principibus aliis, quorum principatus ad alios terminantur, ut puta regis Castelle ad illum qui regis Aragonum. Ex quo sequitur quod Monarcha sincerissimum inter mortales iustitie possit esse subiectum.
[...] 12. Sed Monarcha non habet quod possit optare: sua nanque iurisdictio terminatur Occeano solum: quod non contingit principibus aliis, quorum principatus ad alios terminantur, ut puta regis Castelle ad illum qui regis Aragonum. Ex quo sequitur quod Monarcha sincerissimum inter mortales iustitie possit esse subiectum.
 13. Preterea, quemadmodum cupiditas habitualem iustitiam quodammodo, quantumcunque pauca, obnubilat, sic karitas seu recta dilectio illam acuit atque dilucidat. Cui ergo maxime recta dilectio inesse potest, potissimum locum in illo potest habere iustitia; huiusmodi est Monarcha: ergo, eo existente, iustitia potissima est vel esse potest.
13. Preterea, quemadmodum cupiditas habitualem iustitiam quodammodo, quantumcunque pauca, obnubilat, sic karitas seu recta dilectio illam acuit atque dilucidat. Cui ergo maxime recta dilectio inesse potest, potissimum locum in illo potest habere iustitia; huiusmodi est Monarcha: ergo, eo existente, iustitia potissima est vel esse potest.
 14. Quod autem recta dilectio faciat quod dictum est, hinc haberi potest: cupiditas nanque, perseitate hominum spreta, querit alia; karitas vero, spretis aliis omnibus, querit Deum et hominem, et per consequens bonum hominis. Cumque inter alia bona hominis potissimum sit in pace vivere - ut supra dicebatur - et hoc operetur maxime atque potissime iustitia, karitas maxime iustitiam vigorabit et potior potius.
14. Quod autem recta dilectio faciat quod dictum est, hinc haberi potest: cupiditas nanque, perseitate hominum spreta, querit alia; karitas vero, spretis aliis omnibus, querit Deum et hominem, et per consequens bonum hominis. Cumque inter alia bona hominis potissimum sit in pace vivere - ut supra dicebatur - et hoc operetur maxime atque potissime iustitia, karitas maxime iustitiam vigorabit et potior potius.
 15. Et quod Monarche maxime hominum recta dilectio inesse debeat, patet sic: omne diligibile tanto magis diligitur quanto propinquius est diligenti; sed homines propinquius Monarche sunt quam aliis principibus: ergo ab eo maxime diliguntur vel diligi debent. Prima manifesta est, si natura passivorum et activorum consideretur; secunda per hoc apparet: quia principibus aliis homines non appropinquant nisi in parte, Monarche vero secundum totum.
15. Et quod Monarche maxime hominum recta dilectio inesse debeat, patet sic: omne diligibile tanto magis diligitur quanto propinquius est diligenti; sed homines propinquius Monarche sunt quam aliis principibus: ergo ab eo maxime diliguntur vel diligi debent. Prima manifesta est, si natura passivorum et activorum consideretur; secunda per hoc apparet: quia principibus aliis homines non appropinquant nisi in parte, Monarche vero secundum totum.
 16. Et rursus: principibus aliis appropinquant per Monarcham et non e converso; et sic per prius et immediate Monarche inest cura de omnibus, aliis autem principibus per Monarcham, eo quod cura ipsorum a cura illa supprema descendit.
16. Et rursus: principibus aliis appropinquant per Monarcham et non e converso; et sic per prius et immediate Monarche inest cura de omnibus, aliis autem principibus per Monarcham, eo quod cura ipsorum a cura illa supprema descendit.
 17. Preterea, quanto causa est universalior, tanto magis habet rationem cause, quia inferior non est causa nisi per superiorem, ut patet ex hiis que De causis; et quanto causa magis est causa, tanto magis effectum diligit, cum dilectio talis assequatur causam per se.
17. Preterea, quanto causa est universalior, tanto magis habet rationem cause, quia inferior non est causa nisi per superiorem, ut patet ex hiis que De causis; et quanto causa magis est causa, tanto magis effectum diligit, cum dilectio talis assequatur causam per se.
 18. Cum igitur Monarcha sit universalissima causa inter mortales ut homines bene vivant, quia principes alii per illum, ut dictum est, consequens est quod bonum hominum ab eo maxime diligatur.
18. Cum igitur Monarcha sit universalissima causa inter mortales ut homines bene vivant, quia principes alii per illum, ut dictum est, consequens est quod bonum hominum ab eo maxime diligatur.
 19. Quod autem Monarcha potissime se habeat ad operationem iustitie, quis dubitat nisi qui vocem hanc non intelligit, cum, si Monarcha est, hostes habere non possit?
19. Quod autem Monarcha potissime se habeat ad operationem iustitie, quis dubitat nisi qui vocem hanc non intelligit, cum, si Monarcha est, hostes habere non possit?
 20. Satis igitur declarata subassumpta principalis, quia conclusio certa est: scilicet quod ad optimam dispositionem mundi necesse est Monarchiam esse.
20. Satis igitur declarata subassumpta principalis, quia conclusio certa est: scilicet quod ad optimam dispositionem mundi necesse est Monarchiam esse.
B. IL SOFISMA DELLA "FALLACIA ACCIDENTIS"
Monarchia (III. 11):
Gli avversari portano poi un argomento di ragione.
Utilizzando infatti un principio del decimo libro della Metafisica, essi argomentano così:
 tutti gli esseri appartenenti ad uno stesso genere si riconducono ad uno, che è misura di tutti gli altri inclusi in quel genere;
tutti gli esseri appartenenti ad uno stesso genere si riconducono ad uno, che è misura di tutti gli altri inclusi in quel genere;
 ora tutti gli uomini appartengono allo stesso genere;
ora tutti gli uomini appartengono allo stesso genere;
 quindi vanno ricondotti ad uno come misura di tutti quanti.
quindi vanno ricondotti ad uno come misura di tutti quanti.
Se questa conclusione è vera, il Sommo Pontefice e l’Imperatore, essendo uomini, vanno ricondotti ad un solo uomo. Ma poiché non è possibile ricondurre il Papa ad altri, resta che l’Imperatore, insieme a tutti gli altri uomini, deve essere ricondotto al Papa come misura e regola; e così anche con questo ragionamento arrivano alla conclusione da essi voluta.
Per confutare tale ragionamento, ammetto come vera la loro affermazione che «tutti gli esseri appartenenti allo stesso genere debbono ricondursi ad un essere di quel genere, che, nell’ambito di questo, costituisce la misura»; come pure è vera l’affermazione che tutti gli uomini appartengono ad un medesimo genere; ed è vera altresì la conclusione ricavata da tale premessa, che cioè tutti gli uomini vanno ricondotti ad un’unica misura nell’ambito del loro genere. Ma quando da questa conclusione essi inferiscono la conseguenza applicativa nei confronti del Papa e dell’Imperatore, incorrono nella fallacia dell’accidente [40].
Per afferrare bene questo bisogna tener presente che una cosa è essere uomo e un’altra essere Papa, come d’altra parte una cosa è essere uomo e un’altra essere Imperatore, così come una cosa è essere uomo e un’altra essere padre e signore.
L’uomo infatti è quello che è per la sua forma sostanziale, in forza della quale rientra in una specie e in un genere, ed è posto nella categoria della sostanza; il padre invece è tale per una forma accidentale che è la relazione, per la quale rientra in una specie e in un genere particolari, ed è posto nella categoria dell’«ad aliquid», cioè della «relazione». Se così non fosse, tutto si ricondurrebbe - ma ciò è falso - alla categoria della sostanza, dal momento che nessuna forma accidentale può sussistere per se stessa senza il supporto di una sostanza sussistente.
Pertanto Papa e Imperatore essendo ciò che sono in forza di certe relazioni (quelle appunto dell’autorità papale e dell’autorità imperiale, la prima delle quali rientra nell’ambito della paternità e l’altra nell’ambito del dominio), è chiaro che Papa e Imperatore, in quanto tali, devono essere posti nella categoria della relazione e quindi essere ricondotti ad un elemento rientrante in tale categoria. Quindi affermo che altra è la misura cui debbono essere ricondotti in quanto uomini, ed altra in quanto Papa e Imperatore.
Infatti, in quanto uomini, vanno ricondotti all’uomo perfetto (che è misura di tutti gli altri e, per così dire, loro modello ideale, chiunque esso sia), come a quello che è sommamente uno nel suo genere, come si può rilevare dai capitoli finali dell’Etica a Nicomaco. Invece, in quanto sono termini di relazione, allora, com’è evidente, o vanno ricondotti l’uno all’altro (se l’uno è subalterno all’altro o se sono accomunati nella specie per la natura della relazione), oppure ad un terzo elemento come alla loro comune unità.
Ora, non si può affermare che uno sia subalterno all’altro, poiché, in tale caso, l’uno si predicherebbe dell’altro, il che è falso (noi infatti non diciamo che l’Imperatore è Papa e nemmeno viceversa); e neppure si può affermare che siano accomunati nella specie, in quanto l’essenza formale di Papa è diversa da quella di Imperatore in quanto tale. Quindi si riconducono a qualcos’altro, in cui devono trovare la loro unità.
A questo proposito bisogna tener presente che i soggetti delle relazioni stanno tra di loro come le rispettive relazioni. Ora quelle particolari relazioni d’autorità che sono il Papato e l’Impero vanno ricondotte ad una [suprema] relazione d’autorità, da cui quelle discendono con le loro determinazioni particolari; quindi i soggetti di quelle relazioni, cioè il Papa e l’Imperatore, andranno anch’essi ricondotti a qualche soggetto unitario che realizzi la relazione d’autorità nella sua essenza formale, al di fuori di ogni determinazione particolare.
E questo soggetto unitario sarà o Dio stesso, in cui tutte le relazioni particolari trovano la loro unificazione assoluta, oppure una qualche sostanza inferiore a Dio, nella quale la relazione d’autorità, che proviene da quella relazione assoluta, si particolarizza attraverso una differenziazione nel grado d’autorità. E così diventa chiaro che Papa e Imperatore, in quanto uomini, vanno ricondotti ad un elemento comune, mentre, in quanto formalmente Papa e Imperatore, ad un elemento comune diverso. Attraverso questa distinzione si risponde all’argomento di ragione [portato dagli avversari].
MONARCHIA, III. 11:
Ratione vero sic arguunt. Summunt etenim sibi principium de decimo Prime phylosophie dicentes: omnia que sunt unius generis reducuntur ad unum, quod est mensura omnium que sub illo genere sunt; sed omnes homines sunt unius generis: ergo debent reduci ad unum, tanquam ad mensuram omnium eorum.
Et cum summus Antistes et Imperator sint homines, si conclusio illa est vera, oportet quod reducantur ad unum hominem. Et cum Papa non sit reducendus ad alium, relinquitur quod Imperator cum omnibus aliis sit reducendus ad ipsum, tanquam ad mensuram et regulam: propter quod sequitur etiam idem quod volunt.
Ad hanc rationem solvendam dico quod, cum dicunt «Ea que sunt unius generis oportet reduci ad aliquod unum de illo genere, quod est metrum in ipso», verum dicunt. Et similiter verum dicunt dicentes quod omnes homines sunt unius generis; et similiter verum concludunt cum inferunt ex hiis omnes homines esse reducendos ad unum metrum in suo genere.
Sed cum ex hac conclusione subinferunt de Papa et Imperatore, falluntur «secundum accidens». Ad cuius evidentiam sciendum quod aliud est esse hominem et aliud est esse Papam; et eodem modo aliud est esse hominem, aliud esse Imperatorem, sicut aliud est esse hominem, et aliud est esse patrem et dominum.
Homo enim est id quod est per formam substantialem, per quam sortitur spetiem et genus, et per quam reponitur sub predicamento substantie; pater vero est id quod est per formam accidentalem, que est relatio per quam sortitur spetiem quandam et genus, et reponitur sub genere «ad aliquid», sive «relationis». Aliter omnia reducerentur ad predicamentum substantie, cum nulla forma accidentalis per se subsistat absque ypostasi substantie subsistentis: quod est falsum.
Cum ergo Papa et Imperator sint id quod sunt per quasdam relationes, quia per Papatum et per Imperiatum, que relationes sunt altera sub ambitu paternitatis et altera sub ambitu dominationis, manifestum est quod Papa et Imperator, in quantum huiusmodi, habent reponi sub predicamento relationis, et per consequens reduci ad aliquod existens sub illo genere.
Unde dico quod alia est mensura ad quam habent reduci prout sunt homines, et alia prout sunt et Papa et Imperator Nam, prout sunt homines, habent reduci ad optimum hominem, qui est mensura omnium aliorum, et ydea ut dicam quisquis ille sit ad existentem maxime unum in genere suo: ut haberi potest ex ultimis ad Nicomacum. In quantum vero sunt relativa quedam, ut patet, reducenda sunt vel ad invicem, si alterum subalternatur alteri vel in spetie comunicant per naturam relationis, vel ad aliquod tertium, ad quod reducantur tanquam ad comunem unitatem.
Sed non potest dici quod alterum subalternetur alteri, quia sic alterum de altero predicaretur: quod est falsum; non enim dicimus «Imperator est Papa», nec e converso. Nec potest dici quod comunicent in spetie, cum alia sit ratio Pape, alia Imperatoris, in quantum huiusmodi: ergo reducuntur ad aliquid in quo habent uniri.
Propter quod sciendum quod, sicut se habet relatio ad relationem, sic relativum ad relativum. Si ergo Papatus et Imperiatus, cum sint relationes superpositionis, habeant reduci ad respectum superpositionis, a quo respectu cum suis differentialibus descendunt, Papa et Imperator, cum sint relativa, reduci habebunt ad aliquod unum in quo reperiatur ipse respectus superpositionis absque differentialibus aliis.
Et hoc erit vel ipse Deus, in quo respectus omnis universaliter unitur, vel aliqua substantia Deo inferior, in qua respectus superpositionis per differentiam superpositionis a simplici respectu descendens particuletur. Et sic patet quod Papa et Imperator, in quantum homines, habent reduci ad unum; in quantum vero Papa et Imperator, ad aliud: et per hoc patet ad rationem.
NOTA [40]. Il sofisma della fallacia accidentis si ha quando ciò che si dice di un soggetto si fa valere anche per il suo accidente (o viceversa), mentre non necessariamente vale per questo, in quanto sostanza e accidente non sono identici nella loro essenza formale, pur riferendosi allo stesso soggetto. Aristotele fa questo esempio: A è uomo; ora B è diverso da A; quindi B non è uomo, ove la diversità nelle proprietà accidentali individuali (es. uno è biondo, l’altro è bruno) viene erroneamente trasferita alla loro essenza specifica, che invece è identica.
Dante prospetta diffusamente il caso inverso di un’identità essenziale (papa e imperatore in quanto uomini sono identici nella specie) che si vorrebbe trasferire ai loro rispettivi accidenti quali sono le funzioni di papa e imperatore, che invece sono relationes diverse e specificamente contrarie, e quindi non mediabili e non riducibili ad unum o riferibili ad una stessa sostanza, per cui chi li identifica o li assoggetta l’uno all’altro va contro la legge di non-contraddizione e cade nella fallacia accidentis. (traduzione e nota di Pio Gaja)
* Sul tema, nel sito, si cfr.:
RATZINGER ’A SCUOLA’ DEL VISIONARIO SWEDENBORG. Una nota di Leonard Boff e una di Immanuel Kant
- A LEZIONE DA PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo, e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).
- AL DI LA’ DELLA LEZIONE DI PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).
- FORZA "CRISTO RE"!!! (Paolo di Tarso)" vivendo secondo la verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa verso di lui, che è il capo, Cristo, dal quale tutto il corpo, ben compaginato e connesso, mediante la collaborazione di ogni giuntura, secondo l’energia propria di ogni membro, riceve forza per crescere in modo da edificare se stesso nella carità" (Ef. 4,15-16)
- "È significativo che l’espressione di Tertulliano: "Il cristiano è un altro Cristo", sia diventata: "Il prete è un altro Cristo"" (Albert Rouet, arcivescovo di Poitiers, 2010.)
- L’IMPERATORE COSTANTINO, LA "PAROLA" DI "DIO", E LA FIGURA DI "MICHELE" - OGGI: [...] San Michele. Voi sapete che cosa vuol dire Michele? È un nome prettamente orientale, ebraico, che vuol dire: “Quis ut Deus?”, “Chi è come Dio?”. Questa parola è parola che ha vinto, parola vincente nel grande scontro tra il bene e il male. Questa parola - Michele, “Chi è come Dio?” - ha vinto [...] “Quis ut Deus?”. E questa parola vince, vince come una volta l’imperatore romano Costantino ha vinto nella Croce: “in hoc signo”, in questo segno vincerai. Vi auguro questa vittoria (GIOVANNI PAOLO II, "Visita Pastorale alla parrocchia di Santa Maria Assunta e San Michele a Castel Romano", 13 febbraio 1994).
- Iolanda Anna Richichi La teocrazia. Crisi e trasformazione di un modello politico nell’Europa del XVIII secolo (Firenze University Press 2016).
- "ECCLESIA DE EUCHARISTIA" (Giovanni Paolo II, 2003)
- Ubuntu: una parola da e per non dimenticare. Una nota a margine della Lettera enciclica di Giovanni Paolo II SULL’ EUCARISTIA (del 17.04.2003)
- USA (1630) - Come fare le cose con i testi: A Modell of Christian Charity di John Winthrop (Carla Vergaro - "L’ANALISI LINGUISTICA E LETTERARIA", 2017.)
IL "GRANDE RACCONTO" EDIPICO DELLA CHIESA CATTOLICO-ROMANA E’ FINITO
- OGGI, COME IERI (CONTRO I "DUE SOLI" DELLA "MONARCHIA" DI DANTE), IL GIOCO "ETERNO" DELLA DIALETTICA ("SOLE E LUNA"): "IUSTITIA DUCE, CARITATE COMITE"! GAUDIUM ET SPES ( Paolo VI, 7 dic. 1965)):
 "69. De bonorum terrestrium ad universos homines destinatione.
"69. De bonorum terrestrium ad universos homines destinatione.
 Deus terram cum omnibus quae in ea continentur in usum universorum hominum et populorum destinavit, ita ut bona creata aequa ratione ad omnes affluere debeant, iustitia duce, caritate comite [...]" ("69. I beni della terra e loro destinazione a tutti gli uomini. Dio ha destinato la terra e tutto quello che essa contiene all’uso di tutti gli uomini e di tutti i popoli, e pertanto i beni creati debbono essere partecipati equamente a tutti, secondo la regola della giustizia, inseparabile dalla carità [...]")
Deus terram cum omnibus quae in ea continentur in usum universorum hominum et populorum destinavit, ita ut bona creata aequa ratione ad omnes affluere debeant, iustitia duce, caritate comite [...]" ("69. I beni della terra e loro destinazione a tutti gli uomini. Dio ha destinato la terra e tutto quello che essa contiene all’uso di tutti gli uomini e di tutti i popoli, e pertanto i beni creati debbono essere partecipati equamente a tutti, secondo la regola della giustizia, inseparabile dalla carità [...]")
 La Fenomenologia dello Spirito... dei “Due Soli”.
La Fenomenologia dello Spirito... dei “Due Soli”.
 Ipotesi di rilettura della “Divina Commedia”.
Ipotesi di rilettura della “Divina Commedia”.
Federico La Sala
Forum
-
> LA "MONARCHIA" DI DANTE --- FILOLOGIA E CRITICA. OLTRE IL MACHIAVELLISMO, A SCUOLA DI SHAKESPEARE E COLLODI: QUANDO IL "TOPO" DIVENTA UN "GATTO" (UNA "GATTA") E SVELA IL "GOLPE" (DEL "LIONE").7 luglio 2024, di Federico La Sala
CON AMLETO (ED EDIPO), A SCUOLA DA MACHIAVELLI: TEATRO (FILOSOFIA) E METATEATRO (METAFILOSOFIA).
QUANDO IL "TOPO" DIVENTA UN "GATTO" (UNA "GATTA") E SVELA IL "GOLPE" (DEL "LIONE"). Una traccia per una ri-lettura dell’opera di Shakespeare ...
- In memoria di Sigmund Freud e Marie Bonaparte...
SHAKESPEARE E COLLODI. Se è vero, come è stato detto da qualcuno, che "L’ Amleto è antiamletico come Pinocchio è antipinocchiesco; totalmente e quindi ambiguamente", c’è da chiarire e precisare che Amleto non diventa un "ragazzino per bene" (un "Pinocchio"), ma vince la sua battaglia (personale e politica), resta fedele a se stesso, alla Legge, e al ricordo del Padre-Re, e restituisce onorevolmente a "Fortebraccio" la #corona della "Danimarca".
UNA QUESTIONE DI #STATO: "IL PRINCIPE". Se la "sconfitta" di Pinocchio passa per la morte e l’impiccagione (cap. XV) prima e poi per la falsa "rinascita" finale (Geppetto: "quando i ragazzi cattivi diventano buoni", cap. XXXVI), al contrario, la "storia" di Amleto passa per il ribaltamento della posizione e la vittoria: "Stasera si recita in presenza del re:/ una scena del dramma s’avvicina ai fatti/che t’ho detto sulla morte di mio padre. /Ti prego, quando vedi cominciare quell’episodio /con tutto l’acume della tua anima osserva mio zio." (III. 2.85-90).
LA VOLPE E IL LEONE. "Sendo, dunque, uno principe necessitato sapere bene usare la bestia, debbe di quelle pigliare la golpe e il lione; perché il lione non si defende da’ lacci, la golpe non si defende da’ lupi. Bisogna, adunque, essere golpe a conoscere e’ lacci, e lione a sbigottire e’ lupi." (N. Machiavelli, "Il Principe", cap. XVIII).
EDUCAZIONE CIVICA E CITTADINANZA ATTIVA E CRITICA: UN GATTO ("THE MOUSETRAP") E UN ("SERPENTE" CAMUFFATO DA) "TOPO". Amleto, ben consapevole (come chiarisce a Orazio) del fatto che, «se la sua [del Re Claudio] colpa occulta non si stana a un certo discorso, è uno spettro dannato quello che noi abbiam visto» (III.2. 90-92), per chiarire a sé stesso e a tutti e a tutte i dubbi, da "cacciato" si fa "#cacciatore" e aziona la "trappola per topi" ("The Mousetrap"), per mostrare come chiarire gli "amletici" dubbi: "Questo dramma è la rappresentazione di un assassinio compiuto a Vienna. Gonzago è il nome del Duca, quello di sua moglie Battista. [...] l’assassino è un certo Luciano, #nipote del Re [...]. Lo avvelena nel #giardino per prendergli il #regno. Il suo nome è Gonzago. La storia è dei nostri giorni, e scritta in italiano scelto. Ora vedrete come l’assassino ottiene l’#amore della moglie di Gonzago" (III.2.247).
NOTE:
- STORIA FILOSOFIA E ANTROPOLOGIA (KANT, 2024): CON LA EVANGELICA E FRANCESCANA "REGALITA’ ANTROPOCENTRICA DI #DANTE" ( * ), NON CON IL "PARTO MASCHIO DEL TEMPO" DELL’ANDROCENTRISMO PLATONICO-PAOLINO DI FRANCESCO BACONE. CON IL RIFERIMENTO al tema del #giardino e del #serpente ("Amleto", III.2), Shakespeare colloca la "riflessione" di Amleto nell’orizzonte del suo tempo (ricordare la Riforma Protestante, la Riforma Anglicana, Giordano Bruno, e Tommaso Campanella, Elisabetta I d’Inghilterra sul trono e sull’altare) e, in consonanza, nel solco e in continuità con il programma antropologico e teologico di Dante: andare oltre la "#caduta" (di Eva e di Adamo) e restituire a "Maria" ("Gertrude") e "Giuseppe" ("Amleto") la loro regalità antropologica (non platonico-demiurgica e cosmoteandrica) e la loro genitorialità di ogni Bambino ("Amleto" /"Cristo") del loro "stato di Danimarca".
- * Cfr. E. H. #Kantorowicz, "I #duecorpi del re. L’idea di regalità nella #teologia politica medievale" (cap. "VIII. La regalità antropocentrica: Dante"), Einaudi.
- FRANCESCO BACONE, IL "PARTO MASCHIO DEL TEMPO", E LA "VIRGINIA COMPANY". "#Francis #Bacon, latinizzato in Franciscus Baco (-onis) e italianizzato in Francesco Bacone (Londra, 22 gennaio 1561 - Londra, 9 aprile 1626), è stato un filosofo, politico, giurista e saggista inglese vissuto alla corte inglese, sotto il regno di Elisabetta I Tudor e di Giacomo I Stuart. [...] Dopo privatizzazione delle terre, come uomo politico concettualizzò la scienza del terrore assecondando e sostenendo le deportazioni di massa dei diseredati e dei poveri nelle colonie americane della #Virginia. Tra le altre cose è necessario ricordare che nel 1619 il Consiglio Privato, di cui a quel tempo Bacone faceva parte, violando apertamente la legge inglese, e per assecondare la volontà della Virginia Company, costrinse alla deportazione nelle colonie americane ben 165 bambini, provenienti dal Bridewell Palace. Di quei 165 bambini (di età compresa tra gli 8 e i 16 anni) nel 1625 a seguito dei maltrattamenti subiti nelle piantagioni ne rimasero in vita solo dodici. Le deportazioni continuarono coinvolgendo altri millecinquecento bambini nel 1627 e ulteriori quattrocento, di origine irlandese, nel 1653 [...]".
- INFANZIA, STORIA, E LETTERATURA. Carlo Collodi, "Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino (1881-1883),Cap. 15
- AMLETO (#HAMLET): LA "TRAPPOLA PER TOPI" ("THE MOUSETRAP") E IL PRINCIPE MOSCHETTIERE ("THE MUSKETEER PRINCE") ...
- UN OMAGGIO AI "#TRE MOSCHETTIERI", AL CAPOLAVORO DI #ALEXANDRE #DUMAS: «Non credete ai denigratori. "I tre moschettieri" emana un vero profumo storico: non meno di "Guerra e Pace"; un #profumo che Dumas ricava con #astuzia e #grazia dalle memorie, dalle lettere e dai romanzi del primo #Seicento.».
-
> LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE --- IL CIRCUITO DELLA "PAROLE", LA LINGUISTICA DI SAUSSURE, E LA PSICOANALISI: UN OMAGGIO A MARIE BONAPARTE.5 luglio 2024, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA FILOSOFIA, PSICOANALISI, E CIVILTA’ (KANT 2024): CRITICA DELLA COSMOTEANDRIA OCCIDENTALE.
RIATTIVARE IL "CIRCUITO DELLA PAROLE". Oltre il lacanismo (e il paolinismo), l’omaggio di Sigmund Freud a Marie Bonaparte:
 "La grande domanda, alla quale nemmeno io ho saputo rispondere, è questa: che cosa vuole la donna?” (Freud 1933). *
"La grande domanda, alla quale nemmeno io ho saputo rispondere, è questa: che cosa vuole la donna?” (Freud 1933). *- Una nota in memoria di Ferdinad de Saussure e a Sigmund Freud, e a Marie Bonaparte*
PIANETA TERRA: ALLA LUCE DEL "CANTICO DEI CANTICI" (è "l’amor che move il sole e le altre stelle"), DOPO MILLENNI DI COLONIZZAZIONE DEL " LOGOS" (DIVENTATO UN "#LOGO"), e, dopo aver gettato in pasto all’algoritmo la "lingua" ("#langue" ) del "Corso di linguistica generale" di Ferdinand de #Saussure, forse, è ora di ri-attivare antropologicamente il "circuito della #parole", e, al contempo, fare chiarezza sulle #ideologie falloforiche nelle loro tragiche pretese androcentriche e platonizzanti e passare alla "commedia" (#DanteAlighieri): almeno dai lavori di #Michelangelo Buonarroti, per riflettere teologicamente sul tema, le Sibille camminano insieme ai #Profeti nella Volta della #CappellaSistina e l’ amore di ogni "Maria" e ogni "Giuseppe" cerca di illuminare non solo il cammino di ogni loro bambino e di ogni loro bambina ("Gesù"), ma anche le loro stesse comunicazioni e le loro stesse relazioni tra di loro e con tutti gli esseri umani (e non solo).
Note:
- Célia Bertin, "Marie Bonaparte. La principessa della psicoanalisi", Introduzione di CesareMusatti, OL - Odoya Library, 2023. Cesare Musatti, con Ernst Jones, nel 1957, incontrò Marie Bonaparte a Parigi e ne ebbe una viva immagine di persona "con libertà di spirito e modernità di vedute".
- Giuliana Proietti, "Marie Bonaparte e lo studio dell’anorgasmia" ("Psicolinea" 30 Marzo 2024).
- Marie Bonaparte, Sigmund Freud,"Correspondance intégrale.1925-1939", Édition de: Rémy Amouroux,Traduction (Allemand): Olivier Mannoni, Flammarion 2022.
-
> LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE --- STORIA E LETTERATURA: RIPENSARE LA "LETTURA DANTESCA E LETTURA UMANISTICA NELL’IDEA DI IMPERO" DI MERCURINO GATTINARA PROPOSTA DA GIUSEPPE GALASSO.24 giugno 2024, di Federico La Sala
RIPENSARE LA "LETTURA DANTESCA E LETTURA UMANISTICA NELL’IDEA DI IMPERO" DI MERCURINO GATTINARA PROPOSTA DA GIUSEPPE GALASSO, RICONSIDERANDO CON ATTENZIONE IL CLIMA TEOLOGICO POLITICO E SOCIALE DELLA NAPOLI E DELLA SALERNO ALL’EPOCA DEL PRINCIPE FERRANTE SANSEVERINO:
A) RICONSIDERARE LA FIGURA DI FERRANTE SANSEVERINO.
B) RIPRENDERE E RIPENSARE L’ANALISI DELLA "Lettura dantesca e lettura umanistica nell’idea di impero del Gattinara" DI GIUSEPPE GALASSO:
"«L’ideale imperiale» del Gattinara -affermó il Brandi- «non era stato diverso dal sogno imperiale di Dante». II giudizio del Brandi merita una considerazione particolare. E noto che la svolta fondamentale negli studi sul cancelliere di Carlo V è stata segnata dalle ricerche e dai lavori di Carlo Bornate tra la fine del secolo xix e i primi decenni del secolo xx. E anche noto, pero, che «i risultati del Bornate sarebbero passati inosservati, se non fosse stato per le ricerche di Karl Brandi, due decennii dopo, nella preparazione del suo grande studio su Carlo V», il cui primo volume apparve nel 1937 e il secondo, contenente appunto, con le note al primo volume, gli esiti di quelle ricerche, nel 1941. Eppure, l’importanza del Gattinara nell’ entourage di Carlo V fu ben nota agli stessi contemporanei’’. Sarebbe di grande interesse spiegare l’oblio al quale la sua figura storica appare consegnata fino a che, da Bornate e Brandi in poi, egli è riemerso come un punto di riferimento fondamentale nella storiografia su Carlo V per gli anni ’20 del lungo regno dell’Imperatore’. Qui noi ci vogliamo, pero, fermare piuttosto sull’idea di impero, per la quale si ha un consenso generale degli studiosi nel vedere in essa uno dei motivi piü importanti, se non proprio il piú importante, della sua influenza su Carlo V. [...]
[...] attraverso un’acuta riflessione sul mutare delle circostanze secondo il corso degli eventi; é nella centralita della posizione dinastica asburgica, perno di quella tradizione; che Gattinara maturo le convinzioni e le posizioni per cui esercitò su Carlo V, specialmente in alcuni momenti o su alcuni problemi, un’influenza notevole.
Ben poco c’entra, come si è visto, l’idea imperiale di Dante; e ben poco anche
l’Umanesimo, erasmiano o non erasmiano che fosse. Molto, invece, c’entrava il tipo di cultura giuridico-amministrativa, che fu suo; e molto anche O rápido assorbimento dei principii e delle spinte dell’ideologia e della politica asburgica: una restaurazione della maestà imperiale in tutto ñ suo prestigio, vigore, ampiezza, specialmente dacché, grazie ai matrimoni borgognoni e iberici, «la potenza mondiale della casa offriva a questeaspirazioni di dominio sopranazíonale una base moderna e concreta». Ed è, quindi, alla luce di queste considerazíoní che vanno letti anche gli indirizzi di politica italiana e imperiale di cui il Gattinara si fece interprete e propose all’attenzione del suo Imperatore, sulla base di valutazioni molto più realistiche, modeme, pregne di «ragion di
stato» e di Real-politik e molto meno ideologiche e volte al passato di quanto molti studiosi ancora ritengono. " (cfr. G. Galasso, "Lettura dantesca e lettura umanistica nell’idea di impero del Gattinara", pp. 93-114, - ripresa parziale, senza note).
C) RILEGGERE LA MONARCHIA DI DANTE ALIGHIERI, FOCALIZZANDO L’ATTENZIONE SULLA DOTTRINA DEI "DUE SOLI", E, IN PARTICOLARE, SULLA LETTERA DI MERCURINO GATTINARA AD ERASMO DI ROTTERDAM DEL MARZO DEL 1527 PER SOLLECITARLO A PROMUOVERE UNA EDIZIONE DELL’OPERA DI DANTE (cfr. Enrico Castelli, "Machiavellismo e Cristianesimo", in: E. Castelli," I presupposti di una teologia della storia", Padova 1968, p. 217).
Federico La Sala
-
> LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE, E --- UN "ALBERO" SEMPRE VERDE DEL PIANETA TERRA. Una nota sulla citazione dai "Salmi" (1,3) da parte di Dante18 aprile 2024, di Federico La Sala
"DUE SOLI", A #GLORIA E A #MEMORIA DI #DANTE, UN "#ALBERO" SEMPRE VERDE DEL #PIANETATERRA:
#ENIGMISTICA #CRUCIVERBA, #FILOLOGIA E #ANTROPOLOGIA #POLITICA.
Una breve nota alla parte iniziale del primo capoverso del Libro Primo del capitolo I della #Monarchia di #DanteAlighieri:
- "Gli uomini tutti, cui la natura superiore ha infuso l’impulso ad amare la verità, sembrano dare il massimo valore al fatto di lavorare per i posteri, onde questi ricavino un arricchimento dalle loro fatiche, così come essi stessi sono stati arricchiti dal lavoro degli antichi. Stia quindi pur certo di aver mancato al proprio dovere colui che, dopo aver fruito di tanti insegnamenti forniti dalla società, non si cura poi a sua volta di recare qualche contributo al bene comune: egli infatti non è un “albero che lungo il corso delle acque porta frutti nella sua stagione” [Salmi, 1.3], ma piuttosto è una voragine perniciosa che ingoia sempre senza mai restituire quanto ha ingoiato. Perciò, ripensando spesso fra me queste cose e non volendo un giorno essere tacciato di aver colpevolmente sotterrato il mio talento, desidero non solo accrescere la mia cultura, ma anche portare frutti per il bene pubblico, dimostrando delle verità che altri non hanno mai affrontato. [...]" (cfr. Dante Alighieri, "Monarchia", in "Opere minori di Dante Alighieri", vol. II, #UTET, Torino, 1986).
RILEGGENDO #OGGI QUESTE CHIARISSIME PAROLE DI AVVIO DEL "DISCORSO" E, CONTEMPORANEAMENTE, GUARDANDO DAL #TEMPO IN CUI è stata scritta l’Opera, appunto, la #Monarchia, non c’è che da riferire allo stesso Autore , cioè #DanteAlighieri, la "visione profetica" incorporata nella citazione dei versi ripresi dal testo biblico: "Sarà come albero piantato lungo corsi d’acqua, /che darà frutto a suo tempo /e le sue foglie non cadranno mai; / riusciranno tutte le sue opere" (Salmi, 1.3); RINGRAZIARLO E, POSSIBILMENTE, CERCARE DI CAPIRE MEGLIO LA SUA PROPOSTA ANTROPOLOGICA E TEOLOGICO-POLITICA, SINTETIZZABILE NELLA #FORMULA PARADIGMATICA DEI "#DUE SOLI".
***
"DUE SOLI" IN #TERRA, E UN SOLO #SOLE IN CIELO: "#TRE SOLI". #GENERE UMANO: "I SOGGETTI SONO DUE, E TUTTO E’ DA RIPENSARE"! NON SOLO SUL PIANO TEOLOGICO-POLITICO .
-
> LA "MONARCHIA" DI DANTE --- FILOLOGIA E ANTROPOLOGIA. Con lo spirito dell’opera “The Penelopiad” di Margaret Atwood e della "Divina Commedia" di Dante Alighieri, un segnavia di uscita dall’orizzonte della tragedia10 marzo 2024, di Federico La Sala
PENELOPE-IDEA E COMMEDIA: FILOLOGIA E ANTROPOLOGIA. Con lo spirito dell’opera “The Penelopiad” di Margaret Atwood e della "Divina Commedia" di Dante Alighieri, un segnavia di uscita dall’orizzonte della tragedia...
#STORIAELETTERATURA. Data la immersione totale di tutta la cultura occidentale nell’immaginario dell’#Odissea, "étudier, très succinctement, la technique d’« écriture féminine » de Margaret Atwood, à travers son ouvrage «The Penelopiad» et plus précisément, à travers l’ironie dans son rapport aux «métamorphoses» apportées au texte de l’Odyssée d’Homère" (cfr. Rebecca Plewinski, "La technique d’«écriture féminine» de Margaret Atwood: l’exemple de The Penelopiad») che con mente "penelope-idea" sa catturare e aggiogare persone e popoli con il proprio "canto" e l’ esperienza tragica della sua "fenomenologia dello #spirito".
L’ALBA DELLA MERAVIGLIA ("Earthrise"). Per #Dante, con l’aiuto del "padre" #Virgilio ("Eneide") su sollecitazione della "#bella e beata" #madre Beatrice (sollecitata a sua volta da Lucia, inviata da Maria, madre di Gesù "Cristo"), la "folle impresa" di uscire dalla "selva oscura" e ritrovare la "diritta via", con il vecchio "Ulisse" e con la vecchia "Penelope" sulle proprie spalle, è possibile: è l’amore che muove il sole e le altre stelle.
- STORIA E LETTERATURA E ANTROPOLOGIA: MARGARET ATWOOD, "IL CANTO DI PENELOPE" (Wikipedia).
- ANTROPOLOGIA #PSICOANALISI E #8MARZO2024: RICORDANDO #DANTEALIGHIERI E I #DUESOLI DELLA SUA "MONARCHIA", RIPENSARE L’#UNO, ri-pensare l’ONU - a partire da #Due, "almeno due" (#GregoryBateson).
 CON #BATESON, OLTRE #VERSAILLES: LA FRANCIA, CON UN PASSO DECISIVO, SI E’ PORTATA (E IN-VITA A PORTARSI) COSTITUZIONAL-MENTE OLTRE L’ORIZZONTE DEMIURGICO DELL’#ANDROCENTRISMO DELLA #TRAGEDIA E HA RESTITUITO ALLA #DONNA LA SUA "KANTIANA" FACOLTA’ DI #GIUDIZIO.
CON #BATESON, OLTRE #VERSAILLES: LA FRANCIA, CON UN PASSO DECISIVO, SI E’ PORTATA (E IN-VITA A PORTARSI) COSTITUZIONAL-MENTE OLTRE L’ORIZZONTE DEMIURGICO DELL’#ANDROCENTRISMO DELLA #TRAGEDIA E HA RESTITUITO ALLA #DONNA LA SUA "KANTIANA" FACOLTA’ DI #GIUDIZIO.
-
> LA "MONARCHIA" DI DANTE --- NATURA, INTELLIGENZA ASTUTA, E GRATITUDINE: "L’AMORE NON è LO ZIMBELLO DEL TEMPO" (W. Shakespeare, Sonetto 116)10 febbraio 2023, di Federico La Sala
FILOLOGIA E ANTROPOLOGIA: NATURA, INTELLIGENZA ASTUTA, E GRATITUDINE ...
Una sollecitazione a pensare al "mondo divenuto favola" (lezione di Esopo, Fedro, e Nietzsche): come la filosofia, la teologia, e la politica mondiale, senza più Grazia (gr.: XAPIS, "CHARIS") e senza più Grazie (gr.: XAPITES, "CHARITES") perde la testa e ricade nel sacco, nella tradizionale "luminosa" caverna dell’ "homo homini lupus est" ... Dov’è l’etica? E dove la carità (gr. XAPITAS, "CHARITAS") della stessa grazia ("charis")?!
 MEMORIA (E MUSE): "L’AMORE NON è LO ZIMBELLO DEL TEMPO" (W. Shakespeare, Sonetto 116).
MEMORIA (E MUSE): "L’AMORE NON è LO ZIMBELLO DEL TEMPO" (W. Shakespeare, Sonetto 116).- Il lupo e il contadino
- Un lupo supplicò un contadino di nasconderlo ma, quando il pericolo fu passato, saltò fuori e volle mangiarsi il suo salvatore. «Non è giusto che tu mangi chi ti ha aiutato!» esclamò il contadino, ma il lupo ribatté: «Nessuno mai ricorda i benefici ricevuti. Perché dovrei essere io il primo a ricordarlo?». «Ti prego, lupo, sentiamo cosa ne pensano i passanti, prima di decidere».
- Si trovava a passare di là un vecchio cane e confermò che il suo padrone, dopo anni di fedele servizio lo trattava, ora che non gli era più utile, con immensa ingratitudine. Giunse anche un cavallo e ammise di aver ricevuto lo stesso trattamento del cane.
- Il contadino oramai disperava di dissuadere il lupo dal mangiarlo e quindi di salvarsi quando, d’improvviso, vide arrivare una volpe e, confidando nella sua astuzia, le fece un cenno d’intesa e rivolgendosi al lupo disse: «Interroghiamo anche quest’ultimo passante, poi farai quello che vorrai». «Volpe cara, questo lupo non vuole essermi grato di averlo nascosto nel sacco dai cacciatori che lo inseguivano. Cosa ne pensi?».
- E la volpe: «Un lupo così grosso in un sacco così piccolo? Non posso crederlo. Fatemi vedere.» Il lupo rientrò nel sacco e subito la volpe aiutò il contadino a chiuderlo ben bene con un grosso nodo. L’uomo prese allora un bastone, riempì di legnate il lupo ch’era dentro il sacco e poi si girò verso la volpe e atterrò anche lei con un gran colpo in testa esclamando poi: «Sai, volpe? A forza di dirmelo hanno convinto anche me che la gratitudine non esiste affatto!».
PSICOANALISI E "DISAGIO NELLA CIVILTÀ" (S. FREUD, 1929): "Il sentimento di gratitudine è una delle espressioni più evidenti della capacità di amare. La gratitudine è un fattore essenziale per stabilire il rapporto con l’oggetto buono e per poter apprezzare la bontà degli altri e la propria. (Melanie Klein).
-
> LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE, E -- STORIA E MEMORIA: DANTE ALL’INFERNO PER PAPA GIOVANNI XXII E BUFFALMACCO (IN UN AFFRESCO DEL TRECENTO A PISA).3 febbraio 2022, di Federico La Sala
ARCHEOLOGIA FILOSOFICA E ANTROPOLOGIA.
MEMORIA DELLA MONARCHIA DEI #DUESOLI (#DANTE2021) E STORIA DELLA LOTTA "COSMOTEANDRICA" TRA PAPA (guelfi) E IMPERATORE (ghibellini).
RINASCIMENTO E #COSMOLOGIA. Dante all’inferno per Giovanni XXII e Buffalmacco (https://www.artribune.com/arti-visive/archeologia-arte-antica/2022/02/professoressa-normale-dante-alighieri-affresco-pisano-trecento/ ) ....
Oggi, si continua a parlare di Sole-Luna ma si ignora non solo la cosmologia della relatività di Galileo Galilei e Albert Einstein, ma anche la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo (1948), la Costituzione della Repubblica italiana (1948), la "Pacem In Terris" dfi Giovanni XXIII (1963), ma anche lo stesso #sorgeredellaTerra (https://it.wikipedia.org/wiki/Sorgere_della_Terra), dell’Earthrise (24 dicembre 1968)!
Federico La Sala
-
> LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE, E --- LA "MUSICA DELLE SFERE": DANTE GAFFURIO, LEONARDO, E LA "MITOLOGIA CREATIVA" (J. CAMPBELL)..1 febbraio 2022, di Federico La Sala
DANTE2021
LA MEMORIA DI APOLLO E DELLE MUSE E IL MESSAGGIO SEGRETO DELLA DIVINA COMMEDIA, DEL MUSICO DI LEONARDO, DELLA PRATICA DELLA MUSICA DI GAFFURIO, E DELLA GAIA SCIENZA DI NIETZSCHE...
- DISAGIO DELLA CIVILTÀ (FREUD, 1929). Tenendo ferma la generale non-volontà di sapere di sé e la messa fuori campo della musica dalle accademiche orecchie platoniche (colpite da cecità e zoppia come quelle di Edipo) per le quali già il solo "parlare è suonare il proprio corpo" (Alfred Tomatis), il messaggio di fondo di questi grandi interpreti della tradizione europea è rimasto per lo più "segreto" (esoterico)
A) IL MUSICO. "Il messaggio segreto nel quadro di Leonardo: Un messaggio nascosto, per di più in chiave musicale, all’interno di un quadro: “Il Ritratto di Musico” di Leonardo da Vinci. Lo ha svelato lo storico d’arte e ricercatore siciliano Giuseppe Petix alla Fordham University di New York. [...] Petix ci racconta anche: «Il rebus all’interno del cartiglio è stato trovato grazie alle conoscenze musicali che abbiamo del periodo di Leonardo. Un rebus che se decifrato forma il versetto o meglio il rondò “Oh Re fammi lagnar: Sol l’amore mi fa sollazzar”, che in versione prosaica potrebbe essere visto così “Oh dio, permettermi di lamentarmi, concedimi un lamento da uomo, solo l’amore mi rende felice”». Un inno, quindi, una preghiera, una richiesta di aiuto [...] Questa frase ricorda le lamentazioni presenti nei salmi della bibbia, e di preciso il "dio" del quale si parla potrebbe rappresentare l’anima del Davide Biblico [...]" (Laura Pace , i.Italy, November 25, 2019)
C) LA GAIA SCIENZA (IV, fr. 334). "Si deve #imparare anche l’amore. Si deve imparare ad amare. Ecco quel che ci accade nella musica: si deve prima imparare a udire una sequenza e una melodia in genere, a enuclearla nell’ascolto e a distinguerla isolandola e delimitandola come se avesse una vita propria; quindi bisogna sforzarci e impiegare la nostra buona volontà per sopportarla, malgrado la sua estraneità, bisogna fare un esercizio di pazienza di fronte al suo sguardo e alla sua espressione, considerare con benevolenza quel che c’è di inusitato in essa - finalmente arriva un momento in cui ne abbiamo preso l’abitudine, in cui l’attendiamo, [...] finché non si sia diventati i suoi umili ed estasiati amanti, per cui non v’è più niente di meglio da chiedere al mondo se non la melodia e ancora la #melodia.
Questo ci accade però non soltanto con la #musica: proprio in questo modo abbiamo imparato ad amare tutte le cose che oggi amiamo. In definitiva, siamo sempre ricompensati per la nostra buona volontà, per la nostra pazienza, equità, mitezza d’animo verso una realtà a noi estranea, quando lentamente essa depone il suo velo e si manifesta come una nuova inenarrabile bellezza: è questo il suo ringraziamento per la nostra ospitalità. Anche chi ama se stesso, lo avrà appreso per questa strada: non ce ne sono altre. Si deve imparare anche l’amore. (F. Nietzsche).
D) COSMOLOGIA DANTESCA. "L’amor che move il sole e le altre stelle" (Par., XXXIII, 145).
E) DANTE LEONARDO E GAFFURIO: LE TRACCE DI UN PROGRAMMA E DI UNA STRATEGIA CULTURALE CON RADICI PROBABILMENTE GIOACHIMITE E FRANCESCANE...
Il messaggio segreto del Musico di Leonardo e il legame stretto con la Musica delle Sfere ("Theorica Musicae", (1492; "Practica Musicae", 1496) di Franchino Gaffurio (con Apollo, le Grazie, le Muse, il Cielo delle Stelle Fisse e dei Pianeti, e il Serpente) rende possibile una interpretazione e connesione con il viaggio della Divina Commedia: il cammino nel regno dell’Apollo de-caduto (dopo la venuta del nuovo Re, di Cristo), cioè di Lucifero, è finito ed è "ora" che Dante con Virgilio si liberino della loro stessa pelle di serpente e, lasciato Lucifero con" le gambe in sù" (Inf. XXXIV, 90) alle loro spalle, ... mettano i piedi a terra! La strada per il paradiso terrestre e celeste è libera.... sotto il cielo stellato, inizia la "vita nuova"!
- Nota: A proposito di RE, sicuramente legato alla tradizione criptata dell’amore (come in Dante Alighieri), da ricordare (in consonanza) che "L’Adorazione dei Magi" di Leonardo è solo a un primo livello di abbozzo: nel settembre del 1481 stava ancora lavorando al dipinto, ma pochi mesi più tardi lasciò Firenze per recarsi a Milano, alla corte di Ludovico il Moro.
F) LA MUSICA DELLE SFERE, LA DIVINA COMMEDIA, E LA QUESTIONE ANTROPOLOGICA. Nella sua "Mitologia creativa" (Milano 1992), Joseph Campbell, dopo aver premesso che "anche Dante invocò le Muse - all’inizio dell’inferno, nel Canto II - e fu guidato sia attraverso l’Inferno sia sulla cima paradisiaca del Monte del Purgatorio dal pagano Virgilio" (p. 128) e aver analizzato in dettaglio la Figura di «la Musica delle Sfere», "trattada un’opera neoplatonica del quindicesimo secolo, la Pratica musicae di Franchino Gaffurio, pubblicata a Milano nel 1496", scrive che "[...] l’intera Divina Commedia di Dante esprime questa visione pagana di una dimensione spirituale dell’universo", e, al contempo, lo "imbottiglia" (senza resti) nella tradizione cattolico-romana: "[...] Il fatto che, in Dante, il potere di guida dei pagani termini alla sommità del Purgatorio, nel Paradiso Terrestre, si accorda con la formula di san Tommaso secondo cui la ragione può condurre, come fece con gli antichi, fino al vertice delle virtù terrene, ma solo la fede e la grazia soprannaturale (personificata da Beatrice) possono portare oltre la ragione, fino alla sede di Dio". Pur, se con incertezze e difficoltà, continua e finisce paradossalmente col riportare Dante nell’orizzonte della tragedia e dell’antico patto edipico (di "mammasantissima", altro che patriarcale): "Tuttavia, analizzando questo Dio Trinitario che, nella dottrina cristiana delle tre persone divine in un’unica sostanza divina, abbiamo una trasposizione delle tre Grazie e dell’Apollo Iperboreo in un ordine mitologico di maschere escusivamente maschili di Dio, il che si accorda bene con lo spirito patriarcale dell’Antico Testamento, ma sbilancia radicalmente le connotazioni simboliche, e quindi spirituali, non solo del sesso e dei sessi, ma anche dell’intera natura".
Federico La Sala
-
> LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE, E ---- I "GIOCATORI DI DADI" (GEORGES DE LA TOUR): "UNO. IL BATTITO INVISIBILE". Note a margine del libro di Giulio Busi.26 gennaio 2022, di Federico La Sala
IMPARARE A CONTARE! "UNO. IL BATTITO INVISIBILE". Note a margine del libro di Giulio Busi *
RICOMINCIARE DA CAPO, DALLA COSTITUZIONE: UNO NON EQUIVALE UNO (=1), MA RENDE POSSIBILE E FONDA OGNI - UNO (= 1). IN PRINCIPIO ERA IL LOGOS, NON UN LOGO! TRACCE PER UNA SECONDA RIVOLUZIONE COPERNICANA....
NONOSTANTE GIOACCHINO DA FIORE, NONOSTANTE DANTE ALIGHIERI (E LA DIVINA COMMEDIA) , NONOSTANTE GIOVANNI BOCCACCIO (E LA MEMORIA DI MELCHISEDEC E DEI TRE ANELLI), NONOSTANTE MICHELANGELO (E IL SUO TONDO DONI), NONOSTANTE LESSING (E IL SUO ELOGIO DEL SAGGIO NATHAN), NONOSTANTE FREUD E NONOSTANTE EINSTEIN ....
...SI VIVE ANCORA NEL REGIME DELL’UNO (= 1) E DELLA "DOTTA IGNORANZA" (1440) E DELLA COSMOTEANDRIA PLATONICA?!
"Dio non gioca a dadi" ma, dopo la lezione di Georges de La Tour (cfr. Giulio Busi, "Uno. Il battito invisibile": [...] A Preston Hall, nella grande serra in vetro e ferro trasformata in museo, i "Giocatori di Dadi" di Georges de la Tour accolgono i visitatori con il loro sorprendente mistero. Tre lanci, un unico risultato... I tre lanci hanno dato lo stesso risultato. Uno [...]"), l’Uno è ancora il più sfuggente e misterioso tra i numeri? Ogni essereu mano è un uno, ma ancora non si sa chi è l’Uno? Ma a che gioco giochiamo?! La storia è sempre e solo fatta da Uno (=1) solo? E i tre moschettieri lavorano ancora per il solito Uno (=1)?!
UNO. IL BATTITO INVISIBILE: "L’Uno ci avvolge, pulsa in noi. Troviamolo. L’Uno è stupore, incompletezza, mistero. A tratti, in una grande sventura o in una gioia profonda, per caso o dopo avere cercato a lungo, ci rendiamo conto d’essere parte di un tutto che ci sovrasta, ci avvolge e allo stesso tempo si sottrae alla nostra #comprensione. Lo sentiamo, il tutto, senza poterlo distinguere con esattezza. Sebbene non ci sia consentito misurarlo con la #ragione, ci pare quasi di toccarlo, tanto è vicino, intimo.
 Vecchie storie bibliche, sogni di mistici, saggezza indiana, inquietudini dei filosofi greci, poesia del Novecento. Sono i bracci di un fiume immenso e segreto, che questo libro risale passo dopo passo in cerca dell’Uno, del suo fulgore, del suo battito lieve, profondo, invisibile. L’Uno, il più sfuggente e misterioso tra i numeri" (G. Busi, "Uno. Il battito invisibile", Il Mulino).
Vecchie storie bibliche, sogni di mistici, saggezza indiana, inquietudini dei filosofi greci, poesia del Novecento. Sono i bracci di un fiume immenso e segreto, che questo libro risale passo dopo passo in cerca dell’Uno, del suo fulgore, del suo battito lieve, profondo, invisibile. L’Uno, il più sfuggente e misterioso tra i numeri" (G. Busi, "Uno. Il battito invisibile", Il Mulino).- IMPARARE A CONTARE: FILOLOGIA ARTE ARTE TERAPIA E RINASCIMENTO, OGGI...
QUATTRO PROFETI (1+1+1+1) O DUE PROFETI + DUE SIBILLE?! Nella cornice del Tondo Doni di Michelangelo, secondo gli esperti della Galleria degli Uffizi, "Vi sono raffigurate la testa di Cristo e quelle di quattro profeti" (https://www.uffizi.it/opere/sacra-famiglia-detta-tondo-doni)? Non è bene, forse, rianalizzare il quadro e la cornice e ri-verificare la situazione, data la strettissima connesione anche con il lavoro portato avanti nella Cappella Sistina?!
- COSMOLOGIA ANTROPOLOGIA E CIVILTA’...
... IMPARARE A CONTARE E USCIRE da interi millenni di labirinto (Nietzsche) e riprendere la diritta via (Dante2021), comporta un globale capovolgimento del puntodivista e, con Freud, l’aprire gli occhi (tutti e due) e guardare finalmente "da dove veniamo"... e lo straordinario sorgere della Terra, come è apparso ai primi esploratori del cosmo ...
DANTE2021, QUESTIONE ANTROPOLOGICA (ECCE HOMO) E GIOCO DELLA TUNICA:
 QUATTRO SOLDATI, TRE GIOCATORI DI DADI E PROBLEMA DELL’UNO.
QUATTRO SOLDATI, TRE GIOCATORI DI DADI E PROBLEMA DELL’UNO.
 A CHE GIOCO GIOCHIAMO?! Ancora al Grand Tour della cosmoteandria?
A CHE GIOCO GIOCHIAMO?! Ancora al Grand Tour della cosmoteandria?FLS
-
> LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE, E --- LE "RES GESTAE" DI AUGUSTO: L’ITALIA, LE SUE "28 COLONIE, E LA FONDAZIONE DI AOSTA (25 a. C.)..14 dicembre 2021, di Federico La Sala
DANTE 2021: ARCHEOLOGIA, ANTROPOLOGIA, FILOSOFIA, E STORIOGRAFIA...
A 700 ANNI DALLA MORTE DI DANTE ALIGHIERI, UN INVITO A RILEGGERE la sua "Monarchia", a cercare di capire meglio le ragioni di "quella Roma onde Cristo è romano" (Purg. XXXII, 102), e rimeditare le "Res Gestae" di Augusto, alla luce dei 2046 anni dalla fondazione di Aosta, avvenuta nel 25 a. C., in coincidenza con il solstizio d’inverno.
AUGUSTO, L’ITALIA, E LE SUE "28 COLONIE":
- Le Res gestae divi Augusti, cioè Le imprese del divino Augusto, o Index rerum gestarum, sono un resoconto redatto dallo stesso imperatore romano Augusto prima della sua morte e riguardante le opere che compì durante la sua lunga carriera politica. Il testo ci è giunto inciso in latino e in traduzione greca sulle pareti del tempio di Augusto e della dea Roma (Monumentum Ancyranum) ad Ancìra (latino Ancyra), l’odierna Ankara in Turchia.
- Indice
- 1 L’originale e le copie sopravvissute
 2 Funzione e testo delle Res Gestae
2 Funzione e testo delle Res Gestae
 3 Testo latino e traduzione delle Res Gestae dal Monumentum Ancyranum
3 Testo latino e traduzione delle Res Gestae dal Monumentum Ancyranum
 [...]
[...]
- Testo latino e traduzione delle Res Gestae dal Monumentum Ancyranum
- Il testo si compone di un’introduzione, 35 paragrafi raggruppabili in 3 sezioni, e un’appendice.
- Pars prima (paragrafi 1 a 14): essa descrive la carriera politica di Augusto, il suo cursus honorum, le cariche, uffici e onori che egli ha ricevuto o dato.
- Pars altera (paragrafi 15 a 24): essa cita le distribuzioni di denaro, i giochi e i monumenti offerti al popolo di Roma.
- Pars tertia (paragrafi 25 a 35): in essa Augusto parla delle sue conquiste militari e della sua azione diplomatica.
- Appendix: scritta in terza persona contrariamente al resto del testo, non fu probabilmente scritta per mano di Augusto. Questa appendice riassume le spese sostenute da Augusto per l’erario, per i monumenti dell’Urbe, per i giochi e per far fronte a diverse calamità naturali. Illuminante l’ultima frase cui si citano le spese sostenute per amici e senatori, caduti tanto in disgrazia da non avere più il censo richiesto per far parte del senato. Tali spese furono innumerabilis, ovvero, non conteggiabili.
- Introduzione
- «Rerum gestarum divi Augusti, quibus orbem terra[rum] imperio populi Romani subiecit, et impensarum, quas in rem publicam populumque Romanum fecit, incisarum in duabus aheneis pilis, quae su[n]t Romae positae, exemplar sub[i]ectum.»
- «Narrazione delle imprese del divino Augusto attraverso le quali sottomise tutto il mondo al potere del popolo romano, e del denaro che spese per la Repubblica e per il popolo romano, come sta scritto su due pilastri di bronzo a Roma.
- [N 1. «La praescriptio non fu certamente scritta da Augusto, come dimostra l’epiteto divus conferito all’imperatore divinizzato solo dopo la sua morte.»]
- [...]
- «28. Colonias in Africa Sicilia Macedonia utraque Hispania Achai[a] Asia S[y]ria Gallia Narbonensi Pi[si]dia militum deduxi. #Italia autem XXVIII [colo]nias, quae vivo me celeberrimae et frequentissimae fuerunt, me auctore deductas habet.»
- «28. Fondai colonie di soldati in Africa, in Sicilia, in Macedonia, in entrambe le Spagne, in Acaia, in Asia, in Siria, nella Gallia Narbonense, in Pisidia. L’#Italia poi possiede, fondate per mia volontà, ventotto colonie, che durante la mia vita furono assai prosperose e popolose»
- [N 53. Sull’identificazione delle 28 colonie augustee d’Italia, cfr. M. Lilli, "L’Italia romana delle regiones", 2004. La deduzione coloniale da parte di Augusto appare ragionevolmente certa per Ariminum, Ateste, Augusta Praetoria, Augusta Taurinorum, Bononia, Dertona, Fanum, Luceria, Lucus Feroniae, Minturnae, Parma, Pisae, Puteoli, Suessa, Urbs Salvia, Venafrum].
- [...]
Sul tema, in rete e nel sito, si cfr.:
- Augusto (Roma, 23 settembre 63 a.C. - Nola, 19 agosto14) è Augusto; Costantino (Naissus, 27 febbraio 274 - Nicomedia, 22 maggio 337) è Costantino e la Donazione di Costantino è la donazione di Costantino - in memoria di Lorenzo Valla.
STORIA E STORIOGRAfIA DEL FASCISMO, "UN RINATO SACRO ROMANO IMPERO" (A. GRAMSCI, 1924).
 IL MITO DELLA ROMANITÀ, LA MONARCHIA, E IL FASCISMO: MARGHERITA SARFATTI E RENZO DE FELICE.
IL MITO DELLA ROMANITÀ, LA MONARCHIA, E IL FASCISMO: MARGHERITA SARFATTI E RENZO DE FELICE.DANTE, ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. Note per una riflessione storiografica
Federico La Sala
-
> LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE, E --- "La sovranità del limite". La questione della giustizia in Alain Supiot (di Mauro Cascio).4 agosto 2021, di Federico La Sala
La sovranità del limite. La questione della giustizia in Alain Supiot
di Mauro Cascio (La voce repubblicana -10/06/2021)
Chi non cerca il limite in sé è condannato a trovarlo fuori di sé. Se si dovesse sintetizzare l’ultimo lavoro di Alain Supiot, La sovranità del limite (una splendida edizione italiana pubblicata da Mimesis e curata da Andrea Allamprese e Luca D’Ambrosio), lo si farebbe così. E limite è anche legge. Se la mia libertà è quella di dispiegare me stesso (che non vuol dire fare quello che voglio, a capriccio: la mia libertà non mi consente per esempio di essere una scopa o un lampadario, se non lo sono), la giustizia è la volontà costante e perpetua di rendere a ciascuno quel che gli è dovuto. E a ciascuno il suo limite. -«Nella lingua Beti del Camerun la parola che significa giusto (sasôô) viene dal verbo soussou, che vuol dire saltare, sormontare un ostacolo. Perciò, come rileva Jean-Godeffroy Bidima [...] la giustizia (così definita) è quello che permette alla società di aprirsi un passaggio nell’intrico di significati. Essa permette agli individui che stanno litigando, oppure scambiando, di aprirsi un passaggio gli uni verso gli altri».
La questione della giustizia è ineliminabile, non ne possiamo fare a meno, ne dobbiamo dare una definizione, ne dobbiamo trovare una collocazione nella nostra idea di mondo. Ma è anche una questione insolubile, cioè ci rimane in mano come problema radicale, perché, a considerare la sua scienza con quella neutralità assiologia che i giuristi vorrebbero (senza cioè ‘sistemi’ filosofici à la Hegel), “non è riducibile all’applicazione di una norma quale che sia, poiché nella nostra tradizione giuridica essa è la ‘madre delle leggi’”. «Principio metagiuridico, la giustizia è stata spesso rappresentata sotto forma di una dea (oggi di una Idea) di cui i giuristi sarebbero i sacerdoti».
E a proposito della Poiesis della Giustizia e della sua rappresentazione poetico-religiosa non possiamo trascurare l’opera di Pietro Piacentino (1130-1192). «Piacentino, che sostiene di aver scoperto il Tempio della Giustizia mentre passeggiava in campagna, lo descrive così. Al centro siede la Giustizia, che esprime dignità ma anche tristezza. Porta sulla testa la Ragione dallo sguardo penetrante, e tra le braccia l’ultima figlia, Equitas, dal volto pieno di bontà, che si sforza di equilibrare i piatti della bilancia tenuta da sua madre». È circondata da sei virtù civiche.
 (1) Innanzitutto la Religio consistente nell’omaggio e nel culto alle “cose sacre”. La cosa sacra, beninteso, è la ragione fondativa stessa, per esempio la Costituzione della Repubblica Romana, i primi articoli della Costituzione Italiana, quanto eleva il principio della dignità umana. La Religio non va confusa con il “sentimento oceanico” descritto da Freud: non riguarda il privato e il foro interiore, bensì il pubblico e il foro esterno.
(1) Innanzitutto la Religio consistente nell’omaggio e nel culto alle “cose sacre”. La cosa sacra, beninteso, è la ragione fondativa stessa, per esempio la Costituzione della Repubblica Romana, i primi articoli della Costituzione Italiana, quanto eleva il principio della dignità umana. La Religio non va confusa con il “sentimento oceanico” descritto da Freud: non riguarda il privato e il foro interiore, bensì il pubblico e il foro esterno.
 (2) La Pietas, filiale e patriottica.
(2) La Pietas, filiale e patriottica.
 (3) La Gratia, la virtù consistente nel ricordare i servizi ricevuti nella Città e nel restituirli.
(3) La Gratia, la virtù consistente nel ricordare i servizi ricevuti nella Città e nel restituirli.
 (4) La Vindicatio, da non tradurre come ‘vendetta’, perché il verbo latino vindico equivale all’inglese to vindicate: reclamare giustizia.
.(5) L’Observantia, la deferenza che si mostra a persone superiori in merito e in dignità.
(4) La Vindicatio, da non tradurre come ‘vendetta’, perché il verbo latino vindico equivale all’inglese to vindicate: reclamare giustizia.
.(5) L’Observantia, la deferenza che si mostra a persone superiori in merito e in dignità.
 (6) La Veritas. Verità, certo, ma anche lealtà.
(6) La Veritas. Verità, certo, ma anche lealtà.La tendenza contemporanea del diritto, chiosa Supiot, è quello di darsi semplicemente come oggetto. Anche questo è un grave errore di chi non accetta un’architettura dei saperi e pretende che le scienze dello Spirito siano isolate l’un l’altra. Il diritto oggettivo che semplicemente sta è una cosa che non è a capace, in quanto a stare, nemmeno di stare in piedi e che dipende dai capricci e dalle convenzioni a cui si appoggia per non cadere. E già dire così significa ammettere che il diritto è sempre soggettivo, le condizioni sono spesso singolari e si danno una condizione data, cioè in un momento storico del determinarsi dello Spirito.
 Già Michel Foucault aveva osservato la connessione tra istituzioni e soggettività. Non ci può essere una rigida contrapposizione: le istituzioni devono essere fatte di soggettività. Ma Vico e Montesquieu hanno fatto di meglio, perché sono stati più attenti a non ridurre il tutto a schemi formali, esterno ai soggetti. Il diritto è di chi lo partecipa. La sostanza del diritto è la morale. Lo schema formale esterno ai soggetti è la dittatura. L’istituzione vissuta dai soggetti la Repubblica.
Già Michel Foucault aveva osservato la connessione tra istituzioni e soggettività. Non ci può essere una rigida contrapposizione: le istituzioni devono essere fatte di soggettività. Ma Vico e Montesquieu hanno fatto di meglio, perché sono stati più attenti a non ridurre il tutto a schemi formali, esterno ai soggetti. Il diritto è di chi lo partecipa. La sostanza del diritto è la morale. Lo schema formale esterno ai soggetti è la dittatura. L’istituzione vissuta dai soggetti la Repubblica. -
> LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE, E IL VATICANO CON IL SUO TRADIZIONALE SOFISMA DELLA "FALLACIA ACCIDENTIS". --- Simone Weil batte Carl Schmitt? «Senza coscienza del limite non c’è diritto né giustizia». Parla il giurista francese Alain Supiot (di Simone Paliaga).3 agosto 2021, di Federico La Sala
Idee.
«Senza coscienza del limite non c’è diritto né giustizia»
Parla il giurista francese Alain Supiot: «Il neoliberismo piega la democrazia alla ricerca di una efficienza economica a breve termine. E questo favorisce l’adesione all’uomo forte»
di Simone Paliaga (Avvenire, martedì 3 agosto 2021).
L’illimitato, il superamento dei limiti sembra essere la cifra caratterizzante il mondo di oggi. Ne parla in La sovranità del limite (Mimesis, pagine 216, euro 18,00) Alain Supiot, professore emerito del Collège de France e membro della Commissione mondiale sul futuro del lavoro.
Cosa significa l’espressione “sovranità del limite”, professore?
L’idea si ispira a Simone Weil, una delle più grandi menti del XX secolo. Nel suo libro La prima radice, scritto a Londra poco prima di morire, nel 1943, critica la sentenza di Hitler per cui “la forza regna ovunque e da sola domina la debolezza”. A essa, che esprime rozzamente una convinzione ampiamente condivisa nella civiltà occidentale, risponde che “la forza bruta non è sovrana quaggiù. È per natura cieca e indeterminata. Ciò che è sovrano qui è la determinazione, il limite”. Purtroppo il suo messaggio è rimasto inascoltato. Le correnti principali della filosofia politica, della sociologia o dell’economia hanno ridotto qualsiasi tipo di rapporto umano a un rapporto di dominio rimanendo cieche dinanzi ai limiti delle risorse del pianeta. Le molteplici crisi che ci assalgono oggi ricordano che gli uomini incapaci di autocontrollo sono condannati a raggiungere il loro limite catastrofico, come Hitler nel suo bunker il 30 aprile del 1945.
Simone Weil batte Carl Schmitt, dunque?
Schmitt, giurista cattolico e nazista, come Hitler fa del potere il segno della sovranità. L’opposizione con Weil diventa più chiara risalendo ai dibattiti medievali sull’Onnipotenza divina. Per alcuni, questa onnipotenza è assoluta, così che non esiste ordine nel mondo che non possa essere abolito in qualsiasi momento dalla volontà di Dio. Per altri, si tratta di una Onnipotenza ordinata: Dio si sarebbe autolimitato per lasciare spazio alla sua creazione e alla libertà umana. L’idea dell’autocontrollo di Dio si trova anche nella nozione ebraica di tzimtzum. Sovrano è chi afferma l’onnipotenza della propria volontà o chi possiede in sé il senso dei limiti della volontà? La questione si pone da quando la nozione di sovranità è stata secolarizzata per diventare, da Bodin e Descartes, l’attributo dei re e poi degli individui.
Come interiorizzare il limite?
Sul piano politico, la risposta è data da Montesquieu. “Perché non si abusi del potere, il potere deve fermare il potere”, quindi la costituzione deve garantire la separazione dei poteri. Sul piano individuale, l’interiorizzazione è l’oggetto primario dell’educazione che istituisce l’essere umano, cioè accompagna la sua crescita come il tutore sostiene la pianta finché non ne ha più bisogno. Interiorizzare le regole è una condizione di libertà. Per esercitare la libertà di espressione, per esempio, bisogna sottomettersi prima alla legge di una lingua! Più in generale, è sovrano chi non ha bisogno di un padrone perché è padrone di se stesso.
Perché affrontare oggi la questione del limite?
Perché il neoliberismo sta raggiungendo il suo limite catastrofico! A differenza del liberalismo classico, che poneva i calcoli di utilità individuali sotto l’ombrello di una legge comune, il neoliberismo pone la legge sotto l’ombrello dei calcoli di utilità. La legge non si fonda più su un’ideale di giustizia deliberato democraticamente, ma su una ricerca di efficienza economica a breve termine.
 Se c’è una lezione da imparare dalla storia del diritto, è che un ordine politico la cui legge primaria è la competizione di tutti contro tutti, genera necessariamente violenza. Lo sapevano già gli antichi greci, che condannavano la pleonessia, l’accumulo illimitato di ricchezze. E l’Organizzazione internazionale del lavoro, l’ILO, lo conferma affermando “che solo sulla base della giustizia sociale si può stabilire una pace duratura”. Ignorando questa osservazione, che ora va estesa alla giustizia ambientale, ci si condanna a uno shock con la realtà di cui l’implosione finanziaria del 2008 e l’attuale pandemia globale non sono altro che sue manifestazioni.
Se c’è una lezione da imparare dalla storia del diritto, è che un ordine politico la cui legge primaria è la competizione di tutti contro tutti, genera necessariamente violenza. Lo sapevano già gli antichi greci, che condannavano la pleonessia, l’accumulo illimitato di ricchezze. E l’Organizzazione internazionale del lavoro, l’ILO, lo conferma affermando “che solo sulla base della giustizia sociale si può stabilire una pace duratura”. Ignorando questa osservazione, che ora va estesa alla giustizia ambientale, ci si condanna a uno shock con la realtà di cui l’implosione finanziaria del 2008 e l’attuale pandemia globale non sono altro che sue manifestazioni.Che ruolo ha il Diritto?
Non si dovrebbero né sopravvalutare né sottovalutare le risorse del Diritto, che Simone Weil pone in una regione intermedia tra il Cielo della giustizia e l’Inferno della forza bruta. Ma è chiaro che promuovendo il law shopping e una corsa al ribasso verso il sociale e l’ecologia, la globalizzazione mina il rule of law. Serve un nuovo salto normativo, che, come nel dopoguerra, promuova regole adatte alle nuove sfide tecnologiche, ecologiche e sociali.
E la governance digitale?
Il Diritto, la democrazia, lo Stato e tutti i quadri giuridici sono travolti dalla rinascita del vecchio sogno occidentale di armonia fondata sul calcolo. Riattivato prima dal taylorismo e dalla pianificazione sovietica, questo progetto scientista assume ora la forma della governance attraverso i numeri, sotto l’egida della globalizzazione. La ragione del potere non si trova in un’istanza sovrana che trascende la società ma in norme inerenti al suo corretto funzionamento. Prospera così un nuovo ideale normativo, che mira alla realizzazione efficace di obiettivi misurabili piuttosto che all’obbedienza a leggi giuste. Sospinto dalla rivoluzione digitale, il nuovo immaginario istituzionale è quello di una società in cui il diritto lascia il posto al programma e la regolamentazione alla regolazione. Ma quando la sicurezza non è garantita da una legge uguale per tutti, gli uomini non hanno altra scelta che giurare fedeltà al più forte. Radicalizzando l’aspirazione a un potere impersonale, che già caratterizzava l’imporsi del regno della legge, la governance coi numeri dà origine paradossalmente a un mondo dominato da vincoli di fedeltà.
Che cos’è il principio di solidarietà? Può porre un limite alla globalizzazione?
A differenza dell’assicurazione privata, che si basa sul calcolo attuariale del rischio, un regime di solidarietà si basa sull’appartenenza a una comunità, sia essa nazionale, professionale o familiare. I membri di questa comunità più fortunati e meno esposti al rischio contribuiscono di più dei meno fortunati o dei più esposti, per avere gli stessi diritti. A differenza dell’assistenza o della carità, la solidarietà non divide il mondo tra chi dona senza ricevere e chi riceve senza donare. Tutti contribuiscono secondo le proprie capacità e ricevono secondo i propri bisogni. Dovrebbe essere uno strumento potente per passare da una logica della globalizzazione, che mette in competizione tutti contro tutti, a una logica della mondializzazione, cioè di solidarietà tra nazioni rispettose della diversità delle loro storie e culture. Così, ad esempio, la questione della migrazione non sarà risolta né dalla costruzione di muri né dall’abolizione dei confini, ma dalla solidarietà tra i paesi del nord e del sud, in modo che tutti i giovani africani non siano costretti all’esilio per poter sperare di vivere con un lavoro decente.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
"DUE SOLI" IN TERRA, E UN SOLO SOLE IN CIELO: "TRE SOLI". GENERE UMANO: I SOGGETTI SONO DUE, E TUTTO E’ DA RIPENSARE!!! NON SOLO SUL PIANO TEOLOGICO-POLITICO, MA ANCHE ... ANTROPOLOGICO!!!
 LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE, E IL VATICANO CON IL SUO TRADIZIONALE SOFISMA DELLA "FALLACIA ACCIDENTIS".
LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE, E IL VATICANO CON IL SUO TRADIZIONALE SOFISMA DELLA "FALLACIA ACCIDENTIS".
L’ILLUMINISMO, OGGI. LIBERARE IL CIELO. Cristianesimo, democrazia e necessità di "una seconda rivoluzione copernicana"
FLS
-
> LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE, E --- Il "viaggio" fortunato di "chi è riuscito a conoscere le ragioni delle cose". Modello, mito, padre: chi è davvero Virgilio per Dante? (di Carlo Ossola).7 aprile 2021, di Federico La Sala
In cammino con Dante/3.
Modello, mito, padre: chi è davvero Virgilio per Dante?
Non è solo Maestro ma anche “dolce padre”, consolazione e sprone, modello e mito per il Sommo Poeta: è l’“auctor”, colui che fa crescere il personaggio e ne è propriamente il “nutritore”
di Carlo Ossola (Avvenire, domenica 4 aprile 2021)
- [Foto] “Dante e Virgilio incontrano Beatrice”, incisione attribuita a Baccio Baldini (1481). Siena, Biblioteca Comunale
Delle guide che accompagnano e illuminano Dante nel viaggio di conoscenza e di salvezza, Virgilio ha il ruolo più esteso: è scorta di Dante per due cantiche sino alla cima del Purgatorio ove, nel Paradiso Terrestre, si rivela Beatrice. Non è solo Maestro ma anche “dolce padre”, consolazione e sprone, modello e mito. Appare sin dal canto I dell’Inferno, come uscito da un millenario silenzio: «dinanzi a li occhi mi si fu offerto / chi per lungo silenzio parea fioco» (vv. 62-63), lieto a sua volta di acquistare voce e vita di fronte a un uomo che «rovinava in basso loco ». La sua autopresentazione è solenne, e subito intessuta dei caratteri che saranno proprii di tutta la Commedia, la naturalezza del latino, la coscienza dell’unità profonda della penisola italiana nell’eredità di Roma: «[...] li parenti miei furon lombardi, / mantovani per patria ambedui. / Nacqui sub Iulio, ancor che fosse tardi, / e vissi a Roma sotto ’l buono Augusto / nel tempo de li dei falsi e bugiardi» (vv.68-72). Dante lo elegge come magister, al posto di Aristotele, come era uso nella tradizione medievale, e Dante dichiarava ad apertura del suo Convivio; nell’Eneide infatti viene cantato il destino provvidenziale della fondazione di Roma, «di quella Roma onde Cristo è romano» (Purg., XXXII, 102), poiché la Roma di Pietro, e non più Gerusalemme, è la sede della cristianità.
L’Eneide è dunque pensata come annuncio e preparazione della “nuova Roma” della fede: «Poeta fui, e cantai di quel giusto / figliuol d’Anchise che venne di Troia»: Virgilio si presenta come cantore di “quel giusto”, poiché giustizia è - dal Convivio al De Monarchia alla Commedia - il fondamento di ogni degno ordinamento terreno. Lo conferma, in uno dei passi più belli sul pensiero di Dante, il filosofo Étienne Gilson: «Se esiste una visione unificante della sua opera, essa non si identifica né in una qualche filosofia né in una causa politica, neppure in una teologia. La si troverà piuttosto nella coscienza, così personale, ch’egli ebbe della virtù della giustizia e delle fedeltà che essa impone» ( Dante e la filosofia). Il poeta si presenta, a sua volta, come discepolo fedele: «O dei li altri poeti onore e lume, / vagliami ’l lungo studio e ’l grande amore / che m’ha fatto cercar lo tuo volume. / Tu’ se’ lo mio maestro e ’l mio autore» (I, 82-85).
Il termine “autore” non significa soltanto il modello del «bello stilo che m’ha fatto onore» (sì che Dante si presenta a sua volta come autore di un poema epico), ma è anche auctor, colui che nutre e fa crescere il personaggio: ne è propriamente “il nutritore”. Dante si pone come “creato” di Virgilio, nuovo “pius Aeneas”, del quale nel Convivio aveva tracciato l’alta missione: «Per che Virgilio, d’Enea parlando, in sua maggiore loda pietoso lo chiama. E non è pietade quella che crede la volgar gente, cioè dolersi de l’altrui male, anzi è questo uno suo speziale effetto, che si chiama misericordia ed è passione; ma pietade non è passione, anzi è una nobile disposizione d’animo, apparecchiata di ricevere amore, misericordia e altre caritative passioni» (lib. II, X, 5-6). E non è solo magnanimità umana, ma grandezza del destino di una Roma eterna: «Onde non da forza fu principalmente preso per la romana gente, ma da divina provedenza, che è sopra ogni ragione. E in ciò s’accorda Virgilio nel primo de lo Eneida, quando dice, in persona di Dio parlando: “A costoro - cioè a li Romani - né termine di cose né di tempo pongo; a loro ho dato imperio sanza fine”» (lib. IV, IV, 11).
Di questa Roma eterna, perché cristiana ormai, Dante si farà cantore. Sebbene quella del “famoso saggio” (I, 89) sia la funzione principale, e Virgilio additi a Dante, giunti al Limbo, la “bella scola” di cui fa parte: Omero, Orazio, Ovidio, Lucano, sì che - aggiunge con orgoglio Dante - «io fui sesto tra cotanto senno» (IV, 102); nel poema tuttavia Virgilio è davvero “compagno” maggiore di Dante, in tutto: con prontezza raccoglie una manata di terra e la butta in gola all’avido Cerbero: «E ’l duca mio distese le sue spanne, / prese la terra, e con piene le pugna / la gittò dentro a le bramose canne» ( VI, 25-27). Giunti nella palude che circonda la città di Dite (Inf., canto IX), Virgilio mette energicamente le proprie mani sopra quelle di Dante, per chiudergli gli occhi, affinché non abbia ad esser accecato dallo sguardo della Gorgone; esorta e sprona, difende Dante e lo punge, gli indica persino le anime con cui il viator deve parlare, e delle quali non s’era accorto: «Ed el mi disse: “Volgiti! Che fai? / Vedi là Farinata che s’è dritto: /da la cintola in su tutto ’l vedrai”» (X, 31-33).
Più cresce la gravità delle colpe e delle pene, più la dolente tristezza dei due viandanti li pareggia in un’unica angoscia: «Passo passo andavam sanza sermone, / guardando e ascoltando li ammalati, / che non potean levar le lor persone» (XXIX, 7072). Di fronte ai giganti posti a guardia del pozzo ultimo della Caina, Virgilio prende per mano Dante (XXXI, 28); stringe Dante a sé, alla presa di Anteo: «poi fece sì ch’un fascio era elli e io» (XXXI, 135), come prima l’aveva avvinto con le braccia, per scendere in groppa a Gerione a Malebolge (XVII, 1-27 e 91-111).
 Ma il Virgilio più autentico è quello che, in Purgatorio, dispiega tutta la pietas e tutta la nobiltà della ragione, di cui è emblema: non solo deterge la caligine infernale (“sudiciume”) dal volto di Dante, ma via via si fa il suo araldo: da quando dice solennemente a Catone: «libertà va cercando, ch’è sì cara, / come sa chi per lei vita rifiuta» (I, 71-72) a quando coronerà Dante, libero ormai dalla colpa, e pronto a vedere Beatrice: «Non aspettar mio dir più né mio cenno; / libero, dritto e sano è tuo arbitrio / [...] / per ch’io te sovra te corono e mitrio » (XXVII, 139-140).
Ma il Virgilio più autentico è quello che, in Purgatorio, dispiega tutta la pietas e tutta la nobiltà della ragione, di cui è emblema: non solo deterge la caligine infernale (“sudiciume”) dal volto di Dante, ma via via si fa il suo araldo: da quando dice solennemente a Catone: «libertà va cercando, ch’è sì cara, / come sa chi per lei vita rifiuta» (I, 71-72) a quando coronerà Dante, libero ormai dalla colpa, e pronto a vedere Beatrice: «Non aspettar mio dir più né mio cenno; / libero, dritto e sano è tuo arbitrio / [...] / per ch’io te sovra te corono e mitrio » (XXVII, 139-140).
 Dante cresce, ma Virgilio non scema: l’incontro con il conterraneo mantovano Sordello, al canto VI, e soprattutto con Stazio al canto XXI, sono tra i momenti più alti del poema, qui paragonata la scena addirittura all’incontro di Cristo con i discepoli di Emmaus: «Ed ecco, sì come ne scrive Luca / che Cristo apparve a’ due ch’erano in via, / giù surto fuor de la sepulcral buca, / ci apparve un’ombra, e dietro noi venìa» (vv. 7-10).
Dante cresce, ma Virgilio non scema: l’incontro con il conterraneo mantovano Sordello, al canto VI, e soprattutto con Stazio al canto XXI, sono tra i momenti più alti del poema, qui paragonata la scena addirittura all’incontro di Cristo con i discepoli di Emmaus: «Ed ecco, sì come ne scrive Luca / che Cristo apparve a’ due ch’erano in via, / giù surto fuor de la sepulcral buca, / ci apparve un’ombra, e dietro noi venìa» (vv. 7-10).Ed è proprio Stazio a tessere il più alto, malinconico e inobliabile, elogio di Virgilio: «Facesti come quei che va di notte, / che porta il lume dietro e sé non giova» (XXII, 67 68). Egli è stato il lanternarius, il lampadoforo del nuovo Annuncio: «quando dicesti: “Secol si rinova; / torna giustizia e primo tempo umano”» (vv. 70-71). E allo svelarsi di Beatrice, Virgilio è come “mamma” alla quale corre il “fantolin” impaurito da tanta apparizione: Virgilio, madre e padre del pellegrino, così come, per i secoli cristiani sin da Agostino, era stato il sommo sapiente: «Quanto sia importante questo problema lo dichiara il nobilissimo verso di Virgilio: Fortunato chi è riuscito a conoscere le ragioni delle cose [ Georg., II, 489]» ( La Città di Dio, lib. VII, 9).
-
> LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE, E IL VATICANO --- A che gioco giochiamo? Alla "divina commedia" (con Dante Alighieri) o all’eterna tragedia (con Paolo di Tarso)?1 aprile 2021, di Federico La Sala
#DANTE2021
- La #DivinaCommedia: "l’#amor che move il #sole e le altre #stelle"(Pd. XXXIII, 145), o la eterna #tragedia di un #Dio che «non ha risparmiato il proprio #Figlio, ma lo ha offerto per tutti noi» (San Paolo, Lett. ai Romani., 8.32)? *
STORIA DELL’ARTE E TEOLOGIA:
LA PRIMA “CENA” DI “CAINO” (DOPO AVER UCCISO IL PASTORE “ABELE”) E L’INIZIO DELLA “BUONA-CARESTIA”(“EU-CARESTIA”)!
NELL’OSSERVARE “L’Ultima Cena raffigurata sulla parete di fondo del refettorio dell’ex convento dei francescani di Veglie” (sec. XVI/XVII ca.) E NEL RIFLETTERE SUL FATTO CHE “è tra le più canoniche rappresentazioni del momento in cui Cristo istituì la santissima Eucarestia” (Riccardo Viganò, "Fondazione Terra d’Otranto"), c’è da interrogarsi bene e a fondo su chi (teologi ed artisti) abbia potuto concepire e dare forma con straodinaria chiarezza e potenza a questa “cena”(vedere la figura: “Portata centrale, saliere e frutti”) e, insieme, riflettere ancora e meglio sui tempi lunghi e sui tempi brevi della storia di questa interpretazione tragica del messaggio evangelico - a tutti i livelli, dal punto di vista filosofico, teologico, filologico, artistico, sociologico. O no?
NOTARE BENE E RICORDARE. Siamo a 700 anni dalla morte dell’autore della “COMMEDIA”, della “DIVINA COMMEDIA”, e della sua “MONARCHIA”!
SAPERE AUDE! (I. KANT). Sul tema, per svegliarsi dal famoso “sonno dogmatico”, mi sia lecito, si cfr. l’intervento di Armando Polito, “Ubi maior minor cessat”(Fondazione Terra d’Otranto, 24.02.2021) e, ancora, una mia ipotesi di ri-lettura della vita e dell’opera di Dante Alighieri.
Sul tema, in rete e nel sito, si cfr.:
- San Paolo "ai Romani": "Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli, che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa insieme a lui? Chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelto? Dio è colui che giustifica! Chi condannerà? Cristo Gesù è morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi!" (Lettera ai Romani, 8. 31-34).
- Papa Francesco ai "cari fratelli sacerdoti":
- "[...] La magnanimità di quell’uomo che manda il suo figlio pensando che sarà rispettato dai vignaioli, scatena tuttavia in essi una ferocia fuori da ogni misura: siamo di fronte al mistero dell’iniquità, che porta a uccidere il Giusto (cfr Mt 21,33-46).
- Tutto questo, cari fratelli sacerdoti, ci fa vedere che l’annuncio della Buona Notizia è legato misteriosamente alla persecuzione e alla Croce.
- Sant’Ignazio di Loyola, nella contemplazione della Natività - scusatemi questa pubblicità di famiglia -, in quella contemplazione della Natività esprime questa verità evangelica quando ci fa osservare e considerare quello che fanno San Giuseppe e la Madonna: «Per esempio, camminano e si danno da fare perché il Signore nasca in un’estrema povertà e, dopo aver tanto sofferto fame e sete, caldo e freddo, ingiurie e oltraggi, muoia in croce. E tutto questo per me. Poi - aggiunge Ignazio -, riflettendo, ricavare qualche frutto spirituale» (Esercizi spirituali, 116). La gioia della nascita del Signore, il dolore della Croce, la persecuzione.
- Che riflessione possiamo fare per trarre profitto per la nostra vita sacerdotale contemplando questa precoce presenza della Croce - dell’incomprensione, del rifiuto, della persecuzione - all’inizio e nel cuore stesso della predicazione evangelica? [...]"(OMELIA DEL SANTO PADRE FRANCESCO. Basilica di San Pietro. Giovedì Santo, 1 aprile 2021).
Con Wojtyla (2000), oltre. Guarire la nostra Terra. Verità e riconciliazione
FLS
-
> LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE, E IL VATICANO --- CON IL QUINTO DELL’INFERNO, DANTE SI PORTA OLTRE LA TRAGEDIA E OLTRE COSTANTINO.26 marzo 2021, di Federico La Sala
#Dantedi
#26marzo
CON IL #QUINTODELLINFERNO (http://lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=2758)
#Dante
si porta oltre l’orizzonte
della #caduta,
della #tragedia,
di #Edipo,
e
di #Costantino!
-
> LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE, E IL VATICANO -- MATEMATICA E GRAMMATICA: ECCE HOMO. Donne al futuro. Un chiarimento (di Francesca Rigotti - "Doppiozero").20 marzo 2021, di Federico La Sala
Tweet
*
Controparola/
Donne al futuro
di Francesca Rigotti (Doppiozero, 20 marzo 2021)
Da quando ho scoperto che nella grammatica esistono termini marcati e termini non marcati - me li ha spiegati un illustre linguista amico di tastiera - non dico che non dormo di notte ma quasi. I termini non marcatI, se ho capito bene, sono dominanti e includenti: per esempio il termine «giorno», che comprende il giorno e la notte; notte invece è un termine marcato, giacché designa soltanto il tempo dell’oscurità. Non marcato è uomo (ci avviciniamo al tema) in quanto comprende se stesso e anche la donna, la quale invece, guardacaso, è marcata quale «soltanto» donna.
Dovevo ripensare a questa disparità grammaticale nel leggere Donne al futuro, raccolta di saggi di donne che parlano «soltanto» di altre donne, uscito per il Mulino a cura delle amiche di Controparola. Si tratta di un gruppo di scrittrici e giornaliste, nato nel 1992 per iniziativa di Dacia Maraini, che ha pubblicato diversi libri sulle donne tra i quali Donne del Risorgimento, Donne nella Grande Guerra, nella Repubblica, nel Sessantotto e ora al futuro. Sono Paola Cioni, Eliana Di Caro, Paola Gaglianone, Dina Lauricella, Lia Levi, Dacia Maraini, Cristiana Palazzoni, Maria Serena Palieri, Valeria Papitto, Linda Laura Sabbadini, Francesca Sancin, Cristiana di San Marzano, Mirella Serri, cui si deve Donne al futuro (il Mulino, Bologna 2021). Sempre e soltanto donne. O donne sole, si potrebbe anche dire, che è un’espressione un po’ deprimente ma anche molto divertente, a leggerla con ironia, e con la quale si intendono donne in compagnia di altre donne ma non di uomini. Mentre la dicitura per soli uomini sta per luoghi e/o attività in cui le donne non possono entrare e a cui non devono partecipare (e così è intitolata l’eccellente analisi statistica Per soli uomini. Il maschilismo dei dati, dalla ricerca scientifica al design, appena pubblicata da Codice Edizioni e condotta dalla giornalista Emanuela Griglié e del collega Guido Romeo).
Le donne al futuro di questo libro, soltanto donne marcate nella loro donnità, sono di fatto figure straordinarie, proiettate, come dice il titolo, al futuro o declinate al futuro, visto che siamo partiti dalla grammatica (che innocentemente mi costringe qui a scrivere al maschile benché io sia donna che scrive di donne che scrivono di donne. La lingua sarà anche colpevole ma non nel modo semplificato e a tratti oltraggioso che le attribuiscono le interpretazioni corrive, come spiega puntualmente l’amico linguista il cui nome adesso svelo, Nunzio La Fauci, ma la dice lunga). Donne giovani che lavorano per fabbricare il futuro con l’arte e la musica, l’architettura e l’astrofisica; con l’impegno civile e umanitario (donnitario?), con la ricerca medica, l’economia, la pratica sportiva e l’insegnamento.
 Le elenco qui tutte in fila in ordine alfabetico: Alice Pasquini (AliCè), Paola Antonelli, Marica Branchesi, Francesca Bria, Ilaria Capua, Silvia Colasanti, Ilaria Cucchi, Emma Dante, Sara Gama, Rita Giaretta, Giuseppina Multari, Eliana La Ferrara, Laila Abi Ahmed e Isabella Mancini, Barbara Riccardi, Fulvia Signani e le altre, Beatrice Vio. Un ricordo è dedicato alla cittadina del mondo Agitu Ideo Gudeta, uccisa nel dicembre scorso in Trentino, dove si era trasferita e portava avanti la sua attività di imprenditrice.
Le elenco qui tutte in fila in ordine alfabetico: Alice Pasquini (AliCè), Paola Antonelli, Marica Branchesi, Francesca Bria, Ilaria Capua, Silvia Colasanti, Ilaria Cucchi, Emma Dante, Sara Gama, Rita Giaretta, Giuseppina Multari, Eliana La Ferrara, Laila Abi Ahmed e Isabella Mancini, Barbara Riccardi, Fulvia Signani e le altre, Beatrice Vio. Un ricordo è dedicato alla cittadina del mondo Agitu Ideo Gudeta, uccisa nel dicembre scorso in Trentino, dove si era trasferita e portava avanti la sua attività di imprenditrice.Non potendo parlare di tutte ho scelto di citarne una sola, l’unica tra l’altro che mi era del tutto ignota, lo confesso e chiedo venia: Sara Gama. Sara Gama, classe 1989, madre triestina e padre congolese, capitana della Nazionale azzurra femminile di calcio nonché vicepresidente dell’Assocalciatori (termine non marcato che comprende anche le calciatrici mentre le calciatrici, marcate dall’essere soltanto donne, non comprendono i calciatori).
 Sara Gama, ho scoperto, non soltanto gioca al calcio femminile da quando era una bambinetta ma rivendica anche, per quel calcio di donne, assicurazione sanitaria, previdenze, stipendio e soprattutto dignità. Studentessa liceale, studentessa universitaria - sulla storia del calcio femminile in Europa ha anche scritto la tesi - Sara Gama, che nell’immagine di copertina sembra, coi suoi bei capelli ricci, l’Italia turrita, nel discorso del 4 luglio 2019 al Quirinale, di fronte al presidente Mattarella, ha ricordato l’articolo 3 della Costituzione che sancisce la dignità di tutti i cittadini «senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali».
Sara Gama, ho scoperto, non soltanto gioca al calcio femminile da quando era una bambinetta ma rivendica anche, per quel calcio di donne, assicurazione sanitaria, previdenze, stipendio e soprattutto dignità. Studentessa liceale, studentessa universitaria - sulla storia del calcio femminile in Europa ha anche scritto la tesi - Sara Gama, che nell’immagine di copertina sembra, coi suoi bei capelli ricci, l’Italia turrita, nel discorso del 4 luglio 2019 al Quirinale, di fronte al presidente Mattarella, ha ricordato l’articolo 3 della Costituzione che sancisce la dignità di tutti i cittadini «senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali».
 E questo grazie alle donne della Costituzione, le madri costituient, che contro l’opinione di alcuni padri della costituzione insistettero affinché nell’art. 3 venisse inserita la specificazione «di sesso», perché senza quella la conquista della parità sarebbe stata ancor più difficile di quanto già lo sia.
E questo grazie alle donne della Costituzione, le madri costituient, che contro l’opinione di alcuni padri della costituzione insistettero affinché nell’art. 3 venisse inserita la specificazione «di sesso», perché senza quella la conquista della parità sarebbe stata ancor più difficile di quanto già lo sia. -
> LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE, E IL VATICANO --- TEOLOGIA. La Chiesa superstite, profezia sul domani: "Il piccolo resto nella Bibbia" (Walter Vogels).21 febbraio 2021, di Federico La Sala
- #METAPHYSICS #ANTHROPOLOGY #Mathematics. #Imparare a #intrearsi (#Dante2021). #MenteAccogliente: Traccia per una #svolta_antropologica.
- Forse è meglio ritornare davanti a #PonzioPilato e riascoltare quanto dice sul #Figlio dell’#Uomo: #EcceHomo (gr. «idou ho #anthropos»). O no?!
***
Teologia.
La Chiesa superstite, profezia sul domani
Il biblista Walter Vogels indaga la questione del “resto” come unità residuale che sembra indicare il declino, ma in realtà può annunciare una rinascita
di Roberto Righetto (Avvenire, venerdì 19 febbraio 2021)
L’esilio babilonese: James Tissot, “ La deportazione dei prigionieri” - WikiCommons
Resto. Oggi viene da pensare al popolo dell’Artsakh, violentemente aggredito da turchi e azeri e costretto a rifugiarsi in Armenia, abbandonando case e campi, oltre che chiese e monasteri testimonianze di una civiltà millenaria.
Nelle culture precristiane, il concetto di ’resto’ fu applicato a quel che rimaneva di una popolazione dopo una guerra o un disastro naturale e, come noto, la Bibbia abbonda di citazioni relative al popolo di Israele. In particolare, dopo la serie di crudeli invasioni e deportazioni da parte di Assiri e Babilonesi. Nell’Antichità infatti, al termine di un conflitto, i vincitori si abbandonavano alla distruzione quasi totale degli avversari, a cominciare dai loro leader, ma anche delle fonti di vita, dei villaggi e delle vigne.
Un’esperienza verificatasi più volte, dai Sumeri agli Ittiti, dagli Assiri agli Egizi. Eppure, nonostante questa sistematica opera di annientamento dei vinti, qualche sopravvissuto rimaneva sempre. E in alcune circostanze, dopo anni o decenni la vita poteva riprendere. È il caso appunto di Israele, che riuscì a risorgere dopo periodi di cattività a Babilonia. «Racimolate, racimolate come una vigna il resto d’Israele», scrive Geremia dopo l’invasione babilonese che portò, nel 586 a.C., alla distruzione di Gerusalemme.
In realtà, il primo a parlare di ’resto’ era stato Amos, considerato anche il primo profeta-scrittore. Molto severo verso gli israeliti che avevano abbandonato il Signore, egli preannuncia la distruzione del regno del Nord da parte degli Assiri, che si verificherà nel 721 a.C., ma esprime pure la speranza che «forse il Signore, Dio degli eserciti, avrà pietà del resto di Giuseppe ».
La nozione di ’resto’ si affaccia la prima volta dunque, come accennato, in un contesto di guerra. È noto che gli Assiri erano particolarmente feroci, puntavano ad schiacciare completamente i popoli conquistati e, nei loro rapporti ufficiali, i re rimarcavano come ’il resto’ fosse stato catturato, ucciso o deportato, in modo che i vinti non potessero ribellarsi in futuro. Però, v’era sempre un ’resto’ che era riuscito a fuggire nel deserto.
Gli Assiri dovettero accontentarsi di prendere la Samaria ma non giunsero sino a Gerusalemme, cosa che si verificò invece anni dopo con Nabucodonor, prima nel 597 e poi nel 586, quando il tempio venne distrutto dalla foga dei Babilonesi, e infine in un’ultima deportazione voluta da Nabuzaradan, nel 582. In queste circostanze, vari profeti, da Isaia a Sofonia e Geremia, lamentarono la sorte del resto d’Israele. Dice Isaia: «Da Gerusalemme uscirà un resto, dal monte di Sion un residuo». E Geremia auspica che il suo popolo si lasci sottomettere dai Babilonesi per sopravvivere.
Così Ezechiele, che vede una speranza e un futuro possibile per il popolo di Dio anche nell’esilio. Sarà Ciro, re di Persia, nel 538 a.C., a ridare la possibilità al resto d’Israele di tornare nella sua patria. Così finì il periodo di castigo e purificazione. Nella Bibbia il riferimento al resto è legato anche a circostanze diverse, come il diluvio di Noè o l’incendio di Sodoma (probabilmente conseguenza di un terremoto), ma tutti questi disastri sono dovuti al peccato d’Israele, cui Dio dà però sempre la possibilità di risollevarsi.
È a partire dall’esame accurato di questo tema biblico che attraversa tutte le Scritture che il biblista e teologo Walter Vogels, docente emerito di Antico Testamento all’Università Saint-Paul di Ottawa, nel suo libro Il piccolo resto nella Bibbia (Queriniana, pagine 144, euro 16,00) finisce per applicarlo al declino attuale della Chiesa: «E se la manciata di fedeli pronti a mantenere viva la fede in Cristo svolgesse oggi la stessa missione dei superstiti dell’Antico Testamento».
È sotto gli occhi di tutti il calo enorme non solo nella frequenza alle cerimonie religiose, ancor più evidente in questo periodo di pandemia, tanto che risulta ben difficile parlare ancora di ’Europa cristiana’. Anche secondo le indagini recenti, meno della metà delle persone che vivono nel Vecchio Continente si dice credente o religiosa e i cristiani si collocano ormai fra il 20 e il 30 per cento.
Diversa la situazione nel resto del mondo, in particolare in America, Asia e Africa, dove semmai il cristianesimo è messo in pericolo non dall’abbandono dovuto dalla secolarizzazione ma dalla persecuzione. Vogels enumera il Medio Oriente, che ha visto i seguaci dell’Isis assassinare centinaia di cristiani, o la Nigeria, il Pakistan e l’India, ove molti subiscono angherie, se non conversioni forzate all’islam o uccisioni, solo perché cristiani.«Non è sorprendente - commenta l’autore - che papa Francesco parli della nostra epoca come quella dei martiri. In Occidente, una cultura umana e cristiana è del pari in via di estinzione, e chi si preoccupa?».
Le persone che si collocano dentro la Chiesa hanno tre diverse reazioni. Ci sono i profeti di sventura, che rimpiangono i bei tempi andati e mettono sotto accusa tutta la cultura moderna. Poi ci sono quelli che guardano alla differente e più positiva situazione della Chiesa nel resto del mondo e perciò non si preoccupano più di tanto.
Infine vi sono coloro che vedono in questa situazione di crisi un’opportunità, quella di tornare alle origini, «un’umile, piccola Chiesa, lievito nell’impasto, granello di senape, luce per il mondo». Si apre insomma la possibilità di ritrovare la natura vera ed essenziale della Chiesa, che si deve purificare abbandonando ogni compromissione col potere.
Qui il tema del ’resto’ non appare affatto ingiustificato. Come ha detto Gesù: «il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?», una domanda che non ha una risposta scontata e che deve far riflettere, perché la perdita di fede in Europa potrebbe non aver raggiunto il culmine.
Anche il popolo d’Israele subì una terza deportazione e «rimase il resto di un resto di un resto»: accadrà così anche ai cristiani d’Occidente? Per Vogels non si tratta di consolarsi sostenendo che ora va a Messa solo chi ci crede davvero e che la Chiesa è più pura. Se in questo c’è del vero, non ci si può illudere che il futuro delle comunità cristiane sia costituito solo da pochi eletti, che magari si ritengono perfetti. Anche coloro che in passato frequentavano in massa la parrocchia e che magari non erano acculturati, vivevano però una fede sincera e profonda. E trasmettevano la fede ai loro figli.
Il volume esamina anche le possibili cause del declino, fra cui le stesse colpe della Chiesa dovute per esempio agli scandali e agli abusi, ma pone pure alcuni segni di speranza. «Quanto durerà questo esodo?», si chiede Vogels, e aggiunge: «Dopo tutte le apologie degli ultimi papi per le colpe della Chiesa, la chiamata costante e fervida di papa Francesco alla misericordia di Dio sarebbe una profezia che questo tempo della misericordia, che darà il cambio a quello dell’ira, è vicino?».
Si tratta di ripartire proprio dal ’resto’, da coloro che rimangono legati alla Chiesa e continuano ad impegnarsi e a trasmettere la fede alle nuove generazioni. Sarà capace questo ’resto’, grazie a un processo di riforma autentica e una nuova evangelizzazione, di recuperare almeno una parte di coloro che se ne sono andati? «La rimpatriata non sarà facile. Ma non abbiano il diritto di lasciare i feriti della vita da soli, in esilio, lontani o esclusi dalla comunità». E ancora: «Spalanchiamo le porte della misericordia, della comprensione e della tolleranza. Ci deve essere posto per molti nella casa del Padre, per coloro che sono chiamati liberali o conservatori, tradizionalisti o rivoluzionari, di sinistra o di destra. Ci sarà del vecchio e del nuovo. Nessuna comunità è perfetta ».
Ma si può ricostruire rispettando due condizioni: che sia salvaguardato il patto fra la Chiesa e i diritti dell’uomo, nel rifiuto di ogni violenza, e che si testimoni il primato dell’agape, segno vero della presenza dei cristiani nel mondo.
-
> LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE, E IL VATICANO ---#DANTE2021 A che #gioco giochiamo?!: «Chi dunque è il più grande nel regno dei cieli?».13 gennaio 2021, di Federico La Sala
CON MICHELANGELO a scuola da DANTE:
#Antropologia, #teologia, #filologia e #immaginazione #cosmoteandrica! #DANTE2021 A che #gioco giochiamo?!: «Chi dunque è il più grande nel regno dei cieli?» (Matteo 18,1-5).
-
> LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE, E --- ARCHEOLOGIA FILOSOFICA E MEMORIA ANTROPOLOGICA. USCIRE DALL’ORIZZZONTE DELLA BIBLICA "CADUTA".28 dicembre 2020, di Federico La Sala
ARCHEOLOGIA FILOSOFICA E MEMORIA ANTROPOLOGICA.
USCIRE DALL’ORIZZZONTE DELLA BIBLICA "CADUTA" ...
DANTE - 2021 E LA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO DEI "DUE SOLI": RISALIRE LA CORRENTE E RITROVARE I PROPRI "GENITORI". Al di là di Caino, la nuova Eva - Maria e Giuseppe, il nuovo Adamo , e Gesù è figlio dell’ amore [charitas] che move il Sole e le altre stelle (Pd. XXXIII, v. 145).
Federico La Sala
-
> LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE, E --- «QUELLA ROMA ONDE CRISTO È ROMANO»: LA RICEZIONE DI DANTE NEL MAGISTERO PONTIFICIO CONTEMPORANEO (di V. Merla).17 dicembre 2020, di Federico La Sala
LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE, E IL VATICANO ... *
- «Qui sarai tu poco tempo silvano; /e sarai meco sanza fine cive /di quella Roma onde Cristo è romano.
- Però, in pro del mondo che mal vive, /al carro tieni or li occhi, e quel che vedi, /ritornato di là, fa che tu scrive».
- Così Beatrice; e io, che tutto ai piedi /d’i suoi comandamenti era divoto, /la mente e li occhi ov’ella volle diedi. (Purg. XXXII, 100-109).
«QUELLA ROMA ONDE CRISTO È ROMANO»: LA RICEZIONE DI DANTE NEL MAGISTERO PONTIFICIO CONTEMPORANEO
di VALENTINA MERLA *
In un clima di polemica tra cattolici e non cattolici, negli anni dell’Unità d’Italia, in cui i patrioti italiani avevano studiato la concezione politica dell’Alighieri incasellandola sotto l’egida del ghibellinismo anticlericale, Leone XIII sceglie la strada del dialogo con la società, progettando una riforma della cultura cattolica sulla base del tomismo. La sua ricezione di Dante è possibile proprio alla luce del tomismo: Leone XIII è, in effetti, secondo una definizione di padre Semeria, un’«anima dantesca», soprattutto per la significativa consonanza tra il suo pensiero sociale e la Monarchia (era stato proprio il suo intervento ad assolvere il trattato dantesco dall’accusa di eterodossia, escludendolo dall’indice dei Libri Proibiti). Infatti, come Dante, anche papa Pecci partecipa al dibattito sui rapporti tra Stato e Chiesa, riflettendo “laicamente” sul potere politico e sostenendo la reciproca indipendenza delle due istituzioni.
Alla morte dell’anziano pontefice sale al soglio pontificio Pio X, attento riorganizzatore del Catechismo della Chiesa Cattolica e sostenitore di una nuova concezione pastorale, che considera ogni strumento culturale, anche il testo dantesco, funzionale all’esigenza catechetica. Il pontefice incentiva, dunque, le iniziative in preparazione alla commemorazione del VI centenario dantesco, tra le quali una è particolarmente vicina ai suoi orientamenti pastorali. Si tratta di un lavoro di sinossi e comparazione tra il testo del catechismo del pontefice e la scrittura dantesca, che, in questo modo, viene frammentata al duplice scopo di supportare le affermazioni del catechismo e di dimostrare la perfetta aderenza del poeta al cattolicesimo. L’opera, firmata con lo pseudonimo d Minimo Sacerdote in Cristo, si intitola Il più bel ricordo del VI centenario di Dante, ossia Catechismo della Dottrina Cristiana pubblicato per ordine di sua Santità Pio X, meditato e studiato con Dante.
Una linea spartiacque nella rivalutazione dell’Alighieri da parte del magistero pontificio si ha con l’enciclica In praeclara summorum (1921), scritta da Benedetto XV per commemorare il VI centenario della morte del sommo poeta, che viene per la prima volta apostrofato come figlio prediletto della fede cattolica. Sulla scia del predecessore, sebbene in modi differenti, si colloca il riuso che dell’opera dantesca fa Pio XI, riportando nei suoi documenti ufficiali un ricco corredo di citazioni.
 Ciò emerge maggiormente quando riflette sulla romanità della Chiesa, poiché papa Ratti risolve definitivamente la “questione romana”, affermando la necessità della reciproca collaborazione tra potere spirituale e potere politico.
Ciò emerge maggiormente quando riflette sulla romanità della Chiesa, poiché papa Ratti risolve definitivamente la “questione romana”, affermando la necessità della reciproca collaborazione tra potere spirituale e potere politico.
 Di questa collaborazione si fa simbolo la città di Roma (residenza del Papato e antica capitale dell’Impero di Roma), che assurge a figura della città di Dio, secondo la più canonica esegesi di Pg XXXII 102, verso prediletto dal pontefice e più volte citato. Con Pio XI Dante si presta per la prima volta, in modo significativo, ad essere rispolverato e letto criticamente. In effetti papa Ratti consacra la Commedia come un’opera di fede e se ne avvale come auctoritas a supporto delle argomentazioni dei suoi discorsi.
Di questa collaborazione si fa simbolo la città di Roma (residenza del Papato e antica capitale dell’Impero di Roma), che assurge a figura della città di Dio, secondo la più canonica esegesi di Pg XXXII 102, verso prediletto dal pontefice e più volte citato. Con Pio XI Dante si presta per la prima volta, in modo significativo, ad essere rispolverato e letto criticamente. In effetti papa Ratti consacra la Commedia come un’opera di fede e se ne avvale come auctoritas a supporto delle argomentazioni dei suoi discorsi.Ad imitare il suo esempio è Pio XII, in cui si nota una fitta trama di allusioni desunte dall’Alighieri soprattutto nei discorsi rivolti alla Pontificia Accademia delle Scienze (di cui era membro onorario). Queste prolusioni finiscono inevitabilmente per riflettere sulla vastità dell’universo, sede e immagine di Dio attraverso l’utilizzo della fonte dantesca.
Diversa è la fruizione di Dante da parte di Angelo Roncalli, il cui nome si lega inequivocabilmente al Concilio Vaticano II e all’esigenza di un rinnovato dialogo con il mondo intero, sicché anche la sua ricezione del poeta di Firenze si può ascrivere a questo desiderio di un più agevole confronto con la contemporaneità. Anche se in realtà, nel corpus degli scritti del pontefice, sia in quelli ufficiali che in quelli destinati alla scrittura privata, non se ne conserva una memoria significativa.
Vero e proprio punto di svolta nella lunga vicenda della ricezione dantesca è la lettera apostolica Altissimi cantus, che Paolo VI divulga il 7 dicembre 1965 in occasione del VII centenario della nascita di Dante. In essa il pontefice non esita ad appellare il sommo poeta con l’epiteto di teologo perché ha saputo comunicare le verità di fede servendosi della bellezza del verso. È, quella di papa Montini, una forte presa di posizione che innalza l’Alighieri al ruolo di maestro delle cose di Dio. Non a caso le citazioni del poema abbondano quando affronta temi particolarmente rilevanti, come l’amore di Dio; oppure quando parla del giubileo; numerosi sono poi i documenti che riflettono sul significato simbolico della città di Roma (in cui, a sostegno delle argomentazioni, viene citato If II 22-24 e Pg XXXII 102, evidenziando il significato provvidenziale che il poeta attribuisce all’Urbe).
Albino Luciani è ricordato dalla storia per il suo brevissimo pontificato, ma pur nella esiguità dei documenti del suo magistero, la fonte dantesca non passa sotto silenzio: l’Alighieri, infatti, è uno degli autori più citati dal papa bellunese. La prima interessante presenza si nota nella raccolta, pubblicata nel 1976, sotto il titolo di Illustrissimi. Lettere del Patriarca, in cui non mancano riferimenti danteschi espliciti, tra i quali i più interessanti si ravvisano nella lettera indirizzata a Casella, amico di Dante e personaggio della Commedia. -Tra i documenti che precedono l’elezione al soglio di Pietro, il più interessante è il messaggio quaresimale del 31 gennaio 1978, che risulta essere un vero e proprio microsaggio sul Purgatorio, perché il suo esordio trae spunto proprio da questa cantica.
 Durante il periodo del pontificato, Giovanni Paolo I, sceglie di citare Dante nell’udienza generale del 20 settembre 1978, richiamando alla memoria l’esame teologico sulla speranza che il poeta affronta nel paradiso (Pd XXV).
Durante il periodo del pontificato, Giovanni Paolo I, sceglie di citare Dante nell’udienza generale del 20 settembre 1978, richiamando alla memoria l’esame teologico sulla speranza che il poeta affronta nel paradiso (Pd XXV).Se per Paolo VI e per i suoi predecessori la scrittura dantesca assume una notevole rilevanza come auctoritas, nei discorsi di Giovanni Paolo II la vastissima gamma di citazioni, oltre che emergere nelle più svariate occasioni, predomina nelle riflessioni che hanno per argomento l’arte e il ruolo dell’artista. Nel caso del pontefice polacco tale preponderanza assume un particolare rilievo perché, prima dell’elezione papale, Wojtyla è stato drammaturgo e poeta.
 Il riuso di Dante si intravede non solo nei documenti ufficiali del magistero wojtyliano, ma anche nella sua produzione letteraria, in cui, al di là delle tracce intertestuali (irrisorie a mio parere), è possibile un accostamento a Dante, considerando non solo la concezione del ruolo del poeta e della poesia, ma anche lo sviluppo di alcuni nuclei tematici, ad esempio: il legame con le terra natia; la ricerca problematica di Dio; l’attenzione alla storia contemporanea considerata nella prospettiva escatologica; l’incontro con l’uomo, la concezione dell’io autoriale come “poeta visionario”. Si possono notare anche confluenze dal punto di vista stilistico come, ad esempio, l’insistenza sulle sfere semantiche dell’acqua, del fuoco, della luce, del viaggio, e ciò soprattutto nell’ultimo lavoro poetico, risalente al 2003: il Trittico romano.
Il riuso di Dante si intravede non solo nei documenti ufficiali del magistero wojtyliano, ma anche nella sua produzione letteraria, in cui, al di là delle tracce intertestuali (irrisorie a mio parere), è possibile un accostamento a Dante, considerando non solo la concezione del ruolo del poeta e della poesia, ma anche lo sviluppo di alcuni nuclei tematici, ad esempio: il legame con le terra natia; la ricerca problematica di Dio; l’attenzione alla storia contemporanea considerata nella prospettiva escatologica; l’incontro con l’uomo, la concezione dell’io autoriale come “poeta visionario”. Si possono notare anche confluenze dal punto di vista stilistico come, ad esempio, l’insistenza sulle sfere semantiche dell’acqua, del fuoco, della luce, del viaggio, e ciò soprattutto nell’ultimo lavoro poetico, risalente al 2003: il Trittico romano.
 Interessanti sono anche i documenti ad argomento prettamente dantesco. Tra questi, molto significativa è la lettera indirizzata a Mieczyslaw Kotlarczyk, datata 27 maggio 1964 e risalente al periodo in cui Karol Wojtyla era vescovo di Cracovia. Come già nel magistero dei suoi predecessori, anche nei documenti di Giovanni Paolo II le presenze dantesche non sono sporadiche e casuali: numerosissime sono quelle mariane, (desunte essenzialmente da Pd XXIII 73-74, Pd XXIII 88-89 e Pd XXXII 85-87, da Pd XXXIII 1-18). Tra le citazioni ricorrenti si annovera quella riferita all’Ulisse dantesco (If XXVI 118-120) e quella che descrive la scelta ascetica di san Pier Damiani (Pd XXI 117).
Interessanti sono anche i documenti ad argomento prettamente dantesco. Tra questi, molto significativa è la lettera indirizzata a Mieczyslaw Kotlarczyk, datata 27 maggio 1964 e risalente al periodo in cui Karol Wojtyla era vescovo di Cracovia. Come già nel magistero dei suoi predecessori, anche nei documenti di Giovanni Paolo II le presenze dantesche non sono sporadiche e casuali: numerosissime sono quelle mariane, (desunte essenzialmente da Pd XXIII 73-74, Pd XXIII 88-89 e Pd XXXII 85-87, da Pd XXXIII 1-18). Tra le citazioni ricorrenti si annovera quella riferita all’Ulisse dantesco (If XXVI 118-120) e quella che descrive la scelta ascetica di san Pier Damiani (Pd XXI 117).La Commedia non è ignorata neanche da papa Ratzinger. È esemplare in tal senso il messaggio per l’incontro promosso dal Pontificio Consiglio Cor Unum, il 23 gennaio 2003 in cui il pontefice, sin dall’esordio, afferma di aver attinto da Dante lo stimolo per elaborare l’intera prolusione. La fonte dantesca è, inoltre, ridondante nei discorsi mariani: è come se i luoghi topici della mariologia dantesca avessero delineato in modo talmente ineguagliabile il profilo di santità della Madre divina, da pretendere di essere richiamati alla memoria, proprio per la loro ineguagliabile bellezza.
* Scheda: Cineca Iris (Università di Foggia, Tesi di dottorato - 24-giugno-2014).
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- "ERODE" E LE GERARCHIE CATTOLICO-ROMANE CONTRO CRISTO E "CONTRO CESARE. Cristianesimo e totalitarismo nell’epoca dei fascismi".
DANTE ALIGHIERI (1265-1321)!!! LA LINGUA D’AMORE: UNA NUOVA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO.
VIVA L’ITALIA!!! LA QUESTIONE "CATTOLICA" E LO SPIRITO DEI NOSTRI PADRI E DELLE NOSTRE MADRI COSTITUENTI. Per un ri-orientamento antropologico e teologico-politico.
FLS
-
> LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE, E --- LE SIBILLE DELLA "TESI" DI ANTONIO ROSMINI.14 dicembre 2020, di Federico La Sala
PROFETI, SIBILLE, E MESSAGGIO EVANGELICO:
ANTONIO ROSMINI E LA "CHARITAS". Un invito a ...
Rileggere il testo della "BREVE DISSERTAZIONE DI ANTONIO ROSMINI SULLE SIBILLE" (Patricia Salomoni, "Rosmini Studies", 6, 2019). Che Rosmini abbia iniziato il suo percorso riflettendo sulle figure delle Sibille, è da considerarsi un fatto degno della massima attenzione - e, ovviamente, di ulteriore approfondimento!
La riflessione su tale tema, probabilmente, lo ha reso più vigile nel suo cammino e nella sua fedeltà alla lettera e allo spirito della "Charitas". Il "Kant italiano", infatti, iniziando il suo percorso con la tesi di laurea sulle Sibille (1822), non solo non ha perso il suo legame con la Grazia (Charis) e con le Grazie (Charites), ma - coerentemente - ha saputo custodire anche l’«h» della Charitas! E ha cercato di tenere ferma la sua distanza dalla logica economica - sempre più dilagante - della "carità" del "mercato" ("caritas") e, al contempo, dalla politica di sostegno alla diffusione della "eu-carestia" - a tutti i livelli. Ma, alla fine, non è riuscito a coniugare - come voleva, in spirito di verità e carità - - il rapporto tra filosofia (sapienza pagana) e rivelazione (sapienza ebraica).
Già all’inizio del suo percorso, benché partito con buona volontà e - kantianamente ("Sapere aude!") - con gran coraggio, infatti, egli s’inchina all’autorità di sant’Agostino ("De Civitate Dei", XVIII, 47) e - pur rendendosi conto con lo stesso Agostino che "qualsiasi predizione su Cristo poteva essere dichiarata falsa dagli empi e soggiacere al medesimo discredito, sia che si trattasse degli oracoli delle Sibille o delle profezie degli Ebrei" - conclude con un "non è gradito a Lui stesso che, nelle dispute, noi dedichiamo troppe energie più a quelli che a queste" e attribuisce la palma della credibilità solo a "queste .. certissime, luminosissime, custodite dal popolo ebraico a noi assai ostile, e protette da ogni corruzione con incomparabile ed encomiabile cura nel corso di molti secoli" (P. Salomoni, cit, p. 227).
A partire da "queste" premesse (promesse già non mantenute!), ovviamente, accolta solo la parola dei "profeti" non si può che rinarrare e riscrivere la vecchia "storia dell’Amore" di Adamo ed Eva:
- L’Amore tra gli uomini nacque da Dio. L’Eden fu sua patria, ed ebbe gemella l’Innocenza. Nella creazione stessa dei progenitori del genere umano si ritrova la divina istituzione dell’amore: e in essa compaiono tutte le ragioni che devono rendere persuasi tutti gli uomini. Ecco quali sono le principali.
 La prima ragione dell’amore fra tutti gli uomini è l’unità dell’origine. Dio trae la donna dalla carne e dall’osso di Adamo, appunto al fine di indicare che Adamo è il principio unico del genere umano, dal quale non solo i figlioli sono venuti, ma anche la stessa sua moglie. Perciò tutta intera l’umana generazione è un solo corpo con un solo capo, e questo capo è formato da Dio. Da qui l’uomo è chiamato da san Paolo “divina progenie” (Atti 17,28), allegando un verso del poeta greco Arato, il quale ben mostra essersi conservata fra i gentili la tradizione di questa verità. Da dove parte dunque l’unità della stirpe umana, da lì parte anche la prima ragione dell’amicizia. L’una e l’altra da Dio; e l’una e l’altra si può chiamare ragionevolmente cosa divina. Se dunque gli uomini si devono amare per motivo dell’origine, per la stessa ragione devono prima amare Dio, dall’amore del quale come da fonte limpidissima scaturisce il loro proprio amore.
La prima ragione dell’amore fra tutti gli uomini è l’unità dell’origine. Dio trae la donna dalla carne e dall’osso di Adamo, appunto al fine di indicare che Adamo è il principio unico del genere umano, dal quale non solo i figlioli sono venuti, ma anche la stessa sua moglie. Perciò tutta intera l’umana generazione è un solo corpo con un solo capo, e questo capo è formato da Dio. Da qui l’uomo è chiamato da san Paolo “divina progenie” (Atti 17,28), allegando un verso del poeta greco Arato, il quale ben mostra essersi conservata fra i gentili la tradizione di questa verità. Da dove parte dunque l’unità della stirpe umana, da lì parte anche la prima ragione dell’amicizia. L’una e l’altra da Dio; e l’una e l’altra si può chiamare ragionevolmente cosa divina. Se dunque gli uomini si devono amare per motivo dell’origine, per la stessa ragione devono prima amare Dio, dall’amore del quale come da fonte limpidissima scaturisce il loro proprio amore. - La seconda ragione dell’amore fra gli uomini è nella similitudine della natura. Il divino istitutore della natura umana e dell’amore, nel formare Eva, disse che essa doveva essere ad Adamo un aiuto simile a lui, perché «buona cosa non era che egli stesse solo» (Gn 2, 18). Dio con queste parole faceva il più bello encomio della società umana, nel seno della quale nasciamo tutti, e dalle cui materne sollecitudini siamo educati e sollevati ad una inaspettata e meravigliosa perfezione, e quasi ad una nuova e più eccellente natura. E guai all’uomo solitario che si allontana e rifiuta i benefici della società dei suoi simili, presumendo del proprio giudizio e nutrendosi del proprio affetto individuale! Egli già comincia in quell’ora medesima ad isterilire nei suoi ragionamenti e nei suoi affetti. E appena si potrebbe chiamare ancora uomo, se troppo a lungo tenesse le orecchie chiuse alle amorevoli, alle sagge voci dei suoi simili. Perché i germi di bene più preziosi o starebbero in lui come non fossero, o tralignando porterebbero dei frutti inutili e tristi. Per cui veramente, come dice la Bibbia, «non è bene all’uomo starsene solo [...]».
- La terza ragione assegnata all’amore fu la felicità degli uomini. Gli uomini dovevano trarre vantaggio inestimabile dalla scambievole amicizia. Perciò Eva è nominata da Dio “un aiuto di Adamo”. Essa era aiuto al solitario Adamo allo scopo di rendergli piacevole la vita e permettergli di diffondere e comunicare in lei se stesso. Perché l’umano sentimento, l’uomo stesso, come il bene, cerca di essere diffusivo ed espansivo. Da qui ha origine la dottrina apostolica, che descrive l’uomo quale «immagine e gloria di Dio” e la donna quale “gloria dell’uomo [...]».
- Da tutte queste cose si può pertanto concludere, che nella sacra società coniugale, stabilita da Dio a principio fra gli uomini innocenti e felici, ebbero loro capo e inizio tutte le specie dei legittimi amori. Da lì nasceva l’amore naturale nelle famiglie, da lì l’amore di elezione nelle amicizie, da lì l’amore di vantaggio nell’umano commercio. E come da Dio partivano, così in Dio finivano ugualmente tutti questi affetti, temperati in un unico e sublimissimo affetto (Antonio Rosmini, La storia dell’Amore, "Charitas", 5, maggio 2016, pp. 111-112).
E così, contravvenendo frettolosamente alle regole morali del suo stesso "metodo filosofico", il suo desiderio di lasciarsi guidare "in tutti i suoi passi dall’amore della verità", come dalla carità ("charitas") piena di grazia (charis), resta confinato nell’orizzonte della caduta e della minorità - e la presenza delle Sibille insieme ai Profeti nella Volta della Cappella Sistina è ancora un grosso problema!
Federico La Sala
- L’Amore tra gli uomini nacque da Dio. L’Eden fu sua patria, ed ebbe gemella l’Innocenza. Nella creazione stessa dei progenitori del genere umano si ritrova la divina istituzione dell’amore: e in essa compaiono tutte le ragioni che devono rendere persuasi tutti gli uomini. Ecco quali sono le principali.
-
> LA "MONARCHIA" DI DANTE... E LE "QUATTRO VITE" DI RAYMOND SMULLYAN. Il logico matematico più divertente del mondo (di P. Odifreddi).6 dicembre 2020, di Federico La Sala
Ricordando Smullyan
Il logico matematico più divertente del mondo
di Piergiorgio Odifreddi *
Un giorno Raymond Smullyan andò alla lavagna per una conferenza e disse: «O io ho una moneta tra le dita, o 2 più 2 fa 5». Poiché stava tenendo la moneta in mano, aveva detto il vero. Ma di colpo la moneta scomparve misteriosamente e Smullyan se ne tornò sornione al proprio posto.
 L’uditorio di logici capì immediatamente lo scherzo di cui era stato vittima. Mostrando la moneta, Smullyan aveva dimostrato la verità della propria affermazione basandosi sulla prima alternativa. Ma facendola sparire, diventava vera la seconda alternativa: dunque Smullyan aveva dimostrato che 2 più 2 fa 5.
L’uditorio di logici capì immediatamente lo scherzo di cui era stato vittima. Mostrando la moneta, Smullyan aveva dimostrato la verità della propria affermazione basandosi sulla prima alternativa. Ma facendola sparire, diventava vera la seconda alternativa: dunque Smullyan aveva dimostrato che 2 più 2 fa 5.Strana e paradossale dimostrazione di un’assurdità, che solo un mago poteva permettersi di fare. E Smullyan era effettivamente un mago, che divertiva amici e studenti con una serie di trucchi da prestigiatore, anche se la sua reale professione era la matematica. Più precisamente, la logica matematica, nella quale aveva lasciato il segno nel 1961, mostrando in un famoso libro sulla teoria dei sistemi formali che i teoremi di limitatezza dimostrati da Kurt Gödel e altri negli anni Trenta erano molto più generali di quanto si fosse inizialmente sospettato.
Ma la sua notorietà si estese al grande pubblico con Qual è il titolo di questo libro? (Zanichelli, 1981). Come suggeriva fin dal titolo, il libro conteneva una serie di paradossi e indovinelli che mettevano alla prova l’abilità logica e la pazienza psicologica del lettore. Una serie di questi giochi coinvolgeva l’Isola dei Cavalieri e dei Furfanti (dall’inglese knight, "cavaliere", e knave, che significa sia "fante" che "furfante"), nella quale ciascun abitante o è un cavaliere, e dice sempre la verità, o è un fante, e dice sempre il falso. Se uno incontra un abitante, che domanda deve fargli per sapere se sia un cavaliere o un fante? Naturalmente non basta domandargli se è un cavaliere, perché la risposta sarebbe affermativa in ogni caso: cioè, una verità per un cavaliere e una falsità per un fante. Analogamente, non basta domandargli se è un fante, perché la risposta sarebbe negativa in ogni caso.
In realtà bisogna ricorrere al pensiero laterale: basta fargli una domanda della quale si conosce già la risposta. Per esempio, basta domandargli se è una mucca: il cavaliere dirà di no, ma il fante dirà invece di sì.
 Smullyan spinse al limite questo genere di rompicapi in due libri memorabili: Fare il verso al pappagallo del 1985 (Bompiani, 1990) e Perenne indecisione del 1987. Il primo fornisce un’introduzione alla logica combinatoria. Il secondo è invece un trattamento completo dei teoremi di incompletezza e indecidibilità.
Smullyan spinse al limite questo genere di rompicapi in due libri memorabili: Fare il verso al pappagallo del 1985 (Bompiani, 1990) e Perenne indecisione del 1987. Il primo fornisce un’introduzione alla logica combinatoria. Il secondo è invece un trattamento completo dei teoremi di incompletezza e indecidibilità.Prima ancora di pubblicare il suo primo libro di paradossi, Smullyan aveva percorso una strada diversa per la divulgazione della logica: quella della cosiddetta "analisi retrograda" degli scacchi, in cui si presenta una scacchiera con alcuni pezzi disposti in un certo modo, e si chiede al lettore di individuare l’unica serie di mosse che ha potuto portare a quella disposizione.
Ma Smullyan si interessava anche di religione e filosofia: nel 1977 uscì Il Tao è silente, professione di fede nel taoismo. Ritornò sul tema nel 2003 con Chi lo sa?, presentato nel sottotitolo come "uno studio della coscienza religiosa".
D’altronde, già dal suo aspetto fisico si sarebbe detto che Smullyan era un immortale taoista o un vecchio saggio: la lunga chioma e la folta barba bianche, oltre allo sguardo penetrante, lo facevano infatti assomigliare a Tagore o al mago Gandalf del Signore degli anelli.
 Anche nel campo etico Smullyan ha lasciato un segno, inventando un paradosso che porta il suo nome: "In un’oasi A e B decidono indipendentemente di assassinare C. A mette del veleno nella sua borraccia, B la buca e C muore di sete. Chi è colpevole della sua morte, visto che A ha messo del veleno che lui non ha bevuto, e B ha bucato una borraccia che conteneva acqua avvelenata?".
Anche nel campo etico Smullyan ha lasciato un segno, inventando un paradosso che porta il suo nome: "In un’oasi A e B decidono indipendentemente di assassinare C. A mette del veleno nella sua borraccia, B la buca e C muore di sete. Chi è colpevole della sua morte, visto che A ha messo del veleno che lui non ha bevuto, e B ha bucato una borraccia che conteneva acqua avvelenata?".
 Come se non bastasse Smullyan era anche un ottimo pianista, e in rete si trovano molti video in cui suona.
Come se non bastasse Smullyan era anche un ottimo pianista, e in rete si trovano molti video in cui suona.Per questo il suo allievo Jason Rosenhouse ha intitolato Quattro vite il libro che gli ha dedicato nel 2014. E per questo sono morti quattro Raymond Smullyan il 6 febbraio di quest’anno, tutti di novantott’anni. Ed è doveroso ricordare "il più divertente logico mai esistito". Così Martin Gardner ha definito Smullyan. E dichiarato dal curatore di Alice nel paese delle meraviglie oltre che dal più celebre divulgatore di matematica del Novecento, è tutto dire.
-
> LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE, E IL VATICANO CON IL SUO TRADIZIONALE SOFISMA -- LOGICA E REALTÀ. "Quando la logica va in vacanza. Sulle fallacie comiche in letteratura" (E. Camassa).4 dicembre 2020, di Federico La Sala
LOGICA E REALTÀ: LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE, E IL VATICANO CON IL SUO TRADIZIONALE SOFISMA DELLA "FALLACIA ACCIDENTIS".... *
Quando la logica va in vacanza
di Edoardo Camassa **
- [Esce oggi per Quodlibet Quando la logica va in vacanza. Sulle fallacie comiche in letteratura di Edoardo Camassa. Ne pubblichiamo un estratto per gentile concessione dell’autore]
Il termine “fallacia” può essere inteso in almeno due modi. In senso lato designa una qualsiasi idea, opinione o credenza sbagliata; per esempio che le donne non sappiano guidare o che rompere uno specchio porti sette anni di disgrazie. Come si vede, stando a questa prima accezione del termine, le fallacie si fondano sugli stereotipi, sulla superstizione o comunque su detti e proverbi popolari, e perciò non ambiscono in nessun modo a risultare convincenti. Ma le cose cambiano se ci spostiamo dal linguaggio comune al linguaggio filosofico-scientifico. In senso stretto, infatti, “fallacia” indica un’argomentazione o un ragionamento che sono logicamente viziati ma psicologicamente persuasivi; ciò può avvenire in modo consapevole e deliberato, quando vengono prodotti con l’intenzione di ingannare, e allora parleremo di sofismi, o inconsapevolmente, quando vengono prodotti senza volontà di inganno, e allora parleremo di paralogismi. In estrema sintesi, nella prospettiva della logica dell’argomentazione la fallacia è un ragionamento che ricorda un qualche tipo d’inferenza, ma che se sottoposto a un esame rigoroso si rivela scorretto[1].
Tra gli innumerevoli esempi possibili di fallacie intese in questa seconda accezione ce n’è uno su cui vale la pena di soffermarsi, se non altro perché compare in quello che è in assoluto il primo trattato sistematico sui ragionamenti viziati - il De sophisticis elenchis di Aristotele - e ha il pregio di essere estremamente chiaro[2]. Si tratta della fallacia d’accidente converso, un tipo di generalizzazione indebita che nasce dal considerare ciò che vale sotto un determinato aspetto (παρὰ τὸ πῄ, traducibile nei termini della logica medievale con secundum quid) come se valesse in assoluto, in sé e per sé (ἁπλῶς, corrispondente al latino simpliciter). In base a questo indebito procedimento generalizzante, dal fatto che un indiano è nero ma ha i denti bianchi si passa a concludere, erroneamente, che questo indiano è al contempo bianco e nero (Soph. el., 167a 7-9)[3]. Nel presente lavoro mi occuperò di fallacie intendendole in questo secondo senso, ossia nell’accezione ristretta; mi occuperò cioè di “fallacie logiche”. Più nel dettaglio, mi concentrerò su una particolare classe di ragionamenti scorretti: quella delle argomentazioni viziate che realizzano il loro potenziale comico.
[...]
Per sgombrare il campo da ogni possibile equivoco, occorre però aggiungere subito che qui mi soffermerò sulle fallacie comiche per come appaiono nella letteratura.
[...]
Per provare a esplicitare gli scopi delle fallacie comiche nella letteratura conviene rifarsi ancora una volta a Freud, e nello specifico all’analisi di ciò che egli chiama «storielle con una facciata logica» (o «motti concettuali sofistici»). Secondo Freud, se questo tipo di barzellette mostra una parvenza logica così robusta da rivelarsi come tale solo in seguito a un esame più attento è appunto perché lo scherzo tradisce qualcosa di serio, cela una logica ancor più profonda[4]. Orlando, che dal libro freudiano sul Witz ha tentato di estrapolare una teoria generale del comico letterario, scrive a ragione che i motti con una facciata logica sono «di una logica sofistica, esagerata, che dissimula anziché ostentarla l’erroneità dei propri ragionamenti secondo il livello della coscienza, e con ciò stesso ostenta fingendo di dissimularla la validità dei ragionamenti stessi secondo un’altra logica di fondo»[5].
È proprio questa dialettica di erroneità e validità, di illogicità e logicità che caratterizza le fallacie comiche rinvenibili nelle opere letterarie. Vale perciò la pena di approfondirne l’esame e di articolarne i momenti costitutivi. In prima battuta il lettore (mi riferisco al lettore modello) prende per buono il ragionamento incongruo; in altre parole si lascia persuadere dalla sua coerenza apparente. Il pensiero critico e la valutazione razionale subentrano in lui solo in un secondo momento, così da rendergli la fallacia palese, riconoscibile, e con ciò stesso da muoverlo al riso. Ma non è tutto: il lettore è infine portato a riconsiderare l’argomentazione comica e a intuire che quel che gli pareva erroneo così erroneo non è, dal momento che fa luce su verità paradossali ma profonde a cui la logica ordinaria non può né vuole accedere[6]. Da questa angolatura, assurdo non è più tanto e solo il ragionamento fallace, ma anche e soprattutto qualcos’altro di più generale. Se si vuole, il sistema di pensiero corrente e le sue leggi ritenute inattaccabili.
Un esempio chiarirà meglio cosa intendo: «L’unico modo per liberarsi di una tentazione è quello di cedervi»[7]. Tra tutte le massime che in The Picture of Dorian Gray (1890) Wilde mette in bocca a Lord Henry Wotton, irresistibile campione di freddure, questa è forse la più celebre. Essa di primo acchito sembra sensata, convincente. Tuttavia, a un esame più approfondito, l’aforisma rivela tutta la sua inconsistenza argomentativa. A rigor di logica, oltre a quella suggerita da Lord Wotton, vi sarebbe infatti un’altra e ben più valida soluzione per liberarsi di una tentazione: quella di metterla a tacere, di ignorarla e in definitiva di reprimerla. Come si vede, ci troviamo qui a ridere di una fallacia facilmente individuabile, che è nota come evidenza soppressa (o unilateralità) e che consiste nel dimenticare per strada alcune informazioni in grado di invalidare la tesi proposta. Benché tutto questo sia esatto, va pur detto che la massima sopra citata non si esaurisce nell’errore logico e nel comico puro. Nonostante l’incongruenza, e anzi proprio in virtù di questa, Wilde mira a farci intravedere qualcosa di serio: che tutto sommato non c’è davvero altro modo per liberarsi di una tentazione se non quello di cedervi. Per convincersene, basta leggere come il discorso di Lord Wotton continua: «Resistetele, e la vostra anima si ammalerà di bramosia per le cose che si è proibite da sola, di desiderio per ciò che le sue leggi mostruose (monstrous laws) hanno reso mostruoso e illegittimo (monstrous and unlawful)»[8]. Qui Wilde vagamente anticipa una idea che da lì a poco la psicanalisi cercherà di fondare su basi scientifiche. Per quanto proviamo a domarlo, il desiderio - mostruoso e proibito, sì, ma solo nell’ottica della ragione dispiegata - non si lascerà mai ammansire e combatterà con tutte le proprie forze per emergere. Con buona pace della mentalità borghese-puritana, additata come il “vero” bersaglio comico del ragionamento.
Quanto detto può essere riformulato e arricchito combinando la terminologia di Freud con quella del suo erede cileno Matte Blanco: le fallacie comiche della letteratura sono - un po’ come i sogni, i lapsus e i sintomi psiconevrotici, benché calcolate e coscienti - «formazioni intermedie e di compromesso»[9], frutti di un «sistema logico-antilogico»[10]. Esse ci spingono da un lato a ridere con superiore distacco di assurdità che a tutta prima paiono il risultato di una disattenzione, di un disimpegno mentale, e dall’altro a sentire in modo partecipe che il pensiero consueto in fondo non è altro che uno tra i molti tipi di pensiero possibili e immaginabili. Credo che D’Angeli e Paduano vogliano suggerire qualcosa del genere quando scrivono che nel riso diretto ai danni di chi pronuncia ragionamenti aberranti si maschera il timore che la sua logica altrettanto strutturata e resistente costituisca un grave rischio per la presunta inattaccabilità del sistema di pensiero corrente: le sue leggi, date senza verifica per completamente affidabili, se messe sotto la lente di un simile sguardo straniante, si rivelano discutibili e quindi incerte, e coinvolgono nel dubbio l’intero sistema logico[11].
Ricapitolando, le fallacie comiche in letteratura hanno un intento duplice e ambiguo: punire col riso le argomentazioni che si discostano dalla logica ordinaria e, contemporaneamente, rimarcare i limiti e i vincoli delle certezze comuni. Da ciò si ricava che nella finzione letteraria i ragionamenti ridicoli si presentano come un salvacondotto grazie a cui formidabili deviazioni dalla logica e dal pensiero razionale riescono a trapelare in modo socialmente fruibile. Lo scopo di questo lavoro è appunto mettere in luce, attraverso un congruo numero di esempi, in quali modi la letteratura può trasgredire la logica consueta e dare risalto alle verità paradossali e profonde che emergono proprio in virtù del sovvertimento della logica.
** Fonte: Le parole e le cose, 3 dicembre 2020 (ripresa parziale - senza note)
*
NOTA
LOGICA E REALTÀ: LE FALLACIE “COMICHE” NELLA LETTERATURA DELLA TRAGEDIA.
 E le fallacie tragiche nella letteratura della “Commedia” e della “Monarchia” di Dante Alighieri...
E le fallacie tragiche nella letteratura della “Commedia” e della “Monarchia” di Dante Alighieri... SE “le fallacie comiche in letteratura hanno un intento duplice e ambiguo: punire col riso le argomentazioni che si discostano dalla logica ordinaria e, contemporaneamente, rimarcare i limiti e i vincoli delle certezze comuni [....]”, alla fin fine, confermano il sentimento tragico della vita in cui si collocano. O no?
Se è così, non è meglio capovolgere il senso del cammino e mettere in luce le fallacie “tragiche” nella “Commedia”, e nella “Monarchia”, come da lezione di Dante?! O no?!
-
> LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE, E --- "IL GRANDE ROMANZO DEI PAPI. La storia della Santa Sede attraverso le vite dei successori di san Pietro”. Intervista a Riccardo Ferrigato .11 novembre 2020, di Federico La Sala
UNA "GALLERIA DI PAPI", LA "DONAZIONE DI COSTANTINO", E "IL GRANDE ROMANZO DEI PAPI" ... *
“Il grande romanzo dei papi. La storia della Santa Sede attraverso le vite dei successori di san Pietro” di Riccardo Ferrigato. Intervista ...
di Letture*
Dott. Riccardo Ferrigato, Lei è autore del libro Il grande romanzo dei papi. La storia della Santa Sede attraverso le vite dei successori di san Pietro edito da Newton Compton: in che modo la storia dell’umanità si è intrecciata con quella millenaria di una delle più influenti istituzioni che l’umanità abbia creato, il papato?
Il grande romanzo dei papi. La storia della Santa Sede attraverso le vite dei successori di san Pietro, Riccardo FerrigatoFare riferimento alla “storia dell’umanità” è forse eccessivo, ma di certo il papato è stato elemento di notevole influenza per la storia europea e, in maniera più limitata e differenziata, per quella di alcune aree extraeuropee in cui il cattolicesimo ha avuto una significativa diffusione. In che modo lo ha fatto? Secondo registri completamente differenti, cioè mutando, modificandosi, adeguandosi ai tempi: non credo sia possibile che un’istituzione sopravviva altrimenti per un così lungo periodo.
Il vescovo di Roma ha maturato nei secoli, per gradi, un ruolo preminente all’interno della Chiesa - ruolo che, almeno nel primo millennio della sua storia, era tutt’altro che incontestato - e contemporaneamente ha giocato un ruolo politico in continuo divenire, con fasi di crescita e altre di declino, guadagnando il proprio spazio di manovra tra imperi, regni e repubbliche. Difficile sintetizzare in poche righe la parabola di questo percorso, ma direi così: finché il potere politico di un re o un imperatore ha avuto bisogno di giustificare la propria autorità attraverso il trascendente, il papa è stato un riferimento indispensabile. Questo, in realtà, ha determinato spesso la sottomissione della cattedra di Pietro ai bisogni di questa o quella corona, ma anche la crescita, lasciando persino spazio al sogno, mai realizzato, di mettere il vicario di Cristo al vertice dell’intero occidente.
In che modo da un modesto pescatore di Galilea si è giunti a fare del vescovo di Roma un monarca?
Il pescatore di Galilea, Pietro, primo tra gli apostoli di Gesù di Nazaret, non immaginava una chiesa strutturata in maniera verticista, probabilmente non pensava a figure assimilabili a quelle dei vescovi e lontanissima da lui era l’idea di una singola persona a capo di tutti i cristiani. Da ebreo qual era, immaginava piuttosto i fedeli riuniti secondo le modalità con cui la religione del suo popolo si organizzava da sempre, in piccole comunità collegate ma indipendenti, pronte all’imminente parusia, la venuta di Gesù alla fine dei tempi. Figuriamoci se può mai aver immaginato un vescovo che diviene monarca, cioè che assume su di sé anche un potere temporale!
In estrema sintesi, questo è stato possibile grazie a tre passaggi. Il primo è stato frutto dell’azione di Costantino, che ha dato alla chiesa una struttura affine a quella del potere imperiale, affiancando alle strutture di governo civile quelle ecclesiastiche. In secondo luogo, con la caduta dell’impero romano d’Occidente, la chiesa ha rafforzato la propria funzione politica, con i vescovi, a Roma e altrove, che divennero custodi - si pensi a Leone e Gregorio Magno - dei propri territori di influenza. Infine, l’alleanza con i Franchi di Pipino il Breve: nell’VIII secolo questo sovrano in cerca di una sacra investitura (Pipino non era re per diritto di nascita) conquistò al papa i territori di quello che divenne lo Stato della Chiesa. Di fatto Pipino e Stefano II, il papa dell’epoca, si legittimarono sul trono a vicenda.
Come è stato possibile che santi e martiri abbiano condiviso il medesimo scranno dei dissoluti papi del Rinascimento?
I papi sono stati 266 e questa gran massa di uomini rappresenta un completo campionario dell’animo umano: ogni passione - ma anche ogni vizio, ogni virtù - è stata incarnata. D’altra parte la cattedra di Pietro è un luogo di potere e il potere ha un effetto determinante sugli esseri umani, ne porta alla luce e ne inasprisce i tratti dell’animo.
La maggior parte degli uomini e delle donne possono permettersi di trascorrere una vita all’insegna di una tranquilla mediocritas: né troppo buoni né troppo malvagi, non ci è richiesto di dimostrare grande coraggio o eccezionali doti. Per un sovrano è diverso: nessuna via di mezzo per chi porta la corona, egli sarà vile o temperante, magnanimo o malvagio, perché il potere nelle sue mani è determinante per la vita o la morte di comunità intere.
Nel caso specifico del pontefice, poi, la tensione tra il potere politico e quello spirituale ha determinato spesso una vera iattura. Di norma ci riferiamo ai papi dissoluti del Rinascimento come a coloro che hanno umiliato la cattedra di Pietro - concubinari, nepotisti, festaioli, rivestiti di pietre e tessuti preziosi - ma alcuni di loro, con trame e strategie raffinate, hanno salvato la Chiesa del loro tempo. Al contrario, sant’uomini e personaggi di specchiata moralità, poiché sprovvisti di astuzia politica, hanno talvolta determinato la rovina dell’istituzione di cui erano a capo. Essere insieme re e sommi sacerdoti è come essere servi di due padroni e raccapezzarcisi non è semplice. Per questo Paolo VI poté dichiarare che era stata la Divina provvidenza, nel 1870, a togliere al papa l’incombenza di una corona da sovrano.
Quali sono state le figure di pontefici che maggiormente hanno inciso sulla storia del papato? La lista sarebbe lunghissima e, alla fine, non potrebbe risultare esaustiva. Tante e tali sono le rivoluzioni in questa storia di venti secoli, e tanti i frangenti sui quali un pontefice risulta determinante, che classifiche del genere sono davvero impossibili. In tempi recenti, però, non c’è alcun dubbio: la vera rivoluzione è stata quella di Giovanni XXIII e Paolo VI, grazie al coraggio del primo - quello di inaugurare un concilio, un vero concilio, aperto alla discussione e senza esiti predeterminati - e alla tenacia del secondo, che quell’assemblea ha condotto felicemente in porto. Un esito tutt’altro che scontato. Si tratta di una vicenda esemplare di come due pastori profondamente diversi per temperamento, per estrazione sociale, per esperienze pregresse, uniti quasi solo dalle comuni radici lombarde, abbiano governato la Chiesa con stili diversi, ma siano stati capaci di guardare nella medesima direzione. Purtroppo, però, il modello di una Chiesa maggiormente assembleare si è dovuto poi scontrare con un pontificato, quello di Giovanni Paolo II, fortemente accentratore. La Chiesa è così: si muove lentamente e, anche se talvolta subisce accelerazioni improvvise, la resistenza al cambiamento - la resilienza delle sue strutture secolari - rimane uno dei suoi caratteri distintivi.
Come è destinata a cambiare nel futuro, a Suo avviso, questa istituzione?
Previsioni di questo genere sono destinate a rivelarsi sempre inaccurate e, nel caso della Chiesa cattolica, è particolarmente difficile districarsi tra le tante correnti che spingono la barca di Pietro in diverse direzioni. Inoltre, la Chiesa è una struttura gerarchica, verticista, dove ogni cambio di pontefice può generare rivolgimenti prima impensati, tanto quanto le reazioni conseguenti. Bergoglio ha dato un’impronta, in questi anni, ma nessuno garantisce che il successore vorrà seguire il suo stesso percorso.
Su almeno un punto, però, la direzione è chiara poiché si tratta di un cambiamento ormai duraturo e inarrestabile: la Chiesa sta divenendo sempre più “cattolica”, vale a dire universale. Paesi un tempo marginali oggi guadagnano di importanza; cattedre vescovili prima considerate irrilevanti oggi si fanno centrali, mentre da decenni si parla di un’Europa scristianizzata. La Chiesa, da questo punto di vista, sta mutando lentamente ma inesorabilmente e anche il papato ne risentirà. Se si vuole un metro di giudizio, basti pensare a coloro che oggi entrerebbero in un immaginario conclave. Gli arcivescovi di città come Milano o Parigi rimarrebbero nei loro palazzi, dato che non sono cardinali; lo sono invece quelli di Kigali, in Ruanda, o di Bangui nella Repubblica centrafricana. E questi sono solo alcuni dei tanti che potrei riportare.
*
Fonte: Letture.org
NOTE:
A) - [LA "GALLERIA DEI PAPI"]: CELEBRANDOSI #OGGI [10.11.2020] LA FIGURA DI PAPA #LEONEMAGNO (https://it.wikipedia.org/wiki/Incontro_di_Leone_Magno_con_Attila ), SUL FILO DELLA #MEMORIA DI #RAFFAELLO E #GIULIOII, è BENE RICORDARE DI FARE QUANTO PRIMA UNA VISITA ALLA #GALLERIADEIPAPI DI #PALAZZOALTIERI AD #ORIOLOROMANO...
B) - #Rinascimento e #filologia:"#Erasmo non ha ancora scritto il suo #Elogiodellafollia [pubblicato nel 1511], #Lutero non ha ancora affisso le sue #tesi" [rese pubbliche nel 1517], #AntonioFerrariis, il #Galateo, dona nel 1510 a #GiulioII un esemplare greco della #DonazionediCostantino.
C) - #DANTE2021 #RINASCIMENTO #OGGI. Svegliarsi dal #sonnodogmatico, accogliere l’analisi di #LorenzoValla (https://it.wikipedia.org/wiki/Donazione_di_Costantino) e l’indicazione antropologico-politica dei #DueSoli
Federico La Sala
-
> LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE, E --- LA "NOBILTÀ" DI D’ANNUNZIO E MUSSOLINI. L’ UTILITA’ E IL DANNO DELL’ARALDICA PER LA VITA.2 novembre 2020, di Federico La Sala
“M”: (DANTE, D’ANNUNZIO, E) MUSSOLINI. SULL’UTILITA’ E IL DANNO DELL’ARALDICA PER LA VITA...*
LA BONIFICA DELL’AGRO PONTINO E LO STEMMA DELLA CITTA’ DI APRILIA (25 aprile 1936). A BEN RIFLETTERE, SE SI CONSIDERA che “Il primo bozzetto acquerellato dello stemma del nuovo centro dell’Agro Pontino fu predisposto da Araldo di Crollalanza, presidente dell’O.N.C. (Opera Nazionale Combattenti), e erede di una famiglia di insigni araldisti che contribuirono tra la fine del XIX sec. e l’inizio del XX a un aggiornamento in Italia della scienza del blasone” e, ancora, che “un velato riferimento al nome del fondatore della Città sembra non mancare nello stemma. Esso è dato dalla disposizione delle rondini che non sembra affatto casuale. Infatti le rondini tracciano idealmente una lettera M maiuscola considerate insieme all’andamento perpendicolare dei fianchi dello scudo [...] Tale stratagemma del richiamo al nome di Mussolini era più esplicito nella prima versione dello stemma di Pontinia [...]. Un richiamo del genere si trovava anche nell’originario stemma di Sabaudia, nel quale campeggiava un’aquila caricata da uno scudo sabaudo e posata su tre monti che, per numero e disposizione, accennavano ad una lettera M” (cfr. don Antonio Pompili, “Lo stemma”, Comune di Aprilia, NON E’ IMPENSABILE CHE nel “gioco” dell’immagine elaborata da Araldo di Crollalanza sia presente una volontà di alludere a Dante (alla “M”, all’Aquila, del canto XVIII del Paradiso) e al contempo di inviare un “messaggio” al “primo duce”, a D’Annunzio (e al suo “Dantes Adriacus”).
* Nota a margine dell’articolo di Aurelio Musi, "Un caso letterario: M, l’uomo della Provvidenza", "L’identità di Clio", 5 Ottobre 2020.
Federico La Sala
-
> LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE, E --- L’INVITO DI PAPA FRACESCO A PAGARE IL TRIBURO A "CESARE".18 ottobre 2020, di Federico La Sala
DUE SOLI.
La Costituzione, la "Monarchia" di Dante, e la indicazione di Papa Francesco...
- PROPOSTA DI INTERPRETAZIONE. Per Dante, Roma aveva "due soli" (Purg. XVI, v. 107): Ponzio Pilato, "che fece per viltade il gran rifiuto" (Inf. III, v. 60), ruppe la bilancia dei due poteri e aprì la strada a Costantino prima e al "novo Pilato" che porta "nel Tempio le cupide vele” poi (Purg. XX, vv. 91-93).
Pagare il tributo a Cesare «è un dovere»! Con la precisazione evangelica sulla necessità di pagare le tasse allo Stato (secondo la Costituzione della Repubblica italiana), Papa Francesco apre la strada a Dante -2021 e, insieme, a una comprensione più precisa e contestualizzata della "misteriosa" figura che "fece per viltade il gran rifiuto".
Federico La Sala
-
> LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE, E IL VATICANO -- NON SI TRADISCONO COSI’ DIO E LA NAZIONE. Lettera agli evasori fiscali (di Luigi Bettazzi, vescovo emerito di Ivrea).9 luglio 2020, di Federico La Sala
Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio... *
Un vescovo emerito scrive.
Evasori fiscali, non si tradiscono così Dio e la nazione
di Luigi Bettazzi (Avvenire, mercoledì 8 luglio 2020)
Egregi evasori fiscali,
(e-gregio vuol dire infatti "fuori, al di sopra del gregge", della gente comune) da vescovo più giovane e da presidente di Pax Christi, Movimento internazionale per la pace, m’era venuto di scrivere ai politici del tempo - ad esempio al democristiano Benigno Zaccagnini e al comunista Enrico Berlinguer - invitandoli a essere coerenti con le loro scelte politiche e convergenti al bene della nazione, ora, al termine della mia vita (ho ormai più di 96 anni), mi viene di scrivere una lettera a voi.
La pandemia che stiamo vivendo ci ha obbligati a vivere più ritirati, quindi più pensosi per la nostra vita personale e per il bene della collettività. Ed è così, ad esempio, che ci siamo resi conto del lavoro delle varie mafie che, attente a evitare situazioni più clamorose, come quelle che finiscono in uccisioni e stragi, sfruttano la situazione per aumentare le loro ricchezze, ad esempio con prestiti a usura a chi non riesce a trovare mezzi legali per sovvenire alla mancanza di danaro causata dalla limitazione del lavoro o dalla sua perdita. Al contrario, v’è chi arriva a frodare per avere sovvenzioni a cui non ha diritto.
Questo ci ha fatto pensare come le limitazioni, sia del sistema sanitario antecedente come dei provvedimenti per arginare l’espandersi della pandemia e frenare le crisi dell’industria e delle aziende, derivi anche dalle minori disponibilità economiche dovute anche a quanto viene evaso da chi non paga le tasse, soprattutto di chi, con la ricchezza, riesce a trovare i mezzi per portare i suoi beni nei cosiddetti paradisi fiscali. Questa è una grossa ingiustizia perché quanto viene portato fuori dalla nazione è stato raggranellato con il lavoro dei concittadini e utilizzando le leggi (e le sottigliezze) dello Stato. È triste pensare che la nazione vi abbia fatti crescere e sviluppare fino al punto di poterla tradire.
Non voglio pensare che tra voi ci siano quelli che formalmente figurano come rispettosi - o addirittura partecipi attivi - del cristianesimo che ha accompagnato la storia della nostra nazione, ma poi trasgrediscono il suo messaggio fondamentale, che è quello di non chiudersi nel proprio egoismo, ma di aprirsi agli altri, proprio cominciando dai più piccoli, dai più poveri, dai più emarginati.
 Così fanno i boss delle varie mafie, che poi a copertura delle loro violenze proteggono le devozioni popolari e se ne fanno riverire, o quei politici che nel mondo ostentano oggetti e proteggono frange di strutture religiose per coprire le loro minori attenzioni umane. Non vorrei che anche voi, magari sovvenendo pubblicamente alcune opere di solidarietà, vogliate così "scontare" la vostra ingiustizia di fondo.
Così fanno i boss delle varie mafie, che poi a copertura delle loro violenze proteggono le devozioni popolari e se ne fanno riverire, o quei politici che nel mondo ostentano oggetti e proteggono frange di strutture religiose per coprire le loro minori attenzioni umane. Non vorrei che anche voi, magari sovvenendo pubblicamente alcune opere di solidarietà, vogliate così "scontare" la vostra ingiustizia di fondo.È vero che alle volte, nel mondo, le tassazioni possono sembrare eccessive o ingiuste. Ma, in democrazia, si devono trovare i mezzi, soprattutto da parte dei più abbienti come siete voi, per correggerle, non per avere un pretesto per evaderle, portando il proprio danaro negli... inferni fiscali.
 Perché purtroppo il danaro diventa quasi una divinità, anzi la vera alternativa a Dio: aveva già detto chiaramente Gesù (usando un termine locale) che non si possono servire due padroni: o Dio o mammona (il danaro).
Perché purtroppo il danaro diventa quasi una divinità, anzi la vera alternativa a Dio: aveva già detto chiaramente Gesù (usando un termine locale) che non si possono servire due padroni: o Dio o mammona (il danaro).Non so se anche qualche parroco vi ha mai detto che l’evasione fiscale è peccato mortale: l’ha detto qualche tempo fa laicamente Romano Prodi, ve lo ripete oggi un vescovo, anche se emerito. Mi verrebbe da ripetere la frase forte che san Giovanni Paolo II proclamò, nella valle di Agrigento, contro le mafie: "Convertitevi! Un giorno dovrete risponderne di fronte a Dio". E allora non ci saranno pretesti e coperture.
Vi chiedo scusa se vi ho attaccati pubblicamente. Spero comunque di avervi fatto pensare.
Da vescovo, pregherò per voi, per le vostre famiglie e per le vostre attività, ovviamente purché siano oneste.
Vescovo emerito di Ivrea
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio ... un cattolicesimo che ha sempre confuso "Erode" con Cesare e Dio con "Mammona" !!!
"ERODE" E LE GERARCHIE CATTOLICO-ROMANE CONTRO CRISTO E "CONTRO CESARE. Cristianesimo e totalitarismo nell’epoca dei fascismi".
VIVA L’ITALIA !!! LA QUESTIONE "CATTOLICA" E LO SPIRITO DEI NOSTRI PADRI E DELLE NOSTRE MADRI COSTITUENTI. Per un ri-orientamento antropologico e teologico-politico.
Federico La Sala
-
> LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE --- IL POETA E L’INTERPRETE. "Dante in Cina: la rocambolesca storia della Commedia nell’Estremo Oriente" (di V. Pagnanini).29 giugno 2020, di Federico La Sala
Il poeta e l’interprete: storia di una passione dantesca
di Valentina Pagnanini (Il Chiasmo/Treccani, 29 giugno 2020)
Ufficialmente è stato al servizio del governo cinese, prima interprete, poi diplomatico, infine console, appassionato di scacchi nonché grande conoscitore della lingua e cultura cinese, coinvolto in iniziative militari segrete: l’effettiva professione di Eugenio Volpicelli ancora oggi resta un mistero.
È stato uno dei più grandi sinologi italiani, tra i primi ad aver diffuso la Divina Commedia in Oriente, coltivando la passione per Dante oltre l’attività diplomatica. È grazie a lui se nell’Ottocento in Cina iniziarono a circolare le prime traduzioni del poema dantesco, l’opera più rappresentativa della cultura italiana in Asia. A far luce su alcuni periodi oscuri della sua vita interviene il saggio di Eric Salerno, Dante in Cina: la rocambolesca storia della Commedia nell’Estremo Oriente, nel quale si ripercorrono i viaggi, le missioni diplomatiche e gli incontri politici di Volpicelli e della moglie Iside. Quello tra i due coniugi è stato un sodalizio affettivo e ideologico. Eugenio e Iside si sono sposati a Milano il 14 febbraio 1891, insieme hanno condiviso l’amore per Dante e per la patria, le missioni diplomatiche e i segreti di stato, nonché i viaggi, da Milano a Hong Kong, a Nagasaki e Macao.
L’interesse per Dante sorge in lui in giovane età. La formazione di Volpicelli è affidata all’Istituto Orientale di Napoli, un unicum organizzato sul modello del Collegio dei cinesi, che costituisce la base per la sua attività diplomatica. Qui egli studia con profitto la letteratura italiana e le lingue orientali, per primo ottiene «una borsa di studio offerta dall’Istituto asiatico. E agli esami finali del 1881 si posizionò ancora una volta in testa a lla classifica. Dieci decimi in persiano e arabo, lingua questa che fu incaricato di insegnare» riporta Eric Salerno. In quello stesso anno, appena diplomato, egli decide di abbandonare Napoli e di seguire il richiamo dell’Est.
- Lasciai Napoli il 23 agosto 1881 e da allora, anche se spesso vi sono tornato, è sempre stato per brevi periodi, come visitatore, e dunque posso considerarmi e mi sono considerato residente dell’Estremo Oriente dove ho trascorso la parte maggiore e migliore della mia vita.
Volpicelli si interessava ai complotti della diplomazia e alle strategie politiche, praticava l’arte della guerra sfidando gli alti ufficiali a scacchi e wei ch’i, un gioco molto praticato in Giappone come esercizio di tattica militare, «istruttivo nell’arte della guerra». Si appassiona a tal punto da pubblicare due articoli su di essi per il Journal of the North China Branch of the Royal Asiatic Society di Singapore. «L’oggetto del gioco di wei ch’i può apparire molto facile, eppure sarà sufficientemente difficile portarlo a termine. Si tratta di occupare più spazio possibile sul tavolo e di impedire all’avversario di fare lo stesso» scrive nel 1892 e continua: «l’interesse del gioco non è concentrato in un posto come con gli scacchi, intorno al re, ma è sparpagliato ovunque sul tavolo, in quanto ogni singolo posto ha un effetto ugualmente importante nel risultato del gioco e conta nel totale finale che rappresenta la posizione delle due parti alla fine della lotta». Per concludere il gioco, «tradotto in termini militari, più che dare scacco matto al re bisognava puntare alla conquista del territorio». In ventotto pagine di spiegazioni e illustrazioni Volpicelli forniva le prime istruzioni di gioco del wei ch’i in una lingua europea, l’inglese. Se in Cina «lo veneravano come esperto degli scacchi cinesi», in Italia «lo idolatravano come uno dei primi ad aver compreso e descritto la struttura della lingua cinese, tra i simboli e le tonalità più diverse».
Egli arriva in Cina sul finire del diciannovesimo secolo e trova un paese profondamente diverso rispetto ai suoi studi, in piena crisi e in balia di conflitti interni ed esterni. Il suo primo incarico inizia nel 1882 ad Amoy, l’attuale Xiamen, porto strategico per le esportazioni di tè nel corso del Novecento. Qui, Volpicelli risiede per un lungo periodo, alternando visite alla capitale e ad altre città d’interesse coloniale, e racconta con orgoglio di una sua impresa compiuta in quegli anni che gli valse un importante impiego. Egli riuscì a circumnavigare a nuoto l’isola di Kulangsu - chiamata anche l’isola dei pianoforti per la più elevata presenza dello strumento musicale - prova della sua intraprendenza e coraggio, nonché di virtù. L’episodio fu seguito dall’assegnazione di un nuovo mandato: si richiedeva la sua presenza come interprete nella missione imperiale cinese volta a ottenere un armistizio con la Francia per il comando del Tonchino. Volpicelli prese parte alla missione, coordinata dalle dogane dell’impero, e diede prova delle sue abilità dialettiche. «Ebbe diritto, in segno della gratitudine cinese, all’ordine del Doppio Dragone» nota Eric Salerno, Parigi invece «insignì Volpicelli della commenda del Dragone dell’Annam, creata ad hoc per chi aveva fornito assistenza durante le operazioni navali in quel settore del Sudest asiatico».
La sua fama era giunta ben presto anche in Italia, il suo volto si stagliava in primo piano sulle copertine delle riviste italiane, le sue imprese erano motivo di orgoglio e onore per il governo italiano. L’8 novembre 1885 è dedicata a lui la copertina Un mandarino italiano in Cina del settimanale L’illustrazione italiana dove appare un’immagine di Volpicelli, fotografato con un casco coloniale in testa, corredata dalla didascalia: «L’italiano Volpicelli e i plenipotenziari per la pace in Cina». L’articolo menzionava le missioni diplomatiche nel Tonchino e in Corea, alle quali aveva partecipato Volpicelli come interprete e mediatore degli interessi italiani, ottenendo per i suoi servizi una commenda cinese:
- In meno di un anno il signor Zanoni Volpicelli s’è reso talmente utile coll’opera sua che il governo cinese lo ha, in ricompensa de’ prestati servigi, nominato mandarino di 4a classe. Le classi dei mandarini sono sedici, in ordine dalla 1a alla 16a. Si può affermare che il grado onorifico conferito allo Zanoni Volpicelli non è mai stato accordato ad alcun europeo.
La carriera di Volpicelli però non fu sempre costellata da riconoscimenti e onorificenze. Ci furono anche momenti bui, periodi di sospetti, critiche e accuse che coinvolsero Volpicelli in intrighi diplomatici. In Gran Bretagna c’era molta attenzione al modo in cui circolavano le informazioni e venivano diffuse le notizie, soprattutto nell’ambiente diplomatico. Volpicelli, d’altro canto, si interessava a questioni appartenenti non soltanto alla sua sfera di competenza, ma dava suggerimenti anche in altri ambiti, come nel campo militare, consigliando con perizia strategie e nuove mosse, tattiche da esperto giocatore di scacchi e wei ch’i. Fu proprio questa sua curiosità a procurargli degli inconvenienti politici. Se nel 1885 Eugenio Volpicelli era ritenuto degno di una delle più alte onorificenze cinesi e stimato in tutta Europa, trent’anni dopo, nel 1914 per l’esattezza, il suo operato non era più ben visto in Occidente e fu in breve tempo allontanato dalla sfera pubblica. Abbandonati gli incarichi ufficiali, egli si dedica alla lettura e alla scoperta dell’opera di un grande poeta e scrittore, viaggiatore esiliato come lui dai pubblici offici: Dante Alighieri.
Come sottolinea il filosofo Aijaz Ahmad in Orientalismo e dopo (2009), «Dante è la figura centrale attraverso cui si possono gettare dei ponti fra l’Antichità e la modernità», questo perché, secondo la definizione dell’orientalista Edward W. Said, «la forza poetica di Dante contribuisce a intensificare e generalizzare questa prospettiva [Orientalista] dalla quale l’Oriente è contemplato». Volpicelli avrebbe condiviso la passione per il poeta fiorentino con suo cugino Francesco Torraca, celebre commentatore della Divina Commedia, che nei primi anni del Novecento era professore di letteratura comparata all’Università Federico II di Napoli. La passione per il sommo poeta lo accompagnò sin dagli inizi, già a Napoli da studente era solito frequentare salotti rinomati nei quali veniva letto Dante.
Oltre l’attività di «interprete, diplomatico, storico e forse qualcos’altro, [Eugenio] si servì di una penna brillante per raccontare momenti importanti della sua avventu ra in Oriente e per spiegare ad altri diplomatici, ministri, re e principi, e poi alla gente comune, la realtà di quel mondo», di quella stessa penna si servì anche, e soprattutto, per tradurre Dante e farlo conoscere al pubblico cinese. «L’autore della Commedia fu sempre nel cuore e nella mente del nostro console generale» racconta Salerno.
L’amore per Dante era nato in Volpicelli da studi e ricerche, letture appassionate e ancora ricerche, Eugenio si era interessato alla vita del poeta in alcuni anni così simile alla sua, una carriera trascorsa al servizio del potere pubblico oscurata da false accuse di corruzione, l’allontanamento dalla propria patria più o meno forzato, la passione per i viaggi e le infinite peregrinazioni. Dante scrive: «Voi credete forse che siamo esperti d’esto loco; ma noi siam peregrin come voi siete», e anche Volpicelli, in definitiva, fu un pellegrino. Confrontando l’Alighieri e il Volpicelli, si notano molti punti di contatto tra le due esperienze biografiche: due uomini politici, il letterato e l’interprete, entrambi orfani fin da giovani, ma con una vasta rete di amicizie, i loro anni migliori spesi tra l’otium litterarum e il negotium. Dal 1319 al 1321 anche Dante era stato ambasciatore, a Venezia, al servizio del signore di Ravenna Guido da Polenta. Comune anche l’interesse per le strutture della lingua, italiana per il poeta, cinese per il console, e per i numerosi dialetti coesistenti, alla ricerca di una lingua comune.
Nel 1942, è Anna Silvia Bonsignore, giornalista per L’Ambrosiano milanese di Umberto Notari, che nell’elzeviro Sull’italiano creato mandarino racconta all’Italia della passione dantesca di Volpicelli e segnala anche un suo viaggio in Cina alla ricerca di Dante. Volpicelli riscontra delle «similarità tra la carriera di Dante e quella del grande saggio cinese Confucio», al punto tale da intraprendere una traduzione della Commedia in lingua cinese. Egli aveva ritrovato nei testi filosofici cinesi echi del poema dantesco, che si traducevano in raffigurazioni, simboli e descrizioni strettamente legati alla Commedia. Si legge da un originale autobiografico del diplomatico:
- Durante i lunghi anni d’esilio. Durante la terribile guerra, scoraggiato dai tristi e sicuri presagi dell’ingratitudine e del tradimento che ci aspettava alla fine dei nostri insuperabili sacrifizi subiti a esclusivo benefizio dei capitalisti esteri, unico mio conforto era stata la lettura di Dante amorosamente guidata dal chiarissimo e pratico commentario di Francesco Torraca. Quindi quando il Circolo per Conferenze del “Canton Christian College” formava il programma per l’anno 1919 e mi chiedeva di inaugurare la serie delle conferenze, scelsi per soggetto Dante e Beatrice. La conferenza fu fatta il 14 febbraio 1919, il giorno di San Valentino, l’anniversario del mio matrimonio e lo telegrafai a mia moglie. Formava un tutto armonico e coerente.
Esattamente un secolo fa, in Cina, Eugenio Volpicelli rivelava al mondo la sua passione per l’opera dantesca, celebrando l’amore di Dante per Beatrice proprio nel ventottesimo anniversario del suo matrimonio, simbolo del duplice legame, affettivo e letterario, che lo univa indissolubilmente al sommo poeta.
Per saperne di più:
Si consiglia la lettura del saggio di Eric Salerno da cui sono tratte le citazioni dell’articolo: Eric Salerno, Dante in Cina: la rocambolesca storia della Commedia nell’Estremo Oriente, Il Saggiatore, Milano, 2018. Per approfondire il processo di divulgazione della Divina Commedia in Oriente si propone la lettura dei contributi di Federico Masini: Una “Divina Commedia” cantonese, in Mondo Cinese, n.73, a. 1991, pp. 27-48 e La Divina Commedia in lingua cinese a Ravenna, in Mondo Cinese, n.98, a. 1994; sui rapporti storico-letterari tra l’Italia e la Cina, si suggerisce il volume di Giuliano Bertuccioli, Federico Masini, Italia e Cina, Laterza, Bari, 1996. Sull’orientalismo si propongono i testi: E. W. Said, Orientalismo, Bollati Boringhieri, Torino, 1991; A. Ahmad, Orientalismo e dopo, in M. Mellino (a cura di), Post-orientalismo, Meltemi, Roma, 2009.
-
> LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE, E IL VATICANO CON IL SUO TRADIZIONALE SOFISMA -- PRINCIPIO DI CARITÀ O EMPATIA?! CAPIRE IL COMPORTAMENTO UMANO (di Antonio Rainone).28 dicembre 2019, di Federico La Sala
USCIRE DALL’INFERNO EPISTEMOLOGICO. Amore (Charitas) o Mammona (Caritas)?! Il "principle of charity", il «principio di carità» ("caritas"!), un assunzione di tipo «imperialistico» (Robert Nozick, "The Nature of Rationality", 1993) *
CAPIRE IL COMPORTAMENTO UMANO
di Antonio Rainone *
- 3.Linguaggio ed empatia in W. V. Quine
Carità o empatia?
Esiste una tematica nella filosofia del linguaggio e nell’epistemologia di W. V. Quine che può apparire per molti versi atipica o sorprendente a chi abbia del celebre filosofo statunitense un’immagine limitata alle sue concezioni fisicalistiche e comportamentistiche, per non dire “scientistiche”, non di rado considerate le più caratteristiche della sua produzione filosofica. Si tratta della tematica dell’empatia, cioè della capacità di avanzare spiegazioni o interpretazioni del comportamento (linguistico e non) di altri soggetti “mettendosi nei loro panni” o “simulandone” la situazione cognitiva o, ancora, assumendone immaginativamente il ruolo.
 L’empatia - anche indipendentemente da Quine - ha peraltro suscitato una particolare attenzione nella filosofia della mente degli ultimi trent’anni, dove ha dato vita a un ampio dibattito sul cosiddetto mindreading, incontrandosi inoltre con la teoria neuroscientifica dei cosiddetti neuroni specchio 1. I più recenti lavori sulla filosofia del linguaggio di Quine dedicano una particolare attenzione a tale tematica 2, anche perché Quine, pur accennandovi in Word and Object (1960), ne ha proposto una esplicita teorizzazione solo nella sua produzione più tarda.
L’empatia - anche indipendentemente da Quine - ha peraltro suscitato una particolare attenzione nella filosofia della mente degli ultimi trent’anni, dove ha dato vita a un ampio dibattito sul cosiddetto mindreading, incontrandosi inoltre con la teoria neuroscientifica dei cosiddetti neuroni specchio 1. I più recenti lavori sulla filosofia del linguaggio di Quine dedicano una particolare attenzione a tale tematica 2, anche perché Quine, pur accennandovi in Word and Object (1960), ne ha proposto una esplicita teorizzazione solo nella sua produzione più tarda.A partire dagli anni Settanta, ma più esplicitamente negli anni Novanta, Quine ha considerato il metodo dell’empatia come il metodo fondamentale di traduzione nel celebre Gedankenexperiment della traduzione radicale (ovvero la traduzione di una lingua completamente sconosciuta), ma anche come una capacità naturale ai fini dell’acquisizione del linguaggio e dell’attribuzione di stati mentali intenzionali (ossia percezioni, credenze, desideri ecc.) ad altri. In effetti, l’empatia ha acquisito un rilievo così crescente in Quine che nei suoi due ultimi lavori sistematici, Pursuit of Truth (1992) e From Stimulus to Science (1995), essa appare come un nucleo centrale della sua filosofia del linguaggio e della mente.
È stato del resto lo stesso Quine a sottolineare la rilevanza dell’empatia nella sua filosofia del linguaggio, “retrodatandone”, per così dire, la teorizzazione agli anni Cinquanta. Così Quine si esprime in uno dei suoi ultimi interventi sulla questione:
- Il mio uso della parola “empatia” è piuttosto recente ed è stato notato, ma io avevo già riconosciuto che l’approccio del traduttore radicale è di tipo empatico in Word and Object e, in realtà, già nove anni prima. «Il lessicografo - avevo scritto - dipende [...] da una proiezione di sé stesso, con la sua Weltanschauung indo-europea, nei sandali del suo informatore Kalaba» (Quine, 2000, p. 410).
Il brano qui citato da Quine, ripreso dall’importante The Problem of Meaning in Linguistics (1951b, p. 63) - una notevole anticipazione della problematica della traduzione radicale - non è privo di una certa ambiguità, prestandosi a una duplice lettura. È forse vero che in Word and Object alcune affermazioni di Quine potrebbero essere interpretate come la proposta di un metodo empatico, sostenuto comunque in modo non del tutto esplicito (cfr. Rainone, 1995), ma possono essere avanzati dei dubbi circa la difesa di tale metodo nel saggio del 1951. Se da un lato il concetto di proiezione sembra proporre il metodo dell’empatia nell’attività di traduzione di una lingua completamente sconosciuta da parte di un etnolinguista, dall’altro sembra in effetti riferirsi non tanto al metodo empatico, quanto, piuttosto, a quello che, grazie allo stesso Quine, e in seguito a Donald Davidson (cfr. Davidson, 1984), sarebbe diventato noto come «principio di carità» (principle of charity). Il linguista - asseriva infatti Quine - proietta sé stesso con la sua Weltanschauung nei panni del nativo che usa una lingua sconosciuta, presupponendo (o ipotizzando) così che il suo informatore si conformi ai suoi principi logici e abbia le sue stesse credenze (ritenute vere) riguardo alla realtà (sono questi, grosso modo, i principali tenet del principio di carità, che presuppone una comune natura razionale tra interprete/ traduttore e interpretato/parlante).
In Word and Object Quine avrebbe esplicitamente utilizzato - e teorizzato - il principio di carità riguardo alla traduzione dei connettivi logici e degli enunciati “ovvi”. L’esempio più pertinente, in merito, è rappresentato dal «caso estremo» di qualche nativo che accetti come veri enunciati traducibili nella forma “p e non-p” (per esempio, “piove e non piove”), una forma enunciativa che, violando il principio di non contraddizione, deporrebbe per Quine non a favore dell’irrazionalità dei parlanti - come riteneva Lévy-Bruhl con la sua teoria della «mentalità prelogica» - ma contro la correttezza della traduzione (Quine, 1960, p. 58).
Il medesimo argomento varrebbe inoltre per la traduzione di enunciati ovvi: una risposta negativa da parte del nativo alla domanda (nella lingua nativa) “sta piovendo?” fatta sotto la pioggia costituirebbe una prova di cattiva traduzione nella lingua nativa, non del fatto che il nativo non condivida con il traduttore la credenza in qualcosa di così evidente. In generale, nota Quine in un famoso passo di Word and Object, «quanto più assurde o esotiche sono le credenze attribuite a una persona tanto più sospetti abbiamo il diritto di essere nei confronti delle traduzioni; il mito dei popoli prelogici segna solo il caso estremo» (ivi, p. 68).
Difficilmente, pertanto, la «proiezione» del linguista nei «sandali» del nativo di cui Quine parlava nel saggio del 1951 potrebbe apparire come una forma di metodo empatico, dal momento che essa “imporrebbe” al nativo uno «schema concettuale» (quello del linguista) che, per quanto il linguista può saperne, potrebbe essergli del tutto estraneo. Questo è, in fondo, il problema sottostante a tutto il celebre secondo capitolo di Word and Object 3. Non vi sarebbe alcuna garanzia, infatti, secondo Quine, che i nativi condividano lo stesso schema concettuale (la stessa Weltanschauung) del linguista. Ma il linguista non può, d’altro canto, che fare affidamento sul proprio linguaggio (o schema concettuale), data la scarsa evidenza empirica di cui dispone nel tradurre la lingua sconosciuta. Basarsi sul proprio schema concettuale, proiettandolo sul «linguaggio della giungla», è una necessità pratica, che - asseriva Quine in Word and Object - investirebbe soprattutto l’elaborazione delle «ipotesi analitiche», ovvero le ipotetiche correlazioni tra le emissioni verbali olofrastiche dei nativi e le loro possibili traduzioni mediante cui il linguista deve stabilire quali frammenti di enunciati andranno considerati termini (singolari e generali), quali congiunzioni, quali articoli, quali desinenze per il plurale e quali pronomi, sulla cui base individuare un insieme plausibile di credenze ontologiche ed epistemiche. La scelta delle ipotesi analitiche, infatti, non è altro che un modo di «catapultarsi nel linguaggio della giungla utilizzando i propri modelli linguistici » (ivi, p. 70).
 Per ricordare il celebre esempio di Quine, la traduzione del proferimento di “gavagai” con “coniglio” (invece che con alternative bizzarre quali “stadi di coniglio” o “sta conigliando”, per quanto ammissibili sulla base dell’evidenza osservativa) equipara l’emissione verbale nativa a un termine generale del linguaggio del linguista, ma nulla esclude che i nativi possano essere privi di un termine referenziale generale per designare i conigli, anche se il linguista ritiene ciò “caritatevolmente” improbabile.
Per ricordare il celebre esempio di Quine, la traduzione del proferimento di “gavagai” con “coniglio” (invece che con alternative bizzarre quali “stadi di coniglio” o “sta conigliando”, per quanto ammissibili sulla base dell’evidenza osservativa) equipara l’emissione verbale nativa a un termine generale del linguaggio del linguista, ma nulla esclude che i nativi possano essere privi di un termine referenziale generale per designare i conigli, anche se il linguista ritiene ciò “caritatevolmente” improbabile.Utilizzare i modelli del proprio linguaggio per tradurre un linguaggio alieno non equivale quindi ad applicare un metodo empatico di comprensione, trattandosi al massimo di un’ulteriore e più ampia applicazione del principio di carità. L’empatia sembra in realtà qualcosa di diverso dalla carità: a differenza di quest’ultima, l’empatia non presuppone necessariamente una condivisione di significati e stati cognitivi (credenze). Forse l’assunzione di un’analogia di stati cognitivi tra interprete e interpretato - il «ritrovamento dell’io nel tu», secondo la celebre formula di Wilhelm Dilthey (1927, trad. it. p. 293) - può apparire inevitabile ed efficace riguardo alle risposte verbali fenomenologiche direttamente connesse a stimolazioni elementari provenienti da eventi osservativi intersoggettivi del mondo esterno (la pioggia, il colore rosso, il caldo e il freddo ecc.): ci si aspetta infatti che i nativi, che presentano una conformazione neurofisiologica e neuropsicologica analoga alla nostra, non abbiano percezioni di tipo diverso dalle nostre, rispondendo linguisticamente a tali percezioni in modo analogo a come risponderemmo noi; in tal caso l’empatia sembrerebbe indistinguibile dalla carità interpretativa, in quanto fondata sull’assunzione dell’esistenza di meccanismi percettivi comuni ai soggetti coinvolti. Ma difficilmente tale analogia potrebbe essere presupposta allorché si tratti di tradurre il linguaggio o spiegare il comportamento di soggetti appartenenti a una cultura del tutto estranea a quella dell’interprete. In questo caso l’interprete dovrà in qualche modo “entrare”, per così dire, nella “mente” dei soggetti da interpretare per comprendere il loro peculiare punto di vista, le loro credenze sulla realtà e i significati delle loro parole.
In definitiva, la differenza tra carità ed empatia può essere intesa come la differenza tra imporre il proprio punto di vista all’altro e assumere il punto di vista dell’altro. La differenza è particolarmente rilevante nei casi di interpretazione di soggetti appartenenti a “mondi” radicalmente diversi da quello dell’interprete. Se così non fosse, difficilmente gli etnoantropologi avrebbero potuto attribuire credenze animistiche o culti religiosi atipici (come i celebri cargo cults) alle popolazioni studiate (in entrambi i casi si dovrebbe trattare, secondo un’interpretazione caritatevole, di errori di traduzione o interpretazione).
Non dovrebbe costituire motivo di sorpresa, allora, che David K. Lewis, in un saggio dedicato alla problematica davidsoniana dell’«interpretazione radicale», avesse dato una definizione del principio di carità che ingloba, per così dire, anche il procedimento empatico: un soggetto di interpretazione, asseriva Lewis, «dovrebbe credere ciò che crediamo noi, o forse ciò che avremmo creduto noi al suo posto; e dovrebbe desiderare ciò che desideriamo noi, o forse ciò che avremmo desiderato noi al suo posto» (Lewis, 1974, p. 336; corsivi aggiunti). In pratica, secondo questa definizione del principio di carità, si tratterebbe di assumere empaticamente il punto di vista dei soggetti interpretati, tenendo conto delle loro credenze (eventualmente false o strane) e della loro cultura di appartenenza, attribuendo a essi non le credenze e i desideri dell’interprete, ma le credenze e i desideri che l’interprete avrebbe se fosse “nei loro panni”. Si può aggiungere, a tale proposito, che l’empatia rappresenta una sorta di “correttivo” del principio di carità, tenendo conto del punto di vista dell’altro.
Ma forse c’è ancora qualcosa da dire: mentre la carità impone dei vincoli normativi sulla razionalità dei soggetti da interpretare - vincoli a priori basati sui principi logici e sulle norme di razionalità epistemica e pratica dell’interprete, ritenuti universali 4 -, l’empatia sembrerebbe invece un metodo descrittivo ed empirico, essendo subordinata all’acquisizione di un’ampia gamma di informazioni relative alle credenze, alla cultura e alle esperienze passate dei soggetti da interpretare (inutile aggiungere che non c’è accordo su quest’ultimo punto).
4. Si può ricordare, riguardo a questa presunta universalità, che Robert Nozick ha contestato il principio di carità in quanto assunzione di tipo «imperialistico», conferendo tale principio «un peso indebito alla posizione che accade di occupare a noi, alle nostre credenze e alle nostre preferenze» (Nozick, 1993, p. 153). Giustamente, Nozick fa notare che difficilmente questa sarebbe l’assunzione di un antropologo relativamente alle cosiddette società “primitive” (ivi, p. 154).
* Cfr. Antonio Rainone, "Capire il comportamento umano. Azione, razionalità, empatia", Carocci editore, Roma, 2019, pp. 55-59, ripresa parziale.
* Sul tema, nel sito, si cfr.:
- L’EUROPA, IL CRISTIANESIMO ("DEUS CHARITAS EST"), E IL CATTOLICESIMO COSTANTINIANO ("DEUS CARITAS EST").Una storia di lunga durata...
- MURATORI, BENEDETTO XVI, E "UNO SPROPOSITO MAIUSCOLO"
- DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE.
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
Federico La Sala
-
> LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE, E IL VATICANO --- ANNO 1223: A GRECCIO IL PRIMO PRESEPE VIVENTE DELLA STORIA.27 novembre 2019, di Federico La Sala
RIPARTIRE DA GRECCIO, DAL PRESEPE ... *
Papa. Francesco: «Domenica sarò a Greccio, vi invierò una lettera sul Presepe»
Domenica primo dicembre con l’avvio del tempo dell’Avvento il Papa invierà una lettera per far capire il significato del Presepe, da Greccio dove san Francesco diede vita al primo presepe vivente
di I.Sol. (Avvenire, mercoledì 27 novembre 2019)
"Domenica prossima inizierà il tempo liturgico dell’Avvento. Mi recherò a Greccio, per pregare nel posto" dove San Francesco realizzò il primo presepe "per inviare a tutto il popolo credente una lettera per capire il significato del presepio".
 È l’annuncio di Papa Francesco al termine dell’udienza generale.
È l’annuncio di Papa Francesco al termine dell’udienza generale.- Il Presepe è per tutti legato alla rappresentazione della nascita di Gesù. La notte della vigilia di Natale del 1223 in località Greccio san Francesco diede vita al primo Presepe vivente della storia
A GRECCIO IL PRIMO PRESEPE VIVENTE DELLA STORIA
Correva l’anno 1223 quando san Francesco d’Assisi scelse l’umile paese montano del alto Lazio di Greccio, affacciato sulla vasta conca reatina, per rievocare la nascita del Salvatore. La tradizione vuole che a far nascere nel mondo la prima idea di presepe vivente fosse sorta su intuizione del Poverello di Assisi con l’aiuto del nobile signore di Greccio Giovanni Velita. Secondo le agiografie, durante la Messa, sarebbe apparso nella culla un bambino in carne ed ossa, che Francesco prese in braccio. Da questo episodio ebbe origine la tradizione del presepe.
- [Foto] Il Santuario di Greccio, in provincia di Rieti (Ansa)
- [Foto]Nel gennaio 2016 il Papa visitò a sorpresa il Santuario di Greccio (Ansa)
La testimonianza di tutto questo ci arriva da un antica fonte come la "Legenda di san Francesco": «Come il beato Francesco, in memoria del Natale di Cristo, ordinò che si apprestasse il presepe, che si portasse il fieno, che si conducessero il bue e l’asino; e predicò sulla natività del Re povero». A simboleggiare ancora oggi questo episodio singolare e della vita del Poverello è il dipinto attribuito a Giotto "Il presepe di Greccio" (realizzato tra il 1295 e il 1299) che è la tredicesima delle ventotto scene del ciclo di affreschi delle "Storie di san Francesco" presenti nella Basilica superiore di Assisi.
Da allora, la tradizione si diffuse nel resto d’Italia e negli altri Paesi cristiani. Oggi, i presepi viventi sono organizzati pressoché in tutto il mondo occidentale cristiano, non solo cattolico, ma anche da parte di fedeli di altre Chiese.
Nella città laziale di Greccio ando a sorpresa anche papa Francesco nel gennaio 2016 proprio per visitare il luogo dove per la prima volta venne realizzato un presepe e per pregare al Santuario che custodisce la memoria di quel Natale 1223, in cui san Francesco volle «vedere con gli occhi del corpo» la povertà del Bambino di Betlemme.
IL VIDEO DELLA VISITA NEL 2016 DEL PAPA A GRECCIO
 Video
Video
*
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- MEMORIA DI FRANCESCO D’ASSISI. "VA’, RIPARA LA MIA CASA"!!!
- FESTA DI SAN GIUSEPPE E DEL PAPA’ - NON DEL PAPA!!! BASTA CON LA "MALA EDUCACION" E CON LA "MALA FEDE"!!!
"DUE SOLI": COME MARIA, COSI’ GIUSEPPE!!!
UOMINI E DONNE. LA NUOVA ALLEANZA di "Maria" e di "Giuseppe"!!!
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE, E IL VATICANO CON IL SUO TRADIZIONALE SOFISMA --- I "DUE SOLI" E I "DUE PADRONI". Democrazia e Cristianesimo (di Dario Antiseri).23 ottobre 2019, di Federico La Sala
"DUE SOLI" (DANTE): I "DUE PADRONI", I "DUE MONDI", E LA DEMOCRAZIA, OGGI.... *
Democrazia e cristianesimo
Per una democrazia inclusiva
di Dario Antiseri (L’Osservatore Romano, 23 ottobre 2019)
In tema di democrazia una domanda ineludibile è la seguente: l’essere cristiano è compatibile con la laicità dello Stato? O, rovesciando l’interrogativo, lo Stato laico sarebbe stato possibile senza l’avvento del cristianesimo? Nella pratica politica, il relativismo - ha affermato qualche anno fa l’allora cardinale Joseph Ratzinger - è benvenuto perché ci vaccina dalla tentazione utopica. E novità essenziale del cristianesimo per la storia è che «fino a Cristo l’identificazione di religione e Stato, divinità e Stato, era quasi necessaria per dare stabilità allo Stato. Poi l’islam ritorna a questa identificazione tra mondo politico e religioso, col pensiero che solo con il potere politico si può anche moralizzare l’umanità».
 In realtà, «da Cristo stesso troviamo subito la posizione contraria: Dio non è di questo mondo, non ha legioni, così dice Cristo, Stalin dice non ha divisioni. Non ha un potere mondano, attira l’umanità a sé non con un potere esterno, politico, militare ma solo col potere della verità che convince, dell’amore che attrae. Egli dice “attirerò tutti a me”. Ma lo dice proprio dalla croce. E così crea questa distinzione tra imperatore e Dio, tra il mondo dell’imperatore al quale conviene lealtà, ma una lealtà critica, e il mondo di Dio, che è assoluto. Mentre non è assoluto lo Stato [...]. I padri hanno pregato per lo Stato riconoscendone la necessità, ma non hanno adorato lo Stato».
In realtà, «da Cristo stesso troviamo subito la posizione contraria: Dio non è di questo mondo, non ha legioni, così dice Cristo, Stalin dice non ha divisioni. Non ha un potere mondano, attira l’umanità a sé non con un potere esterno, politico, militare ma solo col potere della verità che convince, dell’amore che attrae. Egli dice “attirerò tutti a me”. Ma lo dice proprio dalla croce. E così crea questa distinzione tra imperatore e Dio, tra il mondo dell’imperatore al quale conviene lealtà, ma una lealtà critica, e il mondo di Dio, che è assoluto. Mentre non è assoluto lo Stato [...]. I padri hanno pregato per lo Stato riconoscendone la necessità, ma non hanno adorato lo Stato».
 Questa, ad avviso di Ratzinger, è «la distinzione decisiva» - una distinzione che rappresenta uno straordinario punto di incontro tra il pensiero cristiano e cultura liberal-democratica. «Io penso - afferma Ratzinger - che la visione liberal-democratica non potesse nascere senza questo avvenimento cristiano che ha diviso i due mondi, così creando una nuova libertà. Lo Stato è importante, si deve ubbidire alle leggi, ma non è l’ultimo potere. La distinzione tra lo Stato e la realtà divina crea lo spazio di una libertà in cui una persona può anche opporsi allo Stato. I martiri sono una testimonianza per questa limitazione del potere assoluto dello Stato. Così è nata una storia di libertà. Anche se poi il pensiero liberal-democratico ha preso le sue strade, l’origine è proprio questa».
Questa, ad avviso di Ratzinger, è «la distinzione decisiva» - una distinzione che rappresenta uno straordinario punto di incontro tra il pensiero cristiano e cultura liberal-democratica. «Io penso - afferma Ratzinger - che la visione liberal-democratica non potesse nascere senza questo avvenimento cristiano che ha diviso i due mondi, così creando una nuova libertà. Lo Stato è importante, si deve ubbidire alle leggi, ma non è l’ultimo potere. La distinzione tra lo Stato e la realtà divina crea lo spazio di una libertà in cui una persona può anche opporsi allo Stato. I martiri sono una testimonianza per questa limitazione del potere assoluto dello Stato. Così è nata una storia di libertà. Anche se poi il pensiero liberal-democratico ha preso le sue strade, l’origine è proprio questa».Il cristiano de-assolutizza, cioè relativizza, il potere politico; non può servire a due padroni: Dio e il dio-denaro; non può genuflettersi davanti all’altare di una ragione trasformata in dea. E dev’essere fedele al comandamento di amare il prossimo come se stesso. Ed è esattamente in base a questi princìpi che il messaggio cristiano, per dirla con Pëtr J. Čaadaev, «è più che storia, più che psicologia, è la fisiologia dell’uomo europeo». Thomas S. Eliot: «Un singolo europeo può non credere che la Fede cristiana sia vera, e tuttavia tutto ciò che egli dice, e fa, scaturirà dalla parte di cultura cristiana di cui è erede, e da quella trarrà significato». Per questo, è ancora Eliot a parlare, se il cristianesimo se ne va, è l’Europa che scompare: «Se il cristianesimo se ne va, se ne va tutta la nostra cultura; e allora si dovranno attraversare molti secoli di barbarie».
In altre parole, la decadenza dell’Europa è una decadenza spirituale: è l’allontanarsi degli europei dalle idealità cristiane. E quando gli ideali della fede cristiana si sono spenti, l’Europa - annota Röpke - ne ha cercato «un surrogato nelle ideologie politico-sociali (le “religioni sociali”, come le ha definite Alfred Weber): il socialismo, il comunismo e, soprattutto, il nazionalsocialismo».
 E oggi che cosa è rimasto nella mente di non pochi cittadini e soprattutto - e purtroppo - di non pochi dei nostri giovani, una volta lontani dalle idealità cristiane? Rimane l’idolatria del potere sugli altri, considerati e trattati come oggetti delle proprie voglie; rimane l’idolatria del denaro quale fonte perenne che alimenta la vasta fenomenologia della corruzione, con migliaia e migliaia di giovani e meno giovani che scorrazzano sul palcoscenico del gran teatro dell’illegalità; si impone una situazione dove alle ragioni della legge si sostituisce la ragione della forza o, più esattamente, la non-ragione di bande violente di intolleranti - di predoni divorati dalla brama di vestirsi da padroni - padroni del narcotraffico e, dunque, padroni della vita e della morte altrui.
E oggi che cosa è rimasto nella mente di non pochi cittadini e soprattutto - e purtroppo - di non pochi dei nostri giovani, una volta lontani dalle idealità cristiane? Rimane l’idolatria del potere sugli altri, considerati e trattati come oggetti delle proprie voglie; rimane l’idolatria del denaro quale fonte perenne che alimenta la vasta fenomenologia della corruzione, con migliaia e migliaia di giovani e meno giovani che scorrazzano sul palcoscenico del gran teatro dell’illegalità; si impone una situazione dove alle ragioni della legge si sostituisce la ragione della forza o, più esattamente, la non-ragione di bande violente di intolleranti - di predoni divorati dalla brama di vestirsi da padroni - padroni del narcotraffico e, dunque, padroni della vita e della morte altrui.di Dario Antiseri
 Professore emerito di Epistemologia delle scienze sociali - luiss, Roma
Professore emerito di Epistemologia delle scienze sociali - luiss, Roma
 L’Osservatore Romano, 23.10.2019.
L’Osservatore Romano, 23.10.2019.
*
Sul tema, nel sito, si cfr.:
"ERODE" E LE GERARCHIE CATTOLICO-ROMANE CONTRO CRISTO E "CONTRO CESARE. Cristianesimo e totalitarismo nell’epoca dei fascismi".
LA CHIESA DEL SILENZIO E DEL "LATINORUM". Il teologo Ratzinger scrive da papa l’enciclica "Deus caritas est" (2006) e, ancora oggi, nessuno - nemmeno papa Francesco - ne sollecita la correzione del titolo. Che lapsus!!! O, meglio, che progetto!!!
- "DUE SOLI": LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE, E IL VATICANO CON IL SUO TRADIZIONALE SOFISMA DELLA "FALLACIA ACCIDENTIS".
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
VIVA L’ITALIA!!! LA QUESTIONE "CATTOLICA" E LO SPIRITO DEI NOSTRI PADRI E E DELLE NOSTRE MADRI COSTITUENTI. Per un ri-orientamento antropologico e teologico-politico.
Federico La Sala
-
> LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE, E IL VATICANO CON IL SUO TRADIZIONALE SOFISMA --- Giorgio Agamben “Il regno e il giardino” (di Antonio Lucci).10 luglio 2019, di Federico La Sala
Giorgio Agamben “Il regno e il giardino”
di Antonio Lucci (Doppiozero, 14 Giugno 2019)
Michel Foucault, nel suo breve saggio (uscito nel 1984) sui “Luoghi altri”, definì il giardino “un’eterotopia felice”: una definizione forse anche troppo positiva, ma comunque indicativa del fatto che il giardino, per il filosofo francese, rappresentava la realizzazione di una serie di caratteristiche utopiche in un luogo reale, assumendo caratteri spaziali e simbolici fortissimi. Del carattere di luogo simbolico, che dà da pensare, proprio del giardino sembra che i filosofi siano da sempre stati ben coscienti: dal giardino in cui si ritiravano (secondo il motto “vivi nascostamente”) gli epicurei, a quello che consigliava - come ricorda nell’epigrafe al suo ultimo libro anche Giorgio Agamben - di coltivare Voltaire alla fine del suo Candide, passando per il giardino di Herrenhausen ad Hannover, in cui non solo Leibniz amava passeggiare e filosofare, ma che egli stesso contribuì a progettare grazie alle sue conoscenze di matematica e di ingegneria, per fare solo qualche esempio.
Si potrebbe addirittura arrivare a dire che, per comprendere come le società antiche hanno immaginato la propria versione ideale - il proprio paradiso - bisogna guardare al modo in cui esse hanno pensato i propri giardini: il giardino ad Atene era un luogo per la discussione e l’agone scientifico, che corrispondeva agli ideali di democrazia e di paideia propri della cultura greca, mentre il giardino cristiano era hortus conclusus, un luogo in cui le mura proteggevano e al contempo separavano l’uomo dall’esterno, dandogli la sua precisa posizione nel mondo (un mondo in cui la percezione delle barriere, sia fisiche che sociali e culturali, era un tassello psicostorico fondamentale). Il giardino barocco era una sorta di “panottico esterno”, in cui le vie rigidamente disegnate, le piante piegate in forme bizzarre dalla mano umana e l’universale visibilità dall’istanza centrale costituita dal palazzo corrispondevano alla società assolutistica di cui era espressione, quello inglese, invece, con il suo avvicinarsi alla naturalità di una selva, rispecchiava in qualche maniera gli ideali di una società che aveva abolito la monarchia assoluta e cominciava a credere che l’uomo non dovesse essere necessariamente, per natura, indirizzato in maniera univoca nei suoi spostamenti nel mondo.
Non a caso, la parola “paradiso” significa, originariamente, “giardino”: è questo il punto di partenza dell’ultimo libro di Giorgio Agamben. Il filosofo romano rinuncia a un’analisi dei rapporti tra le concrete forme storiche del giardino e i diversi regimi immaginari e ideali politici che le hanno prodotte, per concentrarsi invece su uno specifico giardino: quello dell’Eden.
Tutto Il regno e il giardino, infatti, è una serrata analisi di come, in particolare nella letteratura teologica tardoantica e medievale, il giardino dell’Eden - il paradiso terrestre - sia stato un importante operatore teoretico, usato da autori centrali del canone teologico cristiano - come ad esempio Agostino - al fine di descrivere che cos’è, nella sua struttura più profonda, la natura umana. “Giardino” (o meglio, “Paradiso”) - ci dice Agamben - è il nome che tanto affascinanti quanto spesso dimenticati autori del periodo protocristiano (come Efrem Siro e Sant’Ambrogio) hanno dato alla natura umana, in particolare a quella prima del peccato. Come è noto, a causa del peccato siamo stati banditi dall’Eden, dal Paradiso terrestre: secondo Agamben è proprio questo bando il punto centrale, quando si parla dell’Eden.
Non tanto che esso esista, o il fatto che noi vi abbiamo dimorato (pare, secondo la tradizione teologica, non più di sei ore), quanto il nostro esserne stati cacciati: «Non il paradiso, ma la sua perdita costituisce il mitologema originario della cultura occidentale, una sorta di traumatismo originario che ha segnato profondamente la cultura cristiana e moderna, condannando al fallimento ogni ricerca della felicità sulla terra» (p. 19). Agamben vede nella concezione di Sant’Agostino del peccato originale l’origine della tradizione che si affermerà nel cristianesimo successivo, per cui noi tutti erediteremmo la colpa di Adamo per via fisiologica, e quindi indipendentemente dalle nostre azioni: noi tutti siamo da sempre condannati all’esilio dal Giardino, e questo per colpe non nostre, così come per colpe non nostre siamo condannati al peccato e alla morte. Su questa concezione si basa anche l’idea di una natura umana corrotta per sempre, in tutte le generazioni a venire, da un’azione unica, operata da un singolo: «L’uomo è il vivente che può corrompere la sua natura, ma non risanarla, consegnandosi così a una storia e a un’economia della salvezza, in cui la grazia divina dispensata dalla Chiesa attraverso i suoi sacramenti diventa essenziale» (p. 32). (Se anche Agamben non prende in considerazione qui il tema, si potrebbe allargare il discorso ponendo la domanda relativa a quali conseguenze sulla concezione della colpa e del debito quest’idea agostiniana abbia avuto nella storia del pensiero occidentale). Partendo da quest’idea agostiniana (e anselmiana) Agamben analizza l’affascinante ipotesi connessa con l’idea di una natura umana irrimediabilmente corrotta: quella che - fatta eccezione per le sei ore in cui l’uomo vi abitò felicemente - il Paradiso terrestre sia un giardino vuoto, silenzioso ...e fondamentalmente inutile.
Contro quest’idea Agamben analizza il semidimenticato Scoto Eriugena, che - contro Agostino - legge allegoricamente la narrazione della Genesi biblica, interpretando l’Eden come una figurazione della natura umana prima della sua corruzione. La tesi di Eriugena è il doppio specularmente opposto rispetto alla teoria agostiniana del peccato originale ereditario ed eternamente corruttore della natura umana: quest’ultima è stata creata secondo Eriugena da Dio incorrotta e incorruttibile, come lo è il Paradiso terrestre, e solo il peccato è corruzione, ma corruzione legata all’atto e non alla natura dell’agente. L’uomo, col peccato, è uscito dalla propria vera natura, quella assegnatagli da Dio, perché ne ha abusato: in termini metaforici è uscito dal Paradiso, o meglio, non vi è mai stato.
Quindi, non esisterebbe, per Eriugena, una natura corrotta: la natura è da sempre salva, solo che noi ne siamo fin dall’inizio usciti.
Le dispute dei teologi sul Paradiso terrestre, in ultima istanza, ci dice Agamben, sono delle dispute mirate ad articolare il rapporto tra natura e grazia quali dispositivi teorici reciprocamente connessi tramite l’operatore logico del peccato (diversamente interpretato a seconda della direzione che si vuole dare al rapporto tra queste due istanze), e che definiscono la posizione dell’uomo sia nel mondo, che nell’aldilà.
Uno dei capitoli più interessanti del libro è sicuramente quello dedicato alla Divina Commedia di Dante. Agamben decide (non risparmiando alcune righe ferocemente critiche verso la tradizione dantista) di leggere la narrazione dantesca dell’Eden al di fuori e contro il canone interpretativo tomistico e in generale teologico medievale, in quanto vede in esso un «significato immediatamente politico» (p. 68), che fa del Paradiso terrestre una «figura della beatitudine terrena» (p. 71), a cui «Dante - che rappresenta l’umanità - può acceder[e] senza alcun impedimento» (p. 75). Il rapporto tra beatitudine di questo mondo e Giardino viene ripreso anche nell’ultimo capitolo del suo libro da Agamben, che analizza - partendo da Francisco Suárez - la questione di una possibile “politica del Giardino”, ossia l’esperimento mentale per cui - se non avessimo peccato con Adamo - saremmo potuti restare nell’Eden, dovendo poi sviluppare un qualche tipo di organizzazione sociale.
Agamben rileva come le descrizioni di questa possibile “società politica edenica” nei teologi medievali siano assolutamente carenti, derivandone la conclusione che «il paradiso terrestre non costituisce in alcun modo per i teologi un paradigma politico» (p. 106). Da qui ne segue una discussione, tanto teologicamente avvincente quanto complessa da seguire per i non addetti ai lavori, sulle tensioni chiliastiche del cristianesimo, vale a dire sulle interpretazioni date del passo dell’apocalisse per cui Cristo, tornato alla fine dei tempi, regnerà per mille anni con i giusti su questo mondo prima del giudizio finale. La questione è vicina a quella del giardino terrestre, a volte interpretato, nel corso della storia, come allegoria e a volte interpretato come luogo fisico, presente da qualche parte sulla Terra. Ed entrambe le questioni rimandano a quella - per Agamben sempre centrale - della felicità: è possibile, intravedibile, intravista in alcune epoche della storia del pensiero una felicità vissuta, una felicità della vita, di questa vita in questo mondo?
Il libro di Agamben si chiude con questa domanda, quella sulla dantesca «beatitudine di questa vita» (p. 120), una domanda consegnata al lettore di questo bel saggio, da intendere come un ulteriore tassello nel tentativo agambeniano di portare alla luce le categorie centrali del pensiero occidentale, di cui - sicuramente - il giardino è una delle più importanti, e forse sottovalutate.
-
> LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE, E IL VATICANO CON IL SUO TRADIZIONALE SOFISMA --- LA PENTECOSTE E LE LINGUE DI FUOCO.19 giugno 2019, di Federico La Sala
Catechesi sugli Atti degli Apostoli: 3. «Lingue come di fuoco» (At 2,3). La Pentecoste e la dynamis dello Spirito che infiamma la parola umana e la rende Vangelo *
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Cinquanta giorni dopo la Pasqua, in quel cenacolo che è ormai la loro casa e dove la presenza di Maria, madre del Signore, è l’elemento di coesione, gli Apostoli vivono un evento che supera le loro aspettative. Riuniti in preghiera - la preghiera è il “polmone” che dà respiro ai discepoli di tutti i tempi; senza preghiera non si può essere discepolo di Gesù; senza preghiera noi non possiamo essere cristiani! È l’aria, è il polmone della vita cristiana -, vengono sorpresi dall’irruzione di Dio. Si tratta di un’irruzione che non tollera il chiuso: spalanca le porte attraverso la forza di un vento che ricorda la ruah, il soffio primordiale, e compie la promessa della “forza” fatta dal Risorto prima del suo congedo (cfr At 1,8). Giunge all’improvviso, dall’alto, «un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano» (At 2,2).
Al vento poi si aggiunge il fuoco che richiama il roveto ardente e il Sinai col dono delle dieci parole (cfr Es 19,16-19). Nella tradizione biblica il fuoco accompagna la manifestazione di Dio. Nel fuoco Dio consegna la sua parola viva ed energica (cfr Eb 4,12) che apre al futuro; il fuoco esprime simbolicamente la sua opera di scaldare, illuminare e saggiare i cuori, la sua cura nel provare la resistenza delle opere umane, nel purificarle e rivitalizzarle. Mentre al Sinai si ode la voce di Dio, a Gerusalemme, nella festa di Pentecoste, a parlare è Pietro, la roccia su cui Cristo ha scelto di edificare la sua Chiesa. La sua parola, debole e capace persino di rinnegare il Signore, attraversata dal fuoco dello Spirito acquista forza, diventa capace di trafiggere i cuori e di muovere alla conversione. Dio infatti sceglie ciò che nel mondo è debole per confondere i forti (cfr 1Cor 1,27).
La Chiesa nasce quindi dal fuoco dell’amore e da un “incendio” che divampa a Pentecoste e che manifesta la forza della Parola del Risorto intrisa di Spirito Santo. L’Alleanza nuova e definitiva è fondata non più su una legge scritta su tavole di pietra, ma sull’azione dello Spirito di Dio che fa nuove tutte le cose e si incide in cuori di carne.
La parola degli Apostoli si impregna dello Spirito del Risorto e diventa una parola nuova, diversa, che però si può comprendere, quasi fosse tradotta simultaneamente in tutte le lingue: infatti «ciascuno li udiva parlare nella propria lingua» (At 2,6). Si tratta del linguaggio della verità e dell’amore, che è la lingua universale: anche gli analfabeti possono capirla. Il linguaggio della verità e dell’amore lo capiscono tutti. Se tu vai con la verità del tuo cuore, con la sincerità, e vai con amore, tutti ti capiranno. Anche se non puoi parlare, ma con una carezza, che sia veritiera e amorevole.
Lo Spirito Santo non solo si manifesta mediante una sinfonia di suoni che unisce e compone armonicamente le diversità ma si presenta come il direttore d’orchestra che fa suonare le partiture delle lodi per le «grandi opere» di Dio. Lo Spirito santo è l’artefice della comunione, è l’artista della riconciliazione che sa rimuovere le barriere tra giudei e greci, tra schiavi e liberi, per farne un solo corpo. Egli edifica la comunità dei credenti armonizzando l’unità del corpo e la molteplicità delle membra. Fa crescere la Chiesa aiutandola ad andare al di là dei limiti umani, dei peccati e di qualsiasi scandalo.
La meraviglia è tanta, e qualcuno si chiede se quegli uomini siano ubriachi. Allora Pietro interviene a nome di tutti gli Apostoli e rilegge quell’evento alla luce di Gioele 3, dove si annuncia una nuova effusione dello Spirito Santo. I seguaci di Gesù non sono ubriachi, ma vivono quella che Sant’Ambrogio definisce «la sobria ebbrezza dello Spirito», che accende in mezzo al popolo di Dio la profezia attraverso sogni e visioni. Questo dono profetico non è riservato solo ad alcuni, ma a tutti coloro che invocano il nome del Signore.
D’ora innanzi, da quel momento, lo Spirito di Dio muove i cuori ad accogliere la salvezza che passa attraverso una Persona, Gesù Cristo, Colui che gli uomini hanno inchiodato al legno della croce e che Dio ha risuscitato dai morti «liberandolo dai dolori della morte (At 2,24). È Lui che ha effuso quello Spirito che orchestra la polifonia di lodi e che tutti possono ascoltare. Come diceva Benedetto XVI, «la Pentecoste è questo: Gesù, e mediante Lui Dio stesso, viene a noi e ci attira dentro di sé» (Omelia, 3 giugno 2006). Lo Spirito opera l’attrazione divina: Dio ci seduce con il suo Amore e così ci coinvolge, per muovere la storia e avviare processi attraverso i quali filtra la vita nuova. Solo lo Spirito di Dio infatti ha il potere di umanizzare e fraternizzare ogni contesto, a partire da coloro che lo accolgono.
Chiediamo al Signore di farci sperimentare una nuova Pentecoste, che dilati i nostri cuori e sintonizzi i nostri sentimenti con quelli di Cristo, così che annunciamo senza vergogna la sua parola trasformante e testimoniamo la potenza dell’amore che richiama alla vita tutto ciò che incontra.
* PAPA FRANCESCO
 UDIENZA GENERALE
UDIENZA GENERALE
 Piazza San Pietro
Piazza San Pietro
 Mercoledì, 19 giugno 2019 (ripresa parziale).
Mercoledì, 19 giugno 2019 (ripresa parziale).
Sul tema, nel sito, si cfr.:
KANT E SAN PAOLO. COME IL BUON GIUDIZIO ("SECUNDA PETRI") VIENE (E VENNE) RIDOTTO IN STATO DI MINORITA’ DAL GIUDIZIO FALSO E BUGIARDO ("SECUNDA PAULI").
I "DUE CRISTIANESIMI" E LA PROPRIA FACOLTA’ DI GIUDIZIO. "Perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto?" (Luca 12:54-59). Una nota di Antonio Thellung, da"mosaico di pace"
Federico La Sala
-
> LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE, E IL VATICANO CON IL SUO TRADIZIONALE SOFISMA -- LA COSTITUZIONE DOGMATICA DI ORIENTE E DI OCCIDENTE.17 giugno 2019, di Federico La Sala
IL PRIMOGENITO TRA MOLTI FRATELLI E LA COSTITUZIONE DOGMATICA DEL SOLE DI ORIENTE E DI OCCIDENTE...*
1. La gioia della verità (Veritatis gaudium) esprime il desiderio struggente che rende inquieto il cuore di ogni uomo fin quando non incontra, non abita e non condivide con tutti la Luce di Dio[1]. La verità, infatti, non è un’idea astratta, ma è Gesù, il Verbo di Dio in cui è la Vita che è la Luce degli uomini (cfr. Gv 1,4), il Figlio di Dio che è insieme il Figlio dell’uomo. Egli soltanto, «rivelando il mistero del Padre e del suo amore, rivela l’uomo all’uomo e gli fa nota la sua altissima vocazione»[2].
Nell’incontro con Lui, il Vivente (cfr Ap 1,18) e il Primogenito tra molti fratelli (cfr Rm 8,29), il cuore dell’uomo sperimenta già sin d’ora, nel chiaroscuro della storia, la luce e la festa senza più tramonto dell’unione con Dio e dell’unità coi fratelli e le sorelle nella casa comune del creato di cui godrà senza fine nella piena comunione con Dio. Nella preghiera di Gesù al Padre: «perché tutti siano uno, come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi» (Gv 17,21) è racchiuso il segreto della gioia che Gesù ci vuole comunicare in pienezza (cfr 15,11) da parte del Padre col dono dello Spirito Santo: Spirito di verità e di amore, di libertà, di giustizia e di unità. [:::] "(Costituzione Apostolica «Veritatis gaudium» di Papa Francesco circa le Università e le Facoltà ecclesiastiche, 29.01.2018. Proemio)
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- Costituzione dogmatica della chiesa "cattolica"... e costituzione dell’Impero del Sol Levante. Un nota sul “disagio della civiltà”
L’EREDE: IL PESO DEI PADRI (ATEI E DEVOTI). UN’EREDITA’ ANCORA PENSATA ALL’OMBRA DELL’"UOMO SUPREMO" E DEL "MAGGIORASCATO".
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE, E IL VATICANO --- "L’archivio del mondo. Quando Napoleone confiscò la storia" (Maria Pia Donato).13 aprile 2019, di Federico La Sala
"DUE SOLI" IN TERRA, E UN SOLO SOLE IN CIELO: "TRE SOLI".... *
Storia.
Il sogno di Napoleone: l’archivio dell’impero
Bonaparte aveva capito che, controllando la memoria dei popoli, li si teneva in pugno e si poteva scrivere la storia come prova della legittimità del proprio potere
di Edoardo Castagna (Avvenire, giovedì 11 aprile 2019)
- [Foto] Il ritratto di Napoleone dipinto da François Gerard François Daunou
Del saccheggio napoleonico di opere d’arte, con i lunghi strascichi relativi alle restituzioni o alle mancate restituzioni, molto si è scritto. Assai meno del saccheggio di uomini, della “carne da cannone” razziata come e più di quadri e statue in ogni angolo d’Europa, per finire seppellita tra le colline boeme o nelle steppe di Russia. Tutti iscritti all’anagrafe della storia come “francesi” sebbene in gran parte francesi non fossero affatto, come lo stesso Napoleone si premurò poi di rimarcare. Ma le appartenenze nazionali, così come le tradizioni storiche e le memorie collettive, si costruiscono. Ed è per questo che tra i tanti saccheggi napoleonici uno, perseguito con particolare tenacia, si concentrò sugli archivi delle varie capitali via via occupate e inglobate nell’Impero.
Vicenda meno nota di altre, ben ricostruita da Maria Pia Donato nel suo L’archivio del mondo. Quando Napoleone confiscò la storia (Laterza, pagine 170, euro 19,00). La sua versione dell’eterno sogno della biblioteca universale si declinò utilitaristicamente verso la condensazione sotto un unico controllo di quella che avrebbe dovuto essere la fonte primaria sia per la scrittura della storia nei secoli a venire, sia per la costruzione di una tradizione e di un’identità comune a tutta l’Europa posta sotto lo scettro di Napoleone, in ideale rimando all’unità medievale dei “due soli” a cui esplicitamente tale operazione si ispirò. Furono infatti la conquista, nel 1809, degli archivi del Sacro Romano Impero e del Papato a mettere in moto la macchina accentratrice dell’archivio dell’Impero.
Come in tante altre occasioni, la storia seguiva la propria strada indipendentemente dalla volontà degli uomini, tanto che l’idea di centralizzare gli archivi europei, sottolinea la Donato, seguì e non precedette l’inizio della sua realizzazione: il suo Napoleone è perfettamente tolstojano, in balìa di quegli stessi eventi epocali che si illude di governare. Stando al trattato con l’Austria nel 1809, avrebbero dovuto passare sotto controllo francese soltanto gli atti relativi ai territori ceduti agli occupanti: i quali invece, con militaresca ruvidità, prelevarono in blocco le carte conservate a Vienna, quali che fossero e di ogni epoca. Furono riempite oltre 2.500 casse, caricate sui carri e spedite a Parigi.
Simile fu la brutalità con la quale si procedette al- l’acquisizione degli archivi di Roma, il cui sequestro in realtà fu, almeno inizialmente, funzionale alla volontà di Napoleone di mettere sotto pressione il Papa: tanto che nel 1813, quando l’imperatore credette di averla spuntata su Pio VII, ordinò la restituzione delle carte. Per rimangiarsela, naturalmente, quando mutò nuovamente idea sul conto del Pontefice. Nel frattempo però, e anche in contraddizione con i tatticismi politici del momento, maturava in lui e nei suoi collaboratori «l’idea di creare un sito centrale della memoria per l’impero, anzi una grandiosa raccolta delle testimonianze scritte della civiltà», nota la Donato; via via furono acquisiti gli archivi olandesi, spagnoli, piemontesi, belgi, della galassia di staterelli tedeschi.
A sovrintendere al tutto fu l’archivista capo Pierre-Claude-François Daunou: ex prete, ex illuminista, ex fervente repubblicano, infine comodamente adagiato nell’ordine bonapartista (al quale peraltro sarebbe sopravvissuto). Nella sua opera trasfuse, al pari di quella contemporanea e simmetrica dei curatori del Louvre, del Jardin des plantes o della Biblioteca nazionale di Parigi, l’ideale e l’ambizione enciclopedici degli Idéologues illuministi. «Fu elaborata sul campo - nota la Donato - la dottrina che Édouard Pommier ha chiamato “la teoria del rimpatrio”, ossia l’idea che solo nella Francia rigenerata le opere delle scienze e delle arti avrebbero potuto sprigionare il loro potenziale di conoscenza ed emancipazione».
Daunou aveva ben servito Napoleone compilando un Saggio storico sul potere temporale dei papi tutto teso a mostrare le malefatte plurisecolari del Papato e le buone ragioni di un imperatore nel volerlo ridurre alla sua mercé; il Saggio venne ripetutamente riveduto e ampliato proprio grazie alle nuove fonti archivistiche divenute disponibili. Ma Daunou non era un mero cortigiano, anzi: nella sua opera di gran maestro dell’archivio napoleonico diede indubbie prove di capacità organizzative, di intelligenza pratica (fu l’inventore di quelle “schede”, uniformi per formato e ordine delle informazioni, divenute poi di uso universale fino all’avvento della digitalizzazione) e anche di un po’ di visionarietà.
Non ci fu il tempo di costruire l’immenso palazzo che avrebbe dovuto ospitare i Grandi Archivi, ma quello per affermarne la centralità storica sì: non solo, prosegue la Donato, «furono l’invenzione simbolica di un impero in cerca di radici», ma offrivano anche l’occasione di coltivare la storia pragmatica che era stata degli Idéologues. L’archivio serviva (anche) a scrivere la storia», e per questo esserne i controllori significava essere i controllori della memoria dei popoli. Nelle carte degli archivi si trovano i mattoni fondamentali per erigere quei monumenti umani collettivi che sono le identità naziona-li: una lezione, questa, che gli Stati- nazione che sarebbero sorti dopo il tramonto dell’età napoleonica, e che rientrarono in possesso dei rispettivi archivi, avrebbero ben messo a frutto.
*
Sul tema, nel sito, si cfr.:
DANTE, ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. Note per una riflessione storiografica
- "DUE SOLI" IN TERRA, E UN SOLO SOLE IN CIELO: "TRE SOLI". GENERE UMANO: I SOGGETTI SONO DUE, E TUTTO E’ DA RIPENSARE!!! NON SOLO SUL PIANO TEOLOGICO-POLITICO, MA ANCHE ... ANTROPOLOGICO!!!
- LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE, E IL VATICANO CON IL SUO TRADIZIONALE SOFISMA DELLA "FALLACIA ACCIDENTIS".
- COSTANTINO, SANT’ELENA, E NAPOLEONE. L’immaginario del cattolicesimo romano.
DANTE ALIGHIERI (1265-1321)!!! LA LINGUA D’AMORE: UNA NUOVA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO. CON MARX E FREUD. Una "ipotesi di rilettura della DIVINA COMMEDIA" -Nel 200° anniversario della pubblicazione della "Fenomenologia dello Spirito" di Hegel (1807)
Federico La Sala
-
> LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE, E IL VATICANO -- La catechesi sul "Padre nostro" (di papa Francesco).21 febbraio 2019, di Federico La Sala
Catechesi sul “Padre nostro”: 7. Padre che sei nei cieli
di Papa Francesco *
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
L’udienza di oggi si sviluppa in due posti. Prima ho fatto l’incontro con i fedeli di Benevento, che erano in San Pietro, e adesso con voi. E questo è dovuto alla delicatezza della Prefettura della Casa Pontificia che non voleva che voi prendeste freddo: ringraziamo loro, che hanno fatto questo. Grazie.
Proseguiamo le catechesi sul “Padre nostro”. Il primo passo di ogni preghiera cristiana è l’ingresso in un mistero, quello della paternità di Dio. Non si può pregare come i pappagalli. O tu entri nel mistero, nella consapevolezza che Dio è tuo Padre, o non preghi. Se io voglio pregare Dio mio Padre incomincio il mistero. Per capire in che misura Dio ci è padre, noi pensiamo alle figure dei nostri genitori, ma dobbiamo sempre in qualche misura “raffinarle”, purificarle. Lo dice anche il Catechismo della Chiesa Cattolica, dice così: «La purificazione del cuore concerne le immagini paterne e materne, quali si sono configurate nella nostra storia personale e culturale, e che influiscono sulla nostra relazione con Dio» (n. 2779).
Nessuno di noi ha avuto genitori perfetti, nessuno; come noi, a nostra volta, non saremo mai genitori, o pastori, perfetti. Tutti abbiamo difetti, tutti. Le nostre relazioni di amore le viviamo sempre sotto il segno dei nostri limiti e anche del nostro egoismo, perciò sono spesso inquinate da desideri di possesso o di manipolazione dell’altro. Per questo a volte le dichiarazioni di amore si tramutano in sentimenti di rabbia e di ostilità. Ma guarda, questi due si amavano tanto la settimana scorsa, oggi si odiano a morte: questo lo vediamo tutti i giorni! E’ per questo, perché tutti abbiamo radici amare dentro, che non sono buone e alle volte escono e fanno del male.
Ecco perché, quando parliamo di Dio come “padre”, mentre pensiamo all’immagine dei nostri genitori, specialmente se ci hanno voluto bene, nello stesso tempo dobbiamo andare oltre. Perché l’amore di Dio è quello del Padre “che è nei cieli”, secondo l’espressione che ci invita ad usare Gesù: è l’amore totale che noi in questa vita assaporiamo solo in maniera imperfetta. Gli uomini e le donne sono eternamente mendicanti di amore, - noi siamo mendicanti di amore, abbiamo bisogno di amore - cercano un luogo dove essere finalmente amati, ma non lo trovano. Quante amicizie e quanti amori delusi ci sono nel nostro mondo; tanti!
Il dio greco dell’amore, nella mitologia, è quello più tragico in assoluto: non si capisce se sia un essere angelico oppure un demone. La mitologia dice che è figlio di Poros e di Penía, cioè della scaltrezza e della povertà, destinato a portare in sé stesso un po’ della fisionomia di questi genitori. Di qui possiamo pensare alla natura ambivalente dell’amore umano: capace di fiorire e di vivere prepotente in un’ora del giorno, e subito dopo appassire e morire; quello che afferra, gli sfugge sempre via (cfr Platone, Simposio, 203). C’è un’espressione del profeta Osea che inquadra in maniera impietosa la congenita debolezza del nostro amore: «Il vostro amore è come una nube del mattino, come la rugiada che all’alba svanisce» (6,4). Ecco che cos’è spesso il nostro amore: una promessa che si fatica a mantenere, un tentativo che presto inaridisce e svapora, un po’ come quando al mattino esce il sole e si porta via la rugiada della notte.
Quante volte noi uomini abbiamo amato in questa maniera così debole e intermittente. Tutti ne abbiamo l’esperienza: abbiamo amato ma poi quell’amore è caduto o è diventato debole. Desiderosi di voler bene, ci siamo poi scontrati con i nostri limiti, con la povertà delle nostre forze: incapaci di mantenere una promessa che nei giorni di grazia ci sembrava facile da realizzare. In fondo anche l’apostolo Pietro ha avuto paura e ha dovuto fuggire. L’apostolo Pietro non è stato fedele all’amore di Gesù. Sempre c’è questa debolezza che ci fa cadere. Siamo mendicanti che nel cammino rischiano di non trovare mai completamente quel tesoro che cercano fin dal primo giorno della loro vita: l’amore.
Però, esiste un altro amore, quello del Padre “che è nei cieli”. Nessuno deve dubitare di essere destinatario di questo amore. Ci ama. “Mi ama”, possiamo dire. Se anche nostro padre e nostra madre non ci avessero amato - un’ipotesi storica -, c’è un Dio nei cieli che ci ama come nessuno su questa terra ha mai fatto e potrà mai fare. L’amore di Dio è costante. Dice il profeta Isaia: «Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se costoro si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai. Ecco, sulle palme delle mie mani ti ho disegnato» (49,15-16).
 Oggi è di moda il tatuaggio: “Sulle palme delle mie mani ti ho disegnato”. Ho fatto un tatuaggio di te sulle mie mani. Io sono nelle mani di Dio, così, e non posso toglierlo. L’amore di Dio è come l’amore di una madre, che mai si può dimenticare. E se una madre si dimentica? “Io non mi dimenticherò”, dice il Signore. Questo è l’amore perfetto di Dio, così siamo amati da Lui. Se anche tutti i nostri amori terreni si sgretolassero e non ci restasse in mano altro che polvere, c’è sempre per tutti noi, ardente, l’amore unico e fedele di Dio.
Oggi è di moda il tatuaggio: “Sulle palme delle mie mani ti ho disegnato”. Ho fatto un tatuaggio di te sulle mie mani. Io sono nelle mani di Dio, così, e non posso toglierlo. L’amore di Dio è come l’amore di una madre, che mai si può dimenticare. E se una madre si dimentica? “Io non mi dimenticherò”, dice il Signore. Questo è l’amore perfetto di Dio, così siamo amati da Lui. Se anche tutti i nostri amori terreni si sgretolassero e non ci restasse in mano altro che polvere, c’è sempre per tutti noi, ardente, l’amore unico e fedele di Dio.Nella fame d’amore che tutti sentiamo, non cerchiamo qualcosa che non esiste: essa è invece l’invito a conoscere Dio che è padre. La conversione di Sant’Agostino, ad esempio, è transitata per questo crinale: il giovane e brillante retore cercava semplicemente tra le creature qualcosa che nessuna creatura gli poteva dare, finché un giorno ebbe il coraggio di alzare lo sguardo. E in quel giorno conobbe Dio. Dio che ama.
L’espressione “nei cieli” non vuole esprimere una lontananza, ma una diversità radicale di amore, un’altra dimensione di amore, un amore instancabile, un amore che sempre rimarrà, anzi, che sempre è alla portata di mano. Basta dire “Padre nostro che sei nei Cieli”, e quell’amore viene.
Pertanto, non temere! Nessuno di noi è solo. Se anche per sventura il tuo padre terreno si fosse dimenticato di te e tu fossi in rancore con lui, non ti è negata l’esperienza fondamentale della fede cristiana: quella di sapere che sei figlio amatissimo di Dio, e che non c’è niente nella vita che possa spegnere il suo amore appassionato per te.
*
PAPA FRANCESCO - UDIENZA GENERALE -Aula Paolo VI
 Mercoledì, 20 febbraio 2019 (ripresa parziale).
Mercoledì, 20 febbraio 2019 (ripresa parziale). -
> LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE, E -- IL "DIO DI AMORE" DI OVIDIO. Note Sulle “Poesie” di Brunetto Latini.20 febbraio 2019, di Federico La Sala
IL "DIO DI AMORE" DI (OVIDIO E) BRUNETTO LATINI E "L’AMORE CHE MUOVE IL SOLE E LE ALTRE STELLE" DI DANTE.... *
Su Brunetto Latini, “Poesie”, a cura di Stefano Carrai
di Claudio Giunta (Domenicale del Sole 24 ore, 20 marzo 2016)
- Brunetto Latini, Poesie, a cura di Stefano Carrai, Torino, Einaudi 2016, euro 15.
Il Tesoretto di Brunetto Latini non è certamente quel misconosciuto «capolavoro della letteratura allegorica» che diceva Jauss (ma come mai lo abbiamo preso sul serio?), ma è un modo eccellente per avvicinarsi alla poesia dei primi secoli; e questa nuova edizione a cura di Stefano Carrai è un modo eccellente per avvicinarsi al Tesoretto.
Si tratta di un poemetto, 2944 versi in tutto, scritto da Brunetto Latini al principio degli anni Settanta del Duecento. È uno strano ibrido. Comincia come un racconto di viaggio (il poeta-protagonista si trova a Roncisvalle, e qui incontra uno studente bolognese che gli comunica la sconfitta dei guelfi a Montaperti), prosegue come un trattato didascalico (la Natura personificata illustra al poeta l’ordinamento del cielo e della terra), poi come un trattato morale (il poeta incontra in successione le virtù, il dio d’Amore, il poeta Ovidio), e finisce con una bizzarra ‘Penitenza’, circa 500 versi in cui Brunetto riflette sulla caducità delle cose umane ed esorta un amico a cambiare vita come lui l’ha cambiata («che sai che sén tenuti», scrive, «un poco mondanetti»); dopodiché il racconto riprende e il protagonista si trova sul monte Olimpo, dove incontra il grande Tolomeo, «maestro di storlomia». Qui il testo s’interrompe di colpo.
Al di là però del contenuto, né originale né profondo, e al di là dello stile, senza veneri (anche perché imprigionato in una gabbia metrica da filastrocca: coppie di settenari a rima baciata), il Tesoretto è un testo interessantissimo perché è davvero un repertorio di topoi immaginativi, un campione di medievalità: c’è il viaggio nella foresta, c’è un mondo fantastico all’interno del quale il personaggio-poeta può dialogare via via con la Natura, con Ovidio o con Tolomeo, ci sono le ipostasi delle virtù e delle percezioni, che pescano dall’identico immaginario da cui hanno pescato gli sceneggiatori di Inside Out (Desianza=Joy, Paura=Fear): «Desïanza ... sforza malamente / d’aver presentemente / la cosa disïata / ed è sì disvïata / che non cura d’onore / né morte né romore, / se non che la Paura / la tira ciascun’ora, / sì che non osa gire / né solo un motto dire».
Il commento di Carrai è un commento esatto e intelligente. Sembra poco, ma è tantissimo, perché i commenti alla poesia (e soprattutto alla poesia antica) sono spesso un po’ stupidi. Chi ha studiato per anni un autore o un testo non si rassegna facilmente a farsi da parte, cioè a tacere una volta chiarito ciò che nel testo c’è da chiarire, ed eventualmente a far riflettere il lettore su ciò che il testo può dire sul suo autore o sulla mentalità dell’epoca in cui venne scritto: non si rassegna, gli viene, come diceva il dottor Johnson, «la fregola di dire qualcosa anche quando non c’è nulla da dire», o peggio - e la cosa è specialmente frequente nel campo della medievistica - gli viene la fregola di trovare verità nascoste, di sciogliere gli enigmi, il che porta spesso a postulare enigmi là dove non ce ne sono, onde una ridda di ipotesi e contro-ipotesi da stancare un causidico. E poi, a riempire le pagine, valanghe di ‘riscontri intertestuali’, come se importasse qualcosa che il poeta X ha preso quella parola dal poeta Y o dal poeta Z. Carrai invece non scaraventa sul lettore tutto il contenuto delle sue schede, spiega il testo dove occorre, e dove non riesce a spiegare prospetta delle ipotesi d’interpretazione, appoggiandosi - per consentire o per dissentire - a chi del Tesoretto si è occupato prima di lui.
Al Tesoretto Carrai fa seguire, com’è consuetudine, il Favolello, che è un altro breve poemetto in settenari baciati, più pedestre nel contenuto (è uno scialbo trattatello sull’amicizia), ma interessante soprattutto perché cita come amici-destinatari due rimatori contemporanei, Rustico Filippi e Palamidesse di Bellindote. E al Favolello segue, nel volume (che appunto per questo s’intitola Poesie: è l’opera omnia in volgare italiano di Brunetto), l’unica canzone di Brunetto che ci venga tramandata dai manoscritti, S’eo son distretto, strana poesia d’amore e devozione che alcuni hanno interpretato come un documento dell’omosessualità dell’autore (con ovvi riflessi sull’interpretazione di Inferno XV) e altri, direi più plausibilmente, come canto nostalgico per la patria, Firenze, dal quale il guelfo Brunetto viene bandito dopo Montaperti.
Manca, e avrebbe invece dovuto esserci, la canzone responsiva di Bondie Dietaiuti (così, nel Medioevo, si dissolvevano le tenzoni poetiche: gli scribi copiavano i corpora personali degli autori obliterando i testi missivi e responsivi dei loro corrispondenti, che in questo modo si disperdevano; ma in un’edizione moderna non si vede perché le tenzoni non debbano essere date nella loro integrità).
Il discorso sul Tesoretto e sul Favolello non è chiuso. Sono testi facili solo all’apparenza, specie a causa delle contorsioni che il metro e lo schema delle rime impongono all’autore. Di certi hapax resta poco chiaro, nonostante lo sforzo degli interpreti, il significato. Altri termini sono ambigui (per esempio non parafraserei con ‘verità’, con Contini e Carrai, il drittura di Favolello 7 «e fàllati drittura»: ‘giustizia’, che è il senso che drittura ha usualmente, mi pare più aderente al contesto). E certi passi dovranno forse essere riconsiderati in una futura edizione critica. Per esempio, ai vv. 1275-79 tutti gli editori postulano un (credo inattestato altrove) ablativo assoluto: «E vidi ne la corte, / là dentro, fra le porte, / quattro donne reali / che corte principali / tenean ragione ed uso». Dove «corte principali» vorrebbe dire ‘nella prima corte’. Ma dato che le «donne» di cui si parla sono virtù, e che principales è l’aggettivo che nel Medioevo spesso si predica delle virtù, in genere le cardinali, ci si deve domandare se la lezione corretta non sia piuttosto, con minimo emendamento, «come principali», cioè ‘come signore, regine di quella corte di giustizia’ (e sarebbe un altro errore d’archetipo, da aggiungere a quelli registrati da Pozzi e Contini nei Poeti del Duecento).
Forse potremmo chiudere, invece, il discorso sui rapporti tra Brunetto e Dante, salvo che non saltino fuori nuovi testi che permettano di riconsiderare sotto nuova luce la questione. Questione che è nota ad ogni studente liceale: Dante mette Brunetto all’Inferno, tra i sodomiti, ma non dice nulla della sua colpa (il che sorprende fino a un certo punto, dato che non sempre Dante lo fa), né di questa colpa si parla nelle fonti che non dipendono da Dante (il che non sorprende per niente: ci si aspetta che l’omicidio o la simonia lascino traccia nelle cronache, non necessariamente le inclinazioni sessuali).
Sodomia va allora inteso figuratamente, come ‘peccato contro la propria lingua materna’ (perché Brunetto, fiorentino, ha scritto il suo Tresor in francese)? Oppure come peccato politico (perché Brunetto non avrebbe «riconosciuto la sacra autorità dell’Impero»)? Mi sembra che la soluzione proposta da Zanato e ora da Carrai resti la più sensata: dato che Brunetto ci appare in compagnia di «Prisciano, Francesco Accursio e Andrea de’ Mozzi, [cioè] del gruppo di intellettuali, perlopiù pedagoghi ed ecclesiastici, che si sono resi colpevoli di pratiche omosessuali», non c’è ragione di pensare che lui non si sia macchiato dello stesso - non metaforico - peccato.
Non andrei oltre; né speculerei, per le ragioni che ho già accennato, sulla ‘memoria’ della poesia brunettiana nel canto XV. Il poeta Brunetto non aveva niente da insegnare a Dante, perché il peggior Dante (per esempio quello un po’ lezioso di Inferno IV: «Venimmo al piè d’un nobile castello, / sette volte cerchiato d’alte mura, / difeso intorno d’un bel fiumicello...») è migliore del migliore Brunetto. E l’idea che quando Dante mette in scena un altro poeta si serva - attraverso accorte allusioni - delle parole che quel poeta ha adoperato nelle sue opere mi sembra davvero un’idea tutta nostra, un’idea da filologi moderni, che mettiamo a forza nella testa di scrittori molto meno sottili di noi.
E questo vale anche per la testimonianza che molti (anche Carrai) considerano più probante: l’avvio del canto XV, «Ora cen porta l’un de’ duri margini...», nel quale si condenserebbero «gli echi di mosse identiche del Tesoretto, vv. 1183-84 “Or va mastro Burnetto / per un sentiero stretto”, e 2181-82 “Or si ne va il maestro / per lo camino a destro”». Ma direi di no: è una formula di transizione che si trova molte volte nella poesia narrativa francese, per esempio nel Girart de Rossillon («Ere s’en vait Girarz egal solel / per un estreit sender...» (l’identica immagine del sentiero stretto che si trova in Brunetto Latini), nella chanson de toile Gaiete et Oriour («Or s’an vat Oriour stinte et marrie»), nel Macaire franco-veneto, «Ora se voit sor un corant destrer». Langue, insomma, non parole, come nella poesia medievale capita non dico sempre, ma quasi.
* Sul tema, nel sito, si cfr.:
LA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO DEI "DUE SOLI". DANTE "corre" fortissimo, supera i secoli, e oltrepassa HEGEL.
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE, E IL VATICANO --- Più fede nella politica, la lezione di Dante (Gabriella M.Di Paola Dollorenzo).19 febbraio 2019, di Federico La Sala
DANTE, OGGI. PER UNA NUOVA "BUSSOLA TEOLOGICA" .... *
Classici.
Più fede nella politica, la lezione di Dante
La vicenda biografica e intellettuale del grande fiorentino si rivela di grande attualità ancora oggi, specie per quanto riguarda l’impegno dei credenti a favore del bene comune
di Gabriella M.Di Paola Dollorenzo (Avvenire, 17 febbraio 2019)
- [Foto] La visione del «Paradiso» dantesco in un’incisione di Gustave Doré
L’intervista al cardinale Gualtiero Bassetti (Avvenire, 9 dicembre 2018) ha riportato la nostra attenzione «sull’impegno concreto e responsabile dei cattolici in politica». Già nell’inchiesta del mensile Jesus sul «tempo del rammendo » (ottobre 2018), il presidente della Cei aveva rimarcato l’urgenza di ricostruire una presenza laicale che guardasse alla politica come a un’avventura positiva, nella necessità di una classe dirigente in grado di opporre alla sfiducia popolare un forte senso di concretezza e di responsabilità. Queste virtù o, per meglio dire, questi talenti ci permettono di richiamare la coerenza del pensiero politico di Dante così come ebbe a svilupparsi, sia negli anni di politica attiva sia dopo l’esilio e parallelamente allo svolgersi del suo pensiero teologico nella Commedia. Considerare l’architettura del suo pensiero, il rapporto tra teoria e prassi, l’utilizzo anzi l’interazione delle fonti (Sacre Scritture, autori grecolatini, testi arabi) può essere utile per individuare l’archetipo del cristiano impegnato nella realtà politica del proprio tempo, con l’ambizione di tradurre l’imitatio Christi nel concreto operare all’interno della res publica.
La vicenda umana del Poeta incardinato nella realtà politica del suo tempo, specialmente negli anni che vanno dalla morte di Beatrice (1290) alla condanna all’esilio (1302), ci permette di riflettere sul rapporto teologia- politica, così come fu duramente ma appassionatamente vissuto, in «un crescendo di temerarietà e di coerenza» (Giorgio Petrocchi, Vita di Dante, 1993) e, nello stesso tempo, avendo ben salda la «coscienza della storia», quell’habitus morale in base al quale «gli avvenimenti non si confondono caoticamente nella memoria, ma sono collegati dalla coscienza della causa e dell’effetto, dell’iniziativa e della responsabilità» (Romano Guardini, Dante, 2008). Se accogliamo l’approccio euristico di Jürgen Moltmann (si veda in particolare Dio nel progetto del mondo moderno, edito da Queriniana nel 1999), possiamo capire in che senso la teologia può “binarizzarsi” con la politica determinando le scelte tra il bene e il male, nel concreto avvicendarsi della storia di una città, di una nazione, di un popolo. Non è un caso che la formazione filosofico-teologica di Dante preceda cronologicamente l’attività politica, anzi ne sia quasi il trampolino di lancio: «Io che cercava di consolarme, trovai non solamente a le mie lagrime rimedio, ma vocaboli d’autori e di scienze e di libri: li quali considerando, giudicava bene che la filosofia, che era donna di questi autori, di queste scienze e di questi libri, fosse somma cosa. E da questo imaginare cominciai ad andare là dov’ella si dimostrava veracemente, cioè ne le scuole de li religiosi e a le disputazioni de li filosofanti » ( Convivio, II, xii, 5-7).
Dopo aver approfondito l’Etica Nicomachea e la Politica di Aristotele (nella traduzione latina di Guglielmo di Moerbeke e col commento di Tommaso d’Aquino), nel libro II del Convivio si rivendica il primato della morale. Dante va oltre Tommaso d’Aquino: se la metafisica è la scienza di Dio, l’uomo potrà cercare lo status felicitatis in questa vita e, dato che l’uomo è un animale sociale, in una politica regolata dalla morale. Pertanto non è conforme alla morale rinchiudersi nella contemplazione dell’intelligibile, quando l’odio e la violenza di parte sconvolgono la comunità in cui si vive.
Nel 1294, anno dell’elezione e successiva abdicazione di Celestino V, nonché dell’ascesa al papato di Bonifacio VIII, Dante ha un ruolo diplomatico- culturale di primo piano nella delegazione dei cavalieri destinati dal Comune al seguito dell’imperatore Carlo Martello. In seguito, con la stesura del Paradiso, Dante potrà immaginare un incontro con Carlo al cospetto di Dio; il dialogo tra i due, con esplicito richiamo alla Politica di Aristotele, ma anche al De Anima, ha una precisa connotazione teologica: «“Vuo’ tu che questo ver più ti s’imbianchi?”. /E io: “Non già; ché impossibil veggio / che la natura, in quel ch’è uopo, stanchi”. / Ond’ elli ancora: “Or dì: sarebbe il peggio /per l’omo in terra, se non fosse cive?”. / “Sì”, rispuos’ io; “e qui ragion non cheggio”. / “E puot’ elli esser, se giù non si vive /diversamente per diversi offici? / Non, se ’l maestro vostro ben vi scrive”» ( Paradiso, VIII, 113-120).
Sarebbe un male per l’uomo sulla terra se non facesse parte di un ordine civile, di un organismo sociale? E può esistere un’organizzazione civile se i suoi membri non siano ordinati a vivere esercitando diverse funzioni? E Dante risponde “sì” alla prima domanda e “no” alla seconda. La naturale politicità dell’uomo si accompagna alla necessità di distinguere gli offici poiché Nihil frustra natura facit (Politica I, 2).
Il quinquennio successivo al 1294 segnerà intensamente la vita e l’opera di Dante proprio perché continuo sarà lo scambio tra teoria e prassi, una prassi in toga candida: dalla riflessione filosofica riguardo al primato della morale alla traduzione di ciò nella vita della polis, una sorta di ragion pratica kantiana ante litteram: impegno civile, riflessione morale, tenace inseguimento della giustizia.
Proprio quando Firenze è dilaniata da lotte sociali interne e lo stesso papato non è immune dalla brama di potere che assale i partiti politici, Dante tiene ben ferma la barra del suo operare cristiano, perché è fermamente convinto di agire nella direzione indicata dalla bussola teologica. In questo atteggiamento riconosciamo l’attualità del suo pensiero politico e del suo agire politico. Dopo la condanna, negli anni dell’esilio, Dante consegnerà alle pagine del Convivio, della Commedia, ma soprattutto del trattato Monarchia, la riflessione teorica frutto della sua esperienza politica. È un progetto in fieri perché dovrà fare i conti col divenire della storia, è un progetto politico voluto da Dio per il bene dell’umanità.
Dopo la fine del potere temporale dei Papi, la Chiesa, a partire dall’enciclica In praeclara summorum (1921) di Benedetto XV, fino al Messaggio al presidente del Pontificio Consiglio della cultura in occasione del 750° anniversario della nascita di Dante Alighieri (2015) di papa Francesco, ha pienamente rivendicato, si pensi alla mirabile Altissimi cantus, la lettera apostolica di Paolo VI, l’appartenenza di Dante alla Chiesa cattolica e alla fede di Cristo, proprio considerando la sua battaglia di cristiano impegnato nella vita politica del suo tempo e nella sua somma opera teologica.
Oggi l’umanesimo cristiano di Dante può essere una traccia da seguire nella comunicazione religiosa e laica che stiamo vivendo. Per la preparazione del laicato cattolico alla vita politica, il pensiero di Dante può diventare una “bussola teologica”. Il rapporto tra fede, morale e politica, vissuto alla luce dei valori cristiani, che fece di Dante il segno di contraddizione della sua epoca, oggi fa di lui un nostro contemporaneo.
*
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE, E --- IL REGNO. Il mio regno non è di qui (di Piero Stefani).28 novembre 2018, di Federico La Sala
Il mio regno non è di qui
di Piero Stefani ("Il Regno", 22/11/2018)
- Solennità di Cristo re dell’universo
- Dn 7,13-14; Sal 93 (92); Ap 1,5-8; Gv 18,33-37
«Universo» è parola sconosciuta alla Bibbia. Per dire «il tutto», il primo versetto della Scrittura impiega l’espressione «il cielo e la terra» (Gen 1,1; cf. Ef 1,10). Il posto privilegiato che questo modo di dire riserva a ciò che noi definiamo «nostro pianeta» indica una distanza incolmabile tra l’immagine biblica del cosmo e quella attuale. Non ha senso logico definire un campo come fosse costituito da 100 ettari di terreno e da un granello di polvere. I tentativi di intrecciare teologicamente tra loro la visione cosmica biblica con quella odierna non portano da nessuna parte.
Meglio domandarsi allora perché il Nuovo Testamento, e in particolare Giovanni, precludono l’eventualità di qualificare la solennità odierna ricorrendo all’espressione «re del mondo».
«Il mio regno non è di questo mondo» (Gv 18,36), risponde Gesù a Pilato. Subito dopo Gesù aggiunge: «Il mio regno non è di qui (enteuthen)» (Gv 18,36). Le due espressioni kosmos («mondo») ed enteuthen («qui») gravitano dalla stessa parte.
Kosmos è una parola frequente nel quarto Vangelo. Essa è contraddistinta da una forte ambiguità. Il mondo rappresenta la scena sulla quale si svolge il dramma della redenzione: «Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui» (Gv 3,17; cf. Gv 10,36; 11,27). Il mondo è amato da Dio (cf. Gv 1,29; 4,42) eppure odia Gesù, «perché di esso io attesto che le sue opere sono cattive» (Gv 7,7; cf. Gv 15,18-19; 17,14).
Il Vangelo di Giovanni è caratterizzato da un lessico fortemente duale (luce-tenebre; vita-morte; amore-odio; verità-menzogna...); tuttavia alcuni termini, come appunto «mondo», più che colti in contrapposizione al loro opposto, vanno intesi in relazione a una tensione che sussiste tra vari significati attribuiti alla stessa parola: il mondo è amato e salvato, eppure odia Gesù. «Il mio regno non è di questo mondo» ma io sono venuto a salvare il mondo.
La contraddizione sembra insuperabile. Per cercare di scioglierla è di qualche aiuto seguire l’altro, e assai meno importante, termine: «qui». In effetti esso ricorre poche volte in Giovanni e nella maggior parte dei casi ha un semplice valore spaziale, secondo il senso comune del termine (cf. Gv 2,16; 7,3; 14,31).
Nella risposta a Pilato le cose stanno diversamente. Non ha significato alcuno affermare che «il mio regno non è di qui» perché è «altrove», come se si estendesse su un altro territorio. Tuttavia, guardando all’ultima occasione nella quale Giovanni fa ricorso al termine, si apre all’improvviso uno squarcio. Ciò avviene se nella traduzione, a differenza del solito, si ricorre all’avverbio «qui»: «Lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall’altra (enteuthen kai enteuthen, una specie di «uno di qui e uno di qua»), e Gesù in mezzo» (Gv 19,18).
È solo un cenno, non più di una spia; tuttavia appare calzante pensare a un richiamo tra le due scene; come se si volesse far dire a Gesù: il mio regno non è «qui», ma è sulla croce. Non ci si muove nella logica dei poteri mondani, il tal caso qualcuno avrebbe combattuto (cf. Gv 18,36); il regno si trova invece nella forza attrattiva e salvifica della croce: «“E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me”. Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire» (Gv 12,32-33).
Gesù afferma che il suo regno non è di qui, egli però rivendica pienamente la propria condizione regale: «Tu lo dici, io sono re» (Gv 18,37). Si tratta di una regalità diversa da quella mondana. «Gesù il Nazareno, il re dei Giudei» sarebbe stata la frase scritta sulla croce in ebraico, latino e greco, e che Pilato non volle mutare. «Quel che ho scritto ho scritto» (Gv 19,22) è una specie di definitivo sigillo posto al «Tu lo dici» (Gv 18,37) rivolto da Gesù a Pilato. È sulla croce che si dispiega la regalità «altra» e salvifica di Gesù.
*Sul tema, nel sito, si cfr.:
SAN PAOLO, COSTANTINO, E LA NASCITA DEL CATTOLICESIMO.
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE.
Federico La Sala
-
> LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE, E --- Il ruolo del «terzo». Le vie della riconciliazione (di Piero Stefani).28 novembre 2018, di Federico La Sala
Il ruolo del «terzo»
Le vie della riconciliazione
di Piero Stefani ("Il Regno", Attualità, 20/2018)
Al pari del perdono, del pentimento e della consolazione, la riconciliazione è una realtà che si colloca nell’ambito del «dopo». È così perché in tutti questi casi si tenta di rispondere a quanto c’è stato ma non avrebbe dovuto esserci: lo scontro, la divisione, il contrasto, la lite, la colpa, l’offesa, la perdita, il dolore lancinante.
Si tratta di un «dopo» che non annulla quanto è stato. Non è un colpo di spugna, non sono né dimenticanza, né oblio. Per queste vie ci si misura a viso aperto con il passato per non restarne prigionieri. Ci si colloca quindi agli antipodi non solo dell’oblio, ma anche della rimozione.
Tra i termini prima enunciati sussistono rilevanti differenze. La riconciliazione comporta una bilateralità in atto, il pentimento è invece unilaterale, colui che si pente, anche se esprime una richiesta di essere perdonato, non è nelle condizioni d’imporre d’essere esaudito. Lo stesso vale per un perdono concesso prima che nell’animo dell’offensore prenda dimora il pentimento.
Su un altro piano, pure la consolazione è costretta a operare nell’ambito di una bilateralità «sbilanciata»: chi ha patito una perdita è oggetto di premura da parte di chi si trova in un’altra situazione. Dal canto suo la compiuta bilateralità, tipica della riconciliazione, comporta la pari dignità delle due parti. La precedente sperequazione ora viene a cessare. Ciò vale nel caso di relazioni sia interpersonali sia collettive. Sullo sfondo di questi processi si staglia però una possibile ombra, vale a dire il fatto che l’avvenuta riconciliazione a due apra una frattura nei confronti di un terzo.
Osservata in questa luce, la parabola del «padre misericordioso» (Lc 15,11-32) evidenzia due passaggi rilevanti. Il figlio minore, dopo aver dissipato i beni ricevuti, torna verso casa. Lungo il tragitto egli mostra d’ignorare il cuore del proprio genitore, infatti pensa di conquistarlo declassandosi a servo. Tuttavia «quando era ancora lontano» il padre «lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli gettò le braccia al collo e lo baciò» (Lc 15,20).
Per comprendere questa dinamica non è necessario evocare un diuturno scrutamento dell’orizzonte. La situazione è infatti paragonabile a quella del samaritano che scorge il ferito sul bordo della via. In entrambi i casi ci troviamo di fronte a una stessa successione di verbi: dapprima si vede e immediatamente dopo si prova compassione (verbo splagchnizomai; cf. Lc 10,33). L’atto di misericordia che ci conduce verso l’«altro» non è bilaterale; il padre e il figlio, il soccorritore e il malcapitato non si trovano sullo stesso piano. Nel caso dei fratelli, il discorso può invece diventare più bilaterale.
Esaù e Giacobbe
Giacobbe, dopo tanti anni trascorsi presso suo suocero Làbano, si mette in marcia per ritornare, ricco di prole e di beni, alla terra d’origine. Lungo la via il patriarca apprende che il fratello Esaù, a cui aveva sottratto la primogenitura, viene verso di lui accompagnato da quattrocento uomini. Allora «Giacobbe ebbe paura e fu angosciato» (Gen 32,8). Il tradizionale commento ebraico propone questa spiegazione: Giacobbe ebbe paura di essere ucciso e fu angosciato dall’idea che forse sarebbe toccato a lui uccidere.1 Non tutte le paure sono però uguali, alcune sono paralizzanti, altre sollecitano l’azione.
Nel caso del patriarca essa è del secondo tipo; egli infatti reagisce ed elabora piani difensivi: divide gli accampamenti per far sì che almeno uno dei due si salvi; inoltre invia al fratello copiosi doni, pensando in tal modo di placarlo. Il giorno dopo, quando vide giungere Esaù accompagnato dalla sua numerosa scorta, Giacobbe affidò i propri figli alle loro rispettive madri, si mise in testa al gruppo e, a debita distanza, si prostrò sette volte fino a terra davanti al fratello.
Eppure la primogenitura e la benedizione da lui carpite lo avrebbero dovuto costituire signore. La via verso la riconciliazione è spianata però dallo stesso Esaù. È il fratello maggiore a ricoprire il ruolo più nobile; i vent’anni trascorsi avevano smorzato in lui la sete di vendetta; tuttavia il passare del tempo da solo non basta a spiegare il suo comportamento: troppe volte l’odio ha dimostrato di essere dotato di una memoria più tenace dell’amore. «Ma Esaù gli corse incontro, lo abbracciò, gli si gettò al collo, lo baciò e piansero» (Gen 33,4).
L’atto compiuto dal fratello maggiore in quella circostanza è talmente alto da essere stato assunto come sottotesto del gesto compiuto dal padre nella parabola. Rispetto al Vangelo, tuttavia, nella Genesi c’è un particolare in più: i fratelli piangono assieme. L’atto ora diviene perfettamente bilaterale. Il sigillo della riconciliazione sta nelle lacrime sgorgate dagli occhi di entrambi. È vero che subito dopo questo incontro i due fratelli decisero di separarsi.
Tuttavia Esaù e Giacobbe (nominati proprio in questo ordine allusivo a una specie di primogenitura riconquistata) si sarebbero di nuovo incontrati nell’atto di seppellire il loro padre Isacco (cf. Gen 35,29). La Bibbia presenta quest’ultimo avvenimento in una riga come puro dato di cronaca, ma dietro a quella spoglia annotazione ogni lettore scorge il valore e lo spessore del non detto.
Il ruolo del «terzo»
Nella parabola il padre fa festa per il ritorno del figlio minore. Tra i due è avvenuta una forma di riconciliazione. Tuttavia è proprio quest’ultima a spalancare il problema del terzo, in questo caso rappresentato dalla figura del fratello maggiore. L’avvicinamento degli uni provoca l’allontanamento dell’altro. Si tratta di una dinamica frequente in politica, dove la parola «riconciliazione» è per lo più impropria, ma non assente in altre operazioni riconciliatrici, comprese quelle presenti in campo ecumenico e interreligioso.
La parabola non riporta alcuna conclusiva risposta del fratello maggiore. Luca lascia quindi in sospeso l’esito del tentativo paterno di riconciliarsi anche con il primogenito. Al pari di Andrè Gide,2 ogni lettore è nelle condizioni d’immaginare molteplici «dopo». In questo caso il non detto si apre sull’indefinito. La mancata risposta rende comunque più acuto il problema del «terzo», una questione che, fino a quando resta aperta, incrina inevitabilmente il processo di riconciliazione.
Il «terzo» come mediatore
Nella tradizione giudaica, Aronne è la figura associata più di ogni altra alla costruzione di una pace intesa come riconciliazione. Il fratello di Mosè, nonostante la sua debolezza e accondiscendenza, o forse proprio grazie a esse, viene presentato come il prototipo di chi si sforza senza posa d’instaurare la riconciliazione tra i membri del suo popolo. Su questo punto i commenti narrativi si dilungano ampiamente, prospettando molti episodi leggendari in cui emerge la convinzione che, quando urge la riconciliazione, si è sospinti a compiere molti atti rischiosi e ibridi, ivi compresa la scelta di percorrere, almeno parzialmente, la via della finzione.
Si racconta che, quando due uomini avevano litigato, Aronne si andasse a sedere accanto a uno di loro e gli dicesse: «Figlio mio, bada a quanto sta facendo tuo fratello! Egli si batte il petto e bagna i suoi abiti di lacrime dicendo: “Me sventurato! Come potrò alzare gli occhi e guardare il mio compagno? Sono stato io a trattarlo stoltamente”».
Dopo aver terminato di riferire tali parole, il fratello di Mosè continuava a parlargli fino a quando fosse scomparsa ogni traccia di rancore. Allora Aronne si recava dall’altro contendente e ripeteva lo stesso rito conciliatorio e «quando i due uomini si incontravano s’abbracciavano e baciavano reciprocamente».3
Un altro commento applica l’attività riconciliatrice all’ambito familiare. Allorché un uomo aveva scacciato la moglie, Aronne andava da lui e gli chiedeva come mai avesse litigato con la sua sposa. Se il marito gli rispondeva affermando: «Perché ha agito in modo svergognato nei miei confronti», Aronne replicava che lui stesso si sarebbe reso garante che ciò non si sarebbe più ripetuto. Poi andava dalla moglie e le poneva la stessa domanda e se lei rispondeva che il marito l’aveva picchiata e maledetta, Aronne si rendeva ancora una volta personalmente garante che in seguito ciò non avrebbe più avuto luogo.
Il fratello di Mosè insisteva fino a quando i due non si fossero rappacificati. Come frutto della riconciliazione tra i coniugi la donna avrebbe avuto un figlio a cui sarebbe stato imposto il nome di Aronne. I bambini chiamati in quel modo ammontarono a tremila.4
L’iperbolica cifra sta a significare che in ogni tempo è stata profonda tanto la consapevolezza della precarietà di una convivenza quotidiana insidiata dal logoramento, dalla fatica, dalla stanchezza, quanto la fiducia nelle capacità di ripresa insite nel rapporto coniugale. Tenendo conto di ciò si sarebbe propensi ad affermare che, in un’ottica esistenziale, parlare d’indissolubilità del matrimonio appare formale e astratto, mentre prospettarne la «riannodabilità» è concreto e riconciliatore.
Il ruolo del mediatore rispetto ai processi di riconciliazione è ben più esteso dei casi interpersonali e coniugali ora esemplificati; le dinamiche positive legate alla presenza di un «terzo» illustrate da questi riferimenti giudaici rimangono comunque significative anche quando ci si muove in orizzonti più vasti.
1 Cf. Rashi a Gen 32,8.
2 Cf. il racconto di A. Gide, Il ritorno del figliol prodigo (1907). Per altre esemplificazioni, cf. C. Mazzucco, Il figliol prodigo nella parabola lucana e nelle reinterpretazioni di alcuni autori europei della prima metà del ’900, Edizioni dell’Orso, Alessandria 2008.
3 ‘Avot de-Rabbi Natan A, 12.
4 ‘Avot de-Rabbi Natan B, 25.
-
> LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE, E -- FEDERICO II DI SVEVIA. Musica, architettura e cosmo: una rilettura di Castel del Monte.22 agosto 2018, di Federico La Sala
RIPENSARE COSTANTINO. LA LEZIONE DI DANTE (E DI KANTOROWICZ) .... *
Musica, architettura e cosmo: una rilettura di Castel del Monte
di Cesare Cavalleri (Avvenire, mercoledì 22 agosto 2018)
Tantissimi anni fa, cioè nel 1970, lessi Pietre che cantano, di Marius Schneider, spinto dall’entusiasmo di Elémire Zolla che aveva spiegato come Schneider, osservando i chiostri romanici di San Cugat, di Gerona e di Ripoll in Catalogna, aveva annotato le figure effigiate sui capitelli assegnando a ciascuna un valore musicale; quindi lesse come simboli di note le singole figure, basandosi sulle corrispondenze tramandate dalla tradizione indù, e scoprì infine che la serie corrispondeva alla esatta notazione degli inni gregoriani dedicati ai santi di quei chiostri. Abbagliante erudizione che non ho mai smesso di ammirare.
Con questo precedente, non potevo evitare di tuffarmi (siamo in estate) nel saggio di Giulia Ferraro, Simbologia di Castel del Monte. Rilettura di un’ipotesi sui rapporti tra musica e architettura, pubblicato nel più recente quaderno del Conservatorio "Giuseppe Verdi" di Milano, a cura di Massimo Venuti con Giovanni Acciai e Gabriele Manca (Edizioni ETS, pagine 228, euro 23,00).
Castel del Monte, che si erge solitario nel paesaggio collinare delle Murge, in territorio di Andria, è un enigma che da otto secoli affatica gli studiosi che finora sono riusciti soltanto a scalfirlo. Enigmatico quant’altri mai, del resto, è chi lo fece costruire, l’imperatore Federico II di Svevia (1194-1250), guerriero, astronomo, falconiere, politico antagonista del papato, protettore degli artisti da cui amava circondarsi. Enigmatica anche la destinazione del Castello, che non sembra di difesa né di delizie, con la sua pianta ottagonale e le otto torri angolari.
L’ipotesi che Giulia Ferraro intende rileggere è del musicologo Vasco Zara, autore nel 2000 del saggio L’intelletto armonico. Il linguaggio simbolico musicale nell’architettura di Castel del Monte. Zara collega le forti implicazioni astronomiche, matematiche e geometriche racchiuse nell’architettura del Castello, con le conoscenze musicali dell’epoca. In particolare, viene proposto l’antico accostamento tra pianeti e note musicali, «introducendo il concetto di “musica delle sfere”, per il quale il movimento di ciascun pianeta produce un preciso suono».
È un concetto di ascendenza platonica, che Dante riprenderà nel Canto XII del Paradiso. Zara, «dopo aver associato a ogni facciata interna del pianterreno del Castello un pianeta e del piano superiore una delle gerarchie angeliche, abbina a questi una nota musicale», secondo uno schema rinvenuto in alcuni fogli liberi di un manoscritto del XII secolo, contenente il De institutione musica di Boezio.
Il passaggio dal giro pagano dei pianeti al cielo abitato dalle gerarchie angeliche è scandito nella facciata nord-ovest del Castello dalla statua equestre di un cavaliere, peraltro semidistrutta: «L’immagine è quella di mediatore tra Cielo e Terra, adatta a un imperatore come Federico, autoincoronatosi, in una Gerusalemme da lui liberata, Re del Mondo contro il volere del Papa che l’aveva scomunicato, Re per grazia di Dio e non della Chiesa».
Dunque, l’architettura di Castel del Monte riprodurrebbe in forma plastica la musica delle sfere, la cui inudibilità è così spiegata da sant’Ambrogio in Exameron, II,7: «Alcuni dicono che il suono delle sfere non arriva fino alla terra, per la ragione che gli uomini, sia in Oriente che in Occidente, sedotti dalla soavità e dal fascino di quel suono originato dal movimento velocissimo dei cieli, trascurerebbero ogni dovere e attività e tutto quaggiù rimarrebbe ozioso, perché lo spirito umano sarebbe come portato in estasi da quelle musiche celesti».
Il Quaderno del Conservatorio intitolato “I volti della musica: allegoria, Spirito, realtà”, contiene, oltre allo studio di Giulia Ferraro, altri due saggi: Lutero e la riforma. Alle origini del Corale, di Ivana Valotti; Luigi Nono, al gran sole carico d’amore. La rivoluzione in musica, di Claudia Ferrari. Finché ci saranno studiosi che si dedicano ad approfondimenti come questi, il mondo non cadrà nell’insignificanza.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE, E IL VATICANO CON IL SUO TRADIZIONALE SOFISMA DELLA "FALLACIA ACCIDENTIS".
- PER L’ITALIA, "DUE SOLI". Per una nuova laicità, un nuovo cristianesimo!!! Come MARIA: "FIGLIA DEL TUO FIGLIO", così GIUSEPPE: "FIGLIO DEL TUO FIGLIO"!!! Dante non "cantò i mosaici" dei "faraoni", ma soprattutto la Legge del "Dio" di Mosè di Elia e di Gesù, del "Dio" dei nostri "Padri" e delle nostre "Madri". L’Amore che muove il Sole e le altre stelle ... e la fine del cattolicesimo costantiniano!!!
DANTE: IL PARADISO TERRESTRE, UN PROGRAMMA PER I POSTERI. --- KANTOROWICZ, UN GRANDE LETTORE DI DANTE. Una nota
LA SOVRANITÀ, LA DIGNITÀ DI OGNI CITTADINO E DI OGNI CITTADINA, E "I DUE CORPI DEL RE". La lezione di Kantorowicz.... L’ analisi di Barbara Spinelli (2006)
Federico La Sala
-
> LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE, - "... e l’Italia uscì a riveder le stelle". Nella Divina Commedia i primi principi della Costituzione (di Giovanni Maria Flick).28 maggio 2018, di Federico La Sala
LA LEZIONE DI DANTE. Nella Commedia i primi principi della Costituzione
- A PISA. "DANTEPRIMA" DEL SETTIMO CENTENARIO. Il testo che pubblichiamo in questa pagina è un ampio stralcio della lectio magistralis con cui il presidente emerito della Corte Costituzionale [...]
... e l’Italia uscì a riveder le stelle
Nella Divina Commedia le indicazioni per la Costituzione nata dalla Resistenza
di Giovanni Maria Flick (La Stampa, 27.05.2018)
Per aprire la mia riflessione sulla Costituzione, nel ricordo e nella celebrazione di Dante, ho preso in prestito dalla Divina Commedia una delle espressioni che più mi hanno affascinato e mi sono rimaste impresse nelle letture liceali di essa. Non saprei trovarne altra più adatta - per ricordare il percorso del nostro Paese dalla guerra perduta a quella civile, alla Resistenza e alla Liberazione, alla Repubblica e alla Costituzione - della descrizione del passaggio anche fisico del poeta dall’emisfero boreale a quello australe.
Lasciare la voragine dell’Inferno pietrificato dall’odio, dalla disperazione, dalla solitudine nella folla, dal frastuono caotico, dal gelo luciferino, dalle tenebre, per giungere alla serenità e alla luce nell’ascesa alla montagna del Purgatorio, ai suoi cieli azzurri preludio alla luminosità del Paradiso, all’erba e ai fiori, al «chiaro mondo» e a «le cose belle», alla solidarietà e all’amicizia, alla pena come strumento per la beatitudine e non come costrizione. Tale è - a differenza delle tradizioni dell’epoca, secondo cui il Purgatorio è un Inferno a termine - l’immagine del Purgatorio che ci propone Dante: una comunità in un paesaggio terrestre ma governato da leggi non terrestri; una realtà che è espressa dal poeta in modo più musicale, meno figurativo dell’Inferno e richiama i ritmi naturali dell’esistenza, il ciclo delle stagioni.
La sequenza dalla dichiarazione stolta della guerra nel 1940 (per sedere con qualche migliaio di morti al tavolo della pace) alla disfatta nel 1943; alla lotta fratricida oltre che contro il nazista invasore; alla Resistenza nel 1943 e alla Liberazione nel 1945; alla scelta repubblicana e alla scrittura della Costituzione con il referendum del 1946; alla ricostruzione delle pietre e dei valori del nostro Paese (dopo lo smarrimento della «diritta via» nella «selva oscura» del Ventennio fascista, culminato nel 1938 con la imitazione servile delle leggi razziali naziste). Forse non sono esattamente la stessa cosa dell’Inferno e del Purgatorio danteschi; ma certo vi si avvicinano molto.
Perciò è giusto rendere omaggio a Dante per questo contributo - profetico e preciso, quanto di necessità inconsapevole - alla ricostruzione di quel particolare periodo del nostro passato e alla riflessione odierna sulla Costituzione italiana, a settant’anni dalla sua nascita e a poca distanza dalla sua riconferma nel 2016, con il No a larga maggioranza in occasione dell’ultima proposta di referendum per una sua riforma radicale.
Beninteso, le indicazioni «costituzionali» che possono trarsi dalla lettura della Divina Commedia sono anche altre, sia di carattere generale sia specifico.
Basta pensare, ad esempio, alla definizione primitiva ma attuale dei beni comuni: «com’esser puote ch’un bene, distribuito in più posseditor, faccia più ricchi di sé, che se da pochi è posseduto?». Se il significato di bene comune è stato colto così bene da Dante nel 1300, «com’esser puote» che incontri difficoltà di comprensione nel 2018 di fronte a una serie sempre più estesa (e sempre più minacciata nella sua esistenza) di beni comuni (destinati cioè alla fruizione da parte di tutti e non solo da parte del loro proprietario pubblico e privato o di chi paga un biglietto?).
Basta pensare alle perle di saggezza - che in realtà racchiudono e sintetizzano interi commentari sull’arte di legiferare, da troppo tempo dimenticata - proposte del poeta: «le leggi son ma chi pon mano ad esse?» (Purgatorio, canto XVI, 97); o ancora, a proposito della dichiarazione di Giustiniano imperatore «per voler del primo amore ch’i sento, d’entro le leggi trassi il troppo e il vano» (Paradiso, canto VI, 12), che dovrebbe costituire l’ambizione e l’impegno di qualsiasi aspirante legislatore sia costituente sia ordinario.
Basta pensare infine alla differenza, sottolineata da Dante, tra la giustizia umana distributiva e quella divina: alla «lagrimetta» di Buonconte da Montefeltro (Purgatorio, canto V, 91-129) grazie alla quale l’angelo di Dio priva il diavolo della sua preda, da lui attesa per i trascorsi di vita del morente, che vengono superati e annullati dal pentimento finale di quest’ultimo.
La molteplicità degli aspetti posti in evidenza da Dante, nel descrivere il suo percorso poetico e umano, non consente ulteriori richiami in questa sede, oltre ai pochi accennati dianzi. Questi ultimi, ma in realtà tutto il resto, suggeriscono un filo rosso e una guida nella lettura della nostra Costituzione, di fronte alla vicenda di un grandissimo personaggio, che propone all’attenzione del giurista e del politico nella Divina Commedia un poema non solo autobiografico (il suo conservatorismo, la sua dignità e la sua rigidità, la sua posizione di protagonista e di vittima in quello scontro tra Guelfi e Ghibellini e tra Bianchi e Neri, che ripropone in miniatura temi tuttora presenti nella quotidianità e lotta politica del nostro paese). È soprattutto un poema civile ed etico.
È un poema di denunzia e di protesta contro l’ingiustizia, la corruzione, la degenerazione del potere che non conosce e rifiuta qualsiasi limite, le deviazioni della finanza e del mercato, l’avidità del guadagno, l’orgoglio e l’ostentazione della ricchezza conquistata, l’ipocrisia; quest’ultima considerata da Dante il peccato più grave, l’espressione della malvagità sotto apparenza di bontà, il parlare in modo reticente.
È emblematica in questo senso l’enciclopedia delle passioni umane descritte attraverso l’elencazione e l’esemplificazione dei sette vizi capitali, nel Purgatorio: la superbia, l’invidia, l’ira, l’accidia, l’avarizia, la gola, la lussuria. V’è ben più di quanto basta per agevolare, seguendo questo filo rosso e questa guida, una riflessione e un bilancio sulla nostra Costituzione nei suoi primi settant’anni di vita.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
"DUE SOLI" IN TERRA, E UN SOLO SOLE IN CIELO: "TRE SOLI". GENERE UMANO: I SOGGETTI SONO DUE, E TUTTO E’ DA RIPENSARE!!! NON SOLO SUL PIANO TEOLOGICO-POLITICO, MA ANCHE ... ANTROPOLOGICO!!!
 LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE, E IL VATICANO CON IL SUO TRADIZIONALE SOFISMA DELLA "FALLACIA ACCIDENTIS". Un invito alla lettura
LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE, E IL VATICANO CON IL SUO TRADIZIONALE SOFISMA DELLA "FALLACIA ACCIDENTIS". Un invito alla letturaLA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO DEI "DUE SOLI". Con la morte di Giovanni Paolo II, il Libro è stato chiuso. Si ri-apre la DIVINA COMMEDIA, finalmente!!! DANTE "corre" fortissimo, supera i secoli, e oltrepassa HEGEL - Ratzinger e Habermas!!! MARX, come VIRGILIO, gli fa strada e lo segue. Contro il disfattismo, un’indicazione e un’ipotesi di ri-lettura. AUGURI ITALIA!!!
NUOVO REALISMO (E "GAIA SCIENZA"): LA LEZIONE DI DANTE (E NIETZSCHE), OGGI. CONOSCERE SE STESSI E CHIARIRSI LE IDEE, PER CARITÀ!
Federico La Sala
-
> LA "MONARCHIA" DI DANTE -- GIOACCHINO DA FIORE, LA SORPRENDENTE “CARITÀ”, E IL DRAMMA DEL CATTOLICESIMO ATEO E DEVOTO.3 marzo 2018, di Federico La Sala
DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! GIOACCHINO DA FIORE, LA SORPRENDENTE “CARITÀ”, E IL DRAMMA DEL CATTOLICESIMO ATEO E DEVOTO. ..
"È nostro altissimo dovere tenere sempre presenti e diligentemente imitare i luminosi esempi della ammirabile carità ...": "Mirae caritatis. De sanctissima eucharistia", della "Ammirabile Carità. La santa eucarestia", così è intitolata e così è tradotta la "Lettera enciclica" di Leone XIII, del 1902:
- MIRAE CARITATIS. LETTERA ENCICLICA DI SUA SANTITÀ LEONE PP. XIII. LA SANTA EUCARESTIA
- EPISTOLA ENCYCLICA - MIRAE CARITATIS SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI LEONIS PAPAE XIII. DE SANCTISSIMA EUCHARISTIA.
Se si tiene presente che nel 1183, con grande chiarezza e consapevolezza, Gioacchino da Fiore nel suo "Liber de Concordia Novi ac Veteris Testamenti" così scriveva:
- "Primus ergo status in scientia fuit, secundus in potestate sapientie, tertius in plenitudine intellectus. Primus in servitute servili, secundus in servitute filiali, tertius in libertate. Primus in flagellis, secundus in actione, tertius in contemplatione. Primus in timore, secundus in fide, tertius in charitate"
 ("Il primo stato visse di conoscenza; il secondo si svolse nel potere della sapienza; il terzo si effonderà nella plenitudine dell’intendimento. Nel primo regno il servaggio servile; nel secondo la servitù filiale; il terzo darà inizio alla libertà. Il primo stato trascorse nei flagelli; il secondo nell’azione; il terzo trascorrerà nella contemplazione. Il primo visse nell’atmosfera del timore; il secondo in quella della fede; il terzo vivrà nella carità"),
("Il primo stato visse di conoscenza; il secondo si svolse nel potere della sapienza; il terzo si effonderà nella plenitudine dell’intendimento. Nel primo regno il servaggio servile; nel secondo la servitù filiale; il terzo darà inizio alla libertà. Il primo stato trascorse nei flagelli; il secondo nell’azione; il terzo trascorrerà nella contemplazione. Il primo visse nell’atmosfera del timore; il secondo in quella della fede; il terzo vivrà nella carità"),
si può ben pensare che le preoccupazioni di una tradizione e di una trasmissione corretta del messaggio evangelico e, con esso, del "luminoso esempio" dello stesso Gioacchino da Fiore, non siano state affatto al primo posto del magistero della Chiesa cattolico-romana, né ieri né oggi.
Di Gioacchino se si è conservato memoria del suo lavoro come del suo messaggio, lo si deve sicuramente alla sua "posterità spirituale" - è da dire con H. De Lubac, ma contro lo stesso De Lubac, che ha finito per portare acqua al mulino del sonnambulismo ateo-devoto dell’intera cultura ’cattolica’,.
Federico La Sala
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- L’EUROPA, IL CRISTIANESIMO ("DEUS CHARITAS EST"), E IL CATTOLICESIMO COSTANTINIANO ("DEUS CARITAS EST").Una storia di lunga durata...
 MURATORI, BENEDETTO XVI, E "UNO SPROPOSITO MAIUSCOLO": LA LEZIONE DI VICO. Un breve testo dalla "Prefazione ai lettori" del "Trattato sulla carità cristiana" di Ludovico A. Muratori
MURATORI, BENEDETTO XVI, E "UNO SPROPOSITO MAIUSCOLO": LA LEZIONE DI VICO. Un breve testo dalla "Prefazione ai lettori" del "Trattato sulla carità cristiana" di Ludovico A. Muratori
- IL MAGISTERO DI MENZOGNA DELLA CHIESA CATTOLICA: IL "PADRE NOSTRO" CHE INDUCE IN TENTAZIONE. -- "Traduzione non è buona, Dio non ci induce in tentazione" (Papa Francesco).
-
> LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE, E IL VATICANO CON IL SUO TRADIZIONALE SOFISMA -- «La filosofia in Italia al tempo di Dante» (Carla Casagrande e Gianfranco Fioravanti).29 maggio 2017, di Federico La Sala
Aristotelismo dai bolognesi a Dante
Filosofia medievale. Una ricca silloge del Mulino a cura di Carla Casagrande e Gianfranco Fioravanti («La filosofia in Italia al tempo di Dante») ricostruisce l’epoca delle «disputazioni» universitarie
di Mario Mancini (il manifesto, 28.05.2017)
In un famoso passo del Convivio (II, 12, 6-7) Dante ricorda il suo incontro con la filosofia, attraverso la lettura del De consolatione di Boezio e del De amicitia di Cicerone. La scopre, con emozione, come «somma cosa» e comincia così «ad andare là dov’ella si dimostrava veracemente, cioè nelle scuole delli religiosi e alle disputazioni delli filosofanti».
Le parole di Dante sono di una meravigliosa precisione. Le «scuole delli religiosi» sono, a Firenze, gli «studia» degli ordini mendicanti - dei Domenicani, a Santa Maria Novella, e dei Francescani, a Santa Croce - «studia» che sono aperti, in parte, anche ai laici. «Filosofanti» individua un gruppo di intellettuali nettamente distinto dai «religiosi»: è il nome con cui si indicano, a Parigi, i professori della Facoltà delle Arti. E «disputazioni» è il termine tecnico che indica le discussioni di problemi, teologici e filosofici, in ambito universitario.
Firenze, dunque, ma ancora di più Bologna. Perché qui, verso la fine del Duecento, la filosofia, in stretto rapporto con i maestri della Facoltà delle Arti di Parigi, riceve uno straordinario impulso e le «disputazioni» qui dibattute vengono riprese, appassionatamente, in tutte le principali città italiane. Un caso rilevante è la Questio de felicitate che un non meglio conosciuto Giacomo da Pistoia dedica a Guido Cavalcanti, il che ci dà piena misura di come temi filosofici fondamentali fossero giunti in un ambiente cui Dante, e non solo il suo «primo amico», poteva avere ampio accesso.
Un reduce da Parigi
Alla ricostruzione di questa vicenda culturale, che è una vera svolta, è dedicata la ricca silloge La filosofia in Italia al tempo di Dante, a cura di Carla Casagrande e Gianfranco Fioravanti (Il Mulino, pp. 292, € 23,00). La Parte prima ha come titolo «Il ritorno dei filosofi in Italia: Bologna 1295». Perché questa data? Perché è fortemente emblematica: individua il ritorno a Bologna di Gentile da Cingoli, uno studioso che si è perfezionato a Parigi, nella Facoltà delle Arti, seguendo in particolare corsi sul De generatione animalium di Aristotele, e che il 21 marzo 1295 stipula un contratto con un professore di logica dello studio bolognese per impartire lezioni di filosofia. Si tratta della prima testimonianza dell’esistenza a Bologna e in Italia di un insegnamento di filosofia in senso stretto, e sicuramente non è un caso che a impartirlo sia un reduce da Parigi.
La situazione istituzionale dell’Università di Bologna - analizzata con mano sicura, oltre che da Fioravanti, da Andrea Tabarroni e da Chiara Crisciani - è molto particolare e molto complessa. I docenti di medicina sono attratti dalla dottrina di Aristotele, rilevantissimo è il ruolo di un maestro come Taddeo Alderotti, che insegna nella Scuola di medicina fin dal 1268 e che ha forti interessi filosofici: commenta Galeno e Avicenna, volgarizza, in un compendio, l’Etica Nicomachea di Aristotele. Il legame tra medici e filosofi, con maestri come Gentile da Cingoli, come Taddeo Alderotti e i suoi allievi, porta anche, nel 1316, alla costituzione, accanto al più antico e glorioso Studio giuridico, di uno Studio di Medicina e Arti, e sarà veramente un tratto originale e distintivo della filosofia che si insegna a Bologna e in Italia. Parallelo, ma autonomo, è il discorso che farà Pietro d’Abano, che insegna medicina, filosofia e astrologia a Padova.
I «modi di filosofare» di questi maestri sono ricostruiti, in modo eccellente, in un capitolo di Fioravanti, che è uno dei maggiori studiosi europei di filosofia medievale: basti ricordare il prezioso commento al Convivio da lui curato, nel 2014, per «I meridiani». In primo piano sono i testi che questi filosofi hanno lasciato - come i commemti al De anima aristotelico di Taddeo da Parma, di Matteo da Gubbio, di Giacomo da Piacenza - e questioni che privilegiano i temi della metafisica e della filosofia naturale (fisica, biologia, psicologia).
Il metodo è quello della «quaestio», che vede nel confronto tra tesi contrapposte la via più sicura per la ricerca della verità da parte dei maestri e anche l’esercizio più utile per l’apprendimento da parte degli studenti. I bolognesi conoscono a fondo i testi della tradizione aristotelica, ma anche le opere dei più famosi maestri parigini: Alberto Magno, Tommaso d’Aquino, Boezio di Dacia, Sigieri di Brabante, Giovanni di Jandun.
Il legame con Parigi è dunque ancora una volta decisivo per l’operare di questi filosofi, così come lo era stato all’origine della loro storia. Due grandi temi, per l’importanza che rivestono in ambito metafisico ed epistemologico, sono al centro della ricerca: il primo riguarda l’esistenza o meno del caso e della libertà in un mondo in cui, filosoficamente parlando, ogni effetto sembra derivare necessariamente da una concatenazione di cause; il secondo riguarda l’intelletto, la sua natura e la sua attività.
Il problema dell’intelletto è cruciale, perché coinvolge il tema dell’immortalità dell’anima. Per i maestri bolognesi, che seguono Aristotele e Averroè e sfidano l’ortodossia, solo il pensiero «collettivo» è immortale: «L’intelletto ha un rapporto di appropriazione con la specie umana nel suo insieme e così, quando un individuo è morto, esso continua ad agire in un altro individuo, ma rispetto a chi è morto esso cessa totalmente di agire» (Giacomo da Piacenza).
La riflessione politica
La Parte seconda del libro - «Contesti, temi, figure» - volge lo sguardo a quanto accade intorno e al di fuori dello Studio bolognese. I capitoli riguardano Aristotele e la riflessione politica in Italia nel primo Trecento, dove spicca la figura di Marsilio da Padova (Roberto Lambertini), i volgarizzamenti filosofici, con un sottile confronto tra la Nicomachea di Taddeo Alderotti, fedele all’equivalenza concettuale e lessicale dei traduttori latini di Aristotele, e la soluzione, più superficiale e livellante, di Brunetto Latini nel secondo libro del Trésor (Sonia Gentili) e, a chiudere bene il volume, il Convivio di Dante (Paolo Falzone) e Petrarca e la filosofia (ancora Gentili). Dante affronta, con il Convivio, la grande sfida di fare filosofia in volgare e l’abbandono dell’opera, per Falzone, non è dovuto a un’improvvisa sfiducia nei confronti della filosofia, come si è sostenuto, ma dall’emergere del problema dell’Impero universale.
La cultura filosofica dantesca mantiene tenacemente, anche nella Commedia, un fondo aristotelico e la difesa della felicità umana in questa vita muove dall’idea, scolpita nell’adagio aristotelico «la natura non fa nulla invano» (natura nihil facit frustra) che il cosmo sia regolato da un principio di «pienezza». Ritroviamo qui lo spirito di alcuni maestri della Facoltà delle Arti di Parigi, che difendono l’idea di una perfezione naturale conseguibile nella vita terrena attraverso la filosofia.
Petrarca contrappone invece all’uomo come animale razionale e politico del pensiero aristotelico, decostruito radicalmente con l’arma dell’ironia e del paradosso, la dimensione morale della tradizione agostiniana, la via della vita solitaria, la saggezza della spiritualità individuale. Le sue guide sono Cicerone, Seneca, Agostino: l’unica forma di governo delle passioni consiste nella loro repressione.
Diversissima, anche qui, la scelta di Dante, che, per il primato aristotelico dell’intelletto sulla volontà vede come possibile un termine medio tra le pulsioni dell’anima sensitiva e la volontà, che crede nella capacità del libero giudizio di conformarsi a ciò che la ragione ha deliberato. È la scelta della «virtù che consiglia».
-
> LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE, E IL VATICANO CON IL SUO TRADIZIONALE SOFISMA --- “Ho le chiavi del paradiso”. "Due chiavi" e il capo dei clavigeri (di Paolo Rodari)30 gennaio 2017, di Federico La Sala
"Due chiavi" e il capo dei clavigeri
 "DUE SOLI" IN TERRA, E UN SOLO SOLE IN CIELO: "TRE SOLI". GENERE UMANO: I SOGGETTI SONO DUE, E TUTTO E’ DA RIPENSARE!!! NON SOLO SUL PIANO TEOLOGICO-POLITICO, MA ANCHE ... ANTROPOLOGICO!!!
"DUE SOLI" IN TERRA, E UN SOLO SOLE IN CIELO: "TRE SOLI". GENERE UMANO: I SOGGETTI SONO DUE, E TUTTO E’ DA RIPENSARE!!! NON SOLO SUL PIANO TEOLOGICO-POLITICO, MA ANCHE ... ANTROPOLOGICO!!!- MICHELANGELO E LA SISTINA (1512-2012). I PROFETI INSIEME ALLE SIBILLE PER LA CHIESA UN GROSSO PROBLEMA ....
- DOPO 500 ANNI, PER IL CARDINALE RAVASI LA PRESENZA DELLE SIBILLE NELLA SISTINA E’ ANCORA L’ELEMENTO PIU’ CURIOSO.
L’uomo che apre le porte dei capolavori vaticani: “Ho le chiavi del paradiso”
Gianni Crea è il capo dei clavigeri dei musei della Santa sede. "Ogni mattina, quando entro nella Cappella Sistina, mi sento un privilegiato"
di PAOLO RODARI (la Repubblica, 29 gennaio 2017)
CITTÀ DEL VATICANO. "L’alba è il momento più magico. Entro nel bunker che custodisce le 2797 chiavi dei musei vaticani. Quando non ci sono gli addetti della sagrestia pontificia, tocca a me prelevare l’unica chiave che non ha numero né copie. È un modello antico come la porta che apre, quella della Cappella Sistina. Giro la serratura della Cappella, quella stessa che sigilla i cardinali in conclave, per pochi istanti mi sento investito da una meraviglia che non è facile spiegare. M’inginocchio, mi segno, e dico una preghiera in solitudine. Chiedo che tutti i visitatori che di lì a poco entreranno possano provare il medesimo stupore. Sono un privilegiato, ne sono consapevole. E so che di questo privilegio devo esserne sempre degno".
Gianni Crea, 45 anni, romano ma originario di Melito di Porto Salvo, in provincia diReggio Calabria, è capo clavigero dei musei vaticani. In sostanza, ha il compito di aprire e chiudere tutte le porte e le finestre, 500 in tutto, 300 del percorso dei visitatori e 200 dei vari laboratori collegati. A vent’anni il parroco della chiesa che frequentava sulla via Appia gli chiese se voleva lavorare nella basilica vaticana come custode ausiliario. La Fabbrica di San Pietro in cambio avrebbe contribuito ai suoi studi. Accettò.
Qualche anno dopo, giovane studente di giurisprudenza con il sogno di diventare magistrato, partecipò a un concorso per diventare a tutti gli effetti custode. Per un anno lo osservarono, per valutare se fosse idoneo: puntualità, discrezione e serietà le principali doti richieste. Venne preso: "Da adesso - gli dissero - devi sempre ricordare dove ti trovi. Lavori nel centro della cristianità. I dieci comandamenti devono diventare il tuo secondo vestito". Una richiesta "non da poco", dice. "Tuttavia sono contento di non disattenderla".
Più immaginifica fu, invece, la consegna che gli fece Antonio Paolucci, fino a poche settimane fa direttore dei musei, quando da semplice clavigero venne nominato capo. "Adesso sei tu ad avere simbolicamente in mano le porte del Paradiso", gli disse per fargli comprendere la responsabilità a cui era chiamato. Con lui, infatti, collaborano altri dieci clavigeri che si dividono il lavoro in due turni, una metà dalle 5.30 del mattino alle due del pomeriggio. Gli altri fino a sera tardi. "Da quel momento il Vaticano è diventata la mia seconda casa - dice - Conosco le chiavi come le mie tasche. Ogni porta apre un mondo per me e per tutti i clavigeri familiare. Dietro ogni porta c’è un odore particolare, un profumo, riconoscibile soltanto da noi".
L’apertura e la chiusura di porte e finestre sono momenti entrambi delicati. Alle 5.30 la Gendarmeria di Porta Sant’Anna toglie l’allarme e il clavigero di turno procede con un lungo giro che dura quasi un’ora e mezzo. Dopo ogni apertura c’è il controllo che ogni cosa sia in ordine. "Se ad esempio si rompe un tubo dell’acqua - racconta - spesso tocca a me chiamare l’idraulico". Negli ultimi anni i visitatori dei musei sono parecchio aumentati, 28mila le sole presenze giornaliere in Sistina. Tutto deve essere perfetto. "Ma anche la chiusura non è facile. Bisogna controllare che nessuno rimanga all’interno. Gli imprevisti sono sempre possibili. Una sera chiudemmo tutto e di colpo suonò l’allarme. Accorremmo nella stanza nella quale veniva segnalata una presenza. Per fortuna era soltanto un passerotto rimasto dentro".
Il clavigero è l’erede delle chiavi del Maresciallo del Conclave, colui che fino al 1966 doveva sigillare le porte intorno alla Cappella quando i cardinali si riunivano per eleggere il Pontefice. La sua chiave non è l’unica a essere preziosa: c’è, ad esempio, la chiave numero 1, quella che apre il portone monumentale su viale Vaticano, che oggi è il portone d’uscita dei visitatori dei musei.
 E poi c’è la 401, una delle più antiche: apre il portone d’entrata dei musei e pesa mezzo chilo. "Due chiavi decussate, cioè incrociate a X, appaiono negli stemmi ed emblemi dei papi - scrive Tiziana Lupi su "Il mio Papa" - Sono una d’oro (potere spirituale) e una d’argento (potere temporale); hanno i congegni traforati a croce e sono unite da un cordone, simbolo del legame tra i due poteri ". I musei sono divisi in quattro aree. Ad ogni area corrispondono dei numeri a cui le chiavi si riferiscono. Le chiavi con il numero 100 sono del museo etnologico, quelle col 200 sono del Gregoriano, eccetera...
E poi c’è la 401, una delle più antiche: apre il portone d’entrata dei musei e pesa mezzo chilo. "Due chiavi decussate, cioè incrociate a X, appaiono negli stemmi ed emblemi dei papi - scrive Tiziana Lupi su "Il mio Papa" - Sono una d’oro (potere spirituale) e una d’argento (potere temporale); hanno i congegni traforati a croce e sono unite da un cordone, simbolo del legame tra i due poteri ". I musei sono divisi in quattro aree. Ad ogni area corrispondono dei numeri a cui le chiavi si riferiscono. Le chiavi con il numero 100 sono del museo etnologico, quelle col 200 sono del Gregoriano, eccetera..."La gioia più grande in questi anni - dice ancora Crea - l’ho avuta pochi anni fa. Prima che morisse mia madre ha potuto assistere a una messa del mattino a Casa Santa Marta. Ha ricevuto una carezza dal Papa. Un piccolo gesto che per me ha significato molto".
-
> LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE, E IL VATICANO CON IL SUO TRADIZIONALE SOFISMA -- A lezione di politica dal professor Dante (di Massimo Cacciari)6 novembre 2016, di Federico La Sala
Con il trattato sulla “Monarchia” l’autore della “Divina Commedia” rompe con la tradizione medievale. Ma difende la natura sacrale dell’impero
A lezione di politica dal professor Dante
di Massimo Cacciari (la Repubblica, 06.11.2016)
L’edizione del Monarchia di Dante, a cura di Paolo Chiesa e Andrea Tabarroni, recentemente pubblicata come quarto volume della nuova edizione commentata delle Opere, coordinata da Enrico Malato, non si segnala soltanto per la ricchezza di note e apparati, per alcuni interventi migliorativi del testo-base, per l’ampia introduzione generale e quelle, essenziali, alle singole parti del volume, ma anche per la presenza di alcuni importantissimi “documenti” riguardanti la fortuna dello scritto dantesco, tra i quali il De reprobatione di Guido Vernani, radicale e filosoficamente nient’affatto sprovveduto attacco al Monarchia da parte del frate domenicano; il Commentarium al Monarchia di Cola di Rienzo, testimonianza della sua passione per la gloria di Roma, di un “culto” che Dante definisce nella sua portata teorica e da lì, anche proprio attraverso Cola, trapassa nell’Umanesimo; infine il “volgarizzamento” del Monarchia, steso dal grande Ficino, alla fine degli anni ’60 del ‘400, non solo in funzione antirepubblicana, ma per rivendicare Dante alla pia philosophia e cioè alla “catena aurea” del platonismo. Interpretazioni o “fra-intendimenti” diversissimi, che non nascono soltanto dalle posizioni spesso incompatibili dei loro autori, ma proprio dalla novità e complessità dell’opera di Dante, soprattutto se letta insieme alla Commedia (come appare necessario fare, poiché certamente essa viene scritta in anni nei quali Dante è già tutto immerso, mente e cuore, nella stesura del poema).
Della sua novità Dante è “superbamente” consapevole - e così dello scandalo che essa è destinata a suscitare. Malgrado le numerose citazioni da Agostino, riguardanti essenzialmente questioni intorno al metodo dell’esegesi, Dante non poteva non avvertire l’abisso tra la sua concezione della civitas hominis, la sua idea di Roma e di Impero, e quelle dell’intera tradizione patristica e dello stesso “aristotelismo” tomista. Da remedium o addirittura semplice solacium per l’infermità della nostra natura vulnerata dal peccato, in Dante l’Impero (e cioè la forma provvidenzialmente destinata a unire politicamente il genere umano), la cui idea stessa viene da lui proposta in termini puramente filosofico-scientifici, esclusivamente per philosophica documenta, è chiamato a assicurare autentica felicità terrena, a edificare l’autentico Paradiso terrestre. Da Babilonia, quale era per Agostino, Roma si trasforma in Roma celeste!
Ma nella Commedia questo Fine appare davvero ancora garantito dall’opera del solo Impero, nella razionale autonomia della sua forma? Questo l’enigma, su cui Chiesa e Tabarroni invitano ancora a riflettere. Virgilio, la prima guida di Dante, si arresta alla soglia del Paradiso terrestre, non vi entra e tantomeno potrebbe spiegarne i simboli; stupisce e basta sullo spettacolo che gli si rivela. È Beatrice a “far entrare” il poeta, e solo dopo che egli ha bevuto tutto l’amaro calice della confessione e del pentimento.
L’architettura della Commedia, nei nessi costitutivi rappresentati dalle guide del poeta, segna una profonda discontinuità con quella del Convivio e del Monarchia. Come spiegarla? Amara delusione e disincanto dopo il fallimento delle ultime speranze, che ancora avrebbero animato l’opera politica? Ma il Monarchia è tutto fuorché uno scritto “militante”; provvidenziale appare a Dante il corso della storia, ed egli vuol esserne il profeta. In questo schema è inserita la gloria di Roma, modello di perfetto potere politico, di Impero. Ma è la forza ideal-eterna di questo disegno che finisce col rendere contraddittorio il famoso simbolo dei due Soli, Chiesa e Impero, perfettamente distinti nei rispettivi domini e nelle rispettive missioni. Se, infatti, il perfetto potere politico è concepibile soltanto in quanto voluto ab origine dal Signore, in quanto provvidenziale nel senso più proprio e più forte, la felicitas che esso promette è necessariamente subordinata a quella ultima, alla beatitudo celeste.
E sembra essere questa, alla fine, l’indicazione che emerge dalla Commedia. Dante rompe definitivamente con la teologia politica patristica e medievale, ma non è affatto anacronisticamente leggibile nel senso di Marsilio da Padova e della filosofia politica moderna successiva. L’Impero di Dante non sono i regna, o ormai potremmo dire gli Stati, che ha in mente Marsilio. Dante segna la grandiosa soglia tra due epoche - quella di un’idea del Politico che, pur nel rivendicare la propria razionale autonomia, lotta per non perdere ogni fondamento sacrale, e quella che ne risolve il significato e la missione nella immanente potenza delle sue leggi, nella positività del suo diritto. Per quest’ultima, che il Giustiniano imperatore di Dante trovi posto, e vera pace, solo in Paradiso diverrà il simbolo di un’epoca per sempre tramontata.
-
> LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE, E IL VATICANO CON IL SUO TRADIZIONALE SOFISMA -- Papa Francesco istituirà una Commissione di studio sul diaconato femminile nella Chiesa primitiva.12 maggio 2016, di Federico La Sala
- CREATIVITA’: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETA’ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
Donne nella Chiesa, il Papa apre al diaconato femminile *
- E’ il primo grado dell’ordine sacro, seguito dal sacerdozio e dall’episcopato. I diaconi possono amministrare alcuni sacramenti come battesimo e matrimonio. Bocciata da Giovanni Paolo II, la possibilità prefigurata da Francesco avvicinerebbe la Chiesa Cattolica a quella anglicana che ha donne preti e vescovi. Uno "spazio aperto", così come l’avrebbe voluto il cardinal Martini
Papa Francesco ha annunciato che istituirà una Commissione di studio sul diaconato femminile nella Chiesa primitiva ritenendo che le donne diacone sono "una possibilità per oggi".
Se all’annuncio seguirà una decisione, per la prima volta in questo millennio si riaprirà una prospettiva che era considerata definitivamente chiusa da una decisione di Giovanni Paolo II. Il diaconato, infatti, è il primo grado dell’ordine sacro, seguito dal sacerdozio e dall’episcopato. I diaconi possono amministrare alcuni sacramenti tra i quali il battesimo e il matrimonio e in alcuni paesi ci sono intere regioni nelle quali sostituiscono ormai i sacerdoti nella guida delle comunità parrocchiali.
L’apertura prefigurata da Francesco avvicinerebbe la Chiesa Cattolica a quella anglicana dove ci sono donne preti e vescovi. Al Sinodo si era parlato di questo "tema audace" con l’intervento del reverendo Jeremias Schroder, arciabate presidente della Congregazione benedettina di Sant’Ottilia.
"Sul diaconato femminile la Chiesa non ha detto no", aveva spiegato già nel 1994 il cardinale Carlo Maria Martini, commentando lo stop di Giovanni Paolo II alle donne prete: una dichiarazione solenne, ad un passo dai crismi dell’infallibilità pontificia ed alla quale Papa Francesco ha detto più volte di volersi attenere.
Malgrado quel "no", per il porporato c’erano però ancora "spazi aperti", perchè il discorso sul ruolo della donna avrebbe potuto continuare a partire dal diaconato, "che il documento non menziona, quindi non esclude". Questo perchè, avvertiva il cardinale, occorre evitare che l’ecumenismo si blocchi proprio sul tema delle donne. Il diaconato è il primo grado di consacrazione "ufficiale" che precede l’ ammissione al sacerdozio e nelle prime comunità cristiane era aperto anche alle donne. Per Martini, dunque, non sarebbe stato male riaprire anche alle donne, pur ammettendo che sul sacerdozio femminile "il documento papale è decisivo, non ammette replica, nè riformabilità".
"Tuttavia credo che il vero compito di fronte a questa lettera - aveva osservato il cardinale - non è l’ esegesi puntigliosa dal punto di vista dogmatico, ma è vedere come, con questa lettera e malgrado le difficoltà che potrà suscitare, è ancora possibile sia un cammino di dialogo ecumenico, sia soprattutto un cammino in cui mostrare presenza e missione della donna a tutto campo. Rispetto a un documento di questo tipo, che sembra chiudere una via, come già altri in passato, mentre in realtà hanno favorito un ripensamento teologico e pratico che ha fatto superare certi scogli e ha fatto comprender meglio la natura e la forza della presenza della donna nella Chiesa, io penso che uno spazio rimanga aperto".
Di fatto il principale argomento per il "no" al sacerdozio femminile è infatti l’assenza delle donne nel cenacolo al momento dell’istituzione dell’Eucaristia. Ma una recente decisione di Papa Francesco già lo "smontava" in parte: quella sull’ammissione delle donne alla Lavanda dei piedi che il Papa aveva già attuato nel primo giovedì santo del suo Pontificato, quando andando al carcere minorile di Casal del Marmo, decise che quel giorno anche le ragazze potessero partecipare come protagoniste al rito della Lavanda dei piedi, diventa quest’anno una possibilità per tutte le parrocchie del mondo.
E’ significativo che Papa Francesco abbia scelto l’incontro di oggi nell’Aula Nervi con circa 900 superiore generali degli istituti religiosi femminili per affrontare questo tema così decisivo. Le religiose gli hanno chiesto, nel corso di una sessione di domande e risposte perchè la Chiesa esclude le donne dal servire come diaconi.
E una ha aggiunto "Perchè non costruire una commissione ufficiale che potrebbe studiare la domanda?". Il papa ha risposto che aveva parlato della questione una volta qualche anno fa con un "buon, saggio professore", che aveva studiato l’uso delle diaconesse nei primi secoli della Chiesa e gli ha aveva detto che ancora non è del tutto chiaro quale ruolo avessero. E soprattutto se "avevano l’ordinazione o no? "E’ rimasto un pò oscuro quale fossero ruolo e statuto delle diaconesse in quel momento". Costituire una commissione ufficiale potrebbe studiare la questione?", si è chiesto il Papa ad alta voce. E poi si è risposto: "Credo di sì. Sarebbe fare il bene della Chiesa di chiarire questo punto. Sono d’accordo. Io parlerò per fare qualcosa di simile. Accetto la proposta. Sembra utile per me avere una commissione che chiarisca bene".
-
> LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE, E --- ARISTOTELE "FATTO VOLGARE". Per l’Unesco, Il 2016 è l’anno di Aristotele (di Dorella Cianci).14 febbraio 2016, di Federico La Sala
I 2400 anni del filosofo
Aristotele uomo dell’anno
di Dorella Cianci (Il Sole-24 Ore, Domenica, 14.02.2016)
- Aristotele fatto volgare. Tradizione aristotelica e cultura volgare nel Rinascimento, a cura di David Lines ed Eugenio Refini, Ets edizioni, Pisa 2015, pp. 357, €35.Info sui 2400 anni di Aristotele : http://aristotleworldcongress2016.web.auth.gr/?q=en
Il 2016 per l’Unesco è l’anno di Aristotele e già si annunciano iniziative nel mondo, fra cui spicca quella dell’Università di Salonicco, che terrà un grande convegno in Maggio. Com’è noto Aristotele è stato ed è un pilastro della cultura occidentale che si è consolidato lungo il Medioevo,soprattutto per l’aspetto etico e religioso, ma anche per tutto il Rinascimento, divenendo un autore canonico nella formazione pedagogica. Nonostante il ritorno di Platone nel Quattrocento, lo Stagirita non perse mai, per i giovani di diverse epoche, il ruolo di richiamo alla scienza, ma anche alle possibilità dell’uomo, poiché aveva inquadrato il suo punto di vista sulla terra, togliendolo esclusivamente a una dimensione celeste.
A differenza di Platone, Aristotele aveva compreso che l’educabilità dell’uomo sente spesso l’esigenza di confrontarsi con il tribunale della realtà, senza dover necessariamente delegare tutto al cielo ed è qui che nasce il concetto del “guardando s’impara” teorizzato nella Poetica, perché - per il filosofo - più degli insegnamenti è opportuno affidarsi alla consuetudine.
Nel volume Aristotele fatto volgare, a cura di David Lines (University of Warwick) e Eugenio Refini (John Hopkins University), pubblicato nella collana diretta da Claudio Ciociola e scaturito da un convegno tenutosi nella Normale di Pisa, è riportato un passo della Prefazione dell’Etica Nicomachea nella tradizione latina medievale di Concetto Marchesi dove si comprende la centralità di Aristotele per la storia: «La storia dell’aristotelismo è ancora da farsi: e sarà una storia grandiosa. Ricercare le vie per cui il pensiero umano si lasciò condurre nella successione di molti secoli è rivelare la genesi, lo sviluppo, la lotta giovanile e il trionfo finale di una civiltà nova che procede alla conquiste del vero» (1904).
Magistrali si rivelano, anche oggi, le parole di Garin sul ritorno dei filosofi antichi inteso come il ritorno di un mondo mai scomparso e resistente ai soprassalti del tempo, allora come oggi. Il ritorno dell’antico non è una curiosità da musealizzare, non è un surplus del sapere da utilizzare a effetto, ma è un corredo genetico che di autore in autore porta alla riconquista delle origini.
Veniamo dunque alla peculiarità di Aristotele, tanto da dover pensare di dedicare proprio a lui l’anno in corso, nonostante i trend interpretativi della società contemporanea ci appaiano molto diversi. Già nel nono, nel dodicesimo e nel tredicesimo secolo, le traduzioni si occuparono sempre più di Aristotele, non di Platone e, pian piano, dall’Aristotele “morale”si passò all’Aristotele “logico” della Poetica, figlio dei tempi moderni, maestro nel vero, inventore di ogni riflessioni scientifica sul teatro teorico di ogni produzione artistica.
L’anno di Aristotele ci invita ad alcune riflessioni incardinate sull’importanza delle azioni più che dei tipi umani (i caratteri). Aristotele è stato il primo a teorizzare l’ineluttabilità: ciò che accade deve accadere. Quando si parla del dolore però per l’uomo, nella tragedia come nella vita, è consigliabile mettersi a guardare, imparando dal dolore (proprio e altrui), ma di certo l’azione non si può bloccare, né si può intervenire sull’evento.
L’ineluttabilità tuttavia non vuol dire lasciarsi trasportare senza agire. L’agire umano è sorretto dal volere, poiché, nella tragedia e nella vita, i personaggi assumono dignità più dell’autore. L’autore lentamente scompare e l’azione dei personaggi è protagonista sulla scena, senza il bisogno di scusarsi delle nefandezze compiute, poiché Aristotele ci insegna che l’uomo può scegliere di compiere azioni terribili, anche quando è stato educato al bene. Come ha affermato Taplin nel 1996 le azioni tragiche non hanno bisogno della «parabasi», come accade nella commedia, cioè le azioni terribili non hanno bisogno di un’apologia, poiché è nella natura umana l’ineluttabilità del eventi peggiori. Siamo personaggi in cerca di autore? No. Siamo personaggi il cui autore è un doppiatore, dove il venticello dell’ineluttabilità ci passa accanto, ma l’azione ha il centro della scena.
Aristotele è il maestro di Pirandello e anche di Borges nelle sue riflessioni sull’autore-doppiatore. Non è un caso che maschera e volto, nel mondo greco, siano la stessa parola, poiché entrambi costituiscono ciò che “offriamo agli altri” tramite la vista. Siamo maschere non “addomesticate” dall’autore, né lo cerchiamo; sappiamo che egli esiste e doppia le nostre stesse azioni. Per capire questo è interessante una miniatura di un codice Vaticano Urbinate 355 dell’Hercules furens di Seneca,conservato nella Biblioteca Vaticana, dove ci sono sopra i personaggi, sotto il coro e in un cantuccio l’autore che legge, anzi doppia ciò che accade in un modo senza «parabasi», in un mondo senza giustificazioni.
-
> LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE, E IL VATICANO --- IL RISCATTO DELL’ANIMA (di Peter Brown). La via della Chiesa ai grandi possedimenti ecclesiastici e alla comparsa del purgatorio (di Marco Rizzi)7 febbraio 2016, di Federico La Sala
- L’EUROPA, IL CRISTIANESIMO ("DEUS CHARITAS EST"), E IL CATTOLICESIMO COSTANTINIANO ("DEUS CARITAS EST").Una storia di lunga durata... :
L’aldilà «democratico» che fece della Chiesa una potenza economica
di Marco Rizzi (Corriere della Sera, La Lettura, 07.02.2016)
Verso la fine del VII secolo, il vescovo di Toledo, Giuliano, compilò una vasta antologia di testi degli antichi Padri della Chiesa latina sul destino dell’anima dopo la morte. Il suo intento era confortare un amico malato, Idalio vescovo di Barcellona, che sentiva prossimo l’arrivo della fine. Nei fatti, il Prognosticon futuri saeculi , che si traduce con «Preannuncio del mondo che verrà», divenne uno dei testi più conosciuti e diffusi nel Medioevo.
Raccogliendo pagine dagli scritti di Cipriano, vescovo di Cartagine alla metà del III secolo, di Agostino, di Gregorio Magno e di altri ancora, Giuliano di Toledo si sforza di offrire risposte coerenti alle domande che angosciavano i cristiani dei suoi giorni: cosa accade all’anima quando si muore? Le anime dei defunti rimangono in rapporto con le cose di questo mondo? E soprattutto, cosa accade nel lungo intervallo di tempo che separa il momento della morte individuale dal giorno, terribile ma ancora lontano, del Giudizio universale, quando si consumerà il destino irreversibile di ciascuno e l’anima sarà restituita al corpo rigenerato per la beatitudine o la condanna eterna?
Proprio dall’antologia di Giuliano (che si può leggere nella recente traduzione di Tommaso Stancati per l’Editrice Domenicana Italiana di Napoli) prende avvio il saggio di Peter Brown Il riscatto dell’anima (Einaudi), che ripercorre il formarsi dell’immaginario escatologico del cristianesimo occidentale tra il III e il VII secolo, assumendo però un punto di vista particolare: quello del rapporto tra le ricchezze di quaggiù e il destino delle anime di lassù, se si vogliono utilizzare le parole di Gesù che, nel Vangelo di Luca, ammonisce a vendere ciò che si possiede e darlo in elemosina per costruire un tesoro nei cieli.
Nel mondo antico, la gloria dell’immortalità era riservata solo a pochi spiriti eletti, i filosofi, i grandi legislatori, gli eroi; la morte non cancellava, anzi in qualche misura ribadiva, la gerarchia sociale presente sulla Terra. Il cristianesimo introduce invece quella che Brown definisce una «democrazia delle anime», anzitutto riconoscendo a ciascun uomo, a prescindere dalla sua condizione, una propria natura spirituale, testimoniata appunto dall’anima individuale; poi, assegnandole la possibilità di guadagnarsi la salvezza e conseguire così l’immortalità.
Se nei primi tre secoli la condizione di marginalità o addirittura di persecuzione rendeva la scelta stessa di essere cristiani meritevole della ricompensa celeste nel giorno del Giudizio, o addirittura nel caso dei martiri nel momento stesso della morte, a partire dal IV secolo il problema inizia a porsi in termini profondamente diversi. Agostino non si preoccupa di chi è veramente buono (i martiri e i santi) o di chi è intrinsecamente malvagio: i primi godranno del paradiso, i secondi sono destinati all’inferno. Ma che dire di coloro che non sono né abbastanza buoni, né abbastanza cattivi, ovvero della grande maggioranza dei cristiani comuni? Come potranno purificarsi dai loro peccati, una volta defunti e in attesa del Giudizio?
Proprio intorno a interrogativi del genere si determina un significativo cambiamento nell’uso cristiano della ricchezza. Fino a questo momento, l’elemosina elargita ai poveri serviva al credente per obbedire al comando di Gesù e prepararsi un posto in cielo. Ora, invece, l’anima del defunto resta bisognosa anche nell’aldilà: beneficare i poveri sulla Terra contribuisce a riscattare le anime nei cieli.
 Così la Chiesa assume un ruolo centrale nella gestione della ricchezza, a mezzo tra cielo e terra. I beni offerti per il sostentamento degli indigenti o per l’edificazione degli edifici di culto rappresentano una sorta di cambiale che il donatore, ricco o meno che sia, potrà incassare dopo la sua morte sotto forma di preghiere e di intercessioni; a sua volta, la Chiesa si fa garante della conservazione e del corretto uso dei beni ricevuti, che divengono un vero «patrimonio dei poveri».
Così la Chiesa assume un ruolo centrale nella gestione della ricchezza, a mezzo tra cielo e terra. I beni offerti per il sostentamento degli indigenti o per l’edificazione degli edifici di culto rappresentano una sorta di cambiale che il donatore, ricco o meno che sia, potrà incassare dopo la sua morte sotto forma di preghiere e di intercessioni; a sua volta, la Chiesa si fa garante della conservazione e del corretto uso dei beni ricevuti, che divengono un vero «patrimonio dei poveri».Naturalmente in questo processo si intrecciano in forma tutt’altro che lineare dibattiti teologici, mutamenti culturali, trasformazioni sociali. Ancora alla fine del VI secolo, l’idea antica secondo cui l’immortalità era riservata alle anime elette, questa volta però martiri e santi, riemergeva nelle parole di un membro del clero di Tours secondo cui nel caso dei peccatori - ovvero della stragrande maggioranza dei cristiani - andavano prese alla lettera le parole rivolte da Dio ad Adamo: «Polvere sei e polvere ritornerai». Nessuna offerta, nessuna preghiera poteva redimere le anime comuni. Ma era ormai aperta la strada che avrebbe portato ai grandi possedimenti ecclesiastici, alla comparsa del purgatorio, nella seconda metà del XII secolo, e «alla somma Divina Commedia di Dante Alighieri» - conclude Brown.
-
> LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE, E IL VATICANO CON IL SUO TRADIZIONALE SOFISMA DELLA "FALLACIA ACCIDENTIS". --- LA VIA DEI TRE SOLI.22 gennaio 2016, di Federico La Sala
IL PROBLEMA DELL’UNO E LA VIA DEI "TRE SOLI". NOTE PER LA CRITICA DELLA FACOLTA’ DI GIUDIZIO E DELLA CREATIVITA’ DELL’ "UOMO SUPREMO":
NUOVO REALISMO: LA LEZIONE DI DANTE, OGGI. CONOSCERE SE STESSI E CHIARIRSI LE IDEE, PER CARITA’!
"ANDRAGATHIA" (’NDRANGHETA). IL MONDO COME VOLONTA’ E RAPPRESENTAZIONE DEL MACROANTROPO ("UOMO SUPREMO", "SUPERUOMO", "DOMINUS IESUS"): FILOSOFIA, E TEOLOGIA POLITICA DELLA’ "ANDRO-POLOGIA" ATEA E DEVOTA.... LA RISATA DI KANT.
CREATIVITA’: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETA’ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE.
-
> LA "MONARCHIA" --- Cesare, eroe della Commedia. Uno studio di Canfora sulla biblioteca latina di Dante (di Carlo Ossola)17 gennaio 2016, di Federico La Sala
Studi danteschi
Cesare, eroe della Commedia
Nel poema la storia di Roma è concepita unitariamente: la fase repubblicana prepara l’impero, completando il disegno divino. -Uno studio di Luciano Canfora sulla biblioteca latina del poeta
di Carlo Ossola (Il Sole-24 Ore, Domenica, 17.01.2016)
- Luciano Canfora, Gli occhi di Cesare. La biblioteca latina di Dante , Salerno Editore, Roma, pagg. 104, € 8,90
«I’ vidi Eletra con molti compagni, / tra ’ quai conobbi Ettòr ed Enea, / Cesare armato con li occhi grifagni» (Inf., IV, 121-123): occhi grifagni poiché - come vuole il Buti e ricorda Luciano Canfora - sono «alla guatatura spaventevole ad altrui». Non tanto dunque occhi «rossi come fuoco» (secondo il Tesoro di Brunetto Latini), ma piuttosto di «aspectus terribilis» (Bambaglioli).
E qui Canfora convoca un altro scenario, non quello del «nobile castello» dei «savi» della classicità, bensì quello manzoniano dei bravi che attendono Renzo sulla soglia dell’osteria: «Quando Renzo e i due compagni giunsero all’osteria, vi trovaron quel tale già piantato in sentinella, che ingombrava mezzo il vano della porta, appoggiata con la schiena a uno stipite, con le braccia incrociate sul petto; e guardava e riguardava, a destra e a sinistra, facendo lampeggiare ora il bianco, ora il nero di due occhi grifagni» (I promessi sposi, cap. VII).
Il ricordo dantesco in Manzoni, ricondotto dallo sguardo del grande stratega al ceffo della plebaglia del malaffare, potrebbe ricalcare l’intento di piegare i potenti tutti - come il Napoleone del Cinque maggio - al «disonor del Golgota»; ma è da notare, come è stato proposto, che allorquando egli deve mettere in scena il fulmineo agire di quel grande («Dall’Alpi alle Piramidi...»), altro non possa fare che ricorrere (e questa volta su un registro ben alto) al Cesare di Dante: «Maria corse con fretta a la montagna; / e Cesare, per soggiogare Ilerda, / punse Marsilia e poi corse in Ispagna» (Purg., XVIII, 100-102).
Ben più di Manzoni, è Dante qui a collocare il modello di Cesare accanto a quello di Maria che s’affretta presso Elisabetta: come se quella “ansia di compimento” fosse propria della salvezza temporale e di quella eterna, congiunte ab origine in uno stesso disegno provvidenziale, secondo il testo del Convivio: «E però che ne la sua venuta nel mondo, non solamente lo cielo, ma la terra convenia essere in ottima disposizione; e la ottima disposizione de la terra sia quando ella è monarchia, cioè tutta ad uno principe, come detto è di sopra; ordinato fu per lo divino provedimento quello popolo e quella cittade che ciò dovea compiere, cioè la gloriosa Roma» (IV, V, 4).
Il mito di Cesare, nella Commedia, è tutt’uno con l’unità armonica della venuta salvifica, che fu al tempo del Cristo e che ora non si può che compiangere: «Vieni a veder la tua Roma che piagne / vedova e sola, e dì e notte chiama: / “Cesare mio, perché non m’accompagne?”» (Purg., VI, 112-114).
L’interrogazione finale ricapitola del resto la visione politica che Dante enuncia nitidamente poche terzine sopra: «Ahi gente che dovresti esser devota, / e lasciar seder Cesare in la sella, / se beni intendi ciò che Dio ti nota» (Purg., VI, 91-93). Qui Dante si riferisce certo a Matteo, 22, 21: «Reddite ergo quae sunt Caesaris, Caesari; et quae sunt Dei, Deo»; ma c’è di più: e cioè che la translatio fidei da Gerusalemme a Roma fu fatta per armonizzare e non per sovrapporre o perché la nuova Gerusalemme dovesse assorbire l’antica Roma.
 Ecco perché il modello e il mito di Cesare (eponimo ora di quello dell’Impero) attraversa tutta la Commedia e si suggella nei celebri versi del Paradiso: «Poi, presso al tempo che tutto ’l ciel volle / redur lo mondo a suo modo sereno, / Cesare per voler di Roma il tolle» (Par., VI, 55-57). È l’inizio dell’epico prorompere della storia e delle vittorie di Cesare (Par., VI, 55-81), ricapitolazione mirabile di molte imprese e di una vita che ancora sarà modello al Napoleone del Manzoni: «Da indi scese folgorando a Iuba».
Ecco perché il modello e il mito di Cesare (eponimo ora di quello dell’Impero) attraversa tutta la Commedia e si suggella nei celebri versi del Paradiso: «Poi, presso al tempo che tutto ’l ciel volle / redur lo mondo a suo modo sereno, / Cesare per voler di Roma il tolle» (Par., VI, 55-57). È l’inizio dell’epico prorompere della storia e delle vittorie di Cesare (Par., VI, 55-81), ricapitolazione mirabile di molte imprese e di una vita che ancora sarà modello al Napoleone del Manzoni: «Da indi scese folgorando a Iuba».
 Il Buti, nel suo commento, insiste giustamente su quel momento, su quel «redur lo mondo a suo modo sereno»: «ma notantemente dice tutto ’l Cielo: imperò che, a mutare lo reggimento del tutto, conveniano correre tutte le cagioni insieme; e dice: a suo modo sereno, perchè lo cielo è retto e governato da uno signore, e così volse lo cielo redur lo mondo che in tutto ’l mondo fusse uno monarca. Cesari».
Il Buti, nel suo commento, insiste giustamente su quel momento, su quel «redur lo mondo a suo modo sereno»: «ma notantemente dice tutto ’l Cielo: imperò che, a mutare lo reggimento del tutto, conveniano correre tutte le cagioni insieme; e dice: a suo modo sereno, perchè lo cielo è retto e governato da uno signore, e così volse lo cielo redur lo mondo che in tutto ’l mondo fusse uno monarca. Cesari».Per questo il libro di Luciano Canfora è importante: non tanto e non solo perché restituisce una fonte importante per il mito di Cesare nella Commedia, e cioè quella di Svetonio, ma perché riafferma la «Centralità di Cesare» (penultimo capitolo) nell’economia della visione dantesca, capace di sanare la contraddizione che pure esiste tra il trionfo di Cesare e l’elogio di Catone, pure da questi sconfitto sino a costringerlo, per coerenza di libertà, al suicidio:
 «Dante compone questo dissidio in una visione più alta. Nel superamento di questa contraddizione - scrive Canfora - si manifesta e prende corpo quello che potremmo definire il sincretismo storiografico di Dante alle prese con la storia di Roma: una storia da lui concepita unitariamente, in cui la fase repubblicana non solo precede cronologicamente ma prepara l’impero. L’impero è per lui parte essenziale di un disegno divino, e Cesare ne rappresenta il motore principale».
«Dante compone questo dissidio in una visione più alta. Nel superamento di questa contraddizione - scrive Canfora - si manifesta e prende corpo quello che potremmo definire il sincretismo storiografico di Dante alle prese con la storia di Roma: una storia da lui concepita unitariamente, in cui la fase repubblicana non solo precede cronologicamente ma prepara l’impero. L’impero è per lui parte essenziale di un disegno divino, e Cesare ne rappresenta il motore principale».Resta un fascinoso tema che Canfora solleva in poche dense pagine: Se Dante ha letto Tacito. Lo studioso evoca la presenza a Montecassino del manoscritto (oggi alla Laurenziana) che contiene parte delle Historiae di Tacito (I -V), ricorda la perfetta descrizione dei luoghi stessi in Paradiso XXII, e sottolinea come nessuno, prima del Dante del Monarchia avesse ripreso l’attacco delle Historiae tacitiane: «Opus adgredior opimum casibus, ...», così riscritto da Dante: «Arduum quidem opus et ultra vires aggredior...». Come per ogni novità esegetica intorno ai classici, si possono evocare intermediazioni patristiche (e c’è chi, Pieter Smulders, ha suggerito di convocare la prefazione dell’ Opus Historicum di Ilario di Poitiers); ma intanto resta questa conquista e ancora un lungo compito, sollecitato da Canfora: «La “biblioteca latina” di Dante non smette di riservare sorprese». Anche per questa preziosa tessera si conferma la tesi di Ernst Robert Curtius: che Dante sia stato il supremo suggello di tutta la tradizione latina, classica e medievale.
-
> LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE, E IL VATICANO CON IL SUO TRADIZIONALE SOFISMA --- Dante e i Papi: Vangelo in poesia (di Gianfranco Ravasi)5 dicembre 2015, di Federico La Sala
Dante e i Papi: Vangelo in poesia
di Gianfranco Ravasi
(Avvenire, 5 dicembre 2015) La Chiesa ha mostrato più volte il vivo e sentito desiderio di onorare degnamente la figura di Dante Alighieri, di tenere nella giusta considerazione la sua opera, considerandola come elemento essenziale del suo patrimonio culturale e religioso, per il profondo rapporto con la fede cristiana e con la riflessione teologica e filosofica sviluppatasi intorno alle verità della fede.
Ricordando i più recenti anniversari danteschi, ci si accorge che i pontefici, a nome di tutta la Chiesa, hanno tributato al sommo poeta uno straordinario, singolare onore, dedicandogli importanti documenti magisteriali. Nell’enciclica In praeclara summorum, rivolta ai professori e alunni degli istituti letterari e di alta cultura del mondo cattolico (30 aprile 1921), Benedetto XV celebrava il VI centenario della morte di Dante. Per l’occasione il pontefice aveva anche promosso il restauro del tempietto ravennate, attiguo alla basilica di San Francesco, che custodisce la tomba di Dante. Con l’enciclica il papa intendeva affermare ed evidenziare «l’intima unione di Dante con la cattedra di Pietro». Nel poema sono espresse le verità fondamentali della Chiesa cattolica, così da renderlo un «compendio delle leggi divine». A riguardo invece dei noti attacchi contro la Chiesa del tempo, papa Benedetto XV giustifica il sommo poeta: «Chi potrebbe negare che in quel tempo vi fossero delle cose da rimproverare al clero?». Per Benedetto XV Dante «conserva la freschezza di un poeta dell’età nostra », anzi egli è molto più moderno di alcuni poeti contemporanei, i quali rievocano «quell’antichità che fu spazzata da Cristo, trionfante sulla croce».
Nella ricorrenza del VII centenario della nascita di Dante, anche Paolo VI con la lettera apostolica Altissimi cantus (7 dicembre 1965), evidenziava il profondo interesse della Chiesa per la figura di Dante. Con tale documento il pontefice istituiva, presso l’Università Cattolica di Milano, una cattedra di studi danteschi. La lettera apostolica completava la serie di iniziative attraverso le quali papa Montini volle esprimere l’ammirazione sua e di tutta la Chiesa per il cantore della Divina Commedia: il 19 settembre dello stesso anno aveva inviato per la tomba del poeta a Ravenna una croce d’oro, come segno della risurrezione che Dante professava, e il 14 novembre era stata incastonata nel battistero di San Giovanni a Firenze un’aurea corona d’alloro. Infine, a conclusione del concilio Vaticano II, il papa aveva donato a tutti i partecipanti una pregiata edizione della Divina Commedia.
«Del Signore dell’altissimo canto...». Già con l’incipit della lettera apostolica si evidenzia la centralità assoluta, in tutta la poesia italiana, del sommo poeta, definito «l’astro più fulgido» della nostra letteratura e ancora «padre della lingua italiana». Così scrivendo, Paolo VI rinnovava la profonda riconoscenza al poeta, e seguendo Benedetto XV lo annoverava tra tutti i grandi poeti cristiani. «Dante è nostro», ribadisce papa Montini, seguendo anche in questo Benedetto XV. «Nostro» nel senso di universale, ma anche nostro nel senso della fede cattolica. Paolo VI afferma che è un dovere della Chiesa riconoscere Dante come proprio, che ha come conseguenza necessaria uno studio accurato della sua opera per scoprirne gli «inestimabili tesori del pensiero e del sentimento cristiano».
Tra il sommo poeta e il pensiero cristiano vi sono numerosissimi elementi di contatto. Tra questi il fine stesso della Commedia, che ha in comune col messaggio cristiano l’intento di cambiare radicalmente l’uomo, di portarlo dalla selva oscura del peccato alla rosa mistica della santità. «Onorate l’altissimo poeta!» è l’invito-appello con cui Paolo VI conclude l’Altissimi cantus, sollecitando il «fermo impegno» soprattutto di coloro che, per vari motivi, si sentono a lui più vicini. La cultura contemporanea deve saper incontrare Dante e chiedere a lui la guida verso la «dritta via», spesso impedita dalla selva oscura, verso quello che egli ci indica come «dilettoso monte/ ch’è principio e cagion di tutta gioia».
Benedetto XVI non è meno legato a Dante dei suoi predecessori e più volte, già da cardinale, ricorda e cita il sommo poeta. Il cardinal Ratzinger, infatti, nel libro Introduzione al cristianesimo, scrivendo dello «scandalo del cristianesimo», cioè di Cristo Figlio di Dio fattosi uomo, e quindi del significato dell’essere che va ricercato non nel mondo delle idee ma nel volto di un uomo, rammenta la concretezza di questo pensiero nella conclusione della Divina Commedia di Dante: «Dentro da sé del suo colore istesso,/ mi parve pinta della nostra effigie,/ per che il mio viso in lei tutto era messo». Dante, «contemplando il mistero di Dio, scorge con estatico rapimento la propria immagine, ossia un volto umano, esattamente in centro all’abbagliante cerchio di fiamme formato da “l’amore che move il sole e l’altre stelle”».
Benedetto XVI riprende questo tema e questi versi per spiegare il significato profondo della sua prima enciclica Deus caritas est. Incontrando i partecipanti a un congresso organizzato dal Pontificio consiglio «Cor unum», il pontefice afferma: «Ancora più sconvolgente di questa rivelazione di Dio come cerchio trinitario di conoscenza e amore è la percezione di un volto umano - il volto di Gesù Cristo - che a Dante appare nel cerchio centrale della Luce. Se da un lato nella visione dantesca viene a galla il nesso tra fede e ragione, tra ricerca dell’uomo e risposta di Dio, dall’altro emerge anche la radicale la novità di un amore che ha spinto Dio ad assumere un volto umano». Nell’enciclica, si ribadisce, il papa voleva «tentare di esprimere per il nostro tempo e per la nostra esistenza qualcosa di quello che Dante nella sua visione ha ricapitolato in modo audace».
Il 4 maggio 2015, quando in Senato si sono celebrati i 750 anni dalla nascita di Dante. ho avuto l’onore di essere latore di un messaggio di Papa Francesco che si accosta ai suoi predecessori nella lode e nell’ammirazione per questo grande poeta e credente. Lo stesso pontefice, per altro, nella sua prima enciclica Lumen fidei, aveva raffigurato la luce della fede, che avvolge e coinvolge l’intera esistenza umana, attraverso un’immagine dantesca, la «favilla,/ che si dilata in fiamma poi vivace/ e come stella in cielo in me scintilla» (Paradiso XXIV, 145-147).
-
> LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE, E IL VATICANO CON IL SUO TRADIZIONALE SOFISMA --- Gli occhi di Cesare. La biblioteca latina di Dante. Il libro di Canfora (di Livia Capponi)16 novembre 2015, di Federico La Sala
Ispirazione e tormento
Gli autori latini (e pagani) della biblioteca di Dante
Il libro di Luciano Canfora (Sellerio Editrice)
di Livia Capponi (Corriere della Sera, 16.11.2015)
L’ ultimo libro di Luciano Canfora, Gli occhi di Cesare. La biblioteca latina di Dante, si apre con il ritratto di Cesare «con li occhi grifagni» nella galleria dei grandi pagani che abitano il «nobile castello» posto da Dante all’interno del Limbo. Il particolare deriva da Svetonio, lettura colta per i medievali appassionati di storia romana. La ricostruzione della biblioteca latina di Dante è solo uno dei pregi del volumetto, che, attraverso un’erudita galoppata nei secoli, parte da Cesare e Alessandro, simboli della monarchia assoluta dall’antichità al Medioevo, per poi analizzare l’idea di impero e il rapporto Stato-Chiesa nella Monarchia dantesca.
Per Dante, l’impero romano è la provvidenziale preparazione alla diffusione del Cristianesimo su scala mondiale. Cesare e il suo oppositore Catone Uticense, colui che per la libertà «vita rifiuta» (era morto suicida nel 46 a.C. pur di non assistere alla fine della Repubblica), sono due aspetti di un disegno più grande, da cui consegue Augusto, il «buon monarca» da accettare come garante della convivenza umana.
Una monarchia universale come garanzia di pace è anche la risposta ai problemi dell’Italia di Dante. Lo spiega Giustiniano, protagonista del canto VI del Paradiso e incarnazione del cesaropapismo bizantino, dove è la Chiesa a essere subordinata all’imperatore, che, avendo ricevuto il potere direttamente da Dio, non ha bisogno di obbedire a un suo Vicario. L’errore, se mai, è stato la donazione di Costantino, il documento con cui si assegnava ufficialmente del territorio al Papa, legittimandone il potere temporale (fino al 1517, quando fu dimostrato falso dall’umanista Lorenzo Valla).
Questo è il macigno che costa alla Monarchia la condanna all’ Indice dei libri proibiti nel 1559, e suscita poi una serie di ritrattazioni papali, fino alla risoluzione del problema con la soppressione dell’ Indice stesso nel 1966. È noto che nella storia gli elenchi di libri proibiti funzionarono sempre come pubblicità a rovescio.
Nel Limbo i pagani sono condannati a desiderare, senza mai poterla conseguire, la «vera fede». Ma la desideravano davvero? Difficile per Dante (e per molti suoi lettori) accettare che gli «spiriti magni» dei classici, così grandi ed eticamente impeccabili, fossero esclusi da tutto solo perché nati prima di Cristo.
Per Canfora, quando fa dire al pagano Virgilio che senza la fede «ben far non basta», Dante sta convincendo anzitutto se stesso. Perché «ben far» non dovrebbe bastare alla salvezza? E, infatti, è proprio Virgilio che salva Dante.
Con Borges, Canfora vede in Omero, Orazio, Ovidio e Lucano nell’ Inferno proiezioni o figurazioni di Dante. I classici non solo nutrono la poesia dantesca, ma ne stimolano i risvolti filosofici, fino a insidiarla con dubbi tormentosi sul rapporto ragione-fede. Lo prova il monumento che Dante innalza a Ulisse, eroe pagano dannato in eterno.
Nella Monarchia, e nella Commedia, libertà non è arbitrario soddisfacimento delle proprie pulsioni (cioè il «viver come bruti»), ma libera obbedienza a leggi giuste, perché, anche a rischio di morire, «la semenza» degli uomini è fatta per «seguir virtute e canoscenza».
L’indagine filologica, che si snoda in maniera più appassionante di un giallo, risveglia la curiositas sulle inedite sinapsi fra gli autori del nostro patrimonio comune. Mostra le continuità classico-cristiane e il riaffiorare quasi «carsico» dell’idea di un potere politico sovranazionale più potente della religione. Alla fine, il lettore si ritrova in mano due armi formidabili contro ogni forma di oscurantismo: i classici e Dante.
-
> LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE, E --- IL "FEDERICO II, IMPERATORE" DI KANTOROWICZ. Un’indicazione per una rilettura (di Federico La Sala)6 febbraio 2015, di Federico La Sala
LA DISTRUZIONE DELLA "CRITICA DELLA RAGION PURA": FEDERICO II, DANTE, E KANT.
- Una nota storiografica di Ernst Kantorowicz, dal suo lavoro su "Federico II, Imperatore" (che non solo getta luce sulla filosofia degli anni Venti del XX secolo in Europa , ma illumina meglio e tutto il percorso e l’orizzonte storiografico-filosofico dello stesso Kantorowicz, e sollecita a rileggere il suo lavoro - compreso il suo capolavoro "I due corpi del re" - in modo unitario!, da Berlino a Princeton!) *
"(...) Si tenga presente che Federico II visse alla fine del secolo che conosceva la giustizia come unico fine dello stato - fine, del quale, come si sa, gli statisti del rinascimento si occuparono ben poco. Federico era nato nel tempo della massima fioritura del «secolo giuridico», che chiudeva un millennio dedicato alla ricerca della giustizia, e che senza dubbio ebbe tanta influenza su Federico, quanta egli ne ebbe poi sulla giurisprudenza: si pensi soltanto alla visita dello Staufen a Bologna, al giurisperito Roffredo di Benevento, alla fondazíone dell’università di Napoli.
A buona ragione s’è definito «epoca del diritto» quel secolo (1150- 1250) che chiude il medioevo, perché dai giorni di un Graziano e di un Irnerio, da quelli che segnarono una notevole ripresa del diritto romano da parte del Barbarossa (simbolo dello spirito del tempo), a nessun’altra ricerca scientifica il mondo aveva mostrato effettivo interesse come allo studio del diritto - il che certo non impedì che l’interesse si tramutasse in pazzia: come dimostra l’aver cominciato, verso la fine del XIII secolo, a mettere in versi le Institutiones di Giustiniano, allo stesso modo che si è fatto ai giorni nostri con la Critica della ragion pura di Kant.
Tale degenerazione indica che nel campo in oggetto non resta più nulla da fare. Non che la scienza del diritto si esaurisse con quel secolo: solo, la materia era stata dai glossatori assiduamente e sempre più sterilmente perorata, e, d’alÍo canto, si schiudevano al rinascimento nascente tanti e infinitamente più importanti spazi scientifici, che la cultura profana non poté più, come al tempo di Federico II, essere identificata con quella giuridica. La scienza giuridica, però, che consiste nello studio delle leggi, conraddistingue la nascita d’uno spirito non teologico, anzi essenzialmente laico.
D’altra parte, la chiesa stessa aveva mantenuto, nel campo del diritto, una posizione di guida: tutti i papi più importanti di questo secolo - Alessandro III, Innocenzo III, Onorio III, Gregorio IX, Innocenzo IV - furono giuristi, anzi la conoscenza del diritto canonico diventò elemento essenziale della teologia, o meglio: teologia e scienza giuridica vennero a pericolosi conflitti nell’ambito della chiesa, e la seconda ne patì gravi danni. Sdegnato di ciò, Dante maledisse i Decretali perché papa e cardinali, a furia di studiatli sino a consumarne i «vivagni», dimenticavano Nazareth" (Ernst H. Kantorowicz, Federico II, Imperatore, [Kaiser Friedrich der Zweite, I-II, Berlin 1927-1931] Garzanti, Milano [1976] 1988).
* Federico La Sala, 06 febbraio 2015.
-
> LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE, --- TORNARE AL VERO ADAMO. È un “sacro vuoto” la libertà dell’Occidente La nostra società ha prodotto un’integrazione senza differenze (di Wael Farouq)10 febbraio 2015, di Federico La Sala
- I DUE CORPI DEL RE, DEL PAPA, E DI OGNI ESSERE UMANO. La lezione di Dante, Kantorowicz, Freud e Mandela
 GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITA’ E RICONCILIAZIONE.
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITA’ E RICONCILIAZIONE.
È un “sacro vuoto” la libertà dell’OccidenteLa nostra società ha prodotto un’integrazione senza differenze
Solo il rispetto delle identità religiose e sociali può condurre a un mondo pacifico
di Wael Farouq (La Stampa, 10.02.2015)
Negli Anni Trenta del Novecento, i giapponesi consideravano l’imperatore Hirohito pari ad un dio che li aveva condotti alla rinascita economica e alla costruzione di una forza militare in grado di dominare vaste regioni del mondo. Dopo la disonorevole sconfitta del Giappone in guerra, l’imperatore mantenne la sua sacralità, ma quest’ultima perse tutto il suo significato, anche perché l’imperatore aveva guidato la sua gente verso la distruzione altrui, prima ancora che alla distruzione del proprio Paese. Fu così che i giapponesi presero a chiamarlo «il sacro nulla» (Patrick Smith, Japan: a Reinterpretation, Knopf Doubleday Publishing Group, 2011). Il «sacro nulla» è l’espressione che meglio descrive i valori della civiltà occidentale di oggi. Sia sul piano pratico che culturale, questi valori sono svuotati del loro significato, sebbene tutti quanti li sacralizzino, come nel caso del valore della libertà.
Tutto è effimero
Purtroppo, la faccenda non si limita alla fallita esportazione di questi valori all’esterno, ma si estende anche al loro svuotamento di significato all’interno, sul piano intellettuale e pratico. Nella cultura contemporanea l’effimero è diventato centrale. Nulla reca un segno di distinzione, un significato, perché tutto è fugace. L’attenzione della cultura contemporanea si è così spostata dall’essere nel mondo al divenire, o al transitare, nel mondo. Questo è il mondo del transitorio e dell’effimero. Le ideologie sono cadute, ma la paura dell’altro è aumentata. Il nichilismo ha fatto marcia indietro, ma il suo posto è stato occupato da una neutralità passiva verso ogni cosa. Il termine «post», anteposto a ogni parola che indica un aspetto della conoscenza umana (come in post-industriale, post-storico, post-moderno, eccetera), non implica altro che l’incapacità di attribuire un significato alla condizione umana presente.
Jürgen Habermas vede in questo una conseguenza dell’esclusione della religione dalla vita pubblica. Ed è vero che tutte le sfide sociali cui dobbiamo far fronte sono fondamentalmente riconducibili all’incapacità di dare alla vita un significato, una fonte del quale è rappresentata proprio dalla religione.
L’uniformità
I post-modernisti ritengono di aver liberato l’umanità dalla prigionia di binomi intellettuali quali bene-male, presenza-assenza, io-l’altro, ma in realtà sono solo passati dal contrapporre gli elementi di questi binomi al porli sullo stesso piano - e all’incapacità che ne deriva di formulare giudizi, che a sua volta porta all’interruzione di ogni interazione con la realtà e all’uniformizzazione dell’identità individuale e collettiva.
Il post-modernismo ha combattuto contro l’esclusione dell’altro, il «diverso», operata dal modernismo, ma non ha trovato altra via per farlo che escludere la «diversità», poiché è opinione diffusa che la convivenza pacifica non possa avere successo se non escludendo l’esperienza religiosa ed etica dalla sfera pubblica. Questo, tuttavia, implica l’esclusione della differenza e, quando l’esperienza religiosa è uno degli elementi più importanti dell’identità, l’esclusione della differenza, in realtà, diventa esclusione del sé.
Ma questa laicità estremista è riuscita a realizzare il proprio obiettivo?
Non c’è metropoli europea, oggi, che non ospiti una «società parallela», dove vivono gli immigrati musulmani. Tentativi affrettati d’integrare gli immigrati hanno finito solo per rendere i confini culturali e religiosi invisibili nello spazio pubblico. In Francia è stata promulgata una legge che proibisce l’esibizione dei simboli religiosi nello spazio pubblico. Di conseguenza, la Francia è diventata uno Stato la cui Costituzione protegge la differenza e il pluralismo religioso, ma le cui leggi ne criminalizzano l’espressione.
Gli immigrati
L’esclusione della diversità dallo spazio pubblico ha fatto sì che l’adattamento, e non l’interazione, diventasse il quadro entro il quale s’inscrive la relazione degli immigrati con la loro nuova società. Questo e altri fattori di natura soggettiva, cioè relativi alla cultura degli stessi immigrati, hanno dunque portato alla creazione di società parallele in conflitto con l’ambiente circostante che rimane, per loro, un ambiente alieno, straniero.
In questo contesto culturale, se qualcuno chiedesse «cos’è la libertà?», la risposta sarebbe: qualsiasi cosa. Ma una libertà che significa qualsiasi cosa non è niente. La libertà vera ha un volto, un nome, dei confini rappresentati dall’esperienza umana, che tuttavia non può essere tale se alla persona si strappano la sua identità, la sua storia, la sua esistenza e il suo scopo. Diverrebbe una forma svuotata di significato e contribuirebbe, assieme alla cultura islamica contemporanea, all’esclusione della persona, della sua esperienza e della sua identità. Nel qual caso, passeremmo dal «sacro nulla» al «nulla è sacro». Infatti, nulla è sacro finché la forma sta al centro e la persona al margine.
Nel Corano, come nella Bibbia, Adamo inizia a relazionarsi con il mondo attribuendo un nome alle cose. L’Adamo contemporaneo, invece, perde ogni giorno un pezzo del suo mondo, perché dimentica i nomi delle cose, perché non dà più loro alcun nome, e perché nemmeno gli importa di dar loro un nome. L’uomo, oggi, è diventato un post-Adamo. Mentre per affrontare la sfida dell’oggi abbiamo bisogno come non mai di tornare al senso religioso, all’esperienza personale. Al vero Adamo.
 (Traduzione dall’arabo di Elisa Ferrero)
(Traduzione dall’arabo di Elisa Ferrero) - I DUE CORPI DEL RE, DEL PAPA, E DI OGNI ESSERE UMANO. La lezione di Dante, Kantorowicz, Freud e Mandela
-
> LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE --- L’identificazione tra modernità e laicizzazione non è scontata. Perché Dio è tornato sulla scena (di Roberto Esposito).31 marzo 2015, di Federico La Sala
Perché Dio è tornato sulla scena
La religione diventa un antidoto al dominio dell’economia
L’identificazione tra modernità e laicizzazione non è scontata
Dopo anni di assenza, la teologia politica è al centro di un dibattito internazionale iniziato in America
di Roberto Esposito (la Repubblica, 30.03.2015)
DOPO una lunga parentesi di relativa autonomia, politica e religione tornano ad incrociare le proprie traiettorie con effetti inquietanti, di cui le tragiche vicende di Parigi e Tunisi costituiscono gli ultimi episodi. La condanna più intransigente degli attentatori e la rivendicazione della libertà di espressione in tutte le sue forme è la sola risposta adeguata. Ma ciò è ben lontano dall’esaurire una questione più di fondo, che riguarda il nodo che da qualche tempo si va stringendo tra teologia e politica. La tradizionale tesi della progressiva fine delle religioni nel mondo moderno, portata avanti dai sociologi della secolarizzazione, si scontra con dati di fatto sempre più evidenti. Come già aveva argomentato a suo tempo Gilles Kepel in La rivincita di Dio ( Rizzoli), l’identificazione tra modernità e laicizzazione è tutt’altro che scontata.
A quella che era stata definita “eclissi del sacro”, è parso opporsi il suo “risveglio”. Il primo segno dell’inversione di tendenza è stata la rivoluzione khomeinista in Iran, seguita da una ripresa di fondamentalismo religioso in forme molto diverse, ma convergenti nel riaprire uno scenario teologico-politico che sembrava chiuso per sempre. Senza voler assimilare fenomeni ben differenti, l’integralismo della destra conservatrice americana, il cattolicesimo anti-conciliare, la linea più ortodossa del sionismo ebraico già rompevano in più direzioni lo schema della distinzione liberale tra sfera pubblica della politica e sfera privata della religione. L’esplosione dell’estremismo islamico ha conferito un elemento di assoluta drammatizzazione in questo quadro, ma non va isolato da esso.
Non è un caso se la questione della teologia politica è tornata da qualche anno al centro del dibattito internazionale. Se in America libri come The Faith of the Faithless di Simon Critchley (Verso), Crediting God, a cura di Miguel Vatter (Fordham) o The Power of Religion in the Public Sphere , a cura di E. Mendieta e J. Vanantewepern, con saggi di Butler, Habermas, Taylor (Columbia), stanno monopolizzando la discussione, anche in Europa il rapporto tra teologia e politica è divenuto uno dei temi dominanti.
Da Habermas a Taylor, da Zizek a Badiou, da Cacciari a Tronti, la domanda sul ruolo della teologia nella società attuale sta monopolizzando l’attenzione. La religione contribuisce a generare o a moderare la violenza? È fattore di coesione sociale o di conflitto? La risposta è tutt’altro che scontata. Come risulta dalla Encyclopedia of Wars di Charles Phillips e Alan Axelrod, che prende in esame 1800 conflitti nella storia, meno del 10 per cento di essi è stato causato da motivi religiosi.
Se le Crociate, le guerre tra cattolici e protestanti, le prime conquiste islamiche e ovviamente le attuali stragi jihadiste attestano una palese implicazione della religione nella violenza, il numero di morti ascrivibile a conflitti di tipo laico, come le due guerre mondiali, resta di gran lunga superiore. Non si dimentichi che il primo genocidio moderno, quello degli armeni, è stato compiuto dai Giovani Turchi filo-occidentali e secolarizzati, mentre devoti musulmani cercavano di salvare i superstiti.
Una risposta di carattere dialettico a tale domanda è ora avanzata dallo psicologo sociale Ara Norenzayan in un saggio importante, intitolato Grandi Dei. Come la religione ha trasformato la nostra vita di gruppo , tradotto da Cortina, con un’introduzione di Telmo Pievani. La sua tesi è che inizialmente le grandi religioni abbiano favorito la socialità attraverso il timore suscitato dalla sorveglianza di un Grande Occhio divino sul comportamento degli uomini. Innestandosi su tendenze innate volte all’autoconservazione, le religioni inizialmente hanno giocato una funzione di aggregazione sociale.
Successivamente, però, esse si sono differenziate tra loro entrando in competizione. In questa lotta per la sopravvivenza, non dissimile da quella darwiniana tra le diverse specie, hanno finito per prevalere le religioni che facevano capo a divinità onnipotenti ed interventiste. Da qui un rovesciamento della originaria funzione socializzante in una tendenza conflittuale, attivata soprattutto dai monoteismi, oggettivamente concorrenti nella individuazione di un unico Dio esclusivo di ogni altro.
Da quel momento gli effetti storici delle religioni risultano diversi ed ambivalenti in base a fattori di carattere storico e contestuale sui quali non è possibile pronunciare valutazioni univoche. Dal seno della religione possono nascere il Dalai Lama e Osama Bin Laden. Certo le società moderne più avanzate, come quelle nordeuropee, sono capaci di creare meccanismi di cooperazione senza l’aiuto del Grande Occhio divino.
E dunque, problema risolto? Da quanto accade nel mondo si direbbe di no. Per quanto riguarda l’area islamica la ripresa delle tendenze più radicali è sotto gli occhi di tutti. Ma neanche nelle società occidentali tale distinzione, da tutti ammessa in linea di principio, sembra resistere ad una serie di dinamiche correlate. Da un lato la globalizzazione ha rotto i confini tra civiltà diverse, immettendo quantità crescenti di culture difficilmente integrabili all’interno dei Paesi occidentali.
Dall’altro il regime biopolitico in cui da tempo viviamo, in particolare con lo sviluppo delle biotecnologie, rompe le paratie tra pubblico e privato su questioni che riguardano non solo l’origine e la fine della vita, ma la salute, la sicurezza, l’ecologia - tutte contemporaneamente pubbliche e private, individuali e collettive. Da questo lato sembra profilarsi una nuova alleanza tra politica e teologia. Non tanto, perché nella crisi di legittimazione dell’autorità, il nucleo di senso custodito dalle religioni può svolgere una funzione di supplenza.
Ma perché in un mondo orientato sempre più a un dominio assoluto dell’economia, la teologia sembra rappresentare, per masse sempre più grandi di uomini, l’unica alternativa, l’unica potenza capace di resistere, alla logica anonima del mercato globale. Nel momento in cui si afferma una nuova forma di “teologia economica” del debito - si veda, a questo proposito, il recente volume collettaneo curato da Thomas Macho col titolo Bonds (Fink) - la filosofia contemporanea guarda ad un nuova forma, non più di teologia politica, ma di politica della teologia.
-
> LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE, E IL VATICANO CON IL SUO TRADIZIONALE SOFISMA DELLA "FALLACIA ACCIDENTIS". --- “Rinfrancate i vostri cuori”. Messaggio di Papa Francesco per la Quaresima 201528 gennaio 2015, di Federico La Sala
AMORE ("CHARITAS") O MAMMONA ("CARITAS")?!. QUALE SPIRITO?! QUALE FEDE?! QUALE TESTIMONIANZA?! "La carità di Dio che rompe quella mortale chiusura in se stessi che è l’indifferenza, ci viene offerta dalla Chiesa con il suo insegnamento e, soprattutto, con la sua testimonianza". (fls)
Papa Francesco \ Documenti
Papa, Messaggio Quaresima. Il testo integrale *
“Rinfrancate i vostri cuori”. È il titolo del Messaggio di Papa Francesco per la Quaresima 2015. Di seguito, il testo integrale del messaggio:
“Cari fratelli e sorelle,
la Quaresima è un tempo di rinnovamento per la Chiesa, le comunità e i singoli fedeli. Soprattutto però è un “tempo di grazia” (2 Cor 6,2). Dio non ci chiede nulla che prima non ci abbia donato: “Noi amiamo perché egli ci ha amati per primo” (1 Gv 4,19). Lui non è indifferente a noi. Ognuno di noi gli sta a cuore, ci conosce per nome, ci cura e ci cerca quando lo lasciamo. Ciascuno di noi gli interessa; il suo amore gli impedisce di essere indifferente a quello che ci accade. Però succede che quando noi stiamo bene e ci sentiamo comodi, certamente ci dimentichiamo degli altri (cosa che Dio Padre non fa mai), non ci interessano i loro problemi, le loro sofferenze e le ingiustizie che subiscono... allora il nostro cuore cade nell’indifferenza: mentre io sto relativamente bene e comodo, mi dimentico di quelli che non stanno bene.
 Questa attitudine egoistica, di indifferenza, ha preso oggi una dimensione mondiale, a tal punto che possiamo parlare di una globalizzazione dell’indifferenza. Si tratta di un disagio che, come cristiani, dobbiamo affrontare. Quando il popolo di Dio si converte al suo amore, trova le risposte a quelle domande che continuamente la storia gli pone. Una delle sfide più urgenti sulla quale voglio soffermarmi in questo Messaggio è quella della globalizzazione dell’indifferenza.
Questa attitudine egoistica, di indifferenza, ha preso oggi una dimensione mondiale, a tal punto che possiamo parlare di una globalizzazione dell’indifferenza. Si tratta di un disagio che, come cristiani, dobbiamo affrontare. Quando il popolo di Dio si converte al suo amore, trova le risposte a quelle domande che continuamente la storia gli pone. Una delle sfide più urgenti sulla quale voglio soffermarmi in questo Messaggio è quella della globalizzazione dell’indifferenza.L’indifferenza verso il prossimo e verso Dio è una reale tentazione anche per noi cristiani. Abbiamo perciò bisogno di sentire in ogni Quaresima il grido dei profeti che alzano la voce e ci svegliano.
Dio non è indifferente al mondo, ma lo ama fino a dare il suo Figlio per la salvezza di ogni uomo. Nell’incarnazione, nella vita terrena, nella morte e risurrezione del Figlio di Dio, si apre definitivamente la porta tra Dio e uomo, tra cielo e terra. E la Chiesa è come la mano che tiene aperta questa porta mediante la proclamazione della Parola, la celebrazione dei Sacramenti, la testimonianza della fede che si rende efficace nella carità (cfr Gal 5,6). Tuttavia, il mondo tende a chiudersi in se stesso e a chiudere quella porta attraverso la quale Dio entra nel mondo e il mondo in Lui. Così la mano, che è la Chiesa, non deve mai sorprendersi se viene respinta, schiacciata e ferita.
Il popolo di Dio ha perciò bisogno di rinnovamento, per non diventare indifferente e per non chiudersi in se stesso. Vorrei proporvi tre passi da meditare per questo rinnovamento.
1. “Se un membro soffre, tutte le membra soffrono” (1 Cor 12,26) - La Chiesa
La carità di Dio che rompe quella mortale chiusura in se stessi che è l’indifferenza, ci viene offerta dalla Chiesa con il suo insegnamento e, soprattutto, con la sua testimonianza. Si può però testimoniare solo qualcosa che prima abbiamo sperimentato. Il cristiano è colui che permette a Dio di rivestirlo della sua bontà e misericordia, di rivestirlo di Cristo, per diventare come Lui, servo di Dio e degli uomini. Ce lo ricorda bene la liturgia del Giovedì Santo con il rito della lavanda dei piedi. Pietro non voleva che Gesù gli lavasse i piedi, ma poi ha capito che Gesù non vuole essere solo un esempio per come dobbiamo lavarci i piedi gli uni gli altri. Questo servizio può farlo solo chi prima si è lasciato lavare i piedi da Cristo. Solo questi ha “parte” con lui (Gv 13,8) e così può servire l’uomo.
La Quaresima è un tempo propizio per lasciarci servire da Cristo e così diventare come Lui. Ciò avviene quando ascoltiamo la Parola di Dio e quando riceviamo i sacramenti, in particolare l’Eucaristia. In essa diventiamo ciò che riceviamo: il corpo di Cristo. In questo corpo quell’indifferenza che sembra prendere così spesso il potere sui nostri cuori, non trova posto. Poiché chi è di Cristo appartiene ad un solo corpo e in Lui non si è indifferenti l’uno all’altro. “Quindi se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme; e se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui” (1 Cor 12,26).
La Chiesa è communio sanctorum perché vi partecipano i santi, ma anche perché è comunione di cose sante: l’amore di Dio rivelatoci in Cristo e tutti i suoi doni. Tra essi c’è anche la risposta di quanti si lasciano raggiungere da tale amore. In questa comunione dei santi e in questa partecipazione alle cose sante nessuno possiede solo per sé, ma quanto ha è per tutti. E poiché siamo legati in Dio, possiamo fare qualcosa anche per i lontani, per coloro che con le nostre sole forze non potremmo mai raggiungere, perché con loro e per loro preghiamo Dio affinché ci apriamo tutti alla sua opera di salvezza.
2. “Dov’è tuo fratello?” (Gen 4,9) - Le parrocchie e le comunità
Quanto detto per la Chiesa universale è necessario tradurlo nella vita delle parrocchie e comunità. Si riesce in tali realtà ecclesiali a sperimentare di far parte di un solo corpo? Un corpo che insieme riceve e condivide quanto Dio vuole donare? Un corpo, che conosce e si prende cura dei suoi membri più deboli, poveri e piccoli? O ci rifugiamo in un amore universale che si impegna lontano nel mondo, ma dimentica il Lazzaro seduto davanti alla propria porta chiusa ? (cfr Lc 16,19-31). Per ricevere e far fruttificare pienamente quanto Dio ci dà vanno superati i confini della Chiesa visibile in due direzioni.
In primo luogo, unendoci alla Chiesa del cielo nella preghiera. Quando la Chiesa terrena prega, si instaura una comunione di reciproco servizio e di bene che giunge fino al cospetto di Dio. Con i santi che hanno trovato la loro pienezza in Dio, formiamo parte di quella comunione nella quale l’indifferenza è vinta dall’amore. La Chiesa del cielo non è trionfante perché ha voltato le spalle alle sofferenze del mondo e gode da sola. Piuttosto, i santi possono già contemplare e gioire del fatto che, con la morte e la resurrezione di Gesù, hanno vinto definitivamente l’indifferenza, la durezza di cuore e l’odio. Finché questa vittoria dell’amore non compenetra tutto il mondo, i santi camminano con noi ancora pellegrini. Santa Teresa di Lisieux, dottore della Chiesa, scriveva convinta che la gioia nel cielo per la vittoria dell’amore crocifisso non è piena finché anche un solo uomo sulla terra soffre e geme: “Conto molto di non restare inattiva in cielo, il mio desiderio è di lavorare ancora per la Chiesa e per le anime” (Lettera 254 del 14 luglio 1897).
Anche noi partecipiamo dei meriti e della gioia dei santi ed essi partecipano alla nostra lotta e al nostro desiderio di pace e di riconciliazione. La loro gioia per la vittoria di Cristo risorto è per noi motivo di forza per superare tante forme d’indifferenza e di durezza di cuore.
D’altra parte, ogni comunità cristiana è chiamata a varcare la soglia che la pone in relazione con la società che la circonda, con i poveri e i lontani. La Chiesa per sua natura è missionaria, non ripiegata su se stessa, ma mandata a tutti gli uomini.
Questa missione è la paziente testimonianza di Colui che vuole portare al Padre tutta la realtà ed ogni uomo. La missione è ciò che l’amore non può tacere. La Chiesa segue Gesù Cristo sulla strada che la conduce ad ogni uomo, fino ai confini della terra (cfr At 1,8). Così possiamo vedere nel nostro prossimo il fratello e la sorella per i quali Cristo è morto ed è risorto. Quanto abbiamo ricevuto, lo abbiamo ricevuto anche per loro. E parimenti, quanto questi fratelli possiedono è un dono per la Chiesa e per l’umanità intera.
Cari fratelli e sorelle, quanto desidero che i luoghi in cui si manifesta la Chiesa, le nostre parrocchie e le nostre comunità in particolare, diventino delle isole di misericordia in mezzo al mare dell’indifferenza!
3. “Rinfrancate i vostri cuori !” (Gc 5,8) - Il singolo fedele
Anche come singoli abbiamo la tentazione dell’indifferenza. Siamo saturi di notizie e immagini sconvolgenti che ci narrano la sofferenza umana e sentiamo nel medesimo tempo tutta la nostra incapacità ad intervenire. Che cosa fare per non lasciarci assorbire da questa spirale di spavento e di impotenza?
In primo luogo, possiamo pregare nella comunione della Chiesa terrena e celeste. Non trascuriamo la forza della preghiera di tanti! L’iniziativa 24 ore per il Signore, che auspico si celebri in tutta la Chiesa, anche a livello diocesano, nei giorni 13 e 14 marzo, vuole dare espressione a questa necessità della preghiera.
In secondo luogo, possiamo aiutare con gesti di carità, raggiungendo sia i vicini che i lontani, grazie ai tanti organismi di carità della Chiesa. La Quaresima è un tempo propizio per mostrare questo interesse all’altro con un segno, anche piccolo, ma concreto, della nostra partecipazione alla comune umanità.
E in terzo luogo, la sofferenza dell’altro costituisce un richiamo alla conversione, perché il bisogno del fratello mi ricorda la fragilità della mia vita, la mia dipendenza da Dio e dai fratelli. Se umilmente chiediamo la grazia di Dio e accettiamo i limiti delle nostre possibilità, allora confideremo nelle infinite possibilità che ha in serbo l’amore di Dio. E potremo resistere alla tentazione diabolica che ci fa credere di poter salvarci e salvare il mondo da soli.
 Per superare l’indifferenza e le nostre pretese di onnipotenza, vorrei chiedere a tutti di vivere questo tempo di Quaresima come un percorso di formazione del cuore, come ebbe a dire Benedetto XVI (Lett. enc. Deus caritas est, 31). Avere un cuore misericordioso non significa avere un cuore debole. Chi vuole essere misericordioso ha bisogno di un cuore forte, saldo, chiuso al tentatore, ma aperto a Dio. Un cuore che si lasci compenetrare dallo Spirito e portare sulle strade dell’amore che conducono ai fratelli e alle sorelle. In fondo, un cuore povero, che conosce cioè le proprie povertà e si spende per l’altro.
Per superare l’indifferenza e le nostre pretese di onnipotenza, vorrei chiedere a tutti di vivere questo tempo di Quaresima come un percorso di formazione del cuore, come ebbe a dire Benedetto XVI (Lett. enc. Deus caritas est, 31). Avere un cuore misericordioso non significa avere un cuore debole. Chi vuole essere misericordioso ha bisogno di un cuore forte, saldo, chiuso al tentatore, ma aperto a Dio. Un cuore che si lasci compenetrare dallo Spirito e portare sulle strade dell’amore che conducono ai fratelli e alle sorelle. In fondo, un cuore povero, che conosce cioè le proprie povertà e si spende per l’altro.Per questo, cari fratelli e sorelle, desidero pregare con voi Cristo in questa Quaresima: “Fac cor nostrum secundum cor tuum”: “Rendi il nostro cuore simile al tuo” (Supplica dalle Litanie al Sacro Cuore di Gesù). Allora avremo un cuore forte e misericordioso, vigile e generoso, che non si lascia chiudere in se stesso e non cade nella vertigine della globalizzazione dell’indifferenza. Con questo auspicio, assicuro la mia preghiera affinché ogni credente e ogni comunità ecclesiale percorra con frutto l’itinerario quaresimale, e vi chiedo di pregare per me. Che il Signore vi benedica e la Madonna vi custodisca”.
-
> LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE, E IL VATICANO CON IL SUO TRADIZIONALE SOFISMA DELLA "FALLACIA ACCIDENTIS". --- INDIVIDUO E SOCIETA’. La Chiesa di Chiesa di Costantino e lo Stato di Hegel.22 gennaio 2015, di Federico La Sala
INDIVIDUO E SOCIETA’. La Chiesa di Chiesa di Costantino e lo Stato di Hegel.
P.S. - Una nota:
 La Terra sotto i piedi - letteralmente e sempre più - cede, e ‘noi’ continuiamo imperterriti a far finta di nulla: al polo artico come al polo antartico, i ghiacciai si sciolgono a ritmo vertiginoso e ‘noi’ continuiamo a ripetere vecchi ritornelli del ‘bel tempo che fu’: “lo spirito è, questa assoluta sostanza la quale, nella perfetta libertà e indipendenza della propria opposizione, ossia di autocoscienze diverse per sé essenti, costituisce l’unità loro: Io che è Noi, e Noi che è Io” (Hegel, Fenomenologia dello Spirito).
La Terra sotto i piedi - letteralmente e sempre più - cede, e ‘noi’ continuiamo imperterriti a far finta di nulla: al polo artico come al polo antartico, i ghiacciai si sciolgono a ritmo vertiginoso e ‘noi’ continuiamo a ripetere vecchi ritornelli del ‘bel tempo che fu’: “lo spirito è, questa assoluta sostanza la quale, nella perfetta libertà e indipendenza della propria opposizione, ossia di autocoscienze diverse per sé essenti, costituisce l’unità loro: Io che è Noi, e Noi che è Io” (Hegel, Fenomenologia dello Spirito).
 Leopardi aveva perfettamente ragione a sottolineare e a contestare: E gli uomini vollero le tenebre, piuttosto che la luce..!!! Chiuse le porte e le finestre, non ‘vogliamo’ sapere nulla e ‘continuiamo’ a cantare in coro ... e a prepararci alla guerra: Dio è amore!!!
Leopardi aveva perfettamente ragione a sottolineare e a contestare: E gli uomini vollero le tenebre, piuttosto che la luce..!!! Chiuse le porte e le finestre, non ‘vogliamo’ sapere nulla e ‘continuiamo’ a cantare in coro ... e a prepararci alla guerra: Dio è amore!!!
 Ma cosa c’è di diverso nella “caritas” di Ratzinger-Benedetto XVI dallo spirito di Hegel: “L’amore è divino perché viene da Dio e ci unisce a Dio e, mediante questo processo unificante, ci trasforma in un Noi che supera le nostre divisioni e ci fa diventare una cosa sola, fino a che, alla fine, Dio sia tutto in tutti”(pf. 18)?!
Ma cosa c’è di diverso nella “caritas” di Ratzinger-Benedetto XVI dallo spirito di Hegel: “L’amore è divino perché viene da Dio e ci unisce a Dio e, mediante questo processo unificante, ci trasforma in un Noi che supera le nostre divisioni e ci fa diventare una cosa sola, fino a che, alla fine, Dio sia tutto in tutti”(pf. 18)?!
 La Chiesa di Ratzinger come lo Stato di Hegel: “La Chiesa è la famiglia di Dio nel mondo” (pf. 25)?! Ma, dopo Auschwitz, non è meglio porsi qualche domanda?! Non sentiamo ancora nelle nostre orecchie l’urlo del “Dio lo vuole!”, “Dio è con Noi!”??!
La Chiesa di Ratzinger come lo Stato di Hegel: “La Chiesa è la famiglia di Dio nel mondo” (pf. 25)?! Ma, dopo Auschwitz, non è meglio porsi qualche domanda?! Non sentiamo ancora nelle nostre orecchie l’urlo del “Dio lo vuole!”, “Dio è con Noi!”??!
 Di quale Chiesa’, di quale famiglia, di quale Dio, e di quale mondo si tratta? Di quale famiglia ?! Ma dov’ è nostra ‘madre’ e dov’è nostro ‘padre’ e dove sono i nostri ‘fratelli’ e le nostre ‘sorelle’?! -Maria e Giuseppe, talvolta, si chiedevano: dov’è Gesù?! Ma’noi’, ‘noi’ che pensiamo di essere tutti e tutte figli e figlie di Maria e fratelli e sorelle di Gesù, quando ce lo chiederemo: dov’è Giuseppe, lo sposo di nostra madre e nostro padre?!
Di quale Chiesa’, di quale famiglia, di quale Dio, e di quale mondo si tratta? Di quale famiglia ?! Ma dov’ è nostra ‘madre’ e dov’è nostro ‘padre’ e dove sono i nostri ‘fratelli’ e le nostre ‘sorelle’?! -Maria e Giuseppe, talvolta, si chiedevano: dov’è Gesù?! Ma’noi’, ‘noi’ che pensiamo di essere tutti e tutte figli e figlie di Maria e fratelli e sorelle di Gesù, quando ce lo chiederemo: dov’è Giuseppe, lo sposo di nostra madre e nostro padre?!
 E, ancora, da padri e madri, quando ci sveglieremo e ci chiederemo dove sono i nostri figli e dove sono le nostre figlie?! ... Chi?, che cosa?! Stai zitto e prega!!! Deus caritas est : questo è il ‘logo’ del ‘nostro’ tempo!!! Dormi! Continua a dormire ... fuori del tutto non c’è nulla!!!
E, ancora, da padri e madri, quando ci sveglieremo e ci chiederemo dove sono i nostri figli e dove sono le nostre figlie?! ... Chi?, che cosa?! Stai zitto e prega!!! Deus caritas est : questo è il ‘logo’ del ‘nostro’ tempo!!! Dormi! Continua a dormire ... fuori del tutto non c’è nulla!!!Federico La Sala (06.03.2006)
-
> LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE, E IL VATICANO --- Il destino imperiale della libertà. Catone e Cesare secondo Dante7 gennaio 2015, di Federico La Sala
Alighieri e gli antichi, l’idea della monarchia universale
Il destino imperiale della libertà
Catone e Cesare secondo Dante
di Luciano Canfora (Corriere della Sera, 07.01.2015)
In tutta la tradizione antica (archetipo il duello oratorio messo in scena da Sallustio) Catone è l’anti-Cesare. Aggiungiamo che, per il ritratto di Catone, Dante ha fatto capo alla fonte più ostile a Cesare e maggiormente esaltatoria nei confronti di Catone: la Farsaglia di Lucano. Il Catone di Dante è infatti, già nel sembiante fisico, il Catone della Farsaglia (II, 373-375), vecchio (ma in realtà egli era men che cinquantenne quando si suicidò per la sconfitta) e canuto e dotato di una barba imponente.
E non v’è possibilità di equivoco sul tono duramente anti-cesariano di Lucano che si spinge, nel IX libro, a definire Catone «vero pater patriae» (IX, 601), con evidente allusione polemica alla servile proclamazione di Augusto come pater patriae da parte del Senato nel 2 a.C. Che Lucano fosse il cantore della resistenza repubblicana a Cesare era chiaro a qualunque lettore. Si può guardare in proposito anche la sintetica biografia dell’Uticense nell’opuscolo assai diffuso nel Medio Evo De viris illustribus urbis Romae.
Importanti e autorevoli voci quali quelle di Agostino (DeCivitate Dei I, 23-24) e di Tommaso d’Aquino condannavano di Catone anche il gesto finale - il suicidio in nome della libertà - che invece Dante sacralizza. Per Dante, Catone è colui che «vita rifiuta» per la libertà (Purgatorio II, 72-75): ed è proprio quel gesto estremo che lo spinge a conferire a Catone un ruolo primario all’ingresso del regno della luce.
E nondimeno la vittoria di Cesare su Catone, a Tapso, premessa del suicidio eroico dell’irriducibile repubblicano, rappresenta, nel VI del Paradiso, nelle parole di Giustiniano, il culmine della marcia trionfale di Cesare, che a sua volta campeggia al centro del profilo della storia di Roma concepita come marcia trionfale dell’aquila imperiale (versi 55-72, in particolare 70-72: «Da onde scese folgorando a Iuba (...) ove sentía la pompeiana tuba»).
Dante compone questo dissidio in una visione più alta. Nel superamento di questa contraddizione si manifesta e prende corpo quello che potremmo definire il sincretismo storiografico di Dante alle prese con la storia di Roma: una storia da lui concepita unitariamente, in cui la fase repubblicana non solo precede cronologicamente ma prepara l’impero.
L’impero è per lui parte essenziale di un disegno divino, e Cesare ne rappresenta il motore principale. È questo il senso del grande affresco storico che prende le mosse da Enea e Pallante e giunge fino alla storia contemporanea di Firenze (!), tracciato da Giustiniano nel VI canto del Paradiso. E a ragion veduta, e con chiara intenzione, proprio da Giustiniano, cioè dall’imperatore che non soltanto riunifica l’impero riconquistando l’Occidente, ma che incarna nel modo più incisivo il cesaropapismo bizantino, la totale non-subordinazione dell’impero rispetto alla Chiesa.
Quel profilo storico affidato a Giustiniano è il nocciolo della visione dantesca della storia di Roma, è uno degli epicentri ideologici dell’intero poema ed è il corrispettivo poetico del trattato Sulla monarchia incastonato in un punto nevralgico del poema teologico.
Non abbiamo «perso per strada» l’aporia da cui siamo partiti. Catone rifiuta Cesare e si uccide per testimoniare al grado più alto il valore della libertà . La contraddizione rispetto all’asserito ruolo storico dell’opera di Cesare sarebbe lancinante se la chiave non fosse proprio nella nozione di libertà. È la libertà come consapevolezza della necessità , quella che Dante «va cercando», come Virgilio spiega a Catone.
Come la libertà del cristiano - quella che Dante «va cercando» - si pone agli antipodi dell’arbitrario soddisfacimento delle proprie pulsioni e si realizza nella consapevole autodisciplina, così la libertà che ricongiunge il gesto di Catone al compito storico di Cesare e poi del «baiulo seguente», cioè di Augusto, pacificatore universale, è l’accettazione dell’impero come unica possibile e positiva cornice della convivenza umana. Altro destino tocca invece ai pugnalatori Bruto e Cassio, che «latrano» nel punto più profondo dell’ Inferno , in bocca a Lucifero (XXXIV, 65), addirittura insieme con Giuda. Tradire Cristo e tradire Cesare sono sullo stesso piano!
E come armonicamente la vicenda dell’impero di Roma passa dalla fase repubblicana a quella monarchica, altrettanto armonicamente - nella visione dantesca lontanissima dalla battagliera opzione anticlassica di un Agostino - la cultura classica (pagana) confluisce come complementare praeparatio in quella cristiana: da Virgilio a Stazio (figura strategica al centro del poema: XXI e XXII del Purgatorio ), a Dante stesso. Ecco perché il Purgatorio si apre con l’invocazione, che ad un palato ortodosso può apparire blasfema, alle «Sante Muse». Le Muse, la quintessenza della cultura classica pagana, vengono gratificate con l’epiteto della santità.
Orbene, anche questa continuità classico-cristiana, che salva la cultura pagana facendo capo alla salvifica nozione di praeparatio (donde il castello del Limbo, donde il ruolo di Virgilio) converge verso la centralità dell’impero: perché l’impero stesso si è cristianizzato senza cambiare natura, come spiega Giustiniano. Semmai l’errore è stata la «donazione di Costantino», e Dante lo dice in prima persona più volte: Inferno XIX, 115; Purgatorio XXXII, 124; Paradiso VI, significativamente all’inizio del Canto di Giustiniano; e inoltre Monarchia III, 10, 12.
La monarchia universale creata da Roma è dunque, nella sua visione, non solo l’approdo di una lunga storia, ma anche ideale politico attuale e risposta necessaria e urgente al problema politico quale si manifesta nel presente.
-
> LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE, E IL VATICANO CON IL SUO TRADIZIONALE SOFISMA DELLA "FALLACIA ACCIDENTIS". --- Quel Dio che Dante non può descrivere (di Walter Siti).28 dicembre 2014, di Federico La Sala
Nei versi finali del Paradiso si compie l’obiettivo che il poeta porta con sé durante tutto il viaggio ultraterreno. Ma è difficile raccontare quel che vede perché la sua potenza immaginativa e rappresentativa si è annullata nell’istante stesso in cui si realizzava il proprio fine
Quel Dio che Dante non può descrivere
La Commedia è una “visione in sonno” e il suo autore è convinto della portata profetica della propria narrazione. Egli si sente un predestinato
di Walter Siti (la Repubblica, 28.12.2014)
STAVOLTA non si tratta di una lirica autonoma: sono i 31 versi finali dell’ultimo canto del Paradiso. Qui giunge al termine, e al culmine, un’opera che Dante si portava dietro da una ventina d’anni - e qui il viaggio ultraterreno tocca il suo obiettivo, la visione di Dio. È dall’inizio del canto, e anche da prima, che Dante sta lottando (lui che ha sofferto di malattie oftalmiche e per questo si è raccomandato a Santa Lucia) con la propria acutezza visiva: le preghiere dei beati e l’intercessione di Beatrice gli danno la Grazia necessaria per ficcare sempre più gli occhi nei misteri dell’essenza divina, per successive approssimazioni. Già ha visto, nei versi precedenti, come in Dio sia racchiuso e compresso l’universo, «legato con amore in un volume »; le categorie di spazio e tempo sono saltate e lui continua a scusarsi dell’impotenza espressiva («riesco a raccontare quel che ho visto, e inteso, in percentuale così minima che dire “poco” non rende l’idea»).
Ora vede altre due cose che rappresentano incomprensibili dogmi della religione: la Trinità e le due nature di Cristo. Gli appaiono tre cerchi sovrapposti, con stesso centro e stesso raggio, ma che, ciò nonostante, si distinguono l’uno dall’altro: il secondo sembra un riflesso del primo e il terzo (lo Spirito Santo) si riflette come un fuoco su entrambi. Il secondo poi (quello “riflesso”), dà l’impressione di aver dipinta dentro una figura nel medesimo colore dello sfondo - ulteriore impossibilità fisica che però si impone all’intelletto e allo sguardo. Il secondo cerchio rappresenta il Figlio ed è l’umanità di Cristo quella che si disegna, visibile-invisibile, nella divinità del cerchio.
Dante si sforza di capire come l’immagine si stagli sullo sfondo ad essa omogeneo e fa lo stesso sforzo degli studiosi di geometria quando cercano di venire a capo della quadratura del circolo; ma la sua mente non arriva a tanto - senonché proprio in quel momento viene colpito da una folgorazione in cui la comprensione assoluta si realizza. Dante ha capito i dogmi, ha capito Dio; ma non riesce a raccontarlo perché la sua potenza immaginativa e rappresentativa (la “fantasia”) si è annullata nell’istante stesso in cui realizzava il proprio fine.
Si è discusso a lungo se il viaggio della Commedia sia da intendere come finzione poetica o come effettiva visione mistica dell’aldilà; insomma se Dante credesse davvero di aver “visto” ciò che racconta. Io sono tra chi ritiene che la Commedia sia una “visione in sonno” e che Dante fosse convinto della portata profetica del suo racconto; soffriva periodicamente di crisi epilettiche e fin dal tempo della Vita nova aveva interpretato queste crisi come segno di predestinazione, che il suo corpo fosse un recipiente adatto a illuminazioni trans-sensoriali.
Nella sua epoca le visioni venivano prese sul serio, se ne distinguevano varie specie e nessuno metteva in dubbio che fossero un veicolo per la verità (una volta escluse le loro contraffazioni diaboliche). Inoltre la “visio” era un genere letterario diffuso, un collaudato contenitore narrativo. Dante è «pien di sonno» quando entra nella selva oscura e qui in paradiso, nel penultimo canto, San Bernardo lo incita ad affrettarsi perché il tempo del sonno sta per finire.
Nella lunga durata del poema questo assunto talvolta si perde, Dante stesso un po’ se lo dimentica e il viaggio diventa, sul modello dei classici latini, epico e fantastico; ma nel finale l’esperienza mistica risorge potente. Anzi, accade qualcosa di straordinario e inedito: l’esperienza è talmente viva che impegna non solo il Dante “addormentato” ma lui tutto intero nello spingere all’estremo le proprie umane possibilità - qui supera le “visioni” intese come genere letterario e per forza di introspezione arriva a intuire i meccanismi onirici come li intendiamo noi. Il pi-greco della quadratura del circolo è un numero irrazionale che ha rapporto con l’infinito; la distinzione dei cerchi sovrapposti sarebbe comprensibile solo in uno spazio multi-dimensionale; l’acume visivo può coincidere col torpore patologico solo in una logica che superi il principio di non-contraddizione: tutte caratteristiche che la moderna psicanalisi ha riconosciuto come proprie dell’inconscio. Dante insomma, per genio di coerenza poetica, ha reso realistico e autobiografico il “sonno” della tradizione.
Per descrivere l’indescrivibile mette a frutto quello che sa: il linguaggio della filosofia scolastica (la “sussistenza” cioè l’esistenza di un ente senza bisogno di altri enti, il “velle” cioè la volontà), le conoscenze di geometria, le occasioni personali (la nave Argo vista dal basso, di cui si parla in un paragone pochi versi prima dei nostri, ha la stessa forma delle “mandorle” degli affreschi che aveva visto a Roma durante il Giubileo); inventa perfino un verbo che non esiste (“indovarsi” nel senso di “situarsi”); niente di questo basta - entrare nel meccanismo rotatorio dell’Assoluto significa esaurire se stessi (Dante morirà poco dopo) e insieme aver realizzato un’opera che ha l’analogo ritmo ternario di quel meccanismo (la parola “stelle” che conclude ogni cantica); un libro che può gareggiare con quello riassunto in Dio.
-
>DANTE, IL GIUSTO AMORE, E IL VATICANO CON IL SUO TRADIZIONALE SOFISMA --- Le donne e la Chiesa. Le vie del Papa per la questione femminile (di Carlo Marroni).9 luglio 2014, di Federico La Sala
- NOTA INTRODUTTIVA. PER LA CRITICA DELLA FACOLTA’ DI GIUDIZIO E DELLA CREATIVITA’ DELL’ "UOMO SUPREMO" (KANT):
Le donne e la Chiesa
Le vie del Papa per la questione femminile
di Carlo Marroni (Il Sole-24 Ore, 09.07.2014)
«La Madonna è più importante degli apostoli, la Chiesa è femminile, è sposa, è madre, e il ruolo della donna nella Chiesa non solo deve finire come mamma, come lavoratrice... limitata. No, è un’altra cosa!!!». Così esclamava un anno fa papa Francesco durante il viaggio di ritorno dal Brasile, interpellato sul ruolo delle donne nella Chiesa. Un tema ricorrente nell’apostolato del papa argentino, che più volte ha messo la donna al centro dell’attenzione. Qualcosa sta cambiando? Il tema è affrontato e analizzato da Papa Francesco e le donne, un bel libro pubblicato dal Sole 24 Ore in collaborazione con l’Osservatore Romano, in edicola da oggi e per un mese insieme al quotidiano. *
Il libro raccoglie tutti i testi in cui il Pontefice ha parlato della "questione femminile" nella Chiesa. Testi efficaci, profondi, sorprendenti, che hanno suscitato attenzione e che sono introdotti da due saggi di Giulia Galeotti e della storica Lucetta Scaraffia, firme di punta del quotidiano della Santa Sede, diretto da Giovanni Maria Vian, che da due anni pubblica un inserto mensile femminile.
«In un contesto di emancipazione femminile realizzato, quale è quello dei Paesi occidentali, l’atteggiamento della Chiesa sembra invece rovesciarsi. Soprattutto in una cultura in cui l’emancipazione delle donne è misurata sul libero accesso agli anticoncezionali e sulla legalizzazione dell’aborto, la Chiesa viene percepita come una nemica dell’emancipazione. A questo conflitto culturale si aggiunge - scrive Lucetta Scaraffia - l’assenza di donne nelle sfere decisionali della Chiesa, benché le religiose siano, almeno per ora, molto più numerose dei religiosi. Inoltre, esse sono in genere relegate in ruoli di sottoposte con compiti subalterni".
Gli ultimi dati disponibili, risalenti al 2012, dicono che le religiose cattoliche nel mondo sono 702.529, i religiosi (esclusi i sacerdoti) 55.314: a livello mondiale i maschi costituiscono il 7% della comunità religiosa cattolica. Le proporzioni cambiano se ai maschi religiosi sommiamo i vescovi (5.133) e i sacerdoti (414.313): in questo caso il peso femminile risulta ridimensionato, ma le donne rappresentano comunque il 60% della Chiesa consacrata, quindi un’ampia maggioranza. "Le donne nella Chiesa ci sono - scrive Giulia Galeotti - sono molte e fanno tantissimo (...) Eppure non contano. È incredibile la discrasia tra il reale impegno femminile nella Chiesa a tutti i livelli e il misero spazio che è loro lasciato ai vertici (...) Davvero - si chiede Galeotti a proposito degli uomini di Chiesa - non vedono oppure torna loro più comodo fingere di non vedere?".
Emblematiche appaiono le parole di suor Viviana Ballarin, che in passato ha guidato l’organismo da cui dipendono gli ordini femminili italiani: "È ancora raro che nella Chiesa siano affidati alle donne ruoli a più ampio respiro, di responsabilità, di decisionalità". La causa? Per Ballarin alla fine il nodo è un influsso culturale che "influenza e condiziona anche la Chiesa degli uomini. Ma non la Chiesa di Cristo". Parole coraggiose in un contesto "gerarchico" come quello ecclesiastico, che testimoniano come il dibattito sul tema sia franco e aperto, con prese di posizione decise.
In questo contesto sono provvidenziali le posizioni di Francesco che denuncia con una sincerità e un coraggio nuovi la condizione di subalternità in cui si trovano oggi le donne nella Chiesa. Dal libro emerge anche un’ansia di fondo, il timore che la straordinaria apertura del papa, per quanto forte e autorevole, da sola non sia sufficiente per un cambio strutturale e duraturo, che richiede una riflessione profonda a tutti i livelli.
E infatti l’ultimo capitolo del libro si intitola "Un cantiere aperto", "un cantiere - scrive Scaraffia - di cui il Papa indica sempre più nettamente le caratteristiche. Cominciare ad affrontare la situazione dal punto di vista teologico significa muoversi in una direzione ben lontana da quella auspicata da chi pensa semplicemente che la Chiesa si debba adeguare al mondo, introducendo donne a tutti i livelli di potere di decisione".
*
“La donna per la Chiesa è imprescindibile” Il rivoluzionario pensiero di Papa Bergoglio sulle donne
 Papa Francesco e le donne
Papa Francesco e le donne
 Edizioni Il Sole 24 Ore,
Edizioni Il Sole 24 Ore,
 Dal 9 luglio in edicola a 9,90 euro
Dal 9 luglio in edicola a 9,90 euro«Papa Francesco, rivoluzionario per tanti aspetti, lo è anche per quanto riguarda la questione delle donne nella vita della Chiesa. Bergoglio denuncia con una sincerità e un coraggio veramente nuovi la condizione di subalternità in cui si trovano oggi le donne nella Chiesa, e chiede uno studio teologico approfondito per motivare una loro presenza più autorevole. Un approfondimento necessario non solo per risolvere la questione femminile, ma anche per riformare la Chiesa facendone il luogo dell`accoglienza, della compassione, dell`amore fraterno».
-
> LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE, E IL VATICANO --- Papa Francesco: serve una «teologia fatta in ginocchio» (di Alessandro Gisotti)29 giugno 2014, di Federico La Sala
Ecumenismo
Papa: serve una «teologia fatta in ginocchio»
di Alessandro Gisotti - Radio Vaticana (Avvenire, 28 giugno 2014)
Bisogna lasciarsi guidare dallo Spirito Santo per avanzare verso l’unità dei cristiani. E’ l’esortazione levata da Papa Francesco nell’udienza alla Delegazione ecumenica del Patriarcato di Costantinopoli, ricevuta alla vigilia della Solennità dei Santi Patroni di Roma, Pietro e Paolo. Il Pontefice ha sottolineato che anche partendo da prospettive diverse, attraverso una “teologia fatta in ginocchio” si può arrivare ad un cammino di unità.
Condividere la gioia di essere fratelli. Papa Francesco si è rivolto alla delegazione della “Chiesa sorella di Costantinopoli” rivolgendo innanzitutto il pensiero al Patriarca ecumenico Bartolomeo I, “amato fratello” con il quale ha vissuto insieme l’esperienza del pellegrinaggio in Terra Santa e poi la Preghiera per la pace nei Giardini Vaticani.
Il Papa ha ricordato l’abbraccio tra Paolo VI e Atenagora. Un gesto profetico, ha osservato, che ha dato “impulso ad un cammino” che “non si è più arrestato”: “Il Signore ci ha donato queste occasioni di incontro fraterno, nelle quali abbiamo avuto la possibilità di manifestare l’uno all’altro l’amore in Cristo che ci lega, e di rinnovare la volontà condivisa di continuare a camminare insieme sulla strada verso la piena unità”.
Sappiamo bene, ha aggiunto, che “questa unità è un dono di Dio” ed ha ribadito che grazie alla “forza dello Spirito Santo” possiamo “guardarci gli uni gli altri con gli occhi della fede”, “riconoscerci per quello che siamo nel piano di Dio” e “non per ciò che le conseguenze storiche dei nostri peccati ci hanno portato ad essere”:
 “Se impareremo, guidati dallo Spirito, a guardarci sempre gli uni gli altri in Dio, sarà ancora più spedito il nostro cammino e più agile la collaborazione in tanti campi della vita quotidiana che già ora felicemente ci unisce”.
“Se impareremo, guidati dallo Spirito, a guardarci sempre gli uni gli altri in Dio, sarà ancora più spedito il nostro cammino e più agile la collaborazione in tanti campi della vita quotidiana che già ora felicemente ci unisce”.Questo sguardo teologale, ha proseguito, “si nutre di fede, di speranza, di amore”. Esso, è stata la sua riflessione, “è capace di generare una riflessione teologica autentica”, che è in realtà “partecipazione allo sguardo che Dio ha su se stesso e su di noi”. Una riflessione, ha affermato, “che non potrà che avvicinarci gli uni agli altri, nel cammino dell’unità, anche se partiamo da prospettive diverse”:
 "Confido pertanto, e prego, affinché il lavoro della Commissione mista internazionale possa essere espressione di questa comprensione profonda, di questa teologia “fatta in ginocchio”.
"Confido pertanto, e prego, affinché il lavoro della Commissione mista internazionale possa essere espressione di questa comprensione profonda, di questa teologia “fatta in ginocchio”.La riflessione sui concetti di primato e di sinodalità, sulla comunione nella Chiesa universale, sul ministero del Vescovo di Roma, non sarà allora un esercizio accademico né una semplice disputa tra posizioni inconciliabili.
“Abbiamo tutti bisogno di aprirci con coraggio e fiducia all’azione dello Spirito Santo - ha soggiunto - di lasciarsi coinvolgere nello sguardo di Cristo sulla Chiesa” nel cammino di un “ecumenismo spirituale rafforzato dal martirio” di tanti cristiani che “hanno realizzato l’ecumenismo del sangue”.
-
> LA "MONARCHIA" --- Dante. Altro che Commedia! Le opere politiche e filosofiche delineano un audace progetto culturale (di G, Briguglia)18 maggio 2014, di Federico La Sala
Dante. Altro che Commedia!
Esce il secondo tomo dei «Meridiani». Le opere politiche e filosofiche delineano un audace progetto culturale
di Gianluca Briguglia (Il Sole, 18.05.2014)
- Dante Alighieri, Opere, edizione diretta da Marco Santagata, Volume secondo, Convivio, Monarchia, Epistole, Egloghe, a cura di Gianfranco Fioravanti, Claudio Giunta, Diego Quaglioni, Claudia Villa, Gabriella Albanese, Mondadori, I Meridiani, pagg. 2.000, € 65,00
Dante filosofo e pensatore politico è il protagonista del secondo volume delle Opere di Dante, edizione diretta da Marco Santagata, appena uscito per i Meridiani Mondadori. Il corposo volumetto, quasi duemila pagine, propone infatti il Convivio, cioè il grandioso e non concluso esperimento filosofico dantesco in lingua volgare, la Monarchia, con cui Dante, in latino, dimostra la necessità di un governo universale, le Epistole, che testimoniano di un Dante che è anche parte attiva della politica del suo tempo e le Egloghe, unica testimonianza poetica dantesca in latino.
«Tutti li uomini naturalmente desiderano di sapere»: è con la citazione di Aristotele che si apre il Convivio e si annuncia il progetto rivoluzionario di cui è portatore, cioè la possibilità di una vera filosofia in lingua volgare. Dante - che dei quindici trattati previsti per il Convivio ne porta a compimento quattro, con il commento a tre canzoni - vuole mostrare «la gran bontade del volgare del sì», che è capace di esprimere «altissimi e novissimi concetti convenevolmente, sufficientemente ed acconciamente». Gianfranco Fioravanti, raffinato studioso della filosofia medievale e curatore di questa edizione del Convivio, nel suo imponente commento mostra come la cultura filosofica di Dante si nutrisse della conoscenza diretta di un buon numero di opere aristoteliche, ma anche del complesso Liber de causis e di testi importanti di Alberto Magno fino alla Summa contra Gentiles di Tommaso d’Aquino.
Il Convivio non è infatti una semplice opera di divulgazione di contenuti filosofici in volgare. Si tratta invece di un progetto di radicale rinnovamento della cultura e della società: gli intellettuali delle università, i chierici e il loro latino, hanno chiuso il sapere in un monopolio linguistico e di ceto che il volgare vuole rompere. Il sapere va trasmesso ai molti, perché solo così si moltiplica per tutti, proprio come il pane evangelico. I destinatari dell’opera sono allora «principi, baroni, cavalieri e molt’altra nobile gente, non solamente maschi ma femmine, che sono molti e molte in questa lingua, volgari, e non litterati».
Il quarto trattato, aperto dalla canzone Le dolci rime d’amor ch’io solìa - che Claudio Giunta, curatore delle tre canzoni del Convivio, ci aiuta a comprendere anche nel quadro dell’evoluzione personale delle scelte linguistiche e tematiche di Dante - è allora un esempio di quaestio filosofica in volgare, ed è un’indagine razionale sulla vera nobiltà, tema essenziale per capire come la società vada intesa e rinnovata. Fioravanti mostra la complessità della risposta dantesca: la vera nobiltà è data da un intreccio di caratteristiche personali, legate alla nascita, alla complessione, alla natura, all’ambiente, alla capacità individuale di coltivare i propri talenti; il «divino seme» cade nei singoli, ma non si esclude la possibilità di una concentrazione di «bene nati» in uno specifico lignaggio. La filosofia, in volgare, è rivolta a tutti loro.
La Monarchia - con cui Dante s’interroga sulla necessità di un governo universale, sulla missione storica del popolo romano, sulla relazione tra impero e papato - ci riconduce al contesto del latino e dell’originalissimo pensiero politico dantesco. Diego Quaglioni, curatore dell’opera e profondo conoscitore del pensiero giuridico medievale e moderno, nel corposo lavoro di commento prende posizione su interpretazioni classiche come l’idea che la Monarchia sia il semplice esercizio di un’«utopia politica» e la inserisce nello sviluppo del diritto pubblico del tardo medioevo, rendendo più chiara anche la specifica posta in gioco giuridica del discorso dantesco.
Quaglioni presenta qui un testo latino basato sull’edizione critica di Prue Shaw, ma che propone in molti punti specifici alcune scelte differenti. Particolarmente interessante è la discussione di Quaglioni su uno specifico manoscritto (l’Additional 6891) conservato alla British Library e non utilizzato dalla Shaw. Si tratta di un manoscritto del XIV secolo, già segnalato, che presenta alcune particolarità. Per esempio il copista, nell’indicare il titolo e l’autore dell’opera, si sente autorizzato a segnalare l’avvenuta morte di Dante («...la cui anima riposi in pace»): c’è dunque memoria di Dante ancora vivo?
Se così fosse il manoscritto potrebbe allora risalire ad anni forse molto vicini alla stesura dell’opera. E questo renderebbe importante un altro particolare, cioè il fatto che, in questo manoscritto, un famoso inciso che rimanda al Paradiso («...come ho già detto nel Paradiso della Commedia»), presente nelle altre copie, si legge diversamente e ha tutt’altro significato. Certo sembra un dettaglio - che qui riportiamo perché fornisce al lettore anche uno scorcio sul complesso lavoro filologico delle interpretazioni storiche -, ma un dettaglio che per Quaglioni elimina uno dei pochi appigli interni sulla misteriosa cronologia dell’opera (gli interpreti infatti non sono in grado di dare una datazione univoca della Monarchia) e mette in questione alcune antiche certezze sul testo e sulla sua ricostruzione.
Le Epistole sono in massima parte indirizzate a personaggi politici di primissimo piano e comprendono anche la famosa e controversa lettera a Cangrande della Scala, in cui Dante spiega i princìpi di lettura e interpretazione della Commedia. Il commento e la cura di Claudia Villa consentono non solo una puntualissima contestualizzazione di temi e vicende, ma hanno il merito di intrecciare la scrittura delle epistole nel tessuto ampio dell’evoluzione di Dante e del suo immaginario politico e letterario.
Sono invece le Egloghe, corrispondenza poetica in quattro carmi in latino tra Dante e Giovanni del Virgilio, a chiudere il volume. Si tratta dell’ultima opera di Dante e della sua unica prova poetica in latino, sollecitata proprio da Giovanni del Virgilio, che apparteneva a quel gruppo di avanguardia classicista umanista di area padana che nel latino vedeva la forma espressiva più alta e dal quale Dante era rimasto significativamente distante.
La bella introduzione di Gabriella Albanese, che cura le Egloghe e ne fornisce un’edizione critica, ci parla di un Dante nel pieno delle sue forze e della sua creatività, che a Ravenna esercita l’arte diplomatica per Guido da Polenta ed è lontano dalla mischia politica: in un contesto tanto favorevole, godendo anche del compimento del suo straordinario lavoro intellettuale, senza presagire la morte improvvisa, Dante stava forse già pensando con questi componimenti a un’altra eccezionale sfida letteraria, quella della poesia in lingua latina.
-
>IL VATICANO CON IL SUO TRADIZIONALE SOFISMA --- DOPO BENEDETTO XVI. La Chiesa ha bisogno di una riforma profonda (di Christian Terras - "Le Monde").15 febbraio 2013, di Federico La Sala
- AI CARDINALI, PER L’ELEZIONE DEL NUOVO PAPA, NELLA CAPPELLA SISTINA: GUARDARE IN ALTO! L’orologio della storia della Chiesa è fermo almeno da 500 anni. I Profeti e le Sibille insieme nella Volta della "Cappella Sistina" (Michelangelo, 1512) sono ancora un grosso problema ...
- IL MESSAGGIO EVANGELICO DEL(LA) "LUMEN GENTIUM" O IL CATTOLICESIMO RATZINGERIANO DEL(LA) "DOMINUS IESUS"? I "DUE CRISTIANESIMI" E LA PROPRIA FACOLTA’ DI GIUDIZIO. "Perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto?". "Deus charitas est" (1 Gv. 4.8)!
 LA SOVRANA CERTEZZA DI BENEDETTO XVI - RATZINGER E L’OSCURO AVVENIRE DELLA CHIESA: IL SONNO DOGMATICO DEI VESCOVI.
LA SOVRANA CERTEZZA DI BENEDETTO XVI - RATZINGER E L’OSCURO AVVENIRE DELLA CHIESA: IL SONNO DOGMATICO DEI VESCOVI.
La Chiesa ha bisogno di una riforma profondadi Christian Terras*
in “Le Monde” del 15 febbraio 2013 (traduzione: www.finesettimana.org)
Che il papa dia le dimissioni a causa dell’età, è già un fatto eccezionale! Ma che aggiunga a questa motivazione quella di un mondo che avanza troppo rapidamente per lui è una cosa da sottolineare. A questo punto, come interpreterà il suo atto, il suo successore? Per governare la barca di Pietro in un mondo ricco di cambiamenti, occorre un pontefice che li accolga o che li rifiuti? Alcuni riterranno che a questa alternativa manca la prospettiva di un’accoglienza critica della postmodernità. Perché, di fatto, le dimissioni di Benedetto XVI illuminano di nuova luce la crisi attraversata dalla Chiesa.
Dopo il grande discorso d’addio di Gesù, i suoi discepoli sanno di essere nel mondo senza essere del mondo, ma non hanno ancora finito di discernere il modo in cui possono essere testimoni del Vangelo. Ma da quando la religione non struttura più la realtà sociale, siamo messi di fronte ad una situazione inedita nella storia dell’umanità: quest’ultima può vivere come se Dio non esistesse!
Benedetto XVI ha lottato contro questa scomparsa di Dio come fondamento della verità dell’umano. Avrebbe lottato fino all’esaurimento? Stando così le cose, le sue dimissioni non sarebbero il segno di un fallimento di questa battaglia persa in anticipo?
Il prossimo papa potrebbe chiarire in quale modo la mentalità contemporanea ci permette di scoprire un nuovo volto di Dio, in fedeltà con l’itinerario di Cristo. Per il papa attuale, solo la sottomissione a Dio, e quindi alla sua Chiesa che ne interpreta le volontà, permette di scoprirla. Ma non è possibile immaginare diversamente la relazione con la trascendenza?
La Chiesa ci mostra un Dio nascosto nella carne del mondo che le autorità religiose rifiutano di vedere! Dio non è più in competizione con l’umanità. La sua alterità penetra il nostro desiderio, il suo infinito vive nella nostra finitezza. Gesù ci ha insegnato a scoprirlo nei più piccoli, che sono i suoi fratelli.
La questione della verità è quindi intimamente legata a quella della solidarietà. Se Dio si fa solidale, è per insegnarci un altro modo di vivere con gli altri.
L’imitazione di Cristo ci proibisce quindi di assomigliare agli scribi che impongono agli altri i fardelli di una legge falsamente divina. Se il pontefice romano vuole assomigliare a Gesù dovrà, come lui, essere accogliente e dialogante, soprattutto con coloro che sono rifiutati. Non si tratta di carità compassionevole, ma di una lotta con coloro che rifiutano le strutture economiche e politiche inique.
Ma che la verità si trova in un dialogo solidale implica anche un nuovo modo di governare. I vescovi, tra cui quello di Roma, non possono più pretendere di sapere per e al posto degli altri. Sono al contrario invitati a cercare un Dio sempre più grande che sfugge ai nostri ragionamenti.
La Chiesa istituzionale adotta ancora nella maggior parte dei casi il comportamento dei farisei, nel meglio e nel peggio. Come loro, corre il rischio allontanarsi da coloro che credono, pensano e vivono diversamente da come prevedono le sue definizioni.
Certo, la Chiesa ha fatto, dal Vaticano II, degli sforzi di dialogo, ma a livello pastorale. La teologia non ne è stato toccata. Il catechismo resta lo stesso e le voci discordanti all’interno della Chiesa faticano a farsi sentire. E il cardinale Ratzinger è stato l’artigiano di una “stretta” sui teologi, privando la chiesa di una ricerca indispensabile, in particolare in dialogo con le scienze umane.
Questo modo di governare è diventato insopportabile per i nostri contemporanei per i quali l’autonomia è ineliminabile. È anche in contraddizione con la testimonianza del Nuovo Testamento.
Dall’accoglienza della Samaritana o dell’adultera a quella del buon ladrone sulla croce, Gesù ha spezzato i confini delle leggi disumane. Ogni incontro è stato l’occasione per dire un Dio che libera. Ha aiutato i suoi discepoli a trasgredire delle tradizioni percepite come divine mentre erano solo umane.
La Chiesa è ancora invitata a proseguire questo lavoro di decostruzione. Del resto Luca negli Atti non nasconde i conflitti che portarono la Chiesa ed abbandonare certe prescrizioni, inventando nuovi ministeri e precisando le esigenze della fede. Questi racconti devono ispirare l’agire pontificio.
In materia di morale familiare, ad esempio, è indispensabile un vero dialogo all’interno della Chiesa con le coppie divorziate risposate o le persone omosessuali, nonché il tener conto delle problematiche del genere. Le donne non potranno più essere ancora a lungo messe da parte e impiegate in compiti subalterni.
È anche urgente che il ministero petrino sia messo in tensione con la figura di Paolo: Pietro non ebbe ragione senza l’apostolo dei gentili. Tra i vescovi deve circolare una parola libera su tutti i problemi cruciali del nostro mondo. Non sono semplici cinghie di trasmissione della curia romana.
Inoltre, è altrettanto urgente uno scambio franco e onesto con le Chiese sorelle, soprattutto con i protestanti. È una condizione perché il vangelo si radichi in tutte le culture. Il papa non potrà neppure trascurare l’opinione dei fedeli. Ascoltare come rendono conto del loro modo di vivere, permetterà alla Chiesa di sfuggire alla logica caricaturale del bianco e nero, cercando il senso in tutte le zone grige delle nostre esistenze, per parlare come il defunto cardinal Martini.
In questo senso, ciò di cui la Chiesa ha bisogno non è tanto un nuovo concilio di vescovi, quanto una riforma fondamentale sui temi istituzionali e dottrinali. Essa potrà così essere testimone della pertinenza del cristianesimo nella nostra postmodernità e dire Dio diversamente in un nuovo modo di fare Chiesa, in un dialogo aperto con il mondo, per tentare di raccoglierne le sfide.
*redattore capo di “Golias Hebdo” e di “Golias Magazine”
-
> LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE, E IL VATICANO --- SCIENZA E RELIGIONE. BERTRAND RUSSELL E LA LEZIONE SUL MENTITORE (IGNORATA E ’SNOBBATA’)10 novembre 2012, di Federico La Sala
 COSTITUZIONE E PENSIERO. ITALIA: LA MISERIA DELLA FILOSOFIA ITALIANA E LA RICCHEZZA DEL MENTITORE ISTITUZIONALIZZATO ...
COSTITUZIONE E PENSIERO. ITALIA: LA MISERIA DELLA FILOSOFIA ITALIANA E LA RICCHEZZA DEL MENTITORE ISTITUZIONALIZZATO ...
 BERTRAND RUSSELL: LA LEZIONE SUL MENTITORE (IGNORATA E ’SNOBBATA’), E "L’ALFABETO DEL BUON CITTADINO".
BERTRAND RUSSELL: LA LEZIONE SUL MENTITORE (IGNORATA E ’SNOBBATA’), E "L’ALFABETO DEL BUON CITTADINO". -
> LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE, E IL VATICANO CON IL SUO TRADIZIONALE SOFISMA DELLA "FALLACIA ACCIDENTIS". Un invito alla lettura di due brevi estratti - a cura di Federico La Sala7 novembre 2012, di Federico La Sala
-
> LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE, E LA "FALLACIA ACCIDENTIS" --- Con Aristotele, felici di sapere (di Gianluca Briguglia)19 agosto 2012, di Federico La Sala
Con Aristotele, felici di sapere
di Gianluca Briguglia (Il Sole-24 Ore, 19 agosto 2012)
Chi è ancora abituato a pensare al medioevo filosofico come periodo oscuro e sostanzialmente unitario sarà forse stupito del titolo del convegno organizzato dalla Société internationale pour l’étude de la philosophie médiévale (Siepm), che raduna migliaia di studiosi di medievistica filosofica di tutto il mondo: «I piaceri della conoscenza» (direzione scientifica e organizzazione di Thomas Ricklin e Marc-Aeilko Aris, entrambi docenti alla Lmu di Monaco). Il tema è stato strategico nella ricerca degli ultimi due decenni, ma è ancora ricchissimo e promettente e anzi il convegno, che prevede decine di sessioni e centinaia di relatori, sembra avere tra i suoi obiettivi quello di rilanciare il dibattito e la ricerca su basi ancora più ampie.
Seguiamo qui solo una pista, che è stata il nucleo concettuale di una prima grande fase della ricerca storiografica recente. In che cosa consistono il vero piacere e la vera felicità per l’uomo? Si possono trasformare in una forma di vita? Se domande come queste sembrano perenni, le risposte sono storiche. «Il piacere è conseguenza della conoscenza come l’ombra del corpo». Lo scrive Averroè commentando la Metafisica di Aristotele (libro XII), e un gruppo di filosofi del XIII secolo, tra cui Boezio di Dacia (il cui pensiero è stato analizzato per esempio in Italia da Luca Bianchi e Gianfranco Fioravanti), o Giacomo da Pistoia (oggetto di alcuni bei lavori recenti di Irene Zavattero), lo prende sul serio.
Per costoro l’attività filosofica è la via per la felicità e la ragione è il suo campo proprio. Quella del filosofo è però una professione (è il medioevo che inventa le università, prima non c’erano), e l’affermazione che la vita filosofica è l’unica in grado di raggiungere la vera felicità può essere considerata come la presa di coscienza della forma di vita legata al lavoro effettuato alla Facoltà delle Arti (aspetto sul quale ha insistito a lungo Alain de Libera).
D’altra parte il decimo libro dell’Etica nicomachea di Aristotele sembra parlar chiaro: la vita del filosofo è quella che attualizza pienamente le potenzialità umane. Si è pienamente umani, in quanto si è filosofi: etica e conoscenza si intrecciano, felicità e attività intellettuale, come natura dell’uomo, sono legate. E il filosofo del XIII secolo è appunto il maestro delle Arti, il filosofo di professione riconosciuto da una corporazione, dotato di tecniche per indagare la verità, fornito di un sapere pubblico ma specialistico, di metodi scientifici.
L’immagine del filosofo dell’università - che può raggiungere in questa vita la propria felicità - e lo stile di vita del sapiente morigerato, e anzi quasi ascetico, si fondono allora insieme almeno per un momento dando vita a una nuova figura di intellettuale. Sono dunque in questione classi di domande e progetti di ricerca e vita filosofica molto complesse. Si tratta infatti per questi autori di comprendere come il desiderio di conoscere si strutturi in nuove teorie della conoscenza, quali siano gli oggetti del piacere intellettuale e come essi si incontrino con le facoltà umane o come l’intelletto umano possa incontrare, per sua natura, quello divino (copulatio è il termine che spesso troviamo a indicare quel tipo di unione). Ma si tratta anche di capire quale formazione, tecniche di lavoro e di verificazione della conoscenza siano necessarie e quale ruolo abbiano i filosofi nella ricerca e nel presidio sociale della verità. Dunque idee rilevanti e dal significato dirompente, perché lo spazio di questo nuovo filosofo delinea un modello etico, costruisce una gerarchia di valori che entra in conflitto con altri modelli etici, con altre aspirazioni e concettualizzazioni del piacere e della felicità.
L’attenzione degli storici all’impatto di questa riflessione sulla "felicità mentale" (per usare una fortunata, e variamente utilizzata, espressione di Maria Corti) in un momento preciso e strategico della storia intellettuale europea ha delineato un campo di indagine che si è via via ampliato ad altre fonti (si pensi al Convivio e alla Monarchia di Dante), a una più ampia cronologia (Abelardo e Giovanni di Salisbury avevano già tematizzato un nesso tra piacere e sapere) e alle diverse "durate" storiche del mondo mediterraneo (non solo quello musulmano, ma anche quello greco-bizantino ed ebraico).
Il modello di felicità filosofica di quel gruppo di aristotelici radicali non è dunque l’unico e forse neppure il più ardito (e rappresenta solo una piccola parte degli interessi del convegno di Freising). Ciò che colpisce è il rigore della domanda stessa sulla natura della conoscenza e sulla felicità che essa comporta. Il che significava per loro - e un po’ anche per noi - interrogarsi sulla natura stessa dell’umanità e dei suoi desideri. «Per natura tutti gli uomini desiderano conoscere», avvertiva Aristotele nella Metafisica; e Agostino, certo da una posizione diversa: «Tutti gli uomini vogliono essere felici».
 Siepm 2012, Pleasures of knowledge. International congress of medieval philosophy, Freising (Germania), 20-25 agosto. www.lmu.de/siepm2012
Siepm 2012, Pleasures of knowledge. International congress of medieval philosophy, Freising (Germania), 20-25 agosto. www.lmu.de/siepm2012 -
> LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE, E --- L’indagine di Aristotele alla ricerca della verità. Una nota sul libro I della Metafisica (di Chiara Lalli).16 maggio 2012, di Federico La Sala
L’indagine di Aristotele alla ricerca della verità
Un metodo per avvicinarsi alla conoscenza
di Chiara Lalli (Corriere, 16.05.2012)
Perché dovrebbe interessarci leggere o rileggere il libro I della Metafisica di Aristotele? «Il prefisso iterativo davanti al verbo "leggere" può essere una piccola ipocrisia da parte di quanti si vergognano d’ammettere di non aver letto un libro famoso» scriveva Italo Calvino in Perché leggere i classici, a commento della prima proposta di definizione dei classici, ovvero «quei libri di cui si sente dire di solito "Sto rileggendo..." e mai "Sto leggendo..."». E non c’è dubbio che la Metafisica sia un classico del pensiero, che sembra soddisfare molte delle ulteriori definizioni offerte da Calvino: ogni rilettura è una scoperta e persiste come un rumore di fondo.
Che cosa possiamo trovare o ritrovare in queste pagine aristoteliche? La meraviglia (thauma) della filosofia, la ricerca della verità, la scienza delle cause ultime, la risposta ai problemi che ognuno di noi si trova a risolvere. Certo, la scienza da Aristotele è molto cambiata: il suo universo era lo stesso di Tolomeo, il cosmo immaginato come costituito da cieli concentrici, uno incastrato nell’altro, mossi ognuno da quello precedente e infine dal Primo Mobile, il cielo verso cui tutti gli altri si muovono perché vi tendono, ne sono attratti. Certo, alcune formulazioni aristoteliche possono essere ostiche o quasi incomprensibili per chi non abbia familiarità con le discussioni filosofiche e con gli argomenti trattati.
Tuttavia c’è un primo livello accessibile a tutti: Aristotele ci prende per mano e ci conduce nelle viscere della filosofia, nella filosofia che cerca di definire se stessa e che si offre come metodo di avvicinare la realtà. Non solo: nel I libro, che esce sabato con il «Corriere», è lo stesso Aristotele a confrontarsi con chi lo aveva preceduto e a tracciare quella che potrebbe considerarsi la prima storia della filosofia.
Quel colloquio virtuale con Parmenide, Platone, Empedocle e i Pitagorici è una vera e propria palestra mentale. Un invito a domandarsi il perché e una sfida a cercare ipotesi sempre più convincenti. Una parte rilevante del libro I è dedicata alla definizione della filosofia come conoscenza delle cause e dei principi primi - il perché delle cose. «Diciamo di conoscere una cosa quando riteniamo di conoscerne la causa prima».
Le cause prime sono quattro: materiale, formale, efficiente e finale. La forma e la materia sono profondamente intrecciate: in un tavolo la materia è ciò di cui è fatto, la forma è il modo in cui è realizzato. La forma ha una superiorità ontologica sulla materia, è causa prima dell’essere. Aristotele direbbe che la materia è desiderio della forma. Per gli oggetti artificiali la causa efficiente è l’agente - colui che costruisce il tavolo - ma per i fenomeni naturali? Il rischio è quello di rimandare all’infinito la causa motrice o di ipotizzare un Dio, che secondo Aristotele non basterebbe a spiegare il movimento e la pluralità delle sostanze. Ed ecco che arriviamo alla quarta causa, quella finale, la più affascinante: il movimento si spiega come movimento verso, come tendenza a, come attrazione che ci spinge a muoverci verso qualcosa che è immobile e non ha quindi bisogno di una causa efficiente.
Addentrandoci nel mondo aristotelico possiamo trovare zone d’ombra o formulare domande che non hanno una risposta. Sappiamo che quell’anelito finale è stato messo in crisi, ma il valore dell’ipotesi esplicativa rimane intatto, così come rimane intatta la seduzione di questa spiegazione. Non solo: se la visione teleologica del mondo fenomenico è stata spazzata via - pur permanendo nelle visioni del mondo connotate dalla religione - rimane senza dubbio attuale il metodo aristotelico, quella dialettica che permea non solo la Metafisica ma tutta l’opera di Aristotele. E se è vero che siamo in grado di godere dello spirito dialettico quanto più conosciamo gli argomenti di cui si discute, è innegabile che si può apprezzare - o cominciare ad apprezzare - il metodo anche non avendo familiarità né con la filosofia né con i temi trattati da Aristotele.
Ognuno di noi ha a che fare con la verità e, come dice Aristotele, la verità è alla portata di tutti e dobbiamo imparare a vederla, come gli occhi delle nottole devono abituarsi alla luce del giorno. E a riconoscerla, altrimenti rischiamo di fare come i pesci giovani che si sentono chiedere dal pesce anziano «Com’è l’acqua?» e rispondono «Che diavolo è l’acqua?» (David Foster Wallace al Kenyon College, 1995).
L’angosciato stupore umano
 Corriere 16.5.12
Corriere 16.5.12Autore di estrema densità teoretica, Aristotele, nel primo libro della sua Metafisica (che sarà in edicola il 19 maggio con la prefazione nuova e inedita del filosofo Emanuele Severino) concentra già nei primi tre capitoli non solo le argomentazioni che poi saranno elaborate negli altri libri, quindi la summa della sua metafisica, ma anche un quadro dello stato della filosofia dell’epoca, un ritratto in cui, come illustra Severino nella prefazione, «la filosofia parla della filosofia». Aristotele indaga qui le radici del pensiero filosofico, il suo rapporto originario con il thauma, cioè la meraviglia, ma anche, al tempo stesso, il «mostro», o (come spiega Severino) «l’angosciato stupore» del sapere umano di fronte alla natura. Cosicché, se tramite il mythos l’uomo apprende «da quali Potenze siano prodotti il dolore e la morte, e il mondo stesso», afferma Severino, la filosofia è anche il modo che la sapienza umana ha escogitato per liberarsi dal thauma, dallo spavento, tramite «la conoscenza delle Potenze che producono il dolore». (i.b.)
-
> IL VATICANO CON IL SUO TRADIZIONALE SOFISMA DELLA "FALLACIA ACCIDENTIS". ---- INTERVISTA A SUOR JEANNINE GARMICK. Vittime di un doppio gioco: lo svelamento del tradimento delle suore americane da parte della Chiesa cattolica.15 maggio 2012, di Federico La Sala
 Double Crossed: Uncovering the Catholic Church’s Betrayal of American Nuns
Double Crossed: Uncovering the Catholic Church’s Betrayal of American Nuns
 (Vittime di un doppio gioco: lo svelamento del tradimento delle suore americane da parte della Chiesa cattolica) (dall’intervista a suor Jeannine Garmick della "Lcwr" - Usa).
(Vittime di un doppio gioco: lo svelamento del tradimento delle suore americane da parte della Chiesa cattolica) (dall’intervista a suor Jeannine Garmick della "Lcwr" - Usa). -
>CATTOLICI E CATTOLICHE AMERICANE, A DIFESA DELLA "LCWR". Da Boston a Seattle, da Los Angeles a Washington, davanti alle cattedrali veglie di preghiera e manifestazioni che dureranno fino alla fine del mese (di Céline Hoyeau - I cattolici americani si mobilitano per le loro religiose)10 maggio 2012, di Federico La Sala
I cattolici americani si mobilitano per le loro religiose
di Céline Hoyeau
in “La Croix” del 10 maggio 2012 (traduzione: www.finesettimana.org)
Da Boston a Seattle, da Los Angeles a Washington, davanti alle cattedrali di una quindicina di metropoli americane, martedì sera sono cominciate delle veglie di preghiera e delle manifestazioni che dureranno fino alla fine del mese. “Vogliamo mostrare il vasto sostegno di cui godono le religiose negli Stati Uniti e invitare il Vaticano ad abrogare la dichiarazione critica nei loro confronti”, spiega Jim Fitsgerald del Nun Justice Project, una rete di associazioni cattoliche creata per sostenere la Leadership Conference of Women Religious (LCWR).
Un mese fa, la Congregazione per la dottrina della fede ha chiesto, con l’approvazione di Benedetto XVI, una riforma completa di quell’organismo che rappresenta l’80% delle 57000 religiose americane, ritenendo che le sue prese di posizione dottrinali siano “un argomento di preoccupazione serio e grave”, e facendo riferimento ad un femminismo radicale. Questa decisione ha suscitato la collera di migliaia di cattolici che non comprendono che ce la si possa prendere con delle religiose impegnate a tutti i livelli nella sanità, nell’istruzione, nell’aiuto ai più deboli...
Circolano molte petizioni, una delle quali, sul sito change.org ha già raccolto più di 40 000 firme. In questo dibattito virulento e molto polarizzato, molti non esitano ad opporre senza mezzi termini queste “pioniere della giustizia”, queste “avvocate della pace” al Vaticano e ai vescovi americani accusati di volerle ridurre al silenzio. L’articolo di Nicholas Kristof, famoso giornalista americano, sul New York Times del 28 aprile, riassume questo clima: “Sono le persone più coraggiose, più solide, più ammirevoli del mondo. Durante i miei viaggi ho visto delle religiose eroiche sfidare i signori della guerra, i protettori di prostitute e i banditi. Perfino quando i vescovi sono stati la vergogna della Chiesa coprendo gli abusi sui bambini, le religiose l’hanno riscattata con il loro umile lavoro a favore dei più bisognosi.”
L’associazione Share el Salvador, che ha beneficiato dell’appoggio delle suore negli anni ’80 per l’accoglienza dei rifugiati salvadoregni, coordina una campagna nazionale di raccolta di firme: “Riaffermiamo il nostro amore e la nostra gratitudine, scrivono, per le migliaia di religiose che negli Stati Uniti hanno servito i poveri, curato i malati, accolto i senzatetto, istruito i nostri figli, cercato la pace invece della guerra (...). Rifiutiamo la rivendicazione di certi vescovi di essere l’autorità ultima e i soli arbitri della verità.”
Questo braccio di ferro ha radici molto profonde. Se la LCWR è stata fondata nel 1956 per “facilitare la comunicazione tra il Vaticano e le religiose”, a partire dal 1971, quando ha riscritto i suoi statuti, ha avuto un’evoluzione diventando “un’organizzazione indipendente, professionale, con una propria agenda”, dichiara la giornalista Ann Carey, che ha pubblicato nel 1997 uno studio documentato su Le Suore nella crisi. Secondo lei, molte sono andate oltre rispetto a quello che preconizzava il Concilio. La loro “esperienza vissuta” sul campo è diventata per molte “un riferimento teologico più importante delle voci ufficiali del magistero della Chiesa”.
Ad esempio, nel 2006, le benedettine di Madison (Wisconsin) sono state sciolte dai loro voti per trasformare il loro monastero in un centro ecumenico, dove vivono suore di diverse confessioni. Non vi si celebra più la messa, ma dei culti nel corso dei quali si è invitati a “condividere il pane di vita attorno alla tavola comune”... George Weigel, storico della Chiesa, scrive che in molti casi “la loro vita spirituale è influenzata più da Enneagramme e da Deepak Chopra (NDLR: figura dello sviluppo personale) che da Teresa d’Avila e da Edith Stein, che le loro nozioni di ortodossia sono, per esprimersi gentilmente, innovatrici, e che la loro relazione con l’autorità della Chiesa può essere descritta come un disprezzo appena mascherato.”
A diverse riprese, il Vaticano ha inviato degli avvertimenti alle religiose americane. Nel 1992, una parte delle suore ha lasciato la LCWR e creato un gruppo alternativo, il Consiglio delle superiori maggiori delle religiose (CMSW). Un nuovo avvertimento è stato inviato dalla Congregazione per la dottrina della fede nel 2001. In particolare il Vaticano metteva in discussione gli incontri annuali della LCWR in cui venivano invitati relatori le cui posizioni etiche erano divergenti rispetto a quelle del Magistero della Chiesa. “La Congregazione per la dottrina della fede può aver ricevuto lettere individuali di religiose contestatrici, ma la LCWR, in quanto organizzazione, non ha mai preso ufficialmente posizione contro l’insegnamento della Chiesa”, dichiara padre Thomas Reese, ex redattore capo della rivista America. “Certe suore sono forse andate un po’ troppo in là, ma per la stragrande maggioranza si tratta di persone buone che non fanno altro che cercare di applicare il Vangelo nel quotidiano, e sono rimaste profondamente legate alla Chiesa cattolica. Anche sulla riforma sanitaria di Obama, che comprende il finanziamento dell’aborto e della contraccezione, è vero che alcune religiose si sono opposte ai vescovi, ma non per i contenuti, bensì per la forma.”
Andando più a fondo, si tratta di un “conflitto di potere”, secondo il gesuita. Di fatto, le religiose americane oggi sono piene di diplomi e lauree e dirigono università, ospedali, servizi diocesani, con la levatura di PDG (Presidenti Direttori Generali) di grandi imprese. “Sono donne brillanti, che da decenni si sono specializzate nelle questioni sociali, di istruzione, ecc. I vescovi non devono dire loro ciò che devono pensare”, ritiene padre Reese. Intervistata recentemente dalla Radio pubblica nazionale, Suor Simone Campbell confermava: “Pio XII ha ordinato alle religiose di istruirsi in teologia. Lo abbiamo preso sul serio e lo abbiamo fatto. Ed ora, cercano di modellarci secondo quanto pensano che dobbiamo essere, senza rendersi conto che noi siamo state fedeli all’appello per tutto il tempo.”
-
> CATTOLICI E CATTOLICHE AMERICANE, A DIFESA DELLA "LCWR". --- «CONTINUATE A SOSTENERE LE RELIGIOSE». APPELLO DI EX SUORE AI VESCOVI USA15 maggio 2012, di Federico La Sala
«CONTINUATE A SOSTENERE LE RELIGIOSE». APPELLO DI EX SUORE AI VESCOVI USA *
36679. NEW YORK-ADISTA. «Nessuno spazio per il dissenso; nessuna possibilità di prospettive diverse; nessun modo di impegnarsi nel dialogo su posizioni cattoliche tradizionali e spesso ristrette; in breve, le religiose devono tenersi le loro idee per loro e seguire semplicemente il dettato e la direzione di Roma, pena la censura, imbarazzo pubblico, atteggiamento oppressivo e persino potenziale espulsione». Dopo innumerevoli testimonianze di solidarietà e di appoggio cui hanno dato voce, negli Usa, media cattolici e laici, così inizia una lettera aperta che quindici ex suore statunitensi, capitanate da Helen Urbain-Majzler, direttora di un’istituzione sanitaria di carattere pubblico, hanno inviato ai vescovi del loro Paese - formalmente al card. Timothy Dolan, arcivescovo di New York, con preghiera di condividerla con i confratelli - riguardo all’attacco lanciato dal Vaticano alla Leadership Conference of Women Religious (Lcwr), l’organismo che riunisce i vertici dell’80% delle congregazioni religiose femminili, giudicati da Roma troppo liberal e femministe (v. Adista Notizie nn. 16 e 17/12 e notizia precedente).
Se la Lcwr ha mostrato sorpresa per il provvedimento romano, scrivono le ex-suore, tra le quali medici, psicologhe, docenti universitarie, educatrici, «donne come noi non si sono stupite. Tutte noi - ora ex religiose - abbiamo vissuto molti anni in comunità religiose e abbiamo sperimentato il trattamento crudele e punitivo delle religiose che hanno assunto posizioni coraggiose a livello pubblico per difendere i poveri, i più vulnerabili nella salute, e le vittime della società, tra cui gli omosessuali».
Il Vaticano, proseguono le ex-religiose, non ha riconosciuto i cambiamenti avvenuti nella Chiesa e nella società americana negli ultimi 40-50 anni, nella quale le forze cattoliche, un tempo maggioritarie, hanno lasciato il posto al pluralismo culturale, ma anche religioso; nella quale il cattolicesimo obbediente e mansueto del passato è in gran parte scomparso e numerosissimi sono i fedeli che hanno deciso di abbandonare la Chiesa. «Per molti cattolici adulti - scrivono le suore - le riforme del Vaticano II, così come il divieto della contraccezione naturale da parte della Chiesa, gli scandali degli abusi sessuali, le coperture della gerarchia, hanno cominciato a intaccare l’obbedienza cieca di molti fedeli. Di sicuro, i vescovi americani sono consapevoli del fatto che l’87% dei cattolici si oppone alla proibizione papale della contraccezione artificiale. Forse il Vaticano non ha capito che la cultura occidentale pone più enfasi sulla responsabilità personale».
Anche le superiore delle congregazioni religiose si sono trovate immerse in questa trasformazione e hanno dovuto fare i conti con le mutate esigenze delle donne che facevano parte delle loro congregazioni, nonché pubblico al quale rivolgevano il loro ministero, ma questo cambiamento «non ha messo in discussione l’orientamento spirituale e la fede in Dio», poiché «dottrina e ministero sono questioni separate». Il problema, semmai, è che non si comprende «perché il Vaticano trovi così difficile permettere un dialogo sincero e aperto sul futuro della Chiesa, sulla spiritualità, sulle priorità ministeriali, senza ingenerare paura di un’azione punitiva». E «solo le organizzazioni più repressive e autocratiche temono l’apporto sincero e onesto dei loro membri. Che cosa esprime questo aspetto riguardo all’autorità della Chiesa e alla relazione con le donne, che hanno offerto migliaia di anni di servizio dedicato, coerente e fedele?».
Le suore firmatarie della lettera affermano che l’impatto personale del provvedimento sulle suore della Lcwr, a molte delle quali sono legate da rapporti di amicizia, è stato pesante. «Speriamo che la Conferenza episcopale statunitense mantenga un atteggiamento di apertura mentale e di cuore nei confronti delle leader religiose, e continuino ad apprezzare e promuovere i loro numerosi doni, invece di supportare con atteggiamento mite e obbediente il Vaticano nel mettere al silenzio questa voce dello Spirito nella chiesa di oggi. Speriamo - è la loro conclusione - che abbiate il coraggio di fare la cosa giusta per le donne, anche se non siamo del tutto fiduciose nel fatto che ciò avverrà. Molte di noi hanno lasciato la propria comunità religiosa per il modo in cui le donne venivano trattato. La Chiesa, purtroppo, mostra ancora di avere paura e di volersi difendere dalla nostra influenza. Come potrà sopravvivere la Chiesa se continua a ignorare o a soggiogare metà della popolazione mondiale?».
Nel frattempo si sono moltiplicate, in numerose città statunitensi, veglie di preghiera e di sostegno alle religiose nonché manifestazioni di protesta; per il 29 maggio è stata programmata una grande manifestazione di supporto a Oakland, in California. È stato inoltre lanciato in tempi record un sito, www.nunjustice.org sul quale è possibile, tra l’altro, sottoscrivere le petizioni di sostegno. (ludovica eugenio) * Adista Notizie, n. 19, 19/05/2012
-
-
> LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE, E IL VATICANO CON IL SUO TRADIZIONALE SOFISMA --- IL VIAGGIO DI "ADAMO" (DI OGNUNO E DI OGNUNA)!!! La Commedia di ognuno di noi (di Carlo Ossola).20 marzo 2012, di Federico La Sala
La Commedia di ognuno di noi
di Carlo Ossola (Il Sole -24 Ore, 18 marzo 2012)
Siamo stati formati dalla critica a pensare alla Divina Commedia come «viaggio a Beatrice» (così suona il titolo del celebre saggio di Charles S. Singleton, Journey to Beatrice, 1958). Il fedele d’Amore mantiene la promessa che chiudeva la Vita nova: «Appresso questo sonetto apparve a me una mirabile visione, ne la quale io vidi cose che mi fecero proporre di non dire più di questa benedetta infino a tanto che io potesse più degnamente trattare di lei». Beatrice appare nel Paradiso Terrestre, al sommo della montagna del Purgatorio, ivi trionfa e ivi nomina, per la prima volta nella Commedia, Dante: «Quando mi volsi al suon del nome mio, / che di necessità qui si registra» (Purg., XXX, 62-63). La teoria romantica che da Rossetti a Gourmont ha ispirato la lettura del poema trova qui il suo sigillo.
Ma molti ostacoli presenta tuttavia una lettura siffatta: il primo ed evidente è che Dante si fa lì nominare per essere aspramente rimproverato da Beatrice: «Dante, perché Virgilio se ne vada, / non pianger anco, non piangere ancora; / ché pianger ti conven per altra spada» (Purg., XXX, 55-57). Anche a voler ammettere che Dante si pieghi a un gesto di umiltà, e poi ascenda gloriosamente con Beatrice al Paradiso, sul più bello - come si dice in maniera colorita ma calzante - Dante si fa poi abbandonare da Beatrice: «Uno intendëa, e altro mi rispuose: / credea veder Beatrice e vidi un sene / vestito con le genti glorïose» (Par., XXXI, 58-60).
La guida al mistero e alla visione finale sarà san Bernardo: su questo "transito" Jorge Luis Borges ha scritto pagine finissime e non resta che rinviare ai suoi Nove saggi danteschi. L’ipotesi romantica rimane monca e toglie anzi grandezza al «poema sacro / al quale ha posto mano e cielo e terra» (Par., XXV, 1-2), toglie spessore alla lettura allegorica del testo che Dante difende spiegando, nell’Epistola a Cangrande, e citando nel poema il salmo In exitu Isräel de Aegypto (Purg., II, 46).
Occorre prendere sul serio il testo e ritornare a una ipotesi già avanzata dal Boccaccio e dai primi commentatori e ripresa nel Novecento da Ezra Pound: «In un senso ulteriore è il viaggio dell’intelletto di Dante attraverso quegli stati d’animo in cui gli uomini, di ogni sorta e condizione, permangono prima della loro morte; inoltre Dante, o intelletto di Dante, può significare "Ognuno", cioè "Umanità", per cui il suo viaggio diviene il simbolo della lotta dell’umanità nell’ascesa fuor dall’ignoranza verso la chiara luce della filosofia» (E. Pound, Dante, in Lo spirito romanzo, 1910). Se il protagonista del viaggio è «Everyman», non è più necessario attribuire a Dante viator l’esperienza eccezionale di una visione mistica, ma di riconoscere in lui il volto di Ognuno: per questo «la Commedia di Dante è, di fatto, una grande sacra rappresentazione, o meglio, un intero ciclo di sacre rappresentazioni» (ivi).
La lettura di Pound incontra, dicevamo, la chiosa che il Boccaccio propone sin dall’apertura delle sue Esposizioni sopra la Comedia di Dante, estrema opera della sua vita, suggerendo che non solo da Beatrice Dante si faccia nominare, ma soprattutto da Adamo al sommo del Paradiso: «L’altra persona, alla quale nominar si fa, è Adamo, nostro primo padre, al quale fu conceduto da Dio di nominare tutte le cose create; e perché si crede lui averle degnamente nominate, volle Dante, essendo da lui nominato, mostrare che degnamente quel nome imposto gli fosse, con la testimonianza di Adamo; la qual cosa fa nel canto XXVI del Paradiso, là dove Adamo gli dice: "Dante, la voglia tua discerno meglio", eccetera».
Ora precisamente Boccaccio adotta una lezione, per Par., XXVI, 104, trádita dai più antichi codici (il Landiano, 1336, il Trivulziano, 1337, e molti altri) e confermata dagli antichi commentatori, da Pietro Alighieri, alle Chiose ambrosiane, a Francesco da Buti; lezione che cambia profondamente il senso del poema, poiché ora - nominato da Adamo - Dante non è più solo il fedele d’Amore, ma è il «novello Adamo» di un’umanità redenta, come riassume, nel suo commento, Pietro Alighieri e, con raffinata pertinenza, ribadiscono le «Chiose ambrosiane» (da situare intorno al 1355; traduco dal bel latino): «Dante - Qui il poeta si fa nominare dal primo uomo che impose il nome a tutte le cose e senza quella excusatio alla quale ebbe a ricorrere nel Purgatorio ove disse: "Che de necessità qui se registra". Nota quindi che il poeta mai volle essere nominato nell’Inferno, e neppure nel Purgatorio nei luoghi ove si purgano i vizi, ma concesse di farsi nominare fuori dalle cornici dei vizi, sebbene dovendosi scusare (tamen cum excusatione). Ma in Paradiso senza doversi scusare, come appunto qui - essendo l’opera ormai quasi compiuta - e dopo che, esaminato, aveva fatto professione delle virtù teologali».
Quando parallelamente si osservi il comportamento di Boccaccio copista, in particolare nell’esemplare «Chigiano L VI 213 (= Chig), di mano del Boccaccio, che lo trascrisse non molto avanti la nomina a lettore di Dante, nell’agosto del 1373» (G. Petrocchi, I testi del Boccaccio, in La Commedia secondo l’antica vulgata), si dovrà concludere che anche lì un codice Chig «il quale si impone sugli altri con la qualifica di edizione ultima e definitiva del testo dantesco» (Petrocchi) mantiene la lezione «Dante, la tua voglia discerno meglio» (nel ms. a p. 330; ringrazio di cuore Rudy Abardo per il prezioso riscontro filologico e Marisa Boschi Rotiroti per la sollecitudine) con perfetta coerenza alle ragioni enunciate nelle contigue Esposizioni.
Si tratta dunque di ritornare alle origini, non solo agli autorevolissimi manoscritti che inscrivono: «Dante» o «da- te» e non «da te» (lezione minoritaria), come ha adottato il Petrocchi e con lui - snervando il vigore del testo - le edizioni moderne della Commedia («Indi spirò: "Sanz’essermi proferta / da te, la voglia tua discerno meglio"»); e di riconoscere che - nell’eliminare Dante nominato da Adamo - non si è fatta solo una "rimozione" a favore di una lettura meramente amorosa del poema, ma si è privato il testo stesso di quella grandiosa e universale coralità che Dante voleva conferire al proprio viaggio. Poiché, qui, Dante non è più il poeta della Vita nova, ma l’autore del «poema sacro»; egli è ormai, e per sempre, Everyman, il "novello Adamo" dell’umanità redenta, sì che dal «padre antico» (Par., XXVI, 92) possa ricevere la più alta consacrazione.
Occorre insomma pensare alla Commedia, come a «l’albero che vive de la cima» (Par., XVIII, 29); che si compie nella "nuova Genesi" del Paradiso di Gloria, come ben vide Giovanni Getto, sin dal 1947, sottolineando «cotesto epos della vita interiore come esultanza delle spirito elevato verso le cime vertiginose della partecipazione al Dio della gloria e dell’eterno» (Poesia e teologia nel «Paradiso» di Dante, in Aspetti della poesia di Dante); ma anche come partecipazione dell’umanità tutta alla speranza della Resurrezione della carne della storia e dei corpi, che ansiosamente i beati in Paradiso attendono («Come la carne glorïosa e santa / fia rivestita, la nostra persona / più grata fia per esser tutta quanta», Par., XIV, 43-45).
Così dunque, in questa quotidiana coralità di Everyman, è da proporre al XXI secolo la Divina Commedia, bene comune non dell’Italia soltanto, ma dell’umanità intera; e sempre così è stata intesa, dai primi commentatori al Boccaccio, come il poema al quale bussare e attingere per avere accoglienza, ospitalità, conforto. Lo testimonia ancora, al portale di un palazzo di Cannaregio il battente dantesco, e i tanti uomini che in nome di Dante, e leggendo il suo poema, hanno sfidato la barbarie, da Osip Mandel’štam a Primo Levi. Ogni giorno, Dante è davvero tutti noi.
-
> LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE, E IL VATICANO --- IL GIUDICE ULTRATERRENO: IL POETA GIUDICE. Dante e il tribunale della Commedia (di Nino Borsellino - rec. di Piero Boitani).23 ottobre 2011, di Federico La Sala
Il giudice ultraterreno
di Piero Boitani (il Sole-24 Ore, 23 ottobre 2011)
«Chi dà a Dante il diritto di ergersi a giudice del l’umanità?», domandava in pubblico, qualche anno fa, durante un convegno, una mia amica inglese. «Nessuno: se lo prende da solo», le risposi. E lo fa, si deve ora dire con Borsellino, perché ha un senso e un bisogno profondissimi della giustizia, di cosa essa dovrebbe essere. Sulla porta dell’inferno Dante piazza un’iscrizione che lascia noi moderni turbati: «Giustizia mosse il mio alto fattore: / fecemi la divina potestate, / la somma sapienza e ’l primo amore». L’inferno è stato creato da Dio per giustizia: poiché sulla terra essa non è mai perfetta, e lascia spesso impuniti i colpevoli mentre punisce talvolta gli innocenti, Dio ha fatto l’inferno perché racchiuda in maniera definitiva, per tutta l’eternità, il male del mondo.
Dante non ha né atteggiamenti politicamente corretti né inclinazioni teologiche moderne (l’inferno esiste, dicono alcuni teologi oggi, ma è vuoto, perché in Dio, perfettamente giusto, prevale la misericordia). Tuttavia, ha anche dei dubbi tremendi. Quando nel paradiso incontra gli spiriti giusti e questi formano un’aquila luminosa di stelle, si domanda: uno nasce in India, dove non c’è chi gli predichi il Cristianesimo; le sue azioni sono tutte buone secondo ragione, non commette peccato in pensieri, parole, opere, ma muore non battezzato: «Ov’è questa giustizia che ’l condanna? / ov’è la colpa sua, se ei non crede?». Il buono che non sia stato battezzato finisce, nell’ottica di Dante, al Limbo, che è pur sempre una parte dell’inferno. L’aquila si risponde da sola: nessuno è mai salito in paradiso che non abbia creduto in Cristo, ma l’intendimento di Dio non può essere sondato dall’intelletto umano: il giorno del Giudizio, ci saranno degli Etiopi che condanneranno quei Cristiani dell’apparenza i quali si battono il petto invocando Cristo tutto il giorno!
E poi, esiste anche, grandissimo, il problema della giustizia terrena, umana, e di quella poetica in particolare. Il potente, colui che governa (Giustiniano, Carlo Martello), può essere sempre giusto? E che giustizia è quella che condanna, mettiamo, Paolo e Francesca, Ulisse, o addirittura, in prospettiva, Guido Cavalcanti? Insomma, che giudice è Dante?
Nino Borsellino affronta tutti questi problemi in maniera pacata e sapiente nel libro che inaugura una serie di «Saggi e ricerche» pubblicati dalla Fondazione Sapegno (il suo maestro). Tre splendidi capitoli introduttivi esaminano il problema del rapporto tra giustizia e letteratura quale i millenni, ormai, hanno posto, e il passaggio, in questo ambito, dal divino all’umano: dalla Bibbia a Eschilo a Dante, appunto. Quindi, il corpo centrale affronta, con una serie di indagini su singoli temi o episodi, i «teatri delle cantiche»: l’idea stessa di una natura teatrale della Commedia è feconda, ed ecco svolgersi sotto i nostri occhi le scene memorabili delle metamorfosi, del Limbo, di Farinata e Cavalcante, di Malebolge; poi quelle del Purgatorio (tra i capitoli più affascinanti del volume, quelli su Stazio e Forese); infine quelle del del Purgatorio (tra i capitoli più affascinanti del volume, quelli su Stazio e Forese); infine quelle del Paradiso: Giustiniano, Carlo Martello, Cacciaguida. Una lettura per gradi, appassionatamente argomentata.
Nella sua "pietas", Borsellino salva anche Guido Cavalcanti, il cui celebre "disdegno" non sarebbe rivolto a Beatrice, ma soltanto a Virgilio (dunque non alla fede, ma alla ragione), e gli pronostica il purgatorio, «il luogo della penitenza per la salvezza... dove amici e poeti e artisti indugiano col pellegrino che li ha collocati sulla sua strada, quando la memoria delle passioni testimonia ormai di un riscatto». Ho i miei dubbi, ma come si richiede ai giurati prima del verdetto: si deve esser convinti al di là di ogni ragionevole dubbio. Meglio assolvere un colpevole che condannare un innocente.
 Nino Borsellino, Il poeta giudice. Dante e il tribunale della Commedia, Nino Aragno, Torino, pagg. 266, € 15,00
Nino Borsellino, Il poeta giudice. Dante e il tribunale della Commedia, Nino Aragno, Torino, pagg. 266, € 15,00 -
> LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE, E IL VATICANO CON IL SUO TRADIZIONALE SOFISMA ---- DUE FIUMI E UNA SOLA SORGENTE: IL "TRUCCO" DI SAN PAOLO E L’AMORE.22 ottobre 2011, di Federico La Sala
IL GRANDE COMANDAMENTO, L’AMORE ("CHARITAS"), E IL "TRUCCO" DI SAN PAOLO. “Fatevi miei imitatori, come io lo sono di Cristo” (1 Co 11,1):
L’Amore!di Raymond Gravel
in “www.lesreflexionsderaymondgravel.org” del 20 ottobre 2011 (traduzione: www.finesettimana.org)
XXX Domenica del tempo ordinario A: Esodo 22, 20-26; Matteo 22, 34-40.
Dopo una prima controversia con i farisei a proposito dell’imposta dovuta all’imperatore di domenica scorsa, eccone un’altra con uno dei farisei, un dottore della legge, a proposito del grande comandamento della Legge, non un comandamento tra i 613 (248 prescrizioni e 365 proibizioni), che dovrebbe essere considerato più importante degli altri, ma un comandamento che riassuma tutti gli altri. Non ci sono 36 comandamenti, risponde Gesù al dottoere della legge, ce n’è uno solo, quello dell’Amore, ma che ha due destinatari: Dio e il prossimo. Non l’uno senza l’altro. Tutti e due insieme... Cosa vuol dire?
1. L’Amore: una sorgente e due fiumi. Il teologo francese Patrick Jacquemont scrive: “La Parola di Dio acquista tutto il suo senso: amerai il Signore Dio tuo... amerai il prossimo tuo. Il secondo comandamento è simile al primo, ma non c’è un solo amore. C’è una sorgente unica, e due fiumi differenti”. È perché ci si sa amati da Dio che possiamo amarlo... ma possiamo amarlo solo amando l’altro, gli altri. È l’essenza dell’amore che fa sì che si ami. Non per niente, san Giovanni nella prima lettera dirà: “Se uno dicesse: "Io amo Dio", e odiasse il suo fratello, è un mentitore. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede” (1Gv 4,20). In fondo, ciò che san Giovanni vuol dire, è che amare Dio significa partecipare del suo amore, amando gli altri. Quindi, amando gli altri, si ama Dio.
Alla domanda del dottore della Legge: “Maestro, nella Legge, qual è il più grande dei comandamenti?” (Mt 22,36), cioè il comandamento nel quale sono compresi tutti gli altri? Gesù, che è lui stesso principio di unità, dà la risposta. Riunisce le due parti della Legge, i comandamenti riguardanti l’amore di Dio e quelli riguardanti l’amore del prossimo; li fonde ed unifica la loro espressione, che formula in termini identici, presi dalle Scritture: “Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, tutta l’anima e con tutte le forze” (Dt 6,5), e “Amerai il tuo prossimo come te stesso” (Lev 19,18b). Si tratta di un amore senza restrizioni, che impegna tutta la persona, cuore, anima e mente.
2. L’Amore cristiano: due principi di unità. Unificando l’amore di Dio e del prossimo, il Cristo del Vangelo ci dà due principi di unità:
1) La parabola del giudizio universale (Mt 25,31-46). Cristo si identifica con il prossimo: “Ciò che avete fatto ad uno solo dei miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” (Mt 25,40). E più di così: si identifica con i suoi fratelli, con i cristiani che sono poveri, sprovvisti di tutto, emarginati, perché le loro situazioni di povertà danno l’occasione agli altri, ai non cristiani di incontrare Cristo e di riconoscerlo.
Già nell’Antico Testamento, il Dio dell’Alleanza aveva un debole per i poveri. Nel brano del libro dell’Esodo che abbiamo oggi, i poveri sono l’immigrato, in ebreo ger, cioè lo straniero residente, quel gruppo di persone che aveva uno statuto sociale intermediario tra i cittadini israeliti e gli schiavi. Quelle persone non potevano possedere terre; dovevano solamente offrire il loro servizio agli altri. Erano quindi economicamente deboli: “Non molesterai il forestiero né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri nel paese d’Egitto” (Es 22,20). La vedova e l’orfano sono un’altra categoria di deboli nelle società ebrea di allora; senza risorse, vivevano spesso in miseria: “Non maltratterai la vedova e l’orfano” (Es 22, 21). E che cosa fare per non sfruttare i poveri? Prestare loro del denaro senza interessi e lasciare loro la loro dignità: “Se prendi in pegno il mantello del tuoprossimo, glielo renderai al tramonto del sole” (Es. 22,25).
2) “Seguitemi” (Mt 4,19). La legge dell’amore di Cristo non si riduce ad un codice o a un registro; è Gesù stesso che è la nostra legge, una legge viva, una persona con cui siamo in comunione, il cui Spirito ci abita e di cui noi siamo il corpo. Cosa che san Paolo traduce così: “Fatevi miei imitatori, come io lo sono di Cristo” (1 Co 11,1). Come cristiani, siamo dei cristi viventi, ed è a questo titolo che dobbiamo amare come lui.
Allora, se attualizzo la Parola oggi, le leggi, i precetti della religione, non possono applicarsi che in riferimento alla Legge dell’Amore proposta dal Cristo del Vangelo. Dipende dalla nostra fedeltà a Cristo il fatto che l’Amore sia l’essenziale, non solo nella nostra relazione con Dio, ma soprattutto nella nostra relazione con gli altri; altrimenti, anche l’amore di Dio è impossibile. E il prossimo, non sono solo le persone che la pensano come noi e che ci sono vicine; sono anche e soprattutto coloro che sono diversi da noi e talvolta anche difficili da amare.
Terminando, vorrei leggervi questa breve riflessione del francese Éric Julien: “Perché è così difficile amare Dio? Perché questo vuol dire amare il prossimo. E perché è così difficile amare il prossimo? Perché bisogna amarlo come se stessi, e pochissime persone sanno amarsi al loro giusto valore. E come si fa per amare se stessi? Si cerca di guardarsi come ci guarda Cristo. Con rispetto, tenerezza e... pazienza infiniti”.
-
> IL VATICANO CON IL SUO TRADIZIONALE SOFISMA DELLA "FALLACIA ACCIDENTIS" ---- Per 150 anni dell’Unità d’Italia, messaggio di Benedetto XVI al Presidente Napolitano.16 marzo 2011, di Federico La Sala
 Messaggio al Presidente Napolitano per 150 anni dell’Unità d’Italia
Messaggio al Presidente Napolitano per 150 anni dell’Unità d’Italia di BENEDICTUS PP. XVI (Avvenire, 16 marzo 2011)
di BENEDICTUS PP. XVI (Avvenire, 16 marzo 2011) Illustrissimo Signore On. GIORGIO NAPOLITANO
Illustrissimo Signore On. GIORGIO NAPOLITANO
 Presidente della Repubblica Italiana
Presidente della Repubblica ItalianaIl 150° anniversario dell’unificazione politica dell’Italia mi offre la felice occasione per riflettere sulla storia di questo amato Paese, la cui Capitale è Roma, città in cui la divina Provvidenza ha posto la Sede del Successore dell’Apostolo Pietro. Pertanto, nel formulare a Lei e all’intera Nazione i miei più fervidi voti augurali, sono lieto di parteciparLe, in segno dei profondi vincoli di amicizia e di collaborazione che legano l’Italia e la Santa Sede, queste mie considerazioni.
Il processo di unificazione avvenuto in Italia nel corso del XIX secolo e passato alla storia con il nome di Risorgimento, costituì il naturale sbocco di uno sviluppo identitario nazionale iniziato molto tempo prima. In effetti, la nazione italiana, come comunità di persone unite dalla lingua, dalla cultura, dai sentimenti di una medesima appartenenza, seppure nella pluralità di comunità politiche articolate sulla penisola, comincia a formarsi nell’età medievale.
Il Cristianesimo ha contribuito in maniera fondamentale alla costruzione dell’identità italiana attraverso l’opera della Chiesa, delle sue istituzioni educative ed assistenziali, fissando modelli di comportamento, configurazioni istituzionali, rapporti sociali; ma anche mediante una ricchissima attività artistica: la letteratura, la pittura, la scultura, l’architettura, la musica. Dante, Giotto, Petrarca, Michelangelo, Raffaello, Pierluigi da Palestrina, Caravaggio, Scarlatti, Bernini e Borromini sono solo alcuni nomi di una filiera di grandi artisti che, nei secoli, hanno dato un apporto fondamentale alla formazione dell’identità italiana. Anche le esperienze di santità, che numerose hanno costellato la storia dell’Italia, contribuirono fortemente a costruire tale identità, non solo sotto lo specifico profilo di una peculiare realizzazione del messaggio evangelico, che ha marcato nel tempo l’esperienza religiosa e la spiritualità degli italiani (si pensi alle grandi e molteplici espressioni della pietà popolare), ma pure sotto il profilo culturale e persino politico.
San Francesco di Assisi, ad esempio, si segnala anche per il contributo a forgiare la lingua nazionale; santa Caterina da Siena offre, seppure semplice popolana, uno stimolo formidabile alla elaborazione di un pensiero politico e giuridico italiano. L’apporto della Chiesa e dei credenti al processo di formazione e di consolidamento dell’identità nazionale continua nell’età moderna e contemporanea. Anche quando parti della penisola furono assoggettate alla sovranità di potenze straniere, fu proprio grazie a tale identità ormai netta e forte che, nonostante il perdurare nel tempo della frammentazione geopolitica, la nazione italiana poté continuare a sussistere e ad essere consapevole di sé. Perciò, l’unità d’Italia, realizzatasi nella seconda metà dell’Ottocento, ha potuto aver luogo non come artificiosa costruzione politica di identità diverse, ma come naturale sbocco politico di una identità nazionale forte e radicata, sussistente da tempo. La comunità politica unitaria nascente a conclusione del ciclo risorgimentale ha avuto, in definitiva, come collante che teneva unite le pur sussistenti diversità locali, proprio la preesistente identità nazionale, al cui modellamento il Cristianesimo e la Chiesa hanno dato un contributo fondamentale.
Per ragioni storiche, culturali e politiche complesse, il Risorgimento è passato come un moto contrario alla Chiesa, al Cattolicesimo, talora anche alla religione in generale. Senza negare il ruolo di tradizioni di pensiero diverse, alcune marcate da venature giurisdizionaliste o laiciste, non si può sottacere l’apporto di pensiero - e talora di azione - dei cattolici alla formazione dello Stato unitario. Dal punto di vista del pensiero politico basterebbe ricordare tutta la vicenda del neoguelfismo che conobbe in Vincenzo Gioberti un illustre rappresentante; ovvero pensare agli orientamenti cattolico-liberali di Cesare Balbo, Massimo d’Azeglio, Raffaele Lambruschini. Per il pensiero filosofico, politico ed anche giuridico risalta la grande figura di Antonio Rosmini, la cui influenza si è dispiegata nel tempo, fino ad informare punti significativi della vigente Costituzione italiana. E per quella letteratura che tanto ha contribuito a "fare gli italiani", cioè a dare loro il senso dell’appartenenza alla nuova comunità politica che il processo risorgimentale veniva plasmando, come non ricordare Alessandro Manzoni, fedele interprete della fede e della morale cattolica; o Silvio Pellico, che con la sua opera autobiografica sulle dolorose vicissitudini di un patriota seppe testimoniare la conciliabilità dell’amor di Patria con una fede adamantina. E di nuovo figure di santi, come san Giovanni Bosco, spinto dalla preoccupazione pedagogica a comporre manuali di storia Patria, che modellò l’appartenenza all’istituto da lui fondato su un paradigma coerente con una sana concezione liberale: "cittadini di fronte allo Stato e religiosi di fronte alla Chiesa".
La costruzione politico-istituzionale dello Stato unitario coinvolse diverse personalità del mondo politico, diplomatico e militare, tra cui anche esponenti del mondo cattolico. Questo processo, in quanto dovette inevitabilmente misurarsi col problema della sovranità temporale dei Papi (ma anche perché portava ad estendere ai territori via via acquisiti una legislazione in materia ecclesiastica di orientamento fortemente laicista), ebbe effetti dilaceranti nella coscienza individuale e collettiva dei cattolici italiani, divisi tra gli opposti sentimenti di fedeltà nascenti dalla cittadinanza da un lato e dall’appartenenza ecclesiale dall’altro.
Ma si deve riconoscere che, se fu il processo di unificazione politico-istituzionale a produrre quel conflitto tra Stato e Chiesa che è passato alla storia col nome di "Questione Romana", suscitando di conseguenza l’aspettativa di una formale "Conciliazione", nessun conflitto si verificò nel corpo sociale, segnato da una profonda amicizia tra comunità civile e comunità ecclesiale. L’identità nazionale degli italiani, così fortemente radicata nelle tradizioni cattoliche, costituì in verità la base più solida della conquistata unità politica. In definitiva, la Conciliazione doveva avvenire fra le Istituzioni, non nel corpo sociale, dove fede e cittadinanza non erano in conflitto.
Anche negli anni della dilacerazione i cattolici hanno lavorato all’unità del Paese. L’astensione dalla vita politica, seguente il "non expedit", rivolse le realtà del mondo cattolico verso una grande assunzione di responsabilità nel sociale: educazione, istruzione, assistenza, sanità, cooperazione, economia sociale, furono ambiti di impegno che fecero crescere una società solidale e fortemente coesa. La vertenza apertasi tra Stato e Chiesa con la proclamazione di Roma capitale d’Italia e con la fine dello Stato Pontificio, era particolarmente complessa.
Si trattava indubbiamente di un caso tutto italiano, nella misura in cui solo l’Italia ha la singolarità di ospitare la sede del Papato. D’altra parte, la questione aveva una indubbia rilevanza anche internazionale. Si deve notare che, finito il potere temporale, la Santa Sede, pur reclamando la più piena libertà e la sovranità che le spetta nell’ordine suo, ha sempre rifiutato la possibilità di una soluzione della "Questione Romana" attraverso imposizioni dall’esterno, confidando nei sentimenti del popolo italiano e nel senso di responsabilità e giustizia dello Stato italiano. La firma dei Patti lateranensi, l’11 febbraio 1929, segnò la definitiva soluzione del problema. A proposito della fine degli Stati pontifici, nel ricordo del beato Papa Pio IX e dei Successori, riprendo le parole del Cardinale Giovanni Battista Montini, nel suo discorso tenuto in Campidoglio il 10 ottobre 1962: "Il papato riprese con inusitato vigore le sue funzioni di maestro di vita e di testimonio del Vangelo, così da salire a tanta altezza nel governo spirituale della Chiesa e nell’irradiazione sul mondo, come prima non mai".
L’apporto fondamentale dei cattolici italiani alla elaborazione della Costituzione repubblicana del 1947 è ben noto. Se il testo costituzionale fu il positivo frutto di un incontro e di una collaborazione tra diverse tradizioni di pensiero, non c’è alcun dubbio che solo i costituenti cattolici si presentarono allo storico appuntamento con un preciso progetto sulla legge fondamentale del nuovo Stato italiano; un progetto maturato all’interno dell’Azione Cattolica, in particolare della FUCI e del Movimento Laureati, e dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, ed oggetto di riflessione e di elaborazione nel Codice di Camaldoli del 1945 e nella XIX Settimana Sociale dei Cattolici Italiani dello stesso anno, dedicata al tema "Costituzione e Costituente".
Da lì prese l’avvio un impegno molto significativo dei cattolici italiani nella politica, nell’attività sindacale, nelle istituzioni pubbliche, nelle realtà economiche, nelle espressioni della società civile, offrendo così un contributo assai rilevante alla crescita del Paese, con dimostrazione di assoluta fedeltà allo Stato e di dedizione al bene comune e collocando l’Italia in proiezione europea. Negli anni dolorosi ed oscuri del terrorismo, poi, i cattolici hanno dato la loro testimonianza di sangue: come non ricordare, tra le varie figure, quelle dell’On. Aldo Moro e del Prof. Vittorio Bachelet? Dal canto suo la Chiesa, grazie anche alla larga libertà assicuratale dal Concordato lateranense del 1929, ha continuato, con le proprie istituzioni ed attività, a fornire un fattivo contributo al bene comune, intervenendo in particolare a sostegno delle persone più emarginate e sofferenti, e soprattutto proseguendo ad alimentare il corpo sociale di quei valori morali che sono essenziali per la vita di una società democratica, giusta, ordinata. Il bene del Paese, integralmente inteso, è stato sempre perseguito e particolarmente espresso in momenti di alto significato, come nella "grande preghiera per l’Italia" indetta dal Venerabile Giovanni Paolo II il 10 gennaio 1994.
La conclusione dell’Accordo di revisione del Concordato lateranense, firmato il 18 febbraio 1984, ha segnato il passaggio ad una nuova fase dei rapporti tra Chiesa e Stato in Italia. Tale passaggio fu chiaramente avvertito dal mio Predecessore, il quale, nel discorso pronunciato il 3 giugno 1985, all’atto dello scambio degli strumenti di ratifica dell’Accordo, notava che, come "strumento di concordia e collaborazione, il Concordato si situa ora in una società caratterizzata dalla libera competizione delle idee e dalla pluralistica articolazione delle diverse componenti sociali: esso può e deve costituire un fattore di promozione e di crescita, favorendo la profonda unità di ideali e di sentimenti, per la quale tutti gli italiani si sentono fratelli in una stessa Patria".
Ed aggiungeva che nell’esercizio della sua diaconia per l’uomo "la Chiesa intende operare nel pieno rispetto dell’autonomia dell’ordine politico e della sovranità dello Stato. Parimenti, essa è attenta alla salvaguardia della libertà di tutti, condizione indispensabile alla costruzione di un mondo degno dell’uomo, che solo nella libertà può ricercare con pienezza la verità e aderirvi sinceramente, trovandovi motivo ed ispirazione per l’impegno solidale ed unitario al bene comune".
L’Accordo, che ha contribuito largamente alla delineazione di quella sana laicità che denota lo Stato italiano ed il suo ordinamento giuridico, ha evidenziato i due principi supremi che sono chiamati a presiedere alle relazioni fra Chiesa e comunità politica: quello della distinzione di ambiti e quello della collaborazione. Una collaborazione motivata dal fatto che, come ha insegnato il Concilio Vaticano Il, entrambe, cioè la Chiesa e la comunità politica, "anche se a titolo diverso, sono a servizio della vocazione personale e sociale delle stesse persone umane" (Cost. Gaudium et spes, 76).
L’esperienza maturata negli anni di vigenza delle nuove disposizioni pattizie ha visto, ancora una volta, la Chiesa ed i cattolici impegnati in vario modo a favore di quella "promozione dell’uomo e del bene del Paese" che, nel rispetto della reciproca indipendenza e sovranità, costituisce principio ispiratore ed orientante del Concordato in vigore (art. 1). La Chiesa è consapevole non solo del contributo che essa offre alla società civile per il bene comune, ma anche di ciò che riceve dalla società civile, come affrerma il Concilio Vaticano II: "chiunque promuove la comunità umana nel campo della famiglia, della cultura, della vita economica e sociale, come pure della politica, sia nazionale che internazionale, porta anche un non piccolo aiuto, secondo la volontà di Dio, alla comunità ecclesiale, nelle cose in cui essa dipende da fattori esterni" (Cost. Gaudium et spes, 44).
Nel guardare al lungo divenire della storia, bisogna riconoscere che la nazione italiana ha sempre avvertito l’onere ma al tempo stesso il singolare privilegio dato dalla situazione peculiare per la quale è in Italia, a Roma, la sede del successore di Pietro e quindi il centro della cattolicità. E la comunità nazionale ha sempre risposto a questa consapevolezza esprimendo vicinanza affettiva, solidarietà, aiuto alla Sede Apostolica per la sua libertà e per assecondare la realizzazione delle condizioni favorevoli all’esercizio del ministero spirituale nel mondo da parte del successore di Pietro, che è Vescovo di Roma e Primate d’Italia. Passate le turbolenze causate dalla "questione romana", giunti all’auspicata Conciliazione, anche lo Stato Italiano ha offerto e continua ad offrire una collaborazione preziosa, di cui la Santa Sede fruisce e di cui è consapevolmente grata.
Nel presentare a Lei, Signor Presidente, queste riflessioni, invoco di cuore sul popolo italiano l’abbondanza dei doni celesti, affinché sia sempre guidato dalla luce della fede, sorgente di speranza e di perseverante impegno per la libertà, la giustizia e la pace.
Dal Vaticano, 17 marzo 2011
BENEDICTUS PP. XVI
-
> LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE, E IL VATICANO ---- CHE LA CHIESA PUNTI SULLA GRATUITA’ - NON SUL PROFITTO!!! A "TORINO SPIRITUALITA’" LA SOLLECITAZIONE DI CARLO OSSOLA, UNO DEI MASSIMI CRITICI LETTERARI E FILOLOGI ITALIANI.22 settembre 2010, di Federico La Sala
-
> LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE, ----: «Dall’alleanza fede-ragione un’etica per la democrazia». Testo del discorso di Benedetto XVI nella Westminster Hall di Londra.19 settembre 2010, di Federico La Sala
il discorso Il «giusto posto» del credo religioso nel processo politico al centro della riflessione del Papa nella Westminster Hall di Londra.
Il «giusto posto» del credo religioso nel processo politico al centro della riflessione del Papa nella Westminster Hall di Londra. Il modello: Tommaso Moro, lo statista che nel primato di Dio seppe radicare la sua libertà di coscienza e la dedizione al bene comune
Il modello: Tommaso Moro, lo statista che nel primato di Dio seppe radicare la sua libertà di coscienza e la dedizione al bene comune «Dall’alleanza fede-ragione un’etica per la democrazia»
«Dall’alleanza fede-ragione un’etica per la democrazia» la sfida
la sfida Il processo democratico è fragile se i «principi morali» che lo sostengono si basano soltanto sul consenso sociale. È questa la «sfida reale» che Ratzinger ha additato rivolgendosi, ieri in Parlamento, al corpo diplomatico e agli esponenti della cultura, della società civile e dell’economia
Il processo democratico è fragile se i «principi morali» che lo sostengono si basano soltanto sul consenso sociale. È questa la «sfida reale» che Ratzinger ha additato rivolgendosi, ieri in Parlamento, al corpo diplomatico e agli esponenti della cultura, della società civile e dell’economiaPubblichiamo il testo integrale del discorso pronunciato ieri pomeriggio da Benedetto XVI nella Westminster Hall di Londra all’incontro con gli esponenti della società civile, del mondo accademico, culturale e imprenditoriale, con il corpo diplomatico e con i leader religiosi. (AVVENIRE, 18.09.2010)
Signor presidente,
la ringrazio per le parole di benvenuto che mi ha rivolto a nome di questa distinta assemblea. Nel rivolgermi a voi, sono consapevole del privilegio che mi è concesso di parlare al popolo britannico e ai suoi rappresentanti nella Westminster Hall, un edificio che ha un significato unico nella storia civile e politica degli abitanti di queste Isole.
Permettetemi di manifestare la mia stima per il Parlamento, che da secoli ha sede in questo luogo e che ha avuto un’influenza così profonda sullo sviluppo di forme di governo partecipative nel mondo, specialmente nel Commonwealth e più in generale nei Paesi di lingua inglese. La vostra tradizione di «common law» costituisce la base del sistema legale in molte nazioni, e la vostra particolare visione dei rispettivi diritti e doveri dello Stato e del singolo cittadino, e della separazione dei poteri, rimane come fonte di ispirazione per molti nel mondo.
Mentre parlo a voi in questo luogo storico, penso agli innumerevoli uomini e donne che lungo i secoli hanno svolto la loro parte in importanti eventi che hanno avuto luogo tra queste mura e hanno segnato la vita di molte generazione di britannici e di altri popoli.
In particolare, vorrei ricordare la figura di san Tommaso Moro, il grande studioso e statista inglese, ammirato da credenti e non credenti per l’integrità con cui fu capace di seguire la propria coscienza, anche a costo di dispiacere al sovrano, di cui era «buon servitore», poiché aveva scelto di servire Dio per primo. Il dilemma con cui Tommaso Moro si confrontava, in quei tempi difficili, la perenne questione del rapporto tra ciò che è dovuto a Cesare e ciò che è dovuto a Dio, mi offre l’opportunità di riflettere brevemente con voi sul giusto posto che il credo religioso mantiene nel processo politico.
La tradizione parlamentare di questo Paese deve molto al senso istintivo di moderazione presente nella nazione, al desiderio di raggiungere un giusto equilibrio tra le legittime esigenze del potere dello Stato e i diritti di coloro che gli sono soggetti. Se da un lato, nella vostra storia, sono stati compiuti a più riprese dei passi decisivi per porre dei limiti all’esercizio del potere, dall’altro le istituzioni politiche della nazione sono state in grado di evolvere all’interno di un notevole grado di stabilità. In tale processo storico, la Gran Bretagna è emersa come una democrazia pluralista, che attribuisce un grande valore alla libertà di espressione, alla libertà di affiliazione politica e al rispetto dello Stato di diritto, con un forte senso dei diritti e doveri dei singoli, e dell’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge.
La dottrina sociale cattolica, pur formulata in un linguaggio diverso, ha molto in comune con un tale approccio, se si considera la sua fondamentale preoccupazione per la salvaguardia della dignità di ogni singola persona, creata ad immagine e somiglianza di Dio, e la sua sottolineatura del dovere delle autorità civili di promuovere il bene comune. E , in verità, le questioni di fondo che furono in gioco nel processo contro Tommaso Moro continuano a presentarsi, in termini sempre nuovi, con il mutare delle condizioni sociali. Ogni generazione, mentre cerca di promuovere il bene comune, deve chiedersi sempre di nuovo: quali sono le esigenze che i governi possono ragionevolmente imporre ai propri cittadini, e fin dove esse possono estendersi? A quale autorità ci si può appellare per risolvere i dilemmi morali?
Queste questioni ci portano direttamente ai fondamenti etici del discorso civile. Se i principi morali che sostengono il processo democratico non si fondano, a loro volta, su nient’altro di più solido che sul consenso sociale, allora la fragilità del processo si mostra in tutta la sua evidenza. Qui si trova la reale sfida per la democrazia.
L’inadeguatezza di soluzioni pragmatiche, di breve termine, ai complessi problemi sociali ed etici è stata messa in tutta evidenza dalla recente crisi finanziaria globale. Vi è un vasto consenso sul fatto che la mancanza di un solido fondamento etico dell’attività economica abbia contribuito a creare la situazione di grave difficoltà nella quale si trovano ora milioni di persone nel mondo. Così come «ogni decisione economica ha una conseguenza di carattere morale» ( Caritas in veritate, 37 ), analogamente, nel campo politico, la dimensione morale delle politiche attuate ha conseguenze di vasto raggio, che nessun governo può permettersi di ignorare.
Una positiva esemplificazione di ciò si può trovare in una delle conquiste particolarmente rimarchevoli del Parlamento britannico: l’abolizione del commercio degli schiavi. La campagna che portò a questa legislazione epocale, si basò su principi morali solidi, fondati sulla legge naturale, e ha costituito un contributo alla civilizzazione di cui questa nazione può essere giustamente orgogliosa.
La questione centrale in gioco, dunque, è la seguente: dove può essere trovato il fondamento etico per le scelte politiche? La tradizione cattolica sostiene che le norme obiettive che governano il retto agire sono accessibili alla ragione, prescindendo dal contenuto della rivelazione. Secondo questa comprensione, il ruolo della religione nel dibattito politico non è tanto quello di fornire tali norme, come se esse non potessero esser conosciute dai non credenti - ancora meno è quello di proporre soluzioni politiche concrete, cosa che è del tutto al di fuori della competenza della religione - bensì piuttosto di aiutare nel purificare e gettare luce sull’applicazione della ragione nella scoperta dei principi morali oggettivi.
Questo ruolo «correttivo» della religione nei confronti della ragione, tuttavia, non è sempre bene accolto, in parte poiché delle forme distorte di religione, come il settarismo e il fondamentalismo, possono mostrarsi esse stesse causa di seri problemi sociali. E, a loro volta, queste distorsioni della religione emergono quando viene data una non sufficiente attenzione al ruolo purificatore e strutturante della ragione all’interno della religione. È un processo che funziona nel doppio senso.
Senza il correttivo fornito dalla religione, infatti, anche la ragione può cadere preda di distorsioni, come avviene quando essa è manipolata dall’ideologia, o applicata in un modo parziale, che non tiene conto pienamente della dignità della persona umana. Fu questo uso distorto della ragione, in fin dei conti, che diede origine al commercio degli schiavi e poi a molti altri mali sociali, non da ultimo le ideologie totalitarie del ventesimo secolo. Per questo vorrei suggerire che il mondo della ragione ed il mondo della fede - il mondo della secolarità razionale e il mondo del credo religioso - hanno bisogno l’uno dell’altro e non dovrebbero avere timore di entrare in un profondo e continuo dialogo, per il bene della nostra civiltà.
La religione, in altre parole, per i legislatori non è un problema da risolvere, ma un fattore che contribuisce in modo vitale al dibattito pubblico nella nazione. In tale contesto, non posso che esprimere la mia preoccupazione di fronte alla crescente marginalizzazione della religione, in particolare del cristianesimo, che sta prendendo piede in alcuni ambienti, anche in nazioni che attribuiscono alla tolleranza un grande valore.
Vi sono alcuni che sostengono che la voce della religione andrebbe messa a tacere, o tutt’al più relegata alla sfera puramente privata. Vi sono alcuni che sostengono che la celebrazione pubblica di festività come il Natale andrebbe scoraggiata, secondo la discutibile convinzione che essa potrebbe in qualche modo offendere coloro che appartengono ad altre religioni o a nessuna. E vi sono altri ancora che - paradossalmente con lo scopo di eliminare le discriminazioni - ritengono che i cristiani che rivestono cariche pubbliche dovrebbero, in determinati casi, agire contro la propria coscienza.
Questi sono segni preoccupanti dell’incapacità di tenere nel giusto conto non solo i diritti dei credenti alla libertà di coscienza e di religione, ma anche il ruolo legittimo della religione nella sfera pubblica. Vorrei pertanto invitare tutti voi, ciascuno nelle rispettive sfere di influenza, a cercare vie per promuovere ed incoraggiare il dialogo tra fede e ragione ad ogni livello della vita nazionale.
La vostra disponibilità in questo senso si è già manifestata nell’invito senza precedenti che mi avete rivolto oggi, e trova espressione in quei settori di interesse nei quali il vostro Governo si è impegnato insieme alla Santa Sede.
Nel campo della pace, vi sono stati degli scambi circa l’elaborazione di un trattato internazionale sul commercio di armi; circa i diritti umani, la Santa Sede e il Regno Unito hanno visto positivamente il diffondersi della democrazia, specialmente negli ultimi 65 anni; nel campo dello sviluppo, vi è stata collaborazione nella remissione del debito, nel commercio equo e nel finanziamento allo sviluppo, in particolare attraverso la International Finance Facility, l’ International Immunization Bond e l’Advanced Market Commitment .
La Santa Sede è inoltre desiderosa di ricercare, con il Regno Unito, nuove strade per promuovere la responsabilità ambientale, a beneficio di tutti. Noto inoltre che l’attuale Governo si è impegnato a devolvere entro il 2013 lo 0,7% del reddito nazionale in favore degli aiuti allo sviluppo. È stato incoraggiante, negli ultimi anni, notare i segni positivi di una crescita della solidarietà verso i poveri che riguarda tutto il mondo.
Ma per tradurre questa solidarietà in azione effettiva c’è bisogno di idee nuove, che migliorino le condizioni di vita in aree importanti quali la produzione del cibo, la pulizia dell’acqua, la creazione di posti di lavoro, la formazione, l’aiuto alle famiglie, specialmente dei migranti, e i servizi sanitari di base. Quando è in gioco la vita umana, il tempo si fa sempre breve: in verità, il mondo è stato testimone delle vaste risorse che i governi sono in grado di raccogliere per salvare istituzioni finanziarie ritenute «troppo grandi per fallire». Certamente lo sviluppo integrale dei popoli della terra non è meno importante: è un’impresa degna dell’attenzione del mondo, veramente «troppo grande per fallire».
Questo sguardo generale alla cooperazione recente tra Regno Unito e Santa Sede mostra bene quanto progresso sia stato fatto negli anni trascorsi dallo stabilimento di relazioni diplomatiche bilaterali, in favore della promozione nel mondo dei molti valori di fondo che condividiamo. Spero e prego che questa relazione continuerà a portare frutto e che si rifletterà in una crescente accettazione della necessità di dialogo e rispetto, a tutti i livelli della società, tra il mondo della ragione ed il mondo della fede.
Sono certo che anche in questo Paese vi sono molti campi in cui la Chiesa e le pubbliche autorità possono lavorare insieme per il bene dei cittadini, in armonia con la storica pratica di questo Parlamento di invocare la guida dello Spirito su quanti cercano di migliorare le condizioni di vita di tutto il genere umano.
Affinché questa cooperazione sia possibile, le istituzioni religiose, comprese quelle legate alla Chiesa cattolica, devono essere libere di agire in accordo con i propri principi e le proprie specifiche convinzioni, basate sulla fede e sull’insegnamento ufficiale della Chiesa. In questo modo potranno essere garantiti quei diritti fondamentali, quali la libertà religiosa, la libertà di coscienza e la libertà di associazione.
Gli angeli che ci guardano dalla magnifica volta di questa antica Sala ci ricordano la lunga tradizione da cui il Parlamento britannico si è sviluppato. Essi ci ricordano che Dio vigila costantemente su di noi, per guidarci e proteggerci. Ed essi ci chiamano a riconoscere il contributo vitale che il credo religioso ha reso e può continuare a rendere alla vita della nazione.
Signor presidente, la ringrazio ancora per questa opportunità di rivolgermi brevemente a questo distinto uditorio. Mi permetta di assicurare a lei e al signor presidente della Camera dei Lord i miei auguri e la mia costante preghiera per voi e per il fruttuoso lavoro di entrambe le Camere di questo antico Parlamento. Grazie, e Dio vi benedica tutti!
Benedetto XVI